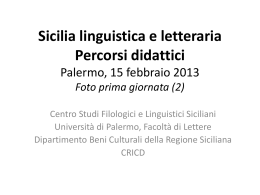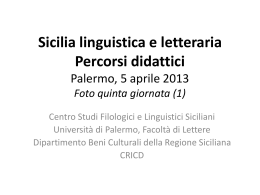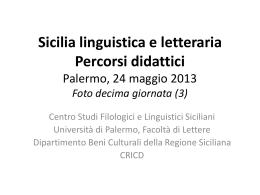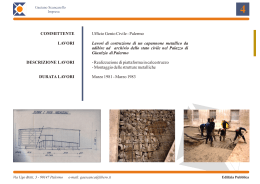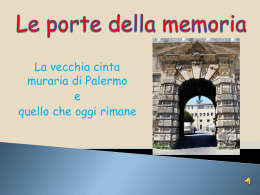SICILIA/BIBLIOTECHE 48/8 I manoscritti di Agostino Gallo A cura di Carlo Pastena 8 Edizione fuori commercio. Vietata la vendita Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Palermo Agostino Gallo Notizie di artisti Siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo (Ms. XV.H.20.1-2.) Trascrizione e note di Angela Mazzè, Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi Introduzione di Angela Mazzè Presentazione di Francesco Vergara Caffarelli Regione siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 2014 Si ringraziano Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra per la trascrizione delle carte iniziali del manoscritto. Si ringrazia il Priore del Convento di San Domenico di Palermo, padre Sergio Catalano, per aver concesso la pubblicazione della foto del monumento funerario di Giuseppe Patania Fotografie di Gaetano Lo Giudice Gallo, Agostino <1790-1872> I manoscritti di Agostino Gallo / a cura di Carlo Pastena. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. – v. 1. Arte – Sicilia. 709.458 CDD-22 SBN PAL0164433 8.: Notizie di artisti siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo (Ms. XV.H.20.1-2) / introduzione di Angela Mazzè ; trascrizione e note di Angela Mazzè, Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2014. (Sicilia/Biblioteche ; 48.8) ISBN 978-88-6164-251-5 1. Artisti siciliani – Origini-Sec. 19. - Repertori. I. Mazzè, Angela. II. Anselmo, Angela. III. Zimmardi, Maria Carmela. 709.458 CDD-22 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” © 2014 Regione siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Presentazione Offrire al lettore l’ottavo ed ultimo volume di una serie iniziata quindici anni fa e lentamente protrattasi fino ad oggi, è per chi scrive motivo di grande orgoglio e, al contempo, felice occasione per esprimere altrettanta gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile un percorso così lungo e fruttuoso. Il grandioso progetto di edizione integrale dei manoscritti di Agostino Gallo (1790-1872) posseduti dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana prese l’avvio sul finire degli anni ‘90 e nel 2000 fu possibile dare alle stampe i primi tre volumi della serie1. L’auspicata pubblicazione nel corso di tre anni di tutti gli otto volumi manoscritti del Gallo, dovette ahimè rivelarsi troppo ottimista se misurata con l’oggettiva difficoltà del lavoro critico di trascrizione, interpretazione, annotazione che tali materiali richiedono. Tutti coloro che hanno avuto occasione di consultare questi preziosi manoscritti sanno quanto sia irta di asperità la disordinata stesura del Gallo e dei suoi collaboratori. Ad una scrittura corsiva già di per sé di difficile lettura, si aggiungono cancellature, chiose, correzioni di ogni genere, e un inchiostro talvolta assai sbiadito, ma non basta! E’ la stessa struttura del contenuto, frammentario, ripetitivo, a tratti lacunoso, a rendere particolarmente gravoso il compito del curatore dell’edizione. Occorre infatti tenere presente che il Gallo affastellava sovente una grande quantità di informazioni, annotazioni, opinioni correnti e citazioni da fonti antiche, brani tratti da vari autori, articoli di giornali, con l’intento esplicito di provvedere in un secondo tempo al riordino dei materiali raccolti e all’inserimento opportuno in una delle sue opere. Il risultato di tale complessa e disorganica attività consiste in lavori che, pur avendo un titolo e una propria struttura, è difficile considerare conclusi. Quasi che l’Autore, mai contento, rimanesse sempre in attesa di raccogliere l’ultimo definitivo particolare, la gemma erudita che avrebbe dovuto consacrare la sua opera e renderla degna di essere data alle stampe. I criteri di edizione furono all’inizio definiti da Carlo Pastena e sono stati mantenuti invariati nel corso degli anni. La cura scientifica dei singo_________________________________ 1 BCRS, Mss. XV.H.17 Notamento alfabetico di pittori e musaicisti siciliani ed esteri …; XV.H.14 Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri soggiornanti in Sicilia …; XV.H.16 Notizie intorno agli incisori siciliani …, cfr. Prefazione al vol. I. V li volumi, con la trascrizione del testo e la redazione dell’apparato critico in nota è stata di volta in volta affidata a personale interno alla Biblioteca o a studiosi esterni. In particolare, il primo volume della serie, il Notamento alfabetico di pittori e musaicisti siciliani ed esteri … (Ms. XV.H.17) è stato curato da Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra, colleghe dell’unità Fondi antichi, al pari di Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi, cui si deve la pubblicazione del terzo volume, Notizie intorno agli incisori siciliani … (Ms. XV.H.16). Più ponderoso ed approfondito è stato il lavoro condotto da Angela Mazzè, storica dell’arte dell’Università di Palermo, sul secondo volume, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri soggiornanti in Sicilia (Ms. XV.H.14), la cui trascrizione viene introdotta dal saggio L’incompiuta Storia delle Belle Arti: progetti e polemiche, nel quale ampio spazio è dedicato alla feroce rivalità tra Gallo e Gioacchino Di Marzo, autore della coeva Delle belle arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo XIV, edita a Palermo tra il 1858 e il 1864. Nel 2002, sempre a cura di Angela Mazzè, compare il quarto volume, Autobiografia2, il cui contenuto va integrato in parte con quello del presente, ottavo, volume3. Anche in questo caso, un cospicuo saggio della curatrice, Il panorama biografico (pp.33-99) fa da commento al testo che Gallo dedica a sé stesso, mentre pari attenzione viene posta alla sua bibliografia ragionata nel saggio La produzione storiografica (pp.100-147). L’opera Notizie di pittori e musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia, da collegare al Notamento alfabetico di cui al volume primo, è stata pubblicata in due distinti volumi, il quinto e il settimo: la Parte prima (Ms. XV.H.18) nel 2003, a cura di M. M. Milazzo e G. Sinagra; la Parte seconda (Ms. XV.H.19) nel 2005, ancora una volta affidata ad Angela Mazzè che introduce la trascrizione con un saggio su Il manoscritto XV.H.19: le fasi della ricerca e le ipotesi cronologiche sulla stesura. La studiosa ne analizza l’impianto progettuale, le fonti, il lessico critico-artistico, concludendo con un breve paragrafo dedicato alle donne nella pittura siciliana. Nell’intervallo di tempo tra il quinto e il settimo, vede la luce nel 2004 il sesto volume della serie (Mss. XV.H.15-16) a cura di A. Anselmo e M. C. Zimmardi. Esso propone una trascrizione riordinata e coerente del contenuto dei due manoscritti, probabilmente alterato da un errore d’origine _________________________________ 2 3 BCRS, Ms. XV.H.20.1 Biografia di Agostino Gallo di Palermo vivente in marzo 1867, pp.3 – 27. VI nella legatura. Il primo riguarda per la massima parte la storia della scultura in Sicilia, pur presentando un titolo4 che ne circoscrive il contenuto agli aspetti artistici della monetazione siciliana, che nell’originale occupa soltanto le cc. 11r-43v. Il secondo manoscritto contiene le Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori e cisellatori siciliani ed esteri. Oggi, dopo nove anni, siamo finalmente in grado di concludere con l’ottavo volume la serie dei manoscritti di Gallo conservati in questa Biblioteca5. Anche in questo caso, esso presenta il contenuto di due volumi manoscritti (Mss. XV.H.20.1-2), la cui trascrizione si deve ad A. Mazzè, A. Anselmo e M. C. Zimmardi, preceduta da un’introduzione della stessa Mazzè che così conclude la sua lunga frequentazione con il Nostro Autore. La natura stessa dei contenuti, destinati ad integrare opere precedenti, e la struttura disarticolata e confusa portano la studiosa a sottolinearne “il disordine metodologico associato alla disorganicità concettuale e storica” che va tuttavia considerato dagli studiosi di oggi come un’opportunità rara e preziosa per penetrare nella costruzione dell’opera in fieri, scrutandone impietosamente i ripensamenti, le ripetizioni, le sviste. Proprio questa possibilità di entrare nel “repertorio” generale di un grande erudito dai variegati interessi culturali e dall’intensa vita pubblica, è la maggiore attrattiva dell’opera che qui presentiamo, alla quale auguriamo almeno la stessa fortunata considerazione che gli studiosi hanno finora dedicato alla faticosa lettura dei manoscritti conservati in questa Biblioteca. A tutti i colleghi che nel corso degli anni hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione di questo progetto di lunga durata, va il plauso e la gratitudine della comunità scientifica insieme al mio personale affettuoso ringraziamento. Francesco Vergara Caffarelli _________________________________ 4 Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione delle monete in Sicilia dall’epoca araba sino alla castigliana. 5 Notizie di artisti siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo. VII NOTA TECNICA Nella trascrizione dei manoscritti di Agostino Gallo, si è scelto di adottare una trascrizione diplomatica del testo filologicamente corretta, ma semplificata. In particolare: 1. È stata sempre omessa l’indicazione della carta; 2. L’indicazione delle pagine bianche è stata omessa; 3. Il testo è stato trascritto così come si presenta, riportando la grafia errata di alcune parole presenti nel manoscritto. Palesi errori sono stati segnalati in nota; 4. È stata in genere rispettata la punteggiatura originale; 5. Le postille marginali, le aggiunte e correzioni sono state inserite nel testo, senza segnalarlo in alcun modo, ma nel rispetto della trascrizione filologica del documento. Eventuali cancellazioni o altre particolarità sono state segnalate in nota; 6. Le parole illeggibili sono state segnalate con tre punti tra parentesi quadre ( [...] ); 7. Gli spazi bianchi nel manoscritto sono stati indicati con tre asterischi ( *** ); 8. Le abbreviazioni che sono state sciolte nel testo, non sono state segnalate; 9. Le integrazioni dei curatori sono state sempre inserite tra parentesi angolari ( < > ) Note al testo 1. 2. 3. 4. Di ogni artista viene data in nota la forma corretta del nome, seguita dagli estremi cronologici se conosciuti o degli anni della sua attività (ad es.: Vito D’Anna, allievo di Pietro Paolo Vasta, nato a Palermo nel 1718 ed ivi morto nel 1769); Le citazioni bibliografiche di A. Gallo, spesso molto sommarie e imprecise, quando identificate sono date per esteso (ad es: Lazzaro Di Giovanni, Le opere d'arte nelle chiese di Palermo, c. 48 r. Manoscritto del sec. XIX, conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo); Sono state segnalate in nota eventuali cancellazioni o particolarità del testo, ritenute utili per una migliore comprensione del testo; L’indicazione di eventuali opuscoli a stampa, fedi di nascita o altro materiale a stampa e manoscritto inserito tra le pagine del manoscritto, di norma non è stato trascritto ma solo segnalato in nota. IX Indici Ogni volume è corredato da un Indice alfabetico degli artisti, in cui si rinvia alle pagine del testo a stampa dove l’autore è citato, seguito, entro parentesi tonda, dall’indicazione della segnatura del manoscritto di A. Gallo e dall’indicazione delle relative carte. Ad es.: Borremans Anna (Ms. XV.H.18., c. 372r) Borremans Luigi (Ms. XV.H.18., c. 372r) Borremans Wilhem (Ms. XV.H.18., cc. 351v, 355r, 356r-358v) p. » » Bova Antonio (Ms. XV.H.18., c. 172r) Bramé Paolo (Ms. XV.H.18., c. 27v; Ms. XV.H.19., cc. 687r-687v) » » X 252 252 235-236 238-241 118-119 21-22 Introduzione Il manoscritto XV.H.20.1, penultimo di quelli depositati presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” (già Nazionale), si compone di 383 carte stilate alternativamente dal Gallo e dai suoi segretari. Custodisce preziosi brandelli di memorie storico-artistiche, corollari e/o addizioni, deputati, presumibilmente, sia a colmare le lacune sia ad ordinare l’affastellata apologia della incompiuta Storia delle Belle arti in Sicilia, la cui estensione temporale spazia dall’arte classica al XIX secolo. La titolazione autografa del manoscritto, Notizie di artisti siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo, induce ad ipotizzare che codesta tranche di appunti reiterati avrebbe, presumibilmente, completato l’ambiziosa stesura dell’opera alla quale il Nostro aveva dedicato energia intellettuale ed epistolare a partire dal 1819. La malferma salute, a partire dal 1855 lo costringe sovente a lunghe pause che danneggiando, inevitabilmente, la qualità della concentrazione, creano vuoti di memoria che inficiano la stesura e si traducono – sovente – in ripetizioni, in omissioni, in sviste. Che Gallo preconizzasse la sua dipartita o che ne avesse certezza, lo si evince dalla necessità che egli sente di stilare la sua autobiografia. In questo manoscritto, alla versione autografa che reca la data del 5 febbraio 1855i, segue una seconda stesura sotto forma di note biografiche dettate (o trasmesse) nel 1867 a Pietro Citrano, e poi pubblicate da Paolo Sansoneii, entrambi suoi amici e segretari. Il Citrano, a sua volta, nel 1873, ossia l’anno successivo alla dipartita del Nostro, pubblicherà a Palermo il saggio intitolato Sulla vita civile, politica e letteraria del cavaliere Agostino Gallo notizie storico-critiche. Il suo studio è subissato dalla caotica mole di annotazioni storiche ed artistiche, ma il Nostro, per custodirne e divulgarne la loro memoria, le fa traghettare sulle sponde dei Beni Culturali con l’ausilio del Citrano, il quale dichiara: «dal 1869 ebbi … l’incarico di coordinare le di lui opere manoscritte rimaste inedite, di alcune delle quali n’ebbi un sunto sotto il suo dettato»iii. Questa testimonianza giustifica il “disordine” metodologico associato _________________________________ La versione autografa dell’autobiografia è stata pubblicata in: Agostino Gallo, Autobiografia (Ms. XV.H.20.1). Trascrizione, saggio introduttivo e note a cura di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali ambientali e della pubblica istruzione, 2002. ii Paolo Sansone, Biografia di Agostino Gallo, Palermo, Tip. Barcellona, 1872. iii Pietro Citrano, Sulla vita civile, politica, e letteraria del cavaliere Agostino Gallo di Palermo e della maggior parte delle opere edite, ed inedite del medesimo delle quali alcune finora ignare. Notizie storico-critiche. [S.l., s.n.], 1873 (Palermo, G. Priulla), p. 7. Paolo Sansone, Biografia di Agostino Gallo, Palermo, Tip. Barcellona, 1872. i XI alla disorganicità concettuale e storica, all’assemblaggio di argomenti riproposti o rielaborati in più versioni. La “filosofia” del Gallo concede alle creazioni degli artisti la peculiarità di monitorare l’opera in fieri e di non cristallizzarla nella forma finale. Il Nostro, infatti comunica e compendia, attraverso la scrittura visiva, la varietà delle tecniche artistiche adattate singolarmente alle tipologie pittoriche e decorative. Questa riflessione la suggeriscono le versioni biografiche dedicate al cavaliere Giuseppe Patania, suo istruttore di pittura, del quale il Gallo non è solo l’amico fraterno ma soprattutto lo sponsor al quale affida l’esecuzione dei centocinquantadue ritratti di Siciliani illustri della sua pinacoteca privata. La morte improvvisa dell’artista (1852) sconvolge le fasi dell’itinerario storico e metodologico: Gallo interrompe l’assemblaggio cronachistico dei fatti e misfatti della Palermo artistica e antiborbonica e si dedica, con acribia, a stendere ben quattro versioni biografiche del Patania, stilando l’elenco della sua produzione artistica a partire dal 1807. In ogni versione biografica il Gallo insiste a rammentare i contrasti del Patania col Maestro Giuseppe Velasques, corregge qualche imperfezione, migliora (talvolta) la qualità della compilazione critica ed evidenzia, soprattutto, che il suo amico «fu il primo pittore a sostenere il buon gusto nell’arte e diffonderlo per mezzo dei suoi numerosi allievi». Di essi il Gallo snocciola un lungo elenco differenziando gli «scolari» dai «dilettanti»; infine, per non tradire il suo “onesto” narcisismo, colloca il suo nome al secondo posto dopo Luigi Scalia. Non si tratta di piaggeria ma di un sincero legame riverentemente affettivo, esteso dal Citranoiv il quale scrive in proposito: «… essendo stata intenzione del Gallo pria di morire di pubblicarla … la rifuse di nuovo aggiungendo e togliendo qualche brano; ma io dubitando che il senso variasse in alcuni luoghi, ebbi l’accortezza di fare visibili le cancellature nell’antico, e unico Ms che si conserva. Essa vita si compone di due cartolari in foglio il primo recentemente dettato che forma l’introduzione tutto scritto di mia mano; il secondo di un copista, e forse dall’autore dettato vivente il suddetto Patania. Ai detti cartolari si aggiungono i documenti e i cataloghi delle opere del nostro dipintore, composto dal Sig. Giuseppe Di Marzo allievo del Patania». Le reiterate versioni biografiche hanno tuttavia il merito di divulgare le tipologie del vasto repertorio tecnico del Patania, pittore storico, di genere, votato all’iconografia sacra, ma soprattutto insigne ritrattista. L’indagine psicologica configura efficacemente la sua peculiarità figurativa: la critica _________________________________ iv Pietro Citrano, Sulla vita civile … cit., p. 11. XII e il mercato dell’arte lo segnalano tuttora tra i migliori interpreti della fisiognomica di età neoclassica. Dotato di memoria fotografica, il Patania non esita a riproporre, a memoria (e sulla cera) le sembianze del defunto, oppure le recupera più facilmente dall’incisione o dal dagherrotipo. L’archivio di documenti e ricordi pubblici e privati conclama la prolifica attività del Gallo poligrafo. Ne fa fede la dichiarazione di Rosalia Sansone e Scinà in Randazzo, erede e nipote di Domenico Scinà, la quale avalla l’impegno del Nostro, «di lui affezionato scolare ed amico», di pubblicare «in uno o più volumi le opere minori» dell’illustre docente di fisica presso la Regia Università degli Studi di Palermo. Era noto a tutti i bibliofili che Gallo aveva curato le edizioni delle opere dello Scinàv; l’A. tuttavia conserva deliberatamente il contratto. Il manoscritto custodisce inoltre missive che il Gallo, presumibilmente non ha collocato nei faldoni del copioso epistolario: sono infatti lettere derubricate dal suo ufficio e custodite come cimeli privati. Ne fa fede la supplica inviatagli da Salvatore Politi da Siracusa il 20 luglio 1858, per «essere nominato a sorvegliatore» delle antichità di Siracusa «che fu un tempo principessa delle greche città». Un disordine metodologico caratterizza l’accozzaglia della progettata scrittura: sono infatti presenti ben quattro versioni correlate indistintamente, l’una al Proemio dell’Istoria delle Belle arti Siciliane, l’altra all’Introduzione alla storia delle belle arti siciliane. Per un successivo ripensamento il Gallo rielabora altre due versioni del paragrafo e intitola, la prima, Belle arti antichissime in Sicilia e la seconda Belle arti antiche in Sicilia reiterando argomenti, biografie e aneddoti già illustrati nei precedenti manoscritti. Non tralascia tuttavia gli aggiornamenti bibliografici come si evince dalla trascrizione integrale di un articolo estrapolato dal Bollettino dell’Istituto di Corrispondenza archeologica del dicembre 1854. La compulsione storiografica del Nostro non si arresta alla ricognizione storica sull’antichità ma si estende altresì al secolo delle cosiddette riforme illuministiche che investono anche la politica urbanistica di Palermo gestita, a partire dal 1778, dal viceré Marco Antonio Colonna. Presumiamo che il Gallo abbia estrapolato i puntuali ragguagli dagli Atti del Municipio di Palermo. _________________________________ Domenico Scinà, Opere letterarie e scientifiche edite e inedite di Domenico Scina da Palermo or pubblicate per la prima volta riunite, e ordinate da Agostino Gallo con sue note, e giunte a quelle letterarie e de’ professori Pietro Calcara e Domenico Ragona Scinà alle scientifiche, Palermo, Tip. Barcellona, 1847; Domenico Scinà, Storia letteraria di Sicilia dei tempi greci ... Con annotazioni ed appendici di Agostino Gallo suo antico scolaro ed amico, Palermo, Tip. della ved. Solli, 1859. v XIII Con l’ultimo paragrafo intitolato Sul tipo siciliano o delle belle arti predominanti nell’isola nostra ab antico il Gallo riparte dal dorico e, attraverso un veloce excursus sull’attività dei “paladini” della pittura di età barocca fino al neoclassicismo, arresta la scrittura al 27 luglio 1868, anno in cui il poeta neoclassico messinese Natale Carta è insignito della qualifica di «Cattedratico di pittura per l’insegnamento del disegno». La carta successiva reca il titolo Belle Arti in Sicilia, stilato autograficamente seguito dalla chiosa redatta dal segretario, come si evince dal ductus della scrittura, che recita: Notizie sugli artisti siciliani / da unirsi alla storia delle belle arti. Il capitolo successivo intitolato Belle Arti in Sicilia. Secolo XIII altro non è che un compendio di notizie storico-etnografiche estrapolate dalla Sicilia sacra di Rocco Pirro (1630) e da Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano (1728) e riguardanti prevalentemente il settore dell’artigianato artistico. L’enciclopedica “Storia delle Belle Arti”, come si evince dal titolo del paragrafo Protettori delle belle arti nei secoli XV e XVI approfondisce lo status dei committenti, ma non conclude definitivamente il frastagliato percorso storico interrotto da episodi che talvolta frantumano il fragile mosaico. Assillato dai ricordi, perseguitato dall’ansia, ma soprattutto debilitato dalla salute malferma, il Gallo attua la ricognizione dello stato di fatto delle opere che rubrica nel paragrafo Oggetti d’arte trasportati da Sicilia all’estero. È una denuncia che trova un alleato nel segretario che ricopia in bella scrittura le labili testimonianze grafiche che il Gallo avrebbe voluto divulgare. È a nostro parere, una delle pagine di denuncia lirica nei confronti della legge Siccardi (7 luglio 1865) che ha depredato dell’arredo sacro le chiese, ma – cosa ancor più grave – contro « l’influenza della setta protestante» per la quale il Senato locale «ha già aperto tre scuole evangeliche in Palermo e fatto molti proseliti» guidati da «Padre Lipari domenicano». Sono pagine inedite di storia dei Beni Culturali da documentare in quanto il Gallo traccia le coordinate correlate allo scempio delle opere d’arte che «nel febbraio e marzo 1866 furono fatte atterrare con rabbia iconoclasta e coll’influenza protestante dell’assessore Raffaello Di Benedetto, il quale «avea provocato un subbuglio popolare nel piano del Monte» di Pietà che cagionò «lo spoglio delle chiese e la depredazione degli oggetti sacri». La rubricazione degli allievi del Maestro Patania fa da chiusa al “registro” (per dirla con Gallo). XIV Il manoscritto XV.H.20.2. costituisce la chiusa integrativa e storicodocumentaria dei precedenti volumi. Ancora una volta gli eterogenei argomenti sono stati assemblati senza un metro cronologico da chi – amorevolmente profano – ha voluto tramandare la filigranata laboriosità del Gallo. Pittura, scultura, architettura sono i temi principi corredati sovente da manifesti o da opuscoletti stampati che sdoganano esempi della feconda produzione isolana composta da artisti che, altrimenti, sarebbero rimasti sconosciuti. Ci riferiamo, per tutti, a quel Giosuè Meli, autore della Madre Pompeiana, la scultura osannata da Teresa Petrozzi nell’ode edita a Roma il 15 luglio 1864. Anche la progettazione del Pantheon siciliano cimenta la cultura della memoria intellettuale, come fa fede la ricevuta di pagamento in favore di Rosolino Barbera, autore tra gli altri del busto di Gioacchino Ventura. La variegata gamma di argomenti include altresì gemme aneddotiche, valga per tutte quella relativa all’amico e scultore Valerio Villareale. Esse interrompono sovente la monotona reiterazione di argomenti rivisitati e al contempo si associano a personali comunicazioni culturali e storiografiche. Nella seconda sezione titolata dal Gallo Mosaici e arte musiva specialmente in Sicilia, l’autore non tralascia di affrontare un tema talvolta omesso dai contemporanei. Il 22 settembre 1864 Gallo stila, o rielabora, una preziosa relazione sulla tecnica di preparazione dell’intonaco. Di seguito sono inserite le biografie di Giambattista Citardo e di altri modellatori in cera. La discontinuità degli argomenti prosegue con l’esposizione della tecnica dell’incisione in Sicilia e dei suoi rappresentanti. Segue la sezione relativa all’Architettura in Sicilia dei tempi più antichi, nella quale Gallo rielabora con riflessioni personali le considerazioni sugli antichi artisti siciliani dello storiografo gesuita e contemporaneo Alessio Narbone riportate nel capitolo Coltura primigenia del primo volume dell’Istoria della letteratura siciliana. L’attualità riprende campo e Gallo accende i fari su Carmelo Lanzerotti, capitano del R. Corpo del Genio, architetto militare, il quale gli offre lo spunto per retrocedere, attraverso la gloriosa epoca barocca, suggellata da Paolo Amato, alla primitiva architettura ciclopica. L’accorpamento alternato tra antico e contemporaneo consegna, alla storia dell’archeologia isolana, e palermitana in particolare, l’attività dell’architetto Saverio Cavallaro, e a quella dell’architettura le note biografiche di Giuseppe Di Martino, Nicolò Puglia, Filippo Juvara, del messinese Carlo Falconieri e della famiglia palermitana dei Marvuglia. XV Il manoscritto contiene il resoconto della traslazione della salma dell’abate Giovanni Meli, suo amico, medico e poeta vernacolare di fama europea. Un foglietto contenente la “Traduzione libera dal francese di Agostino Gallo in metro italiano della Romanza di Mr. Bonnaré” potrebbe ancora una volta testimoniare l’eclettismo culturale del Nostro. Fin qui abbiamo passato velocemente in rassegna i ricordi, le meditazioni dell’autore che intona, nel teatro del dibattito storiografico, acute note di denunzia pubblica contro la classe politica e religiosa. Il suo programma sociale e artistico orientato alla conservazione e alla memoria dei Beni Culturali sarà esteso dal Citrano il quale nella Biografia focalizza le fasi di riordino e di assemblaggio delle carte. Scrive infatti: «le suddette memorie.. abbraccia<va>no meno cento quaderni in foglio e <erano> racchiusi in una gran cartiera»vi. Durante le fasi di trasporto e di rilegatura si sono purtroppo dispersi molti cimeli autografi: ci riferiamo in particolare all’Appendice che tratta degli artisti maltesi vii. La lunga ed estenuante carrellata di notizie che si affastellano e costituiscono, a nostro parere, il pregio della comunicazione immediata, spontanea, da custodire nell’archivio del tempo e della storia. E probabilmente, quando l’entusiasmo della scrittura “adombra” l’intensità dell’evento da denunziare o da catalogare tra gli Annali della storia palermitana, il Gallo reitera (e talvolta ricopia) la pagina per non correre il rischio di smarrire la perla preziosa per rarità ed immediatezza. Ci resta la spontanea esposizione di fatti e misfatti documentati dalla penna (talvolta astiosa) di un cultore d’arte di fede liberale. Angela Mazzè _________________________________ vi vii Pietro Citrano, Sulla vita civile … cit., p. 11. Pietro Citrano, Sulla vita civile … cit., p. 11. XVI Agostino Gallo Notizie di artisti Siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo (Ms. XV.H.20.1., cc. 34-383) Introduzione, trascrizione e note di Angela Mazzè Biografia di Agostino Gallo di Palermo vivente in marzo 1867 1 Dalle più antiche memorie di sua famiglia ricavasi che il conte Agostino Gallo nato in Brescia nel 1499, e morto nel 1570, fu celebre agronomo, e pubblicò un’opera intitolata Le venti giornate dell’agricoltura e dei piaceri della villa, opera allora applaudita e riprodotta nove volte colle stampe e tradotta in francese da M.r Belleforest con titolo alterato Secret de la vraye agriculture et honestes plaisirs qu’on reçoit en la menagerie des chambre, Paris, 1571 ou 1572, in-4°. Quell’autore ha il vanto di avere il primo introdotto in Italia la coltivazione di riso del trifoglio(1)2. Un cadetto della sua famiglia passò in Savona e fu ammesso fra i patrizi(2)3 ed un altro Agostino Gallo suo successore, ricco negoziante, venne in Palermo verso il 1664. Da lui derivarono successivamente un Pietro, Gaetano, un Salvatore ed il vivente Agostino di cui tessiamo la biografia. Costui nacque in Palermo dall’accennato Salvatore e da Gesualda Pisanti a 7 febbrajo 1790. Il padre addetto al negozio di porcellane di cristalli ed altri oggetti, era uomo onoratissimo; e benché avesse pochi capitali, pure non mancò mai di corrispondere a’ suoi obblighi mercantili, e dir soleva: “Prego Dio di morir senza debiti e senza carrozza” ed essendo religioso e caritatevole Dio ne accolse la preghiera e morì nel 1833 compianto da’ buoni. Soleva egli distribuir l’elemosina il sabato nel suo negozio, e per avvezzare il figlio alla carità verso i poveri, ancor fanciullo lo scelse suo elemosiniere, talché ritrasse egli quell’abitudine, che ha conservato nella sua lunga vita. All’età di cinque anni l’avviò alla scuola de’ primi elementi; insieme _________________________________ Le cc. 1-33 del manoscritto XV.H.20.1. sono state trascritte e pubblicate nel v. 4 dei “Manoscritti di Agostino Gallo”: Autobiografia (Ms. XV.H.20.1). Trascrizione, saggio introduttivo e note a cura di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali ambientali e della pubblica istruzione, 2002. Le cc. 34-54, qui trascritte, erano state già pubblicate da Paolo Sansone che le consultò, egli scrisse, su concessione degli eredi “come volere suo [del Gallo] e come promessa fattaci, alquanti anni prima di scendere nella tomba”: Biografia di Agostino Gallo, Palermo, Tip. Barcellona 1872, p. 7. 2 A c. 34r nota in calce: “(1) Diz. di cognizioni utili. Torino, 1864. Tom. 5, pag. 188. Brunet, Manuel du libraire. Bruxelles 1838. Tom. 2, pag. 268. Di lui avvi il ritratto a bulino nella collezione degl’illustri italiani.”<Enciclopedia elementare. Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventù italiana d’ambo i sessi. Opera interamente riveduta da Nicomede Bianchi, Torino, Unione tipografico-editrice, 1863-1865, 11 v.; Jacques Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres …. 4. éd., Bruxelles, Société belge de librairie, Hauman et Comp., Meline, Cans et Comp., 1838-1845, 5 v.>. 3 A c. 34r nota in calce: “(2) Spotorno sulla pittura ligure.” <Giovanni Battista Spotorno, Della pittura genovese avanti Raffael d’Urbino, 1838>. 1 3 con un fanciullo per principio liberale di uguaglianza sociale figlio di una serva, per nome Giacinto Orlando affinché4 il figlio crescesse senza superbia. Laonde quegli divenne il suo più intimo amico, e si amarono vicendevolmente e si compiansero nelle rispettive sciagure della vita. Giunto il fanciullo Agostino all’ottavo anno, fu dal padre messo nel Collegio del Buon pastore in Palermo sebbene quel collegio fosse addetto principalmente alla musica, pure era fornito di buone scuole, che procedevano dagli elementi grammaticali della lingua latina e italiana fino a quella di filosofia con ragguardevoli professori P. Imbastiani e il P. Villari. A dieci anni apprendea ivi le lettere umane ma ignorava ancora i precetti della poesia italiana; benché avesse letto alcuni poeti nelle due lingue, però, spinto da irresistibile tendenza alla poesia italiana cominciò a scrivere in sciolti un poema, in cui rappresentò un ricco barone di Sicilia, il quale, volendo ritrarre maggior profitto da un suo podere, fece devastare alcuni antichi sepolcri sotterranei, e spargere al vento le ceneri dei morti ivi racchiuse; ma il Gallo immaginò che la seguente notte le ombre de’ defunti apparissero al barone a spaventarlo, e alcune più rabbiose lo strozzassero. Quel concetto poetico gli era venuto forse in mente per la venerazione ispiratagli dal padre pei morti, il quale teneva registro de’ suoi amici trapassati, e coincidendo il giorno della loro rispettiva morte, ne alleviava le anime purganti con suffragî cristiani. Verso quel tempo scrisse ancora due sonetti, uno per morte del celebre abate Francesco Carì, gran teologo, letterato e poeta, e l’altro per Maria Clementina Arciduchessa di Austria, e prima moglie di Francesco I° erede della corona delle due Sicilie. Avendo il Gallo mostrato que’ due componimenti al suo zio paterno abate Simone, buon poeta, fu avvertito dal medesimo, che sebbene il concetto fosse affettuoso e poetico, e i versi di giusta misura, pure la forma del sonetto era sbagliata, avendola condotta con quattro quartetti ciascuno con rime diverse invece di due quartetti e due terzine con rime alternate. Tanto il Gallo era allora ignaro dell’arte poetica, ed ottenutone dallo zio i primi rudimenti proseguì a scriver sonetti con regolarità. Uscito dal collegio a tredici anni, cominciò a frequentar la scuola di eloquenza e poetica, diretta dal P. Michelangelo Monti, insigne autore e poeta di classico gusto, e professore prima nell’accademia degli studii, indi Reale Università di Palermo e infine cancelliere della stessa. Il Monti scorgendo i primi progressi del Gallo e la sua felice disposizione alla poesia italiana, lo predilisse su gli altri scolari. Cominciato avea _________________________________ 4 Seguono, cancellate le parole: “con l’eguaglianza non montasse per adulto con”. 4 egli sin d’allora la versione in sciolti italici delle odi di Orazio, dal Monti riputato il maggior lirico tra latini, che formar potea i giovani poeti. Avendo intanto compito il corso annuale gli permise di frequentar in casa sua, affinché continuasse a tradurre5 le dette odi e gli furono utili le sue correzioni nella iniziata traduzione, che conserva tuttavia manoscritta.6 Il Gallo imprese poscia a scriver buoni versi originali di vario metro, piaciuti al Monti e divenne7 l’intimo amico8 suo e alla morte lo preferì agli altri scolari, affidandogli i suoi manoscritti di prosa e di versi, per pubblicarne quelli che giudicasse migliori, il che fu eseguito dal Gallo esattamente9. Per riconoscenza premise all’indicata10 opera, la vita di quel valent’uomo, ne fe dipingere il ritratto dal celebre cavalier Giuseppe Patania11, e gl’innalzò in seguito un monumento funebre col suo busto marmoreo scolpito dall’egregio Sig.r Valerio Villareale12, allievo di Canova,13 nel Panteon degl’illustri siciliani promosso dallo stesso Gallo nella magnifica discesa di S. Domenico in Palermo14. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “in versi sciolti le odi latine di Orazio, che egli riputava il miglior lirico latino, che formar potesse i giovani poeti”. 6 Seguono cancellate le parole: “Il Gallo profittò del consiglio, e d’allora proseguì la versione oraziana”. 7 Segue cancellata la parola: “vieppiù”. 8 Seguono cancellate le parole: “del Monti, il quale”. 9 Cfr. Elogio di Padre Michelangelo Monti, copia ms. del sec. XIX con aggiunte e correzioni di Agostino Gallo, Bibl. Comunale di Palermo 4QqD13, f. 40. 10 Seguono cancellate le parole: “volume delle poesie”. 11 Giuseppe Patania, pittore, incisore di età neoclassica, nato a Palermo nel 1780, ivi morto nel 1852. L’A. focalizza l’attività di incisore dell’artista cfr. Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti siciliani, ed esteri che hanno lavorato pure per la Sicilia ricavato in parte in rari mss. dal Mongitore nella Biblioteca del Senato di Palermo, con aggiunte di Agostino Gallo (Ms. XV.H.17). Trascrizione e note di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra. Presentazione di Marco Salerno, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, 2000, p. 53-54. La moderna storiografia ascrive tre opere: Ivana Bruno, Giuseppe Patania dal neoclassicismo al romanticismo. Palermo, Ariete, 1996; Ivana Bruno, Giuseppe Patania pittore dell’Ottocento. Prefazione di Maria Concetta Di Natale; fotografie di Enzo Brai, Caltanissetta [etc.], S. Sciascia, [1993]; Civica galleria d’arte moderna <Palermo>. Giuseppe Patania nelle collezioni del museo. Civica galleria d’arte moderna 16 maggio-6 giugno. Catalogo a cura di Antonella Purpura; schede di Rossella Sinagra, [Palermo, 1998]. 12 Valerio Villareale, scultore, nato a Palermo nel 1773, ivi morto nel 1854. Il Gallo rubrica le opere dell’artista neoclassico in due precedenti manoscritti: cfr. Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 72-74.; Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione delle monete in Sicilia dall’epoca araba sino alla castigliana (Ms. XV.H.15., cc. 1r, 11-45v); Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori e cisellatori siciliani ed esteri che son fioriti in Sicilia da più antichi tempi fino al 1846 raccolte con diligenza da Agostino Gallo da Palermo (Ms. XV.H.16., cc. 1r-25r; Ms. XV.H.15., 62r-884r). Trascrizione e note di Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, p. 272-274. 13 Seguono cancellate le parole: “come può osservarsi”. Antonio Canova, scultore, nato a Possagno nel 1757, morto a Venezia nel 1822, rappresentante del neoclassicismo europeo. 14 Agostino Gallo, Autobiografia… cit., p. 62 e seg. 5 5 Durante il tirocinio scolastico di belle lettere, il Gallo studiava in ore diverse gli elementi di Filosofia sotto il P. Li Donni, e di algebra e geometria sotto il canonico Giovan Battista Cancilla. Ma primeggiando su gli altri condiscepoli nel liceo del Monti, era bensì inferiore ad essi nello studio delle matematiche, e solea dire ai medesimi, se vi riesce ora d’umiliarmi, nelle belle lettere sarò nella seguente lezione a voi superiore. Un curioso accidente gli fe acquistare la benevolenza di Giuseppe Piazzi celebre astronomo, il quale era amicissimo del Monti. Un bel giorno che Piazzi era nelle stanze di quello, sorvenuto il Gallo mentre que’ due valent’uomini disputavano, potè osservare che il Piazzi d’indole vivacissima, agitandosi, diceva con impazienza al Monti: “Possibile che non ti persuadi delle mie ragioni?”; e l’altro stringendo fra le dita una presa di tabacco rispondeva colla solita sua freddezza: “Non mi persuadono”. Il Gallo a quella scena, con giovanile imprudenza disse: “In questo momento io scorgo il poeta nell’astronomo Piazzi, e l’astronomo nel Monti, e non già il poeta”. Costui non se ne offese, il Piazzi ne rise, e replicò: “Ma non vedi che anche il tuo scolare vuol dirti che sei ostinato ed hai il gelo delle Alpi nelle vene?” e così terminò il diverbio. Il Gallo poco dopo scrisse un’ode saffica italiana, in cui accennava poeticamente i grandi lavori astronomici e la scoverta del pianeta Cerere del Piazzi, ed egli che amantissimo era della poesia latina e italiana, gradì quel componimento e d’allora lo volle suo commensale al giovedì in cui riuniva a desco alcuni suoi dotti amici; ma un funesto accidente gli minacciò la vita; perocchè ritornando dal pranzo e trovandosi nella gran piazza del R. Palazzo due cavalli sfuggiti dalla corsa, nel dì festivo di Santa Rosalia, erano quasi per investirlo e potè rimanere illeso agitando un bastoncino, che fe’ deviarli e permettergli che passasse tra mezzo: Ma d’allora cominciò a soffrire per lo spavento una vertigine, che viepiù si accrebbe per altri accidenti. Scrisse egli verso quel tempo un’altra ode saffica italiana per l’abate Domenico Scinà, dal quale appreso avea la fisica generale e sperimentale sui suoi elaborati elementi, che meritarono di essere ripubblicati due volte in Palermo, e cinque in Milano ad uso delle scuole d’Italia. Lo Scinà fu anche autore dell’istoria della letteratura greco-sicula che rimase incompiuta alla sua morte nel cholera del 1837; però fu data in luce con supplimenti, note copiose ed appendici del Gallo15. Lo Scinà fu anche autore del_________________________________ 15 6 Agostino Gallo, Autobiografia… cit., p. 107 e 109. l’istoria letteraria di Sicilia del secolo XVIII e della topografia di Palermo16 per la parte di storia naturale, opera anche applaudita in Francia. Nell’ode surriferita il Gallo descrisse i fenomeni della fisica con vivaci immagini, rappresentando lo Scinà, che conducevalo a passeggiare pei cieli, e ne svelava i misteri. Egli, sebbene di carattere burbero e severo, pure lo predilesse fino alla sua morte, e un giorno camminando insieme, mentre il cholera infieriva in Napoli, ed agitava di timori la Sicilia, che ancor erane esente, gli chiese: “Credete voi che noi avremo il cholera?” “Credo che no; perocché i cittadini son vigilanti a guardarsene, il magistrato di salute dà lo sfratto ai legni provenienti da Napoli, e il miasma cholerico dovrebbe traversare 180 miglia d’aria marina, e la Sicilia altronde per l’Etna è isola del fuoco, che distrugge i miasmi”. Ed egli replicò: “Ciò nonostante noi avremo il morbo micidiale, e il minor danno, che ne risentirà la Sicilia, sarà nei funesti effetti del morbo; perocché essa se perderà una parte di popolazione, vi succederà l’altra generazione; ma un danno maggiore ne avrà nel perdere tutti i suoi antichi dritti che col pretesto del cholera le saranno tolti dai ministri e dal governo di Napoli. Io presagisco che sarò tra le prime vittime del cholera. Vi ricorderete voi di me? Scriverete qualche piccolo componimento poetico, e m’innalzerete un busto anche di creta sulla mia tomba, poicché io mi contento anche di poco. Lo spero dal vostro ben noto affetto”. Avverossi in tutto il presagimento dello Scinà, il cholera penetrò in Palermo e trascorrendo per l’altre città e fece orrenda stragge in Sicilia di 120mila abitanti, fra i quali lo Scinà e molti altri dottissimi uomini, e valorosi artisti. Il morbo erasi introdotto per mezzo de’ controbandi e per la stolta risoluzione del governo di ammettersi in contumacia i legni provenienti da Napoli. Il Gallo ricordossi delle parole dello Scinà e per riconoscenza gl’innalzò a proprie spese un monumento funebre nel Panteon di S. Domenico in Palermo colla sua medaglia in marmo e la seguente iscrizione latina da lui composta Domin. Scinà panormit. ordin. franc. eq. Phisices in R. Urbis atheneo professori Ab historiis stabulisque _________________________________ 16 Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici, cfr. Giuseppe Maria Mira, Bibliografia siciliana. Ovvero gran dizionario bibliografico delle opere edite e inedite, antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori, Palermo, Ufficio tipografico diretto da G.B. Gaudiano, 1875-1881, v. 2, p. 346-347. 7 Sophorum literatorum sui aevi principii Libris sapientissime elucubratis praeclaro Ingenio Empedocli cujus scripta illustravit Moribus Catoni assimili IV id. Iul. An. MDCCCXXXVII aet. suae LXXII Indica lue perempto Augustinus Gallus Praeceptori et amico dilectissimo M.P. Il Gallo avea prima fatto dipingere il ritratto dello Scinà dal celebre Patania, che fa parte della sua ricca collezione di 120 immagini di uomini illustri siciliani17 colle rispettive epigrafi in versi italiani da lui scritte. Sotto quella dello Scinà leggesi. Forte intelletto del suo secol duce, D’onnigeno saper sparse la luce. Un’altra dimostrazione d’affetto avea egli dato prima al suo precettore. Un giorno mal soffrendo che Scinà fosse sparlato dal giovine avvocato D.r Lo Presti gl’intimò un duello, e questi mancando all’appuntamento, l’affare finì con una soddisfacente conciliazione. In quel frattempo, essendo il Gallo ancor giovine, continuò i suoi studii scientifici e apprese il dritto civile dal Dr. Antonino Garajo, e i sacri canoni dall’insigne canonico Stefano Di Chiara e il dritto di natura e delle genti dal D.r Carmelo Controsceri, essendo ancora incerto, se dovesse addirsi al foro. S’iniziò anche nella lingua greca sotto la direzione del Sig.r Giovanni Leone, e nella tedesca del Sig.r Giuseppe Truckses Sassone; ma fece pochi progressi nell’una e nell’altra, non così nella francese e nell’inglese, che giunse a scriverle e a parlarle. Apprese pure l’istoria naturale dal Beneficiale Giovanni Cancilla, fratello del precedente accennato, e la botanica dal Sig.r Vincenzo Tineo, e volendo innoltrare nelle teorie dell’astronomia, i cui primi rudimenti avea appreso nella fisica, frequentò la specula astronomica di Palermo, di cui era direttore e precettor della scienza il Sig.r Nicolò Cacciatore, già allievo del Piazzi. Fu poi discente nell’agricoltura ed economia politica del celebre abate Paolo Balsamo che nel 1812 fu incaricato dal governo liberale di allora, a scrivere gli articoli fondamentali della nuova costituzione, modellata su quella inglese. _________________________________ 17 8 Agostino Gallo, Autobiografia… cit., p. 75-82. Non guari dopo fu egli lieto di acquistar l’amicizia e la familiarità del celeberrimo poeta Giovanni Meli palermitano, che nel suo dialetto fu riguardato da’ nazionali e dagli stranieri il novello Teocrito ed Anacreonte della Sicilia, e quindi meritò che le sue poesie fossero tradotte in greco, in latino, in italiano più volte, in francese, in inglese e in tedesco, e le sue leggiadre canzonette ornate di note armoniche da’ più insigni compositori di musica. Il Meli giovogli ad avviarlo viemmeglio nel buon gusto della bella e semplice poesia, e presagì che avrebbe proseguito con buon successo sulle sue tracce. Il Gallo per prender sollievo dagli studii, volle imparare anche il disegno e la pittura figurativa dall’egregio Giuseppe Patania e copiò alcuni quadri del suo maestro e un S. Girolamo di Pietro Novelli, detto il Raffaello di Sicilia18. Nel 1812 mentre era aperto il Parlamento in Palermo scrisse un foglio di opposizione al giornale ministeriale, titolato la Cronaca, denominando il suo Riflessioni sulla stessa che essendo spiaciuto al partito dominante ed ai ministri, i quali abusavano del potere, gli cagionò l’arresto di persona, non ostante che egli siasi gagliardamente difeso innanzi al tribunale; poicché fu incolpato di avere offeso Lord Bentick [!], ministro e generale per la Gran Brettagna in Sicilia, accagionandosi ciò al Gallo per la falsa interpretazione d’una allegoria, introdotta nel suo giornale. Nella prigionia, che durò sei mesi, egli tranquillamente occupavasi a leggere, a scrivere e a dipingere, ed era visitato da tutti i suoi amici, fra i quali il celebre poeta Meli, e il dotto abate Scinà, suo maestro, e il pittor Patania. Costui delineò in carta la stanza dell’arresto, se stesso che visitava il Gallo, lo stampatore Vincenzo Li Pomi, che pure era ivi in prigione, il carceriere, e un suo _________________________________ Pietro Novelli, pittore, architetto scenografo di età barocca, nato a Monreale nel 1603, morto a Palermo nel 1647. La biografia dell’artista è rubricata in quattro versioni: cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri soggiornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno 1838. Raccolte diligentemente da Agostino Gallo palermitano per formar parte della sua Storia delle Belle arti in Sicilia (Ms. XV.H.14.). Trascrizione e note di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, 2000, p. 64-66; Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 49-50 e Agostino Gallo, Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.18.). Trascrizione e note di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2003, p. 120-123; Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.19.). Trascrizione e note di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2005, p. 458-459, 466. 18 9 famulo, con tale evidenza ne’ volti che possono essere riconosciuti. Questo monumento dell’arte dell’arte del disegno esiste ancora presso il Gallo19. Lo Scinà, visitandolo, gli disse: “Mi congratulo con voi che per il vostro onorevole arresto avete acquistato una prematura reputazione; perocché la vita di un letterato senza simili incidenze, passata tranquillamente, diviene poco interessante, come quella d’un viaggiatore che trascorre un deserto”. Giovò bensì al Gallo, che era stato condannato a due anni d’esilio la protezione della Signora Giovannina Belvedere, principessa di Paternò, per la quale avea scritto prima un’ode in cui s’intrecciavano le sue lodi con quelle delle sue leggiadre figlie, a quelle del pittore Patania, che ne avea dipinto egregiamente i ritratti. La principessa gli procurò la grazia dal Governo. Uscito in libertà non volendo egli esercitare la professione forenze [!], e molto meno di assistere nel traffico il suo genitore; si determinò a consiglio dello Scinà di recarsi in Napoli per concorrere all’onorevole carica di referendario presso il supremo consiglio di cancelleria, addetto alla riforma delle leggi e a frenare gli arbitrii dei Ministri, dovendo ogni loro atto legislativo esser prima da quello discusso per indi ottener la real sanzione. Giunse egli in Napoli in luglio 1817; dopo un lungo viaggio di cinque giorni; ma il concorso era già eseguito. Recossi subito a visitare il suo amico astronomo Piazzi, che allora trovavasi ivi per innalzarvi la specula e dissegli che sarebbe subito ripartito, essendo stato deluso nella sua brama e il Piazzi gli suggerì di attendere ancora per pochi giorni dovendone implorare dal ministro Sig.r Marchese Donato Tommasi, presidente del supremo consiglio, il suo favore. Difatti glielo raccomandò caldamente con espressioni assai lusinghiere, e quegli rispose: “ma che posso io fare per il vostro raccomandato, se non giunse a tempo per esporre il concorso? Se egli come mi dite è poeta, scriva una satira contro Nettuno, che ne ha ritardato il viaggio”. Piazzi rispose allora: “se da lei sono stati proposti al re sedici referendari, ne faccia aggiungere altri quattro con una seconda risoluzione, e son sicuro che Gallo risulterà al concorso”. Il Ministro, sorridendo, replicò: “ebbene non posso negarmi a chi comanda il cielo e le stelle”. Dopo pochi giorni fu promulgato il secondo decreto per l’aggiunta di altri quattro referendarii da esporsi al concorso in dritto civile, penale, e pubblico, e in economia politica. Gallo prescelse il dritto pubblico nel quale si era più versato, e altronde era allora inalterabile. _________________________________ 19 Per ricomporre la vicenda, cfr. Agostino Gallo, Autobiografia… cit., p. 39-41. 10 Presentatosi al cimento con altri individui fra i quali il giovane giureconsulto Ferdinando Troja, che poscia ascese ai supremi gradi della magistratura, e infine fu presidente del consiglio dei ministri, ed entrambi, ed altri due risultarono nel concorso. I temi dati al Gallo dagli esaminatori rappresentavano le circostanze del regno di Napoli dopo l’invasione francese, ed erano i seguenti: 1. Se nel caso d’interna insurrezione ed invasione nemica il legittimo sovrano fosse costretto a lasciare il proprio regno, i suoi sudditi lo dovessero prima difendere ad oltranza, e se alcuni di essi per obblighi particolari fossero tenuti a seguirlo, e nel caso che rimanessero nel loro paese dovessero osteggiare il nuovo re e il suo governo intruso ovvero ubbidire tranquillamente; dovendosi bensì nello sviluppo della tesi combinare i principii del dritto di natura col dritto pubblico, e i doveri sociali. 2. Se la conquista dia dritto di legittimità al nuovo sovrano e per quali circostanze. 3. Se per dritto di postliminio debbansi o no riacquistare da’ cittadini i beni occupati o venduti dal conquistatore. Il Gallo sul primo quesito scrisse: che se il sovrano abbandonava il proprio regno, i cittadini che non aveano giuramento personale verso di lui, come l’hanno le truppe e gl’impiegati di corte, potevano rimanere nel regno conquistato, e non promuovere insurrezioni; perocché esse producono l’anarchia, che è il peggiore stato sociale, e attendere in pace finchè il monarca legittimo potesse riacquistare il proprio regno; essendo dovere di natura provvedere ciacuno alla sicurezza, e ai bisogni della sua famiglia, anzicché esporla ai pericoli di nuove rivolte, e alla fame. Sul secondo quesito provò che la conquista in se stessa, procedendo dalla forza, che non costituisce dritto alcuno, non da legalmente alcuna legittimità; ma se il conquistatore dopo un lungo corso d’anni governi la nazione invasa, con giustizia e benignità e ne promuova il bene, allora acquista dritto di legittimità col consenso de’ popoli, come già han conseguito non pochi re d’Europa, eredi di conquistatori. Sul terzo tema rispose: che dopo il ritorno del legittimo sovrano al proprio regno, i cittadini per dritto di postliminio sono abilitati a ricuperare i loro beni invasi e venduti dal conquistatore; e per quelli acquistati dagli esteri il monarca è obbligato a indennizzarne i sudditi stranieri. Il Gallo sviluppò queste tesi nel corso di ventiquattro ore. Gli esaminatori ne’ quali presideva l’abate Sarno, insigne professore di dritto pubblico, applaudirono agli scritti del Gallo e ne diressero favorevo- 11 le rapporto al Ministro Tommasi, il quale invogliato dal loro giudizio, richiamò a se que’ scritti per leggerli. Dopo alquanti giorni ordinò che si presentasse a lui il Gallo e ricevutolo bruscamente, rimproverollo dell’arditezza dei suoi principii politici, soggiungendo che sotto altro ministro anzicché ottenere la carica di referendario, sarebbe stato imprigionato. E quegli rispose: che i principii da lui seguiti erano quelli della scienza e se li avesse stravolto avrebbe mostrato o codardia o ignoranza. Altronde ben sapeva che il marchese Tommasi era stato l’amico di Gaetano Filingeri e quindi era sicuro di conoscer bene la scienza, come palesò nello scrivere l’elogio premesso all’opera della legislazione del medesimo. In ogni modo l’incolpazione non dovea addossarsi al Gallo; ma all’imprudenza degli esaminatori, che scelsero que’ temi particolari. “Avete ragione, replicò il Ministro, io ne farò forti rimproveri ai medesimi, intanto io vi fo le mie congratulazioni, avendovi ben meritato la carica, per la quale otterrete ben tosto il dovuto”; e così avvenne di fatti, e d’allora il Tommasi fu il suo special protettore. Nel supremo Consiglio di cancelleria facea plauso egli ai rapporti del Gallo sopra difficili argomenti che gli erano affidati, fra i quali quelli di doversi rivocare un Real Decreto, in cui un Ministro inaccortamente avea spogliato il Sovrano d’un suo dritto di regalia. Il Tommasi gli diè prova del suo favore in varii incontri, prima nel sentire che le poesie stampate dal Gallo nel 1816 erano state impedite dalla Polizia di Sicilia di pubblicarsi; talché avendole egli letto in un volume surrettizio, che gliene presentò, dié subito gli ordini per la pubblicazione. I suoi colleghi referendarii valevansi spesso del Gallo per implorarne i favori, ed egli volentieri si prestava. Egli scrisse in quel tempo una grave canzone sulla nuova legislazione civile e criminale, che sotto la presidenza del Tommasi erasi compilata, e ricevuto avea gli applausi universali per sapienza e spirito umanitario. Napoli, delizia degli uomini pel azzurro cielo, e per le amenissime campagne, era divenuta al Gallo carissima. Ammesso in tutte le società letterarie e poetiche, godea la stima dei dotti, e particolarmente di quelli che coltivavano le Muse, fra i quali levavano allora il grido Francesco Ruffa da Tropea, poeta tragico lirico e Gabriele Rossetti di Vasto in Abruzzi20, leggiadro e facile improvvisatore, ma scrittore allora di versi di _________________________________ Nota a piè di pagina: “(1) Rossetti profugo in Inghilterra per i suoi principii liberali collo studio di Dante migliorò il suo stile e divenne pregievolissimo poeta dei fasti dell’Italia.” 20 12 uno stile di gusto viziato del seicento. Egli illudeva bensì per le sue figure brillanti, recitando con enfasi i suoi carmi. Or avvenne, che il principe di Cassero di cui erano commensali il Gallo e il Rossetti, dovendo maritare una sua avvenente nipote, incaricò i sue poeti a scivere il componimento epitalamico. Comunicò il Gallo al suo amico Ruffa l’incarico avutone; e costui gli disse: “tu sai che il Rossetti ambizioso di superiorità ammazzerebbe chiunque de’ suoi emuli? Bada bene pel tuo componimento, e scegli il metro delle ottave rime, in cui il tuo avversario è più debole; giacché nelle canzoncine, comunque sparse di secentismi, ha pure felice invenzione, spirito, e grazia”. Il Gallo seguì il consiglio del suo amico, ed essendo educato nello stile classico, scrisse un poemetto di molte ottave rime, ove immaginò che il fato, agitando l’urna, destinava per isposa alla bella fanciulla, nata Siciliana, un magnate napolitano, affinchè coll’esempio gli animi fin’allora divisi delle due nazioni, potessero rannodarsi coi legami del matrimonio, e indi la musa Erato cantava le lodi degli sposi, e de’ lor genitori in piccolo metro lirico, onde anche potesse in questo emulare il Rossetti. Compiuto il componimento tre giorni prima delle nozze, il Gallo recollo al principe di Cassero, il quale lo consegnò al suo segretario ch’era un Calabrese, per farlo subito stampare; ma costui compatriota e amico del Rossetti, glielo dié segretamente a leggere, e quegli scorgendone forse la superiorità, lo prevenne di trovare un pretesto per non farlo pubblicare; difatti sino al giorno dinnanzi alle nozze non era stato recato al tipografo. Gallo, avvedutosi dell’intrigo, in un giorno lo fé dare in luce, e la stessa sera in cui si celebravano gli sponsali, fu distribuito alla nobile società degl’invitati. Giunse più tardi il componimento del Rossetti, non già stampato; ma in una copia manoscritta, ed era una canzonetta lirica di sei sole stanzine, che girando attorno, sparì; ma un amico del Gallo ebbe l’agio di trascriverla e il dimani la recò al medesimo, il quale la divulgò per Napoli insieme al suo poemetto epico-lirico. Il Rossetti se ne adirò fortemente, ed’allora divenne suo nemico. Profittò poco dopo d’una pubblica accademia, e conducendo seco i suoi scolari, fé applaudire strepitosamente il suo componimento, e trascorrer sotto silenzio quello del Gallo, il quale avvertì ben tosto esser quello un maneggio del suo avversario. In una prossima accademia, per la quale aveva promesso di scrivere pure un carme, presentatosi egli all’assemblea se ne scusò, dicendo: che aveva atteso invano da Palermo, sua patria dodici scolari per farsi applau- 13 dire, come era costume di qualcuno (e qui col gesto additava Rossetti) non volea azzardare il suo componimento. Ne risero tutti, che ben conoscevano l’artifizio del Rossetti, ed egli se ne adirò per modo, che terminata l’accademia, lo prese per il braccio e gli disse: “Gallo la vuoi finire con me? Ma noi dobbiamo essere amici. I tuoi componimenti sono bene immaginati e.di elegante stile; ma tu le reciti forse per modestia, sì freddamente da non fare effetto. In un’altra accademia manda a me i tuoi versi, e son sicuro che bene declamati da me saranno applauditi”. E ciò era pur vero! In un’altra accademia d’interessante argomento in cui, per ordine del Governo, doveano stamparsi dopo una rigida censura, i carmi recitati, quello del Rossetti fu respinto fino a nuova correzione per i secentismi, e l’altro del Gallo ammesso subito, e difatti fu stampato. Oltre questa rivalità poetica che estese la riputazione del Gallo in Napoli, patria della poesia e della musica, un altro incontro, che riuscir poteagli funesto, ebbe il Gallo in quella nobilissima città. Frequentava egli la compagnia del maresciallo conte Anguissola ove erano ammessi molti suoi concittadini e qualche Siciliano fra i quali un certo21 Salvatore Ruggieri che per lungo soggiorno e per altri rapporti si era dimenticato della patria. L’Anguissola promosse imprudentemente un discorso col quale tacciava i Siciliani d’inumanità per aver espulso i Napoletani dalla Sicilia nel 1813 quando fervevano le idee liberali per la nuova costituzione e il sedente parlamento. Al Gallo sembrò suo special dovere di difendere i suoi connazionali, e rappresentando i fatti come erano accaduti disse: che la torma de’ napoletani che avean seguito il re Ferdinando e la corte in Sicilia, essendo stati scoverti di congiurare contro di essa per suggerimento della regina Carolina e di aver preparato delle armi, furono per ordine del parlamento mandati via dall’Isola; però per impulso umanitario determinò di somministrar loro 20.000 onze per sussidio nella terra straniera ove si sarebbero ricoverati, e quindi il Parlamento mostrassi generoso verso i suoi nemici beneficandoli. Sorse allora il mentovato Ruggieri e disse al conte Anguissola: “non date ascolto a costui che è un fanatico per la sua patria”, e il Gallo replicò: “Ruggieri ha sempre ragionato col fondo de’ suoi calzoni (recava egli allora calzoni alla mussulmana con molte pieghe che lo rendevano ridicolo coll’immenso involucro deretano). La compagnia smascellossi dalle risa che in quelle parole lo vide dipinto, e conosceva altronde la sua goffaggine; _________________________________ 21 Segue cancellata la parola: “Ferdinando”. 14 però il Gallo ebbe da lui intimato un duello che il conte seppe e malignamente non volle impedire conoscendo che Ruggieri era sperimentato ed audace duellista. Recaronsi gli avversari in solitario luogo ov’era il diroccato palazzo della regina Giovanna. Ciò avvenne nel maggio 1818. I patrini scorgendo che i duellanti eran trafelati di sudore, al primo assalto ordinarono di abbassar le armi per prender riposo, il Gallo declinò la spada, e in quel punto il Ruggieri gli vibbrò un colpo che a stento l’altro poté riparare; ma pure ne fu ferito lievemente al petto. Allora il suo patrino reclamò contro l’altro per l’iniquo abuso del Ruggieri, e volea intimare all’uno e all’altro un duello; ma scusandosi amendue di non essersi avvertito l’ordine, l’affare terminò colla pacificazione procuratta dallo stesso Ruggieri, e il Gallo dopo alquanti giorni fortunatamente si guarì dalla ferita. Erasi già trascorsi tre anni che il Gallo serviva qual referendario nel Supremo Consiglio di cancelleria con piena soddisfazione del Ministro Tommasi e dei comsiglieri, quando il Ministro gli disse che avrebbe voluto per benemerenza promuovere a’ giudice del tribunale Civile in Messina. Il Gallo rispose che sebbene avesse studiato il dritto non era laureato ne avea l’esercizio del foro, e quindi in buona coscienza non era sicuro di decidere sulle sostanze e la vita de’ cittadini. Il marchese Tommasi replicò: potreste laurearvi adesso, ed entrato nella Magistratura in breve tempo diverrete colla prattica un buon giudice, ed entrerete in una carriera onorevole e progressivamente lucrosa sino alla Corte Suprema. Tuttavia ricusando il Gallo e mostrandogli di essere invece promosso ad Ufficiale di carico del Ministero di Sicilia, il buon Tommasi volle contentarlo dicendogli: “ve ne pentirete”, perocché i ministri sono tanti pozzi ove se si getti una pietra non vi si pensa più; ma l’altro replicò: che la protezione del Ministro già sperimentata gli sarebbe stata ulteriormente utile. I ministri nei piani de’ ministeri non hanno arbitrio, e sono obbligati a promuovere gradatamente i più antichi. Il decreto del re lo scelse difatti Ufficiale di carico onorario nel ramo d’istruzione pubblica, di belle arti, di salute e beneficenza pubblica, ed egli nel congedarsi dal Ministro ottenne un sopra soldo di dieci ducati in aggiunta a’ cinquanta di soldo ordinario mensile, ed un onorevole rescritto col quale era ammesso a tutte le feste di Corte della luogotenenza di Sicilia. Il Gallo lo ringraziò; ma dissegli che del secondo favore non avrebbe profittato, non amando di sciupar tempo in tali feste. Recatosi in Palermo verso la fine di ottobre 1819 ebbe la fortuna di cominciar a prestar servizio nel suo ufficio sotto il Direttore Sig.r 15 Antonino Della Rovere, uomo, oltre alla dottrina riuniva l’affabilità e la protezione verso i letterati, talché il Gallo attirossi anche il suo favore e la sua confidenza, e molti utili progetti gli presentò che furon da lui bene accolti; ma poco il Della Rovere rimase in quella carica essendo stato promosso in altra eminente finanziaria. I ministri o direttori che gli successero, essendo meno istruiti e abili di lui, si lasciarono spesso vincere dagl’intrighi di altri ufficiali ignoranti e maligni, talché il Gallo rimase stazzionario per circa quarantadue anni essendogli preferiti altri meno antichi e taluni ammessi senza concorso. Dopo la rivoluzione del 1848 inviato dal re il generale principe di Satriano coll’alter ego in Sicilia, dopo di avere incendiato Messina e Catania e organizzata una ferocissima e micidiale polizia volendo far sembiante di promuover le lettere quasi ricordandosi di esser figlio del gran Gaetano Filingeri, famoso autore della scienza della legislazione, chiamò a sé il Gallo incaricandolo di scrivere in due giorni un piano di riforme delle scuole elementari e delle Università di Palermo Catania e Messina. Il Gallo che acquistato avea una lunga pratica nel suo carico per tale facenda, gli presentò il suo lavoro che fu poi alterato e guasto dall’intrigante Antonino Scibona e dal Direttore Sig.r Celesti; talché la riforma riuscì peggiore per il progresso de’ buoni studii, e il Gallo neppure poté ottenere la promozione di giustizia che gli fu rapita da Scibona, meno antico troppo servile al principe Satriano. In quel tempo uno strano avvenimento accadde in Palermo. Il Gallo giovandosi dell’amicizia de’ due pretori successivi Ignazio Lanza conte di Sommatino e Pietro Lanza principe di Scordia e Butera aveva, per loro mezzo, alquanti anni prima, indotto il Decurionato a destinare la somma di onze 500 pel magnifico sepolcro al gran poeta Giovanni Meli proclamato, per le sue svariate poesie siciliane, il nuovo Teocrito ed Anacreonte della Sicilia già tradotte in tutte le lingue antiche e moderne. Il sepolcro era stato scolpito dal celebre Sig.r Valerio Villareale allievo del Canova ed istoriato colla rappresentazione delle muse e decorato coll’effigie di Meli. Il principe di Satriano ordinò una pubblica festa cittadina pel trasferimento delle spoglie mortali del Meli nel grandioso tempio di S. Domenico destinato sin d’allora dal Gallo per Panteon degli uomini illustri Siciliani, ed a sue spese indi accresciuto di altri sette monumenti funebri22. _________________________________ A c. 44v in calce nota: “(1) Quello del poeta e sacro oratore Monti e del dotto Domenico Scinà suoi maestri, di Giuseppe ed Emmanuele Marvuglia padre e figlio insigni architetti suoi parenti, di Pietro Novelli insigne pittore ed architetto, di Nina Siciliana prima poetessa nel volgare italo-siculo, di Giuseppe Piazzi suo amico, sommo astronomo e scopritore della Cerere.” 22 16 Or ricercatosi nella sepoltura de’ PP. Francescani lo scheletro del Meli ove era stato deposto alla morte di lui ed era oggetto di curiosità di tutti i forestieri per la sua perfetta conservazione, non vi fu trovato, talché il Gallo dovette per due anni sostenere un’acerba lite co’ frati che l’aveano occultato; ma il capitano Maniscalco allora direttore di Polizia per denunzia avutane da uno de’ frati imprigionati, lo scuoprì chiuso in un antico sepolcro, e così poté essere eseguito il solenne trasferimento e celebrato con magnifica pompa diretta da un programma del Gallo. Rimaneva intanto il Gallo defraudato del grado di avanzamento a Capo di divisione nel Ministero, e indispettito, recossi in Napoli nel 1858 e per la protezione e benevolenza del suo antico collega referendario, commendatore Ferdinando Troja, già inalzato al posto di presidente del Consiglio de’ ministri, poté alfine ottenere la promozione desiderata, non ostante che gli fosse stato avverso il cav.re Giovanni Cassisi Ministro di Sicilia in Napoli per proteggeva il suo favorito cav.re Mortillaro di minore antichità e ammesso senza concorso. Gallo chiese allora al Re e poté ottenere il grado che gli spettava col soldo mensuale di ducati 120, e stanco dei torti ricevuti, implorò di prestar servizio nella carica di Segretario archeologo con voto presso la commissione di antichità e belle arti ove si rese utile, come prima nel Ministero, per diverse proposte relative a quest’altro officio. Succeduto al Governo borbonico quello d’Italia del Re Vittorio Emmanuele, il Gallo, già inoltrato negli anni, domandò il suo ritiro e l’ottenne con l’intero soldo che gode anche al presente, sebbene onerato di pesi. Libero da’ doveri d’ufficio egi consacra gli ultimi anni della sua vita a dare compimento all’istoria delle belle arti in Sicilia e a quella della lingua siculo-italica e della rima, cui seguiranno i componimenti editi ed inediti ridotti a plausibile lezione, dei primi poeti nel volgare siculo-italico. Prima di quel tempo, avvenuto il fatale cholera del 1837, il Gallo promosse un’accademia funebre pel suo dilettissimo precettore Domenico Scinà. I migliori poeti di Palermo recitarono i loro componimenti, ma persuasi che quel morbo che desolò la Sicilia fosse stato promosso dal re Ferdinando 2° e da’ suoi perfidi ministri, coll’abolire lo sfratto di legni provenienti da Napoli, ove infieriva il morbo micidiale, slanciaronsi ne’ loro versi contro il re e i suoi consiglieri ed uno de’ poeti nell’impeto delle muse ardì profferire, quasi prevedendo il contrito assassinio posteriore di Agesialo Milana, che attendeva che un pugnale squarciar dovesse il petto a chi era stato cagione di tanta mortalità di cittadini. 17 Il commendatore Rega napolitano, allor direttore di Polizia, era presente, e mordendosi per via le labbra, insanguinò il suo bianco fazzoletto. Gallo avea trattato l’argomento con maggior prudenza, intrecciando le lodi dello Scinà colla descrizione del cholera onde quegli era stato la vittima, e così pochi altri. Il Rega scrisse subito al Governo di Napoli l’occorso ma il suo Luogotente [!] in Sicilia duca di Laurenziano che non era intervenuto alla accademia, avendo avuto notizia di quelli audaci componimenti, l’indomani ne chiese informazioni al Gallo. Costui per salvare i suoi amici rispose freddamente: che egli avea udito soltanto versi descrittivi del cholera, e nulla contro il Governo, e soggiunse: che se ne avesse voluto una prova, avrebbe potuto il giorno seguente presentargli tutti i componimenti. ebbene li attendo - Corse il Gallo poco dopo a prevenire i suoi amici che riformassero i versi che ferivano il governo, e glieli mandassaro a casa, così fecero tutti, meno colui che avea lanciata l’indicata imprecazione, lasciandola come l’avea recitata ne’ suo’ versi. Il Gallo mentre ne ammirava il coraggio, anzi la tracotanza, prevedeva che sarebbe stato subito messo agli arresti e punito severamente, quindi per salvarlo si fe lecito di sostituire altri versi a quelli dell’autore, e così rabberciati tutti i componimenti furono l’indomani presentati al luogotenente Laurenzano. Costui non avvertì l’onesto stratagemma e avverso com’era al Direttore di Polizia, perocché sospettava a ragione di essere stato inviato anche per ispionarlo, scrisse un rapporto contro Rega e in difesa de’ poeti incolpati. L’affare non ebbe funeste conseguenze essendo stati inviati i versi già corretti al Governo di Napoli. Per altri importanti oggetti era stato il Gallo anche utile in Ministero, al Governo, e a’ suoi connazionali. Egli per l’istruzione pubblica e per le belle arti presentò al luogotenente i Regolamenti della nuova Università di Messina, della Biblioteca Comunale di Palermo, quelli dell’Esposizione delle Belle Arti da lui promossa e dell’Istituto d’Incoraggiamento per l’Agricoltura e Pastorizia. Fu il primo a suggerire d’introdursi in Sicilia la coltivazione delle patate che tornò a sua grande utilità. Molti altri suoi progetti rimasero ineseguiti col cambiamento de’ due Direttori, il sig.r Della Rovere e il duca di S. Martino, e quest’ultimo indi promosso in Napoli alla Consulta del Governo, dolendosi di quel segretario vincitore disse: che a quell’ufficio sarebbe stato veramente più adatto il Gallo; non per tanto questi rimase in Sicilia nel Ministero, trascurato, 18 anzi conculcato dai successivi direttori per intrighi de’ suo’ colleghi. Il Governo bensì reputandolo miglior letterato che abile Ufficiale del Ministero, lo scelse deputato della pubblica Biblioteca Comunale, e lo confermò per circa dieci anni. Egli acquistò alla medesima 18mila volumi, la fornì di 45 giornali scientifici, letterari, artistici, della serie di edizioni antiche, e principalmente delle Aldine, e di quella magnifica della tipografia di Bodone di Parma, e di moltissimi manoscritti fra i quali quello singolare in gran folio di tutte le antiche leggi di Sicilia fino al secolo XVI che contiene anche le famose Constituzioni dell’Imperadore Federico lo Svevo. Quell’immenso volume fu ammirato dal celebre cardinal Maj, il quale profferì che la Biblioteca Vaticana non possedeva un codice più magnifico e interessante. Esso fu illustrato egregiamente dal dotto giureconsulto sig.r Diego Orlando autore di molte pregiate opere. La Biblioteca mancava di una scala decorosa, ed egli ve la fe costruire di marmi rossi, e bene adornata di stucchi lucidi, innalzato il busto marmoreo del fondatore Alessandro Vanni principe di S. Vincenzo, fin’allora negletto, a cui appose l’iscrizione tratta da Orazio: Crescit laude recens Il Gallo fu scelto anche dal Governo esamimatore di concorsi d’impiegati, e propose un nuovo metodo di giudicar gli scritti: cioè, segnando per punti e mezzi punti gli errori gravi e lievi, sui quali puossi agevolmente convenire dagli esaminatori, e per punti e mezzi punti il merito degli scritti, talché sottraendo i primi poteasi ottenere più sicuro giudizio, ed esatto risultamento. Dallo stesso Governo fu ammesso tra i primi socii fondatori del R. Istituto d’Incoraggiamento, di Agricoltura e Pastorizia, che dal Prefetto Torelli nel 1863 fu vandalicamente abolito per recare un risparmio di onze 800 al Ministro Italiano delle Finanze, che il governo Borbonico gli avea assegnato. Furono vani gli sforzi del Gallo per lasciarlo sussistere e vi si sarebbe forse riuscito col Ministro Manna, suo amico, se costui continuava in carica. Il Gallo nel 1823 era stato anche incaricato dal Governo di scrivere i Nuovi Regolamenti dell’Accademia di Palermo. Ed egli, immutandone l’antico titolo di Accademia del Buon Gusto, che indicava di occuparsi quasi esclusivamente di belle lettere, di poesie, e di archeologia, vi sostituì quello più complessivo dello scibile, dividendola in quattro classi; cioè in quella di Letteratura, e di Storia, nell’altra di Scienze esatte, nella terza di Scienze naturali, e nella quarta di Archeologia e Belle Arti; ciascuna aveva un Direttore, e un segretario, e l’intera Accademia un Presidente, un 19 vice presidente e un segretario generale. Il Gallo fu più volte scelto Direttore o Segretario di classe, e destinato ad apprestarne, come fece, i temi. Fu il primo a cooperarsi ad introdurre in Sicilia le Scuole comunali col nuovo metodo di Bell e Lanchaster [!], già iniziato in Napoli sin dal 1819, dall’abate Antonio Scoppa siciliano, reduce da Francia, suo amico. Sul proposito avvenne un fatto singolare. Stabilitasi in Palermo una scuola in ognuno de’ quattro quartieri interni, il Gallo pregò il Pretore della città Ignazio Lanza conte di Sommatino di proporre in Decurionato un’altra scuola dello stesso metodo per il popoloso quartiere esterno del Borgo Santa Lucia a spese del Comune come le altre. Fattosene rapporto al Governo di Napoli, d’ordine del Luogotenente di Sicilia, dallo stesso Gallo, per autorizzarsene la spesa, fu risoluto negativamente, e siccome quel metodo fu denunciato al re, come sospetto di educare i fanciulli a’ principii liberali, fu da lui ordinato di abolirsi in Palermo le quattro scuole di quel metodo già stabilito; proponendosi bensì un altro mezzo che rendesse i sudditi attaccati al sovrano e alla religione. Ne sentì grave rammarico il Gallo, e profittando delle espressioni di doversi sostituire un altro metodo d’istruzione primaria, fece ordinare dal Direttore del Ministero alla Commissione d’istruzione publlica; che prima di abolirsi le scuole lancastriane si occupasse a compilare il nuovo metodo sui migliori de’ più colti regni d’Europa. E siccome ciò richiedeva lungo tempo e gran fatica, era ben sicuro che l’ordine di abolizione delle scuole lancastriane sarebbe stato dimenticato o revocato, e così avvenne. Anzi accadde: che cambiato il Ministro d’Istruzione pubblica in Napoli, il Gallo ne profittò e fece reiterare dal Luogotenente di Sicilia la proposta precedente, e aggiungersi altre scuole ne’ quartieri esterni, e queste furono approvate dal re. Quelle scuole davano in ogni anno, con poca spesa comunale, circa 700 fanciulli istruiti nei primi elementi di leggere o scrivere, ed abaco; ma un tristo destino minacciava ulteriormente quelle utilissime scuole per sostituirvi le attuali con metodo involucrato, più dispendioso e di minore risultamento come erano introdotti in Piemonte. Il governo italiano mandò espressamente in Sicilia il commendatore Fava a tale oggetto, e sebbene costui fosse un ragguardevole letterato, e il Gallo gli mostrasse la maggiore utilità del metodo lancastriano; pure fu obbligato ad ubbidire agli ordini del Ministro dell’Istruzione pubblica. Il Gallo avea osservato che dopo la morte del celebre canonico Antonino Mongitore avvenuta in Palermo sua patria nel 1743, autore della 20 celebre opera Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis23, si trascurava di scrivere ne’ giornali le biografie de’ valent’uomini che morivano ed egli ripristinò l’uso in Palermo che si diffuse per tutta la Sicilia, dando egli l’esempio ne’ giornali periodici del suo tempo, talché molte ne diè in luce come dal seguente elenco potrà rilevarsi. Gallo non si è mostrato mai avido di onori sociali ed accademici, è stato sempre avverso a quelli cortigianeschi. In effetto non ha fatto mai uso dell’ordine sovrano per l’ammissione alle feste di corte, che spontaneamente per sua benignità gli offrì il Ministro Tommasi. Tuttavia in varie occasioni senza sua richiesta e maneggio n’è stato partecipe. Il cavaliere Ghio napolitano suo amico segretario particolare del re Francesco 1° volea una doppia copia delle opere del Gallo, una per sé, e l’altra per presentarla al sovrano con una supplica per accordargli l’ordine cavalleresco da lui istituito. Negossi il Gallo, dicendo: che mai avea fatto simili domande, ma è indispensabile pel regolamento di farla; e quindi il Gallo giovossi di quel pretesto per non ottenere quella onorificenza, e fu bene per lui, perocché nella successiva rivoluzione que’ cavalieri furono tutti riguardati come spie. Lo stesso gli accadde trovandosi in Napoli nel 1858 e il Presidente del Consiglio de’ Ministri, commendatore Ferdinando Troja voleva decorarlo dello stesso ordine, ed aveva prevenuto il suo segretario cavalier Salvatore Aguglia di ricordaglielo all’imminente nomina, per varii altri letterati. L’Aguglia confidò al Gallo l’intenzione del Ministro; ma ne fu pregato di dissuaderlo a motivo del suo carattere che non ambiva tali onori, e così liberossene la seconda volta, e egli fu utile nell’altra rivoluzione del 1860. Non poté bensì evitare simili onori del Governo Italiano che accordandogli il ritiro di tutte le cariche gl’inviò spontaneamente il diploma di cavaliere ufficiale dell’Ordine di S. Maurizio e Lazzaro, del quale non ha fatto mai uso nelle lettere e nelle stampe delle opere sue, né mai ha recato sul petto l’insegna decorativa; perocché riguarda quella onorificenza, ed altre simili, come ridicole vanità. Non così quelle accademiche; perocché ne ha molte ottenute senza intrighi, e particolarmente le straniere, essendo esse testimonianze di stima e di gradimento delle opere sue. _________________________________ 23 Il canonico palermitano Antonino Mongitore distribuisce in due tomi il prezioso repertorio bibliografico edito in Palermo in due tempi, 1707 e 1714. Il Gallo ricopia i profili di alcuni artisti: cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 406-500. 21 Laonde ha con piacere accolto l’ammissione all’Ateneo di Firenze, alle tre Accademie di Roma, cioè alla poetica detta Arcadia, e alle due di Belle Arti ed Archeologia di S. Luca e del Panteon, e così pure alle tre di Letteratura e storia di Napoli, la Sebezia, la Pontaneana, e quella Reale di Scienze e Archeologia già detta Borbonica, e all’altra delle Belle Arti di Milano, di Antichità di Coppenaken [!], e della Storia Patria di Toscana e dell’Emilia, oltre le molte di Sicilia. Una conoscenza onorifica e singolare fece egli in Palermo allorché nel 1845 l’imperatore di Russia Nicolò 1° soggiornò in Palermo sul pretesto di potersi ristorare in salute la sua augusta consorte, ma certo con qualche scopo politico, di che ben s’accorse lo stesso re Ferdinando 2°. In quella occasione essendosi a lui presentata una strenna di prose e di versi splendidamente stampata coi ritratti dell’imperadore, dell’imperadrice, e di Olga loro bellissima figlia, il Gallo vi aggiunse una prosa sugli amori giovanili di Vincenzo Bellini, ed una sua inedita canzoncina messa in una musica a dodici anni. Un giorno il Ministro russo Nesselrod24 accompagnato dal suo maestro di lingua italiana, venne a trovare in casa il Gallo, di cui avea letto qualche opera di archelogia e belle arti, affinché lo scortasse per la città ad osservarne gli artistici monumenti, le chiese, i quadri, e le statue di maggior pregio. In effetto per più giorni si recarono in giro insieme, e l’illustre Ministro ottenne le notizie e dilucidazioni istoriche e archeologiche che ne bramava, e d’allora volle egli che ne frequentasse la casa di sua dimora nella vicina campagna dell’Olivuzza, e molte interrogazioni gli fece sulle cose di Sicilia. Un simile incontro onorifico inaspettato ebbe egli nel 1861 essendo stato invitato a pranzo dall’illustre Prefetto marchese Pallavicini insieme con Sua Altezza Imperiale il principe Napoleone, ed altri illustri personagi. Il Gallo non conosceva il Pallavicini, ma costui ne avea letto le opere, e siccome sapea che il principe Napoleone era amatore de’ monumenti antichi e delle belle arti, e a tale oggetto recava seco due archeologi, volle aggiungervi il Gallo che allora funzionava da segretario di quel ramo, e presentollo al principe. Costui, parlando bene la lingua italiana; perocché aveva soggiornato a Firenze, gli indirizzò varie domande sulle antichità di Sicilia, alle quali prontamente sodisfece. Dopo quella benigna accoglienza il Gallo gli fe giunfere alcune sue opere, e ne ottenne una lettera di ringraziamento per mezzo del segretario _________________________________ 24 Leggasi: “Nessel’rode”. 22 del Prefetto marchese Pallavicini, accennando che le avrebbe letto al primo momento di suo aggio. Affettuoso e riverente il Gallo alla memoria de’ suo’ illustri amici e precettori defunti, tenne in sua casa due accademie poetiche, una per Vincenzo Bellini famoso compositore di musica, di cui avea fatto dipingere il ritratto dall’insigne cav.re Giuseppe Patania, e dopo di essersene celebrate in casa le lodi, offrì in premio, a giudizio di un comitato di letterati, la copia di quel ritratto adorno di cornice dorata all’egregio poeta Nicolò Cirino che superò gli altri col suo componimento. Nel giorno natalizio del Gran Poeta Giovanni Meli, volle il Gallo, suo intimo amico, festeggiarne la memoria in sua casa con poesie e musica sulle sue stesse canzonette, e farne coronar di rose il busto, dall’ornatissima sig.a Principessa di Galati, e dall’egregia sig.a Concettina Ramondetta, e ne distribuì agli altri poeti il ritratto bene inciso dal Waincher sull’originale del Patania. Un altro progetto vagheggiava egli sin dalla sua giovinezza, di onorare i principali uomini illustri antichi e moderni della Sicilia, con farne dipingere da Patania le loro rispettive immagini ricavate dal vero o sopra autentiche originali, e dei viventi già divenuti famosi per le loro opere. Questo divisamento ha già eseguito, e in moltissimi anni quella collezione è giunta a 124 ritratti che insieme co’ quadri pregievolissimi, e disegni originali di valent’uomini, ed altri oggetti di antichità, rendono la sua casa un museo che spesso è visitato da’ nazionali e dagli stranieri, e che alla sua morte ha destinato al pubblico25. A render poi un più solenne pubblico omaggio a’ suo’ famosi concittadini defunti, ha promosso un Panteon di monumenti funebri nella magnifica chiesa di S. Domenico in Palermo, come si è accennato, ove si ammirano trentaquattro sepolcri con le loro effigie e inscrizioni latine e italiane e in gran parte composte dal Gallo. Sei di questi monumenti furono, come si è detto, a sue spese inalzati oltre dell’ultimo dei quali all’insigne astronomo Giuseppe Piazzi suo amico e protettore, prvandosi egli in vita del busto marmoreo eseguito dal Villareale. Similmente ha donato al pubblico giardino, detto Villa Giulia, il busto marmoreo del poeta Meli, ove in breve sarà onorevolmente inalzato. Essendo il Gallo persuaso che è meglio eseguire in vita che riserbarsi alla morte, per opera degli eredi ciò che può essere utile e decoroso alla patria. Varie controversie letterarie ha dovuto egli sostenere con valent’uomini Siciliani e stranieri, e prima col sig.r A. Bonucci Bolognese, il quale ritraendo _________________________________ 25 Cfr. Agostino Gallo, Autobiografia… cit., p. 78-83. 23 da un antico codice una sacra poesia attribuita dall’antico amanuensi e dallo stesso Bonucci a Dante, il Gallo provò di non appartenergli, e quella sua opinione fu confermata da tre celebri letterati e filologi, Salvatore Betti, Vincenzo Nannucci e Luigi Muzzi. Un’altra controversia ebbe con l’erudito pittore Giuseppe Meli26 pel quadro della Beata Vergine col Bambino, S. Giovanni, e un angelo posseduto dai PP. Filippini di Palermo che il Gallo provò di essere del pennello di Raffaello Sanzio27, e il Meli sosteneva di Lorenzo del Credi28. Sei attestati di artisti e conoscitori stranieri, e di Valerio Villareale, insigne scultore ed esperto in tali giudizii, confermarono l’opinione del Gallo. Un’altra n’ebbe col P. Melchior Galeotti sulla patria del famoso Antonio Gagini scultore del secolo XVI che il Gallo colle iscrizioni apposte dallo stesso Gagini alle sue statue, ed altri documenti, provò di essere nativo di Palermo, mentre il Galeotti sosteneva che fosse nato in Messina29. I Giornali italiani diedero ragione al Gallo. Ma egli aveava [!] già rivendicato a Mesina sua patria il tanto celebre astronomo naturalista e medico Giannalfonso Borrelli del secolo XVII creduto da tutti napolitano; ciò che Gallo provò con documento tratto da un’opera dello stesso Borrelli, e dall’autorità del suo scolaro Alessandro Marchetti. Di più ne fece copiare il ritratto, esistente nella Galleria di Firenze e che fa parte dell’accennata sua collezione, inviandone in pari tempo una seconda copia all’Accademia di Messina, che la gradì immensamente. Ad un’altra più ragguardevole controversia è preparato pel recentissimo suo saggio critico degli scrittori moderni d’istoria di Sicilia30; nel _________________________________ 26 Giuseppe Meli, pittore, litografo, archeologo, teorico, critico e storico dell’arte, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1893. Il 2 dicembre 1831 Giuseppe Patania lo dichiara «idoneo a poter copiare i quadri dipinti» e depositati presso il Real Museo di Palermo. A.S.PA., Permessi di studio… cit., Misc. Archivistica, II, n. 316. 27 Quadro della Vergine creduto di Raffaello, ma di Lorenzo di Credi, oggi nei depositi di Palazzo Abatellis. Cfr. Ciro D’Arpa, Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani all’Olivella, Palermo, Caracol, 2012, p. 81. 28 Lorenzo di Credi, pittore, nato a Firenze fra il 1456 e il 1460, ivi morto nel 1536. 29 Cfr. Agostino Gallo, Elogio storico di Antonio Gagini scultore palermitano, Palermo, dalla Reale Stamperia, 1821. La polemica con gli storiografi precedenti da Tommaso Fazello ai messinesi Placido Samperi e Caio Domenico Gallo ecc. è ben evidenziata dall’A. nelle note di p. 5-6 e sgg.; e Melchiorre Galeotti, Preliminari alla storia di Antonio Gagini, scultore siciliano del secolo 16. e della sua scuola, Palermo, Tip. M. Amenta, 1860. 30 L’opera è stata pubblicata due volte nel 1824, la prima in Giornale di scienze lettere e arti di Palermo, v. VI, a. II (1824), p. I-XX (continuazione del prospetto tra le p. 128 e 129) con il titolo “Belle Arti. Pittura. Art. I°”, la seconda con i tipi del Dato. Successivamente, corretta e ampliata, col titolo “Saggio sui pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842” fu pubblicata nel 1842, in: Memorie su la Sicilia tratte dalle piu celebri accademie e da distinti libri di societa letterarie e di valent’uomini nazionali e stranieri con aggiunte e note per Guglielmo Capozzo, Palermo, Tip. di Bernardo Virzì, 1840-1842, v. 3, p. 123-147. 24 quale ha smascherato l’impostura dell’abate Gioacchino Di Marzo, pseudo autore della versione dal latino del Lexicum topographicum di Vito D’Amico, e dell’opera sulle belle arti in Sicilia31; talché il Gallo a sessantasette anni combatte ancora per le lettere e le belle arti patrie. Egli, come rilevasi dal seguente elenco delle sue opere, ha fondato varii giornali scientifici letterarii, ed ha avuto parte in quasi tutti quelli pubblicati in Palermo, e in alcuni di Roma e di Firenze. Sul suo carattere Quanto alla sua indole e al suo carattere morale è stato osservato, ch’essendo egli di temperamento bilioso sanguigno, disposto alla poesia e nato in un clima caldo, ne risente gli effetti naturali. Laonde è irritabile (genus irritabile vatum) collerico e impetuoso; ma facile a dimetter l’ira e beneficare anche i suoi nemici, e per queste ed altre sue buone qualità gode la stima de’ suoi concittadini ed amici. È tacciato inoltre di troppa bonarietà, e di prestar facilmente fede a chi voglia ingannarlo, non potendo egli supporre, giudicando di se, che vi siano fraudolenti al mondo, talché è sovente colto alla rete. Dal padre acquistò l’abitudine ad essere compassionevole cogl’infelici e indigenti, e a rendere buoni ufficii a chiunque ne lo chiedesse, talché è stato utile a’ molti nel Ministero cui apparteneva. Egli si è mostrato sempre amico e protettore degli artisti, procurando ad essi lavori per mezzo de’ suoi rapporti sociali ed occupandone i migliori per quelle di suo uso e permettendo di copiare in sua casa i quadri d’insigni antichi e moderni pittori. Perocché è persuaso, che questa classe, educata com’è, al soave sentimento del bello, sia la migliore in società. Il Gallo non ha mai corteggiato e adulato Re, ministri, e nobili, né ha dedicato ad alcuno di essi le sue opere, ma a qualcuno de’ suoi amici defunti e all’accademie che l’hanno onorato ad ammetterlo alla loro società. _________________________________ Cfr. Vito Maria Amico, Lexicon topographicum siculum in quo Siciliae urbes, opida, cum vetusta tum extantia montes, flumina, portus adiacentes insula ac singula loca describuntur, illustrantur... Tomus primus[-tertius], Panormi, excudebat Petrus Bentivenga sub signo SS. Apostolorum apud Plateam Villenam [poi] Catanae, in Aetneorum Academiae typographio apud D. Joachin Pulejum, 1757-1760, 3 v. in 6 t., versione italiana: Dizionario topografico della Sicilia di Vito Maria Amico, successivamente tradotto e annotato dal latino da Gioacchino Di Marzo, Palermo, tip. Di Pietro Morvillo, 1855-56, 2 v. La polemica è riportata nell’opera di Agostino Gallo, Sugli scrittori moderni di storie di Sicilia. Saggio critico. Opera iniziata nel 1865 e terminata in febbraro 1867, Palermo, Tipografia Barcellona, 1867., p. LXV, n. 3. Cfr. Gioacchino Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia, Palermo, S. Di Marzo, F. Lao [poi] S. Di Marzo, Clamis e Roberti, 1858-1870. 4 v. 31 25 Egli viene accusato d’inconsideratezza e d’imprudenza, e ciò è vero, essendo irriflessivo e poco accorto. Tuttociò che opera e scrive sempre di furia, e mancando di tenace memoria, è facile a commettere degli sbagli principalmente di nomi; tuttavia detta colla maggiore facilità e sempre su svariati argomenti le opere sue, né si contenta di una prima bozza ma spesso la rifà 2 e 3 volte e dopo che i suoi lavori sono stampati vi scrive marginalmente aggiunte e correzioni per una seconda edizione. Nei suoi principii religiosi e politici, è stato sempre fermo e invariabile. Nato cattolico non si è lasciato mai sedurre a cambiar culto. Odiando il dispotismo ha raffermato collo studio i principii liberali, ma ha sempre abborrito le congiure e le rivoluzioni, che hanno sconvolto la sua patria. Ciò ha prodotto di essere stato escluso da tutti i partiti politici, e non ostante è stato da essi rispettato; ma da nessuno favorito, e quindi in questi ultimi tempi in cui hanno infuriato, non ha avuto alcuna ingerenza nelle cose civili e letterarie. Ecco il ritratto fedele delle sue qualità fisiche e morali. Estratto da un articolo biografico corretto ed ampliato dal cav.re Raimondo Granata da Messina, egregio letterato nella sua Memoria storico-politica, Duecentosessanta giorni in Palermo nel 1861 (1)32. Ivi si legge a pagina 44 “Il Sig.r Gallo negli studii andò innante da darne saggio ancora giovanissimo: ma più che altro poi, la intrinsichezza in che venuto, la quale spesso in taluni puote a bene, con il Meli, Scinà, Monti, Gargallo, Piazzi, Patania, Velasques33, Riolo34, Villareale, e moltissimi altri insigni scienziati ed artisti, gli fu sprone alle lettere e belle arti con ardenza di affetto. Per cui egli ora è poeta, ora pittore: e tra le poesie e le traduzioni, la di lui quadreria si freegia di disegni, e di copie di quadri, condotti per come cennato di sua mano, con tale accuratezza, da far chiaro delle cognizioni attinte nella nobile arte. Da qui addivenuto infaticabile nella ricerca _________________________________ Nota in calce alla c. 52v: “(1) Messina, stamperia del Commercio 1863, in 8°” <Gregorio Raymondo Granata, Duecentosessanta giorni in Palermo nel 1861 ovvero biografia e gabinetto scientifico-artistico dell’archeologo signor Agostino Gallo, Messina, Stamperia del Commercio, 1863>. 33 Giuseppe Velasques, pittore, nato a Palermo nel 1750, ivi morto nel 1826. Due versioni biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 75, 77 e in Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 110-168. 34 Vincenzo Riolo, pittore, figlio di Rosario, nato a Palermo nel 1772, ivi morto nel 1837. Direttore dell’Accademia del Nudo di Palermo nel 1829. Due versioni biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 90 e in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 240, 255-262, 266-267. 32 26 del bello artistico, dovunque frugando e disseppellendo antichità e ceneri di chiarissimi uomini, si è fatto archeologo, non secondo ai più illuminati fra noi. Non altrimenti il benemerito cittadino dall’alba a notte vedesi preoccupato tra libri, manoscritti, disegni, quadri e gessi, posti per le pareti, ed a ribocco dovunque nella stanza di studio: quant’egli sia operoso e utile specialmente col proprio paese. Palermo non lo disconosce benché tal fiata faccia le viste di sfingerlo [!]. Per si affettuoso cittadino essa si gode di moltissime illustrazioni: di opere d’arti, e bellezze artistiche, di sani consigli, di proficue ricerche, ed utili rinvenimenti; a dir breve quanto di patriottico e di antico sorge a giornata, è opera dello zelo di Gallo, che mai posa nella ricerca degli uomini illustri e degli antichi monumenti. Per esso, marmi e mezzo-busti, gessi e quadri, pergamene e privilegi grandeggiano detta città: tra le quali cose è opera immortale da eternare il promotore il Panteon crescente, maestoso nel tempio di S. Domenico. Conciosia che il nostro archeologo si è reso caro agli amici, alla patria ed alla intera Italia. Dapertutto le accademie e le istituzion d’antichità e belle arti, lo celebrano conoscitore esimio in tali cose, ascrivendolo a collaboratore e socio corrispondente ed onorario né mai arriva posta dall’estero senza recargli diplomi e gradi accademici, ultimo essendo sin’oggi quelli indirettogli da Vincenza [i.e. Vicenza](46)35 d’altronde il suo viaggiare per la penisola ove si ebbe ad amicissimi (47)36 in particolare il celebre Giuseppe Borghi, Giovanni Niccolini, Rosini, Lucchesini, ed altri illustri letterati, loro tenendo dotta corrispondenza (48)37, rese sì chiaro ed onorevole il di lui nome, che non evvi angolo di nostra terra da non sapegliene grato. Ora egli si vive modestamente tra le pareti del solitario suo gabinetto, riverito e ricercato dai forestieri, e dai cittadini di sano intendimento e di puro cuore: la patria che a spilluzzico da le lodi e le remunerazioni, si contenta averlo a segretario archeologo della Commissione di antichità e belle arti in Sicilia; ed il Governo ad Ufficiale Capo di divisione del Ministero di Stato. Il Gallo quantunque infaticabile solertissimo al prosperare del nostro _________________________________ 35 A c. 53v nota in calce: “(46) In agosto 1861. Per cui il Gallo a ringraziamento inviò a quella Accademia una canzone in lode della inaugurazione della statua di Andrea Palladio da Vincenza. Adesso però è l’ultimo diploma quello inviatogli da Milano dell’accademia di Belle Arti sotto il 14 aprile 1863: sicché il Gallo fuori patria è ascritto alle più insigni accademie come in quelle di Napoli: la Sebezia, la Pontaniana, e la Reale; all’Ateneo di Firenze, all’Accademia di Archeologia di Copenaghen, di S. Luca e del Panteon di Roma.” 36 A c. 53v nota in calce: “(47) Giacché i più son morti.” 37 A c. 53v nota in calce: “(48) Le cui lettere si sono già cominciate a pubblicare nel giornale Il Diogene.” 27 secolo che sapergliene grato i cittadini, ei pure come ogn’altro ingegno inonorato nella propria patria ha dovuto sperimentare la certa sentenza del Salvatore: “Nemo propheta acceptus est in patria sua” a fede di ché questo brano di lettera lo dimostra (1)38. “I buoni padri Domenicani soltanto più che il pubblico si sono mostrati caldi di gratitudine, per aver promoso con grave mio dispendio quei monumenti agli illustri siciliani, che rendono oramai il loro tempio grandioso ed elegante nelle sue semplicità, degno di essere visitato dai forestieri; quando quasi dimenticato da due terzi di Palermitani. Essi religiosi deliberarono capitolarmente di destinare alla mia memoria il pilastro successivo a quello di Scinà, addossato di fianco all’urna di Meli, ciò mi diè occasione di comporre la mia epigrafe funebre nei seguenti versi: Amò la patria con affetto antico di Meli di Scinà di Piazzi amico. Non credo di meritare altra lode (dotta modestia) e l’amicizia di que’ sommi, che mi fu sviscerata credo di riflettere un benigno raggio sulla mia memoria a’ posteri, come quella del Petrarca sul vostro Tommaso Caloria, del quale forse non si sarebbe né parlato né scritto se non era congiunto di affetto col gran lirico erotico italiano ec.”. Chi ama sapere del Gallo la indole e il cuore, si faccia per poco ad osservarlo: la fisionomia è certa scienza ed io di Lavater, di Gall e de’ loro seguaci mi tengo ammiratore. Gli è alto della persona e ben complesso; ha faccia grande e fronte quadra, serena ed isvelta; occhi grandi e castagni, incavati sotto alle sopra ciglia arcate e vellosette; naso poco più del regolare; guance carnose e colorite; labbra coralline poco grossette e ben pronunciate; bocca analoga alla grandezza del volto, ben chiusa e presta a parlare pacato e piacevole; mento rotondo e carnoso: egli affatto alieno al parere di Musonio porta rasa la barba. Da tale esteriore, che costituisce i segni dell’uomo onesto e scienziato, di leggieri possonsi indagare i talenti e le doti dell’animo del chiaro storiografo. Prima seduta39 Palermo dodici dicembre milleottocentoquarantasei. I socj compilatori della Biblioteca storico sicula hanno stabilito quanto siegue Per ciò che riguarda il sesto, la carta, il prezzo della stampa, ed il nume_________________________________ 38 39 A c. 54r nota in calce: “(1) inviatami li 27 marzo 1862.” Al margine sinistro: “Copia”. 28 ro delle copie da tirarsi dell’opera anzidetta si rimettono alla convenzione che si firmerà di accordo col tipografo Signor Muratori in questo stesso giorno. Il prezzo di ogni dispensa mensile composta di quattro fogli, giusta il manifesto da pubblicarsi sarà di tarì tre, oltre a grana dieci per ogni rame, che occorrerà nel corso dell’opera. La direzione dell’opera è affidata a Monsignor Crispi40 La stampa della medesima al marchese Villarena41 L’amministrazione, e l’Archivio al Signor Castagna La corrispondenza a D. Agostino Gallo Il primo centralizzerà i lavori e passerà vistati allo incaricato della stampa i materiali, che la società stabilirà doversi pubblicare, e collo stesso ordine, che la medesima sarà per indicare. Il secondo avrà la disposizione, ed esecuzione della stampa esclusa la correzione che sarà fatta dagl’interessati, e passerà vistati da lui col tipografo i materiali, e gl’incontri. Il terzo pagherà coi fondi dell’Amministrazione la stampa, a norma della surriferita convenzione, e le altre spese all’uopo occorrenti, conserverà i fascicoli e le carte, e i documenti spettanti alla società, esigerà il prezzo dei fascicoli che si venderanno ed avrà la cura di compilare, e conservare il verbale delle sedute della società firmato da quattro socj. Il quarto finalmente manterrà il carteggio co’ collaboratori per la parte letteraria, e quello ancora per lo spaccio delle copie di associazione. Nelle prime, e seguenti dispense dell’opera si pubblicheranno, oltre la preparazione all’opera del Signor Gallo, Per la prima parte I discorsi di Errante, ed i frammenti42 del medesimo previo il di lui permesso da passarsi in Archivio dal Signor Gallo. Le lettere di Platone di Padre Spata43 _________________________________ Giuseppe Crispi (1781-1859), noto grecista e docente presso la R. Università di Palermo. Vincenzo Mortillaro, marchese di Villarena, docente interino di lingua araba presso la R. Accademia degli Studi di Palermo, redattore di giornali. La sua attività storiografica è rubricata in Giuseppe Maria Mira, Bibliografia siciliana… cit., v. 2, p. 107-108. 42 Errante Celidonio, I Frammenti di Dicearco da Messina raccolti, e illustrati dall’avvocato D. Celidonio Errante de’ baroni di Vanella, e Calastai, Palermo, presso Lorenzo Dato, 1822, 2 v. 43 Nicolò Spata (1821-1855), grecista, allievo del Crispi, Monumenti storici di Sicilia tratti dall’epistole di Platone e dai frammenti di Timeo da Taormina, Eforo, Teopompo, Callia siracusano e Diodoro. Versioni ed illustrazioni del sac. Nicola Spata socio attivo dell’Accademia palermitana di scienze e lettere, Palermo, Stabilimento tip. di Fr. Lao, 1852. 40 41 29 I frammenti di Diodoro di Monsignor Crispi44 e la Geografia Nubiese di Castagna, se non vi siano altri frammenti greci, che dovessero procedere. Per la seconda parte Diploma normanno di Mortillaro45 Per la terza parte Articolo sopra Palermo del Signor Gallo46. I materiali che dovranno far parte delle ulteriori dispense saranno stabiliti in altre sedute. Verranno invitati come collaboratori colla promessa del fascicolo gratis i seguenti individui cioè: I Signori Errante, Spata, Vagliasindi, P. Palmeri, Cordaro. Clarenza, P. Tarallo, P. Lo Presti e P. Granata. Firmato: Giuseppe Crispi - Francesco Castagna - Agostino Gallo Vincenzo Mortillaro.47 Palermo dodici dicembre milleottocentoquarantasei. Fra noi sottoscritti signori nella qualità di socj compilatori dell’opera periodica, che avrà per titolo: Biblioteca storica-sicola, ossia Collezione di frammenti, Relazioni, Cronache e monumenti di ogni maniera relativi alla storia di Sicilia, da una parte, ed il Sig.r Antonio Muratori dall’altra, si è fatta la seguente convenzione in doppio originale per aver forza di pubblico rogito. Io sottoscritto di Muratori mi obbligo stampare nella mia tipografia l’opera anzidetta nel formato in quarto a due colonne in carattere piccolo _________________________________ Diodorus Siculus, I frammenti nuovi di Diodoro Sicolo ricavati da’ palimpsesti vaticani dal cardinal Angelo Mai e tradotti dal testo greco in italiana favella da Giuseppe Crispi; con un preliminare ed un discorso e l’aggiunta di una rivista, correzione e scelta di varianti, e di nuove note ed altri rischiarimenti, ed in fine di una scorsa biblioteca storica, Palermo, Reale Stamperia e Libreria, 1847. 45 Vincenzo Mortillaro, Catalogo ragionato di diplomi esistenti nel tabulario della Cattedrale di Palermo, ora coordinati per ordine del Real Governo da Vincenzo Mortillaro, Palermo, Stamp. Oretea, 1842. 46 Potrebbe trattarsi del saggio pubblicato nella rivista “Passatempo per le dame”, a. IV, n. 6, 6 febbraio 1836, p. 41-42 (I) e a. IV, n. 13, 26 marzo 1836, p. 97-99 (II), dal titolo Sopra alcune opere di architettura eseguite di recente in Palermo. Si tratta di un articolo dedicato ai progetti curati dall’architetto Emanuele Palazzotto, allievo di Giuseppe Venanzio Marvuglia. 47 A c. 53v nota a margine: “Confronta coll’originale esistente in mio potere. Francesco Castagna.”. 44 30 romano e nella carta che mi sarà somministrata da surriferiti signori nel numero di duecentocinquanta esemplari oltre alle copie della Polizia nella carta che mi sarà pure approntata, e ciò per lo prezzo di tarì venti per ciascun foglio in quarto come si è detto in carattere piccolo romano a due colonne per la composizione, di tarì dodici per l’impressione, e consumo come si è detto per duecentocinquanta copie, oltre a quelle della Polizia, e di tarì uno e grani cinque per cilindratura delle intiere duentocinquanta copie di ogni foglio, e precisamente secondo l’acchiusa pagina di modello da tutti noi segnata otto facce della quale formeranno il foglio compreso stimandosi nel prezzo suddetto qualunque quantità di annotazioni di diverso carattere che occorrerà o di testino, o di mignona, e che occuperà luogo in piè di pagina del testo, e che nell’intero foglio non ecceda la sesta parte. Se vi saranno delle colonne in carattere greco queste saranno considerate alla ragione di onza una, e tarì due per ciascun foglio: ma ove andranno soltanto delle parole greche nel testo, o nelle note, o anche qualche linea, purché non oltrepassi la sesta parte della pagina, non sarà corrisposto alcun dippiù. Eccedendo tale quantità, sarà ragionato il prezzo in proporzione del contenuto. E dall’altra parte noi sottoscritti ci obblighiamo non fargli mancare la carta, e pagare al detto di Muratori il prezzo convenuto alla consegna di ogni foglio, e ciò sino alla fine di ogni dodici dispense, o sia di quarant’otto fogli di stampa. E compiuti i detti quarant’otto fogli, non s’intenderà contratta obbligazione da parte dei socj compilatori e dello stampatore per le seguenti dispense, se non cominciata la stampa del foglio quarantanove. Il detto Sig.r Muratori si obbliga dare gratis la stampa del Manifesto dell’opera convenuta non dovendosi altro apprestare dai socj compilatori, che la carta corrispondente per duecentocinquanta copie. Per non accadere degli equivoci nella tiratura dei fogli, il Sig.r Muratori, riceverà i materiali di stampa vistati da Mons. Crispi e da Mortillaro e gl’incontri ancora vistati dal solo Mortillaro, senza di che non avrà alcun diritto al pagamento; anzi sarà risponsabile delle rifrazioni che potranno disporsi a di lui carico. E quando sarà al caso di consegnare i fogli tirati, o cilindrati adempirà ciò in mani del Sig.r Castagna come amm.re della società dei compilatori, da cui sarà soddisfatto coi fondi dell’Amministrazione medesima contro ricevo che dal Sig.r Muratori si rilascerà a favore dello stesso colla qualità anzidetta. Se alcuno estratto si volesse della società degli articoli che faranno parte della Biblioteca, il tipografo sig.r Muratori resta obbligato ad appre- 31 starlo non potendo altro pretendere che tarì sei per ogni cento copie, compreso in detto prezzo ogni diritto di composizione tiratura e consumo e più tarì uno per frontespizio. Se però le copie fossero più di cento, saranno calcolate sin dal principio alla ragione di tarì quattro per ogni centinaio, dovendo sempre apprestarsi la carta dagli interessati. Il sopradetto articolo sarà anche applicabile a tutti gli scrittori della Biblioteca. Giuseppe Crispi Agostino Gallo Francesco Castagna Vincenzo Mortillaro Antonio Muratori48 Palermo li 16 maggio 1839. Io qui sottoscritta qual Coerede del chiarissimo mio zio Sig.r Cav.r Domenico Scinà consento che D.n Agostino Gallo di lui affezionato scolare, ed amico assuma lo impegno di pubblicare in uno o più volumi le opere minori dell’anzidetto mio zio, rinunciando per questo riguardo al dritto che ho come coerede sulle opere medesime, purchè si stampino ad ulteriore fama del medesimo. Rosalia Sanzone e Scinà in Randazzo. Dritto accordato a D. Agostino Gallo dagli eredi Scinà per la stampa delle opere di quest’ultimo e Contratto dello stampatore Barcellona col Sig Gallo per la stampa delle opere di Scinà. Palermo 16 novembre 1844. N. 3634 a 4 luglio 1845, via Salinas Conte I sottoscritti eredi del fu Sig. Cav. D. Domenico abate Scinà cedono al Sig. D. Agostino Gallo ogni loro dritto sulla stampa delle opere dell’anzidetto Sig.r Cavaliero loro defunto zio, tranne la Fisica, a condizione di _________________________________ A c. 58v nota a margine: “Confronta coll’originale esistente in mio potere. Francesco Castagna.”. 48 32 doverne consegnare ai medesimi numero cinquanta copie al momento che ne sarà fatta l’edizione, per distribuirsele fra loro, e gli altri eredi. N. 3634 dalli quattro luglio 1845, lib 2, c. 209 f. 10, c. 5 […] 20 Michele Ragona Rosalia Sanzone e Scinà in Randazzo Salvatore Randazzo marito, ed autorizzante Io qui sottoscritto metto la mia firma sotto la condizione che l’edizione sia regolata e diretta da me e dal Sig.r Gallo e che, stampandosi l’opera, si metta il mio nome e quello del predetto Sig.r Gallo quali editori della medesima. Domenico Ragona-Scinà. Carlo Rosalo tutore dei minori Ragona. Palermo 17 nov 1844. Io qui sottoscritto rilascio la qui indicata concessione co’ patti annessivi al S.r V. Mortillaro nell’intelligenza che debba imprender la stampa delle opere di Scinà fra lo spazio di quattro mesi. Agostino Gallo. Il S.r. V. Mortillaro ringrazia il Signor Gallo, ma trovando poco decoroso fare una ristampa sotto l‘altrui direzione, dichiara non essere in caso d’imprendere l’edizione che si desidera. V. Mortillaro49 S.R.M. Sire D.na Emmanuela Di Blasi, e D’Angelo vedova di D.n Vincenzo Di Blasi difonto nell’attuale esercizio di Sindaco della città di Palermo, infelice madre del50 mal’avventurato figlio D.n Francesco Paolo Di Blasi, piena di tutta l’amarezza, e rossore prostrata innanti al trono di V.R.M. umilmente rappresenta, che nella sua vecchiezza carica di 75 anni, ed aggravata di nuovi dolori ed infermità è rimasta dopo la perdita di quest’ultimo figlio la più inconsolabile donna desolata, ed afflitta, ridotta a finire anticipatamente _________________________________ 49 Sul verso della c. 60: “Barcellona ***e e Scinà Castagna per l’oggetto di stampa”. 50 Seguono cancellate le parole: “l’unico”. 33 i suoi giorni nelle continue lagrime, e nell’universal indigenza, senza veruno sollievo, e conforto, e giacchè il Signore per alti giudizi l’ha privato dell’unico mezzo da cui traeva ogni sovvenimento secondo la decorata condizione, ove Dio la fece nascere, si fà cuore ricorrere alla V.ra Real Clemenza ch’è il Padre de’ suoi fedeli vassalli supplicandola che compassionando nel suo real animo l’infelice stato di un’afflittissima Madre che nell’età cadente,51 portando il cuore ferito di molte piaghe52 e profonde, prova la pena di vedersi priva d’ogni soccorso, e gia vicina al sepolcro, si compiacesse per solo semplicissimo eccesso della sua sovrana beneficenza sollevarla con un pronto annuale sovvenimento quale grazia unicamente spesa dalla sovrana clemenza di V.R.M. per cui la supplica come l’Altissimo53. Al Chiarissimo Signore il Sig. Agostino Gallo Capo di Ripartimento del Ministero dell’Interno. Segretario della Commissione delle Antichità per la Sicilia. Signore, Salvadore Politi da Siracusa rassegna a V.S. che rimasto in tenerissima età povero, e quasi fin d’allora padre di numerosa famiglia non protetto d’alcuno, ma spinto solo dalla Provvidenza mercè un forte sentire alle belle arti del disegno à fatto sforzo per giungere in quel modo che meglio gli è stato possibile. In grazia di tanti veri stenti è egli onorato da dotti viaggiatori, e richiesto di guida artistica, visitando il paese di tante gloriose memorie. Si fa un dovere quindi Politi guidare molti viaggiatori in visitare gli avanzi della magnificenza dell’antica Siracusa istruendo, e chiamando alla loro memoria le classiche prische idee storiche che svegliano le loro osservazioni. Il nostro Real Governo tanto vigile alla conservazione dei bei monumenti non à lasciato in ogni tempo di emanare le più provvide leggi, che mentre provano la sapienza del nostro Real governo dimostrano bensì quanto sia importante la conservazione di tai monumenti che tanto han contribuito al risorgimento delle arti; all’assunto à nominato regi custodi, fra i quali uno per l’Epipoli ultima parte dell’antica Siracusa, l’altro per la curiosa Latomia celebre perché detta l’Orecchio di Dionigi54; Or siccome le anti_________________________________ Seguono cancellate le parole: “ha avuto ferito il cuore”. Segue cancellata la parola: “ferali”. 53 Sul verso della c. 65: “Memoriale della vedova D.a Emmanuela Di Blasi, e D’Angelo della città di Palermo”. 54 Per una ricognizione storiografica, cfr. Angela Mazzè, “I giardini del re orientale: le latomie di Siracusa”, in Agathón, 2010/2, p. 3-8. 51 52 34 chità sono esistenti in vari punti dei quartieri del suolo di quella Siracusa che fu un tempo principessa delle greche città, tanto celebrata dai classici dell’antichità, e di cui fasti son collegati con quelli dei popoli i più illustri, e dell’epoche le più memorabili. Fa d’uopo che sia di mestiere un sorvegliatore che può riuscire con sommo bene dei dotti viaggiatori, che si è il solo Politi in qualche modo esperto nel ramo di antichità patrie, e per essere egli quotidianamente in continue osservazioni sui tanti rispettabili ruderi, in una agli istruiti cultori delle belle arti si nazionali, che stranieri. Il supplicante si augura che venisse dalla saggezza, e benignità di V.S. proposto e nominato a sorvegliatore con assegnarle la mercede conveniente, e richiamando fortemente i custodi alla esatta osservanza dei loro doveri. Siracusa 20 luglio 1858 Salvadore Politi55 Palermo 23 febbraro 1852 Deputazione della Pubblica Libreria del Comune di Palermo n. 117. Oggetto: Proposta di due supplenti con onza una al mese Al Sig.r Intendente Della Provincia di Palermo Signore Atteso l’ingrandimento della Biblioteca, e la distanza di sito, che da un punto all’altro si frappone è indispensabile l’accrescimento di due impiegati, che faccian da supplenti. Questa Deputazione si permette per ora proporli con onza una al mese, e di sua scelta, e senza, che si abbiano alcun titolo per esser proposti […]portuno. La prega quindi a volerne autorizzare la spesa sul fondo di rimunerazione tessuto nello stato discusso. I deputati marchese di Villarena Gius. Patania celebre dipintore che accrebbe ornamento a Palermo sua patria e nome a questa illustre accademia escia e non era più l’anno di vita dal giorno 23 febbrajo fatalissimo per la gloria della pittura nazionale. Quella mente ispirata dall’antico genio siciliano quella mano guidata dalla grazia che furono si operose e feconde di parti sino al giorno innanzi alla sua funesta dipartita giacciono fredde, e inerti nel sepolcro, e riman56 _________________________________ Sul verso della c. 67: “A S.E. l’egregio Signor Agostino Gallo Capo di Dipartimento del Ministero dell’Interno Segretario della Commissione delle antichità per la Sicilia”. 56 Il testo che segue è scritto a margine della c. 68v. 55 35 gono solo in vita il suo nome, e la sua opera all’ammirazione de’ presenti, e de’ posteri Il di che schiuse Pag. stanza verso / testo stampato dal Giunti Si aggiunga a / Patania/ Verità ed armonia Patania fu sempre progressiva egli diceami Il mio spirito non invecchia Ad istanza dei Signori Santo Bruna, Paolo Farinella, maestro Rosario Cammarata, Rosario Gangichiodo di Francesco Paolo, maestro Giuseppe Giarratana di Emmanuele, D. Salvatore Librizzi, e Librizzi, Maria Centineo in Messineo, Pasqua Oddo in Scelfo, D. Giuseppe Antonio Oddo di Rosario, Gaetano Pantano, maestro Calogero Pergola, Sig.ri Antonio Scelfo Rosario di Silvestre, D. Giuseppe Scelfo di Francesco Paolo, Domenico Signa di Carmelo, Maria Gangichiodo vedova Signa, Rosario Signa di Domenico, Salvatore, D. Giuseppe Tedesco, Leonardo Ruggina di Antonio, maestro Filippo Guastaferro, D. Luigi Di Chiara, e consorti domiciliati in Alimena, e maestro Rosario Miserendino domiciliato in Bompietro rappresentati da me sottoscritto patrocinatore domiciliato via Macqueda n.° 77, e sulla istanza altresì di me infrascritto domiciliato come sopra qual patrocinatore dei sudetti Sig.ri Santo Bruno, e consorti sia intimato, e dato copia del soprascritto processo verbale di giuramento dei periti del giorno ventitre Gennaro 1860 registrata la copia in Alimena li quattro febbraro 1860 al n. 22 lib. 3 vol. 5 f. 75 cap.1° dal ricevitore Brucato ai Signori Don Enrico Varvaro qual patrocinatore di Francesca Paola Calabrese vedova Gangichiodo qual tutrice dei suoi figli minori, Maddalena, e Rosario Gangichiodo figli, ed eredi del fù Antonio Gangichiodo, Maria La Lima, Domenico Sapienza marito, ed autorizzante la detta Lima e Francesco Scelfo e consorti, domiciliato discesa San Francesco nonché ai sudetti Francesca Paola Calabrese vedova Gangichiodo qual tutrice dei suoi figli minori Maddalena, e Rosario Gangichiodo figli ed eredi del fù Antonio Gangichivo [!] Maria La Lima in Gangichiovo qual tutrice dei suoi figli minori Antonio, e Giuseppe, e Salvatore, figli, ed eredi del fù loro padre Andrea Gangichiodo Domenico Sapienza qual marito ed autorizzante 36 detta Lima, Francesco Scelfo di Pasquale qual’erede del di lui fratello Antonio, Giuseppa Porrovecchio in Pontano, Gaetano Rosario, e Calogera Pontano figli, ed eredi del fù Antonio, Pasquale Signa marito ed autorizzante detta Calogera, Antonia Gangi Chimenti Palma Gangichiodo, figlia, ed erede del fù Antonio e Francesco Scelfo di Mariano marito ed autorizzante la detta Palma, Calogero Ippolito, Salvatore e Domenico Seminara, Domenica Vazzanò vedova di Antonino Seminara qual tutrice della di lui figlia minore Rosa Ende del detto fu Antonio Seminara, e Giuseppe Di Chiara qual di lei secondo marito, ed autorizzante e contutore di detta minore Illuminata Messineo, maestro Rosario La Porta di lei marito ed autorizzante, Pasquale Messineo, Giuseppe ed Antonia Soldato, figli ed eredi delle furono loro Soldato e Calogera Abbate, Salvatore Rizza, Giuseppe D’Anna di Salvatore Domenico Di Prima, Domenico Signa di Rosario, Francesco Paolo Palermo, Francesco Faulisi, D. Salvatore Gangi Chiodo maestro Antonio Di Maggio, Stefano Lorenzo, Salvatore e Giovanni Oddo, Giuseppa Messineo di lei marito, ed autorizzante, Francesca Paola Iuria in Oddo qual tutrice dei suoi figli minori Antonio e Calogera Oddo, e detti Oddo tutti figli, ed eredi del fu Giuseppe Oddo di Stefano, e maestro Rosario Faulisi qual secondo marito, ed autorizzante detta Francesca Paola Iuria, e come tale contutore di detti minori Giuseppe e Rosario Seminara, Gaetano ed Antonio Sabatino, Teresa, Salvatore Domenico, Pasquale, Francesca Paola, Maruzza, Antonina e Maria Gangi Chiodo, Francesco Fazio qual marito, ed autorizzante detta Francesca Paola, Rosario Curione marito, ed autorizzante detta Maruzza, Gaetano Randazzo marito, ed autorizzante detta Maria, e Lucia Spedale tutrice del minore Francesco Paolo, Giuseppa Lo Cigno in Puma, Giovanni Signa, Giuseppe Carlotta fu Calogero; Giuseppe Gangi, Dino Di Pasquale, Antonio Signa di Domenico, Luciano Randazzo di Rosario, Leonardo Malachia, Luciano di Prima di Lorenzo, Domenica Mantegna ved.a Coco, Carmelo Gangi di Lorenzo, Melchiore Russo di Gioachino, Calogero Federico di Michele, Giuseppe, e Rosario Chimera, Pasquale Intronatolo, Vincenzo Burgo fu Pasquale, Rosaria Scelfo vedova di Pasquale Burgo, Rosario Miserendino, Rosa Vilardo, Francesco Bruna di Domenico, Lorenzo, e Domenico Valenza, Donna Rosalia Gennaro in Alonge, mastro Giovanni Cammarata di Rosario, Salvatore Librizzi in Farinella, maestro Stefano Signa, Salvatore Scelfo di Rosario, Giuseppe Castagna, Rosario, e Maria Antonia Venturella, eredi del fu loro padre Salvatore e Giuseppe Gennuso qual marito, ed 37 autorizzante detta Maria Antonia, Maria Perna in Pera, Santa Saguto, e Calogero Oddo di lei marito, ed autorizzante, Salvatore Signa fu Rosario, Rosa Messina in Lo Vetere, Francesco Paolo Oddo di Rosario, Maddalena Farinella, ed Antonio Cipriano di lei marito ed autorizzante, Michelangelo Richiusa, D. Salvatore Tedesco di Giuseppe e Filippo D’Amico coi nomi, donna Maria D’Amico di lui figlia, e Giuseppe Chimera di costei marito, ed autorizzante, Anna Antonia Scelfo, e Giuseppe Bruna, Carmelo Signa di Domenico, Illuminata Signa, Rosario Signa di lei marito, ed autorizzante, Ignazio Federico col nome, Anna Maria Signa, Francesco Paolo, e D. Giuseppe Giaimo, Francesco P. Gangi Chiodo, Rosaria Faulisi, D. Gregorio Federico, Francesco li Puma di Giuseppe Antonio, e Giuseppe Alfano, Antonino Federico, Giuseppe li Puma Crocca, Antonina di Paola in Pera, vedova di Ignazio li Pera, D. Antonio Calabrese, Maria, Giuseppa, Francesca Paola Pergola, figli ed eredi del fu Antonio, e Lorenzo di Paola; Giuseppa Scrivano, Domenico Saguto marito, ed autorizzante le medesimi, D.a Anna Martina qual erede del di lei fratello D. Salvatore, Rosario Pantano del fu Antonio, qual erede del fu di lei fratello, Giuseppe, Salvatore, e Giovanni Venturella, figli, ed eredi del fu Calogero, tutti proprietarj,57 e consorti, domiciliati in Alimena, chiamati ad intervento forzoso, e per il presente domiciliati nel detto loro domicilio di dritto in casa del detto patrocinatore Signor Varvaro sito come sopra. Restano inoltre intimati, ed avvisati tutte le dette parti a comparire, ed essere presenti se lo vogliono il giorno sedici del corrente aprile 1860 alle ore tredici, giorno ed ora destinati dai periti nel sudetto processo verbale di prestato giuramento sulle terre esistenti nell’ex feudo Destri, territorio di Petralia Soprana. Sull’istanza de’ Sig.ri Santo Bruno Paolo Farinella maestro Rosario Cammarata, Rosario Gangi Chiano di Francesco Paolo, maestro Giuseppe Giarratana di Emanuele D. Salvatore Librizzi e Librizzi Maria Centineo in Messineo Pasqua Oddo in Scelfo Giuseppa Antonio Oddo di Rosario Gaetano Pantano maestro Calogero Pergola Signor Antonio Scelfo Rosario di Silvestre D. Giuseppe Scelfo di Francesco P. Domenico Signa di Carmelo Maria Ganci Chiano ved.a Signa Rosario Signa di Domenico Sacerdote D. Giuseppe Tedesco Leonardo Ruggica d’Ant.o mastro Filippo _________________________________ 57 Seguono cancellate le parole: “Signora Maria Purpura”. 38 Guastaferro D.r D. Luigi Di Chiara Sace.te D. Giuseppe Antonio e Sig.a Maria Purpura ne’ nomi Giuseppa Maria Immurgia e Giuseppa Cerami vedova fu Ganci Dino ne’ nomi proprietarj domiciliati di Alimena e mastro Rosario Miserendino domiciliato in Bompietro rappresentati da me sottoscritto Patrocinatore, e sull’istanza altresì di me infrascritto domiciliato Piazza Feravecchia qual pat.e de’ Signori Santo Bruno e consorti sia intimata notificata e con quest’atto data copia della sopra trasferita ordinanza emessa dal giudice regio del Circond.o di Alimena qual delegato di questo Trib.le Civ.le nel di’ ventinove dicembre 1856 registrato in Alimena al N.° […] 306. Ricevuti grana 30 dal sudetto Brucato a’ Signori 1. D. Benedetto Pirrone qual Patr.e della reverenda madre abbadessa del ven.le monastero del Cancelliere dom.to in questa via Sant’Isidoro. 2. nonché alla reverenda madre d.a Antonia Benedetta Penzabene qual’abbadessa di detto venerabile monastero, nel suo domicilio di dritto in casa di d.o S.r Pat.e Pirrone sita come sopra. 3. D. Michele Russo domiciliato ivi via Alloro qual Pat.e del S.r D. Luigi Mammana agente giudiziario de’ beni della eredità Luparello, 4. nonché allo stesso S.r D. Luigi Mammana col nome, nel detto suo domicilio di dritto in casa di detto S.r patrocinatore Russo sita come sopra. 5. D. Carlo Stefano Bonanno dom.to Piano del Cancelliere qual Pat.e di D.a Ottavina Ricca in Bonanno, nonché alla stessa D.a Ottavina Ricca in Bonanno e D. Simone Bonanno nel d.o loro dom.lio di dritto in casa di d.o Pat.e S.r. Bonanno sita come sopra. 6. D. Francesco Pistone ivi domiciliato Piano Cancelliere qual Pat.e del S.r B.ne D. Giuseppe Luparello e consorti nonché al detto 7. 8. Signor Barone D. Giuseppe Luparello 9. 10. D.a Francesca e D.a Rosaria Luparelli e D. Stefano Testa marito autorizzante di quest’ultima ne’ nomi nel loro sudetto domicilio di dritto in casa di detto S.r. Pat.e Pistone sita come sopra. 11. D. Girolamo Di Guardo domiciliato via Maccherronari qual Patrocinatore di D.a Francesca Paola Calabrese e consorti 12. nonché alla stessa Sig.ra D.a Francesca Paola Calabrese e consorti nel d.o loro domicilio di dritto in casa di detto S.r Di Gerardo sita come sopra. E ciò per averne loro la piena conoscenza e per tutti gli effetti legali di riscritta con dichiarazione di essersi conseparato atto intimato e notificato nonché la sopradetta ordinanza ma altresì la dispositiva della sentenza emessa da questo Tribunale Civile P.ma Cam.a li 24 marzo 1855 reg.a la sped.e a 15 mag.o 1856 al N.° 7219 da Platania a’ periti 39 nominati in detta sentenza D. Francesco Scelfo D. Pasquale Tedesco e Salvatore Alonge. Restano inoltre intimati ed avvisati tutte le suddette parti a comparire ed esseri presenti se lo vogliono nel giorno venticinque cor.te gennaro alle ore sedeci d’Italia alla prestazione del giuramento che faranno i periti D. Francesco Scelfo D. Pasquale Tedesco e D. Salvatore Alonge nelle mani del Giud.e del Circondario di Alimena in esecuzione della sentenza nella sopraenunciata ordinanza meglio enunciata prevenendoli che in caso di contumacia sarà il detto giuramento sempre prestato. Fatt’oggi li 19 genn.o 1857. Francesco Spadaro Pat.e L’anno 1800cinquantasette il g.no diciannove gennaro in Palermo. Io sottoscritto mg.to presso questo Trib.le Civ.e dom.to via Tornieri vi ho intimato e dato rispett.a copia del presente del soprascritto atto e della ordinanza in essa enunciata da me lo mag.to e firmata a’ signori: 1. Rev.d Madre D.a Antonia Benedetta Penzabene abbadessa del Monast.o del Cancell.e di q.o e S.r D. Benedetto Pirrone Pat.e come sopra. 2. R. D. Luigi Mammana col n.o e S.r D. Michele Russo Pat.e come sopra. 3. Sig.i D.a Ottavina Ricca in Bonanno D. Simone Bonanno, e 4. S.r D. Carlo Stefano Bonanno Pat.e come sopra. Sig.i B.ne D. Giuseppe, D.a Francesca, e D.a Rosaria Luparelli, D. Stefano Testa marito aut.te quest’ultima ne’ nomi, e D. Francesco Pistone. 5. Pat.e come sopra.58 D.a Francesca Paola Calabrese e consorti, e D. Girolamo Di Guardo Pat.e come sopra rilasciato avendole ne’ pred.ti rispett.i domicilj di d.i Sig.i Russo Bonanno Pistone, Di Guardo e Pirroneconseg.le a mani delle rispett.e loro serve come dissero. Costo Dritto Reg. Rip. onze 12.00 Orig.le e Copia onze 6.00 Copia di Ord.a onze 5.00 Carta onze 3.18 Totale onze 26.18 Serafino Cannizzaro 19 gen. 1857 1319 Mammana N. 1 _________________________________ 58 Cassate le parole: “Francesca di Calabrese”. 40 Proemio dell’istoria delle belle arti siciliane La Sicilia è la regione prediletta da numi dell’antichità e da’ poeti, la terra del meraviglioso naturale, della straordinaria e onnigena fecondità per produzioni agricole sì per gli svariati e vivaci ingegni onde Cajo Giulio Solino straniero (1)59 ebbe ad esclamare: Quid quid Sicilia gignit, sive soli, sive hominis ingenio, proximum est iis, qui optima iudicantur. Questa amplissima isola triangolare ha di circuito circa 500 miglia ed è segnalata da’ tre promontori cioè dal Peloro che guarda la Calabria, in Pacchino rivolto al Peloponneso e dal Lilibeo verso l’Affrica(1)60 al grado di latitudine 36-39 sino a 38.6 e di longitudine da gradi 30.6 sino a 33.18. Sorge regina del Mediterraneo ed è circondata dal Mar Toscano a tramontana, dal Sicolo Adriatico in Levante, dal Libico a mezzogiorno. All’oriente è divisa dalla Calabria dal Faro di Messina, stretto di mar vorticoso di circa due miglia fra Cariddi e l’opposta Scilla, ove osservasi di rado il fenomeno singolare detto della fata Morgana il quale pel riflesso della luce solare degli oggetti ne’ dintorni di Messina rappresenta sull’opposto orizzonte palazzi, boscaglie, giardini, animali, e talvolta carri, ed armate. L’isola fu pria denominata Trinacria o Triquetra dalla sua figura a triangolo, indi Sicania da popoli Sicani, e in seguito Sicilia da Sicoli che vi soggiornarono. I poeti poi l’appellarono or isola de’ Ciclopi, or del sole ed or Etnea. S’innalza gigante l’Etna indi detto Mongibello dagli Arabi nel Val Demone, sulla base di circa 100 miglia e torreggia perpendicolarmente sino a 4 miglia ed è diviso in tre regioni, la inferiore ossia la piemontana coverta di vigneti e di alberi fruttiferi, e di villaggi e a 10 miglia si eleva la regione nemorale ingombra di boschi, e la soprana che per 8 miglia ignuda ed arenosa conduce al vertice ove mirasi il principal ignivomo cratere o voragine della circonferenza creduta di 3 miglia. Quel monte tremendo per le sue eruzioni di torrenti di lave infocate che tra le fiamme han subissato in vari tempi villaggi campagne e città è forse principal cagione con lo svolgimento interno delle materie infiammabili della feracità della Sicilia, e de’ suoi frequenti tremuoti. Esso è riguardato come un ricco e svariato museo delle più singolari produzioni naturali in erbe alberi arbusti, minerali, metalli, fossili, uccelli e animali d’ogni genere, e per la sua immensa ampie<zza> della circonferenza delle falde di eleva_________________________________ A c. 73r nota in calce: “(1) fiorì in Roma verso la fin del I secolo di G.C. e in quel modo scrisse nella sua ***”. <Caius Iulius Solinus, Collectanea rerum memorabilium, 10>. 60 A c. 73r nota in calce: “(1) Poly hist. c. II”. <Polybius, Historiae, 1, 42, 1-7>. 59 41 tezza che par che tocchi il cielo e per li suoi svariati fenomoni [!] è stato oggetto sempre dello studio de’ naturalisti nazionali e stranieri, e argomento sublime de’ poeti i quali hanno immaginato nelle sue profonde interne caverne Encelado, Tifeo e gli altri giganti fulminati da Giove d’essere calcati dall’enorme peso di quella enorme smisurata mole. Né a quella bizzarra fantasia si sono arresta [!]; ma la Sicilia han reso culla di alcune divinità, e di altre sede prediletta. Cerere, già regina de’ Sicani, fu creduta nascere in Enna, e speculare e favorire l’agricoltura insegnando a’ villici l’arte di seminar e mietere il frumento per miglior<are> quello che producea spontaneo la nostra terra. Giove la sedusse ed essa gli partorì Proserpina a cui fe dono dell’isola e alla genitrice dell’impero; quando dopo d’essere stata rapita Proserpina da Plutone, ne combinò le nozze. Giove stesso, al dir dei poeti, adescò al suo amore la ninfa Talia siciliana e la rese madre degli dei Palici (2)61 Minerva e Diana preferivano a soggiorno di diletto la Sicilia e la prima avea scelto Ortigia e l’altra Imera che condusse a que’ bagni Ercole stanco de’ suoi viaggi e molte prodezze operò in Erice, e altrove. Mercurio generò da una ninfa siciliana fra una selva di allori consegnata alle muse il pastorello Dafni che fu indi inventore della poesia bucolica (1)62. Venere non lasciava di prodigar i suoi galanti favori in Sicilia ch’era prediletta e qui diè in luce al suo amante Bute o Boeto ch’era re, il fanciullo Erice che divenne robusto lottatore e innalzò un tempio nella contrada di quel nome che dominava. La dea della bellezza e della voluttà non dimenticava il figlio, e ogni anno a primavera, preceduto da un nuvolo di colombe, recavasi come per villeggiare in Erice e a ricevere omaggi e sacrifizii nel suo tempio che divenne ricca e famosa. Essa però non potè preservare il suo figlio dalla forza di Ercole nella lotta e ne fu atterrato (2)63. Vulcano stabilì la sua fucina ferraria nelle caverne dell’Etna per fabbricare i suoi fulmini a Giove, ed Eolo l’isola di Lipari che fra le altre fa corona alla Sicilia, per dominare e regolare i venti. La fantasia de’ poeti ammaliata dalla nostra isola non solo creava numi, _________________________________ 61 A c. 73v due note in calce, ma per la prima non risulta corrispondenza nel testo: “(1) Diod. lib. V, c. 2; Strab. lib. VII; Cic. in Ver. 5; Lactan, de fal. relig. c. 21.” <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, V, 2-4; Strabo, Geographica, VI, 2, 1-11; Marcus Tullius Cicero, Orationes. Verrinae, II, 4, 106112; Lucius Caelius Firmianus Lactantius, Divinae Institutiones. 1. De falsa religione deorum, 21>. “(2) Esch. Compend. di St. f. Macrob. l. V c. 19” <Ambrosius Aurelius Theodosius Macrobius, Saturnalia, V, 19, 18>. 62 A c. 74 r nota in calce: “(1) Diod. Lib. IV”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, IV, 83-84>. 63 A c. 74 r nota in calce: “(2) Diod. Virg. Aen. Lib V”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, IV, 23; Publius Vergilius Maro, Aeneis, 5>. 42 e intrecciava i loro amori per esaltarla; ma ne trascinava alcuni dall’Egitto, e dalla Grecia. Iside per ciò fu trasportata dal Nilo e trasformata in Cerere siciliana e così Saturno, Giano, Bacco recaronsi qui e l’onorarono di lor presenza. Anche i Ciclopi feroci antropofaci[!], popoli Arimaspi della Scizia sull’Eussino furon regalati con un solo occhio in fronte alla Sicilia divenuta teatro di fantasmagorie. Essi e i filosofi occorrevano a visitarla, e ripararvi per trovar asilo e fortuna. Qui sospettasi di esser venuto Omero (3)64 (ma è certo), i filosofi Xenofane Colofonio, Protagora di Abdera, Zenone di Elea, Aristippo di ***, Pitagora, Filostrato, Xenocrate, Elicona, Fetone, Carcino, Platone ateniese ed Eudosso suo scolare, i poeti Archia di Antiochia, Filosseno il tragico, Eschine sotto Pindaro, Simonide e il suo nipote Bacchilide, Filosseno da Citera ed altri. Introduzione alla istoria delle belle arti siciliane L’istoria delle arti industriali che servono a’ bisogni della vita e si sviluppano per l’ingegno dell’uomo co’ primordi delle società è antichissima presso tutte le nazioni. E queste arti dette meccaniche, perfezionandosi grado grado con la sua progressiva cultura intellettuale, lo eccitarono a procurarsi quelle di diletto che belle indi vennero appellate avendo per iscopo l’imitazione di ciò che presenta di bello nelle opere sulla multiforme e svariata natura. La vetustà di queste due specie di arti in Sicilia rimonta a’ tempi favolosi. La mente de’ suoi abitatori in tutte le epoche più o meno col favor di infinite circostanze benigne o avverse commossa dall’influenza del clima fervido e salubre e dalla terra produttrice di quanto avvia di meglio altrove e atteggiata sempre al riso di primavera tra fiori perenni divenne anch’essa feconda di opere d’ingegno, d’industria e di gusto squisito. La buccolica, la lirica, la commedia, il ballo qui vantano inventori e cultori di prim’ordine. Nella matematica, nella meccanica, nell’astronomia, nell’agricoltura e pastorizia, nelle scienze fisiche i siciliani segnalaronsi per le loro particolari speculazioni e vieppiù nel lungo periodo delle greche colonie con le quali si frammischiarono ed esercitarono a gara il loro mirabile ingegno divenendo poi unica famiglia. Ma i Greci trovarono in quest’isola popoli più antichi che iniziato avevano la pubblica cultura sulle arti meccaniche e del disegno. _________________________________ A c. 74 r nota in calce: “(3) Valguarnera, De orig. Pan. pag. 89 e seg.” <Mariano Valguarnera, Discorso dell’origine ed antichità di Palermo, e de’ primi abitatori della Sicilia, e dell’Italia, In Palermo, per Gio. Battista Maringo, 1614, p. 89 e seg.>. 64 43 Ciclopi Questa razza di uomini grandi e robusti che per la loro forza e ferocia divenne proverbiale ed incitò la fantasia de’ poeti e innanzi agli altri di Omero (1)65. Primo pittor delle memorie antiche e indi di Pindaro, di Callimaco, di Euripide, di Teocrito l’esistenza del quale è contestata benanco da’ filosofi e istorici (2)66 è stata illustrata e confermata da moderni eruditi per modo che non puossi più dubitare che fosse un popolo della più remota antichità che primariamente abitò la Sicilia. Molti ne hanno indagata l’origine e il dotto mio amico Giuseppe Alessi riferisce de’ principali scrittori le opinioni (3)67 e parmi che abbia provato con molti validi argomenti di essere di quella razza di uomini che nomadi dalla Fenicia trascorsero in Grecia a fabbricar città scortati da Cadmo vennero indi in Egitto, si diffusero in Africa, in Sardegna, in Sicilia, in Melita e in Spagna (4)68. Proemio alla storia delle belle arti siciliane Tutti i popoli della terra, secondo la maggiore e minore influenza della loro peculiare fisica organizzazione, de’ luoghi nativi, e del clima con lo stimolo del bisogno, e del diletto, la guida della ragione prerogativa da Dio più o meno a tutti concessa, sono suscettivi anche nella fitta ignoranza de’primordi sociali d’una tal quale industria che li spinge ad acquistarsi i comodi della vita meno ad evitarne i pericoli o i disagi. Da questo direi quasi istinto procede l’origine delle arti meccaniche, e da queste le posteriori imitative del bello. La storia delle più antiche nazioni conferma quanto ho detto. I figli di Adamo cominciarono a costruire città onde sorsero Naidi Enova e da Caino Enochia. Noè si costruì l’arca in cui salvò se stesso, la sua famiglia e le coppie degli animali dal diluvio universale. Ripristinato il genere umano nacque _________________________________ A c. 75v nota in calce: “(1) Odissea lib. V e VI e Schol. lib. IX” <Homerus, Odyssea, 9, 134-147>. A c. 75v nota in calce: “(2) Platone, Strabone,Tucidide, Giustino, Solino, Plinio nelle rispettive loro opere”. <Plato, Leges, II; Strabo, Geographica, 1; Thucydides, Historiae, 6; Marcus Iunianus Iustinus, Historiae Philippicae, 4, II, 1-3; Caius Iulius Solinus, Collectanea rerum memorabilium, 10; Gaius Plinius Secundus, Naturalis historia, III, 8>. 67 A c. 75v nota in calce: “(3) Stor. Crit. di Sicilia, Catania per Sciuto 1834, vol. I, cap. I, pag. 11 e seg.” <Giuseppe Alessi, Storia critica di Sicilia dall’epoca favolosa insino alla caduta dell’Impero romano, Catania, dai torchi de FF. Sciuto, 1834-1843, 3 v. in 5 t.>. Cfr. anche Bibbia. Genesi, VI, 4 (C’erano poi in quel tempo sopra la terra dei giganti … uomini potenti, famosi nel mondo). 68 A c. 75v nota in calce: “(4) Diod. Sic. Lib. V”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica>. 65 66 44 insieme con essi lo spirito di discordia e di ambizione per la guerra desolatrice e con essa si specularono le armi micidiali. Alcuni credono che Setos abbia inventato le lettere. L’industria edificatoria era giunta alla sua perfezione quando il pazzo orgoglio di alcuni uomini li spinse a edificare l’immensa torre di Babele con la quale presumevasi di avvicinarsi al cielo onde fra gli operai ne nacque la confusione del linguaggio e l’arditissima opera rimase imperfetta. Abele speculò la pastorizia, Caino l’agricoltura, Lamech la caccia, Iabel le capanne pei pastori, Iubal la musica e alcuni strumenti, la famiglia di Noè il lanificio, e il modo di tessere, Tubalcain l’arte ferraria, e sin dai tempi più remoti fuvvi chi costruissi delle zattere con tronchi d’alberi connessi per valicare i fiumi e trascorrere lungo le sponde marittime e tragittare i punti più vicini da un capo ad un altro. Nico primo re degli Assiri par che sia stato il primo a piegare l’industria edificatoria ad arte che aveva il primo elemento del bello, perocchè fe’ costruire un tempio e un simulacro a suo padre Belo e a promuoverne il culto e un simulacro in figure effigiate e quello più esteso degl’idoli in Belfagor Belial e Belzebub. L’arte plastica credesi inventata da Tareemo padre di Abramo (1)69. Ecco i primi rudimenti dell’architettura e della scultura coi modelli in creta poscia eseguiti in legno e da ultimo in marmo e in bronzo, che si diffusero ben tosto per l’Egitto e indi per la Grecia e per opera dei Pelasghi in Italia presso gli Etruschi e da lì in Sicilia se pure come opina il Mazzocchi70 l’industria e le prime informi arti belle non sorsero in Italia senza introduzione degli stranieri. Certo è bensì che a noi furono trasmessi dai Sicani, che qui passarono dal vicino continente e dai Fenicj che quasi allo stesso tempo occupando varî luoghi marittimi della Sicilia le recarono dall’Egitto col culto di alcune loro peculiari divinità come appresso vedremo. Alle colonie greche non si deve che il miglioramento di queste arti che trovarono da più secoli qui introdotte. La Sicilia come isola ricever non poteva i primi elementi di ogni cultura che dai popoli del vicino continente, ai quali colle zattere nei tempi tranquilli era facile di passare e così a Fenici che riconosconsi uni_________________________________ A c. 76v nota in calce: “(1) Iosuè 14”. <Bibbia. Giosuè, 24> Alessio Simmaco Mazzocchi, Dissertazione sopra l’origine dei Tirreni. In: Saggi di dissertazioni … lette nella nobile Accademia Etrusca di Cortona, III, 1741, p. 1-66. La dissertazione fu poi ristampata, postuma, insieme ad altri scritti del Mazzocchi, nel secondo tomo degli Opuscula quibus orationes, dedicationes, epistolae, inscriptiones, carmina ac diatribae continentur, Neapoli, apud Raymundos, 1771-1775, v. 2, p. 75-204. 69 70 45 versalmente come i primi navigatori della terra, i quali colla cultura che avevano attinto dappertutto e coll’attività del commercio a cui erano addetti promossero nei paesi occupati la civiltà, procurarono a loro stessi e alle nazioni ricchezza collo scambio e l’acquisto reciproco delle produzioni di ogni paese. I Greci scrittori ambiziosi di acquistar fama ai loro connazionali, trascurarono maliziosamente di raccoglierne le tradizioni dei Fenicj dei Pelasghi, dei Sicoli, dei Sicani e di altri popoli che li precessero onde ascriverne la gloria di ogni invenzione ai medesimi e soltanto nel sincero istorico Diodoro Siculo assai tardi ne potè raccogliere poche memorie, mentre gli altri storici greci trombettavano i fasti dei loro connazionali. Ma certo si è che con la religione di questi popoli esteri sorsero tempî, altari e simulacri e pubblici edifizî all’uso sociale e noi conosciamo i nomi delle loro divinità, alcune delle quali adottarono gli stessi greci cambiandone i nomi nella loro lingua, talchè parvero greche, ma l’istoria ci avverte di avere avuto in quest’isola tempî, e simulacri molti secoli prima che gli Elleni occupassero l’Isola nostra. Introduzione all’istoria delle belle arti di Agostino Gallo L’uomo dappertutto segue l’origine divina della mente che ha ricevuto dal supremo Fattore l’attitudine a specular nuove cose prima a sua immediata utilità e poi a suo diletto. Appena in tempi immemorabili e antistorici avvicinossi in piccole borgate a’ suoi simili per legami di famiglia che manchevole di tutto ciò ch’eragli necessario, per effetto di una certa industria datagli da Dio fra i tanti privilegi sugli altri animali diessi ad aizzar il suo rozzo intelletto a procurarsi il bisognevole al suo sostentamento, a difendere il suo corpo dall’intemperie cercando un ricovero pria nelle grotte e cresciuta la sua specie ed esaurite quelle a scavarsele ne’ monti di fragile tufo, come per la prima età del mondo si osserva dovunque, e in Sicilia in interi villaggi capaci a contenere in quelle cave qualche migliajo di persone. Quelle piccole città appellansi dagli archeologi trogolitiche e noi possiamo mostrarne almeno tre come appresso dimostreremo. I dotti han diviso quella prima epoca da loro detta archeolitica, in più successive, cioè in quella neolitica così denominata da Michele Leicht, che presenta parecchi avanzi di umano lavoro in diversi oggetti necessarî eseguiti in pietra o in ossa di animali aguzzati per mancanza di strumenti non essendo ancora scoverto ne’ adoprato il ferro. 46 In quest’età antecedente anche nelle tradizioni istoriche si sono trovate in vari luoghi d’Italia e di Sicilia e d’altrove arnesi e strumenti di selce agli usi domestici e sociali, ed armi come coltelli, brandi, frecce e sinanco aghi d’osso. E siccome la pietra è la materia principale che offriva spontanea la natura all’uso domestico prima dell’invenzione del rame e del ferro, così quell’età remotissima venne dai dotti denominata età della pietra. Segue indi tra l’epoche anteriori all’istoria quelle del bronzo e indi l’altra del ferro. Io crederei invero che (1)71 preceder dovesse quello del ferro, perocchè il bronzo composto del primo era con *** e la materia di base alla composizione del secondo, e fa supporre uno sviluppo maggiore di anni. Con queste epoche si chiudono le fasi della vita dell’umanità anteriori alla tradizione storica. E poiché tutti gli accennati lavori in selce, ossi d’animali, rame, ferro, fan supporre negli uomini primitivi un’industria onde procurarsi in quel modo che potevano gli utensili loro necessarî anche nei tempî delle loro primitive rozzezze. Così puossi scorgere da tutti questi lavori che si conservano già in tutti i musei d’Italia e degli altri regni di Europa la processione dello sviluppo del loro ingegno che li spingea gradatamente dall’industria meccanica a quelle di maggior perfezione dopo che il rame e il ferro l’argento, e l’oro ed altri metalli, furono scoverti. E siccome le belle arti procedenti dall’industria dell’imitazione figlia di quelle che abbiamo accennato è propria degl’uomini già muniti in ampi consorzî sociali, e che per il loro maggiore sviluppo meccanico ed intellettuale e per l’agiatezza coi commerci reciproci amano di congiungere alle arti di necessità quelle di diletto, così in questo periodo è da riconoscersi ch’è quello delle belle arti, anch’esse progressive fino alla perfezione, cui poterono attingere in più secoli. La creta ne apprestò loro la materia e di essa già avevano fatto uso anche sin dall’epoca primitivissima detta di pietra formando delle pignatte e delle ciotole per comodo domestico. Or della creta si valsero per modellar colle dita bovi, pecore, caprioli, ed altri animali. La religione fu istintiva in chiunque osservando le bellezze dell’universo, deve supporre un essere superiore che le abbia create s’industriò ad affigurarlo rozzamente in quella materia e indi in legno ad imitazione delle propria figura; perocchè altra non sapeva imaginarne. Per la grossolana scultura in legno si valse del rame o del ferro per for_________________________________ 71 A c. 82r nota in calce: “(1) Annuario scientifico e industriale, Firenze 1868, p. 137-139”. 47 marne gli strumenti all’uopo. E poi aguzzando vieppiù l’ingegno e suscitato colla selce il fuoco riuscì loro di liquefar dei metalli e sui modelli di creta ben disseccata al sole cavarne le forme e indi i rilievi in detti metalli Omero accenna le armi de’ combattenti nell’assedio di Troja non in ferro ma in rame. E ciò si farebbe credere che prima fosse ritrovato questo metallo che l’altro. E come la razza ciclopica delle terza generazione furono riconosciuti da Aristotele e dal Boccaccio come uomini industriosi, ferrarî, e muniafabri, inventori delle torri è detto uno che abitasse in Sicilia nelle caverne dell’Etna e nelle vicine isole Eolie, a foggiare armi, elmi e scudi ed altri ad assicurar i piccoli consorzî sociali con elevar con pietre mura, e piccoli propugnacoli dall’invasione de’ nemici. Così l’arte ferraria e muraria è supposto di essere state coltivate ne’ tempi antistorici in Sicilia. Ma prima era prevalsa l’industria, come dissi, di scavare l’abitazioni in seno dei monti di tufo ad imitazion delle grotte. Belle arti antichissime in Sicilia Le belle arti in Sicilia rimontano a si recondita antichità che s’innestano con la favola e prendono origine dalla stessa. E sebbene essa non rappresenti nudamente il vero, pure l’adombra in modo con ingegnosa allegoria, procedendo dalle più vetuste memorie tradizionali de’ popoli che ci additano i primi elementi dell’istoria. Or siccome la Sicilia è la regione della favola, narrandosi che qui abbiano avuto culla o soggiorno molte divinità del paganesimo (1)72, è avvenuto che anche quella falsa religione, eccitando con l’influenza del fervido clima e la fertilità straordinaria della terra ornata d’una perenne primavera, la mente ed il cuore de’ suoi abitatori, la poesia primogenita delle belle arti, sia nata in quest’isola e poco dopo siano qui venute in luce le altre sue sorelle, la musica, l’architettura, la scultura e ultima la pittura alle quali la poesia è stata scorta, e direttrice, additando ad esse la fonte del bello, che con l’esca del diletto attira e seduce gli uomini, e fa inoltre servire la loro industria al culto della religione a’ vantaggi della vita sociale, e anche al lusso nell’epoca del loro perfezionamento. Si accenna da qualche antico storico un tempio innalzato sulle falde dell’Etna alla favolosa e bella Galatea, amante dell’infelice Aci, schiaccia_________________________________ 72 Al richiamo non corrisponde nota. 48 to da una rupe lanciatagli dal vendicativo e geloso Polifemo (1)73, capo de’ Ciclopi, i primi selvaggi e feroci abitatori dell’isola nostra; ma quel tempio credo io che se pur le sia stato eretto da’ nativi di quella contrada in memoria di lui esser debba posteriore di età. Non così il tempio antichissimo sacro a Vulcano sulle falde dell’Etna di cui pria Eliano(2)74 in questi sensi nella versione latina: In Aetna, Siciliae monte, sacra est Vulcani aedes, et circa eam muri et arbores sacrae. Ibidem ignis perpetuus et inexstinctus adservatur. Sunt et canes in templo lucoque sacri; qui modesté ac decenter in templum et lucum accedenteis [!] blandé et adulantes excipiunt; et tamquam familiaribus, benignos se illis ostendunt. At si quis sceleratus aut manibus impurus adeat; illum et mordent et laniant. Illos verò, qui libidine aliqua turpe se contaminarint fugant solùm et persecuuntur. E il Fazello75 nostro istorico diligente del secolo XVI soggiunge(1)76 ducenti passus infra summum. Aetnae verticem vestigium vetustissimi fornicis lateritium extare; quod a Catanensibus Aetnicolisque turris philosophi nominetur [!]. Praedicare quidpe eos, ducta a majoribus fama, hanc sibi Empedoclem olim ad explorandaos Aetnaei ignis causas ex testudinae opere constituisse aediculam. E lo stesso Fazello indi congettura di essere quella piccola casa creduta di Empedocle resto dell’antico tempio di Vulcano, e ciò sembra credibile; perocchè dopo molti secoli precedenti a quel filosofo agrigentino puossi ragionevolmente supporre che con i continui tremuoti cagionati dalle esplosioni ignee dell’Etna la fabbrica del tempio di Vulcano per quanto solida fosse stata costruita era già scrollata ed Empedocle che pure per la sublimità del suo ingegno un altro dio era reputato si fosse creduto degno di abitarlo facendone rialzare o ristorare le mura onde osservar da vicino i fenomeni naturali del monte Ignivomo, ma esser deve certamente falso quanto scrive di lui Orazio nell’Arte poetica nei seguenti versi: (1)77 … Deus immortalis haberi./ Dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Aetnam/ insinuit. Sit jus liceatque perire poetis. _________________________________ 73 A c. 85v nota in calce: “(1) Ovidio che descrive questa favola nelle sue Metamorfosi sembra che l’abbia tolto da un poema di Polisseno che fu imprigionato da Dionisio per gelosia di essersi invaghito dell’amante di quel tiranno, e il poeta intese adoprar coll’allegoria mitica il proprio infortunio mettendo in scena Dionisio sotto il nome di Polifemo, Aci come lui stesso, Galatea come la sua amante, e Ulisse come loro amico.” 74 A c. 85v nota in calce: “(2) De animal. lib. XI. cap. 3°”. <Claudius Aelianus, Varia historia, 11.3>. 75 Tommaso Fazello, De rebus Siculis decades duae, nunc primum in lucem editae … (Panormi, apud Ioannem Matthaeum Maidam, et Franciscum Carraram, 1558), p. 57. 76 A c. 86r nota in calce: “(1) Hist. Lib. XI cap. IV dec. 1a.” <Tommaso Fazello, De rebus Siculis … cit., p. 57>. 77 A c. 86v nota in calce: “(1) Arte poetica, verso la fine”. <Quintus Horatius Flaccus, Ars poetica, 461-463>. 49 Eliano si scorse della scherzosa espressione del gran lirico latino con la quale chiude la notizia popolare che Empedocle si slanciasse nella voragine dell’Etna ch’egli la deridesse; e tale esser dovea nonostante che il filosofo sia sparito dalla sua patria ove bensì con l’abolizione del consiglio dei mille nobili si era attirato potentissimi nemici, e puossi verisimilmente che l’avessero fatto trucidare spargendo fra la credula plebe la notizia che egli, non avendo potuto comprendere la causa dei fenomeni dell’Etna per disperazione vi si fosse lanciato in seno onde il sommo Scinà colla sua severa critica la smentisse. Presso il moderno comune di Adernò circa 7 miglia lontano da Centuripe sulle falde dell’Etna rammentasi da Diodoro e da Stefano la vetusta città di Adrano di cui il citato Diodoro nel lib. XIV fa cenno parlando di Dionisio e insieme di un famoso tempio dedicato al Dio Adrano di cui scrive Plutarco nella Vita di Timoleonte78 Adranitani, exiguum quidem, sed deo cuidam Hadrano, quem tota Sicilia religiosissimè veneratur oppidum incolentes etc. Alcuni storici spacciarono che Adrano fosse padre dei fratelli Palici contro l’opinione di Eschilo che li dice figliuoli di Giove. Credesi che il culto di Adrano come pure quello dei Palici fosse recato in Sicilia dalle colonie Sirie o Fenicie che vennero a stabilirvisi. Diodoro narra che a quel Dio fossero consacrati più di 100 cani che accarezzavano quelli i quali si appressavano al suo tempio e servivano di scorta anche agli ubbriachi ma sbranavano i malvagi. Ciò sembra una ripetizione dei cani addetti al tempio di Vulcano, ma pure poteva essere un’astuzia dei sacerdoti dell’uno e dell’altro Dio per allontanare i ladri da’ loro tempi e dalle case addette prossimamente agli stessi sacerdoti ove doveano essere accumulate le ricche offerte che gli stolti devoti a quei falsi numi facevano ogni giorno. I gemelli Palici di cui abbiamo fatto cenno avevano anche un tempio presso un lago ad essi sacrato non lungi dalla città di Palica in Sicilia. Secondo Macrobio (1)79 un poeta siciliano scrisse che Giove invaghitosi di una ninfa figlia di Vulcano da taluni detta Talia e da altri Etna80 l’ingravidasse ond’essa pregò Giove di nasconderla nelle viscere della terra donde dopo il parto emersero i due gemelli detti Palici dal significato fan_________________________________ Plutarco, Vita di Timoleonte <Plutarchus, Vitae parallelae. Timoleon, 12, 2>. A c. 87r nota in calce: “(1) Satur. 5 c. 10”. <Ambrosius Aurelius Theodosius Macrobius, Saturnalia, 5, 18-23>. 80 Seguono cancellate le parole: “generasse i due gemelli Palici e per sottrarli alla vista e al risentimento di Giunone pregò l’amante”. 78 79 50 ciulli usciti dalla terra. Essi furono riguardati come semidei ed avevano un tempio presso un piccolo lago d’acqua bollente; il popolo credeva che ivi fosse la culla ond’erano usciti in luce. In quel tempio e innanzi al lago si facevano giuramenti solenni e quelli che vi erano ammessi si purificavano e indi giuravano ai Palici di dovere pagare una forte ammenda se divenissero spergiuri oltre che erano sommersi nel lago o morivano di morte repentina. Quel tempio serviva di asilo agli schiavi maltrattati dai loro81 spietati padroni i quali erano obbligati a promettere a quei semidei ove li volessero riavere a trattarli con una uma<ni>tà il che adempivano per timore di esserne severamente puniti in caso contrario. Questa superstizione suggerita dai sacerdoti divenne utile all’umanità e i ricchi e copiosi doni presentati a quei numi l’impinguavano intanto e facevano loro profferir i soliti ambigui oracoli e crebbe tanto il fanatismo che s’immolavano vittime umane. Ciò mi conferma nell’opinione che sotto la dominazione dei Cartaginiesi dovette introdursi questo nefando abuso della religione; perocchè quei popoli feroci erano usi a tali infami sacrifizî che poi solennemente nel trattato di pace concesso ad essi da Gelone dopo la loro disfatta furono aboliti anche nella regione di Sicilia da lor dominata dove si avevano introdotti per il costume della loro madre patria. Altro tempio antichissimo fu quello edificato da Orione82 presso il faro in Messina e sacrato a Nettuno. Credono alcuni mitologi siciliani ch’ei fosse figlio di Giove, altri di Nettuno ed altri Mercurio. Fu egli di gigantesca statura, amantissimo della caccia e dell’arte fabbrile appresa da Vulcano e divenuto signore di Zancla dopo Zancloto migliorò il porto naturale detto Aetna cingendolo di scogliere, innalzò vari delubri alle divinità fra i quali quello di Nettuno anzi citato che accennasi al di qua del capo Peloro al dir di Diodoro, di Esiodo e di Solino, ampliò e munì di torri la città; onde alla morte gli furono resi onori divini e fu creduto appunto in esilio tra le costellazioni. Questo personaggio, in parte favoloso ed in parte istorico tradizionale lasciò memoria ai posteri delle opere sue e sin dai tempi di Diodoro e anche adesso ne vengono indicati i ruderi. Altro tempio di venustissima antichità fu quello dedicato a Venere in Erice città di Sicilia distante da Trapani circa mille passi. Elevatasi quello sopra un monte che Solino83 dice: Eminet Sicilia montibus Aetna et Eryce _________________________________ Segue cancellata la parola: “immani”. Seguono cancellate le parole: “figlio di Serapione”. 83 Solino <Caius Iulius Solinus, Collectanea rerum memorabilium, 10>. 81 82 51 e Meda84 accenna montium Erix maxime memoratur ob delubrum Veneri ab Aenea conditum e Polipio85 [!] scrivendo di quel monte il più alto dopo l’Etna così si esprime: Habet hic in vertice planicium, cui immolita est Veneris Ericinae aedes; omnium sine controversia, quae tota insula spectatur, et divitiis et reliquo curtu86 longe clarissima. Urbs subixum verticem posita est: adscenditurque ad illam longa admodum hac difficili via. Quel tempio che Virgilio dice di essere stato edificato da Enea puossi più verisimilmente attribuire ad Aceste suo concittadino che lo accolse amorevolmente non essendo probabile che il profugo troiano nella sua breve dimora in Sicilia abbia potuto fabbricar tempî, anzi Diodoro dice chiaramente ch’Erice figlio di Venere e di Buta lo edificò così esprimendosi: in cujus arce templum matri condidit; omnique adparatu et donariorum copia exornavit. Dea igitur cum pietati incolarum tum filii post mortem honori hoc rependit ut urbem ad prime coram haberet, eamque Ericinam Venerem appellaret. Tomi hujus religiosi maiestatem si quis accuratius percitat, merita id admiratione prosequatur. Alia quidpe templa post aliqua gloriae incrementa adversi saepe casus labefactant et convellunt, ut hujus fani cultus a primo dedicationis esordio tantum habest ut defecerit, ut contra sub inde majus acceperit augumentum; nam post honores habi Eryce institutos, Aeneas Veneris filius cum Italiam petiturus ad Siciliam appelleret, multis templum bonis, quod matri consecratum esset, exornavit. At post cum Sicani per multos aetates impensa deam coluere, magnificisque templum sacris et donariis antius et illustrius reddiderunt subsequentiis hine temporibus Carthaginensis, parte Insulae in ditionem redacta, exprimi deam cultu prosequi non destiterunt. Et Romani tandem, tota Insula potiti, honorum amplitudine omnes ante se longe superarunt. Idque haud in merito, unum enim generis sui ortum ad ipsam deam rediverunt; et propitiam in rebus grandis fortunam id cicoexpediderunt: auctorem tanti incrementiconveniente gratia, et honore remunerarunt. Consules namque et praetores, et quiqunque [!] cum imperio in Insulam proficiscuntur, ubi ad Erycem perveniunt, sacris et honoribus augustis templum decorant, et severitate magistrates sui paullisper deposita, ad lusus et conversationem cum mulieribus se convertunt, nec alio, quam hoc, parto gratam se deae forturas praesentiam suone exsistimant. Hac senatus romanum simulari quodam in honores deae propentione, decreto suo statuit, ut fidelissimae per Siciliam civitates quae numero sunt aurum Veneri conferant, et duae militum centuriae pro templi custodia strationen agant. (1)87 _________________________________ Leggasi: “Mela”. <Pomponius Mela, Chorographia, 2, 104>. Polibio <Polybius, Historiae, 1, 55, 8-9>. 86 Leggasi: “cultu”. 87 A c. 90r nota in calce: “(1) Diodo lib. IV in fine”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, IV, 83>. 84 85 52 Su Dedalo artista Ateniese venuto in Sicilia Dedalo interessa le arti siciliane, a cui die’ vita e movimento, recandosi nell’isola nostra, e quindi di lui ragioneremo, dopo diligenti ricerche, spogliandolo del prestigio della favola, onde lo cinse l’antichità, per ridurlo a personaggio istorico, qual si fu. A lui devono tanto le arti meccaniche e liberali, e la Sicilia in particolare per averle qui spinte innanzi, e lasciatavi fiorentissima scuola, che poi fu ridotta a perfezione dopo parecchi secoli dalle greche colonie sovraggiuntevi. Di Dedalo molti hanno scritto. Il Tiraboschi riguardollo come un essere favoloso dimenticando che in Sicilia esistevano al tempo di Diodoro le sue opere di architettura e di scultura altronde contestate da Platone, Aristotile, Luciano, Callistrato, Pausania e rammentate da Plinio e in fine da Giunio88 e da Lessing89 ne’ loro cataloghi degli antichi artisti. L’abbate [Nicolas] Gedoyn ne scrisse un’erudita dissertazione, inserita nel tomo XIII dell’Accademia francese d’iscrizioni e belle lettere, della quale ci siamo in parte giovati, in parte di quello del nostro amico Ambrogio Baldi [!] Genovese che provò la realtà di lui e delle opere attribuitegli (1)90. Tutti gli scrittori han sostenuto che vi furono più Dedali; anzi il suo nome divenne titolo di onore di alcuni artisti, posteriori al più antico, che se l’appropriarono, e fra questi oltre il primo di cui ragioniamo ch’era nativo di Atene, un secondi [!] di Sicione nell’Acaja, figlio ed allievo di Patroclo che visse pochi anni appresso e un altro di Bitinia, noto per una statua di Giove Strazio, cioè dio degli eserciti. Gli Ateniesi li confusero insieme o per ignoranza, o per vanità di cumulare i pregi di tutti in uno solo ch’era lor concittadino e l’adornarono inoltre di mitiche fantasie, facendone oggetto di meraviglia, particolarmente per la supposta invenzione delle ali congiunte colla cera colle quali spacciarono di esser fuggito col figlio Icaro dalla prigione di Minosse. Difatti scorgesi quel dipinto dell’antico Ercolano nell’atto di volare riguardando il figlio che rotta un’ala ha precipitato sul lido e in due altri monumenti pubblicati Winckelmann91 secondo gli attributi datigli dalla favola. _________________________________ François Du Jon, De pictura veterum libri tres, Amstelaedami, apud Johannem Blaeu, 1637, p. 299. Gotthold Ephraim Lessing, Laocoonte. Prima versione integra, con introduzione e note a cura di Emma Sola, Firenze, G.C. Sansoni, [1925], p. 272-273. 90 A c. 95r nota in calce: “(1) Balbi, Opuscoli, Palermo, Tipogr. del Gior. sett. 1833. <Ambrogio Balbi, “Di Dedalo e della realtà di tutte le opere a lui attribuite. Dissertazione …” in Giornale di scienze lettere ed arti per la Sicilia, v. XLI, a. XI (gen.-mar. 1833), p. 61-91>. 91 Il Gallo rielabora la nota della traduzione italiana dell’opera di Johann Joachim Winckelmann, Storia delle arti del disegno presso gli antichi, Milano, nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1779, v. 2, p. 134, nota 2. 88 89 53 Questo prisco Dedalo nacque in Atene e viveva al tempo di Ercole libico, di Teseo e di Edipo e del 3° Minosse re di Creta e certo di Cocalo re dei Sicani circa mezzo secolo prima della guerra di Troja avvenuta secondone le Tavole cronologiche di Blair92 1184 anni prima di Gesù Cristo. Il Balbi troppo recisamente scrive che non poteva esser nato prima più tardi dell’anno del mondo 2705 abbenchè abbia cominciato a figurare nella storia con alcuni dei surriferiti personaggi; ma in fatto di cronologia antica conviene essere più cauti ad indicare gli anni con sicurezza e precisione. Dedalo secondo narraci Diodoro fu figlio di Metione nipote di Erecteo VI re di Atene e secondo Pausania di Palamone che il Gedoyn93 corregge in Eupalamo. Dopo il diluvio di Decaudione erano appena trascorsi come credesi 150 o poco più anni e la Grecia era ricaduta per le lettere e le arti iniziatevi nella più tenebrosa ignoranza ma in Egitto si conservavano e particolarmente quella di fabricare attribuita a Tucorto successore di Menete suo primo monarca (1)94. I Greci avevano imparato a disegnare e modellare le statue dagli Egiziani le quali invero erano rozzissime colle braccia pendenti e attaccate al busto e le gambe e i piedi riuniti e le figure informi e senza atteggiamento e vita così era la statua di Mennone rammentata da Filostrato (1)95. Al tempo di Semiramide la pittura acquistò i colori al naturale nel suo palazzo onde scorgevasi rappresentata quella regina che col dardo feriva una tigre e Nino colla lancia un leone ed ivi erano collocate le statue di Giove Belo di Nino di Semiramide e dei principali cortigiani (2)96. _________________________________ 92 John Blair, The chronology and history of the world from the creation to the year of Christ, 1753, London, printed in the year 1754. 93 Pausanias, Pausanias, ou voyage historique de la Grece traduit en françois avec des remarques par M. l’Abbé [Nicolas] Gedoyn, chanoine de la Sainte Chapelle ... tome premiere [-quatrieme], A Amsterdam, aux depens de La Compagnie, 1733. 94 A c. 95v nota in calce: “(1) Syncell pag. 56 B Marsh pag. 43” <Georgius Syncellus, ... Georgii monachi et S.P.N. Tarasii patriarchae CP. quondam Syncelli Chronographia, ab Adamo vsque ad Diocletianum. Et Nicephori patriarchae CP. Breviarium chronographicum, ab Adamo ad Michaelis et eius F. Theophili tempora ; Georgius Syncellus è Bibliotheca Regia nunc primum, adiecta versione latina, editus. Nicephori Breviarum ad varias editiones recensitum. His tabulae chronologicae et annotationes additae. Cura et studio p. Iacobi Goar ... Parisiis, e typographia Regia, 1652 (Parisiis, in Typographia regia curante Sebastiano Cramoisy, regis ac reginae architypographo, 1652). John Marsham, Canon chronicus Aegiptiacus, Ebraicus, Graecus, et disquisitiones. Liber non chronologicae tantùm, sed & historicae antiquitatis reconditissima complexus. Londini primùm a. 1672 editus. Deindè in Germania recusus, nunc verò longè emendatior typis expressus, adjectis locorum Scripturae, Auctorum, & rerum indicibus locupletissimis. Franequerae, ex Officinâ, Leonardi Strick bibliopolae, 1696>. 95 A c. 96r nota in calce: “(1) De vit. Apollon. L 6 C 4”. <Flavius Philostratus, Vita Apollonii, l. 6, c. 4>. 96 A c. 96r nota in calce: “(2) Diod. L. 2, pag 121 e seg.” <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, II, 8. 6-7>. 54 L’origine in generale del disegno indi applicato alla scultura, alla pittura e cisellatura vanta maggiore antichità e a quest’ultima sin dai tempi di Abramo e di Giacobbe in cui era già prevalso per l’Asia e per l’Egitto l’uso di modellare idoli. Dedalo non trovava in Atene ne modelli di opere d’arte ne maestri che sodisfacessero il suo genio conoscendo per la fama ch’erasi acquistato l’Egitto coi grandi monumenti che ivi soltanto con quegli ajuti divenir poteva un grande artista e difatti recatovisi (3)97 e contemplativi i grandi monumenti divenne il primo artista di Grecia del suo tempo. Attirò la sua attenzione il vasto ingegnoso e avviluppato labirinto fattovi costruire da Mendete antichissimo re (4)98 di Egitto come pure la proporzione delle statue migliore di quelle informi che avea lasciato in Grecia studiò grandiosi e vetusti edifizî anzi architettò (essendosi ivi già acquistata fama) il bellissimo andito del tempio di Vulcano tenuto in gran pregio dagli stessi egiziani quali gli permisero di potere inalzare la sua statua da lui stesso scolpita in legno e gli decretarono onori divini in un tempio edificatogli nell’isole vicine a Menfi che divenne oggetto di culto religioso per quegli indigeni suoi ammiratori. Dedalo fornito com’era di tutte le cognizioni che appreso avea in Egitto antica sede della sapienza e delle arti, ove pure attinto le aveano Orfeo, Museo, Melampode, Omero, Licurgo, Solone, Platone Pitagora, Eudosso, Democrito ed Euripide99 come riferisce Diodoro avere appreso da sacerdoti, ritornò in Atene sicuro che col proprio ingegno maturandole e recandovi maggiore sviluppamento sarebbe stato bene accolto ed esaltato dai suoi concittadini. E lo fu difatto perocchè Atene penuriando allora di artisti riguardollo alle prime opere che egli fece come un dio ma poco durò ivi la sua fama, la stima e l’affetto dei suoi concittadini. Imperciocchè ambizioso egli era di unicità di merito invido dell’altrui e vendicativo di chi attentasse di rapirgli alcun pregio nell’arte. Aveva egli educato in essa Talo (2)100 figlio d’una sua sorella il quale gareggiava anzi superava nell’invenzione il medesimo maestro onde egli _________________________________ 97 A c. 96r nota in calce: “(3) Diod. l. 1° riferisce che sacerdoti egiziani rammentavano fra gli altri uomini illustri di Grecia e di altrove Dedalo di avere soggiornato in Egitto”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, I, 96>. 98 A c. 96r nota in calce: “(4) A detta di sacerdoti e confermato dallo stesso Diodoro lib.1”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, I, 61>. 99 A c. 96v nota in calce: “(1) Diod. Lib. 1°”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, I, 96-98> 100 A c. 96v nota in calce: “(2) Plinio lo appella perDice lib. X C. 20”. <Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia>. Nel libro X Plinio parla delle pernici, in latino perdix. 55 avendo osservato la mandibola dentata di un serpente, l’imitò col ferro ritrovandovi dei dentucci e ne formò una sega per separare le parti del legno all’uopo dell’arte sua, speculò pure il tornio ed altri istrumenti pei quali fu da tutti ammirato e ivi suscitò livore in Dedalo e temendo che fosse in seguito ecclissata la propria gloria lo precipitò d’una torre e dopo di avere scavata la terra per seppellirne il cadavere fu sorpreso da qualcuno e richiesto chi avesse inumato dissegli: un serpente ricordandosi che quegli da un serpente tratto aveva l’idea della sega. Scoverto il suo delitto e dannato a morte dall’Areopago fuggì e ricovrossi nascondendosi in una contrada dell’Affrica onde poscia quegli abitanti per memoria chiamavansi Dedalidi (1)101. Non credendosi Dedalo ivi sicuro delle ricerche del governo di Atene rifuggissi in Creta ove acquistò la stima dapria di Minos terzo re di quel nome per avergli scolpito in legno la statua delle sue figlie Fedra ed Arianna e della dea Britamarte venerata in quel paese. Nel doppio magistero di architetto e di scultore inventò allora o prima la livella e l’ascia e secondo Plinio il succhiello, il filo a piombo e perfino la colla di pesce (2)102 e poscia speculò alcuni ordigni per far muovere e caminare i simulacri ai quali già dato avea un’aria di vita che mancava a quelli di Egitto aprendone le palpebre e toccandone le mani accollate alle cosce talché quelle sue statue sembrarono meravigliose. D’allora divenne egli il prediletto della corte di Minos e il confidente della regina Pasifae la quale innamoratasi di Tauro servo di Minasse (1)103 era secretamente favorita nel maneggio dei suoi amori da Dedalo. Avvenne allora che ella partorisse due gemelli uno somigliante a Minos e l’altro a Tauro e da ciò sorse la favola di aver dato in luce un Minotauro dopo che quell’artista ateniese le avea occultamente scolpito un tauro per sodisfarne la libidine e all’uopo seguito avea un labirinto come quello come quello di Mendete osservato in Egitto affinchè la regina, soltanto con un filo potesse fra gli intricati andirivieni penetrare nel sito di convegno ritrovar l’amante ma il geloso marito scovrì tutto e allora Dedalo temendone la vendetta determinossi a fuggire col figlio Icaro aggiungendo di sua invenzione per la nave ai remi di antico uso l’aiuto delle vele; il che die’ origine alla favola di aver egli speculato di formarsi delle ali con _________________________________ A c. 97r nota in calce: “(1) Diodoro lib. 4”. <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, IV, 76> e Plinio luogo cit. <Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia>. 102 A c. 97r nota in calce: “(2) lib 7° c. 56.” <Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia, 7, 198>. 103 A c. 97v nota in calce: “(1) Servio antico speriaste di Virgilio nella sua nota al L. 6 dell’Eneide”. Nota di Maurus Servius Honoratus, conosciuto anche come Servius grammaticus, ai versi 431 e seg. del libro VI dell’Eneide. 101 56 penne conteste dalla cera e che il suo figlio men abile al volo volendosi inalzare al calore del sole sciolti i vanni naufragasse. In quel tempo godeva fama Cocalo re di Camico in Sicilia di essere ospitale e fautore degli uomini prestanti d’ingegno laonde Dedalo a lui si diresse ch’avea sede presso monte Agraganto ove poscia sorse Agrigento e ne fu accolto ma avendo inteso Minos che Dedalo erasi rifugiato in Sicilia nel doppio scopo di aver consegnato Dedalo da quel re e di vendicarsi anche di lui che lo favoriva fornì una flotta di marinai e guerrieri cretesi per occuparne il regno e giunto alla sua sponda gli richiese lo straniero fuggiasco. Cocalo tutto promise e penetrando lo scopo del re cretese finse di accoglierlo benignamente e dargli ospizio però prevenne in segreto le sue figlie di offrirgli un bagno nelle terme caldissime ed ivi serratone l’uscio farlo morir soffocato dai vapori ed eccessivi calori. E così avvenne. Fremettero allor di rabbia e di vendetta i suoi soldati, ma Cocalo offrì loro delle terre vicine e quegli adescati dalla fecondità e dal clima vi fabricarono una piccola città che ad onoranza del defunto loro re appellarono Minua dandogli ivi decorosa sepoltura. Dedalo intanto salvatosi da quella terribile bufera mostrossi riconoscente al suo benefattore e costruì per lui una cittadella o rocca ove aver potesse una regia sicura da ogni aggressione che credesi dal Cluverio104 d’essere stata denominata Onfale105 alla quale non poteva ascendersi che per via stretta e tortuosa da esser difesa di tre o quattro persone ed ivi Cocalo stabilì la sede regia e vi pose in sicuro il suo tesoro. Io credo che quella regia sia la stessa che in seno del monte Camico si osserva tuttavia e si ammira per molti raggiri sotterranei che allora ricevevano luce dalle aperture superiori e che insomma presenta una piccola città troglolite come vi fu descritta dal Cavalier Leonardo Vigo106 che la visitò. Nella vicina Megaride costruì la Colimbetra cioè a dire un gran bacino ove riunitesi le acque disperse e micidiali per quelle campagne del fiume Alabone spinte poi dalla massa e dal proprio impeto andavano a scaricarsi nel mare. Costruì pei Selinuntini una terma che coi caldi vapori e coll’uso delle acque minerali produceva un trasudamento nel corpo ed era _________________________________ Philipp Clüver, Sicilia antiqua cum minoribus insulis et adiacentibus, Lugduni Betavorum, ex Officina Elseveriana, 1619. 105 Leggasi: “Onface”. 106 Cfr. Lettera di Lionardo Vigo sugl’ipogei e catacombe di Girgenti, in Niccolò Palmeri, Memorie sulle antichità agrigentine, Palermo, dal Gabinetto tipografico all’insegna di Meli, 1832, p. 75-95. 104 57 utile a guarire diversi mali. L’antico tempio inalzato in Erice a Venere e crollante per vetustà e per trascendimento del terrreno fu da lui riparato e collocati immensi massi a impedirne lo smottamento del terreno su cui inalzavasi. E volendo egli rendersi la dea più benevola le offrì in voto un ariete d’oro mirabilmente cesellato. In Onfale [!] scolpì un simulacro d’una dea favorita dei Sicani che poscia fu trasportato in Gela all’arrivo dei Greci (1)107. Dedalo secondo si narra Diodoro, visse molto tempo presso Cocalo e i Sicani e per l’eccellenza dell’arte sua vi ebbe credito grande e vi fu assai onorato (2)108. Tra noi fondò egli una scuola alla quale non solo i siciliani accorrevano attirati dalla di lui fama ma anche gli stranieri e fra questi si accennano un Eudro, un Dipeno, uno Scillide, ed un Alcone di Mile lodato da Ovidio (1)109 per una sua tazza cisellata sebbene che fu offerta in dono da Anio re di Delo ad Enea sebbene il P. Narbone creda che l’arte del cisello sia posteriore però è da osservare che Dedalo secondo Diodoro l’avea esercitato anche prima nell’ariete d’oro presentato in dono a Venere Ericina. Dedalo sia per la morte di Cocalo sia per altre ragioni lasciò la Sicilia e passò in Sardegna chiamatovi da Iolao nipote e compagno di Ercole che vi aveva stabilito una colonia coi suoi compagni tespiadi detta Iolea e la rese ornata di molte e belle opere. Ma la Sicilia più ridente ispirava il suo genio e quivi fondò egli una scuola famosa e della medesima e dei successori fan testimonianza alcune metope selinuntine anteriori certo all’epoca greca in cui per vero l’arte migliorò di molto come per mezzo dei nostri artisti era già migliorata quella lasciatavi da Dedalo sia nell’architettura che nella scultura. Ne Dedalo fu il primo che qui introdusse l’una e l’altra. Tempî avevamo noi nell’epoca sicana come quello dedicato a Cerere a Venere Ericina ad Adrano a Nettuno in Messina anzi, se la favola ci permettesse di prestar fede istorica, il Ciclope Polifemo inalzò un delubro sull’Etna alla sua invano sospirata Galatea ed i Ciclopi della 1a razza divenuti più miti e sociali, secondo Aristotile furono gli inventori ed i primi fabricatori di torri. Statue informi vi erano pure in Sicilia dedicate a Diana, a Cerere, a _________________________________ A c. 98v nota in calce: “(1) Pausania l. 8 c. II”. <Pausanias Periegeta, Graeciae descriptio. 8. Arcadica, 2>. 108 A c. 98v nota in calce: “(2) Diod. lib. cit.”, <Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, IV, 78.1>. 109 A c. 99v nota in calce: “(1) Relazioni ritrovate del 1725 P. Michele del Giudice. Ms. della biblioteca com. di Pal.”. Cfr. Notizie e conghietture sopra un antico sepolcro nuovamente ritrovato a Portella di mare. Ms. del sec. XVIII, Bibl. Com. di Palermo, Qq F 35 n.12. 107 58 Venere ad Adrano a Nettuno ma queste credo io secondo la maniera egiziana rammentata di sopra aveano gli occhi serratte [!], le mani giunte ai fianchi e senza il menomo indizio di vita pure quelli posteriori di Dedalo acquistarono il soffio della medesima e divennero modello a quelle famose migliorate e perfezionate poi dagli artisti greco-siculi. Certo si è che *** secondo ci narra Pausania furono essi che in Atene costrirono [!] la cittadella e vi aggiunsero per ornamento opere di scultura delle teste dei leoni. La pittura sebbene arte posteriore sembra che in epoca anche remota vi fosse recata dall’Egitto per mezzo dei Fenici perocché nel sepolcro scoperto nel 1725 di uno dei due monumenti scolpiti in marmo di donne giacenti trovati nella contrada vicina a Palermo detta Portella di mare vi erano dipinte figure muliebri sedenti in diversi atteggiamenti e alcuni cavalli frenati da un garzoncello ignudo(1)110 e in alcune dellle citate metope selinuntine trovansi vestigi di colori. Fenici in Sicilia Molto tempo pria di Gelone, che già nel 2. anno dell’Olimpiade 72 era stato da Gela chiamato da’ Siracusani a dominar la loro città i Fenici aveano stabilimenti, fattorie commerciali e borgate marittime in Sicilia; perocchè è accennato dalla storia che Gelone sul prestesto di voler vendicare la morte di Dorico spartano, recatagli da’ Fenici nel voler costui qual successore di Ercole rivendicava lo scettro di Egesta, avea divisato di scacciar dalla Sicilia i Fenici; ma poi distolto da altre guerre più importanti ne differì l’impresa. In questa occasione par che i Fenici abbiano chiamato in Sicilia i lor connazionali Cartaginesi ond’esser difesi, e i Cartaginiesi vi furono anche incitati da Serse per dare a Greci suoi nemici un diversivo temendo che fossero soccorsi da’ nostri Greci Sicilioti, come di fatti da quelli era stato tentato invitando Gelone ad associarvi la sua armata, il che non avvenne volendone egli, e non consentendo quelli il comando di terra o di mare dell’esercito o della flotta destinata contro Serse. I Cartaginesi divennero allora formidabili nemici di Gelone e della Sicilia e quell’invitto sovrano, e generale li disfece nella famosa battaglia presso Imera. _________________________________ A c. 99v nota in calce: “(1) Relazione del P. Miche. Del Giudice Ms. della Biblioteca Com. di Pal.” Vedi nota n. 109. 110 59 I Fenici amanti della pace come commercianti, adescati altronde dalle miniere d’oro, e di argento della Spagna, abbandonarono la Sicilia a’ Cartaginiesi più guerrieri di loro, sicuri che con essi avrebbero avuto sempre rapporti di commercio. Altra cagione dell’abbandono si fu l’aver osservato che i Greci avevano già aperto un traffico attivo con Corinto e il Peloponneso. I Pelasgi di Italia derivati dai Fenici e mischiatisi insieme approdarono nell’isola nostra ed ivi furon denominati Ciclopi dalla greca voce κυκλος [ciclos] cerchio e ωψ [ops] occhio, perocchè si spacciò da Omero che avessero un sol occhio in fronte che da’ critici si è giudicato che fosse una lucerna accesa che si attaccavano per scavar le grotte destinate a loro abitazione. E quel Polifemo loro capo dipinto con vivi colori come antropofago da Omero nella voce greca altro non significa che famoso. Statue d’uomini illustri in Siracusa ne’ tempi greci Siracusa la più colta e popolosa delle città siciliane prestò omaggio singolare non solo a’ suoi più illustri cittadini ma anche agli stranieri che la visitaro<no> fra questi Archiloco di Paro il poeta satirico fu onorato d’una statua. Erodoto lo fa contemporaneo di Gige, lib. I, c. 12. Cicerone di Romolo (Tusc. Lib. I) Olimp. VI, 753 av. G.C. (1)111. In Catania fu fatto un gruppo di bronzo a fratelli pii co’ loro genitori sulle spalle per salvarli dall’eruzione dell’Etna dell’Olimpiade 753 av. G.C. Quel gruppo fu trasportato in Roma da Marcello o da Verre e fu ben descritto in versi da Claudiano e da me tradotto. Ciò importa che a quell’epoca remota la Sicilia aveva scultori comechè vogliansi supporre assai rozzi ad Aristeo fu innalzato una statua da’ Sicani nel tempio di Cerere. Saffo celebre poetessa lirica sia che andasse in cerca del suo amante Faone sia che fosse bandita con Alceo da Lesbo come intrigati nella congiura contro Pittaco tiranno di quell’isola capitò in Siracusa e le fu innalzata una statua nel Pritaneo (2)112. Essa fioriva verso la XLV Olimp. (600 av. G.C.). A Stesicoro fu innalzato in Catania un magnifico sepolcro a guisa di tempio, e in Imera sua patria una statua descritta da Cicerone a Simonide di Ceo _________________________________ A c. 105r nota in calce: “(1) Narb. Stor. Letter. di Sicilia, t. I, pag. 189”. <Alessio Narbone, Istoria della letteratura siciliana, Palermo, Stab. Tip. Carini, 1852-1863, v. 1, p. 190, n. VII>. 112 A c. 105r nota in calce: “(2) Narb. ib. pag. 190”. <Alessio Narbone, Istoria … cit., v. 1, p. 190, n. VIII>. 111 60 poeta lirico che morì alla corte di Gerone I in Siracusa verso l’Olimpiade 78 (468 av. G.C.) fu pure innalzato un sepolcro che fu destrutto da fenice Generale dagli Agrigentini quando condusero guerra a quella città. Ad Epicarmo fu eretta una statua di bronzo nel tempio di Bacco in Siracusa a cui Teocrito pose una bella epigrafe in versi dorici. Statua eretta a Gelone da’ Siracusani dopo la sua vittoria in Imera su’ Cartaginiesi (verso l’Olimpiade 75: 480 pria di G.C.) e poi ch’egli mostrossi al pubblico per rinunziare al governo, e fu invece proclamato re. Tempii da Gelone innalzati in Siracusa a Cerere e Proserpina, a Cerere in Enna che rimase non compiuto nel 778 per la sua morte. Questi tempii furono costruiti col bottino del suo trionfo su’ Cartaginesi in Imera. Egli destinò il suo sepolcro un miglio quasi distante da Siracusa ed era racchiuso da nove torri. I prigionieri de’ Cartaginesi d’Imera furono destinati a costruire pubblici edificj. Demarete moglie di Gelone della somma offertale da’ Cartaginesi fa coniare una medaglia bellissima detta demarete. I prigionieri dati da Gelone agli Agrigentini costruirono gli acquedotti Feaci detti così dall’architetto Feaces, Di Blasi, t. I, pagg. 101 e seg.113. Statua de’ tiranni di Siracusa destrutta, nel tempo di Timoleonte, conservandone soltanto quella di Gelone. I Siracusani avendo cacciato in Locri il tiranno Trasibulo fratello e successor di Gerone I coniarono una bella medaglia in oro, e argento con la testa di Giove e l’epigrafe in greco Giove liberatore. In Selinunte è rammentato da Di Blasi t. I pag. 105114 il tempio di Giove forense ove fu trucidato Eurileonte capita<no> di Dorieo allorché spento costui, quello volea renderlo signore di Selinunte. Gelone abbellì di belli edificj e assicurò Siracusa dagli assalti de’ nemici Siracusa [!] con inespugnabili fortificazioni e similmente Falaride Agrigento (Luciano Dial. 5)115 sacrò le piscine, gli acquedotti, i palazzi, i teatri, e i templi furono poscia edificati. E fra questi il famoso tempio di Giove Olimpio che forse fu costruito dall’architetto Feace, autore degli acquedotti. Erano mirabili le sculture di quel tempio la presa di Troia, e la guerra de’ Giganti. Viveva in quel secolo Pittagora di Leontino vantato da Plinio che avanzò nell’espressione e nella miologia lo stesso Policleto. Vantate erano tra le statue quella di artista siracusano vincitore ne’ giochi olimpici _________________________________ Giovanni Evangelista Di Blasi, Storia del regno di Sicilia dall’epoca oscura e favolosa sino al 1774, Palermo, Tip. di P. Pensante, 1861-1864, v. 1, 108-109. 114 Giovanni Evangelista Di Blasi, Storia del Regno … cit., p. 114. 115 Seguono cancellate le parole: “fece costruire”. <Lucianus, Phalaris, 1.3>. 113 61 nell’Olimpiade 73 e quella del giovinetto Libi ignudo che in una mano tenea una lettera, e nell’altra alcune mele. Entrambe quelle statue si osservano in Olimpia e un’altra in Siracusa d’un giovane zoppicante per una piaga che ne mostrava quasi il dolore, e che trasfondea commiserazione agli spettatori. Era famosa non lungi dal faro di Agrigento la statua di bronzo di Ercole e l’altra di Apollo nel tempio di Castore e Polluce. Da Plinio tra i pittori è ricordato Demofilo d’Imera maestro di Zeusi di Eraclea ch’io ho provato esser anche di Sicilia (Vedi l’opera di Gallo). a fioriL’arte d’incider le medaglie secondo il Torremuzza116 cominciò 117 re in Sicilia sotto il regno di Gelone e del suo fratello Gerone 2. e, secondo il Biancone118 bolognese i Siciliani precessero i Greci di Grecia madre. Cominciò anche allora a fiorir l’arte ceramica e si videro bellissimi vasi fittili istoriati, e in Agrigento principalmente lavori cisellati in vasellame di argento e d’oro, e scolpiti in avorio com’erano le lattiche. Valle d’Ispica e Pantalica Sepolcri della Sicilia Articolo copiato dal Bollettino dell’Istituto di corrispondenza archeologica in Roma, N. XII di dicembre 1854 soggiuntevi alcune osservazioni di Agostino Gallo Mai fino ad ora, per quanto io sappia, fu fatta menzione sufficiente d’una specie particolare di tombe che in gran numero si ritrovano nella Sicilia. Esse probabilmente non appartengono all’epoca greca, ma ad un secolo antegresso Sicano o Siculo, e per la loro remota età destano speciale interesse; queste son i cosi detti “Ddieri”119 di cui è piena tutta Val di Noto, il terzo della Sicilia al Sud Est. _________________________________ 116 Gabriele Lancillotto Castelli, principe di Torremuzza, Memorie delle zecche del Regno di Sicilia e delle monete in esse coniate in varj tempi, in “Opuscoli di autori siciliani”, Palermo, 1758-1778, v. XVI (1775), p. 263-392. 117 Fratello di Gerone I era Gelone, tiranno di Siracusa dal 485 al 478 av. C. Gerone II fu tiranno di Siracusa dal 270 al 215 a.C. Era discendente di Gelone. 118 Il riferimento è all’opera di Giovanni Battista Bianconi, Parere intorno una medaglia di Siracusa, per occasione della quale si parla de’ professori antichi delle arti del disegno, Bologna, a San Tommaso d’Aquino, 1763. 119 Il gergo vernacolare è reperibile nel Vocabolario siciliano, a cura di G. Piccitto, Catania-Palermo 1977-1997, v. 1, p. 907: «tratti di parete calcarea in cui sono uno o più ordini di grotte (disposti in piani paralleli) rese accessibili da un davanzale o cornicione di roccia, alcune di queste grotte servono tuttora come abitazioni». 62 Le contrade ove, a mia conoscenza, si trovano tali Ddieri sono i contorni di Leontinoi (i così detti campi i Laestrygoni) le vallate dei due fiumi Morcellino e S. Gusmano, che sboccano nel golfo di Megara Pleinmyrion ora isola, i pendii delle montagne Thymbris che circondano la valle dell’Anapos verso nord, Sortino, Pantalica, Ferla, Bibbio, Bauli, Vallonello o Maramman, Sperone, Gaetani, Pianetta, Castelluccio, Cornelio, la celebre Val d’Ispica e Pinica. La caratteristica di queste tombe consiste nel loro difficile accesso, nella forma e nelle piccole proporzioni. Quasi sempre si trovano in un taglio a picco assai alto di modo che non si può salire ad esse che con mezzi artificiali; edè perciò che sono principalmente opportuni i rapidi e perpendicolari pendii delle rocce nel luogo dei fiumi ove specialmente noi le vediamo stendersi da ambedue le parti in fila lunghe varie miglia; com’è in particolare nella Val d’Ispica lungo il fiume Morcellino, il Gusmano, Buttiglione ed Anapos presso Pantalica, e sull’Anapos fra Sortino e Belvedere. Le uniche tombe cui facilmente si accede sono quelle di Pleinmyrion; solo ponendo a repentaglio la vita salimmo a quelle di Pinita. Queste ultime hanno la fronte verso Nord e sono sovrapposte le une all’altre in 3 o 4 ordini, come quelle di Morcellino e di Buttiglioni, disposte in file irregolari. Anche per arrivare alle file più basse è d’uopo servirsi di una scala che si tirava su per poggiarla di nuovo e salire al secondo piano. Ma come qui fosse assicurata la scala sulla prima fila e più sopra, ove si voleva ascendere, non essendovi alcun punto di appoggio, per me è un enigma. Questo conservare i morti in luoghi inaccessibili che facevano gli antichi abitanti della Sicilia, ci fa vedere, com’essi li ritenessero per sacri ed inviolabili e, per conseguenza quanto dovessero essere innanzi sotto il rapporto religioso. Le camere delle tombe non sono grotte naturali ma del tutto scavate a scalpello hanno piccoli ingressi quadrati a forma di finestra e per solito della larghezza di due piedi e dell’altezza di tre; all’orlo di queste aperture si veggono ancora i buchi per i cardini delle porte di legno che vi erano attaccate. Al di fuori di questi orli e quasi cornici trovansi anche uno, due o tre incavi che si allargano progressivamente nella parte esteriore, quasi che la piccola porta più interna non bastasse, ma vi fosse stato bisogno aggiungere due, tre e quattro porte dalle quali ognuna fosse sempre un poco più grande dell’antecedente e tutte incastrate in questi incavi. È possibile che fuori la porta vi fosse applicato un quadro o qualche rilievo. Nell’interno il suolo è scarpellato e liscio e la forma rotonda, il soffitto orizzontale od 63 a guisa di cupola. In una ho osservato un un banco di pietra alla maniera greca ed in un’altra due finestre. Ad eccezione di poche più grandi queste tombe sono così anguste che un uomo non può starvi che carponi. È molto difficile di conoscere, in quale posizione potessero qui collocarsi i cadaveri se non bruciati. V’è chi suppone che gli si desse la posizione che avevano nel ventre della madre. Una di queste tombe Ddieri in Sperano dev’essere una specie di piccolo θολος [tolos], un fabbricato di sassi poligoni, i cui intervalli sono riempiti con altri piccoli sassi. Ottanta di simili tombe si trovano in Pinita e senza numero in altri luoghi. Qui chiamo l’attenzione sull’opuscolo che tratta di queste tombe Ddieri del dotto di Palazzuolo dottore Gaetano Italia Nicastro, Ricerca per l’istoria dei popoli Acrensi anteriori alle colonie elleniche, Messina, 1856. Al medesimo dotto vado debitore di alcune comunicazioni in iscritto intorno nuove scoverte in un secondo luogo, di cui voleva ancor parlare, cioè intorno alle cosidette tombe ferinee nell’Acrocoro detto della Torre presso S.Giovanni egualmente sulla Pinita. Già il baron Giudica120 avea ivi trovato 228 vasi più centinaia di tazze, ampolle, armille, aghi, crinali, affreschi ferinj, e sopra una tazza un’iscrizione punica sopra due mense di pietra calcarea due altre iscrizioni l’una di 7 e l’altra di 11 righe. Ora furono anche scoverte altre tombe scavate nel duro masso chiuse con coperchi di pietra ed ora coperte di terra piante e brecce. Il suono vuoto che dava il terreno fu indizio al loro rinvenimento. Tra grandi e piccole se ne sono trovate 30 colla direzione per la maggior parte da est ad ovest, altre però da nord a sud. Le tombe verso la prima direzione erano di donne, come si vede dalle ossa calcinate, dalle spille e dai braccialetti che in esse si rinvennero; quelle nell’altra direzione erano per gli uomini. In queste principalmente si trovarono tazze a fianco e sul petto dei scheletri; si osservò peraltro una tazza anche nella tomba di una donna e posta in posizione oscena coll’apertura verso i piedi. Nelle piccole arche stavano piccolissime bottiglie e vasetti di forma singolare e di materia grossolana, il loro colore era per lo più nero piombo con un colore carminio sottoposto che in altro era marrone scuro. Varie tazze avevano due zone, l’una nero piombo, l’altra di un bianco sporco; le spille e i braccialetti erano tutti di rame. La lunghezza ordinaria delle arche è di m 1,50 e m.tro 1,80. Appena si comincia ad aprire una tomba, esalava da ogni piccola fessura un fetore nauseante di cadavere, il quale producea certamen_________________________________ 120 Ma Judica. 64 te anche la muffa che indicava sempre il luogo di un’arca. Gli scheletri erano completamente conservati, con teste assai schiacciate alle tempie ed avevano quasi la forma di una mandorla, i denti molto sporgenti. G. Schudring121. Nel Bollettino di settembre p. 193 seg. il ch.o Renier122 ci diede alla luce quattro lapidi latine scoperte recentemente a Iglitza non lontano da Galaez dal sgr. More le quali vennero a stabilire in quel luogo il sito dell’antica città di Troesmis o Trosmis. Ora per la cortesia del real Ministero degli Affari esteri, mi vengono comunicate altre iscrizioni inviate a cotesto Real Governo del signor Blucher viceconsole prussiano a Galaez; quattro di esse nuove ma ritrovate nelle stesse località le quali mi affretto di rendere di pubblica ragione corredandole di poche osservazioni. Osservazioni di A. Gallo Questo tedesco non rifletté che quelle scavazioni che accenna in gran parte erano primitive abitazioni degli uomini innanzi che fosse sorta l’industria di formar delle case per sovrapposizione di pietre squadrate. Certo si è che le camerette nella Val d’Ispica e quelle di Pantalica scavate indosso ai monti di pietra docile a più ordini non hanno presentato cadaveri interi ad opporsi ai diligenti frugatori; né presso gli antichi credo che vi sia stato uso diverso da quello di riporre in loculi entro la terra i cadaveri. In Pantalica ed Ispica che erano per certo due piccole borgate ove abitavano poche migliaia di cittadini quanto si argomenta poterne contenere quelle camerette eranvi dei cimiteri a pianterreno. Nè i luoghi indicati dal tedesco Schubring sono i soli in Sicilia che indicano abitazioni primitive per scavamento, ma molti altri se ne trovano in diverse contrade di Sicilia e in altre parti del mondo; talchè puossi dedurre che gli uomini per istintiva industria cominciarono dopo che le caverne furono esaurite per le loro famiglie ad imitazion di esse a formarsi con gli scavamenti degli asili alle intemperie e in quelle di Sicilia a più ordini dovevano salirvi con scale artificiali. Poco importava loro che per risparmio di fatica non facessero quelle camerette alte da potervi agevolmente rimanere all’impiedi. Erano per essi refugio principalmente per la notte e bastava ai medesimi che vi si potessero sdraiare. _________________________________ 121 122 Ma Johann Julius Schubring. Léon Renier. 65 In questo argomento ha scritto una diligente memoria l’abate Vincenzo Di Giovanni il quale in opposizione al tedesco ha sostenuto che servivano per abitazione agli uomini che in secoli prima delle memorie istoriche passarono forse dal vicino continente in quest’isola. Alla quale opinione prima dell’abate Di Giovanni e di altri mi ero io abbagliato nella mia Istoria delle belle arti in Sicilia che ancora non ho pubblicato. 18 gennaio 1865 Agostino Gallo Giudizio critico sopra un articolo di archeologia sopra gli scavi praticati in Siracusa dal Dr. Cavallari123 Abbiamo letto con piena nostra soddisfazione un rapporto dell’insigne professore Saverio Cavallaro, egregio architetto ed archeologo negli ultimi scavi praticati in Siracusa sotto la di lui direzione per iscoprirsi un tempio di cui aveasi già indizio per alcune colonne adimate in seno della terra presso l’Ortigia e che tradizionalmente credevasi consacrato a Diana divinità prediletta dai Siracusani. La precedente Commissione di Antichità e Belle Arti nella quale avevo l’onore di appartenere come Segretario archeologo con voto prima della mia renuncia si era dato pensiero di sgombrare dalle soprapposte fabbriche e particolarmente della casa di un certo Santoro l’area a colonnato di quel tempio; ma non pochi ostacoli si presentavano al buon desio e primo quelli che opponeva il proprietario di quella casa e secondo le somme occorrenti pel pagamento di essa nell’atterrare le fabbriche e per eseguirsi gli scavi essendo allora miserabile la dotazione per tali oggetti. Nulladimanco con la giudiziosa economia del denaro la Commessione avea fiducia di compiere quell’opera quando dal Ministero centrale fu abolita e creata questa nuova con generoso accrescimento di dotazione; talché è nel caso di meglio adempiere quanto divisato avea la precedente e di recare ad effetto i progetti della medesima sopra Iccara ed altri siti di Sicilia e certo con miglior successo anche per la direzione ed il sapere dell’attuale architetto direttore Sigr Cavallaro. Egli nella sua relazione ci dice che con lo scoprimento di un’altra colonna e di quella angolare di Nord-Est sotto il muro della piccola chiesetta delle grazie che deve atterrarsi ha potuto scoprire metà del prospetto dell’antico tempio e metà del pronao e nelle gradinate di esso prospetto fu _________________________________ Francesco Saverio Cavallari, architetto, figlio di Cristoforo e Giuseppa Pirrone, nato a Palermo nel 1809, ivi morto nel 1896, docente di architettura decorativa e disegno topografico presso il Collegio delle Belle Arti di Palermo. 123 66 lieto di scorgere in fronte al primo gradino la greca iscrizione benché interrotta dal muro della Chiesetta delle Grazie. Si era già scoverta dal Signor Tarantello architetto locale un tronco di altra colonna nel pronao della cella dove il Cavallaro iniziò i nuovi scavi e così con la sua sagacia e perizia architettonica e archeologica ha potuto congetturare anche con altri dati che s’innalzavano 17 colonne nei due lati; come pure ha osservato che quelle del peristilio e della cella sono striate da 16 scanelli. Nella sua dotta relazione ragiona a lungo sulla scelta della collocazione del tempio riguardata sempre come importante dai Greci in quelli che innalzavano per riguardo alle divinità a cui erano dedicate. Egli crede e bene si oppone al vero che i greco-sicoli imitavano in tutto quelli della loro madre patria continentali e sulla ben nota favola del fiume Alfeo che innamorato della ninfa Aretusa l’inseguiva per cammino sottomarino fino in Ortigia e sulla cognizione che quel fiume d’Arcadia partiva da un luogo ov’era dai Greci stato sacrato ad Artemisia Potomia124, un tempio suppone che anche quello nuovamente scoperto in Siracusa fosse a lei dedicato che altronde si vede figurata nelle belle medaglie siracusane. Questa sua supposizione può esser vera ma non è che una semplice congettura, perocché nelle medaglie siracusane trovansi anche effigiate altre divinità. Importantissima è l’iscrizione da lui scoverta ch’egli giudica di non oltrepassare il V secolo avanti Gesù Cristo e di corrispondere all’epoca di Gelone. Ma ciò sarà confermato o rigettato dalla interpretazione che ne attendiamo dall’insigne ellenista Sigr Giuseppe De Spucches principe di Galati125 il quale in quella intralciatissima e difficile di Taormina fra le tante ce ne dié quella che più soddisfece ai cultori nazionale stranieri dell’ellenismo e che altre ne ha spiegato con sapere filologico e scelta erudizione. Il Cavallaro ha creduto di scoprire in quell’iscrizione il nome di Cleomedej o Cleomenes e messo un celebre artefice destinato alla costruzione dei sacri tempî e che figurerà nell’istoria nelle prime file tra i nomi i più insigni di tutta la Grecia in onore della siciliana cultura e civiltà a cui sono anteriori quello del quasi mitico Dedalo e dei fratelli Trofonio ed Agimade126, illustri architetti che costruirono il tempio di Delfo. _________________________________ Artemide Potnia Theron, patrona degli animali selvatici. Giuseppe De Spuches, ellenista, latinista, archeologo e poeta, è l’autore del saggio, Lettere illustrative di una greca iscrizione trovata in Taormina, e di un tempio di Giove Serapide, Palermo, stabilimento Piola e Tamburello, 1862. 126 Leggasi: “Agamede”. 124 125 67 Noi sapevamo altronde che Gelone sorto tiranno di Siracusa e divenuto, per la sua bravura militare d’indole mite e benigna, amatissimo sovrano proclamato dal popolo, molto si occupò a migliorare la pubblica cultura e a promuovere le belle arti e quindi la congettura del Cavallaro è consona all’istoria ed ove l’interpretazione di tutta l’epigrafe ne dia ulteriori indizî accrescerebbe gloria a Gelone e alla Sicilia che con l’architetto Cleomede o Cleomene, che dobbiam reputare siciliano non incontrando nell’istoria di Grecia tal nome ci apprestò anche in epoca anteriore a Pericle un bel modello architettonico di un magnifico tempio. Quel nome è tanto più interessante quanto perché i Greci vietassero agli architetti di apporre i loro nomi ai tempî da essi costruiti riguardando forse come profanazione di essere associati a quelli delle divinità. E difatti in un tempio di Siracusa si scoprì l’artifizio di un architetto nel fare scolpire il suo nome sotto la base della superficie interna di una colonna, affinché ove fosse rovesciato il tempio come accadde non venisse ignorato il suo nome. Quello però di Cleomede o Cleomene farebbe un eccezione a tal costumanza e forse ne fu autorizzato pei suoi meriti straordinari dal popolo siracusano permettendogli bensì di scolpirlo in un gradino, la parte più umile dell’edifizio onde non offendere la divinità come i nostri devoti si fanno dipingere prostrati e in atto di adorazione innanzi all’immagine di Cristo, della Vergine o di santi. La relazione del Cavallaro è zeppa di opportuna e peregrina erudizione artistica; ma noi facciam plauso principalmente per la sua fine critica e quel tatto artistico ch’egli da molti anni acquistò coadiuvando nella grande intrapresa il duca di Serradifalco famoso illustratore dei nostri monumenti greco-sicoli e normanni e nell’essersi arricchito d’infinite altre cognizioni nei suoi viaggi e soggiorni d’oltremonte e d’oltremare; talchè crediamo di dover rendere lode al Sig.r Ministro [Michele] Amari di averlo destinato a Direttore degli scavi e crediamo che sarebbe utile di associarlo alla nuova Commissione di Belle Arti e dargli il voto nelle sue deliberazioni. Sulle stanze scavate nella valle d’Ispica e in Pantalica e in altri luoghi di Sicilia nel tufo delle montagne per abitazione de’ suoi antichi popoli Altrove ho data la descrizione di queste due vetustissime città troglolitiche di Sicilia di altra scavata nel tufo delle montagne; qui soggiungo alcune osservazioni. 68 Mi fu chiesto da un amico a quale epoca montar dovesse questo genere singolare di architettura. Risposi non dite architettura, ma industria perché quella suppone scienza ed arte che ancor non siano nate, laddove l’industria a soddisfare con essi bisogni degli uomini primitivi nasce quasi istintivamente colla guida della ragione anche poco sviluppata, l’addestra a procurarsi la sicurezza e il comodo della vita. Cresciute le umane famiglie e trovando già occupate le grotte da altri precedenti per ricovero all’intemperie e a difesa contro le belve né servir potendosi più di quello che loro offriva la natura, gli uomini più perspicaci prima dell’invenzione del ferro con rami e tronchi d’alberi aguzzi ovvero con schegge aguzze di selce127 procurarono a grande e lungo stento di scavarsi un ricovero pe’ giorni tempestosi, e nelle notti. Se la ragione illuminata dalla scienza li avesse guidato, avrebbero preferito al penoso scavamento di molti avelli per una piccola stanza la costruzione più facile e rapida con pietre sovrapposte perpendicolarmenti, che è il vero inizio dell’architettura. Ma se non lo fecero, essa non era ancora speculata. Allora replicommi l’amico: io nelle abitazioni, scavate ne’ monti della valle d’Ispica, e in Pantalica, ho dovuto osservare quella regolarità che non avvi nelle grotte; che servirà di modello agli uomini primitivi […] camerette quasi tutte quadrate, ad angoli retti, e talune con lucernali rotondi, e con gl’ingressi sebbene senza scala, in linea perpendicolare e formanti pure ad angoli retti. Ecco dunque in quegli uomini l’uso della scienza geometrica venuta in soccorso dell’infanzia dell’architettura. Né l’una né l’altra risposi: l’uomo nella sua stessa persona e in altri oggetti naturali scorge le principali figure geometriche. Dal suo femore al piede vede esternamente la linea retta, come ne’ cipressi e in altri alberi, se innalza disteso l’antibraccio e il braccio all’altezza della scapula incontra sopra la linea retta e sotto l’ascella un angolo retto, slargato l’indice e il medio della mano vede un angolo acuto, la bocca tutta aperta e la pupilla gli presenta la figura circolare, e l’esterno dell’occhio l’ellittica. Or essendo egli naturalmente dotato del talento d’imitazione nelle opere sue è spinto a ritrarre meccanicamente quelle figure che ha osservato. Ma a qual epoca e a quale razza di uomini appartengono quelle escavazioni? Ciò è difficile a congetturarsi, ma certo prima assai delle greche colonie in Sicilia e prima anche dei Sicoli, e de’ Fenicj che ben conosce_________________________________ A c. 114r nota in calce: “Si son trovate in Sicilia alcune schegge di selce acuminate per modo da servir come <at>trezzo il che mostra che in quell’età nei […]arii ritrova[…] usavano il ferro”. 127 69 vano l’arte di fabbricare. Potrebbe sospettarsi che quelle cave fossero le abitazioni dei Sicoli che secondo Dionigi d’Alicarnasso prima di recarsi in Sicilia abitavano le terre d’Italia occupate poscia dai Pelasgi i quali ajutarono gli aborigeni a cacciare i Sicoli nella Trinacria che poi da loro assunse il nome di Sicilia (1)128. Ma i Sicoli provenienti dall’Italia costruirono per sovrapposizione a gran massi irregolari come puossi osservare in Cefalù e in altri porti dell’isola nostra e quelle fabbriche impropriamente vengono dette [impropriamente] Ciclopiche forse perché a dir di Diodoro la seconda razza dei Ciclopi divenuti alquanto sociali si mischiò coi Sicoli e disparve. Con questi ultimi bensì passarono qui torme di Pelasghi ch’erano fabbricatori di case e non iscavatori e dall’essersi confusi coi Sicoli vengono denominati Pelasghi Siculi da Pausania, Iperbio e Agragora129 i quali recaronsi da qui in Atene a fabbricar la cittadella e vi scolpirono anche per ornamento delle teste di leone come pure le magioni reali di Tirinto e di Micene che sono le più antiche opere dell’arte (3)130. La Valle d’Ispica adunque e Pantalica dovettero essere scavate per abitazioni anche prima dei Sicoli e dei Pelasghi che vi si accompagnarono nell’immigrazione o almeno nei primi tempi del loro arrivo dell’isola nostra; ma è più probabile che quest’immenso e santo lavoro d’industria fosse eseguito dai Ciclopi Tirreni quando già applodati [!] nella Trinacria, cominciando a dirozzarsi e ad unirsi in civile consorzio non trovando più caverne, si procurarono con l’industria naturale quei ricoveri. Difatti Boccaccio appella i Ciclopi della seconda razza artificiosi homines (1a)131. E Plinio (2)132 li crede inventori del ferro ed esercenti l’arte ferraria. Poterono quindi adoprare il ferro negli scavamenti se non come ho sospettato in rami d’alberi aguzzi con la selce acuminata. Frammistisi indi come accenna Diodoro coi Sicoli che avevano in Italia acquistata l’arte del fabbricar per soprapposizione i massi e coi Pelasghi che vi si erano associati cominciarono a dir dello stesso Plinio (1)133 e a _________________________________ 128 A c. 114v nota in calce: “(1) Dion. Alic. Ant. Rom. Lib. 1.”. <Dionysius Halicarnassensis, Antiquitates Romanae, 1.22>. 129 Agrola e Iperbio, architetti pelasgi di origine sicula. 130 A c. 115r nota in calce: “(3) Pausania lib. 1 cap. 28”. <Pausanias Periegeta, Graeciae descriptio. 1. Attica, 28.3; 2. Corinzia, 16>. 131 A c. 115r nota in calce: “(1a) Genealogia degli dei, lib. 10”. <Giovanni Boccaccio, Genealogia deorum gentilium, 10, 16>. 132 A c. 115r nota in calce: “(2) Plinio presso Pol. Virg. da Vr Inv, lib. 2 cap. XVII”. <Polidoro Vergilio, De inventoribus, 2, XIX>. 133 A c. 115v nota cerchiata in fine: “(1) Lib. VII, cap. 56”. <Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia, 7, 56>. 70 costruir torri per loro difesa temendo sempre l’invasione dei pirati Tirreni. Da quanto ho premesso puossi probabilmente congetturare che Ispica e Pantalica furono le città più antiche abitate dai primi uomini che trascorsero in quest’isola dal vicino continente sin da tempo immemorabile talché non conoscendosi per l’istoria l’epoca furono spacciati come gli Aborigeni di cui parlano Diodoro ed altri vetusti nostri scrittori i quali non supponevano certi che fossero sorti dalla terrra come funghi di uomini seminati con Cadmo come quelli nelle glebe della contrada indi detta Beozia. La Sicilia staccatasi dal continente come accennano le tradizioni rimastici presso gli antichi scrittori dovette prima o dopo quella cataclasi essere abitata da uomini che vi trascorsero dalle prossime contrade italiane o da altre più remote e costoro nel modo indicato si procurarono le abitazioni onde sorsero piccole città fatte per escavazioni finché la nuova industria non erasi più oltre elevata come quella dei loro discendenti a costruire più facilmente per pezzi soprapposti e prima senza alcun cemento e poi per maggiore adesione al medesimo. Belle arti antiche in Sicilia Ateneo rammenta esser costume in Sicilia tenere nelle case le immagini delle ninfe, non dice se dipinte, o in scultura o forse dell’uno, e l’altro modo. Or a queste familiari divinità si faceano notturni sacrificj, e si protra<e>va la notte nell’ebrietà tribudiando [!] innanzi a queste. Però molti cittadini per acquistarsi la grazia di Dionisio dissero che non conveniva perdere il tempo al culto d’inanimate figure, ma più tosto rivolgersi a corteggiare il Tirreno, e quindi tralasciando quel culto si recavano a tripudiare attorno a Dionisio. Athen. Dipnosoph. Lib. VI c. 6 pag. 321 Cecilio retore scrisse delle guerre servili. Athen. Lib. 6 cap. 7 pag. 348 Dionisio, forse il giovane, scrisse lettere a Ipseusippo scolare di Platone, a lui affine nelle quali esponeva ciò che era confacente allo studio di ogni sorta di voluttà, all’amor del guadagno. Athen. Lib. 7 c. 3 pag. 357 Ninfodoro Siracusano nella sua circumnavigazione. Aten. Lib. 8 c. 1 Clearco ne’ proverbi scrisse che Terspione134 sia stato precettore di Orchestrato. Ath. Lib. 8 c. 5. Timeus Tauromenites Aristotelem etiam philosophum gulonum fuisse scribit. Ath. Lib. 8 c. 6 p. 435 _________________________________ 134 Leggasi: “Terpsione”. 71 L’istorico Callia in victis citato da Ateneo lib. 8 c. 6 pag. 437. Clearco nelle sue vite narra che il tiranno Falaride spinse sì oltre la sua crudeltà che mangiasse i fanciulli lattanti Athen. Lib. 9 c. 9 p. 502 Hermias Methymaeus lib. 3 rerum siculorum Ateneo lib. X c. 12 pag. 552 Phanias Eressius in libro interitus tyrannorum ex ultione Ibidem Alcimus Siculus in Libro italico inscripto omnes scribit italas mulieres idcirco vinum non bibere, quod cum Ercules sitiens in domum quondam, quae erat secundum viam apud Crotoniatem, ingressus esset accedens bibere poposcit: acciderat autem ut mulier domini eius domi dolium vini paulo ante clam aperuit, quae tum ad virum dixit eum gravior esse facturum, si peregrini gratia delium aperuit, quae tunc ad virum dixit eum gravior esse facturam, si peregrini gratia dolium aperuisset, iussitque ipsum aquam bibere. Cum in foribus staret Ercules atque haec audivisset, virum quidem illius magnopere laudavit quem mox ipsum accedere dolium intueri iussit. Atque is egressus lapideum factum dolium repeperit. Aten Dipn. Lib X c. 13 pag. 56 Polemon autem Siracusis (forse deve essere scritto Siracusius) ait in libro de Morycho et. Lib XI, c. 1, p. 582 Sembra che sia stato scrittore di storia di costumi. Cecilio retore (ex pulcra Acta) scrisse nella sua Storia che Agatocle re possedeva molti vasi d’argento, e d’oro, e mostrandoli a’ suoi amici diceva di averli acquistati durante il tempo del suo regno lib. XI, c. 4, p. 587. Un Polemone scrisse un libro sui pittori dedicato ad Antigone. Ateneo lib. XI, c. 6 pag. 598 Polemone rammentato da Ateneo lib. XI c. 9, p. 600. Philetas Syracusius narrat placentarum ac panium reliquias in mensa relictas cypella vocare consuevisse. Da questo Fileta siracusanosembra scrittore di cose domestiche Aten. lib. XI c. 9, pag. 609 Policrito Mendesio in Sicilia scrisse l’Istoria di Dionisio, e fu suo contemporaneo, e visse con lui. Laerzio in Eschine Cineto di Chio recatosi in Siracusa e raccozzando a’ suoi i versi di Omero li andava declamando. Fiorì verso l’Olim. 69. È citato dagli scoliasti di Pindaro in Od. II Clearco scrisse biografie al dir di Ateneo, e fra queste quella di Dionisio minore tiranno di Siracusa Eveno Pario, scrittore di Elegie, fu maestro di Filisto celebre storico Frammenti di Stesicoro lib. XI, p. 17 p. 600. In Gorgia l. XI c. 21, pag 638 Di Dione l. XI, c. 23, p. 642 72 Di Gerone l. 12 c. 2 p. 647 Di Stesicoro che cambiò molte cose dette pria da Xanto come nell’Orestiade lib. 12 c. 2 p. 648 Frammento di Teognide l. 12 c. 2 pag. 648 Frammento di Filemone, l. 12 c. 4 p. 653 Celebres fuerunt etiam Siculorum mensae ob delicias, qui etiam mare sibi vicinum dulce esse asserunt cum dapibus gaudeant quae fiunt ex eo, ut testatur Clearcus libro Vitarum quinto. Aten. lib. 12 c. 5 p. 665 Fram<menti> di Timeo lib. 12 c. 6.p. 656 Fram<menti> di Timeo lib. 12 c. 6.p. 659 dello stesso p. 661 Ibid. p. 661 Fram<menti> di Platone sulle Delicie dei Siracusani, lib. 12 c. 10 p. 667 Policrate tiranno di Samo che si procurava tutte le delizie fra le altre cose preferiva, e commetteva i porci di Sicilia lib. 12 c. 19 p. 684 Sileno di Calatte scrisse delle cose siciliane un libro parla di un orto magnifico in Siracusa p. 686 lib. 12 c. 2 Callia nella storia di Agatocle parla della fiumara di Palermo lib. 12 c. 21 p. 686 Belle arti Ateneo riferendo quanto scrisse Diodoro dice che i Gelesi costruirono un recinto del giro di sette stadj, e della profondità di venti onde apprestare a Gelone il piacere di potervisi deliziare con il nuoto. In questo circuito venivano a scaricarsi le acque di varie fonti e di un fiume. Vi fecero per esso una piscina, resa abbondevole di pesci e piena di cigni che d’intorno volavano, e la rendeano deliziosa Athen. Lib. 12 c. XX p. 686. Era famoso in Siracusa un orto artificiale detto fabula ove soleva il re Gerone amministrar la giustizia secondo è riferito da Atheneo lib. 12 c. 20 p. 686 il quale cita Sileno di Calatti nel libro delle cose siciliane. Sileno di Calatte scrisse un’istoria delle cose di Sicilia. Athen. lib. 12 c. 20 p. 686 Campagna de’ dintorni di Palermo: At universa Siciliae panormitis hortus appellatur, quoniam domesticis arboribus tota est confita cum asserit Callias, libro octavo historiarum de Agatocle Athen. Lib. 12 c. 20 p. 686 Callia Siracusano storico. Damofilo siculo incitò la guerra servile Athen. Lib. 12 c. 20 p. 686 Parrasio pittore dedito alle mollezze e alle voluttà Athen. Lib. 12 c. 20 p. 686 73 Ateneo scrive di Aristippo alla corte di Dionigi Athen. Lib. 12 c. 22 p. 689 Gorgia Leontino oratore famoso fu assai importante e visse, secondo Clearco scrittor di vita 80 anni Athen. Lib. 12 c. 26 p. 695. Di un antichissimo, e famoso sepolcro in Lipari riferito da Aristotile Sepolcro antichissimo in Lipari «In Lipara insula Eolica sepulcrum aiunt esse circa quod cum etiam alia prodigiosa eveniant tum id, quod ea loca secure, totoque nemini accedere liceat, uno ne perhibent. Sonitum enim tympanarum, cymbalorumque, et risum cum strepitu, plausuque manum, audiri manifesto. Aeque alterum cum primis monstruose id quoque circa nostrum accidit, quod ante lucano quidam ebrius somno isthic oppressus triduum totum cubavit, quaesitusque a familiaribus quarto demum die repertus est: qui mortuum rati ad proprium monumentum extulerunt; dum justa iam prope more celebrarent ex improviso surrexit quaeque sibi obtigissent, exposuit. Quae etsi ad fabulam proprius, quam veri fidem accedere videantur, non potui tamen de locis his scribens, tacitus praeterire». Arist. De mirabil. auscult. liber pag. 727 Paris t. 2 1639 Antro ricco di fiori nell’Etna «In Aetna Siciliae monte est, ut inquiunt, spelonca quam circa florum omnigena copia crescit omni tempore, tum violis immensum quoddam spatium obtegitur. Quae finitima loca adeo fragantia sua replent, ut occupati hac suavitate odoris, venatici canes, lepores vestigare nequeant. Frumento naturale in Sicilia Ac sub eodem hiatu obscurum quoddam antrum latet, quo Proserpinam rapuisse Pluto fertur triticumque repetitur nec domestico, quo utuntur, neque alij importato simile, sed peculiari proprietate insigne. Quo argomento contendunt illic primum omnium triticum conspectum esse; et proinde Cererem etiam sibi, ut apud se natam vendicant». Arist. Ibid pag. 723 e seg. Terra singolare in Lipari «In Lipara insula, aiunt, quidam terram reperiri, qua, si ollam obruas, quidquid injicias linxetur». Arist. Ibid pag. 718 «In Sicilia ferunt aeque vorticem esse, in quem mersa avis, reliquave animantia soffocata, vitae restituantur» Arist. Ibid pag. 719 Evaporaz.e nello stretto di Messina per effetto dei fuochi dell’Etna «Circa igitur Cyaneas non videtur ignis amitti, sed juxta fretum, qui 74 Sicilia ab Italia distinguitur, ab utroque parte evaporatio, tum quod insula continue ipsa flagrat, tum quod flammae Aetnae sepe [!] totam regionem perimeant» Arist. Ibid pag. 729. Croco o zafferano sul Peloro «In Peloro Siciliae promontorio tanta copia provenit ferunt crocus, ut a quibusdam etiam inquilinis Graecis flos cuiusmodi sit haud internoscatur: curribus magnis hunc comportant quibus libitum est. Tum vero strata ex eo scenasque construunt». Segue Arist. Ibid pag. 730 Stagno mirabile annunciato da Policrito scrittore delle cose siciliane «Polycritus, rerum sicularum scriptor, loco mediterraneo stagnum esse ait ambitu suo scutum nihil excedent, aqua resplendente quidem, sed turbolentiora nonnihil: in quem si quis lavandi gratia ingrediatur, in latum extendi; quod si staret, amplius dilatari; adeo ut amplificatum spatium quinquaginta etiam viros capiat. Verum ad eam jam mensuram diffusum ex imo intumescere corporaque lavantum [!] in sublime rapta foras in pavimentum sternere, ac mox ad veteris angustiae spatium contrahi, atque id non solum humanis corporibus, sed quadrupedibus etiam ingressis usu venire perhibent». Arist. Ibid pag. 730 Stretto di Messina «De siculo fretu cum alii complures scribent, tum hîc stupendam in eo rem evenire inquit. Tyrrheni enim maris aestum strepitu ingenti utrinque, cum Siciliae tum Italiae oram quam Rhegium vocant, ferire, delatumque ex mari vasto in angustias postremo concludi, atque ibi fluctum sublimem tolli, sonitu magno spatioque altissimo, ut procul distantibus conspicua sit haec aquarum ebullitio, ut puta alba, et spumosa, nec similis maris incremento. Haec ut credibiliter narratur ita contueri venti nemo sustinet. Interdum enim diffusi rursus ex collisione mutua aestus adeo profundum ac horribilem adspectum necessario intuentibus praebent, ut nonnulli prae timore animi impotentes velut offusa oculis tenebra concidant. Postquam vero ad alterutram partem fluctus accisi, sublatique ad litus supremum, denuo in subiactum mare devolvuntur, tum magno rugitu, cum vorticibus et immensis, et crebris, ex imo fundo ebullit, inque gyrum elevatur, et omnigenos etiam colores reddit. Interdum etiam ater, nonnumquam caeruleus, frequenter purpureus apparet caeterum cursum ac immensitatem fluxus refluxusque ne reptilia quidem vel audire, vel videre sustinent, quo circa ad radius montium justa confugiunt. Tempestate autem desinente, in sublime efferuntur voragines, specie relucente varia, turbinibusque ac motibus ventorum, aut ingentium serpentum spirir non 75 adsimiles». Arist. Ibid pag. 733 e seg. Delle vespe di Nasso «Vespas, ferunt, in Naxo, si serpente gustato, quorum caro pergrata est illis, aculeum infixerint alicui, tantos dolores exicitare; ut tolerabiliores videantur ictus serpentum» Arist. Ibid pag. 736 Sul tonno salato primieramente posto in uso da fenici per trasportarlo in Cartagine «Phoenices, aiunt, qui Gaditam inhabitant *** thunnorum copiam isthic innumerabilem inveniri tradunt, magnitudine, densitaque incredibili, quos salsos vasis impositos Carthaginem deportant, unde soli non evehuntur, sed ob singularem vanitatum absumuntur» Arist. Ibid pag. 734 Sulla marea del faro di Messina/ Fonte di Siracusa mirabile «Fretum inter Siciliam et Italiam una cum luna intumescit et subsidet. Porro in prato iusta viam quae Syracusas ducit, fons est neque amplius, neque aqua larga scaturiens, ad quem cum turba numerosa confluisset, auctus subito praebuit aquarum abunde liberalem copiam». Lago de’ Palici «Est et fons in Palice Siciliae amplitudine decaclini. Aquas ad sex cubitorum altitudinem eiicit, ut inundaturus planitium omnem videatur, verum eodem loco diffluens constitit: porro iuriiurando hic sacer haberi solet. Quae enim cumque libet, tabellae inscribunt, inque fontem abiiciunt: ea si vero iureiurando confirmentur, natans in superficie tabula testabitur: sin secus, velut pondere depressa eripitur ex oculis, igneque corripitur periurus. Quo circa fideiussorem capit sacerdos, qui iusta numinis vindicta sacrum execrandumque, si peierarit, asportet» Arist. Ibid pag. 720. Fuochi notturni naturali che si veggono in Lipari «In Lipara conspicum quidem ignem lucentemque sed noctu tantum videtur. Aiunt et themsis insulis aestuaria esse, ignea quidem vi, ferventique supra modum ardore, nec tamen flammam mittere. Porro alterum in Lipara, inquit Xenophanes, interdum annis sexdecim prorsus extingui, decimo septimo rursum rediri». Fuochi dell’Etna «Illam quoque ignis favillam que ex monte Aetna solet erumpere, aiunt esse nec flammeam, nec continuam; sed post multos annos redire*** Cum primis vero admiratione dignum est, quod circa Siciliae craterem, inquiiunt, ignium emicentium latitudinem stadia quadraginta patere, altitudine autem vix ad tria usque tolli. Arist. Ibid pag. 718 Terra dum ignem sentit, quod plus aut minus it pati soleat, varios saporum colorumque formas contrahit; quippe quae aluminis, calcis et caetero- 76 rum id genus virtutibus plena reddatur: per quae dum trasmittitur aqua quae dulcis est, permutari solet. Et quaedam accessit quo modo in Sicilia agro Sicanico evenire videmus. Inibi enim oxalme (quem acidam muriam interpretor) gignitur, qua ut aceto in quibusdam epularum generibus uti solent. Arist. Meteoro<lo>gicorum lib. 2 t. 1 ediz. cit. pag. 78 Architettura Villa Giulia A 11 giugno 1778 fu compito il giardino pubblico di Palermo detto Villa Giulia dal nome della moglie del viceré di quel tempo Marco Antonio Colonna. Orto Botanico A 27 ottobre 1789 per ordine del viceré Principe di Caramanico si gettò la prima pietra dell’edificio dell’Orto Botanico in Palermo, sul disegno di Leone Duforny architetto francese135 che allora trovavasi in Palermo. Campo santo A 21 aprile 1783 si gettò la prima petra del pubblico Cimitero in Palermo, detto Camposanto, alla presenza del viceré Domenico Caracciolo Marchese di Villamajna. Seminario de’ Greci A 19 dicembre 1734 fu terminato e aperto il Seminario de’ Greci fondato dal P. Giorgio Guzzetta sacerdote Palermitano dell’Oratorio di cui esiste ivi il ritratto in alto rilievo in marmo dello scultore Ignazio Marabitti.136 Albergo de’ poveri L’Albergo de’ poveri di Palermo fu cominciato a 29 aprile 1746 sotto il viceré Principe di Corsini. Terminata a metà la chiesa e qualche dormitorio furono ivi trasferiti i poveri che erano nell’Albergo vecchio a Porta di Termini. Ciò avvenne a’ 6 aprile 1772. <Palazzo Chiaramonte o Steri> Il Palazzo che s’innalza in fondo del largo della Marina detto Steri, e serve al presente per uso di Tribunali fu fabbricato da Manfredi Chiaramonte verso il 1307 e fu occupato da quell’illustre famiglia fino al 1392 in cui _________________________________ 135 Léon Dufourny, architetto, nato a Parigi nel 1754, ivi morto nel 1818, docente di architettura presso l’Institute de France, divulgatore del classic revival; presente in Sicilia dal 1789 al 1794. 136 Ignazio Marabitti, scultore, nato a Palermo nel 1719, ivi morto nel 1797). 77 Andrea Chiaramonte, ottavo di tal nome, e conte di Modica, fu decapitato come ribelle, e il palazzo incamerato alla Reale Corte. Esso avea attinenza di giardini per tutto il piano della Marina fino a quello di S. Erasmo e pel quartiere della Kalsa. Ivi avvi una chiesetta appartenente al Palazzo sotto piano della scala della Dogana che ne facea parte, vi è una sacra imagine della Beata Vergine con Sant’Antonio in fondo dorato che è pittura di quell’epoca. I travi del palazzo sono tutti istoriati e con iscrizioni. Il convento e la chiesa di S. Oliva de’ PP. Minimi di San Francesco di Paola in Palermo fu cominciato nel 1518 a spese del duca di Monteleone. L’altro convento, e chiesa della Vittoria fuori Porta Nuova furono costruiti nel 1598. Carlo Ventimiglia fu nipote di Alfonso Roisio consigliere antico e grande amatore delle patrie antichità dal quale ebbe forse ispirato l’amore per l’archeologia. G. Gualtieri Tab. ant. Siciliae pag. 82.137 Egli fu erede della sua raccolta archeologica Gualtieri pag. 40138 che donolla alla Società di Gesù. Alfonso Zoppetta è lodato come veterum monumentorum investigator. Gualt. pag. 46139. Eredia [!] Sicola Da una lapide in Mazzara in un palazzo presso il Collegio si ricava che Maximo Memoriano sia stato edile in Mazzara nell’epoca romana sotto l’imperatore Antonino. Nel Duomo in Mazzara vi sono due sarcofagi uno all’interno della nave sinistra con una caccia e un altro con un uomo a cavallo e un cane con iscrizioni greche. Altro sarcofago ove sta scritto Tutinus auctor est anno MCLXXX. Avvi una figura cavata da serpenti alati e un putto con vaso libatorio, forse è dell’epoca del difunto racchiusovi. In una lapide è rammentata Mazzara come Catania augusta Lilybetanorum. Alfonzo Bernardo Zoppetta Palermitano gran raccoglitore e amatore di cose antiche regalò a Termini diversi monumenti che riguardavano Imera, _________________________________ 137 Georg Walther, Siciliae obiacentium insulae et Bruttiorum antiquae tabulae cum animadversionib. Georgii Gualtherii, Messanae, apud Petrum Bream, 1624, p. 97, n. 81. 138 Georg Walther, Siciliae obiacentium … cit., p. 40. 139 Georg Walther, Siciliae obiacentium … cit., p. 46. 78 credo che fosser monete dalla descrizione. Da una lapide greca in Marsala si ricava ch’ivi era un ginnasio per l’esercizio pugile della gioventù, fra cui quello che superava era coronato di ulivo. Prefetto destinato dal Senato ne era Eraclide Zopiro. In detta iscrizione sono segnati i nomi di varj giovani vincitori e coronati; cioè Asclepiade, figlio di Asclepiade Artemone figlio di Eutimio Antallo figlio di Antallo Polixeno figlio di Agatarco Protarco figlio di Protarco Gelojo figlio di Gorgilo Aristione figlio di Nimfodoro Soripoli figlio di Isidoo Nicaro figlio di Pirone Apollonio figlio di Sattirrhi Zopiro figlio di Grachide Il popolo e il Senato fecero innalzare un monumento son detti Populus Ionicus Galeae novi coloni. Da un diploma in Mazzara appare che Giorgio Rozier l’ammiraglio Antiocheno viveva nel 1093. Ruggieri pei soccorsi dati a Guglielmo duca di Puglia nel 1122 acquistò il posesso di metà di Palermo, e del ducato di Calabria, e nel 1127 l’intero ducato di Puglia. Caruso Mem. Ist. p. 212 p. 71 t. 3. Pirri Chr. Reg. Sic., Sarri Ius pub. Sic. p. 1 c. 1 p. 166. Et ex inde Magnus Comes Italiae Calabriae et Siciliae dieci capit.140 È da sapere che metà di Palermo pria d’essere stata ceduta a Ruggieri apparteneva a’ duchi di Calabria. Da una raccolta di Francesco Tardia ms. della Bib. Com. di Palermo _________________________________ Giovanni Battista Caruso, Memorie istoriche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo de’ suoi primieri abitatori sino alla coronazione del re Vittorio Amedeo raccolte ... da Gio. Battista Caruso ... Parte prima volume primo [-parte terza volume secondo], Seconda edizione aumentata e corretta sopra il manuscritto dell’autore, In Palermo, nella stamperia di Antonino Gramignani impressore del real collegio borb. de’ R.R. PP. Teatini, 1737-1745, v. 2.1, p. 71; Rocco Pirri, Chronologia regum, penes quos Siciliae fuit imperium post exactos Saracenos. Vbi Regum etiam familiae magna ex parte explicantur; eorumdem vices-gerentes, & praecipui quique consiliarij recensentur. … Panormi, ex typographia Petri Coppulae, 1643; Gaetano Sarri, Gius publico siculo, arricchito di nuove note e di copiosissimo indice, In Palermo, dalle stampe di Gaetano Maria Bentivenga, 1786, v. 1, p. 134. 140 79 <Adversus quem Theodosius> minor Orientis imperator bellum preparavit, quod ad effectum non venit Huniis enim Thraciam Illyricumque vastantibus, exercitus Wandalorum à Sicilia revocatu, et ad defendendos Thraces et Illyrianos transmittitur. Ex Isidori opera, Chronicon Vandalorum, pag. 403 Isidorus vir egregius, Hispalensis Ecclesiae episcopus, Leandri episcopi successor et germanus floruit a tempore Mauritii imperatoris et Recocaredi regis, in quo quiddam sibi antiquitas vindicavit, immo nostrum tempus antiquitatis in eo scientiam imaginavit. Praenotatio ad Isidori operam. Fenia nel 5 libro delle Piante scrisse che il captus [!] è una pianta spinosa siciliana, e Teofrasto nel 6 libro della piante disse che nasca soltanto in Sicilia, né si ritrovi in Grecia. Ciò è riferito da Ateneo Dipnosoph. l. 2 c. 33 Ex Isidori opera Parisiis apud Ionnium, 1601. Originum lib. XIIII – Sicilia – pag. 194141 Sicilia a Sicano rege Sicaniae cognominata est: deinde a Siculo Itali fratre Sicilia. Prius autem Trinacria dicta propter tria άκρα [akra], id est promontoria, Pelorum, Pachinum et Lilyibaeum: Trinacria enim Graecum est, quod Latine, triquetra dicitur, quas in tres quadras diuisa. Hec ab Italia exiguo freto discreta, Africum mare prospectans, terris frugifera, auro abundans: cavernis tamen et fistulis penetrabilis, ventisque et sulphure plena. Unde et ibi Aethnae montis extant incendia: in cuius fretu Scylla est et Charybdis, quibus nauigia aut absorbentur aut colliduntur. Fuit autem quondam patria Cyclopum; et postea nutrix tyrannorum, frugum fertilis, ac primum terris omnibus commissis seminibus aratro proscissa. Principem urbium Syracusas habet: fontem Aretusam, et Alphaeum fluvuium magnorum generatorem equorum. In ea insula primum est inuenta comoedia. Achaten lapidem ipsa primum ex Achate flumine edidit. Parturit et mare eius corallum; gignit et salses Agrigentinos in igne solubiles, crepitates in aquis. Omnis ambitus ejus clauditor stadiorum trium millium. Sallustius autem dicit Italiae conjunctam Siciliam fuisse: sed medium spatium impetu maris divisum et per angustiam scissum. _________________________________ 141 Isidorus Hispalensis, Originum sive Etymologiarum, in: Opera omnia … Parisiis, apud Michaelem Sonnium, 1601, p. 194-195. 80 Tapsus insula, stadiis decem a Sicilia remota jacens et planior, unde et nuncupata, de qua Virgilius – “Tapsumque iacentem”. Aeoliae insulae Siciliae, appellatae ab Aeolo Hippotae filio: quem poetae finxerunt regem fuisse ventorum, sed ut Varro dicit, rector fuit istarum insularum, & quia ex earum nebulis et fumo futuros praedicebat flatus ventorum, ab imperitis visus est ventos sua potestate retinuisse. Eadem insulae et Vulcaniae vocantur, quod et ipsae sicut Aethna ardeant. Sunt autem nouem habentes propria nomina, quarum primam Lyparus quidam Lyparen vocavit, qui eam ante Aeolum rexit. Altera Hiera vocatur quod sit collibus eminentissimis, reliquae vero, id est, Strongyle, Didyme, Ericusa, Phenicusa, Euonymos, Ericodes, Phaecicodes: quae quoniam nocte ardent, Aeoliae siue Vulcaniae dicuntur. Ex iis quaedam ab initio non fuerunt, quaedam postea mari editae usque nunc permanent. Isidori Opera origin. Lib. XIV pag. 194 e seg. Cui Gensericus frater suus (id est Gunderici primi rex Wandalorum) ex catholico apostata factus succedit in regnum annorum sexaginta: qui de Beticae provuinciae litore ad Mauritaniam venit, et Africa relicta in Hispaniam transfretavit. Cui Valentinianus Occidentis imperator non valens obsistere pacem mittit, et partem Africae quam Wandali possederant tanquam pacifico tradidit, conditionibus ab eo sacramenti acceptis ne quid amplius invaderet. Ille autem sacramenti religione violata Carthaginem pervadit Siciliam depraedatur, Panormum obsidet, Arrianam pestilentiam, per totam Africam intromittit, sacerdotes Ecclesiae expellit, martyres plurimos efficit. Adversus quem Theodosium142. Sul tipo siciliano delle belle arti predominante nell’isola ab antico Ogni regione ha il suo tipo particolare nelle belle arti e talvolta ogni provincia, come di recente si è osservato in Italia, dopo il Risorgimento nelli vari secoli di pittura, di scultura e di architettura. La Sicilia bensì fin da’più antichi tempi per le varie genti straniere che l’occuparono le quali provvenivano da diverse regioni e finalmente per le colonie greche che in due terze parti la dominarono, ebbe tipi svariati de’ quali si sono adesso perdute le tracce come quello dei Sicani, de’ Sicoli, _________________________________ 142 Il testo, interrotto, è tratto da Isidorus Hispalensis, Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum, 74-76 81 degli Elimi e solo ne rimangono poche reliquie né intiere di qualche monumento ma moltissime di quelle delle colonie greche. Anche di queste il tipo della pittura ch’è più esposta all’ingiurie del tempo e per se’ evaniscente si è interamente perduta, non così nella scultura, e più nell’architettura delle quali ci rimangono frammenti e cimeli e anche opere intere di un gusto graduato dal più antico dell’arte men perfetta fino progressivamente alla perfezione ma con la caratteristica nostra isolana143. Nella scultura le statue o frammenti sono su’ modello del vero elevato al grande direi michelangiolesco, se così è il famoso Torso che si conserva nel museo Biscari in Catania, di cui avvi il gesso supplito e raccozzato dal Villareale144 nel nostro <Museo> di Palermo. Tipo di eleganza bensì fedele al naturale è quell’altro torso che io riconobbi di essere appartenuto a un Mercurio ed illustrai con un mio scritto e trovasi nel nostro Museo. Un tipo assai più aulico di scultura siciliana è quello che presentano le due metope selinuntine nel nostro Museo in una delle quali scorgesi Ercole uccisore de’ due ladroni che appesi ad un’asta li reca quasi in trionfo pendenti sulle spalle e l’altra di una Quadriga guidata da un vincitore. In questi due alti rilievi in pietra calcare lo stile avvicinasi all’egiziano ma modificato su quello peculiare de’ nostri antichi abitatori che pricorsero i greci ed io appellerei tipo misto. Alcune statue arcaiche ritruate in Sicilia già appartenenti al museo del barone Astuto e da me fatti acquistare, a quello dell’Università con altri molti oggetti archeologici, meritano di essere osservate e studiate non già per le forme rozze ma per essere singolari e pel costume degli abiti indicanti bensì il carattere nazionale e gli usi degli abiti di quei vetustissimi tempi. Due coverchi di sepolcri in marmo e sopra due figure muliebri ad altissimo rilievo trovate a Palermo a Portella di mare mostrano l’antica scultura che introdussero i Fenici nella nostra città dopo che l’occuparono con altri siti marittimi e vi fondarono Palermo, Mozia, Solunto allorchè navigando 800 anni pria di G.C. per il mar Tirreno furono adescati dall’amenità a stabilirvi la loro sede che poi cessero a connazionali cartaginiesi. Questi coverchi sepolcrali si conservano nel nostro Museo di belle arti. Però non sappiamo se la scultura di essi abbia ricevuto modificazioni da’ Fenicj qui soggiornanti da quella primitiva lor patria. In ogni modo quello stile duro e tagliente fu esclusivamente qui da cui parte. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “elegantissimo ma singolari per noi”. Le copie in gesso costituiscono degli esemplari didattici utilizzati anche dai docenti dell’Accademia del Nudo. 143 144 82 Nell’architettura siciliana si manifesta apertamente un tipo tutto proprio in gran parte diverso da quello di madre Grecia e delle nostre stesse città occupate da’ Fenici e poi da’ Cartaginesi benchè in generale ne segua il sistema degli ordini. Un tempio fra più vetusti in Siracusa è quello dorico gravissimo con fusti assai corti e stretto intercolunnio tipo originale primitivo siciliano. Le colonne anche degli altri nostri tempii posteriori dell’epoca greca non sono di cinque diametri ma sovente di quattro o quattro e mezzo, e l’intecolumnio è sempre più stretto ed altre minute particolarità i rendono quell’ordine in parte diverso dal Pericleo di Grecia madre. Talchè da tutti gli architetti è stato denominato per la differenza dorico-greco-siculo. Una particolare predilezione poi mostrarono i siciliani per quest’ordine quasi esprimente la loro antica robustezza e forza di carattere dimostrata in tante imprese guerriere lasciando a’ Greci, lor primitivi progenitori, l’ordine semplice ed elegante jonico e quello festoso ed ornato corinzio che di raro s’incontra ne’ monumenti antichi siciliani. Il nostro severissimo dorico si assomiglia a quello de’ vetusti templi di Pesto, nella prossima Calabria, che gareggiava con la Sicilia. Nel famoso nostro tempio di Giove Olimpico in Agrigento scorgonsi tali particolarità nelle doriche e robuste colonne esterne con terzo addossate a’ pilastri interni e in altre cose che non s’incontrano in nessuno de’ templi di Grecia madre e anche di Pesto, talchè puossi dire non concezione architettonica ma tipo siciliano. Il sontuoso sepolcro eretto eretto in Catania all’insigne poeta lirico ed epico Stesicoro Imerese secondo la descrizione rimastane ha singolarità straordinaria in architettura anche nella forma della pianta che puossi scorgere al tutto nuova e siciliana. L’architettura de’ tempi della dominazione romana fu più imitativa che originale in Sicilia, perocché que’ conquistatori l’assoggettarono a’ loro usi delle palestre, degli odei, de’ circoli ma pure i resti di quegli edifizî presentano delle modificazioni che accennano che l’ingegno siciliano non si rese servile a’ conquistatori romani, i quali se ci diedero leggi politiche colla forza ce ne lasciarono molte amministrative e spogliando l’isola nostra di tutte le belle statue ed oggetti preziosi d’arte per mezzo de’ loro proconsoli, e più per le rapine di Verre pure tolsero da noi il codice agrario, l’uso di coniare monete di argento, di tosar la barba, della veste talare che dava più dignità e degli orologi solari sul modello di quel di Catania trasportato in Roma e anche il culto di Cerere che trasferirono con la gran sacerdotessa nella loro città. Con questo par che siano stati più prudenti e 83 giudiziosi del moderno governo italiano che tutto ha voluto destrurre in Sicilia coll’annessione senza sostituirci il meglio, anzi in molte cose il peggio. Ed ora ci ha rapito preziosissimi lavori d’arte in vari oggetti dopo la soppressione degli ordini religiosi. A continuare le varie istorie degli antichi tempi diremo che gli Arabi che nel 7° sec. di G.C. invasero la Sicilia e l’occuparono fino al 1071 quando i prodi Normanni colla spada la tolsero ad essi e all’impero bizantino, recarono in quest’isola la loro peculiare architettura ma non già la pittura e la scultura vietata ad essi dal Corano. Quella bizzarra architettura torreggiante elevata su colonnette e sopra archi a sesto acuto e ricamata dallo scarpello coi graziosi ornati di fogliame di viti e di fiori tutto opposta a quello dei greci sobria, grave, e regolare e monotona nelle forme subì in Sicilia notabili variazioni come puossi osservare al paragone con l’altra dagli Arabi introdotta in Ispagna più ricca, più capricciosa, ma più goffa, ne’ sappiamo se ciò sia avvenuto per l’influenza degli stessi Arabi o degli architetti siciliani, i quali ad essi si associarono. L’architettura musulmana ha un tipo anche proprio in Sicilia diverso dagli Arabi di Spagna e quella successiva dei conquistatori normanni, che presenta un misto dell’araba della bizantina e della lor propria normanna che scorgesi nei tempî cristiani innalzati al culto di Dio dal conte e re Ruggiero, di Guglielmo 1° e 2°145 si ha un tipo146 d’imitazione anche nostro che puossi dire raccozzato dagli architetti siciliani e che furono raccolti da que’ valorosi conquistatori per tutta l’isola. Qui perché siasi speculata l’architettura simbolica perocchè essendosi fatta ricostruire da Gualtiero di Offamilio arcivescovo di Palermo nel 1170 col soccorso pecuniario di Guglielmo II normanno detto il Buono si volle nella cornice della parete portica indicare per le teste a mezzo rilievo con turbanti e mostaccidi saraceni infedeli debellati che sulla pittura vi figurano appese quasi in olocausto alla religione di Gesù Cristo. Egli è vero che di questa architettura simbolica, i greci sicilioti ci aveano lasciati esempî, avendo ne capitelli delle sculture ne’ tempi delle loro false divinità fatti scolpire gli emblemi delle medesime così puossi osservare in molti capitelli del Duomo di Monreale147 raccolti da tempi più antichi pagani, e difatti in alcumi vi si scorgono gli emblemi di Cerere ed in _________________________________ Seguono cancellate le parole: “innalzati al culto di Dio”. Seguono cancellate le parole: “anche tutto proprio”. 147 Cfr. Guido Meli, Un albero pieno di vita. Opera riscoperta nel portico meridionale della Cattedrale di Palermo, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1991. Il lavoro fu pubblicato in occasione del Convegno “Giornate medievali a Palermo”, Palermo 11-13 aprile 1991. 145 146 84 uno particolare ch’io vidi nel cortile dell’Albergo del Pizzuto in Palermo148 eravi il tridente che mostrava di essere appartenuto a qualche antico delubro sacrato a Nettuno. Ma nella Cattedrale di Palermo, come ho detto, il trionfo de’ principi normanni sopra i Saraceni149 è compitamente150 rappresentato. Nel portico meridionale poi del nostro Duomo, costruito posteriormente151 nell’epoca aragonese come dallo stemma si argomenta, avvi espressa in minuti e diligenti bassi rilievi con simboli la creazione e i vari misterî di nostra religione. Quest’uso della scultura allegorica non è nuovo osservandosi in varî tempi del medioevo in Italia. Una cosa nuova bensì si è che nell’architettura di un palazzo siano espressi i dritti della carica del magnate che n’era proprietario152. Francesco Patella e Abatelli, nobile palermitano prode guerriero, pretore di Palermo e maest<r>o portolano fece costruire nel 1475 il suo sontuoso palazzo nella via dell’Alloro e sulla porta del prospetto fe’ scolpire una forca legata con funi tra il trave superiore e quei laterali per indicare che colla qualità di maestro portolano ne’ casi di peste aveva dritto di far afforcare i contrabbandisti che mettevano in pericolo del contagio la città. Certo che quella strana decorazione non può avere altro significato e non già lo stemma proprio della famiglia che vi è pure espresso in un grifo rappante[!]. Io sono stato il primo a spiegare quella bizzarra simbolica153 scultura che puossi aggiungere154 a quella precedente della cripta cattedrale e prorogate in Palermo fin dal 1475 anno della costruzione del Palazzo Patella, come leggesi nelle due fastose iscrizioni laterali, ove sono indicate tutte le sue gesta e le cariche fra le quali si legge: Regni hujus magister portulanus. Quel magnifico palazzo, mancando egli di figli fu dal medesimo lasciato155 alla seconda sua moglie Maria Tocco e alla morte di lei ordinò di fondarvisi il monistero della Pietà156 e d’innalzarvisi a lato la chie_________________________________ 148 Già ubicato nel mandamento Castellammare, in piazza San Domenico. La residenza era stata ricavata da alcune case possedute dall’omonimo proprietario, il protomedico Paolo Pizzuto. 149 Seguono cancellate le parole: “colle teste de’ sovrani”. 150 Seguono cancellate le parole: “indicato e così pure il”. 151 Seguono cancellate le parole: “verso l’anno”. 152 Seguono cancellate le parole: “e l’aveva fatto costruire”. 153 Segue cancellata la parola: “allegoria”. 154 Seguono cancellate le parole: “all’architettura emblematica”. 155 Seguono cancellate le parole: “per ultimo”. 156 Dal 23 giugno 1954 sede della Pinacoteca nazionale e successivamente denominata Galleria Regionale della Sicilia. La sistemazione del museo reca la firma di Carlo Scarpa (Venezia 19061978), architetto, designer e restauratore. 85 sa per la quale destinò onze 400 e annualmente per il culto onze 100. (1)157 Quel grandioso monistero e la splendida chiesa coverta di marmi colorati è decorata di un magnifico prospetto divennero preda nel 1866 del Demanio e almeno ne avesse fatto buon uso perocchè in tutte le altre soppresse ha negato sinanco le spese del culto divino - e le poche monache ivi ancora ricoverate devono supplirvi col miserabile loro assegnamento alla messa quotidiana. E meno male che il158 Demanio159 cedendolo al nostro Municipio da cotesto intento alla distruzione non160 sia fatto diroccare come l’altro delle Sacre Stimmate profanati per uso di Teatro,161 che nel corrente anno 1868 si è cominciato ad abbattere162 prevenendo forse di mezzo secolo l’innalzamento163 del Teatro Massimo pel quale nella penuria assoluta di denaro mancheranno le ingentissime somme all’uopo necessarie. 164 L’architettura simbolica antichissima in Sicilia, come si è detto165 risorse fra noi rinnovato nel Medioevo e presenta166 pure un tipo nazionale siciliano. La scultura e la pittura figurativa ch’erano qui disparse nella <e>poca saracena e addette soltanto al culto secreto167 de’ cristiani di quel_________________________________ In calce alle c. 131r-132r cassato il testo: “(1) Per la smania antireligiosa di abbattere ed abolire col fatto chiese, come la parrocchia di S. Giacomo incrostata di marmi colorati ed ora diroccando premurosamente il monistero delle Stimmate destinato pel Teatro massimo, anche magnifiche, e monasteri che si elevano come paglicule negli occhi ai protestanti, si è anticipata di molti e molti anni la distruzione del monistero delle Stimmate non essendo ancora dopo un anno e mezzo scelto il disegno riessendo qui arrivati i dis<egni> nonostante si è ancora sotto giudizio il disegno preferibile degli architetti stranieri destinati acciò e che manchi al Comune indebitato l’ingente somma e lasciandosi intanto priva [!] del culto religioso il sontuoso tempio di S. Domenico e ingombrati di tavole le cappelle e i 36 monumenti degli illustri siciliani per appendervi i cento e più disegni. È da osservarsi intanto che per le ingenti somme pazzamente sprecate dall’attuale Municipio (1868) per la fusione di oltre circa tre milioni per il politeama che costerà almeno cinque milioni di lire e rovinerà la più bella strada suburbana e per l’altra spesa senza oggetto di quattro mostruosi nicchioni al tutto inutili della Villa Giulia di cui uno solo è stato compito e pure han costato circa 800mila lire il Comune fallito non meno che l’Erario nazionale non sarà al caso almeno per mezzo secolo di costruire un teatro che come ha imaginato dovrà costare una somma assai più ingente del Politeama. Intanto si è distrutto un grandioso monistero per favorire un impresario”. N.d.C. Il degrado della chiesa di s. Giacomo è datato 1860, anno del bombardamento borbonico e si completerà nel 1943 con le incursioni aeree del secondo conflitto mondiale che ne decreteranno la demolizione. Cfr. Le parrocchie. A cura di Angela Mazze; introduzione di Maurizio Calvesi, Palermo, S.F. Flaccovio, [1979], p. 79 e sg. 158 Segue cancellata la parola: “provvido”. 159 Seguono cancellate le parole: “col Ministero”. 160 Seguono cancellate le parole: “l’abbia”. 161 Seguono cancellate le parole: “come si essere”. 162 Seguono cancellate le parole: “e destrurre”. 163 Seguono cancellate le parole: “di quello”. 164 Precedono cancellate le parole: “Il tipo adunque”. 165 Seguono cancellate le parole: “per rinnovarlo”. 166 Segue cancellata la parola: “esso”. 167 Seguono cancellate le parole: “ne’ siciliani nell’e”. 157 86 la <e>poca168 e soltanto a’ Maomettani conservato l’intaglio169 in marmi170 e l’arte del mosaico per ornamento delle loro moschee ripreser nuova vita sotto i principi Normanni. E siccome la Sicilia resistette alla precedente persecuzione di Leone Isaurico delle sacre imagini e della setta orientale iconoclasta di oriente poté quest’isola vantare sull’Italia d’aver conservato la pittura e la scultura figurativa alla religione del Cristo. Però per le barbarie di tempi si171 rappresentavano in colori o a mosaici o collo scarpello i Santi, Dio padre, Cristo e la Vergine Maria della prima epoca normanna smilzi, secchi, come scheletri quali sono quelli del tempietto che ora appellasi di S. Simone e fu di sacre figure ornato per ordine e spesa di Giorgio Antiocheno, grande ammiraglio de’ due Ruggieri normanni. Però ma i nostri artisti posteriori accortisi bentosto di quel difetto cominciarono ad ingrandirne le forme fino all’esagerazione come scorgesi nell’Eterno padre dell’abside della Cappella Palatina di Palermo e della Cattedrale di Monreale. Quei due periodi successivi a breve intervallo dell’arte del mosaico in Sicilia ricevette la sua perfezione nelle sacre figure dell’abside del172 Duomo di Cefalù di gran lunga superiori del gran tempio di S. Marco in Venezia173, come ho potuto scorgere co’ propri occhi nel 1844. La Sicilia adunque può presentare tre tipi successivi dell’arte del mosaico ne’ suoi magnifici tempî che se non sono originariamente proprî174 degli Arabi175 pure per le modificazioni e l’aplicazioni alle sacre figure, possono dirsi esser divenuta industria artistica nostrale essendo vietato176 a’ Musulmani dal Corano di rappresentare figure umane o sacre. La pittura I principi normanni e svevi ci lasciarono invero pochi monumenti di pittura177 con colori a gomma a toni d’uovi sopra tavole ingessate. _________________________________ Segue cancellata la parola: “saracena”. Seguono cancellate le parole: “di ornati”. 170 Seguono cancellate le parole: “che svariati e ingegnosi mosaici di decorazione”. 171 Seguono cancellate le parole: “effigiavano a co”. 172 Segue cancellata la parola: “tempio”. 173 Costituiscono per la storia delle arti figurative l’archetipo della composizione pittorica bizantina. Il Gallo ricorda, presumibilmente, la decorazione del transetto della basilica di San Marco raffigurante La scoperta delle reliquie di San Marco (sec. XIII). 174 Seguono cancellate le parole: “anche per il magistero e i vetri colorati invenzioni proprie”. 175 Seguono cancellate le parole: “da loro recate in quest’isola”. 176 Segue cancellata la parola: “agl’”. 177 Seguono cancellate le parole: “a guazzo”. 168 169 87 In due madonne una del tempio di S. Simone e l’altro di Monte Vergini lo stile grandeggia goffamente, ma pure è nostro e al tutto contrario di quello secco di Cimabue178 e di altri pittori che si osservano in Italia e di alcuni in particolare nel Cimitero di Pisa179. Un trittico nella chiesetta di Gesù e Maria presso quella di Santa Cuma ha la singolarità di mostrare l’arte in progresso sebbene vi si legga l’anno segnato 1222 anteriore a Cimabue ed a Giotto. Un altro quadro sopra asse, quasi della stessa epoca, vi fu fatto osserva180 re dal nostro egregio scultore Villareale che conservavasi nell’interno del monistero di S.ta Caterina e con gran croce istoriata a figure sacre,181 scorgeasi nel Parlatorio del Cancelliere e un Crocifisso dipinto alquanto posteriore si conserva in Termini. Le quali opere mostrano un carattere proprio siciliano sì per la vivace espressione182 e alcune e alcune [!] per l’ingrandimento delle forme che in Italia riteneansi ancora secche e cadaveriche. La varietà delle Scuole appo noi ebbero ragione verso la metà del secolo XV e in progresso. L’architettura negli anni seguenti ritenne183 nelle fabbriche di alcuni nostri professori l’antico carattere del Medioe Evo con gli archetti a sesto acuto e il ricamo di fogliami a traforo o scolpiti sui muri come si scorge nella gran finestra angolare nel palazzo arcivescovile184 in Palermo e nell’altro surriferito del maestro portulano Patella185. Altri nostri artisti modificarono quel vecchio stile con quello del risorgimento186 rendendo quasi circolari gli archi acuti come sono quelli del portico di Santa Maria della Catena187 e nell’altro ***188 nel quale poste_________________________________ Cenni (o Bencivieni) di Pepo, detto Cimabue, pittore (notizie 1272-1302). Il Camposanto di Pisa fa parte del complesso architettonico della piazza dei Miracoli, progettato da Giovanni di Simone (1278-1283). Nel Camposanto fra gli altri si ricorda l’affresco del Trionfo della Morte prima attribuito al pittore Francesco Traini (sec. XIV), oggi invece al pittore Buonamico di Martino, detto Buffalmacco, nato a Firenze nel 1290, ivi morto nel 1340. 180 Seguono cancellate le parole: “nell’inter”. 181 Seguono cancellate le parole: “ma alquanto posteriore si conservano in Termini”. 182 Cfr. Maria Concetta Di Natale, Le croci dipinte in Sicilia. L’area occidentale dal XIV al XVI secolo, Palermo, Flaccovio, 1992. 183 Seguono cancellate le parole: “in alcuni nostri”. 184 All’angolo della facciata principale di stile gotico del Palazzo arcivescovile, edificato a partire dal 1460 per opera dell’arcivescovo Simone di Bologna, si staglia l’elegante trifora. 185 Matteo Carnilivari, architetto, nato a Noto e vissuto nella seconda metà del sec. XV, è il progettista dell’edificio. Cfr. Filippo Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo da documenti inediti, Roma, F.lli Palombi, 1958. 186 Seguono cancellate le parole: “curvando gli archetti”. 187 Il portico della chiesa di S. Maria della Catena presenta degli elementi ispanizzanti caratteristici dell’architettura del XV secolo. 188 La similitudine stilistica è con la chiesa di S. Maria la Nuova che presenta il portico a tre arcate tra due filoncini. 178 179 88 riormente fu addossata collo stesso stile la fabbrica delle stanze superiori. Queste novità in architettura son tutte siciliane e presentano un tipo nostro peculiare che indi sviluppossi in quello palladiano d’Italia189. Sorsero allora tra noi come ivi le varie scuole di pittura e di scultura. Primeggiarono quella di Palermo e l’altra di Messina più antica190. Ma la prima è tutta originale e la seconda di bella imitazione delle migliori scuole dell’Italia, avendo quel Municipio fin dall’epoca del risorgimento191 sostenuto fuori a studiare i suoi concittadini talché ritornarono egregî artisti sì ma seguaci per lo più di quelle d’Italia. Non così il municipio di Palermo che per molti secoli non si diè mai briga d’inviare in Italia i giovani artisti, ma invece in Bologna quelli che attendevano allo studio della giurisprudenza come Antonio <Beccadelli detto il panormita>. Da questa trascuranza del Comune di Palermo provenne alle nostre scuole di pittura e di scultura un bene perocché studiando i nostri giovani in patria acquistarono una originalità e si distinsero alcuni anche sugli artisti italiani contemporanei non raggiungendo bensì i sommi Buonarroti, Sanzio, Correggio e Tiziano. L’Anemolo192 recossi in Roma, studiò le opere di Raffaello, fu iniziato particolarmente da Polidoro Caldara, ma avendo osservato il bel colorito de’ pittori veneziani nel disegno mostrossi raffaellesco e nelle tinte seguace della scuola veneziana e in parte di quella di Leonardo da Vinci che ha tinte più robuste e sorgive. Egli puossi dire un pittore ecclettico, e incontra stabilmente per tal qualità superiore agli altri del secolo XVI in Palermo. Talché presenta nei suoi molteplici quadri e più nel suo capolavoro la Discesa dalla Croce193 pria nella chiesa di S. Giacomo ora nella nostra Università, un tipo di bellezza, eleganza artistica siciliana. Pietro Novelli194 nato in Monreale a 2 marzo 1603 ma soggiornante sempre nella vicina Palermo e morto ivi a 22 agosto 1647 ne’ suoi moltis_________________________________ Il concetto di palladianesimo espresso dal Gallo si riferisce al contesto classicistico a cui aderiscono anche gli architetti del neoclassicismo siciliano: leggi per tutti Giuseppe Venanzio Marvuglia. 190 Una lunga e tormentata controversia intercorre tra Gallo e gli storiografi delle due capitali delle arti figurative: Cfr. Carmelo La Farina, Ricerche intorno le belle arti e gli artisti fioriti in varie epoche in Messina, Messina, Stamp. Fiumara, 1835. 191 Segue cancellata la parola: “spedito”. 192 Vincenzo degli Azani da Pavia, conosciuto anche come Vincenzo Anemolo, (detto anche il Romano), pittore attivo dal 1529 al 1557, anno della morte. Una versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 461-463. La mostra antologica, Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V. A cura di Teresa Viscuso, Siracusa, Ediprint, 1999, ne ha individuato le caratteristiche compositive e pittoriche. 193 Il dipinto non è citato nel catalogo Vincenzo degli Azani … cit. 194 Vedi nota n. 18. 189 89 simi quadri mostrò non solo fecondità d’invenzioni, rapida spontaneità di pennello e buon disegno e fondò in Sicilia una scuola di pittura che puossi dire originale, perocchè è da riguardarsi anche per l’Italia come il primo tra i pittori naturalisti che non fu da nessuno superato per la verità de’ volti e per l’efficacia dell’espressioni, talchè sembra a ciascuno che miri i personaggi delle sue tele di averli conosciuti e incontrati in società o nelle campagne. Non pertanto in quelli di una classe più elevata scorgesi rigorosamente il vero congiunto ad un grado d’ideale che confondesi con l’altro lo nobi<li>ta ma non l’altera punto. E siccome egli lasciò molti scolari che nol raggiunsero ma pure ne seguirono le tracce può esser considerato come il fondatore del vero tipo pittorico siciliano sì per l’anzidette qualità e sì per avere ritratto fedelmente le fisionomie de’ suoi connazionali. Nella scultura in legno e particolarmente ne’ piccoli pastori da presepe segnolossi in Sicilia quasi allo stesso tempo del Novelli un certo Matera195 che seppe ritrarre i villici, le pecore, i buoi, i cavalli con tale evidenza e fedeltà nelle forme che non puossi far di meglio. Però, nell’effigiare i Re Magi per i presepi, non seppe elevarsi alla dignità di quegli alti personaggi il che ci fa credere ch’egli sia sempre vissuto nei campi. Similmente nella pittura abilissimo mostrossi a rappresentare i villici e i loro costumi e gli animali. Nella scultura possiam noi vantare una famiglia di artisti di Caltagirone per nome Bongiovanni, i quali dalla metà del secolo XVIII finoggi han modellato in creta i costumi de’ villici, degli artigiani de’ venditori con tale evidenza d’imitazione e di volti di vario carattere che quelle figure di circa un palmo sono ricercate avidamente dagli stranieri e formano ormai l’ornamento de’ gabinetti de i nostri e degli esteri amatori. Quella scuola trascorse in Palermo e in essa si sono distinti *** Marino196, il quale esegue anche bene ritratti in cera ed è buono scultore in legno. In quest’arte poi si elevarono Girolamo Bagnasco197 e Francesco Quattrocchi198 poco dopo la metà del secolo corrente e ornarono di statue molte chiese di Palermo e dell’interno dell’isola.199 Ne’ volti della Vergine Maria e di altre sante e sé in quelle di vecchi di gran carattere è improntato il tipo siciliano e particolarmente in quello femineo la rotondità, il piccante e la _________________________________ Giovanni Matera, scultore, nato a Trapani 1653, ivi morto nel 1708. Pietro Marino, scultore, operante nel XVIII secolo. 197 Girolamo Bagnasco, scultore, nato a Palermo nel 1759, ivi morto nel 1832. Cfr. Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 259-262. 198 Francesco Quattrocchi, scultore e decoratore palermitano attivo nella prima metà del XIX secolo. 199 A c. 135r nota a margine: “E tutti questi artisti non imitatori degli esteri hanno un tipo siciliano”. 195 196 90 grazia delle nostre donne. Il Bagnasco anche si distinse anche ne’ pastori, ne’ bassi rilievi di altari guidato bensì da’ disegni del suo amico Giuseppe Patania e il Quattrocchi ne’ volti senili de’ santi ed elevossi nel suo Cristo morto, figura al naturale nella chiesa della Solidad in Palermo. Era egli operosissimo infaticabile artista e in pochi giorni nel 1860 fe’ molte statue per macchine disposte dalla nostra città per onorar la venuta del nuovo re Vittorio Emanuele ed una colossale in una notte e poche ore del giorno seguente, onde diffaticatosi di troppo ne morì. Nelle opere di questi due valorosi artisti vi ha sempre il tipo siciliano, che par che sia stato esclusivo di quelli di Palermo, onde possono meritare il vanto di originalità fino a Giuseppe Patania di cui ora ragioneremo. Costui, nato in Palermo nel 1780 figlio di un misero sarto cominciò a disegnar da se e per pochi mesi migliorò sotto il celebre Giuseppe Velasques200 e allontanatosene per il brusco trattamento del medesimo gli disse: Sarò pittore senza di lui. E lo fu. Perocchè nel procacciarsi da vivere, cominciò a dipingere per poca moneta cartelloni da teatro e progredendo coll’esercizio in questi dipinti di grande effetto e in piccoli ad olio imitante l’antico divenne grado grado artista di prim’ordine principalmente per l’invenzione, per la grazia e facilità di pennello. Riuscì in tutti i generi, nel paesaggio e vieppiù ne’ ritratti e ne’ disegni a penna, ammirati dallo stesso celebre Camuccini201 in Napoli presso il marchese Gargallo alla mia presenza. Lasciò a’ suoi eredi di questi disegni di storia patria, profana, mitologica e della vita di Gesù tutti di sua originale composizione e condotti con diligenza e vivace espressione circa a 500 carte, di cui metà furono da me acquistati. I migliori pittori attuali Giuseppe Bagnasco202, Natale Carta203, che or si è reso celebre in Roma, Giuseppe Carta juniore204, Giuseppe Di Giovanni205 ed alcuni altri che figurano ormai nell’interno di quest’isola furono suoi _________________________________ Vedi nota n. 33. Vincenzo Camuccini, pittore, nato a Roma nel 1771, ivi morto nel 1884, rappresentante del neoclassicismo romano. 202 Giuseppe Bagnasco, scultore, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1882. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 379-380. 203 Natale Carta, pittore, nato a Messina nel 1800, morto a Palermo nel 1884. Cfr. Agostino Gallo, Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti … cit., p. 275-276 e Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 322-324. 204 Giuseppe Carta <junior>, pittore, figlio e allievo di Natale, nato a Palermo nel 1809/1810, ivi morto nel 1889. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti …, cit., p. 389-391. Il Gallo lo chiama juniore per distinguerlo dal nonno Giuseppe, pittore, nato a Messina, e da un altro Giuseppe, pittore, cugino del padre, nato a Messina nel 1760, ivi morto nel 1832. 205 Giuseppe Di Giovanni, pittore, incisore, illustratore di libri, nato a Palermo nel 1814, ivi morto nel 1898. Il 23 novembre 1834 Valerio Villareale, firma la liberatoria d’ingresso alla «Quadreria della R. Università di Studi», reputandolo «abile a poter studiare ne’ gessi e dipingere» (Archivio di Stato di Palermo, Permessi di studio…, Misc. Arch. II, n. 316. 200 201 91 scolari ma nessuno menochè Di Giovanni e il Carta seguì interamente lo stile del maestro avendolo gli altri modificato colla scuola estera del Riolo206 e del Lo Forte207. Talchè il solo Patania e i predetti due diseguali e particolarmente il loro maestro possono mostrare il vero tipo nazionale e il Patania ne’ dipinti da cavalletto e ne’ volti feminei ritrae sempre con grazia singolare le nostre più belle ragazze, come puossi osservare nelle tre Veneri ch’io ne posseiedo e nell’Amor materno sul concetto di Correggio208. Morì egli compianto da tutti e da nessuno ancor seppelito nel 1852. L’invidia lo proseguì fino alla tomba per essere egli stato preferito dal pubblico ed affollato di lavori. E ben disse sul proposito il poeta inglese Pope: L’invidia siegue il merito come il corpo in sentiero. Ma al par di quello mostraci che sia reale e vero. La prova incontrastabile si è che la sua Venere e Adone presentata dopo la di lui morte all’Esposizione di Firenze e il suo Ritratto furono da tutti ammirati e i suoi piccoli quadri dai suoi eredi venduti al doppio di quanto egli stesso discretamente rilasciavali, che ora anche al triplo, eppure i suoi invidi e non emoli sparlano di lui e del suo massimo tra gli allievi Natale Carta che in Roma era già consigliere dell’Accademia di San Luca ed è stato eletto dal voto della medesima Accademia di San Luca cattedratico di pittura per l’insegnamento del disegno insieme col commendatore Podesti209, come mi avvisa il mio dolce amico Salvatore Betti con sua lettera del 20 luglio 1868. Sembra che col Patania sia cessata in Palermo e in Sicilia la scuola del suo tipo nazionale essendo gli altri valorosi artisti che hanno studiato fuori rivolti alle imitazioni del bello sotto egregi maestri. Nella scultura e architettura che vantavano tra noi una propria originalità ab antico l’han conservata ma sono divenuti imitatrici delle altre scuole italiane. E lo stesso Villareale insigne scultore e allievo di Canova dopo trent’anni circa di dimora in Roma in Napoli recò tra noi il bello classico dell’arte sua al quale educò Rosolino Barbera210, Rosario _________________________________ Vedi nota n. 34. Salvatore Lo Forte, pittore, nato a Palermo nel 1809, ivi morto nel 1885. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 375-378. 208 Antonio Allegri, detto il Correggio, pittore rappresentante del manierismo emiliano, nato a Correggio nel 1488, ivi morto nel 1534. 209 Francesco Podesti, pittore, nato ad Ancona il 21 marzo 1800, morto a Roma il 10 febbraio 1895. 210 Rosolino Barbera, scultore, allievo di Valerio Villareale. Il 27 ottobre 1827 Giuseppe Patania, in qualità di docente della Scuola di Disegno presso la R. Università degli Studi di Palermo, dichiara «di conoscere tutta la suscettibilità» dell’allievo e lo reputa idoneo « a potere studiare sui modelli di gesso esistenti» nella sede accademica. A.S.PA, Permessi di studio … cit., Misc. Arch. II, n. 316. 206 207 92 Anastasi211, Benedetto De Lisi212, Nunzio Morello213, *** Barbera214 e Giuseppe Pollet215 che distinguesi adesso tra’ migliori scultori in Parigi. E’ un problema bensì delle belle arti se il bello classico antico o pure quello troppo naturale di pedantesca imitazione siano preferibili all’altro originale che mostra la fisionomia e il carattere e il tipo di un regno e di una provincia. Certo è bensi che l’Italia era fastosa delle sue varie scuole di cui provinciali o di antiche città come sono la romana, la fiorentina, la lombarda, la bolognese, la napoletana e vi aggiungo la siciliana e fra l’estere la fiamminga, la spagnola, la francese, inglese e tedesca. Laddove confuse queste scuole in una o due soltanto di mera imitazione non possono rappresentare la varietà del bello e le umane figure e anche nel paesaggio che offre la natura dapertutto. Ma così riunite con un modello d’imitazione perdono l’originalità ed acquistano la pesante monotonia che rifugge nella poesia e nelle arti del disegno da quel bello svariato e piccante che noi ammiriamo in natura e riprodotto nelle varie Gallerie di Europa. Palermo, 27 luglio 1868 Dettato da Agostino Gallo Belle arti in Sicilia Notizie sugli artisti siciliani216 Belle arti in Sicilia Secolo XIII La dinastia dei principi Normanni che cominciò sin dall’XI secolo a dominare in Sicilia impugnando i suoi due gran capitani Roberto Guiscardo e Ruggieri Bosso colla destra la spada e con la sinistra la croce favorì sempre la religione cristiana e quindi col culto delle sacre imagini sorsero in quest’isola artisti in gran numero coi nuovi tempî erettivi; tal_________________________________ 211 Rosario Anastasi, scultore palermitano. L’8 ottobre 1830 Valerio Villareale avalla l’ingresso «nello studio de’ quadri e gessi» presso il Real Museo di Palermo. A.S.PA., Misc. Arch. II, n. Permessi di studio … cit. 212 Benedetto De Lisi, scultore, nato a Palermo nel 1831, ivi morto nel 1875. 213 Nunzio Morello, scultore, nato a Palermo nel 1806, ivi morto nel 1875 o 1878. 214 Carlo La Barbera, pittore attivo nel XIX secolo. Rubricato in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 388. 215 Joseph Michel-Ange Pollet, scultore, nato a Palermo nel 1814 e morto a Parigi nel 1870. L’8 ottobre 1830 Valerio Villareale ne avalla l’ingresso «nello studio de’ quadri e gessi» presso il Real Museo di Palermo. A.S.PA., Permessi di studio … cit., Misc. Arc. II, n. 316. 216 Postilla dell’A.: “E tutti questi artisti non imitatori degli esteri hanno un tipo siciliano”. 93 chè architetti, scultori, mosaicisti e pittori furono allora occupati con immenso loro profitto in lavori magnifici e multiplici. L’arte in quel tempo non era che una, la quale piegavasi sul fondamento del disegno all’architettura e alla scultura, alla pittura a colori sciolti in gomme o al torlo d’uovo o al mosaico con sassolini e vetri colorati. La successiva dinastia Sveva sebbene non fosse stata molto tenera per la religione anzi provocata dai Papi l’ostegiasse pure in apparenza per confessar l’amore dei popoli mostrava di favorirla affinchè non desse maggiori pretesti alla corte romana che li avrebbe voluto suportarle a rivolta. In quel secolo eransi iniziate in Germania per spirito di religione e forse di liberalismo le Compagnie degli artisti che si offrivano a costruire tempî a plausibili condizioni onde sorsero le sontuose cattedrali di Germania e d’Italia. L’imperator Federico, secondo il Pirri (1)217, sin dal 1221 confermò in Sicilia la Festa dell’offerta dei cerei, stabilita forse nel tempo dei principi normanni, dei varî consolati di mestieri dandone egli stesso l’empio con offrire il suo cereo nella Cattedrale di Palermo nei giorni solenni della Natività e Resurrezione del Redentore e nell’Assunzione della Vergine. Ecco le parole del Pirro: «Imp. Fridericus II insulae rex in unoque, videlicet anniversario tarenos 200 et cereos et ex aloe tam pro ipsis anniversariis quam pro solemnitatibus dominice nativitatis resurrectionis et assumptionis Virginis secundum quod antea ipsa ecclesia consuevit». Sembra che questa festa dei cerei siesi posteriormente limitata al giorno 15 di agosto in cui festeggiasi dalla Chiesa l’Assunzione della Vergine Maria e Palermo che con tutta la magnificenza la celebrava ne die’ l’esempio a tutte le cattedrali dell’isola come da un regolamento dell’arcivescovo di Palermo pei dì festivi dei santi titolari si argomenta (2)218. Noi tralasciamo d’occuparci delle forme di quella solennità per trarre argomento da quella pratica religiosa seguita dai re Aragonesi e successivamente fino al 1860 in cui fu abolita nella vertigine dei tempi nostri che tutte le antiche usanze ha destrutto per mostrare che un gran numero di artisti vi dovea essere a Palermo nei tempi normanni, svevi, e successivi, il che reca meraviglia per le due epoche menzionate, in cui erano scarsis_________________________________ 217 A c. 140v nota in calce: “(1) Not. 1a Pan. pag. 144”. <Rocco Pirri, Sicilia sacra disquisitionibus, et notitiis illustrata. … Editio secunda. Correctior, ac aucta ampliori Regum Siciliae chronologia, ... Panormi, ex typographia Petri Coppulae, 1644, p. 144>. 218 A c. 140v nota in calce: “(2) Amato, De principe templo panormit., <libri XIII> Pan. 1728, per Aiccardo, pag. 88 e seg.” <Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano libri XIII, in quibus ostenditur panormitana cathedra a S. Petro apostolo instituta ... Panormi, ex typographia Joannis Baptistae Aiccardo, 1728, p. 88 e seg.> 94 simi in Italia benchè per poco fosse stata interrotta quella costumanza sul principio del secolo XVI che indi venne ripristinata e per straordinarie circostanze interrotta dal 1708 fino al 1729. La popolazione divisa sin dall’origine della nostra monarchia in diversi consolati di mestieri era tenuta a prestare omaggio alla Beata Vergine col cereo che offrirle dovea nella Cattedrale ad essa consacrata nel giorno 15 agosto nel quale con solenne processione percorreano le vie della nostra capitale. Da un documento addotto dall’Amato dell’opera citata (1)219 rilevansi tutti consolati ch’erano ammessi a quella sacra funzione fra i quali quelle degli scultori e dei pittori e degli orefici. Però non veggo menzionati gli architetti per la ragione testè indicata che gli scultori e i pittori di quel tempo esercitavano congiuntamente quella professione. Or trattandosi di consolati rappresentanti un ceto di persone addetti ad un mestiere, non puossi supporre che fossero uno o due, ma molti sotto il governo di un capo o superiore; laonde quegli artisti eran per certo in buon numero ed invero nelle antiche chiese di Palermo e delle principali città dell’isola nostra si osservano ancora nonostante la destruzione recatavi dal tempo degl’incendi e dalle guerre a cui essa è stata soggetta molte statue e dipinture e sacri e profani edifizi che annunziano la vetustà del Medioevo. Ma sia che gli artisti non ardivano di apporre il loro nome sotto le sacre imagini forse per riverenza credendo profanarle, come era pur vietato nei tempi greci agli architetti pei tempî sia ch’ora allora prevalsa questa usanza per divieto del Governo, noi ignoriamo gli artefici che eseguirono quelle opere e appena ho potuto di pochissimi indagarne il nome rammentati in diplomi ed altre antiche carte. Ho incluso fra gli artisti gli orefici abilitati anch’essi a presentare il loro cereo perocchè tali devonsi riguardare e particolarmente in quel tempo in cui facevano lavori mirabili di disegno figurativo e ornamentale in rame, in oro e in argento e in leggiadri smalti talchè in una mia operetta220 sostenni che l’arte di smaltare è antichissima in Sicilia, alcuni dei quali lavori conservansi ancora nelle nostre vetuste chiese. Posteriormente prevalse tra noi l’uso che i consolati ciascuno dei quali aveasi costruita una chiesa per le riunioni religiose nel dì della presenta_________________________________ A c. 141r nota in calce: “(1) pag. 86 e seg.” <Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano ..., cit., p. 86-87>. Per le notizie storiche, cfr: “Opuscoli del marchese di Villabianca”, Francesco Maria Emanuele Getani, marchese di Villabianca, Processioni di Palermo sacre e profane. A cura di Angela Mazzè, Palermo, Giada, 1989, p. 115-125. 220 Cfr. Agostino Gallo, Sull’influenza ch’esercitarono gli artisti italiani in vari regni d’Europa ad introdurre, diffondervi e migliorar l’arte d’intagliare cammei e pietre dure, incidere in rame, cesellare e smaltare in argento e in oro, Palermo, Tip. Barcellona, 1863. 219 95 zione del cereo conduceva nel Piano della nostra Cattedrale una macchina di legno ornata architettonicamente di colonne dorate entro le quali scorgeasi la statua di legno del santo protettore ovvero l’imagine di esso con testa, mani e piedi modellati in cera e abbigliato di fine drapperia. Il lusso religioso in questo in questo riguardo crebbe tanto che queste macchine, da noi dette cilî e quelle figure sacre divennero toneggianti monumenti d’arte eseguite magistrevolmente secondo il gusto dei tempi. E in alcuni di questi cilî scorgeansi sempre rappresentati in molte figure brani di storia sacra talvolta profane come nel cilio dei pp. Cappuccini diviso in più ordini di architettura ove vi si scorgevano bene effigiati in cera da circa 60 figure maschili e femmine e di bambini che io con sommo rammarico vidi colla macchina distrutta vendersi a tenuissimo prezzo al modellatore in cera Giuseppe Cocchiara nel 1853 e tuttavia la sua vedova moglie conserva di alcuni le teste. Fra le macchine di tal genere più magnifiche oltre quelle or menzionate dei pp. Cappuccini esservi l’altra dei pp. Domenicani di Santa Cita, sebbene le altre meno grandi eran tutte variate e di bizzarro disegno con ingente spesa d’intaglio e di doratura. Le confraternite non avevano cilio esponevano e recavano in processione le statue dei rispettivi santi protettori sopra una gran base di legno che i devoti come i cilî anzidetti recavano indosso accompagnati da strumenti musicali. Fra queste statue era singolare il gruppo dei due Santi Cosma e Damiani non per bellezza artistica giacchè per questo riguardo era singolare quella scolpita da Gagini221 in legno di San Giacomo a cui indi fu aggiunta l’altra inferiore di S. Filippo. Le due statue congiunte di S. Cosma e Damiano che appartenevano alla Congregazione dei marinari, eran da loro condotte in processione con rapidissima corsa e in mezzo alla piazza Vigliena222 vi faceano eseguire una specie di ridda aggirandoli a tondo come un anemolo. Queste ridicole usanze e la celerissima corsa dei due santi ebbe origine da un fatto istorico perocchè essendo essi implorati dalle città come Santi medici nelle occasioni della peste ciascuna famiglia che n’era affetta desiderava di avere i santi innanzi la propria magione affinchè ne fosse _________________________________ L’opera non è registrata nel saggio che Agostino Gallo dedica all’artista: vedi nota n. 29. Piazza Vigliena, denominazione correlata al nome dell’omonimo viceré, nota altresi come Teatro del Sole o Quattro canti di città. Altri appellativi sono piazza Villena e Teatro del Sole: cfr. Marcello Fagiolo – Maria Luisa Madonna, Il teatro del Sole. La rifondazione di Palermo nel Cinquecento e l’idea della città barocca, Roma, Officina, 1981. 221 222 96 liberata e fermandosi un istante in mezzo alla piazza Vigliena che è centro delle quattro strade che s’incrocicchiano la loro presenza nell’aggirarsi era rivolta ai quattro quartieri della città, sui quali esercitar dovevano la loro sacra influenza. Dimenticata l’occasione primitiva di quell’uso diveniva questo oggetto d’uso ai nazionali e agli homini spettatori. Si aggiungeva a questo curioso spettacolo un altro non meno ridicolo e più periglioso ed era che un robusto facchino recava una gran bandiera attaccata sopra un’antenna di naviglio e la sosteneva or sulla pianta della destra e anche sulla base del mento per modo ch’esquilibrata poteva riuscir fatale a lui e agli spettatori. Protettori delle belle arti in Sicilia secolo XV-XVI Le nobili arti del disegno hanno incrementato sostegno per la protezione de’ principi e di alti personagi che incoraggiano gli artisti commettendo loro delle opere pubbliche o private, e rimunerandole largamente; talchè a questo titolo divengono benemeriti delle arti stesse, e impongono all’istoria di lasciar di loro onorevol ricordanza. Abbiam precedentemente parlato de’ principi Normanni e Svevi i primi de’ quali predominati dallo spirito di religione promossero e migliorarono l’architettura in Palermo, la pittura principalmente a mosaico, ed anche la scultura. Abbiam pure osservato che i principi Svevi ed Aragonesi occupati più in ostinate guerre e nella difesa di quest’isola si diedero poca briga delle belle arti promovuendo e soltanto tra noi l’architettura militare223, e a loro imitazione i nostri baroni, fabbricando ò migliorando i primi immense forteze, e gli altri castelli che servivano loro di abitazione e di difesa. L’opera certo più sontuosa che siasi ideata ed eseguita in Palermo fu l’immenso prospetto occidentale della Cattedrale di Palermo che si estende in lunghezza pal. 92 e in larghezza pal. 118 composto di piccole pietre oblunghe ben lavorate e ornate a sgraffio in molte parti, che ha due torri laterali di pal. 118 formanti in simmetria con altri due della parte portica. Quel prospetto ha tre porte, la maggiore centrale di bianco marmo alta pal. 26 e larg. 18 è lavorata a spire e artificiosamente tagliata con profusione di ornati, e similmente le altre due parti minori. _________________________________ Il riferimento tipologico è all’architettura militare di età federiciana: in particolare il Castello Maniace di Siracusa e il Castello Ursino di Catania. 223 97 Credesi dall’Inveges224 che sia stata promossa da Ottaviano de Labbro arcivescovo di Palermo nel 1352 e 1359, e sebbene contradetto dal Pirri225 che l’attribuisce all’arcivescovo Martino De Marini [i.e. Ubertino De Marinis] nel 1430 e dal Pe Amato al Senato di Palermo prima del 1421, pure io giudicando dallo stile non posso riferirla che all’arcivescovo De Labbro che potè iniziarla e per la ricchezza e complicazione de’ lavori non potè vederla compita; talchè fu attribuita all’arcivescovo posteriore De Marini. Il Senato palermitano, come patrono della Cattedrale, dovette erogarne l’immensa spesa. Nel secolo XV in cui ebbe origine in Sicilia il governo viceregio sotto Martino il giovane e il vecchio, che avevano stabilito in Ispagna la loro residenza, questi rappresentanti de’ nostri re procurarono, per esser graditi a’ popoli dell’isola, di promuovere opere pubbliche, e grandi edifizî; talché per questo riguardo meritano alcuni di essere rammentati, particolarmente come protettori delle belle arti. La regina Costanza divenuta Vicaria di Martino il giovane dal 1409 al 1415 profuse ricchezze per migliorare il monistero di S. Placido delle monache benedettine in Catania, e maggiori per la costruzione della chiesa parrocchiale dell’Albergaria in Palermo col suo alto campanile a forma di torre, avendo ornato quel sacro edifizio di buona architettura conforme a’ tempi226. Sotto il governo del magnanimo Alfonso che da Napoli reggeva la Sicilia sorse nell’ordine benedettino il P. Giuliano Majale da Palermo e acquistossi fama nelle sacre lettere, e pubblicò varie opere ascetiche, e mostrò molta destrezza in varie ambascerie che sostenne a nome di quel sovrano. Costui al ritorno in patria spinto da carità cristiana e sociale fondò l’Ospedale civico in questa capitale ripetto al R. Palazzo che durò dal 1440 in quel sito fino al 1849 quando il principe di Satriano lo convertì in quartiere militare, confinando gli ammalati in un meschino edifizio addetto a’ militari nel quartiere dell’Albergheria227. L’inclito fondatore avea meritato dalla chiesa per la santità della sua vita e dal principe di Pandolfina Giuseppe Monroy allora soprintendente dell’ospedale un monumento marmoreo scolpito egregiamente dal celebre Valerio _________________________________ Agostino Inveges, Annali della felice città di Palermo, In Palermo, nella typographia di Pietro dell’Isola impressor camerale, 1649-1651, v. 3, p. 449. 225 Rocco Pirri, Sicilia sacra … cit., v. 1, col. 175. 226 L’immobile nel 1874 è dichiarato fatiscente e negato alle funzioni religiose: cfr. Le parrocchie cit., p. 313 e sgg. 227 Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria a Palermo dal XVI al XIX secolo. L’ospedale Grande e Nuovo, Palermo, Accademia delle scienze mediche, 1992. 224 98 Villareale da Palermo, che dopo la nuova destinazione dell’ospedale a quartiere fu da me fatto trasportare nel 1861 in S. Domenico divenuto per mia cooperazione il Pantheon degl’illustri siciliani, usando prima che fosse ristorata la figura del genio che scrive il nome del beato Giuliano de’ vasti recatigli da’ vandali militari228. Sotto il vicerè Scimendarre229 fioriva in santità e dottrina il Beato Pietro Geremia da Palermo dell’ordine de’ pp. Predicatori. Costui nell’anno 1444 sollecitò quel rappresentante del re Alfonzo a far riparare la Cattedrale di Catania che minacciava rovina, l’anno seguente quel magnanimo sovrano innalzò in Catania la famosa Università degli studii prima a sorgere in Sicilia, e un magnifico edifizio vi fu costruito; talchè Alfonzo merita di essere riconosciuto benemerito delle scienze, delle lettere, e delle arti belle della Sicilia. Ma convien ricordare ad onor di Palermo che suo Segretario di stato e consigliere influente era il nostro Antonio Beccadelli, detto dalla sua patria il Panormita, insigne istorico e poeta latino, sebbene osceno nel suo Ermafrodita; laonde quanto Napoli ov’egli stabilì la prima accademia letteraria, che ingiustamente fu denominato il Pontaniana dal suo successore Pontano, devesi principalmente all’illustre nostro concittadino Beccadelli, e a buon volere del magnanimo principe. Simon Bologna Palermitano Arcivesco<vo> e presidente del Regno di Sicilia sin dal 1453 sotto il medesimo Alfonzo, è da credere che promovesse la fabbrica del sontuosissimo portico della nostra Cattedrale decorato di tre archi a sesto acuto, e nel prospetto sulla pietra dolce di sacre figurine e di rabbeschi, ove in centro si scorge l’aquila aragonese indicante l’origine d’Alfonzo che a quella famiglia apparteneva, sebbene figura come secondo re castigliano. Simon Bologna splendidissimo fra i nostri prelati dovette suggerire al benefico sovrano quell’opera che accresce magnificenza alla nostra Cattedrale; molto più che di altro fu instancabile promotore230, e che lo stemma reale ci richiama ad Alfonso e al tempo nel quale regnò, come pure a Simon Bologna che resse la chiesa di Palermo. Tra i benemeriti delle belle arti deve pure annoverarsi Cesare Marullo nobile messinese che fu prima vescovo di Girgenti, e poi arcivescovo di _________________________________ Il busto di Giuliano Majali, scolpito da Valerio Villareale, è collocato nella navata destra. Ximenes de Urrea, viceré di Sicilia dal 1443 al 1445. Cfr. Giovanni Evangelista Di Blasi, Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia. 3. ed. Palermo, tipografia Pietro Pensante, 1873, p. 66. 230 Tra tutte le opere promosse da Simone Bologna (1446-65), arcivescovo e presidente del Regno, ricordiamo la edificazione della piazza e del portico meridionale della cattedrale e la costruzione del nuovo Palazzo arcivescovile. 228 229 99 Palermo, uomo d’integerrimi costumi, e di somma carità cristiana che fondò l’Ospedale de’ Benfratelli231 pe’ sacerdoti infermi, ornò la Cattedrale di Palermo, costruì un carcere nel palazzo arcivescovile pe’ sacerdoti delinquenti, abellì il Palazzo arcivescovile, eresse dalle fondamenta il Seminario de’ chierici nel 1582, e gli die’ un pingue assegnamento di 3000 scudi all’anno. Amante della bella architettura aveva egli costruito in Messina un casino di delizie nella spiaggia di San Francesco di Paola. Morì egli in Palermo a 12 novembre 1588, e fu seppellito nell’antica cappella del SS. Crocifisso della nostra Cattedrale, la quale cappella era stata costruita a sue spese. Eppure quell’ottimo prelato non visse che soli anni 51. Nel 1494 si eseguì in Catania ed innalzato nella cattedrale il sepolcro e il busto marmoreo del viceré D. Ferdinando D’Acugna ivi morto. Il viceré Ettore Pignatello duca di Monteleone (1517) fece innalzare sulla chiesa di Castellammare i due arieti di bronzo, lavoro greco sicolo, trovati in Siracusa e dal marchese Geraci pria portati in Castelbono sotto il viceré Gaspare di Spes. Vedi Mario Aretio, Del sito di Sicilia, e Carrera, Epig. 1523232. Furono indi collocati nel R. Palazzo di Palermo, uno destrutto nella rivoluzione del 1820 e l’altro nel 1853 trasportato nella R. Università di Palermo (Auria, Istor. di viceré, p. 32)233. Sotto il viceré Ettore Pignatelli nel 1530 Carlo V concesse in feudo l’isola di Malta appartenente alla Sicilia sin dal tempo del re Ruggiero, a cavalieri della religion gerosolimitana. Quell’isola fu nel secolo XIX appropiata dagl’Inglesi (Auria, p. 32). Il viceré Ettore Pignatelli edificò a sue spese nel 1527 in Palermo il monistero de’ 7 Angeli, destrutto nel bombardamento delle truppe borboniche nella rivoluzione del 1860. Lo stesso Pignatelli edificò nel 1519 il Conservatorio di S. Francesco di Paola fuori le porte di Palermo. Morì il Pignatelli dopo 17 anni di viceregno morì in Palermo in marzo 1534 e il suo <corpo> ricevuto nella chiesa de’ 7 Angeli fu indi trasportato in Monteleone in Calabria (Auria, p. 33). La chiesa e confraternita de’ Bianchi vicino alla Gangia in Palermo fu fondata da’ nobili circa 1540 (Auria, p. 34) e quella della Carità nel 1533 dal Pignatelli. Egli troppo devoto bensì rimise il Tribunale dell’inquisizio_________________________________ Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria a Palermo dal XVI al XIX secolo. Parte II, Palermo, Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Palermo già del buon gusto, 1998, p. 25 e sgg. 232 Claudio Mario Arezzo, De situ insulae Siciliae libellus, Panhormi, 1537 (Panhormi, in officina Antonii de Mayda sua ipsius impensa excussus, mense decembri 1537). 233 Vincenzo Auria, Historia cronologica delli signori vicere di Sicilia dal tempo che mancò la personale assistenza de’ serenissimi rè di quella. Cioè dall’anno 1409 sino al 1697 presente. In Palermo, per Pietro Coppola stamp. cam. della SS. Inqu. e illustr. Senato, 1697, p. 32. 231 100 ne sospeso per tumultuazione della plebe nel 1516 sotto il viceré Moncada (Auria, Ibidem, p. 33 e 34). Nel 1532 fu innalzato il busto in marmo (forse opera di Antonio Gagini palermitano) del viceré Ferdinando Gonzaga nella Compagnia de’ Bianchi in Palermo. Il Gonzaga fortificò Messina con bastioni nel 1536 e il castello detto del Salvatore, e un altro castello detto dal suo nome Gonzaga e in Palermo migliorò il Castello del Molo e pure fortificò Trapani, Melazzo, Catania, Siracusa, Augusta, e ideava di fortificare anche Lentini. Sotto di lui ch’era valoroso guerriero fiorì in Sicilia l’architettura militare (Vedi Gosellini che ne scrisse la vita, Ven. 1539234) Auria pag. 49. Sepolcro marmoreo innalzato nel Duomo di Patti nel 1568 all’arcivescovo di Terragona pria canonico Bartolomeo Sebastiano nella Cattedrale di Palermo (Auria pag. 47). Don Garzia del Toledo, viceré di Sicilia nel 1565 progettò il Molo di Palermo in detto anno di cui gettò la prima pietra il presidente del regno ffte da viceré D. Carlo d’Aragona e Tagliavia a 19 luglio 1567 e proseguì la strada Toledo fino al mare. Cominciò in Messina la fabbrica dell’arsenale per le galere che fu proseguita dal marchese di Pescara, dal duca di Terranova e dal marchese Briatico. Fortificò vieppiù Augusta fabbricandovi due forti in mezzo del porto detto uno Garzia, dal suo nome, e l’altro Vittoria da quello della moglie. Fondò l’Accademia d’armi di molti cavalieri nel 1566 (Auria pag. 49 e seg.) Il sudetto viceré D. Garzia Toledo fe’ comprare al Senato di Palermo nel 1572 per il prezzo di ventimila scudi, 37 statue onde abbellirne la gran fonte innanzi il Palazzo Pretorio. Queste statue erano destinate per una villa del viceré Pietro Toledo in Napoli morto il quale i figli li vendettero al Senato di Palermo. Francesco Camiliani235 scultore ed architetto par che ne abbia suggerito l’idea. Nella statua di Vertumno si legge Opus Francisci Camiliani Florentini 1554 e nell’urna del fiume Oreto anche il suo nome, la patria e l’anno 1555. Nell’urna poi del fiume Papireto, Opus me Angelus Vagherinus [!] flor. Fra le statue vi sono quelle di Venere, di Adone, di Ercole, di Bacco, di Apollide, di Diana, di Mercurio, di Pomona, di Cerere con Tritolamo236 e di Venere con Vertunno, di Opi con l’aquila e _________________________________ Giuliano Goselini, Vita dell’illustrissimo et generosissimo sig. d. Ferrando Gonzaga principe di Molfetta. Diuisa in tre parti ... Di nuouo ristampata, et ampliata …, In Venetia, [eredi di Francesco Rampazetto], 1579. 235 Francesco Camilliani, o Della Camilla, scultore ed architetto, nato a Firenze nel 1530, ivi morto nel 1576, autore di tre delle statue dei fiumi della fontana di piazza Pretoria, la quarta fu opera di Michelangelo Naccherino scultore, nato a Firenze nel 1530, morto a Napoli nel 1622. 236 Leggasi: “Trittolemo”. 234 101 quattro statue di fiumi Oreto, Mare dolce, Papireto e Gabriele. Antonio Veneziano celebre poeta dispose e indi descrisse in versi latini la collocazione delle statue come rilevasi da una sua lettera riferita dal Baronio nel libro De maiest. Pan. Pag. 126.237 Però credo io che quanto alla parte architettonica la fonte sia stata diretta da Francesco Camiliani che venne in Palermo a tale oggetto e indi rimase qui e fu fatto Ispettor generale delle fortificazioni di Sicilia con Carlo Ventimiglia, come ricavasi da un manoscritto della Biblioteca del Senato238. La Fonte Pretoria costò in tutto per compra di statue e collocazione onze 27277 e per prezzo delle case atterrate per la piazza ove fu collocata onze 8823,09. In tutto cioè per le statue ed ornamenti onze 8400, per pulirle onze 1407, per assettarle onze 3641,15 per prezzo di undici denari d’acqua onze 5005 (Auria, pag. 52 e seg.) Sotto il viceré D. Carlo d’Aragona e Tagliavia detto nel 1571 si fece in Palermo la Piazza Bologna colla direzione di D. Giovanni Bologna nobile palermitano. Ivi nel 1631 fu innalzata poi la statua di bronzo di Carlo V (Auria, pag. 58). Il presidente del Regno D. Carlo d’Aragona e Tagliavia palermitano funzionante da Viceré per ordine di Carlo V° eseguito nel 1582, fe’ chiudere con grosse pietre la bocca del porto di Marsala vicino all’Africa onde non essere invaso da’ Turchi. Credo io ch’era meglio di farlo custodire dalle galere, anziché di rovinarlo (Auria, pag. 89). Egli l’Aragona fe’ costruire il Borgo di S.ta Lucia fuori di Palermo che sin dal 1575 era costruito in parte di mura e in parte di tavole onde poi fu tutto edificato insieme con la chiesa e parrocchia di pietre. Nel 1572 i Padri Olivetani sgombrarono dal convento di S.ta Maria dello Spasimo per la costruzione di un gran baluardo in quella parte di Palermo e passarono nel monistero di S.to Spirito ove fu trasportato nel mese di luglio del 1573 il famoso quadro di S.ta Maria dello Spasimo del famoso Raffaello e recato nella chiesa di S.to Spirito239. _________________________________ 237 Francesco Baronio Manfredi, De maiestate Panormitana libri IV, Panormi, apud Alphonsum de Isola, 1630. 238 Camillo Camilliani, scultore, architetto e ingegnere, nato a Firenze, morto a Palermo nel 1603, figlio o fratello di Francesco, sistemò la fontana in piazza Pretoria e rimase a Palermo dove dal 1583 si occupò delle torri costiere siciliane; Carlo Maria Ventimiglia, letterato e matematico (Palermo, 1570-1667). 239 Agostino Gallo, “Sopra un quadro di Raffaello Sanzio posseduto in Palermo da’ P. Filippini dell’Oratorio in Palermo. Osservazioni storico-critiche”, in L’indagatore siciliano, a. I (1835), vol. II, p. 27-43. Con l’ausilio della documentazione archivistica, l’A. rivendica la paternità artistica al maestro umbro. Il saggio successivo è titolato Sopra un famoso quadro di Raffaello nel tempio dell’Olivella. Storia prove ed illustrazione, Palermo, Tip. via dell’Università 44, 1871. 102 Sotto di Marcantonio Colonna Viceré nel 1577 fu fatto eseguire dal Senato di Palermo il quadro di S.to Rocco e S. Sebastiano santi protettori di questa città per la cessazione della peste. Il pittore fu Giovan Paolo Fendulio240 cremonese che vi scrisse sotto il suo nome e l’anno 1578. Questo pittore stabilissi a Palermo e migliorò il suo stile guardando le opere di Vincenzo Anemolo241 palermitano della scuola di Raffaello. E difatti il quadro di S.to Rocco sente tutto della maniera dell’Anemolo mentre gli altri quadri del Fendulio che si osservano nella chiesa di Porto Salvo hanno un altro stile e sono di gran lunga inferiori (Auria, pag. 60). Il Viceré Marcantonio Colonna (1577) fece costruire e gettar le fondamenta di un grande edifizio nella via Toledo a tre aprile 1578 che servir doveva per Regia Dogana, e indi fu convertito in carcere, e poi *** destinato a Palazzo delle Finanze e quasi interamente rifabbricato dall’architetto Emmanuele Palazzolo242 che vi fece imitando come scimia il portico di Giuseppe Marvuglia243 che avea ideato per l’Università di Palermo nel 1866 (Auria, pag. 61). Lo stesso Viceré Colonna fe’ proseguire la strada Toledo dalla chiesa di Porto Salvo nel 1581 sino al mare, e allora si cominciò la costruzione della magnifica Porta (1583) denominata Felice244 per la sua moglie Felice Orsina, e lungo la Marina costruì il passeggio estivo per le carrozze, e allato della Porta de’ Greci vi pose una gran fonte con mostri marini e in mezzo la statua di una Sirena che spargeva acqua dalle mammelle. Quella fonte come molte altre di Palermo fu tolta via da quel sito verso il 1810, né collocata in altro. Lo stesso vicerè nel 1584 fe’ innalzare la Porta detta Nuova opposta a quella Felice in memoria dell’ingresso trionfale in Africa dell’imperatore Carlo V, e nell’anno precedente gettò anche la prima pietra del Seminario de’ Chierici attaccato al Palazzo Arcivescovile essendo allora arcivescovo di Palermo D. Cesare Marullo messinese (Auria, pag. 61). _________________________________ Giovanni Paolo Fonduli o Fondulli, pittore cremonese, operante a Palermo dal 1568, vivente nel 1600. 241 Vedi nota n. 192. 242 Emanuele Palazzotto, architetto, nato a Palermo nel 1798, ivi morto nel 1872. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 206-208. Tra il 1840 e il 1844 trasforma il palazzo della Vicaria (piazza Marina) in Palazzo delle Reali Finanze con l’innesto di un portico dorico. 243 Giuseppe Venanzio Marvuglia, architetto, nato a Palermo nel 1729, ivi morto nel 1814. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 151-152 e Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 471-472. 244 Il progetto originario è del 1582, forse di Giovanni Battista Collipietra; i lavori, interrotti già nel 1582, furono ripresi nel 1602 e affidati all’architetto Mariano Smiriglio che vi lavorò fino al 1636, anno della sua morte; gli interventi di Pietro Novelli operati nel biennio 1636-37 sono documentati in Guido Di Stefano, Pietro Novelli, il monrealese; prefazione di Giulio Carlo Argan; Catalogo delle opere e repertori a cura di Angela Mazzè, Palermo, S.F. Flaccovio, 1989, p. 299-302. 240 103 Questo istesso arcivescovo fe’ coronare Francesco Potenzano245 di Palermo, pittore e poeta con pubblica solennità. Egli avea scritto un poema sulla destruzione di Gerusalemme in otto canti, stampati in Napoli per Antonio Pace nel 1600. Havvi di lui un quadro nell’altare maggiore nella Confraternita della Pace presso l’attuale parrocchia della Kalsa246. I suoi versi bensì e le sue pitture l’annunziano come mediocre, ma fortunato poeta e pittore ch’ebbe pure coniate delle medaglie. Il viceré Colonna partì da Palermo nella Spagna nel 1584 e ammalatosi a Medinaceli morì il 1 agosto 1585 di anni 49 (Auria, pag. 62 e seg.). Le torri che servivano di fari pel littorale di Sicilia onde avvertire coi fuochi le invasioni nemiche credonsi anticamente stabilite dagli Arabi. Ma indi furono accresciute sotto il viceré ***247 e ulteriormente sotto Marcantonio Colonna ottennero dai Parlamenti diverse dotazioni e soggetti ad un regolamento stampato nel 1658. Il viceré D. Diego Henriquez de Guzman, conte d’Albadelista (1585) fe’ ristorare nell’anno seguente lo spedale di S. Bartolomeo248. Fondò la Casa delle verginelle nel 1591 attaccato alla chiesa di S.ta Lucia del Monte di Pietà a spese del Senato di Palermo. Ritornando da Messina a Palermo a 15 dicembre 1590 si sprofondò in mare il ponte costruitogli di legno presso la chiesa di Piedigrotta e vi morirono annegati molti nobili e gentiluomini. Nel 1591 fe’ edificare a spese del Senato il Monte grande di Pietà. Nel suo tempo fe’ disseccare in Palermo il lago del Papireto a consiglio del Protomedico Filippo Ingrassia ond’evitare le febbri micidiali autunnali. Ridusse in bella forma la famosa fontana del Garraffo ora trasportata (1863) con poco senno nel Piano della Marina per consiglio dell’architetto municipale Filippo Basile249 che non seppe calcolare di esser troppo piccina per quella immensa area come lo era adatta nel sito del Garaffo. Altra fonte fé porre al Borgo di Santa Lucia nel 1587, altra al Molo nel _________________________________ Francesco Potenzano, pittore e poeta palermitano vissuto e operante nella seconda metà del XVI secolo. La sua biografia è stata sapientemente redatta da Antonino Mongitore, Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis qui tum vetera, tum recentiora saecula illustrarunt notitiae locupletissimae, Panormi, ex typographia Didaci Bua, 1707-1714, v. 1, p. 234. Ammirato dai contemporanei: cfr. Rime di diuersi eccel. autori in lingua siciliana. Al illustre pittore poeta S. Francesco Potenzano palermitano. Con le risposte marauigliose del medesmo nella istessa lingua siciliana, In Napoli, apresso Horatio Saluiani Cesare Cesari & fratelli, 1582; è, altresì, autore delle seguenti opere: Epitafi fatti in morte del sig. capitano Oratio Acquaviva nell’onorate esequie fatte in Barcellona, Roma, [s.d.]; La destruttione di Gerusalemme dall’Imperatore Tito Vespesiano. Poema heroico diviso in otto canti, Napoli, Pace, 1600, opera postuma. 246 Demolita nel 1852. Per le notizie storiche, cfr. Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici religiosi di Palermo, Palermo, Edi Oftes, 1991, p. 38-39. 247 Juan de Vega (1547-1557) cfr. Salvatore Mazzarella - Renato Zanca, Il libro delle torri, Palermo, Sellerio, 1985, p. 35 e seg. 248 Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria …. parte II, cit., p. 142 e sgg. 249 Giovan Battista Filippo Basile, architetto, nato a Palermo nel 1825, ivi morto nel 1891. 245 104 1589. Ristorò nel 1591 il portico superiore per godere le signore del mare presso la Compagnia della Carità250, ed ora presso la casa di Santocanale. Pose due fontane presso alla porta della Vicaria, indi convertita in Casa di Finanza. Nel 1589 fe’ costruire lo Spedale detto degli Spagnuoli infermi, in parte convertito in Segreteria della Luogotenenza e abbellito nel 1850 dall’architetto Carlo Giachery251. Continuò l’opera del braccio del molo. Coll’elemosine suggerì di costruirsi lo Spedale dei PP. Benfratelli nel 1588252. Riformò e accrebbe le fortificazioni delle isole della Pantelleria e il suo castello e lasciò la Sicilia nel 1592 (Auria pag. 64 e seg.). Don Enrico De Gusman conte di Olivares, viceré nel 1592. Fece eseguire il braccio di grosse pietre sul piccolo porto detto della Garita. Proseguì lo Spedale degli spagnuoli nel quartiere militare253. Compì il Molo cominciato da Don Garzia de Toleto. A 29 agosto 1593 sotto il suo governo incendiossi la polverista entro il Castellammare e vi uccise molti carcerati, tra i quali il celebre poeta Antonio Veneziano da Morreale che per una satira contro il Vicerè vi era stato racchiuso (Auria pag. 67). D. Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci, eletto Presidente del Regno nel 1495 dopo il Conte di Olivares, il quale pria di partire avea fatto innalzare in una torre la lanterna del Molo. Il nuovo viceré conte Olivares nel 1595 fe’ convertire in Vicaria l’antica Dogana, onde il Senato palermitano vi fece ingenti spese per le stanze superiori pe’ magistrati, e sotto per pubbliche carceri. Statua emblematica di Palermo a Selinunte Sotto Giovanni Ventimiglia s’innalzò nel 1595 nel cortile del Palazzo Pretorio una antica statuetta marmorea rappresentante Palermo in un vecchio barbuto, con un serpe che s’avvicina al petto e un canestro di fiori e l’aquila e fenice e un fulmine a’ piedi che il Fazzello (Deca I, lib. 8)254 dice che il serpe significhi: suos devorat alienos nutrit, ed è simile ad una medaglia di bronzo presso di lui. Il Paruta255 bensì la riferisce a Selinunte, perché è rappresentata ivi una donna, e in quella di Palermo un uomo (Auria, pag. 68). _________________________________ Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria … parte II, cit. Carlo Giachery, architetto, nato a Padova nel 1812-, morto a Palermo nel 1865. Cfr. la recente monografia curata da Giuseppe Di Benedetto, Carlo Giachery, Palermo, Flaccovio, 2011. 252 Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria … parte II, cit. 253 Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria … parte II, cit. 254 Tommaso Fazello, De rebus siculis … cit.; [trad. italiana:] Storia di Sicilia; presentazione di Massimo Ganci; introduzione, traduzione e note di Antonino De Rosalia e Gianfranco Nuzzo, Palermo, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 1990, v. 1, p. 400, descrive la fisionomia di Palermo con i tratti fisiognomici di un «uomo <con> barba lunga a punta, la … testa … cinta di un diadema regale; il suo petto è avvolto da un serpente che lo succhia; davanti ai piedi ha una cesta piena d’oro e di fiori con questa scritta: Palermo vaso d’oro divora i suoi e nutre gli estranei. 255 Filippo Paruta, Della Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie parte prima, In Palermo, appresso Gio. Battista Maringo, 1612. 250 251 105 1597 Don Bernardo Cardinas duca di Maccheda viceré sin d’aprile 1597 ingrandì il Reale Palazzo, e vi fece una galleria e il cortile con colonne di selce. Promosse la strada dal suo nome detta Macqueda che fa croce nel centro col Cassero e s’aprì a 24 luglio 1600, fe’ proseguire il tempio di S. Lucia al Borgo, fortificò la castella marittima pel timore di aggressione della Sicilia di Scipione Cicala messinese rinnegato, e salito al grado di Bassa col nuovo nome Sinam; ma pur costui con la sua flotta sbarcò nella fossa di S. Giovanni presso Messina mandò al viceré un suo schiavo cristiano chiedendogli in grazia di fargli vedere sua madre Lucrezia promettendo per tal favore di non assalir più la Sicilia, a cui si era rivolto per vendetta che tal grazia aveva implorato invano per mezzo di suo figlio rimaso in ostaggio al viceré suo predecessore conte Olivares. Ma il duca di Maqueda, reso accorto dal primo caso, il permise, né il Cicala più minacciò la Sicilia con la sua flotta barbaresca che comandava ricevendo pria e abbracciando con lacrime di tenerezza la madre, e due di suoi fratelli, e dando ad essi preziosi doni li rimandò (Auria pag. 71 [ma 70]). Nel 1598 sotto il governo del duca di Maccheda avvenuta la morte del re Filippo II si eseguirono i sontuosi funerali nel Duomo di Palermo, e indi magnifiche feste per l’innalzamento al trono di Filippo III (Auria, p. 71). Morì il Maccheda a’ 16 dic. 1601 ed essendo molto amato ebbe funerali sontuosi nel nostro Duomo ove gli fu innalzata una gran piramide ornata di statue e di emblemi. Pietro Carrera di Militello scrisse questi versi latini per quell’ottimo vicerè, ch’esprimono quelle opere che promosse in Palermo. Reddita quadrifida est me praecipiente Panormus, Accepitque suam Curia tota domum. Regia celsa novas aedes, seriemque columnarum Induit, ipse Afris terror, et ipse reis. Pacavi aequoreas sedes, urbemque viasque, mox cecidi, cita sors optima quaeque rapit. Auria p. 71 [ma 72] Oggetti d’arte trasportati da Sicilia all’estero e monumenti destrutti a Palermo Fonti pubbliche tolte via in Palermo Una piccola fonte bassa nel semicerchio rimpetto Porta Felice. Altra grande elevata e adorna di statue di divinità marine allato di 106 Porta de’ Greci e collocata a proposta di Agostino Gallo in centro della piazza di Santa Teresa dietro il Real Palazzo. Alle statue furono rifatte le teste dal Villareale e sottratte nella rivoluzione del 1848 e sostituito al gruppo di mezzo una sgarbata aguglia co’ nomi di alcuni liberali morti in quel tempo. Due fonti magnifiche destrutte La fonte nel largo del Carmine. Statue distrutte nella rivoluzione del 1820 nel Foro Borbonico di Carlo 2°, di Filippo V, di Carlo IV°, di Ferdinando 3 restituitosi l’ordine pubblico e rifatta da Villareale la testa a Ferdinando ed innalzata la statua di Francesco 1° scolpita da Villareale coll’altra abbattuta nel 1848. Ritornato il governo borbonico furono scolpite da artisti di Napoli le statue di Carlo 3°, di Ferdinando 1°, di Francesco 1°, di Ferdinando 2° furono distrutte nel 1848 e similmente quella leggiadrissima di Filippo 2° di scuola del Gaggini che dal palazzo del Santo Uffizio ora del Tribunale era stata collocata rimpetto la Doganella. La statua della Beata Vergine presso la spiaggia rimpetto il palazzo di Aragona non si sa da chi involata. Statua di Ferdinando 3° nel Palazzo Pretorio mutilata della testa. Statua di Filippo 2° di bronzo nella piazza del Real palazzo destrutta nel 1848. Statue di bronzo di *** a lato della colonna di S. Domenico destrutta nel 1848. Statua di S. Gaetano a tre bassorilievi tolta dal lato dell’Università nel 1864.256 _________________________________ Alla c. 153r-v duplicato il testo: “Oggetti d’arte trasportatai da Sicilia all’estero e i monumenti destrutti in Palermo Fonti pubbliche tolte via in Palermo Una piccola fonte bassa nel semicerchio rimpetto Porta Felice. Altra grande elevata e adorna di statue di divinità marine allato di Porta de’ Greci e collocata a proposta di Agostino Gallo in centro della piazza di S. Teresa dietro il R. Palazzo. Alle statue furono rifatte le teste dal Villareale e sottratte nella rivoluzione del 1848 e sostituito al gruppo di mezzo una sgarbata aguglia co’ nome di alcuni liberali morti in quel tempo. Due fonti magnifiche destrutte nella via di Mezzomorreale La fonte nel largo del Carmine. Statue distrutte nella rivoluzione del 1820 nel Foro Borbonico di Carlo 2°, di Filippo V, di Carlo III, di Ferdinando III restituitosi l’ordine pubblico e rifatta da Villareale la testa a Ferdinando ed innalzata la statua di Francesco I scolpita da Villareale coll’altra abbattuta nel 1848. Ritornato il governo borbonico furono scolpite da artisti di Napoli le statue di Carlo III, di Ferdinando I, di Francesco I, di Ferdinando II e furon destrutte nel 1848 e similmente quella leggiadrissima di Filippo II di scuola del Gagini che dal palazzo del Santo Uffizio ora del Tribunale era stata collocata rimpetto la Doganella. La statua della Beata Vergine presso la spiaggia rimpetto il palazzo di Aragona non si sa da chi involata. Statua di Ferdinando III nel Palazzo Pretorio mutilata della testa. Statua di Filippo II di bronzo nella piazza del Real palazzo destrutta nel 1848. Statue di bronzo di *** a lato della colonna di S. Domenico destrutta nel 1848. Statua di S. Gaetano a tre bassorilievi tolta dal lato dell’Università nel 1864”. 256 107 Oggetti monumentali e quadri e statue principali da osservarsi in Palermo. Università degli Studi Dopo la prima soppressione dei PP. Gesuiti nel 1768 in Palermo essendo stata eretta un’Accademia di studio nel Collegio Massimo gesuitico e ripristinata la Compagnia di Gesù nel 1805 fu nella Casa dei PP. Teatini rimpetto al Real Teatro detto Carolino fondata la Regia Università per efficace cooperazione del P. Piazzi e del principe di Belmonte Giuseppe Ventimiglia257. Il primo, facendo cedere dai PP. del suo Ordine Teatino quel loro magnifico edifizio, e l’altro cooperandosi colla Real corte per elevarlo al grado di Università al pari di quell’antica di Catania. Giuseppe ed Emmanuele Marvuglia famosi architetti riformarono la fabbrica all’uso a cui venne destinata. Ma sventuratamente il sontuoso portico dorico siculo, che avea cominciato ad innalzare Giuseppe Marvuglia per intrighi ed invidia dopo che il principe di Belmonte per la tentata rivoluzione del 1812 cadde dalle grazie della Real Corte fu atterrato quel portico, che ne avrebbe manifestato a’ posteri la sua benefica influenza, e vi fu sostituito quel presente ed ignobile ingresso sul disegno del Sigr Cristoforo Cavallaro. E nel 1864 quel balordo prospetto eseguito dall’architetto Carlo Giachery milanese e professore di detta Università. Il principe di Belmonte memore sempre delle sue patrie, e di quell’edifizio, che destinato ad una Università da lui promossa volle alla sua morte donare alla stessa la sua scelta collezione di quadri e di stampe rare da sommi artisti incise alle quali furono indi rubate quelle rarissime dell’Eleghin258. Il marchese Haus259, che prima n’era stato deputato lasciolle in testamento alcuni suoi quadri, altri le furono donati da Ferdinando 2° e di recente il famoso quadro di Luca di Leiden260 e una Santa Rosalia del Van Dych261 dal principe di Malvagna262, _________________________________ 257 Le vicende correlate alla presenza di G. Piazzi e di Giuseppe Emanuele Ventimiglia principe di Belmonte si intersecano nella poderosa indagine di O. Cancila, Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860, Palermo 2006. 258 Probabilmente Jan van Helegen (sec. XVI). 259 Giuseppe Haus, amico di Agostino Gallo il quale gli dedica la biografia: Su la vita e le opere del march. Giac Gius. Haus insigne letterato. Memorie, Palermo, dalla Tip. di F. Solli, 1833. 260 Lucas van Leyden (Luca da Leida), incisore e pittore olandese (1489/94-1533). 261 Antoon van Dyck, pittore fiammingo di età barocca, (Anversa 1599- Londra 1641). Una versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 70. Qui il riferimento è alla tela commessa all’artista nel 1624 in occasione della peste dilagata in Palermo dai Confratelli dell’Oratorio di S. Domenico e raffigura la Madonna del Rosario con S. Domenico e le patrone di Palermo, tra le quali fa capolino S. Rosalia, la taumaturga della moria. Il pittore completa l’opera nel 1628 a Genova da dove la spedisce. 262 Al patrizio è correlata la presenza dell’omonimo Trittico ligneo, prezioso olio su tavola dipinto nel 1510 dal pittore fiammingo Jan Gossaert Mabuse (1478-1532). È raffigurata La Madonna in trono col Bambino e angioletti (nella parte mediana), le SS. Caterina e Dorotea nella parte interna delle antine, Adamo ed Eva e altre figure all’esterno delle stesse. 108 che ancora non si è potuto dall’eredità conseguire. Fu indi comprato il bozzetto dello Spasimo di Raffaello vendutogli per onze cento dal Sig.r Valerio Villareale. E in seguito per maneggi di Agostino Gallo fu acquistata la testa del Cristo spirante del Correggio venduta per onze cinquanta dal marchese di Santa Lucia. Vi furono aggiunti altri due insigni quadri di Pietro Novelli, già appartenuti alla Congregazione del Ponticello rappresentanti San Pietro nel carcere liberato da un angelo, e l’altro Maria Santissima con altre sante vergini e ultimamente il quadro dell’Anemolo del San Corrao comprato dall’eredità del principe di Palagonia per onze quattrocento. Dopo la soppressione degli ordini monastici nel 1866 quella Pubblica Galleria bene ordinata e fatta ristorare ne’ suoi quadri e nelle statue dal Gallo quando era deputato dell’Università e salvato l’avea nella rivoluzione del 1848 fu essa accresciuta notabilmente di nuovi quadri pregevoli. E soprattutto di quelli dell’Anemolo scolare di Raffaello della chiesa distrutta di San Giacomo la Marina e delle Congregazione dei Santi Quaranta Martiri alla Guilla e di altri dipinti delle chiese e confraternite abolite; e principalmente di dodici quadri della Chiesa di Santa Cita dei Padri Domenicani, che possono riguardarsi come i migliori di Palermo. Il Museo di antichità dopo di avere acquistato molte statue antiche dalla vedova di M.r Fagan, console inglese per onze ottocento e la collezione numismatica di monete greco-sicule del signor Gandolfo di Termini che fu in parte espilata nella rivoluzione del 1820 e in parte riacquistata per cooperazione dell’abate Domenico Vinci allora cancelliere è stata accresciuta col dono del benemerito Sig.r Girolamo Valenza e di tutti i suoi libri d’arte. E finalmente con l’acquisto di un alto rilievo fenicio per diecimila lire venduto dal principe di Niscemi, anche prima per cooperazione del barone Pietro Pisani263 aveva acquistato le famose metope selinuntine anteriori alcune all’epoca greca ed altre nell’inizio della medesima scavata in Selinunte dai due artisti inglesi Harris ed Egel264 e raccozzate da molti fram_________________________________ Pietro Pisani (Palermo 1760-1837), patrizio palermitano ed illuminato cultore d’archeologia e di arte, è l’icona della cultura positivi sta in Sicilia. Cfr. G. Agnetti-A. Barbato, Il barone Pisani e la Real casa dei matti, Palermo 1997; Angela Mazzè, “Tipologia e arredo nella Real casa dei matti di Palermo nel progetto di Pietro Pisani”, in: Struttura e funzionalità delle istituzioni ospitaliere siciliane nei secoli 18. e 19. Salute e società. Atti del 3. Seminario di studi, Palermo, 26-28 ottobre 1989. A cura di Calogero Valenti, [S. l.], Centro italiano di storia sanitaria e ospitaliera Sicilia, 1991 (Palermo, S.T.ASS.), p. 313-323. 264 Samuel Angell - William Evans, Sculptured Metops discovered amongst the Ruins of the Temple of the ancient City of Selinus. Londra, 1826. Traduzione in italiano di F. Gruis nel Giornale di scienze, lettere e arti per la Sicilia, v. 20, a. 5 (1827), p. 65-82. Cfr. anche Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco, “Sulle metope nuovamente scoperte a Selinunte: lettera… al sig. Gerhard”, in Giornale di Scienze Lettere e arti per la Sicilia, 36, 1831, n. 108, p. 290-297. 263 109 menti con somma industria dall’egregio scultore sig.r Villareale ed arricchito vieppiù dalla compra della collezione di statue, bassorilievi, candelabri, iscrizioni del barone Astuto265, comprata per onze milledugento con la cooperazione del Sig.r Agostino Gallo. E finalmente accresciuto col museo di antichità etrusche per cooperazione del senatore del regno Sig.r Francesco Di Giovanni, è diventato sì numeroso che non potea più contenersi nel locale antico dell’Università, sebbene vi si avrebbe potuto aggiungere come proposto avea il deputato Gallo un altro locale dietro ad una casa laterale de’ PP. Teatini. Nulla di meno la deputazione di antichità e belle arti preseduta dal Sig.r Francesco Perez266 propose di trasportarsi quadri, statue, bassorilievi e tutt’altro nell’abolita casa dei PP. Olivetani che invero sarebbe stata troppo angusta pei corridoi. Ma determinossi di alternare i nuovi divisori delle stanze monastiche e anche alcune volte; e così con ingente spesa si è resa adatta anche pei quadri grandi di chiesa. I tre cortili bensì sono opportuni per le statue, bassi rilievi, metope e iscrizioni ed altri oggetti. Però essendosi erogata un ingente somma per la fabbrica e più pel capriccio del Soprintendente Cav. Giovanni Fraccia267 destinato allo scorso del Perez, la Commessione di Antichità e belle arti che ne ha fornito la spesa ha dovuto sospendere gli scavi di monumenti antichi. Il Fraccia intanto profittando di venti stanze monocali dell’ordine superiore, ne avea formato un palazzetto per la sua famiglia, e di altre quattro stanze di suoi parenti con farvi costruire tre scale per proprio uso. Il Governo bensì avvertito di questo enorme sopruso ne lo cacciò affidandone l’incarico della continuazione della riforma dell’edificio all’insigne architetto Sig.r Saverio Cavallaro268. Passeranno molti anni che quella fabbrica potrà dirsi compiuta. E se nella scelta si fosse avuto più giudizio a destinare per stabilimento delle belle arti la parte dell’edificio del _________________________________ Antonino Astuto, barone di Fargione, illuminato collezionista e fondatore a Noto (Siracusa) dell’omonimo Museo di antichità congiunto ad un Gabinetto di storia naturale sicula e ad una biblioteca dotata di rari manoscritti. Cfr. Luca Francesco La Ciura, “Lettera intorno al Museo e alla Biblioteca Astuziana, col catalogo dei manoscritti di essa biblioteca”, in: Nuova raccolta di Opuscoli di autori siciliani, Palermo 1788-1797, v. VII (1795), p. 289-320. 266 Cfr. Francesco Perez, Raccolta di prose e poesie edite ed inedite, Palermo, tip. Clamis e Roberti, 1845. Un cameo critico è stato curato da Antonino Sole, Francesco Perez fra storia e ideologia, Palermo, 1990 (Siciliani illustri / Accademia nazionale di scienze lettere e arti già del Buon gusto di Palermo, 1/2) 267 Fraccia Giovanni archeologo, numismatico e storiografo. La sua vasta produzione è rubricata in Giuseppe Maria Mira, Bibliografia siciliana … cit., v. 1, p. 365-366. Il riferimento è al saggio Ricerche ed osservazioni ultimamente fatte in Segesta. Relazione archeologica … diretta alla Commessione di Antichita e Belle Arti, Palermo, Stab. tip. di F. Lao, 1855. 268 Vedi nota n. 123. 265 110 Collegio Massimo269 a man sinistra che corrisponde alla strada che conduce a San Cosma ove trovansi immense sale e un gran cortile interno, non si sarebbe sciupate quelle ingentissime somme erogate per le riforme dell’Olivella. La proposta di quella parte dell’edifizio gesuitico che era stata fatta dal Gallo al barone Mandralisca270 allora segretario del governo recarvisi insieme a visitarlo e il trovarono opportunissimo all’oggetto ma uscendo egli di carica come pure il271 Gallo da quello di Segretario con voto della Commissione di antichità e belle arti fu abbandonata, e invece per intrighi del Sig.r Giovanni Fraccia che dovea procurarsi per suo uso della famiglia e de’ suoi parenti un palazzetto fu preferito l’edifizio dell’Olivella privandosi il pubblico di una biblioteca di circa 30 mila volumi, che quei Padri tenevano aperta ad uso del pubblico ed anche del vantaggio, di una farmacia fondata col sistema chimico moderno del celebre Dr. Casoria che vi avea bene istruito diversi allievi ed ivi discretissimo prezzo vendonsi i medicamenti bene eseguiti. Invero poteasi conservare la biblioteca a vantaggio degli abitanti di quel quartiere e anche la farmacia aprendovi una piccola porta nel lato settentrionale e dividendo ogni comunicazione nel primo atrio interno o destinato in parte al delle statue. Il trasporto poi delle medesime degli alti rilievi delle metope delle lapidi iscritte dell’immensa quantità di altri oggetti archeologici ha costato moltissimo per le casse pe carretto e i facchini senza calcolarne il danneggiamento, contando i dolosi del Municipio che anzi di dover conservare di buono e pregevole _________________________________ 269 Per la storia del Museo Salnitriano cfr. Roberto Graditi, Il museo ritrovato. Il Salnitriano e le origini della museologia a Palermo. Direzione scientifica del progetto di documentazione Francesco Vergara Caffarelli, Palermo, Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, 2003 e le p. 396-397 dell’articolo di Angela Mazzè, “L’epifania della civiltà artistica. Il collezionismo litico in Sicilia (sec. XVI-XIX)” in: Plumelia. Almanacco di cultura/e a cura di Aldo Gerbino, Bagheria, Plumelia, 2010, p. 385-415. 270 Enrico Pirajno, barone Mandralisca (1808-1864) raffinato naturalista collezionista d’arte classica e, numismatico, prestato alla politica sotto la presidenza di Ruggero Settimo, fonda nel palazzo patrizio di Cefalù (Palermo) il Museo omonimo, noto per la custodia del Ritratto d’ignoto di Antonello da Messina. Cfr. Pietro Saja, La pinacoteca del Museo Mandralisca, Palermo, L. Misuraca, 1979. 271 A c. 160r-v: “ne alla lingua siculo-italica che passata indi sulle rive dell’Arno ripulissi e s’ingentilì per modo ch’e’ divenuta la delizia colla poesia e col canto di tutti i regni di Europa. E praticamente fu dal Frugoni proclamata “La lingua che nel ciel parlan gli dei”. Gli scrittori che in essa stesero le loro opere prima quasi della metà del secolo decimosesto in Sicilia e in Italia lasciaronsi guidare delle due linguedella grammatica latina; ma verso quel tempo cominciarono a compilaregrammatiche e vocabolarî per la lingua volgaresulle osservazioni da’ classici latini. Il primo fra gli scrittori italiani, secondo il Fontanini nella Eloquenza italiana [Giusto Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana di monsignore Giusto Fontanini ... con le annotazioni del signor Apostolo Zeno istorico e poeta cesareo ... accresciuta di nuove aggiunte. Tomo primo [-secondo], Parma, per li fratelli Gozzi, a spese di Luigi Mussi, 1803-1804], che pubblicasse in due libri in 4° in Ancona nel 1516 le regole grammaticali della lingua volgare fu Gianfrancesco Fortuni [Giovanni Francesco Fortunio, Regole grammaticali della volgar lingua, (Impresso in Ancona, per Bernardin Vercellese, 1516 del mese di settembre)] ma l’eruditissimo Apostolo Zeno accenna per nata che il Fortunio seguì indi il Bembo nella sua prosa edita in Vinegia nel 1538 sulla lingua volgare di cui da’ precetti dati in una in Vinegia nel 1525 Nicolò Li Bormio aveva vulgato il trattato delle sue vulgari eloquenze. La lingua dotta come le orientali e la greca per tutto il secolo XIV e XV erano poco cangiate in Italia”. 111 ch’eravi nella città in fonti pubbliche che costarono moltissimo adornavano la città e la strada di Mezzomorreale ed erano utilissime a’ cittadini furono quasi tutte distrutte. E fra queste quelle anzidette di Mezzomonreale menochè due. La fonte presso Porta de’ Greci, quella della piazza del Carmine, nell’altra fuori porta di S. Antonino e nel largo della chiesa di S.ta Teresa fuori Porta Nuova. Moltissimi de’ nostri sontuosi tempî appartenenti a conventi o a monisteri sono stati aboliti, spogliati di quadri, di statue e di oggetti d’arte preda in parte di un rapace artista che li ha venduti e continua a venderli di soppiatto agli esteri amatori. E in parte sono stati almeno trasportati alla pubblica galleria o al museo delle belle arti. Per siffatto motivo accennerò i principali di quelli oggetti preziosi trasferiti in quel pubblico stabilimento e quelli che tuttavia si conservano nelle poche chiese rimaste illese dalla desolatrice rapina. Dirò intanto quelle che sono state abolite. Le chiese di quasi tutte le congregazioni e confraternite convertite in scuole pubbliche. Quelle del convento di S.ta Teresa fuori Porta Nuova, di S. Elena e Costantino, di S.ta Elisabetta, della Ss.ma Trinità, delle monache della Pietà, e di S. Teresa alla strada Butera e a Porta de’ Greci, del convento del Carmine delle monache di S. Giuliano entrambi con magnifica cupola, delle Stimmate e di S.to Vito, del convento di S.ta Cita, e di S. Domenico ed altre.272 E queste sono invero sontuose e magnifiche e ricche di quadri, di statue e di sacri arredi. Talchè io credo che non senza influenza della setta protestante sia ciò avvenuto perocchè ha già aperto tre scuole evangeliche in Palermo e fatto molti proseliti, e fra questi la più pericolosa nel piano di S.to Onofrio che vi ammette di sera i giovanetti adescativi da un certo P. Lipari domenicano, di *** reso altronde scandaloso per il suo matrimonio. Il popolo e le altri classi che rimangono attaccati al cattolicismo o restano pure di messa o de’ sacramenti, o devono percorrere da un punto all’altro della città per adempiere quel sacro dovere. Il Demanio ha preso possesso di tutte le chiese abolite, ha invaso le loro rendite ha impedito la distribuzione dei legati di messe, non paga le spese di culto divino di quelle chiese esistenti, né la mercede a’ poveri preti o frati disciolti, talché la miseria si è accresciuta per questa legge infelice troppo bersagliata anzi calunniata di aver promosso la rivoluzione in Palermo nel _________________________________ Via che unisce Palermo a Monreale. Scrive al proposito Giuseppe Bellafiore, Palermo. Guida della città e dei dintorni, 2. ed., [S.l., s.n.], 1980, p. 107: «In ricordo della battaglia garibaldina del 1860 si chiama oggi Corso Calatafimi. Fu tirata in asse con il Cassaro negli anni 1580-84 al tempo del viceré Marc’Antonio Colonna. Nel 1630 furono poste lungo il suo corso sei esedre con altrettante fontane. Nei secoli XVII-XVIII e XIX vi si affacciavano numerose ville e palazzi suburbani». 272 112 settembre 1866. Eppure il Parlamento che decretò di abolirsi i frati, le monache, i conventi, e i monasteri non v’incluse le chiese, anzi vi sostenne energicamente il barone Vito Ondes deputato che non andavano comprese come qualche altro deputato sosteneva di doversi considerare di proprietà del Governo come accessorî dei conventi e dei monasteri aboliti; ampia e sciocca proposta, perocché la casa di Dio non può riguardarsi che principale. Dopo questa digressione scendo a ragionare de’ molti monumenti d’arte che pian gemevano nelle principali delle chiese abolite, e de’ pochi che tuttavia si osservano nelle chiese esistenti.273 Non parlo già dell’abuso e della sacrilega devastazione di tutte le sacre immagini che per devozione de’ particolari erano sparse per la strada della città che nel febbraro e marzo 1866 furono fatte atterrare con rabbia iconoclasta e coll’influenza protestante o massonica dell’assessore Sig.r Don Raffaele Di Benedetto, che aveva cagionato un subbuglio popolare nel piano del Monte.274 Dopo quella prima esplosione ebbe inizio lo spoglio e la chiusura delle chiese, la depredazione degli oggetti sacri e l’invasione abusiva del Demanio, che dal popolo vien denominato demonio. <Cattedrale> È rimasa illesa la Cattedrale e conserva tuttavia le belle statue marmoree e i bassi ed alti rilievi del celebre Antonello Gagini da Palermo e de’ suoi figli e scolari che fiorirono nel secolo XVI. Fra quadri più antichi più pregevoli avvene quello piccolo della Vergine a mosaico sopra lavagna donata da re Ruggiero uno antico di mezzana grandezza sopra asse di Scuola lombarda rappresentante la Vergine col Bambino, quello di S. Francesco di Paola di Pietro Novelli insigne pittore del secolo XVII e i due famosi dell’Assunzione della Vergine, capolavoro di Giuseppe Velasques da Palermo celebre pittore de’ tempi nostri, e l’altro della Santa Cristina coronata in cielo da Gesù Cristo. Nella Cattedrale si conservano ancora i famosi sepolcri alcuni di porfido, altri di marmo de’ nostri re e nell’ipogeo quelli più antichi scolpiti con figure allegoriche in parte del Medioevo e in parte più antiche che contengono le spoglie mortali de’ nostri arcivescovi ed altri illustri personaggi275. _________________________________ Una puntuale rubricazione è stata condotta da Giovanni Sances, Appunti sulla topografia e sulle trasformazioni delle antiche chiese di Palermo, Palermo, Stab. tip. Virzì, 1914. Il puntuale aggiornamento storico e urbanistico è stato curato da Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici religiosi di Palermo … cit. 274 Più noto come Piano del Monte di Pietà, ubicato tra le vie Maqueda e Candelai. Noto per lo manifattura dei panni che conferiva alla piazza la denominazione Panineria. 275 Ipogeo della cattedrale di Palermo oggi aperto al pubblico. Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano ... cit., p. 184-194, riferisce notizie storiche sul Pontificium coemiterium ed in particolare a p. 188 riferisce che nel 1713 avvenne la traslazione dei sepolcri. Una successiva pubblicazione è quella di Giovanni Compagni, L’antico ipogeo del Duomo di Palermo, Palermo, Stamp. Oretea, 1840. 273 113 Nella Cattedrale conservansi nella sua integrità nell’esterno coll’aggiunta però di una cupola troppo elevata moderna in aperta contraddizione coll’esterno col Medioevo come fu fatta costruire nel ***276 da Gualterio Offamilio, arcivescovo di Palermo. Nell’interno poi fu tutta riformata dall’architetto Ferdinando Fuga, fiorentino277 che come scrisse il celebre conte Rezzonico278 messa in quella riforma in fuga il buon senso, e peggio sarebbe avvenuto se incaricato dell’esecuzione del disegno il celebre architetto Giuseppe Marvuglia non l’avesse in piccole parti modificato279. Nell’antica costruzione essa era tutta ad archi acuti, e nel cappellone vi eran tre serie di statue di santi con gli angioli, a tutto rilievo e i miracoli degli Apostoli in piccole figure a tutto rilievo. Ma secondo il nuovo disegno del Fuga furono altrimenti distribuiti280. Chiesa del Collegio Massimo de’ PP. Gesuiti La Chiesa del Collegio Massimo de’ pp. Gesuiti si conserva nello stesso stato, ma vi furono tolti i due bei quadri della Vita di S. Luigi del celebre Velasques. Chiesa del monistero del SS. Salvatore. L’interno è di figura sferoidale in unica nave e tutta coverta di marmi _________________________________ Gualtiero, arcivescovo di Palermo, nel 1184 fa edificare la Cattedrale di Palermo che sarà consacrata l’anno successivo. 277 Ferdinando Fuga, architetto, nato a Firenze nel 1699, morto a Roma nel 1781. La notizia della “demolizione” dell’interno della Cattedrale balza agli onori storiografici: cfr. P. Fedele da S. Biagio, Dialoghi familiari sopra la pittura. A cura e con introduzione di Diana Malignaggi, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, 2002. Ripr. facs. dell’ed.: Palermo, per D. Antonio Valenza, [1788], p. 189-190. Anche Gioacchino Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia dai Normanni sino al secolo XIV, Palermo, Salvatore Di Marzo editore, Francesco Lao tipografo, 1858-1862, v. 2, p. 196, stila una puntuale relazione sulla «sacrilega devastazione operatavi dal Fuga». Antonio Zanca, La Cattedrale di Palermo, 1170-1946, Palermo, IRES, 1952, p. 294 giustifica il Fuga, affermando che «non resti limpidamente provato con documenti che egli vi sia stato costretto da un esplicito incarico». 278 Il viaggiatore Carlo Gastone conte della Torre di Rezzonico, che visita l’isola nel 1793, nel Viaggio della Sicilia, Palermo, presso gli Eredi Abbate del fù Francesco, 1828, a p. 6 commenta: «Entrai nella Cattedrale che si rifabbrica tutta nell’interno con un’architettura discordante dalla normanna esteriore». 279 Per Giuseppe Venanzio Marvuglia vedi nota n. 243. Cfr. Guido Di Stefano, “Sguardo su tre secoli di architettura palermitana”, in: Atti del VII Congresso Nazionale di Storia dell’Architettura. Palermo, 24-30 settembre 1950, Palermo, a cura del Comitato presso la Soprintendenza ai monumenti, 1956, p. 393-407, pubblica alle p. 405-406 e nella tav. XXIX il progetto del Marvuglia relativo alla trasformazione “in stile”della cupola tardo-barocca del Duomo e completamento del campanile progettato da Emanuele Palazzotto. 280 Un primo “commento” sulla demolizione fu efficacemente condotta da Maria Accascina, “La Cattedrale di Palermo. L’opera di Ferdinando Fuga. La distruzione della tribuna di Antonello Gagini”, in: L’Ora, a. XXVII, n. 214, 8-9 settembre 1926, p. 4. Un’interpretazione architettonica è stata fornita da Roberto Pane, Ferdinando Fuga; con documenti a cura di Raffaele Mormone, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, stampa 1956, p. 156-162. 276 114 colorati con cupola ellittica centrale di mirabile artifizio dipinta egregiamente dal celebre frescante Vito d’Anna281, palermitano, che vi rappresentò Il Paradiso. Quel tempio fu eseguito sul disegno dell’insigne architetto Fra’ Paolo Amato da Ciminna282. Ha quadri pregevoli del tenore di messinesi e qualche altro più antico. Il monistero fu nel 1866 destinato per l’influenza del generale Masi ad Istituto di donzelle283. Chiesa di S. Giuseppe dei PP. Teatini L’interno di questa chiesa si conserva con i bellissimi quadri del Novelli284 ed altri antichi pregevoli. Però di questa grande e sontuosa chiesa con cupola coll’abbassamento della via Toledo e via Maqueda285 la porta ad ornato con sue colonne rimase elevata circa cinque palmi dal pianterreno e così pure la fonte Pretoria ricchissima di statue della scuola del Buonarroti286. Come ancora la vicina287 elegantissima chiesa ornata di marmi colorati in unica nave alla quale essendosi destrutta per l’abbassamento la gradinata alle due porte non vi sono da due anni sostituite dal Demanio, che ne ha in uso la rendita. L’interno nella chiesa rimane lo stesso288. Chiesa di S. Matteo o delle Anime del Purgatorio Il magnifico prospetto marmoreo di questa chiesa ideato da Giacomo _________________________________ Vito D’Anna, pittore, nato a Palermo nel 1718, ivi morto nel 1769. Due versioni biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 3-4 e in Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 38-52, 55. 282 Paolo Amato, architetto e teorico, nato a Ciminna (Palermo) nel 1634, morto a Palermo nel 1714. Una versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 107113. 283 Si tratta dell’Istituto magistrale Regina Margherita oggi Liceo psico-pedagogico. 284 Si tratta chiaramente della tela raffigurante San Gaetano (1635-36): cfr. Guido Di Stefano, Pietro Novelli il Monrealese, Palermo, F. Ciuni, 1940, e Guido Di Stefano, Pietro Novelli il Monrealese … Catalogo … a cura di Angela Mazzè cit., p. 219. Il dipinto raffigurante l’Estasi di San Gaetano, è stato inserito inefficacemente nell’elenco delle opere del Maestro barocco. A nostro avviso si tratta di una soffocante attribuzione alle fonti della storiografia artistica. Cfr. catalogo della mostra Pietro Novelli e il suo ambiente. Palermo, albergo dei poveri, 10 giugno-30 ottobre 1990. [Redazione e coordinamento dei materiali Maria Pia Demma ... et al.], Palermo, Flaccovio, [1990], p. 200. 285 «Tra il 1856 e il 1860 il livello della via Maqueda fu abbassato di circa m. 1,30 per regolarizzare l’altimetria dell’intera zona circostante l’Ottangolo» [Quattro canti]: Cfr. Giovanni Cardamone, La scuola di architettura di Palermo nella Casa Martorana; presentazione di Marcella Aprile; prefazione di Mario Giorgianni, Palermo, Sellerio, 2012, p. 182. 286 Le recenti ricerche condotte sono registrate in: La fontana pretoria in Palermo: hic fons, cui similis nullus in orbe patet. A cura di Maria Pia Demma, Giuseppina Favara, Palermo, Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2006. 287 Nota illeggibile a causa dell’inchiostro sbiadito. 288 Nota illeggibile a causa dell’inchiostro sbiadito. 281 115 Del Duca289 di Cefalù, scolare del Buonarroti avea molto sofferto nel lato sinistro e fu fatto riparare bene secondo l’antico per cura dell’attuale Deputazione. La chiesa frequentatissima si conserva co’ suoi quadri pregevoli due del Novelli nel pristino stato ed è la sola abbondante di messe e quindi frequentata da’ fedeli. Olivella Abbiamo accennato le due devastazioni del Convento di quei buoni e nobili Padri esemplarissimi. Fortunatamente la <chiesa> è rimasa nella sua integrità senza spogli e depredazione di quadri. Ivi ammirasi il quadro di Raffaello290 dell’Adorazione del San Giovannino sostenuto da un angelo col neonato Gesù e questo tempio magnifico sì pel prospetto, sì pel l’adornamento interno di squisito gusto eseguitavi dallo architetto Marvuglia291 è la sola finora in cui il Demanio non ha disteso interamente gli artigli ed è bene officiata e ben frequentata da’ fedeli. Però il Demanio credette di aver diritto sopra una moderna statua di argento della Beata Vergine e l’incarcerò in un magazzino, per motivo che nel giorno della Concezione si poté esporre al pubblico. Però un devoto che vi aveva donato una bella corona di argento tempestato di gioie si credette in diritto di ripigliare in deposito il suo dono finché la Beata Vergine ne fosse scarcerata, e fece bene. Chiesa di S. Simone o della Martorana Questa chiesa fondata da Giorgio Rosier ammiraglio del re Ruggiero è coverta all’interno di mosaici figurativi e ornamentali con un magnifico quadro di Vincenzo Anemolo292, scolare di Raffaello, e con due interessanti mosaici rappresentanti uno L’adorazione del fondatore a Gesù Cristo e l’altro La coronazione di Ruggiero da Gesù Cristo stesso. Manca il pavi_________________________________ Giacomo (o Jacopo) Del Duca, scultore e architetto, nato a Cefalù (Palermo) intorno al 1520, ivi morto nel 1604. Cinque versioni biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 45-49; Lavoro … cit., p. 129-131; Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 31; Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti … cit., p. 19; Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 437-438. 290 Madonna con Gesù bambino e san Giovannino di Lorenzo di Credi, a lungo attribuito a Raffaello, oggi al Museo di Palazzo Abatellis a Palermo. Cfr. Ciro D’Arpa, Architettura e arte religiosa a Palermo … cit., p. 81. 291 L’approccio cronologico di Giuseppe Venanzio Marvuglia con i padri Filippini risale al 1763, anno in cui l’architetto presenta il modello ligneo della chiesa. Per ulteriori riferimenti, cfr. Vincenzo Capitano, Giuseppe Venanzio Marvuglia, architetto, ingegnere, docente. Parte prima [-terza], Palermo; Sao Paolo, Renzo e Rean Mazzone Editori, 1984-1989, 3 v. Maria Giuffrè, “Classicismo e neoclassicismo nell’opera di Giuseppe Venanzio Marvuglia”, in: Ricordo di Roberto Pane. Incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli, 14-15 ottobre 1988. [Promosso da] Dipartimento di storia dell’architettura e restauro, Universita di Napoli Federico II, Napoli, Napoli Nobilissima, stampa 1991 292 Si tratta dell’olio su tavola raffigurante l’Ascensione collocata sull’altare maggiore. Per ulteriori informazioni storico-bibliografiche, cfr. il catalogo della mostra Vincenzo degli Azani … cit., p. 372-374. 289 116 mento d’ingresso per l’abbassamento del piano della regia porta. Dicesi che l’interno sarà destinato a scuola di belle arti. 293 Antico Palazzo Pretorio Vi fu adibita una cappella di S.ta Rosalia294 e venduto vergognosamente una gran mazza di argento indicante il dominio del Municipio ed altri oggetti antichi. Chiesa di S. Domenico dei PP. Predicatori Questo tempio a tre navate con colonne di marmo bigio era più grande in Palermo. Ha un prospetto di marmi bianchi con statue di stucco e due coronanti campanili; ma nell’interno non è vestita di marmi colorati anche nella cappella a sfondo. Però nella sua semplicità è imponente per la sua grandezza perocché secondo il calcolo fatto da uno dei dotti padri in matematica295 può contenere all’impiedi escluso il coro ***. Ha a sinistra del T<ransett>o uno de’ migliori quadri di Anemolo296 rappresentante La Vergine del Rosario in un giardino di rose co’ santi domenicani e il popolo devoto abbasso, e gli angioli superiori che versano rose sul medesimo in allusione alla devozione per cui accorrer soleva ivi di primissimo mane. Mancava a compimento di questo tempio una cupola e l’adornamento di marmi colorati nelle pareti. L’insigne oratore sacro P. Luigi Di Maggio297 presentò al pubblico un programma affinché con particolari contribuzioni potesse eseguirsi, ma il suo progetto per le circostanze dei tempi non fu secondato. Il signor Agostino Gallo che avea osservato in suoi viaggi in Italia, e particolarmente in Firenze e in Bologna onorata memoria de’ rispettivi uomini illustri con magnifici monumenti funebri con busti, medaglie, iscrizioni divisò di promuovere in S. Domenico il Panteon dei famosi siciliani298 e ne diede esecuzione a proprie spese col monumento del famoso _________________________________ 293 Non siamo in grado di poter documentare, cronologicamente, la notizia. Giovanni Cardamone, La Scuola di Architettura di Palermo… cit., p. 62, afferma al riguardo: «senza voler entrare nel merito delle trasformazioni interne». Il faticoso iter burocratico è stato ricomposto dal Cardamone alle p. 216-220. 294 Le notizie sono state tratte, presumibilmente, dal coevo Giornale dell’Intendenza di Palermo. 295 Il riferimento è all’architetto Andrea Cirrincione, attivo nella IIª metà del XVII secolo, il quale «nel 1640 presentò il disegno e curò la riedificazione della nuova chiesa». Cfr. A. Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 61. 296 Il riferimento è alla preziosa tavola di gusto manieristico raffigurante la Madonna del Rosario con i santi Cristina, Vincenzo Ferrer, Tommaso d’Aquino e Ninfa (1540). Per ulteriori informazioni storico-bibliografiche, cfr. il catalogo della mostra Vincenzo degli Azani … cit., p. 378-382. 297 Luigi Di Maggio, segretario generale a vita dell’Ordine dei Padri Domenicani dal 1876, sepolto in San Domenico. Un cameo è stato filigranato da Enrico Onufrio, Guida pratica di Palermo con la pianta della cittá. Nuova ed., Milano, F.lli Treves, 1892, p. 32. 298 Cfr. Agostino Gallo, Autobiografia cit., p. 62. 117 pittore ed insigne architetto del secolo XVII Pietro Novelli da Morreale sua patria detto Morrealese299. E persuaso che il governo Borbonico era negativo a qualunque novità di suo arbitrio col consenso dei PP. Domenicani ne collocò il busto scolpito dallo egregio Villareale in una bene ornata nicchia con sua iscrizione italiana essendo egli persuaso di adoprare la lingua latina per gli uomini dotti e la volgare per gli artisti, o di altri personaggi più noto al popolo. Accadde che il re Ferdinando 2° visitando quel tempio osservò il monumento del Novelli, lesse l’iscrizione col nome di Gallo, chiese ai Padri chi fosse costui che ne avea fatto la spesa e avutane informazione di appartenere al ministero rispose: Lo conosco e ha fatto bene ad onorar la memoria del Novelli. Talché d’allora fu colla parola del re approvato il nuovo Panteon, che crebbe progressivamente di altri monumenti. Un’accanita lotta dovette bensì sostenere coll’Intendente di Palermo, duca di Laurino, il quale seccato di essersi trascurata la sua autorità che sarebbe stata contraria come lo fu in tutte le cose utili in questa antica capitale, e fingendo di proteggere i Padri Francescani del Terz’Ordine che dalla loro sepoltura conservavano il corpo del celebre poeta Giovanni Meli ostinossi alla proposta del Gallo di trasferirsi nella chiesa de’ PP. Domenicani per collocarsi in un magnifico sepolcro marmoreo scolpito nel fronte in un basso rilievo colle Muse del Villareale, e cagionò un’accanita lite di due anni tra i frati e il Gallo, pel corpo del Meli ch’era stato da loro occultato, e ceduto da suoi parenti per ricevere maggior omaggio nel Panteon di San Domenico300. Il Governo di Sicilia espose a S. M. il contrasto tra il Laurino autorità e il Gallo semplice ufficiale di carico in Ministero e il re diede ragione a quest’ultimo. Però ricercatosi il cadavere allora stato occultato da i frati ne fu mostrato uno acefalo che per alcuni indizi del corpo fu creduto del Meli e particolarmente per i tre diti congiunti della destra in attitudine di stringere ancor la penna. Il principe di Satriano, allora Luogotenente di Sicilia, ordinò che si fossero fatte perquisizioni in tutte le stanze di monaci per ritrovare il teschio del celebre poeta affinché ricongiunto al corpo fosse trasportato solennemente in S. Domenico e ne incaricò il Gallo. Vane furono per allora le perquisizioni della Polizia e un pro_________________________________ Il Gallo, stilando l’epigrafe (1865), lo segnala «tra i dipintori siciliani massimo imitator della natura, sperto architetto e incisore». 300 Il 6 giugno 1853 i resti mortali del poeta sono trasferiti dalla chiesa di S. Francesco d’Assisi; sarà sepolto vicino la cappella di S. Rosalia Il cameo scultoreo (altorilievo), opera di Valerio Villareale (1828) reca sul basamento il corteo delle muse del canto e della poesia, preceduto dal dio Apollo che incorona il Meli seduto su un tronco di albero d’alloro. Il testo dell’epigrafe, curato da M. Monti, recita: «Theocritus alter et Anacreon musarum sicelidum, amor deliciae decus….». 299 118 cesso a carico dei monaci fu iniziato. Ma essendo tre frati trovati in contraddizione furono imprigionati ed uno di essi per nome Francesco Catalano denunciò al fine al Direttore di Polizia, capitano Salvatore Maniscalco, l’antica tomba nell’ultima cappella presso l’altare dell’Immacolata Concezione, dov’era occultato. Rimosso ivi e fattonelo estrarre e chiuso in una cassa lo trasportò nella parrocchia de’ Tartari301 chiuso e sugellato in una stanza della sagrestia, e indi fattane la ricognizione giudiziaria fu solennemente con pompa magnifica trasportato in un feretro per la città accompagnato da professori dell’Università, dell’Accademia e da’ magistrati solennissimamente in processione fra i nembi di fiori che gli piovevano da tutti i balconi. Nel tempio era preparato un arco di trionfo, una musica solenne e un funebre elogio profferito dal P. Melchiorre Galeotti302. Questa orazione fredda, insipida e inopportuna non soddisfece il pubblico, anzi fu accompagnata da qualche sibilo di disapprovazione. Ma l’oratore che avea protestato di non richieder mercede, scroccò al Gallo onze otto. La direzione di questa magnifica festa funebre affidata al Gallo riuscì a piena soddisfazione del pubblico. Il quale desiderava di scorgere l’effigie del gran poeta che era stato chiuso in un tumulo di legno. Il Gallo aveva predisposto una maschera di cera ricavata co’ proprî naturali colori dal busto marmoreo del Villareale modellato prima sullo stesso Meli e somigliantissimo. Talché i vecchi che l’aveano conosciuto gridarono: È d’esso, è d’esso, contuttoché non avesse apparito col suo abito di abate ma avvolto in un manto bianco di seta con ricami d’oro. Per un giorno intero fu soddisfatta la curiosità del pubblico che per l’affollamento nella chiesa non avea potuto intervenire a quella funzione. A sera fu racchiusa nella magnifica tomba fra le preci della chiesa il corpo di quel valentuomo. Il Gallo incoraggiato dal buon successo proseguì con efficacia ad arricchir di altri monumenti il Panteon che egli a proprie spese ne fece innalzare tombe onorarie de’ suoi precettori p. Michelangiolo Monti, insigne poeta ed oratore303 professor di belle lettere nell’Università di Palermo, _________________________________ 301 Dichiarata fatiscente nel 1874 e successivamente demolita. Per le notizie storiche e documentarie, cfr. Le parrocchie cit., p. 313-339. 302 Melchiorre Galeotti, Elogio di Giovanni Meli nella traslazione del suo corpo al monumento erettogli dal Senato di Palermo nel tempio di S. Domenico con una breve narrazione della pompa celebratasi con l’intervento di S.E. il principe di Satriano luogotenente in Sicilia, Palermo, per M. Amenta 1854. 303 Monti Michelangelo († 1822) monumento funebre a San Domenico Il Gallo indirizza l’epigrafe latina al «praeceptori amantissimo». 119 dell’abate Domenico Scinà sommo scienziato e letterato, ed ivi professor di fisica, di Giuseppe Marvuglia e del suo figlio304 Emmanuele capi architetti e professori entrambi nella detta Università, riformatori del buon gusto nella scienza ed arte edificatoria, del menzionato Pietro Novelli egregio pittore, di Nina Siciliana305 prima poetessa in volgare, di Giuseppe Piazzi, primo astronomo e ritrovatore del pianeta Cerere, fondatore della Specula di Palermo e di Napoli, e anche professore dell’Università306, amicissimo e protettor del Gallo ed ora vi à anche destinato il busto di Vincenzo Bellini, suo amico. Ma ne è stato impedito da una circostanza che or ora accenneremo. Il Gallo poi promosse qual Segretario della Commissione di Antichità e Belle Arti, che questa a proprie spese innalzasse i monumenti de’ tre insigni pittori Patania307, Velasques308 e Riolo309 e dello egregio scultore Sig.r Villareale. Il principe di Galati, ragguardevole ellenista e poeta originale, letterato ed archeologo innalzò ivi un grande alto rilievo opera del Villareale alla di lui moglie Giuseppina Turrisi celebrata poetessa310. E così la Signora Margherita Adamo alla di lei figlia, poetessa signora Lauretta. Dal conte di Gallitani fu fatto eseguire il busto dal suo nepote, signor Narciso Gozzo che combattendo per la libertà italiana nella conquista di Napoli per salvare un amico ferito rimase anch’egli ucciso. In seguito sorse il magnifico sepolcro del sommo _________________________________ Giuseppe Venanzio Marvuglia monumento funebre a San Domenico. Sepolto insieme al figlio Emanuele Alessandro, i loro profili emergono dal bassorilievo marmoreo. Il Gallo ne perpetua così il ricordo professionale: «…co’ loro precetti nell’Ateneo e co’ modelli di bene ordinati edifizi per la Sicilia diffusero la scienza e il buon gusto dell’architettura attinto in Roma maestra delle belle arti e or nelle vetuste elleniche forme or nell’eleganti palladiane tramutarono le precedenti goffe e capricciose entrambi per sapienza e severa virtù esempio agli artefici». Alessandro Emanuele, architetto camerale e figlio di Giuseppe Venanzio, nato a Palermo nel 1773, ivi morto nel 1845. La sua versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 171-172. 305 Il monumento funebre è stato distrutto durante le incursioni aeree della seconda guerra mondiale. 306 Piazzi Giuseppe monumento funebre a San Domenico: Il Gallo ricorda ai posteri che «ab anno 1780 R. nostrae Universitatis conspicuus praeceptor Italiam Galliam Britanniamque diu pergratus effusi astronomorum maximus Speculae Panormi et Neapoli fondatae moderatorque…». 307 Il Gallo ne celebra il talento artistico: «Franco inventor scelse in natura il bello /pinse e animâr le Grazie il suo pennello». 308 Il medaglione, scolpito da Rosolino Barbera, sovrasta la poetica epigrafe: «Diè alla pittura che giacea informe vere purgate ed eleganti forme». 309 Il medaglione, scolpito da Rosolino Barbera, sovrasta la poetica epigrafe: «Alla patria pittura esaminata diè vaghe tinte ombre gagliarde e vita». 310 Il monumento funebre è stato scolpito da Valerio Villareale nel 1849. 304 120 archeologo ed architetto Domenico Lo Faso duca di Serradifalco311, erettogli dalla sua figlia signora Giulietta marchesa di Torrearsa ed altro più magnifico fu innalzato al maresciallo Ruggero Settimo presidente del Regno di Sicilia312 nel 1848, uomo liberale saggio e virtuoso. Figuravi anche ivi con busti o medaglie il medico e professore universitario signor Michele Pandolfini313 e il poeta leggiadro e magistrato Pietro Cirino314, ed il dottor *** Bellia315 intrepido difensore di rei di Stato e il cerusico Giovanni Salemi316, che meritò l’onore di essere ascritto all’Istituto di Francia e il bravo pittore Giovanni Patricolo317 e il dotto p. Barcellona318 dell’Oratorio Filippino celebrato per opere sue ecclesiastiche. E infine il sig.r Carlo Giachery architetto e professore nella nostra Università. Fra i monumenti eravi quello antico sontuoso del marchese Villabianca319 ineffaticabile istorico e illustratore delle cose patrie. _________________________________ 311 Una pletorica epigrafe ricorda il suo vissuto letterario e politico: «Con la mente con le avite dovizie le lettere e le arti siciliane promosse incorando per beneficî la gioventù al sapere. Presidente della Commissione di Antichità i vetusti tesori di civiltà greca e normanna studiò e dottamente descrisse … al ritorno della borbonica dinastia patì l’esilio. Rivide la terra natia non pur anco redenta e pio caritatevole ne divise i dolori, ma poi mirò l’Italia risorta per sempre al più bello avvenire…». 312 Ricordato nell’epigrafe come Ministro di Guerra e di Marina (1778-1863). 313 Il monumento gli fu eretto nel 1861 e reca la seguente epigrafe «Insigne medico quanto ardito filosofo per integrità di vita e potenza d’ingegno in questa Università professore di Patologia, di celebrati volumi aureo scrittore». 314 In effetti il monumento è dedicato a Nicola Cirino, nato a Nicosia nel 1802, morto a Palermo nel 1851, «sapiente magistrato e poeta… ornamento dl XIX secolo». Il fratello Giovanni gli innalza il monumento nel dicembre 1862. 315 Si tratta di Emmanuele Bellia, da Paternò. Il mausoleo funebre a San Domenico scolpito da Benedetto De Lisi nel 1861. L’epigrafe ne focalizza la statura culturale: «dotto ed eloquente giureconsulto di virtù pubbliche e private modello con la parola e col senno in tempi difficili salvò molte vite dalla ferocia di corti militari». 316 Salemi Giovanni (†1849): l’epigrafe del suo mausoleo recita: «nel professare il chirurgico magistero ebbe all’Ateneo sì felice la mente e la parola come esperta all’oprare la mano la decorazione della legione d’onore meritar seppe non accettar turpemente per virtù domestiche e sociali alla famiglia agli amici alla patria dilettissimo in vita…». 317 Patricolo Giovanni, pittore, nato a Palermo nel 1789, ivi morto nel 1861. Due versioni biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori siciliani … cit., p. 91 e in Agostino Gallo, Parte seconda …, cit., p. 9, 18, 304-307 L’epigrafe del mausoleo recita: «Pio buono devoto sacerdote ed in pittura valentissimo». Il medaglione fu scolpito da Benedetto de Lisi nel 1862. 318 Barcellona Antonio (1726-1805), religioso della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri. L’epigrafe focalizza le sue doti morali e intellettuali: «antiqua morum disciplina rei Theologicae sapientia spectantissimo et admirando ab doctissimas in profeta et evangelia lucubrationes». 319 Seppellito nella cappella gentilizia di S. Rosalia, secondo le sue volontà testamentarie. Il mausoleo fu scolpito da Leonardo Pennino; nell’epigrafe sono focalizzate le virtù morali ed intellettuali del «Caesaris» noto «clari eruditone, comitate, prudentia, religione vero muneribus, boni publico studio…». 121 Avevo io disposto d’innalzare il busto marmoreo a Vincenzo Bellini famoso compositore di musica, ma abolitisi gli Ordini monastici nell’ottobre del 1866 sul pretesto della rivoluzione del precedente settembre, poco dopo la chiesa fu chiusa e ceduta dal Demanio al Municipio di Palermo, venne dal medesimo destinata a sala di esposizione de’ progetti del gran Teatro da costruirsi in Palermo, Dio sa quando. La chiesa fu spogliata di *** pregevolissimi quadri che appartenevano una volta a quella di Santa Cita dello stesso Ordine domenicano e ch’era stata da più anni convertita in ospedale militare320. Quei quadri sono stati i più pregevoli delle chiese di Palermo e principalmente la Disputa di S. Tommaso con altri teologi e col re Carlo d’Angiò321, altro busto ad Antonello da Messina, pittore del secolo XV. La Deposizione dalla croce, capolavoro di Vincenzo Anemolo, Sant’Anna che conduce a mano la giovinetta Maria con in fondo un tempio; una delle migliori opere di Rosalia Novelli, ed altri dipinti ragguardevoli che furono tutti trasportati nella Galleria della Regia Università322. L’esposizione de’ disegni del nuovo Teatro durò più mesi; ma è già un anno che la chiesa è serrata attendendosi che il Municipio scelga tre architetti per decidere quale tra i trentadue disegni sia preferibile per ordinarne la costruzione323. Questo esame, a mio avviso, durerà più anni dovendosi di ogni progetto esaminare la pianta, lo spaccato, il prospetto e le altre carte particolari di decorazione. Intanto il pubblico è privato per un oggetto profanissimo delle funzioni sacre di una delle chiese più frequentate e i forestieri che condotti da’ servidori di piazza amavano di visitare i monumenti ne sono delusi. Che se il Municipio non influito dallo spirito protestante adesso _________________________________ La trasformazione è datata 1 maggio 1853: cfr. alla p. 81: Angela Mazzè, “Topografia sanitaria in Sicilia (sec. XII-XIX)”, in: Sanità e Società. Udine, Casamassima, 1986-1990, v. 3: Sicilia e Sardegna secolo XVI-XX, a cura di Calogero Valenti, Gianfranco Tore, p. 51-107. 321 Tommaso De Vigila, pittore (1444, notizie- 1497). Per un’esaustiva conoscenza storico-artistica cfr. Maria Concetta Di Natale, Tommaso De Vigilia (Parte I), Quaderni A.F.RA.S. n. 4, Palermo 1974, e (Parte II) n. 5, Palermo 1977. 322 In esecuzione della Ministeriale 2 agosto 1830, l’Università degli Studi di Palermo acquisisce le opere d’arte provenienti dagli edifici religiosi della città. 323 Il riferimento è correlato all’esposizione dei 35 progetti stilati per la partecipazione al concorso dell’erigendo Teatro Massimo. L’8 aprile 1867 si inaugura la prima rassegna grafica cui seguirà la seconda compresa tra il 16 agosto e il 4 settembre 1868. La manifestazione registra enorme successo, contestualmente alla stampa di un opuscolo-guida curato dall’ing. Pietro Mutti: Una visita a S. Domenico. Esame dei progetti pel Teatro Massimo di Palermo. Impressioni provate e scritte, Palermo, Stamperia di Francesco Roberti, 1867. Per i dettagli iconografici, cfr. Il Teatro Massimo cento e più anni fa. Fonti storico-documentarie A cura di Eliana Calandra, Palermo, I.L.A. Palma, 1997, p. 68. 320 122 prevalente avesse fatto senno di chiedere per mezzo del Ministero di Casa Reale a S. Maestà il re d’Italia una delle sale superiori del R. Palazzo di Palermo che resteranno a lungo a disposizione dei topi, certo che ne avrebbero ottenuto il permesso. E il grandioso tempio di S. Domenico per l’addietro frequentatissimo da’ fedeli sarebbe rimaso a disposizione del pubblico anche per ammirarvisi da’ nazionali e da’ forestieri il Panteon degli uomini illustri che presenta ormai trentadue monumenti. Né il Gallo ha potuto innalzare quelle al Bellini. Un altro grave inconveniente ha potuto danneggiare quelli già esistenti; perocché i nostri maestri falegnami trascurati come sono per far presto hanno potuto addossare le favole sopra i monumenti per affiggervi tutt’intorno i disegni teatrali. Ma tutto in Palermo si esegue alla carlona e senza procedimenti. Altri danni ha pure sofferto quel tempio monumentale nel prospetto perocché abbassatosi il portone, le basi delle colonne e la gradinata sono stati tolti e i marmi derubati. Talché si è dovuto supplire con gradini di legno per essere osservati dal pubblico i disegni. Né si pensa a ristorare questi guasti perché il Municipio crede doversi eseguire a spese del Demanio, e questo dell’altro avendo esso prodotto i danni indicati. La chiesa adunque rimarrà chiusa e inefficiente per moltissimi anni e notabilmente danneggiata nel suo sontuoso prospetto. Sull’antiche cattedrali di Palermo sino all’ultima attuale riedificata nell’interno nel sec. XVIII Tralasciando di ragionare del sacro luogo di riunione de’ primitivi cristiani di Palermo per l’esercizio degli atti della nuova relione [!], che il P. Amato nell’opera De principe templo panormitano324, e il celebre canonico Stefano Di Chiara, mio maestro, in quell’erudito suo discorso sulle chiese maggiori o cattedrali325, ri<co>noscono essere stato l’antico sotterraneo dell’abside dell’attuale Cattedrale allor detto Cimitero di tutti i Santi, essendovi stati sepolti i corpi de’ SS. martiri, esporrò le vicende del nostro Duomo contestate con maggior certezza dall’istoria, dopo le tre antichissime, è quello accennato. Il Di Chiara con una lettera del pontefice S. Gregorio Magno alla quale _________________________________ Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano ... cit., p. 21. Stefano Di Chiara, Discorso istorico critico sopra le chiese maggiori e cattedrali a Dio in questa città erette e dedicate sin da’ primi tempi del suo cristianesimo del canonico Stefano di Chiara professore di sacri canoni nella R. Università di Palermo, Palermo, tipografia di F. Solli, 1825. 324 325 123 assegna la data del dicembre 603 dopo G.C., prova che già era sta<ta> innalzata indubitamente una Cattedrale a Palermo; perocché quel santo pontefice concede al vescovo, che l’Amato326 credette esser Giovanni, la facoltà di farne la rituale consacrazione, prova anche con plausibili argomenti che occupasse superiormente lo stesso sito dell’antico cimitero. Sospetta ragionevolmente il Di Chiara che quella Cattedrale per ragion de’ tempi e sull’esempio di altre non potea esser grandiosa e magnifica; ma crede che fosse ancora in piedi nel 1071 quando i prodi conquistatori Normanni debellati i Saraceni occuparon Palermo, e restituirono quel tempio profanato colla falsa religion maomettana al culto del vero Dio, e dedicata ab antico alla Beata Vergine Maria, come rapporta lo storico contemporaneo a’ principi Normanni Goffredo Malaterra327. A questa prova storica, io ne aggiungo una di fatto sfuggita al Di Chiara. Nell’attuale portico, rivolto a mezzogiorno, si leggono nelle colonne di granito, scolpite in arabo alcune iscrizioni tratte dal Corano328, il che mostra che quelle colonne erano state aggiunte all’antico Duomo, quando dagli Arabi fu convertito in moschea, e serbate pel valor del granito vennero adoperate poscia pel portico. Certo si è che secondo la testimonianza del Malaterra, il duca Roberto e il conte Ruggieri dopo la conquista di Palermo ripristinarono il culto della Beata Vergine l’antica chiesa cattedrale vi richiamarono il vescovo confinato nella miserabile chiesa di S.ta Ciriaca, ne accrebbero la dote, e gli ornamenti e quel duomo sussistette fino al 1180, quando l’arcivescovo di Palermo, Gualterio Offamilio di nazione inglese, che godea la grazia del re Guglielmo II, detto il Buono, essendone stato precettore, ottenne da lui il permesso di riedificarlo a proprie spese e di quel religioso sovrano, in una forma più splendida, e di maggior estensione nello stes_________________________________ Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano ... cit., p. 33. Galfredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, citato da Amato, p. 115-116, lib. 2, cap. 45, f. 313: “10 luglio 1071: Panormo principe Regni urbe capta, primarium illius templum, B. Virgini Mariae quondam sacrum, catholicis ceremoniis expiatum, eidem Virgini postlimini jure resti tui, infra: priori Domina, Magnae Dei matri restitui, dicarique”. <Giovanni Maria Amato, De principe templo panormitano ... cit., p. 45>. In edizione moderna: Galfredus Malaterra, Imprese del Conte Ruggero e del fratello Roberto il Guiscardo. Introduzione Vincenzo D’Alessandro; traduzione e note di Elio Spinnato, Palermo, Flaccovio Editore, 2000. 328 Cfr. Guido Meli, Un albero pieno di vita … cit., foto 12, p. 13. In particolare il Meli afferma: “Il recente restauro ha portato alla straordinaria scoperta di un portico dipinto rinvenendo l’originaria composizione cromatica del programma iconografico, secondo quanto confermato dalla fonti archivistiche. (…) Molti sono gli elementi architettonici che, ad una attenta osservazione, risultano reimpiegati e provenienti da precedenti costruzioni. Una preziosa tavoletta del Corano inciso sulla colonna laterale sinistra del portico, dichiara la sua provenienza dalla distrutta Moschea <Sura VII del Corano v. 55> (…)”. 326 327 124 so luogo ov’era l’antico, e per l’intera nuova costruzione dovette atterrare le mura di quello e per l’ingrandimento destrurre nel 1187 la sontuosa cappella di S. Maria Maddalena329 di padronato di Alvira moglie di re Ruggiero, ov’erano i sontuosi avelli di porfido che contenevano i corpi di principi e principessa della dinastia normanna. E per ampliare l’abside che corrispondeva al sottostante cimitero ingrandissi anche questo, però conservando l’antica cappella di S. Maria l’Incoronata330, così detta perché ivi coronavansi i nostri monarchi; però per ragion di simmetria la staccò dal corpo del Duomo. Questa insigne Cattedrale fu compiuta in quindi<ci> anni nel 1085 nel terzo lustro dell’arcivescovato di Gualterio, come rilevasi dall’antica iscrizione che tuttavia è affissa al lato destro di chi entra per la porta maggiore ed è del tenor seguente: Si ter quinque minus numerent331 de mille Ducentis / invenient332 annos rex pie Christe tuos / Dum tibi constructum333 praesul Gualterius aulam / obtulit officii post tria lustra sui. / Aurea fulgebant334 Villelmi335 regna secundi / Quo tantum tanto sub duce fulsit336 opus / Sit tibi laus perpes, sit gloria Christe perennis / Sit decus et templi sit tibi cura tui / Tu quoque florigerae mater pulcherrima turbae / Perpetuus sacrae virginitatis apex / Respice prostrati lacrymas, et vota clientis / Aeternis penses haec sua dona bonis. Questi versi, credo io, che fossero stati composti dallo stesso arcivescovo Gualtierio che si sa di essere stato versificator latino, e di avervi educato lo stesso re Guglielmo al quale si attribuisce pure un inno sacro. Il tempio fu dedicato a Maria Vergine Assunta in cielo e consacrato a 6 aprile 1186 dal medesimo arcivescovo (1)337. Ignorasi338 l’architetto direttore del medesimo e gli altri subalterni che co’ loro nomi avrebbero recato onore all’arte edificatoria siciliana del XII secolo, come per quelli ignoti altresì del Duomo di Monreale, di Cefalù, di Messina, de’ tempii di S. Pietro nel Regio Palazzo, e dell’Ammiraglio Rozier or detto di San Simone in Palermo; ma furon certo siciliani già istruiti dagli Arabi famo_________________________________ Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria …. parte II, cit. Ubicata in via Matteo Bonello, di epoca normanna. 331 Leggasi: “numeres”. 332 Leggasi: “invenies”. 333 Leggasi: “constructam”. 334 Leggasi: “florebant”. 335 Leggasi: “Wilhelmi”. 336 Leggasi: “surgit”. 337 A c. 176v nota in calce: “(1) Ciò si ricava da un antico Breviario del Duomo”. 338 Seguono cancellate le parole: “chi stato fosse”. 329 330 125 si edificatori i quali molti insigni monumenti lasciarono nell’isola nostra, e particolarmente in Palermo, lor sede principale forse a que’ siciliani si aggiunsero architetti bizzantini; perocché molti qui soggiornavano di quell’impero orientale a cui era stata prima soggetta la Sicilia. Lo stile misto arabo-bizzantino di quella Cattedrale mi conferma in tale opinione. E siccome essa fu destrutta nell’interno nel 1781 come diremo, né trovasene disegno così credo conveniente per non perdersene la memoria, ritrarne almeno la descrizione da Tommaso Romolo, scrittore del 1688 nell’opera sua: Gli orti Esperidi339, e da quella eruditissima del P. Amato, De principe templo panormitano pubblicata in Palermo nel 1728. Il Romolo ci fa sapere che quella cattedrale innalzata dall’arcivescovo Gualterio fu assai più grande della precedente. Soggiunge che l’altare maggiore dell’abside era rivolta all’oriente, e la porta maggiore all’occidente come molte altre chiese del medioevo e secondo il primitivo rito cristiano. Era essa di croce latina, a tre navate che stendevansi sino a’ gradini innanzi l’abside in lunghezza 390 palmi siciliani, in larghezza da una parete all’altra delle tre navi palmi ottanta, ed elevasi al tetto diviso in cassettoni con freggi dorati a pittura palmi ottantaquattro. Nelle due navi inferiori che faceano ali alla maggiole [!] centrale s’aprivano per comunicazione in ciascuna cinque grandi archi a sesto acuto poggianti sopra piloni, e in corrispondenza al vano vi erano altrettante cappelle con fondo ed altari dedicati a varii santi. L’abside elevavasi su due gradini era poco men che quadrato con quattro grand’archi poggianti sopra pilastroni che sostenevano la soffitta con ricchi ornati d’intaglio in doratura. Suppongo che la cornice interna del tempio sia stata poco sporgente secondo l’uso degli Arabi nelle loro moschee ch’era piuttosto un listellino e che fu adottato nell’architettura successiva dai Normanni con aggetto di poco maggiore. Nella tribuna di centro Gualterio fè costruire sopra tre gradini un magnifico altare marmoreo, e l’arcivescovo Diego Aedo l’ingrandì ed elevò a quattro gradi ed altro di legno e il successore Paolo Visconti nel 1469 innalzò sull’altare una statua in marmo della Beata Vergine che poi l’altro arcivescovo Giovanni Paternò nel 1510 trasferì nella parte destra laterale. Prima di costoro dovette il suo fondatore Gualterio fornire di sacre immagini in marmo o in mosaico o in altra guisa di pittura la sua chiesa prediletta. Si sa anche per tradizione che nel tempio precedente atterrato _________________________________ Giuseppe Maria Polizzi, Gli horti hesperidi tributarij nella solennità dell’anno MDCLXXXX alla vergine patrona S. Rosalia liberatrice di Palermo sua patria dal mortifero dragone della pestilenza estinto dalla fragranzia delle ritrouate di lei odorose reliquie, In Palermo, per Tomaso Romolo, 1690. 339 126 da Gualterio vi fosse un quadro a mosaico sopra pietra rappresentante la testa della Beata Vergine donata dal re Ruggiero, la quale in parte danneggiata principalmente nel campo dorato fu fatta ristorare dal signor Riolo a mio suggerimento dal dotto mio amico canonico Alessandro Casano340 ed ora si osserva nella predella di un altare a man destra di chi entra. Si sa pure che per tradizione che lo stesso re Ruggiero donò a quella chiesa una macchinetta con colonne e filagrani e statuette d’argento ove riponeasi la Sfera del Sacramento e conduceasi in processione nella chiesa. Quest’opera di singolare lavoro artistico per quei tempi detta Confalone fu tolta da Ferdinando III residente in Palermo dopo il 1806 e fusa con tutti gli altri vasi sacri delle nostre chiese per ricavarne argento da coniare monete. Questo Confalone era stato conservato nella Cattedrale innalzata da Gualterio con tutte le altre immagini di santi come pure la grande sfera sacramentale d’oro circondata di gemme a guisa di stelle crinite del valore in oro di seimila onze e delle gemme di onze 450341. Non sappiamo se questa magnifica sfera sacramentale sia stata fusa con gli altri oggetti di argento e d’oro della chiesa fra per i quali vi erano sei grandi candelabri certo [!] dell’epoca aragonese essendovi cisellata l’aquila bicipite stemma di quella dinastia, i quali erano calcolati del valore di onze mille. Vi era l’anno segnatovi 1630 e il nome del Cardinal Doria e la notizia di essere stati eseguiti a spese della chiesa. Uno di essi rubato fu supplito sotto l’arcivescovo Pietro Martines. In detto cappellone fu dipinta la tela quadragesimale d’Antonio Grano di Palermo342 nel 1682 ove scorgeasi in color celeste oscuro Gesù Cristo spirante sulla croce e a piè della stessa la Vergine Madre e le Marie dolentissime. Al lato destro del cappellone eravi una minor cappella in forma semicircolare della profondità di palmi sedici con sei colonne. Sulla finestra altra uguale con la statua marmorea della Vergine di sopra accennata ed ivi erano i sepolcri degli arcivescovi, secondo fu stabilito dallo stesso Gualterio che ivi volle esser deposto, e nel 1510 vi fu collocata la bellissima tavola dipinta della Presentazione al tempio della vergine. _________________________________ 340 Alessandro Casano, Del sotterraneo della chiesa Cattedrale di Palermo, Palermo, Stamp. della ved. Solli e C., 1849, p. 8. 341 Maria Concetta Di Natale, Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, Milano, Electa, 1989, p. 153 attribuisce ad un «argentiere siciliano l’ostensorio raggiato in filigrana d’argento», custodito nel Tesoro della Cattedrale di Palermo e lo data agli «inizi del XVII secolo». 342 Antonino Grano, pittore, architetto, incisore, nato a Palermo nel 1660, ivi morto nel 1718. Quattro versioni biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 117; Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti … cit., p. 134, 135-136, 254-256; Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 35; Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 415-417, 481. 127 Quella cappella fu adornata di marmi da Vito Solfarello, ed ornata in pittura dei simboli della Vergine da Andrea Carreca trapanese343 ed ulteriormente abbellita da diversi arcivescovi. Paolo Amato da Ciminna architetto del Senato nel 1689 diè il disegno per nuovi abbellimenti di quella cappella e Baldassare Pampillona palermitano344 vi scolpì sei statue marmoree di angioli, e prima il celebre Antonio Gagini da Palermo345 quelle di S. Giovanni Battista e di S. Silvia della città di Monte S. Giuliano. Nel 1469 era stata commessa a Francesco Laurana veneziano346 per onze 62.6. la statua in marmo di Maria Vergine347; ma il Senato palermitano ammirandone il lavoro volle ritenerla per la nostra Cattedrale. Quella statua divenuta famosa pei miracoli procacciò a Laurana di eseguirne la simile pel Monte S. Giuliano348 nel 1469 e indi ad Antonio Gagini altra simile nel 1538 per la chiesa di S. Maria di Gesù in Caltagirone349 Vincenzo350 Guercio351 palermitano altro conforme nel 1611 pel Duomo di Ciminna. La primitiva del Laurana si osserva ancora in una cappella del lato sinistro di chi entra, sebbene essa abbia cambiato il titolo in quello di Maria Vergine che libera nos a poenis infermi, ed è certo lavoro diligente e pregevole per quel tempo; ma di gran lunga inferiore a quelle che pochi anni dopo scolpiva il nostro rinomato Antonio Gagini come vedremo. Quella cappella magnificamente ornata costò per vasi di argento, gemme, 1500 onze. _________________________________ Andrea Carreca, pittore, nativo di Trapani agli inizi del secolo XVIII, attivo fino al 1677. Una versione biografica è reperibilein Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 413, 480. 344 Pampillona Baldassare, scultore, nato a Palermo nel 1646, ivi morto nel 1710. Una versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 172-173. 345 Antonello Gagini, scultore, nato a Palermo nel 1478, ivi morto nel 1536. 346 Francesco Laurana, scultore, nato a Vrana in Dalmazia intorno al 1430, morto dopo il 1500. Due versioni biografiche sono reperibili, rispettivamente, in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 82-83 e in Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 413, 480. Gallo reitera il refuso mnemonico affermando che il Laurana è veneto: cfr. Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 38. Per un aggiornamento cfr. “I rapporti con Antonello da Messina” in: Benedetto Patera, Francesco Laurana in Sicilia, Palermo, Novecento, 1992, p. 66-71. 347 Seguono cancellate le parole: “di Trapani da collocarsi in una cappella a lei dedicata”. 348 Antica denominazione di Erice (Trapani). 349 Seguono cancellate le parole: “e dal suo figlio”. 350 Segue cancellata la parola: “Gagini”. 351 Gaspare Guercio, scultore (notizie dal 1635-† 1679). 343 128 Opere pubbliche fatte in Palermo dal 1778 fino al 1832 1778 Essendo pretore D. Antonio La Grua Talamanca marchese di Regalmici si cominciò la cosi detta Villa Giulia sul gusto de’ giardini francesi ideata da M.r Le Notre352, prese nome di Villa Giulia dalla moglie del vicerè Colonna allora dominante. Fu costruito nel *** il regio Orto Botanico sul disegno di M.r Fourny architetto francese353 con l’assistenza di D. Giuseppe Venanzio Marvuglia354, il quale inalzò di sua idea i due piccoli edifizj laterali detti il caledario, e il tepedario. I bassi rilievi del portico dell’edifizio centrale, e i ritratti de’ principali botanici di Europa nell’interno son lavoro del pennello di don Giuseppe Velasques355. Fu aperta verso quel tempo la porta detta Reale, che corrisponde rimpetto all’ingresso laterale della Villa Giulia. Furono costruite in quel tempo tre nuove vie, una che conduce da Molino356 fino al luogo di Cappello presso il Ponte dello Ammiraglio, e passa per li Sette Cannoli o sia Musica d’Orfeo; altra per la parrocchia di Brancaccio sino a Mar Dolce, e l’ultima che va direttamente a Buon riposo. 1822 Fu destinato il locale di S. Giovanni de’ Leprosi, antico Ospedale de’ matti357, per la fabbrica delle pelli, dopo che i maestri conciapelle vennero allontanati dal centro della città358 per la rivoluzione del 1820. Fu aperto lo stradone della Porta di S. Antonino che procede per quasi mezzo miglio sino alla Guadagna, e termina con un ponte lasciato a metà per mezzo del quale si dovea tragittare alla parte opposta della Guadagna. Fu costruito il pubblico Cimitero detto Campo santo nel luogo ov’esiste l’antica chiesa di S. Spirito, famosa pel Vespro siciliano359. _________________________________ Andrè Le Nôtre, architetto dei giardini, nato a Parigi nel 1613, ivi morto nel 1700. Vedi nota n. 135. 354 Giuseppe Venanzio Marvuglia ma è Trombetta il vero architetto. 355 Per il ciclo degli affreschi eseguiti: cfr. Angela Mazzè, “L’iconografia del naturalismo nel ciclo pittorico dell’Orto Botanico di Palermo”, in: I naturalisti e la cultura scientifica siciliana nell’800. Palermo, 5-7 dicembre 1984. Atti a cura di G. Liotta; con la collaborazione di A. Agro e S. Burgio, Palermo, 1987 (Palermo : STASS), p. 371-385. 356 Via del Molino <dei Mulini>, mandamento Orto Botanico. Carmelo Piola, Dizionario delle strade di Palermo. Preceduto da una corsa per Palermo e i suoi dintorni, Palermo, Reprint, 1994. Ripr. facs. dell’ed.: Palermo, Stamperia M. Amenta, 1870, p. 142, la colloca «fuori Porta S. Antonino, via Oreto». 357 Dal 1824 il luogotenente marchese delle Favare D. Petro Ugo concede al barone P. Pisani, per grazia del sovrano Ferdinando I di trasferire i malati di mente dall’ospedale di S. Giovanni dei Lebrosi alla casa del Noviziato dei P. Teresiani scalzi. 358 I conciapelli erano a Santa Margherita: Cfr. Le parrocchie cit., p. 291 e sgg. 359 Noto con l’appellativo di S. Orsola, progettato dall’architetto Carlo Chenchi e fondato nel 1782 dal viceré marchese Domenico Caracciolo. Inglobato nell’area in cui sorge la chiesa medievale di S. Spirito o dei Vespri (1173-1178). 352 353 129 1819 Furono alberati, e divisi in viottoli simmetrici il Piano di S. Teresa360, il Piano della Marina361, e aggiunte due passeggiate alberate al passeggio esterno della Marina. 1827 Fu collocato nel piano di S. Teresa una gran fonte, che pria era laterale. 1827 Nel cominciamento dello stradone di Mezzomonreale fu eretta una colonna milliarica dal disegno dell’architetto Raineri362. Fu ampliato, e decorato l’edifizio detto del Noviziato di S. Teresa, già destinato ad Ospizio de’ matti363. Il disegno è dell’architetto Raineri: il gran bassorilievo esterno, e un quadro interno rappresentante Orlando furioso, furon dipinti a fresco da D. Vincenzo Riolo palermitano. 1826 Fu ristorata la Porta Nuova dopo il tremuoto del 1823 e decorata nell’interno di vasi, trofei, ed iscrizioni dal capo maestro Patricolo364. I due genj che sostengono lo stemma reale nell’interno della porta furono modellati da D. Francesco Quattrocchi365. Furono ritrovati e ristorati gli antichi sepolcri che credonsi dell’epoca saracena verso la Porta di Ossuna366. Ivi vicino la casa di Gastone fu costruito l’ospedale degli etici tisi367 ci . 1832 Fu aperto lo stradone rimpetto la casina del razionale Delfino dietro il giardino del convento di S. Francesco di Paola che rettamente conduce all’Olivuzza368. Fu costruita la Porta detta di Carini. _________________________________ 360 Piano di S. Teresa, ex piazza omonima, oggi Indipendenza. La sua denominazione rimanda alle battaglie combattute durante le storiche rivoluzioni siciliane. 361 Piano della Marina, oggi Foro Italico. 362 Pietro Raineri, architetto, nato a Palermo nel 1739, ivi morto nel 1816. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 178. 363 Riconosciuta come chiesa di S. Maria dei Rimedi dell’Ordine carmelitano, ubicata in piazza Indipendenza. 364 Giuseppe Patricola, capomastro della Real Casa, attivo a Palermo nel XIX secolo. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 304-307. 365 Vedi nota n. 198. 366 Un aggiornamento storiografico è stato condotto da Giuseppe Lo Jacono - Clemente Marconi, L’attività della Commissione di Antichità e belle Arti in Sicilia, parte II (1835-1845), in: “Quaderni del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Supplemento, 1998, n. 4, p. 129. 367 Una interessante carrellata storico-documentaria è stata condotta da Francesco Di Gesù - Antonio Martorana, Assistenza sanitaria della malattia tubercolare in Sicilia nell’età borbonica. Strutture, terapie, medici e ciarlatani, in: “Struttura e funzionalità… cit., p. 53-83. 368 Olivuzza (corso), mandamento Molo, ubicato fuori Porta Carini, via Volturno, via Alberto Amedeo: cfr. Carmelo Piola, Dizionario … cit. 130 Fu edificato l’Orfanotrofio di Ardizzone369. Il prospetto, e l’interna riforma deesi all’architetto Don Emmanuele Marvuglia. Furono aperti due stradoni, uno che giunge sino al Piano di S. Oliva370, ed è traversato dall’altro, che da un lato giunge fino alla Porta di Carini, e dall’altro fino al Borgo di S. Lucia371, e precedentemente a’ Quattro Cantoni, che da un lato va alla chiesa di S. Francesco di Paola, e dall’altro fino al Borgo372. Fu costruito il Collegio di Maria al Borgo a spese del parroco Custos indi vescovo di Mazzara. Fu aperto lungo, e largo stradone che dalla Casina del duca di Gualtieri allo Ucciardone373 conduce a pié del Monte Pellegrino, che poi venne spianato nel 1830374 dal luogotenente marchese Nunziante. Fu condotta l’acqua con grandissimo dispendio dalla fonte del Gabriele375 sino alla Casina detta della Favorita per opera dell’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia376. Fu stabilito da Mons.r Gioeni il Seminario Nautico nel convento de’ Padri Mercenari al Molo377. _________________________________ Istituito, per volontà testamentaria nel 1818, dalla marchesa Ardizzone, la quale emana anche i Regolamenti per l’Orfanotrofio femminile. Ubicato in via Pignatelli Aragona, sotto titolo dell’Immacolata Concezione. Cfr. Antonino Abbadessa, Tre allievi di Giuseppe Venanzio Marvuglia, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, 1999. 370 Oggi piazza, mandamento Molo, ubicata nei pressi di piazza Ruggero Settimo. 371 Mandamento Molo, ubicato fuori porta S. Giorgio. 372 Mandamento Molo, ubicato fuori porta S. Giorgio. 373 La documentazione grafica è riportata nel giornale Il telegrafo siciliano, a. II, n. 27, 2 aprile 1836, p. 4. La recente storiografia delle fonti ha rubricato i disegni delle piante custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe presso la Galleria Regionale della Sicilia, cfr. Palermo nell’età dei neoclassicismi. Disegni di architettura conservati negli archivi palermitani. A cura di Maria Giuffrè Marco Rosario Nobile, Palermo, Dipartimento di storia e progetto nell’architettura, Università degli studi di Palermo, 2000, p. 23 e sgg. 374 Già noto nell’antichità con l’appellativo di Ercta. Per ulteriori notizie cfr. Lucia Bonanno Salvatore Amoroso, “La città e il suo monte. Iconografia storica e sviluppo urbanistico”, in: Actas del VI Congreso Internacional de Expresion Grafica Arquitectonica.Pamplona, 9-10 de mayo de 1996, Pamplona, [EGA], 1996. 375 La doviziosa storiografia è compendiata in Villabianca, La Fontanografia oretea, a cura di S. Di Matteo, Palermo 1986, p. 80-87. 376 Il Parco è apprezzato, soprattutto, dai viaggiatori stranieri: Cfr. Angela Mazzè, Il paesaggio antropico. La Sicilia da Idrisi a Brandi, Palermo, Pitti, 2012, p. 210-226, passim. 377 Seminario nautico Gioeni, fondato nel 1788 da mons. G. Gioeni dei duchi d’Angiò, aveva sede all’Acquasanta. Trasferito nel 1792 nei locali del convento dei P. Mercedari al Molo ristrutturati, per l’uso, dall’ing. Teodoro Gigante. Nel 1864 acquisisce la denominazione R. Istituto nautico della marina Mercantile e l’anno successivo sarà intitolato a “Gioeni Trabia”. Dopo il 1943 la sede definitiva, progettata da Antonio Bonafede, P. Gagliardo, Giuseppe Spatrisano e Vittorio Ziino sarà Piazza del Cavallo marino. Cfr. Alfonso Sansone, Storia del R. Istituto Nautico “Gioeni-Trabia” (1789-1892), Palermo, Tip. Filippo Barravecchia e figlio, 1892 e Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria ... parte II, cit. 369 131 Fu ristorata la lanterna del Molo, e il Fortino contiguo378. Fu rifatto l’antico Forte della Garita379, e ridotto a camere matte con piloni, e lamie, e con una salita rampa. Presso lo stesso furono riformate le stanze per la Deputazione della Salute380. Fu costruita la barchetta della Marina con sedile spalleggiato. Fu innalzata un’aguglia marmorea alla fine della Villa Giulia. 1824 Nel Foro borbonico381 furon meglio distribuite le statue di Carlo 2°, Filippo 5° Carlo 3° e Ferdinando 3° e aggiuntavi quella di Francesco 1°, lavoro di Valerio Villareale palermitano. All’occasione della venuta di S.M. Ferdinando 3° nel 1798 fu eseguito il mosaico nella parte esterna della Cappella Palatina, rappresentante Ferdinando 3. e la regina Carolina. Nell’ante sagrestia di detta Cappella furono fatti scolpire due bassi rilievi da D. Liberto Quattrocchi382 palermitano rappresentanti il battesimo del defunto principe D. Ferdinando figlio del re Francesco, e di Maria Clementina seguito nel 1800, e l’altro del principe D. Ferdinando attuale re seguito nel 1810. Nell’altro bassorilievo dello stesso scultore si scorgono gli stessi sponsali della real principessa Maria Cristina con Carlo Felice principe ereditario di Sardegna seguito nel 1807, e l’altro della real principessa Maria Amalia sposata con Ludovico Filippo duca d’Orleans nel 1809. Nel R. Palazzo fu costruita la Specola astronomica dall’architetto D. Giuseppe Venanzio Marvuglia sotto la direzione del celebre abate Piazzi383. Fu traslocato l’Ospedale militare di S. Giacomo nella Casa di S. Francesco Saverio384. _________________________________ Il Gallo cita la notizia riportata dalla chiosa di Girolamo Di Marzo Ferro, Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni riprodotta su quella del cav. d. Gaspare Palermo, Palermo, Stamperia di Pietro Pensante, 1859, p. 732: «dal 1° aprile 1853 in vece delle 32 lucerne» l’illuminazione del Faro è sostituito da un «fanale posto sulla torre del Molo con apparecchio catadiottrico…». 379 Forte della Garita (1592-97), «braccio di pietre grosse…sicurissimo sbarcatore….piccolo Molo» destinato all’approdo dei Vicerè. 380 Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria a Palermo …. Nuovo, cit., p. 33. 381 Denominazione settecentesca dell’asse viario incluso dalla Cala al piano di S. Erasmo. Le statue dei sovrani borbonici conferirono l’omonima denominazione alla strada che nel 1848 fu ribattezzata Foro Italico. 382 Quattrocchi Liberto, scultore, nato a Palermo nel 1782, ivi morto nel 1811. Una nota biografica è reperibile in Agostino Gallo, Lavoro … cit. p. 249-250. 383 Più noto come Osservatorio astronomico, è ubicato sulla Torre Pisana del Palazzo Reale. Edificato nel 1791, al tempo del viceré Caramanico, vi si accede dalla loggia più alta del cortile Maqueda. 384 S. Giacomo dei Militari trasferito a S. Francesco Saverio, Per le vicende storiche, cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria … parte II, cit. Del documento grafico (1824 ca) relativo al prospetto dell’immobile si evincono informazioni nell’inventario curato da M. Giuffrè- M.R. Nobile, Palermo nell’età dei neoclassicismi… cit., n. 22, p. 43-44. 378 132 Fu costruito un magnifico portico d’ordine dorico siculo dal capitano Ragona per decorare la Pubblica Biblioteca del Senato385. Fu costruito l’infame portone della Regia Università dall’architetto Cavallaro386, sostituito al bellissimo portico dorico siculo ideato dal celebre D. Giuseppe Marvuglia. Nella stessa Università fu costruito il magnifico salone dall’architetto D. Antonino Gentile387 per collocarvi i quadri, e per le funzioni delle lauree dottorali. Ivi fu costruito dallo stesso architetto il magnifico Teatro Anatomico388. Dopo il terremoto del 1823 fu ristorata la Casa Pretoria389, costruitavi un’infame scala, ed erettovi un vestibolo discordante dall’ordine interno dell’edifizio dall’architetto Niccolò Raineri390. Fu costruito il portico del Regio edifizio della Posta dall’architetto D. Emmanuele Marvuglia391. Fu costruito il R. Teatro Carolino dall’architetto D. Niccolò Puglia392. Fu costruito il Teatro S. Ferdinando393. _________________________________ 385 Costruito nel 1858, il portico di ordine dorico-siculo in calcarinite per interessamento dell’abate D. Scinà, durante il governo del pretore principe di Torrebruna. Cfr. per la storia, Le parrocchie cit., p. 38-39. 386 Così viene ricordato da Girolamo Di Marzo Ferro, Guida istruttiva per Palermo … cit., p. 464465: «…si è aperto un gran portone nella strada Nuova con quattro colonne scannellate di pietra bigia di Billieme con cancello di ferro, del quale nel fronte si legge Regia Studiorum Universitas, e al di sopra una ringhiera con parapetto di marmo, con delle nicchie ai fianchi, dove dovranno situarsi delle statue, ed in cima dell’apertura della ringhiera si è collocato lo scudo colle armi reali. Il disegno è dell’architetto D. Cristofaro Cavallaro, sotto la direzione, per Real Ordine, di tre ingegneri militari, Giambattista Mori e Sig. brigadiere D. Errico Sanchez». 387 Antonino Gentile, architetto, nato a Palermo nel 1790, morto a Catania nel 1834. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 182-199. 388 Il «nuovo anfiteatro anatomico», istituito da Giovanni Gorgone nel 1828, occupava l’ultimo piano: cfr. Orazio Cancila, Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 466-481. 389 Un puntuale riferimento ai danni, classificati secondo un criterio topografico, fu condotto dal tenente colonnello del Genio Carlo Dolce, autore del saggio Riflessioni sul tremuoto avvenuto in Palermo il 5 marzo 1823, Palermo 1823; una puntuale ricognizione storica e documentaria è stata condotta da Pietro Gulotta in: Camillo Filangeri, Palermo. Palazzo delle Aquile. La residenza municipale tra arte e storia [di] Camillo Filangeri, Pietro Gulotta, Maria Antonietta Spadaro, [Palermo], Quattrosoli, [2004]. In particolare cfr. il cap. IV, p. 45-65 esaustivo di notizie correlate agli interventi di restauro e di riqualificazione di alcune parti dell’immobile. 390 Nicolò Raineri, architetto attivo nel XIX secolo. 391 Con R. Dispaccio del 16 aprile 1787 la Casa di San Cataldo fu destinata alla Posta delle Lettere, rammenta Girolamo Di Marzo Ferro, Guida istruttiva di Palermo… cit., p. 291. 392 Nicolò Puglia, architetto, morto a Palermo nel 1855. 393 Denominato successivamente Umberto, era ubicato in Via Merlo. Costruito come teatro di tipo popolare (1802-1816), fu distrutto dai bombardamenti nel 1943. Cfr. Antonella Mazzamuto, Teatri di Sicilia, Palermo, S.F. Flaccovio, 1989, p. 95. 133 Fu costruito un portico d’ordine dorico-romano nel Piano della Marina per uso della Gran Guardia394. Fu costruita una Loggia decorata da servizio per la estrazione del Regio Lotto dall’architetto D. Emmanuele Cardona395. 1823 Fu demolita la chiesa della Kalsa396 di disegno arabo normanno, e nobilitata la strada del principe di Butera. Fu spianato il passaggio superiore delle Mura delle Cattive, e fattovi un giardino pensile, e decorato di statue, vasi, e sedili per opera dell’architetto Raineri397. I Quattro Telamoni de’ due ingressi furono scolpiti da piccolo Bagnasco398. 1825 Fu riunito allo Spedale Grande quello di Santo Bartolomeo, e destinatone l’edifizio a’ projetti399. La riforma fu fatta dall’architetto Raineri, il gran bassorilievo da D. Vincenzo Riolo, le statue di stucco del cornicione da Niccolò Bagnasco. Il ritratto di Francesco, e le due figure laterali da Francesco Quattrocchi. È stato destinato l’antico palazzo di Pietraperzia dietro S. Cita a Monte di Prestamo sotto il titolo di S. Rosalia400. Fu fatta la fabbrica quadrilatera con le botteghe nella Piazza della Bucceria dall’architetto D. Carlo Chenchi401. 18** Nel locale dell’antica Conceria fu fatta la piazza del mercato di commestibili dallo architetto D. Vincenzo Di Martino402. L’edifizio di contro del barone Grasso fu ideato dall’architetto Puglia403. Fu trasportato il portico del Duomo in avanti per opera di D. Giuseppe Marvuglia, e del capo maestro Patricolo404. _________________________________ 394 Ubicato in piazza Marina, vicino al Palazzo dello Steri (oggi sede del rettorato dell’Università), fu abitazione dei principi di Niscemi Valguarnera e successivamente acquistato dalla Regia Corte. 395 Giovanni Emanuele Cardona, architetto (notizie fino al 1820). 396 Cfr. Angela Mazzè, Le parrocchie cit., p. 246 e sgg. 397 Vedi nota n. 390. 398 Nicolò Bagnasco, scultore, nato a Palermo nel 1791, ivi morto nel 1827. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 253-254 e 260-262. 399 Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria …. parte II, cit., p. 129, 133 e sgg. 400 Ubicato in via Bara all’Olivella. I passaggi di proprietà sono stati rubricati da Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati di Palermo. Palermo, D. Flaccovio, 19941997, v. 1: Gli edifici entro le mura, p. 187-188. Il recente restauro è stato condotto dall’ architetto Gae Aulenti (1906-2013). 401 Carlo Chenchi, architetto, nato a Palermo nel 1740, ivi morto nel 1815. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 175-177. 402 Vincenzo Di Martino, architetto, nato a Palermo nel 1773, ivi morto nel 1837. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 210-214. 403 Vedi nota n. 392. 404 Vedi nota n. 364. 134 Furono restaurati li quattro campanili a guglia di stile arabo-normanno da Fra Felice di Palermo cappuccino405; e altro costruitovi dello stesso stile da Don Emmanuele Palazzotto406. Fu rifatto l’interno del Duomo di Palermo sul disegno dell’architetto Fuga, ed eseguito con modificazioni notabilissime dall’architetto Marvuglia407. I pesantissimi genj di stucco, che sostengono le armi reali, e il Padre eterno furono modellati da Francesco Quattrocchi. La volta fu dipinta dal pittore Mariano Rossi da Sciacca408. Il quadro dell’Assunta, e di S. Ninfa da Velasques. Il fonte battesimale fu scolpito da D. Filippo Pennino409. I due grandi alti rilievi nella Cappella di S. Rosalia furono scolpiti da D. Valerio Villareale. Fu stabilito lo Spedale de’ convalescenti a lato a quello de’ Sacerdoti, e dipendenti dall’Ospedale Grande. 1833 [!] Fu terminata la parrocchia di S. Antonio rovinata dal terremoto del 1823 sul disegno imitante lo stile arabo normanno dall’architetto Niccolò Raineri410. 1830 Fu abbellito lo spiazzo del Papireto e fattovi un giardino per opera del generale Tschudy. 1834 Fu abbellito l’esterno prospetto del palazzo del principe di Partanna411 dall’architetto Domenico Cavallari. 1834 Similmente fu abbellito l’esterno del prospetto di palazzo del duca della Ferla, e rifatto l’interno dopo che passò in proprietà dell’Ex. Presidente Arcuri412 dall’architetto Firriolo413, il quale in qualità di stuccatore vi fece il bassorilievo sulla entrata. _________________________________ Fra Felice da Palermo, architetto cappuccino, attivo nella prima metà del sec. XIX. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 178-179; e Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 58. 406 Vedi nota n. 242. 407 G.iuseppe Venanzio Marvuglia trasporta il portico del Duomo. 408 Mariano Rossi, pittore, nato a Sciacca nel 1731, morto a Roma nel 1807. Le notizie biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 89-93. 409 Filippo Pennino, scultore, nato a Palermo nel 1733, ivi morto nel 1794. Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 202, 221. 410 Le parrocchie cit., p. 182 e sgg. 411 Già ubicato in Piazza Marina era appartenuto a Girolamo Grifeo e Statella principe di Partanna (1788). Le successive destinazioni sono state: Palazzo dei Telegrafi, Sede dell’Istituto Superiore di commercio (1920), Facoltà di Economia e Commercio (1937). Parzialmente distrutto nel 1943, demolito nel 1956, nell’area di risulta è sorto un fabbricato condominiale. Cfr. Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 199-200. 412 Palazzo del duca di Miraglia, barone della Ferla. Cfr: Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 179. 413 Firriolo Giovanni, architetto e scultore, nato a Palermo nel 1759, ivi morto nel 1837. Le notizie biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 209-210 e in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 262-263. 405 135 1832 Fu fabbricato il palazzetto del negoziante francese Mario Guenda nello stradone, che conduce ai Quattro Venti414, dall’architetto D. Arcangelo Lauria415, allievo di Speranza416. 1833 Fu terminato il prospetto stile arabo-normanno della parrocchia di S. Antonio dall’architetto comunale D. Niccolò Raineri417. 1835 Fu terminato il grande edifizio dell’albergo de’ poveri di Monreale418 dall’architetto D. Luigi Speranza sul disegno fattone dal suo allievo D. Arcangelo Lauria. 1834 [!] Fu fatto il prospetto della R.l Segreteria di Stato sul disegno di D. Luigi Speranza, con alcune modificazioni suggerite dal Sig. D. Agostino Gallo419. 1835 Fu abbellito il prospetto del Palazzo del principe di Cutò, rimpetto il Duomo, dall’architetto D. Emmanuele Palazzotto420. 1835 Fu terminato il campanile del duomo di Palermo di stile arabonormanno, dallo architetto D. Emm.le Palazzotto. 1834 Fu terminato il prospetto del Palazzo del principe della Cattolica alla marina, or posseduto dal marchese Forcella421, con la direzione dello stesso marchese. Le pitture della Stanza di compagnia furon cominciate da Vincenzo Riolo e terminate dal suo figliuolo Antonio422. _________________________________ Mandamento ubicato fuori porta S. Giorgio. Tra via del Borgo e via Molo. La denominazione deriva dalla fontana, eretta nel 1589 (e distrutta nel 1786), coperta da una cupola poggiata sopra quattro archi di pietra, munita di sedili, che nella stagione estiva rendeva gradevole la sosta per la gradevole quaterna ventilazione. 415 Lauria Arcangelo architetto operante nella prima metà del XIX secolo. 416 Speranza Luigi, architetto (Palermo 1763-1835). Le notizie biografiche sono reperibili in Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 180-181. 417 Vedi nota n. 390. 418 Fondato nel 1733 da F:P. Gravina, principe di Palgonia, su progetto di Orazio Furetto, il cantiere è aperto nel 1746 e, dopo alterne vicende si chiude nel novembre 1829, sotto la direzione di Nicolò Puglia. Una puntuale ricerca storico-archivistica è stata condotta da Maurizio Vitella, Il real Albergo dei poveri di Palermo. Premessa di Maria Concetta Di Natale. Presentazione di Maria Giuffrè, Napoli [etc.], Edizioni scientifiche italiane, [1999]. 419 Ubicato in via V. Emanuele (già Toledo), l’immobile costruito nella prima metà del XIX secolo nell’area dove sorgeva il settecentesco palazzo Reggio di Acicatena. 420 Vedi nota n. 242. 421 Ubicato sul tratto delle vecchie mura della Porta dei Greci, la sua denominazione è correlata al proprietario, il marchese Enrico Forcella, amministratore generale della Casa e dei siti reali di Palermo, “dilettante” di architettura, esperto conoscitore del medioevo siciliano, “progettista” dell’omonimo palazzo oggi De Seta. Per i riferimenti storici cfr: Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 104-105. 422 Riolo Antonio, pittore, figlio e allievo di Vincenzo, nato a Palermo nel 1808, ivi morto nel 1837. Biografia compendiata nel ms. XV. H.19: cfr. Agostino Gallo, Notizie di pittori e mosaicisti… cit., p. 262-263. Il 19 luglio Vincenzo Riolo, avalla l’istanza dell’allievo che «desidera studiare e disegnare i gessi in questa Reale Università» e lo dichiara «atto a tale studio». A.S.PA., Permessi di studio…cit., Misc. Arch. n. 316. 414 136 1834 Fu abbellito con un piccolo giardino il largo del R. Palazzo col disegno dell’architetto Raineri e la direzione del generale Tschudy. 1835 Fu costruito il litterino della chiesa del R. Palazzo col disegno dell’architetto D. Niccolò Puglia. 1835 Fu abbellito il prospetto dell’antica torre di Santa Ninfa nel R.l Palazzo, ove sta la Specola col disegno arabesco423 dell’architetto Puglia. Luglio 1835 Riforma ed abbellimento del palazzo del principe di Cutò424 nel prospetto fatta dall’architetto D. Emmanuele Palazzotto. Novembre 1835 Campanile a due ordini con aguglia sopra costruito rimpetto alla porta maggiore del Duomo di Palermo, ed appartenente allo stesso dall’architetto D: Emmanuele Palazzotto secondo lo stile arabo-normanno sul gusto dilli altri quattro della stessa Cattedrale che costò la spesa di onze 2000425. 1835 Fu terminato il quartiere della Vittoria fuori Porta Nuova dagli architetti militari426. 1834 [!] Fu terminato il prospetto e la chiesa del Collegio di Maria di Schi<a>ttini in Palermo dall’architetto D. Niccolò Puglia427. 1835 In ottobre di quest’anno si buttò la prima pietra senza alcuna formalità della nuova prigione in Palermo nel Piano del Ciardone428. Il disegno fu fatto da D. Vincenzo De Martino429, e poscia riformato con l’aggiunta di quattro fortini agli angoli dagli architetti militari. Il prospetto, e in parte, l’interna divisione rimase come era stato ideato dal De Martino. 1835 In quest’anno fu terminato dagli architetti militari *** il quartiere della Vittoria a Mezzomonreale, e ristorato quello di S. Giacomo. 1835 Furono diroccate le antiche fabbriche di stile arabo-normanno rimpetto il palazzo del principe della Cattolica430 nella strada di S. _________________________________ 423 Disegno arabesco: tipo di decorazione vegetale utilizzato nel linguaggio della critica d’arte intorno alla metà del XVI secolo. Il teorico Paolo Pino, nel Dialogo di pittura di messer Paolo Pino nuouamente dato in luce, In Vinegia, per Pauolo [!] Gherardo, 1548 (In Vinegia, per Comin da Trino di Monferrato, 1548), afferma che «lo dipingere arabesco <fu> usato dai Mori». La letteratura artistica, a partire da G. Vasari rielabora i concetti storici e iconografici. 424 Ubicato in Corso Vittorio Emanuele. I passaggi di proprietà sono stati rubricati da Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 121. 425 Neogotico: fenomeno architettonico di cultura e di gusto associato alla rivalutazione del Medioevo e diffusosi in Europa tra i secoli XVIII e XIX. Anche la Sicilia ne viene influenzata. 426 Cfr. Angela Mazzè, L’edilizia sanitaria a Palermo … Nuovo, cit., p. 111 e il doc. 250, p. 190-197. 427 Ubicato nel quartiere Kalsa, altrimenti noto col titolo di Collegio di Maria della Sapienza. 428 Dal francese chardon, ossia cardo spinato, nell’area della produzione vegetale sorgeranno le grandi prigioni progettate da Vincenzo Di Martino La denominazione deriva dalla piazza dell’Ucciardone. Mandamento Molo, fuori porta S. Giorgio. 429 Vedi nota n. 402. 430 Palazzo del Principe della Cattolica. Cfr. Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 103-104. 137 Francesco, e costituitevi le attuali case con semplice ed elegante prospetto. 1836 Fu cominciata la riforma interna della chiesa di S. Francesco [d’Assisi] dall’architetto Patti padre431 devastandosi barbaramente e senza urgente necessità le pitture della volta, e delle ali fatte dal celebre Pietro Novelli432, non che quelli degli spigoli degli archi per ridursi gli stessi capricciosamente dalla forma di sesto acuto a quella semicircolare. A quest’oggetto furono ricoverti gli affreschi dei sottarchi dipinti da Gherardo Astorino433 forse su i cartoni del Novelli e con lo stesso stile per modo che erano stati giudicati di lui, e solo fu avvertito di essere dell’Astorino essendosi trovato in uno di essi scritto G. Ast. S 16…. La riforma rimase interrotta, fu continuata per tutto l’anno 1836 sulle stesse tracce del Patti dall’architetto Domenico Cavallaro434 e terminata nel seguente anno 1837. È da avvertire che la maggior cappella era stata riformata molti anni prima sul modello della quale vi seguirono gli archi, decorata da pilastri corinzi. 1836 Fu cominciata la riparazione della chiesa di S. Rocco nell’angolo laterale alla strada che conduce alla Piazza Nuova e fu elevato il pavimento della chiesa per costruirsi tre botteghe con la direzione dell’architetto D. Niccolò Raineri. 1837 Fu fatto il prospetto delle case laterali a detta chiesa di S. Rocco435 ove pria era l’Orfanotrofio col nome del menzionato Santo436 che fu trasferito nell’antico Collegio dei Padri delle Scuole Pie. Delle quali opere fu architetto Niccolò Raineri. _________________________________ Patti Giuseppe, architetto nativo di Partinico, attivo nella prima metà del sec. XIX. La ricostruzione documentaria condotta da F. Rotolo, La basilica di S. Francesco d’Assisi in Palermo, Palermo 1952, p. 159-163, compendia i punti salienti dell’infausta decisione del Patti (1823): sostituire le volte reali «per alleggerire… il peso, e scemare di vantaggio la spinta delle medesime»; demolire «le attuali volte di pietra e ricostruirle con delle curve di legname , vestite di canne, ricoperte di calce» per agevolare la «leggerezza delle volte». 432 La documentazione storica e archivistica è riportata in Guido Di Stefano, Pietro Novelli … Catalogo … a cura di Angela Mazzè cit., p. 188-195. 433 Astorino Gherardo, pittore, architetto, matematico e scultore, nato a Palermo, ivi morto nel 1663. Il Gallo elabora ben cinque versioni della biografia dell’Astorino: cfr.Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … a cit., p. 81; Notizie intorno agli incisori siciliani … cit., p. 20; Notamento alfabetico di pittori e musaicisti… cit., p. 16, 63-64; Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti … cit., p. 113, 144-145; Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 431-432. 434 Domenico Cavallari Spatafora, architetto, figlio di Cristoforo e Maria Antonia Spatafora, nato a Palermo nel 1788, ivi morto nel 1837. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti … cit., p. 208-209. 435 Distrutta e già ubicata in via Maqueda; per la ricognizione storiografica, cfr: Rosario La Duca, Repertorio storiografico degli edifici religiosi … cit., p. 182. 436 Orfanotrofio di S. Rocco, Già ubicato in via Maqueda; per la ricognizione storiografica, cfr: R. La Duca, Repertorio storiografico degli edifici religiosi … cit. 431 138 1837 Incominciata ad abbellirsi la Villa Giulia sotto la direzione del botanico D. Vincenzo Tineo437 e per darle vista di maggiore estensione fu demolito il nuovo divisorio tra la detta Villa e l’Orto Botanico, e sostituitavi una ferriata con colonnette che lo sostengono in guisa che si presentano all’occhio i due giardini pubblici in continuazione. Opere di pittura che si vanno eseguendo in Palermo 1828 Quadro ad olio di S. Vincenzo di Paola438 che predica in un villaggio a persone di campagna dipinto da Francesco La Farina439 palermitano, scolare di Velasques e da me illustrato. È di buon effetto, e buon disegno. Ritratto del conte D. Corrado Ventimiglia, mezza figura a olio dipinto da Patania. Le Grazie, ed Amore che dorme, quadretto a tempera dipinto da Patania in uno stanzino della casa di campagna di detto Ventimiglia, a’ Quattro Cantoni; e due paesi, una de’ quali rappresenta il Bagno di Diana, e l’altro Atteone cangiato in cervo, da me illustrato. Due ballerine, ed amorini che suonano degli strumenti nella camera da pranzo, a tempera. Pitture di soggetti mitologici dipinte a tempera nella volta della Galleria di detto Ventimiglia, dipinto da Francesco la Farina, e il coverchio del cammino [!] ad olio rappresentante soggetto mitologico. Gli ornati di questa elegante casina furono dipinti da D. Raimondo Gioia napoletano. 1823 Piccoli ritratti ad olio sopra rame di diversi ufficiali tedeschi dipinti dal Patania. Gran ritratto del generale *** tedesco dipinto ad olio dal Patania. 1828 Ritratto grande della moglie del console francese Mr. *** dipinto da Patania. Ritratto piccolo, ad olio, del P. Palermo di Alcamo dipinto dal Patania. 1828 Ritratto piccolo ad olio, del marchese Haus presso lo stesso, e replica per me. Patania. _________________________________ 437 Vincenzo Tineo, botanico, nato a Palermo nel 1791, ivi morto nel 1856. Tra gli encomi degni di nota, rammentiamo quello espresso da Enrico Onufrio, Guida … cit., p. 28: «È qualche cosa che nulla a che fare con l’Acquasola di Genova, coi Giardini pubblici di Milano, col Valentino di Torino, col Pincio di Roma. È leggiadro, elegante, fantastico… la eleganza dei giardini inglesi incastonata nella splendida vegetazione del mezzogiorno». 438 S. Vincenzo de’ Paoli. 439 Francesco La Farina, pittore, nato a Palermo nel 1789, ivi morto nel 1837. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 268-281. 139 Patania 1824 Piccoli quadri orizzontali rappresentanti le Storie di Amore e Psiche, dipinti ad olio con estrema diligenza ed amore da Patania per il R. Procuratore R D. Antonio Agnetta. 1824 La Madonna e il Bambino, e S.n Giuseppe quadrettino ad olio condotto con grande amore, e diligenza da Patania pel Sig.r D. Giuseppe Tortorici, e da lui regalato a D. Antonio Agnetta. Patania Ritratto della principessa di Belvedere, piccolo all’impiedi presso il conte di Sommatino. Ritratto della principessa di Montevago che incide alcune lettere sopra un albero. Mezze figure a olio Ritratto della principessa di Butera. 2 ritratti della baronessa Martines. Ritratto della marescialla Minutoli per la principessa di Paternò. Idem per la principessa di Beaufrimont440 rappresentata da Ebe presso Paternò. Idem per la marescialla Filangeri rappresentata da Psiche presso Paternò. Ritratto della moglie del Sig. D. Ferdinando Perricone, è bellissimo. Ritratto della moglie del Sig.r D. Medina, che sta acconciandosi i capelli alla toletta, è bellissimo. Ritratto dell’abate Filangeri fatto a memoria dopo morto, presso lo stesso pittore Patania. 1828 [Ritratto] Del pittore Patania dipinto da lui stesso pel suo amico l’Abate Palermo. 1828 [Ritratto] dell’Abate D. Giuseppe Crispi per Gallo. 1827 [Ritratto] Del pittore Giuseppe Velasques per lo stesso. Fu fatto quasi a memoria. _________________________________ 440 Leggasi “Beaufremont”. 140 Patania 1828 Piccola Battaglia, sopra legno di figura rotonda, da servir da compagna a tre antiche. per Gallo. 1824 Venere che abbraccia Adone ritornata dalla caccia, quadro piccolo di grande amore e diligenza per servire di compagno ad uno copia sopra Corregio [!] di Venere che scherza con Cupido, fatto per D. Vincenzo Cappone verso il 1812. Ora sono entrambi presso di Gallo. 1820 Gran quadro di altare rappresentante la Religione che offre Gesù Cristo morto a Dio Padre, in Sant’Orsola in Palermo. 1826 La Beata Vergine addolorata bellissima mezza figura ad olio fatta pel *** Replica fatta a un forestiere. 1822 Una ragazza che bacia una colomba mezza figura ad olio di bello effetto, grazia, e diligenza presso Gallo. 1814 [!] Un putto che abbraccia un coniglio presso lo stesso. È di colorito assai grazioso, e dipinto con gentilezza, e sommo amore, presso Gallo. 1826 Ritratto a mezza figura dell’abate Cirillo. È di bellissimo effetto, e di un fare grandioso. 1826 Ritratto intero della marchesa D.na Marianna Merlo, e D’Amico. Ha un’arpa in mano ed è vestita secondo il costume della corte di Enrico quarto. 1825 Ritratto dl marchese D.n Domenico Merlo mezza figura seduta. È somigliantissimo e di buono effetto. Patania Ritratto della famiglia del principe Cutò in un giardino; piccole figure alla pussina441. È quadro condotto con molta diligenza. 1816 Ritratti di quattro figli del principe di Trabia. Le figure sono bene aggraziate, e l’invenzione è graziosa. Ritratti di due figli del principe di Villafranca. È ben dipinto, e la composizione è graziosa. _________________________________ 441 Il riferimento è alla tipologia pittorica di Nicolas Poussin (1594-1665), pittore fiammingo vocato allo studio dell’antico e della pittura italiana. L’artista si muove tra due poli intellettuali: dal manierismo cromatico di Tiziano all’ideale classico di Raffaello Sanzio. Da qui l’invenzione poussiniana che spazia dai soggetti mitologici a quelli storici e sacri. 141 Ritratto d’un inglese con un gran cane. Ritratto della famiglia del Cancelliere della Gran Corte de’ Conti, D. Giuseppe Milazzo. Le figure sono alla pussina, i ritratti somigliantissimi, la composizione è graziosa. 4 teste di filosofi a mezze figure per lo stesso. Sono ben dipinti. 1828 [!] Una sacra Famiglia per D. Paolo Fagiano, piccolo quadro di graziosa composizione, e molto diligente. 1827 Due ritratti al naturale del Presidente D. Francesco Cupane, somigliantissimi. Uno presso lo stesso, e l’altro presso il suo amico ***. 1824 Ritratto del principe di Cutò all’impiedi. È somigliante, e di buono effetto. Trovasi nel R. palazzo nella sala de’ Viceré442. 1825 Ritratto del principe di Campofranco all’impiedi. È somigliantissimo, e d’un effetto mirabile ed è di stile rigoroso. È nella sala de’ Viceré. 1821 Ritratto del cardinale Don Pietro Gravina all’impiedi. È eccellente, e trovasi nella sala de’ Viceré. Patania Ritratto a mezza figura della madre dell’architetto D. Giuseppe Puglia. È bellissimo malgrado che l’originale sia una vecchia bruttissima. Ritratto a mezza figura della prima donna Camerani. È in Napoli. Ritratto piccolo di D. Giambattista Cutelli. Fu fatto a memoria ed è a sufficienza somigliante. Ritratto a mezza figura del Consigliere D. Giambattista Cutelli. Una Venere che abbraccia Cupido presso lo stesso Cutelli. È graziosa. 1828 Ritratto di Patania dipinto da lui stesso con abito nero in seta, e regalato al principe Lanza. Una Madonna col Bambino piccolo quadro presso la principessa di Butera. 1826 Ritratto della principessa Lanza madre, e ritratto del principe Lanza padre. 1827 Ritratto dell’abate Raimondi. 1827 Ritratto grande del principe Lanza vestito alla spagnuola, seduto sotto un albero. È di bell’effetto, e somigliante. _________________________________ Cfr. Nel Palazzo dei Normanni di Palermo. Ritratti di Vicerè, presidenti del Regno e luogotenenti generali di Sicilia. 1747-1840. A cura di Romualdo Giuffrida; presentazione di Salvatore Lauricella, Palermo, Accademia nazionale di scienze lettere e arti, 1989. 442 142 1828 Una taverna sopra tavola con varie figure alla pussina, che indicava lo stravizzo d’un banchetto, e l’ubbriachezza. È opera dipinta con gran verità, con bell’accordo di luce, e di colori, e di composizione graziosissima sullo stile fiammingo443. Piacque molto all’insigne dipintore fiammingo Henseleere. 1826 Ritratto d’una ragazza, figlia del marchese *** presso il principe Lanza suo zio. È graziosissima. 1826 Ritratto piccolo sopra rame della ballerina *** presso il principe Lanza. Patania 1819 Ritratto ad olio all’impiedi del maresciallo D. Domenico Merlo dipinto da D. Giambattista Carini. Era di buono effetto, e fu destrutto nella rivoluzione del 1820. 1826 Ritratto ad olio mezze figure di S.M. Francesco e di S.M. la regina. Furono copiati da D. Giambattista Carini su gli originali mandati da Napoli, e fatti da D. Giuseppe Camerano; presso la Real Segreteria di Stato in Palermo. 1827 Ritratto di Ferdinando principe ereditario delle Due Sicilie, copiato sopra l’originale di Camerano dallo stesso Carini. È delle migliori sue opere, nella Real Segreteria di Stato di Sicilia. 1825 Quadro grande da altare rappresentante S. Francesco in estasi, dipinto ad olio da Carini nella chiesa delle Stimmate, in Palermo. È duro. 1816 [!] San Carlo Borromeo, ad olio, nella chiesa dell’Olivella. Fu dipinto da Carini. È duro. 1823 Ritratto ad olio mezza figura di Ferdinando I dipinto da Patania. Nella Real Segreteria di Stato. È dipinto con molto effetto ed energia. 1823 Copia di detto ritratto di Carini nella Real Segreteria di Stato. 1827 Ritratti a mezze figure ad olio di Francesco I, e della Regina Elisabetta sua moglie. Sono dipinti con molta grazia di colore, e particolarmente la regina. L’abbigliamento di seta è toccato mirabilmente, nello appartamento basso di S.M. nel R. Palazzo in Palermo. 1827 Cefalo, e Procri quadretto ad olio sopra legno, e compagno, _________________________________ Arte che nasce nelle Fiandre, l’attuale Belgio. La cultura figurativa, ossia la pittura, è caratterizzata da una minutissima analisi dei particolari resi più preziosi dall’uso dell’olio (sulle tavole o sulle tele) che conferisce trasparenza. 443 143 Galatea che piange dei morti, e Polifemo che sta sulla rupe. Questi due quadretti son disegnati, composti, e coloriti egregiamente. Il tocco di pennello è diligente, e risoluto allo stesso tempo, e furon fatti da Patania con impegno pel poeta suo amico, cioè D. Leonardo Vigo di Acireale. Patania 1828 Piccolo ritratto dell’abate [Domenico] Scinà, e ritratto a mezza figura della madre dell’anzidetto Vigo. 1828 Ritratto ad olio del signor Linares di Girgenti pel figlio fatto da Patania. 1826 Ritratto d’una ragazza figlia del marchese Spedalotto. È assai grazioso e con tocco felice presso il principe Lanza. 1826 Ritratto della Sig.a *** ballerina presso lo stesso. È sopra rame e in piccolo, e ben toccato, presso il principe Lanza. 1828 Ritratto del Procurator generale Duca di Cumia, Don Marcello Fardella. Patania. 1828 San Vincenzo Ferreri che predica la fede di Cristo a molte persone, quadro grande con mezze figure sotto per la chiesa di *** nella città di Carini, fatto per onze *** Vincenzo Riolo da Palermo 1826 Quadro grande ad olio della moglie del negoziante Fazio, in atto di scrivere. È molto somigliante e ben dipinto. 1825 [!] Ritratti a mezze figure riunite in un quadro della famiglia di M.r Donody444 francese. Sono vagamente dipinti, e somiglianti. 1824 [!] Ritratto del negoziante D. Stefano Campo, con la toga di giudice del Commercio. È somigliantissimo. 1828 Quadri trasparenti per la macchina dell’artificio di fuoco rappresentante i fatti di Enea in Trapani ideati da Riolo, e dipinti in unione de’ suoi scolari Li Volsi, e Calascibetta445. _________________________________ Leggasi “Donaudy”. Paolo Calascibetta, pittore, nato a Palermo nel 1801, ivi morto nel 1834. Una succinta scheda biografica è reperibile in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 328-329. 444 445 144 1823 [!] Cappelle dipinte a tempra, nell’Olivella. Rappresentano fatti sacri di storia antica, e moderna. Gli angeli sotto gli archi furno dipinti dallo scolare di Riolo, Lo Forte detto il barbiero. Riolo 1828 Una piccola testa dipinta da Riolo, e regalata ad Agostino Gallo. È secondo la maniera di Rubens446 e condotta con bel colore e carattere robusto. Opere di Giuseppe Patania 1811 Ritratto ad olio del medico dottor Don Francesco Calcagni, presso le eredi. 1819 La Madonna del Coniglio di Corregio [!] copiata sopra un rame presso D. Giambattista Castelli. 1822 Venere che bacia Amore, piccolo quadretto presso lo stesso. È assai diligente, e grazioso 1815 Danae giacente quadro mezzano di grande espressione presso lo stesso 1827 Due paesi mezzani presso lo stesso 1824 Ritratto di Pietro Baglio, presso Don Giambattista Cutelli. 1821 (sic) [Ritratto] di Rosalia Cutelli, piccolo sopra rame, presso Don Giambattista Cutelli. [Ritratto] di Salvad. Cutelli sopratela presso Don Giambattista Cutelli [Ritratto] di Pelligra Cutelli, e di Giorgio [Cutelli] presso Don Giambattista Cutelli [Ritratto] di Giuseppe Patania presso Don Giambattista Cutelli. 1823 [Ritratto] di Vincenzo Li Pomi in Caltanissetta. 1818 [!] Ecce Homo per lo stesso Li Pomi. 1826 [Ritratto] della principessa di Larderia, in piccolo, sopra rame, pel principe Lanza. Replica per il principino di Larderia. 1818 Ritratto intero in picciola dimensione della duchessa di _________________________________ Pieter Paul Rubens, pittore fiammingo di età barocca, nato a Siegen nel 1577, morto ad Anversa nel 1640. 446 145 Castrofilippo presso il conte di Sommatino. 1819 Ritratto del principe di Trabia, mezza figura, in casa del principe. Detto della principessa di Trabia. mezza figura, in casa del principe. 1819 Ritratti de’ figli di esso principe, in unico quadro per uso di sopra arcata. 1822 Quattro sopra porte a tempera di soggetto di storia gotica in casa del principe di Belmonte nella strada dell’Alloro447. 1821 (sic) Uno stemma con figura, presso il medesimo. 1825 Uno stemma con figura del confettiere Gulì. 1812 [!] Un leone per la bottega di d. Giovanni Lanzitti, destrutto nel 1831. 1816 [!] Ritratto di D. Niccolò Puglia architetto. 1826 Ritratto del marchese Mango. 1828 Ritratto della Signora Medina. Patania 1831 Quadrone a tempra rappresentante Gesù Cristo, la Beata Vergine e San Giovanni Evangelista, per la chiesa de’ Greci. 1826 [!] Ritratto del conte Corrado Ventimiglia. 1826 Detto della marchesa D. Marianna Merlo. 1826 Detto del principe Lanza. 1830 Ritratto del cavaliere D. Domenico Grano da Messina. 1830 Ritratto del marchese Cassibili, ivi. 1830 Ritratto del trafficante Manzella. 1828 [!] Ritratto d’una religiosa antoniana, di tinta caldissima, di stile grande, e somigliante. 1824 [!] Ritratto del giovane Lo Forte pittore. Sente della maniera di Wandick448. 1831 Ritratto di Sua Maestà, in mezza figura per la Regia Università di Palermo. 1831 Altro per la Direzione di Ponte, e Strade. 1831 Altro per il Monte grande di pietà, all’impiedi. 1831 Ritratto di S.A.R. D. Leopoldo Borbone conte di Siracusa, per la _________________________________ Potrebbe trattarsi di un refuso: Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 71-72, lo colloca in corso V. Emanuele, di fronte alla piazza Bologni. 448 Vedi nota n. 257. 447 146 direzione di Ponti, e Strade. 1831 Medoro ferito, e medicato da Angelica quadretto per D. Paolo Faggiani ligator di libri. 1831 S. Spiridione, quadro di altare ben dipinto, con tinta calda e di bello effetto, per la Piana de’ Greci. 1828 [!] S. Rosalia, S. Sebastiano, s. Rocco che pregano la Beata Vergine per far cessar la peste. Quadro ben condotto, e di bello effetto per la chiesa di *** illustrato da D. Ferdinando Malvica. 1828 Gesù Cristo che dà le chiavi a S. Pietro. Quadro d’altare per la Chiesa madre di Noto, illustrato da Agostino Gallo. 1826 [!] La Beata Vergine del Rosario con due sante monache. Quadro per altare per la chiesa di *** 1827 Gesù Cristo che consegna il grege cristiano a S. Pietro con gi apostoli. Quadro imitato da Raffaello con qualche varietà, per la chiesa di Montevago fondata da monsignor cardinale D. Pietro Gravina. Di Giuseppe Velasques Quadri di chiesa grandi Gesù Cristo che discaccia i profanatori dal Tempio in Casteltermini La donna adultera in una chiesa in Casteltermini. Il re Guglielmo 2° che rinviene il tesoro, quadro grande nella scala del monistero dei Benedettini in Monreale. Il bozzetto presso il marchese Gargallo in Napoli. La Madonna dell’Itria, San Gaetano abbozzati da Francesco La Farina per chiesa nel Regno. S. Vito per la chiesa regia della Ficuzza. Pitture a tempra nel R. Palazzo di Palermo rappresentanti Le forze di Ercole fatte nel 1790, per onze 270. Queste pitture furono poi cancellate dallo stesso Velasques, e rifatte nel 1800 con gli stessi soggetti per onze 540. Più soggiunte altre pitture per onze 260. Più per medaglie a chiaro oscuro nell’ornato onze 120, calcolate le medaglie ad onze 6 l’una. Quadro ad olio rappresentante una Danza di Amorini in un giardino innanzi la statua di Cerere nella stanza che guarda la strada Nuova dal palazzo Pretorio in Palermo. 147 Giuseppe Patania 1827 Ritratto di D. Paolo Fagiani. 1827 Nascita del Salvadore presso d. Paolo Fagiani 1828 Riposo in Egitto presso d. Paolo Fagiani 1831 Angelica e Medoro presso d. Paolo Fagiani. 1827 [!] Ritratto del fu barone D. Giuseppe Merlo, presso gli eredi. 1826 [!] Ritratto del morto principe Lanza. 1826 Detto della vecchia principessa Lanza. 1827 Ritratto dell’abate D. Vincenzo Raimondi, presso lo stesso principe Lanza. 1828 Ritratto del Padre Giglio Paolotto. 1829 Ritratto del Padre Barcia prete greco. 1828 Ritratto del signor Gravaglia. 1831 Gesù Cristo morto in braccio della Beata Vergine con angioli, quadro mezzano. 1831 La nascita del Salvatore, presso *** 1826 [!] Ritratto, in mezza figura, di monsignor Gatto, vescovo di Patti. 1826 Ritratto del signor Dottor Don Francesco Cupane, Procuratore generale della Suprema Corte. Replica 1824 Ritratto del cavalier D. Antonio Mastropaolo, ministro presso il Luogotenente di Sua Maestà. 1821 [!] Ritratto di Ferdinando I re delle due Sicilie. 1826 Ritratto all’impiedi di monsignor *** vescovo di Cefalù. 1823 [!] Ritratto del cav. Figueras spagnuolo. 1828 Ritratto de madame Clouseau, moglie del console francese. Patania presso Cutelli Madonna del Coniglio. 1820 Venere che bacia Amore. 1822 Venere, e Marte a cui amore presenta un dardo di colombe. 1815 La Danae. 1827 Due paesi. 1824 [!] Ritratto di Pietro Bajle. 1821 [!] [Ritratto] di Giovanni Battista Cutelli. 148 1820 [!] [Ritratto] di Rosalia Cutelli. 1828 [Ritratto] di Salvadore Cutelli. 1812 [!] [Ritratto] di Pellegra Cutelli e di Giorgio. 1823 Ritratto di Patania. Il Bagno di Venere per il principe di Mattabagnaca. Il suo ritratto. Venere e Marte. La festa dell’offerta dei ceri alla B. Vergine influente sulle Belle Arti dal secolo XI sino al 1863 La Cattedrale di Palermo ricostruita dall’arcivescovo Gualterio Offamilio inglese nell’epoca normanna e dedicata alla Beata Vergine assunta in cielo sin dall’origine attirossi la protezione de’ sovrani di quella dinastia e de’ posteriori che l’arricchirono di rendite e di privilegi accennati dal Pirri, e raccolti in gran parte in apposita opera dall’eruditissimo canonico Antonino Mongitore, instancabile illustratore della gloria di ogni genere della Sicilia. Or i re normanni con il loro esempio introdussero la devozione, di presentare un cero alla Beata Vergine nella nostra Cattedrale a 15 agosto, giorno della sua Assunzione in cielo. Questo costume è stato costantemente seguito da tutti i re di Sicilia fino al 1859. In un diploma del 1211 di Federico II lo Svevo imperatore trascritto dal Pirri (1)449 si concessero a’ cannonici [!] del nostro Duomo duecento tarì e i soliti ceri per anniversario funebre del re Rugieri, Guglielmo e per l’anima de’ genitori e parenti di esso Federico e per celebrar le feste della Natività e Resurrezione del Redentore e de l’Assunzione di Maria Vergine. Un altro simile diploma del 1368 avvi di Federico III l’aragonese detto il semplice, ed altro del re Martino del 1392 riferiti nelle Memorie sull’istoria letteraria di Sicilia (1)450 anzi quel sovrano ordinò che col solito cero si pagasse al Duomo onze dugento d’oro. Dalla corte passò la devozione della presentazione de’ ceri sull’altare di Maria nel giorno indicato, in tutte _________________________________ A c. 217r nota in calce: “In Eccl. Pan.” <Rocco Pirri, Sicilia sacra disquisitionibus, et notitiis illustrata. … Editio secunda … cit., p. 144>. 450 A c. 217v nota in calce: “(1) Parte 2 pag. 82 e seg. ediz. in Pal.o per Bentivenga 1756.” <Domenico Schiavo, Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia. Tomo primo [-secondo], In Palermo, nella stamperia de’ SS. Apostoli, per Pietro Bentivenga, 1756, v. 2, p. 82-86>. 449 149 le classi e condizioni professionali de’ cittadini rappresentati da’ loro rispettivi capi; talché essendo grande l’affollamento, e magnifica la funzione, dovette il re Martino emettere un regolamento (2)451 nel quale si scorgono anche accennati all’obbligo de’ ceri gli architetti, i pittori e gli scultori che allora come tutte le altre professioni e mestieri avevano confraternite e superiori laonde argomentasi che gli artisti addettivi erano numerosi come gli artigiani e sin da quel tempo avevano tutti i rispettivi consolati. Verso la fine del 500 la Deputazione della Maramma, presieduta da’Arcivescovo di Palermo e intenta alla riparazione delle fabbriche e all’abbellimento di quel magnifico tempio ordinò che fosse scolpita da un allievo di Antonio Gagini452 morto nel 1571 e forse da uno de’ suoi figli Giacomo e Fazio453 un grande alto rilievo in cui scorgesi al naturale e intera spiccante dal fondo del mare la Beata Vergine circondata da una corona di angeli nell’attitudine di salire in cielo. Quella bellissima scultura che per poco non gareggia con le opere magnifiche di Antonio non so se fu destinata ad essere attaccata sulla parte maggiore del Tempio, ovvero sulla parete di qualche cappella, ma certo è che nella barbara riforma che si fece nel 1778 nell’interno del tempio di architettura di greco stile in contraddizione dello esterno rimaso, meno che la cupola aggiuntavi di stile arabonormanno e ciò sul disegno di Ferdinando Fuga, fiorentino, quell’insigne alto rilievo fu tolto e gettato in un magazzino insieme con un piccolo sepolcro in marmo effigiato nell’epoca normanna dov’erano forse deposte le ceneri dell’arcivescovo Nicodemo chiamato dal conte Ruggiero dall’Africa a reggere la sede di Palermo, ed altri angioli e sacre figure allegoriche o bei festoni di fiori furon tolti dal tempio come cose inutili, laddove dopo la riforma si potevano adattare ad un sito per la decorazione del medesimo. Il sepolcro di Nicodemo che era stato per l’interesse istorico di quel vescovo divenuto santo, oggetto di dispute del secolo presedente con gli angioli, festoni, ed altri marmi fu venduto al duca di Serradifalco che collocollo nel suo giardino con gli altri ornati ed angioli. Io il riconobbi e ne avvertii il dotto canonico Alessandro Casano, il quale per l’interesse religioso e istorico lo recuperò gratuitamente dal signor duca di _________________________________ 451 A c. 217v nota in calce: “(2) Amato de Temp Princ. Pan. cap. 3 pag. 86”. <Giovanni Maria Amato, De principe templo Panormitano libri XIII, Panormi, ex typographia Joannis Baptistae Aiccardo, 1728, p. 86>. 452 Seguono cancellate le parole: “e forse dai suoi figli”. 453 Giacomo Gagini, scultore, nato a Palermo nel 1517, ivi morto nel 1598. Le notizie biografiche sono reperibili rispettivamente in Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 104. Fazio Gagini, scultore e architetto, nato a Palermo nel 1520, ivi morto nel 1567. 150 Serradifalco e lo ripose con gli altri sepolcri d’istorici personaggi nell’ipogeo della Cattedrale. L’avvertì similmente di conservarsi ancora in un magazzino il sopradetto grande alto rilievo della Vergine assunta in cielo e il buon canonico ch’era grande amatore delle cose d’arti ne lo fece estrarre e riparare in alcuni guasti degl’angioli dallo scultore Rosario Anastasi454 di Acireale, già allievo di Villareale e ne adornò una cappella a man sinistra della cattedrale ove fa un bellissimo effetto. Ritornando ora alla indicata sacra funzione dei ceri presentavansi dai nostri re e da tutti i consoli delle varie arti e mestieri a’ 15 di agosto soggiungo che circa al 1600 crescendo vieppiù in Palermo lo spirito religioso, molte confraternite che appartenevano ai detti consolati credettero opportuno per viemeglio dimostrare la loro devozione particolarmente verso S.ta Rosalia divenuta santa padrona di Palermo dopo la cessazione della peste sul 1624 di far costruire dei cilî, ossia grandi macchine di legno, talune a due altre a tre ordini di architettura con colonne e pilastrini ben dipinti con lavori d’intaglio dorati collocandovi nel centro sacre immagini di legno e di cera, e queste macchine portate sul dorso di robusti facchini erano esposte successivamente nello spiazzo innanzi alla Cattedrale illuminati a cera nella sera de’ 14 luglio della festività di santa Rosalia e erano condotti nelle successive ad accompagnare la processione della Santa e l’immensa urna di argento istoriata magnificamente a cesello co’ fatti della medesima, lavoro egregio di grandissimo valore del secolo XVII nel giorno della processione. Artisti anatomici siciliani del secolo XVI e XVII Nelle Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia pubblicato in Palermo nel 1756 per Bentivenga, fra le altre eruditissime lettere anonime avvene una a pag. 389 della parte 4ª che reca la data de’ 10 dicembre di quell’anno in cui scrivesi l’elogio di Gaetano Giulio Zummo455 siracusano _________________________________ Rosario Anastasi, scultore, nato ad Acireale nel 1806, morto a Palermo nel 1876. Gaetano Giulio Zumbo (o Zummo), ceroplasta, nato a Siracusa nel 1656, morto a Parigi nel 1701. Al “genio prodigioso” il Gallo dedica un rilevante cammeo: cfr. Agostino Gallo, Lavoro … cit., p. 176-180. Una smilza sintesi biografica è altresì reiterata in: Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti… cit., p. 430. Ha esplorato, con acribia critica, la sua personalità artistica A. Gerbino, La corruzione e l’ombra. Civiltà figurativa siciliana, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1990, p. 206-207. Un interessante articolo curato da Amelia Crisantino, in Repubblica 4.09.2007, ripercorre l’itinerario delle Mostre e delle pubblicazioni dedicate al “Mago della cera”, ideatore dei “Teatrini della morte”. 454 455 151 da’ continuatori del Dizionario del Moreris456 chiamato erroneamente Giovan Gastone Zummo, che i giornalisti di Trevoux appellavano Gaetano Giulio. In quella lettera molte cose si accennano di quel valentissimo modellatore in cera colorata ed anatomico, che seppe bene effigiar figure umane e si rese famoso in Italia. Ma di costui scrisse posteriormente l’elogio con più diligenza il dotto canonico e parroco indi monsignor Ignazio Avolio di Siracusa. Io ho spigolato dall’uno e l’altro elogio e ridotto in maggior compendio le notizie che riguardano quel valentuomo. Gaetano Giulio Zummo e non Zumbo nacque in Siracusa nel 1656 da nobile genitore appartenuto ad antica patrizia famiglia di cui Fra’ Giaimo e Don Niccolò cavalieri gerosolimitani trasferitisi in Palermo impiegarono le loro ricchezze a fabbricare il monastero di S. Vito sotto titolo di Santa Maria di tutte le grazie nel 1629 (1)457. Gaetano Zummo comunque dall’autore della lettera citata si annunziasse poco fornito di beni di fortuna pure mancar non doveva di mezzi per soddisfare l’intensa brama di viaggiare per perfezionarsi nelle arti del disegno in cui erasi iniziato in patria modellando delle piccole figure in creta e in cera. E a viemeglio riuscirvi riuscirvi volle apprendere gli elementi dell’anatomia persuaso di essere indispensabile ad uno scultore. Giovinetto ancora senza la guida di maestro modellò in cera un S. Girolamo penitente e due ritrattini che ancora si conservano nella sua patria e mostrano i primi lampi del suo genio.Egli sin d’allora avea preferito la cera colorata come più agevole del marmo e del legno per soddisfare la sua irresistibile tendenza alla scultura (2)458. Egli recossi in Roma, e indi percorse tutta Italia per ammirare e studiare i più bei dipinti e le statue migliori de’ valentuomini antichi e del suo secolo della bella penisola. Rivoltosi a Bologna lavorò in cera diverse _________________________________ 456 Louis Moreri, Le grand Dictionnaire historique. Nouvelle edition dans laquelle on a refondu les supplémens de l’abbé Goujet, revue et augmentée par Drouet. Paris, 1759. 457 A c. 219r in calce nota: “(1) Il monistero e la chiesa adorna di bei quadri del Novelli della sua figlia Rosalia e di Giacomo Lo Verde [pittore trapanese morto a Palermo nel 1687] di quella scuola furono aboliti con tutti gli altri monisteri e chiese annessevi nell’ottobre 1866 con precoce rivoluzione del vandalo generale Cadorna che ne anticipò di due mesi il decreto del Parlamento sbandò le monache e i frati. Indi venne destinato il monastero di San Vito allo Stabilimento degli artigianelli. Nella sagrestia si osservano ancora i ritratti dei due fondatori.” 458 A c. 219v in calce nota: “(2) Si attribuisce a lui un metodo particolare di colorar la cera in varie tinte pe’ volti e per le vesti e vi riuscì meglio che il Marino e il Rallo aveveano in essa operato piccoli ritratti prima di lui”. Rallo Antonino, scultore, operante nella IIª metà del XVII secolo. 152 figure che precedettero la sua fama riducendosi indi a Firenze. Il granduca Ferdinando 2° de’ Medici amantissimo, come gli altri di sua famiglia, delle belle arti avendo osservato alcune statuette del Zummo lo ricolmò di onori e di doni e volle ritenerlo alla sua corte ordinandogli di rappresentare in piccole figurine le miserie della vita humana con l’uomo agonizzante; indi morto in seguito quello che comincia a corrompersi altro già corrotto e459 quello pieno di putredini e di vermi rappresentò infine una sepoltura460 i cadaveri secondo io metodo di disseccarli e collocarli in nicchie perpendicolari ed orizzontali praticato dai PP. Cappuccini di Palermo461 ch’egli forse aveva osservato. Quelle affliggevoli rappresentazioni462 che io ho veduto ed ammirato chiuse in vetrine nel Museo di Firenze fanno invero raccapriccio per la verità. Lo scultore vi appose il suo ritratto dipinto ad olio sopra una piccola lastra che io feci copiare ed aggiunsi alla mia collezione degli uomini illustri siciliani (1)463. Egli mostrossi un giovane di circa anni trenta di una tinta pallidetta e con occhi sentimentali, di un naso ben profilato e lunghetto e con piccola bocca atteggiata a sevenità, con gran parrucca nera e in abito alla spagnuola con bavero quadrato. Mentre io ammiravo lo Zummo in quelle sue figure, che mi facevano rabbrividire, non sapevo applaudire al suo gusto per la scelta. Avrebbe egli potuto sfoggiare il suo mirabile talento rappresentando il bello virile e muliebre nelle figure de’ nostri primi progenitori. Ma il suo umor malinconico pur troppo visibile nel suo ritratto464 lo trascinò a quegl’ingrati e attristanti soggetti. Pure piacquero al granduca quelle figurine e ne fece ornamento del suo Gabinetto e indi passarono nel Museo di Firenze. Altre opere certo, dovette egli modellare per il granduca e per la nobiltà fiorentina amantissima delle belle arti e per gli stranieri che in quella città accorrono in folla di frequente essendo ivi rimaso molti anni. Voglioso com’era egli di viaggiare chiese congedo dal Granduca, il _________________________________ Seguono cancellate le parole: “finalmente un cadavere”. Seguono cancellate le parole: “col metodo di disseccare”. 461 Presso il Convento dei Cappuccini è possibile ancora oggi visitare le catacombe con l’esposizione dei cadaveri disseccati. 462 Seguono cancellate le parole: “delle affligevoli miserie umane”. 463 A c. 220r in calcea sinistra nota: “(1) Quello che si osserva nel tomo 2° della Biografia degli uomini illustri della Sicilia annesso all’elogio scrittone dall’Avolio è certo imaginario come gran parte di quei ritratti perocché per nulla somiglia all’altro di Firenze che nel costume è vestito alla spagnuola, sì nella fisionomia.” I. Avolio, “Gaetano Giulio Zummo”. In: Giuseppe Emanuele Ortolani, Biografia degli uomini illustri della Sicilia ornata de’ loro rispettivi ritratti. Napoli, presso Nicola Gervasi, 1817-1821, v. 2. 464 Segue cancellata la parola: “fisionomia”. 459 460 153 quale gli disse. ‘Voi potrete trovare un mecenate più ricco di me, ma non troverete al certo chi meglio sappia apprezzarvi e stimarvi’. Da Firenze si condusse egli in Genova. (1)465 Ivi modellò la Natività di Gesù Cristo e la Deposizione dalla croce opere meravigliose per diligenza, bellezza ed espressione delle figurine, e nel Cristo ignudo deposto dalla croce per lo studio dell’anatomia; talché ne fu ammirato dal chirurgo francese monsieur De Nouves466 che fe’ disegno sullo Zummo di trarne vantaggio facendogli modellare sopra i pezzi umani da lui preparati i simili in cera varî pezzi anatomici, e poscia gli suggerì di rappresentare al naturale il corpo ignudo di una donna dal cui addome che aprivasi mostravasi il feto tolto e l’organismo interno (1)467; ma poco dopo si disgustò col Zummo per ragion d’interessi. L’Orlandi nel suo Abecedario pittorico pag. 15468 lodando i lavori dello Zummo dice ch’egli principalmente riusciva ne’ cimiteri, ne’ cadaveri e negli scheletri era verissimo artista. Ma non riflette s’egli acquistò celebrità come anatomico giovando alla scienza colle rappresentazioni in cera durevoli per le osservazioni che a lungo non permettono i cadaveri nocenti alla salute. Egli fu non pertanto sommo artista ne’ soggetti devoti che possonsi riguardare senza rimbrezzo [!] come in quello famoso della Natività di Cristo e della Deposizione dalla croce. Però non sappiamo e abbiamo dal lato figure voluttuose in cui abbia potuto raccozzare il bello naturale e ideale e mostrare gusto più delicato. In ogni modo in quelle due opere sacre fatte in Genova, egli riponea gran fiducia per la sua reputazione, e di fatto recavale seco, e giunto a Marsiglia le mostrò a monsieur Montmor<t>469 Intendente delle galere, il quale ammirandole ne scrisse alla Real Corte e n’ebbe risposta d’inviare a Parigi quel forestiere. Egli pria d’imprendere quel viaggio volendo mostrare la sua abilità anatomica s’impose ad effigiare sopra un470 reciso capo umano appostato là da un gio_________________________________ A c. 220v inserita nota, poi cassata: “(1) Ciò è detto nelle Memorie di Trevoux”. Si tratta di Guillaume Desnoues, chirurgo parigino dell’Ospedale di Genova. 467 A c. 221r nota in calce: “(1) Questa figura fu poi imitata per il teatro anatomico dell’Università di Palermo da uno scultore fiorentino per nome ***.” 468 L’Orlandi nel suo Abecedario pittorico pag. 15 <Pellegrino Antonio Orlandi, Abecedario pittorico dall’autore ristampato, corretto et accresciuto di molti professori e di altre notizie spettanti alla pittura a monsieur Pierre Crozat, Bologna, per C. Pisarri, 1719>: «Abate D. Gaetano Zumbo siciliano: questo virtuoso comparve in Bologna l’anno 1695. E fece stupire i più virtuosi dilettanti colle sue figurine di cera colorite che formava, ma spezialmente nei cimiterj, nei cadaveri e negli scheletri era rarissimo. Di tale perfezione se ne compiacque il serenissimo principe di toscana, che per molti anni o trattenne al suo servigio, stipendiato alla grande. Morì in Francia l’anno 1702». 469 Jean-Louis Fargis-Habert, cavaliere di Montmort. 470 Seguono cancellate le parole: “i teschi”. 465 466 154 vane chirurgo il simile in cera ch’esattamente mostrava nell’esergi l’interna struttura cerebrale con tutti i più minuti organi; e partito da Genova471 recossi a Parigi ove espostolo all’Accademia delle Scienze essa ne dié conto nella Istoria della medesima ove leggesi che in quel lavoro anatomico si trovano le più piccole particolarità naturali, e con arterie, nervi, muscoli, tutti coloriti al naturale; laonde l’Accademia giudicò che quella invenzione meritava di esser proseguita. Perché se vi fossero simili imagini di tutte le parti del corpo umano si sarebbe fuori d’imbarazzo di cercar cadaveri che non sempre si hanno pronti quando si vogliono e lo studio dell’anatomia diverrebbe meno disgustaso e più familiare (1)472. Quel lavoro fu da tutt’i medici applaudito e S.A. Filippo delfino di Francia, duca d’Orleans, profuse anch’egli lodi al grande artista e influì forse a farla acquistare a gran prezzo dal re e a donarlo a monsieur Maresciall suo primo chirurgo. Mentre lo Zummo godeva de’ trionfi del suo sapere e della sua abilità artistica e attendeasi in quella entusiastica e ricca città che gli fossero affidate lavori d’importanza la <morte> lo sorprese nel 1701 e fu compianto e onorato dall’Accademia delle Scienze. Ma un avvenimento inopinato doveva473 mettere in dubbio la reputazione meritamente acquistatasi; perocchè dopo cinque anni ch’egli era sceso nel sepolcro nella vertigine delle cose che sparge d’oblio co’ grandi avvenimenti i minori di Parigi quel lavoro dello Zummo fu dimenticato. E non si <sa> come sia passato in mano del chirurgo monsieur De Noûues [!] il quale avea conosciuto e sperimentato l’abilità artistica e anatomica dello Zummo in Genova che ignorava474 quello fosse opera del medesimo. Epperò cominciò a mostrarli a varî suoi colleghi spacciandola come fatta da lui, il che acquistò facile credenza essendo egli chirurgo e giunse l’audacia al punto di fare inserire un articolo nella Memoria di Trevoux (1)475 spacciandosi autore di quell’opera e quel che più trattando lo Zummo come furbo e impostore chi se l’aveva aggraziato. Ma non andò guari non trascorsero che pochi mesi che scoverta l’impostura del chirurgo francese che ne trionfava, gli stessi giornalisti di Trevoux con ammirevole zelo di sincerità annunziarono al pubblico di essere stati ingannati e addussero incontrastabili prove e documenti che quell’insigne lavoro anatomico apparteneva allo Zummo e ne tesserono gli elogi meritati, come pure delle _________________________________ Seguono cancellate le parole: “si pose (passò) allo spedale di Marsiglia”. A c. 222r nota in calce: “(1) Hist. dell’Accad. Royal des sciences an. 1701, pag. 57.” 473 Seguono cancellate le parole: “offuscarne la fama. Perocché”. 474 Seguono cancellate le parole: “che il capo modellato da lui a Parigi eppur fosse opera dello Zummo”. 475 A c. 222v nota in calce: “(1) Anno 1707 mese di giugno pag. 1297”. 471 472 155 altre sue opere meravigliose conchiudendo colle seguenti parole Ecco qual’era quest’uomo che l’invidia sembrò rispettare mentre c’ei visse e non osò attaccarlo se non che morto per perseguitarlo soltanto di là dalla tomba. L’autore però che osò oltraggiare la di lui memoria dovea ricordarsi che non è lecito insultare i morti e che il vero merito trova sempre difensori in tutti quelli che sono amici della verità. Onde si da noi che un esposizione semplice plice [!] di essa ci cattiverà il credito dei nostri lettori assai meglio che molte riflessioni che avranno potuto fare (1)476. Sembra che l’impostore siasi allontanato da Parigi e che ebbe scritto una lettera da Roma colla quale risposero conchiudendo i giornalisti che doveano ringraziarli se si erano astenuti a bello studio di far su lui delle riflessioni che non sarebbero state di suo gusto. Tutti i dotti di Parigi conobbero l’impostura e non dubitarono che quella [!] insigne lavoro anatomico al pari di tanti altri di quello e di altri generi che aveva esposto altrove, appartenesse allo Zummo, di cui fè onorata memoria l’Orlandi e l’eruditissimo Tiraboschi nella sua Storia letteraria, il quale lo colloca nella classe di quelli che illustrarono la scienza anatomica del secolo XVII e se nol può conoscere coi libri quanto ci ne sapesse mostrollo col fatto e in modo da farne stupire l’Accademia delle scienze di Parigi (1)477. E il Signorelli non solo lodollo come artefice raro ma dotto nell’anatomia da meritare gli encomî della posterità (2)478. Come artefice modellatore in cera io soggiungo ch’egli doppiamente merita di essere applaudito, si per l’arte di avere479 ben rappresentato il vero in soggetti sacri e profani, e si per essere stato utile agli anatomici con alcune sue opere480 e sarebbe maggiore il di lui merito se prima degli altri, come credo, abbia applicato a quest’uso l’arte che indi per l’anatomia con altri congegni e con altri mezzi481 fu seguito dall’anatomico Giuseppe Mastiani palermitano che meritossi anch’egli la lode de’ medici di Francia. La sig.a Anna Fortino contemporanea allo Zummo poi gentil donna palermitana eccelse sopra tutti nei lavori in cera di sacre immagini e di ritratti e di lei faremo particolare invenzione. _________________________________ A c. 223v nota in calce: “(1) Memorie di Trevoux, ottobre n. 137 p. 1380 e seguenti.” A c. 224r nota in calce: “(1) Torino VIII, lib. 2.” 478 A c. 224r nota in calce: “(2) Vicende della cultura tomo V p. 349.” 479 Segue cancellata la parola: “espresso”. 480 Seguono cancellate le parole: “non sapendo se altri abbia prima dello Trevoux”. 481 Seguono cancellate le parole: “di filetti di ferro”. 476 477 156 Memoria artistica presentata da Agostino Gallo all’illustre suo amico Sig.r Francesco Di Giovanni senatore del Regno d’Italia e presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia 1° La precedente Commessione coi propri fondi innalzò in S. Domenico i monumenti di Velasques, di Riolo, di Patania e di Villareale. Per che convenga all’attuale Commessione di adoprarsi ad accrescere il lustro del Panteon siciliano con altri monumenti e potrebbe essa farlo con lieve spesa ordinando che fosse trasferito ivi il busto del celebre Di Gregorio dalla chiesa di S. Matteo che dipende omai non più dai confrati, ma da una estranea deputazione di uomini istruiti e zelanti di amor patrio e similmente far trasferire dalla chiesa della Mercé al molo già abolita l’altro busto di Fileti insigne matematico e navigatore. Nella Biblioteca Comunale fu depositato dal nostro Municipio il busto dell’insigne arabista Salvatore Morso, scolpito dal Villareale a spese del Comume. Ivi è mal collocato e per nessuna ragione vi appartiene. Dovrebbe suggerirsi al nostro Municipio di farlo trasferire in S. Domenico con apporvi una iscrizione opportuna di memoria adesso essendo stato con le sue illustri fatiche memerito di questa città coll’opera del Palermo antico482. 2° Il Museo dell’Università di Palermo manca di una statua del nostro Villareale, il migliore scultore che possiamo vantare. Havvi quella della Psiche che è tra le sue più pregevoli che potrebbe acquistarsi a discretissimo prezzo ed a rate dal signor Sommariva che la possiede. 3° Nel magnifico monumento marmoreo della piazza di S. Domenico dedicato alla Beata Vergine con statua in bronzo della stessa di G. Battista Ragusa palermitano483 mancano due altre statue in bronzo di Carlo 3° e della regina Amalia Walburga atterrate e fuse nel 1848 che rendono adesso deforme e incompiuto quel monumento e ristorarsi nei guasti sofferti già innalzato a spese del Regio Erario nel 1729. Dovrebbero supplirsi anche con minore spesa in marmo sostituendo alle antiche le statue di Vittorio Emanuele e del principe Umberto e così sarebbero pure incoraggiati i nostri artisti, il che è obbligo ancora della Commissione di Belle arti. 4° In Firenze tutte le opere di architettura, di scultura e di pittura si fanno a spese del Municipio son dirette dal Consiglio di quella Commissione locale di Belle Arti. In Palermo si fa tutto ad arbitrio del Municipio e spesso male. _________________________________ Salvatore Morso, Descrizione di Palermo antico ricavata sugli autori sincroni e i monumenti de’ tempi, Palermo L. Dato, 1827. 483 Giovanni Battista Ragusa, scultore, morto a Palermo nel 1727. 482 157 La nostra Commissione dovrebbe acquistare questo diritto. Gli oggetti di belle arti che si rinvengono nell’interno dell’Isola per mezzo degli scavi fatti a spese della nostra Commissione e che siano trasferibili dovrebbero trasportarsi nel Museo di Palermo come sotto il passato governo praticavansi in Napoli e ne fu arricchito quel magnifico Museo e similmente gli altri più magnifici di Roma. Le città dell’isola nostra hanno diritto soltanto agli oggetti che si rinvengono per gli scavi fatti a spese loro, dei quali oggetti potrebbero formar dei piccoli musei e non appropriarsi quelli che appartengono alla nostra Commissione. 5° La precedente Commissione aveva stabilito in ogni quartiere della nostra città e nelle principali dell’isola letterati ed amatori per vigilare agli oggetti di belle arti ed avvertir la nostra Commissione dei guasti che vi si recano. Quest’utile pratica484 credo che sia andata in dimenticanza. Converrebbe ripristinarla. Presso lo nepote ed erede del sig.r. Giuseppe Scaglione esisteva fino a poco tempo addietro un bel quadro a mosaico rappresentante Pietro Perugino e Raffaello Sanzio. Converrebbe acquistarlo per la Galleria dell’Università, si perché il lavoro è bellissimo e sì pei ritratti ricavati da quelli del Vaticano di quei due celebri artisti. Nella chiesa di Montesanto esiste un bel quadro di Pietro Novelli danneggiato; ma agevole a ben ristorarsi. Converrebbe reiterare gli ordini al superiore di quei religiosi sull’oggetto e minacciarli in caso di resistenza di trasportarsi all’Università. Nella Congregazione abolita di S. Agata li Scorruggi havvi un bel quadro di van Houbracken segnato del suo nome485. Al cappellano che486 negossi più volte alla passata Commissione di Belle Arti di consegnarlo, si potrebbe adesso facilmente costringere anche depositarsi nella Galleria dell’Università. Dovrebbe anche la Commissione suggerire al Consiglio Municipale d’innalzarsi un busto a Giacchino Ventura palermitano celebre sacro oratore e scrittore politico il quale pubblicò due famose opere, una sul diritto della Sicilia a proclamar la decadenza borbonica e l’altro sulle menzogne diplomatiche a danno della stessa. Non par credibile che un uomo sì benemerito per tanti titoli e che sacrificò la sua vita in 14 anni di esilio non abbia ottenuto un omaggio dalla sua ingrata patria. Se il Municipio farà senno ad innalzargli un busto, io sarei pronto ad ele_________________________________ Seguono cancellate le parole: “fu anche adottata per le principali città dell’isola”. Giovanni van Houbracken, pittore fiammingo del sec. XVII, si trasferì a Messina. 486 Segue cancellata la parola: “mostrosi”. 484 485 158 vare anche un altri a mie spese, ciò al celeberrimo astronomo Piazzi ascritto alla cittadinanza di Palermo ed a Bellini, egregio compositore di musica, nonostante che prima avessi sofferto il grave dispendio di onorare con monumenti Scinà, i due architetti Marvuglia, Michelangelo Monti, Pietro Novelli e Nina Siciliana prima nostra poetessa nel volgare siculo italo. Artisti stranieri in Palermo Secolo XIX L’anno il 1814 recavasi in Palermo Paolo Caccianica paesista, scenografo, architetto e poeta tragico milanese, e qui diessi ad esercitar que’ suoi svariati talenti. Dipinse varii paesi, e particolarmente alcuni ricoverti di neve che sapea bene imitare, e due pel barone Pietro Pisani, uno rappresentante un Sepolcreto, e fra le varie tombe quella del suo figlio Antonino, ch’ora è posseduto dal cav. Baldassare Galletti, ereditato dalla principessa di S. Cataldo, sua madre, e l’altro il Tragitto per gli Elisi dall’ombra del suddetto Antonino Pisani con graziose figurine, dipinte dal nostro celebre Giuseppe Velasques, fra le quali vi erano rappresentati due medici che lo spacciarono nell’ultima infermità, ed erano battuti a colpi di remi da Caronte, bizzarro e vendicativo pensiero suggerito al pittore dal barone Pisani. Dipinse pure varie scene ed una nave che furono applaudite. Costruì nel giardino dell’Olivuzza del duca di Monteleone un portichetto d’ordine jonico, ch’è grazioso, e regolare. Dipinse un tempio dorico in un gran quadro del Velasques del Martirio di S. Giacomo per la città di Randazzo, pel quale ed altri due, essendo sorta lite fu scelto apprezzatore il Caccianiga e sostenne le ragioni del pittore e gli fe pagare più del doppio del meschino prezzo convenuto. Pubblicò in Palermo due tragedie regolari nella condotta, e con buoni versi ma freddi nel dialogo, una delle quali Il Telogono fu dedicata ad Agostino Gallo, che gli diresse una sua ode stampata in Palermo con le sue poesie nel 1816. Verso il 1819 il Caccianiga ritornòin Italia, né so che sia più avvenuto di lui. Verso quel tempo recaronsi a Palermo tre valorosi artisti fratelli, credo piemontesi, o milanesi, Battista, Antonio e Vittorio Calleani che avevano studiato in Roma. Antonio era divenuto un famoso disegnatore e compositore di grandi invenzioni, ma nel colorito sia a fresco che ad olio, era un po’ duro e tagliente, come mostrò in un vastissimo affresco nel R. Palazzo 159 di Caserta del quale espose in Palermo il cartone a chiaro scuro che fu da tutti ammirato, e più da me che il giudicai migliore per l’effetto del fresco da me osservato in Caserta. Il nostro Velasques solo avrebbe potuto contender con lui nella bravura del disegno, seppure nella mitologia il Galeani [!] non gli era superiore, come il Velasques a quello nella pittura. Quel cartone del Caleani svegliò la mente, e la gara di tutti i nostri artisti, Riolo, La Farina, Scaglione, Patania, Calascibetta, e divennero più accurati, e diligenti disegnatori, nell’andamento de’ muscoli e particolarmente lo Scaglione. Calogero de Bernardis487, mediocre pittore, divenne scolare del Calliani, e migliorò molto, e sarebbe progredito, se non fosse morto di tisi pochi anni dopo. Il Calleani dipinse a fresco la gran volta d’una stanza da caffè nel giardino surriferito del duca di Monteleone, rappresentandovi il parnaso d’illustri siciliani, fra’ quali alcuni viventi, amici del duca. Dipinse anche al vero l’intera figura della Sig.ra Arianna Tessuti, bellissima toscana favorita del duca, e sospettasi anche segnatamente dello stesso pittore. Dipinse anche il ritratto in grande della signora Margherita Adamo. L’affresco di Ulisse e Telemaco che riconosconsi e s’abbracciano nella volta d’una stanza del palazzo del duca di Sperlinga fuori Porta Maqueda in Palermo488, decorato nella sopra porta di belle e franche pitture a olio dal Patania. Io capitai lo schizzo a penna del fresco del Calleani segnato del suo nome, e lo tengo carissimo. L’altro fratello Battista era insigne e insuperabile miniature e portò e pose in mostra in Palermo il ritratto di Napoleone I a cavallo in un cartoncino di circa un palmo ch’ei dicea di averlo ricavato dal vero. Questo diligentissimo lavoro condotto con gusto ed arte singolare fu da tutti ammirato, ed indi acquistato dal signor Testa suo amico. L’altro fratello, Vittorio, era un buono architetto, e credo che abbia costruito al duca di Monteleone quella grande stanza rotonda da caffè di sopra riferita. I fratelli Galeani erano liberali in un tempo in cui i governi dopo il 1815 cominciarono una più feroce reazione. Antonio e Vittorio vollero lasciar Palermo verso il 1819 per recarsi in Spagna, e Battista forse altro_________________________________ Calogero De Bernardis, incisore, nato a Palma di Montechiaro, Agrigento, nel 1790, morto a Palermo nel 1824. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori siciliani … cit., p. 97-98. Altra replica biografica in: Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 326-327. 488 Ubicato in piazza Garraffello. I passaggi di proprietà sono stati rubricati da Rosario La Duca, Repertorio bibliografico degli edifici pubblici e privati … cit., v. 1, p. 268. 487 160 ve. Que’ due giunti in Madrid si associarono col resto de liberali di quella città, ed arrestati con molti altri furono barbaramente fucilati. Verso il 1823 venne in Palermo il signor *** Rosaspina colla moglie, incisor bolognese, figlio del celebre intagliatore in rame. Il padre gli era invero di gran lunga superiore nel maneggio del bulino, sebbene l’altro fosse anche abile in quell’arte, e pure buon disegnatore come mostrato avea nelle molte tavole condotte in semplici contorni a litografia de’ capi lavori della Galleria di Bologna. Quell’artista, capo liberale del suo paese, o sfuggito forse alla fiera polizia romana, se l’intese agevolmente co’ nostri, e intanto per vivere spacciava i rami della collezione bolognese di suo padre, e diessi ad incidere per associazione le principali vedute di Palermo e de’ suoi contorni campestri e molti ne pubblicò in diversi anni, che appena passavano la mediocrità, però, essendo egli più inoltrato de’ nostri incisori nell’arte, giovò a’ medesimi; giacché Pietro Waicher palermitano489 oriundo tedesco egregio disegnatore, scolare di Velasques ed elegante incisore in semplici contorni de’ costumi romani, Bartolomeo Pinelli490 e della porta del Battistero di Firenze di Lorenzo Ghiberti491, aveva lasciato pochissimi allievi, anche dopo il suo breve soggiorno in Roma, ove incise anco a tutto bulino i ritratti de’ poeti Meli e Scimonelli. Il Rosaspina dopo il 1848 lasciò Palermo. Verso il 1860 recossi in Palermo Saverio Pistolesi romano492, degno allievo di Lasinio il giovane nell’invenzione a contorni e messe in vendita la sua egregia collezione de’ capi-lavori degli artisti italiani di 300 tavole pubblicate col modesto titolo di Album pittorico. Lavorò subito 20 tavole a bulino e a mezzombra per l’opera dell’Istoria delle belle arti in Sicilia del abate Di Marzo e il pontefice *** per la vita dello scultore Marino, il ritratto di Zeusi, e due statue del Gagino per le opere di Agostino Gallo. Questo insigne artista figlio di Erasmo, archeologo, ben conosciuto in Italia, imprese in Palermo l’opera in gran foglio con illustrazioni della guerra d’Italia di Vittorio Emmanuele, e di Napoleone III nel 1860 e pei loro trionfi in Magenta, S. Martino, e Solferino nelle rappresentazioni delle battaglie e i ritratti degl’illustri capitani che vi ebbero azione. I dise_________________________________ Pietro Waincher, pittore, nato a Palermo nel 1789, ivi morto nel 1846. Un’esaustiva biografia è reperibile in: Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori siciliani … cit., p. 100-105; 119-121. 490 Bartolomeo Pinelli, disegnatore e incisore, nato a Roma nel 1781, ivi morto nel 1835. 491 Lorenzo Ghiberti, scultore, nato a Firenze nel 1378, ivi morto nel 1455. Partecipa con la formella del sacrificio di Isacco (Firenze, Museo del Bargello) per la seconda porta del Battistero di Firenze. 492 Saverio Pistolesi, artista operante nella seconda metà del XIX secolo. 489 161 gni parte suoi, e parte di altri sono eseguiti a mezzombra a litografia493. Fondò in questa occasione una scuola in sua casa di giovani siciliani, e gl’istruì a disegnare e a colorir le tavole con buono effetto. Imprese poscia a pubblicare con lo stesso metodo e nella stessa grandezza, l’opera della rivoluzione di Sicilia del 1860, lo sbarco a Marsala, e l’entrata trionfale in Palermo del generale Garibaldi co’ suoi mille prodi. L’illustrazione è scritta con fuoco da Giovanni Villante494, giovane palermitano. Sono usciti finora 12 fascicoli con 24 tavole, il resto è in corso di stampa (1865). Su l’atterramento delle sacre immagini in Palermo nel marzo 1867 per insofferenza di protestanti In Sicilia, e particolarmente a Palermo, tutto cospira in danno della religione di Cristo, dei suoi ministri, sia preti, sia ex frati, e anche monache. A disprezzo delle chiese sono stati addossati i pisciatoi e tolte via le cancellate di ferro anche quelle che non impedivano il passaggio del pubblico essendo nelle gradinate. Nei mesi di marzo e di aprile scorsi rinovossi l’esempio degli eretici iconoclasti d’oriente sotto l’empio Leone Isaurico: e furono strappate le sacre immagini vicino le porte dei cittadini e ammonticchiate sopra carrette vennero trasferite al nostro Municipio per ordine secreto del sindaco sig.r Salesio Balsano con vandalica esecuzione dell’assessore sig.r Raffaele Di Benedetto. Nel quartiere del monte grande di prestano, il popolo s’era mosso a subbuglio, e similmente nella via Macqueda per una Madonna detta la Bella, collocata in un angolo sopra un altarino marmoreo. Essa apparteneva ad un buon prete il quale abitava vicino e inteso il fracasso che facevano di notte i maestri, si fé consegnare l’immagine e l’ordine ricevuto dal Di Benedetto. La popolazione divota, di quella strada ne fremette, e il prete fu calunniato di avere lui abusivamente tolta la sacra immagine e alla minaccia dell’arresto dal Zuccatore, presentò l’ordine in iscritto e poté evitarlo. L’immagine allora fu rimessa ma senza alcun ornamento de’ precedenti ricami colorati. La grandiosa chiesa di S.ta Cita dei PP. Domenicani con il convento, _________________________________ 493 Il Gallo traduce la terminologia “ombra media o mezzana” scelta da Leonardo da Vinci (14521519) nel Trattato della pittura (n. 673), in cui si legge: «ombra mezzana è detta quella che tinge la superficie de’ corpi ombrosi dopo l’ombra principale, e vi si contiene dentro il riflesso, e si fa tanto più oscura o chiara, quanto essa è più vicina o remota dall’ombra principale». 494 Sconosciuto alle fonti della letteratura artistica. 162 da tre anni prima della loro abolizione, fu con violenza occupata dagli officiali addetti allo spedale militare, i quali presero domicilio nel convento e servironsi della chiesa per aggregazione all’ospedale vicino, sfondarono alcune cappelle, ma quel luogo riuscì fatale ai poveri ammalati per mancanza di ventilazione e divenne un cimitero. I monaci intanto, cacciati dalle loro celle, trasportarono via i quatri magnifici della chiesa nell’altro loro Ordine in S. Domenico e ivi ebbero asilo. Quei quadri più pregevoli che vi erano a Palermo, fra i quali la Deposizione della croce di Vincenzo Anemolo scolare di Raffaello e l’altro più antico e rarissimo della disputa di S. Tommaso di Antonello da Messina495, e così pure alcuni di Pietro Novelli e di sua figlia Rosalia496 furono tutti restorati e forniti di cornici dorate con grave spesa del convento, e collocati nella ante sagrestia nella quale si aprì un lucernale superiore per l’effetto artistico. Essi richiamavano l’attenzione dei forestieri che venivano a visitare i monumenti funebri degli uomini illustri che decorano l’annessovi magnifico tempio. Gli ex frati addetti al servizio del medesimo temendo che fossero que’ quadri tolti via e trasportati dalla Commissione di Antichità e Belle Arti nella sua Pinacoteca, scrissero al Ministro del culto per essere conservati nella loro chiesa e il ministro si annuì, ma cambiato costui, il successore autorizzò l’anzidetta commissione a’ portarli via con grave rammarico non solo de’ frati, ma anche degli amatori, che li scorgevano ivi meglio collocati che nella pubblica Galleria, la quale divenuta troppo angusta, essendo altronde priva di buon effetto di luce per mancanza di un lucernale nella volta. La sudetta Commissione tolse via dall’altare del tempio dei PP. Benedettini bianchi una bellissima statua della Beata Vergine col Bambino di Antonio Gagini palermitano, celebre scultore del secolo XVI, come pure da un altro altare il quadro di S. Benedetto titolare della chiesa dipinto dall’insigne artista Giuseppe Velasques. Così per furti violenti si spogliano le chiese in Palermo, le quali sono frequentate e non abolite. Restituitasi quella di S. Cita agli ex frati, tutte le cappelle sono rimase senza le antiche immagini carpite come si disse dalla Commissione di belle arti. Gli ex frati mascherati ormai da preti regolari ai quali è stato affidato il culto delle rispettive chiese, languiscono di fame perocché da 7 mesi mancano del sussidio lor promesso dal parlamento e dal Governo. Il Direttore delle tasse e del Demanio, signor Minneci che per effetto delle sue funzioni _________________________________ Antonello da Messina, pittore, nato a Messina nel 1430 ca., ivi morto nel 1479. Rosalia Novelli, pittrice, nata a Palermo nel 1628, ivi morta dopo il 1688, figlia di Pietro e maestra di Anna Fortino. 495 496 163 avrebbe dovuto esigere le rendite dei corpi morali in case e botteghe e fondi rustici se ne è creduto autorizzato ed ha scritto più volte a Ministro senza ottenere risposta. Intanto gli ex frati e le moniali non sono pagati, e così pure tutti gli impiegati nei conventi e nelle abadie che secondo la promessa conservar doveano i loro soldi. Gl’inquilini delle case e botteghe, e gli affittatori de’ fondi degli aboliti corpi morali e i poveri ex frati e le monache no sodisfano all’erario i loro debiti e muojono di fame. Molti litigi son sorti per sequestri lasciati al direttore del demanio, dei creditori di conventi e di abadie, e i giudici non credonsi abilitati di demolire secondo giustizia contro il Governo, e tutto ciò perché il Ministero non permette l’esigenza ne’ i pagamenti e fa perdere nell’imminente agosto in effettuar lo sgombero, l’introiti dell’asse ecclesiastico per l’abolizione sanzionata; laddove se desse gli ordini corrispondenti al Direttore del Demanio di far depositare in una cassa a parte i detti introiti potrebbero sodisfarsi tutti i creditori. Palermo non solo è desolata dalla miseria per migliaia d’impiegati che sono usciti o escono dalla disponibilità ma pure per497 moria di artigiani498 che mancano di lavori e di impiegati dimessi di tanti utili uffici499 di già aboliti500. Fu abolito, di fatti, l’Istituto Centrale d’Incoraggiamento, di Agricoltura, Pastorizia e Industria, onde la Sicilia non ha più unica centro direzione nell’invio dei suoi prodotti scelti all’Esposizione di Parigi e prima a quella di Dublino e il commercio che ne derivava è in minorato. Fu sospeso per più anni lo Stabilimento della Statistica affinché fosse riformato, talché adesso i dati501 del movimento di popolazione ed altri molti presentano una lacuna. Le utili scuole lancastriane furono abolite e sostituitovi un metodo barbaro anche per quelle elementari a peso dei municipii. I libri scolastici non si possono stampare a Palermo, essendo inviati dal Governo centrale, talché i nostri tipografi accrescono il gran numero dei miserabili. La lucrosa coltivazione dei tabacchi sì prospera in Sicilia, è impedita, e frattanto i cittadini son gravati dal Governo e dal Municipio di onze un 25 % oltre la ricchezza mobile, e al mutuo forzoso, che si estende sin’anco sopra i ciabattini, e i barbieri. Il numero dei briganti, i sequestri di persona, gli omicidii e i furti crescono ad ogni giorno né il governo ha saputo remuovere questa peste _________________________________ Segue cancellate le parole: “mancanza di lavori”. Segue cancellate le parole: “ma si pure per”. 499 Segue cancellata la parola: “sociali”. 500 Seguono cancellate le parole: “e i loro impiegati messi sul lastrico”. 501 Seguono cancellate le parole: “di statistica”. 497 498 164 sociale502. Maggior flagello per la tranquillità domestica è l’istruttione dei processi. Il signor Nicolosi che per farsi merito e salire503. Aggiunte all’articolo di belle arti Ma dimenticò il Meli che il supposto capo di quella scuola da lui detta esanime era il Camuccini autore del gran quadro dell’Assassinio di Giulio Cesare, in cui tutti i congiurati che l’attorniano non sono esanimi, ma in una tremenda attività di movenze, di attitudini, di espressione e dell’altro quadro della Morte di Lucrezia che pure è amatissimo e sono stati amendue ammirati come capolavori da tutti gl’intendenti italiani e stranieri ed è pure autore della Caduta di S. Paolo ch’io vidi in Roma nel quale all’infuori di aversi abusato del troppo lusso di colori, le figure sono animatissime, né ricordossi il Meli dell’altro gran dipinto della Giuditta del Benevenuti504 ch’io ammirai in Arezzo e che al merito della magnifica e serrata composizione unisce quello delle figure che spirano energica vita. Camuccini e Benevenuti furon certo i primi grandi pittori del corrente secolo e avendo stancata la fama e attiratosi l’onore universale anche con le molteplici incisioni delle loro opere, han suscitato da pochi anni dopo la morte un popolo di piccoli artisti a discreditarli; e il volgo de’ loro scolari vi han fatto eco. E ciò è avvenuto in parte pel nostro Velasquez [!] e degno di seder terzo tra cotanto senno artistico, essendosi molto avvicinato per la correzione del disegno e per la sennata composizione del Camuccini, perché entrambi procedevano alla insaputa l’uno dell’altro collo stesso metodo, cioè, di disegnare sul nudo, e di guardare ad un tempo l’eleganti forme delle statue greche. E così correggere i difetti di cui sovente nell’individuo tra la generalità pena il vero, non sempre bello in tutte le parti di un solo, due o tre uomini anche di belle forme. Ma a questo metodo si è gridata la croce sostituendo il vero, comunque sia, e spacciandosi arte morta quella degli antichi qui per tanti secoli ammirata nelle loro statue. Difatti le ho vedute bandite dagli studî dei nostri pittori che credono tenere il primato e imitando solo il vero ne imitano anco le sconcezze dell’individuo. È tempo questo di pervertito giudizio in tutto, in tutto. E gli italiani che _________________________________ Seguono cancellate le parole: “Circa lo stato di Palermo e di conseguenza della Sicilia”. La stesura del testo s’interrompe a causa della distrazione del rilegatore che ha tagliato la parte finale del foglio. 504 Pietro Benvenuti, pittore, nato ad Arezzo nel 1769, morto a Firenze nel 1844, diffonde a Firenze i principi del neoclassicismo. 502 503 165 già furon primi e di alte cose insegnatori altrui guidati dal loro esclusivo genio dell’arte, or pochi esclusine son divenuti tapini imitatori degli stranieri di cui erano per l’addietro maestri, da’ quali è lor pervenuto questo mal vezzo nelle belle arti. Gli antichi nostri pittori naturalisti come il Novelli seguivano più da vicino il vero; ma pure facevano scelta di modelli umani, che meno difettassero; talché il Novelli ha tutta l’efficacia del vero; ma vero non disgustevole da parti viziose e triviali. E i suoi vecchi, i bimbi, particolarmente sono ammirati e per le sue grandi invenzioni per la saggia distribuzione e per le altre qualità indicate soddisfano pienamente gli artisti, sebbene nel disegno505 mostri l’eleganza greca sposata al vero come il Camuccini, il Benvenuti, il Velasques. Che cessi una volta questa smania di novità che della rivoluzione e dalla politica de’ tempi e dal giornalismo si trasferisce alla letteratura e alle belle arti. Le novità son belle e buone quando son necessarie, opportunamente introdotte e regolate dal giudizio. Ma506 il gran concetto del bello ideale raccolto dalle parti belle di inclite persone devesi a Zeusi siciliano (1)507 fu applaudito da tutta la Grecia e se dominò per moltissimi secoli sulla pittura di tutte le nazioni successive ebbe il consentimento di milioni e milioni di uomini e non avrebbe dovuto essere sì facilmente bandito dalle meschine scuole di questi ultimi anni al più ravvisato dalla congiunta imitazione del vero. Ma i delirî nella razza umana cessano dopo alquanti anni e presagisco, senza esser profeta, che si ritornerà a quel bello colle modificazioni del Camuccini, del Benvenuti e del Velasques. Per ora son sicurodi gridare al deserto! Epigrafe per la mia storia delle belle arti in Sicilia L’Histoire des arts est peut-être le plus utile de toutes, quand elle joint à la connaissances de l’invention et du progrès des arts la description de leur méc<h>anisme ancient. Enciclopédie art histoire par La Clar Javoust. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “e nel colorito non senta”. Seguono cancellate le parole: “il tipo delle figure”. 507 A c. 231bis v nota in calce: “(1) Io ho provato in una mia operetta che Zeusi, con solidi argomenti fu nativo di Eraclea di Sicilia e non di Grecia, ove ben iniziato nell’arte da Demofilo di Imera passò ad esercitarla in Atene. I giornali stranieri han confermato questa mia opinione”. 505 506 166 Giuseppe Patania Nacque in Palermo a 19 gennaio 1780 e morì a 23 febbraio 1852 da umili e onesti genitori. Studiò per pochi mesi sotto il Velasques, e se ne allontanò, divenne pittore studiando più da sé che sotto la scorta altrui; si perfezionò nel disegno nell’Accademia del Nudo nella Regia Università di Palermo diretta dal Velasques; giovossi molte delle pitture e della Galleria Borbonica allora trasferita da Napoli in Sicilia, e imitò anche da principio il colorito di Vincenzo Riolo che da Roma erasi già trasferito a Palermo ma lo ridusse in seguito a più evidenza e verità coll’esercizio continuo di copiare il vero nei molteplici ritratti che dipinse. Fu oltremodo diligente nei piccoli quadri, e di bello effetto nei grandi. La grazia era la sua special prerogativa, fu felicissimo nell’invenzione, come l’attestano centinaia di schizzi a penna di soggetti istorici e mitologici. Quelli del Telemaco passati in Parigi furono ammirati ed incisi e molto lodati sui giornali. L’Accademia di belle arti di Nuova York, ove penetrò un suo ritratto di un inglese lo scrisse, ad unanime voto a suo socio onorario a 12 maggio 1841, come rilevasi dalla lettera del segretario m.r Morton. Anche prima era stato onorato dal re Francesco del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Francesco I. Il Patania fu uomo modesto benefico e dotato di tutte le virtù sociali e cristiane; incoraggiava i giovani artisti. La sua scuola ne era affollata e dopo il Velasques è stato il primo pittore a sostenere il buon gusto nell’arte e a diffonderlo per mezzo dei suoi numerosi allievi. Egli riuscì nei quadri di storia, nei ritratti e nel paese e talvolta dipinse anche con felice successo quadri di genere. Il pubblico mostrò estremo cordoglio alla di lui morte. Circa a cento artisti amici e conoscenti vollero consociarne il cadavere che fu deposto onorevolmente nella chiesa di S. Maria di Gesù vicino Palermo. M.r Vicar508 per 35 anni rimase in casa. Ritratto della regina de’ Francesi, lodato dallo Chateaubriand, altro ed alcuni schizzi dal Camuccini. Il dottor Minà, e Catolica e Sanfilippo. _________________________________ 508 Jean Baptiste Joseph Wicar (Vicar o Vicart), pittore, nato a Lille nel 1762, morto a Roma nel 1834. 167 Giuseppe Patania nacque in Palermo da umili ed onesti genitori a 19 gennaio 1780 e morì a 23 febbraio 1852. Apprese per pochi mesi il disegno sotto il Velasques, e se ne allontanò. Divenne poi pittore studiando più da sé, che sotto la scorta altrui. Si perfezionò nel disegno all’Accademia del Nudo della Regia Università di Palermo, diretta dal Velasques. Giovossi molto delle pitture della Real Galleria Borbonica allora trasferita da Napoli in Sicilia, e imitò anche da principio il colorito di Vincenzo Riolo che da Roma erasi già recato a Palermo; ma lo ridusse in seguito a più evidenza e verità coll’esercizio continuo di esprimere il suo nei molteplici ritratti che dipinse. Fu oltre modo diligente nei piccoli quadri, e di bello effetto nei grandi. La grazia era la sua special prerogativa. Fu felicissimo nell’invenzione, come l’attestano centinaia di schizzi a penna di soggetti istorici e mitologici. Quelli del Telemaco passati in Parigi furono ammirati ed incisi, e molto lodati nei giornali. L’Accademia di Belle Arti di Nuova York, ove penetrò un suo ritratto di un inglese l’ascrisse ad unanime voto a suo socio onorario a 12 maggio 1841, come rilevasi dalla lettera del segretario mister Morton. Anche prima era stato onorato dal re Francesco del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Francesco I. Il Patania fu uomo modesto, benefico e dotato di tutte le virtù sociali e cristiane. Incoraggiava i giovani artisti. La sua scuola ne era affollata, e dopo il Velasques è stato il primo pittore a sostenere il buon gusto nell’arte e a diffonderlo per mezzo dei suoi numerosi allievi. Egli riuscì nei quadri di storia, nei ritratti, e nel paese e talvolta dipinse anche con felice successo quadri di genere. Il pubblico mostrò estremo cordoglio alla di lui morte. Circa a cento artisti amici e conoscenti vollero consociarne il cadavere che fu deposto onorevolmente nella chiesa di S. Maria di Gesù vicino Palermo. Patania Nel 182* il marchese della Favara, luogotenente di Sicilia, ebbe segreto incarico dal re Francesco I di proporgli alcuni distinti scienziati ed artisti siciliani per conferir loro il titolo di cavaliere dell’Ordine nuovamente istituito che portava il suo nome. Don Giovanni Lima allora segretario del Governo, conferì con me l’affare, essendo io l’Ufficiale di carico nel Ministero destinato alle cose letterarie, scientifiche ed artistiche. Io gli dissi che quelli tra i viventi che godevano allora maggior stima erano 168 l’abate Domenico Scinà e l’abate Francesco Ferrara. Fra gli artisti poi i pittori Giuseppe Patania Vincenzo Riolo, l’architetto Emmanuele Marvuglia e lo scultore Valerio Villareale, e il compositore di musica Giovanni Bellini. Da questa nota furono esclusi il Marvuglia e il Villareale, e in vece fu sostituito Vincenzo Tineo botanico che allora ordinava ed abbelliva la villa del Luogotenente Favara a Malaspina. Tutti gli anzidetti individui, e non so se altri uomini di merito lette<ra>rio, e scientifico furono decorati del titolo di Cavaliere, e della medaglia d’oro di Francesco I. Il Villareale, e il Marvuglia furono esclusi a quel che credo per antiche opinioni politiche che nella vecchiaja in cui eran ridotti potevano dimenticarsi. Fra gli altri che si congratularono col Patania dell’onore conferitogli vi fu d. Ferdinando Rossi a cui rispose, come costui mi ha riferito: Se questo onore mi fosse stato conferito de’ celebri pittori Camuccini, o Benvenuti dopo di avere osservato le opere mie io ne menerei vanto sicuro che valessero qualche cosa; nulla di meno l’ho gradito, e mi protesto tenuto nel Governo; ma non saprei tenermi da più del passato. L’abate Scinà, similmente par che ne abbia preso conto; perché si segna col titolo di cavaliere e ne recò addosso la medaglia non così Ferrara che509 ne’ pranzi di etichetta presso il principe di Trabia, al Regio palazzo, come talvolta recaronsi ne aveva decorato il petto. [Epitaffio] Qui riposa / Giuseppe Patania da Palermo / celebre onnigeno dipintore / del R. Ordine di Francesco I / cavaliere della Commissione di Antichità / e di Belle Arti / Alle Accademie nazionali / e a quella del Disegno di Nuova York / ascritto / Ne accrebbe ornamento / ispirato dal genio / prediletto dalle Grazie / gareggiò nell’arte coi migliori di Sicilia. / Accostossi ai sommi d’Italia / emulò il vero nei ritratti / nei paesi nei fiori nella frutta / ma superò molti e sé stesso / nei quadri di storia / e più in quelli di leggiadro argomento. / Per cercatrice fantasia e fecondità d’ingegno e prontezza di mano / negli schizzi a penna, e nelle tele / Da tutti ammirato / per indole buona gentile / generosa soccorrevole / dai parenti e dai poveri amato / ai suoi amici agli allievi carissimo / cagion di cordoglio in morte / spirò in Dio d’anni LXXII / a 23 feb. MDCCCLII. / ____ / _________________________________ Seguono cancellate le parole: “Patania Quando il Patania fu insignitodel titolo di cavaliere dell’ordine di Francesco I”. 509 169 Chi ha senso al bello e alla virtù / pianga sul suo frale funerale???/ E preghi pace all’anima benedetta / Le eredi meste e riconoscenti /questa lapide posero.510 Scolari di Patania Giuseppe Meli di Palermo511. Andrea D’Antoni di Palermo512. Salvatore Cutelli di Palermo513. Gerlando Marsiglia regnicolo514 che recossi in Nuova York ove morì nel 1851. *** Adelfo515 Carlo La Barbera di Palermo516. Ferdinando Raimondi di Misilmeri, adesso a Roma. Giuseppe Bagnasco da Palermo517. Natale Carta da Messina. Giuseppe Carta da Palermo. Giuseppe Caponetto di Palermo *** Minutilla da Palermo518 che lasciò la pittura e fa il pedante. Luigi Lo Jacono di Palermo519 e poi studiò sotto Lo Forte. Angelo Zarbo da Licata ove al presente fa il pittore. Angelo Guadagnini di Canicattì520 e ora è nell’estero, e fa il pittore. _________________________________ Il necrologio, dettato dal Gallo, contempla e compendia (in forma esaustiva) l’abilità tecnica e pittorica nonché le modulazioni compositive e iconografiche dell’amico. 511 Giuseppe Meli, pittore, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1893. 512 Andrea D’Antoni, pittore, nato a Palermo nel 1811, ivi morto nel 1868. Il 17 maggio 1832 Giuseppe Patania firma la dichiarazione connessa all’abilità del giovane allievo a «copiare i quadri e disegnare i gessi» nella Regia Accademia degli studi di Palermo. Cfr. A.S.PA, Permessi di studio…cit., Misc. Arch. II, n. 316. 513 Salvatore Cutelli, pittore. Il 25 giugno 1829 Valerio Villareale avalla il suo ingresso nella Quadreria della Regia Università di Palermo per «studiare tanto ne’ gessi che ne’ quadri». Cfr. A.S.PA, Permessi di studio…cit., Misc. Arch: II, n. 316. 514 Gerlando Marsiglia, pittore, nato a Giuliana (Palermo) nel 1793, morto a New York nel 1852 ca. Una prima versione biografica è reperibile in Agostino Gallo, Notamento alfabetico di pittori, e musaicisti… cit., p. 47: una reiterazione in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 290-291. 515 Antonio Adelfio, pittore, sconosciuto alle fonti della letteratura artistica. 516 Vedi nota n. 214. 517 Giuseppe Bagnasco, pittore, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1882. 518 Giuseppe Minutilla Lauria, pittore, attivo nella seconda metà del XIX secolo. 519 Luigi Lojacono, pittore, nato a Palermo nel 1810, ivi morto nel 1880, padre di Francesco. 520 Angelo Guadagnini, pittore. Valerio Villareale il 25 giugno 1829 avalla il suo ingresso nella R. Università di Palermo «per studiare tanto ne’ gessi che ne’ quadri». Cfr. A.S.PA, Permessi di studio…cit., Misc. Arch. II, n. 316. 510 170 Giuseppe Di Marzo da Palermo. Pietro Lo Jacono da Palermo521 e ora dipinge in Napoli. Giuseppe Tranchetta da Palermo e ora dipinge in Napoli. Pietro Volpes da Palermo522 e ora studia sotto D’Antoni. *** Bonanno da Palermo523, e indi studiò sotto Lo Forte. Eugenio Formisano da Palermo che nel 1832 fu per concorso prescelto a perfezionarsi nella pittura in Roma. Baronello Di Stefano di S. Stefano dilettante indi studiò in Roma sotto Natale Carta. Giovanni Nizzola che indi diessi alla miniatura e fu apprezzato in Firenze. I fratelli Sacco miniaturisti. I fratelli Faja. Dilettanti Luigi Scalia di Palermo. Agostino Gallo da Palermo. Padre Sarulli da Ciminna524, monaco francescano. Padre Gaetano da Traina Cappuccino, ora studia sotto D’Antoni. Padre Arcangelo Cappuccino525 ora morto che riuscì nel paese. Morte di Patania Giuseppe Patania palermitano celebre dipintore morì di anni 72 il giorno di lunedì 23 febbraro 1852 alle ore 18 ¾ e 33 minuti in un attacco convulsivo. Fino al giorno precedente avea dipinto il ritratto della Signora Piraino _________________________________ Pietro Lo Jacono, pittore attivo nel XIX secolo. L’8 ottobre 1830 Valerio Villareale autorizza l’ingresso del giovane nel R. Museo di Palermo per addestrarsi allo «studio de’ quadri e gessi». Cfr. A.S.PA, Permessi di studio…cit., Misc. Arch. II, n. 316. 522 Pietro Volpes, pittore, nato a Palermo nel 1830, ivi morto dopo il 1886. 523 Antonino Bonanno. Il 19 giugno 1829 Valerio Villareale lo dichiara «abile» a studiare nel Museo dell’Università di Palermo. A.S.PA., Permessi di studio…cit., Misc. Arch. II, n. 316. 524 Pasquale Sarullo, pittore, nato a Ciminna (Palermo) nel 1828, morto a Palermo nel 1893, frate minore conventuale. 525 Padre Arcangelo da Palermo (al secolo Giuseppe Rizzo), pittore, nato a Marsala (Trapani) nel 1786, morto a Palermo nel 1849. Notizie bio-bibliografiche più estese sono presenti in Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 391-192. 521 171 e ne avea quasi compita la testa. Alle ore otto italiane della notte fu attaccato da forte dolore al petto con vomito, ed evacuazione che indi si comunicò alle viscere. Furono tosto i medici, Dottor Minà e Dottor San Filippo e gli apprestarono i rimedi che credettero opportuni, ma lo fecero munire dei sagramenti che egli alla mia presenza ricevette con straordinaria tranquillità d’animo. Egli conservò serenissima la testa, ed essendomi io avvicinato a lui, due ore prima di morire, per dargli qualche conforto, non solo mi ricobbe e mi chiamò a nome ma rispose a quelle mie parole: io sono indifferente alla vita, e alla morte. Essa non mi disturba, e vi sono apparecchiato. La sua camera era affollata dei suoi amici, dei suoi scolari, e dei suoi parenti e questi ultimi me ne rammentavano i benefici, e tutti gli altri le virtù, uno dei suoi parenti disse: quest’uomo travagliò tutta la vita per soccorrere a tutti noi; e sospirando piangeva. Il pianto e il dolore era in tutti gli astanti. Don Ferdinando Melazzo, suo esecutore testamentario anche presente, rammentava che egli detto gli avea un giorno: io desidero morire repentinamente, perché in una lunga malattia dovrei consumare quel poco di danaro che ho raccolto, o ridurmi alla miseria; ciò sarebbe a danno dei miei parenti. Salvatore Lo Forte egregio artista impetrò dal Rettore dell’Università di tener chiusa la scuola per dimostrazione di lutto, sebbene non ne fosse stato professore, ma semplice esaminatore di concorsi artistici. Dettato da me Agostino Gallo Un mese circa prima di morire avea dipinto in una tela di palmi 4 per tre, e mezzo orizzontalmente una Sacra Famiglia a mezza figura, e col putto Gesù intero ignudo. In quest’opera spiegò uno stile grande e una mirabile armonia di colori. Il putto è d’una bellezza straordinaria ed uno de’ suoi migliori. Dipinse anche per me il Ritratto di Costantino Costantini, poeta, e giureconsulto. La sera innanzi alla sua morte, fino a 3 ore disegnò, e cominciò a tracciar di penna uno degli schizzi che per consuetudine far solea dicendo che si divertiva con la penna, e di cui un gran numero esistono fra le sue carte, e circa 60 gliene furono rubate relative all’istoria di Sicilia da un suo scolare, e che egli in parte e con nuona invenzione rifece indifferente a tanta perdita. Quello schizzo ultimo rappresenta Gesù Cristo condotto a Pilato per giudicarlo. La brevità del tempo che dà la legge dello stato civile di tenere in casa 172 i cadaveri mi aveva posto fuor di speranza di vederlo accompagnato da’ suoi amici, e dagli artisti, molti de’ quali per corto spazio della sua malattia ne ignoravano la morte. La mattina però del 24 di prim’ora venneroda me circa 10 artisti condotti da Bonanno, già stato suo scolare, e mi chiesero di associarmi a loro per far corteggio di lutto al cadavere. Ciò fu eseguito e in men di un’ora si vide una furia di circa 80 artisti ed amici. Il corteggio commuoveva i cuori, ed era magnifico delle carrozze, e servitori a lutto che alcuni magnati vollero inviargli. Tutti lo seguivano mestamente, e a capo scoperto, e fecer me precedere che come il più intimo amico vi ero più addolorato. Un d’essi per la strada sclamò accompagniamo il padre di tutti noi, l’uomo virtuoso, un grande artista che ha fatto onore a Palermo sua patria, e alla Sicilia. Io gli feci togliere per ricordo un ciuffo di capelli. Agostino Gallo La moglie del pittore Giuseppe Patania fu la vedova D.na Narda Bucalo, bellissima donna ch’era stata pria sua amica. Di lei esiste un somigliantissimo e magnifico ritratto a mezza figura presso la sua figlia. Un’altra sua figlia, per nome Concetta, ch’era bella, graziosa e di cui avvi quasi il ritratto in un dipinto del Patania di una Fanciulla che bacia una colomba, si maritò con *** ispettor di Polizia. Un altro figlio, somigliantissimo a Patania, ha nome Giuseppe Bucalo, che coltivava la musica e la pittura a miniatura, ed era singolare nella mimica imitativa delle persone e gli animali. Di lui innamoratosi Maria Malibran celebre cantante, lo recò a Parigi, e alla di lei morte si sostenne con accademie di canto e con la pittura a miniatura. Indi passò in America. Patania costituì suoi eredi: Concetta *** nella somma di circa 6mila onze in danaro e in vendita di quadri, e di stampe e fu suo fedecommessario D. Ferdinando Melazzo. La moglie di Vincenzo Riolo chiamavasi Maria Stella Torciarotto sorella d’un maestro di scherma e parente di mia madre. La moglie di Giuseppe Velasques chiamavasi Anna, una figlia Teresa maritata con l’avvocato Anselmo, un’altra con Riolo e un figlio morto, per morso d’un cane rabbioso. Di lei avvi il ritratto in una donna che abbraccia un bambino nel quadro di S. Vincenzo Ferreri in S. Domenico. 173 Su Patania Il signor Lorenzo Ruggi526 da Bologna professor di architettura, ed autore d’un’egregia opera di architettura prospettica per gli artisti, e intenditissimo di pittura, ch’ebbe la bontà di visitarmi nel dicembre del 1856 osservando in mia casa la raccolta de’ miei quadri antichi e moderni, guardò con compiacenza quelli del Patania del quale mi chiese notizie, giungendogli ignoto il suo nome, disse: questo è un delicato, leggiadro, e simpatico pittore, che fa onore alla scuola siciliana. Patania Patania sul fiore della sua età e del suo genio pittorico dipinse per l’avvocato signor Antonio Agnetta che dilettavasi di sporcar tele co’ colori, sei od otto quadri di figure terziane di soggetti della mitologia di Psiche che per l’invenzione per la grazia e il florido colorito furono reputati i migliori tra le opere sue e quelle degli artisti contemporanei di Sicilia. Mi ricordo con diletto il Bagno di Psiche con le ninfe, il Ratto della medesima in cielo fra gli abbracci di Cupido. Que’ quadri furon pagati in amicizia onze venti ciascuno. L’avvocato Vaginelli in emulazione commise a Patania altri otto quadri di soggetti varij mitologi<ci>, che ho riveduto a 25 giugno 1867. Si conservano dopo molti anni splendidi, e freschi. Avvi una Venere dormiente e presso un Satiro che vuole scoprirla, Danae, Psiche trasportata in cielo, e in altre attitudini, Venere che prega Giove a favorire i Troiani, e simili soggetti in parte replicati di quelli Agnetta ma con diversa invenzione, però non migliori. La grazia del pennello del Patania il bel colorito e la fusione e lo smalto delle tinte è sempre lo stesso; ma alcune figure sono527 trascurate nel disegno. Gambe e braccia troppo lunghe, e corpi assi svelti, e in generale dipinti con minor cura e più rapidamente de’ quadri di Agnetta; sebbene gli fossero stati pagati allo stesso prezzo. I soggetti dei quadri per il dottor Pietro Vaginelli, sono: Giove che bacia la Ninfa Io. Venere che carezza Vulcano per foggiare le armi di ***. Giove cambiato in toro che rapisce Europa. _________________________________ 526 Forse l’incisore del sec. XIX riportato in: Giorgio Milesi, Dizionario degli incisori. Saggio di bibliografia ragionata a cura di Paolo Bellini, Bergamo, Minerva Italica, 1982, p. 216. 527 Segue cancellata la parola: “più”. 174 Venere che abbraccia Adone. Un Satiro che tenta d’assalir una ninfa che dorme. Giove in pioggia d’oro che scende su Danae. Venere che sorge dalla spuma del mare. Quadri descritti nel seguente sonetto dall’abate Francesco Ferrara. Sonetto all’avvocato Pietro Vaginelli 1° quadro: Io languisce di Giove ai baci ardenti. 2° Tinto ispira a Vulcano ciprigno amore. 3° Un nume Toro con ferito core rapisce528 Europa529 al mar s’affida e a’ venti. 4°Adon la bella dea con dolci accenti530 tiene e si strugge di cocente ardore 5° 531Un Satiro con lubrico furore par che una ninfa d’assalirla tenti. 6° Giove in oro532 su Danae discende. 7° Dalla spuma del mar Venere nasce. 8° Fiamma d’amore in sen cupido accende / di si soavi immagini si pasce. / qui l’occhio, o Pietro, o qui l’Olimpo scende /O qui di Grecia al genio rinasce. Dall’abate Ferrara Per otto quadri di circa tre palmi per larghezza e circa quattro per lunghezza dipinti da Patania pel Signor barone Avvocato D. Pietro Vaginelli. Il cavalier D. Giuseppe Patania dipinse un ritratto di Mr Laurence Americano, il quale commise allo stesso tempo il ritratto di sua moglie al pittore Lo Forte, e riportò l’uno e l’altro in America, e li presentò all’Esposizione dell’Accademia Nazionale di disegno di New York. Ivi il corpo di professori applaudì a quello del Patania, e il propose per membro onorario della stessa in data de’ 12 maggio 1841, e il giorno dopo gliene fu partecipato l’avviso dal segretario Giovanni L. Morton e fugli spedito il i regolamenti, e il libro degli oggetti dell’esposizione in pittura, disegno, scultura ed architettura, coiè n. 330 oggetti di pittura, e disegno, e n. 18 pezzi di scultura, e modelli di architettura. Ciò mostra quanto il Patania sia apprezzato non che in Sicilia, ma fuori ancora. _________________________________ 528 Segue cancellata la parola: “tolto”. 529 Seguono cancellate le parole: “l’affida”. 530 Seguono cancellate le parole: “per lei”. 531 Precedono cancellate le parole: “Par ninfa in sogno”: 532 Seguono cancellate le parole: “un dio”. 175 In Firenze fu mostrato poi da D. Agostino Gallo nell’agosto 1841 uno schizzo a penna di gran composizione al celebre pittore commendatore Pietro Benvenuto e dal medesimo fu assai lodato. L’altro celebre pittore Camuccini lodò allo stesso Gallo due altri schizzi che aveva molti anni fa veduti in Napoli in casa del marchese Gargallo. Il famoso scrittore Chateaubriand loda il ritratto fatto dal Patania alla duchessa di Berry che da Sicilia era stato trasportato in Parigi. Lo Forte Baufrimont Abate Giglio di *** Cav. D Francesco Trigona S. Elia. Barone Vito presso Franco. Quadro del Beato Valfrà[!] uno in Messina e l’altro all’Olivella in Palermo. Copia del quadro del Novelli di S. Maria Maddalena di S. Cita. National Academy of Design New York may 13, 1841. Sir I have the honor to inform you that at the Annual Meeting of the Academy held on the 12e Inst. You were unanimously elected an Honorary member of the National Academy of design. With great respect. I have the honor to be you obt. Ser.t John L. Morton Sec. N.A. Chevalier Joseph Patania Sul pittore Giuseppe Patania Il Patania non soleva mai censurare alcuno artista né soffriva che alcuno facesse osservazioni critiche su i dipinti proprii e di altri; benché 176 pe’ suoi interrogasse in secreto qualche amico amatore, e intelligente, fra i quali chiedeva l’opinione dell’egregio disegnatore e pittore sig. Giuseppe Scaglione533, dello scultore Valerio Villareale, del dilettante sig.r Ferdinando Melazzo, e anche la mia. Una sera, trovandomi solo con lui mi domandò se egli si fosse avvicinato al suo maestro Giuseppe Velasques di cui faceva grandissima stima al punto di dire che tutti i pittori siciliani vivendo in chiuso, il primo lui, nessuno valeva un pelo del Velasques. Io, secondo il mio giudizio, credevo che nella grazia de’ volti femminei l’avesse superato essendo stato in gioventù più amante delle donne, laddove l’altro era scrupoloso ed aveva una buona, ma brutta moglie; ed egli, il Patania, una bella. Ne’ putti talvolta eguagliava in leggiadria il Villareale, nel colorito e nell’originalità e facilità della composizione il superava; nella perfezione del disegno, e ne’ volti di gran carattere gli era inferiore. Egli non si offese del mio giudizio riconoscendolo sincero. Dopo alquanti giorni mostrommi alcune teste di gran carattere disegnate e condotte a chiaro-scuro che immaginava di rappresentare Achille, Diomede, Ulisse, e non molti di appresse altre di filosofi e sommi personaggi dell’istoria con venerandi aspetti tutti variati, e di sua invenzione, e dissemi: mi sono avvicinato a Velasques per le teste di gran carattere? Si, risposi io, ma voi non li avete dipinti con lo stesso effetto come li avete ora disegnati. Li dipingerò meglio appresso. E di fatti li eseguì nel quadro della Flagellazione di Gesù Cristo ne’ manigoldi per la chiesa della Magione, e ne’ poveri del S. Gaetano per la chiesa del titolare in Monreale. Io possiedo la collezione di quelle magnifiche teste a chiaro-scuro. Un’altra volta io gli parlavo svantagiosamente di un ritratto dipinto da un suo invido e ingrato scolare che lo sparlava, ma egli ignoravalo. Dissemi: ho veduto quel ritratto. È somigliante e mi piace. Ma vi piaccion le mani, che mi sembran di gatta. Io non parlo di mani, ma del volto. Ma le mani sono ben disegnate? Non so dirvelo, ma già lo avete detto con la vostra reticenza! Un altro giorno vidi scolpiti ad alto rilievo in legno da Francesco Quattrocchi alcune figure mitologiche nelle botteghe in via Toledo del duca di Serradifalco, e conobbi nello stile di essere ricavati da’ disegni in _________________________________ Giuseppe Scaglione, pittore, nato a Militello (Catania) nel 1772, morto a Palermo nel 1857. La biografia dell’artista è rubricata nell’opera di Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 241-244. 533 177 grande del Patania. Me lo richiese, ed egli adirato si tacque. Ho capito, e vieppiù s’adirò. Erano eseguite su’ suoi disegni che far soleva di notte e a porte chiuse pe’ suoi scolari, e amici artisti. D. Carlo La Barbera fece i cartoni d’una volta da lui dipinti per la chiesa nell’interno dell’isola nostra. Presso l’erede dell’egregio scultore in legno Girolamo Bagnasco vidi moltissimi disegni del suo amico Patania pe’ bassi rilievi di altari che questi in varii tempi scolpì con grazia e diligenza. Un giorno disse il Patania ad un suo maledico [!] scolare che sparlava un pittore miglior di quello: ma non vedi che sei sciocco, se tu encomiassi il merito qualche parte di lode rimarrebbe per te che gli sei inferiore, e quindi perdi e non acquisti non restandoti che la taccia di male lingua. E se sparlassi anche me da cui hai imparato l’arte, tu resteresti un nulla. Abbii giudizio, studia, e con la tua buona disposizione supera me e gli altri, e fa che tutti dicano che tu sei di me, e degli altri miglior pittore. Per ben giudicare è d’uopo d’aver molto studiato, molto veduto e contemplato fuori le opere de’ valentuomini, e molto progredito nell’arte. Così il Patania educava i suoi allievi non solo nella pittura; ma anche nella morale e meritossi l’affetto, e la stima universale. Opere di Patania Ritratto al vero all’impiedi bellissimo, somigliante, e nobilmente atteggiato di Giuseppe Mantegna con costume spagnuolo, da maschera Ritratto a mezza figura dell’architetto Niccolò Puglia Idem del cav. Gaetano Vanni Idem della sua moglie signora Rosalia Idem del magistrato signor Gramignani Due quadri bellissimi orizzontali co’ Fanciulli, figli del barone Paino che scherzano seduti in una campagna Un quadro bellissimo della Famiglia del consigliere Melazzo in una villa campestre Ritratto, a mezza figura, di Alessandro Cutò, e della signora Bianconcini Ritratto, a mezza figura, d’una donna di Gaetano Filingeri junior, or principe di Satriano I ritratti nell’attitudini delli Cenci della baronessa Martines 178 Ritratti di Patania Per Parigi: Di S.A.R. Maria Amalia indi regina de’ Francesi Per Roma: Della signora Vincenza Grassellini duchessa Brolo, per suo fratello il cardinale. Del greco Madragna, pel suo figlio in Roma In Napoli: D. Vincenzo Bellini, presso l’incisore Aloisio534 In New Iorck [!] Di un giovane che pose il suo ritratto all’Esposizione e l’Accademia in benemerenza, ascrisse fra’ suoi soci di onore Patania Di mister Sigar, negoziante inglese in Palermo, e di suo fratello, che trovasi in Londra Del magistrato Gramignani, presso il figlio Dell’architetto Niccolò Puglia, presso il nipote Del Bellini, presso il Gallo e Santo Canale Di Scinà presso il Gallo, col canonico Vigo in Acireale Di Donna Rosalia Vanni, presso il fratello in Napoli Di Gaetano Vanni, presso i suoi nepoti. 2 quadri per la chiesetta nel podere Judica, feudo del conte Tasca uno rappresentante la Vergine Addolorata e l’altro S. Lucia, dipinti egregiamente da Giuseppe Patania535. Biografia di Giuseppe Patania Giuseppe Patania nacque in Palermo a 18 gennajo 1780. Il suo genitore Giacinto, sarto di professione e la sua madre Giuseppina D’Anna, levatrice l’aveano appena avviato alle scuole elementari, essendosi per discordie in famiglia separati, pigliò cura di quel giovinetto l’ava paterna; ma scorgendo costei che poco attendeva allo studio occupandosi sempre a disegnar sulla carta o a modellare in creta bam_________________________________ Tommaso Aloysio Juvara, incisore, nato a Messina nel 1809, morto a Roma nel 1875, figlio di Giuseppe e Nicoletta Juvara. Cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori … cit., p. 117-119. 535 Questa nota a c. 260r è scritta sul verso di una convocazione per il giorno 11 luglio 1867 dell’assemblea della Commessione di agricoltura e pastoirzia [!] per la Sicilia. 534 179 bocci il condusse allo studio di uno scultore di figure e d’ornato in legno. Quel fanciullo non toccava ancora i 10 anni e quasi sentiva per impulso di sangue ch’egli per parte della madre era pronipote del celebre dipintore frescante Vito d’Anna, e sin da quella tenera età mostrava nelle figurine modellate ed ornate in creta di esser nato artista. Talché essendo quei diligenti e graziosi lavori osservati da un architetto consigliò i suoi parenti di destinarlo alla pittura ed assunse egli l’incarico di condurlo allo studio del rinnomato pittore Giuseppe Velasques, principe degli artisti siciliani e riformatore del buon gusto dell’arte del disegno e del colore. In pochi mesi giunse egli a disegnare busto e statue in gesso con tanta esattezza di contorni e intelligenza di chiaroscuro che il suo maestro previde fin d’allora che sarebbe divenuto suo emulo; laonde essendo stato da lui richiesto un giorno di permettergli di copiare ad olio in colore una testa da quello dipinta ne fu sgarbatamente minacciato colla bacchetta, di che piccatosi il giovinetto raccolse i suoi disegni nel cartolare e gli disse andando via, io sarò pittore senza il vostro ammaestramento. D’allora cominciò a dipingere in casa ed a frequentare l’Accademia del Nudo536. E come erano ricercate dall’amatore signor Giambattista Di Stefano quadrettini e bozzetti antichi il Patania diessi allora in vecchie tele ad imitarne il tocco in composizioni bensì originali ch’erano comprati da quello; ma scovertane finalmente la fraude anziché adirarsene, divenne suo protettore e continuò ad acquistarne piccoli lavori. In quel tempo solevano esporsi dall’impresario del teatro di prosa detto di Santa Lucia537 i cartelloni dipinti ov’era espresso il punto principale dell’opera drammatica da rappresentarsi. Il Patania giovinetto a 15 anni fu preferito ad altri e per tutta quell’impresa e la seguente ogni giorno dava bella e finita un quadro in carta spesso di composizione complicata per soli due scudi. Questo esercizio gli sviluppò l’imaginazione, il sentimento e rese pronto e celere il suo pennello, qualità che ritenne per tutta la vita migliorandole. Un giorno che il cav. Tommaso Puccini da Pistoia gran conoscitore e direttore della Galleria e Museo di Firenze il quale soggiornava allora a _________________________________ 536 Fondata nel 1783 presso la Reale Accademia degli Studi, con sede nella casa dei P. Teatini. La direzione è affidata al pittore Francesco Sozzi. Nel 1805 l’Accademia acquisisce il titolo di Regia Università e l’insegnamento prosegue nella stessa sede. Cfr. Regolamenti dell’Università degli studi di Palermo, 1805-1841. A cura di G. La Grutta, R. Giuffrida, [S. l., s. n.], stampa 1978 (Palermo, STASS). Ripr. facs. dell’ed.: Palermo, dalla Reale stamperia, 1805. 537 Oggi denominato Bellini, ubicato nell’omonima piazza. Cfr. Antonella Mazzamuto, Teatri di Sicilia, Palermo, S.F. Flaccovio, 1989, p. 88 e sgg. 180 Palermo osservò appeso sulla piazza Villena uno di quei cartelloni in compagnia del barone Pisani, suo amico. Gli chiese il nome e l’età del pittore e saputo ciò gli disse: - Incoraggiate questo giovinetto; io presagisco che diverrà gran pittore tanto genio egli mostra in questi saggi. L’amor del guadagno non isviava bensì il Patania dallo studiare il disegno da sé sulle migliori stampe, sui gessi e nell’Accademia del nudo quando per la fama che già cominciava ad acquistarsi, fu invitato da un ricco negoziante di recarsi seco a Maone, città marittima nell’isola di Minorica per dipingere di figure e di ornato le stanze della sua casa e i ritratti di sua famiglia assegnandogli un buon soldo e offrendogli ospitalità, pranzo e servizio. Accolse egli la proposta e giunto a Maone imprese subito i lavori ordinatigli e per la dolcezza e gentilezza del carattere e la figura avvenente e l’abilità pittorica divenne bentosto il favorito di quella famiglia. Molti quadri e ritratti lasciò in quella città che priva com’era di opere d’arte furono riguardati e si ritengono tuttavia come opere prodigiose. Era egli adescato dalle larghe mercedi a stabilirsi ivi; ma l’amor della patria e dell’arte essendo lontana dalla prima e conoscendo di non potere ivi progredire nell’arte per esser mancante di capi-lavori determinassi dopo circa due anni a ritornare alla terra natia col pericolo di far naufragio. Approdando a Napoli, fermossi ivi alquanti giorni ed avidamente contemplò più e più volte i quadri, i marmi e i bronzi della Galleria e del Museo Borbonico e colla semplice vista non avendo il tempo di poter nulla copiare si eccitò e sviluppò in lui a cento doppî il talento pittorico per modo che ritornato a Palermo colle prime opere che fece ad olio ed a fresco nella chiesa del Ritiro di San Pietro538, nel Refettorio del Seminario Arcivescovile539 e nella casa del barone Atanasio acquistossi fama di egregio dipintore per modo che l’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia che ammirato avea in Roma i capi lavori dell’arte e riformata in Sicilia l’architettura credette meritevole il giovane Patania di fargli dipingere un quadro per la chiesa della Real Casina della Ficuzza540 in competenza del suo mae_________________________________ 538 Conservatorio fondato nel 1666 dal sacerdote G. Bonfante per accogliere le donne traviate. La denominazione fu scelta in onore del cardinale D. Pietro Martines Rubio. 539 Ubicato in via dell’Incoronazione, collaterale alla chiesa della Badia Nuova (altrimenti nota come S. Maria di Monte Oliveto). Edificato, nel 1512, sui resti dell’ex monastero della Badia e del vecchio Arcivescovado. 540 Una recente indagine è stata condotta da Giovanni Fatta - Tiziana Campisi, “La costruzione della Real Casina di Ficuzza”, in: Il Barocco e la regione corleonese. Atti della giornata di studio Chiusa Sclafani, 5 ottobre 1997. A cura di Antonino G. Marchese; introduzione di Maria Giuffre; premessa di Giuseppe Governali, Palermo, Sao Paulo, Ila Palma, 1999, p. 169-230. 181 stro Giuseppe Velasques, laonde verificossi il presagio ch’egli fatto avea di sé che avrebbe divenuto buon pittore senza di lui. Verso quel tempo poco prima ritornava da Roma Vincenzo Riolo, palermitano che erasi ivi perfezionato nell’arte sotto la disciplina dell’insigne dipintore francese M.r Vicart541. Del Riolo morto nel 1837 l’epigrafe funebre apposta al suo monumento da Agostino Gallo rappresenta le qualità pittoriche nei seguenti versi: Alla patria pittura esanimita diè vaghe tinte ombre gagliarde e vita. Il Patania profittò ben tosto dei pregi dei quadri del Riolo e d’allora divenne miglior coloritore e compositore dandovi maggior risalto di chiaroscuro ai suoi dipinti; talché un bozzetto542 presso il menzionato di Gallo fu da tutti i conoscitori giudicato del Riolo, come pure un S. Pietro. Ma avendolo osservato il Patania disse sorridendo di essere sua opera giovanile da non meritare di essere accolta in una galleria e così pure profferì per modestia per una sua Danae presso lo stesso Gallo, sebbene nel volto mostra tal voluttà che meglio non l’avrebbe potuto esprimerla quando divenne più adulto nell’arte. Così proseguiva egli a dipinger quadri, ritratti nella maniera gagliarda del Riolo, che costituisce il suo secondo stile dopo il primo che sentiva alquanto del Velasques. Giunse intanto in Palermo M.r Fagan pittore543 e console inglese il quale espose in sua casa alcuni quadri da lui eseguiti con delicatezza di tinte per mezzo di velature. L’effetto era debole ma grazioso. Il Patania l’adottò ben tosto e dipinse in quel modo Due fanciulle figlie di Giuseppe Alliata principe di Villafranca che si contendevano un piccione tolto al nido della madre, la quale colle ali544 lottava a difendere i suoi nati, composizione anacreontica e corregesca lodata in una canzone del predetto Agostino Gallo. Allo stesso modo dipinse Un giovinetto da costui or posseduto e due Ritratti delle giovinette figlie della principessa di Paternò. Ma essendosi accorto che col sistema delle velature545 le tinte svaniscono in pochi anni ritornò alla precedente maniera riolesca e già divenuto _________________________________ Vedi nota n. 508. Seguono cancellate le parole: “che io ne acquistai”. 543 Robert Fagan (1761-1816), pittore e console inglese a Palermo dal 1089 al 1816. Durante la permanenza romana (18 anni) svolge l’attività primaria di pittore e associa quella di collezionista ed esperto di opere d’arte. 544 Seguono cancellate le parole: “faceva loro”. 545 Luigi Grassi – Mario Pepe, Dizionario della critica d’arte, Torino, Einaudi, 1978, v. 2, ad vocem: «pittura condotta con colori molto diluiti, utilizzata sovente sovrapposta ad una superficie già dipinta per correggere il tono di un colore, per ottenere particolari effetti». 541 542 182 padrone dell’arte non più replicava le figure ma le dipingeva alla prima e <a>vevano bellissimo effetto. Il Patania venne allora in competenza col Riolo, ed essendosi esercitato senza precedente ammaestramento a dipinger bene il paese fu scelto dal D.r Vincenzo Gagliani ad esprimere col pennello l’origine del ballo in Sicilia in una amenissima campagna con una Musa che ritraeva la signora Campilli famosa ballerina e un altro quadro anche di grazioso argomento e in contrapposto affidò al Riolo argomenti più gravi per due quadri. Il giudizio del pubblico restò dubbio; ma per la grazia di pennellare ebbe più parteggiani il Patania. Il paesaggio ch’egli nell’uno e nell’altro introdusse gli diè opinione di essere allora il miglior paesista e il generale Fardella gli commise un quadro di una Festa campestre come il barone Battifora la rappresentazione di un villaggio la dama e il proprietario ed era accolto dai suoi vassalli con offerte di fiori, di frutta e con giuochi festivi, quadro che puossi riguardare come un poemetto anacreontico. Venne indi in competenza col Riolo e coll’abate Giovanni Patricola, già stato allievo del Velasques per alcuni quadri di gran dimensione relativi ai Fasti del re Ruggiero in una delle Gallerie del Real Palazzo di Palermo ed essendosi trasmessi i bozzetti di tutti e tre al marchese Ruffo, direttore del Ministero di Casa Reale in Napoli, costui sul giudizio di quell’Accademia riconobbe preferibile quello del Patania. Quei quadri furono indi eseguiti a tempra dai tre competitori e per la grazia fu dal pubblico proclamato il migliore quello del Patania. Nella luogotenenza di S.A.R. il principe D. Leopoldo Borbone ebbe anche affidato un gran quadro ad olio esprimente Il giardino d’Armida e gli amori di lei con Rinaldo. E questo quadro fu certo il migliore che avesse fin allora dipinto il Patania per la bellezza del volto della maga seducente e del giovine guerriero sedotto per la voluttà del sentimento e per l’incantevole campagna che l’adornava. Patania si esercitò molto nel dipingere i ritratti, in cui riuscì meravigliosamente. Le più belle donne di Palermo e le straniere che qui capitavano ambivano di avere la propria effigie che sapeva con fina arte ce<le>brarne i piccoli difetti non tralasciando di riuscir somigliantissimi. La giovane marchesa Merlo fu dipinta in una bella campagna nell’atto di suonar l’arpa. La graziosa signora Medina in attitudine di vagheggiarsi allo specchio. La signora baronessa Concetta Martinez, una delle più belle donne del suo tempo in varii atteggiamenti. Due ritratti fece al principe Giovanni Lanza, uno al naturale vestito da crociato in amena campagna e 183 l’altro a mezza figura seduto. E i ritratti ancora della signora Rosalia Vanni come una sibilla e del suo marito cav. D. Gaetano, in cui seppe esprimere quell’aria beffarda e mordace del suo carattere. Agostino Gallo amicissimo del Patania gli fè eseguire in molti anni successivi circa 20 ritratti a mezze figure per la sua collezione degli uomini illustri siciliani antichi e moderni ricavati da genuini originali e dai valentuomini del suo tempo. E qui è da osservarsi la generosità del pittore che disse al suo amico: conosco che le vostre finanze sono inferiori alla vostra nobile impresa; io mi contento di un prezzo discretissimo per favorir voi e servire alla patria, ai fasti della quale è destinata quella collezione. Il suo pennello era così rapido riuscendo546 sempre alla prima che in tre giorni il rtitratto era già bello terminato e maestrevolmente dipinto. Il Gallo gli chiese allora i ritratti di Velasques, e quello dello stesso Patania e volendogli dare la pattuita mercede rispose: Non vendo la testa del mio Maestro, né la mia. E così generosamente donò pure i ritratti dello stesso Gallo e dei suoi genitori. Per Gallo dipinse ancora una Venere e Adone che inviato dopo la morte del pittore all’Esposizione di Firenze del 1861 fu ammirato da tutti. Avea dipinto pure per Gallo la copia della Venere con Amore e il satiro che gli ruba la faretra attribuito al Correggio ritraendola da una mediocre incisione migliorandola nel disegno. Dipinse anche prima Un putto che stringe al seno un coniglio, ed una fanciulla, una tortorella ritraendo in questa una sua bella figlia. Dipinse per lui ancora in competenza del Riolo e del Velasques in piccoli quadretti, La Speranza che abbraccia Amore, Il Tempo che avverte la Bellezza di esser troppo fugace, mentre i due Amorini trangosciano nelle […]547 e il bozzetto del Ratto di Proserpina, bellissimo quadro dipinto per il conte D. Corrado Ventimiglia. Moltissimi paesi di piccola dimensione rappresentanti le vicende dell’anno e della campagna pel signor D. Angelo Nicolao e quattro altri per il D.r Antonino Samonà al quale e per la sua moglie fece pure i ritratti. Avea dipinto per la regina Elisabetta di Napoli una Santa Rosalia, quadro di piccola grandezza e finito con tutto amore e diligenza che non essendo stato ulteriormente richiesto fu acquistato da Agostino Gallo. Il Patania riusciva principalmente nei quadri da cavalletto, nei ritratti e nei paesi; tuttavia fu adoprato in diversi grandi quadri di raro argomen_________________________________ 546 547 La c. 266 è mal rifilata per cui la parola “riuscendo” scritta al margine inferiore si intuisce appena. Illegibile l’ultimo rigo del foglio, in quanto la c. 266 è mal rifilata. 184 to per chiese nei quali se si fece ammirare pure è inferiore a sé stesso principalmente per l’effetto del chiaro scuro, sebbene nella composizione, nel disegno e nel colorito si mostri già maestro nell’arte. Fra questi gran quadri vuolsi eccettuare però il primo ch’egli dipinse per una chiesa di Randazzo, ove rappresentò l’Adorazione dei Magi a lume di notte548 con bel colorito e grande effetto di luce procedente dal Bambino Gesù e dalla Vergine, onde sono irradiati con artifiziosa degradazione i Re dell’Oriente e la turba che li segue. Altro quadro per chiesa che per le stesse qualità attirossi la pubblica ammirazione è quello del S. Gaetano che sfama i poveri e scorgesi nella chiesa del titolare delle monache in Monreale, che trionfa al confronto di quello miserabile di Giuseppe Meli e dell’altro migliore di Giovanni Patricola che, a dire dell’egregio pittore Verburt549, sembrano opere di dilettanti. Tra i migliori quadri d’altare è quello della Flagellazione di Gesù Cristo nella chiesa della Magione a Palermo. La figura del Cristo è nobilissima, imponente e di un disegno che tende all’ideale. La composizione ed espressione delle varie figure è mirabile e l’insieme lascia un po’ a desiderare un effetto più gagliardo. Non così saprei lodare per la composizione e pel disegno rappresen<ta>nte questo che si offre a Dio Padre e gli angioli che recano il simbolo della Redenzione e che scorgesi nella chiesa delle monache della Badia Nuova in Palermo. Meritano lode all’incontro due altri quadri d’altare, quello delle Anime del Purgatorio ove la luce del fuoco è ben riflessata sulle figure ignude che spiccano tra le fiamme e un altro di S. Francesco di Paola. È similmente ammirevole il S. Vincenzo Ferreri che predica e si scorge nella sua chiesa di Carini e quello550 di Gesù Cristo che guarisce un sordomuto e nel Collegio addetto a quegl’infelici in Palermo. La pittura mostra quasi la sordità e la mutolenza di quel giovinetto che già comincia a scioglier la voce e a porgere le orecchie al suono della parola. È pure bello il S. Nicolò di Bari per una chiesa di Palazzo Adriano. Ma più che queste opere è da ammirare il quadro551 della Cena di Gesù Cristo coi due discepoli in Emmaus con figure al naturale che dipinse per il _________________________________ 548 Il Gallo rielabora la scrittura di Giovanni Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura, …, diuiso in sette libri. … In Milano, per Paolo Gottardo Pontio, stampatore regio, a instantia di Pietro Tini, 1585, secondo il quale l’adozione del pittore del lume “naturale”, quello notturno, indebolendosi, sembra «quasi spento». 549 Probabilmente Franz Vervloet, pittore, nato a Mechelen nel 1795 e morto a Venezia nel 1872. 550 Seguono cancellate le parole: “della Vergine a cui si raccomanda devotamente”. 551 Seguono cancellate le parole: “di mezzana grandezza”. 185 Refettorio del Seminario dei PP. Benedettini in Monreale, ove552 è divino per bellezza il volto di Cristo, florido il colorito e insuperabile l’espressione del riconoscimento. Per il consigliere Cafisi di Favara dipinse con figure di circa due palmi con somma cura e diligenza L’Ambasceria dei Siciliani al re Giacomo d’Aragona, chiedendogli di lasciar libera e indipendente al suo fratello Federico la Sicilia essendo a quello spettata per eredità l’Aragona. Il re accoglie di mal animo la domanda e fa scrivere al suo Segretario di Stato la negativa mentre gli ambasciatori accorati ne ascoltano il divieto. In questo quadro dipinse, tra essi, i volti dei suoi amici Gallo e Cutelli. Due ritratti del Patania, uno di Giorgio Matranga e l’altro della duchessa di Brolo furono recati in Roma, meritarono gli encomî del famoso pittore Camuccini, e un altro Ritratto di una signora americana condotto a Nuova Iorch [!] a mezzo all’Esposizione fé ottennere al pittore l’onor di socio di quella Accademia di Belle arti e gli avrebbe attirato il premio come accennò il segretario se fosse stato esposto a quest’oggetto e d’ordine del pittore. Patania valeva sopra tutto pel talento mirabile dell’invenzione, composizione ed espressione. Egli con incredibile prontezza letto o ricevuto il tema sia sacro sia profano o mitologico, ne improvvisava a penna gli schizzi, lavoro che ordinariamente, come diceva, per suo sollazzo eseguiva la sera spesso alla presenza de’ suoi amici e in poche ore era ogni soggetto recato a compimento. Tra le sue carte si trovarono da circa cinquecento schizzi di composizione riguardanti la storia di Sicilia antica e moderna, fra i quali quelli delle rivoluzioni del 1820-48 acquistati in parte dal sig. Agostino Gallo. E qui è da osservare che circa 60 schizzi di argomenti siciliani, essendogli stati rubati da un suo scolare, egli freddamente disse al Gallo che n’era dolente: Ebbene li rifarò migliori, avendo più progredito nell’arte. E li rifece, in effetti, in pochi mesi con nuova composizione e migliori. Tra i primi schizzi eravi la serie di quelli che rappresentavano le varie vicende del bel romanzo francese di Fenelon, Il Telemaco. Questi disegni a penna in mezzo foglio di carta comune furono donati al suo figliastro Giuseppe Bucalo e Patania che, recatosi a Parigi li mostrò al sommo amatore intelligente, signor Antonio Descamps553. Costui in un articolo pubblicato in un giornale di Belle Arti di Parigi del 1846 scrisse del Patania paragonandone la felice invenzione con i migliori pittori allo_________________________________ 552 553 Seguono cancellate le parole: “gareggiano in bellezza”. Antonio Descamps, pittore ritrattista, operante nel XIX secolo. 186 ra viventi nel modo che segue554 qui tradotto dal francese: “Mi è caduta sotto gli occhi una collezione di disegni sul Telemaco, lavoro del signor Giuseppe Patania da Palermo. Al certo se vi ha cosa che possa farci riconciliare con gli artisti italiani di quest’epoca sono appunto questi superbi studj, dai quali esala quasi un profumo della terra di Grecia. Tutta l’antichità pagana coi suoi simboli meravigliosi e la sua brillante mitologia è evocata innanzi allo spettatore. Tutti questi disegni fatti a penna, sembrerebbero eseguiti al tempo dei falsi dei, se non si sentisse, per dir così, il sangue moderno siciliano circolare in queste figure antiche. Ciò avviene perché in effetto la Sicilia un dì abitata dai Greci rappresenta anche oggi tutti i modelli classici, e tutte le attitudini naturali che tanto piacciono al pittore ed allo statuario. Quindi il distinto artista di cui parliamo, è bene avvisato di ritrarre così per analogia la Grecia antica, soltanto osservando i suoi compatriotti di Palermo. Il signor Patania distinguesi soprattutto nel saper rappresentare l’attenzione e la varietà delle attitudini. Non vi ha nulla di più poetico e al tempo stesso più vero delle Ninfe vedute sdrajate intorno a Calipso. Le battaglie son trattate con mano maestra in quest’opera, e fa meraviglia come la stessa matita abbia ritratto così bene delle cose tanto diverse la grazia e la forza. Ciò avviene perché bisogna esser forte per esser grazioso. I disegni di cui parliamo sono 40 e non s’incontra ripetizione in questa lunga serie di soggetti, ove gli stessi personaggi ritornano sovente innanzi ai nostri occhi. Coloro che hanno ben presente allo spirito le opere di Haxaman555 e di Auerberch556 potranno farsi un’idea della maniera dell’artista italiano. Il Sig.r Patania, ch’è dotato di una gran memoria, ha eseguito questi lavori in Palermo, senza quasi sortir mai dalla sua camera. Travagliando tutto il giorno ed in gran parte della sera, egli ci presenta una di quelle imagini di pittori che non si vedono mai in prospetto perché sono piegati sopra le loro opere. Felice privilegio di un arte che comprende al tempo stesso l’invenzione ideale e l’esecuzione materiale, e che permette così di travagliar quasi sempre. La testa si riposa e la mano tuttavia agisce, che va colla mente e col corpo dimora, secondo l’espressione di Dante. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “da noi”. Eugène Haussamann (Parigi 1809-1891), urbanista francese, noto per la sua pianificazione conservativa. 556 Friedrich Overbeck (1799-1869), pittore tedesco orientato prevalentemente allo studio delle opere medievali italiane di carattere religioso. Nel 1810 fonda a Roma il gruppo dei Nazareni. 554 555 187 Questi belli disegni sono stati affidati alla pietà filiale di uno de’ figliuoli dell’autore che coltiva a Parigi l’arte della pittura con un ardore tutta siciliana e con il gusto di un artista riflessivo e studioso.” Antonio Deschamps E questo stesso francese illustre conoscitore pagò un altro tributo di omaggio al Patania nel giornale dell’Illustrazione con un articolo necrologico riproducendone il ritratto da quello che recato avea in Sicilia il di lui figliastro. Altronde se il Patania fu ammirato per i suoi schizzi in Parigi non lo era stato meno da monsieur Chateaubriand per il bel Ritratto di Maria Amalia regina dei Francesi che le fu dipinto quando il duca d’Orleans la sposò a Palermo. Il Patania puossi dire onnigeno pittore. Nella sua giovinezza dipinse anche a miniatura. Indi ad olio, a tempra, a fresco, e quadri557 di figure, di animali, e di paesi. Sono commendati di lui una piccola tela di fiori che invitano ad odorarsi, altro di frutta, altro di pesci, un quarto di uccellame che seducono la gola e son posseduti dal marchese Merlo. Tentò anche con buon successo di pingere a pastello. Il Patania fu d’indole buona e virtuosa. Amava i suoi allievi558 di cui si vide nella sua lunga vita affollato e ad essi era generoso anche di soccorsi quando eran poveri come lo fu a varî artisti mancanti di lavoro nel tempo delle due rivoluzioni. A tutti essi apprestava disegni gratuitamente. Nell’ultimo periodo della sua vita per l’inesprimibile facilità di pennello affrettava559 i suoi lavori dipingendo alla prima e siccome era malsano in salute per una giovanile infermità così credea di dover provvedere alla vecchiaja che lo potesse rendere inabile con far presto a guadagnar denaro. Difatti nonostante un furto commissionatogli di circa 1200 ducati, lasciò alla sua morte agli eredi circa D.ti 18mila ducati. L’ultima sua malattia fu di poche ore. La sera precedente al giorno 23 febbraro 1852 aveva fatto lo schizzo a penna della Presa di Cristo all’Orto mancante soltanto d’una figura accessoria e nel giorno terminato quasi il Ritratto della signora Piraino, meno che le mani. La notte fu assalito da forte dolore alle viscere e indi al petto, ove per il freddo dei gioni precedenti tutto l’aere erpetico che gli era disperso dal braccio sinistro s’era trasfuso. Il giorno appresso alle 2 p.m. non era più. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “di vario genere, cioè di storia”. Seguono cancellate le parole: “e l’educava”. 559 Seguono cancellate le parole: “forse di troppo”. 557 558 188 Conservò fino all’ultimo istante la favella e l’uso dell’intelletto e chiesto da Gallo se lo riconoscesse, gli disse: Oh, non conosco il mio amico di quarant’anni. Costui il confortava e insinuavagli a ricevere i sacramenti. Volentieri, rispose, essendo io buon cristiano, non avendo rimorsi se Dio vuol concedermi l’acetto, se à disposto che io muoja ne son contento. Così spirò il giorno 23 febbraro 1852 placidamente in Dio e fu accompagnato al sepolcro da una immensa turba di artisti e di amici. Notizie della vita pittorica del sig. D. Giuseppe Patania560 Nato nel 1780 a 19 gennaio sul Bastione dello Spasimo, ed in questo luogo561 ove si formano i modelli di figure, e di adorni, che dovevano servire al Carro di Santa Ros<al>ia, il ragazzo Patania si sentiva spinto naturalmente a modellare, e disegnare. Dall’età di anni sette una sua zia, che aveva conoscenza con un modellatore di figure di desar562, lo collocò a scolare presso di questo, ove passò due anni senza che il maestro gli avesse dato delle nozioni, motivo per cui l’istesso maestro, facendosi scrupolo suggerì ai parenti del ragazzo di collocarlo altrove. Il ragazzo Patania levato da questo maestro fu messo nuovamente alla scuola, ed in questo tempo sua nonna, con cui dimorava fu chiesta se proseguiva col suddetto maestro, e quella riferendogli il passato, questi le suggerì di collocarlo in scuola di pittura, e da quel momento andò a studiare presso Velasques, e dopo cinque anni circa, che il ragazzo avea studiato ivi, Patania chiese al suo maestro di voler copiare un’accademia dipinta perché tutti gli altri scolari di minore abilità copiavano siffatti studj dipinti; a questa inchiesta il maestro Velasques lo minacciò colla bacchetta. Da questo momento il ragazzo Patania mortificato di siffatto affronto, determinò di andarsene dal suo maestro, e così praticò.563 Di allora in poi Patania sempre è rimasto solo senza altro maestro, senonché pigliando dei lumi, discorrendo col sig. D. Vincenzo Riolo, _________________________________ Al margine sinistro grafia diversa da quella del Gallo: “inutile, essendo stato il contenuto trascritto nell’altro più lungo e distinto cartolare”. 561 Seguono cancellate le parole: “il ragazzo Patania si sentiva spinto a modellare, a disegnare le opere che si facevano per le feste”. 562 “Dessert”. Cfr. Leonardo Vigo, “Giuseppe Patania”. In: Il vapore. Giornale istruttivo e dilettevole, a. III, v. III, n. 2 (20 gennajo 1836), p. 13. 563 Seguono cancellate le parole: “Per tutte queste circostanze Patania si determinò”. 560 189 che era venuto da Roma, ed allettato di quello nuovo stile procurava imitarlo; in quest’epoca il Patania si esercitava nel dipingere cartelloni per la compagnia comica, dei soldati, masnadieri, turchi, ed altre figure per i maestri di fuochi artificiali. In questo tempo cominciarono a conoscierlo gli ornamentisti, e lo impiegarono a dipingere nelle volte delle camere dei bassirilievi, delle figure colorite, nel grande artifizio di fuoco di S.a Rosalia, e così conoscendolo il pittore scenografico lo volle a dipingere nelle scene, molto più quando si trattava di figure, paese, e fabriche rustiche; in questi lavori consumò sei anni, dove acquistò facilità di lavorare. Per mezzo degli ornamentisti Navarra fece il primo quadretto a secco in una volta della casa del presidente di San Giuseppe, dopo per l’istessi le furono allegati varj lavori nella casa del conte Capace, che dopo aver terminato la prima stanza diede mano alla galleria nella quale si migliorò di molto, quando non avea che fare in questi sudetti lavori dipingea varj quadretti a oglio dando ad un venditore di quadri il quale portava dal Distefano delettantissimo, e le comprava per quadri dipinti da pittore forestiere, che poi sapendo che erano dipinti dal Patania lo commissionava di varii quadretti. 31 anno [!] addietro fu adibito per andare a dipingere una casa, per la parte delle figure564 in Minorea nella città di Maone dove stette un anno, e dopo andò in Napoli dove stied<e> meno di un mese, e se non era per le vertigine politiche andava a vedere Roma, tornò in patria, e dopo varii lavori che fece fu colpito dalla malattia che lo afflisse per un anno, e mezzo. Ristabilito cominciò nuovamente a lavorare dei molti quadri, molti per chiese di provincia, come pure varii quadri per volte per case di Palermo, ritratti, e quadretti pure per Palermo. Ornatissimo signor Zereca Così alla meglio che ho potuto vi servii, anzi accausa [!] ch’io no [!] sto bene in salute l’avevo fatto cominciare da un mio amico, e siccome il detto dovea andarsene di premura, mi sforzai di io continuarlo, e feci quanto legerete. Devo ringraziarvi anticipatamente del favore che mi farete nello scrivere la mia biografia, ma d’altro lato mi dispiace di vedere scatenata la critica, e l’invidia, giaché io non mi credo meritevole di tante cose, che per me si fanno. _________________________________ 564 Seguono cancellate le parole: “in Porto”. 190 Conservatemi la vostra amicizia, e tornandovi a ringraziarvi mi do il bene di dirvi Palermo 18 gennaio 1836 Um.o Servo ed Amico Giuseppe Patania Eccellenza Il cav. Giuseppe Patania da Palermo pittore, ed uno de’ componenti la Commessione di Antichità e Belle Arti, rispettosamente espone all’E.V. quanto segue:565 Fu stabilito dalla detta Commessione di doversi rifare interamente il quadro a mosaico dell’Immacolta Concezione devastato dall’incendio avvenuto nella chiesa di S. Francesco in Palermo, per cui è indispensabile che sia dipinto ad olio che servir deve di modello allo stesso. Or l’esponente è venuto in cognizione che si voglia farlo dipingere da qualche abile artista italiano. Se vivesse il Camancini [!], o il Benvenuti, pittori di fama europea, il commetterne ad uno di essi l’incarico sarebbe plausibile risoluzione, quantunque non lusinghevole pel decoro dell’arte siciliana, ma poicché l’Italia li ha perduto, e la Sicilia mercè il genio del Velasques e del Riolo morti da alquanti anni, ha già una buona scuola di pittura l’affidare il quadro ad un artista italiano, tornerebbe adesso a disonore della nostra natione e a discapito dell’opinione degli artisti siciliani. L’esponente già allievo del Velasques è il più anziano tra costoro. Spiace566gli in quest’occasione di dover parlar di sé e riferir fatti che sembrar potrebbero jattanze567 ma è per d’uopo rammentarli568. Qual che egli, sia si è acquistato in patria e fuori il benigno compatimento del pubblico sin d’allora che eseguì il Ritratto di Maria Amalia indi regina de’ Francesi che fu569 rammentato con onore dal celebre monsieur Chateaubriand. Una sua opera capitata in America fu sì ben ricevuta da attirargli la elezione a socio onorario dell’Accademia di Nuova Yorc [!], e due altre in Roma furon lodate da un Camuccini. Ha avuto anche l’onore essere570 ado_________________________________ Segue cancellata la parola: “Essendosi”. Seguono cancellate le parole: “all’esponente di essere spiato della necessità a dover”. 567 Seguono cancellate le parole: “ed essere ascritti alla doverosa modestia”. 568 Seguono cancellate le parole: “per sostenere di mostrare che gode l’opinione del pubblico”. 569 Segue cancellata la parola: “lodato”. 570 Seguono cancellate le parole: “scelto a pittore di corte dalla nostra R.”. 565 566 191 prato insieme col Velasques e col Riolo dal re Ferdinando I, Francesco e dall’attuale sovrano, per cui ottenne l’Ordine cavalleresco571 di Francesco I. Per572 tali riguardi, e per quello di avere anche573 dipinti i bassi rilievi pe’ funerali di Ferdinando I fatti eseguire dal Senato palermitano, il quale dovrà a proprie spese far eseguire574 pel quadro di cui si tratta, e per essere anche uno de’ componenti la Commissione di Antichità e Belle Arti, crede l’esponente di dovere essere agli altri ottimi artisti siciliani, preferito. E ciò spera della benignità e giustizia dell’E.V. Patania Nel 1845 o poco prima o dopo il Patania ricercava575 nelle sue cartiere gli schizzi a penna ch’egli delineato avea ricavandone i soggetti dall’Iliade di Omero e dall’istoria di Sicilia e non li rinvenne in quella ov’erano stati da lui collocati, e dopo di essersi diffaticato invano restò convinto d’essergli stati rubari. Non eran questi oggetti di poco conto, si perché studiati, ed eseguiti con tutto il foco dell’immaginazione della sua mente576 per l’addietro più fervida, e vigorosa per l’età, sì perché condotti a penna con tutta diligenza, sì perché al numero di circa 60 carte di un mezzo foglio di carta doppia. Pure placidamente mi disse: se mi resta ancor577 vita li rifarrò forse migliori nelle sere invernali come pel passato. Però cadutogli in sospetto per fondati argomenti d’essergli stati sottratti da un suo prediletto scolare che spesso li svolgeva e ch’erasi da lui allontanato, non tralasciò d’interporre la Polizia per ricuperarli; ma divulgatosi il caso tornaron vane le ricerche. Egli si diè subito a riprodurre i principali soggetti, e fornito com’è di memoria mi faceva osservare di aver alcuni migliorato nelle attitudini delle figure e nella composizione, e a me parea per quanto avessi potuto ricordarmi degli antici [!] che ciò era vero ma che578 sebbene più regolari, alcuno perduto avea di fuoco, e di vivacità. Gli dissi una volta, essendo a solo con lui, che il579 suo maestro Giuseppe Velasques era stato da lui superato nella grazia delle teste femminili, ma che _________________________________ Seguono cancellate le parole: “del secondo”. Segue cancellata la parola: “siffatti”. 573 Seguono cancellate le parole: “fatto lavori”. 574 Seguono cancellate le parole: “il nuovo”. 575 Seguono cancellate le parole: “fra’ suoi”. 576 Segue cancellata la parola: “allor”. 577 Segue cancellata la parola: “tempo”. 578 Seguono cancellate le parole: “con la maggior regolarità”. 579 Seguono cancellate le parole: “di lui”. 571 572 192 all’incontro gli fosse superiore nelle teste senili, e principalmente di gran carattere. Egli lodò moltissimo quest’ultimi, e l’eleganza e correzione del disegno in tutte le sue opere, ma si tacque sul riguardo del paragone. Dopo circa un mese mi fé osservare in mezzi fogli di carta doppia varie teste senili e di gran carattere condotte a sfumo di tutto finimento, colle quali intendeva rappresentare altissimi personaggi dell’antichità come Achille, Aiace, Ettore e simili secondo ci sono stati annunziati dall’istoria per le rispettive passioni di cui per vero portavano in volto le caratteristiche ne’ suoi disegni. Questa collezione variata indi per sesso, età, e nazioni, e caratteri fu da lui condotta sino ad un numero di circa 50. 1846. Mi aveva egli una volta confidato di aver cumulato da circa onze ottocento co’ suoi onorati lavori, e di ritenerli per sussidio della sua vecchiaia nel caso che per incomodi in salute non potesse più ritrarre la giornaliera sussistenza dall’arte sua. Io gli feci osservare che essendo egli solo in casa (giacché era morta sua moglie) quel denaro era mal sicuro, e che avrebbe potuto procacciargli qualche sciagura, e gli consigliavo di depositarlo in banco, od impiegarlo in frutti onesti. Mi rispose che si sarebbe più tosto a questo secondo partito; ma che in tanto dubitava per alcuni indizj che tutto o parte gli fosse stato rubato. Certificatevene, gli riposi io e tosto. Al che replicò: non l’ho fatto finora sul dubbio di potermi esser fatale alla salute la certezza. La sera seguente alla presenza di altro suo amico confidente, il sig. Ferdinando Melazzo si riprodusse da lui quel suo dubbio funesto ed entrambi il consigliammo a darsi animo e a verificarlo. Ci mostrò allora due scanzie di libri, una delle quali ci annunziò di aver trovata aperta, si schiusero la porta, si sgombrarono i volumi, e si rinvennero tre o quattro saccetti [!] di meno della serie di quelli che in fila eran dietro collocati. Rispose egli tardamente: meno male che non mi hanno rubbato [!] che da circa onze 300 in questa scanzia. Vediamo l’altra opposta. Si tolsero il libri della scaffa di mezzo da lui indicato [!], e non si trovarono sacchi. Egli disse freddamente: ma questo è troppo, pigliarsi poi tutto. Vediamo, soggiunsi io, se trovansi nella scanzia superiore. Si fece ricerca, e si trovarono i sacchi in fila. Meno male, sclamò il Patania, mi hanno lascaito questi, e gli altri, il ladro è stato discreto. I sospetti cadevano sopra una sua cameriera ch’erasi allontanata in pochi mesi dal suo servizio, e cambiata nuova fortuna. Di fatti fattale dalla Polizia visita domiciliare la trovò bene agitata, e le sorprese un cinto che con moneta d’oro, che in parte era quella che mancava al Patania. Fu posta agli arresti. Nulla confessò, la prova secondo la legge non era sufficiente, dopo qualche mese fu posta in libertà, Patania perdette da circa onze 300 e conservò la sua tranquillità d’animo e il suo buon umore. 193 Patania Giuseppe Patania dopo pochi mesi di esercizio di disegno sotto Giuseppe Velasques desideroso di copiare a olio un di lui bozzetto fu minacciato dal maesto come presuntuoso di colpi di bacchetta; ond’egli piccatosi allontanassi dal suo studio, e cominciò a dipingere da sé. E siccome conosceva egli alcuni pittori del Teatro di S.ta Cecilia580 si offrì a dipinger loro i cartelloni che si581 mettevano in vista del pubblico per582 raffigurare il punto principale dell’azione drammatica che si doveva rappresentare. Questo genere di pittura a guazzo sopra carta richiede la maggior possibile rapidità di pennello, pronta e viva imaginazione per rappresentare con tono il soggetto, e un grand’effetto nell’esecuzione per vie meglio colpire i riguardanti e adescarli al teatro. Nello spazio di metà del giorno il cartellone doveva esser terminato, e affisso al pubblico. Sovente l’azione era composta di tre quattro o sei figure con campi a paese, a stanza, a tempio, etc. Era insomma l’accingersi a questo genere un’improvvisata pittorica. Non studj, non ischizzi preventivi. Il Patania disegnava e coloriva alla prima la sua rappresentazione espostagli a voce, o brevemente in iscritto dal poeta direttor del teatro. In questo violento sforzo del suo genio, il giovinetto pittore mostrossi prodigioso. È stato riferito da testimonio degno di fede che il celebre cavaliere Tommaso Puccini, direttore dell’Imperiale e Regia Pinacoteca di Firenze, soffermatosi una volta a riguardare uno di quei cartelloni volle sapere il nome dell’artista e venuto in cognizione ch’era giovinetto, disse: costui riuscirà un gran pittore. E come egli guardando le opere del Riolo sin d’allora provetto nell’arte, in che erasi perfezionato in Roma sotto il Vicari, si era dato ad imitare il vivace colorito una volta fu creduto da un conoscitore che uno di quei cartelloni fosse dipinto dal Riolo, e gliene fece le sue congratulazioni. Di che questi si offese, rispondendogli bruscamente: io non pingo cartelloni, rivolgetevi a Patania. Egli bensì sin dall’ora presagì di aver in costui un emulo del quale un giorno sarebbe stato oscurato. Nulla di manco in un momento di espansione di cuore disse a me: io invidio a Patania il modo di sfilare e ondeggiare i capelli, e la barba, la grazia delle bocche, e quell’umido che traspare negli occhi delle sue figure. Molte volte furono messi in competenza, fra le altre quando dipinseo insieme i gran bassi rilievi in chiaro-scuro pe’ funerali fatti nella Cattedrale di Palermo al re Ferdinando I dal Senato di Palermo. Toccò a Patania di effigiare in molte figure l’incontro di quel sovrano negli Elisi con Carlo 3°, e gli _________________________________ Ubicato nell’omonima piazza. Cfr. Antonella Mazzamuto, Teatri di Sicilia, cit., p. 83. Segue cancellata la parola: “presentavano”. 582 Seguono cancellate le parole: “per mostrare dell’”. 580 581 194 altri suoi maggiori secondo il tema da me datogli. In questo lavoro portossi egregiamente talché recatasi la tela dipinta per attaccarsi al mausoleo insieme con quella di Riolo, tutti corsero ad ammirare l’opera del Patania per modo che l’altro accortosi della poca attenzione che facevasi alla sua, la tolse via di mezzo per allora onde sfuggir il paragone. Il Senato poi spinto dalle lodi del pubblico la volle conservare nel Palazzo della città, e retribuì al pittore onze 10 di più della somma convenuta. Questa tela fu destrutta dopo molti anni nell’occorrenza de’ ripari fatti in quel Palazzo. Similmente venne il Patania in concorrenza col Riolo e col Patricolo nel Regio Palazzo di Palermo, ove nella volta della gran galleria fu destinato a ciascuno di essi un gran quadro furono da tutti e tre gli artisti inviati pria i bozzetti in Napoli al marchese D. Giuseppe Ruffo direttore della Real Segreteria di Casa Reale. Costui mostrogli a’ migliori artisti di quella città, e agli stranieri che vi si trovavano e secondo egli mi disse fu giudicato infinitamente miglore quello di Patania, e così in effetto riuscì il quadro. Quel bozzetto il conservava egli nelle sue stanze come lavoro prezioso. S.A.R. il principe D. Leopoldo Borbone nel tempo della sua luogotenenza in Sicilia gli avea commesso una gran tela rappresentante Armida e Rinaldo voluttuosamente abbracciati. Di questo quadro egli era sì pienamente soddisfatto che recatolo in Napoli ed essendosi bruciato con altri oggetti del suo appartamento, mi disse nel 1843 che principalmente dolendogli della perdita di quell’opera egregia. Al che io risposi: Altezza, Patania è vivo, potrebbe averla adesso, anche migliore, poiché egli sempre più progredisce nell’arte. E bene, replicò, dopo che sarà rassetato il mio palazzo penserò a’ quadri. Il Patania dicevami un giorno, ch’ora dava trasparenza, e dolcezza agli scuri de’ suoi quadri, mischiando al nero l’oltremare e che ciò gli era stato suggerito da un buon paesista romano. Patania Giuseppe Patania da Palermo ritrasse [della pit]tura il genio dell’arte pittorica, e ne [trattò] bene tutti i generi. Cominciò da ragazzo a dipinger a guazzo583 cartelloni da teatro, e fé t[utti] presagire, comecché fosse scor_________________________________ 583 Tecnica pittorica realizzata mediante colori stemperati con colla e gomma diluiti in acqua, come afferma Filippo Baldinucci, Vocabolario toscano dell’arte del disegno nel quale si esplicano i propri termini e voci, non solo della pittura, scultura, & architettura; ma ancora di altre arti a quelle subordinate, e che abbiano per fondamento il disegno ... In Firenze, per Santi Franchi al segno della Passione, 1681. Spesso si identifica con la pittura a tempera. 195 retto nel disegno, con l’originalità della invenzione, con le gagliarde movenze, e adatta attitudini e l’espressione, e al franco maneggio del pennello co’ colori sciolti in acqua, e colla che sarebbe divenuto un grande artista. Servì indi di ajuto agli ornamentisti di storie nelle figure dipinte a calce, e vi riuscì. Tentò allo stesso tempo dipingendo a olio d’imitare l’antico e ingannò spesso con le sue tele il signor Giambattista di Stefano saputo il miglior conoscitor de’ suoi tempi, il quale convinto poscia dell’inganno diessi generosamente a proteggere chi lo aveva illuso co’ quadri che gli aveva venduto e gliene commesse degli584altri. Vide in seguito alcuni paesi del Pequignon posseduti dal principe di Belmonte, e ricavando de’ bei punti campestri da’ dintorni di Palermo dipinse in quel genere con tal verità e grazia di colori, sp[…]deggiando gli altri, e smaltando di verzura e di fiori il terreno con tal bravura, che fu detto dagl’intendenti che il suo genere favorito era il paese. E questa opinione conservò molti anni essendo riputato di molto superiore non che a Velasques che poco vi si era esercitato, ma a Riolo che con lui spesso gareggiò. Non avea mai dipinto a fresco finallora e volle farne esperimento nel refettorio del Seminario dei Chierici in Palermo e vi riuscì nella Cena di Emmaus. Non avea neppure dipinto a miniatura e tuttavia con molta grazia, e do[…] il ritratto d’un fanciullo, e una donna ignuda strajata, dipinta sopra carta ch’io possiedo ed è bellissimo tuttoché non finita. Gli giungeva nuovo il gener di fiori, frutta, uccelli, e pesci e ne dipinse quattro quadri sul vero, per il marchese Merlo, indi per l’avvocato Franco che parvero meravigliosi. Non conoscea il metodo di dipingerer a secco sul muro, e condusse in tal guisa con felice successo tre gran quadri nella volta della galleria del palazzo del principe di Belmonte in Palermo ora posseduto dal barone Riso, e indi i piccoli quadri in quella del duca di Serradifalco; anzi da sé per la migliore unione delle mezzetinte co’ chiari, e gli oscuri di tratteggiarli a traverso con una tinta più calda generale che avesse ad unirli e dargli maggiore armonia. Si era intanto molto esercitato con quadri ad olio d’istoria e, all’occasione dipingeva anche ad olio il ritratto, e fu osservato che nessun altro de’ pittori provetti sapea colpir si bene la somiglianza all’originale, e condurlo con franchezza e armonia e gusto di colori. Fu detto allora quel [che] si disse per la sua bravura nel paese. E diffuse la fama ch’egli era il miglior ritrattista; giacché quelli di Riolo mancavano spesso nella somiglianza dipinse migliaia di ritratti. Tutte _________________________________ 584 Jean Pierre Pequinot, paesaggista e pittore di genere, nato a Beaume-les-Dames (Doubs) nel 1765, morto a Napoli nel 1807. 196 le belle donne domandavano il proprio ritratto a Patania, che sapea con grand’arte conservar loro la bellezza, e coprire a molte le ingiurie degli anni. Dotato di felice immaginazione, e ritentiva tanto talvolta pel bisogno di far ritratti a memoria. Un suo amico gli richiese quello d’una sua amante. La vide tre volte, e ne impresse l’immagine sulla tela senza la di lei presenza. Similmente pel padre del barone di Stefano che negossi al figlio di prestarsi ad esser ritratto sul pregiudizio di mal augurio di vicina morte. Del pari pel ritratto dell’abate Filingeri suo amico che morto improvvisamente volle averne per sé l’imagine. Per quello di mia madre gli bastarono poche linee che ne trasse il Di Giovanni per darmene il ritratto a olio somigliantissimo, e quanto il vero. Agostino Gallo Riverit. P. Arciprete Dal Padre D. Francesco Tresca per una sua lettera intesi che passata la vernice al quadro di S. Rosalia fino alle ore 20 fa buono effetto, ma scorsi diviene tutto lucido. Io a ciò fo’ riflettere a V.R.a che questa lucidezza proviene dal cambiamento della luce, poiché è solito che fino ad una certa ora il quadro riflette tutta la sua bontà, ma poscia va cambiando come va a tramontare il sole. La vernice si passa per la conservazione della pittura allorquando si trova disseccata come fanno tutti, ed hanno fatto tutti i pittori del mondo, e sulle prime, cioè quando è stata passata per lo più fà l’effetto di luccicare, ma scorso alquanto tempo questo lucido si và a mitigare, ed il quadro ritorna ad esser più bello di prima. Vi posso ancora sommettere che io ho spedito questa vernice585 per far figurare la mia opera, contentandomi anche del dispendio, e ciò pel buon’essere del quadro. Mi auguro che di ciò mi restiate convinto non solo voi, ma tutte quelle persone che sono persuasi così malamente, a cui vi prego di comunicare le ragioni sopra esposte, ed ossequiandovi mi dico.586 Riveritis.o S.r Arciprete Per una lettera del signor D. Francesco Tresca intesi che passata la verrnice al quadro di S. Rosalia fà sino alle ore 20 buono effetto, ma dopo diviene tutto lucido; io vi posso dire che è una coglioneria di ritenere ciò, _________________________________ Seguono cancellate le parole: “piuttosto per riportarne il quadro”. Nota a matita di mano di A. Gallo: “Bozza di lettera del pittore Giuseppe Patania al p. arciprete di Montevago”. 585 586 197 mentre è solito che girando il sole produrre tale effetto, e precisamente quando il sole guarda direttamente il quadro, quindi serenatevi una volta, e per sempre, e non stiate a credere tante chiachere, e mi auguro che ne restiate convinto non solo voi stesso, ma pure tutto il Comune. Vi ossequio, rispettando tuttoi gli amici, sono Palermo 16 aprile 1847 Di Voi S.r Arciprete di Montevago Vostro Servo Elenco delle opere eseguite dal cav. Giuseppe Patania Quadri presso il principe di S. Giuseppe. Altri nelle volte della casadel conte Capaci. Volta nella casa del magistrato Atanasio. Nell’anno 1811 Un leone giacente, dipinto ad olio per insegna della bottega di d. Giovanni Lenzitti. Un quadro ad olio denotante S. Antonio Abbate, per la chiesa di S. Biagio vicino porta di S. Agata. Un picciolo quadro per la volta dell’istessa chiesa. Quadri a tempra rappresentanti i Miracoli del Beato Tommasi, fatti per la beatificazione del medesimo. Opere eseguite dal cav. Giuseppe Patania Ritratti Merlo – Melazzo - Cutò - Montevago - Campobello – Castrofilippo – Montalto – Butera – Perricone – Medina. Ritratto del Borrelli e di Epicarmo per D. Agostino Gallo. Sopraporte da Castrofilippo Adone, e Venere nella volta, ivi. 198 Quadri ad olio per chiesa S. Spiridione, e S. Filippo Neri per la Piana dei Greci. Battesimo di Gesù Cristo e Gesù Cristo coi discepoli in Emmaus, quadro a tempera per la chiesa dei Greci in Palermo. La fucina di Vulcano pel barone Catania di Mistretta. Quadro picciolo denotante Leda con due suoi figli Castore, e Polluce per il signor Guglielmo Bechi da Napoli. Quadretto di Fiori per lo stesso. Giove e Leda, e Giove e Danae per lo architetto Raineri. Il Salvadore per Padre Sgarlata. La Beata Vergine della Purità per Padre Giglio. La Beata Vergine col Bambino e S. Giovanni per D. Giuseppe Cantoni. La Beata Vergine col Bambino pel Padre Palermo di Alcamo. Tre poeti per l’inglese M.r Grimsham [!]. La morte di Saffo colla veduta del promontorio Leucadio per Padre Palermo di Alcamo. Gesù Cristo crocifisso, S. Francesco e S. Chiara, quadro grande per S. Stefano di Camastra. Ritratto al vero del giureconsulto D. Antonino Torretta. Gesù Cristo, la Beata Vergine e S. Giovanni Evangelista nella volta della parrocchia dei Greci a Palermo Ritratto di monsignor Chiarchiara vescovo greco. Altro del prete greco Ferrara. Altro del Padre Giglio Paulotto. Altro del prete Vico. Angelica che medica la piaga a Medoro per Fagiani, ligatore di libri. Atala spirante in braccio al suo amante, per lo stesso. Questo quadro alla morte del Fagiani fu riacquistato dal Patania. La nascita di Gesù Cristo per lo stesso Fagiani. Il riposo in Egitto. Un paese. Il ritratto del menzionato Fagiani. Ritratto del dottor Don Salesio Emmanuele. Detto della baronessa Martines. Detto del barone Martines. Altro del marchese Drago. Altro del canonico Cirino. Altro dell’inglese mister Grimsham [!]. 199 Altro del cav. Lucchesi col flauto Ritratto di S.M. Ferdinando II all’impiedi pel Monte. Detto per il Lotto a mezza figura. Idem per l’Università di Palermo. Altro per la Direzione dei Ponti, e Strade. Detto di S.A.R. D. Leopoldo. Ritratto di [Tommaso] Gargallo per Gallo. Ritratto di [Vincenzo] Bellini per Gallo. Detto per Santocanale. Detto per Catania. Detto per [Tommaso] Aloisio [Juvara] di Messina. Elenco delle opere pittoriche eseguite da Giuseppe Patania nell’anno 1832 Ritratto di Gian Alfonso Borrelli. Altro del dottor D. Salesio Emmanuele. Altro del barone Martines. Altro dell’inglese Grimsham [!]. Altro in mezza figura del cav.e Lucchesi col flauto in mano. Altro mezzano di un gentiluomo di Terranova. Altro di monsignor Chiarchiara. Altro del Padre Giglio. Altro del defunto marchese Sessa. Altro, a mezza figura, dell’abate Cirino. Altro del marchese Drago. Altro del re all’impiedi, nel Monte grande di Pietà. Altro ritratto a mezza figura per l’officina del Lotto. Altro, come sopra, per l’Università degli Studî. Altro, come sopra, per la Sopraintendenza delle Strade, e Ponti. Altro, come sopra, per la Real Segreteria. Ritratto di S.A.R. il conte di Siracusa per la Real Segreteria. Altro per la Sopraintendenza delle Strade, e delle Foreste. Ritratto del professore di musica Vincenzo Bellini, sull’originale, per la collezione del signor D. Agostino Gallo. Copia dello stesso per D. Filippo Santocanale. Altro per la famiglia del Bellini di Catania. Ritratto della signora Carlotta Vico per Aci-Reale. 200 Elenco delle opere pittoriche eseguite dal cav. Giuseppe Patania nell’anno 1835 Un quadro grande per l’Albergo di Monreale, rappresentante La Pietà. Altro per la chiesa del Collegio di S. Maria del Gisino [!] che rappresenta L’Immacolata. Altro per il monastero di S. Vincenzo Ferreri in Carini, che indica la Crocifissione di Gesù Cristo. Altro piccolo per Aci-reale dell’istesso soggetto. Altro che contiene il solo Crocifisso per il signor D. G. Cutelli. Quattro sopraporte sull’istoria romana per il signor conte Si Stefano di S. Ninfa. Un quadro per la Piana [dei Greci] nel quale scorgesi effigiato, a mezza figura, [il] Beato Sebastiano Valfrè. Un picciol quadro la di cui composizione è ricavata dal romanzo, La monaca di Monza. Un quadro per il Monte Erice ov’è dipinto il Cuore di Gesù più piccolo del naturale. Un S. Crisostomo, secondo il naturale, per il Palazzo Adriano. Una Madonna a mezza figura per il Comune di Sciacca. Un Cuore di Maria per detta città. Il Ritratto del signor [Giuseppe] Borghi. Altro di una signora romana. Quello del dottor D. Benedetto Morici. Quello del principe di Leonforte. Un altro di una signora di cognome Cannone. Due ritratti per due inglesi-americani, uno uomo, e l’altro donna. Un ritratto dell’attuale regnante Ferdinando II a mezza figura per Caltanissetta. Altro anche a mezza figura del sig. barone Salvatore Cutelli. Altro del marchese Villalba. Un quadro di S. Vincenzo di Paola, a mezza figura, per il sacerdote sig. D. Giovanni Cirino. Un ritratto, a mezza figura, del signor Bruno, confettiere. Nell’anno 1836 Un ritratto a mezza figura della figlia della principessa di San Cataldo. 201 Un ritratto sulla maschera del birraio Manzella. Una replica del Ritratto di Bellini per l’incisore sig. [Tommaso] Aloisio [Juvara]. Un picciolo quadro indicante la Madonna Addolorata. Due Amorini che si lottano per una palma, piccolo quadretto per la signora principessa di Montevago. Un bozzetto d’Ifigenia. Altro per un quadro di altare il di cui soggetto è Santo Nicolò di Bari, per il signor Sergio. Un ritratto a mezza figura dell’inglese signor Valentine. Ritratto del presidente Cannizzaro a mezza figura sulla maschera. Altro, di mezza figura, di D. Graziano Cirino. Altro, anche a mezza figura, della baronessa Mortellara. Altro, nell’istessa posa, del figliulo d’Urso. Altro ritratto sino al ginocchio del ministro Averna. Un quadretto di palmi tre che rappresenta il Ratto di Proserpina per S.E. il P. D. Corrado Ventimiglia. Un ritratto, a mezza figura, di un barone ***. Altro, a mezza figura, della signora Urso. Altro della principessa Lanza. Altro, a mezza figura, della principessa Belvich. Altro piccolo della medesima. Ritratto della signora Cloos in maschera a mezza figura. Ritratto intero del contino Bellavia. Altro, come sopra, del figlio di D. Luigi Sergio. Ritratto della Signora Valentine. Altro, a mezza figura, della signora Lucchese. Ritratto, per intero, del dottor Surretta. Altro, a miniatura, della marchesa Spitalotto. Ritratto, a mezza figura, del dottor Antonio Urso. Ritratto del ministro Fardella, sino a ginocchio, per Trapani. Altro del detto, per il signor duca di Cumia. Copia del ritratto della fu principessa di Butera, a mezza figura per l’avvocato Franco. Un ritratto, sino al ginocchio, della principessa di Resuttana. Un quadro per altare, di grandezza palmi 11 per 7 denotante S. Nicolò di Bari, che patrocina tre individui creduti rei di delitto capitale, dinanzi all’imperadore Costantino. Il detto quadro è per commissione del barone Sergio di S. Stefano di Camastra. 202 Nell’anno 1837587 Ritratto, a mezza figura, della marchesina Gregorio. Altro, come sopra, dell’avvocato Tumminelli. Altro del beato Giuliano Majali, per Gallo. Altro di Guido delle Colonne, per detto Sig.r Gallo. Gran quadro rappresentante il Sacrificio d’Ifigenia. Ritratto, al naturale, del giureconsulto Torretta, sedente. Altro, mezza figura, della marchesa di Serradifalco. Altro di D. Ignazio Serretta. Nell’anno 1838 Ritratto, quasi intero, del signor D. Gaetan Fiamingo. Altro, a mezza figura, del Pres.e Costantino. Altro, come sopra, del duca di Serradifalco. Altro del marchese Rudinì. Replica del ritratto dell’abate Nascè, a mezza figura, per D. Gaetano Fiamingo. Un ritratto a memoria del signor Di Stefano di Santa Ninfa, a mezza figura. Replica del ritratto del marchese Rudinì, a mezza figura. Un picciol quadro pel barone Seggio [!], ov’è rappresentata la Vergine con Santa Rosalia, e S. Stefano con un angiolo che discacciò il mostro cholera. Replica del ritratto di Serradifalco. Ritratto, a mezza figura, del marchese Spitalotto. Ritratto, sulla maschera, della signora Emmanuella Violante, per il di lei sposo signor D. Calogero Violante. Replica per uso della signora D. Rosalia Tedeschi, di lei sorella. Ritratto del duca di Cumia e della fu duchessa, sino a ginocchio, per Regalbuto. _________________________________ 587 Cassato e perimetrato da quattro linee: “Copia del ritratto a mezza figura della fu principessa di Butera per il Sig.r Avvocato Franco. Ritratto sino al ginocchio del ministro Fardella per Trapani. Altro del detto ministro, più piccolo del naturale per il signor duca di Cumia. Un quadro per altare di grandezza palmi 11 per 7 che denota S. Nicolò di Bari, che patrocina dinanzi all’imperatore Costantino tre individui creduti rei di delitti capitali. Questo quadro fu eseguito per S. Stefano di Camastra per commissione del signor D. Luigi Sergio. Ed un ritratto a mezza figura della fu signora pricipessa di Resuttano.” 203 Uno piccolo della fu duchessa, a mezza figura, per la famiglia. Un quadro di pal. 11 per 8.8 per il paese di S. Mauro, rappresentante il S. Francesco di Paola nell’atto che restituisce in vita un suo nipote commissionato dal signor dottor D. Francesco Franco. Ritratto della nostra sovrana per il Magistrato supremo di salute. Ritratto di S.M., a mezza figura, per Aci reale. Ritratto, a mezza figura, del signor Nicolò Palmeri. Altro, come sopra, per l’architetto Di Martino, entrambi per il signor D. Agostino Gallo. Una mezza figura denotante la Gioventù, per il Dottor Franco. Due ritratti, a mezza figura, in una tela <raffigurante> Il padre ed una bambina per Antonio Vaccaro. Ritratto, a mezza figura, di D. Salvadore Biondi. Ritratto del fu ciantro Bacile di Caltanissetta, mezza figura con le mani. Una Madonna col bambino, al naturale, per l’avvocato Franco. Ritratto, per intiero, della fu duchessa di S. Martino. Un ritratto, a mezza figura, del medico D. Mariano Dominici. Altro, come sopra, della principessa Giardinelli. Idem, di monsignor Balsamo. Ritratto, a mezza figura, della fu duchessa di S. Martino, per il signor Franco. Ritratto di una signora, a mezza figura ed a memoria. Un quadro di pal. 6 per 5.4 eseguito per il signor Franco, rappresentante Lucrezia e Sesto Tarquinio. Un ritratto, a mezza figura, del giudice di Navarra. Ritratti, a mezza figura, della fu principessa e principe di Torremuzza. Ritratto, sulla miniatura, a mezza figura, della fu principessa di Altofonte. Altro, a mezza figura, della moglie di D. Salvatore Biundo. Copia del ritratto della fu principessa di Torremuzza per il di lei fratello marchese San Giacinto. Ritratto, a mezza figura, del prete regolare *** Cirino, per suo fratello. Altro, come sopra, del P. Preposito dell’Oratorio della Piana. Altro, con mani, della moglie del dottor Erech, inglese. Altro, su contorno, del pittore Francesco Zerilli, a mezza filigrana, pel signor D. Agostino Gallo. Due ritratti, a mezza figura, del fu D. Giacinto Astorina per D. Isidoro Testaferrata. Ritratto, come sopra, della signora Cirino per suo figlio beneficiale. Ritratto, senza mani, del cav. Galletti, figlio della principessa San Cataldo. 204 Nell’anno 1839 Un quadro alto pal. 18 per pal. 10.7 per la chiesa dell’abadia di S. Gaetano in Monreale, rappresentante il detto Santo che dà il pane agli affamati. Un ritratto, con una mano, di fanciullo, figlio del valente chimico fu Furitano. Ritratto della regina con mani, per il Palazzo reale. Un picciol quadro per i Padri Capuccini di S. Francesco d’Assisi, sul concetto del Domenichino. Un piccolo ritratto del duca di Serradifalco. Un ritratto, sino al ginocchio, di Maria Carolina principessa per la R. Segreteria. Un ritratto di D. Fania Sancataldo, con le mani. Un ritratto piccolo, ed intiero, del cav. Di Stefano con una giumenta per il paese di Santa Ninfa. Ritratto, con le mani, del trafficante Gud588 Inglese. Ritratti di due inglesi. Un ritratto della figlia del sopradetto Gud. Un ritratto intero di Ferdinando II per l’Albergo di Monreale. Altro, a mezza figura, del marchese Nunziante. Una replica di uno dei ritratti de’ due inglesi sopra cennati. Quadro di Maria Addolorata con le mani, per il signor D. Giambattista Cutelli. Ritratto a mezza figura della principessa di Fitalia in età giovanile, ricavato da una miniatura. Altro, sino a ginocchio, sulla maschera, della fu M. Altavilla per suo marito, il signor tenente Longo. Ed uno, sino a petto, per il signor avvocato Franco. Un quadro della Madonna Addolorata, con mani, per Mistretta. Altro del signor Gud per il signor D. Gaetano Fiamingo. Un ritratto, a mezza figura, di S. E. il principe di Campofranco per S.A.R. la duchessa di Bari. Un quadro di pal. 12 per 8 denotante la Madonna del cholera con S. Stefano, S. Rosalia ed un cherubino che discaccia il mostro, per il signor D. Luigi Sergio, da collocarsi in Santo Stefano di Camastra. Un ritratto, a mezza figura, del Prefetto di polizia. _________________________________ 588 Presumibilmente George Wood. 205 Un ritratto, come sopra, di un inglese. Un quadro a guazzo di pal. 5 circa, dove si esprime l’Amore, per il signor Tasca. Un ritratto, a mezza figura, sulla maschera, del duca di Castrofilippo. Una grande parte di un freggio esprimente una Allegoria degli sponsali antichi, cioè per via di Genietti. Il freggio è di pal. 1.1. di altezza e pal. 18.6 per la stanza di dormire del signor Tasca. Nell’anno 1840 Continuazione del sopradetto freggio del barone Tasca. Un picciolo ritratto di un inglese. Ritratto a mezza figura del capitano di marina Vincenzo Di Bartolo. Altro, con una mano, del signor P. Giardinelli. Ritratto di un Inglese americano Lorenz, a mezza gamba, per Nuova Iorck [!]. Tela di pal. 2.9 p. 2 del Crocifisso per D. Gerardo Volpe. Ritratto a mezza gamba del fu signor Tasca. Un quadro di p. 2.6 p. 2 rappresentante uno dei martirj di S. Filomena per Regalbuto. Un Gesù in mezzo ai misteri della Passione, per il padre regente Giglio. Quadro di palmi 2.6 p. 2 rappresentante Maria con Gesù, e S. Giovanni per il barone Mendola di Favara. Due ritratti, a mezza figura, dei marchesi Cafis<i> di Favara, uno del padre, eseguito a memoria, e l’altro del figlio, sul vivo. Un ritratto, al ginocchio, del Procuratore generale Carbonaro di Catania. Una Madonna Addolorata in un tela di pal. 8.6 per 2, per il sudetto marchese di Favara. Una replica del ritratto del P. Giardinelli, per il marchese Rudinì. Altra, a mezza figura, del ritratto dell principessa ***. Un ritratto di un ragazzino con una mano; egli è figlio di contadini. Un ritratto, a mezza gamba, del vescovo di Mazara, monsignor S<c>alabrini, per la Collegiata di Alcamo. Altro, con mezza mano, della sorella del dottor Franco, vestita da educanda. Altro della duchessa di Caccamo, a mezza figura, eseguito a memoria. 206 Questo ritrato, eseguito nel 1830, fu compito nella vestimenta, l’anno 1840. Altro, sino al ginocchio, della fu duchessa di Sperlinga. Una copia del ritratto a mezza figura del fu duca di Santo Stefano. Un quadro di pal. 2 per 2.6 rappresentante S. Giuseppe che mostra un cardellino al Bambino Gesù, per il marchese Cafisi di Favara. Una replica del quadro eseguito per il barone Mendola, della Madonna con il Bambino, e S. Giovanni per589 l’avvocato Agnetta. Un ritratto, sino a mezza gamba, del barone Pastore. Altro del cavaliere Vanni. Altro della moglie del detto Vanni. Un quadro di S. Francesco di Sales, in una tela di pal. 4.6 <e> p. 3.6 per il barone Pastore. Un ritratto a mezza figura del nipote dell’abate Cirino. Altro per sua moglie. Una mezza figura ritrattesca per l’avvocato Franco. Nell’anno 1841 Un ritratto, sino a mezza gamba, della duchessa S. Rosalia, moglie del signor Ingam. Altro, sino al ginocchio, di mister Giuseppe ***, nipote del dottor Ingam. Ritratto del negoziante Ingam, sino a mezza gamba. Un ritratto di Giovannino Villa, intiero, secondo il naturale, che scherza con un pecorello. Un quadro di caccia per Francesco Franco. Un quadro di pal. 4.6 per 4 esprimente Erminia che trova i pastori, per il marchese Cafisi di Favara. Un ritratto, a mezza figura, della figlia del marchese Spedalotto. Quadro di pal. 4.6 per 4 esprimente il Templario che vuole rapire Rebbecca, soggetto preso dell’Ivanoe di Valter Scot [!], per il marchese Cafisi. Un ritratto, a mezza gamba, del barone Bordonaro. Replica del medeimo, sino al ginocchio. Ritratto della sorella di D. Luigi Scalia, sino al cinto con una mano. _________________________________ 589 Seguono cancellate le parole: “il marchese”. 207 Un quadretto di cinque putti che con festoni di fiori girano attorno un’ara da servire per portello di camino per il principe di Montevago. Due quadri di pal. 4.6 per il marchese Cafisi da Favara, denotante uno D. Abondio che viene abbordato dai Bravi, soggetto cavato dai Promessi Sposi del Manzoni, l’altro esprimente una nostra Bettola. Ritratto a mezza figura, con mano, della sorella del dottor Franco. Un quadro dell’Immacolata con varî putti, alto pal. 10 per 6, per il signor D. Lucio Tasca. Altro di una Madonna Addolorata con due putti. Ed una testa di Addolorata per capezzale. Un quadro di pal. 5.4 per 4.6 esprimente Venere che esce dal bagno, per l’avvocato Franco. Un ritratto dell’abate Scinà, in mezza figura, pel signor D. Agostino Gallo. Numero due quadretti di pal. 2.6 per 2 per il contino Tasca. Nell’anno 1842 Un quadretto di palmi 2 per 2.6. esprimente L’Assunzione di Maria Vergine con tre putti per il canonico D. Leonardo Palermo d’Alcamo. Un Ritratto, a mezza figura, del fu D. Fedele Barbalunga. Un ritratto del re Ferdinando II, a mezza figura, per il principe Scilla. Un quadro di palmi 7.4. per 5.3 denotante Il Ritorno da caccia, sullo stile del 500 per il barone D. Francesco Battifora. Un quadro di palmi 8 per 5 circa, rappresentante S. Antonio abate, per Capizzi. Un ritratto di un inglese , a mezza figura, per mister Vood [!]. Replica dello stesso. Un quadro di palmi 8 per palmi 11.8 denotante il Martirio di S. Bartolomeo per la chiesa di questo santo in Randazzo. Un ritratto, a mezza figura, dell’abate D. Nicolò Buscemi. Altro, come sopra, del fù abate Cirino. Altro del fu astronomo [Nicolò] Cacciatore. Altro picciolo del fù D. Ignazio Sanfilippo. Un picciolo quadro denotante Il Tempo che fa conoscere alla Bellezza il suo impero, per il signor Agostino Gallo. Un ritratto della signora Di Bartolo. Un quadro di palmi 8 per palmi 11.8 denota S. Benedetto che risuscita un bambino per la chiesa di questo santo in Randazzo. 208 Altro di palmi 8 per *** denotante la Triade SS. per Calatafimi. Ritratto del marchese della Favara all’impiedi per la sala dei Luogotenenti. N. 6 piccoli paesi. Un ritratto a mezza figura del fu d. Ignazio Sanfilippo per D. Agostino Gallo. Nell’anno 1843 Un picciol quadro sulla tavola rappresenta Le tre Marie ai piedi della Croce per ***. Un ritratto a mezza figura della baronessa Mortellaro. N. 4 quadretti che raffigurano, in mezza figura, quattro illustri siciliani: Empedocle, Archimede, Gaggini e il Novelli per il confettiere Rolleri. Un ritratto a mezza figura del barone Mortellaro. Un ritratto di un ragazzino espresso da S. Giovanni Battista. N. 2 ritratti, uno di donna e l’altro di uomo a mezza figura per D. Mariano, e D. Leonardo Gambino d’Aci [Reale]. Due quadri di palmi 6 per 4 circa esprimenti uno S. Pietro che al canto del gallo si accorge di avere negato il suo divino Maestro, l’altro S. Stefano che porta nella sinistra man il suo martirio, e nella destra il Vangelo, entrambi per Calatafimi. Un ritratto sul dagherotino590 del celebre musicista di musica Paccini [!]. Due ritratti a mezza figura delle sorelle del canonico Cirino. Un’Immacolata con mani per il detto canonico. Un paesetto che esprime quanto scrive il Petrarca nella sua Canzone, Chiare, fresche etc. per D. Agostino Gallo. Un quadro di palmi 5.8. per palmi 4 esprime Maria col Bambino che porta in mano una picciola croce con vari serafini nel campo, per Aci Reale. Un ritratto a mezza figura del dottor D. Diego Orlando. Un quadro di palmi 9 circa per palmi 4 rappresentante una Madonna addolorata con mani, commissionata dall’architetto D. Giuseppe Patti. Una picciola Addolorata con mani per un nepote dell’autore. _________________________________ 590 Processo fotografico ideato, nel 1838, dal francese Louis-Jacques-Mandé Daguerre, pittore, scenografo francese (1789-1851). 209 Altra pel padre reggente Giglio. Un picciolo quadro esprimente due Amorini che lottano per una palma, per D. Simone Gramaglia. Un ritratto della fù moglie di D. Mariano Leonardi Gambino d’Aci. Un picciolo ritratto del signor D. Agostino Gallo. Altro di Amore e Psiche sull’idea del Corregio per il detto signor Gallo. Un ritratto della duchessa Brolo sino a ginocchio, per suo fratello, il prelato Grassellini. Un ritratto con una mano del duca di Caccamo. Altro con mani della moglie di D. Gaetano Fiamingo. Una replica del Ritratto a mezza figura del padre del canonico Cirino. Ritratto a mezza figura della moglie del capitano di marina Di Bartolo e sorella del signor Bracci. Un quadro di palmi 10 circa per 9 rappresentante i Discepoli in Emmaus per il Refettorio del Seminario di Monreale. Un ritratto con una mano del fù figlio di Cusimano. Altro a mezza figura del pittore Vandik. Altro con una mano di Correggio per D. Giuseppe Cantone. Altro con una mano del duca di Caccamo vestito da gentiluomo di Caccamo per la Compagnia dei Pescatori di Termini. Un quadro di palmi 7 per 13 circa denotante S. Benedetto che dà la Regola a S. Scolastica per Aci. Un quadro di palmi 4 per 3 rappresentante Maria con Gesù che lo carezza ed ella rivolta al cielo versa delle lagrime, a commissione dell’avvocato Franco. Nell’anno 1844 Un quadro di palmi 12 per 8 circa esprimente Gesù Cristi no[!] in atto di esser legato alla colonna per venir fragellato, per la chiesa detta la Maggione. Un ritratto con una mano sopra miniatura del fù Pignatelli Farina. Altro, come sopra, di un americano. Altro a mezza figura del fratello del canonico Cirino. Una replica del ritratto di [Vincenzo] Bellini per il signor Florio da Catania. Un ritratto con le mani di un americano. Un picciol quadro denotante Il Riposo in Egitto, per il barone D. 210 Francesco Battifora. Un ritratto con le mani del figlio del principe Scilla. Altro con le mani di una ragazzina, sulla maschera. Un Ecce Uomo [!] con mani, al naturale, per D. Giovanni Battista Cutelli. Un picciol quadro che esprime Polifemo ubbriaco per l’artista [Nunzio] Morello. Un ritratto con le mani del canonico D. Giovanni Cirino. Altro a mezza figura del giudice D. Francesco Prato. Altro come sopra del cognato del sudetto Cirino. Un bozzettino per il signor Panebianco591 denotante Amore che vuol provare il suo arco scagliando un dardo ad Anacreonte. Un quadro di palmi 13 circa per palmi 8 denotante l’Adorazione dei Magi per la chiesa dei Benedettini in Randazzo. Un picciol quadro ove si raffigura la Gioventù che sollazza nulla curando il Tempo che volando sorride, per il dottor in chirurgia Signor Minà. Un quadretto che rappresenta Una giovane che riceve un biglietto di sua consolazione, per D. Antonino Savona. Due piccoli paesi. Un picciolo ritratto della fu baronessa di Mandrascate nell’età giovanile, per il suo consorte. Un paese di palmi 3 per 4 [raffigurante] la Veduta della Guadagna, per il negoziante Florio. Un ritratto di un capitano inglese dell’Armata delle Indie, sino a mezza gamba. Altro a mezza figura di Raffaele di Urbino. Altro, come sopra, di Poussin592 per D. Giuseppe Cantone. Un picciol quadro d’un palmo circa esprime S. Rosalia in penitenza, a richiesta del marchese Forcella, per la Regina Madre Isabella, moglie di Francesco I. Un cane corso, quasi al naturale, dipinto ad acquerello per il detto marchese. Un paesetto con alte rocche, e cascata d’acqua per ***. Un ritratto a mezza figura della fu moglie di Palmieri, sulla maschera. _________________________________ Michele Panebianco, pittore, nato a Messina nel 1806, ivi morto nel 1873. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti… cit., p. 306-358. 592 Vedi nota n. 441. 591 211 Nell’anno 1845 Due sopra porte di palmi 8 una per palmi 2.8, in ciascuno dei quali vi sono dipinti Due putti per il nipote del barone Bordonaro. Un ritratto con una mano della fu moglie di D. Ferdinando Barone, eseguito sulle parole. Un ritratto della signora Dicsiton [!] Numero 4 paesetti esprimenti il primo una Cascata d’acqua, l’altro l’Eruzione di un Vulcano, il 3° Un uragano e l’ultimo finalmente una Tempesta di mare per il signor Savona. Un ritratto sino a ginocchio del Prefetto di Polizia, Mistretta. Ritratto di Carlotta Vigo. Ritratto della marchesa Sessa. Quadro bellissimo del Patania dentro la Madrice di Monte S. Giuliano [Erice], rappresentante il Cuore di Gesù, nella figura cioè di Gesù Cristo che mostra il suo cuore ai fedeli593. Catalogo del quadri di Giuseppe Patania dal 1835 sino al 23 febbraio 1852, giorno di sua morte Si avverta che quelli precedenti in gran parte trovansi nell’elenco fattone da Agostino Gallo indicati nel Giornale del Vapore e del Passatempo per le dame594 Anno 1835 Un quadro grande per l’Albergo di Morreale, la Pietà. Altro per la chiesa del Collegio di Maria di Gisino [!], l’Immacolata. Altro per Carini, nella chiesa del monasto [!] di S. Vincenzo Ferreri, la Crocifissione. _________________________________ Sul verso della c. 300 una contabilità di onze siciliane. Il riferimento più fedele è al giornale Il Vapore, dove il Gallo dedica due articoli al maestro del neoclassicismo siciliano: cfr. tomo V, 1833, “Intorno a due quadri uno dipinto dal cav. V. Riolo e l’altro dal cav. G. Patania per commissione di S.A.R. il Luogotenente generale di S.M. in Sicilia il conte di Siracusa D. Lepoldo”; nel secondo saggio l’A. ricorre all’ausilio tecnico dell’artista: cfr. t. VII, fasc. 20-21, p. 3-15, “Sul dipingere quadri a fresco portatili. Lettera critica di Agostino Gallo segretario della classe di Letteratura, e belle arti nell’Accademia di Palermo diretta dal cav. Lionardo Vigo”. 593 594 212 Altro piccolo dell’istesso soggetto per Aci Reale. Un Crocifisso solo per il p. D. Giovanni Battista Cutelli. Quattro sopraporti [!] sull’istoria romana per il signor cavaliere Di Stefano di Santa Ninfa. Un Beato Sebastiano Valfrè per la Piana [dei Greci] mezza figura. Un quadretto esprimente un punto del romanzo detto la Monaca di Monza. Quadro del Cuore di Gesù più piccolo del naturale, per il Monte Elice [!], per il Palazzo Adriano. Un S. Giovanni Crisostomo al naturale. Una Madonna a mezza figura. Il Cuore di Maria per Sciacca. Il ritratto del P. [Giuseppe] Borghi. Altro di una signora romana del dottor D. Benedetto Morini. Altro del principe di Leonforte, di una signora di cognome Cannone. Due ritratti per due inglesi americani. Altro sulla maschera del dottor ***. Altro del Re, per Caltanissetta, sino al petto. Altro del dottor D. Salvatore Cutelli, a petto. Altro del marchese Villalba. Un quadro di S. Vincenzo di Paola per il sacerdote signor D. Giovanni Cirino, a petto. Un ritratto, a petto, del confettiere Bruno. Anno 1836 Ritratto della figlia della principessa di S. Cataldo, a petto. Altro del cerusico Manzella, sulla maschera. Una replica del ritratto di [Vincenzo] Bellini per il signor [Tommaso] Aloisio [Juvara] incisore. Una Madonna addolorata, piccolo quadro. Due Amorini che si lottano per una palma. Piccolo quadretto per la signora principessa Montevago, un bozzetto [raffigurante] l’Ifigenia. Altro per un quadro d’altare per il signor Sergio, rappresentante S. Nicolò di Bari. Ritratto del P. Valentain [!] inglese, a petto. Altro del Presidente Cannizzaro, a petto sulla maschera. 213 Altro di D. Graziano Cirino, a petto. Altro della baronessa Mortillaro, a petto. Altro di Nené Urso, a petto. Altro del ministro Averna, sino a ginocchio. Un quadretto di palmi 3 per 3/6, [raffigurante] Il ratto di Proserpina, per S.E. D. Corrado Ventimiglia. Ritratto di un barone *** a petto. Altro della signora Urso, a petto. Altro della principessina Lanza. Altro della principessa Belvich, a petto. Altro di D. Policarpio Fogliani, sulla maschera. Altro della signora Gloos, a petto, sulla maschera. Altro del contino S. Marco, intiero. Altro del figlio di D. Luigi Sergio. Altro della signora Valentain [!]. Altro della signora Lucchese, a petto. Altro dell’avvocato Turretta per intiero. Altro della signora Spitalotto, sulla miniatura. Anno 1837 Copia del ritratto della principessa di Butera, a petto, per il R. avvocato Franco. Ritratto del ministro Fardella, a ginocchio, per Trapani. Altro simile, più piccolo del naturale, per il R. duca di Cumia. Un quadro d’altare di grandezza palmi 11 per 7, denotante S. Nicolò di Bari che patrocina dinanzi l’imperatore Costantino tre creduti rei di delitto capitale, per commissione di D. Luigi Sergio da S. Stefano di Camastra. Ritratto della fu signora principessa di Resuttana, a mezza figura. Altro, replica di detto, per sua sorella, la marchesa di Altavilla. Altro sulla maschera della sorella dell’avvocato Franco, con le mani. Altro, a petto, della signora marchesa *** figlia di Scazzone. Un paralume esprimente l’Ultimo giorno di Pompei, per il signor Garofalo figlio. Ritratto della fu signora principessa di Resuttana, per intiero, con molti accessori, per suo padre signor principe di Fitalia. Altro del signor Don Ignazio Serretta, a petto. Altro della fu s.a duchessa di Serradifalco, per il principe Lanza, a petto. 214 Replica dello stesso per il signor duca, suo sposo, a petto, sulla miniatura. Altro, sulla miniatura, della principessa Larderia, a petto, per il signor principe Lanza. Altro per lo stesso. Numero sette ritratti in una tela di palmi 5 per palmi 6 circa denotante varie persone della famiglia del signor avvocato Franco, tutti sono sino al dettride [!] Un piccolo quadro, il Salvatore, per il P. reggente Giglio Paolotto. Un quadro di palmi 4 per 3 esprimente un Baccanale per il signor Don Giovanni Battista Cutelli. Ritratto di Guido delle Colonne per D. Agostino Gallo. Altro del fu D. Gioachino Zappulla, a petto, sulla maschera. Un quadro di palmi 6/6 per palmi 3/8 rappresentante Efigenia che gli viene annunziato il suo sacrifizio, per il signor avvocato Dara di ***. Un piccolo ritratto del figlio del fu Enrico Merlo per la signora marchesa Merlo. Ritratto, con una mano, della fu figlia del principe di Montevago. Altro del Beato Giuliano Majale, copiato su quello ch’esiste nello Ospedale Grande. Un quadro, a mezza figura, della Madonna del Soccorso, per Trapani. Un ritratto, sino a mezza gamba, del fu padre del barone Riso. Un quadro di palmi 4 per 3 esprimente S. Rosalia che prega il Bambino Gesù in braccia della S. Vergine e vicino vi è S. Giuseppe, abbasso a lato dritto S. Venere, e vicino ad essa un putto che si tura il naso guardando un teschio. Ritratto del fu Lucchese, a petto, sulla maschera. Altro del fu Petrino Urso, con una mano, fatto a memoria. Altro della principessa Scilla, di palmi 4 per 3. Altro del fu egregio [Domenico] Scinà di palmi 5 per 4, cavato su di quello del signor Agostino Gallo, da servire pei PP. Di S. Calasanzio. Piccolo ritratto della fu figlia della principessa di Montevago. Ritratto del Re per l’Università dei Studi, sino a mezza coscia. Altro del figlio del cavaliere Ramondetta, a memoria. Altro del sud.o cavaliere, sino a petto. Altro di D. Gaetano Marvuglia. Altro di donna Gaetanina Urso. Altro di donna Teresa Urso, replica. Altro di Peppino Urso, sino al ginocchio. 215 Anno 1838 Altro di D. Gaetano Fiamingo, quasi intiero. Altro del presidente Costantino, sino a petto. Altro del duca di Serradifalco, sino a petto. Altro del marchese Rudonì [!] Altro dell’abate Nascè, replica per D. Gaetano Fiamingo, sino a petto. Altro del P. Dis<te>fano di S. Ninfa, sino a petto, a memoria. Altro del marchese Rudonì [!]. Replica, mezza figura. Un quadretto per il barone Sergio, consistente la Madonna, S. Rosalia, S. Stefano ed un angelo che discaccia il mostro colera. Replica del ritratto di Serradifalco. Ritratto del marchese Spedalotto, sino a petto. Altro della signora Emmanuela Violante, per il signor D. Calogero Violante di lei sposo, sulla maschera. Replica dello stesso per la signora donna Rosalia Tedeschi di lui sorella. Altro del duca di Cumia. Altro della fu signora duchessa, sino al ginocchio, per Regalbuto. Altro piccolo per la fu signora duchessa, sino a petto, per la famiglia. Un quadro rappresentante S. Francesco di Paola nell’atto che pare di vivere un suo nipote, di palmi 11 per 8.6., commissionato per il signor D. Francesco Franco da servire per S. Mauro [Castelverde]. Ritratto della Regina per il magistrato supremo di salute. Altro del Re per Aci Reale, mezza figura. Altro del fu Nicolò Palmeri, sino a petto. Altro dell’architetto [Vincenzo] Di Martino, sino a petto, entrambi per il signor D. Agostino Gallo. Una mezza figura denotante la Gioventù per l’avvocato D. Francesco Franco. Due ritratti in una tela, Il padre ed una bambina, per Antonio Vaccaro, sino a petto. Altro di D. Salvatore Biundo, sino a petto. Altro del fu ciantro Basile di Caltanissetta, mezza figura con le mani. Una Madonna con il Bambino, al naturale, per l’avvocato D. Francesco Franco. Ritratto della fu duchessa di S. Martino, per intiero. Altro del medico D. Mariano Dominici, sino a petto. Altro di monsignor Balsamo, sino a petto. Altro della fu duchessa San Martino, sino a petto, per l’avvocato Franco. 216 Altro di una signora, a memoria, sino a petto. Un quadro di palmi 6/6 per palmi 5/4 rappresentante Lucrezia Sesto Tarquinio, per l’avvocato D. Francesco Franco. Ritratto, a petto, per il giudice di Favara. Altro a petto della fu principessa Torremuzza. Altro del principe di Torremuzza, sino a petto. Altro della fu principessa di Altomonte, sulla miniatura, fino a petto. Altro della fu moglie di d. Salvatore Biundo, sino a petto. Altro del fu principe di Torremuzza pel di lui fratello marchesino S. Giacinto Replica. Altro a petto del prete regolare Cirino per suo fratello. Altro del Proposito dell’Oratorio della Piana [dei Greci] sino a petto. Altro della moglie del dottor Vrecchi inglese con le mani. Altro del pittore D. Francesco Zerilli595 sino a petto, per Agostino Gallo. Due ritratti sino a petto del fu Giacinto Astorino per Don Isidoro Testaferrata. Altro della signora Cirino, a petto, per suo figlio, il beneficiale. Altro del cav. Galletti figlio della principessa San Cataldo, senza mani. Anno 1839 Un quadro alto palmi 18 per palmi 10.7 per la chiesa dell’Abadia di S. Gaetano in Monreale, rappresentante il Santo che dà il pane agli affamati. Ritratto di un fanciullo, figlio del fu [Antonio] Furitano, valente chimico, con una mano. Altro della Regina, con le mani, per il Palazzo Reale. Un piccolo quadro di S. Francesco di Assisi con le mani, dal concetto di Domenichino596 per i PP. Cappuccini. Un piccolo ritratto del duca di Serradifalco. Ritratto, sino a ginocchio, della regina Maria Carolina d’Austria per la Segreteria Reale. Altro di donna Fania San Cataldo, con le mani. Altro del cav. Di Stefano, piccolo ed intero con una giumenta, per S. Ninfa. _________________________________ Francesco Zerilli, pittore, nato a Palermo nel 1794, ivi morto nel 1837. Domenico Zampieri detto Domenichino, pittore, nato a Bologna nel 1581, morto a Napoli nel 1641, rappresentante dell’ideale classicista in età barocca. 595 596 217 Altro del trafficante Gud, inglese, per intero. Altro del Re, intiero, per l’Albergo di Monreale. Altro del marchese Nunziante sino a petto. Altro replica dei due inglesi. Quadro di Maria Addolorata, con le mani, per il S.r D.Giovanni Battista Cutelli. Ritratto della fu principessa di Fitalia dell’età giovanile, sino a petto, cavato da una miniatura. Altro della fu marchesa Altavilla, fino a ginocchio, sulla maschera per suo marito il Tenente Longo. Altro, sino a petto, per l’avvocato d. Francesco Franco. Un quadro della Madonna Addolorata, con le mani, per Mistretta. Altro del trafficante Gud sino a petto, per il signor D. Gaetano Fiamingo. Altro di S.E. signor principe di Campofranco, sino a petto, per S.A.R. la duchessa di Berry. Un quadro di palmi 12 per 8 denotante la Madonna del cholera con S. Stefano, S. Rosalia, ed un cherubino che discaccia il mostro per il S.r D. Luigi Sergio, da collocarsi in S. Stefano di Camastra. Ritratto del Prefetto di Polizzi, sino a petto. Altro di un inglese, sino a petto. Un quadro a guazzo di palmi 5 circa ove si esprime l’Aurora, per il S.r Tasca. Ritratto fino a petto del duca di Castrofilippo, sulla maschera. Una quarta parte di un fregio esprimente una allegoria di Sponsali antichi, ciò per via di genietti. Il cennato fregio è di palmi 1.1/2 di altezza e palmi 18.6 da servire per la stanza di dormire del signor Tasca. Anno 1840 Continuazione del sopradetto fregio del barone Tasca. Un piccolo ritratto di un inglese. Ritratto del capitano di marina, Vincenzo Di Bartolo, a petto. Altro con una mano, del principe di Giardinelli. Altro fino a petto del *** parente di Don G[iusepppe] Marvuglia. Altro di un inglese americano detto Lorenzo, sino a mezza gamba, mandato a Nova Jorchs [!] 218 Un Crocifisso in una tela di palmi 2/9 per 2 per D Gerardo Volpe, per commissione. Ritratto, fino a mezza gamba, del fu signor Tasca. Un quadretto di palmi 2/6 per palmi 2 rappresentante una dei martiri di S. Filomena, per Regalbuto. Un Bambino Gesù in mezzo ai Misteri della Passione per il padre Reggente, Giglio. Un quadro di palmi 2.6. per palmi 2 rappresentante Nostra Donna col Bambino Gesù e S. Giovanni per il barone Mendola di Favara. Due ritratti del marchese Cafis<i> di Favara, uno del padre eseguito per via di suggerimenti, l’altro del figlio, entrambi sino a petto. Altro del presidente generale Carbonaro di Catania, sino a ginocchio. Una Madonna addolorata, in una tela di palmi 2.6 per 2 per il suddetto marchese di Favara. Ritratto del P. Giardinelli, replica per il marchese Rudonì [!]. Altro, sino al petto, dello stesso. Altro di un ragazzino con una mano, figlio di contadini. Altro, a mezza gamba, del vescovo di Mazzara, monsignor S<c>alabrini, da collocarsi in Alcamo nella Nuova Collegiata. Altro della sorella dell’avvocato D. Francesco Franco, vestita da educanda, con mezza mano. Altro della duchessa di Caccamo, sino a petto, eseguito a memoria a dieci anni prima e indi finito il vestimento. Altro della signora duchessa di Sperlinga, sino a ginocchio. Copia del ritratto del fu duca di S. Stefano, a petto. Un quadretto di pal. 2 per 2.6 rappresentante un S. Giuseppe che mostra un cardellino al Bambino Gesù, per il marchese Cafisi di Favara. Replica della Madonna, Bambino e S. Giovanni come quella del barone Mendola, per l’avvocato D. Antonio Agnetta. Ritratto, sino a mezza gamba, del barone Pastore. Altro, sino a mezza gamba, del cavaliere Vanni. Altro, dell’istessa misura, di sua moglie. Quadro di S. Francesco di Sales in una tela di palmi 4.6 per 3.6 per il barone Pastore. Ritratto del nipote dell’abate Cirino, sino a petto. Altro per sua moglie, a petto. Mezza figura, sino a petto, ritrattesca, per l’avvocato D. Francesco Franco. 219 Anno 1841 Ritratto della duchessa S. Rosalia, moglie d’Ingham, sino a mezza gamba. Altro del nepote d’Ingham, mister *** sino a ginocchio. Altro del negoziante Ingham, sino a mezza gamba. Altro di un ragazzo, Giovannino Villa, intiero al naturale, che scherza con un pecorello. Un quadro di caccia per D. Francesco Franco. Un quadro di larghezza pal. 4.6 per 4 esprimente Erminia che trova i pastori, per il marchese Cafisi di Favara. Ritratto, sino a petto, della figlia del marchese Spitalotto sul ritratto all’ombra. Quadro di palmi 4.6 per 4 per il marchese Cafisi, esprimente il Templario che vuole rapire Rebbecca, soggetto preso dall’Ivanou di Valter Scot [!]. Ritratto del barone Bordonaro, sino a mezza gamba. Altro, replica dello stesso, sino a ginocchio. Altro del presidente Piraino, sino a ginocchio. Altro della sorella di D. Luigino Scalia, sino a cinto, con una mano. Un quadretto di cinque putti che con festoni di fiori girano attorno un’ara da servir per portello di camino per il principe di Montevago. Due quadri di palmi 4-6 per li denotanti, uno Don Abondio abbordato dai Bravi, cavato dai Promessi sposi del Manzone [!], l’altro esprime una nostra bettola per il marchese Cafisi di Favara. Ritratto della sorella dell’avvocato Franco, sino a petto, con una mano. Quadro dell’Immacolata con varii putti di altezza palmi 10 per 6 per il barone D. Lucio Tasca per un suo feudo presso Valle d’Olmo. Quadretto di fiori per suo nepote. Altro quadro per il medesimo luogo ed uguale grandezza per detto signor Tasca della Madonna addolorata con due putti. Una testa di Addolorata, per capizzale. Quadro di grandezza palmi 6.4 per 4.6 esprimente Venere che esce dal bagno, per l’accennato Franco. Ritratto dell’abate [Giovanni] Meli per D. Agostino Gallo, a petto, per darlo al marchese Ruffo. Due paesetti di grandezza palmi 2.6 per 2 per il contino Tasca. 220 Anno 1842 Quadretto di palmi 2 per 2. 6 esprimente l’Assunta Maria Vergine con tre putti, per il canonico D. Leonardo Palermo di Alcamo. Ritratto, fino a petto, del fu D. Fedele Barbalunga. Altro del Re, sino a petto, per il principe Scilla. Quadro di palmi 7.4. per 5.3 denotante il Ritorno dalla caccia, costume del ‘500, per il barone D. Francesco Battifora. Quadro di palmi 8 per 5 circa rappresentante S. Antonio abate, per Capizzi. Ritratto di un Inglese per mister Nood[!], sino a petto. Altro replica dello stesso. Quadro di palmi 8 per palmi 11.8 per Randazzo, denotante il Martirio di S. Bartolomeo per la chiesa di questo santo. Ritratto sino a petto dell’abate D. Nicolò Buscemi. Altro dell’abate Cirino, sino a petto. Altro del signor astronomo [Nicolò] Cacciatore. Altro piccolo del fu D. Ignazio Santifilippo. Piccolo quadretto denotante Il Tempo che fa conoscere alla Bellezza il suo impero, per D. Agostino Gallo. Ritratto della signora Di Bartolo. Quadro di palmi 8 per 11.8 per Randazzo, nella chiesa di S. Bartolomeo, appartenente alle monache benedettini, esprimente S. Benedetto che fa redivivere un bambino. Altro denotante una S. Triade per Calatafimi, di palmi 8. per ***. Ritratto, all’impiedi, del marchese della Favara per la Sala dei luogotenenti. Numero sei piccoli Paesi. Ritratto a petto del fu Don Ignazio Sanfilippo. Anno 1843 Un piccolo quadretto sulla tavola, rappresentante Le tre Marie ai piedi della croce per Don Salvatore Di Marzo. Ritratto, sino a petto, della baronessa Mortillaro, sino a cinto. Numero quattro quadretti esprimenti quattro uomini illustri siciliani, sino a petto, cioè Empedocle, Archimede, Gaggino e il Novelli per il confettiere Rollieri. Ritratto fino a petto del barone Mortillaro. 221 Altro di un ragazzino espresso da S. Giovanni Battista. Numero due ritratti di marito e moglie sino a petto, in una tela per Mariano Leonardo Gambino di Aci. Due quadri di palmi 6 per 4 circa, esprimenti S. Pietro nel momento che sente il gallo e si accorge di avere negato il suo Divino Maestro; l’altro S. Stefano portante la palma del suo martirio e nella destra tiene l’Evangelo, tutti e due per Calatafimi. Ritratto a petto del celebre maestro di musica [Giovanni] Pacini, sul dagherrotipo. Altri due a petto delle sorelle del canonico Cirino. Un quadro dell’Immacolata sino a petto per il detto canonico Cirino, con le mani. Un Paesello esprimente la Canzona del Petrarca, Chiare, fresche etc. etc. per D. Agostino Gallo. Quadro esprimente la Madonna col Bambino che tiene una piccola croce; nel campo vi sono varii serafini, di palmi 5.8. per 4, per Aci reale. Ritratto a petto di D. Diego Orlando. Quadro della Madonna addolorata con le mani, pal. 5 per 4 circa commissionato dall’architetto D. Giuseppe Patti. Altra piccola senza mani, per un nipote del detto Patania. Altra piccola per il P. Reggente, Giglio Paolotto. Quadretto esprimente Due Amorini che lottano per una palma, per D. Simone Gramaglia. Ritratto della fu moglie di D. Mariano Leonardo Gambino di Aci. Altro piccolo di D. Agostino Gallo. Quadro piccolo per detto Gallo, denotante Amore e Pisiche, sull’idea di Correggio. Ritratto della duchessa Brolo sino a ginocchio, per suo fratello il prelato Grassellini. Ritratto con una mano del duca di Caccamo. Altro con le mani della moglie di D. Gaetano Fiamingo. Altro del padre del canonico Cirino, replica, a petto. Altro della sorella di Bracci, moglie del capitano di nave Di Bartolo, a petto. Quadro di pal. 19 e palmi 9 circa rappresentante I Discepoli in Emmaus per il Refettorio di Monreale. Ritratto con una mano del fu figlio di Cusumano. Altro a petto del pittore [Anton] Vandich597. _________________________________ 597 Vedi nota n. 257. 222 Altro di Correggio con una mano per D. Giuseppe Cantone. Altro del duca di Caccamo con una mano, vestito da gentiluomo di Camera, per Termini per la Compagnia dei Pescatori. Quadro di palmi 7 palmi 13 circa denotante S. Benedetto che dà la Regola a S. Scolastica per Aci. Altro di Nostra Donna col Bambino Gesù in atto che lo carezza ed ella rivolta al cielo visa [!] una lacrima, di palmi 4 per 3, per l’avvocato Francesco Franco. Anno 1844 Quadro di palmi 12 per 8 circa esprimente Gesù Cristo che lo stanno legando alla colonna per flagellarlo, per la chiesa dell’Amagione598. Quadro del fu Pignatelli Farina con una mano sopra una miniatura. Altro di un Americano con le mani. Altro del fratello del canonico Cirino sino a petto. Altro del Bellini replica per il signor Florio di Catania. Altro di un Americano con le mani. Quadretto rappresentante Il riposo in Egitto per il barone D. Francesco Battifora. Ritratto del figlio del principe Scilla, con le mani. Altro di una ragazzina, sulla maschera, con le mani. Un Ecce Omo [!] con le mani per Don Giovanni Battista Cutelli, al naturale. Piccolo quadro che esprime Polifemo ubriaco per l’artista [Nunzio] Morello. Ritratto con le mani del cavaliere D. Giovanni Cirino. Altro del giudice Don Francesco Prado, a petto. Altro del cognato di detto Cirino, a petto. Un bozzettino per il pittore Michele Panebianco dinotante Amore che vuol provare l’arco scagliando un dardo ad Anacreonte. Quadro di palmi 13 circa per palmi 8 esprimente L’Adorazione dei Magi per la chiesa delle monache benedettini di Randazzo. Un quadretto della Gioventù che si sollazza niente curandosi del Tempo che volando sorride, per il dottor di chirurgia Minà. Altro di una giovane che ha ricevuto un viglietto consolante, per Don _________________________________ 598 Intendi chiesa della SS. Trinità della Magione. 223 Antonino Samonà. Due piccoli paesetti. Un piccolo ritratto della fu baronessa Mondrascate di quando era giovane, per suo consorte. Un Paese di palmi 5 per 4: Veduta della Guadagna per il negoziante Florio. Ritratto di un Capitano inglese dell’Armata delle Indie, sino a mezza gamba. Si crede di aver rimasto in Palermo. Altro, fino a petto, di Raffaele d’Urbino. Altro di Possino per Don Giuseppe Cantone, ambidue. Un quadretto di un palmo circa esprimente S. Rosalia penitente, per la Regina Madre detta Isabella, moglie di Francesco I, commissionato dal marchese Forcella. Un cane corso, quasi al naturale, dipinto all’acquarella per l’istesso marchese. Un Paesetto con alte rocche e cascate d’acqua per ***. Ritratto della moglie di [Nicolò] Palmieri, sulla maschera, a petto. Anno 1845 Due sopraporte di palmi 8 per palmi 2.8. ove sono dipinti Due Putti per ciascuno con varii accessorii per [il] barone Bordonaro. Ritratto, con una mano, della fu moglie di d. Ferdinando Bronfatto, sulle parole. Altro della Signora Dichson. Numero quattro Paesetti esprimenti uno Cascata d’acqua, altro Una eruzione di Vesuvio, Un uragano, ed il quarto Una tempesta di mare, per il signor Samonà. Ritratto, fino a ginocchio, del Prefetto di Polizia, Mistretta. Replica del ritratto della fu duchessa di Serradifalco, sino a petto. Altro dell’Inglese Dixchson, sino a petto. Numero altri tre paesetti di sopra cennati, e repliche, il quarto è notato nell’anno 1844. Quadro di palmi 4 per 3 rappresentante Gesù Cristo che và al Calvario, Maria sua Madre all’estremo dolore, per Cutelli. Ritratto della fu signora governante della casa del duca di Sommatino, sulla miniatura e sino a petto. Altri due di marito e moglie del chirurgo Cataliotta, sino a petto. 224 Altro della moglie in un piccolo quadro sino a ginocchio. Altro di Giorgio Matranga della Piana dei Greci, sino a petto. Una testina del Salvatore Altra del Battista. Ritratto di una bambola seduta sopra una pelle di leone che scherza con una cagna figlia del barone Paino. Altro della baronessa Bordonaro, sino a ginocchio. Una Nostra Donna intitolata il Cuore di Maria, per Cefalù. Ritratto piccolo del padre dell’inglese Dixson[!], sino a ginocchio. Due piccole Teste, una del profeta Geremia, e l’altra di Giuditta per il barone Ciotta. Un Bambino Gesù che dorme, al naturale per Don Giovanni Battista Cutelli. Ritratto, con una mano, copiato da dagherrotipo della figlia del marchese Spitalotto per la principessa San Cataldo. Altro della stessa San Cataldo, con le mani, per Spitalotto. Piccolo bozzetto o quadretto del Principio del Vespro Siciliano per l’autore Ritratto della fu moglie del medico Di Bartolo sulla maschera sino a petto. Detto del fu Morana, sulla miniatura, sino a petto. Altro della moglie del barone Bordonaro di palmi 5 e palmi 4. Altro di un fanciullo rappresentante S. Giovanni Battista, con le mani. Altro della madre di questi, rappresentante una Saffo, ambidue della principe Lanza. Altro della principessa San Cataldo, con le mani, replica. Altro del cavaliere Di Giovanni con l’uniforme di cavaliere di Malta, con mezza mano. Altro del Reverendo Bartolini, con le mani. Quadretto a lume di lanterna che rappresenta Torquato Tassso visitato da Eleonora per Don Agostino Gallo. Due piccole Teste sulla tavola, una Giuditta, e l’altra Geremia. Anno 1846 Ritratto piccolo della signorina De Franchis, sino a petto. Veduta della Torre dell’Acqua de’ Corsali a vedere da Bagheria, di palmi 4 per 3 per l’avvocato Emmanuele Viola. 225 Altri Due Paesi, uno ideale, l’altro la Veduta del principe di Trabia alla Bagheria per composizione dell’architetto Palazzolo. Ritratto, sulla maschera, del fu [Giuseppe] Bertini. Altro del fu Francesco Villa, colle mani, sulla maschera. Altro del fu barone Bellizini di Noto, con le mani sopra, un cattivo ritratto per sua nepote. Una Testa esprimente Giuditta che parla col Fattore delle cose pria di vibrare il colpo, indi Oloferne al naturale, per Don Giuseppe Di Martino. Ritratto del colonnello Di Piazza Punio, sino a petto. Altro all’impiede vestito di gentiluomo di Camera del principe di Manganelli. Altro del canonico Valenza, sino a ginocchio. Altro di marito e moglie Corrao, abitanti a Nuova Jorch, sino a petto, con una mano. Copia di ritratto della principessa di Partanna, per l’avvocato Franco. Un quadretto di S. Vito nel momento che nega di sacrificar agli Idoli, per Regalbuto. Quadro di palmi 9 per 7 circa rappresentante la Madre e tre figli per il nipote del barone Bordonaro. Ritratto di un bambino che tira un gattuzzo per la coda, figlio del barone Paino. Altro, sino a ginocchio, del re Ferdinando 2° per l’IstitutoAgrario. San Giovanni Battista che predica, sino a ginocchio, per Cutelli. S. Giuseppe col Bambino, sino a ginocchio, per lo stesso Cutelli. Immacolata, fino al ventre, per l’avvocato Franco. Anno 1847 Quadro di palmi 9.6 per palmi 6/2 rappresentante la Crocifissione di Gesù Cristo con la Madonna, S. Giovanni e la Maddalena, dell’istessa mnisura con l’altro rappresentante la Sagra Famiglia, cioè S. Giuseppe, Nostra Donna, il Bambino Gesù ed il piccolo Giovanni entrambi per la chiesa in Alcamo, detta la Madonna dei miracoli, per commissione del canonico D. Leonardo Palermo. Due ritratti dei coniugi D. Ferdinando Lello, in tela, di palmi 4 per 3. Copia del ritratto del principe di Manganelli, fino a petto. Due ritratti dei coniugi Raccuglia, sino a petto. Quadrettino esprimente una Rissa di ladri. 226 Altro da servire di bozzetto per un quadretto esprimente la Nascita di Cristo, da servire per una cappella domestica del barone Cafisi di Favara. Ritratto, sino a petto, di Don Antonino Samonà. Altro di palmi 3 e palmi 4 del fu avvocato Francesco Franco. Altro dello stesso, sino a petto, sulla maschera. San Francesco Saverio di palmi 4 per 3, per Sciacca. San Giuseppe col Bambino per il cavaliere Cirino. Ritratto dello stesso autore Patania, sino a petto, per il marchese Milo. Altro del fu barone Papaleo di Scicli, di palmi 4 e palmi 5 sulla maschera. Altro di D. Pietro Mirto morrealese, con le mani, sulla maschera. S. Paolo con le mani, di palmi 3 per palmi 2½. S. Pietro con le mani, come sopra. Ritratto della signora Scoppa con una mano. Altro del marito. Altro della signora Catalano, sino a petto. Altro della moglie di D. Diego Orlando. Altro di un fanciullo con le mani, figlio del dottor Samonà Una piccola Addolorata per il dottor Cappello di Settecannoli. Anno 1848 Un piccolo quadro del Salvatore. Quadretto, copia sulla stampa della Madonna della segiola di Raffaello, per l’abbadia delle monache benedettini di Randazzo. Numero quattro piccoli quadri, uno del Vespro siciliano. Altro l’Assassinio di Guglielmo I. Il terzo, Il giorno 12 del gennaio 1848, il quarto La fuga dei soldati che difendono il Palazzo Reale di Palermo. Ritratto del barone Cafisi, con una mano. Altro del di lui fratello, il cavaliere, sino a petto. Altro del marchese Di Gregorio, la moglie e il figlio, fino a mezza gamba. Due quadretti di palmi. 2 per palmi 1.1/3 circa, in uno, S. Rosalia nella grotta con il libro, nell’altro S. Filomena. Ritratto della moglie Amodea *** messinese, con le mani. Altro della moglie del signor Grasso, sorella di D. Luigi Ciotti, con le mani. Altro della signora Rossi di Petralia, fino a petto. Altro di D. Ruggiero Settimo, con le mani, per Vittoria. 227 Il Vespro siciliano, quadro di palmi 4 e palmi 5 per il barone Cafisi di Favara. Altro quadro denotante Guglielmo detto il Malo, compagno del Vespro, nell’atto che i congiurati lo stanno per assassinare. Ritratto di D. Ruggiero Settimo. Altro del marchese di Torrearsa. Altro piccolo, con una mano, della signora Gazzanica, prima donna cantante, per la famiglia Scaglione. Altro del fu Leonardi D’Aci, con le mani, per suo figlio. Altro di D. Angelo Nicolao, con le mani. Altro per sua moglie. Anno 1849 Quadro di palmi 5 per 4.8. per il cav. Cafisi di Favara, rappresentante quando Gli ambasciatori siciliani si presentano al re Giacomo d’Aragona e francamente gli parlano. Nel detto quadro vi sono 26 figure ed in questi varii ritratti, quello che al re dirigge la parola è Agostino Gallo, quello che ha la mano sul viso Giuseppe Velasques maestro dell’autore, quello che siede con le mani sulla tavola, Vincenzo Riolo, quello che parla con questo un apprendista detto Formisano, il primo del quadro alla sinistra, D. Giovanni Battista Cutelli, il pittore di genere ed ornamentista Giuseppe Tripi599, vicino vi è l’autore. All’altro fianco del signor Gallo, Ottavio Viola. Immacolata, piccolo quadro per un prete. Paese, per D. Simone Gramaglia. Ritratto dello stesso autore Giuseppe Patania con una mano tenendo una bacchetta per D. Angelo Nicolao. Quadretto di palmi 3 per 2.6. denotante il Tempo dopo la battaglia di Benevento, quando Carlo d’Angiò fa cercare il corpo di Manfredi fra i cadaveri, per lo stesso D. Angelo Nicolao. Piccolo S. Francesco di Paola per uso di un confrate per un fallegname. Ritratto rifatto di Rosalia Novelli, per Agostino Gallo. Quadro compagno del sudetto di Manfredi per detto Nicolao, denotante Annibale che assolve le matrone salinontini dopo la rovina della detta città. Piccolo Salvatore, per lo stesso Nicolao. Numero otto piccoli Paesi. Più altri quattro della istessa misura, una per detto S.r Nicolao. _________________________________ 599 Giuseppe Tripi, pittore attivo nella prima metà del XIX secolo. 228 Ritratto della fornaja Russo con le mani. Piccolo quadro di una Venerabile monaca teresiana, a mezza figura. Quadretto esprimente Federico lo Svevo che detta il testamento, per Luigi Ciotti. Ritratto, a petto, del direttore di Grazia e Giustizia, La Lumia. Altro del fu Martino Spitalotto, sopra un ritrattino, sino a petto. Due altri del Re, sino a ginocchio, per la Gran Corte dei Conti, e per l’Intendenza. Numero quattro Paesetti poco più grandi di quei sopra descritti, per l’Inglese Dixchson[!]. Quadretto denotante S. Teresa che infiamma una giovane a farsi monaca, per l’abbadia di detta santa. Ritratto del Re e della Regina per il Magistrato di Salute. Altro del cavaliere Di Giovanni sino a petto con l’uniforme di ufficiale della Guardia Nazionale. Numero quattro Paesetti uguali ai predetti, per mister Dixchson [!]. Anno 1850 Quadretto denotante la Regina Bianca che esce dal tetto per fuggire dalle mani di Caprera. Ritratto all’impiede del Re per la Consulta. Altro, a petto, della moglie di Paterna droghiere. Altro, con le mani, dell’avvocato Buttafoco. Altro di sua moglie ed un nipotino. Altro del celebre anatomico, Giovanni Gorgone, con le mani. Altro, sino a petto, del Direttore di Polizia, Maniscalco, sopra un piccolo ritratto. Piccolo quadro denotante una Mascherata per l’autore. S. Lorenzo, quadretto per D. Giuseppe Cantone. Ritratto di una signora annoverese, sino a petto. Quadro di palmi 11.6 per 6 con la figura di vescovo greco, S. Nicolò dei Bari per il Palazzo Adriano. Ritratto della signora Caterina Scalia di anni 70, sino a petto. Un semi quadretto denotante la Nunziata. Altro simile denotante la Nascita della Bambina. Altro simile denotante la Discesa del popolo palermitano in buio da Monreale. 229 Altro simile denotante la Condotta del cavallo corsiero col premio per le strade di Palermo, a lume di fiaccole. Piccolo ritratto della moglie di Salvatore Attinelli, fatto a memoria. Continuazione dell’anno 1850 Un ritratto fino a petto con una mano della fu signora Sciarrino in Salvo, sulla maschera. Ritratto del figlio dell’architetto Palazzotto. Due Paesi, uno di marina, l’altro di campagna, per il nipote di Bordonaro negoziante. Un ritratto del commendatore Benintende, sino a petto. Un ritratto all’impiedi del cefalutano Giovanni Battista Favara. Un ritratto della signora Buzomo, con le mani. Un quadro esprimente l’Angelo Raffaele con Tobiolo per la Chiesa Madre di Termini. Un ritratto del fu figlio del marchese Rudonì [!] a mezza gamba, sulle parole. Un Cuore di Gesù per andar in Corsica. Un ritratto del fù cav. Ajroldi, sino a ginocchio. Un ritratto della moglie del fu Costantoino Costantini, sino a petto. Un ritratto all’impiedi del marchese Rodinì [!] vestito da gentiluomo. Un ritratto della moglie del cavaliere Ramondetta, fino a petto, sulla maschera. Numero 4 ritratti, di forma ovali, della famiglia Statella per il marchese Spaccaforno. Un ritratto, all’impiedi, del fu marchese delle Favare per la Sala dei viceré. Anno 1851 Un quadretto di S. Giovanni Battista che predica, fino a ginocchio, per il canonico Palermo. Un ritratto all’impiedi del principe di Campofranco per la Sala dei Vicerè. Un quadro per altare dell’Annunziata, per Alcamo. Un ritratto con una mano per il principino di Satriano di una signora. Un ritratto di una cantante per il principe di Cutò, sino a petto. 230 Un ritratto, sino a mezza gamba, del celebre maestro di contrapunto, signor Raimondi. Un ritratto di un orefice Cataldi con una mano. Un ritratto fino a petto del barone Martines. Un ritratto dell’architetto [Nicolò] Puglia, sino a petto. Un ritratto, sino a mezza gamba, del fratello maggiore di D. Angelo Nicolao. Altro piccolo dello stesso, per intero. Altro simile della stessa misura, e con le mani, del fratello minore dell’istessa facoltà. Due ritratti, sino a petto, del principe di Cutò. Altro quadro compagno dell’Annunziata per Alcamo e per la stessa chiesa, esprimente la Nascita della Bambina. Un Santo vescovo non al natutrale, per lo stesso paese. Un quadro che esprime Gesù Cristo nell’atto che spiega un passo della Scrittura a S. Giuseppe, di grandezza al naturale, per una chiesa latina del paese greco detto Palazzo Adriano. Un ritratto, a mezza mano, del prete Pietro Gulli. Un quadro esprimente Gesù Cristo che guarisce un minuto[!]. La grandezza delle figure mettà del vero per la Cappella dei sordomuti in Palermo. Un ritratto, a mezza mano, di una sorella di d. Ferdinando Melazzo. Un ritratto del fu giudice di Commercio, Adamo. Un ritratto del pittore G. Patania con mezza mano per il gioielliere Cataldi. Un quadretto esprimente Flora e Zefiro presso il figlio di Di Stefano che si trova in Sciacca. Un ritratto, a mezza gamba, del padre del negoziante Lello. Quadretto della Madonna del rosario, per lo stesso signor Lello. Un ritratto di donna con le mani. Ritratto di Ariosto con una mano. Altro di Tasso per Cantone. Due Paesetti per D. Angelo Nicolao. Un bozzettino per un napolitano, Caino ed Abele ed Angelo. Una copia del ritratto del presidente Costantino Costantini per D. Agostino Gallo. Un ritratto della figliastra del pittore Patania da bambina, fatto anni prima e finito ora. Due ritratti, senza mano, del medico Dominici. Altro del figlio. Altro, fino a petto, del medico Proiti se pure un cattivo ritratto. 231 Anno 1852 Un quadro di Gesù, Maria, Giuseppe per D. Angelo Nicolao. Un ritratto del principe Lanza, fino a ginocchio. Un S. Francesco piccolo per i Cappuccini. Un ritratto dello stesso Patania da servire per le stanze dei Ritratti dei pittori nella Galleria ducale di Firenze. Un ritratto della nuora del presidente Piraino con le mani, che non compì perché fu l’ultimo lavoro pria di morire. Supplimento degli anni 1837 sino al 1851 Anno 1837 Ritratto dell’avvocato Turetta, intero. S. Nicolò di Bari, quadro per Sergio. Le figure al naturale pel S. Stefano di Camastra. Un quadro di palmi 4 per 3 esprimente un Baccanale per Giovanni Battista Cutelli. Un quadro di palmi 6.6. per 3.8 rappresentante Efigenia che sta per sposare Achille per Girgenti, per l’avvocato Dara. Ritratto di [Domenico] Scinà, palmi 4 per 5 per il Calasanzio. Anno 1838 Ritratto dell’abate [Francesco] Nascè per il S. Gallo. Un quadro di Varj santi con il mostro colera per Mistretta, di grandezza al naturale. Un quadro di S. Francesco di grandezza palmi 11 per 8.6. per S. Mauro. Anno 1839 Un ritratto di un negoziante americano detto Loren, fino a mezza gamba. Un quadro di S. Gaetano per l’abadia di S. Gaetano di Monreale, alto pal 18 per pal. 10.7. Un ritratto intiero del Re Ferdinando 2° per l’Albergo di Monreale. Un fregio per la camera a dormire de conte Tasca, rappresentanti Varii putti che esprimono varj fatti del matrimonio. 232 Anno 1840 Un quadretto di S. Filomena, che prende il martirio. Altro simile per Regalbuto. Anno 1841 Un quadro di Erminia che trova il Pastore, di grandezza palmi 4.6 per 4 per Favara Altro quadretto per Cafisi per Favara, rappresentante il Templario che vuole rapire Rebecca, sul romanzo [di] Valter Scot [!] Altro di Don Abbondio che è parlato dai sgherri. Manzoni, Monaca di Monza. Più altro che esprime una Nostra taverna. Un quadro denotante il Ritorno dalla caccia per il barone Battista, di palmi 7.4 per 5.3. Altro pello stesso di palmi 2 per 3 esprimente il Riposo di Egitto. N 1° quadro grande [raffigurante] la Trasfigurazione alto 21 per 8 circa per Randazzo. Numero 3 quadri per altare, cioè l’Adorazione dei magi, il Martirio di S. Bartolomeo, ed Un miracolo di S. Benedetto. Un quadro per altare rappresentante S. Benedetto, per Aci Reale, che dà la Regola a sua sorella Abadessa. Due quadri mezzani per Calatafimi, un S. Pietro ed un S. Stefano. Altro della Trinità per l’altare maggiore per Calatafimi. Quadro [rappresentante] i Discepoli di Emmaus per il Refettorio dei PP. Benedettini di Monreale. Un quadro per altare denotante S. Gaetano che distribuisce il pane agli affamati, per la chiesa di S. Gaetano. Anno 1844 Un quadro di Gesù Cristo che stanno leganno alla colonna, di grandezza palmi 12 per 8 circa. Un ritratto del celebre [Vincenzo] Bellini, per Gallo. Anno 1845 Un ritratto di Giorgio Matranga della Piana dei Greci, spedito a Roma. Un picciolo quadretto del Vespro Siciliano, presso l’Autore. 1846 e 1847 Due quadri mezzani per una chiesa di Alcamo, uno raffigurante la Crocifissione, e l’altro la Sacra Famiglia. 233 Altri tre quadri per la stessa chiesa, uno fatto anni prima per l’altare maggiore ove ora vi sono Varie Sante, e due più piccoli, uno l’Annunziata e l’altro la Nascita della Madonna. 1848 Due quadri, uno il Vespro Siciliano e l’altro l’Assassinio di Guglielmo per Cafisi di Favara. 1849 Un quadro di palmi 6 per palmi 4.8 per il cavaliere Cafisi di Favara, rappresentante Gli ambasciatori siciliani che si presentano al re Giacomo di Aragona. Un Paese per D. Simone Gramaglia, di mezzana grandezza. Due ritratti dello stesso S.r Patania, uno per D. Angelo Nicolao, e l’altro per il gioielliere D. Pietro Cataldi. Due quadri di Istoria Sicula, uno dopo la battaglia di *** dove Carlo trova il corpo di Manfredi; l’altro Annibale che fa grazia a molte donne di Selinonte di palmi 3 per palmi 2.6, per D. Angelo Nicolao. 1850 Un quadretto esprimente la Regina Bianca che esce dal tetto per fuggire da Caprera, per lo stesso Patania. Un ritratto del celebre anatomico D: Giovanni Gorgone. Numero 4 piccoli quadri denotanti un Carnevale, la Discesa di Monreale, il Cavallo premiato, e la Processione dell’Immacolata in Palermo, per ***. Un quadro con le figure, molte dal vero, esprimente Tobiolo, per Termine. Due Paesi per il signor barone Bordonaro. Un Salvatore, mezza figura per Corsica. S. Nicolò di Bari, quadro al vero, per il Palazzo Adriano. 1851 Ritratto di una prima donna cantante con una man<o>. Quadro con le figure al naturale denotante S. Giuseppe ed il Salvatore per il Palazzo Adriano. Un quadro che esprime Gesù Cristo che guarisce un mutolo per lo Stabilimento dei Sordimuti con le figure molto al naturale. Un quadretto di Flora e Zefero. 234 Su Giuseppe Patania celebre pittore Giuseppe Patania che tanto onorò Palermo, sua patria e sé stesso con l’arte di Apelle in cui fu eccelso dopo il Velasques, suo maestro, e che era fornito di tutte le virtù sociali e cristiane e lasciò scolari degni di lui, nessuno de’ quali bensì l’ha superato, meritò in vita di essere da tutti riverito ed amato menocché da un ingrato e fanatico suo discente che ultimo fra i pittori viventi ne ha offeso la memoria in una sua indigesta opera titolata Delle Belle Arti in Sicilia pubblicata a nome dell’abate D. Gioacchino Di Marzo per iscanzare la vergogna della iniqua maldicenza delle sue pazze lodi come riformatore della pittura in Palermo600. Il Patania ottenne in vita l’onore di una biografia scritta dall’egregio poeta sig. Lionardo Vigo di Acireale e d’infiniti artisti di varî scrittori sulle opere ch’egli dipinse e non per la poesia e fra questi autori di prosa e di versi vuolsi nominare il primo, il celebre abate Giovanni Meli, il quale visitandone lo studio, il ritrovò in compagnia di diversi letterati che ama601 vano di vederlo dipingere e gli diresse il seguente sonetto : Dissi chi non ti invidiu ‘ntra stu munnu / S’aja un tozzu, e la paci sta cu mia; / Ma doppu ch’acconusciu a Patania, / Di la mia indifferenza nun rispunnu / Vidiri un omu non vinci a funnu / D’una fecunna e ricca fantasia, / E quantu pensa, imagina e disia / Lu crea e anima in tili netti e summi / Vidirlu in tra la stanza immenza a tanti / parti di lui so geniu e curunatu / Da genti saggia e di bell’arti amanti / Cunfessu a tali vista chi tentatu / Jeu sugnu da l’invidia non ostanti / Ch’aju lu tozzu e la mia paci a latu. Fra gli altri componimenti poetici avvi un ode di Agostino Gallo, suo scolare, in cui rassegna partico<lar>mente alcune delle principali opere del Patania, e quel componimento fu allora applaudito e inserito nella decade delle Belle Arti e indi corse stampato fra le poesie del *** pubblicate colle stampe del Dato nel 1816. Questi scrisse poi varî articoli su gli altri dipinti del medesimo, come quelli della Lega [!] col cigno602, bellissimo quadro dipinto sopra tavola, pel cav. *** fiorentino, segretario della Commissione di Belle Arti in _________________________________ 600 Per l’opera di Gioacchino Di Marzo cfr. n. 25. Il riferimento è al pittore Giuseppe Meli, allievo del Patania, ritenuto dal Gallo l’artefice della fatica; difende altresì il Patania nel saggio Sugli scrittori moderni … cit. p. 76-78, dove fa un’acuta disanima dell’arte del Maestro. 601 Cfr. Poesie siciliane dell’abate Giovanni Meli. … Volume postumo che può servir di seguito all’edizione del 1814 pubblicato a spese delle eredi da Agostino Gallo, Palermo, per Baldanza, 1826. 602 Potrebbe trattarsi del cav. Puccini. Cfr. Agostino Gallo, “Leda col cigno, favola dipinta da Patania”, in: Mercurio Siculo, 1826, n. 31. 235 Napoli, e lui indi lo vendette a carissimo prezzo, e scrisse pure un altro articolo sul quadro da chiesa rappresentante Cristo che consegna a S. Pietro le chiavi alla presenza degli altri apostoli, opera delle migliori in gran dimensione commessagli da monsignor Gravina arcivescovo di Palermo per la chiesa di Montevago. L’avvocato Zerega Antonino amatore delle belle arti, D. Ferdinando Malvica ed altri scrissero pure articoli encomiastici per altri quadri del Patania603. D’allora vennero ricercati al medesimo da varî amici il suo ritratto, a’ quali prestossi egli gratuitamente e primo pel suo più intimo Agostino Gallo e da ultimo per la Galleri di Firenze richiestagli per mezzo del Gallo dal Direttore della medesima. La pubblica opinione in tutto favorevole al Patania gli attirò una folla di commissioni tanto per Palermo che per l’interno dell’isola, per Roma e anche per America e per Francia sebbene non fossero che ritratti, nel qual genere egli allora primeggiava per la somiglianza e per la grazia ed espressione. Il suo ritratto di un giovane inglese fu esposto a Nuova Jorch [!] e giudicato degno del premio. Ma l’inglese che lo presentò disse che non aveva avuto quell’incarico e quindi invece del premio ottenne l’ammissione a vôti unanimi di socio di quella Accademia. Il ritratto di Maria Amalia regina dei Francesi, capitato in Francia, fu applaudito da monsieur Chateaubriand e due altri, uno della signora Vincenza Grassellini duchessa di Castelbrolo dipinto di commissione del cardinale suo fratello e un altro di un prete greco, come pure alcuni suoi schizzi a penna, furono lodati dal celebre pittore cav. Camuccini. Pervenuti in Parigi alcuni schizzi a penna sulla Storia del Telemaco recativi da Giuseppe Bucalo, suo figliastro, meritarono a Patania in un giornale di belle arti604 un lungo articolo encomiastico e alla sua morte un altro necrologico col suo ritratto. Lo stesso Governo borbonico, poco curante de’ letterati e degli artisti, spinto dalla pubblica opinione, avea già decorato dell’Ordine cavalleresco di Francesco I quell’insigne dipintore. L’invidia intanto si accresceva tra i suoi colleghi che vedevano scemati assai i lavori al loro pennello e per abbatterne la reputazione605 lo discreditavano dicendo che il Patania pingesse di maniera e come suol dirsi a braccio con un falso colorito. I conoscitori imparziali e gli stranieri artisti ed amatori che visitavano sovente il suo studio giudicava_________________________________ 603 Antonino Zerega, “Sopra un dipinto di Patania”, in: Passatempo per le dame, 9 maggio 1835 e Ferdinando Malvica, Santa Rosalia pregante la Vergine perché spegnesi la peste del 1743 che la Sicilia desolava. Egregio quadro di Giuseppe Patania dipinto, da Ferdinando Malvica illustrato, Palermo, presso Lorenzo Dato, 1828. 604 Il presunto riferimento è al giornale Il Vapore. Vedi alle p. 277-284. 605 Segue cancellata la parola: “giudicavano”. 236 no all’opposto. Il vero si è che Patania non aveva fra i suoi contemporanei alcun rivale nella invenzione e composizione pittorica, ch’egli eseguiva in schizzi a penna con la rapidità del fulmine senza guardare le movenze delle stampe dei personaggi. E io spesso la sera da lui destinata a questo esercizio da lui riguardato come passatempo gli apprestai dei temi istorici e mitologici, ch’ej improvvisava subito sulla carta. E di queste sue composizioni sulla storia di Sicilia dopo di essergliene state rubate circa 60 da un suo scolare, egli mostrandosene poco dolente disse al Gallo: «Ebbene le rifarrò certo migliori perché sembrami di esser meglio progredito nell’arte» e non trascorsero che pochi mesi che furono eseguiti di nuovo. Dotato di tanta fecondità e facilità d’ingegno, egli lasciò nelle sue cartiere da circa 600 schizzi606. Questo prodigio avveniva per le sue facoltà intellettuali che in lui erano in grado eminente per l’immaginazione e la memoria. L’una che sapea attuare prontamente il il concetto artistico ideato o datogli e l’altro ritenere a memoria le attitudini e le movenze delle persone, che giudicava formar parte della composizione ch’egli diligente com’era aveva osservato e ne riteneva in serbo le immagini607 nella memoria; talché solea dire che come vivo gli si presentava il pensiero, la mano l’ubbidiva sul momento. La seconda incolpazione ch’egli pingesse di maniera era anche falsa e calunniosa e così pure la terza che il suo colorito fosse falso. Egli ritraeva sempre dal vero i movimenti dell’attitudine de’ quadri grandi che avea già determinato collo schizzo, e quelli dei piccoli quadri li ricavava spesso dal mettere in mosse i suoi scolari e l’eleganza dei contorni delle statue di gesso al confronto del vero secondo il sistema di Velasques, onde ottenersene l’evidenza e l’eleganza ad un tempo. Era impossibile poi per lui che dipinse molte centinaia di ritratti somigliantissimi di uomini, di donne, di giovani e di vecchi e di fanciulli, di cui coll’esercizio riteneva la varietà del colorito che gli apprestava la natura negli originali che avesse poi potuto falsarlo nelle figure ideali delle sue composizioni. Però come istintivo era in lui e per abitudine divenuto608 abituale il bello, avveniva che le sue figure lo mostrassero talvolta di troppo. Ed io una volta che fu chiesto da lui se nelle teste di carattere avesse raggiunto il suo insigne maestro Velasques, gli dissi francamente di no; ma l’avete bensì superato nelle teste muliebri, perché siete stato più donnaiolo di lui609 e sapete meglio esprimerne la grazia sì ne’ ritratti delle giovani donne talché tutte le belle _________________________________ La Galleria Regionale della Sicilia di Palermo custodisce i preziosi reperti. Segue cancellata la parola: “della”. 608 Segue cancellata la parola: “familiare”. 609 Segue cancellata la parola: “Rise”. 606 607 237 di Palermo han ricercato a gara il vostro pennello. Rise al mio giudizio temperato con equità di biasimo e di lode e dopo alquanti giorni cominciò a mostrarmi delineati e tratteggiati a lapis e a fumino610 in carta varie teste di caratteri differenti ch’egli indicava col nome di diversi personaggi dell’Iliade di Omero e dell’istoria conosciuti per le diverse passioni e per l’indole lor propria. Ed erano invero molto espressive. Ma osservai che ne’ suoi quadri grandi l’espressione appariva più debole e principalmente nel colorito in cui molto sacrificava all’effetto del vero; e difatti i manigoldi della Flagellazione di Gesù Cristo, quadro insigne ch’egli dipinse per la chiesa della Magione vi avrei desiderati più fieri e un colorito più fosco - nei piccoli bensì, e ne’ suoi soggetti leggiadri e particolarmente nei quadri da cavalletto. Patania vantar poteva il primato tra i pittori della sua età, e basterebbe a sua gloria l’accennare le due Veneri, l’una dell’idea del Correggio col satiro che ruba il turcasso ad Amore, e l’altra di sua invenzione col suo amante Adone che ritorna dalla caccia, che fu ammirato nella Esposizione di Firenze, come si disse.611 Altri tre piccoli quadri di singolar venustà ch’egli dipinse con amore sommo e due pel suo amico signor Giambattista Cutelli e l’atro per me. Ma tutte e tre ora pervenute in mio potere sono essi612 Venere che bacia con un viso di sentimento di voluttà e compiacenza materna il suo fanciullo Cupido, l’altro Cupido che abbraccia la Speranza mentr’essa ne sostiene viva la face; tema da me dato al pittore in contrapposto di altri quadrettini di egual misura, uno del Velasques in cui Venere allatta Cupido e l’altro di Vincenzo Riolo ove scorgesi Amore che annoda le braccia al Tempo con un serto di fiori. Il terzo quadrettino di Patania è ricavato dall’idea di Correggio sopra una stampa meschinamente incisa presentatagli per613 copiarne il concetto dal signor Cutelli e rappresenta l’Affetto materno con tre bambini, uno614 all’impiedi presso la poppa, l’altro stretto da lui colla sinistra e il terzo sul collo cui porge un bacio. In questo quadrettino di singolare bellezza, Patania corresse il disegno viziato nella incisione e sulla idea che aveva della grazia del Correggio cercò di supplirla col suo legiadrissimo pennel_________________________________ 610 Dalla forma latina lapis haematites, pietra di color rosso sangue adatta per disegnare, deriva l’italiano lapis amatita. Il teorico Filippo Baldinucci, in Vocabolario toscano dell’arte del disegno (Firenze, per Santi Franchi al segno della Passione, 1681), la identifica in «una pietra naturale molto dura, della quale si vagliono i Pittori, er fare i disegni su’ fogli, lasciandovi il suo colore, che è rosso». Fumino è il termine elaborato presumibilmente dal Gallo: è assente nel lessico tecnico, è invece presente il verbo fumeggiare, ossia degradare i colori smorzandoli mediante il chiaroscuro. 611 Segue corretto “Un altro piccolo quadro” in “Altri tre piccoli quadri”. 612 Segue cancellata la parola: “una”. 613 Seguono cancellate le parole: “l’imitazione”. 614 Segue cancellata la parola: “alla” sostituita da “all’impiedi presso la”. 238 lo quasi volendone emulare l’originale. È questo615 una gemma di ornamento del mio gabinetto, e son persuaso che opera più diligente e venusta non fu mai dipinta da quel mirabile artista. Patania fra le delizie del bello e delle grazie era giunto a non sentire più gli affanni della sua vita travagliata da un lungo morbo, che convertito in erpete, gli aveva corroso tutto il braccio sinistro ed estendevasi quasi al petto essendogli d’uopo deviarne l’umore di due emissarî alle gambe che disseccati lo tolsero a’ viventi per l’umore che gli assalì il petto in poche ore nel nevoso febbraio 1852 e spirò tra le mie braccia co’ suoi consueti sentimenti e gli ajuti della religione, e fu accompagnato al sepolcro da tutti gli artisti anche da quelli che gli erano stati avversi in vita. Noi abbiamo voluto premettere questo articolo a maggiore schiarimento della sua necrologia scritta da616 Carlo Frataccia suo scolare e pubblicato la prima volta nel Giornale dell’Armonia in Palermo617 e riprodotto nel Poliorama pittoresco col suo ritratto somigliante nell’anno 1853 a pag. 279 e sg.ti. Necrologia di Giuseppe Patania Il dì 22 febbraro 1852 il pittore Giuseppe Patania mancava ai viventi. Spirava fra le braccia dei congiunti e degli amici che non sapevano reggere a tanto strazio. Una crudelissima cistite che per lunghi anni afflisse la sua esistenza già in preda a tanti mali, vinse le sue tenui forze vitali. Eppure non potea concepirsi come questa esistenza tutta concentrata nello spirito, questa vita in cui solo brillava il pensiero, questa larva animata dal genio si fosse spenta. Nella stanza contigua ove giacea fredda la salma dell’artista, egli vivea nelle sue opere di cui parte, ordinavano le pareti e confortavano il riguardante, che in quelle era chiuso un avvenire per l’illustre pittore. Patania nacque per l’arte. Fu dotato di altissimo ingegno e dalle sole prime notizie del disegno seppe elevarsi alla sublime conoscenza dell’arte pittorica non meno che all’analisi filosofica del cuore e degli atti umani; e quindi di trasferire nelle sue opere questo sapere vestito delle forme sensibili dell’arte. Una spontaneità nel comporre, una618 evidenza nel conce_________________________________ Seguono cancellate le parole: “il meglio”. Seguono cancellate le parole: “chi gli fu”. 617 Carlo Frataccia, “Necrologia”, in: Giornale dell’armonia, a. 3, n. 18 (29 febbraio 1852). L’articolo non è firmato. 618 Segue cancellata la parola: “conoscenza”. 615 616 239 pire i soggetti, un sano giudizio nella esecuzione erano i suoi primi pregi che lo somigliano a’ più grandi artisti. Egli era uso dire che allorquando volea comporre, gli si rappresentava così viva l’idea del quadro, che gli parea toccarlo; e la mano mal prestavasi per ubbedire alla foga del pensiero. L’anima sua gentile gli dettò uno stile nel pingere che da’ classici non avea potuto apprendere a cagione della sua inferma salute che gl’impedì di recarsi a studiare in Roma. Egli fu però nel colore di un sentire tenero e di un affetto mediocre, amando meglio la calma anziché quel tono vibrato che sovente abbaglia la vista ma non muove l’intelletto e il cuore. Ne’ suoi quadri oltre l’eleganza del disegno s’operò quasi sempre una convenienza ed uno spirito proprî del genio e congiunti alla riflessione. Molti sanno ch’egli componea del continuo, e lasciò infatti una innumerevole quantità di schizzi o a dir meglio composizioni a contorno. Le ore che v’impiegava erano per lui le più deliziose della vita, poiché diceva esser la composizione l’unico lavoro del quale rimaneva soddisfatto quand’ei, pingendo ricorrea alla mente colle opere dei più grandi artisti desistea spesso dal lavoro e con trasporto ne parlava agli amici, talché parea informarsi del genio degl’illustri pittori; e ne ragiovava con tanto gusto nell’arte, che, tenendo parole di Raffaello fu visto cadergli qualche lagrima. Ma in Patania non si è perduto solamente l’illustre pittore. Era egli il padre di quanti artisti a lui ricorrevano, de’ giovani che accoglieva nel suo studio per educarli nell’arte, dei poveri che domandavano il di lui soccorso. Ei dirigeva gli uni nelle opere di arte; istruiva gli altri nei principî con quel disinteresse, con quello impegno ch’è proprio delle anime benfatte e grandi. Era giusto e spassionato ammiratore del619 merito degli artisti suoi contemporanei e cercava sempre lodarne i pregi serbando un ammirevole silenzio per la parte dei difetti. Sensibile sino al grado del fanciullo amava il bello in modo che lo movea a sdegno il deforme. Il suo cuore accoglieva con tanta tenerezza la virtù con quanto orrore detestava il vizio. Dolce e insinuante nei modi, nel conversare era tanto piacevole che rendeva difficile a chiunque il prender commiato da lui. Ragionava con tanto buon senso della sua patria e sulla morale e sopra altre difficili materie che gli uomini dotti aveano qualche volta a cavarne argomenti di nuove ed utili riflessioni. Benché innoltrato negli anni, il suo cuore non avea perduto le dolci illusioni della gioventù ed era ardente nei desiderî e nelle speranze. Fiero della sua dignità, e modesto del poco in vita sino all’umiltà, sapea a proposito _________________________________ 619 Segue cancellata la parola: “genio”. 240 lanciare uno sguardo fulmineo, una parola sdegnosa e accogliere senz’alterigia la lode scevra d’adulazione. Fermo ne’ suoi proponimenti, anima umana non potea rimunerarlo mai. Rifuggiva dalla idea della vendetta, se alcuno volea nuocergli, o gli nocque. Odiò i tristi, perché amava la virtù non già perché lo avessero costretto a tracannare il calice dell’amarezza. Fu alto di statura, nobile e gentile di forme, il suo naso alquanto sformato per morbo aggiungeva per lui una caratteristica anche più interessante. Gli occhi eran grandi e pieni del fuoco del genio, e quegli occhi ubbidivano a tutti i modi del suo intelletto, informavansi di tutti i sentimenti del suo cuore. Avea lunghi i capelli, e quella chioma ormai fatta rara, chiudeva come in una cornice un bianco volto tinto di un interessante pallore, e in cui la vita del pensiero parea reggere l’esistenza organica del grand’uomo. Vivendo chiuso sempre in una stanza nella quale una tremenda malattia l’avea forse da un 20° confinato, lavorava incessantemente né mai stancavasi, impiegando più di 12 ore al giorno in profonde applicazioni. Costretto ad esser parco nei cibi, a limitarsi entro una sfera ristrettissima di fisiche soddisfazioni, la sua vita era un miracolo; la scintilla inventrice del suo genio lo reggeva, anzi parea che l’arte sola fosse l’unica sua vita; ed egli ripetea di continuo, in tuono malinconico ch’era stanco alfine d’una esistenza piena di dolori, che il solo amor dell’arte gli rendea sopportabile, e ancor men dura. Ed il momento fatale si appressò e fu sì breve che rispose affatto a’ suoi desideri. Parlò con coraggio del suo fine. Ringraziò a Dio che lo conducea in porto e con serenità ricevé gli estremi ufficî della religione. Quando egli compiva la sua carriera toccava gli anni 72. Chi scrive queste parole, con l’anima rattristata per la perdita di un tanto uomo, non può tratteggiare in breve cenno la vita di un artista degno di eterna memoria, e sul quale l’Haez620 e il D’Azeglio non che molti altri artisti non italiani hanno profferito onorevoli sentenze. Il suo corpo fu seppellito nella chiesa di S. Maria di Gesù dopo essere stato accompagnato da tutti gli artisti di Palermo. Sui pittori G. Patania, G. Velasques e Giuseppe Camerano Michele Cortegiani621 stato scolare di Patania, rapportava al signor _________________________________ 620 621 Francesco Hayez, pittore storico, nato a Venezia nel 1791, morto a Milano nel 1822. Michele Cortegiani, pittore, nato a Napoli nel 1857, morto a Tunisi dopo il 1897. 241 Ferdinando Milazzo che ritrovandosi in Roma ed essendo un giorno in compagnia di varii artisti, e fra’ quali il nostro cavaliere Natale Carta egregio pittore, e il commendatore Tenerani622 celebre scultore *** si mosse discorso dal Cortegiani sul merito pittorico del Patania e specialmente nella pronta invenzione. Carta soggiunse in alcune cose è certo un valente artista. Il Cortegiani disse vol farvi meglio conoscere anche da un semplice disegno a penna di sua invenzione delineato sotto gli occhi miei in due ore, e corse subito alla vicina sua casa, poco dopo recò all’onorevole brigata il disegno a penna d’una Venere giacente con Cupido in un’amenissima campagna; quindi può idearsi quella di Cipro o di Citera. Fu tosto diligentemente contemplato da tutti gli artisti quel disegno e fu ammirato per la grazia e623 l’espressio[ne] e pel buon disegno, per la facilità d[…]co della penna, e il commendator [Tene]rani in particolare lodollo per la […] qualità prevalente nel suo famoso Cupido e in altre statue di soggetti leggiadri. Un simile caso avvenne a me in Napoli quando il cav. Vincenzo Camuccini insigne pittore, avea recato ivi il suo egregio quadro del miracolo di S. Francesco di Paola che resuscita un morto, e si ammira nella chiesa di quel santo, di contro al Real palazzo di città. Era stato egli invitato a pranzo con me dal marchese Tommaso Gargallo. Costui mostrò al Camuccini tre bozzetti del nostro Giuseppe Velasques, e due disegni a penna del Patania. Questi, alla mia presenza, disse: Velasques è un gran pittore, guardando poi attentamente i disegni del Patania, chiese l’età di lui che allor contava anni 38, e saputala disse: costui mostra un felicissimo ingegno nell’invenzione e una grazia ed espressione singolar con la penna; ma difetta nella prospettiva degli edifici di cui ha ornato una composizione e di ciò resi tosto avvertito per lettera il Patania che d’allora dessi a studiar meglio la prospettiva, comprando qualche opera su tale oggetto. Quando poi rividi in Roma il Camuccini dopo molti anni il Camuccini nel 1841, egli ricordandosi del Velasques, e di Patania del quale dicevami di averne ammirato il Ritratto della duchessa di Brolo presso il figlio, monsignor Grassellini, e un altro di un greco-sicolo, mi chiese se ancor vivevano ed io gli dissi che il primo era morto nel 1827 e l’altro viveva ancora, e progrediva nell’arte, affollato di commissioni. Il Camuccini dissemi: potete vantare due valorosi artisti e per la grazia della pennetta e del pennello particolarmente Patania, e prima di essi quel Mariano Rossi624 da _________________________________ 622 Pietro Tenerani, scultore, nato a Torano, Carrara, nel 1789, morto a Roma nel 1869, rappresentante del neoclassicismo europeo. 623 Il testo che segue è incompleto per una lacuna della c. 337. 624 Vedi nota n. 408. 242 Sciacca per il chiaro-scuro e colorito e grandi composizioni sebbene sentano alquanto di maniera ne’ panni e nelle attitudini convenzionali; e di più fra’ pittori giovani e viventi il vostro Natale Carta qui soggiornante che gareggia co’ migliori nel dipingere il ritratto, e si distingue ne’ quadri di leggiadro argomento pel suo delicato stile Guidesco625. Don Ferdinando Milazzo intimo amico di Patania al pari di me, Agostino Gallo, riferivami che un giorno si facevan alla sua presenza del giovane medesimo pittore Calogero De Bernardis626 elogio d’un quadro in una chiesa di Sciacca, d’un quadro da lui attribuito a Mariano Rossi Patania gli domandò che rappresentasse e la chiesa ove fosse. Quegli glielo disse.627 Patania sorridendo rispose: [il] quadro da molti anni fu dipinto da [Mariano] Rossi. Eb[…] rerico il [De Be]rnardis: Allora voi dipingevate meglio d’ora. Montò in furia il Patania e disse: E tu minchione che sapesti distinguere il mio stile tutto diverso da quello di Rossi, pensi giudicar se allora pingeva meglio di adesso? Anche Giuseppe Camerani628 che nato in Sciacca dimorò sempre in Napoli e segnalossi nelle629 complicate composizioni sì istoriche come quel del Gran Sipario del Regio Teatro di S. Carlo, lodava il Velasques col Patania, e dicevami che al primo avea servito da aiuto, trovandosi a Palermo in gioventù. Il Camerano poi menava vanto di esser nato siciliano, e quando era in broncio con altri artisti napoletani, dir soleva: io son siciliano, né mi lascio vincere da voi marmotte. Egli scriveva versi danteschi napoletani ed epigrammi piccanti e per diletto rappresentava benissimo in Carnevale ne’ teatri privati il personaggio di Pulcinella in cui erasi reso fanno suo padre. Or quando intese che un artista napoletano detto avea ch’era miglior Pulcinella che pittore, gli disse: il rappresentando quel personaggio mi propongo di far ridere, ciò che ottieni tu dipingendo, ed io all’incontro col pennello fo’ guardare con attenzione e diletto i miei quadri. Ad un altro pittore, suo nemico, che avea fatto una Venere accovacciata, e un Cupido in piedi con la caccia aperta, figure leccate e con sfumature condotte, scrisse per epigrafe il Camerano: Pittura liscia, liscia/ l’Amore caca, Cupido piscia. _________________________________ Riferimento allo stile del pittore Guido Reni, nato a Bologna nel 1575, ivi morto nel 1642, educato nell’Accademia emiliana dei Carracci. 626 Vedi nota n. 487. 627 Segue cancellata la parola: “Allora”. Il testo che segue è incompleto per una lacuna della c. 337. 628 Giuseppe Camerani (o Cammarano o Camerano) pittore, scenografo, nato a Sciacca nel 1766, morto a Napoli nel 1850. 629 Segue cancellata la parola: “grandi”. 625 243 Camerano lasciar voleva un ricordo di riconoscenza nel Duomo della città di Sciacca, ov’era nato, un suo quadro della Beata Vergine per la predella dell’altare maggiore e scrisse al Vicario per inviargliene la proporzionata dimensione. Costui gli mandò la misura d’un immenso quadro del cappellone. Il Camerano disgustatosi per l’indiscrezione come dicevami non gli dipinse e donò né l’uno né l’altro. Dipinse bensì, per la mia Collezione degli uomini illustri siciliani, il suo ritratto da me chiestogli e pagatogli discretamente, ch’è somigliante e ben dipinto al quale apposi la seguente epigrafe: Gius. Camarano nato in sciacca nel 1765, morto in Napoli nel 1850. Pittor e poeta, comico e faceto / sé, e la patria onorevol in sul sabato. Lasciò un figlio per nome *** pittore scenografo e un altro *** poeta egregio, comico. Un anedoto [!] della vita di Giuseppe Patania, celebre pittore palermitano Giuseppe Patania fu pittore operosissimo di pronta esecuzione, essendo di pronta immaginazione, e di rapido e instancabile pennello. L’amore dell’arte e della gloria era in lui prevalente sull’amor del guadagno, e del denaro. Di fatti metteva egli un prezzo assai discreto alle belle opere sue, che per l’indicata qualità del suo ingegno, furon pressoché infinite, particolarmente i ritratti, i piccoli quadri da cavalletto in che egregiamente e principalmente riusciva. Cumulò quindi nella lunga sua vita alquante migliaia d’onze; non ostante che molto spendesse per la sua cronica infermità, pel suo sostentamento, per soccorsi mensili dati al padre, al fratello, e per largizioni segrete a’ poveri artisti. Rapporterò un fatto narratomi da un pittore adornista sulla beneficienza usatagli dal Patania. Nella rivoluzione del 1848 era quegli senza lavoro, e una mattina, privo di mezzi, di dare vitto alla sua famiglia, visitò Patania, che trovavasi solo, si accorse costui dell’aria mesta dell’altro. Ne indovinò la cagione e il soccorse, senza richiesta, di onze due. Nella sua stanza da studio tenea due grandi scanzie di principalmente di storia, di mitologia, di costumi antichi e moderni, di autori d’opere d’arte, e di poeti. Eran questi ben legati, e in buon ordine disposti. Erasi egli fornito di sacchetti da potere ciascuno contenere onze630 cento. Dietro i libri _________________________________ 630 Segue cancellata la parola: “cinquanta”. 244 delle superiori scanzie teneva nascosti quei saccetti pieni di moneta di argento, e in uno di essi riunite molte di oro. Con nessuna precauzione quelle scanzie eran fermate da una piccola chiave e da un cricchetto interno; talché con lo scu<o>terne i telai si staccava il crocchetto, e quelli si aprivano. Dormiva egli in un prossimo camerino. Alzatosi da letto una mattina nell’entrar nella stanza da studio si accorse di essere aperti gli sportelli delle scanzie. Suppose che nella notte gli fosse stato rubato il danaro; ma temendo che col verificare il sospetto dovesse soffrirne dispiacere, chiuse nuovamente gli sportelli, e si pose, secondo il consueto, a dipingere. Però non ripose più altro denaro che ricavava pe’ suoi lavori in quel sito, ma in un armadio meglio custodito. Alla sera io, e D. Ferdinando Melazzo, ch’eravamo i più intimi amici di lui, trovandoci in sua casa, egli ci narrò l’avvenimento accennato, e il suo sospetto che chiudea nel cuore da sei o più mesi. Amendue sclamammo: oh, poi questa vostra è un’apatia senza esempio. Rispose scusandosi, che non voleva aver certezza di ciò che potea nuocere alla sua salute. Replicammo: dunque tenete quasi per certo che il danaro vi sia stato rubato? Si, per vero; perché i chiusi le scansie e le ho trovate aperte. Se dunque adesso ne foste confermato coll’ispezione ne soffrireste gravemente. Non più; perché son persuaso che il danaro mi è stato involato. Dunque verifichiamo il fatto. Ecco le chiavi, e tosto ce le porgette. Rimaneva intanto impassibile al suo tavolino a tracciar di penna un disegno, sua occupazione consueta, e gradita della sera. Furon da noi aperte le due scanzie, buttati a terra i libri, e nella prima osservossi un vôto di spazio di631 quattro sacchetti, rimanendovi gli altri in serie successiva. Allora egli alzò gli occhi, e disse: meno male, mi è rimasa tanta somma da poter viver alquanti anni stentatamente, se non avrò più lavori. Tolsimo via i libri dalla’altra superore scansia e vi632 trovammo sacchetti. Me l’era aspettato, rispose, egli, senza alterarsi punto. Convien aver pazienza! Ma veggiamo se possiam trovare negli altri scaffali. Fate – replicòSgombratine tosto i volumi, apparvero i sacchetti. Li vide il Patania, e sclamò: mano male. I ladri sono stati discreti, m’involarono soltanto alcuni sacchi dell’altra libreria. Fatto allora il calcolo sul numero di essi che occupar doveano e sulla somma che approssimativamente come gli altri contener potevano, rilevossi che il furto era di onze 350, fra le quali 50 in oro. _________________________________ 631 632 Segue cancellata la parola: “sette”. Seguono cancellate le parole: “furon trovati”. 245 Spintolo a dirmi su qual persona cadevan i suoi sospetti per farne reclamo alla Polizia, rispose di essersi avvenuto che una sua cameriera entrata in casa poverissima, in progresso facea sfogio di abiti di seta, di scialli, di ornamenti d’oro, e che da un mese prima gli avea chiesto congedo sul pretesto ci convenirle meglio far sicari che servire. Con renitenza divenne il Patania a presentare a suo nome ricorso alla Polizia. Fu eseguita visita domiciliare alla donna. Le fu trovata una casa ben fornita e un cinto di cujo con le onze cinquanta di moneta d’oro. All’interrogazione fattale dal giudice rispose che co’ risparmi del suo salario avea raccolto, e convertito in oro quel denaro. In difetto di altre prove, il giudice la sciolse in libertà, e il Patania ne pur se dolea, e diceami: era meglio di secondar la mia volontà di non ricorrere alla Polizia, e al giudice. Altra volta gli furono anche rubati sessanta bellissimi disegni a penna di storia di Sicilia fatti di sua invenzione ed eseguiti mirabilmente a penna, dissemi freddamente: li farò nuovamente, e migliori nella composizione, perché ora ho progredito alquanto nell’arte; in meno di due anni li rifece, e son quelli in parte ch’io comprai da’ suoi eredi. Osservazioni di Patania sul rame del Toschi633 del quadro dello Spasimo di Raffaello raccolte a 10 settembre 1847 Il rame è della altezza di palmi due, e oncie sette, largo palmo uno ed onze undici collo scritto: Lo Spasimo di Sicilia dal quadro originale nella R. Galleria di Madrid. A Ludovico, re di Baviera. Pubblicato a Mannheim da Arteria e Fontaina a destra Raffaele d’Urbino dipinse a sinistra, P[aolo] Toschi disegnò a Parigi, e incise a Parma. La composizione è ottimamente ideata, giudiziosamente distribuita ed essendo disposta in un quadro per lungo di piccola estensione ha dovuto faticare la mente di Raffaello per superare la difficoltà di esporre ordina<ta>mente, senza confusione, sedici figure oltre quelle di piccolissime macchie, che tutte hanno un particolare ufficio nelle quali, sebbene alcune si scorgano a metà, altre anche erano tutte634 bensì fanno argomentare per la parte visibile l’intero movimento e l’attitudine di quella che non si vede. _________________________________ 633 Toschi Paolo, pittore, incisore, architetto, nato a Parma nel 1788, ivi morto nel 1854, interprete originale anche delle opere del Correggio e del Parmigianino. 634 Segue cancellata la parola: “mostrano”. 246 L’intera composizione è divisa in due grandi masse, e suddivisa in due principali numerosi gruppi di figure, nella parte più bassa, e in un altro dal lato sinistro, e in una figura anche superiore dal destro. D’onde risulta una mirabile armonia, e varietà delle linee, e635 la figura geometrica dei due semicerchi opposti; mentre poi il centro costituito dalle figure basse piramideggia, e presenta un grazioso contrasto, e una bella varietà nello insieme, e colla parte superiore, lasciando nel centro signoreggiare il Cristo come oggetto principale. Il gruppo inferiore a destra è composto di cinque figure, cioè dalla Vergine Madre, da tre Marie e dal San Giovanni636. In questo gruppo visibilmente richiama l’attenzione, come dovrà, la Vergine Madre. L’altro gruppo inferiore, a sinistra, si compone di quattro figure in avanti, e di più indietro, e fra’ queste il Cristo trionfa su tutte. È d’esso in atto di sostenere colla sinistra mano sopra un sasso dopo di esser caduto sotto l’ingente peso della Croce, mentre il Cireneo procura di sollevarla per farlo risorgere. Un manigoldo intanto colla lancia lo minaccia incitandolo di far presto, e l’altro volto di spalle colla fune che legata al cinto del Cristo, procura di tirarlo. Un soldato collo scudo par che riceva gli ordini dal proconsole a cavallo che appartiene al gruppo superiore a sinistra ed è accompagnato da altri capi della nazione giudea, e da due soldati. Alla parte opposta havvi un centurione a cavallo colla bandiera spiegata colle lettere iniziali S.P.R., che precede l’accompagnamento al Calvario. Il campo a destra presenta superiormente una delle porte della città; il rimanente mostra il Calvario con637 alberi, e piccolissime figure638 in più gruppi. In uno si scorgono i due ladroni accompagnati da manigoldi, e seguiti da un personaggio639 con corona radiata che par che voglia indicare il re Erode; in un altro piccolo gruppo si veggono alcuni che portano una scala, al lato opposto alcuni viandanti su i cameli, e per per mezzo altri individui che si diriggono alla parte superiore del Calvario, ove stendesi un piano con due croci già piantate, e dove dovrà similmente innalzarsi quella del Cristo, ove scorgesi il popolo che attende la crocifissione de’ tre destinati all’ultimo supplizio. Si è voluto descrivere questa parte accessoria, e le piccole macchiette per mostrare che in questa composizione di Raffaello nulla è vizioso, tutto si collega al soggetto principa_________________________________ Seguono cancellate le parole: “una bella”. Seguono cancellate le parole: “nel quale”. 637 Segue cancellata la parola: “piccoli”. 638 Seguono cancellate le parole: “. L’Aria è”. 639 Segue cancellata la parola: “coronato”. 635 636 247 le, e tutto tende a svilupparne l’azione direi drammatica. Volgendo ora l’attenzione alla parte del disegno, giova osservare che nell’eleganza consueta di Raffaello all’imitazione del vero, alla nobiltà, e bellezza delle forme in ciascun personaggio secondo il proprio carattere, Raffaello volle congiungere un certo carattere di grande non eccedente ricavato bensì dal naturale dei manigoldi scelse una robustezza di forme, e particolarmente nella figura innanzi, volta di spalle di colui che sostiene la corda640 ed è uno de’ carnefici, ove il braccio muscoloso sinistro, e le gambe poderose mostrano tutta la forza virile. Il Cireneo anche vigoroso, pure al paragone del carnefice è meno, ed il soldato colla lamia anche meno di costui, è meno l’altro collo scudo che stà dietro; talché in quattro figure mostrasi una degradazione di forza secondo il rispettivo officio di ciascuno. La testa di Gesù Cristo è grande, e nobilissima, come pure quella della Vergine Madre sebbene di un carattere più gentile appropriata al sesso muliebre, e alla sua età, e questa nobiltà va insensibilmente degradando in due Marie, e nel S. Giovanni, giacché nella terza, quasi in profilo si avvicina alla Vergine Madre, mentre nella Maria atteggiata a mani giunte, il disegno si piega ad una maggior gentilezza, e leggiadria. Nelle figure superiori si scorge un carattere di un disegno al naturale, e meno grandioso. Se il quadro è ammirevole per l’espressione, e il disegno secondo i rispettivi caratteri, lo è vieppiù nella espressione vera, e toccante, e nella movenza delle figure, in che Raffaello non fu da nessuno superato, anzi viene riguardato come il filosofo dei pittori; egli è vero che a questa parte molto contribuisce la composizione stessa, e il disegno, ma pure havvi un elemento tutto proprio che il pittore sa cogliere nelle osservazioni del cuore umano, e colle passioni che si modificano in società, secondo la qualità delle persone. E in questo riguardo puossi asserire francamente che il quadro dello Spasimo è superiore a tutti gli altri quadri di Raffaello, avendo egli saputo trarre profitto dal soggetto che presenta la scena più commovente che possa esservi in società, quella cioè dell’incontro di un infelice madre col suo figlio condotto al supplizio, e straziato acerbamente dai manigoldi nel tragitto. E cominciando dalla Vergine Madre si strugge essa in lagrime sopraffatta da cupo, immenso e profondo dolore nel tremendo abboccamento, e mostrasi sfinita dal dolore in mod, che la mano destra è quasi sul punto di cadere abbandonata, e cadrebbe per terra lungo la persona se non fosse sostenuta dalle ascelle da due pietose Marie, e sembra anche dal S. Giovanni. La testa, e il petto pendenti in avanti _________________________________ 640 Seguono cancellate le parole: “ch’è una specie”. 248 mostrano il vivo desiderio di avvicinarsi al suo caro figlio, e quasi l’irresistibile istinto di volerlo soccorrere, il cordoglio è minore nelle altre figure di questo stupendo gruppo e quello della più giovane delle Marie più tenero, ed affettuoso come questa passione esser suole nella più fresca età. La Maddalena ch’è la terza figura più indietro che la sostiene per l’ascella, mostra ad un tempo l’ardenza dell’affetto, e del dolore, ma che pure le permette di dire alcune parole al Cristo, laddove la V.M. è641 sopraffatta dal dolore, e può volgerle appena qualche parola; mutolo e piangente è pure il S. Giovanni, ma sembra più intento a soccorrer la Madre e voglia quasi evitare ad osservar lo strazio di Cristo. Piange con dolore più aperto l’altra Maria, in ginocchio, che sostiene la V.M. Il Cristo è predominato da due intensi dolori, quello dello strazio che soffre nell’essere trascinato, e gravato dell’immensa croce, e vieppiù dal dolore dell’afflizione della Madre. Lo scontro degli occhi suoi con quelli di lei, è d’una espressione che non puossi indicare in parole, e in questo la pittura di Raffaello è superiore alla prosa e alla poesia la più commovente, energica ed eloquente. Le attitudini principalmente del Cristo e della Vergine Maria secondano la forza delle espressioni, il Cristo piega verso la Madre la testa, ed essa similmente verso il Figlio642. Il Cristo piange, e il suo volto è sparso di lagrime, e di sangue, ma le lagrime sono più abbondanti nella Vergine perché il Cristo coopera volontariamente al gran mistero della Redenzione, e non versa lagrime che per gli affanni della Madre, laddove essa è strazziata dai patimenti del figlio, e versa lagrime più copiose spinta dall’amore materno. L’espressione643 si manifesta anche nelle parti accessorie per indicare che la caduta del Cristo è avvenuta nello istesso momento dello scontro saggiamente ha dipinto le pieghe della larga manica del braccio sinistro nel punto che stan per trascendere giù spinte dal peso naturale del grosso pannolano. Similmente per dare migliore effetto di espressione graziosa alla Maria in ginocchio che sostiene la Vergine Madre colla sinistra, e non lasciarla senza l’altra mano visibile immaginò il pittore che il manto della Vergine Maria era sul punto di caderle indietro dalla testa, e la Maria lo rialza, e così fa scorgere l’altra mano. Il carnefice poi mostrasi al tutto impaziente del ritardo della funesta esecuzione cagionata dalla caduta del Cristo, e colla destra sgarbatamente tira la corda che lo lega al Cristo, _________________________________ Seguono cancellate le parole: “quasi muta”. Seguono cancellate le parole: “il movimento degli occhi, e delle ciglia”. 643 Segue cancellata la parola: “mostrasi”. 641 642 249 mentre rivolgesi al Cirineo di accelerare l’inalzamento della Croce che avrebbe ritardato di potersi il Cristo rialzare. Dietro al Cireneo havvi un manigoldo che mostra tutta la ferocia dell’animo perocché mentre colla sinistra calca la Croce sul Cristo caduto onde fargliene più soffrire il peso par che lo derida, e allo stesso tempo lo minaccia con la punta [della] lancia644, tarda a risorgere. Il Cirineo poi che ben si accorge dell’inumanità di quell’uomo efferato mentre con ambe le mani si affretta a rialzare la croce, indispettito sembra che lo rimproveri di tanta crudeltà. Il645 vessillario a cavallo ha tutto il nobile contegno di un militare romano. Il proconsole Pilato a cavallo dal lato opposto sul volto esprime una certa commiserazione in conformità di quella dimostrata allorquando646 gli venne strappata la sentenza del popolaccio ebreo, e dai scribi, e farisei, e fa intravedere ancora quella dubbiezza di carattere che lo costituisce un imbecille nell’istoria della Passione di Cristo; all’incontro l’ebreo capo del popolo, che gli sta a fianco, manifesta in viso tutta la burbanza e la severità di un animo freddo che con pronta volontà si presta647 all’ingiusta esecuzione ordinatagli dal Governo, gli altri soldati hanno un’aria triste, e quasi son pervasi dall’ingiusta esecuzione. Chiaro-scuro Sebbene non sappiamo argomentar compitamente del merito del chiaro scuro del quadro che in parte risulta dai tuoni dei colori perché lontano dagli occhi nostri, pure fidando nell’abilità del Toschi che n’eseguì egli stesso il disegno, mentre questo capolavoro, trovavasi in Parigi648 ne diremo alcunché guidati soltanto dal suo egregio rame. Per quanto permette la dimensione del quadro in linea perpendicolare la luce, non potea meglio distribuirsi in tutte le parti principali, ed accessorie, perocché essa dal lato destro, e quasi per angolo, và a diffondesi sugli oggetti, e siegue il suo movimento della composizione e si comporta con molta intelligenza nei due gruppi principali, quello cioè della Vergine, e dei manigoldi dal lato opposto649. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “il Cristo”. Seguono cancellate le parole: “soldato che sostiene la bandiera spiegata”. 646 Seguono cancellate le parole: “a viva forza”. 647 Seguono cancellate le parole: “con piacere”. 648 Seguono cancellate le parole: “che n’eseguì egli stesso il disegno”. 649 Seguono cancellate le parole: “; lasciando il corpo l’abito del Cristo in oscuro con qualche tratto di luce scegliendo”. 644 645 250 Per effetto di questa collocazione e distribuzione di luce, risultano grandi masse di chiari e di oscuri. Laonde il piano avanti del terreno è tutto in ombra ove si scorgono sassi, e piante screziate appena di luce a interromper la monotonia della massa oscura. Per tale effetto il pittore ha scelto anche per l’abito del Cristo un colore opaco, giacché650 quello chiaro gli avrebbe guasto l’effetto. Chiari però651 ha fatto gli abiti del Cirineo, e dei manigoldi per dare una massa di luce a questo gruppo che si equilibra al gruppo opposto delle Marie. In questo bensì la luce principale è riunita sulla Vergine Maria, onde richiamare l’attenzione su di essa del riguardante, perché il soggetto è propriamente lo spasimo della medesima. E qui è da osservare che per conseguire questo oggetto le pose addosso varj bianchi veli, che richiaman più la luce, e lasciò il di lei volto in chiaro ed in contrapposto in minor luce la figura in ginocchio di una delle Marie in primo avanti, onde meglio far risaltare l’altra. L’istesso artificio si scorge sull’altra Maria più vicina e sul S. Giovanni, e maggior luce che in costoro havvi nella più giovane Maria situata nell’alto del gruppo, e così gradatamente va decrescendo la luce sull’altro gruppo superiore del Pilato coi compagni, e similmente nella652 figura opposta del portabandiera. In contro posizione poi di questa gradazione di luce, ha saputo distribuire in grandi masse le ombre per l’effetto generale del quadro, e parziale delle figure, dando una maggiore forza e intenzità di ombre nel terreno di primo avanti653. Né deve sfuggire all’osservatore che per conseguire questo effetto ha saputo scegliere opportunamente la qualità, ed i colori di panni che anche nella cattiva copia che ne abbiamo in Palermo si possono, in conferma, osservare e nelle parti anche accessorie ben si scorge la stessa sagace intelligenza, perocché come la luce va degradando nella parte superiore del quadro654 e nel cielo che mostrasi in aria cupa. Così la bandiera spiegata è trattata di un tuono più in basso dello stesso vessillario, e la fabrica in opposto presenta una massa di oscuro all’angolo onde concentrarsi tutto l’effetto di chiaro, e di scuro ne’ gruppi inferiori, il che giova opportunamente allo stacco, e allontanamento del655 monte Calvario in fondo del quadro. Le pieghe degli abiti de’ varj personaggi sono, in generale, trattati con verità, e con largo e bello stile, ma particolarmente secondo la qualità656 della materia del tessuto. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “con color”. Segue cancellata la parola: “affatto”. 652 Segue cancellata la parola: “gruppo”. 653 Seguono cancellate le parole: “coll’aspetto”. 654 Seguono cancellate le parole: “il cui cielo che mostra il”. 655 Seguono cancellate le parole: “piano, che”. 656 Seguono cancellate le parole: “di pannolano o di pannolino”. 650 651 251 In effetto657, quelle di pannolano sono più grandiose,658 e le altre di materia di tessuto; e materia più fina sono più sottili, tal che se ne può riconoscere la loro rispettiva qualità. In somma, in questa parte Raffaello come in altre della pittura tenne il primato, e in questo quadro mostrossi in essa non meno studioso, sagace, e diligente che nelle altre parti, ma sopra tutto trionfa il suo merito pittorico per l’espressioni come abbiamo osservato di sopra, in cui sembra difficile non che di poter essere eguagliato, ma superato. Giuseppe Patania Patania compose, e delineò due schizzi a penna pel marchese Tommaso Gargallo, allora residente in Napoli, affinché scegliesse uno tra essi per soggetto di un quadro che egli doveva commettere. Un di questi rappresentava Cicerone che rinveniva in Siracusa il sepolcro di Archimede, tema favorito del detto Gargallo, e ch’egli precedentemente avea affidato al Velasques, e per ragion del prezzo non poté ottenerne il quadro, come indicai nella sua vita. L’altro rappresentava il Verboso contrasto fra Damone e Pitia pittagorici siracusani innanzi al tiranno Dionisio, cui eran divenuti sospetti, affinché l’uno liberasse l’altro dalla morte accusandosi ciascuno reo. La composizione di amendue gli schizzi era ricca di figure, ma il secondo, come era conveniente, era caldissimo di espressione. Il marchese Gargallo volle mostrarlo a Camuccini che allora era in Napoli, un giorno ch’eravamo stati invitati a paranzo da lui, come pure gli volle mostrare due bozzetti del Velasques che aveva nella sua collezione di quadri. Il Camuccini lodò molto pel disegno le opere del Velasques; ed osservando poi gli schizzi di Patania, ne commendò la composizione, e la grazia, e franchezza come eran condotti a penna. Però osservò in quello di Damone e Pizia che le linee delle fabbriche non ricorrevano bene secondo le leggi di prospettiva, e a di più che sembravagli poco giudizio che il carnefice il quale attendeva la fine del contrasto659 di quei due eroi dell’amicizia, e la decisione di Dioniso per dar la morte ad uno di essi fosse in sì grande attitudine di sorpresa, dicendo il Camuccini che in un manigoldo di cuore sembrar doveva incompetente tal sentimento espresso dal pittore. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “le prime sono” Seguono cancellate le parole: “e sinuose”. 659 Seguono cancellate le parole: “di uno”. 657 658 252 Il marchese Gargallo riferì per lettera l’opinione del Camuccini, e Patania, persuaso del suo errore, quanto alla parte prospettica architettonica l’emendò, anzi ciò gli diè occasione di studiar meglio la prospettiva, e si fornì di libri all’uopo. Per riguardo all’attitudine del carnefice, volle sentire l’opinione di Don Giuseppe Tortorici, uomo assai dotto e intendente delle belle arti660, il quale così ragionò sull’istoria nello schizzo raffigurata ch’indusse il dipintore a quell’atteggiamento. Strano e singolare era il caso di due che, per amicizia, s’incolpano all’oggetto l’uno di salvar l’altro dalla morte. Il tiranno Dionisio ne fu tanto colpito che infine liberò entrambi dalla pena decretata. Il carnefice s’era avvezzo al sangue non era però avvezzo a scorgere simile lotta di straordinaria virtù. Era anch’egli un greco-siculo di energico sentir dotato, e quindi ammirar dovea quel tratto di virtù straordinaria, e rimanerne stupito, ed esprimer co’ gesti la meraviglia. Molti approvaron l’opinione del Tortorici, e Patania non credet<t>e dovere emendare lo schizzo nella parte di censura fattagli dal Camuccini. Io era allora in Napoli (1819). Pranzai una volta in casa del vecchio principe di Cassaro, ove era stato invitato anche il Camuccini. Alla fine del pranzo mi accompagnai con lui, e mosso discorso del Patania, egli encomiollo per que’ due schizzi come pure lodò il Velasques per li suoi bozzetti. Essendomi poi nel 1841 recato in Roma e visitatolo, tornò a parlarmi con lode del Patania, e del Velasques. Giovinetto copiò il Patania un quadro del Padre Fedele da San Biagio cappuccino661 alla di lui presenza, e ne fu molto lodato. Nell’occasione della Beatificazione del Beato Tommasi della famiglia dei principi di Lampedusa dipinse sopra tela a guazzo, varj gran quadri rappresentanti i Miracoli del medesimo che furono sommamente applauditi, e indi fatti trasportati in Palma di Sicilia, città della suddetta famiglia, ove osservati dal pittore Don Calogero Di Bernardis furon creduti del celebre pittore Mariano Rossi di che disingannollo lo stesso Patania. _________________________________ Dei saggi di estetica di estetica di Giuseppe Tortorici ricordiamo: Lettera sulla contesa letteraria se sia preferibile ai nostri tempi lo scrivere secondo lo stile degl’antichi, o adottare quello de’ buoni, e moderni italiani, In Palermo, dalle stampe del Solli, 1790 e Le Grazie, Palermo, Lorenzo Dato, 1831, 2 v. 661 Padre Fedele da San Biagio (al secolo Matteo Sebastiano Tirrito), pittore, storiografo, letterato e accademico, nato a San Biagio Platani (Agrigento) nel 1717, morto a Palermo nel 1801. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti… cit., p. 104-105. 660 253 Patania Riferirò una risposta del Patania che mostrerà quali fossero i principi che guidavano il suo cuore nell’amicizia e la sua mente nel giudicar delle cose. Ben conosceasi da qualche maligno artista quanto affetto e reciproca stima, da moltissimi anni tenesse in saldi vincoli me e lui. Non ignoravasi che le migliori sue opere erano state da me illustrate e ch’io non lasciavo sfuggirmi l’occasione di tesser le sue lodi. Si ideò da quel maligno il progetto di farci disputare e cagionar tra noi una rottura. Si fece susurrare all’orecchio del Patania che un giorno che io erami incontrato al pranzo di un magnate con un pittore reduce da lunghi viaggi e abile conoscitore in fatto di bello arti, io fossi convenuto con lui che Patania appena toccasse la mediocrità, e particolarmente nel paesaggio genere in cui era quegli in vero giudice competente. Patania ascoltò pacatamente quanto gli fu riferito e disse al calunniatore: non può esser vero, io conosco bene l’indole del mio amico, si è voluto ordire questa menzogna per allontanarlo da me ed io anzi avrei per lui più affetto e stima d’oggi innanzi se maggiore potessi sentirla. Narrommi il giorno appresso ch’io lo visitai l’occorso ed io giustificar mi voleva con lui dicendogli il vero che neppur conoscevo di vista quel pittore, e molto meno ch’ero stato suo commensale. Troncommi le parole ridendo ed abbracciandomi mi disse: credeva quel malvagio ch’io fossi uno sciocco, ma la palla è tornata contro di lui, peroché non metterà più piede in mia casa. Un simile avvenimento è narrato da Valerio Massimo di Platone (1)662 a cui era stato riferito che Senocrate suo scolare aveva sparlato di lui; al che non663 prestò fede e chiedendogli l’accusatore perché non dava credito alle sue parole, rispose: perché non è credibile ch’ei non fosse amato scambievolmente da colui ch’egli cotanto amava, ma l’altro, avendolo affermato con giuramento, soggiunse che non volendo disputare se avesse in quel punto giunto il falso664, concluse che Senocrate era tal uomo da non dir simili cose di lui se non a retto fine. E qui, osserva Valerio Massimo che Platone abitava non già in un corpo mortale,665 ma in una rocca celeste discacciando da sé con animo invitto l’impatto delle passioni ed affetti umani, e conservando nell’altezza e profondità del suo petto tutte le virtù della maggior perfezione. _________________________________ A c. 352v nota in calce: “(1) Detti e fatti memorabili lib. 4°”. Seguono cancellate le parole: “diede orecchio”. 664 Seguono cancellate le parole: “disse va”. 665 Il testo passa dalla c. 352v alla c. 354r. 662 663 254 Patania imitò Platone senza aver letto le sue opere né quelle di Valerio Massimo, e il suo cuore e la sua mente incontraronsi col filosofo ateniese per uniformità di principî e rettitudine ispirata nel nostro dipintore da buona indole, e nell’altro da questa e dalla sapienza. Anedoto [!] riguardante Patania666 Narrasi che Zeusi, avendo dipinto una vite con grappoli d’uva gli uccelli volgessero il volo al quadro per beccarla; dal che fu giudicato giustamente che fosse mirabilmente dipinta. Un simile anedotto riferirò di un ritratto dipinto dal cavaliere Giuseppe Patania. Aveva questi, che in quel genere era insuperabile, dipinto a mezza figura al naturale, il cavalier Gaetano Vanni, giudice della Gran Corte e quel ritratto sembrava a tutti meraviglioso non solo per la somiglianza ne’ tratti esterni del volto; ma ben anche per l’espressione del suo spirito mordace, e irrisorio per modo che essendo stato ciò osservato da alcuni magistrati napoletani egli rispose sgarbatamente: il Patania mi ha dipinto nell’attitudine di coglionar voi quando cianciate nell’aula di giustizia. Ora avvenne ch’essendo egli seduto gli fu presentato da sua moglie una cagnetta per ammirarne la bellezza, ma egli la rigettò con un calcio, e quella povera bestiola sebbene non colpita corse via nella prossima stanza ov’era il ritratto del suo offensore, e667 al guardarlo identico all’originale, credette che fosse lui stesso e bajandogli in faccia668 e digrignando i denti, fuggiva intanto in altra stanza. Un fatto dello stesso genere avvenne all’egregio scultore Valerio Villareale. Aveva egli in caso un nipotino a quattro anni circa, che familiarizzato con un cane domestico gli porgeva del pane. Il Villareale ristorava allora il famoso quadro de’ PP. Olivetani di Palermo ove scorgesi S. Giovannino fanciullo che adora il Bambino Gesù. Lasciò il quadro sul cavalletto, e sul merigge andò a dormire. Svegliatosi poscia, e ritornando nella stanza trovò il cane che lambiva con la lingua il San Giovannino che per l’età e carnagione somigliava al di lui piccolo nipote, come far soleva quando porgevagli il pane. Questo anedoto mi fu dallo stesso Villareale riferito, deducendone un argomento per l’insuperabile verità di quella figura, ch’egli e il Patania _________________________________ La c. 353 contenente il testo è rilegata all’inverso. Segue cancellata la parola: “credendolo”. 668 Segue cancellata la parola: “timidamente”. 666 667 255 reputavano la migliore in quel quadro. Ecco una testimonianza anche di un cane al merito straordinario di Raffaello, come nel precedente anedotto a quello del Patania pel ritratto del cavaliere Vanni! L’uomo è meno facile a ingannarsi in simili casi, perché giudica col senso della vista e della ragione; non così gli animali che, con l’uso della prima, illudonsi più facilmente; ma non pertanto contestano nella pittura co’ segni che loro son concessi, e senza prevenzione la somiglianza perfetta al vero! Quadro dello Spasimo di Raffaello Sul quadro dello Spasimo di Raffaello che si trovava nella Chiesa de’ PP. Benedettini in Palermo e fu per male arti sottratto, e trasportato in Ispagna per ordine segreto di Filippo IV. Questo sovrano amante della pittura scrisse al suo viceré in Sicilia che avrebbe avuto a piacere d’otte<ne>re il quadro indicato. Il viceré adoperò il suo confessore di maneggiare co’ PP. Benedettini; ma costui conoscendo che nulla vrebbe ottenuto co’ mezzi regolari ebbe segreta conferenza col loro superiore abate Scoropoli669 perché permettesse di farne segretamente la copia da sostituirsi all’originale che sarebbe inviato al re ed egli ne avrebbe ottenuto una pingue Abadia e pensione. Ciò fu eseguito perché il quadro teneasi chiuso in una custodia in chiesa; ma il venerdì santo in cui si apriva fu il furto scoverto. Veggasi l’altro mio scritto estratti dall’archivio de’ PP. Benedettini Bianchi. Materiali riguardanti la vita del celebre pittore cavalier Giuseppe Patania da Palermo Esaminati e spogliati di ciò che poteva essere superfluo alla stessa. Potrebbero però di nuovo consultarsi nel caso di stamparsi quelli ordinati e corretti dall’autore che trovansi riuniti nelle Memorie storiche delle belle arti tra’ pittori del secolo XIX.670 _________________________________ Clemente Staropoli, olivetano, abate. Cfr. Sergio Troisi, “Spasimo e Serpotta. San Giorgio racconta” In: La repubblica. Sez. Palermo, 3 ottobre 2009. 670 Potrebbe trattarsi dell’operetta curata dal Gallo, Saggio sui pittori… cit., p. 123-127. 669 256 N. 3 Materiali riguardanti la vita di Patania insigne pittore Esaminati e spogliati di ciò che poteva essere superfluo alla stessa. Scolari della 2ª epoca di Patania671 Eugenio Formisani in Napoli672. Giuseppe Dolce Palermo673. Pietro Volpes Palermo. Tronchetta [Tranchetta Giuseppe] da Palermo morto giovane. Pietro Lojacono da Palermo, in America 674. Giuseppe Mosca, da Palermo675. Antonino Perdichizza da Messina, indi allevio [!] di Lo Forte, oggi in Firenze. Minutilla sordomuto, da Palermo, adesso in America. Nizzola miniaturista. Michiele Corteggiani676. Giocomia [!] Morrealese che studia a Roma677. Sacco miniaturista da Palermo678. Guglielmo Faija679. Andrea D’Antoni, Palermo. Giuseppe Bagnasco da Palermo. Giuseppe Dimarzo da Palermo. Giuseppe Meli da Palermo. Natale Carta da Messina indi studio sotto Velasquez e poscia in Roma sotto Camuccini Algozer, miniaturista _________________________________ Al margine sinistro nota: “Pittura secolo XIX da unirsi al Patania”. Eugenio Formisani, pittore operante nella seconda metà del XIX secolo. 673 Giuseppe Dolce, pittore palermitano, operante nella seconda metà del XIX secolo. 674 Vedi nota n. 521. 675 Giuseppe Mosca, pittore attivo nella seconda metà del XIX secolo. 676 Vedi nota n. 621. 677 Salvatore Giaconia, pittore, nato a Monreale, Palermo, nel 1825, morto a Palermo nel 1899. Il 30 marzo 1842 Giuseppe Patania approva la sua’ammissione per «disegnare nella Quadreria della Regia Università degli Studi». A.S.PA, Permessi di studio…cit., Misc. Archivistica, II, n. 316. 678 Francesco Sacco pittore miniaturista palermitano, operante nella prima metà del XIX secolo. 679 Guglielmo Faija, pittore e miniaturista, nato a Palermo nel 1803, ivi morto dopo il 1861. Un’interessante nota biografica è reperibile in: Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti… cit., p. 358-360. 671 672 257 Paolo Priolo da Palermo andò poscia in Inghilterra, ove si è fatto onore. Giuseppe Carta da Palermo cuggino [ma figlio] a Natale nel 1867 in Costantinopoli. Andrea Di Martino680 da Palermo pria scolare di Patania poscia di Benvenuto in Firenze. Carlo Barbiera da Palermo riuscì principalmente nei ritratti: dipinse il Ritratto di Pio IX in Napoli, un’Immacolata per il re. Ritratti per il principe del Cassaro. Antonio Licata da Licata681 seguì lo stile del Patania osservandolo spesso a dipingere. Passò in Napoli ove la fama di buon pittore di storia. Scolari di Patania Vitale Giuseppe da Sciacca682. Carta Natale, Giuseppe. Ramistella Giuseppe da Palermo683. Dantone684 pria scolare di Patania e poi di Patricola. Pietro Loiacono da Palermo685 per il paese. Giuseppe Gulotta da Termine. Giuseppe Spampinato da Palermo pensionato in Roma da la comune di Palermo. Ferdinando Santifallari da Palermo686. Filippo Barba suo nipote da Palermo, progredì in Roma. Pasquale Conti da Palermo687. Raffaello Genovese da Palermo688. _________________________________ Martino Andrea Antonio, pittore, nato a Palermo, ivi morto nel 1864. Antonio Licata, pittore, nato a Licata, Agrigento, nel 1810, morto a Napoli nel 1891. 682 Giuseppe Vitale da Militello, assente nei repertori biografici d’arte, è citato da Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti … cit., p. 100. 683 Giuseppe Ramistella, ignoto alle fonti della letteratura artistica. L’11 ottobre 1834 Valerio Villareale concede al giovane di «disegnare i gessi e copiare i quadri della Regia Università di Palermo»: A.S.PA., Permessi di studio…cit., Misc. Arch. II, n. 316. 684 Dantone potrebbe trattarsi di d’Antoni. 685 Vedi nota n. 521. 686 Ferdinando Santifollar, pittore della seconda metà del XIX secolo. Il 13 giugno 1829 Giuseppe Patania lo dichiara «abile a copiare i quadri e igessi che esistono nella R. Università»: A.S.PA., Permessi di studio… cit., Misc. Arch. II, n. 316. 687 Pasquale Conti, ignoto alle fonti della letteratura artistica. Il 28 novembre 1831 Valerio Villareale avalla l’istanza del giovane ritenuto «abile» e lo ammette «a studiare ne’ gessi e quadreria» del «Real Museo». cfr. A.S.PA., Permessi di studio… cit., Misc. Arch. II, n. 316. 688 Raffaello Genovese, ignoto alle fonti della letteratura artistica. Il 21 dicembre 1835 Valerio Villareale avalla il suo ingresso nel laboratorio dei gessi presso la R. Accademia di Palermo. 680 681 258 Scolari di Giovanni Patricola Ultimi scolari di Patania sino alla sua morte nel 1852 Eugenio Formisani. Da Palermo buono, ora in Napoli. Pietro Lojacono. Da Palermo, buono, ora in Napoli. Pietro Volpes. Da Palermo, buono nel ritratto. Ignazio Cortegiani da Palermo, buono. Giuseppe Tranchetta da Palermo nel ritratto e copia. Giuseppe Mosca da Palermo restò nel disegno, ora presso D’Antoni. Stefano Conigliaro da Palermo689, buono copista della casa di Patania. Leonardo Piombo da Trapani, nella copia. Giuseppe Dolce da Palermo buon pittore nella copia, ora presso D’Antoni. Antonio Perdichizzi da Messina disegnava bene, ora presso D’Antoni. Carlo Fratacci da Palermo copiava presso Patania; ora è in Napoli ed è peggiorato. Girolamo Spallino690 in miniatura Nizzola da Palermo riuscì bene nella miniatura, e fu gradito in Firenze. Scolari di Patania Primi scolari di Patania D’Antoni palermitano. Giuseppe Bagnasco palermitano. Giuseppe Meli palermitano. Giuseppe Di Marzo dilettante ottimo alla copia. Lo Jacono palermitano, indi allievo di Lo Forte. Lillo De Bernardis691 indi di Galeani. Scolari di Patania Gerlando Marsiglia fu in Roma Giuseppe Navarro di Palermo, fu in Roma. _________________________________ Stefano Conigliare, pittore, attivo nel XIX secolo. Girolamo Spallina, pittore e scultore, nativo di Prizzi, attivo nella seconda metà del secolo XIX. 691 Calogero (detto Lillo) De Bernardis, pittore, nato a Palma di Montechiaro, Agrigento, nel 1790, morto a Palermo nel 1824. 689 690 259 Andrea Martino di Palermo, fu in Firenze. Ferdinando Raimondi di Misilmeri fu in Roma. Guglielmo Faija di Palermo miniaturista in Roma, e in Parigi. Giambattista Marchese fu scolaro di Patania, e indi di Errante, copiò da Patania in miniatura, Cefalo e Proeri. Natale Carta nato in Messina, fu in Roma Giovanni Giampallari morto a 17 anni nel 1825. Era abilissimo a copiare in lapis. Giuseppe Bagnasco di Palermo riesce nel ritratto ad olio. Antonino Adelfio di Palermo copiava ottimamente le pitture di Patania. Tabella del Leone col cigno, del Cane col serpe, una Madonna del Patania, e diverse teste di uomini illustri siciliani del Patania. Carlo La Barbera di Palermo ritratto del barone Ondes, ad olio. Riesce nei ritratti a lapis, fra i quali è bellissimo quello di Velasques, di Patania, di Ca[…]tore, ed altri. Psiche a lapis trasportata dai Zefiri a lapis, presso il luogotenente marchese delle Favare. Luigi Lo Jacono di Palermo, Ebe che versa il nettare all’aquila, insegna di caffè. Necrologia di Giuseppe Patania Prevenuti dal pubblico cordoglio annunziamo la morte di Giuseppe Patania famoso dipintore, agli stranieri che l’ignorano; perocché egli era non solo onor della Sicilia, ma dell’Italia ancora. Egli nacque in Palermo a 19 gennaio 1780 da umili ma onesti genitori. Fu avviato nell’arte da Giuseppe Velasques, allora massimo pittore in Palermo. Poco tempo rimase bensì sotto la sua disciplina peroché tosto allontanossene per gli aspri modi di quello, e cominciò a disegnar da sé, e a frequentar l’Accademia del Nudo, diretta dallo stesso Velasques. Per procacciarsi da vivere, imprese indi a dipingere i cartelloni figurati del teatro comico, e ciò contribuì a sviluppare il suo genio. Essi furono ammirati, e fecero sin d’allora presagire qual pittore sarebbe divenuto. Giovossi de’ vaghi dipinti di Vincenzo Riolo, reduce da Roma, e colorì meglio, e con più forte macchia pittorica i suoi quadri. La Regia Galleria Borbonica verso quel tempo trasferita da Napoli in Palermo, contribuì co’ capi lavori dell’arte al suo progresso. Egli tentò tutti i generi e, se non in tutti, in parecchi ottenne il primato. Dipinse a fresco, a tempera, a olio, ad acquarello, e sinanco a miniatu- 260 ra, e usualmente a olio quadri di storia, paesi, ritratti, frutta, fiori, uccelli, pesci. Il suo genio si piegava ad ogni modo di rappresentar al vivo tutte le cose che uscirono dalla mano di Dio; ma quelle su cui il Creatore sparso avea il sorriso della grazia richiamavano la sua mente, e il suo cuore e lo eccitavano; talchè non fu mai più gran pittore che ne’ soggetti leggiadri. In questi non avea rivali in Sicilia, negli altri aver potea competitori. Egli recossi giovinetto a Minorca, e vi lasciò opere che furon pregiate da que’ paesani. Ritornato in patria fu affetto da tale infermità, divenuta indi abituale che non gli permetteva di uscir di casa; ma non gl’impediva ad essere, oltre ogni credere, operoso anzi instancabile nell’arte. Pressoché infiniti furono quindi i suoi quadri più da cavalletto che da chiesa, e viepiù di ritratti, nel qual genere, sì per la somiglianza che per la fusione delle tinte, e la bravura del pennello si avvicinò a’ più grandi maestri. Il Patania fu amato, e stimato da tutti. La Real Corte l’adoprò insieme col Velasques, col Riolo, e indi col Patricolo. Il ritratto da lui dipinto alla principessa Maria Amalia, indi regina dei Francesi, meritò in Parigi le lodi d’un Chateaubriand, e quello dell’inglese mister Lorenz il fece proclamar socio onorario dell’Accademia del disegno di Nuova York; ma più che quest’onore può egli andar fastoso degli encomj del celebre Camuccini, il moderno Raffaello, il quale ne ammirò alcuni schizzi in Napoli presso il marchese Gargallo, e in rame il Ritratto della duchessa Brolo: dulce est laudari a laudato viro. Il Patania fu decorato della medaglia d’oro di Francesco I ed eletto dal Governo membro della Commissione di Antichità e Belle Arti. Morì di anni 72 compiti il giorno 23 del corrente febbrajo alle ore 19, munito de’ soccorsi della religione. Due ore pria di spirare disse al suo amico Agostino Gallo che gli porgea parole di conforto: La vita, e la morte mi è (sic) indifferente. Quella accetto, se Dio vuol concedermela, questa non mi sgomenta. Con tal serenità di coscenza, e mente tranquilla volò l’anima sua al cielo. Tutti i suoi amici e scolari e gli artisti d’ogni genere, atteggiati a dolore, col capo scoverto ne accompagnarono il cadavere alla chiesa di S. Maria di Gesù. Alcuni nobili gl’inviarono a cortegio funebre le loro carrozze. [Un] de’ vecchi artisti gridò allora per la via: abbiamo perduto il nostro padre. E ben a ragione, perché egli aiutò sempre i suoi colleghi che aver poteano bisogno di soccorsi pecuniarj, e di suoi schizzi, onde dar loro mezzi di sussistenza. Non conobbe invidia, e gelosia di mestiere, né censurò alcuno. Accoglieva amorosamenti i giovani che a lui si presentavano 261 per esser ammaestrati. Fu semplice, e modesto, senza abiezione soccorrevole a’ poveri ed a’ parenti. Amò la gloria; ma sdegnava di procacciarsela con ciarle ed intrighi, né aveane bisogno sicuro, com’era, del suo merito. Compianto da tutti, e sebbene lontano per 35 anni da’ sollazzi della società, visse, e morì felice co’ soli piaceri che si procurava con l’arte. Che Dio accolga nel suo amplesso l’anima sua dolce, e virtuosa! Agostino Gallo Necrologia di Giuseppe Patania Appena il dolore mi permette di annunziare692, non già ai miei concittadini palermitani, ma agli altri693 connazionali e agli stranieri, che ne sono ignari, l’irreparabile perdita che ha fatto questa città, la Sicilia tutta, e direi anzi l’Italia, dell’egregio dipintore Giuseppe Patania. Sollecitato da alcuni bennati giovani694, dottori di questo giornale, ho dovuto cedere alle loro premure, non ostante che il mio spirito agitato dal cordoglio e dal tristo spettacolo di vederlo spirar fra le mie braccia credea non mi avesse permesso di spargere questi primi fiori di encomio sul suo cadavere695, ma fatta energica forza a me stesso696 e rianimato dal mio e dal suo affetto, scrivo ora queste incomposte e dimesse parole, come il cor mi detta, e la memoria de’ suoi fogli mi suggerisce per adempiere quel sacro dovere che un’amicizia inviolata e costante di quarant’anni m’impone. Giuseppe Patania, originario di Acireale, nacque in Palermo da umili ma onesti genitori a 19 gennajo 1780. Eccitato dal genio delle belle arti sin da fanciullo, né oltrepassando ancora il duodecimo anni, fu introdotto a preghiere di una zia, e per mezzo dell’archite[tto] Attinelli697 nello studio di Giuseppe Velasques, massimo tra i pittori siciliani del corrente secolo. In pochi mesi egli già copiava colla matita i disegni del maestro con tale una franchezza e diligenza, che quegli ben s’accorse ch’era nato per lasciare un nome nell’arte, e per rapirgli un giorno non pochi fiori alla sua _________________________________ Seguono cancellate le parole: “la morte”. Segue cancellata la parola: “miei”. 694 Segue cancellata la parola: “estensore”. 695 Seguono cancellate le parole: “che ho accompagnato lacrimando fino alla tomba”. 696 Seguono cancellate le parole: “per come fui in si lugubre occasione, detto”. 697 Salvatore Attinelli, architetto camerale, nato a Palermo nel 1736, ivi morto nel 1802. La biografia dell’artista è rubricata in quattro versioni: cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti… cit., p. 165-167. Il primo impianto del giardino reca la sua firma: cfr. Tiziana Campisi - Sabrina Mutolo, “Il giardino di Botanica di Palermo nel progetto dell’ingegnere camerale Don Salvatore Attinelli”, in: Quaderno di Botanica Ambientale Applicata, 10, 1999, p. 69-79. 692 693 262 corona; epperò alla domanda del giovinetto di voler copiare a olio in colore698 un suo bozzetto, lungi di secondarlo, il minacciò colla pittorica bacchetta, di che699 quegli indispettito, e insofferente, raccogliendo i suoi cartolari dileguossi balbettando con dire: sarò pittore senza di voi. Il disse e il fu, ma a vero dire per la influenza del Velasques da cui ritrasse meditandone le opere. Il bello stile gli fece onore. Perocché la luce di un grande uomo si spande come quella del sole e per l’universo ne è mestieri di raccoglierla dalla sua stessa fonte. D’allora il giovinetto Patania cominciò disegnare e a dipingere da sé, e scarso com’era di soccorsi domestici700, imprese per alimentarsi a figurare e colorar i grandi cartelloni da teatro che si esponevano al pubblico per adescarlo alla rappresentazione della sera. Ciascuno di essi era l’opera del giorno precedente, e la mercede corrispondente al lavoro di un giovinetto e del breve tempo impiegatovi. Ma queste opere gli valsero allo sviluppo del genio, e a fargli proseguire gli studj. E per vero quelle opere improvvisate701 schizzavano scintille702 d’immaginazione e di sentimento e piacevano al pubblico e furon lodate dal cav. Puccini fiorentino, sommo conoscitore e Direttore della Regia Imperiale Galleria di Toscana, il quale allora qui soggiornava, e presagì qual sarebbe divenuto in progresso il giovane artista. Egli non tralasciava intanto di frequentare assiduamente l’Accademia del Nudo diretta da Velasques, e studiò per molti anni, più che altri, sel credo, il vero e l’antico su gessi di capi lavori703 dell’arte e formossi gradatamente uno stile come quello del suo maestro704, che riunisce all’eleganza delle forme, l’efficacia del vero scelto in natura. Nato egli705 con un versatile ingegno che a tutti i generi dell’arte piegavasi, non solo diessi alla pittura istorica706, ma al ritratto, ed al paese, e invitato a trasferirsi a Minorca da un ricco di quel paese, vi si recò per dipingere; recovvisi e dopo circa due anni di soggiorno lasciovvi opere di vario genere che incontravano il general gradimento. Restituitosi a Palermo, e avvenuto verso quel tempo da Roma il ritorno “in patria” di Vincenzo Riolo che qui condusse il troppo colorito e la _________________________________ Seguono cancellate le parole: “una delle più belle teste”. Seguono cancellate le parole: “l’altro”. 700 Seguono cancellate le parole: “cominciò a colorare”. 701 Seguono cancellate le parole: “mostrano i migliori”. 702 Seguono cancellate le parole: “di quel genio che animava il suo ingegno”. 703 Seguono cancellate le parole: “dell’antichità”. 704 Seguono cancellate le parole: “elegante e vero congiuntamente”. 705 Seguono cancellate le parole: “con genio onnigeno per l’arte”. 706 Seguono cancellate le parole: “al paese ed”. 698 699 263 forte macchia pittorica del suo maestro, monsieur Vicar707, ne restò sifattamente708 adescato il Patania che diessi tosto ad imitarlo, per modo che di una sua tela di quel tempo pugno di me fu creduta da un attuale valoroso pittore opera del Riolo, e da Patania riconosciuta per sua, consigliandomi bensì a bruciarlo, come lavoro di poco conto. L’energia dello stile del Riolo era già709 trascorsa e divenuta propria nel pennello del Patania, quando qui710 venne mister Fagan buon pittore inglese711 di cui osservato avendo troppo soavi perché condotti a mezze tinte712 e per semplici velature svogliossi egli dello stile del Riolo, e all’altro (questo- cassato con una linea orizzontale) appligliossi e in esso perdurò molti anni, lusingato dalle lodi di molti, finché viaggiando io in Italia713 e contemplati i quadri de’ valent’uomini, gli scrissi fra le altre cose, sacrificate alla divinità delle ombre e diventate sommo e714 invidiabile pittore. Né il mio consiglio tornò vano; perocché d’allora rafforzò di generi715 i suoi dipinti e ben tranne argomento la Lucrezia716 ch’eseguì verso quel tempo per l’esimio avvocato signor Francesco Franco; ma non caricò mai d’ombre717 per brama di grand’effetto ma quanto il vero in luce ristretta richiede; perocché diceami che col tempo crescendo sempre più vendono i quadri disgustevoli718 e contradico al vero719 che dee aver di mira la pittura. Il Velasques e il Riolo applauditissimi720 nell’arte si videro circa quindici anni prima di loro morte721, scemati i722 lavori; perocché molti lor preferivano723 il Patania, e tutti nel ritratto e nel paese lo credevano, e non a torto, a quelli superiore, finché scesi essi nel sepolcro rimase a lui il campo della pittura in Sicilia che ora è occupato da altri valorosi artisti, parte da _________________________________ Segue cancellata la parola: “adescò”. Seguono cancellate le parole: “il giovane artista”. 709 Segue cancellata la parola: “passata”. 710 Segue cancellata la parola: “recatosi”. 711 Seguono cancellate le parole: “allora svogliossi dello stile del primo e quello dell’altro seguì troppo grave”. 712 Luigi Grassi – Mario Pepe, Dizionario della critica d’arte, Torino, Einaudi, 1978, v. 2, ad vocem: «tinta intermedia tra due o più colori diversi, ma più luminosi o più scuri». 713 Seguono cancellate le parole: “ed osservando le opere”. 714 Segue cancellata la parola: “egregio”. 715 Seguono cancellate le parole: “il suo stile”. 716 Seguono cancellate le parole: “da lui dipinta”. 717 Seguono cancellate le parole: “i suoi dipinti”. 718 Seguono cancellate le parole: “allontanano dal”. 719 Seguono cancellate le parole: “l’effetto delle figure”. 720 Seguono cancellate le parole: “pittori fino a pochi anni prima della loro morte”. 721 Segue cancellata la parola: “videro”. 722 Segue cancellata la parola: “loro”. 723 Seguono cancellate le parole: “ad essi”. 707 708 264 lui educati724 e parte725 del suo maestro Riolo negli ultimi anni di loro vita726, e parte ancora ammaestrati in Roma, e in Firenze i quali accresceranno, pian piano, nuovi fasti alla pittura siciliana727. Il Patania fu felicissimo e spontaneo nella invenzione e composizione come puosssi rilevare in più centinaja di schizzi a penna ch’egli improvvisava la sera sulla storia della mitologia, e sopra altri728 soggetti de’ quali passati in Parigi, quelli relativi al romanzo del Telemaco furon lodati ne’ giornali ed elegantemente incisi. Sua special prerogativa fu la grazia e l’armonia729 nella scelta delle tinte e quindi riusciva in preferenza ne’ piccoli quadri e ne’ soggetti leggiadri in cui non ebbe730 competitore. Tentò anche la pittura di genere e mostrò pure quanto in questa valesse; talché furono ammirati i suoi quadri di fiori, di frutta, di uccelli e di pesci che dipinse pel marchese Merlo, e per l’avvocato Franco. Nel paese ebbe pochi731 rivali, anzi fu il primo del nostro tempo ad esser salutato per egregio paesista; perocché imitando732 seguiva la natura da lui studiata nella sua prima gioventù, e il frappeggiar del Denis733 e del Pekignon734 che vide nella Galleria della Regia Università di Palermo,735 ma la natura era per lui sempre abbigliata in abito di nozze. Le sue campagne eran sempre vaghe e ridenti736, e ben rappresentavano quelle che in primavera ornano, e profuman di odori la centrale Palermo. Egli ne variava le parti737 su i suoi antichi schizzi, come può osservarsi in quelli dipinti per l’avvocato e indi consultore Vincenzo Gagliani, pel generale e ministro Fardella, e da ultimo del signor Nicolai. Maggior corona da tutti consentita, acquistossi ne’ ritratti per la somiglianza, per la verità, e fusione delle tinte e per la738 venustà del pennello. _________________________________ Segue cancellata la parola: “fuori”. Seguono cancellate le parole: “in patria superstiti da lui e dal suo maestro”. 726 Seguono cancellate le parole: “di quei periti artisti 727 Seguono cancellate le parole: “; perocché né han di quelli che hanno alcuni cui non manca la scintilla del genio e l’ammaestramento dell’arte”. 728 Seguono cancellate le parole: “obbietti fra”. 729 Seguono cancellate le parole: “de’ colori”. 730 Seguono cancellate le parole: “in vita”. 731 Segue cancellata la parola: “competitori”. 732 Seguono cancellate le parole: “quelli della natura”. 733 Antoine Denis, pittore e incisore operante nel XVII secolo. Accolto nell’Accademia romana di S. Luca. 734 Segue cancellata la parola: “francese”. Vedi nota n. 584. 735 Seguono cancellate le parole: “rappresentava vaghissime”. 736 Seguono cancellate le parole: “camapagne che circondano Palermo raccozzandone”. 737 Seguono cancellate le parole: “e variandole”. 738 Segue cancellata la parola: “grazia”. 724 725 265 Egli fu il pittore di tutte le nostre belle, le quali non potendolo avere a casa per i suoi incomodi abituali739 di salute, di qualunque condizione si fossero recavansi al suo studio740 per farsi ritrarre, ed ammirar durevolmente sulla tela. Da circa cento ritratti di uomini illustri siciliani antichi e recenti dipinti per me. Uno egregiamente condotto di un inglese americano e da lui esposto all’Accademia di New York fu preferito a tutti gli altri e procacciogli l’onore di esserne proclamato socio all’unanimità di voti, come rilevasi dalla lettera del segretario de’ 13 maggio 1841. Il ritratto che fatto avea alla reale principessa Maria Amalia indi regina de’ francesi, passato in Parigi, fu ammirato e fatto degno di lode dal celebre monsieur Chateaubriand. Il Camuccini, pittor di gran rinomanza, le profuse741 a quello della duchessa Brolo dipinto per di lei fratello monsignor Grassellini risedente in Roma, e quegli pure ivi mi rammentava con742 sentita stima alcuni schizzi a penna che ne avea veduti in Napoli in casa del marchese Gargallo. Fra i suoi grandi quadri di743 sacro argomento primeggiano il Cristo744 flagellato nella chiesa della Maggione in Palermo, il San Vincenzo Ferreri in Carini, il San Gaetano in Monreale e i Ss. re Magi in Randazzo745, abbenché il primo746 gran quadro da lui dipinto. Fra quelli di argomento profano e di mezzana o piccola dimenzione il cui numero è pressoché infinito, io747 accennerò L’ambasceria de’ Messinesi a Giacomo d’Aragona nel quale rappresentò il Velasques, il Riolo, Giambattista Cutelli, e me. Un idilio del Gesner vagamente dipinto, la Festa del villaggio all’arrivo del barone feudatario e della sua moglie e la sublime poesia del Niccolini è il quadro del Vespro siciliano.748 Ne’ quadri mitologici e soggetti graziosi egli è guidato dal genio di un Anacreonte, di Teocrito, e di Meli. Tale è Venere che abbraccia Adone al ritorno dalla caccia, La Speranza che stringe il suo amore, una Fanciulla _________________________________ Seguono cancellate le parole: “della di lui”. Seguono cancellate le parole: “fra le quali una di esse fino al giorno che precedette la sua morte”. 741 Segue cancellata la parola: “encomii”. 742 Segue cancellata la parola: “lode”. 743 Segue cancellata la parola: “storia”. 744 Seguono cancellate le parole: “legato alla colonna e deriso”. 745 Seguono cancellate le parole: “che fu pure fu”. 746 Segue cancellata la parola: “daltro”. 747 Segue cancellata la parola: “racconterò”. 748 Segue cassato il testo: “Venere e Adone, un ragazzo che stringe al petto un coniglio, una fanciulla che bacia una colomba, la speranza ed amore piccoli quadri da me posseduti ed altri molti fra i quali alcuni dal dottore Agnetta si fanno ammirare per felice invenzione per elegante disegno per vero e vago colorito ricavato dal vero e per la spontanea grazia inseparabile dal suo pennello”. 739 740 266 che bacia una colomba, e un Ragazzo che ferma col mento e con le braccia un fugitivo coniglio, quadri per me dipinto con sommo amore. Né diversi sono la Psiche con la ninfa nel bagno, e l’altra trasportata in aria da’ Zeffiri presso l’egregio avvocato signor Agnetta, e la Francesca da Rimini sorpresa col cognato dal marito, dipinta per altro avvocato di Palermo, e cento altri quadretti tutti fioriti di leggiadria, e di soave espressione. Né è da trasandare una Sacra Famiglia dipinta, non è un mese, per il signor Nicolai con grande stile, e belle forme nella Vergine, e nel putto Gesù. Il Patania fu da circa quarant’anni affetto da tale abituale infermità che gli impediva di uscir di casa, tranne poche volte all’anno nell’estiva stagione, gli permetteva di essere operoso, anzi ineffaticabile nel maneggio del suo pennello al giorno, e della penna alla sera, in cui lavorava per divertirsi come diceva, i suoi schizzi. Sul proposito io gli feci osservare, che l’arte ed egli stesso davano a quaella infermità la gloria che749 ottenutane pel suo concentramento, per l’assiduo studio non mai750 distratto dai piaceri della società, al che risposemi: ciò751 se pur fosse vero, non mi fa però goder del mondo; ma io me ne sono rivendicato de’ suoi piaceri perduti752 con quelli che mi sono creato coll’esercizio dell’arte che fa la mia passione. Il cielo aveva versato per lui, a piene mani, non solo i doni dell’intelletto ma l’egregie qualità del cuore cui753 or tocchiamo di volo, essendo754 a quei che il conobbero ben nati, e che è pur giusto che passino non alterate a’ posteri. Egli fu semplice nelle maniere e non conobbe né invi<di>a o la gelosia di mestier, dignitoso e modesto senza abbiezione ed avverso alle lodi755. Ei diceva un giorno ad un esagerato encomiatore: lasciate questa profusione di lodi, io non credo meritarle e per altro mi recan più male che bene. Sfuggì sempre di censurar menomamente gli artisti, sebbene ne fosse talvolta provocato da qualcuno mediocre. Negossi più d’una volta ad osservare qualche nuovo quadro di taluno per evitare che gli fosse appiccato un giudizio ch’egli dato non avrebbe756. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “n’era conseguita”. Segue cancellata la parola: “pagato”. 751 Seguono cancellate le parole: “può esser”. 752 Seguono cancellate le parole: “col procacciarmi”. 753 Seguono cancellate le parole: “delle quali che”. 754 Seguono cancellate le parole: “a tutti”. 755 Segue cancellata la parola: “talché”. 756 Seguono cancellate le parole: “poteva bensì”. 749 750 267 Se ascoltava l’altrui troppo aspro e severo, il moderava colle sue benigne riflessioni757 o taceva se sostener non potesse la difesa.758 Accoglieva nella sua scuola759 amorosamente tutti i giovani760 che a lui si presentavano, e molta cura si dava a ben guidarli nell’arte coll’apprestar loro disegni e modelli e a mandarne di sua mano le copie, e indicarne a voce i difetti, soccorreva spesso quelli che non erano favoriti da fortuna761 di mezzi bisognevoli all’arte, laonde molti a lui correvano e le sue stanze eran sempre affollate di discenti né in ciò soltanto utile si rese; perocché alcuni di essi già provetti, e altri non suoi scolari ritraevano le sue invenzioni e i suoi cartoni che egli loro disegnava generosamente giovavansi [!] per facilitarli a conseguir lucro e credito nell’arte. Tra i suoi migliori allievi, or già762 artisti di763 onorevol reputazione segnalavansi Giuseppe Bagnasco, Carlo La Barbera, e Giuseppe Carta. Egli fu affabile e soccorrevole a’ poveri e segnatamente a’ suoi parenti per i quali non volle ritenere a vitalizio un buon valsente, raccolto colle sue oneste fatiche, come altri il consigliavano, ed uno di essi fu udito sclamare col linguaggio del cuore mentre egli agonizzava: Ei travagliò incessantemente sessant’anni per trarne un meschino pranzo, che altro la sua salute non comportava, e per dar da vivere a tutti noi. Con queste prestanti qualità di ingegno, e di cuore non è da mervigliare che meritato avesse in vita la stima e l’affetto d’un Meli, d’uno Scinà, d’un Gargallo, d’un Turtorici, e di quanti altri uomini dotti riuniva Palermo a tempi migliori, né da meravigliar manco che la sua morte avvenuta per cestite improvisa dopo dieci ore del primo assalto, e dopo di essere stato soccorso in vano dall’arte medica,764 e piamente dalla religione, abbia recato universale dolore. Egli menar poté il vanto di essere amato da tutti, da nessuno odiato. Spirò765 il giorno 23 di questo infausto febbraio alle ore 18¾ e 10 minuti, con la tranquillità di animo dell’uom virtuoso, e del buon cristiano, e di fatti a me, che qualche conforto poco innanzi alla tremenda dipartita gli davo, riconoscendomi, rispose: la vita e la morte mi è indifferente, accetto la prima se Dio vuol concedermela, l’altra non mi sgomenta. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “ove fosse troppo appena. Agevolò tutti gli altri”. Segue cancellata la parola: “Riceveva”. 759 Segue cancellata la parola: “benignamente”. 760 Segue cancellata la parola: “artisti”. 761 Seguono cancellate le parole: “alcuni talché alcuni”. 762 Segue cancellata la parola: “pittori”. 763 Segue cancellata la parola: “buona”. 764 Seguono cancellate le parole: “ed efficacemente”. 765 Seguono cancellate le parole: “fra le mie braccia”.. 757 758 268 E ben ne avea ragione, poiché moriva senza rimorsi, e con l’intimo convincimento di aver fatto sempre bene a’ suoi simili. Conservò766 fino a quest’ultimo punto della vita buona la vista, ferma e operosa la mano lucida la mente, creatrice di tanti singolari concetti fino al giono innanzi in cui terminato avea di dipingere la testa della signora Paino e fino alle ore tre della sera, in cui compì lo schizzo a penna di Gesù Cristo presentato a Caifas. Divulgatasi la nuova della sua morte più rapidamente767 del fulmine, i suoi affezionati scolari mi chiesero che io mi facesi loro guida nell’accompagnarne il cadavere alla chiesa di S. Maria di Gesù, ove destinato avea di essere modestamente seppellito, ma in ciò fu contraddetto dal pubblico voto; perocché alcuni della nostra nobiltà768 il fecero anch’essi associare dalle loro carrozze e da servidori a lutto, mentre tutti gli artisti e gli amici suoi, a capo scoverto, atteggiati a dolore, e rammentandone a quando a quando le virtù e i pregi dell’ingegno gli faceano lungo e numeroso corteggio ed un vecchio artista fu udito gridar fuori di città: abbiam perduto il nostro padre. A me suo amico di quarant’anni, e suo sincero ammiratore769 nella perdita fatale che di lui ho fatto, mi è solo rimasa a conforto la sua immagine ch’ei dipinse e donommi che par che dicami ad ogni istante: “procura d’imitarmi se puoi nelle virtù e preparati a seguirmi, e par contento si rimanga da’ quell’epigrafe che io gli scrissi: Franco inventor, sposò natura al be<llo> Pinse, e animar le Grazie il suo pennel<lo> Qui riposa /Giuseppe Patania da Palermo / onnigeno dipintore di gran nome / cav. del R. Ordine di Francesco I / ascritto alla Commessione di Antichità e Belle Arti / alla Nazionale Accademia / E a quella del Disegno di Nuova York / Ne accrebbe ornamento e decoro / ispirato dal genio / prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte co’ migliori di Sicilia / Accostossi a’ sommi d’Italia / Emulò il vero ne’ ritratti / Ne’ paesi ne’ fiori e nelle frutta / ma superò molti e sé stesso / ne’ quadri di storia / E _________________________________ Seguono cancellate le parole: “quasi fino all’ultimo istante”. Seguono cancellate le parole: “ch’io non credevo”. 768 Seguono cancellate le parole: “che più a lui affezionato per le opere che aveano del suo pennello fatte a loro”. 769 Seguono cancellate le parole: “del suo ingegno e delle sue virtù”. 766 767 269 più ne’ piccoli di leggiadro argomento / per creatrice fantasia e sennato comporre / per eleganza di stili e nuova espressione / Negli schizzi a penna e nelle tela/ in quest’isola sorrisa dal cielo / E fuori ammirato / della patria amantissimo / i fasti e gli illustri suoi figli / Ne eternò col pennello / Modesto affabile leale / d’animo compassionevole e generoso / da’ parenti da gli amici / da suoi allievi da tutti / meritossi in vita la stima e l’affetto / l’universal cordoglio in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / a 23 febbrajo MDCCCLII /_____ / Chi ha senso al bello e alla virtù / sparga lacrime pel suo frale / e preghi pace all’anima benedetta! / _______ / Le eredi meste inconsolabili / Questa lapide / posero. Scolari di Patania Gerlando Marsiglia buon copista che recossi in Nuova York ed ivi morì sul cominciamento del 1832. Ferdinando Raimondi buon disegnatore e copista, che vive in Roma 1851. Carlo La Barbera palermitano, buon pittore di ritratti, che vive in Napoli 1852. Giuseppe Bagnasco da Palermo il migliore suo scolare che operava col Riolo ne’ trasparenti de’ fuochi di S. Rosalia770. *** D’Antoni palermitano, buon pittore. Natale Carta, da Messina figlio di Giuseppe che pure fu scolare del Velasques, ottimo pittore che vive in Roma (1852). Giuseppe Carta da Palermo suo cugino [ma figlio], buon pittore, che vive in Palermo 1852. Rosolino La Barbera da *** che studiò il disegno sotto di Patania, e la scultura sotto Villareale (1852). *** Cortigiani che indi studiò sotto Natale Carta in Roma (1852) _________________________________ Sono dipinti su tela «illuminate da tergo», dove «la pittura, spiegando a sua posta il bel prestigio, rappresenta in quei quadri le più sublimi immagini». Cfr. Silvana Riccobono, “I “trasparenti” nelle festività di S. Rosalia e i pittori dell’Ottocento” in: Immaginario e tradizione: carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell’Ottocento. Palazzo Abatellis, Palermo 14 ottobre 1993-9 gennaio 1994. Premessa di Vincenzo Abbate; saggi di Elvira D’Amico ... [et al.], Palermo, Novecento, [1993], p. 89-102; p. 90. Il procedimento non è dissimile dalla preparazione degli affreschi: si preparano i cartoni su scala, e poi si trasportano sulla mussolina e si usa l’olio ed «acqua di raja». Dopo aver amidato il tessuto «con colletta ed amito ed indi dopo asciutti darsi una passata d’acqua raggia mista con cera di Trieste». Catalogo della Mostra Immaginario… cit., p. 232. L’effetto cromatico e luministico dei trasparenti, posti dietro un’adeguata illuminazione, offriva una sapiente scenografia teatrale. 770 270 Paolo Cataldi di Capaci che indi si diè al cisello e all’orificeria. Giuseppe Di Giovanni di Palermo incisore e pittore Carlo la Barbiera palermitano riuscito buon pittore di ritratti e stabilitosi in Napoli Giovanni Nizzola di Palermo che diessi alla miniatura. Giuseppe Di Marzo di Palermo buono dilettante ch’esercita la professione di patrocinatore Giuseppe Lo Jacono da Palermo che fu iniziato nell’arte dal Patania e poi passò sotto la direzione di Salvatore Lo Forte. Giovanni Fecarrotta771 che diessi alla incisione ad acquaforte, e bulino al cisello e all’orificeria, e riuscì egregio artista. Adelfio da Palermo che diè prove di gran abilità in un Leone giacente che dipinse per mostra d’una bottega772 indi si ritrasse dalla pittura. Qui riposa / Giuseppe Patania da Palermo / onnigeno dipintore di gran nome / cav. del R. Ordine di Francesco I / Ascritto alla Commessione di Antichità e Belle Arti / Alle Nazionali Accademie / E a quella del disegno di Nuova York / ne accrebbe ornamento e decoro / Ispirato dal Genio / prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte co’ migliori di Sicilia / Accostossi a’ sommi d’Italia / Emulò il vero ne’ ritratti / Nei paesi nei fiori negli uccelli nei pesci / Ma superò molti e sé stesso / nei quadri di storia / E più ne’ piccoli di leggiadro argomento / per creatrice fantasia e sennato comporre / Per eleganza di stile e vivace espressione / In questa isola cui sorrise il cielo / E fuori ammirato / Della patria amantissimo / I fasti e gl’illustri suoi figli / ne eternò col pennello / i fasti e gli illustri suoi figli / ne eternò col pennello e coll’artistica penna / Modesto affabile leale / d’animo compassionevole generoso / dai parenti da gli amici / dai suoi allievi e da tutti / meritossi in vita la stima e l’affetto / l’universal cordoglio in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / A 23 febbrajo MDCCCLII / __________ / Chi ha senso al bello e alla virtù / sparga lacrime sul suo frale/ E preghi pèace all’anima benedetta! / ________ / Il fratello e gli altri eredi e mesti e riconoscenti / Questa epigrafe scritta col core dal suo Agostino Gallo / sacrarono. _________________________________ Giovanni Fecarotta, incisore, nato a Palermo nel 1799, ivi morto dopo il 1830. Un’esaustiva biografia è reperibile nel ms. XV.H.16, Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori siciliani… cit., p. 114-116. 772 La tradizione delle pitture di insegne era stata introdotta nella cultura meridionale da Polidoro Caldara da Caravaggio, pittore allievo di Raffaello Sanzio, nato a Caravaggio nel 1500ca., morto a Messina nel 1546. Egli, noto per le decorazioni a stucco e a grottesche che inquadrano piccole scene affrescate, in seguito al Sacco di Roma, si trasferisce infatti a Messina. 771 271 1773 Qui riposa 9 2774 Giuseppe Patania da Palermo 24 3 Onnigeno dipintore di gran nome 27 4 Cav. del R. Ordine di Francesco I 25 5 Ascritto alla Commessione 23 6 Di Antichià e Belle Arti 21 7 Alle nazionali Accademie 22 8 E a quella del disegno di Nuova York 26 9 Che accrebbe ornamento e decoro 29 10 Ispirato dal genio 26 11 Prediletto dalle Grazie 16 12 Gareggiò nell’arte co’ migliori di Sicilia 21 13 Accostossi a’ sommi d’Italia 3.5 14 Emulò il vero ne’ ritratti 23 15 Nei paesi nei fiori nella frutta negli uccelli nei pesci 23 16 Ma superò molti e sé stesso 22/16 17 Nei quadri di storia 33 18 e più nei piccoli di leggiadro argomento 33 19 Per creatrice fantasia e sennato comporre 36 20 Per eleganza di stile e vivace espressione 36 21 In questa775 isola cui sorrise il cielo 16 /14 E fuori ammirato 22 Della patria amantissimo 23 I fasti e gli illustri suoi figli 24 Ne eternò col pennello e coll’artistica penna 25 Modesto affabile leale 26 D’animo compassionevole generoso 27 Dai parenti dagli amici 28 Dai suoi allievi e da tutti 29 Meritossi in vita la stima e l’affetto 30 L’universal cordoglio in morte 31 Spirò in Dio d’anni LXXII 32 A 23 febbraio MDCCCLII __________ _________________________________ Il testo dell’epigrafe reca annotati a matita, a sinistra il numero di ogni rigo e a destra il numero dei caratteri per ciascun rigo. 774 Al rigo 2 nota al margine sinistro: “più grande”. 775 Segue cancellata la parola: “coltissima”. 773 272 Chi ha senso alla virtù 26 Sparga lacrime sul suo frale 24 E preghi pace all’anima sua detta! __________ 28 Il fratello e gli altri eredi mesti e riconoscenti777 24 Questa epigrafe scritta col core dal suo Agostino Gallo778 12 Sacrarono 776 Qui riposa /Giuseppe Patania da Palermo /Onnigeno dipintore di gran nome / Cav. del R. Ordine di Francesco I / membro della Commessione / di Antichità e Belle Arti / delle Nazionali Accademie / E di quella del disegno di Nuova York / Socio ornamento e decoro / Ispirato dal genio / Prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte coi migliori di Sicilia / Accostossi ai sommi d’Italia / Emulò il vero nei ritratti / Nei paesi nei fiori nelle frutta / ma superò molti, e sé stesso / nei quadri di storia / E più nei piccoli di leggiadro argomento / per creatrice fantasia e sennato comporre / per l’eleganza di stile e vivace espressione / Negli schizzi a penna e nelle tele / Qui e fuori ammirato / Della patria amantissimo / Ne eternò i fasti / E gli illustri suoi figli col pennello / Modesto affabile leale / Di animo compassionevole e generoso / Dai parenti dagli amici da suoi allievi / Meritossi in vita l’affetto / l’universal compianto in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / A 23 febbrajo MDCCCLII / ________ / Chi ha senso al bello e alla virtù / sparga lacrime sul suo frale / e preghi pace all’anima benedetta! / ________ / Le meste e riconoscenti eredi / Questa lapide / Posero. Qui riposa /Giuseppe Patania da Palermo / Egregio ed onnigeno dipintore / Cavaliere / Del R. Ordine di Francesco I / Della Commessione di Antichità / E belle Arti / Delle Nazionali Accademie / E di quella del disegno di Nuova York / Socio ornamento e decoro / Ispirato dal genio / Prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte coi migliori / Che vanti Sicilia / Accostossi ai sommi d’Italia / Emulò il vero nei ritratti / Nei paesi nei fiori nelle frutta / E superò molti e sé stesso / nei quadri d’istoria / E più nei piccoli di leggiadro argomento / Per creatrice fantasia / Per sennato comporre / Eleganza di stile e vivace espressione / Negli schizzi a penna _________________________________ Al rigo 26 nota al margine sinistro: “più piccolo”. Seguono cancellate le parole: “questa lapide”. 778 Segue cancellata la parola: “posero”. 776 777 273 e nelle tele / In patria e fuori ammirato / Buono modesto affabile generoso / Dai parenti dagli allievi / Dagli amici e da tutti amato in vita / E compianto in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / A 23 febbrajo MDCCCLII / ________ / Chi ha senso al bello e alla virtù / sparga lacrime sul suo frale / e preghi pace all’anima benedetta / ________ / Le meste eredi riconoscenti / Questa lapide / Posero. Qui riposa /Giuseppe Patania da Palermo / Egregio ed onnigeno dipintore / Cavaliere / Del R. Ordine di Francesco I / Della Commessione di Antichità / E belle Arti / Alle Nazionali Accademie / E a quella del disegno di Nuova York / Spontaneamente ascritto / ei fu ornamento e decoro / Dal genio ispirato / Prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte coi migliori / Che vanti Sicilia / Accostossi ai più rinomati sommi di gran nome / Onde primeggia l’Italia / Emulò il vero nei ritratti / Nei paesi nei fiori nelle frutta / E superò molti e sé stesso / nei quadri d’istoria / E meglio nei piccoli di leggiadro argomento / Per creatrice fantasia / Per sennato comporre / Eleganza di stile e vivacità d’espressione / Negli schizzi a penna e nelle tele / Fuori ammirato / Per bontà modestia e cuor generoso / Dai parenti dagli amici dagli allievi e da tutti / Amato in vita / E compianto in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / A 23 febbrajo MDCCCLII / ________ / Chi ha senso al bello e alla virtù / sparga lacrime sul suo frale / e preghi pace all’anima benedetta / ________ / Le eredi meste e riconoscenti / Questa lapide / Posero. Qui riposa /Giuseppe Patania da Palermo / Onnigeno dipintore di gran nome / Cav. del R. Ordine di Francesco I / Ascritto alla Commessione / di Antichità e belle Arti / Alle Nazionali Accademie / E a quella del disegno di Nuova York / Ne accrebbe ornamento e decoro / Ispirato dal genio / Prediletto dalle Grazie / Gareggiò nell’arte coi migliori di Sicilia / Accostossi a’ sommi d’Italia / Emulò il vero ne’ ritratti / Ne’ paesi ne’ fiori nelle frutta / Ma superò molti e sé stesso / Ne’quadri di storia / E più ne’ piccoli di leggiadro argomento / Per creatrice fantasia e sennato comporre / Per eleganza di stile e vivace espressione / Negli schizzi a penna e nelle tele / In quest’isola sorrisa dal cielo / E fuori ammirato / Della patria amantissimo / I fasti e gl’illustri suoi figli / Ne eternò col pennello / Modesto affabile leale / D’animo compassionevole e generoso / Da’ parenti da gli amici / Da suoi allievi e da tutti / Meritossi in vita la stima e l’affetto / L’universal cordoglio in morte / Spirò in Dio d’anni LXXII / A 23 febbrajo MDCCCLII / ________ / Chi ha senso al 274 bello e alla virtù / sparga lacrime sul suo frale / e preghi pace all’anima benedetta / ________ / Le eredi meste e riconoscenti / Questa lapide / Posero. Allievi in pittura del signor Patricola e alcuni anche di Patania 1 Sig. Giuseppe Vitale da Sciacca. 2 Sig. Andrea d’Antone da Palermo e anche fu scolare di Patania. 3 Filippo Provenzale, idem. 4 Sig. Ramistella Giuseppe, idem 5 Sig. Pietro Lojacono, idem, fu anche scolare di Patania. 6 Sig. Giuseppe Varvaro suo nipote, idem. 7 Sig. Pasquale Conti, idem. 8 Sig. Raffaele Genovese, idem. 9 Sig. Ferdinando Santifoller, idem. 10 Sig. Giuseppe Gulotta da Termini. 11 Sig. Giuseppe Spampinato da Palermo. 12 Sig. Giuseppe Buja idem. 13 Sig. Salvatore Cento, miniaturista, idem. 14 Sig. Popò Milazzo, idem. 15 Sig. Giuseppe Barone, incisore di camei, da Termine. 17 [!] Sig. Giuseppe Rasura da Palermo. 18 Sig. Salvatore Gulotta, idem. 18 [!] Sig. Placido Crastonuova da Palermo 275 277 278 279 280 281 282 283 284 Agostino Gallo Notizie di artisti Siciliani da collocarsi ne’ registri secondo l’epoche rispettive raccolte da Agostino Gallo Ms. XV.H.20.2. Trascrizione e note di Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi Appunti sui pittori Pietro Ruzzolone1 pittore Sua croce con sacra storia descritta dal Cav. Di Miceli2, in Termini, con l’anno del contratto 1483, nella cattedrale. In quell’anno nasceva Raffaello Sanzio. Altra simile ma alquanto variata nella figura nella chiesa di S. Francesco, senz’anno. Vi erano sue opere sino sino [!] al 1520. Baronio3, Mongitore4 Prodigio artistico attuale Tutto rinnovasi e si riproduce nell’istoria in cui le vicende le grandi imprese gli eccelsi talenti i vizii le virtù degli uomini di tutte le nazioni ed età come se fossero affissi ad una ruota al suo volgersi vi appariscono quasi nello stesso aspetto o con piccole differenze. Nessuno che abbia percorso quello delle belle arti ignora ciò che avenne [!] un giorno a Cimabue pittore del XIII secolo. Errava egli a diporto per osservare le svariate bellezze della natura per la campagna del villagio di Vespignano vicino a Firenze sua patria quando si accorse d’un garzoncello che stando in guardia d’un branco di pecore per passar mattana era tutto intento a disegnare sopra una lastra con selce appuntuta una delle sue pecore che strajata e tranquilla ruminava la pastura. E sorpresolo alle spalle ebbe agio ad osservare che quell’animale nell’attitudine, nella peculiar sembianza ne’ velli era a perfezione delineato qual da mano maestra sperar si potesse. Di che meravigliato chiese al fanciullo se bramasse di esse_________________________________ Pietro Ruzzolone, pittore palermitano, operò tra il 1484 ed il 1526 in vari centri dell’Isola. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.19.). Trascrizione e note di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2005, pag. 460. 2 Ignazio De Michele, Sopra un’antica croce nel Duomo di Termini Imerese, Palermo, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1859. 3 Francesco Baronio Manfredi, De maiestate panormitana libri IV, Panormi, apud Alphonsum de Isola, 1630, v. 3, p. 102. 4 Antonino Mongitore, Memorie dei pittori, scultori, architetti, artefici in cera siciliani. A cura di Elvira Natoli, Palermo, S.F. Flaccovio, 1977, p. 136-137. 1 287 re istruito da lui nella pittura, e quegli mostrandosene lieto si abbandonò al volere del padre che acconsentì, talchè il condusse al suo studio e in breve superò il maestro per modo che Dante scrisse credette Cimabue nella pittura tener lo campo, ed or ha Giotto il grido, sì che la fama di colui oscura (1)5. E non solo oscuro Cimabue il che non era difficile, ma tutti gli altri artisti contemporanei nella verità e nella grazia, e diligenza, laonde merito l’amicizia e le lodi di Dante intendente del disegno e la protezione de’ pontefici Benedetto XI, Clemente V, e Bonifacio VIII e lasciò opere che tuttavia si ammirano benchè l’arte fosse posteriormente progredita. E nella mia prima giovinezza conobbi pel grido della fama che Giuseppe Velasques6 da Palermo, fanciullo, senza la direzione di maestro imitava con la penna le istorie incise in rame e poscia sovramettendo a queste i cristalli le ritraeva esattamente a colori finchè entrando nello studio di Giuseppe Tresca7, e al primo anno l’ecclissò e procedendo rapidamente nell’arte di opera in opera divenne nella composizione, nel disegno il primo pittore della Sicilia che non è stato finora superato e lo sarà difficilmente. E così pure avvenne al suo concittadino Valerio Villariale8. Costui a 7 anni senza guida di alcuno modellava pastori in creta pel suo zio canonico Mandalà che ne adornava9 il suo presepe, e poi a 10 anni un poco più li scolpiva in legno in buone proporzioni con vivace espressione di volti e di attitudine, ed io ho veduto uno di questi suoi presepi posseduto ormai dal cav. Benzo e segnato col nome del giovinetto artista che nelle figure è mirabile per le indicate qualità e sembrano di uomo provetto nell’arte. Il cav. Lioy allora ammiratore dei fondi della Magione assegnati a S.A.R.D. Leopoldo principe di Salerno vide queste figurire del Villareale e da buon conoscitore qual’era volle presentarlo a S.A. e l’ardito giovinetto gli chiese in grazia di permettergli di modellargli in creta il busto e in pochi giorni l’eseguì con tal somiglianza e grazia che superava di gran _________________________________ A c. 3r nota al margine sinistro: “(1) Purgat. c. XI.” Giuseppe Velasquez, pittore, nato a Palermo nel 1750 e ivi morto nel 1827. 7 Giuseppe Tresca, pittore, nato a Sciacca nel 1710, morto a Palermo nel 1795. 8 Valerio Villareale, scultore, nato a Palermo nel 1773 e ivi morto nel 1854. 9 L’articolo Prodigio artistico attuale, riportato alle c. 2-3, che termina con le parole “che ne adornava” prosegue alla c. 187v con le parole iniziali “il suo presepe” e le parole finali “negli anni e nell’arte”, alla c. 186r-v con le parole iniziali “Laonde S.A.R.” e le parole finali “gli disse: proteggete”, alla c. 187r con le parole iniziali “questo giovinetto che mostra genio” e le parole finali “più culti regni di Europa”, e alle c. 188r-191r con le parole iniziali “e sarebbero certo saliti” e le parole finali “nella istoria dell’arte”. Alle c. 4-7: Ignazio De Michele, "La Sala del Consiglio comunale di Termini Imerese". Estr. da: L'Imerese, n. 6, in due copie. In testa al titolo la nota manoscritta: Pel pittore Vincenzo Barbera di Termini 1610. 5 6 288 lunga quelle scolpitogli in marmo da Federico Siracusa10, artista provetto negli anni e nell’arte Laonde S.A.R. dopo qualche anno gl’interuppe dalla R. Corte il sostentamento in Roma, ove con l’ammaestramento del Canova divenne anch’egli sì egregio scultore da meritare l’affetto e la stima del suo maestro Giuseppe Patania11 anche di Palermo. Né conviene trasandare sul proposito di giovinetti artisti che per impulso di genio pria che per ammaestramento dell’arte fan presagire dai più teneri anni la loro riuscita. Egli era figlio di un sarto e al sesto anno e di pria che maneggiasse la penna per iscrivere tracciava sulla carta graziose figurine e dopo qualche anno che attese allo studio elementare delle lettere persistendo a scarabocchiare figurine, a consiglio di un architetto fu allogato nello studio di uno scultore e poi presentato a quello di Giuseppe Velasquez ove in 6 mesi giunse ad disegnare con diligenza ed esattezza in gesso e preso ardimento chiese al suo maestro di volerne dipingere una testa, ma quegli bruscamente il minacciò alla bacchetta ma il giovinetto insofferente della minaccia raccolse i suoi disegni e gli disse: sarò pittore senza la sua direzione e andò via. Difatti cominciò a dipingere i cartelloni di teatro in cui rappresentavasi la scena principale del dramma spesso con molte figure al vero che gli venivano pagate due scudi per ciascuno ed erano esposti ad uno dei cantoni della piazza Vigliena. Or avvenne che passando un giorno il cav. Puccini,12 direttore della galleria di Firenze e grande amatore ed essendo in compagnia del suo amico Bar. Pietro Pisani fermossi a guardare quella scena dipinta e chiese al barone chi ne fosse l’autore. Gli fu risposto d’essere un giovinetto a 16 anni e quegli meravigliatosene gli disse: proteggete questo giovinetto che mostra genio, fantasia in queste opere, e diverrà egli con lo studio gran pittore, e lo fu come mostrò in breve nella cena in Emmaus nel refettorio del Seminario arcivescovile e in altri dipinti di quel tempo e progressivamente nell’invenzione spontanea e nella grazia e nell’espressione nelle opere successive qualità in cui non è stato ancora eguagliato. Pare che gli artisti ed altri uomini di genio in diverse discipline sorgano in Sicilia spontaneamente come funghi. La natura figlia di Dio li crea ma l’arte13 sua nepote secondo il concetto di Dante può solo educarli alla perfezione. Abbiam veduto verso il 1830 sorgere in Sicilia dei meravigliosi fan_________________________________ Federico Siracusa, scultore, nato a Trapani nel 1759, morto a Palermo nel 1837. Giuseppe Patania, pittore, nato a Palermo nel 1780 e ivi morto nel 1852. 12 Tommaso Puccini (1749-1811), studioso d’arte. 13 Seguono cancellate le parole: “come balia l’educa”. 10 11 289 ciulli decenni matematici e un violinista senza studio ma col semplice pratico esercizio recan stupore a’ più culti regni di Europa e sarebbero certo saliti all’apice della scienza fino all’astronomia se il ministro Santangelo non li avesse sviato e voltili ad altra carriera privandoli dei larghi sussidi ottenuti dalla beneficenza comunale. Ed ora un altro fenomeno artistico singolare è sorto in Sicilia. Nella meschina14 terricciuola di Villalba che conta appena 1.018 abitanti e dipende dalla diocesi di Girgenti una villica famigliuola di sei individui di cui fu genitore Gaetano Piemonte e madre Marianna Cristianna ha dato un genio nell’arte scultoria nel suo quarto figliuolo Litterino. Il padre addetto pria alla vanga e poi a guardiano di un fondo del sig. Nicolò D’Ina lasciò nella miseria morendo la famiglia e il figlio Litterino all’età di anni 8 e il figlio maggiore Giuseppe provvedeva l’una ad alimentarla con istruire all’industria delle calze le fanciulle del villaggio e l’altre alla fatica giornaliera della campagna. Il misero fanciullo Litterino a tre anni cominciò a modellare in creta i pastori del villaggio e colorandoli li vendeva agli altri fanciulli e cresciuto, dopo la morte del padre, ajutava il fratello maggiore a zappar la terra e nei ritagli di tempo continuava a modellare in creta delle figurine. La madre l’avviò alla scuola di quel paese e appena potè imparare a leggere stentatamente; ma il fratello per l’utile proprio ne lo ritrasse e punto al 12 anno copiò in creta a tutto rilievo dell’altezza di due palmi una statua in legno di S. Giuseppe e la vendette, poi un Crocifisso di tre palmi e un’Immacolata sopra una statua, ma non potè compirla e indi si ruppe. Giuseppe Cammarata l’adoperò per effigiargli i pastori, gli animali, la Vergine, S. Giuseppe e il Bambino per il suo presepe. In Villalba non havvi alcuno che potè istradarlo nel disegno e nell’arte di modellare e quanto egli operava nella creta era impulso del suo genio, diligenza nell’osservazione dei modelli ed occhio finissimo nel conservare le forme e le proporzioni originali delle copie. Un bel giorno avendo egli inteso che in Palermo vantatagli come grande città vi erano moltissime belle statue e quadri eccellenti spinto dall’amore dell’arte e raccolti pochi tarì dai suoi lavori fuggì15 dalla casa paterna a 25 luglio 1844 e recatosi qui vagava per la strade entrando in ogni chiesa che incontrava e rimanendo sbalordito ad ogni imagine di santo o di santa che scogeva sugli altari per modo che all’ora di chiudersi le chiese n’era cacciato dai sagrestani. _________________________________ 14 15 Segue cancellata la parola: “villaggio”. Seguono cancellate le parole: “verso la fine di luglio di quest’anno”. 290 Non aveva fin allora potuto ritrovare ricovero e già aveva esaurito le piccole monete recatesi in tasca quando per caso introdottosi nella Rua Formaggi si avvide che ivi lavorava nel suo studio in legno una statua della Vergine il signor Giovanni Scimone, fermossi a lungo a contemplarla e quegli accortosene e lo richiese se gli piacesse. Rispose il dodicenne fanciullo: Moltissimo, ma io so fare anche qualche cosa. Ebbene, replicò lo Scimone, qui vi è creta, se sai fare modella qualche testa. Esultò il piccolo Litterino e die’ opera ad effigiare ad alto rilievo al vero di memoria la testa del Cristo spirante che avea copiato nella sua patria. Ne rimase sorpreso lo Scimone nello scorgere la prontezza dell’operare e la regolarità del disegno del modello, e lo accolse in casa e gli ha dato fino adesso alimento. Sia lode quindi a quel buon uomo tanto più che tira bene una medioce sussistenza dalla sua professione. Divulgatasi la fama di quel fanciullo prodigioso d.n Leopoldo Borboni e d.n Ferdinando Consales lo recarono da me per farmi ossevare la testa del Cristo che a vero dir sembrommi così regolare di grande espressione nell’indicare l’atto di chi spira che io avrei creduto quell’opera di un giovane provetto nello studio di un buono artista anziché di un fanciullo che sapea far tanto senza la guida di maestro. L’indomani recommi modellato un bambino di un palmo modellato di memoria in tutte le proporzioni del corpo. Allora mi convinsi che quegli fosse un prodigio artistico dei nostri tempi ed insieme col sign. Consales e Scimone gli abbiamo formulato una supplica al governo per dargli qualche ajuto ed io lo raccomandai particolarmente al cav. Senatore Francesco Di Giovanni Presidente della Commissione di antichità e belle arti non potendo io fare altro che dargli dei piccoli soccorsi avendo già renunziato alla carica di segretario archeologo con voto di quella Commissione. Il giorno 27 del corrente agosto recossi da me nuovamente il fanciullo, portò seco della creta e volle modellare sotto gli occhi miei al vero in alto rilievo la testa del Meli sul busto che io ne possiedo, ed in meno di un’ora era già abbozzata sì bene che la nepote di quel poeta recandosi a casa da me subito lo ravvisò. Il giorno appresso l’attendevo avendolo invitato a pranzo da me ma egli non venne e ne chiederò notizia allo Scimone avendomi promesso di dover terminare quel suo lavoro. Spero che il governo voglia interessarsi di questo giovane prodigioso nell’arte perocché il suo comune miserabile com’è non può sostenerlo in Palermo e appena ha saputo ottenere un piccolo soccorso dalla sua madre indigente da me da Scimone e da qualche altro. Veramente la provincia di Girgenti che è ricca e alla quale appartiene Villalba dovrebbe dargli un 291 assegnamento mensile per progredire nell’arte sotto la direzione di un ottimo maestro in Palermo, e poi spedirlo in Roma come praticò col Carta la generosa principessa di Paternò, la quale partecipa ormai alla gloria di sì gran pittore ed il nome di amendue passeranno alla posterità nella istoria dell’arte.16 Vincenzo La Barbera17 da Termini pittore del secolo XVII Di lui havvi un bellissimo quadro della cena del Signore coi dodici apostoli figure al naturale nella cappella dello Spedale di Caccamo. Pittura siciliana sec. XVI Luigi Roderigo18, detto il Siciliano, nacque in Palermo verso la fine del secolo XVI da Diego Roderigo ufficiale spagnuolo di Filippo III, mentre colà trovavasi stanziato con la guarnigione. Desiderava il padre che Luigi, studiate le lettere, fossesi applicato alle armi; ma non così avvenne, chè egli circa il suo diciassettesimo anno volle darsi alla pittura, ricevendo i primi insegnamenti da un pittore palermitano. Nel 1604, venuto in Napoli con un suo zio materno, onde perfezionarsi nell’arte da lui prescelta, fu messo a scuola di Belisario Corenzio19, come quegli che in quell’epoca avea maggior grido. Studiò Luigi indefessamente e con grande profitto, come lo attestarono le primitive sue opere eseguite nella chiesa dello Spirito Santo. Impegnato a dipingere alla Certosa i freschi dell’atrio della chiesa, commessigli dal suo maestro Belisario, trovò che vi dipingea anche il cav. D’Arpino, ed egli curioso e parte per ammirare le opere di sì famoso artista, non fu tardo ad affezionar_________________________________ Al margine si legge: “sull’epoca della nascita del volgare”. Vincenzo La Barbera, pittore ed architetto, nato a Termini Imerese, attivo tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVII. 18 Luigi Rodriguez (o Roderigo), detto il Siciliano, nato a Messina, documentato a Napoli tra il 1594 e il 1608. Altri ipotizza come date di nascita e morte: 1585-1630, cfr. Agostino Gallo, Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.18.). Trascrizione e note di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2003, p. 31-34, 60-61; Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori… cit., p. 451-452, 492-493. Giambattista Gennaro Grossi indica come data di nascita “circa il 1594” in Le belle arti dell’avvocato G.B. Gennaro Grossi… Opuscoli storici su le Arti, e Professori dipendenti dal disegno ne’ luoghi che oggi formano il Regno di Napoli, Napoli, dalla Tipografia del Giornale Enciclopedico, 1822, v. 2, p. 114. 19 Belisario Corenzio, pittore di origine greca nato in Acaia nel 1558 e morto ad Esperia (FR) intorno al 1646, fu attivo nell’Italia centro-meridionale. 16 17 292 glisi, allettandolo non poco la bella maniera del cavaliere, che se’l volle tenere compagno in altri lavori che dovea eseguire in diverse chiese della capitale. Di poi furongli allogati i freschi della navata della chiesa del Carmine, esprimenti fatti del Redentore, freschi che gli procacciarono infinite lodi; per la qual cosa attiratosi contro l’invidia del Corenzio suo primiero maestro, questi un dì entrato nella chiesa del Carmine, e riunitosi alla moltitudine che ivi trovavasi per ammirare le opere di Luigi, onde sentire da vicino che che ne dicessero, domandò ad uno della folla (che era un artista) il nome dell’autore di quelle pitture, e qual giudizio egli ne desse, e sentendo da colui che erano opere del Roderigo, il quale discepolo di Belisario, avealo in quelle di gran lunga superato nell’arte, fu preso da tale odio e livore contro dell’infelice Luigi, che ne giurò la perdita; propinandogli un lento veleno, fattogli bere ad un pranzo in cui lo avea invitato, che in fra non molto lo estinse. La sua morte che seguì nel 1630, fu da tutti compianta con immenso rammarico. Le ultime sue opere, lasciate imperfette, osservavansi nella chiesa della Concezione degli Spagnuoli, ora non più esistente. Comunicazione del Dottor G. Bandiera Alcuni paesisti ed internisti di Palermo. Sopra un famoso pittore20 sig. Abbate21 soggiornante in Napoli nel 184622 Pochi de’ nostri pittori si son dati a questo leggiadro genere di dipinti ad olio offrendo scarso lucro a coloro che potrebbero esercitarne in Sicilia. Due dilettanti bensì il p. Piazzia da Palermo che apparteneva all’Ordine Benedettino in Monreale dipinse il famoso chiostro del medioevo del suo monistero da un punto angolare da cui poteansi scorgere i quattro lati e riuscì col bello effetto pittoresco.23 Anche il cav.re Benzo24 da Palermo studiando la prospettiva si esercitò nel dipingere l’interno della nostra real Cappella palatina e della camera a mosaico del re Ruggiero nel R. Palazzo la quale è stata ritratta molte e molte volte da pittori stranieri e ridotta in incisione. Ma il Benzo ha colpito il vero da un punto più favorevole e per diligenza ha gareggiato con gli esteri dipintori. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “d’interno siciliano”. Vincenzo Abbate, pittore, attivo nel secolo XIX. 22 Seguono cancellate le parole: “professore Abbate”. 23 Segue cancellata la frase: “e con molta intelligenza della prospettiva architettonica”. 24 Salvatore Benzo, pittore, attivo nel sec. XIX. 20 21 293 Il celebre internista M.r Verbrut25 che io conobbi familiarmente dipinse in Palermo verso il 1846 diversi interni delle nostre più belle chiese e in particolare il bellissimo prospetto meridionale della nostra cattedrale. Egli era intelligentissimo prospettico e pittore di gusto squisito anche di paesi e quel prospetto della nostra cattedrale fu da lui eseguito per ordine di Ferdinando 2° e pagatogli largamente. Massimo d’Azeglio milanese celebre romanziere e non meno celebre paesista e internista, essendosi recato in Palermo verso il 1846 per rannodare le fila della rivoluzione italiana con quella di Sicilia che dovea promuoverla ricavò gli schizzi de’ più ameni siti campestri di Palermo, che io osservai con diletto e stupore essendo divenuto suo amico, dopo di essere stato commensale con lui in un pranzo nella sua casina a’ Colli datogli dal principe di Scordia. In quella occasione io gli dissi: Sapete che ignorando io che voi foste pittore, dalle letture dei vostri romanzi, l’indovino ed egli sorridendo mi rispose: Qualch’altro mi ha fatto la stessa osservazione. Eravamo intanto verso il tramonto del sole affacciati al balcone di quella deliziosa magion campestre e l’astro maggior della natura ravvivava i bei colori del vicino monte Pellegrino, e l’Azeglio ammirando quella gran massa di roccia per le belle tinte dissemi O quanto bramerei di aver quel monte vicino Milano per istudiarvi quel seducente colorito ravvivato dalla luce. Ebbene risposi io noi siamo pronti a regalarvi quel monte, avendone altri attorno Palermo e giovandovi molto di sgombrare quel sito settentrionale che c’impedisce il libero passaggio dell’aria più salubre. Ed egli, il farei volentieri se me lo potessi trasportare nella mia patria che manca al tutto di monti e di modelli a’ nostri pittori sì colossali e ornati di sfolgoranti e svariati colori. Ritornando agl’internisti ed a’ pittori di paesi dirò che de’ primi anni replico penuria in Sicilia non già de’ secondi. Il primo che in Palermo abbia dipinto con verità e buon gusto di colori il paesaggio fu Giuseppe Patania26 il quale nella sua prima gioventù ritrasse a matita i più bei punti pittoreschi delle campagne attorno a Palermo e ne arricchì i suoi cartolari, onde servirgli variandoli e raccozzandoli pe’ suoi dipinti; e così fece in effetto elevandosi sopra Vincenzo Riolo27 che pure tentò il paese e vie meglio sul massimo Giuseppe Velasquez28 famoso figurista, del quale abbiam solo quattro paesi presso _________________________________ Franz Vervloet, pittore, nato a Mechelen nel 1795 e morto a Venezia nel 1872. Vedi nota n. 11, p. 289. 27 Vincenzo Riolo, pittore, nato a Palermo nel 1772 e ivi morto nel 1837. 28 Vedi nota n. 6, p. 288. 25 26 294 il Monistero de’ Benedettini in Morreale ed uno migliore presso di me. Del Riolo poi ve ne sono alcuni commessigli dal Dr. Vincenzo Gagliano da Catania che lo pose a gara col Patania in alcuni paesi con personaggi istorici. Dopo quel tempo Giuseppe Tripi29 da Palermo imitatore del Patania essendo assiduo al suo studio quando dipingeva paesaggi avvicinossi al suo stile e ne dipinse molti che pur sono veri e leggiadri, ritraendoli coi contorni campestri di Palermo, e di cui io ne possiedo i bozzetti. Fra i migliori paesi dipinti dal Patania avvi una serie di alcuni di piccola dimensione in cui esprime tutte le vicende della natura nei giorni e ne’ mesi dell’anno. Prima aveva dipinto un uscita di selve pel miniaturista della Real Corte Giovanni Salvaggio30 e l’altro del Riolo in contrapposto. Altro bellissimo paese di lui fu quello pel principe di Santantimo lodatissimo da un pittore straniero altro pel Generale poi ministro Fardella rappresentante una danza campestre, altre pel barone Battifora rappresentante l’arrivo d’un feudatario nel suo villaggio e una festa che rendono al loro padrone alcuni villici e forosette. Io ne possiedo quattro che nonostante che siano della sua prima età pure sono graziosi. Giuseppe Bucalo31, figliastro del Patania, dipingeva ad olio prospetti e figure che sentivano lo stile del Patania e indi passò in Francia ove divenne attivo ritrattista in miniatura. La scuola napoletana influita allora da l’Alpe guastò alcuni nostri dei dilettanti paesisti come con quel maledetto color rossastro che predomina dapertutto i dipinti. Fra questi fuvvi il sigr. Giovanni Ondes che poscia se ne ritrasse come pure Giovanni principe Lanza Vettimiglia [!] quando non era ancora divenuto cieco che mostrava ad imitazione del Patania melliflua disposizione non che nella pittura di genere come pesci fiori e frutti in piccole dimenzioni ad acquarello a colore. Erasi recato in Palermo colla R. Corte il sig.r Raimondo Gioja32 napoletano pittore eccellente scenografo e ornamentista il quale diessi poscia a dipingere ad acquarello paesi di bellissimo effetto ma di false tinte. E costui anche eccitò in Palermo nei nostri dilettanti l’amor del _________________________________ Giuseppe Tripi, pittore, attivo nel secolo XIX. Giovanni Salvaggio (o Salvagio) scultore in legno nato a Sciacca, attivo nel secolo XVII. 31 Giuseppe Bucalo, pittore attivo nel secolo XIX, figlio di Narda Brucalo, o Bucalo, moglie di Giuseppe Patania. 32 Raimondo Gioia (o Gioja), pittore e scenografo, nato a Napoli intorno al 1772 e morto a Palermo nel 1837. 29 30 295 paesaggio occupandosi in questo genere a tempere colorate negli ultimi anni della sua vita e offrendo le sue dipinture delle quali io possiedo due. Il sig.r Gaspare Peranni33 figlio del generale letterato dilettante di pinger paesi superò il padre in questo genere e molti paesi e interni ha dipinto par per alcuni condotti con molta diligenza. Su tutti questi paesisti e dilettanti pittori s’innalzò di recente Lojacono34 figlio di35 Giuseppe valente dipintore figurista. Appreso avea in Napoli il paesaggio ove quel genere è coltivato egregiamente. Molti ne ha eseguito dipinti su imitamento sul vero ma che mancano talvolta di effetto non credendo di dovere aggiungere uno due albero o una rupe per il contrapposto pittorico, e conducendo i suoi dipinti con minuziosa esattezza. Nulla di manco ha un tocco felice ed è mirabile nelle imitazioni dal vero. Io ignoravo un celebre internista siciliano che soggiornando in Napoli anche pria del 1847 n’ebbi notizia leggendo alcuni ricordi d’artisti di Domenico Ventimiglia36 messinese, il quale descrivendo una veduta cittadinesca che in Napoli dal largo di S. Ferdinando mette al vastissimo piano del castello dipinta da Gabriello Carelli37 così scrive parlando anche degli interni del medesimo. Chi vide difatti “quegl’interni ch’egli recò all’ultima esposizione delle nostre arti riconobbe in lui un internista degnissimo di stare accanto al siciliano Abbate38 del quale ho veduti stupendi interni e fra tutti meraviglioso quello rappresentante la Galleria dell’onorando Duca di Caporana largo protettore delle arti ed artista egli pure assai lodati”. All’opinione del Ventimiglia che ne’ suoi ricordi artistici ove erano citati mostra buon giudizio intorno alle belle arti io non saprei oppormi, ma non avendo veduto nulla del sig.r Abbate, mi uniformo al parere del sig.r Ventimiglia. Né per vero pel nostro dipintore potrebbe vivere in Napoli colla pittura dell’interno se non fosse riguardato come uno tra i primi in quel genere perochè ivi moltissimi l’imitano con fede. _________________________________ Gaspare Peranni, pittore, attivo nella prima metà del XIX secolo. Francesco Lojacono, pittore, nato a Palermo nel 1838, ivi morto nel 1915, figlio di Luigi, non di Giuseppe, anch’egli pittore. 35 Segue cancellata la parola: “un” ed è aggiunto successivamente il nome “Giuseppe”. Ma il padre di Francesco era Luigi, e non Giuseppe. 36 Domenico Ventimiglia, Arte e storia, ricordi della Sicilia, Palermo, 1856. 37 Gabriele Carelli, pittore, nato a Napoli nel 1820 e morto a Londra nel 1900. 38 Vedi nota n. 21, p. 293. 33 34 296 Gliptica in Sicilia 1866 Pietro Bordino39 figlio del fu Francesco e di Vincenza Ilardi nacque in Trapani a 13 marzo 1803 studiò il disegno nel patrio liceo sotto Francesco Cutrona40 trapanese buon disegnate [!], felice inventore e mediocre coloritore. Diessi indi all’incisione in pietre dure sotto Michele Laudicina41 di quella città ch’era stato scolaro in Roma del famoso Picheler42. Dopo la morte del Laudicina maestro in quel liceo di gliptica avvenuta nel 1831 il Bordino ne fu scelto sostituto finchè ne fu soppresso l’insegnamento. Recossi in Palermo nel 1841 indi in Napoli ove eseguì molti lavori d’invenzione e di ritratti in pietra dura. Restituitosi in Palermo ha sempre atteso all’arte sua con crescente reputazione e vive sino al corrente agosto 1866. Opere in diversi musei Nel museo de’ Gesuiti, un’imitazione egiziana ed altro intaglio in quello di Valenza reputati antichi. Su calcedonia i segni del zodiaco presso un inglese. Un fatto romano sopra corniola con 4 figure presso un inglese. Un suggello ovale sopra gran corniola cotognina imitazione di quello di Cesare Augusto con una testa imberbe, con un delfino e un tridente e con globo e iscrizione greca. Ritratto reale di F. II sopra sardonica. Celebre dipintura sopra tavola del secolo XIV Nell’anno 1516 fu rinvenuta sepolta in43 un nascondiglio un famoso _________________________________ 39 Per Pietro Bordino cfr. Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione delle monete in Sicilia dall’epoca araba sino alla castigliana (Ms. XV.H.15., cc. 1r, 11-45v); Notizie de’ figularj degli scultori e fonditori e cisellatori siciliani ed esteri che son fioriti in Sicilia da più antichi tempi fino al 1846 raccolte con diligenza da Agostino Gallo da Palermo (Ms. XV.H.16., cc. 1r25r; Ms. XV.H.15., 62r-884r). Trascrizione e note di Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2004, p. 258. 40 Francesco Cutrona, pittore trapanese, attivo tra la fine del secolo XVIII e l’inizio del sec. XIX. 41 Michele Laudicina, incisore, nato a Trapani nel 1762 e ivi morto nel 1832. 42 Antonio Picheler, incisore, nato a Bressanone nel 1697 e morto a Roma nel 1779. 43 Segue cancellata la parola: “antico”. 297 antico dipinto sopra tavola rappresentante sette angeli nella chiesa e monistero di tal denominazione in Palermo fondato da Ettore Pignatelli allora vicerè di Sicilia. Il sac.te Antonio Lo Duca dotto e pio ecclesiastico eletto dal Pignatelli rettore di quella chiesa eccitato avendo la divozione del popolo verso i sette santi angeli fu spedito in Roma ed ottenne per mezzo del cardinal Dal Monte che si potesse a’ medesimi celebrar messa festiva. Questa tavola esisteva ancora nell’interno del monistero sino al 1848 quand’esso fu rovinato come altre parti di Palermo dalle bombe borboniche; tuttavia fra le macerie fu osservata da un mio amico pittore e indi sparì, come credesi rubata da un trafficante di antichi quadri che li vende segretamente a gran prezzo agli stranieri amatori44. Pitture del secolo XV in Polizzi Nell’Abadia di S.ta Croce, sita nell’Agro di Polizzi, edifizio del secolo XIII di stile arabo-normanno, come rilevasi da antiche scritture, che contestano non solo l’epoca, ma di esservi stato annesso un monastero de’ PP. Benedettini, nella volta, e nelle pareti della chiesa che45 ancor si conserva con 6 nicchiette ne’ due lati, essendo distrutto il monistero, si osservano i resti delle vetuste pitture a fresco quasi svanite. Nel cappellone era dipinto, in quanto il vero, Gesù Cristo, che sustenea il libro degli Evangeli con la scritta: Ego lux mundi, e coll’indice della destra che l’indicava. Sull’interno della porta eravi dipinta la regina Bianca, che Rocco Pirri credette fondatrice, ed altri dotatrice della chiesa46 Nelle pareti si scorgono anche vestigie di sacre pitture. Notizia comunicatami dal p. Ciro Marzullo che n’è l’Abate Nella chiesa di S. Maria delle Grazie de’ PP. Gangetani avvi una bella copia in tavola detta spasimo di Raffaello. Notizia comunicatami dal pittore Andrea Sottile47. _________________________________ 44 Su c. 15v. “Al carissimo sig. Agostino Gallo uomo di lettere Sicilia Palermo” Incollati quattro francobolli da 1 centesimo e due da 5 centesimi. 45 Seguono cancellate le parole: “sola rimane”. 46 Rocco Pirri, Sicilia sacra disquitionibus et notitijs illustrata… Liber secundus, Panormi, apud haeredes Petri Coppulae, 1733, p. 829. 47 Andrea Sottile, pittore, nato a Termini Imerese nel 1802, documentato fino nel 1856. 298 Pittura in Sicilia del secolo XVII e seguente Giovambattista Bruno e Cristofaro Manna di Castrogiovanni Giovambattista Bruno48 nato a 2 giugno 1647 in Castrogiovanni appartenne all’ordine dei Minori Conventuali di S. Francesco e segnalossi dapprima nelle belle lettere e nella poesia pubblicando in progresso canzoni siciliane sacre, morali e proverbiali (1)49 ed una tragedia col titolo s. Clemente. Nel 1666 fece i voti solenni nel suo ordine religioso, ove ottenne il titolo di cancelliere e fu scelto professore di filosofia nel patrio cenobio in Messina e in Palermo. Però incontrando in quelle facoltà delle forti vertenze si rivolse alle matematiche discipline e siccome nella famiglia paterna si era esercitata la pittura anche a quest’arte liberale volle darsi e vi riuscì, per modo che dipinse quadri nella cattedrale di Catania, nelle città di Piazza, di Butera, di Terranova ed anche in Palermo come riferisce il Mongitore (2)50 il quale ci dice nella sua Biblioteca che ancor vivesse quando la pubblicava in Palermo nel 1708. Dall’opera del Bruno annoverata dal Mongitore: Anatomia di prospettiva ottica, anottica e catottica51 puossi congetturare che coltivasse ancora con le matematiche applicate l’architettura. Un altro suo concittadino di epoca posteriore per nome Cristoforo Manna abbiam notizia che fosse pittore di vaglia e di molte lettere (1)52 Null’altro sappiamo di questo nostro artista e spiacemi che sia morto il canonico Alessi53 mio amico anche per non potere ottenere informazioni di _________________________________ 48 Giambattista Bruno, letterato e pittore, nato ad Enna nel 1647, morto non prima del 1707. Mongitore lo ricorda vivente a p. 354 del v. 1 della Bibliotheca sicula, stampata nel 1707. 49 A c. 17r nota in calce: “(1) In Palermo per Felice Marino 1701” < Giovanni Battista Bruno, Fascetto di mirra, ò vero Mazzetto di diverse canzoni siciliane sacre, morali e proverbiali, Palermo, per Felice Marino, 1701>. 50 A c. 17r nota in calce: “(2): Bibliot. Sic. pag. 324” < Antonino Mongitore, Bibliotheca sicula, sive de scriptoribus siculis qui tum vetera, tum recentiora saecula illustrarunt, notitiae locupletissimae... Panormi, ex typographia Didaci Bua [poi] ex typographia Angeli Felicella, 1707-1714, p. 324.> 51 Giambattista Bruno, Anatomia di prospettiva ottica, anottica e catottica. Opera rimasta manoscritta cfr. Giuseppe Mira, Bibliografia siciliana. Ovvero gran dizionario bibliografico delle opere edite e inedite, antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori, Palermo, Ufficio tipografico diretto da G.B. Gaudiano, 1875-1881, v. 1, p. 131. 52 A c. 17v nota in calce: “(1): Guida per la Sicilia di Giovanna Power. Napoli Stabilimento poligrafo del Cirelli pag. 146. Citiamo questa eruditissima viaggiatrice che abbiamo conosciuto in Palermo e che strinse rapporti letterari girando la Sicilia col dottissimo canonico Giuseppe Alessi dal quale ricavar dovette le notizie di Castrogiovanni sua patria come la suddetta sig. Power far soleva giovandosi in ogni nostra città dei lumi dei letterati” <Jeannette Power, Guida per la Sicilia, Napoli, dallo Stabilimento Poligrafico di Filippo Cirelli, 1842, pag. 146>. 53 Giuseppe Alessi, canonico erudito, naturalista, collezionista, nato ad Enna nel 1774 e morto a Catania nel 1837. 299 quel pittore suo concittadino, di cui non fa cenno il Mongitore nella sua Biblioteca Sicula, come uomo di molte lettere il che mi fa congetturare che vivesse dopo il54 1708 quando pubblicò l’opera sua. Di quanti artisti della nostra interne città che illustrarono la Sicilia abbiam perduto memoria per mancanza di scrittori locali. E ciò è pure avvenuto in Palermo, città capitale di maggior cultura ove dai nostri autori sono stati trascurati gli artisti; talchè molta fatica ho dovuto durare almeno per secondarî di rintracciarne la memoria e di non pochi di cui osserviamo le opere non di rado pregevoli ignoriamo sinanco il nome. Pittura siciliana nel secolo XVIII Paolo Girgenti55 nacque in Girgenti circa il 1769 e giovinetto recossi in Napoli, ove non so se come è costume per gli esteri gli sia stato applicato il cognome ritratto dalla patria in sostituzione a quello della famiglia. Studiò il disegno forse sotto il Fischetti56 ed ebbe a compagno Giuseppe Camerata57 che nato in Sciacca da fanciullo fu dal padre napoletano fu [!] portato in patria; ma il Girgenti conoscendo che il colorito è la magia della pittura diessi a copiare in quella R. Galleria e nelle altre private nobilesche i quadri de’ migliori, e più vaghi coloristi, e conseguì il bramato intento per modo che dal governo per la fama acquistatasi fu scelto professore delle varie maniere di colorire nelle regie scuole dell’arti dipendenti dal disegno, e membro della R. Accademia delle Belle Arti (1)58 e fu addetto e custode dell’anzidetta R. Galleria. Ivi copiava i migliori dipinti sì bene che n’erano adescati gli amatori stranieri, e nazionali e glieli pagavano a gran prezzo. Giuseppe Ventimiglia da Palermo, principe di Belmonte ne acquistò un bel putto dormiente al naturale che per il florido colorito e l’espressione dell’ansare dal sonno non che pel buon disegno è ammirato da tutti e copiato da’ giovani nella pinacoteca della R. Università di Palermo alla quale fu donato da quel pattriotta e munifico principe in morte, con gli altri _________________________________ Seguono cancellate le parole: “prima del”. Paolo (o Paolino) Girgenti, pittore e incisore, nato ad Agrigento intorno al 1769, morto a Napoli nel 1819. 56 Fedele Fischetti, pittore, nato a Napoli nel 1734 e ivi morto nel 1789. 57 Intendasi Giuseppe Camerano (o Cammarano). Pittore scenografo, nato a Sciacca nel 1766 e morto a Napoli nel 1850. 58 A c. 19r nota in calce: “(1): Grossi sulle Belle Arti. Ricerche sulle stesse. Annotazioni pag. XXVIII. Nap. 1822” <Giambattista Gennaro Grossi, Ricerche su l’origine, su i progressi e sul decadimento delle arti dipendenti dal disegno, Napoli, dalla tipografia del Giornale Enciclopedico, 1821, p. XXVIII, n. 17>. 54 55 300 suoi sceltissimi quadri. Né solo segnalossi il Girgenti nelle sue facilissime copie condotte bensì con franco pennello come in quella eccellente d’una Madonna di Raffaello d’Urbino; ma fa mostra della sua abilità pittorica ne’ quadri di originale composizione59 è rammentato dal Grossi intelligente scrittore quello di S. Francesco di Sales. Il Grossi che pubblicava l’opera sua nel 182260 non accenna l’anno di morte del Girgenti che forse ignorava, ma essendomi io recato in Napoli nel luglio del 1817 non vidi tra i custodi della R. Galleria né intesi parlar di lui, il che mi diè indizio di sua morte. Il Grossi nell’opera citata a pag. XXIX61 dice che Giuseppe Camerano fu napoletano e nacque circa il 1767 e lo accenna come scolare del Fischetti. Io fui amico del Camerano e lo conobbi in Napoli nel 1817, ed egli manifestommi ch’era nato in Sciacca e ragazzo fu condotto dai suoi genitori in Napoli loro patria e che recossi adulto in Palermo e lavorò col celebre nostro dipintore Giuseppe Velasques. Quanto all’anno di nascita sbaglia anche il Grossi perocchè il Camerano vide la luce in Sciacca nel 1766 e morì in Napoli nel 1850. Ivi per la sua abilità nell’arte fu scelto professore delle regie scuole del disegno in cui era valentissimo come pure nelle complicate composizioni e ne diè prova principalmente nel gran sipario del Real Teatro di S. Carlo, ove erano rappresentate tutte le provincie del Regno di Napoli e di Sicilia bene aggruppate e in belli atteggiamenti. Dipinse molti affreschi nei reali appartamenti di Napoli e di Caserta e nel guazzo era riguardato a niuno secondo. Coltivò la poesia e la musica. Era di spirito piccante ed epigrammatico e rappresentava egregiamente nel carnevale il personaggio di Pulcinella. Ebbe un figlio che divenne famoso nelle composizioni comiche. Agostino Gallo Vedi l’altro articolo che riguarda il Camerano da me scritto Leggesi nel Mondo Illustrato giornale universale62 che si pubblica in Torino al foglio anno 4 N° 7 16 febbraro 1861 che il cav. Giovanni Busato, professore di pittura e degno sostenitore del decoro della scuola veneta era allora tornato da Pietroburgo, ove d’ordine dell’imperatore di _________________________________ Segue cancellata la parola: “lodato”. Giambattista Gennaro Grossi, Ricerche … cit. 61 Giambattista Gennaro Grossi, Ricerche … cit., p. XXIX, n. 22. 62 Il mondo illustrato. Giornale universale, Torino, 1847-1861. 59 60 301 Russia dipinse vari lavori nel nuovo teatro Michele63 ricostruito dal cav.re Cavos64 pure veneziano. Il Busato65 raffigurò nel soffitto di quel teatro le arti liberali civilizzatrici del mondo. Dipinse pure il nuovo sipario rappresentante l’inaugurazione del busto di Moliere all’Accademia di Francia sulla composizione dell’altro egregio professore italiano Cosroe Dusi66 morto prima del 1861. Il Busato compose due grandi cartoni coloriti per eseguirsi a mosaico ed esser collocati nella chiesa di s.to Isacco e dipinse pure nel teatro Maria sul soffitto della loggia del ministro una graziosissima Ebe che versa nettare all’aquila di Giove auspici le Grazie ed altri molti quadri per privati amatori reggi. Da questi tre artisti italiani surriferiti la capitale della Russia ha ricevuto nuovi impulsi al miglioramento della pittura e dell’architettura, nonostante che siansi fondate ivi scuole per le belle arti oltre che il governo vuole sempre inviare e mantenere in Roma i giovani artisti fra i quali nomineremo un certo G.C. Mogel [!], il quale riuscì valentissimo dipintore e ora ne appresta argomento il ritratto a mezza figura al naturale della signora Pelagia Bologni moglie del console di Russia, dipinto dal Vogel67 in Roma, opera che io possiedo ammirata dal Patania. Dicesi che questo pittore siesi suicidato. Anche mister Fagan68 console inglese educato in Roma e riuscito delicato dipintore dessi la morte affogandosi nel Tevere. Anche nel 1841 quando io fui in Roma fui invitato ad ammirare un gran quadro di affollata composizione e di mirabile effetto di un pittore russo. Insomma lo splendore delle arti non parte che dall’Italia e principalmente da Roma e si diffonde per tutta Europa. Da Caccamo 7 aprile 1864 Ottimo distintissimo signore Sebbene tardi, ma rispondo alla mia promessa archeologica - E primo. Nella chiesa de’ Padri Agostiniani esiste un dipinto di Matteo Stommer69, _________________________________ 63 Si tratta del teatro Mariinskij di San Pietroburgo intitolato a Maria, moglie dell’imperatore Alessandro II. 64 Alberto Cavos (1800-1863), architetto veneziano naturalizzato russo. 65 Giovanni Busato, pittore, nato a Vicenza nel 1806 e ivi morto nel 1886. 66 Cosroe Drusi, pittore, nato a Venezia nel 1808 e morto a Marostica (Vicenza) nel 1859. 67 Carl Christian Vogel von Vogelstein (noto con il solo nome Vogel), pittore, nato a Wildenfels nel 1788 e morto a Monaco di Baviera nel 1868. 68 Robert Fagan, pittore e archeologo, nato a Londra nel 1761 e morto a Roma nel 1816, nel 1809 console generale inglese per la Sicilia. 69 Matthias Stomer, pittore, nato a Amersfoort intorno al 1600 morto in Sicilia dopo il 1650. 302 rappresenta S. Isidoro Agricola visitato da un grande di Spagna, il santo battendo la pertica su cui si pogia manegiando l’aratro fa il miracolo di far scaturire dell’acqua. Le figure sono tutte al vivo, ed in grande. Dipinto di quel renomato pittore. Il bozzetto trovasi in Termini presso De Michele Nella chiesa de’ padri Domicani [!], che può dirsi un santuario, poiché esiste il corpo del mio beato Giovanni Liccio, chiuso in una cassa. Vi ha nella cappella 3a a man sinistra una statua della Madonna con un Bambino. Statua di porfido, di forme così belle, divine, chiunque la ha veduta è rimasto per un momento sorpreso, quel che più, l’artista col suo divino scarpello ha voluto dar forme diverse, poiché, guardando la Madonna in faccia nel mezzo della cappella vi mostra un sentimento. Guardandola da uno dei lati allora vi parla di un’altro [!] sentire. Signore, come han detto più uomini intendenti, avanza lo scarpello del Canova. D’essa viene appellata la Madonna degli Angeli, perché vuolsi per tradizione essere stata là posta dagli stessi. Nessuna notizia negli archivii, nessun millesimo, o cifra nella statua. Può Ella prenderne conto dall’ottimo pittore Meli palermitano Nella parrocchia dell’Annunzione [!]. Un dipinto nell’altare magiore. Quadro in grande rappresentante l’Annunzione [!] di Maria Vergine. La Madonna in atto di adorazione in ginocchio innanzi ad un genuflessario, di una espressione così divina, così dolce, e semplice degna del pennello artistico, e poi una pannegiatura così naturale, che giurereste esser dalla tela in fuori. Il dipinto è di Guglielmo Borremans70 fatto nel 1725. Più un san Girolamo in atto di chieder perdono battendosi il petto con un sasso, è dipinto ignudo sino amezzo del corpo. Dipinto al vivo molto pronunziato nelle membra, più santo nella faccia, dicesi del Barbieri71 inteso il Guercini, certo un dipinto di non poco rilievo. È stato posto nell’oratorio di detta chiesa. Una statua di san Giuseppe degna di ammirazione vuolsi dello Zoppo di Gangi72. Più in detta chiesa quattro evangelisti statue al vivo in stucco de nostro Serpotta ed altri piccoli putti, e un presepe dello stesso. Vi sono altri quadri che non meritano tanta importanza, ma buoni. Finalmente una Madonnina con un Bambino di due palmi in quadro. Dipinto raffaelliano - Nella chiesa di Padri Francescani. Una croce alla greca dipinto dal pittore De Ruzzulone73. Croce a due facci, nella prima un _________________________________ Guglielmo Borremans, pittore, nato ad Anversa nel 1670 e morto a Palermo nel 1744. Giovanni Francesco Barbieri, detto Guercino, pittore, nato a Cento (Ferrara) nel 1591 e morto a Bologna nel 1666. 72 Con lo pseudonimo di Zoppo di Ganci sono conosciuti due pittori: Giuseppe Salerno, nato a Ganci nel 1570 e ivi morto nel 1632, e Gaspare Vazano, nato a Gangi nel 1565 e morto a Palermo nel 1630. 73 Vedi nota n. 1, p. 287. 70 71 303 Cristo estinto - ai quattro angoli della croce, i seguenti simboli. In testa un Pellicano che dilania le proprie carni, e le porge in cibbo ai pellicanotti pulcini dipinti al vivo - agli altri angoli le Marie piangenti d’un aspetto calmo, angelico. Nell’altra faccia rappresenta un Cristo risuscitato col stendardo - ai quattro angoli i quattro evangelisti che parlano, e più acanto la tomba una testa di un giudeo spaventato perché il sepolcro vuoto. Scherzo del pittore che fa conoscere la franchezza del pennello. Più nella detta chiesa dipinto anco sopra la tavola, la ascesa al Calvario di molte figure dicesi di Simone Vumbrech74, anche questi dipinti in osservati, ed abbietti per l’avarizia ed ignoranza dei monaci. Degenerati dall’immortale istitutore. Degenerati da quelli antichi frati e primi apostoli e guerrieri ad un tempo, degni frati allora di propaganda religiosa e di politica ancora. Esistono pure in detta chiesa altri quadri che ristorati possono annoverarsi fra il numero di quadri, i più uno che rappresenta i tre Maggi guidati dall’astro in Bettelem [!] - Nel monastero di s. Benedetto. Un bel quadro in grande dipinto alla greca del 400, rappresentante s. Lorenzo, però assai schietto. Monache senza sentimento - Nell’Ospedale civico. Un grande quadro l’apparizione del Signore agli apostoli, quadro di 13 figure dipinte al vivo dal Barbera75 pittore rinomato - Finalmente nel Duomo. Cinque quadri, i cinque sensi scuola messinese del Rodriguez76, quadri originali. Altro del Pietro Novelli77 la Madonna della Grazia, quadro di quel grande uomo. Più un Cristo dello stesso autore come dicono, taluni però il negano, però buon dipinto. Quattro quadri rappresentanti fatti di Sacra Scrittura del cavalier D’Anna78. Più altri due quadri di Patania sullo stesso genere, e finalmente tre piccoli quadri alla greca dipinti in tavola degni di tutta l’ammirazione, di fratelli Cresenzi79, quadri del 400. Uno rappresenta un S. Giorgio a cavallo. L’altro un Madonna ed il terzo un S. Pietro col gallo. Nel castello esiste tuttavia un avanzo di prospettiva de’ tempi degli Aragonesi. Più esistono due avanzi di entrate alla saracena. Ecco quanto ho potuto raccogliere per prometterlo a lei amante e più promotore e propugnatore delle cose patrie. A lei qual uno degli archeologi siciliani prego d’accogliere, e compatire queste poche righe. _________________________________ Simon de Wobreck, pittore, nato ad Lharlem ed attivo a Palermo tra il 1558 e il 1587. Vedi nota n. 17, p. 292. 76 Vedi nota n. 18, p. 292. 77 Pietro Novelli, pittore, nato a Monreale nel 1603 e ivi morto nel 1647. 78 Vito D’Anna, pittore, nato a Palermo nel 1718, ivi morto nel 1769. 79 Antonio (o Antonello) Crescenzio, pittore, nato a Palermo nel 1467, ivi morto nel 1542; Guglielmo Crescenzio, fratello minore di Antonello. 74 75 304 Mi onori de’ suoi comandi, gradisca e fora gradire quando ne avrà occasione all’altissimo Sg. Principe di Galati e Sig.ra Principessa, nonché all’ottimo sig. medico Longo i più distinti rispetti ho l’onore segnarmi Illustr. Signore Sg. Agostino Gallo Palermo Aff. Obb. Servidore Vincenzo Rini80 Intorno ad un quadro dipinto ad olio del cav. Natale Carta81 Il cav. Natale Carta82 è divenuto in Roma e nelle altre provincie d’Italia e fuori un fasto della pittura siciliana. Condotto fanciullo dal suo padre Giuseppe, buon ritrattista, da Messina in Palermo83 sua patria fu da lui iniziato nel disegno e tentò di maneggiare i colori e in breve fu di ajuto al suo genitore nel vestire i personaggi che egli ritraeva. Questi con buon senso l’introdusse nello studio del cav. Giuseppe Patania, ove quel giovinetto divenne fra la turba degli allievi il più diligente ed esatto disegnatore. Il sig.r Agostino per adescarlo al lavoro ne comprava i disegni onde convertirne il prezzo in lapis e carta. Il Patania presagì fin d’allora che84 avrebbe fatto onore alla sua scuola. Benché il Carta fosse assiduo allo studio di Patania pure visitava spesso quello del celebre pittore Giuseppe Velasques dal quale se non imparò per principio l’arte, apprese con gli occhi il suo elegante stile. Laonde ne fè prova dipingendo un quadro che espose nello studio del suo genitore e fu allora da tutti ammirato per la franchezza del pennello superiore alla sua fresca età. Giunto a circa 14 anni il padre di Patania l’indusse a dipingergli il ritratto ed egli rispose scherzando il farò, ma mel dovete pagare e l’altro replicò, la merenda per la tua età si è una guastella85 per cinque giorni in cui l’opera dev’essere compita. Fatemi apprestare tela e colori da vostro figlio ed eccomi pronto. Patania rideva di questo scherzevole diverbio. Gli fè dare una tela preparata e la tavolozza, e richiesto il ritratto a _________________________________ A c. 23v: “Notizie interessanti di opere d’arti in Caccamo – Risposta”. Nota scritta a matita: “Stampato”. 82 Natale Carta, pittore, nato a Messina nel 1800 e morto a Palermo (o Messina) nel 1884. 83 Segue cancellata la frase: “all’età di anni quattro”. 84 Segue cancellata la frase: “sarebbe divenuto il migliore fra i suoi scolari”. 85 Seguono cancellate le parole: “al giorno”. 80 81 305 mezza figura al vero in cinque dì fu bello e compiuto e di tale evidente somiglianza che il maestro gli disse: mi hai dispensato a dipingere il ritratto di mio padre e difatti lo ritenne sempre nel suo studio. In quel tempo il Gallo frequentava la sig.ra Giovannina Belvedere principessa di Paternò, la quale avea fatto dipingere da Patania i ritratti delle due sue figlie e della marescialla Minutoli, sua amica. Cadendo il discorso sul Patania chiese ella al Gallo se quel gran pittore avesse qualche scolare da poterlo un giorno eguagliare un giorno. Le rispose che il giovinetto Carta promettea di divenirne emulo - presentatemelo, lo voglio conoscere. Questi86 fu condotto un bel mattino alle stanze della principessa e benissimo accolto. Or siccome scherzevole egli era e faceto alla di lei inchiesta se credesse poter divenire buon87 artista rispose - Se rimarrò a Palermo credo che88 sarò pittor di barche e di corvette ove scorgersi santi e madonne con bocche ed occhi storti con volti da ubbriachi; ma se avrei la fortuna di essere sostenuto in Roma potrei sperare di divenir buon pittore - Ebbene io ti appronterò il sostentamento in quella città. Nell’udir89 quelle parole il Gallo credette giovarsene a pro di cuel [!] giovinetto e scrissi ritornando a casa un articolo e pubblicai tosto sull’occorso che pubblicò in un giornale del tempo annunziando la benefica promessa di quella dama generosa. Affidato il giornale al Carta per recarlo a lei, essa dopo di averlo letto con compiacenza disse - Siamo in ottobre, nella vegnente primavera ti manderò e sosterrò a mie spese in Roma. L’ardito giovinetto replicò - Io ci anderei anche90 adesso e mi getterei a nuoto. - E che? Potresti correr pericolo di annegarti - Forse che no91; sapendo io ben nuotare e spero poi che s. Pietro mi salvi - Ma avvi legno che porta per Fiumicino? Ve n’è appunto uno che fa vela questa sera - Attendi un po’ che scriverò una lettera a Turronia di apprestarti sei once al mese, ti bastano? - Si per certo e ne la ringrazio infinitamente. Scrisse, allora, la lettera d’ordine per Turronia e il giovinetto li tolse avidamente, fece valigia e la sera partì. Dopo pochi mesi inviò in dono alla sig.ra principessa ad onor del suo nome una copia del S. Giovanni di Guido Reno92 che sembrava invero eseguita da pittor provetto. Perocchè uscito egli dalla scuola del Patania93 e _________________________________ Seguono cancellate le parole: “invitato da me”. Segue cancellata la parola: “pittore”. 88 Segue cancellata la parola: “diverrò”. 89 Seguono cancellate le parole: “Io ove mi giovai … di quella grande promessa e congedatici da lui”. 90 Seguono cancellate le parole: “col timore”. 91 Seguono cancellate le parole: “no signora principessa”. 92 Guido Reni, pittore, nato a Bologna nel 1575 e ivi morto nel 1642. 93 Segue cancellata la frase: “e dall’imitazione congiunta all’imitazione di quella del Velasquez intro…”. 86 87 306 frequentando quella del Velasques che altronde erano affini tra loro di per la placida maniera sebbene quella del primo fiorente di leggiadro colorito il Carta94 trovossi ben disposto anche per propria indole a seguire lo stile di Guido95 Reno in parte conforme a quella dei maturati artisti siciliani. Cominciò egli fin da principio a frequentare lo studio del celebre Camuccini, valoroso disegnatore di raffaellesca eleganza, il quale disse al Gallo in Roma nel 1843 - Carta è buon pittore istorico; ma primeggia tra i valorosi ritrattisti d’Italia. Per circa 10 anni continuarono le beneficenze della principessa di Paternò verso di lui e quando egli inviavale in dono qualche suo dipinto ella per sovragiunta di generosità ricambiavagli il dono con denaro.96 Or avendo egli cominciato ad acquistar fama in quella città non volendo più abusare dei favori della principessa le scrisse97 ringraziandola e pregandola di togliergli il conferito assegnamento del quale più non avea bisogno essendo già98 affollato di lucrosi lavori. In Roma verso quel tempo condusse a moglie una bella romana che gli servì spesso da modello per quadri d’istoria nelle avvenenti figure muliebri. Egli par che abbia in parte ereditato in parte il genio di Patania nell’invenzione nel colorito e nella grazia laonde questi era divenuto nell’osservarne i quadri che inviava a Palermo suo ammiratore particolarmente per la delicatezza dei paesaggi, delle mezze tinte e per la99 leggiadria dello stile. E100 per riguardo alle mezze tinte confessava con animo nobile e generoso quasi di averlo superato101 e difatti ne ritenne compiacente nel suo studio il ritratto di Giuseppe Bucalo suo familiare e invero puossi102 asserire che nell’artifizio delle mezze tinte abbia forse superato tutti i pittori contemporanei. Egli oltre d’esser massimo artista ne’ ritratti come si è detto e di felice invenzione principalmente ne’ soggetti sacri, istorici e mitologici e principalmente in quelli di leggiadro argomento. La sua composizione è sempre ben regolata103 il disegno corretto e placido e incantevole il colorito. Il Carta ha conosciuto una gran verità nell’arte annunziata per altro da Leonardo da Vinci che chiesto da un suo scolare qual colo_________________________________ Segue cancellata la frase: “beneficar prende che trovasse ne’ dipinti”. Segue cancellata la frase: “per analogia di stile con terzo ottimo precettore”. 96 Segue cancellata la frase: “Il Carta stesso spinto da discreta moderazione”. 97 Seguono cancellate le parole: “alli i Paternò”. 98 Segue cancellata la parola: “fornito”. 99 Segue cancellata la parola: “grazia”. 100 Seguono cancellate le parole: “in quest’ultima”. 101 Seguono cancellate le parole: “ed io soggiungo di essersi innalzato sovra tutti”. 102 Segue cancellata la parola: “francamente”. 103 Seguono cancellate le parole: “da buon giudizio”. 94 95 307 re dovesse adoperare in un dipinto, rispose a scherno Se tu none sai metti del nero riguardando quella tinta come avversa alla buona pittura e simile a chi voglia uscir d’imbarazzo con un falso effetto. Laonde il nostro artista è nemico giurato del nero ed a ragione perocchè nella carnagione dalla natura fu escluso, e mostrasi soltanto ne’ capelli, nella barba e nelle pupille di alcuni giovani e negli occhi e nelle chiome di talune donzelle. Tutt’i colori dell’iride confondonsi dolcemente ne’ volti umani, il nero ne rifugge, quindi Raffaello, Guido, Domenichino, Tiziano lo bandirono dalle loro figure riserbandolo soltanto misto ad altri colori alle vesti ed a’ campi104 con giudiziosa economia e se alcuni pittori ne abusarono in contraddizione del vero in natura furono meritamente detti oscurantisti e confessarono col fatto che non sapevano ben maneggiar le mezze tinte. Al Carta di recente fu affidato un quadro che servir debbe ad una chiesa di Sicilia, rappresentante la Vergine Immacolata fra un coro di angioli ma gli fu prescritto di dover copiare un dipinto su quel soggetto d’antico famoso pittore. Egli scelse quello del Vandick105 della cattedrale di Termini. Quell’insigne artista fiammingo che recatosi in Palermo verso il 1623 dipinse la famosa tela delle sante vergini palermitane per la chiesa del Rosario e atterrito dalla sopravvenuta peste lo compì in Malta e inviollo a Palermo106 ha uno stile singolare che tiene in parte a quello del suo maestro Rubens e in parte è tutto suo proprio, perocchè nell’adoprare squisite tinte ne’ volti particolarmente delle donne contrappone sempre nelle vesti colori gagliardi pel maggiore effetto. Nel quadro indicato dell’Immacolata per Termini adoprò quel suo metodo favorito, ma nella Vergine immersa nel roseo chiarore di un cielo ridente osservasi il piccolo manto in troppo oscuro celeste107 e queste tinte gagliarde invero de la tunica in cupo rosso contrastano coll’aria d’intorno, se pure gl’indicati forti colori108 non siano col tempo di troppo cresciuti. Il Carta fu invero costretto ad imitarlo e convien che ciò si avverta perché non gli si addossi la colpa dell’originale. Però il volto della Vergine109 è del suo tipo: nobile, bello e maestoso, e l’insieme della figura, le mani e i piedi ben disegnati e i nove angeli che l’attorniano in svariate attitudini e movenze sembran discesi dal Paradiso, e leggieri e graziosi volteggiano nell’aria circostante. Non so se nell’originale per fine _________________________________ Seguono cancellate le parole: “per l’effetto”. Antoon van Dyck, pittore, nato ad Anversa nel 1599 e morto a Londra nel 1641. 106 Seguono cancellate le parole: “da Malta”. 107 Seguono cancellate le parole: “non bene armonizzano”. 108 Seguono cancellate le parole: “dell’abito e del manto”. 109 Seguono cancellate le parole: “e bellissima come puossi ben”. 104 105 308 accorgimento110 del Carta la parte bassa del quadro che indica il mondo, sia stata trattata con tinte assai calde quasi indicanti un cielo tempestoso. Se questo fu un artifizio del nostro artista conviene applaudirlo avendo egli bene espresso l’attuale politica situazione di Europa immersa fra le guerre e le rivoluzioni. Certo che se il nostro artista non fosse stato costretto a copiare un quadro antico ed avesse operato di sua invenzione e secondo il suo stile consueto avrebbe fatto meglio, evitando quel rosso e il celeste troppo cupi e taglienti.111 E son sicuro, che se egli fatto avesse senza la pastoia dell’imitazione, che preferito avrebbe le solite sue tinte soavissime le quali avrebbero meglio armonizzato col campo e con gli angioli. E invero per quel sacro argomento, credo io, che sarebbe stato miglior modello la Vergine Immacolata del Morillo che si osserva112 nella privata galleria dell’or defunto signor Michele Puero113 che spicca sugli altri quadri per l’armonia e le tinte squisite; ma il Carta non potea averla presente in Roma e prescelse invece quella di un pittore altronde famoso, ma in quest’opera inferiore a se stesso e la Beata Vergine con gli angioli inviata all’Esposizione di Palermo nel 1862114. Però condusse la copia con tal facilità di pennello da gareggiare con l’originale;115 talche puossi dire più tosto una libera imitazione116. Essa ha quindi il pregio particolare della117 vaghezza del volto della Vergine improntata di celestial maestà e della grazia e di quelli degli angioli in cui egli si è sempre segnalato, e basterà ricordare l’altro suo quadro di propria invenzione sullo stesso soggetto da lui presentato nell’esposizione di Palermo nel 1842, la famosa vestale per principe di Campoformio, le tre Grazie con gli amorini presso il dr. Rocco Nicoletti, la Dea Flora che sparge rose sulla terra presso il sig. Agostino Gallo; talchè per questi ed altri suoi _________________________________ Segue cancellata la parola: “artifizio”. Segue cancellata la frase: “Né so se avesse preferito d’imitar per modo che”. 112 Segue cancellata la parola: “ammira”. 113 Seguono cancellate le parole: “ammirata da tutti”. 114 Catalogo degli oggetti di Belle Arti esposti nelle sale del Palazzo Comitini in Palermo il dì 7 giugno 1863, Palermo, Tipografia Morvillo, 1863, p.17 n. 137. 115 A c. 28r segue cancellato il testo: “… pel coro degli angioli già egli negli aspetti muliebri giovanili e ne’ putti si è sempre segnalato e basterà osservare la sua famosa vestale pel principe di Campofranco, le tre grazie presso il dr. Rocco Nicoletti e la dea Flora che sparge rose pel mondo presso di Agostino Gallo. Quindi ben si è adempito il presagimento del Patania e del Comencini che egli dovea primeggiare tra i pittori italiani ed essere insuperabile ne’ ritratti, come ben contestano quelli della famiglia della principessa di Paternò della marchesa Rudinì e gli altri anche della famiglia del grande amatore e suo mecenate principe di Cassaro e in particolare quello del medesimo degno di figurare in una pubblica galleria”. Il testo cassato è sostituito dalla nota riportata alla c. 28bis, nella quale sono cancellate le prime parole: “ In ogni modo quella copia del Carta che”. 116 Segue cancellata la frase: “dal famoso originale per la facilità e franchezza del pennello com’è condotta”. 117 Segue cancellata la parola: “bellezza”. 110 111 309 dipinti si è bene avverato il presagimento del Patania e del Comencini sul nostro artista. E qui giova osservare che quando le copie sono eseguite da valentissimi professori col tempo tengon luogo di originali perocchè questi van deperendo ogni anno e gli altri rimangono. E sul proposito ben si avvisava il conte Algarotti, celebre conoscitore, il quale proponea ai sovrani e ricchi amatori che di tutt’i capi lavori dell’arte italiana si eseguissero per loro conto da valentuomini viventi, secondo il proprio genio, la copia nella stessa dimensione da supplir poi agli originali che il tempo dovrà distrudere. E questa del Carta che abbiamo descritto sarà certo una delle118 migliori; come lo fu quella del suo maestro Patania rappresentante il S. Pietro in vinculis del Novelli la quale con colori meno119 gagliardi da imitare i primitivi non iscuriti dal tempo, potrà figurarsi appresso come una replica più fresca dello stesso Novelli di che ognuno rimarrà persuaso osservando nella chiesa dei PP. degli esercizi spirituali fuori porta S. Antonino. Tra i ritratti del Carta di maggior celebrità sono indicati quelli della principessa di Paternò, della marchesa di Rudinì e gli altri della famiglia di Antonio Statella principe del Cassaro grande amatore suo mecenate e in particolare incluso quello magnifico di lui stesso che potrebbe figurare in una pubblica galleria. Il Carta ha bensì un emulo in Sicilia nella delicatezza e soavità del pennello e questi si è l’insigne pittore Michele Panebianco120, messinese il quale di recente ha spedito il suo ritratto a mezza figura al sigr. Agostino Gallo ch’è stato oggetto di encomi121 dei nostri artisti e giunse opportunamente pel confronto ma con l’altro ritratto dipinto dal Carta del famoso sacro oratore Fr. Ventura commessogli dallo stesso sigr. Gallo e quel dipinto è stato pure applaudito da tutt’i conoscitori non solo per l’evidente somiglianza, ma pure per la verità e la delicatezza del pennello nelle sue mezze tinte che ben armonizzano e risaltano in un fondo cupo rossastro. A.G. Opere di Vincenzo Riolo122 da Palermo morto nel 1837 in Palermo Nel palazzo del principe di Villafranca nella volta della Galleria la caduta di Fetonte. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “più pregevoli”. Segue cancellata la parola: “scuriti”. 120 Michele Panebianco, pittore, nato a Messina nel 1806 e ivi morto nel 1873. 121 Seguono cancellate le parole: “e di ammirazione”. 122 Vedi nota n. 27, p. 294. 118 119 310 In casa del barone Pietro Coglitore alcuni suoi dipinti e il suo ritratto al naturale. Nel palazzo pretorio o della città soggetti mitologici nella volta ….del principe Principe di Palagonia presso la chiesa della Gancia figure cinesi graziosissime ….del marchese Forcelli ora principe di Montevago figure fantastiche nelle pareti ….del principe di Cassaro ora del principe Niscemi sulla volta e nelle sovraporte soggetti mitologici ….del principe di Fitalia soggetti mitologici dipinti in concorrenza con Velasques. Nella stanza del maresciallo Settimo 3 dipinti mitologici a chiaroscuro ora posseduti da Agostino Gallo. Nel R. Palazzo della Favorita soggetti cinesi in concorrenza con Velasques. In casa del negoziante sig.r Floria via de’ materassari nella volta della Galleria Diana ed Endimione e putti in un’altra stanza, e sovraporte. In casa del barone Inguaggiato ora di Sommariva presso la chiesa di Casa Professa de’ Gesuiti, soggetti mitologici Nel palazzo del principe di Pandolfina, putti. Nella chiesa de’ PP. Filippini Olivetani soggetti sacri nelle volte delle cappelle. I putti ne’ sottarchi furono dipinti da Salvatore Lo Forte suo scolaro. Nel cortile della Casa de’ matti Orlando Furioso il cui bozzetto è presso il Gallo e anche un filosofo che legge un papiro a lume notturno e il ritratto di Rubens. Nel R. Palazzo di Palermo nella volta di una galleria uno de’ tre quadri sul conte Ruggiero dipinti in competenza di Patania e Patricolo. Fuori di Palermo Nella chiesa del monistero del Salvatore a Petralia Soprana l’Ascensione di Gesù Cristo e l’Assunzione di Maria Vergine. Nella cattedrale il martirio di san Pietro In una chiesa di Petralia Sottana la Madonna del Carmine con le anime del Purgatorio Presso gli eredi del dr Vincenzo Gagliano in Catania l’origine della danza in Sicilia ed altri quadri dipinti in competenza con Patania. 311 Pittura e Accademia del nudo in Palermo Don Vincenzo Riolo fu scolare prima di recarsi in Roma del pittore don Francesco Sozzi123 il quale sollecitò il Governo recandosi in Napoli a stabilirsi in Palermo. L’Accademia del nudo a cui fu indi direttore la quale era prima privatamente tenuta dal principe della Catena in propria casa indi venduta dagli eredi al Governo per locale di ministero essendo quel principe gran dilettante divenuto anche buon pittore sotto la direzione del celebre Gioacchino Martorana. Del principe della Catena vi erano in quella casa le sopraporte di figure a paesaggi ben dipinti come io potei osservare nel tempo che appartenei al Ministero. Belle arti sec. XIX Nota necrologica del pittore Andrea Martin Il pittore Andrea Martin124 figlio di francese maestro di casa del principe di Belmonte morì a 4 marzo 1864 di anni 60. Si era reso celebre nel dipingere pesci, frutta e caccie fu scolare in Firenze del famoso Benvenuti125. Recò da lì un suo bellissimo quadro rappresentante Prometeo legato ad uno scoglio che fu premiato nell’esposizione di Palermo dipingeva bene i ritratti. Eseguì in Palermo il gran quadro di composizione di Venere ed Adone con Amorini e florida campagna e sebbene le figure principali fossero belle e ben disegnate, tuttavia mancando il quadro di armonia non piacque ed egli indispettito lo distrusse. Lasciò alla morte un quadro a mezze figure sacre sull’imitazione di Correggio con bellissimo colorito che fu posto all’esposizione della società incoraggiatrice nel 1863. Dipinse un bel ritratto al naturale con un cane del principe di Castelreale, altro all’impiedi per la principessa di Partanna Lucia Migliaccio, altro di un inglese con un gatto bellissimo. Altro dell’indoratore *** più ritratti del Generale Garibaldi. Fu d’indole placida buona e modesta e poco ambizioso di fama, gravato di numerosa famiglia visse sempre povero, nonostante il suo merito pittorico e abbisognò spesso dei soccorsi degli amici in vita e in morte per l’esequie e la tumulazione. _________________________________ Francesco Sozzi, pittore, nato a Palermo nel 1731 e ivi morto nel 1795. Andrea Antonio Martino, pittore, nato a Palermo nel 1797 e morto nel 1864. 125 Pietro Benvenuti, pittore, nato ad Arezzo nel 1769, morto a Firenze nel 1844. 123 124 312 Pittura in Sicilia sec. XIX Andrea Martin, che italianizzando il suo cognome si fe chiamare Martino nacque in Palermo da padre francese e madre palermitana. Il suo genitore ch’era maestro del palazzo di Giuseppe Ventimiglia principe di Belmonte, scorgendo la felice disposizione del suo figlio per l’arte del disegno per mezzo di fantocci ch’eseguiva con la penna l’inviò allo studio di *** ed accortosi che progrediva e dava ottime speranze di sé, volle spedirlo in Firenze co’ soccorsi del suo padrone in Firenze ove con la raccomandazione del medesimo fu ricevuto nella scuola del Benvenuti che allora era divenuto famoso pel suo quadro della Giuditta ch’io ammirai nella cattedrale di Arezzo ed è divolgato per belle incisioni. Il Martino in più anni che si ritenne in Firenze presso quel rinomato artista divenne buon disegnatore e colorista per la sua abilità e pel suo placido carattere ed onorati costumi meritò la stima e l’affetto del suo maestro com’egli dicevami quando io nel 1843 fui a visitarlo in casa. Il Martino non solo ne seguì facilmente lo stile; ma procurò di perfezionarsi nell’arte e nel gusto con la diligente osservazione de’ capolavori che nelle chiese e pubbliche e private pinacoteche ivi si contemplano. Volle allora tentare un quadro grande di sua composizione, e dipinse al naturale Prometeo incatenato, e smanioso giacente sopra una rupe. Quella figura e una bell’accademia ritratta dal vero, molto studiata per la parte della miologia, molto efficace nell’espressione della rabbia e del dolore ben dipinta e armonizzata col fondo e gli accessorj, e meritato avendo l’approvazione del Benvenuti fu da lui incoraggiato a presentarla all’esposizione ove meritò d’esser premiata. Ritornato il Martino in Palermo recò seco quel quadro che fu da tutti i nostri artisti ammirato per modo ch’alcuni maligni tra essi spacciaro di essere opera del Benvenuti. L’autore soffrì in pace quella calunnia persuaso di smentirla con altre opere, nonostante che non era credibile che il Benvenuti, che mettea tanta stima e gran prezzo a’ suoi abbia voluto esser generoso al suo scolare d’uno grande e ben studiato. Essa fu poi presentata all’esposizione di Palermo ed ottenne la prima medaglia d’oro e indi venduto al principe di Pandolfina. Diessi allora a ideare un quadro immenso di complicata composizione con molte figure di soggetto mitologico, e scelse Adone di ritorno dalla caccia seguito da’ suoi compagni che si presenta a Venere la quale era circondata dalle Grazie e da alcune ninfe che le offrivano due colombe. Il fondo era un amenissimo giardino. Lavorò il Martino per anni in quel qua- 313 dro ed io lo vidi quasi finito. Mi parvero le figure femminee, e maschili ben disegnate ma la composizione era mal distribuita, i colori per troppo lusso di tinte discordanti; sebbene ogni figura fosse ben dipinta e stesse bene da se. Venere era assai leggiadra e le ninfe partecipavano della sua grazia, e sfoggiavano con quella bellezza del nudo. Gli feci alcune osservazioni e le accolse benignamente, e dissemi, tardi mi sono accorto io stesso dei difetti del mio quadro, ma ora non potrei ripararvi che cancellandolo. Di fatti l’abbandonò ne so che ne abbia fatto. Nulla dimanco quel quadro avendo i pregi da me indicati se ne avesse certato i difetti e principalmente quello della mancanza di armonia e in parte di prospettiva anco avrebbe fatto compitamente onore al Martino, il quale essendo allora giovanissimo prometteva che sarebbe in breve divenuto ottimo artista, anche nella pittura istorica; ma il nostro paese non gliene presentò occasione; perocchè non si ricercano qui quadri per chiese, essendo anche cessato l’uso di adornare di pitture le volte, le sopra porte e le pareti delle stanze dei palazzi dei nobili e dei privati, e solo fino a pochi anni addietro rimaneva l’uso dei ritratti ad olio, per gli affetti di famiglia ed a miniatura per quelli di amore. Ma anche quest’uso è stato bandito dal Dagherotico [!] e poscia interamente dalla fotografia, la quale meschinissimi prezzi vi ha supplito col suo meccanismo. Il Martino profittò dei pochi anni di transizione tra l’antica, e la nuova economica usanza, e dipinse molti ritratti ad olio pregevolissimi non solo per la somiglianza, ma anche pel calore e la grazia del pennello, e quando gli originali il permettevano anche per il colorito. Io ne vidi parecchi sorprendenti uno a mezzo figura al naturale d’un inglese che carezzava una gatta, ed un altro dell’indoratore Cortina, e diverse repliche di mezzana grandezza del generale Garibaldi. Su questi primeggiava bensì quella al naturale del principe di Castelreale, in costume di cacciatore stando in riposo col suo cane a piedi in amenissima campagna. Questo ritratto che riuniva tutti i pregi del buon disegno, della somiglianza, del vago colorito, del cane, del paesaggio, fu premiato nella nostra esposizione essendo stato giudicato come un bel quadro. Un altro suo ritratto all’inpiedi al naturale, pure molto applaudito fu quello della sig.ra Lucia Migliaccio principessa di Partanna indi moglie di coscenza del re Ferdinando I. La bellezza e la grazia di quella dama rifiorirono sotto il pennello del Martino, che giovossi del di lei ricco abito di corte, e di tanti ornamenti e vezzi feminei, egregiamente dipinti e bene armonizzati, per isfoggiar la sua bravura. Questo ritratto che si ammira ed è il migliore tra la serie dinastica de’ principi e principesse di Partanna nel lor palazzo in Palermo può 314 quasi gareggiare con quello magnifico ma poco somiglievole della principessa di Villafranca, dipinto dal Benvenuti per gran prezzo di che ottenne appena un terzo per il suo scolaro Martino. Altri bei ritratti dipinse, fra i quali il suo, che adorna la mia ricca collezione degli illustri siciliani, come pare eseguì diverse sacre famiglie e pure i quadri di santi, e sante, tutti di sua invenzione e ben condotti. Era egli abilissimo nel ristorare e supplire con felice imitazione le parti mancanti in pregevoli quadri antichi come il mostrò nel dipingere la testa della Beata Vergine in una tela della nascita di Nostro Signore da lui creduta del Correggio. Il Martino tentò per mancanza di lavori di maggiore importanza la pittura di genere e principalmente quella di pesci, di uccellame e di frutti di cui avea dato in Palermo l’esempio con felice riuscita Giuseppe Patania onnigeno pittore in quattro quadri per il marchese Giuseppe Merlo insieme con quello di fiori che parevano raccolti nell’orto del Paradiso. Al Martino bensì devesi l’onore di aver fondato in Palermo e recato ad eccellenza una scuola della pittura di genere. Nei pesci era poi proclamato insuperabile per la verità e la grazia del pennello. Di questo suo peculiare metodo artistico trassero profitto alcuni maligni pittori figuristi e ritrattisti per toglierli i negozi di qualche quadro istorico o di ritratti, spacciando che in quel genere soltanto riuscisse; laonde occupossi egli principalmente della pittura di genere tutta la vita che trasse fra le angustie domestiche e il morbo di stranguria d’uretra che finalmente lo condusse al sepolcro nella miseria all’età di circa anni 60 il giorno 3 marzo del corrente anno 1864. Il Martino si rese ammirevole non solo per la pittura di genere e pei ritratti e sul primo fiore della gioventù per il suo quadro del Prometeo, ma pure per le sue virtù domestiche e sociali, pel suo carattere placido e gentile e per la sua avversione alla mormorazione. Egli lodava i buoni artisti, sebbene non lo avessero favorito taceva dei mediocri. Quindi fu amato, apprezzato e riverito da tutti e compianto in morte. Secolo XIX Francesco Ognibene126 Nacque in Palermo da un conciapelle. Fu avviato nello studio di Giuseppe Velasques e nell’accademia del nudo di cui era direttore, e riu_________________________________ 126 Francesco Ognibene, pittore, nato a Palermo nel 1785 e ivi morto nel 1837. 315 scì ottimo e castigato disegnatore. Profittò di Vincenzo Riolo genero di Velasques che conviveva con lui, e in parte ne imitò il colorito sebbene più languido e giallognolo. Fu quindi miglior disegnatore e felice compositore che coloritore. Verso il 1834 dipinse nell’età giovanile un quadro sacro per una chiesa di Randazzo in gara di Patania e di La Farina127 e quello di Ognibene anche piacque. Essendogli stati tolti i quadri della chiesa de’ pp. Liguorini all’Uditore nella campagna presso Palermo dall’abate Giovanni Patricolo montò in ira e pazzia, e con un rasoio si taglia legermente il collo. Io lo feci recare all’ospedale e ne guarì e doleasi indi meco dicendomi ch’era meglio che lo lasciassi morire per torsi d’una vita misera e penosa. Ognibene dipinse in fresco a chiaro-scuro, genere in cui più riusciva, nel palco per l’estrazione dei numeri del lotto, la fortuna e i suoi capricci con buon disegno e felice invenzione. Dipinse a olio e a colori nella chiesa di san Filippo e Giacomo un quadro di altare della Beata Vergine ben disegnato e composto; ma di languido - flavo colorito, e nella parrocchia del Borgo la Madonna del Rosario in competenza dell’abate Patricolo che vi dipinse il martirio di s. Lucia ed amendue que’ quadri fanno onore agli autori e quello di Ognibene è forse meglio di Ognibene. [?!] Fece il cartone della Madonna col Bambino eseguito in istucco da Sanseverino128 nella porta del prospetto della chiesa del Carmine. Diessi all’incisione e si distinse pel tratto energico del bulino. Incise molte piante per l’opera botanica di Mr. Rafinesque e pel sig.r Vincenzo Tineo. Verso il 1835 essendo pazzo con lucidi intervalli fu indotto a dipingere a fresco a colori sotto la sorveglianza del suo amico adornista Vincenzo Li Greci la cupola nel liceo dello stabilimento agrario del principe di Castelnuovo a’ colli presso Palermo. Ivi effigiò Sileno ubriaco sull’asino figura poco più del vero, Cerere che129 insegna ad un villico ad arar la terra, l’agricoltura rimpetto una donna indicante la pastorizia che munge una vacca che par vera. Minerva che ammaestra nella scienza agraria un giovinetto. Ai quattro spigoli della cupola dipinse a chiaro-scuro le quattro stagioni. In fondo alla via de’ cipressi aveva prima della pazzia dipinto a fresco nel muro in fondo un gran paese con strada, la montagna di Gallo, un tempietto. Quest’opere sono tra le sue reputate migliori. Morì di circa 64 anni miserabile nel calare del 1837. _________________________________ Francesco La Farina, pittore, nato a Palermo nel 1778, ivi morto nel 1837. Bartolomeo Sanseverino, stuccatore, attivo nel sec. XVIII. 129 Seguono cancellate le parole: “insegna a un fanciullo alato”. 127 128 316 Francesco Ognibene da Palermo pria scolare di Velasques e poi di Riolo riuscì un valoroso compositore, e disegnatore e in seguito un diligente incisore in rame. Segnalossi nella pittura a fresco monocromata come puossi vedere nelle sue rappresentazioni mitologiche sulla fortuna nel palco di la R. Lotteria in Palermo. Fu anche ammirato nel suo quadro a olio del martirio di s. Lucia nella parrocchia di detta santa nel borgo di Palermo, per la composizione, pel disegno, anche pel colorito superiormente per questo riguardo in quell’opera, sebbene in altre tendesse troppo al flavo e al monotono, come in un quadro nella chiesa di s. Filippo e Giacomo. Son lodati del suo pennello alcune storie di s. Filippo Neri in un pulpito de’ PP. Dell’Oratorio nella loro villa Filippina di Palermo. Si occupò molto dell’incisione a bulino e ad acqua forte, e molte piante incise per un’opera di Mr. Rafinesque naturalista americano e per diverse tavole botaniche del sig.r Vincenzo Tineo direttore dell’orto delle piante. Egli condusse a penna in fogli di carta grande con molta grazia ed esattezza i disegni della Fata Galante poema di Giovanni Meli e venne a gara con Giuseppe Patania che ne avea fatte le vignette come pure dell’altro poema del don Chicotte dello stesso poeta, quelle del Patania sebbene in figure microscopiche sono più graziose; ma l’invenzione in amendue è felice. In un accesso di delirio tagliossi con un rasoio superficialmente le fauci, e fatto da me recare all’ospedale fu guarito, e rimproverommi che gli aveva procurato una vita che gli era divenuta insoffribile per la miseria dovendo sostenere una famiglia di tre maschi ed una femina. Era buono, compassionevole e me ne diè una prova che avendogli io fatto apprestare dopo la sua guarigione un brodo con ovo e una pagnotta di pane, e scorgendo dal balcone un povero per la strada scese subito per le scale e divise la merenda col medesimo. Però era troppo iracondo e sul proposito mi riferiva che avendo una volta eseguito un gran disegno a chiaro-scuro d’un edificio per conto del sig.r Giambattista Bertino ed essendo da costui avvertito di non so quale difetto, nell’istante lo tagliò tutto col temperino e perdette due mesi di fatica. Fece per me il disegno del quadro del Trionfo della morte di *** nell’Ospedale e i lucidi delle istorie di s. Francesco in S. Maria di Gesù. Morì nell’indigenza di anni ***. 317 <Gerlando Marsiglia> Gerlando Marsiglia130 morì in New York nell’aprile del 1850, lavorava ritratti fra degli altri quello di Cristadoro Giuseppe, e restauratore di quadri antichi. Pittura in Sicilia de’ bassi tempi Quando morì nel 1467 Giorgio Castriota Scanderberg re d’Albania, prode guerriero, e cadde quella greca regione in potere de’ Turchi, molte famiglie di varie condizioni vennero profughe in Sicilia e chiesero a Giovanni re di Aragona e dell’isola nostra l’autorizzazione di fondarvi delle città per loro soggiorno e l’ottennero. Si divisero allora in quattro colonie, una fabbrica un piccolo comune denominato Piana de’ Greci, 16 miglia distante da Palermo, l’altra Palazzo Adriano, 42 miglia, la terza Mezzojuso 26 miglia, e l’ultima Contessa 36 miglia. Fra quella immensa turba eranvi nobili preti di rito greco-cattolico, agricoltori, artigiani131 con le loro donne e figli e nepotini, e argomento che vi fossero pittori, scultori e architetti, avendosi essi stessi fabbricate case, palazzetti, e chiese che fornivano immagini di Dio Padre, di Gesù Cristo, della Vergine Maria, di S. Lucia, di San Spiridione, e altri Santi della Chiesa greca che si oppose gagliardamente ben da principio all’eresia degli iconoclasti introdotta in Oriente con violenza dall’imperatore Leone Isaurico. La pittura e la scultura in quell’impero e in tutta Grecia erano andate giù si per la ignoranza prevalsa e per le successive persecuzioni degli iconoclasti e per il pregiudizio religioso di attenersi sistematicamente a certi tipi uniformi nelle devote immagini che sembravano secchi e immobili cadaveri più che viventi. Tutto in esse era uniforme, i volti, la attitudine, i colori, i fondi dorati a guisa dei mosaici, i colori parziali e l’uso di pingere trittici in tavole di vetro di dimensione varia per le case e per chiese. Il risorgimento della pittura in Italia per opera del fiorentino Cimabue morto di anni 70 nel 1310 sentiva lo stile della greca decadenza ma le figure cominciarono ad aver vita all’aura d’Italia col pennello di quel benemerito e l’acquistarono interamente con quello di Giotto coetaneo di Dante. _________________________________ Gerlando Marsiglia, pittore, nato a Giuliana, in provincia di Palermo, nel 1792 o 1793, morto a New York nel 1850. Il Marsiglia fu uno dei fondatori nel 1726 della National Gallery of Design di New York. 131 Seguono cancellate le parole: “e artisti”. 130 318 Le sue figure, condotte con la maggiore diligenza, per l’aria de’ volti, e le movenze espressero le svariate passioni. In Sicilia il risorgimento era anticipato almeno d’un secolo e mezzo, perocchè nonostante l’occupazione de’ Saraceni, che proibivano, secondo il precetto del Corano la rappresentazione d’immagini, e durante il divieto degli imperatori iconoclacisti, la pittura era secretamente coltivata per il fervore dei cristiani di quest’isola talchè quando la conquistarono interamente i Normanni nel 1071 subito migliorò ne’ mosaici e ne’ quadri sopra tavola che tuttavia esistono e di cui altrove farò distinta menzione. Cimabue e Giotto posteriori, e molto meno i pittori delle colonie albanesi che più tardi vennero in Sicilia per nulla contribuirono non che al risorgimento, ma neanche al miglioramento della pittura tra noi che già era stato operato dagli stessi artisti siciliani a’ quali si poterono unire alcuni pochi esteri che qui erano venuti per far fortuna, anzi taluni de’ nostri per indole girovaghi giovar poterono all’Italia come nel Duomo d’Orvieto (1)132. Un gran numero di dittici a due battenti o trittici a tre con sacre figure dipinte a gomma sopra legno o tela sovraposta ingessata corrono in Sicilia, sia che fossero imitate sovra quelle antiche bizzantine, ma essendo più animati e di santi e sante del rito latino mostrano di essere di pennello siciliano e dallo stile si argomenta di appartenere alcune al secolo XIII altre al successivo e talaltre al XV. Ve ne ha nella galleria della R. Università di Palermo, un trittico famoso nella chiesa di S. Michele Arcangelo e altri inferiori depositati dopo la ristorazione fattane eseguire da Pizzillo per disposizione del deputato Sig.r D.o Domenico Arista nella camera della contabilità all’ospedale civico in S. Francesco Saverio, altro trittico del cominciamento del secolo XVI nella chiesa del Cancelliere e in altra di Palermo, non molte dall’interno dell’isola nostra. Ma i dittici e i trittici di cui principalmente abonda la Sicilia son quelli recati qui dalle colonie albanesi e fatti eseguire da’ loro artisti già divenuti siciliani nella seconda generazione. Il rinnomato archeologo P. Paciaudi su queste dipinture scrisse una erudita dissertazione che è la quinta tra quelle dell’opera sua: De cultu s. Iohannis Baptistae133 Ivi accennando alle medesime così si espresse: _________________________________ A c. 41 v nota in calce: “(1) Nel catalogo degli artisti lasciatoci dal Vasari vi sono alcuni siciliani” <Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori scritte da m. Giorgio Vasari pittore et architetto aretino, di nuouo dal medesimo riuiste et ampliate con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ viui, & de’ morti dall’anno 1550 insino al 1567. Prima, e seconda [terza] parte. Con le tauole in ciascun volume, delle cose piu notabili, de’ ritratti, delle vite degli artefici, et de i luoghi doue sono l’opere loro, In Fiorenza, appresso i Giunti, 1568>. 133 Paolo Maria Paciaudi, De cultu S. Johannis Baptistae antiquitates christianae accedit in veterem ejusdem ordinis liturgiam commentarius, Romae, excudebant fratres Palearini ad theatrum Pompeii, 1755, Dissertatio sexta, p. 229. 132 319 Tabulae effigiatae inter altaris ornamenta sunt recensenda. Non autem haec semper diptychae et bipatentis sed sepe triptychae et ad modum plutej, qui duobus ostiolis interius, esteriusque ornatissimis claudebatur. Aliquando unica tabula omnis effiguratio continebatur(1)134. Uno dei trittici più antichi, giudicato de’ tempi normanni(2)135, composto di laminette di rame indorato al di fuori e ne’ fianchi assai piccoli due anelletti al di sopra per recarsi appesa al petto e che i Greci diceano Encolpio136. Esso esistea al museo salnitriano de’ PP. Gesuiti di Palermo, che certo andò perduto nella rapina fattavi nel 1863 dopo la terza espulsione de’ PP. Gesuiti. Nella laminetta a destra vi erano dipinti i santi dottori della Chiesa orientale, S.n Nicola, S. Giovan Crisostomo, S. Gregorio, S. Basilio, a sinistra S. Stefano, S. Giorgio, S. Demetrio, S. Antonio abate, nel mezzo Gesù Cristo sedente in trono, a destra la Beata Vergine a sinistra un santo ricoverto da un pallio. Nello stesso museo esistevano pure pria della [!] dell’ultima depredazione due altre piccole tavolette con sovra pittura ritrovate nella chiesa sotterranea di S. Conone abate in Noto. Nel museo Martiniano conservasi un quadro di mezzana grandezza acquistato dal p. Salvatore Maria Di Blasi, dipinto sopra tavola ad imitazione de’ musaici. Esso rappresenta S. Giovan Battista con ali grandissime la destra in atto di benedire alla greca e la sinistra che sostiene una lunga e sottile croce, e una cartella svolta con ellenica iscrizione e sopra sacri monogrammi e sotto in lettere greche in cui scorgeasi il nome del pittore Pietro Luparao137. La pittura sembra del secolo XIV e si avvicina allo stile nobile, e grande del seguente. Quel Pietro Luparao non appare fra’ pittori italiani, anzi il cognome l’annunzia siciliano e138 seguace del rito delle albanesi colonie qui residenti, che abbia per esse e sotto la lor direzione dipinto quel quadro singolare non solo per bellezza nella bizantina maniera e con maggiore spirito, ma per le ali appiccate nel dorso di quel santo (1)139. Un altro trittico di mezzo palmo creduto dell’epoca aragonese in _________________________________ 134 A c. 42r in calce: “(1) Presso l’art. X p. 17, part. 3 Mem. per la Storia lett. di Sicilia, Palermo per Bentivenga, 1756” <Domenico Schiavo, Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, Tomo primo[-secondo], In Palermo, nella stamperia de’ SS. Apostoli, per Pietro Bentivenga, 1756, v. I, pt. III, p. 28>. 135 A c. 42r in calce: “(2) Ibid. pag. 29” <Domenico Schiavo, Memorie… cit., v. I, pt. III, p. 29>. 136 Domenico Schiavo, Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, Tomo primo[-secondo], In Palermo, nella stamperia de’ SS. Apostoli, per Pietro Bentivenga, 1756, v. I, pt. III, p. 29. 137 Domenico Schiavo, Memorie… cit., v. I, pt. III, tav. inserita dopo p. 16. 138 Segue cancellata la parola: “forse”. 139 A c. 42v in calce: “(1) Io l’ho osservato molti anni addietro ma si potè scorgere l’incisione nelle citate Memorie letterarie di Sic. t. I parte 3” <Domenico Schiavo, Memorie… cit., v. I, pt. III, p. 24>. 320 Sicilia cioè del secolo XIII e seguente che era in Girgenti e passò nel museo Martiniano mostra dipinti la Beata Vergine col Bambino nel mezzo nella tavoletta a destra S. Giovanni Evangelista, e nella sinistra S. Giovan Battista a’ suoi piedi la testa fattagli recidere da Erode (2)140. Nel museo anzidetto c’è pure un altro trittico d’un palmo creduto del secolo XIV con S. Niccolò da un lato nell’interno e la reliquia di s. Spiridione dall’altro, indicati da una iscrizione e nell’intorno due tavolette, la Beata Vergine e l’angelo Gabriello e nel centro Dio Padre col Figlio e la mistica colomba dello Spirito Santo. Nello sgabello dell’Eterno padre sta scritto in greco dopo questo una voce in latino: In primis recordare, Domine, Cyrilli falsi monaci idest peccatoris(3)141. Dall’iscrizione suddetta pare che si possa argomentare che il monaco Cirillo ne sia stato il pittore: talchè in tre trittici abbiamo i nomi di chi tra essi esercitava la pittura nel Medio evo, altri di un Pietro rammentato in un diploma della epoca normanna. Pittura del medioevo in Sicilia dal 1132 sino al 1482 La R. chiesa Palatina dedicata a S. Pietro e cominciata a costruirsi per ordine del re Ruggieri, nel 1129 e terminata nel 1132 ha il tetto a soffitta a cassettoni, e questa insieme co’ travi riquadrati e dipinta a rabeschi, e figurine di santi con arabe iscrizioni, il che mostra che quelle pitture furono eseguite subito che la chiesa fu finita essendo allora prevalente la lingua araba. Quando sul cominciamento del sec. XIX dovette in parte ristorarsi trascurossi di copiar le iscrizioni e delinearsene le sacre figurine che a stento ora si scoprono da basso. Dovettero essere dipinte con colori sciolti in gomma liquida secondo l’uso del tempo e sono un singolare monumento anteriore al risorgimento della pittura in Italia ch’ebbe inizio con Dulichio142 creduto greco e Cimabue fiorentino nato un secolo e più anni dopo. Le molte sacre storie di santi rilevati a mosaico in tempi successivi, ma di cui i più antichi nel cappellone e nel te [!] furon nell’epoca di Ruggieri lavorati da greci artisti come scrisse il contemporaneo istorico greco _________________________________ A. 42v in calce: “(2) Ibid. pag. 29”. <Domenico Schiavo, Memorie… cit., v. I, pt. III, p. 29>. A. 42v in calce: “(3) Memorie della storia let. di Sicilia parte IV pag. 272”. <Domenico Schiavo, Memorie… cit., v. II, pt. IV, p. 272>. 142 Buscheto (o Buschetto), architetto pisano vissuto a cavallo dei sec. XI-XII, da taluni creduto originario di Dulichio (probabilmente l’odierna Cefalonia). 140 141 321 Giambattista Amelio; ma quelli artisti erano delle tante famiglie bizantine e trapiantate in Sicilia, e quindi divenuti siciliani, che ritenevano non per tanto la denominazione e il rito della loro origine. Io credo che greco-siculi, vi lavorarono; ma con essi arabo-sicoli cui Ruggieri permise di rimanere e conservare la loro religione dopo la sua conquista della Sicilia compita nel 1071. Ai saraceni-siculi furono senza dubbio affidati i mosaici d’ornato in cui erano abili artisti e di feconda invenzione, non potendo eseguire le sacre figure per divieto del Corano, e i greco-siculi erano esclusivamente addetti a questi insieme, com’è da supporre da un’artista che aveva origine siciliana, perocché i santi della chiesa greca avevano il corrispondente costume e l’iscrizione greca e per posto quelli della chiesa latina. Amelio ch’era greco ne volle dare tutto l’onore ai suoi connazionali originarii. Matteo Ajello gran cancelliere di Guglielmo 1° fondò in Palermo la chiesa or detta della Magione nel 1150 e la consacrò alla SS. Trinità. Sulla porta maggiore vi fe’ dipingere tre angeli seduti a Mamre e Abramo prostrato, e leggevasi scritto in lettere gotiche il motto nella scrittura Tres vidit et unum adoravit. Quella dipintura fu rovinata con la intrusione del nuovo campanile, e sarebbe stato interessante forse ragionare sul tempo e pel modo com’era eseguita, supponendosi che fosse a fresco, essendo per più secoli resistita all’intemperie dell’aria esterna e della pioggia. Un quadro sopra tavola sullo stesso soggetto si osserva nel cappellone che fu fatto dipingere da Teutonici e che fu concesso la chiesa coll’annesso convento dall’imperatore Arrigo VI nel 1195 e vi rimasero per circa tre secoli. Il quadro è bell’opera del secolo XV. Nella chiesa Monistero del Cancelliere fondata dallo stesso Matteo Ajello per esecuzione del testamento di sua moglie nel 1771 entro il parlatorio grande si osserva una gran croce in legno con Gesu Cristo dipintovi e nell’estremità dei quattro lati sacre figure. Nella chiesa poi avvi un quadro sopra legno della Madonna detta della perla donato dallo stesso Matteo Ajello, ma ristorata più volte. Nella chiesa di S. Paolo esistente pria del 1316 eravi un antico quadro della conversione di quel santo. Nell’antica cappella dell’Incoronata presso il Duomo così detta perché ivi coronavansi i nostri antichi re, si osservava sul muro pria del bombardamento del 1860, dipinti a fresco sul muro esterno e nell’abside interna143 l’Eterno Padre e le sacre figure e la scrittura Hic regi corona datur alla _________________________________ 143 Seguono cancellate le parole: “a fronte Gesù Cristo”. 322 sinistra e S. Pietro che colla destra coronava Pietro di Aragona e la sua moglie amendue genuflessi. A fianco del re era S. Pietro col motto piccante relativo a Dio Padre Petrus ero Petro regi Siculorum intendendosi che Dio stesso e con il suo vicario in terra coronava il re Pietro in difetto dell’altro che si era negato. Allato della regina Costanza era S. Paolo con un motto svanito per antichità. Quella pittura è certo del 1282 ed avanti vi si osservava la immagine, benchè alquanto fosse vetusta svanita, pure mi sembravano di uno stile un po’ goffo, ma grande all’opposto dei quello de’ quadri d’Italia da me veduti nei viaggi del 1841-43 che erano secche, cadaveriche e deformi. Le nostre pitture somigliano a mosaici più antichi della menzionata chiesa di S. Pietro del R. Palazzo in Palermo a quelli quasi contemporanei della Chiesa di S. Simone detta La Martorana e a quelli del Duomo di Monreale. Nell’antico cortile dell’Ospedale di S. Giovanni dei Lebbrosi nella campagna meridionale un miglio distante da Palermo affidato dall’imperatore Federico II a’ Teutonici nel 1219 vidi, già son molti anni molte figure dipinte a fresco sulle mura, ma mi parvero goffe e appartenevano all’epoca indicata. Nell’Ospedale dei pellegrini attaccato alla Chiesa antica di S. Cristina fondati nel 1174 da Gualtiero Offamilio, arcivescovo di Palermo si osservavano sul muro esterno diverse figure dipinte a fresco di pellegrini alquanto goffe e nell’altare della parte dell’Epistola vi era un trittico, un fondo dorato ov’era rappresentata la Vergine Maria, S.ta Cristina a destra e S.ta Caterina a sinistra e sotto a lettere gotiche leggevasi: Anno Domini 1402 hoc opus fieri fuit Petrus Belvedere canonicus panormitanus per manus Nicolai de Magès de son … L’Oratorio fabbricato dalla compagnia aggregato alla chiesa ed ospedale di S.ta Cristina la Vetere prima ch’essa compagnia fosse abolita fu dipinto a fresco da Antonio Pomazzo144 probabilmente siciliano e nel cappellone scorgeasi un antica tavola, un Gesù Cristo recato al sepolcro che alcuni credevano di esser dipinto dal fiammingo Simone Volbech145. Nella chiesa del Monistero di Monte Vergini avvi un quadro sopra tavola della Madonna detta della Consolazione dipinta a stile bizantino quella stessa che il conte Ruggieri fondando la chiesa di S. Maria la Mazzara nel 1075 le avea donata e poi abolita passò nel 1453 a quella di S. Giorgio in Alga, e anch’essa abolita fra molt’altre cose pervenne alla chiesa di Montevergine. In uno scudo sotto si legge: Mater consolationis iterum renovata anno Domini 1690; ma ciò par che debba intendersi della _________________________________ 144 145 Antonio Pomazzo, pittore attivo a Palermo nel sec. XVII. Vedi nota n. 74, p. 304. 323 cornice perché la pittura tuttavia esistente e da noi più volte osservata ha tutto l’aspetto di pristina antichità dell’epoca del Medioevo. Nella chiesa di S.ta Maria Maddalena entro al quartiere militare edificato nel 1187 da Gualtiero Offamilio arcivescovo di Palermo eravi un quadro su tavola rappresentante la resurrezione di Lazzaro; ma non si sa nella riforma di quella chiesetta che ne sia avvenuta. Nell’antica chiesa di S. Michele Arcangelo che rimonta al di là del 1149 e fu di recente riparata, vi era un antico trittico sopra tavola che rappresentava l’Epifania creduto di Filippo Lippi fiorentino, ed altro146 quadro antico sull’altare maggiore dedicato ai santi Arcangeli. Passata la chiesa in dominio del grande Ospedale civico il deputato dr Domenico Arista nel 1861 fe’ ristorare quei quadri da Michele Pizzillo e riacquistato l’antico splendore per la diligenza di costui furono ritenuti dal suddetto deputato nella contabilità dell’Ospedale presso la chiesa di S. Francesco Saverio. Nella sudetta chiesa di S. Michele eravi l’antica confraternita dei Naupatissari nel cui diploma pubblicato dal beneficiale Salvatore Morso scorgevasi l’immagine ben dipinta a miniatura della Beata Vergine appartenente all’epoca normanna. Il disegno inciso in contorno trovasi nell’opera del medesimo titolata Palermo antico147. Nella chiesa ed Anciconfraternita di S. Nicolò lo Reale fondata nel 1306 trovasi l’antico ruolo dei fratelli fra i quali il re Federico III° e in questa gran tabella vi sono varie figure che per quel tempo annunziano essere la pittura in progresso. Ivi è ancora il quadro di S. Nicolò che dallo scritto annunzia di esser dipinto da Tommaso Vigilia148 nel 1448. Nella chiesa della Compagnia di S. Maria di Gesù presso quella di S.ta Anna havvi un trittico coll’anno segnatovi a caratteri gotici 1220, giacchè quella chiesa è di antichità anteriore sebbene rifatta nel 1687 e adornata ai miei tempi. In quel trittico posto adesso sull’altare a sinistra vicino il cappellone si scorge la Madonna della Misericordia sopra fondo dorato assisa in una sedia ornata di mosaico a pittura col Bambino in braccio e ai fianchi quattro angeli, a destra S. Giovanni Battista e a sinistra S.ta Caterina coll’anno come si è detto MCCXX. Nell’antica chiesa detta della Pinta riunita a quella della Madonna _________________________________ Segue cancellata la parola: “trittico”. Salvatore Morso, Descrizione di Palermo antico ricavata sugli autori sincroni e i monumenti de’ tempi. Edizione seconda riveduta ed ampliata dall’autore, In Palermo, presso Lorenzo Dato, 1827, p. 111-113. 148 Per Tommaso De Vigilia cfr. alla voce Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori… cit. 146 147 324 dell’Itria rifabbricata nel 1390 e149 atterrata per isgombrare quel sito nel 1648 e ricostruita nuovamente a poca distanza eravi l’antica imagine della Madonna dell’Itria e un crocifisso dipinto a fuoco staccato dal muro dell’antica chiesa e il quadro sopra tavola della Madonna della grazia con S.ta Caterina e S.ta Agata opera dello stile del secolo XV. Nella Compagnia di S. Alberto presso il Carmine si osserva un antico quadro del titolare collo scritto Hoc opus depinxit magister de Parucho150 anno Domini 1412. Nell’antico palazzo fabbricato da Manfredo Chiaramonte nel 1307 come rilevavasi dall’iscrizione che fu detto dello Steri e terminato nel 1320 e abbellito di pitture dall’ammirante Manfredi III Chiaramonte nel 1380 se ne conservano alcune tuttavia, una cioè nella scala su fondo dorato con la Beata Vergine in mezzo a S. Antonio abate e un altro santo, opera che io credo eseguita sotto Manfredi III, ma quelle che sono certo del 1320 son le sacre figure e i rabeschi dipinti nelle travi e cassettoni delle soffitte. In una trave della seconda stanza ora coverta dalla volta moderna si scorgeva S. Giorno [!] a cavalli [!] accompagnato da due cavalieri. Quel palazzo per la ribellione di Andrea Chiaramonte a cui fu fatta troncare in punizione la testa dal re Martino venne confiscato dal governo e rivolto ad uso di tribunale è stato barbaramente alterato in s[…] modificazioni. Artisti di Nicosia Pittori principali che fiorirono in Nicosia in varie epoche Nel secolo XVII segnalossi nella pittura in Nicosia Nicolò Mirabella151 che ivi era nato. Egli dipinse quadri di152 bella invenzione e di gran composizione come quella dell’Ascenzione nel Duomo, del Giudizio Universale nella chiesa della Misericordia, della Cena e Deposizione della Croce e della morte di S. Francesco ai Cappuccini. Tra i suoi quadri pregevoli havvi la natività di Gesù Cristo in sant’Eligio, la circoncisione in S. Antonio, la morte di S. Giuseppe nella chiesa del titolare, e la Sacra Famiglia in S. Maria dell’alto fuori le mura. Se appartiene al suo pennello come è stato giudicato da qualcuno di _________________________________ Segue cancellata la parola: “trasferita”. Matheus De Peruchio, pittore, attivo tra il 1392 ed il 1435. 151 Nicolò Mirabella, pittore nativo di Nicosia, attivo nel sec. XVII. 152 Segue cancellata la parola: “grande”. 149 150 325 Nicosia il quadro della morte della beata Vergine Maria con gli Apostoli che si scorge nella chiesa di S. Francesco in Palermo in una parete della nave minore a man dritta il Mirabella merita lode non solo per la ricca composizione, ma pel buon disegno e colorito e sembra ch’egli abbia attinto il suo stile da qualche scolaro di Vincenzo Anemolo. Se non che non ha l’eleganza del fondatore di quella scuola nè le belle teste raffaellesche che nei suoi quadri si ammira, nulla di manco è certo uno dei migliori pittori del cominciamento di quel secolo in cui fiorì. Ignorasi l’anno della sua nascita e della morte. Tra i pittori del secolo XVII nati in Nicosia si possono ricordare con lode Giacomo Campione153 che dipinse la Circoncisione in S. Antonio Abbate, il Cenacolo in S.ta Domenica, S. Lorenzo in S.ta Maria ed altri quadri pregevoli in quella città. Puossi aggiungere a costui un Antonio Cardella154 che fornì vari buoni quadri alla chiesa del Carmine, di S. Calogero, di S. Antonio e di S.to Stefano fuori le mura, come pure appartenne a quella città e forse alla fine del secolo pure Ascanio Donguida155 canonico regolare lateranense che ben maneggiava il pennello e la penna in opere di pittura ed ascetiche e morì nel 1600. Il Beritelli156 nella sua diligente storica di Nicosia accenna che molte varie dipinture del Donguida esistono in Palermo, ma noi le ignoriamo non essendo segnate del suo nome157. Nel declinare del secolo XVIII dipingeva Giovanni Garigliano158 di famiglia patrizia di Nicosia il quadro della Madonna de Libera Inferni nella chiesa di S.ta Agata, il S. Francesco in quella dei Cappuccini ed altri quadri nel Collegio di Maria. Filippo Randazzo159 da Nicosia fiorì verso la metà del secolo XVIII e fu allievo del celebre Sebastiano Conca160 morto nel 1764. Si era distinto anche a Roma tra i migliori allievi di quell’insigne dipintore, ed ivi e in Napoli dipinto aveva pregevoli quadri e in Palermo tutta la volta della chiesa161 della Casa Professa dei PP. Gesuiti, ove segnalossi pei vari com_________________________________ 153 Giacomo Campione, pittore, nato a Nicosia, attivo nei primi anni del secolo XVII. E’ citato con il nome “Domenico” in Agostino Gallo, Parte prima delle notizie di pittori… cit., p. 205. 154 Antonio Cardella, pittore, nato a Nicosia, attivo nel secolo XVII. 155 Ascanio Donguidi, canonico regolare lateranense siciliano, ex gesuita, studioso della sua Congregazione, autore di opere di spiritualità, morto nel 1601. Per la sua attività di pittore vedi Agostino Gallo, Parte prima delle notizie di pittori… cit., p. 93; Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione… cit., p. 136, 145. 156 Giuseppe Beritelli, Notizie storiche di Nicosia compilate da Giuseppe Beritelli e La Via barone di Spataro riordinate e continuate per Alessio Narbone, Palermo, Stamperia di Giovanni Pedone, 1852. 157 Seguono cancellate le parole: “Antonio Cardella. Al cominciamento del 1600”. 158 Giovanni Garigliano, pittore, nato a Nicosia nel 1727 e morto nel 1797. 159 Filippo Randazzo, pittore, nato a Nicosia nel 1692 e ivi morto nel 1744. 160 Sebastiano Conca, pittore napoletano, nato nel 1680, morto nel 1764. 161 Seguono cancellate le parole: “di Gesù”. 326 partimenti per ricca e feconda invenzione nei dipinti a fresco di sacro argomento, sebbene spesso con colori troppo vaghi e disarmonici e con uno stile che tirava al minuto. Il Randazzo istoriò anche a fresco la chiesa del Monistero di Monte Vergine in Palermo e dipinse ad olio nell’altra di S.to Vito il quadro del martire S. Ciro. In Nicosia, sua patria,162 lasciò molte dipinture nel Duomo e nelle chiese di S. Calogero e S. Francesco di Paola. Nella Guida del Cav. Palermo si accenna che il Randazzo fosse monocolo163 ma, ma [!] ciò si tace dal suo concittadino Beritelli barone di Spataro. Anche Nicolò Sauro164 da Nicosia, cappellano dei Cavalieri di Malta si era rivolto alla pittura e ne avea dato saggi soddisfacenti; ma cessò di vivere nel fior degli anni nel 1782. Scultori nativi di Nicosia Vincenzo Calamaro165 padre e Giovan Calogero166 figlio segnalaronsi nella scultura principalmente nel secolo XVII il padre era anche pittore ed architetto e lasciò molte opere di pennello e di architettura in diverse città della Sicilia; ma principalmente riuscì nella scultura in legno e il figlio nei bassi rilievi in stucco di cui adornò la navata di S. Nicola e il cappellone di S.ta Maria, Vincenzo scolpì in legno il Crocifisso al naturale nella chiesa di S. Maria Maggiore e di S. Giovanni evangelista della sua patria. Felice Cardella167 figlio di Antonio buon dipintore di sopra menzionato vestito l’ordine carmelitano segnalossi in diligenti lavori figurativi in avorio e in osso che incontrarono il gusto del nostro vicerè Pietro Giron, Duca d’Ossuna, il quale li spedì in dono alla corte di Spagna. Fioriva quindi questo buon religioso poco dopo del 1611 quando quel Duca cominciò a governar da vicerè la Sicilia e terminò nel luglio 1616. _________________________________ Segue cancellata la parola: “dipinse”. Gaspare Palermo, Guida istruttiva per Guida istruttiva per potersi conoscere con facilita’ tanto dal siciliano che dal forestiere. Tutte le magnificenze, e gli oggetti degni di osservazione della città di Palermo capitale di questa parte de’ r. dominj prodotta... dal cav. Gaspare Palermo dei principi di Santa Margherita. Giornata III e IV, In Palermo, dalla Reale Stamperia, 1816, p. 146. 164 Fra’ Nicolò Sauro da Nicosia, pittore, attivo nella seconda metà del sec. XVIII, morto nel 1782. Cfr. Giuseppe Beritelli, Notizie storiche di Nicosia… cit., p. 357 e Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori… cit., p. 222. 165 Vincenzo Calamaro, scultore, pittore e architetto, nativo di Nicosia attivo nel secolo XVII. 166 Giovanni Calogero Calamaro, scultore, nativo di Nicosia attivo nel secolo XVII. 167 Per Felice Cardella cfr. Giuseppe Beritelli, Notizie storiche di Nicosia… cit., p. 352; Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione… cit., p. 140, 146. 162 163 327 In quel tempo adunque vuolsi stabilire che fiorivano nell’arte Antonio e Felice Cardella. Giambattista Li Volsi168 da Nicosia fu insigne scultore in legno sul cadere del secolo XVI e sul cominciamento del seguente quando ancora sostenevano con decoro l’arte della scultura Giacomo e Fazio Gagini figli del celebre Antonio. Giambattista Li Volsi frequentò la loro scuola e ne apprese i segreti dell’arte, e ne seguì lo stile per quanto il permetteva il secolo che alterava di già le belle forme. Molte opere fece in sua patria e particolarmente è lodato il Cristo alla colonna in S. Francesco, l’Angelo custode e il S.to Onofrio in S.ta Maria Maggiore, il S. Giovan Battista nella chiesa del titolare e il S. Nicolò a mezzo169 rilievo nella soffitta del Duomo, come pure i quattro rilievi uno esprimente l’ingresso del Salvatore in Gerusolima, l’altro l’Assunzione di Maria in cielo, il terzo il martirio di S. Bartolomeo e il quarto S. Nicolò. Nel 1630 per la fama acquistatasi fu scelto in Palermo170 a modellare la statua che doveasi fondere in bronzo per onorar Carlo V imperatore e che poi fu eseguita come osservasi nella piazza Bologni. In quella statua ammirasi uno stile nobile e severo. Sul suo modello credo pure che siasi fusa la statua in bronzo di Filippo IV che decorava la piazza del Real Palazzo e fu vandalicamente abbattuta e rotta nel 1848. Stefano Li Volsi171 figlio del precedente riuscì pure sotto la direzione del padre buono scultore, particolarmente nei bassi rilievi del coro della Cattedrale di Nicosia. Sono pure pregiate le sue statue di S. Benedetto nella chiesa S.ta Domenica e di S. Calogero in quella del titolare e le tre di S. Michele nella parrocchia di quell’Arcangelo nel Duomo di Caltanissetta e nel comune di Leonforte. Intendeva pure l’architettura come ne diè prova nell’elegante prospetto dell’organo grandioso del Duomo di Nicosia e nella bella e ingegnosa bara di S. Lorenzo nella Basilica di S.ta Maria. I due Li Volsi fondarono una numerosa scuola di giovani nella loro patria, fra i quali merita ricordanza un Filippo Provenzale172 ch’opera i bassi particolarmente in eleganti rabeschi in legno, come scorgonsi nel seggio senatorio di Nicosia intagliati circa il 1665. _________________________________ Giovanni Battista Li Volsi, scultore, nativo di Nicosia, attivo nel sec. XVII. Segue cancellata la parola: “reale”. 170 Seguono cancellate le parole: “modellare e scolpire il modello del”. 171 Stefano Li Volsi, scultore, nativo di Nicosia, attivo nel sec. XVII. 172 Filippo Provenzale, scultore in legno, nativo di Nicosia, attivo nel sec. XVII. 168 169 328 Nel secolo XVII fioriva anche Macario da Nicosia173 laico cappuccino scultore ed architetto che fu caro a Francesco Bonavides Duca di S. Stefano, spagnolo che fu vicerè di Sicilia sotto Carlo II dà 29 novembre 1678 sino agli 11 aprile 1687 e da lui fu adoperato come architetto secondario nell’immensa costruzione della cittadella di Messina e in altre fortezze dell’isola nostra, essendo divenuto peritissimo nell’architettura militare. Non sappiamo quali opere di scultura abbia fatto comecche dal Beritelli sia stato indicato come scultore. E poiche ho trasceso a parlar del Macario come architetto militare dirò in soggiunta che segnalaronsi pure in essa il nobiluomo Gutterra della Valle174 barone di Valdora che il Beritelli rivendicò a Nicosia, essendo stato creduto, e annunciato palermitano dal Mongitore nella sua Biblioteca Sicola175, poiché a lungo visse in questa città e morì nel 1725. Il Gutterra stanziando in Roma patria originaria di sua famiglia coltivò ivi gli ameni studii e le arti liberali, e particolarmente l’architettura civile e militare. Viaggiò indi per le altre città176 d’Italia per la Francia, e per diversi altri regni di Europa, ove contrasse amicizia con molti dotti, e si fè ammirare per estese cognizioni, pei suoi talenti poetici e la sua cultura nelle belle arti. Ritornato in Sicilia fu capitano di fanteria, e scrisse un compendio su l’arte militare, fu certo adoperato in opere di fortificazione, ma non sappiamo quali fossero. Luigi La Via177 anche nativo di Nicosia fu capitano de’ rr. eserciti di S.M. Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia e venne adoprato in varie costruzioni militari in quella metropoli, ed essendo per esse reputato valoroso professore, fu scelto primo ingegnere di quel sovrano che regnò dal 1759 sino al 1824 nel quale periodo visse Luigi La Via. Gaetano Cipolla178 da Nicosia cappuccino acquisto nel secolo XIX tal rinomanza in architettura civile che il tribunale del R. Patrimonio in Palermo, ove quegli stabilito avea il soggiorno l’adroprò in molte costruzioni, e meritossi anche la carica di architetto regio ossia camerale. _________________________________ Macario da Nicosia, scultore e architetto, attivo nel sec. XVII. Guttera Della Valle, letterato e architetto, nato a Nicosia (o Palermo) nel 1648 e morto nel 1725. Per la data di morte cfr. Giuseppe Beritelli, Notizie storiche di Nicosia… cit., p. 343. 175 Antonino Mongitore, Bibliotheca Sicula… cit., v. 1, p. 267-268. 176 Segue cancellata la parola: “provincie”. 177 Per Luigi La Via e Beritelli cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esterisoggiornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno 1838. Raccolte diligentemente da Agostino Gallo palermitano per formar parte della sua Storia delle Belle arti in Sicilia (Ms. XV.H.14.). Trascrizione e note di Angela Mazzè, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, 2000, p. 152-153. 178 Gaetano Cipolla, architetto, progetta nel 1801 la porta di S. Francesco ad Alcamo. 173 174 329 Brevi memorie sulla179 vita del pittore Michele Panebianco180 da Messina scritte da lui stesso nel 1865 Io nacqui a Messina il 20 dicembre 1806 da Cosimo Panebianco nativo da Aci Reale, e da Caterina Di Bartolo messinese, e fui battezzato nella parrocchia di San Leonardo in Messina. Sin da fanciullo ebbi la più grande inclinazione per l’arte del disegno, e cercai con tutte le forze dell’anima mia d’istruirmi in essa. Però in quel tempo sperimentandosi nel mio paese mancanza di bravi artisti, fui costretto dalla necessità ad imparare i primi rudimenti del disegno dal signor Giuseppe Miller, il quale non era altro che un professore di lingue, e di callegrafia, e che nello stesso tempo dilettavasi di fare qualche ritratto in miniatura. Venuto in seguito il Subba in Messina cercai iniziarmi presso di lui nella carriera dell’arte; ma non confacendosi col mio carattere, e col mio modo di sentire, il metodo adottato dal detto professore, decise di fare da me stesso, e di abbandonarmi a quel fuoco d’ingegno che il Buon Dio si era degnato concedermi. Per la quale cosa pregai il mio amico Signor Carmelo La Farina, che in quell’epoca s’avea la carica di prefetto della quadreria di Messina, perché mi permettesse l’ingresso nella stessa per studiare quanto di buono si contenea. Infatti ottenuto il chiesto permesso colla più grande ansia di progredire nell’arte mi accinse allo studio dei capolavori della scuola messinese, facendo quanto meglio poteva e sapeva da me stesso, senza altra guida che la mia sola ispirazione. Così durai per alquanti anni poi che il Municipio del tempo di questa città, volendo mandare a spese comunali un giovane pello studio della pittura in Roma, aprì un concorso. Diversi giovani intelligenti del mio paese intervennero alla nobile gara, e tra costoro io quantunque giovinetto, e da poco esercitato nell’arte. Il Signore secondò i miei desiderii, vinse i miei competitori, e dopo poco tempo partii a spese del Municipio per Roma. Ivi giunto per mezzo del cardinale Gregorio ebbe l’accesso allo studio del Camuccini181, valoroso artista, e disegnatore correttissimo, il quale toltomi da mano la tavolozza e i pennelli, mi fece ricominciare lo studio del disegno, e sotto la sua scuola severa ed altamente classica, fui in grado concorrere dopo sei mesi, dacchè era in Roma, ai premii pel nudo nell’Accademia di San Luca in182 quella città nel quale ottenni il primo pre_________________________________ Segue cancellata la parola: “mia”. Vedi nota n. 120, p. 310. 181 Vincenzo Camuccini, pittore, nato a Roma nel 1771, ivi morto nel 1844. 182 Segue cancellata la parola: “Roma”. 179 180 330 mio. Contrassi in seguito amicizia coll’esimio artista mio compatriota cavaliere Natale Carta, il quale pieno di amabilità, e gentilezza mi avviò nello studio della pittura, e sotto la sua direzione fece [!] i miei studii sul colorito. Da questo tempo in poi comincia la mia vita artistica, durante la quale ho fatto moltissimi lavori, e per classificare i quali fa d’uopo distinguere tre epoche in cui la mia maniera di dipingere ha subito delle notevoli modificazioni secondo le svariate influenze dei miei maestri, e secondo i capolavori che ho indefessamente studiati. La prima epoca incomincia dalla mia prima gita per Roma avvenuta nell’8 gennaio 1828 e termina col mio viaggio per Venezia intrapreso nel 1845. Durante questo periodo in tutti i miei lavori cercai sempre d’imprimere una purezza, ed una severità nel disegno, e d’esprimere il concetto con quella robustezza, che ho potuto migliore; imitando la maniera piena d’energia, propria del mio maestro Camuccini, e cercai l’effetto piuttosto nella forza, e nella purezza dei contorni, nell’armonia del chiaro-scuro, anziché nel colorito. Le opere da me eseguite nel succennato periodo con figure grandi al vero sono le seguenti: - Un sant’Antonio eremita per Aci reale - Un’Immacolata con una gloria di Angeli ai piedi pella chiesa del Convento di San Francesco in Messina - La Madonna degli Agonizzanti per la chiesa dei PP. Crociferi in Messina - Il sipario pel teatro La Munizione in Messina rappresentante i giochi olimpici - Il Ritratto del Signor Duca di Sperlinga - Una grande tela con undici ritratti rappresentante l’intiera famiglia del B.ne Pennisi di Aci Reale. Ho ancora eseguiti diversi lavori a mezza figura, che sono: - Una Vergine col Bambino Gesù fra sant’Omobono e san Gerolamo per Reggio di Calabria - Un San Lorenzo, e una Santa Cristina per un paese di Calabria - Una deposizione dalla croce per un privato - Un Santo Rocco, e una Madonna della Purità per Aci Reale - Un’Immacolata, un San Paolo, e un San Bartolomeo per un privato - Il Samaritano lavoro eseguito, e che non giunse nel tempo stabilito per un concorso aperto in Napoli, ma che in seguito spedito in Palermo fu premiato colla grande medaglia d’argento 331 - Quasi un centinaio di ritratti mezze figure più o meno grandi del vero di diversi privati - Due disegni originali a chiaroscuro ad acquarello premiati in Napoli, ed in Palermo nell’esposizione con medaglie d’argento, ed un terzo grande eseguito collo stesso metodo premiato con medaglia d’oro, e d’argento. Venuto l’anno 1845 partii per Venezia in cui mi condusse il desiderio di perfezionarmi nel colorito. Dalla partenza per quella monumentale città principia la seconda epoca della mia vita artistica, la quale termina col mio secondo viaggio per Roma avvenuto nel anno 1854. Arrivato colà contrassi amicizia col Gregoletti183 per mezzo del quale ebbi il libero accesso nella veneta quadreria, in cui con tutto lo zelo possibile mi diedi a copiare i capolavori del Tiziano, di Paolo Veronese, e di tanti altri celebri artisti che formano il decoro della scuola veneziana. Imbevuto della maniera dei veneti pittori, ed educato a quelle loro tinte per quanto vaghe, altrettanto vere ritornai in Messina, dopo aver percorso le principali città italiane, e sotto l’influenza di tale scuola eseguii diversi lavori, nei quali si rivela palpabilmente un sostanziale mutamento nella mia maniera di colorire. In seguito con Ministeriale dell’8 giugno 1852 fui nominato professore di disegno, pittura e nudo nell’Università di Messina. Durante il periodo della succennata seconda epoca ho eseguito i seguenti lavori: - Il ritratto del Cardinale Villadicani intiero, e grande al vero in cui ho fatto lusso di colorito. La quale opera riuscì secondo il mio parere felicissima, ed in quanto a me la è una delle migliore opere da me fatte. - Una natività di nostro Signore con figure grandi al vero. - Il grande sipario pel teatro massimo di Messina rappresentante Gelone, che accorda la pace ai Cartaginesi, con figure più grandi del vero. - Una grande tela con numero sei ritratti delle figlie e ragazzino del Principe Alcontres di Messina. - Un quadro con figure metà del vero rappresentante il riposo in Egitto della Vergine col Bambino, e San Giuseppe, eseguito per il celebre Pietro Tenerani, per cui il sommo artista indirizzavami la seguente lettera: “Signor Prof.re Panebianco amico pregiatissimo: Rispondo alle due stimatissime lettere da me ricevute negli ultimi di dicembre, e ne’ primi giorni di gennaio p.p. Colla prima Ella mi dava la piacevole notizia del quadro del Riposo in Egitto, che lei si è compiaciuto _________________________________ 183 Michelangelo Grigoletti, pittore, nato a Rorai Grande di Pordenone nel 1801, morto a Venezia nel 1870. 332 eseguire per me, e che mi giunse in ottimo stato. Coll’altra si degnava, nella sua solita cortesia, esprimermi i suoi buoni auguri nell’occasione del novello anno. Benchè si per l’una che per l’altra le abbia fatto dare precrariamente [!] riscontro del signor Zagari, conosco bene che avrei dovuto darglielo io direttamente, ma per ragione di salute, come ben sa, e delle molte faccende, ne fui impedito, onde su questo punto pregola di volermi scusare. In quanto al quadro, ha Ella saputo l’ottimo incontro che ha fatto, come dovea esserci senz’altro appresso coloro che l’hanno veduto, e me in particolare, ed il signor Minardi, il quale riconobbe che Ella anche in tema religioso si è maestrevolmente informato allo stile ed al carattere che gli è propizio. Egli ne fa seco Lei i più sinceri rallegramenti; ma soprattutto ne sono rimasto io soddisfatto quanto mai possa dirsi, e contento di possedere questo prezioso ricordo della somma sua valentia nell’arte e della sua pregiata amicizia. Su questo particolare sarebbe stato pieno ogni mio desiderio, qualora Ella si fosse piegato alla preghiera che le feci fare dal nostro Zagari, volendomi dare un cenno per mia regola per retribuirla di quel dispendio, e tempo, che da Lei detratto ad altre sue opere ha impiegato per me in questo lavoro; ma posto che Ella nella sua delicatezza ha rimesso la cosa a me, io nell’intendimento solo di mostrarle in qualche maniera la mia riconoscenza, e ben lungi dell’idea di sdebitarmi verso di Lei delle mie obbligazioni, Le faccio tenere col mezzo del Signor Zagari scudi romani quattrocento, che pregola di accettare qual contrasegno, siccome dissi della mia piena soddisfazione per suo egregio lavoro. Nel tempo stesso però ne abbia ancora i miei ringraziamenti anche per quegli augurii, che con tanta espressione d’animo volle manifestarmi per Capo d’anno, auguri, che sebbene allora non Le ricambiassi, pure feci nel cuor mio, e faccio sempre per la sua prosperità. Mia moglie La saluta, ed unisce le sue congratulazioni a quelle di tutti gli altri amici per la sua bell’opera. Carlo, figlio del Tenerani, non mai dimentico di quanto Ella ha fatto per averlo iniziato nello studio del disegno la riverisce e ringrazia. Mi comandi senza risparmio, e creda con alta stima invariabilmente. Roma 11 Febbraio 1859 Suo aff.mo e obb.mo amico P. Tenerani” E finalmente in detta seconda epoca dipinsi più di sessanta ritratti di privati mezze figure più o meno grandi. - Una Madonna col Bambino Gesù con figure metà del vero fatta pel villaggio di Bordonaro sopra tavola. 333 - Altra mezza figura grande al vero rappresentante la Vestale pel Principe di Castellaci. - Un piccolo quadro dipinto sopra tavola rappresentante la Sacra Famiglia pel B.ne Pennisi. - Una replica del ritratto del Cardinale quasi intiero, con qualche modifica nel fondo per il M.se Moleti. E tante altre opere per feste pubbliche, e per diverse occasioni. Ricevuta dal Municipio di Messina la commissione di un quadro di grandi dimensioni, cioè di palmi 22 di lunghezza per 12 di altezza, rappresentante la compagnia dei Verdi, che difende l’Eucaristico Sacramento della persecuzione dei Saraceni, ripartii per Roma, perché ivi studiassi maggiormente la composizione in discorso, e mi giovassi di tutti i mezzi che offre quella metropoli per le Belle Arti. Da questa seconda partenza per Roma, avvenuta nell’anno 1854, data l’incominciamento della terza epoca, la quale dura fino a questo giorno in cui scrivo. Pergiunto in Roma trovai l’arte grandemente progredita, e gli artisti di quell’epoca facevano già presentire nei loro lavori il sorgere di una scuola novella, che avrebbe tracciato, con un metodo del tutto originale all’arte una novella via, dischiudendogli un campo novello. Io studii [!] le opere di questi nuovi artisti, e le imitai in tutte quelle cose che a me parvero buone a seguire, e che si affacceano nello stesso tempo al mio sentimento. La qual cosa portò delle modificazioni nella mia maniera di dipingere. I lavori da me eseguiti durante quest’ultimo periodo sono i seguenti: - La sopradescritta tela dei Verdi dipinta in Roma con figure più grandi del vero, che attualmente conservasi in Messina nel Gabinetto di Mineralogia dell’Università di Messina - Una Sacra Famiglia ed un Cuor di Gesù con figure grandi al vero eseguiti in Roma per la Chiesa del Monistero di Santa Maria della Scala in Messina. Per tutti e tre sudetti lavori, fui nominato mentre trovavami in Roma nel 1855, virtuoso di merito nell’insigne congregazione dei virtuosi al Pantheon. Ritornato da Roma in Messina dipinsi le seguenti opere con figure quanto al vero: - Sant’Agata nelle prigioni nel momento, che le appare San Pietro per Aci Reale - Due quadri per Barcellona Pozzo di Gotto rappresentanti l’uno Sant’Eleuterio, e l’altro il Cuore di Gesù 334 - Le stigmate di San Francesco per la chiesa del Monastero di Santa Chiara in Messina - Un quadro con figure metà del vero rappresentante la morte di San Francesco - L’Olimpo nel momento che Aurora abbraccia Psiche, per un privato - Una deposizione dalla croce per Attolia villaggio di Messina - Un quadri di grandi dimensioni pel soffitto dell’Oratorio dei Mercanti in Messina rappresentante l’Apoteosi di San Francesco - Tre mezze figure rappresentanti un Cuor di Gesù, un’Immacolata, un San Giuseppe - Due quadri con figure metà del vero rappresentanti l’uno l’Annunziazione della Vergine, l’altro San Giuseppe - La battaglia di Milazzo con figure terzine - Una Venere ed una replica della stessa metà del vero - Numero 20 ritratti mezze figure più o meno grandi del vero - Finalmente sto lavorando per Venetico un quadro con figure poco meno del vero rappresentante un miracolo di San Nicolò - Una mezza figura grande al vero rappresentante un Cuore di Gesù per un privato. Dalla lettura dell’elenco delle mie opere si rileva facilmente, che la maggior parte delle stesse sono di genere religioso, ramo di pittura in cui mi ho sempre versato sin da principio della mia carriera, e per cui ho sempre avuto un’inclinazione particolare. Riguardo al disegno l’ho ritenuto sempre, per come è, parte principale nella pittura, e mezzo efficace perché un artista potesse ottenere l’effetto, che brama nella composizione, per cui non è da recar meraviglia se ho posto tutte le mie cure per perfezionarmi in esso, e se la franchezza prodotta dal lungo esercizio, e la scrupolosa esattezza nell’incassare le figure delle mie composizioni, forma la caratteristica principale del mio184 stile nella pittura. Ho tanto indefessamente studiato questo ramo, ed ho acquistata tanta franchezza nel maneggio della matita, che un giorno ebbi il compiacimento di disegnare in meno di una mezz’ora fra una brigata d’amici, mentre trovavami ammalato a letto in un pezzo di carta più di 50 puttini, che dormivano in posizioni differenti; e ciò oltre a tanti lavori che al presente non mi ricordo, e a tanti altri eseguiti per Album di amici, e molti schizzi a matita fatti per mio esercizio. Finalmente ho cercato per quanto hanno permesso le mie forze di mantenere l’Arte nella sua matronale dignità a cui la chiama l’altezza della sua _________________________________ 184 Segue una parola cancellata di cui si leggono solo le prime due lettere “ma=” 335 missione, né mi sono mai servito di essa per accarezzare passioni di qualunque siasi genere. Mi ho sempre sforzato d’imprimere nella gioventù nascente, che attende allo studio dell’Arte, i più sani principi del Vero e del Bello, ed ho fatto e faccio quanto posso per progredimento dell’Arte, che ho sempre amato con tutte le potenze dell’anima mia. Messina li 20 agosto 1866 Michele Panebianco185 Quadri di Gius. Velasques186 In casa del M.se Vannucci in Palermo sopra porta e volta i fatti di Enea desunti da Virgilio. In Malta Nella chiesa di S. Paolo alla Valletta Il naufragio di S. Paolo, e l’arrivo in Malta gran quadro L’altro quadro S. Paolo quando guarisce dalla dissenteria il padre di Pubblio [!] giacente in letto. Publio era governatore di Malta inviato da’ Romani. Egli fu consacrato vescovo da S. Paolo, e morì martire in catene. Notizia comunicatami da papa Nicola Bicera Parroco cattolico in Malta Pietro Alberti187 pittore Pietro Alberti nato in Erice l’anno 1778 da un calzolaio che era in voce di valoroso meccanico, morto ivi nella fresca età di anni 22, mostrò sin da fanciullo tale un’indole da parer nato fatto per la divina arte di Raffaello; vasto cioè e fervido immaginare, organizzazione squisita sotto una ruvida scorza, sentimento del vero bello188 e una scintilla di quel fuoco sacro che accendendo il cuor dell’uomo, lo solleva sopra la schiera volgare. Sfornito peranco di ogni istruzione, tracciava con mano pronta in quadri condotti o a penna o a matita i parti della sua bollente fantasia in modo da eccitar la maraviglia nei riguardanti sotto la disciplina di un cotal Giuseppe _________________________________ Alle c. 60-65, testo a stampa di Antonio Picciotto, “Cenno artistico sopra un dipinto del Professore Michele Panebianco”, Messina, Tipografia Ribera, 1866. Estr. dalla Gazzetta di Messina del 18 e 25 luglio 1866. 186 Vedi nota n. 6, p. 288. 187 Pietro Alberti, pittore, nato a Erice nel 1781 e ivi morto nel 1802. 188 Seguono cancellate le parole: “bello verace”. 185 336 Pollina189, mediocre pittore e scultore ericino; apprendea in patria celerissimamente i principii dell’arte. Fra gli aneddoti del suo genio precoce si narra che un bel dì il suo maestro occupato nella dipintura di un quadro, non ponea mente a quello che il giovine Alberti si facesse dentro l’officina medesima. Da ultimo rivoltosi istintivamente, lo trovò arrampicato sopra sgabelli e sedie sul punto di condurre a fine con del carbone un quadro del Giudizio universale, di che aveva istoriato una intera parete. Attonito il buon maestro si guardava dallo scuoterlo, quasi temesse di non veder compiuto190 quell’egregio lavoro, e come ei discese, corse con uno slancio irresistibile a serrarlo fra le sue braccia. Recatosi indi l’Alberti in Trapani ad apparare sotto il pittore Cutrona191, vi facea maravigliosi progressi. Ben conscio a sé stesso di che immenso e multiforme sapere abbisogna colui che vuol procacciarsi gloria verace nella pittura, rivolgea con mano diurna e notturna i volumi dei classici, poeti, storici ed artisti. Studiava con trasporto in tutti i tempi, in tutte le ore, sotto ogni aspetto: nella primavera che schiude il sorriso dell’anno, allorchè la verzura è sì fresca, i fiori così svariati; nei campi coperti di messe, allorchè la brezza del mezzogiorno sviluppa le larghe dorate ondulazioni; e in quelle tinte abbaglianti, vermiglie, di cui è colorato l’orizzonte al cadere di un giorno d’estate. Nel verno poi l’imponente spettacolo del patrio monte, ora gremito di nebbia, ora di neve, la fioca luce dell’astro maggiore semivelato, i tronchi anneriti e adusti della campagna, le acque spumose dei torrenti ingrossati dalla pioggia, il baleno dei lampi, il rombo dei tuoni, lo schianto delle folgori rapiano l’Alberti fuor di sé stesso. Non istancavasi egli mai di vedere e di osservare; i segni forieri della tempesta non lo sgomentavano, non lo turbavano affatto, che anzi trovando la furia degli elementi ne contemplava rapito in un’estasi taciturna gli orrori sublimi. Tutte le facoltà dell’anima sua si esaltavano, entusiasmavano alle magnifiche scene della natura. Venuto carissimo al col. marchese Agostino Cardillo, allora Presidente del Regno, e cultore, non che mecenate delle belle arti e scienze, fu da lui raccomandato al sommo pittore Giuseppe Velasquez, in quei tempi Precettore del nudo nella Università di Palermo. Nella metropoli di Sicilia nostra correva a passi di gigante il difficile aringo del disegno, vinceva alla prova i suoi colleghi, e si meritava sempre egli solo i premi mensili. E già arrivava ben presto al punto da metter da banda le sue matite per maneggiare il pennello. Già possedea molta correzione nei contorni, puri_________________________________ Giuseppe Pollina, pittore e scultore, nativo di Erice, attivo nel sec. XVIII. Seguono cancellate le parole: “un’opera tanto solenne”. 191 Vedi nota n. 40. 189 190 337 tà nelle forme; ai quali pregi aggiunse bentosto la soavità del colorito, e dei tocchi fini e morbidi. Per che il Velasquez fra una numerosa corona di allievi prediliggeva l’Alberti192. Nel disegno dei paesaggi e degli adorni nessuno potea vincere o eguagliare il giovine artista ericino. Però è a dolersi che pochissimi monumenti ci restino di quel senno preclaro. La chiesiuola dell’Ex-fondo di Inici, pertinente al Cardillo, mostra ancora nelle sue pareti i freschi a stucco dipinti dall’Alberti, rappresentanti la vita di S. Paolo primo eremita. E questo bel lavoro lo faceva prima di condursi in Palermo per apprendervi la pittura. Poscia che mal condotto in salute fece ritorno alla patria, dipinse colà con freschi a stucco la chiesiuola di S. Chiara. Conducea a lapis in soli 3 giorni un quadro mirabile, rappresentante l’apostolo S. Paolo che predica nell’Areopago di Atene, bella copia dell’unico Raffaello, e ne facea dono all’illustre famiglia Palazzolo ericina, da cui riconosceva nella sua carriera incitamenti e conforti. Corre grido che il cel. Vincenzo Manno193, mentre in Erice ornava di freschi la chiesa di S. Martino, conosciuto il merito grande dell’Alberti, volesse dargli a sposa la propria figliuola, matrimonio, a cui il giovine pittore, innamorato unicamente dell’arte, si rifiutava. Gli schizzi dell’Alberti, sorprendenti per l’invenzione, si conservavano dal prete ericino d. Carmelo Peraino194, buon paesista, stanziato in Palermo, ed ivi lettore di disegno nel nobile Convitto delle Salesiane, e alla morte di esso Peraino passavano nelle mani di suo nipote Vito Alastra, buon pittore anche lui. I sospiri dell’Alberti erano rivolti a Roma, sede e maestra delle arti belle, ove si struggea per desiderio d’ispirarsi a quei non perituri monumenti che chiamano lo straniero nella città eterna dei Cesari e dei Papi. Ivi la scintilla del suo genio volea prorompere, ivi brillare di tutta la sua luce. Ed oh! Se egli avesse potuto incarnare quel grande divisamento! La sua fervida immaginazione, l’esattezza del disegno, l’inarrivabile celerità nel comporre, sposata allo studio dei capo-lavori della Galleria Romana, ne avrebbero fatto un sommo artista. Ma il cielo non secondò i voti dell’Alberti. Una consunzione ribelle a tutti gl’ingegni della medicina lo rapia sul verde aprile degli anni alla speranza della Patria, cui già preparava tale un serto novello di gloria da non invidiare nè a Morreale il suo Novelli, né a Messina il suo Antonello, né a Trapani il suo Errante. _________________________________ Segue cancellata la frase: “e se non mentisce la fama, sceglieva l’Alberti a coadiuvarlo nella pittura del Duomo di Palermo”. 193 Vincenzo Manno, pittore, nato a Palermo intorno alla metà del sec. XVIII, ivi morto nel 1821. 194 Carmelo Peraino, pittore e intagliatore in legno, nato ad Erice, attivo nel sec. XIX. 192 338 Pittura in Sicilia, e scultura in legno nel secolo XVIII Francesco Ugdulena195 da Termini nato di agiata famiglia pria della metà del secolo XVIII e morto o verso la fine o ne’ primi anni del seguente. Avea per diletto studiato la pittura in Palermo nella scuola del celebre Vito d’Anna o de suoi migliori allievi i fratelli Manno196. Restituitosi in patria l’esercitò generosamente, donando per lo più i suoi quadri a chiese di monasteri e confraternite della sua patria e ritraendoni [!] complimenti e forse la spesa di tela e colori. Più volte venne in gara col suo concittadino Alessio Geraci197, e lo superò per diligenza, per bel colorito ed effetto che col suo buon gusto si formò da se, abbandonando quello languido de Manno; talchè il celebre Giuseppe Velasquez al guardare i quadri dell’Ugdulena dicea: Se costui fosse rimaso a Palermo a studiare piu a lungo avrebbe superato i Manno anche nel disegno e nella composizione. Fra i migliori suoi quadri in Termini si additano quello198 di Maria Vergine, e di199 S. Marco nel monistero della Concezione nella chiesa del Collegio di Maria la B. Vergine fra una turba di ragazze, S. Bartolomeo in atto di pregare Dio nella chiesa del titolare. Inferiori sono i quadri di S. Vincenzo di Paola che predica al popolo nella chiesa di S. Giuseppe200. L’Ugdulena fu anche buono e diligente disegnatore a penna, e scultore in legno. Nella chiesa del convento del Carmine in Termini avvi di lui la statua della Beata Vergine di quella denominazione e in quella di S. Giacomo la statua della Vergine addolorata col Cristo morto201. Paesaggio in Sicilia nel secolo XVIII Francesco Politi202 e Gandolfo Ferrara203 da Termini Contemporaneo e concittadino a Ferara e ad Ugdulena in Termini Francesco Politi che riuscì buon paesista a tempera e ad olio di cui molti _________________________________ Francesco Gregorio Ugdulena, pittore, nato a Termini nel 1730 e ivi morto nel 1792. Antonio, Vincenzo, Francesco e Salvatore Manno, pittori palermitani attivi tra il XVIII e il XIX secolo. 197 Alessio Geraci, pittore, attivo nel secolo XVIII. 198 Seguono cancellate le parole: “della Concezione”. 199 Seguono cancellate le parole: “di S. Bartolomeo orante”. 200 Segue cancellata la frase: “S. Bartolo in atto di orare pria del martirio, nella chiesa del titolare”. 201 Seguono cancellate le parole: “su le ginoc”. 202 Francesco Politi, pittore, attivo nel secolo XVIII. 203 Gandolfo Ferrara, pittore, nato a Termini nel 1766 e morto intorno al 1830. 195 196 339 si conservano nella casa de’ particolari. Poco dopo vivea204 Gandolfo Ferrara dilettante che schizzava con diligenza paesi a penna di cui io, ne ho alcuni. Egli morì vecchio. Artisti Termitesi del secolo XVIII Francesco Ugdulena205 Statue Maria del Carmelo a convento Addolorata con il Cristo morto nelle gambe in S. Giacomo Quadri nel monastero di S. Chiara Concezione * e S. Marco Colleggio di Maria la Vergine con educande ragazze* In S. Giuseppe S. Vincenzo de Paula che predica In S. Bartolo per il detto Santo in adorazione* notizie datemi da Andrea Sottile pittore Terminese Francesco Pulito206 paesista207 Pittura in Sicilia nel secolo XIX Salvatore Ajello208 da Palermo La pittura del paesaggio, e di genere d’ogni maniera era stata trascurata in Sicilia sino al cominciamento del secolo XIX. Pel paese appena accennavasi un Onofrio Lipari209. Benedetto Cotardi210 napoletano buon pittore adornista trattava qualche volta nelle volte e nelle pareti de’ palazzi il paese, fiori e frutta, ma sempre di fantasia con facilità e deboli tinte. Con miglior gusto di colore e maggior grazia successe al Cotardi Raimondo Gioia211, anche napoletano, e indi il suo scolare Giulio Bonomo da Palermo, e indi il suo concittadino Giuseppe _________________________________ Segue cancellata la parola: “fra”. Vedi nota n. 195, p. 339. 206 Vedi nota n. 202, p. 339. 207 A c. 71v: “All’Onorevole Cittadino Sig. D. Francesco Sottile delegato capo in Marsala”. 208 Salvatore Aiello, pittore, nato a Palermo nel 1801 e morto nel 1865. 209 Onofrio Lipari, pittore, nativo di Trapani fu attivo nel secolo XVII. 210 Benedetto Cotardi, pittore napoletano, a Palermo operò tra il 1775 e il 1818. 211 Vedi nota n. 32, p. 295. 204 205 340 Tripi212, vivente, egregio adornista e buon paesista. Ma su tutti elevossi nel dipinger paesi Andrea Martino213 nato in Palermo da madre siciliana e da padre francese. Andrea riusciva anche nella figura e nel ritratto scolare del celebre Benvenuti; ma prescelse il genere dei paesi, nel quale non fu superato da alcuno. Il cav.r Giuseppe Patania214 palermitano onnigeno pittore e celebre ne’ quadri di storia, e nei ritratti, pennellegiò il primo con verità e grazia il paese, spesso di sua invenzione, ed eseguì per commissione dal marchese Giuseppe Merlo un quadro di caccia uccellanea, altro di pesci, altro di frutta, e un quarto di fiori, che furono riguardati come meravigliosi. Allora si eccitò una gara fra molti e si divisero la pittura del paese il p. Arcangelo215 cappuccino e Andrea Sottile216, e quella di genere Tripi, di Martino e Salvato [!] Aiello che frequentavano la sua scuola e col vederlo dipingere i paesaggi, e i quadri del Merlo divennero suoi imitatori. L’Ajello scelse in particolare il genere della frutta e vi riuscì egregiamente e riportò premj nella nostra esposizione di belle arti e fu suo competitore ma inferior di merito il dilettante barone Melchiorre Pisani217. L’Ajello nel paese, e ne’ fiori218 non acquistossi egual reputazione che nella frutta. Egli morì di anni 64 di polmonite acuta agli 11 novermbre 1865. Era d’indole buona e pacata sottili nell’economia, e diligentissimo ne’ suoi lavori. D.n Salvatore Ajello pittore di frutta premiato con diverse medaglie, morì la notte degli undici novembre 1865 in età di sessantaquattro anni. 219 Opere pittoriche di Vincenzo Riolo220 Grande affresco nel palazzo del principe di Villafranca – La caduta di Fetonte. Altro nel palazzo del Duca di Cannizzaro ora del cav. Galletti. Altro nella casa del Bne Pietro Coglitore e suo ritratto al naturale. Figure cinesi ad olio nel palazzo del pricipe di Palagonia. Pitture ad olio presso il principe di Pandolfini. _________________________________ Vedi nota n. 29, p. 295. Vedi nota n. 124, p. 312. 214 Vedi nota n. 11, p. 289. 215 Padre Arcangelo da Palermo, cappuccino, nato a Marsala nel 1786, morto a Palermo nel 1849. 216 Seguono cancellate le parole: “il barone Melchiorre Pisani”. 217 Melchiorre Pisani, pittore, nato a Palermo nel 1787e ivi morto nel 1840. 218 Seguono cancellate le parole: “fu inferiore”. 219 Precede cancellata la parola: “Contrapponghi”. 220 Vedi nota n. 27, p. 294. 212 213 341 Figure cinesi nel R. palazzo della Favorita. Figure ad olio nel palazzo già della principessa di Montevago ora della duchessina di Serradifalco. Pitture ad olio dipinte in competenza col Velasquez nel palazzo del principe di Fitalia Un filosofo che legge un papiro al lume di notte presso D. Agostino Gallo Il bozzetto di Orlando Furioso e un piccolo ritratto di Rubens e un altro bozzetto Gesù Cristo con la Samaritana221 Pittura siciliana secolo XIX Agostino Martines222 da Palermo Due disegni ad acquerello uno che sembra originale è rappresente la Sacra Famiglia e l’altro copiato da S. Rovetti rappresentante223 la Speranza, l’Amore e Venere che spennacchiano e acciuffano il tempo entrambi da me posseduti e condotti con diligenza, nel primo dei quali è segnato Agostino Martines Pan s. delineavit 1806 nell’altro Augustinus Martines delin. 1803 mi han fatto conocere questo pittore o dilettante che io ignoravo. Dallo stile del disegno della Sacra famiglia argomento ch’egli appartenne alla scuola dei fratelli Manno, che fu numerosa di allievi fra i quali il Coppolino e il Salpietra che prima avevano studiato col celebre Vito D’Anna comune maestro coi Manno ed224 erano stati di ajuto al d’Anna nel condurre il grande fresco della cupola del SS.o Salvatore essendo quegli gravemente attaccato di tisi onde poco dopo morì. Il Martines forse fu anche uno degli ajuti in quella celebre dipintura, il cui cartone con l’immensa composizione era stato lavorato dal D’Anna. Pittura in Sicilia verso la fine del secolo XVIII Alessio Geraci225, e Francesco Ugdulena226 da Termini. Questa città che fu patria ad entrambi ha avuto ne’ suoi figli vari cultori di belle arti, che noi abbiamo rammentato secondo l’ordine de’ tempi in cui vissero. Riuniamo ora il Geraci e l’Ugdulena entrambi essendo compaesani e coetanii. _________________________________ Seguono le parole: “Al Sigr Gallo”. A c. 74v a stampa: “Il Socio Segretario Giulio Strina”. Agostino Martines, pittore palermitano, attivo nel secolo XIX. 223 Seguono cancellate le parole: “le Grazie e la Fama”. 224 Segue cancellata la parola: “avevano”. 225 Alessio Geraci, pittore, nato presumibilmente a Termini Imerese, attivo nel secolo XVIII. 226 Vedi nota n. 195, p. 339. 221 222 342 Il primo fu allievo in Palermo della scuola fondata dall’egregio frescante Vito D’Anna di cui abbiam fatto onorata menzione e alla sua morte sostenuta con minor plauso dai fratelli Manno. Dopo il tirocinio ritiratosi il Geraci in patria dipinse molti quadri per le chiese della stessa e pe’ privati, seguendo sempre lo stile, e spesso copiando le composizioni di quell’insigne capo scuola, e più ravvivandone talvolta il colorito, come in quello di S. Ferdinando di Castiglia nel tempio del R. Castello, atterrato con la fortezza nella rivoluzione del 1860. Egli era buon frescante sull’esempio del D’Anna e dipinse in quella maniera le Anime del Purgatorio nella volta del tempio di S. Orsola quasi copiando l’egual soggetto da quello dipinto in S. Matteo in Palermo. Condusse a olio il quadro dell’Angelo Custode nella chiesa della Nunziata in Termini, ed ivi S. Agata in quella di Gesù e Maria, e S. Bartolomeo nella Gancia. Il miglior suo quadro è forse quello sulla morte del B.to Agostino Novelli nella Parrocchia. Rapportasi che il Geraci penuriasse con la sua famiglia poco ritraendo dalla pittura nonostante che fosse sollecito ed operoso e molti quadri eseguisse per varie chiese dell’interno dell’isola. Ma ciò fa credere che si contentasse per bisogno di discretissima mercede. Dicesi che il padre Fedele da S. Biagio, cappuccino e fecondo pittore anch’egli richiesto una volta di dipingere un quadro da chiesa avesse detto a chi ne avea l’incarico: Andate dal Geraci e ve lo dipingerà bene se lo pagherete bene, a me non occorre denaro essendo un frate provveduto di tutto dal mio convento e trovandomi occupato sempre a dipinger quadri per le chiese della mia religione. L’Ugdulena poi che era agiato attendea la pittura più qual dilettante che professore e spesso donava i suoi quadri alle chiese ai particolari ottenendone regali o ringraziamenti. Egli dipingeva più per l’amor della gloria che pel guadagno. Le sue migliori sono le seguenti: ***. Il Geraci cessò di vivere in prolungata età verso la fine del secolo XVIII o nel cominciamento del seguente e l’Ugdulena ***. Secolo XIX Pittura e vasi fittili moderni imitanti i greco-sicoli Libertino Cardella227 nacque in Girgenti o negli ultimi anni del secolo _________________________________ Libertino Cardella, pittore, nato ad Agrigento nel 1778, vivente nel 1845, non si conoscono luogo e data di morte. 227 343 XVIII, o nei primi del seguente. Avviatosi nella carriera ecclesiastica, ed eccitato intanto dall’amore per le belle arti recossi in Palermo e vi fu allievo del celebre pittore Giuseppe Patania sotto la direzione del quale non solo progredì nel disegno figurativo, ma cominciò a dipingere e a copiar bene i quadri del maestro, imitandone il colorito. Ritornato in patria diessi alla composizione di storie sacre e profane. I suoi dipinti per quanto fossero graditi non gli apprestavano mezzi di sussistenza. All’occasione dell’arrivo in Girgenti di S.E. Pietro Ugo marchese delle Favare Luogotenente generale in Sicilia volle offrirgli un suo quadro di argomento istorico per procacciarsene la protezione e difatto in seguito giovogli, come vedremo. Io osservai quel quadro nel palazzo del marchese Ugo, e indovinai che l’autore era stato allievo del Patania per la somiglianza del colorito. La protezione di quell’alto personaggio essendogli allora tornata infruttuosa, e scorgendo il Cardella che i suoi quadri o non eran ricercati, o meschinamente pagati imprese a speculare d’imitar gli antichi vasi greco-sicoli de’ quali in Girgenti molti si eran disotterrati e o veniva a gran prezzo comprati dagli stranieri ed alcuni conservavansi da intelligenti amatori del paese. Dopo diligente studio sulle svariate forme dagli antichi fittili, cavando de migliori i disegni delle figure anche dalla incisione dell’opera di Amilton228 e di altra che ne accompagnano le illustrazio [!], giunse ad imitarne la leggerezza col decantare la creta, e l’eleganza delle forme delineandovi esattamente le figure. Però non pote mai il segreto della vernice nera degli antichi, si aderente alla creta e sempre lucida che si osserva nei fondi de’ vasi, e che i chimici stessi non hanno saputo finora indovinare. Ma il Cardella vi supplì con vernice a spirito, che è poco durevole e facilmente sfregata collo spirito si toglie, laddove l’antica resiste. Nulla di manco quella speculata dal Cardella illudeva per modo da ingannar sin anco i conoscitori che non facevano l’esperimento dello spirito. Molti vasi si fattamente imitati fece e vendette a gran prezzo a’ forestieri che li credevano antichi. Raddoppiando studio e diligenza ne modellò uno di straordinaria grandezza e vi delineò più ordini di figure con la maggiore eleganza, talchè inorgoglitosi della riuscita dell’opera, che riguardava come suo capolavoro, ad imitazione de’ pochi229 pregevoli antichi, su cui l’artefice scriveva il _________________________________ 228 William Hamilton, Pitture de’ vasi antichi posseduti da sua eccellenza il sig. cav. Hamilton... Edizione prima fiorentina, Firenze, presso la Società Calcografica, 1800-1803, 4 v. 229 Segue cancellata la parola: “più”. 344 suo nome, anche il Cardella volle segnarvi il suo in minutissime lettere greche e lo confinò in un canto ov’era poco visibile. Quel vaso creduto greco-sicolo da un ricco inglese e da lui comprato a rilevantissimo prezzo, fu230 trasferito in Londra, ed esposto all’ammirazione de’ conoscitori, che lo giudicarono opera insigne antica, senonche un di loro più diligente, vi scoprì colla lente un nome in greco, e però lo credette di maggior pregio; ma al leggere il nome Cardella, l’inglese che l’avea comprato avvertì ch’era quello del venditore ch’egli per memoria avea notato nel tacuino. Allora s’accorse dalla fraude, e dopo alquanti mesi ritornò di proposito in Girgento col vase, e recatolo in casa del Cardella, gl’impose con minacce di riprenderselo e restituirgli il denaro, e ciò dovette eseguire l’artista senza replica. Il Cardella nonostante queste231 geniali occupazioni, dopo il 1820 s’impicciò in una setta liberale, e fu arrestato e condotto a Palermo, racchiuso in rigidissimo carcere nel nostro castello, ove per le incontrastabili prove temea, come tanti altri di dover essere fucilato; ma un bel giorno, ricercato nel carcere per essere interrogato dalla Commissione militare, era disperso fu creduto allora che ciò era avvenuto per la potente secreta influenza del marchese Ugo, memore del merito di quell’artista, e di ciò è pur giusto applaudirlo. Il fugitivo Cardella non si sa ove siasi recato, né mai si è avuto più nuove di lui. Convien supporre ch’egli sia morto in estero paese ove rifuggiosi; perocche nelle successive rivoluzioni dal 1848 a 60 non fece più ritorno, come con sicurezza il potea, in Sicilia. Notizie storiche in Palermo Nella chiesa di Monserrato a Palermo si osservano molte pitture di Pietro dell’Aquila232 sì affresco che ad olio. Fra quelle233 ad olio si osservano S. Benedetto che sale in cielo con due angioli e sotto vari monaci dell’ordine Benedettino. Altro suo quadro ad olio dell’altare di contro rappresentante la _________________________________ Seguono cancellate le parole: “da lui” Segue cancellata la parola: “artistiche”. 232 Pietro Dell’Aquila, pittore e incisore, nato a Palermo (o a Marsala o a Mazzara) intorno al 1630 e morto ad Alcamo nel 1692. 233 Seguono cancellate le parole: “a fresco”. 230 231 345 Madonna col Bambino S. Gregorio Magno e la chiesa Romana in una nobile e dignitosa donna. In S.ta Cita havvi un intera cappella nel Tè a man234 destra di chi entra a fresco dello stesso dell’Aquila. Nella chiesa del Monistero di S.ta Teresa nel cappellone vi sono due suoi grandissimi quadri ad olio, cioè, il padre che abbraccia il figlio prodigo pentito ed altro rimpetto di sacro argomento. Nel palazzo del principe di Cutò vi erano moltissimi quadri ad olio nelle sovraporte e a fresco nelle volte, e fra questi il ritratto del celebre capitano e letterato Giovanni Filingieri, sinatore di Roma. Nella chiesa di S. Pietro martire vi sono quattro quadri ad olio di sacro argomento riguardati come belli fra le sue dipinture. Egli si esercitò in Roma nell’incisione ad acquaforte ed a bulino insieme col suo fratello Francesco235, ritraendo gran parte degli antichi monumenti. Le sue tavole in rame sono molto pregiate. <Giuseppe Patania>236 Da Giuseppa D’Anna cugina del celebre pittore Vito D’Anna e da Giacinto Patania oriundo da Aci Reale nacque in Palermo sul bastione dello Spasimo Giuseppe a ***. Suo padre sarto di professione, e la madre levatrice poco si occupavano dell’educazione del giovinetto; ma l’ava materna per nome *** e Antonina Benevires sorella del padre se ne diedero la briga, e l’avviarono alle pubbliche scuole ove poco profittò, occupandosi in preferenza a modellar figurine in creta. La zia Antonina volendo secondare la inclinazione del nipote l’introdusse presso un modellatore di figure di Desir per nome Mariano nel cui studio rimase per due anni dedito più presto a’ suoi servizi domestici che ad altro. Lavorava bensì alla forma delle piccole foglie di quercia, e di soppiatto faceva delle figure. Il suo maestro intanto scorgendo che il giovane allievo mostrava de’ talenti, ed essendo geloso della sua professione lo mandò via. L’ava allora gli procurò un introduzione nello studio di pittura del Velasques per mezzo dell’architetto Attinelli.237 _________________________________ Segue cancellata la parola: “sinistra”. Francesco Faraone Dell’Aquila, incisore, nipote di Pietro Aquila, nato a Palermo nel 1676 ca., attivo a Roma dal 1690 al 1740. 236 Vedi nota n. 11, p. 289. 237 Sulla c. 80r: “Patania”. 234 235 346 Pittura siciliana Pietro Ruzzolone238 da Palermo Secolo XV Di Pietro Ruzzolone pittore palermitano aveva fatto encomî il p. Amato nell’opera sua De principe tem. Pan.239 come uno dei migliori seguaci dello stile raffaellesco e il Mongitore nel suo manoscritto degli artisti siciliani240 li aveva ripetuto, ma né l’uno né l’altro riflettè che Raffaello nacque quando il Ruzzolone era già pittore provetto e quindi non potè egli seguire lo stile; ma piuttosto quello241 di Pietro Perugino maestro del Sanzio. Laonde fu dal Ruzzolone adottato nella sua242 giovinezza e che era altronde conforme243 alla prima maniera di Raffaello, come ho osservato in Perugino così puossi tra loro in alcune parti incontrarsi244 qualche somiglianza di pennello. Mongitore accenna che del Ruzzolone eravi un quadro nell’altare maggiore della chiesa di S. Pietro martire in Palermo rappresentante il titolare e dipinto sopra legno. Avendone io fatto ricerca mi fu detto che da’245 precedenti confrati non sono molti anni fu convertito in un tavolino pei superiori. Altri suoi quadri col suo nome non ho potuto incontrare in questa città, forse avvene qualcuno246 anonimo tra molti che abbiamo nella chiesa e nella galleria della R. Università che nello stile mostrano appartiene a quell’egregio artista l’andamento pittorico del secolo XV. Però dobbiamo alla diligenza e alle cognizioni pittoriche247 del cav. Di Micheli di avere incontrato e verificato con un contratto del 1483 di essere stata dipinta con molte sacre figure una magnifica e grande croce pel Duomo di Termini248. Altra alquanto variata nella figura ne fu da lui scoverta in Caccamo nella chiesa di S. Francesco. _________________________________ Vedi nota n. 1, p. 287. Giovanni Maria Amato, De principe templo Panormitano libri 13… Panormi, ex typographia Joannis Baptistæ Aiccardo, 1728. L’elogio non è di Amato, ma di Francesco Baronio Manfredi, De majestate Panormitana libri IV, Panormi, apud Alphonsum de Isola, 1630, lib. 3, p. 102. 240 Antonino Mongitore, Memorie de’ pittori, scultori… cit., p. 136 corrispondente al f. 225 del manoscritto conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo ai segni QqC63. 241 Seguono cancellate le parole: “la maniera”, “quello”. 242 Segue cancellata la parola: “prima”. 243 Seguono cancellate le parole: “a quella di Raffaello. Laonde”. 244 Segue cancellata la parola: “conformità”. 245 Seguono cancellate le parole: “gli antichi”. 246 Seguono cancellate le parole: “di quei”. 247 Segue cancellata la parola: “artistiche”. 248 Ignazio De Michele, Sopra un’antica croce … cit. 238 239 347 Del Ruzzolone vi sono opere segnate fino al 1520 quando appunto morì Raffaello. Or supposto che il Ruzzolone quando dipinse la croce di Termini, cioè, nel 1483 avesse almeno 25 anni di età essendo quell’opera di artista249 provetto dovette egli nascere verso il 1455 e morire oltre i 75 anni, perocchè nel 1520 dipingeva ancora. Ed essendo egli nativo di Palermo recar deve meravigliar di non250 trovarsi suoi quadri nelle nostre chiese essendosi barbaramente devastato quello di S. Pietro martire come dissi251 e all’incontro alcuni essersene rinvenuti nelle altre chiese delle subalterne città dell’Isola nostra. Quale essere potè la ragione di ciò, credo io poterla indovinare. Dopo il 1520 era ritornato in Palermo sua patria il celebre Vincenzo Anemolo252 che frequentato avea la scuola di Raffaello e imitato il colorito dei veneziani e il chiaro scuro di Leonardo da Vinci; onde era riuscito nel disegno delle teste, nell’estremità e nei panneggiamenti pittor raffaellesco dell’ultima maniera e assai miglior pittore del Ruzzolone che riteneva ancora253 l’antico far peruginesco. Tutt’i lavori della capitale furono quindi affidati ad Anemolo e al Ruzzolone rimasero quelli delle altre città subalterne254, sembra bensì che costui abbia migliorato nel colorito dopo il ritorno in Palermo d’Anemolo, perocchè mi è stato riferito dall’intelligente cav. Di Michele che le figure della croce istoriata di Caccamo abbiamo un colorito più vivace e gustoso di quelle della croce di Termini. In ogni modo il Ruzzolone fu certo uno dei migliori pittori255 che nel secolo XV si possono vantare tra i nostri. L’anno di nascita, e di morte di Pietro Vannucci, detto il Perugino (1)256, bene si accordano con l’età del Ruzzolone ed è probabile ch’egli avesse frequentato la sua scuola o ne abbia studiato i dipinti, talchè il suo stile come mi è stato assicurato dal cav. Di Michele sente del Perugino. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “un uomo”. Segue cancellata la parola: “riscontrarsi”. 251 Seguono cancellate le parole: “trovandosene alcuni in quelle delle città del regno”. 252 Vincenzo Anemolo è da identificarsi con Vincenzo degli Azani da Pavia, detto anche Vincenzo Romano, pittore nato a Pavia nell’ultimo ventennio del Quattrocento e morto a Palermo nel 1557. Il cognome Ainemolo o Anemolo è riferito dal Mongitore, sulla base della testimonianza del cappellano della Confraternita di San Pietro Martire, cui il pittore pare appartenesse. 253 Seguono cancellate le parole: “la maniera”. 254 Seguono cancellate le parole: “e pare”. 255 Segue cancellata la parola: “siciliani”. 256 A c. 81v nota in calce: “(1) nacque nel 1446 e morì nel 1524.” 249 250 348 Francesco Zerilli257 da Palermo pittore paesista Francesco Zerilli nacque in Palermo da un Giuseppe e da una donna di cui ignorasi il nome verso il 1793. Il genitore era cameriere del monistero ed ospizio dei Benedettini e scorgendo l’inclinazione del giovinetto per la pittura l’avviò alla scuola del celebre cav. Giuseppe Patania. Questo insigne professore può riguardarsi come onnigeno pittore di quadri di storia, di ritratti e anche di paesaggi. Egli fu il primo, a vero dire, che trattò questo genere con buon gusto e verità e fedele imitazione della bella natura. Nella sua prima gioventù quando non era oppresso da mali che gl’impedivano di uscir di casa ritraeva dalle amenissime campagne de’ dintorni di Palermo schizzi a matita e ne aveva riempito i suoi cartoloni e così pure di animali. E ritenendo le tinte di memoria o pure per accenni dipingeva ad olio i suoi paesi raccozzando le varie parti dei diversi siti che avea ricavato ne258 dipingeva ad olio paesi259 che mostravano una bella originalità, ma260 tutta ricavata da natura. Il Patania fu felicissimo e svariato nel grandeggiare nella degradazione dei mari e dei monti261 ed arieggiare nelle acque brillanti di luce, nelle rupi e ne’ tronchi di alberi talchè acquistossi al suo tempo pure gran fama come buon paesista oltre quella generalmente più consentita di felice inventore ne’ ritratti ne’ suoi schizzi istorici e nell’esecuzione dei piccoli quadri a cavalletto e segnatamente per la grazia e vivacità dell’esecuzione. Il giovane Zerilli che per genio era trascinato più al paese che alla figura guardava attentamente le opere del maestro in tal genere, che ne divenne imitatore; come lo fu anche il cappuccino *** e Giuseppe Tripi egregio pittore ornamentista. Il Zerilli bensì che intendea più di proposito a trarre vantaggio dal paese come sua sussistenza preferì a’ colori ad olio quelli più pronti a tempra e disegnò tutti i contorni di Palermo anche la topografia a volo di uccello o in prospetto dal mare; talchè col corredo di questi disegni abbozzati in colori a gomma e poi ricopiati in grande con somma abilità adescava i nazionali e principalmente gli stranieri esponendoli nel suo studio a pian terreno vicino Porta Felice. Bentosto fu affollato di vendite e di commissioni, perocchè i suoi paesi ritraevano fedelissimamente le nostre belle _________________________________ Francesco Zerilli, pittore, nato a Palermo nel 1794 ed ivi morto nel 1837. Segue cancellata la parola: “formava”. 259 Segue cancellata la parola: “originali”. 260 Seguono cancellate le parole: “faceva secondo”. 261 Al margine cancellate le parole: “a diversità dell’aria”. 257 258 349 scene campestri, la veduta deliziosa della marina di prospetto a Palermo e anche l’insieme della città,262 osservata dalla strada e da’ punti eminenti di Morreale. Nella diligenza maneggiò delle tinte adattabili a’ diversi oggetti e nella grazia era egli insuperabile e gareggiava col suo maestro Patania se non che adoprando costui i colori ad oglio e lo Zerilli quelli più variati e più brillanti a gomma nelle cassettiere inglesi adescava più gli occhi, talchè in molti anni dell’esercizio dell’arte sua visse agiatamente. Dicesi ch’egli263 frequentasse la scuola di Vincenzo Riolo,264 che pure avea tentato di maneggiare ad olio il paese, nonostante che265 era ottimo ed energico figurista ed era entrato in emulazione col Patania nel paese sin da quando il Ch.o giureconsulto Dr. Vincenzo Gagliano fe’ dipingere alcuni paesi al Riolo ed altri al Patania. Ma gli uni e gli altri volle che fossero ornati di figure istoriche. Il Zerilli si avvide che Patania superava il Riolo nel paesaggio e seguì più da vicino lo stile del pittore266. Egli sciaguratamente fu una delle numerose vittime del fatale colera del 1837 in Palermo, ed era appena giunto florido e robusto al 44° anno di sua età. Io ne feci copiare il ritratto dal Patania per la mia collezione degli illustri siciliani che riuscì somigliantissimo e ben dipinto come gli altri, ch’egli eseguimmi. Sulle arti in Sicilia del sec. XIX scultori e incisori trapanesi D.n Michele Laudicina267 trapanese fu in Vienna, ed ebbe commessa dall’imperatore l’incisione in pietra dura del suo ritratto e dell’imperatrice collocati sulle ali dell’aquila imperiale. Questa incisione si conserva nel museo di Vienna. Lo stesso artista fece il ritratto del re Francesco ed Elisabetta su due cornacopie, e con un caduceo nel centro che sostiene la corona. E’ sopra sardonica. Di Tipa268 il cavaliere Fardella Ripa ha un bellissimo Cristo, e la prin_________________________________ Segue cancellata la parola: “veduta”. Segue cancellata la parola: “pur”. 264 Seguono cancellate le parole: “eppure avea”. 265 Segue cancellata la parola: “prima”. 266 Segue cancellata la parola: “Patania”. 267 Vedi nota n. 41, p. 297. 268 Andrea Tipa, nato a Trapani nel 1725, ivi morto nel 1766, scolpì in marmo e legno, ma anche in avorio, ambra, conchiglie, alabastro e pietra. 262 263 350 cipessa Pignatelli la presentazione dei Magi con figurine di quattro pollici. Sono di avorio. Giuseppe Scudieri269, trapanese, valoroso scultore di figure in alabastro e in legno, morto nella età di circa anni quaranta in agosto 1820. In un momento di delirio lanciossi dalla sommità della sua casa. Lavorò molte opere pregevoli, fra le quali in legno una statua della Madonna di Trapani, che si conduce processionalmente ogni anno in quella città, ed in alabastro un Mercurio di due palmi circa in atto di lanciarsi a volo, forse imitato da quello di Gian Bologna. Un Moisè in selce di circa un palmo e mezzo. Castore e Polluce in marmo, circa due palmi e mezzo. Il Moisè esisteva in Marsala presso monsignor Spanò. Questo artista fu maestro elementare di figura dell’incisore D.n Pietro Bordino. Vitta270, trapanese, spedito dalla sua comune in Roma per imparare l’incisione pochi anni prima del 1836. Fece molte opere a bulino, che furono graditissime ai conoscitori. Nel cominciamento del secolo XIX fiorirono un certo Genovese271 di cognome; ma nativo di Trapani. Fu educato in Roma nella scultura a bulino sì per la figura che per gli ornati. Protetto dal suo concittadino generale Fardella allora ministro di guerra in Napoli ottenne ivi l’impiego di incisore nella R. Topografia e molti lavori fece per la medesima e altri in particolare anche di figura che per la diligenza furono ammirati. Egli segnalossi bensì nell’incidere fiori come ho potuto osservare in un piccolo festone di essi che adorna il nome del suo mecenate Fardella per biglietto di visita che ei lasciava di gusto squisito272. Osservazioni del p. Carmelo Narbone […] ex gesuita professore di filosofia e belle lettere morto di circa anni 63 nel 1860 _________________________________ 269 Per Giuseppe Scuderi cfr. Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione… cit., p. 257. 270 Per Giuseppe Vitta cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori siciliani diligentemente raccolte da Agostino Gallo (Ms. XV.H.16.). Trascrizione e note di Angela Anselmo e Maria Carmela Zimmardi, Palermo, Regione siciliana. Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, 2000, p. 121-122. 271 Per Michele Genovese cfr. Agostino Gallo, Notizie intorno agli incisori… cit., p. 121. 272 Incollato a piè di pagina il biglietto da visita del generale Fardella su cui è scritto: “Genovese fu valente incisore in rame. Nacque in Trapani. Lavorò nella Tipografia Reale di Napoli, nella quale fu impiegato per opera del generale Fardella”. 351 Corpo deposto273 del r.p. Alessio Narbone della Comp. di Gesù274 Nato in Caltagirone, l’agosto del 1789, da pii consorti il dottore in medicina d.n Giuseppe e d.na Carmela Blandini, par succhiasse col latte l’amore alla275 virtù ed alle lettere del che col crescer degli anni dava prove ognora maggiori, infinchè nel 1806, abbandonato il mondo, venne in Palermo, ove, da pochi anni in fuori, visse per sempre, per entrare nella Compagnia di Gesù. Se, durante il biennio del tirocinio, fu divoto ed edificante, fatti al fine di quello i voti semplici, da lui privatamente anticipati d’un anno, senza lasciar d’essere appresso quel di prima, diessi con ardore agli studi, talchè dopo fatta con plauso pubblica difesa filosofica, fosse inviato a Modica per insegnare umanità e rettorica in quel collegio276 riaperto l’anno stesso 1812, il che fece con molta riputazione del suo nome e pari utilità de’ discenti per un triennio; e finito il corso teologico e già sacerdote da un anno, ne sostenesse pur in pubblico e maestrevolmente ben dugento ponderode tesi, comechè la sua preparazione stendesi a quattrocento. E277 rispondendo a que’ di dottrina278 gli sperimenti di religiosità279, dal marzo del 1825 ammettavasi alla solenne professione de’ quattro voti propri dell’Istituto. Oltre alla Rettorica che ripetutamente280 insegnò, la Lingua greca, la Logica, e la Metafisica colla Matematica, la Scrittura, la Storia ecclesiastica, la Canonica, la Teologia dogmatica, e questa per anni venti. Fu prefetto delle scuole inferiori del Collegio Massimo assai lungo tempo e della biblioteca pubblica e della privata del medesimo; Esaminatore giurato del sapere di chi trà suoi s’avesse a giudicare idoneo alla solenne professione; Consultore ed Ammonitore del Rettore dello stesso collegio; Elettore del nuovo preposito generale, a nome della siciliana provincia, nella congregazion generale del 1827 in Roma; Storiografo della provincia medesima; Esaminator sinodale, dal 1830; regio Revisore de’ libri da pubblicarsi, dal 1836; Teologo della Monarchia ed Apostolica Legazia dal 1846; Socio delle principali Accademie dell’Isola e segnatamente della _________________________________ Seguono le parole: “dal di lui fratello il celebre”. Seguono le parole: “e sull’artic. biografico di Giu. Pitrè”. 275 Segue cancellata la parola: “pietà”. 276 Segue cancellata la parola: “allor”. 277 Seguono cancellate le parole: “e presi sopra lui”. 278 Segue cancellata la parola: “Appresso”. 279 Seguono cancellate le parole: “ e dottrina”. 280 Segue cancellata la parola: “professò”. 273 274 352 palermitana, prima del Buongusto, dal 1818, poscia di Scienze, Lettere ed Arti, dal 1832, levato successivamente quivi a gradi onorevoli;281 e nel Congresso de’ vescovi dal 1850 si volle la facesse da Segretario. Le tante incombenze, egregiamente da lui eseguite, non gli erano d’impedimento a comporre282 le sì numerose opere onde sol parte vide la luce. Alle riportate però dalla sua Bibliografia sicola283, qual apparato, premessa alla Storia letteraria sicola284, si vogliono aggiugnere quelle altre285 le quali286 ricordansi nel Catalogo ragionato che delle stesse sue opere edite o inedite, poc’anzi all’ultima sua malattia da lui medesimo si dettava, perita però287 molte delle inedite e parte d’esso catalogo come vedrossi più sotto. Nè distoglieanlo dall’udire le confessioni de’ suoi o degli esterni, massimamente scolari, prigioni e gente povera e bassa; o dal predicare288 che spesso era, oltre a’ suoi conreligiosi, nella chiesa del collegio agli scolari, nella congregazione di s. Luigi di esso collegio, composta di giovinetti scelti tra quelli, della quale fu perpetuo direttore ed alla quale aggiunse il Ristretto di s. Stanislao per gli scelti in tra la detta congregazione; nel Gesù ove il pubblico ne udì anche il quaresimale, l’annuale, ed orazioni per ogni più splendida e straordinaria congiuntura; in monasteri di sacre vergini all’occorenza d’avvento, di quaresima, d’esercizi spirituali; di altro ad ogni sorte di adunanze come quando per gli esercizi concorrevano nel duomo i funzionari e gli impiegati ovvero il clero secolare e regolare289. Anzi il vigor dello spirito talmente suppliva in lui alle forze del corpo da sostenere le gravi fatiche di missionario in varie città riguardevoli dell’Isola, col farla più volte da capo. Assistette caritatevolmente a’ colerici nel 1854 e molto più nel 1837, in pro loco290 consecratosi presso a un mese, ed a’ feriti che trasportavansi nel convento di S. Anna nel 1848, ed a’ giustiziati nel 1851, siccome ascritto alla Congregazione de’ Bianchi. Ma lo zelo pe’ prossimi, concepito nel noviziato, nutrito negli studi, _________________________________ Segue cancellata la parola: “Segretario”. Seguono cancellate le parole: “assai molte”. 283 Alessio Narbone, Bibliografia sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, Palermo, stamperia di Giovanni Pedone, 1850-1855, 4 v. 284 Alessio Narbone, Istoria della letteratura siciliana, Palermo, Stabilimento tipografico Carini, 1852-1863, 12 v. 285 Segue cancellata la parola: “inedite”. 286 Segue cancellata la parola: “invengonsi”. 287 Seguono cancellate le parole: “buon numero di loro nel sono da ricordare”. 288 Segue cancellata la parola: “assiduo”. 289 Seguono cancellate le parole: “pel fine degli esercizi”. 290 Seguono cancellate le parole: “impiegandosi dì e notte”. 281 282 353 notabilmente cresciuto all’ora del sacerdozio e a quella della solenne professione, non era da lui posto in opera che coll’intedimento di santificare sé stesso, come fan fede indubitata i suoi ricordi in molti luoghi privati e di proprio pugno i quali, per sorte campati con altri suoi scritti dalla ruba e da’ danni del sacco291 che dirò, si son avuti con gioia alle mani. E se il concetto che s’avean di lui i suoi e gli altri quanti l’ebbero conosciuto, era quello d’un gesuita egualmente virtuoso che dotto; egli era davvero un di coloro qui esuriunt et sitiunt justitiam ed il proponimento da lui fatto al principio di sua carriera religiosa e che ne’ su cennati ricordi si rinviene: “Non solamente non perderò l’anima con un peccato mortale, e non le recherò detrimento con un veniale deliberato; ma nè anche lascerò un minimo grado di grazia o di gloria per tutto il mondo”, regolò tutta sua vita. Però la lezione de’ libri spirituali frà quali a lui sempre carissimo quello De celesti conversatione del p. Natale; la meditazione santa da parere in essa come assorto e dandovi, in virtù di voto, tempo oltre il prescritto; il rigido esame generale e particolare della coscienza; il diligente registro delle cose dell’anima; il frequente render conto intorno ad esse ai superiori; il ritiramento d’un giorno in ogni mese conformemente a un secondo voto oltre varî altri alla ricorrenza di vigilie, di feste, o del suo proprio natale, de’ suoi voti religiosi, del suo sacerdozio, della sua solenne professione; l’assistenza cotidiana a più messe oltre al dire la propria; le spesse visite al Divin Sacramento, stando in casa o, uscendo fuori, per le chiese della città; la divozione alla sacra Infanzia, alla Passione, al Cuore di Gesù Cristo e a quello della divina Madre, il culto dei quali Cuori per un terzo voto s’era obbligato a promuovere; il prender parte ad ogni sorta di sacre alleanze, come alla Propagazione della fede, a diffonder la quale e non poche altre ei parimenti impiegavasi; il praticare per sé quanti atti292 religiosi insinuava ad altri colla voce e co’ libretti in istampa; e finalmente il perenne esercizio della presenza di Dio con profondo sentimento intorno al medesimo e con indirizzare a Lui l’intenzione in tutto ciò che faceva. Or mentre la sua pietà era d’ordinario coronata dal dono delle lagrime, persuaso egli che il generale e necessario strumento della perfezione cristiana e religiosa è l’annegazione e mortificazione, estendeva questa fino à moti primi, talchè poi, contro al vero, creder si potesse flemmatico. Severa custodia de’ sensi, rari passeggi; scarso uso de’ sollievi soliti accor_________________________________ 291 292 Seguono cancellate le parole: “la dichiarazione del quale tuttora si differisce”. Seguono cancellate le parole: “di pietà”. 354 darsi a’ suoi confratelli, poco sonno, astinenze a mensa, e digiuno, con un quarto voto promesso, i venerdì e i sabbati tutti dell’anno, ed in pane ed acqua, almen per metà, le vigilie delle principali solennità, e disciplinarsi, e portar la catenella ed ciliccio. Esimio nell’umiltà trovava in ogni cosa i motivi d’esercitarla al cospetto di Dio e al paragone degli altri, qualunque fossero. Ella gli era norma nel vestire, nel parlare, ne’ portamenti tutti, e suggerivagli di ministrare a’ poveri nella porteria del collegio, di servire293 i suoi fratelli a tavola, e di palesare allor che e’ vi sedeano, ginocchioni, a capo chino, a mani giunte, suoi mancamenti294 a tutti loro, chiestane da’ superiori la licenza e295 fattasi imporre la penitenza. Nel faticare tanto per Dio, senza mira di nulla umana ricompensa, vedeasi la sua carità la quale egli spingeva all’eroismo quando, col suo patriarca Ignazio, prescindeva dall’acquisto della gloria celeste: vedeasi nel patire per Dio, spezialmente il lungo corso delle malattie che lo finirono. E mercecchè rinosceva Dio stesso nel prossimo, lungi dal fare a296 veruno ancor minima offesa, usava affabilità ed ogni termine di rispetto con chicchessia ancorchè difettuoso; e le offese a sè fatte ricambiava con cortesie e benefici, massimamente verso il creduto avvelenatore d’una sua sorella. Specchio di regolare osservanza, amava sommamente la sua Compagnia, conoscendo sì bene dal molto studio sull’Istituto, sulle storie di lei, sulle opere di que’ dell’Ordine, quanto e quale strumento ella fosse della gloria di Dio e del297 bene delle anime: e pigliava motivo d’amarla dalle stesse persecuzioni d’essa. La onorò col298 sua condotta, la illustrò e difese dalle calunnie cogli scritti né mai cessò di procurarne a tutt’uomo i vantaggi spirituali e letterarî, professandosele debitore d’ogni suo sapere. Nell’immensa afflizione per lo scioglimento alla medesima imposto del 48 qui in Sicilia come in299 quasi tutta l’Italia, ottenne ricovero nel convento di S. Antonino ove edificava que’ religiosi, intervenendo al canto dell’ufficio del coro, e300 prendendo insieme con301 essi il lor comune ali_________________________________ Seguono cancellate le parole: “a mensa”. Seguono cancellate le parole: “alla comunità ond’era membro, insieme adunata per la refezione”. 295 Seguono cancellate le parole: “la prescrizione del”. 296 Segue cancellata la parola: “questo”. 297 Segue cancellata la parola: “vantaggio”. 298 Seguono cancellate le parole: “coi suoi portamenti”. 299 Seguono cancellate le parole: “due altre provincie d”. 300 Seguono cancellate le parole: “alla mensa”. 301 Seguono cancellate le parole: “loro e quale un di loro”. 293 294 355 mento, non pretermesse le sue letterarie occupazioni. Poscia nel 49 gli si diè ricetto e cattedra di rettorica nel seminario arcivescovile; finchè302 il novembre dell’anno stesso rientrò nel collegio a riprendere i suoi consueti uffici. Infermo303 però gravemente dal principio del 1860, non potè seguire gli altri figli d’Ignazio, banditi nel giugno dall’Isola; ed impetrò d’essere ammesso nell’Infermeria de’ rr. sacerdoti, ove i suoi libri e manuscritti e quant’altro da povero religioso avea, precedentemente trasportativi, incorso aveano il saccheggiamento e dove il 12 dicembre304 dell’accennato anno, ricevuti gli ultimi sacramenti ed assistito dal vice deputato dell’Infermeria e dal proprio germano il p. Carmelo,305 gesuita pur egli, spirò nella confidenza de’ giusti l’anima benedetta, contando d’età anni 71 di già compiti. Si ricevea con rammarico l’annunzio di tal morte e mentre altri lamentava la perdita di tanto letterato, d’un sì stimabile illustratore delle patrie cose, un affettuoso ripetere d’altri e non volgo: è morto un santo, è morto un santo,306 il che tuttor siegue a fassi, menzionati particolarmente la sua modestia ed umiltà, né mancando chi domandasse alcuna cosa di lui come di santo. Si disponeva poi da m. arcivescovo di Palermo che da’ rr.pp. Cappuccini si desse al cadavere un luogo distinto; ed appresso, correndo l’aprile del 1863 ed essendo già quello più che abbastanza rasciutto, che, da307 due testimoni riconosciuto, si serrasse in una cassa la quale dal suo cancelliere sigillata, in luogo similmente distinto si tenesse riposta. Nascimento in Caltagirone il 9 agosto del 1789, genitori di civil condizione e pii. Trasporto dagli anni primi per le cose sante e per lo studio, da secolare fino alla metafisica. Ingresso nella Compagnia in Palermo il 3 ottobre del 1806. Dopo due anni di noviziato, due di studio di Rettorica, due delle Filosofiche, quattro delle Teologiche discipline, interpostivi tra queste e _________________________________ Seguono cancellate le parole: “nell’ottobre”. Segue cancellata la parola: “poi”. 304 Segue cancellata la parola: “consecutivo”. 305 Seguono cancellate le parole: “dell’Ordin medesimo”. 306 Segue cancellata la parola: “come”. 307 Segue cancellata la parola: “quattro”. 302 303 356 quelle tre altri d’insegnamento d’Umanità e Rettorica, e terminato il corso d’entrambe con pubblica difesa di numerose tesi date alle stampe308. Sacra ordinazione sulla fine del 1818; professione solenne di 4 voti che in riguardo di virtù e di dottrina s’accorda nell’Ordine, nel marzo del 1825. Vita fino all’ultima malattia durata un anno, di applicazione indefessa, di grande austerità ed esemplarità, in continuo esercizio di zelo, spezialmente rispetto alla gioventù studiosa ed alla povera e bassa gente, per tacer ciò che spetta a’ suoi confratelli. Predicazione frequente al Gesù di Palermo, ov’anche se ne udì il quaresimale e l’annuale, oltre alle orazioni per ogni splendida e straordinaria occasione; ed in altre chiese come nel duomo per gli esercizî del clero e per quelli de’ funzionarî ed impiegati; e in varî monasteri d’uomini e di donne; sempre con comune soddisfazione. Sacre missioni in diverse e ragguardevoli città dell’Isola, con farla anche da capo. Assistenza a’ colerici nel 1854 e molto più nel 1837, ed a’ feriti, nel convento di s. Anna nel 1848, ed a’ giustiziati nel 1851, come ascritto alla Congregazione de’ Bianchi. Magistero, oltre quel ripetuto di Rettorica, di Lingua greca, di Logica, Metafisica e Matematica, di Sacra Scrittura, di Storia ecclesiastica, di Canonica, di Teologia dogmatica, il quale ultimo fu ventenne. Prefettura di più congregazioni di spirito, degli studi inferiori, della biblioteca pubblica del Collegio. Qualità d’uno de’ 3 Elettori del Preposito generale, spediti dalla gesuitica provinciale di Sicilia alla general Congregazione del 1829 in Roma; deputazione dal 1830 di Esaminator sinodale; dal 1836, di regio Revisore de’ libri da pubblicarsi; dal 1846, di Teologo della Monarchia ed apostolica Legazia. Ammissione alle principali accademie dell’Isola, e segnatamente alla palermitana del Buon-gusto, nel 1818, ed a quella che le succedette di Scienze e di Lettere, nel 1832, ove fu Anziano, Segretario generale e Direttore della 2° Sezione. Nel 1848, sciolti i collegi, ricovero nel convento di s. Antonino, e309 l’anno appresso nel seminario arcivescovile e quivi cattedra di rettorica: _________________________________ Alessio Narbone, Theses philosophicae publicae disputationi propositae facta cuilibet post tertium arguendi potestate, Panormi, typographia Philippi Barravecchia, 1812. 309 Segue cancellata la parola: “poi”. 308 357 nel 1860 complicazione di gravissime malattie che non gli consentono d’ire in bando; e ricetto nell’Infermeria de’ rr. Sacerdoti ov’era avvenuto il sacco dei suoi libri, manuscritti ed altro. Morte nella detta Infermeria il 12 dicembre dell’anno poc’anzi notato, ricevuta, dopo la confessione sacramentale e il s. viatico, l’estrema unzione, e contando d’età anni 71 già compiti. In questo, dolersi altri della perdita d’un tanto letterato, d’un tanto insigne illustratore delle patrie cose; un ripeter altri, e non volgo: è morto un santo, è morto un santo, il che segue a farsi fin oggi; menzionata in particolare, tra le altre virtù, la modestia e l’umiltà, e non mancando chi come di santo domandasse alcun che di lui. Sepoltura presso i rr.pp. Cappuccini. Le opere edite ed inedite310 riporta la Bibliografia sicola, premessa, qual apparato, alla Storia letteraria sicola di cui s’è di fresco stampato quanto mancava a compire il tomo decimo, restando i manuscritti dell’undecimo e del duodecimo ed ultimo, dal periodo del sacco felicemente campati. Nell’indice dunque degli autori compresi in tutta la Bibliografia, posto in sul fine del 4° vol. di essa, trovasi il nostro coll’indicazione dei luoghi che parlan di lui (a)311. Articolo biografico nel giornale la Religione e la Patria312, ed altro nel Precursore313 addì 31 dicembre 1860. N.B. Non si pretende in niun conto che s’abbia a far uso di tutto che è qui scritto, ma si lascia liberissima la scelta. Note a Pitrè p. 88 con un compendio dell’opera ec. Dicasi in vece: con un compendio del primo tomo dell’opera. ivi dieci volumi. Dicasi in vece: dieci tomi in dodici volumetti, stante l’essere gli ultimi due di quelli divisi in due parti o volumi. 89 Aggravato dagli anni ec. Tutto questo periodo va soppresso. ivi (1852 e seg. ec.). Si corregga: (1852-64 t.i XII) ivi Ha un’appendice ec. Si dica in vece: Siccome nel tomo terzo avvi un’appendice sopra de’ monumenti esotici, esistenti tuttora fra noi; _________________________________ Seguono cancellate le parole: “benchè molte di queste siensi perdute”. A c. 93v nota in calce: “(a) Altre nella Bibliografia non ricordate han luogo nel Catalogo ragionato che delle stesse sue opere egli dettava poc’anzi all’ultima sua malattia: benchè molte delle inedite andaron perdute nel suddetto saccheggio.” 312 Religione e Patria, Palermo, 1860, a. I, n. 11 (20 dicembre 1860), p. 87-88. 313 Il Precursore. Giornale politico quotidiano, Palermo, 1860-1870. 310 311 358 così fu disegno dell’autore che poscia il dismise, d’apporne un’altra al tomo ultimo sulla coltura ec. ivi non potè ec. Dicasi in vece: non potendo abbracciare tutti i rami storici de’ tempi appresso, si proponea darne come per assaggio uno soltanto, cioè la Storia letteraria della Compagnia di Sicilia. Indi di ciò stesso depose il pensiero in vista di suo314 mal essere: e i materiali che dicea averne in pronto, fece in gran parte lacerati315 e dispersi nel sacco di cui più innanzi si dirà. 90 Varie iscrizioni ec. Dicasi in vece: un tometto d’Iscrizioni latine e d’italiane. 91 Cessava di vivere il 13 ec. Anzi il 12. ivi Il fratello di lui ec. Se questo tratto fino alla parola Palermo non vuolsi al tutto omettere, può riformarsi così: Il fratello di lui curò l’edizione rimanente a farsi d’una parte del tomo decimo e degli altri ultimi due della Storia letteraria sicola, non essendo per una felice combinazione di cose i manuscritti a ciò richiesti soggiaciuti al pericolo del sacco anzidetto. Il medesimo conserva quegli che potè raccorre dopo quella ruba e que’ danni. Gli Annali sicoli poi della Compagnia di Gesù, in 4 vol. in folio, dalla provincia ripristinata nel 1805 fino al 59, e gli Elogi de’ suoi defunti, in un volume pari a’ cennati, eran riposti nell’archivio provinciale dell’Ordine. La storia di questo Seminario arcivescovale che dalla seconda metà del secolo scorso fino a tutta la prima del presente stese il p. Narbone, in continuazione della pur inedita del can.co Di Giovanni, si trova nella libreria dello stesso seminario. ivi chi appartiene a quella compagnia ec. Attestato impareggiabile su l’ambizione, i brogli, la misantropia de’ gesuiti! <Opere di Giuseppe Patania316> 2 quadri a fresco dal C.r Capaci. 3 volte a fresco da Atanasio. 1 volta a fresco dal P.pe di Cassaro. sovraporte del medesimo. quadro della favorita. ritratto del ragazzo di Leonforte. ritratto di M.a Amalia. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “i avversi”. Segue cancellata la parola: “irreparabilmente”. 316 Vedi nota n. 11, p. 289. 314 315 359 una volta a fresco da Siciliano. sovraporte del med. ritratto della figlia del P.pe di Villafranca. 5 paesi per Gagliano. l’origine del Ballo. i Romani che disbarcano le rapine di Verre tolte alla Sicilia. la morte di Dafne nella grotta. la statua scoperta. E l’onde del fiume. Il quadrone della trasfigurazione. Il ritratto di Susinno. un paese del brigadiere Fardella. un quadro di frutta. altri paesi prima d’allora. la divisione di Venere e d’Adone Venere di Capone quadro a fresco d’Artale Sovraporte di Sperlinga ritratto di Gargallo Paese di Quattrocchi Fiori del M.se Merlo quadro de’ Maggi. ritratto del Panittieri. ritratto della nipote D. Costanza. ritratto della figlia di Paternò due paesi di Sperlinga due altri per detto317 _________________________________ Alla c. 98 v. è scritto: “And where is the late king James II; having abdicated. L’ultimo vizio finalmente inerente alla costituzione di questo Governo è quella continua fluttuazione di potere tra i diversi corpi che si dividono l’autorità, fluttuazione difficile a prevenirsi, fluttuazione che in ultimo risultato produce l’incostanza della costituzione. All’apparenza è così, e realmente in parte è vero, ma io dirò che ove questo governo non sia nel massimo stato di depravamento ed assai la tirannide allora questa fluttuazione anzi che nuocere dee giovare, perchè essa è l’espressione dirò così del vigore della libertà, e perché non si cambia che per migliorare in una nazione che non venda la sua libertà al re. Bisogna però supporre che le prerogativea del potere esecutivo fossero stabilite, in modo tale che non dessero luogo ad equivocazione, ove la nazione non possa usurparne senza vedere che guasta guastare l’equilibrio della bilancia da cui risulta il sostegno di tutti e due i poteri, allora, costanza non può nuocere perché non si usurpa i diritti all’altra […]er trovare i mezzi migliori onde ven[…]”. In senso inverso è scritto: “fremer venti o contro i proter scelesti indegni in seno intro al turcasso i strali contro i protervi acuti stali sentio frementi lento al turcasso in seno”. 317 360 <Filippo Iuvara> Vi son di Juvara una raccolta di targhe fatta da professori primarj di Roma disegnate e intagliate dal cav. Filippo Juvara318 architetto ed accademico di S. Luca ristampata per la seconda volta nel 1722 in Roma319. Juvara ideò tre armi del porto di Messina che sono delineati nell’ultima pagina del libro in detto *** da le proporzioni pratiche per ben disegnar, dette targhe, o armi. Patania Ritratto di una ragazza del P.pe di Villafranca Ritratti di famiglia Melazzo S. Atanasio nel duomo di Palazzo Adriano Quadronetto Melazzo Patania 2 paesi 4 filosofi 1 Madonna Ritratti di famiglia320 <Vincenzo degli Azani321> Quadro di Vincenzo Anemolo rappresentante la Madonna del Rosario esistente in Lipari nella Cattedrale *** oltre altro quadro dell’epoca del 1400 rappresentante la morte della Madonna M.a Santissima nella stessa cattedrale. Altro quadro di Vincenzo Anemolo rappresentante la Circoncisione esistente nella chiesa dell’Addolorata in Lipari su al castello vicino la Madrice. _________________________________ Filippo Juvarra (o Juvara), architetto, nato a Messina nel 1676 e morto a Madrid nel 1736. Filippo Juvarra, Raccolta di varie targhe di Roma fatte da professori primarj, disegnate, ed intagliate da Filippo Juvarra architetto e dedicate all’eminentissimo, e reverendissimo principe Pietro card. Otthoboni vice-cancelliere di S. Chiesa, In Roma, per Antonio de’ Rossi alla piazza di Ceri, 1711. 320 Sul verso della carta è scritto: “Biglietti Giusep[…]”. 321 Vedi nota n. 252, p. 348. 318 319 361 Vincenzo Anemolo da Palermo Pittura del sec. XVI Dovette recarsi in Roma circa 1515 e dicesi ivi mandato e sostenuto a spesa di una dama palermitana che il sig.r Lazzaro Di Giovanni manifestavami di aver letto in un antico manoscritto di essere stata una principessa di Cattolica. Supposto che quella dama si fosse invogliata a proteggerlo dopo di averne osservato i primi saggi di pittura322 che ben promettevano la sua riuscita, egli doveva allora contare anni 20 e quindi era nato verso il 1495. Raffaello Sanzio era di 12 anni323 maggior di età dell’Anemolo. Raffaello erasi prima recato in Roma sin dal 1508 chiamato da papa Giulio II ed avea cominciato a dipingere la Sala della Segnatura, e tosto si vide affollata di scolari, attirati da quella prima opera del suo genio prodigioso. Polidoro Caldara nato in Caravaggio nel 1495 coetaneo quindi dell’Anemolo erasi anche portato in Roma nel 1511 e si pose a servir da manovale nella fabbrica delle Logge vaticane, ove scorgendo dipingere Raffaello e i suoi scolari s’accese di amore per l’arte, e cominciò anch’egli a disegnare e meritò l’attenzione e la stima del Maturino ch’ivi lavorava, e giovogli co’ suoi consigli. Disegnavano poscia324 insieme i monumenti antichi, cioè fabbriche e statue e bassirilievi. Polidoro riuscì a dipingerli benissimo a mano ormai si bene che indi fu adoperato dallo stesso Raffaello in tal genere. Anemolo conobbe allora Polidoro, si affezionò a lui e ne ottenne direzione, mentre osservava attentamente i prodigj del pennello di Raffaele nell’opera delle stanze del Vaticano. Morto Raffaello in Roma nel 1520 è probabile che l’Anemolo facesse qualche corsa a Milano per osservare le opere stupende di Leonardo da Vinci, come alcuni volsi, e l’effetto del chiaro-scuro di varie sue figure il mostrano. Dovette anche recarsi a Venezia ove i quadri di gl’impararono a colorire con maggior gusto. Ritornato in Roma, e avvenuto nel 1527 il sacco del Borbone fuggì in Napoli col suo amico Polidoro, due miserabili e furono accolti da Andrea di Salerno antico scolaro di Raffaello. S’imbarcarono poi per Messina, e fecero naufragio vicino alla spiagia di Lipari, e salvatisi a stento furono soccorsi da un negoziante. In Lipari dipinsero due quadri uno sulla _________________________________ Seguono cancellate le parole: “di lui”. Seguono cancellate le parole: “di Raffaello Sanzio e recarsi in Roma nell’anno 1515 sopra indicato”. 324 Segue cancellata la parola: “amendue”. 322 323 362 Madonna del Rosario per la Cattedrale e l’altro sulla presentazione al tempio per la chiesa ***. S’imbarcarono in seguito per Messina, e Polidoro ch’ebbe ivi affidati molti lavori vi rimase più anni e divenne agiato, ma nel 1543 fu strangolato di notte dal suo scolaro Tonno calabrese per rubargli il denaro. Anemolo assai prima era passato a Palermo, ove fece molti bei quadri, formò una scuola e morì vecchio. Il quadro della Madonna del Rosario in S. Domenico in Palermo fu da lui dipinta nel 1540. Statua antichissima In Catania in un piccolo delubro eravi un’antichissima statua di Cerere alla quale solo le donne poteano avere accesso e da donzelle era esercitato il culto ed era quindi quasi ignota agli uomini. Verre n’ebbe notizia325 e la rapì con altri monumenti d’arte alla Sicilia. / Eusebio Praep. Ev. lib. I c. 10326 Pittura in Sicilia del secolo XVI Sebastiano Bagolino327 Nacque in Alcamo da Leonardo pittor veronese ch’erasi ivi stabilito e da Caterina Tabonia alcamese a 19 gennaro 1560. Avviato ai buoni studi seguì la professione del padre, coltivò la musica e proseguendo nelle umane lettere fu diretto nell’arte poetica da Marco Gentiluccio di Spoleto e recatosi in Napoli s’innoltrò negli studj dell’arte oratoria sotto Ascanio Vopisco e quindi acquistò rinnomanza particolarmente nella poesia latina e giunse spesso a improvvisare in latino, in italiano e anche in spagnuolo e fu ammirato dagli uomini dotti del suo tempo. In Napoli aprì scuola alla gioventù nobilesca e celebrò nei suoi versi latini molti individui di preclare famiglie come Fabio Giordano, Andrea Tufo, marchese di Gargano, Adriano Spatafora ed altri molti. Ritornato in patria sposò Francesca Battiati e recatosi in Palermo divenne familiare di Francesco Moncada, principe di Paternò e fu suo precettore nella poesia e nella pittura e da quello largamente rimunerato. Alla morte di quel generoso principe avvenuta nel 1597 divenne caro a _________________________________ Seguono cancellate le parole: “il seppe”. Eusebio di Cesarea, De evangelica praeparatione. 327 Sebastiano Bagolino, pittore e poeta, nato ad Alcamo nel 1562 e ivi morto nel 1604. 325 326 363 Giovanni Orosio vescovo di Agrigento, come in Palermo al dotto e celebre Mariano Valguarnera, a Filippo Paruta, a Bartolomeo Sirillo e altri uomini dotti e restituitosi ad Alcamo e fondando ivi un’insigne scuola di poesia latina morì verso328 di febbre a 27329 luglio nel 1604. Molte opere poetiche nella lingua del Lazio principalmente e anche in italiano e in spagnuolo scrisse ed alcune pubblicò, altre lasciò manoscritte. Ignoriamo bensì il suo valore nella pittura, perocchè il Mongitore330 da cui abbiamo ricavato queste notizie tralasciò, considerandolo soltanto come scrittore, di accennare quali siano e dove trovansi in Alcamo e in Palermo. Alcune, credo io, debbansi rinvenire nei palazzi in Palermo di Paternò e di Valguarnera, e forse in alcune nostre chiese, ma non avendovi segnato il suo nome non sapremmo indovinarli. Ci basta bensì di avere accennato che questo pregevolissimo poeta latino fu anche pittore e musico. Pittura siciliana secolo XIX Salvatore Lo Forte331 da Palermo Da un barbiere nacquero Salvatore, Gaetano e *** Lo Forte. L’ultimo vestì l’abito religioso di S. Filippo Neri, gli altri due che mostravansi inclinevoli alla pittura cominciarono a frequentare lo studio di Vincenzo Riolo egregio artista e Salvatore che era il maggiore d’età fece maggiori progressi, talchè giovinetto ancora fu volto dal maestro in suo ajuto pei lavori pittorici nella riforma della332 Chiesa dei PP. Olivetani di S. Filippo Neri in Palermo ed eseguì gli angioli sotto gli archi della medesima nello stile di Pietro Novelli, ma col colorito brillante di Riolo. Dopo quel tempo acquistatasi un opinione recossi in Roma, sostenuto a spese di e frequentò per poco tempo lo studio del Camuccini e indi dessi a dipingere bozzettini che vendeva ai forestieri. Ritornato a Palermo verso il 1837 dopo alquanti anni ottenne senza concorso la direzione del nudo per la morte avvenuta del suo primo maestro Riolo che vi era addetto e convenne di rilasciare onze due del suo soldo alla vedova di quello. Erano ritornati in quel tempo da Italia Giuseppe Meli333 e Andrea D’Antoni334 e convennero con Salvatore Lo _________________________________ Seguono cancellate le parole: “l’anno 1596”. Segue cancellata la parola: “giugno”. 330 Antonino Mongitore, Bibliotheca sicula… cit., p. 213-214. 331 Salvatore Lo Forte, pittore, nato a Palermo nel 1804 e ivi morto nel 1885. 332 Segue cancellata la parola: “cappella”. 333 Giuseppe Meli, pittore, critico e storico d’arte, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1893. 334 Andrea D’Antoni, pittore, nato a Palermo nel 1811, ivi morto nel 1868. 328 329 364 Forte di cui conoscevano il merito pittorico, di collegarsi insieme per abbatter l’opinione dei precedenti ottimi artisti Giuseppe Velasquez da Palermo già morto sin dal 1827 che lasciato avea gran numero di opere e gran reputazione di se e Giuseppe Patania che meritamente la godeva con Vincenzo Riolo, amendue allora viventi e palermitani. Il Riolo bensi era trattato col disprezzo del silenzio, il Velasques col titolo di pittor di maniera / eppure era stato il primo a bandirla dalla pittura siciliana coll’imitazione del vero essendo direttore dell’Accademia del nudo e colla scorta del bello dell’antiche statue di cui raccolto avea i gessi nel suo studio, Patania però come superstite e più affollato di lavori era divenuto il sogno a cui miravano tutti i loro strali di maldicenza, e diceano di lui, e particolarmente Meli più cianciatore ed avventato, sebbene inferiore di gran lunga nell’arte agli altri due, ch’era pittor di falso, e debole colorito, ma invero non poteva ne dovea di tal difetto essere incolpato dopo di aver335 in diversi tempi poi studiato il vero e diverso colorito ne’ suoi ritratti somigliantissimi che sono circa trecento(1)336, onde in questo era riguardato come il primo e insuperabile artista. Que’ maligni co’ frizzi non poterono travolgere la pubblica opinione; talchè gli cresceano ogni giorno le commissioni; e gli fu d’uopo in una nota stabilire il tempo successivo pei lavori, che esattamente adempiva e solea dirmi che da’ soli ritratti che sbrigava in tre giorni quand’erano a mezzo busto al naturali senza mani e che facevasi pagare ducati 24 e in otto giorni a mezza figura con le mani d.ti 54 ritraeva egli regolare sussistenza, pel tempo che v’impiegava, dipingendoli alla prima, e velandoli qualche volta in alcune parti, giacchè co’ quadri da chiesa che richiedevano lungo studio e spesa di modelli, di gran tela, e di modelli pel prezzo stabilito di d.ti 240 nulla si profittava e dipingevali per amor della gloria. Lo Forte cominciò a muovergli una sorta [!] guerra e toglieva i lavori sì di ritratti, e di quadri grandi, valendosi de’ maneggi di suoi amici Daita, Peres, Castiglia,337 i due sfratati Lo Giudice e Galetti338, alcuni de’ quali a voce, altri con articoli ne’ giornali dicevano e scriveano mirabilia di questo artista vantato come genio straordinario, e si giunse a tale arro_________________________________ Seguono cancellate le parole: “per circa trecento volte”. A c. 106v nota in calce: “(1) Circa un centinaio ne dipinse per me per la collezione degl’illustri siciliani antichi, e moderni. Tutte le belle di Palermo di quel tempo ambivano di averne il suo, come magistrati, nobili, e ricchi negozianti.” 337 Segue cancellata la parola: “padre”. 338 Intendasi: “Galeotti”. Amici del Lo Forte furono Gaetano Daita, poeta, Francesco Paolo Peres, letterato e ministro, Benedetto Castiglia letterato e giornalista, Paolo Emiliani Giudici, storico e critico letterario, Melchiorre Galeotti, religioso erudito. 335 336 365 ganza e pazzia che il poetastro secentino *** Di Petra che ne avea scroccato un suo piccol ritratto scrisse un carme in cui manifestava che due geni (egli e il Lo Forte) ben si apprezzavano, e onoravansi a vicenda e il pittore avea già eguagliato Raffaello e stava per dargli di cappotto. Si rise dagli uomini del cattivo poeta fanatico, e del buono artista che nel suo stile non avea nulla del sublime ideale, e della grazia ingenua di Raffaello; ma più tosto la maniera gagliarda e caratterista della brusca fisonomia del Caravaggio, con un colorito forse più sugoso. Il Lo Forte fece la prima prova nel ritratto a mezza figura, dipingendo quello dello scultore Nunzio Morello, rappresentandolo facchinamente mezzo scombiniato [!] colla mano appogiante alla ***, e il braccio su un tavolo e una pietra. Il ritratto era somigliante ed animato; ma monotono nella tinta gialliccia predominante. Tuttavia da’ suoi amici si fece baldoria per quel mediocre dipinto, e giuntane notizia al sig.r Vincenzo Riolo, primo maestro di Lo Forte, disse un giorno a me e al sig.r d. Antonino Zeriga, che aveva impegno di vederlo; ma non volendo mostrare di ricercarlo di proposito avrebbe voluto che ciò apparisse per casualità. E’ facile a combinar questo fortuito incontro, risposimo al Riolo. Il ritratto trovasi depositato nella bottega del nevajuolo fuori porta Macqueda presso il palazzetto già del Marchese Forcella, noi vi precederemo e faremo intanto porre il ritratto sulla panca, e chiameremo voi ad osservarlo, fingendo d’interrompere il vostro passeggio. Così fu fatto ma noi, bramosi di sentir la sua opinione, lo interrogammo, che ve ne pare: egli rispose con le vocali: a, e nulla più. Riolo ch’era giudice competentissimo, e dovea anzi esser parziale pel suo scolare, non profferì una parola in lode; ma col suo silenzio, sembrommi che non rimanessene contento. E pure quel fatto, contestato da me e dall’onorato dr. Zerega egregio avvocato, alla morte di Riolo avvenuta nel colera del 1837 nella vita di lui scritta, dopo quella ch’io, immediatamente ne pubblicai339, dal frate Paolo Lo Giudice340 fra le altre bugie fu detto che Riolo che orgoglioso era per vero, abbia profferito in osservar quel ritratto: Ahi spiacemi ch’io son vecchio, che se nol fossi, vorrei divenir scolare del mio scolare. Con questi mezzi, e con la progressiva abilità cresceva la reputazione di Lo Forte, ma non giunse mai ad atterrare quella di Velasquez, di Riolo che sopravvisse pochi anni, e di Patania moltissimi essendo morto nel 1852 _________________________________ 339 Agostino Gallo, Cenni sulla vita di Vincenzo Riolo da Palermo egregio dipintore scritti da Agostino Gallo, [Palermo, dopo il 1837]. 340 Paolo Emiliani-Giudici, Vincenzo Riolo. In: Biografie e ritratti d’illustri siciliani morti nel cholera l’anno 1837, Palermo, presso G. Alleva librajo-editore, 1838, p. 203-216. 366 il quale fino allora tenne principalmente il campo della pittura in Palermo, lasciando a Lo Forte, e agli altri poche spighe rimase dalla messe. Lo Forte341 mancato il Patania, apparia indubitamente il pittore di più bello effetto di chiaroscuro, e di più vigoroso colorito, ed efficace espressione, sebbene sia povero di propria invenzione, aiutandosi spesso delle altrui per le attitudini delle figure ricavate dalla sua copiosa collezione di stampe. Egli non elevossi mai all’ideale nel disegno, neppure se dovesse trattare soggetti mitologici, e di Cristo, di Dio Padre, della Vergine Maria, o di Santi, e Sante che assunti in cielo dee supporsi che debbano avere acquistato forme342 più nobili delle consuete nel disegno quindi si per la correzione che per l’eleganza non è superiore né uguale a Velasques che migliorava il vivo dell’uomo nudo colte co’ gessi dalle statue antiche che il Lo Fonda343 [!] ha bandito dal suo studio. E’ monotono anche nel disegno i suoi modelli non sono che due, quelli dell’accademia per le figure giovanili e un certo Piediscalzi facitore di pennelli per la provetta e barbuta. Il S.n Niccolò di Bari, de’ PP. Olivetani e il S.n Benedetto sono fratelli somilissimi. Per circa 30 anni egli sudò a contrastare invano la palma a Patania, pittore di fecondissima invenzione, e sennata composizione (e basti dire che lasciò circa 600 schizzi a penna di soggetti mitologici, storici, sacri, fantastici che in buon numero io possiedo, alcuni de’ quali mostrati alla mia presenza in Napoli al cav.re Camuccini furon da lui lodati, e sol censurati per la linea di prospettiva di edifizj nel campo). Appena il Lo Forte trapelava che si volesse affidare un quadro da chiesa o altro a Patania che con maneggi, e intrighi de’ suoi amici gli toglieva il lavoro, mostrando di contentarsi dello stesso modico prezzo di d.ti 240 che poi non eseguiva, o per lite ne pretendeva il doppio o il triplo. Io avevo procurato a Patania la commissione del Cristo flagellato della chiesa della Maggione col Marchese Ugo deputato di cui fatto avea lo schizzo a penna, mercè le tante raccomandazioni dei nobili amici di Ugo fu il Lo Forte preferito allo stesso prezzo, e ottenutane l’anticipazione di d.ti 120, in tre anni non avendo fatto nulla, fu sfidato in giudizio ed obbligato a restituire il danaro e il quadro fu indi eseguito da Patania in un anno. Gli tolse anche il quadro di S. Benedetto per la chiesa di S. Maria del Bosco pel quale in sei anni avea dipinta una sola testa, e poi lo cedette344 _________________________________ Segue cancellata la parola: “morto”. Seguono cancellate le parole: “migliori e ideali”. 343 Intendasi: “Lo Forte”. 344 Seguono cancellate le parole: “per minor prezzo con la tela”. 341 342 367 al meschino pittore Battista Carini dandogli la tela e ritenendo per sé parte del prezzo convenuto. Gli usurpò anche l’altro quadro del S.n Niccolò all’Olivella commessogli dal P. Lucchese-Palli, e questi alla viva istanza del Lo Forte, dissegli se Patania a cui ho dato la mia parola vi consente, io devengo ad affidarlo a voi. Interrogato quello rispose nobilmente Io ho molti lavori e poco m’importa di quel quadro; diasi pure a Lo Forte, che il può far bene. E questa volta invece corrispose all’impegno e all’aspettativa, ed io gli ho lodato quel quadro in un giornale; sebbene son ora persuaso che la nave che si scorge tempestare non sia in buona prospettiva, e per l’effetto della luce, e delle ombre inferiore a l’altro nella stessa chiesa del beato Valfrè, ove bensì l’attitudine del povero giacente è tolta di peso da una composizione del Camuccini. Ma un fatto di più trista conseguenza avvenne per altro quadro di S. Giuseppe col Bambino commessogli dal suo amico il consigliere Castagna integerrimo magistrato per una chiesa di un monistero di Modica cui l’abadessa sua zia voleva farne dono; ma non era in grado di spendere più di ducati 180. Lo Forte negossi da pria di assentire a quel prezzo, e il Castagna dissegli dissegli [!]: Vi darò qualche cosa di più, intendendone ducati 30. Lo Forte assentì con la condizione di dovere eseguire anziché un suo originale, la copia di quello del Novelli in una nostra parrocchia. Dopo tre anni il quadro fu terminato; ma egli ne chiese d.ti 600, e gli mosse lite, profittando che non eravi convenzione in iscritto. Il giudice volle interrogare le parti contendenti. Lo Forte negò l’accordo a voce e diede al Castagna in pubblico una mentita. Quegli che era un magistrato e un uom d’onore se ne accurò tanto che ammalossi, e morì; talchè la timide sorelle eredi, per togliersi d’addosso la molestia si contentarono dargli d.ti 450. Ecco i fasti della condotta civile ed artistica di Lo Forte, la quale gli ha in conseguenza minorato i lavori di grandi quadri;345 pochi sono stati in molti anni quelli da lui dipinti;346 talchè a’ surriferiti per compierne il numero conviene aggiungere l’altro347 del beato Valfrè per una chiesa di Messina, divenuto tenebroso, e un S. Benedetto per348 quella della Gattina349 di Noto, in cui la testa del santo è bella ed espressiva, ma quel_________________________________ Segue cancellata la parola: “talchè”. Seguono cancellate le parole: “per modo che a quelli”. 347 Segue cancellata la parola: “quatro”. 348 Seguono cancellate le parole: “la chiesa”. 349 La chiesa di Noto cui fa riferimento l’autore è quella di S. Chiara. 345 346 368 la di sua sorella triviale e l’altra d’un frate goffa. L’originale modello della testa di S. Benedetto dipinta con maggior franchezza e spirito è posseduto dal Principe di Galati. Ne’ ritratti che non richiedono il talento dell’invenzione e composizione Lo Forte si portò meglio che ne’ gran quadri da chiesa. Egli ne colpiva in generale la somiglianza da esserne riconosciute le persone rappresentate, ma non con quella evidenza de’ ritratti di Patania che possono dirsi identifici agli originali con cui sembra a chiunque di sentirli parlare. Questa direi identità risaltava in parte dalla facoltà potentissima in lui di ritenere le immagini; talchè fece una volta innanzi a me prova di fare il ritratto al vero improvvisato dell’abate Filangeri suo amico, che gli disse un suo scolare esser morto la notte precedente e così fece pure pel sig.re Ignazio Sanfilippo professore alla R. Università di Palermo di Economia politica, e pel suo maestro Giuseppe Velasques, ritratti somiglianti della mia collezione degli illustri siciliani. A questa sua speciale facoltà si associava, anzi la favoriva il suo metodo di dipingere i ritratti alla prima, e senza replica di colori, laonde guardò con doppie occhiate attentamente l’originale e disegnandolo col lapis bianco, e talvolta col pennello intinto nel rosso con la maggior scrupolosa esattezza di ritratto riconoscevasi da’ semplici contorni, e con le franche pennellate con la guida del vero risultava somigliantissima. E il vero lo avvertiva a non caricare le ombre, e valersi per lo stacco dalle parti di semplici e lievi mezzetinte; perché il vero non dà ombre forti, che al lume di lucerna, o almeno nelle tarde ore vespertine. E così vidi condotto un bel ritratto di Guido Reni in Pavia ma Lo Forte usando un opposto metodo artificiale con ombre risentite tanto ineria al vero, che non le ha, quanto dà di effetto al ritratto, e se non illude più, piace maggiormente col suo stile piccanti a’ mezzani, conoscitori e artisti della scuola caravagesca, e non già della raffaellesca nemica de’ forti sbattimenti. Con queste considerazioni prenderò all’esame dei ritratti di lui per lo più a mezza figura con mani. Del primo di Nunzio Morello ho già parlato. Il ritratto del vecchio B.ne Riso seduto in un seggiolone coverto di velluto ora ammirato dagli sciocchi pel medesimo artifizio di mostrare quel drappo in alcune parti scioperato; il che era prodotto da una piccola ombra. Piaceva a molti per l’atteggiamento naturale e consueto della persona e in parte per la somiglianza; ma non piacque al Barone il quale ignaro dell’arte incolpava il pittore di avergli fatto i bianchi calzoni sporchi e non si accorgea ch’erano le ombre delle pieghe, ma invero troppo forti. Rifiutò il ritratto e fu comperato dal d.d. Francesco Franco. 369 Poi verso quel tempo dipinse quella della principessa Beaufrimont350 a mezza figura quella dama era bianchissima di carnagione, la caricò di ombre e di rosso. Essa ricusò il quadro dicendo al pittore: mi avete fatto una villana non lo voglio e fu similmente comprato dal d.r Franco, il quale facea collezione di ritratti di belle donne. Alla sua morte si credette conveniente dall’esecutore testamentario *** nel vendersi i quadri d’inviare il ritratto della principessa a lei medesima per acquistarlo a prezzo di vendita: disse, Non lo voglio, come non lo volli quando mi fu fatto, recatelo al Duca di Monteleone che forse lo acquisterà perché desiderava di sposarmi, ne si potè combinare il matrimonio. Al beneficiale Giglio aveva fatto ritratto il Patania somigliantissimo. Ne volle un altro di Lo Forte, il quale gli diè un’aria ispirata da poeta, laddove egli non era altro che un buon prete da breviario. Io fui invitato a vederlo dal p. Giglio che ne rimanea contentissimo, meno forse pel somiglio che per quell’attitudine interessante. Chiese il mio giudizio a come quel dipinto era collocato a fianco dell’altro di Patania io gli dissi: Questo è il vostro ritratto che vi rappresenta come uom dabbene, buon prete e non già qual poeta non conoscendovi tale, né io, né il pubblico. Ma rispose e spiritosamente e con arte atteggiato, ed io sorridendo replicai: Non omnibus omnia. Dipinse inoltre Lo Forte i ritratti del cav. Michele da Termini, del cav. Gioachino Ondes da Palermo, del d.r Antonio Gulli, dell’abate Longo, delle signorine Di Stefano e del consigliere Cini. Non avendoli osservato non ne dò giudizio. Vidi bensì quello del consigliere Castagna ch’essendo di carnagione pallida lo ritrasse351 con quella di un campagnuolo e in caricatura nei contorni similmente quello della sig.a Giuseppina Turrisi Colonna or posseduto dal principe di Galati, ma pregevole per l’espressione del volto. Copiò dall’originale di Patania a mezza figura il ritratto di Ferdinando 2° ma per mostrare ch’era suo originale sostituì nel campo alcune colonne alla cortina di un drappo verde. Fra tutti i ritratti di Lo Forte il più bello fu quello della sig.a Mariannina Majo, figlia del duca De’ Majo luogotenente in Sicilia. Ne ritrasse bene i contorni, la carnagione brunetta e la grazia e n’eseguì con molto artifizio gli ornamenti352 della sua toelette e il drappo nero di cui _________________________________ Leggasi Beaufremont. Segue cancellata la parola: “come”. 352 Seguono cancellate le parole: “dei dentelli”. 350 351 370 era abbigliata. Quel ritratto potrebbe meritare di essere un giorno esposto in una pubblica galleria, molto più ch’essendogli stato riferito che io l’avevo censurato per altri ritratti per le ombre troppo caricate, egli se ne astenne trattandosi di una leggiadra donzella e ne fu da me lodato come meritava. Ciò importa ch’egli potrebbe mettersi nel buon sistema di dipingere con seguire rigorosamente il vero particolarmente nei ritratti fra i quali ad eccezione di questo della signorina Majo gli altri di donne sono sempre inferiori e migliori a quelli di uomini che abbiano teste di gran carattere. Lo Forte fino al corrente anno 1865 non ha fatto altre opere d’importanza ed ora molto più havvene poche a sperare, perocchè è poco attivo e tardo nell’operare e amante di svagarsi ed ora principalmente che ha ottenuto l’accrescimento del soldo come direttore del nudo nella R.a Università di Palermo dalle meschine onze 80 a circa onze 400 annuali ed egli altronde traffica a comprare e vendere quadri antichi, su di che è bello il tacere circa ai mezzi che adopera nell’acquistarli sostituendone le copie agli originali. Ritratti di Lo Forte Mariannina Majo Barone Riso Cav. De Michele Scultore Morello Cav. Gioacchino Ondes Beaufremont principessa Galati D.r Antonio Gulli Ferdinando 2° copia da Patania Abate Longo Signorine De Stefano Cirino Cons. Castagna Beneficiale Giglio G. Turrisi Colonna B. Valfrè a Palermo, e a Messina S. Niccolò di Bari S. Benedetto a Noto monastero delle sr. Gattine Copia di S. Giuseppe per Noto 371 Francesco Lopes Sebbene il genio degli artisti è costituito principalmente dall’invenzione; pur nella perfetta e diligente esecuzione e nel gusto onde son condotte le opere avvi pure una parte secondaria di genio ch’io dirò di meccanismo qualora esso sia applicato ai lavori del bello o grazioso effetto; perocchè il bello e la grazia sono il vero scopo delle arti liberali. Franco Lopes appartiene a questa seconda classe di artisti, non ostante che operasse soltanto di commesso di marmi colorati in cui riuscì eccellente. Per tre successive generazioni i suoi maggiori esercitarono l’arte medesima da Francesco e dal suo fratello *** seguita, istruitivi dal loro gentitore. Lavori di fogliami, di fiori, e di svariati simili rabeschi in marmi colorati per pavimenti, e per cappelle, per tavolini furon da Francesco eseguiti che attiravano l’attenzione per la diligenza ed esattezza da nazionali e stranieri e quest’ultimi in gran numero recaron fuori le tavole in marmo bene ornate di Francesco e di suo fratello, che belle e fatte trovavano di varie dimensioni a diversi prezzi nella loro officina presso Porta Felice. L’opera che recò maggiore onore a Francesco fu la gran fonte contesta di diaspri con un tempietto ottagono per base che le dame di Palermo regalarono a Vittorio Emmanuele re d’Italia, la quale fu ammirata da tutti nella esposizione che se ne fece a Palermo, e quando fu inviata a Torino, e su cui scrissi io un articolo nel giornale il Diogene353 tributando all’artista i meritati elogii. Una gran prova di abilità prima dato avea allorchè per incarico affidatomi dal Senato di Palermo e da me al Lopes commesso staccò l’immenso pavimento di marmi colorati e intrecciati in vari disegni della confraterna della Pace fatta atterrare per ragioni politiche nel 1851 dal luogotenente Principe di Satriano, e ricollocava nella sua integrità e bellezza nella galleria del palazzo Pretorio. <Giovanni Patricolo> Si aggiungano se mancano le seguenti notizie all’art. necrologico del pittore Giovanni Patricola354 da Palermo stampato nel giornale il Diogene. _________________________________ 353 354 Diogene. Giornale letterario, Palermo, 1858-1889. Giovanni Patricolo, pittore, nato a Palermo nel 1789 e ivi morto nel 1861. 372 Patricolo segnalossi principalmente nel dipingere i putti e sono bellissimi quelli che fece in casa del conte Tasca fuori porta S. Antonino in Palermo come pure quelli nella casa del negoziante De Michele Lucio nella via Butera. Si distinse similmente nel dipingere a tempera o a guazzo e sono leggiadri i quadrettini di vario argomento nella volta e negli spigoli degli archi nella Parrocchia di S. Ippolito. Segnalossi egualmente nel dipingere tele quaresimali che nella settimana santa si veggono pendere nella volta dinanzi all’altare maggiore delle chiese rappresentanti la discesa dalla croce del corpo di Gesù Cristo. Egli introdusse il primo il costume di dipingerli a diversi colori al naturale, invece di essere monocromate di color turchino che invece è disgustevole. La tela a colori della chiesa del Monistero di S. Caterina è ricca di composizione e di bello effetto. È’ pure bella quella del Monistero di S.ta Teresa e inferiore l’altra della Parrocchia di S. Antonio. Il quadro ad olio del transito di S.ta Rosalia che fu da lui dipinto nella chiesa del Monistero del Salvatore sostituito a quello più antico di Giacinto Calandrucci355, pittor palermitano, non è delle migliori opere del Patricola e inferiore in merito a quello del suo predecessore. E così pur dicesi dell’altro quadro nell’altare maggiore del Monistero dell’Assunta sostituito al precedente di Giuseppe Marchese scolare del Novelli. Gli ultimi suoi quadri a tempra nella volta e ad olio nel primo altare a mano sinistra entrambi nella chiesa del Monistero delle Stimmate non sono certo de’ migliori, sebbene in quella ad olio vi siano delle belle teste senili. In Carini vi sono in diverse chiese quadri ad olio del Patricola. In Palermo l’opera migliore per feracità di composizione, armonia e buon gusto di colorito, sebbene in molte figure con poca correzione nel disegno è quella dell’altare maggiore della sudetta chiesa delle Stimmate che fu la prima opera grande ch’egli dipinse, promettendo più di quello che poi fece in progresso di anni lavorando troppo a braccio e di pratica per l’affollamento delle commissioni. Un’altra sua opera insigne è quella sul Conte Ruggiero dipinto356 a tempera in centro nella galleria del Real palazzo di Palermo in gara con _________________________________ 355 356 Giacinto Calandrucci, pittore e incisore, nato a Palermo nel 1646 e ivi morto nel 1707. Seguono cancellate le parole: “a fresco”. 373 Giuseppe Patania e Vincenzo Riolo che pur vi dipinsero alle due opposte estremità altre azioni di Ruggiero, e in esse il Patania superò Riolo e questi il Patricola. Famiglia siciliana Del Po’ cioè Pietro Giacomo e Teresa Celebri artisti Famiglia siciliana Del Po’che diè rinomati artisti Pietro Del Po’357 Nacque costui in Palermo nel 1610 forse fu allievo, ma certo imitatore del Domenichino in Roma ove esiste di Pietro il quadro di S. Leone nella chiesa della Madonna di Costantinopoli. Era principalmente ammirato per diligenza squisita ne’ quadretti di storia. Si conservavano di essi un S. Giovanni decollato e la crocifissione di S. Pietro presso i signori della missione di Piacenza. Nell’Accademia di S. Luca in Roma insegnò anatomia e prospettiva; ivi diessi ad incidere ad acquaforte e a ritoccare le stampe a bulino. Molte ne incise fra cui la Vergine con angioli del Domenichino, S. Girolamo genuflesso, la prudenza, la giustizia, la temperanza, la fortezza, S. Girolamo nel deserto sull’originale di Annibale Caracci [!], la Cananea dal medesimo, l’Annunciazione della Vergine e la fuga in Egitto dal Poussin, Nettuno sul cervo da Giulio Romano. Par che i piccoli quadri da lui ben dipinti e pure l’incisione gli abbiano dato maggior fama. Morì in Napoli nel 1692 di 82 anni. Giacomo del Po’358 Figlio del precedente. Non si sa se sia nato in Palermo o in Roma o Napoli verso il 1654 (1)359. Già per ragion del padre dalla legge è da considerarsi palermitano. Il padre gli diè i primi elementi del disegno, ma volle poi avviarlo alla scuola di Niccolò Pussino, suo amico, talchè cogli ammaestramenti di _________________________________ Pietro Del Po’, pittore, nato a Palermo nel 1610 e morto a Napoli nel 1692. Giacomo Del Po’, pittore, nato a Palermo nel 1654 e ivi morto nel 1726. 359 A c. 117v nota in calce: “(1) De Dominici Vita dei pittori, scultori ed architetti napoletani. Napoli per Trani, 1846, tom. 4, pag. 280” <Bernardo De Dominici, Vita de’ pittori, scultori ed architetti napoletani... In Napoli, per Francesco e Cristoforo Ricciardi, stampatori del Real Palazzo, 17421743, v. 3, p. 496-515>. 357 358 374 amendue riuscì egregio disegnatore e studioso di anatomia come il suo genitore e a 19 anni meritò di essere accolto nell’Accademia di S. Luca in Roma ove trovasi notato fra varî nel 1664 e gli fu conferita la carica di precettore di anatomia. Ivi dipinse il quadro del martirio di S. Lorenzo nella chiesa di Sant’Angelo in Peschiera, l’altro della beata Vergine col Bambino, S. Agostino ed altri santi che furono molto lodati, ed egli se ne inorgoglì tanto che divenne aspro censore delle opere altrui da cattivarsi molti uomini; talchè il suo genitore risolvette nel 1679 di recarlo con lui in Napoli e fu ricevuto nella congregazione dei pittori ed ivi mostrò molto valore nel disegno del nudo e venne riguardato come ottimo disegnatore col fondamento di anatomia, di che intese gelosia il vecchio maestro Francesco Di Maria360 e più si accrebbe il disgusto fra loro361 per ragion del nome di un muscolo e di un’arteria che il De Maria aveva sbagliato e indovinato il giovinetto Giacomo. Insolentì Giacomo nel trionfo e fattosi amici molti giovani pittori, non solo divenne loro maestro, ma lodato da essi e sostenuto dal merito delle sue opere condotte con amore, studio e diligenza. Fu adoprato da molti particolari in quadri da camera e indi da’ pp. Predicatori nella Chiesa di S.to Spirito di palazzo, ove rappresentò Gesù bambino circondato dagli angioli nella parte superiore e nell’inferiore vi dipinse S. Pietro e San Paolo. Nel quadro mostra ch’egli si era già piegato più allo stile di Lanfranco362 che del Domenichino, ma non è certo de’ suoi poiché superò se stesso negli affreschi di quella chiesa. Aveva egli fatto molto studio pe’ poeti latini e italiani ed eccitatasi la fantasia ideava caste composizioni di poemi pittorici con incredibili varietà di figure e bizzarrie abbaglianti per accidenti di luce, e magia di ben armonizzato colore. Questo nuovo sistema l’allontanò dalla semplicità del Domenichino trasfusagli nella prima età da suo padre, talchè trascese alquanto nel difetto di grandi frescanti macchinosi del suo secolo e in parte nel manierismo. Tuttavia il suo pennello brilla negli affreschi del marchese Genzano in una stanza del duca di Matalona e in altre sette del principe di Avellino. Francesco Solimena363, gran compositore e buon coloritore sebbene sentisse più di maniera di Giacomo che sapea all’opportunità moderarla forse per invidia o per diversità di stile sprezzava le opere di Giacomo e vi _________________________________ Francesco Di Maria, pittore, nato a Napoli nel 1623, ivi morto nel 1690. Seguono cancellate le parole: “la gara”. 362 Giovanni Lanfranco, pittore, nato a Parma nel 1582, morto a Roma nel 1647. 363 Francesco Solimena, detto l’Abate Ciccio, pittore, nato a Canale di Serino, nel 1657, morto a Barra, Napoli, nel 1747. 360 361 375 contrappose le sue che da molti furono preferiti per la fama e pe’ rapporti che godeva, di che Giacomo rimase dolentissimo e volendosi rivalere pose maggiore studio in un affresco del palazzo del principe di Cellammare ove intrecciò364 alla favola dello sponsalizio di Teti con Nettuno figure di finto stucco con quelle colorate e pregò il principe di non manifestare chi ne fosse l’autore finchè non avesse sentito il parere del Solimena. Chiamato costui a giudizio con altri pittori lodò quell’opera, ma per lo stile già mutato e migliorato di Giacomo non seppe indovinarne il pennello. D’allora Giacomo salì in rinomanza e moltissime e principali opere per chiese e per palazzi ebbe affidati in quella città come nel palazzo del Duca di Maddaloni, del M.se Positano, nella chiesa di S.ta Caterina a Formello365 de’ PP. Domenicani, come pure nella cappella del Real Palazzo ove dipinse Dio Padre fra una schiera di angioli nella sagrestia di S. Domenico maggiore ove gareggiò col Solimena che ne avea dipinto la soffitta. Le opere di Giacomo ivi figurano fra le sue migliori. Infinite sono quelle ch’egli fece nelle chiese di Napoli e sempre con bella e felice invenzione con tocco franco e con gusto ed armonia di colori e gli si perdona se talvolta pecca secondo il secolo alquanto di maniera, ma in lui è pur grazioso e tollerabile. Ed io nel mio reiterato soggiorno in Napoli ammiravo sempre i quadri di questo insigne artista che se fosse vissuto nel cinquecento avrebbe certo primeggiato tra i pittori di second’ordine, ma in quello in cui visse fu uno dei primai, sì per la composizione sempre originale sì pel buon disegno e sì pel colorito. Giacomo fu anche buon incisore; ma occupossi di quest’arte meno del padre366, e morì in Napoli di anni 72 nel 1726 avendo meritato un lungo articolo biografico di Bernardo De Dominici fra le vite degli artisti napoletani; sebbene egli non affermi assolutamente di essere nato in Napoli. Giacomo giovò molto con l’emulazione da lui eccitata in quella città al progresso della pittura e per suo padre nell’incisione e vi lasciò molti scolari, ma nessuno il raggiunse. Teresa Del Po’367 Fu figlia di Pietro e sorella di Giacomo. Anche per essa si dubita se sia nata in Palermo, in Roma o in Napoli, ma per ragione del padre può riguar_________________________________ Seguono cancellate le parole: “al soggetto mitologico”. Intendasi: “Formiello”. 366 Seguono cancellate le parole: “di cui intagliò qualche”. 367 Teresa Del Po’, pittrice, incerto il luogo della nascita (Palermo, Roma o Napoli) intorno alla metà del ‘600, morta a Napoli nel 1716. 364 365 376 darsi come palermitana. Dal progenitore apprese la pittura e progredì sotto la direzione del fratello. Dapprima diessi a colorire ad olio piccole istoriette, poi sotto un bravo miniatore straniero apprese in Roma a dipingere in quella maniera ed indi anche a pastello. I suoi diligenti e leggiadri lavori li procacciarono l’onore di essere ancor giovinetta ascritta all’Accademia di S. Luca. Recatasi in Napoli diessi a dipingere ritratti a miniatura e a pastello e a mezze figure la Maddalena e S. Giambattista per il duca di Maddalone e pe’ sig.i Valletta una testa di cherubino ch’è modello di bellezza e perfezione e spira un aura di paradiso sembrando delle mani di Guido Redi368. Per la duchessa di Laurenzano Aurora Sanseverino dipinse l’immagine dell’Immacolata Concezione di Maria corteggiata dagli angioli. In casa Bisignano eranvi suoi quadretti preziosissimi, cioè una Sacra Famiglia e la morte di S. Giuseppe ben disegnati dipinti con meravigliosa finitezza. Imitando il padre maneggiò il bulino e l’acquaforte; e incise opere di Giacomo suo fratello e di altri valentuomini e pel marchese del Carpio a cui fu carissima la famosa Madonna col Bambino e l’angioletto, opere del Correggio. Sposatasi in Napoli e divenuta madre di una figliuola per nome Vittoria l’educò bene e ammaestrolla anche nella miniatura e poi diella a marito al sig. Bonifacio Patino, gentiluomo di S. Germano. Di costei dipinti possedeva il sig. presidente Tommaso Criscuolo un ballo grazioso di putti e una Madonna col Bambino con mezze figure al naturale. Però non raggiunse col pennello la perfezione della madre. Essa cessò di vivere nel 1716 con dolore universale di tutti, che ne avevano ammirato i suoi singolari talenti artistici. Di Teresa Del Po’ io possedo nella mia collezione il ritratto al naturale del giovine conte di Monforte dipinto mirabilmente a369 pastello con corazza a gola riccamata dipinta a tempra e bianca e prolissa parucca con ricci capelli toccati a370 pastello. Sotto vi sta scritto: Teresa Del Po’ accademica romana. Questo famoso ritratto anche per la bellezza del nobile personaggio siciliano, che secondo il gusto strano del suo secolo essendo giovanissimo amava di comparir vecchio colla bianca parrucca fu da me acquistato, da un rivenderglielo [!], ma era alquanto sfregiato perocchè il pastello non ricoverto di cristallo facilmente si guastò. Io il mostrai al celebre pittore Giuseppe Patania il quale anche nello _________________________________ Leggasi: “Reni”. Seguono cancellate le parole: “chiuso in ammirabile”. 370 Segue cancellata la parola: “tempra”. 368 369 377 stato in cui si era ridotto ammirollo talchè m’invogliai a farglielo ristorare ed egli l’eseguì con tanta bravura che vedesi ripristinato alla primitiva bellezza. Ed io ne lo pregai di scrivervi allato opposto col nome dell’autrice e il nome dello stesso Patania come ristoratore e l’anno 1844. Epifanio371 pittore forse del secolo XII° Da una lapide e dalla tradizione rilevasi che il Conte Ruggiero in due contrade vicine a Caltagirone riportò una vittoria sopra i saraceni e quindi372 si appellano tuttavia il piano del Conte e lo Sarracine. Ivi fu innalzato da quel prode guerriero un tempio a S. Giacomo di Galizia in omaggio alla riportata vittoria. Or son due secoli (1869) quel tempio crollò per un tremuoto e rimase soltanto una cappella e il vetusto campanile. Si sa per una lapide che la chiesa era tutta istoriata di affreschi e nella lapide si legge ancora Epiphanius pinxit. Ignorasi bensì quando fosse pitturata quella chiesa e donde fosse nativo quel pittore. Il dipingere a fresco è dei tempi più antichi ed è probabile che dopo di esser compito quel delubro il conte Ruggiero e i devoti del Santo in tempo non molto posteriore vi abbian fatto dipingere da Epifanio i miracoli del Santo o altre sacre istorie. Se esistesse ancora effigiata qualche figura si potrebbe indovinare373 l’epoca in cui visse ed operò l’artista al confronto di altre dipinture antiche che abbiamo in Palermo o che sono sparse nell’isola nostra. Ne’ miei registri di artisti i cui nomi ho raccolto con gran pena e diligenza non ho incontrato quello di Epifanio. Convien credere quindi che fosse un pittore locale, e forse di Caltagirone città colta ed opulenta. Io ho creduto di assegnarli il tempo di un secolo dopo a Ruggiero – quanto ho creduto opportuno pel compimento della chiesa col campanile per introdurvi la sacra officiatura e per adornar di pitture le pareti – queste notizie mi sono state partecipate dal sig. Prof. Antonio Grimaldi di Caltagirone con sua lettera di 20 Ott. 1869, nella quale chiedeva da me notizie e chiarimenti sull’indicato dipintor e gli fu risposto da me a 26 del detto mese come appare dal mio registro nel modo che ho indicato compendiosamente.374 _________________________________ Epifanio Rosso, pittore, nato a Noto, attivo a Caltagirone nel sec. XVI. Segue cancellata la parola: “quella”. 373 Seguono cancellate le parole: “al confronto”. 374 Alle c.123-124 bifolio a stampa contenente l’ode “La madre pompeiana” dedicata da Teresa Petrozzi allo scultore Giosuè Meli. A c. 124r note manoscritte: “Questa opera di scultura fu apprezzata a Roma trenta-mila piastre e un Inglese, che l’ammiro, ha fatto un Cuntratto per averla a Londra, riturlo dal G. Meli a cui darà settemila lire sterline.” e “che si crede parente del nostro poeta Meli”. 371 372 378 Scultura siciliana 1864 Giosuè Meli375 Costui nacque in Palermo e vantasi di appartenere alla famiglia del celebre poeta Meli, ed io credo piuttosto che sia di una delle altre dello stesso cognome che esistono in Palermo ma di diversa origine e forse è figlio di uno che faceva pupi di carta e di creta ed abitava pria del 1848 in Toledo rimpetto la chiesa di porto Salvo. Giosuè Meli giovinetto lasciò Palermo verso il 1844 recossi a Roma ove studiò la scultura, e riuscì pregevole artista; talchè avendo impreso a scolpire in marmo una statua al naturale rappresentante una donna desolata nell’eccidio di Pompei, per la quale lavorò cinque anni fu ammirata da que’ conoscitori, ed apprezzata trenta mila scudi e lodata con un’ode da Teresa Petruzzi e venduta ad un ignoto signore inglese sette mila lire sterline con l’obbligo di recargliela sana collocargliela nel suo palazzo in Londra. Il Meli difatti partiva da Roma e indi da Livorno ove avea spedito la statua nell’agosto del 1864. Notizia comunicatami dal cav. Carlo Merlo con sua lettera da Livorno de’ 24 agosto 1864. Del dipingere a fresco intonacare Questa maniera di pittura rimonta all’epoca greca, e passò nel Lazio ed in Roma come si osserva in Ercolano, Pompei e in ***. Gl’Italiani quattrocentisti l’ereditarono e i posteriori la seguirono preparando l’intonaco con calce ed arena crivellata di fiume; giacchè quella del mare co’ sali che spuntano fuori nuoce alla pittura. Vi si adoprano colori che la calce che vi si mischia non può alterare, e questi sono le terre colorate. Le grandi opere di Raffaello, di Michelangelo Buonarroti e di Correggio mostrano per l’effetto che il metodo moderno non è diverso dall’antico. Però i colori degli affreschi di Ercolano, e di Pompei sono più vivi. Si è supposto che gli antichi conoscessero più bei colori che noi ignoriamo, e in effetto in Oriente vi son terre colorate più belle che in Italia e di fatto la scuola di Venezia che col commercio se ne provvedeva è la più colorita fra le altre italiane. Il sig.r Niccolò Müller originario tedesco; ma nato in Messina con _________________________________ 375 Giosuè Meli, scultore, nato a Luzzana nel 1816 e morto a Roma nel 1893. 379 assidue ricerche credette di trovare il modo come gli antichi dipingevano gli antichi [!] e dato prove che sono state applaudite, e particolarmente lodate a cielo da Luigi Cangrini [!] in una nota a pagina 261 del suo bel Poema in isciolti Beatrice o il campo della natura e la sapienza italiana376: Napoli per Nobile 1860. A me sembra che quanto al metodo nulla abbia potuto specular o congetturare di nuovo, se non l’adoperar maggior diligenza nel preparare con la calce, e l’arena di fiume ben crivellata, e lavata, nè questa può dirsi invenzione. Più tosto ha potuto trovare a specular migliori colori più adatti pel bello effetto negli affreschi. E questo è certamente un gran servizio che ha reso a quella maniera di dipingere. Del resto se egli non isvelasse il suo vero o supposto segreto non puossi giudicar d’altro che dell’effetto de’ colori. I messinesi menarono gran vampa in un loro giornale ove apparve l’articolo l’intonaco Zancleo377, come un gran ritrovato. Un accenno sul metodo si trova nella nota citata dal Cancrini [!] ch’è del tenor seguente: “Si è creduto finora che gli antichi dipingessero sugl’intonachi freschi della calce; ma è questo un more che per tanti secoli ha intratenuto l’opinione de’ chimici e de’ pittori. Non è così per Muller, il di cui intonaco sembra un granito per durezza; ed egli mostra che i dipinti di Pompei non sono trasfusi sulla calce fresca, e sviluppa co’ fatti, com’eglino dipingessero, mercè la forza de’ colori e liquidi incancellabili sull’intonaco fresco”. Sul passo indicato mi sia lecito osservare che il metodo del sig. Muller si riduce non a dipingere sul tonaco fresco, come s’è fatto finora, per modo che i colori sciolti in calce aderiscano perennemente su quello, ma sull’intonaco secco. Or questo modo di dipingere detto da’ pittori a secco è conosciuto. Però non potendo i colori immedesimarsi e disseccar mutano perennemente coll’intonaco fresco, la pittura è meno durevole perchè l’aria particolarmente quand’è esposta all’aperto e più la pioggia se la porta via non così sull’intonaco ancora umido. Ne importa che quello del sig.r Muller dopo di essere disseccato sembra un granito per durezza, perocchè tale diviene ancora l’intonaco dopo di essere prosciugato. Non saprei quali prove adduca che i dipinti di _________________________________ 376 Luigi Cancrini, La sapienza e le arti, o, La terra di Beatrice. Poema in 3 volumi, Napoli, Androsio, 1851-1852. 377 Carmelo Allegra, Pittura a fresco sull’intonaco Zancleo scoperta dal messinese Nicola Miller… Messina, Stamperia di M. Nobolo, 1845. Estr. da: Scilla e Cariddi. Giornale messinese di Scienze, lettere ed Arti, diretto dall’ab. Carmelo Allegra, anno III, Nuova Serie, fasc. I. 380 Pompei non siano stati trasfusi sulla calce fresca giacchè non saprei persuadermi che per la forza dei colori liquidi siano essi divenuti incancellabili sull’intonaco secco. Si adduce per prova che il toro dipinto dal Müller sembra staccato da Pompei; essendo seccato potrà esser caduto in inganno com’egli asserisce qualche forestiere osservandolo. Credo verissimo il carminio e cinabro più tenero e i gialli adoprati dal Muller possano apparire vivi e così pure l’amaranto e il violaceo, e ch’egli adopri anche il verde ignoto agli antichi frescanti, e questo colore in particolare sia stato trovato dal Muller. Ciò conferma quel che dissi di sopra che per tal riguardo e non per altro la pittura a secco e non a fresco debba a lui moltissimo. Poiché altro non si ottiene dal metodo di Müller che l’antico dipingere a secco nel quale il celebre nostro Giuseppe Patania da Palermo fece opere bellissime come puossi scorgere in tre sacri dipinti entro la chiesa del Seminario dei Greci nella gran volta della Galleria nell’antico palazzo del principe di Belmonte, ora del Barone Riso in Palermo di soggetti mitologici non siamo al Müller obbligati pel suo metodo che è antico quanto la pittura; ma solo pe’ colori che ha potuto egli come asserisce l’articolo Zancleo aggiungere nuovi e più splendidi a’ suoi dipinti. Il suo metodo a secco ha l’inconveniente ch’essendo i colori distesi sul muro non sfumano tra loro come quando sono sciolti in olio sulla tela, sul legno e anche sul muro. E per questo diè un felice risultato il nostro insigne pittore Gioachino Martorana378 nel gran quadro dell’altare maggiore nella chiesa dei PP. Crociferi in via Macqueda a Palermo; talchè ciascuno è convinto alla sfumatura delle tinte e mezze tinte cogli oscuri che il muro è suscettibile delle degradazioni quante volte i colori siano sciolti in olio. Nel dipingere a secco bensì co’ colori sciolti in acqua collata sulla tela o sul muro essi difficilmente possono tra di loro sfumare e risultano duri e taglienti, menochè non si osservi il dipinto a gran distanza. Patania previde con fine accorgimento questo effetto e speculò d’intersecare a guisa di rete con fine pennello le parti del dipinto tra la luce, le mezzetinte e le ombre con colori omologhi; talchè venne a sparire la durezza e il tagliente del primo effetto e le carni ov’egli adoprava quest’artifizio appariscono morbidissime come nell’antica maniera della miniatura a piccoli tratti o a punta di pennello. Della nuova invenzione del Müller potrassi dir forse se non sia comprovata coll’essere esposti i suoi dipinti per lunghi anni alle intemperie a cui solo possono reggere i colori a calce sul muro fresco quello che io pro_________________________________ 378 Gioacchino Martorana, pittore, nato a Palermo nel 1736 e ivi morto nel 1779. 381 vai colla esperienza nel tentativo del sig.r Mariano Grassi da Acireale che credette di avere speculato di dipingere a fresco con calce ed arena fine ben lavata, ma sopra tavola e non sopra muro. Quel metodo sarebbe stato comodo invero al pittore che eseguendo il suo quadro pelle volte poner doveva a maneggiar il pennello colla testa supina credea il Grassi che essendo il dipinto eseguito comodamente sul cavalletto poteva poi sospendersi con sgraffie di ferro alla volta ma ingannossi. Ed io gli scrissi un articolo critico in un giornale379 provando che la calce anche con un mestruo adesivo non si attaccava mai fermamente al legno; talchè resi fermi i suoi dipinti alla volta, in breve per il peso della calce e dell’arena dovevano staccarsi e cadere sul capo di che vi stava sotto. Patania fu incaricato a giudicare della quistione e accorto com’era volle per più mesi lasciato il dipinto in sua casa e senza anche essere sospeso in aria la calce si screpolò non avendo potuto aderire al legno sottomesso onde sarebbe stato pericoloso affisso ad una volta. Il rinnomato poeta cav. Lionardo Vigo che scritto avea in favore del suo concittadino Grassi380 restò convinto che l’invenzione di quello era vana e difatti fu in Grecia dimenticata. Così presagisco di quella di Müller. Palermo, 27 gennaio 1866 Io qui infrascritto certifico che nel Libro de’ Consigli di questo Convento di S. Domenico di Palermo trovai scritto quanto appresso: Palermo, 18 gennaio 1866 Fu congregato consiglio per me p. maestro fr. Domenico Cipolla priore di questo Convento di S. Domenico nel tenore seguente: Da molti artisti e amatori di belle arti si desidera che dal Convento dei Padri Cappuccini fossero trasferite in questa nostra chiesa le ceneri del chiarissimo pittore Giuseppe Velasquez, di cui noi abbiamo un bel quadro di S. Vincenzo. In questo nostro Panteon già esiste un monumento innalzato meritamente alla memoria di quell’illustre artista. Sarebbe perciò _________________________________ Agostino Gallo, Lettera di Agostino Gallo al chiarissimo sig. Leonardo Vigo di Aci-Reale egregio poeta sul dipingere a fresco quadri portatili. In: Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia, Palermo, a. II(1833), v. VII, p. 107-124. La lettera è datata 20 agosto 1833. 380 Lionardo Vigo, Su di un trovato di Emmanuele Grasso Naso pittore d’Aci Reale per dipingere a fresco sopra tavola o tela: Lezione di Lionardo Vigo pronunciata nella tornata pubblica ordinaria dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti de’ Zelanti d’Aci-Reale addì 14 marzo 1833. In: Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia, Palermo, a. II(1833), v. VI, p. 240-251. Il testo è “copia conforme all’originale esistente nel primo volume degli atti dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti de’ Zelanti d’Aci-Reale” (p. 251). 379 382 conveniente e giusto che, previo il permesso delle autorità ecclesiastiche e civili, dalla Chiesa dei Padri Cappuccini si trasferissero in questa nostra le spoglie di quel celebre Pittore tanto benemerito alla patria e tanto stimato dagli artisti. A questo i Padri componenti il Consiglio annuirono e passatosi il segreto scrutinio, tutti i voti furono affermativi. P. Maestro fr. Domenico Cipolla Priore, P. Maestro fr. Luigi Di Maggio, P. M.ro de’ Novizî di Provincia e Sottopriore fr. Giovan Battista Vaccaro, P. Predicatore Generale fr. Reginaldo Lodato, P. Lettore fr. Luigi Di Lorenzo, P. Lettore fr. Francesco Ferrante, P Lettore fr. Vincenzo Capritti Segretario. Per copia conforme Il Segretario de’ Consigli P Lettore fr. Vincenzo Capritti Pittori a miniatura in Sicilia Riuniamo in questo solo articolo un legiadrissimo genere d’arte pittorica che sin dal secolo XII fu coltivato in Sicilia infinito è il numero di libri sacri di varie dimenzioni adornati di figurine della vita di Cristo, della Vergine e dei santi, e anche dell’antico testamento e di rabeschi a colore e in oro che si conservano nella biblioteca di Catania dei PP. Benedettini in quella dei medesimi di S. Martino presso Palermo, della Comune in questa città e presso i particolari. Le ho veduto molte ed uno in particolare posseduto dalle monache del Salvatore che secondo un’antica tradizione ed un’iscrizione a mano in greco apparteneva alla Regina Costanza mentre ivi rimanea prima di sposarsi a Enrico VI. Quel sacro ufficio in piccolo sesto fu da me illustrato con alcune storiche e critiche osservazioni381. Le figurine di tutti questi libri divoti ordinariamente dipinti sopra pergamena sentono dello stile dei musaici e mostrano che i pittori adoprati nel preparare i fondi per essi colle figure a colore si occupavano anche a dipingere a miniatura in quei libretti; o che altri derivanti dalla loro scuola ne fossero gli artisti. Quelle figure più o meno ben condotte mostrano colori vaghissimi particolarmente i vermigli, i celesti o pavonazzi e i gialli. _________________________________ 381 Agostino Gallo, Di un sacro codice membranaceo esistente presso le monache basiliane del SS. Salvatore in Palermo, che credesi essere appartenuto alla regina Costanza normanna. Relazione, Palermo, [1823?]. 383 L’arte della miniatura par che sia stata in decadimento tra noi nel secolo XVII se debbo giudicare da un dipinto della Beata Vergine col Bambino ricavato dall’originale del Correggio e ridotto alla dimenzione di palmo 1. e 4. di lunghezza e di palmo 1. di larghezza, che io possiedo lasciatomi in memoria da mio padre. Nel cominciamento del secolo XVIII bensì cominciò a risorger quest’arte in Sicilia e particolarmente a Palermo come ho potuto osservare da molti quadrettini di varie istorie nel Palazzo di Trabia vicino Palermo dietro il Reclusorio delle Croci. E particolarmente progredì quando il Velasques accogliendo nel suo studio e indi il Patania molti allievi382 migliorarono notabilmente la pittura ad olio. Giuseppe Scaglione383 da Mistretta che frequentava lo studio del Velasques impegnato nell’esercizio di dipingere il nudo e di dipinger ad olio diessi tra i primi ad esercitare anche la miniatura divenuta a lui profittevole pei ritratti; talchè egli ricavava da questo genere maggiore lucro e divenne il migliore miniaturista del suo tempo e meritò di essere scelto a precettore384 del Duca e della Duchessa d’Orleans soggiornanti in Sicilia nel 1812 indi saliti al trono di Francia. Lo Scaglione disegnando correttamente le figure e con estrema somiglianza i ritratti sapea condurre i suoi lavori con buon gusto dei colori e bell’effetto. Io ne possiedo un quadrettino di circa 2 palmi e 4 per largo e di palmi 2 per lungo della famiglia di Francesco Bologni rappresentato da cacciatore, la moglie ed una figlia in una casina campestre con veduta d’un giardino e pure dello stesso Scaglione un altro quadrettino quasi della stessa dimenzione ove scorgonsi due fanciulli che si trastullano in un giardino. Ho veduto pure di lui un ritratto a miniatura della dimensione di un palmo per lungo e poco meno per largo rappresentante un signore inglese vestito per bizzarria alla musulmana, lavoro insigne da meritare un posto distinto in un gabinetto di una pubblica galleria. Lo Scaglione solea dipingere sopra cartoncini inglesi preparati all’oggetto non appunti di pennello come anticamente predicavansi ma a tratti vicinissimi da non poterne scorgere la prossimità, talchè le tinte sembravano fuse tra loro come se fossero ad olio ed aveano tale effetto vigoroso che le figure sembravano dipinte ad olio. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “fecero progredire”. Giuseppe Scaglione, pittore e miniaturista, nato a Mistretta nel 1772 e morto a Palermo nel 1857. 384 Seguono cancellate le parole: “di miniatura”. 382 383 384 Buon pittore e miniatore fu Francesco Sacco385 da Palermo e anche un certo Cento386. E sebbene il primo fosse dell’altro migliore entrambi non raggiunsero lo Scaglione il quale abbandonatosi alla miniatura e a dar lezione di disegno perdette l’esercizio di dipingere ad olio, in cui sembrava di riuscir bene con i387 primi suoi quadri da chiesa dipinti per la sua patria. Il Nizzola388 da Palermo allievo del Patania ridusse a miniatura sotto la sua direzione alcuni suoi quadri da cavalletto di leggiadro argomento e recatosi a Firenze migliorò molto nell’arte e divenne, morto lo Scaglione, amico del Sacco. Anche un certo Spallina389 da Palermo copiando il mestiere paterno di tagliapietre ove giovinetto disegnava su’ massi e sulla carta e osservato dal re Ferdinando 2° gli assegnò una piccola pensione. Introdotto da me nello studio di Patania e inoltratosi, nel disegno cominciò a copiare a miniatura i più leggiadri quadri del suo maestro, ed io ne possiedo uno ov’è rappresentata una donna con tre bambini, che il Patania ad inchiesta di d. Giov. Batt. Cutelli ricavato avea dalla stampa originale del Correggio. Egli diessi poi con buon successo alla pittura ad olio. Il Patania nella sua prima gioventù dipinse bene a miniatura come negli altri generi e fece il ritratto del giovinetto figlio del marchese Drago come pure una donna ignuda giacente sul letto voluttuosamente che lasciò incompiuto, e che io possiedo e quello e questa ben dipinti e particolarmente il primo con la consueta sua grazia. Superò tutti bensì il vivente Guglielmo Faija390, che dapprima si esercitò nella miniatura in Palermo col suo fratello Stefano391 e lasciollo indietro allorchè ebbe la fortuna d’essere sostenuto da d.a Giovanna Moncada principessa di Paternò per migliorare nell’arte prima in Napoli e poi in Francia presso il celebre M.r Comte392 ove divenne un artista di prim’ordine in quel genere. Aspirando egli a maggior fortuna recossi in Londra e avendo mostrato al pubblico i suoi ritratti condotti con mirabile artificio e squisito gusto acquistò fama di essere il migliore artista in quel genere altronde ben col_________________________________ Francesco Sacco, pittore e miniaturista, nato a Palermo nel 1797, vivente nel 1841. Salvatore Cento, pittore miniaturista, nato a Palermo e documentato nel 1833. Cfr. ASP, Real Segreteria di Stato, Presso il Luogotenente Generale in Sicilia. Ripartimento Polizia, Repertorio anno 1833, filza 170, fasc. 1, doc. 104 (21 nov. 1833). 387 Segue cancellata la parola: “alcuni”. 388 Giovanni Nizzola, pittore e miniaturista, attivo nel secolo XIX. 389 Girolamo Spallina, pittore e scultore, nativo di Prizzi, attivo nella seconda metà del secolo XIX. 390 Guglielmo Faija, pittore e miniaturista, nato a Palermo nel 1803, morto a Londra nel 1861. 391 Stefano Faija, miniaturista, nato a Palermo, vivente a Parigi nel 1848. 392 Pierre-Charles Comta, pittore, nato a Lione nel 1823, morto a Parigi nel 1895. 385 386 385 tivato da’ diligenti inglesi e la393 regina Vittoria che ne volle i ritratti lo nominò pittore di corte. Vive egli agiatissimamente nella città e sposò una signora inglese. La miniatura in Palermo come altrove è stata destrutta dalla fotografia dopo il 1830, in cui essendo stata introdotta in questa città dal menzionato Stefano Faija e poscia da molti altri siciliani e stranieri e apprestando ritratti somigliantissimi, opera del sole e non dell’arte al modico prezzo di una lira l’ha reso quasi inutile essendo sin più dispendiosa. Io previdi sin dal principio il danno che recar doveva394 la fotografia395 ai pittori tanto ad olio che a miniatura molti de’ quali vivevano co’ ritratti, e ne scrissi un ragionato articolo in cui provai non solo il danno, ma che non meritasse quella invenzione di essere neppure esaltata perocchè in essa non può ammirarsi l’arte ch’esalta l’ingegno dell’uomo per l’imitazione del vero e gareggia con la natura; laddove questa, ministra di Dio, opera per effetto della sua potenza e non fa ammirare l’uomo che nella sua fisica struttura, e insieme Dio per questa e per le facoltà intellettuali insieme. Sostenni poi che sia vero che la fotografia diviene utile per alcuni casi straordinarî quando, cioè, non avvi il tempo sufficiente per condurre ad olio o a miniatura un ritratto, e che giova poi moltissimo all’architettura, perocchè possono ottenersi senza il dispendio d’innalzar palchi i disegni de’ grandi e belli edifizî, che sono norme agli studiosi di quell’arte, i quali ne ottengono i disegni facendo le esatte proporzioni degli originali. Difatti io ne ho veduti molti e fra questi in una gran carta il portico del Vaticano. Ad ora la fotografia ha tanto progredito che all’esposizione di Firenze fu presentato il ritratto al naturale dell’intera persona di Vittorio Emmanuele Re d’Italia, né seppesi giudicare se fosse in un solo pezzo o in varî ben congiunti artifiziosamente infime. Quella fotografia era certo una meraviglia dell’arte. Su Paolo Brami396 o Bramero397 e su Giovanni Brama398 entrambi di Palermo Poco sappiamo di questo egregio artista palermitano che fiorì dopo la metà del secolo XVI. Il Mongitore appena ne accennò il nome399 in un suo _________________________________ Seguono cancellate le parole: “Real Corte”. Seguono cancellate le parole: “alla pittura”. 395 Seguono cancellate le parole: “agli artisti”. 396 Paolo Bramè (o Bramero), pittore, nato a Palermo nel 1560, morto presumibilmente tra il 1609 ed il 1610. Cfr. Agostino Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori… cit., p. 455. 397 Seguono cancellate le parole: “di Palermo”. 398 Giovanni Brame, pittore su porcellana, nato a Palermo, attivo a Faenza nel 1546. 399 Antonino Mongitore, Memorie dei pittori, scultori, architetti … cit., p. 120-121. 393 394 386 manoscritto ed io un quadro da chiesa dipinto ad olio400 della Circoncisione già posseduto dalla Camera Notarile di Palermo e donato alla Pinacoteca della nostra Università. In esso leggesi il nome latinizzato e l’anno 1589. Il Mongitore lo crede scolare di Polidoro da Caravaggio. A giudicare dallo stile di quel quadro comunque alterato per molti restauri a me sembra che egli abbia seguito la maniera grandiosa del Buonarroti. Io copiando il Mongitore lo accennai per nota di n. 1 a pag. 23 nell’elogio del Novelli401, indicandolo anche allievo del Polidoro, ma a più matura riflessione lo credo piuttosto del Buonarroti. Posteriormente sono venuto in cognizione di un altra sua opera acquistata dal Duca della Verdura, ed è un suo diligente dipinto a miniatura sopra una pergamena circa un palmo lunga, larga oncie otto rappresentante in figure intere all’inpiedi diligentemente colorate S. Francesco e S. Lorenzo con rabeschi in oro attorno al quadrettino e sotto i piedi de’ due santi in minutissimi caratteri leggesi Paolo B.ma F che facilmente s’interpetra [!] Paolo Brama fece. Molto più che che in un’opera veduta sulle maioliche e porcellane stampata e pubblicata in Parigi da Demmin402 pag. 26 sta annotato un Giovanni Brama di Palermo come autore di una lastra di creta di Faenza a smalto vitreo della Deposizione dalla Croce, col detto nome senza accorciamento, e l’anno 1546 e sotto sta scritto Faenza che conservasi in un museo di Scugard403 in Germania. Dunque il nome di famiglia era Brama che ridotto in latino nel quadro di Paolo divenne Bramerus. Or questo Giovanni che viveva e dipingeva stoviglie figurate in Faenza nel 1546 per l’anteriorità a Paolo, che fioriva nel 1589, puossi supporre, essendo come l’altro palermitano, di essere stati padre, zio o fratello maggiore di Paolo. Giovanni poi, lasciando Palermo si addusse come artista operajo alla fabbrica di Faenza. Quanto a Paolo che appartenne come è da supporre alla stessa famiglia, par che abbia fornito i suoi studi in Roma, poiché ne’ quadri ad olio, come in quello della nostra galleria rilevasi par che abbia imitato il gran Buonarroti, e nella stessa sua miniatura scorgesi lo stile404 michelangiolesco nonostante la piccola diligenza e finitezza del lavoro. _________________________________ Seguono cancellate le parole: “de’ santi Pietro e Paolo”. Agostino Gallo, Elogio storico di Pietro Novelli da Monreale famoso dipintore anchitetto ed incisore … Seconda edizione riveduta e corretta, Palermo, R. Tipografia,1828, p. 27, nota 1. 402 Auguste Demmin, Guide de l’amateur de faïences et porcelaines … Paris, Veuve Jules Renouard, 1861; Nouvelle édition augmentée, Paris, Veuve Jules Renouard, 1863. 403 Forse Stuttgart. 404 Seguono cancellate le parole: “ma con maggior”. 400 401 387 Altri suoi quadri non abbiamo in Palermo, forse se ne possono incontrare nelle chiese dell’interno dell’Isola nostra, onde può credersi ch’egli morì giovane senza aver lasciato altre opere. Nella destrutta parrocchia di S. Giacomo alla Marina in Palermo vi era un quadro rappresentante S. Pietro e Paolo figure al naturale, che io giudicai del suo stile ma o della prima gioventù o sia di qualche suo scolare. Di Giovanni suo parente altro non sappiamo che il dipinto della majolica in Faenza. Appunti sulla scultura Queste antichissime sculture in Sicilia sentono dello stile etrusco, come quelle su le rocce, e alcune dello stile egiziano come tre metope dentro de’ tempii di Selinunte che scorgonsi ora deportate nell’Università di Palermo, e che appartengono agli scolari siciliani dagli scolari di Dedalo, ma quelle sulle rocce forse sono più antiche e dovettero essere lavorate da qualche artista etrusco passato in Sicilia dal vicino continente. Si sa dall’istoria che gli Etruschi coltivarono la scultura e la pittura prima de’ Greci come ha provato con buone ragioni il Mazzocchi nell’opera sua sull’origini italiche405. Si sa ancora dall’istoria che Suriano scultore etrusco 590 pria di Cristo fu chiamato in Roma da Tarquinio per farvi de’ lavori di scarpello, e il suo figlio dello stesso nome detto il Superbo invitò anche in Roma altri406 molti scultori allo stesso oggetto; perocchè pria di quel tempo fiorivan le arti in Etruria, come può rilevarsi dall’opera del Conte di Caylus sulle antichità etrusche407 / Tallets Chronol, t. 1 pag. 533/.408 _________________________________ Alessio Simmaco Mazzocchi, Dissertazione sopra l’origine dei Tirreni. In: Saggi di dissertazioni … lette nella nobile Accademia Etrusca di Cortona, III, 1741, p. 1-66. La dissertazione fu poi ristampata, postuma, insieme ad altri scritti del Mazzocchi, nel secondo tomo degli Opuscula quibus orationes, dedicationes, epistolae, inscriptiones, carmina ac diatribae continentur, Neapoli, apud Raymundos, 1771-1775, v. 2, p. 75-204. 406 Segue cancellata la parola: “artisti”. 407 Anne-Claude-Philippe de Pestels de Levis de Tubières-Grimoard, archeologo francese noto come Comte de Caylus. Scrisse la Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, Paris, 1752-1767, 7 v. 408 Francis Tallets, Chonological tables of the history. Citato In: Johann Burkhardt Mencke, Bibliotheca Menckeniana quae autores praecipue veteres graecos et lat. historiae item literariae, eccl. et civilis, antiquitatum ac rei nummariae scriptores, philologos, oratores, poetas et codices mss. complectitur, ab Ottone et Jo. Burchardo Menckeniis, patre et filio multorum annorum spatio studiose collecta, et justo ordine disposita, Editio altera, longe emendatior, ordinatiorque, quarta nunc parte aucta, et notulis raritatis appositis, magis ad usum accomodata, Lipsiae, apud Jo. Frid. Gleditschii fil, 1727, p. 250. 405 388 La vicinanza dell’Etruria alla Sicilia ci fa fondamenta credere che la prima e più antica scuola di scultura in quest’isola sia stata fondata da qualche artista qui venuto da quella regione o da qualche siciliano ch’essendosi recato in Etruria e poi ritornato in patria vi abbia introdotta quell’arte. La scuola di Dedalo che venne e dimorò molto in Sicilia sarebbe posteriore all’etrusca. Notizie artistiche Il canonico vicario Pietro Calcara possiede un lavoro egregio modellato in cera di figure della celebre Anna Fortino409 rappresentante la fuga in Egitto con Maria il Bambino e S. Giuseppe ed una corona di angioli. L’autrice reputandolo degno di lei vi scrisse il suo nome. _____________ Il Presepe di molte figure incise in legno nella prima gioventù di Valerio Villareale410 con grazia ed espressione singolare e segnati dal suo nome acquistato dal cav. Benzo fu venduto nel 1865 ad un signore inglese che lo spedì in Inghilterra. Però con poco decoro n’escluse alcune figure di villani che furono ritenute dal cav. Benzo. Soscrizione per un monumento onorario funebre del celebre p. Gioachino Ventura col suo busto marmoreo nella Chiesa di S. Domenico in Palermo divenuta il Panteon degl’illustri siciliani per cooperazione di Agostino Gallo. Il p. Gioachino Ventura411 nato a Palermo agli 8 dicembre 1792 e morto a a Versailles a 2 agosto 1861 acquistò somma celebrità con la sua onnigena dottrina, colla sfolgorante sacra eloquenza e con le molte sue opere applauditissime in Roma, in Napoli, nelle altre parti d’Italia e finalmente in Parigi ove gareggiò nel pulpito col rinomato Lacordaire413 e dagli stessi 412 _________________________________ Per Anna Fortino cfr. Agostino Gallo, Lavoro di Agostino Gallo sopra l’arte dell’incisione … cit., p. 208-209. 410 Vedi nota n. 8, p. 288. 411 Gioacchino Ventura, religioso, filosofo e patriota palermitano. 412 Segue cancellata la parola: “Parigi”. 413 Jean-Baptiste (in religione Henri-Dominique) Lacordaire (1802-1861), religioso, giornalista e politico francese, sostenitore del cattolicesimo liberale. 409 389 giornali francesi n’ebbe la preferenza e meritò da Napoleone 3° un busto marmoreo. Questi titoli basterebbero ad ottenergli in patria l’omaggio di un monumento funebre; ma ben altri per noi importantissimi può egli vantare perocchè con quattro opere414 politiche difese i dritti della Sicilia e smascherò la perfidia della diplomazia che di concerto col Governo napoletano li avevano annullati. Egli sostenne la decadenza della real famiglia allora dominante e per quest’opera ed altre dovette rifugiarsi in onorato esilio in Parigi e premorì col desiderio di riveder la patria libera e unificata all’Italia. Ma essa seguace dell’antica sentenza Nemo propheta in patria sua ha interamente or obbliato la sua memoria che fu onorata soltanto da una415 vita in Italia fra quelle degli ultimi insigni uomini del secol nostro416, e prima di una più estesa e più sennata e particolarizzata nel supplimento alla biografia universale antica e moderna417, stampata a Parigi da Beck nel 1862 e compilata da’ primi letterati e colti della Francia. Questi onori tributati meritatamente al Ventura dagli stranieri sono un tacito rimprovero alla sconoscenza della sua patria, che neppur ne possiede il ritratto. A ciò riparar volle Agostino Gallo, suo ammiratore, e ne fe’ dipingere in Roma l’effigie dal suo amico cav. Natale Carta418 sull’originale, che ne possiedono i pp. Teatini in Roma ed è riuscito di tal somiglianza ch’è stato riconosciuto da tutti. Or egli419 desideroso d’innalzarglisi un monumento funebre in S. Domenico offre per modello del busto il ritratto che ne possiede e a sì nobile impresa invita tutti i suoi buoni concittadini zelanti delle glorie patrie e affinchè non si dica ch’egli sia largo in parole420 e avaro infatti nonostante le sue ristrette circostanze per altri simili dispendî nel Panteon indicato si sottoscrisse il primo Agostino Gallo ————————————————-lire 25 _________________________________ Segue cancellata la parola: “diplomatiche”. Segue cancellata la parola: “biografia”. 416 Enrico Montazio, Gioacchino Ventura, Torino, Unione Tipografico-Editrice torinese, 1862 (I contemporanei italiani. Galleria nazionale del secolo XIX, 56). 417 Biographie universelle ancienne et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants, Paris, 1811-1862, 85 v. 418 Vedi nota n. 82, p. 305. 419 Segue cancellata la parola: “propone”. 420 Il testo che termina a c. 140v con le parole “ch’egli sia largo in parole” continua alla c. 145r con le parole “e avaro infatti” e termina con le parole “lire 25”. Segue trascritto il testo delle c. 141-144 che comincia con le parole “Sul p. Ventura di Palermo” e termina con le parole “pe’ pp. Teatini di Roma”. 414 415 390 Sul p. Ventura di Palermo celebre orator sacro e scrittore politico In una vita del Ventura scritta da Enrico Montazio nelle raccolte dei contemporanei italiani del secolo XIX e stampate in Torino dai tipi della Società editrice nel 1862 con l’incisione del ritratto affatto dissomigliante (1)421 un avvenimento interessante di quel valentuomo è appena accennato e tradita in parte la di lui nobilissima aspirazione all’unità italiana secondo la possibilità del tempo calcolando con poco senno le progressive mutazioni nel Governo italiano quando nel 1860 agglomerò la penisola e la Sicilia allo stato piemontese. Il Montazio liberale italianissimo e fautore dell’unità non calcolò bene i tempi successivi benchè rapidi quando adopravasi il Ventura al grande scopo e scriveva alcune opere sue e gli addebitò colpe che non meritava né seppe penetrare nel primario scopo del medesimo, né ravvisare l’indole morale e intellettuale. Il Ventura nato in Sicilia in Palermo amantissimo della patria allora oppressa dalla tirannide, spogliata di tutti i suoi antichi dritti costituzionali e cruciata da feroce polizia dettò le sue opere politiche sulla Sicilia per strapparla al giogo borbonico e conservandone l’indipendenza e la costituzione politica annodarla per lega difensiva ed offensiva agli altri stati d’Italia sotto il nuovo sovrano scelto dal Parlamento del 1848 talchè riconoscendo i principî manifestati allora di Pio nono e la supremazia che apprestavagli la religione col papato potesse giovare all’isola nostra anche colla protezione del medesimo dal Ventura espressamente implorata onde Ferdinando la cedesse al di lui secondogenito. Tutto ciò ignora il Montazio, né penetrò mai quel gran principio del Ventura opportunissimo allora, cioè che la religione sostiene la libertà dei popoli e la libertà la religione. Principio ch’egli sparse in tutte le sue opere. Ignorava anche il Montazio i motivi segreti e le mene cardinalizie per far cadere dall’animo di Pio nono il Ventura che ne dirizzava la mente e la coscienza talchè fu obbligato ad abbandonare Roma e ripararsi in422 Parigi ove coll’eloquenza del pulpito superò o almeno rivaleggiò col celebre Lacordaire come i fogli francesi annunziarono e s’attirò la stima di Luigi Napoleone nonostante che gli abbia annunziato ardue verità onde gli fu innalzato un busto. Le ragioni segrete che l’indussero ad allontanarsi dal Pontefice ch’egli _________________________________ A c. 141r nota in calce: “(1) Potevasi ricavare dall’originale somigliantissimo dipinto del celebre cav. Natale Carta pe’ pp. Teatini di Roma.” 422 Segue cancellata la parola: “Francia”. 421 391 tanto riveriva ed amava al quale pe’ suoi consigli contribuito avea ad acquistare una fama universale e l’amore de’ popoli. Questi motivi sono svelati dal prelato monsignor Carlo Gazola che acquistossi estesa riputazione coi suoi dotti giornali *** e il Positivo423 scritti nelle vertigini del 1849-50 per cui dopo la reazione e il ritorno del Pontefice nonostante l’amnistia generale fu egli dall’iniqua corte giudiziaria in Roma condannato all’ergastolo perpetuo di Cometa, ove per l’insalubrità dell’aria in breve perir doveva. Ma egli ch’erasi attirato la stima come credesi dell’esercito francese in Roma evase dal Castel Sant’Angelo. Ecco quel che narra delle prime, lodevolissime imprese di Pio nono e in seguito dell’influenza su lui del p. Gioachino Ventura: “Chi ama di ritrovare il bindolo di quanto si fa e pensa nella odierna corte di Roma non è a dimenticare mai che i primordî del pontificato di Pio tanto applaudito dal popolo erano tormento e paura a’ cardinali di qualunque fazione, tanto da quelli che in conclave non lo volevano papa, quanto a quelli tranne cinque o sei che lo avevano co’ loro voti eletto papa: né parevano mortificati e pentiti i secondi e non dissimulavano a fatti e parole i loro mali umori, egli però poco curando gli uni e gli altri, forte dell’adesione popolare, poco dopo l’amnistia metteva mano a liberali riforme. Allentò il guinzaglio della censura alla stampa, concesse l’apertura, istituì la guardia civica, creò ministri responsabili. E procedeva sì franco nella nuova maniera che siccome i nemici di Giulio 2° il mordevano che fosse più soldato che papa, così gl’invidiosi e nemici di Pio nono lo accusavano di apparire più profano che sacro, più capo dei liberali scomunicati d’Italia che capo visibile della chiesa di Cristo, più sognatore di conquiste sull’Austria che premuroso della salute delle anime. Gl’intromisero con fine destrezza questa opinione nella reggia e gli fecero fin anche arrivare all’orecchio il sarcasmo di quella dama di Francia che in ogni conversazione di Parigi appellava il novello Pontefice col nome di Caporal Pio nono. Ne lodavano astuti l’ingegno compiangendolo ad un tempo che troppo risentisse del fuoco dell’Etna, onde come siciliano traeva i natali, peccato dicevano che fosse di poco ferme opinioni peccato che scrittore delle napoletane effemeridi dopo la rivoluzione dei carbonari di Napoli del 1820 e 1821 difendesse con tanta eloquenza i gesuiti ed oggi li avversasse con tanto livore. Stato amico e seguace di Lamennais424 tenea sempre _________________________________ Il Positivo, quotidiano romano, fu fondato e diretto da Carlo Gazzola dal 30 dicembre 1848 al 31 maggio 1849. 424 Felicité-Robert de La Mennais (1782-1854), sacerdote, pubblicista e filosofo. 423 392 alcun che di quella fanatica scuola. Fatto da Leone XII professore nella Romana Università di pubblico dritto ecclesiastico ebbe ivi a non molto ad abbandonare la cattedra per discussioni almeno più prudenti se non si devono chiamare erronee. Con tutto ciò conchiudevano il p. Ventura è un grand’uomo e pochi possono con lui gareggiare in eloquenza e sapienza. Conditi così ad arte con molte lodi impressionavano il fievole animo del Pontefice che odi oggi a favellare in tal guisa Monsignor Catterini assessore del Santo Uffizio odi domani il cardinal Simonetti, e poi il Cardinale Patrizi, e poi Monsignore Bernabò segretario di propaganda, e poi Monsignor Gentilucci, finì come da aspettar era col diffidar del Ventura. Tanto più che il coraggioso padre gli schiccherava certi amarissimi versi non graditi per solito a chi vi ascolta dall’alto. Un bel giorno, a cagion d’esempio, gli disse (a noi raccontollo il Ventura). Guai se V.S. si arresta nell’impreso cammino delle istituzioni civili. Per la S.V. non vi è più via di mezzo o salire al sommo della gloria correndo co’ liberali, o cader nel fango co’ retrogradi.– Mostrava il Pontefice di gradire dalla bocca del suo privato consigliere tai franchi parlari: sa Dio solo ciò che in cuor meditasse. Certo è che le chiamate del Ventura al palazzo divennero più rare in modo che il pubblico sospettò dissapori da una parte e dall’altra o mutati consigli nel papa” 425. Scultura in Sicilia nel secolo XIX426 I fratelli Lanzarotto da Palermo si sono addetti alla scultura verso il 1860. Uno di essi per nome ***427 presentò all’Esposizione delle belle arti modellato un cane al naturale che dolente guardava la tomba del suo padrone. La verità e l’espressione della tristezza gli attirarono il plauso universale. L’altro fratello428 recossi in Parigi ed entrò nello studio di Giuseppe _________________________________ 425 Carlo Gazola, Il prelato italiano monsignor Carlo Gazola ed il Vicariato di Roma sotto Papa Pio IX. 1849-1850. Accusa, carcerazione, difesa, condanna e fuga del presunto reo di crimenlese coi relativi documenti autentici giustificativi, Torino, Tommaso Vaccarino, 1850, p. 16-19. 426 La c. 146 contente il testo è cucita in modo che il verso precede il recto. 427 Francesco Lancerotti o Lanzarotti. Citato come Francesco Lancerotti nel Catalogo degli oggetti di Belle Arti esposte nel Palazzo Senatorio di Palermo il dì 30 maggio 1853, Palermo, stamperia di Pietro Morvillo, 1853, p. 31, n. 159; citato come Francesco Lanzarotti nel Catalogo degli oggetti di Belle Arti esposte nel Palazzo Senatorio di Palermo il dì 30 maggio 1856, Palermo, Tipografia di Benedetto Lima Lao, 1856, p. 31, n. 165-167. 428 Giovanni Antonio Lanzirotti, scultore, nato verosimilmente a Napoli nel 1830 e morto a Palermo nel 1911. 393 Pollet429, figlio di un francese e di una palermitana, nato in Palermo e uno dei migliori allievi del celebre Valerio Villareale. Il Pollet ch’erasi acquistata già fama nel Belgio e indi in Parigi con le sue statue indirizzò il Lanzarotti sì bene nell’arte che dopo qualche anno divenne anch’egli buono scultore; ma mostrossi ingrato verso il suo maestro e gli fe’ acuta guerra per mezzo del giornalismo. Questo esempio non è nuovo nell’istoria dell’arte; ma quegli artisti o letterati che divengono sconoscenti verso i loro precettori non sono dissimili di alcuni animali di cattiva indole che mordono le poppe della madre che porge loro l’alimento della vita. Il Lanzarotti detrimendo la fama del suo maestro se pure lo ha superato si è acquistata con la sua ingratitudine una reputazione infame. Non così praticò il buono e gentile Raffaello Sanzio che nonostante di essersi430 elevato a grande altezza sopra il suo maestro Pietro Perugino, pure volle onorarlo col dipingerne il ritratto nella scuola di Atene, ed essendogli stato ordinato di cancellare alcune pitture nel palazzo Vaticano e sostituirvi le vere negossi ostinatamente; talchè esistono le prove della sua delicata morale e riconoscenza. Egli si fe’ ammirare coi suoi sublimi dipinti nelle altre stanze di quel sontuoso palazio senza offendere la reputazione di colui che lo aveva sì bene indirizzato nell’arte. Il Lanzarotti vive agiatamente in Parigi (1866) con la scultura, ma ignoriamo quali opere abbia egli fatto. L’altro fratello modellatore del cane431 ignoriamo se viva e se abbia lavorato ulteriormente nell’arte sua. Associati alla scultura del busto del p. Ventura da eseguirsi da me Rosolino Barbera432 Soscritti e promessi Agostino Gallo pel valore del ritratto dipinto del celebre busto in Roma nel suo originale Cav. P. Giovanni Vannucci Cav. P. Salvatore Lanza £. 153 £. 50 £. 50 _________________________________ Joseph Michel-Ange Pollet, scultore, nato a Palermo nel 1814 e morto a Parigi nel 1870. Segue cancellata la parola: “innalzato”. 431 Seguono cancellate le parole: “è ignoto”. 432 Rosolino Barbera, scultore, la cui attività è documentata tra il 1851 ca. e il 1863. 429 430 394 Conte Tasca Un incognito P.pe Diego Ansaldi P. Alliata P. Lucchese £. 100 £. 10 £. 25 £. 25 promesse promessa a tempo e somma indeterminata Cav. Vigo £. 10 Municipio di Palermo £. 100 Il P. Ottavio Lanza £. 50 Conte Sommatino £. 10 Cav. Ercole Lanza £. 10 Principe di Scalea £. 10 Pagata la somma al Gallo e da questi allo scultore Barbera P. Evola £. 5 Principe Galati £. 50 Esazione di Barbera su i pagamenti eseguiti sin’oggi 15 luglio e da me Barbera ricevuti Dall’ incognito £. 10 Dal Conte Tasca £. 100 Dal P. Salvatore Lanza £. 50 Barbera Pagati Dal Municipio Pagati P. Ansaldi Vigo Ricevute Rosolino Barbera £. 100 £. 25 £. 10 pagata P. Vannucci Ricevute Rosolino Barbera pagata £. 50 Padre Ottavio Lanza Rosolino Barbera pagata £. 50 Pagati al Barbera lire 30 per tre individui della famiglia Lanza come di contro Rosolino Barbera 395 Pagati lire 5 per conto del p. Evola A Barone Ventura, e canonico Da parlarsi al barone Atanasio Battifora Si volti Palermo li 26 sette. 1869 Il Barone Atanasio ha pagato per mezzo del sig.r Agnello lire 25 £. 25 Monsign. Cirino Giudice della Monarchia £. 25 Palermo li 19 del 1870 Io qui sottoscritto ricevo lire cinquanta ricevuti dal principe di Cutò Tasca per mani del sig. Agostino Gallo. Lire 50 Rosolino Barbera Le lire sette a me spettanti dal sig. Agostino Gallo le pagherà allo scultore sig.r Rosolino Barbera. Palermo, 4 dicembre 1868 Ho ricevuto dal sig. Agostino Gallo in quattro rate le lire cinquanta da lui anticipatemi 433, pagatemi dal Principe di Galati, qual uno degli associati pel busto in marmo del p. Gioacchino Ventura, celebre sacro oratore, da me scolpito, e da collocarsi nel Panteon di S. Domenico in Palermo. Dico Lire 50 Rosolino Barbera Palermo, 12 dicembre 1868 Ho ricevuto in anticipazione dal sig.r Gallo per conto delle lire 25 pagate da Puglia lire dieci £. 10 Rosolino Barbera Più a compimento delle lire 25 già pagata a Gallo da Puglia Rosolino Barbera _________________________________ 433 Seguono cancellate la parole: “che promise pagarmi”. 396 £. 15 A 24 dicembre 1868 Più lire dieci di mia borsa lire 10 A 29 dicembre 1868 Più lire 10 di mia borsa lire 10 Rosolino Barbera Palermo 6 del 1869 Più lire 5 di mia borsa lire 5 Rosolino Barbera Palermo 22 Gennaro 1868 Mandati a Barbera lire 5 per mezzo del suo scolare Litterino Piemonte Lire 5 Palermo 2 luglio 1870 Fino a ritrovarsi il precedente conto in altra carta per la medaglia di Monsignor Crispi, il Barbera pensa di essere rimasto allora creditore in £. 110. Ne riceve oggi stesso da Agostino Gallo lire venti talchè resta di lire novanta Ricevo oggi 2 luglio 1870. £. 20 Rosolino Barbera Salvo errore Palermo 2 agosto 1870 Ricevo io infrascritto in conto dal sig.r Agostino Gallo lire quindici. Dico £. 15 Oltre £. 2,55 per l’iscrizione del Gabinetto Rosolino Barbera Più primo settembre ricevo lire venti. Dico Rosolino Barbera £. 20 Palermo lì 3 ottobre ricevo lire quindici. Dico Rosolino Barbera Gallo £. 15 397 Palermo lì 21 ottobre ricevo altre lire cinque. Dico Rosolino Barbera £. 5 Palermo lì 2 novembre 1870 ricevo altre lire quindici. Dico Rosolino Barbera £. 15 Più lo stesso giorno Ricevei altre lire tre. Dico Rosolino Barbera £. 3 A 3 dicembre 1870 Ricevuti £. 17 diciassette a saldo e compimento di £. 300 per la medaglia in marmo del celebre ministro Mr Crispi D.o £. 17. Dico £. 17 Rosolino Barbera A 2 luglio fatto conto 1870 + In detto giorno + 2 agosto d.o + 1 settembre d.o + 3 ottobre d.o + 21 d.o mese + 2 novembre d.o + più detto giorno £. 110 £. 20 £. 15 £. 20 £. 15 £. 5 £. 15 £. 3 ________ Ricevuti salvo errore £. 303 20 15 20 15 5 15 3 ___ 93 Conto di Barbera per la medaglia di Crispi 398 Associazione per innalzarsi un monumento col busto marmoreo al celebre p. Gioachino Ventura palermitano P. Gioachino Ventura palermitano egregio orator sacro, che per l’eloquenza meritò quest’onor in Parigi e per le opere diplomatiche in favor della Sicilia, di cui sostenne i dritti e soffrì un esilio di anni 14. E’ pur giusto che la sua patria gli appresti un tributo d’onor nel Panteon di S. Domenico fra gli altri illustri siciliani. Agostino Gallo ne ha fatto eseguire il ritratto dall’egregio pittore Natale Carta in Roma sull’originale presso i PP. Teatini talchè è riuscito facile al nostro ragguardevole scultore Sig.r Rosolino Barbera già allievo di Villareale di farne il modello somigliantissimo in creta, che potrà osservarsi nel suo studio nel cortile del Duca di Castelluccio in via Macqueda. Nomi de’ soscrittori Agostino Gallo – oltre la spesa del ritratto a colore offrirà una somma proporzionata alle sue ristrette finanze L’onorevole p. P. Vannucci si è segnato in altre carte per lire 50 Pagate P. Salvatore Lanza lire 50 cinquanta Pagato Conte Lucio Tasca lire 100 pagate pag.te Monsig.r Rinaldi lire 25 + P.e Vannucci £. 50 + P. Ansaldi £. 25 + Un incognito £. 10 + Cav. Salvatore Vigo £. 10 + P. D. Ottavio Lanza £. 50 + Municipio di Palermo £. 100 + P. Filippo Evola £. 5 + Barone Ataniasio £. 25 + Conte Summatino per la famiglia £. 30 Ho ricevuto sino al 26 ottobre 1868 Lire quattrocentoottanta in conto della scultura del busto in marmo del P. Ventura propostomi dal Sig.r Agostino Gallo che mi ha consegnato la detta somma Rosolino Barbera Ricevuti da d. Agostino Gallo di proprio denaro per conto del principe Galati £. 50 399 E più dall’avvocato Puglia £. 25 Pagati a Gallo da costui al Barbera quest’oggi li 19 dicembre 1868 In tutto ricevuti dal Barbera £. 555 A 24 dicembre Più ricevuti da Gallo per conto proprio £. 10 Rosolino Barbera £. 565 Ultimo conto del sig. Barbera Associazione per il busto del p. Gioachino Ventura celebre sacro oratore, scrittore di opere politiche per sostenere i dritti della Sicilia nel 1848. Municipio di Palermo Conte Lucio Tasca P. Giovanni Vannucci P. Salvatore Lanza P. Diego Anzaldi Cav. Salvatore Vigo Un incognito P. Ottavio Lanza Famiglia Trabia Monsignor Cirino Principe di Galati Parroco Evola Barone Ataniasio Avvocato Puglia Agostino Gallo Sino a 26 genn.o 1869 resto lire £. 100 pagati al Barbera £. 100 Idem £. 50 Id. £. 50 Id. £. 25 Id. £. 10 Id. £. 10 Id. £. 50 Id. £. 30 Id. £. 25 Id. £. 50 Id. £. 5 Id. £. 25 Id. £. 25 Id. £. 30 Id. ____________ Lire 585 215 Alla convenzione collo scultore Barbera pel monumento da collocarsi in S. Domenico. Si avverte che il busto del Ventura è bello e finito e riuscito somigliantissimo, e puossi osservare da chiunque nello studio dello scultore in fondo al cortile del Duca di Castelluccio in via Macqueda. Rosolino Barbera Si volti 400 Palermo a 29 gennaro 1869 E più per denaro del sig. Gallo lire dieci L. 10 Rosolino Barbera Per Barbera Associazione per il busto del p. Gioachino Ventura celebre sacro oratore sino a 26 gennaro 1869. Ultimo conto sino a 26 gennaro 1869434 Municipio di Palermo Conte Lucio Tasca P. Giovanni Vannucci P. Salvatore Lanza P. Diego Ansaldi Cav. Salvatore Vigo Un incognito P. Ottavio Lanza Famiglia Trabia Monsignor Cirino Principe Galati Parroco Evola Barone Ataniasio Avvocato Puglia Agostino Gallo Marchese Torrearsa £. 100 pagato £. 100 Id. £. 50 Id. £. 50 Id. £. 25 Id. £. 10 Id. £. 10 Id. £. 50 Id. £. 30 Id. £. 25 Id. £. 50 Id. £. 5 Id. £. 25 Id. £. 25 Id. £. 40 Id. £. 20 Id. ___________ Sino a 26 gennaro 1869 Lire 615 Resto £. 185 ___________ £. 800 Resto a compiere la convenzione collo scultore in Lire 800 Rimanenti Lire Resto 615 185 _______ £. 800 _________________________________ 434 L’annotazione è scritta verticalmente vicino alla cucitura centrale. 401 Alla convenzione collo scultore Barbera pel monumento da collocarsi in S. Domenico Si avverte che il busto del Ventura è bello e finito e riuscito somigliantissimo, e puossi osservare da chiunque nello studio dello scultore in via Macqueda. Marchese di Torrearsa lire Ricevute lire Rosolino Barbera 20 20 585 10 20 ____ 615 Conti per il busto e monumento del p. Gioacchino Ventura Ricev. Di Barbera Anedoto[!] su Valerio Villareale435 da Palermo insigne scultore Quando divampò la rivoluzione francese in Roma nel 1799 e vi fu trucidato Ugo Bauville inviato dalla Francia a suscitarla, Valerio Villareale recossi in Napoli ed eccitato anch’egli dalle idee liberali seguì il partito de’ letterati avvocati che secondavano la rivoluzione francese avversata dal popolaccio e dal cardinal Ruffo e da Fra Diavolo che la Real Corte Borbonica ricoveratasi in Sicilia sosteneva in Napoli. In un attacco tra il popolo e i liberali, il Villareale fu ferito in una gamba, e un giorno me ne mostrò il solco sulla carne cagionatogli da una palla di moschetto, e dicevami: anch’io nella mia gioventù feci il bravaccio e mostrai coraggio. Egli allora apparteneva alla setta patriottica, e indi a quella de’ Carbonari, e ritornando in Sicilia fu capo di loggia, e come solea vantarsi di essersi mostrato coraggioso in Napoli in varie mischie tra i due partiti; il pittore Vincenzo Riolo nel ritratto che ne fece per la mia collezione lo rappresentò per dargli la caricatura come un fanciullone col bavero a pizzi ricamati che gli cinge il collo ignudo, e di più in un’aria di minaccia con una spalla _________________________________ 435 Vedi nota n. 8, p. 288. 402 alzata e l’elsa del pugnale de’ carbonari sotto l’ascella sinistra. Il Villareale che era mio commensale alla domenica ne rise ma disse: se in casa vostra penetra qualche delator del governo borbonico comprenderà ch’io sono stato carbonaro. Riolo è stato indiscreto, ditegli che vi cassi il pugnale e così fu eseguito. Ritornando al suo soggiorno in Napoli436 è da soggiungere che egli avendo ivi acquistato fama di egregio scultore, fu adoprato da molti generali francesi, e dallo stesso re Murat pei loro ritratti in marmo e per le statue allegoriche modellate in437 gesso nelle feste pubbliche che quel re ordinava ad ogni vittoria di Napoleone I°. Sebbene quelle statue fossero improvvisate in poche ore, pure riuscivano bellissime per l’invenzione e gli atteggiamenti vivaci ed espressivi, talchè meritarono di essere conservate, ed io le ho vedute nel 1844 in un magazzino annesso al gran palazzo degli studii come pure la copia colossale in gesso di Napoleone I° scolpita in marmo dal Canova. Quando la Real Corte si restituì la prima volta in Napoli ed ordinò di perseguitare tutti i liberali, il Villareale fu anch’egli imprigionato e si era iniziato il di lui processo insieme col suo concittadino Emmanuele Marvuglia egregio architetto, Giuseppe Ventimiglia principe di Belmonte che reduce dei suoi viaggi si era fermato in Napoli, seppe l’arresto del Villareale e recossi dal re Ferdinando detto IV° e difese tanto efficacemente quel giovane scultore incolpato di liberalismo e di avere effigiato i busti di Muratt [!] e de’ suoi principali generali, e le statue per le vittorie di Napoleone, che potè persuadere il sovrano a farlo restituire in libertà dicendogli che gli artisti non sono mai incolpabili, molto più se giovani, perocchè eccitati dalla fantasia e dall’amor del guadagno per sostener la vita, rappresenterebbero colla stessa indifferenza Dio e Satanasso. Il Villareale affollato di lavori fino al 1814 era rimaso in Napoli, ma volendo rivedere i suoi parenti recossi in Palermo. La deputazione dell’Università degli studii ad istigazione del sig.r D.r Lazzaro Di Giovanni l’invitò a rimanere in Palermo come professore di scultura e direttore delle belle arti col soldo di onze ottanta annuali da pagarglisi tantosto che le circostanze economiche di quello stabilmente il permettessero e il Villareale aderì alla proposta; perocchè allora avea recato seco un capitale anzi una parte n’era stata da lui impiegata in compra di alcune montagne vicino Caserta. Col resto del capitale ottenne a censo gravissimo dal sig.r Gioachino Lenzitti un corpo di case con giardino e magazzeno nella via che conduce dal quadrivio di Porta Macqueda alla chiesa e convento di S. Francesco di Paola. _________________________________ 436 437 Seguono cancellate la parole: “dopo che Ferdinando”. Segue cancellata la parola: “istucco”. 403 Per moltissimi anni non ottenne il soldo nonostante ch’ei prestasse servizio all’Università con istruire non solo nella scultura molti scolari; ma anche nell’osteologia, miologia e nella direzione delle belle arti. Fra i suoi allievi si distinsero Nunzio Morello438 da Palermo, Rosolino La Barbera da S. Caterina, Rosario Anastasio439 da Acireale, Costantino La Barbera440 e Benedetto Delisi441 entrambi da Palermo, ed altri, talchè fiorentissima divenne la sua scuola. La commissione di antichità e belle arti lo scelse insieme col Patania egregio pittore a socio, e molto se ne giovarono i due successivi presidenti Giuseppe Lanza principe di Trabia, e Domenico Lo Faso duca di Serradifalco negli scavi degli antichi monumenti fatti per moltissimi anni nell’Isola nostra e scoprì avanzi di tempii di Selinunte, e colla sua direzione fu ristorato in parte il teatro di Segesta ed altri magnifici cemelii. Fu mirabile la sua industria e il talento artistico nel sapere raccozzare e congiungere insieme infiniti frammenti delle metope con figure ad alti rilievi ritrovate in Selinunte che or si osservano nella nostra R. Università. Al Villareale devesi l’arte di ben ristorare i quadri antichi con colori sciolti a vernice che prosciugandosi subito non ne fa alterare le tinte laddove prima adoprandosi colori ad olio ne risultavano delle macchie che imbruttivano le carni. Egli fe’ risorgere a nuova vita il bellissimo quadro di Raffaello Sanzio della Vergine col Bambino, S. Giovanni, ed un angiolo, posseduto dagli ex PP. Olivetani. Quel dipinto era stato barberamente coverto di nuovi colori che lo deturpavano, Villareale con pazienza adoprando lo spirito allungato e *** ne staccò la nuova tinta e fe’ ricomparire l’antica, supplendo ai piccoli mancamenti di essa, talchè si riconobbe com’egli avea indovinato di essere uscito dal pennello del Sanzio. Nell’arte di ristorare i quadri formò anche valorosi allievi: il sig.r Giuseppe Mazzaresi442 da Trapani, e il sig.r *** Pizzillo443 da Palermo i quali ormai sono adoprati da tutti gli amatori. _________________________________ Nunzio Morello, scultore, nato a Palermo nel 1806 e ivi morto nel 1875 (o 1878). Rosario Anastasi, scultore, nato ad Acireale nel 1806 e morto a Palermo nel 1876. Costantino La Barbera, scultore, nato a Palermo nel 1822. 441 Benedetto De Lisi, scultore, nato a Palermo nel 1831 e ivi morto nel 1875. 442 Giuseppe Mazzarese, pittore e restauratore, nato a Trapani nel 1755 e ivi morto nel 1847. 443 Luigi Aloysio Pizzillo, pittore e restauratore, attivo nei primi decenni del XIX secolo. Cfr. Mariny Guttilla, Dai precetti del Mazzarese al mestiere di Luigi Aloysio Pizzillo. Metodi ed esperienze del restauro pittorico nella Sicilia dell’Ottocento. In: Storia del restauro dei dipinti a Napoli e nel Regno nel XIX, Atti del Convegno internazionale di studi, Napoli, Museo di Capodimonte, 14-16 ottobre 1999, a cura di Maria Ida Catalano e Gabriella Prisco, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 2003, pp. 239-258. Volume speciale di: Bollettino d’arte, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 2003. 438 439 440 404 Scolari di Valerio Villareale da Palermo celebre scultore Di Simone che morì in Roma verso il 1844 e fu anche allievo di Teneraro444 Palermitani Nunzio Morello Costantino La Barbera Giuseppe Pollet Rosolino Barbera di S.ta Margherita Palermitani Ferdinando La Torre Benedetto De Lisi Marco di Chiara che poi diessi all’arte del cisello, e orificeria Opere di Villareale Due alti e grandi rilievi nella Cattedrale di Palermo Altro *** nel palazzo pretorio Statua di Francesco I alla marina Testa di Ferdinando I per la statua mutilata di Marabitti nel 1820 ivi Statua di Francesco I bellissima per le pieghe del manto per Gergenti Statua di Ferdinando I e Francesco I per Caltanissetta Statua di Ferdinando II per lo stabilimento di poveri allo Spasimo Statue modellate pe’ funerali di Ferdinando I e Francesco I e di Maria Cristina, ove furono imitate le statue delle piramidi di Canova per disposizione di Pietro Lanza P.pe di Scordia pretore La Minerva de’ funerali di Ferdinando I e gli alti rilievi nella cappella di S. Rosalia della Cattedrale si conservano in casa Trabia La Baccante ballerina e l’Ariana strajta [!] pel conte Corrado Ventimiglia, ora presso gli eredi del Duca di Serradifalco Il Paride, la Baccante dormiente in Londra, e una Venere greca a cui supplì la testa le braccia e le gambe presso gli eredi di Lord Standisch Un amorino scolpito in Roma per Vienna, che fu applaudito ne’ giornali del tempo La Silvia che piangeva sul cervo feritogli spedita in Londra e appropriatasi per dritto di magazzino da un ladro inglese _________________________________ 444 Pietro Tenerani, scultore, nato a Torano, Carrara, nel 1789, morto a Roma nel 1813. 405 Monumenti Busto di monsignor Alfonso Airoldi Monumento per Fileti nella chiesa della mercè al molo Della duchessa di Serradifalco nella sua villa all’Olivuzza Busto di Leopoldo Borbone principe di Salerno, e di Carolina sua madre Busto di monsignor Ventimiglia nella cattedrale di Catania, bellissimo. Ivi quello di monsignor Orlando, e replica nella chiesa francescana dell’Annunziata a Porta Montalto in Palermo Nella Villa Giulia in Palermo busto di Bellini Monumento di Vito Oddo da Sambuca segretario generale d’Intendenza, il busto e l’urna con due Genii Monumento del beato Giuliano Majale ora in S. Domenico Della principessa di Galati Giuseppina Torrisi Busto del negoziante Pace Busto del Maranzano presso Gallo Busto di Monti in S. Domenico Monumento di Meli ivi Busto di un militare di cavalleria nella chiesa della vittoria a mezzo Monreale Busto di Piazzi nella villa Belmonti all’Acqua Santa Busto del barone Pietro Pisani Busto di Pietro Ugo marchese delle Favare per la casa de’ matti d’onde fu tolto alla sua persecuzione né si sa ora dove sia Nella chiesa di S. Teresa monumento per la bella figlia del colonnello Costa d’onde fu tolta la figura quasi ignuda, che ora si trova nella fonte della entrata del sig. Michele Puero in Palermo *** Segue Monumento del principe di Palagonia nel Collegio di Maria al Capo Monumento di d. Stefania Branciforte principessa di Trabia in S. Francesco di Paola con figure Ritratto della stessa, e del principe d. Giuseppe seniore in istucco nella scala del suo palazzo via Macqueda Mezzi rilievi in marmo dell’Affrica e dell’America nella base della statua di Filippo IV al piano del R. Palazzo in Palermo. Villareale morì nel colera del 1854 mentre scolpiva l’America come io indicai nella mia iscrizione latina appostavi. La Psiche statua scolpita nel 1843 Busto di Niccolò Palmeri per Termini Agostino Gallo 10 marzo 1865 406 Opere di Villareale in Napoli Scoppiata la rivoluzione in Roma sotto Pio VI il Villareale passò in Napoli445 ove ancor fervea la rivoluzione del 1899446. Egli si iscrisse al partito liberale, e in trambusto popolare fu ferito ad una gamba e un giorno me ne mostrò la cicatrice. Scelto da Napoleone primo Gioacchino Murat re di Napoli, fu prevenuto dalla fama artistica del Villareale, volle conoscerlo, e farsene scolpire il busto, e così molti suoi generali, e diegli il titolo di cavaliere. L’incarico inoltre di modellare, e ridurre in gesso tutte le statue allegoriche per le feste popolari che teneansi ad ogni vittoria di Napoleone. Alcune di queste statue al naturale io ho vedute conservate sino al 1843 in un magazzino del palazzo degli studii, e sebbene lavori improvvisati erano d’un bell’insieme ben drappeggiati; ma nelle attitudini sentivan lo stile francese forse per l’influenza de’ personaggi di quella nazione che allor dominava Napoli, e allora aveva sempre innanzi agli occhi. Murat gli affidò i 4 grandi alti rilievi di soggetti omerici della R. Galleria di Caserta, che sono le sue opere migliori per l’invenzione, l’espressione e l’elegante disegno ricevuto dal lungo studio che fatto avea in Roma sulle statue greche. Quegli alti rilievi sono ammirati da tutti gli artisti nazionali e stranieri vieppiù al confronto di altri quattro d’uno scultore napoletano. Il Villareale profittò in Napoli tanto co’ suoi lavori che potè acquistarsi la proprietà agricola di alcune montagne di Caserta. Nel 1814 ritornò in patria per rivedere i suoi parenti. La deputazione dell’Università di Palermo gli offrì il pubblico insegnamento della scultura, e la soprintendenza delle belle arti. Egli istituì come fondamento della scultura lo studio della miologia su’ cadaveri umani che durò circa due anni, e fu indi soppressa per la spesa che recava. Egli insegnò a’ nostri artisti il metodo di restaurare i quadri antichi danneggiati con i colori sciolti in vernice. Nella scultura fece con molti allievi risorger l’arte caduta giù e allo scarpello di Federico Siracusa447 trapanese che pure era il migliore scolare del mirabile scultore alquanto manierato ne’ panni ma grande artista, e di forte effetto. _________________________________ Seguono cancellate la parole: “ove sedeva re”. Si intenda: “1799”. 447 Vedi nota n. 10, p. 289. 445 446 407 Si ringrazî da parte di A. Gallo il suo dotto e buono amico Sig.r Francesco Di Paola Avolio, e gli si domanda ulteriormente se quell’artista Tamiro448 che l’Avolio disse di essere residente in Tindaro fosse nativo di quella città,449 ovvero di Grecia madre,450 e se fosse lo stesso che nell’opera di Silling è annunziato come incisore di gemme, o pure qualche altro451 dello stesso nome. Gli si chieda a qual’uso era destinato l’edificio452, ove sono stati scoverti i mosaici, e se era di privata proprietà, ovvero destinato a qualche pubblico uffizio, e si desidera saper la causa della453 sua distruzione e l’epoca precisa della distruzione. Si vuol anche sapere il primo possessore come si chiamava. Scultura nel secolo XV in Sicilia Andrea Machino454 da Palermo Dobbiamo all’incessante cura e diligenza del cavaliere Ignazio de Michele455 terminese grande amatore e conoscitore delle arti belle la scoverta di un ignoto scultore nativo di Palermo, Andrea Machino che lavorò alcune statue di marmo tuttavia esistenti nella chiesa dell’Annunziata in Termini come pure dello scultore su legno Giacomo Dileo456 e dei due due [!] pittori Giacomo Graffeo457 e Nicolò Pittineo458 amendue terminesi. Per ora ci occupiamo del Machino e del Dileo onde proseguir la serie degli scultori siciliani. Il De Michele459 trovò460 trascritto negli atti del notaro Antonio De Michele a 30 giugno 1495 XIII ind.461 il contratto nella città di Termini con _________________________________ Ma Tomiro. Cfr. più avanti p. 433. Annotazione di risposta: “no”. 450 Annotazione di risposta: “Atene”. 451 Annotazione di risposta: “un altro”. 452 Annotazione di risposta: “Casa di un generale dei primari”. 453 Annotazione di risposta: “Prima tio [!] detto molto, basta basta addio”. 454 Andrea Machino, scultore palermitano, attivo a Termini Imerese e Sciacca tra il XV e il XVI sec. 455 Ignazio, Sopra alcune pitture e sculture esistenti in Termini-Imerese, Palermo, Stabilimento titpografico di Francesco Giliberti, 1865. 456 Giacomo Di Leo, scultore in legno, attivo a Termini Imerese all’inizio del sec. XVI. 457 Giacomo Graffeo, pittore, nativo di Termini Imerese, attivo nel sec. XVI. 458 Nicolò da Pettineo, pittore, attivo a Termini Imerese nel sec. XVI. Cfr. Francesco Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale, Roma, Donzelli, 2009, v. 3: Il Cinquecento, p. 32. 459 Ignazio De Michele, Sopra alcune pitture e sculture… cit., p. 7. 460 Segue cancellata la parola: “indicato”. 461 Segue cancellata la parola: “trascritto”. 448 449 408 Andrea Machino. Civis f. civitatis Panhormi scultor marmorarius col quale egli obligossi di scolpire per il prezzo di on. 11 la statua di marmo della Vergine Maria di 4 palmi che adora in ginocchio il Bambino Gesù e S. Giuseppe anche genuflesso dell’altezza di 4 p. e ½. Quelle statue sono tuttavia esistenti nella chiesa di S.M. Annunziata in Termini. Il De Michele colla sua fine cognizione d’arte rilevò nella Vergine e nel Bambino lo stile della scuola di Antonio Gaggini coi caratteri bensì peculiari che diversificano le opere d’ogni singolo autore; non così nel simulacro del S. Giuseppe inferiore all’altre due figure sebbene nel contratto si fosse al Machino obbligato di scolpire anche questa. E ben si oppose al vero perocchè da un altro contratto presso notar Filippo Di Ugo dei 19 febbrajo 1516 rilevasi che la statua del S. Giuseppe non solo differente nella qualità del marmo ma d’una mossa affettata massime nella gamba sinistra e di minor grazia nelle pieghe appartiene allo scalpello di Francesco Limastri carrarese. Lo[da] il De Michele la Vergine e il Bambino e particolarmente nella prima la aria del volto esprimente nella preghiera la gioja di essere madre dell’uomo Dio e l’eleganza delle pieghe sinuose nella veste che la cuopre il seno stretta da una cintola e fregiata nel petto da un gallone con una crocetta e in un ampio mantello col cappuccio sulla testa contornata da due morbide trecce da farla apparire più vezzosa e pur modesta dandole quel bello ideale caratteristica del secolo che si avvicinava all’apice della perfezione artistica. Loda similmente l’infante Gesù con esili ma graziose membra. Or da questa sua diligente descrizione sorgono alcune riflessioni che io aggiungo al suo pregevole dettato e primo, se Andrea Machino palermitano nel 1494 si era obligato di scolpire tutte e tre le figure e se la statua di S. Giuseppe d’inferiore merito fu lavorata invece da Francesco Limastri carrarese nel 1516 dobbiamo credere che per la morte del Machino462 un’infermità che lo rendeva inabile dovette avvenire talchè i terminesi furono dalla cruda necessità costretti a valersi dell’altro scultore per compire la rappresentazione della nascita del Redentore. Lo scorgere poi che l’opera del carrarese sia evidentemente inferiore a quella del palermitano sebbene eseguita nel bel secolo della scultura mostra che quest’arte era in Sicilia in miglior condizione nonostante che Antonio Gaggini non aveva ancora spiegato le ale del suo genio come rile_________________________________ 462 Seguono cancellate le parole: “avvenuta nell’intervallo di circa 22 anni o altro”. 409 vasi dalla sua meschina statua della beata Vergine col Bambino nel tesoro della cattedrale di Palermo. Quel Francesco Limastri poiché da Carrara erasi recato in quest’antica capitale per esercitar la scultura dovette essere incitato dalla fama che qui le opere sue sarebbero state più rimunerate che in Italia e forse colla speranza di farsi da noi ammirare più che gli altri scultori del Paese e così avvenne pure a Francesco Laurano da Venezia che colla sua statua della B.V. Libera inferni sebbene lodata allora dal pubblico pure inferiore alle altre di poco posteriore al menzionato Antonio Gaggini. Ma se la Vergine e l’infante Gesù del Machino come asserisce il Sig. De Michele sentono lo stile gagginesco prima che Antonio avesse sfolgorato bella luce colle sue opere dobbiamo credere che da Domenico Gaggini di lui padre lombardo di origine e nato nel castel di Lagano e non già in Palermo come per illusione di un erroneo contratto descrisse Paolo Giudice sia stato guida allo scalpello del modesto Machino. Perocchè Domenico Gaggini a tutti gli elementi della grazia che poi sviluppò nelle sue statue il figlio e solo sente un po’ della timidezza e tenuità dello stile proprî del secolo XV laonde il Machino potè essere con Antonio condiscepolo forse più adulto sotto la direzione di Domenico e similmente quell’Angiolo Marini463 siciliano del quale ho raccolto in Italia le notizie della vita che ne ho pubblicato in Palermo coi tipi del Barcellona nel 1862464 sebbene il Marini per le opere da me osservate in Milano in Pavia abbia poscia modificato il suo stile sul fare del Buonarroti. Tre scuole di scultura dunque fiorivano allora in Palermo quella del Laurano veneziano di Francesco Limastri carrarese inferiore al primo e l’altra di Domenico Gaggini superiore a tutti due e in seguito l’altra del suo figlio Antonio che utilizzò entrambi. Anteriore a queste scuole eravi quella di Antonio Gambara465 certo siciliano e di un Bartolomeo della Chiana466 che ho veduto citato da chi non merita molta fiducia in fatto d’arte (1)467 nè ho potuto osservare opere a Palermo. _________________________________ Angelo Marini, scultore palermitano, attivo nel XVI sec. Agostino Gallo, Vita di Angelo Marini siciliano insigne scultore ed architetto del secolo XVI, Palermo, Tipografia Barcellona, 1862. 465 Antonio Gambara, scultore palermitano del XV secolo. 466 Bartolomeo Della Chiana, scultore, attivo nel sec. XV. 467 A c. 170r nota in calce: “(1) Il p. Galeotto nei suoi strani intralciati ed erronei preliminari alla storia di Antonio Gaggini p. 4 Pal. per Amenta 1860”. <Melchiorre Galeotti, Preliminari alla storia di Antonio Gagini scultor siciliano del secolo XVI e della sua scuola, Palermo, Tipografia di Michele Amenta, 1860, p. 4>. 463 464 410 Scultura in Sicilia nel secolo XVII Filippo Planzone468 nacque in Nicosia circa il 1604. Ivi era allor fiorente una scuola di pittura, e da qualcuno di quegli artisti apprese certo gli elementi del disegno (sebbene dicasi dall’Orlando (1) di non avere avuti maestri), e guidato poscia dal suo genio diessi per capriccio ad un genere di scultura in avolio in corallo o legno con figurine469 di estrema piccolezza che recavan sorpresa a vederle colla lente. Recatosi in Palermo volle far prova di questo singolare talento in una cappelletta in quadrato di cipresso di circa oncie470 quattro copiando il bellissimo quadro471 della Deposizione di G.C. dalla croce di Vincenzo Anemolo da Palermo scolare di Raffaello nella chiesa di S. Cita de’ PP. Domenicani. Le otto figurine microscopiche erano nell’attitudini eseguite con incredibile industria e diligenza da ben rappresentare l’originale. Questo gioiello dell’arte era posseduto fino al 1824 dal principe Giovanni Lanza il quale non ostante che fosse grande amato [!] ne fe dono al suo amico a M. Yrisson francese cedendo all’irresistibile istanza di quello. Due opere in avorio di ricca e bella composizione possiede nel [!] Planzone fra Antonino Falla dell’ordine degli Olivetani di Palermo che io ho ben osservato. In una è rappresentata con sei figurine di due pollici la nascita del Redentore, cioè la Vergine col Bambino microscopico, S. Giuseppe, e due animali del presepe, tre pastori e Dio padre fra le nubi. Nell’altra i Re Magi la diva Madre col neonato Gesù e S. Giuseppe e sopra quattro angioletti di un pollice e la stella in madreperla. Questi lavori furono ammirati da Salvatore Lo Forte, egregio pittore e da me per le buone proporzioni i variati atteggiamenti delle figure e la grazia del volto della Vergine e la diversità dei volti dei Magi non che di quelli per l’aspetto senile del S. Giuseppe e di Dio padre. Però nello stile delle pieghe, se di troppo avvolgimenti sente alquanto nel gusto viziato dei pittori e scultori del Seicento; ma in questo stesso difetto mostra la grazia ch’era sua peculiare qualità. Il Planzone per far fortuna trascorse in Toscana e presentò i suoi lavori al Gran Duca che ne rimase siffattamente stupito e forse per accertarsi che quegli ne fosse l’autore gli ordinò di scolpirgli in piccolissime dimensioni e in corallo una santa Margarita con un dragone472 frenato da una catena rilevata e connessa in minutissimi pezzi e ne ottenne applausi da lui _________________________________ Filippo Planzone, incisore, nato a Nicosia nel 1610 e morto a Genova nel 1636. Seguono cancellate le parole: “quasi microscopiche”. 470 Seguono cancellate le parole: “tre d’altezza per quattro di larghezza”. 471 Segue cancellata la parola: “raffaellesco”. 472 Segue cancellata la parola: “incatenato”. 468 469 411 e da tutti gli artisti e 500 scudi mercede (1)473. Indi intagliò in avorio anche pel lo stesso Gran Duca una gabbia della grandezza d’un uovo con entro un cavallo in rilievo recando somma meraviglia come ve l’abbia potuto scolpire a traverso della gabbia, e ne ottenne un maggiore guiderdone. Pervenutane la fama a papa Urbano VIII l’invito a Roma per osservarne le opere, e acquistarne, o commetterne qualcuna. Il Planzone era allora in Genova; ma preparandosi al viaggio fu colpito dalla morte nel 1630 nell’ancor fiorente età di anni 26. Il Soprani nell’opera sua su’ pittori genovesi474 ne fece onorata menzione ch’è stata ripetuta dall’Orlandi e da me colla giunta de’ lavori fatti dal Planzone in Palermo. Agostino Gallo A giudicare soltanto dell’opera del Planzone che ho veduto ed osservato con diligenza presso l’Olivetano Falla posso per convinzione asserire che nonostante la piccolezza delle figure egli ben conosceva il bell’insieme del disegno e sapeva esprimerle ed atteggiarle con mirabile leggiadria475: mi rammentano le tre figure più grandette entro una bettola in un quadrettino di tre pollici dipinto sopra seta egregiamente come è stato giudicato da diversi artisti stranieri dal Temiers476 o da Van-Crasbek477 e da taluno da Van-Ostade478. Questa479 graziosissima gemma appartiene alla mia collezione. Però ho ragion d’ammirare più il Planzone che chiunque sia l’autore di quel quadrettino giacchè maggior difficoltà presenta in quella esigua dimenzione che la pittura che puossi agevolmente correggere e non già l’altra in ispecie nel corallo e nell’avorio che schieggiano facilmente. Non so poi comprendere quali ferrucci abbia dovuto adoprare il Planzone per condurre a compimento le opere sue e come quei piccoli strumenti abbian potuto insinuarsi nelle manine, ne’ _________________________________ 473 A c. 176r nota in calce a margine: “(1) Diz. pittorico pag. 367 e seg. Firenze 1788”. <Pellegrino Antonio Orlandi, L’abecedario pittorico dall’autore ristampato corretto et accresciuto di molti professori e di altre notizie spettanti alla pittura, In Bologna, per Costantino Pisarri, 1719, p. 154.> L’opera ebbe diverse edizioni aggiornate fra le quali quella citata dal Gallo del 1788. 474 Raffaele Soprani, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti genovesi... in questa seconda edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti pittore... In Genova, nella stamperia Casamara dalle Cinque lampadi, 1768-1769. 2 v. 475 Seguono cancellate le parole: “grazia talchè esse” e cancellato il testo scritto al margine: “Il solo difetto che io trovo da appuntare nelle figure è nelle pieghe e nel troppo avvolgimento dei panni secondo lo stile degli artisti del seicento, epoca in cui viveva; ma in questo stesso difetto egli paga meno il tributo al suo secolo. Questo suo lavoro”. 476 David Teniers il vecchio (1582-1649) pittore fiammingo, studiò a Roma. Anche il figlio David Teniers il giovane (1610-1690), fu pittore. 477 Joos van Craesbeek (1605-1662), pittore fiammingo. 478 Adriaen van Ostade, (1610-1685), pittore olandese. 479 Seguono cancellate le parole: “graziosissimo dipinto ad olio con grande amore della”. 412 piedini, negli occhi, nelle bocche e nelle barbe per darvi il conveniente effetto; laonde son più disposto ad ammirare il Planzone sebbene creda che avrebbe fatto meglio a scolpire più in grande per non faticar troppo la sua e l’altrui vista ed uscir d’imbarazzo più facilmente onde i suoi lavori potessero più agevolmente contemplarsi. In ogni modo egli può essere riguardato in quel genere come artista meraviglioso. E spiacemi che nessuna sua opera trovisi da mostrarla ai nazionali e agli stranieri ne’ due nostri pubblici musei. E veramente sarebbe un bello acquisto se il Falla volesse cedere per l’onor della Sicilia all’uno e all’altro il grazioso lavoro del Planzone. Agostino Gallo Artitetti [!] viventi 1863 educati in Napoli Pier Giuseppe Tranchida Francesco di Paola Rollari Giuseppe Tripiciano *** Di Simone *** Damiani Pietro Castiglia Niccolò Puglia suo nipote *** Basile Andrea Di Martino Salvatore Lo Forte Luigi Lo Iacono suo figlio paesista Giuseppe Meli *** D’Antoni Giuseppe Carta Natale Carta Giuseppe Bagnasco480 *** Liardo481 In Palermo Pittori _________________________________ 480 481 Giuseppe Bagnasco, pittore, nato a Palermo nel 1807, ivi morto nel 1882. Filippo Liardo, pittore, nato a Leonforte nel 1840, morto ad Asnières nel 1917. 413 Scultori Rosolino Barbera Rosario Anastasio *** Fratallone482 *** Barba483 Benedetto De Lisi *** Carvillo *** Bagnasco484 Scultura in Sicilia nel secolo XIX Federico Siracusa485 da Trapani recatosi in Palermo divenne scolare d’Ignazio Marabitti palermitano che avea studiato per molti anni la scultura da Lorenzo Valla fiorentino, e quasi l’avea eguagliato nello stile di grande effetto; ma di maniera ne’ panni e nelle movenze delle figure. Il Siracusa riuscì inferiore al Marabitti nel disegno; ma condusse i panni men goffamente; però fugli infelice imitatore nella bravura dello scarpello, essendo nato meno artista si per l’invenzione, e si per la grazia ne’ putti. Entrambi furon poi eclissati dal genio e dal buon gusto di Valerio Villareale da Palermo scolare di Canova in Roma. Dopo che il Villareale ritornò verso il 1814 in Palermo. riconosciutasi la sua superiorità dagli artisti e dal pubblico fu affollato da’ lavori, e vennero meno al Siracusa, e quelli che di lui s’incontrano nelle nostre chiese e nell’interno dell’isola, ad eccezione di pochi, sono anteriori all’arrivo qui del Villareale e questi sono Un grand’angiolo che sostiene la fonte d’acqua santa a man *** entrando dalla porta maggiore della chiesa di S. Giuseppe de’ PP. Teatini in Palermo ch’egli imitò sull’altro opposto del suo maestro, e fece bene cambiandovi il movimento delle braccia. Il grande altorilievo nella stessa chiesa nel486 paliotto dell’altare di S. Andrea Avellino con angioli e sotto il quadro del santo dipinto da Sebastiano Conco487 [!] altro bassorilievo con angioli. Questi, e l’angiolo _________________________________ Giuseppe Frattallone, scultore, nato a Caltanissetta nel 1832, morto forse a Firenze nel 1874. Luigi Barba, scultore e pittore, nato a Palermo nel 1828. 484 Per Girolamo Bagnasco cfr. Agostino Gallo, Sugli scrittori moderni di storie di Sicilia. Saggio critico, Palermo, Tipografia Barcellona, 1867, p. 79. 485 Vedi nota n. 10, p. 289. 486 Segue cancellata la parola: “fronte”. 487 Vedi nota n. 160, p. 326. 482 483 414 della fonte dell’acqua santa sono le migliori opere del Siracusa sebbene giovanili, essendo stata dirette dal suo maestro. Busto di S.A.R. il principe di Salerno Leopoldo Borbone, opera meschina e brutta che fu fatta a pezzi nella rivoluzione del 1820. Villareale giovinetto ne modellò in creta un altro che fu somigliante, e per esso con la protezione del cav.r Lioy spedito in Roma da quel principe reale. Due piccoli monumenti funebri pe’ conti *** e Gaspare Manzone padre e figlio nativi della Piana de’ Greci, quella del figlio è migliore nella chiesa de’ Greci in Palermo. Monumento funebre grandioso con figura di Pallade al naturale di un generale tedesco *** morto in Palermo nel 1824 nella chiesa di S. Nicola in Palermo lavoro mediocre in vecchiaia dell’autore. Statua al naturale di Francesco I per Trapani, fu destrutta nella rivoluzione del 1848. E nell’anno 19 V 1510 In quest’anno fu incominciata la Tribuna con figure a personaggi di marmo nella Metrop.na Chiesa di Palermo che in Italia non vi è cosa più bella opra di mano di Antonino Chaggino palermitano ancorchè il Fazello lo chiama messinese
Scarica