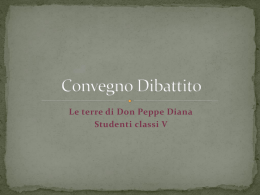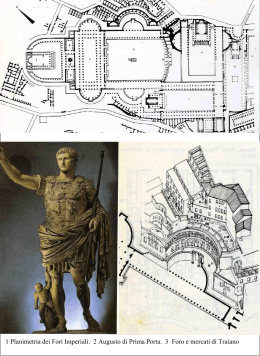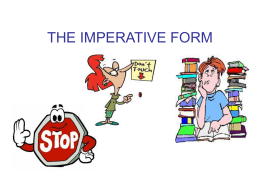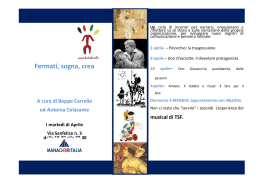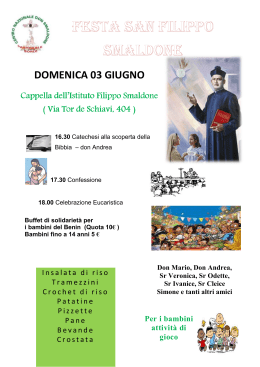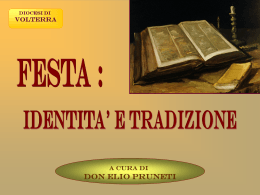Carlo Lucchesi Commemorazione del canonico Don Augusto Banorri arciprete di Salto Tenuta il 25 settembre 1956 presenti tutti i sacerdoti della congregazione e numeroso popolo nell’oratorio di S. Agata annesso a quel cimitero dopo la traslazione ivi fatta dal cimitero di S. Cataldo (Modena) dei suoi resti mortali Bologna, 1956 Reverendi Sacerdoti, Amici e compaesani miei. Prima che si disperda, col fumo degli incensi, anche l’eco di questo rito funebre particolarmente solenne: rito di suffragio all’Anima e tributo di affetto, insieme, alla memoria del compianto Arciprete Don Augusto Banorri, il cui Nome aggiunge nuovo decoro al nostro Clero e costituisce un giusto vanto per il nostro Paese; raccogliamo un momento il pensiero su di Lui e consideriamone, passo passo, la vita e i meriti. Né a voi rincresca o rechi meraviglia, amici e compaesani miei, ch’io mi rivolga a voi proprio con questi cari appellativi che mi escono spontanei dal cuore, che sciolgono ogni diaframma ed eliminano ogni distanza fra me che vi parlo e voi che m’ascoltate. Ignoto, è vero, io sono alla maggior parte di voi, e ignoti siete voi pure a me la maggior parte; anch’io però ho respirata nascendo, come l’avete respirata voi, questa purissima aria; e come voi, sono cresciuto anch’io sotto questo bel cielo e fra questi amenissimi monti; e qui, sulle ginocchia della madre, e sui banchi della scuola, e fra le sacre mura della mia Chiesa, ho ricevuto anch’io, come avete ricevuto voi, quei primi e sani alimenti spirituali, che mi hanno poi guidato e sorretto nel cammino, ormai lungo, della mia vita. In grazia appunto di questa nostra comune origine e di questa conformità - che non esito a chiamare fraterna - di pensieri e di sentimenti, non so dirvi davvero ciò che provo in cuore nel trovarmi qui nuovamente fra voi, dopo tanti anni, e tanti eventi, e tante rovine, e tanti lutti; né so dire inoltre quanto grato io sia a Lei, Signor Arciprete di Salto, alle sorelle e ai parenti del caro Estinto, alla prof. Luisa Cuoghi che per i recenti lutti di famiglia e per la sua malferma salute non è potuta intervenire (fiaccata dal dolore, anch’essa è volata al Cielo il 21 ottobre 1956): a tutti coloro, insomma, che hanno voluto affidare a me l’ambito incarico di questa commemorazione. Senonché, nell’atto in cui mi accingo a rievocare al mio e al vostro pensiero la cara immagine di Lui, trepidante e commosso è l’animo mio: trepidante, per la responsabilità che senti di essermi assunta di fronte a Lui e di fronte a voi, qui convenuti ad ascoltarmi; commosso, per gl’infiniti ricordi che qui, a pochi passi dalla sua tomba, mi si affollano alla mente, di Lui, e dei giovani nostri anni trascorsi insieme nel Seminario di Nonantola, e della fraterna amicizia che poi sempre ci unì per tutta la vita. Oh, gl’indimenticabili nostri conversari, durante le vacanze estive, all’ombra dei verdi castagneti di Cà di Zocco, o giù a Salto, nella sua ospitale canonica, o lungo la pubblica via, nei luminosi tramonti; e le frequenti nostre gite, o su al Montello, ad ammirare lo splendido panorama che di lassù si gode; o al Lago Bracciano, a parlare di archeologia, e di antichi templi pagani ivi sommersi, e delle strane leggende che ivi intorno sono fiorite; o al Molino di Gea, attirati dalla bellezza selvaggia del luogo; o al Mingolino, attesi e sempre accolti con paterna benevolenza dal santo professor Cuoghi di venerata memoria, nume tutelare del nuovo edificio scolastico che avete intitolato al suo Nome. Tempi e ricordi ormai lontani. La vita, con le sue ineluttabili esigenze, presto interruppe quella nostra cara consuetudine. Dovemmo separarci e seguire ciascuno la via che il Signore ci aveva segnata. L’ultima nefasta guerra poi, alzando fra di noi come una barriera, ancor più ci divise, quasi ci avulse l’uno dall’altro, né più ci siamo riveduti. Qui l’ho ritrovato, nel cimitero qui presso, pietosamente ricomposto in quell’umile tomba sulla quale, or ora, mi sono inchinato io e fra poco tutti ci inchineremo, mentre su di essa scenderà, con l’acqua lustrale, la preghiera del sacerdote. Che tristezza, che pianto nell’anima!... 1 Tanta tristezza però viene temperata, almeno in parte, dal vedere finalmente ristabilito, nel campo dei diritti umani, quell’equilibrio che parve un giorno spezzarsi per il funesto insorgere di eventi che furono più forti di ogni nostra volontà. Parlo del diritto che hanno i Morti - tutti i Morti! - di riposare in pace, ciascuno nella propria terra, accanto ai propri Morti: diritto che affonda le sue radici e trova le sue ragioni nelle origini stesse della società umana e che la Religione ha sancito e santificato. Anch’Egli, ora, riposa nella sua terra, accanto ai suoi Morti. Laggiù infatti, sotto la fredda terra del cimitero di San Cataldo, sì lontano dai suoi cari, vivi e morti, sì lontano dai suoi monti, dalla sua Chiesa, dai suoi parrocchiani, il nostro Don Augusto non aveva pace, non poteva avere pace. Sì, lo so, tutti lo sappiamo che qualsiasi tomba, vicina o lontana, fiorita o disadorna, è per sé stessa triste e fredda. Ma ben più triste, e più fredda, e più sconsolata essa si fa, ove non la riscaldi e conforti la pietà dei superstiti. Pesa troppo la terra sui nostri poveri Morti, se su di essa non cade, a quando a quando, per mano nostra un fiore. Pesa troppo la terra sui nostri poveri Morti, se su di essa non ci inginocchiamo, a quando a quando, a versare preghiere e lacrime. Quelle preghiere e quelle lacrime, accolte e benedette da Dio, oh, come scendono consolatrici al cuore dei nostri Morti! E che misteriosi incontri, quali arcani colloqui non fa intessere la Fede fra chi giace in quella tomba e chi su quella tomba si raccoglie e sosta pensoso. Persino Ugo Foscolo, il cantore dei sepolcri, sebbene la sua mente e il suo spirito fossero tanto lontani dalle sublimi certezze della Religione, sentì la divina dolcezza di quei colloqui e la espresse in quei suoi mirabili versi: ...Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi, celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con l’amico estinto e l’estinto con noi: purché la tomba che ne racchiude le ceneri sia confortata dall’amore e dal pianto dei superstiti. No, laggiù, sotto la fredda terra del cimitero di San Cataldo, sì lontano dai suoi cari, vivi e morti, sì lontano dai suoi monti, dalla sua Chiesa, dai suoi parrocchiani, il nostro Don Augusto non aveva pace, non poteva avere pace. Soltanto qui, nel cimitero qui presso, Egli l’ha riavuta la tanto sospirata pace, e gliel’avete ridonata voi, gente di Salto, amici e compaesani miei, accogliendone con amore i resti mortali accanto agli altri vostri Morti e qui accorrendo, oggi, a rievocarne con me la cara memoria. Il suo Spirito, purissimo ed immortale, aleggia sereno in questo momento su di voi e tutti, per bocca mia, vi ringrazia e vi benedice. Sono trascorsi undici anni, undici lunghi anni, da quando il povero Don Augusto, dopo avere cercato al di là delle linee Alleate uno scampo ai pericoli che lo minacciavano da presso, e dopo avere errato qualche tempo qua e là, esule nella stessa sua patria, chiuse mestamente i suoi giorni in una clinica di Modena. Sono trascorsi undici anni; eppure vibra ancora nell’aria l’eco di quella luttuosa notizia che si diffuse improvvisa quassù il 17 giugno 1945, e strinse i cuori, ed afferrò le anime: Don Augusto è morto! Don Augusto è morto!... A quell’annuncio, chi pianse, chi chinò il capo pregando, chi si arrestò pensoso nel suo cammino o sul suo lavoro, mentre i lenti rintocchi della campana maggiore: Pace! dicevano agli esacerbati spiriti, pace, pace!... E Pace! ammonivano le case distrutte, le torri smozzicate, i campi sconvolti dal turbine della guerra; Pace! invocavano i Morti, antichi e recenti, dalle loro fosse sparse un po’ ovunque. Poi, dopo il sacro rito di Trigesima, celebrato nella Chiesa devastata e muta, uno di voi, Reverendi Sacerdoti - l’Arciprete di Montese Don Antonio Dallari - parlò di lui con commosse parole, mettendone in giusto rilievo la serena fanciullezza, la precoce e forte intelligenza, la vocazione al sacerdozio, la mistica ascesa all’Altare, il candore del costume, la pietà, la saggezza, lo zelo, la vasta cultura, i meriti verso il suo popolo, la sua Chiesa, il suo Comune. Non vi dispiaccia, cortesi ascoltatori, riudire oggi quello che fu detto allora di Lui. Nacque il nostro Don Augusto qui a Salto il 6 novembre 1873. Fanciullo di vivace ingegno, di animo buono e pio, di esemplare compostezza nel portamento, fu avviato agli studi medi dallo stesso 2 suo parroco Don Cesare Valloni che, ravvisando in lui i segni di una probabile vocazione al sacerdozio, lo aveva preso a ben volere. Poi passò a Lucca, nel Collegio Salesiano di S. Croce, dove, per la generosità di un pio suo benefattore, poté compiere gli studi ginnasiali, sempre eccellendo per ampiezza e profondità di profitto. Infine passò a Nonantola, nel cui Seminario compì brillantemente gli studi filosofici e teologici e dove, nel 1898, venne consacrato sacerdote. La stima e l’affetto che, in quegli anni della sua formazione sacerdotale, Egli seppe guadagnarsi presso i Superiori, e l’ascendente che già esercitava sui giovani Seminaristi, gli ottennero subito la nomina di Insegnante nel Seminario stesso, dove occupò, successivamente, le cattedre di Italiano e Latino nel Ginnasio Superiore e nel Corso filosofico, o Liceo, poi quelle di Storia Ecclesiastica e di Eloquenza Sacra nel Corso teologico. Quanta luce di sapere Egli profondesse nel suo insegnamento e quanto felice ed efficace fosse il suo metodo didattico, ben posso farne testimonianza io stesso, che lo ebbi Maestro nei tre anni di Liceo. Nel 1902, Don Augusto passò dal Seminario di Nonantola al Seminario di Fiumalbo quale titolare della cattedra di Filosofia, e lassù appunto Egli cominciò a svolgere una feconda e più vasta attività anche fuori della sua scuola e del Seminario. Fu infatti uno dei Soci più attivi di quell’Associazione culturale, costituitasi in quegli anni a Pievepelago, che, chiamata dapprima Circolo Scoltenna ed eretta poi in Ente morale sotto il nome di Società letteraria Scoltenna, ebbe ed ha tuttora sì larga eco in tutto il Frignano. Nel 1906, essendo stato soppresso il Corso filosofico nel Seminario di Fiumalbo, Egli venne meritamente eletto, secondo il voto unanime della popolazione, a reggere questa parrocchia di Salto, resasi vacante, proprio in quell’anno, con la morte del venerando Arciprete Don Valloni, Così Don Augusto, per un provvidenziale evolversi e concatenarsi di eventi, partitosi di qua fanciullo, qui ebbe a fare ritorno nella matura età quale pastore di anime e guida del suo popolo. Che Sagra memorabile fu per Salto quella del 15 agosto di quel lontano anno, quando Don Augusto prese possesso della parrocchia, e con che fervoroso slancio, con quale esultante affetto clero e popolo si strinsero allora attorno al novello Arciprete! Pochi di voi forse lo ricordano, ché troppo è ormai il tempo trascorso; ma ben lo ricordo io, bene ricordo la commozione che mi prese quando, alla Messa solenne, intonato che ebbe Don Augusto, con voce malferma per il nodo di pianto che gli serrava la gola, il Gloria in excelsis Deo, proruppe festoso nella Chiesa gremita il suono dell’organo a pieno registro, e nel sagrato attiguo rullarono giulivi i tamburi, e dal campanile si diffuse tutt’intorno l’armonioso concento delle vostre campane, e dal prato sottostante la canonica echeggiarono per l’aria i colpi dei mortaretti e dei razzi artificiali. Parve proprio che cielo e terra unissero la loro voce alla voce degli uomini per festeggiare il lieto evento. A Salto le belle doti di mente e di cuore di Don Augusto rifulsero e si affermarono in pieno. Egli invero non fu soltanto il pio sacerdote che conforta e regge le anime nel cammino della virtù, o il solerte parroco che cura, restaura, amplia, abbellisce la sua Chiesa e coscienziosamente adempie tutti i doveri del suo sacro ministero; ma fu anche l’iniziatore e propulsore del progresso economico e sociale del suo paese, nonché lo studioso attento ed instancabile che, innamorato della sua terra natia, ne vuole conoscere e penetrare la segreta vita, indagandone le secolari vicende, dalle più remote origini ai giorni suoi. In quale alto concetto Egli fosse tenuto dalle Autorità Ecclesiastiche per il suo illuminato insegnamento nei due Seminari della diocesi, per la saggezza dei suoi consigli, per il suo zelo e la sua operosità in ogni ramo della vita parrocchiale, lo testimoniano la sua nomina a Canonico Onorario dell’augusta Abbazia di Nonantola e il delicato Ufficio di Vicario Foraneo in questa zona, che la Curia di Modena ebbe ad affidargli. Ed in quale alto concetto fosse pure tenuto dalle Autorità Civili per le sue benemerenze nel campo dell’agricoltura locale, lo dice l’aperto riconoscimento avutone dal Governo italiano, che volle citarne il Nome all’Ordine del Giorno della Nazione, quando l’Italia, promovendo la cosidetta Battaglia del grano, tentò di raggiungere una sua autonomia economica. Don Augusto infatti - voi stessi, gente di Salto, ne foste i testimoni oculari - per assicurare a voi e al paese un pane sempre più bianco e sempre più abbondante, fu un convinto e tenace pioniere dei più moderni sistemi di agricoltura e di agronomia, mostrando con la parola e con l’esempio come si go3 vernano i terreni, come si bonificano gli acquitrini, come si eliminano le masere e le salde, come si adeguano ai nuovi bisogni e alle progredite esigenze della vita moderna i vecchi fabbricati colonici: conseguendo con questa sua nuova e lungimirante attività risultati che apparvero e furono veramente sorprendenti. Questo fu, in rapida sintesi, il suo apostolato parrocchiale. Ma qui bisogna far parola anche di un’altra attività che rifulse nel nostro Don Augusto, mirabilmente associata a quel suo apostolato ed in perfetta armonia con esso, l’attività letteraria, per la quale chiaro risonò ed ancora risuona il suo Nome in tutto il Frignano. Terso scrittore e bene agguerrito polemista, Don Augusto fu presente, infatti, su quasi tutti i giornali e periodici della regione: la Ghirlandina, lo Scoltenna, il Diritto Cattolico, il Giornale di Modena, l’Eco del Panaro, il Frignano, l’Avvenire d’Italia, la Giovane Montagna: i quali ben volontieri ne accoglievano e ne sollecitavano la collaborazione. Su di essi Egli andava pubblicando, in uno stile semplice e volutamente disadorno, o racconti e novelle di ambiente locale, o spigolature storiche, o note folcloristiche, od altre cose di simil genere, quali si possono leggere ancor oggi in due grossi quaderni, dal titolo Sfumature di vita popolare e La mia montagna, che la sorella Teresa, memore quanto cara fosse a Don Augusto la Società Scoltenna, ha depositati con altri suoi manoscritti nell’Archivio di quella Società. Ma il più delle volte erano articoli vivaci, a spunto polemico, coi quali Egli propugnava gli interessi morali civili religiosi della sua gente, strettamente connessi, nel suo pensiero, al bene economico e sociale di essa. Senza dire, invero, della vasta eco che quei suoi articoli suscitavano nel campo politico e amministrativo del Comune, molti di voi certo ricordano che, se Salto poté ottenere l’istituzione di un suo Ufficio Postale e l’impianto dell’acquedotto e l’ampliamento delle scuole elementari, questo avvenne per l’instancabile interessamento di Lui e per l’efficacia degli articoli che Egli pubblicava in proposito. Oggi, a tanta distanza di tempo e nel ritmo vertiginoso della vita moderna che, anche quassù da noi, tutto va modificando e trasformando col suo incessante dinamismo, quelle sue benemerenze sembrano come scolorirsi e perdere il loro fascino; ma quaranta o cinquant’anni fa, quando quassù la vita, per così dire, stagnava, quelle benemerenze apparvero e furono una vera conquista. Ora, a conferma appunto di quanto sono venuto fin qui dicendo intorno all’attività letteraria del nostro Don Augusto, mi piace riferivi, testualmente, il giudizio che ne ha dato anche il prof. Ferruccio Pedrazzoli, Preside del Ginnasio-Liceo San Carlo di Modena e Presidente della Società Scoltenna: il quale, dopo avermi fornite, da me pregato, ampie notizie sui manoscritti di Don Augusto conservati a Pievepelago, così mi scriveva il 18 luglio dello scorso anno: “Banorri non era un grafomane, bensì un uomo che sentiva e che sapeva vedere. Possiede, in generale, uno stile facile, brioso, chiaro. Ama e comprende la sua gente e la sa ritrarre nelle abitudini, nei gusti, nei pregi e nei difetti. Il suo intento è quello di educare e di emendare, e quello insieme di descrivere i suoi monti nei loro aspetti più belli. E’ un innamorato dei monti. Lo ricordi, egregio professore, come un benemerito, e come una delle figure più geniali, fra le molte geniali che si trovano nel Frignano. Il povero prof. Gimorri lo amava e parlava di lui con affetto e con ammirazione. Io non l’ho conosciuto, ma lo avverto assai nostro e assai vicino al mio spirito leggendo i suoi scritti. Si dovrebbe di questi pubblicare qualcosa; forse ne vale realmente la pena. E si farebbe un regalo alla Montagna”. Belle e giuste parole, delle quali rendo qui all’illustre professore pubbliche grazie. Agli scritti del compianto amico, più sopra ricordati, un altro se ne può aggiungere, Campane e campanili del Comune di Montese, che - se l’Archivio parrocchiale di Salto non è andato disperso durante la guerra - si dovrebbe trovare ivi giacente. Egli stesso così me ne dava notizia in una sua lettera del 15 gennaio 1943: “In questo tempo, alla mia modesta attività parrocchiale ho aggiunto la compilazione di un lavoruccio suggeritomi dalle circostanze, voglio dire dal decreto di requisizione delle campane. Ho pensato fra me: se è giocoforza che le campane se ne vadano, resti almeno la loro memoria. Perciò ho compilato in gran parte una monografia dal titolo: Campane e campanili del Comune di Montese. Non storia, ma solo note sulla loro fusione, grossezza, sonorità etc., ponendo cura specialmente nel ricopiare le iscrizioni, i motti e le invocazioni dettate dalla fede e dalla pietà popolare. M’è toccato salire sui campanili, e rovistare anche gli archivi parrocchiali, ma ora sono soddisfatto della fatica”. 4 Esista ancora o più non esista l’interessante manoscritto, esso documenta pur sempre il vigile amore che animava Don Augusto verso le patrie memorie e verso tutto ciò che ad esse comunque si riferisse. Monumenti di tale sua peculiare attività ci restano, a stampa, una sua monografia su San Pellegrino dell’Alpe e la sua Storia di Montese. Anche Don Augusto capiva e sentiva di avere fatto, con quelle due pubblicazioni, opera non caduca, e se ne compiaceva, e tutto se ne consolava, pensando forse al non omnis moriar di oraziana memoria. Lo desumo da una sua lettera, in data 29 dicembre 1944, nella quale comunicava all’amico Don Giovanni Barbieri, Prevosto di Castelluccio Moscheda, di averlo segnalato per l’inclusione in quel Dizionario dei Frignanesi illustri, che Don Arturo Rabetti stava allora compilando. In quella lettera Don Augusto diceva di sé: “Io la maggior gloria l’attendo da due opere, pur esse già pronte, ma che difficilmente vedranno la luce: San Pellegrino (terza edizione) e Montese (seconda edizione). Chissà che non venga voglia a qualche studioso di metterle poi in luce, quando io non sarò più che un pugno di polvere, supposto sempre che gli uomini conservino qualche barlume almeno di amore per il vero e per il bello”. Povero Don Augusto, già quasi presago della prossima sua fine! Esaminiamole un po’ da vicino codeste due opere. San Pellegrino in Alpe - tale è il titolo dell’opuscolo - è un ampio ed accurato Saggio storico-critico intorno a quell’antico santuario che è meta ancor oggi di devoti pellegrinaggi e sul quale Don Augusto ebbe a fermare la sua attenzione di studioso nei quattro anni di sua permanenza nell’alto Frignano, riuscendo a raccogliere intorno ad esso un’abbondante messe di notizie e di dati, che poi riordinò e rielaborò qui a Salto, nella serena quiete della sua canonica. Se non per la sua originalità, giacché altri valenti studiosi, prima di Lui, si erano occupati dell’argomento, certo per la completezza della trattazione, l’opera ha una sua intrinseca importanza e segna un punto di arrivo o pietra miliare, da cui dovranno prendere l’avvio quanti, in avvenire, vorranno mettersi su tale cammino. L’Autore infatti non si limita soltanto a raccontare quello che di storico o di leggendario ci hanno tramandato gli scrittori intorno alla vita e al culto di S. Pellegrino e del suo compagno S. Bianco, ma illustra anche e adeguatamente documenta le origini e le vicende della chiesa e dell’ospizio costruiti lassù in remotissimi tempi, e si diffonde soprattutto sulla secolare controversia, mai nettamente definita, a chi spetti, di diritto, la giurisdizione ecclesiastica e civile su quel valico appenninico dove confluiscono i confini territoriali di diocesi e di provincie diverse. Basti dire - annota, a questo proposito, l’Autore - che oggi, su quel punto, la giurisdizione ecclesiastica viene esercitata dal vescovo di Massa Carrara, ma non senza esplicite riserve da parte delle curie vescovili di Reggio Emilia e di Modena; e che il paese, ossia l’agglomerato civico di San Pellegrino, dipende parte dal Comune di Frassinoro, in provincia di Modena, e parte dal Comune di Castiglione Garfagnana, in provincia di Massa Carrara. Naturalmente, non spettava al nostro Don Augusto dirimere l’indirimibile controversia che neppure un Muratori e un Tiraboschi erano riusciti a risolvere: gli va però data ampia lode per averla Egli storicamente prospettata nei suoi termini e nel suo svolgimento. Il bell’opuscolo, adorno di cinque tavole fuori testo, fu pubblicato nel 1915 presso la Società Cattolica Tipografica di Modena, e reca la seguente dedica, che è come un’eco dell’affettuosa voce di Lui: Alle mie buone sorelle / Berenice Emma Teresa / Agli amici vicini e lontani / Con immutabile affetto / Questo tenue lavoro consacro. Molto più da vicino ci riguarda e ci interessa la monografia su Montese, la quale non solo rappresenta un fattivo contributo alla migliore conoscenza di questa cara terra dove siamo nati, ma costituisce anche, per Don Augusto, un titolo di benemerenza verso il nostro Comune, al quale Egli ha dato una Storia che Montese non possedeva, tale non potendosi considerare, sebbene sia un lavoro pregevole sotto ogni rispetto, il breve excursus pubblicato da Mons. Enrico Zaccaria nel 1924: Montese nella Storia. Più vasta e più esauriente è l’opera di Don Banorri: un volume di 265 pagine dal titolo Montese e suo territorio, che vide la luce a Bologna nel 1929, presso la Tipografia di Giorgio Gazzotti, e che si estende dalle remote origini del Comune al 1928. Le fonti storiche - maggiori e minori, dirette e indirette - che l’Autore cita qua e là a piè di pagina ed elenca poi alla fine del volume, chiaramente attestano e documentano, con quanto amore, e dili5 genza, e costanza, e serietà di intenti, e rigore di metodo Egli abbia intrapreso e condotto a termine il suo lavoro. Non restrinse Egli la trattazione ai soli eventi o fattori civili e religiosi, ma la estese anche ai multiformi aspetti della vita economica e sociale del Comune e a tutti i fenomeni di varia natura che a codesta vita comunque si riferiscano; né la circoscrisse al solo territorio di Montese, ma opportunamente la inserì ed inquadrò in quelle che furono le vicende dell’intera regione: sicché, dalla conoscenza delle condizioni politiche e sociali del nostro Comune, facile a noi riesce renderci approssimativamente conto anche delle condizioni politiche e sociali di tutto il Frignano attraverso i secoli. E’ interessante - ed anche piacevole - per noi che ci troviamo, per così dire, al centro della narrazione, scorgere nella lontananza dei tempi il lento evolversi ed attuarsi degli ordinamenti civili e religiosi del nostro Comune e delle singole sue frazioni; seguire le alterne vicende di questa povera terra, corsa e ricorsa continuamente dalle soldatesche bolognesi e modenesi che se ne contendevano il possesso; vedere i nostri padri reggersi, qualche volta, e governarsi da soli, ma più spesso, a seconda del prevalere dell’una o dell’altra parte, dell’una o dell’altra fazione, fare atto di sottomissione ai vari signorotti dei dintorni, si chiamassero essi Gualandelli, o Guidotti, o Tanari, o Montecuccoli, per finire poi definitivamente sotto la signoria degli Estensi; afferrare gli echi che quassù giungevano o della Rivoluzione Francese, o delle vittorie napoleoniche, o dei moti del Risorgimento nazionale, e i fermenti che quegli echi qui suscitavano; conoscere il largo tributo di sangue versati dai nostri fratelli nella prima guerra mondiale; incontrare infine, qua e là, nomi di nostri conterranei che ebbero a segnalarsi o per forza d’ingegno o per corredo di virtù: alti prelati della Chiesa, governatori di provincie, consiglieri aulici, giureconsulti, scienziati, letterati, martiri del nostro Risorgimento, che possibile non è qui elencare, tanto sono numerosi: da un Padre Bernardo di Montese, che sul principio del secolo XIV fu vescovo in Corsica, al benedettino Fortunato Tamburini, che fu creato Cardinale da Papa Benedetto XIV nel 1743; dall’Ing. Carlo Tamburini, che ebbe a soffrire carcere ed esilio per avere partecipato alla congiura di Ciro Menotti nel 1831, all’avvocato Carlo Lucchi, che fu Deputato all’Assemblea Costituente di Modena del 1859, in cui venne decretata la decadenza degli Estensi; dal pio e zelante Pasquale Bononcini, vero apostolo in mezzo al suo popolo di San Giacomo Maggiore, a Don Emilio Bernardi, appassionato cultore egli pure della storia locale, all’abate Giuseppe Mazzetti, geologo ed echinologo di fama nazionale, a Mons. Enrico Zaccaria, consumatissimo filologo, del quale lo stesso Don Banorri tessé l’elogio funebre nelle solenni onoranze che qui gli furono rese il 2 settembre 1926. Né soltanto questo contiene il volume. Gli studiosi di economia e di sociologia, ad esempio, troveranno in esso frequenti e interessanti dati sulla distribuzione della proprietà terriera e della ricchezza, sui prodotti del suolo, sui sistemi di agricoltura qui in uso, sulle industrie locali, sul commercio, sull’emigrazione etc.; e per chi si diletta di folklore, sono in esso ammanite gustose notizie sulle superstizioni, le leggende, gli usi e i costumi nostrani; chi invece si occupa di meteorologia e dei fenomeni ad essa attinenti, vi troverà fatto ricordo di cicloni, di piogge e nevicate eccezionali, di terremoti, frane, carestie, pestilenze, che hanno funestato il paese nel corso dei secoli; e non mancano neppure rapidi cenni sulla geologia, la mineralogia, la flora e la fauna del nostro suolo. Considerata l’opera sotto questa luce ed impostata in questi termini, io non ho che a confermare oggi il giudizio che ne diedi, ventisette anni or sono, scrivendone a Don Augusto. Gli dicevo infatti: “E’ un lavoro, il tuo, curato in ogni parte con grande amore, elaborato con metodo, condotto con chiaro intendimento del suo fine pratico e divulgativo, non disgiunto dalla speranza di fare anche un po’ di bene all’anima del lettore. Quante volte infatti, accanto allo storico, fa capolino il moralista e il laudator temporis acti! Alla sintesi coscienziosa delle fonti storiche da te citate si aggiunge il prezioso contributo delle tue indagini personali e della tua esperienza locale, che dona al libro un pregio che nessuno potrà mai disconoscere. La critica indubbiamente lo addenterà, poiché non vi mancano (non te lo nascondo) dei punti vulnerabili: esso però, nel suo insieme, resisterà”. Quale giudizio ne abbia dato la critica non so, od almeno nessuna eco me ne è giunta mai in tutto il tempo che fui direttore della Biblioteca Gambalunghiana di Rimini, né dopo. In ogni modo, è certo che, se si dovesse addivenire - ed è augurabile che si addivenga - ad una nuova edizione dell’opera, 6 qualche sfrondatura, qualche ritocco, fors’anche qualche emendamento si renderanno necessari: non per questo, però, ne verrà toccato o diminuito l’intrinseco valore. Sarebbe incompleto il mio dire, se non facessi anche un breve cenno di una Cronaca manoscritta che l’affezionata sorella di Don Augusto, Teresa, amorosamente conserva presso di sé. Quella Cronaca, fatta - come il nome stesso lascia intendere - di semplici e scarne registrazioni di eventi che all’Autore parvero degni di memoria, abbraccia soltanto il periodo che corre dal gennaio 1908 al gennaio 1945: ma non è né può chiamarsi una prosecuzione o completamento della Storia a stampa, pure costituendo essa una fonte preziosa per chi di quella Storia vorrà un giorno procedere ad una nuova edizione. Sono infatti pagine di palpitante attualità - come oggi comunemente ci si esprime -, pagine anche commoventi, in quanto che emergono da esse, e ci vengono incontro, e ci parlano al cuore, cari volti di persone che abbiamo conosciute e che più non sono; vi troviamo ricordati eventi, or tristi or lieti, che abbiamo noi stessi vissuti o come attori o come spettatori; ed infine ci si para davanti agli occhi della mente la terrificante visione dell’ultima guerra, dapprima coi suoi lontani echi di battaglie, ritirate, bombardamenti dal mare, sbarchi di truppe, incursioni aeree sulle belle e fiorenti città d’Italia; poi nel suo lento e pauroso avanzare verso le nostre terre; poi nel suo furioso irrompere su di noi dal Monte Belvedere; e finalmente nell’ultima sua fase, quella che Don Augusto chiama la battaglia di Montese: gennaio 1945. Qui, a questa data, la Cronaca improvvisamente si arresta con queste poche parole in poche righe: “La lotta, in seguito, si svolse nelle vicinanze del Capoluogo: gli Alleati si attestarono cioè sui monti delle Borre, dei Tufi, di Montarigola e di Scanello; i Tedeschi si fermarono sulle vette che sovrastano il paese”. Null’altro! La pagina è rimasta bianca a metà, e bianchi sono rimasti tutti i fogli successivi. Debbo dirlo?... Quando mi trovai di fronte a quell’improvviso arresto dello scritto, l’animo mi si strinse di pietà e di tristezza. Mi balenò al pensiero la lettera, da me più sopra citata, che Don Augusto aveva scritta pochi giorni prima - 29 dicembre 1944 - a Don Giovanni Barbieri e che si chiudeva purtroppo in un tono di profondo turbamento, con chiari accenni alla sua vita di ansie, di timori, di preoccupazioni. Come per un’improvvisa associazione di idee, mi parve di capire, quasi mi parve di sentire che proprio in quel momento dovette forse precipitare l’angoscioso dramma. Giunto Don Augusto a quel punto della sua Cronaca, forse non poté, forse non gli resse l’animo di procedere più oltre, fors’anche si profilò ai suoi occhi, od almeno al suo spirito, un pericolo immediato, al quale non era possibile sottrarsi se non allontanandosi e nascondendosi. Lasciò allora la sua canonica; errò, triste e sgomento, pei boschi vicini, rivelandosi soltanto a qualche persona amica o caritatevole: il 1° aprile celebrò la Pasqua nella sperduta chiesa dei Bertocchi, chiedendo a Dio consiglio e aiuto; poi, il giorno seguente, col pianto nell’anima, varcò le linee Alleate. Sassomolare, Gaggio Montano, Firenze, Fiesole furono le sue dolorose tappe. Poi, quando finalmente i Tedeschi furono cacciati oltre i sacri confini della Patria, e per le piazze e per le vie s’alzarono i canti della Liberazione, anche Don Augusto ricomparve quassù e si inginocchiò piangendo nella sua Chiesa, pressoché solo, pressoché ignorato!... Ma breve fu il suo ritorno, giacché, fiaccato ormai nello spirito, minato anche nel fisico da un insidiosissimo male, il 1° giugno 1945 dovette farsi accogliere in una clinica di Modena. E in quella clinica, diciassette giorni dopo, morì: santamente morì, pregando e perdonando, come si addice a un sacerdote di Cristo; e laggiù fu sepolto, accompagnato all’ultima dimora da pochi suoi intimi, oranti e piangenti. Che lungo soffrire, che desolata morte, che desolata sepoltura fu la tua, povero Don Augusto!... Qui almeno, sotto il tuo bel cielo, nel tuo tranquillo cimitero, dove tanti tu hai accompagnati e composti dei tuoi parrocchiani e dove te pure ha finalmente riaccompagnato e composto la pietà dei superstiti, ti sia leggera la terra. Riposa in pace! Riposa in pace! Reverendi Sacerdoti, amici e compaesani miei, che con tanta attenzione e benevolenza mi avete ascoltato; che ho sentiti sì vicini al mio cuore e all’anima mia mentre parlavo: inchiniamoci reverenti alla sua memoria; inchiniamoci reverenti alla memoria di quanti dei nostri fratelli hanno sofferto e sono morti per la Patria, per la Libertà, per il Dovere; uno dei quali - l’ultimo dei nostri gloriosi Caduti -, nel cui Nome si riassumono, per così dire, e si glorificano tutti gli altri; cresciuto alla scuola 7 di un Padre che potrebbe meritamente essere assunto nel Cielo dei Santi, è stato assunto dalla Patria nel cielo degli Eroi: Pio Cuoghi, Medaglia d’Oro. Tutti questi Spiriti purissimi, mentre noi qui li rievochiamo commossi, fanno in Cielo affettuosa corona all’integerrimo sacerdote che fu a loro, qui in terra, guida ed esempio nelle vie del bene; e tutti, ad una voce, implorano con lui: Pace, o fratelli!... Pace nelle vostre anime, nelle vostre case, nei vostri campi, pace, pace!... Ascoltiamola questa cristiana invocazione, che ci giunge da un mondo ove regna soltanto l’amore: mondo invisibile ai nostri occhi, mondo inafferrabile dai nostri telescopi, ma vero, ma certo, che sta e si apre infinito oltre quell’estremo traguardo al quale siamo tutti incamminati. Ascoltiamola questa cristiana invocazione che risuona, in questo momento, intorno a noi e dentro di noi, che tutti ci solleva in una mistica luce soprannaturale, che tutti ci riempie e conforta di ineffabili speranze. Ascoltiamola ed accogliamola nelle anime nostre, con quell’amore, appunto, e per quell’amore che tutti ci avvince alla santa memoria dei nostri Morti. Pace! Pace! I Montecuccoli di Montese - Percorso storico 8
Scarica