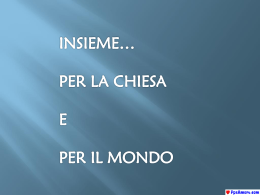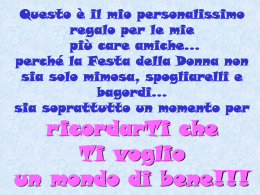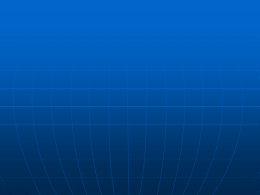Associazione culturale umanistica
“ All’ombra del Monviso “
C. Sismonda: “Pensando a Picasso”, 1999
“ANTINOO”
la bellezza nella diversità / la diversità della bellezza
Racconigi, 29 giugno 2013
1
In copertina: C. Sismonda “Pensando a Picasso”, 1999, gessetto policromo
2
3
4
Pensando a Picasso,
come dichiara nel titolo, Carlo Sismonda ha eseguito negli anni
Novanta il ritratto di un ragazzino triste vestito da Arlecchino.
Questa immagine oggi viene scelta per rappresentare Antinoo, il
bellissimo bitinese amato dall’imperatore Adriano e annegato nel
Nilo (?), o più probabilmente sacrificato attraverso un’uccisione
rituale.
La successiva divinizzazione del giovane, assolutamente voluta
dall’imperatore che gli aveva dedicato un tempio all’ingresso della
sua villa di Tivoli, e la conseguente proliferazione di statue e di
rappresentazioni idealizzate, ha fatto di Antinoo uno dei più noti
modelli di bellezza maschile del mondo classico; tanto da far
certamente dimenticare la valenza tragica della sua storia, la crudeltà
del destino di qualcuno che la leggenda vuole essere stato ucciso per
la sua bellezza e che la storia successiva vede, una seconda volta,
esecrato e condannato per la sua pederastia; tanto che i primi
cristiani non esitarono a distruggerne o a deturparne moltissime
effigi, considerate ormai emblema di turpitudine e di devianza
demoniaca.
È tutto questo, questo aspetto rimosso ed oscuro del destino
materiale e simbolico di un ragazzo che l’associazione fra il bambino
di Sismonda e l’antico amante divinizzato vuole riportare
all’attenzione di una contemporaneità altrettanto pronta a scagliare i
suoi anatemi e le sue condanne senza appello su “diversi” di volta in
volta identificati in base alle abitudini sessuali, all’appartenenza
etnica o culturale, in base all’ideologia o semplicemente al
pregiudizio.
In gioco, ed esposta agli occhi, qui c’è solo la mortificazione di un
bambino, tratteggiato nella grana luminosa dei gessetti, con colori
morbidi e una certa intensificazione di tensione grafica soltanto nel
contorno del volto e intorno alla curva scura della nuca e delle
spalle. Di Picasso Sismonda non ha colto, forse volutamente,
l’ambiguità adolescenziale degli arlecchini e dei saltimbanchi così
frequenti nel periodo blu, proiezioni di umore saturnino e di
malinconia mortifera, gettata su di lui dal suicidio dell’amico Carlos
Casagemas e, certo, anche dalla difficile ricerca di se stesso come
artista ancora straniero e solo a Parigi, fuori dall’orbita opprimente e
protettiva del padre.
5
Se, come sempre in Picasso, la proiezione di amori, umori e
desideri si trasfigura in immagini, colori, segni e uno stile distintivo
che affonda le radici nella consistenza esistenziale da cui quelle
immagini derivano ma che questa stessa consistenza trascende nelle
forme eleganti, anzi sublimi, memori del manierismo italiano come
delle estenuate atmosfere post-impressioniste, Sismonda invece
lascia tutto nel vago – non propone una storia personale, non lascia
intravedere molto di sé. C’è solo quest’immagine silenziosa e opaca,
tenera come il tocco del gessetto che, a questo punto, interpella
direttamente noi, le nostre proiezioni e la nostra sensibilità.
Non ci guarda questo fanciullo colorato, non ha più sguardo per
guardare, come non ha parole da dire, da far sentire. La sua è una
muta mancanza di gioia, a monte della parola articolata, inaridita,
sterile. A questo punto, ciascuno è lasciato libero, a ciascuno il suo
linguaggio e la sua interpretazione: la psicoanalisi ? dice “trauma”.
La giustizia ? ”abuso”. La morale ? “ingiustizia”.
Ci si potrebbe anche esercitare a fantasticare ragioni e retroscena
dello stato di cose evocato dall’immagine, ma quest’ultima rimane
muta e anche sorda alla forzatura interpretativa che ognuno articola
incessantemente in base al suo vissuto, opinione, stato d’animo,
fantasia. Mentre l’aspetto più interessante resta nell’evidenza di
questo mutismo, che si vorrebbe dire ostinato nel conservare il
segreto che è la sua ragion d’essere.
L’immagine non è ambigua, ma scatena una ridda di interpretazioni
e di associazioni infinitamente arbitrarie e sempre inadeguate ad
abbracciare la semplice presenza di quel dolore rappresentato in
quanto tale, sterminato nella sua inaccessibilità e che forse,
depositandosi lentamente in chi acconsenta ad aprirsi ad un istante
di altrettanto silenziosa contemplazione, potrebbe suggerire non una
reazione, sempre opinabile, limitata, contingente, ma un
cambiamento – il cambiamento che permette davvero la
considerazione dell’altro, della sua abissale distanza, della sua
inscalfibile pregnanza, della sua preziosa inaccessibilità. Così, forse,
Antinoo. Così, forse, Picasso e Sismonda.
Dipende da noi.
Martina Corgnati
6
7
8
Associazione culturale umanistica
“ All’ombra del Monviso “
“ANTINOO”
la bellezza nella diversità / la diversità della bellezza
Contributi di
Mario Abrate Anna Alasia Ezio Albrile Francesca Antonino
Domenico Appendino Beppe Artuffo Umberto Casale
Natascia Chiarlo Renato Coda Martina Corgnati Piero
Flecchia Ezio Fulcheri Gianna Gancia Lino Lantermino
Beppe Mariano Lorenzo Orione Vanna Pescatori Carlo Petrini
Gianni Rabbia Sergio Soave Ugo Volli
Racconigi, 29 giugno 2013
9
Patrocini
Provincia di Cuneo
Città di Racconigi
Città di Savigliano
Città di Torre San Giorgio
ASL CN 1
L’associazione culturale umanistica “All’ombra del Monviso”, nella
persona del Presidente dott. Mario Abrate, ringrazia per il sostegno
alla pubblicazione degli atti del convegno
“ANTINOO”
la bellezza nella diversità / la diversità della bellezza
la Provincia di Cuneo nella persona del Presidente
sig.ra Gianna Gancia,
la Città di Racconigi nella persona del Sindaco
sig. Gianpiero Brunetti,
la Città di Savigliano nella persona del Sindaco
prof Sergio Soave
la Città di Torre San Giorgio nella persona del Sindaco
geom. Mario Monge,
l’ASL CN 1 nella persona del Direttore Generale
dott. Gianni Bonelli,
gli Autori dei contributi,
il “Centro cicogne” di Racconigi nella persona del
dott.ssa Lorenza Vaschetti,
il dott. Ilario Bruno, per la collaborazione all’organizzazione del
convegno;
il prof. Gabriele Abrate, per la precisione nella correzione delle
bozze.
Con l’edizione del volume, l’Associazione “All’ombra del Monviso”
ha promosso anche l’edizione della stampa “Pensando a Picasso”
del Maestro Carlo Sismonda, tirata in 130 esemplari
10
“ANTINOO”
la bellezza nella diversità / la diversità della bellezza
Nel mito di Antinoo misuriamo tutta la distanza culturale: la
sostanziale difformità tra le visioni del mondo pagano e del mondo
costruito sulle categorie biblico-evangeliche dai teologi e padri della
chiesa, visione poi trapassata in principi giuridici e norme
comportamentali, a caratterizzate la tradizione occidentale.
Entro questa tradizione giudaico-cristiana il mito di Antinoo ha
interrogato e continua a interrogare artisti e pensatori
dell'Occidente, in ragione di un preciso sentimento originario;
generativo del mito nella sensibilità del grande imperatore filosofo, e
che sempre nella nostra lingua un solo vocabolo individua
adeguatamente: stupore.
Adriano ha raggiunto una articolata e complessa visione del mondo,
quale ancora ci emoziona, quando avviciniamo le sue grandi pagine,
eppure la visione dell'adolescente in fiore lo turba e lo commuove,
gli svela quanto profondamente sia anche nella persona di più
elevato sentire radice il sentimento naturale dell'eros; che nella
propria coscienza Adriano sente attraversare e annichilire la grande
costruzione metafisica interiore, ma anche trasformare la pulsione
sessuale originaria in un complesso gioco di tenerezze e protezioni
dell'adulto verso il giovane.
Il mito di Antinoo svela il turbamento non solo dell'uomo antico
davanti al momento nel quale, contro un ordine culturale articolato,
l'istanza naturale costringe a un ripensamento interiore e a un tempo
di tutte le relazioni sociali. Questo si compendia nel mito di
Antinoo, che noi cogliamo nello specchio di Adriano, ma qual'è
l'immagine di Adriano nello specchio dell'adolescente Antinoo?
Questo altro rispecchiamento è il senso dell'adolescente nella figura
realizzata da Carlo Sismonda: sguardo di stupore della coscienza che
si desta davanti al mondo; trattenere, fermare nelle coscienze il cui
valore è la funzione essenziale nell'arte.
Ogni opera di Carlo Sismonda sorge dallo stupore segreto che coglie
la sua coscienza attraverso il suo sguardo, davanti a quel quotidiano
che lo sguardo culturale ha banalizzato: usurato fin nelle parole,
come ci dicono tante e troppe affabulazioni e letterarie e televisive.
Restituire la percezione vera della bellezza, attiva in ogni nostro
presente, sottrarla all'usura della sua banalizzazione: questo è il senso
11
dell'arte. E questo appunto ci dice nel disegno, da noi scelto a
emblema del convegno, il maestro Carlo Sismonda; ci fa percepire
attraverso lo sguardo di un adolescente, senso originario di ogni
operazione estetica. Ma ci sono società che non vogliono percepire
il moto di stupore originario naturale che l'artista coglie, chiudendosi
così in fortezze giuridiche, ma che sono solitudini e a un tempo
condannando a una piccola privata solitudine ogni vita.
12
Il destino di un amore ambiguo
È un’alba o un tramonto?
Per l’Uomo che emerge dal ventre
dell’umida terra,
dall’antro più oscuro
che l’anima tende a celare,
terribile albergo del Mostro,
cos’è quella palla di fuoco
che sull’orizzonte
si lascia ammirare
e pare che danzi?
Per l’Uomo che lascia vincente
le orribili tenebre,
che ha udito la Bestia,
annusato il suo puzzo,
l’ha morsa, l’ha uccisa,
è un’alba e un tramonto
e l’occhio che torna alla Luce
si bagna per sempre
dei raggi del sole
forieri di pace, di amore,
d’immensa armonia.
Beppe Artuffo
13
14
Sommario
Martina Corgnati
Pensando a Picasso
“ANTINOO” la bellezza nella diversità/la diversità della bellezza
Beppe Artuffo
Il destino di un amore ambiguo
Gianna Gancia
Antinoo. La bellezza della diversità/La diversità della bellezza
Ugo Volli
Gli intrecciati oracoli di un nome che forse non è tale
Mario Abrate
La bellezza nella diversità/la diversità della bellezza: la risposta alla
bellezza nell’arte secondo l’amigdala
Umberto Casale
Bellezza. Amore e Verità. Un percorso filosofico e biblico
Francesca Paola Antonino
La bellezza dell’icona, imago Dei, la Scrittura si fa Immagine
Ezio Albrile
Il potere della diversità: i Magi evangelici
Domenico Appendino
L’arcana bellezza della scrittura nella Cina antica
Renato Coda
Identità immaginaria, diversità suo malgrado – Divagazioni
sul tema
Beppe Mariano
Il giovane aitante
Gianni Rabbia
Divagazioni sui temi della bellezza e dell’omoerotismo nel mondo
classico
15
Lino Lantermino
Più o meno diversi
Vanna Pescatori
Da Antinoo a Marilyn: la grande illusione
Natascia Chiarlo
Lettura da “Il cantico dei cantici”
Ezio Fulcheri
La bellezza di ciò che si desidera, si ama e si ricorda
Carlo Petrini
Il valore della diversità
Anna Alasia
Considerazioni grafologiche nell’ambito delle diversità
Lorenzo Orione
La bellezza della metodologia della conoscenza in medicina
Sergio Soave
Antinoo: memorandum al riguardo…
Piero Flecchia
2013 aprile 25 tanti 25 aprile dopo se non conosci se non ricordi
ascolta
Note Biografiche
16
Antinoo. La bellezza della diversità/La diversità della
bellezza
Gianna Gancia
Pochissimi davvero sono i temi tanto evocativi e suggestivi, tanto
preziosi e fecondi quanto quello che è stato scelto per la giornata di
oggi. Nel mio breve intervento, mi limiterò proprio ad alcune
evocazioni e suggestioni.
La bellezza della diversità evoca nel profondo del mio cuore un
titolo di un saggio del 1924, “La bellezza della lotta”.
Lo scrisse Luigi Einaudi, un professore di scienze delle finanze
all’epoca cinquantenne, a cui la vita avrebbe riservato ancora molte
esperienze.
Lo scrisse su una pubblicazione, ‘ Le lotte del lavoro ’, edita da un
suo giovanissimo allievo torinese, che di anni vissuti ne aveva 23 e,
purtroppo, da vivere soltanto altri due, visto che una morte figlia di
crudeltà e violenza l’aspettava nel 1926 in esilio a Parigi: Piero
Gobetti.
“Alla quiete che è morte è preferibile il travaglio che è vita”: queste
parole einaudiane sono un po’ il suggello e la verità della bellezza
della lotta. Liberale, disprezzava e contrastava i monopolisti, quelli
industriali e quelli sindacali. Anche e soprattutto quando erano forti.
Anche e soprattutto quando s’ergevano a casta. Dedicò tutta la sua
vita a spiegare una cosa apparentemente semplice: il libero mercato
e la concorrenza producono il bene comune, con prezzi via via più
competitivi. Da qui l’obiettivo che Einaudi assegnava all’azione
politica: “far sì che gli uomini nella lotta per la vita possano partire
da punti non troppo diversi”. L’uguaglianza nei punti di partenza,
insomma, e mai nei punti d’arrivo che sono invece il frutto della
libera competizione, della concorrenza, della lotta appunto e che
quindi devono semmai essere commisurati al merito, non certo
prescritti da norme o direttive precostituite.
Un precetto che valeva nel mercato delle merci e, Einaudi sostiene
proprio nella ‘Bellezza della lotta”, anche nel mercato del lavoro: la
concorrenza, la stessa lotta sociale sono strumento di progresso
dell’umanità, ovvero un ascensore sociale.
Affermazioni all’epoca sorprendenti, in bocca ad un professore
liberale e sicuramente antimarxista.
17
Affermazioni ancora più spiazzanti nel 1924, in un’Italia che aveva
conosciuto l’esperienza delle occupazioni delle fabbriche e veniva
rifugiandosi, malauguratamente, nelle braccia dell’estremismo
opposto, il fascismo.
Einaudi fissa a chiare lettere in quelle pagine queste parole eterne:
“Si addita l’esempio delle corporazioni fasciste, le quali, inimicissime
del monopolio sinché questo era tenuto dai rossi, ora che ne hanno
la forza lo pretendono per sé”.
Puntava il dito, con parole quanto mai lungimiranti, contro quelle
che lui vedeva come due forme di monopolio politiche: il fascismo e
il comunismo, non a caso entrambi regimi in cui il partito è uno solo
ed è messa al bando la stessa lotta politica. Il monopolio della
politica altro non è se non il totalitarismo, quello rosso piuttosto che
quello nero.
Di qui la bellezza della lotta, perfino delle lotte operaie. La bellezza
della lotta. La bellezza della diversità.
18
Gli intrecciati oracoli di un nome che forse non è tale
Ugo Volli
Antinoo è innanzitutto un nome proprio, dunque va pensato in
prima istanza come un significante senza significato, legato solo ai
suoi referenti, cioè a coloro che lo portano, siano esseri umani o
altre entità in qualche modo capaci di farsi nominare così (vedremo
presto il perché di questa precisazione). Un nome greco, che ci
rimanda alle origini della nostra cultura. La tradizione classica ci
elenca infatti quattro Antinoo, di cui tre appartengono all'epica
omerica. Ricordiamoli qui per quanto è possibile.
Il primo e forse più misterioso di tutti è uno dei cinquanta figli
maschi di Priamo, qualificato come illegittimo, cioè non nato a una
delle sue mogli Arisbe, Ecuba e Laotoe, ma da una concubina.
Questo Antinoo non è citato da Omero né da Apollodoro, fonti
principali per le imprese dei numerosissimi priamidi, ma solo da
Gaio Giulio Igino, spagnolo di origine, liberto di Ottaviano Augusto
e da lui fatto direttore della biblioteca del Tempio di Apollo al
Palatino, autore di libri sulle api, su Virgilio e sugli dei Penati, ma
anche fra l'altro di un'opera di erudizione intitolata De familis troianis
in cui è nominato il nostro. Di questo Antinoo ricordato o inventato
da Igino, non conosciamo la madre né l'uccisore e neppure nulla
della sua vita, salvo che era illegittimo e che morì in guerra. Ci resta
anche l'interrogativo che si chiamasse Antifono o Antifo. Così
dubita, senza peraltro citare altre fonti, la Biografia mitologica
pubblicata a Venezia nel 1832 presso Gianbatista Missaglia, ad
vocem.
Di un altro Antinoo, contemporaneo al primo, sappiamo invece
solo che militava nel campo greco, e fu ucciso da Deifobo o forse
da Ettore proprio all'inizio della guerra, in un assalto
all'accampamento greco in cui morì accanto ad Antinoo anche
Ascalafo, figlio di Ares. Lo afferma sempre Igino, nella sezione 113
delle sue Fabulae, dedicato a coloro che uccisero principi; ma forse è
più corretta l'attribuzione tradizionale delle Fabulae a un altro Igino,
detto Astronomo per aver composto un De astronomia e
appartenente all'età degli Antonini (II secolo). E' notevole peraltro il
19
fatto che anche l'altro oscuro Antinoo troiano sia nominato nelle
Fabulae e precisamente nella sezione dedicata ai figli di Priamo.
Incuriosisce, per ragioni che vedremo, il fatto che Deifobo fosse
coinvolto poi in una sorta di crimine di guerra secondo i criteri
omerici, cioè nella disonesta uccisione di Achille, e anche che, dopo
la morte di Priamo, sposasse Elena - la donna più bella del mondo e fosse ucciso nel sonno, dunque a tradimento, da Menelao o da lei
stessa, mentre giaceva ubriaco la notte della distruzione di Troia,
dopo l'apertura del cavallo.
Il terzo Antinoo è il più noto di tutti i suoi omonimi della mitologia..
Figlio di Eufite o di Eupite, era il capo dei Proci che invasero la casa
di Ulisse. Omero ne parla nel libro I, IV e XXI dell'Odissea.
Quando Telemaco andò a Samo a cercare notizie del padre, questo
Antinoo gli fece tendere un'imboscata a tradimento presso l'isolotto
di Asteride, a metà strada da Itaca, ma fallì il colpo per intervento
divino; al ritorno di Ulisse vestito da mendicante nella reggia lo
percosse e lo costrinse a battersi per il suo divertimento con l'altro
mendicante Iro (detto anche Arneo). Per contrappasso Antinoo fu il
primo dei Proci che Ulisse uccise con una freccia, nella grande scena
della vendetta finale. Egli pure fu preso in un certo senso a
tradimento da Ulisse, ci dice Omero, mentre beveva da una coppa.
Ubriaco anch'egli?
Simili agli uomini, ardite nel mare, combattenti o commerciali, o
innocuamente vacanziere sono le navi, che infatti spesso portano
nomi umani. Nella storia marittima del Novecento Antinoo divenne
il nome anche per tre di esse, ci assicurano le cronache. Fra questi
navigli ne spicca uno, che appartenne alla marina militare tedesca
durante la Prima guerra mondiale. "Antinoo", che allora in realtà si
chiamava Wolf, cioè "lupo" era un "merchant raider" cioè una finta
nave commerciale che in realtà al momento buono aggrediva a
tradimento i nemici che avvicinava apparentemente innocua, che
dopo un'onorata carriera piratesca con trentasette navi affondate
con mine o cannonate, fu ceduta dopo la sconfitta alle Messageries
Maritimes francesi e ribatezzata per l'appunto "Antinoo", ridotta a
un normale innocuo cabotaggio commerciale, e infine disarmata e
smantellata in Italia nel 1931: nave traditrice, sconfitta e distrutta
lontano dal mare della patria.
20
Più che per queste designazioni belliche e violente, il nome di
Antinoo è però ricordato per una storia d'amore, segnata anch'essa
tuttavia dalla violenza. Com'è noto, un giovane Antinoo, di cui
sappiamo solo provenisse dalla Bitinia, la riva anatolica del Mar di
Marmara o del mar Nero, divenne amante dell'imperatore Adriano,
quasi ai tempi del secondo Igino. Antinoo, il bell'efebo, però presto
misteriosamente affogò, non si sa se per disgrazia, per suicidio o più
facilmente per delitto o tradimento, nelle acque del Nilo nel 130 d.
C. mentre fioriva il suo amore col sovrano, e dopo la morte fu
deificato dal suo inconsolabile augusto fidanzato. E' una storia
misteriosa, che mette in luce il rischio di un'omosessualità non così
frequente e accettata nella Roma imperiale come lo era invece
nell'Atene classica. Ma questa morte mette in evidenza anche un
permanente coté noir del potere romano, ben noto per altri sovrani
come Caligola e Nerone. Questo legame fra impero e delitto è però
ben presente anche nel caso di un sovrano dipinto come benevolo e
saggio dai suoi propagandisti (da Cassio Dione fino alla Yourcenar),
benché un'analisi storica spassionata debba mostrare che Adriano
andrebbe annoverato piuttosto nella serie degli imperatori più
violenti, distruttivi e vendicativi. E però sembra che la morte di
Antinoo non sia stata attribuita a qualcuno e venficata, ma solo
pianta.
Fu l'imperatore stesso a far uccidere il suo imbarazzante amico, il
più bello di tutti i ragazzi? Di notte, mentre dormiva, magari
ubriaco? O fu qualcuno che voleva difendere l'onore della
disprezzata moglie Vibia Sabina, parente del suo predecessore
Traiano e ragione fondamentale della successione toccata
all'imperatore spagnolo (spagnolo come il primo Igino)? O agì un
rivale che osava contendere al sovrano il suo boytoy, come si direbbe
oggi, o che distrusse il bel giocattolo che gli era stato sottratto? O un
nemico politico che volle vendicarsi del grande sul piccolo, del
potente sul bello? O fu davvero un caso, una disgrazia? Il frutto
sciagurato di un gioco erotico, magari con lo stesso Adriano? O
Antinoo, per qualche ragione che ignoriamo, scelse egli stesso la
morte? Gli dei, invidiosi della sua bellezza e della felicità di Adriano,
secondo l'eterno fthonos theon, lo rapirono al mondo mortale
condannandolo a qualche ovidiesca metamorfosi? Ovidio in fondo
era contemporaneo del primo Igino ed era morto in esilio a Neri,
non lontano dalla Bitinia... Che fosse insomma intervenuta una
21
poetica vendetta della bellezza e della gioia, patrocinata dal ricordo
di lui? Una vendetta amorosa, perché hon oi theoi philusin apothnēskei
neos, «muor giovane colui ch’al cielo è caro», come Leopardi traduce
il celebre frammento di Menandro (111 K.-Th)
Non sappiamo e non sapremo mai. I fili si intrecciano, l'acqua e la
morte e il tradimento e la Spagna e l'Impero e i Dardanelli: la morte
a tradimento li controlla tutti, quegli degli uomini, dei miti e delle
navi. Certo che le troppo clamorose pubbliche lamentazioni
dell'imperatore, la divinizzazione contro tutte le regole (gli
imperatori e i loro familiari si promuovevano regolarmente a divi,
non gli amanti e le prostitute imperiali...) e infine l'assenza di
condanne pur pretestuose e vendette per questa morte misteriosa a
corte ci fanno dubitare della sua casualità.
Da questa storia e dalla favoleggiata bellezza del giovane che
proveniva dall'Anatolia sono rimaste fino a noi numerose statue in
vari travestimenti e altrettanto frequenti citazioni letterarie, dal
Wilde del "Ritratto di Dorian Gray", a un prezioso e alquanto
estenuato poemetto inglese di Pessoa, una delle sue pochissime
opere pubblicate in vita in un opuscolo isolato del 1918:
It rained outside right into Hadrian's soul.
The boy lay dead
On the low couch, on whose denuded whole,
To Hadrian's eyes, that at their seeing bled,
The shadowy light of Death's eclipse was shed.
The boy lay dead and the day seemed a night
Outside. The rain fell like a sick affright
Of Nature at her work in killing him.
Through the mind's galleries of their past delight
The very light of memory was dim.
O hands that clasped erewhile Hadrian's warm hands,
That now found them but cold!
O hair bound erstwhile with the pressing bands!
O eyes too diffidently bold!
22
O bare female male-body like
A god that dawns into humanity!
[...]
Antinoo è dunque molte cose
La bellezza mediorientale, certamente; la violenza furbesca del
nobilotto di Itaca; la fibra del principe illegittimo di Troia (anch'essa
sita poco lontano dalla Bitina dove doveva nascere quindici secoli
dopo il suo tardo omonimo, ma dal lato opposto a Neri, sulla
sponda mediterranea dell'Anatolia); la nobiltà dell'altro Antinoo che
aveva abbastanza gloria per essere ucciso accanto al figlio di un dio
dai più coraggiosi degli eroi troiani; una nave che si fingeva innocua
e sparava a tradimento su nemici inconsapevoli...
Su tutti costoro, anche sull'amante di Adriano, grande è il mistero:
abbiamo quasi solo notizie delle circostanze delle morte, subite e
inferte o tentate, sempre violente e a tradimento, magari notturne e
alquanto erotiche, spesso legate al pericolo del mare (che Omero
ama paragonare al vino) o del Nilo o di bevande inebrianti gustate
subito prima della morte... sulla vita invece poco o nulla.
Che il nome Antinoo sia un destino? O piuttosto che Antinoo non
sia un nome vero ma un soprannome, che si debba pensare antinoo
con la minuscola, non un significante puro privo di significato e
ricco solo di referenti come i nostri nomi, che, semmai avevano un
senso, l' han perduto (chi sa ormai che Emanuele significò in
ebraico "Dio è con noi" o Giacomo "colui che aumenta"?), ma
piuttosto come una descrizione, un modo di caratterizzare una
persona per le sue qualità o i suoi difetti, magari a posteriori.
Ora Antinoo, per la sua etimologia, suggerisce un'idea inquietante:
ciò che nega il nous, vale a dire l'intelletto, la retta comprensione del
mondo o forse lo anticipa. Che l'Antinoo di Itaca sia considerato
uno stolto arrogante, oltre che un prepotente, in Omero è
chiarissimo. Dei due morti sotto le mura di Troia sappiamo poco, se
non che nella mischia in cui finì il mondo degli eroi ci voleva la metis,
l'astuzia di Odisseo per riportare a casa la pelle e ricominciare a
esplorare il mondo dopo, ed essi non avevano né metis né nous e
23
morirono presto per tale mancanza. In fondo tutti gli eroi di quella
guerra erano antinoi, corpi selvaggi e poco saggi.
Ma che dire dell'Antinoo compagno di un imperatore che la
propaganda storiografica descrisse come saggio, pieno di nous e
pure di fronesis, benché la sua ferocia contro Gerusalemme, due
anni dopo la morte di Antinoo, sia stata senza limiti? Forse in fondo
lo stesso Adriano era Antinoo o un antinoo. Forse in questo caso
nel ragazzo che portava il nome della sua insensatezza avrebbe allora
amato se stesso e la sua follia e da se stesso si sarebbe ucciso? O
forse - ipotesi più convincente - quel che si intende in questa storia è
che la bellezza stessa stia opposta contro il nous, con solo contro la
fronesis, la saggezza e l'equilibrio, ma che faccia proprio "perdere la
testa" fino alla morte?
Non è giusto allora il destino di chi è stato deificato come Antinoo,
di cui non sappiamo null'altro che fu bello, perciò fu amato e morì; e
per essere bello e amato e morto prematuramente, come accade a
coloro che gli Dei amano, entrò nel Pantheon ed è venerato - da
alcuni raffinati - ancora dopo diciannove secoli?
24
La bellezza nella diversità/la diversità della bellezza: la
risposta alla bellezza nell’arte secondo l’amigdala
Mario Abrate
"vedere è già un'operazione creativa che richiede uno sforzo"
H. Matisse
Francis Crick, co-scopritore della struttura del DNA, nell’illustrare
come dovremmo spiegare la visione, ha sostenuto che, per quanto ci
sembri di avere nel cervello un’immagine del mondo visivo, in realtà
ne abbiamo una rappresentazione simbolica, un’ipotesi. Egli
afferma: “qui abbiamo un esempio di simbolo. L’informazione contenuta in un
computer non è l’immagine, ma simboleggia l’immagine. Un simbolo è qualcosa
che sta per qualcos’altro, proprio come fa una parola…… Un simbolo non deve
essere una parola…….. Chiaramente, quello che ci aspettiamo di trovare nel
cervello è una rappresentazione della scena visiva in qualche forma simbolica.”
Sappiamo oggi che tutte le nostre percezioni del mondo esterno –
visioni, suoni, odori, sapori e sensazioni tattili- iniziano nei nostri
organi di senso. La visione inizia negli occhi, che rilevano
informazioni sul mondo esterno in termini di luce. Il cristallino
dell’occhio concentra e proietta una piccola immagine
bidimensionale sulla retina, dalle cui cellule specializzate emergono
dei dati che creano nel cervello rappresentazioni in forma di codici
neurali. E’ quindi nella costruzione di queste rappresentazioni
interne del mondo visivo che si concretizza la creatività del cervello:
l’occhio, infatti, non funziona come una macchina fotografica, ma,
come afferma lo psicologo cognitivo Chris Frith, “ciò che percepisco non
sono gli indizi grezzi ed ambigui che dal mondo esterno arrivano ai miei occhi,
….. Percepisco qualcosa di assai più ricco, un’immagine che combina tutti questi
segnali grezzi con un’enorme quantità di esperienze passate… La nostra
percezione del mondo è una fantasia che coincide con la realtà”.
La creatività del cervello si evidenzia nella capacità del sistema visivo
di identificare la stessa immagine in condizioni di luce e di distanza
differenti, nella capacità di percepire un oggetto come costante
nonostante i cambiamenti di taglia, forma, luminosità e distanza,
nella capacità di trasformare schemi luminosi transitori e
25
bidimensionali sulla retina in un’interpretazione coerente e stabile
del mondo tridimensionale.
L’elaborazione della percezione visiva inizia, quindi, nella retina, per
mezzo della trasmissione attiva delle immagini che vengono
trasformate in un modello di potenziali d’azione, sfruttando un
vasto numero di fotorecettori e cellule nervose che lavorano in
parallelo secondo principi di elaborazione che offrono una grande
potenza di calcolo, e procede nel nucleo genicolato laterale del
talamo e successivamente attraverso una trentina di aree visive della
corteccia cerebrale. Nella corteccia temporale inferiore, la regione
più elevata del cervello visivo, i neuroni rispondono a forme
complesse, a scene visive, a specifici luoghi, alle mani, ai corpi e in
particolare alle facce, ma anche al colore, alla localizzazione nello
spazio e al movimento di queste forme. I segnali inviati dai neuroni,
alla fine, producono ciò che diventa la nostra consapevolezza
cosciente degli aspetti distintivi di un’immagine visiva.
La luce richiesta dalla visione è catturata dagli occhi in forma di
radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da onde di varia
lunghezza prodotte da particelle chiamate fotoni, riflesse dagli
oggetti che vediamo. La visione umana cattura una stretta banda di
queste lunghezze d’onda, che si estende da 380 nanometri, percepiti
come viola profondo, a 780 nanometri, percepiti come rosso scuro.
Quando i fotoni di luce emessi da un’immagine raggiungono il
cristallino dell’occhio, questi li concentra sulla retina, dove vengono
catturati dai fotorecettori, insieme ordinato di cellule nervose
fotosensibili, che rispondono ai fotoni di luce convertendoli in
schemi di segnali elettrici trasmessi alle cellule gangliari della retina,
neuroni in uscita dalla retina, i cui assoni formano il nervo ottico che
porta l’informazione alla corteccia visiva primaria. In questo modo
la retina acquisisce ed elabora tutti gli effetti del mondo visivo
esterno e li trasmette al sistema visivo cerebrale.
Negli studi sulla percezione visiva, Sthephen Kuffler (1913-1980),
dimostrò, tra l’altro, che il sistema nervoso visivo risponde solo a
quelle parti di un’immagine in cui l’intensità della luce cambia, cioè
scoprì che le cellule gangliari della retina non rispondono ai livelli
assoluti di luce, ma al contrasto tra luce e buio. Scoprì dunque la
straordinaria importanza del contrasto per i processi di segnalazione
nella retina, preparando la strada alle ancora più sorprendenti
26
intuizioni sulla visione che dovevano emergere dagli studi sulla
corteccia visiva.
"l'occhio non basta, bisogna anche pensare"
P. Cezanne
Il lavoro di smistamento dell’informazione visiva avviene dunque
nelle regioni della corteccia cerebrale destinate alla visione. Ispirato
dalle scoperte di Kuffler, Hubel e Wiesel sul modo in cui il cervello
decostruisce la forma, il neurobiologo britannico David Marr,
coniugando la psicologia cognitiva della percezione visiva con la
comprensione della fisiologia del sistema visivo ottenuta da Kuffler,
sostenne che la percezione visiva procede attraverso una serie di
passi di elaborazione delle informazioni, o rappresentazioni, ognuno
dei quali trasforma ed arricchisce il precedente.
I neuroscienziati contemporanei hanno quindi sviluppato un
modello di elaborazione dell’informazione visiva in tre stadi:
- il primo stadio è rappresentato dalla elaborazione visiva di
basso livello, che stabilisce le caratteristiche di una
particolare scena visiva individuando la posizione di un
oggetto nello spazio ed identificandone il colore.
- Il secondo stadio, che inizia nella corteccia visiva
primaria, consiste nella elaborazione visiva di livello intermedio:
assembla semplici segmenti lineari, ciascuno con una
specifico asse di orientamento, ottenendo contorni che
definiscono i confini dell’immagine, costruendo una
percezione unitaria della forma di un oggetto; questo
processo viene definito integrazione del contorno; al tempo
stesso separa l’oggetto dallo sfondo, definito processo di
segmentazione della superficie. Tale fase è ritenuta
particolarmente impegnativa, in quanto richiede alla
corteccia visiva primaria di determinare quali siano i
segmenti appartenenti ai vari oggetti nel contesto di una
scena visiva complessa, composta da centinaia o
addirittura da migliaia di segmenti di linea, prendendo
anche in considerazione i ricordi di precedenti esperienze
percettive, che sono memorizzati nella aree superiori del
sistema visivo.
27
-
Il terzo stadio, l’elaborazione visiva di alto livello, che si
dipana lungo la via della corteccia visiva primaria alla
corteccia temporale inferiore, stabilisce categorie e
significati. Qui il cervello integra l’informazione visiva
con l’informazione utile proveniente da una varietà di
altre fonti, che permette di riconoscere oggetti specifici,
volti e scene.
Questi studi sull’elaborazione visiva iniziano a spiegarci le strategie
di un artista per evocare su una superficie bidimensionale oggetti e
figure umane tridimensionali: gli artisti hanno compreso che gli
oggetti sono definiti dalle loro forme, che a loro volta derivano dai
loro bordi. Nella pittura si può rappresentare un bordo mediante un
cambiamento di colore o di luminosità da una regione all’altra o con
una linea implicita; ciò dimostra come le cellule cerebrali siano
bravissime a leggere le linee ed i contorni come bordi. Il
neuroscienziato Charles Stevens ha rilevato che per riconoscere
immediatamente e senza sforzo la rappresentazione di un volto
siano sufficienti poche particolari linee di contorno, quelle che
definiscono gli occhi, la bocca ed il naso. Questo permette agli artisti
di sottoporre un volto a distorsioni estreme, senza pregiudicare la
capacità di riconoscerlo da parte del cervello dell’osservatore,
attraverso una ricostruzione creativa di percezione ed
interpretazione dell’opera d’arte.
La capacità del cervello di tollerare illusioni, o una fisica
semplificata, nelle opere d’arte dimostra la sua notevole flessibilità
visiva, che ha permesso ai pittori, attraverso i secoli, di prendersi
notevoli libertà nella presentazione di una scena visiva senza con ciò
sacrificare la credibilità dell’immagine; tali libertà vanno dalle sottili
manipolazioni e alterazioni di luci ed ombre degli artisti del
Rinascimento sino alle drastiche distorsioni spaziali e cromatiche
degli espressionisti austriaci. Tutto questo ci illumina sul modo in
cui il cervello crea il senso delle immagini, sul modo in cui il cervello
inconscio crea ciò che vediamo.
Gli studi sulla percezione visiva di alto livello hanno portato alla
scoperta di una trentina di centri che, oltre alla corteccia visiva
primaria, continuano il compito di analizzare e isolare, o segregare,
informazioni sulla forma, il colore, il movimento e la profondità.
L’informazione proveniente da tutte queste aree specializzate è
28
segregata e convogliata separatamente alle regioni cognitive
superiori del cervello, tra le quali la corteccia prefrontale, dove infine
è coordinata in un’unica, identificabile percezione. Già Freud aveva
capito che la percezione visiva di ordine superiore era
presumibilmente elaborata nelle regioni superiori della corteccia
cerebrale, ipotizzando che l’agnosia, cioè la mancanza di
conoscenza, non dipendesse da un difetto degli occhi ma da un
difetto in queste regioni superiori che interessano la loro capacità di
combinare gli aspetti della visione in un modello significativo.
Influenzati dall’intuizione di Freud e di Kris e Gombrich, per la
quale il cervello reagisce con una forte risposta emotiva alle
caratteristiche facciali esagerate in quanto anatomicamente collegate
con l’amigdala, i neuroscienziati hanno iniziato una più rigorosa
analisi cellulare dei sistemi sensoriali dell’uomo, con la conferma che
il nostro sistema sensoriale è creativo in quanto genera ipotesi su
facce, espressioni facciali, posizioni delle mani, movimenti del
corpo, e su cosa distingue il movimento biologico da quello non
biologico.
Secondo Ernest Gombrich, la memoria ha un ruolo essenziale nella
percezione dell’arte: quando un grande artista crea un’immagine
della propria esperienza di vita, l’immagine è intrinsecamente
ambigua. Conseguentemente, il suo significato dipende dalle
associazioni di ogni osservatore, dalla sua conoscenza del mondo e
dell’arte, e dalla capacità di ricordare quella conoscenza e metterla a
confronto di quella particolare immagine. Questo è il fondamento
del contributo di chi guarda, la ri-creazione dell’opera d’arte da parte
dello spettatore, in quanto i simboli culturali richiamati dalla
memoria sono cruciali, sia per quanto concerne la produzione sia
per la visione dell’arte.
La memoria è il collante che tiene insieme la nostra vita mentale, sia
nella nostra risposta all’arte sia negli altri eventi della vita. Infatti, il
sistema della memoria forma rappresentazioni interne astratte che
originano da una precedente esposizione a immagini o esperienze
simili.
Molti studi hanno dimostrato che la memoria non è una facoltà
unitaria della mente. Esistono infatti due forme principali di
archiviazione a lungo termine della memoria: l’esplicita, relativa a
persone, luoghi e oggetti, che si basa sul richiamo cosciente ed è
29
correlata con il lobo temporale e l’ippocampo; e l’implicita, che
consiste nel richiamo inconscio delle abilità motorie e percettive e
dei risvegli emotivi, e richiede l’amigdala, il corpo striato e, nei casi
più semplici, le vie del riflesso.
Una delle conseguenze più interessanti dell’elaborazione visiva di
alto livello è che noi sperimentiamo una risposta cerebrale simile sia
quando ci imbattiamo in un oggetto per la prima volta che quando
lo richiamiamo alla memoria. La nuova esperienza visiva deriva dalla
elaborazione dell’informazione visiva dal basso verso l’alto e
rappresenta quello che tradizionalmente si pensa di vedere. Il
ricordo, o l’elaborazione e arricchimento, di quell’immagine, è un
prodotto dell’elaborazione dall’alto verso il basso e costituisce la
memoria pittorica e il richiamo delle immagini visive: il vedere
un’immagine e in seguito il ricordarla e immaginarla, recluta, almeno
in parte, gli stessi circuiti neurali.
Se consideriamo che una rappresentazione figurativa ha due
componenti: la consapevolezza focale della persona o della scena
rappresentata, e la consapevolezza sussidiaria, che riguarda le
caratteristiche di superficie, le linee ed i colori, e la superficie
bidimensionale della tela, comprendiamo il perché vediamo in una
rappresentazione figurativa qualcosa di simile alla realtà. Detto
altrimenti, inconsciamente imponiamo alla nostra percezione sia
correzioni precedentemente apprese, sia intuitive, quindi non
apprese.
“Vorrei che le scienze e le scienze umane diventassero grandi amiche,
riconoscendo una parentela profonda e una necessaria connessione alla ricerca
della dignità e del comportamento dell’uomo, ma mantenendo i propri obiettivi,
ineluttabilmente diversi e separati. Come due moschettieri, tutti per uno e uno
per tutti …”
Stephen Jay Gould
Compreso che le differenze stilistiche veicolano un diverso
contenuto emotivo, gli artisti moderni quali Cézanne, Picasso,
Mondrian, Kandinskij, iniziarono a sperimentare modi per andare al
di là delle interpretazioni realistiche, iniziando ad esplorare la
decostruzione della forma, alla ricerca degli elementi primitivi
figurativi, attraverso nuovi linguaggi per analizzare forme e colori.
Circa nello stesso periodo, Van Gogh, Gauguin, Munch, e
30
successivamente, Klimt, Kokoschka e Schiele e gli espressionisti
tedeschi, incominciarono a decostruire l’emozione alla ricerca degli
elementi primitivi emozionali, cioè quegli elementi che evocano forti
risposte emotive consce ed inconsce nell’osservatore alle scene ed
alle persone, in particolare a facce, mani e corpi.
Nella ricerca dei primitivi emozionali gli artisti tentavano di
penetrare al di sotto delle apparenze di superficie per esplorare ed
esporre aspetti della vita affettiva del modello e, per estensione, di
influenzare i sentimenti dello spettatore e la sua risposta emotiva al
modello, sperimentando una varietà di tecniche per veicolare lo
stato emotivo del modello, e puntando sul ricordo dello spettatore
di esperienze emotive simili, come pure sulla loro capacità di
riconoscere chiari riferimenti storici e comprendere il significato dei
simboli.
L’approfondimento della conoscenza biologica di un’emozione,
necessita di due fasi:
- la prima è la necessità di un fondamento psicologico che
permetta di analizzare quell’emozione;
- la seconda lo studio dei meccanismi cerebrali che ne sono
alla base: come la neuroscienza della percezione trova il
suo fondamento nella psicologia cognitiva della
percezione, così la ricerca dei meccanismi biologici alla
base delle emozioni e dell’empatia deve fondarsi sulla
psicologia cognitiva e sociale di emozione ed empatia.
Le emozioni sono meccanismi biologici istintivi che colorano le
nostre esistenze e ci aiutano nei compiti fondamentali della vita:
cercare il piacere ed evitare il dolore: sono disposizioni ad agire in
risposta a qualcuno o qualcosa che sia importante per noi. E’
probabile che l’intero spettro delle emozioni si sia evoluto dalle
disposizioni all’azione di base di organismi assai semplici, che hanno
a disposizione solo due classi di motivatori, tra loro opposti:
l’approccio e l’evitamento.
Sia Darwin che Freud si resero conto che il comportamento umano
può dare origine ad una varietà di risposte emotive tra i poli estremi
dell’approccio e dell’evitamento, modulandosi attraverso un continuum che
varia da bassi ad alti livelli di intensità, o di eccitazione. Secondo
Darwin, lungo tale continuum, si possono individuare sei componenti
31
universali, che si riflettono nelle espressioni facciali che denotano
emozioni.
Queste sei componenti includono i due principali primitivi
emozionali: la felicità, nella quale l’eccitazione varia dall’estasi alla
serenità, e la paura, che varia dal terrore all’apprensione. Fra questi
due estremi si trovano quattro sottotipi: la sorpresa, dallo stupore al
disinteresse, il disgusto, dal ribrezzo alla noia, la tristezza, dal
cordoglio alla pensosità, e la rabbia, dalla furia al fastidio.
Sul modo in cui si esprimano e come si trasmettano queste
emozioni, Darwin ipotizzò che avvenisse attraverso un numero
limitato di espressioni facciali; inoltre, affermò che la capacità di
formare le espressioni facciali, così come leggere quelle delle altre
persone, siano innate, sostenendo che la capacità di distinguere i sei
tipi di espressioni facciali sia geneticamente determinata ed
evolutivamente conservata in tutti i gruppi di persone in tutte le
parti del mondo. Tale osservazione è stata confermata ed ampliata
un secolo più tardi dallo psicologo statunitense Paul Ekman: oggi
abbiamo la prova che, a queste percezioni comuni, le diverse culture
hanno aggiunto sfumature che gli stranieri devono imparare a
riconoscere per poter comprendere appieno l’emozione espressa,
entro la dialettalità locale.
La maggior parte degli studiosi delle emozioni è oggi
tendenzialmente d’accordo sul fatto che le sei principali emozioni
rappresentino dei punti lungo un continuum e che abbiano elementi
neurali sia distintivi sia condivisi. Inoltre, le emozioni e le loro
espressioni facciali non sarebbero del tutto innate, ma verrebbero in
parte determinate dalle precedenti esperienze in ragione delle
emozioni e dall’associazione di determinate emozioni a determinati
contesti. Oggi sappiamo che l’emozione nasce da una valutazione
soggettiva inconscia delle situazioni e degli eventi in corso. Così, la
risposta emotiva consapevole all’arte può essere fatta risalire al
dispiegarsi di una serie di processi di valutazione cognitiva.
"un'opera d'arte è in grado di smuovere i sentimenti dell'osservatore solo se i
personaggi in essa raffigurati mostrano i propri moti dell'animo e se questi ultimi
sono riconoscibili dal movimento dei corpi"
Leon Battista Alberti
Gli studi sulla percezione visiva hanno permesso di comprendere
come gli artisti catturino l’attenzione dell’osservatore, non solo
32
sollecitando la risposta emozionale inconscia al soggetto ritratto,
ma rendendolo anche consapevole dei loro metodi artistici per farlo:
attraverso l’uso del colore e di simboli.
Ma in che modo un’opera d’arte cattura l’attenzione dello
spettatore? Lo psicofisico russo Yarbus, prima e Nodine e Locher,
dopo, hanno scoperto che ci sono delle fasi nella percezione visiva e
che queste sono evidenti nei movimenti di scansione oculare usati
per esaminare un’opera d’arte. La prima fase, la scansione percettiva,
comporta una scansione globale dell’opera. La seconda, di
riflessione e immaginazione, comporta l’individuazione di persone,
luoghi e oggetti sulla tela: l’osservatore afferra, capisce ed empatizza
con la natura espressiva dell’opera. La terza fase, quella estetica,
riflette i sentimenti dello spettatore e la profondità della sua risposte
estetica all’opera.
Così come alcune regioni del cervello rispondono selettivamente ai
volti, altre rispondono alle mani e ai corpi, in particolare ai corpi in
movimento. La Risonanza Magnetica Funzionale ha rilevato che la
risposta del cervello al corpo intero è più forte, ad esempio, della sua
risposta alle mani. Questo potrebbe spiegare perché un artista come
Schiele si sia servito dell’autoritratto, come di un mezzo per
esplorare la tensione tra le pulsioni d’amore e di morte e il senso di
sé. Raffigurando il proprio corpo per intero, spesso nudo e in
atteggiamenti non di rado atrocemente contorti, questi autoritratti
rappresentano un tentativo di ricreare in un’immagine il suo stato
psicologico verso il proprio corpo, esasperando il proprio stato
d’animo. Tali immagini, molto potenti, spiegano la ragione per cui
molte persone si siano sentite disturbate dall’opera di Schiele,
proprio perché la sua arte sollecita le emozioni dell’osservatore in
modo tutt’altro che passivo, attraverso la percezione dello stato
emotivo di un’altra persona come un qualcosa di separato dallo stato
emotivo dell’osservatore, cioè con una partecipazione empatica. Il
tentativo consapevole di ricercare il bello nella bruttezza della
visione, rappresentando appunto la bruttezza della malattia e
l’ingiustizia come tema artisticamente importante ed originale, già
presente in Klimt, raggiunge il suo apice negli autoritratti di Schiele.
33
“Sono completamente assorbito dalle leggi dei colori. Se solo ce le avessero
insegnate in gioventù!…”
Van Gogh
Un ultimo contributo alla risposta emotiva all’arte, lo dà il colore: il
colore è importante in un modo unico per il cervello dei primati,
quasi quanto le rappresentazioni del viso e delle mani; per questo i
segnali del colore vengono trattati nel cervello in modo diverso
rispetto alla luce ed alle forme. I colori vengono percepiti come
dotati di specifiche caratteristiche emotive, e la reazione a tali
caratteristiche varia con l’umore. A differenza della lingua parlata,
che spesso ha un significato emotivo indipendente dal contesto, il
colore può assumere significati diversi per soggetti diversi,
generando emozioni diverse dipendenti dallo spettatore e dal
contesto.
Gli studi sulle basi neurali della percezione dei colori (Zeki e altri),
hanno rivelato che il cervello percepisce le forme in gran parte
attraverso i valori di luminanza, o luminosità: questo spiega perchè
artisti come van Gogh abbiano utilizzato il colore anche per
esprimere un ampio spettro di emozioni.
La comunicazione delle emozioni attraverso l’espressione del viso,
dello sguardo, delle mani, del corpo e del colore, ha riproposti ai
neuroscienziati il problema già di Freud e dei modernisti austriaci su
quali aspetti delle emozioni siano coscienti e quali inconsci e se le
emozioni consce ed inconsce siano rappresentate in modo diverso
nel cervello.
Le moderne teorie neuroscientifiche hanno modificato
drasticamente il modo in cui gli scienziati considerano l’emozione.
Nonostante sia mediata da sistemi neurali parzialmente indipendenti
da sistemi cerebrali della percezione, del pensiero e del
ragionamento, vi è ora la convinzione che l’emozione sia anche una
forma di elaborazione dell’informazione e quindi una forma di
conoscenza. Questo comporta una visione più ampia della
conoscenza, che comprende tutti gli aspetti di elaborazione
cerebrale dell’informazione; quindi, non solo percezione, pensiero e
ragionamento, ma anche emozione e cognizione sociale.
34
L’amigdala: il direttore d’orchestra delle emozioni
Le tecniche di brain imaging, hanno permesso di indagare in che
modo vengano coordinate le risposte emotive, su quale sia la
relazione tra i sentimenti consci e inconsci, sui cambiamenti
fisiologici innescati da stimoli emotivamente carichi. Gli studi della
corteccia insulare anteriore o insula, situata tra i lobi parietale e temporale,
area cerebrale nella quale sono rappresentati i sentimenti, cioè la
consapevolezza cosciente della risposta del corpo agli stimoli
emotivamente carichi, hanno messo in evidenza che questa si attiva
in risposta alla valutazione consapevole degli stimoli emotivi,
rappresentando quindi la consapevolezza di molte pulsioni istintuali,
quali la sete, la fame, l’amore materno, lo sfioramento sensuale,
l’amore romantico, l’orgasmo sessuale. L’insula, non solo valuta ed
integra l’importanza emotiva e motivazionale di questi stimoli, ma
funge anche da centro di coordinamento tra le informazioni
sensoriali esterne e gli stati motivazionali interni: è la misura della
piena presa di coscienza emozionale di sé, del sentire “sono io”.
Ulteriori studi di neurobiologia delle emozioni (Weiskranz;
LeDoux), hanno portato alla scoperta che l’amigdala, struttura che
assieme all’ippocampo si trova in profondità, all’interno del lobo
temporale, orchestra le emozioni attraverso le sue connessioni con
altre regioni del cervello. La connessione dell’amigdala con le aree
cerebrali della visione e di altri sensi sono ritenute responsabili della
notevole capacità del cervello di trasformare uno stimolo visivo
biologicamente saliente in un sentimento, una risposta emotiva
cosciente. Il cervello trasforma l’oggetto percepito in un’emozione
sentita consciamente. L’amigdala, svolge un ruolo centrale nel
sistema neurale coinvolto nella percezione e nel coordinamento
delle emozioni, nell’elaborazione di quattro aspetti dell’emozione:
- apprendere il significato emotivo degli stimoli attraverso
l’esperienza;
- riconoscere l’importanza di questa esperienza quando si
presenta;
- coordinare le risposte fisiologiche del sistema autonomo,
di quello endocrino e di altri in un modo adeguato al
significato emotivo dell’esperienza;
35
-
calibrare, come già sottolineò Freud, l’influenza delle
emozioni su altri aspetti della conoscenza, cioè la
percezione, il pensiero ed il processo decisionale.
L’amigdala, potendo comunicare, oltre che con tutte le aree
sensoriali principali della corteccia, con quasi tutte le regioni del
cervello che vengono reclutate dall’emozione, coordina la risposta di
questi circuiti neurali agli stimoli emotivi, smistando su circuiti
appropriati ciascuna emozione e silenziando quelli inappropriati,
orchestrando, in sintesi, tutta l’esperienza emotiva, sia positiva che
negativa.
A causa dell’interazione con i face patch della corteccia prefrontale e
con numerose altre strutture cerebrali, le funzioni dell’amigdala si
estendono al di là della regolazione delle emozioni e dei sentimenti
personali per orchestrare la cognizione sociale. Come già aveva
ipotizzato Darwin, esiste uno stretto legame biologico tra il mondo
privato delle nostre emozioni e il mondo pubblico delle nostre
interazioni con gli altri: l’amigdala, con la sua rete di collegamenti
con altre aree del cervello, identifica i segnali sociali ambigui e
conferisce loro un senso, rendendo così possibile l’interazione
sociale.
Gli affascinanti risultati ottenuti dagli studi neuroscientifici
mostrano che nel regno delle emozioni, come nel regno della
percezione, uno stimolo può essere percepito in maniera conscia e
inconscia; confermano l’importanza biologica del concetto
psicoanalitico di emozione inconscia. Da qui ne discende, come già
Freud aveva delineato, che gli effetti di ansia si esplicano nel cervello
in maniera più drammatica quando uno stimolo è lasciato
all’immaginazione
rispetto
a
quando
viene
percepito
coscientemente.
La risposta biologica alla bellezza nell’arte
Quando si guarda un’opera d’arte, il cervello assegna diversi livelli di
significato alle varie forme, ai colori ed ai movimenti. Tale
assegnazione di significato, o estetica visiva, dimostra che il piacere
estetico non è una sensazione elementare, come la sensazione di
caldo o freddo, o di dolce o amaro, ma rappresenta una valutazione
di ordine superiore delle informazioni sensoriali, elaborate attraverso
36
percorsi cerebrali specializzati, che stimano il potenziale di
ricompensa da uno stimolo ambientale: in questo caso l’opera d’arte.
Per molto tempo si è ritenuto che gli standard di bellezza maschile e
femminile fossero il risultato di un’arbitraria convenzione culturale,
in quanto si pensava che la bellezza fosse un giudizio personale
nell’occhio-mente di chi guarda. Si è scoperto che tutte le persone,
indipendentemente da età, ceto o razza, condividono un insieme di
criteri inconsci di ciò che è attraente. In ogni caso, le qualità che si
trovano attraenti sono indicative della fertilità, della salute e della
resistenza alle malattie.
Una delle caratteristiche che rendono attraente un volto è la
simmetria. Per David Perret, una buona simmetria indicherebbe
quanto il genoma di una persona sia in grado di resistere alla malattia
e al mantenimento di uno sviluppo normale di fronte ai fattori di
stress ambientali che possono portare a modelli di crescita della
faccia asimmetrici: la simmetria della faccia comunicherebbe, quindi,
anche sulla salute di un potenziale compagno e sui suoi potenziali
figli. Oltre alla simmetria, altre caratteristiche sono considerate
universalmente attraenti in un volto femminile: sopracciglia arcuate,
occhi grandi, naso piccolo, labbra carnose, viso stretto, mento
piccolo. Le caratteristiche maschili che esercitano attrazione si
basano su criteri diversi: si è osservato che spalle, gomiti e ginocchia
fortemente squadrati sono associati sia con la mascolinità sia con
l’aggressività; così come il mento sporgente, il profilo marcato della
mascella, della fronte e delle guance, con l’allungamento della parte
inferiore della faccia. Tali caratteristiche facciali del maschio, e
l’implicito eccesso di testosterone, oltre ad un’ipersessualità,
suggeriscono anche il potenziale per un comportamento asociale,
aggressivo e dominante.
E’ stato dimostrato che anche i bambini di soli tre-sei mesi
condividono questi valori (Judith Langlois); inoltre, gli psicologi
evoluzionisti hanno notato che le caratteristiche di un volto
universalmente preferite emergono nei ragazzi e nella ragazze
durante la pubertà, quando aumenta la concentrazione degli ormoni
sessuali.
Egon Schiele aveva perfettamente compreso il significato latente
della distorsione dei lineamenti del viso e del corpo: gli atteggiamenti
37
in cui dipinse il proprio corpo mostrano distorsioni anatomiche
estreme, che indicano aggressività. Tuttavia, poiché le caratteristiche
maschili e femminili non si escludono necessariamente a vicenda,
Schiele spesso sottolineava anche i tratti femminili del viso, quali le
sopracciglia arcuate, gli occhi grandi, il naso piccolo, le labbra
carnose, comunicando un’intima sensualità, ma anche una ferina
aggressività, unificando in una sintesi sottile ed assai efficace, le due
pulsioni istintive freudiane Eros e Thanatos.
Ciò che è sorprendente, nella biologia della bellezza, è che l’ideale di
bellezza è variato assai poco da un millennio all’altro e da una
cultura all’altra, facendo ipotizzare che diversi aspetti di ciò che
implicitamente viene giudicato attraente si sia conservato nel corso
dell’evoluzione, evidenziando quindi che i pregiudizi nel valutare la
bellezza siano sopravvissuti ad anni di pressione selettiva.
Fondamentale contributo alla valutazione della bellezza di un volto
viene anche dall’espressione facciale: la direzione dello sguardo, ad
esempio, è molto importante nell’elaborazione delle emozioni,
perché il cervello combina l’informazione ottenuta dallo sguardo
con quella ottenuta dalle espressioni facciali, stimolando le risposte
emotive primitive di approccio ed evitamento e svolgendo una
cruciale funzione di adattamento nell’evoluzione umana.
In conclusione: perché la risposta all’arte è così diversa?
La risposta all’arte nasce da un’irrefrenabile urgenza di ricreare nel
proprio cervello il processo creativo, cognitivo emotivo ed
empatico, attraverso il quale l’artista ha realizzato l’opera. Questo
impulso creativo dell’artista e dello spettatore spiega probabilmente
perché quasi tutti gli esseri umani, in epoche e luoghi diversi, hanno
creato immagini, nonostante l’arte non sia una necessità fisica per la
sopravvivenza.
L’arte è un tentativo dell’artista e dello spettatore, per quanto ne
decifra, di comunicare e condividere il processo creativo che
caratterizza ogni cervello umano, un processo che porta
all’improvviso riconoscimento visto nella mente di un’altra persona,
e che permette di vedere la verità che sottostà sia alla bellezza sia alla
bruttezza raffigurate dall’artista. E soprattutto l’arte, a differenza
della vita, e più di essa, nel suo linguaggio universale, sa accogliere,
con fraternità ed uguaglianza, non solo i belli, i forti, i vincenti; ma
38
anche i brutti, i diseredati, i malati, i perdenti, dalle immagini dei
quali ci giungono richiami di una stessa patria che si avvera quando
il PATHOS nel suo significato più vasto e l’ETHOS nel più alto, si
uniscono nel prodigio della creatività.
39
40
Bellezza. Amore e Verità.
Un percorso filosofico e biblico
Umberto Casale
IL PERCORSO FILOSOFICO CLASSICO
«Solamente la bellezza ricevette questa sorte:
di essere ciò che è più manifesto e più amabile»
(Platone, Fedro, 250d-e)
«Se mai un momento della vita merita
d’essere vissuto dall’uomo, è quello che
egli vive quando contempla la bellezza in sé»
(Platone, Simposio, 211d.
1. L’esser e, la vita e la bellezza
Se con A. Baumgarten (1714-1762), che definisce l’estetica una
“conoscenza inferiore”, si smembra l’unitarietà del pensiero
filosofico (separando ontologia e gnoseologia); se per I. Kant1
(1724-1804) l’estetica non si occupa dell’essere, ma soltanto del preporsi delle cose davanti al soggetto che le osserva e le giudica, non
così era per gli antichi filosofi greci. Per la filosofia ellenica l’essere,
che s’impone con la pienezza della sua vita, possiede tutte le
perfezioni, fra le quali rientra la perfezione estetica. L’essere è
perfezione nel senso di compimento della forma interiore, è
interezza, pienezza in sé conclusa ed equilibrata. Al contrario, il
brutto, il disordinato, il deforme sono le resistenze del caos alla forza
ordinatrice dell’essere, sono “ciò che non è”.
Per la sua origine il termine greco καλός va accostato all’anticoindiano kalja (sano, dotato, eccellente), nella lingua e nella letteratura
greca assume una triplice accezione: a) sano, adatto, usabile («καλός
λιμήν»: un porto adatto); b) bello: quando una cosa o una persona è
sana, idonea e ordinata, si dice ‘bella’ secondo la percezione sensibile
(«καλός… δέμας»: bello di aspetto); c) buono, quando il termine è
applicato all’intimo atteggiamento dell’uomo, significa moralmente
1
Cfr. I. KANT, Critica della ragion pura, 2, 3-4.
41
buono (così si dice, per esempio, dell’atteggiamento di Socrate). Nel
pensiero greco il concetto di καλός è legato a quello di τάξις (ordine)
e di συμμετρία (simmetria): «τήν τάξιν καί συμμετρίαν αποφαίνομεν
αυτοίς καλά»: dimostriamo loro che l’ordine e la simmetria sono il
bello.
Le tre accezioni e il legame con ordine e simmetria danno al
concetto greco di bello «una incomparabile e classica importanza»,
con tale concetto si pensa «una condizione complessiva, in cui ciò
che è salutare, integro, ordinato, forma un tutt’uno tanto
nell’apparenza esteriore quanto nell’atteggiamento interiore… perciò
il bello attiene in linea assoluta anche alla sfera del divino»2.
Assai frequente è anche la locuzione καλός καί αγαθός (bello e buono),
dalla quale deriva il sostantivo καλοκαγαθία, che ha una notevole
importanza per la vita greca. Si possono incontrare due significati
della locuzione: uno politico-sociale (“i belli e buoni” come classe
privilegiata: Tucidide, Senofonte), uno etico-spirituale (esprime
l’ideale di vita greca, si deve a Socrate la trasformazione del
concetto). Col tempo la καλοκαγαθία dell’uomo interiore si
rispecchia nel comportamento esterno (nella δικαιοσύνη: giustizia),
fino a divenire «il bene maggiore e più prezioso che vi sia in natura»
(Filone )3.
Il bello dunque, come il bene, è una realtà che concerne l’essere nel
suo aspetto interiore (la “cosa in sé”), prima che come valore
sottoposto alla valutazione del soggetto. Significa, in altri termini,
che la bellezza non è in primo luogo una questione di valore
estetico, cioè stabilire se la realtà o una cosa sia bella, ma una
questione della pienezza dell’essere, che la cosa porta al suo interno.
Per i pensatori greci la bellezza è, usando un’espressione di Plotino,
«la fioritura dell’essere» 4, attiene alla sfera del divino.
W. GRUNDMANN, καλός, in Grande Lessico del Nuovo Testamento (GLNT ),
Paideia, Brescia 1969, V, col. 9.
3 Ibid., 15. Mentre nel periodo arcaico (pre-omerico e omerico) la ‘bellezza’
diventa accessibile tramite il mito di Afrodite: «La caratteristica
fondamentale della bellezza afrodisiaca consiste nella spontaneità,
nell’irresistibilità, nella diffusività – simile a quella della luce – del “venire
alla luce”, del phein, del generare. Nella sua dimensione afroditica, la vita è
bella proprio in ragione della charis, di questo contraccambiarsi reciproco
delle sue forze»: G. CARCHIA, L’estetica antica, il Mulino, Bologna 1999, pp.
8-9.
4 PLOTINO, Enneadi 5, 8, 10.
2
42
2. Platone. La be lle zza tra idea e rivelazione
Una breve ricognizione del percorso di ricerca del grande filosofo
ateniese (Aristocle, 427-347 a.C., noto col nome di Platone, da
πλατύς: ampio) consente di comprendere l’estetica platonica. Platone
stesso, attraverso i suoi Dialoghi, spiega come sia partito dalla
filosofia dei fisici o naturalisti (φύσις: natura) e, resosi conto
dell’inconsistenza di essa, sia giunto alla scoperta della nuova
dimensione dell’essere. Egli mette in bocca a Socrate (suo maestro,
divenuto personaggio centrale nei Dialoghi) il percorso spirituale dal
sensibile all’intellegibile, dalla prima alla seconda ‘navigazione’: vuole
così indicare, in modo paradigmatico, quale sia la storia, il tragitto
ideale che la mente umana deve compiere per giungere alla
conoscenza della verità.
Le due tappe sono qui delineate: il filosofo ha dapprima affrontato
le questioni di fondo (quelle della generazione, della corruzione e
dell’essere delle cose, nella ricerca della causa prima o principio che ne
sta a fondamento), nella ricerca della verità, cercando di risolverle
percorrendo le vie tracciate dai primi filosofi nell’indagine della
natura. Sulla base di tale metodo le risposte ai problemi riguardanti
la causa e i principi delle cose risultano essere di carattere fisico: la
vita, per esempio, spiegata con tali criteri, si genererebbe dai
processi legato al caldo e al freddo; lo stesso pensiero umano
verrebbe inteso in funzione di soli elementi materiali5. Ma Platone
pensa che tali filosofi non portino alcuna chiarificazione e soluzione
ai problemi di fondo, semmai producono complicazioni e, in ultima
analisi, confusione (confondono il mezzo con la causa)6.
Qualche esempio: Empedocle ‘spiega’ il pensiero in funzione del sangue,
Anassimandro in funzione dell’aria, Eraclito in funzione del fuoco,
Alcmeone in funzione del cervello come organo fisico: si veda, per testi e
notizie, I presocratici. Testimonianze e frammenti, I-II, Laterza, Roma-Bari 1995.
6 «E neppure sono convinto di sapere [seguendo il metodo dei naturalisti]
come l’uno si generi e, in una parola, come qualsiasi altra cosa si generi, si
corrompa ed esista, stando a questo tipo di indagine. E cerco di mettere
insieme alla meglio un altro tipo di indagine, e non accetto più questa in
alcuna maniera»: Fedone 97B, anche 99B.
5
43
Così ha inizio la “seconda navigazione”7: poiché il metodo usato
dai pensatori naturalisti legato ai sensi non chiarisce ma oscura la
conoscenza e non giunge alla conoscenza della verità, il nuovo
metodo deve fondarsi sui logoi, aprire alle realtà sovrasensibili,
all’Intelligenza che fa essere le cose disponendole nel modo migliore
possibile. Con la seconda ricerca l’anima scopre l’esistenza di due
piani dell’essere: oltre il piano dell’essere fenomenico (fisico,
sensibile) esiste il piano dell’essere meta-fenomenico (metafisico,
meta-sensibile), il piano delle Idee. Alla luce di queste categorie
teoretiche, la natura e il cosmo fisico non risultano più essere la
totalità delle cose che sono, ma solamente la totalità delle cose che appaiono e
si raggiunge il mondo intellegibile, quella sfera delle realtà che non sono
sensibili, ma pensabili. E ciò che è pensabile, se pensato in modo
coerente, non può che essere (come già Parmenide aveva intuito)8.
Per esprimere la realtà metafisica Platone ricorre al termine forma,
precisamente ai termini greci ιδέα e είδος: l’idea non è propriamente
il pensiero, bensì l’oggetto del pensiero, a cui il pensiero si rivolge;
entrambi i termini derivano del verbo ιδειν che significa ‘vedere’,
dunque indicano l’oggetto del vedere. Prima di Platone venivano
usati per indicare la forma visibile delle cose, la forma esteriore che si
coglie con l’occhio (il veduto visibile), ora vengono usati per
indicare la forma interiore delle cose, la loro essenza. Così, grazie alla
“seconda navigazione”, la forma passa dal piano fisico a quello
metafisico, così è ora l’occhio della mente l’organo del ‘vedere’, della
comprensione tanto nella scienza come nell’arte9. Nella Grecia
classica le varie forme dell’arte (scultura, architettura…) si fondano
su ‘canoni’ che formano una regola di perfezione essenziale,
7
‘Navigazione’ è una metafora del linguaggio marinaresco: la prima
navigazione fatta da Platone con le vele ai venti corrisponde alle ricerche
compiute secondo i naturalisti e il loro metodo (le vele ai venti sono i sensi e
le sensazioni); la seconda navigazione, fatta con i remi, corrisponde al
nuovo metodo di ricerca che Platone introduce: porta alla conquista del
mondo sovrasensibile (i remi sono i ragionamenti e i postulati razionali): cfr.
Fedone 99D-100.
8 «La stessa cosa è il pensare e l’essere… Lo stesso è il pensare, poiché
senza l’essere nel quale è espresso, non troverai il pensare. Infatti,
nient’altro è o sarà all’infuori dell’essere»: PARMENIDE 28B 3-8 (DielsKranz).
9 Cf. G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica
dei grandi dialoghi alla luce delle dottrine non scritte, Vita e Pensiero, Milano 1995.
44
esprimibili attraversi numeri e rapporti numerici. La forma e la
bellezza hanno dunque a loro fondamento numeri, nessi numerici e
proporzioni. Inoltre i greci identificano il bello con il bene (come si
evince dal termine composto kalokagathia, che, come visto, è
traducibile con ‘bellezza-bontà’), pertanto la bellezza, coincidente
con la bontà, è misura, proporzione, verità e virtù (nel senso greco di
una perfetta attuazione dell’essenza di una cosa).
Nei dialoghi e anche nelle dottrine non scritte, per Platone il Bene
coincide con l’Essere, con l’Uno, la misura suprema di tutte le cose.
L’Uno è, per sua natura, rivelativo: così il dispiegarsi del bene, del
bello e del vero consiste nell’esplicarsi dell’unità nella molteplicità,
appunto mediante misura e proporzione, ordine e armonia. Dunque
l’ordine del mondo è retto da numero e misura, la trama di questi
rapporti (logoi) ha reso possibile il passaggio dal disordine all’ordine,
dal caos al cosmo. «La grande importanza della bellezza – sintetizza
un profondo conoscitore del pensiero platonico – consiste nel fatto
che essa è (soprattutto nel Fedro) la sola tra le forme intellegibili che
risulta essere visibile dagli occhi fisici, oltre che da quelli dell’anima:
“solamente la bellezza ricevette questa sorte di essere ciò che è più
manifesto e amabile”»10.
Platone ha cosi scoperto la dimensione ontologica del Bello, ora questo
Bello intellegibile si mostra, si rivela nella dimensione del sensibile: il
Bello è lo splendore, il luminoso con cui il Bene si fa vedere («La
potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello; infatti la misura
e la proporzione vengono a realizzare, dovunque, bellezza e
virtù»)11, il bello come un risplendere nel sensibile di qualcosa di
soprasensibile, dunque è, per sua natura, ciò che è più manifesto, è
strutturalmente rivelativo12. «La luminosità dell’apparire non è dunque
soltanto una delle proprietà del bello, ma ne costituisce la vera e
propria essenza. La caratteristica del bello, per cui esso attira l’anima
umana, è fondata nel suo essere stesso. In quanto strutturato
secondo misure, l’ente non è soltanto ciò che è, ma fa apparire entro
di sé una tonalità in sé misurata e armonica. È questa la ri-velazione
10
G. REALE, Saggezza antica, Raffaello Cortina, Milano 1995, p. 135.
Platone, Filebo, 64, a 5.
12 «Il καλόν si manifesta come forma del bene nel mondo del divenire,
appunto perché questo è plasmato secondo l’idea eterna e invisibile del
καλόν, che è la forma dell’essere eterno e del bene»: W. GRUNDMANN,
καλός, cit., p. 17.
11
45
(a-letheia) di cui parla Platone nel Filebo, che appartiene all’essenza
del bello. La bellezza ha la natura del risplendere […], ha il modo
d’essere della luce» 13.
Chi spinge l’uomo alla ricerca del bene? Chi sollecita l’anima umana
alla ricerca del bello? A questa domanda Platone risponde con il
Simposio, un capolavoro di stile e di pensiero in cui il filosofo
ateniese utilizza una particolare tecnica espressiva: quella del
progressivo disvelamento della verità con una sequenza di discorsi
degli invitati al simposio, che culminano nel discorso di Socrate. Qui
viene offerta la rivelazione della natura e dei caratteri di Eros, che
Socrate dice di aver ricevuto da una donna, Diotima di Mantinea14.
Dopo che i vari invitati hanno espresso il loro pensiero sull’Amore,
quando infine Agatone parla e loda il dio Eros («il più felice, il più bello
e il più nobile di tutti gli dei»), esalta la virtù di Eros (una virtù che
partecipa alla giustizia, temperanza, fortezza, sapienza) e conclude
dicendo che Eros, «l’amore naturalmente della bellezza»15, comporrà
tutte la faccende di dei e di uomini, Socrate stabilisce l’orizzonte
della ricerca, quello della verità, in questo contesto l’eros mostra la
sua struttura relazionale: sempre in rapporto con l’altro l’amore si
rapporta con qualcosa di cui sente la mancanza, fino alla sua
realizzazione suprema, quando raggiunge la Bellezza e il Bene. Così
riporta la risposta della donna di Mantinea alla domanda: «Ma chi è
questo Eros?».
È un demone che ricerca le cose belle e buone perché ne è privo e
prova il desiderio irresistibile di raggiungerle e di possederle per
sempre («l’amore è desiderio di possedere il bene per sempre»), è la tendenza
al bene nella dimensione del bello. Egli è, secondo un’antica
narrazione, figlio di Poros (espediente) e di Penia (povertà), concepito
quando nacque Afrodite (Venere), la dea della bellezza16. Eros è
H. G. G ADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 549. Si può
qui ricordare che il termine greco αλήθεια, letteralmente ‘dis-velamento’, è
tradotto ‘verità’, confermando la convergenza di bello, buono e vero.
14 Ancora una volta la fantasia di Platone fa di un personaggio evocato da
personaggi ‘reali’ – qui Diotima evocata da Socrate – una maschera
drammaturgica per esprimere il suo originale pensiero, cf. J. N. FINDLAY,
Platone. Le dottrine scritte e non scritte, (a cura di G. Reale), Vita e Pensiero,
Milano 1994.
15 Le tre citazioni dal Simposio 195a-b, 196b-d, 197b.
16 «Quando nacque Afrodite gli dei tennero banchetto, e fra gli altri c’era
Poros (Espediente), figlio di Metidea (Sagacia). Ora, quando ebbero finito,
13
46
dunque un ‘intermedio’ tra bello e brutto, tra buono e cattivo, tra
sapiente e ignorante, un intermedio in senso verticale, in quanto non è
un dio immortale né un semplice mortale, è una sorta di legame che
collega il tutto a sé medesimo, congiungendo il divino all’umano. In
quanto tale è anche intermedio in senso orizzontale, dal momento
che attua in sé la sintesi dei contrari: privazione e acquisizione,
bisogno e capacità di procurarsi ciò di cui ha bisogno, povertà e
ricchezza, o una sintesi mediatrice e dinamiche di forze opposte, che
Poros e Penia rappresentano. Eros non è, propriamente parlando, il
bello, esso conduce alla bellezza, esso è ricerca, è tendere al Bene in
tutti i sensi, con il desiderio di possederlo per sempre; in particolare
Eros realizza la tendenza al Bene nella dimensione del Bello, per
procreare nel Bello17.
In quale modo si muove questa tensione? Quale mai sarà la sua
azione? «La procreazione nel bello – risponde Diotima – secondo il
corpo e secondo l’anima, Eros è procreare e partorire nel bello» 18.
Sul piano fisico, procreando bei corpi; sul piano spirituale
realizzando le bellezza di opere d’arte, di conoscenze, di attività
umane. Da qui parte la scala dell’amore che porta all’assoluta Bellezza,
nella fruizione della quale si raggiunge il momento supremo della
arrivò Penia (Povertà), siccome c’era stata festa grande, per mendicare
qualcosa, e si teneva vicino alla porta. Poros intanto, ubriaco di nettare,
inoltratosi nel giardino di Giove, schiantato dal bere, si addormentò. Allora
Penia, meditando se, contro le sue miserie, le riuscisse di avere un figlio da
Poros, gli si sdraiò accanto e rimase incinta di Eros (Amore). Così Eros
divenne compagno e seguace di Afrodite, perché fu concepito il giorno
della sua nascita, ed ecco perché di natura è amante del bello, perché anche
Afrodite è bella»: Simposio 203b-c.
17 «Non si può concepire Afrodite, la bellezza in quanto amore, senza charis,
senza favore, senza contraccambio. È questa reciprocità a fare
propriamente di Afrodite l’emblema della bellezza. Come mostra Platone
nel Simposio, Eros non è in sé stesso bello, Eros conduce alla bellezza. Solo
Afrodite è veramente bellezza, perché è dono. La caratteristica
fondamentale della bellezza consiste nella spontaneità, nell’irresistibilità,
nella diffusività – simile a quella della luce, del “venire alla luce”. La
bellezza è quindi legata alla benevolenza, alla grazia insita nella bellezza
stessa»: G. CARCHIA, L’estetica antica, Laterza, Bari 1999, pp. 8-9.
18 Simposio 206b-e.
47
vita19. Per questo Diotima conclude invitando a tener caro Eros, a
esercitare il desiderio che, attraverso un percorso che va dai bei
corpi alle belle occupazioni (il bello morale) e alle belle conoscenze,
giunge fino alla conoscenza del Bello in sé. In tal modo Socrate
mostra come l’uomo, attraverso l’Eros, giunga all’esperienza del
bello, un’esperienza che consiste in un μάθημα: la scienza della stessa
bellezza, fino alla Bellezza in sé.
Con l’intuizione della bellezza quale idea che si manifesta nel
sensibile, Platone ha messo in luce il dominio più intimo del bello,
cioè il cerchio di bellezza e bontà, di verità e di apparizione. La verità
e la bellezza si fondano sul manifestarsi dell’idea, entrambe rivelano
l’essere: la verità della conoscenza distaccandosi dal sensibile, la
visione della bellezza penetrando in esso, così che la rivelazione del
bello acquista la sua accentuazione ontologica. L’idea della bellezza
si distingue dall’idea del buono, del giusto in quanto appare la più
luminosa ai sensi umani, in modo da attrarre l’anima e di elevarla
all’essere delle idee: «così la bellezza sortì questo privilegio di essere la più
percepibile dai sensi e la più amabile di tutte»20. La bellezza è dunque un
fenomeno originario, il venire-alla-luce dell’idea stessa (il verbo
pháinethai – manifestarsi – viene dalla radice pha- da cui deriva anche
phôs: chiarezza, luce), in questo modo essa offre rifugio all’essere,
che si sottrae alla vista, diventa il rifugio dell’idea di bene. Quanto
queste siano unite lo dice una luminosa frase del Filebo: «Ora dunque
la potenza del bene ci è sfuggita e s’è rifugiata nella natura del bello. La misura
infatti e la simmetria senza dubbio risultano dovunque bellezza e virtù» 21.
La tesi della simmetria (che recupera accenti pitagorici) vede nella
costanza del numero e della misura la causa principale dell’idoneità e
della bontà, così del bello si dice che si presenta chiaro e puro in
virtù del suo attenersi alla misura. Questa spiegazione della
simmetria conferisce alla bellezza un aspetto sorprendente.
Nell’armonia di una creazione equilibrata si manifesta l’essere
«Dalle bellezze partecipate e terrene, procedendo per tramite
trascendente, si comincia a scorgere la Bellezza suprema e l’uomo è giunto
al termine: conosce il Bello nella sua assoluta perfezione […], ciò che è
questa bellezza in sé: questo è il momento – caro Socrate – o mai più altro,
degno di vita per l’uomo, quando contempli la bellezza in sé»: Simposio
211c-d.
20 Fedro 250d.
21 Filebo 64e.
19
48
ineffabile e incomprensibile, che trascende tutti gli enti; qui esso
splende come bellezza, armonia e verità dell’ente: la simmetria così
congiunge il bello con il vero, poiché soltanto l’unione determinante
la misura può far sì che un ente venga alla luce per quello che
veramente è. Dunque la simmetria produce insieme la koinonía di
bello, di buono e di vero, e quella di apparenza (forma) adeguata e di
idea (contenuto), confermando così il concetto metafisico del bello:
la bellezza, unita all’armonia e alla verità è la manifestazione
dell’essere (dell’idea trascendente di bene).
Un ulteriore approfondimento sull’Eros si trova nel Fedro: qui
Platone collega la natura mediatrice-sintetica di Eros con la dottrina
della conoscenza intesa come reminiscenza, ossia ricordo del mondo
intellegibile da cui essa proviene 22. Eros è dunque un intermediario,
«un terzo genere» in rapporto agli altri due che sono l’essere e il
divenire, è desiderio incontenibile di raggiungere l’assoluto, forza
che arricchisce l’uomo e lo fa salire a livelli sempre più elevati. Così,
con il tema della Bellezza, si tocca «il punto più alto della filosofia
platonica e del pensiero greco, anzi di tutto il pensiero umano: il
καλόν, che in quanto idea eterna appartiene alla sfera del divino, è
ciò che, come forma del bene, abbraccia in una unità ideale divinità,
mondo, uomo, e conferisce all’esistenza umana, vissuta nell’arte e
nella virtù, significato, comunione, eternità»23.
3. Aristotele. Diafana è la B ellezza
In Aristotele (384-322 a.C.), il più illustre discepolo di Platone, la
filosofia si configura per la prima volta come una scienza inserita in
un sistema globale del sapere; di tale sistema la filosofia, nella sua
accezione specifica di metafisica, sta al culmine e assegna alle altre
scienze i loro confini e le loro connessioni. A partire da una critica
del platonismo lo Stagirita concepisce la filosofia non più come
esercizio di sapienza o innalzamento dell’anima alle idee (ascesi), ma
come attività scientifica articolata in un sistema di discipline distinte
e miranti ad abbracciare tutta la realtà.
Il corpus aristotelico comprende quattro gruppi di opere: un gruppo
di scritti di logica, un gruppo di scritti di filosofia della natura o fisica,
quattordici libri sotto il titolo di metafisica (chiamati così perché nella
22
23
Fedro 251a-b.
W. GRUNDMAMM, καλός, cit., 20.
49
serie ordinata da Andronico, veniva dopo [μετα-] la fisica) o
dell’essere, infine un gruppo di opere morali e politiche, di retorica e
di poetica. È in quest’ultime opere che Aristotele tratta della bellezza:
una definizione del concetto di bello si trova nella Poetica: «Il bello,
sia esso animato o sia qualunque altro oggetto, purché egualmente
costituito da parti, non soltanto deve presentare in codeste parti un
certo ordine, ma anche deve avere, dentro determinati limiti, una sua
propria grandezza: di fatti il bello consta di grandezza e di ordine»24.
Il bello, per Aristotele, implica dunque ordine, simmetria di parti,
proporzione25. Egli identifica l’essenza dell’arte nell’imitazione, vede
nella musica e nella tragedia uno strumento di catarsi, di
purificazione e di educazione. Lega l’arte all’elemento ideale che
rivela e, poiché anche per lui l’arte non può essere separata dalla
verità, l’arte è imitazione, è rappresentazione ideale della realtà, vive
dei suoi momenti più significativi. La realtà narrata è la storia, l’arte
non è vera in tal senso, ma è verosimile, cioè racconta ciò che è
possibile accada in ogni tempo, è universalizzazione, in quanto
rappresentazione non di fatti o eventi comuni, ma di situazioni che è
possibile siano vissute da tutti (l’esempio delle tragedie – che
Aristotele ha studiato – è emblematico a questo proposito)26.Questa
universalizzazione si ottiene con la forma bella, che trasfigura la
realtà in mimesi della realtà: questa è l’arte. La forma bella è, come
visto, splendore dell’ordine, ossia unità, proporzione e precisione. Il
godimento estetico è anche morale, nel senso che il bello porta, per
sua stessa natura, al bene.
Nei testi di etica definisce il bello come il bene puro e semplice, come
il fine della virtù27. Esso si realizza nella καλοκαγαθία: «l’uomo bello e
buono è tale in quanto possiede per sé stesse le cose belle e perché è
A RISTOTELE, Poetica VII, 1450b.
«Le superiori forme del bello sono: l’ordine, la simmetria e il definito, e le
matematiche le fanno conoscere più di tutte le altre scienze»: Metafisica XII,
1073, 31b
26 Nella Poetica Aristotele scrive che la tragedia produce una sorta di catarsi,
ossia la purificazione delle passioni nell’animo degli spettatori: chi assiste
alla tragedia prova pietà (per l’eroe, che apparentemente non merita i mali
che gli accadono, si pensi, per esempio a Edipo, Antigone …), o timore
(per sé stesso, al pensiero che potrebbe succedergli la medesima sorte). Ma
una volta che, nello scioglimento della vicenda tragica, i fatti hanno una
spiegazione razionale, pietà e terrore vengono acquietati.
27 Etica Nicomachea, 3, 10.
24
25
50
capace di produrre cose belle per amore di esse»28. Inoltre
Aristotele elabora anche una dottrina della percezione: l’αίσθησις è
un sentire-sapere, diverso dal νοέιν, il patire-agire in cui consiste la
sensazione è sempre legato al tempo, sia nell’atto del percepire, sia
nel percepito, poiché nella percezione il movimento è duplice: da
parte della cosa e da parte del senziente29.
Un altro apporto alla questione della bellezza lo Stagirita lo offre
nella teoria del diafano: è la disponibilità recettiva sensibile, l’apertura
luminosa, che rende la percezione del mondo possibile (δια-φαινω:
lasciar trasparire, tralucere, mostrare). Non basta che ci sia la luce e
l’oggetto affinché il mondo possa essere visto e conosciuto, ci vuole
un ‘terzo’ che lega tra loro i due mondi. Oscura la sua identità
(sensibile? intellegibile?), il diafano è conditio sine qua non della
relazione, c’è perché esista il dialogo e l’alterità, permette all’atto
luminoso di uscire da sé e dall’oscurità delle cose che esso, in un
certo senso, genera al mondo dando loro visibilità e colore. Per
Aristotele (e anche per tutta l’epoca medievale) il diafano è il
substrato, l’aspetto invisibile dello stato visibile e corporeo delle
cose; l’incorporeità di una luce che pure si incarna nella materia
stessa dei colori, e insieme la natura mediatrice ed epifanica
dell’immagine, dell’icona come ricettacolo di una presenza diafana,
che si svela pur restando ineffabile30.
Così il lascito estetico di Aristotele, sul quale il medioevo a lungo
discuterà, resta la questione della luce e quella dell’immagine (icona): a
queste due nozioni, proprio attraverso quella del diafano, il Medioevo
darà ampio sviluppo, la nozione di immagine esplicitata in quella di
forma (έιδος), mediatrice tra l’oggetto che si mostra, che si intravede
e il pensiero che si forma. E il concetto di diafano offre stimoli per
un teologia della luce come quella che si trova nel Prologo del vangelo
di Giovanni.
Etica Eudemia 8, 35
Cfr. B. M. D’IPPOLITO, L’invisibile potenza del sentire. Descartes Leibniz,
Angeli, Milano 2012, pp. 58ss., che elenca gli elementi rilevanti della
percezione: la polisemanticità del sentire, il suo carattere cognitivo ( e la sua
diversità dalla ragione astratta), l’intrinseca distensione temporale, il tratto
naturale dell’anima e il suo legame con la dimensione corporea dell’uomo,
luogo di interazione e di comunicazione col mondo.
30 Cf. il saggio di A. VASILIU, Du diaphane, Paris 1997.
28
29
51
4. Plotino. La teofania della Bellezza
La bellezza torna a occupare un posto di primo piano nella
speculazione di Plotino (205-270 d.C.), considerato l’ultimo
esponente dalla filosofia classica greca. Il principio primo di tutto è
l’Uno: infinito, trascende l’essere e il pensiero, è ineffabile e dunque
non si può dire quello che è (soltanto ciò che non è: una sorta di
teologia negativa). L’unico termine che si può ‘accostare’ all’Uno è
quello di Bene, inteso quale potenza e ricchezza infinita, origine di
tutte le cose. L’Uno è dunque la prima ipostasi.
Essendo infinito e traboccante, l’Uno emana sostanza da sé stesso:
come il sole illumina l’universo con i suoi raggi, senza perdere
potenza, così l’Uno emana sostanza. La seconda ipostasi è l’Intelletto
(νούς), che pensa sé stesso e nello stesso tempo è pensato,
rappresenta quindi un’unificazione del “motore immobile” di
Aristotele (atto puro) e del mondo delle idee platonico. La terza
ipostasi è l’Anima: come il demiurgo platonico guarda all’Uno e
all’Intelletto da una parte, dall’altra plasma la materia a somiglianza di
quelle. Essa partecipa alla materia e richiama il lόgos degli stoici, che
penetra nella materia, dandole forma e governando il mondo. Il
pensiero di questo filosofo neoplatonico è raccolto in sei gruppi di
nove trattati, detti appunti Enneadi.
Ora, essendo l’Uno al di là dell’essere e del pensiero, la Bellezza è
attributo essenziale della seconda ipostasi eterna, il νούς:
l’Intelligenza è bella per sé stessa31, è il più bello degli esseri ed è
creatrice di bellezza32. Per Plotino la bellezza coincide, in generale,
con la forma: una cosa è bella in quanto possiede una forma;
l’Intelligenza, che è il mondo delle forme e delle idee, è la suprema e
assoluta bellezza33. Anche l’Uno, benché si trovi al di là di ogni cosa,
al di sopra di ogni bellezza, è «Bellezza che trascende ogni bellezza»,
è «potenza di ogni cosa bella»34.
Seguendo Platone, egli insegna che la bellezza esercita un grande
fascino sull’anima, la sprona ad abbandonare questo mondo
sensibile per salire al mondo intellegibile. La causa di questo non sta
31
PLOTINO, Enneadi V, 9, 2; cfr. G. FAGGIN, Plotino, Edizioni Aśram Vidya,
Roma 2008 (specialmente pp. 121-132).
32 Enneadi, III, 8, 11.
33 Enneadi, V, 8, 3.
34 Enneadi, VI, 7, 22.
52
tanto nella simmetria quanto nella loro partecipazione all’ideale
bellezza: quando l’anima si trova di fronte al bello, un fremito di
gioia la pervade nel riconoscerla. Pertanto il primo trattato delle
Enneadi si chiude con questa esortazione: chiunque desideri vedere
Dio e la bellezza deve innanzitutto diventare simile a loro: «Così nel
suo cammino verso il cielo, l’anima perverrà dapprima al principio
intelligente, vedrà ogni idea bella realizzata in questo essere così
nobile e proclamerà che questo è Bellezza e che le idee sono
Bellezza. Ciò che si trova al di là e al di sopra del principio
Intelligente è per noi la natura del Bene che irradia il Bello verso
l’esterno» 35.
In questa mistica plotiniana, il sensibile è άιστησις άνγελος, non è
portatore soltanto di sé stesso, ma immagine di una realtà
intellegibile a cui rinvia, è rilucere dell’idea, bagliore, apertura.
Partendo dalla bellezza sensibile, egli cerca di vedere in che cosa sia
radicata, e superando l’estetica del tempo che coincide con la
simmetria, afferma che la bellezza è la vera realtà, la più alta visione,
e che le cose belle partecipano all’Idea, sono in comunione con la
Bellezza trascendente che emana i suoi effetti nel bello del mondo.
Il bello è l’Idea, l’arte la sua rivelazione. Dal momento poi che l’idea
è anche l’Essere, il bello è allora l’Essere universale ed eterno, così
chi contempla il Bello si inserisce nell’Essere attraverso un processo
di purificazione 36. Il bello più elevato è «nella visione», così chi
contempla il Bello lo possiede e diviene bello lui stesso: «Se
qualcuno ha fissato lo sguardo in Colui che, dispensando a tutti
bellezza, resta immobile in sé stesso, offrendo tutto non riceve nulla
per sé… di quale bellezza avrà mai bisogno? La primigenia bellezza
rende belli e amabili i suoi ammiratori»37.
Anche l’artista vive i due momenti del ritmo della vita: la salita alla
visione pura e la discesa nell’espressione sensibile di ciò che ha
intuito e contemplato. Così l’arte può essere parto dell’intuizione
dell’Essere da cui si è fecondati in una forma espressiva che non è
chiusa in sé, ma lascia trasparire bagliori, apre all’Essere. Essendo
35
Enneadi, I, 6, 9.
Cf. Enneadi, I, 6, 6.
37 Enneadi, I, 6, 7. «Ognuno diventi innanzitutto deiforme e bello se vuole
contemplare Dio e la Bellezza … ciò che è al di là della bellezza e il Bene e
la Bellezza gli sta innanzi tutt’intorno, poiché il Bene è sorgente e principio
del bello»: I, 6, 6-9.
36
53
però lo scopo ultimo quello di raggiungere il Primo Principio
assoluto, l’esperienza dell’Ineffabile, anche l’espressione è destinata a
essere superata per arrivare infine alla vera visione, all’estasi. A
questo punto «l’arte non esiste più, avendo consumato il suo ruolo
di riportare al silenzio dell’Uno, dove il bello sensibile non è più un
valore che bisogna creare, dal momento che l’anima stessa è bella e
il suo essere stesso è un’opera d’arte»38.
Al termine di questo percorso filosofico si può dire che il mondo
classico greco (e latino) ha dedicato al tema della bellezza riflessioni
di grande intensità e approfondimenti pieni di fascino. Anche se
l’estetica come disciplina a sé stante sorgerà molto più tardi, la
metafisica e la gnoseologia degli antichi greci (soprattutto con il
Fedro e il Simposio platonici) ha posto le basi per esaltare il nesso tra
essere, bene e bello, mentre con Plotino ha sottolineato il carattere
religioso del Kalòn: chi lo raggiunge diventa esso stesso bello e
amabile. Infine, la contemplazione libera e pura dell’armonia delle
forme ha originato i canoni dell’arte, della poesia e della letteratura
di quella civiltà. E non solo di quella civiltà39.
38
Cf. M. I. RUPNIK, Bellezza, G. BARBAGLIO-G. B OF (edd.), Teologia, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002, pp. 158-159.
39 Cfr. A A. V V., La conoscenza estetica, Ed. Leonardo da Vinci, Roma 2000; G
. CARCHIA, L’estetica antica, Laterza, Bari 1999; H. G. GADAMER, L’attualità
del bello, Marietti, Genova 1986.
54
IL PERCORSO BIBLICO
«Amore e verità s’incontrano,
giustizia e pace si baciano,
la verità germoglia dalla terra
e giustizia si afaccia dal cielo»:
Gesù, rivelazione della Bellezza
(cfr. Sal. 85, 11-12)
«πάντα δοκιμάζετε,
τό καλόν κατέχετε»
(1Ts 5, 21)
1. Il lessico della bellezza
Un primo sguardo sulle pagine della Scrittura rivela che, rispetto al
pensiero greco che abbiamo visto nel capitolo precedente, il
concetto del bello è sempre unito all’esperienza etica e teologica.
Traspare una concezione funzionale del bello, lo stupore della
bellezza induce la domanda etico-teologica, come si nota, tanto per
citare uno di numerosi esempi, nel Salmo 8: il salmista contempla le
bellezze del creato («Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e
le stelle che hai fissato»: v. 4) e sorge in lui la domanda di carattere etico
e teologico: «Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell’uomo
perché te ne curi?». Non diversamente il profeta Geremia (VII sec.):
contempla le bellezze della natura («un ulivo verde, maestoso»: 11, 16;
«un tamerisco in luoghi aridi del deserto»: 17, 6) e dell’arte («un vaso di creta
modellato dal vasaio»: 18, 4) e ne trae subito una morale, un richiamo
etico e religioso al popolo d’Israele 40.
Si può fare una prima considerazione: «se è vero che l’autore sacro
ha la consapevolezza della dimensione estetica dell’essere cosmico,
umano e divino, al punto tale da confessare che “belle sono le realtà che
si vedono” (Sap 13, 7), egli però adotta subito il metro teologico per
interpretare quella bellezza, come dirà il libro della Sapienza: “Dalla
grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro artefice”
(13, 5).
Sul Salmo 8 cfr. G. RAVASI, «Lungo i fiumi …». I Salmi, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Mi) 2001.
40
55
Questo si può vedere anche analizzando il lessico dell’esperienza
estetica: il principale termine ebraico è tôb: ricorre 741 volte, è un
termine semplice e complesso insieme, dal ricco valore semantico:
indica la ‘bellezza’ vera e propria (così nella sua prima apparizione in
Gen 1, 4: «Dio vide che la luce era ‘tôb’»), ma anche il riflesso della
‘bontà etica (quella che caratterizza l’eletto re d’Israele: 1Sam 15, 28).
Può anche indicare il ‘vero’, la ‘verità’, in quanto termine di un
affetto intenzionale e di una forte passione: il piacere sensibile per
un paesaggio incantevole (Ez 17, 8), o la tenerezza del sentimento
d’amore (1Sam 1, 8). Così la versione greca dell’Antico Testamento
(detta dei Settanta) traduce tôb con diversi vocaboli: αγαθòς (buono),
κρεστòς (utile), καλòς (bello), anche se quest’ultimo è prevalente41.
Inoltre riscontriamo, sempre in questo ambito, un altro termine
ebraico: jāfeh, che ha un’accezione prevalentemente estetica,
traducibile con ‘stupendo’, ‘incantevole’ ‘bellissimo’; così anche il
termine nawè, che evoca qualcosa di ‘ammirevole’, ‘affascinante’. Ma
permane anche in questi casi il riferimento etico, proprio perché,
avendo alle spalle una gnoseologia simbolica, unitaria e un’analoga
antropologia e cosmologia, si considera sempre in modo compatto
bene e bello, buono e mirabile, etica ed estetica.
Nel complesso, ciò che la filosofia greca pensava del bello,
considerato come un’idea, può rientrare nella religione biblica – sia
pure con una determinazione e una forma diversa, attesa la
concezione del Dio personale – nelle affermazioni sulla gloria (kābôd)
di Jahvè: il legame dell’estetica teologica con il tema della rivelazione
divina trova proprio nel concetto di ‘gloria’ il suo punto di
applicazione più illuminante.
Nel greco neotestamentario καλòς (ricorre 100 volte) è quasi sempre
sinonimo di ‘buono’ (αγαθòς), entrambi i vocaboli si sostituiscono
reciprocamente (cfr. Mc 3,4; Mt 12, 12; Ef 2, 10, Eb 10, 24), o, più
precisamente: mentre αγαθòς indica più la disposizione d’animo e il
valore morale che vi fonda, καλòς più l’aspetto del bene in
comportamenti degni di lode. In questo primo accostamento, nei
testi del Nuovo come dell’Antico Testamento, «il ‘bello’ nel senso
della concezione platonica ed ellenistica non è preso in
41
Cfr. G. RAVASI, Bellezza e mondo biblico, in G. RAVASI , M. I. RUPNIK , Il
fascino del bello. Tra Bibbia e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010,
pp. 9-10; G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento, Paideia, Brescia 19721974; P. EICHRODT, Teologia dell’Antico Testamento, Paideia, Brescia 1979.
56
considerazione» 42. Per lo più esso indica il bene morale, l’eccellenza,
l’auspicabilità (Mc14, 6; Mt 26, 10; Gv 10, 33; 1Tim 3, 1…) e ha come
opposti κακòς (‘brutto’: Rom 12,17) o πονηρòς (‘cattivo’: 1Ts 5, 21).
Va notato che il termine è usato per lo più per caratterizzare la
qualità morale dell’agire («καλά έργα»: buone opere, Mt 5, 16) , ma,
in uno spettro semantico più ampio, può designare la perfezione
(fisica), la convenienza o l’utilità di una cosa (in senso figurato) e si
può tradurre con utilizzabile, utile, prezioso (Mt 3, 10: riferito al frutto;
Mc 4, 8: riferito al terreno fertile; Mt 13, 24: al seme; Lc 8, 15: al
cuore; Gv 2, 10: al vino).
Nel corpus paolino la presenza di καλòς decresce in favore di αγαθòς:
nelle espressioni parenetiche l’apostolo esorta a “tendere al bene”
(Rom 12,17), a “fare il bene” (Gal 6,9; 2Cor 13,7), a valutare ogni
cosa e a “tenere ciò che è buono/bello”(«πάντα δοκιμάζετε, τò καλòν
κατέχετε»: 1Ts 5, 21). Nel vangelo di Giovanni Gesù è chiamato
“buon pastore” (ποιμήν ο καλòς: 10,11. 14): qui ha un significato
assoluto, quasi paragonabile al ‘vero’ (αληθινός, come in 6, 32. “il
pane vero”, o in 15,1: “la vera vite”): Gesù è il pastore buono, che dà
la vita per le pecore, unico e vero, che, diversamente dai falsi pastori,
accoglie i suoi nella sua comunione con il Padre. Soltanto nel quarto
vangelo le opere di Gesù sono qualificate come “opere buone”
(«καλà έργα»: 10, 32; «καλά έργα εκ του πατρός»: 10, 37): così
l’evangelista indica i segni di rivelazione compiuti da Gesù in virtù
del potere conferitogli dal Padre: sono le opere di Dio che Gesù
compie come Messia.
Infine il nostro termine compare frequentemente nelle lettere
pastorali: serve a indicare la bravura, la conformità all’ordine: così
“le opere buone” (1Tim 5, 10.25), “la buona condotta dei cristiani”
(1Tim 5, 10), chiamati a fare la “bella confessione di fede” («καλή
ομολογία»: 1Tim 6, 12), quella dei titolari di uffici (Tit 2, 7), “la
buona fama” del vescovo (1Tim 3, 7), che deve custodire e
trasmettere “il buon deposito” («καλή παραθήκη»: 2Tim 1, 14).
Anche se in questi ultimi scritti l’uso del καλòς sembra più vicino
42
J. WANKE, καλòς, in H. BALTZ-G. SCHNEIDER (a cura di), Dizionario
esegetico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2004, p. 1895. Il καλòς va
tradotto con ‘bello’ nel senso di un giudizio estetico probabilmente
soltanto in Lc 21, 5 (“le belle pietre” del tempio).
57
alla sensibilità greca, non manca qui il riferimento all’agire morale,
reso possibile dalla grazia di Dio43.
Per ragioni di completezza va infine ricordato che la tradizione
biblica conosce anche l’ambivalenza del concetto di bellezza: la sua
dimensione seduttiva e una potenzialità diabolica che «acceca gli
occhi, e induce l’uomo alla ribellione contro Dio» (P. Eichrodt). In
effetti il culto della bellezza può essere anche idolatria e deriva
peccaminosa. Ma non sembra che questo comporti l’individuazione
di un pregiudiziale sospetto nei confronti dell’estetico come antitesi
al ‘religioso’, a motivo del fatto che, da un lato, l’estetico contiene in
sé un legame originario con la ‘giustizia’ delle cose e con la ‘santità’
della creazione; e, d’altro canto, la religione integra i valori
dell’estetico mediante le più fondamentali figure della rivelazione di
Dio e della fede personale.
2. Poes ia biblica
Nel florilegio (antologia) dei generi letterari che compongono la
Bibbia (libri) spicca per bellezza la poesia: in essa, più che in altri
generi, il connubio di mistero e di apparenza, di bontà e di bellezza,
di visibile e d’invisibile è trasparente. In effetti la poesia è fonte di
ispirazione della filosofia e, in qualche modo, le indica delle
frontiere: la religione, l’esperienza estetica, la questione del male 44.
Secondo il filosofo M. Heidegger, la valorizzazione della poesia (e
dell’arte) s’accompagna alla vicinanza fra pensare e poetare: soltanto
nel dialogo con la poesia il pensiero si avvicina all’essenza del
linguaggio, e quindi all’essere, perché il linguaggio è “la casa
Cfr. J. WANKE, op. cit., p. 1897. Anche l’avverbio καλ ς, presente 37
volte nel N.T., indica prevalentemente l’adeguatezza, la giustezza di un
modo di agire, di una situazione o di un fatto (“agire giustamente”: 1Cor 7,
37; “hai detto bene”: Mc 12, 32; “fare del bene”: Mt 12, 12); cf T. KRÜGER,
Bellezza, in A. BERLEJUNG, C. FREVEL (a cura di), I concetti teologici
fondamentali dell’Antico e del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2009, I, p.
193.
44 Cfr. P. RICOEUR, La metafora viva, Jaca Book, Milano 1981; anche O.
AIME, Senso e essere. La filosofia riflessiva di Paul Ricoeur, Cittadella, Assisi 2007,
pp. 96-100. 218-222; cfr. R. ALTER, L’arte della poesia biblica, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Mi) 2011.
43
58
dell’essere” in cui abita l’uomo, di cui i poeti e i pensatori sono i
custodi45.
La poesia biblica, presente nella letteratura sapienziale e in quella
profetica, rivela propriamente quel intreccio di estetica, etica e
teologia di cui abbiamo detto sopra. Si possono trovare numerosi
esempi nei salmi, una preghiera in forma poetica che tocca tutti gli
ambiti del vivere cosmico e umano, tutte le situazioni umane tradotte in orazione. Una bella pagina poetica è il Salmo 19: descrive,
con lo sguardo attonito, il sorgere del sole, simile a quello dello
sposo che, sul far del giorno, esce dal talamo nuziale, simile a un
forte atleta lanciato nella corsa. Il poeta orante vive veramente
un’esperienza estetica, scorge nelle bellezze del creato un’epifania
della gloria di Dio:
«I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorni ne affida il racconto,
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio» (vv. 2-5)46.
Mentre nella prima parte si celebra il Creatore, nella seconda parte
del salmo si canta l’Autore della Legge: la natura e la legge
manifestano le perfezioni divine, la maestosa bellezza (la ‘Gloria’):
come il cielo e il sole lodano il Signore, così deve fare l’uomo con la
legge, donatagli da Dio:
Cfr. M. HEIDEGGER , La poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988. Già
Aristotele scriveva: «la poesia è qualche cosa di più filosofico e di più
nobile della storia, perché la poesia si occupa tendenzialmente
dell’universale»: Poetica, IX, 3, 1451 b6.
46
L’odierna dominante visone scientifica ha smarrito questa
contemplazione del mondo creato: dall’immagine del libro della natura a
quella di un gigantesco automa cosmico. L’automa non obbedisce più se
non a meccanismi: si svuota il simbolismo, i cieli non parlano più se non di
sé stessi. «”I cieli narrano la gloria di Dio”, diceva il Salmista; dopo
Newton, Pascal scrive: “Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi
spaventa”»: A. JEANNIÈRE, Qu’est-ce que la modernité?, «Etudes» 373 (1990),
p. 502.
45
59
«La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore,
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi» (vv.8-9).
Una delle espressioni dell’attuale crisi dell’estetica è l’incapacità di
apprezzare l’inestimabile valore della poesia, il disinteresse verso il
linguaggio poetico, l’inettitudine a leggere (ascoltare, interpretare,
cogliere, attraverso la bellezza dei versi, il messaggio, la verità del
testo) una poesia. Sembra smarrito quel rapporto che Ricoeur
chiama la poetica del testo e l’estetica della ricezione. Leggiamo,
superando la sordità del cuore e la cecità della mente, un altro
ammirevole esempio nel Salmo 85: avendo invocato il ritorno di
Dio nel tempio e in Gerusalemme presso il popolo che torna
dall’esilio («la gloria del Signore abiterà la nostra terra»: v.10), il salmista
canta quest’incontro con termini ispirati:
«Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il su frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino»
(vv. 11-14).
‘Amore’ e ‘verità’ sono le virtù dell’alleanza, ‘giustizia’ e ‘pace’ sono
la salvezza e la pace messianica, insieme alle altre virtù personificate
ricostruiranno l’armonia della creazione e dell’alleanza interrotta dal
peccato.
Non mancano testi poetici anche nella tradizione profetica:
soprattutto Isaia (VIII sec. a.C.), oltre che eroe nazionale che
partecipa alle vicende del suo paese, è un poeta di genio. Lo
splendore del suo stile, la novità delle sue immagini fanno di lui un
‘classico’ della Bibbia. Le sue composizioni hanno una forza concisa,
60
un’apertura sorprendente, un’armonia che forse non saranno più
raggiunte. Egli è poeta, e la sua grandezza è soprattutto religiosa:
segnato per sempre dalla scena della sua vocazione nel tempio (Is 6),
ha cantato la trascendenza di Dio (la maestà e la santità, la bellezza e
la gloria) e l’indegnità dell’uomo chiamato a conversione. Isaia è il
poeta della fede e il profeta del Messia: questi farà regnare sulla terra
pace e giustizia, diffonderà la conoscenza del vero Dio (il “tre volte
Santo”: 6, 3).
Scegliamo un paio di esempi: dapprima il “Canto della vigna” 47,
poema composto da Isaia all’inizio del suo ministero, forse
ispirandosi a una canzone di vendemmia: con la metafora della vigna
descrive i rapporti fra Dio e il popolo alleato ma infedele:
«Voglio cantare per il mio diletto
il mio cantico d’amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre
e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva,
essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi i giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna
che io non abbia fatto?
Perché mentre attendevo che producesse uva,
essa ha prodotto acini acerbi?
47
Il tema della vigna-Israele, già preparato da Osea (10, 1), sarà ripreso da
altri profeti: Geremia (2, 21; 5, 10; 12, 10), Ezechiele (15, 1-8; 17 ,3-10) e
dal Salterio (Ps 80, 9-19). Gesù lo trasporrà nella parabola dei vignaioli
omicidi (Mc 12, 1-12; Mt 21, 33-44; Lc 20, 9-19): qui, rispetto al canto della
vigna di Isaia, Dio invia suo Figlio, non solo i profeti, il popolo ha rifiutato
il Figlio, non solo i profeti: cfr. B. M AGGIONI , Le parabole di Gesù, Vita e
Pensiero, Milano 1995, pp. 52-58. Infine, nel quarto vangelo viene rivelato
il mistero della ‘vera’ vigna: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo». (Gv
15, 1-2).
61
Ora voglio farvi conoscere
che cosa sto per fare alla mia vigna:
taglierò la sua siepe
e si trasformerà in pascolo;
demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata.
La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni;
alle nubi ordinerò di non mandare la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti
è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi»(5,1-7)
Questo “cantico d’amore” (o “cantico dell’amato”) è un capolavoro
nel quale l’arte poetica e il messaggio profetico si fondono in
un’unità di straordinaria bellezza e di inesauribile ricchezza. La
poesia non canta un amore bucolico, ma una storia umana d’amore:
canta il dramma dell’amore del Signore verso il suo popolo, amore
che si manifesta nell’intensità appassionata della tenerezza sponsale
e sperimenta l’amarezza di una grave in-corrispondenza che si
manifesta come infedeltà. Il tema della vigna, già preparato dal
profeta Osea (10, 1), verrà ripreso più volte nelle Scritture del primo
e dell’ultimo Testamento.
L’altra pericope poetica possiamo riprenderla dagli annunci
messianici, così il profeta pennella la luminosa era messianica in quel
che è chiamato il “libro dell’Emanuele” :
«Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce:
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
62
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva,
la sbarra alle sue spalle
e il bastone del suo aguzzino,
perché un bambino è nato per noi
c’è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere,
e il suo nome sarà
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia.
Questo farà lo zelo del Signore» (9,1-6).
L’evento della liberazione è descritto poeticamente come l’irrompere
improvviso della ‘luce’ (simbolo di vita, di libertà) nel luogo stesso
dell’oscurità e delle ‘tenebre’. Al motivo della luce viene connesso
quello della ‘gioia’ che costituisce il contenuto di una dichiarazione
di fede. Il motivo di tale gioia è costituito dalla proclamazione del
“bimbo nato per noi” (bimbo ‘dato’: passivo teologico), su di lui la
mano di Dio lo renderà grande sovrano (consigliere ammirabile,
principe della pace, Dio potente …).
Anche nel Nuovo Testamento è possibile rintracciare questo
intreccio di estetica, etica e teologia, soprattutto nella trama
narrativa delle parabole di Gesù. La loro bellezza sta tanto nella
forma come nel contenuto: il parlare figurato appartiene a ogni
linguaggio, specialmente a quello poetico, è il meno inadeguato per
parlare di Dio. Dio è al di sopra dei nostri pensieri e delle nostre
parole: per parlare di Lui dobbiamo utilizzare le esperienze che
abbiamo a disposizione, così Gesù, per aiutarci a comprendere
qualcosa dell’amore sconfinato di Dio, prende spunto da
un’esperienza che tutti possono comprendere: «Un padre aveva due
figli…».
Ma il fascino delle parabole è anche un altro: sebbene legate al
contesto storico in cui furono proclamate, tuttavia è come se non
fossero datate: la loro forza di meraviglia e di interrogazione è
63
sempre intatta, chiunque le legga si trova coinvolto nel racconto,
«sono pagine sempre aperte che nessuna esegesi riesce a chiudere
una volta per tutte»48. Il linguaggio parabolico ha penetranti accenti
poetici, presenta tre caratteristiche: è inadeguato, desunto dal vissuto
quotidiano, cosciente dei limiti, ha la pretesa di rinviare a qualcosa di
ulteriore; è aperto, capace di dire cose indicibili (il Regno di Dio), che
sono altre da noi, ma hanno una profonda relazione con noi, è
evocativo e invocativo; dà da pensare, induce a riflettere, provoca un
cambiamento verso l’autenticità. Lo scopo della parabola è di
‘rivelare’: rivelare la bellezza dell’amore di Dio, il suo sorprendente
perdono. Le parabole di Gesù contengono una parola creatrice
(l’ebraico dabar): realizza quel che annuncia, «che il cielo si rallegri di
più per un peccatore pentito che non per novantanove giusti che
non hanno bisogno di pentirsi non è affatto ovvio, ma lo diventa
subito quando diviene evidente nella parabola della gioia per la
pecorella smarrita e ritrovata»49.
Infine occorre aggiungere che quando Gesù prende spunto dalla
realtà vissuta, quando osserva l’armonioso volo degli uccelli e la
bellezza sapiente dei gigli del campo, non lo fa per comporre una
lirica, bensì per guidare chi li sta contemplando verso un piano
superiore, verso un orizzonte trascendente. Per questo le parabole
iniziano così: «Il Regno di Dio è simile a…a che cosa paragonerò il regno dei
cieli?», per questo si può ribadire che «l’estetica è qui funzionale
rispetto all’annuncio religioso, bellezza e verità s’incrociano,
l’armonia è l’altro volto del bene»50. Colui che annuncia e porta il
Regno di Dio in noi e tra noi la fa in modo grazioso e bello, in
modo eloquente e incisivo, invita alla contemplazione e all’azione,
già il salmista esortava a «cantare inni con arte a Dio, re di tutta la terra»,
così il sapiente e l’apostolo invitavano a risalire, dalle bellezze e dalle
48
B. MAGGIONI , Le parabole di Gesù, cit., p. 9; a proposito di una certa
‘poetica’ e singolarità delle parabole, scrive ancora B. Maggioni: «Se le
parabole – e questo è un dato di fatto – parlano ancora oggi, non è perché
sono talmente generali da adattarsi a ogni epoca e domanda, ma perché
sono talmente precise –‘singolari’, appunto – da riproporre in ogni tempo
la medesima e unica domanda»: p. 15.
49 E. J ÜNGEL, Dio mistero del mondo, Queriniana 1982, p. 461.
50 G. R AVASI, Bellezza, cit., p. 13 ; cfr. V. FUSCO, Oltre le parabole. Introduzione
alle parabole, Borla, Roma 1983.
64
perfezioni del creato, all’Artefice di ogni bellezza (Sap 13, 1; Rom
1, 20)51.
Chi vuole conoscere chi è Dio, come Dio agisce nei nostri
confronti, chi vuole sapere come cercarlo e dove trovarlo, deve
guardare e ascoltare Gesù: i racconti di Gesù manifestano chi è Dio
nella sua intima profondità: amore, comunione, dono, solidarietà
incrollabile e universale, vi si scorge una realtà di grazia che
gratuitamente si dona, che si prende cura degli umani (il buon
samaritano, cfr. Lc 10,25ss). Gesù stesso può essere chiamato la
parabola di Dio: in lui si svela la verità di Dio, la verità dell’uomo e il
senso della storia.
3. La creazione, capolavor o di Dio
Fermo restando questo aggancio con l’etico e il teologico, è
possibile scoprire nella Scrittura una più immediata percezione della
bellezza e una meditazione sull’esperienza estetica, per esempio, nel
racconto ‘sacerdotale’ della creazione in Gen 1. Al termine di ogni
giorno della “settimana lavorativa” del Creatore, vi si trova un
giudizio, una sorta di approvazione dell’opera compiuta: «Dio vide che
era ‘tôb’» (Gen 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25), mentre dopo la creazione
dell’uomo e della donna si dice: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto ‘tôb’» (v. 31). «Non è un linguaggio fatto di parole» –
commenta a questo riguardo il Salmista – ma una visione e una voce
che possiamo vedere e ascoltare col cuore (nel lessico biblico è
l’organo dell’auditus fidei).
Come già accennato, si tratta dell’aggettivo etico-estetico che
traduciamo con “bello”, “buono”. Anche se alcuni esegeti e teologi
ritengono che il termine non esprima tanto un giudizio estetico,
quanto piuttosto la conformità al fine 52 e la compiutezza
51
Cfr. U. CASALE, Qual è il tuo Nome? Il mistero trinitario di Dio, Esperienze,
Fossano (Cn), pp. 143-149.
52 Cfr. G. VON RAD, Genesi capitoli 1-11, Paideia, Brescia 1969, pp. 58-59.
70-71. Va comunque segnalato che la versione greca dei LXX traduce il tôb
con il greco καλόν. Si potrebbe collegare Gen 1 – che vede il Dio creatore e
lo spettacolo della bellezza – con Sap 11, 20, che vede la creazione come
un universo di misure, di calcoli e di relazioni (11, 20). Cfr. i commenti di
AGOSTINO, De libero arbitrio, II, 16, 42 e di TOMMASO D’A QUINO, Summa
Theologiae I, q. 39, a.8.
65
dell’ordito53, tuttavia a noi sembra che l’aspetto estetico abbia, in
questa pericope, una certa importanza: l’intensa visione del creato, la
soddisfazione per l’opera riuscita, l’icona del Creatore – un vero
artista – permettono di rendere l’espressione: «Dio vide che era bello...
molto bello!»54. In tal modo si afferma la positività dell’essere creato, la
compiutezza e l’armonia (nessun male è stato introdotto nel mondo
dalla mano di Dio) e la qualità estetica non appare come qualcosa di
aggiunto alla creazione, bensì appartiene al suo stesso statuto e alla
sua struttura.
Non diversamente la letteratura sapienziale loda Dio per le “sue
opere”, esalta la bellezza del creato, l’armonia e lo splendore della
gloria di Dio che riempie l’universo. Così il salmista canta e benedice
Dio per gli splendori della creazione:
«Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda…
Sia per sempre la gloria del Signore,
gioisca il Signore delle sue opere»
(Ps 104, 1-2. 31).
La letteratura sapienziale, mentre parla della bellezza della Sapienza
(Qo 3, 11), proclama la bellezza della creazione. Così, una pagina
poetica del Siracide (un sapiente del II sec. a.C.) inneggia alla gloria di
Dio nella natura e nella storia (42, 15-43, 33): l’Autore di questa
lirica, unendo estetica poetica e pedagogia sapienziale, vede nelle
opere create la presenza maestosa di Dio (teofania), con stupore
53
«Il contesto suggerisce di tradurre “ben riuscito”»: W. GRUNDMANN,
καλός, cit., p. 29.
54 La creazione significa dipendenza/legame delle creature col Creatore, la
speciale creazione dell’uomo/donna significa una particolare relazione
(“molto bello”), ossia l’umano è voluto da Dio in maniera speciale, perché
è l’unico essere capace di conoscerlo (meglio: di ri-conoscerlo). Questa
affermazione di fede non riguarda tanto una lontana origine nel tempo,
quanto il fatto che gli sta in una particolare relazione col Creatore (creatio
continua); cfr. U. CASALE, Introduzione, in J. Ratzinger-Benedetto XVI, Il
problema di Dio nel mondo contemporaneo, Lindau, Torino 2011, pp. 7-151
66
descrive le meraviglie dell’universo, abbagliato da sì tanta bellezza.
La prospettiva biblica dell’intreccio tra estetica e teologia permane,
ma è lampante l’emergere della contemplazione lirica della bellezza
del creato.
Tutto l’universo appare saldo e compatto, partecipe del progetto
armonico voluto dal Creatore, così grande e profondo che neppure i
‘santi’ riescono a narrare. L’accento è posto proprio sulla perfezione
e armonia del progetto voluto da Dio, anche le realtà antitetiche
(poste l’una di fronte all’altra) esprimono pienezza ed equilibrio, la
sfilata poi delle varie creature è assai suggestiva: dapprima il
firmamento e i suoi astri, il sole che avvolge l’orizzonte del suo
calore, la luna che segna tempi e date, le stelle chiamate “bellezze del
cielo” e sentinelle che vegliano nella notte, l’arcobaleno “molto
bello”, tracciato nel cielo dalla mano di Dio; poi il vento e i fulmini,
la rugiada e la brina, il mare e i naviganti, la pioggia e la neve il cui
candore “incanta gli occhi e il cuore”.
L’incipit della lirica è costituito da un interrogativo retorico,
espressione di un’ammirazione che scopre la luminosità e l’armonia
della bellezza. Poi, tutto l’inno è percorso da questa ammirazione
che scopre la Bellezza increata riflessa nelle creature, scorge che
Dio, con la sua Parola, tiene insieme tutte le cose: ogni opera supera
la bellezza dell’altra, «chi si sazierà di contemplare la sua gloria?»:
«Ricorderò le opere del Signore
e descriverò quello che ho visto.
Per le parole del Signore sussistono le sue opere.
Il sole che risplende vede tutto,
della gloria del Signore son piene le sue opere.
Neppure ai santi del Signore è dato
di narrare le sue meraviglie,
che il Signore, l’Onnipotente, ha stabilito
perché l’universo stesse saldo nella sua gloria.
Vanto del cielo è il limpido firmamento,
spettacolo celeste in una visione di gloria.
Il sole quando appare nel suo sorgere, proclama:
che meraviglia è l’opera dell’Altissimo!
Anche la luna, puntuale nelle sue fasi
regola i mesi e indica il tempo.
Viene dalla luna l’indicazione di ogni festa
fonte di luce che decresce fino a scomparire.
67
Bellezza del cielo è la gloria degli astri,
ornamento che brilla nelle altezze del Signore,
osserva l’arcobaleno e chi l’ha fatto,
quanto è bello nel suo splendore!
Col suo comando fa cadere la neve,
sparge la neve come uccelli che discendono,
l’occhio ammira la bellezza del suo candore,
e il cuore stupisce nel vederla fioccare».
(Sir 42, 15-43, 20).
La dimensione estetica traspare da questa lirica, senza mai sganciarsi
dalla dimensione teologica: essa diventa una sorta di via pulchritudinis
per approdare al Creatore e immergersi nella sua opera molto bella55.
4. Il cantic o della bellezza dell’amore
Oltre e più che la bellezza del creato, la Bibbia esalta la creatura
umana – l’uomo e la donna – come già diceva la formula
d’approvazione di Gen 1, 31, che introduce il superlativo: «e Dio vide
che era molto bella». Più volte loda la bellezza umana, la bellezza delle
“figlie degli uomini” (Gen 6, 2), di Rebecca moglie di Isacco («molto
bella d’aspetto»: Gen 24, 16; 26, 8), di Betsabea moglie di Uria e
amante di Davide (2Sam 11, 2), di Tamar sorella di Assalonne (2Sam
13, 1), di Abisàg (la ragazza «straordinariamente bella» che serviva
Davide nella vecchiaia, cfr. 1Re 1, 4), delle eroine Giuditta («bella e
molto avvenente»: Giud 8, 7) ed Ester (Est 2, 7), così anche per la
bellezza di uomini quali il re Davide (1Sam 16, 12), Assalonne
(2Sam 14, 25) e i giovani ebrei esuli a Babilonia (Dan 1, 4.15).
In questa linea va vista quella raccolta di canti d’amore intitolata con
espressione superlativa Cantico dei Cantici (“Shir hashshirim”): il più bel
cantico che celebra l’amore di un’amata e di un amato che si
raggiungono e si perdono, che si cercano e si trovano56. Un grazioso
Per un ripensamento complessivo della fede nel Creatore e della teologia
della creazione: M. KEHL, “E Dio vide che era cosa buona”: Una teologia della
creazione, Queriniana, Brescia 2009; cfr. N. FRYE, Il grande codice. La Bibbia e
la letteratura, Einaudi, Torino 1986; G. RAVASI, Per un’estetica biblica,
«Rassegna di Teologia» 30 (1989), pp. 36-51.
56 L’A.T. si serve soprattutto della radice ‘hb (‘ahăbâ) col significato di
‘amore’ (in riferimento sia alle persone sia alle cose e azioni), della radice
55
68
poema nel quale è posto l’accento sulla dimensione estetica del
paesaggio e soprattutto della dimensione estetica delle persone
innamorate, una sinfonia che celebra l’amore quale realtà più grande
e più bella sotto il cielo. E sopra il cielo!
La natura fa parte di questo intreccio amoroso: un giardino
(chiamato ‘paradiso’: 4, 13) ricco di molti alberi odorosi, una vigna
lussureggiante con viti in fiore, fiori che sbocciano nei campi dopo
l’inverno (gigli, anemoni, narcisi), un bosco folto di alberi da frutta
(meli e cedri, ginepri, melograni, fichi) e piante aromatiche. Luoghi
che sembrano fermarsi incantati a far da scenario alla vicenda: la
camera e il giardino, il pascolo e le vie della città, monti e colli, valli,
sorgenti e deserti.
Al centro della scena, come detto, due innamorati – lei e lui – che
intessono un dialogo intenso: i vari poemi sono costellati di simboli
fascinosi e si dispiegano in una serie libera di affreschi, ma con una
profonda unitarietà di sentimenti e d’affetti. Tutto appare in
movimento: la dialettica fra gli amanti si rinnova continuamente
senza mai trovare una soluzione definitiva: la dialettica tra ricerca e
incontro, tra assenza e presenza, tra lontananza e vicinanza. Nei
corpi dei due scorre una forza attrattiva, una spinta vitale, l’eros che
cerca e ricerca una pienezza che non possiede, ma che lascia
intravedere: la relazione con l’altro57. L’amore, nella sua duplice
dimensione erotica e agapica, è il cuore del Cantico dei Cantici58 è il
rhm che indica ‘amore di compassione’, ‘misericordia’ (Dio è detto rahûm:
misericordioso). L’idea di ‘amore’ ha nell’A.T. un carattere profano o
immanente e uno teologico e trascendente: «sono le espressioni amorose
del primo tipo (soprattutto i rapporti fra i sessi, genitori e figli…) quelle
che ci permettono di capire le più rare, ma ben importanti espressioni del
secondo tipo… così leggiamo nell’A.T. che l’uomo ama Dio e Dio ama
l’uomo»: G. Q UELL, γάπη, in GLNT I, 61-62. 74.
57 Nella stessa struttura poetica primeggia il movimento, l’alternanza tra
maschile e femminile, l’intervento del ‘coro’: cfr. J.-P. SONNET, Le cantique:
la fabrique poétique, in ACFEB (a cura di), Les Nouvelle voies de l’exégèse, Cerf,
Paris 2002, pp. 159ss. Inoltre, la differenza sessuale che marca ogni verso
del Cantico, è «la cifra, la più preziosa, dell’apertura all’altro e della loro
apertura all’alterità divina»: p. 103.
58 Vale la pena riascoltare qui le parole che BENEDETTO XVI ha scritto
nella sua prima enciclica: «In realtà eros e agape – amore ascendente e amore
discendente – non si lasciano mai separare completamente l’uno dall’altro.
Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità
69
vertice della bellezza: capace di permeare di sé tutta la realtà, più
forte di ogni ostacolo che tenta di contrastarlo, e della stessa
separazione dei due che incombe (si vedano le due scene notturne in
3, 1-5; 6, 1-3).
L’agape accoglie e trasfigura l’eros: la bellezza del corpo della ragazza
è presentata con alcune descrizioni di accesa passione e di sincera
purezza interiore:
«Quanto sei bella [jafah], amata mia, quanto sei bella!
Gli occhi tuoi sono come colombe,
le tue chiome sono come un gregge di capre,
i tuoi denti come gregge di pecore tosate,
come nastro di porpora le tue labbra,
la tua bocca è piena di fascino
come spicchio di melograno è la tua tempia,
il tuo collo è come la torre di Davide,
i tuoi seni come due cerbiatti, gemelli di una gazzella,
tutta bella sei tu amata mia…
Come sono belli i tuoi piedi nei sandali,
la curve dei tuoi fianchi sono come monili,
il tuo ombelico è una coppa rotonda,
il tuo ventre è un covone di grano circondato di gigli.
Quanto sei bella e quanto sei graziosa,
o amore pieno di delizie!» (4,1-7; 7,2-7).
Così l’amata canta e desidera il corpo del suo amico e fratello,
amante e sposo:
«L’amato mio è bianco e vermiglio,
nell’unica realtà dell’amore, tanto più si realizza la vera natura dell’amore.
Anche se l’eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente –
fascinazione per la grande promessa di felicità – nell’avvicinarsi poi all’altro
si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità
dell’altro, si preoccuperà sempre più di lui, si donerà e desidererà ‘esserci’
per l’altro. Così il momento dell’agape si inserisce in esso; altrimenti l’eros
decade e perde anche la sua stessa natura. D’altra parte, l’uomo non può
neanche vivere esclusivamente nell’amore oblativo, discendente. Non può
solo donare, deve anche ricevere. Chi vuole donare amore, deve egli stesso
riceverlo in dono»: Deus caritas est (25 dicembre 2005), LEV, Città del
Vaticano 2006, n. 7, 20-21.
70
riconoscibile fra una miriade.
Il suo capo è oro, oro puro,
i suoi riccioli sono grappoli di palma,
i suoi occhi come colombe su ruscelli d’acqua,
i suoi denti si bagnano nel latte,
le sue guance sono aiuole di balsamo,
le sua labbra sono gigli che distillano fluida mirra.
Le tue mani sono anelli d’oro,
il tuo ventre è tutto d’avorio tempestato di zaffiri.
Le sue gambe colonne d’alabastro,
il suo aspetto è quello del Libano.
Dolcezza è il suo palato: egli è tutto delizie!
Questo è l’amato mio, questo l’amico mio»
(5,10-16).
Il Cantico non inizia con una lode astratta dell’amore59, ma con la
richiesta della ragazza amata: «Mi baci con i baci della tua bocca» (1, 2):
esprime il vivo desiderio di essere baciata dal suo innamorato,
attenzioni particolari di tenerezza, anzi, qualcosa di più dei baci. Il
bacio è espressione del desiderio dell’amplesso e di uno scambio
reale dell’interiorità fra i due amanti. Non soltanto un contatto
fisico, è «un congiungimento affettivo e fisico fra i corpi, segno e
incentivo della comunione interiore»60. Con il bacio, specialmente il
bacio sulla bocca, una soglia è superata; sul registro dell’oralità nel
cammino tra la parola e il dono reciproco, il bacio si dà come «inizio
dell’amplesso». Così, nella meraviglia dell’eros, vissuta nel contesto
dell’agape, ciò che è più carnale esprime ciò che è più spirituale, «le
leggi dell’eros raggiungono quelle della vita interiore: nell’uno e
nell’altro caso, è possibile dire, secondo una parola attribuita a san
P. RICOEUR ravvisa tre aspetti del discorso d’amore: il legame tra amore
e lode, il diffuso impiego della forma imperativa, la potenza di metaforizzazione,
tutti aspetti che si ritrovano nella poetica d’amore del Cantico: Amore e
giustizia, Morcelliana, Brescia 2000, pp. 9-21.
60 B ERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermoni sul Cantico dei cantici, Vivere in,
Roma 2007, II, p. 80; cfr. V. BONATO, Il Cantico dei Cantici. Significato
letterale, teologico e mistico, EDB, Bologna 2009, pp. 7-10.
59
71
Francesco: “è donando che si riceve»61. Il culmine è espresso
nell’epilogo:
«Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore» (8,6).
L’immagine del sigillo, segno di legame e di appartenenza, esprime il
desiderio della donna (di entrambi) che la morte non abbia l’ultima
parola, l’intuizione che l’amore sia l’unica forza in grado di vincere la
morte. Così anche il Cantico ripropone la battaglia fra eros e thanatos,
presente nella poesia di tutti i tempi. La celebrazione dell’amore non
ha qui alcunché di ingenuo, nel poema traspare la bontà e la bellezza
della sessualità umana, ma, con sano realismo, non nasconde motivi
di paura: la sessualità umana è, insieme, fascinosa e tremenda, per
questo è una finestra aperta sul mistero trinitario di Dio che la
Bibbia presenta come “nuzialità eterna”, è l’unione e l’intimità (non
la fusione o la confusione) di due alterità fatti l’uno per l’altra, fino a
formare “una sola carne”. Nella prospettiva biblica, i colpi che gli
amanti infliggono alla morte sono i colpi del Dio d’Israele, di Gesù
Cristo che ha immesso nel corpo degli umani qualcosa del suo
infinito Amore («Theos agape estin»), la fede che salva, l’amore che
dona eternità62.
Questa intensa e ammirata «contemplazione estetica ed estatica della
corporeità – che nel simbolismo biblico è espressione non soltanto
61
X. LACROIX , Connaître au sens biblique. “Toi en moi, et moi en toi”, «Christus»
n. 213, gennaio 2007, p. 9. Altrimenti detto: il desiderio si inscrive e si apre al
suo compimento nella forma del dono, «anticipa simbolicamente l’attuarsi di
una relazione come grazia»: P. SEQUERI , Non ultima è la morte. La libertà di
credere nel Risorto, Glossa, Milano 2006, pp. 5-7; cfr. ID., L’enigma del desiderio,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1999; C. CIANCIO (a cura di), Metafisica
del desiderio, Vita e Pensiero, Milano 2003.
62 Si legge nell’Epopea di Gilgamesh: «Il bel giovane e la bella ragazza,
quando fanno l’amore, affrontano la morte»: R. J. T OURNAI, A. SHAFFER,
L’Epopée de Gilgamesh, Cerf, Paris 1994, p. 217. Se l’amplesso è una petit mort,
poiché gli amanti, che per un attimo vengono meno, sembrano oltrepassare
le soglie della morte, scoprendosi miracolosamente ancora in vita, per
l’uomo/donna di fede si tratta di entrare nella casa di Dio, dove dimora
eternamente amore e giustizia; cfr. D. VERDE, Leggere il Cantico dei Cantici
nella postmodernità, «Rassegna di Teologia» 52 (2011), pp. 573-596.
72
della fisicità, ma dell’intera personalità – ha una finalità ulteriore,
quella appunto di celebrare l’esperienza suprema dell’amore»63. Così
il Cantico libera l’amore dell’uomo e della donna sia dalle costrizioni
del puritanesimo, sia dalla licenza dell’erotismo, e questo è appunto
il senso letterale dello scritto, che giustifica la sua collocazione tra i
libri sapienziali, tra il libro del dolore (Giobbe) e il libro del disincanto
(Qoelet): come questi, esso si preoccupa della condizione umana
prendendo in considerazione l’esperienza più bella e più completa,
quella che confina e sconfina nell’esperienza religiosa.
Per questo l’interpretazione allegorica (non in contrasto, ma insieme
a quella letterale) è divenuta comune sia presso gli Ebrei sia presso i
Padri della Chiesa: la relazione d’amore con Dio è così radicalmente
segnata, in entrambi i Testamenti, dal transito attraverso le figure
della relazione dell’uomo e della donna, che non si potrebbe fare a
meno di questa figura simbolica senza deformarne la testimonianza.
Di questo canta il poema dei poemi dell’amore, per questo il Cantico
«può presentarsi, sine glossa, come parola di Dio», e l’interpretazione
teologale di questa relazione amorosa è considerata «uno dei luoghi
più istruttivi della rivelazione circa l’attitudine dell’ordine degli affetti
a istruire sulla relazione stessa con Dio»64. In particolare la
letteratura profetica ha sviluppato il tema dell’alleanza con questa
63
G. RAVASI, Bellezza, cit., 130-131. Ciò che distingue il Cantico dai testi
classici antichi è la natura umana dell’amore cantato, per descriverlo non si
ricorre al mito, semmai viene presentato come paradigma per la
comprensione di ogni altro evento simile; cfr. C. YANNARAS, Variazioni sul
Cantico dei Cantici, Cens-Interlogos, Cernusco 1992.
64 P. SEQUERI , Non ultima è la morte, cit., p. 28. «La parola di Dio istruisce
sulla qualità del simbolo nuziale appropriandosene con un’intensità che non è
riservata a nessun’altra figura di relazione. E con ciò la poesia di eros è
riscattata dalla sua instancabile ri-caduta nell’orizzonte di una concupiscenza
priva di agape. Ma al tempo stesso, risplende pura l’attitudine impensabile di
eros a rappresentare il grembo che istruisce e nutre ogni risonanza affettiva
(cioè umanamente effettiva) dell’amore di Dio. I commentatori patristici e
medievali (monastici!) del Cantico, a loro volta eredi di un’ammirata
tradizione antica, hanno istruito l’Occidente cristiano da entrambi i lati»: ivi.
Cfr. C. SPICQ, Agapè dans le Nouveau Testament, Gabalda, Paris 1959; B.
STANDAERT , L’arte di amare, Qiqajon, Bose 1988; B. WELTE, Dialettica
dell’amore, Morcelliana, Brescia 1986; M. SCHOEPFLIN , Via amoris. Immagini
dell’amore nella filosofia occidentale, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1998; J.
PIEPER, Sull’amore, Morcelliana, Brescia 20122.
73
allegoria nuziale: da Osea (1, 1-3, 5) a Ezechiele (16, 1-63), da Isaia
(«Tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra Sposata, perché il Signore
si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo»: 62, 4-5) all’ultimo
Testamento: da Paolo (Ef 5, 29-32) all’Apocalisse (21, 9-22, 17).
Così teologi e mistici cristiani scorgono qui un rinvio alle relazioni di
Gesù Cristo con la sua Chiesa, o, al singolare, con ciascun credente.
L’amore umano rimanda di sua natura all’amore supremo di Dio per
le sue creature, per questo Origene (un teologo del III sec.) scrive:
«Beato colui che comprende e canta i Cantici della Scrittura; ma ben
più beato chi comprende e canta il Cantico dei Cantici»65.
5. La glor ia di Dio, splendore di bellezza
Quanto abbiamo visto poc’anzi ha consentito a Israele prima e al
Cristianesimo poi di aprirsi a un’estetica della rivelazione capace d
integrare teologicamente l’ordine della fede e l’ordine dell’amore.
Nella sua storia, come custode della promessa del Regno
escatologico e della legge datagli a tutela della sua libera relazione
con Dio, Israele fa esperienza della bellezza. Ispirandosi alla
rivelazione dell’unico vero Dio, Israele vive secondo l’ordine della
fede e l’ordine dell’amore, riconosce l’Assoluto e la sua
presenza/manifestazione, concepisce il culto come lo spazio sacro
in cui percepisce l’integrità di sé e del mondo66, prende coscienza di
65
ORIGENE, Commento al Cantico dei cantici, Città Nuova, Roma 1976. Il
Cantico è all’origine dell’erotica mistica ebraica e cristiana, ma nessun
allegorismo riesce a cancellare la lettera. Il cantico della bellezza dell’amore
ha ispirato musica, pittura, poesia: per cantare l’amore la musica e la pittura
si sposano con la parola poetica, così la musica per comunicare deve
ricorrere alla parola (anche soltanto per il titolo), «l’amore, pur ineffabile,
ha bisogno della parola, ricorre a una molteplicità di discorsi, anche quello
filosofico. (…). Presentando il ciclo pittorico Cantico dei Cantici I-V, Marc
Chagal dichiarava: “Nell’arte, come nella vita tutto è possibile, se alla base,
c’è l’Amore”»: O. AIME, Il circolo e la dissonanza, Effatà, Cantalupa (To)
2010, p. 373. Si può vedere: V. MELCHIORRE, Metafisica dell’eros, Vita e
Pensiero, Milano 1977; C. S. LEWIS, I quattro amori. Affetto, Amicizia, Eros,
Carità, Jaca Book, Milano 1980; A. FABRIS, I paradossi dell’amore fra grecità,
ebraismo e cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2000; J.-L. MARION, Le phénoméne
érotique, Grasset, Paris 2003.
66 Israele esce dall’Egitto innanzitutto per poter «servire Dio nel deserto»
(Es 7, 16; 9, 1; 10, 3), tale culto è la giusta modalità del rapporto con Dio,
74
sé e del mondo in quanto creati, così la creazione nella sua integrità
e armonia, nella sua totalità è percepita come bellezza.
Le opere del Creatore partecipano alla kābôd (gloria, splendore di
bellezza, δόξα nel greco biblico)67 divina («I cieli narrano la gloria di
Dio»: Ps 8, 2), specialmente gli umani quali vertici della creazione
(«Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore l’hai coronato»:
Sal 8, 6), così la vita personale e sociale si percepiscono come
cariche della presenza di Dio, una presenza che viene dalla libera
scelta di Dio che, attraverso la sua azione creatrice, la sua alleanza
rende il mondo pieno della sua gloria. Una simile impostazione,
basata appunto sull’amicizia e sull’alleanza con Dio, dispiega il
dramma della storia, dal momento che il tutto si fonda e si realizza
sulla base della fedeltà a una relazione. «La bellezza del mondo
biblico acquista così più il carattere della storia, perché basata sulla
relazione tra Dio e l’uomo»68.
La kābôd mostra che Dio è trascendente e nascosto e, nel contempo,
si rivela ed è presente, sono accentuati sia il carattere di luce
(splendore, bellezza) sia di potenza (santità, salvezza). I luoghi in cui
appare, oltre all’evento straordinario del Sinai (Es 24, 17), sono la
costitutiva per la giusta esistenza umana nel mondo, una sorta di «terra
interiore, senza la quale quella esteriore rimarrebbe inabitabile… abbraccia
l’ordinamento dell’intera vita umana, l’uomo diventa glorificazione di Dio, lo
mette per così dire in luce (e questo è culto), se vive del guardare verso
Lui»: J. RATZINGER, Opera Omnia. Teologia della Liturgia, vol. XI, LEV, Città
del Vaticano 2010, pp. 33-34.
67 Il termine δόξα, che nel greco classico significa opinione, parere, nel greco
biblico acquista tutta l’ampiezza di significato che l’ebraico kābôd ha
nell’A.T.: «indica la gravitas di stima e onore che un uomo possiede
(specialmente il re), ma anche ogni uomo in considerazione della sua
posizione nell’ambito della relazione; soprattutto è riferito a Dio come
espressione del suo manifestarsi nel suo dominio sovrano sulla natura e
sulla storia, sia nel suo aspetto sfolgorante di potenza e di bellezza che assume
nelle teofanie, sia e ancor di più nella maestà – visibile all’occhio della fede –
della sua azione storica di salvezza e di giudizio»: H. HEGERMANN, δόξα, in
H. BALZ, G. SCHNEIDER (a cura di.), Dizionario esegetico del Nuovo Testamento,
cit., pp. 915-916. Così il termine, che connotava l’idea di pensare (opinare)
e di supporre, atti del tutto soggettivi, con tutte le oscillazioni del pensare e
del supporre, passa a esprimere l’oggettività assoluta, la maestà e la bellezza
di Dio.
68 G. RAVASI, Bellezza e mondo biblico, in ID.-M. I. RUPNIK, Il fascino del bello,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2010, p. 19.
75
tenda del convegno (Es 40, 34-38), il tempio (in quanto dimora
divina: 1Re 8, 10), Gerusalemme («la gloria del Signore brilla sopra di te»:
Is 60,1); anche il mondo intero, in quanto segno della rivelazione di
Dio e partecipazione alla santità di Dio: «Santo, santo, santo il Signore,
tutta la terra è piena della sua gloria» (Is 6, 3; cfr. Sal 57, 6; 72, 19).
Scopo della gloria è l’opera salvifica di Dio, opera che appare
luminosa e benefica: sia i libri profetici sia quelli sapienziali
riconoscono ed esaltano la manifestazione gloriosa del Signore.
Ezechiele, un autentico cantore della gloria di Dio, la contempla in
esilio attraverso la visione del “carro del Signore”, segno che Dio
non è legato al tempio di Gerusalemme, ma segue i suoi fedeli anche
in esilio: attraverso un trono tempestato di pietre preziose e di
splendidi gioielli, «percepii in visione la gloria del Signore, quando la vidi,
caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava»(1,28)69.
Il Nuovo Testamento si ricollega all’Antico, anche qui la gloria è il
segno peculiare della rivelazione del mistero trascendente di Dio. Ma
l’ultimo Testamento va oltre: qui Gesù Cristo diventa il portatore
della gloria, la gloria stessa di Dio che «viene nel mondo e illumina ogni
uomo» (Gv 1, 9). Tutta la vita di Gesù, secondo il quarto Vangelo, è
una epifania della gloria, la gloria traluce in segni e miracoli, nel segno
di Cana manifesta la sua gloria (2, 11) e in quanto è il primo del suo
genere, è da considerare quasi come un programma. La gloria che si
manifesta al momento della sua nascita (così ai pastori di Betlemme
«la gloria del Signore li avvolse di luce»: Lc 2, 9) come segno della sua
origine divina, è la stessa di cui parla Gesù stesso nella sua ora:
«Padre, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te… glorificami davanti a
te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (17, 1.5).
In tal modo Giovanni descrive la vita, la morte e la risurrezione di
Gesù alla luce della gloria finale, che si ricongiunge a quella che
69
Gli ebrei temevano di vedere il volto di YHWH, così solitamente Dio
mostra la sua ‘gloria’, ossia i segni esterni che circondano e rivelano la sua
‘persona’; la gloria è dunque il segno della sua presenza, di una presenza
luminosa e salvatrice, potente e santificante. In Es 33, 18ss. si parla del
desiderio di Mosè di vedere la kābôd di Jahvé: «finché Mosè sta in una
fenditura della roccia e Jahvé tiene la sua mano su di lui, Jahvè vuol passare
davanti a lui in tutta la sua bellezza (così sembra da intendere kol-tōbi);
quando è passato e Jahvé ha tolto la sua mano da lui, Mosè può vederlo di
spalle»: G. V ON RAD, ‘kāb d’ nell’Antico Testamento, in GLNT, II, coll.
1363-1364.
76
aveva prima che il mondo fosse. «Nell’ascensione Cristo ritorna
nella gloria anteriore al mondo: “Egli si manifestò nella carne… fu
assunto nella gloria”(1Tim 3, 16»70.
La gloria di Dio nel creato e nella storia è una presenza discreta e
luminosa insieme, una presenza ‘personale’, stabilita nella promessa
prima e nel compimento poi, cioè in Gesù Cristo, nel quale inabita
la gloria. La sua opera è l’amore di Dio come unica realtà che può
rendersi presente anche nel frammento, nella tragedia e nella morte,
cioè nell’antitesti della bellezza, nel brutto della storia. Così la
splendida gloria di Dio, che possiamo conoscere come suprema
bellezza, è Gesù stesso, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Ps 45, 3) e «il
più sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto» (Is 52, 14). Questo
strabiliante paradosso, questo ossimoro bello/brutto è accessibile con
la luce della grazia, con gli occhi della fede. Proprio nel morire Gesù,
che ha amato fino alla fine, viene innalzato alla potenza salvifica che
reca salvezza al mondo perduto, nel morire avviene la glorificazione
sua e del Padre (Gv 13, 31)71. Qui si mostra quella δόξα del Logos di
Dio divenuto uomo: è piena di «grazia e verità» (1, 14): la rivelazione
della gloria di Gesù si compie nel suo sacrificarsi per amore fino alla
morte, così Gesù ha dato e dà ai suoi grazia e verità, bellezza e
l’amore più grande72.
Tutta la Scrittura, come visto, esprime il senso della bellezza del
creato, lo celebra e lo canta, ma soprattutto ha elaborato il καλόν
negli eventi della storia, come vita di relazione di Dio con gli uomini
e degli uomini con Dio, avendo saputo assumere in esso anche il
brutto, il tragico. Il bello e il bene si realizzano come superamento
del male e del brutto, come distruzione del peccato e la pienezza
della gloria si manifesta nel gesto supremo dell’amore, su quello
stesso volto sfigurato: «guarderanno a colui che hanno trafitto» (Zac 12,
10; Gv 19, 37) e chi saprà guardare con fede e amore vedrà tutta la
70
E. PAX, Gloria, in H. FRIES (a cura di), Dizionario teologico, Queriniana,
Brescia 1967, II, p. 21.
71 H. HEGERMANN, δόξα, cit., pp. 922-923.
72 Pur avendo avuto già delle manifestazioni o anticipazioni nella vita
terrena, «la δόξα di Gesù nasce dalla sua morte, allo stesso tempo l’opera
che Gesù compie nella sua passione è un evento per cui “Dio è stato
glorificato in lui” (Gv 13, 31); il riconoscimento della gloria divina implica la
certezza di una corrispondente partecipazione a quella medesima gloria:
“Dio, da parte sua, lo glorificherà”»: G. KITTEL, δόξα, in GLNT, II, col. 1389.
77
bellezza dell’amore sconfinato di Dio. Nell’evento cristologico è
chiaro dunque che amore e bellezza, grazia e verità non sono
separabili: essi non si trovano in una cosa da osservare, ma in un
evento che è un dono, un dono a cui rispondere, intrecciando
relazioni che hanno il sapore dell’eternità.
La bellezza della vita eterna è già fruibile e avrà pienezza di luce e di
gioia nell’escatologia: già ora viviamo e partecipiamo alla gloria del
Cristo risorto, venendo trasformati a sua immagine: «Il Signore
Gesù trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo
corpo glorioso» (Fil 3, 21), così quando «Cristo in voi, speranza della
gloria… e vostra vita, sarà manifestato, anche voi apparirete con lui
nella gloria» (Col 1, 27; 3, 4; cfr. Rom 8, 17)73.
Se dunque Dio ci chiama, in Cristo, «alla gloria eterna» (1Pt 5, 10),
allora essa diventa oggetto di speranza, una speranza che non delude
e la cui certezza è anche un motivo per cui gloriarci («saldi nella
speranza della gloria di Dio»: Rom 5, 2-3). E se già abbiamo conosciuto
«la gloria di Dio risplendere sul volto di Cristo» (2Cor 4, 6), se grazie al
dono dello Spirito Santo («Spirito della gloria», caparra della gloria
futura: 1Cor 1, 22; Ef 1, 14; Rom 8, 23) camminiamo «di gloria in
gloria», allora giungeremo all’éschaton, dove – come rivela l’ultimo
libro della Scrittura – questa gloria si manifesterà come splendore e
compiutezza dell’amore, in cui anche i segni dei dolori saranno
superati: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro… e
asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non vi sarà più la morte, perché le cose di
prima sono passate… la città non ha bisogno della luce del sole, né della luce
della luna, la gloria di Dio la illumina» (Ap 21, 3-4. 23).
6. La Scr ittur a, grande codice estetico
I paragrafi precedenti hanno mostrato la qualità estetica del testo e
del messaggio della Scrittura. Ora vogliamo richiamare il fatto che la
Bibbia ha esercitato un grande influsso nel campo artistico e
letterario, fino a divenire una sorta di grande codice della cultura
occidentale e mondiale, un “immenso vocabolario” (P. Caudel) un
ampio “atlante iconografico” (M. Chagal)74.
73
Cfr. F. HADJADJ, Il paradiso alla porta. Saggio su una gioia scomoda, Lindau,
Torino 2013.
74 Scrive il famoso pittore Marc Chagal, un narratore su tela: «Fin da
ragazzo sono stato rapito dalla Bibbia. Mi è sempre parsa e mi sembra
78
In effetti, insieme all’esegesi che sempre ha accompagnato il testo
biblico (data la natura ispirata dei testi canonici, contenente «la parola
Dio in parole umane»)75 con metodi e accostamenti variegati
(dall’esegesi crtico-storica all’esegesi teologica e all’esegesi spirituale),
troviamo, lungo le varie epoche storiche, una interpretazione della
Scrittura attraverso l’arte, attraverso numerosi modelli artistici, nelle
varie espressioni delle arti76. Da questo punto di vista la Bibbia è
stata ed è un immenso codice estetico che ha ispirato musicisti e pittori,
poeti e scrittori, artisti di ogni genere, di ogni tempo e di ogni luogo.
La musica
Innanzitutto la musica: musica e esperienza religiosa, musica e fede
cristiana appaiono integrate in un’esperienza, che non spinge verso il
polo dell’oggettivazione, ma del vissuto, aperto alle attese, alle
realizzazioni, alle speranze – alla sfera soggettiva, in una parola – di
chi partecipa alla vita di fede, ove sono integrati sentimenti e
pensieri, credenze e convinzioni, visioni del mondo che investono
quella che si può chiamare la realtà, in un atto che è di un soggetto
che istituisce un orizzonte entro il quale sente di essere già
originariamente collocato.
Se le arti si prestano come lo strumento più efficace per far brillare
l’ideale di cui l’uomo si ispira e tende, «quale arte si presta, nel dargli
figura, meglio della musica, la quale lavorando sul suono – la più
ancora la più grande fonte di poesia di ogni tempo. Da allora, ho cercato
questo riflesso nella vita e nell’arte» cit. in D. ZAPPPALÀ, Chagal. Dalla guerra
alla pace, «Avvenire» del 31 marzo 2013, Agorà, p. 1.
75 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione
Dei Verbum, (18 novembre 1965), n. 13; cfr. U. CASALE, Il concilio Vaticano
II. Evento, attualità, documenti, Lindau, Torino 2012..
76 «Le grandi narrazioni bibliche, i temi, le immagini, le parabole hanno
ispirato innumerevoli capolavori in ogni settore delle arti, come pure hanno
parlato al cuore di ogni generazione di credenti mediante le opere
dell’artigianato e dell’arte locale, non meno eloquenti e coinvolgenti»:
BENEDETTO XVI, Incontro con gli Artisti (Cappella Sistina, 21 novembre
2009), in Insegnamenti di Benedetto XVI 5/2, LEV, Città del Vaticano 2009;
cfr. T. VERDON (ed.), L’arte e la Bibbia. Immagine come esegesi biblica, Giuntina,
Firenze 1992; C. DE CAPOA, S. ZUFFI (a cura di), La Bibbia nell’arte, Electa
Mondadori, Milano 2013.
79
malleabile delle materie! – non incontra pressoché limiti alcuno?»77.
Non a caso il rapporto tra musicale e teologico richiama il mistero: la
radice my – sorgente etimologica onomatopeica del greco μυστέριον
– richiama il gesto delle labbra chiuse con l’indice sulla bocca
emettendo un suono inarticolato, per alludere a qualcosa di
inaccessibile al pensiero discorsivo, alla conoscenza razionale, anche
se la richiede, e per aprire una possibilità nuova di un suono, di una
parola (perché l’uomo è strutturalmente linguaggio). Così la musica è
«scienza dell’anima più che arte dei suoni» perché la simbolica dell’ascolto
(principio di conoscenza e condizione del riconoscimento di sé
come dell’altro) è la forma originaria dell’esperienza dell’anima, e
non vi è «via migliore per l’affinamento di un esercizio profondo e
personalizzante dell’ascolto di quella che si inoltra lungo il doppio
filare dell’esperienza musicale e della meditazione religiosa»78.
Inoltre il meditato approfondimento del simbolico – e di ogni
esperienza estetica – consente «di articolare la specifica rilevanza dei
molti modi in cui il teologico e il musicale possono venire a
rapporto». Ecco allora il mistero della musica e il suono del Mistero: una
lettura del “Mistero cristiano” («del mistero di Dio, cioè Cristo»: Col
2, 2) in quella che si chiama l’arte dei suoni – e dei silenzi che
confersicono loro respiro – attraverso armoniche proporzioni.
Traducono armonicamente quel che Dio ha disposto per gli uomini
«in vista della grande ‘sinfonia’ della salvezza» 79, nei suoni e nei
silenzi si può infine esprimere e dire qualcosa di indicibile e di
ineffabile: il cuore della musica evoca e invoca l’ineffabile mysterium.
Nella Bibbia la Parola del Creatore è teofonica, ovvero, in un senso
analogico, è suono dotato di significato per l’uomo, dunque «una
componente di ampia ri-sonanza in Dio, nella parola – dabar – che
fa essere la cosa»80. Sempre nella vicenda biblica la musica è
G. BOF, Il senso religioso della musica, «Hermeneutica» Nuova Serie 2003, p.
176.
78
P. SEQUERI, L’estro di Dio, Glossa, Milano 2000, p. 226; cfr. ID., La musa
che è la Grazia. Il musicale e il teologico nei ‘prolegomeni’ all’estetica di H. U. von
Balthasar, «Teologia» 15 (1990), pp. 104-129; G. GUANTI, Estetica musicale.
La storia e le fonti, La Nuova Italia, Firenze 1999.
79 Così scriveva un antico Padre della Chiesa (II sec.), IRENEO DI LIONE,
Adversus haereses, IV, 14, 2-3 (S.C. 100, 542ss.)
80 G. SANTUCCI , Theophonia. Mistero della musica e suono del Mistero,
«Hermeneutica» Nuova Serie 2003, pp. 189-190. In quanto opera umana,
77
80
prodotto del poiein dell’uomo, finalizzata alla lode del Creatore, di
Dio Salvatore: «Cantate a Dio con arte» (Sal 47, 8). La valenza teologica
della musica si riconosce nella connessione con la Rivelazione: «una
delle forme della rivelazione naturale di Dio» 81, nel senso duplice di
specchio della bellezza e dell’armonia della creazione e del simbolo
di fede di ogni creatura. Dio ha creato il mondo come tôb, come
bellezza diafana e diafonica, e se il peccato, che ha rotto armonia e
relazioni, ha prodotto dissonanza, «questa è stata ricomposta sul
pentagramma della Croce di Cristo»82, che oggi risuona conducendo
la storia al concerto escatologico83.
Al fondo di questa riflessione sta la questione di come la musica
possa farsi espressione di Dio, o porsi come mediazione di
trascendenza verso il Mistero divino. Già Agostino intese la musica
come l’espressione più alta dell’ordine dei rapporti numerici che
reggono l’universo, eco purissima dei “numeri del cielo”, come
strumento privilegiato per incontrare il divino, muovendo dalle
tracce sensibili conduce alle dimore più elevate, dando accesso a
un’esperienza profonda di bellezza e di gioia. Inoltre, il vescovo
d’Ippona intuisce una sorta di analogia fra la musica e
l’esperienza/dottrina dello Spirito Santo: la musica, in quanto arte
del ben modulare, si presta singolarmente a evocare l’azione dello
Spirito in quanto vinculum caritatis aeternae, ossia la circolarità
dell’amore intra-trinitario (circumissesio), a evocare il dinamismo
non sfugge all’ambiguità, al rischio – sempre denunciato dalla Scrittura –
dell’idolatria, tuttavia «nessuna condanna intende colpire la musica, unica
fra le arti che richiede la priorità assoluta del canale uditivo»: p. 190. Il
canale privilegiato della Scrittura («Ascolta Israele!», «Chi ha orecchi, ascolti»),
anche se non manca quello del ‘vedere’ (privilegiato nella filosofia greca).
81 P. SEQUERI, Mozart e i teologi, in ID.-A. TORNO, Divertimenti per Dio. Mozart
e i teologi, Piemme, Casale Monferrato (Al) 1991, p. 147; ID., L’estetico per il
sacro. ‘Affectus fidei’ e ‘ars musica’: la questione teologica, «La Scuola Cattolica» 123
(1995), pp. 621-663.
82 G. SANTUCCI, Theophonia. Mistero della musica e suono del Mistero, cit., p. 196.
Si pensi alla musica ispirata alla passione del Signore, un titolo per tutti: J.
S. Bach, Passione secondo Matteo.
83 Vengono alla mente i versi di T. ELIOT: «Nell’immobilità del violino,
mentre la nota perdura, / non quella soltanto, ma la consistenza, / oppure
diciamo che la fine precede il principio, / e la fine e il principio erano
sempre là, / prima del principio e dopo la fine. / E tutto è sempre ora»:
Quattro Quartetti (tr it. R. Sanesi), Book, Castel Maggiore 2002, p. 33.
81
insondabile delle relazioni di comunione del Padre e del Figlio
nell’unita dello Spirito Santo84.
«Ogni arte lo è in quanto analogon: certe qualità del divino che
afferriamo col pensiero, le possiamo analogicamente rendere
sensibili alla materia. La verità, che è pensiero, diventa, nella
dimensione materiale, bellezza». Ogni arte ha la sua specificità, la
musica è legata al paradosso. In quanto intessuta con i fili del tempo
e con la grammatica dei numeri, è in grado di tracciare la dinamica
(exusia/kenosi) dell’Eterno, per questo il teologo H. von Balthasar
coglie «una sorta di intatto arcobaleno che viene dalla memoria del
paradiso terrestre», qualcosa in cui sorge «un immenso
presentimento d’amore, di luce, di splendore, di eterna verità e
armonia»85. Qui il teologo svizzero pensa soprattutto alla musica di
W. A. Mozart: un percorso musicale che disegna come l’immagine
dell’itinerario umano dall’eterno al tempo, dal tempo all’eterno.
Come un’armonia sonora e silente avvolgeva la creazione in statu
nascenti, così la voce che risuona nel compimento escatologico è
«quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe.
Cantano un cantico nuovo» (Ap 14, 2-3)86.
Dunque anche per la musica la Bibbia è un grande codice estetico:
in essa si mostra il legame indisgiungibile tra spirituale e sensibile, e
«il rapporto della musica con l’elemento emozionale, affettivo,
simbolico e persino ludico della “verità del mondo” non può essere
espulso dalla coscienza religiosa della “verità di Dio”. Perché la sfera
Cf AGOSTINO, De musica, Rusconi, Milano 1997. Una concezione simile
dell’analogia fra la concezione dello Spirito e l’estetica musicale si trova in
G. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della religione, I-II voll., Zanichelli, Bologna
1973-1974.
85 H. U. VON BALTHASAR, Lo sviluppo dell’idea musicale. Testimonianza per
Mozart, Glossa, Milano 1995, pp. 37. 63; ID., Parola e silenzio, in Verbum caro.
Saggi teologici, Morcelliana, Brescia 1985; cfr. H. KÜNG, Mozart. Tracce della
Trascendenza, Queriniana, Brescia 1992.
86 Nel trattato di escatologia sono sviluppate tre dimensioni: l’escatoestetica, l’escato-prassi, l’escato-logica: J. WOHLMUTH, Mistero della
trasformazione. Tentativo di una escatologia tridimensionale, Queriniana, Brescia
2013. Anche per diletto, si può ricordare la battuta del teologo K. BARTH
sulla musica paradisiaca: «Non sono sicuro che gli angeli, quando
glorificano Dio, suonino musica di Bach; sono certo, in compenso, che
quando stanno tra loro suonano Mozart, e che Dio ama allora, in modo
particolar, ascoltarli»: W. A. Mozart, Labor et Fides, Ginevra 1969, p. 12.
84
82
delle evidenze emozionanti e degli ascolti incantati appartiene di
diritto alla costituzione della coscienza credente»87.
«La musica dà a pensare» - scrive Ricoeur: la nostra esistenza è
anzitutto ‘affettiva’ (prima che riflessiva) e l’infinito delle nostre
emozioni è ricco di sfumature (nuances) spesso a noi sconosciute,
non ancora esplorate, regioni del nostro essere che possiamo
‘scoprire’ soltanto con la musica88. La musica dice il mondo non
rappresentandolo, ma iconizzando il rapporto emozionale, offre uno
svelamento che solo lei può fare, un’ aletheia del tutto particolare. Il
linguaggio musicale dunque, oltre essere universale ha una sua verità,
un linguaggio il cui ascolto «vibra dentro di noi e ci trasporta. Dove?
Dentro noi stessi? Fuori di noi stessi? Forse né dentro né fuori. In
una ‘regione’ che è paradossalmente dischiusa soltanto all’ascolto»89.
La musica – ha scritto Benedetto XVI, papa emerito amante della
musica, Mozart uber alles – è «un linguaggio davvero universale della
bellezza, capace di unire tra loro gli uomini di buona volontà su tutta
la terra e di portarli ad alzare gli occhi verso l’Altro e ad aprirsi al
bene e la bello assoluti, che hanno la loro ultima sorgente in Dio
stesso»90.
La pittura
Un percorso analogo è quello della pittura, dove grandi artisti hanno
ri-tratto la storia biblica con grande maestria e bellezza: tanto la
tradizione iconografica dell’Oriente quanto le tele dei grandi artisti
dell’Occidente appaino percorsi della via pulchritudinis. Tanto da
parlare – per lunghi secoli – della pittura ispirata alla Scrittura di una
“bibia pauperum”: per molti e per molto tempo, i vari cicli pittorici
(Giotto …) erano la via principale per giungere a una qualche
P. SEQUERI, Anti-prometeo. Il musicale nell’estetica teologica di H. U. von
Balthasar, Glossa, Milano 1995, p. 112; cfr. ID., Il teologico e il musicale,
«Teologia» 10 (1985/4), pp. 307-338; J. RATZINGER, La festa della fede, Jaca
Book, Milano 1984, (sul fondamento teologico della musica sacra pp. 85115.
88 J.-M. BROHM, Arts, langage et herméneutique. Entretien avec Paul Ricoeut,
Philagora, Paris 1996.
89 A. CAPUTO, “La musica dà a pensare”. La ‘sinfonia’ delle arti e il ‘mistero’ del
linguaggio musicale, «Frontiere. Rivista di filosofia e teologia» 9 (2012), pp.
119-132 (qui, 125).
90 BENEDETTO XVI, Sulla musica, Marcianum Press – Lev, Venezia 2013, p.
25.
87
83
conoscenza della Bibbia. Dalla pittura dei grandi maestri di tutti i
tempi (Giotto, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci …) è
possibile ancora oggi contemplare i grandi misteri della fede che la
Scrittura narra in vari generi letterari.
Nella tradizione ortodossa-orientale ogni icona, ogni pittura
biblicamente ispirata spinge colui che l’osserva oltre i limiti e i colori
percepibili con sensi, verso una realtà trascendente, tende a
condurre verso il mondo spirituale dove appaiono spettacoli
misteriosi e soprannaturali. P. Florenskij, nel saggio sull’icona,
distingue tra la tela cattolica, basata su una superficie elastica e
compiacente, e l’incisione protestante, basata sulla razionalità e sulla
linea astratta impressa con lo stampino, sostiene che «la pittura
dell’icona è una metafisica dell’essere, una metafisica non astratta,
ma concreta. Mentre la pittura a olio è più adatta a riprodurre la
presenza sensibile del mondo e l’incisione il suo schema
razionalistico, la pittura di icone sente ciò che raffigura come
manifestazione sensibile dell’essenza metafisica»91.
La pittura in generale, le grandi opere dei pittori dell’Occidente e le
icone della tradizione ortodossa (in pieno sviluppo dopo le decisioni
del secondo concilio di Nicea, 787)92, hanno lo scopo di spingere chi
osserva-guarda-medita oltre al limite dei colori e della tela percepibili
coi sensi, verso la realtà che, trascendendo il creato, tutto abbraccia;
l’icona ha propriamente «lo scopo di sollevare la coscienza al mondo
spirituale, di mostrare “spettacoli misteriosi e soprannaturali”»93.
La poesia
Un altro percorso è quello della letteratura, in particolare della poesia:
in un tempo in cui vi è una quasi totale dimenticanza della poesia,
della sua bellezza e verità, tanto da far risuonare con maggior forza
la domanda di F. Hölderlin: «perché i poeti nel tempo della
povertà?»94, diventa esiziale riprendere in mano la grande poesia e
P. FLORENSKIJ, Le porte regali. Saggio sull’icona, Adelphi, Milano 1977, p.
125.
92 Per una ricostruzione della disputa tra iconoduli e iconoclasti cfr. il
recente E. FOGLIADINI, L’immagine negata. Il Concilio di Hieria e la
formalizzazione ecclesiale dell’iconoclasmo, Jaca Book, Milano 2013.
93 P. FLORENSKIJ, Le porte regali, cit., p. 61.
94 Il tempo della povertà di cui parla il poeta tedesco (nell’elegia Pane e vino)
è ulteriormente specificato da M. HEIDEGGER, come «tempo diventato
91
84
lasciarsi nuovamente incantare da quel linguaggio che precede e
illumina la filosofia.
Prendiamo l’abbrivio dal “sommo poeta”, dalla genialità maestosa di
Dante: nella Commedia (quasi divina) vi è una tras-figurazione che
rende la Bibbia «non soltanto veicolo di verità, ma anche di
bellezza»95. Nella parte finale del Paradiso, superati i cerchi angelici,
scomparsi come le stelle di primo mattino, Dante incontra
finalmente Beatrice, la cui bellezza trascende così tanto ogni misura
umana, «che solo il suo fattor tutta la goda» (XXX, 21). Fin dal primo
momento in cui la vide, egli mai si è stancato di descrivere
poeticamente tale bellezza, ora deve fermare il suo canto, come ogni
artista giunto al limite delle sua capacità espressive e lasciare a una
voce più alta della sua poesia di svolgere fino alla fine questo ardito
argomento: «Cotal qual io la lascio a maggior bando / che quel de la mia
tuba, che deduce / l’ardua sua materia terminando» (XXX, 34-36).
Beatrice conduce Dante verso l’Empireo, e il poeta chiede di avere
occhi, parola e forza per «dir com’io lo vidi!» (XXX, 99). Dopo aver
visto la «candida rosa» dei beati (della Chiesa trionfante, «che nel suo
sangue Cristo fece sposa»: XXXI, 3) e della schiera angelica («che volando
vede e canta / la gloria di colui che l’nnamora»: 4-5) Dante ascolta
l’orazione di san Bernardo alla Vergine («umile e alta più che creatura /
tu se’ colei che l’umana natura /nobilitasti sì, che ‘l suo fattore / non disdegnò
di farsi sua fattura»: XXX, 2-6), e giunge infine là dove la sua capacità
visiva è maggiore di quanto possa esprime la parola umana: giunge
alla visione in Dio dell’unità dell’universo («Nel suo profondo vidi che
s’interna, / legato con amore in un volume /ciò che per l’universo si squaderna»:
XXX, 85-87), e, sempre consapevole che la favella si fa corta, canta
con grande liricità la visione del mistero dell’amore trinitario di Dio
e la sua manifestazione/donazione nel mistero dell’Incarnazione:
«Non perché più ch’un semplice sembiante
fosse nel vivo lume ch’io mirava,
che tal è sempre qual s’era davante,
ma per la vista che s’avvalorava
in me guardando, una sola parvenza,
tanto povero da non poter più riconoscere la mancanza di Dio come
mancanza»: Perché i poeti?, in Sentieri ininterrotti, La Nuova Italia, Firenze
19905, p. 247.
95 G. R AVASI, Bellezza e mondo divino, cit., p. 25.
85
mutandom’io, a me si travagliava.
Ne la profonda e chiara sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d’una contenenza,
e l’un da l’altro come iri a iri
parea riflesso, e il terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.
O luce eterna che sola in te sidi
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
Quella circolazion che sì concerta
pareva in te lume riflesso,
da li occhi miei alquanto circospetta,
dentro da sé, dal suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige.
A l’alta fantasia qui mancò possa
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amore che move il sole e le altre stelle».
(XXX, 109-145)96.
Bellissima la poetica della visione incantata: la conoscenza e la
fruizione di Dio si equilibrano nella visione dell’Altissimo, col quale
Dante si sintonizza anche nel sacrificio della fantasia con piacere
paradisiaco.
96
Cf D. ALIGHIERI, Commedia, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Garzanti,
Milano 1987; cfr. R. GUARDINI, Dante, Morcelliana, Brescia 1999; H. U.
VON BALTHASAR, Dante, in Gloria. 3/Stili laicali, Jaca Book, Milano 1976,
pp. 3-93.
86
La bellezza dell’icona, imago Dei, la Scrittura si fa
Immagine
Francesca Paola Antonino
L’icona, dal greco eikon, immagine, nasce nella parte orientale del
bacino del Mediterraneo e si sviluppa negli ambienti GrecoBizantini e Russo-Slavi. Porta in eredità mille anni d’arte greca e
latina ma rigetta i canoni estetici classici per sviluppare altre
dimensioni compositive.
Le icone sono eseguite secondo precisi e severi canoni e sono
autentiche solo quelle approvate dalla Chiesa stessa.
Oggi è possibile trovare le icone in diversi luoghi, nelle chiese,
nelle cappelle votive, nelle abitazioni ad imitazione della tradizione
dei cristiani orientali dell’angolo della bellezza nella vita domestica.
L’icona non è un quadro a soggetto religioso che esprime episodi biblici e, il
luogo in cui l’icona nasce non è il laboratorio dell’artista ma è quel
laboratorio in cui l’uomo si costruisce come immagine visibile di un Dio
invisibile. 97
L’icona è un’immagine sui generis, è un’Immagine-Parola. L’icona si
“scrive” non si dipinge. Essa coglie la Parola di Dio come
Immagine. Racchiude il significato più profondo dell’arte figurativa
del cristianesimo poiché l’elemento essenziale che la caratterizza è la
comunicazione.
L’immagine sacra è per i cristiani un elemento di incontro, una sorta
di “simbolo” in cui essi si riconoscono. Si pensi al pesce. Esso
rappresenta un riconoscimento per i cristiani ma è anche
comunicazione di un contenuto spirituale, teologico.
L’iconografia vera riscrive i fatti biblici. Il suo compito non è l’esatta
riproduzione degli avvenimenti ma è la loro interpretazione
teologica.
La teologia orientale ha molto sofferto per arrivare ad affermare
che Dio può essere raffigurato perché si è rivelato ed è apparso in
forma umana. L’iconografia perciò è fondata sull’incarnazione di
Cristo, vera immagine di Dio riflessa nel creato.
“E Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio
e femmina” (Genesi 1,27)
97
Evdokimov P. N., La teologia della bellezza. L’arte dell’icona
87
“E noi tutti contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del
Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di lui, di gloria in gloria,
secondo che opera il Signore, che è Spirito” (2 Corinzi 3,18)
L’icona si sviluppa quindi su una base cristologica come una vera e
propria arte della fede cristiana. Cristo nella sua umanità ci è
accessibile. L’icona è Parola visibile, il Logos, in Gesù Cristo, si
rivela come l’immagine del Figlio a noi accessibile.
Come ogni simbolo, è un luogo in cui non solo si unisce il mondo
sensibile e quello sovrasensibile, ma anche dove si accorciano le
distanze e si vive una sorta di contemporaneità.
L’icona, secondo Evdokìmov, non ha le caratteristiche di essere
un’opera d’arte perfetta; la sua originalità consiste nel mettere
insieme povertà e ricchezza: infatti il materiale di cui è fatta un’icona
è poverissimo, in quanto si tratta di una tavola di legno; ma la
povertà di questo materiale diviene veicolo di una sovrabbondanza
di significato. La sua bellezza viene innanzi tutto dalla verità
spirituale e dall'esattezza del simbolismo, dall'utilità per la
contemplazione e il culto dei fedeli
Si potrebbe dire che il fascino più grande dell’icona consiste in
questa straordinaria unità della parola-immagine, che comporta a
livello psicologico-comunicativo, l’unità di concetto e sentimento, di
ragionamento ed intuizione.
Nell’icona sono presenti i cinque Regni, quello vegetale (la tavola),
quello minerale (i colori), quello animale (la colla di coniglio o di
pesce), quello umano (il lavoro dell’iconografo) e quello divino (la
presenza divina durante la scrittura).
Il mondo dell’iconografia si muove dentro la bidimensionalità,
volutamente si ignora il volume che rappresenta la pura
dimensione “carnale” dell’uomo.
Nell’icona, come in tutta la pittura bizantina, esiste una distinzione fra
corpo e carne. Il pittore di icone riproduce il corpo senza attirare
l’attenzione sulla carne.
Quello che l’iconografo deve presentare è il corpo trasfigurato e
spiritualizzato. Egli lavora dentro uno spazio divino, non usa mai la
tecnica della profondità, non cerca di dare volume ai corpi come
succede nelle sculture (nelle chiese bizantine non esistono sculture),
o nelle pitture rinascimentali in cui, nello sforzo di riprodurre la
natura, si è preoccupati di dare plasticità ai corpi e agli oggetti
88
rappresentati. Al contrario, le icone rappresentano scene
teofaniche e persone che sono state trasformate, cristificate.
Nella realizzazione dell’icona si pone un centro ideale da dove
partono e si sviluppano tutti i particolari, è i l punto fonte di ogni
realtà, è il divino, e ad esso d e v e e s s e r e condotto chi
contempla l’icona.
Ricorrendo al simbolo si riproduce solo ciò che è necessario per
esprimere non solo lo slancio dell’uomo verso Dio, della sua offerta,
ma anche “la discesa di Dio verso l’uomo, una forma nella quale avviene
l’incontro di Dio con l’uomo, dell’eternità con il tempo”98.
L’icona è una realtà nella quale si compenetrano, in una
comunicazione reciproca, divino e umano.
La tecnica utilizzata è quella della prospettiva inversa. Le linee non
vengono tracciate per convergere in un punto all’interno
dell’icona bensì al suo esterno: la direzione della prospettiva non si
trova dietro il quadro ma davanti, nell’occhio di chi guarda.
Così la sensazione ottica è che l’immagine raffigurata vada verso
l’osservatore quasi ad incontrarlo. Il significato teologico indica che è
Dio che ha l’iniziativa, è Lui che va verso l’uomo per incontrarlo e
offrirgli la sua amicizia.
Il tempo n e l l ’ i c o n a non è rappresentato in modo strettamente
cronologico e vari fatti distanti anche nel tempo, sono accostati tra
loro. Spazio e tempo sono indipendenti ed è per questo che le
scene delle icone non sono inquadrate dentro un telaio. Esse
sono lasciate libere da limiti per indicare che superano lo spazio e
il tempo e si aprono un varco verso l’infinito.
Nell’icona non si manifesta una sorgente naturale di luce ed i corpi non
possiedono ombre proiettate. La luce proviene solo dalle parti
dorate a simboleggiare la vita divina partecipata agli uomini.
Per togliere ogni percezione di sensualismo i volti sono realizzati
con colori molto sfumati e a volte viene adottata la sproporzione
geometrica delle fattezze rispetto al naturale.
Pavel Florenskij99, parlando dell’icona, scrive che essa non è da
intendersi come l’espressione della personalità soggettiva dell’artista,
secondo la concezione estetica del mondo occidentale, ma è da
intendersi come un simbolo che reca già in sé la realtà di cui é
98
Uspensky L., Teologia dell’icona nella Chiesa ortodossa
Pavel Florenskij (Evlach, 9 gennaio 1882 – Leningrado, 8 dicembre 1937) è stato
un filosofo, matematico e religioso russo
99
89
simbolo, ovvero quel mondo soprannaturale a cui l’artista,
spogliandosi della propria soggettività, deve potersi elevare
contemplativamente per potersi esprimere artisticamente. In essa si
legge la vera bellezza poiché “La verità manifestata é amore. L’amore
realizzato é bellezza”100
Le opere che ci ha lasciato Andrej Rublëv101 sono un’eloquente
espressione di questa teologia della bellezza.
Tra tutte le icone, la più profonda e artisticamente pregevole è
proprio quella della Trinità di Rublëv, considerata un capolavoro di
rara profondità teologica, di bellezza incomparabile e di finissima
ricchezza di simboli. Il Concilio dei Cento Capitoli (1551) la dichiarò
“icona delle icone”, modello universale della rappresentazione della
Trinità. 102
Il tema trinitario ha ispirato molti iconografi ed artisti.
Dipingere la santissima Trinità sarebbe un peccato di blasfemia e
orgoglio. E’ possibile dipingere l’immagine nella quale la Santissima
Trinità si rivela e si comunica agli uomini103.
I cristiani sono monoteisti, ma in maniera del tutto eccezionale
poiché nel dire “crediamo in un solo Dio”, affermano nello stesso
tempo di credere nelle Tre Persone divine in una sola natura. Perciò
la storia della fede cristiana è la storia della pedagogia di Dio per
preparare ad accogliere questo suo imperscrutabile mistero.
L’immagine preferita nel cristianesimo per la rivelazione di questo
mistero divino è la vista dei tre angeli ad Abramo e Sara alla quercia
di Mamre descritta nel capitolo 18 del Libro della Genesi che inizia
raccontando che Yhwh si manifestò ad Abramo e narra dei tre
angeli che fecero visita ad Abramo e furono accolti con una tipica
100
Mura G., Pavel Florenskij: L’icona e la bellezza
Andrej Rublev è il sommo iconografo russo. Nacque a Mosca intorno al 136070 e fu allievo e poi assistente di Teofane il Greco, altro grande autore di immagini
sacre. Diventò monaco del Monastero Andronikov di Mosca dove trascorse la
maggior parte della sua vita e vi morì nel 1430 circa. Rublev fu canonizzato nel
1988 in occasione del Millennio del Battesimo della Russia, ma la sua fama di
Santità aveva già attraversato i secoli insieme con le sue celebri opere.
101
Venne scritta tra il 1422 ed il 1427 per la canonizzazione di Sergio di Radonez,
morto trent’anni prima, fondatore del monastero di Trockij dove Rublëv viveva.
102
103
Spidlik T., Rupnik M. I., La fede secondo le icone
90
ospitalità, quell’ospitalità che va molto oltre i convenevoli e la
generosità. 104
“Poi il Signore apparve a lui [Abramo ] alle Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e
vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro
incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore,
se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo.
Si vada a prendere un pò di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.
Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo,
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fà pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella
tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne
focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e
lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco
insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava
in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è
Sara, tua moglie?». Rispose: «E' là nella tenda». Il Signore riprese: «Tornerò
da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio»
(Genesi 18, 1-10)
Chiesa di San Vitale a Ravenna - mosaico della metà del VI sec.
Il passo descritto dalla Genesi è diventato il soggetto di molte
rappresentazioni dell’arte religiosa. Una delle più antiche
La Chiesa orientale chiama questa icona philoxenia che indica proprio
quell’ospitalità che va oltre i convenevoli e la generosità
104
91
rappresentazioni di questo avvenimento è il mosaico della metà del
VI secolo nella chiesa di San Vitale a Ravenna: tre giovani stanno
seduti a tavola sotto la guercia di Mamre, aspettando il pasto e le loro
teste sono attorniate da nimbi.
Andrej Rublëv - la Trinità
L’icona presa a modello da Rublév era spesso dipinta anche con la
presenza di Abramo e Sara. Con la raffigurazione della vista dei tre
angeli ai due di Mamre si ha una finestra nel mondo sensibile in cui
si apre il mondo divino e tra loro avviene una reale comunicazione.
Dio è la comunione, è l’amore che accorcia le distanze. I tre sono la
vita, i due la sterilità.
L’impotenza umana di dare la vita è, presso Abramo e Sara, arrivata
al punto in cui ogni speranza è irreale. Dio, resosi ospite, fa uscire
Abramo dal guscio in cui si trovava rinchiuso con Sara. Abramo
esce dalla tenda, accoglie gli ospiti, e proprio la loro presenza suscita
in lui tutta una generosa ospitalità. I due troveranno la loro vera
relazione solo quando sprofonderà in quella dei tre che sono venuti.
Nell’icona di Rublëv si possono rilevare la tenda di Abramo, la
quercia presso Mamre, la montagna.
I tre pellegrini sono raffigurati come angeli con le ali. Hanno volti
uguali e giovanili e nessuno sembra più anziano o più giovane,
perché in Dio non c’è un prima o un dopo, un ieri o un domani ma
solo un perenne oggi.
92
Tutti e tre tengono in mano il bastone del viandante, segno della
stessa autorità. Le aureole, luminose, sono tutte e tre uguali senza
alcun segno di distinzione.
Tre ipostasi di Dio, indivisibili e inconfondibili, è la consustanziale
Santissima Trinità.
Essi sono racchiusi in un cerchio, simbolo della perfetta uguaglianza
ed equilibrio, della pienezza e della perfezione e sottolinea la
circolarità degli sguardi d’Amore delle tre Persone.
“I bastoni dei vian-danti”
“Il cerchio”
“Il calice”
L’angelo centrale è il Salvatore, Gesù Cristo. Egli è posizionato sotto
la quercia di Mamre, sotto le quali riposarono i visitatori; un albero
grande come quello dell’Eden sotto il quale Eva fu tentata.
Il vero frutto dell’albero della vita, il Figlio, è situato proprio sotto la
quercia.
Cristo è quel frutto dell’albero che mangiandolo dà la vita eterna.
“Io sono il pane, quello vivo, venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà per sempre. Il pane che io gli darò è il mio corpo, dato perché il mondo
abbia la vita.”
(Gv 6,51)
Ciò significa che l’uomo non correrà più dietro alle passioni ed ai
desideri per saziare le proprie soddisfazioni.
L’albero rappresenta anche la Croce, ovvero l’albero sul quale è
morto Cristo: albero di morte che diviene albero di vita eterna.
Egli ha il braccio grande e potente perché è il braccio di Dio per
mezzo del quale sono state create tutte le cose.
“La tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza, la tua destra, o Eterno,
schiaccia i nemici.” (Es 15,6)
“Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati.” (Es 15,12)
93
Il Cristo al centro, vestito con una tunica rossa, ricoperta da un
manto blu, il rosso intenso della divinità, rivestita dal blu
dell’umanità. Egli è nella postura benedicente, con le due dita che
puntano sul tavolo verso la coppa dell’offerta. Le due dita indicano
anche la sua doppia natura divino-umana. L’angelo centrale, il
Cristo, è completamente rivolto verso l’angelo alla sua destra, il
Padre, per fare la Sua volontà. Tutto è rivolto verso il Padre, anche
l’altro angelo, l’albero e la montagna, per fare la Sua volontà.
Il Padre è avvolto in un abito oro. L’oro è la luce senza tramonto di
Dio. Sul petto traspare il blu dell’umanità che sta a cuore al Padre.
Dietro al Padre si intravede la casa, la tenda, la “casa del Padre”. Il
Figlio, tutto proteso a lui, ci vuole portare in quella casa dove va a
preparare un posto per noi. E’ la casa dove finisce l’esilio di Adamo,
ricondotto da Cristo al Padre.
“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado
a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto,
ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. (Gv
14, 2-3).
La destra del Padre è nell’atto di benedire, cioè di mandare lo Spirito
Santo, che è l’angelo alla destra dell’icona, il luogo a cui rimanda la
mano del Padre.
Questo angelo è il più curvo verso terra, è avvolto di blu e rivestito
di verde. E’ lo Spirito di Dio che aleggiava sopra le acque nell’ora
della creazione e che muove dal di dentro tutto il creato (il color
verde) verso il Creatore. E’ rivestito di blu perchè è donato all’uomo
e inabita il suo cuore. E’ quell’ospite interiore che fa l’uomo tale,
versando nel suo cuore l’amore del Padre che rende l’uomo un
essere ad immagine del Dio Amore.
“La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.” (Rm 5,5).
Lo Spirito Santo è indicato nella tradizione orientale come
l’iconografo interiore, l’artefice della santità. È colui che rivela il
Cristo come immagine del Padre, ma è anche Colui che porta
l’uomo alla progressiva somiglianza con Cristo, «scrivendo» la sua
immagine di santità nell’uomo.
Dietro all’angelo dello Spirito Santo è raffigurata una rocciamontagna.
Le montagne sono i luoghi privilegiati di rivelazione di Dio, luoghi
dove il cielo e la terra sembrano incontrarsi (Mosé incontrò Dio
sulla montagna, la trasfigurazione di Gesù avvenne su una
94
montagna, sul monte Moriah era il luogo del sacrificio di Isacco
come il Golgota lo divenne per il Cristo).
La montagna è immagine della Sua dimora.
“Dio ha scelto a sua dimora il monte di Basan, il monte delle alte cime; il
Signore lo abiterà per sempre”. (Sal 67, 14-17)
Gli angeli sono seduti attorno ad una mensa. Al centro della mensa
vi è un calice-coppa con dentro la testa del vitello, ma sull’icona si
legge un altro calice, disegnato dal profilo delle due figure esterne (il
Padre e lo Spirito), in mezzo al quale si trova il vero Agnello, il
Figlio di Dio, Gesù Cristo. E’ il calice della Pasqua ebraica, la festa
della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il simbolo del sacrificio
che il Dio Trino e Uno compie per la redenzione dei peccati degli
uomini. Manda alla crocifissione e alla morte il Figlio che s'incarnerà
ad immagine dell'uomo.
È all’interno di un’esperienza di fede che va capita la concezione della bellezza.
La bellezza non è una decorazione aggiunta ad una fede già completa in se
stessa ma appare come luogo della rivelazione di Dio stesso e luogo dello
svelamento della verità dell’uomo. La bellezza pertanto è rivelazione
dell’originario ed anticipazione del definitivo.105
Bibliografia essenziale
Dutto G., Contemplazione della icona della Trinità, Torino 2003
Evdokimov P. N., La teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Roma
2002.
Florenskij P., Le porte regali. Saggio sull’icona, Milano 1981
Sendler E., L’icona immagine dell’invisibile. Elementi di teologia, estetica e
tecnica, Roma 1985.
Spidlik T., Rupnik M. I., La fede secondo le icone, Roma 2004
Uspensky L., Teologia dell’icona nella Chiesa ortodossa, Parigi 1982.
105
Op. cit.: Evdokimov P. N.
95
96
Il potere della diversità: i Magi evangelici
Ezio Albrile
I. Origini
I Magi iranici sono descritti da Erodoto come una tribù
meda (1, 101) e come specialisti del sacro, esperti della ritualità
religiosa al servizio innanzitutto della casata imperiale achemenide.
La loro presenza appare indispensabile per le libagioni (7, 43, 2) e
per i sacrifici (7, 113–114; 191) e, secondo altre fonti, sono loro a
celebrare la cerimonia di iniziazione al trono del sovrano (Plutarco,
Artaserse 3,1–2). Inoltre sempre ai Magoi è attribuito l’incarico di
salmodiare delle teogonie (1, 132, 3), ovvero di recitare i testi sacri,
cioè qualcosa di simile agli Yašt, gli inni avestici, ma anche di
praticare l’esposizione dei cadaveri e di uccidere gli animali ritenuti
nocivi (1, 140). Tutte circostanze che sono in sintonia con alcune
nozioni essenziali della tradizione religiosa mazdea, e anche
propriamente zoroastriana, sulle quali si diffonde anche Senofonte
nella Ciropedia (8, 1, 23), affermando che i Magoi cantano inni al Sole
nascente (8, 1, 23; 3, 11) e scelgono gli dèi a cui offrire il sacrificio,
secondo la consuetudine indo-iranica per cui, all’inizio del rito, si
apre una parte introduttiva in cui vengono elencate proprio le
divinità invitate alla cerimonia e quelle che ne saranno, invece,
escluse, come specificamente avviene nel caso dei daēva- nello yasna,
il rituale sacrificale avestico. Nella descrizione di Erodoto (7, 43)
non appena Serse raggiunse il fiume Scamandro, i Magi al suo
seguito avrebbero offerto «libagioni» agli «eroi» (choas de hoi magoi
toisi herōsi echeanto). Questi herōes non sono altro che gli artāvan- dei
Persiani, ossia gli artaioi, come ancora lo stesso Erodoto precisa (7,
61, 2), i guerrieri dei quali erano venerate le fravaši-, le anime
immortali.
Nell’Iran preislamico con il termine magu- si designava una
gerarchia sacerdotale di notevole rilevanza nella vita religiosa; il
nome magu-, verisimilmente di origine meda, è chiaramente attestato
nelle iscrizioni achemenidi in antico-persiano: ma-gu-šú nella versione
babilonese, ma-ku-iš in quella elamica. La parola passa all’aramaico
magūšā (pl. magūšaia), da cui la tarda e posteriore denominazione di
Magousaioi, i «Magi ellenizzati» di Cumont. Prima, però, il termine
97
magu- aveva dato origine al prestito greco magos e successivamente a
quello latino magus.
Il prestigio di questa cerchia sacerdotale sarebbe col tempo
accresciuto, al punto che, nelle fonti classiche, lo stesso Zoroastro
sarà considerato un «mago». Per di più il pahlavi mowbed (< avestico
*magu-pati-, «signore dei magu-») connoterà parte del clero
zoroastriano in epoca sassanide, al cui vertice ci sarà un mowbedān
mowbed, un «mago dei magi», ovvero un archimagos. Sappiamo, invece,
che il termine magu- non è mai attestato nelle fonti avestiche, fatta
eccezione per un passo di interpretazione controversa, ove ricorre il
composto moγu.t~biš-, probabilmente «nemico dei magu-».
È nota l’accezione positiva del termine nelle fonti greche,
tanto nel platonico Alcibiade maggiore (121e-122a), quanto nei
frammenti sopravvissuti del trattato Magikos di Aristotele.
Nell’Alcibiade si afferma che i dinasti persiani venivano educati da
quattro saggi, scelti tra i più valenti dell’impero, e si aggiunge che il
più sapiente istruiva il futuro sovrano nella mageia di Zoroastro figlio
di Oromazes – ossia nella «cura degli dèi» (theōn therapeia) – e nell’arte
di regnare. Secondo il frammento del Magikos aristotelico,
pervenutoci attraverso Diogene Laerzio, l’autetica mageia, specifica
dei Magoi, è da intendersi come una cosmologia e un rituale veri e
propri, in antitesi con la goēteutikē mageia, la «magia incantatrice»,
l’arte del sortilegio.
Sicuramente negativo è invece il giudizio che Platone
formula sui Magoi nella Repubblica, in un passo in cui se ne parla
come di «nefasti creatori di tiranni» (572e) anelanti al controllo della
gioventù. Tratto spiegabile con la fama di manipolatori e intriganti
che gli adepti di un certo clero mazdeo ebbero in Occidente, sin
dall’antichità achemenide. Il riferimento immediato è alle vicende
narrate da Dario I nell’iscrizione trilingue di Bīsutūn a proposito del
Mago «medo» Gaumāta, il falso Smerdi di Erodoto. Gaumāta vi è
descritto come una sorta di cinico criminale, che usurpa il potere
grazie alla propria somiglianza con il figlio minore di Cambise,
Bardiya, eliminando quanti potrebbero riconoscerlo.
II. Interferenze
Ma la fama dei Magi iranici è diffusa in Occidente
soprattutto nel contatto con il cristianesimo:
98
«Nato Gesù in Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, dei
Magi giunsero dall’Oriente a Gerusalemme dicendo: “Dov’è il neonato
re dei Giudei? Abbiamo visto infatti la sua Stella in Oriente e siamo
venuti per adorarlo”».
Sono le parole con cui il Vangelo di Matteo (2, 1-12)
introduce l’episodio dei Magi. Ben presto diverrà uno dei motivi più
celebrati della letteratura e dell’arte del cristianesimo antico,
medievale e moderno, fino a costituire, soprattutto a Roma, il tema
centrale dell’Epifania, la manifestazione di Dio nel Gesù bambino.
Tutti conosciamo il resto del racconto dell’Evangelista: il cammino
indicato dalla stella; il dono dell’oro, dell’incenso e della mirra;
l’inganno ordito da Erode e fallito per il sogno che spinse i Magi a
ripartire per il loro paese senza render conto al sovrano di dove
avessero visitato il bambin Gesù.
L’Adorazione dei Magi fu motivo ricorrente dell’iconografia
bizantina nel ciclo della Natività, di cui sono buoni esempi, tra i
molti altri, i mosaici dell’arco trionfale di Santa Maria Maggiore a
Roma o quelli ravennati di Sant’Apollinare Nuovo. Essa, in realtà, fu
illustrata in opere d’arte, a volte splendide, dalle pitture e sculture
paleocristiane al pulpito del Battistero di Pisa, di Nicola Pisano, dai
dipinti di Lorenzo Monaco, Gentile da Fabriano e Sandro Botticelli
alla Galleria degli Uffizi, a quello di Hieronymus Bosch al Museo del
Prado. Fra queste, le più eloquenti sull’identità dei Magi sono le più
antiche, che li rappresentano in un caratteristico costume persiano
(berretto frigio, pantaloni lunghi, i doni custoditi in scrigni di foggia
sasanide), non discostandosi in ciò da alcune raffigurazioni in dipinti
catacombali. Il numero di tre Baldassarre, Melchiorre e Gaspare, è
un probabile riflesso dei tre doni. Matteo parla solo di «Magi» e non
di «Re».
I Magi sono noti nel Vangelo di Matteo e in una serie di fonti
che testimoniano la diffusione del verbo cristiano nel mondo
aramaico. Esse rimandano a una cultura religiosa, verosimilmente
iranica, con cui la comunità giudaica aveva da tempo strette relazioni
culturali. Una cultura che attendeva autonomamente la venuta di un
«Salvatore del mondo» e si contrapponeva, peraltro, al potere di
Roma. I Magoi che ungevano i sovrani achemenidi, erano venuti a
«ungere» con gli unguenti sacri il nuovo re del mondo. Essi inoltre
appaiono quali interpreti dei moti degli astri, ma la loro sapienza, per
quanto pagana, non viene guardata con disprezzo e certamente i
99
suoi detentori non sono stregoni. L’opera dei Magi, forse nota
attraverso una aggadah (un racconto tradizionale ebraico) letta e
interpretata nella cerchia famigliare di Gesù, sarà recepita in modo
estremamente positivo dalla fonte neotestamentaria, e da lì confluirà
in tutta la cultura cristiana di lingua aramaica, cioè siriaca.
Una fra le tante testimonianze medievali di questa
interferenza, sta nella basilica romanica di Sant’Ambrogio a Milano.
Tra le vestigia figurative più antiche, un posto di rilievo è certamente
tenuto dall’ambone di Guglielmo, importante insieme scultoreo
databile tra la fine del XII e i primi anni del XIII secolo. Nella parte
inferiore del pulpito è conservato un grande sarcofago
paleocristiano di notevole interesse iconologico. Osservando i
numerosi soggetti eccezionalmente scolpiti su tutti i lati, la nostra
attenzione cade sul coperchio che presenta, in sequenza da sinistra
verso destra, la scena di Nabucodonosor nell’atto di richiedere
l’adorazione del proprio busto issato su di una colonna, i tre Magi in
abiti persiani (non ancora differenziati nelle tre età) che avvistano la
Stella (fig. 1) e, infine, gli stessi in adorazione di Gesù bambino che
li benedice (fig. 2). L’infante è seduto in grembo alla Madonna, a sua
volta assisa su di una roccia. Guardando attentamente la scena
dell’adorazione (in parte mutila) notiamo che solo due dei tre Magi
portano i doni consueti (incenso, mirra), il primo di essi,
tradizionalmente riconosciuto in Melchiorre, non reca l’oro, bensì
un oggetto circolare, un anello (fig. 3).
Si tratta probabilmente di una metafora legata al dominio
sul tutto, sul tempo infinito, sull’Aiōn, il «Tempo trascendente e
assoluto», eternità immobile e una per Platone (Tim. 37d),
contrapposto a Chronos, il Tempo empirico in movimento
continuo, che ne è l’immagine; principio immobile e immutabile,
«immortale e divino» (athanatos kai theios), «qualità stessa del Cielo»
per Aristotele ( De cael. 1, 9, 279а, 22 ss.; 2, 1, 283b, 26 ss.), in
opposizione al tempo come principio del movimento e della
mutazione. E ciò in ragione del kyklos, di quell’anello in mano al
primo Re Mago. Vediamo come.
Platone si diffonde dettagliatamente su un sofisticato
meccanismo cosmico celebrato anche nei versi del vate e astromante
Manilio, contemporaneo di Augusto: Quippe etiam mundi faciem
sedesque movebit / Sidereas, caelumque novum versabit in orbem (Astr. I, 4,
267-268). L’universo è sferico e il Demiurgo lo mantiene in
movimento come in un anello.
100
La parola latina anulus «anello» è il diminutivo di anus
«cerchio», legato etimologicamente ad annus «anno», ma anche
«periodo, stagione». I primi due termini corrispondono al greco
kyklos «cerchio, anello», inteso come circonferenza dello Zodiaco,
nel duplice significato di volta del cielo (Herod. 1, 131, 2; Hom.
Hymn. 8, 6) o succedersi di mesi e stagioni (Eur. Or. 1645), quindi
sinonimo di Aiōn, il tempo nella sua estensione e durata infiniti.
Svariate fonti letterarie latine fanno riferimento alla «ruota
dell’anno» (Sen. Herc. fur. 178-180; Philostr. Im. 2, 34; Macr. Sat. 1,
21, 13). La relazione tra il Tempo eterno = Aiōn e Annus è stabilita
nelle celebrazioni che a Roma si tenevano per l’assunzione del
consolato (Claud. Carm. 1, 266-274). Una riprova che è il Tempo
eterno a governare lo Zodiaco è data dal confronto con la
figurazione medievale di Cristo entro la mandorla di luce: evidente la
trasformazione dell’ellisse zodiacale, immagine del percorso astrale
del Sole, nell’alone di luce soprannaturale che circonda il
Cristo Dominus lucis. L’idea è quella del Cristo come vera luce e Sole
spirituale (Sol Iustitiae): così ad esempio nella scena della resurrezione
(Firm. Err. 24, 4) e in quella della trasfìgurazione, dove lo splendore
di Cristo viene assimilato a quello del Sole (Aug. Serm. 78 [PL 38,
490]).
A partire dal I sec. d.C. nelle figurazioni e nei rilievi
scultorei lo Zodiaco spesso è rappresentato come un anello che
incornicia una scena, esso è suddiviso in tanti riquadri che
racchiudono i singoli «animaletti». Infatti la parola «Zodiaco»,
Zōdiakos, è derivata da zōdion, diminutivo di zōon «animale, essere
vivente»; zōdion significa letteralmente «animaletto», ma anche
«figurina che rappresenta un animaletto». Quindi Zōdiakos, cui si
sottintende kyklos, «cerchio, ruota», sarebbe il «circolo delle figure
animali», con esplicito riferimento a quelle costellazioni la cui forma
suggerisce l’immagine di un animale e che nel contesto dello
Zodiaco sono da ritenersi la maggioranza. La composizione a forma
d’anello infine si prestava particolarmente a interpretazioni
simboliche e religiose, perché attraverso lo Zodiaco si faceva
riferimento alle orbite dei Pianeti (comprensivi di Sole e Luna) e in
genere a tutti i fenomeni legati alla sfera celeste.
La conferma si trova nei Papiri Magici Greci, dov’è
menzionato un anello magico che arreca potere, successo, fortuna,
sul quale sono incise le immagini di un serpente che inghiotte la
propria coda, cioè l’Ouroboros, e del Sole splendente. Il dio a cui il
101
mago rivolge la propria invocazione è collegato con Aiōn, il mago
stesso si autodefinisce Phoinix, «Fenice». Animale palingenetico,
morente e risorgente a nuova vita, come Aiōn.
Infatti lo Zodiaco si accompagna spesso alla figura di Aiōn
posto al centro dell’anello zodiacale. Si vedano il mosaico alla «Casa
di Aiōn» in Antiochia (arco), un aureo di Adriano (anello), alcune
monete dal II sec. d. C. sino alle raffigurazioni di Costantino o un
mosaico di Ostia, in cui sull’anello zodiacale sfilano le Ore. Che in
ognuno di questi casi si tratti dello Zodiaco è dimostrato da altri
manufatti, come il mosaico proveniente dal Mithraeum di Sentino
(Sassoferrato, Ancona, ora nella gipsoteca del Museo archeologico
di Monaco) dove Aiōn sta all’interno di un anello con 12 figure, in
parte erroneamente integrate; e il mosaico di Haidra (Tunisi, Museo
del Bardo) datato tra la seconda metà del III o l’inizio del IV sec.
d.C., sul cui anello zodiacale si possono riconoscere le immagini
dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro; o ancora la patera
d’argento di Parabiago (Milano, Museo archeologico) datata tra il II
e il IV sec. d.C.. Il motivo dello Zodiaco a forma di arco, di cerchio
o di anello, fu raffigurato anche su oggetti d’uso comune e sulle
vesti, per simboleggiare il rapporto tra colui che li portava sulla sua
persona e il cosmo.
III. Tempo e Potere
Un testo latino, l’Opus imperfectum in Matthaeum,
erroneamente attribuito a Giovanni Crisostomo (In Matth. hom. II
[PG 56, 637-638]), ma verosimilmente scritto da un vescovo in
odore di eresia ariana, il goto Massimino, parla di un Liber apocryphus
nomine Seth nel quale si narrava dei Magi e della Stella attesa, segno
della nascita del Gran Re del mondo. Ogni anno, dopo la trebbiatura
(post messem trituratoriam), dodici Magi salivano sul Mons Victorialis, il
«Monte delle Vittorie», dove si trovava una caverna circondata da
alberi lussureggianti. Qui, dopo essersi purificati a una fonte d’acqua,
pregavano e onorano Dio in silenzio per tre giorni. Trascorsi molti
anni, durante i quali il rito venne celebrato ininterrottamente, una
Stella appare sul Monte. Questo astro splendente assunse le forme
di un fanciullo sovrastato da una croce, il quale comandò ai Magi di
recarsi a Betlemme.
A sua volta l’Opus imperfectum in Matthaeum è la trascrizione
di testi più antichi scritti in siriaco (l’aramaico di Edessa), di cui il più
102
importante è la Cronaca di Zuqnīn. Fra le differenze rispetto al testo
dell’Opus, scendendo dal «Monte delle Vittorie» (siriaco Ṭūr neṣ̣ḥānē),
i Magi della Cronaca di Zuqnīn parlano della visione della Stella e
scoprono che in essa ognuno ha visto una cosa diversa e che ognuna
riflette momenti diversi della vita del Salvatore: dal Bambino al
Crocefisso, la discesa agli inferi e la resurrezione, sino alla gloria in
Paradiso. Questa e altre tradizioni confluiscono ne Il Milione (cap.
30) di Marco Polo (1254-1324). Giunto in Persia, nella città in cui si
venerano i fuochi sacri, Marco apprende una storia sui Tre Re Magi,
sui tre doni (oro, incenso e mirra) e su come Gesù apparve loro in
tre diverse forme, corrispondenti all’età di ognuno (giovane, adulto,
vecchio).
Nel trimorfismo di Gesù fanciullo, adulto e vecchio si
ritrovano le vestigia del culto di Aiōn, versione ellenistica dell’iranico
Zurwān, il Tempo illimitato, sintesi di passato, presente e di futuro.
Aiōn è durata infinita, saeculum, eternità, ma anche ciclo cosmico in
perpetuo rinnovamento. La sua iconografia è in gran parte
rintracciabile nei sacelli dedicati al dio Mithra, nei quali appare un
essere mostruoso, alato, con la testa di leone e il corpo avvolto nelle
spire di un grande serpente.
Nella figurazione di Aiōn confluisce l’idea del Tempo che
dissolve e consuma: le ali accennavano alla rapidità del suo fluire; le
circonvoluzioni del serpente, la cui testa poggiava di solito sopra il
capo leonino, alludevano alla vicenda ciclica alla quale erano
sottoposti i moti stellari, vigili implacabili nello scorrere del divenire.
Saturno, così come lo dipingono Nonno di Panopoli
(Dionys. 7, 24-25 ; 41-44 ; 41, 179-182) e Claudiano (De consul. Stilich.
2, 433-440), è il vecchio Aiōn: ogni anno il suo corpo invecchia
nell’inverno e ridiventa giovane in primavera. Plasticamente è un
essere zoomorfo in continuo cangiamento con il mutare delle
stagioni: il suo capo passa dalle fattezze di serpente (freddo), a quelle
di leone (caldo), mentre nel rigore, nella furia degli elementi, assume
le sembianze di un cinghiale.
Aiōn è il leontocefalo, effigiato talora con i tratti di un
vecchio, talora con quelli di un fanciullo. Agli albori del V sec. d.C.,
Marziano Capella, nella sua opera enciclopedica (De nupt. 2, 197),
dipinge «il freddissimo creatore degli dèi» Saturno, cioè il ciclo
annuale, come un orrido essere mutante, ora drago, ora leone, ora
cinghiale, stigma del cambiare delle stagioni: l’Aiōn invecchia,
rincorrendo i mesi sino a ridiventare fanciullo.
103
Il dominio sul tutto è il dono che il primo Mago fa al
pargolo Re del mondo, offrendo un potere che si estende dal visibile
all’invisibile, dal tempo all’eternità. Se pensiamo che il nome iranico
dei Magi, cioè l’antico persiano magu- è connesso con una radice
indo-iranica *magh dal significato di «potere, avere forza», a sua volta
ben attestata nelle lingue germaniche come il gotico mag «potere»,
nonché nell’antico slavo mog , con lo stesso significato, troveremo
nel rilievo dell’ambone una diretta corrispondenza.
Se i Magi possono offrire al bambin Gesù il potere sul
tempo, ciò è fattibile anche grazie alle abilità di astromanti cui sono
noti nel mondo antico. Torniamo un attimo alla pericope di Matteo,
in cui i Magi chiedono:
«“Dov’è il neonato re dei Giudei? Abbiamo visto infatti la sua Stella in
Oriente e siamo venuti per adorarlo”».
Ora, usualmente si traduce il greco en tē anatolē con «in
Oriente», il che rivela una apparente contraddizione, poiché se i
Magi vengono dall’Oriente (Mt. 2, 1) e sempre a Oriente vedono la
Stella (astēr) del Salvatore, dovrebbero mettersi in cammino in senso
opposto. In altre parole, ipotizzando che all’inizio del viaggio i Magi
si trovino in Persia e da lì vedano la Stella «in Oriente», seguendone
lo splendore dovrebbero mettersi in marcia verso la Cina e non
verso Gerusalemme, che sta nel loro Occidente.
In realtà la frase del Vangelo di Matteo svela nel verbo anatellō
«sorgere, levarsi» l’uso di un lessico prettamente astrologico, quindi
la Stella sarà intravista non «in Oriente», bensì «in levare»,
verisimilmente eliaco. La profezia di Zaccaria riportata nel Vangelo di
Luca 1, 78 trascrive un motivo analogo: il Salvatore è invocato quale
luce «sorgente dall’alto» (episkepsetai hemas anatolē ex hypsous).
Nel Vangelo di Matteo l’atto di omaggio, la proskynēsis dei
Magi, ricorda quello della regina di Saba, presentatasi a Salomone
con aromi, oro e pietre preziose, ma soprattutto il racconto è la
replica della profezia di Balaam in Numeri 24, 17 che nella versione
greca dei Settanta invoca la «stella che sorgerà da Giacobbe» (anatelei
astron ex Iakōb) utilizzando lo stesso lessico.
La ricorrenza di termini verbali e sostantivi derivanti da
anatellō fa pensare a una indicazione della posizione dell’astro che
aveva iniziato il suo levare eliaco, cioè in concomitanza con il
sorgere del Sole (oppure di una stella mattutina), in un cielo
104
particolare, forse al Solstizio. Un astro che, in piena sintonia con le
attese del tempo, si levava in cielo al nascere di un Signore del
Mondo, e ne rappresentava il suo «oroscopo».
È il Rex magnus de caelo celebrato negli Oracoli di Hystaspe
(Lact. Div. inst. 7, 17, 11), una raccolta di profezie attribuite al re
iranico Vištāspa (nell’idioma avestico > medio-persiano Wištāsp >
neopersiano Goštāsp), sopravvisute solo in una manciata di
frammenti, di cui i più lunghi sono conservati nell’opera di
Lattanzio, che li ha adattati solo in parte al messaggio cristiano.
Il principio spirituale, come il Saošyant atteso dai Magi
zoroastriani, si manifestava ciclicamente nel mondo annunciato da
una Stella, essa stessa oggetto di venerazione, come avvenne in
Roma per il misterioso sidus Augustum, identificato nella
costellazione del Capricorno (Manil. Astr. 2, 507-509; Svet. Div. Aug.
94, 18), ma che in realtà celava una manipolazione dello stesso
Ottaviano (Svet. Div. Aug. 5, 1).
Nel Saošyant iranico si materializza la forza siderea del
Salvatore del mondo. Zoroastro stesso ha origini sideree: Giovanni
Malala lo assimila alla costellazione di Orione, rivivificando di fatto
una tradizione che ha origini avestiche. Zarathuštra custodisce gli
uomini, così come la stella Tištrya/Sirio custodisce la volta celeste
(Yašt 8, 44 [PANAINO, p. 68]). Il passo è fatto proprio da Plutarco
che descrive Horomazes pittore di un cielo stellante; tra esse ne
scelse una a guardia (phylax) e custodia (prooptēs) sopra tutte le altre,
la stella Sirio (De Is. et Osir. 47 F: 370 A).
L’attesa di un Salvatore venturo, di un Saošyant
rinnovatore, sono parte dell’ideologia regale iranica e trovano
compimento nel simbolismo della luce. Secondo Filostrato (Vit.
Apoll. 1, 25) i re partici raffiguravano i propri dèi in sembianze
sideree. Questo perchè essi stessi avevano un’origine celeste e ignea:
discesi dal cielo in una colonna di fuoco, stigma del loro carisma era
lo xvar nah, la fortuna che s’irradia dal capo dei degli esseri eletti.
Ammiano Marcellino (17, 5, 1) trascrive l’epiteto che designava il
«Re dei Re» Šāpuhr quale discendente di una stirpe divina
consustanziale agli astri e ai due luminari: particeps siderum, frater Solis
et Lunae.
Tiridate, re d’Armenia, nel 66 d.C. si recò a Roma con un
corteggio di Magi ad adorare Nerone mithrizzato (Svet. Nero 13;
Dion. Cass. Hist. Rom. 63, 1-7). Seguendo i moduli espressivi della
regalità sacra il re Mithridate Eupatore era incarnazione di Mithra e
105
come Mithra era nato in una caverna da una Stella discesa dal cielo,
di un fulgore superiore a quello del Sole; le stesse vesti dei sovrani
comprendevano una tiara e un abito cosparsi di stelle, un
abbigliamento che influenzerà non poco il crepuscolo di Bisanzio.
Sia a Roma che in Oriente, in epoca ellenistica, la Stella
diviene simbolo di un dio o di un re divinizzato, immagine della luce
che si coagula in una forma corporea. Nei Vangeli il configurarsi del
sapere astronomico e astrologico quale strumento verso la salvezza
non è unicamente relegato alla pericope dei Magi di Matteo: una
terminologia affine è rintracciabile in una enigmatica frase del
Battista, trascritta in Giovanni 3, 30: «bisogna che egli cresca e che io
diminuisca» (ekeinon dei auxanein, eme de elattousthai).
Ricongiungendoci a quanto detto prima, anche qui sembra ci si
riferisca al levare e al tramontare di una Stella, quella del Salvatore.
Il contesto astrale è confermato nella pericope successiva,
che sottolinea come «colui che giunge dal Cielo», cioè il Salvatore,
sia «superiore a tutti» (3, 31). Il verbo auxanō «accrescere, esaltare»
tradisce infatti un uso astrologico, ed è, in un contesto astronomico,
applicato alle fasi della Luna (Aristot. An. post. 78b 6); ricordando
che in Vettio Valente (2, 18) l’esaltazione di una data natività è
definita in ragione della posizione del Sole (diurna) e della Luna
(notturna). Lo stesso dicasi per elattoō «diminuire, sminuire», da cui
elattōsis «diminuizione, sminuimento», relato forse al tramontare
dell’astro.
IV. Magi gnostici
Dei quattro evangeli, quello attribuito a Giovanni a ragione
è ritenuto il più simbolico, ricolmo di insegnamenti genericamente
definibili come «gnostici», o comunque riconducibili al mondo
dell’antico gnosticismo.
Per gnosticismo (dal greco gnōsis «conoscenza») è da
intendersi un grande fenomeno religioso nel cui alveo sono confluite
le più svariate fascinazioni misteriche provenienti dal mondo
ellenistico e vicino-orientale, inclini a dimostrare un unico assunto:
la «discesa», la katabasis e l’imprigionamento nel nostro mondo di un
principio spirituale superiore, una scintilla luminosa che solo
attraverso la vera «conoscenza» l’uomo può riconoscere e ritrovare
in se stesso. Un tempo noto unicamente nelle fonti degli avversari,
cioè nei Padri della Chiesa che lo combatterono aspramente, anni
106
addietro ha avuto una nuova riscoperta grazie al ritrovamento,
nelle sabbie del deserto egiziano nei dintorni di Nag Hammadi
(l’antica Chenoboskion), di un’importante biblioteca in lingua copta.
Dei testi anteriori, quelli avversati dai Padri della Chiesa, uno tra i
più significativi è il Kata pasōn aireseōn elenchos di Ippolito di Roma (m.
nel 235 d.C.), la «Confutazione di tutte le eresie», come traducono
gran parte delle edizioni. Fra le 33 «eresie» gnostiche confutate, un
posto di rilievo è tenuto da uno dei più antichi gnostici, Basilide, la
cui scuola fiorì ad Alessandria d’Egitto ai tempi di Adriano e
Antonino Pio (ca. 120-140 d.C.) e fu continuata dal figlio Isidoro.
Secondo Ippolito, Basilide e suo figlio insegnavano una
disciplina arcana che il Salvatore stesso aveva comunicato
segretamente al discepolo Mattia. Fondamento di questa dottrina è il
credo in un Dio che non esiste, un Dio che non è (ouk ōn), un nonessente che «senza pensiero, senza sensibilità, senza volontà, senza
divisamento, senza passione, senza desiderio», crea il seme del
mondo (tēn tou kosmou panspermian). Un seme che si divide in tre parti
o «filialità» (hyiotēs): una sottile, una spessa, una bisognosa di
purificazione. Mentre le prime due tornano nel Dio che non è, la
terza resta in basso, nel «grande ammasso della semenza», da cui
trarranno origine gli Arconti facitori dell’universo.
Tra le opere che circolavano sotto il nome di Basilide, una
era probabilmente un’esegesi dei Vangeli in 24 libri. Commentando
il passo del Vangelo di Giovanni nel quale Gesù sostiene che «la sua
ora non è ancora giunta» (2, 4), Basilide vi ritrova un’allusione al
determinismo astrale (Hipp. Ref. 7, 27, 5).
Ogni cosa ha il suo tempo, è stata preordinata: così i Magi
hanno visto una Stella concepita, «prescelta» (prolelogismenos) sin
dall’inizio nel grande ammasso della semenza. Tutto è stato
preordinato: dalla nascita degli astri (genesin asterōn) alla restaurazione
finale (apokatastasis). I Magi sarebbero quindi i prescelti nel cogliere
questi segni celesti, esegeti di un libro scritto sin dalle origini del
mondo, il cui alfabeto sono gli astri stessi.
L’abilità astromantica dei Magi è ribadita dai seguaci di
Valentino, l’unico gnostico, assieme a Basilide, a parlare dei Magi
evangelici. Il testo di riferimento sono gli Estratti di Teodoto, una
silloge di sentenze valentiniane nota attraverso l’opera confutatoria
di Clemente Alessandrino.
Il tempo e il destino sono stabiliti sin dall’inizio, quale
ordito in cui si intrecciano le sorti, un tessuto fatale che prende il
107
nome di Heimarmenē. Ecco perché le predizioni astrologiche, gli
apotelesmata si avverano (Ex. Theod. 75, 1).
Gli astrologi predicono eventi futuri e compongono trattati
cui sovente danno il nome di apotelesmatika, poiché sono degli
apotelesmatologoi. Certo non potrebbero compiere predizioni se non
ritenessero gli astri apotelestikoi, «che conducono ad un fine,
produttivi»: un pianeta o una stella è ritenuto apotelestikos proprio in
quanto produce e conduce a effetto una cosa o un evento. Gli astri,
nella loro azione a distanza, determinano, producono gli eventi
terreni. Non a caso esistono degli Apotelesmatika, «Sull’influsso degli
astri», ascritti all’autorità di Zoroastro. A causa del suo nome,
Zoroastro (Zōroastrēs) è ritenuto dai Greci legato agli astri; una finta
etimologia che ne giustifica l’appellativo di astrothutēs, «adoratore di
astri», e che sin dal IV sec. a.C. stabilisce un nesso fra il grande
profeta iranico e le stelle. Zoroastro è così ritenuto una sorta di
mentore o di decano degli astrologi.
Quindi secondo Valentino i Magi, in quanto apotelesmatologoi,
non solo videro la Stella ma conobbero la Verità (alēthes egnōsan)
inscritta nei cieli (Ex. Theod. 75, 2): il Re di coloro che onorano il
vero Dio era stato partorito (basileus etechthē). La verità oroscopica
coincideva con quella salvifica.
Che gli gnostici Valentiniani conoscessero e praticassero la
disciplina astrologica, lo confermano sempre gli Estratti di Teodoto
(71, 1-2): le Potenze che hanno creato il mondo, muovono un
complesso meccanismo oscillatorio al cui centro stanno i Dodici
segni dello Zodiaco e i Sette Pianeti. La congiunzione (synodeuō),
l’opposizione, il levare (anatellō) e il tramontare di questi astri, cioè
l’«oroscopo», tracciano il «movimento dell’essenza» (kinēsin tēs ousias)
in vista della generazione del cosmo, dell’uomo e di tutti gli esseri
che lo abitano in balia della legge del divenire.
S’è detto come la pericope di Matteo modelli l’arrivo dei
Magi sulla visita della regina di Saba a Salomone nel Primo Libro dei
Re (10, 1-13): la vergine che gli lascerà un figlio spirituale. Idea
presente in un trattato gnostico di Nag Hammadi, l’Apocalisse di
Adamo, una rivelazione di Adamo al figlio Seth sulla venuta di un
Phōstēr, un «Illuminatore», destinato a sconfiggere le forze del male, a
ristabilire il regno paradisiaco in terra, il quale si manifesta e «sorge»
sull’acqua.
Il suo avvento è annunciato da una serie di «regni»; il terzo e
il quarto (V, 78, 19-79, 19) ne descrivono il concepimento:
108
Salomone cerca e trova una «vergine» (parthenos) dalla quale avere
una posterità. La donna, incinta, è cacciata dalla città e si rifugia nel
deserto, dove partorisce l’«Illuminatore». L’Apocalisse di Adamo
sembra ritrascrivere la leggenda iranica dell’eroe Farīdūn (Dēnkard,
cap. 7) e del Re-Drago che lo vuole uccidere alla nascita perché un
sogno ne rivela il pericolo. Tradizione già nota agli gnostici Sethiani,
che riformulavano la lista dei Salvatori in base a quella pre-sasanide
degli eroi portatori della «gloria», lo xvar nah-, il potere fulgureo.
Il Phōstēr dell’Apocalisse di Adamo è rivestito di «gloria e
forza» divine. Il termine «gloria» (doxa) ha qui il valore di
«splendore», la «forza luminosa», lo xvar nah- che nella soteriologia
iranica è intimamente legato allo stesso profeta Zarathuštra: secondo
una tradizione, nelle acque del lago Kąsaoya sarebbe celato il seme
del Profeta, da cui nascerà il Saošyant- (> pahlavi Sōšyans), il
Salvatore futuro, letteralmente «Colui che farà prosperare»,
l’operatore della frašōk r ti (> pahlavi frašgird), la trasfigurazione del
mondo che si compirà al termine dell’ultimo ciclo cosmico.
L’astro luminoso è quindi il segno tangibile di questo
avvento.
Circondata da un corteggio di creazioni o entità luminose
che possono essere reinterpretate come il succedaneo gnostico dei
Magi evangelici, la Stella di Luce fa la sua comparsa in uno dei più
lunghi trattati di Nag Hammadi, la Parafrasi di Sēem, uno scritto la cui
natura intricata fa pensare che si tratti di un commentario a una
perduta «Apocalisse di Sem» menzionata nel Codice Manicheo di
Colonia. La Stella è presentata come l’indomabile vestimento del
Sōtēr:
«... E la Stella di Luce è la mia veste invincibile che indossai nell’Ade; essa
è la grazia sovrastante l’intelletto, la testimonianza di chi ha visto; la prima e
l’ultima, la Fede, l’intelletto del vento di tenebra» (VII, 33, 17-26).
La Stella di Luce è la veste invincibile del Salvatore
Derdekeas, che richiama il paidion del Vangelo di Matteo 2, 9: una luce
aurorale che si leva prima del sorgere eliaco e dove l’Anatolē è il suo
termine tecnico; è l’alfa e l’omega, inizio e fine di un frammento
divino che degradato brilla nelle tenebre. Lo stesso uso ricorre in
precedenza nello stesso testo a indicare la costituzione di un corpo
magico edificato sulle rovine del corpo fisico.
109
Bibliografia essenziale:
E. ALBRILE, «La caverna dell’esilio. Momenti della religione iranica
nel mondo aramaico», in Orientalia Christiana Periodica, 75 (2009), pp.
157-174.
D.W. BOUSSET, «Der Gott Aion», in Religionsgeschichtliche Studien.
Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters (Novum
Testamentum Supp. L), hrsg. A.F. VERHEULE, Leiden 1979, pp.
192-230.
M. BUSSAGLI, I Re Magi. Realtà storica e tradizione magica (in
collaborazione con M. G. Chiappori), Milano, 1985.
J. DUCHESNE-GUILLEMIN, «Jesus’ Trimorphism and the
Differentiation of the Magi», in E.J. SHARPE-J.R. HINNELLS (eds.),
Mand and his Salvation. Studies in memory of S.G.F. Brandon, Manchester
1973, pp. 91-98.
M. LE GLAY, s.v. «Aion», in LIMC, I/1, Zürich – München 1981,
pp. 399-411; I/2, pp. 404-405.
GH. GNOLI, «L’évolution du dualisme iranien et le problème
zurvanite», in Revue de l’Histoire des Religions, 201 (1984), pp. 115-138.
H.M. JACKSON, The Lion Becomes Man. The Gnostic Leontomorphic
Creator and the Platonic Tradition (SBL Dissertation Series, 81), Atlanta
(Georgia) 1985.
A. MAGRIS (cur.), ‘Ippolito’. Confutazione di tutte le eresie (Letteratura
Cristiana Antica – Nuova serie, 25), Brescia 2012.
G. MESSINA, I Magi a Betlemme e una Predizione di Zoroastro (Sacra
Scriptura Antiquitatibus Orientalibus Illustrata, 3), Roma 1933.
U. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici
(Studi e Testi, 163), Città del Vaticano 1952 (repr. 1973).
L. OLSCHKI, Marco Polo’s Asia. An Introduction to his «Description of the
World» called «Il Milione», Berkeley-Los Angeles 1960.
A. PANAINO, I Magi e la loro Stella, Milano 2012.
J. ROBINSON (ed.), The Nag Hammadi Library in English, Second
edition, Leiden 1984.
G. SCARCIA, «I Magi Afghanizzati», in GH. GNOLI- L. LANCIOTTI
(cur.), Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata (Serie Orientale Roma,
LVI/3), IsMEO, Roma 1988, pp. 1295-1304.
M. SIMONETTI (cur.), Testi gnostici in lingua greca e latina, Milano 1993.
M.J. VERMASEREN, «A Magical Time God», in J.R. HINNELLS (ed.),
Mithraic Studies, I, Manchester 1975, pp. 451 ss.
110
G. WIDENGREN, Die Religionen Irans (Die Religionen der
Menschheit, 14), Stuttgart 1965.
W. WITAKOWSKI, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tell-Maïr‡.
A Study in the History of Historiography (Studia Semitica Upsaliensa, 9),
Uppsala 1987.
R.C. ZAEHNER, Zurvān. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955 (repr.
New York 1972).
111
112
L’arcana bellezza della scrittura nella Cina antica
Un percorso attraverso significativi reperti fittili di scavo
dall’uguaglianza del Neolitico alle successive diversità fino
alla dinastia Ming
Domenico Appendino
Le lontane origini e la lunga storia della scultura nella Cina antica,
fanno di quest’arte, che annovera capolavori considerati tra i
migliori del mondo, una componente essenziale della cultura cinese.
All’interno di questa produzione, caratterizzata durante tutta la sua
evoluzione da stili sempre di forte vigore espressivo, le opere in
terracotta occupano uno dei capitoli più significativi e costituiscono
una parte fondamentale di questo grande patrimonio artistico.
La scultura fittile è un’arte che affonda le sue radici nella
produzione di manufatti di utilizzo quotidiano: nel periodo neolitico
l’invenzione e l’uso di recipienti di terracotta non solo fu
determinante per il miglioramento della vita umana, ma allo stesso
tempo contribuì allo sviluppo dell’agricoltura ed all’allevamento
degli animali. Nella realizzazione in terra di vasi, giare, pentole e
tripodi, l’uomo cominciò a dominare la natura e l’uso della argilla, e
le capacità pratiche che sviluppò nella produzione degli oggetti
comuni furono determinanti nel formare e migliorare gradualmente
una tecnica che a poco a poco divenne una vera e propria forma
d’arte, la scultura.
Il Neolitico in Cina copre l’ampio arco temporale che si estende
convenzionalmente dall’8500 al 1700 a.C. ed è caratterizzato da varie
culture contemporanee, nate e sviluppatesi in diverse aree del grande
territorio cinese.
L’archeologia cinese è relativamente recente e solo in questi
ultimi decenni, archiviati gli eccessi del maoismo e la rivoluzione
culturale, le ricerche sono state riprese in modo sistematico,
portando alla luce diversi siti neolitici e contribuendo all’evoluzione
ed al completamento della ricostruzione storica di questo lungo
periodo ancora largamente sconosciuto. Alcune ricerche tuttora in
corso stanno cercando di definirne il quadro completo, tuttavia si
possono oggi delineare con chiarezza due grandi aree distinte: una al
nord, caratterizzata dalla cultura delle varie qualità del miglio, tipica
113
del clima secco di queste regioni, e l’altra nei territori umidi e
piovosi del sud, basata essenzialmente sulla cultura del riso.
La prima civiltà neolitica di cui si è venuti a conoscenza è la
cultura Yangshao, scoperta nel 1921 nei pressi del villaggio
omonimo e databile tra il 5000 e il 2000 a.C.. Scavi successivi operati
in alcune province meridionali hanno tuttavia portato alla luce
reperti risalenti addirittura al X millennio a.C., mentre a nord, lungo
il fiume Liao, per trovare le prime civiltà occorre giungere all’8500
a.C.. Il grande sviluppo si ebbe, però, nel centro nord, in un grande
complesso di aree intorno al fiume Giallo, la cui distribuzione
geografica attraversa tutta la Cina da ovest ad est.
Il ritrovamento dei corredi funerari risalenti a questo periodo
rivela la presenza di una forma di religione che, oltre a praticare un
complesso di cerimonie e rituali purtroppo a noi sconosciuti,
credeva nell’esistenza di un mondo ultraterreno. Inoltre
l’appartenenza ad alcune sepolture di ossa animali, impiegate per la
divinazione, indica la presenza di una struttura gerarchica della
società dominata dall’autorità religiosa.
In questo periodo i recipienti di terracotta più antichi (figura 1)
hanno una forma molto semplice, focalizzata sulla funzionalità
dell’oggetto più che sugli elementi estetici o formali; tuttavia non di
rado questi reperti sono arricchiti con alcune decorazioni che, per
quanto poco ricercate, mostrano una indiscussa efficacia. Nella
maggior parte dei casi la superficie dell’oggetto subisce un semplice
processo di pittura, ma su alcuni di essi i disegni vengono anche
incisi, stampati o intagliati.
E’ sorprendente la somiglianza di questi reperti con quelli coevi
delle civiltà mediterranee (figure 2 e 3): nella sua fase iniziale la
cultura dell’uomo primitivo è semplice e focalizzata sugli aspetti
essenziali della vita, non si infatti è ancora sviluppata alcuna
specificità legata al territorio o alla precedente ancor brevissima
storia del gruppo etnico di appartenenza, per cui i manufatti e le
espressioni artigianali “proto artistiche” sono simili ovunque.
In Cina l’idea di scultura in senso più completo si affaccia
solamente in alcuni rari reperti realizzati con una forma che inizia ad
allontanarsi dal modello strettamente funzionale: è di questo tipo il
bellissimo pezzo appartenente alla cultura Yangshao di figura 4, un
vaso i cui tratti antropomorfi vanno a sostituire i canoni
strettamente funzionali che si riscontrano negli altri reperti di questo
periodo; le fattezze umane corrispondono probabilmente a quelle di
114
uno sciamano, ovvero il capo spirituale delle antiche comunità
neolitiche, al quale era riservata la pratica della divinazione.
Proprio nelle opere neolitiche, per quanto semplici possano
apparire, vanno ricercate le origini della scultura fittile cinese; le
recenti scoperte archeologiche confermano ulteriormente che molte
qualità di ceramica, ritenute fino a poco tempo fa originarie di
periodi successivi come le dinastie Shang o Zhou, comparvero
invece nel Neolitico sia come foggia che decorazione.
Verso la fine del III millennio a.C. iniziò la lavorazione di metalli
quali il rame, l’oro, l’argento e infine il bronzo. In Cina l’Età del
bronzo comprende tre importanti dinastie succedutesi fino al III
secolo a.C.: la dinastia Xia dal XXI al XVI secolo a.C., alla quale
successe la dinastia Shang, perpetuatasi fino al XI secolo a.C. e
seguita dagli Zhou Occidentali ed Orientali. Gli Zhou Orientali
tuttavia, nell’ultimo periodo, regnarono solo in una parte della Cina,
dal momento che in alcune zone si affermò, nei periodi chiamati
Primavere ed Autunni (770 - 476 a.C.) e Stati Combattenti (475 221 a.C.), la dominazione di diversi sovrani di altre dinastie. Questi
governi, per la loro continuità ed affinità, nel loro insieme sono
accomunati dagli storici come un unico periodo chiamato appunto
“Tre Dinastie”.
Il passaggio dal Neolitico all’Età del bronzo avvenne senza
traumi e con continuità di sviluppo in seno alla cultura Longshan
nelle regioni centrali della Cina. L’Età del bronzo è un periodo
caratterizzato da grandi innovazioni che la storiografia antica ha
idealizzato con miti e racconti fantastici. Apparterrebbero infatti a
questo periodo figure come Sui Ren, l’inventore del fuoco, Xi,
inventore della caccia, della pesca, dell’allevamento degli animali
domestici, e persino della scrittura e della musica, Shen Nong,
creatore dell’agricoltura e della medicina, Huangdi, famoso anche
come il mitico Imperatore Giallo, cui viene attribuita l’invenzione
della ruota, del calendario e della bussola.
Il potere sembra fosse nelle mani di saggi-sovrani dotati di
ineccepibili caratteristiche morali e grande saggezza; in realtà la
società stava subendo un processo di sempre più forte
differenziazione e durante la dinastia Shang era dominata da una
classe politica costituita da sacerdoti-sciamani i quali derivavano il
proprio potere dalla facoltà di comunicare con i propri antenati e
con l’Ente Supremo o Signore dell’Alto; in qualità di intermediari
con il trascendente, identificato con il Cielo o con il Supremo
115
Antenato del clan reale, gli sciamani si consideravano partecipi
della stessa natura divina. L’interesse magico-religioso fu dunque di
primaria importanza e condizionò positivamente lo sviluppo delle
tecniche di lavorazione dei metalli, che trovarono le loro prime
importanti applicazioni proprio nella realizzazione degli oggetti
rituali; solo in seguito le nuove tecnologie furono applicate nelle
produzioni agricole e belliche, la cui superiorità portò questa dinastia
ad un lungo predominio su tutti i popoli confinanti, considerati
barbari, dai quali proveniva un gran numero di schiavi.
A causa dell’importanza della sfera religiosa, intesa appunto
come rapporto con la divinità realizzato tramite gli antenati e la vita
ultraterrena, durante l’Età del bronzo le tombe conobbero una
profonda evoluzione; infatti, mentre nel Neolitico le dimore ultime
erano costituite da piccole fosse scavate nel terreno, nelle quali
venivano deposti con la salma alcuni utensili e recipienti in
terracotta contenenti i cibi e le bevande ritenuti necessari al defunto
nell’altra vita, durante l’Età del bronzo le sepolture raggiunsero
dimensioni notevoli, e furono dotate di corredi funebri molto
imponenti.
Oltre a depositare nella sepoltura i beni più preziosi del defunto
e gli oggetti necessari per le funzioni cerimoniali che il suo rango
richiedeva, in questo periodo si intensificò notevolmente l’abitudine
di seppellire anche delle vittime sacrificali. Queste ultime
appartenevano a due categorie: le spoglie delle figure che erano state
vicine all’illustre defunto nella vita, quali congiunti, servitori e
soldati, erano collocate intorno alla sua salma, con lo scopo di
continuare a servirlo e difenderlo nell’Aldilà, mentre più lontano e di
solito in fosse perimetrali esterne alla sepoltura principale, era
inumato un numero adeguato di schiavi e prigionieri di guerra,
normalmente sacrificati per decapitazione e di fatto equiparati alle
vittime animali. Il numero di animali inumati col defunto cui
appartenevano, quali cavalli, cani e talvolta anche pollame,
dipendeva dall’importanza del rango del defunto stesso e non
costituiva una novità, in quanto l’usanza era già diffusa durante la
precedente dinastia Xia, tuttavia la quantità delle vittime sacrificali
Shang è veramente impressionante e questa macabra pratica, tipica
di una società schiavista, superò i confini temporali della dinastia per
proseguire ancora durante gli Zhou.
Tuttavia oltre alle vittime sacrificali umane, sono state trovate
nelle tombe anche figure di uomini e animali realizzate in pietra,
116
giada o terracotta, usate appunto come offerte funebri; esse,
escludendo quelle neolitiche prima citate, costituiscono certamente i
più antichi reperti di scultura in terracotta sino ad ora rinvenuti in
Cina (figura 5).
Queste figure se viste vicino a quelle appartenenti a culture coeve
dell’area mediterranea cominciano a delinearsi con elementi stilistici
e iconografici diversi (figura 6) ma non così distanti come invece
avverrà nei periodi storici successivi.
Tuttavia in questi anni la presenza di figure in terracotta o pietra
accanto alle vittime sacrificali umane non sembra per nulla generata
da compassione o comunque da necessità o desiderio di ridurre il
numero delle vittime, quanto piuttosto dalla supposizione che ciò
fosse dovuto alla volontà di fornire al morto per l’Aldilà più schiavi
di quanti se ne potesse permettere nella sua vita terrena. La presenza
di queste statue, cui venne dato il nome di “oggetti dello spirito”
(“mingqi”), era una sorta di aggiunta al sacrificio tradizionale,
apportata allo scopo di onorare maggiormente il defunto. Perché si
avverta la necessità, e di conseguenza ne entri in uso il concetto, di
sostituire i sacrifici funebri con figure di terracotta, bisogna
attendere il completamento della transizione da società schiavista a
società feudale, avvenuta intorno al 500 a.C., dopo i periodi
Primavere ed Autunni e Stati Combattenti.
Inoltre nell’ultimo periodo dell’Età del bronzo il potere centrale
perse il suo valore carismatico e divino, in quanto il proliferare di
poteri periferici sempre più forti ne mise in discussione la legittimità,
fino a distruggerlo completamente, tanto che l’imperò fu riunificato
solo in seguito, sotto la breve dinastia Qin. Fu questo un periodo di
confusione spirituale ed ideologica in cui si sentirono forti istanze
morali, le quali portarono a nuovi riferimenti ricercati in valori etici
ed intellettuali. Mentre le pratiche divinatorie stavano sempre di più
perdendo il loro significato, e di conseguenza la loro importanza, si
formarono nuove culture, religioni e scuole di pensiero: fu allora che
nacquero le grandi correnti filosofiche, culturali e religiose della Cina
antica, le famose “Cento Scuole”, tra cui il confucianesimo ed il
taoismo, apparse nella fase iniziale come dottrine filosofiche e
quindi gradualmente sviluppatesi anche come religioni. E’
interessante notare che lo sviluppo culturale del periodo fu globale:
esso non riguardò solo religione, politica, etica e società, ma
coinvolse profondamente anche le tecnologie in genere, ed in
particolare la lavorazione dei metalli. Fu infatti tra il VI e il V secolo
117
a.C., che in Cina la tecnologia dei metalli permise la fusione del
ferro e presto si arrivò alla produzione della ghisa e dell’acciaio: è
interessante notare come in Occidente si sia giunti alle stesse
conoscenze più di un millennio dopo.
Anche l’introduzione dell’uso dei mingqi al posto delle vittime
sacrificali umane, costituisce dal punto di vista sociale e culturale un
segno fondamentale della grande e profonda metamorfosi storica in
atto durante il periodo. Questo cambiamento ebbe un’importanza
sostanziale soprattutto nell’evoluzione dell’arte antica cinese,
generando e portando allo sviluppo la scultura delle figure in
terracotta, diventate, sulla spinta della grande richiesta che si stava
generando, una pratica assai più diffusa rispetto ai secoli precedenti,
quando essa costituiva in genere un fatto anomalo o eccezionale. La
completa sostituzione dei sacrifici umani ed animali con i mingqi fu
quindi una pratica innovativa ed importante che, quando i grossi
cambiamenti etico-culturali lo consentirono, permise un notevole
risparmio della forza produttiva di allora, ovvero gli schiavi; non a
caso questa “rivoluzione” si sviluppò parallelamente al
miglioramento della condizione sociale degli schiavi e può essere
considerata la definitiva testimonianza dell’avvenuta transizione da
società schiavista a feudale.
Non è quindi un fatto casuale che, circa cento anni dopo,
quando gli eserciti della dinastia Qin guidati dal re Ying Zheng
riunificarono l’impero, sia stato realizzato un imponente mausoleo
in onore del loro condottiero, divenuto l’unico grande imperatore
della Cina assumendo il prestigioso nome di “Primo Augusto
Imperatore”. Il mausoleo è una delle opere d’arte più famose nel
mondo intero, pur essendo stato scoperto soltanto da poco più di
un quarto di secolo a Lintong, trentacinque chilometri ad est di
Xi’an. Si tratta della celeberrima armata di terracotta (figure 7 e 8),
che conta all’incirca settemila guerrieri e seicento cavalli in
dimensioni naturali: gli uomini sono infatti di altezza compresa tra
centottanta e centonovantacinque centimetri, mentre i cavalli sono
alti mediamente centocinquanta centimetri e lunghi duecento.
Quest’opera rappresenta una pietra miliare e forse il più grande
riferimento nella storia dell’arte cinese.
Dal punto di vista tecnico, uomini e cavalli sono ben
proporzionati e mostrano una certa conoscenza dell’anatomia; le
componenti principali delle figure sono state realizzate con stampi e
quindi riunite per poi essere finemente scolpite, cotte ed infine
118
dipinte. Gli scultori e gli artigiani che hanno partecipato alla
realizzazione di queste statue hanno sfruttato tutte le loro capacità
tecniche e stilistiche per creare delle figure realistiche, ispirandosi ai
veri soldati dell’armata Qin: in esse gli artisti hanno catturato ed
immortalato aspetti, atteggiamenti, umori e sensazioni dei soldati di
tutte le età, gerarchia e regioni dell’impero, incluse le minoranze
etniche. Alcuni soldati appaiono solenni e dignitosi, altri calmi e
composti, altri ancora coraggiosi ed intelligenti; dal volto dei più
anziani si percepisce grande esperienza e prudenza, mentre da quello
dei più giovani emergono ingenuità ed entusiasmo. Gli artisti non
hanno solo dato molta importanza alla rappresentazione delle forme
dei personaggi, ma si sono anche preoccupati di caratterizzare
ciascuna figura con un proprio carattere e uno specifico mondo
interiore. Lo stile quindi non è da considerarsi puramente realistico,
in quanto si avverte un attento studio del carattere e delle sensazioni
che lo scultore immagina nella sua creatura e alle quali pare
partecipare con profondità ed attenzione. Tuttavia ogni statua non
rappresenta un individuo ma un gruppo, una categoria, un etnia o
un livello gerarchico e questo si percepisce con immediatezza da un
esame di questi reperti ma ancor più se si tenta un confronto con
una statua coeva appartenete alla cultura del nostro paese (figura 9).
Il breve (221 - 206 a.C.) ma importantissimo regno del Primo
Augusto Imperatore pose le fondamenta dell’impero cinese: le leggi
e l’ordinamento del principato di Qin furono estese a tutte le
popolazioni conquistate e il territorio dell’impero fu suddiviso in
governatorati e distretti, furono unificati scrittura, sistema
monetario, unità di misura ed addirittura la distanza fra le ruote
(scartamento) di tutti i carri dell’impero. Il codice promulgato
rappresentò il fondamento della legislazione dell’impero per venti
secoli e in questo periodo furono avviate grandiose opere pubbliche
civili e militari come la rete stradale e la Grande Muraglia.
Poco dopo la morte del Primo Augusto Imperatore scoppiò una
rivolta popolare e si passò alla prima dinastia Han (Han Occidentali)
la quale ebbe la capacità e il merito di continuare l’opera della
precedente dinastia in tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e
culturali. Questo rese possibile l’espansione dell’impero, e il suo
rafforzamento portò un notevole benessere economico e sociale. Le
grandi opere pubbliche furono continuate: nel 150 d.C. la rete viaria
giunse ad un’estensione di seimila chilometri, con strade che in
alcuni casi raggiungevano i ventitré metri di larghezza ed erano
119
dotate di una corsia centrale, lastricata in pietra, dedicata
esclusivamente a corrieri e funzionari. Nel 129 a.C. fu terminata una
grandiosa opera di scavi che, estendendosi per un centinaio di
chilometri di lunghezza, collegava il fiume Giallo e il fiume Wei; la
costruzione della Grande Muraglia continuò fino a farle raggiungere
una lunghezza di cinquemila chilometri. La soppressione delle
ribellioni interne e un’efficace opera di prevenzione da parte del
potente esercito nei confronti dei potenziali invasori portarono ad
una situazione di pace sostanzialmente stabile e duratura che
consentì al potere centrale imperiale il consolidamento definitivo
della sua struttura amministrativa.
La continuità politica che il regime feudale centrale, ormai
stabile, seppe mantenere e l’alto livello tecnico raggiunto sia
nell’artigianato che nell’agricoltura, furono motori di un grande
sviluppo in tutte le discipline, tra cui anche le arti, con un processo
che continuò anche nella seconda dinastia (Han Orientali). Sono di
questo periodo molte importanti invenzioni, come il sismografo ed
altri strumenti scientifici di cui facciamo uso ancora oggi; inoltre,
grazie alle scoperte archeologiche degli ultimi decenni, è ormai certo
che la carta, conosciuta dagli Arabi solo nel VIII secolo d.C. e dagli
Europei nel X secolo, fu inventata in Cina intorno al I secolo d.C..
Prodotta con fibre di canapa o di seta, conobbe in breve tempo una
grande diffusione in tutto l’impero.
Un altro evento che caratterizzò profondamente questi tempi, sia
da un punto di vista storico-culturale che sotto il profilo artistico, fu
l’apertura della famosa “Via della Seta”, avvenuta proprio in questo
periodo. Infatti gli artisti ebbero l’opportunità di essere investiti da
una ventata di continue novità provenienti dai paesi con cui la Cina
intratteneva contatti commerciali o culturali: nuovi modelli e
soggetti, importati da altre popolazioni, potevano più velocemente
insinuarsi quali nuovi temi nelle espressioni artistiche, causando
originali e singolari sviluppi che interessarono anche la scultura
fittile.
La prima dinastia Han, detta dinastia degli Han Occidentali dalla
sua area geografica di origine, perpetuò la pratica funeraria di dotare
le tombe di un gran numero di figure nelle sepolture. In questo
periodo il taoismo aumentò gradualmente la sua influenza, ma lasciò
ampio spazio alle precedenti pratiche religiose ed al mondo degli
spiriti, mantenendo la credenza dell’Aldilà e di conseguenza le
sepolture e le arti funerarie continuarono ad avere una grande
120
importanza. A causa di queste abitudini sono stati ritrovati un gran
numero di figure in terracotta raffiguranti guerrieri, cavalieri, cavalli,
carri, servitori di sesso femminile o maschile, danzatrici, musici
(figura 10), acrobati, cantastorie e giullari; sono anche state ritrovate
molte altre figure zoomorfe di ogni tipo rappresentanti animali
domestici e volatili, tra i quali, oltre ai cavalli, figuravano anche buoi,
oche, cani, maiali, galline, anatre. Un’altra tipologia ricorrente di
sculture tombali del periodo è costituita dai modelli architettonici in
terracotta raffiguranti le proprietà del defunto: sono stati ritrovati
modelli di case, cascine, porcili, torri, granai, forni, cucine,
imbarcazioni, magazzini.
Una delle sepolture più famose ed importanti di questo periodo è
il complesso tombale del mausoleo del primo imperatore della
dinastia, Liu Bang. In sei fra gli scavi di questo vasto gruppo di
sepolture, appartenenti tutte a membri della famiglia imperiale o ad
importanti personaggi dell’aristocrazia di corte, sono stati ritrovati
circa seicento cavalieri, ciascuno in sella al proprio cavallo; nei
rimanenti cinque invece sono stati rinvenuti circa duemila fanti ed
un solo comandante che, in piedi, impartisce ordini al suo
sterminato esercito di terracotta. Queste bellissime sculture, di cui
molte hanno conservato buona parte della colorazione originaria,
sono decisamente più piccole di quelle del mausoleo del primo
grande imperatore Qin. Così le statue che rappresentano i fanti
hanno altezza compresa tra quaranta e cinquantacinque centimetri e
le statue equestri raggiungono settantacinque centimetri al massimo,
compreso il cavaliere. Molti di questi reperti hanno conservato in
numerose parti la colorazione originaria, fatto che li rende molto
importanti sia artisticamente che storicamente, in qualità di
testimonianze molto accurate e precise dei costumi del periodo.
Oltre alle sepolture della famiglia imperiale, sono state ritrovate
moltissime tombe dello stesso periodo appartenute a personaggi
meno elevati per rango o posizione sociale, provenienti appunto da
classi, che iniziando proprio da questa dinastia, presero a curare con
particolare attenzione la propria tomba, con interesse pari a quello
dei membri della famiglia imperiale. I reperti provenienti da queste
sepolture, per quanto più poveri, sono altrettanto importanti dal un
punto di vista storico, poiché consentono agli archeologi di
conoscere almeno alcuni particolari della vita comune di quell’epoca,
ricavando dalle fogge delle sculture in terracotta alcuni degli usi, dei
modi e dei costumi della gente meno importante; infatti in essi è
121
focalizzata l’attenzione su soggetti che gli storici hanno quasi
sempre disdegnato o dimenticato, non solamente in Cina, prestando
attenzione e documentando solo i personaggi più famosi ed i grandi
eventi di ogni epoca.
Le figure Han rappresentano stilisticamente una logica
prosecuzione di quanto manifestatosi nella scultura Qin, anche se il
realismo delle grandi opere tende a stemperarsi, almeno nelle figure
minori, in una ripetizione di specifici modelli. Oltre a questo
impoverimento tematico si riscontra anche una tendenza alla
semplificazione stilistica che attraversò tutto il periodo e diventò più
marcata durante il periodo degli Han Orientali, dinastia che è
succeduta alla precedente dopo il breve regno di Wang Mang (9 - 24
d.C.). In questo periodo le forme diventarono più semplici e meno
curate, in alcuni casi addirittura solo abbozzate, anticipando quella
che da molti è considerata la “decadenza” che si manifestò dopo la
fine di quest’epoca. Tuttavia esistono alcune sculture, ritrovate in
varie sepolture vicino a Chengdu e risalenti alla dinastia degli Han
Orientali, i cui volti sprigionano incredibile allegria ed amore per la
vita. Il loro corpo però ha completamente perso il senso delle
proporzioni e si presenta per lo più sgraziato, talvolta addirittura
informe, ma questo non inficia la loro bellezza, che è ispirata a
canoni nuovi e diversi (figura 11). Si tratta di sculture stilisticamente
molto diverse da quelle della prima dinastia Han, nelle quali gli
artigiani espressero la loro vena artistica con un linguaggio nuovo:
l’esagerazione degli atteggiamenti della figura e la trascuratezza tanto
delle proporzioni quanto dell’anatomia, incentrano l’attenzione sulla
forza espressiva dei visi, dai quali sembra sprigionarsi tutta la loro
forza e liricità.
Queste sculture chiudono un periodo che, per la quantità e la
bellezza delle opere prodotte, è considerato secondo forse solo al
famosissimo successivo periodo Tang: le figure in terracotta Han,
duemila anni dopo, rappresentano un mondo di immagini che ci ha
riportato, nelle sue forme e nei suoi colori, la vita e le abitudini della
potente dinastia che ha in modo definitivo consolidato il più
duraturo e grande impero della storia dell’uomo. Nella
schematizzazione classica della storia dell’arte cinese, la dinastia Han
è generalmente riconosciuta come il primo grande periodo della
scultura fittile, cui hanno fatto riferimento tutti i successivi in
termini di ispirazione, soggetti, iconografia e confronto. Dopo le
dinastie Han dovranno trascorrere quasi quattro secoli per ritrovare
122
un periodo, la dinastia Tang appunto, in cui le sculture in terracotta
tornino ad avere diffusione, importanza e bellezza comparabili.
La caduta dell’impero Han, avvenuta nel 220 d.C., fu seguita da
un periodo di continui conflitti fra le trenta diverse dinastie che nei
seguenti trecentosettanta anni contesero tra di loro il potere. Non è
facile schematizzare l’evoluzione degli eventi, tuttavia si può
sommariamente riassumere questo arco temporale descrivendo
l’impero cinese come diviso in due: nella parte settentrionale le
dinastie del nord, popolazioni nomadi “non Han”, cioè di origine
non cinese, provenienti dalle steppe del nord, e nella parte
meridionale le dinastie del sud, popolazioni con usi e costumi
tradizionali cinesi, la cui capitale fu trasferita a Nanchino. Questa
divisione non ebbe solo un significato politico, ma anche culturale e
religioso: ne conseguirono infatti differenti abitudini funerarie e
diverse sensibilità artistiche. Durante le dinastie degli Han il taoismo
aveva perso gradualmente importanza, lasciando sempre più spazio
al confucianesimo, che divenne la religione ufficiale; tuttavia il crollo
dell’unità imperiale in questi anni causò nuovamente una profonda
confusione ideologica. Un’altra religione, il buddismo, introdotto
dall’India durante il I secolo d.C. trovò in questo specifico momento
storico un fertile terreno per una grande e veloce crescita,
raggiungendo il suo culmine di diffusione e splendore culturale nella
prima fase della successiva grande dinastia Tang. La pratica di
inumare nel sepolcro del defunto molte figure di terracotta non
decadde sotto l’influenza del buddismo, ma subì comunque un
cambiamento che si concretizzò nella sensibile riduzione del
numero delle statue deposte. Nuovi influssi culturali arrivarono sia
da questa nuova religione che dai contatti con le popolazioni
confinanti le quali, per quanto tradizionalmente considerate
decadenti o barbare, ebbero senza dubbio una loro considerevole
influenza; si ebbe, di conseguenza, l’introduzione di alcune
importanti novità anche nell’arte funeraria, fra le quali alcune nuove
figure ed iconografie che entrarono nel mondo della scultura fittile.
Oltre alla presenza di cammelli, cacciatori e personaggi “non Han”
provenienti dalle steppe del nord, la più grossa novità comparsa in
questo periodo è rappresentata dai guardiani delle tombe: la
convinzione che nell’Aldilà esistesse un mondo parallelo popolato
anche da esseri demoniaci, fu infatti l’origine della presenza sempre
più frequente nelle tombe di immagini e statue protettive. Queste
figure, i guardiani della tomba, avevano lo scopo di difendere il
123
defunto da spiriti maligni e demoni, e inoltre potevano aiutare
l’anima spirituale nel suo viaggio ultraterreno. Si ricordi che in tutta
la storia cinese antica è sempre stata viva la convinzione che l’uomo
fosse dotato di due anime: quella spirituale, fonte del pensiero, della
creatività e della morale, avrebbe lo scopo di tornare al Cielo dopo la
morte, mentre quella materiale o corporea, sorgente della vita e del
movimento, dovrebbe tornare alla terra e perciò risiedere nel
sepolcro.
Parecchi studiosi hanno visto in questo periodo di transizione
molte analogie con il nostro Medioevo: la fine di un grande impero,
la decadenza di una civiltà ad esso connessa, il diffondersi di una
nuova religione totalmente estranea alla tradizione locale
proveniente da un’altra cultura e da un paese lontano, la pressione e
la conseguente invasione dal nord di popolazioni “barbare” con una
funzione almeno inizialmente distruttiva, non possono che ricordare
la caduta dell’Impero Romano, l’avvento del Cristianesimo, la
discesa dei barbari verso Roma e tutto l’insieme di rivolgimenti
sociali, politici e culturali che coincidono con l’inizio del Medioevo.
Anche l’analogia temporale è in un certo senso particolarmente
impressionante: in questo specifico momento storico due grandi
civiltà totalmente indipendenti e tra di loro sconosciute subirono il
medesimo destino.
E’ curioso ricordare che queste due civiltà sapevano ciascuna
dell’esistenza dell’altra, ma le reciproche conoscenze che esse
avevano, erano molto vaghe e indirette. Risulta che una sola volta
l’impero cinese avesse deciso di approfondire la sua cognizione,
durante la dinastia degli Han Orientali, quando fu organizzata una
spedizione per cercare di mettere il governo imperiale cinese in
contatto con il sovrano dell’altro grande impero occidentale. Gan
Ying, ufficiale dell’esercito imperiale che, durante una campagna
militare di espansione, giunse fino sul mar Caspio, fu incaricato nel
97 d.C. della missione. L’ufficiale tuttavia fallì completamente
perché astutamente fuorviato dai Parti, i quali temevano di perdere i
vantaggi derivanti dal controllo dei commerci che i due imperi
effettuavano tramite la Via della Seta che attraversava appunto il
territorio da loro controllato: di conseguenza fu destino che i due
più grandi imperi della storia non si conobbero mai direttamente.
Tornando tuttavia al periodo medioevale, mentre dalle spoglie
dell’Impero Romano nacque il sistema feudale, costituendo in
occidente una nuova e importante cultura, in Cina il periodo
124
compreso tra quello che alcuni studiosi chiamano il “Primo
Impero” dei Qin e degli Han ed il “Secondo Impero” dei Sui e dei
Tang, è da considerasi come una fase transitoria di un sistema
politico e culturale disgregatosi, ma solo in attesa di rigenerarsi
ancora. Infatti in occidente il sistema feudale nel medioevo
rappresentò la prima fase di una evoluzione sociale e culturale che si
è perpetuata e sviluppata, generando nuove forme di cultura ed
organizzazioni politiche differenti. Stati nazionali e comuni furono
sistemi sociali sconosciuti ed estranei alla Cina dove, pur con alterne
vicende, l’impero è invece durato fino al secolo scorso.
Nelle espressioni artistiche di questo periodo continua
l’involuzione stilistica e figurativa iniziata nella seconda dinastia
Han, arrivando ad elementi figurativi caratterizzati dalla
disgregazione di qualunque realismo e raffinatezza espressiva: chi
non conosce l’arte cinese, vedendo un’opera di questo periodo
accanto ad una scultura della dinastia precedente, è naturalmente
portato a crederla più antica perché stilisticamente più primitiva.
Tuttavia le forme di queste opere che, per continuare l’analogia con
la storia occidentale, si potrebbero chiamare “medioevali”,
conferiscono, nella loro semplicità ed ingenuità stilistica,
un’espressività immediata e profonda che si esprime in un fascino
del tutto particolare incentrato sulla loro essenzialità (figura 12).
Se torniamo a confrontare questa situazione con la nostra storia
dell’arte, è facile notare che certamente una scultura paleocristiana
prima e romanica poi è caratterizzata da uno stile meno appariscente
e ricco di un’opera classica romana: infatti durante le invasioni
barbariche si perdettero molte tecniche figurative ed espressive della
precedente cultura, caratterizzata da un linguaggio assai avanzato dal
punto di vista stilistico; tuttavia questa apparente regressione è
confinata nel linguaggio e non pregiudica affatto il potenziale valore
artistico dell’opera stessa.
Nel 581 d.C. Yang Jian, un aristocratico condottiero proveniente
dal nord, si proclamò primo imperatore della dinastia Sui e riuscì
con una fortunata campagna militare a riunificare l’impero in meno
di un decennio; durante il suo regno furono avviate imponenti opere
civili e promosse grandi riforme, ma le campagne militari e gli sfarzi
della corte incisero pesantemente sullo sviluppo della dinastia e
furono la causa principale della sua breve durata (581 - 618 d.C.).
Per Li Yuan, noto con il nome postumo Gaozu, non fu
particolarmente difficile conquistare l’impero e dare inizio nel 618
125
d.C. alla dinastia Tang, grazie anche all’aiuto del figlio Li Shimin
che, dopo l’abdicazione del padre, divenne uno dei più grandi
imperatori di tutte le dinastie. Noto con il nome di Taizong, egli
seppe cogliere l’importanza di tutte le religioni, comprese le nuove, e
volle valorizzare tutte le culture: fu durante il suo regno (626 - 649
d.C.) che l’ideologia ufficiale fece proprio il sincretismo religioso
espresso dalle Tre Dottrine, cioè l’unione di taoismo,
confucianesimo e buddismo.
Con il governo di questo sovrano, la Cina ritornò a essere la
grande potenza che era stata durante la prima dinastia Han. In
questo periodo il potere centrale venne rafforzato grazie ad una
oculata ed efficace riorganizzazione dell’apparato statale, le vie di
comunicazione stradali e fluviali furono ulteriormente potenziate e
l’impero raggiunse la sua massima estensione. Molte nuove rilevanti
scoperte lo caratterizzarono: la polvere da sparo e la stampa sono
generalmente considerate le due invenzioni più importanti di questa
dinastia.
La città di Chang’an, corrisponde all’attuale Xi’an, diventata
nuovamente capitale dell’impero, era una città cosmopolita che
contava più di un milione di abitanti all’interno delle mura ed
altrettanti nelle campagne circostanti, costituendo indiscutibilmente
la più grande metropoli del mondo d’allora. In essa fiorivano
l’artigianato, il commercio, la scienza, la tecnologia, e anche la
musica e la letteratura: immensa in questo periodo è la produzione
poetica, gran parte della quale è considerata la più elevata ed
importante della storia della letteratura cinese; si pensi che il
compendio delle più famose poesie Tang edito nel 1707 ne
comprende circa cinquantamila.
Chang’an e Costantinopoli, la capitale dell’impero Bizantino,
erano i due estremi della via della seta e costituivano effettivamente i
due più importanti poli culturali, artistici e commerciali, uno
dell’oriente e l’altro dell’occidente, dal momento che
rappresentavano i ricchi confini del più importante canale
commerciale e culturale del tempo. Chang’an era un centro
internazionale e cosmopolita che attirava moltissimi visitatori
provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’impero, e sappiamo
che in essa vivevano in modo stanziale alcune migliaia di stranieri
quali Indù, Persiani, Arabi, Turchi e anche etnie meno note agli
occidentali quali Uiguri, Sogdiani e Tokhari, provenienti da regioni
ad ovest ed a nord della Cina; nel centro della città si raccoglievano
126
emissari stranieri, minoranze etniche, mercanti, artisti, musicisti e
viaggiatori di ogni tipo.
Nel periodo Tang (618 - 907 d.C.) la scultura in terracotta
raggiunse il suo massimo splendore: l’ambiente era una sorgente
inesauribile ed estremamente varia di ispirazione per gli scultori, i
quali potevano osservare svariati campioni di vita quotidiana e
immortalare nelle loro opere una grande varietà di persone ed
animali, colti ciascuno nella propria differente situazione,
caratterizzando le loro immagini fin nei minimi dettagli.
Gli artisti Tang non tendevano solo ad una rappresentazione
realistica, ma cercavano sempre di cogliere lo spirito o le sensazioni
dei loro soggetti: osservando queste opere, alcune delle quali
universalmente riconosciute come veri capolavori, oltre alla grande
tecnica figurativa si percepisce una enorme vitalità che sembra
sprigionarsi dalle figure, quasi che ciascuna di esse racchiuda un
proprio carattere o esprima delle precise sensazioni. Un’altra
caratteristica dello stile di questo periodo è una più grande eleganza
e grazia: il buddismo, che in questi anni raggiunse la sua massima
espansione, influenzò in modo diffuso e profondo le manifestazioni
artistiche, trasferendo appunto in Cina molti aspetti dell’arte indiana,
ricca di elementi stilistici di grande raffinatezza espressiva.
Facendo particolare riferimento ai reperti più importanti, e cioè
quelli ritrovati nell’area di Chang’an, le figure si possono classificare
in sei gruppi principali. Il primo è quello che raccoglie le varie
tipologie di guardiani delle tombe che consistevano in guerrieri
simili ai “lokopala”, i guardiani dei Re Celesti buddisti, oppure in
maestose e terrificanti figure antropomorfe, zoomorfe e anche
androzoomorfe, sovente colte nell’atto di schiacciare col piede o la
zampa un demone.
Una simile funzione svolgevano le statue, comparse anch’esse nel
corso di questo periodo, che raffiguravano i dodici animali del ciclo
lunare cinese (topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo,
capra, scimmia, gallo, cane e maiale), normalmente presentati con il
corpo umano ed il capo zoomorfo.
Il secondo gruppo comprende tutte le figure che potremmo
chiamare “cerimoniali”, cioè carri trainati da buoi, cavalli, cammelli,
guerrieri e cacciatori in piedi o a cavallo, palafrenieri, ufficiali,
musicisti e danzatrici, attendenti ed altri personaggi protagonisti
delle cerimonie di quel periodo. I restanti quattro gruppi sono meno
particolari e caratteristici: tre di questi sono costituiti uno da
127
servitori, l’altro da animali domestici, il quinto da oggetti ed attrezzi
della vita di tutti i giorni, mente il sesto ed ultimo è costituito dai
modelli architettonici.
Come si può notare si tratta di una ripresa di tutti i temi Han,
rielaborati ovviamente in una nuova chiave stilistica e figurativa e
ampliati da un importante numero di nuovi soggetti introdotti nei
periodi storici successivi a quella grande epoca della cultura cinese.
Da un punto di vista storico è possibile suddividere la
produzione di tutte queste figure in quattro periodi. Il primo
comprende la dinastia Sui e giunge fino alla fine del regno
dell’imperatore Tang Gaozong (581 - 683 d.C.): questo periodo è
caratterizzato dalla presenza di una gran quantità di guardiani delle
tombe, oggetti cerimoniali e carri trainati da buoi.
Il secondo (684 - 711 d.C.) si estende dal breve regno
dell’imperatore Zhongzong fino a quello della successiva imperatrice
Wu Zetian, sua madre, che fece decadere il figlio perché troppo
succube della moglie.
In questi anni i cavalli subentrano gradualmente ai buoi nei carri
e nelle cerimonie: cavalli e cavalieri, grazie alla loro enorme
diffusione, diventarono infatti sempre di più il punto focale delle
cerimonie stesse, e vennero rappresentati con un gran numero di
attendenti o servitori che ruotavano loro intorno.
Si giunge quindi al terzo periodo, che si sviluppa tra gli
imperatori Ruizong e Daizong (712 - 780 d.C.) ed è considerato
convenzionalmente il periodo centrale della dinastia Tang: l’interesse
si trasferisce dalle grandi cerimonie alla più semplice vita domestica,
la cui presenza è riflessa nella produzione artistica, dove si trovano
ampiamente rappresentati servitori, ancelle, musicisti e danzatrici. Il
periodo successivo, iniziato con il regno dell’imperatore Dezong e
durato sino alla fine della dinastia (780 - 907 d.C.), è caratterizzato
da una progressiva diminuzione delle figure in terracotta a vantaggio
di altri oggetti tombali appartenuti al defunto, quali pregiati
ornamenti in oro, argento ed altri materiali o pietre preziose.
Famosi fra le figure di questo periodo per la loro bellezza, sono i
cammelli e soprattutto i cavalli: essi sono caratterizzati da corrette
proporzioni, da grande eleganza e nobiltà del portamento e da
bellissima muscolatura che, negli esemplari migliori, sembra quasi
affiorare “sotto pelle”. La figura di cavallo Tang rappresenta lo
stereotipo del destriero in terracotta nella scultura antica cinese: si
tratta di un animale bellissimo con folta criniera, testa finemente
128
scolpita in fogge eleganti, ricchi paramenti ornamentali e che, di
conseguenza, appare profondamente diverso da quello Han, tanto
quanto un dignitario di corte è diverso da un guerriero. La forza, la
dignità, la potenza del cavallo Han si sono trasformate in leggiadria
ed eleganza: queste differenze si potrebbero sintetizzare
nell’affermazione che il cavallo Han è un cavallo da guerra, mentre il
cavallo Tang è un tipico cavallo da parata.
A conferma di quanto espresso si faccia riferimento al cavallo
bianco rampante presentato in figura 13. Il destriero presenta le
cosce rotonde e una testa robusta e proporzionata, con una lunga
criniera che si adagia su un lato del collo in modo raffinato ed
elegante, mentre la coda annodata è raccolta verso l’alto. Il cavallo
non reca alcun paramento ornamentale, ma basta il suo portamento,
sottolineato dalla posizione della zampa anteriore destra,
elegantemente sollevata e plasticamente piegata, per conferire alla
figura una bellezza classica, fissata in un movimento che sembra
accennare ad una danza.
E’ importante anche ricordare i cavalli Tang invetriati “sancai”,
quasi sempre ornati con ricchi paramenti dove tanto il gioco dei tre
colori, quanto quello della luce che si riflette sulle superfici smaltate,
creano sensazioni estetiche di grande effetto (figura 14).
Un altro genere di figure di grande livello artistico che ha avuto
ampia diffusione in questo periodo è rappresentato dalle figurazioni
equestri di caccia e di polo (quest’ultimo importato dalla Persia) e da
quelle relative alla danza e alla musica. E’ importante notare che la
figura femminile assume sempre di più il ruolo di protagonista, e
non solo nell’arte, ma anche nella cultura e nella politica. Non è
quindi da considerarsi casuale il fatto che in questi anni una donna,
Wu Zetian, abbia potuto assumere la carica di imperatrice al pari
dell’uomo, addirittura destituendo il proprio figlio.
Nel mondo delle figure femminili in terracotta di questa dinastia,
grande diffusione e particolare fortuna ha avuto la rappresentazione
di un modello di donna molto aggraziata e formosa, solitamente
denominata con l’espressione inglese “fat lady” (figura 15). Il tipico
ideale cinese di “armonia” sembra identificarsi nello spirito estetico
di questa tipo di scultura, in cui la testa, leggermente girata di lato,
sembra sottolineare uno sguardo dolce che si perde lontano; le
braccia con le mani congiunte sotto uno splendido drappeggio sono
morbidamente distese sul ventre e l’acconciatura dei capelli è
moderatamente elaborata pur rispettando i rigorosi canoni estetici
129
del tempo: bellezza, eleganza, grazia, tranquillità e fascino,
caratteristiche peculiari di questo stile, sembrano essere emanate e
trasmesse a distanza di secoli con un’intensità ed una forza quasi
incredibili, nonostante le dimensioni della figura, che non supera i
quarantacinque centimetri di altezza.
Ribellioni e violenze causarono il declino e la fine della dinastia
Tang, seguita dalle Cinque Dinastie (907 - 980 d.C.) e dalla dinastia
Song (980 - 1279 d.C.), che aprirono un nuovo periodo di
confusione politica, sociale e culturale.
Tuttavia, a differenza di quanto tradizionalmente ritenuto dalla
storia cinese, dall’accurata datazione dei reperti provenienti da
alcune tombe recentemente scoperte nell’area corrispondente
all’antica Chang’an, sembra emergere che nella capitale l’influenza
culturale della dinastia precedente sia durata ancora a lungo,
condizionando fortemente le espressioni artistiche di questi due
periodi, perlomeno in questa area. Esse infatti si manifestarono
come ripetizione ed evoluzione di temi Tang, sovente con
espressioni stilistiche e figurative molto elevate, come mostrano i
recentissimi ritrovamenti nell’area dell’attuale Xi’an (figura 16). Sono
opere che anticipano per certi aspetti stilistici il nostro Rinascimento
e chiaramente testimoniano l’importanza della cultura cinese in un
momento storico in cui l’occidente era in una fase di profondo
sopore.
In base ad un esame puramente stilistico, sovente non è facile
distinguere questi reperti dalle opere dell’ultimo periodo Tang:
tuttavia le scritte presenti sulle rispettive pietre tombali ed altri
oggetti provenienti dalle stesse sepolture, le datano in modo
inequivocabile.
La teoria che già in questo periodo inizi una profonda decadenza
stilistica ed artistica sembra essere parzialmente rettificata da queste
ultime scoperte che, senza confutarla, ne confinano l’ambito nelle
aree più periferiche dell’impero, dove erano più forti le influenze
sociali e culturali delle nuove dinastie sovrane.
Le dinastie Liao ( 916 - 1125 d.C.) e Jin (1115 - 1234 d.C.) che
regnarono in parallelo, e le successive Yuan (1271 - 1368 d.C.) e
Ming (1368 - 1644 d.C.), furono caratterizzate da un graduale
declino della scultura funeraria in terracotta, perdendo durante
l’ultima delle dinastie citate anche il significato originario del temine
mingqi. Infatti nel periodo Ming le figure, pur realizzate con
l’intenzione di voler fortemente imitare quelle del periodo Tang in
130
stile, colorazione, soggetti e tecniche produttive, cominciarono a
svolgere una diversa funzione e ad essere utilizzate nella vita di tutti i
giorni come decori o suppellettili. Fra i reperti risalenti alla dinastia
Ming, più rari sono i ritrovamenti di reperti tombali, anche perché
allora si diffuse sempre di più l’abitudine di sostituire le figure in
terracotta con immagini di carta, in modo da poterle bruciare con il
defunto. Questa abitudine era nata nella seconda parte del periodo
Tang, quando la cremazione dei defunti cominciò ad essere praticata
in modo consistente. Allora emerse la credenza che il poter bruciare
con il defunto figure in carta di servitori, animali, suppellettili, mobili
e vestiti, fosse propiziatrice per il defunto aiutandolo a raggiungere
più facilmente l’Aldilà; si pensava infatti che tutte queste figure,
consumandosi con il corpo dell’estinto durante la cremazione e
trasformandosi insieme alle sue spoglie in fumo e luce libranti verso
il cielo, si unissero a lui in modo più forte e gli conferissero uno
speciale potere contro gli spiriti malvagi.
E’ curioso ricordare che la prima descrizione di queste usanze è
giunta in occidente attraverso Marco Polo, il cui viaggio in Cina
avvenne durante la dinastia Yuan, e che esse sono ancora
attualmente in uso in aree di cultura cinese al di fuori della
Repubblica Popolare dove, per i noti motivi storico politici, nel
secolo scorso è stata fatta in modo indiscriminato una completa
pulizia di ogni credo religioso. Queste particolari abitudini di
cremazione ebbero una diffusione così grande in questa dinastia,
che dovettero essere disciplinate da specifiche leggi sulle cerimonie
funebri, con le quali furono regolamentate quantità e dimensioni
delle figure da bruciare con il defunto, in funzione del suo rango
sociale. Anche questo fatto non è nuovo: nel secondo periodo della
dinastia Tang, a causa della grande diffusione dei corredi funebri, i
governanti furono costretti a promulgare leggi che regolamentavano
rigidamente, in funzione del rango, la quantità e le dimensioni dei
mingqi (decreto del 742 d.C.) e proibivano l’inumazione di oggetti di
intrinseco valore come monili o manufatti in oro, argento o anche
bronzo (vari decreti dal 806 al 936 d.C.).
Con l’avvento della dinastia Yuan, decadde l’uso delle sculture
funerarie in terracotta per poi terminare definitivamente: tuttavia i
mingqi non scomparvero ancora del tutto, in quanto i loro
ritrovamenti si perpetuano, più raramente, fino all’inizio della
dinastia Ming, in alcune sepolture. Non risulta infatti che esistesse
una regolamentazione ufficiale che decretasse l’uso di una pratica
131
funeraria piuttosto che l’altra, ma sembra che fosse effettuata una
scelta individuale o che dipendesse dalle abitudini di ogni singola
località. Le sculture fittili, col passare del tempo, diminuirono quindi
progressivamente fino ad estinguersi del tutto nel corso del periodo
Ming, all’incirca a metà di questa dinastia.
Un ritrovamento molto importante, sia per il valore artistico dei
reperti che per la quantità, inusuale per il periodo, è il complesso
funerario della famiglia degli He, che per tre generazioni coprì
importanti funzioni civili e militari alla corte degli Yuan, la dinastia
fondata dal famoso condottiero mongolo Gengis Khan. Uno dei più
belli tra questi è un cavallo grigio con cavaliere (figura 17): la
scultura in origine non era dipinta, e l’artista ha affidato tutta
l’estetica dell’opera al gioco delle forme realizzato nel modellato
della scultura equestre, per altro piuttosto difficile a causa del colore
della terracotta che, essendo scura con superficie opaca, non riflette
la luce e ne attenua ogni effetto. Tuttavia la figura, grazie al suo stile
semplice e preciso, ha un grande risalto, ed i particolari più
importanti emergono dalle forme, quasi a dispetto della mancanza
della luce riflessa: si notino ad esempio la sella che copre la schiena
del cavallo, la completa bardatura e la bellissima criniera. Guardando
con attenzione questa scultura, si ha l’impressione di un cavallo che
non è “da battaglia” come quello Han o “da parata” come nella
dinastia Tang, ma piuttosto “da tiro”, robusto e ben attrezzato,
come si conviene ad un popolo che ha radicate abitudini nomadi
quali quelle dei Mongoli, che dopo il 1250 conquistarono la Cina,
fondando la dinastia Yuan.
Il cavallo di figura 18 è un esempio delle ultime espressioni di
terracotta tombale ed appartiene alla dinastia Ming. In questo
periodo furono ripresi, con una produzione molto vasta,
praticamente tutti i temi della dinastia Tang, però espressi in figure
di dimensioni più piccole, utilizzate per la maggior parte con
funzioni ornamentali o decorative, non più con la classica
destinazione tombale che aveva caratterizzato la scultura fittile fino a
questo periodo.
132
133
134
135
136
Identità immaginaria, diversità suo malgrado –
Divagazioni sul tema
Renato Coda
L’unità elementare biologica, la cellula è tale perché ha una sua
identità, garantita da una pellicola di lipidi, dello spessore di 5
milionesimi di millimetro, dotata di caratteristiche chimiche e fisiche
molto complesse. Questa sottile e fluida barriera divide il
microcosmo cellulare dal restante macrocosmo. Sopravvivere, ossia
mantenere l’identità, significa, per la cellula, sapere (un sapere
biochimico, s’intende) quanto dell’universo not-self, con cui viene a
contatto, possa essere accettato e quanto debba essere respinto.
Accettare, a sua volta, vuol dire introdurre, trasformare, assimilare,
omologare alla propria identità. Il dualismo identità/differenza è
legato, già a un livello biologico elementare, al binomio
accettazione/repulsione. Con entrambi i meccanismi, la diversità è
annullata, “digerita” o eliminata, ma mai conservata in quanto tale.
In maniera analoga, si comportano gli organismi superiori, a un
livello organizzativo più complesso, attraverso organi e apparati
specifici, quali il sistema immunitario e il tubo digerente. Il dualismo
identità/diversità si ripropone, come un frattale, a livello fisiologico,
psicologico, sociale, politico, etico, sempre con caratteristiche
analoghe e sempre accompagnato dal suo corollario
integrazione/rifiuto.
Che certe antinomie si riproducano anche nella storia è tutto da
dimostrare. Ciò non toglie che, in alcune epoche, come, per
esempio, il Rinascimento, si sia presentato, nel mondo intellettuale
ed artistico, un forte stimolo all’integrazione delle diversità esistenti,
in un unico, coerente movimento culturale. Il più compiuto
manifesto artistico di questa pulsione mi sembra identificabile nella
Pala di Brera (1472) di Piero della Francesca, un dipinto nel quale
architettura, Madonna con Bambino, angeli, santi e persino il losco e
catafratto committente sono fatti di un’unica sostanza luminosa,
ordinata secondo una perfetta geometria euclidea. Nel punto
d’incrocio delle diagonali del dipinto, sta sospeso e senz’ombra,
come un blasone o un simbolo, l’uovo cosmico, sintesi
dell’universo, autentica monade, che, nella sua forma compiuta,
137
racchiude, in germe i cinque elementi: guscio-terra, membrana-aria,
albume-acqua, tuorlo-fuoco e capacità generativa-quintessenza. In
quegli stessi anni, Giovanni Pico della Mirandola, nelle “Conclusiones
philosophicae, cabalisticae et theologicae”, elaborava il programma di un
grande convegno di dotti, che avrebbe dovuto conciliare Ermete
Trismegisto, Aristotele, Platone, Averroè, Tommaso d’Aquino e la
qabbalah, per dimostrare la concordanza di tutte le religioni e
l’assoluta unità del pensiero umano; Marsiglio Ficino lavorava a
conciliare la filosofia platonica e la religione cristiana; Bernardino
Telesio teorizzava l’unità sostanziale del mondo naturale inorganico,
vegetale, animale e umano; Nikolaus Krebs da Cues, meglio noto
come Nicola Cusano, insegnava che le antinomie di questo mondo
non sono altro che l’explicatio dell’Uno nel molteplice, e che, nella
loro Origine, ritrovano la loro perfetta e totale coincidenza. Furono
tutti tentativi di recuperare le diversità, senza snaturarle,
integrandole in una sintesi. Naturalmente altro è la cultura e altro
sono il potere politico e il potere religioso. Le tesi di Pico e Telesio
furono oggetto di una condanna ecclesiastica e Marsiglio Ficino fu
sospettato di negromanzia. Tutte le aspirazioni del loro secolo, volte
al raggiungimento di una sintesi delle verità contenute nelle diverse
scuole filosofiche, religiose ed esoteriche, avvennero in un contesto
politico, militare e sociale disastrato da profonde spaccature. A
pochi anni di distanza dalla pala di Brera, l’uovo cosmico si schiuse,
o meglio, esplose, facendo scaturire una malata progenie di
mostriciattoli, gli stessi che popolano gli incubi di Bosch e che,
secondo Brueghel, accompagnano la corsa della “Dulle Griet, Ghita
la Pazza” verso l’Inferno. Due grandi eventi accaddero in
quell’intervallo di tempo: la scoperta del Nuovo Mondo nel 1492 e
la Riforma Protestante nel 1517. Il Continente Americano fu una
fonte inesauribile di nuove, inattese, mirabolanti diversità: piante,
animali, cibi, malattie ed esseri umani, scandalosamente differenti
per costumi, morale, religione e che, disgraziatamente, non si
potevano neppure considerare dei selvaggi. Le splendide civiltà precolombiane potevano forse passare inavvertite agli occhi di avidi
avventurieri come Pizarro o Almagro, ma non erano sfuggite al
colto Hidalgo Cortéz. Il pensiero che si potesse essere uomini
civilizzati e vivere e prosperare, senza dovere nulla, ma proprio
nulla, alla civilizzazione, alla storia e alle religioni del Vecchio
Mondo dovette sembrare intollerabile a più di una persona. Sul
piano politico ed economico, la questione fu risolta molto
138
facilmente: genocidio, riduzione in schiavitù, evangelizzazione
forzata, rapine e distruzioni senza limiti. L’unico problema fu la
spartizione del bottino, che diede luogo a qualche dissapore tra le
grandi potenze. Tra gli intellettuali europei, solo il grande Dürer
espresse aperta e incondizionata ammirazione per le opere d’arte
provenienti dal Messico, viste in esposizione ad Anversa, e ringraziò
Dio per avere ispirato, in terre tanto lontane, il lavoro di artigiani
così abili.
La Riforma, a sua volta, riportò alla ribalta, amplificandole, le
dissidenze religiose, che si pensavano ormai marginali. Con le guerre
di religione e la colonizzazione del Nuovo Mondo, iniziò uno dei
periodi più oscuri della storia dell’umanità, durante il quale le
popolazioni di Europa e di America, furono decimate da massacri,
esecuzioni di massa, genocidi, distruzioni, razzie, violenze di ogni
sorta, persecuzioni e torture, cui si aggiunsero; come naturale
complemento del passaggio degli eserciti, le epidemie di vaiolo, di
peste, di tifo, di colera e, in più, la sifilide diffusa dalle coureuses
d’armée.
Tra gli artisti vi fu chi continuò, ad onta degli avvenimenti politici, a
coltivare il sogno di un’armonizzazione di tutto il sapere umano, ivi
compreso quello eterodosso, al di là dello spazio e del tempo.
L’estrema, generosa utopia della “Scuola di Atene” di Raffaello
(1509-1510), appena trent’anni dopo, s’infranse contro il “Giudizio
universale” di Michelangelo. Non vi era più posto per le diversità: il
mondo si era diviso, tra salvati e sommersi e gli intellettuali
dovevano abbandonare i sogni di universalità e operare delle scelte
ineludibili. In molti casi le vicende biografiche di artisti e letterati si
sarebbero intrecciate, spesso in modo drammatico, con gli eventi
bellici. Nel 1524, nel Sacro Romano Impero, scoppiò la Bauernkrieg,
la rivolta dei contadini e dei seguaci di Thomas Müntzer, che
ottenne l’adesione di alcuni dei maggiori artisti tedeschi. Al
momento della feroce repressione, nel 1526, il pittore Jörg Ratgeb fu
legato a quattro cavalli e squartato, il grande scultore Tilman
Riemenschneider imprigionato e torturato, i fratelli incisori Sebald e
Barthel Beham e Georg Pencz esiliati, Mathis Gothart NithartGrünewald costretto alla fuga. Dürer, non coinvolto direttamente
dalla repressione, incise però un derisorio monumento trionfale per i
vincitori: una torre di stie, covoni, vanghe, zangole, tini, sormontata
139
Eliminato:
Eliminato:
da un contadino seduto, con una spada da cavaliere piantata tra le
scapole. Nel 1527, in Italia, avvenne la diaspora dei manieristi
romani sotto l’incalzare delle truppe di Frundsberg: il Parmigianino
e il Rosso ostaggi dei lanzichenecchi, Perin del Vaga fuggiasco a
Genova, Polidoro da Caravaggio a Napoli, Giovanni da Udine, in
patria, Sebastiano dal Piombo rinchiuso in Castel Sant’Angelo. Fu
proprio nella generazione dei manieristi che nacque la figura
dell’artista tormentato e disadattato, da cui gemmò, più tardi, il mito
dell’artista maledetto. Furono gli stessi Autori a dare segno del loro
disagio psicologico, sia con atteggiamenti asociali, sia soprattutto,
con autoritratti, in cui erano sottolineati gli aspetti fisionomici tipici
dell’alienazione mentale: l’artista si autodenunciava come un
“diverso” e tale sarebbe stato fino ai giorni nostri.
Nel frattempo la tolleranza per le diversità stentava ad imporsi: nel
1721, la 96enne ebrea Maria Barbara Carillo fu bruciata a Madrid;
l‘ultimo autodafé avvenne a Palermo nel 1724; nel 1762 l’anziano
negoziante protestante Jean Calas, colpevole di avere nascosto il
suicidio del figlio, per potergli dare cristiana sepoltura, fu accusato di
averlo assassinato per impedirgli di farsi cattolico, e di conseguenza
fu torturato, e giustiziato sulla ruota; nel 1766, il giovane cavaliere
De la Barre, fu, a sua volta, torturato e giustiziato, in spregio delle
leggi vigenti, per blasfemia. Sul rogo che inceneriva il cadavere,
significativamente, i giudici fecero bruciare il “Dictionnaire
philosophique” di Voltaire. Solo sul finire del XVIII secolo, la
Rivoluzione Francese intraprese una formidabile opera di recupero
di tutte le possibili diversità. In questo lavoro s’impegnarono uomini
di diverso temperamento e fede politica, da Brissot, a Robespierre,
al vescovo Gregoire. Decaddero i privilegi feudali e il voto di nobili
e clero contò quanto quello dei borghesi. Furono emancipati i
protestanti e alla Convenzione Nazionale sedettero dieci pastori
riformati, uno dei quali, Jean Bon Saint André divenne membro del
Grande Comitato di Salute Pubblica. In questo Parlamento furono
eletti anche il primo uomo di colore, il deputato senegalese JeanBaptiste Belley, detto Mars e due operai, Granet, bottaio e
Armonville, cardatore. Si arrivò con molta fatica, e altrettanti
compromessi all’abolizione della schiavitù nelle colonie. Fu avviata
la faticosa “rigenerazione” degli ebrei, che non solo erano
discriminati e privi di cittadinanza, ma divisi da profonde rivalità tra
la comunità sefardita bordolese e quella ashkenazita alsaziana. Molti
140
ufficiali ebrei militarono nelle armate della Rivoluzione e
dell’Impero. Nell’esercito, nel quale qualsiasi soldato semplice
poteva arrivare al comando di un’armata combatterono generali
mulatti come Dumas, mentre l’ex-schiavo Toussaint-Louverture
raggiunse il grado di generale di divisione. Il chirurgo militare
Dominique-Jean Larrey fece prevalere l’imperativo etico di non
abbandonare mai i feriti e di curarli in ordine di gravità, senza tenere
conto delle differenze di bandiera o di grado. Adottando questi
principi, la Francia stessa divenne un’inaccettabile diversità tra le
Nazioni e ciò comportò la guerra contro l’intera Europa e contro le
rivolte interne, in Vandea, a Bordeaux, a Lione, a Marsiglia, a
Tolone. Sappiamo come andò a finire, con venticinque anni di
guerra e con la ghigliottina promossa a strumento privilegiato di
omologazione delle devianze. Per quanto riguarda la più
numericamente consistente delle“diversità”, le donne, i tentativi di
integrazione furono avviati, ma fallirono. Dato per scontato lo
scarso entusiasmo dimostrato dal sesso maschile, (il solo Condorcet
scrisse contro la disuguaglianza femminile), furono le donne stesse a
promuovere la causa della loro emancipazione, partecipando in
prima persona e, spesso promuovendo le giornate rivoluzionarie,
assistendo ai dibattiti parlamentari dalle tribune, fondando i propri
clubs politici. Non furono M.me Roland o la baronessa de Staël,
eredi dei salotti intellettuali dell’Illuminismo, a porre il problema dei
diritti delle donne, quanto piuttosto le militanti sul campo, Etta
Palm, Pauline Léon, Olympe de Gouges, Théroigne de Mericourt.
Finì male: i clubs femminili furono soppressi, M.me Roland e la
povera Olympe, che si era impegnata a redigere la carta dei “Diritti
della Donna e della Cittadina” pagarono sul patibolo la loro
sventatezza politica, Pauline Léon fu costretta a rientrare
nell’anonimato, Etta Palm, passata per denaro all’avvilente
professione di spia, fu incarcerata e la bellicosa Théroigne subì, da
parte delle sue stesse consorelle rivoluzionarie, un’umiliante
pubblica sculacciata “a cü biot” e terminò i suoi giorni,
completamente demente, alla Salpêtrière. Con la pazzia della
Théroigne si giunge all’ultima categoria di diversi, che all’epoca
iniziarono un percorso di liberazione dalle catene (letterali) della
schiavitù, per tornare ad essere accettati nel consorzio umano: i
malati di mente. Il processo di affrancamento dei pazzi, per merito
di psichiatri come Philippe Pinel, permise al marchese de Sade di far
recitare i suoi psicodrammi nel manicomio di Charenton, ma ebbe
141
Eliminato: ,
Eliminato:
come conseguenza maggiore lo studio e la classificazione delle
differenti patologie psichiatriche. A questo punto, rientrarono in
gioco gli artisti, che, per anni, si erano esercitati a descrivere la
mimica facciale dei sentimenti. La malattia mentale non aveva altri
segni morfologici se non le alterazioni dell’espressione. Dunque vi
era lavoro per scultori e pittori, tanto più che il Romanticismo stava
imponendo tra i suoi temi prediletti, oltre alla Morte, alla Carne e al
Diavolo, anche la Follia. Théodore Géricault fu senza dubbio il
primo e il maggiore tra coloro che s’interessarono al problema, ma
fu accompagnato da un gran numero di più oscuri colleghi,
disegnatori, incisori, illustratori di testi di medicina. Un ulteriore e
più obiettivo metodo di documentazione fu un sottoprodotto della
ghigliottina: la lama, che fissava i lineamenti nella rigidità della
morte, era l’equivalente di un otturatore fotografico. Marie Tussaud,
per prima, lo capì. In un’epoca in cui le immagini avevano poche
possibilità di circolare, i calchi in cera dei famosi uomini politici
passati sotto il “rasoio nazionale” erano l’ideale per soddisfare la
curiosità giornalistica dell’Europa intera. I clienti della Tussaud
furono presto emulati, nel lasciare ai posteri l’eredità delle loro
ricalcate sembianze, dai membri della banda degli “chauffeurs
d’Orgère” così denominati per la pessima abitudine di “riscaldare” i
piedi delle loro vittime al fuoco del camino, onde stimolarli a
ricordare dove avessero nascosto i risparmi. Era nata l’Antropologia
Criminale. Naturalmente, anche i malati di mente furono oggetto di
questo straordinario precursore della fotografia, a cominciare dalla
stessa Théroigne. Ora, se si uniscono in un’indagine sulla base di
immagini e pertanto morfologica, gli artisti che si autodenunciano
come alienati, i malati di mente, i criminali e si mescola il tutto con
una generosa dose di pensiero positivo, un po’ di darwinismo mal
digerito e un pizzico di pseudocultura storico-umanistica, si ottiene
l’opera dell’enfant chéri della Scienza di fine Ottocento: Cesare
Lombroso. Non fu certamente il solo, né il primo a percorrere il
cammino, eticamente scivoloso, dell’antropologia dei devianti, ma fu
certamente colui che conferì alle sue teorie un successo e una
risonanza internazionali senza precedenti. Il personaggio non era
esente da contraddizioni: epigono del positivismo, coltivava lo
spiritismo e si faceva abbindolare dalla medium Eusapia Palladino;
socialista, non esitava a classificare tra i criminali Jean-Paul Marat,
eminente medico, scienziato, giornalista e uomo politico, nonché
l’eroica e generosa Louise Michel e gli altri protagonisti della
142
Eliminato:
Comune di Parigi; uomo di cultura, confondeva tranquillamente il
generale Jean Baptiste Jourdan, Maresciallo dell’Impero, con il
delinquente Mathieu Jouve detto Jourdan Coupe-Tête. A colpi di
approssimazione, il Lombroso amalgamò gli artisti ai malati di
mente e questi ai criminali, tutti identificabili grazie al marchio
genetico di caratteri morfologici “ancestrali”, che ne facevano una
specie umana a sé stante, da confrontarsi con i popoli “primitivi” e
con le con le razze “inferiori”. Se, nel corso del XX secolo, da
questo maleolente calderone pseudoscientifico, nacquero mostri,
non è responsabilità diretta del Lombroso e dei suoi emuli. Le loro
teorie furono però il pretesto ideologico, utilizzato da menti
criminali, per risolvere i problemi politico-economici posti dalla
diversità, applicando comportamenti comodamente mutuati dal
mondo biologico (la famosa cellula, di cui si parlava all’inizio):
eugenetica, pulizia razziale, soluzione finale.
Il medico Karl Brandt, responsabile del programma di eutanasia
mediante ossido di carbonio, di 70.000 indesiderabili, il 2 giugno
1948, sotto la forca, proclamò di avere agito nell’interesse
dell’umanità e di morire vittima di una ingiustizia. Purtroppo, anche
se saremmo felici di poter confidare nella neutralità della scienza,
non abbiamo motivo di credere che fosse del tutto in malafede.
143
Eliminato:
144
Il giovane aitante
di Beppe Mariano
Femmineo all’aspetto, estravagante,
ma saldo in sé; d’ambiguo amplesso
insegue della propria immagine
il riflesso in vetrine, parti luccicanti d’auto,
alti bicchieri risonanti,
laghetti, pozzanghere e cristalli
per amarsi in essi, narcisamente.
Ostile a ciò che non è
riflettente, odia il nero,
che secondo lui non è un colore,
ma tutto ciò che è assente.
Solo le nubi, pur se nere sono bene accolte
perché possono, a volte,
disegnare in cielo il suo profilo.
I piedi ha serrati
nei pattini a rotelle,
un borsone stretto alla vita,
in spalla regge una
superbicicletta da salita,
l’altra racchette e sci.
Dove vi era un tempo a tracolla
una chitarra, adesso pende
la custodia d’una scimitarra,
traboccante, per fortuna, soltanto
di fotografie in posa;
e accanto vi è pure lo smartphone
che gli ricorda con un bip-bip
di un appagante appuntamento
sic con un riccone.
Nonostante i molti, troppi pesi
il giovane aitante
sale con sveltezza
145
le alte rampe, come avesse
fretta di arrivare in cima,
equipaggiato a vincere il presente.
146
Divagazioni sui temi della bellezza e dell’omoerotismo
nel mondo classico
Gianni Rabbia
Mai come da quando il principio dell'uguaglianza tra gli
uomini è stato sancito in documenti di portata planetaria appare
chiaro che, per una sorta di eterogenesi dei fini, irrompono
tumultuosamente per drammatico contrasto gli elementi
differenzianti, spesso con aperte forme di conflitto dal profilo di
vere e proprie "guerre". Identità nazionali (rectius: nazionalistiche
e/o di varia natura ideologica) assumono tipologie antropiche di
dimensione tribali, talora pesantemente sanguinarie; nuovi e vecchi
"razzismi" (laicisti come spiritualistici, identitari al pari di quelli di
omologazione delle "diversità") alzano le loro bandiere, danno fiato
alle trombe e fuoco alle polveri: in nome di una astratta e dogmatica
(e quindi tendenzialmente fanatica) "battaglia in difesa dei diritti",
alla omologazione cui tendono tutte le forme di aggregazione umana
fino alla denominazione di "civiltà", finisce invece per corrispondere
una frammentazione decomposta di un quadro che si vorrebbe,
almeno per comodità di analisi, passabilmente unitario e concorde.
E' sì vero che ogni affresco sociale, nel tempo e nello spazio, non
risulta mai omogeneo, per quanto ci si sforzi nel dipingerlo per tale:
la cosiddetta "cultura", come momento di identità etnica, ad ogni
tentativo di rappresentarla in sintesi complessive come "foto di
gruppo", bene che vada, appare almeno sfocata e di assai complessa
lettura; proprio per la disarmonicità contraddittoria degli elementi
"umani" che la coloriscono e la differenziano, quanto più ci si
avvicina al ritratto, tanto meno se ne vedono con nettezza le
coordinate d' insieme. Una sorta di avvelenata condanna del
"particulare" eternamente ribelle ed anarchicamente insorgente
finisce per punire con una fatica erculea tutti coloro che cercano di
tracciare le linee di studio su di un qualsiasi soggetto: storico,
artistico, filosofico, etico. Figurarsi politico: sono d'accordo con il
presidente Mao, quando sermoneggiava che è troppo presto per
parlare con equilibrio della rivoluzione francese. La vicenda della
torre di Babele pare trovare ripetuta conferma nelle gongolanti
affermazioni di una libertà rivendicata e mai da calpestare. Ma di
quale libertà si intende poi parlare? La cosiddetta "ricerca della
147
verità", compito di ogni esistenza degna di essere vissuta, si
inabissa sconcertata nella "complessità del reale": tutto sfugge tra le
mani nello stesso momento in cui sembra lo si sia afferrato
saldamente, ciò che poco fa appariva acquisito come certezza
limpidamente oggettiva, "scientifica", rischia di venire annullato e
smentito un istante dopo. I postulati dell'egualitarismo, così belli e
suadenti nella recita per addormentare le coscienze soddisfatte di sé,
al momento della discesa sul terreno non tardano a confliggere
bellicosamente tra di loro, nel contrasto stridente fra le libertà e la
libertà, fra i termini dell'uguaglianza "formale" in antinomia
insoddisfatta con l'uguaglianza "materiale". I più attenti infatti alle
terminologie troppo ottimistiche, per esempio, al posto del concetto
di "fraternità", con una punta di cinismo lessicale, usavano il
termine, altrettanto confusionario e grondante sangue, di "giustizia".
Così all'ottimismo "sociale" ("magnifiche sorti e progressive")
sembra di doversi opporre una prudente terapia preventiva di
disprezzo ontologico nei confronti dell'uomo: da questo eterno
conflitto di umanità oppressa proprio in quanto anelante ad una
insorgenza liberatoria sembra saggio ricorrere per cautelativa
profilassi ad un atteggiamento di cinismo omeopatico, catafratto di
scetticismo, quando non di pessimismo nichilistico. I cosiddetti
"valori morali"? Sì, servono ad alleggerire il peso della pena che
opprime le coscienze più consapevoli dell'umana pochezza; ma solo
il vero credente, aureolato dal dono liberatorio della Fede, può
permettersi di considerare possibile una redenzione per chi,
commesso il delitto e scontato in tutto il castigo di vivere,
intravvede un destino di salvezza propiziato dalla coscienza dei suoi
limiti, dal pentimento e dalla donazione di sé alla misericordia
salvifica di Dio. Il trionfo dell'Assoluto resta inconfutabilmente
unica strada di liberazione con la morte redentiva dalla miserabile
vicenda umana, in risposta alle derive dell' uomo penosamente
autoinvestitosi del diritto di "misura di tutte le cose". Così leggiamo
in una delle ultime note di Cesare Pavese: "Solo Cristo e Dostoevskij. Il
resto sono balle."
La bellezza, formale in quanto dono alla sensorialità oppure
sostanziale in quanto immanente nel profondo dei misteri della
coscienza individuale, sembra apparire come una dostoevschiana
"via per la salvezza", una sirena ammaliante con caratteri di
angelicità soterica. Ma la bellezza è o norma-canone, o rischia di non
essere bellezza, essendo la pluralità nelle sue varianti l'esatto
148
contrario della norma-canone unitaria ed unificante. Nel mondo
classico la soluzione più alta fu raccolta nel concetto sintetico della
kalokagatìa, nel quale forma apparente e sostanza intima venivano
correlate in una formula perfetta, al di fuori della quale si apriva
l'abisso della tragedia che è per definizione sregolatezza colposa e
dolosa, cui neppure gli dei possono sottrarsi. In più sul capo degli
uomini pendeva costante la minaccia dell'invidia divina, lo ftònos
theòn, pronto a scagliare fulmini inceneritori su chi avesse avuto per
sé doni di eccellenza tali da provare un brivido di umanizzazione
competitiva con l' Olimpo, egocentrico ed egoarchico per
definizione. Il segno più alto dell'uomo classico sta nella perfetta
unione raffigurata dalla "serenità" nel dominio armonico tra la sua
dimensione corporea (bellezza e forza plastica) e l'energia delle sue
virtù intime ed individuali: non a caso in latino (lingua che ha in
orrore i termini astratti) "virtus" significa "capacità eccelsa", prima di
assumere, soprattutto per influssi religiosi (inizialmente a carattere
misterico, poi con la diffusione del cristianesimo) il senso della
accezione morale, valore squisitamente astratto. Virtus era quella
dell'agricola capace di far fruttare con il suo labor la terra, come del
miles che si distingueva per il pugnace coraggio fino al sacrificio
estremo. Questo è il pantelòs àntropos, l'uomo integrale "misura di
tutte le cose", capace di ponderare il tempo e lo spazio (terreni), di
provarli e di dominarli, ben consapevole della brevità della sua vita e
proprio per ciò investito di un ruolo di responsabile esemplarità. Ma
la bellezza è precipuo dono divino, solo in minima parte da
ricondursi alla corporeità ed ai sensi; infatti il bello sensibile è la
garanzia percettiva contingente di quello intelleggibile, ideale e, per
così dire, celestiale anche nelle sue declinazioni, emotive prima e poi
concettuali. Del resto il mondo classico (e quello ellenico in specie)
ha saputo come nessuna altra civiltà successiva dare regole ed
esempli alla ipotesi della "perfezione umana", identificandola
nell'unità presso la stessa persona della reciprocità tra bellezza e
valore morale. Ogni altra epoca ha trafficato con questo tema
spuntando una apparente originalità, talora con le più alienanti delle
dissociazioni, avvalendosi delle varie tipologie dei relativismi e degli
esistenzialismi più disperanti. Ma sempre, alla fine, si è trovato che le
idee del bello non sono mai soltanto delle idee (=apparenze). Sono,
già al solo momento percettivo, qualcosa di meno se contingenti e
insieme - ma soprattutto - molto di più se elevate a modello.
149
Quando si parla di simmetria, di armonia, di proporzione, di
completezza, di equilibrio, il resto che intenda differenziarsi mette
sempre drammaticamente allo scoperto l'angoscia della ricerca
identitaria di individui e collettività, negatrice di senso etico-estetico
in nome del mutamento confuso, della varietà scomposta, della
diversità ricca solo di carenze di limpidezza. La luce della bellezza
non si estingue se non nella oscurità delle tenebre e nell'eclisse delle
coscienze. Detto altrimenti, la bellezza non è diversa dalle
aspettative e dalle aspirazioni generali (anzi, la sua ricerca è
universale motivo esaltante di piacere e di sogno), quindi proprio
per questo è tale se le esprime come mediazione "alta", al di fuori
dalle manipolazioni e dagli sfregi, poiché realizza al meglio un
sentire diffuso, per quanto di difficile decifrazione. La bellezza è
prima di tutto equilibrio, anche se nelle epoche esso non è risultato
immutabile né staticamente fissato una volta per sempre. Quindi la
bellezza può apparire mutabile ed immutabile insieme, cedendo alle
contaminazioni ed alle gerarchie dei valori del tempo e dello spazio.
Quando si dice che "la bellezza sta negli occhi di chi l'ammira", è
chiaro che se ne accettano anche le presenze imperfette, i dettagli
destrutturanti, le intrusioni. Ma ciò non basta a negare l'universalità
di un unico modello estetico, in grado di esemplare la perfezione (o
ciò che le appare più simile), proprio perché anche la rottura
dell'uniformità e la domanda di varietà, di novità, di diversità sembra
fare da stimolo ad un bisogno ulteriore di scoprire, di correggere, di
sognare. Il poeta-filosofo americano Ralph Waldo Emerson ebbe a
dire (Saggi) : "Le cose possono essere graziose, eleganti, aggraziate, avvenenti,
ma finché non parlano all'immaginazione non sono ancora belle." Del resto è
vero che, per esempio nelle forme più semplici, il difetto attira la
curiosità, generando una attenzione critica che vuole spiare i
significati nascosti; così il difetto diviene un dettaglio perturbante
capace di assicurare alla bellezza tutta la sua espressività, il fascino
dell'ignoto, il magnetismo delle allusioni irradianti dal profondo.
Venere, il supremo ideale della bellezza femminile, non era infatti
leggermente strabica? Un'opera d'arte incompleta (es.: la
michelangiolesca Pietà Rondanini al Museo Sforzesco di Milano)
può sprigionare una forza espressiva assai più intensa che se fosse
stata ultimata e levigata. Noi sappiamo bene, con cicatrici nella
nostra carne, che in ogni realtà si cela il suo fantasma danzante nel
nostro inconscio con la forza degli elementi simbolici primordiali, i
sogni, i desideri, le pulsioni ancestrali. Ma forse occorre meditare su
150
Giacomo Casanova (Memorie scritte da lui medesimo, XV) quando per
primo ha osservato che "una bella donna è mille volte più attraente quando
esce dalle braccia di Morfeo, che dopo un'accurata toilette": all'artificio della
toilette risulta più ricco di suggestioni erotiche un corpo ed un
abbigliamento che parlino all'immaginazione ed alle libertà
alimentate ed esaltate dal desiderio. Può persino risultare possibile
che se la bellezza è la rappresentazione più plastica della perfezione,
ogni anomalia della stessa voglia interpretare la imperiosa necessità
della disarmonia e della stonatura, la violazione della norma come
ansia di palingenesi. Il tentativo di plasmare la perfezione estetica
non è affatto facile, come sanno bene tutti eccetto quello scrittore
italiano che credeva, con immensa presunzione, di "capolavorare"
quotidianamente, sedendo davanti alla macchina da scrivere dalle
otto a mezzogiorno. Dopo essersi stravaccato sul sofà delle Muse ed
aver indossato la maschera di Minosse intellettuale per affliggenti
decenni, alla sua scomparsa sull'opera del "venerato maestro" è poi
caduto un imbarazzante silenzio, come capita appunto ai "maestri"
di cui si può dire con libertà (ma post mortem) che è stato un
"immenso stronzo". La bellezza (perfetta come ideale o relativa
come reale) è, per così dire, forte ma non robusta, se a
destabilizzarla basta un qualsivoglia elemento di incongruità e di
rifiuto delle regole. Si assiste allora ad una "rivoluzione" (o ad una
scimmiottatura, spesso tragicamente oscena e repellente, di ciò che
si vorrebbe cambiare) in cui alla tensione spirituale si mettono
addosso gabbie e demarcazioni ideologiche, buone per teatralizzare
il tallone del potere e la catene dell'assolutismo tirannico, che è poi
la traduzione storica allargata della ragione per cui già il solo
individuo unitario si crede parte dell'universo, ma alla condizione di
esserne padrone, nell'ipotesi più generosa, di non meno del 51 %.
Dostoevskij, nell'Idiota (1868-69) facendo domandare da Ippolit al
principe Myŝkin se e quale bellezza potrebbe salvare il mondo,
afferma che la bellezza non ha il dovere di redimere l'esistenza dalla
sua finitezza, ma di indicare il passaggio per liberarsi dal male
connaturato alla vita stessa. La bellezza è quindi, prima di ogni
connotazione, educativa alla tensione spirituale dedicata al
riconoscimento della verità, se non altro del suo nome, verità
riconoscibile e condivisibile per liberarsi dall'angoscia dell'autismo.
E' la conquista dei propri limiti, con la relativa consapevolezza che
ci si pone al bivio, quello che valicarono Ulisse e la "compagnia
picciola" o stare al di qua delle colonne d'Ercole. L'emozione del
151
bello è il potente mezzo di conoscenza che schiude un cammino in
salita verso dimensioni di esperienze profonde del reale, forse
ineffabili ed inesprimibili ma autentiche. Come Beethoven, che
afflitto dalla sordità usò la musica come ascesa al mondo supremo,
o gli artisti che realizzarono le vetrate delle cattedrali per unire al
senso meraviglioso del colore e della luce la visione del miracolo
della redenzione dal cupo silenzio verticale della cattedrale gotica, o
lo stesso silenzio che trasferisce nella dimensione della
contemplazione la condizione ambìta di annullamento del limite
temporale. La conoscenza che si libra dalla bellezza non è ancorata
al peso della nozione, non è dimensionata dall'informazione,
inchiodata alla fattualità: è invece per sua natura indescrivibile,
coinvolgente, totalizzante, intensa. Secondo la tradizione indiana, il
bello, rasa, che si ricava dalla contemplazione non è né udibile né
visibile perché ciò che ne viene non è una vibrazione di colori o di
lunghezze d'onda, ma scaturisce potente dalla bellezza senza forme
visibili che è dentro ognuno di noi, fonte celata di gioia nirvanica
quale è la scoperta dell'essenza insita nella radice dell'esperienza
umana. Per il Corano "Dio è bello ed ama la bellezza". Ciò vuol dire che
l'uomo è portatore nel suo spirito della somma potenza generatrice,
possiede la bellezza e la può amare come visione dell'Invisibile. Nel
X° libro delle Confessioni sant'Agostino scrive: "Tardi ti ho amato,
Bellezza, così antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Sì, perché tu eri dentro di
me ed io fuori: lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle sembianze delle tue
creature. Con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue
creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti ed il tuo grido sfondò la
mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua
fragranza, respirai ed ora anelo verso di te; ti gustai ed ora ho fame e sete di te;
mi toccasti, e arsi dal desiderio della tua pace."
Bertrand Russell, con straordinario lirismo, cantò (Mistica e
logica, 1919) l'inno della bellezza matematica: "La matematica, vista nel
modo giusto, possiede non solo verità, ma anche suprema bellezza, una bellezza
fredda ed austera come la scultura, senza richiamo ad alcuna parte della nostra
natura più debole, senza le splendide trappole della pittura o della musica, è
invece pura in maniera sublime e capace di una severa perfezione quanto solo la
grande arte può mostrare. Il vero spirito di gioia, l'esaltazione, la sensazione di
trascendere l'essere umano, che è la caratteristica dell'eccellenza più alta, si può
trovare nella matematica con quella stessa sicurezza con cui si trova nella
poesia."
152
"La bellezza è l'eternità che si ammira in uno specchio" (Kahlil
Gibran), "è la promessa delle felicità" (Stendhal), "il futuro appartiene a
coloro che credono alla bellezza dei propri sogni" (Eleanor Roosevelt). Ma
anche la diversità è affascinante, di solito a piccole dosi: "ricorda che
sei unico, esattamente come tutti gli altri" (Anonimo), "una volta nel gregge, è
inutile che abbai: scodinzola !" (Anton Cechov), "genio e follia hanno
qualcosa in comune: entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste
per gli altri" (Arthur Schopenhauer), "tra due mali, scelgo sempre quello che
non ho provato prima " (Mae West), "ogni volta che la gente è d'accordo con
me, provo la sensazione di avere torto" (Oscar Wilde), "nessun uomo si bagna
due volte nello stesso fiume" (Eraclito), "ciò che vediamo non è ciò che vediamo,
ma ciò che siamo" (Fernando Pessoa), "nessuno può essere libero se costretto
ad essere simile agli altri" (Oscar Wilde), "occorre somigliarsi un po’ per
comprendersi, ma occorre essere un po’ differenti per amarsi" (Paul Bourget),
"abituarsi alla diversità dei normali è più difficile che abituarsi alla diversità dei
diversi" (Giuseppe Pontiggia), "solo se riusciremo a vedere l'universo come un
tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità in cui la grande bellezza sta nella
sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo" (Tiziano
Terzani).
La bellezza è, piaccia o meno questa affermazione, ordinata
disciplina del bello, somma ambiguità misteriosa, ma è profumata di
incenso mistico, unico vero fascino ammaliante che, nelle sue
diverse declinazioni di forme, mantenga una sostanza di "dignità"
etica ed estetica insieme, e per questo è sigillata in una dimensione
ancora più ambigua e indicibile quanto più se ne goda e la si
assapori. Il "fermati attimo…" faustiano contiene tutto del
metafisico proprio quando scorre via appena intuito in superficie.
L'eterna favola di Orfeo ed Euridice.
L'amore come desiderio ansioso della gioia frutto del bello è
un termine che per noi banali sempliciotti di oggi ha un valore
onnicomprensivo. Per i greci èros è una forza di carattere divino, per
esempio come in Saffo (fr. 130), proprio in quanto dolce amaro.
Erastès è chi è preso nella rete d'amore, disponibile a far nascere una
relazione fra chi origina eros e chi ne prova gli effetti. Non a caso il
verbo eràn (desiderare) regge la costruzione al genitivo in quanto
indica la condizione di passività dell'individuo trafitto dal dardo di
Cupido. Eros, dice Platone, (Crat., 420 b) si chiama così perché
"scorre" (eshrei) dall'esterno ma si impadronisce di qualsiasi altro
desiderio in chi ne diviene succube, tanto da fare sentire il dolore
acutissimo della mancanza nella soddisfazione del desiderio
153
racchiuso nella persona oggetto d'amore. Anacreonte sostiene (fr.
402 b) che per Eros è bello ciò che è giusto, proprio essendo la
giustizia riparatrice delle ineguaglianze causate da ogni rottura di
equilibrio. Dall'istintivo "amore di sé", il passaggio all'amore di
"altro da sé" è causa di forte rischio di sofferenze e di
incomprensioni, fino alla brutalità del rifiuto ed al disprezzo della
trepidante domanda di reciprocità. Il verbo phìlein è lontano dalla
libido amorosa, in quanto prevede una opportunità di una alleanza
amichevole e rompere -anche unilateralmente- questo contratto di
fedeltà comporta l'insorgere di una ingiustizia. Per tutto il mondo
greco sembra quindi di poter affermare che la dedizione amorosa è
da distinguere dalla semplicità (fisiologica, ma non solo) del
desiderio. Così accade che il termine paidophìlein abbia una
connotazione assai diversa dalla aberrante condizione del pedofilo
post-classico, essendo allora pienamente accettato che all'educazione
di un uomo ed alla sua iniziazione alla vita sociale (comprese le
pratiche sessuali) fino alla guerra e alla morte potesse concorrere
anche una attenzione erotica. Il rapporto sessuale aveva valore di
rapporto sociale, come descrive Demostene nell' Eròticos : ma nei
rapporti tra uomo e ragazzo deve essere preservata l'onorabilità di
quest'ultimo, sottoposto al compimento dei 18 anni alla prova della
dokimasìa, cioè all'esame con cui si veniva abilitati a ricoprire cariche
pubbliche. Data l'importanza assai alta con cui nel mondo greco si
valutava l'onore ed il coraggio, identitari per l'eccellenza della
mascolinità,, ogni concessione imputabile come femminilizzante
finiva, come nel teatro di Aristofane, per essere materia di dileggio,
quando non di aperto disprezzo collettivo.
L'amore di Patroclo e di Achille in Omero non trova mai
descritto il loro legame come esplicitamente sessuale, e nelle
immagini sulle ceramiche Patroclo è ritratto con la barba, mentre
Achille è un attraente giovane appena uscito dall'adolescenza. Solo
Eschilo in un frammento dei Mirmidoni ( fr. 135) accenna ad un
rapporto intercrurale tra i due, in sintonia con il Fedro che nel
Simposio di Platone ( testo considerato, con moltissima
approssimazione grossolana dalla cosiddetta "cultura omosessuale"
contemporanea, come una sorta di vangelo) afferma che la bellezza
di Achille lo qualificava come eròmenos del guerriero Patroclo. In
analogia vi saranno i legami di Oreste e Pilade e di Damone e
Pynthias. Come personaggi storici sono noti per il loro appassionato
omoerotismo il drammaturgo Agatone con Pausania, non meno di
154
Alessandro Magno con il suo carissimo amico d'infanzia Efestione,
stando a Plutarco e ad Arriano. Amante di Alessandro dopo la
battaglia di Gaugamela sui Persiani fu l'eunuco adolescente Bagoas
(Curzio Rufo, St. Al. Magno, VI, 5, 23). Parmenide aveva un amante
di nome Zeno (fonte: Platone, Parmenide, 127 ter); Eudosso di Cnido
fu lungamente adorante il medico Feomedonta (Diogene Laerzio,
VIII, 86); Gerone siracusano era follemente innamorato del bel
Dailoha (Senofonte, Ierone, I, 31); Cicerone (Tusculane, V, 20)
racconta di Dionigi il Vecchio che ordinò la morte del suo drudo ,
temendo che lo volesse uccidere; Tucidide (Peloponnesiache, 132-3)
riferisce che Pausania, re di Sparta, condannò a morte l'amante
Argila nel timore che complottasse contro di lui; Plutarco (Agesilao,
2) dice che Agesilao II spartano da giovane era stato acceso
intensamente da Lisandro, che operò per la sua conquista del potere;
Archidamo I di Sparta fu innamorato del demagogo ateniese Cleon
(Senofonte, Storie, V, 4); Epaminonda tebano morì al fianco del suo
prediletto nella battaglia di Mantinea (Cornelio Nepote, Epaminonda,
4); l'adolescente Alcibiade cercò di sedurre Socrate (Plutarco,
Alcibiade, 4), ma si rifece avendo poi come amante Anita , uno degli
accusatori di Socrate (ibid.); Temistocle ed Aristide in gioventù
contrastarono per l'amore dello stesso uomo (Plutarco, Temistocle, 3 e
Aristide, 2). Il settantenne commediografo Euripide era perso
d'amore per l'avvenente drammaturgo trentacinquenne Agatone. Lo
spartano Alcmane ci ha lasciato versi molto accesi di tono
omoerotico; segni anche in Simonide di Ceo, Teognide di Megara,
Ibico, Anacreonte e nello stesso Solone. In Aristofane compaiano, a
fini di scherno satirico nei confronti della deriva dell'effeminatezza
gravante sulla tendenza omosessuale, diversi personaggi. Pindaro (fr.
123) nel celebrare le Olimpiadi loda il "fresco corpo adolescente" del suo
amasio, rivaleggiando sul tema con Bacchilide (X, 39-45). Parmenide
nel suo poema "Sulla natura" (fr. B 18) spiegò la comparsa
dell'omoerotismo, mentre Ippocrate (Su una dieta, I, 28) la attribuisce
ad una sorta di "miscela scombinata" all'atto del concepimento. Lo
scultore Fidia (Pausania, Descrizione della Grecia, 11, V, 3) fu tanto
legato all'eleatino Pancart da inciderne il nome sul dito della statua di
Zeus Olimpio (Clemente Alessandrino, Esortazione ai Gentili, 53, 4).
Prassitele scolpì una effigie di Eros così bella da far innamorare del
manufatto un giovane di Rodi che vi lasciò la "traccia bagnata" del
suo affetto (Plinio il Vecchio, Nat. Hist., XXXVI, 22).
155
Graecia capta ferum victorem cepit: L'omoerotismo trionfante in
Grecia fu esportato con convinzione in quella Roma dove le relative
pratiche erano concesse solo a danno di schiavi e liberti.. La lex
Scatinia arrivò lapidariamente a condannare i rapporti omosessuali
tra adulti e pueri, mentre la sodomia tra cittadini adulti liberi veniva
punita con sanzioni economiche in danno di chi assumeva il ruolo
passivo. In piena analogia con il mondo greco, presso i romani la
società era fondata su robuste basi maschilistiche che, dagli
atteggiamenti derisori ad altri più persecutori, portavano a
disprezzare apertamente ogni ruolo di sottomissione visto come
abdicazione alla virilità e sintomo di mollezza. La contrapposizione
attivo/passivo superava gioiosamente (si fa per dire) la tormentata
concezione dell'antitesi omo-eterosessuale, tanto da suggerire ad
Eva Cantarella il titolo di un saggio straordinariamente felice:
"Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico" (1988); in questo studio
emerge che né Roma né Atene erano la terra felice della libertà
sessuale (come certa schiamazzante pseudo-letteratura da gay pride
vuol far credere a chi urlazza di "orgoglio omosessuale"). Intanto,
diversamente dall'anarchia sociale che si vuol contrabbandare per
"difesa dei diritti" (diritti che nessuno dotato di minimo senso
comune intende negare a chi, chiusa la porta di casa, si trastulla
come gli pare opportuno con chi gli si conceda liberamente, anche
prezzolato). Gaio Valerio Catullo, per stare ai romani, nel carme 16
(che non si legge mai a scuola) minaccia i rivali d'amore che cercano
di screditarlo presso l'amato Giovenzio avvertendoli che li stuprerà
in tutti gli orifizi. In questo atto di vendetta verbale appare chiaro
che se Lesbia si dona generosamente al giovane poeta (e ad altri),
compie un atto di sottomissione "secondo natura", essendo appunto
"secondo natura" soggiogare uomini e donne: con il che è
dimostrato che con "secondo natura" si etichettava un simbolo di
natura culturale accettata e persino di morale universale.
Non tutto il mondo classico è concorde nel considerare la
pulsione erotica come segno di positività. Anzi, presso Epicuro e gli
Stoici in particolare la "passione" si connota di negatività, come una
fonte di turbamento, irrazionale segno di disordine interiore.
Platone concorda nel valutare negative le "passioni", inquinanti
l'anima e legate alla corporeità, mentre si sforza di accentuare la
positività dell' "amore" quale strumento che innalza dal mondo
sensibile e fenomenico al sovrasensibile cielo delle "Idee". Ma
occorre ricordare che in greco eìdos significa "forma". Quindi,
156
cacciato dalla finestra, l'amore con volto di philìa (amore-amicizia)
trionferebbe come èros, cioè amore-passione. Infatti nel Fedro (244 a
- 245 c) l'amore è manìa (follìa); ma è "follia divina" (theìa manìa). E
per un colpo d'ala classificatorio (tipica patologia dei filosofi) arriva
a catalogare ben quattro forme di theìa manìa : la follia mantica
(profetica) ispirata da Apollo e dal sole suo simbolo (propria, per
esempio dei poeti-vati che si "ispirano" (aspirano) divinando dai
fumi dei trìpodi); la follia telesica (dei riti orgiastici) ispirata da
Dioniso [quante volte poi ci sentiremo analizzare dai medici come
dionisiaci vs/apollinei ! ]; la follia artistica, ispirata dalle Muse; la
follia erotica, ispirata da Eros ed Afrodite, che è la più comune e
desiderata di tutte. Lo stesso Platone nel Simposio (testo ambientato
nel 416 a.C. che è assurto a Bibbia di ogni omosessuale bisognoso di
patetiche certificazioni culturali per le sue tendenze) descrive, per
bocca di Socrate che riferisce un racconto della sacerdotessa
Diotima, il mito della nascita di Eros, figlio di una mendicante
(Penìa, Povertà) e di un dio (Pòros, Espediente): segno che l'amore
nasce dalla mancanza ed è pronto a tutto per soddisfare i suoi
bisogni. Figlio di una mortale e di un dio, egli è un daìmon, termine di
difficile interpretazione, tanto che ci si accontenta di spiegare il
simbolo come tensione interiore che affligge l'amante il quale
desidera ciò che non ha, come il filosofo che cerca la sapienza, ma
non la raggiunge. Eros è il desiderio bruciante della bellezza e della
bontà, della sapienza e delle virtù in chi, desiderandole fortemente,
non le possiede. Quindi è un "tendere verso". La bellezza è l'unica
Idea (sempre da intendersi come Forma) che si manifesti nel mondo
visibile, fenomenico; quando ci appare abbiamo la percezione
(quasi) netta di chi siamo, da dove veniamo e infine (ma con lo
struggimento del desiderio) di dove vorremmo andare. Il processo
della conoscenza è più forte come anàmnesis, cioè come ricordo di
ciò che eravamo e siamo, al confronto di chi vorremmo essere. Il
cammino di ascesa nel mondo delle Idee si innalza grazie alla spinta
di Eros che ci invita a contemplare il "bello in sé e per sè", l'Idea di
Bello che corrisponde al Bene. Non è facile salire dalla philìa, che ci
lascia dove ci troviamo, al mondo di Eros, dove vorremmo essere.
Di qui nasce uno degli equivoci più comuni: quello di considerare il
cosiddetto "amor platonico" come asessuato per definizione,
condannato ad una castità persino gioiosa, tutta cerebrale e
spirituale. Una parte della "colpa" è proprio di Platone (ma ancor
più dei suoi esegeti), quando - sempre nel Simposio dando voce a
157
Pausania- il filosofo distingue due Veneri, la Pandemia e l'Urania, e
quindi due amori. Il primo, pandemio, è "volgare", nel senso
proprio, in quanto popolarmente approvato perché realizzato nel
tripudio sessuale e -soprattutto- rigorosamente eterosessuale. Si
aggiunga il sospetto che per Platone (come per tutti i greci) la donna
non fosse in grado di suscitare attrazione spirituale, da compensare
quindi con la quasi celestiale condizione dell'orgasmo compensativo
e di non difficile conseguimento, come è nell'ordine generale della
riproduzione in tutta la vita biologica. Ecco invece che l'amore
"uranio" (etimologicamente: celeste) induce ad invaghirsi della
bellezza dell'anima, prescindendo dalla componente sessuale, così
terragna; elevarsi all'Idea vuol dire liberarsi dalla materiale
corporeità, innalzati dal "cavallo bianco" ricordato nel mito della
biga alata del Fedro che simboleggia l'elegante lindore dell'anima
nobile ed eccelsa. Da allora, quanti "cavalli bianchi" sfileranno nei
sogni e negli spot pubblicitari ! L'amore "uranio" è roba da spiriti
evoluti che cercano altrettali spiriti evoluti: in questa dimensione
perfetto sarebbe (ahimè) il caso di maschi (esseri superiori ?) che
amano maschi, magari giovani e piacenti, con un rapporto di fedeltà
durabile, tale da codificarsi in Achille e Patroclo, nel "battaglione
sacro " tebano (di cui parla Plutarco nella Vita di Pelopida) così
presente ad un Oscar Wilde nella sua autodifesa nel celebre processo
di sodomia. Però è prudente avvertire che la "falange degli amanti"
non era ritenuta una sezione dell' Arcigay, risultando almeno
grottesco il tentativo di indossare come omosessuale l'abito della
virilità di temibile soldato sopra la pelle di un omosessuale.
Platone regalò uno strumento formidabile, con il suo "amor
platonico", al neoplatonismo di Plotino ed alla dottrina cristiana
teorizzante l'amore come unione mistica con Dio. In Marsilio
Ficino ed in tutta la filosofia rinascimentale l'eros è visto come
potente mezzo per identificarsi con Dio inteso quale razionalità
della natura: lo dice un neologismo come "indiarsi", fino alla mens
insita omnibus di Giordano Bruno. Per Ficino, primo traduttore in
latino dell'opera di Platone, l'anima (e perciò l'uomo) è copula mundi,
punto di congiunzione e di sintesi tra Dio e il mondo. Con il che il
vero amore per Ficino non può che essere omosessuale, equazione
non necessariamente legata alla otturazione di orifizi tra uomini
legati dal concorde amore del sapere: parrebbe una arditezza
giustificativa di pulsioni da Venere Pandemia traviata. Anche perché
egli dichiara che le donne sono del tutto inadatte a corrispondere la
158
profondità della spiritualità, in quanto stimolabili alla congiunzione
finalizzata alla riproduzione della specie. Ficino non ebbe troppe
soddisfazioni dalla Venere Urania: fu innamorato del giovane e pare- bellissimo Giovanni Cavalcanti che lo trattò con freddo
distacco, poco persuaso dalle chiacchiere sulle "bellezze" ideali che
puzzavano lontano un miglio di turgori non desiderabili.
Pico della Mirandola invece ebbe miglior fortuna sentimentale,
grazie all'ardore che gli dedicò Girolamo Benivieni, tale da superare
la morte che colse Pico trentaduenne il giorno stesso dell'ingresso in
Firenze di Carlo V ° (17 novembre 1494). Girolamo meditò il
suicidio, ma prevalse -se non l'amore- il fedele ricordo che durò fino
alla sua fine (89 anni). Volle quindi farsi seppellire con Pico nella
chiesa di san Marco, dove è visibile la lapide che li unisce, che reca
inciso: "Girolamo Benivieni, affinchè dopo la morte la separazione di luoghi
non disgiunga le ossa di coloro i cui animi in vita congiunse Amore, dispose
d'essere sepolto nella terra qui sotto." Girolamo Savonarola, che conobbe
Pico, tuonò in una sua predica che non aveva potuto salire subito al
paradiso, perché impedito da "certi peccati" su cui sorvolò; ma
invitò i devoti a pregare per la sua anima. E a Firenze la colpa di
sodomia era di solito "purificata" con le fiamme del rogo. Qualche
scrittore di libri gialli potrebbe sbizzarrirsi a mettere insieme la storia
di Pico con quella del Poliziano, morto rapidamente a due mesi di
distanza poco dopo un giovane prostituto che l'aveva accusato di
averlo infettato. Forse incombeva la grande, terribile epidemia di
sifilide che devastò l'Europa nel 1493-4. Come sempre ci si divide
sui nomi: si volle chiamare la sifilide "mal francese" ed i francesi la
denominarono "mal napoletano". La differenza geografica del
morbo non risultava meno mortale.
Senza dubbio il mondo classico nei confronti
dell'omosessualità differiva totalmente da ogni altra epoca. Ogni
valutazione relativa alla sessualità non si basava sulla scelta del
genere tra i due cosiddetti "sessi principali", essendo prevalente la
funzione del ruolo, con una netta distinzione tra passività (talora
violentemente disprezzata) ed attività, considerata comunque segno
di virilità. In più la liceità dell'atto omoerotico si distingueva per la
condizione personale (uomo libero o schiavo) del soggetto ricettivo.
Nessuna connotazione negativa cadeva sui rapporti di adulti con
minori, ma con il limite netto nella condizione del raggiungimento
dei diritti di cittadinanza del pupillo. Certo la Grecia arrivò a
giustificare l'amore omosessuale con motivazioni filosofiche e
159
raffigurazioni artistiche, la cui originalità mancò ai romani. Ma la
vera differenza avvenne con il passaggio al mondo cristiano, erede
della teologia ebraica. O se vogliamo, con l'ultimo grande mito del
mondo classico, quello appunto di Antinoo e della sua morte.
Anche per questo il Rinascimento, l' italiano in primis, proprio
per la sua natura di nuovo ed attivo erede del mondo classico e della
sua concezione antropocentrica, nella prodigiosa e geniale fioritura
artistica che recuperò soggetti e temi a carattere laico e mondano
(senza per questo assumere nel suo complesso rilevanti
atteggiamenti ateizzanti, materialistici, laicistici ed anti cristiani), è
stato letto in chiave di "orgoglio omosessuale", come un'età di
"liberazione" dei costumi dal pesante giogo medievale, soprattutto
clericale. A parte il fatto che non fu affatto così (nel senso che il
medioevo non fu per nulla un succedersi di "secoli bui"), e che il
Rinascimento non ruppe catene di alcun carcere, occorre prendere le
distanze da quella variopinta lettura cosiddetta "gay" che elenca con Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Cellini, Caravaggio,
Poliziano, Pulci e via chiassosamente citando - una sorta di
processione di indubbi "geni" per dimostrare ( o comunque
insinuare) che la eccellenza creativa risiederebbe nella deriva
omosessuale. Nulla di più falso, nel senso che la "genialità", come lo
Spirito Santo, "soffia dove vuole"; e che perciò, ammesso ma non
concesso che i suddetti avessero chiare inclinazioni alle pratiche
omoerotiche, resta sempre da stabilire per quale ragione certa
l'omosessualità sia una leva, necessaria e persino indispensabile, così
potente di creatività eccezionale suprema nel cammino del pensiero
umano. Come si usa dire, molte brave persone sono vegetariane,
anche perché provano legittimo orrore nel nutrirsi di carne animale
morta. Hitler, per esempio, era un convinto vegetariano: e allora?
Più banalmente ancora, non è da molto e per molti roba da
shaarya la convinzione diffusa (in una vasta accezione della opinione
pubblica di cultura "occidentale") della accettazione delle libertà
sessuali (in un regime di ammesso consenso, pur con un dibattito
normativo in fieri). Allora perché far tanto chiasso sul tema della
"diversità"? Come diceva un grande saggio: "Ci siano pure i
"diversi"; mi basta che accettino che io sono "differente".
160
Più o meno diversi
Lino Lantermino
Al Prado, c'è un dipinto di Goya che amo particolarmente: è una
delle pitture nere della Quinta del Sordo, forse la più inquietante.
Vi si vede soltanto la testa di un cane, colto nella sua tenace , ma
cieca ed affannosa lotta per tenere la testa fuori dalla sabbia, una
sabbia che frana su di lui.
Il suo è soltanto un breve respiro nella morsa di un meccanismo
privo di appigli, e colpisce... colpisce perché il cane non ha colpa.
Il cane è innocente.
Il suo ritratto esprime soltanto solitudine, privazione, paura ed
abbandono.
Andate al Prado.
Scoprirete che quel cane abbandonato e solo, è la suprema
rappresentazione dell'uomo truffato dalla vita, “jeringado” (come
commentava Goya il suo 58° Capricho) “l'uomo fottuto da Dio,
dalla vita, dagli uomini... da tutto”.
Andate al Prado.
O, se vi capita, andate a Barcellona Pozzo di Gotto, vicino a
Messina; andate all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di quella bella
cittadina siciliana, e vi troverete lo stesso sguardo disperato del cane
di Goya, la stessa solitudine, lo stesso abbandono. Moltiplicati per
223 volte.
Tanti sono gli internati dell'O.P.G. Di Pozzo di Gotto: 223 esseri
umani diversi, più diversi, molto più diversi degli altri diversi.
Se volete cercare la bellezza della diversità, non andate soltanto a
pretendere diritti in colorite sfilate, non andate soltanto a gridare la
giusta pretesa di sradicare ogni forma di intolleranza, odio e
discriminazione, non andate solo ad esigere accoglienza ed
uguaglianza, per tornarvene poi tranquilli alle vostre case sicure.
No! Andate all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Pozzo di Gotto.
Respirate con il mucchio di corpi stivati...le insonnie e le ore delle
notti d'estate, i rimbombi nei corridoi, le veglie, le urla, le grida
improvvise, la dignità difficile, l'infamia, le mutilazioni e lo sconforto
mescolati insieme...
Sono 223 esseri umani “diversi”, più diversi degli altri.
Se volete tutelare la bellezza della diversità, andate a Pozzo di Gotto:
161
O.P.G.
Non è un carcere, non è un ospedale, eppure ci sono sbarre e malati:
Ospedale Psichiatrico, dove vengono applicati norme e regolamenti
penitenziari.
Se volete difendere i diritti civili, se volete lottare per abbattere le
cosiddette cortine culturali, se volete garantire i diritti di tutti,
cominciate da lì.
O.P.G. di Pozzo di Gotto, dove vivono internati i “diversi” più
diversi di tutti, animali rinchiusi in uno zoo senza visitatori, un
piccolo mondo...alla periferia del mondo.
O.P.G., oltraggio alla coscienza civile.
O.P.G., inaccettabile per sua natura, per il suo mandato, per la
legislazione incongrua che lo sostiene.
O.P.G.,frutto di omissioni e mancata assunzione di responsabilità da
parte di Governi,
Regioni,ASL locali e Dipartimenti di salute mentale.
O.P.G., dove sono rinchiuse persone che da 23 anni hanno finito di
scontare la pena e sono ancora lì, buttati in una discarica sociale
dove si gettano le più diverse categorie di indesiderabili...quelli
“diversi”, i più diversi di tutti.
O.P.G., dove sono rinchiusi esseri umani magari prosciolti dai reati
di cui sono stati accusati, ma che continuano a scontare il loro
“ergastolo bianco” perché non è stata dichiarata cessata la loro
presunta pericolosità sociale (concetto ambiguo, di vago sapore
lombrosiano).
O.P.G., dove il malato recluso non può sapere quando uscirà, dove
la durata della prigionia non ha attinenza con il reato commesso e
dove il termine “infermo di mente” equivale a socialmente
pericoloso.
Andate all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Pozzo di Gotto.
Troverete Paolo, che nel 1993 alla stazione di Catania rapinò di 7000
lire un tale puntandogli contro il dito indice nascosto in una tasca,
(una specie di rapina a dito armato). Paolo, scontata la pena, è in
O.P.G. da diciotto anni.
Andate all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
Troverete Franco, cittadino invisibile, condannato per aver
disturbato una funzione religiosa.
E' lì da 14 anni, tolto di mezzo perché pericoloso per la società.
E pensare che, quando lo portano fuori, va a rifugiarsi negli ultimi
162
banchi della prima chiesa che incontra... forse alla ricerca di un dio
che si è scordato di lui.
Franco è silenzioso e muto... comunica soltanto con un gatto
randagio, randagio quanto lui.
Andate all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, dove si dice
pericolosità sociale per disinteressarsi del problema.
Andate a trovare Giuseppe, gettato in O.P.G. per seminfermità
mentale. Pena scontata; non prende farmaci, non vuole la pensione
perché sa lavorare e vuole lavorare, ma lo tengono lì perché ogni
volta che chiede la revoca dell'O.P.G., si vede riaffibiata la
“proroga”: cioè la mancata scarcerazione pur avendo scontato la
pena.
E questo per pericolosità sociale o, meglio, per assenza di un
programma di inserimento sul territorio.
Andate in O.P.G. e chiedetevi perché esiste un istituto di questo
tipo, dopo che è stata decretata la chiusura dei manicomi in nome
della CURA e della PIETA' verso gli uomini.
Chiedetevi in nome di cosa, è possibile l'esistenza di luoghi in cui
una persona resta rinchiusa per anni in attesa di cure, di giustizia, di
un reinserimento sociale che non avverrà mai.
E' “diverso”? E se è diverso, cosa ha di più diverso degli altri? Forse
è più diverso perché appartiene alla categoria dei più deboli, degli
ultimi?
Ricordo soltanto che il 17 gennaio 2012 la commissione giustizia del
Senato dispose la chiusura definitiva dei 6 O.P.G. Italiani entro il 31
marzo 2013.
Con decreto legge del 25 marzo 2013, il governo italiano ne ha
disposto la proroga al 1 aprile 2014.
Andate a Pozzo di Gotto.
Parlate con don Pippo Insana, da 28 anni cappellano impavido di
quell'inferno.
Chiedetegli della sua casa d'accoglienza con solo 12 posti letto (di
più non può).
Chiedetegli della sua guerra contro la sordità delle istituzioni, contro
i comportamenti ottusi e dilatori di costoro.
Chiedetegli delle autorità che preferiscono prolungare i
tentennamenti, l'oblio, l'indifferenza e le pavide abulie.
Chiedetegli dei suoi malati definiti pericolosi, anche se curabili
all'esterno...
163
Chiedetegli soprattutto se fa tutto questo per coerenza umana o
per coerenza cristiana.
Vi risponderà:”per rispetto della dignità, quella del diverso, il più
diverso di tutti”.
164
Da Antinoo a Marilyn: la grande illusione
Vanna Pescatori
Chi è Antinoo? Antinoo è una straordinaria operazione mediatica di
quasi duemila anni fa che ha creato la grande illusione. L’illusione
della bellezza assoluta. L’illusione della composizione degli opposti.
L’illusione della superamento del dualismo eros-thanatos. L’illusione
dell’immortalità.
E’ l’espressione della trasformazione di un’esperienza individuale e
privata in comunicazione collettiva, una comunicazione così forte da
aver superato venti secoli di storia, offrendosi a sempre nuove
interpretazioni, da quelle negative dei cristiani che distruggevano le
statue dedicate al bellissimo giovane amato dall’imperatore Adriano,
considerandolo simbolo di pederastia, al poeta Shelley che lo esalta
in un sonetto,”Eager and impassionated tenderness, sullen effeminaci ’’ .
Cambiano i tempi, cambiano i media, ma nella costruzione del mito
di Antinoo si possono riconoscere elementi che non differiscono
troppo da quelli impiegati nella moderna costruzione di un mito
contemporaneo, o forse di qualsiasi mito, in quanto poggiano su
costanti dell’umano sentire.
Adriano fa venerare il suo favorito, morto non ancora ventenne,
come un dio. Gli dedica una città, Antinopoli, vicino al luogo, sulle
sponde del Nilo, dove era stato ritrovato il corpo. Dichiara la sua
data di nascita, il 27 novembre, giorno festivo. Il giovane bitinio
viene rappresentato dai sacerdoti egizi con le sembianze di Osiride,
il dio che rinasce dalle acque, la massima divinità religiosa a cui
erano assimilati i faraoni. Quando fa ritorno in Italia dall’Egitto
dopo il 133, l’imperatore progetta di onorare, a Villa Adriana, il suo
perduto amore con un grande edificio funebre, in cui è stato
riconosciuto l’Antinoeion, collocato lungo l’ingresso monumentale
che conduceva al Grande Vestibolo, ritrovato negli scavi
archeologici del 2002. Persino una costellazione prende il suo
nome.
Antinoo, il vero Antinoo, quello che è rimasto
statue, nelle effigi, nelle monete che l’imperatore
dalla sua morte (“Piangeva come una donnicciuola ’’
Aelius Spartianus, nel XIV capitolo di “De
165
consegnato nelle
Adriano, provato
scrive il biografo
Vita Hadriani’’:
‘’Antinoum suum, dum per Nilum navigat, perdidit, quem muliebriter flevit
“), gli fece dedicare, è diventato la materia prima di un mito – quindi
una esperienza collettiva - che lo trascende e, trascendendolo, lo
eternizza.
La voce del mito
Marguerite Yourcenar dà voce, con la parola, a questo mito
sollevando Antinoo dalla dimensione storicizzata, a cui attinge da
studiosa, per elevarlo a quella della poesia. E’ una specie di gioco di
matrioske: l’autrice conferisce il suo pensiero a quello di Adriano
che a sua volta lo conferisce ad Antinoo: l’ultimo è colui che si
nasconde nel fondo e che perde progressivamente la sua consistenza
di essere umano, con i suoi limiti e le sue debolezze per rinascere in
forma simbolica: bellezza assoluta, passione assoluta, fedeltà
assoluta, sacrificio assoluto.
Si tratta, dunque, di un trasferimento sostanziale dalla materia,
testimoniata dai ritrovamenti archeologici, dalle cronache, dalle
biografie, all’immaterialità della rappresentazione mitica, per cui
l’Antinoo nato probabilmente nel 114 in Bitinia e incontrato da
Adriano nel suo transito per la regione, nel 123, è solo un pretesto,
un “incipit’’, un’ispirazione.
Seguendo gli studi di Kàroly Kerénky, la costruzione del mito di
Antinoo sembra ricondursi ai “mitologemi’’. “Il modellamento, nella
mitologia, è immaginifico – scrive nei “Prolegomeni allo studio
scientifico della mitologia’’ – Scaturisce un fiume di immagini mitologiche.
Uno scaturire che, nello stesso tempo, è un esplicarsi: fissato, come i mitologemi
sono fissati nelle sacre tradizioni, esso è una specie di opera d’arte’’. E più oltre
‘’La mitologia, come la testa recisa di Orfeo, continua a cantare anche dopo la
sua morte, anche a lunga distanza dalla sua morte’’.
E’ quello che è successo con il giovane amante di Adriano al quale il
maturo imperatore ha conferito la dimensione sovratemporale e,
con essa, l’altro status che Kerénky richiama: la dimensione poetica
che illumina le “Memorie’’ della Yourcenar. ‘’Da quest’aspetto
immaginifico-significativo-musicale della mitologia deriva che l’unico giusto modo
di comportarsi nei suoi riguardi è quello di lasciar parlare i mitologemi per se
stessi e prestar loro semplicemente ascolto. La spiegazione deve rimanere in
questo caso sullo stesso piano che occupa la spiegazione di un’opera musicale o,
tutt’al più poetica...’’Orecchio’’ significa anche qui vibrar insieme, anzi un
espandersi insieme’’.
166
La parola della scrittrice “vibra’’ accostandosi alla vicenda, fino ad
esprimere, con la narrazione, una sorta di penetrazione empatica nel
sentire di Adriano, all’interno della quale si possono riconoscere
alcuni temi, come tappe. La Yourcenar conduce il lettore a
ricostruire l’elaborazione del mito di Antinoo, attraverso la
declinazione di coppie di opposti.
Gioventù-vecchiaia:
Antinoo ‘’Era greco’’, “Aveva le infinite capacità di allegria e d’indolenza di
un cucciolo, la selvatichezza, la fiducia’’.
Adriano: nato ad Italiaca, in Spagna, nel 76, aveva quasi 50 anni
quando incontra il giovinetto e se ne innamora. Due mondi distanti,
nello spazio geografico-culturale e nello stacco anagrafico, che
vengono a contatto. L’incontro con Antinoo rinvigorisce Adriano:
“Quando mi volgo indietro a quegli anni, mi sembra di ritrovare l’Età dell’Oro.
Tutto era facile: le fatiche d’altri tempi erano compensate da una facilità quasi
sovrumana. ...La passione appagata ha la sua innocenza...Quell’avventura
iniziata in modo banale arricchiva la mia vita, ma la rendeva, d’altro canto, più
semplice: l’avvenire contava poco, cessavo d’interrogare gli oracolo, le stelle non
furono più, d’allora in poi, che disegni mirabili sulla volta del cielo’’.
E alla fine del viaggio in Africa: “il mio compagno indossò con gioia puerile
la corazza e la tunica militare; io fui per qualche giorno il Marte nudo, che, con
l’elmo in testa, prende parte alle esercitazioni del campo, l’Ercole atletico ebbro
della consapevolezza del suo vigor ancor giovane’’.
Inesperienza-esperienza:
Adriano era un uomo colto, un letterato, appassionato di rime, di
note e di stelle, curioso di misteri e di magia, ma anche razionale per
l’esperienza militare e di governo.
Antinoo ‘’era poco istruito, ignaro quasi di tutto, ma riflessivo, ingenuo’’,
dunque plasmabile.
L’imperatore può costruire la sua creatura, innestando la conoscenza
sulla bellezza, di cui è appassionato osservatore e cultore: ‘’Trahit sua
quemdue voluptas: ciascuno la sua china, ciascuno il suo fine, la sua ambizione,
se si vuole, il gusto più segreto, l’ideale più aperto. Il mio era racchiuso in questa
parola: ‘’il bello’’, di così ardua definizione a onta di tutte evidenze dei sensi e
della vista. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo’’. Conoscenza o
sapere solo e soltanto da lui scelti e atti ad aggiungere perfezione
167
alla sua creatura. ‘’l’alunno, che a Claudiopoli aveva imparato a memoria
lunghi frammenti di Omero e si appassionava di poesia lasciva e raffinata, ora si
estasiava di alcuni brani di Platone. Il mio pastorello diventava un giovane
principe’’. ‘’Mi accadde di dimenticare la persona umana, il fanciullo che
s’affannava invano a imparare il latino, o pregava l’architetto Decriano di dargli
lezioni di matematica...’’
Anche la modificazione fisica, dipendente dalla crescita, diventa, per
l’imperatore, frutto della sua opera di artista: ‘’In verità, quel volto
mutava, come se ogni notte e ogni giorno io l’avessi scolpito’’.
Sottomissione-dominio
Adriano prova l’ebrezza di essere stato ‘’padrone assoluto una volta sola,
di un solo essere’’.
Antinoo è fedele, sottomesso: ‘’quelle palpebre tante vole abbassate
nell’acquiescienza e nel sogno, si levavano; gli occhi più attenti del mondo mi
scrutavano il viso; mi sentivo giudicato. Ma lo ero, come lo è un dio da un suo
fedele’’.
Il senso del dominio inebriante perdura anche dopo la morte
dell’amato: ‘’I miei rimorsi, a poco a poco, sono divenuti anch’essi un aspetto
amaro di possesso, un modo per assicurarmi d’essere stato sino alla fine lo
sventurato padrone del suo destino’’ – appena velato da un senso di
rispetto –‘’Ma non ignoro che bisogna fare i conti con le iniziative personali di
quell’estraneo affascinante che resta, malgrado tutto, ogni essere amato. Se
m’assumo tutta la colpa, riduco quella giovane figura alle proporzioni d’una
statuetta di cera che io avrei modellata e poi infranta con le mie stesse mani.
Non ho il diritto di avvilire quel raro capolavoro che fu la sua fine; devo lasciare
a quel fanciullo il merito della propria morte’’.
Piacere-repulsione
‘’In quell’epoca, nel consolidare la mia felicità, nell’assaporarla, nel valutarla
persino, ponevo l’attenzione costante che ho sempre prestata ai particolari più
futuli delle mie azioni; e che cos’è la stessa voluttà se non un momento di
attenzione appassionato del corpo? Qualsiasi felicità è un capolavoro: il minimo
errore la falsa, la minima esitazione la incrina, la minima grossolanità la
deturpa, la minima insulsaggine la degrada’’. Al colmo del suo rapporto
con Antinoo, Adriano esalta la pienezza del sentimento amoroso
come perfetta sintesi di esperienza sensoriale e psichica.
168
Un’esperienza che lo fa partecipare della natura divina: il giovane
amante inizia a tramutarsi in un fanciullo-dio.
‘’Quel giovinetto dalle gambe ripiegate sul letto era Ermes in persona, che si
scioglie i sandali, era Bacco, mentre coglieva un grappolo o assaggiava per me
una coppa di vino rosato; le sue dita, indurite dalla corda dell’arco, erano quelle
di Eros’’.
Il giogo dell’amore però si fa sentire e diventa inquietante:‘’Ma il peso
dell’amore, come quello di un braccio teneramente posato sul petto, a poco a poco
si rendeva pesante”. Adriano ritorna alle vecchie consuetudini: le notti
di piacere, passando a Dardi “da un luogo di perdizione a un altro” e a
Smirne dove ‘’costrinsi il mio giovane amico a subire la presenza di una
cortigiana ’’. Il fanciullo s’era fatto dell’amore un’idea che restava austera, perché
era esclusiva; il suo disgusto giunse fino alla nausea. Poi, ci si abituò. Quelle
vane prove si spiegano con la mia inclinazione alle sregolatezze; vi si mescolava
la speranza d’inventare un’intimità nuova…vi si mescolava la bramosia
d’istruirlo…fors’anche, più inconfessata, l’intenzione di degradarlo a poco a poco
al livello dei piaceri banali che non impegnano ’’.
Adriano si fa condizionare dai pregiudizi di Roma ‘’essi concedono al
piacere la sua parte, ma stimano l’amore una mania disdicevole; ero ripreso dalla
furia di non dipendere da nessun essere in maniera esclusiva ’’.
L’irritazione cresce fino al gesto incontrollato: ‘’mi accadde di
percuoterlo. Ricorderò sempre i suoi occhi atterriti ’’.
Morte rituale – rinascita
Nelle “Memorie’’, tutto il rapporto tra Adriano e Antinoo è segnato
da riferimenti alla morte. Questo si rende indispensabile, proprio in
quanto racconto a posteriori, ma la Yourcenar vi aggiunge, di suo,
una lunga preparazione, un declinazione di indizi in cui la vita e la
morte si contrappongono, sempre sfiorandosi.
Adriano autorizza il filosofo Eufrate a togliersi la vita, per porre
fine alle sofferenze che pativa. ‘’Eufrate...ottenne l’autorizzazaione che
implorava; gliela feci portare dal mio fanciullo, forse perchè io stesso avrei gradito
ricevere dalle mani d’un simile messaggero quel responso finale. Quella sera, il
nostro filosofo si presentò a palazzo per una conversazione che non differiva in
nulla dalle precedenti; si uccise l’indomani. Parlammo più volte di questo
incidente, il fanciullo ne rimase contristato per qualche giorno. Quello splendido
essere sensuale guardava la morte con orrore, non mi accorgevo che ci pensavo già
da molto.Quanto a me, stentavo a comprendere che si lasciasse volontariamente
169
un mondo tanto bello; che non si esaurisse fino in fondo, a onta di tutti i mali,
l’estrema possibilità di pensiero, di contatti, di spettacolo, persino’’.
Altri episodi offrono un percorso di avvicinamento all’epilogo:
Il sacrificio del toro, a cui Antinoo partecipa come attore.
L’improvvisa e “magica’’ uccisione in vetta al monte Cassio, della
vittima sacrificale e di colui che avrebbe dovuto compiere il
sacrificio, colpiti entrambi da un unico fulmine:’’La folgore del Monte
Cassio gli indicava una soluzione: la morte poteva diventare una forma estrema
di devozione, l’ultimo dono, il solo che sarebbe rimasto’’’.
Il sacrificio del falcone (con una curiosa analogia alla novella del
Boccaccio “Federigo degli Alberighi’’, Decameron, V Giornata,
dove vi è anche un rapace sacrificato all’amore).
Una maga,
interrogata a Canopo, fa predizioni sinistre all’imperatore e per
contrastare il responso, propone un sacrificio magico utilizzando un
animale domestico che doveva essergli appartenuto.
‘’Il mio giovane amico mi propose il suo falcone..Il fanciullo lo nutriva con le sue
mani, era una delle poche sue proprietà alle quali fosse affezionato...Antinoo
tolse il cappuccio al suo falcone, ne carezzò lungamente la testolina insonnolita e
selvatica, lo consegnò all’incantatrice... L’animale inerte, cosparso di miele e di
essenze di rose, fu deposto sul fondo di una bacinella colma d’acqua del Nilo; la
creatura annegata si assimila va a Osiris portata dalla corrente del fiume. Gli
anni terrestri dell’uccello si aggiungevano ai miei ’’.
Presagi di una morte sacrificale per restituire la vita e quando
Antinoo muore, Adriano ne coglie il senso: “provavo io stesso una specie
di gioia orrenda a ripetermi che quella morte era un dono ’’. ‘’ Mi si accusava di
averlo sacrificato e, in un certo senso lo avevo fatto ’’.
La descrizione della morte, per affogamento, sulla sponda di un’ansa
del Nilo, e la stagione, si collegano alle celebrazioni del mito di
Osiride, che gli Egizi rinnovavano ogni anno, sia per propiziare la
crescita delle messi, sia come rappresentazione metaforica (e
simpatetica) dell’immortalità, attraverso la resurrezione del dio, dopo
che il suo corpo era stato smembrato dal fratello Seth.
Scrive James Frezer, ne “Il Ramo d’oro’’: ‘’Plutarco, per esempio ci dice
che Osiride fu ucciso nel dicissettesimo giorno del mese di Athyr, quando il sole è
nel segno dello Scorpione, e che pertanto, gli Egizi osservavano quattro giorni di
lutto a partire da quella data. Nel calendario alessandrino seguito da Plutarco,
quei quattro giorni corrispondono al 13, 14, 15 e 16 novembre, data che collima
perfettamente con le altre indicazioni fornite dallo scrittore e cioè che, all’epoca
della festa la piena del Nilo si stava ritirando, si placavano i venti del Nord, le
170
notti si allungavano e le foglie cadevano dagli alberi’’. E più oltre: ‘’Anche se
la cerimonia può aver presentato particolari differenti in differenti località, il
finto ritrovamento della spoglia del dio e, probabilmente anche la sua rinascita,
era un evento importante nell’anno festivo egiziano...’’ ‘’ E dalla morte e
resurrezione del grande dio, gli Egizi traevano non solo appoggio e sostentamento
in questa vita, ma anche la speranza di una vita eterna dopo la morte’’.
Antinoo muore in quella circostanza. Dalle fonti, com’è noto, non si
sa se ucciso per gelosia, vittima di un sacrificio umano per la salute
di Adriano, o come preferito dalla Yourcenar, suicida per dare al suo
maturo e potente amante il dono della sua giovane esistenza. Ed è
una morte che, nelle “Memorie’’ si presenta rituale, ancora una
volta, materia per la costruzione mitologica e pronta al passaggio
ultimo: quello all’eternità.
Per Adriano, le stelle dimenticate, nella sua Età dell’Oro, ridiventano
drammaticamente importanti dopo la morte di Antinoo: ‘’Una sera
Cabria mi chiamò per indicarmi una stella, nella costellazione dell’Aquila, che
era stata appena visibile fino allora e che improvvisamente palpitava come una
gemma, batteva come un cuore. Ne feci la sua stella, il suo segno. Ogni notte, mi
esaurivo a seguirne il corso, ho scorto strane figure in quella parte del cielo.’’
Siamo all’ultimo atto: Antinoo diventa un dio e come tale viene
rappresentato nelle statue, nelle monete, nelle gemme,
rappresentazioni che lo assimilano al mito preesistente del fanciullo
divino che, nella cosmogonia greca, è Dioniso, ma è anche Eros e
Ermes: tutti collegati all’elemento primordiale dell’acqua e tutti –
come hanno dimostrato gli studi antropologici – mitologemi arcaici
che hanno attinenza al tema della nascita, dell’amore e della fertilità.
Le mostre, anche recenti, come quella allestita a Villa Adriana l’anno
scorso, hanno raccolto quanto è rimasto dell’ operazione mediatica
del II secolo con la quale la vicenda personale e storicizzata del
giovane favorito ha dato luogo al mito, attraverso un complesso
“agganciamento’’ della sua figura, a modelli ben radicati nella
cultura greco-romana e dunque, facilmente riconoscibili: una sorta
di stereotipi per i destinatari del tempo, che forse noi non siamo
neppure in grado di decodificare completamente, se non attraverso
un apparato di studi specifici.
Chi muore giovane è caro agli dei.
171
Lo dicevano i greci e, per lo meno nei confronti di Antinoo, hanno
avuto ragione. La sua morte prematura gli ha permesso di entrare
nell’Olimpo e ha portato la sua memoria fino a noi.
E’ oggi diverso? Il mito di Marilyn Monroe, che forse non durerà
quanto quello di Antinoo, incarna per diversi aspetti le stesse
costanti: come il bitinio, anche l’attrice, icona della bellezza
femminile contemporanea, proveniva da una famiglia oscura. Come
Antinoo, diventa simbolo di eccessi erotici e di trasgressione, per
relazioni sessuali maschili e saffiche. Si lega alle sfere del potere e ne
resta invischiata; muore nel “fiore degli anni’’ lasciando dubbi e
inquietudini sulle modalità reali del suicidio che avviene,
nuovamente, in un modo rituale: alcol e psicofarmaci, simboli di un
preciso momento e di un preciso clima socio-culturale: quello
dell’America dei primi Anni Sessanta.
Dopo la morte, la bionda Marilyn rinasce sotto forma di mito: la sua
immagine, moltiplicata da Andy Warhol, diventa l’immagine di
un’epoca e il sex symbol irraggiungibile dell’eterna bellezza.
172
Natascia Chiarlo
173
«Quanto sei bella [jafah], amata mia, quanto sei bella!
Gli occhi tuoi sono come colombe,
le tue chiome sono come un gregge di capre,
i tuoi denti come gregge di pecore tosate,
come nastro di porpora le tue labbra,
la tua bocca è piena di fascino
come spicchio di melograno è la tua tempia,
il tuo collo è come la torre di Davide,
i tuoi seni come due cerbiatti, gemelli di una gazzella,
tutta bella sei tu amata mia…
Come sono belli i tuoi piedi nei sandali,
la curve dei tuoi fianchi sono come monili,
il tuo ombelico è una coppa rotonda,
il tuo ventre è un covone di grano circondato di gigli.
Quanto sei bella e quanto sei graziosa,
o amore pieno di delizie!»
174
«L’amato mio è bianco e vermiglio,
riconoscibile fra una miriade.
Il suo capo è oro, oro puro,
i suoi riccioli sono grappoli di palma,
i suoi occhi come colombe su ruscelli d’acqua,
i suoi denti si bagnano nel latte,
le sue guance sono aiuole di balsamo,
le sua labbra sono gigli che distillano fluida mirra.
Le tue mani sono anelli d’oro,
il tuo ventre è tutto d’avorio tempestato di zaffiri.
Le sue gambe colonne d’alabastro,
il suo aspetto è quello del Libano.
Dolcezza è il suo palato: egli è tutto delizie!
Questo è l’amato mio, questo l’amico mio»
175
176
La bellezza di ciò che si desidera, si ama e si ricorda
Ezio Fulcheri
Riflessioni introduttive sul tema
Il bello non è un valore assoluto; è essenzialmente una
categorizzazione della nostra mente che si applica a tutto ciò che ci
circonda, dagli esseri inanimati, al mondo vegetale e al mondo
animale e, soprattutto, con connotati sempre più particolari,
all’uomo.
Il bello è tale nella diversità dell’essere poiché è la diversità delle
menti che categorizza il bello secondo parametri e pulsioni
assolutamente non uguali in tutti gli uomini. Per comprendere
quest’affermazione basti solo pensare all’arte moderna e più in
particolare alle arti figurative del novecento ove opere raffinatissime
e culturalmente dense di significato possono essere, e sono da molti,
considerate non solo non belle ma addirittura brutte. Mode e
modelli, differenti culture e sentimenti fanno del bello un concetto
variabilissimo e dinamico. Proprio la parola “dinamica” ci sembra
caratterizzante più di ogni altra ed applicabile al divenire
intellettuale, culturale, etico e religioso dell’uomo. In quest’ottica
comprendere il divenire del senso del bello vuol anche dire accettare
le diversità, non comprendere vuol dire, al contrario, categorizzare
rigidamente e quindi escludere.
In questo momento tuttavia ci pare di poter offrire una serie di
riflessioni che scaturiscono dalla nostra personale esperienza,
un’esperienza singolare, da patologi che tuttavia ci consente di
effettuare osservazioni da una prospettiva del tutto particolare e
direi, sotto certi aspetti, privilegiata.
Non vorrei addentrarmi, anche se ne sono fortemente attratto ed
affascinato, nel tema antropologico relativo al mutare dei canoni di
bellezza a seconda delle varie popolazioni e dei vari contesti
etnografici. Da antropologo sarei tentato di fare excursus classici tra
le popolazioni non solo di differenti aree geografiche e contesti
ambientali ma anche, e soprattutto, nella storia, nelle diverse epoche
e ciò anche nell’ambito di una sola civiltà.
I gusti, la moda, la percezione dell’estetica e la condivisione dei
canoni variano, infatti, nel tempo e ciò che era bello ed elegante,
177
dopo anni può apparire buffo e di cattivo gusto, più in generale,
non più bello.
Preliminarmente occorre però differenziare la bellezza della fisicità
di una persona dalla bellezza dell’apparire di quella persona e quindi
dal modo di presentarsi, di vestirsi, di costruire o modificare la
propria immagine. Ogni individuo in fatti presenta se stesso in una
determinata connotazione che può variare a seconda delle mode e
delle influenze culturali; sotto un profilo antropologico ciò è
possibile ed anzi è assolutamente naturale poiché configura quella
scorza che è diretta emanazione del proprio io e che serve non solo
a manifestarlo ma in un certo senso a plasmarlo ed esteriorizzarlo.
Ciò che possediamo è espansione della nostra persona e tanto più
ciò che è più vicino al nostro corpo come l’abbigliamento. Il taglio
dei capelli, le cure estetiche ed i trucchi sono tuttavia qualcosa di più
diretto e più penetrante al punto da creare la nostra immagine
personale. Si parla speso di persona e di personalità ma per capire
appieno il senso del termine occorre risalirne all’etimologia. Nel
teatro romano la “persona”era la maschera che indossavano gli
attori ed attraverso la quale parlavano. La persona assolveva ad un
duplice scopo: il primo consisteva nella proprietà di amplificare la
voce mediante una sorta d’imbuto rovesciato (prototipo di un
megafono); la seconda consisteva nella possibilità di rappresentare il
volto di un personaggio ed il suo stato d’animo (ilare, irato, triste o
piangente). Proprio ricollegandosi a questo secondo aspetto, per
traslato, il termine persona fu impiegato per indicare le
caratteristiche di un soggetto e personalità per indicare l’insieme
delle caratteristiche psichiche, emozionali e di carattere. La persona
si serve dunque anche degli effetti di trucco e di colore della
maschera e la personalità si esprime nel comportamento, nella
proposizione ed anche nell’esteriorità dell’abbigliamento e delle
acconciature e con anglofonismo nel “look”.
Quanto sopra per ribadire provatamente come sia estremamente
variabile il gusto e la manifestazione culturale di esso e come questi
possano condizionare la presentazione della nostra fisicità e quindi
influire sul concetto di bellezza.
Il ragionamento allora si sviluppa obbligatoriamente tra le percezioni
del bello ed il significato che è attribuito ad esso. La percezione del
bello nell’uomo è fortemente condizionata dal pensiero per cui in
178
biologia dovremmo chiederci se esiste la percezione del bello ad
esempio tra gli animali.
Credo che gli etologi siano unanimemente concordi nell’affermare
che il concetto di bello in natura non abbia assolutamente il senso
che noi attribuiamo ad esso. I fiori sono belli secondo un nostro
canone estetico ma, in effetti, i colori e la forma obbediscono ad una
necessità funzionale e riproduttiva e non meramente estetica. I
caratteri sessuali secondari degli uccelli che determinano splendide
livree sono belli per noi ma per essi solo funzionalmente utili quali
trasmettitori di messaggi. Ne deriva che il concetto di bello è
esclusivamente una prerogativa umana al pari dell’estetica e dell’arte
che del bello è artefice, oggetto e protagonista.
“E’ bello ciò che ci assomiglia.”
Sotto un profilo psicologico ed evolutivo-comportamentale, l’uomo
è portato a categorizzare i propri simili ponendo come parametri, in
modo conscio o inconscio, una scala di valori profondamente
radicati nella percezione del proprio io.
Per tale motivo i canoni della bellezza, maschile o femminile, non
sono assoluti ma riflettono la percezione, reale o desiderata, della
propria fisicità assumendo questa come modello. Una donna
magrissima sarà portata a condizionare il concetto di bello alla
magrezza e così via per gli opposti. Ciò, tuttavia, non basta poiché
nella ricerca del bello rientrano altri parametri quali il senso
dell’eleganza, la delicatezza del comportamento, la capacità di
attrarre affascinando con la cultura o con altre doti o caratteristiche.
Finiremmo dunque con il dire che è bello ciò che ci assomiglia o che
per lo meno rientra nei nostri canoni che a loro volta sono
profondamente influenzati non solo dalla percezione della propria
fisicità e personalità ma anche dalle caratteristiche comportamentali.
E’ curioso notare come da differenti osservatori o da studiosi del
comportamento è oggi accettato che per qualche misteriosa via si
realizzi tra cane e padrone una sorta di simbiosi che porta il secondo
ad assomigliare al primo o viceversa. Questo gioco, per cui i padroni
assomigliano ai proprii cani, è molto interessante poiché, se
analizzato correttamente lasciando da parte le facili assonanze e tutti
gli aspetti ridicoli e burleschi, offre lo spunto per una considerazione
molto importante. In fatti nella scelta del cane si realizza, seppure in
modo minore e con contorni più sfumati, quella selezione di cui si
parlava poco sopra. Un padrone brachitipo, grasso e pigro
difficilmente apprezzerà un cane snello e sottile come un levriero,
179
attivo e vivace mentre una persona socievole ed aperta ben
raramente sceglierà un cane riservato, distaccato dall’ambiente e
freddo di carattere. La somiglianza parte dunque dall’inizio, dalla
scelta del cane, e poi ineluttabilmente si perfeziona con un processo
di affinamento e d’inconscia emulazione, oseremmo dire quasi
vicendevole, negli atteggiamenti e nei modi di esteriorizzazione della
personalità. Alla fine avremo un cane volpino che scherzosamente
potremmo dire, assomigli alla sua padrona per il viso aguzzo e
puntuto, la chioma un poco arruffata e, sostanzialmente, un’arguzia
ed un acume del tutto particolare. Scherzi e suggestioni forse
superficiali che tuttavia insegnano a guardare oltre le banali
apparenze per cercare le radici vere del concetto di bello.
Lasciate tuttavia queste facili riflessioni possiamo addentrarci in un
campo molto più delicato che la psicologia del comportamento può
disegnare con discreta precisione. Il concetto di bello trova, infatti,
un’accezione del tutto particolare allorquando si tratti di valutare il
proprio figlio. Al di là del fatto che ogni bimbo è bello per la sua
mamma ed ogni adolescente è perfetto per la sua mamma e ogni
ragazzo è aitante, bello ed intelligente per la sua mamma, possiamo,
oltre uno stereotipo sentimentalismo, trovare una motivazione
molto più profonda ed anche inconscia in questo atteggiamento.
In una riflessione di alcuni anni fa relativa alle etnie avevamo
accennato marginalmente al concetto secondo il quale i modelli ed i
canoni della bellezza sono fortemente condizionati dall’etnia di
appartenenza. L’etnia ha disegnato nei secoli un modello ed un tipo
antropologico cui rifarsi così che ogni popolazione ha, attraverso i
secoli, acquisito e modificato progressivamente i proprii canoni di
bellezza. Ora, andando oltre questo concetto ormai acclarato,
possiamo dire che anche ogni tipologia antropica (nel senso
costituzionalistico di Pende), all’interno della stesa etnia, ha modelli
di bellezza e costituisce elemento di raffronto e valutazione nella
definizione del bello. Questo fatto trova le proprie radici nella già
espressa considerazione che ognuno ritiene bello ciò che gli
assomigli e quindi la propria persona costituisce elemento di
raffronto e termine di paragone.
In più, è necessario aggiungere un’altra riflessione questa
volta basata non su un dato antropologico bensì su un aspetto
psicologico e relazionale. Il proprio figlio rappresenta, infatti, il
frutto di un’unione basata su una pulsione affettiva ma anche su di
un’attrazione fisica. Il figlio, che necessariamente assomiglierà al
180
padre o ne avrà tratti caratterizzanti, rappresenterà sempre per la
mamma il soggetto per il quale si era avvertita attrazione. Il cerchio
è così chiuso e ogni figlio sarà bello per la sua mamma quanto più
sarà simile a quel giovanotto che l’aveva fatta innamorare, si voglia o
no ammetterlo.
“E’ bello ciò che si desidera o che si ama”.
Il binomio in cui più marcatamente vi può essere confusione è
quello di bellezza e desiderio laddove si confonda una valutazione
obiettiva secondo precisi canoni estetici e artistici con la valutazione
di una pulsione e di un obiettivo configurato dai sentimenti e
dall’amore.
Sarebbe riduttivo interpretare questo binomio esclusivamente da un
punto di vista sessuale ed erotico poiché la sfera delle ambiguità,
delle varianti e delle sfumature è molto più ampia.
La bellezza della diversità non è dunque la bellezza di ciò che
obiettivamente è bello anche se differente da un modello canonico o
stereotipato ma diventa la bellezza di ciò che si desidera fortemente
o che si ama e che in vece non necessariamente è bello.
“Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace” ed a questo aforisma
potremmo agevolmente sostituire con l’affermazione che è bello ciò
che si desidera o che si ama.
Da questo spunto di riflessione si può snodare un
ragionamento, non antropologico, come già detto, ma
anatomopatologico.
Nei reparti di neonatologia è sempre presente una grande vetrata al
di la della quale vengono esposti per brevi periodi i neonati cosicché
i parenti possano vederli, riconoscerli, scrutarne le sembianze ed
apprezzarne le caratteristiche. Chiunque sia passato accanto alle
vetrine in orario di visita sarà stato certamente colpito dalla gran
quantità di apprezzamenti che sono espressi dai genitori, nonni e zii
all’apparire del neonato in una culla. Proprio il grande strepito e la
concitazione che conseguono a queste esposizioni devono aver
indotto i medici ad evitare il contatto diretto e ad interporre una
barriera di vetro tra l’oggetto dei desideri e lo stuolo di passionali
(maschi o femmine che siano). In queste situazioni si può registrare
quasi all’unisono una serie di sperticate lodi e di apprezzamenti sulla
bellezza del neonato non disgiunta da altre doti quali lo sguardo
intelligente, l’espressione furba ed accattivante, l’eleganza di tratti, la
181
soavità dell’incarnato e così via. Il bello è laudativamente espresso
in tutta la sia potenza senza defezione di alcun valutatore.
Obiettivamente, chi parente non è (o non è neppure amico,
obbligato per deferenza al rituale) fa molta fatica a definire bello un
neonato impacchettato in una cullina, con un visetto i cui caratteri
somatici non possono essere apprezzati sia per la distanza con ciò
che viene presentato sia per gli effetti luce/ombra o riverbero cui è
sottoposto.
Il concetto di bello viene sicuramente sostituito dalla percezione
affettiva del bene desiderato ed atteso che per tanto diviene bello.
Su questa traccia si può ancora sviluppare un piccolo
approfondimento. Se al tema del figlio desiderato ed amato si
aggiunge la variante dell’attesa, di una lunga attesa, l’effetto che ne
deriva viene amplificato in modo incontrollabile (gli psicologi ben
conoscono questi quadri e gli effetti educazionali devastanti che da
essi derivano).
Proviamo ad immaginare cosa voglia significare avere un figlio
atteso a lungo dopo una storia di infertilità, di insuccessi
(fecondazioni non riuscite), di tentativi esitati in perdite molto
precoci (aborto ripetuto o abituale). Il figlio atteso e sofferto assume
connotati del tutto particolari e tra i vari sentimenti che è capace di
suscitare, tutti fortemente caratterizzanti la specifica situazione, c’è
pure l’ammirazione per la bellezza. E’ una bellezza che non teme
confronti perché è in primo luogo il frutto di una vittoria, è essa
stessa un successo; sul neonato convergono tutte le energie e tutti i
pensieri per l’unicità dell’evento e la centralità del soggetto
nell’ambito della vita di coppia.
“E’ bello ciò che è sano”
Il concetto di salute è da sempre indissolubilmente legato al
concetto di bello. Innanzi tutto perché una persona sana attrae o per
lo meno non evoca diffidenza ed atavica riluttanza al contato ed in
secondo luogo perché la persona sana ha con sé il messaggio di vita,
prosperità e salute, in altre parole, tutto ciò che consciamente o
inconsciamente desideriamo sopra ogni altra cosa.
Poche volte gli artisti hanno deliberatamente scelto di
rappresentare il soggetto ammalato (o comunque non sano) non a
scopo documentaristico (come avviene nelle raffigurazioni delle
182
malattie) bensì per descriverne l’intima bellezza; una bellezza che
va al di là delle forme e che può essere evidenziata solo scavando nel
profondo del cuore e degli occhi del soggetto; una sorta di
trasfigurazione che trasforma i tratti e le linee per fare emergere il
sentimento e lo spirito. I moti dell’anima, così come le passioni, l’ira
e la rabbia, la cupidigia e l’invidia, possono trasformare il più soave
profilo in una smorfia ed al contrario, la serenità, la dolcezza e
l’amore possono trasformare un viso duro e provato dalla malattia
in un viso dolce e bello nella sua semplice soavità.
Credo che il pittore torinese Colombotto Rosso abbia saputo
cogliere queste bellezze e ci abbia portato a considerare il bello
dentro la malattia e la sofferenza. Andando però oltre lo sguardo
dell’artista, possiamo con certezza asserire che nessuna mamma ha
mai trovato veramente brutto il suo bambino, anche se con il volto
segnato dai tratti sindromici più forti. Può in questi casi trattarsi
solamente di una esasperazione dell’amore che rende ciechi; è noto
come l’amore possa trasformare la persona più equilibrata in
passionale ed irrazionale e la più imparziale in faziosa e l’amore di
una mamma sa trasfigurare la propria creatura (i pediatri ben
conoscono questa situazione). Da parte nostra tuttavia crediamo che
si sviluppi parallelamente un secondo processo mentale che rafforza
il primo che è assolutamente soggettivo ed irrazionale. Siamo sicuri
che la madre, in questo caso, cerchi il particolare più normale e più
bello nel suo bambino ed attorno a quello costruisca tutto il sistema
di valutazione ed apprezzamento; possono essere gli occhi, il colore
dei capelli o il tratto delle labbra che fa sì che il sorriso sia
dolcissimo e delicato. Potrà in questo modo, il genitore, tenere non
solo per se il giudizio di bello ma anche proporlo agli altri operando
ad un livello ed in una categoria sicuramente condivisibile ed
accettata. Più volte ci è capitato, a riprova di quanto detto, sentir
esaltare il colorito e l’incarnato soave di un neonato, unico campo
non devastato dalla malattia.
Tornando al tema riprendiamo il concetto cardine secondo
il quale una persona sana ed eutrofica è sicuramente “bella” anche
se, particolare dopo particolare, analizzato spietatamente e
soprattutto separatamente, non rientra nei canoni più comunemente
accettati. A questo pensiero potremmo però agevolmente
aggiungerne un secondo, e non meno rilevante, quale quello dell’età.
Si tratta della bellezza dell’età o, com’era tradotta
maccheronicamente dal francese (nel Piemonte che è francofono ma
183
non lessicalmente o grammaticalmente colto) la “bellezza
dell’asino”.
Se a questo punto prendiamo i due ingredienti, quello dell’età e
quello della salute e li uniamo in un solo soggetto, comprendiamo
perché il neonato sia sempre e comunque bello, in ogni cultura e
civiltà del mondo.
Tuttavia c’è di più perché ancor più bello è il neonato grosso e
grasso, segno di un’opulenza che, in Italia, era impensabile in
periodo bellico o post bellico. La fame, le privazioni della madre
riverberavano sulla salute e sul benessere fetale; molti bambini
nascevano, oltre che IUGR (Intra Uterine Growth Restriction)
anche e semplicemente piccoli per l’età gestazionale con segni di
denutrizione.
La nascita di un bambino grosso, paffuto e roseo sembrava invece
uno smacco alle povertà ed all’indigenza ed una vittoria su questo
triste quadro; poco importa se oggi sappiamo che questo bambino è
grosso perché figlio di madre diabetica, che grosso ma meno maturo
di un pari di epoca gestazionale, grosso ed in definitiva patologico.
In campo medico la frase “gran bel bambino, sano e grosso, pesava
più di quattro chili alla nascita” suona particolarmente pericolosa e
greve nei significati prognostici.
Dopo queste riflessioni serie non poteva mancare anche
uno sguardo ironico ai così detti “neonati oggetto”, reclamizzino
essi un pannolino o un omogeneizzato. Eutrofici, grossi e grassi
(come riportava una pubblicità che tanto fece discutere “da far venir
la voglia di mangiarli vivi”), neonati imboccati, rivoltati e profumati.
La pubblicità, con le sue leggi acute e spietate, ha saputo cogliere il
senso comune del bello e del sano e lo sfrutta per lanciare messaggi
rassicuranti e promettere risultati eccezionali. Ricordiamo a titolo
esemplificativo alcuni neonati in veste natalizia o peggio ancora
disposti, mediante ritocchi d’immagine, all’interno di barattoli di
creme a loro volta grasse, o incappucciati con foglie di cavolo. Non
si può certo dire che fossero belli in senso assoluto ma certamente
lo erano in senso relativo per portare un messaggio forte ed incisivo
alle madri e far breccia nel loro comune sentire e percepire “il
bello”.
184
“Bello ciò che si ricorda o si vuole ricordare”.
Uno dei temi più discussi in merito alle varie operazioni nella
gestione del lutto, riguarda l’opportunità consegnare ai parenti
qualche ricordo materiale del defunto.
E’ stato infatti accertato, con forti evidenze scientifiche che dopo
una perdita sono estremamente importanti i ricordi tangibili o
meglio i “pezzi di realtà” cui ancorarsi e che permettono di evocare
a loro volta una cascata di ricordi da elaborare e strutturare nella
mente.
Per questo motivo, per i neonati, si esegue oggi la rilevazione delle
impronte del piedino o della manina; si trasmettono cioè brandelli e
sensazioni di fisicità su cui costruire positivamente un ricordo.
Questa impostazione è relativamente moderna ed ha soppiantato
progressivamente la paura di costruire feticci.
Le foto post mortem non sono un’invenzione moderna; queste
sono tipiche dell’ottocento e si può dire rappresentino una
caratteristica dell’Epoca vittoriana, ove il tasso di mortalità infantile
era molto elevato. In un primo momento la fotografia (veramente
artistica e professionale) raffigurava solo il volto o il busto mentre
più tardi ritraeva il neonato o il bambino nella bara. Altri reperti
documentano invece il bambino nel letto di morte o ancora in
braccio alla madre (non si dimentichi che era consuetudine ritrarre i
personaggi celebri nel letto di morte ed ognuno di noi ha certamente
il ricordo delle fotografie di personaggi illustri, politici, regnanti e
papi). Alcuni recenti studi antropologici tendono a dimostrare che
l'usanza vada ricondotta a più antiche e radicate pratiche di
tanatometamorfosi (trattamento delle spoglie). In questo caso esse
rappresenterebbero una sorta di mummificazione visiva
nell’impossibilità di disporre di una mummificazione reale come nel
celeberrimo caso della piccola Rosalia conservata nelle latomie dei
cappuccini di Palermo.
Ricordo, molto tempo fa, di aver visto un ciuffo di capelli
recisi ad una bimba morta prematuramente all’inizio del novecento
conservati gelosamente dalla mamma assieme ai dentini da latte della
bimba e dei fratellini che in vece erano vivi e vegeti. La cosa, devo
dire, mi aveva francamente affrontato sia per la commistione dei
ricordi del morto con i ricordi dei vivi ma ancor più per il senso di
macabro che vedevo in quel ciuffo di capelli recisi e legati con un
nastrino rosa.
185
Oggi ho cambiato idea e sono convinto che l’accettazione della
morte passi anche attraverso la serena raccolta di segni e frammenti
di affettività e che proprio nella non differenza tra il morto ed il vivo
ci sia il segreto della costruzione dei ricordi e dell’accettazione della
morte. In altre parole occorre ammettere che, per credenti o non
credenti, la vita può essere interpretata come una cosa sola, un unico
tratto, una linea lunga o breve che rimane tale a prescindere che il
soggetto sia vivo o morto; in quest’ottica non si può parlate di
commistione ma di unicità e nella unicità stanno i ricordi di colui
che non c’è più o di colui che è vivo ma che ha già superato il
momento nel quale il ricordo era stato raccolto. A questa
impostazione, che è molto più agevole da intendere per un credente,
deve aggiungersi un secondo elemento di riflessione. Oggi non si
delinea più una separazione netta tra la vita pre natale e la vita post
natale, si tratta di un unico percorso che si svolge in situazioni ed in
contesti differenti. La tecnologia avanzata applicata alla diagnostica
per immagini è in grado di consegnare ricordi e tracce della vita
prenatale del tutto affascinanti e sorprendenti; questi vanno ben al di
là della semplice definizione del sesso ma riguardalo le posizioni del
feto, i tratti somatici più rilevanti e, con tecnologia tridimensionale,
offrono addirittura l’immagine del viso e permettono di conoscere
con largo anticipo le caratteristiche fisionomiche. La mamma oggi
conosce meglio e più approfonditamente il suo figlio prima che
nasca. Queste tecnologie, per certi versi discusse, credo invece siano
state, e sono tuttora, lo strumento più incisivo e forte che ha
permesso di dare piena dignità al feto. Più che tante discussioni e
conferenze sulla dignità della persona umana vale una fotografia,
consegnata alla madre, che ritragga suo figlio e le permetta non solo
di immaginarlo ma anche di vederlo. In questo contesto “la linea”
della vita si ancora certamente in epoca pre natale ed anche le
fotografie del feto o del neonato morto peri partum rappresentano
una tappa di un percorso di elaborazione del lutto. Chiaramente la
fotografia scattata alla salma ricomposta, seppure struggente, è
molto forte e deve essere proposta solo a richiesta e nell’ambito di
un percorso particolare di sostegno quale oggi si sta delineando e
costruendo grazie ad Associazioni di volontariato ed in Centri di
elevata specializzazione.
Altre volte capita che dopo un poco di tempo (in verità
anche dopo mesi) sorga nei genitori il desiderio di avere una
fotografia del neonato o del feto ed in questo caso è richiesto al
186
patologo che ha effettuato l’autopsia di selezionare un’immagine
adatta. Molti patologi ricusano nettamente questa richiesta mentre
altri, più attenti al cambiamento ed ai segni dei tempi, l’assecondano.
Più volte mi è capitato di dover rivedere nella serie di immagini
scattate quale fosse la più adatta e successivamente con opportuni
tagli e correzioni ricavare un formato comprensivo del solo volto.
Occorre dire che di solito si tratta di un volto composto e quasi
irreale nel rigore e nella freddezza della morte; la perdita
dell’espressione e della mimica rende quei piccoli visi alla stregua di
una statuina di cera, di un artefatto virtuale.
Certamente non si può parlare di bellezza ma non è mai capitato che
la madre o il padre non esprimessero sentimenti di affettuosa
ammirazione per il viso del loro bambino, non del feto o del
neonato come siamo abituati noi a denominare quei piccoli corpi
sottoposti ad autopsia; il loro bambino, tenerissimo e bellissimo,
non un angioletto, uno spirito, un sentimento (le frasi del gergo delle
espressioni compassionevoli che tanto irritano i genitori nel
momento del lutto) ma il bambino bello ed atteso che era e sempre
sarà il loro figlio, qui su questa terra con la sua fisicità.
187
188
Il valore della diversità
Carlo Petrini
Sentiamo dire ogni giorno che il mondo ha un futuro sempre più
incerto. La cosa un po’ ci spaventa, tanto più in tempi di crisi, ma a
pensarci bene non dovremmo spaventarci tanto: il futuro è incerto
perché imprevedibile per definizione. Ciò crea innegabilmente una
certa ansia, ma è un’ansia che fa parte della vita, perché i veggenti
non esistono. Tuttavia nel passato un barlume di veggenza ci è parso
di possederlo: un sistema che sembrava perfetto per risolvere il
problema dell’incertezza era quello figlio della scienza illuminista.
Isolare i processi, estrapolarli dal contesto, consente di comprenderli
meglio. E, se si presenta un problema, si può provare a “migliorare”
questi processi, inventarne di nuovi e più efficienti o anche costruire
macchine in grado di riprodurli. All’inizio quasi non ci sembrava
vero: credevamo di aver capito come funziona la Natura, ci
sembrava di poter prevedere, migliorare all’infinito, capire tutto.
Riduzionismo e meccanicismo, completati da consumismo, ci hanno
però fornito un’illusione, quella di essere completamente padroni
delle nostre vite e di poter disporre della Terra a nostro piacimento,
per trarne giovamento e soprattutto profitto. Non sta a me criticare
questi modi di pensare che sono stati messi fortemente in
discussione negli ultimi anni, visto e considerato che hanno
mostrato falle paurose. Certo è che chi si occupa di gastronomia ed
ecologia non può non notare come la mancanza di un approccio
sistemico e olistico, che tenga conto di tutte le connessioni tra i
sistemi viventi, nei propri campi di competenza abbia fatto più
danni che altro. Ridurre la coltivazione, la trasformazione e il
consumo del cibo a processi che hanno le caratteristiche della
serialità, della meccanica, come se potessero esistere isolati gli uni
dagli altri, ha fatto perdere i significati più profondi di queste attività
indispensabili per la nostra sopravvivenza. E non soltanto: ci ha
lasciati sempre più soli, inconsapevoli di ciò che ci accade attorno. Il
sistema del cibo agro-industriale mondiale ha iniziato a essere
strumento distruttivo, più che creativo. Se in un primo tempo è vero
che questo modo di produrre e sfruttare la Terra ha affrancato
consistenti fette della popolazione occidentale dagli stenti e dalla
fame, è pur vero che lo ha fatto a caro prezzo: squilibri nelle
condizioni di vita tra Nord e Sud del mondo, gravi problemi
189
ecologici, perdita di biodiversità. Mangiare è diventato un atto
passivo: oggi è il cibo a mangiare noi.
Il primo problema di questo modo di pensare e della cultura
consumista è che sono omologanti: si abbeverano di prodotti seriali,
uguali ovunque, ci portano a dimenticare il nostro passato e le sue
eredità culturali, cancellano le nostre identità in nome di ciò che
possiamo permetterci di possedere. Per esempio, molte lingue
ancestrali – una lingua rappresenta un modo di vedere il mondo, per
come lo descrive e lo interpreta – spariscono del tutto e il processo
sembra avere un andamento esponenziale: trionfa il globish, una
versione molto impoverita dell’inglese. Questo mondo reso sempre
più uguale dappertutto, per ovviare alla complessità dell’esistente ci
rende infine impersonali, appiattisce le diversità che sono il
principale elemento creativo che ha disposizione l’umanità. È
attraverso le diversità che si costruisce l’identità, con lo scambio,
l’incontro e il confronto tra modi diversi di esistere. Senza la
diversità - esattamente come avviene in natura dove la biodiversità è
garanzia di evoluzione, soluzione delle crisi e delle malattie – la
nostra illusione di controllare e prevedere, di ridurre per avere in
mano le redini del nostro destino, si trasforma in un boomerang che
ci cade dritto in testa, lasciandoci storditi: volevamo ridurre la
complessità ma ci ritroviamo ancora più confusi di prima. La
complessità dei sistemi viventi - quindi dell’esistenza - non deve
essere controllata, perché non la si può controllare. Ma meno male:
perché è una risorsa infinta, che l’uomo può sfruttare per imparare,
trarre giovamento e nutrimento. È nella complessità che ho stimoli,
che sono vivo, che provo piacere, che mi riesco a sorprendere, che
creo. E la complessità si ha soltanto grazie alla sopravvivenza di
buone dosi di diversità, biologica e culturale.
Le società rurali e le comunità del cibo di Terra Madre (il grande
meeting internazionale organizzato da Slow Food sin dal 2004 e che
si è subito trasformato in una rete permanente di diversità da oltre
150 Paesi www.terramadre.org), paradossalmente, conducendo una
vita semplice restano immerse nella complessità e la sanno anche
governare, consce dei propri limiti, e senza mai porre fine
all’innovazione. Credo che quest’atteggiamento pacato, saggio,
orgoglioso, non ansiogeno, sia ciò che si chiama volgarmente “buon
senso”: una cosa ormai rara, che dovrebbe essere insegnata a scuola.
Oggi non sappiamo immaginare il futuro perché non siamo neanche
in grado di vivere il presente, presi a correre per soddisfare bisogni
190
che non sapevamo neanche di avere fino a poco tempo fa. Come
se la vita, e il cibo, che è essenziale per essa, fossero ormai cose
scontate, solo perché abbiamo l’illusione di averne ridotto la gamma
di diversità. Ma non abbiamo ridotto un bel niente: abbiamo
approssimato, dimenticato, demandato, ritrovandoci più poveri e in
qualche modo persi in un deserto. Rendere tutto uguale ci fa
sembrare il mondo come una grande distesa di sabbia: ogni chicco
simile all’altro.
Non commettiamo più quest’errore, l’errore di chi vive
nell’incertezza: coloro che pretendevano di essere sicuri e che ora
brancolano nel buio cercando di risolvere i problemi con lo stesso
sistema che li ha creati. Le comunità del cibo di Terra Madre, per
esempio, ci insegnano che un’altra via è possibile. Ci insegnano che
è a ripartire dal cibo, dalla sua centralità, dal nostro comprenderlo,
coltivarlo, sceglierlo e mangiarlo senza farci mangiare, che
troveremo un modo migliore di stare al mondo.
L’unico grande segreto della rete di Terra Madre, il più grande
elemento che deve darci fiducia nel futuro, è anche l’unico elemento
che ci serve per descrivere bene questa rete di comunità: la diversità.
Una diversità che aumenta la complessità fino all’incomprensibile,
che impedisce di ridurre, di ordinare in maniera lineare, di applicare
quelle teorie economiche o produttive ancora dominanti ma che si
stanno rivelando incapaci di darci prospettive reali. È una rete che a
prima vista ci appare disordinata, non gestibile, non raccontabile, ma
tutto ciò che dobbiamo fare di fronte ad essa è fidarci, farla crescere,
ascoltarla anche solo in parte, darle modo di esprimersi e di
attecchire presso le nuove generazioni e di rispettare quelle passate.
È un grande insegnamento: fidiamoci della diversità.
Essa è un inno all’intelligenza e alla creatività umana, a tutto ciò che
potremmo realizzare perché ognuno abbia il diritto di nutrirsi a
sufficienza e secondo le proprie preferenze; la speranza di tutto ciò
che potremmo realizzare perché la terra non collassi. La diversità, e
la complessità che ne scaturisce, non sono un ostacolo, ma
un’opportunità. E il fondamento su cui tutto questo poggia, tutta la
gamma di possibilità che abbiamo, sta nella biodiversità, che va
salvaguardata. La Natura ci insegna che un sistema con un alto tasso
di diversità ha maggiori possibilità di sopravvivere ed evolversi, è più
fiorente, ricco di risorse, in grado di affrontare le avversità che si
possono presentare.
191
Lo stesso vale per gli uomini e la loro diversità culturale che è
frutto di un adattamento secolare nei territori. Le diverse identità si
possono definire proprio in funzione delle differenze, e senza
scambio, senza confronto, sarebbero asfittiche, buone soltanto per
un museo etnografico.
Senza rispetto per le diversità non può esserci sovranità alimentare:
un sistema del cibo che appaghi chi mangia e chi produce anche
perché consente loro di potersi riconoscere nel cibo, il frutto di una
base naturale, la biodiversità, e di una tradizione che si evolvono in
maniera congiunta, in cui sono rispettati tutti i tantissimi, diversi,
modi di trasformare la Natura in cultura. Diversità e biodiversità,
senza di loro non c’è futuro. Non c’è un futuro fatto di benessere,
creatività, felicità.
Tratto e adattato dal libro “Terra Madre, come non farci mangiare
dal cibo” di Carlo Petrini (Giunti e Slow Food Editore, 2009)
192
Considerazioni grafologiche nell’ambito delle diversità
Anna Alasia
La mia Grafologia, quale scienza umana, fu definita dal caposcuola
italiano Girolamo Moretti: “Scienza sperimentale che dal solo gesto
grafico di uno scritto umano rileva le tendenze sortite da natura”
(‘Trattato di grafologia ’ di G. Moretti pag. 3 Ed. Messaggero
Padova).
Un altro grande studioso in materia quale fu J. Crepieux-Jamin, in
Francia, disse che la grafologia era: ”Lo studio del carattere per
mezzo della scrittura” (‘ABC della grafologia ’ di J. Crepieux-Jamin
pag. 13 Ed. Messaggero)
Comunque la grafologia venga diversamente definita essa rappresenta
un valido strumento per la conoscenza della personalità. In
particolare, permette di venire a conoscenza dei molti aspetti della
personalità di un individuo in un definito momento della sua vita, in
quanto l’evolversi degli eventi, nei diversi ambienti, uniti alla
maturità individuale, mutano le caratteristiche delle persone.
E’ a questo punto importante sottolineare che permette di
conoscere solo alcune parti della personalità dell’individuo, perché
come ammonisce Allport: “nessuna scienza può presupporre di
avere il monopolio della conoscenza quando si tratta della
personalità umana che è indubbiamente la più complessa delle realtà
create”.
Date queste premesse, mi preme sottolineare, senza entrare in
tecnicismi troppo specialistici, che esistono, riconosciute in ambito
accademico, diversi metodi per l’interpretazione della scrittura, belli,
ed interessanti tutti allo stesso tempo.
Il già citato italiano Moretti per esempio ha elaborato il suo metodo,
inizialmente studiando le persone: come si muovevano, come
agivano, come si pettinavano, come pensavano, le loro capacità ecc.
Ha quindi correlato tutti questi aspetti del loro essere quotidiano a
segni grafici arrivando a dedurre dall’insieme di tutto, le
caratteristiche personali dello scrivente.
Il caposcuola francese Crepieux – Jamin diversamente ha in un primo
momento catalogato tutti gli elementi scritturali che i soggetti
scriventi esprimevamo svolgendo quindi un lavoro statistico su
centinaia e centinaia di persone. In un secondo tempo, li ha
193
interrogati ed osservati, riferendo quindi quei gesti grafici all’essere
della persona.
In questi due metodi si osserva la specularità del processo
scientifico.
Ci sono poi ancora altri diversi metodi grafologici interessantissimi
perché originano da differenti punti di partenza ma la cosa ancor più
interessante è che questi diversi metodi portano tutti allo stesso
risultato: cioè i rilievi svolti su uno scritto con un metodo piuttosto
che un altro in conclusiva portano ad analoghe definizioni delle
caratteristiche di personalità dello scrivente.
Neurofisiologicamente la scrittura non è un prodotto della mano ma
del cervello.
La scrittura da un punto di vista grafologico, viene considerata non
tanto nel suo contenuto ma nel suo movimento sotto l’aspetto di
gestualità estremamente individualizzata perché non esistono sulla
terra due scritture uguali espresse da diversi scriventi. Sul piano
simbolico, noi nella scrittura proiettiamo i nostri ‘archetipi’, i nostri
modi profondi, con cui ci esprimiamo ed interpretiamo la realtà.
Si propongono a seguire scritture ma per far comprendere al non
conoscitore della disciplina aspetti di come si svolge una analisi su di
un tracciato grafico si espongono alcune valutazioni e segni
grafologici.
La lettera si compone di tratti o prassie ed in questa “d” si
osservano nr. 3 tratti
194
Le parole si distribuiscono sul foglio di carta e le lettere si
sviluppano in:
Zona Superiore che contempla la sfera degli ideali
Zona media che è l’area della realtà, del quotidiano
Zona inferiore che è lo spazio riferito agli istinti
La lettera è formata da un ‘corpo’ e nell’essenzialità di quello che
deve significare ha una determinata forma. Si possono stilare
diverse grafo-forme. Si possono unire diversi ulteriori tratti allo
scheletro della lettera e quanto viene aggiunto è un ‘gesto che sfugge
alla persona’.
Seguono i principali segni grafologici con un accenno al loro
significato.
195
196
197
198
199
SCRITTURE con breve esame delle caratteristiche salienti
Lo scritto si presenta attentamente organizzato negli spazi,
diversamente l’individuo, rigido nei suoi schemi, non è attento alle
persone che lo circondano, risultando persino esasperante nella
convivenza.
Maschio – Età 58 anni – Laureato in sociologia – Dirigente in
azienda pubblica
Lo scritto appare ordinato e composto e così si mostra la persona.
All’analisi si rileva che l’individuo procede entro schemi a lui ben
prefissati e da quelli non esula. Infatti non accoglie le proposte dei
propri collaboratori e non propende per innovazioni. Il suo
200
dialogare è stereotipato e solo dopo chiari e apparenti
dimostrazioni di possibili miglioramenti, agisce per modificare ma
solo se si è fedeli alle osservanze delle norme dei procedimenti. La
sua memoria è come un registratore che con paziente meticolosità
rifinisce quanto apprende. Non gradisce gli imprevisti; si sente
invece a suo agio nel ripetere quanto conosce ed è talmente
perfezionista e preciso che risulta con lui ed agli altri, difficile la
convivenza e la cooperazione.
Maschio – Età 40 anni – Laureato in Architettura – Libero
professionista
Lo scritto mostra tenuta, decisione. Diversamente all’individuo
non appartiene reale tenuta e decisione perché è un atteggiamento
che propone senza aver basi a supporto della figura che vuole
mostrare.
Ritenendosi defraudato da molti aspetti della vita la persona cerca
rifugio in pensieri fantastici ed irreali. Ha bisogno di distinguersi e
richiede onorabilità. La sua attività mentale è predisposta a
201
rappresentare, percepire la realtà in maniera distorta tanto che
racconta fatti immaginari e se l’interlocutore non approva o crede a
quanto propone, prende le distanze per
complesso di superiorità.
Femmina – Età 35 anni – Laurea in medicina e chirurgia con
specializzazione – Ospedaliera
Lo scritto mostra eccessiva gestualità quasi a pretesa di essere
osservati. Diversamente lo scrivente non pretende adulazione o
speciale attenzione ma si muove piacevolmente cercando il giudizio
favorevole dell’ambiente.
La signora è dotata di intuito e supportata da buona memoria si
pone con attenzione a vagliare quanto apprende e quanto le viene
proposto, mettendo in atto approfonditi ragionamenti che la
portano a raggiungere con successo i propri obbiettivi. Non prende
facilmente iniziative ma se necessario si attiva operando con
fermezza perché le situazioni si risolvano.
Cura i convenevoli (a volte eccessivamente) nelle relazioni con
l’ambiente e tiene moltissimo a proporsi come persona educata e di
buone maniere. Benché sia apparentemente amabile con il gruppo,
si ritrae a difesa del proprio io risultando alla vista più disponibile di
quanto in realtà lo è agli effetti. Sicuramente il suo comportamento è
un po’ stucchevole e la personalità, risente di questo culto per le
202
forme esteriori. La persona preferisce dare di se questa immagine
anche se la spontaneità a queste condizioni viene meno.
Maschio – Età 33 anni – Scuola media superiore – Impiegato
203
Lo scritto risulterebbe un po’ disordinato ma si osservano gradi di
tenuta. Diversamente la sciattezza che si rileva all’analisi definisce
l’individuo trasandato con facilità a cedere al disimpegno.
Lo scrivente pur cercando di resistere al disimpegno che caratterizza
globalmente la persona, tendenzialmente dopo un po’ cede.
Appare trascurato nelle cose che fa e segue ciò che gli è più facile da
raggiungere, calpestando anche la propria dignità per perseguire ciò
che gli sembra più vantaggioso.
Essendo così di indole, cioè propenso a fare il comodo suo, è scarso
di spirito di iniziativa. Meglio dire che può avere iniziative ma è
difficile si scomodi per realizzarle.
Nel dialogo è facile metta in risalto valori importanti per desiderio di
apparire ma nella vita lui personalmente non ne tiene conto.
Mentalmente è vivace ed ha immaginazione ma non approfondisce
quanto apprende, in oltre non passa al vaglio a sufficienza le cose
per cui non è soggetto a cui affidare compiti di responsabilità.
204
Nella pagina precedente si sono osservate due differenti scritture che
presuppongono provenire da due mani diverse. Contrariamente
proviene dalla stessa mano scrivente che stila così diversamente ad
un anno di distanza. Chi verga è un adolescente disgrafico che ha
seguito per un periodo di più di un anno, il corso di rieducazione
della scrittura ottenendo i risultati visibili nella seconda parte del
foglio.
La grafologia ad oggi in Italia è poco diffusa. Le regioni che ne
fanno più uso sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la
Toscana, le Marche ed il Lazio.
Nei colloqui di lavoro gli italiani utilizzano la grafologia in una
percentuale del 5 - 6%.
All’estero l’utilizzo di questa disciplina è maggiore. Nelle assunzioni,
per esempio, i Francesi ne fanno uso in una percentuale del 60%.
205
206
La bellezza della metodologia della conoscenza in
medicina
Lorenzo Orione
“Et hoc modo ignorantia potest esse causa actus peccati: est enim privatio
scientiae perficientis rationem, quae prohibet actum peccati, inquantum dirigit
actus humanos.”
“E in questo modo l’ignoranza può essere causa di peccato: essa infatti è una
privazione di quella scienza che, informando la ragione in quanto direttiva degli
atti umani, impedirebbe l’atto peccaminoso.”
Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Prima Secundae, Q.
LXXVI
Potrebbe apparire azzardato, in una riflessione incentrata sulla
relazione biunivoca che lega bellezza e diversità, introdurre il tema
della medicina, che suole farsi pensare in una prospettiva collegata
alla patologia, e pertanto al male ed al disfacimento morfofunzionale
di quella perfetta integrità che in termini astratti definiamo salute.
La bellezza che incontra la diversità può, forse ed entro certi limiti,
riconoscersi nella prospettiva relazionale ed umana che una certa
produzione letteraria, attenta alla dimensione spirituale e
filantropica, ha voluto sottolineare quale prima e più nobile
vocazione di una medicina connotata come missione.
Non a caso è lungamente invalsa, in passato, l’abitudine a definire la
medicina come un’arte, sottolineando implicitamente il parallelismo
esistente tra la genialità creativa dell’artista ed in guizzo intuitivo
diagnostico, misurato sulla capacità di cogliere la sfumatura del
segno e del sintomo da parte del medico, per un virtuoso
inquadramento nosologico. Salvo poi constatare una ben diversa
verità al tavolo autoptico.
È ancora oggi forte la lettura identificante il bravo clinico con la
figura geniale dotata di un potere di lettura della dinamica salutemalattia che affonda non poco nella visione magica del guaritore ed
in quella sacra del sacerdote, da cui il medico ha anzitutto un potere
conferitogli dal proprio status sacrale ed esorcizzante: Libera nos a
malo.
In questa prospettiva, tuttavia, l’effetto -la medicina- soggiace
annichilita a fronte della magnificazione del suo effettore -il medico-
207
ed il vettore risultante sta in una banalizzazione della complessità
delle concrete dinamiche fisiopatologiche che presiedono alla
corretta interpretazione della condizione osservata e delle azioni
dotate di reale evidenza nei suoi riguardi.
Inoltre, altrettanto facilmente con cui il paziente giudica il diagnosta
sulla base di un’inconscia attesa taumaturgica, talvolta il medico
giudica il trattamento sulla base di una serie di osservazioni raccolte
e poi comunicate narrativamente in chiave esperienziale.
La medicina, la scienza medica, ovviamente, non è questo.
Essa ha da tempo abbandonato la centralità della dimensione
soggettiva narrativa fondata sull’esperienza e sul ricorso
all’induzione, a favore di una dinamica oggettiva quantitativa
incentrata sul ricorso alla deduzione, consapevole che, come
richiama K. Popper in Congetture e Confutazioni, la verità oggettiva
esiste ed è argomento certamente degno di essere perseguito dalla
scienza, mentre la certezza non lo è.
La medicina evidence-based relega all’ultimo posto nella scala della
capacità dimostrativa dell’evidenza scientifica le opinioni basate
sull’esperienza clinica. L’occhio clinico, ove fondato sulla semplice
esperienza, spesso non ha più valore dell’azzardo del taumaturgo.
Ciò che veramente pesa, in medicina, è l’applicazione di linee guida
fondate su approccî corretti di metodologia epidemiologica e clinica
e sottoposte a rigorose valutazioni di impatto e di processo.
In ciò, certamente, è possibile cogliere la bellezza: nella capacità
della ricerca di guidare per probabilistiche approssimazioni alla
verità clinica, pur nella costante impossibilità di giungere alla
certezza del suo raggiungimento.
Il metodo, nel porsi quale sorta di disciplinamento della dottrina,
consente di convertire a bellezza composta, ordinata, il disordine
con cui si presenta la diversità.
La metodologia, va precisato, non è un instrumentum adattabile o
riducibile ad un procedere soggettivo, che il medico possa ritenere di
possedere personalmente, giocando sull’ambiguità del termine
stesso.
Essa è metodo di ricerca e conoscenza oggettivo.
Sappiamo che il procedere conoscitivo muove attraverso
l’osservazione, l’analisi e la sperimentazione.
L’approccio puramente osservazionale descrittivo fornisce scarsa o
nulla capacità di misurare la forza di un’eventuale associazione tra
causa ed effetto.
208
Ove si adottino approccî di tipo trasversale, o di prevalenza
puntuale, l’assenza di un correlato temporale preclude la possibilità
di cogliere il nesso.
Più capaci, a tal fine, sono certamente gli approccî osservazionali
analitici di tipo longitudinale retrospettivo, o caso-controllo, i più
semplici a basarsi sul confronto, che restituiscono la misura della
forza dell’associazione tra patologia ed esposizione al fattore di
rischio in termini di stima del rischio relativo, non fondandosi su
confronti opportunamente riferiti a denominatori di popolazione.
Ancora più capaci di fornire evidenze sulla forza dell’associazione
tra esposizione al fattore di rischio e patologia sono gli approccî
osservazionali analitici di tipo longitudinale prospettivo, o di coorte,
in grado di fornire un’esatta dimensione del rischio assoluto, relativo
ed attribuibile, in quanto fondati sulla misura dell’incidenza,
particolarmente informativa nel caso in cui le coorti di osservazioni
dinamiche siano gestite attraverso l’impiego della densità di
incidenza, capace di restituire all’osservatore misure precise.
Il livello dell’evidenza è tuttavia certamente superiore allorchè il
confronto venga attuato in condizioni sperimentali ed il criterio di
randomizzazione nell’attribuzione dei soggetti rientranti nei criterî di
inclusione avvenga in modo da equidistribuire le caratteristiche
prognostiche nei due gruppi di trattamento e di controllo. Per cui,
l’unica variabile agente sull’end point consista nell’effetto
dell’intervento sperimentale, o meno.
Dotate di alta validità interna grazie alla qualità metodologica, le
sperimentazioni randomizzate controllate presentano tuttavia il
limite di una scarsa generalizzabilità esterna e di ciò si deve sempre
tenere conto, per non incorrere nell’approccio ingenuo di chi ritenga
possibile traslare direttamente il risultato della sperimentazione alla
realtà assistenziale, non cogliendo la sottile differenza che esiste tra
efficacy ed effectiveness. La sperimentazione ha, quindi, capacità di
parlarci in modo esaustivo solo del setting sperimentale.
La dimensione della metanalisi, quale revisione sistematica
quantitativa delle evidenze, si pone al vertice dell’evidenza medica:
se in un trial randomizzato controllato si ricerca l’informazione di
sintesi di quelle dei singoli pazienti grazie ad un protocollo basato su
criterî di inclusione ed esclusione dei pazienti, in una metanalisi si
ricerca l’informazione di sintesi di quelle dei singoli trial
randomizzati controllati grazie ad un protocollo basato su criterî di
inclusione ed esclusione dei trial randomizzati controllati.
209
Anche in questo caso, tuttavia, è importante prestare grande
attenzione alla struttura dei trial inclusi nell’analisi integrata, perché
quasi sempre l’eterogeneità degli stessi non può non essere tenuta in
considerazione nell’interpretazione delle conclusioni della revisione
sistematica.
Tutto ciò premesso, va detto che lo strumento di quantificazione
della sintesi delle misure delle osservazioni e della loro dispersione
intorno alla tendenza centrale ha natura probabilistica in riferimento
ad una funzione integrale.
Nell’operazione di misurazione della variabile nell’universo umano,
l’errore di campionamento, fisiologicamente legato alla variabilità
biologica, espressa dalla normalità distributiva gaussiana misurata
dalla deviazione standard, condiziona la necessità di dilatare
inferenzialmente intorno alla tendenza centrale misurata in
quell’universo in miniatura che è il campione un intervallo di
confidenza le cui dimensioni saranno diversa funzione della
disponibilità quantitativa di osservazioni, della loro dispersione e
della probabilità fiduciale che arbitrariamente si intenda assumere
nel respingere un’ipotetica ipotesi nulla.
Quando si vorrà applicare tale ragionamento all’interpretazione della
relazione tra causalità e casualità rispetto alle differenze riscontrate
tra sintesi di misure di osservazioni, ciò assumerà un significato del
tutto particolare e alla misura della probabilità di rischiare di asserire
erroneamente la significatività di una differenza, cioè la sua causalità,
quando in verità essa sia fondata sulla semplice casualità, si
contrappone quella di rischiare di asserire erroneamente l’assenza di
significatività di una differenza, cioè la sua casualità, quando in verità
una causalità esista ma sia sfuggita a ragione della scarsa potenza del
confronto in relazione ad una limitata grandezza della differenza
stessa.
È importante non rischiare in termini di capacità di rilevare
un’eventuale significatività sottesa alla differenza osservata, avendo
cura di dimensionare l’oggetto di studio non solo sulle due citate
variabili, ma anche sul tasso dell’evento nei controlli e su quella
dimensione dell’effetto dell’intervento sperimentale che si intenda,
in termini probabilisticamente arbitrarî, avere la capacità di rilevare.
Tutto ciò è bellezza.
Il metodo è bellezza che si rapporta con la diversità insita
nell’universo biologico dell’ Homo sapiens cui, sottoposto alla
correttezza del metodo osservazionale e sperimentale ed
210
all’oggettività della misura fondata sul numero, dimensione astratta
regolatrice, viene restituito lo spazio del rispetto valoriale che
l’approccio fondato sull’arbitrarietà autoreferenziale sottrae.
Il rispetto del metodo oggettivo, in altri termini, sposta la
prospettiva della sacralità del medico a quella della sacralità della
Persona umana, operando la traslazione dalla sottomissione del
paziente alla soggettività del medico, alla sottomissione del medico
all’oggettività dell’approccio epidemiologico e clinico.
In ciò, la bellezza del metodo incontra la Virtù umana della
Giustizia; Giustizia verso l’uomo, in quanto fatto ad immagine e
somiglianza del Creatore.
Oggettività per la Giustizia che emancipa il medico ad un linguaggio
diretto, forte della propria umiltà, e che gli consente di asserire,
veramente in scienza e coscienza: “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no,
no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37).
211
212
Antinoo: memorandum al riguardo…
Sergio Soave
Caro Mario,
quest'anno non riesco a mandarti il pur modesto contributo
di altre volte circa l'attinenza del mito di Antinoo con la politica di
oggi o con la dimensione politica più in generale.
Posso mandarti soltanto una sorta di memorandum sulle
questioni che sarebbero da affrontare al riguardo. Se tu riterrai di
farmi fare brutta figura, le pubblicherai. Altrimenti, amici più e
meglio di prima.
Dunque, ecco che cosa mi viene in testa in quest'ora e poco più che
posso dedicare a te e in memoria del vecchio amico scomparso di
cui hai pubblicato uno dei più belli, dei più teneri e dei più intensi
quadri:
1. La diversità che, a partire dalla bellezza della diversità tu poni
come valore positivo e da perseguire e' in realtà uno dei più grandi
problemi della politica moderna, diventata appendice della
rivoluzione industriale e costretta a inseguire il moto sempre più
rapido delle cose, determinato dallo sviluppo della scienza,
dell'economia e della tecnica che se ne sono andare per conto loro.
Perché mai, mi chiederai tu?
Perché tutto va a cozzare nell'antitesi tra natura e storia, tra
istintualità e razionalità.
E tanto le prime (natura, istintualità) sono restie a distaccarsi dalla
originaria fissazione biblica, tanto più le seconde sono veloci a
muoversi e a proporre sistemazioni nuove, senza avere voglia e
tempo di misurarsi, fino in fondo, con la staticità o lentezza delle
prime.
2. Così sul piano politico si è passati dall'identità famigliare a quella
tribale, dalla tribale a quella cittadina, dalla cittadina alla nazionale e
infine sovra-nazionale, ma il tutto e' avvenuto per giustapposizione e
non per sostituzione e senza cambiare veramente, nel profondo i
caratteri permanenti della natura umana che, per grande
soddisfazione delle religioni che ci si appellano per contenerne i
213
danni, e' sempre li, persistente, imbarazzante, ritornante, in ogni
caso determinante.
Lo so che adesso tu mi citerai Rousseau che sulla concezione
opposta ci ha fatto le sue belle fortune e vende libri ancora adesso.
Ma, un secolo dopo, Pareto, senza vendere i libri di Rousseau e
suscitare le sue aspettative palingenetiche, e' andato un po' più
vicino a definire alcuni lineamenti del rapporto tra natura e storia
che hanno trovato nel secolo appena trascorso, ahimè, verifiche
molto più precise e amare.
3. Bene! Ora che forse ti sentì un po' spiazzato veniamo al dunque
ed elenchiamo alcune questioni della diversità che sono sul tappeto:
- la questione del rapporto con uomini e donne di diverse
nazionalità, etnie e religioni e di quello che noi chiamiamo
integrazione
- la questione dei diritti dei "diversi" all'interno di società omogenee,
(stanziali o migranti, omosessuali o eterosessuali)
- la questione delle diverse concezioni attinenti la padronanza della
vita dalla nascita (fecondazione artificiale, scelta predeterminata del
genere) alla morte .
Catalogare tutto ciò unicamente sotto il segno di bellezza della
diversità costituisce un bel gesto di fiducia nella razionale evoluzione
"progressiva" dell'umanità, ma se non si calcolano anche le
controspinte inevitabili, diventa azzardo che può tradursi in
regresso.
Non dimentichiamo, per fare un solo esempio, che tutte le ideologie
totalitarie sedicenti rivoluzionarie, sono state spinte al potere da
colossali movimenti di massa, proprio in relazione alla loro
dichiarata volontà di opporsi alla modernità e di fermare e incanalare
con autorità il moto convulso delle cose che altrimenti non
riuscivano più a padroneggiare.
4. Dunque, prima che qualcuno ti dimostri la indicibile bellezza della
unicità, della omogeneità e della uniformità (tutte aspirazioni
altrettanto profonde della ricerca di identità personali e collettive),
sarà bene considerare la contraddizione tra natura e storia almeno
inserendo la variabile tempo come non eludibile.
Pareto, ad esempio, riteneva che per cambiare gli atteggiamenti
profondi di comunità o popoli ci vogliono almeno 600 anni. Forse
era pessimista.
214
Io più modestamente considero che, nei casi più semplici ci voglia
qualche decina di anni e nei più complessi qualche secolo.
Vogliamo parlare di integrazione tra settentrionali e meridionali in
Italia? Certo in cinquant'anni si è' passati dal "non si affitta ai
meridionali", a una predisposizione più largamente positiva e
tollerante. Ma qualche rigurgito c'e' ancora oggi. Eppure si trattava
di uomini che pur venendo da regioni diverse dalla nostra erano
italiani, parlavano la stessa lingua, avevano la stessa religione,
andavano alla stessa scuola, vedevano la stessa televisione. E ancora
si nostri giorni, cinquant'anni dopo, le differenze originarie di
costumi e mentalità sono stereotipi che affiorano di tanto in tanto
sotto la pelle di conversazioni popolari.
Se cosi e', quanto ci vorrà, dunque per integrarsi con i cosiddetti
extracomunitari, specie qualora essi professino religioni totalizzanti
(come e' proprio del mondo musulmano), o rifiutino a priori la
integrazione (come le enclaves cinesi o indù)? Non siamo più vicini
allo scontro di civiltà paventato da Huntington, piuttosto che
all'embrassons nous di certi facili profeti di una integrazione a
portata di mano?
Vogliamo passare ora alla questione dei matrimoni gay? E parlo di
equiparazione di fenomeni (il matrimonio, appunto) e non solo di
riconoscimento di diritti di convivenza e famigliarità (i famosi
DICO). Dimentichiamo che per affermare e con molta prudenza
questi elementari diritti di civiltà, cosa per la quale si registra già un
certo un maggiore e forse maggioritario convincimento positivo,
alcuni anni fa, in Italia, e' caduto un governo e di coalizione?
Ma allora che fare?
Andare avanti, certo, e proclamare la bellezza della diversità che può
essere frutto maturo della libertà. Ma sapendo che la libertà richiede
un uso faticosissimo della responsabilità e che la variabile tempo si
interpone tra cultura e natura. Il che implica non la semplice
dichiarazione della bellezza della diversità e il ricorso al mito, ma la
costruzione della bellezza della diversità, si che la sua percezione
diventi via, via elemento ordinario della propria identità di cittadino
responsabile e attivo.
In altre parole, se io penso di scalare una montagna con la stessa
velocità con cui percorro un'autostrada, mi sfiancherò ai primi metri
della salita. Se invece sono consapevole della differenza di passo che
la cosa richiede, mi attrezzerò a un più lungo e arduo cammino. E
215
non sarò costretto a fermarmi o ad arretrare al primo duro impatto
della scalata.
E questa e', in fondo, la metafora più verosimile del cammino della
politica, quando si appresti ad affrontare questioni così impegnative.
Ecco, sono ormai oltre l'ora che potevo dedicare al tema e,
affrontando il rischio di vedermi rimandato a ottobre, questo è
quanto posso consegnare al tribunale del tuo confronto culturale.
Appellandomi, s'intende, alla clemenza della corte.
216
2013 aprile 25 tanti 25 aprile dopo se non conosci se non
ricordi ascolta
voci dalla terra dei morti nella trascrizione di Piero Flecchia
Piero Flecchia
quando gli Inca dilagarono sulle Ande, loro prima cura fu di abrogare le forme
di scrittura locale ad abrogare ogni altra tradizione comunitaria, tutte
sostituendo con la loro propria. Questa politica etnocidaria, spesso spinta fino al
genocidio, vediamo nel tempo della storia praticata diffusamente da chi detiene il
potere statale: attraverso il quale la esercita; e in modo insuperato da stati
cristiani ed islamici. E questo perché ogni società si fonda e tramanda, e
soprattutto legittima il potere politico che la governa, su in insieme di memorie
condivise, la cui forma e contenuto decide la forma e contenuto delle relazioni
sociali, letture del passato a orientare il futuro.
M.
Ribotto, Dopo l’Italia che cosa?
Più tra quel popolo valgono i buoni costumi che tra noi le leggi … vivere là
significa non corrompere né lasciarsi corrompere
Tacito, La Germania
immerso nella meditazione, gettando gli occhi della mente sull'universo morale,
vidi che non solo i grandi eventi nacquero da tenui cagioni, ma conobbi che tutto
nacque da ciò che confina col nulla.
G.
Casanova, Historia delle turbolenze della Polonia
nota introduttiva
Nell’ambito della tradizione occidentale scritta, a discendere da
Platone, la riflessione politica persegue un modello ideale di
ricomposizione dei conflitti, cercando almeno nella scrittura di
realizzarlo. Sono i tanti modelli utopici, e tutti procedono da
un’illusione che li rende devastanti, quando e dove se ne cerca
l’inveramento concreto; come descrive il fallimento recente del
bolscevismo, ma anche della medioevale tripartita res publica
cristiana, puro platonismo passato per gli evangeli.
Le utopie sono nefaste in quanto bloccano, e quindi pervertono, la
dialettica che governa l’azione politica, e che solo le scoperte
dell’etologia hanno permesso di decifrare.
Tutte le specie animali sociali sono governate in natura alla stessa
forma di associazione: la primitiva società naturale universale
217
fondata sui duelli di gerarchia, che stabiliscono il posizionamento,
o rango, del singolo individuo dentro il gruppo animale o branco.
Questo posizionamento decide poi l’ordine d’acceso al cibo e al
sesso: effetto e non causa della pulsione gerarchia, il modo in natura
di utilizzarla, seguendo una pulsione istintuale interna al singolo ente
naturale. Ma quando il sapiens sapiens impara l’uso sistematico
dell’utensile, la forma sociale naturale fondata sul duello di gerarchia
diventa inadeguata, in quanto nella specie sapiens sapiens ogni
duello di gerarchia mediato con l’utensile si trasforma in duello
mortale. Il sapiens sapiens doveva: aut rinunciare all’utensile, aut
imparare a controllare la pulsione al duello di gerarchia, secondo
quella logica della sottomissione simbolica che vediamo presente in
tutte le specie predatrici, dai leoni ai lupi. Ma lo sviluppo della
memoria e del linguaggio hanno permesso al sapiens sapiens lo
sviluppo d’una forma di interdizione al duello di gerarchia molto più
complessa che nelle altre società animali predatrici. E la forma
evoluta di questa nuova società è quella entro la quale il sapiens
sapiens si umanizza, in quanto assume il controllo sul proprio ego
naturale e lo trasforma. È l’assemblea intorno al fuoco del gruppo;
attraverso la quale: lo scambio della parola, il gruppo prendere sotto
controllo la pulsione al duello di gerarchia dei singoli, per
trasformarla in reciprocità scambista. Il sapiens sapiens con lo
scambio linguistico ha trasferito al gruppo, in quanto forza superiore
al singolo, comportamenti culturalmente elaborati a governare i cicli
del cibo e del sesso entro la comunità. Ma l’ente naturale rimane ben
presente come struttura basica nell’ homo faber, e interferisce con la
formalizzazione razionale scambista dell’atto politico; cerca di
evertirla, soprattutto dove la sente per lui svantaggiosa, ritornando
alla pulsione di gerarchizzazione. Tutta la politica dei gruppi di
sapiens sapiens si muove entro questa dialettica tra fondamento
naturale gerarchico: che preme per il duello di subordinazione
interindividuale, e la necessità di bloccare le tensioni devastanti
omicide che scatena il duello naturale di gerarchia nell’ homo faber.
Solo ponendo questa dialettica al centro si comprende il complesso
problema della lotta politica: perché sia lotta, e per quale ragione
assuma volta a volta forma culturali diverse, ma sempre processo
esplicabile solo per la comprensione del conflitto centrale tra
pulsione naturale al duello di gerarchia e cultura: che preme per
bloccare la gerarchia a vantaggio della reciprocità scambista, per la
via della mediazione d’una lettura simbolica linguistica. Ma lo
218
scambio si definisce secondo locali stereotipi culturali e a un tempo
definisce le forme del controllo dell’universale conflitto politico. Un
conflitto in primis interno alla psiche del sapiens sapiens: intorno al
suo saper di faber costretto contro la natura a fabbricare anche la
sua politica, dandole un adeguato linguaggio rappresentativo nel
quale si gioca il processo di umanizzazione entro ogni comunità di
sapiens sapiens.
Nel nostro universo culturale nulla quanto il Giano bifronte romano
simbolizza il conflitto politico, che strutturalmente si articola come
scontro tra due fazioni o più spesso federazioni di fazioni; scontro
descrivibile solo con una serie di opposizioni duali a discendere da
quella tra bene (quello impugnato da una fazione contro l'altra) e
male (impersonato dalla fazione opposta). Bene e male che, ad
evitare allo scontro la forma cruenta, il fare politico vela di
mediazioni conciliatrici intorno alle mediazioni tra ragione e torto
diritto e trasgressione, che il mondo classico simbolizzava nelle
diverse forme del divino, ognuna con le sue proprie norme rituali e
insegnamenti teologici. Ma la mediazione dei conflitti politici è
possibile per via religiosa solo fin quando un popolo non sussume in
un dio, o una metafisica, tutta la verità; vi fonda la sola via alla
verità.
Con il monoteismo la religione come strumento di mediazione dei
conflitti politicosociali diventa strumento inservibile, ma permane il
peso d'una tradizione mediatrice della funzione religiosa, dalla quale
prende allora forma il concetto di tolleranza come figura chiave della
retorica politica; che nel mondo classico sconosciuta.
Sempre per tenerci nella metafora del Giano bifronte, il conflitto
politico, mentre definisce e governa gli spazi sociali pubblici, agita e
determina nel profondo anche la visione privata del singolo
individuo, per cui una vera e attenta riflessione sulla politica
coinvolge di necessità, a dare rappresentazione complessiva del
processo politico, tanto la dimensione sociale collettiva che quella
psichica individuale. In questa duplicità fondativa dialogante tra
psichico personale e fenomenico sociale è la ragione per la quale gli
antichi storici, a discendere da Erodoto, sapendo di raccontare
eventi politici, nell'esporli impiegarono costantemente quella tecnica
che oggi si tende a individuare come propria della narrazione
romanzesca; e che infatti nei grandi romanzi trasmette rilevanti
insegnamenti circa la lotta politica. E questo perché solo la forma
narrativa cosiddetta romanzesca permette di cogliere nella sua
219
duplicità psichica individuale e sociologica collettiva l'azione
politica, come documenta il Tucidide che riduce e a un tempo
simbolizza il conflitto imperialista tra diritto e forza in modo
insuperato nel dialogo tra gli ateniesi e i meli. E ancora, per opporre
in tutta evidenza le ragioni politiche reciprocamente escludentisi tra
politica democratica assembleare comunalista e politica statale
gerarchica burocratica, Erodoto ricorre allo scontro sceneggiato tra
Ciro il grande e gli ambasciatori di Sparta.
Questo modo di riflettere sulla politica raccontando le storie dei
popoli nei loro momenti emblematici definisce nel mondo classico
la ricerca speculativa sulla politica e la sua imprescindibile forma di
narrazione. Forma che troviamo ripresa in Machiavelli: che
costruisce la sua riflessione politica in margine ad accadimenti
concreti, come ben si esemplifica e nei 'Commentari sopra la prima
deca di Tito Livio' e nel 'il Principe'. E non dovrebbe esistere altro
modo di riflettere sull'universo complesso della politica, a costruire
modelli formali esplicativi del conflitto politico, ma la ricerca
accademica, fatta di formalizzazioni arbitrarie, libri di note che
rimandano ad altre note di altri libri, oggi spesso nutriti da racconti
ricavati da archivi statali quasi sempre collettanee di falsificazioni
plausibilificate e, altra fonte, un giornalismo affrettato e di fazione,
hanno finito per smarrire la ragione costitutiva della politica statale,
nelle loro stesse menti oscurata per l'esuberare erudito: l'azione di
pura rapina dei ceti dirigenti sulle classi subalterne. Qui il senso
universale della politica nel tempo della storia, la sua forma, pur in
diverse maschere di pseudolegittimazione, sostanzialmente
criminogena, quando non calcolatamente criminale.
Le società politicamente organizzate in stati, endemicamente e
sotterraneamente sono percorse da una resistenza tenace, e spesso
oscura, dei ceti subalterni alle feroci predazioni economiche fiscali
delle macchine statali. Predazioni fiscali in alcuni momenti e società
apertamente combattute e, se non debellate, almeno contenute, in
quanto controllate da strutture assembleari comunitarie e corpi di
magistrature elettive subordinate nel mandato alle assemblee.
In questa lotta tra macchine burocratiche statali e ceti sfruttati: che
cercano di trasformare la loro resistenza da passiva in attiva
istituzionalizzata, sta l'essenza dell'azione politica umana nelle
società storiche. Da questo conflitto discendono, per trasformazioni
e mascheramenti, tutti gli altri. E di questo conflitto primario e
primitivo, vera macchina energetica dell'azione politica, intendiamo
220
nelle pagine che seguono occuparci, alla maniera: nel linguaggio
degli antichi narratori di cose politiche, da Erodoto a discendere.
quel bisogno primario naturale: la politica
la religione non è tanto un'aberrazione, un travisamento del pensiero, bensì e
soprattutto una potente protesta della natura vivente contro le ristrettezze della
vita reale
M. Bakunin, Stato e anarchia
“Possiamo quindi concludere - sintetizza uno dei due adolescenti
per entrambi - che il fascismo fu ideazione artistica del Dannunzio,
realizzata politicamente dal Mussolini; e che ha trovato la sua
metafisica con Giovanni Gentile, ma non sarebbe mai stato per
vent'anni la politica italiana senza l'appoggio del Vaticano.”
Pieno mezzogiorno d'una prima domenica d'agosto. Sotto un
pergolato d'uva fragola due adolescenti e un uomo attendono, allo
schermo di frescura dei pampini, il pranzo. L'uomo cela il volto
dietro le pagine d'un quotidiano, mentre segue, fingendosi in altri
pensieri preso, l'appassionato argomentare intorno al fascismo dei
due adolescenti. Ascolta, e ricorda quello che fu vivo tumulto di
sangue agli anni della propria gioventù. Vede quel suo tempo, nel
ragionare dei due adolescenti farsi interpretazione, a decifrare in
uno, per quel tempo, il loro presente politico e il suo senso. Le due
vergini menti cercano nelle vicende della trascorsa tirannide
genealogie a spiegarsi il presente, a decifrare segni presaghi di futuro.
Anche l'uomo ha a lungo creduto che la conoscenza di tipo
genealogico bastasse a spiegare le vicende umane, ma ora sa che
cercare nel passato le ragioni che hanno determinato egemone nel
proprio presente una fazione politica piuttosto che un'altra, per
quanto acuta la mente e argomentata sulla più vasta messe di dati
storici la riflessione, il quadro esplicativo che ne consegue è poco
più che ricostruzione d'un quadro astrologico. E questo perché la
politica è azione volta all'autoaffermazione, sa l'uomo che ha
ascoltato il discorrere dei due adolescenti. Quella conversazione ha
soprattutto confermato nell'uomo la convinzione che i tratti concreti
dell'azione politica si eludano nelle coscienze umane per mitologie
fantastiche, a nascondere più spesso che a chiarire le forze reali che
determinano le forme degli eventi politici, anche perché queste forze
si esprimono e si muovono: appaiono entro linguistiche simboliche
221
mitologiche. Solo procedendo oltre il racconto fenomenognomico
storico e i miti interpretativi che cercano di darne conto, scendendo
fino al fondamento naturale del conflitto politico, se ne decifra il
senso universale; e a un tempo la sua natura di bisogno primario
dell'ente umano. Egli infatti esiste: trova forma nel reticolo di
relazioni politiche che, entro la propria comunità, sorgono intorno e
a mediare gli altri tre altri bisogni primari: il sonno il cibo e il sesso.
L'esplicarsi e realizzarsi di questi tre bisogni primari in quanto
prende forma e nel prendere forma edifica lo spazio sociale di una
comunità, accade entro relazioni politiche, sotto il loro imperio.
Nelle società animali un agire politico semplice e immediato che ha
la forma di scontro tra due enti naturali per stabilire la prevalenza, e
soprattutto nell'ambito comunitario di gruppo chiarissimo il suo
senso e risultato a tutti i membri di una comunità naturale, che per
questi scontri, anche quando non vi partecipano, deducono, e
condividono con tutti gli altri animali del proprio gruppo un
posizionamento entro il gruppo dei singoli, in base al quale ogni
singolo sa il proprio momento e limite di accesso al cibo e al sesso, e
il posizionamento per il sonno.
Questo in tutte le società naturali, una tra le quali è stata anche
quella del sapiens sapiens delle origini, ma la società naturale, il cui
scopo organizzare, attraverso il conflitto, entro il gruppo posizioni
di rango, dalle quali discendono e sulle quali si fondano l'ordine di
accesso al cibo e al sesso, ovvero il grado di soddisfacimento, entro
il gruppo, dei bisogni primari del singolo individuo.
E una eco attenuata ed estenuata del conflitto naturale di gerarchia
l'uomo ha sentito suonare là sotto il pergolato anche nella riflessione
dei due giovani sul fascismo. È convinzione di quell'uomo che,
effetto dello sviluppo manipolativo tecnico sulla natura, la specie
umana ha occultato e trasformato, per la mediazione della parola, lo
scontro di gerarchia: la sua pulsione primaria, inglobandolo nella e
subordinandolo alla parola, con la quale, mentre con l'utensile
manipola la natura, l'uomo manipola il suo simile. Così ha preso
forma per gradi la politica naturale mediata dal linguaggio, fino
all'aberrazione di istituzioni storiche come la schiavitù e il suo
perfezionamento nel lavoro salariato, la politica come rapina
dell'uomo sull'uomo, trasformazione e mascheramento a un tempo
in brache culturali della politica naturale. Ma in natura l'esclusione
dal cibo e dal sesso e il rischio connesso al sonno, sono fatti
immanenti, forme del rischio dell'esistere. In natura manca la scelta
222
maliziosa, il calcolo che trasforma stabilmente, entro consorzi
umani complessi, il conspecifico in strumento. Nei gruppi sociali
naturali si esclude al momento il conspecifico più debole dal cibo e
dal sesso, ma mangerà secondo l'ordine gerarchico, per quanto
avanza di cibo, e l'estro naturale regola l'accesso alle femmine per la
riproduzione. In natura i maschi si escludono vicendevolmente dal
sesso, ma il disegno naturale decide nel contempo quando potranno
congiugersi con l'altro sesso per la riproduzione, il cui piacere è
funzione della riproduzione della specie. Non così dove l'uomo
evolve tecniche e linguaggio, sviluppa un esistere cosciente non più
subalterno ai cicli naturali. Ma qui, se mantiene come forma
d'organizzazione sociale lo schema gerarchico escludente della
società naturale, questo schema lo porta a creare gruppi sociali
intorno a maschi dominanti le cui femmine sono confinate in
harem. Ma in ragione della possibilità permanente di estro anche
nelle femmine della specie sapiens sapiens, chiuse nell' harem di un
maschio dominante si trovano nella condizione, sconosciuta in
natura, di patire la frustrazione sessuale come condizione
permanente e di vivere il sesso come stupro, quando lo subiscono
non consenzienti. Simmetricamente, i maschi subalterni, nella
socialità naturale esclusi dal sesso per la confisca delle femmine in
harem, vivono una esperienza di frustrazione, che si riflette sulla
collaborazione per la sicurezza e il cibo.
Lo sviluppo della coscienza e del linguaggio hanno gettato il sapiens
sapiens delle origini nella necessità di cambiare lo schema della
socialità naturale in quanto e per quanto non era più possibile la sua
forma politica gerarchica violenta. costruita sui duelli di gerarchia.
Il duello di gerarchia determinano, a discendere dal maschio alfa,
l'ordine di accesso al sesso e al cibo, e quindi il rango sociale, forma
evoluta di memoria posizionale applicata dagli individui al proprio
spazio sociale, che ricostruiscono intorno al proprio rango. Ma la
specie sapeins sapiens stava procacciandosi il cibo sempre più
attraverso la collaborazione di gruppo: impossibile tra soggetti
naturali in forte antagonismo circa la ripartizione dei frutti della
collaborazione, e soprattutto in opposizione intorno all'accesso al
sesso, mentre parallelamente l'impiego generalizzato dell'utensile, se
utilizzato nei duelli di gerarchia, rendeva i duelli di gerarchia scontri
mortali. Non solo, un individuo frustrato e dotato di calcolo
razionale poteva aggredire e uccidere con la sorpresa, usando una
pietra o un bastone appuntito, il più forte fisicamente. L'utensile
223
rese irrilevante la forza fisica come elemento centrale nella
costruzione del posizionamento gerarchico, mentre introdusse
l'assassinio come rischio immanente in uno spazio sociale
fortemente conflittuale. La combinazione duello di gerarchia: frutto
della pulsione politica naturale, più utensile: frutto della riflessione
sul mondo naturale, stava trasformando ogni sapiens sapiens in un
potenziale assassino, e il suo spazio sociale nel luogo più pericoloso
per ogni individuo della specie sapiens sapiens. Qui giunta, la specie
sapiens sapiens doveva: aut rinunciare all'utensile, aut abbandonare il
tipo di politica naturale e passare a una politica di mediazione
collaborativa paritaria, che avrebbe trovato il suo centro dinamico e
trova nella parola: il suo scambio aperto nel gruppo, a gestire
secondo un principio di reciprocità scambista tra eguali le pulsioni
primarie al sonno al cibo e al sesso. Ma la reciprocità scambista
diventa praticabile in un gruppo umano soltanto quando e dove si
affermi una tradizione culturale che prenda sotto controllo e
interdica: e in ogni singolo individuo, la pulsione al duello di
gerarchia; attraverso un complesso processo pedagogico, inibendo,
interdicendo la pulsione al duello di gerarchia in quanto a monte la
tradizione culturale si oppone alla gerarchizzazione: forma di
organizzazione dello spazio sociale entro la politica naturale. Ma
questo è possibile solo dove prenda forma una visione di spazio
sociale centrata sulla reciprocità collaborativa, che ponga, oltre le
differenze naturali di sesso, età, patrimonio genetico, tutti i singoli
individui del gruppo tra loro nello spazio della vita comunitaria, e
quindi politicamente, uguali. E questo è possibile solo tra quei
gruppi umani capaci di produrre un'idea simbolica egualitaria di
spazio sociale, sostenendola con processi educativi e di controllo
capaci di riprodurre tanto entro i singoli individui che nelle relazioni
tra individui il codice culturale egualitario.
La riflessione antropologica sulle società trascorse aveva maturato
nell'uomo sotto il pergolato la convinzione che solo i gruppi di
sapiens sapiens giunti ad elaborare comportamenti culturali capaci di
tenere a bada la pulsione egotica alla gerarchia nei singoli,
controllandola con una politica egualitaria di collaborazione
scambista sostenuta dal calcolo razionale, avessero continuato a
progredire, usando dentro il gruppo l'utensile a vantaggio di tutti.
Ma anche queste società, in quanto composte da individui immutati
nel fondamento naturale: anche le società umanizzate in senso
scambista da ben progettati modelli culturali che insegnano i
224
vantaggi della reciprocità, contengono in apparizione nel
fondamento la pulsione egotica, sempre pronta a esplodere, quando
e dove, per vicende contingenti le più diverse, i codici culturali di
comportamento scambista egualitario e le forme linguistiche del loro
insegnamento nel gruppo non riescono a tenere a freno la pulsione
egotica. Una pulsione egotica capace di servirsi sottilmente ed
evertire la stessa reciprocità scambista umanizzante, ideando forme
sfruttatrici di pseudoscambio, come documenta la disumanità, ma
perfettamente naturale, delle società schiaviste, la più mistificante
delle quali è quella nostra presente: che separa i produttori dagli
strumenti di produzione, costruendo raffinate forme tecniche di
predazione pseudoscambista quali la finanza e le mitologie di
legittimazione delle diseguaglianze interpersonali, ma che minano
inesorabilmente la coesione comunitaria. Dalla riflessione sul suo
tempo, l'uomo aveva maturato la convinzione che nelle società
tecnologiche complesse la regressione nella socialità gerarchica
naturale accadesse sempre per la mediazione di mitologie egualitarie
gestite da un potere statale centralizzato, a dare nel popolo
dominato l'illusione che la reciprocità scambista continuasse a
governare le relazioni entro la comunità. Aveva maturato questa
convinzione riflettendo sulla parabola del bolscevismo nel XX
secolo e sui due millenni di egualitarismo illusorio alimentato dei
credo monoteisti. Questo conosceva l'uomo sotto il pergolato che,
seguendo l'argomentare dei due adolescenti, s'era chiesto quanto
fossero maturi per comprendere una visione politica con al centro lo
scontro tra la dialettica immanente nel controllo culturale scambista
e la pulsione egotica naturale verso il ritorno a forme di totale
gerarchizzazione dello spazio sociale, mascherandole con miti
culturali ora egualitari ora fondati sul mito del governo dei migliori.
Una pulsione egotica capace di trasformare perfin il messaggio
evangelico in strumento di legittimazione degli stati dinastici
assoluti. Ma, si chiede l'uomo, per quale via trasmettere ai due
adolescenti la coscienza che ogni forma di politica statale repressiva
non è altro che riemersione nello spazio sociale scambista egualitario
di forme culturali di gerarchizzazione che riconducono alla socialità
naturale, verso la quale una deriva psichica porta ogni individuo. Per
contrastare nel singolo individuo la pulsione egotica naturale il
modello culturale scambista orchestrato dal calcolo razionale evoca
forze psichiche che mobilitano alla compassione intorno alla
comune coscienza del soffrire, e alla fratellanza universale,
225
integrando l'universalità del dolore nell'erotizzazione dell'amore
materno, sublimandolo in amore per il proprio gruppo. Ma di
questo sentimento quanto perfidamente sappia servirsi il tiranno in
qualche modo i due giovani lo hanno già intuito, anche mettendo al
fascismo le gambe del Vaticano.
E qui l'uomo intravede una possibile via per condurli alla reale
comprensione delle dinamiche politiche intorno al fondamentale
distinguo tra politica naturale gerarchica e politica culturale
scambista egualitaria. Deve preliminarmente l'insegnare loro a
cogliere lo specifico delle due dimensioni politica e religiosa, che
hanno origini del tutto diverse. L'azione politica si svolge sotto il
segno e come forma sociale della pulsione egotica individuale: aut
controllandola con la reciprocità, aut secondandola con le varie
forme fantastiche di gerarchia naturale, tra quelle nobiliari e quelle
clericali. La religione oppostamente procede dalla paura che prende
l'essere umano quando la ragione gli svela l'ineludibile destino di
decadenza e morte di ogni ente vivente: “Quando uno ha
conosciuto bene il mondo, scrive Gabriel Matzneffne in Le suicide
chez les Romaines, non gli resta che il suicidio o dio.” Questo
l'orizzonte duro nel quale si inscrive la vita terrena, a uscirne verso
più alte e consolatrici visioni sorge, sublimazione e simbolizzazione
del sorriso materno, e dell'amplesso amoroso, la consolazione
religiosa.
Ma come esporre tutto questo?
E separare la politica dalle sue forme illusorie e consolatorie, può
davvero rendere migliore l'esistere che attende i due adolescenti, o
non piuttosto, farne degli isolati?
Introdurli al sotteso senso nel vocabolo anarchia non ne farà dei
solitari catari in un mondo di monocausisti?
Se mostrasse loro le dinamiche reali dei conflitti politici, non
incamminerebbe sulla dura strada dell'esilio interno due giovani vite?
Ma la coscienza del caro prezzo che gli è costato la conquista della
fondativa separazione tra politica e religione, ora là sotto il pergolato
rende l'uomo debitore verso i due adolescenti d'un abbozzo di
spiegazione circa il soffocante intreccio che impicca la vita civile
quando religione e politica si congiungono e reciprocamente
legittimano, fino ad apparire una cosa sola. Almeno, deve mostrare
loro la necessità per l'umanizzazione di questa separazione.
Questo deciso, ripiega il giornale; e a indicare che vuol interloquire,
leva il braccio nel gesto lento e ampio d'esordio dell'arringatore, ed
226
espone: “Avevo circa i vostri anni quando appunto, come avete
appena concluso, Dannunzio inventava il fascismo: le sue adunate di
massa, la camicia nera, il manganello, l'olio di ricino – l'uomo ne
sente ancora il disgusto in bocca, mentre la sua voce incide – e il
Truce ne assumeva la guida, per poi chiedere alla teologia gentiliana
di darne spiegazione a posteriori. Ma per capire tutta quella loro
poderosa azione che travolse e assoggettò politicamente per
vent'anni il nostro paese e lo condusse al disastro della seconda
guerra mondiale, la religione serve poco. Nell'ascesa del Fascismo i
preti cercavano e trassero molto più vantaggio come gruppo di
quanto per e da loro ne traesse il fascismo ascendente, al quale
procurarono anche non pochi impicci. E poi ci furono, e neanche
così pochi, preti che bevvero la loro razione d'olio di ricino e si
smerdarono sotto il grandinare dei manganelli. E non bastano le dita
della mani e neanche dei piedi a contare i preti ammazzati dalle
bande nere. Preti morti condannando il fascismo, e perdonando
quanti per quel credo feroce s'erano fatti aguzzini. Ma prima che
preti erano uomini che, in abiti da prete, partecipavano, come i loro
confratelli che sostenevano la trucidificazione del paese, a vicende
politiche, anche se ambo le due fazioni clericali credevano di
portarvi il punto di vista religioso. E sbagliavano entrambe le fazioni
clericali, dall'accecamento politico preti fatti incapaci di scorgere che
l'universo spirituale religioso è completamente altro da quello
politico. Il fatto è che nelle lotte di potere tra gruppi, i politici
tendano a servirsi della religione e i religiosi, per quanto agiscono nel
mondo, e perseguono quindi disegni politici di potenza, tendono a
travisare il senso e la ragion d'essere del sentimento religioso:
contrastare la paura della morte nella vita, dandole un senso;
orizzonti oltre il mondo di dolore e di incertezze dove si svolge da
sempre la vita umana.”
“Questo vuol dire che in Italia il fascismo avrebbe vinto anche senza
il papa?”, gli domanda uno dei due adolescenti.
“Nell'ascesa del fascismo il papato c'era ben presente, attiva forza
politica. Ma come forza politica, negli anni del risorgimento, era
stato clamorosamente sconfitto, e proprio per aver ridotto la
religione a politica. E infatti le figure cattoliche forti del
risorgimento sono i don Bosco i Cottolengo, che svolsero la loro
missione consolatoria religiosa con vigore, ma nello spazio
interpersonale privato, anche se non mancarono di sostenere la
politica papista, ma qui del tutto inefficaci. E se svolsero il loro
227
magistero soprattutto tra i poveri, è solo perché il povero s'appaga
con poco, e quindi si consola con poco, a differenza di chi ha avuto
molto e desiderato troppo e sente la vita mancargli. Per quello a
mala pena bastano le visioni di solenni The Deum e magniloquenze
tombali monumentali. Generalizzando. Nella lotta contro le proprie
paure, mentre crea il complesso universo religioso, all'uomo accade
di collocare in esso sempre più crescenti e irragionevoli speranze.
Anche alla religione, alla sua articolazione in miti, accade come al
denaro, che da strumento essenziale per agevolare la reciprocità
scambista si trasforma, da strumento, mezzo, in fine ultimo, creando
gli universi fantastici e tragici della finanza e dell'usura, a discendere
dalle antiche forme di schiavitù per debito fino al presente esplodere
delle grandi bolle speculative finanziarie, che condannano alla
miseria innumeri moltitudini e arricchiscono pochi esorbitanti
farabutti segnati dalla buona sorte. E similmente, sotto la pressione
crescente e fantasticante del desiderio religioso sono stati creati i
paradisi e le connesse costruzioni infernali, che poi saranno
trasformate e permutate, combinandosi con il denaro, in mercati
finanziari, anche con effetti sorprendenti, per cui un grande usuraio,
lo Scrovegni, con i soldi predati alle bocche dei poveri,
commissionerà a Giotto la mirabile cappella in Padova, dove si
celebra l'universo di fraterna eguaglianza evangelica. Insomma, da
ben prima che Marx si tramutasse in Stalin, la bizzarra metamorfosi
metapsichica è un tratto tipico negli universi storici sotto il dettato
di sintassi fantastiche dominate dall'istinto alla gerarchia.”
Dal tacere perplesso dei due adolescenti l'uomo comprende di aver
proceduto entro un'astrazione troppo radicale; d'essere andato
troppo oltre l'orizzonte delle loro esperienze; spinto il discorso dove
la loro immaginazione non può ancora giungere. È come per il
bambino, nel quale sì già agisce la pulsione sessuale, ma se si
traducesse in vera esperienza sessuale, annienterebbe psichicamente
il bambino. Così l'adolescente può intuire, dall'universo di
turbamento interiore, le reali forze agenti nel mondo: e fino ad
esserne sopraffatto e annichilito, soprattutto se il mondo intorno a
lui non gli offre alcun linguaggio esplicativo coerente, ma come la
teologia cattolica, solo le genealogie fantastiche d'una divinità che
combatte la paura umana dell'ignoto, sopraffacendola con la paura
d'un dio noto terribile, ma pronto a consolare quanti gli si
sottomettono. È per questa via che da innumeri generazioni
moltitudini a popoli, sono condotte nelle grandi visioni consolatrici
228
teologiche, ma dove la ragione è imprigionata, la coscienza
modellata al servire. Prendono così forma sistemi di relazioni sociali
confusive, con al centro la confusione prima: l'occultamento della
natura distinta e separata dell'universo politico. Perché questo non
accada ai due giovani, là sotto il pergolato d'uva fragola, l'uomo
sente di dover, per parole piane, mostrare loro la natura autonoma
istintuale dell'azione politica: la sua dimensione naturale devastante,
se lasciato agire liberamente l'istinto pulsionale che determina la
forma della politica naturale: la costruzione di strutture gerarchiche
di subordinazione, nello spazio socializzate delle società del tempo
storico realizzate con l'ostentazione di una incombente articolata
repressione organizzata: lo stato.
L'uomo ha deciso: deve insegnare ai due giovani a vedere la
necessità, per la vita umana, di strutture culturali che perseguano il
controllo e la trasforma delle pulsioni egotiche al conflitto,
articolando lo spazio sociale in luogo di collaborazione cambista tra
individui, intorno al principio della reciprocità, che in modo
insuperato il Cristo martinettiano ha sintetizzato nel: “Fate agli altri
quello che vorreste essi facessero a voi.” Questo è necessario
capiscano i due adolescenti, poi circa la religione potranno decidere
con cognizione, secondo le conoscenze ed esperienze che faranno e
delle leggi della natura e dell'angoscia del vivere. Precisa: “Di
religione oggi e da sempre si parla molto, anche perché grande è da
sempre la paura del domani: la paura dell'ignoto sta in ognuno di
noi, come nel nostro presente raccontano i vari cornetti e santuzzi
che ballonzolano appesi agli specchietti retrovisori negli abitacoli
delle auto. Ma la vera salvaguardia dal rischio di incidenti stradali, e
le morti che ne conseguono e le degenze ospedaliere e mutilazioni
corporali e psichiche, è nell'istinto di autopreservazione di ogni
guidatore d'auto: anche del più sconsiderato. Ma tu puoi essere di
natura prudente quanto vuoi, se però ti fai una bella bevuta
alcoolicamente eccessiva, anche se resti un pauroso, perdi di riflessi,
sbandi, finisci fuori strada. Se poi inclini a un carattere gradasso,
fortunati gli altri se finisci alla prima curva contro un muro. Come il
vino anche il fenomeno religioso induce a stati alterati di coscienza,
ma che alterano le pulsioni naturali solo marginalmente: almeno nei
più, come descrivono, circa i credenti cristiani, contro i dettati
sapienziali evangelici le bimillenarie trasgressioni porcelle, un cui
ritratto sintetico nel Giovanni Boccaccio della novelletta dove si
conta per quale via mettere il diavolo nell'inferno, che ci fa anche
229
scorgere come le religioni agiscano non sugli istinti primari del
corpo ma sulla paura, fenomeno proprio di ogni psiche individuale;
che spesso esordisce come dubbio, a incominciare dal dubbio più
semplice e immediato: 'Il mio desiderio sarà corrisposto?' E come il bacio
della persona amata porta placazione nello spirito amante e gioia,
così accade per l'angoscia, madre di pensieri spaurati davanti al
tempo a venire, per il bacio del sentimento religioso: che rasserena e
consola, rende luminoso l'oscuro. E infatti le preghiere al nume
mutuano spesso i vocaboli dalla commozione amorosa, che non
meno spesso idealizza la figura amata mutuando le metafore dal
linguaggio religioso: “Simile agli alti dèi a me sembra chi mi sta davanti e
parla.” canta ancora in ogni cuore amante Saffo. Ma questo uso
permutativo di linguaggi a descrive lo sfuggente con l'evidente,
genera soltanto l'illusione d'una vera conoscenza: non se ne realizza
che il fantasma; e innesta nella coscienza una pericolosissima
commistione linguistica: di linguaggi simbolici che l'anima umana
deve temere ed evitare, e che dove si verifica determina la
degenerazione della religione in religione politica e la degenerazione
della politica in politica religiosa, mentre il; denaro da strumento di
scambio mediatore tra equivalenti diventa il cemento che salda
religione e politica in un blocco di dominio devastante per la vita
libera, tutta la vita umana ora ridotta sotto la peggiore delle tirannidi:
quella che pretende di subordinare al principio primo ordinatore
religioso ogni forma di relazione sociale, l'azione politica ridotta a
repressione volta alla correzione degli errori, a imporre l'unica verità,
che deve essere presente in ogni aspetto e momento dell'esistere
quotidiano, ma secondo le pretese del padrone avido nella vita dei
suoi schiavi. In queste società dominate dalla religione politica le
metafore linguistiche descrivono la funzione e il ruolo dell'uomo
politico mutuando il gergo e i vocaboli dall'universo religioso. Il
politico diventa l'esecutore subalterno, il fedele credente, per la sua
fede designato dall'Alto, e degno d'amore universale del suo popolo.
Ma simmetricamente, anche la religione costruisce il suo
immaginario mitico con imprestiti dal potere politico,
rappresentando il divino in forma antropomorfizzata di grande capo
cosmico sovrastante gerarchie angeliche; e del quale i capi politici
terreni sono il locale inveramento. Questo doppio scambio di
corruttele linguistico simboliche legittima e sottende corruttele
morali e soprattutto economiche: arricchimenti smisurati di pochi a
generare smisurate miserie nei più. Questo accade dove e quando la
230
religione trapassa da percezione di un numinoso indifferenziato,
grembo materno generatore dal quale sono venuti gli antenati e
verso il quale il loro insegnamento tramandato guida la comunità, a
fenomeno di forme divine personalizzate con tratti sempre più di
tipo gerarchico autoritario. E mentre il clero organizza un panteon
sacro gerarchico; simmetricamente la politica nella comunità è
pensata dai suoi capi come costruzione d'una asimmetria terrena
mutuata dall'asimmetria cosmica. Nascono in un lento accumulo
fantastico gli universi politici dispotici come proiezione terrena
dell'universo divino, mentre l'universo divino assume i tratti
aggressivi violenti delle guerre terrene tra gruppi. La persona umana
come ente sociale si trova imprigionata in una costruzione a un
tempo linguistica e teologicometapsichica fantastica che tutto
avvolge; ma soprattutto rende incomprensibile l'ordine delle
relazioni alla semplice percezione sensoriale: che i preti e i politici
dichiarano sempre fallace e illusoria, vero il mondo fantastico che
essi inculcano, fatto di miracoli divini. Miracoli che anche oggi
continuano, diventati miracoli finanziari, per il prevalere della
teologia monetaria sulla scienza economica. E questa falsificazione
accade perché tutto un universo linguistico antecedente è stato
falsificato dalla commistione tra politica e religione. Ma se la
percezione di questa commistione falsificante si affaccia a tratti in
ogni vita, occorre la forza semplice e grande del bambino che sta nel
filosofo, per costringere il filosofo a gridare al popolo: il re è nudo.
E questo perché troppo spesso, come insegna il sogno platonico
della società politica perfetta, anche il filosofo si costruisce e
trasmette sue genealogie mitiche dei processi sociali, sotto l'impulso
psichico a sottrarli al divenire, per dare loro forma metareligiosa
stabilizzata, procedendo da illusorie interpretazioni esplicative del
passato. Soltanto con gli stoici e gli epicurei la filosofia separa
politica e religione e costruisce una non meno capitale separazione
tra pubblico e privato che, nella Roma della tragedia politica delle
guerre civili e dell'impero, trova la prima formulazione tra la grande
poesia di Lucrezio, e quelle di Virgilio e Orazio, non meno
impregnate di epicureismo. Davanti alle degenerazioni della politica
in tirannide, gli uomini onesti si rifugiano in un universo privato di
resistenza. E infatti la politica imperiale romana, ormai pura politica
di potenza, doveva trovare la sua immagine simbolica legittimante in
un qualche monodio adeguato. E la trovò in quella figura di
dissidente ebreo che fu il Cristo mitizzato degli evangeli, intorno al
231
quale il dispotismo e il terrorismo del potere imperiale poteva
occultarsi e celebrarsi per la dimidiazione del suo racconto mitico tra
il Gesù crocefisso: emblema del povero esistere delle plebi, e il dio
Padre biblico, immagine trionfante celeste del signore terreno:
l'imperatore.”
“Sì, ma qual'è l'altra possibilità politica. Quella tra uomini che non
confondono religione e politica.”, chiede l'un adolescente e l'altro gli
assente.
L'uomo, che credeva d'aver esposto chiaro il punto, comprende che
la sua chiarezza interiore si fonda su un percorso che deve mostrare
ai due adolescenti. In questo disegno loro precisa: “Una politica di
libertà si realizza quando e in quanto i magistrati investiti di potere
politico lo esercitano sotto il controllo delle assemblee popolari, alle
quali a fine mandato, sempre breve: non oltre l'anno, i magistrati
devono rendere conto. Questa politica parla per linguaggi che si
misurano sulle cose, ed evitano imprestiti dalla poesia amorosa e
dalla teologia. Basta e avanza la simbolizzazione dello spazio
fisicopsichico territoriale della comunità come grembo materno
generoso; che nutre per quanto il lavoro dei suoi figli lo fecondano:
“Lavoro, pane e libertà sono i tre bisogni primari della natura umana.”,
insegnava Bakunin, la cui acuta intelligenza capace d'un vero
francescano afflato umanitario, scorgeva in tutta la sua sopraffacente
vastità l'universo simbolico onniavvolgente di servitù, quale ancora
oggi tra noi si delinea nel peso sopraffacente delle immagini e
artistiche e architettoniche politicoreligiose; che da secoli dominano
il paesaggio antropizzato. E infatti, a ritrovarsi in uno spazio a
misura d'uomo e non d'incubo mentale, i potenti evadono
intellettualmente dalle mitologia della quale sono al centro - fatte ieri
di pittura religiosa e oggi i linguaggi pubblicitari: teologie, e
mitologie dei capi buoni e saggi e delle guerre giuste - ritirandosi in
privati giardini calcolatamente progettati per proiettare visioni
puramente naturali, mentre attorno tutto impronta la intollerabile
miseria progettuale d'un paesaggio angosciosamente antropizzato.
Qui, dal principio del tempo della storia, svettanti palazzi e chiese si
stagliano su un paesaggio di capanne e denutrizione, come ancora
oggi nel cosiddetto terzo mondo, mentre nei centri metropolitani le
presenti plebi, fatte di corpi inquinati, gonfiati da devastante
alimentazione, si muovono tra virus epidemiologici e condomini già
fatiscenti non appena costruiti, e una propaganda peggiore del
232
pessimo cibo comprato a prezzo esorbitante, inculca il demone del
buon servire.”
Ma proprio per quanto preso della propria suggestione, mentre
espone la truculenta visione l'uomo comprende che il proprio sogno
politico sta flettendo il proprio ragionamento verso l'utopia, mentre
importante è che i due adolescenti percepiscano la natura diversa e
altra del fenomeno politico e del fenomeno religioso. Annuendo a
questo pensiero, scandisce: “Per capire la politica dovete partire
dalla sua dimensione semplificata più evidente e universale, e che sta
al centro anche della vostra giovane età: il gioco. Fate centro sulla
vostra esperienza di giocatori e chiedetevi: che cosa c'è al centro di
ogni gioco?”
L'uomo lascia che la domanda si depositi dentro e interroghi le
coscienze dei sue adolescenti. Scorgano quale sia il sentimento forte
che accomuna, al di là delle forme e delle regole, tutti i giochi. E
infatti i due adolescenti intravedono: nel gioco si esprime, sua
essenza, la volontà di prevalete sugli antagonisti: primeggiare.
L'uomo li incalza: “Sì, se volete capire la politica dovete partire dal
gioco, dove si muove banalizzato: reso appunto gioco, il più
pericoloso istinto naturale, fortemente radicato al centro di ogni
persona umana: la volontà egotica, che instancabile cerca di imporsi,
vincere, dominare. Ecco che cosa si esprimeva anche nell'agire
politico pubblico dei Dannunzio, Mussolini, Gentile. Ma una
volontà di autoaffermazione che si modula da persona a persona in
modo diverso: in ognuno secondo propria natura ed educazione.
Dannunzio era troppo preso nel soddisfare il suo gusto fantastico,
che si nutre di sempre nuove forme di piacere, natura propria del
poeta. Anima sempre volta al nuovo, il poeta manca del tratto
essenziale proprio al politico: la tenace persistenze nello scopo che si
realizza e definisce come conquista ed esercizio del potere politico.
Dannunzio seppe immaginare la conquista d'Italia, spingendosi fino
alla sua premessa: l'occupazione di Fiume, primo passo per marciare
su Roma. Ma questo gli bastò. Andare oltre, esercitare il potere
politico era calarsi nel reale, diventarne strumento e non creatore. E
non poteva accettarlo, a differenza di Mussolini, ma la cui capacità
immaginativa non sapeva andare oltre il luogo comune, come si poi
vide, preso il potere con le penne del pavone dannunziano, e gli
toccò governare l'Italia. Capo dello stato, il Mussolini non seppe di
meglio che antologizzare tutti i luoghi comuni della politica
imperialista, come racconta la sua grande farsa tragica: la guerra
233
d'Abissinia. Il Duce non aveva altro disegno politico oltre
l'assassinio. È quanto sanno fare tutti i politici senza genio ideativo,
forti solo di malizia tattica, come oggi illustra un Andreotti. Per
procedere oltre una pura politica contingente opportunista
Mussolini, mancandogli un vero fondamento religioso da dove
trarre un disegno di falsificazione politica e occultamento del
proprio dispotismo, doveva inventarsene uno. Aveva bisogno di
immaginarsi inventore di un disegno politico, appunto il fascismo, la
cui articolazione teologica affidò al Gentile, filosofo che voleva
dominare il paesaggio metafisico italiano napoleonicamente, e si
trovava in accanito antagonismo con un altro spirito metafisico non
meno napoleonico: Benedetto Croce. Questa la vicenda umana
locale del trio di padri del fascismo, ma la cui azione corrispondeva a
un bisogno primario della natura umana: la politica. La politica è
nell'individuo bisogno naturale primario non meno essenziale dei tre
altri bisogni primari naturali che modellano sia fisicamente che
psichicamente la figura umana.”
L'uomo li osserva: stanno cercando di dare contenuti al simbolico
tre, ma in sfere troppo elevate: tra gli eroi della storia, tra le leggende
sacre. Deve guidare l'immaginazione dei due adolescenti a un volo
più basso. Per questo precisa: “Incominciamo da quello che tutti gli
altri bisogni li fa dimenticare, e spesso procede dal loro
appagamento: il sonno, che si fa evidente fisicamente quando
chiudete gli occhi perché la mente anela a sciogliersi dal mondo. Ma
difficile a stomaco vuoto. Infatti il secondo bisogno primario
naturale è il cibo. E se il sonno si coglie in un ritrarsi di tutta la
persona dalla coscienza del suo presente, il processo alimentare ha
scolpito con la massima evidenza il corpo umano, tra la bocca, ad
introdurre il cibo, e dopo la sua trasformazione in energia che
alimenta il nostro agire, espellerne le scorie dagli opposti orifizi. E se
intorno al sonno, a dare sicurezza al dormiente, le società umane
hanno, contro la paura primigenia dei predatori, costruito un recinto
di sicurezza, dal quale sono poi sorte le abitazioni, intorno al cibo ha
preso forma una trama di relazioni sociali di contenuti originari
religiosi, per la percezione nella coscienza umana che l'alimentazione
della persona è una predazione violenta di altra vita: vita che nel farsi
nostro cibo è sottratta al proprio ciclo naturale. La coltivazione
agricola, l'allevamento per il lavoro e la macellazione di alcune specie
animali, hanno poi ottuso il senso originario sacro del pasto. Sono
prevalse nelle dimensioni conviviali l'attenzione ai galatei dei pranzi;
234
l'estetica nei quali si compongono, a nascondere, allontanare,
perdere la dimensione sacra del pasto; la cui percezione riaffiora
dove e quando una società esclude alcuni gruppi umani dal cibo, li
condanna alla fame. Allora questi esclusi si riuniscono in una nuova
comunione sacra e fantasticano un nuovo sacro, come i primi
cristiani nel collasso sociale di Roma, o gli operai socialisti divorati
dalle fabbriche capitaliste. È il ritorno a una originaria comunità
indivisa. Oppostamente, dalla parte di chi ha il potere e si nutre per
quanto sottrae, generando miseria, il cibo si trasforma in una golosa
sequenza di portate, che procedono in un dispiegarsi di preziose
ceramiche e cristalli, brindisi e risate, e spesso su uno sfondo
musicale, premessa a danze e copula, mentre la tavola diventa
crapula di corpi enfiati, luogo di coscienze ottuse, incapaci di
intravedere il costo in dolore animale e lavoro servile sul quale la
loro crapula si regge. E non meno importante dell'alimentazione è in
ogni vita umana il sesso, che infatti, come il cibo, ha scolpito la
figura fisica. E in modo così radicale da dividere tutte le specie che si
riproducono per via sessuale in due generi: il femminile e il maschile.
Una differenza anatomica a trasmettere segnali informativi che
sottendono pulsioni e suggestioni forti, che le società umane si sono
studiate di contenere e ordinare: velare l'esercitarsi attivo della
differenza sessuale, celandola, riducendo la dimensione sessuale a
pura presenza indiziaria nello spazio sociale. E questo tende ad
accadere quanto più una comunità si autonomizza dalla natura,
sussume e controlla il proprio ciclo di produzione e riproduzione
della vita, attraverso la regolazione del cibo e del sesso, ma così
siamo trapassati alla pulsione politica, nella quale tanto la pulsione
per il cibo che quella sessuale finiscono sottomesse. Tutto questo
tende a sfuggire alla riflessione in quanto la persona umana
percepisce il controllo calcolato di cibo e sesso come parte del suo
paesaggio naturale, a incominciare e discendere dalla sua prima
sensazione concreta dell'esistere: il seno materno che le empie la
bocca di stillante latte.
Si aggiunga che, con l'articolarsi della specie umana in gruppi sempre
più numericamente grandi e complessamente coordinati al loro
interno da un patrimonio di tradizioni, mancando un segno fisico
che faccia evidente nella persona la pulsione politica, questa, nel
farsi azione, tende a concentrarsi in gruppi di specialisti, tanto da
apparire ai più un delle tante professioni nelle quali le società
storiche si articolano. Oppostamente al cibo e al sesso, la cui
235
percezione permane cosciente nella quasi totalità degli individui, la
percezione della pulsione politica come istinto della perdona è
sempre più confinata entro una cerchia ristrette di persone, il fare
politica isolato in pochi luoghi culturali astratti, come astratte, al
sentire comune, appaiono le figure che esercitano il fare politica. Ma
se partite dal gioco e studiate in voi stessi, scoprite che il desiderio di
primeggiare, sovrastare gli altri è istinto primario dell'ente umano.
Ogni ente umano nel suo fantasticare si immagina al centro del
mondo, e dove lo può, tende a ridurre tutto l'altro a entità
subalterna, come appunto realizzano tutti i capi politici, se la fortuna
e l'abilità li conducono al primato nel proprio consorzio umano,
come appunto un Mussolini: nelle cui vicende parla la forma
naturale gerarchica dell'agire politico: la politica naturale, la cui
pulsione è asservire a sé l'altro. Questo è lo schema di politica
naturale che regge tutti i branchi animali, entro i quali l'accesso al
cibo e al sesso si stabilisce in un continuo susseguirsi di scontri di
posizionamento. E questa logica politica animale tende a riemergere,
se non controllata, nelle società civili, pervertendole a forme di
politica tirannica, come appunto illustra il percorso politico di
Mussolini, la cui visione culturale si esprime nel suo progetto di
fascistizzazione dell'Italia, ovvero nella riduzione della complessità
di una società allora di 40 milioni di persone alla semplificazione
politica primeva del branco animale. Ma questa politica del branco
sta alla politica di una comunità umana libera come la stupro sta alla
relazione sessuale. E infatti, nella storia, violenza politica e stupro si
tengono, e i paesi soggetti a tirannidi tendono a legittimare in
qualche modo, entro gli spazi sociali che organizzano, lo stupro, a
discender dal primato sociale dell'uomo sulla donna. Ma in natura,
tra animali, non c'è stupro, e neanche in quelle specie animali che,
attraverso il duello di gerarchia tra maschi, inglobano le femmine in
harem. Infatti poi il maschio dominante copula con le sue femmine
solo quando quelle sono in estro, altrimenti lo respingono. Lo
stupro compare come evento nel mondo del sapiens sapiens quando
l'estro femminile diventa, come l'estro maschile, permanente. In
quelle società in corso di umanizzazione nello spazio sociale si
impose, contro il trauma dello stupro, un controllo sociale della
copula, mediando l'atto fisico entro un rituale simbolico di
trasformazione della copula in eros; la cui forma spirituale più alta e
raffinata è la passione amorosa, quale si disegna per la mediazione
del linguaggio, fino ai vertici della poesia amorosa, con i suoi giochi
236
di desiderio eros e tensione inappagata, a rendere poi l'abbraccio e
l'abbandono più pieni. Impedire lo stupro, regolare la copula
attraverso la sua sublimazione in eros fu il passo decisivo attraverso
il quale il gruppo prese sotto controllo comune la pulsione egotica
naturale nella sua manifestazione più rischiosamente esplosiva e
devastante: lo stupro. Fu bloccando lo stupro che si crearono le
prime comunità umane, prese forma il processo di umanizzazione.
Ma impedire lo stupro era e resta interferire nella pulsione fondativa
della politica naturale: la subordinazione gerarchica, che nello stupro
ha la sua massima evidenza. Controllare il sesso nella sua
dimensione di stupro è intervenire sulla: trasformare la politica
naturale. E questa svolta verso una umanizzazione dell'azione
politica si realizza con il tabù dell'incesto, ma che segna anche la
separazione tra sesso e politica nelle comunità umane; il passo
decisivo nel processo di umanizzazione. Con il tabù dell'incesto i
gruppi umani che lo affermano, mentre separano politica e sesso,
segnano una frattura tra cultura e natura nelle dinamiche politiche,
in quanto accade una netta separazione tra il gruppo e la politica
gerarchica fondata sulla violenza generalizzata. Ora la ragione
prevale sulla pura pulsione: questo è il tabù dell'incesto, per il quale
si introduce l'esclusione del sesso tra genitori e figli e tra fratelli. Una
esclusione che crea la famiglia come divenire nel tempo, e costruisce
la separazione tra generazioni. L'amore come libera scelta, lo
sviluppo che per esso raggiunge ogni coscienza che si individua e si
umanizza proprio per l'esperienza amorosa, e conseguentemente la
possibilità di un essere politico per la libertà, sono fondati nel
primordiale tabù dell'incesto, possibile solo quando un gruppo
umano matura una visione spirituale improntata al rispetto
reciproco. La tirannide, ritorno alla politica naturale, non è altro che
regressione nello spazio delle relazioni politiche al mondo di prima
del tabù dell'incesto, caduta nella barbarie della dimensione
pubblica, che poi finisce per modellare anche le relazioni private,
intorno alla relazioni fondativa, quella tra l'essere maschile e
femminile della nostra specie, relazione erotica interpersonale, che il
linguaggio dell'eros mantiene separata dal fatto politico, inscrive
nella sfera del privato. Mentre quando il sesso, come nei matrimoni
dinastici o di interesse, si inserisce nelle dinamiche politiche come
fattore attivo, segnala sempre un riemergere della socialità gerarchica
naturale. Dice che un processo di disumanizzazione è in atto. Una
regressione alla politica nella sua forma naturale, ma che nel mondo
237
dell' homo faber; nel mondo dominato dall'utensile, significa
immediata regressione nell'omicidio, fino alle dimensioni tragiche
del gulag, dell'orrore della guerra nucleare.”
Ascoltavamo, gli occhi della mente abbacinati dagli spazi visionari
che l'uomo adulo ci dispiegava, e che avevamo fin là dislocato
nell'inconoscibile, mentre ora scorgevamo ben presenti e attivi in
noi per quanto procedano dal nostro fondamento naturale. Per
penetrare in quella complessità, traducendola in contenuti noti,
domandammo all'uomo contezza del nostro presente politico. E
l'uomo ci sembrò fin grato della domanda: lo sottraeva a un
complesso gioco di esemplificazioni didascaliche dove non era certo
d'esseri mosso da buon maestro. Sì, c'era del sollievo nella sua voce
mentre constatava: “La nazione italiana, dopo che si sono ritirati gli
eserciti alleati, ha il suo spazio politico ancora occupato dallo
straniero, visto che i nostri due maggiori partiti politici agiscono
come emanazioni, strumenti di due potenze politiche esterne: Mosca
e il Vaticano. E questo accade per la sobria ragione che il fascismo
ha talmente screditato il valore 'patria' da far vero nella gran massa
degli italiani il sotteso senso psicologico nel distico del Pascoli che
recita: “La mia patria or è dove si vive, gli altri poco lungi, in cimitero.” Il
vero nodo della questione politica oggi sta nel fatto che i due
maggiori partiti politici: il democristiano e il comunista, agendo
come forze al soldo di potenze esterne, tendono conseguentemente
ad agire secondo la logica di tutte le bande mercenarie: che devono
fare la guerra per poter mantenersi predando e rafforzarsi, ma più si
rafforzano e più devono saccheggiare, da dove un crescente
impoverimento dei territori infestati da bande mercenarie. Una
inclinazione allo sfruttamento parassitario del popolo sottomesso
che al momento in Italia trova limitazione e contenimento nel fatto
che, dovendo trovare alleati nel paese, tanto democristiani che
comunisti devono moderare al momento i loro appetiti, chiedendo
sostegno economico ai loro patroni esterni.”
“In tavola!”, ci convocò la voce di mia madre, e mio padre: “Due
parole conclusive e siamo da te.” E poi a noi rivolto: “Fin quando
dura la guerra fredda in Italia dura la cuccagna, in quanto arriva, con
le rimesse degli emigrati, con i noli delle navi, i profitti del
commercio estero e del turismo, una doppia corrente, e spesso
cospicua, di rimesse finanziarie segrete da Mosca al PCI e alla DC
dai capitali cattolici raccolti negli USA e girati in Italia per
combattere il comunismo. Insomma, stiamo godendo di quella che
238
in economia si chiama rendita di posizione. Fin quando dura la
guerra fredda.”
In quella visione sottilmente ironica della politica italiana ci
avviammo a tavola. Era quello l'agosto di tutti trent'anni prima della
caduta del muro di Berlino, che avrebbe segnato la perdita di
importanza strategica del nostro paese, consegnando la politica
italiana del tutto alle proprie forze interne. Ma la nostra classe
politica aveva omai troppo maturato una visione da corpo di
occupazione che vive saccheggiando il paese, come la vicenda Craxi
e lo scandalo Mani pulite avrebbero poi messo in luce, partiti che
rubano per fare voti e fanno voti per rubare. Un caso a chiarire
quella spartizione saccheggiatrice del paese, alla caduta dal muro di
Berlino clamorosamente detonata nelle vicende note come 'Mani
pulite.”, che se fece chiasso, non ha mutato l'andazzo lurco.
Negli anni 1970-80 in Milano i proventi delle mazzette sui lavori per
la metropolitana erano sparititi a metà tra democristiani e socialisti,
che amministravano insieme la città. I comunisti invece
amministravano il comune di Torino, e volevano intascare solo loro
le mazzette sugli appalti della locale costruenda metropolitana, visto
anche che a Milano erano rimasti a guardare gli altri due compari di
rubarizzi farsi grassi e per loro niente. Ma per impedire che,
controllando la finanza locale, i comunisti diventassero troppo oltre
grassi, il democristianesimo aveva concentrato i prelievi fiscali a
Roma, da dove poi si decidevano, e soprattutto negli investimenti
straordinari, trasferimenti di capitali da Roma agli altri comuni. A
Torino c'era il progetto della metropolitana, ma i comunisti lo
dicevano chiaro: il lavoro doveva restare tutto in mani comuniste
per il giro delle cooperative rosse. Ergo niente tangenti ai ciucciaDC,
ma che avendo il controllo del governo centrale controllavano i
trasferimenti alle periferie. Da dove niente soldi per la metropolitana
di Torino, che i comunisti volevano trattare come cosa propria.
Questa era la reale dialettica politica demokrat del cattocomunismo,
quando il muro di Berlino gli franò addosso in forma di 'mani
pulite'. Dalle rovine dei ciucciaDC venne l'evo sempre idem del
demokratbungabunga, quale si simbolizza nell'epica dell'arcorico
Cavteleballista e sodali della crostata.
239
240
Note biografiche
Mario Abrate: nasce a Racconigi nel 1951. Direttore della S.C. di
Anatomia Patologica dell’Ospedale di Savigliano, mentre ricopre
numerosi incarichi professionali e nelle istituzioni della società, con
gli interessi scientifici ha sempre anche coltivato il versante
umanistico, con brillanti sintesi nei due campi, come esemplarmente
nelle sue indagini tra malattia e arte, medicina ed etica.
Anna Alasia: nasce a Pavia nel 1962. In ambito grafologico,
consegue in un primo tempo il Diploma in Consulenza Grafologica
presso la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università di
Urbino "Carlo Bo". Specializzata inizialmente in Consulenza
Professionale e Consulenza Evolutiva. Appassionata alla disciplina
segue seminari e si fa seguire da tutor anche per la Consulenza
familiare e la Consulenza Peritale. Effettua il passaggio a Laurea.
Interessata a studi grafologici - psicologici, pubblica sulla rivista
"Scrittura" articoli sui meccanismi di difesa freudiani in ambiente
grafologico. Collabora con Alberto Boano del Politecnico di
Torino per l'elaborazione al software Yourself basato sull'uso della
grafologia che vince alle finali italiane di Immagine CUP 2007, il 1°
premio. Libero professionista dal 2003 è membro dell'Associazione
Grafologica Italiana AGI. Svolge: Profili di Personalità,
Orientamento Scolastico, Rieducazione della Scrittura, Consulenza
Professionali e Perizie Tecniche Grafologiche giudiziali ed
extragiudiziali per Tribunali, Procure, Studi Legali e
Privati relativamente a scritture di incerta paternità.
Ezio Albrile (Torino 1962). Storico delle religioni del mondo
antico. Si è occupato in particolare delle interazioni fra dualismi
occidentali (orfismo, ermetismo, gnosticismo, manicheismo) e
religioni dell’Iran antico (preislamico). A una nutrita bibliografia
scientifica unisce quella di divulgatore culturale. È docente di storia
religiosa dell’Iran e dell’Asia centrale presso il CESMEO di Torino.
Francesca Paola Antonino nasce ad Oria (BR) nel 1964. Dal 1995
esercita la libera professione di architetto. E’ cootitolare dello studio
associato Fabrica Aedificandi di Cherasco (CN). E’ specializzata sia in
architettura sacra sia nel restauro conservativo e nella riabilitazione
strutturale inerenti la rifunzionalizzazione di edifici storico-
241
monumentali. Alcuni interventi significativi da lei seguiti hanno
interessato: il castello di Ozegna (TO), l'Accademia delle Scienze di
Torino, il castello di Piobesi Torinese, Palazzo Madama di Torino, la
torre del Palazzo Capranica (Roma), l’antico Albergo di Virtù (TO),
il castello di Legnano (MI); la residenza dell’Ambasciatore d’Italia
all’Aja (Paesi Bassi) - Ministero degli Affari Esteri, il Battistero di
Casciago (VA). Ha tenuto corsi presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino relativamente al Restauro Conservativo ed al
Consolidamento degli edifici esistenti e sugli stessi argomenti è
autrice di alcuni contributi e pubblicazioni.
Domenico Appendino, nato nel 1951, liceo classico, ingegnere
nucleare nel 1974, vicepresidente di Prima Industrie con delega per
lo sviluppo e le partecipate, è autore di un centinaio di articoli e
pubblicazioni. Dopo un primo periodo di ricerca e progettazione nel
nucleare e nella meccatronica, è stato per trent’anni dirigente
industriale nel gruppo di aziende guidato da Prima Industrie (robot e
generatori laser, macchine per la lavorazione della lamiera e
automazione, elettronica e controlli numerici) per cui ha seguito la
costituzione e lo sviluppo delle società in Asia. Da sempre
appassionato e studioso di arte antica ed archeologia, grazie
all’intensa e più che ventennale frequentazione della Cina, ha potuto
approfondire le sue conoscenze dell’arte antica di questo paese, con
particolare attenzione alla scultura fittile di scavo. Da un decennio è
interpellato come esperto per classificazioni storiche di reperti fittili
cinesi, per datazioni stilistiche di pezzi museali e partecipa con
lezioni e testimonianze a eventi relativi alla civiltà cinese in vari Enti
ed Università.
Giuseppe Artuffo nasce a Canelli nel 1963. Laureato in Farmacia ,
negli anni ricopre cariche presso l'Ordine dei Farmacisti di Cuneo,
Unifarma s.p.a. ed il proprio Comune di residenza, Santo Stefano
Belbo dove viene eletto per due mandati consecutivi sindaco. In
quegli anni costituisce la Fondazione Cesare Pavese e ne rimane
Presidente fino alla fine del proprio mandato elettorale. Svolge la
professione di Farmacista, ma si diletta anche di poesia fin dal
periodo liceale ed il risultato sono due libri: "Dentro l'anima delle
colline" e "Sedotti dalla luna", Pieraldo Editore.
242
Umberto Casale: nasce a Racconigi nel 1951. Teologo e docente
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Facoltà di
Teologia di Torino, è autore di numerose pubblicazioni. Collabora
con diverse riviste specializzate, in particolare con “Archivio
Teologico Torinese”. E’ consulente presso l’U.D.C. della Curia di
Torino per la formazione degli operatori pastorali.
Natascia Chiarlo: nasce nel 1972 a Savigliano. Diplomata in
pianoforte e canto lirico al Conservatorio "G.Verdi" di Torino e in
formazione teatrale presso la RAI di Torino. Protagonista di recital
teatrali, si esibisce in duo con il fratello Ivan. Il duo Chiarlo
(Associazione Culturale "Arturo Toscanini"), producendo spettacoli
ed eventi di carattere culturale. Collabora, fra l'altro, con l'Orchestra
Sinfonica di Sanremo, con il Museo Parigino a Roma e con
l'orchestra Sinfonica giovanile del Piemonte. Il duo è promotore
dell'evento"La Santità sconosciuta – Piemonte terra di Santi" che si svolge
annualmente nell'Abbazia di Staffarda
Renato Coda: nasce a Torino nel 1946. Professore di Anatomia
Patologica all’Università di Torino, dirige la Struttura Complessa di
Oncologia dell’Ospedale Gradenigo di Torino. Da alcuni anni
insegna Iconografia delle malattie nella Scuola di Perfezionamento
di Paleopatologia all’Università di Pisa.
Martina Corgnati (1963), storica dell’arte e curatrice, insegna Storia
dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Torino. È autrice di numerose
monografie di artisti contemporanei, tra i quali Pinot Gallizio
(Essegi, Ravenna 1992), Albino Galvano (Tip. Valdostana, Aosta
1995), Bernard Damiano (Electa, Milano 1995), Lamberto Pignotti
(Parise, Colognola ai Colli 1996), Enrico Baj. Catalogo generale
(Marconi-Menhir, Milano-La Spezia 1997), Carlo Sismonda (Skira,
Milano 2012). Tra le sue pub-blicazioni: Dizionario d’arte contemporanea
(con Francesco Poli, Feltrinelli, Milano 1994); Cracking art. Nascita di
un’avanguardia (Mazzotta, Milano 2005) e la cura di Meret Oppenheim
(Skira, Milano 1998). È presidente del comitato scientifico del
Premio Suzzara, consulente responsabile per l’arte contemporanea
del Parco Letterario Horcynus Orca (Messina), consulente per le
attività espositive dei Musei di Spoleto. Collabora stabilmente a
diversi periodici e quotidiani con rubriche e interventi dedicati
all’arte moderna e contemporanea. Per la Bruno Mondadori ha
243
pubblicato Dizionario dell’arte del Novecento (Milano 2001) e Artiste
(Milano 2004).
Piero Flecchia: nasce a Torino nel 1938. Esordisce come narratore
apprezzato da Filippini Contini e Pampaloni (Bompiani, Emme
edizioni, Lerici) per poi studiare, dagli anni 1970, quasi soltanto
l’istituzione stato, sulla quale ha pubblicato episodici e dispersi saggi
e articoli.
Ezio Fulcheri: nasce ad Alba nel 1952. Professore di Anatomia
Patologica presso l’Università di Genova e di Paleopatologia presso
l’Università di Torino. Responsabile del Centro di Patologia fetoneonatale, svolge attività diagnostica e di ricerca sulle malformazioni
congenite. Presidente dell’Associazione “L’abbraccio di don Orione”
per la tutela e la cura dei neonati e della maternità.
(www//abbracciodonorione.it)
Gianna Gancia: nata a Bra nel 1972, dopo aver conseguito la
maturità scientifica ed essersi iscritta a giurisprudenza a Torino,
interrompe gli studi per prendere in mano in prima persona
l’azienda di famiglia, a seguito della prematura scomparsa del padre
Gianpiero. Si occupa della filiera produttiva e commerciale del
settore e le sue aziende si sviluppano e articolano a livello nazionale
e internazionale. Agli interessi e attività nel settore viti-vinicolo
affianca ben presto l’iniziativa imprenditoriale nel settore
cinematografico, scommettendo su autori giovani e sulla qualità dei
loro lavori fonda una casa di produzione di film, di cui diventa Vice
Presidente, propiziando la realizzazione di lungometraggi e film,
come It’s not me, it’s not you (Torino Film Festival 2002), Fratelli di
Sangue (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2006), fino
all’ultimo Corazones de mujer (selezionato per il Festival del Cinema di
Berlino 2008). Sempre a cavallo tra anni Novanta e Duemila
l’esperienza nelle realtà associative imprenditoriali: in particolare, è
Vice Presidente dei Giovani Imprenditori della Provincia Granda. In
quegli stessi anni, è consigliere comunale a Narzole e consigliere
d’amministrazione dell’Acquedotto delle Langhe e delle Alpi
Cuneesi. La passione politica, maturata grazie agli studi approfonditi degli scritti del Presidente Luigi Einaudi, la portano ad iscriversi
alla Lega Nord e a diventarne militante attiva. Nel 2004 la candidatura a Presidente della Provincia di Cuneo: vince al primo turno,
244
con il miglior risultato da quando è prevista l’elezione diretta del
Presidente e diventa la prima donna Presidente della Provincia di
Cuneo. Ha un figlio, Gianpiero, di tredici anni.
Lino Lantermino: nato nel 1940, farmacista per necessità, studioso
della Shoah per passione, tiene corsi, conferenze ed incontri.
Predicatore battista, si occupa part time del tempio evangelico di
Cuneo.
Beppe Mariano: nato nel 1938 a Savigliano. Poeta e scrittore. Negli
anni ’70 ha fondato, con Sebastiano Vassalli, la rivista “Pianura” ed
è stato “Poeta visivo” (Catalogo Marcovaldo 2002). Già Direttore
del Teatro Toselli di Cuneo. Per venti anni ha scritto sulla terza
pagina della “Gazzetta del Popolo” ed in seguito su “Stampa Sera”.
Premiato più volte in concorsi letterari. Ha pubblicato sette raccolte
di poesia, l’ultima delle quali, “Il passo della salita” (Interlinea 2007),
raccoglie trent’anni di lavoro. Del 2010, “Mòria e Mistà. Ballate dei
monti perduti”. Da quattro anni condirettore della rivista romana di
narrativa e critica“Il cavallo di Cavalcanti”. In corso di stampa, presso
“Aragno Editore” l’opera omnia della sua produzione poetica.
Lorenzo Orione: nato nel 1960 a Genova da antica famiglia
piemontese di Piverone, è medico specialista in Igiene e Medicina
Preventiva, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Direttore della
Struttura Complessa Unità di Valutazione e Organizzazione degli
Screening (Prevenzione Serena) per le aziende sanitarie ed
ospedaliera della Provincia di Cuneo, è autore di numerose
pubblicazioni medico-scientifiche inerenti l’epidemiologia e gli
screening dei tumori.
Vanna Pescatori: nata a Trieste nel 1953, si è laureata nell'ateneo
triestino in Filosofia teoretica. Docente di materie letterarie dal
1977, tiene da tre anni il corso di Teoria e Metodo dei Mass Media
all'Accademia di Belle arti di Cuneo. Da oltre vent'anni collabora
come giornalista alla testata de < La Stampa > edizione di Cuneo,
per le pagine culturali e, più sporadicamente, con alcune altre testate
del territorio.
Carlo Petrini: nasce nel 1949 a Bra. Fondatore del movimento
culturale “Slow food”, si occupa di enogastronomia sui principali
245
periodici e giornali italiani e stranieri. Ideatore di importanti
manifestazioni di rilievo internazionale come il “Salone del Gusto”,
“Cheese”, “Terra madre”, è stato inserito da «Time Magazine» tra gli
"eroi del nostro tempo" nella categoria «Innovator».
Gianni Rabbia: nasce ad Omegna nel 1944. Già docente di
letteratura negli Istituti Superiori e direttore IRRE Piemonte.
Attualmente è Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Saluzzo. Collabora con alcune testate locali.
Sergio Soave: nasce a Savigliano nel 1946. Professore di storia
contemporanea all’Università degli Studi di Torino, collabora con
numerose riviste del settore. Ha studiato i problemi del movimento
cattolico, delle autonomie regionali e del movimento socialista. Dal
1983 al 1992 e, successivamente, dal 1996 al 2001 è stato deputato
al Parlamento. Dal 1996 al 2004 ha ricoperto la carica di sindaco
della città di Savigliano.
Ugo Volli (1948) è ordinario di Semiotica del testo all'Università di
Torino, dove coordina anche il Centro interdipartimentale di ricerca
sulla comunicazione (CIRCE) e l'indirizzo comunicativo del
dottorato di ricerca in scienze del linguaggio e della comunicazione.
Ha al suo attivo oltre 250 pubblicazioni scientifiche e una quindicina
di libri. Collabora con vari giornali, radio e televisioni. Svolge attività
di consulenza sulla comunicazione per numerose aziende e
istituzioni pubbliche. Ha insegnato in numerose università italiane
straniere. Fra i suoi libri più recenti, "Laboratorio di semiotica"
(Laterza 2005). "Lezioni di filosofia della comunicazione" (Laterza
2008), "Parole in gioco" (Compositori 2009).
246
247
248
249
250
Scarica