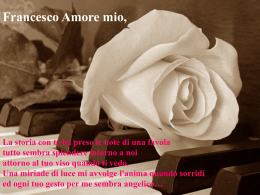870 Questa è un’opera di finzione. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi sono il frutto della fantasia dell’autrice o sono usati in maniera fittizia, e qualunque somiglianza con persone, viventi o defunte, aziende, eventi o località reali è da ritenersi puramente casuale. Titolo originale: The Good Girl Copyright © 2014 by Mary Kyrychenko All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Books S.A. Traduzione dall’inglese di Daniele Ballarini © 2015 Newton Compton editori s.r.l. Roma, Casella postale 6214 ISBN 978-88-541-7586-0 www.newtoncompton.com Realizzazione a cura di Librofficina, Roma Progetto grafico: Sebastiano Barcaroli Immagini: © Corbis Image Mary Kubica Una brava ragazza Per A & A Eve Prima Quando squilla il telefono, sono seduta in cucina, al tavolinetto riservato alla colazione, e mi sto gustando una tazza di cioccolata. Sono sovrappensiero, dalla finestra fisso il giardino sul retro che, nel pieno di un autunno arrivato in anticipo, è cosparso di foglie. Sono perlopiù morte, sebbene alcune, pur senza vita, restano ancora attaccate agli alberi. È pomeriggio inoltrato. Il cielo è coperto, le temperature stanno precipitando sotto i dieci gradi. Non credo di essere ancora pronta per questo, mi chiedo come sia volato il tempo; sembrava ieri che accoglievamo la primavera appena arrivata e, poco dopo, l’estate. Lo squillo del telefono mi allarma, sono certa che sia un venditore di qualche call-center, perciò non mi preme alzarmi subito. Mi godo le ultime ore di silenzio prima che James irrompa dalla porta e venga a invadere il mio mondo, per cui non voglio proprio sprecare minuti preziosi per un’offerta pubblicitaria che sicuramente rifiuterò. Cessa il suono irritante dell’apparecchio, che però ricomincia poco dopo. Rispondo per un unico motivo: farlo tacere. «Pronto», dico in tono seccato, in piedi al centro della cucina con un fianco poggiato all’isola. «La signora Dennett?», mi chiede una donna. Penso per un attimo di dirle che ha composto il numero sbagliato, oppure di anticipare la sua tirata pubblicitaria con un semplice «non sono interessata». «Sono io». «Signora, sono Ayanna Jackson». Ho già sentito questo nome. Non l’ho mai vista, ma da più di un anno lei compare spesso nella vita di Mia. Quante volte ho sentito mia figlia pronunciare il suo nome… «Io e Ayanna abbiamo fatto questo… Io e Ayanna abbiamo fatto quello…». La donna al telefono mi spiega che conosce Mia, che insegnano nella stessa scuola superiore della città, un istituto dal metodo sperimentale. «Spero di non disturbarla», aggiunge. Prendo fiato. «No, Ayanna, sono appena rientrata», mento. Mia compirà venticinque anni tra un mese, il 31 ottobre. È nata nel giorno di Halloween, e presumo che la sua collega abbia chiamato per questo. Vuole fare una festa, un party a sorpresa per mia figlia? «Signora, oggi Mia non è venuta al lavoro», dice. Non è ciò che mi aspettavo di sentire. Mi ci vuole comunque poco per riprendermi. «Be’, sarà malata», esclamo. Il primo pensiero è giustificarla; Mia avrà una spiegazione plausibile per non essere andata al lavoro o per non aver avvisato della sua assenza. Mia figlia è uno spirito libero, certo, ma anche molto affidabile. «Non ha avuto sue notizie?» «No», dico, ma la cosa è quasi normale. Passiamo giorni, a volte settimane, senza parlarci. Da quando è stata inventata la posta elettronica, ci inoltriamo al massimo informazioni banali via computer. «Ho cercato di telefonarle a casa, ma non risponde». «Hai lasciato un messaggio?» «Parecchi». «E lei non ha richiamato?» «No». Ascolto malvolentieri la donna all’altro capo del filo. Fisso fuori dalla finestra, osservo i figli dei vicini scuotere un alberello, così che le foglie residue cadano su di loro. I bambini sono il mio orologio: quando escono in cortile so che il pomeriggio sta per terminare, poiché è finita la scuola. Quando rientrano in casa, sarà ora di cena. «E al cellulare?» «Parte la segreteria». «Hai provato…?» «Ho lasciato un messaggio». «Sei sicura che non abbia avvisato la scuola per telefono?» «In segreteria non sanno niente». Temo che Mia finirà nei guai. Mi preoccupo che possano licenziarla. Ma non mi viene affatto in mente che possa già essere nei guai. «Spero non siano sorti troppi problemi». Ayanna afferma che gli studenti della prima ora non avevano informato nessuno dell’assenza di Mia, e solo alla seconda ora era cominciata a circolare la voce che mancava la signorina Dennett e che non c’era una sostituzione pronta. Per mantenere l’ordine in classe, si era mosso il preside, mentre si individuava un supplente. Aveva trovato delle scritte sulle pareti, fatte con gessetti costosissimi, quelli comprati dalla stessa Mia quando l’amministrazione della scuola glieli aveva negati. «Signora Dennett, non crede che sia strano?», mi domanda Ayanna. «Non è da Mia». «Sì, ma sono certa che avrà un motivo valido». «Per esempio?», ribatte. «Proverò a chiedere agli ospedali. Ho il numero di quello nella sua zona…». «Già fatto». «Allora chiamo le sue amiche», dico, benché non ne conosca nessuna. Ho sentito qualche nome di sfuggita, quelli di Ayanna e Lauren, e so che ce n’è una dello Zimbabwe con visto studentesco che sta per essere rimpatriata, sebbene mia figlia pensi non sia giusto. Ma non le conosco, e non è facile rintracciare il loro cognome o i contatti. «Già fatto». «Si farà viva, Ayanna. Sarà un contrattempo. Possono esserci tantissime ragioni». «Signora Dennett», insiste lei, ed è a quel punto che lo capisco: c’è qualcosa che non va. Mi arriva dritto allo stomaco, e il primo pensiero è di quando aspettavo Mia, ero al settimo o ottavo mese di gravidanza e lei scalciava e si dimenava con un’energia tale da far intuire la forma dei piedini e delle manine sotto la mia pelle. Scosto uno sgabello e mi metto a sedere in cucina, pensando che mia figlia fra pochissimo compirà venticinque anni e io non ho ancora deciso che regalo farle. Non ho proposto l’idea di una festa, né suggerito di andare tutti (io, James, Grace e lei) in un ristorante elegante del centro. «Quindi, cosa proponi di fare?», le chiedo. Colgo un sospiro dall’altra parte del telefono. «In realtà speravo che Mia fosse lì con lei», esclama Ayanna. Gabe Prima È buio mentre accosto l’auto al marciapiede. Dalle finestre della casa in stile Tudor la luce riverbera fin sul viale alberato. Dentro, riesco a distinguere un gruppo di persone in attesa del mio arrivo. Ci sono il giudice che incede a lunghi passi e la signora Dennett, seduta sul bordo di una poltrona imbottita, che sorseggia qualcosa di alcolico, almeno all’apparenza. Ci sono dei poliziotti in divisa e un’altra donna, bruna, che scruta dalla finestra mentre parcheggio con calma, ritardando la mia entrata a effetto. I Dennett assomigliano alle altre famiglie che vivono nel North Shore di Chicago, i sobborghi che costeggiano le sponde del lago Michigan a nord della città: sono ricchi da fare schifo. È normale quindi che attenda sul sedile della mia auto, anche se, in virtù del potere che mi hanno indotto a credere di avere, dovrei affrettarmi verso l’enorme dimora. Ripenso alle parole con le quali il sergente mi aveva affidato il caso: «Non incasini quest’affare». Occhieggio l’imponente edificio dal calore rassicurante della mia macchina sgangherata. Dall’esterno, non appare maestoso come immagino siano gli interni. Ha tutto il fascino della vecchia Inghilterra che offre lo stile Tudor: legno e muratura, finestre strette e tetto spiovente. Mi rammenta i castelli medievali. Il sergente mi ha ammonito a tenere il segreto, ma si suppone debba ritenermi privilegiato per l’assegnazione di un caso di grande importanza. Eppure, per qualche motivo non mi sento affatto privilegiato. Mi dirigo verso l’ingresso principale, attraversando il prato per salire un paio di gradini, dopodiché busso. Fa freddo. Infilo le mani in tasca per tenerle al caldo durante l’attesa. Sto pensando di essere vestito in modo ridicolmente semplice e informale (pantaloni color cachi e una polo sotto una giacca di pelle), quando ricevo il saluto di uno dei giudici di pace più influenti della contea. «Giudice Dennett», esordisco, scivolando dentro. Mi comporto con più autorità di quella che mi pare di avere, facendo ricorso a quel briciolo di autostima che tengo nascosto da qualche parte per momenti simili. Il giudice di pace è un uomo importante, per stazza e potere. Incasinare la faccenda mi farebbe perdere il lavoro, nel migliore dei casi. La signora Eve Dennett si alza dalla poltrona e le dico col tono più educato che riesco a trovare: «La prego, si accomodi», mentre l’altra donna – più giovane, forse poco più che trentenne, presumo dalle mie indagini preliminari si tratti di Grace Dennett – viene incontro a me e al giudice, fra l’ingresso e il salotto. «Ispettore Gabe Hoffman», dico senza i soliti convenevoli. Non sorrido, non porgo la mano da stringere. La ragazza afferma effettivamente di essere Grace; da qualche mio lavoro precedente, so che è una socia dello studio legale Dalton & Meyers. Però mi ci vuole solo un briciolo di intuito per accorgermi che non mi piace; quando osserva dall’alto in basso la mia tenuta da impiegato, sfoggia un’aria di superiorità e un tono cinico che mi innervosiscono. La signora Dennett parla ancora con un marcato accento britannico, nonostante sappia dalla mia precedente disamina dei fatti che vive negli Stati Uniti da quando aveva diciotto anni. Pare in preda al panico. È la prima cosa che noto. La sua voce è stridula, le dita indugiano nervosamente su tutto quanto le capiti a tiro. «Mia figlia è scomparsa, ispettore», farfuglia. «Le sue amiche non l’hanno vista. Non hanno parlato con lei. Io l’ho chiamata al telefonino, le ho lasciato dei messaggi». Smozzica le parole, tenta disperatamente di non scoppiare a piangere. «Sono andata nel suo appartamento per vedere se c’era», aggiunge, ma poi ammette: «Ho fatto tutto quel tragitto in auto e la padrona di casa non mi ha fatto entrare». La signora è una donna da mozzare il fiato. Non posso fare a meno di fissare i suoi lunghi capelli biondi scendere sull’incavo del seno prosperoso che sbuca dalla camicetta: il primo bottone è aperto. Avevo visto alcune sue foto, in piedi di fianco al marito sulla scalinata del tribunale. Ma non rendono idea di cosa significhi vederla in carne e ossa. «Quand’è stata l’ultima volta che ha parlato con lei?», chiedo. «La settimana scorsa», replica il giudice. «Non la settimana scorsa, James», dice Eve, che fa una pausa, consapevole dello sguardo contrariato del marito a causa dell’interruzione, prima di continuare: «La settimana precedente. Forse quella ancora prima. Il nostro rapporto con Mia è così, a volte passano settimane senza che ci sentiamo». «Quindi, la cosa non è insolita», indago. «Cioè, non avere sue notizie per un certo periodo…». «No», ammette la signora Dennett. «E lei, Grace?» «Ho parlato con Mia la settimana scorsa. Una telefonata rapida. Era mercoledì, mi pare. O forse giovedì. Sì, era giovedì, perché mi ha chiamato mentre entravo in tribunale per un’udienza su un’istanza da respingere». Un commento aggiunto appositamente per farmi sapere che è avvocato, come se non me l’avessero già rivelato la giacca gessata e la valigetta di cuoio ai suoi piedi. «Qualcosa di insolito?» «Mia che agisce da Mia». «E cosa vuole dire?» «Gabe», interviene il giudice. «Ispettore Hoffman», affermo deciso. Se lo devo chiamare giudice, lui può benissimo chiamarmi ispettore, o detective. «Mia è molto indipendente. Segue un ritmo tutto suo, per così dire». «Perciò, volendo fare un’ipotesi, sua figlia manca da giovedì scorso». «Ieri un’amica ha parlato con lei, l’ha vista al lavoro». «A che ora?» «Non so… Le tre di pomeriggio». Do uno sguardo al mio orologio. «Dunque, è scomparsa da 27 ore?». La signora Dennett s’informa: «È vero che non la si ritiene scomparsa finché non sono trascorse quarantotto ore?» «Ovviamente no, Eve», replica il marito con un tono tale da umiliarla. «No, signora», preciso. Tento di essere il più cordiale possibile. Non mi piace la maniera in cui il marito la mortifica. «In realtà, nei casi di persone scomparse, le prime quarantotto ore sono spesso le più importanti». Il giudice s’intromette di nuovo: «Mia figlia non è scomparsa. Si è smarrita, sta facendo qualcosa di imprudente, di irresponsabile. Ma non è scomparsa». «Vostro onore, chi è stato allora l’ultimo a vederla, prima che…», sono un bel presuntuoso e non posso fare a meno di dirlo, «si smarrisse?». È la signora Dennett a rispondere: «Una donna di nome Ayanna Jackson. È una collega di Mia». «Ha un numero al quale contattarla?» «Su un foglietto, in cucina». Faccio un cenno col capo a uno degli agenti, che va in cucina a prenderlo. «Mia ha mai fatto una cosa simile in passato?» «No, assolutamente no». Tuttavia, il linguaggio corporeo del giudice e di Grace Dennett smentiscono quest’ultima affermazione. «Non è vero, mamma», protesta lei. La guardo impaziente. Gli avvocati adorano sentirsi parlare. «Mia è scappata di casa cinque o sei volte. Passava le notti a fare chissà cosa con Dio solo sa chi». Sì, penso, Grace è una stronza. Ha i capelli scuri come il padre, l’altezza della madre e le fattezze paterne. Non è un bel mix. Alcuni direbbero che ha una forma a clessidra, e lo direi anch’io, se mi piacesse. Invece secondo me è grassottella. «Ma è una cosa diversa. Allora andava alle superiori. Era un po’ ingenua e scapestrata, ma…». «Eve, non sovrainterpretare», dice il giudice. «Mia beve?», chiedo. «Non molto», risponde la signora. «Eve, come fai a sapere quel che fa Mia? Non vi parlate quasi mai». La signora si porta una mano al viso per tamponare il naso che le cola, e per un attimo sono talmente sorpreso dalle dimensioni della gemma che ha al dito da non udire il giudice mentre racconta borioso come la moglie fosse riuscita, prima che lui tornasse a casa, a farsi passare Eddie (attenzione, qui torno concentrato per lo stupore che il signor Dennett non solo chiami il mio capo per nome, ma che ne conosca anche il nomignolo). A quanto pare James Dennett è convinto che la figlia si stia dando alla pazza gioia e che non vi sia alcun bisogno di un interessamento delle autorità. «Non crede che sia un caso per la polizia?», gli chiedo. «Assolutamente no. È una questione che deve sbrigare la famiglia». «Qual è l’etica professionale di Mia?» «Prego?», reagisce Dennett, mentre gli si formano sulla fronte delle rughe che tenta di celare con un gesto esasperato della mano. «La sua etica professionale. Ha una buona reputazione sul lavoro? Ha mai evitato di andarci? Telefona spesso in segreteria per darsi malata anche se non è vero?» «Non saprei. Ha un posto, la pagano. Si mantiene da sola. Non faccio domande». «Signora Dennett?» «Adora il suo mestiere. Lo ama. Ha sempre voluto insegnare». Mia è docente d’Arte. Alle superiori. Lo appunto sul mio taccuino per ricordarmene. Il giudice desidera sapere se penso che ciò sia importante. «Forse», ribatto. «E come mai?» «Vostro onore, sto solo cercando di capire sua figlia. Capire chi è, tutto qua». La signora Dennett sta quasi per piangere. Le si stanno gonfiando e arrossando gli occhi azzurri mentre tenta pateticamente di trattenere le lacrime. «Pensa che le sia accaduto qualcosa?». Rifletto tra me e me: non è questo il motivo per cui mi ha chiamato? Lei pensa che sia successo qualcosa alla figlia; però dico: «Voglio agire subito per poi ringraziare il Signore se verrà fuori che è stato tutto un grosso equivoco. Sono certo che sta bene, davvero, ma sarebbe vergognoso trascurare la questione senza approfondirla». Mi morderei le mani se si scoprisse che qualcosa non va. «Da quanto tempo Mia vive da sola?», domando. «Fra trenta giorni saranno sette anni», afferma la signora a bruciapelo. Sono stupito. «Tiene il conto? A livello di giorni?» «Era il suo diciottesimo compleanno. Non vedeva l’ora di andare via di qui». «Non voglio ficcare il naso», dico, ma la verità è che non devo. Pure io non vedo l’ora di andarmene di lì. «Dove abita adesso?». Risponde il giudice: «In un appartamento, in città. Vicino a Clark e Addison». Sono tifoso dei Chicago Cubs e quindi la cosa mi emoziona. Basta menzionare le parole Clark o Addison che rizzo le orecchie come un cucciolo affamato. «Wrigleyville. Un quartiere molto bello. Sicuro». «Le do l’indirizzo», propone la signora Dennett. «Mi piacerebbe controllare, se non avete nulla in contrario. Guarderò se ci sono vetri rotti, segni di effrazione alla porta». La voce della madre trema mentre chiede: «Ritiene che qualcuno abbia fatto irruzione nell’appartamento di Mia?». Cerco di rassicurarla. «Voglio soltanto controllare, signora. L’edificio ha un portiere?» «No». «Un sistema d’allarme? Telecamere?» «Come facciamo a saperlo?», ringhia il giudice Dennett. «Non le fate visita?», chiedo, riuscendo a fermarmi in tempo. Aspetto una risposta, che però non arriva. Eve Dopo Le chiudo la lampo del giaccone e le tiro il cappuccio sulla testa, poi camminiamo in mezzo all’implacabile vento di Chicago. «Adesso dobbiamo affrettarci», dico, e Mia annuisce senza chiederne il motivo. Le raffiche quasi ci spostano mentre ci dirigiamo verso la monovolume di James, parcheggiata a una quindicina di metri; le afferro il gomito e l’unica cosa di cui sono sicura è che se una di noi due cadesse, si tirerebbe appresso anche l’altra. Il parcheggio è una lastra di ghiaccio, sono passati quattro giorni dal 25 dicembre. Cerco di proteggerla dal freddo e dal vento sferzante, attirandola verso di me e passandole un braccio attorno alla vita per tenerla calda, sebbene la mia corporatura sia più esile della sua, per cui sono certa di fallire nel mio intento. «Torneremo la settimana prossima», le dico mentre sale sul sedile posteriore, a voce alta per superare il suono delle portiere che sbattono e delle cinture di sicurezza che vengono allacciate. La radio gracchia, il motore dell’auto fa una fatica del diavolo in questa giornata pungente. Mia ha un sussulto, allora chiedo a mio marito di spegnere la radio, per favore. Se ne sta seduta a guardare fuori dal finestrino tre vetture che ci accerchiano come un branco di squali famelici; alla guida uomini invadenti e implacabili, uno di loro alza una macchina fotografica, inquadra e scatta, il flash quasi ci acceca. «Dove diavolo sono i poliziotti quando ce n’è bisogno?», chiede James rivolto a nessuno in particolare, prima di suonare così tanto il clacson che Mia si mette le mani sulle orecchie per non sentire quell’orribile frastuono. Di nuovo i lampi delle macchine fotografiche. Le auto indugiano col motore acceso, scaricando dal tubo di scappamento un fumo che ingrigisce ancora di più la giornata. Lei alza lo sguardo e vede che la osservo. «Mi hai sentito, Mia?», le domando in tono gentile. Scuote la testa, e riesco appena a percepire il pensiero fastidioso che le passa per la mente: Chloe, mi chiamo Chloe. I suoi occhi azzurri sono incollati ai miei, che sono rossi e acquosi per il tentativo di trattenere le lacrime, una cosa normale da quando è tornata mia figlia, anche se James è qui, come sempre, a ricordarmi di restare calma. Fatico a dare un senso al tutto, atteggio il volto a un sorriso forzato eppure completamente onesto, e una frase non detta mi riecheggia in testa: Non riesco a credere che sei a casa. Mi premuro di lasciarle spazio sufficiente, non so di quanto ne abbia bisogno, ma so bene di non volerle stare troppo addosso. Scorgo il suo malessere in ogni gesto ed espressione, nel modo in cui sta seduta, non più traboccante di fiducia in sé, come la Mia di una volta. Comprendo che le è successo qualcosa di spaventoso. Mi chiedo comunque se senta che è accaduto qualcosa anche a me… Mia distoglie lo sguardo. «La prossima settimana torniamo dalla dottoressa Rhodes», dico, e lei annuisce. «Martedì». «A che ora?», domanda James. «All’una». Lui consulta il suo smartphone con una mano, quindi mi dice che dovrò accompagnare da sola nostra figlia all’appuntamento. Sostiene di avere un processo a cui non può mancare. Inoltre, afferma, è sicuro che io sia in grado di gestire la situazione. Gli dico che ovviamente ce la posso fare, però mi sporgo per sussurrargli all’orecchio: «Adesso ha bisogno di te. Sei suo padre». Gli ricordo che ne abbiamo già discusso, ci siamo accordati e lui me lo ha promesso. Risponde che vedrà quel che può fare, però mi resta un forte dubbio. A suo dire, la sua rigida agenda professionale non gli lascia tempo per crisi familiari come questa. Sul sedile posteriore, Mia guarda dal finestrino il mondo che scorre mentre percorriamo in fretta la I-94 per uscire dalla città. Ormai sono le tre e mezza del venerdì pomeriggio che precede il fine settimana di Capodanno, per cui il traffico è in tilt. Restiamo bloccati in un ingorgo, aspettiamo e poi riprendiamo a passo di lumaca, neanche cinquanta chilometri l’ora su un’autostrada. James non ha pazienza in queste situazioni. Tiene gli occhi sullo specchietto retrovisore, aspetta che ricompaiano i paparazzi. «Allora, Mia», esordisce James tanto per passare il tempo. «La strizzacervelli dice che soffri di amnesia». «Oh, James», imploro. «Per favore, non ora». Mio marito non è disposto ad aspettare. Vuole andare fino in fondo alla questione. Non è nemmeno una settimana che Mia è tornata a vivere con noi, dal momento che non è in grado di stare da sola. Penso al giorno di Natale, quando la vecchia auto bordeaux aveva percorso lentamente il viale d’accesso con Mia a bordo. Ricordo la maniera in cui James, quasi sempre distaccato, pressoché indifferente, si era fiondato per essere il primo ad accoglierla, a stringere tra le braccia la ragazza emaciata sul vialetto coperto di neve, come se fosse stato lui, e non io, a trascorrere in lutto tutti quei lunghi, tremendi mesi. Ma da allora ho visto quel sollievo momentaneo di James scemare, e Mia, con la sua smemoratezza, diventare un fastidio per lui, come uno dei tanti casi che si accumulano nel suo ufficio, e non di nuovo nostra figlia. «Allora, quando?» «Dopo, te ne prego. E poi, quella donna è una professionista», insisto. «Una psichiatra, non una strizzacervelli». «Benissimo, Mia, la psichiatra dice che soffri di amnesia», ribadisce, ma lei non risponde. Lui la guarda dallo specchietto retrovisore, coi suoi occhi castano scuro che la tengono prigioniera. Per un fugace attimo, Mia tenta di reggere lo sguardo, poi i suoi occhi si posano sulle mani, dove sono attirati da una crosticina. «Hai intenzione di commentare?», le chiede. «Così ha detto anche a me», risponde, e mi sovvengono le parole della dottoressa che sedeva davanti a me e a James nel suo triste ufficio (Mia era stata invitata ad andare nella sala d’attesa a sfogliare delle datatissime riviste di moda). La psichiatra ci aveva fornito la definizione letterale di un disturbo da stress acuto, e a me erano venuti in mente soltanto i poveri reduci dalla guerra del Vietnam. James sospira. Intuisco che lui non lo ritiene plausibile, che reputa impossibile che la memoria svanisca nel nulla. «Quindi, come funziona? Ricordi che sono tuo padre e che lei è tua madre, eppure pensi di chiamarti Chloe. Sai la tua età, dove vivi e che hai una sorella, ma non hai idea di chi sia Colin Thatcher? Non sai veramente dove sei stata negli ultimi tre mesi?». Intervengo in difesa di Mia: «Si chiama amnesia selettiva, James». «Intendi dire che sceglie le cose che preferisce ricordare?» «Non lo fa mica lei, lo fanno il suo inconscio, il suo subconscio, o qualcosa del genere. Le mettono i pensieri penosi dove non può rintracciarli. Non è qualcosa che lei decide di fare. È la maniera che ha il suo organismo per aiutarla a cavarsela». «Cavarsela in che cosa?» «L’intera faccenda, James. Tutto quanto è accaduto». Lui vuole sapere come risolveremo la questione. Non lo so con certezza, ma suggerisco: «Col tempo, immagino. La terapia, i farmaci, l’ipnosi». Lui sghignazza beffardo, pensa che l’ipnosi equivalga all’amnesia. «Che tipo di farmaci?» «Antidepressivi», replico. Mi volto e, dopo aver dato un colpetto sulla mano di mia figlia, aggiungo: «Forse non recupererà mai più la memoria, ma andrà bene lo stesso». La osservo per un attimo: è praticamente la mia fotocopia, sebbene più alta e giovane e, a differenza di me, ancora molto lontana dalle rughe e dalle ciocche canute che stanno cominciando a insinuarsi nella mia chioma biondo scuro. «E come faranno gli antidepressivi a farle tornare la memoria?» «La aiuteranno a sentirsi meglio». James è sempre sincero, fino in fondo. Uno dei suoi difetti. «Maledizione, Eve, se non riesce a ricordare, per cosa può stare male?», mi chiede, dopodiché i nostri sguardi si rivolgono fuori dei finestrini, fermi nel traffico: la conversazione può considerarsi conclusa. Gabe Prima La scuola in cui insegna Mia Dennett si trova nell’area nordoccidentale di Chicago chiamata North Center. Un buon quartiere, per così dire, non distante da casa sua, dove vivono soprattutto bianchi che pagano affitti superiori ai mille dollari al mese. Buon per lei. Non lo sarebbe stato altrettanto se avesse lavorato a Englewood. La sua scuola intende offrire agli studenti che si ritirano da altri istituti una possibilità di recupero. In piccole aule didattiche, si tengono lezioni di formazione professionale, test d’informatica, si danno consigli di vita, eccetera. E poi arriva Mia Dennett, insegnante d’Arte, incaricata di portare un po’ di quell’anticonformismo che non trova posto nelle scuole tradizionali, quelle che prevedono più ore per scienze e matematica, tediando a morte sedicenni disadattati che se ne infischiano. Ayanna Jackson mi riceverà in segreteria. Devo attendere un buon quarto d’ora perché è nel mezzo di una lezione, quindi devo starmene su una di quelle sedie di plastica che sembrano fatte apposta per strizzarti. Una cosa che non mi piace. Certo, non sono più il figurino di una volta, ma sono convinto di portare molto bene i miei chili di troppo. La segretaria mi tiene d’occhio per tutto il tempo, come se fossi uno studente mandato in presidenza per uno scambio di vedute col preside. Una scena a cui sono tristemente abituato, visto che tanti giorni della mia carriera scolastica li ho passati in una situazione simile. «Lei è quello che cerca di ritrovare Mia», dice mentre mi presento come l’ispettore Gabe Hoffman. Le confermo la sua supposizione. Sono quasi quattro giorni che nessuno la vede o ha più parlato con lei, quindi l’abbiamo iscritta ufficialmente tra le persone scomparse, alla faccia del giudice. Giornali e telegiornali ne hanno riportato la notizia, e ogni mattina, quando scivolo fuori dalle coperte, mi convinco che quella sarà la giornata in cui troverò Mia Dennett e diventerò un eroe. «Quando ha visto Mia per l’ultima volta?» «Martedì». «Dove?» «Qui». Ci dirigiamo in classe, e Ayanna (che mi prega di non chiamarla signorina Jackson) mi invita ad accomodarmi in una delle sedie di plastica attaccate alla cattedra, malridotta e imbrattata di graffiti. «Da quanto tempo conosce Mia?». Lei è seduta in cattedra, su una comoda poltroncina di pelle, e io mi sento un ragazzino, mentre in realtà sono almeno trenta centimetri più alto di lei. Accavalla le lunghe gambe, lo spacco della gonna nera si apre a mostrare la pelle. «Tre anni. Da quando Mia insegna». «Va d’accordo con tutti? Con gli studenti, col personale?». Una risposta solenne: «Non c’è nessuno con cui lei non vada d’accordo». Ayanna prosegue raccontandomi com’è Mia. Quando è arrivata in quella scuola alternativa, aveva una certa grazia naturale, simpatizzava con gli studenti e si comportava come se anche lei fosse cresciuta per le strade di Chicago. E poi aveva organizzato una raccolta fondi per comprare il necessario per gli studenti meno abbienti. «Non si sarebbe detto che è una Dennett». Secondo la signorina Jackson, la maggior parte dei nuovi docenti dura poco in quel genere di ambiente pedagogico. Data l’attuale situazione del mercato, le scuole alternative sono gli unici posti in cui si assumono insegnanti, e i laureati accettano quella posizione finché non gli si presenta un’occasione migliore. Ma non Mia. «Era qui che voleva stare. Mi permetta di mostrarle una cosa», dice Ayanna apprestandosi a prendere una pila di fogli da una vaschetta sulla cattedra. Mi si avvicina e si siede su uno dei banchi, di fianco a me. Mi posa i fogli davanti e noto uno scarabocchio in pessima calligrafia, peggiore della mia. «Stamattina gli studenti hanno compilato la loro parte del diario settimanale», spiega mentre esamino con attenzione il lavoro e noto che il nome della signorina Dennett compare così tante volte che è impossibile contarle. «Lo facciamo ogni settimana. Il compito di questa», continua, «era descrivere cosa intendono fare dopo le superiori». Mi accorgo che le p a r o l e signorina Dennett sono scarabocchiate su quasi ogni foglio. «Ma il novantanove percento degli studenti pensa solo a lei», conclude Ayanna, e dall’avvilimento nella sua voce capisco che anche lei non può far altro che pensare a Mia. «Aveva dei problemi con qualche studente?», chiedo, così per sicurezza. Ma so quale sarà la sua risposta prima ancora che scuota la testa. «E che mi dice di un eventuale fidanzato?», insisto. «Immagino ce l’avesse», replica, «se lo si può definire tale. Un Jason qualcosa. Non conosco il suo cognome. Niente di serio. Escono insieme da poche settimane, forse da un mese, non di più». Me lo appunto. I Dennett non avevano fatto alcun riferimento a un ragazzo. Possibile che non lo sappiano? Ovviamente sì. Con la famiglia Dennett tutto è possibile, comincio a capirlo. «Sa come contattarlo?» «È un architetto», dice. «Sta in uno studio dalle parti di Wabash. Di solito si incontrano il venerdì sera per l’happy hour. Wabash e… Non so, forse Wacker? Da qualche parte lungo il fiume». Mi sembra un’impresa rintracciarlo, ma ci proverò. Trascrivo quest’informazione sul mio taccuino giallo. Il fatto che Mia abbia un ragazzo difficile da trovare è per me un’ottima notizia. In casi come questo, è stato sempre il fidanzato. Se trovo Jason, sono sicuro di ritrovare anche Mia, o ciò che resta di lei. Tenuto conto che è scomparsa da quattro giorni, comincio a sospettare che la storia possa finire male. Jason lavora dalle parti del fiume Chicago: brutta notizia. Dio sa quanti corpi vengono ripescati ogni anno da quelle acque. Lui è architetto, quindi intelligente, capace di risolvere problemi, per esempio come scaricare un corpo di cinquantacinque chili senza che se ne accorga nessuno. «Se Mia e Jason stavano insieme», ipotizzo, «non è strano che lui non cerchi di trovarla?» «Crede che Jason sia implicato?». Faccio spallucce. «So che se avessi una ragazza e non le parlassi da quattro giorni, mi preoccuperei almeno un po’». «Concordo», ammette Ayanna. Si alza dal banco e comincia a cancellare la lavagna. Ha tracce di gesso sulla gonna nera. «Non ha telefonato ai Dennett?» «Il signore e la signora Dennett non hanno la minima idea che abbia un fidanzato. Per quanto li riguarda, Mia è single». «Non è in rapporti stretti coi genitori. Hanno dei… contrasti ideologici». «Concordo». «Non penso che parlasse con i suoi di cose simili». Sta sviando dall’argomento, così tento di riportare Ayanna sul sentiero giusto. «Però lei e Mia siete in rapporti stretti». Me lo conferma. «Direbbe che Mia le racconta tutto?» «Per quanto ne so…». «Che cosa le diceva di Jason?». Ayanna si rimette a sedere, stavolta sul bordo della cattedra. Sbircia l’orologio appeso al muro, si toglie la polvere di gesso dalle mani. Riflette sulla mia domanda. «Non sarebbe durata», mi svela, cerca le parole giuste per spiegarlo. «Mia non s’impegna spesso, quasi mai fa sul serio. Non le piacciono i legami, sentirsi impegnata. È molto indipendente, forse fin troppo». «E Jason è… appiccicoso? Dipendente?». Scuote il capo. «No, non è questo, solo che non è il ragazzo adatto. Quando parlava di lui, Mia non si entusiasmava. Non ciarlava come fanno le ragazze quando hanno incontrato quello giusto. Dovevo sempre costringerla a spifferarmi qualcosa su di lui, e poi mi sembrava di ascoltare un documentario: siamo andati a cena, abbiamo visto un film… E so che lui aveva orari terribili, una cosa che la irritava: mancava agli appuntamenti o arrivava in ritardo. Lei detestava sentirsi vincolata ai suoi ritmi. Quando ci sono tanti problemi il primo mese, non è destinata a durare». «Quindi, è possibile che Mia stesse pensando di lasciarlo». «Non so». «Ma non era felice». «Non direi che non fosse felice», precisa Ayanna. «Non credo che le importasse di esserlo o no». «Da quel che ne sa, Jason aveva lo stesso atteggiamento?». Dice non di saperlo. Quando parlava di Jason, Mia era riservata. Le conversazioni erano distaccate: un elenco delle cose che avevano fatto in una particolare giornata, dati e dettagli su di lui (altezza, peso, colore degli occhi e dei capelli), ma non, si noti bene, il suo cognome. Comunque, Mia non raccontava mai se si baciavano e non menzionava mai quelle «farfalle nello stomaco» (espressione di Ayanna, non mia) che si sentono quando s’incontra l’uomo dei sogni. Sembrava irritata quando lui le dava buca, cosa che secondo Ayanna accadeva spesso, eppure non pareva eccitata le sere in cui avevano in programma di vedersi sul lungofiume. «E questa sarebbe per lei la prova del suo disinteresse?», le chiedo. «Per Jason? Per la loro relazione? Per tutta la faccenda?» «Mia ci passava il tempo in attesa che qualcosa di meglio arrivasse». «Litigavano?» «Non che io sappia». «Ma se ci fosse stato un problema, Mia gliel’avrebbe detto», provo. «Mi piacerebbe pensare di sì», ribatte la donna, mentre il suo sguardo si intristisce. La campanella suona, seguita da uno scalpiccio di passi nell’androne. Ayanna Jackson si alza, e io colgo l’antifona. Le dico che resterò in contatto e le lascio il mio biglietto da visita, invitandola a chiamarmi se le venisse in mente qualcosa. Eve Dopo Sono a metà delle scale quando vedo quelli della troupe giornalistica sul marciapiede di fronte a casa nostra. Stanno in piedi tutti tremanti, coi microfoni e le telecamere. Tammy Palmer, della cronaca locale, con un impermeabile beige e stivali fino al ginocchio, staziona sul prato. Mi dà le spalle, c’è un uomo che fa il conto alla rovescia sulle dita (tre… due…) rivolgendosi a lei, mentre sento la sigla del suo programma, prima che lei dica: «Mi trovo qui a casa di Mia Dennett…». Non è la prima volta che vengono. Ormai i loro servizi si sono diradati, i reporter cominciano a interessarsi ad altre storie: le leggi sulle nozze gay, la condizione disastrosa dell’economia… Ma subito dopo il ritorno di Mia si erano accampati nei dintorni, volevano disperatamente cogliere di sfuggita la ragazza danneggiata, avidi di qualsiasi brandello di informazione da trasformare in titolone. Ci seguivano in auto per tutta la città, finché non rimase che rinchiudere mia figlia in casa. C’erano auto misteriose parcheggiate lì fuori, coi fotografi delle riviste spazzatura che puntavano dai finestrini i loro teleobiettivi, nel tentativo di trasformare Mia in una gallina dalle uova d’oro. Chiudo le tende. La vedo seduta al tavolo della cucina. Scendo le scale in silenzio, la osservo nel suo mondo prima di entrarvi. Indossa un paio di jeans strappati e un comodo maglione blu a collo alto, che scommetto farà sembrare meravigliosi i suoi occhi. Dopo la doccia, ha ancora i capelli umidi e ondulati che si stanno asciugando sulla schiena. Sono sconcertata dai calzini di lana grossa che ha ai piedi e dalla tazza di caffè attorno a cui tiene giunte le mani. Sente che mi avvicino e si volta. Sì, penso tra me, il maglione a collo alto rende bellissimi i suoi occhi. «Stai bevendo il caffè», esordisco, e la vaga espressione sul suo volto mi fa capire di aver detto la cosa sbagliata. «Non bevo caffè?». Ormai è una settimana che ci vado coi piedi di piombo, tento sempre di dire la cosa giusta, esagerando ridicolmente per metterla a suo agio. Mi sforzo, per compensare l’apatia di James e il marasma di Mia. E poi, quando meno me l’aspetto, nel bel mezzo di una conversazione apparentemente normale, mi capita di fare una gaffe. Mia non beve caffè. Non ingerisce caffeina quasi per nulla. La innervosisce. Però vedo che sorseggia dalla tazza, pigra e distratta; penso (e spero) che magari un po’ di caffeina possa fare effetto. Chi è questa ragazza debole davanti a me, di cui riconosco il viso, ma della quale ignoro i gesti, il tono di voce, o il silenzio allarmante che la avvolge come una bolla? Ci sono milioni di cose che vorrei domandarle. Ma non lo faccio. Mi sono ripromessa di lasciarla in pace. James si è immischiato più che a sufficienza per entrambi. Lascerò la faccenda ai professionisti: la dottoressa Rhodes, l’ispettore Hoffman e quelli che non sanno mai quando smettere (mio marito). È mia figlia, però non è mia figlia. È Mia, ma non è Mia. Le assomiglia, però indossa calzini, beve caffè e si sveglia singhiozzando nel cuore della notte. Risponde prima se la chiamo Chloe rispetto a quando la chiamo col suo nome di battesimo. Sembra svuotata, pare che dorma quando è sveglia, resta vigile allorché dovrebbe dormire. Ieri sera, quando ho azionato lo smaltimento rifiuti, ha fatto un balzo sulla sedia ed è scappata in camera sua. Non l’abbiamo più vista per ore, e quando le ho chiesto come avesse passato il tempo, ha saputo dire solamente «non so». La Mia che conosco non riesce a stare ferma tanto a lungo. «Sembra una bella giornata», butto lì, ma non risponde. Effettivamente lo sembra. Il sole splende, però a gennaio è ingannevole e di sicuro la temperatura non supererà i -5 °C. «Voglio mostrarti qualcosa», dico, conducendola dalla cucina all’attigua sala da pranzo, dove a novembre, quando ero certa che fosse morta, avevo sostituito una stampa a tiratura limitata con una delle sue opere. È il dipinto a olio di un pittoresco villaggio della Toscana che Mia aveva copiato da una foto dopo aver visitato la zona insieme a noi alcuni anni fa. Aveva steso i colori a strati, creando una rappresentazione drammatica del villaggio, un momento nel tempo ora fissato dietro un pannello di vetro. La osservo mentre guarda il quadro e penso: Se si potesse conservare tutto così… «Sei stata tu a farlo», dico. Lo sa. Questo se lo ricorda. Rammenta la giornata in cui si mise a sedere al tavolo della sala da pranzo con i colori e la fotografia. Aveva supplicato il padre di comprarle il cartoncino e lui aveva acconsentito, sebbene fosse certo che la nuova passione per l’arte sarebbe stata per la figlia una fissazione passeggera. Quando lei aveva finito il disegno, le avevamo manifestato il nostro apprezzamento e ci eravamo affrettati a riporlo da qualche parte, insieme ai costumi smessi di Halloween e ai vecchi pattini, inciampandovi per caso solo durante la ricerca affannosa di una sua foto per l’ispettore. «Ricordi il viaggio che abbiamo fatto in Toscana?», chiedo. Avanza di un passo per far scorrere le sue graziose dita sul quadro. È diversi centimetri più alta di me, ma in questa sala da pranzo è una bambina, un uccellino che ha appena messo le penne e non sa ancora reggersi in piedi. «Pioveva», replica senza staccare gli occhi dal dipinto. Annuisco. «Sì, pioveva», confermo, felice che se ne sia ricordata. Ma era piovuto solo per un giorno, per il resto eravamo stati davvero fortunati. Voglio dirle di aver appeso il quadro perché ero tanto preoccupata per lei. Ero terrorizzata. Tutte le notti, per diversi mesi, ero rimasta sveglia, distesa nel letto, a chiedermi: Cosa succede se…? Se non stava bene? Se stava bene ma non l’avessimo più trovata? Se fosse morta e non l’avessimo mai saputo? Se l’avessimo saputo e il detective ci avesse chiesto di identificare le sue spoglie in decomposizione? Voglio dire a Mia di aver appeso il sacco di Babbo Natale al camino nella fortunata eventualità che tornasse, di averle comprato i regali e averglieli incartati e messi sotto l’albero. Voglio che sappia che lasciavo accesa ogni notte la luce della veranda e che l’avrò chiamata migliaia di volte al cellulare, non si poteva mai sapere. Magari una volta non sarebbe scattata la voce della segreteria. Invece avevo ascoltato il messaggio infinite volte, le stesse parole, lo stesso tono: «Ciao, sono Mia. Per favore, lasciate un messaggio», gustandomi per un attimo il suono della sua voce. Mi domandavo cosa sarebbe successo se quella fosse stata l’ultima frase che ascoltavo da mia figlia. Cosa sarebbe successo…? Il suo sguardo è vitreo, la sua espressione vacua. Generalmente ha l’incarnato perfetto della pesca, il più bello che abbia mai visto, ma adesso il colorito roseo è scomparso e lei è bianca come uno straccio, o un fantasma. Quando parliamo, non mi guarda in faccia, fissa un punto alle mie spalle; mi attraversa, non mi affronta direttamente. Tiene perlopiù gli occhi a terra, fissa i piedi o si guarda le mani, qualsiasi cosa pur di evitare lo sguardo altrui. E lì in piedi nella sala da pranzo, a un tratto il suo volto perde ogni traccia di colore. Accade in un istante, la luce che penetra dalle tende aperte enfatizza il suo barcollare mentre incurva le spalle: la sua mano scende con un movimento rapido dal quadro della Toscana alla pancia. Il mento si piega sul petto, il suo respiro diventa affannoso. Le appoggio una mano sulla schiena (magrissima, sento le ossa) e aspetto. Ma non troppo, sono impaziente. «Mia, tesoro», la chiamo. Lei però dice che va tutto bene, che non è niente, e io sono sicura che è colpa del caffè. «Cos’è successo?». Si stringe nelle spalle, con la mano ancora sull’addome. So che non si sente bene. Comincia a camminare a ritroso, per uscire dalla sala da pranzo. «Sono stanca, tutto qui. Devo solo sdraiarmi», dice, e io mi ripropongo di eliminare dalla casa ogni traccia di caffeina prima che si risvegli dal sonnellino. Gabe Prima «Lei non è un uomo facile da trovare», dico mentre mi accoglie nella sua postazione di lavoro. Più che un ufficio, è un cubicolo, però le pareti sono più alte del normale e offrono un minimo di riservatezza. C’è una sedia soltanto, la sua, per cui resto sulla soglia del cubo, incastrato contro la parete mobile. «Non sapevo che qualcuno mi stava cercando». La mia prima impressione è che sia tronfio, un idiota pieno di sé, come ero io anni fa, prima di rendermi conto che avrei dovuto essere meno presuntuoso. È un uomo grosso e robusto, non proprio alto. Sono certo che fa sport, prende integratori proteici e forse perfino steroidi. Lo annoto sul taccuino, anche se, per il momento, evito di farmi scorgere da lui assorto in queste mie congetture. Potrebbe prendermi a calci in culo. «Conosce Mia Dennett?», chiedo. «Dipende». Si volta con la sedia girevole e finisce di scrivere un’email dandomi le spalle. «Da che cosa?» «Da chi lo vuole sapere». Non sono troppo disposto a stare al suo gioco. «Io», dico, tenendo in serbo il mio asso nella manica. «E lei è?» «Sto cercando Mia Dennett», replico. Mi rivedo in questo ragazzo: avrà al massimo ventiquattro o venticinque anni, fresco di università, e magari crede ancora che il mondo giri attorno a lui. «Se lo dice lei». Io invece sono sulla soglia dei cinquanta, e proprio stamattina ho notato i primi capelli bianchi. Sono convinto di dover ringraziare il giudice Dennett per questa novità. Lui continua a scrivere la sua e ma i l . E che cazzo, penso. Non gliene frega niente che io sia lì, in attesa di parlargli. Sbircio da sopra le sue spalle per capire. Si tratta di football universitario, il nome utente del destinatario è «dago82». Mia madre è italiana – da lei ho preso gli occhi e i capelli neri che mi pare affascinino tutte le donne – quindi prendo come un insulto al mio popolo quel nomignolo spregiativo1, benché non sia mai stato in Italia e non conosca una sola parola di italiano. Sto solamente cercando un’altra ragione per detestare quest’individuo. «Dev’essere una giornata piena di lavoro», commento, con lui che sembra scocciato che legga la sua email. Iconizza la pagina sullo schermo. «Chi diavolo è lei?», chiede di nuovo. Infilo una mano nella tasca posteriore ed estraggo il distintivo luccicante che adoro. «Ispettore Gabe Hoffman». Abbassa visibilmente la cresta, e parecchio. Sorrido. Dio mio, come mi piace il mio mestiere. Finge stupore. «C’è un problema con Mia?» «Sì, ritengo che si possa dire così». Apetta che prosegua io. Ma non lo faccio, proprio per irritarlo. «Che cosa ha fatto?» «Quando ha visto Mia l’ultima volta?» «Un po’ di tempo fa. Circa una settimana». «E l’ultima volta che ha parlato con lei?» «Non so. La settimana scorsa. Martedì sera, mi pare». «Le pare?», chiedo. Lo conferma sul calendario. Sì, era martedì sera. «Ma non l’ha vista martedì?» «No, dovevo farlo, ma sono stato costretto a disdire l’appuntamento. Sa, il lavoro». «Capisco». «Cosa le è successo?» «Quindi non la sente da martedì». «Esatto». «È normale? Passare quasi una settimana senza sentirsi?» «L’ho chiamata», confessa. «Mercoledì, forse giovedì. Non mi ha richiamato. Ho pensato che fosse incavolata». «E come mai? Aveva motivo di esserlo?». Fa spallucce. Allunga una mano per prendere una bottiglia d’acqua sulla scrivania e ne beve un sorso. «Martedì sera ho annullato l’appuntamento. Dovevo lavorare. Al telefono è stata brusca, sa? Era arrabbiatissima, lo capivo. Però dovevo lavorare. Pertanto, ho pensato che mi tenesse il muso e non mi ritelefonasse… Non so». «Che progetti avevate?» «Martedì sera?» «Certo». «Incontrarci in un bar a Uptown. Mia era già arrivata quando l’ho chiamata. Ero in ritardo. Le ho detto che non ce l’avrei fatta». «E lei era incavolata?» «Non era contenta». «Perciò, martedì sera lei era qui, al lavoro». «Fino alle tre di notte». «Qualcuno lo può confermare?» «Mah, sì. Il mio capo. Stavamo sistemando alcuni progetti per un incontro coi clienti il giovedì. Mi sono sentito ogni tanto con lei durante la serata. Sono nei guai?» «Ci arriveremo», replico seccamente, e intanto trascrivo il dialogo con la mia stenografia che nessuno sa decifrare. «Dov’è andato dopo aver finito di lavorare?» «A casa, amico. Era notte fonda». «Ha un alibi?» «Un alibi?». Comincia a sentirsi a disagio, si sposta sulla sedia. «Non saprei, ho preso un taxi per tornare». «Ha la ricevuta?» «No». «Nel suo palazzo c’è un portiere? Qualcuno che possa confermare che è tornato a casa?» «Ci sono le videocamere», dice, e poi chiede: «Dove caspita è Mia?». Dopo aver incontrato Ayanna Jackson, mi ero procurato i tabulati telefonici della Dennett e avevo trovato chiamate quasi giornaliere a un certo Jason Becker, poi rintracciato in uno studio di architettura del Chicago Loop2. Mi sono recato da lui per capire cosa sapesse della scomparsa della ragazza, e quando gli avevo fatto il nome di lei avevo subito notato un’emozione evidente sul suo volto. «Sì, conosco Mia», aveva detto invitandomi verso il suo cubicolo. L’avevo capito all’istante: gelosia. Era convinto che fossi il suo rivale. «È scomparsa», dico, cercando di interpretare la sua reazione. «Scomparsa?» «Sì, sparita. Da martedì nessuno l’ha più vista». «E lei pensa che io abbia qualcosa a che fare con questo?». Mi irrita il fatto che si preoccupi più della sua colpevolezza che della vita di Mia. «Sì», mento. «Credo che possa avere qualcosa a che vedere con questa faccenda». Invece, la verità è che, se il suo alibi è di ferro come pretende lui, sono di nuovo al punto di partenza. «Mi serve un avvocato?» «Pensa di averne bisogno?» «Gliel’ho detto, stavo lavorando. Martedì sera non ho visto Mia. Lo domandi al mio capo». «Lo farò», gli assicuro, sebbene l’espressione che gli passa fugacemente sul viso mi implori di non farlo. I colleghi di Jason origliano. Quando passano davanti al suo cubicolo, rallentano il passo, indugiano all’esterno e fingono di conversare. Me ne fotto. Lui no. La cosa lo fa ammattire. Si preoccupa per la propria reputazione. Mi piace vederlo agitarsi sulla sedia, diventare ansioso. «Le serve altro?», chiede per accelerare le cose. Vuole che smetta di pressarlo. «Devo sapere che piani avevate per martedì sera. Dov’era Mia quando le ha telefonato. Che ora era. Ho bisogno di vedere i suoi tabulati telefonici. Di parlare col suo capo per assicurarmi che lei era qui, e di controllare col servizio di sicurezza a che ora se n’è andato. Mi servono le riprese delle videocamere del suo palazzo per verificare che è tornato a casa. Se non ha problemi a fornirmi queste cose, è tutto a posto. Oppure, se preferisce, mi faccio rilasciare un mandato…». «Mi sta minacciando?» «No», mento, «le illustro soltanto le sue opzioni». Accetta di fornirmi le informazioni che mi servono e, prima che me ne vada, di accompagnarmi dal suo capo, una donna di mezz’età in un ufficio notevolmente più grande del suo, con finestre a tutta altezza che danno sul fiume Chicago. Dopo aver avuto la conferma che l’uomo aveva sgobbato tutta la notte, dichiaro: «Jason, faremo tutto il possibile per ritrovare Mia», per ritrovarmi davanti la sua espressione apatica prima di andarmene. 1 Dago (guappo) è il termine con cui gli americani indicano gli italiani e le persone di altri Paesi latini. (n.d.t.) 2 Centro storico ed economico della città. (n.d.t.) Colin Prima Non ci vuole molto. Pago qualcuno che resti al lavoro un paio d’ore più di quanto vorrebbe. La seguo fino al bar e mi metto a sedere dove posso osservarla senza che mi veda. Aspetto che arrivi la chiamata e, appena viene a sapere che le ha dato buca, mi attivo. Non so granché di lei. Ho visto un’immagine. Una foto indistinta mentre esce dalla metropolitana e si dirige verso un’auto parcheggiata a poca distanza. Tra la ragazza e l’obiettivo ci sono una decina di persone, per cui attorno alla sua faccia è stato tracciato un cerchietto rosso. Sul retro della foto compaiono le parole Mia Dennett e un indirizzo. Me l’hanno data circa una settimana fa. Mai fatto prima una cosa simile. Furto, sì. Molestie, anche. Non rapimenti. Però mi servono i soldi. È da qualche giorno che la seguo. So dove fa la spesa, dove va a farsi lavare i vestiti, dove lavora. Non le ho mai parlato. Non saprei riconoscere il suono della sua voce. Non conosco il colore dei suoi occhi o come siano quando ha paura. Ma lo saprò. Ho ordinato una birra, che non bevo. Non posso rischiare di ubriacarmi. Non stasera. Ma non voglio attirare l’attenzione su di me, quindi ho chiesto una birra per non stare a mani vuote. Quando le arriva la telefonata, è già seccata. Esce all’esterno per rispondere e rientra delusa. Pensa di andarsene, eppure decide di finire il suo drink. Recupera nella borsa una penna e disegna qualcosa sul tovagliolo del bar, mentre ascolta un testa di cazzo che legge poesie sul palco. Cerco di non pensarci. Di non pensare che è carina. Ricordo a me stesso che ho bisogno di denaro, non lo dimentico. Non sarà difficile, in un paio d’ore sarà tutto finito. «È bello», dico accennando alla salvietta. È il meglio che mi viene in mente. Non capisco nulla di roba artistica. Ostenta freddezza quando mi avvicino. Non vuole avere niente a che fare con me. Questo mi facilita le cose. Ha alzato appena lo sguardo dal tovagliolo, perfino quando le ho detto di apprezzare la candela che ha disegnato. Desidera che la lasci in pace. «Grazie», dice senza guardarmi. «Qualcosa di astratto». La cosa apparentemente sbagliata da dire. «Pensa che sia una merda?». Un altro uomo si sarebbe messo a ridere. Avrebbe detto che scherzava e l’avrebbe sommersa di complimenti. Ma non io. Non con lei. Le scivolo accanto. Con qualsiasi altra, in qualsiasi altro giorno, me ne sarei andato. In un altro giorno qualunque non l’avrei nemmeno abbordata al tavolino, non mi sarei avvicinato a quello di una ragazza incazzata, con l’aria da stronza. Lascio le chiacchiere futili, i corteggiamenti e queste boiate agli altri. «Non ho detto che è una merda». Mette la mano sulla giacca. «Me ne stavo per andare», dice. Finisce la sua bibita e posa di nuovo il bicchiere sul tavolino. «Il posto è tutto per lei». «Sembra Monet», esclamo. «Monet faceva roba astratta, vero?». Lo dico di proposito. Mi guarda. Sono sicuro che è la prima volta. Le sorrido. Mi chiedo se quel che vede sia sufficiente per farle togliere la mano dalla giacca. Il suo tono si addolcisce, sa di essere stata brusca. Forse non è così stronza, dopotutto. Forse è solo arrabbiata. «Monet è un pittore impressionista», mi corregge. «Picasso, la sua è arte astratta. Kandinsky, Jackson Pollock». Mai sentiti nominare. Lei ha ancora in mente di andarsene. Non me ne preoccupo. Se decide di uscire, la seguirò fino a casa. So dove abita. E ho un sacco di tempo. Quindi ci provo lo stesso. Prendo la salvietta che ha accartocciato e buttato in un posacenere. Tolgo la cenere e la stiro per bene. «Non è brutto», dico, piegando il disegno che infilo nella tasca posteriore dei jeans. Questo basta per indurla a cercare con gli occhi la cameriera del bar; pensa di ordinare qualcos’altro. «Lo vuole conservare?», domanda. «Sì». Ride. «Nel caso che in futuro diventassi famosa?». Alla gente piace sentirsi importante. Lei si lascia sopraffare da questa sensazione. Mi rivela di chiamarsi Mia. Quando mi chiede il mio nome, faccio una pausa così lunga che ha il tempo di dire: «Non immaginavo fosse una domanda difficile». Le rispondo che il mio nome è Owen. Spiego che i miei genitori vivono a Toledo e che sono cassiere in banca. Due bugie. Non mi svela molto di sé. Parliamo di cose impersonali: un incidente d’auto sulla Dan Ryan, un treno merci che ha deragliato, l’imminenza delle finali del campionato di baseball. Suggerisce di trattare cose meno deprimenti. Non è facile. Ordina qualcosa da bere, due volte. Più beve e più si apre. Ammette che il suo ragazzo le ha dato buca. Mi racconta di lui, che escono insieme dalla fine di agosto e che può contare sulle dita della mano il numero di volte che lui ha rispettato l’appuntamento che avevano preso. Cerca una comprensione che non le offro. Non è da me. A un certo punto scivolo sulla panca, più vicino a lei. A tratti ci tocchiamo, ci sfioriamo le gambe, ma non intenzionalmente. Mi sforzo di non pensarci. Di non pensare al dopo. Cerco di non pensare a me che la spingo a forza nell’auto o che la consegno a Dalmar. La ascolto parlare a lungo, di cosa non lo so, perché penso solo ai soldi. A quanto ammonterà la somma. Questa roba (starmene seduto con una donna in un bar e prenderla come ostaggio per un riscatto) non fa per me. Però sorrido quando lei mi guarda e, se la sua mano sfiora la mia, la lascio fare, perché ne sono certo: questa ragazza può cambiarmi la vita. Eve Dopo Sfoglio l’album dei ricordi d’infanzia di Mia e allora mi viene l’illuminazione: in seconda, aveva un’amichetta immaginaria che si chiamava Chloe. È lì, sui fogli ingialliti dell’album; l’ho scritto io in corsivo con inchiostro blu, lungo il margine, tra la sua prima frattura e una brutta influenza che l’aveva fatta finire al pronto soccorso. La foto di lei in terza copre parzialmente il nome Chloe, ma riesco a decifrarlo. Mi soffermo su quest’immagine: il ritratto di una ragazzina felice e disinvolta, ancora molto lontana dall’acne e dall’apparecchio, e da Colin Thatcher. Sorride contenta senza denti, sotto una massa arruffata di capelli fiammeggianti. La faccia è spruzzata di lentiggini, che col tempo sono sparite, e i suoi capelli sono leggermente più scuri di come sarebbero diventati in seguito. Il colletto della camicetta è aperto e sono sicura che sulle sue gambe magre avesse un paio di pantacalze fucsia, probabilmente smesse da Grace. Scorro le foto nell’album: quella della mattina di Natale, quando Mia aveva due anni e Grace sette, coi loro pigiami coordinati, mentre James aveva i capelli unti dritti sulla testa. I primi giorni di scuola. Le feste di compleanno. Sono seduta al tavolinetto dove facciamo colazione con l’album d’infanzia aperto davanti a me, guardo i biberon e i pannolini di tessuto, e vorrei tornare indietro. Faccio una telefonata alla dottoressa Rhodes. Con mia grande sorpresa, risponde. Quando le dico dell’amica immaginaria, lei parte in quarta con un’analisi psichiatrica. «Spesso, signora Dennett, i bambini si creano amici di fantasia per compensare la solitudine o la carenza di amici veri nella vita reale. E attribuiscono a questi compagni immaginari le qualità che desidererebbero avere per sé, rendendoli estroversi se sono timidi, per esempio, o grandi atleti se sono sgraziati. Avere un amico immaginario non è necessariamente un problema psichiatrico, purché la fantasia scompaia quando il bambino cresce». «Dottoressa», ribatto, «Mia chiamava Chloe la sua amica immaginaria». Si calma. «Molto interessante», dice, e io ammutolisco. Questo nome mi ossessiona. Passo la mattinata su internet a imparare tutto quanto c’è da sapere su Chloe. L’etimologia greca significa sbocciare, fiorire, crescere, verdeggiante… a seconda del sito che si consulta; in ogni caso i significati sono sinonimi. In questo periodo è uno dei nomi più diffusi, ma nel 1990 era il duecentododicesimo fra tutti quelli imposti alle bambine, dopo Alejandra e prima di Marie. Oggi ci sono negli USA 10.550 persone che si chiamano Chloe. A volte si trova la parola scritta con la dieresi sulla E (cerco il senso dei due puntini sulla vocale, e alla fine ne deduco che servono solo a distinguere il suono della O da quello della E, per cui capisco che ho perso venti minuti), altre volte senza dieresi. Mi chiedo come lo scriva Mia, sebbene non osi domandarglielo. Dove l’avrà scovato un nome simile? Forse era sul certificato di nascita di una delle bambole Cabbage Patch arrivata dal Babyland General Hospital3. Vado sul sito internet ufficiale. Mi stupisco dei nuovi colori di pelle dei bambolotti di quest’anno (caffè, crema, caffelatte), ma non ne figura una chiamata Chloe. Forse era una bimba, una compagna di classe di Mia in seconda. Allora cerco personaggi celebri con questo nome: sia Candice Bergen che Olivia Newton-John hanno chiamato le loro figlie Chloe. Che è il primo vero nome della scrittrice Toni Morrison, anche se dubito che Mia potesse leggere Amatissima già in seconda. Esistono una Chloë Sevigny (con la dieresi, o umlaut che dir si voglia) e una Chloe Webb (senza), ma sono sicura che la prima sia troppo giovane e la seconda troppo anziana per aver potuto attirare l’attenzione di una bambina di otto anni. Potrei chiederglielo. Potrei salire al piano di sopra, bussare alla porta della camera da letto di Mia e domandarglielo. James farebbe così. Andrebbe fino in fondo alla questione. Anch’io voglio andare fino in fondo, ma senza violare la privacy di Mia. Anni fa avrei chiesto consiglio a James, o il suo aiuto. Ma anni fa. Prendo il telefono, compongo il numero. La voce che mi saluta è gentile, il tono informale. «Eve», dice, e mi sento già più rilassata. «Salve, Gabe». 3 Clinica di Cleveland in cui “nascono” queste bambole. (n.d.t.) Colin Prima La conduco a Kenmore, in un appartamento all’interno di un palazzone. Prendiamo l’ascensore fino al settimo piano. Da un interno esce musica ad alto volume mentre ci dirigiamo verso la porta in fondo al corridoio, passando su una moquette macchiata di pipì. Apro la porta e lei aspetta di fianco. Dentro è buio. È accesa solo la fiammella della caldaia. Attraverso il pavimento in parquet e faccio scattare l’interruttore della lampada vicino al divano. Le ombre vengono rimpiazzate dal contenuto della mia magra esistenza: numeri di «Sports Illustrated», un mucchio di scarpe addossate all’anta dell’armadio, un panino sbocconcellato su un piatto di plastica sopra il tavolinetto. La osservo in silenzio mentre lei mi squadra. Non c’è tensione. Stasera qualche vicino ha cucinato cibo indiano, e l’odore del curry le chiude la gola. «Tutto bene?», chiede, poiché odia il silenzio pieno di imbarazzo. Probabilmente pensa di aver commesso un errore, che forse dovrebbe andarsene. Mi avvicino e faccio scorrere una mano sui suoi capelli, afferro quelli alla base della nuca. La fisso come fosse una dea, e noto nei suoi occhi il desiderio di rimanere, almeno per un attimo. È da parecchio tempo che non si sentiva così. Aveva dimenticato cosa si prova ad avere qualcuno che ti guarda in quel modo. Mi bacia e scorda completamente l’impulso di andarsene. Premo le mie labbra contro le sue in una maniera allo stesso tempo nuova e consueta. Agisco con determinazione. L’ho fatto migliaia di volte. Ciò la mette a suo agio. Se fossi impacciato, rifiutando di compiere la prima mossa, avrebbe il tempo di ripensarci. Così, invece, tutto accade troppo in fretta. E poi, finisce rapidamente com’era iniziato. Cambio idea, mi tiro indietro, e lei mi chiede: «Che succede?», col fiato corto. «Cosa c’è che non va?», esclama cercando di attirarmi di nuovo a sé. Abbassa le mani verso la mia cintura, con dita incerte, da ubriaca, comincia ad armeggiare. «È una pessima idea», dico allontanandomi. «Perché?», la sua voce è supplichevole. Si attacca alla mia camicia, disperata. Mi scosto. Poi comincia ad accettare il rifiuto. È imbarazzata. Si preme le mani sulla faccia, è accaldata, sudaticcia. Si lascia cadere sul bracciolo di una sedia e tenta di riprendere fiato. Attorno a lei, la stanza gira. Lo intuisco dalla sua espressione: non è abituata a sentirsi dire di no. Si risistema la camicia spiegazzata, si passa le mani sudate tra i capelli, si vergogna. Non so per quanto tempo rimaniamo così. «È una pessima idea», ripeto, e mi viene l’improvvisa ispirazione di raccogliere le scarpe. Le lancio nell’armadio, un paio per volta. Sbattono contro la parete posteriore e finiscono sulle altre. Poi chiudo l’anta, lasciando il mucchio dove non posso vederlo. In lei si insinua il risentimento, e mi domanda: «Perché mi hai portato qui? Perché mi hai portato qui, solo per umiliarmi?». Rivedo la scena del bar. Immagino i miei occhi avidi quando mi sono sporto verso di lei per suggerire: «Andiamo via da qui». Le ho detto che il mio appartamento era vicino, in fondo alla strada. Abbiamo corso per tutto il tragitto. La fisso. «È una pessima idea», ripeto. Lei si alza e prende la borsa. Alcune persone passano nel corridoio fuori la porta, le loro risate sono come una coltellata. Lei cerca di camminare, perde l’equilibrio. «Dove stai andando?», chiedo, impedendole l’uscita col corpo. Adesso non se ne può andare. «A casa», esclama. «Sei ubriaca». «E allora?», mi sfida. Caracolla fino a una sedia per rimettersi in sesto. «Non puoi andare», insisto. Non quando sono tanto vicino, penso, però dico solo: «Non così». Sorride e mi dice che sono gentile. Crede che mi preoccupi per lei. Non sa proprio niente. Non me ne frega un accidente. Gabe Dopo Quando arrivo, Mia e Grace Dennett sono sedute davanti alla mia scrivania, di spalle. Grace non potrebbe sembrare più a disagio di così. Afferra una penna da sopra il ripiano e toglie il cappuccio masticato con la manica della camicia. Mi aggiusto la cravatta a disegno cachemire sulla camicia e, mentre mi dirigo verso di loro, sento che Grace mormora «aspetto sciatto», «inappropriato», «un pupazzo». Presumo si riferisca a me, e dopo la sento dire che i capelli ricci di Mia non vedono un phon da settimane, che ha delle borse sotto gli occhi dovute alla stanchezza. I vestiti della ragazza sono sgualciti, sembrano quelli di un liceale. Lei non sorride. «È assurdo», afferma Grace. «Vorrei tanto che mi inveissi contro, che mi dessi della stronza, della narcisista, uno di quei soprannomi sgradevoli con cui mi chiamavi prima di incontrare Colin Thatcher». Invece, Mia si limita a fissarla. «Buongiorno», esordisco, e Grace mi interrompe bruscamente dicendo: «Non sarebbe possibile iniziare? Oggi ho molto da fare». «Naturalmente», concedo, vuotando il più lentamente possibile le bustine di zucchero nel mio caffè. «Speravo di parlare con Mia, di vedere se era possibile ottenere da lei qualche informazione». «Non vedo come possa essere d’aiuto», sostiene Grace. Mi ricorda dell’amnesia. «Non rammenta quello che è accaduto». Ho chiesto che Mia venisse nel mio ufficio stamattina per provare a rinfrescarle la memoria, per vedere se Colin, in quel capanno fatto con i tronchi d’albero, le avesse rivelato qualcosa che può essere prezioso per le indagini in corso. Siccome la madre non si sentiva tanto bene, ha mandato Grace al suo posto per tenerla d’occhio, ma dallo sguardo capisco che lei avrebbe preferito una seduta dal dentista che stare lì con me e Mia. «Vorrei provare a rinfrescarle la memoria. Vediamo se possono servire alcune immagini». Lei alza gli occhi al cielo e dice: «Santo cielo, ispettore, le foto segnaletiche? Sappiamo tutti com’è fatto Colin Thatcher. Abbiamo visto quelle immagini. Mia le ha viste. Crede che non sia in grado di identificarlo?» «Non le foto segnaletiche», la rassicuro, allungando una mano verso un cassetto della scrivania per prendere qualcosa da sotto una scorta di fogli protocollo. Lei sbircia per vedere di che si tratta, e rimane sbalordita dal blocchetto di fogli da disegno 11x14 che ho tirato fuori. È un quaderno a spirale; i suoi occhi scrutano la copertina per cogliere qualche indizio, ma le parole «carta riciclata» non le rivelano niente. Mia, invece, ha un breve sussulto: riconosce qualcosa che né io, né lei sappiamo cosa sia, però un lampo l’ha attraversata, l’ombra di una reminiscenza, che scompare altrettanto velocemente di com’era apparsa. Lo percepisco dal linguaggio del suo corpo: si irrigidisce, si piega in avanti, protende le mani alla cieca verso il quaderno e lo attira a sé. «Lo riconosce?», chiedo, dando voce alla domanda sulla punta della lingua di Grace. Mia lo tiene in mano senza aprirlo, preferisce far scorrere le dita sulla copertina. Non dice una parola, e poi, dopo un minutino, scuote la testa. È andato. Si riaffloscia di nuovo sulla sua sedia e lascia cadere il quaderno sulle ginocchia. Grace lo prende, lo apre, e viene colpita da una quantità di disegni e schizzi della sorella. Una volta, Eve mi aveva detto che la figlia minore portava con sé, ovunque andasse, un quaderno per disegnare, lasciare una traccia di tutto, dai senzatetto del Loop alle auto parcheggiate nella stazione ferroviaria. È il suo modo di tenere un diario: i luoghi in cui si reca, le cose che vede. In questo quaderno da disegno in carta riciclata, per esempio, ci sono alberi, un sacco di alberi; un lago circondato da arbusti; un piccolo capanno fatto di tronchi, che ovviamente abbiamo visto tutti nelle immagini; un gatto soriano scheletrico che dorme in uno spicchio di sole. Nulla di tutto questo pare stupire Grace, almeno finché non giunge all’illustrazione di Colin Thatcher che emerge vistosamente dalla pagina, davanti ai suoi occhi, proprio nel mezzo dello schizzo, tra gli alberi e il capanno coperto di neve. Ha un aspetto trasandato, i capelli ricci completamente in disordine. La barba lunga, i jeans sbrindellati e la felpa col cappuccio vanno oltre la sciatteria: sono decisamente sporchi. Mia aveva raffigurato un uomo alto e possente. Si era impegnata particolarmente sugli occhi, ombreggiandoli, sottolineandone il contorno, tanto che questi fari profondi e maliziosi quasi costringono Grace a distogliere lo sguardo dalla pagina. «Lo hai disegnato tu, lo sai», insiste, obbligando Mia a guardare il foglio. Glielo mette in mano affinché lo veda bene. Lui se ne sta davanti a una stufa a legna, seduto a gambe incrociate sul pavimento, con la schiena rivolta al fuoco. Mia fa scorrere la mano sulla pagina e sfuma leggermente il tratteggio. Si guarda i polpastrelli e vede il residuo di matita, che strofina tra pollice e indice. «Qualcosa le fa suonare un campanello?», chiedo sorseggiando dalla mia tazza di caffè. «Questo è…», Mia esita, «lui?» «Se con lui ti riferisci alla canaglia che ti ha rapita, allora, sì», dice Grace, «è lui». Sospiro. «È Colin Thatcher». Le mostro una foto. Non segnaletica, come quelle che le abbiamo fatto vedere spesso, ma un bel ritratto di Colin vestito bene. Gli occhi di Mia vanno avanti e indietro, collegano le due immagini. I capelli ricci. La corporatura robusta. Gli occhi scuri. La pelle ruvida e abbronzata. Le braccia che tiene conserte, il sorriso che si sforza di trattenere. «Lei è un’artista», le dico. Mia domanda: «L’ho disegnato io?». Annuisco. «Hanno trovato il quaderno degli schizzi nel capanno, coi suoi effetti personali e quelli di Colin. Suppongo che appartenga a lei». «L’hai portato con te nel Minnesota?», chiede Grace. Mia fa spallucce. I suoi occhi sono fissi sulle immagini di Colin Thatcher. Ovviamente non lo sa. Grace sa che la sorella non lo sa, ma glielo chiede lo stesso. Pensa esattamente quello che penso io: questo mascalzone la sequestra, la conduce in un capanno abbandonato del Minnesota e lei ha la possibilità di portarsi appresso un quaderno da disegno, e non altro? «Cos’altro ha portato con sé?» «Non so», dice con una voce al limite dell’udibile. «Be’, cos’altro avete trovato?», stavolta è Grace a rivolgermi la domanda. Osservo Mia, mi stampo in mente la sua comunicazione non verbale, il modo in cui le sue dita continuano a scorrere sulle immagini che ha davanti, la frustrazione che si sta lentamente, silenziosamente facendo strada in lei. Ogni volta che prova a rinunciare, spingendo via le immagini, finisce per riprenderle, come se implorasse dentro di sé, nel suo animo: Pensa, rifletti. «Niente di particolare», dico. Grace si arrabbia. «Cosa significa? Abiti, cibo, armi (pistole, bombe, coltelli), un cavalletto da artista, degli acquerelli. Questo», dice strappando il quaderno da disegno dalle mani della sorella, «è insolito. Generalmente un rapitore non permette a chi ha sequestrato di disegnare le prove su un quaderno di scadente carta riciclata». Si volta verso Mia e spiattella l’evidenza. «Se lui restava fermo tanto a lungo, Mia, abbastanza da lasciarti il tempo di disegnare questa roba, perché non sei scappata?». Lei fissa con espressione desolata Grace, che sospira esasperata, fuori di sé. Guarda la sorella minore come se dovessero rinchiuderla in manicomio. Come se Mia non si rendesse conto della realtà, non sapesse dove si trova o perché è viva. Come se volesse colpirla in testa per farle tornare il senno. Accorro in sua difesa e dico: «Forse aveva paura. Forse non c’era nessun posto in cui fuggire. Il capanno è nel mezzo di una vasta landa desolata, e d’inverno il Nord del Minnesota assomiglia a una città-fantasma. Probabilmente non c’era nessun luogo dove andare. Lui l’avrebbe ritrovata e catturata di nuovo, e allora cosa sarebbe successo?». Immobile sulla sua sedia, Grace appare contrariata, e si acciglia mentre sfoglia le pagine degli schizzi, nota gli alberi brulli, la neve a perdita d’occhio, quel lago pittoresco circondato dal bosco fitto e… Lo tralascia quasi del tutto, per far scorrere le pagine all’indietro e strapparne una dalla spirale. «Ma questo è un albero di Natale?», sbotta, guardando con aria inebetita quell’immagine nostalgica, in un angolo del disegno. Il rumore della pagina strappata fa fare a Mia un salto sulla sedia. Io la osservo mentre s’inquieta, poi le poso una mano sulle sue per tranquillizzarla. «Certo», dico mettendomi a ridere, sebbene non sia così divertente. «Sì, ritengo che possiamo considerarlo un fatto straordinario, fuori del comune, o no? Abbiamo trovato un albero di Natale. Grazioso, davvero, se volete sapere la mia opinione». Colin Prima Quando arriva la chiamata, lei sta lottando con il sonno incipiente. Ha detto un sacco di volte che deve andarsene. L’ho rassicurata, le ho ribadito che non è necessario. Mi ci è voluto tutto il mio autocontrollo per staccarmi da lei. Per volgere le spalle ai suoi occhi supplichevoli, per sforzarmi di lasciar perdere. C’è qualcosa di sbagliato nel farti la ragazza che stai per rapire. In qualche modo, però, sono riuscito a convincerla a rimanere. Lei crede che sia per il suo bene. Le ho detto che quando le sarà passata la sbornia la accompagnerò a prendere un taxi. Se l’è bevuta, a quanto pare. Squilla il telefonino. Lei non sussulta. Mi guarda come se immaginasse che si tratta di una ragazza. Chi altri chiamerebbe a notte fonda? Sono le due, ormai, e mentre mi dirigo in cucina per rispondere, vedo che si alza dal divano. Cerca di ribellarsi alla sonnolenza che sta prendendo il sopravvento su di lei. «Tutto a posto?», Dalmar vuole sapere. Di lui non so altro, se non che è appena sbarcato da una nave ed è più nero di qualsiasi cosa abbia mai visto. Ho già fatto altri lavori per lui: furto e molestie, ma mai rapimenti. «Mmh-mmh». Guardo furtivamente la ragazza che se ne sta imbarazzata in salotto. Attende che finisca la telefonata. Poi se ne andrà. Io mi sposto il più lontano possibile. Per prudenza prendo la mia semiautomatica dal cassetto. «Alle due e un quarto», dice Dalmar. So dove ci incontreremo: in un vicolo buio dalle parti della metropolitana, dove a quest’ora di notte girano solo i barboni. Controllo l’orologio. Dovrò fermarmi dietro a un furgoncino grigio. Loro prenderanno la ragazza e mi daranno i soldi. Facilissimo. Non dovrò nemmeno uscire dalla mia auto. «Alle due e un quarto», confermo. La figlia dei Dennett pesa solo cinquantacinque chili, è sbronza persa e ha un’emicrania pazzesca. Sarà facile. Quando torno in salotto, mi dice subito che sta per andarsene. Va verso la porta. Le cingo la vita con un braccio per fermarla. La trascino via dalla porta, il braccio a contatto con la sua pelle. «Non vai da nessuna parte». «Senti, davvero», ribatte. «Domattina devo lavorare». Fa una risatina, come se fosse divertente. Ma c’è la pistola. La vede. E in quel momento le cose cambiano. L’attimo in cui elabora l’informazione e capisce cosa diamine sta per succedere, spalanca la bocca e le scappa un’esclamazione di sorpresa. Poi, davanti alla pistola puntata, dice: «Cosa vuoi fare con quella?». Indietreggia, urta contro il divano. «Devi venire con me». Faccio un passo in avanti, mi avvicino. «Dove?», chiede. Quando riesco ad afferrarla, fa uno scatto per allontanarsi. Con un movimento rapido la blocco. «Non renderlo più difficile del necessario». «Cos’hai intenzione di fare con quella?». È più calma di quanto mi aspettassi. È preoccupata, ma non grida, non piange. Tiene gli occhi fissi sull’arma. «Devi solo venire con me». L’afferro per un braccio. Lei si dimena, però la trattengo, torcendole il braccio. Geme per il dolore. Mi rivolge un’occhiataccia, si sente ferita. Mi dice di lasciarla stare, di toglierle le mani di dosso. Nel suo tono avverto un senso di superiorità che mi innervosisce. Come se fosse lei a condurre il gioco. Cerca ancora di liberarsi, ma scopre di non farcela. Non la mollo. «Chiudi il becco», ordino. Le stringo di più il polso, so di farle male, perché le mie dita le lasciano dei segni rossi sulla pelle. «C’è un errore», protesta. «Stai sbagliando tutto». Ha una strana padronanza di sé, sebbene continui a tenere lo sguardo incollato alla pistola. Non saprei dire quante volte ho sentito questa solfa. Ogni vittima, per così dire, sostiene che sto commettendo un errore. «Taci». Stavolta sono più duro, il mio tono è più deciso. La spingo verso la parete, sbattendola contro una lampada, che cade a terra con un rumore sgradevole. La lampadina va in frantumi, ma la lampada è intatta. La blocco lì. Le dico di stare zitta. Continuo a ripeterlo. «Chiudi quella cazzo di bocca». Lei non proferisce più parola. Adesso ha un’aria impassibile, anche se dentro di sé dev’essere furiosa. «Va bene», dice a un tratto, come se fosse una sua scelta. Come se avesse voce in capitolo. Annuisce sprezzante. Verrà con me. Tiene gli occhi fissi, anche se stanchi. Belli, penso. Ha occhi azzurri notevoli. Ma poi scaccio subito questo pensiero. Non posso soffermarmi su stronzate simili. Non adesso. Non prima di consegnarla a Dalmar. Devo finire il lavoro. Portarlo a termine, prima di analizzarmi col senno di poi. Mentre le tengo la pistola premuta contro il cranio, le spiego cosa accadrà. Verrà con me. Se grida, premerò il grilletto. Semplice. Ma non ha intenzione di urlare. Lo capisco perfino io. «La mia borsa», dice, mentre inciampiamo nella tracolla che aveva buttato a terra qualche ora fa, quando siamo entrati nell’appartamento incespicando nei nostri vestiti. «Lascia perdere la tua fottuta borsa», ringhio. La trascino nel corridoio e chiudo la porta. Fuori fa freddo. Dal lago giunge una raffica di vento che le soffia i capelli sulla faccia. Sta gelando. La stringo con un braccio, ma non per riscaldarla. Non me ne frega niente se sente freddo. Non voglio che scappi. La tengo talmente stretta che il suo fianco sinistro struscia contro il mio e ci intralciamo a vicenda. Camminiamo svelti, affrettandoci verso l’auto parcheggiata sulla Ainslie. «Sbrigati», le ripeto, anche se sappiamo entrambi che sono io a rallentare. Mi guardo alle spalle, per constatare che non ci segua nessuno. Tiene gli occhi a terra, cerca di evitare il vento tagliente. La sua giacca è rimasta nell’appartamento. Ha la pelle d’oca. La sua camicia leggera non riesce a difenderla dalla fredda aria d’ottobre. Per strada stasera ci siamo solo noi. Le apro la portiera, e lei sale in auto. Non perdo tempo ad allacciarmi la cintura di sicurezza. Avvio il motore e parto, facendo un’inversione a U e percorrendo la strada a senso unico contromano. Le vie sono vuote. Guido troppo veloce, sapendo che non dovrei farlo, però voglio chiudere questa faccenda il prima possibile. Lei è stranamente composta. Con la coda dell’occhio però vedo che trema: di freddo, di paura. Mi chiedo a cosa pensi. Non mi supplica. Sta raggomitolata sul sedile del passeggero del mio pick-up e osserva la città. Non impiegheremo molto a fermarci dietro il furgoncino di Dalmar; i suoi uomini le metteranno le loro luride mani addosso per tirarla fuori dalla mia macchina. Dalmar è un duro. Non so cos’hanno in programma per la ragazza. Un riscatto. È tutto quel che so. Trattenerla finché il padre non sgancerà una cifra sostanziosa. Una volta che lui avrà pagato, non so cosa faranno. La uccideranno? La rimanderanno a casa? Ne dubito. E se lo faranno, sarà solo dopo che Dalmar e gli altri se la saranno spassata con lei. Mi frullano mille pensieri in testa. Adesso penso a cosa accadrà se mi beccano. Non sarà servito a niente. La pena per un rapimento può arrivare a trent’anni di galera. Lo so, ho controllato. Ci ho riflettuto diverse volte, dopo che Dalmar mi ha ingaggiato. Ma una cosa è pensarci, un’altra farlo. E ora, eccomi qui, con la ragazza nella mia auto, a pensare al trentennio al fresco. Lei non vuole guardarmi. Arrivati a un semaforo, la fisso. Tiene gli occhi sulla strada davanti, ma so che mi vede. So che sente il mio sguardo su di sé. Trattiene il fiato. Si sforza di non gridare, anche se vorrebbe farlo. Guido con una mano, con l’altra tengo la pistola sulle ginocchia. Non che m’importi granché di lei, anzi. Il fatto è che mi chiedo cosa accadrà quando si verrà a sapere che ho fatto una cosa simile. Quando il mio nome sarà legato a un rapimento/omicidio. E succederà. Dalmar non metterà mai la firma su questa faccenda. Mi incastrerà. Se le cose andranno male, sarò il pesce piccolo, il capro espiatorio, a finire sotto la scure del boia. Il semaforo diventa verde. Svolto sulla Michigan. Un branco di ragazzi ubriachi è fermo all’angolo, in attesa dell’autobus. Fanno i buffoni, cazzeggiano. Uno di loro inciampa sul gradino del marciapiede. Devo sterzare per non investirlo. «Cretino», borbotto a fior di labbra. Lui mi fa il dito medio. Ripenso al piano di riserva. Ne ho sempre uno pronto, qualora le cose si complichino. Non ho mai dovuto servirmene. Controllo il livello del carburante. Ce n’è abbastanza per arrivare fuori città, come minimo. Dovrei svoltare sulla Wacker. I numerini rossi sul cruscotto segnano le 2:12. Dalmar e i ragazzi aspettano già sul posto. Poteva farlo da solo, ma non ha voluto. Lui non vuole mai sporcarsi le mani. Recluta qualcuno, un reietto come me, per fare il lavoro più schifoso, così può starsene a guardare bello rilassato. Se le cose andassero male, avrà sempre le mani pulite. Niente impronte digitali sulla scena, la sua faccia non comparirà mai sulle prove fotografiche. Lascia che a cadere nella rete sia il resto della banda, ci definisce gli «operativi», come se appartenessimo alla fottutissima CIA. Saranno probabilmente in quattro sul furgoncino, delinquenti che aspettano di rinchiudere questa ragazza ancora seduta vicino a me, mentre potrebbe reagire per salvarsi. Ho le mani scivolose, sto sudando come un maiale. Me le asciugo sui jeans, poi do un pugno al volante e la ragazza emette un grido soffocato. Dovrei uscire all’altezza della Wacker, ma non lo faccio. Continuo a guidare. So di commettere una stupidaggine. Sono consapevole di tutto quello che potrebbe andare storto. Ma lo faccio lo stesso. Guardo di sfuggita nello specchietto retrovisore, per accertarmi che non ci seguano. E poi giù a tavoletta. Lungo la Michigan, fino alla Ontario, e quando l’orologio segna le 2:15 sono già sull’interstatale 90. Alla ragazza non dico niente, perché non crederebbe a niente di quel che potrei dirle. Non mi accorgo dell’attimo in cui succede: da qualche parte, mentre usciamo dalla città, l’orizzonte comincia a scomparire nel buio e gli edifici vengono inghiottiti dalla distanza. Lei si muove sul sedile, è a disagio, la sua compostezza è svanita. Guarda dal finestrino laterale, si gira e osserva dal lunotto posteriore la città che sparisce. Come se qualcuno avesse finalmente premuto l’interruttore e adesso lei capisse cosa caspita sta succedendo. «Dove stiamo andando?», chiede con voce isterica. L’espressione impassibile ha ceduto il posto agli occhi sgranati, al volto in fiamme. Me ne rendo conto grazie ai lampioni ai bordi della strada, che la illuminano più o meno ogni cinque secondi. Per un attimo mi supplica di liberarla. Le dico di chiudere il becco. Non voglio neanche sentirne parlare. Adesso però piange. È iniziato il piagnisteo, ha aperto i rubinetti, mi implora di lasciarla libera. Domanda ancora: «Dove stiamo andando?». Allora impugno la pistola, non sopporto il suono della sua voce, stridulo e acuto. Voglio che la smetta. Le punto contro l’arma e le ordino di chiudere quella boccaccia. Obbedisce. È calma, ma continua a piangere, si pulisce il naso sulla manica troppo corta, mentre ormai siamo fuori città. Avanzando verso la periferia, i grattacieli cedono il passo agli alberi, i treni della Blue Line serpeggiano in mezzo alla strada. Eve Dopo Mia è seduta al tavolo della cucina, tiene in mano una grande busta gialla col suo nome scritto in stampatello con una calligrafia evidentemente maschile. Preparo la cena per lei e per me. Nella stanza accanto c’è la TV accesa, che fa da sottofondo e compensa il silenzio fra noi. Sembra che Mia non se ne accorga, ma ultimamente il silenzio mi snerva, per cui comincio a fare chiacchiere futili. «Vuoi il petto di pollo con l’insalata?», le chiedo; lei si stringe nelle spalle. «Pane integrale o bianco?», insisto, ma non risponde. «Preparo il pollo», dico. «A tuo padre piace». Però sappiamo tutte e due che James non tornerà. «Cos’è quello?», chiedo con un cenno al pacchetto che ha in mano. «Cosa?», replica. «La busta». «Ah», fa. «Questa». Appoggio una padella sui fornelli, sbattendola senza volere. Lei sussulta, io mi scuso subito, assalita dal senso di colpa. «Mia, tesoro, non volevo spaventarti», esclamo, ma ci impiega un po’ a calmarsi. Dice che non sa perché si sente così. Una volta adorava il momento in cui comincia a fare buio, quando cambia il mondo esterno. Me lo descrive anche adesso: lo sfavillio dei lampioni e dei palazzi contro il cielo notturno. Dice che le piacevano l’anonimato della situazione, e tutte le possibilità che si aprono allorché il sole tramonta. Per contro, ora il buio la terrorizza, la spaventano le cose anonime dall’altra parte delle tende di seta. Mia non aveva paura, di solito. Le piaceva vagabondare per le strade della città anche a notte fonda, e si sentiva perfettamente al sicuro. Mi confida che spesso provava sollievo perfino nel traffico più assordante, coi clacson che strombazzavano all’impazzata e le sirene che ululavano tutta la notte. Adesso invece il suono del cibo che frigge la rende nervosa. Mi scuso in modo esagerato, e lei mi dice che va tutto bene. Ascolta l a TV nell’altra stanza. Alle sette, il notiziario della sera ha ceduto il posto a una sitcom. «Mia?», chiamo, e lei si volta verso di me. «Cosa c’è?», domanda. «La busta», faccio un gesto e lei se ne ricorda. Se la rigira tra le mani. «Me l’ha data il poliziotto», afferma. Sto tagliando a fette un pomodoro. «L’ispettore Hoffman?» «Sì». Mia scende abitualmente al pianterreno solo dopo che è uscito James. Resta nascosta per il resto del tempo. Sono certa che questa stanza le ricorda l’infanzia. Non è cambiata da più di dodici anni: le pareti crema, la luce soffusa. Sono accese le candele, ho spento i faretti sul soffitto. Il tavolo rotondo è scuro, con le gambe ricurve, e le sedie sono tappezzate: da bambina lei ci passava fin troppo tempo, con lo sguardo critico del padre addosso. Sono sicura che si senta piccola, incapace di stare da sola, e che si debba sempre sorvegliarla, cucinare per lei. La sua indipendenza è svanita. Ieri mi ha domandato quando può andare a casa, nel suo appartamento, e tutto ciò che ho saputo risponderle è stato «col tempo». Io e mio marito non la lasciamo uscire mai, a meno che non si vada dalla dottoressa Rhodes o al comando di polizia. A fare commissioni, non ci si pensa nemmeno. Per giorni è suonato il campanello dalla mattina alla sera: uomini e donne con microfoni e telecamere ci aspettavano sui gradini dell’ingresso. «Mia Dennett, vorremmo farle qualche domanda». Pretendevano di metterle il microfono davanti alla bocca, finché non le ho detto di non aprire, di ignorare del tutto il campanello. Il telefono squillava continuamente, e le rare volte che rispondevo l’unica cosa che dicevo era: «Non ho nessun commento da fare». Dopo un paio di giorni, ho inserito direttamente la segreteria telefonica; poi, siccome il continuo squillare mi era insopportabile, ho staccato la presa dell’apparecchio dal muro. «Allora, non hai intenzione di aprirla?», le ricordo. Fa passare un dito sotto il lembo adesivo e apre la busta. Dentro c’è un solo foglio di carta. Lo estrae delicatamente e dà un’occhiata. Poso il coltello sul tagliere e mi sposto verso il tavolo, di fianco a Mia, fingendo un interesse minimo, sebbene io sia sicura di essere la più attenta, tra noi due. È la fotocopia di un disegno da un quaderno a spirale, coi cerchietti in alto: l’originale era stato strappato dall’attaccatura. Ritrae una persona, una donna, in base a quanto posso desumere dalla chioma piuttosto lunga. «L’ho fatto io», dice Mia, e le tolgo il foglio dalle mani. «Posso?», chiedo sprofondando in una sedia di fianco a lei. «Perché lo dici?», le domando con lo stomaco in subbuglio e le mani che cominciano a tremarmi. Mia disegna da sempre, per quanto io possa ricordare. È un’artista, ha talento. Una volta le chiesi perché le piacesse disegnare, perché lo adorasse a tal punto. Mi aveva spiegato che era l’unico modo per realizzare un cambiamento: poteva trasformare oche in cigni, una giornata nuvolosa in una bella mattinata di sole. Nel disegno, la realtà non contava e non esisteva. Eppure, questo schizzo è una cosa totalmente diversa. Gli occhi sono perfettamente rotondi, il sorriso è quello che aveva imparato a delineare alle elementari. Le ciglia sono linee verticali. Il volto è deforme. «È stato preso dallo stesso quaderno che aveva l’ispettore Hoffman. Quello coi miei disegni». «Ma questo non l’hai fatto tu», dico con certezza assoluta. «Forse dieci anni fa, quando eri principiante. Ma non ora. È troppo ordinario per te. Una cosa mediocre, al massimo». Al segnale acustico del timer, mi alzo in piedi. Mia riprende il foglio in mano per guardarlo di nuovo. «Allora perché il poliziotto me l’ha dato?», chiede girandosi la busta tra le mani. Le rispondo che non lo so. Sistemo i panini integrali su una piastra da mettere nel forno quando Mia mi domanda: «Allora chi l’ha disegnato?». Sui fornelli si abbrustolisce il pollo. Abbasso la piastra sul fondo del forno. Giro il pollo e comincio a tagliare a cubetti un cetriolo, come se avessi Colin Thatcher sul tagliere davanti a me. Mi stringo nelle spalle. «In quel disegno…», azzardo cercando di non piangere. Mia è seduta al tavolo, scruta lo schizzo, e io lo vedo bene, chiaro come il sole: i capelli lunghi, gli occhi rotondi, il sorriso a forma di U. «In quel disegno», continuo, «sei ritratta tu». Colin Prima Siamo sulla Kennedy e non mi sono ancora preoccupato di azionare il riscaldamento. Da qualche parte del Wisconsin accendo la radio. Dagli altoparlanti posteriori escono le scariche delle interferenze elettriche. La ragazza guarda dal finestrino laterale. Non apre bocca, è muta. Sono sicuro che per tutta la I-90 ci hanno seguito due fari, che però sono scomparsi poco dopo Janesville. Esco dalla interstatale. La strada è buia e deserta, sembra che non porti da nessuna parte. Mi fermo in una stazione di servizio. Non ci sono benzinai. Spengo il motore ed esco a fare il pieno, prendo la pistola con me. Tengo continuamente gli occhi su di lei, e all’improvviso vedo un bagliore all’interno dell’auto, la luce di un cellulare che si accende. Come ho potuto essere tanto stupido? Spalanco la portiera di scatto, la spavento a morte. Lei trasalisce, cerca di nascondere il telefonino sotto la camicia. «Dammi il cellulare», ringhio. Sono su tutte le furie per aver scordato di buttarlo via prima di partire. La luce della stazione di servizio illumina il pick-up. Lei è un disastro, ha il trucco colato sulla faccia, i capelli spettinati. «Perché?», chiede. So che non è così scema. «Dammelo e basta». «Perché?» «Dammelo, forza». «Non ce l’ho», mente. «Dammi quel maledetto telefono», strillo allungando una mano per strapparglielo da sotto la camicia. Mi dice di toglierle le mani di dosso. Controllo l’aggeggio. Era riuscita a selezionare la rubrica, tutto qua. Mentre vado a riempire il serbatoio, mi assicuro di spegnerlo e buttarlo nell’immondizia. Anche se gli agenti risaliranno al segnale, in quel momento noi saremo da tutt’altra parte. Rovisto nel retro dell’auto per trovare qualcosa di utile: una corda, un cavo, un fottuto laccetto. Le lego le mani, così forte da strapparle un grido di dolore. «Provaci di nuovo», dico tornando al posto di guida, «e ti uccido». Sbatto la portiera e avvio il motore. Di una cosa sola sono certo: non appena non mi sono presentato con la ragazza, Dalmar avrà sguinzagliato tutti quelli che conosce per darci la caccia. Ormai avranno messo sottosopra il mio appartamento. Ci staranno cercando in lungo e in largo. Col cavolo che torno indietro. Se sarà tanto cretina da provarci, è morta. Ma non permetterò che ciò accada, rivelerebbe dove mi trovo prima che la uccidano, e piuttosto l’ammazzo io. Ho già fatto troppe opere buone… Proseguiamo in auto per l’intera nottata. Lei chiude gli occhi, soltanto per un paio di secondi, poi li riapre di scatto, si guarda intorno per accertarsi che non è un incubo. È tutto reale: io, lo sporco pick-up, i sedili plastificati e laceri con l’imbottitura che esce fuori, le interferenze della radio, la campagna sconfinata e il nero del cielo notturno. La pistola è ancora appoggiata sul mio grembo, so che non ha il coraggio di allungare la mano per prenderla, e io stringo le mani sul volante, anche se ormai guido più piano poiché so che non ci inseguono. Mi chiede solo una volta, con voce tremante, per quale motivo mi stia comportando così: «Perché lo stai facendo a me?». Ci troviamo nei pressi di Madison. Per tutto il tragitto è rimasta in silenzio, ha ascoltato un prete cattolico che straparlava sul peccato originale, uno che si mangiava una parola ogni tre o quattro. E poi, all’improvviso, «perché lo stai facendo a me?», ed è quel «me» che davvero mi irrita. Lei crede di essere al centro della situazione, e invece non c’entra nulla. È una pedina, una marionetta, l’agnello sacrificale. «Non pensarci», le dico. La risposta non le piace affatto. «Non mi conosci neppure», mi accusa con aria arrendevole. «Ti conosco», le dico guardandola per un attimo. Nell’auto è buio. Riesco a scorgere solo il suo profilo, oscurato dalle tenebre all’esterno. «Che ti ho fatto? Cosa ti ho mai fatto?», implora. Non mi ha mai fatto nulla. Lo so. Lei lo sa. Ma le dico lo stesso di chiudere il becco. «Basta». E siccome non lo fa, lo ripeto: «Taci, maledizione». La terza volta, glielo urlo: «Chiudi quella cazzo di bocca», agitando la pistola e puntandogliela contro. Sterzo bruscamente di lato e faccio stridere i freni. Esco dalla macchina mentre lei continua a strillare di lasciarla in pace. Prendo un rotolo di nastro isolante dal pianale del pick-up, ne strappo un pezzo coi denti. L’aria è gelida, si sente il rumore di un semiarticolato che percorre la strada nella notte fonda. «Cosa stai facendo?», chiede, colpendomi non appena apro la sua portiera. Scalcia forte e mi centra alle viscere. È tosta, lo ammetto, ma l’unica cosa che le riesce è di farmi incazzare. Entro a forza nell’abitacolo, le applico il nastro isolante sulle labbra che ancora muove e dico: «Te l’avevo detto di stare zitta!». Adesso tace. Risalgo in macchina e sbatto la portiera, imboccando di nuovo la corsia, alla cieca, con le gomme che sollevano la ghiaia dal bordo dell’interstatale. Niente di strano, quindi, se passano circa 150 chilometri prima che mi informi di dover pisciare: trova il coraggio e posa una mano tremante sul mio braccio per attirare la mia attenzione. «Che c’è?», sbraito, scostando il braccio dalla sua mano. Ormai sta spuntando l’alba. Si dimena sul sedile. Negli occhi le si legge il senso di urgenza. Le strappo il nastro isolante e lei lancia un gemito. Fa male, un male terribile. Bene, penso tra me. Così impara a tenere la bocca chiusa quando glielo dico. «Devo andare alla toilette», borbotta timorosa. Mi fermo sullo sterrato di una piazzola per camionisti, poco fuori Eau Claire. Il sole sta sorgendo a est, dietro un caseificio. Una mandria di mucche frisone pascola nei campi. Sarà una giornata di sole splendente, ma fa un freddo cane. È ottobre, gli alberi stanno cambiando. Nel parcheggio esito. È quasi vuoto, c’è un’auto soltanto, una station-wagon con adesivi di slogan politici sul retro e i fari posteriori attaccati col nastro da pacchi. Mi batte forte il cuore. Infilo la pistola nella cintola dei pantaloni, dietro la schiena. Quando siamo scappati ci ho pensato, sapevo che era una cosa che avrei dovuto fare. Ma a questo punto la ragazza sarebbe dovuta essere nelle mani di Dalmar, e io a tentare di dimenticare quel che avevo fatto. Non ho ideato un piano. Ma visto che è così, ci saranno cose di cui avremo bisogno, per esempio i soldi. Ho un po’ di denaro con me, non abbastanza per la fuga. Prima di andarcene, ho svuotato il suo portafoglio. Usare le carte di credito è fuori questione. Prendo un coltello dal cassetto del cruscotto e, prima di tagliarle i legacci, dico: «Resta vicino a me, non fare sciocchezze». Le spiego che potrà usare il cesso quando glielo dirò io, cioè solo quando sarà tutto okay. Le libero le mani. Poi taglio altri sessanta centimetri dalla corda di riserva e me la caccio nella tasca della giacca. Quando esce dall’auto, ha un aspetto ridicolo, la camicia spiegazzata non le arriva nemmeno ai polsi. Incrocia le braccia e se le stringe davanti. Sente freddo e ha i brividi. I capelli le cadono sul viso. Tiene la testa abbassata. Ha dei lividi sulle braccia, che si vedono malgrado lo stupido tatuaggio cinese disegnato nella parte interna di uno degli avambracci. C’è solo una donna al lavoro, nemmeno un cliente. Lo supponevo. Metto il braccio attorno alla ragazza e la attiro verso di me, per far sembrare che siamo amici. Ha il passo esitante e non riesce a sincronizzarlo col mio. Inciampa, ma riesco a sostenerla prima che cada. Con lo sguardo la minaccio di comportarsi bene. Le mie mani su di lei non sono un segno d’intimità, bensì una dimostrazione di forza. Lei lo sa, a differenza della signora dietro il registratore di cassa. Camminiamo su e giù per le corsie, per essere sicuri al cento percento che non ci siano altre persone. Prendo un pacco di buste da lettera. Controllo il bagno, per assicurarmi che sia vuoto. Mi accerto che non vi sia una finestra da cui la ragazza potrebbe svignarsela e poi le dico che può pisciare. La donna alla cassa mi lancia uno sguardo strano. Alzo gli occhi al cielo e le racconto che la mia amica ha bevuto troppo. Pare che ci creda. La ragazza sembra metterci un’eternità, e quando guardo di nuovo dentro la vedo davanti allo specchio che si lava la faccia. Fissa a lungo il riflesso della sua immagine. «Andiamo», esclamo dopo qualche attimo. Ci dirigiamo verso la cassa per pagare le buste. Però non lo facciamo. La donna è distratta, guarda la replica di una trasmissione degli anni Settanta in un televisore dodici pollici. Scruto attorno per assicurarmi che non ci siano le videocamere di sorveglianza. Dopodiché mi metto dietro di lei, tiro fuori la pistola e le ordino di vuotare la cassa coi fottuti soldi. Non so chi abbia più paura. La ragazza si raggela, ha il terrore dipinto sul volto. Eccomi lì, con la canna della pistola premuta contro i capelli grigi di una signora di mezz’età, e lei è una testimone. Una complice. La ragazza comincia a chiedermi cosa stia facendo, lo ripete all’infinito. «Cosa stai facendo?», urla. Le dico di tacere. La signora mi prega di risparmiarla. «Non mi faccia del male, per favore, mi lasci stare». La spingo in avanti, le ripeto di svuotare la cassa. Lei la apre e inizia a mettere le mazzette di banconote in una busta di plastica con disegnata una faccina sorridente e la scritta BUONA GIORNATA. Dico alla ragazza di guardare fuori dalla vetrata, per riferirmi se arriva qualcuno. Annuisce con espressione sottomessa, come una bambina. «No», balbetta tra le lacrime. «Nessuno». Poi chiede: «Cosa stai facendo?». Premo la pistola ancora più forte e intimo alla signora di sbrigarsi. «La prego, non mi faccia del male». «Anche le monetine», preciso. Sono chiuse in rotoli di carta. «Ha pure dei francobolli?», domando. La donna fa per avvicinare le mani a un cassetto e io urlo: «Non tocchi niente. Mi risponda: ha dei francobolli?». Per quel che ne so, in quel cassetto potrebbe esserci una semiautomatica. Il mio tono la fa frignare: «Nel cassetto. Per favore, non mi faccia del male», implora. Parla dei nipotini. Ne ha due, un maschietto e una femminuccia. Riesco ad afferrare solo il nome di Zelda. Che razza di nome stupido! Allungo una mano nel cassetto e trovo un contenitore di francobolli, che infilo subito nella busta di plastica, strappandola alla donna e passandola alla ragazza. «Prendi questa roba», le dico. «Rimani lì e tienila in mano». Punto per un attimo la pistola contro di lei, per farle sapere che non scherzo. Lei caccia un grido e scansa la testa, come se le avessi già sparato. Con la corda che ho in tasca lego la signora. Poi, per precauzione, sparo al telefono. Tutte e due si mettono a strillare. Non posso permetterle di chiamare la polizia troppo presto. Verso l’uscita c’è una pila di maglie. Ne afferro una e dico alla ragazza di indossarla. Sono arcistufo di vederla battere i denti. Mentre se la infila la scossa le elettrizza i capelli. È la felpa più brutta che abbia mai visto: L’ÉTOILE DU NORD, qualunque cazzata significhi. Prendo altri due maglioni, diversi calzini e pantaloni termici. Oltre ad alcune ciambelline stantie per il viaggio. E poi andiamo. Nel pick-up lego ancora le mani alla ragazza. Piagnucola di nuovo. Le dico di trovare il modo di chiudere la bocca, altrimenti la troverò io, la maniera. I suoi occhi si posano sul rotolo di nastro isolante rimasto sul cruscotto, quindi tace. Sa che non scherzo affatto. Prendo una busta e scrivo l’indirizzo. Ci caccio dentro quanto più denaro possibile, incollo un francobollo in un angolo. M’infilo il resto dei soldi in tasca. Proseguiamo in auto finché non vedo una cassetta blu delle poste nella quale faccio scivolare la mia busta. La ragazza mi guarda, si chiede cosa diavolo stia facendo, ma non apre bocca e io non glielo spiego. Quando incrociamo lo sguardo, esclamo: «Non preoccuparti», e penso: Non sono cazzi tuoi. Non è perfetto, tutt’altro. Ma per il momento deve bastare. Eve Dopo Mi sono assuefatta a vedere le auto di pattuglia della polizia parcheggiate fuori da casa. Ce ne sono sempre due, giorno e notte, con quattro agenti in divisa, che sorvegliano Mia. Stanno seduti sul sedile anteriore, bevono caffè e mangiano panini, che vanno a comprare a turno nella vicina gastronomia. Li osservo dalla finestra della camera da letto, scrutando oltre le tapparelle che allargo con una mano. Mi sembrano scolaretti, più giovani delle mie figlie, però hanno fucili e manganelli, e rispondono al mio spiarli puntando verso di me il binocolo. Mi convinco che non possano sbirciare quando, tutte le sere, smorzo le luci per cambiarmi e indossare il pigiama, anche se in verità non ne sono certa. Ogni giorno Mia si siede nel portico, apparentemente noncurante del freddo pungente. Guarda a lungo la neve che circonda la casa, come il fossato di un castello. Osserva gli alberi spogli che oscillano al vento. Non nota le auto della polizia, i quattro uomini che la studiano tutto il giorno. Le ho chiesto di non allontanarsi dal portico e lei ha acconsentito, sebbene talora azzardi qualche passo nella neve, fino al marciapiede, da dove si spinge verso le residenze dei Pewter e della famiglia Donaldson. Mentre una delle vetture la segue a passo d’uomo, dall’altra esce un agente a chiamarmi, e io mi precipito fuori dalla porta, a piedi nudi, per recuperare mia figlia che vaga. «Mia, tesoro, dove stai andando?», le dico afferrandola per la manica e riportandola indietro. Non si mette mai un giaccone e le sue mani sono fredde come il ghiaccio. Non sa dove sta andando, però mi segue docile e torna a casa; e mentre passiamo davanti ai poliziotti, li ringrazio, prima di ricondurla in cucina per darle una tazza di latte caldo. Lei la beve tutta tremante, e quando finisce dice che vuole mettersi a letto. La settimana scorsa si è sentita poco bene, voleva sempre rifugiarsi sotto le coperte. Oggi, però, nota per qualche motivo le auto della polizia. Tiro fuori la mia macchina dal garage e imbocco la strada per portarla dalla dottoressa Rhodes, che la sottoporrà alla prima seduta di ipnosi. In un breve istante di lucidità, scruta dal finestrino e chiede: «Cosa stanno facendo qui?», come se fossero arrivati in quel preciso momento. «Badano alla nostra sicurezza», dichiaro diplomaticamente. Intendevo dire la sua sicurezza, comunque non voglio che tema per qualche motivo di non essere al sicuro. «Da cosa ci difendono?», domanda lei, girando la testa per non perdere di vista gli agenti dal lunotto. Uno di loro avvia la sua macchina e ci segue lungo il percorso. L’altro resta indietro a tener d’occhio la casa mentre siamo assenti. «Non c’è niente da temere», replico anziché rispondere alla sua domanda, e lei lo accetta con riconoscenza, voltandosi a guardare attraverso il parabrezza, dimenticando del tutto che siamo seguite e sorvegliate. Proseguiamo lungo la strada di quartiere. Poco traffico. Dopo due settimane di vacanze natalizie, i bambini sono tornati a scuola e non perdono più tempo davanti al giardinetto di casa a costruire pupazzi e lanciarsi palle di neve schiamazzando. Tutti suoni inusuali per la nostra casa taciturna. Fuori dalle abitazioni ci sono ancora gli addobbi natalizi, ma i pupazzi gonfiabili di Babbo Natale sono ormai senza luci, adagiati sui mucchi di neve. Quest’anno James non ha messo le decorazioni all’esterno, anche se io dentro casa ho esagerato con gli addobbi, nel caso in cui Mia fosse tornata. Lei ha accettato di sottoporsi all’ipnosi. Non abbiamo dovuto forzarla o blandirla. Adesso Mia concorda quasi su tutto. James è ovviamente contrario, ritiene che la terapia ipnotica sia una pseudoscienza, una cosa fasulla come l’astrologia e la lettura della mano. Io non so bene cosa pensare, ma non voglio lasciare assolutamente nulla d’intentato. Se l’ipnosi aiuta mia figlia a ricordare anche solo mezzo secondo dei mesi della sua scomparsa, vale la pena di spendere una cifra esorbitante e trascorrere tutto quel tempo nella sala d’attesa della dottoressa Avery Rhodes. Ciò che sapevo una settimana fa su questa tecnica era davvero poco. Dopo una nottata a navigare su internet, ho avuto l’illuminazione. L’ipnosi, come l’ho interpretata io, è una condizione di rilassamento in stato di trance, analoga ai sogni a occhi aperti. Ciò permetterà a Mia di perdere le inibizioni e di sintonizzarsi col mondo esterno, in modo che, grazie all’aiuto della dottoressa, riuscirà a recuperare la memoria perduta. In stato ipnotico, il soggetto diventa enormemente suggestionabile ed è in grado di recuperare informazioni che la mente aveva accantonato. Ipnotizzando Mia, la Rhodes agirà direttamente sul suo inconscio, la parte del cervello che le occulta i ricordi. Si tratta sostanzialmente di indurre mia figlia in uno stato di rilassamento profondo, affinché la sua coscienza si addormenti, per così dire, e la dottoressa possa intervenire sull’inconscio. L’obiettivo è quello di far riaffiorare nella sua mente tutto il periodo trascorso nel capanno, o anche solo qualche piccolo dettaglio; dopodiché lei saprà venire a patti con l’idea del rapimento e guarire. Per quanto riguarda l’indagine dell’ispettore Hoffman, però, tutte le informazioni così ottenute saranno preziose. Lui vuole assolutamente cogliere ogni indizio che Colin Thatcher potrebbe aver lasciato nel capanno, ogni particolare che faciliterà il suo compito: trovare colui che ha fatto questo a Mia. Quando arriviamo nello studio della dottoressa, James insiste che entri anch’io. Vuole che sorvegli quella «pazzoide», così definisce la Rhodes, nel caso provasse a «strizzare» il cervello di Mia. Mi accomodo su una poltrona, a una certa distanza, mentre mia figlia si stende schizzinosamente sul lettino. Sugli scaffali che occupano un’intera parete ci sono dei manuali di psichiatria. C’è una finestra che dà sul parcheggio. La Rhodes tiene chiuse le persiane, fa penetrare solo una minima quantità di luce, per cui la riservatezza è garantita. La stanza è in penombra, prevale la discrezione, i segreti svelati fra queste mura sono assorbiti dalla tinta bordeaux alle pareti e dai battiscopa di quercia. Ma è piena di spifferi, e mentre Mia cade gradualmente nel sopore, mi stringo il maglione al corpo, cingendomi con le braccia. «Cominceremo dalle cose semplici, con quanto sappiamo che è vero, e vedremo dove ciò ci condurrà». I ricordi non riaffiorano in maniera cronologica, tantomeno sensata, e per me rimangono un enigma, anche molto tempo dopo essere uscite di nuovo nel pungente freddo invernale. Immaginavo che l’ipnosi potesse schiudere il bunker della sua mente, da dove in un attimo tutti i ricordi di Mia si sarebbero riversati sul falso tappeto persiano, così che io, lei e la dottoressa potessimo fiondarci su di loro e dissezionarli uno a uno. Ma non funziona affatto in questo modo. Per la durata limitata dello stato ipnotico (una ventina di minuti, non di più), la dottoressa cerca di scavare, con voce suadente e armoniosa, fra gli strati del biscotto per raggiungere il cuore di panna. Ecco allora che si staccano le briciole: la sensazione ruvida del capanno, con le assi di pino nodoso e le travi a vista, le interferenze dell’autoradio, le note di Per Elisa di Beethoven, il punto in cui stava un alce. «Mia, chi c’è nella macchina?» «Non ne sono sicura». «Tu sei lì dentro?» «Sì». «La stai guidando?» «No». «Chi la guida?» «Non so. È buio». «Che ore sono?» «Mattina presto. Il sole sta sorgendo adesso». «Riesci a vedere dal finestrino?» «Sì». «Vedi le stelle?» «Sì». «E la luna?» «Sì». «Luna piena?» «No». Scuote la testa. «Mezzaluna». «Sai dove ti trovi?» «Su un’autostrada. È piccola, solo due corsie, attorniata dai boschi». «Ci sono altre auto?» «No». «Vedi segnali stradali?» «No». «Senti qualche suono?» «Interferenze. Dalla radio. C’è un uomo che parla, ma la sua voce… Ci sono interferenze». Mia è stesa sul lettino, con le gambe incrociate sulle caviglie. In queste ultime due settimane è la prima volta che la vedo rilassata. Ha le braccia distese lungo i fianchi, scoperti (il pesante maglione color crema si è sollevato di qualche centimetro quando si è distesa), come se fosse in una bara. «Riesci a capire cosa dice l’uomo?». La dottoressa parla dalla poltrona rossiccia su cui è seduta, di fianco a Mia. La donna è l’immagine dell’autocontrollo. Tutto è a puntino: abiti senza alcuna piega, non un capello fuori posto. La sua voce è monotona, mi sento cullata anch’io, tanto che potrei addormentarmi. «La temperatura è sui cinque gradi, molto sole…». «Le previsioni del tempo?» «È un disc-jockey, il suono viene dalla radio. Ma le interferenze… Gli altoparlanti anteriori non funzionano. Mi arriva la voce dal sedile posteriore». «C’è qualcuno sul sedile posteriore?» «No, siamo solo noi due». «Noi?» «Vedo le sue mani nel buio. Guida con due mani, tiene strettissimo il volante». «Cos’altro puoi dirmi di lui?». Mia scuote la testa. «Riesci a vedere cosa indossa?» «No». «Ma ce la fai a vedergli le mani?» «Sì». «Ha qualcosa sulle mani, un anello, un orologio? Qualsiasi cosa…». «Non so». «Cosa sapresti dire delle sue mani?» «Sono ruvide». «Puoi vederlo? Puoi vedere che sono ruvide?». Mi metto sul bordo della poltrona, resto appesa alle ultime parole attutite di Mia. So che mia figlia, quella di una volta, prima di Colin, non avrebbe mai voluto che ascoltassi una conversazione del genere. A questa domanda non risponde. «Ti sta facendo male?». Mia si contorce sul lettino, ma non risponde. La dottoressa insiste: «Ti sta facendo del male? Lì, nell’auto, o forse in precedenza?». Non arriva nessuna risposta. La Rhodes continua. «Cos’altro puoi raccontarmi della macchina?». Invece Mia afferma: «Questo non doveva… non era previsto… che accadesse». «Cosa non doveva accadere?», chiede la dottoressa. «Cosa non era previsto?» «È tutto sbagliato», replica Mia. È disorientata, la sua visione è confusa, i ricordi casuali che riemergono sono alla deriva nella sua mente. «Cosa è tutto sbagliato?». Nessuna risposta. «Mia, cosa c’è di sbagliato? L’auto? Qualcosa al suo interno?». Ma lei non dice nulla. Almeno all’inizio. Poi però inspira violentemente, quasi con un risucchio, e afferma: «È colpa mia. È tutta colpa mia», e mi ci vuole una grande forza di volontà per non correre ad abbracciare la mia bambina. Voglio dirle che non è vero, che non è colpa sua. Riesco a vedere quanto ciò la addolori, i lineamenti del suo viso si contraggono, le mani le si chiudono a pugno. «Sono stata io a farlo», dice. «Non è colpa tua», sottolinea la dottoressa, la cui voce è riflessiva, consolatoria. Afferro i braccioli della poltrona su cui mi trovo e mi costringo a restare calma. «Non è stata colpa tua», le ripete. Una volta finita la seduta, mi avrebbe spiegato in privato che le vittime attribuiscono la responsabilità quasi sempre a se stesse. Che questo capita sovente alle vittime di stupro e che è il motivo per cui viene denunciato solo il cinquanta percento delle violenze sessuali: la vittima ritiene di averne la colpa. Bastava che non fosse entrata in questo o quel bar, che non avesse parlato con questo o quello sconosciuto, bastava che non avesse indossato quei vestiti seducenti. Avrebbe detto che Mia sta attraversando una fase naturale che psicologi e sociologi studiano da anni: l’autocolpevolizzazione. «Ovviamente, se portata agli eccessi, l’autocolpevolizzazione può essere devastante», avrebbe chiarito, mentre Mia in sala d’attesa aspettava che la raggiungessi. «Ciononostante, essa può anche impedire alle vittime di diventare vulnerabili in futuro». Come se quelle parole dovessero confortarmi… «Mia, cos’altro vedi?», la dottoressa inizia nuovamente a indagare dopo che mia figlia si è ripresa. Lei, all’inizio, è taciturna. La Rhodes la interroga ancora: «Mia, cos’altro vedi?». Stavolta risponde: «Una casa». «Parlami della casa». «È piccola». «Qualcos’altro?» «Una piccola gradinata conduce nella foresta. È un capanno di legno, tronchi scuri. Quasi non lo si scorge in mezzo a tutti gli alberi. È vecchio. Ogni cosa è antica, i mobili, gli accessori». «Parlami dei mobili». «S’incurvano. Il sofà ha la stoffa a quadri bianchi e blu. In questa casa è tutto scomodo. C’è una vecchia sedia a dondolo, le lampade riescono appena a illuminare lo spazio. Il tavolo è piccolo e ha gambe traballanti, è ricoperto da una tovaglia di plastica a quadretti, quella che si usa per le scampagnate. I pavimenti di legno duro scricchiolano. Dentro fa freddo, c’è puzza». «Di che cosa?» «Palline di naftalina». Quella stessa sera, dopo cena, mentre indugiamo in cucina, James mi chiede cosa diavolo abbia mai a che fare il cattivo odore di naftalina con tutto questo. Gli spiego che è un progresso lento, ma almeno un passo in avanti. Un inizio. Una cosa che ieri Mia non riusciva a ricordare. Anch’io avrei desiderato tanto qualcosa di eccezionale: una sessione ipnotica e Mia sarebbe guarita. La dottoressa Rhodes aveva percepito la mia delusione mentre uscivamo dal suo studio, tanto da chiarirmi che dovevamo avere pazienza; sono cose che richiedono tempo, e mettere fretta alla paziente avrebbe fatto più male che bene. James non abbocca, è sicuro che sia una manovra per guadagnare di più. Lo vedo prendere con rabbia una birra dal frigorifero e andare a lavorare nel suo studio, mentre io mi accingo a lavare i piatti della cena, notando per la terza volta in questa settimana che Mia non ha quasi toccato le sue portate. Fisso gli spaghetti rappresi nei recipienti di terracotta e ricordo che erano il suo piatto preferito. Faccio mente locale e comincio ad archiviare un elenco di cose: le mani ruvide, per esempio, o le previsioni del tempo. Passo la nottata su internet a scovare notizie utili. L’ultima volta che, nel Minnesota settentrionale, le temperature erano state sui 5 gradi risaliva all’ultima settimana di novembre, anche se l’oscillazione fra zero e 5 gradi si era mantenuta dal periodo della scomparsa di Mia fino al giorno seguente alla festa del Ringraziamento. In seguito, erano crollate a -5, o ancor più in basso, senza probabilmente risalire sopra lo zero per diversi giorni. C’era stata la mezzaluna il 30 settembre, il 14 ottobre e il 29 dello stesso mese; poi di nuovo il 12 e il 28 novembre; comunque, Mia non era certa che la luna fosse esattamente a metà, per cui le date sono solo indicative. In Minnesota gli alci sono assai diffusi, specie d’inverno. Beethoven scrisse Per Elisa intorno al 1810, anche se la sua Elisa era probabilmente una Teresa, la donna che avrebbe dovuto sposare in quel periodo. Prima di coricarmi passo davanti alla camera in cui dorme Mia. Apro piano la porta e resto lì a guardarla, avvolta nelle lenzuola, mentre la coperta, gettata via durante la notte, giace sul pavimento. La luna entra benevola nella stanza dalle fessure delle tapparelle, illuminandola a strisce, dalla faccia al pigiama pesante color melanzana. La gamba destra è piegata e appoggiata su un altro cuscino. Questo è l’unico momento della giornata in cui è in pace. Entro e mi muovo nella stanza per coprirla meglio, e sento il mio corpo mentre mi abbasso ai bordi del letto. Il suo viso è sereno, l’espressione rilassata; anche se ormai è una donna, rivedo in lei la mia bambina felice, molto prima che me la portassero via. Averla con me è troppo bello per essere vero. Resterei seduta qui tutta la notte, se potessi, per convincermi che non è un sogno, che quando mi sveglierò domattina Mia (o Chloe) sarà ancora qui. Mentre m’infilo a letto di fianco al corpo bollente di James (l’enorme piumino lo fa effettivamente sudare), mi domando in che modo mi saranno utili quelle informazioni (previsioni del tempo, fasi lunari ecc.). In ogni caso, le ho messe in una cartellina, insieme alle decine di significati del nome Chloe. Il motivo non lo conosco, però dico a me stessa che qualunque dettaglio tanto importante da affiorare durante le sedute di ipnosi cui si sottopone Mia è evidentemente importante anche per me: potrebbe spiegarmi cosa le è successo tra le pareti di legno di quel capanno nella campagna del Minnesota. Colin Prima Ci sono degli alberi, davvero tanti. Pini, abeti, abeti rossi. I loro aghi verdi sono saldamente attaccati ai rami. Tutt’attorno si seccano e cadono a terra le foglie di olmi e querce. È mercoledì, la notte è scesa e passata. Lasciamo l’autostrada e procediamo a velocità spedita su una strada a due corsie. La ragazza si regge al sedile ogni volta che c’è una curva. Potrei rallentare ma non lo faccio perché voglio arrivare presto. Lungo il tragitto non c’è quasi nessuno. Di tanto in tanto sorpassiamo un’auto, saranno turisti che viaggiano al di sotto del limite di velocità per godersi il panorama. Non ci sono stazioni di servizio. Niente drugstore. Solo negozietti a conduzione familiare. Lei guarda dal finestrino per tutto il percorso. Sono sicuro che pensi di trovarsi a Timbuctù. Non si premura nemmeno di domandarlo. Forse lo sa. Forse se ne infischia. Ci spingiamo ancora più a nord, fino agli angoli più remoti e sconosciuti del Minnesota. Dopo Two Harbors, il traffico diminuisce ulteriormente e la mia vettura si ritrova quasi impantanata tra aghi e foglie. La strada è piena di buche che ci fanno sobbalzare, io le maledico una dopo l’altra. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una gomma bucata. Qui ci sono già stato. Conoscevo il proprietario di quell’orribile capanno nel bel mezzo del nulla. È nascosto tra gli alberi, e il terreno circostante è cosparso di strati di foglie morte, secche e scricchiolanti. Gli alberi sono poco più che rami spogli. Guardo il capanno: è proprio come lo ricordavo da quando ero un ragazzino. È una casupola fatta di tronchi di legno, affacciata su un lago, che sembra molto freddo, anzi, sono sicuro che lo è. Nel giardino ci sono sedie a sdraio di plastica e un piccolo barbecue. L’ambiente circostante è squallido, una desolazione per chilometri e chilometri, senza nessuno in vista. Esattamente quello che serve. Spengo il pick-up e usciamo. Prendo dal pianale un piede di porco e saliamo sulla collinetta, fino al capanno. Sembra abbandonato, come immaginavo, anche se controllo ugualmente l’eventuale presenza di segni di vita: un’auto parcheggiata sul retro, ombre che passano dietro le finestre. Niente di niente. Lei rimane immobile dietro il veicolo. «Forza, andiamo», la sollecito. Si decide a salire la decina di gradini fino allo spiazzo d’ingresso. Si ferma per riprendere fiato. «Sbrigati», le dico. Potremmo anche essere visti da qualcuno. Busso alla porta per essere sicuro che siamo soli. Poi dico alla ragazza di tacere e ascoltare. Tutto è immerso nel silenzio. Uso il piede di porco per forzare l’apertura. Rompo il legno. Le dico che lo riparerò. Sposto un tavolino e lo metto davanti alla porta per tenerla chiusa. La ragazza va a mettersi con le spalle contro una parete in tronchi di pino americano. Si guarda attorno. La stanza è piccola. Ci sono un sofà blu sgangherato, una brutta sedia rossa di plastica e, nell’angolo, una stufa a legna che non diffonde neanche un briciolo di calore. Alcuni vecchi scatti in bianco e nero, fatti con una macchina a cassetta, ritraggono le varie fasi di costruzione della casa; ricordo che, quando ero piccolo, il proprietario mi aveva raccontato che le persone che l’avevano costruita, un secolo prima, avevano scelto il posto non per il panorama, ma per la fila di pini che lo ripara dai venti sferzanti a est. Come se lui sapesse cosa frullava per la testa delle persone, ormai morte, che avevano eretto il capanno. Ricordo che anche allora, mentre osservavo i suoi capelli unti e radi, la sua pelle rovinata, pensavo quanto fosse imbecille. La cucina con gli elettrodomestici è color senape, il pavimento in linoleum e sulla tavola c’è una tovaglia di plastica. Ovunque prevale la polvere. Non mancano ragnatele, coccinelle o insetti vari morti sui davanzali. C’è cattivo odore. «Dovrai abituarti», le dico. Noto il disgusto nei suoi occhi. Sono certo che la casa del giudice non avrà mai quest’aspetto. Accendo la luce e controllo l’acqua. Il capanno era stato preparato per l’inverno, prima che il proprietario se ne andasse. Non ci parliamo più, però lo tengo d’occhio. So che il suo matrimonio è fallito di nuovo, e che un anno fa lo hanno arrestato per guida in stato di ubriachezza. So che da un paio di settimane ha preso la sua roba merdosa e si è tolto dalle scatole, come fa ogni autunno, per tornare a Winona, dove lavora per l’assessorato municipale ai trasporti, spala la neve e toglie il ghiaccio dalle strade. Strappo il telefono dalla presa e, dopo aver trovato un paio di forbici in un cassetto della cucina, taglio il filo. Lancio un’occhiata alla ragazza immobile al suo posto. Tiene gli occhi fissi sulla tovaglia a scacchi. È orribile, ne sono consapevole. Esco fuori per fare pipì. Rientro subito dopo. Lei fissa ancora quella schifosa tovaglia. «Perché non ti rendi utile? Accendi il fuoco», dico. Si mette le mani sui fianchi e mi fissa, con quell’orribile felpa rubata alla stazione di servizio. «Perché non lo fai tu?», dice con voce tremante. Le tremano anche le mani, ma so che ha meno paura di quel che vuol farmi credere. Esco fuori e rientro col passo appesantito da tre ceppi di legna da ardere, che scarico sul pavimento, davanti ai suoi piedi. Lei fa un balzo. Le porgo dei fiammiferi, che lascia cadere a terra; la scatoletta si apre e il contenuto si sparpaglia. Le ordino di raccoglierli e lei mi ignora. Deve capire che sono io a comandare, non lei. È un passeggero, purché tenga il becco chiuso e faccia come le dico io, che sono al posto di guida. Glielo faccio notare. I suoi begli occhioni azzurri passano dalla sicurezza all’esitazione quando mi sussurra: «Hai capito proprio male», e allora armo minaccioso il cane della pistola e le ordino di raccogliere i fiammiferi e di accendere il fuoco. Mi chiedo se ho commesso un errore, se non sarebbe stato meglio consegnarla semplicemente a Dalmar. Non so cosa mi aspettassi da lei, ma certamente non questo. Non avrei mai immaginato di finire con un’ingrata. Mi fissa. Una sfida. Vuole capire se dentro di me progetto di ucciderla. Mi avvicino e le punto la pistola alla testa. Allora cede. S’inginocchia e raccoglie i fiammiferi con mani tremanti. Uno a uno. Poi li rimette nella scatola. Io resto fermo con la pistola contro di lei, mentre strofina un paio di fiammiferi sulla superficie ruvida. La fiamma le brucia le dita ancor prima che possa accendere il fuoco. Si succhia il dito e ci riprova. Prova ancora, e ancora di nuovo. Sa che la osservo. Ormai le mani le tremano tanto che non riesce ad accendere quei dannati fiammiferi. «Lascia fare a me», dico incombendo alle sue spalle. Si tira indietro. Accendo il fuoco senza problemi e, sfiorandola, mi dirigo in cucina per cercare qualcosa da mangiare. Non c’è niente, nemmeno un pacchetto di cracker andati a male. «E adesso?», mi chiede, ma la ignoro. «Cosa faremo qui?». Cammino avanti e indietro nel capanno, per controllare. L’acqua non scorre. Sono state chiuse le tubature per l’inverno. Però posso ripristinarle. Una cosa rassicurante. Lasciando il capanno, il proprietario immaginava di tornarci solo in primavera, il periodo in cui va in letargo, vivendo da eremita per sei mesi all’anno. Sento che lei si muove inquieta, in attesa di qualcuno o qualcosa che venga a tirare giù la porta per ammazzarla. Le dico di calmarsi, di mettersi a sedere. Resta in piedi a lungo, dopodiché appoggia una sedia di plastica alla parete, dall’altra parte dell’entrata, e crolla. Attende. È assurdo vederla sulla sedia a fissare la porta, ad aspettare che arrivi la fine. Cala la notte e arriva il giorno. Né io, né lei abbiamo dormito. Il capanno sarà gelato, d’inverno. Non era stato progettato per essere abitato dopo il primo di novembre. All’interno, l’unica fonte di calore è la stufa a legna. Nei tubi del gabinetto c’è l’antigelo. L’elettricità era stata staccata. L’ho riattivata ieri sera. Ho trovato la centralina e ho sollevato l’interruttore. Ho sentito la ragazza che ringraziava Dio per i 24 watt sprigionati dalla brutta lampada sul tavolo. Mi sono fatto strada attorno al capanno, andando a controllare cosa c’è nella rimessa sul retro. È piena di robaccia inservibile che non vorrebbe nessuno, tranne alcune cosette che potrebbero tornare utili, come una cassetta degli attrezzi. Ieri ho detto alla ragazza che doveva pisciare all’esterno. Ero troppo stanco per occuparmi dell’idraulica. L’avevo vista scendere gli scalini, come se andasse a gettarsi in alto mare. Si era nascosta dietro un albero e abbassata pantaloni e mutandine, accovacciandosi dove riteneva che non potessi scorgerla; poi, siccome non si azzardava a usare le foglie, aveva aspettato di asciugarsi all’aria. Aveva pisciato una volta sola. Oggi individuo la valvola di erogazione idrica e comincio a far scorrere lentamente l’acqua. All’inizio spruzza forte, poi ricomincia ad affluire normalmente. Tiro lo sciacquone del gabinetto, pulisco i lavandini e le tubature per sbarazzarmi dell’antigelo. Nella mia mente elenco le cose che ci servono: materiale isolante, altro nastro per i tubi, carta igienica, scorte alimentari. Lei è presuntuosa, prepotente e compiaciuta, come una diva. Mi ignora perché è incavolata e impaurita, ma anche perché immagina di essere troppo per me. È seduta sull’orrenda sedia rossa e fissa fuori della finestra. Cosa guarda? Niente, si limita a sgranare gli occhi. Da stamattina non ha detto più di due parole. «Andiamo», esclamo io, le spiego che riprendiamo la macchina. Andiamo a farci un giretto. «Dove?». Non vuole andare da nessuna parte. Preferirebbe restare a fissare fuori da quella cazzo di finestra per contare le foglie che cadono dagli alberi. «Vedrai». È in preda al panico. L’incertezza non le piace. Non si muove, mi guarda con atteggiamento di sfida, ma è un’illusione, un falso coraggio, poiché so che è terrorizzata a morte. «Ti va di mangiare, vero?». Apparentemente le va. Quindi usciamo e risaliamo nel veicolo. Ci dirigiamo verso Grand Marais. Mi sto convincendo a mettere in atto un piano: andarmene al più presto dal Paese. La abbandonerò, non mi serve portarmela dietro, mi rallenterebbe soltanto. Troverò un volo per lo Zimbabwe o l’Arabia Saudita, una nazione che non prevede l’estradizione. Al più presto, dico a me stesso, lo farò. La legherò nel capanno e scapperò a Minneapolis, e all’aeroporto salirò su un volo prima che lei possa avere la possibilità di dare il mio identikit all’Interpol. Le dico che non posso chiamarla Mia. Non posso farlo in pubblico, presto si spargerà la voce della sua scomparsa. Dovrei lasciarla nell’auto, ma non posso. Taglierebbe la corda. Perciò le dico di mettersi il mio cappellino da baseball e di tenere gli occhi bassi, di non stabilire un contatto visivo con nessuno. Forse non c’era nemmeno bisogno di precisarlo: non alza mai lo sguardo da terra. Le chiedo come vuole che la chiami. Dopo un’esitazione abbastanza lunga da irritarmi, tira fuori il nome di Chloe. A nessuno importa che io sia scomparso. Se non mi presento al lavoro, di solito pensano che non abbia voglia di faticare. Sembra che io non abbia amici. Lascio che sia lei a scegliere il brodo di pollo per il nostro pranzo. Non mi piace proprio, ma accetto lo stesso. Ho davvero fame. Prendiamo una ventina di scatolette: pastina in brodo di pollo, zuppa di pomodori, mandarini, crema di mais. Il cibo che si ritrova in un kit di sopravvivenza. La ragazza se ne accorge ed esclama: «Forse non hai intenzione di uccidermi subito», e io la rassicuro, spiego che non ho intenzione di farlo, almeno finché non abbiamo finito la crema di mais. Nel pomeriggio cerco di dormire. Non è facile addormentarsi in questi giorni. Ritaglio un’ora qui e un’ora là, ma perlopiù mi risveglio con l’idea di essere inseguito da Dalmar, o di avere gli agenti di polizia che bussano alla porta. Sto sempre in allerta, scruto da ogni finestra davanti a cui passo. Mi guardo sempre alle spalle. Barrico la porta prima di coricarmi, e sono contento che qualche idiota abbia sigillato le finestre con la vernice. Non pensavo di dovermi preoccupare del fatto che la ragazza volesse fuggire. Non immaginavo che avesse dentro di sé questa pulsione. Abbasso la guardia, lascio le chiavi dell’auto in bella vista, ci mancava solo questo per incoraggiarla. Così, mentre sono mezzo addormentato sul sofà, stretto alla pistola, sento sbattere la porta. Mi alzo subito, mi ci vuole un attimo per ritrovare l’orientamento. Allora noto che sta scendendo precipitosamente gli ultimi gradini per accedere al vialetto di ghiaia. Esco dalla porta, sono furibondo e urlo. Lei zoppica. La portiera dell’auto è aperta. Entra nell’abitacolo e prova a mettere in moto. Non riesce a trovare la chiave giusta. La vedo dal finestrino del guidatore. Vedo che dà un pugno sul volante. Mi avvicino. Ormai è disperata, scivola dall’altra parte ed esce dalla portiera del passeggero. Scappa nei boschi, corre veloce, ma io di più. I rami degli alberi sporgono e le graffiano braccia e gambe. Incespica su un pietrone e cade a faccia in giù su un mucchio di foglie. Si rialza e continua a correre. Si sta stancando, perde velocità. Piange, mi implora di lasciarla stare. Invece io sono arrabbiato. La afferro per i capelli. Continua a muovere i piedi, scappa ma la strattono per la testa. Cade di nuovo sulla terra dura. Non ha neanche il tempo di mettersi a piangere che la schiaccio al suolo con tutti i miei novanta chili che premono sul suo corpo esile. Boccheggia, mi supplica di smetterla. Io invece non lo faccio, sono incazzato nero. Lei piange disperata. Le lacrime le rigano la faccia, si mescolano col fango, col sangue e col mio sputo. Si contorce. Sputa contro di me. Sono certo che si vede passare davanti tutta la sua vita. Le dico che è veramente una stupida. E poi le punto la pistola alla testa e armo il cane. Cessa di sbattersi, si paralizza. Premo forte la canna, che le lascia un circoletto in testa. Potrei farlo, mettere fine alla sua esistenza. È una cretina, una scema, una deficiente. Mi ci vuole tutta la mia buona volontà per non premere il grilletto. L’ho fatto per lei. Le ho salvato la vita. Chi diavolo crede di essere per tentare di scappar via? Pigio ancor più forte l’arma, le faccio quasi penetrare la canna nel cranio. Lei si lamenta. «Scommetto che fa male», dico. «Ti prego…», mi supplica, ma non le do retta. Avrei dovuto consegnarla quando ne avevo la possibilità. Mi alzo, la afferro per i capelli. Lei strilla. «Chiudi il becco», dico. La trascino tra gli alberi. Poi la spingo davanti a me e le ordino di muoversi. «Sbrigati», ma sembra che le sue gambe funzionino male. Inciampa, cade. «Alzati», urlo deciso. S’immagina cosa mi farebbe Dalmar se mi trovasse? Una pallottola in testa sarebbe il modo più semplice per “scamparla”. Una morte facile e rapida. Mi metterebbe in croce, mi torturerebbe. La spingo su per i gradini, la faccio entrare nel capanno. Chiudo con forza la porta, che però si riapre. La sbatto con un calcio e ci addosso di nuovo il tavolino per impedire che si spalanchi. Spingo la ragazza in camera da letto e le dico che, se la sento anche solo respirare, non rivedrà più la luce del giorno. Gabe Prima Mi reco in centro con l’auto, per la quarta volta in questa settimana, ripromettendomi di protestare se non mi rimborseranno i chilometri che percorro a mie spese. Sono solo sedici chilometri, ma con questo traffico assurdo ci impiego quasi mezz’ora. Ecco perché non abito in città. Sborso di tasca mia altri quindici dollari per il parcheggio, un furto vero e proprio, visto che sono passato davanti all’incrocio fra Lawrence e Broadway una dozzina di volte e non sono riuscito a trovare un posto libero. Il bar resterà chiuso per alcune ore. Tento la fortuna, bussando alla vetrina per attirare l’attenzione del barista. Sta facendo il rifornimento del bancone e so che mi sente, ma non si muove. Busso di nuovo e stavolta, quando volge lo sguardo verso di me, gli mostro il distintivo. Apre la porta. Il locale è tranquillo, le luci sono soffuse, sono pochi i raggi di sole che riescono a penetrare dai vetri sporchi. Per il resto, abbonda la polvere e ristagna una puzza di fumo da sigaretta, cose che nessuno nota quando prevale l’atmosfera creata dalle candele e dalla musica jazz. «Apriamo alle sette», dice. «Chi è il responsabile, qui?», gli chiedo. «Ce l’ha di fronte». Si volta per rientrare nel locale. Lo seguo e vado ad appollaiarmi su uno dei malridotti sgabelli in vinile. Infilo una mano in tasca per prendere una foto: Mia Dennett. Un’immagine affascinante, una di quelle che mi ha dato Eve la settimana scorsa. Le ho promesso di non perderle o danneggiarle, e mi rincresce che si sia già spiegazzata nel taschino della mia camicia. Per la signora Dennett, era la foto esemplare in cui Mia era «tutta lei» – si era espressa così – l’immagine specchiata della ragazza dallo spirito libero, coi lunghi capelli biondo scuro, gli occhi azzurri e un sorriso diretto, onesto. È in posa davanti alla Buckingham Fountain: l’acqua schizza per via del vento di Chicago e la spruzza, mentre lei ride come una bambina. «Ha mai visto questa ragazza?», domando appoggiando la foto sul bancone. Lui la prende in mano e ci dà un’occhiata. Gli dico di fare attenzione. Noto subito che l’ha riconosciuta. La conosce. «Viene sempre qui, si siede a quel tavolo», replica, accennando con la testa a quello dietro le mie spalle. «Scambiate mai due chiacchiere?» «Sì, quando mi ordina da bere». «Tutto qua?» «Tutto qua. Cos’è successo?» «Si trovava qui martedì sera? Verso le otto?» «Martedì sera? Amico, riesco appena a ricordare cosa ho mangiato stamattina a colazione. Lei è stata qui tante volte, so solo questo con certezza». Mi restituisce la foto. Mi rompe le scatole il fatto che mi abbia chiamato amico. È umiliante. «Ispettore», faccio notare. «Prego?» «Sono l’ispettore Hoffman, non un amico». Procedo: «Può dirmi chi era di servizio martedì sera?» «Ma di che si tratta?», chiede ancora. Gli dico di non preoccuparsi di questo. Gli domando di nuovo chi lavorava martedì sera, stavolta con un tono bellicoso a cui non può tener testa. Si scoccia per la mia scortesia. Sa che, se volesse, potrebbe cacciarmi in malo modo. C’è solo un problema: io ho una pistola. Comunque, si ritira nel retrobottega buio e, quando torna a mani vuote, dice: «Sarah». «Sarah?» «Sì, deve parlare con lei. Era lei a s e r v i r e quel tavolo», spiega indicando il sudicio posto in fondo al bar. «Martedì sera. Arriva tra un’ora». Resto seduto per un po’ davanti al bancone e lo osservo mentre allinea le bottiglie di alcolici. Lo guardo riempire i secchielli di ghiaccio e contare i soldi nel registro di cassa. Cerco di parlare del più e del meno, per fargli sbagliare il conto mentre impila quelli che sembrano essere migliaia di centesimi. Lascio perdere quando arriva a quarantanove. Misuro a passi il locale. Sarah Rohrig arriva nel giro di un’ora, accede dalla porta principale con un grembiule in mano. Il suo capo la trattiene per uno scambio di battute, durante le quali gli occhi della donna incrociano i miei. Sul suo volto appare un’espressione preoccupata, un sorriso forzato. Io mi trovo a un tavolino e faccio finta di cercare indizi nei dintorni, laddove tutto ciò che vedo sono una panca in plastica e un’asse di legno fatta passare per tavolino. Oltre a una candelina verde decorata che penso di sgraffignare e portarmi via. «Sarah?», le chiedo e lei risponde affermativamente. Mi presento e la invito ad accomodarsi. Le porgo la foto di Mia. «Ha visto questa ragazza?» «Sì», ammette. «Ricorda se è stata qui, martedì scorso, verso le otto di sera?». Dev’essere la mia giornata fortunata. La Rohrig è infermiera professionale a tempo pieno e lavora nel bar solo il martedì sera, per intascare qualche dollaro in più. Era una settimana che non metteva piede nel locale, per cui l’immagine di Mia ce l’ha fresca in mente. Sostiene con sicurezza che lei era nel bar una settimana fa, aggiunge che lo frequenta tutti i martedì. A volte da sola, altre volte con un uomo. «Perché il martedì?» «È la serata dello slam, una competizione tra poeti», dice, «presumo venga per questo. Però non sono certa che ascolti. Sembra sempre distratta». «Distratta?» «Sogna a occhi aperti». Chiedo cosa diavolo sia uno slam, non ho mai sentito parlare di questo tipo di poesia. Immagino le composizioni di Yeats o di Whitman buttate lì, ma non è questo il caso. E l’idea di ascoltare della gente che recita su un palco le proprie poesie mi sconcerta ancor di più. Chi diamine vorrà mai stare a sentire roba simile? Pare che abbia ancora molto da imparare su Mia Dennett. «La settimana scorsa era da sola?» «No». «Con chi era?». Sarah riflette per un attimo. «Un tizio. L’ho già visto qui». «Insieme a Mia?», chiedo. «Si chiama così?», domanda. «Mia?». Rispondo affermativamente. Lei mi racconta che la ragazza era gentile (l’uso dell’imperfetto mi investe come un treno merci) e sempre molto amichevole. Lasciava buone mance. Sarah spera che sia tutto a posto. Ma dalle mie domande intuisce che le cose stanno altrimenti, sebbene non voglia sapere cosa sia successo, per cui non glielo riferisco. «L’uomo con cui Mia era la settimana scorsa… Erano venuti insieme altre volte?». Dice di no. Era la prima volta che li vedeva insieme. Lui se ne stava di solito da solo, al bar. Lo notava perché era carino, ma in modo enigmatico; questo me lo appunto, dovrò cercare il significato sul vocabolario. Mia si piazzava sempre a quel tavolino, a volte da sola, altre volte no. Ma il martedì precedente erano insieme e se ne erano andati di fretta. Sarah non sa come si chiami l’uomo, io la esorto a descrivermelo e lei lo fa: alto, robusto, capelli folti e spettinati, occhi scuri. Accetta di incontrare un nostro ritrattista per vedere se, in base alla sua descrizione, si riesce a ricavare un identikit somigliante. Le chiedo di nuovo: «È sicura che se ne siano andati insieme? È molto importante». «Sì». «Li ha visti uscire?» «Sì, cioè quasi. Ho portato loro il conto e, quando sono tornata, non c’erano più». «Le sembrava che Mia se ne andasse di sua volontà?» «Mi sembrava che non vedesse l’ora di uscire di qui». Le domando se erano arrivati al bar insieme. Dice di no, non pensa che lo fossero dall’inizio. Come ha fatto lui a ritrovarsi al tavolo di Mia? Sarah non lo sa. Le chiedo di nuovo: conosce il nome dell’uomo? No. C’è qualcuno che potrebbe conoscerlo? Probabilmente no. L’uomo e Mia avevano pagato in contanti, lasciando più di cinquanta dollari sul tavolo, cosa che Sarah ricorda ancora perché, per cinque o sei birre, era una mancia generosa. Più di quanto lascino solitamente i clienti. Ricorda di essersene vantata in seguito, sventolando la banconota con la faccia di Ulysses Grant davanti a tutti i colleghi. Quando esco dal bar, controllo su e giù per la Broadway le videocamere di sicurezza fuori dei ristoranti, delle banche e dei centri yoga per trovare qualcosa che mi faccia capire con chi era Mia Dennett la sera del martedì in cui è scomparsa. Colin Prima Non vuole mangiare. Le ho offerto cibo per quattro volte, lasciandole una scodella piena sul pavimento della sua camera. Come se fossi il suo stupido cuoco. Lei se ne sta a letto, sdraiata su un fianco, dà le spalle alla porta. Quando entro, non si muove, ma la vedo respirare, so che è viva. Se continua così a lungo morirà di inedia. Ora sarebbe paradossale. Esce dalla stanza come uno zombie, con una massa aggrovigliata di capelli che le nasconde la faccia. Si dirige verso il bagno, fa quel che deve e torna indietro. La ignoro, lei mi ignora. Le ho detto di lasciare aperta la porta della stanza da letto. Voglio essere sicuro che non escogiti niente, lì dentro; comunque non fa altro che dormire. Fino a questo pomeriggio. Ero stato fuori a tagliare la legna per il fuoco. Una bella sudata! Ero a corto di fiato. Mi ero precipitato nel capanno avendo in mente una cosa sola: l’acqua. Lei era in piedi al centro della stanza, con solo gli slip e il reggiseno di pizzo addosso. Pareva morta, la sua pelle aveva perso qualsiasi traccia di colorito. I suoi capelli erano in disordine, sulla coscia aveva un livido grosso come un uovo d’oca. Aveva un labbro spaccato e un occhio nero, oltre ai graffi che si era procurata contro gli alberi. Dagli occhi, gonfi e iniettati di sangue, scendevano lacrime che le rigavano il volto dalla pelle chiara. Era in preda alle convulsioni, la pelle d’oca su tutto il corpo. Avvicinandosi a me, ho notato che zoppicava. Mi ha detto: «È questo che vuoi?». L’ho fissata. Ho fissato i suoi capelli, che le cadevano disordinatamente sulle spalle bianche come l’avorio. Il pallore della sua pelle non curata. I crateri formati dalle sue clavicole e la forma perfetta dell’ombelico. Le sue mutandine e le lunghe gambe. La sua caviglia, talmente gonfia che poteva essere slogata. Le lacrime che colavano sul pavimento davanti ai suoi piedi nudi, di fianco alle unghie laccate di rosso vermiglio, lungo le gambe talmente traballanti che pensavo le cedessero. Ho fissato il muco che le colava dal naso, visto che non riusciva più a frenare il pianto mentre allungava una mano e, tremando, me la posava sulla cintura, cominciando a sganciare la fibbia. «È questo che vuoi?», ha domandato ancora, e per un momento l’ho lasciata armeggiare con la mia cintura. Le ho permesso di togliermela e di chinarsi. Le ho permesso di sbottonarmi i jeans e di tirare giù la cerniera. Non riuscivo a dire che non era quello ciò che volevo. Lei sudava e puzzava, come me del resto. Quando mi ha toccato, le sue mani parevano di ghiaccio. Ma non è stato quello a dissuadermi. L’ho scostata delicatamente. «Smettila», ho sussurrato. «Lasciami fare», ha implorato. Pensava che sarebbe servito. Pensava che avrebbe cambiato le cose. «Rimettiti i vestiti», ho detto. Ho chiuso gli occhi, non ero in grado di guardarla. Era in piedi davanti a me. «Non…». Voleva che le mettessi le mani addosso, mi forzava. «Basta». Non mi dava retta. «Basta». L’ho detto con più forza, con più energia. E ho aggiunto: «È ora di finirla», spingendola via da me. Le ho ripetuto di rimettersi i suoi maledetti vestiti. Mi sono fiondato fuori dal capanno, ho afferrato l’ascia e ho cominciato a tagliare di nuovo la legna, con vigore maniacale. Avevo dimenticato completamente l’acqua. Eve Prima Siamo nel cuore della notte e non riesco a dormire, come capita ormai da una settimana. I ricordi di Mia mi ossessionano giorno e notte, le immagini di quando aveva un anno, col suo costumino a pois verde oliva e le sue cosce grassocce che sporgevano, mentre tentava inutilmente di camminare. Le unghie laccate di rosa shocking sui piedini da bimba di tre anni. I suoi lamenti quando le facemmo forare le orecchie, ma poi la sua ammirazione per gli orecchini di opale, restava ore a guardarsi davanti allo specchio del bagno. Mi trovo nella dispensa della nostra casa oscurata, l’orologio sui fornelli della cucina segna le 3:12. Rovisto tra gli scaffali per prendere la scatola di camomilla, so di averla riposta da qualche parte, malgrado sia sicura che ci voglia molto più di un infuso per aiutarmi a prendere sonno. Rivedo Mia alla prima comunione, avevo notato il disgusto sul suo volto quando le misero sulla punta della lingua il Corpo di Cristo; dopo avevamo riso sul suo letto, io e lei, perché l’ostia era stata difficile da masticare e inghiottire, e il vino l’aveva quasi fatta strozzare. E poi ne sono colpita come se mi piovesse addosso una scarica di mattoni, mi rendo improvvisamente conto di questa cosa sconvolgente: la mia bambina potrebbe essere morta, e allora, nel pieno della notte, lì nella dispensa, comincio a piangere piano, cado a terra e premo le maniche del pigiama sulla faccia per smorzare i gemiti. La rivedo nel costume a pois, con un sorriso smagliante e sdentato, mentre si aggrappa al bordo del tavolino e si protende a fatica verso di me, che la aspetto a braccia aperte. La mia bambina potrebbe essere morta. Faccio quel che posso per contribuire alle indagini, eppure tutto appare banale e inutile, perché Mia non è a casa. Ho trascorso un’intera settimana nel quartiere dove abita lei, distribuendo a chiunque transitasse da quelle parti volantini con la foto e la scritta SCOMPARSA. Affiggevo l’immagine di Mia ai lampioni e nelle vetrine dei negozi, una foto su carta rosa shocking, impossibile da non notare. Mi sono vista con la sua amica Ayanna per pranzo, abbiamo ripercorso insieme, dettagliatamente, l’ultima giornata di Mia, nella ricerca disperata delle stranezze che avrebbero potuto spiegare la sua sparizione, purtroppo invano. Sono stata in centro con l’ispettore Hoffman, dopo che si era procurato una chiave dell’appartamento di Mia, e ho controllato che non poteva affatto dirsi la scena di un delitto. Insieme abbiamo poi passato al vaglio i suoi effetti personali e tutto il resto: materiale per la preparazione delle lezioni, rubrica degli indirizzi, lista della spesa, cose da fare, sperando di trovare un indizio. Nulla. Il detective mi telefona una volta al giorno, anche due. Non passa quasi mai una giornata in cui non ci parliamo. Trovo che la sua voce, la sua gentilezza, siano rassicuranti; lui è sempre amichevole, anche quando James lo punzecchia. Mio marito sostiene che sia un idiota. Hoffman mi dà l’impressione di essere la prima a venire a sapere qualsiasi informazione, per quanto insignificante, che gli portano sulla scrivania; sono comunque certa che non è vero. Lui passa al setaccio anche le minuzie prima di riferirmele. Sono frammenti di notizie che scatenano una miriade di ipotesi nella mente di una madre. La scomparsa di mia figlia non smette mai di occupare i miei pensieri. Ci penso quando vedo le madri che tengono i figli per mano; quando vedo i ragazzini salire sull’autobus per andare a scuola. Quando vedo le foto dei gatti smarriti incollate ai pali della strada, o sento una madre chiamare per nome un suo pargolo. L’ispettore vuole sapere tutto il possibile su Mia. Rovisto tra le vecchie foto che tengo nel seminterrato; m’imbatto nei vecchi costumi di Halloween, nei vestiti di taglia minuscola, nei pattini e nelle Barbie. So che ci sono altri casi, altre ragazze scomparse, oltre a Mia. Mi immagino le loro madri. So che ci sono ragazze che non tornano mai più a casa. Hoffman mi ribadisce che, quando non ci sono notizie, è una buona notizia. Talvolta mi telefona per dirmi che non ci sono altre informazioni, nel caso mi preoccupassi, cosa normale per me. Mi tratta con grande tatto, promette di fare qualsiasi cosa per rintracciare Mia. Glielo leggo negli occhi quando mi guarda, o indugia un attimo più di quanto dovrebbe, per accertarsi che non stia per crollare. Però ci penso sempre a quanto sia diventato arduo reggersi in piedi e camminare, a quanto stia diventando impossibile vivere e funzionare in un mondo che pensa allo sport e alle forme di intrattenimento, che si preoccupa di economia e politica, mentre io riesco a pensare solo a Mia. Non sono stata certamente una madre perfetta. Non c’è nemmeno bisogno di dirlo. Non ero partita però con l’intenzione di essere una pessima madre. È successo e basta. In effetti, agire in modo sbagliato era un gioco da ragazzi rispetto al comportarmi da vera madre, una cosa che invece era una lotta incessante, un conto in perdita ventiquattr’ore al giorno. Anche dopo aver messo le bimbe a letto, mi tormentavo ripensando a quel che avevo o non avevo fatto durante le ore in cui eravamo rimaste insieme. Perché avevo permesso a Grace di far piangere Mia? Perché avevo sgridato Mia per costringerla a smettere di fare chiasso? Perché mi rifugiavo in un angolo tranquillo ogni volta che potevo? Perché affrettavo le loro giornate – forzandole a sbrigarsi – per rimanere sola? Le altre madri portavano i figli al museo, ai giardinetti, in spiaggia. Io tenevo le mie ragazze in casa il più possibile, per non provocare scenate. Di notte resto sveglia a chiedermi: cosa succederà se non avrò la possibilità di recuperare il tempo perduto con Mia? Cosa accadrà se non sarò mai capace di dimostrarle che sono il tipo di madre che avrei sempre desiderato essere? Quella che gioca per ore e ore con le figlie, che chiacchiera con loro, di sera, sui ragazzi più carini della scuola media. Avevo sempre creduto che sarei diventata un’amica delle mie bambine. Immaginavo di andare a fare le commissioni insieme a loro, di condividere i nostri segreti, e invece ora ho soltanto un rapporto formale con Mia e Grace, sembra un obbligo da parte loro. Ripasso mentalmente tutte le cose che direi a Mia, se potessi. Che avevo scelto quel nome in onore della mia bisnonna Amelia, ponendo il veto ad Abigail, l’alternativa proposta da James. Che il giorno di Natale, quando lei aveva quattro anni, James era rimasto alzato fine alle tre del mattino per costruirle la casa di bambole dei suoi sogni. Che anche se i suoi ricordi del padre sono pieni di ostilità, non erano mancati attimi di bontà: per esempio quando lui le aveva insegnato a nuotare o l’aveva aiutata a prepararsi per l’esame di ortografia, in quarta. Che mi addoloro tutte le volte che chiudo un libro, prima di coricarmi, disperata perché vorrei avere altri cinque minuti per ridere con lei su Harry the Dirty Dog4. Che vado in libreria a comprarne una copia, dopo aver frugato senza successo in cantina per trovare quella che aveva una volta. Che la leggo seduta sul pavimento della sua vecchia camera da letto, la rileggo e poi la rileggo ancora. Che le voglio bene. Che mi dispiace. 4 Libro per l’infanzia (1956) di Gene Zion, illustrato da Margaret Bloy Graham. (n.d.t.) Colin Prima Si nasconde tutto il giorno in camera da letto. Non vuole uscire di lì. Non le consento di avvicinarsi alla porta del capanno, così resta seduta sul letto. Siede e pensa. A cosa, non lo so. Non me ne frega niente. Piange, le lacrime si spargono sulla federa fino a inzupparla, probabilmente. Quando va al bagno per pisciare, ha la faccia rossa e gonfia. Cerca di farlo sommessamente, come se io non potessi udirla. Però il capanno è piccolo, non vi è nulla che attutisca i rumori. Ha dolori in tutto il corpo. Lo vedo dal modo in cui cammina. Non può far forza sulla gamba sinistra per via della ferita che si è procurata cadendo dai gradini del capanno e nel bosco. È claudicante, per arrivare al gabinetto barcolla e deve appoggiare una mano alla parete. In bagno, fa scorrere un dito su un livido, nero per la congestione del sangue. Sente che sono nell’altra stanza. Mi muovo a lunghi passi. Taglio la legna da ardere, abbastanza da tenerci al caldo per tutto l’inverno. Ma non è mai davvero caldo. Sono sicuro che lei senta continuamente freddo, sebbene indossi i pantaloni termici e si rifugi sotto il piumone. Il tepore della stufa non raggiunge la camera da letto. Però rifiuta di venire qui dove il calore è sufficiente. Immagino che il suono dei miei passi la spaventi a morte. Ascolta solo questi passi, in attesa che succeda il peggio. Cerco di tenermi indaffarato. Pulisco il capanno. Elimino le ragnatele e raccolgo gli scarafaggi morti. Li getto nell’immondizia. Spacchetto le cose che abbiamo comprato in paese: cibo inscatolato, caffè, dolci, sapone, nastro isolante. Riparo la porta d’ingresso. Lavo bene il piano di lavoro della cucina con acqua e salviette di carta. Lo faccio solo per passare il tempo. Raccolgo i vestiti della ragazza dal pavimento del bagno. Sto per rimproverarla, voglio dirle che è sciatta perché lascia in giro i panni sporchi. Ma poi sento che piange. Riempio d’acqua la vasca. Lavo camicia e pantaloni con un pezzo di sapone e li appendo fuori ad asciugare. Non possiamo continuare così. Il capanno è un espediente temporaneo. Mi arrovello per escogitare le prossime mosse, vorrei averci pensato prima di decidere di rapire la ragazza e fuggire con lei. Striscia di fianco a me per andare in bagno. È piena di lividi e zoppicante, io non sono uno che si sente in colpa facilmente, però sono stato io a ridurla così, là fuori, tra gli alberi della foresta, quando aveva tentato di scappare. Mi dico che se l’era cercata. Mi rassicuro pensando che almeno adesso è tranquilla, se ne sta buona, ed è meno sicura di sé. Ora sa chi comanda: io. Bevo il caffè perché l’acqua del rubinetto fa schifo. L’ho offerto anche a lei. Le ho offerto anche dell’acqua, ma non la vuole. Ancora insiste a non voler mangiare. Presto la immobilizzerò e le caccerò il cibo giù per la gola. Non le permetterò di lasciarsi crepare di fame. Non dopo tutto questo. La mattina dopo mi invito da solo a entrare nella camera da letto. «Cosa vuoi per colazione?», chiedo. È sdraiata, dà le spalle alla porta. Quando mi sente entrare, è ancora mezzo addormentata. Il rumore inatteso dei miei passi e l’esplosione delle parole nel silenzio la costringono a uscire dalle coperte. Ecco qua, pensa, troppo sconcertata per udire quello che dico. Le s’impigliano le gambe nelle lenzuola. Col corpo vorrebbe scappare da quel rumore, ma i piedi la tradiscono. Cade sul pavimento ligneo. I suoi piedi lottano contro le lenzuola per far presa a terra. Col corpo si allontana il più possibile da me. Va a collocarsi con la schiena alla parete, stringendo ancora in una mano tremante la biancheria del letto. Resto sulla soglia, indosso gli stessi vestiti da quasi una settimana. Mi fissa, le si legge il panico negli occhi spalancati, ha le sopracciglia sollevate e la bocca aperta. Mi guarda come se fossi un mostro, un cannibale in attesa di mangiarla per colazione. «Cosa vuoi?», urla. «È ora di mangiare». Deglutisce. «Non ho fame», dice. «Peccato». Le faccio notare che non può decidere lei. Mi segue nell’altra stanza e mi osserva mentre verso in una padella quelle che si definiscono uova, anche se hanno un odore di robaccia inscatolata. Le faccio abbrustolire, ma la puzza mi fa venire i conati di vomito. Di me, lei detesta ogni cosa. Lo so. Glielo leggo negli occhi. Odia il mio portamento. Odia i miei capelli sporchi e i peli della barba che mi vede sul mento. Odia le mie mani, il modo in cui girano le uova nella padella. Detesta la maniera in cui la guardo. Odia il mio tono di voce e il modo in cui la mia bocca forma le parole. Ma soprattutto ha una profonda avversione per la pistola che ho in tasca, la vede bene. Io comunque la tengo continuamente addosso, per assicurarmi che lei si comporti a dovere. Le dico che non ha più il permesso di recarsi nella camera da letto. Ci può andare solo per dormire. Tutto qui. Per il resto della giornata, dovrà restare sempre in vista, così che possa tenerla d’occhio. Constaterò che mangi, beva, pisci. Come se dovessi badare a una ragazzina. E lei mangia come una bambina piccola, un morsetto qui e uno là. Afferma di non avere fame, però si nutre abbastanza per sopravvivere. È quel che conta. La sorveglio di modo che non cerchi nuovamente di andarsene, come l’ultima volta. Prima di coricarmi, spingo un tavolo più grosso e pesante contro la porta, così da udirla se prova a svignarsela. Io ho il sonno leggero. Mi appisolo con la pistola sotto di me. Ho rovistato la cucina per appurare che non ci siano altri coltelli. Solo il temperino che tengo sempre con me. Lei non ha un cazzo da dirmi, e io non ci provo nemmeno a parlare. Perché tentare? Non posso rimanere qui per sempre. In primavera arriveranno i turisti. Presto dovremo tagliare la corda. Presto io dovrò andarmene. Me la farò, immagino, e poi la abbandonerò per salire su un aereo e filare via. Prima che i poliziotti mi trovino. Prima che mi trovi Dalmar. Dovrò scappare. Però c’è qualcosa che mi trattiene, che mi impedisce di prendere il volo e andarmene via. Gabe Prima Mi trovo nella cucina dei Dennett. La signora si affaccenda al lavandino, scrosta i residui della cena a base di carne di maiale. Vedo che il giudice aveva ripulito bene il suo piatto, mentre quello della moglie mostra ancora il filetto e un mucchietto di piselli. Li sta buttando via davanti ai miei occhi. Scorre l’acqua bollente, il vapore si diffonde nella stanza; benché tenga le mani immerse nel liquido, pare non avvertire il calore. Sfrega la porcellana con una determinazione che non ho mai visto in nessuna lavapiatti. Stiamo davanti all’isola, al centro della cucina. Nessuno m’invita ad accomodarmi. È una cucina molto elegante, con mobili in legno di noce e piani di lavoro in granito. Gli elettrodomestici sono tutti di acciaio inossidabile, compresi due forni per i quali mia madre, italiana, darebbe un braccio e una gamba. Immagino il giorno del Ringraziamento senza la drammatica preoccupazione di mantenere ogni cosa in caldo fino all’ora di cena, e senza lacrime perché mio padre accennava al fatto che le patate erano un po’ fredde. Sull’isola della cucina, davanti a me e al giudice, è posata l’immagine di un uomo. È il ritratto fatto dalla polizia, tracciato da uno dei nostri disegnatori sulle indicazioni fornite dalla cameriera. «Questo sarebbe l’uomo? Quello che ha rapito mia figlia?». Mentre tiravo fuori l’identikit dalla cartellina marrone, Eve Dennett si era messa a piangere. Le lacrime le rigavano il viso. Aveva voltato le spalle alla conversazione e cercava di perdersi nelle faccende di casa, gemendo piano sul rumore dell’acqua corrente. «Martedì scorso hanno visto Mia con quest’uomo, di sera», chiarisco, anche se a questo punto è girata di spalle. L’immagine davanti a noi è quella di un tipo rude. Il suo aspetto è piuttosto volgare, però non assomiglia affatto agli uomini mascherati dei film dell’orrore. Solo che non è all’altezza dei Dennett. Né lo sono io, del resto. «E…?», abbozza il giudice. «E siamo convinti che sia coinvolto nella scomparsa della ragazza». Lui torreggia dall’altra parte dell’isola, sfoggia un completo il cui prezzo equivale a due o tre mesi del mio stipendio. Ha la cravatta slacciata e buttata su una spalla. «Ci sono prove per sostenere che Mia non è andata via con lui di sua volontà?» «Be’», dico, «no». Il signor Dennett si è già messo a bere. La scelta per questa serata è whisky con cubetti di ghiaccio. Penso che potrebbe essere brillo. Parla farfugliando un po’ e ha il singhiozzo. «Supponiamo che Mia se la stia spassando con lui. Che si fa?». Mi parla come se fossi idiota. Però ricordo a me stesso di avere la responsabilità dell’incarico. Sono io a poter ostentare il distintivo luccicante. L’indagine è sotto il mio comando, non il suo. «Vostro onore, sono otto giorni che è iniziata l’indagine», affermo. «Nove da quando è stata vista Mia per l’ultima volta. Secondo le sue colleghe, non si assentava quasi mai dal lavoro. Secondo sua moglie, questo comportamento (inefficienza, irresponsabilità) non è tipico del carattere di sua figlia». Prende un altro sorso di whisky e posa il bicchiere troppo in fretta sull’isola. Eve trasalisce per il rumore. «Naturalmente c’è anche la sua condotta indisciplinata. Vandalismo e violazione di proprietà. Possesso di marijuana», dice e poi, per rompermi le palle, aggiunge: «Solo per nominare alcune cose». L’espressione del suo volto è compiaciuta, ha stampata in faccia un’aria di superiorità. Lo fisso, non ci sono parole. Disprezzo la sua sicumera. «Ho controllato gli archivi della polizia», dico. «Non c’è niente a carico di Mia». La sua fedina è immacolata. Neanche una multa per eccesso di velocità. «In effetti, non potevano esserci denunce, o no?», chiede lui e colgo il sottinteso: le aveva fatte sparire. Chiede permesso per andarsi a versare un altro bicchiere. La signora Dennett strofina ancora i piatti. Mi sposto verso il lavandino e giro il rubinetto sull’acqua fredda, così le mani della povera donna non si ustioneranno più. Mi lancia un’occhiata, presa alla sprovvista, come se avesse avvertito adesso il primo sentore di una bruciatura, e sussurra: «Avrei dovuto dirglielo», ha gli occhi estremamente tristi. Sì, penso, avrebbe dovuto dirmelo, ma mi mordo la lingua e la lascio continuare. «Lui lo fa per negare la realtà. Vorrei poter dire che è talmente addolorato da rifiutare di credere che Mia è davvero scomparsa». Il giudice torna appena in tempo per udire le ultime parole della confessione di sua moglie. Tutto è calmo, ma per un secondo mi preparo ad affrontare l’ira di Dio. Invece, nulla, non succede niente. «Questo comportamento di Mia non è strano come hai indotto l’ispettore a credere, o mi sbaglio, Eve?», chiede. «Oh, James», protesta lei. Si asciuga le mani su uno strofinaccio e aggiunge: «Quello era successo anni fa. Andava ancora a scuola. Ha fatto la sua parte di errori. Ma è successo anni fa». «E che ne sai della Mia attuale? Sono anni che non abbiamo più rapporti con nostra figlia. Non la conosciamo quasi più». «E lei, signor giudice…», intervengo per togliere la signora dalla graticola. Detesto la maniera che ha di fissarla, facendola sentire una cretina. «Cosa sa della Mia di oggi? Qualche infrazione o illecito che sono stati recentemente cancellati dal casellario?», azzardo. «Infrazioni stradali? Prostituzione? Ubriachezza molesta?». Non devo pensarci due volte sui motivi per cui le sue trasgressioni giovanili sono sparite dai registri. «Non sarebbe stato positivo per il nome dei Dennett, vero? E anche tutto q u e s t ’ a f f a r e , se alla fine dell’indagine si scoprirà che Mia è da qualche parte a darsi da fare, se la ritroveremo in perfetta forma che se la stava spassando, non sarebbe positivo, vero?». Io guardo e ascolto i telegiornali, sono informato sulla politica. So che il prossimo novembre il giudice Dennett dovrà ricandidarsi. E mi ritrovo a chiedermi se la cattiva condotta di Mia si limiti alla sua adolescenza o se ci sia dell’altro. «Faccia attenzione, ispettore», mi ammonisce il giudice, mentre sullo sfondo la moglie piagnucola: «Prostituzione? James!». Era solo una mia congettura. Lui la ignora. Lo facciamo entrambi, mi pare. «Sto soltanto cercando di trovare sua figlia», ribadisco. «Perché forse è da qualche parte a fare la stupida. Però rifletta per un attimo sul caso in cui non sia così. Ci pensi bene. Cosa succederà? Sono sicuro che, se va a finire che sua figlia è morta, lei chiederà le mie dimissioni o mi farà sbattere fuori». «James», sibila la signora. Le sono tornate le lacrime non appena ha sentito che in una sola frase sono stato capace di usare le parole «figlia» e «morta». «Chiariamo questa cosa, Hoffman», esclama lui. «Lei ritrova Mia e la riporta a casa. Viva. Tenga ben conto di tutte le possibilità, perché ci sono cose di mia figlia che non si sanno e che valgono molto», dopodiché chiude il discorso, prende il suo whisky e si eclissa in un’altra stanza. Colin Prima La sorprendo mentre si guarda allo specchio del bagno. Non riconosce il riflesso: i capelli ispidi e la pelle trascurata, i lividi che stanno cominciando a guarire. Adesso sono gialli e chiazzati, anziché gonfi e violacei. Quando esce, la aspetto. Sono appoggiato allo stipite della porta. Fa un passo e sbatte contro di me, mi fissa, come se fossi un animale che la bracca e le sottrae l’aria. «Non volevo colpirti», le dico leggendole nel pensiero, ma lei non si esprime. Le faccio una carezza con la mano fredda sulla guancia. Lei freme e si tira indietro, evita il mio tocco. «Vanno meglio», mi riferisco ai lividi. Mi passa davanti e se ne va. Non so da quanto facciamo così. Ne ho perso traccia. Cerco di ricordare quando eravamo a lunedì o martedì. Col tempo, i giorni diventano uguali, non si distinguono più uno dall’altro. Lei resta a letto finché non la costringo ad alzarsi. Ci sforziamo di ingoiare la colazione. Poi lei trascina una sedia vicino alla finestra e si siede. Fissa l’esterno. Pensa, sogna a occhi aperti. Desidera ardentemente essere altrove. Io penso sempre a come andarcene di qui. Ho abbastanza soldi da prendere un volo per qualche posto, e allora sarà tutto finito. Ma ovviamente non ho il passaporto con me, e il posto più lontano in cui possa andare è Tecate o Calexico, in California, per cui l’unica maniera per uscire dal Paese sarebbe poi pagare un trafficante messicano, o nuotare verso l’altra riva del Rio Grande. Riuscire a varcare i confini del Paese è però solo una parte del problema, per me. È tutto il resto che non riesco a concepire. Cammino nel capanno, medito sulla maniera per cavarmi da questo maledetto imbroglio, consapevole che, per il momento, qui sono al sicuro, anche se più ci nascondiamo, più io mi nascondo, e peggio sarà. Abbiamo delle regole, dette o non dette. Lei non deve toccare la mia roba. Usiamo solo un pezzo di carta igienica per volta. Cambiamo l’aria solo quando è possibile. Usiamo il sapone in quantità minima, per non puzzare di sudore. Non lasciamo che le cose imputridiscano. Non apriamo le finestre. Né potremmo farlo, peraltro. Se fuori del capanno ci imbattiamo in una persona, lei si chiama Chloe, non Mia. In realtà, sarebbe meglio che dimenticasse del tutto il suo nome di battesimo. Le vengono le mestruazioni e imparo l’interpretazione letterale dell’espressione «usare le pezze». Vedo il sangue in un sacchetto dell’immondizia e chiedo: «Cosa diavolo è questo?», ma me ne pento subito. Raccogliamo il pattume in buste di plastica bianca che si accumulano. Ogni tanto andiamo con l’auto a scaricarle in un cassonetto dietro un casotto, di solito a notte fonda per essere certi che nessuno ci veda. Mi domanda perché non le abbandoniamo semplicemente all’aperto. Le chiedo se per caso voglia farsi sbranare da un orso. C’è uno spiffero da una finestra, ma la stufa contribuisce a tenerci al caldo. Le giornate si stanno accorciando. Fa sera sempre più in anticipo, finché l’oscurità non ammanta il capanno. Abbiamo la luce elettrica, però non voglio attirare l’attenzione su di noi. Accendo solo una lampadina di notte. La stanza da letto è immersa nel buio più nero. Durante le ore notturne, lei resta sdraiata ad ascoltare il silenzio. Aspetta che compaia io, in mezzo alle tenebre, per mettere fine alla sua vita. Durante il giorno si siede però vicino alla finestra con lo spiffero. Osserva le foglie che rotolano a terra. Tutto il suolo è cosparso di foglie in decomposizione. Non resta nulla a celare la vista sul lago. Ormai finisce l’autunno. Siamo talmente a nord da lambire il confine col Canada. Siamo persi in un mondo disabitato, circondati dalla desolazione più totale. Lei ne è consapevole, come me. È per questo che l’ho condotta qui. Adesso l’unica vera preoccupazione sono gli orsi. Ma poi, d’inverno, essi andranno in letargo. Fra poco si iberneranno nel sonno. E allora l’unica preoccupazione per noi sarà il gelo mortifero. Non parliamo molto. Soltanto per necessità: «il pranzo è pronto»; «mi faccio un bagno»; «dove stai andando?»; «Vado a letto». Non ci sono scambi di battute informali. Prevale il mutismo. A causa di questa mancanza di conversazione, udiamo qualsiasi rumore: lo stomaco che borbotta, i colpi di tosse, il vento notturno che fischia fuori del capanno, i cervi che calpestano le foglie. E inoltre ci sono i rumori immaginari: le gomme delle auto sulla ghiaia, i passi sugli scalini che portano al capanno, le voci. Probabilmente lei spera che siano reali, così la sua attesa sarà finita. La paura la ucciderà, non ci sono dubbi. Eve Prima La prima volta che misi gli occhi su James avevo diciotto anni, mi trovavo negli USA con delle amiche. Ero giovane e ingenua, ipnotizzata dall’enorme grandezza di Chicago, dal senso di libertà che sentivo sottopelle dal momento in cui noi ragazze avevamo messo piede sull’aereo. Venivamo dalla campagna inglese, eravamo abituate ai piccoli villaggi con poche migliaia di abitanti, a uno stile di vita rurale, a una comunità semplice e dalla mentalità ristretta. All’improvviso ci ritrovavamo sballottate in un mondo nuovo, paracadutate in una metropoli rumorosa, e perdipiù mi innamorai a prima vista. A sedurmi inizialmente fu la città, con tutte le promesse che sapeva offrire. Gli edifici immensi, i milioni di abitanti, l’ostentata sicurezza con cui camminavano, l’espressione risoluta impressa sul loro volto quando incedevano fra le strade animate. Era il 1969. Stava cambiando il mondo che conoscevamo ma, se devo essere sincera, me ne infischiavo. Ero fuori da quel giro. La mia sola esistenza mi eccitava, com’è normale quando si hanno diciott’anni: il modo in cui mi guardavano gli uomini, il modo in cui mi sentivo portando una minigonna, molto più corta di quanto avrebbe mai approvato mia madre. Ero terribilmente inesperta, anelavo di essere donna, volevo smettere di essere bambina. Ciò che mi aspettava a casa, nella campagna inglese, era stato deciso dal destino della mia nascita: avrei sposato uno dei ragazzi che conoscevo da sempre, uno di quelli che, da piccolo, alla scuola elementare, mi tirava i capelli o mi dava nomignoli. Non era un segreto che Oliver Hill volesse sposarmi. Mi aveva chiesta in moglie da quando aveva dodici anni. Suo padre era parroco della Chiesa anglicana, sua madre la casalinga che non avrei mai voluto essere: una di quelle che obbedisce al marito come se i suoi ordini fossero di origine divina. James era più grande di me, e la cosa mi emozionava; era brillante e cosmopolita. I suoi discorsi erano appassionanti, la gente pendeva letteralmente dalle sue labbra, che parlasse di politica o del più e del meno. Era estate quando lo vidi per la prima volta in un ristorante del Loop, seduto a una grande tavola rotonda con un gruppo di amici. La sua voce rimbombava al di sopra dei rumori del locale, e non si poteva fare a meno di ascoltarla. Ti conquistava con la sua eleganza e la sua presunzione, col tono veemente. Attorno a lui, gli occhi degli amici aspettavano la battuta fulminante alla fine di una storiella; allora tutti, anche gli estranei, ridevano fino alle lacrime. Alcuni si mettevano perfino ad applaudirlo. Sembrava che il suo nome fosse arcinoto, sia da quelli seduti al suo tavolo sia dal personale del ristorante. Il barista chiedeva a voce alta, dall’altra parte del locale: «Ancora un giro di bevute, James?», e in un attimo i boccali di birra riempivano la tavola. Non potevo evitare di fissarlo. Non ero la sola. Anche le mie amiche non potevano fare a meno di fissarlo, se lo mangiavano con gli occhi. Le donne sedute vicino a lui non perdevano occasione per toccarlo: un abbraccio, un colpetto sulla spalla. C’era una brunetta coi capelli che le arrivavano al fondoschiena che si sporgeva verso di lui per confidargli qualcosa, ma era un pretesto per un ulteriore contatto. Lui era l’uomo più baldanzoso che avessi mai visto. Allora frequentava la facoltà di diritto. Lo avrei appreso in seguito, la mattina dopo, quando mi risvegliai al suo fianco, a letto. Io e le mie amiche non eravamo abbastanza grandi per bere, perciò dev’essere stata la mia infatuazione a indurmi a cedere sconsideratamente, quella sera. Mi ero ritrovata al suo tavolo, seduta di fianco a lui, mentre la donna coi capelli lunghissimi aveva assunto un’espressione ostile e feroce quando James mi aveva passato un braccio sulla spalla. E poi il modo in cui lui aveva adulato il mio accento britannico, come se fosse la cosa migliore al mondo dopo il pane in cassetta… James allora era diverso, non l’uomo che è diventato col passare del tempo. I suoi difetti apparivano molto più sopportabili, la sua spavalderia era affascinante, non un tratto sgradevole del suo carattere, com’è ora. Sapeva lusingarmi da maestro, molto prima che la sua parlantina diventasse offensiva e intollerabile. C’è stato un periodo nella nostra vita in cui siamo stati felici, completamente stregati l’uno dall’altra, non riuscivamo a non saltarci addosso… Ma l’uomo che sposai è scomparso del tutto. Telefono all’ispettore Hoffman, è la prima cosa che faccio stamattina, dopo che James esce per andare in ufficio. Aspetto come sempre di udire la chiusura della serranda del garage, il rumore della monovolume che scende sul vialetto, prima di alzarmi dal letto e andare in cucina con la mia tazza di caffè, avendo fissa in testa solo la faccia dell’individuo che ha rapito Mia. Osservo l’orologio, attendo che la lancetta piccola completi il percorso sul quadrante e, quando le 8:59 lasciano il posto alle 9, compongo il numero che ormai, dopo tutti questi giorni, mi è diventato familiare. Lui risponde subito con la sua voce autorevole e professionale: «Ispettore Hoffman». Lo immagino all’interno della stazione di polizia, sento sullo sfondo l’affaccendarsi delle persone, le decine di agenti che cercano di risolvere i problemi altrui. Mi ci vuole un momento per concentrarmi e dirgli: «Detective, sono Eve Dennett». La sua voce si addolcisce mentre pronuncia il mio nome: «Signora Dennett, buongiorno». «Buongiorno». Lo rivedo nella nostra cucina, ieri sera; avevo notato il suo sguardo assente sul volto gentile quando James gli aveva raccontato i guai che combinava Mia. Se n’era andato in fretta. Ancora adesso riesco a sentire dentro di me il modo in cui aveva sbattuto la porta. Non avevo tentato di occultargli il passato di Mia. In tutta onestà, il comportamento che lei teneva non contava nulla. Ma l’ultima cosa che voglio è che l’ispettore nutra dei dubbi su di me. È il mio unico legame con mia figlia. «Dovevo chiamare», dico, «fornire una spiegazione». «Per ieri sera?», chiede, e io confermo. «Non ne ha bisogno». Lo faccio lo stesso. L’adolescenza di Mia è stata difficile, anni duri, a dir poco. Voleva disperatamente inserirsi, voleva essere indipendente. Era impulsiva, in balia dei desideri, e le mancava il buonsenso. Le amiche la facevano sentire accettata, ma non la famiglia. Tra i coetanei suscitava simpatie, la cercavano tutti, e per lei questa era una dose di autostima. Gli amici la facevano sentire in cima al mondo, non c’era niente che non avrebbe fatto per loro. «Forse Mia era capitata nel gruppo sbagliato di amici», dico. «Forse avrei dovuto controllare meglio per capire chi erano quelli con cui trascorreva il tempo. Avevo notato solo che i suoi temi da 7+ erano passati a 6-, e che non studiava più al tavolo della cucina, di pomeriggio, ma si ritirava a fare i compiti in camera sua, dopo aver chiuso a chiave la porta». Mia era in piena crisi di identità. Ciò rientrava nel suo anelito disperato di diventare adulta, anche se una parte di lei restava bambina, incapace di ragionare come avrebbe fatto in seguito. Si sentiva spesso frustrata, pensava poco a se stessa. E l’insensibilità di James peggiorava le cose. Lui la paragonava continuamente alla sorella Grace, ormai più che ventenne e al college, quello che aveva frequentato lui, ovviamente: stava per laurearsi col massimo dei voti, e con la lode. Le ripeteva che Grace seguiva anche lezioni di latino e di retorica per la successiva specializzazione in diritto, a cui si era già iscritta. All’inizio gli errori di Mia si limitavano alla normale indisciplina degli adolescenti: disturbare in classe, non finire i compiti per casa. Non invitava quasi mai le compagne in casa. Quando venivano degli amici o delle amiche a prenderla, andava ad aspettarli sul vialetto e, se spiavo dalla finestra, mi inchiodava subito: «Cosa fai?», diceva con un tono di rimprovero che una volta apparteneva solo a Grace. Quando la sorprendemmo a uscire di casa nel cuore della notte, aveva quindici anni. Era la prima di una delle sue tante fughe. Aveva dimenticato di staccare il sistema d’allarme, per cui era scoppiato il finimondo proprio mentre se la dava a gambe. «È una delinquente minorenne», disse James. «È una ragazzina», corressi, osservandola mentre saliva su un’auto parcheggiata alla fine del vialetto, senza premurarmi né del sistema d’allarme che fischiava a tutto spiano, né di guardare James che malediva il congegno perché aveva scordato la password. Per mio marito, l’apparenza è tutto. Da sempre. Era sempre consapevole di dover difendere la propria reputazione, pensava costantemente a quello che la gente avrebbe detto o creduto di lui. Sua moglie doveva essere un trofeo da mostrare, me lo confessò ancor prima delle nozze e, in un modo perverso, ero contenta di svolgere quel ruolo. Non chiesi cosa significasse il fatto che avesse smesso di invitarmi alle cene coi colleghi, o che ritenesse ormai superfluo che le bimbe partecipassero alle feste di Natale del suo ufficio. E poi, quando venne eletto giudice, fu come se non esistessimo più. Si può quindi immaginare come si fosse sentito James quando la polizia locale aveva riportato a casa da una festa una sedicenne ubriaca e scarmigliata: lui se ne stava in attesa davanti all’ingresso, in vestaglia, costretto a implorare gli agenti di non far trapelare niente. Poi la sgridò nonostante lei stesse ancora male: non riusciva nemmeno a tenersi la testa sulla tazza del bagno per vomitare. Sbraitava perché i cronisti famelici amavano tanto sguazzare in questa melma: «Figlia adolescente del giudice Dennett denunciata per consumo illegale di alcol», avrebbero titolato. Naturalmente, la cosa non finì sui giornali. Lui si adoperò nel modo giusto, fece le mosse corrette. Adottò ogni trucco per assicurarsi che il nome di Mia non comparisse mai sulla stampa locale, neanche in futuro. Lo stesso accadde quando lei, insieme ai suoi amici scalmanati, cercò di rubare una bottiglia di tequila dalla rivendita di liquori, o quando insieme agli stessi disgraziati venne sorpresa a fumare erba, dentro un’auto parcheggiata dietro un centro commerciale dalle parti di Green Bay Road. «È un’adolescente», dicevo a mio marito. «I ragazzi fanno di queste cose». Eppure, nemmeno io ne ero tanto sicura. Malgrado tutte le sue difficoltà, Grace non era mai stata nei guai con la legge. Niente, neanche una multa per eccesso di velocità, ed ecco qui Mia, in stato di fermo in una cella della stazione di polizia locale, mentre James pregava o ricattava le autorità giudiziarie affinché non la incriminassero o cancellassero le accuse dagli schedari. Metteva a tacere con il denaro perfino gli altri genitori purché non menzionassero ai loro figli, altrettanto complicati, le disavventure di Mia. Però non era mai preoccupato per lei, per le motivazioni del suo disagio e quindi del suo comportamento scorretto. Si premurava solo per gli effetti che le azioni di Mia avrebbero causato a lui. Non gli passava per l’anticamerca del cervello che, se le avesse fatto pagare le conseguenze delle sue azioni, come si fa con qualsiasi f i g l i o normale, forse sarebbero cessate le sue intemperanze. Così, lei poteva fare tutto quel che le pareva senza pagarne il fio. Le malefatte di Mia erano la cosa che mandava più di tutto in bestia James: per la prima volta, lei riusciva ad attirare le attenzioni paterne. «Origliavo le conversazioni telefoniche di Mia con le amiche e venivo così a sapere che rubavano gli orecchini nei negozietti, come se non potessimo permetterci di pagarli. Dopo che prendeva in prestito la mia auto per un qualsiasi motivo, l’abitacolo puzzava di fumo di sigarette, ma ovviamente mia figlia non fumava. E neanche beveva…». «Signora Dennett», mi interrompe l’ispettore. «Gli adolescenti rientrano in una categoria speciale. Cedono alle pressioni degli amici per conformarsi al gruppo. Sfidano i genitori. Rimbeccano alle sgridate, fanno esperienza di tutto quello su cui possono mettere le mani. Noi dobbiamo solo fare in modo che sopravvivano a questo periodo delicato, e senza riportarne danni permanenti. Ciò che mi racconta di Mia non è affatto anomalo», conclude. Io ho la sensazione che direbbe qualsiasi cosa pur di farmi stare meglio. «Le potrei confidare le tantissime stupidaggini che facevo a sedicidiciassette anni», ammette. Le snocciola una dopo l’altra: sbronze, tamponamenti, falsificazione degli esami, droghe leggere, quasi sussurra nella cornetta del telefono. «Perfino le brave ragazze hanno la tentazione di rubacchiare gli orecchini in un centro commerciale. Gli adolescenti ritengono di essere invincibili e che non possa succedere niente di male. Solo più avanti con gli anni si accorgono che le cose brutte accadono veramente. I figli senza difetti, quelli impeccabili», aggiunge, «mi preoccupano molto di più». Gli spiego che Mia è cambiata da quando aveva diciassette anni, tento disperatamente di presentargliela come qualcosa di più che una minorenne con tendenze delinquenziali. «È maturata», e c’è dell’altro. Lei è letteralmente sbocciata, è diventata una giovane e bellissima donna. Il tipo di donna che, da bambina, avrei tanto voluto essere io. «Sono certo che è così», dice, ma non posso finirla lì. «Ci saranno stati un paio d’anni, forse tre, di pericolose imprudenze, poi però lei invertì la rotta. Aveva visto la luce in fondo al tunnel: presto avrebbe compiuto il diciottesimo anno di età e avrebbe potuto liberarsi di noi, una volta per tutte. Sapeva ciò cosa voleva. Aveva iniziato a fare progetti. Un posto in cui vivere da sola, la libertà. E poi voleva aiutare il prossimo». «Gli adolescenti», dice, e mi riduce al silenzio perché, senza averla mai vista, vedo che conosce mia figlia meglio di me. «Quelli che si cacciano nei guai e si sentono incompresi. Come lei». «Sì», mormoro piano, anche se Mia non me l’ha mai detto chiaro e tondo. Non ci siamo mai sedute a parlare del modo in cui sarebbe entrata in relazione coi ragazzi, o del modo in cui lei, più di ogni altra, avrebbe saputo capire le difficoltà dei giovani, con le loro emozioni contraddittorie; di quanto fosse difficile, per loro, tornare a galla e respirare. Non l’ho mai capito. Per me, era una cosa superficiale, e non riuscivo a immaginare come lei avrebbe potuto comunicare con loro. Questa non è una situazione definita: bianco, o nero; ricchi, o poveri. È implicata la natura umana. «James non si è mai dimenticato l’immagine della figlia rinchiusa nella guardina della stazione di polizia. Per lui, contano tutti gli anni che ha combattuto per impedire che il nome di Mia comparisse sulle pagine dei giornali scandalistici, e si arrovella ancora per la delusione che lei gli ha dato. Mia non voleva ascoltarlo. Rifiutava di credere che la laurea in giurisprudenza fosse la ciliegina sulla torta della sua vita. Per James, lei era un peso. Mio marito non ha mai superato questa fase, non ha mai accettato che diventasse la donna forte e indipendente che è oggi. Per lui, è…». «Una casinista», l’ispettore termina la mia frase in modo appropriato, e gli sono grata che sia stato lui a pronunciare quella parola. «Sì». Ripenso a quando avevo diciotto anni, alle mie emozioni che contraddicevano il buonsenso. Come sarei finita se non mi fossi recata in quel pub irlandese del Loop di Chicago, in quella serata di luglio del 1969? Cosa mi sarebbe successo se James non fosse stato lì, se non avesse disquisito sulle leggi antitrust, se non avessi bevuto fino all’ultimo le sue parole, se non fossi rimasta ammaliata quando aveva girato lo sguardo verso di me? Non solo per la Federal Trade Commission, le fusioni e le acquisizioni industriali, ma anche per la maniera che aveva di trasformare argomenti così aridi in qualcosa di eccitante, facendo brillare i suoi occhi scuri dentro i miei? Se l’istinto materno non mi convincesse altrimenti, ci sarebbe una parte di me che sarebbe disposta a condividere il punto di vista di James. Ma non lo ammetterei mai. Il mio intuito mi dice al contrario che a mia figlia è accaduto qualcosa. E qualcosa sento urlare dentro sveglia nel cuore qualcosa è accaduto a di brutto. Lo di me, mi della notte: Mia. Colin Prima Le dico che usciamo. È la prima volta che la porto fuori dal capanno. «Ci servono dei rami per il fuoco», dico. Presto nevicherà e verranno tutti sepolti sotto la neve. «Ma abbiamo la legna da ardere», dice lei. È seduta a gambe incrociate sulla sedia, di fianco alla finestra. Fissa le nuvole grigie, basse e opprimenti, che sono sospese al di sopra degli alberi. Non la guardo. «Ne abbiamo bisogno di più, per l’inverno». Si alza lentamente, stirandosi. «Hai intenzione di tenermi qui così a lungo?», chiede, infilandosi dalla testa il brutto felpone rossiccio. Non le do la soddisfazione di una risposta. Uscendo, mi metto proprio dietro di lei. Lascio che la porta a zanzariera sbatta quando si chiude. Mi precede scendendo i gradini. Comincia a raccogliere i bastoncini da terra, ce ne sono a tonnellate, tutti i rametti caduti dagli alberi durante il maltempo. Sono bagnati. Mescolati al fango e alle foglie marce che coprono il terreno. Lei li ammucchia in fondo ai gradini e si pulisce le mani sui pantaloni. Abbiamo i vestiti stesi ad asciugare fuori. Li laviamo nella vasca da bagno e poi li stendiamo lì. Usiamo un pezzo di sapone, oppure niente. Quando li indossiamo di nuovo, sono freddi e irrigiditi, a volte ancora umidi. Sul lago incombe una nebbia densa, che poi si sposta verso il capanno. Una giornata deprimente. Il cielo è pieno di nuvole gonfie di pioggia. Presto comincerà a piovere. Le dico di sbrigarsi. Mi chiedo quanto dureranno gli arbusti. Dentro il capanno abbiamo già tanta legna da bruciare addossata a una parete. Uscivo ogni giorno con l’ascia, spaccavo i tronchi caduti e tagliavo i rami più grossi. Però ho voluto che raccogliessimo anche questi legnetti piccoli, per non annoiarci. Passiamo meglio il tempo così. Lei non se ne lamenta di certo: l’aria è fresca, e ne gode il più possibile. Non sa se avrà mai un’altra occasione simile. La osservo mentre raccoglie i rametti. Li posa su un braccio mentre si piega per arraffarne ancora dal terreno con l’altro. Esegue un movimento rapido e aggraziato. Ha legato i capelli, che le cadono su una spalla, per avere sempre la vista libera. Raccoglie questa roba finché non riesce più a tenerla su un braccio, allora si ferma per riprendere fiato. Si stira, tende la schiena ad arco. Poi si abbassa di nuovo. Quando il carico è pesante, lo ammucchia davanti al capanno. Evita di stabilire un contatto visivo con me, anche se certamente sa che la osservo. Ogni volta che scarica un mucchio, si avventura sempre più lontano, e i suoi occhi azzurri sono attirati dal lago. La libertà. Inizia a piovere. Uno scroscio torrenziale: prima niente, dopo un minuto siamo inzuppati. La ragazza torna di corsa dall’estremità del nostro terreno, con una fascina tra le braccia. L’avevo lasciata libera di andarci purché lavorasse. Le tenevo gli occhi addosso, accertandomi di poterla riprendere se ce ne fosse stato bisogno. Non credo che farà di nuovo la stupida. Sto già cominciando a portare questa legna su per i gradini e dentro il capanno. La ammucchio di fianco alla stufa. Lei mi segue all’interno, scarica l’ultima fascina e poi scende ancora gli scalini. Non mi aspettavo questa collaborazione. Lavora più lentamente di me. Le fa ancora un po’ male la caviglia, ma è da ieri che non la vedo zoppicare. Ci sfioriamo sui gradini ed è quasi senza pensarci che mi viene da dirle «scusa». Lei non risponde. Si cambia i vestiti e li appende all’asta delle tende, in soggiorno. Io avevo già raccolto i panni stesi all’esterno e li avevo appoggiati dentro. Col tempo, li asciugherà il fuoco, se non altro. Il capanno gronda umidità. Fuori, la temperatura sarà scesa di dieci gradi. Rientrando, abbiamo lasciato impronte sporche e bagnate. I rametti stillano acqua piovana sul pavimento di legno. Le dico di trovare uno straccio nel bagno e di pulire il più possibile. Il resto si asciugherà, prima o poi. Preparo la cena. Lei si dirige in silenzio verso la sua sedia e scruta la pioggia dalla finestra. Le gocce tamburellano sul tetto, un rumore continuo. Un paio dei miei pantaloni appesi all’asta delle tende le rovina il panorama. Il mondo è soffocato dalla nebbia, prevale l’indistinto. Mi cade di mano una tazza e lei ha un sussulto, mi squadra con occhi accusatori. Faccio rumore, lo so. Non tento nemmeno di fare piano. Le scodelle sbattono sul piano di lavoro, chiudo gli sportelli con forza. Ho il passo pesante. Mi cadono di mano i cucchiai, che ticchettano sul piano di lavoro arancione scuro. Sulla stufa comincia a bollire la pentola, da cui esce dell’acqua. Scende la sera. Consumiamo il pasto in silenzio, grati per il rumore della pioggia. Guardo dalla finestra il buio che conquista il cielo. Accendo la lucina e inizio ad alimentare il fuoco coi rametti. Lei mi controlla di sottecchi, mi chiedo cosa possa vedere. All’improvviso sento un rumore all’esterno e balzo in piedi, intimandole di fare silenzio, benché lei non abbia aperto bocca. Prendo la pistola e la stringo forte in mano. Sbircio fuori dalla finestra e noto che il vento ha fatto cadere il barbecue: che sollievo! Lei mi fissa, guarda come sposto le tende per controllare il prato, per maggiore sicurezza. Potrebbe esserci qualcuno. Richiudo le tende e mi rilasso. Lei mi osserva ancora, nota sul mio maglione una macchia che sta lì da due giorni, i peli scuri sul dorso delle mie mani, la maniera disinvolta con cui tengo la pistola, come se non avesse la capacità di metter fine alla vita di una persona. La guardo e dico: «Cosa c’è?». È seduta in modo scomposto di fianco alla finestra, come al solito. Ha i capelli lunghi, ondulati. Stanno guarendo le abrasioni sul volto, però nei suoi occhi permane la paura. Ancora sente l’arma che le avevo premuto contro la tempia e sa, mentre mi fissa da tre metri di distanza, che lo rifarò, è solo questione di tempo. «Cosa stiamo facendo qui?», chiede. Una frase intenzionale, pronunciata con forza. Finalmente ha avuto il coraggio di domandarlo. Voleva farlo dal momento in cui siamo arrivati. Il mio sospiro è lungo, esasperato. «Non preoccuparti», dico dopo una pausa. Una risposta spiccia ed estemporanea per metterla a tacere. Invece non tace: «Cosa vuoi da me?». Il mio volto è ingessato in un’espressione impassibile. Non voglio aver niente a che fare con lei. «Niente», rispondo. Attizzo il fuoco spostando i legnetti. Non la guardo nemmeno. «Allora lasciami andare». «Non posso». Mi tolgo una maglia e la poso ai miei piedi sul pavimento, di fianco alla pistola. Il fuoco riscalda il capanno, almeno qui. La stanza da letto è fredda. Di solito, lei s’infila sotto le coperte con maglione, pantaloni termici e calzini, eppure rabbrividisce a lungo prima di addormentarsi. Lo so perché mi sono messo a osservarla. Mi chiede di nuovo cosa voglia da lei. È ovvio che voglio qualcosa, sostiene. Perché mai l’avrei portata via dal mio appartamento per tenerla lì? «Mi avevano commissionato un lavoro. Rapirti e lasciarti dalle parti di Lower Wacker. Dovevo consegnarti a qualcuno. Tutto qua. Poi avrei dovuto sparire». La Lower Wacker Drive è il tratto finale di una strada su due livelli, nel centro storico di Chicago, e ha una galleria talmente lunga che non saprei dire quanto. Glielo vedo negli occhi, lo sconcerto. Distoglie lo sguardo, fissa dalla finestra il buio della notte. Ci sono parole che non co m pre nde : lavoro, consegnarti, sparire. Per lei era più realistico pensare che tutto questo fosse successo per caso. Che un pazzo l’avesse sequestrata così, per scherzo. Dice che l’unica cosa che sa della Lower Wacker è che era solita andarci con la sorella quando erano ragazzine, le piaceva vederla illuminata da luci verdi fluorescenti, che adesso non ci sono più. È il primo ricordo personale che mi racconta. «Non capisco», dice, aspettando disperata una risposta. «Non conosco tutti i dettagli. Riscatto», dico. Mi sto arrabbiando, non ne voglio discutere. «Allora perché siamo qui?». I suoi occhi implorano una spiegazione. Mi guarda con un misto di disorientamento, frustrazione e presunzione. Una domanda maledettamente azzeccata, penso. Avevo controllato le notizie su di lei online, prima di catturarla. So qualcosina sul suo conto, sebbene lei ritenga che non sappia un accidente. Ho visto le foto della sua famiglia, mondani come sono coi loro abiti firmati, ricchi e incazzati allo stesso tempo. So quando il padre era diventato giudice. So quand’è che si deve ripresentare alle elezioni. Ho visto dei filmati su di lui, diffusi in rete. So che è uno stronzo. Si assomigliano tutti in famiglia. Le voglio dire di lasciar perdere. Di chiudere il becco. Invece dico: «Ho cambiato idea. Nessuno sa che siamo qui. Se lo sapessero, ci ucciderebbero. Tutti e due». Si alza e prende a gironzolare nella stanza. Cammina a passi leggeri, tiene le braccia avvolte al corpo. «Chi?», mi chiede. Quelle parole, «ucciderebbero, tutti e due», le tolgono il respiro. La pioggia cade, se possibile, ancora più forte. Lei si piega per udire bene le mie parole. Sono in piedi sul pavimento di legno del capanno ed evito il suo sguardo avido di risposte. «Non preoccuparti», dico. «Chi?», insiste. Allora le riferisco il nome di Dalmar. Più che altro per indurla al silenzio. Le racconto del giorno in cui lui mi aveva scovato e dato una foto di lei. Mi aveva detto di trovare la ragazza e consegnargliela. Lei mi volta le spalle e mi lancia in tono accusatorio: «Allora perché non l’hai fatto?». Vedo l’odio che la pervade tutta, dalla testa ai piedi, e penso che avrei dovuto farlo. Avrei dovuto cederla a Dalmar ed eclissarmi. A quest’ora sarei a casa, pieno di soldi con cui saldare conti e bollette, per il vitto e i debiti. Non dovrei premurarmi di quel che ho lasciato dietro di me, di come le cose stanno andando avanti, a casa, del modo in cui lei potrà sopravvivere, e di quello con cui la avvicinerò prima di scappare. Mi ritrovo a pensare continuamente a queste cose. Mi tengono sveglio tutte le notti. Quando non sono in ansia per quel che mi faranno Dalmar o la polizia, penso a lei, da sola in quella vecchia casa. Se avessi consegnato la ragazza, com’era mio dovere, tutto questo sarebbe già finito. L’unica cosa di cui dovrei preoccuparmi sarebbero i poliziotti alle mie calcagna. Ma non è una novità. Non rispondo alla sua sciocca domanda. È qualcosa che lei non ha bisogno di sapere. Non ha bisogno di sapere perché ho cambiato idea, o perché l’ho portata qui. Per contro, le racconto ciò che so su Dalmar. Non so perché lo faccio. Forse perché sappia che non sto scherzando. Così, avrà paura. Capirà che stare lì con me è l’alternativa migliore, la sola alternativa. Gran parte di quello che so su Dalmar sono informazioni di seconda mano. Voci secondo le quali lo si ritiene un ex bambinosoldato, uno di quelli che, in Africa, subivano il lavaggio del cervello e venivano indotti a uccidere. Si racconta che avesse picchiato un uomo d’affari in un magazzino abbandonato, dalle parti del West Side, perché non gli ripagava un debito. Che avesse ucciso un ragazzino di nove o dieci anni perché i genitori non erano in grado di versare il riscatto; dopo averlo freddato, aveva spedito ai genitori le foto per girare il coltello nella piaga, per provare un piacere perverso. «Solo bugie», dice lei. Però ha il terrore negli occhi. Sa che non mento. «Come fai a esserne certa?», chiedo. «Hai un’idea di quel che ti avrebbe fatto se ti avesse messo le mani addosso?». Torture e violenza carnale sono le cose che mi vengono in mente. Lui ha una tana a Lawndale, un tugurio a South Homan dove sono stato un paio di volte. È lì che immagino avrebbe rinchiuso la ragazza, in quella casa di mattoni con la scalinata rotta che conduce al portone. Un tappeto pieno di macchie. Le prese degli elettrodomestici staccate e inservibili perché all’ultimo proprietario, insolvente, era stato tolto il diritto di riscatto dell’ipoteca. Infiltrazioni d’acqua dal soffitto, pareti ammuffite. I vetri infranti delle finestre rimpiazzati da pannelli di plastica. Lei, al centro di una stanza, legata e imbavagliata. In attesa, solo in attesa. Mentre Dalmar e i suoi scagnozzi si sarebbero divertiti con lei. E anche dopo il pagamento del riscatto da parte del giudice, immagino che Dalmar avrebbe detto a uno dei suoi di ammazzarla. Eliminare le prove. Di scaricarla in un cassonetto in città, magari nel fiume. Le racconto queste cose e poi dico: «Una volta entrata in questo tipo di casini, non c’è verso di uscirne». Lei non apre bocca. Non fa parola di Dalmar, sebbene io sappia che pensa a lui. So che ha stampata in testa la sua immagine mentre spara a un bambino di nove anni. Gabe Prima Il sergente mi dà il via libera per far trasmettere l’identikit del rapitore nei telegiornali del venerdì sera. Cominciano a pervenire informazioni. Tanta gente chiama il numero d’emergenza per dirci di conoscere il nostro uomo. Solo che per alcuni si chiama Tom e per altri Steve. Una certa signora è convinta di essere stata sulla metropolitana con lui la sera prima, ma non può giurarci (C’era una donna insieme a lui? No, era solo). Un altro tizio sostiene che il ricercato lavorava come custode nell’edificio di State Street, ritiene che sia di origine ispanica, mentre io devo ribadirgli che non lo è. Ho delegato la gestione di questa linea rossa a un paio di reclute: devono passare al setaccio le informazioni attendibili da quelle che porterebbero in un vicolo cieco. La mattina dopo, il succo della questione si riduce a questo: o nessuno ha idea di chi sia l’uomo dell’identikit, oppure lo si conosce sotto un numero tale di falsi nomi e pseudonimi da costringere una caterva di poliziotti a ricerche inutili per il resto dell’anno. Rendermene conto mi fa impazzire. Il nostro individuo potrebbe essere più esperto di quanto credessi. Rifletto a lungo su di lui. Riesco a immaginare molte cose sul suo conto senza averlo mai conosciuto, senza nemmeno sapere il suo nome. Non ci sono dei fattori precisi che inducono una persona a darsi a comportamenti violenti o antisociali. Spesso è l’insieme delle circostanze. Sono certo che le sue condizioni socioeconomiche non lo collocano nello stesso ambiente della famiglia Dennett. Immagino che non abbia mai frequentato l’università, o che abbia avuto problemi a trovare un lavoro e tenerselo stretto. Suppongo che, da piccolo, non abbia avuto legami forti con molti adulti. Forse non ne ha avuto nessuno. Probabilmente si sentiva alienato. Forse i suoi genitori non lo consideravano e fra loro c’erano problemi coniugali. Potrebbe anche aver subìto degli abusi. Forse non si dava abbastanza peso alla sua istruzione, e nella sua famiglia mancava l’affetto. Nessuno gli rimboccava le coperte prima di dormire, né gli leggeva dei libri, forse. Presumibilmente non andavano a messa, o non erano religiosi. Non è detto che, da piccolo, fosse crudele con gli animali domestici. Magari era iperattivo e faticava a concentrarsi. Probabilmente era depresso, violento o antisociale. Forse si sentiva alla deriva, incapace di controllarsi. Non ha mai imparato a essere flessibile. Non sa cosa siano l’empatia e la comprensione. Non sa come risolvere una divergenza senza sferrare un pugno o puntare una pistola. Ho seguito dei corsi di sociologia e conosciuto un numero sufficiente di detenuti che coincidono tutti con queste caratteristiche particolari. Non è detto che il rapitore assuma stupefacenti, però potrebbe averlo fatto. Forse non è cresciuto nelle case popolari, o forse sì. Non è scontato che faccia parte di una banda criminale, comunque non lo escluderei del tutto. E nessuno può dire se i suoi genitori possedessero un’arma. Presumo tuttavia che non sia mai stato molto coccolato. A tavola, la sera, prima di consumare il pasto, la sua famiglia non pregava mai. Non facevano scampagnate, né si stringevano tutti insieme sul divano per guardare un film in TV. Suppongo che il padre non lo abbia mai aiutato a fare i compiti di aritmetica. La mia ipotesi è che almeno una volta uno dei genitori si sia dimenticato di andarlo a prendere all’uscita della scuola. Immagino che, a un certo punto della sua vita, nessuno facesse più attenzione a quello che guardava alla televisione. E sono certo che qualcuno di cui si fidava, che avrebbe dovuto sapersi comportare meglio, lo abbia schiaffeggiato. Faccio zapping: i Bulls stanno facendo schifo, Illinois ha appena perso coi Badgers5. Una pessima serata televisiva per me. Prima di fermarmi su It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, ripeto un altro giro sui circa duecento canali del mio apparecchio (chi ha detto che i soldi non fanno la felicità?): per mia grande fortuna, m’imbatto nella faccia del giudice Dennett che tiene una conferenza stampa all’interno del telegiornale delle sei. «Che cazzo?», sbotto prima di alzare il volume per sentire bene. Di norma accanto a lui ci dovrebbe essere l’ispettore incaricato delle indagini – verrebbe da pensare – che se non altro avrebbe dovuto essere al corrente della conferenza stampa. Invece, al mio posto c’è il sergente, amicone del giudice da quando questi aveva lavorato nell’ufficio del procuratore distrettuale, molto prima che si dedicasse al privato. Dev’essere bello avere amici in posti altolocati. L’insigne Eve compare a fianco del marito, gli tiene la manina (sono sicuro che sia una cosa preparata, perché non avevo mai notato gesti affettuosi tra loro); Grace, accanto alla madre, ammicca alle telecamere, come se fosse l’occasione per il suo debutto da attrice. Il giudice sembra veramente addolorato per la scomparsa della figlia, e non c’è dubbio che qualche avvocato o consigliere politico gli abbia suggerito cosa dire o fare nei più piccoli particolari: per esempio, tenere la moglie per mano, o cadere in qualche lapsus volontario per poi fingere di tornare padrone di sé, sebbene io non lo abbia ancora mai visto perdere la calma. Un giornalista tenta di rivolgere una domanda, ma gli negano il permesso, e il portavoce della famiglia interviene per accompagnare dal marciapiede all’interno della loro dimora il giudice, la moglie e la figlia. Il sergente resta in onda abbastanza a lungo da annunciare a tutto il mondo di aver sguinzagliato i suoi detective migliori affinché risolvano il caso, come se questo dovesse rabbonirmi, prima che la scena torni in uno studio televisivo di Michigan Avenue. Qui un mezzobusto ricapitola le vicende del rapimento di Mia, mostrando per un attimo sullo schermo anche l’identikit dell’uomo che cerchiamo. Dopodiché si passa al devastante incendio di un grattacielo nel South Side. 5 Nel primo caso si tratta di baseball, nel secondo di football. (n.d.t.) Colin Prima Mi rincresce farlo, ma non c’è altro modo. Non mi fido di lei. Aspetto che sia entrata nel gabinetto e poi la seguo con una corda. Avevo anche pensato al nastro isolante sottratto a Grand Marais, ma non ce n’è bisogno. Non c’è nessuno nei dintorni che possa udire i suoi strilli. «Cosa stai facendo?». È davanti al lavandino che si strofina i denti con un dito. Col terrore negli occhi, mi guarda entrare nel bagno con la corda, senza che mi abbia chiamato. Prova a fuggire, ma la intrappolo fra le mie braccia. È semplice. In questi giorni è fragile, non tenta nemmeno di opporsi. «Non ci sono altre maniere», dico, e lei dà in escandescenze, mi accusa di essere bugiardo, un testa di cazzo. Le lego la corda ai polsi, poi la fisso alla base del lavandino. Roba da boyscout. Non uscirà mai di lì. Prima di andarmene, mi assicuro di chiudere la porta d’ingresso a chiave. Ho imparato gran parte di quel che so negli scout, da ragazzino. Il maestro di quarta era un capo scout, nel periodo in cui m’importava ancora veramente di quello che gli insegnanti pensavano di me. Non ricordo neppure quante medaglie mi sono guadagnato: tiro con l’arco, escursionismo, canoa, campeggio, pesca, tecniche di pronto soccorso. Ho imparato a sparare col fucile, a capire quando c’è brutto tempo in arrivo, a sopravvivere in una bufera di neve, ad accendere il fuoco, a fare i nodi (nodo sabaudo, nodo inglese, nodo di sicurezza). Non si sa mai quando possano tornare utili queste cose. Avevo quattordici anni, scappai di casa col mio amico Jack Gorsky, un ragazzo polacco che abitava in fondo alla via. Siamo stati irrintracciabili per tre giorni. Eravamo riusciti ad arrivare fino a Kokomo, poi i poliziotti ci hanno trovato accampati in un cimitero abbandonato, tra tombe secolari. Ci eravamo ubriacati con la bottiglia di vodka della signora Gorsky che Jack aveva messo nel suo zaino prima di uscire di casa. Era marzo. Avevamo acceso un fuoco solo con la legna. Il mio amico era inciampato su una pietra e si era sbucciato il ginocchio. Io glielo avevo medicato con le garze e il contenuto della cassetta di pronto soccorso che mi ero portato dietro. Una volta provai ad andare a caccia con Jack Gorsky e suo padre. Avevo dormito a casa loro, e ci svegliammo alle cinque di mattina, ci vestimmo e ci inoltrammo nei boschi. Loro erano cacciatori professionisti con tutto l’occorrente: fucili e balestre, binocoli, visori notturni, munizioni. Io ero un dilettante, mi ero messo un maglione verde bosco che avevo acquistato da Wal-Mart il giorno prima. Jack e il padre avevano le tute mimetiche che il signor Gorsky aveva riportato dalla guerra del Vietnam. Lui individuò un cervo dalla coda bianca, un animale splendido, un maschio con palchi ramificati da cui non riuscivo a staccare gli occhi. Era la prima volta che cacciavo. Il signor Gorsky pensava che toccasse a me sparare il primo colpo. Così mi accovacciai per mettermi in posizione e presi di mira il cervo, fissando quegli occhi neri che mi sfidavano a sparare. «Prenditi il tuo tempo, Colin», disse il padre. Ero certo che vedesse quanto mi tremava il braccio, come se fossi una femminuccia. «Attenzione!». Mancai di proposito il bersaglio, spaventando il bellissimo esemplare e facendolo fuggire. Il signor Gorsky disse che accadeva a tutti così, che la prossima volta sarei stato più fortunato. Jack mi dette del finocchio. Poi fu il suo turno. Vidi il mio amico sparare a un cerbiatto proprio in mezzo agli occhi, dopodiché mamma cerva guardarlo morire. La volta seguente che mi invitarono a caccia dissi che ero malato. Qualche tempo dopo, non molto, Jack venne chiuso in riformatorio perché aveva minacciato un professore con la pistola del padre. Sto percorrendo la County Line Road, dopo aver superato la Trout Lake Road, quando me ne rendo conto: potrei proseguire e non tornare indietro. Oltre Grand Marais, via dal Minnesota, fino al Rio Grande. La ragazza è legata, non c’è verso che possa scappare. Non può chiamare la polizia e tradirmi. Anche se riuscisse a slegarsi, cosa impossibile, le ci vorrebbero ore per raggiungere a piedi un posto civile. Nel frattempo, io sarei già in South Dakota, o da qualche parte nel Nebraska. La polizia diramerebbe un «avviso a tutte le unità», ma tutto quello che la ragazza sa di me è che dovrei chiamarmi Owen, per cui ho buone possibilità di cavarmela, a meno che non si sia stampata in mente il numero di targa. Mi crogiolo in quest’idea: abbandonare lo schifoso capanno e scomparire. Eppure, ci sono tantissime cose che potrebbero andare storte. È probabile che la polizia ormai sappia che sono con lei. Forse hanno scoperto il mio nome. Forse hanno già diramato davvero un avviso a tutte le loro unità sul mio conto. Forse lo stesso Dalmar ha già fatto una soffiata alle autorità per vendicarsi. Ma non sono queste le idee che mi trattengono dal filarmela. Vedo la ragazza legata al lavandino del cesso, in una zona disabitata, per tutta la bassa stagione. Non la troverebbe nessuno. Se non dopo essere morta di fame. Se non a primavera, al ritorno dei turisti, attirati verso il capanno dall’odore della putrefazione. Ecco cosa mi tiene in carreggiata. Uno dei motivi che mi impediscono di darci un taglio e svignarmela, sebbene ne sia tentato. E forse ne abbia bisogno. Anche se so che qualsiasi giorno di permanenza in più è un ulteriore chiodo che sigilla la mia bara. Non so per quanto tempo sono rimasto fuori. Sicuramente ore. Quando torno, chiudo la porta con forza. Mi presento sulla soglia del bagno con un coltello. Noto che la ragazza comincia ad avere paura, ma non dico nulla, mi abbasso verso di lei e taglio la corda con cui l’avevo legata. Le allungo una mano per aiutarla a rimettersi in piedi. Lei mi spinge via, io perdo l’equilibrio e sono costretto ad appoggiarmi alla parete. Lei è malferma sulle gambe, si passa le mani sui polsi segnati dalla corda. «Perché ci hai provato?», chiedo, afferrandole le mani per guardare meglio. Era stata accovacciata tutto il giorno a tentare di slegarsi. Mi colpisce più forte che può. Poca roba. Le afferro un braccio per farla smettere. Le faccio male, me ne accorgo dal modo in cui si immobilizza. «Pensavi che ti avrei abbandonata qui?», esclamo. La allontano da me con decisione e dico: «La tua faccia compare in televisione, non potevo portarti con me». «L’ultima volta mi hai portato». «Adesso sei conosciutissima». «E tu?» «Non gliene frega un cazzo a nessuno di dove sono». «Sei un bugiardo». Vado in cucina a sistemare le cose. Le sporte di carta vuote cadono a terra. Altra roba da ardere. Si accorge della nuova canna da pesca che ho appoggiato di fianco alla porta. «Dove sei stato?» «A procurarmi questa roba». Sono brusco, sto andando fuori di testa. Caccio il cibo in scatola nella dispensa, sbatto gli sportelli. Poi mi fermo. Smetto di riporre le cose e mi fermo a guardarla. Non capita spesso. «Se avessi voluto ucciderti, saresti già morta. Là fuori c’è un lago che sta gelando. Non ti ripescherebbero fino alla prossima primavera». Nella caligine pomeridiana, guarda dalla finestra il lago gelato. Il pensiero del suo corpo inanimato sotto la superficie lacustre le fa venire i brividi. E poi lo faccio. Prendo la pistola dall’armadietto, lei si volta per scappare. Le agguanto un braccio e le metto con forza l’arma nelle mani. La cosa ci sorprende entrambi. La sensazione della pistola, del metallo pesante, la immobilizza. «Prendila», insisto. Non vuole. «Prendi la pistola», urlo. Lei la tiene nella sue mani tremanti e per poco non la fa cadere a terra. Le afferro le mani e gliele stringo attorno all’arma. La costringo a posare l’indice sul grilletto. «Qui, lo senti? Ecco come si fa a sparare. La punti contro di me e fai fuoco. Credi che ti stia mentendo? Credi che voglia farti del male? È carica. Prendi la mira e sparami». Se ne sta con l’arma in mano, imbambolata. Si sta chiedendo cosa diavolo sia successo. La solleva per un attimo, sente che il suo peso è molto maggiore di quel che credeva. La punta contro di me e io la guardo negli occhi, sfidandola. Spara, dài, ammazzami. Non sa sostenere lo sguardo, le sue mani tengono la pistola in modo incerto. Non ha la forza dentro di sé per fare fuoco. Lo so. Eppure, mi meraviglio. Rimaniamo così per una ventina di secondi, trenta forse, prima che lei abbassi l’arma ed esca dalla stanza. Eve Dopo Mi racconta il sogno che ha fatto. La vecchia Mia non mi avrebbe detto molto di quello che le frullava per la testa. Ma quest’esperienza onirica la tormenta, si tratta di un sogno ricorrente che afferma di fare da non so quante notti, sempre identico, almeno a sentire lei. Si vede seduta su una sedia da giardino in plastica bianca, dentro l’unico stanzone di un piccolo capanno. La sedia è addossata alla parete opposta rispetto alla porta d’ingresso, e lei vi si accoccola, con una coperta ruvida buttata sulle gambe. Sente freddo da morire, trema in modo incontrollabile, sebbene sia profondamente addormentata, col corpo stanco pencolante sul bracciolo. Indossa una brutta felpa bordeaux che ha ricamato sul davanti una strolaga maggiore, con le parole L’ÉTOILE DU NORD6 cucite sotto. Nel sogno, vede se stessa mentre dorme. Il buio del capanno la avvolge e la soffoca. Avverte l’inquietudine e qualcos’altro, qualcosa di più. Paura, terrore, brutti presagi. Sussulta quando lui le tocca un braccio. Mi dice che la sua mano è fredda come il ghiaccio. Sente di avere la pistola in grembo, appoggiata sulle gambe intirizzite, formicolanti. È sorto il sole, che splende dalle finestre luride; le vecchie tende a quadri sono tirate. Afferra l’arma, la punta contro di lui e solleva il cane. La sua espressione è agghiacciante. Mia non sa niente sulle armi. Tutto ciò che sa, dice, gliel’ha insegnato lui. Si sente maldestra con la rivoltella pesante nelle mani che tremano. Però nel sogno si rende conto di essere molto decisa: potrebbe benissimo sparargli. Certo, potrebbe mettere fine alla sua vita. Lui è tranquillo, non si muove. Lentamente si raddrizza, fino a ergersi dritto davanti a lei. Appare riposato, sebbene gli occhi mostrino ancora un certo disagio: le sopracciglia aggrottate, lo sguardo cupo con cui reagisce ai suoi occhi irremovibili. Non si è rasato, da giorni la peluria gli cresce incolta sul viso, ora ha barba e baffi. È appena uscito dal letto. Ha la faccia segnata dalle pieghe delle lenzuola e gli occhi ancora assonnati. I vestiti sono sgualciti perché ci ha dormito. Si mette a una certa distanza dalla sedia da giardino, ma lei riesce comunque a sentire il suo fiato mattutino. «Chloe», la chiama con la sua voce tranquillizzante. Lei dice che è gentile e rassicurante, e benché siano entrambi consapevoli che potrebbe strapparle l’arma dalle mani tremanti per ucciderla, non ci prova nemmeno. «Ho preparato le uova». Poi si sveglia. Secondo me, ci sono due cose che spiccano con particolare evidenza nel sogno: la scritta sulla felpa (L’ÉTOILE DU NORD) e le uova. Ovviamente oltre al fatto che Mia (nom de plume Chloe) brandisce un’arma. Nel pomeriggio, dopo che mia figlia si rifugia in camera per uno dei suoi tanti sonnellini, accendo il mio computer, clicco su un motore di ricerca e digito la frase in francese che dovrei ricordare dai tempi delle superiori (un milione di anni fa) ma che non rammento bene. Una delle prime occorrenze fa riferimento alla stella polare come motto dello Stato del Minnesota. Se il sogno è un ricordo, non un’effettiva esperienza onirica, ma la reminiscenza del tempo trascorso in Minnesota, perché lei brandisce una pistola? Ma soprattutto, perché non se ne è servita per ammazzare Colin Thatcher? Com’è andata a finire questa vicenda? Ho bisogno di saperlo. Mi tranquillizzo con la congettura che il sogno sia solo un simbolo. Mi metto a cercare il significato dei sogni, focalizzandomi sulle uova. M’imbatto in un manuale di interpretazione onirica e la definizione comincia a mettermi sulla pista giusta. Immagino Mia in quello stesso momento, sdraiata nel suo letto, rannicchiata in posizione fetale, sotto le coperte. Mi ha detto di non sentirsi bene quando è salita in camera; ormai me lo ripete spesso, e lo attribuisco allo stress e all’affaticamento di questi ultimi mesi. Però adesso comprendo che potrebbe esserci dell’altro. Mi si bloccano le dita sulla tastiera, comincio a piangere. È davvero possibile? Si presume che le nausee mattutine (in gravidanza) siano ereditarie. Io stessa ero stata male da cani quando aspettavo le ragazze, specie la prima volta con Grace. Si dice che funzioni così. Passavo giorni e notti a vomitare in bagno, fino a quando non mi rimaneva altro da rimettere che la bile. Ero sempre stanca, provavo un senso di sonnolenza mai conosciuto prima; il solo fatto di aprire gli occhi esauriva le mie forze. James non capiva. Naturalmente, non avrebbe potuto: era una cosa che nemmeno io avrei capito, finché non ci sono passata, alla fine sopravvivendo, sebbene in quegli attimi desiderassi solo morire. Secondo il manuale di interpretazione onirica, le uova in un sogno potrebbero indicare qualcosa di nuovo e fragile. La vita che prende forma. 6 La strolaga è il simbolo dello stato del Minnesota, il cui motto è, appunto, l’espressione francese che significa «stella polare», o del Nord. (n.d.t.) Colin Prima Mi sono svegliato presto e sono uscito con la canna da pesca, spingendomi fino al lago con tutta l’attrezzatura comprata nel negozio. Avevo speso una fortuna per l’occorrente, aggiungendoci anche una trivella per quando il lago si congelerà. Non che abbia intenzione di rimanere qui tanto a lungo. Lei si è infilata un maglione e viene verso il lago. Ha ancora i capelli bagnati dopo essersi lavata, e le punte si stanno increspando a causa dell’aria fredda. Mentre si avvicina, è tutto calmo. Il sole sta sorgendo adesso. Sono sovrappensiero, cerco di convincermi che a casa vada tutto bene. Tento di cancellare il senso di colpa con una sorta di autolavaggio del cervello: nel frigo c’è cibo a sufficienza, lei non è ancora caduta e non si è rotta un’anca. E proprio mentre me ne sto persuadendo, nella mia mente s’insinua un nuovo timore: ho dimenticato di accendere il riscaldamento, per cui dopo creperà dal freddo, oppure lei ha lasciato la porta aperta e qualche animale potrebbe essere entrato. Dopodiché prevale la razionalità, e a ragione: ho effettivamente acceso il riscaldamento, ci metto dieci minuti per rivedermi mentre giro la manopola sui venti gradi. Ormai dovrebbero essere arrivati anche i soldi, a sufficienza per mantenerla. Almeno per un po’. Ho portato dal capanno una sedia da giardino e mi riposo con una tazza di caffè appoggiata ai miei piedi. Mentre lei si avvicina al lago, osservo come si è vestita. I suoi pantaloni non bastano a bloccare il vento. Sugli alberi non ci sono più le foglie a rallentarlo: le sferza i capelli gelati contro la faccia, s’infila su per le gambe dei calzoni color cachi e giù per il collo della camicia. Sta già tremando tutta. Avevo acceso il riscaldamento, naturalmente. Venti gradi. «Cosa fai qui fuori?», chiedo. «Ti si congeleranno le chiappe». Tuttavia si siede in riva al lago, senza che l’abbia invitata a farlo. Potrei dirle di rientrare in casa, ma taccio. Il terreno è umido. Lei si porta le ginocchia al petto e si abbraccia le gambe per tenersi calda. Non parliamo. Non ne abbiamo bisogno. Lei è contenta solo per il fatto di starsene all’aperto. Il capanno manda cattivo odore, di muffa e stantio. Penetra nel naso perfino dopo tutti questi giorni, quando credevamo di esserci abituati. Dentro è altrettanto freddo che fuori. Dobbiamo risparmiare il più possibile la legna per l’inverno. Fino ad allora, accendiamo la stufa solo di notte. Durante il giorno la temperatura all’interno precipita verso i dieci gradi. So che lei non sente mai caldo, sebbene si vesta con diversi strati. In queste zone del Nord, l’inverno è inclemente, raggiunge livelli cui non siamo abituati. Fra pochi giorni sarà novembre, l’ultimo periodo di calma prima delle bufere. Un branco di strolaghe maggiori si alza dalla superficie dell’acqua diretto a Sud. Sono le ultime rimaste a queste latitudini settentrionali: i pulcini nati la scorsa primavera e che solo ora hanno acquisito la forza necessaria per completare il lungo viaggio. Gli altri se ne sono già andati. Scommetto che lei non ha mai pescato. Io invece sono bravo, lo faccio da quand’ero piccolo. Tengo la canna ferma, il corpo immobile. Osservo il galleggiante sulla superficie dell’acqua. Lei è abbastanza saggia da tener chiusa la bocca. Sa che il suono della sua voce spaventerebbe i pesci, facendoli scappare. «Tieni», dico, tenendo la canna in equilibrio tra le ginocchia. Mi tolgo il giaccone impermeabile con il cappuccio e glielo passo. «Mettitelo prima di congelarti». Non sa cosa dire. Non mi ringrazia nemmeno. Non facciamo queste cose. Infila le braccia nelle maniche troppo ampie per lei e, dopo un momento, smette di tremare. Solleva il cappuccio sulla testa e si ripara dal freddo. Io non sento freddo. E comunque non lo ammetterei. Abbocca un pesce. Mi alzo in piedi e strattono la lenza, poi comincio a riavvolgere il filo, tirando l’aspo per tenerlo teso. Quando l’animale emerge dall’acqua, dimenandosi per salvarsi la vita, lei si volta. Deposito il pesce al suolo e osservo le sue contorsioni prima che tiri le cuoia. «Adesso puoi guardare», dico. «È morto». Ma non ce la fa. Non guarda. Almeno fino a quando le blocco la vista. Mi chino sul pesce e gli tolgo l’amo dalla bocca. Poi infilo una nuova esca e le porgo la canna. «No, grazie», dice. «Hai mai pescato?» «No». «Non sono cose che si insegnano nell’ambiente da cui vieni». Sa cosa penso di lei. Una ragazza ricca e viziata. Deve ancora dimostrarmi di essere diversa. Mi strappa la canna di mano. Non è avvezza a farsi dire dagli altri cosa fare. «Sai cosa stai facendo?», chiedo. «Posso immaginarlo», ribatte. Ma non ne ha la minima idea, per cui sono costretto ad aiutarla a lanciare la lenza. Si mette a sedere sul bordo del lago e aspetta. Vorrebbe che i pesci scappassero. Mi accomodo sulla mia sedia e prendo un sorso di caffè ormai freddo. Passa un po’ di tempo. Non so quanto. Rientro per fare pipì e prendere altro caffè. Quando torno, lei si dice sorpresa che non l’abbia legata a un albero. Il sole è alto, fatica a scaldare la giornata. Non è sufficiente. «Ritieniti fortunata». Dopo un po’ le chiedo di suo padre. All’inizio non reagisce, fissa l’acqua stagnante. Persa tra le lunghe ombre degli alberi sul lago e il cinguettio degli uccelli. «Cosa vuoi sapere?», chiede. «Com’è fatto?», domando. Anche se in realtà lo so. Voglio solo sentirlo da lei. «Non mi va di parlarne». Restiamo in silenzio per qualche momento. Poi è lei a romperlo. «Mio padre è nato ricco», spiega. «In una famiglia ricca da sempre». Di antico lignaggio. Oggi hanno tanti di quei soldi da non sapere cosa farne. «Basterebbero per sfamare una piccola nazione», aggiunge. Però non lo fanno, se li tengono tutti per loro. Mi dice che suo padre ha un lavoro importante. Lo so. «La gente lo conosce», precisa. «Tutto questo lo ha fatto diventare spocchioso. E il suo desiderio inestinguibile di accumulare sempre più soldi lo ha corrotto. Non dubito che possa fare cose illecite, per esempio accettare mazzette, ma non lo hanno mai beccato. Per lui l’immagine personale è tutto», soggiunge. Dopodiché si mette a raccontarmi della sorella, Grace. Come suo padre, è una persona vuota, edonista e pretenziosa. La guardo e mi pare che sua sorella non sia l’unica ad avere questi tre difetti. È la figlia di un ricco bastardo. La vita le è stata servita su un piatto d’argento, è nata con la camicia. So di lei più cose di quante possa immaginare. «Pensa quello che ti pare», dice, «ma io e mio padre siamo di una pasta diversa». Molto diversa, puntualizza. Mi racconta che non è mai andata d’accordo con lui. Né da piccola, né ora. «C’è poco dialogo. A volte ci parliamo, ma è una finta, un artificio. Nel caso che qualcuno controlli». Grace, l’avvocatessa, è la cocca del paparino. «Lei è tutto quello che io non sono mai stata», dice. «È l’immagine specchiata del babbo, che a me non ha voluto pagare l’istruzione universitaria, mentre a mia sorella ha assicurato sia la laurea, sia la specializzazione in diritto. Le ha comprato un appartamento in centro, cosa che avrebbe potuto pagarsi da sola. Io invece spendo 850 dollari al mese per l’affitto, e spesso il mio conto è in rosso. Ho chiesto a mio padre di fare una donazione alla scuola in cui insegno. Avrebbe anche potuto garantire una borsa di studio annuale. Si è messo a ridere. E poi Grace lavora in un grande studio legale del centro. Ai clienti che chiedono una consulenza fa pagare più di 300 dollari l’ora. Nel giro di un anno farà carriera e diventerà ancora più importante. Lei è tutto quello che mio padre avrebbe desiderato che fossi anch’io». «E tu?» «Io sono l’altra, quella ai cui errori doveva rimediare». Afferma che il padre non si è mai interessato a lei. Per esempio, quando aveva cinque anni e si era esibita in uno spettacolino estemporaneo. Né quando ne aveva diciannove ed era riuscita a far esporre il suo primo quadro in una galleria d’arte. «In compenso, la sola presenza di Grace lo mette di buonumore. Lei è brillante, come lui, ha la parlantina, i suoi discorsi sono concreti, non tendono agli aspetti “illusori” delle cose, come ama dire lui. La “grande illusione” che coltivo da quando ho deciso di diventare un’artista. O la concezione “illusoria” della realtà che ha mia madre». La cosa che mi fa arrabbiare è che lei parla come se avesse dovuto subire tutte le ingiustizie di questo mondo, come se la sua vita fosse piena di durezze e delusioni. Non ha la minima idea di cosa voglia davvero dire avere sfortuna. Ripenso alla roulotte color menta, a quando fummo costretti a osservare da una specie di rifugio l’infuriare della tempesta che spazzava via la nostra casa. «Dovrei forse compatirti?», chiedo. Un uccellino comincia a gorgheggiare. Da lontano un altro risponde al suo richiamo. La sua voce è bassa. «Non ti ho mai domandato di provare dispiacere per me. Mi hai fatto una domanda, ti ho dato una risposta», spiega. «Ti stai autocommiserando, vero?» «Non c’entra niente». «Sempre la vittima». Ostento indifferenza. La ragazza non sa un cazzo di cosa sia la vera sfortuna. «No», ribatte, gettandomi la canna da pesca tra le mani. «Tieni», dice. Si abbassa la lampo del giaccone, se lo toglie e lo scaraventa a terra accanto a me. Io lo lascio lì. Non apro bocca. Rimane esposta all’aria fredda. «Torno dentro», dice. E supera il pesce morto, i cui occhi la fissano con disprezzo per averlo lasciato spirare. Sarà a cinque metri da me quando le dico: «E a proposito del riscatto?» «In che senso?», chiede. Si ferma all’ombra di un grande albero, con le mani sui fianchi. I capelli le svolazzano attorno nella fredda aria d’ottobre. «Tuo padre lo avrebbe pagato?», chiarisco. Se lui la detesta come lei vuol far credere, non avrebbe scucito un centesimo per riaverla. Lei ci riflette, so che è così. È una domanda estremamente pertinente. Se il padre non avesse pagato il riscatto, lei sarebbe morta. «Immagino che non lo sapremo mai», dice, e poi se ne va. Sento il crepitio delle foglie sotto i suoi passi, poi il cigolio della zanzariera che si apre, più lontano. Infine la porta sbattere. So di essere solo. Gabe Prima Sto percorrendo in auto il viale alberato più bello al mondo. Aceri rossi e tremuli pioppi gialli formano una volta sulla strada angusta coperta dalle loro foglie. È presto per chi va in giro a chiedere «dolcetto o scherzetto», quei piccoli disadattati saranno ancora a scuola per un altro paio d’ore. Ma le case da un milione di dollari li aspettano, immerse nei loro meravigliosi giardini, dai prati che avrebbero proprio bisogno di un tagliaerba… anche se qui nessuno si abbassa a falciarli. Addobbati con balle di fieno, spighe di grano e zucche tonde e perfette. Il postino si avvicina alla cassetta dei Dennett proprio mentre sto arrivando sul vialetto ammattonato. Metto la mia auto schifosa di fianco alla stupenda berlina della signora Dennett e lo saluto amichevolmente con la mano, come se abitassi lì, poi mi dirigo verso la cassetta postale, una costruzione vera e propria, più spaziosa del mio gabinetto. «Buongiorno», dico, allungando una mano per farmi dare la posta di oggi. «Buon pomeriggio», replica lui mentre mi deposita in mano una gran quantità di corrispondenza. È freddo qui fuori. Una giornata uggiosa. Come sempre: da quel che mi ricordo, tutti gli Halloween sono così. Le nuvole grigie si abbassano fino al suolo, tanto da non distinguere più la differenza tra cielo e terra. Infilo la posta sotto l’ascella e mi ficco le mani in tasca prima di raggiungere l’entrata. Ogni volta che arrivo, la signora Dennett spalanca la porta con slancio ed entusiasmo, ha il fervore dipinto sul volto finché non mi vede. Allora il sorriso scompare, le si spegne lo sguardo. Qualche volta emette anche un sospiro. Non la prendo come un’offesa personale. «Oh», dice. «Ispettore». Ogni volta che suona il campanello è sicura che sia Mia. Indossa un grembiule color senape sopra un completo da yoga. «Sta cucinando?», chiedo, cercando di non soffocare per l’odore. O sta cucinando o qualche animaletto è entrato in cantina e ci è morto. «Ci provo». Mi sta già abbandonando, lascia aperta la porta. Ride nervosa, mentre la seguo in cucina. «Lasagne», dice, affettando una mozzarella enorme. «Le ha mai preparate?» «La mia specialità è la pizza surgelata», dico scaricando la posta sull’isola. «Ma le risparmio l’esperienza». «Oh, grazie», ribatte, posando il coltello e prendendo la distinta delle spese mediche coperte dall’assicurazione. Si eclissa per cercare un tagliacarte con cui aprire la busta, mentre sui fornelli le salsicce cominciano a bruciarsi. Sulle lasagne so un paio di cosette. Da bambino, avrò visto mia madre prepararle un milione di volte. Le stavo tra i piedi, giocando sul pavimento della nostra piccola cucina, mentre si affaccendava ai fornelli («Sono pronte? Non sono ancora pronte?»). Pesco un cucchiaio di legno dal cassetto dei Dennett e do una rimestata. «Cosa stavo…», chiede distrattamente la signora rientrando nella stanza. «Oh, ispettore, non doveva…», continua, e io le dico che non è niente. Poso il cucchiaio accanto alla padella. Lei fa una cernita della posta arrivata. «Ha mai visto tanto ciarpame?», mi domanda. «Cataloghi. Bollette. Un sacco di gente che vuole i nostri soldi. Ha mai sentito parlare…», alza la busta per leggere meglio il nome dell’opera pia, «della sindrome di Mowat-Wilson?» «Mowat-Wilson?», ripeto. «Mi pare di no». «La sindrome», ripete, sistemando la busta su una pila di carte che presumibilmente finiranno nel superplanning attaccato alla parete. Ero convinto che i postulanti della Mowat-Wilson sarebbero finiti tra la carta da riciclare, invece può darsi che presto riceveranno un assegno. «Il giudice deve aver fatto qualcosa di speciale per meritarsi un piatto di lasagne», ipotizzo. Mia madre le prepara continuamente, non c’è niente di speciale. Ma per gente come Eve Dennett immagino che un pasto fatto in casa come questo sia un evento raro. Ovviamente anche per via delle probabilità di sopravvivenza: dall’aspetto, posso ritenermi fortunato che non mi abbia invitato a rimanere per assaggiarle. Sono un esperto in stereotipi, e come cuoca la signora Dennett mi pare alquanto limitata. Al massimo conoscerà una ricetta con il pollo e forse saprà anche far bollire l’acqua. Non di più. «Non sono per James», dice lei mentre si affaccenda ai fornelli dietro di me. Mi sfiora con la manica di una maglia nera elasticizzata, ma sono certo che non se n’è accorta. Io sì. Continuo ad avvertire il contatto per alcuni secondi perfino dopo che lei si è spostata. Poi versa in padella una gran quantità di cipolle, che sfrigolano. So che è il compleanno di Mia. «Mi dica, signora». «Non le avrei fatte», assicura, completamente impegnata a rosolare la carne: è una sorta di trasformazione per lei che fino a due secondi prima se ne infischiava altamente. «E non ho intenzione di piangere». È allora che noto i palloncini sparsi dappertutto, vanno dal magenta al verde lime. I suoi colori preferiti, a quanto pare. «Sono per lei», spiega. «Mia adora le lasagne. Qualsiasi tipo di pasta. Era l’unica che finisse tutto quanto avevo cucinato. Non che mi aspetti che arrivi all’ultimo momento. So che non accadrà. Ma non potevo…». La sua voce s’incrina. Vedo le sue spalle tremolare e le salsicce assorbire le lacrime. Facile dare la colpa alle cipolle, eppure non lo fa. Distolgo lo sguardo. Mi concentro sulla mozzarella. Lei prende uno spicchio d’aglio e comincia a schiacciarlo col palmo della mano. Non sapevo che conoscesse questa tecnica. Pare che l’aglio faccia molto bene alla salute. Lo mette nella padella, dopodiché lei prende dalla dispensa una gran quantità di condimenti (basilico, finocchio, sale e pepe) e li rovescia sul piano di lavoro in granito. Il barattolo del sale sporge dal bordo e cade sul pavimento di legno. Non si rompe, ma il sale si versa. Fissiamo il mucchietto di cristalli bianchi a terra e pensiamo la stessa cosa: porta male. Sarà per sette anni? Non saprei. Comunque dico: «Spalla sinistra». «Sicuro che non sia la destra?», chiede. C’è panico nella sua voce, come se questo piccolo incidente dovesse determinare il ritorno – o il mancato ritorno – di Mia a casa. «La sinistra», replico, certo di avere ragione, ma poi per accontentarla aggiungo: «Al diavolo, meglio lanciarne un pizzico anche dietro la destra. Giusto per essere sicuri». Lancia il sale e si pulisce le mani sul grembiule. Mi chino per raccogliere il contenitore mentre lei si abbassa per pulire il sale da terra. È un attimo, ci urtiamo con la testa. Lei si preme una mano sul punto dolente e io mi ritrovo ad accarezzargliela. Le domando se sta bene, le porgo le mie scuse. Ci rialziamo in piedi e, per la prima volta, la vedo ridere. Santo cielo, è bellissima, anche se la sua risata è incerta, sembra che stia per scoppiare a piangere da un momento all’altro. Una volta uscivo con una ragazza con un disturbo bipolare. Poteva essere tanto euforica da voler conquistare il mondo e subito dopo talmente depressa da non voler nemmeno alzarsi dal letto. Mi chiedo se il giudice Dennett, da quando è iniziata questa storia, abbia messo almeno una volta un braccio attorno alle spalle della moglie per dirle che si sarebbe sistemato tutto. Quando si riprende, le dico: «Immagini che Mia ritorni stasera, che si presenti alla porta e non ci sia niente da mangiare». Scuote il capo. Non riesce proprio a immaginarselo. «Perché ha scelto di fare il detective?», mi domanda. Niente di speciale nella mia scelta. Mi pare quasi imbarazzante. «Mi hanno promosso perché ero un buon agente. Ma sono diventato poliziotto perché un compagno di università aveva deciso di iscriversi all’accademia di polizia. Non ho saputo far altro che imitarlo». «Però le piace il suo mestiere». «Sì, mi piace». «Non è deprimente? Io non riesco a sopportare i telegiornali della sera». «Anche noi abbiamo brutte giornate», dico, ma poi mi accingo a elencarle tutti gli aspetti positivi che mi vengono in mente. Far chiudere un laboratorio di metanfetamine. Ritrovare un cane smarrito. Acciuffare un ragazzino che va a scuola con un coltello nella borsa. «Ritrovare Mia», concludo, ed evitando di dirlo ad alta voce penso: Se riesco a liberarla e a riportarla a casa, se riesco a risvegliare la signora Dennett dall’incubo in cui vive, vale la pena di fare il mio lavoro. Dimenticherei tutti i casi irrisolti, tutte le malefatte che succedono ogni giorno in questo fottuto mondo. Lei torna a occuparsi delle lasagne. Le spiego che vorrei porle alcune domande. La osservo versare la pasta, la carne e il formaggio in un tegame, mentre parliamo di una ragazza di cui appaiono magicamente sempre più foto in giro per la casa ogni volta che varco la porta d’ingresso. Mia che sorride mezzo sdentata il suo primo giorno di scuola. Mia con un bernoccolo enorme sulla testa. Mia con il costumino e le gambette magre in bella vista, coi bracciali come salvagente. Mia che si prepara al ballo studentesco di fine anno. Nemmeno due settimane fa, non si sarebbe neanche detto che Grace Dennett avesse una sorella minore. Adesso sembra che Mia sia l’unica presenza in questa casa. Colin Prima Ho la fortuna di possedere un orologio col datario. Altrimenti saremmo entrambi perduti. Non lo faccio come prima cosa al mattino. Lei non mi parla da ventiquattr’ore. È incazzata perché ho ficcanasato, ma soprattutto perché lei mi ha spifferato parecchie cose. Non vuole farmi sapere niente di sé, ma io ne so abbastanza. Aspetto di finire la colazione. Aspetto fin dopo il pranzo. La lascio col broncio per un bel pezzo. Mi tiene il muso girando per il capanno a compatirsi. Fa una smorfia. Non le passa nemmeno per l’anticamera del cervello che preferirei essere in tanti altri posti, mica qui, perché questa è la sua disgrazia, solo sua. O almeno così crede. Non sono uno a cui piacciono le ostentazioni. Aspetto che abbia finito di lavare i piatti. Si sta asciugando le mani in un panno di spugna, quando lo faccio cadere sul ripiano accanto a lei. «È per te». Rivolge un’occhiata al quaderno da disegno. Per farci degli schizzi. Con dieci matite automatiche. «Le mine sono tutte lì. Non finirle subito». «Che roba è?», chiede scioccamente. Ma lo sa bene. «Qualcosa per passare il tempo». «Ma…», s’interrompe, non sa finire. Prende il quaderno e fa scorrere una mano sulla copertina. Sfoglia la pagine bianche immacolate. «Ma…», balbetta, non sa cosa dire. Vorrei che non dicesse nulla. Non c’è bisogno di parole fra noi, adesso. «Ma… perché?» «È Halloween», dico, in mancanza di una risposta migliore. «Halloween», borbotta a mezza voce. Sa che c’è dell’altro. In fondo, non si compiono venticinque anni tutti i giorni. «Come facevi a saperlo?». Le mostro il mio segreto, il piccolo 31 sull’orologio che ho rubato a un fesso. «Come facevi a sapere che è il mio compleanno?». Il tempo trascorso a navigare su internet prima di rapirla sarebbe la risposta più onesta. Però non voglio rivelarglielo. Non è necessario che sappia che l’ho pedinata per giorni prima del sequestro, che la tallonavo mentre si recava al lavoro e quando tornava a casa, che la spiavo dalla finestra della sua camera da letto. «Ricerche». «Ricerche», ripete. Non mi ringrazia. Parole del genere (grazie, per favore, scusami) sono segni di pace, e ancora non siamo a quel punto. Forse non ci arriveremo mai. Tiene il quaderno da disegno vicino a sé. Non so perché l’ho fatto. Ero stufo di vederla ciondolare o fissare oziosamente fuori dalla finestra, quindi ho speso cinque dollari per carta e matite, e sembra che le abbia regalato una giornata meravigliosa. Nei negozi dei dintorni non li hanno neanche i taccuini per disegnare, così ho dovuto guidare fino a Grand Marais e sono entrato in una cartolibreria dopo averla legata al lavandino del gabinetto. Eve Prima Organizzo una festa per il suo compleanno, non si sa mai. Invito James, Grace e i parenti acquisiti: i genitori di James e i suoi fratelli con le loro mogli e i figli. Mi spingo fino al centro commerciale e le compro dei regali che lei adorerebbe. Non è difficile: più che altro abbigliamento, felpe e maglioni col collo largo, oltre alla bigiotteria voluminosa che va di moda adesso. Da quando Mia è apparsa nei telegiornali, appena metto piede fuori di casa tutti vogliono notizie. Nel negozio di alimentari, le donne mi fissano, sussurrano dietro le mie spalle. Preferisco gli sconosciuti agli amici e ai vicini di casa, che vogliono parlarne. Non ce la faccio a parlare di mia figlia senza scoppiare in lacrime. Mi affretto a lasciare il parcheggio per evitare di essere ripresa dai furgoni delle televisioni, che ci seguono ovunque. All’interno del centro commerciale, la cassiera esamina la mia carta di credito e si chiede se il nome Dennett sia quello della ragazza di cui si parla tanto in TV. Mento, fingo di non saperne niente perché fornire qualunque spiegazione mi sconvolgerebbe. Impacchetto i regali e impilo le scatole col grosso nastro rosso. Preparo tre teglie di lasagne e compro il pane per le bruschette. Preparo l’insalata e vado al forno a ritirare una torta con mousse al cioccolato. La preferita di Mia. Compro venticinque palloncini e li dissemino per tutta la casa. Appendo un terribile striscione con la scritta BUON COMPLEANNO, che abbiamo da quando le ragazze erano piccole, e metto un CD jazz rilassante. Non viene nessuno. Grace sostiene di avere un appuntamento col figlio di un suo socio, però non ci credo. Anche se non lo ammetterebbe mai, in questi giorni è sulle spine, sa bene che quanto riteneva essere solo un espediente della sorella per attirare l’attenzione invece è qualcosa di più. Ma preferisce fingere, piuttosto che ammettere di essersi sbagliata: assume un’aria di indifferenza, come se il destino di Mia non la riguardasse. Eppure, quando parliamo e le sfugge il nome della sorella, dal tono della sua voce capisco che la sua scomparsa la fa soffrire. James si ostina a dire che non si può organizzare una festa se manca il festeggiato. Perciò, senza informarmi, telefona ai suoi genitori, a Brian e a Marty, per dire a tutti che questa faccenda è una farsa, che non c’è alcuna festa. Però me lo riferisce solo alle otto di sera, quando rientra dal lavoro e, vista la quantità di pasta sull’isola della cucina, sbotta: «Cosa diavolo hai preparato a fare tutte quelle lasagne?» «La festa», rispondo ingenuamente. Forse sono in ritardo. «Non c’è nessuna festa, Eve», dice. Si versa l’ultimo bicchierino di liquore prima di ritirarsi nel suo studio, come fa sempre, ma a un tratto si ferma a guardarmi. Una cosa rara, che mi guardi. La sua espressione è inconfondibile: occhi afflitti, pelle aggrinzita, labbra tirate. Si avverte dal suo tono di voce, sommesso e confidenziale. «Ti ricordi il sesto compleanno di Mia?», chiede. Certo. Sono stata tutto il giorno seduta a ripescare le foto dei compleanni, tutte le feste arrivate e passate in un baleno. Tuttavia mi stupisce che se lo ricordi. Annuisco. «Sì, allora Mia voleva un cane». Un mastino tibetano, per la precisione, un fedele cane da guardia, con tanto pelo, soggetto a muta. Di solito può pesare più di cinquanta chili. Ma non ci sarebbe stato nessun cane. James lo aveva subito messo in chiaro. Né per quel compleanno, né mai. Mia aveva reagito con uno scoppio di pianto isterico, e il padre, che abitualmente avrebbe ignorato quei capricci, aveva speso una fortuna per regalarle un esemplare di peluche che aveva dovuto ordinare in un negozio di giocattoli a New York. «Non credo di averla mai vista più felice di allora», dice, ricordando come Mia stringesse contenta il molosso impagliato di novanta centimetri, cingendolo con le braccia. È a questo punto che mi rendo conto di quanto sia preoccupato. Per la prima volta, si preoccupa per la nostra bambina. «Ce l’ha ancora il cane di peluche», gli faccio notare. «Di sopra, in camera sua», aggiungo, e lui annuisce, lo sa. «La vedo ancora», ammette, «era euforica quando entrai nella stanza col mastino di peluche nascosto dietro la schiena». «Le piaceva moltissimo», dico, dopodiché lui si rifugia nel suo studio e chiude solennemente la porta. Mi sono completamente dimenticata di comprare le caramelle per i bambini del vicinato. Da una certa ora comincia a suonare il campanello e, sperando stupidamente che siano i parenti acquisiti, vado ad aprire ogni volta. All’inizio sono la signora pazza che regala le monete del salvadanaio, ma da metà serata in poi inizio a distribuire le fette della torta di compleanno. I genitori che sono all’oscuro mi guardano storto, quelli che sanno mi fissano con compassione. «Qualche buona nuova?», domanda una vicina, Rosemary Southerland, che passa coi nipotini, troppo piccoli per suonare da soli ai campanelli altrui e declamare «dolcetto o scherzetto». «Nessuna novità», rivelo con le lacrime agli occhi. «Preghiamo per voi», dice, aiutando i piccoli, travestiti da Winnie the Pooh e Tigro, a scendere i gradini. «Grazie», replico, ma penso che tanto non serve a un bel niente. Colin Prima Le dico che può uscire. È la prima volta che la lascio andar fuori da sola. «Resta dove ti posso vedere», aggiungo. Sto coprendo le finestre con dei fogli di plastica, in vista dell’inverno. Mi ci vuole una giornata intera. Ieri ho stuccato bene tutte le porte e le finestre. Il giorno precedente ho isolato le tubature. Mi ha domandato perché lo facessi, e l’ho guardata come se fosse cretina. «Così non scoppiano», ho detto. Non è che voglia rimanere per tutta la stagione invernale, ma finché non mi viene in mente un’opzione migliore abbiamo poche altre possibilità. Lei indugia davanti alla porta. Tiene il quaderno da disegno in mano. «Non vieni?» «Ormai sei grande», dico. Si avventura fuori, fermandosi sui gradini. La tengo d’occhio dalla finestra, non le conviene tentare troppo la fortuna. Ieri sera è nevicato un po’. Il terreno è coperto di aghi di pino marroni e di funghi che presto moriranno. Sul lago ci sono lastre di ghiaccio. Niente di grave, a mezzogiorno saranno già sciolte. Ma è il segno che l’inverno è prossimo. Lei spazza i gradini per liberarli dalla neve, si siede e apre il quaderno da disegno sulle ginocchia. Ieri siamo usciti insieme ad ammirare il lago. Ho pescato una trota mentre lei disegnava una decina di alberi con linee frastagliate che attraversavano il terreno. Non so quanto tempo rimango a osservarla dalla finestra. Non che abbia paura che scappi, ormai sa cosa le conviene fare, ma comunque la sorveglio. Noto che le si arrossa la pelle per il freddo e che la brezza le scompiglia i capelli. Lei se li sistema dietro l’orecchio, sperando di trattenerli, ma non funziona. Non tutte le cose possono essere contenute. Osservo le sue mani che si muovono sulla superficie del foglio. Rapide, agili. Con carta e matita, lei assomiglia a come mi sento io con un’arma: padrone di me, capace di controllare e dominare le cose. È l’unico momento in cui è sicura di sé. È questa fiducia in sé che mi tiene incollato alla finestra, oltre al fatto di non perderla di vista. Immagino il suo viso, che non vedo essendo voltata di spalle. Non è niente male da guardare. Apro la porta ed esco sbattendola; lei sussulta, si gira per capire cosa diavolo voglio. Sul foglio di carta che ha davanti c’è un lago con la superficie increspata dal vento. Su una lastra di ghiaccio trasparente è appollaiato un gruppetto di oche. Finge che io non sia lì, ma so che la mia presenza le rende arduo far altro se non respirare. «Dove hai imparato a farlo?», chiedo. Intanto osservo il lato esterno di porte e finestre, in cerca di eventuali fessure. «A fare cosa?», domanda, coprendo il disegno con la mano per non farmelo vedere. Smetto di controllare gli infissi. «Pattinare sul ghiaccio», commento sarcastico. «Secondo te?» «Ho imparato da sola», dice. «Per il gusto in sé?» «Immagino di sì». «Perché?» «E perché no?». Comunque, mi racconta che ci sono due persone che deve ringraziare per il suo talento artistico: un professore delle medie e Bob Ross7. Non so chi sia quest’ultimo, così me lo spiega. Dice che piazzava il cavalletto e i colori davanti alla televisione per disegnare secondo le istruzioni che dava lui. Grace la criticava, suggerendole di uscire a farsi una vita. La definiva una perdente. La madre faceva finta di non sentire questi scambi di battute. Poi mi dice che aveva già cominciato a disegnare in precedenza, nascosta in camera sua con gli album da colorare. «Niente male», commento, senza guardare né lei né il disegno. Sono impegnato a raschiare via il vecchio stucco bianco da una finestra. Le schegge cadono ai miei piedi, formando un mucchietto sul terreno. «Come fai a saperlo?», ribatte. «Non hai guardato». «Ho guardato». «No», dice. «Riconosco l’indifferenza, ci sono abituata, l’ho vista per tutta la vita». Sospiro e impreco a bassa voce. Lei continua a tenere la mano sul disegno. «Allora dimmi, di cosa si tratta?», chiede. «Cosa diavolo intendi?» «Che ho rappresentato?». Smetto di occuparmi dello stucco e comincio a fissare le oche, che se ne vanno una dopo l’altra. «Quelle», dico, e lei tace. Mi sposto verso un’altra finestra. «Perché me lo hai comprato?», domanda poi sollevando il quaderno. Mi interrompo di nuovo per fissarla. So quello che pensa lei: Meglio lo stucco di me. «Perché fai queste domande del cazzo?», replico acido, riducendola al silenzio. Comincia a tratteggiare il cielo, bassi nubi stratificate in movimento. A un certo punto aggiungo: «Così non devo farti da baby-sitter. Così stai zitta e la smetti di rompermi le scatole». «Oh», fa lei. Si alza e rientra in casa. Ma non è tutta la verità. Se avessi voluto evitare di farmi rompere le scatole, avrei comprato altra corda per legarla al lavandino del bagno. Se avessi voluto che restasse sempre zitta, avrei usato il nastro isolante. Ma se avessi voluto scusarmi, le avrei comprato quel quaderno da disegno. Quand’ero un adolescente, tutti avrebbero scommesso che sarei finito in quella maniera. Mi cacciavo sempre nei guai. Picchiavo i ragazzini e litigavo con gli adulti. Saltavo le lezioni, non superavo i test. Alle superiori, la consulente dell’orientamento scolastico suggerì a mia madre di portarmi da uno psicologo. Sosteneva che avessi dei problemi a gestire la rabbia. Mia madre le spiegò che, se avesse passato tutto quello che avevo passato io, anche lei sarebbe stata arrabbiata. Mio padre se n’era andato di casa quando avevo sei anni. Ci era rimasto abbastanza perché me lo ricordassi, ma non tanto da prendersi cura di me e della mamma. Ricordo bene le botte, non solo le liti. I miei genitori si picchiavano e si lanciavano gli oggetti. Di notte, fingevo di dormire quando sentivo i cocci. Porte sbattute e insulti reciproci urlati a squarciagola. Ricordo le bottiglie di birra vuote e i tappi che gli uscivano dalle tasche dei pantaloni, nonostante lui affermasse di essere sobrio. A scuola mi facevo coinvolgere nelle risse. Avevo mandato affanculo il prof di matematica perché ripeteva che non avrei mai combinato niente di buono. Avevo detto all’insegnante di biologia delle superiori di andare a farsi fottere perché era convinta di potermi aiutare a superare l’esame nella sua materia. Non volevo che qualcuno si interessasse a me. Mi sono ritrovato per caso in questa vita. Facevo il lavapiatti in un ristorante snob del centro. Avevo tutto lo schifo degli avanzi dei pasti altrui sulle mani, bruciate dall’acqua bollente mentre impilavo i piatti puliti provenienti dal nastro trasportatore. Dita ustionate, fronte grondante di sudore. Il tutto per un salario da fame e una parte delle mance delle cameriere. Avevo chiesto di fare qualche ora di straordinario, dicendo che ero a corto di soldi. Il capo mi aveva risposto: «Lo siamo tutti». Gli affari andavano a rilento, però lui conosceva un posto dove avrei potuto ottenere un prestito. Non era una banca. Credevo di saper gestire la cosa. Avrei potuto ottenere una cifra non esagerata, da coprire con il salario successivo, e invece non andò così. Non riuscii nemmeno a pagare gli interessi. Trovammo un accordo. C’era un pezzo grosso che era in debito dieci volte più di me: se fossi riuscito a obbligarlo a pagare, mi avrebbero estinto il debito. Allora mi presentai in quella casa di Streeterville, legai la moglie e la figlia alle seggiole del salotto di antiquariato e, puntando una pistola alla testa della donna, lo vidi estrarre le banconote nuove di zecca dalla cassaforte, nascosta dietro una riproduzione delle Ninfee di Monet. Ero entrato nel giro. Qualche settimana dopo, mi scovò Dalmar. Non lo avevo mai visto né conosciuto. Mi trovavo in un bar a pensare agli affari miei quando entrò. Ero il nuovo teppistello del quartiere, il loro passatempo. Pareva che tutti avessero qualche incarico da darmi. Perciò, quando Dalmar disse che un tizio gli aveva rubato della roba, fu evidente che dovevo essere io a preoccuparmi di recuperarla. Mi ricompensarono generosamente. Adesso potevo pagare l’affitto, prendermi cura di mia madre, mangiare. Ma più guadagnavo, più sapevo di appartenere ormai a qualcun altro, non a me stesso. Lei si allontana ogni giorno di più dal capanno. Una volta scende tutti gli scalini, il giorno dopo arriva fino a dove c’è l’erba. Oggi si spinge fino al terriccio, pur sapendo che rimango seduto alla finestra a osservare quello che fa. Si mette a sedere sul terreno gelido e duro, disegna fino a intorpidirsi i muscoli. Immagino l’aria fredda che le irrigidisce le dita. Non riesco a vedere cosa disegna, ma lo intuisco: tronchi e cortecce, i rami spogli ora che le foglie sono scomparse. Tratteggia un albero dopo l’altro. Non spreca nemmeno un centimetro della preziosa carta. Chiude il quaderno e prova a spingersi fino al lago, per sedersi a riva, da sola. Vedo che raccoglie dei sassi, cerca di farli saltare sulla superficie dell’acqua. Affondano tutti. Passeggia lungo il bordo lacustre. Non troppo lontano. Alcuni metri più in là, dove non era mai arrivata. Non penso che voglia scappare, però all’improvviso non mi va più di stare da solo dentro il capanno. Lei si volta per lo scricchiolio delle foglie alle sue spalle. Vado verso il lago, con le mani infilate nelle tasche dei jeans e il colletto del giaccone alzato per proteggermi dal freddo. «Mi controlli?», domanda prima che la raggiunga. Mi fermo dietro di lei. «Ne ho bisogno?». Restiamo l’uno di fianco all’altra, senza parlare. La sfioro con il braccio, e lei si sottrae. Mi chiedo se sarebbe in grado di ritrarre questa scena, sul quaderno, intendo dire. La forma del lago azzurro e le foglie sparse a terra. Gli alberi sempreverdi e i pini scuri. Il cielo immenso. Sarebbe capace di disegnare il vento che sferza ciò che resta degli altri alberi? Saprebbe raffigurare l’aria fredda che ci divora mani e orecchie fino a farle bruciare? Comincio ad allontanarmi. «Vuoi fare una passeggiata, vero?», chiedo, siccome non mi pare che mi segua. È così. «Allora, andiamo», concludo, anche se resto sempre due passi avanti a lei. Tra noi non c’è niente, solo aria senza vita. Non so quanto sia esteso questo lago. È grande. Non so quanto possa essere profondo nel punto più basso. Non ne conosco il nome. Non c’è spiaggia, la linea della costa è frastagliata, con promontori rocciosi a strapiombo sull’acqua tutt’intorno. Sotto i nostri piedi, le foglie scricchiolano come pezzetti di polistirolo. Lei fatica a tenersi in equilibrio sul terreno accidentato. Non la aspetto. Camminiamo a lungo, finché non vediamo più il capanno tra gli alberi. Sono certo che le faranno malissimo i piedi, con quelle scarpe ridicole, le stesse che aveva all’inizio. Stravaganti scarpe da lavoro. Però l’aria fresca e l’esercizio fisico le fanno bene. Un bel cambiamento rispetto al suo poltrire pieno di autocommiserazione dentro il capanno. Mi chiede qualcosa, ma non la sento. Aspetto che mi raggiunga. «Cosa c’è?», domando di scatto. Non sono uno che si perde in convenevoli. «Hai fratelli?» «No». «Sorelle?» «Ma tu devi sempre parlare?», chiedo. Mi supera e comincia a fare strada lei. «E tu devi sempre essere così sgarbato?», domanda. Non replico. Questi sono i nostri dialoghi. Il giorno dopo esce ancora, vaga senza meta nei dintorni del capanno. Non è tanto stupida da spingersi dove non potrei vederla. Non ancora, perché sa che perderebbe questo privilegio. Ha paura dell’ignoto. Forse di Dalmar, oppure di quel che le farei se provasse a fuggire. È il timore a mantenerla nel mio campo visivo. Potrebbe mettersi a correre, ma non c’è alcun posto in cui scappare. Ha la pistola, potrebbe spararmi. Tuttavia, non ha ancora capito come far funzionare l’aggeggio. Per quanto la riguarda, vale la pena tenermi vicino solo per quello. Però finché possiede l’arma non dovrò più ascoltare le sue lamentele. Per il momento va bene così. Può uscire dal capanno nell’aria fredda a congelarsi le chiappe. Può disegnare tutto il giorno quel cazzo che le pare. Ritorna molto prima di quanto mi aspettassi. Tiene in braccio un gatto sudicio. Non che mi facciano schifo i gatti, solo che il cibo è scarso, il calore è poco. Qui non c’è spazio sufficiente per due, figurarsi per tre. E io non voglio dividere niente. Mi implora con gli occhi. «Se rivedo ancora quella bestia», dico, «le sparo». Non sono nella disposizione giusta per agire da buon samaritano. 7 Robert Ross (1943-1995), pittore e conduttore del programma televisivo The Joy of Painting. (n.d.t.) Gabe Prima Dopo aver atteso quella che ci sembrava un’eternità, anche se erano solo tre settimane, ci arrivò l’informazione giusta: una donna indiana che viveva in un grattacielo di Kenmore era sicura che il ricercato fosse un suo vicino di casa. Sembrava che si fosse assentata per un certo periodo dalla città ed era la prima volta che vedeva la sua faccia in televisione. Prendo quindi con me i rinforzi e mi reco di nuovo in centro. Il palazzone si trova precisamente a Uptown, di sicuro non il miglior quartiere della città, ma nemmeno il peggiore. Tutt’altro. A metà strada fra chi non può permettersi le zone di lusso, come Lakeview o Lincoln Park, e quelle dove vivono gli immigrati arrivati da poco. Una variegata diversità. I ristoranti etnici sono allineati lungo le strade, non solo quelli cinesi o messicani: ci sono anche locali marocchini, etiopi, vietnamiti. A prescindere da tale promiscuità, quasi metà della popolazione di Uptown è ancora di pelle bianca. Girare qui di notte è tuttora relativamente tranquillo. Peraltro, Uptown è nota per la vita notturna, pullula di bar e teatri storici. Molti personaggi famosi vi si sono esibiti davanti a persone insignificanti come me. Trovo l’appartamento e parcheggio in seconda fila, l’ultima cosa che voglio fare è regalare altri spiccioli al municipio di Chicago per la sosta dell’auto. Io e un’agente dai tratti virili entriamo nell’edificio e prendiamo l’ascensore giusto. Non risponde nessuno, la porta è chiusa a chiave. Ovviamente preghiamo la padrona di casa di farci entrare. È una signora anziana che si trascina a stento e si rifiuta di darci la chiave. «Di questi tempi non ci si può fidare di nessuno», dice. Sostiene che l’appartamento è affittato a una donna chiamata Celeste Monfredo, ha dovuto cercarne il nome nel suo archivio. Non sa nulla di lei, tranne che versa l’affitto puntualmente. «Naturalmente potrebbe esserci qualcuno in subaffitto». «Come facciamo a saperlo?», chiedo. L’anziana signora fa spallucce. «Impossibile. Gli inquilini possono subaffittare l’appartamento o pagare per recedere dal contratto». «Non ci sono moduli da riempire?». Io non posso comprare in farmacia nemmeno uno spray nasale se non metto per iscritto il mio nome… «Non che io sappia. Basta che gli inquilini continuino a versarmi la pigione. Se succede qualcosa, è un loro problema. Non mio». Le prendo le chiavi di mano e m’introduco nell’appartamento. La padrona s’intrufola insieme a noi: le devo ripetere più volte di non toccare niente. Non saprei dire cosa mi colpisce innanzitutto: una lampada rovesciata, le luci accese in pieno giorno, o il contenuto di una borsa da donna sparso sul pavimento. Estraggo dalla mia tasca un paio di guanti di gomma e perquisisco l’appartamento. Una pila di lettere è appoggiata sul banco della cucina, sepolta sotto il libro di una biblioteca che doveva essere restituito tempo fa. Controllo il destinatario e noto che tutte le lettere sono state inviate alla casella postale di un certo Michael Collins. La mia collaboratrice si infila i guanti di gomma e mette le mani nella borsa; ci trova un portafoglio e una patente di guida. «Mia Dennett», esclama ad alta voce leggendo l’intestazione, anche se ovviamente ce l’aspettavamo. «Voglio i tabulati telefonici», dico. «E le impronte digitali. Dobbiamo ispezionare l’intero edificio. Perquisire ogni appartamento. Ci sono videocamere di sicurezza?», domando alla padrona di casa. Risponde affermativamente. «Mi serve tutto quello che ha dal primo di ottobre». Esamino le pareti. Cemento. Nessuno deve aver sentito nulla di ciò che è accaduto nella stanza. Colin Prima Vuole sapere quanto mi hanno pagato per l’affare. Fa troppe domande. «Non sono stato pagato un bel niente», le ricordo. «Mi danno la mia parte se porto a termine il lavoro». «E quanto ti hanno offerto?» «Non sono affari tuoi», dico. Siamo nel gabinetto, pensa un po’. Lei ci sta entrando, io sto uscendo. Non mi scomodo a dirle che l’acqua è gelata. «Mio padre ne è al corrente?» «Te l’ho già detto, non lo so». Si doveva chiedere il riscatto al padre, questo lo sapevo. Ma non ho assolutamente idea di quello che ha fatto Dalmar quando non gli ho consegnato la ragazza. Ha l’alito pesante di chi si è appena svegliato, i suoi capelli sono un dedalo di biondo scuro. Mi chiude la porta in faccia e la sento aprire il rubinetto. Cerco di non immaginarla mentre si spoglia e scivola nell’acqua ghiacciata. Quando esce dal bagno, si sta ancora asciugando le punte dei capelli con un telo. Io sono in cucina a mangiare cereali, müsli e latte in polvere. Ho dimenticato il gusto del cibo genuino. Ho sparso sul tavolo i soldi rimasti e li sto contando. Lei adocchia le banconote. Non siamo al verde. Non ancora. Questo è positivo. Mi confida di aver sempre pensato che qualche ex galeotto incallito potesse sparare al padre sulla scalinata del tribunale. Ma dalla sua voce deduco una versione leggermente diversa: non pensava che potesse accadere, lo sperava. Resta in piedi nella stanza, vedo che trema, ma non si lamenta per il freddo. Non stavolta. «Prima di diventare giudice di pace, era stato avvocato civile, si occupava di class-action, denunce per violazioni dell’uso di amianto. Non si premurava mai di stare dalla parte del giusto. La gente moriva di malattie orribili (asbestosi, mesotelioma) e lui si adoperava per far risparmiare anche un solo dollaro alle grandi aziende. Non parlava mai di lavoro. “Informazioni confidenziali fra cliente e avvocato”, diceva, ma so che era una scusa per la reticenza, punto e basta. Io però entravo di soppiatto nel suo studio, di notte, quando dormiva. All’inizio curiosavo per trovare le prove di una sua relazione extraconiugale, nella speranza che mia madre lo lasciasse. Ero piccola, avrò avuto tredici-quattordici anni. Non avevo idea di cosa fosse un mesotelioma. Però sapevo leggere bene. Sputare sangue, palpitazioni cardiache, bozzi sotto la pelle. La metà dei pazienti muore entro un anno dalla diagnosi. Non è neppure necessario lavorare a stretto contatto con l’amianto: mogli e figli dei malati morivano perché esposti ai vestiti di questi ultimi. Più mio padre aveva successo come avvocato e più venivamo minacciati. Mia madre riceveva lettere minatorie. Sapevano dove abitiamo. Ci telefonavano. C’erano degli uomini che speravano che io, Grace e mia madre andassimo incontro a una morte dolorosa come quella delle loro mogli e dei loro bambini. Poi è diventato giudice. La sua faccia compariva sempre nei telegiornali. Sulla stampa c’erano dei grandi titoli col suo nome. Lo importunavano di continuo, ma dopo un po’ smettemmo di prestare attenzione a quelle minacce senza conseguenze dirette. Anzi, lui se ne vantava. La cosa lo faceva sentire importante. Più gente faceva incazzare e meglio svolgeva il suo lavoro». Non c’è niente da aggiungere. Non me ne intendo di questa robaccia. Non sono bravo nelle chiacchiere e di certo non sono incline alla compassione. In realtà, non so niente del criminale che può aver pensato fosse suo interesse minacciare la figlia di un bastardo. Così vanno i nostri affari. Quelli come me li tengono all’oscuro. Eseguiamo un compito senza saperne i motivi. Così, non potremo mai accusare nessuno. E comunque io non lo farei. So cosa mi succederebbe se lo facessi. Dalmar mi aveva ordinato di sequestrare la ragazza, non gli avevo chiesto perché. In tale maniera, se la polizia mi avesse beccato e sottoposto a interrogatorio, non avrei saputo rispondere alle domande subdole. Né so chi ha commissionato a Dalmar questo lavoro. Non so cosa vogliono dalla ragazza. Dalmar mi aveva detto di prenderla, e io avevo eseguito. Ma poi ho cambiato idea. Sollevo lo sguardo dalla mia scodella e poso gli occhi su di lei. Mi supplica con un’occhiata di dire qualcosa, di fare la confessione finale che spiegherebbe tutto, per lei. Ciò la aiuterebbe a capire la ragione per cui si trova qui. Perché lei e non quella stronza di sua sorella? Perché lei e non quel giudice arrogante che è suo padre? È disperata, vorrebbe una risposta esplicativa. Come mai tutto può cambiare in un batter d’occhi? La sua famiglia. La sua esistenza. Ma si arrovella invano, se pensa che io conosca la risposta. Sbaglia se crede che un tipo abietto come me possa aiutarla a vedere la luce. «Cinquemila», dico. «Come?». Non era questo che si aspettava di sentire. Mi alzo dalla sedia e la faccio strisciare sul pavimento di legno. I miei passi sono pesanti. Sciacquo la scodella sotto l’acqua del rubinetto. La poso nel lavandino facendola sbattere e lei sussulta. Mi volto verso di lei: «Mi hanno promesso cinquemila dollari». Eve Prima Mi sembra di sprecare le giornate. Faccio spesso fatica a uscire dal letto e, quando mi alzo, il mio primo pensiero va a Mia. Tutte le notti mi sveglio singhiozzando e, per non disturbare James, mi affretto a scendere al pianterreno. Di giorno è una pena continua. Vado al supermercato e sono certa di vedere mia figlia che fa la spesa tra lo scaffale dei cereali, mi fermo appena in tempo per non gettare le braccia al collo di una sconosciuta. Quando vado a riprendere l’auto, mi sembra di essere a pezzi, ci impiego più di un’ora a lasciare il parcheggio: m’incanto a osservare le madri che entrano nel negozio coi figli, tengono loro la mano mentre attraversano la piazzola; altre mettono quelli più piccoli sul seggiolino del carrello. Sono cinque settimane che vedo la faccia di Mia e l’identikit di quell’uomo apparire sugli schermi televisivi. Ma ormai ci sono cose più importanti che accadono nel mondo. Un vantaggio e uno svantaggio, presumo, perché ultimamente i cronisti sono meno invadenti. Non mi braccano davanti a casa, non mi seguono quando esco per le commissioni. L’accerchiamento e le richieste di interviste sono in fase calante: posso aprire le tende delle stanze senza vedere decine di giornalisti accampati sul marciapiede. Eppure questo cambiamento m’inquieta, ormai il nome della mia bambina suscita apatia, sono stanchi di aspettare il titolo da prima pagina che potrebbe non avverarsi mai: «Mia Dennett torna a casa», oppure «Mia Dennett trovata morta». Mi sembra che sia tutto deciso, come le nubi nere che oscurano una giornata invernale. Non verrò mai a sapere niente. Penso alle famiglie che recuperano i resti dei loro cari dopo dieci, vent’anni dalla scomparsa, e temo che sarà così anche per me. Quando sono stanca di piangere, mi faccio prendere dalla furia, rompo i calici di cristallo italiano tirandoli contro il muro, e dopo spacco tutte le stoviglie della nonna di James. Urlo con quanto fiato ho in gola, lancio grida selvagge che non mi appartengono. Raccolgo i cocci prima che rientri mio marito e nascondo i milioni di pezzi di vetro nel bidone dell’immondizia, sotto un filodendro morto, così lui non può vederli. Trascorro un pomeriggio intero a osservare i pettirossi che migrano a Sud, in posti come il Mississippi, per l’inverno. Arrivano nella veranda sul retro, grassi e infreddoliti, a fare scorte di tutto quanto gli è possibile reperire per il lungo viaggio. Piove, e ci sono vermi ovunque. Li osservo per ore, sono triste quando se ne vanno. Passeranno mesi prima del loro ritorno, le loro pance rossastre riporteranno la primavera. Un’altra volta arrivano le coccinelle. Sono migliaia, prendono il sole nel cortile sul retro. È l’estate di san Martino: fa caldo, le temperature sono risalite sopra i 15 gradi, splende il sole. La tipica giornata che si vorrebbe sempre in autunno, i colori della natura sono al loro meglio. Cerco di contarle tutte, ma loro si disperdono, e ne arrivano altre, per cui è impossibile tenere il conto di quante siano. Non so per quanto tempo mi intestardisca a farlo. Mi chiedo cosa faranno le coccinelle durante l’inverno. Moriranno? E poi, alcuni giorni dopo, quando la terra è coperta dalla gelata, ripenso alle coccinelle e mi viene da piangere. Mi torna in mente Mia quand’era bambina. Penso alle cose che facevamo. Vado al parco giochi dove ero solita portarla mentre Grace era a scuola. Mi siedo sull’altalena. Con la mano sposto la sabbia nella cassetta, poi mi accomodo su una panchina e fisso i bambini. Guardo le madri fortunate che hanno ancora i loro figli a cui badare. Ma soprattutto penso alle cose che non ho fatto. A quando rimanevo zitta se James sgridava Mia perché 7 non era un bel voto nei test di chimica, a quando lei ci portò a casa un dipinto impressionista da mozzare il fiato, su cui si era impegnata più di un mese, e lui l’aveva derisa: «Se avessi dedicato lo stesso tempo alla chimica, adesso avresti un bel 9 in questa materia». Io li avevo solo guardati di sottecchi, incapace di intervenire. Per timore che James si arrabbiasse, non ero stata capace di consolare Mia dalla sua delusione. E quando lei lo informò che non aveva affatto intenzione di iscriversi a giurisprudenza, lui disse che non aveva la possibilità di scegliere altro. Mia aveva diciassette anni, era nel pieno della tempesta ormonale e mi implorava: «Mamma». Era disperata, voleva che, almeno per una volta, mi imponessi. Avevo continuato a lavare i piatti, pur di eludere il loro scontro. Ricordo la disperazione sul volto di mia figlia, la contrarietà di James. Scelsi il minore dei due mali. «Mia», dissi. Non dimenticherò mai quel giorno. Sullo sfondo, lo squillo del telefono, sebbene nessuno di noi vi prestasse attenzione. L’odore di qualcosa che avevo bruciato in cucina, la fredda aria primaverile che entrava da una finestra che avevo aperto per far sparire quella puzza. Il sole indugiava ancora, era una cosa che valeva la pena di commentare, se non fossimo stati preoccupati per Mia. «Per lui è molto importante», le dissi. «Vuole che tu diventi come lui». Lei era uscita furibonda dalla cucina e, di sopra, aveva sbattuto la porta della sua camera. Sognava di studiare all’Art Institute di Chicago, voleva diventare un’artista. Era tutto ciò che le interessava fare, da sempre. James invece si opponeva. Da quel giorno Mia iniziò il conto alla rovescia per il suo diciottesimo compleanno, preparava le cose che avrebbe portato via con sé al momento della partenza. Oche e anatre volano sopra di me. Mi stanno lasciando tutti. Mi domando se Mia, da qualche parte, stia osservando il cielo, se stia vedendo la medesima cosa. Colin Prima Abbiamo tempo per pensare, ne abbiamo un sacco. Quello stupido gatto continua a gironzolare da queste parti, ora sa che la ragazza è disposta a sacrificare parte dei suoi pasti per lui. Lei ha trovato una coperta tarlata nell’armadio e, con una scatola vuota presa dal pianale del pick-up, ha creato una specie di cuccia per quella bestia. Ogni giorno gli porta del cibo. Gli ha trovato perfino un nome: Canoa. Non che si sia presa la briga di dirmelo, però l’ho sentita stamattina che lo chiamava, perché non aveva dormito nella scatola. Adesso è preoccupata. Vado al lago e mi siedo là, pesco tranquillamente. Mangerei trote per il resto della vita se ciò significasse non dover più ingurgitare qualcosa di liofilizzato. Il più delle volte prendo lucci, poi occhiogrigi. A volte trote. I lucci li distinguo per le macchie chiare, e perché sono i primi ad abboccare. Il lago si riempie ogni anno, così trovo avannotti e pesciolini di pochi mesi. Il persico è quello che mi fa arrabbiare di più. Finché non lo tiro fuori dall’acqua, scommetterei che è il doppio di come poi si rivela. Brutto bastardo. Passo gran parte del tempo a riflettere sul modo in cui ce la caveremo. Sul modo in cui mi salverò da questo casino. Comincia a scarseggiare il cibo, il che vuol dire tornare in un negozio. Ho i soldi. Solo che non so quanto ci vorrà prima che qualcuno mi riconosca. E cosa faccio della ragazza, quando esco? La scomparsa della figlia di un giudice è una notizia da prima pagina, ci scommetterei qualsiasi cosa. Qualunque commessa di negozio la riconoscerà e chiamerà la polizia. Il che mi induce a chiedermi: La polizia ha scoperto che ero con lei la sera della sua scomparsa? La mia faccia e la sua sono su tutti i fottuti canali televisivi? Forse è un fatto positivo, mi dico. Non per me, se ciò significa che verrò catturato. Ma se Valerie vede i miei connotati in televisione, saprà che sono la persona implicata nella scomparsa di una donna di Chicago, e si darà da fare. Saprà che non potrò essere dove serve a garantire che ci sia cibo in tavola e che le porte siano chiuse. Saprà quel che occorre fare. Quando la ragazza è distratta, tiro fuori dal mio portafoglio una fotografia. È logorata dal tempo, rovinata sui bordi dalle tante volte che l’ho tirata fuori e rimessa dentro. Mi chiedo se e quando sarà arrivato il denaro che ho rubato durante la sosta a Eau Claire. Mi chiedo se sa che proviene da me. Al momento del recapito, si sarà accorta che sono nei guai: cinquecento dollari o più infilati in una busta senza indicazione del mittente. Ma non sono un sentimentale, mi basta sapere che lei sta bene. Non è che sia sola. O almeno è ciò che mi ripeto. La vicina passa ogni settimana, raccoglie la posta e controlla come sta lei. Vedranno i soldi. Passata la domenica, non vedendomi, lo sapranno. Se non hanno già notato la mia faccia in TV. Se Valerie non l’ha già vista e non è andata da lei a controllare, ad assicurarsi che stia bene. Cerco di convincermi: c’è Valerie. È tutto okay. Quasi quasi ci credo. Quella sera, più tardi, stiamo all’esterno. Provo a grigliare il pesce per la cena. Purtroppo, non abbiamo la carbonella, quindi cerco qualcos’altro per accendere il fuoco. La ragazza siede sulla veranda, avvolta in una coperta. Si arrovella per il gatto, vuole sapere dove si trovi. Sono due giorni che non lo vede, si preoccupa. Comincia a fare sempre più freddo. Prima o poi il gatto morirà. «Immagino che tu non sia un cassiere di banca», dice. «Cosa credi?», chiedo. Lo prende come un no. «Allora cosa fai?», domanda. «Lavori?» «Lavoro». «Una roba legale?» «Faccio quel che serve per sopravvivere. Come te». «Non penso», commenta. «Come mai?» «Io mi guadagno da vivere onestamente. Pago le tasse». «Come fai a sapere che io non le pago?» «Tu paghi le tasse?», si stupisce. «Lavoro», ribadisco. «Mi guadagno di vivere in modo onesto. Pago le tasse. Ho pulito i pavimenti dei cessi in un’agenzia immobiliare. Ho fatto il lavapiatti, ho scaricato le casse dai camion. Lo sai quanto pagano di questi tempi? Salario minimo. Hai un’idea di cosa significhi sopravvivere col salario minimo? Faccio un doppio lavoro, tredici o quattordici ore al giorno. Così pago l’affitto e compro da mangiare. Le persone come te, cosa fanno? Otto ore al giorno più le ferie annuali». «Io insegno anche alla scuola estiva», interviene lei. Una cosa stupida da dire. Lo sa da sola, ancor prima che glielo faccia capire con lo sguardo. Lei non sa un’acca di queste cose. Non riesce nemmeno a immaginarsele. Alzo gli occhi al cielo, alle nuvole scure che minacciano non pioggia, ma neve, che presto arriverà. Lei si stringe la coperta addosso. Trema per il freddo. È consapevole che non le permetterò mai di scappare. Ho da perdere più io di lei. «Hai fatto altre volte questa cosa», afferma. «Fatto cosa?» «Rapimenti. Puntare la pistola alla testa di qualcuno». Non è una domanda. «Forse sì, forse no». «Non mi hai sequestrata come uno alle prime armi». Ho acceso il fuoco, metto i pesci sulla griglia e vedo che cominciano a cuocere. «Non ho mai dato fastidio a nessuno che non lo meritasse». Però lo so anch’io che non è vero. Giro i pesci. Si cuociono più in fretta di quanto desideri. Li sposto sul margine della graticola, per evitare che si brucino. «Potrebbe essere peggio», le assicuro. «Molto peggio». Mangiamo all’aperto. Lei siede a terra, con la schiena appoggiata alle assi dello steccato. Le porgo una sedia, mi ringrazia ma la rifiuta. Allunga le gambe davanti a sé, incrocia le caviglie. Il vento soffia tra gli alberi. Ci voltiamo entrambi a osservare le foglie che perdono la loro presa sui rami e cadono al suolo. Ed è allora che li sentiamo, i passi sulle foglie secche che coprono il terreno. È il gatto, penso subito, ma poi mi accorgo che sono troppo pesanti e decisi per quella bestiola rinsecchita. Scambio un’occhiata con la ragazza, mi porto l’indice alle labbra e sussurro: «Shh». Dopodiché mi alzo e tasto la cintola dietro la schiena, per cercare una pistola che non c’è. Gabe Prima Aspettavo per parlare coi Dennett, prima volevo avere dei fatti in mano, ma le cose vanno diversamente. Sono alla mia scrivania e sto masticando un panino unto con una fettina di manzo quando Eve Dennett si presenta alla centrale di polizia; chiede all’addetto alla ricezione di potermi parlare. Mi sono appena pulito il grasso dalla faccia con dei tovagliolini di carta quando la vedo lì davanti a me. È la prima volta che viene in centrale, e sembra proprio fuori posto. Lei è tutt’altra cosa rispetto agli ubriaconi e ai disgraziati che ciondolano da queste parti. Sento il suo profumo da lontano. Sfila contegnosa davanti agli occhi dei poveri stronzi seduti nello stanzone, invidiosi nel vedere i suoi tacchi alti fermarsi davanti a me. Sanno tutti che il caso Dennett è nelle mie mani, ed è ancora aperta la scommessa sul mio eventuale fallimento. Perfino il sergente era disposto a puntarci dei soldi: diceva che la posta in palio gli avrebbe fatto comodo quando io e lui ci saremmo ritrovati senza un lavoro. «Salve, ispettore». «Signora». «È da qualche giorno che non ci sentiamo», aggiunge. «Mi chiedevo se ci fossero… notizie». Ha un ombrello che gocciola sul linoleum. La tempesta che infuria fuori le ha scompigliato i capelli. È una giornata orribile, fredda e ventosa. Non da trascorrere all’aperto. «Avrebbe potuto telefonare», dico. «Sono uscita per delle commissioni», spiega, ma so che mente. Oggi non uscirebbe nessuno di casa, se non obbligato. È una di quelle giornate in cui chi può resta a casa in pigiama davanti alla televisione. La accompagno nella stanza dove facciamo gli interrogatori e la invito ad accomodarsi. Un posto squallido, male illuminato, con un grosso tavolo al centro e un paio di sedie pieghevoli. Lei lascia l’ombrello a terra ma tiene stretta la borsa. Le chiedo di darmi il cappotto, ma non vuole. Qui dentro fa freddo, l’umidità penetra nelle ossa. Mi siedo davanti a lei e metto sul tavolo la cartella coi dati del caso. Noto che posa gli occhi sulla copertina marrone. Mi concentro soprattutto sui suoi occhi azzurri. Stanno già cominciando a gonfiarsi di lacrime. Più passano i giorni e più mi ritrovo a pensare a cosa succederà se non riuscissi a rintracciare Mia. È evidente che la signora Dennett sta crollando, ogni giorno di più. Ha gli occhi gonfi e stanchi, come se non dormisse da tempo. Non voglio nemmeno pensare a come si ridurrà se la figlia non tornasse più a casa. Penso sempre a questa donna, giorno e notte, la immagino sola e smarrita nella sua residenza, a lambiccarsi il cervello sugli orrori che potrebbero aver inflitto alla sua bambina. Avverto un bisogno fortissimo di proteggerla, di rispondere alle domande impellenti che la tengono sveglia di notte: chi, dove e perché? «Stavo per chiamarla», affermo con calma. «Ero proprio in attesa di buone notizie». «È accaduto qualcosa», dice lei. Non è una domanda. È come se sapesse che è successo qualcosa, e quello è il motivo che l’ha portata in centrale. «Qualcosa di brutto». Posa la borsetta sul tavolo e ci infila una mano per prendere un fazzolettino. «Ci sono notizie, ma per il momento niente di grave. Non ho ancora vagliato bene cosa possano implicare». Se fosse qui, il giudice Dennett mi criticherebbe subito aspramente. «Crediamo di sapere con chi era Mia prima di sparire», dico. «Una persona ha identificato la foto che abbiamo fatto trasmettere dai telegiornali; quando siamo stati nell’appartamento dell’uomo, abbiamo trovato alcuni effetti personali di Mia, la sua borsetta e una giacca». Apro la cartellina e sparpaglio delle foto sul tavolo, quelle scattate nell’appartamento dalla poliziotta che mi aveva accompagnato. La signora Dennett prende in mano l’istantanea della borsa, una di quelle tracolle da fattorino enormi. Si trovava sul parquet, ne erano usciti un paio di occhiali da sole e un portafoglio verde. Eve si tampona gli occhi col fazzoletto. «Riconosce qualcosa?», chiedo. «L’avevo scelta io, la borsa. Gliel’ho comprata io. Lui chi è?», domanda, senza pause tra un pensiero e l’altro. Esamina anche le altre foto, una per volta, poi le mette in fila. Incrocia le braccia sul tavolo. «Colin Thatcher», scandisco. Avevamo analizzato le impronte digitali rilevate nell’appartamento di Uptown e identificato l’uomo; ogni altro nome che compariva in quell’appartamento (posta, telefonino ecc.) era uno pseudonimo, un falso. Avevamo confrontato le segnaletiche degli arresti precedenti con lo schizzo del ritrattista forense. Bingo. Vedo che le tremano le mani, anche se tenta di controllarsi. Senza pensarci, tendo un braccio verso di lei per tranquillizzarla. Sento che ha le dita gelate, prima che lei possa ritrarle, nella speranza di dissimulare la paura che prova. «Ci sono delle riprese delle videocamere di sicurezza. Mia che entra nell’appartamento con Colin, verso le undici di sera, e poi delle sequenze successive, quando lasciano l’edificio». «Voglio vederle», dice con mia grande sorpresa. La sua reazione è decisa, diversa dal suo abituale comportamento. «Non credo sia una buona idea», ribatto. L’ultima cosa che Eve deve vedere ora è la maniera in cui l’uomo ha scaraventato Mia fuori dell’edificio e il terrore negli occhi della figlia. «È un brutto spettacolo», ne deduce. «È inutile», mento. «Non voglio che si faccia un’impressione sbagliata». Ma nella fretta con cui l’uomo esce dall’ascensore, facendo attenzione che nessuno veda qualcosa, o nella paura impressa negli occhi della ragazza non vi è nulla di ambiguo. Lei piange; lui articola delle frasi, che sono certo contengano parolacce. È accaduto qualcosa in quell’appartamento. Anche le riprese di quando erano arrivati sono eloquenti: due piccioncini che non vedevano l’ora di farsi una sveltina. «Ma lei era viva?» «Certo». «Lui chi è?», domanda. «Questo Colin…». «Colin Thatcher». Lascio la mano della signora e armeggio ancora nella cartella. Tiro fuori la fedina penale dell’uomo. «È stato già arrestato per vari reati, piccoli furti, violazioni di proprietà, possesso di marijuana. Ha scontato pene detentive per spaccio di stupefacenti e lo si deve ancora interrogare su un fatto in cui è implicata la criminalità organizzata. Secondo l’ufficio di sorveglianza della libertà vigilata, si è reso uccel di bosco alcuni anni fa e attualmente è ricercato». Non saprei descrivere l’orrore impresso negli occhi azzurri della donna. In quanto ispettore di polizia, sono assuefatto a espressioni come «violazione di proprietà», «criminalità organizzata» e «ufficio di sorveglianza della libertà vigilata». La signora Dennett, invece, le ha sentite solo nelle repliche di Law & Order. Non riesce ad afferrare bene il quadro generale. Comunque, la terrorizza il fatto che sua figlia sia nelle mani di un delinquente di tale risma. «Cosa vorrà da Mia?», mi chiede. Mi sarò posto quell’interrogativo un migliaio di volte. Il crimine casuale è piuttosto raro, generalmente le vittime conoscono il loro aguzzino. «Non saprei», ammetto. «Non ne ho idea, ma le prometto che lo scoprirò». Colin Prima La ragazza posa il piatto sul pavimento di legno di fianco a sé, poi si alza per venirmi vicino; guardiamo entrambi oltre lo steccato, verso la foresta fitta da cui emerge una donna. Una cinquantenne coi capelli corti e scuri, con indosso un paio di jeans, una camicia di flanella e gli scarponi da escursione. Agita la mano come se ci conoscesse, mentre mi viene in mente che possa essere una trappola. «Oh, grazie al cielo», esclama la donna entrando nella nostra proprietà senza chiedere permesso. Uno sconfinamento, un’invasione abusiva del nostro spazio. Qui non doveva esserci nessuno. Mi sento soffocare, mi manca l’aria. La donna tiene una borraccia d’acqua in mano. Ha l’aspetto di una che ha camminato per cento e più chilometri. «Possiamo aiutarla?», le parole mi escono di bocca prima di poter riflettere e decidere quello che conviene fare. Il mio primo pensiero sarebbe di prendere la pistola ed eliminarla. Scaricare il suo corpo nel lago e scappare. Ma non ho più l’arma e non so dove la ragazza la nasconda. Comunque, potrei legarla e passare al setaccio il capanno per trovarla. Sotto il materasso, in camera da letto, oppure in una fenditura tra i tronchi delle pareti. «Ho una gomma a terra, sulla strada a quasi un chilometro da qui», dice. «Il vostro capanno è la prima casa abitata. Ho cominciato a camminare…», aggiunge, poi si ferma a riprendere fiato. «Vi dispiace se mi siedo per riposare?», chiede. Quando la ragazza annuisce appena, crolla sull’ultimo gradino e tracanna dalla borraccia come se vagasse nel deserto da giorni. Allungo una mano per afferrare quella della ragazza e la stringo fino a strapparle un gemito. Dimentichiamo del tutto la nostra cena. Ma ce la rammenta la donna. «Mi dispiace di avervi interrotto», soggiunge, indicando i piatti sul pavimento. «Volevo sapere se potete aiutarmi a cambiare la gomma. O magari a chiamare qualcuno. Qui il mio telefonino non ha campo», dice tenendolo in alto per farcelo vedere. Ripete le scuse per averci interrotto. Non ha idea del casino in cui si sta infilando. Non sta certo disturbando solo la nostra cena. Guardo negli occhi la ragazza. Ora ha una possibilità, penso. Potrebbe dire qualcosa alla donna, spifferarle che sono un pazzo che l’ha rapita, che la tiene prigioniera nel capanno. Trattengo il fiato, temo che possa andare storto un mucchio di cose: la ragazza che mi tradisce, la donna che potrebbe essere un’esca per catturarmi. Forse agisce sotto copertura, oppure per Dalmar. O potrebbe anche essere una semplice telespettatrice, che prima o poi si accorgerà che quella è la ragazza scomparsa. «Non abbiamo un telefono», dico, memore di aver lanciato il cellulare di Mia nel bidone dell’immondizia, a Janesville, e aver tagliato il filo del telefono fisso subito dopo essere arrivati. Né posso farle mettere piede nel capanno e vedere come viviamo da settimane: come due evasi in fuga. «Però posso aiutarla», aggiungo controvoglia. «Non vorrei darvi fastidio», precisa la donna, mentre la ragazza si affretta a dire: «Io resto qui a lavare i piatti», chinandosi subito per raccoglierli dal pavimento. Non glielo permetterò mai, cazzo. «Meglio se vieni anche tu», le intimo. «Potrebbe servirci il tuo aiuto». Al contrario, la donna insiste: «Per carità, non voglio trascinarvi fuori tutti e due di notte», stringendosi addosso la camicia di flanella per sottolineare quanto faccia freddo. Ma naturalmente non posso lasciare sola la ragazza, anche se la donna assicura di essere un’ottima assistente. Mi prega di non trascinarmi dietro la mia «fidanzata» in una sera come quella. È da brividi, ribadisce, e presto sarà notte. Però non posso lasciarla sola, se lo faccio potrebbe scappare. Già me la immagino fiondarsi nei boschi e allontanarsi per un paio di chilometri prima che io finisca di cambiare la gomma e torni indietro. E poi sarebbe già buio e non avrei alcuna chance di riacchiapparla. La donna si scusa per avere creato quest’inconveniente. Penso di usare le mani per strozzarla: basta comprimere la giugulare per bloccare l’afflusso di ossigeno al cervello. Forse è proprio quello che dovrei fare. «Ma io laverò solo i piatti…», obietta la ragazza, calma. «Così non dovremo più pensarci dopo», aggiunge, lanciandomi uno sguardo allusivo, come se volesse passare con me la notte. «Credo debba venire anche tu», ripeto gentilmente, posandole una mano sul braccio, come se l’idea di separarmi da lei mi fosse insopportabile. «Una fuga romantica?», azzarda la donna. «Qualcosa del genere», rispondo, poi mi volto verso la ragazza e sussurro, poco conciliante: «Forza, vieni anche tu!». Mi avvicino al suo orecchio e aggiungo piano: «Altrimenti la donna non esce viva di qui». Per mezzo secondo, resta immobile, raggelata. Poi posa i piatti a terra e ci dirigiamo verso il pick-up; io e la donna davanti, lei si raggomitola dietro. Tolgo in fretta i residui di corda e di nastro isolante dal sedile del passeggero, sperando che la donna non li abbia notati. Li caccio nel vano portaoggetti e chiudo la portiera, dopodiché mi rivolgo a lei con un bel sorriso: «Dove andiamo?». Durante il tragitto ci racconta di venire dal sud dell’Illinois. Insieme a qualche amica si era sistemata in un cottage, poi erano andate in canoa sulle Boundary Waters. Estrae una fotocamera dalla borsetta e ci mostra le immagini digitali delle quattro signore attempate: sono sulla canoa, col cappello da sole, o trincano vino attorno a un fuoco. Questo mi fa stare già meglio: non è una trappola. Ci sono le foto a provarlo. Era uscita in canoa con le amiche, sulle Boundary Waters. Lei però si premura di dirmi, come se me ne fregasse qualcosa, che aveva deciso di restare un altro paio di giorni. È divorziata da poco e non ha fretta di tornare in un appartamento vuoto. Una divorziata da poco, penso. Nessuno la aspetta a casa. Passerà del tempo prima che qualcuno si metta a cercarla e ne denunci la scomparsa; sicuramente alcuni giorni, se non di più. Abbastanza per darmi agio di fuggire, di essere già lontano quando qualcuno s’imbatterà nel suo cadavere. «E poi, proprio mentre progettavo di rituffarmi nella civiltà», racconta, «la gomma a terra. Devo averla bucata su una pietra appuntita, o sarà stato un chiodo». La ragazza partecipa, cordiale: «Probabile». Io faccio fatica anche solo ad ascoltare. Ci arrestiamo dietro la sua utilitaria. Prima di uscire dalla macchina, controllo rapidamente la fitta boscaglia circostante: scruto nei più piccoli recessi degli arbusti per vedere se ci sono poliziotti, fucili, binocoli. Mi assicuro che la gomma sia bucata davvero. Lo è. Se fosse stato un agguato, non si sarebbero affidati a un piano tanto complicato per fregarmi. In tal caso, non appena uscito dal mio veicolo mi avrebbero sbattuto con la faccia a terra, e qualcuno sopra di me mi avrebbe messo le manette ai polsi. Vedo la donna che mi guarda mentre arraffo alcuni attrezzi dal pianale del pick-up; poi mi accingo a togliere il coprimozzo e ad allentare i bulloni, sollevando l’auto col cric e sostituendo lo pneumatico con la ruota di scorta. Le due donne parlano di canoa, dei boschi del Minnesota settentrionale, del vino rosso, di un alce che la donna aveva visto durante il viaggio, un maschio dai palchi enormi che errava fra gli alberi. Sono sicuro che si sta sforzando di ricordare se ci ha visti in televisione o no. Ma mi ripeto che è stata per un po’ nel bel mezzo del nulla con le amiche; aveva pagaiato, aveva campeggiato, aveva bivaccato e bevuto vino. In tali occasioni non si guarda la televisione. Metto una torcia elettrica in mano alla ragazza e le dico di reggerla. Ormai è buio e non ci sono lampioni da queste parti. Incrociando i suoi occhi, la minaccio con lo sguardo, ricordandole di evitare termini come «pistola», «rapimento» e «aiuto». Le ucciderei tutte e due. Io lo so, mi chiedo se lei ne sia consapevole. Allorché la donna ci domanda informazioni sul nostro viaggio, vedo la ragazza impietrirsi. «Fino a quando resterete?», s’informa. Siccome lei non risponde, sono io a dire: «Una settimana più o meno». «E da dove venite?», domanda. «Green Bay», rispondo. «Ma davvero?», si stupisce. «Ho visto la targa dell’Illinois e pensavo…». «Non sono ancora riuscito a cambiarla, tutto qua», spiego, maledicendomi mentalmente per il mio errore. «Siete originari dell’Illinois?», insiste. «Sì», dico, senza aggiungere da dove veniamo di preciso. «A Green Bay vive un mio cugino; in effetti, molto vicino, a Suamico». Mai sentito parlare di questo buco in culo al mondo. Eppure, lei continua a cianciare. Il cugino è preside in una scuola media. Lei ha i capelli castani molto corti, come quelli di una vecchia. Se la conversazione langue, si mette a ridere. Una risata nervosa. Poi cerca un altro argomento da trattare. Qualsiasi cosa. «Siete tifosi dei Packers, la squadra di football?», chiede, e io confermo, mentendo. Sistemo il più rapidamente possibile la ruota di scorta, poi abbasso il cric, stringo i bulloni e mi rialzo a guardare la donna, in dubbio se lasciarla andare via e farla tornare nella civiltà, dove potrebbe scoprire chi siamo e avvertire la polizia. L’alternativa sarebbe spaccarle la testa con la chiave inglese e abbandonarla per sempre nei boschi. «Non sapete quanto apprezzi quel che avete fatto», esclama, e io penso a mia madre, abbandonata nei boschi a diventare cibo per gli orsi, allora annuisco e le dico che non è niente. È così buio che riesco appena a vederla e lo stesso vale per lei. Stringo la chiave inglese in mano, penso con quanta forza dovrei colpirla per ucciderla. A quante volte dovrei farlo. Mi chiedo se sarebbe in grado di reagire, oppure se cadrebbe subito giù, tirando le cuoia. «Se non vi avessi incontrato, non so cosa avrei fatto». Avanza di un passo per stringermi la mano e aggiunge: «Credo di non aver capito bene i vostri nomi». Tengo stretta la chiave inglese. Molto meglio che ucciderla a mani nude. Molto meno personale. Non dovrei fissarla negli occhi mentre oppone resistenza. Un colpo ben assestato e sarà tutto finito. «Owen», dico, stringendo la sua mano fredda, «e questa è Chloe», mentre la donna afferma di chiamarsi Beth. Non so quanto tempo rimaniamo così, in piedi sulla strada buia, senza aggiungere altro. Mi batte forte il cuore quando vedo un martello nella cassetta degli attrezzi. Forse potrebbe funzionare meglio. Ma poi avverto la mano della ragazza sul mio braccio e sento le sue parole: «Dovremmo andare». Mi volto verso di lei e capisco che mi legge nel pensiero, anche perché ha notato come stringo la chiave inglese, pronto a colpire. «Andiamo», ripete, conficcandomi le unghie nella pelle. Rimetto la chiave inglese nella cassetta degli attrezzi, che sistemo sul pianale del pick-up. Osservo la donna mentre sale nella sua auto e se ne va lentamente, coi fari che si perdono nella folta vegetazione. Ansimo, le mie mani sono sudatissime quando apro la portiera dell’auto ed entro per riprendere una respirazione normale. Eve Dopo Siamo seduti nella sala d’attesa, io, Mia e James; lei sta in mezzo a noi due, come la farcitura di crema al latte degli Oreo. Me ne sto in silenzio a gambe accavallate, con le mani intrecciate sulle ginocchia. Osservo un’illustrazione sulla parete di fronte, uno dei tanti Norman Rockwell in questa stanza: un vecchio che applica lo stetoscopio alla bambola di una ragazzina. James è seduto con una caviglia sul ginocchio, e intanto sfoglia le pagine di «Parents». Sbuffa impaziente, io lo prego di calmarsi. Aspettiamo da più di mezz’ora la dottoressa, che è la moglie di un giudice amico di mio marito. Mi chiedo se Mia non ritenga strano il fatto che tutte le copertine delle riviste che ci sono in giro ritraggano dei neonati. La gente la squadra, cominciano i commenti a bassa voce, sentiamo il nome di Mia sulla bocca di perfetti sconosciuti. La rassicuro con dei colpetti sulla mano, le dico di non agitarsi, suggerisco di ignorarli, però anche a me riesce difficile farlo. James va dalla segretaria per accelerare le cose, e la donnetta coi capelli rossi scompare per accertarsi del motivo del ritardo. Non abbiamo svelato a nostra figlia la vera ragione per cui oggi siamo qui. Non le abbiamo riferito i miei sospetti. Le abbiamo solo detto che eravamo preoccupati perché ultimamente accusava dei malesseri, e James aveva suggerito una dottoressa dal cognome russo, quasi impossibile da pronunciare. Mia ci aveva spiegato di avere il suo dottore di fiducia, nel cui ambulatorio in centro si recava saltuariamente ormai da sei anni; ciononostante, il padre aveva insistito, dicendo che la dottoressa Wakhrukov era meglio. E a nostra figlia non era venuto in mente che la donna potesse essere una ginecologa e un’ostetrica. L’infermiera chiama il suo nome, anche se ovviamente quando dice «Mia», James deve darle un colpetto con il gomito per ottenere la sua attenzione. Lei posa la rivista sulla sedia e io la guardo con occhi dolci, chiedendole se vuole che l’accompagni. «Se ti fa piacere», dice, mentre aspetto la disapprovazione di James, che invece tace. L’infermiera fissa Mia mentre la pesa e le prende l’altezza. La guarda come se fosse una celebrità, anziché la vittima di un crimine. «Ti ho vista in televisione», dice, ma le parole le escono in modo imbarazzato, quasi fosse incerta se le ha pronunciate davvero o sono rimaste nella sua testa. «Ho letto la tua storia sui giornali». Noi due non siamo sicure di quello che si possa dire. Mia ha visto un sacco di articoli che avevo ritagliato durante la sua assenza. Avevo cercato di nasconderli, però lei li ha trovati lo stesso una volta che cercava ago e filo in un cassetto del mio comò per riattaccare un bottone della camicetta. Non volevo che vedesse quegli articoli per paura che potessero ferirla. Invece lei se li è letti uno per uno, finché non l’ho interrotta, per cominciare io stessa a leggerle le storie sulla sua scomparsa, sulla polizia che sospettava di un uomo e, col passare del tempo, sui timori per la sua possibile morte. L’infermiera la invita ad andare in bagno per orinare in un contenitore. Pochi minuti dopo torna. L’infermiera le misura la pressione sanguigna e le prende i battiti del polso, poi le dice di spogliarsi e di indossare un camice. Aggiunge che la dottoressa arriverà a breve; mentre Mia si spoglia, io mi volto. La Wakhrukov è una donna triste e austera, ormai vicina ai sessanta. Entra nella stanza in modo brusco e dice a Mia: «Quando hai avuto le ultime mestruazioni?». A lei deve sembrare strana quella domanda. «Non ne ho… idea», dice, al che la dottoressa annuisce, forse rammentando solo a quel punto l’amnesia di cui soffre mia figlia. Dice che eseguirà un’ecografia transvaginale: copre una sonda con una sorta di preservativo che spalma di gel. Ordina a Mia di appoggiare i polpacci sulle staffe e, senza altre spiegazioni, inserisce la sonda. Mia sussulta e vuole sapere cosa le sta facendo, non sa come collegare quest’esame al grande affaticamento che prova, alla svogliatezza che le rende quasi impossibile alzarsi dal letto al mattino. Resto in silenzio. Vorrei essere in sala d’attesa con James, ma mi ripeto che Mia ha bisogno di me, e allora comincio a guardarmi intorno, distogliendomi dall’esame intrusivo della dottoressa nonché dall’ovvio disagio e sconcerto di mia figlia. Capisco che avrei dovuto rivelarle i miei sospetti, spiegarle che l’affaticamento e le nausee mattutine non sono sintomi di un disturbo acuto dovuto allo stress. Anche se forse non mi avrebbe creduto. La stanza in cui si svolge l’esame è sterile e asettica come la dottoressa. C’è abbastanza freddo da uccidere tutti i germi. Mia ha la pelle d’oca. Il fatto che sia completamente nuda, a parte il camice di carta, non aiuta di certo. Sul soffitto ci sono luci al neon molto forti, che mettono in risalto ogni capello grigio sulla testa della dottoressa. Lei non sorride, ha zigomi alti e il naso sottile da russa, ma quando parla non ha un accento slavo. «Confermo la gravidanza in corso», dichiara, come un fatto conclamato, come se Mia lo sapesse già. Sento le gambe cedere e vado a sedermi su una sedia, che probabilmente è destinata ai futuri papà inorgogliti. Non a me, la sedia non era destinata a me. «Il battito cardiaco si comincia a sentire intorno al ventiduesimo giorno. Non è sempre possibile rilevarlo subito, ma qui è evidente. Piccolo, ma evidente. Vede?», chiede a Mia mentre sposta lo schermo per mostrarglielo. «Questo guizzo, questo movimento?», prosegue, puntando un dito su una macchia scura, quasi immobile. «Come?», domanda Mia. «Qui, vediamo se è possibile scorgerlo meglio», dice la dottoressa spingendo la sonda ancor più a fondo. Mia si contorce per il dolore e il disagio, mentre la russa la invita a rimanere ferma. Tuttavia, la domanda di mia figlia implicava una cosa diversa da quella immaginata dalla dottoressa. Non è che lei non riuscisse a vedere dove puntava il dito. Mia si porta una mano sulla pancia. «Non può essere». «Qui», ripete la dottoressa, dopodiché estrae la sonda e porge a Mia un pezzetto di carta plastificata, un quadretto grigio, bianco e nero che figurerebbe bene fra l’arte astratta. È una foto, molto simile a quella della stessa Mia quando non era ancora nata. Stringo la borsetta tra le mani tremanti, rovistando dentro in cerca di un fazzolettino. «Cos’è questo?», chiede Mia. «Il bambino. La stampa dell’ecografia». Poi le dice di alzarsi, mentre si toglie il guanto di gomma e lo getta in un cestino. Le sue parole sono neutre, come se ripetesse una lezione per l’ennesima volta: Mia dovrà tornare in visita una volta al mese, fino alla trentaduesima settimana, poi ogni quindici giorni. Ci saranno esami da fare: analisi del sangue, anche l’amniocentesi se vuole, e il test dell’intolleranza al glucosio, oltre a quello per l’infezione da streptococco di gruppo B. Verso la ventesima settimana di gravidanza, se lo desidera potrà conoscere il sesso del nascituro. «È interessata a saperlo in anticipo?», le domanda. «Non saprei», è tutto quanto riesce a dire Mia. La Wakhrukov s’informa se mia figlia abbia altre curiosità da soddisfare. Ne avrebbe una, sebbene trovi appena la voce per formularla. Si schiarisce la voce e ci prova, la sua domanda è poco più che un sussurro: «Sono incinta?». Sarebbe il sogno di tutte le ragazze che si realizza. Cominciano a pensarci fin da giovanissime, ancora prima di sapere come si fanno i bambini. Si baloccano con le bambole, le accudiscono e fantasticano sul nome. Mia da piccola preferiva nomi sofisticati: Isabella, Samantha, Savannah. Poi ci fu la fase in cui dovevano finire sempre con I: Jenni, Dani, Lori. Non le veniva mai in mente che avrebbe potuto partorire un maschio. «Sì, di circa cinque settimane». Non doveva succedere così. Appoggia una mano sulla pancia, sperando di percepire qualcosa: il battito cardiaco, un calcetto. È troppo presto, eppure sperava di sentire una vibrazione dentro di sé. Niente di niente. Lo intuisco dal suo sguardo quando si volta e mi vede in lacrime. Si sente vuota, evanescente. Mi dice: «Non può essere. Non posso essere incinta». La dottoressa prende uno sgabello girevole e si siede. Copre le gambe di Mia con il camice e poi dice, stavolta in tono più cortese: «Non ricordi come sia accaduto?». Mia scuote la testa. «Jason», azzarda, ma ci ripensa. «No, sono stata con lui diversi mesi fa». Li conta sulle dita: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. «Cinque mesi», conclude. I conti non tornano. E ovviamente io so che Jason non può essere il padre del bambino. «Hai tempo per decidere cosa preferisci fare. Ci sono varie opzioni». La dottoressa porge a Mia degli opuscoli: adozione, aborto. Le parole la colpiscono come schioppettate, la confondono. La dottoressa manda a chiamare James, lasciando a Mia il tempo di rivestirsi, prima che l’infermiera arrivi con lui. Mentre aspettiamo, chiedo a mia figlia di poter vedere l’ecografia. Me la porge, ripetendo meccanicamente «non può essere». Ed è allora, prendendo in mano la riproduzione fotografica di mio nipote, carne della mia carne, sangue del mio sangue, che scoppio a piangere. James entra nella stanza e il mio pianto si tramuta in lamento. Cerco di trattenere le lacrime, ma mi è impossibile. Strappo un pezzo di carta dal dispenser a parete e mi asciugo gli occhi. Quando torna la dottoressa, non ce la faccio più a tacere e sbotto: «Ti ha stuprata, quel bastardo ti ha violentata». Ciononostante, Mia non prova ancora niente. Colin Prima È arrivato l’inverno. Al nostro risveglio stava nevicando e la temperatura all’interno del capanno era scesa di una decina di gradi. Non abbiamo l’acqua calda. Lei si mette addosso vari strati di vestiti. Due paia di pantaloni termici e quel felpone bordeaux mezzo sformato. S’infila un paio di calzini di lana, sostenendo di odiarli, ma senza le si congelerebbero i piedi. Ripete di aver sempre detestato i calzini, anche quando era piccolissima. Se li toglieva rabbiosamente dai piedini e li lanciava sul pavimento fuori della culla. Non ho mai ammesso di sentire freddo anch’io, però adesso si gela, maledizione. Appena alzato, ho acceso il fuoco. Ho già bevuto tre tazze di caffè. Sono seduto al tavolo, con davanti a me una vecchia cartina geografica degli Stati Uniti lacera. L’ho presa nel vano portaoggetti del pick-up, insieme a una penna che scrive a malapena con cui traccio un cerchio intorno al nome delle strade migliori per allontanarci da questo postaccio. Mi sono fissato col deserto, da qualche parte fra Las Vegas e Baker, in California. Un posto caldo. D’acchito progetto di deviare verso Gary, nell’Indiana, per evitare d’incorrere nelle pattuglie autostradali che possono localizzare e identificare l’auto. Potrei anche abbandonarla e rubarne un’altra, sperando che non denuncino il furto. Oppure si potrebbe salire su un treno merci. Se già ci cercano, ci saranno blocchi stradali dappertutto, specie dalle parti di Gary, nel caso avessi il fegato di avvicinarmi a casa mia. Forse la polizia la sorveglia. Magari hanno piazzato una squadra attorno alla vecchia casa di Gary, aspettano che ci passi o faccia una mossa sbagliata. Maledizione. «Andiamo da qualche parte?», chiede la ragazza guardando la cartina, mentre io la ripiego e la metto via. Non mi degno di risponderle. «Vuoi un caffè?», propongo invece, consapevole che non potremmo resistere a lungo nel deserto. Le possibilità di una vita normale sarebbero praticamente azzerate, ci rimarrebbe solo la prospettiva della sopravvivenza. Allora decido che non possiamo dirigerci verso le zone desertiche. L’unica scelta che rimane è espatriare. Non abbiamo soldi sufficienti per prendere un volo, per cui, a mio avviso, restano due opzioni: verso Nord o verso Sud, il Canada o il Messico. Ma per espatriare ovviamente ci servono i passaporti. È allora che lo capisco: devo darmi da fare. Lei scuote la testa. «Non bevi caffè?» «No». «Non ti piace?» «Non assumo caffeina». Mi racconta che aveva bevuto il caffè per molto tempo, benché la facesse agitare e innervosire. Non riusciva a stare ferma. Poi l’euforia svaniva e un forte affaticamento prendeva il suo posto. Così, prendeva un’altra tazza di caffè. Un circolo vizioso. «E se evitavo la caffeina», aggiunge, «mi venivano emicranie spaventose che mi toglievano le forze, e che passavano solo se scolavo una lattina di Mountain Dew8». Gliene verso comunque una tazza. Lei prende tra le mani il recipiente caldo e avvicina la faccia al bordo. Il vapore sale verso il suo viso. Sa che non dovrebbe, ma lo fa lo stesso: si porta la tazza alle labbra e le appoggia per un attimo. Poi beve un sorso, bruciandosi l’esofago. Tossisce. «Attenzione», dico troppo tardi. «È bollente». Non ci sono cose da fare se non stare seduti a guardarci negli occhi. Perciò, quando mi propone di farmi un ritratto, accetto. Non c’è molto altro da fare, qui. In realtà, non vorrei dire di sì. All’inizio non è difficile, ma poi vuole che stia fermo, guardi dritto davanti a me e sorrida. «Basta», sbotto. «Mi sono rotto». Mi alzo. Col cavolo che me ne resterò lì a sorridere per un’altra mezz’ora. «Va bene», dice conciliante, «non sorridere. Non guardarmi nemmeno. Resta solo fermo, seduto». Mi piazza davanti al fuoco, premendomi le sue dita ghiacciate sul petto. Mi fa abbassare sul pavimento. Sfioro quasi la stufa con la schiena. La fiamma per poco non mi fa un buco nella maglia, e comincio a sudare. Ripenso all’ultima volta che mi ha toccato. La disperazione delle sue mani quando voleva spogliarmi. E all’ultima volta che l’ho toccata io: un sonoro schiaffo in faccia. La stanza è tetra, i tronchi di pino che formano le pareti e il soffitto escludono ogni spiraglio di luce. Li conto: sono esattamente quindici in altezza. Non c’è sole che possa penetrare dalle piccole finestre. La guardo. Non è brutta, tutt’altro. La prima sera, nel mio appartamento, era bellissima. Mi fissava con quei suoi occhi azzurri senza sospettare nulla, senza immaginare neanche per un attimo che, dentro di me, avevo architettato questa cosa. Sta seduta sul pavimento con la schiena appoggiata al sofà, le gambe raccolte e il quaderno da disegno sulle ginocchia. Prende una matita dal mazzo ed estrae la mina. Inclina la testa, i capelli cadono di lato. Con gli occhi traccia la forma del mio viso, la curva del mio naso. Non so perché, ma mi viene l’impulso di picchiare l’uomo che stava con lei, prima di me. «L’ho pagato», confesso. «Il tuo ragazzo, gli ho dato cento dollari perché si trattenesse al lavoro quella sera». Non mi aveva domandato il motivo e io non glielo avevo detto. Quel vigliacco mi aveva strappato i soldi di mano ed era scomparso nel nulla. Non le dico che l’avevo affrontato a muso duro nel bagno, con in mano una pistola. Con cento dollari, oggi, si possono comprare molte cose. «Doveva lavorare», dice. «È quello che ha raccontato a te». «Jason fa sempre gli straordinari». «Questo è quello che dice». «È la verità». «Forse, a volte». «Ha successo». «Nel mentire». «Quindi l’hai pagato. E allora?», scatta. «Perché sei voluta venire a casa mia?», indago. «Prego?» «Perché ci sei venuta, quella sera?». Deglutisce a fatica e non risponde. Finge di essere concentrata sul disegno, tratteggia furiosamente le linee sulla pagina. «Non mi pare una domanda difficile», commento. Gli occhi le si riempiono di lacrime. Una vena le pulsa sulla fronte. Comincia a sudare e le tremano le mani. È furibonda. «Ero ubriaca». «Ubriaca». «Sì, lo ero». «Perché questo sarebbe l’unico motivo per cui una come te andrebbe a casa di uno come me, non è vero?» «Perché è l’unico motivo per cui io andrei a casa con te». Mi osserva, e mi chiedo cosa vede. Cosa crede di vedere. Pensa che io sia insensibile alla sua indifferenza, ma si sbaglia. Mi tolgo il maglione e lo lascio cadere vicino ai miei stivali pacchiani. Ho una canottiera e un paio di jeans, senza i quali non mi ha mai visto probabilmente. Traccia il mio volto sul foglio, linee e ombre inquiete per rappresentare il demonio che vede davanti al fuoco. Certo, quella sera aveva bevuto qualche bicchiere, però era abbastanza lucida per sapere ciò che stava facendo, per accettare con piacere le mie mani su di lei. Ma questo ovviamente era accaduto molto prima che si rendesse conto di chi ero in realtà. Non so quanto tempo restiamo in silenzio. Sento il suo respiro, il rumore della mina che graffia la superficie del foglio. Mi sembra di avvertire anche i suoi sentimenti: rabbia e ostilità. «Assomiglia alle sigarette o alla marijuana», dico infine. La frase la sconcerta. «Cosa?». Non smette di disegnare, fa quasi finta di non ascoltare. Ma in realtà presta grande attenzione. «La mia vita, quello che faccio. Si sa che fanno male la prima volta che le provi. Le sigarette. L’erba. Ma ci si convince che va tutto bene, che è tutto sotto controllo. Una volta, poi basta, solo per fare quell’esperienza. E all’improvviso ti ci ritrovi dentro, non è più possibile uscirne neanche volendo. Non era tanto perché mi serviva il denaro, il che è vero. Quanto perché se tentavo di uscirne mi avrebbero ucciso. O qualcuno avrebbe fatto la spia sul mio conto e sarei finito in galera. Non esisteva la possibilità di dire di no». Smette di disegnare. Mi chiedo cosa dirà. Un commento da saccente, ne sono sicuro. E invece no. Non dice niente. Ma scompare la vena sulla sua fronte, le sue mani smettono di tremare. I suoi occhi non sono più lucidi. Mi guarda e annuisce. 8 Bevanda gasata, commercializzata dalla Pepsi Cola. (n.d.t.) Eve Dopo Dall’atrio vedo James che si lancia verso la camera di Mia con grande furia. Il rumore dei passi pesanti fuori della porta la sveglia e la fa sussultare. Si siede, probabilmente con gli occhi sbarrati dalla paura e il cuore che le batte all’impazzata nel petto, come capita quando si è terrorizzati. Le ci vuole un attimo per rendersi conto di dove si trova: quel che resta del suo guardaroba adolescenziale ancora appeso nell’armadio, il tappeto di iuta e un poster di Leonardo DiCaprio che aveva incollato alla parete quando aveva quattordici anni, tutte cose familiari. Ricorda dove si trova. È a casa, al sicuro. Nasconde la faccia tra le mani e comincia a piangere. «Devi vestirti», dice James. «Andiamo dalla strizzacervelli». Dopo che lui esce dalla stanza, entro e aiuto Mia a scegliere un completo coordinato. Cerco di placare le sue paure, ricordandole che qui a casa è al sicuro. «Nessuno ti può far del male», la rassicuro, sebbene nemmeno io ne sia tanto certa. In auto, Mia mangia un pezzetto di pane tostato che le ho portato. Non lo vuole neanche, ma io mi volto continuamente e la incoraggio: «Forza, un altro boccone», come se avesse di nuovo quattro anni. «Ancora un piccolo morso». Ringrazio la dottoressa Rhodes per averci trovato un buco di mattina presto nella sua agenda. James la requisisce per dirle qualche parola in privato, mentre io aiuto Mia a togliersi il cappotto, dopodiché la dottoressa e mia figlia scompaiono in un’altra stanza. Stamattina la Rhodes si soffermerà sul nascituro. Mia nega che un feto si stia formando nel suo grembo. E suppongo che sia anche il mio atteggiamento. È appena in grado di pronunciare la parola «bambino». Quasi le rimane in gola, e ogni volta che io o James tiriamo fuori l’argomento, lei giura che non può essere vero. Così, abbiamo pensato che sarebbe stato utile farla parlare con la psichiatra, che è imparziale. La Rhodes le ribadirà le opzioni disponibili, anche se immagino già la reazione di Mia: «Le mie opzioni per cosa?», al che la dottoressa dovrà ricordarle del feto. «Chiariamolo subito, Eve», mi dice mio marito dopo che Mia e la dottoressa si sono chiuse nell’altra stanza. «L’ultima cosa che vogliamo è che lei porti a termine la gravidanza di un figlio avuto da quell’individuo. Dovrà abortire, al più presto». Indugia, riflette sulla possibile organizzazione della cosa. «Quando la gente chiederà, racconteremo che il bambino non ce l’ha fatta. Lo stress di questa situazione», precisa. «Non è sopravvissuto». Non commento. Non ce la faccio. Osservo James che tiene una mozione in limine sulle ginocchia. Legge il documento con più attenzione di quella che dedica alla figlia e al nipote non ancora nato. Cerco di convincermi che si sta comportando bene. Ma non ne sono sicura. Non è stato sempre così. Non è sempre stato tanto disinteressato alle questioni di famiglia. Nei pomeriggi di calma, quando lui è al lavoro e Mia schiaccia un pisolino, vado a riesumare i nostri ricordi più piacevoli con le ragazze: vecchie foto in cui lui tiene in braccio Grace o Mia in fasce, filmini amatoriali in cui gioca con loro, lo riascolto cantargli la ninnananna. Allora era diverso. Rammento i primi giorni di scuola delle nostre figlie e le loro feste di compleanno, giornate speciali a cui James non sarebbe mancato per nulla al mondo. Recupero le foto in cui insegna loro a usare la bicicletta senza rotelline, in cui nuotano insieme in una splendida piscina d’albergo o ammirano i pesci in un acquario. Lui proviene da una famiglia ricca sfondata. Suo padre è avvocato, come lo era suo nonno, e forse anche il bisnonno, questo non lo so onestamente. Suo fratello Marty è un deputato dello Stato, mentre Brian è uno dei più famosi anestesisti della città. Le figlie di Marty (Jennifer ed Elizabeth) sono avvocati, una nel ramo industriale e l’altra nel diritto d’autore. Anche Brian ha avuto il privilegio di avere degli eredi: un figlio è un legale esperto in diritto societario, un altro dentista e il terzo neurologo. James fa di tutto perché la sua immagine non ne esca offuscata. Non lo ammetterebbe mai, però è sempre stato in competizione coi fratelli: fanno a gara per chi guadagna di più e per chi è il più potente fra loro; ognuno vuole essere il Dennett più importante dello Stato. E James non ha mai concepito l’idea di arrivare secondo. Il pomeriggio scendo spesso nel seminterrato e passo al setaccio le vecchie scatole di scarpe dove abbiamo accumulato le fotografie, per dimostrare a me stessa che quei momenti di amore paterno sono stati reali, seppur passeggeri. Non immaginavo di ritrovare un disegno che Mia ha fatto a cinque anni con mano incerta, con tanto di scritta TI VOGLIO BENE, PAPÀ. La figura più alta e quella più bassa si tengono per mano (anche se le dita non sono disegnate) e i sorrisi sulle loro facce sono esagerati. Tutt’attorno al foglio lei aveva appiccicato una trentina di adesivi rosa e rossi a forma di cuore. Una sera, dopo che era tornato dall’ufficio, glielo avevo mostrato, e lui si era messo a studiarlo a lungo, per poi portarselo nello studio e fissarlo con una calamita allo schedario nero. «È per il bene di Mia», dice spezzando il silenzio assordante. «Le serve tempo per guarire». Non lo so, forse le cose stanno diversamente. Vorrei dirgli che esistono altre maniere. Per esempio, l’adozione. Mia potrebbe dare il figlio a una famiglia che non può averne e renderla molto felice. Ma mio marito valuta le cose altrimenti: per lui ci sarebbero sempre degli inconvenienti. Cosa succederebbe se l’adozione non andasse a buon fine? Se i genitori adottivi decidessero di non volere più il neonato? Se il bambino nascesse con un difetto genetico? Se, una volta cresciuto e diventato adulto, cercasse Mia e le rovinasse di nuovo la vita? Per contro, l’aborto sarebbe una soluzione facile e rapida. Così la vede James. E chi se ne frega del senso di colpa che ossessionerebbe nostra figlia per il resto della vita… Quando finisce la seduta con Mia, la dottoressa Rhodes la accompagna nella sala d’attesa e, prima di congedarci, le posa una mano sul braccio, dicendole: «Non è una cosa che devi decidere oggi, subito. Hai molto tempo a disposizione». Io invece capisco dal suo sguardo che James ha già deciso. Colin Prima Non riesco a dormire, e non è la prima volta. Ho provato a contare le pecore, i maialini, qualsiasi cosa, perciò adesso misuro con i passi la stanza. Ogni notte è una fatica. Ogni notte penso a lei. Ma stanotte è ancora peggio, perché la data sul mio orologio mi ricorda che è il suo compleanno. Così, penso a lei tutta sola, a casa. È buio pesto, ma all’improvviso sento dei passi nella stanza che non sono i miei. «Mi hai spaventato a morte», dico. Riesco appena a scorgere il suo profilo nel buio. «Mi dispiace», mente la ragazza, che poi chiede: «Cosa stai facendo?». Mia madre brontolava sempre per il mio passo pesante. Diceva che avrei potuto svegliare i morti. Non accendiamo la luce e ci scontriamo a causa dell’oscurità. Ma non ci scusiamo. Proseguiamo nella nostra direzione. «Non riuscivo a prendere sonno», spiego. «Sto cercando di schiarirmi le idee». «Su cosa?», chiede lei. All’inizio taccio. Non voglio dirglielo, non ha bisogno di saperlo. Ma poi glielo spiego. È così buio che posso fingere che lei non sia lì. Comunque, non è per questo, il motivo è diverso. Ha qualcosa a che fare col modo in cui ha detto «non importa» prima di dirigere i passi fuori della stanza. Allora mi è venuta voglia di raccontarglielo, di farla rimanere nella stanza. Le dico che mio padre ci ha abbandonato quando ero piccolo, ma che comunque non aveva importanza. Era come se non ci fosse mai stato. Beveva. Frequentava i bar e scommetteva. Eravamo a corto di soldi anche senza bisogno che lui li sprecasse. Inoltre era un puttaniere e un truffatore. Le dico che ho imparato a vivere nel modo più duro: non sempre c’era cibo in tavola o acqua calda per il bagno. E peraltro nessuno mi faceva il bagno. Avrò avuto tre-quattro anni. Mio padre aveva un brutto carattere. Era irascibile e mi impauriva da matti quando ero piccolo. Con me più che altro urlava, non parlava. E poi picchiava mia madre. L’ha fatto parecchie volte. Capitava che lavorasse, ma perlopiù era disoccupato. Lo licenziavano spesso perché non arrivava in orario, o perché si presentava ubriaco, oppure insultava il capo. La mamma lavorava come un cane. Non era mai a casa perché fino alle cinque di pomeriggio faticava in panetteria e poi la sera faceva la barista, in un locale dove gli uomini le mettevano le mani addosso e la chiamavano «tesoro» o «bambola». Mio padre le dava della troia. «Una troia buona a nulla», diceva. Le racconto che mia madre mi comprava i vestiti nei negozi dell’usato, che nei giorni di raccolta dell’immondizia perlustravamo la città per caricare nella nostra auto qualsiasi cosa trovassimo. Siamo stati sfrattati diverse volte. Dormivamo in macchina. Prima di scuola, ci affrettavamo verso una stazione di servizio, così potevo intrufolarmi nei gabinetti per lavarmi i denti. Alla fine, gli inservienti capirono l’antifona e ci dissero che avrebbero chiamato gli sbirri. Racconto tutte le volte che, nei negozi di alimentari, aiutavo la mamma a fare la spesa. Avendo una ventina di dollari in tutto, metteva nel cestino il necessario: latte, banane, scatole di cereali. Alla cassa però il totale superava sempre i venti dollari, anche se ci eravamo sforzati di calcolare bene, a mente. Allora dovevamo scegliere cosa scartare (cereali o banane?), mentre qualche rompicoglioni che aspettava in fila sbuffava, ci diceva di sbrigarci. Ricordo che una volta dietro di noi c’era un cretino della mia stessa scuola. La voce si sparse e dovetti sorbirmela per due settimane: ripetevano che la mamma di Thatcher non aveva abbastanza soldi per comprare le fottute banane! Adesso sto zitto, e lei non dice niente. Qualsiasi altra ragazza avrebbe detto di essere tanto dispiaciuta o una cosa per dimostrare solidarietà, oppure avrebbe commentato su quanto dovesse essere stata dura per me. Ma lei no. Non perché non sia capace di immedesimarsi, ma perché sa che non è la compassione quello che cerco o di cui ho bisogno. Non avevo mai raccontato a nessun altro la storia di mio padre. Né quella di mia madre. Ora l’ho fatto. Forse per la noia, non so. Eppure, mi sembra che vi sia dell’altro, che questa ragazza abbia qualcosa che mi aiuta a confidarmi, che mi invoglia a parlare, che mi induce a liberarmi del peso che mi opprime. E magari, forse, dopo potrò dormire. «Quando avevo cinque o sei anni, lei cominciò a tremare, prima le mani», proseguo. Quindi iniziò ad avere problemi sul lavoro. Le cadevano le cose, versava da bere dappertutto. Nel giro di un anno cominciò a trascinare i piedi, non riusciva più a camminare dritta. Poi quasi si immobilizzò, braccia e gambe praticamente bloccate. La gente la fissava, le diceva di darsi una mossa. Lei smise di sorridere, quasi non batteva più ciglio. Cadde in depressione. Non ce la faceva più a tenersi il lavoro. Era troppo lenta, troppo maldestra. «Il morbo di Parkinson», interviene la ragazza, e io annuisco, anche se lei non mi può vedere. La sua voce è talmente vicina che potrei toccarla, però non vedo l’espressione del suo volto. Non riesco a cogliere la commozione nei suoi occhi azzurri. «Così dicevano i dottori». Quando ero alle medie, dovevo già aiutarla a infilarsi i vestiti, sempre maglioni, perché altrimenti avrebbe avuto difficoltà con le cerniere lampo. Arrivato alle superiori, dovevo portarla anche in bagno. Non riusciva più a usare un coltello, non ce la faceva più a scrivere il suo nome. Per attenuare i sintomi, assumeva delle medicine, che però avevano forti effetti collaterali. Nausea, insonnia, incubi. Allora smise di prenderle. A quattordici anni cominciai a lavorare, mi ammazzavo di fatica ma non guadagnavo mai abbastanza. Mio padre nel frattempo se ne era andato. Non appena la mamma si era ammalata, lui aveva preso il volo. Quando divenni maggiorenne lasciai la scuola e me ne andai di casa. Pensavo che in città avrei potuto accumulare più soldi. Le spedivo tutto il possibile per pagarsi l’assistenza sanitaria e comprare qualcosa da mangiare. Così non sarebbe finita per strada. Però i soldi non erano mai sufficienti. Poi un giorno, facevo il lavapiatti in un ristorante, chiesi al capo se potevo fare degli straordinari perché ero quasi al verde, e lui mi disse: «Non lo siamo tutti?». Gli affari andavano a rilento, comunque sapeva da chi avrei potuto ottenere un prestito. E il resto è storia nota. Gabe Prima Rintraccio una parente di Colin a Gary: Kathryn Thatcher, è sua madre. Avevamo trovato un cellulare nascosto in un cassetto della sua cucina (intestato a Steve Moss, altro nome di Colin) e ci eravamo subito adoperati per recuperare le chiamate effettuate. Quasi ogni giorno lui telefonava a una donna di mezz’età residente a Gary, nell’Indiana. L’altra cosa che aveva attirato la mia attenzione erano state tre chiamate a un cellulare con scheda prepagata, la sera in cui era scomparsa Mia, oltre a una decina di telefonate ricevute dallo stesso numero nelle prime ore della mattinata seguente. Metto al lavoro i tecnici per scaricare la segreteria, dopodiché ce ne stiamo lì tutt’orecchi ad ascoltare i messaggi. Un tipo vuole sapere dove diavolo sia la ragazza, la figlia del giudice, e perché Thatcher non l’abbia consegnata. Non ha un tono amichevole, sembra parecchio arrabbiato. Incazzato. Devo quindi dedurne che Colin Thatcher lavora per qualcun altro. Ma chi? Cerco di rintracciare il proprietario di questo telefonino con scheda prepagata. So che era stato acquistato in un negozio di casalinghi a Hyde Park. Ma il proprietario del locale, un indiano che conoscerà al massimo tre parole di inglese, non ha idea di chi l’abbia comprato. Sembra che sia stato pagato in contanti. La mia solita fortuna. Decido di interrogare la madre. Il sergente vorrebbe usare la sua influenza per servirsi di un agente del posto, ma io mi oppongo: lo farò io stesso. Gary non gode affatto di buona fama, qui a Chicago. Lo si considera un posto infernale, in cui gran parte della popolazione crepa di fame. Ci abita una fetta notevole di afroamericani, e ci sono enormi acciaierie che scaricano fumi tossici nell’aria situate intorno al lago Michigan. Il sergente vuole venire con me, ma lo convinco a non farlo e ci vado da solo. Non voglio spaventare la povera donna, che in tal caso non aprirebbe bocca. Ho commesso l’errore di rivelare alla signora Dennett che il mio viaggetto è programmato per oggi. Non che abbia chiesto di accompagnarmi, però me l’ha fatto capire con un’allusione. Le ho posato delicatamente una mano sul braccio e le ho promesso: «Sarà la prima che informerò». Mi ci vogliono un paio d’ore. Sono un’ottantina di chilometri, ma la gran quantità di autoarticolati che percorrono la I-90 mi costringe a rallentare, a procedere ai quaranta all’ora. Faccio lo sbaglio di fermarmi in un posto dove servono caffè senza che si debba uscire dall’auto, e quasi me la faccio addosso prima di arrivare a destinazione. A Gary mi fermo in una stazione di servizio, felice di avere un arsenale sotto i vestiti. Kathryn Thatcher vive in una fattoria celeste. L’abitazione è vecchia, risale come minimo agli anni Cinquanta. Il prato non è stato falciato e le erbacce crescono ovunque. Le piante nei vasi sono morte. Busso alla zanzariera e attendo sul passetto di cemento, che avrebbe un disperato bisogno di qualche riparazione. Una giornata fosca, tipica del novembre qui nel Midwest. Che cosa noiosa: con 5 gradi si sente freddo, e tra un paio di mesi pagheremo per avere temperature simili. Siccome non risponde nessuno, apro la zanzariera e busso alla porta di legno con una ghirlanda appesa a un chiodo arrugginito. La porta è aperta. Cede nonostante il mio tocco sia stato leggero. Maledizione. Forse sarei dovuto venire col sergente. Metto la mano sulla pistola, entro in punta di piedi e chiamo: «Signora Thatcher!». L’ingresso è talmente datato che mi sembra di stare a casa di mia nonna: tappeti polverosi, rivestimenti in legno, carta da parati strappata e mobili sparsi, il tutto assolutamente privo di qualunque criterio estetico, come ad esempio la tappezzeria a fiori abbinata a un rivestimento in pelle grigio talpa, peraltro strappato. Mi tranquillizza un ronzio proveniente dalla cucina. Ripongo la pistola nella fondina per non spaventare a morte la donna, poi mi cadono gli occhi su una foto che ritrae Colin Thatcher e quella che presumo sia Kathryn, tutta in ghingheri, in una cornice sopra un televisore 27 pollici. L’apparecchio è acceso ma senza sonoro, sullo schermo passano le immagini di una telenovela. «Signora Thatcher», chiamo, di nuovo senza ottenere risposta. Seguo il ronzio in cucina e busso allo stipite, fermandomi sulla soglia dopo aver osservato per un attimo le dita tremanti della donna che tentano per una, due, tre volte di togliere l’involucro di plastica del contenitore del suo pasto. Sembra talmente anziana da poter essere la nonna di Colin, tanto che mi chiedo se non mi sia sbagliato. Indossa una vestaglia e delle pantofole sfilacciate ai piedi; è senza calze, e preferisco non pensare che non abbia niente sotto. «Signora», dico, procedendo sul pavimento in vinile. Stavolta si gira: è sbalordita dalla presenza di uno sconosciuto in casa; perciò tiro fuori il distintivo per rassicurarla che non sta per essere ammazzata. «Santo cielo», farfuglia, mettendosi la mano tremante sul cuore. «Colin?» «No, signora», esclamo avvicinandomi a lei. «Mi permetta», aggiungo, prima di strappare l’involucro del contenitore davanti a lei e buttarlo in un secchio stracolmo di rifiuti dietro la porta. È un pasto da microonde per bambini, con crocchette di pollo, mais e un dolce al cioccolato. Allungo una mano per stabilizzarla. Con mia grande sorpresa, lei accetta il mio aiuto. Non ce la fa a tenersi in equilibrio, sia che cammini sia che debba solo stare in piedi. Si sposta con movimenti molto cauti, senza alcuna espressione sul volto. Cammina ricurva, trascinando i piedi, mi pare che debba cadere da un momento all’altro. Dalla bocca le cola un filo di saliva. «Mi chiamo Gabe Hoffman, sono ispettore di polizia. Devo…». «Colin?», domanda ancora, stavolta è piuttosto un’implorazione. «Signora», dico, «si sieda, per favore». La aiuto a mettersi seduta, le porto il contenitore col pasto e recupero una forchetta dal cassetto; però le mani le tremano talmente da non consentirle di infilarsi il cibo in bocca. Allora afferra la crocchetta direttamente con le dita. Sembra una donna anziana, sulla settantina, ma se è davvero la madre di Colin avrà probabilmente poco più di cinquant’anni. Ha i capelli bianchi, anche se nella foto di non tanto tempo fa che ho visto nell’altra stanza, erano castani. Sembra che sia dimagrita, la vestaglia le sta grande, è pelle e ossa. Sul piano di lavoro è allineata una serie di confezioni di medicinali, oltre a frutta marcia in un cesto. E naturalmente non mancano i lividi e i bernoccoli sparsi qua e là sul suo corpo: la conseguenza, presumo, di cadute recenti. So che tutto ciò ha una spiegazione, il nome della malattia ce l’ho sulla punta della lingua. «Ha visto Colin?», le chiedo. «Tutte le settimane. Falcia l’erba». Guardo fuori della finestra e vedo il giardino pieno di foglie secche. «Viene qui a darle una mano?», continuo. «Sistema il prato, va a fare la spesa…». Dice che lo fa. Torno a guardare la frutta marcita sul piano di lavoro, coperta da un’infinità di moscerini. Mi permetto di curiosare nel freezer e nel frigorifero e trovo una sporta di pere congelate, una busta di latte scaduto, un paio di contenitori di cibo precotto. La dispensa è altrettanto desolata: solo alcuni barattoli di minestra che la signora non è in grado di aprire, oltre a dei cracker. «È lui a portar fuori l’immondizia?», chiedo. «Sì». «Da quanto tempo la aiuta? Un anno? Due?» «Era ancora un bambino quando mi sono ammalata. Suo padre…», le si affievolisce la voce. «Se n’è andato», finisco la frase per lei. Annuisce. «Adesso Colin abita con lei?». Scuote la testa. «Viene a farmi visita». «Ma non questa settimana?» «No». «La settimana scorsa?». Non lo sa. Nel lavandino ci sono pochissime stoviglie, mentre l’immondizia è stracolma di piatti di carta. Sarà stato lui a incoraggiarla in questo senso: quelli di carta sono di certo più facili da gestire per lei. «Però le fa la spesa, le pulizie e…». «Fa tutto». «Certo, eppure non viene qui da un po’ di tempo, vero, signora Thatcher?». Il calendario appeso al muro è rimasto al mese di settembre. Il latte nel frigorifero è scaduto il 7 ottobre. «Vuole che le porti fuori la spazzatura?», domando. «Vedo che è piena». «Grazie», dice. Il suo tremore è spaventoso, mi mette a disagio, non riesco a guardarla. Afferro il sacco dell’immondizia lurido, lo tiro fuori dal secchio ed esco dalla porta di servizio. Che puzza! Scendo di corsa i tre gradini e lo sistemo nel baule della mia auto, lo butterò poi. Mi assicuro che nessuno mi veda e vado a curiosare nella cassetta della posta, prendendo quello che c’è dentro: un mucchio talmente alto da traboccare quasi sulla strada. C’è anche una cartolina del servizio postale che esorta il residente ad andare a ritirare altra posta in un ufficio apposito. Il postino avrà stipato tutto il materiale possibile, finché non era rimasto più spazio. Torno dentro e vedo la signora alle prese col mais. Una cosa insopportabile. Nessuno dovrebbe faticare tanto per nutrirsi. Mi avvicino a quella donna gracile e le dico: «Lasci che l’aiuti». Prendo la forchetta e la imbocco. Lei ha un momento di esitazione. Piuttosto che vedere il giorno in cui qualcuno dovrà imboccarmi per farmi mangiare, preferisco morire. «Dov’è Colin?», mi chiede. Continuo a imboccarla molto lentamente, un boccone per volta. «Non lo so, signora. Temo che Colin possa essere nei guai. Abbiamo bisogno che lei ci aiuti». Prendo una foto di Mia Dennett e la mostro alla donna. Le chiedo se l’ha mai vista prima. Chiude gli occhi. «In televisione», esclama, «L’ho vista alla TV… È la… Dio mio, Colin, il mio Colin», e comincia a singhiozzare. La rassicuro, dicendole che non sappiamo nulla di preciso. Solo congetture: Mia potrebbe essere con lui, oppure no. Anche se io so che è così. Le spiego che ho bisogno del suo aiuto per ritrovarlo. Che vogliamo essere certi che lui e Mia stiano bene, che non si siano cacciati nei guai, però non ci crede. Ha perso interesse per il cibo. Il suo corpo deformato si accascia sul tavolo, e lei ripete più volte il nome di Colin, rispondendo così a tutte le domande che le pongo. «Signora Thatcher, sa dirmi se c’è un posto dove potrebbe rifugiarsi suo figlio se ne avesse bisogno?» «Colin». «Può darmi i recapiti di suoi amici o familiari? Chiunque possa aver contattato se si fosse trovato nei guai. Suo padre? Ha uno schedario, una rubrica degli indirizzi?» «Colin». «Per favore, cerchi di ricordare quand’è stata l’ultima volta che vi siete parlati. Lo ha sentito di nuovo dopo la sua ultima visita? Magari per telefono…». «Colin». È inutile, non sto concludendo niente. «Signora, ha qualcosa in contrario se perquisisco la casa? Vedrò se c’è qualcosa che possa aiutarmi a ritrovare suo figlio». È come rubare le caramelle a un bambino. Un’altra madre avrebbe chiamato subito un avvocato o chiesto di vedere il mandato di perquisizione. Ma non lei. Sa cosa le succederà se Colin non torna a casa. La lascio in lacrime in un angolo della cucina e mi scuso. Supero la sala da pranzo, un bagnetto di servizio, la camera da letto principale e finisco nella stanza del diciassettenne Colin Thatcher, con le pareti blu scuro, i gagliardetti dei White Sox (perbacco!) e i manuali delle superiori mai restituiti. Nell’armadio ci sono ancora alcuni vestiti: una maglia da football e un paio di jeans strappati; sul pavimento, un paio di scarpe da calcio coi tacchetti sporchi. Alle pareti sono appesi con puntine da disegno dei poster di atleti degli anni Ottanta, mentre sull’anta interna dell’armadio, dove la madre non andava a vedere, campeggia un inserto centrale di un’ammiccante Cindy Crawford. Piegata ai piedi del letto c’è una coperta lavorata all’uncinetto da Kathryn quando le sue mani la assistevano ancora; su una parete c’è un buco, opera probabilmente di un pugno di Colin durante un momento di rabbia. Sotto la finestra c’è un termosifone, mentre in una cornice di fianco al letto compare la foto di Colin in fasce insieme a una bellissima Kathryn e a un pezzetto della testa di un uomo: il resto è stato strappato. Torno indietro e continuo a perlustrare. Gironzolo nella camera principale, con il letto sfatto che puzza di sudore. Vestiti sporchi ammucchiati in un angolo. Le tende sono chiuse, è buio. Schiaccio l’interruttore, ma la lampadina è fulminata. Tiro la cordicella nell’armadio e una debole luce rischiara appena la stanza. Ci sono foto di Colin in ogni fase della sua vita. Non mi pare molto diverso da me. Un tipico fagottino grassoccio, diventato poi adolescente appassionato di football e in seguito il ricercato n. 1 d’America. Ci sono dei denti di leone sottovetro: forse li aveva raccolti per la madre da ragazzino. C’è il disegno di un omino stilizzato. Il suo? E un cordless a terra. Lo raccolgo e lo rimetto sulla sua base. È scarico, ci vorranno ore per ricaricare la batteria. Mi dico di controllare i tabulati telefonici. Prendo in considerazione la possibilità di richiedere l’autorizzazione per mettere delle microspie. Nell’ingresso faccio scorrere le dita sui tasti di un pianoforte impolverato. È scordato, ma il suono attira la signora Thatcher, che arriva trascinandosi. Ha ancora il mais incollato al mento. Mette un piede in fallo e riesco a prenderla prima che cada. «Colin», ripete per l’ennesima volta mentre la depongo sul divano. La esorto a sdraiarsi e le sistemo un cuscino sotto la testa. Trovo il telecomando e attivo il sonoro alla TV. Chissà da quanto tempo la guardava senza. Ci sono degli album di ritagli allineati in uno scaffale di quercia, uno per ogni anno di Colin fino al tredicesimo. Ne prendo uno e sprofondo in una poltrona di pelle. Sfoglio le pagine. I boy-scout, compiti in classe e pagelle. Una collezione di foglie raccolte durante le passeggiate pomeridiane. Ritagli di giornale. Cartoncini segnapunti per il minigolf. Un lista di regali per il Natale. Una cartolina spedita alla signora Thatcher da Grand Marais, Minnesota, con un francobollo da quindici centesimi incollato di sbieco in un angolo. Sulla cartolina compare la data «1989», con l’immagine di una foresta, un lago e la natura circostante. Due sole frasi: «Il babbo rompe, mi manchi». Ci sono foto a bizzeffe, perlopiù vecchie e ingiallite, che ormai cominciano a curvarsi. Resto il più possibile con la signora Kathryn. Ha bisogno di compagnia. Anzi, molto di più: ha bisogno di qualcosa che non le posso dare. L’ho già salutata e le ho promesso di rimanere in contatto con lei, ma non me ne vado. I pasti precotti finiranno presto, e le basterà una bella caduta per farle venire una commozione cerebrale che metterà fine alla sua esistenza. «Signora, non posso lasciarla qui», ammetto. «Colin», sussurra. «Lo so», dico. «È Colin a prendersi cura di lei, però adesso non c’è, e lei non può rimanere sola. Ha una famiglia, signora? C’è qualcuno a cui posso telefonare?». Interpreto il suo silenzio come un no. Ciò mi induce a riflettere: se Colin si prendeva cura della madre sofferente da tanto tempo, cosa potrebbe averlo costretto ad abbandonarla? Prelevo alcuni vestiti dall’armadio della signora e li metto in una valigia. Non dimentico le confezioni di medicinali. A Gary c’è un ricovero per anziani. Per il momento può andare. Le dico che andiamo a fare un giretto. «No, per favore», mi supplica mentre la conduco verso l’auto. «Voglio restare qui, non voglio andare via». Le copro la vestaglia con un cappotto, ma le lascio le pantofole sfilacciate ai piedi. Lei protesta nella maniera più veemente che le è possibile, che non è poi granché. So che non vuole andare via, non vuole lasciare la sua casa, ma io non posso abbandonarla lì. Un vicino esce sulla veranda per vedere chi è che fa tanto chiasso. Alzo una mano e dico: «Va tutto bene», mostrandogli il mio distintivo. La faccio accomodare nell’auto e mi sporgo verso di lei per allacciarle la cintura di sicurezza. Piange. Guido in fretta, ma nel rispetto dei limiti, così in pochi minuti tutto sarà finito. Penso a mia madre. Nel parcheggio, un inserviente mi aspetta con una sedia a rotelle e poi preleva la signora Thatcher dall’auto, che sembra un animale impagliato in braccio a un bambino. Dopo averlo visto spingere la carrozzella all’interno dell’edificio, sgommo via dal posteggio. In seguito, mi metto a cercare nel sacco dell’immondizia con un paio di guanti di lattice. Un mucchio di robaccia, tranne lo scontrino di un benzinaio datato 29 settembre (alla signora era stata ovviamente revocata la patente di guida) e quello di un negozio di alimentari, con la stessa data, per un totale di 32 dollari. Sufficiente per sopravvivere una settimana. Colin Thatcher progettava di tornare entro otto giorni. Non aveva intenzione di sparire. Rovisto fra la posta. Bollette, bollette e ancora bollette. Avvisi scaduti. Quasi nient’altro. Ripenso a quella cartolina, a tutti quegli alberi. Mi viene in mente che Grand Marais potrebbe essere un bel posticino da visitare in autunno. Colin Prima Le dico che mia madre si chiama Kathryn, le mostro una foto che conservo gelosamente nel mio portafoglio. È un’immagine molto vecchia, scattata una decina di anni fa. Lei dice che rivede i miei occhi in quelli di mia madre, la serietà e il mistero. Il sorriso della mamma è forzato, a causa di un dente storto che la imbarazzava. «Quando parli di lei», mi dice, «sorridi». I capelli di mia madre sono scuri, come i miei. Lisci come spaghetti. Pure quelli di mio padre. I miei ricci, invece, sono un mistero, la conseguenza di un gene recessivo, suppongo. Non ho mai conosciuto i miei nonni, non so se avevano capelli ricci. Per diverse ragioni, non posso tornare a casa, ma il motivo che non rivelo mai è che la polizia mi vuole mettere al fresco. Avevo ventitré anni quando ho violato la legge per la prima volta. È successo otto anni fa. Avevo cercato di vivere nel modo giusto, volevo rispettare le regole, ma la vita ha preso un’altra piega. Scassinai una stazione di servizio e spedii ogni dollaro rubato a mia madre affinché potesse comprarsi le medicine. Qualche mese dopo lo feci di nuovo per pagare le parcelle mediche. Capii che vendendo droga avrei potuto intascare più soldi, quindi lo feci per un certo periodo, finché non mi pizzicò un agente sotto copertura e dovetti passare diversi mesi in galera. Dopodiché provai di nuovo a restare pulito ma, quando mia madre ricevette un avviso di sfratto, mi feci prendere dalla disperazione. Non capisco perché sono tanto fortunato, perché i poliziotti ci mettano un sacco di tempo prima di inchiodarmi. Dentro di me, spero in parte che ci riescano, così non dovrò più fuggire, nascondermi sotto nomi falsi. «Quindi…», dice lei. Siamo fuori, passeggiamo nel bosco. È una mite giornata novembrina, le temperature si mantengono ancora sui 5 gradi, lei indossa il mio giaccone, con le mani affondate nelle tasche e il cappuccio sulla testa. Non ho idea da quanto tempo stiamo camminando, però il capanno è ormai invisibile. Calpestiamo tronchi caduti, e sposto i rami di un sempreverde per evitarle di zigzagare fra abeti balsamici alti venti metri. Ci inerpichiamo sulle collinette e per poco non cadiamo nei fossi. Calciamo via le pigne e ascoltiamo il richiamo degli uccelli. Ci appoggiamo a un tronco per riprendere fiato. «Quindi, non ti chiami Owen». «No». «E non vieni da Toledo». «No». Però non le dico il mio nome. Le racconto che una volta mio padre mi aveva portato lì, nel Minnesota, lungo il Gunflint Trail. Confesso che il capanno appartiene a lui, che l’aveva ricevuto in eredità dalla sua famiglia, che lo possedeva da chissà quanto tempo. Aveva incontrato una donna. «Non so cosa ci trovasse lei in quel bastardo», dico. «So che non è durata». Non ci parlavamo da anni e avevo dimenticato quasi tutto di lui. Poi, una volta, mi invitò a fare questo viaggetto. Affittammo una roulotte, arrivammo nel Minnesota dall’abitazione che aveva a Gary. Questo succedeva molto prima che si trasferisse a Winona per lavorare nel dipartimento dei trasporti. Non volevo andarci, ma la mamma mi disse che era mio dovere. Pensava ingenuamente che mio padre volesse sistemare le cose con me, invece si sbagliava di grosso. «La donna aveva un figlio della mia età, un mezzo scemo. Mio padre aveva progettato una bella vacanza, qualcosa da fare tutti insieme. La donna, suo figlio e io. Voleva impressionarla. Mi aveva promesso una bicicletta se mi fossi comportato bene. Tenni la bocca chiusa per tutto il tempo. Mai vista la bicicletta». Le dico che da allora non l’ho più rivisto. Comunque lo tengo d’occhio, non si sa mai. Lei dice che non comprende come faccia a orientarmi fra i boschi. Le rispondo che mi viene naturale. Innanzitutto, perché sono stato un boy-scout, e poi ho una capacità innata di intuire dove sono il Nord e il Sud. Infine, perché ho trascorso molto tempo a vagare nei boschi: da piccolo, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare lontano dai miei genitori che litigavano. Lei regge il mio passo tra gli alberi, non si stanca. Come fa una ragazza cresciuta in città a conoscere tutti i nomi degli alberi? Me li indica uno a uno (abete balsamico, abete rosso, pino), come se fosse una merdosa lezione di biologia. Sa che le ghiande sono i frutti della quercia, e che i frutti degli aceri planano a terra come dei piccoli elicotteri. Certo, non ci vuole un genio per saperlo. Solo che non me ne ero mai interessato, almeno prima di vedere le sue mani che lasciano cadere i semi e i suoi occhi che fissano meravigliati il loro atterraggio a elica. Mi insegna delle cose senza averne l’intenzione. Ripete che quegli elicotteri sono le samare, che quel pettirosso è un maschio. Trova ingiusto che nel regno animale la bellezza appartenga solitamente al sesso maschile, mentre le femmine sono poco appariscenti. Leoni, passeri, anatre, pavoni. Non avevo mai notato tale differenza. Non lo troverebbe tanto ingiusto se non fosse stata fregata da tutti gli uomini della sua vita. Dice di non aver mai saputo esprimere bene il modo in cui la faceva sentire suo padre. Afferma che comunque non l’avrei capito, perché lui non l’aveva mai picchiata, né le aveva mai fatto passare una notte all’addiaccio. Non l’aveva nemmeno mai mandata a dormire senza cena. In classe, ha uno studente che si chiama Romain, un ragazzo nero che dorme in un rifugio per senzatetto, dalle parti della periferia nord. A lui piace frequentare la scuola, sebbene nessuno lo obblighi. Ha diciotto anni, è deciso a prendere il diploma perché non si accontenta della licenza media. Passa le giornate a studiare come un matto, la mattina va scuola e il pomeriggio si spacca la schiena a pulire le strade della città. La sera va a chiedere l’elemosina in centro. Lei si era offerta come volontaria per aiutare i senzatetto di quel rifugio, voleva vedere la realtà di quel posto. «Per due ore ho tolto la muffa dal formaggio dei panini preconfezionati», racconta. Ma il suo gesto ha permesso alle persone di avere qualcosa da mangiare. Forse lei non è, come presumevo, chiusa e interessata solo a sé. Conosco la sensazione che danno gli sguardi sfuggenti, o di chi ti guarda senza vedere niente. Conosco il tono sprezzante nella voce, so come ci si sente quando si è traditi e disillusi, quando qualcuno che potrebbe darti il mondo rifiuta perfino di concedertene un pezzetto. Forse non siamo tanto diversi, in fondo. Gabe Prima Controllo i tabulati telefonici di Kathryn Thatcher. Nessuna chiamata dubbia da rilevare. L’ultima volta che ha parlato col figlio è stato quando lui le ha telefonato da un cellulare registrato a nome di Steve Moss, alla fine di settembre. Il resto erano televenditori, agenzie di recupero crediti e segretarie di studi medici che le ricordavano appuntamenti a cui la donna non si presentava. Chiamo al ricovero per anziani di Gary. L’inserviente s’informa se sono un familiare, rispondo di no, e loro non mi considerano. In sottofondo sento le urla di un vecchio. Preferisco non pensare alla signora Thatcher in mezzo a quel frastuono. So che ne sarà sconvolta. Mi consolo all’idea che la nutrono, la curano e la tengono pulita. Mi dico che non sono suo figlio. Non è mia la responsabilità. Eppure, non riesco a scacciare dalla mente l’immagine di mia madre nella sua vestaglia, seduta su un letto sfondato, mentre fissa nel vuoto da una finestra sporca: sola, senza speranze, mentre un vecchio sdentato grida nel salone. Le infermiere sottopagate la ignorano. L’unica prospettiva decente è quella del giorno in cui morirà. Il caso di Mia Dennett viene trattato tutte le sere nei telegiornali, anche in seguito alle pressioni del padre giudice, ma non c’è ancora alcuna pista. M’informo presso la motorizzazione, ma non ci sono veicoli a nome di Colin Thatcher o Steve Moss, e neanche sotto quello di Kathryn Thatcher. Abbiamo contattato chiunque fosse rintracciabile e potesse conoscere Colin. Pochi amici, solo un paio di compagni delle superiori che non gli parlano da anni. A Chicago vive una sua ex, che non sono certo lui non pagasse in cambio di prestazioni sessuali. Su di lui, non sa dirmi niente di carino. È una donna perduta, non ha altro da offrirmi se non una sveltina, nel caso fossi interessato, ma non lo sono. Alcuni docenti della sua scuola mi dicono che Colin era un ragazzo sfortunato, altri lo descrivono come un disadattato. I vicini della madre confermano che lui va spesso a trovarla, le porta fuori l’immondizia e tiene in ordine il giardino. Tutto qua. Il vicinato non sa cosa succede dentro quella casa. Però mi riferiscono che guida un pick-up. Di che colore? La marca? Il modello? Pare che non lo sappia nessuno. O le risposte si contraddicono. Il numero di targa neanche a parlarne… Ogni tanto mi viene in mente la cartolina da Grand Marais. Cerco questo porto lacustre su internet, ordino online opuscoli dalle agenzie di viaggio. Calcolo la distanza da Chicago, mi spingo perfino a chiedere le riprese delle videocamere lungo il tragitto, benché non sappia bene cosa sto cercando. Sono in un vicolo cieco. L’unica cosa da fare è aspettare. Colin Prima Ho di nuovo fortuna, perché la ragazza è ancora addormentata quando sento raspare alla porta. Mi spavento a morte, ovviamente. Scatto dal floscio sofà e mi accorgo di non avere la pistola. È l’alba, il sole sta sorgendo proprio adesso. Scosto le tende per guardare, ma non vedo nulla. Al diavolo, penso. Apro la porta e scopro che il fottuto gatto, sparito da giorni, ci ha portato un topo morto. Ha un aspetto miserevole, quasi come quello del roditore decapitato che tiene tra le zampe insanguinate. Prendo il gatto in braccio, dopo mi occuperò anche del sorcio. Per il momento, userò il felino come pegno. Un intervento divino, se credessi in queste cose. La dispensa è stata spazzolata. Non ci resta niente da mangiare. Se non vado presto in un alimentari, creperemo di fame. Non aspetto che si svegli. Entro nella stanza da letto e dico: «Vado in città». Lei si mette a sedere. È confusa e si stropiccia gli occhi. «Che ore sono?», chiede, ma ignoro la domanda. «Lui viene con me». Il gatto miagola, attirando la sua attenzione. Lei si allarma. Allunga una mano per prenderlo, faccio un passo indietro. Il piccolo bastardo mi pianta gli artigli nel braccio. «Dove l’hai…?» «Se sarai ancora qui quando torneremo, non dovrò ucciderlo». Poi me ne vado. Mi precipito in città. Raggiungo i 110 su un tratto di strada il cui limite è 80. Ci scommetto le palle che la ragazza non farà nessuna stupidaggine, eppure non riesco a togliermi dalla mente l’immagine del capanno invaso di piedipiatti in attesa del mio ritorno. Passo davanti a due negozi di abbigliamento prima di arrivare a Grand Marais. Cerco sempre di confondere le acque, non sono mai stato due volte nello stesso posto. Non voglio che qualcuno mi riconosca. Comunque, l’unica cosa che ho in testa adesso sono i generi alimentari che mi devo procurare. Conosco un tipo che fornisce passaporti falsi, è uno specialista. Trovo un telefono a gettoni fuori un negozio di ferramenta e recupero un paio di monetine nelle tasche. Spero di non commettere un errore. Non ci vogliono tre minuti, come dicono in televisione, per rintracciare una chiamata. Gli operatori sono in grado di farlo nello stesso istante in cui si connette la linea. Non appena digito il numero. O basta che Dan spifferi agli agenti di aver ricevuto una mia telefonata e domattina tutta la polizia sarà ammassata davanti alla ferramenta per darmi la caccia. Ma che scelta mi resta? Cercheremo di superare l’inverno, e poi che succederà? Saremo fregati. Se a primavera saremo ancora vivi, non ci sarà più nessun posto in cui nasconderci. Di conseguenza, inserisco le monetine nell’apparecchio e digito il numero. Al mio ritorno, lei si fionda sui gradini coperti di neve per strapparmi lo stupido felino dalle mani. Mi grida in faccia che tanto non sarebbe scappata. Mi insulta per aver minacciato il gatto. «Come potevo esserne sicuro?», le chiedo. Dal sedile posteriore del pick-up, scarico le buste di carta col cibo in scatola. Ne ho riempite una decina di barattoli vari. Ecco qua, mi sono detto, questo è l’ultimo viaggio in città. Finché non saranno pronti i passaporti, ingoieremo zuppe liofilizzate, fagioli in scatola e pomodori pelati. Oltre a quello che riuscirò a pescare nel lago. Mi stringe il braccio, obbligandomi a guardarla. La sua presa è forte. «Non me ne sarei andata», ripete. Mi sottraggo alla stretta e dico: «Non potevo rischiare». Salgo gli scalini, lascio fuori lei e il gatto. Vuole far entrare anche l’animale. Ogni giorno è più freddo. Non sopravvivrà all’inverno. «Nemmeno per sogno», protesto. Lei insiste: «Lui sta dentro». È perentoria. Sta cambiando qualcosa. Le racconto di quando, da ragazzo, lavoravo con mio zio. Ne parlo malvolentieri. Però c’è un limite al silenzio che si può sopportare. Cominciai a lavorare per il fratello di mia madre quando avevo quattordici anni. Era un uomo dalla pancia gonfia di birra che mi faceva fare il suo lavoro e, alla fine della giornata, intascava il novanta percento dei proventi. Nella mia famiglia, nessuno ha frequentato l’università. Nessuno. Forse un lontano cugino o qualcosa di simile. Ma nessuno di quelli che conosco. Siamo tutti operai. I miei parenti lavorano perlopiù nelle industrie siderurgiche di Gary. Sono cresciuto in un ambiente nel quale, in quanto bianco, ero in minoranza e dove un quarto della popolazione viveva sotto la soglia di povertà. «La differenza tra me e te», dico, «è che io sono cresciuto con niente, né speravo di avere di più. Sapevo che non lo avrei ottenuto». «Però sognavi certamente di diventare qualcosa?» «Aspiravo a mantenere lo statu quo. Non volevo cadere più in basso di quel che ero già. Ma poi l’ho fatto». Louis, mio zio, mi aveva insegnato a riparare i rubinetti, a installare le caldaie, a imbiancare le pareti, a ripescare uno spazzolino da denti dalla tazza del cesso. A falciare l’erba dei prati, a riparare le serrande dei garage, a cambiare la serratura di casa alle persone che cacciano l’ex convivente. Louis si faceva pagare venti dollari l’ora, e a fine giornata mi mandava a casa con trenta dollari in tasca. Sapevo che mi imbrogliava. A sedici anni mi ero già messo in proprio. Comunque, il lavoro era saltuario, avevo bisogno di qualcosa di più stabile. A Gary il tasso di disoccupazione è molto alto. Mi chiede con quale frequenza io faccia visita a mia madre Kathryn. Quando pronuncia il suo nome, prima mi irrigidisco e poi mi calmo. «Ti preoccupi per lei, vero?», chiede. «Finché sono qui non posso aiutarla». Allora capisce. «I soldi», esclama. «I cinquemila dollari…». Sospiro. Ammetto che erano per mia madre. Lei non vuole prendere le medicine, a meno che non sia io a costringerla. Afferma di dimenticarsene, mentre in realtà non vuole subire gli effetti collaterali o indesiderati. Dico alla ragazza che di solito vado da lei ogni domenica. Separo per mia madre i farmaci nel dispenser, vado a fare la spesa, tengo pulita la casa. Ma lei avrebbe bisogno di molte altre cose, di qualcuno che la segua continuamente, non solo di domenica. «Un ricovero per anziani», dice. In effetti, volevo portarcela, e i cinquemila dollari erano destinati a quello scopo. Adesso però quella somma è svanita, perché d’impulso avevo deciso di salvare lei; così, in un attimo, oltre a fregarmi da solo, avevo coinvolto nella disgrazia anche mia madre. Ma in fondo so bene perché l’ho fatto. E la ragazza non c’entra niente. Se mia madre avesse scoperto che ero stato io a rapire inizialmente la figlia del giudice – magari ritrovata morta quando tutto fosse finito – sarebbe comunque crepata di dolore. I cinquemila dollari non avrebbero contato niente. Mia madre sarebbe morta dentro e avrebbe perso ogni interesse per la vita. Non mi ha allevato per diventare un simile ceffo. A questo non avevo mai pensato, prima di far salire la ragazza sul mio pick-up. Allora la chimera dei soldi aveva ceduto il posto alla realtà: la ragazza in lacrime di fianco a me, l’immagine degli scagnozzi di Dalmar che la strappano di forza dal sedile, i trent’anni di galera. Mia madre sarebbe morta molto prima del mio rilascio. A cosa sarebbe servito? Comincio a camminare per la stanza. Sono nervoso. Non ce l’ho con lei, ma con me stesso. Le chiedo: «Che uomo metterebbe la madre in un ricovero perché non ne può più di curarla a casa?». È la prima volta che mi mostro vulnerabile. Sono in piedi nell’angolo, appoggiato alla parete di pino, mi premo una mano sulla testa per via di un’emicrania persistente. La guardo negli occhi comprensivi e le ripeto la domanda: «Sul serio, che uomo metterebbe la madre in un ricovero perché non ne può più di curarla a casa?» «Ci sono dei limiti a ciò che si può fare». «Io posso fare di più», ribatto. Lei rimane vicino alla porta d’ingresso, osserva cadere i fiocchi di neve. Il gatto le gironzola attorno ai piedi, vuole uscire. Ma lei non glielo permetterà. Non stasera. «Davvero, puoi fare di più?». Le dico che delle volte, la domenica, quando arrivo, mi sorprende il fatto di vederla ancora viva. La spazzatura trabocca. Non ha mangiato, i pasti che le avevo lasciato nel frigo sono intatti. La porta d’ingresso spesso è aperta, talvolta il forno è acceso. Le avevo proposto di venire a stare da me, ma aveva rifiutato. Quella era la sua casa, non voleva andarsene da lì. Ci aveva vissuto tutta la sua vita, ci era cresciuta. «Ci sono i vicini», aggiungo. «Una signora va a vedere come sta una volta alla settimana, ritira la posta, controlla che abbia cibo a sufficienza. Ha settantacinque anni, ma se la cava molto meglio di lei. Ognuno però ha la sua vita cui pensare. Non posso pretendere che siano gli altri a preoccuparsi al posto mio». Le spiego che ci sarebbe anche mia zia, Valerie, che abita a Griffith, nelle vicinanze. Di tanto in tanto va a darle una mano. Spero che Valerie abbia intuito qualcosa: la telefonata di un vicino, la mia faccia in televisione. Spero si sia accorta che mia madre è sola e si sia affrettata a fare qualcosa, qualunque cosa, per rimediare alla situazione. Mia madre non sapeva niente dell’ospizio, però non ha mai voluto essere un peso per gli altri. Era il meglio che potessi escogitare, un compromesso. Tuttavia sono consapevole che il ricovero per anziani è un compromesso di merda. Nessuno vuole viverci. Ma quali opzioni migliori ci sono? Prendo rabbiosamente il mio giaccone dalla spalliera di una sedia. Ce l’ho con me stesso. Ho deluso e abbandonato mia madre. Mi metto le scarpe in fretta, infilo le braccia nelle maniche del giaccone. Non guardo la ragazza, quasi la travolgo mentre mi dirigo verso la porta. «Sta nevicando», dice. Si sposta lentamente, mi appoggia una mano sul braccio per cercare di fermarmi. «Nessuno si azzarda a uscire in una notte come questa». «Me ne frego». La spingo via e apro la porta. Solleva il gatto tra le braccia per impedirgli di scappare fuori. «Ho bisogno di una boccata d’aria, maledizione», dico sbattendo la porta. Eve Prima Poco dopo il giorno del Ringraziamento una donna cuoce nel forno a microonde il suo bambino di tre settimane e un’altra squarcia la gola alla figlia di tre anni. Non è giusto. Perché queste madri ingrate avevano la fortuna di avere in casa la loro benedizione, mentre la mia me l’hanno strappata? Sono stata altrettanto pessima, come madre? Il giorno del Ringraziamento il clima era primaverile: temperatura sui quindici gradi, parecchie ore di sole. Venerdì, sabato e domenica idem, anche se abbiamo mangiato gli avanzi del tacchino farcito e del purè di patate, che sono piatti tipicamente invernali. Qui a Chicago, ci si sta preparando al peggio. Le previsioni meteo annunciano bufere e tempeste in arrivo, forse fin da giovedì prossimo. Nei negozi hanno esaurito le scorte di acqua imbottigliata, la gente si appresta a rifugiarsi in casa. Dio mio, penso, siamo in inverno, è la stessa cosa ogni anno, mica la bomba atomica. Approfitto del relativo tepore per decorare la casa. Certo, non sono allegra, né in spirito natalizio, però ci provo lo stesso, tanto per combattere la noia e gli orribili pensieri che mi ossessionano. Non che James lo noti, e a me non interessa, ma per ravvivare l’atmosfera nel caso Mia torni. Se fosse qui con noi, per Natale, lei ne sarebbe contenta: l’albero, le luci, la calza dei regali della sua infanzia ormai logora, con l’angelo ricamato che sta perdendo i capelli. Bussano alla porta. Mi agito subito, ormai è normale, penso che possa essere lei. Mi impiglio nel filo delle lucine natalizie che stavo provando a dipanare. Non so come fanno a formarsi tutti quei nodi, nei contenitori di plastica che teniamo in soffitta, eppure ogni anno siamo sicuri di ritrovarli, come l’impietoso inverno di queste lande. Lo stereo trasmette canzoni natalizie di tradizione celtica, fra cui Carol of the Bells. Indosso un pigiama di seta a righe, composto da giacca con bottoni e calzoni allacciati con un cordoncino. Sono appena le dieci, per cui è ancora accettabile essere in tenuta da notte, almeno per la mia mentalità, anche se il caffè sta diventando tiepido e il latte comincia a rapprendersi. La casa è nella confusione più totale: contenitori di plastica rossi e verdi sparsi dappertutto coi coperchi gettati alla rinfusa, i rami dell’albero di Natale artificiale che montiamo ogni anno, da quando io e James abitavamo in affitto in un appartamento di Evanston e lui non si era ancora laureato in legge. Tutto ammucchiato in salotto. Ho rovistato nelle scatole delle decorazioni che si sono accumulate negli anni, dalle palline «Baby’s 1st Christmas» ai bastoncini caramellati che le ragazze avevano realizzato in terza elementare. Tutti oggettini che non erano mai riusciti a guadagnare la dignità dell’esposizione sull’albero e rimanevano nelle scatole a impolverarsi. Io insistevo sempre per addobbarlo con molto sfarzo, in modo che gli ospiti potessero ammirarlo qualora ne avessimo avuti per una festa. Sdegnavo il ciarpame con cui gli altri riempivano le loro residenze nel mese di dicembre, i pupazzi di neve e la chincaglieria accumulata per anni. Ciononostante, quest’anno ho deciso di appendere tutte le decorazioni delle ragazze. Mi alzo da terra, lascio perdere le luci. Ho visto che l’ispettore Hoffman sbircia da dietro il vetro. Gli apro la porta e sono investita da una ventata d’aria fredda. «Buongiorno, signora Dennett», dice, entrando subito dentro. «Buongiorno, ispettore». Mi passo una mano fra i capelli spettinati. Il suo sguardo perlustra la casa. «Siamo alle decorazioni, mi pare». «Ci provo», spiego. «Ma le luci sono tutte aggrovigliate». «Be’», esordisce togliendosi la giacca. «Sono un esperto nello sciogliere i nodi dei fili delle luci elettriche. Permette?», mi chiede, e io accetto con un ampio gesto della mano, contenta che ci sia qualcuno a finire questa scocciatura. Gli offro un caffè, consapevole che accetterà, perché lo fa sempre: ci vuole anche la panna e molto zucchero. Sciacquo la mia tazza e la riempio di nuovo, tornando in salotto con entrambe le mani occupate. Lui è inginocchiato sul pavimento, con la punta delle dita separa delicatamente i fili delle luci. Appoggio la sua tazzina su un sottobicchiere sopra il tavolino e mi siedo a terra per dargli una mano. È venuto per parlarmi di Mia. S’informa su una certo paesino del Minnesota. Ci sono mai stata? E Mia? Gli dico di no. «Perché?», domando. «Semplice curiosità», si schermisce. Sostiene di aver visto delle foto di questa cittadina, sembra graziosa. Un porto lacustre a una sessantina di chilometri dal confine canadese. «Ha qualcosa a che vedere con Mia?», lo incalzo. E sebbene lui ci provi, non riesce a eludere la domanda. «Di che si tratta?», insisto. «Una semplice intuizione», ammette. «Non ho ancora nulla. Però voglio approfondire la questione», e siccome i miei occhi implorano una spiegazione, promette: «Lei sarà la prima a esserne informata». «Grazie», dico dopo un attimo di esitazione, so che l’ispettore è l’unico a preoccuparsi tanto per mia figlia, come me. Sono quasi due mesi che Gabe si presenta inaspettatamente a casa mia. Ci viene ogni volta che ne ha voglia: una domanda urgente su Mia, un’ipotesi che gli è venuta in mente di notte. Si irrita se lo chiamo «detective», e d’altronde io mi irrito se mi chiama «signora Dennett». Eppure, manteniamo una parvenza di formalità, anche se dopo settimane che analizziamo la vita di Mia nei minimi dettagli ormai dovremmo darci del tu e chiamarci per nome. Lui è molto bravo a parlare del più e del meno, a saltare di palo in frasca. James non è ancora certo che non sia un cretino. Io invece penso che sia molto dolce. Fa una pausa dal groviglio di fili e allunga una mano per afferrare la tazza di caffè, ne beve un sorso. «Si dice che cadrà tanta di quella neve…», cambia subito argomento. Per contro, io mi fisso sul paesino: Grand Marais. «Come minimo trenta centimetri, se non di più», lo assecondo. «Sarebbe bello avere la neve per Natale». «Come no», ne convengo. «Ma non accade mai. Forse sarebbe il segno di una benedizione, o forse, con tutti gli spostamenti e le commissioni che bisogna fare in questo periodo, è meglio che non nevichi». «Sono sicuro che avrà finito di sbrigare tutte le commissioni molto prima del 25». «Lei crede?». Sono sorpresa dalla sua supposizione, e aggiungo: «Non ho tante persone a cui fare regali. Solo James e Grace, e… Mia». Lui non commenta, e rimaniamo un istante in silenzio, per rispetto verso di lei. Dovrebbe essere un momento di disagio, eppure è accaduto tante di quelle volte negli ultimi tempi, ogni volta che se ne pronuncia il nome… «Lei non mi sembra una che rimanda le cose», dichiara dopo un attimo. Rido. «Ho troppo tempo a disposizione per potermi permettere di rimandare», gli spiego, ed è la verità. Con James al lavoro per l’intera giornata, cos’altro dovrei fare se non andare in giro per negozi a comprare regali? «Ha sempre fatto la casalinga?», mi chiede, e io mi raddrizzo, meravigliata, quasi a disagio; come diavolo abbiamo fatto a passare dagli addobbi natalizi e il tempo a questa confidenza? Odio la parola casalinga. Fa tanto anni Cinquanta, è obsoleta. Inoltre, ha una connotazione negativa che forse non aveva una sessantina di anni fa. «Cosa intende con casalinga?», replico, e poi aggiungo: «Abbiamo la donna delle pulizie, non lo sa? Talvolta cucino, ma di solito James torna tardi e finisco per mangiare da sola. Non credo quindi si possa dire che pensi alla casa. Forse lei intendeva se sono sempre stata disoccupata». «Non volevo offenderla», si affretta a ribattere. È imbarazzato, siede di fianco a me sul pavimento, separa le luci. Sta facendo degli evidenti progressi, se la cava molto meglio di me. Davanti a lui si stende un filo quasi privo di nodi, per cui si accinge a testarlo nella presa del muro. Sono meravigliata nel vedere che si accendono tutte. «Bravo», mi complimento, e poi fingo: «Non sono offesa». Gli do un colpetto rassicurante sulla mano, cosa che non avevo mai fatto, nessun gesto che potesse annullare lo spazio fisico che ci separava. «Per un certo periodo ho fatto l’arredatrice d’interni», spiego. Lui osserva la stanza, assimila i più piccoli dettagli. In effetti ho arredato anche questa casa, una delle poche cose di cui vada orgogliosa, mentre sono stata scarsa nel mestiere di madre. Quello era un lavoro che mi appagava, ma con la maternità cominciò a sembrarmi lontanissimo: da quando erano nate le bambine, la mia esistenza era mutata e mi ritrovavo a dover cambiare i pannolini, o a lavare il parquet sporco di rimasugli di purè. «Non le piaceva?», chiede Hoffman. «Assolutamente, lo adoravo». «Cos’è successo? Se non sono troppo ficcanaso…». Penso che lui abbia un bel sorriso, dolce e giovanile. «Sono arrivate le figlie», dico in tono leggero. «Cambiano tutto». «Ha sempre voluto dei bambini?» «Immagino di sì. Li sognavo da quando ero piccola, è una cosa comune a tutte le donne». «L’istinto materno è una vocazione? Una cosa per cui le donne sono state programmate dalla natura?» «Mentirei se dicessi che non ero felicissima quando mi sono accorta di essere incinta di Grace. Mi piaceva avere la pancia, sentirla muoversi dentro di me». Lui arrossisce, s’imbarazza per quest’improvvisa rivelazione intima. «Quando nacque, fu un richiamo alla realtà. Avevo sognato di cullare la mia bambina per addormentarla, di calmarla col suono della mia voce. Invece dovetti affrontare notti insonni, nervosismo dovuto alla mancanza di riposo, pianti ininterrotti che non riuscivo a calmare in nessuna maniera. E poi anni di fatiche per insegnarle a mangiare, di capricci e bizze infinite, non mi rimaneva nemmeno il tempo per limarmi le unghie o truccarmi. James rimaneva in ufficio fino a tardi e, quando rientrava, non gli andava molto di occuparsi di Grace, se ne lavava le mani della sua educazione. Quello spettava a me, ventiquattr’ore al giorno, un mestiere sfibrante, privo di riconoscimenti, e lui alla fine non capiva perché non avevo avuto il tempo di andare in lavanderia a ritirare i suoi vestiti, o di piegare la montagna biancheria pulita». Cala il silenzio. Stavolta il disagio è palpabile. Ho detto troppo, sono stata eccessivamente sincera. Mi alzo, comincio a montare i rami sul tronco dell’albero di Natale. L’ispettore finge di ignorare la mia confessione, stende ordinatamente i fili delle luci in righe parallele. Ce ne sono in quantità, più che sufficienti per decorare l’albero, per cui mi chiede se può aiutarmi, e io accetto. Quando abbiamo quasi finito di disporre le luci sull’albero, mi butta lì: «Ma poi è arrivata Mia, e a quel punto doveva essere diventata brava nel mestiere di madre». So che voleva essere un complimento, eppure sono colpita dal fatto che la mia precedente confessione lo abbia indotto a credere non che la maternità sia un lavoro duro di per sé, ma solo che mi mancassero le capacità per essere una brava mamma. «Avevamo tentato per anni di concepire Grace. Ci avevamo quasi rinunciato. Dopo, credo che siamo stati ingenui. Pensavamo che Grace fosse il frutto di un miracolo. Di certo non si sarebbe ripetuto, perciò non prendevamo più precauzioni. Invece accadde di nuovo, una mattina ebbi le nausee, l’affaticamento. Compresi subito di essere incinta un’altra volta. Aspettai diversi giorni prima di rivelarlo a James. Non ero sicura della sua reazione». «E come la prese?». Afferro un altro ramo dalla mano del detective, lo metto sul tronco. «Rifiuto, mi pare. Riteneva che mi sbagliassi, che interpretassi male i sintomi». «Non voleva un altro erede?» «Forse non voleva nemmeno la prima figlia», ammetto. Gabe Hoffman mi sta davanti con la sua giacca di pelo di cammello, che dovrà essergli costata un occhio della testa. Sotto, indossa una felpa, e poi una camicia elegante, per cui non riesco a immaginare quanto possa sudare. «Oggi è vestito con tutti i crismi», dico, mettendomi davanti all’albero di Natale con il mio pigiama di seta. In quel momento, rivolta verso la luce del sole che entra dalle finestre, mi sembra che lui appaia in tutta la sua dolcezza ed eleganza. «Tribunale, questo pomeriggio», è tutto quel che riesce a dire, e poi restiamo a fissarci in silenzio. «Amo mia figlia», rivelo all’ispettore. «Lo so», dice lui. «E suo marito? Le vuole bene anche lui?». Sono sconvolta dalla sua impudenza, ma ciò che dovrebbe offendermi e spingermi a voltargli le spalle mi attira ancor più verso di lui. Mi affascinano i suoi modi diretti, perché Gabe non si perde in chiacchiere. Mi fissa, e sono costretta ad abbassare lo sguardo. «Mio marito vuole bene solo a se stesso», confesso. Sulla parete più lontana c’è una foto incorniciata: io e James il giorno del matrimonio. Ci siamo sposati in un’antica cattedrale cittadina. Erano stati i suoi genitori ad accollarsi le spese esorbitanti, laddove la tradizione avrebbe voluto che fosse mio padre a provvedere. I Dennett non lo avrebbero mai permesso. Non per gentilezza, anzi, ma perché altrimenti le nostre nozze sarebbero state dozzinali, un’umiliazione di fronte alle loro conoscenze altolocate. «Non era questa la vita che avevo sognato quand’ero ragazza». Lascio cadere i rami dell’albero a terra. «Chi sto ingannando? Quest’anno non avremo nessun Natale. James sosterrà di dover lavorare, sebbene sia certa che non sarà il lavoro a occuparlo, mentre Grace starà con i genitori dell’uomo con cui sta uscendo, che io ancora non conosco. Io e James ceneremo insieme il giorno di Natale, come tanti altri giorni dell’anno. Sarà una cosa ordinaria. Staremo seduti e rumineremo in silenzio prima di ritirarci per la notte, ognuno in camera sua. Io telefonerò ai miei genitori, ma mio marito mi dirà di sbrigarmi, perché le chiamate internazionali costano. Poco importa», concludo. «Tanto tutto quello che vogliono sapere sono le novità su Mia, una questione che tutti mi ricordano continuamente…». Tento di riprendere fiato. Alzo una mano: basta. Scuoto la testa e volto le spalle all’uomo che mi fissa con uno sguardo compassionevole che mi fa vergognare. Non ce la faccio a proseguire. Non riesco a finire. Sento che mi batte forte il cuore. La pelle è appiccicosa, comincio a sudare. Faccio fatica a respirare. Avverto il bisogno irresistibile di gridare. È così che comincia un attacco di panico? Eppure, quando le braccia dell’ispettore mi avvolgono, sparisce ogni sintomo. Lui mi avvinghia da dietro. Il ritmo del mio cuore rallenta fino a tornare normale. Lui appoggia il mento sulla mia testa, e io riprendo a respirare, l’ossigeno mi riempie i polmoni. Non dice che andrà tutto bene, perché forse non sarà così. Non mi promette di ritrovare Mia, perché forse non potrà farlo. Ma mi tiene così stretta che per un attimo le emozioni si placano. La paura e la tristezza, il rimpianto e il disgusto. Le assume su di sé per un istante, raccogliendole tra le sue braccia ed evitandomi di essere la sola a dover sostenere quel fardello. Mi giro verso di lui e abbandono il viso sul suo petto. Le sue braccia esitano, dopodiché mi stringono nel mio pigiama di seta. Profuma di schiuma da barba. Mi accorgo di mettermi in punta di piedi per avvicinare il volto al suo. «Signora Dennett», protesta piano. Mentre bacio le sue labbra, mi ripeto che non è stato lui a volerlo. È una cosa allo stesso tempo nuova, eccitante e disperata. Allora stringe un lembo del mio pigiama tra le mani e mi attira a sé. Gli allaccio le braccia al collo, faccio scorrere le dita tra i suoi capelli. Sento l’odore del caffè che ha bevuto. Ricambia il bacio. Solo per un attimo. «Signora Dennett», sussurra di nuovo, portando delicatamente le mani sui miei fianchi, per allontanare il mio corpo da sé. «Eve, per favore», dico, e lui si scosta, passando il dorso della mano sulle labbra. Compio un ulteriore, vano tentativo di attirarlo a me. Ma non mi vuole. «Signora Dennett, non posso». Il silenzio dura un’eternità. Abbasso lo sguardo. «Dio mio, cos’ho fatto?», sussurro. Non sono abituata a queste cose. Non l’ho mai fatto, io sono integra e virtuosa. Questo è un comportamento infedele… di cui lo specialista è James. Una volta avevo sempre lo sguardo degli uomini addosso. Pensavano che fossi davvero bellissima. Se attraversavo una stanza al braccio di James, ogni uomo e la relativa compagna invidiosa si voltavano a guardarmi. Sento ancora le braccia dell’ispettore che mi stringono, con compassione e desiderio di rassicurazione, avverto con forza il suo calore. Ma adesso si allontana, e mi ritrovo a fissare il pavimento. Mi solleva il mento, mi costringe a guardarlo. «Signora Dennett», dice, ma non riesco a guardarlo, mi vergogno di vedermi riflessa nei suoi occhi. «Eve», insiste. Lo fisso, e non vedo disprezzo né rabbia. «Non c’è cosa al mondo che vorrei fare di più, ma le circostanze…». Annuisco. Lo so. «Sei un uomo d’onore», esclamo. «O un gran bugiardo». Mi accarezza la nuca. Chiudo gli occhi e cedo al suo tocco. Lui mi attira a sé. Depone un bacio sulla mia testa, fa scorrere una mano sui capelli e sulla schiena. «Nessuno mi obbliga a venire qui due o tre volte alla settimana. Lo faccio di mia iniziativa, perché desidero vederti. Potrei telefonare, invece vengo per vedere te». Rimaniamo in quella posizione per un minuto, poi dice che deve andare in tribunale, in centro. Lo accompagno alla porta, lo seguo con gli occhi mentre se ne va, poi resto ferma davanti al vetro gelido, a fissare la strada alberata finché la sua auto sparisce. Colin Prima La chiamano «Alberta clipper». È un’area di bassa pressione a spostamento rapido che si verifica quando l’aria calda dell’oceano Pacifico si scontra con le montagne della British Columbia. Allora si formano venti di caduta che hanno la forza di uragani e portano aria boreale verso Sud. Appena due giorni fa non sapevo niente di queste cose. Finché la temperatura all’interno del capanno non è precipitata così in basso da indurci ad accendere per qualche minuto il riscaldamento del pick-up e riscaldarci lì. Avevamo bisogno di scongelarci. Ci siamo avventurati nel freddo pungente per rifugiarci nel veicolo. Lei camminava dietro di me, per proteggersi dal vento. Le portiere erano praticamente bloccate dal gelo. Una volta dentro l’abitacolo, ho acceso la radio e le previsioni parlavano, appunto, di questo fenomeno che prende il nome dalla provincia canadese di Alberta. Si stava abbattendo proprio in quel momento sulla nostra zona, infieriva con bufere di nevischio e venti incredibilmente gelidi. Dalla mattina le temperature erano scese probabilmente di dieci gradi o più. Non credevo che l’auto si sarebbe messa in moto. Ho lanciato qualche imprecazione mentre lei recitava varie Ave Maria, ma alla fine è andata. Ci è voluto un po’ prima che il riscaldamento si accendesse e l’aria calda uscisse dalla griglia, ma poi ce l’abbiamo fatta. «Da quant’è che hai questo pickup?», chiede. Secondo lei, ha più anni dei suoi studenti. Gli altoparlanti anteriori non funzionano. I sedili sono rotti. «Da troppo tempo», dico. Le previsioni meteo sono seguite dagli annunci pubblicitari. Sposto la manopola della radio e passo dalla musica country a Per Elisa di Beethoven. Che sfiga! Ci riprovo e m’imbatto in una stazione che trasmette classici del rock. Sono soddisfatto e abbasso il volume. Fuori il vento ulula, e fa oscillare il veicolo. Deve soffiare ai cento all’ora. Ho la tosse e mi cola il naso. Mi dice che è colpa della passeggiata nel freddo della sera precedente, ma secondo me non ci si ammala così. Poi mi volto dall’altra parte e tossisco. Ho gli occhi pesanti, non mi sento bene. Guardiamo fuori dai finestrini. Gli alberi vacillano sotto le sferzate del vento impetuoso. Da una quercia vicina si stacca un ramo che colpisce la macchina. Lei sussulta e mi guarda. Dico che va tutto bene, che presto sarà tutto finito. Mi chiede quale sia il mio piano, fino a quando ho intenzione di tenerla nel capanno. Le confesso che non lo so. «Ci sono alcune cose che devo risolvere prima di andarcene», spiego. So che, quando ce ne andremo, lei verrà con me. Questo è fin dove riesco a spingermi riguardo i giorni che restano: quando tagliare la corda e dove dirigerci. Le temperature in rapido calo rendono evidente il fatto che non possiamo più restare qui. Ho detto a Dan di procurarci passaporti falsi, e lui mi ha risposto che gli occorre del tempo. Ma non so quanto, fuori dalla ferramenta col telefono a gettoni avevo insistito, gli avevo detto che non ne abbiamo molto. «Richiamami tra un paio di settimane, vedrò quel che si può fare», aveva assicurato. Quindi, per il momento dobbiamo aspettare. Ma non glielo rivelo, la lascio nella convinzione che non ho la minima idea di come fare. Alla radio passano i Beatles. Dice che le ricordano sua madre. «Quando io e Grace eravamo piccole, ascoltava sempre i loro dischi. Le piaceva la loro musica, ma soprattutto era un modo per restare in contatto con la cultura britannica. Adorava tutte le cose inglesi: il tè, Shakespeare, i Beatles». «Perché non parli mai di tua madre?», le chiedo. Afferma di essere certa di averne parlato. «Ma forse solo di sfuggita. Lei è così, non è mai sotto la luce dei riflettori. Non c’è mai molto da dire. È tranquilla, sottomessa, malleabile». Metto le mani davanti alla griglia da cui esce il calore, cercando di assorbirne il più possibile. «Cosa crede che ti sia accaduto?», domando. Riesco a percepire l’odore del sapone che le resta sulla pelle, a me non succede. Un profumo acre, come quello delle mele. «No so», replica. «Non ci ho pensato». «Ma lo sa che sei scomparsa». «Forse». «Ed è preoccupata». «Non saprei», riflette. «Come mai?». Ci pensa. «L’ultimo mese mi ha telefonato un paio di volte. Io però non l’ho richiamata, e lei non voleva disturbarmi. Perciò ha lasciato perdere». Ma sostiene di avere dei dubbi. Dice che ha pensato spesso a cosa avrebbero creduto gli altri il giorno del suo compleanno, o quando non aveva partecipato alla cena del Ringraziamento. Si domanda se c’è qualcuno che la sta cercando. Se si sono accorti che è sparita. «Mi chiedo se la polizia sia già al lavoro o se la mia scomparsa rientri solo nelle chiacchiere dei curiosi. Mi hanno sostituito e ho perso il mio lavoro? Mi hanno tolto l’appartamento per non aver pagato l’affitto?». Le dico che non ne so niente. Forse gliel’hanno tolto. Ma cosa conta adesso? Non può mica tornare a casa. E nemmeno riprendere a insegnare… «Però ti vuole bene», aggiungo. «Tua madre». «Sicuro», dice. «È la mia mamma». Poi comincia a raccontarmi di lei. «Mia madre è figlia unica», spiega. «È cresciuta nel Gloucestershire, in un piccolo villaggio sonnolento con gli antichi cottage di pietra, quelli coi tetti spioventi. Ci vivono i miei nonni. Il loro cottage non è niente di speciale, è antiquato, disordinato, una cosa che mi faceva venire i nervi. Mia nonna è una che non butta via niente, mio nonno è il tipo d’uomo che beve fino a cent’anni. Puzza di birra, anche se in modo gradevole, e i suoi baci sono sempre umidi e alcolici. Sono i tipici nonni: lei sa cucinare come nessun’altra donna al mondo, lui sa raccontare per ore delle storie affascinanti sulle guerre che ha combattuto. La nonna mi scrive delle lettere, lunghi papiri su carta per appunti, in una calligrafia perfetta, un corsivo che sembra danzare sulla pagina; d’estate ci metteva dentro dei fiori di ortensia rampicante che ho sempre adorato, colti dalla meravigliosa pianta che sale sulle pareti del cottage e ormai ne ricopre anche il tetto». Mi dice che, quand’era piccola, la mamma le cantava Lavender’s Blue. Mai sentita, la informo. Ricorda di essere cresciuta insieme alla sorella. Una volta, avevano giocato a nascondino; mentre Grace chiudeva gli occhi e contava fino a venti, lei era andata in camera da letto e si era messa gli auricolari. «Mi ero nascosta nell’armadio», dice. «Ci tenevamo un sacco di biancheria ammucchiata. Ho aspettato che mi trovasse». Era rimasta seduta lì dentro per più di un’ora, aveva quattro anni. Alla fine fu la madre a trovarla, dopo aver cercato in tutta l’abitazione da cima a fondo. Ricorda il cigolio della porticina dell’armadio che si apriva. Lei mezzo addormentata. Gli occhi della madre che pareva volessero scusarsi e il modo in cui poi lei l’aveva cullata, continuando a ripeterle: «Tu sei la mia piccola bambina», in un modo che lei trovò misterioso. Ricorda che la sorella non veniva quasi mai sgridata o ripresa. «Doveva scusarsi», racconta, «e lo faceva, ma con aria di superiorità». Anche all’età di quattro anni si accorgeva che non c’erano vantaggi nell’essere buoni. Però lei voleva essere buona. Me lo dice apertamente, faceva di tutto per essere una brava bambina. Dice che quando a casa era sola perché la sorella era a scuola o da qualche parte a giocare, e il padre stava per i fatti suoi, lei e la madre bevevano il tè. «Era il nostro segreto. Mi scaldava il sidro di mele e preparava per sé un infuso che teneva nascosto per queste occasioni. Mangiavamo insieme un sandwich con burro d’arachidi e marmellata che lei tagliava a strisce. Bevevamo col mignolo alzato e ci chiamavamo con nomi affettuosi (tesoro, amore), mentre mi raccontava le cose magiche che accadevano nel regno inglese, come se ogni giorno principi e principesse passeggiassero ancora sulle vecchie strade acciottolate». Mi spiega che il padre odia l’Inghilterra. Aveva costretto la madre a adeguarsi alla cultura americana, a perdere il senso della sua civiltà europea. Era una sorta di imperialismo, un rapporto basato su dominio e subordinazione. Quando parla di lui fa delle smorfie. Ma non apposta, credo. Mi pare che non se ne accorga, però le fa. E poi il rapporto fra i suoi genitori non è l’unico a basarsi sulla forza. Fuori è scuro, buio pesto, visto che non c’è luna. La luce nell’abitacolo mi permette di vedere solo il suo profilo, il riflesso del bagliore negli occhi. Aggiunge: «La mamma ha quasi perso del tutto l’educazione inglese, vive qui da quando era più giovane di me. Papà l’aveva obbligata a non usare più i termini inglesi nei casi in cui ci siano corrispettivi americani. Non so quando accadde, quando smise di usare le parole che aveva imparato crescendo, ma di sicuro a un certo punto della mia infanzia». Le chiedo chi pensa che la stia cercando. Di certo si saranno accorti che è scomparsa. «Non so». Comunque presume che qualcuno ci sia. «Le mie colleghe saranno preoccupate, i miei studenti. Ma in famiglia… onestamente non lo so. E tu?», mi chiede. «Chi ti sta cercando?». Mi stringo nelle spalle. «Non gliene frega niente a nessuno di me». «Tua madre», dice. Mi giro a guardarla, non apro bocca, nessuno dei due sa se è una domanda oppure no. Ciò che so è che sento un cambiamento dentro di me ogni volta che mi guarda. Non mi attraversa più con gli occhi, come se non mi vedesse. Adesso, se parla, mi fissa sempre. Odio e rabbia sono spariti. Le accarezzo una guancia con la mano riscaldata dalla griglia. Le sistemo una ciocca di capelli dietro l’orecchio. Avverto che la sua guancia si appoggia fiduciosa alla mia mano. Non si ritrae. Poi le dico: «Dovremmo rientrare. Più rimaniamo qui e più ci sarà difficile farlo». Lei si muove lentamente, esita. Penso voglia dire qualcosa, come se ce l’avesse sulla punta della lingua. Ed è allora che tira in ballo Dalmar. «Cosa c’entra Dalmar?», le chiedo. Lei non risponde. Rimugina su qualcosa. Per esempio, come abbia fatto a finire nel capanno. O almeno penso. Come mai la figlia di un giudice ricchissimo finisce per nascondersi in una casa di legno schifosa con me? «Lasciamo perdere», fa. Ha riconsiderato la questione, non ne vuole più parlare. Potrei insistere, ma decido di non insistere. Parlare di Dalmar è l’ultima cosa che voglio ora. «Torniamo dentro», propongo. Lei annuisce. «Va bene, andiamo». Apriamo le portiere, lottando contro la forza delle raffiche contrarie. Riprendiamo la strada verso il capanno buio e freddo; una volta dentro, sentiamo solo l’ululato del vento. Gabe Dopo Sfoglio le pagine del quaderno da disegno, cerco disperatamente degli indizi, e a un certo punto ci arrivo: quel fottuto gatto. Personalmente, odio i gatti. La loro elasticità mi spaventa a morte. Hanno la tendenza ad appisolarmisi in grembo, quasi certamente perché sanno di farmi un dispetto. Perdono i peli ed emettono quel rumore quando fanno le fusa. Il mio capo mi sta addosso, vuole che risolva il caso una volta per tutte. Ripete che sono settimane che Mia Dennett è tornata a casa e ancora non ho fatto un passo in avanti verso la scoperta di chi ha organizzato tutto questo. Il problema è semplice: l’unica che può aiutarmi è lei. Ma lei riesce a ricordarsi a malapena come si chiama, dal momento che ha dimenticato tutti i particolari dei suoi ultimi mesi di vita. Devo rinfrescarle la memoria. E a quel punto m’imbatto nel disegno del gatto. Mia madre dice sempre a mio padre che preferisce lo schnauzer a lui. Io sono stato obbligato a convivere con un pappagallo. La mia vicina di casa sbaciucchia continuamente il suo barboncino. La gente ha un rapporto strano con gli animali domestici. Io sono diverso: l’ultimo animaletto da compagnia che ho avuto è finito nello sciacquone del bagno. Così telefono a un tipo del Minnesota per chiedergli un favore. Gli spedisco per fax il disegno, dicendogli che cerchiamo un gatto soriano bianco e grigio, tigrato, che pesa circa quattro chili. Lui manda da Grand Marais un agente al capanno per dare un’occhiata. Non ci sono gatti, ma impronte di animali sulla neve sì. Su mio suggerimento (non che sia un colpo di genio), lascia una ciotola di cibo e una di acqua, che probabilmente si congeleranno durante la notte. Meglio di niente. Gli chiedo di tornare la mattina dopo per vedere se il gatto ha mangiato. In questo periodo dell’anno la caccia dà scarsi risultati, e quel maledetto animale sentirà sicuramente freddo. Il mio amico dice che cercare gatti randagi non è l’unica priorità che hanno. «E quali sono le altre?», azzardo. «Arrestare chi supera la quantità massima di trote pescabili?». Gli ricordo che si tratta di un caso di sequestro di persona, di cui hanno parlato tutti i giornali della nazione. «Va bene, va bene», replica lui. «Ti aggiorno domattina». Colin Prima Le rivelo che il mio secondo nome è Michael, in onore di mio padre. Lei non conosce ancora il mio nome vero, mi chiama Owen, quando deve farlo. Io di solito non la chiamo per nome. Non ce n’è bisogno. Ho una cicatrice sul fondoschiena che ha visto una volta mentre uscivo dalla vasca da bagno. Me ne chiede conto. Le dico che è il morso di un cane ricevuto da piccolo. Della cicatrice sulla mia spalla, però, non voglio parlare. Non mi dilungo nemmeno sulle ossa che mi sono rotto: la clavicola in un incidente stradale da ragazzino, il polso mentre giocavo a football e il naso in una rissa. Quando rifletto, mi accarezzo la barba. Se sono arrabbiato, cammino a passi lunghi. Faccio di tutto per tenermi occupato. Non mi piace restare seduto per più di qualche minuto se non ho un motivo: alimentare il fuoco, mangiare, dormire. Le racconto com’è cominciata questa storia. Un uomo mi aveva offerto cinquemila dollari per rapirla e consegnarla sulla Lower Wacker Drive. Allora non sapevo nulla su di lei. L’avevo vista in fotografia e poi l’avevo pedinata per giorni. Non era una cosa che desideravo fare. Non ero stato al corrente del piano fino alla sera decisiva. Finché non mi telefonarono per darmi le istruzioni. Così funziona: meno ne sai e meglio è. Le altre volte era stato diverso, ma in quest’occasione la somma di denaro in ballo era superiore a qualunque cifra precedente. La prima volta mi ero attivato solo per ripagare un prestito, «per non farmi prendere a calci in culo», le dico. In seguito, l’avevo fatto per poche centinaia di dollari, a volte un migliaio. Le dico che Dalmar è soltanto un intermediario, gli altri si celano dietro una cortina di fumo. «Non so assolutamente chi paga i conti», preciso. «E ti disturba?», chiede. Faccio spallucce. «Questa è la realtà». Dovrebbe detestarmi per ciò che le ho fatto. Per averla portata lì. Però comincia a intuire che la mia decisione potrebbe averle salvato la vita. Per il mio primo lavoro dovevo trovare un certo Thomas Ferguson. Ero incaricato di fargli sputare i soldi di un suo debito di notevole entità. Era un uomo ricco, bizzarro a suo modo. Un genio della tecnologia che era emerso negli anni Novanta. Aveva il debole delle scommesse. Aveva contratto un prestito ipotecario, e con le scommesse aveva perso la sua casa quasi per intero. Poi aveva sperperato anche il fondo per gli studi universitari del figlio, poi le obbligazioni che i suoceri avevano lasciato in eredità a sua moglie e a lui. Quando se n’era accorta, la donna aveva minacciato di lasciarlo. Allora lui aveva chiesto altri soldi ed era andato a spenderli nel casinò di Joliet per recuperare tutte le perdite. Ironia del caso: a Joliet, Ferguson guadagnò una fortuna, però non estinse mai il suo debito. Scovarlo fu un gioco da ragazzi. Ricordo che mi tremavano le mani mentre salivo i gradini della sua casa nel quartiere di Streeterville. Non volevo cacciarmi nei guai. Suonai il campanello. Un’adolescente aprì appena la porta e io la travolsi. Erano le otto di una sera d’autunno, ricordo che faceva freddo. La casa era quasi al buio. La ragazzina si mise a urlare, la madre accorse e insieme si rifugiarono sotto una vecchia scrivania, perché avevo tirato fuori la pistola. Dissi alla donna di chiamare il marito. Quel vigliacco ci impiegò cinque minuti buoni per portare lì le sue chiappe. Si stava nascondendo al primo piano. Avevo preso tutte le precauzioni: tagliato i fili del telefono e bloccato la porta secondaria. Non se ne sarebbe andato. Eppure, Ferguson aspettò tanto da darmi il tempo di legare moglie e figlia, e quando comparve tenevo la canna della pistola puntata contro la tempia della donna. Sosteneva di non avere soldi. Neanche un centesimo a suo nome. Non poteva essere vero, ovviamente. All’esterno era parcheggiata una Cadillac nuova di zecca, che aveva registrato a nome di lei. Giuro alla ragazza di non aver mai ucciso nessuno. Né quella volta, né mai. Parliamo di stupidaggini, per passare il tempo. Le dico che quando dorme russa. Lei esclama: «Non saprei, non ricordo quand’è stata l’ultima volta che qualcuno mi ha visto dormire». Tengo sempre le scarpe ai piedi, anche se sappiamo di non dover andare da nessuna parte. Anche quando le temperature precipitano sottozero e non ci muoviamo da davanti al fuoco. Lascio gocciolare l’acqua dai rubinetti, le dico di non stringerli. Se si congela l’acqua, i tubi scoppieranno. Mi domanda se creperemo di freddo. Rispondo di no, ma non ne sono tanto certo. Sono annoiato, per cui la chiedo di insegnarmi a disegnare. Strappo una pagina dopo l’altra, perché i miei schizzi fanno schifo. Li getto nel fuoco. Provo a farle un ritratto, lei mi mostra come gli occhi devono essere centrati. «Di solito gli occhi sono allineati con la parte superiore delle orecchie, e il naso con la parte inferiore», spiega. Mi chiede di osservarla bene. Con le mani, divide la sua faccia in sezioni. È una brava maestra. Penso ai suoi allievi. Probabilmente le vogliono bene. A me non piaceva nessuno dei miei professori. Ci riprovo. Quando ho finito, le sembra di assomigliare al pupazzo della signora Potato Head. Strappo la pagina dal quaderno a spirale e vorrei gettarla nel fuoco, ma lei me la prende. «Nel caso un giorno tu diventassi famoso», scherza. In seguito la nasconde dove non posso trovarla. Sa che, se la trovassi, la butterei nel fuoco. Eve Dopo James mi ha tartassata per tutto il weekend con le sue allusioni sottili; diceva che Mia sarebbe ingrassata, che nel suo utero stava crescendo il figlio del peccato. Gli ho detto di smetterla, ma lui ha ignorato le mie suppliche. Mia deve ancora accettare l’idea di avere una vita dentro di sé. Io sapevo che aveva le nausee mattutine e l’avevo sentita vomitare nel bagno. Avevo bussato alla porta per domandarle se andava tutto bene, ma lui mi aveva spostato con la forza. Mi ero aggrappata allo stipite per non cadere, fissandolo sbigottita. «Non hai da fare delle spese?», ha sbraitato. «La manicure, il podologo. Qualcosa?». Sono contraria all’aborto, per me è un omicidio. Dentro di lei sta crescendo un figlio, a prescindere dal pazzoide che ha contribuito al concepimento. Un feto col battito cardiaco, a cui si stanno formando braccia e gambe, col sangue che gli scorre nel corpicino, che sarà quello di mio nipote. James non mi ha mai lasciato sola con Mia. L’ha tenuta chiusa in camera sua per quasi tutto il fine settimana, le ha riempito la testa con i libri del movimento abortista, con gli opuscoli presi nelle cliniche della città, con gli articoli stampati dai siti internet. Lui sa qual è la mia opinione sull’interruzione di gravidanza. In senso generale, siamo entrambi conservatori dal punto di vista politico, ma adesso che cresce un figlio illegittimo nella pancia di nostra figlia lui butta al vento ogni approccio razionale. C’è solo una cosa che conta: sbarazzarsi di quella nuova vita. Ha deciso di coprire le spese per l’intervento. Me lo ha detto a mezza voce, come se parlasse a se stesso. Vuole sborsare personalmente quella cifra perché non vuole che le fatture arrivino mai all’assicurazione sanitaria. Per lui, non devono r i m a n e r e tracce di questa situazione. «Non puoi costringerla a farlo, James», gli ho detto domenica sera. Mia non stava bene. Lui le ha portato dei cracker in camera. Non le ha mai rivolto questo tipo di attenzioni. Lei non era scesa per cenare con noi, e non era un caso: ero certa che James l’avesse chiusa in camera per impedire che io la influenzassi. «Lei vuole farlo». «Perché le hai detto che deve». «È ancora una bambina, Eve, non ricorda come abbia fatto a rimanere incinta di quel bastardo. Sta male, ha sofferto tanto. Per il momento, non è in grado di decidere». «Allora aspetteremo», ho suggerito, «finché non sarà in grado. Abbiamo tutto il tempo». In effetti, è così. Abbiamo settimane, anche di più. Invece mio marito la pensa diversamente. Vuole subito l’aborto. «Maledizione, Eve», ha detto infuriato, facendo stridere la sedia per lasciare la tavola. Poi si è eclissato senza finire la minestra. Stamattina ha tirato Mia giù dal letto prima che finissi la mia tazza di caffè. Sono seduta al tavolo della cucina quando lo vedo spingerla sulle scale, facendola quasi cadere. Lei indossa dei vestiti scoordinati, sono sicura che lui abbia preso i primi che trovava nei cassetti, obbligandola a metterseli. «Cosa stai facendo?», chiedo, mentre lui prende rabbiosamente un cappotto dall’armadio, insistendo perché lei se lo metta. Mi precipito nell’ingresso, la tazza di caffè scivola dal bordo del tavolo e si frantuma in mille pezzi sul parquet. «Ne abbiamo già parlato», dice. «Siamo tutti d’accordo. Noi tutti», mi fissa per costringermi a convenirne. Aveva già chiamato al suo amico giudice per fare in modo che la moglie, la dottoressa Wakhrukov, gli rendesse un grande favore. L’ho sentito ancora al telefono stamattina presto, alle sette, che pronunciava la frase «radiazione dall’albo», il che mi ha indotto a fermarmi davanti alla porta del suo studio. Si praticano gli aborti in varie cliniche della città, ma secondo me non negli ambulatori di ginecologhe rispettabili. La Wakhrukov lavora per mettere al mondo i bambini, non per eliminarli. Tuttavia, l’ultima cosa che mio marito vuole è che qualcuno lo sorprenda a entrare in una qualsiasi clinica per aborti trascinandosi dietro la figlia. Somministreranno a Mia dei sedativi per tranquillizzarla, così non potrà opporsi nemmeno se lo volesse. Le dilateranno la cervice, le infileranno qualche strumento per risucchiare fuori il feto, strappandolo via dall’utero come con un aspirapolvere. «Mia, tesoro», dico, prendendole una mano. È fredda come il ghiaccio. Lei è confusa, mezzo addormentata, non ancora padrona di sé. Peraltro, non lo è mai stata da quando è scomparsa. La Mia che conoscevo è diretta ed esplicita, ha convinzioni forti e decise. Sa quel che vuole e riesce anche a ottenerlo. Non ascolta mai i consigli del padre, perché lo giudica un uomo freddo e discutibile. Però adesso è inebetita, priva di emozioni, e lui ne approfitta. L’ha quasi ipnotizzata, lei è sotto il suo influsso. Non le permette di prendere una decisione in questa faccenda. Ma sarà una scelta che lei dovrà portarsi dietro per tutta la vita. «Vengo anch’io», dico. James mi sbatte addosso a una parete, mi punta contro un dito e mi ordina: «No, tu stai qui». Lo spingo via e vado a prendere il mio cappotto. Lui mi sbarra la strada. Mi strappa il cappotto di mano e lo getta a terra. Afferra Mia per un braccio e la trascina verso la porta. Il vento di Chicago penetra nell’atrio di casa, mi colpisce le braccia e le gambe nude, fa svolazzare la mia camicia da notte. Tento di raccogliere il cappotto, intanto urlo: «Non devi farlo, Mia, non sei costretta», lui però mi trattiene, e siccome non la smetto, mi spintona al punto di buttarmi a terra. Sbatte la porta prima che possa riprendere fiato e rialzarmi. Raccolgo tutte le forze e guardo dalla finestra l’auto che esce dal vialetto. «Nessuno ti può costringere, Mia», grido ancora, sebbene sappia che lei non può più sentirmi. Giro lo sguardo verso il portachiavi a muro in ferro battuto e noto che mancano le mie chiavi: James deve averle prese per tentare di tenermi lontana. Colin Prima Un paio di giorni e l’influenza mi è passata. Il primo giorno mi sono sentito davvero di merda, ma proprio quando cominciavo a disperarmi, mi si è aperto il naso e ho ricominciato a respirare bene. Sono fatto così. Per lei è leggermente diverso. Me ne accorgo dalla tosse che ha. Ha iniziato a tossire poco dopo di me. Non dei colpi secchi come i miei, bensì qualcosa di più profondo. La costringo a bere l’acqua del rubinetto. Non sono un medico, non ne so granché, ma potrebbe farle bene. Sta veramente male. Glielo leggo in faccia. Ha lo sguardo spento, le lacrimano gli occhi. Ha il naso arrossato e screpolato dalla carta igienica, i piedi continuamente ghiacciati. Si mette a sedere davanti al fuoco con la testa appoggiata al bracciolo di una sedia, persa in un luogo remoto dove non è mai stata prima. Nemmeno quando le puntavo la pistola alla tempia. «Vuoi andare a casa?», chiedo. Cerca di schermirsi, ma so che piange. Vedo le lacrime che le rigano le guance, prima di cadere sul pavimento. Solleva il capo. Si pulisce la faccia con la manica. «Non mi sento tanto bene», mente. È chiaro che vuole andare a casa. Il gatto vuole stare sempre sul suo grembo. Non so se ciò dipenda dalla sua coperta o dal fatto che cucini davanti al fuoco. Forse è per pura devozione. Maledizione, come faccio a saperlo? Mi rivedo mentre le puntavo la pistola alla testa. La immagino sdraiata sui sassi, circondata dalle foglie. In questi giorni non ce la faccio a scacciare quest’immagine dalla mente. Le tasto la fronte e mi rendo conto che scotta. Dice di essere sempre stanca. Fa fatica a tenere gli occhi aperti; quando si riprende, sono sempre pronto con un bicchiere d’acqua, che le faccio bere. Mi racconta che sogna sua madre, di adagiarsi sul divano della sua famiglia, come faceva da piccola quand’era malata. Sogna di farsi coccolare avvolta in una coperta che portava sempre con sé. A volte la madre gliela metteva nell’asciugatrice per alcuni minuti, così si riscaldava. Le preparava un toast alla cannella e rimaneva a vegliare su di lei, prima guardando i cartoni animati e poi, quando fu più grande, le telenovelas. C’era sempre un succo di frutta da bere. I liquidi servono a reidratarsi, le ricordava la madre. «Devi bere». Mi dice che è sicura di vedere la madre nella cucina del capanno, con la sua vestaglia di seta e le pantofole che sembrano scarpe da ballerina. C’è una canzone di Natale, un pezzo di Ella Fitzgerald. La madre canticchia sottovoce. C’è profumo di cannella nell’aria. Chiama la madre, ma quando si volta vede me e scoppia a piangere. «Mamma», singhiozza. Era certa che sua madre fosse lì. Attraverso la stanza e le appoggio una mano sulla fronte. Si sottrae, la mia mano è come il ghiaccio. «Scotti», dico, e le porgo un bicchiere di acqua tiepida. Mi siedo di fianco a lei, sul sofà. Tiene il bicchiere contro le labbra ma non beve. È sdraiata su un fianco, ha la testa posata su un cuscino che ho preso dal letto. È sottile come un foglio di carta. Mi chiedo quante persone ci abbiano appoggiato la testa prima di lei. Raccolgo la coperta, che era caduta a terra, e la copro. La lana è ruvida e le graffia la pelle. «Grace era la prediletta di papà, io la preferita della mamma», esclama all’improvviso. Come se se ne fosse appena accorta, in un momento di lucidità. La madre accorreva nella sua stanza quando aveva gli incubi. La abbracciava forte – sente ancora la sensazione – e la proteggeva dall’ignoto. La rivede mentre la spinge sull’altalena quando Grace era a scuola. «Rivedo il suo sorriso, sento ancora la sua risata. Mi amava moltissimo, solo che non sapeva come dimostrarmelo», dice. La mattina, si lamenta per il mal di testa e di gola, la tosse che la tormenta. Non protesta però, me lo dice solo perché sono io che glielo chiedo. Le fa male anche la schiena. A un certo punto cambia posizione sul sofà e si addormenta a pancia in giù. Brucia come il fuoco dell’inferno quando la tocco, sebbene tremi tutta, come se stesse per congelarsi. Il gatto le cammina sulla schiena finché non lo caccio via. Allora si rifugia dietro il divano. Nessuno mi ha mai amato tanto. Nel sonno bofonchia di cose lontane da qui: un uomo in tuta mimetica, dei graffiti su un muro di mattoni, fatti illegalmente con bombolette spray, wild-style e tag illeggibili. Vernice nera e gialla. Lettere grosse, intrecciate tridimensionalmente. Le lascio il mio posto sul sofà. Ormai sono due notti che dormo su una sedia. Sul letto starei più comodo, ma non voglio allontanarmi troppo. Resto sveglio a causa di quella tosse maledetta, anche se in qualche modo riesce a riposare lo stesso. Di solito è il naso chiuso a svegliarla, l’insopportabile incapacità di respirare bene. Non so che ore sono quando dice che deve andare in bagno. Riesce a mettersi in piedi, ma dal modo in cui si muove è facile capire che le duole ogni muscolo del corpo. Fa qualche passo, ma le mancano le forze. «Owen», riesce a sussurrare. Allunga una mano verso la parete, afferra il vuoto e crolla a terra. Non credo di essermi mai mosso tanto rapidamente in vita mia. Non ce l’ho fatta a evitarle la caduta, però ho evitato che sbattesse la testa su qualche spigolo. Resta priva di sensi al massimo un paio di secondi. Quando rinviene, mi chiama Jason. Pensa che sia lui. Potrei incavolarmi, invece la aiuto a rialzarsi e l’accompagno al gabinetto, le abbasso i pantaloni e la metto seduta sul water. Poi la riporto sul sofà e la copro bene. Una volta mi ha domandato se ho una fidanzata. Le avevo risposto di no, che ci avevo provato in un’occasione ma che per me non funzionava. Le avevo chiesto di questo suo ragazzo. L’avevo incontrato nel cubicolo di un cesso pubblico e lo avevo detestato al primo sguardo. È il tipo di bastardo che si comporta da duro. Crede di essere superiore a tutti gli altri, ma invece è un vigliacco. Assomiglia a Thomas Ferguson, e sarebbe capace di lasciare che un altro uomo le punti una pistola alla testa. La guardo dormire. La tosse sembra un rantolo. Ascolto il suo respiro corto, vedo che il petto si solleva e si abbassa in modo irregolare. «Cosa vuoi sapere?», aveva detto a proposito del suo ragazzo. Tutto a un tratto non mi importava più. «Niente», avevo risposto. «Lascia stare». «Perché ci credo a quello che hai detto», aveva aggiunto. «In che senso?» «Che lo hai comprato coi soldi. Ti credo». «Davvero?» «La cosa non mi sorprende». «Perché lo dici?». Si era stretta nelle spalle. «Non lo so, in realtà». So che non posso lasciare che le cose vadano avanti così. Lei peggiora ogni giorno. Ha bisogno di prendere degli antibiotici, è evidente, altrimenti potrebbe anche morire. Non so proprio che fare. Eve Dopo Non può restare da sola, assolutamente. Esco di casa non appena James ritorna senza Mia al seguito. Non c’è niente più importante di lei. Sono certa che si trovi all’angolo di una strada, abbandonata da suo padre, senza mezzi per tornare a casa. Gli urlo in faccia, chiedendogli come abbia potuto fare questo a nostra figlia. L’aveva lasciata uscire da sola dallo studio medico, ad affrontare il freddo terribile di gennaio, ben sapendo che non è in grado di prepararsi neppure la colazione, figurarsi ritrovare la via di casa. Lui afferma che è lei la testarda. Mia non aveva voluto sentire ragioni a proposito di quel dannato figlio. Dice che aveva rifiutato di abortire, che era scappata dallo studio della ginecologa non appena l’infermiera l’aveva chiamata. James sbraita e si rifugia nel suo studio, non si accorge che sto preparando la valigia e sto scendendo piano le scale per andarmene. Non ci credevo molto. E invece, mentre strappavo dalle mani di James le chiavi della mia auto e facevo più volte il giro intorno allo studio medico, Mia era riuscita a rifugiarsi nel suo appartamento. Adesso si sta scaldando un barattolo di minestra sui fornelli. Il suo pranzo. Mi apre la porta, mi fiondo ad abbracciarla, la stringo più forte che posso. Se ne sta nel suo appartamentino, quello che chiamava la sua casa. È da molto che non ci abita più. Le piante sono aggrappate alla vita per un filo, e c’è polvere ovunque. Sa di nuovo, un odore che rivela che il posto è stato disabitato a lungo. Il calendario sul frigorifero in cucina è fermo al mese di ottobre, l’immagine risplende di foglie rosse e arancioni. La segreteria telefonica continua a emettere segnali acustici; ci saranno migliaia di messaggi che aspettano di essere ascoltati. Mia ha molto freddo, ha dovuto camminare e poi aspettare un taxi. Dice che non aveva un soldo per pagare la corsa. Nell’appartamento si gela. Si è messa la sua felpa preferita, quella col cappuccio, sopra a una camicetta leggera. «Mi dispiace tanto, perdonami», le ripeto all’infinito. Ma lei sta bene. Mi tiene a distanza e chiede cos’è successo. Allora le dico di James. Sono io a perdere il controllo, a cadere a pezzi. Mi prende la valigia di mano e la porta nella stanza da letto. «Allora rimani qui», afferma. Mi fa sedere sul divano e mi posa una coperta sulle ginocchia, poi va in cucina a finire di preparare la minestra: brodo di pollo, dice, perché le ricorda casa. Mangiamo la nostra minestra, dopodiché mi racconta cos’è successo nell’ambulatorio della ginecologa. Si accarezza la pancia e si raggomitola su una sedia. Tutto stava procedendo come programmato. Dice che si era convinta ad abortire, mancava poco, e poi tutto sarebbe finito. James era seduto vicino a lei, leggeva una rivista di diritto e aspettava il suo turno. Dopo pochi minuti l’ostetrica russa si sarebbe sbarazzata del feto. «Però c’era un bambino con sua madre», dice. «Avrà avuto quattro anni». Mi racconta della donna, con una pancia grossa come un pallone da basket. Il piccolo giocava con le sue macchinine, le faceva correre su e giù per le zampe delle sedie della sala d’attesa. «Vruum, vruum, vruum…». Gliene era caduta una tra i piedi di James e quel bastardo aveva avuto il coraggio di calciarla via coi suoi mocassini italiani, senza mai alzare gli occhi dalla rivista. «Dopo ho sentito la madre», continua Mia, «vestita con una graziosa salopette di jeans e piuttosto in difficoltà, dire al figlio: “Owen, vieni qui”. Lui si è precipitato verso di lei e ha cominciato a far correre la macchinina sul pancione della madre, poi l’ha abbracciata, dicendo: “Ciao, piccolo”, al suo fratellino non ancora nato». Si ferma a riprendere fiato e infine ammette: «Owen. Non sapevo cosa significasse, ma di certo qualcosa. Non riuscivo a staccare gli occhi dal bambino. “Owen”, continuavo a borbottare, e la madre e il piccolo si sono voltati a guardarmi». James le aveva domandato cosa stesse facendo e lei gli aveva spiegato di avere l’impressione di un déjà-vu. Era come se fosse stata già lì. Ma cosa significava? Allora si era sporta dalla sedia per dire al bimbo che le piacevano le sue macchinine. Lui gliene aveva fatta vedere una, ma la madre si era messa a ridere e aveva esclamato: «Owen, non credo che voglia vederle». Invece Mia lo voleva. James l’aveva sgridata, invitandola a restituirla al bambino. Però lei desiderava tanto restare vicino a quel piccolo. Diceva che il suono del suo nome le toglieva il respiro. Owen. «Ho preso in mano uno di quei giocattolini, un camioncino viola, e gli ho ripetuto che mi piaceva, gliel’ho passato sulla testa e lui si è messo a ridere. Ha detto che presto avrebbe avuto un fratellino, Oliver». A quel punto era apparsa sulla soglia l’infermiera per chiamare Mia, e James era balzato in piedi di scatto, sollecitandola ad alzarsi. L’infermiera l’aveva chiamata di nuovo, fissandola negli occhi. James aveva ripetuto diverse volte il suo nome, cercando di tirarla per un braccio, e le aveva urlato in faccia per ricondurla alla disciplina, come solo lui sa fare. Le aveva ricordato ancora una volta che era il suo turno. Mia mi dice: «La madre ha chiamato Owen, io gli accarezzavo i riccioli, non so chi fosse più atterrito, se lei o papà, ma al bambino quel gesto piaceva, perché mi ha sorriso e io l’ho ricambiato. Poi ho rimesso le due macchinine nelle sue mani e mi sono alzata dalla sedia». Mi racconta che James aveva emesso un sospiro di sollievo: «Finalmente, era ora». Ma non lo era. Mia aveva preso il suo giaccone e gli aveva sussurrato: «Non posso farlo». Era sgattaiolata verso l’uscita. Lui l’aveva inseguita, naturalmente, protestando, urlando e minacciandola. Le ripeteva di ripensarci, ma lei non poteva. Non sapeva dare significato a quel fatto. Owen. Non sapeva perché quel nome significasse tanto per lei. Sapeva solo che non era ora che il feto morisse. Colin Prima Sono le due di notte quando vengo svegliato dal suo urlo. Mi alzo dalla poltrona e vedo che indica qualcosa nel buio pesto, una cosa che non c’è. «Mia», dico, anche se non riesco a farle distogliere lo sguardo. «Mia», ripeto con forza. Ho un tono deciso, ma sono spaventato a morte. I suoi occhi sono colmi di lacrime, fissano qualcosa. Mi allungo verso l’interruttore, accendo la luce e mi rassicuro: siamo soli. Poi mi inginocchio davanti al sofà. Le prendo la testa fra le mani e la costringo a guardarmi. «Mia», insisto, ma lei si divincola. Dice che c’era un uomo alla porta, con un machete e una bandana rossa sulla fronte. È isterica. Sta delirando. Può descrivere l’uomo dettagliatamente, ha anche un buco sulla coscia destra dei jeans. Un nero, con una sigaretta tra le labbra. La cosa che mi preoccupa di più è il calore che emana il suo viso. Quando finalmente mi vede, ha lo sguardo vitreo, dopodiché appoggia la testa sulla mia spalla e comincia a piangere. Apro l’acqua della vasca da bagno e la riempio. Non ho farmaci. Niente per far abbassare la febbre. È la prima volta che sono contento che l’acqua sia solo tiepida. È abbastanza calda per impedire che vada in ipotermia e abbastanza fredda per non farle venire un colpo. La aiuto a mettersi in piedi. Si appoggia a me e la porto di peso nel bagno. Mentre le tolgo i calzini, si siede sul water. Trema quando i piedi nudi toccano le mattonelle. «No», implora. «Andrà tutto bene», dico, ma mento. Chiudo il rubinetto e la rassicuro che rispetterò la sua privacy, invece lei allunga una mano per trattenermi: «Non andartene». La osservo mentre con una mano tremante tenta di sbottonarsi i pantaloni color cachi. È debole e si appoggia al lavandino per riuscirci. La aiuto a slacciare un bottone. Le sfilo i pantaloni. Poi le tolgo anche i pantaloni termici e le lego una maglia attorno ai capelli. Geme mentre si cala nell’acqua della vasca. Porta le ginocchia al petto e le fa sbucare dalla superficie dell’acqua. Abbassa la testa verso le ginocchia e le sfuggono i capelli di lato, le si bagnano le punte. M’inginocchio davanti alla vasca e inzuppo un asciugamano per strofinarla. Lei non smette di tremare. Cerco di non guardarla. Alzo gli occhi al cielo, almeno ci provo; poi mi stimola a parlare, fa di tutto per evitare di sentire freddo. Tento di non immaginare le cose che non vedo. Di non pensare alla sua pelle diafana o alla curva della sua spina dorsale. Non voglio fissarle i capelli che nuotano sulla superficie dell’acqua. Le parlo della donna che abita nell’appartamento davanti al mio. Una settantenne che riesce sempre a chiudersi fuori dalla porta quando porta la spazzatura nello scivolo in fondo al corridoio. Le racconto di come mia madre avesse tagliato la faccia di mio padre da tutte le foto di famiglia. Le immagini delle loro nozze le aveva gettate nel tritadocumenti. Aveva lasciato che tenessi solo uno scatto di lui, ma dopo che avevamo smesso di parlarci lo usavo come bersaglio per le freccette. Le dico che da piccolo speravo di giocare nel campionato di football americano. Nel ruolo di ricevitore esterno, come Tommy Waddle. Le spiego che so ballare il fox-trot perché me l’ha insegnato mia madre. Ma non mi farei mai vedere da nessuno. Di domenica, se si sentiva bene, ascoltava Frank Sinatra e facevamo quattro salti nella stanza. Ormai sono di gran lunga più bravo io. L’aveva imparato dai suoi genitori. In quei tempi molto duri, non c’era niente di meglio da fare. Era veramente una vita durissima. Mi diceva sempre che non sapevo cosa significasse essere poveri in canna, perfino nel periodo in cui per dormire dovevo raggomitolarmi nel sacco a pelo, sul sedile posteriore della nostra auto. Le confido che, se fosse per me, vivrei sempre in un posto come quello, in mezzo alla natura. La città non fa per me, tutta quella fottutissima gente. Ciò che non le dico è che la prima sera lei mi sembrava bellissima. L’avevo osservata in quel bar, da sola, nascosta dalle luci soffuse e dal fumo di sigarette. Ero rimasto incantato più a lungo di quanto potessi permettermi. Non le racconto che la luce della candela le faceva brillare il viso, che la fotografia che mi avevano dato non le rendeva giustizia. Queste cose le tengo per me. Non le spiego come mi sento quando mi guarda, o che di notte sento la sua voce in sogno che mi perdona. Non le confesso che mi dispiace, davvero. Non le dico quanto ammiri la sua bellezza, anche quando si guarda allo specchio e odia l’immagine che vede. È stanca di tremare. Noto che chiude gli occhi, come se volesse dormire. Le metto una mano sulla fronte e mi convinco che la febbre è scesa. La sveglio. La aiuto a mettersi in piedi nella vasca. La avvolgo in un telo ruvido e la faccio uscire. La aiuto a vestirsi dopo aver cercato gli abiti più caldi, dopodiché le asciugo le punte dei capelli. Si sdraia sul sofà, davanti al fuoco che sta cominciando a spegnersi, perciò aggiungo un ramo sui ciocchi. Prima che possa coprirla, si è già addormentata, sebbene continui a tossire. Mi siedo vicino a lei, mi sforzo di non assopirmi. Osservo il suo petto alzarsi e abbassarsi, so che è viva. A Grand Marais ci sono dei dottori. Le spiego che bisogna andarci. Lei vorrebbe obiettare qualcosa. «Non possiamo», dice. Insisto che occorre farlo. Le ricordo che si chiama Chloe. Penso a come camuffarci. Le chiedo di raccogliersi i capelli, magari in una crocchia, una cosa che non fa mai. Lungo il tragitto mi fermo in una drogheria e compro un paio di occhiali da vista. Le dico di metterseli. Non è un granché, ma basterà. Io mi calco in testa il cappellino dei Sox. Le dico che pagheremo in contanti. Niente detrazione fiscale. Le ricordo di non parlare più di quanto sia necessario. Me la sbrigherò io. Ci serve solo una ricetta. Guido in paese per una mezz’oretta, prima di decidere quale dottore consultare. Lo scelgo in base al nome. Kenneth Levine è troppo formale. Questo bastardo si addormenta tutte le sere davanti al telegiornale, penso. C’è un ospedale, ma proseguo: troppa gente. C’è un dentista, un ginecologo. Opto per una donna – Kayla Lee – medico di famiglia, con un parcheggio vuoto davanti all’ambulatorio. C’è la sua piccola auto sportiva posteggiata. Poco pratica per la neve già abbondante. Dico a Mia che non ci serve il miglior medico disponibile, solo uno che sappia scrivere una ricetta. La aiuto ad attraversare il parcheggio. «Fa’ attenzione», ripeto. Uno strato di ghiaccio ricopre il terreno. Pattiniamo quasi fino al portone. Non le passa quella tosse cattiva, anche se mi ha detto di sentirsi meglio: una bugia. Lo studio è al primo piano, sopra una copisteria. Entriamo e saliamo la stretta scalinata. Mi dice che è rincuorante trovarsi in un posto riscaldato. Sembra un paradiso. Mi chiedo se creda in queste stronzate religiose. C’è una signora dietro una scrivania, canticchia una merdosa canzone natalizia. Invito Mia a sedersi. Si soffia il naso con un fazzolettino di carta. La segretaria alza la testa: «Poverina», esclama. Mi faccio dare i fogli e mi accomodo su una sedia bariatrica. Mia riempie i moduli. Riesce a ricordare che si chiama Chloe, ma al momento di scrivere il cognome si blocca. «Permetti che faccia io?», chiedo. Le tolgo la penna di mano e lei resta a guardare mentre scrivo Romain. Invento un indirizzo. Lascio in bianco le informazioni sull’assicurazione sanitaria. Porto questi documenti alla segretaria e le comunico che pagheremo in contanti. Poi mi siedo di fianco a Mia e le domando se si sente bene. Le prendo la mano. Intreccio le dita alle sue, stringo un po’ e dico: «Andrà tutto bene, vedrai». Lei immagina che sia una finzione per la segretaria, ma quello che non sa è che sono un disastro come attore, non so fingere. La signora ci porta in un’altra stanza e controlla i parametri vitali di Mia. La stanza è piccola e ci sono animali dipinti sulle pareti, un vero murales. «La pressione sanguigna è bassa», dice. Il battito del polso e il ritmo del respiro sono elevati. Febbre a 40. «Poverina», ripete. Ci informa che la dottoressa arriverà presto. Non so da quanto tempo aspettiamo. Mia siede sul bordo del tavolo e fissa gli stravaganti animali (leoni e tigri), mentre io misuro la stanza a lunghi passi. Vorrei andarmene il prima possibile. Lo dico almeno tre volte. Kayla Lee bussa ed entra con calma. È di buonumore, ha i capelli scuri, non biondi come avevo immaginato. Speravo in una bionda svampita. La dottoressa parla ad alta voce, si rivolge a Mia come se avesse tre anni. Si piazza su una sedia girevole e si avvicina a lei, che tossisce. È conciata male. Ma forse la malattia aiuta a nascondere il fatto che è spaventata a morte. La Lee ci chiede se ci ha già visti. Mia non sa che dire, per cui intervengo. Sono sorprendentemente calmo: «No», dico. «Siamo pazienti nuovi». «Allora, Chloe, qual è il problema?», chiede dando un’occhiata al modulo. Mia si sta stancando. Non riesce a sostenere lo sguardo della dottoressa. Sono certo che Kayla senta la puzza di sudore dei nostri vestiti, gli stessi che indossiamo tutti i giorni, al punto che non ci accorgiamo più dell’odore che emanano. Mia tossisce. È una tosse canina, sembra di sentire abbaiare un branco di terrier. La sua voce è roca, la sta perdendo. «Tossisce così da circa quattro giorni», intervengo. «Febbre, brividi. Le avevo proposto di venire qui venerdì pomeriggio, ma non ha voluto, pensava fosse un semplice raffreddore». «Affaticamento?». Mia annuisce. Le spiego che è sonnolenta, apatica, che è svenuta in casa. La dottoressa prende appunti. «Vomito?» «No». «Diarrea?» «No». «Diamo un’occhiata», dice e punta subito una luce in un occhio di Mia, nel naso e dentro le orecchie. Le dice di aprire la bocca e tirare fuori la lingua, le palpa le ghiandole. Poi con lo stetoscopio le ausculta il torace. «Fa’ un bel respiro». Io intanto continuo a camminare nervosamente. Lei passa ad auscultare la schiena. Fa stendere Mia. Poi la fa sedere di nuovo e la picchietta sul petto, restando in ascolto. «Sospetto una polmonite. Fumi?» «No». «Hai avuto attacchi d’asma?» «No». Analizzo l’opera d’arte alla parete. Una giraffa a pallini, un leone la cui criniera assomiglia a quegli aggeggi a forma di cono che mettono ai cani per impedirgli di leccarsi. Un elefantino celeste che sembra appena uscito da una sala parto. «C’è parecchia robaccia nei tuoi polmoni, per parlar chiaro. La polmonite è un’infiammazione provocata da un’infezione. Le secrezioni bloccano e restringono le vie aeree. Perfino un semplice raffreddore può decidere di fissarsi a livello dei bronchi, e questa è la conseguenza», conclude, passando una mano davanti agli occhi di Mia. La dottoressa odora di profumo. Continua a parlare anche quando Mia tossisce. «Ci vogliono degli antibiotici», prosegue. Riflette sulle possibilità, su cosa scrivere nella ricetta. «Ma prima di tutto vorrei avere una conferma della diagnosi con una lastra al torace». La faccia di Mia sbianca, come se avesse perso ogni traccia di vita. Non possiamo assolutamente mettere piede in un ospedale. «Apprezzo la sua scrupolosità», mi affretto a dire. In un ospedale ci vedrebbero decine di persone, se non di più. Mi stampo un sorriso ipocrita sulla faccia e confesso di essere disoccupato. Non abbiamo assistenza sanitaria. Non possiamo permetterci il lusso di spendere i due o trecento dollari che ci costerebbero le radiografie. Mia comincia a tossire tanto che temiamo possa vomitare. La dottoressa le riempie un bicchiere di plastica e la fa bere. «Va bene», dice; scrive la fottuta ricetta e lascia la stanza. La rincontriamo nell’ingresso, mentre usciamo. È piegata sulla cartella medica a nome di Chloe Romain, sta scrivendo. Il camice le arriva fino agli stivali di cuoio da cowboy, sotto indossa un brutto vestito e ha ancora lo stetoscopio al collo. Siamo quasi sulla porta quando ci ferma e dice: «Sicuro che non l’abbia già vista? Il suo viso mi è familiare». Non guarda Mia, si rivolge a me. «No», taglio corto. Non ho bisogno di essere gentile. Ho avuto quel che volevo. Fissiamo una visita di controllo per Chloe, un appuntamento a cui lei non andrà mai. «Grazie, dottoressa», dice Mia mentre la spingo piano oltre la porta. Arrivati al posteggio, le dico che è andata bene. Abbiamo la ricetta. È tutto quel che serve. Sulla strada del ritorno, deviamo per una farmacia. Lei mi aspetta in auto, mentre io entro, contentissimo di trovare una sedicenne mezzo fatta alla cassa e un farmacista nel retrobottega che non alza mai la testa. Faccio ingoiare una compressa a Mia ancora prima di lasciare il parcheggio, poi vedo con la coda dell’occhio che si addormenta. Mi tolgo il giaccone e la copro per non farle sentire freddo. Gabe Prima Faccio visita a Kathryn Thatcher nel suo nuovo alloggio ormai da diversi giorni. La prima volta mi sono presentato come suo figlio, e la segretaria mi ha detto: «Grazie al cielo è venuto, parla sempre di lei», dopodiché mi ha accompagnato nella sua stanza. Ho letto negli occhi di Kathryn la delusione nel vedere me, ma era talmente contenta di avere un po’ di compagnia da non rivelare che avevo mentito. Adesso la curano bene, è quasi autonoma. Divide la camera con una donna di ottantadue anni, malata terminale, a cui resta poco da vivere. È talmente imbottita di morfina da non rendersi nemmeno conto di dove si trovi, ed è certa che la Thatcher si chiami Rory McGuire. Non viene a visitarla nessuno. Tranne me, nessuno viene neppure dalla signora Thatcher. Scopro che le piacciono i romanzi gialli. Vado in libreria e compro tutti i bestseller che trovo. Mi siedo sul bordo del suo letto e glieli leggo. Non so leggere bene ad alta voce. Cioè, non so leggere bene in generale, forse non ho mai imparato a farlo come si deve. Comunque, mi accorgo che anche a me piacciono i gialli. Le porto le crocchette di pollo, sebbene sia vietato. Appena possiamo ce ne finiamo dieci pezzi in due, oltre alle patatine fritte. Le ho portato anche un mio vecchio lettore CD e abbiamo preso alcune raccolte di canzoni natalizie in prestito dalla biblioteca. Dice che nel ricovero non sembra che sia Natale; riesce a vedere la neve fuori della finestra, ma dentro tutto è come sempre. Di sera, prima di andarmene, accendo la musica per evitarle di ascoltare i rantoli della sua compagna di stanza. I giorni alterni in cui non vado dalla Thatcher li trascorro con Eve. Accampo le scuse più stupide per presentarmi continuamente alla sua porta. È dicembre inoltrato, l’inverno si avvicina, e lei si rabbuia. Dice che è un malessere emotivo stagionale, o come caspita si chiama. S’immalinconisce ed è perennemente stanca. È triste, si mette a sedere davanti alla finestra e osserva la neve che cade. Trovo piccole informazioni nuove, vere o presunte, per darle l’impressione che il caso non sia finito in un vicolo cieco, che non brancoliamo nel buio. Le insegno a fare le lasagne come mia madre. Non la voglio trasformare in una cuoca, ma magari è l’unico modo per indurla a mangiare qualcosa. Mi dice che il marito torna a casa sempre meno. Lavora fino a tardi, a volte fino alle dieci o alle undici di sera. La notte scorsa l’ha passata fuori di casa. Ha detto di aver lavorato l’intera nottata per mettersi in pari con le istanze giudiziarie, una cosa che, secondo Eve, non aveva mai fatto prima. «Che cosa pensi?», le chiedo. «Stamattina aveva l’aria tesa. È passato a cambiarsi». Cerco di attingere alle mie grandi capacità investigative per capire come mai non pianti il marito. Finora non l’ho capito. «Quindi, era effettivamente in ufficio», ne deduco. Molto improbabile, ma se questo può far sentire meglio Eve, amen. Non alludiamo mai al bacio che ci siamo scambiati. Tuttavia, ogni volta che la vedo immagino le sue labbra sulle mie. Se chiudo gli occhi ne avverto ancora il sapore, ormai riconosco il suo profumo, e addirittura l’odore del sapone con cui si lava le mani. Mi chiama Gabe e io la chiamo Eve. Stiamo fisicamente vicini, più di quanto facessimo prima. Adesso, quando apre la porta, vi è in lei un moto di felicità, non solo la delusione perché non le sto riportando la figlia. Il moto di felicità è per me. Eve mi prega di portarla al ricovero per anziani, ma so che sarebbe una situazione ingestibile per lei. Vorrebbe parlare con la signora Thatcher, da madre a madre. Pensa che la donna potrebbe rivelarle qualcosa che non le va di dire a me. Eppure, glielo nego. Mi domanda che aspetto abbia Kathryn, le spiego che è una donna forte e orgogliosa. Eve mi dice che anche lei era forte, a corromperla sono state le porcellane raffinate e gli abiti firmati. Non appena la malattia sarà sotto controllo, la Thatcher sarà dimessa e andrà a stare da sua sorella, che abita da quelle parti. È una donna che sembra non aver mai visto i telegiornali negli ultimi mesi. L’altro giorno le ho telefonato su richiesta di Kathryn: non aveva idea che il nipote si fosse dato alla macchia e non sapeva un accidente del fatto che erano in atto le ricerche di Mia Dennett. Mi hanno già assegnato altri casi da risolvere. Un incendio in uno stabile, probabilmente di natura dolosa; una denuncia di alcune ragazzine scatenate a carico di un loro professore delle superiori. Ma di sera, quando rientro nel mio appartamento, bevo per riuscire a prendere sonno, e una volta addormentato vedo l’immagine di Mia nelle sequenze del video di sorveglianza, mentre viene scortata da un irritante Colin Thatcher. Immagino che anche Eve sia depressa, che pianga prima di assopirsi. E ricordo a me stesso che sono l’unico a poter mettere fine a tutto ciò. Mi reco in visita all’ospizio un martedì pomeriggio. Nevica, e Kathryn mi chiede della vicina di casa, Ruht Baker. «Lei sa che sono qui?». Io mi stringo nelle spalle, non lo so. Non ho mai sentito parlare di questa donna, anche detta Ruthie. Mi dice che è quella che va da lei ogni settimana, nei giorni in cui Colin non può farle visita. Ritira la posta tutti i giorni feriali e poi gliela consegna. La cassetta delle lettere era stracolma, tanto che lo sportellino non si chiudeva neanche più. In effetti, avevo dovuto spingermi fino all’ufficio postale di Gary con una delega per ritirare tutto quello che il postino non aveva più potuto infilare dentro. Parlo con i vicini, ma non rintraccio nessuna Ruth (o Ruthie) Baker. Eppure, la signora Thatcher insiste a dire che Ruth abita nella casa bianca in stile Cape Cod, in fondo alla strada. E allora mi ricordo del cartello VENDESI che avevo già notato. Nessuno aveva risposto al campanello. Faccio delle ricerche e trovo l’annuncio funebre della prima settimana di ottobre. Vado a prendere il registro dei decessi e vedo che Ruth Baker è morta di infarto alle 17:18 del 7 ottobre. Kathryn non lo sapeva. La Baker doveva sorvegliarla in assenza di Colin. Suppongo che, ovunque si trovi adesso, lui non sappia che la settantacinquenne a cui aveva lasciato in custodia la madre è deceduta. Decido di occuparmi della posta. Prendo il mucchio di lettere recuperate dalla cassetta della Thatcher e all’ufficio postale e le divido in base alla data del timbro. C’è un vuoto evidente dalla scomparsa di Mia fino all’inizio delle bollette e degli avvisi di pagamento scaduti. Circa cinque giorni. Mi domando chi possa mai avere quella posta mancante. Torno nell’abitazione di Ruthie Baker e busso alla porta. Nessuna risposta. Per cui rintraccio una sua parente, una donna della mia età, la figlia di Ruth, che abita a Hammond con marito e figli. L’indomani suono alla loro porta. «Posso aiutarla?», dice stupita nel vedere il distintivo che tiro fuori. «Ruth Baker è sua madre?», chiedo ancor prima di presentarmi. Lo conferma. Quando un poliziotto si presenta alla porta di casa di qualcuno, tutti si chiedono subito cosa sia accaduto… Dimentico di farle le condoglianze. Vado direttamente al sodo, ho un solo pensiero in testa: trovare Mia. «Credo che sua madre ritirasse la posta di una sua vicina di casa, Kathryn Thatcher», dico, e vedo che un’ombra di disagio e di senso di colpa le attraversa il volto. Comincia a profondersi in scuse infinite. Lo so che è dispiaciuta, però so anche che ha paura di finire nei guai. In fondo, il furto postale è un reato, e io sono pur sempre un agente che la interroga sulla porta di casa. «Scusi… solo che siamo stati molto indaffarati», dice. «Tutte le disposizioni… il funerale, il trasloco delle sue cose». Aveva visto la posta. Ci sarà passata davanti un milione di volte, quando entrava o usciva dalla casa della madre; era ammucchiata su un tavolino di legno, proprio nell’ingresso. Solo che non aveva mai trovato il tempo di restituirla al legittimo proprietario. Seguo il minivan della donna fino alla via in cui vive Kathryn. Accostiamo al marciapiede della casa di Ruth ed entriamo nel vialetto; la donna corre a prendere la posta. La ringrazio e gliela strappo di mano, fermandomi lì sulla ghiaia a rovistare fra le lettere. Il menu di un ristorante cinese, una bolletta dell’acqua, pubblicità di generi alimentari, altre bollette e una busta rigonfia indirizzata a Kathryn Thatcher, senza indicazione del mittente. Una scrittura frettolosa. La apro e dentro trovo un bel mucchietto di contanti. Nessun foglio, nessun indirizzo per la restituzione. Me la rigiro tra le mani. Leggo il timbro postale (Eau Claire, Wisconsin), lancio le altre scartoffie sul sedile del passeggero della mia auto e sgommo a tutta velocità. In centrale mi collego online per esaminare una mappa. Seguo la strada da Chicago a Grand Marais. Ci siamo. Proprio lì, dove la I-94 prosegue verso Ovest fino a St. Paul, Minneapolis e la US Highway 53 piega a Nord, e poi di nuovo a Ovest per entrare nel Minnesota settentrionale, c’è la città di Eau Claire, nel Wisconsin, ad appena cinque ore da Grand Marais. Contatto il funzionario, Roger qualcosa, responsabile del distretto del Minnesota nord-orientale. È convinto che io sia sulla pista sbagliata, però farà lo stesso un controllo scrupoloso. Gli dico che gli spedirò per fax un identikit, per maggiore sicurezza. I connotati di Colin Thatcher sono stati diffusi in TV solo in tre Stati contigui. Le stazioni televisive del Minnesota e del resto del mondo non hanno la minima idea di chi sia. Ma presto lo sapranno. Colin Prima L’antibiotico comincia a fare effetto e stanotte sembra che lei stia già meglio. Certo, la tosse imperversa ancora, ma la febbre è scesa parecchio. Non ha più l’aspetto di uno zombie, pare tornata fra i vivi. Si sente meglio, e vedo che qualcosa è cambiato. Mi dico che dipende dagli antibiotici, ma so anch’io che non è vero. È calma e tranquilla. Le chiedo se va meglio, lei dice che ancora non si sente tanto bene. Non vuole mangiare. Cerco di convincerla a ingoiare qualcosa, lei si limita a fissare fuori della finestra. Il silenzio pervade il capanno, un silenzio imbarazzante che ci pesa addosso. Provo a chiacchierare, ma lei non collabora, risponde a monosillabi. Dice che moriremo di freddo, che odia la neve, che se mangerà ancora brodo di pollo vomiterà. A questo punto perderei le staffe, di solito. Le direi di chiudere la bocca, le ricorderei di averle salvato la vita. La costringerei a bere il brodo, anche a costo di cacciarglielo giù nella gola a forza. Non ne vuole sapere nemmeno di disegnare. Le domando se preferisce andare fuori, la giornata è meno fredda rispetto alle ultime, ma non mi dà soddisfazione. Io esco lo stesso, lei non si sposta di un millimetro durante la mia assenza. Non sa prendere una decisione. Non vuole mangiare il brodo di pollo con la pastina. Lo so. Quindi le presento altre opzioni per la cena. Le elenco tutto quello che c’è nella dispensa. Afferma di infischiarsene. Tanto non ha fame. Dice che è stanca di tremare continuamente, stanca dello schifo che mangiamo, dei barattoli di sbobba che fanno passare per alimenti. Il solo odore del cibo inscatolato la fa rimettere. È stanca della noia. Stufa di non avere assolutamente niente da fare, un giorno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Non vuole fare altre passeggiate in una landa fredda, dimenticata da Dio. Non ha alcuna intenzione di tracciare un altro disegno. Ha le unghie rovinate, i capelli unti, talmente aggrovigliati che pensa di non poterli più spazzolare. Siamo immersi nella nostra puzza, anche se ci sforziamo di farci il bagno quasi tutti i giorni in quella vasca sporca. Allora le dico che se mi beccano, mi chiudono in galera. Chissà fino a quando… Trent’anni? Ergastolo? Ma non è questo, le dico. Il numero degli anni non conta niente, non c’entra col discorso. Non sopravvivrei comunque alla detenzione. Ogni criminale conosce qualcuno che è al fresco. In un penitenziario sarei già morto. Qualcuno provvederebbe. Non è una minaccia. Non sto cercando di farla sentire in colpa. Solo che le cose stanno così. Neanch’io vorrei restare nel capanno. Penso di continuo a quando Dan si farà vivo coi passaporti, a come recuperarli senza che mi prenda la polizia. Il cibo è scarso, le notti sono sempre più fredde, finché una mattina non ci sveglieremo più. So che il momento di andarcene è adesso. Prima che finiscano i barattoli di cibo, prima che finisca il denaro. Prima di congelarci e morire. Lei lascia che sia solamente io a preoccuparmene. Dice che in non c’era mai stato nessuno a farlo per lei. Penso a tutte le cose che potrebbero andare storte. Morire di stenti. Congelati. Essere beccati da Dalmar. Rintracciati dalla polizia. È pericoloso tornare a casa. È pericoloso restare qui. Lo so io, e lo sa lei. Ma ora la mia preoccupazione principale è non averla con me. Gabe Dopo Che ci crediate o no, hanno trovato lo stupido gatto. L’animaletto si nascondeva in una rimessa dietro il capanno, gli si era congelato il culo e stava tirando le cuoia. Non aveva niente di che nutrirsi, per cui non era riuscito a resistere ai croccantini che gli avevano portato gli agenti. Ma di sicuro non voleva entrare nella gabbia, a detta loro, perché aveva lottato coi denti e gli artigli per non farsi mettere dentro, e aveva continuato anche dopo che lo avevano intrappolato. Il felino era stato messo su un turboelica fino a Minneapolis, poi su un aereo di linea diretto a O’Hare, lo scalo di Chicago. Quel bastardo viaggia più di me! Sono andato a prenderlo stamattina per portarlo dai Dennett, dove ho scoperto, guarda un po’, che Eve e Mia non c’erano più. Allora mi sono diretto a Wrigleyville e ho sorpreso con un gatto soriano malnutrito le due donne alle dieci di mattina che mangiano ciambelle e bevono caffè. Sono entrambe in pigiama, guardano la televisione. Quando arrivo, qualcuno sta uscendo dal portone, quindi non citofono. Voglio fare loro una sorpresa. «Buongiorno», dico a Mia sulla porta. Non mi aspettava. Eve si alza dal divano e si sistema i capelli arruffati. «Gabe», dice, infilandosi la vestaglia. Provo a lasciare il gatto nell’ingresso, ma non appena Mia mi ringrazia per il caffè e le ciambelle che ho portato, la bestiola comincia da agitarsi forsennatamente, artiglia le sbarre della gabbia ed emette rumori che non ho mai sentito prima da un gatto. La mia sorpresa va così a farsi friggere. Eve impallidisce. «Cos’è questo chiasso?», chiede. Io prendo l’animale e chiudo la porta. Secondo recenti ricerche, chi vive con un animale domestico è meno ansioso, ha la pressione sanguigna più bassa, e perfino un tasso di colesterolo inferiore. È più rilassato, meno stressato, quindi gode di uno stato di salute migliore. A meno che non abbia un cane che piscia continuamente dove gli pare o riduce a brandelli i mobili. «Che cosa ci fa col gatto?», chiede Eve. È chiaramente perplessa e pensa che io sia fuori di testa. «Questo animaletto?», replico. Faccio il finto tonto. Mi accovaccio e apro la gabbia, prendendo il felino in braccio. Lui mi pianta gli artigli nella pelle. Merda! «Lo custodisco per un mio amico. Spero che non le dispiaccia. Qualcuno è allergico ai gatti?», domando posandolo a terra e guardando Mia negli occhi. Quella palla di pelo va verso di lei e inizia a strusciarsi attorno alle sue gambe, non la smette più. Miagola, fa le fusa. Eve si mette a ridere. Si passa una mano tra i capelli. «Sembra che tu abbia un amico», dice alla figlia. La ragazza mormora qualcosa sottovoce, come se provasse a pronunciare una parola nuova, dopodiché la sputa fuori, facendoci rimanere a bocca aperta. Lascia che il gatto si strusci su di lei per non so quanto tempo, mentre Eve parla del debole dell’animale per i piedi di Mia. «Che cosa ha detto?», le chiedo quando lei si abbassa per prenderlo e stringerlo tra le braccia. Non la graffia. Si strofinano il naso a vicenda, e poi lui le dà un colpettino con il muso. «Le ho sempre detto che avrebbe dovuto tenersi un gatto in casa», Eve continua a cianciare. «Mia?», insisto. Mi guarda con le lacrime agli occhi. Sa che io so, e che ho fatto questo per un motivo preciso. «Canoa», sussurra. «Ho detto Canoa». «Canoa?» «Si chiama così». Non poteva chiamarsi Max o Fido? Canoa? Che razza di nome è? «Mia, tesoro…». Eve le si avvicina, ora sa che sta accadendo qualcosa di importante. «Chi è che si chiama Canoa?», chiede. La sua voce è calma, come se si rivolgesse a una bambina con problemi mentali. È sicura che la figlia stia farneticando, forse un effetto collaterale del disturbo acuto da stress. Io invece è la prima volta che sento Mia dire qualcosa di sensato. «Eve», dico sollevando delicatamente la sua mano dal braccio della figlia. Prendo dalla tasca del mio cappotto il fax che avevo inviato alla polizia di Grand Marais, mostrandole lo schizzo che ritrae perfettamente Canoa. «Questo», dico mettendoglielo davanti agli occhi, «è Canoa». «Ma allora non è…». «C’era una rimessa», interviene Mia, senza rivolgerci lo sguardo. È tutta concentrata sul felino. La madre mi strappa il disegno dalle mani. Adesso sa. Ha guardato e riguardato quel quaderno con gli schizzi, ogni figura, perfino quella di Colin Thatcher, che mi ha confessato le faceva venire gli incubi di notte. Ma del gatto si era dimenticata. Sprofonda nel divano. Mia racconta: «C’era una rimessa dietro il capanno. Viveva lì dentro. L’avevo trovato mentre dormiva in una canoa arrugginita. La prima volta si è spaventato. Avevo aperto la porta per dare un’occhiata e lui è fuggito terrorizzato da un buco nella rimessa, scomparendo a razzo nei boschi. Pensavo non sarebbe più tornato. Ma aveva fame e io lasciavo fuori del cibo. Lui diceva che non gli passava nemmeno per l’anticamera del cervello di permettermi di tenerlo nel capanno». «Chi lo diceva?», le chiedo. Ovviamente lo so. Avrei dovuto fare lo strizzacervelli di professione. Però la sua risposta mi giunge inattesa. «Owen», dice, dopodiché scoppia in singhiozzi e si appoggia con una mano alla parete per reggersi. «Tesoro, chi è Owen? Non c’è nessuno che si chiama così. L’uomo del capanno? Quell’individuo? Ma si chiama Colin Thatcher…». «Eve», mi intrometto. La mia autostima aumenta in modo esponenziale. Sono riuscito in quello che non sa fare nemmeno un cultore della materia. Ho fatto sì che Mia si collocasse nel capanno con un uomo di nome Owen e un gatto di nome Canoa. «Quell’uomo ha un sacco di pseudonimi, Owen era probabilmente uno dei tanti. C’è qualcos’altro che ricorda, Mia? Può darmi qualche informazione su di lui?» «Dovremmo telefonare alla dottoressa Rhodes», mi interrompe Eve. So che le sue intenzioni sono buone, che agisce nell’interesse della figlia, ma non posso permettere che ciò accada. Lei prende la sua borsetta, io la chiamo per nome. Ormai sono successe delle cose fra noi, e Eve sa che può fidarsi di me. Non danneggerò Mia. Lei mi guarda e io scuoto la testa. Non adesso, stiamo facendo progressi. «Diceva di odiare i gatti, che se lo avesse visto nel capanno gli avrebbe sparato. Non diceva sul serio, altrimenti non l’avrei fatto entrare». «Aveva una pistola?» «Sì». Certo che ce l’aveva. Lo so, non è difficile da immaginare. «Aveva paura di lui, Mia? Temeva che potesse spararle?». Annuisce. «Sì». Poi si blocca. «No». Scuote la testa. «Non saprei. Penso di no». «Ma certo che avevi paura, tesoro, lui aveva una pistola! Ti aveva rapita». «La minacciava con l’arma?» «Sì». Riflette. Si sta svegliando da un sogno e tenta di rammentare i dettagli. Riesuma pezzi e brandelli, mai il quadro intero. Conosciamo tutti questo fenomeno. A livello onirico, la nostra casa è una casa, ma non proprio quella reale. C’è una donna che non assomiglia alla nostra mamma, però sappiamo che lo è. Poi una volta svegli, il sogno sembra perdere il suo significato. «Mi tratteneva, fuori, nei boschi. Mi aveva puntato la pistola alla tempia. Era fuori di sé. Urlava». Scuote il capo con forza. Le si rigano le guance di lacrime. La madre è scossa, un fascio di nervi, devo mettermi in mezzo a loro due per trattenerla. «Perché?», chiedo. La mia voce è calma, tranquilla. In una vita precedente, forse ero uno strizzacervelli. «È colpa mia, tutta colpa mia». «Qual è la sua colpa, Mia?» «Avevo cercato di dirglielo». «Dirgli cosa?» «Non voleva ascoltare. Aveva la pistola, continuava a puntarmela contro. Sapevo che, se qualcosa andava storto, mi avrebbe uccisa». «Gliel’aveva detto? Che se qualcosa andava storto l’avrebbe ammazzata?». No, no. Fa segno di no. Mi guarda dritto negli occhi. «Lo indovinavo dal suo sguardo». Dice che aveva avuto paura di lui, già quella sera nel bar. Aveva lottato contro quella sensazione, ma il timore era rimasto. Ripenso al jazz bar di Uptown, al proprietario con la calvizie incipiente e alla candelina verde. Lì Mia aveva incontrato Colin Thatcher la prima volta, cioè Owen. Secondo la testimonianza della cameriera, Mia se ne era andata in tutta fretta, di sua spontanea volontà. Mi tornano in mente le parole della cameriera: «Mi è sembrato che non vedesse l’ora di uscire di qui. Non ho notato nessuna paura. «E poi», geme Mia, «tutto ha preso una piega sbagliata. Volevo dirglielo, ci ho provato. Ma ero terrorizzata. Aveva la pistola, e sapevo che se qualcosa andava storto mi avrebbe uccisa. Ci ho provato…». «Colin Thatcher», la interrompo. «Owen, lui l’avrebbe uccisa se qualcosa fosse andato storto?». Annuisce, poi scuote rapidamente la testa. «Sì, no». È confusa. «Non so», farfuglia. «Cosa aveva cercato di dirgli?», chiedo, ma lei cambia atteggiamento, nega, è scoraggiata, sembra ostacolata da qualcosa; non ricorda più quel che voleva raccontare. Molti pensano che la paura inneschi due reazioni naturali alternative: lotta o fuga. Eppure, quando ci si trova davanti a una situazione difficile, esiste una terza reazione: il congelamento o immobilità. Come fanno i cervi davanti alle luci delle auto: si immobilizzano. Lo dimostrano anche le espressioni di Mia («avevo paura», «cercavo di dirglielo»). Nessuna reazione di lotta o fuga: si era irrigidita. Era terrorizzata, l’adrenalina le pompava nelle vene, però lei non era stata in grado di fare alcunché per salvarsi la vita. «È tutta colpa mia», ripete. «Cosa è colpa sua?», insisto, e mi aspetto di ricevere le stesse risposte di prima. Però stavolta lei dice: «Avevo tentato di scappare». «E lui l’ha ripresa?». Annuisce. Ritorno alla sua precedente dichiarazione. «Fuori, nei boschi?», chiedo. «E lui era furibondo perché aveva tentato di fuggire? Quindi, le ha puntato contro la pistola, le ha detto che se ci avesse riprovato…». «Mi avrebbe uccisa». Eve è a bocca aperta, solleva una mano a coprirla. È chiaro che lui aveva minacciato di farla fuori. È così che fanno i ceffi di quel calibro. Sono sicuro che sia accaduto molte volte. «Cos’altro diceva?», azzardo ancora. «Che ricorda?». Mia scuote la testa, non le viene in mente niente. «Canoa», suggerisco. «Aveva detto che gli avrebbe sparato se l’avesse visto nel capanno, ma non l’ha fatto. Ricorda se il gatto era nel capanno?». Lei accarezza il pelo della bestiola. Non mi guarda. «Diceva che mi era rimasto vicino per giorni interi. Non mi abbandonava mai». «Chi non l’abbandonava?», chiedo. «Diceva che nessuno lo aveva mai amato tanto. Nessuno gli era stato così devoto». «Come chi?». Mi guarda. Che scemo, dicono i suoi occhi. «Canoa». Allora comprendo: se la vista del gatto è sufficiente a farle riportare a galla tante cose, quali ricordi potrebbero riesumare riportarla in quella casupola di tronchi di legno? Devo trovare la persona che le ha fatto questo; fino ad allora non sarò certo che lei e sua madre siano al sicuro. Colin Prima Le dico che usciamo per una passeggiata. Fuori è buio, sono le dieci di sera. «Adesso?», chiede, come se avessimo di meglio da fare. «Adesso». Cerca di protestare, ma non glielo permetto. Non stavolta. Le infilo il mio giaccone e ci avviamo. La neve cade lenta, le temperature oscillano intorno allo zero. I fiocchi depositati sul terreno sono leggeri, perfetti per fare delle palle e lanciarsele. Mi ritorna in mente il parcheggio delle roulotte, quando facevo battaglie a colpi di palle di neve coi pezzenti delle altre roulotte, prima che la mamma comprasse una casa che non fosse mobile. Lei mi segue sui gradini. Arrivata in fondo, si ferma per osservare. Il cielo è nero. Il lago buio. Sarebbe tutto scuro, se non fosse per il candore della neve. Lei apre il palmo rivolto all’insù, altri fiocchi le cadono sui suoi capelli e sulle ciglia. Io tiro fuori la lingua per assaggiarla. La notte è silenziosa. Qui la neve rende tutto più luminoso. Fa un freddo pungente, ma non è gelido. Una di quelle sere in cui la neve ti fa quasi sentire caldo, in qualche modo. Lei è ancora in fondo ai gradini. La neve le arriva alle caviglie. «Vieni qui», dico. Calpestiamo il manto bianco fino alla schifosa rimessa sul retro. Devo forzare la porta per aprirla, liberandola dalla neve che la ostruisce. Mica facile. Mi aiuta a tirare, poi quando siamo dentro chiede: «Cosa stai cercando?» «Questo», dico sollevando un’ascia. Mi sembrava di averla già vista lì dentro. Due mesi fa avrebbe senz’altro creduto che servisse per farla fuori. «A cosa serve?», chiede senza traccia di paura. Ho un piano. «Vedrai». Ormai ci saranno dieci centimetri di neve, forse più. Ci sguazziamo coi piedi e ci inzuppiamo il fondo dei pantaloni. Camminiamo per un po’, fino a non scorgere più il capanno. Siamo in missione, una cosa di per sé rivitalizzante. «Hai mai tagliato il tuo albero di Natale?», domando. Mi guarda come se fossi pazzo, come se solo i bifolchi a cui manca qualche rotella si mettessero a tagliare i loro alberi di Natale. Ma poi vedo sparire la sua esitazione, e sento che dice: «Ho sempre voluto tagliare il mio albero di Natale». Le si illuminano gli occhi, come a una bambina. Mi racconta che a casa sua erano sempre artificiali. Gli alberi veri sporcano. Sua madre non li avrebbe mai comprati. A Natale, in casa sua, non c’era gioia. Tutto era fatto per le apparenze. E poi lo addobbavano con quelle decorazioni di cristallo: la sgridavano se si avvicinava a meno di un metro dall’albero. Le dico che può sceglierlo lei, quello che preferisce. Mi indica un abete di quasi due metri. «Riprova». Anche se lo fisso per un attimo e penso che potrei farcela. Mi convinco che si sta divertendo. Non le importa del freddo, né della neve che le entra nelle scarpe. Sostiene che le si stanno gelando le mani, me le preme sulle guance, ma non sento nulla, perché sono altrettanto ghiacciate. Le racconto che, da piccolo, io e mia madre non festeggiavamo il Natale. Certo, mi portava a messa, ma non ci bastavano i soldi per i regali, l’albero, le decorazioni e tutto il resto. Non ho mai voluto che si sentisse in colpa per questa mancanza. Lasciavo che il 25 dicembre arrivasse e passasse, come qualunque altra giornata. Al ritorno in classe, gli altri si vantavano dei regali ricevuti. Io inventavo qualcosa, non mi compativo. Non sono mai stato uno che si compatisce. E poi le spiego di non aver mai creduto in Babbo Natale. Mai nella vita. «Che cosa volevi?», mi chiede. Un padre, qualcuno che provvedesse a me e mia madre, così non avrei dovuto farlo io. Però le dico che volevo un videogioco dell’Atari. Trova un albero adatto. Un metro e mezzo di altezza. «Vuoi provarci tu?», le chiedo porgendole l’ascia. Ride, prendendola in mano. Un suono che non avevo mai udito. Dà un colpo alla pianta. Dopo altri quattro o cinque tentativi mi restituisce l’ascia. Esamino la base dell’albero: lo ha appena intaccato. Sembra un lavoro per niente facile. Le consiglio di scostarsi mentre mi impegno a buttarlo giù. Lei osserva con gli occhi spalancati di una bambina di cinque anni. Mi galvanizzo, che figura se non ci riesco. Il mondo tace. Ogni cosa è immersa nel silenzio, nella pace. Sono sicuro di non aver mai passato una notte simile. Mi confida che è impossibile credere che da qualche parte del mondo infuri la guerra, che della gente stia morendo di stenti, che ci siano dei bambini abusati. Siamo lontani, estranei alla civiltà. Dice: «Due figurine in un globo di neve che un bambino ha rovesciato». Me lo immagino: noi due che arranchiamo su montagne di ceramica mentre la neve luccicante scende nella nostra bolla. Mi pare di sentire in lontananza il verso di un gufo. Mi fermo e dico: «Shh». Restiamo per un attimo ad ascoltare. È qui che migrano d’inverno i gufi delle nevi. Noi avvertiamo un gran freddo, ma loro vengono qui per stare al caldo. Lei osserva il cielo e guarda le nuvole inondarci di neve. L’albero è pesante. Lo trasciniamo insieme, lei davanti, io dietro. Lo facciamo scivolare sul manto nevoso, ma quattro o cinque volte cadiamo bocconi. Abbiamo le mani così intirizzite che quasi non riusciamo ad afferrare il tronco. Arrivati al capanno, prendo l’albero dalla base e, camminando all’indietro, lo sollevo su per i gradini. Lei rimane in fondo. Finge di aiutarmi, ma sappiamo entrambi che il suo contributo è nullo. Lo facciamo entrare dalla porta e lo puntelliamo contro una parete. Crollo dalla fatica. L’albero peserà una settantina di chili, carico di neve com’è. Mi tolgo le scarpe bagnate, che lancio da una parte, e bevo un po’ d’acqua dal rubinetto della cucina. Lei accarezza gli aghi. Annusa il legno, sa di linfa. È la prima volta che nessuno di noi due si lamenta per il freddo. Abbiamo le mani spaccate, il naso e le guance rossi. Ma sudiamo sotto gli strati di vestiti. La fisso, vedo che il freddo l’ha colorita. Vado in bagno per lavarmi e cambiarmi. Lei asciuga l’umidità sul pavimento. Riesco a sentire la linfa appiccicosa dell’abete sulle mani. Inspiro a fondo. Poi crollo di nuovo sul sofà. Lei va in bagno per togliersi i vestiti bagnati e asciugarsi. S’infila un altro paio di pantaloni termici che aveva steso alla tenda della finestra, e quando torna fa: «Nessuno mi aveva mai regalato un albero». Ravvivo il fuoco mentre lei attraversa la stanza. Osserva le mie mani che manovrano i ciocchi. Dice che faccio tutto così, con una certa perizia pratica, ma fingendo di non averla. Non rispondo. Torno a sedermi sul sofà e mi metto una coperta sulle gambe. Appoggio i piedi sul tavolinetto. Ancora non ho recuperato il ritmo regolare di respirazione. «Non so cosa darei per una birra», affermo. Lei resta lì a guardarmi per non so quanto tempo. Sento i suoi occhi su di me. «Anche tu?», aggiungo. «Una birra?» «Certo». «Sì», conferma. Ripenso a noi due seduti uno di fianco all’altra a bere la birra in quel bar. Le chiedo se lo ricorda e dice di sì. Le pare sia accaduto un milione di anni fa, molto prima che qualcuno facesse luce nel nostro mondo. «Che ore sono?», domanda. Ho l’orologio sul tavolino di fianco a me. Mi piego in avanti per controllare e la informo che sono le due di notte. «Sei stanco?», chiede. «Un po’». «Grazie per l’albero», dice. «Grazie per aver regalato un albero a entrambi», aggiunge. Non vuole essere presuntuosa. Lo fisso, appoggiato lì alla parete di legno. È storto, brutto, però lei dice che è perfetto. «No», la contraddico. «È per te, così la smetti di tenere il muso lungo». Le prometto di trovare delle luci. Non so come farò, ma glielo prometto. Lei mi dice di non preoccuparmi: «Va benissimo così». Io invece voglio addobbarlo. Mi chiede se uso mai la metropolitana nel centro di Chicago, la famosa L. Le rispondo ovviamente di sì. Nessuno può spostarsi in centro altrimenti. Lei dice di usare spesso la Red Line. Volare sottoterra, come se in superficie non imperversasse tutta quella baraonda. «Prendi mai l’autobus?», chiede. Mi domando dove voglia andare a parare. «A volte». «Esci, frequenti i bar, roba simile?» «Qualche volta». Faccio spallucce. «Non è il mio ambiente». «Ma ci vai?» «Ogni tanto». «Vai mai al lago?» «Conosco uno che ha una barca a Belmont Harbor». Voglio dire un delinquente della mia risma, uno che lavora per Dalmar e vive nella barca, un cabinato di seconda mano che tiene sempre ormeggiato col pieno di carburante, nel caso avesse bisogno di scappare in fretta. Inoltre ci tiene un sacco di provviste, da sostentarsi per un mese, se capitasse di fare il giro dei Grandi Laghi, fino in Canada. Così vive la gentaccia come noi, sempre pronta a fuggire. Annuisce. Belmont Harbor, naturalmente. Afferma di passare continuamente da quelle parti. «Potrei averti già visto. Magari ci siamo incrociati per strada, sullo stesso autobus. O forse mentre aspettavamo la stessa corsa della metro». «A Chicago vivono milioni di persone». «Eppure…». «Va bene, forse. A cosa vuoi alludere?» «Stavo solo fantasticando…», la sua voce si affievolisce. «Cosa?», chiedo. «Se ci saremmo mai conosciuti, se non fosse stato per…». «Questo?». Scuoto la testa. Non voglio fare la figura del coglione. È la verità. «Probabilmente no». «Non ci credi?» «Non ci saremmo mai incontrati». «Come fai a saperlo?» «Non ci saremmo mai incontrati», ribadisco. Distolgo lo sguardo, mi tiro la coperta sulle spalle e mi sdraio sul fianco. Le chiedo di spegnere la luce e, sentendola attardarsi in cucina, dico: «Non vai a dormire?» «Come fai a esserne sicuro?», riattacca. Non mi piace la piega che sta prendendo la conversazione. «Che differenza fa?», domando. «Mi avresti rivolto la parola se ci fossimo veramente incontrati? Quella sera, mi avresti rivolto la parola se non fossi stato obbligato a farlo?» «Innanzitutto non sarei stato lì, in quel bar». «Ma… se ci fossi stato». «No». «No?» «Non ti avrei presa in considerazione». Il rifiuto è come uno schiaffo in faccia, per lei. «Oh». Attraversa la stanza e spegne la luce. Però non posso troncare lì. Non posso lasciarla andare a letto contrariata. Nel buio, ammetto: «Non è come pensi tu». Resta sulla difensiva. Ho ferito i suoi sentimenti. «Che cosa penso?» «Non ha niente a che vedere con te». «Ma certo che ce l’ha». «Mia…». «Allora?» «Mia». «Che cosa?» «Non ha niente a che vedere con te. Non significa nulla». Non è vero. Per lei significa qualcosa. La sento muoversi per la stanza, quando ammetto: «La prima volta che ti ho vista uscivi dal tuo appartamento. Ero seduto dall’altra parte della strada, sui gradini di una casa quadrifamigliare, aspettavo. Avevo visto una tua fotografia. Ti avevo chiamato dal telefono a gettoni all’angolo. Avevi risposto e io avevo riagganciato subito. Così, sapevo che c’eri. Non so quanto ho aspettato, quarantacinque minuti, un’ora. Dovevo sapere in cosa mi stavo cacciando. Poi ti ho vista dalla finestrella di fianco all’entrata, che saltellavi giù dalle scale con gli auricolari. Hai aperto il portone e ti sei fermata ad allacciarti una scarpa. Nel frattempo memorizzavo la tua acconciatura, il modo in cui i capelli ti cadevano sulla spalle, prima che li legassi sulla nuca. È passata una donna con quattro o cinque cani. Ti ha rivolto la parola, tu le hai sorriso, e dentro di me ho pensato di non aver mai visto niente di altrettanto… non so… di altrettanto bello in vita mia. Sei scomparsa di corsa in fondo alla strada, nel frattempo io ti aspettavo. Osservavo i taxi che passavano, frotte di persone che tornavano a casa a piedi dopo essere scese alla fermata dell’autobus dietro l’angolo. Erano le sei, forse le sette di sera. Cominciava a imbrunire. Il cielo era quello tipico autunnale, fantastico. Sei tornata a piedi. Mi sei passata davanti diretta dall’altra parte della strada, ringraziando un taxi che aveva rallentato per farti attraversare. Ero quasi certo che mi avevi visto. Poi hai preso la chiave e sei entrata, e io non potevo più vederti. Vedevo la finestra illuminata e il tuo profilo. Immaginavo quel che facevi all’interno. Immaginavo di stare lì dentro con te, a come sarebbe stato se non avessi dovuto fare quello che ho fatto». Resta in silenzio. Dopodiché sostiene di ricordarsi di quella sera. Non aveva dimenticato il cielo vibrante, la luce del sole morente. Dice che il cielo era color cachi e sangria, sfumature di rosso che solo Dio è capace di impastare. Inoltre ricorda «i cani, tre labrador neri e un golden retriever, e la donna, in tutto una quarantina di chili, che si facevano sballottare dai guinzagli aggrovigliati». Ricorda anche la telefonata, che allora l’aveva lasciata indifferente. Le viene in mente che se ne stava seduta e si sentiva sola, perché quel cretino del suo ragazzo doveva lavorare, ma soprattutto perché era contenta che dovesse lavorare. «Non ti ho visto», sussurra. «Altrimenti me lo ricorderei». Si china sul sofà, di fianco a me. Io sollevo la coperta e la accolgo. Mi preme la schiena sul petto, aderiamo completamente. Sento il battito del suo cuore. Sento il sangue pulsarmi nelle orecchie. Fa rumore, sono sicuro che lo sente anche lei. Le sistemo meglio la coperta. Frugo con la mano e trovo la sua, le nostre dita s’intrecciano. La sua stretta mi rassicura. Dopo un po’, la mia mano smette di tremare. Faccio scivolare il braccio sulla sua clavicola. Lei si accomoda in tutti gli spazi vuoti tra noi, finché diventiamo una cosa sola. Appoggio la testa su un viluppo di capelli biondo scuro, abbastanza vicino da farle sentire il mio alito sulla pelle, rassicurandola così che siamo vivi, sebbene facciamo fatica a respirare. Cadiamo nell’oblio, in un mondo dove non conta nient’altro, se non noi due. Quando mi sveglio, lei non c’è. Non avverto più la sua pressione contro di me. Mi manca qualcosa, anche se solo poco prima non c’era niente. La vedo all’esterno, seduta. Si sta gelando le chiappe. Ma pare che non le importi. Ha una coperta sulle spalle, ai piedi si è messa le mie scarpe. Una misura sproporzionata. Ha levato con i piedi la neve dai gradini, anche se i lembi della coperta toccano il suolo e si stanno bagnando. Non esco subito. Preparo il caffè. Prendo il mio giaccone. Mi muovo coi miei tempi. «Ehi», esclamo uscendo a piedi nudi. Le porgo una tazza di caffè. «Forse questo ti riscalderà». «Oh», sussulta. Si accorge che sono scalzo e dice: «Le tue scarpe», ma la fermo prima che possa togliersele. Dico che non mi servono, che mi piace vederle addosso a lei. E che mi piace che si fosse sdraiata di fianco a me. Potrei abituarmici. «Fa freddo, qui», dico. In effetti, si gela. Saranno cinque gradi sottozero. «Davvero?», chiede. Non rispondo. «Ti lascio sola», propongo. Presumo che chi decide di stare a congelarsi le chiappe in una giornata simile è perché vuole restare da solo. Non che sia accaduto niente, ma il fatto di rimanere per ore appiccicato a lei, senza altri scopi, solo per starle vicino, per godere la sensazione della sua pelle morbida e il rumore del suo respiro mentre russa: questo sì che è accaduto. «Ti si stanno surgelando i piedi». Me li guardo. Sono su uno strato di neve e ghiaccio. «Hai ragione», convengo, e mi volto per rientrare nel capanno. «Grazie per il caffè». Non so cosa altro mi aspetti che dica, ma sicuramente mi aspetto qualcosa. «Di niente». E sbatto la porta. Non so quanto tempo passi, abbastanza da farmi incazzare. Ce l’ho con me perché sono arrabbiato con lei. Dovrei fregarmene. Non dovrei attribuire alcuna importanza a questa cosa. Ma poi ricompare. Ha le guance rosse per il freddo. I capelli sulle spalle. «Non voglio restare da sola», dice. Fa cadere la coperta sulla soglia. «Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che qualcuno mi ha detto che sono bella», dice. Bella non le rende affatto giustizia. Ci fissiamo a lungo, da una parte all’altra della stanza, assaporando quella sensazione. Sforzandoci di respirare. Viene verso di me. Le sue mani mi toccano con prudenza. L’altra volta l’avevo respinta, ma allora era diverso. Era una donna diversa. Io ero un uomo diverso. Faccio scorrere le dita tra i suoi capelli. Le mie mani scendono sulle sue braccia. Memorizzano le sue dita e la forma della sua schiena. Lei mi fissa con uno sguardo che non avevo mai visto, né in lei né in nessun’altra donna. Fiducia, rispetto, desiderio. M’imprimo nella mente ogni lentiggine, ogni macchiolina sul suo viso. Imparo la forma delle sue orecchie, e le passo un dito sulle labbra. Mi prende per mano e mi conduce nella camera da letto. «Non sei obbligata a farlo», dico. Non è più mia prigioniera. Voglio solo che lei abbia voglia di essere qui. Indugiamo sulla soglia. Cerca le mie labbra con le sue, le tengo la testa tra le mani. Le accarezzo i capelli. Lei intreccia le braccia dietro la mia schiena. Non mi molla. Ciò che cambia è il modo in cui ci tocchiamo. C’è contatto, una cosa che solitamente evitavamo. Ci sfioriamo a vicenda se dobbiamo entrare in una stanza. Lei passa le dita tra i miei capelli. Io lascio la mia mano a indugiare sulla sua schiena. Lei segue i contorni del mio viso. Condividiamo lo stesso letto. Con le mani e con le dita memorizziamo ciò che non possono memorizzare gli occhi. Un’irregolarità del cuoio capelluto, punti di pelle secca. Non c’è nulla di frivolo in tutto ciò. Non flirtiamo. Siamo già oltre. Non rivanghiamo le relazioni sentimentali del passato. Non cerchiamo di ingelosirci a vicenda. Non inventiamo nomignoli affettuosi con cui chiamarci. Non usiamo la parola «amore». Passiamo il tempo. Parliamo. Raccontiamo le cose strane che si vedono in città. I senzatetto che vanno in giro coi carrelli per la spesa. Gli invasati religiosi che camminano col crocifisso sulla schiena. Idioti. Mi domanda qual è il mio colore preferito. Dico che non ce l’ho un colore preferito. Allora qual è il mio piatto preferito, e io verso una cucchiaiata di brodaglia nella scodella: «Tutto, tranne questo», dico. Mi chiede cosa le sarebbe successo se non fossimo venuti qui. Se l’avessi consegnata e mi fossi preso la ricompensa per il rapimento. «Non lo so», ammetto. «Sarei morta?». Impariamo cose che non conoscevamo: il contatto della pelle ci aiuta a riscaldarci; gli spaghetti in scatola sono buoni coi fagioli precotti; in due si sta comodi su quella poltrona sgangherata. Mi fissa con quei suoi occhi, pretendono una risposta. «Non lo so», ripeto. Immagino la scena mentre la strappano dalla mia auto e la gettano nel furgoncino. Le legano le mani e le bendano gli occhi. Sento che urla e piange. Scosto la scodella, non ho fame. Ho perso l’appetito. Lei sta in piedi e prende la mia ciotola. Afferma che stasera i piatti li lava lei, io le stringo piano il polso e dico: «Lascia stare». Ci accomodiamo davanti alla finestra per ammirare la luna, una scheggia nel cielo. Le nuvole sono in movimento, a tratti la coprono. «Guarda quante stelle», dice. Conosce i nomi delle costellazioni: Ariete, Fornace, Perseo. Dice che a Chicago esprimeva i suoi desideri al passaggio degli aeroplani perché, rispetto alle stelle, ce n’erano molti di più nel cielo notturno. Certe volte è troppo distante, anche se siamo nella stessa stanza. Mi insegna a contare fino a cento in spagnolo. Io le insegno a ballare il fox-trot. Quando il lago ghiaccia del tutto, peschiamo praticando un foro sulla superficie. Non rimaniamo mai fuori per troppo tempo. Non le piace restare ferma a osservare. Cammina sul lago come se Mosè avesse diviso le acque per lei. Ama la neve appena caduta. Talora notiamo impronte di animali. Talvolta sentiamo in lontananza il rumore dei gatti delle nevi. Quando è diventata un ghiacciolo, rientra nel capanno. Allora mi sento solo. La porto fuori. Prendo con me la pistola. Ci inoltriamo un po’ nei boschi, verso un posto talmente desolato che di sicuro nessuno udrà lo sparo. Le dico che desidero impari a sparare, o almeno come usare quest’arma. Gliela poggio sui palmi aperti, come fosse un gioiello prezioso. Lei non la vuole nemmeno toccare. «Prendila», sussurro. «Perché?», chiede. «Non si sa mai». Voglio che impari a sparare, così saprà difendersi. «Ci sei tu per questo». «E se una volta non ci fossi?», chiedo. Le sistemo una ciocca di capelli dietro l’orecchio gelato. Ma il vento gliela scompiglia di nuovo. «È scarica». Stringe l’arma tra le mani. È pesante, il metallo è freddo. Le sistemo l’indice sul grilletto e il pollice verso il basso. Siccome tengo la mia mano sulle sue, è sicura che andrà tutto bene. Che sarà una cosa giusta. Ha le mani fredde, come le mie. Ma mi accettano senza riserve, non come una volta, quando mi evitava. Le spiego le parti della pistola: il tamburo, la canna e il ponticello. Estraggo dalla tasca dei jeans un caricatore e le mostro come si fa a inserirlo. Le elenco i tipi di arma esistenti: fucile, rivoltella e semiautomatica. Questa è una pistola semiautomatica. Quando si spara un colpo, il caricatore ne inserisce un altro nella camera di scoppio. Basta premere il grilletto. Le dico di non puntare mai l’arma contro qualcuno se non intende ucciderlo. «L’ho imparato nel modo peggiore», dico. «Quando avevo sette anni, forse otto. Nel quartiere c’era un ragazzino, e suo padre possedeva un revolver. Se ne vantava continuamente. Pensavo fosse un bugiardo e glielo dissi. Lui volle dimostrarmelo, per cui un giorno andai a casa sua, dopo la scuola. Non c’era nessuno. Il padre teneva l’arma carica in un comodino senza serratura. La presi dal cassetto come un giocattolo. Giocammo un po’ a guardie e ladri. Lui era la guardia, però la pistola l’avevo io. Quando disse: “Mani in alto!”, io mi voltai e gli sparai». Restiamo nel freddo pungente. Ricordiamo le volte in cui lei fissava atterrita il tamburo della pistola. Senso di colpa, dispiacere. Sono sicuro che me li legge negli occhi. Sono sicuro che senta la sincerità nel mio tono di voce quando affermo: «Non ti avrei uccisa». Le stringo la mano convulsamente, alla cieca. «Ma avresti potuto farlo», dice. Sappiamo entrambi che è vero. «Sì», devo ammettere. Non sono uno che si scusa. Ma sono certo che lei sappia interpretare la mia espressione. «Però era diverso», aggiunge. «In che senso?». Mi metto dietro di lei, le sollevo il braccio e miriamo insieme un tronco. Le allargo le gambe e le insegno come deve reggersi in piedi, poi armiamo il cane e premiamo il grilletto. Un rumore assordante. Il rinculo la fa quasi cadere. La corteccia dell’albero esplode. «Perché se ne avessi avuto la possibilità, anch’io ti avrei ucciso», dice. Ecco come abbiamo risolto le cose che erano accadute fra noi nei primi giorni. Ecco come compensiamo tutte le parole cattive e meschine che ci siamo detti, i pensieri orribili che ci ossessionavano. È il modo in cui cancelliamo l’odio e la violenza dei primi giorni e delle prime settimane dentro il capanno, fra le pareti di legno che sono diventate la nostra casa. «E il tuo amico?», chiede. Accenno alla pistola che tiene in mano e stavolta la incoraggio a provare da sola. «Fortunatamente per lui, da piccolo avevo una pessima mira. La pallottola gli sfiorò un braccio. Solo un graffio». Eve Vigilia di Natale Gabe mi ha chiamato presto, stamattina, per dirmi che stava arrivando. Erano le cinque e mezza quando il mio cellulare ha squillato e, a differenza di James che stava dormendo come un angioletto, ero sveglia già da alcune ore, tormentata da un’altra notte insonne. Non mi do la pena di svegliarlo. Prendo la vestaglia ed esco. Ci sono notizie. Sono ferma sui gradini, tremo dal freddo, aspetto che l’auto di Gabe entri nel vialetto coperto di neve. Sono appena passate le sei, è ancora buio. Le decorazioni natalizie dei vicini illuminano il cielo notturno: gli alberi addobbati che luccicano dalle finestre delle abitazioni, le candele tremolanti sui davanzali. Dai camini escono mulinelli di fumo nell’aria gelata. Mi stringo ancor più forte la vestaglia e aspetto. Lontano si sente passare un treno che sferraglia verso la città. Non c’è nessuno che lo attende sulla piattaforma, all’alba di questa domenica mattina che è la vigilia di Natale. «Cosa c’è?», chiedo non appena esce dall’auto. Viene dritto verso di me, non chiude nemmeno la portiera. «Andiamo dentro». Mi prende per mano e mi conduce dove è più caldo. Ci sediamo su un divano di velluto bianco, molto vicini. Quasi non ci accorgiamo di toccarci con le cosce. È buio in casa, è accesa solo la luce della caldaia in cucina. Non voglio svegliare James, parliamo a sottovoce. C’è un’espressione strana nei suoi occhi, qualcosa di nuovo. «È morta», mi arrendo. «No», dice, ma poi si corregge e, fissandosi le mani, ammette: «Non lo so. In una cittadina del Minnesota nord-orientale vive la dottoressa Kayla Lee. Non volevo darti false speranze. Una settimana fa abbiamo ricevuto una sua telefonata, aveva visto la faccia di Mia nei telegiornali e l’aveva riconosciuta come una delle sue pazienti. Sono passate settimane, forse un mese, da quando Mia è stata lì per un consulto. Ma è sicura che fosse lei. Tua figlia si è presentata con uno pseudonimo: Chloe Romain». «Una dottoressa?» «La Lee ha detto che era con un uomo. Colin Thatcher. Ha detto che era malata». «Malata?» «Polmonite». «Polmonite». Se non viene curata, la polmonite può causare avvelenamento del sangue, può provocare difficoltà o incapacità respiratorie. Senza cure, una persona potrebbe anche morirne. «La dottoressa le aveva fatto una ricetta e l’aveva congedata. Le aveva chiesto di farsi rivedere entro una settimana. Mia non si è presentata all’appuntamento». Gabe sostiene di avere la sensazione ricorrente che si trovino a Grand Marais. È un’intuizione, una cosa viscerale… «Cosa ti fa credere che siano a Grand Marais?», chiedo, ricordando la volta in cui si era presentato qui e mi aveva domandato se ne avevo mai sentito parlare. «Una cartolina che ho trovato casualmente in casa della signora Thatcher. Da Colin a sua madre. Per un ragazzo che non lasciava quasi mai la casa, mi ha colpito notevolmente. È un ottimo posto in cui nascondersi. E poi c’è dell’altro», aggiunge. «Cosa?», pendo dalle sue labbra. Mia aveva avuto una ricetta, ma non è detto che sia andata in farmacia. Non è detto che abbia ingerito le compresse per curarsi. «Ho parlato con Kathryn Thatcher e fatto delle ricerche sulla sua famiglia. Sembra che abbiano ormai da anni una capanno a Grand Marais. Kathryn non ne sa granché, non ci è mai stata. Ma il suo ex marito ci portava Colin da piccolo. È una residenza estiva, per così dire, disabitata per gli altri mesi dell’anno. Ho chiesto a un funzionario locale di andare a darci un’occhiata, lo ha fatto e ha visto un pick-up rosso con targa dell’Illinois che era parcheggiato fuori». «Un pick-up rosso», ripeto. Gabe mi ricorda che i vicini della Thatcher erano certi che Colin avesse un veicolo simile. «E allora?», chiedo ansiosa. Si alza. «Vado lì, con la mia auto, stamattina. Stavo per salire su un aereo, ma non è una buona idea, niente rotte dirette, e fra scali e soste…». Mi alzo per accompagnarlo. «Vengo anch’io. Metto qualcosa nella borsa…». Cerco di muovermi, lui però mi blocca dalle spalle. «Non puoi venire», dice con tenerezza. Afferma che è solo un’intuizione, una possibilità. Non ci sono prove. Il capanno è attualmente sotto controllo. Non ci sono nemmeno certezze che Mia sia lì dentro. Colin Thatcher è un uomo pericoloso, ricercato per vari delitti. «Certo che posso», grido. «È mia figlia». «Eve». Ho la voce rotta. Mi tremano le mani. Sono mesi che attendo questo momento ma, adesso che è arrivato, non sono certa di essere pronta. Tante cose potrebbero andare storte. «Ora ha bisogno di me. Sono sua madre, Gabe. È mio dovere proteggerla». Mi abbraccia, una stretta vigorosa. «È mio dovere proteggere te», dice. «Fidati. Se Mia è lì, la riporterò a casa». «Non posso perderla ora», piango. I miei occhi si soffermano su una foto di famiglia scattata alcuni anni fa: James, Grace, io e Mia. Sembriamo tutti essere stati costretti a posare, abbiamo il sorriso stampato ma siano accigliati, gli occhi guardano altrove. Solo Mia pare felice. Perché? Non le abbiamo mai dato motivo di esserlo. Gabe mi bacia sulla fronte e prolunga questo gesto d’affetto, sento le sue labbra premute sulle rughe della pelle. Siamo in questa posizione quando James scende impacciato le scale, con addosso solo un pigiama aderente di tartan. «Cosa diavolo succede?», domanda. Sono la prima a staccarmi. «James», grido correndogli incontro. «Hanno trovato Mia». Ma lui ignora il mio approccio, il suo sguardo mi evita. «Ed è così che ci dà la notizia?», dice in tono di sfida, deridendo Gabe. «Mettendo le mani addosso a mia moglie?» «James», ripeto prendendogli la mano affinché capisca: nostra figlia tornerà presto a casa. «Hanno ritrovato Mia». Lui però reagisce lanciando uno sguardo altero in direzione di Gabe. Non mi guarda. «Ci crederò quando la vedrò», esclama ed esce dalla stanza. Colin Prima Sull’albero di Natale ci sono le luci. Non le dico come sono finite lì. Sostengo che non le piacerebbe saperlo. Le ho accennato che lo svantaggio altrui viene a nostro vantaggio. Secondo lei, sono meravigliose di notte, quando spegniamo l’interruttore principale e ci sdraiamo vicini, al buio, rischiarati solo dal fuoco e dalle lucine sull’albero. «È perfetto», dice. «Non abbastanza», correggo. «Cosa intendi? È perfetto». Tuttavia, sappiamo tutti e due che non lo è. La cosa perfetta è il modo in cui mi guarda, la maniera in cui pronuncia il mio nome. Il modo in cui mi accarezza i capelli, anche se mi pare che non sia consapevole di farlo. Il modo in cui facciamo l’amore tutte le sere. Il modo in cui mi sento: realizzato. La cosa perfetta è la maniera in cui a volte sorride e altre volte ride fragorosamente. Il fatto che possiamo dire tutto quello che ci passa per la mente, oppure rimanere seduti per ore senza interrompere il silenzio. Di giorno il gatto ci ronza attorno. Di notte dorme con noi, sul cuscino di lei, dove c’è un briciolo di calore. Le dico di cacciarlo via, ma lei non vuole. Allora lei mi si avvicina, viene a condividere il mio cuscino. Dà al gatto gli avanzi, che lui divora. Però sappiamo che, siccome la dispensa si sta svuotando, dovrà decidere: o lui o noi. Chiacchieriamo del luogo in cui vorremmo andare se ne avessimo l’occasione. Elenco tutti i posti caldi che mi vengono in mente. «Messico, Costarica, Egitto, Sudan». «In Sudan?» «Perché no? Lì si crepa dal caldo». «Senti tanto freddo?», chiede. Io me la metto sulle ginocchia. «Così va meglio», dico. Le domando dove vorrebbe recarsi, se riusciremo mai ad andarcene di lì. «Un paesino in Italia», dice. «Una città fantasma, quasi completamente abbandonata, dove restano solo gli ulivi e circa duecento anime, con un castello medievale e una vecchia chiesa». «È lì che vuoi andare?», sono sorpreso. Mi aspettavo Machu Picchu o le Hawaii. Roba di questo genere. Invece capisco che è un’idea ponderata. «È un posto in cui potremmo rintanarci. Un mondo senza televisione, né tecnologia. Si trova in Liguria, la regione italiana che confina col sud della Francia. Saremmo a pochi chilometri dalla riviera. Potremmo campare coi frutti della terra e coltivare quello che mangeremo. Non dovremo dipendere da nessuno. Non dovremmo preoccuparci della polizia, di qualcuno che ci possa rintracciare…». La guardo dubbioso. «Pensi che sia una sciocchezza», aggiunge. «Penso che la verdura fresca sarebbe un bel cambiamento, dopo questi pomodori precotti». «In effetti, odio i pomodori in scatola», ammette. Confermo, li avevo comprati solo perché avevo fretta. «Potremmo acquistare un rustico, uno di quegli antichi casolari di granito, che avranno cento o duecento anni. Ammireremmo panorami mozzafiato, magari fino al mare, col tempo buono. Potremmo allevare gli animali, mangiare cibo sano». «L’uva?» «Sì, un bel vigneto. Cambieremo i nostri nomi, cominceremo una nuova esistenza, da zero». Mi appoggio sui gomiti. «La tua nuova identità?» «Cosa vuoi dire?» «Il nome che prenderesti». Risposta ovvia: «Chloe». «Chloe, ecco chi sarai», dico. Lo osservo. Ricordo che qualche mese fa, quando andavamo a Grand Marais, l’avevo costretta a scegliersene uno, e lei aveva escogitato questo pseudonimo. «Perché Chloe?», chiedo. «Cosa intendi?» «Quella volta, quando ti spiegai che non potevi più essere Mia, avevi pensato a Chloe». «Oh», esclama mettendosi a sedere. La mia maglietta le ha lasciato delle pieghe sulla pelle del volto. Ha i capelli sciolti, le arrivano fino a metà schiena. Forse anche più giù. Mi aspetto una risposta semplice. Mi piaceva, una cosa simile. Ma ne vengo a sapere di più. «Una ragazza che avevo visto alla televisione», afferma. «Cosa vuoi dire?». Chiude gli occhi, so che non vuole rivelarmelo. Però parla lo stesso: «Avevo sei o sette anni. La mamma era in cucina, ma aveva lasciato accesa la TV, c’era il telegiornale. Stavo colorando. Lei non sapeva che prestavo attenzione. Un programma su un viaggio scolastico di gruppo, nel Kansas o nell’Oklahoma, mi pare. Una banda di ragazzini in una corriera, forse andavano a una gara. A questo non facevo caso. La corriera prese a sbandare e precipitò in un burrone. Una decina di bambini morti, insieme all’autista. Poi apparve la famiglia, una mamma, un papà, e due ragazzi grandi, di diciotto o diciannove anni. Me li rivedo ancora adesso. Il padre, magro e quasi calvo, i due figli, entrambi alti e snelli, sembravano giocatori di baseball, coi capelli rossicci. La madre pareva che l’avesse investita un autotreno. Piangevano tutti, nessuno escluso, davanti a quella piccola casetta bianca. Questo attirava la mia attenzione. Il fatto che piangessero. Avevano il cuore infranto. Erano distrutti dal dolore. Osservavo soprattutto il padre, ma anche gli altri, il modo in cui singhiozzavano senza vergognarsi per la figlia o la sorella morta nell’incidente. Era finita in fondo al burrone perché l’autista si era addormentato al volante. Aveva quindici anni, ma ricordo bene che il padre gemeva per la sua “bambina”. Non la smetteva di raccontare quanto fosse straordinaria, anche se le cose che diceva (che era gentile e sapeva suonare il flauto, sebbene non fosse un genio) non erano necessariamente straordinarie. Per lui però lo erano. Continuava a ripetere: “La mia Chloe, la mia bambina”. Quello era il suo nome: Chloe Frost. Non riuscivo a pensare ad altro che a lei. Volevo essere nei suoi panni, avere qualcuno che soffrisse per me nel modo in cui la sua famiglia pativa per lei. Piansi per lei per giornate intere. Le parlavo, quando ero sola. Intrattenevo conversazioni con la mia amica morta, Chloe. La disegnavo. Decine di disegni di Chloe, coi suoi capelli rossicci e gli occhi color caffè». Si passa una mano tra i capelli e distoglie lo sguardo, in modo umile e impacciato. Imbarazzato. Poi ammette: «La invidiavo, davvero. Ero gelosa di lei che era morta, perché da qualche parte c’era qualcuno che la amava più di quanto amassero me». Esita, poi soggiunge: «È una follia, lo so». Invece scuoto la testa e faccio: «No», perché so che è quello che vuole sentirsi dire. E penso a quanto dovesse essere stata sola durante l’infanzia. Tanto da voler essere l’amica morta che non aveva neppure conosciuto. Io e mia madre non abbiamo mai avuto granché, ma non siamo mai stati soli. Lei cambia discorso. Non vuole parlare più di Chloe Frost. «E tu chi sarai?», mi chiede. «John?», azzardo. Non potrei essere più lontano da un John qualsiasi. «No», fa, e pensa a una risposta tanto ovvia quanto quella di Chloe. «Sarai Owen. Anche perché non conta più, ormai. Non è il tuo vero nome». «Lo vuoi sapere?», chiedo. Scommetto che ci ha pensato migliaia di volte. Scommetto che ha cercato di indovinare quale possa essere il mio vero nome. Mi chiedo se abbia mai immaginato di chiedermelo. «No», ripete, «perché per me questa è la tua identità. Tu sei Owen». Afferma che qualsiasi cosa fossi prima di questo non conta niente. «E tu sarai Chloe». «Sarò Chloe». In quel momento, Mia cessa di esistere. Eve Dopo Mi consiglio con la dottoressa Rhodes, la quale mi spalleggia, alla condizione che possa accompagnarci. Compro i tre biglietti per l’aereo con la carta di credito che condivido con James. Il distretto copre i costi di Gabe. Torneremo nel capanno in cui Mia è stata tenuta prigioniera per tutto il tempo. Spero che la visita la aiuti a recuperare la memoria, a ricordare qualcosa del periodo di cattività. Se basta il gatto a farle tornare in mente Colin, non riesco a immaginare cosa potrà provocare la casupola. Io e Mia prepariamo una valigia per entrambe, non abbiamo molte cose. Non dico a James dove stiamo andando. Mia prega Ayanna di badare a Canoa per qualche giorno, e la collega accetta volentieri. Ronnie, suo figlio di nove anni, è felice di avere la compagnia di un gatto. Sulla strada per l’aeroporto chiamiamo un taxi per farci portare verso il suo appartamento. Mia si separa da Canoa per la seconda volta, con grande difficoltà. Mi chiedo cosa sia successo la prima volta che lo ha lasciato. L’aeroporto è un posto orribile per una persona nelle sue condizioni. Un rumore assordante, migliaia di persone, altoparlanti, aerei che solcano il cielo. Mia è tesa e nervosa, lo si vede bene, benché sia stretta fra me e la Rhodes, e io la tenga sottobraccio. La dottoressa le suggerisce una dose di Valium, che ha portato nella sua valigia, non si sa mai. Gabe si sporge. «Cos’altro ha messo lì dentro?», chiede. Siamo seduti tutti e quattro allineati, al terminal. «Altri sedativi», replica. «Tranquillanti più forti». Lui si rilassa, prende il giornale che qualcuno ha dimenticato. «Non ci sono rischi?», chiedo. «Per il…». «Per il bambino», Mia finisce la frase senza scomporsi. Non ero riuscita a pronunciare la parola. «Ecco», dico, umiliata dal fatto che lei ci sia riuscita. «Non ce ne sono», ci rassicura la dottoressa. «Almeno per una somministrazione. Ma suggerirei di non assumerlo spesso durante la gravidanza». Mia ingoia la pastiglia con un sorso d’acqua, poi aspettiamo. Quando annunciano il nostro volo, è pressoché assopita. Voleremo fino a Minneapolis-St. Paul, scalo con sosta di tre quarti d’ora, prima di proseguire per Duluth, Minnesota, dove un amico di Gabe, l’ispettore Roger Hammill, ci accompagnerà in auto fino a Grand Marais. Gabe dice che è un suo amico, ma colgo una nota di scherno nella sua voce quando parla di questo detective. L’aereo decolla presto, alle nove di mattina, e sale verso un cielo terribilmente freddo: sappiamo che sarà una giornata lunghissima. L’unica cosa positiva è che Mia dorme. Io sono seduta al suo fianco. Lei è vicina all’oblò, io ho il posto lungo il corridoio. Dall’altra parte dello stretto passaggio c’è Gabe, che un paio di volte mi rassicura toccandomi il braccio e chiedendomi se è tutto okay. Di fianco a lui c’è la dottoressa Rhodes, persa in un audiolibro, con le cuffie che le tappano le orecchie. Il resto dei passeggeri non fa caso a noi. Confabulano, s’intrattengono sul tempo che fa, sulle condizioni della neve per gli sciatori, sui voli in coincidenza che non devono perdere. Una donna recita il Padre Nostro mentre l’aereo decolla, poi prega affinché l’atterraggio avvenga in tutta sicurezza. Tiene il rosario fra le mani tremanti. Il comandante annuncia che sarà un volo pieno di turbolenze e ci invita quindi a restare seduti. Mia si risveglia prima dell’atterraggio a Minneapolis, ma l’agitazione la sconvolge di nuovo. Domando alla psichiatra quando dovrà assumere altri farmaci, ma lei consiglia di attendere; Mia dev’essere lucida per tutto il pomeriggio. Mentre aspettiamo la nostra coincidenza, Gabe le passa il suo iPod, scegliendo la musica più gradevole per attutire gli altri rumori. Mi chiedo cosa succederà quando arriveremo. Mi basta pensarci per sentirmi male. Rivedo la reazione di Mia davanti al gatto. Come si comporterà nel momento in cui scopriremo il sito in cui è stata relegata per tutto quel tempo? Da quando è tornata a casa, ha fatto progressi; li dimenticherà? Chiedo permesso perché devo andare al bagno, così la Rhodes va a sedersi al mio posto, per non lasciare sola Mia. Uscendo dal gabinetto, vedo che Gabe mi aspetta. Mi lancio verso di lui, che mi sostiene e mi dice: «Tutto questo molto presto sarà finito. Fidati». Mi fido. A Duluth un uomo che si presenta come ispettore Hammill ci scorta fino alla monovolume del distretto di polizia. Gabe lo chiama Roger. Mia si dice lieta di conoscerlo, sebbene l’ispettore mi avverta che non è la prima volta che si vedono. È un uomo con una pancia incredibile, avrà la mia età ma sembra molto più anziano, il che mi ricorda che anch’io invecchio giorno dopo giorno. All’interno della monovolume è appesa con lo scotch la foto di sua moglie: una bionda decisamente obesa, circondata da una mandria di monelli. Ne hanno sei, uno più grasso e corpulento dell’altro. Io, Mia e la dottoressa scivoliamo sul sedile posteriore, mentre Gabe si mette di fianco a Roger. Mi hanno invitato a sedermi davanti, ma sono felice di rifiutare: non mi sentivo all’altezza di due chiacchiere informali col guidatore. Il tragitto supera le due ore. Gabe e Hammill si perdono in ciance oziose sul mestiere di poliziotto. Cercano di surclassarsi a vicenda, e intuisco subito che l’ispettore non va d’accordo con il collega. La sua voce è poco amichevole, talvolta le risposte sono brusche, anche se restano sul livello di una certa educazione, per rispetto di noi donne. Cerca di rivolgere la parola a me o a Mia più del nostro guidatore, e per il resto del percorso rimaniamo in silenzio, mentre Hammill si lancia in un soliloquio sui Timberwolves, che quest’anno hanno battuto due volte i Chicago Bulls. Non conosco lo sport professionistico, pallacanestro inclusa. Gran parte del viaggio si dipana sulla Highway 61, un lungo tratto costeggia il Lago Superiore. Mia tiene gli occhi fissi sull’acqua. Mi chiedo se abbia già visto quel posto. «Qualcosa di familiare?», Gabe le chiede spesso. Le pone gli interrogativi che io non ho mai il coraggio di rivolgerle. In precedenza, la psichiatra gli aveva detto di non curiosare con troppa insistenza. Gabe le aveva risposto che doveva portare a termine il suo lavoro; mentre quello della dottoressa consisteva nel raccogliere i pezzi dopo che erano caduti. «Tenuto conto che la distanza minore fra due punti è una linea retta», dice Hammill rivolgendosi a Mia dallo specchietto retrovisore, «avrebbe dovuto percorrere questa strada». Superiamo Grand Marais e imbocchiamo un tracciato chiamato Gunflint Trail. Hammill è una miniera di informazioni, sebbene poche cose di quel che dice mi siano nuove, dato che da quando è tornata Mia ho memorizzato ogni dettaglio di questa strada secondaria nelle mie notti insonni. Proseguiamo su una stradina a due corsie, addentrandoci nella Superior National Forest, siamo attorniati da più vegetazione di quanto abbia mai visto. Ormai il verde è quasi scomparso, sepolto sotto cumuli di neve; riemergerà con la primavera. Le piante sempreverdi accolgono la neve tra i loro aghi, sembrano crollare sotto il suo peso. Proseguendo il viaggio, noto che mia figlia assume una postura più rigida, i suoi occhi sono in maggiore sintonia con l’ambiente esterno, non ha più lo sguardo vitreo che le avevo visto recentemente; ora ha una consapevolezza che attesta il suo interesse. La dottoressa Rhodes la istruisce negli esercizi di visualizzazione e in un’affermazione positiva da reiterare: «Posso fare questo». Mi sembra di sentire James, che la sbeffeggiava per le sue tecniche irrazionali. «Riconosce qualcosa, adesso?», Gabe chiede a Mia girandosi sul sedile. Lei scuote la testa. È pomeriggio inoltrato, le tre, forse le quattro, il cielo si sta già oscurando; abbondano le nuvole. Sebbene il riscaldamento dell’auto sia sempre accesso, mi si cominciano a intirizzire mani e piedi. Il riscaldamento non regge la competizione con la temperatura esterna, abbondantemente sotto zero. «È stata fortunata a uscirne al momento giusto», dice Hammill a Mia. «Non sarebbe sopravvissuta all’inverno». Il pensiero mi fa rabbrividire. Se Colin Thatcher non l’avesse uccisa, lo avrebbe fatto Madre Natura. «Ah», bofonchia Gabe per alleggerire l’atmosfera. Nota qualcosa in me che non gli piace affatto. «Ma forse Mia ti stupirebbe, lei è una che non si arrende. Giusto?», dice facendole l’occhiolino. Poi muove solo le labbra senza proferire parola: Questo puoi farlo. Nel frattempo, le gomme della monovolume si fermano su un mucchio di neve e ci ritroviamo di fronte a uno squallido capanno in tronchi di legno. Lei ha visto le fotografie. Tante volte l’ho ritrovata quasi addormentata a fissare le immagini del capanno o gli occhi vacui di Colin Thatcher, ma sembrava che non vedesse niente. Adesso però vede qualcosa. L’ispettore Hammill apre la portiera e Mia esce dal veicolo come se fosse attirata da un magnete, per cui devo fermarla. «Aspetta, prendi il cappello», dico, «anche la sciarpa», perché qui si gela talmente che basta l’aria per ghiacciare la pelle. Lei pare invece del tutto inconsapevole del freddo, così che devo costringerla a indossare i guanti, come se avesse ancora cinque anni. Il suo sguardo è calamitato dal capanno, dai pochi gradini che conducono dal sentiero innevato a una porta, davanti alla quale è stato messo un nastro di sbarramento giallo. I gradini sono coperti di neve, ma si notano ancora delle impronte, e le tracce degli pneumatici sul vialetto d’accesso indicano che qualcuno è rimasto lì fino all’ultima nevicata. La neve ammanta ogni cosa: il tetto, l’ambiente spoglio attorno alla casupola. Mi chiedo come si sentisse Mia arrivando in questo posto, che è così remoto da far pensare di essere gli ultimi abitanti sulla Terra. Se ci penso, mi vengono i brividi. C’è il lago che ho visto nei suoi disegni, che si sarà ghiacciato chissà quante volte, è improbabile che avvenga il disgelo, se non a primavera. Sono tanto sgomenta da queste sensazioni di solitudine e disperazione da non accorgermi che Mia sale i gradini con grande familiarità, come se fosse a suo agio. Il primo a raggiungerla è Gabe, che si offre di aiutarla. I gradini sono bagnati e scivolosi, occorre fare attenzione. Arrivati in cima, aspettano che Hammill apra la porta. Io e la dottoressa seguiamo a poca distanza. L’ispettore spinge la porta e la sentiamo cigolare. Tutti noi ci affanniamo a lanciare un’occhiata dentro, ma è Gabe, con la sua buona creanza, a dire a Mia: «Prima le signore», sebbene sia lui a mettersi subito alle sue spalle. Gabe Vigilia di Natale Da qualche parte nel Minnesota, comincia a nevicare. Guido il più velocemente possibile, ma non è abbastanza. Non è agevole vedere dal parabrezza, malgrado i tergicristalli si spostino rapidissimi. Questo è il sogno di ogni bambino: la neve il giorno della vigilia per un bianco Natale. Staserà arriverà Babbo Natale, coi regali sulla slitta da distribuire a tutti i bimbi e le bimbe. Telefona l’ispettore Hammill. Ha un paio di agenti che tengono sotto sorveglianza il capanno. Me l’ha detto, è una casupola persa nei boschi. Però non hanno visto nessuno arrivare o andarsene, né hanno notato movimenti di persone all’interno. Nel frattempo, ha deciso di riunire una squadra per circondare il luogo: una decina dei suoi uomini migliori. Un affare grosso, da queste parti non è roba di tutti i giorni. Penso a Eve. Ripeto mentalmente mille volte le cose da dirle, la parole da usare per darle la splendida notizia. Ma poi realizzo che le notizie potrebbero essere negative, che Mia magari non si trova nel capanno, o che potrebbe non sopravvivere al tentativo di salvataggio. Possono andare storte un milione di cose. Quando raggiungo la costa del Lago Superiore, i ragazzi di Roger diventano inquieti. Ne ha sguinzagliato un gruppetto in mezzo ai boschi. Delimitano la zona. Sono armati con la massima potenza di fuoco che può sfoggiare il distretto. Hammil si sente in missione. Sembra che abbia qualcosa da dimostrare. «Nessuno spari un colpo finché non entro lì», dico mentre accelero a tutto gas su una strada stretta e innevata. Le gomme slittano, faccio fatica a recuperare il controllo dell’auto. Sono spaventato a morte. Ma la cosa che mi preoccupa di più è la boria di Hammill. Lui, ancor più di me, è uno ligio al senso del dovere, con la possibilità di sfoderare una pistola. «Hoffman, è la vigilia di Natale, e i miei ragazzi hanno una famiglia da rivedere». «Sto facendo il possibile». Tramonta il sole, adesso è buio. Sono a tavoletta. Attraverso gli stretti passaggi, i rami potrebbero svellermi il tetto dell’auto, da quanto pendono appesantiti dalla neve. Parecchie volte rischio di impantanarmi perché le ruote scivolano, slittano, non mi permettono di procedere. Quest’auto schifosa sarà la mia rovina. Vado più veloce che posso, so che devo mettere le mani su Colin Thatcher prima che lo faccia Hammill. Impossibile prevedere ciò che farà quell’individuo. Colin Vigilia di Natale Questo pomeriggio sono tornato in città per telefonare a Dan. È tutto pronto, si può procedere. Ci vedremo il 26 a Milwaukee, è il meglio che possa fare. Lui non poteva arrivare in auto fino a Grand Marais. Lo aveva messo subito in chiaro. È il mio regalo di Natale per lei, una sorpresa per la festa di domani. Ce ne andremo al tramonto e viaggeremo per l’intera nottata, è la maniera meno rischiosa. Suggerisco di incontrarci allo zoo. Un bel luogo pubblico, aperto anche per le feste natalizie. Ci ho pensato mille volte. Ci fermeremo nel posteggio. Lei si nasconderà dietro al recinto dei primati, io incontrerò Dan davanti a quello dei lupi. La riprenderò quando lui se ne sarà andato e sarò certo che nessuno ci sta pedinando. Di lì la strada più rapida per arrivare in Canada passa per Windsor, nell’Ontario. Ci arriveremo e poi ci spingeremo il più lontano possibile, in base al rifornimento di benzina che potremo fare coi soldi rimasti. Per adesso bastano. Dopo, quando saranno finiti, vivremo sotto pseudonimo. Mi troverò un lavoro. Ho commissionato a Dan un’identità falsa anche per la mamma e, quando sarà possibile, gliela farò avere. Dovrò risolvere pure questo aspetto. Questa sarà l’ultima notte nel capanno. Lei non lo sa. Sto già dicendo segretamente addio alle cose. Domani sarà Natale. Ricordo che da ragazzino il 25 dicembre uscivo presto la mattina. Prendevo un dollaro e due centesimi dagli spiccioli che tenevamo in un salvadanaio e arrivavo fino alla panetteria all’angolo della strada, aperta fino a mezzogiorno. Fingevamo che fosse una sorpresa, ma non lo era mai. La mamma restava a letto finché non mi sentiva rientrare di soppiatto. Non andavo mai direttamente in panetteria. Ero molto curioso, guardavo dalle finestre aperte gli altri bambini del quartiere, volevo vedere cosa avevano ricevuto come regalo. Fissavo per un attimo i loro volti felici e sorridenti, poi calpestavo stancamente la neve e, lungo la strada, pensavo: Affanculo tutti. I campanellini delle renne alla porta sulla panetteria annunciavano la mia entrata alla signora incartapecorita che ci lavorava da sempre. Indossava il cappellino rosso di Babbo Natale e diceva: «Oh, oh, oh». Le chiedevo due paste al cioccolato da cinquantuno centesimi, e lei me le metteva in un sacchettino bianco di carta. Tornavo a casa, dove la mamma preparava due tazze di cioccolata calda e consumavamo la nostra colazione, fingendo che non fosse Natale. Fisso fuori dalla finestra. Penso a mia madre, sperando che stia bene. Domani sarà la prima volta in più di trent’anni che non mangiamo insieme uno di quei dolci al cioccolato del 25 dicembre. Se riesco a recuperare carta e penna, le scriverò un biglietto e lo lascerò in una buca delle lettere di Milwaukee. Le dirò che Chloe sta bene, così quegli sfigati dei suoi genitori si metteranno l’anima in pace, se gliene frega qualcosa. Quando il biglietto sarà recapitato, noi saremo già fuori del Paese. E non appena saprò come risolvere la questione, riuscirò a far espatriare anche la mamma. Chloe mi abbraccia da dietro, chiede se sto aspettando Babbo Natale. Penso a cosa cambierei, se potessi, ma non cambierei nulla. L’unico rimpianto è non avere con me anche la mamma. Ma non avrei potuto farlo senza mettere in p e r i c o l o questo. Un giorno ci riuscirò. Così scaccio anche il mio senso di colpa. Non so come o quando. Mica è facile procurarsi un’identità falsa per mia madre senza che mi scoprano, e nemmeno mandarle denaro sufficiente per un volo. Ma un bel giorno… Mi volto e la prendo in braccio, in tutti i suoi quarantacinque chili. Ha perso peso, i pantaloni le cadono dai fianchi. Se li risistema sempre per non farli scivolare. Guance incavate, occhi che perdono brillantezza. Così non può durare. «Sai cosa voglio quest’anno per Natale?», domando. «Cosa?» «Un rasoio», dico. Mi pettino barba e baffi con le dita. Li odio. Mi fanno schifo. Penso a tutto ciò che migliorerà quando saremo fuori da questo Paese. Non sentiremo più freddo, perdio. Ci faremo la doccia con sapone vero. Potrò radermi i peli sulla faccia. Potremo uscire nel mondo, insieme. Non dovremo nasconderci, anche se ci vorrà un’eternità prima di sentirsi al sicuro. «Mi piace», scherza lei sorridendo. Quando ride, tutte le tessere tornano al loro posto. «Bugiarda», l’accuso. «Allora ne ordineremo due», dice, facendomi sfiorare la peluria sulle sue gambe. «E tu cosa vuoi come regalo da Babbo Natale?», chiedo. «Niente», dice d’impulso. «Ho tutto quel che mi serve». Appoggia la testa sul mio petto. «Bugiarda», ripeto. Si tira indietro e mi guarda. Ciò che vuole, dice, è apparire bella e graziosa. Per me. Farsi una doccia, profumarsi. «Sei già bellissima», dico, e lo penso davvero. Ma lei mi dà del bugiardo. Afferma di non essersi mai sentita così brutta in vita sua. Le prendo il viso tra le mani. È imbarazzata, cerca di sottrarsi, ma la costringo a guardarmi. «Sei molto carina», ribadisco. Annuisce. «Va bene, va bene», si arrende e poi mi accarezza la barba. «E a me piace la tua barba». Ci fissiamo per un attimo. «Un giorno», le prometto, «potrai profumarti e tutto il resto». «Okay». Elenchiamo le cose che faremo un bel giorno. Usciremo a cena, andremo al cinema. Tutte le cose che il resto del mondo fa ogni santo giorno. Dice di essere stanca e si ritira nella stanza da letto. So che è triste. Parliamo del futuro, ma dentro di sé è convinta che non esisterà mai un’eventualità simile. Raccolgo le nostre cose, cerco di essere silenzioso. Le accantono sul bancone, le sue matite e il quaderno da disegno, quel che resta dei soldi. Bastano due minuti per mettere assieme le cose che contano. In fondo, ho bisogno solo di lei. Poi, per la noia, con un coltello affilato incido le parole SIAMO STATI QUI sul piano di lavoro della cucina. Poco spazio tra le lettere, tutt’altro che un capolavoro. Appoggio il mio giaccone sull’incisione, così lei la vedrà solo al momento della partenza. Ricordo la prima notte passata nel capanno. Siamo stati qui, penso, ma adesso che ce ne andiamo siamo diversi. Osservo il tramonto. La temperatura all’interno precipita. Alimento il fuoco con altra legna. Guardo i minuti scorrere sull’orologio. Quando ormai la noia sta per uccidermi, comincio a preparare la cena. Minestrina in brodo di pollo. Mi riprometto che questa è l’ultima volta che mangerò questa sbobba. È allora che sento il rumore. Eve Dopo Mia è stata già qui. Se ne rende conto immediatamente. Dice che c’era un albero di Natale, ora non c’è più. Nella stufa scoppiettava sempre il fuoco, ma ora tutto tace. C’era un odore molto differente da quello attuale, adesso si sente solo la puzza pungente della candeggina. Dice di vedere delle immagini: barattoli di minestra sul piano di lavoro e nella dispensa, anche se ormai non ci sono più. Sente il rumore dell’acqua che scorre dal rubinetto, il fracasso delle scarpe pesanti sul pavimento di legno; noi restiamo in silenzio, la fissiamo come falchi, con la schiena appoggiata contro una parete di tronchi. «Sento la pioggia cadere sul tetto», dice, «e vedo Canoa zampettare da una stanza all’altra». Segue con gli occhi il percorso immaginario, dalla stanza alla camera da letto, come se stesse davvero osservando il gatto, mentre noi sappiamo di averlo lasciato in custodia ad Ayanna e a suo figlio. Poi dice di udire il suo nome. «Mia?», chiedo con un filo di voce, ma lei scuote la testa. No. «Chloe», mi ricorda, si posa una mano sul lobo dell’orecchio e sorride: ora tutto il suo corpo è in pace, per la prima volta dopo tanto tempo. Ma il sorriso si spegne presto. Colin Vigilia di Natale Mia madre diceva che ho un udito finissimo, come un pipistrello, non mi sfugge niente. Non capisco cosa sia il rumore, però mi fa balzare in piedi. Spengo l’interruttore della luce e il capanno piomba nell’oscurità. In camera da letto, Chloe comincia ad agitarsi, cerca di orientarsi al buio. Mi chiama. Siccome non rispondo subito, insiste. Adesso ha paura. Scosto la tenda dalla finestra. È la debole luce lunare a permettermi di scorgere qualcosa. Ce ne saranno quasi una decina, di auto della polizia, e almeno il doppio di agenti. «Maledizione». Lascio la tenda, mi affretto a chiamarla. «Chloe, Chloe». Lei salta su dal letto, una scarica di adrenalina le percorre il corpo mentre si risveglia a fatica. La strappo dal letto, portandola verso la parte della stanza senza finestre. Piano piano diventa del tutto cosciente. Mi afferra una mano, mi conficca le unghie nella pelle. Sento che trema. «Cosa succede?», chiede con voce esitante. Le lacrime le scendono dagli occhi. Sa cosa sta andando storto. «Sono arrivati», dico. «Dannazione», geme. «Dobbiamo scappare!». Scivola via da me e corre verso il bagno. Immagina che possiamo squagliarcela dalla finestra, che sia possibile fuggire in qualche modo. «Non ce la faremo», dico. La finestra è bloccata, non si aprirà mai. Lei ci prova lo stesso. La afferro per trascinarla via. Il mio tono è calmo: «Non possiamo fuggire da nessuna parte». «Allora resisteremo», propone. Mi passa davanti. Cerco di evitare le finestre, anche se il buio all’interno del capanno ci rende invisibili. Lei piange, afferma di non voler morire. Tento di spiegarle che sono i poliziotti, i maledetti poliziotti, ma non ascolta le mie parole. Ripete all’infinito di non voler morire. Lacrime copiose sulle sue guance. Crede che sia Dalmar. Non riesco a pensare con chiarezza. Scruto dalla finestra, le ripeto che non possiamo fuggire da nessuna parte. Non è possibile scamparla. Sono troppi. Non funzionerà mai. Peggioreremmo soltanto le cose. Lei prende comunque la pistola nel cassetto. Sa come usarla. La prende, seppur con mani tremanti. Inserisce il caricatore. «Chloe», dico con tenerezza, la mia voce è un sussurro. «Non servirà a niente». Lei mette il dito sul grilletto. Regge l’arma con entrambe le mani. La tiene stretta. «È finita, Chloe». «Per favore», implora. «Dobbiamo combattere. Non possiamo lasciare che finisca così». È frenetica, folle. Isterica. Io sono stranamente calmo. Forse perché sapevo che prima o poi saremmo giunti a questo punto. Comunichiamo senza bisogno di parole. La guardo negli occhi, pesti e sconfitti. Piange, le cola il naso. Non so quanto tempo trascorra. Dieci secondi, o dieci minuti. «Lo faccio da sola», dice, ormai esasperata. È furibonda perché non lo faccio io al posto suo. Vedo che la pistola le trema nelle mani. Non ci riesce. E se ci prova, finirà per uccidersi. «Ma la tua mira…». Non dice nulla. Interpreto la sua espressione: sfiducia, disperazione. «Non importa», esclama dopo un po’. «Lo farò da sola». Ma non glielo consento. «Va bene», dico, e mi allungo per toglierle l’arma di mano. Non posso permettere che finisca così. Non con lei che mi supplica di salvarle la vita, e io che mi rifiuto di farlo. Le luci dei proiettori illuminano il capanno. Ci accecano. Siamo davanti alla finestra, completamente esposti. Io ho la pistola in mano. Ho lo sguardo fermo, lei invece ha gli occhi spalancati dalla paura. La luce la fa sussultare e cadere su di me. Faccio un passo in avanti per occultarla alla vista. Alzo una mano per coprire la luce. La mano con l’arma. Gabe Vigilia di Natale Mi chiama Hammill per dire che i suoi uomini li hanno individuati. «Cosa significa?», chiedo. «Ci ha sentiti». «Potete vedere bene?», chiedo. «Sì, è sicuramente lui», replica. «È Thatcher». «Che nessuno spari», ordino. «Che nessuno si muova finché non arrivo io. Mi hai capito?». Lui risponde di sì, ma so che dentro di sé non gliene frega un cazzo. «Ho bisogno di prenderlo vivo», aggiungo, però adesso non mi sente. Ci sono interferenze sulla linea, mi pare che Hammill sia lontanissimo. Dice che ha con sé i cecchini migliori. Cecchini? «Che nessuno spari», ripeto all’infinito. Mettere le mani su Thatcher per me sarebbe come svolgere solo la metà del mio compito, l’altra metà consiste nel trovare chi lo ha ingaggiato. «Evitate il fuoco. Di’ ai ragazzi di non sparare». Hammill è troppo impegnato ad ascoltare il suono della propria voce, non mi presta la minima attenzione. Dice che è buio dentro il capanno, anche se hanno i visori notturni. Riescono a scorgere la ragazza, che appare terribilmente impaurita. Dopo una pausa, Hammill aggiunge: «Hanno una pistola», e io sento un tuffo al cuore. «Che nessuno spari», ripeto mentre comincio a vedere il capanno, nascosto tra gli alberi. Avranno parcheggiato una marea di auto, lì davanti. Ci si può meravigliare che Colin li abbia sentiti? «Ha la ragazza con sé». Una piccola derapata sulla neve mi induce a fermarmi, consapevole che non è più possibile procedere. «Sono qui!», urlo al telefonino. Affondo i piedi nella neve sporca. «Lui ha una pistola». Abbandono il cellulare e continuo a correre. Li vedo allineati dietro le auto, tutti aspettano il primo sparo. «Che nessuno spari», grido quando il rumore sordo di un colpo mi costringe ad arrestarmi di botto. Eve Dopo Non sono sicura di quel che mi aspettavo quando siamo tornati al capanno. All’aeroporto avevo elencato a Gabe tutte le prospettive peggiori che potessi concepire: Mia che non ricordava nulla, settimane di psicoterapia vanificate, e la definitiva perdita di autocontrollo da parte sua. La guardiamo tutti mentre perlustra l’interno della casupola, una baracca in mezzo ai boschi del Minnesota. Fa scorrere lo sguardo su ogni cosa. Non ci vuole molto prima che i ricordi la travolgano, e mentre Gabe le chiede per l’ennesima volta: «Mia, ricorda qualcosa?», capiamo di dover fare attenzione alle domande che le poniamo. Il suono che sento uscire dalla bocca di mia figlia non l’avevo mai udito prima, sembra analogo a quello degli animali agonizzanti. Lei cade in ginocchio in mezzo alla stanza. Urla, emette versi incomprensibili. Singhiozza, scoppia in un pianto dirotto e selvaggio di cui non la credevo capace, e a quel punto mi metto a gemere anch’io. «Mia, tesoro», mormoro, desiderando solo di poterla abbracciare. La dottoressa Rhodes mi consiglia invece di essere prudente. Mi trattiene con una mano, impedendomi di consolarla. Gabe si avvicina e ci dice piano che in quel punto del pavimento, dove si è chinata Mia in preda alle convulsioni, era stato trovato, meno di un mese prima, un corpo insanguinato. Coi suoi begli occhi azzurri, Mia si rivolge angosciata all’ispettore e lo investe: «L’ha ucciso, l’ha ucciso lei», non la smette di ripeterlo. Piange, delira, è isterica, afferma di vedere il sangue che sgorga a fiotti dal corpo e penetra nelle fessure del pavimento. Rivede il gatto che fugge, lasciando tracce delle sue impronte insanguinate in tutta la stanza. Sente il colpo che spezza il silenzio della stanza, e sussulta. Rivive quel momento fatidico, percepisce il rumore dei vetri infranti a terra. Dice che lo vede cadere. Vede il suo corpo diventare flaccido e cadere a terra. Ricorda i suoi occhi spenti, il suo corpo disteso in modo innaturale, sghembo. Lei aveva il sangue sulle mani e sui vestiti. «C’è sangue dappertutto», singhiozza disperata, toccando il pavimento. La Rhodes sostiene che si tratta di un episodio di psicosi. Scosto la dottoressa per andare a consolare mia figlia. Quando sono quasi su di lei, Gabe mi abbraccia per fermarmi. «Dappertutto. Sangue rosso ovunque. Svegliati!». Mia schiaffeggia il pavimento e poi raccoglie le ginocchia al petto, cominciando a dondolarsi furiosamente. «Svegliati! Dio mio, per favore. Non lasciarmi». Gabe Vigilia di Natale Non sono il primo a entrare nel capanno. Localizzo il faccione di Hammill tra la folla. Lo prendo per il bavero e gli chiedo cosa cazzo è successo. Normalmente potrebbe prendermi a calci in culo, se volesse. Ma questo non è un giorno come gli altri, oggi sono un ossesso. «Stava per ucciderla». Dichiara che Thatcher non gli aveva lasciato scelta. «Questo lo dici tu». «Sei fuori della tua giurisdizione, coglione!». Un agente di diciotto o diciannove anni, con l’aria di chi vuole fare carriera, esce dal capanno e dice: «Quel bastardo è morto», e Hammill alza il pollice in segno di assenso. Qualcuno applaude, dev’essere il cecchino, un giovanotto troppo stupido per riflettere. Mi ricordo di quando avevo vent’anni, l’unica cosa che mi interessava era mettere le mani su un’arma. Oggi il pensiero di usarla mi spaventa a morte. «Che problema c’è, Hoffman?» «Lo volevo vivo». Stanno tutti entrando nella casupola. Un’ambulanza si fa strada fra la neve, le sirene ululano, osservo le luci rosse e azzurre alternarsi nel buio della notte. Gli infermieri si affannano, scaricano una barella e faticano a farla procedere sulla neve. Hammill segue i suoi agenti all’interno. Si fiondano sui gradini e varcano la porta. I proiettori illuminano l’ambiente, finché qualcuno non è tanto saggio da accendere la luce. Trattengo il respiro. Non ho mai incontrato Mia Dennett. Dubito che lei abbia mai sentito il mio nome. Non sa assolutamente che, da tre mesi, l’unico pensiero che ho è per la sua situazione, che è sua la faccia che vedo tutte le mattine quando mi sveglio e tutte le sere quando mi metto a dormire. Mia esce dal capanno scortata da Hammill, che la stringe talmente forte da farla sembrare ammanettata. È coperta di sangue: mani e vestiti, perfino sui capelli. Le ciocche bionde sono screziate di rosso. È pallida, cadaverica per lo spavento, livida sotto l’odiosa luce del proiettore, che nessuno ha avuto la grazia di spegnere. È un fantasma, uno spettro, l’espressione del suo volto è vuota. La luce è accesa, ma dentro non c’è nessuno. Le si ghiacciano le lacrime sulle guance mentre scende i gradini e Hammill la lascia libera di reggersi da sola. «Prima me ne occupo io», dice allontanandola da me. Gli occhi di lei mi guardano di sfuggita. Io ci vedo Eve trent’anni fa, prima di James Dennett, di Grace e di lei, prima di me. Figlio di puttana. Se non temessi di spaventare Mia, lo prenderei a calci nel sedere. Non mi piace il modo in cui la tocca. Dentro il capanno vedo il corpo di Colin Thatcher disteso in modo scomposto. Un paio di volte, quando ero agente della stradale, avevo dovuto estrarre un cadavere da un’auto incidentata. Non è possibile descriverlo. La sensazione della carne morta: il freddo e la rigidità nel momento in cui l’anima se ne va. Gli occhi, aperti o chiusi, senza vita. Quelli di Colin sono aperti. La sua carne è fredda. Mai visto tanto sangue. Gli abbasso le palpebre e dico: «Piacere di incontrarti, finalmente, Colin Thatcher». Penso a Kathryn, sua madre, in quello schifoso ricovero per anziani. Immagino l’espressione del suo viso segnato dalla malattia quando le darò la notizia. I colleghi di Hammill si stanno già attivando: fotografie della scena del crimine, impronte digitali, raccolta delle prove. Non so cosa pensare di questo posto. Un locale inadatto a viverci, come minimo. C’è puzza. Non so cosa mi aspettassi. Uno schiacciatesta o uno spaccaginocchia da torture medievali? Catene e mazzafrusto? O le manette, se non altro? Ciò che vedo è un locale brutto, con un fottuto albero di Natale. Il mio appartamento è comunque peggio. «Guarda qui», dice qualcuno facendo cadere a terra un parka. Mi accosto coi crampi alle gambe. Sulla formica hanno inciso le parole SIAMO STATI QUI. «Cosa ne deduci?». Faccio scorrere le dita sulla scritta. «Non so». Hammill entra nel capanno. La sua voce è così forte da resuscitare i morti. «È tutta per te», mi dice mentre assesta un calcio a Thatcher, non si sa mai. «Cosa dice?», chiedo per amor di conversazione. Non me ne frega niente di quel che ha detto a lui. «Sbrigatela da solo», sbraita. Nel suo tono c’è qualcosa che suscita il mio interesse. Ostenta il suo sorriso arrogante (so qualcosa che tu non sai) e aggiunge: «È buono». Mi chino su Thatcher per dargli un’ultima occhiata. Giace senza vita sul pavimento di legno, non ci sono dubbi. «Che cosa hai fatto?», chiedo piano, poi mi precipito fuori. Lei è seduta nell’ambulanza, un’infermiera se ne sta occupando. Le hanno messo sulle spalle una coperta di lana. Vogliono assicurarsi che nessuna goccia di tutto quel sangue sia sua. Adesso l’ambulanza ha smesso di ululare, luci e sirene sono spente. Però c’è il rumore delle persone che parlano, qualcuno ride. Mi avvicino. Lei guarda nel vuoto, lascia che l’infermiere la visiti, sebbene rabbrividisca ogni volta che viene sfiorata. «È freddo qui fuori», dico per attirare la sua attenzione. Ha i capelli che le coprono il volto, occultandole la visuale. Ha un’espressione ineffabile, non riesco a decifrarla. Del sangue secco (o congelato?) le inzacchera la pelle. Il muco le cola dal naso. Prendo dalla tasca un fazzoletto e glielo metto in mano. Non mi sono mai preoccupato tanto per una persona che non conosco. «Dev’essere sfinita, questa è stata un’odissea. La riporteremo a casa. Presto, glielo prometto. Conosco qualcuno che non vede l’ora di sentire la sua voce. Io sono l’ispettore Gabe Hoffman, la stavamo cercando da tempo». Mi è impossibile credere che è la prima volta che ci vediamo. Mi pare di conoscerla meglio della metà dei miei amici. Alza gli occhi e mi guarda per mezzo secondo, poi si accorge del sacco vuoto di plastica per cadaveri che stanno prendendo. «Non ha bisogno di guardare», dico. Ma il problema non è il sacco in sé. È lo spazio. Lei ha lo sguardo perso nel vuoto. L’ambiente pullula di persone che vanno e vengono. Perlopiù sono uomini, c’è solo una donna. Parlano dei progetti per il Natale: la messa e la cena coi parenti acquisiti, il dover rimanere alzati fino a tardi per aspettare l’arrivo del giocattolo che la moglie ha comprato online. Tutte cose che vanno fatte. In qualsiasi altro caso mi sarei congratulato («dammi il cinque!») per il lavoro portato a termine, ma questo non è un caso qualunque. «L’ispettore Hammill le ha fatto alcune domande. Anch’io ne avrei qualcuna, ma posso aspettare. So che non è stato facile… per lei». Mi viene in mente di accarezzarle i capelli o darle una pacca su una mano, di fare un gesto semplice per riportarla in vita. Ha lo sguardo perso. Appoggia la testa sulle ginocchia piegate, non profferisce parola. Non piange. Ma questo non mi sorprende, visto che è sotto shock. «So che per lei è stato un incubo. Anche per la sua famiglia. Tante persone si sono preoccupate. La riporteremo a casa in tempo per il Natale. Lo prometto», dico. «Ce la riporterò io direttamente». Non appena me ne daranno l’autorizzazione, io e Mia faremo il lungo viaggio in auto fino a casa, dove Eve l’aspetterà a braccia aperte, davanti alla porta. Prima però dovremo fermarci nell’ospedale più vicino per un esame completo. Spero che nessun giornalista sia stato avvisato, di non vedere l’assembramento dei cronisti nel parcheggio dell’ospedale, coi loro microfoni e le videocamere, e la raffica di domande. Lei non apre bocca. Penso di chiamare Eve al cellulare e di lasciare che sia la stessa Mia a comunicarle la buona notizia. Mi caccio le mani in tasca, ma dov’è il mio telefonino? Maledizione, troppe cose contemporaneamente. Lei non è pronta, però Eve sta sulle spine, attende mie notizie. Presto. «Cos’è successo?», chiede finalmente con voce flebile Mia. È ovvio, penso. È successo tutto così in fretta. Cerca di dare un senso al tutto, se ci riesce. «Lo hanno beccato», dico. «È tutto finito». «Tutto finito». Le parole escono di bocca pesanti e scivolano sulla neve. Si guarda attorno. Osserva tutto come se fosse la prima volta. Forse è la prima volta che esce dal capanno? «Dove sono?», sussurra. Scambio un’occhiata con l’infermiera, che si stringe nelle spa lle. Be’, penso, questo è più affar suo che mio. «Mia», ritento. La seconda volta che pronuncio il suo nome, mi appare stordita. Lo ripeto per la terza volta, perché non mi vengono altre parole. Cos’è accaduto? Dove sono? Queste erano le domande che pensavo di porre io a lei. «Non mi chiamo così», dice a bassa voce. L’infermiera mette via i suoi strumenti. Vuole che la controlli un medico, anche se per il momento la trova in buono stato. Ci sono segni di malnutrizione, ferite in corso di guarigione, ma niente che sia un rischio vitale immediato. Deglutisco. «È il suo nome, lei si chiama Mia Dennett. Non ricorda?» «No». Scuote la testa. Il fatto non è che non ricordi, ma che è certa che mi sbagli. Mi si avvicina, come se volesse rivelarmi un segreto: «Mi chiamo Chloe». L’ispettore Hammill ci passa davanti e pronuncia una frase odiosa: «Te l’avevo detto che era buono». Sogghigna mentre abbaia ordini ai suoi sottoposti: «Sbrigatevi, così finiamo in tempo». Gabe Dopo Alloggiamo in un albergo di Grand Marais, una specie di locanda tradizionale sul Lago Superiore, sulla cui insegna vistosa si vantano di offrire gratis la colazione continentale. Non c’è volo di ritorno fino alla mattina seguente. La dottoressa Rhodes ha dato a Mia un sedativo che l’ha messa al tappeto. La porto io nel letto matrimoniale della stanza che divide con Eve. Noi rimaniamo nella hall a parlare un po’. Eve è un fascio di nervi. Sapeva che era un errore farlo. Si spinge quasi a darmi la colpa, riuscendo a fermarsi in tempo. «Prima o poi la cosa sarebbe affiorata», decide infine, sebbene io non sappia dire se ci creda davvero o se voglia tranquillizzarmi. Più tardi le spiegherò come stanno le cose, cioè che non era stato Colin Thatcher a ideare il sequestro di Mia. C’è qualcuno, ancora in libertà, che la sta cercando, per cui occorre che sua figlia sia lucida il più possibile al fine di rintracciare questa persona. Colin dovrebbe avergliene parlato, averle spiegato l’intera questione. Eve è addossata alla parete della hall con carta da parati color pastello. La dottoressa si è cambiata, adesso indossa un paio di pantaloni comodi e le pantofole. Si è raccolta i capelli in un severo chignon che le scopre la fronte alta. È in piedi, tiene le braccia conserte e dice: «La definizione esatta è sindrome di Stoccolma, capita quando le vittime si affezionano ai sequestratori. Si legano a loro durante la prigionia e, alla fine, li difendono e hanno paura della polizia che viene a liberarle. Non è affatto insolito. La casistica è ampia. Anche nelle situazioni di abusi domestici, di minori violentati, di incesti. Sono sicuro che le è successo spesso, ispettore: una donna chiama in centrale per dire che il marito la picchia, ma quando arrivano gli agenti lei se la prende con loro e difende il coniuge. Affinché si sviluppi la sindrome di Stoccolma, bisogna che vi siano alcuni prerequisiti. Mia doveva sentirsi minacciata dal suo aggressore, come in effetti sappiamo che era. Avrebbe dovuto sentirsi isolata dagli altri, ma non da lui. Anche questo è appurato. Doveva ritenersi incapace di sfuggire alla situazione, e questo va da sé. Infine, occorreva che Thatcher le avesse dimostrato un minimo di umanità, per esempio…». «Non lasciarla morire di fame», provo a ipotizzare. «Esatto». «Darle dei vestiti, proteggerla dal freddo», potrei continuare all’infinito. Per me è sensato. Ma non per Eve. Aspetta che la Rhodes si congedi e vada in camera sua per la notte, dopodiché dice quello che pensa: «Lo amava», col tono della madre che ha intuito tutto. «Eve, io ritengo che…». «Lo amava». Non l’ho mai vista così sicura di sé. Si ferma sulla soglia della camera per osservare Mia mentre dorme. La guarda come se fosse la sua nuova bambina da proteggere. Si infila nel letto matrimoniale, vicino a Mia. Io dormo nell’altro letto matrimoniale, sebbene abbia una stanza tutta per me. È stata Eve a pregarmi di rimanere. Chi sono io per metterlo in discussione?, penso mentre scivolo tra le lenzuola. Non so niente dell’amore e dell’innamoramento. Nessuno di noi due prende sonno. «Non sono stato io ad ammazzarlo», ripeto a Eve, ma conta poco, perché qualcuno l’ha fatto. Eve Dopo Mia appare smarrita durante l’intero volo di ritorno. Ha scelto il posto vicino all’oblò e appoggia la fronte al vetro freddo. Se tentiamo di rivolgerle la parola, non reagisce, ogni tanto la sento piangere. Vedo le lacrime che scendono sulle sue guance e le cadono sulle mani. Provo a consolarla ma mi respinge. Una volta sono stata innamorata: era talmente tanto tempo fa che non me lo ricordo. Ero rapita dall’uomo affascinante che avevo conosciuto in un ristorante in città, mi seduceva al punto che mi pareva di camminare a un metro da terra. Adesso quell’uomo non c’è più, ciò che resta fra di noi sono le recriminazioni e i sentimenti feriti. Non me lo hanno tolto, sono io che me ne sono distaccata, tanto da non riuscire più a vedere il suo volto giovanile o il suo sorriso affascinante. Eppure, fa ancora male. La dottoressa Rhodes si congeda da noi all’aeroporto. Vuole rivedere Mia domattina. Abbiamo deciso di aumentare le sedute a due volte la settimana. Il disturbo acuto da stress è una cosa, la sofferenza un’altra. «È troppo da sopportare, per una persona», mi dice la psichiatra, mentre ci sporgiamo a guardare Mia che lascia scivolare una mano sulla pancia. Il nascituro non è più un peso, bensì l’ultima traccia di lui, qualcosa a cui aggrapparsi. Penso a cosa le sarebbe successo se avesse abortito. Forse sarebbe davvero impazzita definitivamente. Recuperiamo l’auto di Gabe nel parcheggio. Si è offerto di accompagnarci a casa. Tenta goffamente di prenderci tutte le valigie, non vuole che io mi sforzi. Mia cammina più velocemente di noi e fatichiamo a tenere il suo passo. Lo fa per non vedere il disagio sulla mia faccia o per non guardare negli occhi l’uomo che ritiene abbia ucciso il suo amore. Per l’intero tragitto resta in silenzio sul sedile posteriore. Gabe le chiede se ha fame, ma lei non risponde nemmeno. Le domando se è abbastanza caldo, e mi ignora. Il traffico non è eccessivo. È una domenica molto fredda, di quelle in cui si preferisce rimanere a letto. La radio è accesa, col volume basso. Mia si distende sul sedile e dopo un po’ si addormenta. Noto che i capelli scompigliati le coprono le guance rosee, ancora intirizzite per l’aria invernale. Le palpebre si muovono, le immagini le riempiono la mente mentre il corpo dorme. Cerco di dare un senso al tutto: com’è possibile che una come Mia si sia innamorata di uno come Colin? Poi il mio sguardo si posa sull’uomo che è di fianco a me, uno talmente diverso da James da rendere comica la situazione. «Lo lascio», rendo ufficiale la notizia, senza mai distogliere gli occhi dalla strada davanti a noi. Gabe tace, ma quando posa la mano sulla mia, dice tutto quel che c’è bisogno di dire. Ci fa scendere davanti al portone, vorrebbe aiutarci a portar su le cose, però glielo risparmio, lo rassicuro che possiamo farcela. Mia comincia a entrare. La osserviamo in silenzio. Gabe dice che tornerà domattina. Con qualcosa per lei. Appena il pesante portone si chiude e lei non ci può più vedere, Gabe vuole baciarmi, ignorando bellamente i pendolari che tornano a casa lungo i marciapiedi e i taxi che sfrecciano sulla strada trafficata. Lo fermo con le mani sul suo petto. «Non posso», dico. Fa più male a me che a lui, lo vedo che mi studia per ottenere una spiegazione, se ne chiede la ragione coi suoi occhi teneri, poi comincia ad annuire piano. Non è una cosa contro di lui, però è ora che stabilisca le mie priorità. Sono sballate da troppo tempo. Mia mi racconta il rumore del vetro infranto. Di quando lo aveva visto boccheggiare per prendere fiato. Sangue dappertutto, mentre lui annaspava e lei non poteva far altro che guardarlo cadere. Si sveglia nel suo letto, strilla. Non faccio in tempo a entrare nella stanza che cade sul pavimento, si getta su qualcuno che non è lì. Mormora il suo nome: «Per favore, non lasciarmi», dice e poi va a rigirare le coperte e il materasso, lo cerca ovunque. Butta all’aria le lenzuola, le strappa. «Owen», grida disperata. Poi mi sposta dalla soglia da cui osservavo la scena straziante e fa appena in tempo ad arrivare in bagno per vomitare. Tutti i giorni questa storia. Certe volte la nausea mattutina non è così forte. Ma allora, sostiene Mia, è ancora peggio, perché quando non si preoccupa per questo costante malessere le viene in mente che Owen è morto. Rimango a osservarla. «Mia», dico. Farei di tutto per guarirla dal dolore, però non c’è niente che si possa fare. Quando è pronta, mi racconta gli ultimi momenti dentro al capanno, gli spari che sembravano fuochi artificiali, la finestra infranta, i vetri a terra, l’aria invernale che penetrava. «Il rumore mi aveva terrorizzato, i miei occhi saettavano verso l’esterno, poi udii Owen rantolare. Ansimava il mio nome: “Chloe”. Faticava a respirare, le gambe cominciarono a cedere. Non sapevo cosa fosse accaduto», piange, scuote il capo, rivive quel momento, anche se mentalmente lo rivivrà centinaia di volte al giorno. Le metto una mano sulla gamba per fermarla. Non c’è bisogno di raccontare altro, ma lei prosegue. Lo fa perché ne sente l’impulso, perché la sua mente non riesce più a trattenere le scene che riaffiorano. Erano rimaste sopite e adesso riemergono come lava da un vulcano. «Owen?», sbotta ad alta voce, intrappolata in un momento avulso dal presente. «La pistola gli cadde con un tonfo sul pavimento. Tendeva le mani verso di me. C’era sangue ovunque. Gli avevano sparato. Cercai di sostenerlo, il suo peso era enorme. Crollò a terra. Caddi su di lui. “Owen, mio Dio, Owen!”», singhiozza. Dice che in quell’attimo ha visto la costa frastagliata della riviera ligure. Proprio in quel momento. Le barche che veleggiano lente al largo del Mar Ligure, le cime aguzze delle Alpi marittime e degli Appennini. Vedeva un rustico di pietra tra le colline, dove loro due faticavano nel verde lussureggiante delle campagne, fino a spezzarsi la schiena. Lei e l’uomo noto col nome di Owen. Immaginava che non fossero più in fuga. Erano a casa. Alla fine, aveva visto dei bambini correre nell’erba alta, o tra i filari. Avevano occhi e capelli scuri come quelli di lui, e infilavano parole italiane (bambino, allegro, vero amore) in un inglese sempre più lontano. Mi racconta di come gli sgorgava il sangue. Di come si spargeva sul pavimento, del gatto che correva per la stanza, delle sue zampette che lasciavano impronte rosse a terra. E i suoi occhi guizzano di nuovo nella camera, come se accadesse qui, adesso, sebbene il gatto resti appollaiato sul davanzale della finestra, simile a una statua di porcellana. Dice che il suo respiro era lento, sempre più affaticato. Il sangue continuava a spandersi a terra. «Poi gli occhi rimasero fissi, il petto immobile. “Sveglia, sveglia”, lo scuotevo. “Dio mio, svegliati, per favore. Non lasciarmi, te ne prego”», singhiozza tra le lenzuola. Dice che lui aveva smesso di muovere le gambe proprio mentre spalancavano la porta del capanno. C’era stata una luce accecante e una voce rude che le ordinava di allontanarsi dal cadavere. «Per favore, non lasciarmi», piange. Ogni mattina si sveglia urlando il suo nome. Dorme in camera da letto. Io srotolo il futon e mi corico nel soggiorno. Non vuole aprire le tende, non accetta che il mondo entri lì. Le piace restare al buio, così può credere che sia continuamente notte, per ventiquattr’ore, e cedere alla depressione. Riesco a malapena a darle qualcosa da mangiare. «Se non lo fai per te», tento, «fallo almeno per il bambino che nascerà». Dice che è l’unico motivo per cui continua a vivere. Mi confida che non ce la fa ad andare avanti. Non lo ammette quando è lucida, ma quando singhiozza, travolta dalla disperazione. Pensa alla morte, alle maniere che avrebbe per uccidersi. Me le elenca tutte. Io mi riprometto di non lasciarla mai da sola. Il lunedì mattina Gabe arriva con uno scatolone di cose prese dal capanno. Le aveva trattenute come reperti della scena del crimine. «Volevo restituirle alla madre di Colin», dice, «ma poi ho pensato che forse lei voleva darci un’occhiata». Sperava in una tregua. Ha ottenuto da Mia soltanto uno sguardo di rimprovero, e la solita invocazione («Owen») fra i denti. Quando riesco a trascinarla fuori dalla camera da letto, si siede davanti alla televisione con sguardo assente. Devo prestare attenzione a quel che segue. I telegiornali la sconvolgono, specie quando parlano di morte, omicidi, pregiudicati. Le dico che non è stato Gabe a sparare a Owen, e lei commenta che non è importante. Non significa niente, è morto. Non è che detesti Gabe per questo, è che non sente niente. La sua anima è solo un immenso vuoto. Io giustifico quel che lui ha fatto, che tutti noi abbiamo fatto. Cerco di convincerla che la polizia è intervenuta per proteggerla. Che avevano trovato un pregiudicato armato e la sua vittima. Più che altro, Mia incolpa se stessa. Dice che è stata lei a mettergli la pistola in mano. Di notte piange a dirotto, chiede scusa. La dottoressa Rhodes le spiega quali sono le fasi del dolore e della sofferenza: rifiuto e rabbia. Un bel giorno, le assicura, interverrà l’accettazione della perdita. Ha aperto lo scatolone portato da Gabe e ha tirato fuori una felpa col cappuccio. Se l’è messa sulla faccia, ha chiuso gli occhi e odorato il tessuto. Era evidente che volesse tenerla. «Mia, tesoro», le ho detto, «lascia che la lavi». Puzzava terribilmente, ma lei non ha lasciato che gliela togliessi di mano. «Non farlo», insisteva. Dorme tutte le notti con quella felpa, finge che siano le braccia di Owen a coccolarla. Lo vede dappertutto: in sogno, e anche quando è sveglia. Ieri ho insistito per andare a fare una passeggiata. Per essere gennaio, era una giornata accettabile. Avevamo bisogno di aria fresca. Eravamo rinchiuse nell’appartamento da diversi giorni. Lo avevo ripulito, avevo scrostato la vasca da bagno che nessuno usava da mesi. Avevo potato le piantine con le forbici dentellate, buttando le foglie morte nel bidone della spazzatura. Ayanna ci aveva procurato alcune cose al supermercato: latte, succo d’arancia e fiori freschi, su mia richiesta specifica; volevo qualcosa per ricordare a Mia che la vita continua. Ieri si è infagottata in una grande giacca presa dallo stesso scatolone confiscato da Gabe, e siamo uscite. In fondo alle scale, si è fermata a fissare un luogo immaginario, dall’altra parte della strada. Non so per quanto sia rimasta incantata così, poi l’ho presa per un braccio e le ho detto: «Camminiamo un po’». Non riuscivo a capire cosa stesse osservando, non c’era niente di particolare, solo un palazzo a quattro piani coi ponteggi dei muratori. A Chicago, l’inverno è rigido. Ma ogni tanto il buon Dio ci regala qualche grado sopra lo zero, forse per rammentarci che le disgrazie vanno e vengono. Saremo stati sui tre gradi, così ci siamo avventurate fuori, era una di quelle giornate in cui i più temerari vanno a correre in pantaloncini corti e magliette di cotone a mezze maniche, dimenticando che, in ottobre, eravamo atterriti da temperature simili. Siamo rimaste nei quartieri residenziali, perché pensavo che ci sarebbe stato meno chiasso. Poco distante, si sentiva il rumore della città a mezzogiorno. Lei trascinava i piedi. Girato l’angolo per Waveland, è andata a sbattere contro un giovanotto. Forse avrei potuto evitarlo, se non mi fossi fermata ad ammirare una decorazione natalizia ancora appesa a una balconata, mezzo nascosta tra i cumuli di neve sporca, quasi sciolti, che mi hanno fatto presentire la primavera. Il giovanotto era carino e aveva un cappellino da baseball con la visiera sugli occhi. Mia era distratta. Si è piegata in due dal pianto. Lui non riusciva a capirne il motivo. «Mi dispiace», ripeteva, e io gli ho detto di non preoccuparsi. Era lo stesso cappellino che Mia aveva ritrovato nello scatolone, e che tiene sul letto. Il dolore e le nausee mattutine la fanno correre in bagno tre, quattro volte al giorno. Gabe è venuto questo pomeriggio, deciso più che mai a chiarire le cose. Fino a oggi si era accontentato di brevi visite, al solo scopo di riconciliarsi. Però mi ricorda che la minaccia ai danni di Mia è ancora in atto e che la scorta dei poliziotti con le auto parcheggiate fuori del suo appartamento non può essere eterna. Si è messo a sedere con lei sul futon. «Mi parli di sua madre», dice Mia. Questo si chiama compromesso. L’appartamento misura circa quaranta metri quadrati. C’è il soggiorno con il futon e un piccolo televisore; lei lo tira fuori quando deve ospitare qualcuno. Ho pulito il bagno diverse volte ma ancora non mi sembra a posto. Ogni volta che faccio la doccia, la vasca si riempie d’acqua. La cucina è minuscola, ci sta appena una persona. Il radiatore capita che non riscaldi affatto la stanza, oppure che porti la temperatura ai 30 gradi. Pranziamo sul futon, che non riponiamo quasi mai, perché poi lo uso di notte come giaciglio. «Kathryn», replica Gabe. Se ne sta seduto goffamente sul bordo del futon. Sono giorni ormai che Mia mi chiede della madre di Colin. Non sapevo cosa dire, tranne che Gabe ne avrebbe saputo più di me. Non ho mai conosciuto la signora Thatcher, anche se fra pochi mesi avremo entrambe un nipote. «È una donna malata», dice. «Ha il Parkison in fase avanzata». Mi eclisso in cucina, fingendo di lavare i piatti. «Lo so». «Adesso viene curata. Vive in un ospizio, non può badare a se stessa da sola». Mia gli domanda chi l’ha portata all’ospizio. Per quel che ne sapeva Colin (Owen), la madre si trovava ancora nella propria casa. «Ce l’ho portata io». «Ce l’ha portata lei?», ripete. «Sì», confessa Gabe. «La signora aveva bisogno di cure continue». Questa, per lei, è una nota di merito. «Lui se ne preoccupava molto». «Ne aveva ben donde. Ma adesso sta bene», la rassicura l’ispettore. «L’ho accompagnata io al funerale». Fa una pausa per darle il tempo di digerire la cosa. Gabe mi aveva raccontato delle esequie. Pochi giorni dopo il ritorno di Mia a casa. Noi eravamo occupati con la dottoressa Rhodes, e avevamo scoperto che il rumore del frigorifero spaventava a morte la nostra bambina. Gabe aveva ritagliato il necrologio da un giornale di Gary e me l’aveva portato. Mi aveva consegnato anche il programma della cerimonia funebre, con quella foto lucida in bella vista, un bianco e nero su fondo di cartoncino avorio. Allora ero arrabbiata per il fatto che Colin Thatcher ricevesse una sepoltura con tutti i crismi. Avevo gettato il programma nel fuoco del camino, osservando il suo volto andare in fiamme. Speravo che succedesse la stessa cosa a quell’uomo tra le fiamme dell’inferno. Smetto per un momento quello che sto facendo e aspetto di sentire il pianto di Mia, che però non arriva. Lei tace. «È andato al funerale?» «Sì. È stato dignitoso, come dev’essere». L’immagine di Gabe ne guadagna enormemente. Sento che il tono di Mia cambia, che non trasuda più disprezzo per lui. Si addolcisce, non ha più un atteggiamento diffidente. Io invece resto in cucina con un piatto di ceramica in mano, immagino Colin bruciare all’inferno e desidero disperatamente poter ritrattare quel mio desiderio. «E la bara era…». «Chiusa. Ma c’erano le fotografie. E un sacco di gente. In tanti lo amavano, più di quanto si immagini». «Lo so», sussurra. Silenzio. Più di quel che riesco a sopportare. Mi asciugo le mani sui pantaloni. Quando ficco il naso nel soggiorno, vedo che Gabe siede molto vicino a Mia, la quale ha appoggiato la testa sulla sua spalla. Lui la cinge con un braccio, lei piange. Vorrei intromettermi, essere io quella che offre la spalla a Mia, ma non oso. «Ora la signora Thatcher vive con la sorella, Valerie. Segue le cure e riesce a gestire meglio la malattia». Vado a nascondermi in cucina, fingo di non ascoltare. «L’ultima volta che l’ho vista», afferma Gabe, «c’era… speranza». Poi la esorta: «Mi dica come è finita in quel capanno». Lei dice che queste sono le cose più facili da spiegare. Trattengo il respiro. Non so se ho voglia di sentire il racconto. Mia gli dice quel che sa, che lui era stato ingaggiato per rapirla e consegnarla a un uomo di cui non sapeva niente. Però lui non ce l’aveva fatta, quindi l’aveva portata in un posto dove riteneva che sarebbero stati al sicuro. Io sospiro. Lui l’aveva portata in un posto dove lei sarebbe stata al sicuro. Tutto sommato, forse, non era pazzo. Mia dice qualcosa a proposito del riscatto. Una cosa che ha a che vedere con James. Rientro in soggiorno, dove posso ascoltare bene. Nel sentire il nome di James, Gabe si alza concitato dal futon e comincia a misurare la stanza a lunghi passi. «Lo sapevo», ripete diverse volte. Guardo mia figlia seduta sul futon e penso che, una volta, suo padre era in grado di proteggerla. Esco dall’appartamento, cerco sollievo nella fredda giornata invernale. Gabe mi vede andarmene, sa che non può consolarci entrambe allo stesso tempo. La sera, quando lei si corica, la sento rigirarsi varie volte. Piange e invoca il suo nome. Resto fuori della sua stanza, vorrei far sparire tutto, ma so di non poterlo fare. Gabe dice che non c’è niente che posso fare. «Resta lì con lei», mi ripete. Mia afferma che potrebbe affogarsi nella vasca da bagno. Tagliarsi le vene con un coltello. Oppure mettere la testa nel forno. Buttarsi nella tromba dell’ascensore. Gettarsi sui binari della metropolitana, di notte. Gabe Dopo Mi procuro un mandato per perquisire l’ufficio del giudice Dennett. Lui è fuori di sé. Mi accompagna il sergente, che cerca di appianare il diverbio, ma James se ne sbatte, e lui dice che se restiamo a mani vuote, ci ritroveremo entrambi disoccupati. Eppure non restiamo a mani vuote. Negli archivi personali del giudice, chiusi a chiave, scopriamo tre lettere minatorie, con richieste di riscatto. Nelle lettere, gli autori affermano di avere Mia nelle loro mani; per la sua liberazione, vogliono una vagonata di soldi, altrimenti divulgheranno a tutto il mondo che nel 2001 Dennett aveva accettato una mazzetta di 350.000 dollari per emettere una sentenza favorevole in un caso di mafia. Un ricatto. Ci metto un po’ di tempo (interrogatori e indagini varie), ma alla fine riusciamo a identificare gli artefici di questa richiesta fallita di riscatto, fra cui Dalmar Osoma, il somalo a capo del piano. Approntiamo una squadra speciale per rintracciarlo. Mi darei una pacca sulla spalla per complimentarmi, se ci arrivassi. Lascio che lo faccia il sergente. Per quanto attiene al giudice Dennett, è lui a ritrovarsi senza lavoro. Lo hanno radiato dall’albo. Comunque, questa è l’ultima delle sue preoccupazioni. Mentre aspetta il processo ai suoi danni, deve pensare alle accuse di inquinamento delle prove e intralcio alle indagini. Hanno aperto un’inchiesta sullo scambio di favori in rapporto alla mazzetta citata. Scommetto che se l’è intascata. Altrimenti perché avrebbe messo le lettere nel suo archivio, senza nemmeno immaginare che qualcuno le avrebbe cercate? Lo interrogo prima che lo mettano al fresco. «Lo sapeva», dico incredulo, «l’ha sempre saputo che Mia era stata rapita». Che razza di padre farebbe una cosa simile alla figlia? La sua voce vibra ancora di egoismo, ma per la prima volta vi percepisco anche una traccia di vergogna. «Non all’inizio», dice. È nella guardina della centrale, in stato di fermo. Dennett dietro le sbarre, un’immagine che sognavo da quando si erano incrociate le nostre strade. È seduto sull’orlo della branda, fissa la tazza del cesso, sa che prima o poi dovrà pisciare davanti a tutti. Sono sicuro che è la prima volta che è sincero. Dice che all’inizio era certo che Mia fosse da qualche parte a combinare stupidaggini. Era nella sua natura. «Era già scappata di casa». Poi erano arrivate le lettere. Non voleva che si sapesse che era un corrotto, che tanti anni prima aveva accettato delle mazzette. Lo avrebbero radiato dall’albo. Eppure sostiene, e per un attimo gli credo, che non voleva accadesse nulla di male alla figlia. Avrebbe versato il riscatto per la sua liberazione, oltre che per indurli a tacere. Però aveva preteso la prova che lei fosse ancora viva. Non gliel’avevano data. «Perché», dico, «non ce l’avevano». La teneva prigioniera Colin Thatcher, il quale presumibilmente le aveva salvato la vita. «Pensavo che fosse morta», spiega. «Allora?» «Se era morta, nessuno avrebbe saputo quel che avevo fatto», ammette con un’onestà che non mi sarei aspettato da lui. Onestà e rimorso? Era dispiaciuto di ciò che aveva fatto? Penso a tutti i giorni che era rimasto a casa con Eve, a tutte le notti in cui aveva condiviso il letto con lei, nella convinzione che Mia fosse morta. Eve ha chiesto il divorzio e, una volta ottenutolo, ha ricevuto metà dei beni posseduti dall’ex marito. Una quantità di denaro sufficiente per cominciare una nuova vita insieme a Mia. Epilogo Mia Dopo Sono seduta nello studio poco illuminato della dottoressa Rhodes e le racconto i fatti di quella sera. Cadeva la pioggia, fitta e pesante, io e Owen eravamo nella stanza, era buio, ascoltavamo le gocce battere sul tetto del capanno. Eravamo stati fuori a raccogliere la legna da ardere, la pioggia ci aveva inzuppati prima che potessimo rientrare. «Quella», le dico, «fu la sera in cui cambiò qualcosa fra me e Owen. Allora compresi perché mi trovavo lì, in quel capanno, con lui. Non voleva farmi del male», spiego ricordando il modo in cui mi guardava coi suoi occhi scuri e seri, e diceva: «Nessuno sa che siamo qui. Se lo sapessero, ci ucciderebbero. Tutti e due». All’improvviso mi ero sentita parte di qualcosa, non ero più sola com’ero sempre stata nella vita. «Owen mi stava salvando», aggiungo. Allora era cambiata ogni cosa. Da quel momento non avevo avuto più paura. Avevo capito. Lo racconto alla dottoressa, le parlo di Owen, del capanno, della nostra vita lì dentro. «Lo amavi?», mi chiede, e io annuisco. Mi si riempiono gli occhi di tristezza, la dottoressa strappa un fazzoletto di carta dalla scatola sul tavolino che ci separa, lo prendo e mi asciugo le lacrime. «Raccontami le tue sensazioni, Mia», riprende subito. E dico che lui mi manca, che avrei desiderato non riacquisire più la memoria, così da restare all’oscuro, inconsapevole del suo decesso. Ma ovviamente c’è dell’altro, molto di più. Ci sono cose che non confiderei mai a un dottore. Posso dirle di essere sempre triste, tutti i giorni, ma non posso parlarle del mio senso di colpa. Della consapevolezza di essere stata io a portare Owen in quel capanno, e a mettergli la pistola in mano. Se gli avessi detto la verità, avremmo potuto escogitare un piano. L’avremmo fatto insieme. Ma all’inizio, ero troppo spaventata da ciò che poteva farmi per confessargli la verità, e in seguito non potevo svelargliela per timore che le cose cambiassero. Lui non mi avrebbe protetta da mio padre o da Dalmar, se fosse stato tutta una farsa, un imbroglio pianificato a tavolino. Ho passato la vita nella disperazione, cercando qualcuno che si prendesse cura di me. Ed ecco arrivare lui. Non potevo lasciarmelo scappare. Passo la mano sulla pancia cresciuta a dismisura e sento i calci del bambino. Dalle finestre appannate, vedo che è arrivata l’estate, col caldo e l’umidità che rendono difficoltoso respirare. Presto nascerà, il ricordo di Owen, e io non sarò più sola. Conservo nella mente un’immagine di diversi anni fa. Sono alle medie e torno orgogliosamente a casa con un compito a cui avevo preso il massimo dei voti, che la mamma si affretta ad attaccare allo sportello del frigo con una stupida calamita a forma di ape che le avevo regalato io per Natale. Rientra mio padre e vede il compito. Ci dà un’occhiata e poi le dice: «Dovrebbero licenziare il professore di inglese. Mia ormai sa distinguere fra there e their, vero?». Usa il foglio come sottobicchiere e, prima di fuggire dalla stanza, vedo le gocce d’acqua che colano sulla carta. Avevo dodici anni. Ripenso a quel giorno di settembre, quando ero entrata in uno squallido bar. Il tempo era buono, quasi estivo, ma dentro era tetro, praticamente vuoto. Il tipico bar alle due del pomeriggio, appena un paio di clienti silenziosi ai loro tavoli, che affogavano i propri dispiaceri in cicchetti di bourbon e whisky liscio. Era un buco all’angolo di un isolato con edifici coperti da graffiti. In sottofondo, la musica. Johnny Cash. Ero fuori del mio quartiere, a Lawndale, molto più a sud-ovest; guardandomi attorno, mi ero accorta di essere l’unica bianca nel bar. Lungo il bancone erano allineati sgabelli di legno, alcuni col sedile spaccato, altri con gli schienali sgangherati, e addossate alla parete c’erano bottiglie di alcol su ripiani di vetro. L’aria era impregnata di fumo, fitto come nebbia. La porta era aperta da una sedia, eppure esitava a entrare anche l’aria di quell’autunno tiepido e soleggiato. Il barista, un uomo calvo col pizzetto, mi aveva fatto un cenno per sapere cosa volevo. Avevo chiesto una birra ed ero andata nel retro, verso un tavolino nei pressi del gabinetto degli uomini, dove lui mi aveva indicato. Appena l’avevo visto, mi si era chiusa la gola e avevo cominciato a respirare a fatica. Aveva gli occhi neri come il carbone, la pelle scura e gommosa come gli pneumatici delle auto. Era seduto, concentrato su una birra. Indossava la giacca di una mimetica, che in una giornata simile era inutile, io la mia me l’ero levata e legata alla vita. Gli avevo domandato se era lui Dalmar; mi aveva osservato per qualche istante, scrutando con gli occhi color antracite i miei capelli ribelli, la determinazione nel mio sguardo. Poi aveva squadrato il mio corpo, la camicia in tessuto Oxford e i jeans. Aveva visto la mia tracolla nera e il parka allacciato ai fianchi. Non ero mai stata così sicura come in quel momento. Non aveva né ammesso né negato di essere Dalmar, mi aveva domandato invece cosa avessi per lui. La sua voce era profonda e l’accento africano. Dopo aver raccolto il coraggio per sedermi davanti a lui, avevo notato che era enorme, molto più grande di me, le mani il doppio delle mie: le avevo notate quando aveva afferrato la busta che avevo preso dalla borsetta e posato sul tavolo. Era più scuro di un orso bruno, con la pelle più nera del dorso di un’orca assassina, un maschio alfa, che non ha altri predatori che lo braccano. Mentre sedeva di fronte a me, in quel locale dalle scarse pretese, sapeva di essere in cima alla gerarchia della catena alimentare, mentre io ero una semplice alga. Mi aveva chiesto il motivo per cui doveva fidarsi di me, come faceva a essere sicuro che non lo stessi ingannando. Mi ero fatta coraggio e gli avevo risposto con aria impassibile: «Come faccio a sapere io che lei non mi inganna?». Si era messo a ridere sguaiatamente, quasi come un pazzo, e aveva detto: «Ah, certo. Ma, vedi, c’è una differenza. Nessuno inganna Dalmar». Allora avevo capito che, se qualcosa fosse andato storto, lui mi avrebbe uccisa. Tuttavia, non mi ero fatta impaurire. Lui aveva preso i fogli dalla busta: le prove, che avevo in mano da circa sei settimane, il tempo che mi era servito per riflettere su cosa farne. Rivelare tutto alla mamma o andare alla polizia sarebbe stato banale, troppo facile. Doveva esserci di più, una punizione orrenda per un crimine raccapricciante. La radiazione dall’albo non compensava una paternità schifosa, ma la perdita di un’enorme somma di denaro e la rovina della sua splendida reputazione ci andavano vicino. Molto vicino. Non era stato facile procurarseli. Questo è sicuro. Ero casualmente venuta in possesso di alcuni documenti chiusi a chiave in un archivio, una sera che lui aveva trascinato mia madre a una cena di beneficenza al Navy Pier: gli era costata 500 dollari a sostegno di u n a ONG che si occupava di sostenere la carriera scolastica dei bambini poveri; una cosa assurda, ridicola, se pensavo al modo in cui si era comportato riguardo alla mia carriera scolastica. Ero andata a casa dei miei quella sera, avevo preso sulla Purple Line fino a Linden, dopodiché avevo chiamato un taxi. Ci ero andata con la scusa del computer rotto; mia madre mi aveva concesso di usare il suo, vecchio e lento, suggerendomi di portare qualcosa per trascorrere anche la notte da loro, e io avevo accettato. Naturalmente, non sarei rimasta là. Mi ero portata una sacca, per non destare sospetti, il modo perfetto per trafugare le prove, dopo qualche ora di ricerca accurata fra le carte del suo studio. Allora avevo chiamato un altro taxi ed ero tornata nel mio appartamento, poi avevo acceso il mio computer perfettamente funzionante e mi ero messa a cercare gli investigatori privati per trasformare i miei sospetti in prove effettive. Il mio scopo non era l’estorsione. Non proprio. Cercavo qualsiasi cosa: evasione fiscale, contraffazione di documenti, spergiuro, molestie, eccetera. Invece avevo trovato le prove di un’estorsione. Gli estremi di un trasferimento di 350.000 dollari su un conto offshore, che mio padre teneva in una busta sigillata dello schedario chiuso a chiave. Io, assistita dalla fortuna, avevo scovato la chiave nascosta in un oggetto di antiquariato (una scatoletta di tè) che lui aveva ricevuto da un uomo d’affari cinese una decina di anni prima. Era in mezzo alle foglie di tè. Piccola, argentata, sublime. «Come funziona la cosa?», avevo chiesto a Dalmar, l’uomo di fronte a me. Non sapevo bene in che modo definirlo. Un sicario, un assassino su commissione? Comunque è quello che fa. Mi aveva dato il suo nome un vicino di casa dalla dubbia reputazione, più volte scontratosi con la legge, tanto che la polizia si presentava spesso di notte nel suo appartamento. Un millantatore, il tipo a cui piace dilungarsi sui passi falsi della sua vita salendo le scale fino al terzo piano. La prima volta che avevo parlato con Dalmar dal telefono a gettoni all’angolo della strada per fissare l’appuntamento, mi aveva domandato come volevo che uccidesse mio padre. Gli avevo spiegato che non lo volevo morto. Il mio progetto sarebbe stato peggiore, per lui: rovinargli la reputazione, umiliarlo, fargli perdere la faccia, sputtanarlo, ridurlo a vivere tra i reietti che lui stesso condannava alla galera. Quello, per mio padre, sarebbe stato molto peggio, come essere scaraventato in purgatorio: l’inferno sulla Terra. Dalmar si sarebbe trattenuto il sessanta percento, io il quaranta. Avevo accettato, anche perché non ero nelle condizioni di trattare. E poi il quaranta percento della richiesta di riscatto erano comunque un sacco di soldi. Per essere esatti, 80.000 dollari. Avevo in mente una donazione anonima alla mia scuola con la mia parte. Avevo previsto tutti i dettagli, preparato ogni cosa in anticipo. Non sarei semplicemente scomparsa, occorrevano delle prove, nel caso della successiva indagine: testimoni, impronte digitali, registrazioni video, roba del genere. Non avrei chiesto chi, cosa o quando; doveva intervenire il fattore sorpresa, affinché in quel momento il mio comportamento sembrasse naturale, quello di una donna terrorizzata, vittima di un piano per il suo sequestro. Avevo scovato un monolocale in pessime condizioni dalle parti di Albany Park, su a nord-ovest. Mi sarei nascosta lì mentre i professionisti (Dalmar e i suoi compari) avrebbero portato a termine il resto. Questo era il piano. Col contante ricevuto come anticipo da Dalmar, avevo pagato già tre mesi di affitto, fatto scorte d’acqua, frutta sciroppata, pasti e filoni di pane congelati, per non aver bisogno di uscire. Avevo comprato carta igienica, tovaglioli e materiale da disegno, per non correre il rischio di essere vista. Una volta pagato il riscatto e messe in piazza le azioni sporche commesse da mio padre, la polizia sarebbe venuta a liberarmi in quel lurido monolocale: lì mi avrebbero ritrovata, legata e imbavagliata, coi miei rapitori già in fuga. Dalmar voleva sapere chi avrebbe dovuto essere la persona sequestrata, cioè per chi doveva chiedere il riscatto. Lo avevo fissato negli occhi neri da serpente, avevo osservato il suo cranio pelato e la cicatrice di una decina di centimetri che gli sfregiava la guancia – un solco nella pelle, nel punto in cui immaginavo che la lama (di un machete o un coltello a serramanico) gli avesse intaccato la superficie esterna, più vulnerabile, creando però all’interno un uomo granitico. Mi ero guardata attorno per constatare che fossimo davvero soli. Tranne una cameriera ventenne in jeans e top fin troppo attillato, erano tutti uomini; tutti neri, io ero l’unica bianca. Un uomo appollaiato su uno sgabello davanti al bancone era caduto a terra, ubriaco fradicio, poi si era rialzato, barcollando verso il gabinetto degli uomini. L’avevo osservato mentre mi passava davanti e poi spingeva la grossa porta di legno, dopodiché avevo riportato lo sguardo negli occhi seri e spietati di Dalmar. E gli avevo detto: «Io». Ringraziamenti Innanzitutto mi preme ringraziare Rachael Dillon Fried, la mia straordinaria agente letteraria, che ha creduto talmente in questo romanzo da incoraggiarmi sempre. Non potrò mai ringraziarti abbastanza, Rachael, per il sostegno immancabile e le ore di duro lavoro, ma soprattutto per aver fatto sì che quest’opera non rimanesse fra i documenti inediti archiviati nel mio computer. Se non fosse stato per te, tutto ciò non sarebbe successo! Erika Imranyi, la mia editor, si è prodigata in modo eccezionale per l’intero processo editoriale. Non avrei potuto trovare una persona più perfetta per questo lavoro. Sono state le tue brillanti idee, Erika, a conferire la forma definitiva a questo romanzo, e io sono orgogliosa del risultato. Riconosco il mio debito di gratitudine nei tuoi confronti per avermi concesso quest’occasione e incoraggiato a fare del mio meglio. La mia riconoscenza va inoltre alla Greenburger Associates e alla Harlequin MIRA per aver contribuito allo sforzo. Un grazie anche agli amici e ai familiari, specie quelli che non sapevano che avevo scritto un romanzo, che mi hanno supportato e hanno risposto con orgoglio; in particolare, mamma e papà, gli Shimanek, le famiglie Kahlenberg e Kyrychenko, nonché Beth Schillen per il suo parere onesto. Grazie infine a mio marito Pete, che mi ha dato l’opportunità di realizzare un sogno, e ai miei figli, che forse sono i più emozionati per il fatto che la loro mamma ha scritto un libro! Indice Eve. Prima Gabe. Prima Eve. Dopo Gabe. Prima Eve. Dopo Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Gabe. Dopo Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Prima Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Prima Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Prima Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Prima Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Eve. Prima Colin. Prima Gabe. Dopo Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Eve. Dopo Colin. Prima Gabe. Prima Colin. Prima Gabe. Dopo Colin. Prima Eve. Vigilia di Natale Colin. Prima Eve. Dopo Gabe. Vigilia di Natale Colin. Vigilia di Natale Eve. Dopo Colin. Vigilia di Natale Gabe. Vigilia di Natale Eve. Dopo Gabe. Vigilia di Natale Gabe. Dopo Eve. Dopo Gabe. Dopo Epilogo. Mia. Dopo Ringraziamenti
Scaricare