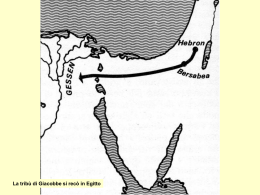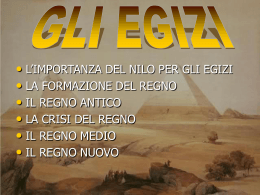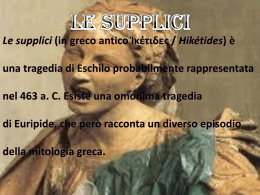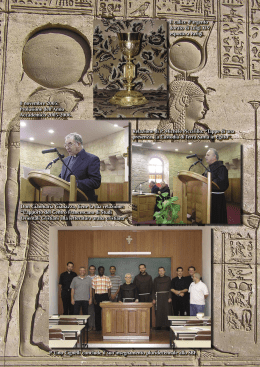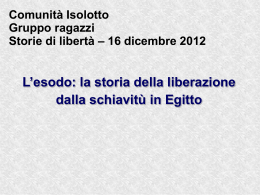Prefazione del Catalogo Electa Di Sergio Donadoni Sotto i colpi di tre successivi attacchi (l’ellenismo prima tolemaico e poi romano, il cristianesimo, l’Islam) l’antica civiltà dell’Egitto faraonico è andata prima affievolendosi, poi si disperse. Ma, insieme, si è dapprima diffusa come modello culturale e religioso, in seguito come memoria, assai oltre i suoi vecchi confini: poco riconoscibile, in molti casi, ma solido elementoispiratore in mondi altri da quello originario. È quel che è stato detto in poesia: “Comme le fruit se fond en jouissance / Comme en délice il change son absence, / Dans une bouche où sa forme se meurt” così l’esperienza globale di un Egitto plurimillenario è uscita sì dai suoi confini, ma creando cose nuove e nuovamente vive. Nel quadro generale di tale metamorfica sopravvivenza non è difficile identificare una specifica tradizione, connessa con Roma, a partire dal momento in cui l’Egitto diviene romano con Augusto, fino a poco prima dei tempi nostri. La Roma imperiale ha preso e ha dato da e a questa sua provincia. Nel campo religioso anzitutto, diffondendo un particolare culto di una Isi divenuta dea dai diecimila nomi e salvatrice universale. Un simbolo di questo andirivieni di integrazioni e rinnovamenti potrebbe essere il tempietto dedicato alla dea, la quale appare in una statua abbigliata alla greca in fondo a una cappella, che ha il suo parallelo a Pompei. Un decurione romano lo ha offerto come dono di compleanno all’imperatore Adriano nel 126, edificandolo proprio a Tebe, e proprio nel piazzale davanti al tempio di Amon a Luxor: si testimonia così come la grande dea egiziana si sia fatta nel frattempo universale, e come tale anche nella sua terra patria si presenti carica di valori altri da quelli che erano stati i suoi originarii. Ma a Roma in forma più specifica l’Egitto doveva essere non solo presente, ma seme di future esperienze di cultura. Più che nelle particolari forme degli edifici cultuali, connessi con una ritualità ormai diversa da quella originaria, il tono egiziano viene ottenuto per mezzo dell’arredo monumentale che a loro si appoggia: statue, elementi architettonici, rilievi, oggetti varii. Il ben consolidato costume di importare opere d’arte greca per decorare strutture, case, ville illustri si allarga a una simile importazione di sculture e oggetti egiziani: sono statue di cui si gusta il sapore esotico sia nelle tematiche sia nelle materie prime: le nere pietre dell’età saitica, i graniti. E, prova dei trionfi e del potere romano nel paese, gli obelischi. Si importano e talvolta si imitano o si inscrivono, con testi in geroglifico, opera, naturalmente, di egiziani presenti nei templi. Ci sono, a Roma, tredici obelischi: più di quanti ce ne siano oggi in tutto l’Egitto. Roma diviene così un forziere di monumenti egiziani; ne adopererà ancora qualcuno nel Medioevo, ma, soprattutto, li riscoprirà con il Rinascimento, e li avrà come materiale di base per ogni ricerca archeologica sull’Egitto e sull’arte egiziana fino all’Ottocento. Come spesso accade, questa presenza di originali pregiati invita a imitarne le tipicità, e si ha una ricaduta di materiale egittizzante, tanto in oggetti di arte industriale che esibiscono ricordi nilotici, quanto nelle decorazioni dipinte delle case nobili che hanno richiami e allusioni a un Egitto ormai sempre più acclimatato al nuovo ambiente. La riscoperta nel Rinascimento di questo concreto Egitto romano si accompagna a un altro importante approccio in quel centro di cultura greca che fu l’accademia ficiniana a Firenze. Quando là furono letti e intesi i testi del Corpus Hermeticum, scritti sì in greco, ma collocati dal loro contenuto nel più antico e mitologico Egitto, si constatò come il dio della sapienza egiziana, Thot, sia nella sua interpretatio graeca come Hermes, sia con il suo nome egizio, vi esprimesse ammaestramenti in cui dogmi e atteggiamenti cristiani erano facilmente identificabili. Si arrivò così ad attribuire a tali testi un valore di premessa e di profezia, per cui Hermes divenne addirittura l’ispiratore di Mosè. L’Egitto, nei suoi scritti illuminati, è a suo modo cristiano assai prima della presenza terrena di Cristo. Questa dottrina è riserbata a singoli eletti, e non per nulla (si dice) davanti ai templi sono collocate sfingi, cariche della loro enigmaticità. I suoi testi sono tramandati in una scrittura che deve superare la banalità dell’alfabeto, e che deve essere non letta, ma interpretata (e riserbata anch’essa a un gruppo di ben definiti e scelti personaggi, che se la tramandano fra di loro): i geroglifici. Su questo sfondo ha un peso singolare l’arrivo di un manoscritto dal titolo di Hieroglyphika, portato dalla Grecia da un mercante fiorentino, scritto in egiziano da un certo Orapollo e tradotto in greco da un certo Filippo. È una lista di segni, illustrati secondo una schema fisso: la “lepre” significa “apertura” perché la lepre dorme a occhi aperti. Se ne acquistò la convinzione che chi volesse interpretare un geroglifico dovesse chiedersi quali potessero essere i richiami a concetti figurabili per suo mezzo, rifacendosi alla storia naturale, al mito, alla letteratura: un gioco, senza regole precise e senza definiti confini, e pertanto – in verità – senza senso. Ma così si consolidò il mito di un Egitto sede di un santo, precoce e riserbato sapere, patrimonio di una classe di sacerdoti, assai simili ai filosofi cui Platone avrebbe affidato volentieri il governo della sua Repubblica. Ed è proprio in ambiente romano che questa scoperta fiorentina dà i suoi frutti. Il Maestro del Sacro Palazzo di Alessandro VI, il domenicano Nanni da Viterbo (m. 1502) dichiarò di aver compulsato in una biblioteca di Mantova (che nessun altro ha potuto visitare) scritti di Catone, di Fabio Pittore e Senofonte, da cui aveva potuto trarre le indicazioni su un viaggio di incivilimento compiuto in Italia da Osiri, venuto a combattere i giganti che opprimevano il paese. Li sconfisse, restò a regnare per un decennio a Viterbo, e lasciò l’Italia ormai civile a due giovani giganti suoi successori. Questa, per noi, abbastanza ingenua falsificazione ebbe ai suoi tempi e in quelli immediatamente seguenti, vasta risonanza; ed è comunque parallela alle pitture dell’appartamento Borgia in cui il Pinturicchio alla fine del Quattrocento narrò le origini egizie della casata del pontefice e l’opera civilizzatrice degli dei egizi nella nostra terra. E, ancora a Roma, questo fiducioso culto del mito egiziano ha un altro monumento nei Hieroglyphica del Cameriere Segreto di Leone X, il bellunese Pierio Valeriani. La ripresa del titolo dell’opuscolo dell’Orapollo non è casuale: in una voluminosissima opera in 58 libri, una serie di capitoli illustra (segno per segno: il leone, l’elefante, il toro e così via per i 58 libri) tutti i valori che ognuno dei segni può avere, considerandolo sotto tutti i punti di vista possibili. Munito dell’opera di Pierio, un lettore avrebbe potuto porsi davanti a un testo in geroglifici, e con pazienza incrociare tutti i valori di un segno con tutti i valori possibili per ognuno degli altri: nessuno ha mai potuto adoperare questa mirabile adunata di notizie scompagnate, ma ne è nata invece l’arte e l’uso delle “imprese” che riuniscono una immagine e un motto in ingegnosa simbiosi. A questi geroglifici oggetto di ricerca o fantasia ingegnosa, si contrappone, proprio a Roma, l’esistenza dei geroglifici non descritti a parole, ma incisi nella pietra, soprattutto degli obelischi. Al geroglifico immaginato dal Valeriani, utile a comporre “imprese”, si fa specchio il geroglifico che si offre alla lettura, che è un segno grafico e non più la descrizione del segno. Gli obelischi ne danno esempi bene osservabili nelle loro caratteristiche, in ordinate serie che più di una volta si ripetono. Cosa volessero dire quelle descrizioni si sarebbe potuto immaginare appoggiandosi a una antica traduzione di uno di essi fatta da un egiziano autentico, riportata da Ammiano Marcellino. Una traduzione così valida che permette oggi di identificare il testo cui si appoggia. Ma era un testo formato di nomi e titoli di persone, semplici formule di offerta: non certo tale da soddisfare quelle che erano le aspettative di una scrittura segreta, appannaggio di una classe di sapienti, degna di essere eternata nell’incisione nel granito ribelle, pronta per un futuro perpetuo. E questa scrittura, di valore universale, superiore a ogni lingua e leggibile in ogni lingua, doveva (per definizione) essere accessibile agli spiriti più eccelsi dei secoli seguenti alla sua incisione. Gli obelischi ebbero ora, a Roma, chi li affrontò, talvolta mano a mano che entravano nella storia dell’urbanistica della città, cioè il gesuita tedesco Athanasius Kircher, un principe dei saperi inestricabili: cosa sarebbe avvenuto se la torre di Babele fosse stata compiuta? Come erano organizzati i giardini pensili di Babilonia? Come si fa apparire una figura in luce su una parete oscura? Come si organizza una lingua universale? Come si struttura e si fa funzionare l’arca di Noè? Come si spiega l’attività dei vulcani? E, naturalmente e con posizione centrale dell’interesse, cosa c’è davvero scritto nella lingua di quegli antichi sapienti che eternavano sugli obelischi le più antiche e importanti verità di fede? Puntualizzando – e in certo modo rovesciando – l’impostazione di Valeriani, Kircher si è accinto con baldanza a trovare nei geroglifici quanto immaginava dovesse trovarvisi di consegnato all’eternità di quella grafia. È una grandiosa esibizione di sapere e di fantasia, di cui quel che oggi resta è l’intuizione del fatto che il copto (la lingua dell’Egitto cristiano) è l’ultima fase dell’egiziano antico, ed è stato un apporto non dappoco. Ma in verità l’opera di Kircher è la stupefacente testimonianza di una personalità che ha la sua giustificazione proprio nel suo semplice esserci, e sapersi manifestare. Non è un caso se, proprio nello stesso ambito di cultura, gli obelischi non solo andavano fissando – con la loro successiva messa in opera – quasi una segreta chiave di lettura della città come organismo vitale, ma ispiravano ora un’opera come la Fontana dei Fiumi, dove l’obelisco baldanzosamente si fa centro di un ben più ampio discorso, e come sarebbe stato l’obelisco del “Pulcin della Minerva” secondo i progetti noti da schizzi del Bernini, che lo voleva tenuto variamente in braccio da una statua di Ercole stante (la soluzione dell’elefante che lo sorregge sul dorso ha piuttosto il carattere di una “impresa”, completa del motto che dice robustae mentis esse solidam sapientiam sustinere e risale in realtà a una figurazione dell’Hypnerotomachia, e perciò di tono più rinascimentale che barocco). L’interesse per l’Egitto favoloso porta a una più attenta osservazione dei monumenti che se ne possono recuperare. Quasi a contrasto con l’atteggiamento di Kircher (che difatti ne giudica pavido e sterile il risultato) è la pubblicazione, all’inizio del Seicento, di una lastra di bronzo che porta una serie di immagini egiziane di culto, corredata da una iscrizione in geroglifici. È la Tabula Bembina dal nome del primo proprietario, il Bembo; probabilmente tavola d’offerta da un Iseo romano, apparsa sul mercato durante il sacco di Roma nel 1527. Autore del breve testo illustrativo è il padovano Pignoria, che si occupò di darne una copia, una precisa descrizione, e una ricerca di paralleli da affiancare alle immagini che vi apparivano. Saggiamente si astiene da ipotesi interpretative, in attesa che ce ne possano essere gli strumenti adatti. Tale semplice interesse per i monumenti in sé aiuta il formarsi di raccolte che a fianco di quanto si trovava a Roma poneva i primi arrivi di materiali archeologici provenienti dall’Egitto per merito di viaggiatori, di pellegrini, di religiosi missionarii. Una moda che – proprio così – ha già avuto, in Kircher, un primo esperimento di collezionismo, e che non per nulla troverà il suo culmine nella raccolta che, alla fine del Settecento nella sua villa di Velletri, formò il cardinale Borgia, Prefetto della Propaganda Fide. Proprio da questa valenza del materiale archeologico nasce nella Roma neoclassica una reinvenzione dell’Egitto come ispiratore e patria di un’arte da osservare, amare, imitare al modo di quel che si era fatto con i resti dell’arte classica. Quasi un simbolo di questo atteggiamento è l’incontro davanti al Quirinale (1781) dell’obelisco con le grandi statue dei Dioscuri in una serena composizione. Ma già nel 1764 Winckelmann prese atto della presenza egiziana nella storia delle arti, e ne identificò tipologie ed elementi di stile e un tanto di svolgimento, dandole così in certo modo una preziosa patente di nobiltà. Non c’era solo arte. Ospite del cardinale Borgia, un giovane studioso danese, Schow, pubblicò a Roma nel 1788 il primo papiro greco, inaugurando così un nuovo capitolo del sapere, la papirologia. E a Velletri, come curatore delle antichità del cardinale, operò Georg Zoega, un danese che ne pubblicò la collezione di testi copti e una esemplare opera sugli obelischi, preziosa per il futuro della scienza. Ma in certo modo più interessante è l’atteggiamento di chi allora dall’arte egiziana ha tratto modelli e ispirazione. Piranesi, anzitutto, che esplicitamente oppone un suo giudizio positivo riguardo a quella “durezza” di che altri accusavano le opere egizie, notando che si tratta di “solidità richiesta dalla solidità dell’architettura” in cui sono inquadrate. E così ammucchia elementi egiziani nelle sue composizioni decorative, che vi trovano un punto di partenza per la fantasia. In altro campo, quell’architettura egiziana di cui ora si ha notizia dai viaggiatori e poi in più dalla spedizione napoleonica, è imitata nelle architetture egiziane del Canina a Villa Borghese, con i suoi obelischi iscritti ormai in autentici testi geroglifici (così come gli obelischi di Villa Torlonia) dopo che da Roma, acclamato, e bene accetto al pontefice, era passato Champollion, il punto di partenza di una nuova e infine limpida visione dell’Egitto. Se è lecito riassumere un quadro già così schematico, si può dire che l’Egitto ha fornito alla Roma antica una religione che vi si è acclimatata, e vi ha fisicamente costituito una sorta di scrigno dell’eredità monumentale egiziana conservandola e tramandandola al mondo occidentale. Ha dato alla Roma rinascimentale il mito del passaggio dei divini instauratori egizi di civiltà nelle terre del Lazio e la visione di una religiosità che precede e prevede la fede cristiana, con Nanni da Viterbo e col Pinturicchio. Ha fornito alla Roma Barocca, con Kircher e con Bernini, la spinta per avventurose meraviglie speculative e figurative. Si è proposto come modello e come esperienza culturale alla Roma neoclassica con Winckelmann, Piranesi, Zoega, Canina. La catena di questi bene identificabili momenti caratteristici dei rapporti fra Egitto e Roma non ha – penso – eguali. La sfinge è stata più e più volte ospite della lupa, e lupa e sfinge hanno saputo bene integrare le loro storie. Questo deve apparire dalla mostra che si apre a Castel Sant’Angelo.
Scaricare