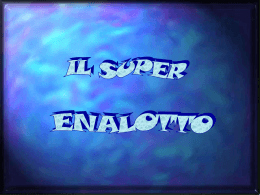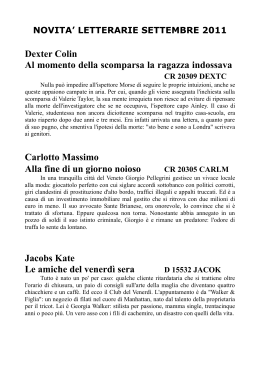Breve storia della detective fiction di Paolo Ferrucci http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Ferrucci http://ferrucci.wordpress.com/ Il genere C’è chi sostiene che la letteratura sia sempre esistita come sistema di generi. Ogni nuovo genere letterario che nasce, rappresenterebbe l’evoluzione di uno o più generi precedenti. E sulla nascita del genere poliziesco, inteso come indagine su un mistero legato a un delitto, le teorie sono diverse: da quelle che ne identificano l’origine con l’opera d’un singolo autore (facendo coincidere, ad esempio, la nascita del poliziesco coi racconti di Poe), a quelle più retrospettive che, quando identificano un “caposcuola”, ritengono abbia raccolto l’eredità del passato, rinnovandola con innesti originali o con varianti capaci di creare un salto di livello. Di certo, nessun genere letterario nasce dal nulla: alle sue spalle c’è sempre una trama sottile e complessa di antecedenti e influenze. Nel dibattito sulle origini, si possono distinguere tre orientamenti: quello dei cosiddetti puristi, che individuano il primo esempio di detective fiction in The Murders in the Rue Morgue, pubblicato nel 1841 da Edgar Allan Poe; quello dei cosiddetti filologi, che fanno risalire la genealogia dei detective a Caleb Williams, un romanzo di William Godwin apparso nel 1794; e quello degli enciclopedisti, pronti a cogliere paradigmi polizieschi nei più diversi ambiti della letteratura antica e moderna, a partire dalla Bibbia (non dimentichiamo che il primo furto, scoperto e punito, avvenne nel giardino dell’Eden). Edipo Re Diversi elementi cardine del genere poliziesco li troviamo nella tragedia Edipo re di Sofocle, che affonda le radici nella mitologia greca. Ecco la fabula. Durante un viaggio, il re di Tebe Laio viene crudelmente massacrato a bastonate. Dopo molti anni, a Tebe sale sul trono un nuovo re: Edipo, uno straniero che ha liberato la città dall’incubo della Sfinge e che ha sposato Giocasta, la vedova di Laio. Ma l’assassinio di Laio, rimasto impunito, grida vendetta al cielo, e gli dèi fanno scontare il peccato alla città scatenando una terribile pestilenza. Per placare la loro collera, è necessario che il colpevole venga scoperto e punito “di mano violenta”. Deciso a salvare la sua città, Edipo si propone d’indagare per far luce su quell'antico delitto: interroga la vedova del morto, i notabili di Tebe, l’indovino Tiresia, un vecchio pastore, finché scopre che l’assassino è lui stesso. E un vecchio servo della casa di Laio, fra dolorose reticenze, svela che Edipo è figlio di Laio, che lo espose neonato sulle balze del monte Citerone affinché morisse; qui lo raccolse Polibo, che lo adottò come suo nella terra di Corinto. Gli elementi del genere ci sono quasi tutti: la morte violenta (l’omicidio di re Laio), il mistero (perché a Tebe s’è scatenata la peste?), il rapporto passato-presente (le radici del male di oggi affondano in un atto compiuto nel passato), le testimonianze e gli indizi (il mistero della peste verrà risolto facendo luce su un omicidio insoluto), la detection (Edipo ragiona e cerca di ricostruire i fatti). L’elemento più straordinario della tragedia, però, è nel modo in cui l’indagine ha termine: facendo scoprire a Edipo di essere lui stesso l’assassino, Sofocle gioca già con gli elementi del genere, infrangendo la regola che vuole separate le figure del detective e del colpevole. In più, l’accanimento degli dèi contro Edipo si basa su una colpa di cui lui s’è macchiato inconsapevolmente, poiché non poteva riconoscere suo padre quando l’ha ucciso e non poteva sapere che la splendida regina che ha sposato è sua madre. Sotto quest’aspetto, è evidente che l’Edipo re celebra l’oscurità del destino, il non senso della vita, la disarmonia che oggi ritroviamo nei romanzi noir. (per approfondimenti: I padri fondatori. Il “giallo” da Jahvè a Voltaire, a cura di Oreste Del Buono, Einaudi Tascabili 1991). La Bibbia e l’enigma della camera chiusa Dopo aver parlato di Edipo, andiamo ancora più indietro. Se vogliamo cercare il primo enigma della camera chiusa, caro a tanti giallisti, troviamo il primo antecedente storico nell’episodio biblico di Daniele, XIV. Qui Daniele smaschera i sacerdoti del dio Bel, i quali nascondevano i loro furti giurando che ogni notte il loro dio mangiava dodici staia di farina e quaranta pecore, e beveva sei anfore di vino. Per dimostrare al re che i sacerdoti lo stanno ingannando e che sono loro e le loro famiglie a divorare quel cibo, entrando da un’apertura segreta nel tempio che veniva chiuso e sigillato dal re in persona, Daniele cosparge il pavimento di cenere. E il mattino seguente mostra al sovrano le impronte di uomini, donne e ragazzi. Superfluo dire che i sacerdoti, così smascherati, verranno giustiziati con le loro mogli e i loro figli. Il primo investigatore Il prototipo di investigatore più celebre risale al Settecento: nientemeno che al racconto filosofico Zadig di Voltaire, ripreso dalla tradizione persiana. ZADIG o Il destino [Zadig ou la destinée] è un racconto di Voltaire (Francois-Marie Arouet, 1694-1778), pubblicato nel 1749. Zadig è un giovane cittadino di Babilonia, virtuoso e saggio, contro cui pare che la sorte si accanisca, divertendosi a togliergli di mano in mano quanto egli ottiene con i suoi meriti. La sua fidanzata, che egli ha difeso valorosamente con le armi, concede a un altro la mano non appena le giunge la falsa notizia che egli è diventato guercio in seguito alle ferite riportate. Il più saggio dei matrimoni gli procura le più gravi delusioni. Divorziato, si dà alla scienza e non ne ricava che danno, fa una poesia in lode del re, e un invidioso riesce con questa a farlo condannare a morte per lesa maestà. Solo il caso lo salva e gli procura il favore del re, di cui diviene ministro. Ma tra lui e la regina Astarte sorge insensibilmente l'amore, che, per quanto nessuno dei due osi confessarlo nemmeno a se stesso, desta la terribile gelosia del re. Zadig prende la via dell'esilio, dove la sua mala sorte lo segue. Per aver difeso una donna percossa dall'amante perde la libertà. Portato schiavo in Arabia, combatte, in nome della ragione, le più crudeli superstizioni, e solo con l'astuzia e la fuga si sottrae al furore dei sacerdoti. Ritrova finalmente Astarte, rimasta vedova e divenuta schiava in seguito alle più drammatiche avventure, e riesce a liberarla. Essa ritorna sul soglio regale, e si bandisce un concorso per darle come consorte l'uomo più prode e più saggio. Zadig vince la prova delle armi, ma è truffato dalla furfanteria di un rivale. Allora il suo coraggio vien meno, ed egli dubita che il mondo sia governato da un destino crudele che aiuta i malvagi a spese dei buoni. A questo punto incontra un eremita, il quale gli dimostra che il caso non esiste sulla terra, ma tutto è prova, o punizione, o ricompensa, o prevenzione, e, divenuto un angelo luminoso, lo ammonisce: "Misero mortale, cessa di discutere là dove conviene adorare!". E finalmente Zadig, superate vittoriosamente le ultime prove raggiunge la felicità e l'amore. Uscito già due anni prima, nel 1747, con qualche capitolo in meno, sotto il titolo di Memnone. Storia orientale [Memnon. Histoire orientale], é questo uno dei primi saggi di quei racconti filosofici e morali a cui doveva rimanere più durevolmente legata la gloria del migliore Voltaire; di quello che, compiuta la sua evoluzione intellettuale e fissato nitidamente il suo pensiero, si compiaceva, con raffinata cura d'artista, di calarlo nelle figure dei suoi personaggi, lanciandoli, obbedienti al verbo del loro creatore, a combattere le sue battaglie. Di intrighi sentimentali e di viaggi usati come pretesto alla esposizione di teorie filosofiche, di fantastici paesi orientali, in cui potesse spaziare la libertà d'invenzione dell'autore, non mancavano esempi nella precedente letteratura inglese e francese; nuova è la luminosità del pensiero, che dal problema centrale si riflette sul ricco contenuto filosofico sparso nei vari episodi secondari, nuovo l'appassionato interesse per la conquista razionale del benessere umano, nuovi, soprattutto, l'ironia scintillante, la libertà, il movimento, la varietà dello stile, che ha tutta la freschezza e la grazia di una affascinante conversazione. Due citazioni. “Le opere di Voltaire sono come quei volti sproporzionati che risplendono di bellezza” (Montesquieu). “Una fantasia e un equilibrio continuo governano questi reami di fantasia e di verità, l'immaginazione, procede armata del più quotidiano buon senso” (Massimo Bontempelli). Un “assaggio”. Un giorno, al Primo Eunuco che gli chiede se ha visto il cane della regina, Zadig risponde: “È una cagna, e non un cane”. “È vero” ammette il Primo eunuco. “È una cagna piccolina, di razza spagnola” precisa Zadig, “ha da poco avuto i piccoli, zoppica con la zampa anteriore sinistra e ha orecchie lunghissime.” “L’hai dunque vista?” gli chiede l’altro. “No, non l’ho mai vista, né ho mai saputo che la regina avesse una cagnolina.” Così Zadig, Sherlock Holmes ante litteram, spiega il mistero: “Ho visto sulla sabbia le impronte di un animale, e ho capito facilmente che erano le impronte d’un piccolo cane. Dai solchi lunghi e leggeri impressi sui minimi rilievi della sabbia, fra le orme delle zampe, ho capito che si trattava di una cagna con le mammelle penzoloni per avere figliato da pochi giorni. Altri segni, tracciati in senso diverso sulla superficie sabbiosa, ma lateralmente alle orme delle zampe anteriori, m’hanno fatto capire che la cagna aveva orecchie molto lunghe; e poiché una delle orme risultava più lieve delle altre, ho capito che la cagna zoppicava un poco”. Lo svelamento L’episodio di svelamento più famoso lo troviamo nell’Amleto di Shakespeare. Amleto, deciso a smascherare il responsabile della morte del padre, fa recitare davanti alla corte di Danimarca il dramma di un assassinio che riproduce esattamente le circostanze di quella morte. Così riesce a mettere alle strette il colpevole – suo zio Claudio – e lo induce a svelarsi, manifestando la propria agitazione. Qui siamo davanti al prototipo, se vogliamo, della classica riunione finale dei personaggi d’un romanzo giallo – tanto cara ad Agata Christie – nella quale l'investigatore smaschera il colpevole “rappresentando” il suo delitto e ricostruendone il meccanismo. In definitiva, l’anima della classica detective fiction è il connubio di un mistero (come un furto o un fatto di sangue) e di uno svelamento, differito a lungo, ma destinato inevitabilmente a far trionfare la razionalità e la giustizia. In genere, lo spazio più ampio del racconto viene riservato alla detection, mentre il crimine avviene spesso dietro le quinte, per essere ricostruito e spiegato solo alla fine. Come ha scritto Carlo Ginzburg in un suo saggio, apparso nel volume Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce (Bompiani 1983), l’abilità del detective discende dagli atavici inseguimenti in cui l’uomo, cacciatore da millenni, era costretto a ricostruire “le forme e i movimenti di prede invisibili da orme nel fango, rami spezzati, pallottole di sterco, ciuffi di peli, odori stagnanti”. Va da sé che, nelle tradizioni antiche, all’investigazione e allo smascheramento manca il carattere tipico che nascerà solo nell’Ottocento: l’indagine professionale del crimine. Cioè, manca la polizia, pubblica o privata. E non stupisce, se si pensa che fino alla metà del Settecento non esistevano processi indiziari: il verdetto si fondava soltanto sulle deposizioni dei testimoni e sulla confessione – regina di tutte le prove – che spesso veniva estorta con la tortura. (per approfondimenti: I padri fondatori. Il “giallo” da Jahvè a Voltaire, a cura di Oreste Del Buono, Einaudi Tascabili 1991) Il criminale Dal Giardino dell'Eden fino al Settecento, dunque, l’interesse del pubblico si concentra sulle imprese del criminale - d'estrazione popolare nella letteratura bassa, e di statura eroica nella tragedia, come nel caso di Macbeth. Ma è possibile rintracciare anche una letteratura di enigmi, i cui protagonisti mostrano doti logiche non comuni, che affonda le radici nell'antichità. I contributi sviluppati dalle tre scuole critiche cui s'è fatto cenno (i filologi, i puristi e gli enciclopedisti) sono stati successivamente ricomposti in un quadro unitario, che vede confluire nel genere poliziesco due forme di "scandalo": la prima, che ha come scenario i bassifondi, è rappresentata dalla criminalità endemica tra le classi meno abbienti (al centro di opere popolari che preludono al reportage giornalistico); la seconda è data dalle azioni illecite dei potenti, già celebrate nella tragedia elisabettiana e giacobiana. Nel Settecento, questi due filoni di letteratura criminale si contaminano attraverso i romanzi Moll Flanders (1722) di Daniel Defoe, Jonathan Wild (1743) di Henry Fielding e lo stesso Caleb Williams di Godwin; ma è solo nell'Ottocento che all'interesse per il criminale si sostituisce quello per il detective. Il romanzo criminale settecentesco. Sin dal finire del Seicento, a Londra, il cappellano della prigione di Newgate (“The Ordinary Chaplain”, detto “The Ordinary”), dopo aver assistito i condannati a morte, aveva il diritto di pubblicare il resoconto dei loro ultimi istanti e delle loro imprese delittuose. Queste narrazioni – in forma di pamphlets, talvolta venduti il giorno stesso dell’esecuzione – ebbero un largo pubblico, così alcuni stampatori decisero di raccoglierle in volume. Nacque così, nel 1773, The Newgate Calendar, un almanacco che conobbe numerose riedizioni. L’iniziativa venne poi ripresa da vari editori, che si misero a pubblicare opuscoli basati sui resoconti ufficiali dell’Old Bailey, il tribunale di Londra, ovviamente arricchiti di particolari truculenti per soddisfare l’interesse morboso del pubblico per i criminali e le loro gesta. Nel Settecento era la località di Tyburn – oggi Marble Arch –, spesso menzionata insieme a Newgate negli annali del crimine, lo scenario delle impiccagioni dei delinquenti comuni. I prigionieri d’alto rango, invece, venivano giustiziati a Tower Hill mediante il taglio della testa. Come sappiamo, la popolarità delle esecuzioni era altissima. L’occasione si trasformava in una sorta di kermesse, come mostra una lettera scritta da un viaggiatore italiano – Alessandro Verri, fratello di Pietro – nel gennaio 1767: Tutta Londra era in moto per tal funzione, della quale sono curiosi gl’Inglesi ancor più di noi. Vi sono de’ gran palchi di legno dall’una e dall’altra parte del patibolo, per montare su i quali si paga un tanto. Sono sempre pienissimi. Qui, spesso, il condannato faceva il cosiddetto “discorso del patibolo”, con cui era chiamato a riconoscere, insieme ai propri crimini, la giustizia della condanna. In questo modo egli incarnava, come osserva Michel Foucault nel saggio Sorvegliare e punire (Einaudi 1976), “sotto la morale apparente dell’esempio da non seguire, tutto un ricordo di lotte e di scontri” ingaggiati “contro la legge, contro i ricchi, i potenti, i magistrati, la polizia militare e la ronda di notte, contro l’esattoria e i suoi agenti”, tutte istituzioni per cui il popolo di sicuro non parteggiava. Infatti, non di rado, dopo l'esecuzione il condannato veniva celebrato come un santo, e la proclamazione postuma dei suoi delitti gli assicurava la gloria. In pratica, il pubblico settecentesco vedeva nel criminale un malfattore e un eroe al contempo: questo era dovuto all’estrazione popolare dello highwayman o bandito di strada, il cui comportamento deviante era l’unico modo per eludere un sicuro destino di povertà. Una figura opposta a quella del criminale comune, visto come un individualista alla ricerca della libertà contro le pesanti costrizioni economiche, morali, sociali, è quella del celeberrimo criminale Jonathan Wild, un vero e proprio genio del male a cui si ispirò la History of the Life of the Late Mr Jonathan Wild the Great (1743) di Henry Fielding. Con la figura di Wild, il fuorilegge perde lo statuto dell’eroe popolare e diviene uno strumento del potere. Parlare di lui significa parlare delle opere che ne narrano le gesta, poiché nei tre mesi successivi alla sua esecuzione ne furono pubblicate almeno diciassette. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). Vita e avventure di Jonathan Wild il Grande Jonathan Wild fu uno dei più noti criminali inglesi del Settecento: un vero “genio del male”, che storicamente incarnò l’emblema dell’integrazione fra malavita e “sistema”. Cominciò avviandosi alla carriera di sfruttatore e ladruncolo, per poi inventarsi il mestiere d’intermediario fra il ladro e la vittima. In pratica, si recava nelle dimore di cittadini recentemente derubati (con la sua complicità), sostenendo di essere venuto a conoscenza del furto e d’avere con ogni probabilità individuato la refurtiva. Indicava quindi la cifra richiesta dal ladro per restituirla: se il cliente accettava, lo pregava di consegnare il denaro a un proprio emissario, che avrebbe restituito il maltolto. Quanto all'onorario, Wild si rimetteva alla generosità della controparte. Col tempo, egli acquistò grande fama, e la sua casa divenne una sorta di “ufficio oggetti smarriti”: lungi dal sospettarlo coinvolto nei crimini, i suoi clienti lo consideravano un uomo fondamentalmente onesto. Wild, dunque, arrivò a organizzare una vasta corporazione di ladri, strutturandola con logica imprenditoriale, e allo stesso tempo lavorò come informatore della polizia. Ciò che lo distingue dagli altri pendagli da forca è innanzitutto l’accurata organizzazione della sua banda di grassatori e briganti, dove si tenevano libri contabili con tanto di entrate e uscite, e i sottoposti erano inquadrati in una ferrea gerarchia. In secondo luogo, Wild strinse un ambiguo patto col potere politico, al quale consegnava ladri e malfattori in concorrenza con lui, arrivando a spedire al patibolo i gregari che rifiutavano le sue condizioni o si dimostravano pericolosi. Alla fine divenne così importante che, nel 1720, il Privy Council giunse al punto d’interpellarlo per arginare furti e rapine. Qualche anno prima della sua caduta, si proclamò addirittura Thief-Taker General of Great Britain and Ireland. In realtà, a favorire l’ascesa di Jonathan Wild fu il sistema giudiziario inglese settecentesco. La creazione di un corpo di polizia era avversata dal popolo, in quanto strumento dispotico, ed era vista con sospetto dagli stessi organismi statali. Quindi, per assicurare la cattura dei criminali, ci si affidò all'iniziativa privata. Con il cosiddetto "Highwayman Act" del 1692, per ogni bandito di strada catturato e dichiarato colpevole si corrispondevano quaranta sterline: nacque così la figura dello thief-taker professionista, o cacciatore di taglie. Gli affari di Wild, dunque, prosperavano. Ma, come spesso accade, l’impunità spinse l’eccentrico “trovarobe” a uno sprezzo sempre maggiore della legge, tanto che non solo continuò a orchestrare furti, ma commise l’imprudenza di prendervi parte, offrendo ai complici l’opportunità di testimoniare contro di lui. Forse fu proprio la sua doppiezza ad alienargli il favore popolare e a segnare l’inizio del suo declino, che si concluse con la cattura, la prigionia e l’impiccagione. Alla vigilia del processo, Wild tornò a proclamarsi paladino della giustizia, facendo circolare i nomi dei sessantaquattro uomini e della donna che aveva fatto impiccare; ma il cinismo del gesto gli si ritorse contro, e il giorno dell'esecuzione fu accompagnato al patibolo da una folla inferocita. Tra i criminali venduti da Wild alla giustizia spiccano Jack Sheppard, che assunse lo statuto di eroe grazie all’abilità con cui evadeva dalla prigione, salvo venire puntualmente riacciuffato, e Joe “Blueskin” Blake, la cui vendetta fallì di poco allorché, dopo la cattura, accoltellò lo thief-taker alla gola. Wild, dunque, è l'antitesi del criminale settecentesco: a differenza dei condannati che muoiono con fermezza e con sentimenti eroici, egli si avvia al patibolo sotto una pioggia di pietre e di fango. Della storia di Jonathan Wild abbiamo diverse fonti, fra le quali quella di Daniel Defoe, che fu testimone della sua esecuzione capitale. Ma la più importante resta il romanzo del 1743 History of the Life of the Late Mr Jonathan Wild the Great di Henry Fielding. Tuttavia, nel romanzo Fielding punta su Wild il suo sguardo ironico soprattutto per farne il simbolo di un sistema politico deviato: molto riconoscibile è l’analogia fra l’organizzazione criminale di Wild e l’amministrazione corrotta del governo di Sir Horace Walpole. E qui la narrazione serve soprattutto al rovesciamento parodico: l’autore non ha alcun interesse per il folklore della malavita organizzata e per i metodi del suo operare, ma punta dritto alla satira politica. (per approfondimenti: Maurizio Ascari La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998) Caleb Williams Scritta nel periodo che vide fiorire, anzi furoreggiare, il romanzo "nero" o "gotico" farcito di avventure orripilanti, la storia del giovane Williams si distingue nel genere per la relativa sobrietà dell'intreccio, e per l'innegabile vitalità artistica di molte parti. Caleb è un giovinetto di umili natali che Ferdinando Falkland accoglie nella sua casa ed educa per farne il proprio segretario. Egli si affeziona con trasporto giovanile al suo benefattore e ne è ricambiato. Falkland è un ottimo uomo ma ha un'eccessiva cura della propria reputazione che, a poco a poco, si trasforma in una vera e propria mania. Vicino al castello di Falkland abita Barnaba Tyrrel, ricco signore, protervo e prepotente, gelosissimo dell'ascendente che Falkland esercita su coloro che lo avvicinano. Un contadino, di nome Hawkins, vessato per futili motivi dal signorotto, si rivolge per protezione a Falkland e tanto basta perché Tyrrel lo faccia scacciare dal villaggio con tutta la sua famiglia. Sorte anche più triste tocca a Emilia Melville; ma si rifiuta di credere all'evidenza delle sue congetture finché Falkland non conferma direttamente i suoi sospetti, facendogli giurare che per nessun motivo mai rivelerà il segreto. Evaso dal carcere, cade nelle mani di briganti il capo dei quali, un ribelle non cattivo, lo prende a benvolere destando così la gelosia di un certo Gines che si mette al servizio di Falkland per vendicarsi di Caleb. E questi è costretto a mutare continuamente nome e residenza sempre perseguitato da Falkland che, sicuro del suo silenzio, è tuttavia furioso contro di lui che sa il suo segreto, e vuole rovinarlo. Finché un giorno, ridotto ormai alla completa indigenza, Caleb torna nella città natale e denuncia Falkland. Messo a confronto con il vecchio si commuove e, pur mantenendo l'accusa, elogia le grandi virtù di quell'uomo ch'egli ancora ama e rispetta. Una tale condotta riempie di vergogna e di ammirazione Falkland, che finalmente confessa il suo delitto e muore poco dopo. La vita continua per Caleb offuscata dal ricordo delle sofferenze passate e dal rimorso di non aver saputo serbar fede al giuramento fatto. Il libro incontrò un grande successo grazie soprattutto all'ottimo studio dei caratteri: il progressivo sviluppo della monomania di Falkland è condotto con straordinaria verosimiglianza. William Hazlitt dichiarò addirittura: "Forse l'arte con la quale questi due caratteri sono descritti, in modo che l'uno dia risalto all'altro, non è stata superata mai in nessun romanzo eccettuata l'immortale satira di Cervantes". Godwin, le cui idee razionaliste e rivoluzionarie influenzarono profondamente la letteratura inglese, scrisse questo romanzo per divulgare la sua filosofia e, infatti, si vendettero più copie di questo che non dei suoi Saggi e della Inchiesta concernente la giustizia politica. Caleb, Emilia, Hawkins e altri minori rappresentano i poveri perseguitati dai ricchi, impossibilitati a difendersi e ad avere giustizia, mentre i frequenti arresti dei vari personaggi offrono lo spunto ad acerbe critiche contro il sistema carcerario del tempo. Il romanzo ideologico di William Godwin – I° parte Caleb Williams, dedito a risolvere con logica inflessibile un caso d'omicidio, si può definire il primo detective in senso moderno. Il romanzo in tre volumi di cui è protagonista venne pubblicato nel 1794 da William Godwin (1756-1836), col titolo: Things as They are; or The Adventures of Caleb Williams. Da molti anni la mia vita è teatro di sventure. Sono stato oppresso da una tirannia ossessionante alla quale non potevo sfuggire. Ho visto le mie speranze stroncate. Il nemico si è dimostrato sordo alle implorazioni e infaticabile nel perseguitarmi. Le sue vittime: la mia reputazione e la mia felicità. Con questo incipit d’impatto melodrammatico, Caleb Williams scrive le sue memorie affinché i posteri gli rendano giustizia: la sua narrazione rappresenta per lui il solo strumento di riscatto. Egli racconta di essere divenuto segretario di Mr. Falkland, un gentiluomo colto e onesto. Ma i ripetuti attacchi di depressione e collera a cui questi è soggetto infiammano la curiosità e i sospetti di Caleb, spingendolo a indagare sul passato del suo padrone presso Mr. Collins, il maggiordomo. Egli descrive così la giovinezza di Falkland, il suo viaggio in Italia, dove venne coinvolto più volte in questioni d’onore, poi il suo ritorno in patria e lo scontro che lo oppone all’arrogante Mr. Tyrrel, un vicino signorotto locale, rozzo e violento. Ad accrescere l’inimicizia fra i due contribuisce la sfortunata storia d’amore tra Falkland e Emily, parente povera del protervo Tyrrel, che prima le impone il matrimonio con un bifolco e poi, non riuscendo a convincerla, la perseguita con ferocia finché la poveretta muore nella prigione dove egli l’ha fatta rinchiudere per pretesi debiti. Falkland, conosciuti i fatti, eccita l’opinione pubblica contro il malvagio, fino a farlo radiare dal circolo locale. E Tyrrel, inviperito dall’affronto, arriva a schiaffeggiare pubblicamente Falkland; ma, poche ore dopo, viene trovato assassinato. Fatta una sommaria indagine, il fittavolo Hawkins e il figlio, a loro volta angariati da Tyrrel, sono accusati del delitto e impiccati. Da quel momento, Falkland sfugge ogni compagnia e Caleb si persuade che l’assassino di Tyrrel sia lui. Così, nel secondo volume si svolge la metaforica partita a nascondino che oppone il segretarioinquisitore a Falkland, il quale tenta con ogni mezzo di sottrarsi all’esame. Caleb, convinto della colpevolezza di Falkland, nella frenesia di trovarne le prove tenta di scassinare, durante un incendio, il baule che Falkland conserva nello studio; ma questi lo coglie sul fatto, e in un impeto d’esasperazione finisce per confessargli l’assassinio, vincolando Caleb al segreto con terribili minacce. Ne segue una convivenza forzata. Dopo quella confessione, Caleb s’accorge che ormai Falkland segue ogni suo gesto e non gli permette di allontanarsi da casa. E, quando finalmente riesce a fuggire, viene catturato e condannato per furto su denuncia di Falkland. Il terzo volume ha inizio con l’evasione dal carcere di Caleb, che viene riacciuffato dal cacciatore di taglie Gines, grazie a un falso pamphlet in cui si narrano le avventure del bandito Caleb Williams. Ricondotto in prigione, il protagonista viene fatto scarcerare dallo stesso Falkland, che rinuncia a procedere contro di lui. Ma i suoi guai non sono finiti, poiché Gines continua a perseguitarlo grazie all’opuscolo, distruggendo la sua reputazione ovunque egli cerchi di rifarsi una vita. Vicino a perdere ogni speranza, Caleb ottiene un inatteso confronto con Falkland al cospetto di un magistrato. Mosso a pietà dalla vista del nemico ridotto all’ombra di se stesso, il giovane si riconcilia con Falkland, che alla fine ammette la propria colpevolezza e muore pochi giorni dopo, mentre il protagonista, lungi dal trionfare, si riconosce responsabile della sua morte. Una trama complessa, dunque. Nei primi due volumi del romanzo è il segretario a perseguitare il padrone, la cui vendetta si rivela affine al torto subìto: come Caleb ha estorto con armi subdole la sua confessione, così Falkland nasconde la propria argenteria nel baule del segretario (riposto in una stanza segreta, che crede di conoscere lui solo), accusandolo d’un furto che è emblema del suo vero “crimine”. Il romanzo è basato sull'assunto che il potere immancabilmente corrompe: a macchiarsi del crimine è infatti uno squire, esponente dei ceti nobiliari che usano eludere la severità della legge, purché non si tradisca la loro classe sociale. Alla giustizia divina, che per definizione colpisce il criminale comune, e alla nemesi popolare che mette il cappio al collo di Jonathan Wild, nel romanzo di Godwin si sostituisce un vero e proprio vendicatore: Caleb Williams, da molti considerato il primo detective. Successivamente, vedremo come l’intero romanzo sia una ricognizione realistica dell’Inghilterra di fine Settecento. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). Il romanzo ideologico di William Godwin – II° parte Things as They are; or the Adventures of Caleb Williams. Sin dal titolo, il romanzo si presenta come una ricognizione realistica dell’Inghilterra di fine Settecento. Nasce come romanzo giacobino, pregno dell’ideologia dell’autore, che condanna l’istituzione monarchica e allo stesso tempo rifiuta il regime democratico: Godwin, fiducioso nella perfettibilità dell’uomo e nel sistema di convivenza sociale, sostiene che è necessario abolire le leggi, le prigioni, la proprietà privata, il matrimonio e la chiesa. Infatti, nella prefazione del 1794, l'autore pone in rilievo il valore di pamphlet del romanzo, spiegando di aver tracciato un quadro delle cose “così come sono” perché in esse si specchia il governo politico, il cui spirito deviante s’infiltra in ogni strato della società. Ma, quando il romanzo viene ripubblicato nel 1831, col solo titolo di Caleb Williams, ormai gli ideali giacobini sono in declino e gli intenti ideologici sono stati oscurati dal ritratto del protagonista e dalla forza coinvolgente della storia. Godwin ricorda di aver concepito il progetto di un libro d’avventure sostenuto da un potente motivo d’interesse, e di aver seguito un metodo compositivo “inverso”, ideando dapprima il terzo volume, poi il secondo, e infine il primo. Partire dall’epilogo per arrivare all’incipit gli avrebbe consentito di costruire una trama incalzante e priva di smagliature, capace di catturare l’attenzione del lettore. Questo è il dato rilevante: Godwin concepisce prima l’effetto e poi la causa, dando al romanzo la coerenza strutturale (unity of design) tipica del novel, in cui l’autore ha una tesi da illustrare e considera superfluo tutto ciò che non è funzionale al procedere della trama o alla descrizione di una situazione o di un personaggio. L'eredità di Godwin verrà in seguito raccolta da Edgar Allan Poe, che allude più volte al metodo di composizione dello scrittore, sostenendo che la trama è una costruzione complessa che dev'essere determinata in tutte le sue componenti ancor prima d'iniziare a scrivere, e che nessun elemento del plot può essere alterato senza stravolgerne la struttura. In particolare, secondo Poe, il metodo “inverso” di Godwin riflette il modo di ragionare induttivo tipico del detective: partendo dalla causa, si cerca di risalire agli effetti che l'hanno determinata. Ma mentre in Poe (e, più in generale, nei detective novelists) economia e coesione suscitano un piacere di tipo “enigmistico”, in Godwin esse hanno l’unico scopo di meglio istruire. Tuttavia, lo stile incalzante di Caleb Williams induce a un passo svelto di lettura e lo rende, più che un romanzo impegnato, un proto-romanzo poliziesco. Caleb Williams, dunque, può essere considerato un antecedente diretto del poliziesco alla Poe. In primo luogo, per il metodo compositivo, che richiede un piano, rispetta certe regole e sa in ogni momento dov’è diretto. In secondo luogo, per l’indagine psicologica che accompagna la “unity of design”, del tutto simile al metodo di Poe, secondo cui le azioni umane obbediscono a leggi e sono quindi prevedibili. In terzo luogo, per la materia narrativa basata su elementi di matrice poliziesca, quali l’omicidio, l’indagine, la scoperta del colpevole; e poi la calunnia, il furto, la prigione, l’evasione, l’inseguimento, il processo. Caleb Williams apprendista detective Pur essendo sprovvisto di una formazione specifica, Caleb è dotato di una “inquisitive mind”: non trascura di trarre preziose informazioni da conversazioni e da libri. Con la mente sempre all'erta, dimostra quella particolare sensibilità per le concatenazioni di cause ed effetti che costituisce il marchio dell’investigatore. La sua passione per la logica si traduce anche nell’ossessione di “leggere” nell’animo umano: proprio alla lettura è riconducibile il lavoro che Falkland svolge insieme al segretario, il cui compito è scrivere sotto dettatura saggi letterari, spesso consistenti in “an analytical survey of the plans of different authors, and conjectural speculations upon hints they afforded, tending either to the detection of their errors or the carrying forward their discoveries”. La terminologia che troviamo in questo frammento – analytical survey, conjectural speculations, detection, discoveries – non potrebbe essere più allusiva: in pratica, è lo stesso Falkland a iniziare Caleb al metodo d’indagine che questi applicherà. Alla formazione dell’apprendista detective, tuttavia, non concorrono soltanto le doti logiche, la capacità di osservazione e la curiosità, ma anche la conoscenza della letteratura criminale. La natura di queste letture è rivelata dal personaggio stesso: rifugiatosi a Londra per sfuggire alla prigione, Caleb sopravvive pubblicando racconti, ma invece di attingere a una vena personale, sfrutta “the resource of translation” e, grazie alla sua ottima memoria, riscrive i libri che ha letto, tra cui le storie di Cartouche e Guzmàn de Alfarache. A ben vedere, la posizione di Caleb sta a metà fra il detective e il ladro: lo dimostra l’episodio in cui, per trovare conferma ai propri sospetti su Falkland, tenta di forzare il suo baule. Caleb, raccogliendo informazioni sul padrone, spiando ogni sua espressione, leggendo una lettera a lui indirizzata, compie un vero e proprio furto metaforico. Investigare appare dunque più un vizio che una missione: già conosciamo la scarsa simpatia che i delatori e i thief-takers esercitano sull’opinione pubblica dell’epoca; ad essa corrisponde la situazione ambigua dell’investigatore, la cui indagine mira alla distruzione di un gentiluomo che ha ucciso in un momento di follia. Anche se, in realtà, è più grave il secondo crimine di Falkland: quello di lasciar condannare due innocenti al posto suo, per un eccessivo senso dell’onore. Del resto, l’onore è il fondamento di una società stratificata, dove l’aristocrazia fonda il suo potere sulla solidarietà di classe e sul continuo mantenimento di un equilibrio al suo interno. La perdita dell’onore avrebbe comportato per Falkland un destino di proscrizione dai suoi pari, analogo a quello che egli, per vendetta, decide di infliggere a Caleb. L’immagine riproduce due pagine del William Godwin’s Journal, in cui William Godwin annota la nascita della figlia Mary (la futura Mary Shelley, autrice di Frankenstein, il più famoso romanzo gotico di tutti i tempi), il 30 agosto 1797, nell’ottavo dei 32 volumi del suo diario. (per approfondimenti: Bodleian Lybrary, University of Oxford http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wgjournal.html Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). Wieland di Charles Brockden Brown Il romanzo americano nasce sotto la costellazione dell’orrore. Malinconico e inquieto, sensibile e torturato, realista nelle intenzioni e visionario per temperamento, Charles Brockden Brown ne apre la storia con una potente tessitura d’incubi. Wieland; or The Transformation, apparso nel 1798, non è il primo documento, ma è certo la prima decisione narrativa di una letteratura alla ricerca di sé, il primo scatto della fantasia oltre i confini dell’imitazione. […] Brown trasforma profondamente l’orrore, forzandolo a significare l’inedita violenza e le laceranti contraddizioni della vita americana. Dopo di lui il “gotico”, in cui il preromanticismo aveva trovato il favoloso specchio deformante delle proprie inquietudini e nostalgie, non sarà più tanto un genere narrativo quanto una categoria dell’immaginazione. Così comincia l’introduzione all’edizione italiana del 1965 (Neri Pozza) del romanzo Wieland, ovvero la trasformazione, dell’americano Charles Brockden Brown (1771-1810). Dalla succinta scheda del Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi, scopriamo che l’intreccio deriva da un fatto di cronaca che insanguinò la città di Tamhannock nello Stato di New York nel dicembre del 1781. La scena è posta sulle rive dello Schuylkill, ma l’azione si svolge in realtà in un «fantastico clima romantico» e i personaggi sarebbero figure «bizzarre e irreali». Wieland, il protagonista, viene spinto al delitto da una voce misteriosa, la quale non è altro che l'eco della malvagità latente nella sua natura. E Carwin, il ventriloquo sobillatore che lo suggestiona, è un criminale che sfugge al giudizio della morale comune, visto che egli stesso è vittima di uno spirito del male a cui nessuno potrebbe resistere. Secondo il secco giudizio del Dizionario, «La narrazione è mal condotta; gli avvenimenti sono tutt’altro che verosimili; la catastrofe è prematura e quindi artisticamente ingiustificata. Il libro deriva la sua indiscutibile potenza unicamente dall'atmosfera di febbre che lo pervade e che riduce a unità gli elementi più lontani e disparati». Ma, secondo i critici più attenti, è con questo romanzo che la narrativa americana comincia in ogni senso: non solo perché è fra i primissimi comparsi negli Stati Uniti, ma anche perché annuncia e scopre molti dei temi sui quali i maggiori scrittori americani, da Poe e Hawthorne (che da Brown furono direttamente influenzati), a James e Faulkner costruiranno il loro lavoro. Ossia: l’ambiguità del reale, il conflitto fra ragione e mistero, l’identificazione della storia e dell’angoscia. La trama, in effetti, è fondata su coincidenze ed eventi al limite del miracoloso, con l’utilizzo di espedienti che vanno dall’autocombustione al ventriloquismo: vediamola per sommi capi. Convertitosi a una religiosità dominata dal terrore del divino, il padre della protagonista – Clara Wieland, che narra la vicenda nel corso di una lunga lettera – si trasferisce nel Nord America per diffondere il vangelo fra gli indiani. Una notte, quando Clara ha sei anni, il padre si reca come al solito a pregare in un tempietto e, nel corso delle sue sofferte meditazioni, prende fuoco per un fenomeno di autocombustione. Dopo il padre, muore anche la madre, e Clara, orfana insieme al fratello Theodore, viene allevata da una zia. Theodore, incline come il padre a una fede tormentata, si sposa e ha dei figli. A sei anni dal matrimonio – in un’epoca compresa fra le guerre indiane del 1763 e la rivoluzione del 1776 – si colloca l’azione principale, legata al manifestarsi di misteriose voci, talora benevole e talora minacciose. A produrle è Francis Carwin, un girovago che è entrato nella cerchia familiare dei Wieland attraverso Henry, il fratello della moglie di Theodore. Sfruttando il dono del ventriloquismo, Carwin comincia a intervenire in modo innocuo e buffonesco nel destino della comunità. Ma poi, incapace di controllare il pericoloso strumento di cui dispone, si dà a giochi via via più crudeli, facendo credere a Clara (per mettere alla prova il suo coraggio) che nello stanzino adiacente alla sua camera si celino due uomini pronti a ucciderla, e in seguito distruggendo la sua reputazione agli occhi di Henry, di cui è innamorata. Ma le inspiegabili voci prodotte da Carwin si rivelano fatali nell’influsso che hanno sul precario equilibrio mentale di Theodore, provocando conseguenze inimmaginabili. E’ indubbio che il romanzo, con una trama ai limiti dell’eccesso, offre più piani di lettura: la vicenda a forti tinte vuole convogliare un messaggio filosofico e politico. Brockden Brown è stato spesso definito dai critici ottocenteschi “the Godwin of America”. Innanzitutto perché, rinunciando all’onniscienza dell’autore, affida la narrazione alla protagonista, facendo propria la tecnica narrativa godwiniana. Però, ne ribalta i presupposti: mentre per Godwin il sintomo della verità è la “coerenza” (consistency, che si rivela però soggettiva), Brown mostra che sulla base delle nostre percezioni – inevitabilmente incomplete, talora viziate – costruiamo spesso “sceneggiature” di per sé coerenti ma infondate. Ciascun protagonista di Wieland riscrive una propria versione dei fatti, sincera quanto inesatta. Henry s’inganna nel credere Clara colpevole d’una relazione illecita sulla base delle voci udite nell’oscurità; Clara s’inganna nel ritenere che il ventriloquo Carwin abbia istigato il fratello, perché le sue voci simulate hanno contribuito solo in modo indiretto a suscitare una follia già latente; Theodore s’inganna nel credere che le ingiunzioni che sente provengano da Dio; infine Carwin, animato da intenti puerili, avvia un meccanismo su cui non ha controllo, adducendo a propria discolpa lo stesso vizio di Caleb Williams: «my only crime was curiosity». In realtà, più che sulla manipolazione delle apparenze fatta dal ventriloquo Carwin, l’autore sembra concentrarsi sul tema della leggibilità del reale, particolarmente sui processi cognitivi: sono le limitazioni del punto di vista – in senso ottico, valutativo e uditivo – a fare di ciascun personaggio un narratore inaffidabile. Il desiderio di leggibilità permea tutto il romanzo, e si esprime in un incrocio di sguardi indagatori cui fanno seguito lunghe riflessioni, come quelle di cui è oggetto Carwin al suo ingresso nella famiglia Wieland, o quelle solitarie di Clara, che medita sul giovane nel corso di notti insonni. È un romanzo gotico o poliziesco? Certamente Wieland costituisce un ponte fra i due generi. L’autore evoca l’armamentario orrifico del gotico, ma al contempo lo rinnega, perché dà alla figura di Clara una volontà di controllo razionale sui fenomeni inspiegabili che le accadono, prima aiutandola a superare le prove predisposte per lei da Carwin, e poi inducendola a incolpare lo stesso Carwin della pazzia di Theodore, proprio nel tentativo di quantificare ogni incognita della vicenda. E i crimini, intessuti a toni cupi sull’orditura del romanzo, sono spesso solo annunciati o enunciati. Così, allo scoccare della mezzanotte (l’ora in cui il padre è morto) dal suo letto Clara avverte un sussurro, ma dopo una ricognizione mentale della casa deduce che nessuno può essere entrato nella camera a sua insaputa. Poi, sente un secondo sussurro provenire dallo studiolo attiguo, dove due uomini discutono sul modo migliore per ucciderla. Così, fugge verso la casa del fratello, dove i familiari considerano il suo racconto come un sogno, non potendo credere che due persone fossero riuscite a intrufolarsi in un ambiente inaccessibile dall’interno e dall’esterno. Ecco, dunque, il topos della camera chiusa, familiare ai cultori del poliziesco: l’enigma delle voci sembrerebbe richiamare l’intervento di un detective; ma, paradossalmente, il solo personaggio che rivela una logica di tipo poliziesco è il malvagio. Wieland è disponibile in due traduzioni italiane: una di Neri Pozza (1965) e una di Studio Tesi (1988). Volumi acquistabili a metà prezzo, sciupati e scuriti dallo sballottamento nei brutali magazzini dell’oblio, dove vegetano e invecchiano i libri di cui nessuno si cura. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998. I Mémoires di Vidocq Disertore, falsario, ladro, galeotto: sono questi i trascorsi di Eugéne François Vidocq (1775-1857). Nato ad Arras, E. F. Vidocq intraprese presto la strada del crimine: più volte venne arrestato e puntualmente evase di prigione. Ma, in seguito, si mise a collaborare con la giustizia, avviando una straordinaria carriera che lo portò nel 1812 a capo della prima grande polizia moderna, la Sûreté parigina, ruolo da cui decadde nel 1827. Fu allora che Vidocq, forse nella speranza di un facile guadagno, forse per difendersi dalle accuse di corruzione che da più parti gli venivano indirizzate, s’accinse alla stesura dei suoi famosi Mémoires, i cui primi due volumi apparvero nel 1828, seguiti l’anno dopo da altri due. Poi, riottenuto il comando della Sûreté nel 1832, Vidocq rimase in carica solo otto mesi, a causa d’uno scandalo che coinvolse un suo agente. I Mémoires di Vidocq riscossero un successo clamoroso: vennero tradotti in inglese non appena pubblicati (in America li lesse attentamente anche Edgar Allan Poe), ed ebbero anche il merito di ispirare personaggi letterari immortali come Jean Valjean, il forzato evaso dei Miserabili di Victor Hugo, e, soprattutto, Vautrin (alias Jacques Collin, alias abate Herrera), uno dei personaggi più celebri della Comédie Humaine di Balzac. È complessa la genesi dei Mémoires: l’opera deve la sua forma definitiva all’intervento di due scrittori, identificati in Emile Morice e Louis-Francois L’Héritier, a cui sarebbero dovute sia le allusioni erudite sia alcuni plagi – come un episodio che era già stato pubblicato da L’Heritier in forma di romanzo. È dunque difficile – come può accadere con qualche scrittore di oggi – stabilire in che misura i Mémoires siano da attribuirsi a Vidocq. Per lo stesso motivo, è discutibile il loro reale valore di documento. Credo li si possa definire una “autobiografia romanzata”, che ha alcuni punti di contatto con Caleb Williams di William Godwin: così come Caleb si affida alla penna per sventare la persecuzione di Falkland – fondata sul pamphlet accusatorio diffuso da Gines – così Vidocq scrive i Mémoires per proclamare pubblicamente la “sua” verità. Inoltre, l'ambiguità del protagonista ricorda quella di Jonathan Wild, ladro e thief-taker alleato del potere, un parallelo che non sfuggì al pubblico inglese dell'epoca. L’infiltrato e il trasformista Il metodo poliziesco di Vidocq a capo della Sûreté era abbastanza semplice. Quando doveva svolgere un’inchiesta, sguinzagliava i suoi uomini, in genere ex criminali come lui, e i suoi informatori. Lui stesso si travestiva da delinquente e andava ad aggirarsi nei locali malfamati, dove conquistava le simpatie di ladri e assassini e li induceva a confidarsi con lui o a rivelargli precisi indizi, che poi utilizzava contro di loro. Dunque, l’attività investigativa di Vidocq implica un ampio spettro di talenti, primo fra tutti la conoscenza del mondo criminale maturata nel corso della sua precedente “carriera”. Vidocq fonda la sua ascesa proprio su questo tratto, riconducibile ai due ruoli dell’informatore e del detective, che tanto lo accomuna al thief-taker settecentesco: ma in questo modo si espone alla calunnia e si vede negare la rispettabilità. La professione d’informatore lo costringe a una frequentazione assidua dei bassifondi, per indurre i malviventi a tradire i compagni in cambio dell’immunità e di altri compensi. Grazie ai suoi trascorsi criminali, Vidocq dispone della più importante chiave d’accesso al mondo malavitoso che, come si sa, gode di convenzioni e codici propri: la padronanza dell'argot, la lingua gergale utilizzata fin dal Seicento da mendicati, truffatori e assassini, che erano costretti a celare alle orecchie indiscrete il senso dei loro discorsi. L'argot è un registro linguistico di natura criptica, decodificato dalla polizia nei primi anni dell’Ottocento e ammesso nella letteratura “alta” proprio attraverso i Mémoires di Vidocq. Infatti, i Mémoires sono infarciti di dialoghi argotiques, e se in un primo tempo Vidocq dà la traduzione delle espressioni oscure, a poco a poco il lettore finisce per scoprirsi iniziato al gergo della malavita. Più volte Vidocq ha svolto il ruolo di agente provocatore, inducendo al furto i malviventi per poi coglierli sul fatto: qui è di grande importanza la sua abilità nei travestimenti, in cui eccelle, riuscendo addirittura a modificare di alcuni centimetri la propria statura. Il pubblico londinese poté osservare le sue performances nel 1845, allorché Vidocq organizzò in Regent Street una specie di esposizione, discutendo i suoi casi più celebri ed esibendo le sue molteplici identità. Oltre all’astuzia e alle pratiche non ortodosse, Vidocq adotta moderne tecniche sistematiche, provvedendo a schedare tutti gli arrestati, per poi ritrovarli più facilmente in caso d'evasione. Infatti, nel quarto volume dei Mémoires egli traccia un’ampia tassonomia, dividendo i criminali in tre categorie: ladri di professione, ladri occasionali e ladri per necessità, ognuna di queste dotata di classi e sottoclassi. Prendiamo ad esempio i cambrioleurs, o ladri d'appartamento, solitamente di età compresa fra i 18 e i 30 anni: secondo la classificazione, vestono decorosamente ma conservano qualcosa d’ordinario; spesso hanno le mani sporche, e tengono in bocca una cicca di tabacco che deforma loro il volto; di rado portano il bastone, e ancor più di rado indossano guanti. Si dividono in cambrioleurs à la flan, che s'introducono nelle abitazioni senza aver preparato il colpo; caroubleurs, che tramite i domestici, i cardatori di materassi, gli imbianchini e i tappezzieri, assumono informazioni sull’appartamento da svaligiare – e talvolta vi penetrano servendosi di chiavi false, fabbricate grazie ai calchi forniti dai complici; e infine i nourisseurs, così detti perché i loro furti hanno una lunga gestazione, nell’attesa che giunga il momento opportuno. A dispetto di tutte le accuse di cialtroneria che gli furono indirizzate, Vidocq difese sempre questa sua classificazione come fondata sull’esperienza, dichiarandosi capace di riconoscere tra i passanti i ladri di professione, e persino d’indicare lo specifico gruppo a cui appartenevano. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998 http://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Fran%C3%A7ois_Vidocq) Edgar Allan Poe Storicamente, si possono distinguere due Poe. Uno è l’Edgarpò che suscitò l’entusiasmo dei francesi, da Baudelaire a Valéry, e ha avuto ininterrotta fortuna in Europa. L’altro è Edgar Allan Poe, l’americano – poeta e narratore di cassetta, instancabile fornitore di testi per l’incipiente mercato di massa (scrive quasi esclusivamente su riviste), figura di irregolare ostilmente accolto dai letterati dell’epoca, che stenta ancora a trovare pieno riconoscimento in patria. Il primo […] è il narratore dell’assurdo e del terrore, precursore degli effetti surreali e dell’angoscia esistenziale, il creatore di una propria cosmologia metafisica che è puro sogno dell’intelletto; lo scrittore precocemente consapevole delle potenzialità combinatorie e scombinatorie del linguaggio, della scrittura come costruzione mistificatoria e della lettura come esercizio di decifrazione. Questo Edgarpò scoperto o privilegiato dalla cultura europea – anche perché ha ottimi traduttori che magari ne mascherano certa farragine o pesantezza stilistica – arriva da Baudelaire fino a noi per susseguenti ondate di interesse. È autore sofisticato, quasi d’élite. L’altro si arrabatta. È quello che Lionel Trilling ha chiamato – riferendosi agli americani, ma vale anche per noi – “nostro cugino, Mr. Poe”: lo scrittore tormentato dal vuoto e dalle incomprensioni in cui vive, che si dibatte in una società ostile e in una cultura in formazione, tutta da definire, plasmare, indirizzare, ma come restia a ogni richiamo, stimolo, indicazione non meramente commerciali. È, questo Poe, il primo scrittore alienato d’America, e su una dimensione assoluta: sperso nella vastità degli spazi e nella mancanza di un centro, girovago fra il sud natio di cui si fa non richiesto paladino e le città centro-meridionali che lo tengono ai margini e ne rifiutano il messaggio, eppure caparbiamente animato dalla volontà di dare una voce e una cultura al nuovo paese, rigoroso nelle scelte e in anticipo sui tempi. Come tale, esprime la desolazione di quel paesaggio e le antinomie dei suoi valori, e al tempo stesso riflette le tare e i turbamenti di una morbosa predisposizione psicologica, vuoti e scompensi dell’animo, angosce e terrori che in seguito si diranno esistenziali, e che sorgono come fantasmi dal profondo. (dall’introduzione di Sergio Perosa ai Racconti, ed. Mondadori 1985.) Calcolo e analisi: I delitti della Rue Morgue In numerosi racconti, Edgar Allan Poe premette alla vicenda narrata uno o più paragrafi dedicati a considerazioni di carattere generale, nate da un’intuizione, da una massima, o da una riflessione filosofica. Queste “istruzioni” preliminari sono particolarmente importanti in The Murders in the Rue Morgue, il racconto che inaugura la trilogia dell’investigatore francese Auguste Dupin. Qui la struttura è tripartita, secondo un criterio formativo: alla definizione teorica delle facoltà analitiche, segue una prima dimostrazione del talento di Dupin e, infine, l’applicazione delle sue doti investigative a un caso d’omicidio. La voce narrante inizia subito col distinguere il calcolo dall’analisi, due categorie di ragionamento riconducibili rispettivamente agli scacchi e alla dama, passatempi che chiamano in causa da un lato l’attenzione e dall’altro l’acume. L'elevato numero di pezzi che si fronteggiano in una partita a scacchi, infatti, impegna non solo le doti mnemoniche, ma certamente una capacità d’analisi molto inferiore a quella necessaria per vincere una partita a dama, ove restino in campo solo quattro regine. In un confronto del genere, essendo la gamma di movimenti e valori quanto mai semplificata, la possibilità di sviste è ridotta al minimo, e per assicurarsi la vittoria è necessario sapersi identificare con lo spirito dell’avversario. Ma una prova ancor più forte per le facoltà analitiche del detective è rappresentata dal gioco del whist, in cui non basta osservare attentamente, aver buona memoria e conoscere a fondo la condotta di gioco, ma è necessario sapere “cosa osservare”. Il modo di reggere una carta, il gesto con cui viene calata, le espressioni d’un giocatore, sono tutti segni rivelatori di cui l’analitico si avvale. Terminata questa trattazione teorica, Poe entra nel vivo del racconto introducendo il cavalier Auguste Dupin, incontrato dal narratore in un «oscuro gabinetto di lettura di rue Montmartre». Rampollo decaduto di un’illustre famiglia, Dupin è un uomo di abitudini frugali, che deve alla generosità dei creditori il fatto d’avere «un piccolo resto di patrimonio», e il cui unico lusso risiede nei libri. Tra lui e il narratore nasce dunque un sodalizio, sanzionato dalla scelta di stabilirsi in una dimora cadente, oggetto d’imprecisate superstizioni. I due trascorrono le ore diurne nell'oscurità più completa, uscendo solo al calar delle tenebre, quando la città, deposta la maschera borghese, rivela il suo volto criminale, perverso e inebriante. Il detective sonda implacabile le ombre della notte e, nella seconda parte del racconto, si dimostra anche capace di leggere nei cuori. Tutto comincia con una strage. Alle tre di notte, gli abitanti di Rue Morgue vengono svegliati «da una serie di grida spaventevoli», provenienti da un appartamento al quarto piano d’un vecchio stabile, abitato dall'anziana madame L’Espanaye e da sua figlia Camille. Per entrare, i primi soccorritori devono sfondare la porta d’ingresso, solidamente chiusa dall’interno. Lo spettacolo che si trovano di fronte è terrificante: «La stanza è nel più grande disordine; i mobili spezzati e sparsi in tutte le direzioni. I materassi del letto sono stati tolti e gettati nel mezzo dell’impiantito. Su una sedia giace un rasoio intinto di sangue. Sul camino, due o tre lunghe trecce di capelli grigi che sembrano essere state strappate violentemente dalle radici. Nessuna traccia di madame L’Espanaye: si osserva però una quantità insolita di fuliggine sul focolare; allora si cerca nel camino e (orribile a dirsi!) ne viene estratto il cadavere della figlia, che è stato spinto, con la testa in giù, a viva forza, fino a un bel tratto della stretta apertura!». Dopo una minuziosa investigazione della casa, in un cortiletto situato sul retro i vicini trovano il cadavere della vecchia signora, con la gola profondamente tagliata, al punto che, quando si prova a sollevarlo, il capo si stacca completamente dal busto. Sia il corpo sia la testa «appaiono spaventosamente mutilati ed è tanto se conservano un aspetto umano», come scrivono l’indomani i giornali parigini. La polizia brancola nel buio: l’appartamento è stato trovato ermeticamente chiuso, e nessuno sembra poterne essere uscito dopo il delitto. Le porte erano sbarrate, le finestre anche; e dalle scale si sono sentite le urla degli assassini, proferite in un linguaggio su cui nessuno dei testimoni riesce a mettersi d’accordo: secondo alcuni è italiano, secondo altri inglese, o francese, o spagnolo, o russo. La polizia «denuda addirittura i pavimenti, soffitti e pareti», per scoprire un’eventuale uscita segreta, ma senza risultato. Non resta che fare appello alle facoltà investigative di Dupin. Munito dell’autorizzazione del prefetto di Parigi, il cavaliere e il suo amico si recano nella casa del delitto. Sebbene si sia frugato dappertutto, il detective non si fida degli occhi della polizia e vuole cercare coi propri. In effetti, non esistono uscite segrete, così come non è possibile passare attraverso il camino, troppo stretto. Dalla prima stanza dell’appartamento, poi, l’assassino o gli assassini non possono essere usciti, perché sarebbero stati visti dalla folla che guardava in alto o dai soccorritori che salivano per le scale. «Devono essere passati dalle finestre della stanza sul retro» spiega Dupin: proprio le finestre trovate ermeticamente chiuse. «Essendo ora arrivati a questa conclusione per mezzo d’irrefragabili deduzioni, non è affar nostro, come ragionatori, rigettarla in ragione della sua impossibilità apparente. Non ci resta che dimostrare che questa apparente impossibilità in realtà non esiste». Così, il detective parte alla ricerca della prova che dimostri la validità del suo ragionamento. E la trova: un chiodo spezzato che sembra intatto, una molla che chiude automaticamente il telaio della finestra, e l’enigma è spiegato. Fuori della finestra, però, c'è una parete liscia, e l'altezza è notevole; ma a due metri di distanza passa il filo d’un parafulmine, e un essere dotato di una «straordinarissima e quasi sovrannaturale specie di forza e agilità», un essere capace di ficcare Camille nella cappa del camino, può benissimo essere saltato da quel filo alla finestra e viceversa, utilizzando la pesante persiana di legno come appoggio e prolunga. A conferma di ciò, ai piedi del filo del parafulmine Dupin trova un pezzo di nastro, legato con un nodo tipico dei marinai maltesi. Scoperta la possibile chiave dell’enigma, non sarà difficile completare il mosaico e inserire al loro posto quegli indizi così apparentemente contraddittori che disorientano la polizia: la ferocia e la gratuità del delitto, la forza sovrumana dell’assassino, gli strani peli rossicci trovati nelle mani di una delle vittime, il linguaggio incomprensibile sentito dai vicini. In questo racconto, pubblicato nell'aprile del 1841 sul The Graham's Lady's and Gentleman's Magazine, abbiamo il mistero della camera chiusa, il problema investigativo per eccellenza, alla cui soluzione può arrivare solo la sottigliezza dell’investigatore. Ma troviamo anche la classica mancanza di fantasia e la suscettibilità dei funzionari di polizia: «...il funzionario non poteva nascondere il suo dispiacere per la piega che aveva preso l’affare e si lasciò sfuggire qualche sarcastica osservazione su quanto sarebbe desiderabile che ognuno s'occupasse delle proprie faccende». In più, ci sono l’arresto di un innocente e lo stratagemma dell’investigatore per forzare la mano al colpevole. Senza dubbio, il metodo investigativo di Dupin ricalca alcune caratteristiche tipiche del procedere scientifico: la capacità di ricostruire il tutto da una parte; la convinzione che dietro l’apparente complessità di un enigma si celi una soluzione semplice; l’attenzione data a indizi e circostanze che invece appaiono marginali. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). Edgar Allan Poe e l’eroe seriale Con la trilogia di Auguste Dupin, Poe crea la prima figura di eroe seriale, un modello destinato a diventare, attraverso l’opera di Arthur Conan Doyle e i serials televisivi, la forma narrativa dominante del ventesimo secolo. I suoi tre racconti, tuttavia, presentano una chiara progressione: nel primo, Dupin si confronta con un omicidio privo di movente; nel secondo, Poe tenta di mescolare realtà e finzione, misurandosi con un autentico caso di cronaca; nel terzo, il geniale detective si scontra con un avversario suo pari, secondo un disegno che prelude alla celebre coppia di antagonisti Sherlock Holmes - dottor Moriarty. In The Mystery of Marie Roget, il cavalier Dupin torna nuovamente agli onori della cronaca tentando di risolvere, sulla base delle testimonianze riportate dai vari giornali, il mistero della scomparsa di una graziosa commessa di profumeria, Marie Roget. Ispirandosi a un reale caso di cronaca avvenuto a New York, l’omicidio della sigaraia Mary Rogers, il narratore espone i fatti: uscita di casa per recarsi dalla zia, Marie Roget viene trovata quattro giorni dopo, annegata nella Senna e recante segni di violenza. Sui resoconti della stampa Dupin fonda la propria indagine, spesso demolendo le ipotesi via via formulate dagli articolisti. Disgraziatamente, nella realtà, mentre è in corso la pubblicazione a puntate del racconto, un’albergatrice confessa in punto di morte che il decesso di Mary Rogers è stato causato da un tentativo di aborto. E questa versione, pur confermando numerose deduzioni di Dupin, contraddice in pieno le sue conclusioni: a Poe non resta dunque che modificare il finale, per tener conto della testimonianza. L’indagine viene troncata allorché Dupin ha identificato l’assassino in un marinaio dalla carnagione scura di cui Marie sarebbe stata innamorata, e Poe redige una nota fittizia, in cui il direttore della rivista dichiara di non aver pubblicato – per «ovvie ragioni» – il seguito del manoscritto, assicurando i lettori che l’inchiesta venne condotta a buon fine dalla polizia parigina. Per rimediare all’inconveniente, e giustificare la mancata aderenza del racconto alla conclusione della vicenda reale, Poe si rifà all’immagine delle due serie di eventi paralleli, dichiarando che se il destino di Mary e quello di Marie sono legati da numerose coincidenze, ciò non vale per lo scioglimento del mistero. La lettera rubata Un anno dopo la pubblicazione dei Murders in the Rue Morgue, Poe riporta Auguste Dupin sulla scena parigina per fargli interpretare un breve ma perfetto racconto: La lettera rubata (The purloined letter). È il tardo crepuscolo: i due protagonisti siedono nel “gabinetto di lettura” del loro appartamento, quando arriva il prefetto. Dupin s’appresta ad accendere un lume, ma all’udire che il prefetto è venuto a consultarlo su una questione complicata, preferisce restare nella semioscurità. Questo è il primo dei ribaltamenti operati da Dupin: a essere rovesciato è il tradizionale meccanismo associativo che unisce la ragione alla luce. Nel seguito della conversazione, allorché il prefetto confessa la sua impotenza a risolvere un caso che pure si presenta semplicissimo, il detective replica: «Forse il mistero è un po' troppo semplice». Il prefetto espone quindi le inconsuete circostanze su cui s’è trovato a indagare. Una lettera compromettente è stata rubata alla regina da un ministro intrigante. Mentre è nel boudoir, immersa nella lettura di una lettera strettamente personale, all’ingresso del consorte la regina posa la lettera sullo scrittoio, col testo rivolto verso il basso. Entra allora il ministro, che, riconosciuto il mittente nella grafia dell'indirizzo riportato sul retro, decide di sottrarre il prezioso documento per usarlo a fini di ricatto. Messa sul tavolo la lettera che ha in mano, egli conversa per qualche tempo e, prima di congedarsi, s’appropria come per errore dell’altro foglio. Da quel momento, l’uomo regge le sorti della politica francese, grazie all’ascendente che esercita sulla regina. Convinti che il ministro conservi sempre la lettera a portata di mano, gli uomini della polizia perquisiscono accuratamente tanto lui quanto la sua abitazione, senza alcun risultato. La visita del prefetto rappresenta quindi il riconoscimento della sua sconfitta, e l’analitico Dupin provvede a smontare pezzo per pezzo il metodo da lui adottato. Richiamandosi al gioco del “pari o dispari”, in cui un bambino può battere i compagni identificandosi con loro e prevedendone le mosse, l’investigatore mette a nudo l’incapacità della polizia di valutare l’avversario: se la loro forma mentale è quella della massa, non appena si confrontano con un criminale diverso da loro, si trovano in scacco. Le ricerche della polizia si dimostrano inefficaci perché fondate sul presupposto che a occultare la lettera sia stata una persona dai comuni percorsi mentali, per cui nascosto è sinonimo d’invisibile. Non è affatto detto che la lettera sia stata sottratta alla vista: richiamandosi a un gioco in cui si cerca di trovare su una carta geografica un nome scelto dagli avversari, Dupin osserva che, contrariamente a quanto si crede, le scritte a chiare lettere sono spesso meno individuabili delle più piccole. Il metodo con cui il detective affronta il caso è ben diverso. Munito d’occhiali scuri, per consentire ai suoi occhi di vagare indisturbati, Dupin s’introduce nello studio del ministro, e non tarda a notare un portacarte appeso alla mensola del camino, dove insieme ad alcuni biglietti da visita si offre negligentemente allo sguardo una lettera sdrucita. In questa visibilità così marcata, egli coglie un segno d’ostentazione, che rimanda paradossalmente alla volontà di celare la lettera. Tornato il giorno seguente dal ministro, in apparenza per recuperare la propria tabacchiera, Dupin approfitta della momentanea distrazione dell’ospite, attirato alla finestra da uno sparo (trucco organizzato dallo stesso Dupin), e s’impadronisce della lettera, sostituendola con una del tutto simile. Così, quando il capo della polizia si reca dal detective, questi gli consegna la lettera rubata. Non ci resta che concludere con una citazione dai Mémoires di Vidocq: «Il luogo più in vista è spesso quello dove non si pensa di cercare». (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998. Emile Gaboriau Nella Francia dell’Ottocento, quasi tutti i grandi scrittori si cimentano nel feuilleton: da Balzac ad Alexandre Dumas padre; ma il più grande successo di pubblico in questo genere di letteratura lo riscuote Eugéne Sue con I Misteri di Parigi (Les Mystéres de Paris, 1842-43). Fra i principali autori di feuilleton, citiamo i due più prolifici creatori di intrighi, Paul Féval (1817-1887), che sfornò oltre 100 romanzi, e il visconte Pierre Alexis de Ponson, in arte Ponson du Terrail (1829-1871), il creatore di Rocambole, il delinquente destinato ad avere una lunga progenie di seguaci e imitatori. Genio del male in una lunga serie di romanzi, da Les drames de Paris a Les exploits de Rocambole (1859), nel quale il terribile bandito muore col volto devastato dal vetriolo, Rocambole si trasforma in seguito in un detective votato al bene (da La Resurrection de Rocambole, 1862). In realtà, il vero erede francese di Edgar Allan Poe è Emile Gaboriau (1832-1873). Dopo una giovinezza tumultuosa, Gaboriau arriva a Parigi, diventa segretario dello scrittore Paul Féval e comincia a dedicarsi al giornalismo. Ed è proprio in occasione di un reportage per Le Pays nel quartiere della Porte d’Italie, che Gaboriau stringe amicizia con un ex-ispettore della Sureté, Tirabot, detto Tirauclair (“Mettinchiaro”), e decide di scrivere un romanzo poliziesco sul tipo di quelli di Poe, che tanto l’hanno entusiasmato nella traduzione di Baudelaire. Nasce così L'Affare Lerouge (L'Affaire Lerouge). Pubblicato a puntate nel 1863 su Le Pays, il romanzo passa praticamente inosservato, mentre la sua riedizione su Le Soleil, due anni più tardi, riscuote un clamoroso successo. Il giovedì 6 marzo 1862, posdomani del martedì grasso, cinque donne del villaggio della Jonchére si presentavano all’ufficio di polizia di Bougival. Esse raccontarono che da due giorni nessuno aveva più visto una loro vicina, la vedova Lerouge, che abitava sola, in una casetta isolata. Parecchie volte avevano bussato, ma inutilmente. Le finestre, come la porta, erano chiuse ermeticamente, quindi era stato impossibile gettare un’occhiata nell’interno. Questo silenzio, questa scomparsa, le turbavano. Temendo un delitto o aleno una disgrazia, esse domandavano che «la Giustizia», per rassicurarle, forzasse la porta e penetrasse nella casa. In questo primo romanzo poliziesco, Gaboriau segue molto la lezione degli Assassinii della Rue Morgue: «Tutto, nella prima stanza, denunciava con lugubre eloquenza la presenza dei malfattori. I mobili, una credenza e due grandi cassapanche, erano forzati e rovesciati. Nella seconda stanza, che serviva da camera da letto, il disordine era ancora maggiore: pareva che qualcuno, in preda alla follia, si fosse impegnato a buttare ogni cosa fuori posto. Infine, presso il caminetto, il viso nella cenere sparsa, era steso il cadavere della vedova Lerouge. Tutto un lato della faccia e dei capelli erano bruciati». Ben tre sono i personaggi chiamati a risolvere il caso della vedova: il capo della polizia, Gevrol, funzionario ligio al dovere, tipico poliziotto di routine; l’anziano dilettante Pére Tabaret (detto Tirauclair) e, infine, in una parte minore, un giovane ispettore arrivista, Lecoq (nome che ricalca quello di Vidocq). Sarà Pére Tabaret a risolvere l'enigma della vedova Lerouge, dopo che la polizia ha fallito e ha pure arrestato un innocente. Nei successivi romanzi, Il dossier 113 (Le dossier 113), Il dramma d’Orcival (Le crime d’Orcival), entrambi del 1867, Monsieur Lecoq (1869) e La corda al collo (La corde au cou, 1873), l’attenzione dell’autore si sposta da Gevrol e Tabaret a Lecoq. Soprattutto a partire da Il dramma d’Orcival, la storia di un duplice misterioso omicidio avvenuto nel castello dei conti Trémorel: la polizia locale è convinta d’aver fatto piena luce sul fatto di sangue e ha arrestato i presunti colpevoli, quando da Parigi giunge Lecoq a infrangere ogni illusione. Coi suoi metodi particolari, il detective avvia le indagini: esamina tutte le circostanze del crimine, raccoglie dettagli, individua i moventi, collega fra loro i vari personaggi e le diverse vicende; infine, trova l’uomo la cui colpevolezza giustifica tutte le circostanze, i dettagli, i dati raccolti e collegati. Lecoq è un investigatore eccezionale, perché è paradossalmente dotato di una “mentalità criminale”, che gli permetterebbe di commettere crimini perfetti e, quindi, anche di svelarli. Ex piccolo delinquente “riconciliatosi con la legge”, prima di entrare nella polizia Lecoq ha lavorato come assistente presso un celebre astronomo, il barone Moser. Anzi, è stato proprio il barone, al quale aveva sottoposto un suo “piano perfetto” per rapinare una banca, a scoprire in lui la vocazione poliziesca: «Quando si hanno le vostre disposizioni e si è poveri, si diventa o un ladro o un celebre poliziotto. Scegliete!». Lecoq sceglie di entrare nella Sureté. Il tratto della “mentalità criminale” non è scelto a caso da Gaboriau: esso spiega in realtà il metodo di “identificazione psicologica” con cui opera il suo personaggio. Nel corso delle indagini, Lecoq si spoglia della propria personalità, sforzandosi d’entrare nei panni e nella mentalità dell'assassino. In questo, egli è l'erede spirituale di Dupin, ma a differenza dell’eroe di Poe, Lecoq non si isola nell’astrazione. Dupin è un infallibile ragionatore, che si dedica ai particolari unicamente per la morbosa soddisfazione di constatare d’aver raggiunto conclusioni esatte. Il suo interesse è rivolto al problema “in sé”, e non ai personaggi che gli si muovono intorno. Lecoq, al contrario, esita, segue una pista, s’accorge che non è quella giusta e ricomincia le indagini. Invece di avanzare ipotesi ardite, che la verifica dei fatti dimostrerà esatte, il detective francese esprime il proprio giudizio solo dopo aver svolto un esame minuzioso degli avvenimenti. Lecoq è un uomo, non un sillogismo personificato, quindi preferisce l’indagine al puro ragionamento intuitivo. Un criminologo degli anni Trenta, Edmond Locard, ha così sintetizzato la differenza dei metodi investigativi di Poe e di Gaboriau: «Per quanto riguarda l'inchiesta criminale, l’americano incarna il genio e il francese il talento. Il poliziotto di Poe è tutto intuizione; quello di Gaboriau è tutto esperienza, saggezza e pratica del mestiere». Gaboriau e Poe, insomma, hanno inventato i due personaggi-chiave del racconto poliziesco, il detective dilettante e il commissario di polizia, creando così due scuole ben differenziate: quella francese e quella angloamericana. «A seconda che gli autori diano più importanza all'inchiesta o al mistero», scrive il giallista francese Thomas Narcejac, «si inseriscono in due scuole che corrispondono a temperamenti nazionali molto marcati. Gli anglosassoni, in genere, si interessano particolarmente alle vicende dell’inchiesta, quella speciale partita a scacchi che l’investigatore è chiamato a giocare. I francesi, invece, sono più sensibili all’aspetto romanzesco e melodrammatico del poliziesco: ambiente, personaggi pittoreschi, colpi di scena». (per approfondimenti: Stefano Benvenuti - Gianni Rizzoni, Il romanzo giallo, Mondadori, Milano 1979). L’intermezzo giapponese di Contenebbia Nel raccontare le “origini della detective fiction”, non potevo trascurare un interessantissimo tributo che il Contenebbia, in due recenti post, ha offerto a uno scrittore mistery giapponese di cui non conoscevo l’esistenza: Edogawa Ranpo. Lo ripropongo qui, su gentile concessione, come imprescindibile tassello dell’affresco che sto cercando di costruire. Ranpo, il cui vero nome è Tarō Hirai, nasce il 21 ottobre 1894 a Nabari, presso la prefettura di Mie, da una famiglia di samurai. Nel 1912 il padre si trova ex abrupto sul lastrico e fugge, alla ricerca di miglior sorte, per la Corea. Il ragazzo si trasferisce quindi a Tōkyō dove, accettando una serie di lavoretti saltuari, riesce a mantenersi e a proseguire gli studi, non senza fatiche e stenti. Proprio qui, nelle giornate trascorse alla Biblioteca Pubblica, scopre i romanzi di Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, insopportabile per quanto imbattibile detective cocainomane, e gli allucinati racconti di Poe (la cosa non deve stupire, visto che, già nella seconda metà dell’Ottocento, dopo quasi tre secoli di volontario isolamento- anche- culturale, il Giappone aveva cominciato a pubblicare opere di scrittori stranieri). Buttata alle ortiche una laurea in economia, Ranpo sceglie l’impervia strada del nomade, spostandosi un po’ per tutta la nazione, accettando gli impieghi più disparati: impiegato in varie piccole aziende , gestore di un negozio di libri usati, e poi di un ristorante di soba cinese, per finire poi nella redazione di un giornale. Nel frattempo, in tutti questi anni “di formazione” Ranpo non smette di scrivere racconti e, cosa importantissima per la solidificazione della propria weltanschauung autoriale, di tradurre romanzi di “colleghi” stranieri. A questo punto, il Contenebbia apre un’interessante parentesi su Edgar Allan Poe, definito da Baudelaire «un Lord Byron abbandonato in una terra che gli è nemica», un punto di non-ritorno del Romanticismo Nero. Con la creazione del gelido Auguste Dupin, protagonista dei racconti I delitti della Via Morgue, Il mistero di Marie Roget e La lettera rubata, Poe diede vita al primo detective nella storia della letteratura di genere, anticipando tutti i gialli “deduttivi” a venire. Ma la sua fama è maggiormente legata ai Racconti Straordinari fra cui vale la pena ricordare quelli che lo stesso Poe amava citare: Ligeia, Il crollo della casa degli Usher, Il cuore rivelatore, Il gatto nero, Il pozzo e il pendolo… Prima di lui, tutti gli scrittori, anche i portavoce del Gotico, erano sempre rimasti legati a precise convenzioni letterarie, come, ad esempio, la scansione manichea fra Bene e Male col conseguente trionfo del primo sul secondo… Avevano, insomma, come dirà poi H.P. Lovecraft: «lavorato per la maggior parte al buio, senza comprendere il fondamento psicologico esercitato dal tema dell’orrore». Ecco la grande novità di Poe: scandagliare gli oscuri recessi dell’animo umano, dove l’Es urla e cerca di strapparsi le catene, facendosi così interprete, prima di Freud, delle più celate pulsioni (si pensi alle pesanti allusioni necrofile presenti in Ligeia o in Morella). In questa fondamentale “dualità”, nell’aver saputo coniugare lo “speculum” del medico legale con la tremolante lanterna del Visionario Errante, va ricercato il motivo dell’incondizionata ammirazione di Ranpo per il maestro americano. Infatti, nei primi esperimenti narrativi, Tarō Hirai cercherà di emulare le pagine di Poe, come nel racconto Odoru Issunbōshi (Il nano danzante), inequivocabilmente ispirato a Hop-Frog. E quando nel 1924 arriva improvvisamente il successo, col racconto Nisen dōka (La moneta da due sen) pubblicato dalla rivista Shinseinen (Gioventù nuova), l’ombra di Poe è più che mai presente: il protagonista che riesce a scoprire il bottino di una rapina decifrando un crittogramma inciso su di una monetina di rame, non è che una citazione de Lo scarabeo d’oro. È qui, dunque, che inizia la letteratura poliziesca giapponese; ed è qui che nasce lo pseudonimo di Edogawa Ranpo, che letteralmente significa «a zonzo per il fiume Edo» ma che riecheggia senz’ombra di dubbio il nome di Edgar Allan Poe. Scrive Contenebbia: L’anno successivo, col romanzo Dizaka no satsujin jiken (Assassinio alla Salita D) crea la figura del detective Akechi Kogorō che otterrà con gli anni uno straordinario successo grazie ad una serie di libri pensata dall’autore per il pubblico dei ragazzi. Da questo momento la lista di bestseller si fa quasi interminabile: Akai heya (La camera rossa), Ningen Isu (La poltrona umana), Yami ni ugomeku (Brulicare nelle tenebre), Inju (La belva nell’ombra) e Akumu (L’incubo)…Ed è proprio in questi volumi che lo sguardo di Ranpo sembra scollegarsi sempre più dalle rigide impalcature della “detection” per librare verso i lidi dell’Irrazionale, dove l’Orrore si può sposare col Sublime, ed il Grottesco danza un paso doble col Raccapricciante… I suoi personaggi vivono sempre un’esistenza grigia, triste genitrice di noia e frustrazioni assortite. Solo attraverso la fuga in un mondo squisitamente utopico, mentale (se non paranoico, in molti casi), soltanto grazie al brivido dell’atto criminale o dell’abominio sessuale, le creature di Ranpo trova una paradossale forma di appagamento, di riscatto. Proprio per codesta propensione allo scandagliare il Mr. Hyde che sonnecchia in ognuno di noi, (e per l’abitudine di sfruculiare nei talami dei propri connazionali svelandone le più intime perversioni), il buon Edogawa Ranpo divenne, soprattutto negli anni della nouvelle vague nipponica (ma non solo) l’autore più amato dai giovani registi, indecisi fra languide efferatezze da ero-guro e pulsioni avant-garde… Ed ecco che, implacabilmente, arriviamo al cuore, alla “magnifica ossessione” esistenziale – se mi è consentito – di Contenebbia: il Cinema. Citando solo per dovere di completezza i 9 film, prodotti tra il 1956 ed il 1959, del ciclo Shonen tanteidan (Il club dei ragazzi detective) e tralascindo gli innumerevoli adattamenti televisivi, va qui detto che solo grazie a sguardi obliqui come quelli di un Masumura o di un Tsukamoto e alla voglia di solidi mestieranti come Teruo Ishii di “sporcarsi le mani” il putrescente sottobosco umano descritto da Ranpo ha avuto, davvero, modo di venire alla luce. Il saggista Soji Shimada ha sviluppato una interessante teoria: tutte le grandi città attraversate, come Tōkyō (ma anche Praga, Budapest, Londra…) da un fiume, vengono da quest’ultimo divise in due zone opposte: la parte buia ad est e la zona di luce ad Ovest. E’ quindi solo a est che troviamo il regno delle ombre, quel reticolo di bettole, postriboli e scannatoi ove, oltre che la bussola dei sensi, puoi perdere la vita. O l’anima, a scelta. Ma anche i feudi ove il Buio regna sovrano hanno i propri aedi, cantastorie erranti: Edogawa Ranpo è stato, per il Giappone, il più grande narratore dell’anemica fauna cresciuta ove mai batte il sole… Charles Dickens – I parte Se in Francia il romanzo poliziesco s’innesta sul corpo del romanzo romantico, del feuilleton e delle memorie alla Vidocq, in Inghilterra incontra un terreno forse ancora più fertile, rappresentato dal romanzo “nero” o gotico. Anche un gigante della letteratura come Charles Dickens (1812-1870) finisce per introdurre nelle sue opere temi criminali ed elementi polizieschi. Già nelle Avventure di Oliver Twist (pubblicato a puntate dal 1837 al 1839), in cui il giovanissimo protagonista è sballottato tra un ospizio di mendicità da un lato e una benevola protezione dall’altro, con la terza alternativa di essere costretto a far parte di una delle bande criminali di Londra, c’è un notevole passaggio di detection, dato dalle indagini di Mr. Blownlow sul passato di Oliver. Il romanzo è ricco di simboli ossessionanti di frustrazione, isolamento, prigionia, e vi si trova una galleria di ritratti e una serie di quadretti acutamente incisivi. Qui compaiono i funzionari di polizia Blathers e Duff, due autentici incapaci che sono oggetto di pesante scherno da parte dello scrittore. Temi “gialli” emergono anche in Barnaby Rudge (1839-1841), uno dei due romanzi a sfondo storico di Dickens (l’altro è A Tale of Two Cities), incentrato sui Gordon Riots, le rivolte antipapali del 1780, in cui l’elemento melodrammatico viene disciplinato in una trama cupa con risvolti tragici. Il romanzo racconta dell’omicidio di Reuben Haredale, il cui fratello cattolico Geoffrey si allea col malvagio Sir John Chester, a dispetto dell’odio reciproco, allo scopo di impedire il matrimonio fra la nipote del primo e il figlio del secondo. Durante i Gordon Riots, la casa di Haredale viene data alle fiamme e la nipote Emma è rapita; il figlio di Chester riesce a ritrovare la ragazza, guadagnando così il diritto di sposarla. In seguito viene scoperto il responsabile dell’omicidio di Reuben, mentre l’arguto Barnaby Rudge, condannato alla forca, ottiene la sospensione dell’esecuzione, nonostante abbia partecipato alla rivolta. L’investigatore privato Nel romanzo Martin Chuzzlewit (1843-1844) abbiamo addirittura un investigatore privato, lo stravagante Nadgett, che viene assunto da un fraudolento assicuratore per scoprire informazioni riservate sui propri clienti. Il romanzo ruota principalmente intorno alla figura di Pecksniff, un perfetto ipocrita che non ammette mai la realtà delle sue intenzioni, nemmeno con se stesso, ed è uno studio sinistramente ironico degli effetti dell’avidità sul carattere, e delle possibilità di conoscere veramente se stessi e gli altri. È la storia di Martin, nipote del vecchio Martin Chuzzlewit, un riccone diventato misantropo a causa dell’avidità dei parenti. Il vecchio è accudito da Mary Graham, un’orfana che egli ha cresciuto e che considera sua figlia; il giovane Martin, grazie all’impegno e all'influenza positiva del suo domestico Tapley, riesce a tramutare il suo egoismo in generosità e s’innamora di Mary, ma il padre putativo diffida delle intenzioni del ragazzo e fa sì che venga licenziato dall’architetto presso cui è tirocinante, l’ipocrita Mr. Pecksniff. L’andamento del romanzo è, per così dire, spezzato dal viaggio del giovane Martin in America, dove cade ammalato, parte che venne criticata negli ambienti d’oltreoceano per l'immagine approssimativa e stereotipata della vita statunitense data da Dickens. Al ritorno del protagonista in Inghilterra, il tono comico che tratteggia i personaggi sgradevoli sfuma, per lasciare il posto a ritratti più nettamente negativi, come nel caso del criminale Jonas Chuzzlewit e di Tigg Montague. Il nonno che riabilita il nipote, riconoscendo il suo sincero mutamento d’animo, conduce la vicenda allo scioglimento. Tre sono gli elementi essenziali del romanzo: l’intreccio Pecksniff-Jonas, che si focalizza sui guasti provocati dall’egoismo e dall’ipocrisia e sull’introspezione psicologica del criminale, inserita in un tipico crime-and-detection plot; il viaggio in America del giovane Martin e del compagno Tapley, dipinto con toni swiftianamente politico-satirici; il successivo intreccio, legato al primo, che si sviluppa intorno alla compagnia Sairey Gamp and associates. Dickens e i detectives Negli ultimi romanzi dello scrittore compaiono spesso figure di poliziotti, per lo spazio sempre maggiore dedicato a vicende misteriose da risolvere, come il funzionario che in Our Mutual Friend (1864-1865) presidia la piccola stazione di polizia nella quale viene portato il cadavere di John Harmon, o Dick Datchery. Our Mutual Friend è la più compiuta rappresentazione che Dickens ci offre degli effetti che l’ambizione sociale e finanziaria produce sul carattere; egli raggiunge questo risultato sia attraverso l’elaborazione letteraria, sia attraverso un complesso uso di simboli. Il comico, il drammatico, il tragico e il sentimentale si fondono in un intreccio basato su una sostituzione di persona e su molte messe in scena; l’atmosfera, misteriosa e quasi poliziesca, dà vita a una brillante galleria di personaggi. L’interesse di Dickens per gli argomenti polizieschi e per le figure dei veri poliziotti si ravviva intorno agli anni Cinquanta, quando stringe amicizia con l’ispettore Whicher di Scotland Yard, il detective coinvolto nel celebre caso di Constance Kent, che gli ispira la figura del sergente Witchem per una serie di articoli-racconti (lo stesso poliziotto che ispirerà anni dopo il più famoso sergente Cuff a Wilkie Collins). Un altro amico di Dickens fu Charles Frederick Field (1805-74), un noto detective dell'epoca, le cui imprese vennero immortalate dallo scrittore in una lunga serie di resoconti giornalistico-narrativi di true crime fiction scritti per il periodico “Household Words” con titoli come “On Duty with Inspector Field” o “A Detective Police Party”. Field, che aveva iniziato la sua carriera nei Bow Street Runners, nel 1846 divenne ispettore capo a Scotland Yard e nel 1852 si ritirò, seguitando a lavorare come detective privato. Egli ispirò a Dickens il personaggio dell'ispettore Bucket nel romanzo Bleak House, di cui andremo ora a occuparci. Charles Dickens – II parte I due romanzi di Dickens in cui l’elemento poliziesco è più evidente sono Bleak House (Casa desolata, 18521853) e The Mystery of Edwin Drood (Il mistero di Edwin Drood, 1870). Bleak House è uno dei romanzi più lunghi e più complessi di Dickens, che si propone di dimostrare, fra le altre cose, quanti danni possono derivare dall’interminabile trascinarsi delle cause giudiziarie, il cui unico vero scopo sembra quello di rimpinguare le tasche degli avvocati. (In questo senso, il post potrebbe anche essere inserito nella categoria “Sempre attuali”!) Ecco l'inizio del romanzo: Londra. Sessione autunnale da poco conclusa e il Lord Cancelliere tiene udienza a Lincoln's Inn Hall. Implacabile clima di Novembre. Tanto fango nelle vie... fumo che scende dai comignoli come una soffice acquerugiola nera con fiocchi di fuliggine grandi come fiocchi di neve vestiti a lutto, si potrebbe immaginare, per la morte del sole. Cani che si distinguono appena nella mota... Nebbia ovunque... Jarndyce contro Jarndyce si trascina da anni. Questo processo spauracchio è diventato col tempo così complicato che nessuno sa più cosa significhi. Innumerevoli bambini sono nati nel corso della causa... innumerevoli giovani si sono sposati, innumerevoli vecchi sono morti... Il piccolo attore o convenuto, al quale fu promesso un cavallo a dondolo, quando si fosse conclusa la causa Jarndyce contro Jarndyce è cresciuto, è diventato padrone di un cavallo vero e se ne è andato al galoppo all’altro mondo. La trama è ingegnosa e piena d’inventiva, con molte storie parallele che s’intersecano e s’intrecciano per effetto del caso o del destino. La giovane Esther Summerson, personaggio principale e a tratti narratrice, è orfana. Allevata severamente dalla madrina, viene presa sotto la protezione di un personaggio delizioso e vagamente eccentrico, John Jarndyce, divenuto padrone di Casa Desolata e coinvolto suo malgrado nella celebre causa («un processo che è in se stesso un monumento all’attività della corte», secondo l’avvocato Kenge detto “il Conversatore”), di cui però non vuol sapere nulla. A lui il tribunale affida due giovani pupilli della corte, due lontani cugini, orfani di qualche defunto attore della causa: Ada – di cui Esther sarà la compagna e l’amica – e Richard, che sposerà Ada, ma sarà via via travolto dal gorgo di Jarndyce contro Jarndyce. Nelle vicinanze di Casa Desolata, nel piovosissimo Lincolnshire, troviamo Chesney Wold, l’antica dimora della famiglia Dedlock, dove Sir Leicester vive con la splendida moglie, assai più giovane di lui e perpetuamente annoiata. Le vicende di Casa Desolata e di Chesney Wold verranno gradualmente intrecciandosi in un moltiplicarsi di situazioni e personaggi, che trovano i loro sbocchi in una Londra che contrappone il quartiere degli avvocati, Lincoln’s Inn Fields o Chancery Lane, alla desolazione totale della viuzza squallida e decrepita chiamata Tom all Alone’s. Al centro del libro c’è il denaro, il vortice terribile creato dall’attrazione per il denaro, e la causa Jarndyce contro Jarndyce è la ruota che fa girare il tutto, che fa incontrare e separare i personaggi e ne intreccia le vicende. Ma ci vorranno ottocento pagine perché la causa arrivi a conclusione per autoesaurimento, dopo aver assorbito l’intero patrimonio degli attori. Nel frattempo, Chesney Wold sembra celare un enigma: l’altera Lady Dedlock, spinta da un’irresistibile noia, si sposta continuamente a Londra e a Parigi e anche lei sembra nascondere uno sconvolgente segreto. L’oscuro copista che si cela sotto il nome di Nemo viene trovato morto nel suo stambugio londinese per eccesso di oppio, e il suo padrone di casa, lo straccivendolo alcolizzato Krook, muore sorprendentemente di autocombustione dopo avergli sottratto un misterioso pacco di vecchie lettere d’amore. Sorte simile tocca all'avvocato Tulkinghorn, «l'intendente dei misteri legali, il cantiniere della cantina legale dei Dedlock», che viene inopinatamente ucciso da un colpo di pistola sotto il soffitto affrescato del suo studio: il mistero della sua morte fa entrare in scena, in uno dei punti culminanti del romanzo, il detective Bucket, che assume un ruolo crescente dipanando gli enigmi che si sono accumulati. L’ispettore Bucket Nei capitoli finali, la vicenda prende il tono di un rebus poliziesco. L'apparizione della figura dell'ispettore Bucket di Scotland Yard, «robusto, dallo sguardo intento e dalla vista acuta», segna un inedito punto di svolta per la letteratura inglese dell’epoca: un autentico funzionario di polizia chiamato a risolvere un autentico mistero, un caso d’omicidio la cui soluzione è raggiunta con brillantezza e logica degne degli investigatori più famosi. Quando l’ispettore si presenta per arrestare il colpevole, tutti i sospetti s’incentrano su Lady Dedlock, ma il detective smaschera un’altra persona, che odiava sia l’assassinato sia la sospettata e aveva deciso di vendicarsi uccidendo il primo e facendo ricadere la colpa sulla seconda. L'ispettore Bucket precede di sedici anni il ben più celebre sergente Cuff, il personaggio di Wilkie Collins comunemente considerato il primo vero detective professionista della letteratura inglese. In seguito, stimolato da quell'enorme successo, Dickens cominciò a pubblicare a puntate, sulla rivista “All the Year Round”, il romanzo The Mystery of Edwin Drood (1869-70), che rimase interrotto alla sua morte e che molti cercarono di completare basandosi sugli indizi disseminati nei primi capitoli o utilizzando appunti e confidenze dello scrittore stesso. Il mistero di Edwin Drood «Dov'è mio nipote?» urlò Mr. Jasper. «Dov'è vostro nipote?» replicò Neville. «Perché me lo chiedete?» «Perché voi siete l’ultimo ad averlo incontrato, e lui è sparito.» Tante furono le congetture sui possibili sviluppi dell’incompiuto The Mystery of Edwin Drood. Tutto fa pensare che le maggiori preoccupazioni di Dickens fossero l’efficacia dell’ambientazione e la caratterizzazione dei personaggi, in particolare del protagonista-criminale Jasper. L’antica città di Cloisterham e la sua cattedrale, a ricordare la mortalità e la fragilità umana, fanno da sfondo a una vicenda che, come ebbe a dire la figlia dello scrittore, è imperniata sui “tragici segreti dell'animo umano”. Ricca doveva essere la galleria dei personaggi, da Mr. Grewgious, avvocato eccellente ed eccentrico, e Miss Twinkleton, sorvegliante del Seminario delle Signorine, allo scalpellino ubriacone Durdles e all'irriverente Deputy, addetto alle camere ammobiliate. La promessa di matrimonio fra Edwin Drood e Rosa è alla base dello svolgimento dell’azione, e ogni personaggio e ogni avvenimento paiono riferirsi e prendere spunto da essa. Ma al centro della cittadina di Cloisterham, e al centro dello stesso romanzo – accanto al personaggio di Jasper – c’è la cattedrale, simbolo solenne del contrasto tra la vita e la morte e tra il bene e il male. La cattedrale fornisce anche lo sfondo ideale per un’atmosfera paurosa ricca di segreti: è il luogo dove nessuno si azzarda a passare di notte, perché «un minaccioso silenzio di tomba pervade l’antico edificio, il chiostro, il sagrato», in cui i cittadini sentono l’istintiva repulsione per la polvere che ha ospitato il soffio della vita, e dove si possono fare brutti incontri. La morte di Dickens a metà dell’opera, l’8 giugno 1870, diede luogo a molte supposizioni sul suo seguito e a diversi tentativi di continuazione. Le questioni più dibattute furono se Edwin Drood sarebbe morto oppure no, l’innocenza o la colpevolezza di Jasper, in che modo il crimine si sarebbe consumato, le vie attraverso cui Jasper, se colpevole, sarebbe stato trascinato in giudizio, l’incognita della reale identità di Datchery, e l’eventualità di un collegamento fra Jasper e Princess Puffer. Le due scene ambientate nella fumeria d’oppio hanno contribuito ad alimentare l’atmosfera di mistero che pervade il libro, spingendo alcuni a supporre che il malvagio Jasper fosse destinato a commettere il suo delitto in preda agli effetti della droga. Ciò richiama un parallelo con La pietra di luna, dove allo stesso modo Franklin Blake si macchia inconsapevolmente di un crimine, seppur minore; ma mentre il personaggio di Wilkie Collins non è cosciente di aver assunto l’oppio, Jasper lo fa deliberatamente, come reazione alle proprie frustrazioni. Sembra comunque certo che nelle intenzioni iniziali di Dickens un nipote doveva essere assassinato dallo zio, e alla fine il colpevole si sarebbe ritrovato in una cella a rivivere l’intero corso delle sue malefatte in una sorta di straniamento, come se la vittima delle tentazioni malvagie fosse stata un'altra persona. La scoperta dell’assassino, naturalmente, si sarebbe avuta verso la conclusione della storia, grazie a un anello d’oro sopravvissuto all’azione corrosiva della calce in cui era stato gettato il corpo. Tanti provarono a trovare la risposta agli interrogativi, lungo tutto un secolo. E nel 1980 Leon Garfield, uno studioso e narratore inglese, ha scritto la “sua” prosecuzione del romanzo, definita la più convincente e definitiva, perfettamente aderente alla cultura, allo stile, al mondo fantastico di Dickens. Questa versione “completa” de Il mistero di Edwin Drood (di 510 pagine) è stata pubblicata in Italia da Bompiani nel 2001. La pietra di luna – I° parte Il vero padre del detective novel inglese è uno scrittore cresciuto alla scuola di Charles Dickens: William Wilkie Collins (1824-1889), autore molto popolare e molto prolifico di grandi romanzi vittoriani. L’amicizia fra Collins e Dickens – nata dall’interesse comune per il teatro, ma cresciuta anche grazie alla loro passione per l’editoria, i viaggi in Francia e in Italia, gli ideali radicali e i bordelli londinesi – fu feconda per entrambi. Nel 1856, Wilkie Collins si trova a scrivere per la rivista Household Words una serie di articoli a sfondo poliziesco, traendone i temi dai casi giudiziari raccolti nel Recueil des causes célèbres (1807-1814) di Maurice Mejean, un libro che aveva acquistato in Francia durante uno dei suoi viaggi sul continente in compagnia di Charles Dickens. E sempre al Recueil è ispirato uno dei suoi grandi successi, La signora in bianco (The Woman in White, 1859-60), un complicato romanzo con forti influssi balzachiani. Ma il capolavoro di Wilkie Collins resta La pietra di luna (The Moonstone), ispirato al caso mai risolto di Constance Kent, ovvero il celebre “delitto della casa di campagna”, pubblicato nel 1868, prima a puntate su All The Year Round, il giornale diretto da Dickens, e poi in tre volumi. Molti hanno giudicato La pietra di luna il più bel romanzo poliziesco di tutti i tempi, e il poeta T. S. Eliot ha scritto che «tutto quello che c’è di buono e di efficace nella narrativa poliziesca moderna lo si può già trovare nella Pietra di luna. Gli autori più recenti hanno introdotto l’uso delle impronte digitali e di bagattelle dello stesso genere, ma in sostanza non hanno realizzato alcun progresso rispetto alla personalità o ai metodi del sergente Cuff. Cuff è il poliziotto perfetto. I nostri poliziotti moderni sono il più delle volte delle macchine efficienti ma anonime, che si dimenticano nel momento stesso in cui si chiude il libro, o hanno troppe caratteristiche come Sherlock Holmes. Costui è talmente sovraccarico di capacità, di meriti e di peculiarità da diventare una figura quasi statica: ci viene descritto, anziché esserci rivelato, attraverso le sue azioni. Il sergente Cuff è invece una personalità reale e attraente, ed è brillante senza essere infallibile». Per incatenare il pubblico alle pagine, Collins sfrutta sia l’aspetto umoristico della vicenda narrata, sia quello patetico-sentimentale, sia quello più strettamente poliziesco, cioè la suspense, l’attesa vigile dei lettori, desiderosi che i misteri della storia siano svelati uno dopo l’altro. Per ottenere nei lettori questo triplice coinvolgimento, Collins elabora una particolare tecnica narrativa: egli affida il resoconto dei fatti non a un solo narratore, ma a tutti i protagonisti, che si alternano uno dopo l’altro come se fossero testimoni chiamati a deporre. Siccome i vari narratori possono raccontare solo i fatti a cui hanno partecipato o assistito in prima persona, l’autore gioca sul punto di vista limitato, che gli consente di mantenere nel testo un gran numero di lacune narrative, che verranno riempite da qualche altro personaggio nel prosieguo del racconto. Inoltre, il fatto di affidare la voce narrante a personaggi particolarmente eccentrici consente a Collins di ottenere straordinari effetti di comicità, come accade col maggiordomo Betteredge, che è il primo ad assumere il ruolo di narratore, e con Miss Clack. La trama La “Pietra di luna” è un favoloso diamante sacro appartenente a una setta indiana di Seringapatam, predato nel 1799 dal malvagio colonnello inglese John Herncastle, che ha trucidato i tre bramini che lo custodivano. Sul diamante – ovviamente – pesa una maledizione, e quando Herncastle torna in patria, tutti lo sfuggono, a partire dai suoi familiari, ben consapevoli delle sue malefatte. Dopo quasi mezzo secolo, nel 1848, il colonnello muore e lascia in eredità il diamante alla nipote Rachel Verinder, figlia di sua sorella Julia. Siccome i legami con la famiglia erano interrotti da decenni, Lady Julia non tarda a interpretare il gesto – donare un diamante maledetto! – come una vendetta del malvagio colonnello. Al cugino della ragazza, Franklin Blake, spetta il compito di portare il diamante – la Pietra di luna – a Rachel in occasione del suo compleanno. Quando si reca nella casa di campagna dei Verinder, nello Yorkshire, il suo arrivo è preceduto da quello di tre indiani, che in compagnia d’un bambino compiono strani riti per seguire i movimenti di Franklin e del diamante. Dopo la riunione degli invitati e la cena di compleanno, a cui partecipa anche un altro cugino di Rachel, Godfrey Ablewhite, gli indiani si presentano nel giardino di casa fingendosi giocolieri, ma un viaggiatore che conosce bene l’India individua in essi tre bramini che cercano di riportare in patria la pietra sacra. Ed ecco il colpo di scena: la mattina dopo, il diamante è scomparso. Dunque viene chiamata a investigare la polizia locale, nella persona del Sovrintendente Seegrave, il quale fa perquisire la casa e tutti i presenti (tranne Rachel, che misteriosamente si rifiuta), ma senza alcun risultato. Di fronte all’insuccesso della polizia locale, Franklin Blake fa quindi venire da Londra il sergente Cuff, celebre investigatore di Scotland Yard. Il sergente Cuff Il diamante è stato portato via dal boudoir di Rachel, dov’era racchiuso in un mobiletto. A fornire un indizio al sergente è la porta del locale, che Rachel e Franklin avevano dipinto insieme nei giorni precedenti il furto, mentre tra loro nasceva una storia d’amore. La porta reca una macchia sulla vernice, che il sergente conclude sia stata prodotta dal ladro che di notte ha portato via la pietra. Comincia dunque l’affannosa ricerca d’un capo di vestiario che porti una macchia di vernice, ma senza risultati. Siccome Rachel rifiuta di lasciar ispezionare il proprio guardaroba, mostrandosi apertamente ostile, Cuff conclude che il diamante non sia stato davvero rubato e che la ragazza l’abbia nascosto con l’idea di venderlo per pagare qualche debito che ha contratto, magari con un gioielliere, come spesso accade alle giovani aristocratiche. Secondo Cuff, ad aiutare Rachel è stata Rosanna Spearman, una cameriera con un passato di ladra, che nei giorni successivi al furto ha avuto un comportamento strano, fingendosi malata, mentre in realtà usciva di casa per motivi imprecisati. Il crescendo di tensione che l’indagine provoca in casa Verinder culmina proprio col suicidio di Rosanna, che si toglie la vita perché innamorata di Blake, che a sua volta è innamorato della cugina Rachel. Il sergente Cuff comunica a lady Julia la versione dei fatti di cui è convinto, cioè che il diamante è in possesso di Rachel; ma quando lady Julia interroga di persona la figlia, questa nega di averlo, e anche solo d’aver parlato con Rosanna dopo il furto della pietra. A Lady Julia, quindi, non resta che pagare Cuff, che aveva ingaggiato privatamente, con un lauto assegno e chiedergli di abbandonare il caso, che così rimane irrisolto. La presenza del diamante maledetto ha gettato la famiglia nella disperazione. Rosanna Spearman si è suicidata, mentre Rachel, che in un primo tempo ricambiava l’amore di Franklin Blake, dopo il furto si rifiuta di vederlo e a solo sentire il suo nome viene colta da attacchi d’isteria. Rachel abbandona la campagna per recarsi con la madre a Londra, dove Lady Julia spera di procurare alla figlia sufficienti distrazioni perché dimentichi la brutta avventura. Dal canto suo, Blake parte per un lungo viaggio in Europa per dimenticare le sue pene d’amore. Nel finale di questa prima parte, al narratore Mr. Betteredge giunge notizia che Rosanna, prima di uccidersi, ha lasciato a un’amica una lettera indirizzata a Mr. Franklin in cui potrebbe essere contenuta la chiave del mistero; ma la ragazza che ne è in possesso si rifiuta di consegnare la lettera a persone diverse da Mr. Franklin, a cui è indirizzata. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, Lezioni accademiche all’Università di Bologna, Facoltà di Lingue e letterature straniere moderne, A.A. 1999-2000. Stefano Benvenuti - Gianni Rizzoni, Il romanzo giallo, Mondadori, Milano 1979). La pietra di luna – II° parte Nella prima parte del romanzo di Wilkie Collins, due sono i detectives che si alternano a casa Verinder per condurre le indagini: il Sovrintendente Seegrave e il Sergente Cuff. Qui si possono riscontrare quattro tipi di atteggiamenti. Il primo è quello del Sovrintendente Seegrave, che rappresenta il tipico esponente delle forze di polizia, fin dall'inizio destinato allo scacco. Egli si presenta come un uomo molto competente, ma ben presto, dopo essere giunto a qualche conclusione esatta, si arena nelle secche del mistero. Quel che si riesce a stabilire in questa prima indagine è che il furto è stato commesso da qualcuno che si trovava dentro casa, poiché era impossibile per quegli indiani o per altri malviventi accedervi dall’esterno, in quanto i cani erano liberi nel giardino e non si sono riscontrate impronte o altri segni di scasso. Si propone qui una situazione – simile a quella della camera chiusa – che avrà grande fortuna nel poliziesco: quella della casa o del luogo isolato in cui si trova un gruppo di sospetti, fra i quali dev’esserci il colpevole. A ogni modo, Seegrave finisce per trascurare quello che si rivelerà l’indizio fondamentale, cioè la macchia che s’è prodotta nella decorazione eseguita sulla porta del salottino. Secondo Seegrave, a causare la macchia è stata qualche cameriera che ha sfiorato la porta dopo la scoperta del furto, mentre invece il sergente Cuff capirà subito che la macchia indica in realtà il passaggio di qualcuno nella notte del furto, probabilmente il ladro stesso, poiché la mattina dopo il colore della porta doveva già essere asciutto. Da bravo detective, Cuff sa che la chiave d’accesso alla verità risiede spesso nei dettagli, e afferma: «In tutta la mia esperienza lungo le sporche strade di questo sporco piccolo mondo, non ho mai incontrato nulla che fosse un’inezia». Proprio in obbedienza a questo principio, Cuff non trascura il dettaglio della macchia sulla porta e fa di tutto per scoprire se in casa sia stato nascosto un vestito o una camicia da notte macchiata, o se qualcosa manchi dall’elenco della biancheria. Disgraziatamente, nel seguire questo indizio, Cuff sarà portato a sospettare delle persone giuste per i motivi sbagliati. In altre parole, Cuff capisce che al centro del mistero si trovano Rachel e Rosanna, i cui movimenti e atteggiamenti sono talvolta inspiegabili o sospetti, ma nel ricostruire i fatti si lascia guidare dalla convinzione errata che Rachel sia indebitata e che la cameriera l’abbia aiutata, grazie al suo passato criminale, a vendere il gioiello a un ricettatore. In particolare, Cuff è convinto che, dopo aver sottratto il gioiello dal salotto per conto di Rachel, Rosanna si sia resa conto d’aver macchiato la camicia da notte e, fingendosi malata, sia corsa in paese a comperare nuova stoffa per cucirsene una identica all’altra. Il detective rinunciatario Comunque sia, Cuff deve rinunciare al caso perché ha accusato del crimine la figlia della padrona di casa. La ragazza rifiuta di spiegare la sua condotta e quindi è soggetta a legittimi sospetti; eppure, Cuff si sbaglia. Mentre in molta narrativa poliziesca la ragione del detective – sensibile ai dettagli, capace d’introspezione psicologica, dotata di spirito logico – riesce a penetrare il mistero, qui Cuff fallisce. Contro la sua versione dei fatti si schiera la fiducia intuitiva che personaggi come Lady Verinder, Mr. Betteredge e sua figlia Penelope hanno in Rachel e Rosanna. Paradossalmente, qui la ragione diventa qualcosa dai cui attacchi ci si deve difendere, per non cadere nell’errore. Alla ragione si oppongono il sentimento, la lealtà, l’istinto. In più, alle indagini di Seegrave e Cuff si oppongono le indagini dei tre bramini indiani che inseguono il diamante, i quali non usano la razionalità occidentale, ma la chiaroveggenza. Addirittura, nel seguito del romanzo, i bramini riusciranno con questo sistema a seguire gli spostamenti della pietra e a rientrarne in possesso. Dunque, in The Moonstone convivono due sistemi di valori: uno occidentale, fondato sui presupposti della ragione, e uno orientale, legato a una visione mistica del mondo. Indagini multiple Ai quattro livelli d’indagine individuati nella prima parte del romanzo, se ne aggiungono altri tre nella seconda parte. Una è l’indagine per eccellenza: quella di stampo psicologico che viene condotta dal medico Ezra Jennings attraverso l’ipnotismo, un’indagine che scava nell’interiorità dell’uomo, oltre il suo livello cosciente, e che anticipa l’avvento della psicanalisi. Le altre due, invece, sono quelle di Mr. Franklin e di Mr. Bruff. In particolare, la ricerca di Franklin rimanda direttamente alla vicenda di Edipo: colui che ha avviato la macchina investigativa, in quanto ha convocato il sergente Cuff da Londra per cercare la verità, è anche l’individuo che inconsapevolmente ha causato tanta confusione e dolore intorno a sé. E, come Edipo interroga ripetutamente l’indovino Tiresia, senza capire la verità che questi gli dice con parole ambigue, finché non cade il velo che ha davanti agli occhi, così anche Franklin nel corso della vicenda ripenserà alle parole pronunciate da Rachel e Rosanna nei giorni successivi al furto, e scoprirà che entrambe hanno tentato di dirgli la verità. Per finire, la ricerca di Mr. Bruff, che viene perseguita nell’ultima parte: l'avvocato ritiene che l’unico modo per incastrare il colpevole sia aspettare che, allo scadere di un anno dal deposito in banca del diamante, incontri Mr. Luker per rientrarne in possesso. A quel punto, rientra in scena lo stesso Cuff che, informato degli sviluppi dell’indagine, ammette apertamente di aver commesso uno sbaglio. L’autore, tuttavia, gli concede di prodursi in un numero teatrale: per provare le sue doti di detective, Cuff consegna a Franklin una lettera contenente il nome del colpevole, invitandolo ad aprirla solo quando ne avranno accertata l’identità. Wilkie Collins grande precursore Tralasciamo le altre sfaccettature del romanzo, che sono numerose: da quella melodrammatica a quella dell’identità a quella dell’imperialismo britannico. Fra i tanti meriti, a Collins va riconosciuto quello di aver inaugurato la regola del fair play nei confronti del lettore, inserendo nei primi capitoli del romanzo tutti gli indizi necessari alla spiegazione dell’enigma. Inoltre, egli ha concepito l'idea di scegliere il colpevole fra le persone meno sospette e, infine, ha dato prova di grande accuratezza nei particolari di ordine medico, legale e di procedura poliziesca. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, Lezioni accademiche all’Università di Bologna, Facoltà di Lingue e letterature straniere moderne, A.A. 1999-2000. Stefano Benvenuti - Gianni Rizzoni, Il romanzo giallo, Mondadori, Milano 1979). Si leva il sipario: Uno studio in rosso Il primo capitolo di A Study in Scarlet, il romanzo che inaugura la saga di Sherlock Holmes, si apre sul narratore, John H. Watson, un giovane medico reduce dalla seconda guerra afgana; ed è un suo amico a descrivere l’eccentrico Sherlock Holmes, la cui passione scientifica è all’insegna di un arcano enciclopedismo. Il luogo che fa da sfondo al primo incontro tra Watson e il detective – il laboratorio chimico di un ospedale – rappresenta il simbolo della formazione scientifica di Holmes e l’equivalente della obscure library ove il narratore di The Murders in the Rue Morgue di Edgar Allan Poe stringe amicizia col detective Auguste Dupin. La biblioteca e il laboratorio rimandano al repertorio di conoscenze e abilità che è alla base dei due universi narrativi: caratterizzato nella trilogia di Dupin dalla componente testuale, e nella saga di Sherlock Holmes dall’estensione dei principi scientifici agli affari pratici degli uomini. La scienza della deduzione In “The Science of Deduction”, secondo capitolo di A Study in Scarlet, il narratore fa una sorprendente rivelazione sulla forma mentale di Holmes: «La sua ignoranza era notevole quanto la sua cultura. In fatto di letteratura contemporanea, di filosofia e di politica, sembrava che Holmes sapesse poco o nulla. Una volta mi accadde di citare Thomas Carlyle. Mi chiese nel modo più ingenuo chi era e cosa aveva fatto. Ma la mia meraviglia giunse al colmo quando scoprii casualmente che ignorava la teoria di Copernico nonché la composizione del sistema solare. Il fatto che un essere civile, in questo nostro diciannovesimo secolo, non sapesse che la terra gira intorno al sole mi pareva così straordinario che stentavo a capacitarmene». Non solo Holmes ignora queste informazioni, ma afferma che, una volta recepite, farà il possibile per dimenticarle. Egli paragona il cervello umano a un’angusta soffitta in cui riporre gli oggetti da conservare a portata di mano; se lo sciocco vi ammassa ogni sorta di cianfrusaglie, e gli è impossibile poi ritrovarle, il bravo operaio conserva solo attrezzi utili, collocandoli col massimo ordine, poiché: «È un errore illudersi che quella stanzetta abbia le pareti elastiche e possa ampliarsi a dismisura. Viene sempre il momento in cui, per ogni nuova cognizione, se ne dimentica qualcuna acquisita in passato». Il tratto principale di questa metafora è la concezione specialistica del sapere holmesiano, che il narratore esemplifica con una tabella, dove riporta il grado d’interesse dimostrato da Holmes per le diverse discipline. All’assoluta indifferenza nei confronti di letteratura, filosofia e astronomia e al superficiale aggiornamento politico, si contrappongono invece la conoscenza teorica della botanica, in particolare delle piante velenose, nonché elementi pratici di geologia, come le qualità di fango delle diverse zone di Londra, la profonda padronanza della chimica, nozioni di anatomia accurate ma non sistematiche, e l’immensa erudizione in fatto di letteratura sensazionale, che fa del detective «un calendario vivente del crimine». Holmes elabora un metodo d’indagine infallibile, facendo della criminologia una scienza esatta: la scienza della deduzione. Egli non è solo un investigatore, ma un teorico dell’investigazione. All’inizio di A Study in Scarlet, fa leggere distrattamente a Watson un articolo sulla criminologia che ha scritto per una rivista: «Come tutte le altre arti, la scienza della deduzione e dell’analisi può essere acquisita soltanto attraverso uno studio lungo e paziente». Prima di occuparsi di quegli aspetti morali e cerebrali della questione che presentano le maggiori difficoltà, lo studioso affronti i problemi più elementari. Incontrando un suo simile, impari a dedurne a prima vista la storia e il mestiere o la professione che esercita. Per quanto possa sembrare puerile, questo esercizio acuisce lo spirito d’osservazione e insegna dove si deve guardare e cosa si deve cercare. Dalle unghie di un uomo, dalle maniche della sua giacca, dalle scarpe, dalle ginocchia dei calzoni, dalle callosità delle dita, dall’espressione, dai polsini della camicia: «da ognuna di queste cose si può avere la rivelazione del mestiere di un uomo. Che tutte queste cose messe assieme, poi, possano mancar di illuminare l’indagatore che sa il fatto suo, è virtualmente inconcepibile». E, subito dopo, Holmes fornisce a Watson un saggio pratico del suo talento: «Vedete, possiedo una quantità di nozioni particolari che applico ai problemi e che mi facilitano in modo meraviglioso. Le regole esposte in quel capitolo che vi ha fatto sogghignare, mi sono preziose e io le applico praticamente nel mio lavoro. In me, lo spirito d’osservazione è una seconda natura. Voi siete rimasto stupito quando vi ho detto, al nostro primo incontro, che venivate dall'Afganistan.» «Senza dubbio, qualcuno ve l’aveva detto.» «Niente di tutto ciò. Io ho capito che venivate dall'Afganistan. Per lunga abitudine, il lavorìo dei miei pensieri è così rapido, che sono arrivato a quella conclusione senza esser conscio dei passaggi intermedi. Però, ci sono stati dei passaggi intermedi. Eccovi il filo del mio ragionamento: quest’uomo ha qualcosa del medico, ma anche qualcosa del militare. Evidentemente, un medico militare. È reduce dai tropici, poiché ha il viso molto scuro, ma quello non è il suo colorito naturale dato che ha i polsi chiari. Ha subìto privazioni e malattie, come dimostra il suo viso emaciato. Inoltre, è stato ferito al braccio sinistro. Lo tiene in una posizione rigida e poco naturale. In quale paese dei tropici un medico dell’esercito britannico può esser stato costretto a sopportare dure fatiche e privazioni, e aver riportato una ferita a un braccio? Nell’Afganistan, naturalmente.» A Study in Scarlet A Londra, in una casa abbandonata, al numero 3 di Laurinston Gardens, è stato rinvenuto il cadavere «di un signore ben vestito». Non esiste alcun indizio su come l’uomo abbia trovato la morte. Scotland Yard brancola nel buio, e gli ispettori Gregson e Lestrade decidono di ricorrere all’aiuto di Sherlock Holmes. Il detective comincia subito le indagini: esamina accuratamente i dintorni della casa, interroga i funzionari di polizia, poi trae di tasca un metro e una grossa lente d’ingrandimento rotonda e si mette a gironzolare per la stanza. S’inginocchia, si sdraia addirittura a terra, individua e misura tracce invisibili agli altri e, alla fine, raccoglie un mucchietto di polvere grigia, che ripone accuratamente in una busta. «Che ne pensate?» gli domandano i funzionari di polizia. «Se tentassi di aiutarvi, farei la figura del presuntuoso e vi ruberei il merito delle indagini» risponde sarcastico Holmes. «Avete già fatto tali progressi, che sarebbe un peccato se qualcun altro ficcasse il naso nella faccenda.» Poi, prima di uscire a parlare con l’agente che ha trovato il cadavere, soggiunge: «Qui c'è stato un delitto, e l’assassino è un uomo. E' alto un metro e ottanta, è ancora giovane, ha i piedi piccoli per la sua statura, porta scarpe grossolane con la punta quadrata e, al momento del misfatto, fumava un sigaro Trichinopoly. È arrivato assieme alla vittima, su una carrozza a quattro ruote, tirata da un cavallo che aveva tre ferri vecchi e uno nuovo allo zoccolo anteriore sinistro. Con tutta probabilità, l’assassino ha il viso florido e le unghie della mano destra notevolmente lunghe. Queste sono solo piccole indicazioni, ma può darsi che vi giovino.» Lastrade e Gregson si guardano con un sorriso incredulo, poi il primo domanda: «Se quell'uomo è stato vittima di un assassinio, in che modo è stato ucciso?» «Veleno», risponde laconicamente Holmes. Allo sbalordimento del dottor Watson, che lo interroga su come abbia fatto a ricavare tutte quelle informazioni, Holmes risponde con i fatti: «Per prima cosa, quando sono arrivato in Lauriston Gardens, ho osservato che le ruote di una carrozza avevano lasciato un duplice solco presso il marciapiede. Ora, fino a ieri sera non pioveva da una settimana, quindi quei solchi dovevano essere stati prodotti durante la notte. C’erano pure le impronte degli zoccoli del cavallo, una delle quali era assai più nitida che non le altre tre, prova evidente che si trattava di uno zoccolo ferrato di nuovo. Siccome la carrozza è arrivata sul luogo dopo che ha cominciato a piovere, ma non durante la mattina (su questo punto ho la testimonianza di Gregson), ne consegue che dev’essere arrivata durante la notte e che, quindi, ha portato i due sconosciuti alla casa del numero 3.» E il metodo usato per calcolare la statura del secondo uomo è semplice e logico: «Ho potuto osservare la lunghezza del passo di quell’uomo, tanto sul terreno argilloso all'esterno, quanto sul pavimento polveroso, all’interno. Inoltre, ho trovato il modo di controllare l’esattezza dei miei calcoli. Quando una persona scrive su un muro, l’istinto la porta a scrivere all'altezza dei suoi occhi. Ebbene, quell’iscrizione era a circa un metro e ottanta dal suolo.» Ugualmente logiche sono le deduzioni di Holmes in merito all'età dell'individuo e alla faccenda delle unghie lunghe e del sigaro Trichinopoly: «Se un uomo può fare dei passi più lunghi di un metro e venti, senza il minimo sforzo, non è possibile che sia anziano e che abbia degli acciacchi. Quella, infatti, è la larghezza di una pozzanghera che c'era sul sentiero del giardino e che, evidentemente, lo sconosciuto ha scavalcato. L'uomo dalle scarpe di vernice l’ha aggirata, ma quello dalle scarpe quadrate l’ha scavalcata. (...) Quella parola sul muro è stata scritta con un indice intriso di sangue. La lente d'ingrandimento mi ha consentito di osservare che l’intonaco è leggermente graffiato, cosa che non sarebbe accaduta se l’unghia di quell’indice fosse stata corta. Quanto al sigaro... ho raccolto un po’ di cenere sparsa sul pavimento. Era di color scuro e si presentava a falde. Soltanto il Trichinopoly produce una cenere simile. Ho studiato in modo particolare la cenere dei sigari, anzi ho scritto una monografia in proposito. Mi vanto di poter distinguere a prima vista la cenere di una qualsiasi qualità nota di sigaro o di tabacco. Proprio in simili particolari, l’esperto investigatore differisce dai vari Gregson e Lestrade.» (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). Il canone sherlockiano La prima avventura di Sherlock Holmes, Uno studio in rosso, venne pubblicata sul Beeton's Christmas Annual nel dicembre 1887. L’accoglienza del pubblico fu tiepida, tanto che Conan Doyle, deluso, sfogò la sua voglia di scrivere in una serie di romanzi storici, coi quali sperava di conquistare la fama letteraria. Il personaggio di Sherlock Holmes sarebbe forse stato abbandonato se, dalla direzione di un periodico americano, il Lippincott's Magazine, non gli fosse giunta la richiesta di un’avventura inedita dell’investigatore. Conan Doyle scrisse così The Sign of Four (Il segno dei quattro), in cui Sherlock Holmes indaga sulla scomparsa di un certo capitano Morstan, avvenuta dieci anni prima in circostanze misteriose. Apparso sul Lippincott's nel febbraio 1890, nello stesso anno il romanzo venne stampato in volume a Londra, con grande successo. Conan Doyle, subissato di richieste, dovette pubblicare su uno dei più letti periodici dell’epoca, lo Strand Magazine, una serie di dodici racconti che in seguito sarebbero stati raccolti in The Adventures of Sherlock Holmes. Complessivamente, il cosiddetto canone sherlockiano è costituito da Quattro romanzi e cinquantasei racconti, pubblicati nell’arco di ben quarant’anni - quelli che separano A Study in Scarlet (1887) dal racconto “The Adventure of Shoscombe Old Place” (1928). Nell’episodio conclusivo dei Memoirs of Sherlock Holmes, intitolato significativamente “The Final Problem”, Conan Doyle decise di liberarsi del protagonista, divenuto troppo ingombrante. «Oggi ho ucciso Sherlock Holmes», scrisse compiaciuto nel suo diario, dopo aver regalato al suo personaggio una morte sublime e misteriosa nell’orrido di Reichenbach in Svizzera. Ma la liberazione non doveva durare a lungo: l’improvvida fine dell'eroe suscitò nel pubblico un’ondata di sdegno senza precedenti. Lettere di protesta e d’insulti vennero indirizzate all’autore da Inghilterra, Francia e Stati Uniti; una di queste si apre addirittura con l’apostrofe: «You, Beast!». Gli uomini d’affari si recarono alla City col lutto al cappello, molti lavoratori scesero in sciopero e un parlamentare presentò un’interpellanza al governo. L’autore, quindi, dovette far resuscitare Sherlock Holmes: dapprima in The Hound of the Baskervilles (1901-2), presentato come memoria postuma, e poi in “The Adventure of the Empty House” (1903), ove Watson scopre che l’amico ha solo “finto” di morire. Si tratta d’un caso di feedback letterario legato proprio alla struttura della detective story, concepita da Poe e da Conan Doyle come un modello narrativo aperto a innumerevoli ripetizioni. Così, agli attributi del detective si aggiunge ben presto un’aura d’immortalità, che Doyle (soggetto alla paradossale anxiety of influence nei confronti del personaggio) aveva cercato di soffocare nel celebre corpo a corpo fra Sherlock Holmes e il dottor Moriarty sulle cascate di Reichenbach; ma, come s’è visto, il successo dell’eroe costringe l’autore a riconoscerne la supremazia e a riportarlo in vita. Così facendo, Doyle sancisce il passaggio di Holmes alla leggenda, attribuendogli una condizione mitica simile a quella di altri personaggi immortali come King Arthur o Federico Barbarossa. Il mito Scriveva Alberto Tedeschi nella Premessa al secondo “Omnibus” mondadoriano dedicato a Sherlock Holmes nel 1971: Il fatto più clamoroso è che Sherlock Holmes è una leggenda divenuta realtà. Non è possibile non credere alla sua esistenza: gli hanno dedicato “biografie” e film, hanno intitolato targhe alla sua memoria; i cacciatori d’autografi continuano a scrivergli per chiedergli uno scritto “di suo pugno”; i turisti che si recano a Londra corrono numerosi a cercare la famosa casa di Baker Street, e ancora oggi, non senza imbarazzo, gli impiegati della posta di Sua Maestà Britannica si trovano a dover smistare un imponente flusso di lettere da tutto il mondo, indirizzate, si badi bene, al “Signor Sherlock Holmes”. Raramente al suo autore. Chi visita il museo sherlockiano di Lucens in Svizzera può vederne a migliaia, vecchie di ottant’anni e più, ma anche recentissime. Lettere di ammiratori, convintissimi della reale esistenza di Sherlock Holmes, che gli chiedono i più svariati consigli. Molti gli espongono “casi” misteriosi che solo lui può risolvere; altri (numerosissimi) vogliono sapere “come si diventa investigatori” e manifestano la volontà di seguire le orme del Maestro. A tutt’oggi arrivano moltissime lettere all’indirizzo inesistente di 221B di Baker Street: a ognuna viene risposto su carta intestata che, purtroppo, Mr Holmes si è ritirato a vita privata e non può più occuparsi di alcuna questione. Ed è vivissima la disputa fra i “conan-doyliani ortodossi”, secondo i quali fu lo scrittore Arthur Conan Doyle a creare i personaggi immaginari di Sherlock Holmes e John Watson, e i cosiddetti “fondamentalisti sherlockiani” che, intrisi di fanatismo, sono convinti sia Conan Doyle il personaggio immaginario, o piuttosto lo pseudonimo con cui il vero dottor Watson firmava i suoi scritti, che quindi racconterebbero casi autentici, puntualmente ricostruiti e discussi da scrittori, scienziati e anonimi lettori da ogni parte del mondo, impegnati a rintracciare i pezzi mancanti di un incredibile puzzle potenzialmente infinito. È una sorta di Grande Gioco, quello del fare-finta-che Sherlock Holmes sia realmente esistito, da cui scaturiscono serissimi saggi sulla sua infanzia, sul suo orecchio musicale, sulla sua dipendenza dalla droga, sulle sue indubbie origini americane, sull’arte di fumare la pipa. L’immortalità di Holmes è dunque legata al carattere ciclico del racconto poliziesco, per cui il successo di un certo personaggio induce l’autore a narrarne nuove avventure, riproponendo insieme ad esso la cornice in cui si muove. Ma prima ancora che per la saga di Holmes, questo vale per la formula ideata da Edgar Allan Poe per la trilogia Dupin, i cui tratti ricorrenti sono la coppia detective/narratore, il prefetto di polizia e l’ambientazione parigina, mentre l’elemento innovativo di ogni racconto è l’enigma con cui l’investigatore si confronta. Fra le doti più riconosciute a Conan Doyle vi è proprio l’abilità nel tessere trame, anche se – come spesso accade – nella seconda metà del canone sherlockiano la routine tende a prevalere. Interessante è la tendenza del protagonista ad adattare il proprio profilo nel corso degli anni al mutato gusto del pubblico. Per esempio, di avventura in avventura il bagaglio culturale di Holmes si amplia sempre più, per un processo di magnificazione indotto dalla popolarità dell’eroe. In pochi anni, il detective dà prova non solo di aver letto Carlyle, ma di esser risalito attraverso di lui al poeta Jean Paul; citerà Goethe, converserà di Miracle plays e ceramiche medievali, di violini e del buddismo di Ceylon, leggerà Petrarca e compirà ricerche sulla musica medievale. (per approfondimenti: Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998). La saga di Sherlock Holmes La studiosa Alessandra Calanchi ha raccolto sei casi sherlockiani, tratti da raccolte diverse, nel volume 221B Baker Street edito da Marsilio: il suo intento è di offrire al lettore una certa varietà di contenuti e di stili che possa decostruire il personaggio di Sherlock Holmes, spogliandolo dalle stratificazioni svianti che ha subito nel corso del tempo, restituendogli un volto più composito, più simpatico e più accattivante. Ne risulta un’immagine del grande detective sottratta a quegli stereotipi della “britannicità” con cui ha pagato l’enorme successo popolare decretatogli dai mass media: uno Sherlock Holmes che si rivela non sempre infallibile e non sempre vincente, colto e autoironico, naïf e impacciato con le donne. Per proseguire il discorso su Sherlock Holmes, dunque, riporto un passo dell’Introduzione al volume (Decostruire gli stereotipi di Alessandra Calanchi): Primo fra gli stereotipi che intendiamo mettere in discussione, la “odiosa” infallibilità di Holmes. Come vedremo, ne I cinque semi d’arancia, posto in apertura di questa antologia, il grande detective risolve il caso senza però riuscire a salvare la vita al suo cliente, né a mettere le mani sui criminali; simmetricamente, l’ultimo racconto qui presentato si concluderà con la piena ammissione, da parte di Holmes, di essersi sbagliato troppo a lungo, di essere stato lento nel comprendere la verità. Per molto tempo ha prevalso, nell’immaginario popolare, l’idea che Sherlock Holmes rappresentasse il prototipo dell’investigatore arrogante, antipatico, che ha sempre ragione e che lo dimostra maltrattando Watson, la polizia e perfino i lettori. Anche questo è falso: Conan Doyle ci presenta con puntigliosa coerenza un personaggio fin troppo umano (al punto da cedere al vizio del fumo e della droga), generoso e disponibile, semmai abile nei mascheramenti,ma sempre animato da nobili scopi. Altro esempio di stereotipo: l’imprescindibile convivenza Holmes-Watson. Nei racconti che abbiamo scelto, la celebre “spalla” di Holmes – che tradizionalmente condivide con lui l’altrettanto celebre appartamento – in realtà è già sposato e si trova a Baker street solo per qualche giorno. Il che non toglie assolutamente nulla all’intimità che esiste indubbiamente fra i due, un’intimità le cui sfumature omoerotiche non hanno mancato di rappresentare un fecondo terreno di studio, ma che è sempre rigorosamente sottomessa al rispetto reciproco e alla professionalità di entrambi i personaggi. Ognuno nel suo settore – l’uno come detective, l’altro come medico – essi svolgono infatti le loro mansioni senza che mai l’amicizia che li lega degeneri o si incrini; e quelle comiche o patetiche prese in giro di Watson da parte di Holmes a cui certo cinema ci ha abituati sono del tutto assenti. Anche quando si permette di fare della lieve ironia, secondo il costume anglosassone, Holmes è pieno di rispetto nei confronti del compagno, e le sue battute di spirito – sempre affettuose – rientrano in quel tipico humour che non desidera offendere ma semplicemente far sorridere con stile. Per non parlare, infine dei veri e propri “falsi”: la frase «Elementare, Watson!» che non uscì mai dalla penna di Conan Doyle; la mantellina e soprattutto il cappellino da caccia – il cosiddetto deerstalker – che furono creati dall’illustratore (Sidney Paget, assunto per errore dall’editore al posto del più famoso fratello Walter) e non dall’autore; o, ancora, la pipa calabash che non esisteva ai tempi in cui le storie venivano scritte. Molto interessante è anche l’apparato di note della Calanchi ai diversi racconti: ne riporterò qui alcune, che puntualizzano la figura sherlockiana e ne integrano gli aspetti forse meno noti. Il metodo Sherlockiano Il metodo di Sherlock Holmes si basa su un processo logico che può essere superficialmente frainteso come abilità intuitiva, capacità di indovinare, o mera deduzione (lo stesso Doyle intitolò il secondo capitolo di Uno studio in rosso “La scienza della deduzione”). In realtà, come è stato spiegato da illustri studiosi e matematici, si tratta piuttosto di “abduzione”, consistente nell’inferire da un’accurata osservazione un’ipotesi (laddove “dedurre” significa inferire una tesi e “indurre” inferire una sintesi). Si rimanda in proposito a Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, a cura di U. Eco e T.A. Seboek (Milano, Bompiani 1983), che fra le altre cose, propone un confronto di tipo metodologico fra il celebre detective e il filosofo americano C.S. Peirce, fondatore del pragmatismo e della semiotica. Holmes e la polizia I rapporti che Holmes ha con la polizia sono di un tipo assolutamente originale. Holmes si fregia di essere l’unico consulting detective, e la sua competenza è tanto straordinaria che perfino la polizia, che inizialmente è insofferente ai suoi metodi e alla sua presenza sul luogo del delitto, giunge a volte a consultarlo. I vari ispettori che troviamo nei racconti (almeno una decina, su cui campeggia Lestrade) si recano da Holmes quando non sanno più che pesci pigliare, e allora Holmes, compiaciuto ma un po’ sulle sue, accetta generalmente di occuparsi del caso e alla fine, con magnanimità estrema, dopo averlo risolto ne lascia il merito e gli onori alla polizia. È dunque un rapporto di collaborazione impari, basato sul rispetto pur nella totale mancanza di stima professionale da parte di Holmes. All’epoca le forze di polizia erano ben nutrite, e a Londra c’era il corpo più preparato, la Metropolitan Police, detta scotland Yard dalla sede che occupava a Westminster (il luogo in cui anticamente esisteva un palazzo dove i re scozzesi soggiornavano a Londra) prima dell’attentato irlandese del 1884 (la nuova sede sorse in Victoria Embankment). Holmes e gli Irregulars Sherlock Holmes, in questo e nei successivi racconti qui raccolti, agisce da solo. In altri romanzi e racconti del Canone, invece, i migliori alleati di Holmes sono una banda di monelli da strada, reclutati dall’investigatore per aiutarlo nelle indagini: sono i celebri Irregulars, gli Irregolari di Baker Street (che fra l’altro hanno dato il nome a una delle più prestigiose associazioni holmesiane del mondo). Poverissimi, e costantemente a rischio di venire risucchiati nel giro della criminalità, essi vengono ricompensati da Holmes con uno scellino al giorno, più le spese, più un premio speciale di una ghinea per chi trova l’obiettivo della ricerca. Li incontriamo, per fare un paio di esempi, in Uno studio in rosso e ne Il segno dei quattro. (per approfondimenti: Arthur Conan Doyle, 221B Baker street – Sei ritratti di Sherlock Holmes, a cura di Alessandra Calanchi, con testo originale a fronte, Marsilio Editori 2001; http://www.uniurb.it/lingue/docenti/calanchi/; www.unostudioinholmes.org) La Londra holmesiana La Londra holmesiana è stata giustamente definita da Carlo Fruttero e Franco Lucentini «un’emanazione del personaggio». Come essi hanno infatti osservato, nonostante l’investigatore si sposti in più occasioni in altre zone (basti pensare agli ultimi due racconti della nostra raccolta), «il paesaggio di Londra prevale, è quello che associamo automaticamente al nome di Sherlock Holmes. Nebbie, carrozze, lampioni a gas, lunghe cancellate, vicoli oscuri […] Si può dire che la Londra di fine-secolo esista, nella geografia letteraria, per merito di S.H.» (Indagine preliminare in forma di dialogo, in A. Conan Doyle, Il cane dei Baskerville, Milano, Rizzoli 1982). L’appartamento di Holmes Gli studiosi discutono ancora sull’esatta ubicazione dell’appartamento, al fine di ricrearne una planimetria corretta. In generale si può ipotizzare ceh l’appartamento fosse situato al primo piano di una palazzina, che fosse composto di due confortevoli camere da letto e di un ampio salotto, a cui dobbiamo aggiungere un ripostiglio e, forse, una stanza da bagno. Sull’argomento si rimanda al capitolo The Home of Holmes in My Dear Holmes: Studies in Sherlock (Gavin Brend, 1951) e al più recente studio di E.S. Smith Jr., The Floor Plans of Baker Street (© dell’autore, ottobre 1996). Holmes e Watson Il rapporto fra Holmes e Watson non è mai né di sudditanza, né di soci d’affari, ma è improntato fin dall’inizio sul rispetto reciproco e su una progressiva amicizia. Questa male friendship, la tipica amicizia maschile britannica che è al centro ditanta letteratura dell’Ottocento, affonda le sue radici nel concetto vittoriano di “mascolinità”, un concetto oggi dibattuto e oggetto di reinterpretazione soprattutto a opera dei gender studies. Come ha scritto G.P. Caprettini, Watson rappresenta per Holmes lo «spazio trasparente e fidato di una complementarietà» laddove la donna è un fattore di turbamento e squilibrio (Le orme del pensiero, ne Il segno dei tre, cit., pp. 159-81). Siamo in un contesto fortemente maschile, sia dentro il testo sia fuori dal testo (anche la readership dei racconti è prevalentemente maschile), e senza arrivare ad accuse di misoginia e ad allusioni di omosessualità è innegabile che il tipo di rapporto che lega i due personaggi è proprio quella particolarissima British male relationship vittoriana che, pur escludendo ogni interferenza di tipo sessuale, si coniuga facilmente con un sentimento omoerotico latente. […] Fra le molteplici interpretazioni dell’amicizia fra Holmes e Watson, una delle più originali è indubbiamente quella dello scrittore e saggista inglese George Orwell, il quale, come ricordano Fruttero e Lucentini, sostiene che «Il rapporto Holmes-Watson […] è lo stesso rapporto di Don Chisciotte con Sancio Panza. L’anima e il corpo. L’ideale e la realtà. L’ingenua generosità e il buon senso materialista». Ma, attenzione, avvertono i due: Orwell vede non Sherlock Holmes «come paladino, come continuatore della cavalleria», bensì Watson, poiché «Conan Doyle, con l’aiuto delle illustrazioni di Paget, ha invertito le carte, dando a Holmes i tratti affilati, nobili, del cavaliere della Mancia, e a Watson un aspetto borghese e terra terra. In realtà, è sempre il buon dottore a trasfigurare catinelle e mulini a vento, a immaginare il mondo più vario, ricco, stupefacente, fantastico di quanto non sia. Mentre Holmes ha il compito, ogni volta, di disilluderlo, di sgonfiargli le bolle di sapone, di smontare anche il mistero più affascinante, riducendolo alle solite tre o quattro prosaiche componenti, vendetta, odio, amore, cupidigia, un cugino arrivato dall’estero con barba finta…» (Indagine preliminare in forma di dialogo, cit., pp. 9,10). Fruttero e Lucentini alludono qui a un saggio del 1941, L’arte di Donald McGill, in cui Orwell parla della coppia Don ChisciotteSancio Panza come di una forma dell’antico dualismo fra anima e corpo, e sottolinea appunto come le caratteristiche fisiche dei due personaggi siano invertite. Orwell, del resto, nomina molto di frequente Sherlock Holmes nei suoi saggi critici. Le armi Holmes maneggia solo eccezionalmente delle armi, prediligendo l’uso delle nude mani per difendersi dai suoi aggressori. Watson, invece, possiede una vecchia pistola d’ordinanza che si rivela molto utile in casi come questo. Il fucile ad aria compressa citato in questo capitolo e anticipato nel racconto precedente, infine, non è certo un giocattolo da fiera ma un’arma micidiale, silenziosa e precisa, con cui Holmes si imbatte più volte nel Canone. Il violino Sherlock Holmes si concede struggenti assoli di violino nelle pause che gli concede la sua attività,a puro scopo ricreativo, oppure dopo aver risolto un caso, o ancora nei momenti in cui è alla ricerca di un certo grado di concentrazione. Stando ai vari racconti in cui è menzionato questo strumento, che riposa in un angolo del salotto, Holmes sembra prediligere orari antelucani e suonarlo in modo eccentrico. Si tratterebbe nientemeno che di unno stradivario, acquistato con un colpo di fortuna da un robivecchi per soli 55 scellini (La scatola di cartone, 1893). La biblioteca Holmes possiede molti volumi di consultazione , indici e archivi in cui conserva non solo i resoconti dei casi da lui affrontati, ma anche notizie riguardanti personalità illustri e famosi criminali. Possiede inoltre un album dove incolla ritagli di giornale inerenti annunci personali, persone scomparse, casi non suoi e così via, e infine un’Enciclopedia Araldica, pile di giornali vecchi, un dizionario geografico, almanacchi, orari ferroviari, volumi di botanica e l’Enciclopedia Americana. Holmes legge numerosi giornali, che gli vengono recapitati a casa e sono ben visibili la mattina, come abbiamo visto, sul tavolo della colazione (il “Times”, il “Daily Chronicle”, lo “Standard”, l’ “Echo”, il il “Daily Telegraph” e il “Daily News”). La pipa e oltre Mentre Watson fuma il sigaro, Holmes, come abbiamo già visto, predilige la pipa, pur non disdegnando le sigarette o, come in questo caso, un buon sigaro. Anche se probabilmente non fumò mai la celebre “Calabash”, la pipa di zucca dalla forma caratteristica che comunemente gli si accosta. Ne possiede di diversi tipi. La sua preferita è però una pipa di gesso o di creta nera che lo accompagna nelle più profonde meditazioni, e che di solito riposa sulla mensola del caminetto. Il tabacco viene invece conservato in una babbuccia persiana. Fra le bizzarre abitudini di Holmes vi è quella di caricare la pipa al mattino con gli avanzi del giorno precedente. Mentre il fumo serve a Holmes per migliorare la concentrazione quando riflette sui casi, ben diversa è la cocaina, che egli si inietta per via sottocutanea (e non endovenosa) in soluzione al 7% nei momenti di inattività, ovvero nelle pause di ristagno fra un caso e l’altro. È necessario tenere presente che all’epoca la cocaina (un alcaloide isolato da Albert Niemann nel 1860) non era illegale, anzi fino al 1884 fu considerata un farmaco efficace e fu usata e prescritta dallo stesso Freud. Fu solo alla fine degli anni ’80 che giunsero i primi segnali d’allarme, e dunque è solo negli anni ’90 che Watson cerca di convincere Holmes a disintossicarsi. Un romanzo che si è ispirato all’assunzione di cocaina da parte di Holmes è La soluzione sette per cento di Nicholas Meyer (1974), da cui fu tratto il film omonimo (Herbert Ross, 1976), dove Holmes, nei tre anni in cui è creduto morto, si trova in realtà a Vienna, affidato alle rivoluzionarie cure del giovane dottor Freud, allo scopo di disintossicarsi. L’anoressia Gli studiosi hanno sottolineato la tendenza anoressica di Holmes, il quale non solo è contraddistinto da un’evidente magrezza, ma generalmente non si abbandona a banchetti pantagruelici. Nel primo racconto qui preso in esame egli si nutre voracemente di pane e acqua, e nei successivi vi sono solo rapidi accenni a spuntini. Nella sala da pranzo dell’hotel si discute anziché mangiare, e qui c’è tempo solo per un boccone. Nel prossimo racconto qui raccolto Holmes, dopo un digiuno di tre giorni, si concederà un bicchiere di vino e qualche biscotto, e il ristorante Simpson’s – sebbene nominato – resterà fuori campo. Anche negli altri racconti del Canone, durante le indagini Holmes non è mai nemmeno sfiorato dal desiderio del cibo, e le immagini più frequenti dei suoi pasti restano comunque legate a un’idea di frugalità: certo per mettere in risalto il distacco tra la sfera del puro intelletto e quella delle emozioni, a cui appartiene di fatto il gusto della buona tavola. Della questione si è occupato E.F. Walbridge (The Care and Feeding of Sherlock Holmes), che sottolinea come Holmes rinunci completamente al cibo durante le indagini, e come la prima colazione (breakfast) sia il pasto principale dell’investigatore, il quale odia le verdure e ha invece un debole per le ostriche. Walbridge cita da Uno scandalo in Boemia il seguente scambio di battute, particolarmente rivelatore, fra Mrs Hudson e Holmes. Domanda: «A che ora desidera cenare, signor Holmes?» Risposta: «Alle sette e mezza, dopodomani». Il professor Moriarty Moriarty: l’essere malvagio per eccellenza, l’erede più puro del vilain, il nemico numero uno di Holmes e dell’umanità intera. Se altrove le peripezie sono causate da un potere maligno situato oltre oceano, o, come vedremo oltre, da una misteriosa creatura acquatica o dalla gelosia, ne Il problema finale coinvolgono la sinistra organizzazione che si annida nel cuore di Londra e i cui fili sono retti dal professor Moriarty, lugubre fin dal cognome. Si tratta di un personaggio che, pur incontrando la morte nell’ambito di questo stesso racconto, ritroveremo successivamente (e che in romanzi e adattamenti cinematografici posteriori vestirà via via nuovi panni, compresi quelli di spia nazista, a seconda delle epoche): una mente logica e demoniaca a capo di un’organizzazione incredibilmente estesa e ramificata (o forse non così incredibile, considerando per esempio che la mafia, un’organizzazione simile, nasceva in Italia proprio nell’Ottocento, e che la massoneria era già attiva in Gran Bretagna sin dalla seconda metà del XVII secolo) e il cui ritratto, delineato con parole sempre in bilico fra sommo orrore e intensa ammirazione, non manca di comunicare – perlomeno allo smaliziato lettore del terzo millennio – un’abbondante dose di ingenuità. Ma soprattutto si delinea, a partire dall’inserimento di questa figura nel tessuto dei racconti, il celebre triangolo Holmes-Watson-Moriarty, ovvero lo schema prediletto da Watson-Doyle: un triangolo maschile, epurato da ogni interferenza sentimentale o ideologica, che vede la sua ragione d’essere nel reciproco scambio di valori di segno uguale e opposto (il rispetto, l’amicizia, la ricerca della verità; ma anche la vanità, il conflitto, l’odio) e trova fra le pareti domestiche l’arena più congeniale di incontro/scontro – la poltrona, la scrivania, la porta, la soglia, la lampada, la finestra – fissando un’iconografia simbolica che confluirà in un vero e proprio repertorio mitologico del genere poliziesco. In questo contesto, come vedremo, si possono scorgere allusioni discrete a questioni quali il desiderio omoerotico o la paura dell’impotenza sessuale (la sorpresa di Holmes nel constatare che lui e Watson sono soli, la mano sulla rivoltella, Holmes che si arrampica sulla guglia rocciosa, la scena sulla cascata ribollente, l’abbraccio finale), pur con le dovute concessioni al pittoresco (il transito in Svizzera) e al sublime (la scena presso le cascate). Il fratello Un altro personaggio con cui facciamo conoscenza ne Il problema finale – anche se qui è appena abbozzato, mentre nelle storie successive rivelerà progressivamente una propria complessa identità – è il fratello di Holmes, Mycroft, che altrove viene da lui coinvolto (segretamente) nelle indagini non solo per i suoi legami con le alte sfere dello Stato, ma in quanto possiede una mente se possibile ancor più sottile di quella dello stesso Sherlock, pur prediligendo in realtà una vita molto più tranquilla (è affiliato al Diogenes Club, il cui regolamento impone l’ozio). Qui Mycroft è presente per assolvere a due funzioni: prestare temporaneamente l’abitazione a Holmes per motivi strategici (e vediamo che realmente questi correva dei rischi a Baker Street) e guidare – naturalmente travestito – la carrozza che conduce Watson alla stazione. Il travestimento Il problema finale introduce una delle caratteristiche precipue di Holmes, ovvero il suo gusto per il travestimento e la recitazione di una parte. Se qui il ruolo del vetturino è ricoperto dal fratello per motivi di sicurezza, il vetusto prete italiano è interpretato da Sherlock per sviare il nemico. Si tratta solo di una rapida particina nella lunga teoria di maschere che l’investigatore indosserà nel corso della sua lunga carriera, non solo per far perdere le tracce ai suoi inseguitori, ma anche – è pur vero – per stupire Watson e divertire i lettori. Il travestimento è sì una strategia, ma assume connotazioni ludiche e non solo rituali nel contesto di queste storie. Per non parlare delle ovvie allusioni a un velato desiderio di trasgressione delle norme e delle convenzioni (del resto, anche Dorian Gray nel celebre romanzo di Oscar Wilde si serve del travestimento per recarsi nell’East Side senza essere riconosciuto, rivelando più ovvie dinamiche omoerotiche), sebbene questo tipo di travestimento non coinvolga quasi mai direttamente il genere sessuale. La ricomparsa del nemico in La casa vuota La ricomparsa del nemico è certo un elemento degno di nota. Una volta sparito il pericolo numero uno, il malefico Moriarty, e nell’impossibilità di far resuscitare anche lui (ché la faccenda sarebbe stata troppo sporca), Conan Doyle ricicla la figura nel personaggio malvagio nell’ “amico del cuore” di Moriarty. Due osservazioni. La prima: si viene a delineare una seconda coppia (seconda rispetto a quella di primo piano, Holmes-Watson) che richiede una reinterpretazione di quel “triangolo” a cui si era precedentemente accennato. Dunque anche Moriarty, come Holmes, aveva un socio, un compagno, un collaboratore, un bosom friend. Seconda osservazione: Conan Doyle è costretto a inventare un nuovo nemico (nuovo, ma non troppo, altrimenti si perderebbe la continuità della saga) perché se il pubblico reclama Holmes, questi non esiste senza un nemico contro cui battersi. Dunque Doyle deve compiere una doppia azione di ripescaggio per rendere il meccanismo verosimile, convincente e apprezzabile dalla readership. Holmes è come l’eroe virtuale di un video-game ante litteram: perché il gioco funzioni ci deve essere prima di tutto un avversario, e poi azione, ritmo e colpi di scena. Holmes, è bene ricordarlo, langue letteralmente quando è privato dell’azione: resta disteso giorni e giorni sul divano, suona note strazianti sul suo violino, e ricade regolarmente nel vizio periodico della cocaina. (per approfondimenti: Arthur Conan Doyle, 221B Baker street – Sei ritratti di Sherlock Holmes, a cura di Alessandra Calanchi, con testo originale a fronte, Marsilio Editori 2001) http://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso http://www.ottolenghi.org/salvatore.htm http://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton http://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon) Identità criminali Con questa puntata andiamo a concludere la nostra panoramica sulla nascita e lo sviluppo della narrativa poliziesca. Riepilogando, vediamo che negli ottant’anni che corrono tra il 1830 (quando uscirono i Mémoirs di Vidocq) e il 1910 la criminologia sviluppa tecniche di lettura del corpo sempre più sofisticate. Queste tecniche sono orientate in due direzioni: quella scientifico-statistica, che tende a descrivere il fenomeno che si cela dietro i singoli casi di devianza; e quella poliziesca in senso stretto, volta a elaborare tecniche di riconoscimento tali da riuscire a imprigionare il criminale nella gabbia della propria identità. Nel primo filone d’indagine, che ricerca nei tratti fisici i segni di un’innata inclinazione a delinquere, rientrano il miraggio fisiognomico di matrice settecentesca (che chiama il volto in primo piano), la frenologia (fondata sullo studio del cranio), e la nota avventura fin de siécle di Cesare Lombroso, padre della fisiognomica e fondatore dell’antropologia criminale: secondo la sua controversa teoria, esisteva un preciso rapporto fra l’aspetto fisico delle persone e la loro inclinazione al comportamento criminale. Ma a questo tentativo di leggere nel corpo le componenti del carattere, secondo una concezione determinista, si va ad affiancare l’esigenza di “censire” la popolazione criminale. Il marchio, lo strumento che nei secoli precedenti consentiva l’identificazione dei recidivi – quale il giglio impresso sulla spalla di Milady ne I tre moschettieri, che consente a D’Artagnan di riconoscere in lei un’avvelenatrice – viene abolito in Francia nel 1832; e proprio in quegli anni, il pioniere Vidocq crea uno schedario di tutti gli arrestati. Di lì a poco, è l’invenzione della fotografia che contribuisce a palesare l’identità criminale; ma i maggiori progressi si verificano verso la fine del secolo. È nel 1882 che il funzionario di polizia e antropologo Alphonse Bertillon (1853-1914) fonda il servizio di antropometria della polizia parigina, le cui schede segnaletiche si compongono di undici misure ossee (le dimensioni della testa, dell’orecchio, del dito medio, del piede sinistro, etc.), di una breve descrizione scritta dell’individuo, e di due fotografie (una frontale e una di profilo). Lo stesso Bertillon, tuttavia, riconosce che la scheda non identifica il soggetto con certezza assoluta: il metodo, dunque, consente in molti casi di escludere – ma non di provare – che a una persona corrisponda una certa identità, ed è inoltre soggetto a un largo arbitrio nelle misurazioni e nelle descrizioni scritte (il cosiddetto “ritratto parlato”) che corredano la scheda. In Italia, su impulso dell’allora ministro dell’Interno Giovanni Giolitti, nasce nel 1902 la Scuola di Polizia Scientifica, creata dal professor Salvatore Ottolenghi, assistente di Cesare Lombroso all’università di Torino. Il primo corso ufficiale si svolse nel carcere di Regina Coeli, dove si avevano a disposizione numerosi detenuti con cui illustrare le metodologie scientifiche per l’identificazione personale. L’approccio di Ottolenghi andava a contrapporsi alla tipica immagine letteraria del “genio deduttivo” alla Sherlock Holmes: le procedure scientifiche, ricavate da un lungo lavoro di esperimenti e osservazioni sistematiche, erano controllabili e ripetibili da chiunque le avesse apprese. Ad ogni modo, nel 1903 il sistema di Bertillon viene finalmente sostituito dalla dattiloscopia: l’esame delle impronte digitali, sistema già codificato e adottato in Gran Bretagna nel 1901 dall’antropologo Francis Galton. Si arriva così alla metodologia d’identificazione moderna, fondata su nome, fotografia e impronte digitali. Il criminale assente Concepito essenzialmente come altro, il criminale del romanzo poliziesco costituisce in generale un’assenza, poiché tra le convenzioni del poliziesco vi è il “vuoto testuale” che circonda e protegge i processi mentali del colpevole – un elemento da molti assunto a spartiacque tra detective fiction e crime fiction. Nella prima, l’indagine impone che i processi mentali del criminale non vengano svelati fino allo scioglimento finale, mentre nella seconda il racconto del crimine può esplorare “in chiaro” l’intera sua dinamica. Nella detective fiction, dunque, se non c’è la “mente”, resta il “corpo” del criminale, un enigma di cui spesso si può cogliere qualche attributo – come un capo di vestiario, un’impronta di scarpa, la statura, il colorito, una marca di tabacco – e che si presenta come una superficie da attraversare per giungere all’interiorità, che è la sede della colpa, sottratta dall’esigenza narrativa al voyeurismo del lettore. Nel caso del detective, più ancora che il corpo – che a seconda dei casi può diventare una divisa iconografica (si vedano gli attributi estetici di investigatori quali Sherlock Holmes e Padre Brown) oppure un materiale posticcio (si pensi al trasformismo di Vidocq e Holmes) – è centrale la sua mente. Il racconto poliziesco, infatti, è caratterizzato da una forte componente riflessiva, che si manifesta tipicamente nelle lunghe digressioni sulla forma mentale e sul metodo dell’investigatore. A differenza del successivo genere hardboiled – ove l’azione ha un ruolo primario –, «il “giallo classico” è dominato dall’avventura del pensiero»*, e quindi si svolge, più che su uno sfondo reale, in uno scenario mentale. La realtà non basta a Dupin, l’eroe della trilogia di Poe, il quale nell’esaminare un caso criminale spegne la candela per meglio vedere, e in pieno giorno rifugge la luce del sole, che mostra tutto ma non rivela nulla. Né la realtà basta a Holmes, il quale, destatosi dai suoi «drug-created-dreams», è in breve «hot upon the scent of some new problem», come si addice alla «most perfect reasoning and observing machine that the world has seen». D’altronde, allo svago di una vacanza Holmes preferisce evidentemente giacere in mezzo a cinque milioni di persone (la popolazione di Londra del tempo), col sistema nervoso attento a percepire la più piccola voce o sospetto di un crimine: un’immagine iperbolica (visibilmente influenzata dall’immaginario telegrafico di fine Ottocento) che qualifica il detective come il luogo cerebrale di un immenso sistema nervoso, esteso a toccare i cinque milioni di persone che costituiscono il corpo di Londra. Assolvendo questa sua funzione di controllore, Holmes consente così il buon funzionamento del sistema, e ai suoi occhi la capitale – fulcro della nazione e dell’impero – assume la trasparenza di un Panopticon, ove il detective – moderno semidio – veglia benevolo sul comune cittadino. (per approfondimenti: G. Paolo Caprettini, “Le orme del pensiero”, in Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, a cura di U. Eco e T.A. Sebeok, Bompiani, Milano 1983; Maurizio Ascari, La leggibilità del male, Pàtron, Bologna 1998. S.S. Van Dine e le 20 regole Come scrisse il compianto Oreste Del Buono*, Philo Vance, il grande investigatore dilettante degli anni ’30 (definito da Raymond Chandler «Forse il personaggio più pomposo e balordo dell’intera letteratura poliziesca») creato da S. S. Van Dine, è «l’erede e l’eversore dello Sherlock Holmes di Conan Doyle», nel solco del «cosiddetto romanzo d’analisi, del poliziesco all’inglese, quello della riflessione per la riflessione». È non solo erede, ma anche eversore: infatti, pur discendendo (e chiaramente) da Holmes, Vance rifiuta la specializzazione: è troppo dotato di cognizioni universali. Al dettaglio arriva di volta in volta, come degnandosi di accettare un limite provvisorio, un passatempo per la sua cultura degna di ben altro. In pratica, insomma, innovando, torna indietro, è umanista quanto Holmes è scientifico sebbene sia capace di distinguersi anche nel campo scientifico, perpetuamente dilettante, quindi disposto, teso a ricavar diletto dai più vari problemi. In questo, Philo Vance confessa d’essere, lui così improbabile, così inconcepibile come uomo in carne ed ossa, un riflesso abbastanza conseguente della personalità del suo creatore. Che non si chiamò affatto S. S. Van Dine, secondo la menzognera indicazioned ei frontespizi. Dopo tre anni di mistero (The Benson Murder Case è del 1926) fu scoperto, appunto, che dietro un simile pseudonimo si celava William Huntington Wright (1888-1939), letterato, antropologo, cultore d’arte di consistente allora rinomanza. […] Fu Wright a raccontare in che modo fosse stato indotto a creare Philo Vance. Aveva subito un grave collasso nervoso, il suo medico di fiducia gli aveva proibito qualsiasi fatica intellettuale durante la convalescenza, a eccezione (non la considerava evidentemente una fatica) del leggere e dello scrivere gialli. Wright aveva preferito scriverne. Del resto, la sua insaziabile voracità di sapere gli aveva fatto collezionare una agguerritissima biblioteca di criminologia e lo aveva reso esperto anche in tale ramo. Il delitto era il suo hobby, ma un hobby su cui avrebbe potuto tener lezioni. E le tenne, infatti, con gli intervistatori, con i curiosi eccitati dalla scoperta della vera identità del creatore di Philo Vance. […] Wright non si accontentò di dissertare sul delitto vero, dissertò anche sul delitto inventato, ovvero romanzo poliziesco. Ne dettò addirittura le regole. (Oreste Del Buono, Il ritorno di Philo Vance, introduzione al volume della collana Omnibus Gialli, V° edizione Mondadori 1971.) E così, le “Twenty Rules for Writing Detective Stories”, ossia le Venti Regole di S. S. Van Dine, divennero famose. Restano il segno di un’epoca, di una lunga epoca che oggi è certamente superata, ma che costituisce il terreno fondante di un genere letterario importantissimo e pervasivo. Eccole in dettaglio. Venti regole per scrivere romanzi polizieschi di S.S.Van Dine (1928) Il romanzo poliziesco è un tipo di gioco intellettuale. Anzi, è qualcosa di più – una gara sportiva. Ed esistono leggi ben precise che governano la scrittura di romanzi polizieschi: leggi non scritte, forse, ma ugualmente vincolanti, con le quali si deve misurare ogni rispettabile inventore di misteri letterari che sia anche onesto con se stesso. Ecco di seguito, quindi, una sorta di Credo, basato in parte sull’esperienza di tutti i grandi autori di romanzi polizieschi e in parte sulle sollecitazioni della coscienza dell’autore onesto. Vale a dire: 1. Il lettore deve avere le stesse opportunità del detective di risolvere il mistero. Tutti gli indizi devono essere presentati e descritti con chiarezza. 2. Al lettore non possono essere rifilati altri trucchi o inganni oltre a quelli coi quali il criminale tenta legittimamente di buggerare il detective. 3. Non dev’essere posta eccessiva enfasi sull’elemento amoroso. Lo scopo è quello di assicurare un criminale alla giustizia, non quello di condurre una coppia innamorata all’altare. 4. Né il detective né uno degli investigatori ufficiali possono risultare colpevoli. Questo vuol dire giocare sporco; è come offrire a qualcuno una moneta da un centesimo in cambio di cinque dollari d’oro. È frode bella e buona. 5. Al colpevole si deve arrivare attraverso deduzioni basate sulla logica, non per caso o coincidenza o confessione senza motivo. Risolvere un problema di detection in questo modo equivale a spedire deliberatamente il lettore su di una falsa pista e poi dirgli, dopo che è tornato con le pive nel sacco, che la cosa che lo avevate mandato a cercare ce l'avevate nascosta voi nella manica fin dall’inizio. Un autore di questa fatta è poco più di un buffone. 6. Nel romanzo poliziesco ci dev’essere un investigatore; e un investigatore non può dirsi tale se non indaga. La sua funzione è quella di raccogliere gli indizi che, in fondo al libro, condurranno all’identità di colui che ha commesso il crimine di cui al primo capitolo; e se l'investigatore non arriva alle sue conclusioni grazie all’analisi di questi indizi, non ha risolto il suo problema alla stessa stregua dello scolaro che copia il compito di aritmetica. 7. Ci dev’essere un cadavere nel romanzo poliziesco, e più è cadavere meglio è. Nessun reato minore dell’assassinio può essere considerato sufficiente. Trecento pagine sono troppe per un reato diverso dall’assassinio. Dopo tutto, la fatica e lo sforzo del lettore devono essere ricompensati. 8. Il problema posto dal delitto dev’essere risolto con metodi rigorosamente scientifici. Metodi di scoperta della verità che si basano su lavagnette e tavolette parlanti, lettura del pensiero, sedute spiritiche, sfere di cristallo e simili, sono assolutamente vietati. Un lettore può competere con un detective raziocinante, ma se deve gareggiare col mondo degli spiriti e rincorrere la quarta dimensione della metafisica, allora è battuto in partenza. 9. Ci dev’essere un solo investigatore autorizzato a trarre le conclusioni, un solo deus ex machina. Impiegare i cervelli di tre o quattro o un’intera banda di investigatori per trovare la soluzione al problema, non solo disperde l’interesse e spezza il filo della logica, ma dà all’autore un vantaggio scorretto sul lettore. Se c’è più di un investigatore, allora il lettore non è più in grado di distinguere chi è il suo avversario. Gli tocca correre da solo contro una staffetta. 10. Il colpevole dev’essere una persona che ha avuto un ruolo più o meno significativo nella vicenda; ovvero, una persona che è divenuta familiare al lettore e per la quale egli ha provato interesse. 11. Il colpevole non dev’essere scelto tra il personale di servizio. È assolutamente una questione di principio. È una soluzione troppo semplicistica. Il colpevole deve essere una persona che ha giocato un ruolo significativo, una persona di cui non si dovrebbe sospettare. 12. Ci dev’essere un solo colpevole, al di là del numero degli assassinii. È ovvio che il colpevole può essersi servito di complici o aiutanti, ma la colpa e l’indignazione del lettore devono cadere su una sola e unica anima nera. 13. Società segrete, camorra, mafia e così via non hanno spazio in un romanzo poliziesco. Un assassinio affascinante e ben riuscito è guastato senza remissione da una colpevolezza all’ingrosso. È certo che anche all’assassino debba essere offerta una scappatoia, ma concedergli addirittura una società segreta con cui spartire le colpe è un po’ troppo. Nessun assassino di classe e consapevole dei propri mezzi accetterebbe di giocare contro queste probabilità. 14. I metodi impiegati nell’assassinio, e i sistemi usati per scoprirlo, devono essere razionali e scientifici. Vale a dire, la pseudo-scienza e i congegni di pura e semplice immaginazione non possono esser tollerati in un romanzo poliziesco. Una volta che l’autore è partito verso il regno della fantasia, alla maniera di Jules Verne, si è posto definitivamente fuori dai confini della narrativa poliziesca e si è messo a far capriole in una zona dell’avventura che non è segnata sulle carte geografiche. 15. La rivelazione del problema dev’essere sempre evidente, ammesso che il lettore sia abbastanza sveglio da individuarla. Con questo intendo che se il lettore, appresa la spiegazione del crimine, decide di rileggersi il libro da capo, deve accorgersi che, in un certo senso, la soluzione giusta era sempre stata lì, a portata di mano, che tutti gli indizi portavano al colpevole e che, se solo fosse stato astuto come l’investigatore, anche lui avrebbe potuto risolvere il mistero prima dell’ultimo capitolo. Va da sé che il lettore intelligente risolve spesso l’enigma in questo modo. 16. Un romanzo poliziesco non dovrebbe contenere descrizioni troppo lunghe, divagazioni letterarie su argomenti secondari, studi di caratteri troppo insistiti, preoccupazioni di creare un'atmosfera: questi elementi non hanno spazio in quello che sostanzialmente è il resoconto di un crimine e di una deduzione. Tali passaggi bloccano l’azione e introducono argomenti di scarso rilievo per l’obiettivo finale, che è quello di esporre un problema, analizzarlo e condurlo a una conclusione soddisfacente. È chiaro, comunque, che ci debba essere sufficiente materia descrittiva e studio di carattere per dar verosimiglianza al romanzo. 17. Il colpevole di un romanzo poliziesco non deve mai essere un criminale di professione. Scassinatori e banditi appartengono alla pratica quotidiana dei dipartimenti di polizia, non degli autori e dei loro brillanti investigatori dilettanti. Un crimine davvero affascinante è quello commesso da un vero baciapile, o da una zitella dedita ad attività benefiche. 18. Un crimine, in un romanzo giallo, non può mai essere derubricato in incidente o suicidio. Far finire un’autentica odissea di detection in questo modo così banale significa voler infinocchiare a tutti i costi il fiducioso e gentile lettore. 19. I moventi dei crimini nei romanzi polizieschi devono essere esclusivamente personali. Complotti internazionali e azioni di guerra fanno parte di un’altra categoria di romanzi, quelli di spionaggio, ad esempio. Ma un romanzo giallo deve mantenere un carattere intimo, per così dire. Deve riflettere le esperienze quotidiane del lettore, e offrire uno sfogo ai suoi desideri ed emozioni represse. 20. E, per dare al mio Credo un numero pari di regole, ecco una serie di stratagemmi che nessuno scrittore di gialli degno di questo nome potrà più permettersi di adoperare. Sono già stati troppo sfruttati, e sono molto familiari a tutti i cultori dei crimini di carta. Avvalersene equivale a confessare la propria incapacità e mancanza di originalità. a) Scoprire l’identità del colpevole mettendo a confronto la cicca di sigaretta trovata sulla scena del crimine con la marca fumata da un sospetto. b) La seduta spiritica fasulla che terrorizza il colpevole e lo spinge a confessare. c) Impronte digitali falsificate. d) L’alibi costruito mediante un fantoccio. e) Il cane che non abbaia e quindi rivela che l’intruso gli è familiare. f) L’attribuzione del crimine a un gemello, a un parente troppo somigliante al presunto colpevole. g) La siringa ipodermica e il sonnifero. h) L’assassinio commesso in una stanza chiusa, ma dopo che la polizia vi ha fatto irruzione. i) Il test delle associazioni di parole che indicano il colpevole. j) Il codice cifrato la cui soluzione viene alla fine trovata dall’investigatore. Ed ecco il testo originale: Twenty Rules for Writing Detective Stories (1928) by S.S. Van Dine The detective story is a kind of intellectual game. It is more--it is a sporting event. And for the writing of detective stories there are very definite laws--unwritten, perhaps, but none the less binding; and every respectable and self-respecting concocter of literary mysteries lives up to them. Herewith, then, is a sort of Credo, based partly on the practice of all the great writers of detective stories, and partly on the promptings of the honest author's inner conscience. 1.The reader must have equal opportunity with the detective for solving the mystery. All clues must be plainly stated and described. 2. No willful tricks or deceptions may be placed on the reader other than those played legitimately by the criminal on the detective himself. 3. There must be no love interest. The business in hand is to bring a criminal to the bar of justice, not to bring a lovelorn couple to the hymeneal altar. 4. The detective himself, or one of the official investigators, should never turn out to be the culprit. This is bald trickery, on a par with offering some one a bright penny for a five-dollar gold piece. It's false pretenses. 5. The culprit must be determined by logical deductions--not by accident or coincidence or unmotivated confession. To solve a criminal problem in this latter fashion is like sending the reader on a deliberate wild-goose chase, and then telling him, after he has failed, that you had the object of his search up your sleeve all the time. Such an author is no better than a practical joker. 6. The detective novel must have a detective in it; and a detective is not a detective unless he detects. His function is to gather clues that will eventually lead to the person who did the dirty work in the first chapter; and if the detective does not reach his conclusions through an analysis of those clues, he has no more solved his problem than the schoolboy who gets his answer out of the back of the arithmetic. 7. There simply must be a corpse in a detective novel, and the deader the corpse the better. No lesser crime than murder will suffice. Three hundred pages is far too much pother for a crime other than murder. After all, the reader's trouble and expenditure of energy must be rewarded. 8. The problem of the crime must he solved by strictly naturalistic means. Such methods for learning the truth as slate-writing, ouija-boards, mind-reading, spiritualistic se'ances, crystal-gazing, and the like, are taboo. A reader has a chance when matching his wits with a rationalistic detective, but if he must compete with the world of spirits and go chasing about the fourth dimension of metaphysics, he is defeated ab initio. 9. There must be but one detective--that is, but one protagonist of deduction--one deus ex machina. To bring the minds of three or four, or sometimes a gang of detectives to bear on a problem, is not only to disperse the interest and break the direct thread of logic, but to take an unfair advantage of the reader. If there is more than one detective the reader doesn't know who his codeductor is. It's like making the reader run a race with a relay team. 10. The culprit must turn out to be a person who has played a more or less prominent part in the story--that is, a person with whom the reader is familiar and in whom he takes an interest. 11. A servant must not be chosen by the author as the culprit. This is begging a noble question. It is a too easy solution. The culprit must be a decidedly worth-while person--one that wouldn't ordinarily come under suspicion. 12. There must be but one culprit, no matter how many murders are committed. The culprit may, of course, have a minor helper or co-plotter; but the entire onus must rest on one pair of shoulders: the entire indignation of the reader must be permitted to concentrate on a single black nature. 13. Secret societies, camorras, mafias, et al., have no place in a detective story. A fascinating and truly beautiful murder is irremediably spoiled by any such wholesale culpability. To be sure, the murderer in a detective novel should be given a sporting chance; but it is going too far to grant him a secret society to fall back on. No high-class, self-respecting murderer would want such odds. 14. The method of murder, and the means of detecting it, must be be rational and scientific. That is to say, pseudo-science and purely imaginative and speculative devices are not to be tolerated in the roman policier. Once an author soars into the realm of fantasy, in the Jules Verne manner, he is outside the bounds of detective fiction, cavorting in the uncharted reaches of adventure. 15. The truth of the problem must at all times be apparent--provided the reader is shrewd enough to see it. By this I mean that if the reader, after learning the explanation for the crime, should reread the book, he would see that the solution had, in a sense, been staring him in the face-that all the clues really pointed to the culprit--and that, if he had been as clever as the detective, he could have solved the mystery himself without going on to the final chapter. That the clever reader does often thus solve the problem goes without saying. 16. A detective novel should contain no long descriptive passages, no literary dallying with side-issues, no subtly worked-out character analyses, no "atmospheric" preoccupations. such matters have no vital place in a record of crime and deduction. They hold up the action and introduce issues irrelevant to the main purpose, which is to state a problem, analyze it, and bring it to a successful conclusion. To be sure, there must be a sufficient descriptiveness and character delineation to give the novel verisimilitude. 17. A professional criminal must never be shouldered with the guilt of a crime in a detective story. Crimes by housebreakers and bandits are the province of the police departments--not of authors and brilliant amateur detectives. A really fascinating crime is one committed by a pillar of a church, or a spinster noted for her charities. 18. A crime in a detective story must never turn out to be an accident or a suicide. To end an odyssey of sleuthing with such an anti-climax is to hoodwink the trusting and kind-hearted reader. 19. The motives for all crimes in detective stories should be personal. International plottings and war politics belong in a different category of fiction--in secret-service tales, for instance. But a murder story must be kept gemütlich, so to speak. It must reflect the reader's everyday experiences, and give him a certain outlet for his own repressed desires and emotions. 20. And (to give my Credo an even score of items) I herewith list a few of the devices which no self-respecting detective story writer will now avail himself of. They have been employed too often, and are familiar to all true lovers of literary crime. To use them is a confession of the author's ineptitude and lack of originality. (a) Determining the identity of the culprit by comparing the butt of a cigarette left at the scene of the crime with the brand smoked by a suspect. (b) The bogus spiritualistic se'ance to frighten the culprit into giving himself away. (c) Forged fingerprints. (d) The dummy-figure alibi. (e) The dog that does not bark and thereby reveals the fact that the intruder is familiar. (f)The final pinning of the crime on a twin, or a relative who looks exactly like the suspected, but innocent, person. (g) The hypodermic syringe and the knockout drops. (h) The commission of the murder in a locked room after the police have actually broken in. (i) The word association test for guilt. (j) The cipher, or code letter, which is eventually unraveled by the sleuth.
Scarica