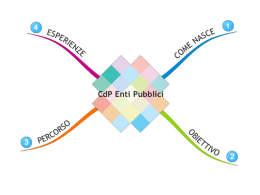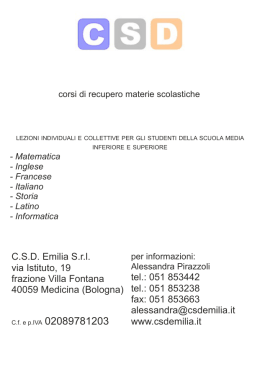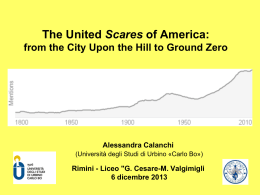Archivio del sito http://www.trio-lescano.it/ Virgilio Zanolla Intervista immaginaria a Giuditta Lescano (ma chissà poi quanto) Ultimo aggiornamento: 26.8.2013 Luglio-Agosto 2013 2 Presentazione (Dalle Notizie dell’8 Agosto 2013) Ricorre oggi il Centenario della nascita di Giuditta Lescano, il cui vero nome era Judik (poi Judith) Leschan: la “piccolina” del celebre Trio, dotata di un’ammaliante voce di contralto, nonché di una deliziosa erre moscia. Come è arcinoto, non è stato finora possibile, malgrado le tante ricerche intraprese ovunque, appurare dove e quando essa sia deceduta, anche se c’è in giro qualcuno che sostiene di saperlo, guardandosi bene però dall’essere più preciso e soprattutto dall’esibire qualche prova a sostegno delle proprie affermazioni. In alcuni siti internet dell’America Latina circolò a suo tempo, insistente, la voce che Giuditta fosse ancora in vita verso il 2007, emulando in ciò la longevità della madre, Eva de Leeuwe, scomparsa alla bella età di 93 anni. Pochi presero allora sul serio tale informazione, a motivo del fatto che nessuno si era mai premurato di fugare ogni dubbio fornendo altri particolari. A noi però, amanti delle vecchie canzoni, come quella intitolata Perché non sognar? [http://www.youtube.com/watch?v=fwndVHZpjw0], piace credere che non si sia trattato di una semplice diceria, magari messa in rete per burla da qualche perdigiorno. Ci alletta troppo l’idea che Giuditta fosse ancora viva e vegeta all’epoca in cui venne lanciato nel web questo sito, interamente dedicato al nostro Trio Vocale Femminile per antonomasia; anzi ci spingiamo fino a immaginare che da qualche parte, in Sudamerica, Giuditta sia tuttora con noi e festeggi oggi le sue cento candeline: un traguardo che ai giorni nostri non è poi così raro, specialmente tra il gentil sesso. Virgilio Zanolla, il nostro biografo ufficiale delle tre mitiche Sorelle, si è lasciato prendere da questa rêverie e ha scritto di getto un’Intervista immaginaria a Giuditta Lescano, alla quale il Curatore del sito ha poi opportunamente aggiunto una galleria di immagini della festeggiata. Tale Intervista si propone – ben inteso sulle ali della fantasia, sorretta però costantemente da una serie di solidi indizi in nostro possesso e di ipotesi del tutto plausibili – di dare risposte soddisfacenti, ancorché provvisorie, ai tanti interrogativi che tuttora circondano le biografie delle Lescano, fermo restando che coltiviamo sempre la speranza che, prima o poi, nuove scoperte ci portino al definitivo accertamento della Verità. Per il momento siamo comunque lieti di celebrare il Centenario giudittiano ricordando innanzi tutto – come è doveroso – la bellissima clip [http://www.youtube.com/watch?v=LyQHfavT_AU] postata giusto due anni fa da Manuel Carrera, e offrendo oggi a tutti gli ammiratori della cara e indimenticabile Judik il suggestivo contributo di Virgilio. 3 Intervista Qualche settimana fa, da un nostro informatore che ha chiesto di mantenere il più rigoroso anonimato, ci era giunta dal Venezuela una notizia incredibile: Giuditta Lescano era ancora viva, e si apprestava a festeggiare il suo centenario. Stentavamo a crederci, ma la fonte era seria e le informazioni forniteci a supporto non lo erano di meno. Per risolvere questo mistero abbiamo subito deciso di recarci sul posto, dove, avuto conferma dell’attendibilità della notizia, dopo qualche tentativo andato a vuoto, con un po’ di fatica e una fortissima emozione siamo finalmente riusciti ad ottenere un abboccamento con l’ultima esponente ancora in vita del celebre Trio vocale, e l’abbiamo infine persuasa a concedere al nostro sito quest’intervista. Il patto, è di non rivelare a nessuno il suo domicilio, né alcun altro particolare che potesse concorrere a rintracciarla. Sicché, eccoci qui, ricevuti nel salotto della sua bella abitazione. Molto piccola, ma non proprio minuta, i bei capelli bianchi corti e raccolti e il volto dolce segnato da una lieve filigrana di rughe, la signora Giuditta siede davanti a noi, con un’espressione, ad un tempo, inquieta e un po’ curiosa. - E così, alla fine siete riusciti a trovarmi. Complimenti - ci dice, per rompere il ghiaccio. - Felicitazioni, signora Giuditta: lei si appresta a compiere un secolo. Avrebbe mai firmato per raggiungere questo traguardo, quando, molti anni fa, cominciò la sua carriera nel mondo dello spettacolo? - A esibirmi ho cominciato prestissimo, che ero ancora bambina: perciò, quei «molti anni» che lei dice sono davvero tanti, troppi; parliamo di un’epoca in cui le auto si azionavano ancora con la manovella, i piani superiori delle abitazioni non disponevano dell’acqua calda, e i servizi igienici, quando c’erano, erano degli spazi miserrimi, spesso situati nei terrazzi, senza tazza e col bagno alla turca. La gente non aveva neppure la radio, ci si coricava al più tardi alle dieci di sera e di mattina alle sei si era già in piedi. Per capire cosa intendo dire dovrebbe aver vissuto a L’Aja negli anni a cavaliere tra i Dieci e i Venti del Novecento: a volte, penso che ci sia più distanza tra allora ed oggi che tra l’epoca di Giulio Cesare e quella di Napoleone. La gente camminava, allora: e a piedi faceva fior di chilometri; in giro c’erano pochissime automobili e molti cavalli, per i percorsi più impegnativi ci si spostava col carro, o con gli omnibus. Comunque, per rispondere alla sua domanda: non so, davvero non so se avrei firmato. In quegli anni, ci si preoccupava al massimo dell’indomani, coi ragionamenti sul futuro non si andava molto più in là. - Quali ricordi ha della sua famiglia? - Poche immagini, ma ancora ben precise, nitide. Un’idea di grande calore, com’è giusto che abbia ciascuno nell’infanzia; ma anche di movimento, di continui sposta- 4 menti. I nostri genitori erano instancabili, con le tournées del circo cambiavamo continuamente città, e siamo stati più volte anche all’estero. Ma cambiavamo spesso abitazione pure stando a L’Aja; e in casa, ogni volta, c’era un grande andirivieni: il nonno David e Sientje, la sua seconda moglie, il prozio Levie, gli zii e le zie... Tutti parenti della mamma, e tutti molto affettuosi con le loro due nipoti. Molti di loro erano musicisti. - E i parenti di suo padre? - Erano tutti in Ungheria. Lui ne parlava, ogni tanto: specialmente dei genitori, e di un fratello; ma nessuna di noi ha mai avuto occasione di conoscerli. - Non eravate, però, le uniche figlie di vostro padre: c’erano anche le vostre due sorellastre Marie Françoise e Diane, nate dal suo primo matrimonio. Quali rapporti avevate con loro? - Scarsi, a dire il vero. Intanto, erano molto più grandi di noi: quando sono nata io, Marie Françoise aveva quindici anni e Diane dodici, e quando, verso i cinque anni, mio padre cominciò a insegnarmi qualche figura del contorsionismo e a farmi stabilmente frequentare il circo, erano tutt’e due signorine, e lavoravano entrambe nell’àmbito circense, soprattutto la primogenita, che si esibiva col nome d’arte di M.lle Françoise. Inutile negarlo: nonostante le reciproche, migliori intenzioni, tra loro e noi c’era un po’ di freddezza. Loro avevano qualche imbarazzo nei confronti di nostra madre, e lei lo aveva nei loro; Alessandra ed io eravamo troppo piccole per entrare in questo gioco di rapporti formali, ma d’istinto avvertivamo che qualcosa era nell’aria. - Questa situazione fin quando andò avanti? - Più o meno, fino al 1925, quando morì nostro fratello Alexander, e tra i nostri genitori i rapporti si fecero tesi. Fino ad allora nostra madre, sebbene fosse considerevolmente più alta di nostro padre e si mostrasse una donna di carattere, pendeva quasi dalle sue labbra; poi, nostro padre cominciò a bere e tra loro l’armonia si guastò. A un certo punto, decisero di separarsi: papà inizialmente andò ad abitare presso le nostre sorellastre, poi partì per la sua terra natale, l’Ungheria, dove non metteva piede da molto tempo. Alessandra, Caterinetta ed io restammo con la mamma, che tornò nella vecchia abitazione della nostra famiglia, in Ziecken 19, a L’Aja. - E da allora, vostro padre tornaste a vederlo? - Sì, naturalmente; in qualche occasione. Ma il più delle volte, in circostanze casuali. Il circo era tutta la sua vita, e noi dal circo ci eravamo allontanate, per sempre. Eppoi, lui e la mamma avevano cessato ogni rapporto: per vederlo, dunque, dovevamo farlo di nostra iniziativa. - Come vivevate, in quegli anni? 5 - Modestamente, ma bene. Lasciato il circo, ad Alessandra e a me mamma fece studiare danza presso la scuola di Louise Bouwmeester, che si trovava a pochi passi da casa nostra. Alessandra aveva già preso lezioni a Parigi (quando soggiornammo là per via di nostro padre, che lavorava al Circo Medrano), ed io, che ero stata istruita da papà al contorsionismo, mi specializzai nel genere acrobatico, dov’ero davvero brava. - Quando iniziaste ad esibirvi? - Quasi subito, in qualche saggio scolastico, eppoi pigliando parte alle coreografie della Bouwmeester per alcuni spettacoli. Fu in quelle circostanze che conoscemmo Simon Dekker-Dickson, un bravissimo coreografo, che aveva appena formato un gruppo di danzatrici con le quali intendeva intraprendere alcune tournées all’estero: il Ballet Dickson. Reclutò anche noi, e assunse la mamma come accompagnatrice per farci da ‘cane da guardia’; consideri che all’epoca - parliamo della fine del 1928 o dei primi del ’29, la memoria non mi sorregge - mia sorella Alessandra aveva diciott’anni ed io appena quindici. - E Caterinetta? - Lei ne contava dieci e studiava in collegio. Quando noi e la mamma partimmo per la tournée in Argentina col Ballet Dickson Caterinetta rimase presso la zia Catharina Matje, a cui era legatissima. La zia, quartogenita di nonno David e nonna Judic, aveva sette anni più della mamma ed era madrina di battesimo di nostra sorella, che infatti portava il suo nome. Era rimasta anch’ella molto legata al mondo dello spettacolo: si era sposata appena ventenne e aveva due figli; anni dopo, quando noi eravamo già in Italia e cantavamo alla radio, avrebbe ottenuto il divorzio e sposato in seconde nozze l’attore e cabarettista Hubertus Pierre Martron. Era una persona molto buona, molto pia e... molto sorda: io la ricordo così. - Cosa ricorda della trasferta in Sudamerica? - Oh, tante cose. Anzitutto la traversata, su quella nave (il Conte Verde) dove ogni mattina e pomeriggio ci esercitavamo sul ponte; non avevo mai visto tanto mare così, una distesa d’acqua che pareva infinita... A Buenos Aires, poi, fu tutto memorabile: la gente ci accolse con un certo interesse e ci applaudì molto, anche se non era abituata a vedere dei numeri come quelli che proponevamo noi, aveva una diversa cultura. Per me fu molto emozionante, anche perché Simon aveva impostato molti numeri di danza sul contorsionismo e le acrobazie, apposta per sfruttare le mie caratteristiche: quindi io, la più giovane del gruppo, ero anche la principale attrazione dello spettacolo, e di ciò andavo ovviamente fiera. - È durante la traversata che conosceste il vostro futuro impresario, Enrico Portino? 6 - Vedo che siete bene informati. Beh, sì, lo conoscemmo durante il viaggio che ci portò a Buenos Aires. - Che tipo era? - Molto compìto, cordiale, ma anche riservato: parlava molto di teatro e spettacoli, per il resto era di poche parole. Volle sapere di noi e delle nostre rappresentazioni, parlò con Simon e con mia madre, mostrando interesse, ma a quanto ne so non avanzò alcuna proposta d’ingaggio. Non credo fosse già impresario, certo stava meditando qualcosa. Venne anche a vederci a teatro, quando ci esibimmo al Regio, in avenida Córdoba, e a salutarci nei camerini. Aveva fatto colpo su nostra madre: era impressionata dalla sua sicurezza. E lei, a lui era piaciuta subito. - Dunque è vero che tra loro ci fu una storia? - Dovessi negarlo, riuscirei a convincerla? Eppoi, sono passati così tanti anni... Ormai, si può dire senza problemi come andarono le cose. Ci fu, ci fu, e noi ci accorgemmo subito del loro interesse reciproco. Tuttavia, Enrico aveva affari da sbrigare lì a Buenos Aires, e noi la nostra tournées: perciò, dopo quella sera ci perdemmo di vista, fino al nostro ritorno in Europa, che se ben ricordo avvenne molto dopo il suo. Poi, lui venne in Olanda per rivedere la mamma, sempre in luoghi dove si esibiva il Ballet Dickson; e in quell’occasione sentii parlare per la prima volta del loro progetto di formare una compagnia autonoma. Progetto che venne perfezionato in Spagna, tra Madrid e Barcellona, nel primo semestre del 1930, con l’acquisizione di cinque danzatrici nostre colleghe ed amiche, che come noi lasciarono il Ballet Dickson: nascevano le Sunday Girls, che poco dopo, in agosto, avrebbero debuttato al Lido di Madrid. - Di questa formazione, la stella era sempre lei. - Eggià. Eseguivo dei numeri di contorsionismo che lasciavano molti spettatori a bocca aperta. Quando i giornali menzionavano le Sunday Girls, il mio nome era sempre il più citato; a volte, trovava posto anche in cartellone, e negli opuscoli sulle Sunday Girls che Enrico fece stampare facevo la parte del leone. Per lui, ero un ‘piccolo fenomeno’. In Spagna mi chiamavano «Miss Judith, la danzatrice di gomma», per sottolineare quant’ero agile e snodata. - Come mai a un certo punto le Sunday Girls divennero Sunday Sisters? - Accadde alla fine del ’33, ma dopo più di un anno di transizione. Il fatto è che Enrico, puntando tutto su di me e Alessandra, aveva messo in atto questa strategia: chi si allontanava non veniva sostituita. Sicché, prima - già nel ’32 - se ne andò Riemke van der Voort, la migliore amica di Alessandra, con cui ella lavorava in coppia: Riemke doveva tornare dai suoi in Olanda, e ci lasciò piuttosto a malincuore. Poi fu il turno di altre: chi per lo stesso motivo, chi per malattia o qualche altra indisposizione, chi perché non era soddisfatta della paga... Nel novembre del ’33, quando ci esibimmo al 7 Music Hall Cabaret Hollywood di Atene, eravamo diventati il Trio Sunday Girls: così Enrico decise di licenziare anche l’ultima nostra collega rimasta e fondò le Sunday Sisters. - Un duo col quale giraste l’Europa e foste anche in Egitto, Siria e Libano. Ma non in Italia; anche le Sunday Sisters non furono mai nel nostro paese: eppure il loro impresario era italiano, e redasse l’opuscolo promozionale anche nella nostra lingua. - Il motivo è che, a differenza di quanto avveniva in tutte le altre nazioni dove andammo ad esibirci, allora in Italia chi t’invitava non era disposto a pagarti le spese di viaggio; non si trattava, dunque, di una differenza da poco. Quanto alla lingua italiana, presente accanto allo spagnolo, al francese e all’inglese nell’opuscolo promozionale delle Sunday Girls, si deve proprio al vecchio sogno di Enrico, quello di riuscire a portarci in Italia in tournée: lui contava, prima o poi, di riuscire a superare quell’impasse, grazie ad amici che aveva presso il governo italiano: ma fu tutto inutile. - Allora come mai nel 1935 veniste in Italia, e decideste di fermarvi a Torino? - Perché Enrico era torinese, e desiderava prendersi un po’ di riposo per riordinare le idee circa la prosecuzione della nostra attività artistica, e noi con lui. Per questo, una volta conclusa la tournée in Polonia lasciammo Varsavia e ci trasferimmo in riva al Po, in un appartamento in via Lanfranchi 24. In questo modo, potevamo programmare delle esibizioni mirate in Italia, contenendo le spese; ma la nostra idea, quella di tutti, era di mutare in buona parte il repertorio. Perché, per questioni d’impatto coreografico, le esibizioni di danza acrobatica hanno più senso quando sono effettuate da un gruppo, come con le Sunday Girls; inoltre, non si può continuare con gli stessi numeri per tutta la vita, e studiarne di nuovi diventava difficile: tenga presente che anche se Alessandra era molto sciolta e aggraziata e sapeva fare la spaccata, la contorsionista ero io; per creare nuovi numeri avrei avuto bisogno d’avere accanto un bravo allenatore come mio padre, ma papà era in Olanda e pensare a lui per questo era per più di un motivo improponibile. - È per tale motivo che pensaste di mettervi a cantare? - In realtà, di canto Alessandra ed io non eravamo proprio del tutto inesperte. Non tanto per i trascorsi musicali della nostra famiglia del ramo materno, e perché, da giovane, in qualche esibizione anche al circo, la mamma aveva cantato motivi di operette in coppia con una nostra zia, ma in quanto, nel repertorio delle Sunday Girls, era inclusa anche l’esecuzione vocale di alcuni brani musicali, da effettuare coralmente: aspetto che il pubblico di ogni nazione in cui ci esibimmo mostrò di gradire. Da qui l’idea, negli spettacoli da tenere in Italia, di assegnare uno spazio alla componente vocale altrettanto importante di quello coreografico. - Chi vi consigliò su questo? 8 - Nessuno, soltanto il buon senso. Fu una decisione che pigliammo tutti e quattro, perché ci parve la migliore. Così, cominciammo a guardarci attorno, per cercare qualcuno che potesse aiutarci a riunire un piccolo repertorio di motivi ad hoc. Il fatto era, però, che allora non conoscevamo ancora l’italiano. Per fortuna, molto presto conoscemmo Carlo, il maestro Carlo Alberto Prato, colui che divenne il nostro insegnante di canto, d’italiano, di tante cose... Qualcuno scrisse che fu il nostro Pigmalione, ed è vero: perché fu proprio lui a far nascere il Trio Lescano. - Come andarono le cose? - Lo conoscemmo un giorno nel negozio di strumenti musicali Chiappo, in piazza Vittorio Veneto angolo via Bonafous. Lui ci chiese di cantare qualcosa, e al termine non fu molto soddisfatto della prova; però capimmo subito che aveva dell’interesse per noi, come uno scultore ce l’ha per la creta con cui modella i bozzetti delle sue statue. Era affascinato dal fatto che fossimo olandesi e non ci esprimessimo bene nella vostra lingua, e dalla nostra giovane età. Ci fece un sacco di domande, e altrettante ne rivolse alla mamma. Quando seppe che avevamo una sorella più giovane che stava in Olanda, le disse di portarla in Italia, perché con lei avremmo potuto costituire un trio vocale. Allora i trii vocali femminili andavano di moda in America, grazie alle Boswell Sisters, ma in Italia nessuno li aveva ancora proposti, e a Carlo baluginò subito l’idea di costituirne uno con noi. - Così, vostra madre andò in Olanda a prendere Caterinetta... - Infatti. E Carlo fu molto soddisfatto del ‘nuovo acquisto’: perché Caterinetta aveva la voce più alta, da soprano leggero, Alessandra l’aveva da mezzosoprano e la mia è da contralto: quindi, si integravano alla perfezione; occorreva solo educarle. A quel solo dovrei mettere un paio di virgolette, perché non si trattò di un compito facile: Alessandra, Caterinetta ed io dovevamo, ad un tempo, imparare l’italiano ed imparare a cantare! Però ci mettemmo subito all’opera con tanta buona volontà. Carlo era un insegnante puntuale ed esigente, ma allo stesso tempo divertente e affascinante: quando parlava, partiva da un concetto e poi andava a parare chissà dove, ma a un certo punto era abilissimo a fare dietrofront e tornare all’argomento iniziale; in questo modo, ci forniva un sacco di spunti e suggestioni, senza mai confonderci. Eppoi, sul lavoro era - come dicono a Trieste? - una specie di mulo: si cominciava alla mattina presto, si faceva la pausa pranzo, si riprendeva al pomeriggio e si finiva quando si finiva, ossìa quando capiva che avevamo tutte afferrato bene i temi della lezione in oggetto. - Cosa vi diceva circa gli obiettivi? - Intendeva presentarci all’Eiar per un’audizione, ma intanto non c’impediva di esibirci dove ci chiamavano, ed era riuscito a costruirci un piccolo repertorio di motivi italiani, che sapevamo eseguire con successo. Anche Caterinetta, che non aveva mai calcato un palcoscenico in vita sua, dopo l’emozione dell’esordio andava pigliandoci gusto, e il pubblico ci seguiva con crescente entusiasmo. 9 - Ci racconti del provino all’Eiar. - Noi ce la mettemmo tutta, e a dire il vero non ce la cavammo poi male. Ma i dirigenti dissero che la nostra dizione non era perfetta e su questo s’impuntarono. Certo che non era perfetta: eravamo olandesi, e in Italia soltanto da pochi mesi! Carlo, inoltre, non aveva voluto ‘italianizzarci’ troppo, perché a lui il nostro accento esotico piaceva, diceva che era un motivo di fascino. Però quelli fecero orecchie da mercanti: forse, vollero essere prudenti anche per motivi politici: in quel periodo, alcuni critici musicali molto allineati col regime fascista, con la scusa di protestare contro le «inique sanzioni» che la Società delle Nazioni aveva comminato all’Italia per l’aggressione all’Etiopia, stavano montando una campagna contro i motivi stranieri, soprattutto angloamericani, e contro l’esterofilia di certe canzoni e di certi interpreti che si discostavano dalla tradizione del canto all’italiana. Ma Carlo, che all’Eiar era uno dei maestri responsabili, non si dette per vinto, e con l’aiuto di qualche collaboratore di larghe vedute, come Riccardo Morbelli, continuò a ‘battere il chiodo’ vantando la nostra bravura nel cantare. - Finché? - Finché nel febbraio del ’36 la casa discografica Cetra, allertata dai successi che avevamo riscosso in giro per il nord Italia esibendoci in piazze come Trieste, Stresa, Cortina e Sanremo, dove cantammo al Casinò Municipale, ci propose d’incidere il nostro primo disco, sotto l’etichetta Parlophon, di cui all’epoca era distributrice sul mercato italiano. A quel punto, finalmente l’Eiar ci richiamò, ed esordimmo in radio in una trasmissione di brani musicali eseguiti sotto la direzione del maestro Tito Petralia. Così, quasi da un giorno all’altro, raggiungemmo successo e popolarità. - E da Leschan diventaste Lescano. - In realtà, avevamo iniziato a chiamarci Lescano prima ancora d’incidere il nostro primo brano, Guarany Guaranà, dove figuriamo per la prima volta come «Trio Vocale Sorelle Lescano»: ce l’aveva suggerito Carlo alla vigilia del provino all’Eiar, perché diceva di «conoscere bene i suoi polli». E come sempre, aveva ragione. - In cosa vi deste conto della misura del vostro successo? - Da come presero a trattarci i dirigenti dell’Eiar, e la stessa casa discografica. A Radio Torino iniziarono a giungere fiumi di lettere che ci riguardavano: persone che volevano parlare con noi, sapere di noi, si complimentavano per le nostre canzoni e chiedevano ai dirigenti di farci eseguire questo o quel motivo... E alla Cetra? Sa che in poco tempo giungemmo a vendere la cifra record di trecentocinquantamila dischi, in un periodo in cui i nostri colleghi più affermati non superavano i cinquantamila? Si tratta di un numero rispettabile ancora oggi, a dispetto della televisione e di Internet... si figuri allora, settantasette anni fa! 10 - Il successo e la popolarità che cosa vi portarono? - Vorrei dire denaro e privilegi, e certo, in parte fu senz’altro così. Ma in quell’epoca eravamo così prese dal nostro lavoro che faticavamo a rendercene conto. Si viveva molto alla giornata, anche perché successo e popolarità moltiplicano gli impegni: e se prima, noi ci limitavamo a qualche esibizione pubblica, a cantare alla radio e ad incidere dischi, ora tutto questo lo facevamo con ritmi molto più intensi, inoltre pigliammo a lavorare nel teatro di rivista, negli spettacoli di varietà, e in un paio d’occasioni, perfino al cinema. Insomma, riposavamo solo per un breve periodo in estate, concedendoci qualche settimana al mare. Eppoi, i cordoni della borsa li tenevano sempre Enrico e la mamma: noi, nostra madre l’avevamo soprannominata ‘la carabiniera’, perché nonostante Alessandra ed io fossimo ormai maggiorenni continuava a comandarci a bacchetta, e, devo aggiungere, ci andava bene così. L’unico lusso che ci concedemmo fu un’automobile: una Balilla color grigio topo, con tanto di autista per i nostri spostamenti di lavoro; anche se, nel tempo libero, si divertiva a condurla Alessandra, che aveva conseguito la patente di guida. - Nel dicembre del ’36, improvvisamente, morì Portino. - E noi dovemmo abituarci a camminare finalmente con le nostre gambe: ma ciò non ci dispiacque. Da allora, e per un bel pezzo, non avemmo più manager: fu soprattutto la mamma ad occuparsi di amministrare le nostre entrate. In certo modo, la data della morte di Enrico ha un significato simbolico: perché egli uscì di scena proprio nel momento in cui avevamo raggiunto una situazione economica soddisfacente. La prima cosa che facemmo, difatti, fu il cambio d’abitazione: lasciammo lo stabile di via Lanfranchi, troppo gravido di ricordi, e andammo ad abitare in un bell’appartamento in piazza Vittorio Veneto 23, proprio di fronte al negozio d’articoli musicali Chiappo, che si trovava dall’altra parte della piazza. La stagione d’oro della nostra carriera vocale cominciava in quel momento. - Non solo per quanto riguarda la musica. Vogliamo parlare un po’ della vostra vita privata? - Ma quale vita privata? Se le ho appena detto come tra l’incidere dischi, il cantare alla radio, il partecipare a serate di esibizioni degli artisti Eiar e il prendere parte a spettacoli di rivista a volte ci restava appena il tempo per mangiare e dormire! Guardi, da quando il Trio ha smesso di cantare, su di noi ne sono state dette di cotte e di crude, ma è bene precisare subito una cosa: nessuno potrà mai accusarci di essere state delle scansafatiche: noi il nostro pane quotidiano ce lo guadagnavamo col lavoro costante e indefesso, altro che storie! - Non era certo mia intenzione metterlo in dubbio. Tuttavia, ci risulta che tutte e tre abbiate avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. Vogliamo parlarne un po’? È 11 trascorso tanto di quel tempo... Ormai credo che quanto potrà dirci non lederà la privacy di nessuno. - Non so... Cosa vuol sapere? - La prego, non la metta così. Se è possibile, vorrei fosse lei a parlarci liberamente di questo, senza bisogno di suggerimenti. - Capirà che, anche a distanza di tanto tempo, e anche se si parla di persone che non sono più al mondo, per me non è facile. Su certe cose, noi siamo sempre state piuttosto riservate: è la mamma che ci ha educate così. - Sì, certo. Ma nel frattempo, sono saltate fuori tante cose... Non pensa sia giunto finalmente il momento di aprirsi su questo? Guardi, ho in serbo ben altre domande imbarazzanti da rivolgerle. Sono i suoi cent’anni che mi autorizzano. - Già, dimenticavo che nel frattempo il mondo è cambiato. - Allora, le fornirò uno spunto. Non è suppergiù verso il ’38 che lei, come scrisse con scherzoso garbo un giornale, si fidanzò «con un sassofono»? - Sì, fu verso la fine del ’38. Ma conoscevo Marcello [Cianfanelli] già da tempo: in pratica, da quando iniziammo a cantare nei concerti Cora, con l’orchestra del maestro Semprini: soltanto, per molto tempo non avevamo avuto l’occasione di parlarci. Un giorno, quest’occasione capitò, durante le prove: Marcello aveva un anno meno di me, era piuttosto piccolo di statura, un po’ come me, e, come me, era un tipo che parlava poco, finché non conosceva l’interlocutore. Lo trovai subito molto simpatico e ricco di umorismo, così la nostra confidenza crebbe. Quasi subito, lui mi chiese un appuntamento, e una domenica pomeriggio ci vedemmo da soli: mi portò al cinema, a vedere Ai vostri ordini, signora, una commedia con la Merlini e De Sica, poi andammo a spasso per Torino, e nel parco del Valentino mi offrì un gelato; alla fine, prima di salutarci, mi baciò. La nostra storia cominciò così. - Sua madre e le sue sorelle, quando seppero, cosa dissero? - Le mie sorelle seppero fin dall’inizio, dato che Marcello lo conoscevano anch’esse; a loro tornava simpatico. La mamma lo seppe appena un po’ dopo. Sulle prime ebbe da ridire, poi lo conobbe e si conformò. Anche lei lo trovava simpatico, ma essendo lui un musicista e lei figlia di musicisti, conosceva il genere di vita che essi conducono e non ne era precisamente entusiasta. In ogni modo, la storia con Marcello era la prima importante della mia vita, e fu anche la prima a diventare ‘ufficiale’, perché in pratica ci fidanzammo. - Fu lei la prima delle sorelle a fidanzarsi? 12 - Sì. Anche se in quei mesi, Alessandra frequentava un ragazzo figlio di un uomo molto facoltoso, e anche lei, più o meno, si fidanzò. Ma il loro rapporto non durò molto: perché lui era troppo geloso, e non sopportava di vedere mia sorella circondata da tanti ammiratori, benché ella non gli dette mai motivo di dubitare della sua fedeltà. Avrebbe voluto che fosse sempre a sua disposizione, che non s’allontanasse mai da Torino... Così il loro rapporto cominciò a scricchiolare, e ai primi di settembre del ’39, quando partimmo per la tournée di Viva la radio!, lui non riuscì a tollerarlo e la loro storia finì. - E Caterinetta? - Oh! Lei all’epoca non aveva ancora vent’anni, e si divertiva a far bruciare i cuori degli uomini... Aveva molti spasimanti, ma nessuna storia seria. - Perché finì la sua storia con «il sassofono»? - Perché... Perché, dopo tanti tira e molla tra di noi, lui a un certo punto conobbe un’altra persona... Con la quale anni dopo si sposò. - E lei? - Ci rimasi malissimo. Sognavo di sposarmi, di farmi una famiglia, e invece... - Intanto, il Trio continuava a mietere successi. - Vero. E agli inizi del ’39 cambiammo di nuovo domicilio, trasferendoci in via degli Artisti 26, al terzo piano di una bella palazzina appena finita di costruire; ci si trasferì quasi contemporaneamente anche Carlo, il maestro Prato, assieme alla moglie, la signora Giuseppina. Abitavamo nello stesso pianerottolo, a tre metri di distanza. - Cresceva la vostra popolarità, ma crescevano anche le vostre preoccupazioni, immagino. Perché nell’ottobre 1938 anche in Italia erano state emanate le leggi razziali. - Allude a nostra madre, vero? Guardi, per cautelarla e cautelarci noi avviammo subito le pratiche per conseguire la cittadinanza italiana, e infatti alla fine del ’39 il Ministero degli Interni riconobbe che le mie sorelle ed io dovevamo essere considerate «a tutti gli effetti di legge non appartenenti alla razza ebraica»: quello era il primo passo per l’ottenimento della cittadinanza, che chiedemmo di poter estendere anche a lei. Ma la pratica ebbe uno svolgimento lentissimo: basti dire che divenimmo cittadine italiane soltanto il 30 marzo del ’42; noi, non nostra madre. - ...E nel frattempo, era scoppiata la guerra. 13 - Proprio mentre noi raggiungevamo i vertici del successo. Ormai eravamo seguitissime e richiestissime, ma pochi sapevano del timore che ci portavamo dietro per la sorte della mamma. - La polizia politica, l’Ovra, fin dal vostro ingresso in Italia sapeva sicuramente dell’appartenenza di sua madre alla religione ebraica, ma nessuno la sfiorò. Avevate dei santi in paradiso? - Forse. Il primo santo si chiamava Enrico Portino, che a Roma contava tanti ex colleghi di partito; ma come sa, quel santo morì presto. Per fortuna, a Torino avevamo fatto in tempo a conoscere qualche suo amico, che protesse la nostra tranquillità. Almeno, finché gli fu possibile. - Ovvero, fino a quando? - Fino all’8 settembre ’43. Perché con la caduta del fascismo, i nuovi padroni della piazza, a Torino come in tutto il centro e nord d’Italia, divennero i nazisti, affiancati subito dopo dai loro colleghi repubblichini; gente che non guardava in faccia a nessuno. Fino ad allora, i nostri amici funzionari ci avevano favorito: per esempio ‘dimenticandosi’ della mamma quando, il 1° ottobre del ’42, gli ebrei torinesi ricevettero una lettera in cui li si destinava al lavoro coatto, e il 18 maggio ’43, quando gli stessi di età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni ebbero l’obbligo di denunciare le proprie generalità per essere nuovamente precettati al lavoro: nostra madre contava quarantanove anni, quindi sarebbe dovuta rientrare tra essi. Ma dopo l’8 settembre, da un giorno all’altro i nostri ‘angeli custodi’ sparirono, sostituiti da personale nazista, poi col concorso di quello repubblichino. E la vita, per lei e di conseguenza anche per noi, cominciò a farsi durissima. - Fu allora che decideste di sospendere la vostra attività artistica? - Fu allora. D’altra parte, essa si era ormai ridotta soltanto agli spettacoli di rivista. Perché da quando, l’8 dicembre del ’42, venne bombardata la sede torinese dell’Eiar, a Torino non fu più possibile effettuare registrazioni né incidere dischi. Eppoi, erano davvero tempi difficili. - Correva perfino voce che a Genova vi avessero arrestate e chiuse in carcere... - Non faccia dell’ironia: so bene che siete al corrente di come in effetti andarono le cose. Beh, provi un po’ a mettersi nei nostri panni, a guerra finita, dopo aver commesso l’imprudenza di chiedere l’iscrizione al Partito Fascista! E sa, almeno, il motivo per cui la chiedemmo? Per mostrarci riconoscenti con Mussolini riguardo all’ottenimento della cittadinanza italiana, ed anche per tentare di regolarizzare la posizione di nostra madre; qualcuno ci consigliò in tal senso. Ma quando la guerra finì, per riprendere decorosamente la nostra carriera artistica ci parve indispensabile riacquista- 14 re credito, così per cancellare quella ‘macchia’ci inventammo la storia dell’arresto e della detenzione. - Chi fu ad avere l’idea? - Proprio io. Ero rimasta piuttosto impressionata quando, quel pomeriggio del novembre ’42, a Genova, alcuni funzionari di polizia ci convocarono in commissariato per chiederci notizie sui testi delle canzoni che portavamo in scena. Non so se pensassero davvero che noi potessimo esercitare una forma di spionaggio, come poi qualcuno sostenne, o se volevano solo accertare se i testi fossero diversi rispetto alle versioni ufficiali, e venissero cioè attualizzati con allusioni satiriche sull’andamento della guerra, come in effetti avveniva spesso. In ogni modo, non si scoprirono molto, ma quando ci chiesero le generalità nostre e dei nostri genitori, mi vennero i brividi. Quindi, io ebbi quell’idea, però a perfezionare la storia nei dettagli fu Alessandra, e di questo parlò sempre lei, così evitammo di confonderci. - Ci racconti come e quando decideste di lasciare Torino. - Subito dopo l’8 settembre, quando un nostro amico che lavorava in pretura c’informò sulle nuove disposizioni che stavano per essere emanate riguardo agli ebrei. Con la maggior discrezione, ma anche con la maggior fretta possibile, una sera, con la mamma, lasciammo Torino rifugiandoci a Valperga Canavese, in casa di una coppia di conoscenti sulla quale potevamo contare. - Ma, almeno per voi tre, non si trattò di una vera fuga. - No. In quel momento, il nostro intento era stato soltanto quello di mettere al sicuro la mamma, dicendo che era tornata in Olanda; tant’è vero che, per non destare sospetti, ripigliammo il lavoro in teatro, in tournée con uno spettacolo di rivista. Ma presto decidemmo di sparire anche noi. E raggiungemmo nostra madre, per la quale nel frattempo avevamo trovato un rifugio più sicuro a Saint-Vincent, in una pensione piuttosto fuori mano, dove restammo nascoste fino al termine della guerra. - Certo che quel lungo periodo per sua madre dové riuscire particolarmente duro: tra l’altro, mentre lei si trovava lì, in Olanda buona parte dei suoi parenti venne eliminata dai nazisti. - Sì, la famiglia De Leeuwe venne quasi sterminata. Nostro zio Aaron e la moglie Marianne, con ogni probabilità si suicidarono per non cadere in mani naziste, mentre nostra zia Paulina e suo figlio Benjamin morirono ad Auschwitz, e così tanti altri familiari... - E vostro padre? - Nostro padre? 15 - Sì: Alexander Leschan, vostro padre. Morì a L’Aja il 5 febbraio del ’45, non si sa esattamente come, ma si sa che se la passava decisamente male. A quanto pare, voi l’avevate rimosso dalla vostra memoria. - Ma non è assolutamente vero. - E allora mi spieghi perché, in un’intervista del 1938 su “Film”, sua sorella Alessandra disse che «il Papà era ungherese e la mamma è olandese»: l’aveva fatto morire quasi sette anni prima del suo termine naturale... - Ma questo... avrebbe dovuto chiederlo ad Alessandra, ammesso e non concesso che non si sia trattato di un errore di stampa. - Sarà. Ma l’impressione è che di vostro padre vi vergognaste. Forse perché nel circo aveva intrapreso con successo anche la carriera di clown?... Ogni volta che parlava di lui, sua sorella Alessandra lo presentava sempre soltanto come acrobata. Del resto, finì poi per ammetterlo lei stessa, in una delle sue ultime interviste, quando disse: “Negli anni del nostro successo in Italia [...] si evitava con cura di ricordare nostro padre e l’attività circense”. - Beh, questo è vero, sì; ma non mi chieda il perché. C’era, che quella separazione così brusca da nostra madre... Era stata lei stessa a suggerirci di parlare di lui il meno possibile... Comunque, non posso negare che di lui ci si vergognasse tutte un poco. - Quando fu l’ultima volta che lo vedeste? - Io... non mi ricordo precisamente, ma... suppongo fu verso il 1933 o ’34, cioè nell’ultima occasione in cui andammo in Olanda, tra una e l’altra tournée delle Sunday Sisters. - Con lui non vi scrivevate? - No. E del resto, noi giravamo il mondo in tournées, lui i Paesi Bassi col circo: anche volendolo, come ci si sarebbe potuto scrivere? Senta, cambiamo argomento, su questo non desidero più tornare. - Come vuole. Torniamo agli ultimi anni di guerra. Ci risulta che lei conobbe qualcuno: qualcuno che le fu molto caro. - Oh, ma lei mi vuol male! Dio, che storia triste... [Dopo una lunga pausa] E va bene: nel ’44, durante il periodo in cui eravamo rifugiati a Saint-Vincent, conobbi un ragazzo americano molto attraente, Ray. Si trattava di un ufficiale in abiti civili, paracadutato in una valle di quelle montagne per tessere i collegamenti con le formazioni partigiane che s’andavano raggruppando tra il confine svizzero e Torino. Veniva da 16 noi ogni tanto, e non mancava mai di portarci del cibo ed altre piccole cose per noi allora molto preziose; tra l’altro, fu lui a trarci d’impaccio quel giorno in cui, uscite con la massima discrezione per compiere una passeggiata all’aria aperta, venimmo arrestate da una formazione partigiana. Era gentile e coraggioso. Beh, c’innamorammo. La nostra storia durò otto o nove mesi; perché un giorno del marzo del ’45, quando la sorte della guerra era ormai decisa a favore degli alleati e i tedeschi tentavano le ultime disperate difese delle città del nord, Ray mise inavvertitamente un piede su una mina che lo straziò orribilmente. Riuscì a salvare la vita ma dovettero amputargli tutti gli arti, inoltre perse la vista da un occhio. Non le dico, quando lo seppi, come ci rimasi. La sorte si era accanita contro di lui, ma anche, e per la seconda volta, contro di me. - Lo rivide? - No. Me ne mancò il coraggio; del resto, lui si rifiutò categoricamente. Avevo il cuore straziato, e rimase tale per molto, moltissimo tempo. Pensi che, molti anni dopo, qualcuno decise di fare un film su un caso analogo, forse ispirato al suo; quando, del tutto inaspettatamente, mi capitò di vederne una scena in televisione, mi sentii svenire e stetti male due giorni. Povero Ray... - Cosa fece per cercare di dimenticarlo? - Moltissime sciocchezze. - Come quella di mettersi a bere? - Sì. Ma provi per un attimo a mettersi nei miei panni: la guerra era finita, tutti festeggiavano, mentre io avevo la morte dentro. Così mi attaccai a quello; non lo feci con determinazione: successe così, un po’ per caso. Mi resi conto che bevendo riuscivo per qualche tempo a dimenticare i miei guai: nel farlo cercavo di contenermi, ma era tutt’altro che facile. - E le sue sorelle? Non hanno cercato di aiutarla? - Ma certo. Alessandra si vergognava un po’ di me, ma mi compativano. Io però ero insofferente, anche indisponente, a volte. Finché una sera non m’ubriacai di brutto e, rincasando, sul pianerottolo all’ingresso del palazzo dove nel frattempo eravamo andate ad abitare, una pensione per artisti in via Battisti 3, caddi dalle scale. Ero talmente sbronza e dolorante che non ce la facevo neppure a rialzarmi, e non avevo un filo di voce per mettermi a gridare, inoltre mi vergognavo. Restai lì per terra per più di un’ora, finché un baritono che tornava a quell’ora non mi vide, e chiamò un’ambulanza, che mi portò all’ospedale, dove mi medicarono. Intervenne anche la polizia e qualcuno sospettò che m’avessero aggredita, perché ero piena di lividi, ma la verità è quella che le ho appena raccontato. 17 - In quel periodo non ha frequentato nessun uomo? nessuna persona ‘sbagliata’? - Se l’ho fatto, non lo vengo mica a dire a lei. Quello, era un momento tutto particolare: la gente aveva voglia di felicità, dopo tanto penare. E io non ero certo diversa dagli altri, anzi. Mi sentivo disperatamente sola e disillusa. - È per questo motivo che riprese a frequentare il «sassofono»? - Accidenti, ma lei queste cose da chi le ha sapute?! Non certo dal diretto interessato. - No, infatti. Si dice il peccato ma non il peccatore. Nel frattempo, però, il suo ex fidanzato aveva preso moglie... - E dunque, ero anche un’adultera, una fedifraga... Cosa vuole che le dica? Non sono stata io a cercare lui, né è stato lui a cercare me: è successo semplicemente che ci siamo ritrovati assieme ad uno spettacolo, io a cantare e lui a suonare, come ai tempi dei concerti Cora. È vero, era sposato; ma se non ha esitato a tradire la moglie, con cui era sposato da appena un paio d’anni, non è stata certo colpa mia. - In quel periodo, incontraste a Livorno le Andrews Sisters, e forse le sentiste anche cantare. Che impressione vi fecero? - Noi sentimmo cantare loro, e loro noi. Erano le classiche ragazzone americane, alte, allegre, vitaminizzate; simpatiche, e brave. Sapevano che avevamo avuto successo con Tulipan, la versione italiana del loro Tulip Time, e ci fecero molti complimenti. Se devo essere proprio sincera, a sentirle cantare non ci fecero poi quella grande impressione: secondo me, non avevano un repertorio molto variato, e difettavano un po’ di swing. Ma il pubblico che le ascoltava, composto dai soldati statunitensi di stanza a Livorno, andava in sollucchero; come del resto ascoltando noi. - Poco dopo, scoppiò il caso Caterinetta. Perché lei manifestò l’intenzione di lasciare il Trio. - Guardi, le cose non andarono proprio così. Caterinetta non era stufa di cantare, e forse neppure di cantare nel Trio: ma non aveva più molta voglia di fare tournées, essendosi fidanzata da poco. Inoltre non andava per niente d’accordo col nostro nuovo impresario, Nino Gallizio, che era il compagno di Alessandra: sosteneva che dietro i suoi modi galanti e signorili era un grande imbroglione, e purtroppo aveva tragicamente ragione. Ma tu, allora, vallo a far capire ad Alessandra! D’altra parte, all’epoca anch’io mi fidavo di lui. - È proprio sicura che fu quello l’unico motivo? Non c’entrava mica anche del rancore di Caterinetta verso di lei e verso vostra madre? - Rancore? e a proposito di che cosa? 18 - Del fatto che entrambe voi brigaste perché Caterinetta accettasse la corte di un certo signore, un tipo molto più grande di lei, quasi anziano, e molto facoltoso. - Ma questa è una cattiveria gratuita! - No, purtroppo è solo la verità, nuda e cruda. - Ah sì? Ma se Caterinetta finì per accettarla, la corte di quel signore!... - Non, però, come sarebbe piaciuto a voi... Tant’è vero che la storia non ebbe l’esito sperato. - Ebbene, quand’anche fosse? Volevamo soltanto il suo bene. - Diciamo meglio: il vostro. [Con un gesto d’insofferenza] Uff! In quell’epoca, a guerra appena finita, non avevamo soldi da spendere, e perdipiù eravamo gravate da un pesantissimo debito contratto a causa del lungo periodo di totale inattività; due anni prima, lasciando in fretta Torino non avevamo risolto il contratto d’affitto dell’appartamento in via degli Artisti, e il proprietario pretendeva tutti gli arretrati, ma noi stentavamo a riprendere il lavoro... Cos’altro avremmo dovuto fare? - Sicché litigaste con ella. - E di brutto. Ci si mise anche la mamma, che minacciò di fare causa a Giulio, il fidanzato di Caterinetta, perché il comportamento di lei rischiava di mandare a monte la firma di un importante contratto; ma Caterinetta tenne duro, e finimmo per trovare un accordo. A noi, però, toccò sostituirla. - Per fortuna, trovaste quasi subito Maria Bria. - Già. Aveva un timbro di voce diverso da quello di Caterinetta, leggermente più alto e squillante, e forse meno sorvegliato in certi passaggi; ma andava benissimo. Per fondere meglio i timbri, operammo qualche modifica abbassando certe tonalità: Alessandra subentrò a nostra sorella nel registro più acuto, Maria prese il posto di Alessandra e io conservai il mio. A Maria, che era meno alta di Caterinetta, dovemmo fare adattare tutti i suoi abiti da spettacolo; era una persona rispettosa e tranquilla: un’ingenua, finché durò. - Con lei giraste l’Italia cantando, e in qualche occasione foste anche all’estero. - Sì. Per esempio, a Vienna. 19 - Eppoi, partiste per l’Argentina. - Già; insieme al maestro Mildiego, il nostro arrangiatore, e a qualche membro della sua orchestra. Non dimenticherò mai quel viaggio, per la paura che mi assalì quando, già sorvolando il Brasile, uno dei motori dell’aereo prese fuoco... A bordo, ci furono scene di panico, io stessa persi la calma. Per fortuna, il pilota riuscì a compiere un atterraggio di fortuna a Vitória, dove cambiammo apparecchio; questo è uno dei motivi per cui io, da allora, ho preso l’aereo il meno possibile. - E una volta a Buenos Aires? - La capitale argentina era piuttosto cambiata da diciott’anni prima, quando ci giunsi la prima volta con Alessandra, la mamma e il Ballet Dickson; non tanto nell’aspetto urbano, quanto nelle persone. La gente mi pareva diversa, più curiosa degli altri e delle novità; erano i primi anni del governo Perón, lui e la moglie Eva Duarte godevano di un grande consenso popolare. Trovammo là tanti italiani, tra cui alcuni nostri cari e reputati colleghi: Rabagliati, Carboni e Bonino. Il nostro esordio a Radio El Mundo fu un successo, diventammo molto richieste. Così, dopo qualche mese facemmo una tournée per il paese, che sollevò un certo entusiasmo. - È vero che con i compensi percepiti in pochi mesi riusciste a saldare ogni debito contratto in Italia nei mesi di guerra? - È vero. Anzi, sa cosa le dico? Col senno di poi, quei debiti avremmo forse anche potuto finire di pagarli prima. Ho il sospetto che quel mascalzone di Gallizio abbia cominciato a far la cresta sui nostri guadagni fin dalla nostra prima tournée italiana... - Mascalzone, ma... - Non la seguo. Cosa intende dire? - Che spesso, più i mascalzoni sono tali e più hanno del fascino. Non era anche il caso di Gallizio? - Dove vuole andare a parare? - C’è proprio bisogno che glielo dica? - [Dopo un attimo di silenzio e un sorriso amaro] Non c’è che dire, è stato proprio informato bene. Mi domando da chi, e ho qualche sospetto. Beh, è vero, sì, tra noi c’è stato qualcosa; ma mi creda, nulla d’importante. È iniziato tutto per ripicca verso Alessandra, che coi suoi modi da gran donna a volte mi faceva davvero imbestialire. Lui, poi, era insinuante, perché mi sapeva sola. In quel periodo, avevo anche ripreso a bere... 20 - Inoltre, Mildiego si era dimostrato refrattario alle sue avances... - Ma insomma, si può sapere chi vi ha informati? Lei tace... Cos’è, avete fatto un patto col diavolo? Comunque, se proprio ci tenete a saperlo, a Dante [Dante Milano era il vero nome di Mildiego] io ero tutt’altro che indifferente. Soltanto che quell’uomo era un gran fifone. Si era sposato da poco e attendeva da un giorno all’altro l’arrivo della moglie. Che infatti di lì a poco giunse a Buenos Aires... col suo pancione, dato che era in stato di avanzata gravidanza. - Delle sue prodezze con Gallizio, Alessandra lo seppe mai? - Forse ad un certo punto giunse a sospettarlo, ma seppe tacere e far finta di nulla. Finché anni dopo non fui io stessa a dirglielo, dopo un’ennesima litigata; ma in quel momento, lei e lui non stavano più assieme, nell’orizzonte di Alessandra si era appena affacciato Guido. - Con le sue sorelle, lei ha sempre litigato spesso. E non era sempre colpa loro... - Dopo così tanto tempo, non ho difficoltà a riconoscerlo. Alessandra mi dava spesso sui nervi con le sue arie da signora, ma è stata anche affettuosa con me; quanto a Caterinetta, era gioviale e spensierata, e questo suo atteggiamento beato, di chi non mostra di avere problemi, a volte mi urtava tremendamente, per pura invidia, dato che io mi sono spesso sentita insicura; così, mi divertivo a farle stupidi scherzi; ma lei ha sempre avuto molto affetto per me, come per Alessandra. Tutt’e tre abbiamo litigato sovente l’una con l’altra, non lo nego, ma non abbiamo mai smesso di volerci bene. - Mentre voi vi esibivate con successo in Argentina, a Torino, colpito da un tumore, moriva a soli trentanove anni il vostro maestro Carlo Alberto Prato. - Sapevamo che era malato, ma apprendemmo del suo decesso solo alcune settimane più tardi. Per noi fu un grande dolore. Accordammo all’evento un significato simbolico; fu come se Carlo ci avesse detto: «Beh, io mi fermo qui, adesso continuate voi». Ma purtroppo, non facemmo molta strada. - Ad un certo punto decideste di intraprendere una tournée in altri paesi. - Accadde verso la metà del 1949. Ci esibimmo in Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia e Venezuela. Arrivati a Caracas, dopo tre o quattro mesi ci capitò l’occasione di una tournée a Panamá e in altri paesi dell’America Centrale, ma poco prima di partire litigammo e il nuovo Trio si sciolse per sempre. - Di chi la colpa? - Oh, certamente non mia. La colpa fu di Gallizio, questa è la verità, e di Alessandra, che continuava a tenergli bordone anche quando aveva ormai aperto gli occhi sulle 21 sue malefatte. Successe che, dopo quasi quattro anni che lavorava con noi senza compenso, Maria, allertata da Manuel Beiras, il nostro agente in Sudamerica, che era anche il suo compagno e fu il padre delle sue due figlie (in quel momento, lei era incinta della prima), pretese giustamente d’essere pagata anch’essa. Allora Alessandra (proprio lei, non Gallizio, che quale impresario e amministratore avrebbe dovuto essere il naturale interlocutore di Maria), le fece una sfuriata terribile, dandole dell’irriconoscente: e, senza pensarci due volte, Maria ci piantò in asso. - Non era rimpiazzabile? - No, certo. A parte la qualità della voce, dove mai potevamo trovare, a Caracas e in così poco tempo, una cantante che conoscesse e fosse in grado di cantare a modo il nostro repertorio? Senza contare che, quand’anche fossimo riusciti nel miracolo di rimediare una sostituta, l’ipotetica nuova venuta avrebbe senz’altro preteso di essere pagata, e l’idea non sorrideva molto a Gallizio, che quei soldi amava giocarseli ai dadi o alle carte. Così, dovemmo rassegnarci. - Nessuna di voi pensò a proseguire comunque la carriera? - E come? L’unica di noi sorelle che avrebbe potuto intraprendere una carriera da solista era Caterinetta, che infatti nei primi anni della guerra incise con successo alcuni brani; la voce di Alessandra era da mezzosoprano, e la mia addirittura da contralto: io però non ero Norma Bruni... La stessa Maria, a quanto mi risulta, lì a Caracas smise di cantare, e si mise a fare la moglie e la madre, tirando avanti con lavori di cucito. - E voi? - Ahimè, dovemmo rassegnarci anche noi a ‘tornare sulla terra’... Alessandra aprì una specie di mescita assieme a Gallizio, ma non durò molto: lui era uno sfaccendato che passava le giornate seduto a bere e a giocare a carte coi clienti, mentre a lei, che ha sempre avuto il senso dell’economia e della casa, toccava incaricarsi di tutto. Quanto a me, mi trovai un impiego; anzi, più di uno: lavorai soprattutto come commessa. - Ma ebbe anche incarichi di maggiore impegno. Ad esempio, fu responsabile di un negozio italiano di tessuti, biancheria e oggettini in ceramica: dove le successe di essere licenziata perché accusata di furto... - Ma lei, come può sapere tutte queste cose?! Le assicuro, quell’ammanco non fu opera mia: in quel negozio c’era sempre un gran va e vieni, e spesso ci mettevano piede anche persone poco raccomandabili, come alcuni rappresentanti; gente che girava spesso attorno alla cassa. Purtroppo, non potevo mica star sempre piantata lì davanti... - Però, non trova strano che tanti anni dopo, incontrando Maria Bria a Salsomaggiore, sua sorella Alessandra l’accusi di averle «trafugato» un bracciale d’oro? 22 - Mah, Sandra ha sempre sofferto di un complesso di persecuzione da parte mia. [Si alza, apre un cassetto e mi mostra un bracciale]. Il famoso bracciale, lo vede?, è questo. Che lei stessa mi regalò nel ’63, poco prima di rientrare in Italia. - Strano. Perché all’epoca, lei era in condizioni economiche decisamente migliori di Alessandra... Comunque, torniamo ai primi anni Cinquanta. Ci risulta che finì per lavorare come commessa anche sua sorella. - Dopo la cessione della mescita e la fine della sua storia con Gallizio, si trovò anche lei senza un soldo e non ebbe altra soluzione. Per fortuna, dopo tanti errori e tanto patire tutt’e due finimmo per conoscere gli uomini della nostra vita, quelli che avremmo sposato. Per Alessandra si trattò di Guido Franceschi, un italiano che era il padrone della pensione dove alloggiavamo... - Per lei, invece, si trattò di un petroliere canadese. - Quando lo conobbi, Edward importava petrolio per conto di una ditta statunitense. Gli affari gli andavano bene, diceva che ero il suo portafortuna; così decidemmo di sposarci. Lo facemmo nel novembre del ’54 a Caracas, e fu una cerimonia in grande stile. Per l’occasione, venne pure la mamma dall’Olanda. - Mancò solo Caterinetta. - Già, e mi spiacque moltissimo. Lei in quel momento stava ancora in Italia, credo fosse in procinto di lasciare Torino per trasferirsi a Roma. Lei venne in Venezuela giusto un anno dopo: avevamo deciso di ricostruire il trio originale, per esibirci a Radio Caracas. - Come la trovò? - Non bene. Aveva problemi di salute, e problemi economici, inoltre, anche se ci disse poco o nulla, capii che era ferita nell’intimo, ma orgogliosa com’era si teneva tutto dentro. - Il Trio Lescano, dunque, si riformò? - Sì, anche se divenne «Hermanas Lescano». Ma durò solo poco più di un anno. Cantammo a Radio Caracas e ci esibimmo in qualche locale, con buon successo, anche se non certo paragonabile a quello ottenuto nel ’48-49 in Argentina. Poi Caterinetta conobbe anch’ella l’uomo della sua vita: un ingegnere italiano, molto più giovane di lei, che lavorava alla costruzione di un ponte a Puerto La Cruz: tra loro fu amore a prima vista. Nel ’57 si sposarono e si stabilirono in una cittadina nei pressi di Caracas; col suo matrimonio, il trio si sciolse definitivamente, e stavolta senza litigi: perché anch’io avrei avuto difficoltà a proseguire la carriera artistica, dato che il lavoro di mio marito ci portava lontano. 23 - Sicché lasciaste Caracas? - Già. Edward decise di mettersi in proprio, e volle avviare l’attività accordandosi col governo venezuelano, che gli dette in concessione alcuni terreni presso il lago di Maracaibo, dove impiantò alcune trivelle e scoprì dei pozzi. Ma presto ci spostammo anche da lì, perché, come una specie di rabdomante, lui ‘fiutava’ e seguiva il petrolio, comprando concessioni e mettendoci subito all’opera le trivelle. - Cos’aveva di speciale suo marito per farla innamorare? - Era un uomo gioviale, ottimista e profondamente buono; inoltre, pur senza essere proprio ricco, era una specie di re Mida: aveva il dono specialissimo di far fruttare le cose, tutto ciò che toccava diventava oro. Io non sono tanto allegra, e sono decisamente pessimista, per tacere del fatto che allora vivevo appena un filo sopra la povertà: perciò ci completavamo, in ogni senso. - Non era più giovanissimo. - Beh, se è per questo neanch’io. Quando ci sposammo aveva quarantotto anni, sette più dei miei. Però era giovane dentro; e mi amava: mi amava per quella che ero. - La vostra vita in quei primi anni di matrimonio fu dunque piuttosto movimentata. Ma fu anche felice? - Sì, nonostante tutto. Lui era un uomo casa e lavoro: usciva alla mattina presto per andare ai pozzi e rientrava di sera dopo le cinque, quando calava la luce; io avevo così tutto il giorno a disposizione per occuparmi della casa, uscire per acquisti, svagarmi e riposare. Quando rientrava, era mia cura servirgli sempre un ottimo pasto: avevamo una bravissima cuoca, la Rina, una signora italiana che avevo assunto io; in cucina non sono mai stata un fenomeno, ma con un po’ di applicazione e amor proprio imparai l’indispensabile, e alla domenica, quando Rina restava con la famiglia, mi mettevo ai fornelli e preparavo ad Edward qualche gustoso manicaretto che avevo appreso da lei. Il piatto di cui lui andava più ghiotto era però l’unico che sapevo già fare: le tagliatelle alla bolognese, che m’aveva insegnato tanti anni prima Norma Bruni. Era un piacere vederlo mangiare con tanto appetito: ogni volta, mi dicevo che quella era la vita che avevo sempre sognato: fare la padrona di casa, la moglie affettuosa. Alla nostra felicità mancava solo un figlio. Temevo di essere troppo avanti in età per poter dargliene uno, finché un giorno mi scoprii incinta: ero al colmo della felicità. - E lui? - Non lo era di meno. Edward era già stato sposato molti anni prima, divorziando dopo un paio d’anni di matrimonio, e non aveva figli: ne desiderava anche lui ardente- 24 mente uno. Purtroppo, il destino ci negò quella gioia. Quand’ero al quarto mese di gravidanza mio marito ed io venimmo coinvolti in un grave incidente stradale; viaggiavamo in auto sulla carretera tra Grico e Las Mercedes quando d’un tratto, a un camion a rimorchio che si trovava davanti a noi e trasportava legname, per un forte sobbalzo a causa d’una cunetta si sbloccò lo sportello posteriore: uscirono delle grosse assi che finirono sul cofano della Buick guidata da Edward: una spezzò il vetro del parabrezza e solo per miracolo s’infilò nello spazio tra noi due senza colpirci, altrimenti oggi noi sarei qui a raccontarglielo. Il peso improvviso di queste assi e la frenata di mio marito fecero sbandare la Buick, che uscì di strada e si cappottò, arrestandosi nel bel mezzo di un campo di sorgo. Edward venne ferito alla testa dallo spostamento dell’asse, che fuoriuscì, io picchiai la testa contro il vetro del finestrino e mi feci un taglio su un braccio. Perché giungesse a recuperarci un’autolettiga ci vollero quasi tre quarti d’ora; il risultato fu che trascorremmo due settimane all’ospedale di San Juan de los Morros: io persi il bambino, e mio marito fu vittima di una cecità temporanea, ed anche in seguito ebbe qualche problema alla vista. - Da allora, non provaste più ad averne? - Non era più possibile; i medici che mi operarono ce lo dissero subito, e dovemmo rassegnarci. Per fortuna, proprio in quel periodo giunse Caterinetta dall’Italia e ripigliai a cantare con le mie sorelle, riuscendo a svagarmi un po’. - Non pensaste a un’adozione? - Ci pensammo, ma i casi del destino sopperirono in qualche modo a questa nostra mancanza, perché due anni dopo quel terribile incidente morì a Toronto Dorothy, l’unica sorella di Edward, vedova e madre di un figlio di quattro anni. Mio marito naturalmente se ne fece carico e così il piccolo Daniel lasciò il Canada e venne in Venezuela ad abitare con noi. Io, che nel frattempo avevo riversato tutto il mio amore, oltreché su mio marito, su cani, gatti e uccelli che avevamo in casa, mi affezionai subito a lui. L’ho sempre considerato come un figlio, e devo dire che Daniel ha sempre ricambiato il mio affetto. - Sua sorella Caterinetta fu meno fortunata di lei. - Già. Subì anch’ella un aborto, e pure a lei i medici non dettero più speranze di maternità, ciò che l’afflisse tantissimo. Inoltre, lei in Venezuela proprio non ci si ritrovava: non ne sopportava il caldo, aveva continui problemi di salute... Era innamorata dell’Italia, di cui aveva grandissima nostalgia. Pur possedendo case e terreni, e conducendo un buon tenore di vita, lei e suo marito sarebbero rientrati in Italia di corsa, ma non potevano: perché a causa della pesante svalutazione del bolívar, la valuta venezuelana, non disponevano della necessaria liquidità. Poi, nel ’63 ella si scoprì gravemente ammalata. - Sapevate delle sue condizioni? 25 - Le sapevamo, e le sapeva anche lei: un male che non perdona. Povera Kitty! A pensarci, ancora adesso mi viene un groppo in gola: lei così giovane e sfortunata, con tanta gioia di vivere... [Si asciuga una lacrima] Fu un calvario... - E voi? - Vivevamo tutte molto lontane da lei: la mamma risiedeva in Olanda; Alessandra, che già sul finire degli anni Cinquanta si era trasferita con Guido a Maracaibo, nel ’63 era rientrata con lui in Italia; Edward ed io stavamo dall’altra parte del Venezuela, ad oltre seicento chilometri di distanza. Ma come poté, ciascuno cercò d’esserle vicino, e quanto a suo marito, non la lasciò un attimo. Quando il suo stato si aggravò, nell’estate del ’65, venni a Caracas a trovarla, venne la mamma dall’Olanda, e dall’Italia tornò perfino Alessandra. Nostra sorella spirò circondata da persone care. - Poi sua madre e sua sorella Alessandra tornarono in Europa... - ...e quella, fu l’ultima volta che le vidi; ma, sinceramente, non lo presentivo. Edward ed io ci trovavamo piuttosto bene in Venezuela, anche se mio marito, qualche volta, era stato tentato di tornare in Canada, più che altro per fare studiare convenientemente Daniel. Pensavo in ogni caso che, prima o poi, ci saremmo concessi un viaggetto in Italia, oppure Alessandra sarebbe tornata a trovarci, anche se del Venezuela non aveva poi un buon ricordo, era innamorata dell’Italia come Caterinetta. Invece, anche stavolta il destino ci giocò un brutto tiro... - Ma con loro non vi scrivevate? - Non sono mai stata una grande scrittrice, ma corrispondevo con entrambe: due o tre lettere all’anno almeno. Così sono venuta a sapere del matrimonio di Alessandra con Guido a Parma nel ’66, della morte a L’Aja di zia Matje nel ’68, e della morte di Guido a Parma nel ’76... - Già. Ma poi cosa successe? Perché, da un certo punto in poi, sua sorella Alessandra lamentò di non avere più ricevuto sue notizie? Lei e vostra madre la credevano morta. Precisamente, Alessandra fornì tre versioni sull’interruzione dei vostri rapporti. Al musicologo Adriano Mazzoletti, che l’intervistò, disse che «Giuditta nel 1982 viveva ancora in Venezuela», mentre, intervistata dalla Aspesi nell’85, disse di lei di non saperne «più nulla da otto anni [cioè dal ’77], [che] probabilmente è morta», e un mese dopo, nell’intervista a Verre, affermò: «Assieme al marito, Giuditta andò a vivere a Maracaibo, da dove scrisse fino a dieci anni fa [cioè al ’75], poi più niente, silenzio: non so se è viva o morta». Qual è la verità? - La verità è che un giorno dell’ottobre 1977 Edward fu colpito da infarto e in pochi minuti rimasi vedova. Questo fatto, oltre ad un grandissimo dolore, mi causò un’incredibile serie di problemi, ai quali dovetti far fronte praticamente da sola, perché in 26 quel periodo Daniel si trovava a Londra per concludere gli studi universitari: seguiva una facoltà di economia e commercio per prepararsi ad affiancare lo zio, difatti qualche tempo dopo gli subentrò nella conduzione della sua impresa. Ma in quei frangenti, il carico di problemi e di decisioni operative lasciate da mio marito ricadde quasi interamente sulle mie spalle, io che di petrolio sapevo poco o nulla, dato che Edward aveva sempre cercato di tenermi lontana da ogni preoccupazione. Oltretutto, l’anno prima c’era stata la nazionalizzazione dei giacimenti petroliferi da parte della Petroven, e molte cose erano ancora in discussione col governo venezuelano. - Così? - Così, per un periodo di circa sei mesi (prima che tornasse Daniel e mi subentrasse in questo compito), dovetti confrontarmi quasi da sola, quotidianamente, con la realtà del lavoro che era stato di mio marito, potendo contare soltanto sulla collaborazione di un paio di suoi dipendenti che si occupavano con lui dell’amministrazione: perché per carattere Edward aveva sempre assolto a tutti gli impegni in prima persona. La cosa all’iniziò mi atterrì, ma pian piano, quando cominciai a conoscere i meccanismi del suo lavoro, non nascondo che prese ad affascinarmi: mio marito era un uomo che si era fatto da solo, e aveva creato un piccolo ma consistente impero finanziario, dando lavoro a tanta gente e scoprendo alcuni importanti giacimenti petroliferi. - Beh, e vuol dirmi che per questo smise di dare notizie di sé ai suoi familiari? - So bene che quanto sto per dirle le sembrerà incredibile, ma cominciò tutto proprio così. È assurdo, certo, e me ne resi conto io per prima. Anche perché, tornato Daniel, fu lui a prendere in mano la situazione, e lo fece brillantemente, rivelandosi il degno nipote di Edward: così io mi trovai di nuovo libera, e in possesso di un solido patrimonio: avrei potuto concedermi tutti i viaggi in Europa che desideravo, e se volevo, anche trasferirmici. Ma... ma... io ormai mi trovavo bene in Venezuela, amavo Daniel come un figlio e per nulla al mondo avrei lasciato i luoghi dov’ero stata felice con mio marito. Insomma, non feci nulla di tutto ciò, e per quanto questo possa sembrarle paradossale, cominciai a convincermi che era meglio lasciar credere ai miei familiari che fossi morta. In fin dei conti, neanch’io sapevo più nulla della mamma e di Alessandra, e potevo credere lo stesso di loro; ma crederlo non è come saperlo: dandolo per supposto, si conserva in fondo al cuore una speranza, quella che le cose non stiano così. - Ma questo assurdo lo è davvero! - E perché? Ci rifletta bene: fino a quel momento, nella vita io avevo perduto troppe persone care, l’ultima delle quali era stata Edward. Non volevo più soffrire, non l’avrei tollerato; sicché decisi scientemente di darmi per morta. Nel farlo, fui aiutata da alcune circostanze. Prima di tutto, io portavo il cognome di mio marito, che in Venezuela era piuttosto noto, ma essendo straniero veniva regolarmente storpiato nei loro uffici anagrafici; poi, un mese prima della morte di Edward noi avevamo cambiato 27 città e domicilio, e io non avevo ancora comunicato ad alcuno quello nuovo; infine, le uniche persone che avevano rapporti con Alessandra e che conoscevo in Venezuela, sia pure molto alla lontana, erano i tre figli di Guido, residenti a Maracaibo: ma non li avevo mai cercati, né loro me, e a quel punto anch’essi avrebbero avuto difficoltà a farlo. - In Italia, però, esisteva pur sempre l’ambasciata venezuelana. Sua sorella e sua madre avrebbero potuto rivolgersi a loro... - Chissà se lo fecero. Comunque, ad agevolare la mia intenzione ci fu un’altra circostanza del tutto fortuita: successe cioè che quando morì Edward, per un incredibile errore dell’agenzia di stampa che divulgò il fatto, qualche giornale italiano, anziché riportare la notizia del suo decesso, scrisse che era morta anche la seconda delle sorelle Lescano. Io lasciai correre. So che molto tempo dopo, addirittura quattro anni fa, c’è stata una trasmissione televisiva italiana, Chi l’ha visto?, che ha inteso promuovere ricerche su di me in Venezuela. Per fortuna so bene come vanno le cose qui: la mia tranquillità era al sicuro. ...Finché non è arrivato lei. - Dica, come ha vissuto questi trentasei anni dalla morte di suo marito? - Bene non posso dirlo, perché Edward mi manca moltissimo ancora oggi, tanto che spesso (non rida), quando sono da sola parlo con lui come se fosse ancora qui. Ho vissuto come una signora anziana agiata e riverita, ma anche, me lo lasci dire, amata, perché il mio personale di servizio lavora con me da decenni, l’ho sempre trattato benissimo e ho l’orgoglio di poter dire che mi è sinceramente affezionato. Ho fatto, e faccio tuttora, molta beneficienza. Quanto al resto, da quando è salito al potere Chavez, le cose per noi stranieri sono andate di male in peggio. Per fortuna, in quel periodo Daniel ha sposato la figlia di un sindacalista molto vicino al governo, così, pur avendo rinunciato a certi privilegi di un tempo, ho vissuto gli ultimi anni tranquilla. D’altra parte, la mia patria ormai è il Venezuela: non lascerei mai il paese in cui è sepolto mio marito; e ora che anche mia madre e Alessandra non ci sono più, perché mai dovrei tornare in Italia? - Ha saputo dello sceneggiato televisivo che vi è stato dedicato dalla televisione di Rai Uno nel 2010? Lo ha visto? Cosa ne pensa? - L’ho appreso con un certo stupore eppoi l’ho visto, perché come molti venezuelani posseggo un impianto satellitare, dove mi piace tenermi informata sulle cose del mondo. Cosa posso dire? Non mi pare che il regista si sia sforzato molto. Aveva un’ottima occasione per far rivivere un periodo unico come quello degli ultimi anni del fascismo, e disponeva anche di alcuni bravi attori, ma l’ha buttata alle ortiche, con alcuni errori madornali, e naturalmente con tante panzane. Perché non fare cenno del nostro maestro Carlo Prato, che del Trio è stato l’indiscusso creatore? Perché inventarsi amori assurdi come quello di Alessandra per un capetto fascista e quello di Caterinetta per il povero Funaro? Hanno infangato inutilmente la loro memoria... 28 - Signora Giuditta, la nostra lunga intervista volge al termine. Prima di chiudere, vorrei chiederle ancora: sappiamo ormai da tempo cosa sia stato il Trio Lescano nel panorama della nostra musica leggera degli anni dell’Eiar: i valori musicali stanno prendendo il sopravvento e la critica vi giudica ormai come uno dei fenomeni più importanti nello sviluppo della musica sincopata di ascendenza jazzistica. Ma per lei, quell’esperienza cos’ha rappresentato? - Potrei cavarmela con una battuta: la giovinezza. E sarebbe una battuta solo fino a un certo punto. È stata come una corsa, una folle corsa durata poco meno di otto anni, vissuti così rapidamente da sembrarmi, oggi, solo pochi secondi. Da danzatrice contorsionista a cantante, da commessa a signora del petrolio... Che strana vita, la mia, non è vero? 29 Dall’album fotografico personale di Judik/Judith Leschan - Giuditta Lescano a) Fine anni Venti - Inizio anni Trenta Immagini dal Fondo Portino di proprietà di Giorgio Bozzo (per gentile concessione). 30 b) 1935 - 1943 31 32 33 34 c) 1944 - 1945 35 d) 1946 - Metà anni Cinquanta
Scarica