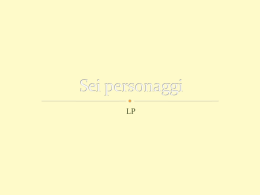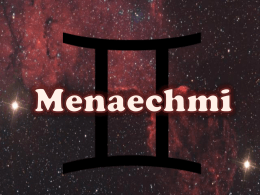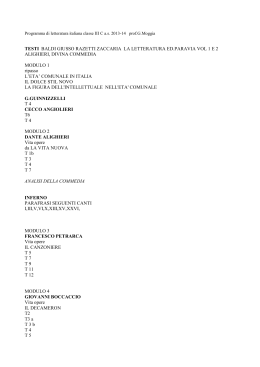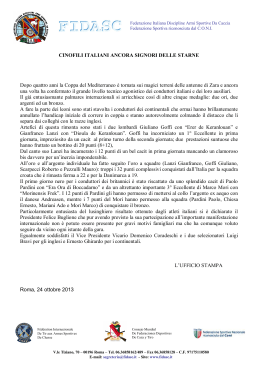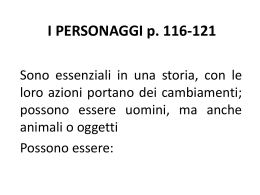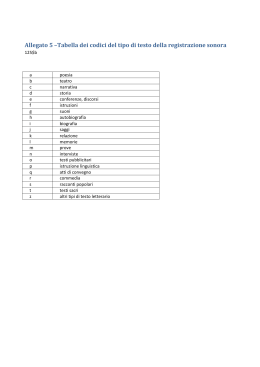Gianfranco Salvatore dispensa per il corso di Etnomusicologia “Minoranze etniche nella musica Rinascimentale” Università del Salento a.a. 2011-2012 IL TEATRO MUSICALE DELLE LINGUE Parodie di stranieri e minoranze nel Rinascimento italiano “Capricci”, versione 1.1 testo in progress VIETATA OGNI CITAZIONE O PUBBLICAZIONE ANCHE PARZIALE DA PARTE DI TERZI © Gianfranco Salvatore 2011 N.B.: questa è la versione 1.1 del testo; al momento manca l’Introduzione. Gli studenti che sosterranno l’esame a partire da Febbraio 2012 dovranno scaricare e studiare la versione 1.2. 2 PRIMA PARTE LE MINORANZE NEI GENERI TEATRALI E MUSICALI DEL RINASCIMENTO 1.1 “Lanzi” e “Todeschi”, e i loro canti Quella del soldato di ventura tedesco - spesso denominato Lantzman o lanzichenecco, a Firenze “lanzo”1 - è una delle caricature più diffuse nella letteratura italiana del Cinquecento. Già durante il Quattrocento i “lanzi” venivano assoldati come mercenari da sovrani e imperatori europei. Provenivano dalle regioni del Sacro Romano Impero, e furono istituiti nel 1487 dall’imperatore Massimiliano I sul modello dei mercenari svizzeri, di cui diventarono acerrimi nemici, riuscendo a sconfiggerli in Italia nelle sanguinose battaglie di Marignano (Melegnano, 1515) e della Bicocca (1522), nei dintorni di Milano. La loro fanteria partecipò ad alcuni fra gli eventi bellici più drammatici del secolo, come il sacco di Roma e la battaglia di Lepanto contro i Turchi; nel Seicento assediarono Mantova e combatterono nella Guerra dei Trent’anni. La fama leggendaria delle loro gesta li fece entrare nell’immaginario popolare, in libelli e fogli volanti, stampe e acqueforti, canti e farse, fino ai Promessi sposi manzoniani. Costituivano quasi una microsocietà separata, e del loro contesto antropologico sono rimasti famosi alcuni elementi pittoreschi: gli elaborati costumi dai colori sgargianti, e spesso scomodissimi; le armi da taglio e da fuoco, sempre all’avanguardia delle ultime tecnologie, dagli archibugi ai moschetti; e soprattutto le “vivandiere”, cioè quelle donne che seguivano le loro unità, ufficialmente per occuparsi della cucina, ma spesso anche come prostitute. Godevano fama di proverbiale ingordigia, per il cibo e per il vino. Una fama non estranea a circostanze storiche: già nel 1486, a Bruxelles (dove erano entrati al seguito dell’imperatore), vennero in contrasto con i cittadini perché insoddisfatti delle vettovaglie che gli erano state destinate. «Si disposero in formazione e, in ordine quadrato, arrivarono davanti al palazzo del governo cittadino. Qui c’erano alcuni carri con botti di vino, che il consiglio cittadino aveva donato all’imperatore. Ciò non impedì ai fanti d’impossessarsene. Misero da parte le lance, dando vita ad una selvaggia gozzoviglia, che cessò solo quando l’ultima botte fu vuotata»2. A Firenze, fra Quattro e Cinquecento, furono spesso impiegati questi mercenari tedeschi, che con la denominazione di Lanzi (familiarmente detti anche “lanzimanne”) entrarono poi ufficialmente a far parte di uno speciale corpo di guardia, fra cui si ricorda in particolare di Cosimo I de’ Medici, duca dal 1537 al 1574. Erano «ben noti al paesaggio sociale fiorentino non solo nella loro funzione di armigeri o di guerrieri, ma anche di artigiani dalle più varie specialità (coltellinai, specchiai, musicanti […])»3. Compaiono spesso nei canti carnascialeschi fiorentini, che nell’insieme non risalgono a prima del 1485, ed è difficile 1 “Lanzo” deriverebbe da lantzman, “paesano”, secondo una proposta etimologica che si rifà anche alle Note al Manmantile, dove si legge (p. 79) che tale voce è “Todesca” e «lasciataci da loro medesimi», dal loro modo di salutarsi reciprocamente. Ma l’antica etimologia della Crusca - da Landsknechte, “lanzichenecco”, fante - non va del tutto respinta: specie quando i Lanzi, come in molti canti carnascialeschi, «compaiono in rapporto al mestiere delle armi» (BRUSCAGLI 1986: 100, a cui si rimanda anche per i riferimenti critici e bibliografici), e come appare anche nel vanto che «todesche star buon fante» (Canzona de’ Lanzi arcieri, 2). L’espressione «Lanzi maine» per lantzmann si trova nelle “canzone” Di Lanzi che fanno schizzatoi, Di Lanzi cozzoni, De’ Lanzi tamburini, e la variante «Lanzi man» nella Canzona di Lanzi tagliatori a tavola (sempre nel verso iniziale). 2 BAUMANN 1996: 29. 3 BRUSCAGLI 1986: L. 3 datarli precedentemente ai primi anni del Cinquecento4: il più tardo, per quel che ne sappiamo, è del 15365. In queste parodie, spesso di tono osceno, i lanzi si interessano soprattutto al cibo, al bere e alle donne, più che alle attività militari; la loro comicità era accentuata da una mimica che doveva simulare l’equilibrio incerto di un ubriaco. Vi emerge però anche la loro attitudine per il canto, la musica e la danza. Cinque canti contengono informazioni sugli strumenti da essi suonati, oltre che su tecniche esecutive6. Abbiamo ben trenta “canti di lanzi”carnascialeschi. La maggior parte dei testi (diciotto) era del poeta e autore di canzoni Guglielmo detto il Giuggiola, che sotto il tono parodistico svolge un catalogo realistico delle loro attività lavorative, sia militari (Canzona de' lanzi alabardieri, … venturieri, … arcieri) che civili (… coltellinai, … sonatori, … cozzoni cioè domatori di cavalli, e - di Giovambattista dell’Ottonaio - stagnatai, mentre nell’anonima Canzona de’ Todeschi sono cuochi), ma anche di aspetti della loro vita personale (Canzona de’ Lanzi che andarono a papa Lione, … pellegrini, o altre come Canzona de’ lanzi poveri, … allegri, etc.). Di dodici “canzone de’ lanzi” si conserva anche la musica. Come tutti i personaggi di stranieri parodiati nella letteratura del Cinquecento (e in particolare nella melica, dove la ridotta estensione del testo costringe alla sintesi), i Lanzi dei canti carnascialeschi sono ritratti tramite una serie di stereotipi comportamentali, continuamente ricorrenti. Hanno una smodata passione per il vino (le varietà più citate sono il trebbiano e la malvasia), e sono sempre ubriachi, come si vede in particolare nelle “canzone” Di lanzi allegri, De’ lanzi cotti e De’ Todeschi. Il vino induce a «dir zolfe e gamautte» (Lanzi allegri, 26), cioè a cantare, e rende più forti: «star poi tutte gagliardie / e aver un gran possanze» (Lanzi cotti, 17-18)7. Bruscagli ricorda inoltre la loro «piena disponibilità erotica, con predilezione per i rapporti a tergo (o alla tedesca, come appunto anche si diceva […])»8. La parodia di simili comportamenti trasmette schematicamente il modo in cui i mercenari tedeschi dovevano essere percepiti nella Firenze rinascimentale. Accanto a questi cliché, comunque, bisogna notare che i canti carnascialeschi, per loro stessa natura - che è quella di una messa in scena tout court, sia pure nel breve spazio dell’esecuzione di una canzone da parte di un gruppo di personaggi mascherati -, danno voce a tali personaggi sempre alla prima persona plurale. L’artificio consente loro spesso di fornire una propria autodefinizione, plausibilmente ispirata, entro certi limiti, alla realtà. I personaggi si autodefiniscono collettivamente come «buon fante» (Canzona de’ Lanzi arcieri, 2) e «falente fenturier» (cioè valenti soldati di ventura: Canzona di Lanzi venturieri, 2). Usano come grido distintivo «Solde, solde», a ricordare la paga che definisce il “soldato” in quanto mercenario (Canzona de’ Lanzi arcieri, 1), e come grida di guerra e incitazioni le esclamazioni “Sbricche, sbricche!”, dove il termine “sbricchi” è autoreferenziale ironico per “furfanti” (nel ritornello della Canzona de’ Lanzi alabardieri), o «Stroche, stroche» (tedeschismo da strolch, furfante, masnadiero: Canzona di Lanzi venturieri, 14). Essi ricordano spesso la propria socievolezza e cordialità: «Questi lanzi buon compagne» (Canzona de’ Lanzi che andarono a Papa Lione), «noi star tutte buon compagne» (Canzona di Lanzi tagliatori a tavola, 36). Provengono generalmente dalle “Magne”, cioè dalle lande tedesche (Canzona de’ Lanzi cotti, 21; Canzona di Lanzi tagliatori a tavola, 5; Canzona de’ Lanzi stagnatai, 6; 4 KIRKENDALE 1972: 187. Fra tutte le “canzone”, una delle più tarde è quella De’ Lanzi tamburini, presentata al Carnevale del 1536 (BRUSCAGLI 1986: 295). È legittimo ritenere che dal 1537 i Lanzi non furono più parodiati per volontà di Cosimo I, di cui furono al servizio? 6 McGEE/MITTLER 1982: 452. 7 Interessante il rovesciamento del cliché operato nella Canzona di Lanzi romiti, dove il personaggio dell’eremita, abbastanza comune nei canti carnascialeschi, si fonde con quello del lanzo per puro paradosso (oltre che per gli immancabili doppi sensi erotici): non essendo credibile che egli, dedicatosi alla penitenza, si rassegni a mangiare solo torsoli di lattuga e a bere acqua e basta. 8 BRUSCAGLI 1986: 100. 5 4 Canzona de’ Lanzi tromboni, 5; «d’Alte Magne», Canzona de’ Lanzi tamburini, 2). Tuttavia fra di loro ci sono anche dei “flamminghe”, fiamminghi, a loro volta soldati imperiali (Canzona de’ Lanzi alabardieri, nel ritornello), definiti peraltro chiaramente «todesche gente» (ivi, v. 5). Un’ulteriore indicazione sta nel fatto che occasionalmente i lanzi si dicano impegnati, sia pure «in terre fostre», in mestieri tipicamente nordici (Canzona di lanzi pescatori all’aringhe, 1-2). Il corpus dei canti carnascialeschi sui lanzi, infatti, ritrae più in generale degli immigrati nordeuropei di lingua tedesca, non sempre soldati di ventura, o a volte degli ex militari integratisi nel tessuto sociale fiorentino intraprendendo vari mestieri. In un brano, la Canzona di lanzi sonatori, i personaggi sostengono la loro compiuta integrazione: «Benché noi todesche stare, / tutte siam ben talianate» (5-6). Ma spesso decantano qualità lavorative superiori alle nostre - «Le cozzone oltramontane / star miglior che le taliane» nella Canzona di Lanzi cozzoni (3-4) -, anche per giustificare la loro venuta in Italia, come nella Canzona de’ Lanzi tromboni: «Noi fenute delle Magne, / perché intese ha lanze dir / che Talian star buon compagne, / quando lanzi fuol servir» (5-8). E così nella Canzona di Lanzi campanai: «Alle belle e buon campane / che far lanzi ioverlicche [valenti, apprezzabili] / […] / Noi gittar coll’arte nostre / tanto buon campane e nette / che non far qua Talian vostre / che più preste e miglior gette: / perché tutte l’ingegne mette» (1-2, 5-7), ovviamente col solito doppio senso sessuato. Si dicono sempre disponibili a insegnarci le loro arti, come nella Canzona de’ Lanzi stagnatai (11-14), in quella De’ Lanzi tromboni (3-4), e ancora in quella Di Lanzi campanai: «Se imparar foler da noi / Italian gittar campane, / noi insegnar a tutte foi; / ma bisogna far pian piane: / che straccar [si stancano] presto Taliana / più che lanze ioverlicche» (35-40). Ma non di rado si dichiarano miseri e affamati (nonché assetati), come nella Canzona de’ Lanzi poveri e in quella Di Lanzi stracchi. Frequenti sono anche le allusioni ai loro pellegrinaggi a Roma (per accattonaggio, ma anche in cerca di indulgenze, in occasione del Giubileo), come quelle che troviamo nelle citata Canzona de’ Lanzi poveri e in quelle De’ Lanzi che andarono a Papa Lione, De’ Lanzi pellegrini e De’ Lanzi cotti. Alcune altre “canzone” sono intitolate alla maestria dei lanzi nel suonare determinati strumenti (Lanzi mastri sonatori di ribecchini, Lanzi tromboni, Lanzi tamburini). La varietà strumentale non ha precisi confini: da una canzona all’altra abbondano i fiati (ottoni e ance), le corde, le percussioni, il cui catalogo più ampio sta nella Canzona di Lanzi sonatori. Inoltre, la Canzona di Lanzi mastri sonatori di ribecchini abbonda di riferimenti alla danza come forma prediletta di svago e di corteggiamento: «Tutte sempre in ogni loche / lanzi star liete e galante, / e con gaudio, festa e giuoche / salte, suone, balle e cante» (29-32). I lanzi sanno fare «belle stampite» (14)9, «cibatte e bel moresche» (36), e anche «quel danz ussesche [zingare] / che si chiama ciascherine»10. Nella generale disponibilità esibita dai Lanzi a insegnare a noi italiani le professioni in cui ritengono di eccellere, i Lanzi si dicono particolarmente disponibili con le «donne belle» che volessero imparare a sonar»: precisando che esse possono trovarli al loro alloggio «Piazze Padelle», dietro alle «stufe», cioè ai bagni pubblici (Canzona de’ Lanzi tamburini, 35-38)11. Oltre che col lavoro, si socializzerà col solito brindisi: «E però foler fenir / a far trinche con voi tutt: / e noi meglie insegnar tutt / a Talian menar trombon» (ancora nei Lanzi tromboni, 912). Complessivamente, nelle simulate “autopresentazioni” dei Lanzi si incrociano punti di vista esterni, cioè pregiudizi e semplificazioni che corrispondono al modo in cui essi erano percepiti dai fiorentini, e dati realistici quali mestieri, attitudini, costumi: una miscela tipica di ogni parodia dei vari soggetti stranieri e alloglotti che prenderemo in considerazione. In essa 9 Anche in Canzona di Lanzi sonatori, ma con riferimento alla musica: «star udir dolze stampite / che ti far nostre stormente» (3-4). 10 Le danze denominate “cibatte” e “ciascherine” non sono state ancora identificate dagli studiosi. 11 Dove si trovava anche un noto bordello (BRUSCAGLI 1986: 296). 5 rientra anche il particolare linguaggio attribuito a questi personaggi: una sorta di italiano maccheronico con pronuncia tedesca, definito farlingotto nei testi carnascialeschi (in particolare nella Canzona de’ Lanzi romiti; mentre “farlingotte”, da intendere come plurale maschile, sta per “Lanzi” tout court nella Canzona de’ Lanzi pellegrini). Sui modi di espressione linguistica - dei tedeschi come di altre minoranze - gli studiosi generalmente concordano sul fatto che fossero simulazioni abbastanza realistiche sia delle pronunce italiane (o meglio dei vari “volgari” italiani) da parte degli alloglotti, sia del loro modo di inserire nell’eloquio, italianizzandole in qualche modo, parole ed espressioni della propria lingua d’origine. Scorrendo i testi dei canti dedicati ai Lanzi, la più tipica distorsione fonetica risulta essere l’assordimento di v in f, ancora oggi un luogo comune in qualsiasi imitazione comica dell’accento tedesco. Nel lessico che ne deriva, si possono segnalare lemmi ed espressioni quali “taferne” (taverna), “fote” o “fotte” (vuote), “pofer” (povero), “foce” (voci), “folte” (volta), “fostre” (vostre), “diafol” (diavolo), “dofe” (dove), “falor” (valore), “lafore” e “laforìe” (lavori, mestieri), e le voci verbali e avverbiali “afer” e “afeme” (avere, abbiamo), “befer” o “beffer” (bere), “fenute” (venuti), “fetute” (visto), “foler”, “fuoi”, “fuol[e]”, “folentier[e]” (volere, vuoi, vuole, volentieri), “mi non fol” (io non voglio). In alcuni casi, questa tipica idiosincrasia dà la stura ad ulteriori allusioni sessuali e comportamentali: tipicamente equivoco “fotteghe” per botteghe (Canzona de’ Lanzi intagliatori, 6)12. Fra le altre, numerose distorsioni caratteristiche, segnaliamo per il momento anche “noie” (noi), “flasche” (fiaschi), “stazzone” (stazioni, nel senso delle processioni di chiesa in chiesa): sui meccanismi che le regolano ritorneremo più avanti. Non mancano dei veri e propri tedeschismi, già studiati da vari studiosi, fra i quali si possono segnalare: “ritte ritte” (Canzona de’ Lanzi poveri, 8), probabilmente dal tedesco recht, “proprio”; “micche”, “latte, da milch (Canzona de’ Lanzi poveri, 14); “scutte vaine” per “buon vino” (Canzona di Lanzi che fanno schizzatoi, ritornello); “lifer trinche” da liefern, “dare”. E ancora “obiott” nel senso di “perdìo!”, da “Ja bei Gott” nella sua forma svizzera di “Jo bi Got” (Canzona di Lanzi tagliatori a tavola, 1); e “bracarnorde”, dalle forme medie tracanolde o dracanolde (moderno trunkebalde) per ubriacone13. “Liffe, liffe” (dall’incipit di Canzona di Lanzi che fanno schizzatoi), con riferimento al tedesco lippe (labbro) e col significato di “ghiottone”, è invece, come chiarito dal Singleton sulla scorta di Leo Spitzer, un’«espressione coniata in derisione dei Tedeschi e degli Svizzeri, allusiva alla loro smodata avidità di bere e di mangiare, analoga al francese lifrelofre»14. I canti dei Lanzi sono un genere prettamente maschile. Eccezionalmente, la Canzona di Lanzi mastri sonatori di ribecchini è cantata dalle compagne tedesche al loro seguito, in lode delle ribecchine “suonate” (con ovvio doppio senso) dagli uomini. Ma nel corpus dei carnascialeschi la presenza femminile germanica si estende anche oltre i “lanzi” nella Canzona di dua tedesche grosse, due donne rimaste incinte durante il loro vagabondaggio «nel menare le lor pedate / e giacere su per le strade» (17-18), e che nella Canzona seguente continuano a darsi il buon tempo lungo la strada. Si è visto anche che a volte i “lanzi” di questo repertorio vanno intesi semplicemente come tedeschi immigrati in Toscana e variamente integrati nel tessuto sociale e lavorativo. D’altronde quella dei lanzi non è l’unica parodia musicale, o teatrale, del “Todesco” in Italia. Una quantità di mestieranti e scolari tedeschi circolava nel nostro paese; a Venezia, ad esempio, non pochi lavoravano come commercianti o, nei casi meno fortunati, come carbonai o fornai15. E nel teatro veneziano puntualmente ritroviamo «imitazioni del linguaggio di quei Tedeschi che scendevano a Venezia, accanto a connazionali impegnati in lucrosi commerci, 12 Fra le altre, numerose distorsioni tipiche, ricordiamo anche “noie” (noi), “flasche” (fiaschi), “stazzone” (stazioni, nel senso delle processioni di chiesa in chiesa). 13 Cfr. BRUSCAGLI 1986: 100 s., 135, 149, 158. 14 BRUSCAGLI 1986: 123. 15 CORTELAZZO 1976: 177. 6 per esercitarvi umili mestieri»16. Si veda ad esempio il personaggio del servo Corado17 nella commedia La Rodiana di Andrea Calmo, composta prima del 1541 (e stampata nel 1553 con l’erronea attribuzione a Ruzante)18. Nel suo linguaggio spiccano tipiche distorsioni vocali e consonantiche come «patruna» e «zurne» per “padrone” e “giorno”, abusi dell’infinito («come star», «anche ti pregar»), immancabili riferimenti alla passione per il «vine dulce», quali «mi no star briaghe», e al ballo, come «mi bale une moresche», imprecazioni («mi no te pagher per Tie vere»), etc. (I, 3; II, 3; V, 1 e 10). In un’altra commedia di Calmo, La Spagnolas (1549), il personaggio tedesco del carbonaio ha sei battute, costellate di imprecazioni: nella più lunga, l’entusiasmo per il vino porta il carbonaio a canticchiare «dan derer don, o, o, dan deren don, viver voie alieg[h]ermente…». Inserita nel discorso, dunque, si trova una strofetta cantata, che plausibilmente aveva anche un’esistenza autonoma, dacché il tipico ritornello “a nonsense” si ritrova pressoché identico in contesti analoghi19: ricollegando così il personaggio teatrale del tedesco alla sua origine in canzone. Ma la più tipica incarnazione del personaggio del Todesco nel teatro veneziano si afferma, già durante gli anni Quaranta del Cinquecento, nei panni del fornaio “mistre Righe”, ovvero Mastro Arrigo, tramite una canzone che si trova in un’altra commedia di Calmo, Il Travaglia, messa in scena nel 1546. La canzone è inserita fra le battute pronunciate dal personaggio di Garbino, un ragazzo (atto II, scena 12). I versi iniziali, che possono essere considerati formulari, sono i seguenti: «Mi me chiamere mistre Righe, / cul boccale vaghe aturne». Dopo alcune interruzioni parlate20 la canzone prosegue, a pezzi e bocconi, così: «Delle donne mi se amighe, / Che sa mettere pan in furne…»21. Il mestiere del fornaio dà la stura ai convenzionali doppi sensi sulle offerte erotiche del personaggio, senza dimenticare gli altri suoi stereotipi: il boccale e la musica. Della parodia linguistica dei germanofoni in Italia abbiamo dunque una tradizione fiorentina, carnevalesca, che risale ai primissimi anni del Cinquecento (o anche prima), e un’altra veneziana, di cui è più problematico inquadrare l’origine: se in àmbito teatrale, o carnevalesco in senso stretto. Sembrerebbe esclusa una popolarità del personaggio del Todesco nell’àmbito dello spettacolo di strada, dato che nessuna imitazione linguistica germanofona compare tra le molte parodie di stranieri di cui era capace il famoso buffone veneziano Zuan Polo, attivo fin dagli anni Dieci, stando al ritratto che ne fa il Caravia nel Sogno (1541, ma Zuan Polo era già attivo nel 1504); né abbiamo opuscoli o fogli volanti relativi al personaggio di Mistre Righe in data precedente al Travaglia (anche se ce n’è una di poco successiva). Esiste però un’importante testimonianza che risale al 1510 (sulla quale torneremo estesamente più avanti), dove Louis Hélian lamenta la passione veneziana di mettere in scena personaggi ridicoli di tedeschi (e di francesi). Apparentemente, dunque, la tradizione veneta sarebbe di origine scenica, con quegli imprecisati precedenti dei primi anni del secolo, fino a ricomparire nelle commedie di Calmo degli anni Quaranta, in varie incarnazioni. Quella di Mistre Righe dovette riscuotere un buon successo, visto che nel 1547 (l’anno dopo la messa in scena del Travaglia) il tipografo Agostino Bindoni pubblicava a Venezia Le canzonette [= “la canzonetta”, stante la storpiatura parodistica delle finali di parola] de Mistro Rigo Forner 16 CORTELAZZO 1971-72: 113. Corrado (anche nelle forme “Corado” e “Currado”) viene considerato un nome tipicamente tedesco, e lo si trova impiegato paradigmaticamente anche nella Canzona de’ Lanzi cotti e in quella De’ Tedeschi. 18 D’ONGHIA 2009: 4. 19 Si veda il testo di Matona mia cara, musica di Orlando di Lasso, dove ogni distico è seguito dal ritornello «Don, don, don, diridiri, don, don, don». 20 «Ho, messere, messere! cantate un poco la canzone de mistre Righe e guardate se questa gnàchera [nacchera o tamburello saraceno] ha buon suono, volete?»; e più avanti: «Aspettate, ch’io vi mostrerò: pigliate con questa mano la gnàcara e con l’altra la mazza e ditte como io: “Mi me chiamere mistre Righe”: mo dite!»21 Cfr. CORTELAZZO 1976: 180; VIANELLO 2005: 144 e n. 39. 17 7 Todesco, «uno dei tanti opuscoletti che in quel periodo riproducevano senza musica i testi di canzonette con chiara ascendenza scenica»22. Naturalmente, i due exploit di Mistre Righe del 1546-47 (nel Travaglia e sull’opuscolo di Bindoni) potrebbero entrambi derivare dall’indipendente successo della canzonetta e dalla sua circolazione orale negli anni immediatamente precedenti. In ogni caso, il personaggio si affermerebbe a Venezia nella sfera della parodia musicale “todesca” negli anni Quaranta del Cinquecento, seguendo di qualche decennio quella carnascialesca dei lanzi a Firenze. Se non è nato nel Carnevale, tuttavia, Mistre Righe deve esserci entrato almeno in un secondo momento: perché del Carnevale si trova l’apologia nelle analoghe strofette di un altro opuscolo, di poco posteriore: «Mi me piase el Carneval / quelle zurne si divine / che con zuche e con buchal / le va inturne e con galline / e de sere e de matine / se fa feste per ste cal. / Mi me piase Carneval …». L’opuscolo riproduce Le Ridiculose canzonette de Mistre Gal forner, padre de Mistro Rigo Todesco, un’altra canzonetta, che documenta la creazione di un nuovo personaggio ricalcato su quello di Mistre Righe e con lui imparentato a testimonianza della popolarità di simili personaggi, a cui è legata una certa fortuna nell’editoria popolaresca. La “famiglia” di Mistre Righe torna infatti una terza volta, a stampa, nella Canzonette De Mistro Sbrufaldo Thodesco, Fratello di Mistro Rigo Forner: «Mi son quel mistro Sbrufalde / Bon Pistor, & bon Furner, / Anche Faure, e bon Murer. / E valente Marangon. Trinche baine me sa bon…»23. È una piccola saga familiare, dove tutti i membri della schiatta condividono la passione per il boccale, benché Sbrufaldo insista anche sui molti mestieri che conosce: annotazione che riflette quella che era, nell’opinione comune, la versatilità e l’arte di arrangiarsi dei tedeschi, a Venezia come già a Firenze, secondo quanto testimoniano - pur umoristicamente - le parodie “todesche” prodotte in entrambe la città. Si fa strada, insomma, l’ipotesi che questi personaggi siano ovunque di origine carnevalesca, salvo ad essere poi recuperati nel teatro e nello spettacolo comico. Intanto va notato che il fatto che il capostipite dell’immaginaria famiglia, Gal, rivendichi la sua passione per il Carnevale veneziano, e il moltiplicarsi di personaggi analoghi24, costituiscono forti indizi della penetrazione del personaggio del tedesco beone (ma gran lavoratore e gran cacciatore di femmine) nel contesto carnevalesco lagunare, in piena analogia con quello fiorentino. Resta al momento impossibile stabilire sia il rapporto fra le due tradizioni (ad esempio se l’una sia un adattamento dell’altra), sia l’eventuale dipendenza del personaggio e della sua fortuna teatrale a Venezia da una già radicata identità di maschera carnevalesca, prima ancora che teatrale (nel qual caso bisognerebbe risalire, stante la testimonianza di Hélian, ai primissimi anni del Cinquecento o addirittura poco prima, in contemporanea con i lanzi fiorentini). Per il momento, restando a Venezia, il confronto fra i personaggi tedeschi di Calmo e quelli delle pubblicazioni popolari testimonia comunque un’osmosi fra teatro e Carnevale veneziani, con scambio non solo di singoli personaggi, ma dei relativi modi di esprimersi linguisticamente, e delle canzoni che vi erano associate. Battute e canti avevano in comune il fatto di simulare un’autopresentazione dei personaggi, una fittizia self-definition nella quale in realtà si può leggere quale fosse la visione - semplificata dall’opinione comune e stereotipata dalla finzione scenica - di questa minoranza straniera in una dei più importanti stati italiani rinascimentali. 22 VIANELLO 2005: 144. Entrambe le cit. in CORTELAZZO 1976: 181. 24 Altri “mistri” seguirono, sulla scia della fortunata invenzione, come “mistro Pizin da le calde arost” e “mistro Bonetto che vende le lesse” (VIANELLO 2005: 144). Ma non tutti erano tedeschi, e se ne trova almento un esempio schiavonesco: nella raccolta del 1547 del Bindoni contentente Le canzonette de Mistro Rigo Forner Tedesco si trovano infatti, precisamente annunciate nel prosieguo del titolo, anche Le Stanze de un Medico Schiavon che se chiama mistro Damian (CORTELAZZO 1976: 180 n. 18). 23 8 Con riferimento alle parodie venete dei “todeschi”, vari studiosi hanno passato al vaglio le idiosincrasie nella pronuncia gergale dell’italiano. Vi si rileva, sul piano fonetico, l’assordimento di v in f, la chiusura di o in u, l’indebolimento -o > -e e altre alterazioni vocaliche in finale di parola; sul piano grammaticale e lessicale, invece, l’abuso dell’infinito, anche tronco; “mi” per “io”; “stare” per essere”; e qualche tedeschismo fra i lessemi più direttamente riferibili agli stereotipi del personaggio, come tanz, trinche, o vaine (ted. Wein) per “vino”25. Confrontandole con quelle stereotipate nelle parodie fiorentine, le idiosincrasie mediamente coincidono: il che, sia pure sotto il filtro di una codificazione tendente allo stereotipo, credo confermi il dato realistico sotteso alla parodia linguistica. Ancora una volta, la parodia della minoranza alloglotta si rivela come una miscela di realtà e pregiudizio. Allo stato attuale della documentazione, per sintetizzare quanto finora discusso, possiamo dire che la parodia del tedesco nasce nel contesto carnevalesco, quanto meno a Firenze, dove essa è documentata dal primo Cinquecento (o poco prima). Pur presente in varie commedie veneziane di Andrea Calmo, tali parodie allignano soprattutto nei contesti musicali e nelle forme cantate: anche di genere madrigalesco, come vedremo adesso. In questo ulteriore repertorio, colpisce il ritorno di stereotipie ormai note in espressioni o anche interi versi, che ricorrono in contesti distinti. Ad esempio i testi dedicati ai lanzi, sia nei carnascialeschi che fra gli autori di madrigali, sono spesso molto simili. Kirkendale ha evidenziato il fenomeno prendendo a campione i carnascialeschi del Giuggiola, dove si trovano i versi «Questi Lanze buon compagne» e «Mi star qui sì buon compagne», e l’analogo incipit in Mi star bon compagnon di Marenzio, conservato da Orazio Vecchi in un brano della Selva di varia ricreatione (Diversi linguaggi)26: Prima Parte Mi star bon compagnon mi trinchere co’l fiascon Mi piasere moscatelle Mi far garaus [uccide] di bon. Seconda Parte Mi folentier star fol [pieno] Mi far tutt’ in un tru[n]ch [“drunk”] Mi mangere bon platais Mi folere star contente Mi non esser minchion Mi star bon compagnon. A sua volta, l’incipit di Marenzio si ripresenterà cantato dai “todeschi” nelle Veglie di Siena di Vecchi e nella Barca di Venetia per Padova di Banchieri. Un caso particolare sta nell’approccio al tema da parte di Orlando di Lasso. Egli musicherà un testo identico a quello su Mistre Righe dei secondi anni Quaranta, ma in una versione molto più completa (a parte secondarie varianti morfologiche o ortografiche): Mi me chiamere Mistre Righe Che con le bucal vò inturne; De le donne mi son amighe Perché mittere pan’ in furne, Tutte nott’ e tutte zurne. Mi me piase magnar fighe [fichi]. 25 26 CORTELAZZO 1976: 177; KIRKENDALE 1972: 188. KIRKENDALE 1972: 187. 9 Mi me chiamere Mistre Righe. Quando vagh’ [le donne] a comandar, Se non è levad’ [lievitato] el pan, Preste mi face levar [lievitare], Quando mette le mie man; Malvasie e tribian Me dar poi per mie fatighe. Mi me chiamere Mistre Righe. Quand’ a cas’ el pan portar Le matonn’ [signore] e masserette [merciaie] Dise: «Care le mie fornar, Canter’ un poch’ un canzonette». E mi preste con pivette [piva, cornamusa] Un canzon sonar de dighe. Mi me chiamere Mistre Righe. Ma Lasso riprende, in Matona mia cara, anche il personaggio del Lanzo: «Matona mia cara, mi follere canzon, / Cantar sotto finestra, Lantze buon compagnon», con l’invito ad ascoltarlo e le immancabili promesse “metaforiche” - «Com’andar alle cazze [cacce], cazzar con le falcon, / Mi ti portar beccazze, grasse come rognon» - che si fanno ormai esplicite nell’ultimo distico: «Se mi ti foller bene mi non esser poltron, / Mi ficcar tutta notte, urtar come monton». L’espressione “bon compagnon”, la metafora sessuale del “monton”, la negazione di essere un “poltron” (che nel lessico familiare del Rinascimento sta per “vigliacco” o “buono a nulla”) sono tutte tipiche del genere. Tuttavia, in questa reinterpretazione del personaggio, si colgono anche note non convenzionali. Nella quarta strofa, ad esempio, spicca un ironico vezzo umanistico dell’autore del testo (che potrebbe essere anche lo stesso Lasso), laddove il personaggio si giustifica della prosaica ruvidezza con cui esprime le sue profferte: «Se mi non saper dire tante belle rason, / Petrarcha mi non saper, ne fonte d’Helicon». Inoltre, ogni distico è seguito dal ritornello «Don, don, don, diridiri, don, don, don», che si è visto associato al personaggio di Mistre Righe. I “todeschi” di Lasso sono dunque frutto di una consapevole contaminazione di due tipi: quello fiorentino del Lanzo, e quello veneziano del Maestro Arrigo. Se ciò non stupisce come scelta autorale, essendo ben note sia la passione di Lasso per parodie e generi minori della musica del suo tempo, sia la sua tendenza all’eclettismo, i suoi due “todeschi” appaiono come chiara testimonianza dell’evoluzione delle tradizioni originali, che nella seconda metà del Cinquecento si sviluppano autonomamente, arricchendosi di dettagli inediti. Ad esempio, sul piano linguistico, è notevole la canzone trasmessa nella stampa popolare intitolata La Galea da Valenza con una Canzon che chi non fa co faro mi hauera la tacha, anche per la sua data del 1549, a ridosso dei personaggi calmiani. Nel distico «Li todeschi non mi lassa / intertoph ala segura», Cortelazzo scorge due “prestiti auditivi” altrimenti inediti: in intertoph l’esclamazione “der Teufel!”, cioè “il diavolo…”; e più avanti loberlich, in cui risuona lo ioverlicche del ritornello nella carnascialesca Canzona di lanzi campani, e che probabilmente è il complimentoso löblich (in medio-alto tedesco) lobelîch, che sta per “laudabilis”27. Un estremo segno di evoluzione, e dunque di fortuna e vitalità, del personaggio. Per noi è rilevante che questa produzione parodistica sulle minoranze europee in Italia si esprima spesso e volentieri in forma di canzone. La documentazione suggerisce anzi sovente 27 CORTELAZZO 1976: 174 s. 10 come nel caso dei canti carnascialeschi fiorentini, per i Todeschi, e in vari altri casi che vedremo fra breve - che il personaggio e la sua “maschera linguistica”28 siano nati proprio in seno alla musica vocale. Nel contesto veneziano, negli anni Quaranta del Cinquecento, il Todesco risulta legato a una sua messa in scena in forma di canzone sia nel teatro di Andrea Calmo, sia nel circuito degli opuscoli popolari. E durante la seconda seconda metà del Cinquecento la diffusione “cantata” del personaggio del Todesco dimostrerà indiscutibilmente l’esistenza di una tradizione già molto solida. Troviamo infatti nella letteratura musicale molti altri riferimenti alle varie incarnazioni del nostro tipo, e li incontriamo nei generi più vari: in raccolte di villotte, in libri di liuto, perfino in descrizioni musicali di battaglie. Come i loro predecessori della prima metà del secolo, tutti questi Todeschi sono rimasti alle prese con alcolici o prostitute29: si vedano, per il bere, la villotta Trince got è malvasia (1566)30, e Mi stare pone Totesche, di cui parleremo qui di seguito; e per le donne di facili costumi Patrone, belle patrone di Ghirardo da Panico (nella prima raccolta di villotte di Filippo Azzaiolo, 1557), dove il florilegio di verbi già caratteristici dell’eloquio del Todesco (“dancere”, “spilere”, “springhere”, con il danzare e sbevazzare tipici del personaggio) si arricchisce degli altrettanto eloquenti “basere” e “minere”31. Tuttavia, come è dimostrato anche dai cimenti in materia di Lasso, in questa produzione più tarda non mancano gli elementi di novità e di perfezionamento. Restando alle peculiarità linguistiche, il testo forse più ricco di tedeschismi nel nostro corpus lo troviamo usato nel Libro di Cosimo Bottegari fiorentino: una raccolta di brani (la maggior parte dei quali in forma di villanella o canzonetta) per voce e liuto di un mercante e compositore che fu per circa cinque anni, a partire dal 1573, alla corte del Duca Alberto di Baviera (lavorando nella cappella guidata da proprio Orlando di Lasso) e poi, tornato a Firenze verso la fine del decennio, a quella del Granduca di Toscana Francesco I. Il pezzo Mi stare pone Totesche è notevole anche per lo sviluppo del tema alimentare. Qui il “totesche” spiega precisamente quali siano - oltre all’amata malvasia - le sue preferenze culinarie: Trinche coraus bon compagnon! Mi mancerò tante le suppe, bon plat ais chinche di craut, hobren, muesse, stochfish auch. Questi quattro versi ricorrono concludendo (con un’unica variante) tutte e quattro le sestine del componimento. Data la conoscenza del tedesco sicuramente acquisita in Baviera, non si può escludere che il testo sia stato elaborato dallo stesso Bottegari, che avrebbe approfittato della sua confidenza con lingua e costumi locali presso il Duca Alberto. Ma la melica risulta notevole anche per gli altri versi. Se non si manca di ricordare la ben nota passione per il canto e la danza del personaggio («Mi springhere, salter’ un danzen / mi cantare belle canzon!»), questi però, per una volta, rifiuta l’amore delle donne, spaventato dal rischio di contrarre il “mal francese”. Anche l’incipit «Mi stare pone totesche / Et fare sempre rason» si distacca dal solito standard. Sempre arricchendosi di sviluppi dei temi consueti, i lanzi entrarono come personaggi di mascherate e protagonisti di canzoni perfino fuori dall’Italia. Non stupisce che ciò si verifichi in un ennesimo contesto carnevalesco, peraltro non distante da quello veneziano. Nella Repubblica di Dubrovnik e nel resto della Dalmazia si tenevano infatti, nel periodo di 28 Adotto qui un’acuta definizione di ----------------------------------KIRKENDALE 1972: 187 e n. 25. 30 In Villotte alla Napolitana a tre voci, con una todescha, non più stampate (Scotto, Venezia, 1566). 31 VATIELLI 1921: 639 s., che trova espressivo il «ritmo energico e brioso» e interessante «il lato armonico per indovinate, e in componimenti così fatti non solite, modulazioni, e per la caratteristica cadenza finale sulla dominante». 29 11 carnevale, mascherate e altri spettacoli pubblici, nei quali si intonavano canti carnevaleschi in lingua croata32. Ed esiste una mascherata in lingua croata di Vetranović, Laci Alemani, trumbetari i pifari, dove i lanzi ripropongono la loro perizia musicale sugli strumenti a fiato, e l’offerta di insegnarne l’arte ai cittadini locali (qui i ragusei, concittadini dell’autore), accontentandosi di essere ricompensati con un semplice, amichevole brindisi. Eccone la traduzione: Siam venuti in questa terra sappiatelo bene ora per insegnare a’ Ragusei a soffiare nelle trombe. Siamo lanzi, trombettieri gran maestri, sappiatelo che suoniamo i pifferi senza chiedere la paga ma suoniamo per amore non vogliamo da voi la paga ma brindar con voi vogliamo dopo la nostra pimfarata33. Ma esistevano anche altre alternative alla caratterizzazione da lanzichenecco o da maestro artigiano: ad esempio, i personaggi di teutonici che frequentavano le università di Bologna e Padova. Esiste un dialogo anonimo del 1567 tra uno di questi personaggi e uno Zanni34, il servitore nella Commedia dell’arte, popolare anche nell’arte di strada per i suoi battibecchi con il Magnifico, anziano e ricco veneziano - qui eccezionalmente sostituito da un Todesco. Eventualmente, e come già fra i canti carnascialeschi fiorentini, il personaggio teutonico poteva anche essere declinato al femminile: in una “villotta alla napoletana” del senese Pompilio Venturi, Andand’ un giorn’ a spasso per Viena (1569), l’autore racconta un suo incontro con una tedesca che per strada gli chiese di offrirle del vino: «Et io ch’era Italian non l’intendia / Vuelsch capon, e sempre mi dicia / Gib mir fluckx brodt un Vuoin un malzia [malvasia]»35. Durante l’ultimo scorcio del Cinquecento il personaggio-standard del Todesco dovette farsi più convenzionale e stereotipato, come si può osservare nel genere oggi definito “commedia madrigalesca”, e all’epoca detta “comedia harmonica” e simili. Tale genere opera infatti delle sintesi nel corpo delle diverse tradizioni, e le travasa nella tecnica dei “diversi linguaggi”, con vari personaggi che alternativamente o simultaneamente si esprimono ciascuno nella sua lingua o dialetto. Del Todesco, i due principali autori di commedie madrigelesche, Orazio Vecchi e Adriano Banchieri, recupereranno la passione per il canto, specie se occasione per brindare, o per celebrare l’agognata bevuta. Ma i versi intonati suonano ormai formulari, con rare varianti. Ad esempio, Kirkendale fa osservare che l’incipit sul tedesco “buon compagnone” usato da Marenzio (e che abbiamo già avuto occasione di considerare) sarà nuovamente sfruttato dallo Orazio Vecchi nelle Veglie di Siena (1604). Mentre una variante del secondo verso in Marenzio sarà inserita nel brano Venetiano e Thedesco, facente parte della Barca di 32 «I testi poetici e i documenti d’archivio conservati testimoniano che le mascherate, come peraltro la maggioranza delle altre forme musicali e sceniche (soprattutto se non venivano incluse nelle feste ecclesiastiche, liturgiche e paraliturgiche) avevano luogo prevalentemente in lingua croata» (STIPČEVIĆ 1993: 36). 33 STIPČEVIĆ 1993: 35 s. 34 KIRKENDALE 1972: 230. 35 CORTELAZZO 1976: 177 n. 13. 12 Venetia per Padova di Banchieri (1605). Annunziato dalla didascalia che lo presenta «con il fiasco»36, il “Thedesco”, nella parte del tenore, brinda così: Brindes iò iò iò iò iò iò Sgott mi trinc con el flascon Brindes iò iò iò verlich Sgott mi piaser el vin bon Brindes iò iò iò iò iò. All’osservazione di Kirkendale va aggiunto che il nostro personaggio compare, nella Barca, anche nel brano immediatamente precedente, Cinque cantori in diversi lenguaggi, che presenta i vari personaggi con le rispettive caratteristiche linguistiche, mettendo in bocca al “Tudesch” i seguenti versi: «Mi star Tudesch / mi canter un bassott / Mò prima foller far un trinc e sgott». Egli coinvolge in quest’invito tutti gli altri “cantori in diversi lenguaggi”, che gli rispondono in coro: «O buono o buono hor cinque siamo / Prima si bevi doppo cantiamo». E in effetti, nel brano successivo, dopo il brindisi cantato dal Tedesco tutti gli altri si uniscono alla bevuta. Questo insistito stereotipo del brindisi, che non trovammo nel contesto dei carnascialeschi fiorentini, non è esclusivo della parodia degli alloglotti germanofoni. Nel secondo Cinquecento esso si trova ad esempio anche nel contesto parodistico degli “stradiotti” balcanici (in questo caso albanesi), di cui ci occupiamo più avanti. Nella Barzeletta de quattro compagni Strathiotti de Albania, zuradi di andar per il mondo alla ventura capo di loro Manoli Blessi da Napoli di Romania (1570) si legge infatti: «Una prindes [brindisi] fo levao / Al cercassa da Manoli»37. D’altronde, la debolezza per il vino veniva attribuita non solo ai “Todeschi”, ma a tutti gli stranieri (e a vari marginali comuni), già in una composizione contenuta nelle Rime pescatorie del Calmo, una raccolta pubblicata nel 1553 che, come evidenziato nel titolo completo38, si componeva sia di forme poetiche in senso stretto che di poesia per madrigali e canzoni: «Possa perder el vin i Borgognoni, / I Francesi, i Todeschi, i Transilvani, / I zaffi, i bravi, con tutti i Schiavoni»39. L’anatema guadagna particolare enfasi in quanto pronunciato da un veneziano, che tradizionalmente di vino (e avvinazzati) dovrebbe essere esperto. Il mutare delle condizioni storiche e politiche, delle dinamiche fra gli stati europei, della circolazione (ora migratoria, ora aggressiva) degli stranieri in Italia, costituisce il limite posto alla sopravvivenza dei personaggi alloglotti nella letteratura popolare e nel teatro comico. La loro vita, certo per un maggiore conservativismo di fondo delle forme festive, sarà più lunga nel contesto carnevalesco. Ancora nel 1788 Goethe lo vedeva rappresentato nel Carnevale romano40. 1.2 Ebraiche ed “Hebrei” Differenze e distinzioni fra il contesto culturale fiorentino e quello veneziano si presentano anche rispetto alle parodie degli ebrei, anche se è nel primo che emerge il nuovo personaggio. 36 KIRKENDALE 1972: 189. Banchieri usò il personaggio comico del tedesco anche in chiave strettamente letteraria, nella sua raccolta di novelle Trastulli della villa (1617), in particolare nella Novella del Tedesco ubriacato e nella Novella del Tedesco insaziabile (KIRKENDALE 1972: 187 n. 22). 37 Cit. in CORTELAZZO 1976: 179 n. 17. 38 Le bizzarre, faconde, et ingeniose rime pescatorie, nelle quali si contengono sonetti, stanze, capitoli, madrigali, epitaphij, disperate, e canzoni. Et il commento di due sonetti del Petrarcha, in antiqua materna lingua per m. Andrea Calmo. 39 Cit. in CORTELAZZO 1976: 182 n. 21. 40 KIRKENDALE 1972: 187 n. 23. 13 Due carnascialeschi di fine Quattrocento gli sono dedicati: i testi sono entrambi di Giovambattista dell’Ottonaio, araldo della Signoria di Firenze e autore di oltre trenta testi di canti (fra i quali tre “canzone” dei lanzi). Nella Canzona de’ giudei gli ebrei si lamentano di essere stati espulsi da Firenze, mentre i fiorentini fanno i prestatori ad usura esattamente come loro; il canto è anche un’eulogia sul mestiere di prestatore, per il quale vengono elargiti vari consigli. La Canzona de’ giudei battezzati celebra invece i ritorno degli ebrei in città, dopo la conversione al cristianesimo. La musica della prima canzona è di Alessandro Coppini, organista e teologo fiorentino41; quella di Per non trovar di Giovanni Serragli. Come è tipico della poesia comica e satirica fiorentina (con l’autorevole eccezione di uno sferzante sonetto di Luigi Pulci dedicato a Napoli e al dialetto napoletano), i due prototipi “ebraici” carnascialeschi non mostrano alcun interesse a caratterizzare i personaggi attraverso un’imitazione del loro linguaggio; d’altronde essi non vengono neppure derisi, essendo la loro presenza - come dimostra la sequenza stessa delle due “canzone” - funzionale all’economia della città, a patto di rinunciare alla propria religione. Nel teatro del Cinquecento, invece, il personaggio del Giudeo - sempre di contorno, mai fra i principali - esordisce nella Cortegiana di Pietro Aretino, che lo riprenderà pochi anni dopo, più concisamente, nel Marescalco. Quest’ebreo dell’Aretino appare più vessato che deriso. Nella Cortegiana è un venditore ambulante, di ferri vecchi e abiti usati42, a cui rubano con l’inganno un saio: e il ladro lo befferà facendolo arrestare. Notiamo, tra i dettagli più significativi, che l’ambulante giudeo si dice fermissimo a non convertirsi mai al Cristianesimo (ma, ironia della sorte, si farà arrestare con il saio indosso). Altri dettagli in parte costituiscono dei cliché pregiudiziali - lo stereotipo antisemita del “crocefissore di Cristo” -, in parte offrono qualche contributo realistico e informativo, ad esempio alludendo al fatto che per strada gli ebrei, riconoscibili dal contrassegno rosso che portano in petto, vengono fatti oggetto di lanci di scorze e frutti da parte dei ragazzi. Osservo che le due commedie furono scritte l’una nel 1525 (La Cortegiana, composta a Roma e rimasta per alcuni anni inedita, fu poi rielaborata e pubblicata dall’autore a Venezia nel 1534) e l’altra fra il 1527 e il 1530: dunque, rispettivamente, poco prima di lasciare la città papalina e non molto dopo il trasferimento dell’autore da Mantova a Venezia. La dimensione del personaggio non è fiorentina e nulla ha a che fare coi carnascialeschi: si tratta di un modesto ambulante e non di un usuraio. L’azione è ambientata a Roma, e impressioni romane possono aver influito sul modo in cui l’ebreo viene trattato. Nel personaggio, comunque, è assente qualsiasi caratterizzazione sia locale che carnevalesca: salvo il ricordo, forse, della crudeltà con cui il Carnevale romano trattava i giudei43. Va anche considerato che il personaggio resterà quasi del tutto assente nella produzione letteraria e teatrale veneziana del primo Cinquecento. Quest’ebreo dell’Aretino non può dunque essere definito come un prototipo44, perché non ha nulla di “tipico”, non attinge a stereotipi caratteriali e nemmeno li introduce. Semmai, come possibile eco carnascialesca, la curiosità circa la sua posizione sociale sembra focalizzata sulla scarsa disponibilità a convertirsi al Cristianesimo, e dunque a integrarsi, neutralizzando la propria “diversità”. Per gran parte del Cinquecento, dunque, l’attenzione verso il personaggio dell’ebreo resterà molto limitata. Nel corso del Rinascimento avanzato la sua presenza più assidua emergerà non tanto nel contesto teatrale, quanto in quello musicale: in particolare in quel 41 Coppini è uno dei tre soli autori a noi noti della musica per i canti carnascialeschi, assieme a Heinrich Isaac (Canto delle dèe) e Bartolomeo Florentino (Canto di pastori bacchiatori di bassette) (GALLUCCI 1981: vii). Per il repertorio carnevalesco Coppini compose anche un Trionfo di diavoli, un Canto di uccellatori alle starne, e un interessante Canto di zingane (cioè “di zingare”). 42 Nel Marescalco si tratta invece di un venditore ambulante di gioielli e abbigliamento da donna, che bussa di casa in casa. 43 Per caratteristiche e contesti delle “giudiate” romane, v. infra in questo stesso paragrafo. 44 Come ha fatto, in modo discutibile, Klein affermando che il personaggio del Giudeo nell’Aretino va considerato come il «capostipite di tutti gli Ebrei da commedia che vennero appresso» (cit. in RE 1912: 384). 14 genere di parodia cantata che verrà detta “ebraica”. È questo corpus, abbastanza esteso (e, come vedremo, eterogeneo), a conservarci anche le prime occorrenze di parole ebraiche riadattate, espressioni di una parlata giudeo-italiana che nei repertori melici, letterari e teatrali costituiranno, nel tempo, un piccolo serbatoio di formule continuamente riutilizzate. Don Harrán ha identificato circa una dozzina di composizioni vocali che classifica omogeneamente come “ebraiche”, in una serie che lo studioso fa partire dai due citati canti carnascialeschi45. La sua sequenza si estende su un arco temporale di oltre un secolo, arrivando fino ai primi decenni del Seicento, e le dodici canzoni appartengono ad almeno otto compositori diversi. A dispetto di come le presenta Harrán, esse non sono affatto omogenee, e la loro sequenza storica e cronologica presenta troppe soluzioni di continuità. Dopo i due precedenti carnascialeschi, infatti, il tema subisce un’eclisse di circa mezzo secolo: sarà ripreso solo negli anni Quaranta del Cinquecento, e in tutt’altro ambiente culturale. Il primo compositore di una “ebraica” non fiorentina è infatti il napoletano Giovan Domenico del Giovane da Nola, che pubblica Ecco la nimpha ebraica chiamata nel 1545, nel contesto stilistico della “canzona villanesca” a tre voci. Sul medesimo testo Orlando di Lasso, che pochi anni dopo sarebbe stato vicino al collega napoletano subendone varie influenze46, avrebbe composto la sua Ecco la nimph’Ebrayca chiamata, pubblicata nel 1581 in una raccolta che conteneva, per esplicita ammissione dell’autore, parecchie composizioni giovanili. Il testo critica una donna ebrea bruttissima e maligna, «faccie da ianara» (faccia da strega), «occhi de bove naserchia accorciata / boccha de sbecchia barba de cochiara», vittima ma anche autrice di prese in giro: «delleggia sempre et sempre è dellegiata». Il ritornello si basa sui verbi all’imperativo “lingnite, pingnite, stringnite”, cioè “lusingate, spingete, stringete”47: termini che si possono riferire sia ad azioni magiche, “da ianara”, sia a indesiderate pressioni di tipo erotico. Siamo dunque lontanissimi dallo stereotipo del mercante o dell’usuraio ebreo, e vicini semmai al filone già tardomedievale del vituperium. Non c’è alcuna continuità né con i personaggi del Carnevale fiorentino, né con quelli dell’Aretino. Tuttavia, appena un anno dopo l’ebraica di del Giovane, il personaggio ebraico ritorna nuovamente declinato “al femminile”. Nel 1546, infatti, Lodovico Novello pubblica la canzone Quattro hebbree madonne siamo nella sua raccolta di “mascherate” musicali. Si trattava di composizioni a quattro voci, per lo più strofiche48, che per definizione riconducono al contesto carnevalesco, come chiarisce sia il titolo completo della raccolta (Mascharate di Lodovico Novello di piu sorte et varii soggetti appropriati al carnevale novamente da lui composte et con diligentia stampate et corrette libro primo a quatro voci), sia la varietà dei suoi soggetti. La collezione raggruppa mascherate “da hebree”, “da mori”, “da nimphe”, “da rufiane”, “da scultori”, “da calzolari”, “da vendi saorine”, “da orefici”, “da maestri di ballar”, “da porta littere”, “da fabri”, con quell’alternanza di tipi etnici e mestieri che già conosciamo dalla tradizione carnascialesca fiorentina, e i medesimi doppi sensi licenziosi49. D’altronde, la fisionomia culturale di Novello - pur essendo l’unico autore veneto nell’intero corpus delle “ebraiche” - tende notevolmente verso il modello fiorentino. Veneziano (di casa anche a 45 HARRÁN 1989: 118 n. 60; HARRÁN 2009: 428 s., n. 6. Secondo Galanti, che riassume opinioni musicologicamente consolidate fino al secondo dopoguerra, Lasso «durante un suo soggiorno napoletano [1549-51] aveva avuto modo di conoscere e di apprezzare l’opera di Giovanni Domenico da Nola, mettendone a profitto non pochi elementi melodici» (GALANTI 1954: xxv). In realtà non esistono documenti utili a rintracciare la presenza di da Nola a Napoli tra il 1547 e il 1563: Donna Cardamone ritiene che probabilmente fosse fuggito a Roma per ragioni politiche (CARDAMONE 1999: 88), e proprio a Roma, in un cenacolo di napoletani esuli, avrebbe potuto esercitare la sua influenza stilistica su Lasso. 47 CARDAMONE 1999: liii s. 48 Dalla dedica: «Di queste come V.S. potra vedere tutte le stanze che seguiranno la prima si cantano sopra le noti di essa prima ne qui alcuno potra pigliare errore per che altro canto non ci e che de una sola stanza per ciaschaduna imascherata salvo che di tre, quali sono questi: i gioiellieri, gli fabri, & i Ballarini. di queste tre l'ultima stanza di ogniuna ha un Canto per se & tutte le altre si cantano come la prima, come si comprendera chiarissimamente V.S. le accetta con lieto animo & mi comandi» (cit. in FELDMAN 1995: 58 n. 24). 49 FELDMAN 1995: 59. 46 15 Padova), dottore in filosofia e medicina, aduso a condividere incontri di poesia, polifonia e ballo con illustri colleghi (frequentò il Tasso, il Ruscelli, il Dolce, l’Atanagi)50, Novello fu infatti poeta “toscano” per scelte stilistiche e linguistiche, autore di sonetti ma anche di una “canzona”, indirizzata Contra l’eresia: è plausibile che nelle sue mascharate abbia tenuto presenti i canti carnascialeschi. Questo elemento di continuità, che fa seguito a uno di rottura (il genere femminile anziché maschile), segnala la perdurante indeterminatezza negli stadi iniziali della parodia degli ebrei. L’unica costante sta nel fatto che tutti gli autori fin qui considerati - dell’Ottonaio, del Giovane, Lasso, Novello - hanno praticato espressioni di tipo carnevalesco. Ciò contraddice definitivamente un’opinione spesso reiterata, a partire da Enrico Re, che [pur consapevole dei precedenti letterari due-trecenteschi] riteneva che il personaggio dell’ebreo fosse stato creato soprattutto «dai comici di corte e di piazza»51. Opinone ribadita anche recentemente da Erica Baricci, la quale ha sostenuto che i principali testi contenenti queste parodie - del tardo Cinquecento, come l’Amfiparnaso e il Ragionamento tra due Hebrei - si rifarebbero a un «sostrato […] da ricercare, fondamentalmente, nelle piazze dell’epoca, dove saltimbanchi e attori cantavano e interpretavano scenette “all’improvviso”»52. In mancanza di documenti di data più alta, dobbiamo invece rilevare il comune approccio carnevalesco alla parodia mostrato da tutti i primi autori di composizioni musicali con personaggi ebrei nel ruolo di protagonisti. Musicalmente, invece, la varietà di forme e stili impiegati resta piuttosto ampia: dalle ballate alle villanelle, passando - con Ghirardo da Panico, come vedremo fra breve - anche dalle villotte. Tutti questi generi, comunque, hanno un timbro popolaresco e condividono alcune caratteristiche della frottola53, per la prevalenza del cantus sulle altre voci, per l’accompagnamento prevalentemente omoritmico, per lo stile sillabico, e - aggiungiamo pure - per una certa sostanza scenica o pseudoteatrale proposta dall’insieme di testo e musica. Ma non si può dire che esista, fino a questo momento, una vera e propria “ebraica”, sia per l’assenza di caratteri linguistici specifici dei personaggi, sia per la loro dimensione eterogenea, essendo declinati ora al maschile ora al femminile: e anzi, all’inizio di questa produzione, sono soprattutto le donne ebree (quelle di del Giovane e Lasso, e quelle di Novello) che che per varie ragioni - sia estetiche che morali - possono essere oggetto di dileggio, forse anche di disprezzo. Nel complesso, fino alla metà del Cinquecento, il personaggio del giudeo resta dunque estremamente ondivago. Solo nella successiva occorrenza “ebraica”, che cade oltre vent’anni dopo la mascharata di Novello, sembra cominciare a formarsi un canone. Siamo ormai negli anni Sessanta del secolo, e solo adesso l’intestazione della partitura definisce la composizione come una “ebraica”. Si tratta di Adonai con voi, lieta brigada del bolognese Ghirardo da Panico, pubblicata in Il terzo libro delle villotte alla padoana a quattro voci, curato da Filippo Azzaiolo nel 1569. Nella villotta (di cui purtroppo sopravvivono solo le parti di tenore e di basso), troviamo una parodia di canto sinagogale: un tópos che nelle ebraiche verrà sfruttato anche in seguito. Con questa villotta ha inizio il filone della parodia linguistica italo-giudaica. Adonai con voi contiene infatti due termini giudeo-italiani particolarmente emblematici, “barucaba” (“benvenuto”) e “parachin” (“denaro”)54. Se il secondo sta per “denaro”, motivo ossessivo del pregiudizio antisemita, il primo definisce il sound dell’intero stereotipo linguistico. 50 Cfr. CICOGNA 1827: 577 s. RE 1912: 385. 52 BARICCI 2010: 142. 53 Ad esempio Einstein considera l’ebraica di Panico come una reminiscenza, per contenuto, delle vecchie frottole, e afferma che, per lo stile musicale, potrebbe aver avuto origine nei primi anni Quaranta del secolo (EINSTEIN 1949: 348). 54 BARICCI 2010: 139 n. 16. 51 16 L’espressione “barukh ha-ba” (che proviene dai Salmi, 118, 26), significa infatti “benvenuto”, ed è tipica sia della preghiera che della vita quotidiana degli ebrei. È la sua stessa frequenza nell’eloquio della comunità a caratterizzarla, per gli ascoltatori non ebrei, come un “suono” tipologico del giudaismo, e dunque come un contrassegno fonico di alterità etnica e culturale55. Questo modello di parodia linguistica sarà destinato ad affermarsi definitivamente nelle successive canzoni sugli ebrei: per le quali, comunque, dopo la pubblicazione dell’ebraica di Panico, bisognerà attendere ancora quasi trent’anni. Quasi tutte queste ultime “ebraiche” fanno parte di alcune commedie madrigalesche di Orazio Vecchi e Adriano Banchieri, apparse negli anni a cavallo fra Cinque e Seicento. Il termine “ebraica” comunque, dopo Ghirardo, non comparirà più: nella commedia madrigalesca i brani di questo genere portano a volte didascalie o sottotitoli come “mascherata di Hebrei”, “imitatione delli hebrei”, o “sinagoga di hebrei”. Definizioni estremamente significative, perché testimoniano in modo complementare il senso e la funzione del genere in questione nel carnevalesco (“mascherata”), nella parodia linguistica (“imitatione”), e nel potenziale scenico evocato dalla sua più frequente ambientazione (la sinagoga). Ma torniamo un momento ad Adonai con voi. Come si è detto, è l’intestazione della partitura a definire la composizione come una “ebraica” (suggerendo alla critica moderna la discutibile possibilità di estendere la definizione a tutto il corpus della musica vocale rinascimentale il cui testo parli di personaggi ebrei). Paul Nettl trovava significativo che il pezzo stesse, nella raccolta di Azzaiolo, tra una “Tedesca” (la citata Patrone, belle patrone) e una “Bergamasca”56. È lecito interpretare questo posizionamento come una conferma dell’attenzione, rivolta in questo caso dal curatore di una raccolta (a sua volta compositore), verso l’ampia varietà di spunti che poteva essere fornita da linguaggi (e forse, in certi casi, anche melodie o ritmi) di carattere locale, come già nel repertorio frottolistico, o di particolare estrazione etnica: ricordiamo, ad esempio, che il fiorentino Coppini aveva musicato canti parodistici sia di ebrei che di zingare. Vi troviamo conferma anche del segnale di una certa omogeneità di approccio sia verso dialetti e danze municipali italiani, sia a costumi e lingue delle minoranze presenti in Italia. Aggiungerei pure che la Bergamasca pubblicata da Azzaiolo è cronologicamente la seconda composizione a stampa a portare tale definizione, dopo l’omonimo saltarello pubblicato solo cinque anni prima da Giacomo Gorzanis nel suo terzo libro per il liuto. Nella sua terza raccolta, Azzaiolo antologizza dunque alcune curiose “novità”, ivi incluse due Napolitane di autori bolognesi, che a loro volta sono segno di una certa delocalizzazione (in crescita col tempo) degli spunti nati in chiave “municipale”. Vi compare anche una Mascharata (di Marc’Antonio Romano), a segnalare la costante presenza del carnevalesco in questi repertori “misti”, caratterizzati dall’attenzione verso le formule di sapore popolaresco o festivo, e soprattutto basate su “personaggi” che parlano o interagiscono seguendo un approccio ormai latamente “teatrale”. Anche nel caso delle “ebraiche” siamo dunque in grado di individuare un momento, poco oltre la metà del Cinquecento, in cui si nota una definizione migliore - e alquanto teatralizzata - delle canzoni dedicate a stranieri e minoranze. La definizione va nel senso di una più ampia caratterizzazione nel caso del “Todesco”, e di una prima formulazione etnicamente marcata (il contesto sinagogale, il pidgin italo-giudeo) nel caso dell’“Hebreo”57. Per la parodia giudaica, questa determinazione viene avviata nel contesto della musica vocale; trova una sua prima definizione - di genere, ambientazione, caratterizzazione linguistica - nel repertorio villottesco di fine anni Sessanta; ma ricomparirà in musica solo negli ultimissimi 55 Cfr. HARRÁN 2008: passim. NETTL 1931: 40. 57 Bisogna dunque anticipare l’imprecisa valutazione di Emilio Re, secondo il quale è «all’ultimo venticinquennio del secolo XVI che va ascritta press’a poco, non l’invenzione, ma la determinazione definitiva del tipo dell’Ebreo» (RE 1912: 388). 56 17 anni del Cinquecento. Se lo iato degli anni Settanta e Ottanta può sembrare difficile da superare, in assenza di fonti musicali “ufficiali”, è almeno possibile cercare di capire cosa avvenisse nella tradizione orale. Elena Baricci indica al riguardo la forma degli “intermedi” teatrali, scenette che si sviluppavano spesso come intermezzi all’interno di una commedia o di uno spettacolo diverso, «essenzialmente sketches indipendenti dalla trama principale»58, in gran voga nel teatro cinquecentesco e in particolare presso le corti dell’Italia centro-settentrionale. Sappiamo che questa forma, spettacolare anche per l’uso di improvvisazione e di apporti del repertorio buffonesco, si serviva di strumenti espressivi - e talvolta comici - basati sul canto e la danza. Fra quelli che Baricci chiama “intermezzi all’ebraica”, di cui si trovano scarse ma importanti testimonianze nella seconda metà del Cinquecento, la giovane studiosa indicava il Ragionamento fra due Hebrei firmato da “Zan Fritada et il figliuolo del Fortunato” e stampato a Pesaro nel 1588, benché la sua composizione si possa far risalire più o meno all’inizio del decennio59. Come buffone, Zan Fritada godette di ottima fama (lo ritroveremo ai primi del Seicento addirittura in Volpone di Ben Johnson): egli innestava i personaggi ebraici (di ascendenza carnevalesca e, più limitatamente, teatrale) nella tradizione orale di cui era, in quanto buffone, portatore privilegiato. Il Ragionamento tra due Hebrei propone una grande varietà di spunti. Il testo60 costituisce un dialogo tra un “Abraam” e uno “Scemuel”, che anticipa con molta evidenza spunti e situazioni sviluppate anni dopo nella commedia madrigalesca. I due personaggi, ad esempio, vengono colti nel momento in cui arriva alla loro bottega un “goim” (non ebreo, cristiano) recante un pegno per ottenere un prestito, come avverrà poi nell’Amfiparnaso di Orazio Vecchi (1597). Nel Ragionamento la parodia si incentra sulla pronuncia italiana dei personaggi - «chi causa volet», «chi causa von», «comincier ch’ades virrai» - e sul loro presunto carattere avido: «Ben venga lo goimme, / ben venga lo goimme». Il «Venite giò, venite giò» rivolto al cliente riecheggerà in Vecchi in un «Venit à bess, venit à bess», a evocare non senza malignità l’ambiente del ghetto con le sue botteghe di usurai sprofondate in bui seminterrati. Si allude perfino, fra i difetti pregiudizialmente attribuiti agli ebrei, a «quel che di più terribile gli addossava il sospetto popolare - il presunto rapimento e sacrifizio degli infanti»61, tema poi abbandonato dalle parodie teatrali di epoca successiva. E si riaffaccia pure la tematica amorosa, non estranea alla “mascharata” di Novello, unendosi a un invito al canto tutto profano, non legato alle attività sinagogali. Versi come «Volem canter, volem canter. / Cominciet ch’ades virraì, ch’ades virraì. / Barucabbà [benvenuta], stelluccia, barucabbà / barucabbà stelluccia, / ch’io t’amo e t’amerai; mordocì, mordocai»62 sembrano anche suggerire che il Ragionamento fosse in musica, e che la scenetta, come era d’uso negli intermezzi teatrali, si concludesse con un ballo dei vari personaggi. Nel Ragionamento viene inoltre anticipato il termine giudeo-italiano moscogn (pur storpiato in “maschion”), che diventerà tipico della scena del banco dei pegni. Anche per questo, l’intermedio buffonesco ci appare come un diretto precedente della parodia ebraica dell’Amfiparnaso. Il conio moscogn sta per l’ebraico moshken, forma volgare di mashkin, “promessa”; ma nell’Amfiparnaso compare anche parachem, probabilmente dalla radice prq, che si riferisce allo scambiare o al riscattare denari o pegni63. Tutte parole «che a un orecchio esterno al ghetto dovevano apparire usuali, concernendo per lo più il mestiere di prestatori. A 58 BARICCI 2010: 138. Zan Fritada è infatti ricordato da Tommaso Garzoni nella Piazza universale, la cui prima edizione è del 1585, e alcuni retrodatano il Ragionamento fino ai primi anni Ottanta (RE 1912: 386; BARICCI 2010: 138). 60 Cit. in BARICCI 2010: 142. 61 RE 1912: 388. 62 Cit. in BARICCI 2010: 138 s. 63 DENT 1911: 343. 59 18 queste si affiancano tuttavia rozze imitazioni e non meno tipiche deformazioni (badanai, merdochai)», e precedentemente nella scena compaiono anche «momenti di mera parodia linguistica, con finte parole che di ebraico hanno solo il suono»64. Il termine «Badanai», nel contesto antiebraico, ha una lunga storia. È un modo biblico per rivolgersi ad Adonai, il Signore; vocativamente starebbe per “signor mio”; ed esiste come nome proprio. Ma in bolognese sta per un pezzo di ciarpame, un vecchio arnese di poco conto; un “pover badanai” sarebbe un povero diavolo65. In questo senso, anche il nome proprio suona umoristico nella satira: così lo usa il bolognese Giulio Cesare Croce in un componimento in versi che vedremo più avanti, e Vecchi lo utilizza come tale nel brano Tich tach toch (atto III, scena 3) dell’Amfiparnaso; mentre Banchieri lo fa indirizzare spregiativamente, alla bolognese, dal personaggio di Burattino verso l’ebreo “Mistro Bortol’ dai ochiai”, che Pantalone vuole invitare al matrimonio della figlia, nel Ragionamento primo della Parte Seconda della Pazzia senile. In generale, il termine può indicare tutti gli ebrei come “razza”: in tal senso lo troviamo ancora nella terzina finale di un sonetto romanesco del Belli del 1833, significativamente intitolato L’inferno: «Gesù mio battezzato e circonciso, / Arberghece li turchi e badanai, / E a noi dacce l’alloggio in paradiso». E proprio a Roma dobbiamo venire adesso, a quelle giudiate che appartengono al contesto del Carnevale romano. Anche qui troviamo infatti una versione parodistica del linguaggio giudeo-italiano, sempre nel formato della “canzone teatralizzata”, e per giunta nella stessa epoca della commedia madrigalesca, ma per ragioni diverse e del tutto indipendenti. Anche perché le parodie romane dell’ebreo non furono affatto bonarie come erano state, e sarebbero state anche in seguito, quelle fiorentine, bolognesi e veneziane. Ciò dimostra che il senso della parodia giudaica dovrebbe essere considerato localmente, alla luce dei contesti e anche dei precedenti specifici. In effetti, prima ancora che in effige, e molto prima delle “giudiate”, gli ebrei erano entrati nel Carnevale romano di persona, partecipando a un indegno palio. Nel 1466 papa Paolo II - che era veneziano - aveva spostato il Carnevale, di cui era grande appassionato e sostenitore, da Testaccio a via Lata (oggi via del Corso), istituendovi la selvaggia corsa equestre detta dei “barberi”, cioè dei cavalli arabi, lanciati al galoppo senza fantino: l’evento più atteso della settimana di festeggiamenti. Alla vigilia si teneva però un’altra corsa che anticipava parodisticamente il palio dell’indomani: correvano asini e bufali, ma anche esseri umani, in tre categorie: i “garzoni” (cioè i giovani), i vecchi, e le cosiddette “bestie bipede”, ovvero gli ebrei. Detta anche “Palio de Judei”, la loro corsa era ancora viva nel Carnevale romano di fine Cinquecento. Fin qui, si trattava di un’umiliazione contenuta e condivisa, oltre che volontariamente subìta66. Ma l’atteggiamento verso gli ebrei, sul Tevere, era destinato a peggiorare. Una famosa bolla di Paolo IV del 14 luglio 1555, Cum nimis absurdum, impose la chiusura del ghetto e riportò in vigore molte aspre prescrizioni contro gli ebrei67. S’inasprì anche il loro palio. Michel Montaigne, che vi assisté nel 1581, ci documenta che nel frattempo tutte le varie categorie di “bipedi” erano costrette a correre nude. Due anni dopo, nel 1583, un’altra cronaca riferisce che «la plebe romana sfidava i tratti di corda comminati dai Bandi pur di levarsi il gusto di tirare fango, sassi e legnate sugli ebrei che correvano il palio»68. La corsa fu abolita solo nel 1668 da Clemente IX, tra le proteste dei romani, che amavano accanirvisi. 64 BARICCI 2010: 141 s. ROUCH 2006: 182 n. 168. 66 Secondo lo storico ottocentesco Agostino Ademollo, dalle cronache del tempo «non appare alcun indizio di atti di scherno o di barbarie usati contro gli ebrei nelle corse del carnevale romano al principio del secolo decimosesto» (ADEMOLLO 1883: 5 s.). 67 RE 1912: 395 n. 2. 68 ADEMOLLO 1883: 10. 65 19 Ma nel frattempo, fin dall’inizio del Seicento (o al più presto dalla fine del Cinquecento)69, nel Carnevale romano era stata introdotta la “giudiata” carnevalesca, scenetta cantata e recitata da attori. Non se ne conosce bene il contesto né lo svolgimento. Si sa però che l’odio antisemita che vi era sotteso trovava una giustificazione religiosa e confessionale: «gli attori che vi prendevano parte pensavano […] che l’eseguirla dovesse fruttare per la salute dell’anima: dell’anima propria e di quella degli spettatori»70. I riferimenti ci vengono forniti da un’opera in sei volumi di Moraldi, un bibliofilo del Seicento, nella ripresa che ne fece il Crescimbeni nei Commentarj della volgar poesia: «molto più delle zingaresche s’assomigliano alle farse quelle popolari rappresentazioni che soglion fare nel carnovale i Rioni di Roma sopra carri tirati da buoi, le quali si chiamano giudiate, perciocchè in esse non si tratta d’altro che di contraffare e schernire gli Ebrei in istranissime guise, ora impiccandone per la gola, ora strangolandone ed ora scempiandone e facendone ogn’altro più miserabil giuoco»71. Si simulavano, insomma, tormenti d’ogni tipo rivolti dai romani verso gli odiati “crocefissori di Cristo”. In queste giudiate, ambientate nella “schola del ghetto”, i personaggi subivano le peggiori vessazioni. Volta per volta li si vedeva frustati, appiccati, arsi vivi, come si può desumere dai titoli che ci restano: titoli destinati ad essere complicemente rievocati nel periodico fascista «La difesa della razza», come è stato recentemente ricordato72. A volte il tono della contumelia e della violenza, sia pure solo scenica, trascendeva talmente che doveva intervenire la forza pubblica73. Ma anche queste piccole e ignobili farse carnevalesche si compiacevano di restituire il pidgin giudìo e le deformazioni ebraiche dell’italiano messe in musica e cantate, come rammentava ancora Crescimbeni parafrasando Moraldo: esse erano «composte di ogni sorta di versi e versetti tagliati tutti col roncio e d’ogni sorta di linguaggi corrotti e storpiati e mescolati insieme; né ànno altro ordine che di condursi con lunghissima cantilena di molti sciocchi personaggi allo spettacolo della burla che si fa al supposto Ebreo; né altro ornamento che di rami di lauri e d’altra [sic] fronde disposti per lo carro. Elleno si cantano anch’esse e in varie maniere, tutte particolari del volgo, e coll’accompagnamento di tali suoni che non sono sconvenevoli a tutto il resto; e pure allorchè si fanno, o giorno o notte che sia, infinito popolo si tirano appresso e con estremo godimento e riso s’ascoltano»74. Del tutto innocenti sono, al confronto le presenze ebraiche sia nella commedia madrigalesca che nella Commedia dell’arte: presenze da mettere in stretta relazione le une con le altre. La commedia madrigalesca di fine Cinquecento è infatti un prezioso deposito di temi del coevo teatro dell’arte, altrimenti documentati solo dal secondo decennio del Seicento, quando Flaminio Scala cominciò a pubblicarne gli scenari: cioè i canovacci sintetici, privi dei dialoghi che venivano sviluppati estemporaneamente sulla scena. Un tipico tema ebraico della 69 La “giudiata” di tradizione romana, «come azione determinata, non va certo più indietro della fine del sec. XVI» (RE 1912: 394 n. 1). 70 RE 1912: 393. 71 Cit. in RE 1912: 393 s., n. 1. 72 PERRELLI 2004: 55. I titoli sono La zingara giudia arsa viva, L’Aquilano finto ebreo appiccato, Le sue rosette simili con Ragnetto schernito et il giudio frustato. 73 Una testimonianza contenuta nel verbale di un processo tenuto a Roma nel 1666 contro l’organizzatore di un carro di giudiata parla del «recitare una comedia sopra un carro»: «fu recitata per Roma una comedia de Hebrei». Sul carro, «tirato da bovi», c’era una scena costruita da un falegname e dipinta da un indoratore, raffigurante «quattro porte due aperte e due serrate», cioè «quattro case et quattro fenestre et prospettiva di dietro»; a rappresentare «la schola del ghetto [più avanti «il tempio dell’Hebrei, dico meglio la scola dell’Hebrei»] et è tutta con colori gialli, rossi, bianchi et anco turchini». Il testimone ha visto la commedia «più volte in detto carnovale sopra il carro». Il “caporale” del carro, tal Francesco Palmieri, viene arrestato perché «se recitasse in detta comedia cosa indecente contro detti Hebrei»: al momento dell’arresto, egli e altri «recitavano in detta comedia che fu l’ottava del primo sabbato di carnevale» (cit. in RE 1912: 397 s.). La “giudiata” di tradizione romana comincerà a decadere durante la seconda metà del Seicento, contemporaneamente all’abolizione delle corse degli Ebrei da parte di Clemente IX (RE 1912: 395). 74 Cit. in RE 1912: 394 n. 1; corsivi miei. 20 Commedia all’improvviso, il cosiddetto “lazzo della circoncisione”, viene appunto anticipato da Adriano Banchieri in una composizione facente parte dell’Hora prima di recreazione (dalla raccolta di Canzonette a tre voci del 1597), Samuel Samuel (Mascherata di Hebrei). La canzonetta nomina esplicitamente coltello e catino, strumenti chirurgici dell’operazione: «Samuel, Samuel / vu che avite lo cortel / E venuto lo badanai. / Mordochi, mordochai, / E venuto lo badanai. // Beniamin, Beniamin, / Vu che havite lo catin…»75. Nel teatro dell’arte la scena ribalta la prospettiva della conversione (opzione quasi forzata per qualunque ebreo vivente in Italia, come ricordavano anche i canti carnascialeschi) in un paradosso comico: qui è un cristiano a doversi accostare alla religione ebraica, per ragioni puramente utilitaristiche (ad esempio per ottenere un prestito o favorire una transazione economica), con tutte le ansie connesse agli aspetti chirurgici della questione. Una scena di questo tipo la troveremo nello scenario di La mula, nel secondo volume della raccolta manoscritta di Basilio Locatelli (1622), alla fine dell’atto I; un’altra, forse non dopo il primo terzo del Seicento, e sempre alla fine del primo atto (scena decima), nello scenario di Il finto principe76. Ma nella commedia madrigalesca le concitate scenette trovano una sonora via musicale, adatta ad esprimere il sound di altre situazioni tipiche, come il litigio o la baruffa, o anche semplicemente il sapore fonico dell’eloquio giudeo-italiano. La trasposizione musicale è tanto più interessante in quanto sa rendere polifonicamente un “personaggio collettivo”, un coro di ebrei - al plurale - che si differenzia dalla semplice “maschera”, non trovando posto sulle scene strettamente teatrali, e ribadendo l’originario legame con le culture carnevalesche, dove i “tipi” regionali o stranieri venivano appunto rappresentati come gruppi, anziché come individui. Nella scena “all’ebraica” dell’Amfiparnaso (atto III, scena 3), Tich tach toch, Francatrippa si reca al banco dei pegni, ma per sbaglio entra prima in sinagoga, dove ascoltiamo un pastiche di nomi propri, tutti allusivi o distorti (Baruchai, Badanai, Merdochai), e termini ebraici comunissimi (ghet, Baruchabà, etc.), e dove l’inizio della linea melodica porta una chiara imitazione delle fioriture melismatiche del canto sinagogale; qualcosa del genere si riascolta all’ingresso nel banco dei pegni, su termini ebraici che simulano un tema penitenziale. Qui i prestatori ad usura si esprimono in una «Babelle […] di voci e horribili favelle» che investe il personaggio di Francatrippa, servo di Pantalone, recatosi al ghetto a «porr’un pegno». Ne segue uno scambio tra lui e un coro di “Hebrei”, che prima gli domandano «che cheusa volit, / che cheusa dicit?», e poi, udita la richiesta del prestito: O Samuel Samuel Venit à bess, venit à bess Adanali che l’è Goi [cristiano] Chìè venut con lo moscogn Che vuol lo parachem L’è sabbà [sabato] cha no podem. È una piccola sintesi dei più stereotipati motivi ebraici: il proprietario della bottega di pegni si chiama Samuel, il “Goi” (cristiano) porta moscogn per averne in cambio parachem ma, ahimè, gli ebrei di sabato non lavorano, e dunque niente da fare per il prestito. Su questo stesso tema del banco dei pegni Vecchi ritornerà nel 1694 nelle Veglie di Siena, con il brano Corrit! corrit! Messer Aron. Contemporaneamente all’Amfiparnaso, Adriano Banchieri pubblica - sulla medesima falsariga - Samuel, Samuel. Mascherata di Hebrei (dalla sua raccolta di Canzonette a tre voci, 1597). E sul genere dell’ebraica Banchieri tornerà altre due volte, ma spostandosi sulla 75 76 Cit. in BARICCI 2010: 153. BARICCI 2010: 149 s. 21 parodia dell’ambiente sinagogale. La prima è Tic tac tic toc, o Hebreorum gentibus (nello Studio dilettevole, 1600), con la parodia del canto sinagogale a bordoni e note lunghe, ma alquanto bizzarra è anche Latrai nai nai, scena della Barca di Venetia per Padova (1605). In didascalia, sotto il titolo di Mercante Bresciano et Hebrei, la scena viene così descritta dall’autore: «Nel tragettar a Dolo (ò dolce spasso) / Fan sinagoga istanza un Bresciano / Bethel e Samuel con gran fracasso». In altri termini, pur avendo ambientato la commedia sul traghetto Venezia-Padova, Banchieri vi trascina di pesa una tipica parodia di sinagoga, ad emblema del proverbiale fracasso degli ebrei, quasi un “latrare” - nella percezione di chi tale non è - quando si riuniscono a pregare: La trai nai nai nai nai nai nai nai nai na Sté su a sentì ol noster Samuell Che vol far sinagoga con Bethel La trai nai nai nai nai nai nai nai nai na Oth zorocot Ballacort Assach mustac Oga magoga hò hò hò hò calla mallacott la baruccabà La sinagoga la sinagoga La trai nai nai nai nai nai nai nai nai na. Il tema sinagogale in musica si esaurirà con la pubblicazione tedesca Musikalischer Zeitvertreiber (1609), dove compare una composizione Barachim e za chai, definita Judenschul (cioè, ancora una volta, “sinagoga”), di autore sconosciuto (ma forse italiano), e di cui ci resta solo una delle sei voci77. Ma un ulteriore motivo ricorrente nelle parodie ebraiche sta nella tipica scena di baruffa dove la confusione viene «spesso provocata dal trafugamento e dall’uccisione di un’oca»78. Il tema emerge nelle Veglie di Siena di Orazio Vecchi: «Corrit! Corrit! Messer Aron, / che gli Goi che gli Goi / hanno ucciso lo Peper e ’l nostro Ochon / Badanai se l’ha traffughet, / assagatet, / se l’hanno pelet!»79. Lo stesso motivo ricorrerà più volte anche nell’opera di Giulio Cesare Croce (1550-1609), uno dei più famosi cantimbanchi italiani, capace di destreggiarsi fra la comunicazione orale e quella scritta, con moltissime operine pubblicate nell’editoria popolare dell’epoca. Ancora una volta, come già nel Ragionamento di Zan Fritada, il contesto degli intrattenitori di piazza fornisce una significativa intermediazione culturale tra generi che stanno a metà strada fra la canzone carnevalesca e il testo musicale. Ma Croce rappresentava uno stadio più avanzato di questa condizione, perché era amico e consulente di Vecchi80. Si veda soprattutto la canzonetta Risa [rissa] tremenda fra Mardochai e Badanai Con il Festino, colatione, e Musica fatta da loro in segno di pace. Opera piacevole, e da ridere, stampata in appendice a La scatola istoriata (la cui probabile prima edizione è del 1605), ma pubblicata anche sciolta81. Tra i difetti attribuiti agli ebrei, la canzonetta di Croce «ne colpisce la litigiosità rumorosa»82: 77 HARRÁN 2009: 428 s., n. 6. BARICCI 2010: 154. 79 Cit. in BARICCI 2010: 155. 78 80 81 Queste le notizie nel catalogo integrale dell’opera di Croce redatto da Olindo Guerrini (GUERRINI 1879: 461 s., 472). DENT 1911: 342 sostiene invece che la Risa fu pubblicata per la prima volta nel 1608 (un anno prima della morte dell’autore), e poi come «intermezzo» (?) di La scatola istoriata, che erroneamente considera pubblicata postuma, nel 1636. In realtà La scatola istoriata non è un lavoro teatrale ma una canzonetta di 33 quartine di settenari sdruccioli (GUERRINI 1879: 471), e la Risa conta da sola oltre cento versi. 82 RE 1912: 388. Croce sfrutterà lo stesso motivo anche in un’altra sua scenetta, la Scaramuccia grandissima occorsa nuovamente nella città d’Ancona fra due ebrei per un’oca, utilizzando peraltro lo stesso ristretto lessico giudeo-italiano (BARICCI 2010: 154). 22 MAR. Badanai, Badanai. BAD. Che dicit Mardocai? MAR. Son con vu molt instizzit [stizzito]. BAD. Perché cheusa? perché cheusa? MAR. Vu m’havit rubet lo Peper [papera, oca], E l’havit assagatet [uccisa, macellata]. […] Me l’ha dit Messer Aron, Che l’havit accaponet83. Da persone pregiudizialmente sospettate di atroci crimini contro i cristiani, o quanto meno detestate per il loro mestiere di usurai, e apertamente dileggiate e aggredite a Roma anche in occasioni pubbliche, gli ebrei di canzonette e madrigali leggeri diventeranno così semplicemente “gente che litiga e fa chiasso”, incline alla baruffa, e che s’esprime in una lingua buffa. Così è anche nella Commedia dell’arte: in Lo schiavetto, di Giovan Battista Andreini (1612), il motivo viene riproposto nella forma di un’azzuffata di mercanti ebrei e servitori84. Ne troviamo una variante, caratterizzata da sequenze di contumelie e maledizioni particolarmente colorite, nel contesto della “commedia ridicolosa” romana, che mutua vari temi dalla Commedia dell’arte, ma col copione interamente steso. Qui, come usuale a Roma, i toni sono più aspri. Nell’Est Locanda di Silvano Floridi (1648) «Sciabadai, fratello di Sciafoch, mercante di pelle di bufali, […] è introdotto a fare l’usuraio a spese di un dissipatore battezzato, Bellodoro. È notevole una scena (I, 4) in cui il Norcino Quacqua [tipico personaggio romanesco] fa a Sciabadai una lunga predica morale sull’avidità degli Israeliti che egli paragona ai rospi; Sciabadai fa le viste di non capire e risponde come se parlasse d’altro; allora Quacqua, da buon cattolico, si adonta e minaccia l’Ebreo di tutte le pene dell’inferno; a questo punto anche Sciabadai si inquieta e lasciato il suo solito linguaggio teatrale con le desinenze in i, e [sic] furibondo esce in questa sfuriata: “Kea nibhar schiechar pam hanusch nash, chilim hinneh el zeh et sbaugh ot daiim” la quale è tradotta dall’autore in: vecchio matto briaco sozzo ecc. Il povero Sciabadai, come si capisce, è bastonato, e la commedia assume anche un vago aspetto di protesta cattolica contro gli infedeli: il che poteva essere di buon gusto nella Roma Papale»85. Nei successivi decenni del Seicento i personaggi teatrali ebraici non si estinguono, pur ripetendo scene già viste. Nell’àmbito della Commedia dell’arte, uno scenario della raccolta veneta del Museo Correr è intitolato Le nozze degli Ebrei, anche se il titolo è giustificato solo da un’esile burla, mentre la trama non fa che ricalcare la vicenda dei Menecmi plautini, sfruttatissimi nel teatro rinascimentale. A fine Seicento un altro autore veneto, Giovanni Bonicelli (alias Bonvicin Gioannelli), scrive la “comedietta” Il Pantalone Bullo overo la pusillanimità coperta (1693), dove le scene 13-16 riprendono il vecchio spunto ebraico dell’Amfiparnaso: «Pantalone, in cambio di Francatrippa, che va in Ghetto per aver danari e pretende una somma eccessiva di alcune “strazze” [stracci, stoffe] che offre in vendita a Bedan[n]a e Menacai»86. Anche le “espressioni tipiche” ebraiche sono ridotte ormai a una ristretta selezione di quelle codificate nel teatro e nella musica del secolo precedente87. Sarà 83 Come la parodia ebraica dell’Amfiparnaso, questa di Croce contiene le parole moscogn, “promessa”, e parachem, “pegno” (DENT 1911: 343). Assagatet si rifà a shachat, cioè “macellare secondo il rito” (BARICCI 2010: 155). 84 BARICCI 2010: 157. Qualcosa del genere si trova anche nel tradizionale spettacolo di burattini Gran bataja d’jabrei d’Moncalv, dove si legge «Giù macot [botte] propia da fol» (BARICCI 2010: 158). 85 CAPRIN 1907: 215. Tra le altre occorrenze caratteristiche, Enrico Re ricorda una scena simile anche nell’Intermezzo dell’oca (RE 1912: 392). 86 RE 1912: 389. 87 BARICCI 2010: 144 n. 32. 23 infine Goldoni, nel Settecento, ad archiviare il genere nelle sue estreme propaggini venete, in due ulteriori scene del banco dei pegni, che almeno, con significativa memoria della loro origine, sono in musica. Nell’intermezzo La pelarina, del 1730 (Opere, 1954-56, X, 24), ritroviamo il termine giudeo-italiano “moscone” (che suonava moscòn nel giudeo-veneziano): Or che tutto va ben con il fagoto voglio andarmene al Ghetto che per fare de mosconi sono perfetto (p. 13). Lo stesso termine viene sfruttato da Goldoni nell’autopresentazione del personaggio di Volpiciona nel dramma per musica La Conciateste del 1735: Son giudìo, son poveromo, De mosconi son perfetto; Ma onorato galantomo, La dimanda a tutto el ghetto, De gabbar l’arte no so. Sabadin e Semisson, Siora Luna e siora Stella, Giacudin e sier Gradella, In t’un tratto De sto fatto Testimoni gh’averò88. Il tema è ormai regressivo: il giudìo non chiede altro che di fare “mosconi” e di essere considerato una persona onesta, né più né meno come all’epoca dei canti carnascialeschi fiorentini. 1.3 Schiavonesco e greghesco Il terzo, ampio àmbito linguistico in cui si esprime la parodia rinascimentale degli alloglotti ha occorrenze letterarie - in senso lato - molto più vaste ed eterogenee di quelle di “Todeschi” ed “Hebrei”. Manlio Cortelazzo ha indicato le principali caratteristiche della letteratura schiavonesca - intesa come un complesso «di poesie e poemetti popolari con riflessi nel teatro, scritti a Venezia nel corso del Cinquecento, ma attribuibili alla prima metà del secolo» - nella resa umoristica della «imperfetta parlata veneziana degli Slavi (Schiavoni), che confluivano numerosi nella città dei Dogi per ragioni di occupazione, di commercio e di milizia»89. Anche nell’ordito di questa letteratura veneto-schiavonesca troviamo fili, sia pur di timbro e consistenza diversa, che collegano problematicamente Venezia ad antecedenti toscani. Dopo il precedente del Poliziano90, abbiamo nella letteratura fiorentina del Quattrocento almeno altri due esempi di sonetti con personaggi slavi. Il primo, intitolato Sonetto di Schiavonia paisa, si trova nel Codice Barberino (3936). Consiste nel dialogo fra due schiave (o schiavi) nati in Slavonia, venduti a Siena e poi incontratisi - forse affrancati - a Pisa, che per dimenticare le durezze della vita se ne vanno in taverna col ricavato di un furto ai danni dei padroni. Di tono farsesco, nella più bieca vena gastrointestinale, il componimento esprime i diffusi pregiudizi sulla disonestà degli schiavi e la loro inclinazione ad ubriacarsi 88 Traggo i due esempi da FORTIS 2006: 26. CORTELLAZZO 1971-72: 113. 90 Una battuta attribuita a un pastore schiavone, anche se non si tratta necessariamente di una riproduzione realistica, si legge già nell’Orfeo (1480) di Angelo Poliziano: «State tenta, bragata. Bono argurio: / che di cievol in terra vien Marcurio» (cit. in CORTELAZZO 1971-72: 115). 89 24 (con conseguenze igienicamente catastrofiche e linguaggio scatologico). Tuttavia non vi ricorrono termini slavi, e anche le distorsioni dell’italiano si limitano alle finali in a, alla confusione fra i generi, agli infiniti con sillaba finale troncata, all’epentesi della n91. Termini slavi autentici emergono invece nell’altro analogo sonetto di autore toscano, Se tu fussi un di quei che fan minestra, di fine Quattrocento o comunque anteriore al 1502. Scritto dal poeta satirico pistoiese Antonio Cammelli (poi fattosi padano, vivendo e lavorando alla corte ferrarese di Isabella d’Este, e dedicando i suoi sonetti a Ludovico il Moro), il sonetto in questione, dai risvolti osceni, mescola all’italiano l’uso letterario - sempre riferito a vicende quotidiane di schiavi - di un pidgin slavo caratterizzato dall’impiego occasionale di parole che Rodolfo Renier, curatore moderno della sua opera poetica, individua come russe92. Se tu fossi un de quei che fan minestra saresti favorito in qualche loco; o, alle volte, dal guattero un poco lavato e posto al sol d'una finestra; di poi riposto al fin ’n una canestra, o sopra una pignatta appresso al foco. O se tu fussi schiava, almanco il coco ti diria: Caco stai, madonna sestra? Tu rispondresti: Dobra, gospodina. Lui, col coraz in pisda a far giebati, ti faria conduttier della cucina. Ma tu se’ pur fra’ pochi numerati de’ pazienti in molta disciplina, nella gran compagnia degli scacciati. Molti sono i vocati, ma pochi son gli eletti a far passaggio, maccaronazzo mio senza formaggio. Nel sonetto (il n. 72 della raccolta) è emblematico il passaggio «Caco stai, madonna sestra?», che unisce sintagmaticamente l’italiano al russo, trovando un facile umorismo triviale nell’ambiguità che può assumere una parola straniera omofona a una nostrana, e che sembra far eco alla conclusione scatologica del sonetto precedente. Ma vari termini slavi - non necessariamente russi, come intendeva Renier: ad esempio il termine coraz, che corrisponde a kokot, pare essere voce ragusea93 - vengono adoperati in corrispondenza delle situazioni innominabili. Se l’apostrofe al v. 8 va letta semplicemente come il saluto del cuoco alla schiava, «Come stai, madonna sorella?», con la risposta «Bene, signore»94, al verso successivo la promozione di lei a capocuciniera avviene invece per “meriti” velati sotto i 91 Il testo si può leggere in FERRARA 1950. Rodolfo Renier (cur.), I sonetti del Pistoia giusta l’apografo Trivulziano, Loescher, Firenze-Roma, 1888, p. 72 (segue il codice trivulziano). 93 CORTELAZZO 1971-72: 115 n. 6. 94 Ibidem, n. 2: Alla nota 2 riferita ai vv. 8-11, il curatore Rodolfo Renier spiega: «Così sembrami bene interpretato questo difficile passo, misto di parole slave. Alla supposta schiava il cuoco dice: Come (russo kako) stai, madonna sorella (russo sestra)? E la schiava risponde: Bene (russo dobro), Signore (russo gospodina). Gospodina non può essere femminile, come ritenne chi ne diede spiegazione al Ferrari (ediz. p. 81) e come ritenni io pure nella Riv. stor. mantov., I, 79, n. 2. Il senso non tornerebbe. La variante Lui del v. 10, data dal cod. Triv., suggerisce la retta interpretazione del verso oscenissimo, a spiegare il quale bastano le indicazioni date dal Ferrari». 92 25 termini coraz, pisda e giebati (o jebati), che indicano rispettivamente i genitali maschili e femminili e il congiungimento sessuale95. Troviamo qui chiari riflessi di un certo disprezzo toscano nei confronti degli schiavi, causato senz’altro anche dalle paure, localmente molto accentuate, nei confronti di questi domestic enemies - come li definisce un saggio ormai classico sull’argomento apparentemente sempre disponibili a furti, angherie e perfino violenze nei confronti dei padroni96. A Venezia, invece, la parodia degli slavi o schiavoni (comunque non ritratti come schiavi) era parte del repertorio dei cantimpanca, dove la figura dello slavo è personaggio comico e maschera linguistica fra molte, accanto a quelle del bergamasco e del pavano, del tedesco e del saraceno, e di varie nazioni balcaniche. Una vera e propria “letteratura schiavonesca” esordisce a Venezia già all’inizio degli anni Dieci del Cinquecento, ma in modo piuttosto anodino. Quella che ne è forse la prima testimonianza consiste in un sonetto caudato datato 1512, di Antonio Salvazo, dove il dialogo si svolge da una parte in croato e dall’altra in bergamasco (non in dialetto veneto), e senza le contaminazioni e interferenze caratteristiche delle cosiddette “rime alla schiavonesca”97. Ma subito dopo - pressappoco nel 1513 - appare la Historia bellissima98 attribuita al famoso buffone, amico e compagno d’arte di Zuan Polo, Domenico Taiacalze. Nel loro repertorio era presente una vera e propria letteratura “schiavonesca” per linguaggio, stile, sentimenti. Zuan Polo e Taiacalze usavano le lingue balcaniche in una sorta di siparietti musicali, basati su canzoni in albanese, greghesco o schiavonesco, interpretate con opportuni travestimenti99. In particolare, «Zuan Polo fu lo specialista per eccellenza nel simulare a fini caricaturali l’integrazione dialettale degli schiavoni, numerosi nella città, giungendo alla definizione di un vero e proprio gergo teatrale e specializzandosi nell’imitazione del raguseo»100, cioè della lingua della Ragusa croata, oggi Dubrovnik. Ma non gli era da meno Taiacalze, che nell’Historia immagina di morire e d’intraprendere il viaggio agl’inferi. Nell’incontrare le prime spaventose presenze infernali, guidate da Minosse, pur tremando egli intona il suo canto: «mossi la voce mia suave tanto / cantando schiavonesco dolcemente / per non ricever da tal turba pianto» (130-32). E «quelle strane brigate dai forconi» (134) si fermano e ridono, «pigliandosi piacer dal canto mio, quantunque al cantar mio non fusser soni» (137-38). Pur non capendo la lingua schiavonesca (o le altre lingue balcaniche praticate dal buffone), i demoni sono affascinati dalla dolcezza di quelle melodie. Sarà conquistato anche Lucifero. Lo stesso Minosse chiederà al principe dell’inferno che, prima di divorare il buffone, ne ascolti almeno il canto. E allora «in greco, in bergamasco e albanese / sforzati cantar suave il mio tenore; / a tal che Lucifèr tanto se accese, / che la man mi toccò con allegrezza, / perché del mio cantar gran piacer prese», conquistato da «tanta dolcezza» (182-86, 189). Così, grazie al suo plurilinguismo greco, albanese e schiavonesco (nonché bergamasco), e al potere della musica, Taiacalze scamperà alle pene dell’inferno, anzi invitato a partecipare a un luculliano banchetto di diavoli. Quella “dolcezza” non dev’essere necessariamente intesa nel senso moderno, ma come un misto di soavità e di mero divertimento: i buffoni veneziani, abili a contraffare linguaggi, li 95 Così spiega Erasmo Percopo, curatore di una successiva raccolta cammelliana (I sonetti faceti di Antonio Cammelli secondo l’autografo ambrosiano editi e illustrati da Erasmo Pèrcopo, N. Jovene e C.o, Napoli, 1908, 163 n. 10), dove il sonetto figura al n. CXXIII. D’altronde il termine jebati o iebati, per l’atto sessuale, è frequente nella letteratura di ispirazione schiavonesca, e compare anche nel Rado (CORTELAZZO 1971-72: 139). 96 Cfr. ORIGO 1955. 97 CORTELAZZO 1971-72: 116 s. 98 Una historia bellissima la qual narra come el spirito de Domenego Taiacalze aperse [apparve] a Zuan Polo narrando tutte le pene dell'inferno. 99 Cfr. Caravia, Sogno, CCXLVII, 6-8. 100 VIANELLO 2005: 105. 26 modulavano sia nel canto che in buffonerie pure e semplici. Lo mostra il contenuto di una raccolta di sei “canzon in Schiavonesco”101 che devono risalire pressappoco agli anni della Historia bellissima: la pubblicazione, che porta sul frontespizio un’immagine raffigurante un ballo di schiavoni, fu stampata nel 1520 circa. Le sei poesiole, di cui non è riprodotta la musica, ricamavano sui consueti espedienti comici delle deformazioni triviali o scatologiche delle convenzioni amorose, e su epiche bisbocce notturne. La passione per il banchetto pantagruelico (spesso non meno movimentato di quello “infernale” di Taiacalze) è un altro tópos dominante nella letteratura schiavonesca, in tutte le sue stereotipie. Caratterizzazioni tipiche ricorrono ad esempio nella citata ballata popolare plurilinguistica della prima metà del Cinquecento, Chi non fa co faro mi havera la taccha, dove il cantastorie invita gli astanti alle gioie del Carnevale rivolgendosi a ciascuno dei presenti nella sua lingua. Così suona il discorso che egli rivolge agli Schiavoni: «Non lassati vui schiavoni / che in tal tempo non si sguaza / ingrassati con caponi / lo boccali con la traza / e menate orba la maza / che dio sa sel fare pi. // Chi non fa… // Brati vuotu snami piti / te daro con vernical / vostu carne rusto fritti. / credo te non za fa mal / hogme nechiu brate priti. / taccho vas da fa cussi // Chi non fa…»102. Qui gli accenni al vino e alle armi ci introducono anche al clima dell’epica fantastica di argomento schiavonesco, che troverà il culmine nell’opera cavalleresca di Zuan Polo. Tutto il suo principale poema eroicomico, il Libero [libro] del Rado stizuxo [stizzoso], di otto canti in ottave, pubblicato nel 1533, è scritto in dalmato-veneto, il dialetto parlato dagli schiavoni di Dalmazia «non solo nei loro paesi marittimi, ma anche a Venezia»103. Zuan ne compose anche un seguito in dodici canti in ottave, il Libero de le vendete che fese i fioli de Rado stizoxo104. In queste opere scritte, il buffone veneziano si firmava, “alla schiavonesca”, Ivan Paulovichio. A lui risale, direttamente o indirettamente, gran parte della produzione letteraria schiavonesca rinascimentale. Un commentatore moderno delle due opere, Giuseppe Vidossi, riconosce in esse «poemi […] da cantambanchi, svolti con i procedimenti propri dei cantori popolari e con spunti parodistici e burleschi»105. Sia per forma e struttura, sia per le caratteristiche intrinseche dei componimenti di Zuan Polo (inclusi quelli che egli improvvisava in pubblico, e che certamente “crescevano” da una esibizione all’altra), i due massimi poemi schiavoneschi scaturiti dalla temperie culturale della Venezia rinascimentale dovevano 101 Taritron taritron Caco Dobro Salzigon. Con molte altre canzon in schiauonesco. Cfr. PICOT 1894: 9 s., che riproduce le strofe iniziali delle sei composizioni. 102 Cit. in CORTELAZZO 1971-72: 114. 103 MELZI 1838: 296. 104 Il primo poema celebra il valore schiavonesco di Rado, alla pari di quello dei paladini d’Orlando, con cui è vagamente imparentato, ma anche le sue prodezze magiche e le virtù miracolose del vino. «Carlomagno manda Orlando e gli altri paladini alla caccia di certi lupi che, in Spagna, fanno strage dei castruni [agnelli castrati] del Re. Per via fanno amicizia con due giganti, Malfatto e Cattabriga» (VIDOSSI 1960: 124). I quattro arrivano in Schiavonia a casa di Rado, che è stizzito per aver rovesciato un barile di vino, ma si scopre che sua moglie è cugina di Orlando: feste e baldoria durano otto giorni. Poi cavalieri e giganti riprendono il viaggio con Rado e in Spagna scoprono che i lupi sono mannari. Con le sue scarpe fatate e la sua prodezza Rado contribuisce a sconfiggerli; in seguito Carlo Magno lo fa cavaliere, ma gli rubano le scarpe e viene rapito dai turchi, che infine l’eroe, ritrovando le scarpe, sconfigge, per poi dedicarsi anch’egli alla vita corsara. Morto, viene venerato e opera miracoli. Il Libero de le vendete parla invece delle imprese dei figli di Rado, Licha (Alessandro) e Michulo o Miochulo (Nicola), per vendicare il padre, e parallelamente di Iatilo (Attilo), figlio della moglie di Rado e del demonio Farfarello. Iatilo si fa turco e va a saccheggiare la Schiavonia; Licha e Miochulo sconfiggono i turchi e fanno prigioniero Iatilo, che però evade grazie alla magia del padre Farfarello. Lo spirito di Rado appare ai figli e li incita alla vendetta. Anche Miochulo, come il padre, comincia a corseggiare, sbaragliando ovunque i Mori, e alleandosi con il sultano del Cairo contro i tunisini e gli arabi: addirittura, alla morte del sultano, gli succederà. Iatilo intanto compie imprese in India e in Ungheria, in Italia distrugge Aquileia, e alla fine uccide la propria madre, cioè la vedova di Rado, gettandola in mare: ma il corpo di lei si trasforma in banchi di sardelle, che divorano il matricida. 105 VIDOSSI 1960: 124. 27 corrispondere a intonazioni vocali, in parte tradizionali e in parte tipiche dell’estro buffonesco dell’autore: insomma erano cantati, e non a caso il poema raffigura spesso l’accompagnamento della piva. Questo repertorio è infatti l’unico, fra le parodie degli alloglotti, a portare segni inequivocabili di cultura popolare: da una parte l’esecuzione sulla piva (in alternativa alla più nobile viola, che appare sui frontespizi delle stampe popolari), dall’altra la tradizione del ballo saltato. Il contributo più spettacolare delle culture slave ai nostri intrattenimenti di strada è infatti quello dei cosiddetti “salti schiavoneschi”, pittoresca specialità acrobatica fatta propria dall’eclettismo buffonesco, e in quanto tale spesso citata come numero altamente spettacolare nelle cronache cinquecentesche di intrattenimenti sia cortesi, specie nel nord Italia, sia popolari. La loro natura tradizionale, propria dei danzatori slavi, viene anche palesata come elemento di autodefinizione del personaggio dello schiavone nel Contrasto de un Fachin e dun Schiavon de un sposo, e de una sposa, contenuto in una raccolta di frottole (Marciana Misc. 2231.11). Lo slavo interviene alla seconda ottava evocando una scena di danza saltata: «Mille salati fazo e salatoni / a vu miser novizo e vu noviza / e atorno tutti questi compagnoni»106. La presenza linguistica schiavonesca a Venezia non poteva sfuggire al teatro di Andrea Calmo, con l’inserimento di quella che egli chiama «parlaura dalmatina» nel Travaglia, messo in scena nel 1546, dove il mercante raguseo «è fatto parlare col suo linguaggio italiano intriso di slavismi», ma anche nei prologhi della Spagnolas e delle Egloghe. «Un altro personaggio, espressamente dichiarato “schiavone”, […] nella Rodiana riproduce con quella approssimativa fedeltà documentaria, che è da aspettarsi in simili reperti, la parlata italoveneziana degli Slavi»107. Anche delle più tipiche deformazioni linguistiche in schiavonesco, Manlio Cortelazzo ha dato ampiamente conto. Tra i mutamenti vocalici, u per o; in minor misura i per e; il dittongamento di e; a per o, e, i; o per a; u per a. Tra quelli consonantici: metatesi, assimilazione, dissimilazione, epentesi, aferesi (specie per la sillaba iniziale a-), e qualche isolato caso di sincope (petentia per “penitenza”, etc.). Per la morfologia, il mancato accordo dei sostantivi femminili con articolo e aggettivo declinati al maschile, l’oscillazione persistente di genere e numero, l’omissione dell’articolo, l’esasperazione del superlativo, e varie distorsioni per i verbi, oltre all’uso della terza persona per la prima o seconda, e della prima per la seconda; l’inversione dei costrutti, etc.108 Fin qui abbiamo parlato di poesia (sonetti e poemi epici), di teatro “ufficiale”, di repertori buffoneschi. Ma, nell’àmbito di una “letteratura schiavonesca” in senso lato, il principale apporto musicale viene dal genere delle “greghesche”. La definizione si riferisce a un pidgin specifico, che andrebbe distinto dallo schiavonesco genericamente inteso. In senso stretto, per “greghesco” va inteso «il veneziano stentato, misto di voci romaiche, pronunciato secondo abitudini fonetiche greche e intriso di calchi morfosintattici dal parlar materno, di cui probabilmente si servivano i numerosi stradiotti o mercanti provenienti dalla Morea [definizione del Peloponneso dal XII secolo, per la forma a foglia di gelso] o dai dominî insulari della Serenissima»109. Il greghesco era definito in passato “lingua degli stradiotti”, cioè di quei feudatari del Peloponneso che, scacciati dai Turchi, si rifugiarono in vari paesi europei. Per lo più lavorarono come condottieri, con alte conoscenze tattiche; ma qualche stradiotto fu anche autore di musica e canzoni. Questo dialetto, come è stato sottolineato da C.N. Sathas, presenta numerose analogie col dialetto grecanico ancora parlato in alcune zone della Calabria110. 106 Cit. in CORTELAZZO 1971-72: 157. CORTELAZZO 1971-72: 116. 108 Cfr. CORTELAZZO 1971-72: 120-132. 109 LAZZERINI 1977: 47. 110 LAZZERINI 1977: 33; per qualche sporadica analogia con il “grico” salentino v. LAZZERINI 1977: 56. 107 28 Gli studiosi che preferiscono parlare di “lingua stradiota” la definiscono come «una specifica lingua letteraria ibrida, coltivata a Venezia durante il Cinquecento […] un misto di dialetto veneziano e di tratti lessicali e fonetici delle parlate istriana, dalmata e neogreca»111. Stipčević considera globalmente in questa letteratura sia il repertorio schiavonesco, sia le greghesche in senso stretto, come quelle pubblicate da Antonio Molino nel 1564; oltre ai ben noti Zuan Polo, Molino, Calmo, Marin Negro, egli cita fra gli autori anche uno stradioto autentico, Giulio Schiavetti (Julije Skjavetic) di Sebenico (Sibenik), città croata sulla costa adriatica della Dalmazia. Pur accomunati dall’origine balcanica, e dalle vicende storiche che li fanno convergere su Venezia, i due gerghi - greghesco e schiavonesco - restano ben distinti, benché tra le loro deformazioni fonetiche esistano varie caratteristiche comuni, come «la frequenza di u per o», e «la costante sconcordanza di genere e numero tra articolo e possessivo»; così come esistono coincidenze fra il greghesco e la parlaura dalmatina, in particolare «la tendenza all’indistinzione delle vocali atone», anche se nella parlaura «il fenomeno è assai più marcato (anche sotto l’aspetto quantitativo)»112. Ma la fonetica del greghesco letterario è frutto della deformazione di parole italiane o venete secondo una pronuncia e una fonologia considerate “tipicamente grecofone”, di cui Lazzerini dà un’ampia rassegna113. Da segnalare in particolare: «lo scambio liquida/nasale»: ad esempio n > l; «la perdita dell’elemento semivocalico nel gruppo qu- primario e secondario, non estranea al veneziano (che del “greghesco” costituisce il background) ma qui generalizzata: chisto», etc.; «la notevole frequenza dell’aferesi», cioè della caduta della prima sillaba di una parola114. Il greghesco comincia a prevalere, nel repertorio schiavonesco (ma più in generale balcanico) veneziano, nella seconda metà del secolo. A dar vita alla canzone polifonica in greghesco fu il citato Antonio Molino, o “da Molin”, detto anche “il Burchiella”: mercante, attore e autore teatrale, abile musicista suonatore di lira (viola), lirone e liuto, direttore di una sua Accademia di musica. Per questa varietà del suo notevole eclettismo, Molino volle usare l’ulteriore pseudonimo di Manoli Blessi, nella raccolta pubblicata nel 1564: Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche. Egli fu amico e collega dei maggiori uomini di teatro veneziani del terzo, quarto e quinto decennio del secolo: se la sua produzione teatrale è perduta, sulla sua bravura di attore abbiamo varie testimonianze coeve, fra cui quella del Sansovino che lo dice «homo piacevole et che parlava in lingua greca et schiavona corretta con l’italiana con le più ridicolose et strane inventioni et chimere del mondo»115. Di lui ci resta anche, in lingua schiavonesca, il poemetto I fatti e le prodezze di Manoli Blessi strathioto (1561), parodia “stradiotta” dell’Orlando Furioso. Molino dunque firmò le sue canzoni greghesche adottando come nome d’arte quello del suo eroe eponimo: ma si sospetta che anche le firme di altri autori “stradiotti” a cui si attribuisce una produzione di canzoni come Stamati Psari e Tonda Theriarchi - fossero in realtà suoi pseudonimi116. A collaborare musicalmente alla stesura di queste canzoni, in polifonia da quattro fino a otto voci, furono alcuni fra i massimi compositori del tempo, sia veneziani (Claudio Merulo, Andrea Gabrieli e altri) che fiamminghi (De Rore, Willaert, de Wert). Gabrieli dovette appassionarsi al genere introdotto dall’amico, giacché pubblicava a sua volta nel 1571 una raccolta di undici grechesche a tre voci (più quattro giustiniane) su testi in greghesco di Molino; e già nel suo secondo volume di madrigali a cinque parti (1570), che proprio al collega e sodale era dedicato, aveva incluso un madrigale in suo onore intitolato Molino, a le virtù tante e sì rare. 111 STIPČEVIĆ 1993: 34. LAZZERINI 1977: 60-62. 113 LAZZERINI 1977: 52 ss. 114 LAZZERINI 1977: 61. 115 Cit. in BARTOLI 1880: X n. 1. 116 LAZZERINI 1977: 33. 112 29 Al testo del poema I fatti e le prodezze di Manoli Blessi, Molino (o il suo editore Antonio Gardano) fece seguire un glossario dei termini greci, a conferma della determinazione con cui veniva usato il greghesco, ma anche del fatto che qui non si trattava di un’invenzione letteraria; la stessa parodia vi svolgeva un ruolo limitato, collocandosi soprattutto all’inizio della produzione. Lazzerini ammette che «il punto di partenza per l’irruzione del “greghesco” nei testi veneti del ’500 può certamente essere parodisticocaricaturale, più mimetico che libresco»117. Tuttavia, a differenza di altri generi musicali ispirati al linguaggio o ai comportamenti di qualche minoranza linguistica, fra le greghesche ci sono molte semplici canzoni d’amore, o comunque prive di contenuti scherzosi o osceni. Infatti «la coloritura linguistica dialettale o regionale non implicava necessariamente una distanza ironica dell’enunciato poetico. Lo dimostrano anche le raccolte di giustiniane e mascherate di A[ndrea] Gabrieli, affini dal punto di vista musicale e poetico all’antologia del Burchiell[a]»118. Fra le greghesche comprese nella raccolta di Molino, alias Manoli Blessi, sono di tono scherzoso la Bataglia strathiotesca, musicata dal compositore fiammingo Ivo de Vento, e una delle composizioni di Skjavetić, Deh’ no far, che contiene anche allusioni volgari: il tono scherzoso di quest’ultima si riflette, secondo Stipčević, anche nella musica, dove «già nelle battute iniziali ciò è annunciato dalla forte pulsazione ritmica nell’ordine omofono»119. Sia sotto il profilo linguistico, sia dal punto di vista poetico e musicale, la forma della greghesca ha dunque una storia diversa da quella delle parodie di tedeschi ed ebrei. La greghesca non intende rappresentare un mondo alieno, un innesto sociale dai tratti ridicoli e dalle espressioni stereotipate o incomprensibili. La produzione lirica greghesca e schiavonesca nasce o da autori nativi, o da veneziani (come Zuan Polo e Antonio Molino) motivati da un sentimento di simpatia e di solidarietà: al punto che essi vi adottarono pseudonimi “schiavoni” come Ivan Paulovichio e Manoli Blessi. Una situazione possibile solo nel macrocosmo veneziano, privo di certe chiusure altrui (come quella fiorentina, orgogliosa di sé e portata all’esclusione; o quella romana, cattolicamente ostile agli esponenti di religioni diverse), e attento - per ragioni sia politiche che commerciali - ai domìni limitrofi, e alla forza-lavoro immigrata in città. SECONDA PARTE PLURILINGUISMO E “DIVERSI LINGUAGGI” NELLA MUSICA E NEL TEATRO RINASCIMENTALI 3.1 Contrappunto dei “diversi linguaggi” sulle scene e sulle piazze Il fenomeno letterario, teatrale e carnevalesco delle parodie di minoranze linguistiche trova evoluzione, verso la fine del Cinquecento, nella costruzione artificiosa di una “Babele” - per usare un termine adoperato da Orazio Vecchi nell’Amfiparnaso - dove polifonia e contrappunto, tecniche compositive dominanti della musica rinascimentale, diventano gli strumenti con i quali articolare anche il gran concerto delle lingue. 117 LAZZERINI 1977: 47. Corsivo mio. STIPČEVIĆ 1993: 35. 119 STIPČEVIĆ 1993: 35. 118 30 Nel genere che potremmo definire (adottando una titolazione spesso usata da letterati e compositori dell’epoca) dei “diversi linguaggi”, compaiono infatti - dialogango o sovrapponendosi - varie parodie di alloglotti alle prese con la lingua italiana, generalmente combinate con dialetti locali. Questo dialogo, una volta messo in musica, produce una duplice polifonie: di melodie, e di lingue. Questo poliglottismo non sarà solo italiano: nella letteratura e nel teatro spagnolo, ad esempio, esso costituisce un fenomeno rilevante. Durante il Cinquecento ne troviamo molti esempi nella poesia iberica di alcuni fra i massimi autori, come Lope de Vega, Gongora, Quevedo; ma il fenomeno era controverso, e illustri intellettuali come Fernando de Herrera (ca. 1534-1597), Juan de la Cueva (1543-1612), e perfino Garcilaso de la Vega (1539-1616), soprannominato El Inca, uno dei primi meticci del Nuovo Mondo, condannarono il mélange linguistico nella poesia lirica120. Ma esso ebbe esempi illustri anche nel teatro, grazie a commediografi e drammaturghi quali Juan del Encina, ancora Lope de Vega (che usa, oltre alle lingue iberiche, il tedesco e l’olandese), Lope de Rueda e Calderón121. Due casi particolari ci attirano più di altri. Il principale precedente europeo è quello del drammaturgo portoghese Gil Vicente, attivo durante l’intero primo terzo del Cinquecento, che scrisse circa un quarto delle sue opere nella lingua nativa, un altro quarto in castigliano, e il resto in un plurilinguismo nel quale, oltre alle lingue iberiche e al latino, erano spesso accolti l’italiano, il francese, il piccardo, e uno dei molti pidgin basati sull’ebraico, il giudeoportoghese. Forse da lui fu influenzato Torres Naharro, il quale - fondatore della poetica teatrale spagnola con Propalladia, prologo alla raccolta del 1517 delle sue opere drammatiche e poetiche - sviluppò il suo plurilinguismo in Italia. Fu infatti dal 1508, ventitreenne, a Roma, dove scrisse varie opere teatrali, per poi trasferirsi a Napoli nel 1517 o poco prima. La sua commedia Soldadesca (1509-10) ricreava l’ambiente della numerosa colonia ispanica nella città papale, denunciando coraggiosamente gli abusi della soldataglia spagnola a Roma, e dunque alternando l’italiano alle lingue ispaniche. Tra il 1514 e il 1515 venivano rappresentate a Roma altre sue commedie: in particolare la Trophea, dove l’autore già incrementava il numero delle lingue utilizzate, e soprattutto La Tinellaria. Questa, ambientata durante un banchetto in un palazzo cardinalesco, sfruttava un poliglottismo che mescolava vari dialetti e lingue spagnole, assieme al latino maccheronico, all’italiano, al portoghese, al francese e al tedesco, attingendo forse anche al cosmopolitismo della città romana122. Caso quasi isolato in Francia, ma splendido ed emblematico nel contesto europeo, è poi quello di Rabelais, che riesce a parodiare - con le domande di Panurge quando incontra Pantagruele - la varietà di competenze linguistiche che si potevano dimostrare nella società europea del Cinquecento. Nella scena Panurge, per porgere a Pantagruele una comunicazione fra le più banali - aveva fame -, gli risponde in tedesco, ripetendo poi varianti della stessa risposta e poi in italiano, inglese, basco, olandese, spagnolo, danese, ebreo, greco, latino (intervallando, per ben tre volte, con una lingua immaginaria), e solo alla fine in francese123. Tuttavia, in Spagna come in Francia, non venivano usati i dialetti124. In Italia, invece, pluridialettismo e poliglottismo a scopi di intrattenimento parateatrale o musicale hanno la medesima origine, nel lavoro dei buffoni e dei commedianti di strada, e in particolare nella loro tecnica del contrafar, cioè dell’imitare a scopo comico e parodistico. Nella palestra della comicità, la capacità di esibire una varietà di lingue era quanto di più spettacolare potesse offrire, all’inizio del Cinquecento, un intrattenitore di strada. Come 120 ELWERT 1960: 413, 421. Quando il poliglottismo fu proibito anche in questo contesto, si conservò presso alcuni autori «in una misura ristretta e sotto circostanze molto particolari» (ELWERT 1960: 421). Quanto agli altri paesi europei, in Inghilterra ricordiamo Shakespeare nell’Enrico V per l’uso del francese, e nelle Allegre comari di Windsor per il latino (ELWERT 1960: 413, 420); mentre nella commedia tedesca del Cinquecento si usavano vari dialetti: spesso i contadini parlano in brandeburghese o in basso-tedesco, i pastori in brandeburghese o turingiano (ELWERT 1960: 436 s.). 122 Per il teatro di Torres Naharro si può consultare LIHANI 1979. 123 Anche in seguito, Panurge citerà in arabo o in greco durante il racconto della sua fuga dai Turchi (2, 14), e in italiano quando racconta la storia di un senese (4, 67). 124 Con l’eccezione del sayaguès, il gergo convenzionale dei pastori iberici (v. infra). 121 31 abbiamo visto, questa risorsa comica dilaga, nel giro di pochi decenni, fino al teatro veneziano e a quello della Commedia dell’arte, nonché in varie espressioni fra musicali e teatrali che andanno a culminare a fine Cinquecento nella commedia madrigalesca. Ma l’acme del virtuosismo sarà toccato in due opere polifoniche, il madrigale Dialogo a dieci di Michele Varotto (1586) e nella mini-commedia madrigalesca Diversi linguaggi di Orazio Vecchi (1590), che intrecciano dialetti, lingue straniere e maschere, e poi, nel teatro, in una commedia letteraria quale Li Diversi linguaggi dell’Accademico Intrigato romano Vergilio Verucci (pubblicata a Venezia nel 1609), dove gli interlocutori parlano nove dialetti italiani e il francese. Il Caravia, nel Sogno (1541), immaginava che Zuan Polo - da poco defunto - gli raccontasse del modo in cui da morto, ricongiungendosi nell’aldilà al collega Domenico Tagliacalze, fosse riuscito a sopraffare le forze dell’inferno, sciorinando innanzi ai diavoli l’intera rassegna dei suoi “pezzi forti” comici. Lì egli dava prova delle sue capacità imitative e parodistiche, vocalizzando i versi di cani e gatti, fantolini e vecchi, bergamaschi, e stranieri: albanesi, greci, schiavoni, e perfino saraceni nelle «canzon da sarasin»125. La capacità di coinvolgere e divertire l’inferno rappresenta iperbolicamente il potere comico del contrafar voci umane e versi animali, dialetti e lingue, utilizzando anche la musica126. Il plurilinguismo veneto si esprimeva anche nella musica popolare e nel contesto carnevalesco. Nella già citata ballata popolare Chi non fa co faro mi havera la taccha il cantastorie si esprimeva in tutte le lingue degli spettatori presenti per invitarli al Carnevale. Era insomma una specialità istrionica, tipica dello spettacolo di strada, che continuò a essere proposta lungo tutto il Cinquecento, e anche all’esterno del contesto veneto. Una notevole descrizione delle capacità linguistiche e mimetiche di un buffone di ambiente non veneto sta nella Piazza universale di Tommaso Garzoni (1585): «fa del Bergamasco a spada tratta, come fusse il primo della vallata, è Magnifico nel porgere, Spagnolo nel gestire, è Todesco nel camminare, è Fiorentino nel gorgheggiare, è Napoletano nel fiorire, è Modenese in fare il gonzo, e Piemontese nel languire, è la simia [scimmia] di tutto il mondo nel parlare, è nel vestire»127. Questo plurilinguismo era stato portato fin sui palcoscenici del teatro ufficiale fin dall’inizio del secolo, inizialmente come “intermedio”, cioè piccolo episodio spettacolare recitato o coreografato, inserito incongruamente (ma spesso con grande successo) fra due atti di una commedia o di un dramma. Il diario di Marin Sanudo descrive un “intermedio” recitato da Zuan Polo a Venezia a febbraio del 1515, per il Carnevale, fra gli atti del Miles gloriosus plautino messo in scena dagli “Immortali” della Compagnia della Calza. Il buffone vi giocava col tema del viaggio del negromante all’inferno, dove trovava Domenico Taiacalze che «cazava [cacciava] castroni: el qual con li castroni vene fuora, fe’ un ballo essi castroni»128: lo spunto da cui poi il Caravia trasse il Sogno. Ma un episodio pluringuistico (con alternanza di veneziano, bergamasco e schiavonesco) si trova anche in un dialogo in versi contenuto in un intermezzo teatrale anonimo “alla bulesca”, cioè basato sulla figura spavalda del bulo o sbrico, il nostro “bullo”. Il testo è conservato alla Biblioteca Comunale di Treviso, e il suo autore potrebbe essere lo stesso Zuan Polo, o un suo seguace, data la presenza di due suoi personaggi (Rado e Margherita)129. Plurilinguista sarà, nel secondo terzo del Cinquecento, il teatro di Andrea Calmo: «in quella minuscola summa che è la Spagnolas […], al villano, al facchino, al vecchio veneziano si affiancano lo Scarpella spagnoleggiante e lo stradiotto Floricchi, quasi che l’intento documentario della realtà circostante, in questo testo così partecipe degli umori e dei problemi 125 Cfr. Sogno, CCXXXVII, 1-2; CCCXLVII, 6-8; CCCLXXVII, 1-5; CCCLXXXII, 6-7. Sogno, CCCLXXVI, 4. 127 Dal discorso CXIX, De’ Buffoni o Mimi o Istrioni, p. 559. 128 Cit. in HENKE 2002 : 60 s. 129 VIANELLO 2005: 78 e n. 16. 126 32 del tempo, non potesse mancare di coinvolgere l’aspetto linguistico»130. Il “pedante raguseo” che pronuncia il prologo della commedia si esprime invece nella “parlaura dalmatina”. Ma il culmine si tocca nella Rodiana, dove un virtuosistico florilegio poliglotto - paragonabile al precedente rabelaisiano - viene messo in scena grazie a un artificio della trama (Atto II, scena 8). Qui il personaggio di Truffa finge di essere posseduto, e al prete che deve esorcizzarlo risponde in sette lingue e dialetti diversi: francese, dalmata, spagnolo, albanese, e in napoletano, milanese e fiorentino131. Questa vena era cara non solo a Calmo, ma anche agli altri due autori presenti nella sua compagnia, dallo stesso Calmo definita132 come “Scuola d’i Liquidi”: Gigio Arthemio Giancarli, di cui ci sono rimaste due commedie (La Capraria e La Zingana, pubblicate rispettivamente nel 1544 e 1545), e il citato Antonio Molino, le cui opere teatrali non ci sono purtroppo pervenute. Tutte le commedie dei Liquidi sono scritte in “varie lingue”: Zancarini ha calcolato che complessivamente, nelle loro opere, si trovano parole e battute in veneziano, toscano, padovano, bergamasco, friulano, milanese, napoletano, e (tra le lingue non italiane) in dalmata, greco, tedesco, francese, spagnolo, turco e arabo133. Questa voga plurilinguistica nel teatro veneto dura un ventennio scarso, culminando negli anni Quaranta, per estinguersi verso la fine del decennio successivo: ultimo erede diretto ne sarà Marin Negro, che qualche tempo prima prima del 1558 mette in scena la sua commedia plurilinguistica La Pace (pubblicata nel 1561)134. Confronti e contrasti fra “diversi linguaggi” proseguono con gran successo nella Commedia dell’arte per altri due secoli, ma con una differenza, rilevata da Vianello. Se anche i comici dell’arte usarono la contraffazione vocale e i “diversi linguaggi”, essi lo fecero in modo “connotativo”, a creazione e definizione di personaggi comici; mentre il buffone usava tali tecniche in modo “simulativo”, senza identificarsi con un “tipo”, anche perché le sue esibizioni erano generalmente solitarie135. Questo modello sarà adottato anche dalla Commedia madrigalesca, con una significativa, potente variante, fornita dalla musica e dal canto136. 3.2 Polifonia dei “diversi linguaggi” in musica L’artificio dei “diversi linguaggi” troverà infatti il suo massimo exploit in congiunzione con l’arte musicale della polifonia. L’incrocio della tecnica plurilinguistica e di quella polifonica fanno, dell’una, un complemento virtuosistico e sperimentale dell’altra. La loro unione sviluppa un potenziale che si esprime pienamente nel contesto teatrale. In effetti il plurilinguismo nella musica vocale, dopo il caso isolato delle “battaglie” quattrocentesche, e dopo il suo uso in canzone da parte di buffoni e cantimbanca del primo Cinquecento, andrebbe studiato nelle sue relazioni con la Commedia dell’arte, da un lato, e con la tradizione carnevalesca della mascherata dall’altro. Queste relazioni si manifestano pienamente a partire dall’ultimo quindicennio del Cinquecento, in varie opere di alcuni compositori di area padana, che formano un insieme compatto. Esse costituiscono infatti la 130 LAZZERINI 1977: 48. «L’apprezzamento per la rusticitas pavana non esclude necessariamente l’interesse per più eccentriche sperimentazioni» (ibidem). Ritroviamo la tecnica plurilinguistica anche nei versi di Calmo, nella raccolta Le bizzarre, faconde, et ingeniose rime pescatorie, pubblicata nel 1557 (LAZZERINI 1977: 37). 131 ZANCARINI 1992: 127 e n. 21. 132 In una lettera burlesca in forma di testamento; cfr. ZANCARINI 1992: 121. 133 ZANCARINI 1992: 122. Tuttavia non ci sono personaggi francesi, spagnoli e turchi, né napoletani e milanesi: queste lingue e dialetti compaiono solo grazie all’abilità di alcuni personaggi a contrafar (ZANCARINI 1992: 127). La Zingana di Giancarli «è l’unica commedia in cui appare un personaggio la cui lingua originaria è l’arabo», anche se questo personaggio della zingara parla in realtà un italo-veneziano con tratti arabofoni (ZANCARINI 1992: 128). 134 Dal prologo della Pace si evince che verso la metà degli anni Cinquanta Calmo e compagni avevano smesso di scrivere e interpretare queste commedie plurilinguistiche (ZANCARINI 1992: 122). 135 VIANELLO 2005: 50 s. 136 Nel prologo della Selva di varia ricreatione di Vecchi si allude esplicitamente all’uso poliglotto dei “diversi linguaggi” (dove i dialetti italiani vengono usati estensivamente assieme ad alcune lingue straniere) come un artificio tipico delle «Comedie all’improvviso». 33 summa e il punto d’arrivo di due lunghe storie, che attraversano l’intero corso del Rinascimento: la curiosità linguistica, che porta a rielaborazioni artistiche di gerghi, pidgin, latino, lingue straniere, dialetti italiani, e sperimentazioni sull’onomatopea e sul nonsense; e la definitiva commistione di poesia, canto, musica, teatro, mimo buffonesco e mascherate carnevalesche. Fra le prime opere musicali in “diversi linguaggi” è il citato Dialogo a dieci del novarese Michele Varotto, pezzo conclusivo della Fiamma ardente (parte di un gruppo di quattro madrigali a cinque voci risalente al 1586): di ciascuno dei due cori, interamente composti da personaggi che si esprimono o nei dialetti italiani o nelle principali lingue straniere, fanno parte anche tipiche maschere della Commedia dell’arte. Troviamo infatti nel primo coro uno spagnolo, un napoletano, un milanese, un ragazzo zingaro e Graziano, e nel secondo un siciliano, un genovese, un francese, più il classico duetto del Magnifico e Zanni137. I personaggi dialogano simultaneamente a voci singole, con l’effetto che varie conversazioni si intrecciano e si sovrappongono. La duplice presenza linguistica dei dialetti e delle lingue straniere si trova enfatizzata anche nella interpolazione di due canti popolari, Cingarin del babo e A Paris sur petit pont, che vengono però eseguiti alternati fra i due cori. Una struttura analoga verrà riproposta nel brano Diversi linguaggi contenuto nella Selva di varia ricreatione di Orazio Vecchi, pubblicata nel 1590. Il brano costituisce una vera e propria, seppure breve, commedia madrigalesca, per nove voci: cinque preesistenti, scritte da Luca Marenzio (in un momento imprecisato del decennio precedente), e altre quattro aggiunte da Vecchi. Il brano di Marenzio, della cui versione originale non conosciamo alcuna fonte, porta un Tedesco, che si esprime nel suo pidgin italianeggiante, e ben quattro personaggi presi dalla Commedia dell’arte: Zanni e il Magnifico, impegnati in una disputa (il servo, affamato, reclama le paghe arretrate), e insieme a loro Franceschina e Girometta, che cantano i due omonimi canti popolari, rispettivamente in dialetto veneziano e bolognese. Anche qui, i canti di tradizione orale sembrano funzionare come marcatori musicali di identità etnica, prima ancora che dialettale. Si noti che la Girometta viene citata dal personaggio del dottore bolognese, Gratiano, come “la mia canzone preferita quando ero innamorato di una bella fanciulla”. La frase, pronunciata nel suo dialetto, e l’allusione alla canzone delle sue parti, individuano mutuamente un microcosmo perfettamente localizzato, oggetto di un sentimento elegiaco, e doppiamente “identitario”: in quanto autobiografico, e in quanto legato alle proprie tradizioni. Le voci e i personaggi aggiunti da Vecchi vanno ad arricchire il quadro plurilinguistico già impostato da Marenzio, aumentando però non le lingue straniere ma i dialetti, e inserendo anche il latino138. Tutto compreso, l’insieme è notevole: a parte le maschere della Commedia dell’arte, i testi dei Diversi linguaggi di Marenzio/Vecchi mettono insieme il bergamasco, il veneziano, il bolognese, il toscano, il latino “pedantesco” e il pidgin del Tedesco. Un chiaro spaccato linguistico del multiforme cosmo cinquecentesco, di cui Kirkendale ha sottolineato le implicazioni sociali, sottolineando che l’aggiunta di voci da parte di Vecchi incrementa sia le possibilità drammatiche del microcosmo dei personaggi, sia la vitalità ritmica della composizione musicale in sé e per sé139. Interessante il ruolo di Graziano, che commenta le varie parti in commedia, fornendone una traduzione nei tipici “a parte” che in teatro vengono rivolti direttamente agli spettatori. Egli fornisce infatti una “riduzione veneziana” del poliglottismo in scena, localmente collocata sia nel punto di vista che nel dialetto: «Ah, ah, ah, ah, ah, cosa dis questor? Al ghe n’è un che dis “E la bella Franceschina ninina buffina, La filli bustachina”. Es ghe n’è un che dis la me favorida quand’a iera inamorad d’una bella putta, “Chi t’hà fatte quelle scarpette 137 KIRKENDALE 1972: 228. Le aggiunte di Vecchi riguardano quattro personaggi: le ben note figure di Graziano, del Pedante e di uno “Scolare”, più un altro chiamato “Fate ben per voi”, come un celebre eremita romano. Scolare e Pedante intrattengono anch’essi una disputa, come Zanni e il Magnifico (KIRKENDALE 1972: 181). 139 KIRKENDALE 1972: 230. 138 34 Che ti stan si ben?”. Al ghè quell’altra bestiazza de Zan che dis “a voi al me salarie”. E Pantalon ghe dis “tirra via”. Al ghè po un cert’invriagon che dis “Mi non esser minchion, Mi star bon compagnon”. E dov’ lassavi una cera d’Hiporcate chal sta sempr’ in s’una vosa gridando “Fate ben per voi”? Av’ do la bona sira, bon sir». La “diversità” sintagmatica vi trova una sua parallela versione paradigmatica. Giovanni Croce Chiozzotto (da non confondere col cantimbanca Giulio Cesare Croce), impiegato come cantante nella cappella privata del Duca di Venezia, usò a sua volta la tecnica dei “diversi linguaggi” in due suoi cicli di mascherate, che probabilmente venivano eseguiti durante i banchetti del duca, o come intermezzi teatrali (meno probabilmente negli spettacoli di strada, dato il prestigio professionale del cantante-compositore). Nelle Mascarate piacevoli et ridicolose per il Carnevale (pubblicate nel 1590, quando - come si desume dalla dedica - il ciclo era già molto famoso e richiesto), si ascolta in apertura una Mascarata da Lenguazi, per sei personaggi: uno Zane (Zanni), il Magnifico, la Lessandrina, Gratiano, Quinto, e un Tedesco. I sei si sovrappongono, ciascuno con un suo verso (il Tedesco, al solito, invita al brindisi: «Brindes’, io berlich. Mi star bon compagnon, io»), finché intonano in coro il ritornello popolare «Runda, rundella, runda, la rundinella gnechelle», presto punteggiato solisticamente da altri versi e ritornelli. Gli altri brani del ciclo sono tutti di gruppo: i Magnifici (che giocano all’eco), le “Donne Pitoche” (cioè mendicanti), i “Pescaori”, le Buranelle venditrici ambulanti di colletti di pizzo, e in conclusione una Mascarata da Furlani con l’intreccio dei richiami di venditori e operai friulani che offrono le loro prestazioni, non senza confessare quanti barili di vino abbiano già consumato. Sempre del Chiozzotto, la Triaca musicale (1595) sciorina una sorta di catalogo polifonico in cui vari elementi della ricerca linguistica rinascimentale vengono presentati sia “sciolti”, sia nella combinazione plurilinguistica. Il fatto che Croce intitoli la raccolta alla triaca, “panacea di tutti i mali”, rappresenta un atto di fede verso le virtù taumaturgiche del buonumore, ma anche, nello specifico, la testimonianza del potenziale umoristico riconosciuto agli stili messi in commedia. Nei vari brani della raccolta troviamo un singolo Pantalone (non più un coro di Magnifici come nelle Mascarate del 1590) alle prese con l’Ecco (eco) del bosco, e vari gruppi omogenei di maschere nella Canzon da Contadini pavani (in dialetto padovano, col ritornello tradizionale della tandararitondella), nella Mascheratta de Gratiani, nella Canzonetta da Bambini; due versi avicoli gareggiano in onomatopea nella Canzon del Cucco, e Rossignuolo [cuculo e usignolo] con la sentenza del Pappagallo (quest’ultimo dichiara vincitore il cuculo). Si noterà come il potere del comico si esplica qui in una sorta di catalogazione antologica degli esiti formali e spettacolari delle due direzioni di sviluppo già evidenziate: quella del carnevalesco (le mascherate), e quelle della specialità buffonesca del contrafar versi animali, voci di bambini, dialetti, mentre ad alcune lingue straniere è dedicato l’unico brano plurilinguistico della raccolta, l’Incanto della Schiava. Qui lo spunto è dato dalla vendita all’asta di una schiava chiamata Angela, pregevole per bellezza e abilità domestiche, nella quale concorrono due stranieri (uno spagnolo e un tedesco) assieme a un napoletano, un fiorentino, il Graziano bolognese e un veneziano, il quale alla fine si aggiudica la fanciulla per la ragguardevole cifra di ottanta scudi. Gli italiani si esprimono ciascuno nel suo dialetto, mentre dei due stranieri il primo fa la sua puntata in uno spagnolo approssimativo e imbastardito, il secondo inanella i tradizionali stereotipi sui tedeschi (in un pidgin basato, per una volta, sul dialetto veneziano: «Mi foler dar per ste galante fie [questa galante figliola] / Quaranta scudi e pagar malvasie»). Ma il massimo impianto “teatrale” del plurilinguismo si raggiunge in musica con la Barca di Venetia per Padova di Adriano Banchieri (1605), dove scena e intreccio convergono nella tipica immagine veneziana del traghetto. L’iniziale Strepito di pescatori, in dialetto veneto, si apre con i richiami della vendita del pesce che si contrappuntano con una descrizione degli incerti del mestiere della pesca. Poi un Libraio Fiorentino invita in barca cinque cantori per l’esecuzione di «alcune capricciate del Banchieri», annunciando uno 35 «spasso […] artifitioso e onesto». Nel Concerto di Cinque Cantori un Napoletano, un Fiorentino, un Bolognese, un “Venetian” e un “Thedesco” cantano ciascuno da solista un distico nel proprio dialetto (lo straniero nel convenzionale pidgin italo-tedesco), alternati al coro. Seguono, oltre a vari madrigali (fra cui uno alla Romana, un altro alla Napolitana, e un’Aria a imitatione del Radesca alla Piemontese), un episodio solistico affidato al Thedesco e un altro agli Hebrei, di cui abbiamo già trattato. Di questo gruppo di autori e di opere fa parte anche Giulio Cesare Croce (1550-1609), anche se nulla ci è rimasto del modo in cui egli porgeva in musica le sue invenzioni verbali, nella tradizione degli intrattenitori di piazza. Poeta e cantastorie popolare bolognese140 di grandissimo successo, egli ereditava - in quanto cantimpanca e comico “da strada” - vecchie tecniche buffonesche, tra cui lo stesso plurilinguismo. Nello stesso tempo Croce ebbe rapporti, sia diretti che indiretti, con i massimi autori delle commedie madrigalesche. Si è già accennato che egli era amico personale di Vecchi, e suo collaboratore, forse anche per l’Amfiparnaso141; mentre Banchieri aderì al genere di letteratura prediletto da Croce scrivendo nel 1620, dopo la morte dello scrittore e cantimbanco, la Novella di Cacasenno, figliuolo del semplice Bertoldino, a completamento del ciclo del Bertoldo (Le sottilissime astutie di Bertoldo e Le piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldino) che Croce aveva pubblicato fra il 1606 e il 1608, nell’ultimo scorcio della sua carriera. Croce cantava le sue composizioni, accompagnandosi con lo strumento a corde che gli avrebbe dato il soprannome di Giulio Cesare Della Lira, e vendendo opuscoli contenenti i testi del suo repertorio. Come cantastorie agiva principalmente per le strade di Bologna, ma la sua fama lo portava anche a viaggiare: fu a Modena, Ferrara, Mantova, Venezia. Il suo apporto al revival delle tecniche pluridialettali e plurilinguistiche durante l’ultimo quarto del Cinquecento potrebbe essere stato fondamentale. Nello stesso tempo egli recepiva i personaggi della Commedia dell’arte, in una sorta di cortocircuito in cui questi, partiti dalle espressioni più modeste e stradaiole della cultura urbana di stampo popolaresco, passati alle scene veneziane e poi al nomadismo dei comici dell’arte, tornavano allo spettacolo di piazza. La miscela di dialetti e occasionali lingue straniere (in particolare lo spagnolo, tipico del personaggio del Capitano) della Commedia dell’arte viene da lui restituita al contesto carnevalesco nella Tragedia in comedia fra i bocconi da grasso e quei da magro la sera di Carnevale, pubblicata per la prima volta nel 1608: dopo un prologo recitato da un’anguilla, l’autore vi metteva in scena Pantolone, Pedrolino, gli innamorati, Francatrippa, il Dottore, Arlecchino e lo Spagnolo, fra gli altri. Non mancavano né la musica, eseguita fra i vari atti, né la danza buffonesca, nella conclusione affidata a «un garbato mattazzino» eseguito da vari pesci142. E al personaggio di Zanni, da lui spesso frequentato, Croce dedicò il massimo exploit virtuosistico della comicità pluridialettale: Le Nozze del Zane, in lingua bergamasca, nella quale si vedono sedici [!] linguaggi tutti differenti, e dove gli ospiti di Zanni lodano, ciascuno nel proprio dialetto, i piatti preferiti. Croce muore appena tre anni dopo la conclusione della breve stagione della commedia madrigalesca, che discendeva per li rami proprio dal plurilinguismo dei vecchi comici di strada, come Zuan Polo. Con lui si chiude un ciclo la cui evoluzione investe l’intero Cinquecento, ma che nel giro di poco più di un ventennio, già affacciandosi sul secolo successivo, trova l’apice in una sperimentazione musicale sulle radici carnevalesche, buffonesche e teatrali - ormai imbricate - di una nuova comicità. La sperimentazione si trova 140 Come si apprende dalla sua autobiografia, Descrittione della vita del Croce, il futuro scrittore e cantimbanco si trasferì col padre a Medicina, nel bolognese, attorno al 1563, e qui scoprì la sua vocazione di “poeta campestre” («Or quindi dier principio a saltar fuori / i grilli, i parpaglioni, le chimere / de la mia zucca, e i stravaganti umori»), dilettando con le sue canzoni i signori del casale che li ospitava. Diciottenne si trasferì a Bologna dove, oltre a mantenersi col mestiere paterno del fabbro, esordì come poeta di piazza, cimentandosi nei generi “di strada” ma dedicandosi a numerose e disordinate letture, e scoprendo Ovidio. 141 Esiste una lettera che testimonia la cordialità di rapporti e la discussione di un progetto in cui Vecchi chiedeva l’assistenza dell’amico. Dent considera probabile che Vecchi fosse assistito da Croce nell’elaborazione dei testi dell’Amfiparnaso, per alcune corrispondenze fra questo e certe opere del Croce (DENT 1911: 344). 142 DENT 1911: 336 s. 36 espressa su contrappunti e polifonie di lingue e dialetti, usando la musica ora per concertarne il difficile dialogo, ora per rappresentarne icasticamente la sovrapposizione in un’inestricabile Babele. Concluso questo breve ma intenso periodo, la nuova comicità si separa dalla musica per assorbirne gli artifici linguistici in una vena teatrale destinata a una lunga storia. È la dimensione dell’equivoco verbale, sorta di “terza via” - alternativa sia al dialogo che alla cacofonia - per rappresentare scenicamente (a volte anche in musica) i problemi di comunicazione in una società alle prese con l’interculturalità. 3.3 Il secondo Cinquecento: un teatro dei dialetti e degli equivoci La Commedia dell’arte seppe portare a maturazione il potenziale comico delle differenze linguistiche, ma in un modo diverso dalle precedenti sperimentazioni. Il meccanismo dell’interazione fra parlanti dialetti regionali costituisce uno nei nuclei storici della commedia italiana: gli scambi tra veneziani e bergamaschi, ad esempio, sono materia del classico duetto tra un padrone e un servo. Ma essa è innanzitutto, e per sua natura, un teatro dei dialetti - di “diversi dialetti”, e solo secondariamente di “diversi linguaggi”. Nella varietà definibile “lombarda” o settentrionale predominavano il veneziano, il bolognese e il bergamasco; e ne esisteva anche una varietà “meridionale”143. Tuttavia, i personaggi alloglotti non mancavano. La Commedia dell’arte contribuisce infatti allo sviluppo spettacolare del poliglottismo rappresentando, fra le sue presenze minori, alcuni tipi umani e linguistici “locali” (regionali, nazionali, anche internazionali). Negli scenari di Scala, certo facendo sèguito a una tradizione già ben avviata, troveremo ad esempio, al fianco delle maschere canoniche, sia «personaggi dal sottobosco urbano, alcuni dei quali avevano affinità con gli attori itineranti: musicisti girovaghi, mendicanti, vagabondi, bari, pazzi, ciarlatani», sia «figure provienienti da tutte le coste del Mediterraneo, spesso incontrate in trame di intreccio amoroso, come mercanti arabi o turchi, zingari, schiavi di galea, pirati»144. Fra i personaggi alloglotti (senza contare quanti si esprimevano in latino maccheronico, lingua dei dottori pedanti), i più diffusi erano quelli che parlavano in spagnolo, lingua dei capitani sbruffoni. Qualche volta, però, lo spagnolo sbordava dal cliché del Capitano. Vestito da spagnolo, Burattino fa lazzi in lingua spagnola in Li Finti turchi, nella raccolta di di Basilio Locatelli del 1622 (I, f. 21 1v)145. Lazzi analoghi sono basati sulla pretesa di alcuni personaggi di insegnare ad altri la lingua spagnola, come in Li Amanti ingrati (dalla Corsiniana, raccolta risalente ai primi del Seicento, I, f. 126r), e nell’anonimo Gli sdegni amorosi (ms. Museo Correr, II, 246)146. Episodicamente emergevano altre lingue, come il francese, e le tre che abbiamo considerato nella musica vocale: tedesco, greco, ebraico147. Francese e tedesco appaiono solo in forma di pidgin, ma doppiano la metà del Seicento fino al Settecento inoltrato148; assai più rari quelli in ebraico e nelle lingue dell’Europa orientale, come il polacco149. Si schiudono, in 143 Fanno eccezione i personaggi dei giovani innamorati. Perrucci, che nel trattato Dell’arte rappresentativa (1699) enuncia regole ed esempi (molti dei quali dialettali) validi per i vari personaggi della Commedia dell’arte, agli “innamorati” prescrive un italiano letterario, basato sul toscano, e con un’enfasi retorica e iperbolica già nota alla commedia erudita (CLIVIO 1989: 215 s.). 144 HENKE 2002: 18. 145 CAPOZZA 2006: 68. 146 CAPOZZA 2006: 68 s. 147 CLIVIO 1989: 209. 148 Lazzi del genere appaiono in alcuni dei canovacci pubblicati nello Zibaldone di Dominique Biancolelli, attore bolognese presente dal 1662 nella troupe della Comédie-Italienne a Parigi. Ne troviamo in francese in L’ipocrita (574); inoltre, Arlecchino racconta una storia di La Fontaine in un misto (ridicolo e osceno) di francese e italiano in una messa in scena a Parigi nel 1716. Presenze linguistiche in tedesco compaiono sia in commedie del Seicento, come il Baron Todesco (179) di Biancolelli, sia in singoli lazzi detti “della lista”, come quelli presenti in vari scenari contenuti nello Zibaldone del 1734 di Placido Adriani (cfr. CAPOZZA 2006: 69, 352; GORDON 1983: 57). 149 Poco dopo l’inizio del Seicento si trova un raro e precoce lazzo in finto polacco in L’Hospite amoroso (Corsiniana, II, f. 183r) (CAPOZZA 2006: 68). E una qualche forma di ebraico viene attribuita a personaggi di “giudei” italiani, come in Lo schiavetto (1612) di Giovan Battisti Andreini. (CLIVIO 1989: 231 n. 2). 37 forma parodistica, anche orizzonti più esotici, come quelli forniti dal mondo moresco e turchesco150. Questi meccanismi sono gli stessi che troviamo anche nella commedia madrigalesca di fine Cinquecento, a loro volta anticipati di qualche decennio in greghesche, ebraiche e moresche. Stabilire in quale genere - teatrale o musicale - siano cominciati a fiorire è problematico, anche perché, se l’interazione con le pratiche attoriali dei comici dell’arte è certa, il loro apporto nel corso del Cinquecento è difficilmente quantificabile. Come è noto, il problema storiografico della Commedia dell’arte risiede nel fatto che, mentre abbiamo indizi dei suoi primi vagiti fin dagli anni Trenta del Cinquecento, e trent’anni dopo anche un esempio in nuce della sua prassi drammaturgica - consegnataci nel 1568 da due musicisti, Orlando di Lasso e il suo amico Massimo Troiano, che ce ne dà la cronaca151 -, i suoi primi testi a stampa, sotto forma di canovacci, appaiono solo nel 1611 con la pubblicazione degli scenari di Flaminio Scala. Ma le commedie madrigalesche ci tramandano indirettamente alla fine del Cinquecento l’esistenza ormai solida, e perfino già stereotipata, di personaggi caratteristici in relazione fra loro attraverso precisi schemi funzionali, narrativi e drammaturgici. Attraverso opuscoli e vari tipi di personaggi, sappiamo anche che uno dei principali nuclei di questo schema, il duetto tra il vecchio e il servo (in seguito cristallizzati l’uno nel Magnifico e in Pantalone, l’altro nello Zanni e nelle varie sue incarnazioni come Pedrolino, Burattino, Arlecchino, etc.), risale già alla prima metà del Cinquecento. Benché scarseggino riferimenti diretti per quasi cent’anni di storia della “commedia all’improvviso”, quelli indiretti - fra i quali molti da noi finora considerati - sono dunque piuttosto numerosi. Nella Commedia dell’arte, così come in quella madrigalesca, l’insieme dei personaggi dialettali e di quelli stranieri finisce per disegnare il virtuale microcosmo di una società nella quale la comunicazione interpersonale si poneva, spesso e volentieri, il problema dell’intelligibilità. È stato spesso evidenziato come tale problema, causato innanzitutto dalle grandi differenze fra un dialetto e l’altro, andasse a costituire nel teatro una feconda materia comica152. Da parte nostra abbiamo verificato come, in musica, la simultaneità polifonica dell’uso dei “diversi linguaggi” tendesse inevitabilmente a rendere inintellegibili, se non per sprazzi, i vari discorsi. La commedia madrigalesca traduceva in musica quello che doveva essere un reale problema di comunicazione delle società rinascimentali: rappresentazione iperbolica di un normale accidente della vita quotidiana, specie nelle grandi città. Nella musica, la polifonia dell’ordine si prestava a rappresentare la polifonia del caos. Tuttavia, tranne eccezioni, il plurilinguismo “contrappuntistico” non è ingrediente tipico della Commedia dell’arte153, sia perché i personaggi stranieri sono in minoranza e prevale invece la varietà dei dialetti, sia perché il suo meccanismo scenico si basa soprattutto su duetti comici, e dunque non si incontrano quasi mai più di due dialetti simultaneamente, oppure una lingua straniera e un volgare italiano. La commedia “all’improvviso” comunque produrrà, oltre ai suoi duetti dialettali (schematici e alla lunga ripetitivi, come quelli fra Pantalone e Zanni), meccanismi perfetti e non di rado irresistibili di “equivoci verbali”, basati su varie specie di incomprensione reciproca, che si stabiliscono in un repertorio di lazzi ricorrenti. La Commedia dell’arte scioglie la Babele in farsa. 150 In Li tappeti alessandrini (1611) di Flaminio Scala (II, 266), Pedrolino e Pantalone, il primo vestito da turco e il secondo da schiavo, elaborano una scena basata sul “parlare turchesco”. Lazzi “turcheschi” sono più volte affidati ai personaggi di servi: in La Turchetta, nella raccolta di Locatelli (II, f. 146r), Zanni fa lazzi fingendo di parlare in lingua turchesca, e Arlecchino si esibisce nell’imitazione di un mercante turco in Biancolelli, Tre finti Turchi, 320 (CAPOZZA 2006: 68 s.). Più tardi, expolit linguistici dello stesso tipo compariranno sovente nel repertorio napoletano del Sei-Settecento, in particolare nelle raccolte di scenari di Annibale Sersale e di Placido Adriani. Si vedano il Pulcinella travestito da pascià in Sorella picciola (I, 323), nella raccolta di Sersale, conte di Casamarciano, che contiene 176 scenari secenteschi (CAPOZZA 2006: 163), e Coviello in La Sorella, nella raccolta settecentesca di Adriani (II, iv, f. 149r) (CAPOZZA 2006: 69). Ancora Coviello e Pulcinella, in L’insalata di Adriani (III, xi-xiii, ff. 156v-157r), per fare una burla a Lattanzio vanno in scena vestiti da turchi, esibendosi nel parlar turchesco e in lazzi sui salamelecchi (CAPOZZA 2006: 162). 151 152 153 CLIVIO 1989: 211 s. Ma, ad esempio, Zanni fa lazzi in diversi linguaggi in Gli Scambi (Corsiniana, I, f. 49r) (CAPOZZA 2006: 68). 38 In essa, i problemi di comunicazione interlinguistica generavano due diversi modelli nel modo in cui veniva affrontata questa materia comica. L’eventuale incomprensibilità dei personaggi fra di loro, e quella del pubblico posto di fronte a scene polidialettali, erano infatti risolte in modo diverso. Le difficoltà degli ascoltatori - un problema meramente tecnico venivano compensate dalla gestualità, dalla formularità delle situazioni, dalla riconoscibilità di scherzi e beffe espresse dai “lazzi”: la struttura stessa della commedia italiana si presta a integrare la comunicazione verbale con altri supporti espressivi e comunicativi. Le difficoltà di comunicazione fra i personaggi entravano invece a far parte degli spunti tematici, e andavano quindi valorizzate per alimentare il meccanismo comico. Ad esempio, nella prima scena del primo atto di L’amico tradito di Pier Maria Cecchini (1633), il Dottore e Pantalone discutono accaloratamente dei rispettivi figli ma, parlando l’uno in bolognese e l’altro in veneziano, non riescono a capirsi. Ne nasce un equivoco: il dottore intende la parola “far” come farro, Pantalone come infinito sostantivato del verbo fare (implausibile, perché in bolognese si direbbe “fer”)154. Anche un tipico personaggio straniero come il Capitano spagnolo viene spesso e volentieri frainteso, onde poter generare lazzi basati sull’equivoco verbale, come nella commedia Li due Pantaloni (Corsiniana, I, f. 23r)155. Così il meccanismo comico dell’equivoco diventa alternativo a quello della “polifonia”: la catena di significanti e significati fraintesi dinamizza l’intrinseca musicalità dei “diversi linguaggi” in una sorta di sviluppo per temi e variazioni sui suoni delle lingue, con le occasioni offerte da omofonie e solecismi, che sfruttano il meccanismo retorico della paronimìa. Il riflesso di un problema di comunicazione scaturito da una realtà sociale sempre più articolata e complessa consentirà così di sviluppare nel teatro comico una molteplicità di risorse, spunti, dinamiche, che meritano di essere indaghate sia storicamente che morfologicamente. 3.4 La comicità dell’“equivoco interlinguistico” Quando nasce, nella storia del teatro, questa particolare risorsa della comicità? Osservando che nel teatro «il plurilinguismo è premessa indispensabile al funzionamento di uno tra i più collaudati espedienti comici», quello dell’equivoco interlinguistico, Lazzerini pretende di tracciare una continuità che dal Poenulus plautino, col suo personaggio del Cartaginese, passerebbe dagli esempi sacchettiani o burchielleschi (per quanto non di natura scenica) fino al teatro comico del Cinquecento156. Ma è poco credibile parlare di continuità senza essere in grado di riempire un salto più che millenario da Plauto fino alla novella o ai sonetti del Duecento. Sulla derivazione del plurilinguismo dalla commedia antica, si sono spese affermazioni apodittiche, difficilmente condivisibili157. Qualche ipotetico umanista rinascimentale può anche aver riconosciuto nella commedia antica l’anticipazione di un meccanismo comico dei suoi tempi, magari compiacendosene. Ma il plurilinguismo era nella società: in quella romana al tempo di Plauto, in quella italiana all’epoca della commedia rinascimentale, in una relazione puramente paradigmatica, ma per situazioni storiche contingenti e diverse. Stiamo parlando infatti di un dato di realtà che influenza la produzione artistica: l’inverso non si pone. Una realtà anche cruda: nel Cinquecento italiano, diversamente che nel mondo romano antico, sentir risuonare lingue straniere nelle proprie città poteva essere inquietante e minaccioso, specie in tempo di guerra. Ce lo ricorda Pietro Aretino in una 154 CLIVIO 1989: 229. CAPOZZA 2006: 68. 156 LAZZERINI 1977: 34. 157 Ad esempio Elwert suppone che il mélange linguistico nelle opere del Rinascimento sia stato suggerito dalla commedia antica greca e latina, pur ammettendo che lì era ben poco sviluppato: ed è pura illazione che esso sarebbe stato «esagerato sotto l’impulso dello spirito universalistico degli uomini del Rinascimento» (ELWERT 1960: 419). Altrettanto fa la Lazzerini quando, in uno studio successivo a quello già citato, considera probabile «che l’esempio plautino abbia costituito, per gli autori rinascimentali, una sorta di autorevole legittimazione dei più audaci inserti alloglotti (arabo, neogreco, turco)» (LAZZERINI 1978b: 131). 155 39 crudele visione parodistica delle violenze e degli stupri che funestarono il sacco di Roma del 1527, nella frottola Pas vobis, brigate!: «Vidi una suora bella, / che si stava in cagnesco, / che dinanzi un tedesco e dietro avea / un spagnol, che facea / a don Caragio festa», dove il nome del soldato spagnolo sta per carajo, il membro maschile158. L’emergenza di personaggi alloglotti e scene plurilinguistiche nel Rinascimento ha dunque una sua piena autonomia: da tempo, la storiografia critica ha sottolineato il forte legame del teatro comico rinascimentale con la realtà specifica dei suoi tempi e dei suoi luoghi, e la sua sostanziale indipendenza - eccettuate alcune convenzioni, non sempre e non tutte rispettate - dalla drammaturgia romana antica159. È la presenza storica di alloglotti nelle società italiane a fornire spunti per caratterizzazioni e azioni comiche. Prima del Rinascimento, nella letteratura (non solo comica) si riscontra, più che un autentico poliglottismo, qualche forma di contaminazione linguistica: che ha le sue radici nelle lingue maccheroniche, sulla base del latino. Lo spunto tracima anche nel teatro rinascimentale con la figura comica del pedante, parodia che svela l’incompetenza dei presunti intellettuali, mettendone in scena l’incomprensibilità vuota e pretenziosa. Il ridicolo si incentra qui sul parlante, non sull’inadeguatezza linguistica di chi, ascoltando, fraintende. Ma in questo caso, come in altre tipologie di nuova introduzione, sono sempre i difetti di comprensione ad alimentare la comicità dell’equivoco. Prima di svilupparsi in senso interlinguistico, infatti, il meccanismo comico sussiste come equivoco verbale tout court: dove, per semplice echeggiamento fonetico, una parola viene scambiata per un’altra. Risorsa comica fertilissima, specie nel teatro, perché può servire a sottolineare l’ignoranza (per rozzezza o incultura, oppure per estraneità al consesso civico) del personaggio che fraintende, e perché il risultato del fraintendimento può essere, a contrasto con la parola fraintesa, abbastanza buffo da generare involontariamente un “motto di spirito” nel senso freudiano del termine. È la sfera dei malapropismi, distorsioni involontarie di parole malcomprese, e difatto sostituite da altre fonicamente simili, ma con tutt’altro significato. Essi producono, nella realtà, un umorismo involontario: appropriandosene, e sfruttandolo scenicamente, il teatro rinascimentale amplifica la realtà nella parodia, con vari tipi di sfruttamento e modulazione di una risorsa attinta alla realtà. In sé e per sé, i malapropismi involontari che si riscontrano nella realtà comunicativa sono del tutto innocenti: e tali restano anche in alcune zone della comicità che vi si ispira, come nella citata scena tra il Dottore bolognese e il Pantalone veneziano in L’amico tradito di Cecchini. Altra cosa sono invece le deformazioni di parole con intenzione triviale o ingiuriosa, e spesso oscena. Si tratta di due tipi di fraintendimento: uno inconsapevole, un altro intenzionale. Entrambi i tipi costellano già le farse spagnole durante la prima metà del Cinquecento: si vedano esempi come besos > quesos, dove i baci diventano formaggi (Diego Sánchez de Badajoz, Farsa de la hechichera, 224, 16) e açucena > caqucena, gioco di parole su caca (Lope de Rueda, Los Engañados, 23)160. Questi due esempi sono emblematici, perché l’insistenza degli equivoci sulla sfera alimentare o su quella scatologica vanno a formare una lunga e fiorente tradizione, anche letteraria. In Italia, ad esempio, troviamo già nell’opera di Luigi Pulci (1432-1484) un sonetto che, riprendendo il genere medievale della “registrazione” delle grida e dei richiami di un mercato, è dedicato alla parodia del dialetto milanese. Numerosi e notevoli vi sono gli equivoci verbali: ad esempio il richiamo «I ofel, i ofel» al v. 2 viene inteso dall’orecchio fiorentino come “io ho fiele”, cioè l’itterizia (il che merita per risposta un “ti prenda il malanno!”); chi propone in vendita un mestolo, che in milanese suona cazzu, aggiungendo che oggi ne ha da vendere, «inchu gh’è», trova inevitabile risposta al v. 3 in «quel primo in cul ti sia!»; e tutto il sonetto procede sulla medesima falsariga161. 158 Cit. in ORVIETO/BRESTOLINI 2000: 248. Si veda ad es. RADCLIFF-UMSTEAD 1969: passim. 160 CHASCA 1946: 338. 161 Il sonetto si può leggere in ORVIETO/BRESTOLINI 2000: 164 s. 159 40 Esplorando al riguardo le nostre quattro aree di ricerca - i canti carnascialeschi sui “todeschi”, le cosiddette “ebraiche”, le greghesche, le moresche -, vediamo innanzitutto che l’utilizzo a fini comici dell’equivoco interlinguistico vi si esprime in misure molto differenti. Lo scarso interesse o il sostanziale disdegno per le altre lingue, tipico di ogni forma di letteratura toscana, fa sì che nei canti dei Lanzi gli equivoci interlinguistici siano praticamente assenti: la comicità si appunta sul ridicolizzare il carattere del personaggio. Tra le rarissime eccezioni, troviamo un fottèghe (per “botteghe”) anche un po’ forzato, perché qui il tipico assordimento di v in f nelle parole “tedeschizzate” dei canti dei Lanzi si estende eccezionamente alle palatali162. Anche nelle parodie giudaiche questo genere di equivoco ha un’incidenza limitata, trovandosi espresso soprattutto nelle parole ebraiche e non nelle deformazioni idiosincratiche di termini italiani. L’esiguità delle occorrenze dipende anche dal fatto che il numero di parole ebraiche comunemente note e utilizzate in questo genere di composizioni (poetiche, musicali, teatrali) è estremamente esiguo. Una delle parole giudeo-italiane più frequentemente fraintesa è moscogn (“pegno”). Nella commedia Pantalone bullo di Gioannelli 1688, il personaggio dell’ebreo Bedanna si rivolge a Menacai per riferirgli che è arrivato il signor Pantalone «per far moscòn». E Pantalone, pensando all’insetto: «Coss’è sto moscòn, mi no vogo né mosconi né callalini»163. Fin qui ci troviamo ancora nella sfera dell’equivoco innocente. Nel Ragionamento tra due Hebrei (1588) - forse appena più maliziosamente - la stessa parola veniva storpiata in “maschion”. Ma più spesso il gioco si basa sulla deformazione di nomi propri, manifestando un certo disprezzo latente. Ad esempio, il nome Samuel si trova deformato in “Shemuel” nel Ragionamento, e analogamente, in Lo schiavetto di Giovan Battista Andreini (1612), uno dei personaggi ebrei si chiama Scemoel. Questa distorsione, vero e proprio cliché dispregiativo avente per oggetto un nome ebraico fra i più diffusi in assoluto, è ricorrente164. Andreini vi gioca con una paradossale variante: in una scena (Atto II, scena 6), lo “Scemuel” (“scemo-lui”) si rivolge a se stesso apostrofandosi come “Scimison” (“sono scemo”). Si veda anche, analogamente, la distorsione “Merdochai” per il nome proprio “Mordechai”, nella scena del banco dei pegni nell’Amfiparnaso. Ma è nella letteratura schiavonesca che troviamo il maggior numero di equivoci interlinguistici di tipo triviale e scatologico, tutti giocati sulle idiosincrasie delle pronunce slave dell’italiano o dei nostri dialetti. Per l’ambiguità triviale sono interessanti, ad esempio, culami per il veneziano colo mi, “presso di me” (o anche per il croato ragusano kala mene); tra i casi di epentesi di n, perinchuli per “pericoli”; per l’inserzione di r, porcho per “poco”165. Nel Rado stizuso di Zuan Polo spesso le voci veneziane sono deformate ricorrendo al quiproquo: bulle de franza per “bolle di Francia” ma anche per “malfrancese”; merde per “verde”; mira in chulo per “miracolo”; nell’Egloga, il frequente merdecina per “medicina”; e altrove spesso anche chulo o culo per “collo”166. Anche i nomi dei due figli di Rado, Licha e Miochulo, veicolano simili amenità. Quanto alla melica schiavonesca, la prima canzone della citata raccolta del 1520 circa, Taritron taritron Caco Dobro Salzigon, suona: «Taritrun chacho in bun / Tutta note andiro zinte / per so manzi e bin voiente / che vignissima a balcun», col ritornello «Taritrun taritrun / Cacho dobro salsizun [com’è buono il salsiccione]…», con ovvio doppio senso sessuale. E così l’ultima: «Laltro zorno cagando me pensava / De vostro mor doce catherina…»167. Qui traspare, fra il cacho che vuol dire “come”, e il cagare dell’ultima poesiola, l’ossessione scatologica sia nell’equivoco termine slavo che nel suo buffonesco accostamento a un pensiero d’amore. 162 L’esempio è citato in CORTELAZZO 1976: 177. Atto II, scena 15 (cit. in BARICCI 2010: 144). 164 Uno “Sciamuel” è anche nelle Zittelle canterine (1663) di Loreto Vittori (RE 1912: 392). 165 CORTELAZZO 1971-72: 122, 125. 166 CORTELAZZO 1971-72: 134 s. 167 Cit. in PICOT 1894: 9 s. 163 41 Invece, gli equivoci interlinguistici basati sul greghesco in senso stretto sono tutti di tipo “innocente”, senza trivialità o scatologismi. Era così già nel precedente fornito, negli ultimi anni del Trecento, dalla novella XCII di Sacchetti, che contiene il personaggio di Soccebonel di Frioli, parlante in greghesco. «Dice Soccebonel: - Au, può essere cest? [= questo] - E que’ rispose: - Sì, può essere canestre -»168. Lo stesso registro inoffensivo viene tenuto anche nella comicità greghesca presente nel teatro di Andrea Calmo e dei suoi sodali e seguaci. Nella Rodiana di Calmo, nel dialogo tra il veneziano Cornello e il greco Demetrio (III, 6), il primo saluta l’altro: «Co vala, onde tireu?», cioè “Come va, dove vai?”. Risposta di Demetrio: «Mi no tiro gnendi, xe homo de pasi [pace], varda che non have larme [armi]»169. Anche i due personaggi del Diavolo [dialogo] piacevole di un Greco e di un Facchino, attribuito al Burchiella (alias Antonio da Molino), si scambiano battute basate sull’equivoco interlinguistico col greghesco: GRECO: Vu parlan be, propatti ombròs [cammina avanti]. FACCHINO: «Non son Ambris, sun Ze…»170. Nella commedia La pace di Marin Negro (1561), il dialogo fra due veneziani, uno dei quali parla in greghesco, trova un equivoco tra “spiti” (greghesco per “casa”) e “piti” (veneto per “galletti”) quando Francia chiede «No dubitari gnendi, te halla dinto chie porò andari cando voreu mi su la so spiti?», e Tabarin sbotta: «Che volif fa de piti, che ’l no gh’è galin chilò?»171. Nella commedia La capraria di Gigio Arthemio Giancarli (1544) l’equivoco è invece sulla parola “baia”: Dorotea dice ad Afrone che non ha voglia di ascoltare le sue baie, e lui sbotta. «Chie mi xe schillo (“cane” in greghesco), cà, chie baia?»172. Nelle moresche, infine, le tipiche idiosincrasie linguistiche degli africani subsahariani nella pronuncia delle lingue europee provoca occasionali ironie, ma sempre strettamente basate sul contesto narrativo che vede un “moro” alle prese con la situazione tipicamente europea - letteraria e musicale - della serenata o mattinata di corteggiamento. Passiamo così dal vocativo napoletano di gusto petrarchista “core mio” a cula mia (in Tiche toche e O Lucia, miau miau), ma frequentando anche i passaggi intermedi e le neutre distorsioni fonetiche di “core mia” o “cora mia” (in Catalina e A la lappia); e la “cantata” offerta all’amata viene detta “cantarata”, con allusione al “càntaro”, cioè al pitale. La tolleranza e spesso la simpatia verso gli africani neri schiavi o affrancati, tipiche del contesto napoletano, non esprimono alcun disprezzo o malizia, se non l’effetto comico dello spaesamento culturale di chi si cimenta con artefatti linguistici (l’italiano, il dialetto napoletano) e artistici (la serenata) di una cultura lontanissima dalla propria; e gli scambi di contumelie fra l’africano corteggiatore e la corteggiata (con precedenti nella poesia iberica) riflettono rivalità tribali autoctone più che pregiudizi italiani173. Come si può vedere, la melica predilige in generale un approccio ???? Il grande serbatoio comico della commedia madrigalesca provvederà poi a fornire una sintesi sia di questi precedenti melici, sia degli spunti forniti della Commedia dell’arte, assorbendo e sviluppando soprattutto il versante “innocente” dell’equivoco verbale, e solo occasionalmente malapropismi o fraintendimenti “maliziosi”. Nell’Amfiparnaso, ad esempio, troviamo “culintient” per “cuntent” (Atto I, scena 3). Alla sfera “innocente” si limitano invece le distorsioni comiche di nomi propri: il servo Pedrolino chiama Pantalone “Piantalimù” 168 Cit. in LAZZERINI 1977: 34. Cit. in ZANCARINI 1992: 126. Cit. in LAZZERINI 1977: 35. 171 LAZZERINI 1977: 35. 172 LAZZERINI 1977: 36. La Lazzerini precisa che «l’equivoco baia/abbaia è reso possibile dall’alta frequenza dell’aferesi nel linguaggio “greghesco”». 173 Cfr. SALVATORE 2012. 169 170 42 (piantalimoni) (Atto I, scena 1, O Pierulin, dov’estu?), che piccato gli risponde «Sì, pianta rave, e no piantalimon». Nel Ragionamento quarto della Prima Parte della Pazzia senile di Banchieri sarà invece invece il dottor Graziano a chiamare l’amico «messir Piantalimon», al che Pantalone replica chiamandolo «Dottor piantacedron». Spesso in una scena compaiono entrambi i tipi di equivoci. Nell’Amfiparnaso (Atto II, scena 2) dialogano il Capitan Cardone in spagnolo, e lo Zanni in bergamasco, con equivoci sulla parola “mozzo” (che Zanni intende come “evirato”); mentre lo spagnolo “accompana” viene inteso come “sunar la campana” (che nel gergo dell’epoca vuol dire “non udire”)174. Alcuni autori sfruttano un trucco più volte. Nel Metamorfosi musicale di Banchieri, in Non più parol il dottor Michelino insiste che vuole la fanciulla per “isposa” e “consorte”, ma le parole che gli escono sono “spinosa” e “culstort”. Nel Ragionamento quarto della Prima Parte della Pazzia senile è invece il dottor Graziano a usare “spinosa” per “isposa”, promettendo a Pantalone di fare a sua figlia, di cui gli viene offerta la mano, non un “presente” ma “un presidente”: al che Pantalone, ironico, risponde «Sì, e digo un Podestà». I regali promessi sono «una gallana» (per “collana”) e «du pugn’in ti dent» (per “un paio di pendenti”). Si tratta, tutto sommato, di un approccio piuttosto blando rispetto a una ormai lunga tradizione buffonesca e burlesca, che ha già dato molto al teatro e alla musica vocale, e che ormai pare a volte quasi infantile. Vero è che questo carattere blando o poco aggressivo della parodia caratterizza tutti i generi musicali e vocali dedicati alla raffigurazione parodistica delle minoranze. Nelle caricature fiorentine dei Lanzi, i doppi sensi osceni sono affidati come in tutti i canti carnascialeschi - più all’autodefinizione dei personaggi che all’equivoco interlinguistico. Nelle ebraiche, la caricatura linguistica non appare particolarmente dispregiativa, e nelle greghesche è addirittura assente (diversamente che nella letteratura schiavonesca, di cui pure fanno parte). A sua volta, l’atteggiamento parodistico delle moresche pare quasi affettuoso. Tuttavia, nel caso di greghesche e moresche va anche osservato che, sviluppandosi nella seconda metà del Cinquecento, lasciano supporre gli effetti controriformistici di una stretta censoria (e di inevitabili autocensure) nella gestione della comicità più greve o più erotizzata. A maggior ragione ciò vale per le commedie madrigalesche di Vecchi e Banchieri, con le quali ci troviamo ormai al passaggio di secolo. Non per questo, però, tramonta la pratica comica dell’equivoco verbale, destinata anzi a preservarsi nel tempo come elemento fondamentale della comicità popolaresca moderna. Prendiamo ad esempio, fra le maschere, il caso di Pulcinella, a sua volta autentico virtuoso dei malapropismi, e la cui evoluzione, fra i personaggi della Commedia dell’arte, fu lenta e tardiva. I suoi exploit più classici in materia si possono godere nell’opera di Gregorio Mancinelli, prolifico autore di teatro attivo a Roma tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento, in una riuscita serie di farse, come Pulcinella re in sogno ovvero Il pastore dalle selve al trono, La clemenza di Sapiro con Pulcinella mago per amore, La vecchia astuta ovvero il conte Cipoletta sordo con Pulcinella finto contessa delle Bergamotte, e cavalier francese intermezzo, quasi tutte pubblicate a Roma (presso Pietro Paolo Pellegrini) fra il 1769 e il 1771. Anche se i suoi lazzi hanno chiare radici nella Commedia dell’arte175, gli equivoci verbali vi acquistano un sapore speciale: anche perché praticamente tutti i malapropismi di Pulcinella riguardano il cibo. Una delle commedie più riuscite è Le novantanove disgrazie di Pulcinella, premiata da numerose ristampe nel secolo successivo (1807, 1824, 1856). Qui un ebreo lo saluta con un “Baruccabà”, al che Pulcinella prima ribatte «Dove è la perrucca dell’abbate?», poi rilanciando: «Tu puoi dicere baccalà quanto voi, che io no t’intendo»176. In un’altra scena della stessa commedia, sei ebrei danzano attorno alla maschera cercando di convincerla a convertirsi, in cambio del prestito richiesto. Il primo gli fa: «Oh voi da qui a mò 174 DENT 1911: 339. Circa il legame di questi lazzi pulcinelleschi con la Commedia dell’arte, vorrei far notare che un’altra farsa di Mancinelli, Pulcinella marito di tre mogli, debitore a forsa [sic], bastonato dalle donne, e perseguitato dalla magia (Roma, 1769), è sottotitolata “Commedia presa dall’improvviso e composta da Gregorio Mancinelli romano” (corsivo mio). Cfr. FRANCHI/SARTORI 2001: 119. 176 Cit. in BARICCI 2010: 135. 175 43 non vi chiamereti più Pulcinella, ma Miscè Bersalamon», cioè “Mosè figlio di Salomone”; e lui: «Se me chiameraggio Salamone, Merluzzo a mollo». Allora tutti gli ebrei cantano: «Da qui nanti sto longarello [giovanotto] non se tabarrerà [chiamerà] più Pulcinella, ma Miscè Bersalamon»; e lui: «Mosciarelle, e salamone»177. Anche i tedeschi della Commedia dell’arte settecentesca frequenteranno ormai solo i blandi territori gastronomici, ad esempio in una particolare interpretazione del cosiddetto “lazzo della lista”, spesso attribuito a personaggi stranieri tedeschi. Così nella Tabernaria e in altri scenari a cui fa riferimento Placido Adriani nel suo Zibaldone del 1734, dove «l’oste tedesco dà la lista delle spese fatte, cioè: “Quattro pilastri spezzati = quattro pollastri; sette colonne arrostite = sette colombi; tre monti pulciani = tre fiaschi di vino; anteposte de tripla in falze bordon = antipasto di trippa in brodo col polmon; una fottate con dieci oche = una frittata con dieci ova”»178. 3.5 Senso e fortuna di una nuova comicità Dalla nostra analisi di repertori melici, letterari e teatrali, scaturita da un approccio storicoartistico (riguardante cioè la storia della parodia in musica e nelle arti rappresentative), altri due implicazioni, però, si dipanano. Una è di natura strettamente sociostorica, concernendo il modo di interpretare il senso di tali parodie rispetto a una presunta “domanda” dei loro utenti, quasi esse ne fossero automaticamente eterodirette. L’altro ha invece una pertinenza storicostilistica, e riguarda sia le forme assunte da questa nuova comicità, sia le motivazioni alla base di scelte formali e stilistiche. Il modo in cui finora sono stati affrontati questi due aspetti mi sembra spesso limitato, nel primo caso, da considerazioni che andrebbero localmente circostanziate e correlate a un’analisi rigorosa dei singoli contesti, e nel secondo da uno scarso respiro prospettico. Interrogandosi sul senso ultimo della comicità interlinguistica, non pochi studiosi dei singoli repertori italiani e regionali convergono nell’interpretarla rispetto al senso di superiorità degli autoctoni verso agli immigrati, al gusto di ridicolizzare le differenze, al disprezzo che vi sarebbe sotteso. Un’interpretazione analoga, di fatto, a quella applicata - in un contesto socioculturale molto diverso - all’analisi dei pidgin presenti nel teatro spagnolo rinascimentale, come il sayagués del rustico (pastore o “villano”) o il guineo dell’africano nero. A proposito di essi, Sloman sosteneva ad esempio che «chi parla il gergo è ridicolizzato: perciò egli è sempre un servitore, un lacché o altra persona umile, in quanto un simile linguaggio non era in armonia con l’onore e la dignità di un nobiluomo»179. Affermazioni del genere rischiano però di confondere le intenzioni sottese a un testo con il punto di vista (vero o presunto) attribuito al pubblico. Lo si è fatto, ad esempio, per spiegare il successo della comicità poliglotta nel repertorio degli intrattenitori di piazza, in particolare a Venezia. In questo senso Robert Henke ha creduto di interpretare l’uso umoristico dei dialetti italiani: «i buffoni svilupparono un repertorio di questi dialetti codificati, con un lessico limitato ma facilmente recuperabile [retrievable] per l’improvvisazione orale, e li usavano per produrre la “risata di superiorità” nei pubblici veneziani di classe media o superiore»180. A sua volta, Manlio Cortelazzo ha immaginato che il pubblico dei cantimbanca fosse composto da ascoltatori «molto divertiti, evidentemente, delle parodie di atteggiamenti e parlate di gruppi “estranei” non ancora assorbiti, per costumi e lingua, nella comunità veneziana»181. Si riderebbe, dunque, per l’estraneità del soggetto ridicolizzato, e per consolidare il senso di superiorità dei nativi. Il pidgin imitato e 177 Ibidem. Cit. in CAPOZZA 2006: 352. 179 SLOMAN 1949: 207. 180 HENKE 2002: 59. Corsivo mio. 181 CORTELAZZO 1971-72: 114. Corsivo mio. 178 44 stilizzato si porrebbe come vero e proprio simbolo fonico di questa inferiorità sociale e culturale, o estraneità nazionale; la risata confermerebbe e suggellerebbe l’emarginazione. Probabilmente, il limite principale di simili considerazioni sta nella loro genericità. Lo stesso Cortelazzo, quando fa riferimento specifico alla letteratura schiavonesca, preferisce invece immaginare un divertimento giocoso, sia pure da parte di un in-group (cioè, in termini sociologici, del gruppo sociale dominante, i cui membri, in virtù della loro coesione e del senso di opposizione o competizione che proiettano sui gruppi esterni, esprimono la loro distante superiorità)182. Riguardo alla satira degli ebrei, invece, Baricci sostiene - a proposito di un equivoco verbale fra Pantalone e un ebreo nel Pantalone bullo - che «ciò che motiva la risata è l’incomprensione la quale, naturalmente, nasconde il disinteresse per una reciproca, autentica interazione»183. In realtà, scavando dentro i testi, se ne ricavano impressioni diverse. Ad esempio, nella commedia madrigalesca, gli unici accenni dispregiativi ai “diversi linguaggi” si concentrano sul suono delle lingue straniere, come quella «Babelle […] di voci e horribili favelle» riferita ai discorso fra ebrei in un banco di pegni nel brano Tich tach toch dell’Amfiparnaso di Vecchi. Il giudizio si limita alla cacofonia che produrrebbero gli ebrei quando parlano fra di loro, al loro interno: nessun accenno a interazioni esterne, anche perché, per il ruolo sociale che questa minoranza esercitava in alcune professioni, come quella dei prestatori di denaro, l’interazione indubbiamente avveniva a prescindere da qualsiasi diversità linguistica e veniva praticata, entro certi limiti, per ragioni di opportunità. Ogni giudizio in merito andrebbe dunque circostanziato. Stipčević, ad esempio, afferma che - come in altri generi musicali basati su linguaggi diversi dall’italiano o su pronunce atipiche - anche «la lingua schiavonesca e le altre varianti regionali spesso erano oggetto di ironia, soprattutto nel teatro»184. Ma bisogna aggiungere che solo in alcune di queste varianti l’ironia verso i balcanici era motivata da autentica diffidenza o ostilità: ad esempio quando era rivolta verso gli uscocchi, rifugiati bosniaci che, come i greci di Morea a Venezia, s’erano spinti verso le coste italiane dell’Adriatico per sfuggire ai turchi, e che svolgevano attività di pirateria e di saccheggio non solo contro le navi turche, ma anche verso la stessa Venezia. Nella commedia La malandrina (1587), lo scrittore veneziano Giovanni Francesco Loredano prendeva in giro gli uscocchi e le loro abitudini, assieme a quelle delle altre “genti barbare” che abitavano «nel selvaggio paese di Croazia»: la satira, in questo caso, viene spedita a domicilio, non ha relazioni dirette con la società veneziana185. Un’anonima canzone veneziana sulla decadenza della Repubblica, dei primi decenni del Seicento, si rifererisce invece alla guerra contro i pirati uscocchi, che da un secolo ormai infestavano l’Adriatico sotto la protezione austriaca, per definirli «dusento meschini / E grami stravestii da mattacini / Che ha la casa co’ ha i bovoli [lumache] sul cao [capo] / Che magna in pugno come i sparavieri»186. Quei pochi disgraziati - così li insulta la poesia - non hanno fissa dimora, mangiano poco e velocemente, avidamente; ulteriore ludibrio è dirli «vestiti come mattaccini», cioè buffoni da strada che si esibivano in gruppo, con gli abiti penzolanti e un po’ stracciati e i colori accoppiati a casaccio. Qui il disprezzo nasce dalla malevolenza, dall’ostilità, dalla necessità di neutralizzare culturalmente il nemico, screditandolo. Ma gli uscocchi sono un’eccezione, e l’atteggiamento veneziano rispetto ad altri balcanici resta ben diverso. In un foglio volante conservato alla biblioteca veneziana di San Marco si legge la seguente quartina: «Nu la semo de Albania / Strathiotti palicari [valenti] / Chie in cavallo in 182 Secondo Cortelazzo, nei componimenti della letteratura schiavonesca «le storpiature linguistiche servono ad aggiungere un motivo di riso alla materia di per sé pregna di pesanti sali. I testi, scritti (e, soprattutto, recitati in piazza) intenzionalmente in veneziano, affidano alle spezzature, alle inflessioni, alle insuperabili difficoltà sintattiche, alle frequenti chiazze lessicali, reali o convenzionali che fossero (e proprio qui, nella determinazione e nella circoscrizione di quella zona ambigua, sta il loro pieno interesse linguistico), dovute alle naturali abitudini idiomatiche degli Schiavoni, il compito di provocare il giocoso divertimento dell’in-group» (CORTELAZZO 1971-72: 120). 183 BARICCI 2010: 145. Corsivo mio. 184 STIPČEVIĆ 1993: 34. 185 Cit. in STIPČEVIĆ 1993: 35. 186 MEDIN 1904: 395 ss. 45 terra in mari / Nol stimemo la Turchia»187. Gli albanesi vi appaiono rassicuranti, in quanto anti-turchi. È bene anche collegare queste indispensabili distinzioni con una ricognizione più serena sul meccanismo alla base di ogni parodia, che è genere diverso e distinto dalla satira, e di cui vanno dunque considerate le motivazioni che le danno forma e le forniscono stilizzazioni. In questa direzione si può accogliere, quale premessa a una più attenta riconsiderazione degli aspetti sociologici delle parodie delle alloglotti, quella proposta da Lazzerini. La studiosa vi riconosce «un ennesimo recupero dell’antichissimo e universale espediente comico che sembra annettere alla contraffazione della parlata straniera, o addirittura alla parlata in sé, anche non contraffatta, degli alloglotti (visti come bárbaroi in senso etimologico) infallibili proprietà esilaranti. Confluiscono in questo topos tanto la simulazione dell’idioma allotrio (convenzionalmente rappresentato attraverso l’imitazione, all’interno della propria lingua, delle peculiarità fonetiche e morfologiche in quelle colte, con qualche sporadica e ovviamente non peregrina interpolazione lessicale), quanto la diretta parodia dello straniero che alterna il proprio idioma - di cui permangono tracce sensibili, non meri relitti - a quello degl’interlocutori, contaminando e solecizzando nel tentativo d’integrarsi linguisticamente in una comunità per lo più identificabile col pubblico, reale o potenziale, della commedia»188. Considerato dal punto di vista dei parlanti, ogni “idioma allotrio” rappresenta uno sforzo di integrazione linguistica; dal punto di vista degli autori delle parodie si trattava di una stilizzazione stereotipata ma realistica, che possiamo accogliere come un chiaro segno di conoscenza reciproca, non solo linguistica, e di sorridente attenzione verso la loro diversità. Il disprezzo si manifesta, dunque, solo quando c’è ragione di temere individui o gruppi estranei. Oltre a distinguere il tipo di sentimento che anima questo genere di parodia, al di là della sana risata con cui ciascuno può esercitare o esorcizzare il senso della differenza, bisognerebbe pure distinguere tra i vari gruppi allotri, e tra le diverse situazioni di inurbamento nelle grandi città italiane. Come si è visto, a Roma il pregiudizio antiebraico almeno in parte scaturiva (e veniva alimentato e giustificato) dalla propaganda papale, che orientava perfino il Carnevale nelle sue espressioni più discriminatorie. La situazione non è meno peculiare - ma in senso opposto - a Venezia, centro fra i più importanti nello sviluppo della comicità di tradizione buffonesca, e in particolare di quella dei “diversi linguaggi”. Come ha rilevato Jean-Claude Zancarini, «il riso dello spettatore nasce da questo carnevale delle lingue, dei loro confronti e miscugli, non da un sentimento di superiorità del nativo di fronte all’uomo “di fuori” che non padroneggia i codici linguistici dominanti»: a Venezia lavorano, producono ricchezza e benessere; hanno più volte ripopolato la città dopo le pestilenze, e l’hanno difesa in armi dai nemici189. In definitiva, «questo riso non è il segno di un’esclusione» ma di un’identità urbana complessa190. Portiamo un nostro esempio a supporto di questa interpretazione. Nel citato foglio volante di autopresentazione degli stradiotti, il testo introduttivo ai versi parla del diletto che dà ai veneziani «chesta nostra lingua gresesca [sic]»: dal punto di vista degli albanesi (pur simulato dall’anonimo autore, se veneto e non schiavone) si tratterebbe appunto di diletto e non di derisione191. Un altro esempio cogente è offerto dal repertorio delle greghesche. A differenza di altri generi musicali ispirati al linguaggio o ai comportamenti di qualche minoranza linguistica, fra le greghesche ci sono molte semplici canzoni d’amore, o comunque prive di contenuti scherzosi o osceni. Perciò vi sarebbe in parte assente perfino lo spunto 187 Cit. in ELWERT 1960: 422. LAZZERINI 1977: 49. ZANCARINI 1992: 130. Corsivo mio. 190 ZANCARINI 1992: 132. Ad esempio, i tedeschi erano una delle comunità straniere più stabili a Venezia, con un fondaco che risaliva al XIII secolo, forti rapporti commerciali con gli autoctoni, interpreti e manuali di conversazione a disposizione (ZANCARINI 1992: 128). Da qui la presenza di personaggi tedeschi nel teatro di Calmo (un carbonaio in La Spagnolas e il servo Corrado in La Rodiana). 191 Cit. in ELWERT 1960: 422. 188 189 46 comico, il meccanismo della parodia o del sarcasmo: «la coloritura linguistica dialettale o regionale non implicava necessariamente una distanza ironica dell’enunciato poetico»192. Alla necessità di distinguere si accompagna dunque quella di collocare le distinzioni negli opportuni contesti letterari e sociali. Nel corpus plurilinguistico delle commedie dei Liquidi e dei loro pochi continuatori, ad esempio, personaggi padovani, bergamaschi, greci e dalmati sono presenti quasi ovunque, riflettendo la loro reale presenza e distribuzione in città. Anche sulla scena essi rispecchiano una realtà sociale di coabitazione e plurilinguismo, fattori entrambi non privi di tensioni, ma mai di nette contrapposizioni; e una politica di espansione e relazioni sia sulle periferia di terra che sui possedimenti d’oltremare, laddove «la geografia politica che si disegna sulla scena è un riflesso della geopolitica»193. Pur comici, dunque, questi personaggi e le loro lingue stanno su un terreno di parità con i veneziani. Il vecchio innamorato può essere indifferentemente greco, bergamasco o veneziano: così sono democraticamente distribuiti i tre personaggi ridicoli della Spagnolas di Calmo. Quanto al padovano, che rappresenta il campagnolo riciclatosi in servo sulla città lagunare, risulta - già dal teatro del Ruzante - come personaggio astuto e di apprezzabile naturalezza, con una netta inversione di tendenza rispetto all’eredità medievale della satira, asperrima, del “villano”. D’altra parte greci e dalmati, così come i bergamaschi, possono essere personaggi positivi o negativi, vincenti o perdenti, secondo i casi e senza preclusioni194. Questa “rivincita” del villano sta a fondamento del gusto rinascimentale verso il popolaresco, così come le parodie degli alloglotti forniscono elementi creativi di mediazione tra un umorismo di forte impronta popolare e la tendenza a uno sperimentalismo applicato a temi sia “alti” che “bassi” del Rinascimento inoltrato. Quando impiegati nella musica vocale, tali temi trovano caleidoscopiche espansioni polifoniche che li proiettano in una dimensione realmente, letteralmente corale, ormai inclini al sorriso più che alla risata, alla simpatia anziché al disprezzo. L’affermazione protomoderna di un nuovo genere di comicità, basata sull’equivoco verbale ma di ampia e complessa motivazione sociale, troverà in questa simpatia un’autentica vivacità. Conservatasi ancora fresca fino ai generi teatrali “minori” del Novecento e nelle sue forme di intrattenimento più popolare, tale vivacità fa da motore a una comicità ispirata a valori di tolleranza, e capace di giungere a elaborazioni creative anche altamente sofisticate, dai fratelli De Rege a Totò e, in musica, dal Quartetto Cetra agli Shampoo195. *** BIBLIOGRAFIA ADEMOLLO 1883: A. Ademollo, Il carnevale di Roma nei secoli XVII e XVIII: appunti storici con note e documenti, Sommaruga, Roma, 1883. BARICCI 2010: E. Baricci, La scena “all’ebraica” nel teatro del Rinascimento, «ACME», 63, 1, 2010. BARTOLI 1880: A. Baroli, Scenari inediti della Commedia dell’Arte. Contributo alla storia del teatro popolare italiano, Sansoni, Firenze, 1880. BAUMANN 1996: R. Baumann, I lanzichenecchi, Einaudi, Torino, 1996. 192 193 ZANCARINI 1992: 129. ZANCARINI 1992: 130. Le altre lingue presenti sulla scena non corrispondono a personaggi nativi di quella lingua in quanto non integrati nella città (ZANCARINI 1992: 132). 195 MACCHIA 2011: passim. 194 47 BRUSCAGLI 1986: R. Bruscagli (cur.), Trionfi e canti carnascialeschi toscani del Rinascimento, 2 voll., Salerno Editrice, Roma, 1986. BRUSCAGLI 1986a: R. Bruscagli, Introduzione a BRUSCAGLI 1986. CAPRIN 1907: G. Caprin, La Commedia “ridicolosa” nel secolo XVII (Appunti di critica storica), «Rivista Teatrale Italiana», 7, 13, 2-3, 1907. CARDAMONE 1991 D.G. Cardamone (cur.), Orlando di Lasso et al., Canzoni villanesche and villanelle, A-R Editions, Madison, 1991. CHASCA 1946: E. de Chasca, The Phonology of the Speech of the Negroes in Early Spanish Drama, «Hispanic Review», 14, 4, ottobre 1946. CIAPPELLI 1997: G. Ciappelli, Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1997. CICOGNA 1827: E.A. Cicogna, Inscrizioni veneziane…, vol. II, presso Giuseppe Picotti stampatore, Venezia, 1827. CORTELAZZO 1971-72: M. Cortelazzo, Il linguaggio schiavonesco nel Cinquecento veneziano, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», 130, 1971-72. CORTELAZZO 1976: M. Cortelazzo, La figura e la lingua del “todesco” nella letteratura veneziana rinascimentale, in Scritti in onore di Giuliano Bonfante, Paideia, Brescia, 1976, vol. 1. D’ONGHIA 2009: L. D’Onghia, Pluridialettalità e parodia. Sulla “Pozione” di Andrea Calmo e sulla fortuna comica del bergamasco, «Lingua e stile», 1, 2009. DUFOURNET/FIORATO/REDONDO 1992: J. Dufournet, A.Ch. Fiorato, A. Redondo (curr.), L’image de l’autre européen. XVe-XVIIIe siècles, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1992. EINSTEIN 1949: A. Einstein, The Italian Madrigal, Princeton University Press, Princeton, 1949, rist. 1971, vol. I. ELWERT 1960: W.Th. Elwert, L’emploi de langues étrangères comme procédé stylistique, «Revue de Littérature comparée», 34, 3, 1960. FELDMAN 1995: M. Feldman, City Culture and the Madrigal at Venice, University of California Press, Berkeley, 1995. FERRARA 1950: Mario Ferrara, Linguaggio di schiave nel Quattrocento, «Studi di filologia italiana», Bul. Accad. della Crusca, 8, 1950. FORTIS 2006: U. Fortis, La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-italiane, Giuntina, Firenze, 2006. FRANCHI/SARTORI 2001: S. Franchi, O. Sartori, Le impressioni sceniche: dizionario biobibliografico degli editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800, vol. II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2002. GALLUCCI 1981: J.J. Gallucci, Florentine festival music 1480-1520, A-R, Madison, 1981. GHISI 1939: F. Ghisi, Carnival Songs and the Origins of the “Intermezzo Giocoso”, «The Musical Quarterly», 25, 3, 1939. GUERRINI 1879: O. Guerrini, La vita e le opere di Giulio Cesare Croce, Zanichelli, Bologna, 1879. HARRÁN 1989: D. Harrán, Tradition and Innovation in Jewish Music of the Later Renaissance, «The Journal of Musicology», 7, 1, 1989. HARRÁN 2008: D. Harrán, “Barucaba” as an Emblem for Jewishness in Early Italian Art Music, «Jewish Quarterly Review», 98, 3, 2008. HARRÁN 2009: D. Harrán, “Adonai con voi” (1569), a simple popular song with a complicated semantic about (what seems to be) circumcision, in VELTRI/DIEMLING 2009. HÉLIAN 1681: L. Hélian, Lo squitinio della libertà originaria di Venezia, in Colonia, appresso Pietro del Martello, 1681. HERCZOG 2005: J. Herczog, Marte armonioso. Trionfo della Battaglia musicale nel Rinascimento, Congedo, Lecce, 2005. 48 KIRKENDALE 1972: W. Kirkendale, Franceschina, Girometta, and Their Companions in a Madrigal “a diversi linguaggi” by Luca Marenzio and Orazio Vecchi, «Acta Musicologica», 44, 2, 1972. LIHANI 1979: J. Lihani, Bartolomé de Torres Naharro, Twayne, Boston, 1979. LUZIO/RENIER 1888: A. Luzio, R. Renier, Commedie classiche in Ferrara nel 1499, «Giornale storico della letteratura italiana», 11, 1888. MACCHIA 2011: E. Macchia, Il comico nella forma canzone: tecnica e stile della parodia dialettale, tesi di laurea, Università del Salento, 2011. McGEE/MITTLER 1982: T.J. McGee, S.E. Mittler, Information on Instruments in Florentine Carnival Songs, «Early Music», 10, 4, 1982. McGEE 1983: T.J. McGee, “Alla Battaglia”: Music and Ceremony in Fifteenth-Century Florence, «Journal of the American Musicological Society», 36, 2, 1983. MEDIN 1904: A. Medin, La storia della Repubblica di Venezia nella poesia, Hoepli, Milano, 1904. MELZI 1838: G. Melzi, Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani, 2a ed. corr. ed accr., Paolo Antonio Tosi, Milano, 1838. ORIGO 1955: I. Origo, The Domestic Enemy: the Eastern slaves in Tuscany in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, «Speculum», 30, 3, 1955. PERRELLI 2004: F. Perrelli, Lo spettacolo della razza, «L’asino di B.», 8, 9, 2004. PICOT 1894: E. Picot, La raccolta di poemetti italiani della biblioteca di Chantilly, Pisa, 1894 (Estratto della Rassegna Bibliografica della Letteratura italiana, anno II, n. 4, 5). RADCLIFF-UMSTEAD 1969: D. Radcliff-Umstead, The Birth of Modern Comedy in Renaissance Italy, University of Chicago Press, Chicago and London, 1969. RE 1912: E. Re, Qualche nota sul tipo dell’ebreo nel teatro popolare italiano, «Giornale storico della letteratura italiana», 60, 1912. ROUCH 2006: G.C. Croce, L’eccellenza e trionfo del porco e altre opere in prosa (M. Rouch, cur.), Pendragon, Bologna, 2006. SALVATORE 2012: G. Salvatore, Parodie realistiche. Africanismi, fraternità e sentimenti identitari nelle canzoni moresche del Cinquecento, «Kronos», 2012 (in corso di pubblicazione). VATIELLI 1921: F. Vatielli, Canzonieri musicali del ’500 [seconda parte], «Rivista Musicale Italiana», 28, 4, 1921. VELTRI/DIEMLING 2009: G. Veltri, M. Diemling (curr.), The Jewish Body. Corporeality, Society, and Identity in the Renaissance and Early Modern Period, Brill, Leiden, 2009. VIDOSSI 1960: G. Vidossi, La cantata del Rado stizzoso, «Lares», 26, 1-2, 1960. ZANCARINI 1992: J.C. Zancarini, “Etranges étrangers”: L’autre comique dans la comédie polyglotte vénitienne du XVe siècle, in DUFOURNET/FIORATO/REDONDO 1992. ZOTTI 2008: C. Zotti, Le sourire du moine. Adriano Banchieri da Bologna, musicien, homme de lettres, pédagogue, Serre, Nice, 2008.
Scarica