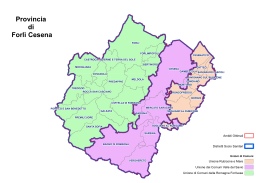AGOSTO 2006 - contiene inserto redazionale Editoriale Le Legazioni “romagnole” e il “lombardo veneto” Nell’ambito dello Stato pontificio le così dette Legazioni, divise nei tre territori di Bologna, di Ferrara e di Forlì, mantennero costantemente una posizione particolare, una specie di autonomia, di fatto ed anche in parte di diritto, che aveva il suo fondamento e la sua ragion d’essere nelle tradizioni storiche emiliane e romagnole ed in rilevanti fattori geografico-economici. Ferrara, entrata a far parte dello Stato della Chiesa alla fine del sec. XVI, sebbene si fosse a poco a poco attenuato nella progressiva decadenza della città il ricordo della fiorente età comunale e rinascimentale, non rinunciò mai del tutto al suo ruolo di Capitale del basso Po, di cui anche sul piano economico continuò ad essere il naturale centro d’attrazione. Molto minore forza d’attrazione ebbe invece Forli. Prima del Congresso di Vienna, del suo territorio, faceva parte anche Ravenna; erano città entrambe popolose e tendenzialmente autonomiste, ognuna delle quali aveva una sua tradizione storica da far valere. Di conseguenza nel quadro della formale unità politicoamministrativa della Legazione romagnola continuarono sempre a sopravvivere, sopiti ma non spenti, particolarismi e antagonismi tra città e città, e perfino tra paese e paese. Anche Bologna, che, come Forlì, era entrata a far parte dello Stato della Chiesa all’inizio del sec. XVI durante il pontificato di Giulio II, conservò in gran parte intatte attraverso i secoli le particolari caratteristiche della sua tradizione culturale e della sua struttura socioeconomica e nell’indole cordiale ed amante del quieto vivere, ma fiera, dei suoi abitanti non andò mai perduto quel senso di orgoglio che aveva animato la città nelle lotte contro Federico II e nel periodo della signoria dei Bentivoglio. Ancora alla fine del Settecento sopravviveva il Senato bolognese; era composto esclusivamente dai nobili, aveva un proprio Ambasciatore presso il Papa e conservava gelosamente i suoi privilegi e la sua autonomia. Molto scarso però, per non dir nullo, il suo peso politico, poiché la sua attività si limitava quasi esclusivamente al formalismo di fastose e costose cerimonie, utili solo, in pratica, a dar lustro al prestigio delle grandi famiglie, tutto ciò non fu tuttavia privo di conseguenze nel periodo risorgimentale, in quanto la polizia pontificia agì sempre assai timidamente e con molta cautela nei confronti dei liberali che appartenevano a famiglie del patriziato bolognese. Bologna, Ferrara e Forlì furono dunque capitali di tre territori diversi tra loro per tradizioni storiche, che anche sul piano amministrativo non ebbero mai una unificazione. Bologna, soprattutto per la sua Università frequentata da molti studenti romagnoli ed anche per il fatto di essere la città più popolosa e il più importante centro economico delle Romagne, godeva di particolare prestigio; ma non si può dire che, pur non essendo capitale delle Legazioni sul piano politico-amministrativo, fosse almeno considerata come una specie di capitale morale, poiché la distinzione tra bolognesi, ferraresi e romagnoli continuò a sussistere anche sul piano psicologico. Se nel loro interno le Legazioni furono ben lungi dal costituire un tutto unico, molto più netta è stata la frattura tra le Legazioni e le altre regioni dello Stato pontificio, e soprattutto tra le Legazioni e il Lazio, per un complesso di fattori storici e geografici di cui sarebbe troppo ampio far cenno in questa sede. Il periodo napoleonico accentua ulteriormente questa frattura: le NUMERO 22 Legazioni per circa diciotto anni fanno parte della Repubblica cispadana, della Repubblica cisalpina e poi del Regno italico, cioè di strutture politico-economiche che gravitano verso il nord, ed esperimentano, dopo secoli di governo clericale, un governo laico. A ciò si aggiunge, sin dalla prima fase del periodo napoleonico, una base giuridica: il trattato di Tolentino, del 19 febbraio 1797, con cui Pio VI rinunciò alle Legazioni a favore della Repubblica francese. È proprio il trattato di Tolentino che, durante il Congresso di Vienna, costituisce un’arma nelle mani del Metternich per rivendicare all’Austria, vittoriosa su Napoleone, il possesso delle Legazioni. Lo stesso Antonio Aldini, già Segretario di Stato del Regno italico presso Napoleone, consultato dal Metternich riguardo al futuro regime da dare alle Legazioni, si espresse a favore della tesi austriaca, ritenendo che sarebbe stato più vantaggioso per le Romagne far parte del sistema politico-economico dell’Italia settentrionale, con una loro amministrazione autonoma nell’ambito dell’Impero d’Austria, piuttosto che rientrare nell’ambito dello Stato pontificio. Tuttavia il cardinale Ercole Consalvi riuscì a conservare le Legazioni al Governo di Roma, agendo con grande abilità e riuscendo a superare molte difficoltà e molti ostacoli. Ma lo sconvolgente periodo napoleonico e le aspirazioni austriache ad inserire le Legazioni nel Regno lombardo-veneto, aspirazioni con cui concordava, sia pure per motivi diversi, anche certo «separatismo» emiliano, non furono senza conseguenze: il distacco tra le Legazioni e Roma si aggravò; da parte degli innovatori, a qualunque tendenza appartenessero, la Roma papale fu vista come un ostacolo ad ogni progresso politico ed economico. A Roma, d’altra parte, Bologna e le Romagne furono sempre considerate come un permanente focolaio di ribellioni e di rivoluzioni. La frattura fra lo Stato pontificio e le Legazioni, che, in qualche modo, era subdolamente favorita anche dall’Austria, si accentuò ulteriormente nel periodo del pontificato di Leone XII (settembre 1823-febbraio 1829), che pur non discostandosi sostanzialmente dalla linea politica del Consalvi, non fu altrettanto moderato e perseguitò duramente i carbonari e, in genere, chiunque fosse sospetto di liberalismo. Dopo il Congresso di Vienna, anche ad opera della saggezza politica del Segretario di Stato, Consalvi, che si ispirò a principi di moderazione e di cauto riformismo, le Legazioni rimasero abbastanza tranquille, almeno apparentemente: la restaurazione ebbe inizio nel luglio del 1815, con un governo provvisorio pontificio e divenne definitiva nel luglio del 1816, con la nomina e l’ingresso dei Cardinali Legati a Bologna, a Ferrara, a Forlì e nella nuova Legazione di Ravenna, la cui aspirazione a rendersi autonoma da Forlì fu esaudita. Non deve far dunque meraviglia se, per l’influenza delle tradizioni storiche e delle più recenti esperienze della Repubblica cisalpina e del Regno italico, le Legazioni pontificie ebbero durante il Risorgimento una vita politica propria, con proprie caratteristiche e vicende e si differenziarono notevolmente dalle altre parti dello Stato Romano, entro il quale costituirono una specie di corpus separatum formando nel complesso quadro del problema nazionale una questione a sé, che in certi momenti balzò in primo piano e attirò l’attenzione della diplomazia europea, come “caso” della massima urgenza e gravità . Né deve far meraviglia, quindi, se furono proprio Bologna e le Romagne a dar vita nel 1831 a quello che fu il primo tentativo di autogoverno realizzato in Italia nel periodo risorgimentale: il Governo provvisorio delle Province Unite. G.F.F. 1 I BRENTATORI 2 I brentatori erano facchini specializzati ed attrezzati per un traproprio questo compito (ed è da pensare che esso sia durato sporto particolare, e si trovavano naturalmente soltanto in città molto a lungo se è vero che i pompieri veri e propri sono istituie più esattamente in quelle città che erano toccate da fiumi. ti a Bologna soltanto nel 1802!). Il problema del trasporto del vino alle abitazioni o alle botteCon gli statuti del 1388 si delinea un’altra funzione per i brenghe, alle mescite o alle osterie si poneva soltanto dove il mezzo tatori: essi, forse loro malgrado, diventano degli informatori fiimpiegato per portare la merce in città non poteva arrivare alle scali in quanto sono tenuti a denunciare il traffico che passa per soglie delle case: un carro può arrivarci, una barca o una chiatta le loro mani, anzi: per le loro brente. In pratica, del resto, se non evidentemente no (salvo il caso dl Venezia). E allora è il vino sbaglio, settanta anni fa la esazione dei dazi comunali si basava che i navicellai conducono ai porti fluviali che viene preso in fondamentalmente sulle denuncie dei trasportatori. consegna da questi brentatori. Ma, a parte questo particolare, quello che gli statuti del 1388 Un argomento che interessava da vicino il commercio e il conmettono in moto è il meccanismo che condurrà alla creazione sumo del vino nelle città dell’Italia padana. di una più articolata struttura del sodalizio che, di lì a poco, Dunque, rapidamente, diremo che le città sono tutte città romadiverrà una vera e propria «arte». ne e hanno avuto un porto fluviale (a Bologna, in particolare, Giusto in ordine alla funzione antincendio si sente, infatti, la quello sul Reno nel quale si sa che esisteva una stazione doganecessità di regolamentare il servizio con l’istituzione di precisi nale longobarda.) turni di guardia sulla torre degli Asinelli, dov’era la campana Perché ricordo questi particolari? Prima di tutto per dire che già antincendio e di conseguenza con la creazione di un «preside » i Romani avevano creato i collegia dei mestieri, che diventeranche ne sia il responsabile. no ministeria in epoca alto-medioeFinalmente, benché con un paio di vale e poi artes in epoca comunale: secoli di ritardo sulle altre, nel 1407, fra le quali organizzazioni, se non durante la legazione del Cossa, prepuò pensarsi a una continuità istitusto antipapa con il nome di Giovanni zionale, si può certamente intraveXXIII, nasce l’ars brentatorum: il dere una continuità di funzioni. preside è sostituito da un «massaIntanto c’è da domandarsi perché ro», che è il capo di un collegio di mai l’arte dei brentatori, come le sei membri che si rinnova ogni sei altre connesse con il traffico delle mesi con un procedimento di coopderrate, sia nata così tardi. La ragiotazione tipico di quelle organizzane è questa: i comuni ostacolavano zioni verticistiche che furono spesso il sorgere di corporazioni nei settori le artes del periodo comunale. del commercio alimentare per imDalle «provvisioni» che vengono pedire il rincaro degli approvvigioadottate da questo consiglio si namenti a cominciare dai costi di evince che sono mantenuti alla cortrasporto. porazione brentatoria certi obblighi È evidente che il problema si popubblici e cioè il servizio antincedio neva più che mai a Bologna dove e quello di bollatura e misurazione lo studio, l’università , e quindi il delle castellate. Per i soci, al divieto costo della sua frequenza, era eledi commerciare vino si aggiunge mento determinante dell’economia quello di esercitare la mediazione. e, direi, della fortuna cittadina. Ma soprattutto appaiono chiaramenL’accenno alle stazioni doganali te la miseria, la bassa estrazione, la longobarde ci serve a radicare in un scarsa moralità e il cattivo comporcostume ormai assodato la preoccutamento di questi soci: frodano il pazione di impedire una forte orgadazio, sono morosi nei confronti del nizzazione di coloro che operavano loro sodalizio, litigiosi e via dicennel campo degli alimentari: gli scado. Viene, cioè, asseverato quello rii, vocabolo appunto longobardo, stupendo quadro che de’ jachini o erano gli addetti alla vigilanza conbastagi in genere, et in ispecie de’ tro il sorgere di società nel settore Brentatori ci dà Tomaso Garzoni da dell’approvvigionamento. Bagnacavallo in quell’incredibile Ma anche per un altro motivo ho Imbonitore di vini, primi del 1900 libro che è La piazza universale, sottolineato la comune origine romana delle città padane: è pubblicato in Venezia nel 1665 e che meriterebbe ben altra proprio nella tradizione romana che ad ogni monopolio corrifortuna. spondano degli obblighi pubblici; cioè su ogni concessionario Gli è che per questi brentatori bolognesi la vita si è fatta sempre incombono dei munera. più dura, il lavoro è diminuito, la tassa di iscrizione è sempre Ebbene, i brentatori bolognesi, pur dietro un compenso di tre più alta. Ad esempio, nel 1410 tale quota era stata di 15 lire per bolognini per ogni intervento, erano tenuti a svolgere il servizio i bolognesi e di 25 per i forestieri, pari al compenso percepito antincendio in esclusiva, mentre in altre città il compito è affirispettivamente per il trasporto di 2.400 e 4.000 brente; nel dato ad altri artigiani, in genere muratori. 1426 per pagare la tassa un bolognese dovrà trasportare ben Con le brente ancora odorose di vino essi dovevano portare 3.600 brente e un forestiero, 5.200 (in litri si passa da 94 a 141 acqua per spegnere le fiamme, frequenti e suscettibili di spae da 157 a 194). Va però notato che per i figli dei soci, evidenventose conseguenze in una città le cui case erano ancora in temente allo scopo di mantenere il monopolio in un ambito gran parte di legno. ristretto, erano previste forti agevolazioni: la tassa di cui sopra È un castigo o una burla? È un contrappasso dantesco o un lamper questi figli dei soci era nel 1410 di sole 2 lire pari a 320 po di ironia petroniana? brente trasportate e nel 1426 sarà di 4 lire e 10 soldi pari a 720 Non so rispondere; così come non saprei rispondere al quesito brente trasportate. tecnico di chi mi chiedesse come, all’indomani, i brentatori Ma ciò non vale a scongiurare il lento declino di questa arte: potessero togliere, prima di iniziare il lavoro, il puzzo di acqua malinconico cammino che noi non possiamo seguire e che finidai loro recipienti! rà nell’abolizione della compagnia alla fine del XVIII secolo. Domenico Berardi Comunque, negli statuti del 1250-67 ai brentatori è imposto SOPRANNOMI In Romagna, cinquanta anni fa, quando volevate identificare qualcuno, non dovevate pronunciare il nome e il cognome perché correvate il rischio di non farvi capire, ma bensì il soprannome che allora tutti immediatamente vi capivano. I cognomi esistevano ma servivanono solo per gli uffici pubblici, i notai etc. Comunemente parlando chi li ha mai usati ? Specialmente nei piccoli centri l’ unico modo di individuare una persona era il soprannome. Faceva eccezione qualche volta il nome patronimico (Toni ‘d Michil) oppure l’accenno al mestiere esercitato (Jusef de’ fabar - Zvanon de’ trator), ma del cognome se ne faceva benissimo a meno. Nel mercato del bestiame non si andava avanti che coi soprannomi. «Ho avuto occasione, tempo fa, (ben dice il Toschi) di consultare alcuni libri (bollati e tenuti scrupolosamente) nell’ ufficio di un notissimo commerciante di Lugo e con sorpresa notai delle partite intestate coi soprannomi: E’ mor de’ sdarz, Muritell de’ Catzlon, E’ sbrengh, E’ svezzar, E’ mor de’ Rose, E’ Gagiôn ecc. Ed avendone richiesto il perché al proprietario questi mi rispose: l’e’ lavor dal besci, se arcurdì un marcant par e’ su cugnom u n e’ cnoss ansun, ma s’ ai degh e’ soranom i1 cnoss tott i marcant dal quatter Legazion!» Certo è che i soprannomi in genere devono aver avuto origine da un atto o da un fatto che serva a determinare un dato soprannome piuttosto che un altro. E questo si può chiaramente vedere da quelli nuovi cioè affibbiati recentemente a chi compie qualche cosa che si distacca dal comune, che è da ricordarsi. Qualche volta il soprannome ha anche origine da una parola qualsiasi che un tale ha il vezzo di ripetere troppo spesso. Per esempio me degh o l’è vera. Se la ricerca di queste provenienze potesse avere qualche interesse si troverebbe con sicurezza ed in breve la genesi di quasi tutti i soprannomi e quindi il fatto o il detto che li determinò. Ne dò alcuni esempi fra quelli esistenti. Alcuni derivano dal luogo di origine come: Cmacès, Bulgnès, Furlès, Mugiana, Ruman, Vintsian. Ravgnan. ecc. Alcuni sanno di autorità, come: E’guéran, E’ vescuv, E’ paruch, E pépa, E’ sendich, E’ Signor, E’ popul, Garibeldi ecc. Molti sono derivati da generi, alimentari: Caplett, Lisagnott, Macarön, Brasula, Bistech, Salamen, Panett, Pulintôn ecc. Altri provengono dal regno, animale; quali: Gatôn, Cagnôt, Vuipetta, Sumaren, Ranoc ecc. Altri ancora si distinguono dai precedenti... quadrupedi per passare fra i... volatili: Rundanena, E’ merel, Pizôn, La ciòzza, Pujan, Quaja ecc. Molti altri non sono che... generi di vestiario quali: Bretta, Caplena, Gabana, Bragunôn, Muda, Cassetta, Curpett, ecc. Alcuni erano di provenienza.., monetaria: Bajoch, Tripéval, Sterlena, Bajuchen, Zantesum I componenti di una famiglia prendevano il nome o il soprannome, anche per più generazioni, dal personaggio più conosciuto della famiglia stessa: per esempio i Camel dal nome del più noto Camillo e così per il soprannome, per esempio i Bajoch dal più noto capostipite. Per esempio: quando sentite dire che un tale lo chiamano l’imbalzè credete che cammini spedito? Se ad un altro sentite dire l’ imbarlè credete che non abbia una imperfezione fisica che lo fa apparire tale? E E’ gobb, E’ tistôn, E sguerz, E merz, ecc. sono tutti soprannomi derivanti da difetti fisici. I nomi di battesimo vanno cambiandosi quasi completamente. Un tempo vi erano molti nomi doppi, oggi scomparsi, come Pir-Sintôn, , Pir-Zvanì, Zvan-Antoni, Pir-Batzton ecc. L’ arsdor che portava uno di tali nomi formava senz’ altro il soprannome della famiglia ed ai discendenti si diceva invariabilmente: Zvanôn d’ Pirsiniô, Toni d’ Pirmareja ecc. I nomi maschili più in uso nelle famiglie erano: Antonio (Tugnì), Giuseppe (Jusef, Jusafita, Fita), Luigi (Gigi), Francesco (Checco), Paolo (Peval), Domenico (Minghì). Del resto il procedimento seguito per mettere il nome al neonato era dei più semplici: quando non vi fosse qualche vecchio da arcrover si ricorreva al lunario e si prendeva senz’ altro il nome d’che-bandett Sant d’incù! La morte di un Papa o di un Re, la conseguente salita al trono del successore, la nascita di un Principe o di una Principessa erano altrettante forniture di nomi per neonati e in questi casi si faceva eccezione alla regola. Anche i campioni sportivi suggerivano i soprannomi: il mio bisnonno Bernardi, oste famoso di Imola, era soprannominato Cipuloni dal cognome di un famoso giocatore di pallone col bracciale. Non esistevano vezzeggiativi solo qualche diminutivo: Franschén, Zvanén, Luisjna, Tugnina, Marianina ed in compenso molti accrescitivi (resi del resto necessari per poter avere una parola sulla quale forzare la voce per chiamare a distanza nei campi) quali Mingôn, Tugnôn, Tugnaz, Luvig, Frazcôn o Chicôn, Pavlôn, Jusfôn ecc. Altre volte una operazione chirurgica particolarmente nuova o su una parte del corpo “particolare”, come per esempio le emorroidi, nel primo Ottocento, diventava l’irriverente soprannome per diverse generazioni e, nel caso di chi esercitava un pubblico servizio, come la gestione di una trattoria, veniva aggiunto al nome del gestore. Per esempio a Forlì la famosa ed ottima trattoria di Pirì ed cul rott aveva ereditato questo irriverente nome da un primitivo gestore che aveva subito, trai primi nell’Ottocento, questa operazione. A questo proposito mi permetto di raccontare come nell’archivio storico comunale forlivese esista una istanza avanzata da un tale che aveva acquistato quella trattoria dopo diversi passaggi di proprietà e che chiedeva fosse proibito l’irriverente, persistente appellativo. Quel civilissimo e romagnolissimo Consiglio forlivese, dopo ampio dibattito, deliberò che da quel momento la trattoria dovesse nominarsi: “Da Pietro dall’ano infranto”! Un interessante elenco di soprannomi possiamo ricavarlo anche dalle opere del grande scrittore romagnolo Francesco Serantini. Ecco riportato un elenco dei più noti briganti della banda di Stefano Pelloni detto il Passatore. Giuseppe Afflitti detto Lazzarino, detto anche Cavina; Francesco Babini detto il Matto o Mattiazza; Angelo Lama detto Lisagna; Felice Scheda detto l’Anguillone detto anche Magnabisce; Primo Bertoni detto Spiga; Antonio Ravaioli detto il Calabrese detto anche il Marcio; Alfonso Panzavolta detto l’Innamorato; Giuseppe Morigi detto Morischi, detto anche l’Incantato; Tomaso Montini detto Teggione; Giuseppe Tasselli detto Giazzolo; Michele Conti detto Carrera; Giuseppe Zanelli detto Cesarino; Domenico Sabbattani detto Ghigno; Antonio Farina detto Dumandone. Appartennero inoltre alla banda: Giuseppe Golfieri detto lo Scalzo; Antonio Basili detto Basèi; Giuseppe Poli detto Faffino; Giacomo Bedeschi detto Maraffini; Francesco Saporetti detto Rizzone; Federico Cantagalli detto Galletto; Giacomo Drei detto il Gobbo; Giacomo Cantoni detto Corneli; Gaetano Morgani detto Fagotto; Giuseppe Prati detto Moro di Scalpella; Paolo Versari detto Sboraccino; Leonardo Garda detto Schivafumo; Giovanni Drudi detto Bastianello. I soprannomi sopravvivono ancora nei piccoli centri abitati e nelle campagne, ma un ritorno si presagisce anche nelle cittadine romagnole, magari in modi e con origini diverse da quelli del passato. GFF 3 A Castel i taia la testa a Zagliòna e Brandlié 4 Mia nonna Oliva, di cara memoria, mi ha, più di una volta, raccontato l’episodio della decapitazione di Pirazzini Giovanni, detto Zagliòna, e di Antonio Gaddoni, detto Brandolino, eseguita a Castelbolognese. Era, si capiva subito, 1’avvenimento più emozionante a cui ella avesse assistito nella sua lunga vita: é morta nel 1922 essendo nata nel 1836. Quante volte me lo sono fatto ripetere. Fu la mattina presto, sulle sette, e faceva un gran freddo. La gaiutena (la ghigliottina) era rizzata in piazza e precisamente contro la torre dell’orologio, dal lato, destro. La campana maggiore cominciò alle sei a suonare lenti e funebri rintocchi. Oh, il senso che faceva quella campana! Chè tutto il paese sapeva: Jè Zagliona e Brandlié chi va a e’tai dla testa. Da tempo ogni speranza era caduta e si attendeva il carnefice da un giorno all’altro. La grazia, sollecitata in tutti i modi a cui le sventurate famiglie avevano fatto ricorso, era stata respinta. I soldati austriaci, cun al baiunètt in cana, tenevano sgombro un vasto quadrato avanti il patibolo. La piazza era gremita di popolo silenzioso. Molte donne piangevano. Si levò un brusio indistinto: arrivavano i condannati. Zagliòna procedeva tra i soldati spedito, le mani legate dietro la schiena, la camicia aperta sul petto. Era alto, un po’calvo, con una gran barba nera. Brandolino era livido. Il boia chiudeva il lugubre corteo, due suoi aiutanti si tenevano immobili vicino al palco. Oliva, per vedere, si era intrufolata fra la gente ed era così pervenuta proprio dietro ai soldati. Ne trovò uno gentile: l’éra un biundò, con gli occhi chiari, piuttosto giovine, che sbirciava ogni tanto con la coda dell’occhio quella romagnolotta bruna che, talora, premuta dalla folla, lo urtava. E le sorrideva da sotto i mustacchi fini e biondi. L’ era un tudesch zentil, però i più erano cattivi come gli accidenti. Quando i condannati comparvero, rullarono i tamburi e la campana si mise a suonare a martello. Si udirono delle grida, dei pianti, forse qualche saluto, forse qualche imprecazione. La nonna non sapeva bene, che lo strepito dei tamburi copriva ogni cosa ed ella era come impietrita, gli occhi sbarrati sulla scena. Il primo fu Brandolino ridotto un cencio tanto era sfatto di terrore con le mascelle inchiodate in una smorfia paurosa. Ma Zagliòna no. Come venne la sua volta, salì i gradini del palco e apparve in alto. Tutti lo videro. Si guardò intorno. Era soltanto pallidissimo. Lo fecero inginocchiare e non si vide più, ma fu un attimo e si levò dalla folla un confuso clamore: la testa del condannato spiccava sinistramente dalla lunetta fatale e pareva accennasse in alto. Ecco: la barba, fluente, era rimasta presa sotto e il condannato si sforzava di liberarla tentando di alzare il capo imprigionato. Così lo colse la fatal mannaia che lo liberò per sempre e la testa sparì. Oliva non respirava più, non si reggeva più; non vide neanche il tedesco gentile che provava a rianimarla d’un sorriso. Quanti anni avevate, nonna? «Ero una burdlèta; deve essere stato l’anno del colera.» Nonna, se tu fossi al mondo, mi sederei con te accanto al fuoco e ti spiegherei le sentenze di Zagliòna e di Brandolino, adesso che le ho trovate. Tu non ti eri sbagliata che di poco! L’anno del colera fu il 1855 e l’esecuzione è del 19 dicembre 1854; tu dunque avevi diciotto anni. E perché, nonna, li mandarono al taglio della ‘testa? «I géva par la pulética.» Siamo nel 1854, a Roma, nel Palazzo Innocenziano, quello stesso che diventerà. poi la sede del Parlamento italico, ove il cavaliere Bernini aveva profuso le dovizie del barocco e del suo ingegno per farne la reggia di una donna che comandava al mondo dietro una tiara: Olimpia Maldacchini, la bellissima, la perversa, la lussuriosa cognata e amica di Giovan Battista Pamfili, romano pontefice col nome di Innocenzo X. Un altro Innocenzo, il duodecimo, il napoletano Pignatelli, per reazione al nepotismo del suo predecessore, fece più tardi trasformare , da Carlo Fontana, la reggia magnifica in sede del tribunali. Il giorno di venerdì 6 febbraio 1854 e il primo turno del Supremo Tribunale della Sacra Consulta è riunito nella grande aula del Palazzo Innocenziano di Montecitorto per giudicare in merito alla causa intitolata: “Castelbolognese di omicidio in persona di Giovanni Budini”. Il fatto di cui si deve conoscere è avvenuto sette anni prima, nel 1847. Entrano gli illustrissimi e venerendissimi giudici: Ecco monsignor Salvo Maria Sagretti, il temuto Presidente, seguito dai giudici monsignori: Costantino Borgia, Domenico Bartolini, Giuseppe Arborio Mella, Lorenzo Valenzi, Gaetano De Ruggiero. Prendono posto monsignor Pietro Benvenuti, Procuratore Generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica e il difensore d’officio dell’imputato avvocato Lorenzo Pieri. Il Cancelliere Castelli chiama la causa contro Pirazzini Giovanni, detto Zagliona, di Michele, di anni 43, nato e domiciliato a Castelbolognese, fattore, coniugato con prole. Si levano le dovute preci all’Altissimo e subito viene introdotto 1’inquisito libero e sciolto. Monsignor Bartolini fa il rapporto, cioè la relazione della causa; il Presidente interroga l’imputato, monsignor Fiscale prende le conclusioni, il difensore propone le discolpe, si chiude la discussione e restano soli i giudici per deliberare. Giovanni Budini era da vari anni contumace, per furti e grassazioni, quando la Guardia Civica di Castelbolognese, di cui il Pirazzini era tenente e comandante, riuscì ad arrestarlo il 28 settembre 1847. Oppose una resistenza accanita, tanto che la Forza si vide costretta a reagire e lo ferì con una fucilata. Chiuso nelle carceri, il Pirazzini, con la scusa che queste erano mal sicure, la mattina dell’11 ottobre caricò il prigioniero su di un biroccio per trasportarlo in Imola. In località Torretta fu fatto scendere, gli fu ingiunto di camminare innanzi e mentre così andava il Pirazzini, che capeggiava la scorta, gli esplose alla schiena la sua schioppa, uccidendolo; in paese, fecero correr voce che il Budini era stato ucciso perchè aveva tentato darsi alla fuga alla vista di sconosciuti i quali venivano in suo aiuto. Su tale difesa l’imputato persistette sempre, ma pare che testimoni lo smentissero. Movente: 1’odio verso il Budini per i misfatti commessi, accresciuto per via della resistenza opposta al momento dell’arresto. Tutto ciò premesso, «visto e considerato quant’altro era a vedersi e considerarsi, visto l’art. 275 del Regolamento penale, il Supremo Tribunale, a pieni voti, condannò il Pirazzini “all’ ultimo supplizio”. Il 27 maggio 1854, giorno di sabato, lo stesso primo turno dei Supremo Tribunale, composto nell’ identico modo, giudicò la causa dal titolo: “Castelbolognese di omicidio” contro: Pirazzini Giovanni, detto Zagliòna; Zaccarini Antonio, detto Onocca, Dan Giovanni, detto il figlio del Zoppo Bronsino; Zannelli Domenico, detto Cesatino; Pediani Antonio; Capra Giovanni; Borghi Carlo, detto Barulione; Gaddoni Antonio, detto Brandolino; Sangiorgi Francesco, detto Segone ; tutti carcerati e Paolo Pirazzoli contumace. Il fatto, in breve, era il seguente: il 26 febbraio 1849 il conte Gaetano Zampieri, Giuseppe Spadoni e Giovanni Conti denunziavano al Tenente della Guardia Civica: che in parrocchia Castelnuovo, erano stati aggrediti da quattro malandrini armati, derubati del denaro, nonché di cavallo e biroccino. 5 Esecuzione nello Stato Pontificio, 1865 Il Pirazzini, nutrendo forse dei sospetti, arrestò certi Batta Gaddoni, Antonio Signani e i fratelli Ruggero e Giacomo Casadio. Era vicina l’Ave Maria e i militi si incamminavano verso Castelbolognese, quando il Pirazzini ordinò che tutti volgessero in un campo attiguo e ivi giunti tentò di ottenere la confessione del misfatto, minacciando di farli fucilare sul posto. Persistendo quei disavventurati nel proclamarsi innocenti, il Tenente, fatti schierare i suoi uomini, ordinò la scarica. Cadono Casadio Giacomo e il Gaddoni, mentre Signani e Ruggero Casadio riescono a darsi alla fuga, ammanettati com’erano, inseguiti dal Civici. Intanto il Gaddoni, che era rimasto illeso e si era invece rovesciato a terra come se fosse stato ferito, profittò del momento per darsi alla fuga. Gli altri due furono raggiunti e fu ripetuta su di loro la scarica che uccise il Casadio, ferendo gravemente il Signani. Tolsero a entrambi le manette e se ne andarono lasciandoli sul terreno. Il Signani riuscì a trascinarsi a casa, di là fu portato all’ospedale donde passò al carcere da cui fu poscia dimesso in libertà. La difesa del Pirazzini fu la solita: il tentativo di fuga da parte degli arrestati. Ma, intanto, dovette egli stesso confessare un particolare gravissimo: che, cioé, egli non aveva avuto alcun ragionevole indizio, nè in seguito lo aveva acquistato, in base al quale procedere all’arresto dei quattro, arresto che apparve dunque arbitrario. Signani e Gaddonl, scampati miracolosamente alla morte, lo accusarono esplicitamente confortati, sembra, da quattro testimoni presenti al fatto. Antonio Gaddoni e Francesco Sangiorgi furono assolti « perché non constò abbastanza della specifica colpabilità loro…» Pirazzini fu condannato “all’ ultimo supplizio”. In base alla nostra legge penale i soldati, i quali avevano eseguito l’ordine del loro comandante sarebbero andati immuni da pena. Invece, Zaccarini, Dan, Pediani e Borghi, furono condannati « alla galera in vita, Zannelli a venti anni Caprara a quindici, data la loro età minore rispettivamente dei 20 e dei 18 anni.’ Sono dunque già due le condanne a morte che pesano sul capo di Pirazzini Giovanni. In entrambe le Sentenze è detto che «non consta abbastanza dello spirito di parte ». Sembra dunque che qui la politica non sia. entrata. Certo non è difficile ritenere che il Governo Pontificio, restaurato sulla punta delle austriache baionette, avesse una matta voglia di disfarsi di tutti coloro i quali al tempo della sfrenata licenza avevano eretti sulle piazze gli alberi della libertà sormontati dal berretto frigio. Ma, onestamente e per storica obiettività, non si può disconoscere come il Pirazzini abbia in effetto commesso condannevoli abusi là dove 1’arbitrio e la violenza offendono le leggi patrimonio e tutela-supremi dei cittadini. Gaddoni Antonio, detto Brandolino, (detto anche il figlio del buon ladrone, per questa volta 1’aveva scampata. Ma la sua gioia fu breve. Quel di stesso il medesimo Tribunale si riunì di nuovo per conoscere e giudicare altra causa dal titolo: “Castelbolognese, omicidio in persona del dottor Francesco Contoli”. Stavolta Brandolino si buscò una condanna a morte, votata a maggioranza. Non era ancora l’irreparabile. Le sentenze della Sacra Consulta erano inappellabili, ma, a mente dell’ art. 550 del Regolamento Organico e di Procedura criminale, qualora la sentenza fosse stata pronunciata a maggioranza di voti, era consentito al condannato il ricorso avanti lo stesso Tribunale che giudicava a turni riuniti. Il male consisteva in questo che, cioè, del nuovo Collegio di revisione facevano parte anche giudici del primo. Brandolino dunque ricorse in appello, ma la sorte gli fu avversa. Era scritto che, per qualche verso, quella testa dovesse cadere. Francesco Serantini SILVERIO CINERI Grande chef, scrittore, artista e attore 6 Disegno a matita di Odette Gelosi In questo nostro mondo in cui la globalizzazione tende a determinare conseguenti spinte uniformizzanti in ogni settore della nostra civiltà tecnologica, anche gli individui vengono sottoposti ad una formazione di massa che consenta una pari possibilità di efficace inserimento nel contesto economico sociale in cui sono chiamati a vivere. Considerati come folla, essi dimostrano di assumere analoghi comportamenti e modi di vita, orientati verso una sempre maggior concretezza. Eppure quell’innumerevole vastità di esseri umani, come l’infinita serie numerica su cui si sviluppa la scienza aritmetica, è costituita da singole individualità dotate di caratteristiche specifiche proprie, assolutamente diverse l’una dall’altra, anche se, all’apparenza, non si manifestano sovente apertamente. Ma, talvolta, qualche personalità si differenzia talmente per singolarità non comuni da imporsi all’attenzione degli altri per le sue doti acclarate e consumate esperienze: è il caso di Silverio Cineri, faentino dalle molteplici attività creative, tutte scaturite dall’estro che plasma le creazioni di ogni artista. Accanto alla scrittura, ai collage e alla scultura, la prima sua fondamentale attività è la cucina, da lui vissuta appunto come un’arte vera e propria. La sua fulgida parabola professionale affonda le radici in un episodio della sua infanzia, quando a soli 10 anni in un campo scout gli impongono, per punizione, di occuparsi del pranzo. La malcelata mortificazione si tramuta presto nel sottile piacere di trasformare ingredienti, di per sé anonimi, in profumate e gustose pietanze; il gioco è fatto, per il bambino si tratta di un’azione fantastica, magica: nasce la passione e una vocazione. Diventa il cuoco del campo scout, distinguendosi ogni volta e riscuotendo ogni giorno una “tacca” per le sue preparazioni. Giunge perfino, a 12 anni, a cuocere al campo teglie di cannelloni in un “forno” creato con sottili pietre di fiume scaldate sotto e sopra da fuoco di legna. Silverio svela già di quali fervide invenzioni è capace la sua mente in eterno esercizio. A 14 anni frequenta a Rimini il primo anno dell’Istituto Alberghiero, mentre si deve trasferire, sempre per punizione, all’Alberghiero di Salerno dove termina gli studi diplomandosi. Le sue prime stagioni lavorative si svolgono a Riccione nei due anni di formazione a Rimini e a Salerno durante le vacanze estive. Firma poi, per un anno, un contratto di lavoro che lo conduce ad esercitare la sua arte in Germania non lontano da Francoforte, dopo di che egli ritorna in Italia dove lavora a Bologna fino al 1971. Ormai consolidata la sua esperienza, si trasferisce a Castrocaro al ristorante La Frasca, dalla sua apertura fino al 1978, e, per merito suo, questo locale si collocherà fra i dieci migliori d’Italia e otterrà una medaglia Michelin. Silverio decide quindi di aprire, da affittuario, a Granarolo Faentino un ristorante tutto suo, intitolato “Amici miei” che, nel primo anno d’esercizio (1978-79) viene inserito nella Guida di Veronelli e nella Guida dell’Espresso, anch’essa ai suoi primi passi. Quando riceve lo sfratto dal proprietario del fabbricato, Silverio si sposta a Faenza alla Galleria Gessi, assegnando al locale lo stesso nome “Amici miei” già avvolto di fama e, in quel medesimo anno, il 1985, riceve la sua prima stella Michelin personale, assegnata per l’unica volta nella città di Faenza. Nei due anni di lavoro nella sua città, Cineri organizza pranzi medievali (i primi in Italia) con armigeri, così riusciti da attirare l’attenzione dell’emittente televisiva RAI 2 che viene a filmarne uno. La parentesi faentina prelude a notevoli cambiamenti evolutivi della carriera di Cineri. Trasferitosi a Bologna, egli apre in via Nosadella il primo ristorante con il suo nome, “Silverio”, che egli conduce dal 1986 al 1991, portandolo al primo posto fra i ristoranti della città felsinea. Unanimi e numerosi piovono i riconoscimenti nei giornali specialistici (circa trecento articoli relativi a “Silverio” di via Nosadella) che elogiano l’arte culinaria dello chef romagnolo, come, ad esempio” quello del periodico “Sale e pepe”, nel cui primo numero si indugia sul suo piatto “Le viole del sottobosco”, ravioli realizzati con mirtilli. Il “Gourmet” australiano segnala Cineri e lo colloca al primo posto nel mondo, prima della parigina Tour d’Argent e del Circus newyorkese. L’autore dell’articolo sul “Gourmet” ha ribadito questi suoi apprezzamenti nel suo libro “Perché non rubo più gli asciugamani al Grand Hotel”. Un’affermazione del famoso buongustaio Luigi Veronelli incorona Silverio il cuoco più fantasioso d’Italia, mentre, sempre in via Nosadella, gli è stata dedicata da un ignoto cliente la frase da lui ritenuta la più bella, ossia “se fossi un’oca, qui vorrei morire e essere cucinata”. Ormai ampiamente affermato, egli dedica il proprio tempo libero al collezionismo di documenti, giornali, menù… e alla scrittura. Sono undici i testi da lui scritti fino ad oggi; i primi tre pubblicati da Officina Immagine in 300 copie (100 per l’editore, 100 per la tipografia Montanari, 100 per l’autore), offerti come auguri natalizi e redatti dal 1987 al 1991, s’intitolano “Silverio per me è così”, “Il sole, l’orto e il fosso” e “Quando l’Artusi uscì di casa”, uscito per il centenario della stampa del volume dell’Artusi. Dopo il 1991, la scrittura procede contemporaneamente all’avviamento di due nuovi esercizi. Lasciato il Nosadella, Cineri apre due locali che egli gestisce in concomitanza: il Circolo dei Giornalisti di Bologna, da lui denominato “I compagni di Silverio” e “Villa Orsi“ a Argento (Bo). Nascono poi altri due libri, “Se il pesce avesse le cosce”, ultimo regalo augurale, e “Cucina poetica”, per i tipi di Ed. Il Fenicottero, Bologna, il primo volume destinato alla vendita. Poi, dopo l’enorme lavoro svolto, per Bologna 2000, nel suo ultimo ristorante “Silverio”, sito in via Mirasole nei pressi del Tribunale, il grande cuoco romagnolo viene colpito da infarto e … deve interrompere la sua frenetica attività. Per diminuire lo stress, è costretto a rinunciare ad una direzione propria e accetta di prestare la sua arte a Milano all’Hotel Duomo, albergo cinque stelle lusso, dove rimane per tre anni fino al 2003. Ma l’esuberante carattere di Silverio non riesce ad imprigionare le sue ansie di cultura: egli approfitta delle sue ferie per recarsi all’estero, in India e in Cina di cui studia le cucine che si reg- gono su tradizioni antichissime e appaiono meno evolute della nostra e, se interpellato, si prodiga ogniqualvolta viene chiamato per beneficenza. Erudito anche sulla cucina medievale e rinascimentale, Silverio si diletta a rispolverare antiche ricette e s’impone pure, quando cucina, di utilizzare possibilmente solo ingredienti locali di stagione, realizzando piatti genuini, raffinati o rustici, leggeri e gustosi. Ora, raggiunta l’età pensionabile, egli ha preso in gestione da quasi un anno La Taverna del Circolo degli Artisti di Faenza, dove ha presentato ultimamente il suo undicesimo libro intitolato “Al dente”, volume originale che propone divertenti ricette adatte a persone “torturate” nelle varie sedute del dentista. Intanto è già pronto il menabò di un’altra sua opera sui tarocchi e la cucina. La mente di Silverio si rivela una vera fucina che analizza, medita e crea. Una sua prima personale di sculture e collage allestita in maggio scorso al Circolo degli Artisti di Faenza ha rivelato l’ampiezza dei suoi interessi culturali, documentati dalle sue collezioni che gli consentono di creare opere singolari, intrise di interessanti aspetti della nostra civiltà presente e passata. Ora egli è pure impegnato in un’esperienza di tutt’altro genere che, tuttavia, si collega alla passione della sua vita, la cucina. In un film girato nel 2006 e ambientato nel periodo medievale, egli ha anche interpretato il ruolo di tre personaggi sotto la regia di Liana Marabini, produttrice della pellicola che narra le vicende legate alla stampa del primo libro di gastronomia italiano, edito per lo Stato Pontificio nel 1474 da Bartolomeo Sacchi, soprannominato il Platina. È previsto che Cineri partecipi pure alla lavorazione di un secondo film su Bartolomeo Scappi che inventò, per così dire, i conclavi protraendone la durata per l’eccellenza delle sue preparazioni culinarie. Questo Faentino infaticabile, grande chef, scrittore, artista, attore, illustra al massimo grado le potenzialità creative e la laboriosità della nostra gente di Romagna… Odette Gelosi Collage 7 Collage NICOLA BOMBACCI RIVOLUZIONARIO Meldolesi e forlivesi con il giornale Lotta di classe 8 Queste pagine sono la storia di un uomo. Non tutta la storia, ma una parte di essa, quella fondamentale della sua formazione morale e politica. L’uomo è un personaggio della Romagna, Nicola Bombacci, quasi coetaneo di Mussolini, col quale ha concordanze e contraddizioni; diverse, e non diverse le strade percorse, l’uno e l’altro uniti alla fine nel drammatico 28 aprile 1945 a Dongo. Bombacci nasce nel 1879 a Civitella di Romagna, Mussolini nel 1883 a Dovia di Predappio. Appartengono entrambi allo stesso ceppo proletario; vengono dall’Appennino romagnolo, quasi montanaro, ma non coi segni della miseria e dell’isolamento sociale ed economico caratteristico dei centri abitati della montagna. Alessandro Mussolini fa il fabbro ed è anarchico; Antonio, padre di Nicola, esercita una piccola attività di trasporto di viveri e carbone, è dunque un birocciaio. Aria di ribellione in casa Mussolini, se pure mitigata dalla presenza di una maestra, la moglie di Alessandro. Antonio, invece, è stato anche milite del governo pontificio e al momento dell’annessione della Romagna al regno sabaudo si è dato alla macchia, per non servire gli «usurpatori». Dunque, una famiglia papalina quella dei Bombacci, con tradizioni e spirito di fedeltà alla Chiesa ben radicati. Nicola, intelligente e irrequieto, fa i suoi primi studi nel seminario di Forlì: inizio normale, logico, considerata l’aria che si respira in casa. Ma il seminario non è il luogo adatto per il giovane Bombacci. Nicola è ammesso da Valfredo Carducci alla Scuola Normale di Forlimpopoli, presso la quale consegue la licenza magistrale nel 1904, la stessa scuola dove si diploma Mussolini. Quasi subito Nicola si trasferì a Baricella, nel basso bolognese, dove cominciò l’insegnamento nella scuola elementare e dove ebbe inizio anche l’attività di uomo politico, sotto la bandiera del socialismo. Si era appena sposato, tuttavia la moglie restò a Forlì in attesa di partorire il primogenito Raoul. Da Baricella il maestro Nicola Bombacci viene trasferito nel Reggiano, poi a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Qui Nicola risiede con la famiglia. Diventa padre per la seconda volta; nasce infatti una bambina, alla quale vengono imposti i nomi di Fathima, Idea, Libertà. La scelta del nome della figlia di Maometto fa già capire che per Nicola i giorni del seminario sono ormai lontani. Fathima muore dopo un mese, forse non battezzata. Certamente il battesimo del primogenito Raoul era avvenuto in forma segreta. L’attività di insegnante e di politico continua poi a Crema. Bombacci, per sua stessa dichiarazione, si definisce socialista tout court, senza qualificarsi né riformista, né rivoluzionario. Queste notizie sulle prime esperienze politiche di Nicola Bombacci e sull’attività di organizzatore e propagandista, esperienze parallele (fino a un certo punto) a quelle di Benito Mussolini, sono state raccolte dalla pronipote Annamaria Bombacci e pubblicate in un volume, che porta la sua firma. Abbracciano il periodo dal 1910 al 1921, quando, al congresso di Livorno, il socialista di sinistra Nicola Bombacci si schiera con la frazione che dà vita al Partito Comunista Italiano. Sono notizie di grande interesse sotto l’aspetto storico, ma servono anche a delineare il profilo umano di Nicola, uomo certamente generoso, seppure politicamente insicuro e certe volte illogico, col carattere tipico della gente romagnola. Dopo l’esperienza emiliano-lombarda, Bombacci nel 1910, ritorna in Romagna e si dedica alla politica a tempo pieno. Diventa segretario della Sezione Socialista di Cesena e direttore del giornale “Il Cuneo”. Durante il periodo romagnolo-cesenate i rapporti con Mussolini diventano più frequenti, senza però che si stabilisca un’amicizia vera e propria. Mussolini ha un carattere assai differente da quello di Bombacci, è più spregiudicato, senza tanti scrupoli nell’azione politica. A Nicola è rimasta addosso l’educazione avuta in seminario e, se anche lo nega in modo deciso, anzi con una punta di ostentazione mista a orgoglio, l’ambiente religioso ha lasciato in lui qualche segno che non si cancella. Da Cesena, Bombacci va a Modena, questa volta con incarichi sindacali di un certo rilievo. Viene eletto consigliere nazionale della Confederazione Generale del Lavoro e nominato segretario della Camera del Lavoro di Modena. L’esperienza di organizzatore sindacale e l’agitazione alla Manifattura Tabacchi sono molto importanti per il suo assestamento ideologico e politico, e forse influenzano pure le scelte che di lì a non molto tempo dovrà fare. Comincia il periodo caldo per il socialista e sindacalista romagnolo. A causa di una sua iniziativa, giudicata illegale, Bombacci finisce in carcere. Ormai si è messo in movimento un processo irreversibile nella politica e nella tormentata vita del Partito Socialista. All’inizio di giugno del 1914 a Villa Rossa di Ancona la forza pubblica, sembra per un tragico errore, spara sui dimostranti, che hanno organizzato una manifestazione antimilitarista: due morti e un ferito gravissimo deceduto il giorno successivo: questo è il bilancio. Tutto il Paese prende fuoco. È la famosa «Settimana Rossa», cominciata l’8 giugno 1914. La Confederazione Generale del Lavoro proclama lo sciopero generale di protesta, che però rientra due giorni dopo. Bombacci non può prendervi parte, è nel carcere di S. Eufemia. Mussolini invece si trova a Milano. Un gruppo d’un centinaio di dimostranti antimilitaristi, il direttore de l’Avanti! è con loro, grida a gran voce contro la guerra; la polizia interviene e lo disperde. Mussolini viene colpito alla testa con uno sfollagente e cade a terra tramortito. Lo soccorrono Alceste De Ambris e altri compagni, che lo portano al sicuro nella sede del giornale. Sembrò che il Paese stesse per crollare sotto l’incalzare dei disordini. Saccheggi, interruzioni del traffico ferroviario, incendi di treni, occupazioni di edifici pubblici, in Romagna balenò la suggestione di fondare la repubblica. Ma il crollo non avvenne. Mussolini continuava a tuonare contro l’intervento armato dell’Italia e contro gli interventisti, ancora per poco, però. Socialisti imolesi prima di partire per il congresso di Bologna 1919, al centro Bombacci e la Kulisciof Nel mese di settembre 1914 Mussolini, socialista rivoluzionario, si comportava da intransigente neutralista, trovandosi paradossalmente concorde coi tre suoi principali avversari: Giolitti, Turati (socialista riformista e moderato) e il Papa. Definiva la guerra come «la forma estrema, perché coatta, della collaborazione di classe», in ottobre però il suo atteggiamento si era già stemperato nella «neutralità condizionata» e a novembre il salto era fatto: Mussolini passava all’interventismo acceso. Bombacci, ritornato in libertà, non cambiò opinione. Continuò a battersi contro la guerra. Si disse che Mussolini avesse avuto aiuti finanziari dai Francesi. In effetti, lasciata la direzione de l’Avanti!, fondò e diresse un nuovo giornale quotidiano, Il Popolo d’Italia, scopertamente favorevole alla guerra contro l’Austria e la Germania. Aveva ormai imboccato la strada che doveva portarlo al fascismo. Bombacci, da intransigente massimalista, fece un’altra scelta e si trovò, sette anni dopo, fra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Eppure entrambi, Bombacci e Mussolini, nella singolare avventura della loro vita, apparvero alla fine insieme nel miserevole epilogo di piazzale Loreto. Le «convergenze parallele» non sono una invenzione recente. Chissà quante volte si sono ripetute nella storia. Bombacci non fa il militare, perché riformato alla visita medica, e si impegna più intensamente nella lotta politica. Al congresso di Bologna del 1919 egli diventa segretario nazionale del Partito Socialista, succedendo a Costantino Lazzari. Nel novembre dello stesso anno è candidato alla Camera per la circoscrizione di Bologna e viene eletto deputato. È questo il momento del suo massimo fervore politico. L’anno seguente va all’estero: a Copenaghen prima, poi a Leningrado; é affascinato dalla rivoluzione dei Soviet e dalla personalità di Lenin in particolare. Ormai decisamente inserito nella “Frazione Comunista”, partecipa al convegno di Imola, svoltosi nei giorni 28 e 29 novembre 1920. E siamo al diciottesimo congresso socialista di Livorno, 15-20 gennaio 1921. Nasce il Partito Comunista Italiano e Bombacci è fra i fondatori. L’impegno e l’entusiasmo, all’inizio, sono totali, senza riserve, senza un attimo di esitazione e di sosta. Finalmente Bombacci si sente parte di uno stesso corpo ideale e di milizia: quello cui appartiene Lenin, l’uomo-guida, l’incarnazione del suo pensiero politico allo stato puro. Poi, a poco a poco, comincia un rallentamento dell’attività, una incrinatura nell’ideologia, che lo porta, ancora iscritto al PCI, su posizioni di moderatismo, se non di destra. Il partito lo espelle nel 1928. Che cosa è accaduto? È difficile poter sondare chiaramente il pensiero dell’uomo, quasi impossibile quando si tratta dell’homo politicus. Annamaria Bombacci interrompe la storia umana del prozio al momento del congresso di Livorno, si ferma al Nicola ancora comunista convinto. Essa non ha voluto raccontare i fatti del dopo ed esprimere giudizi. Questo suo quasi verecondo riserbo è comprensibile, trattandosi di un familiare. Però sarebbe stato oltremodo utile e interessante aver potuto ottenere di prima mano, attingendo dalla privacy della famiglia, notizie, per una valutazione umana e storica nello stesso tempo, delle circostanze, delle cause incidentali o ideologiche, che fecero fare a Nicola Bombacci una scelta di campo così radicale e impensata. Bombacci ebbe poi un incarico dal regime di Mussolini e diede vita alla rivista La Verità. I due personaggi forse si conobbero, negli anni del dominio fascista, più da vicino. Le vite parallele cominciano a muoversi verso il punto di convergenza. Dopo l’8 settembre 1943 Bombacci si schiera con Mussolini e aderisce alla Repubblica Sociale Italiana, seguendo il dittatore a Salò. Perché? Forse per una reazione a quello che i fascisti «repubblichini» giudicarono un tradimento della corona e della nazione verso il fascismo. Forse per un istinto, tipico dei romagnoli, che li spinge a stare con l’amico caduto in disgrazia e a dimostrargli (ma non sarà per caso una forma di estrema spavalderia?) che l’amicizia vince anche le degenerazioni della politica. Una risposta è difficile, quasi impossibile. Socialisti rivoluzionari entrambi, dirigenti di primo piano nel partito, combattivi e convinti delle proprie idee, ebbero esperienze a volte simili a volte opposte. Voltate le spalle al passato, nel mezzo della disfatta nazista, si trovarono alla fine inseguiti da una decisione di morte (preventiva o postuma, non si sa), presa dal CLNAI «in nome del popolo italiano». L’esecuzione di Mussolini avvenne davanti al cancello di Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra: con lui venne uccisa anche Claretta Petacci, la sua amante. Un gruppo di gerarchi fascisti, fra i quali si trovava Bombacci, che gerarca non era, furono fucilati a Dongo. Bombacci si avviò incontro ai mitra, come volesse accelerare la fine e gridò: « Viva l’Italia, viva il socialismo!». Un suo figlio era partigiano nelle formazioni di «Giustizia e Libertà», un altro combatteva al Sud nell’Armata Italiana di Liberazione Aureliano Bassani Annamaria Bombacci, Nicola Bombacci rivoluzionario,19101921, Santerno Edizioni Imola 9 L’ANTICO FORMAGGIO DI SARSINA 10 Sarebbe inutile cercarlo in qualche negozio o direttamente dai produttori come avviene per specialità alimentari poco conosciute od in parte dimenticate. Questo è un formaggio veramente introvabile, non più prodotto chissà da quanto tempo ma ricordato ed esaltato da diversi autori latini duemila anni orsono, un formaggio del quale resta, purtroppo, solo un sapore letterario. Qualche anno fa mi è capitato di leggere su giornali opuscoli ed altro che il noto formaggio di fossa di Sogliano era nominato perfino da Plauto che ne avrebbe decantato virtù e pregi, affermando che possedeva anche poteri afrodisiaci. A parte il fatto che tutti i formaggi stagionati pare ne abbiano, da buon sarsinate mi è sorta subito la curiosità di verificare tale affermazione nei testi plautini. È noto infatti che, tranne alcune rarissime allusioni, Plauto nelle sue commedie non fa riferimenti al mondo romano nè tanto meno a quello italico. Anche la stessa Sarsina è menzionata una sola volta, ed in modo molto indiretto. Nella Mostellaria c’è una scena nella quale il vecchio Simone si lamenta con il servo Tranione perché la sua casa è molto esposta al sole e non c’è ombra. Per tutta risposta il servo ribatte: con un tipico calembour plautino “Quid? Sassinatis acqua est, si Umbram non habes?” (v.770), e cioè “hai almeno una Sarsinate se non hai un Umbra?”, giocando sul facile doppio senso fra umbra, cioè ombra ed Umbra, donna dell’Umbria. (I Sarsinati infatti erano considerati parte del complesso politico e culturale degli Umbri e per questa ragione il territorio di Sarsina fu assegnato alla Regio VI, l’Umbria appunto). Plauto menziona solamente un mollem caseum , formaggio molle, in Captivi v.851, un meus dulciculus caseus in Poenulus v. 367, e ancora huius dulciculus caseus sempre in Poenulus,v.390, ma sempre sotto forma di vezzeggiativi del tipo: mio formaggino dolce, sua dolce caciottina o simili. Ma se Plauto tace non mancano altri importanti scrittori latini che fanno precisi riferimenti al formaggio di Sarsina. In epoca romana l’economia della città era legata all’agricoltura ed alla pastorizia. L’allevamento del bestiame, specie ovino, era molto diffuso conseguente quindi la produzione di formaggi, la fama dei quali si era diffusa fino a Roma. Ecco quindi che il poeta Silio Italico, vissuto nel 1°secolo, descrivendo nel suo poema Punica i popoli che presero parte alla battaglia di Canne contro Annibale ricorda (libro VIII, v.461) Sassina dives lactis (Sarsina ricca di latte). Ricorda anche il giovane Lucio Pisone, comandante dei Sarsinati il quale sebbene gravemente ferito al termine della battaglia, vedendo Annibale cavalcare spavaldo e vittorioso sopra i corpi dei soldati romani avrebbe avuto la forza di scagliare verso di lui la sua lancia facendolo cadere da cavallo destando così l’ammirazione del comandante cartaginese per soldati che combattevano anche da morti. Plinio il Vecchio, morto durante l’eruzione del Vesuvio nell’anno 79, nella sua opera enciclopedica Naturalis Historia (XI,241) menziona il “caseum ovium maxime e Iacte Sassinatem ex Umbria (formaggio sarsinate di latte di pecora dell’Umbria). È anche possibile che il grande naturalista lo abbia assaggiato considerando che aveva una villa nell’attuale zona di Città di Castello, non eccessivamente distante da Sarsina. La testimonianza più importante sul formaggio sarsinate ci viene dal poeta Marco Valerio Marziale, autore di salaci epigrammi che recitava alle mense dei notabili a Roma. A Sarsina trovò un amico, ricco e famoso, Gaio Cesio Sabino al quale dedicò un libro dei suoi epigrammi, scritti probabilmente a Forum Cornelii, l’odierna Imola, dove soggiornò o, meglio, fu costretto ad una specie di soggiorno obbligato dall’anno 81 all’83. Nella dedica del libro VII, epigramma 97, elogia Cesio Sabino come vanto dell’Umbria montana ricordando inoltre il foro, le case, i portici e le taverne di Sarsina in modo molto preciso facendo quindi presupporre una sua visita. Nell’epigramma 43 del libro 1° rivolgendosi ad un anfitrione che si era dimostrato avaro Marziale scrive: “Mancino, ieri ci hai invitati in sessanta e ci hai offerto soltanto un cinghiale. Non c’era nemmeno un po’ di uva tardiva conservata sui tralci, o un po’ di quelle mele che gareggiano in sapore con il dolce miele; mancavano quelle pere che si conservano appese ai lunghi gambi delle ginestre ed anche le mele granate di Cartagine, rosse come le rose”. Segue quindi l’affermazione che ci interessa : ”rustica lactantis nec misit Sassina metas” (e la rustica Sarsina non ha inviato i suoi coni di cacio ancora stillanti latte). Come si può facilmente evincere dal contesto, il formaggio sarsinate è posto fra le delizie più desiderabili che ci potessero essere sulla tavola romana. Viene inoltre sottolineato che la qualità è in rapporto con la genuinità e la freschezza del prodotto: le forme debbono stillare latte e deve essere Sarsina stessa a mandarle. Il nome del luogo dà pregio al prodotto e garantisce l’autenticità della denominazione d’origine. In merito alla freschezza va considerato che il prodotto poteva arrivare a Roma in tempi molto più brevi di quanto si possa immaginare. Nell’epigramma 58 del libro 2° Marziale ricorda ancora che nella villa di Faustino a Baia, nota località termale nelle vicinanze di Napoli, “il contadino non giunge mai a salutare con le mani vuote ma porta una grande quantità di bianco miele con i cerei favi metamque lactis Sassinate de silva (una forma di formaggio della selva sarsinate). L’espressione sembra sottolineare, come l’aggettivo rustica del brano precedente, che si tratta di una genuina produzione di montagna. In questo caso invece si resta perplessi pensando che un contadino di Baia possa offrire un prodotto, tra l’altro fresco, proveniente da un posto così lontano, mentre in tutto il passo Marziale insiste proprio sul fatto che nella villa di Faustino si può disporre di fresche e genuine produzioni locali. Probabilmente l’unica possibilità è di attribuire alla frase metam lactis Sassinate de silva un senso molto più lato e cioè “formaggio fresco del tipo di quello che si produce nei boschi di Sarsina”. In questo modo si può supporre che il formaggio di Sarsina abbia dato luogo ad una certa qualità riconosciuta come veramente tipica, una specie di denominazione d’origine, ma prodotta ed imitata anche in altri luoghi. In entrambi i passi Marziale indica le forme di formaggio con il termine meta, parola che indica comunemente una forma conica, ma che non è attestata altrove per indicare il formaggio. Forse questa forma particolare è stata una ulteriore caratteristica di questo antico formaggio. Se dovessimo in qualche modo avvicinarlo alle produzioni attuali verrebbe da pensare ad una specie di mozzarella di latte di pecora, più o meno stagionata, un po’ simile anche per la forma alle scamorze assai diffuse nel centro e nel sud dell’ Italia. Un’ultima considerazione si rende comunque necessaria. Quando di parla di Sarsina si deve intendere non tanto la città quanto il territorio che ad essa faceva capo e quindi, come concordano gli storici, la valle del Savio, la media ed alta valle del Marecchia, l’alta valle del Bidente. Una conferma è fornita ancora una volta da Marziale. Nell’epigramma 58 del libro 9° scrive: “Ninfa, regina del sacro lago, alla quale Sabino (il Cesio Sabino già ricordato) ha dedicato, quale dono della sua pietà, un tempio bello e duraturo (e qui c’è un’altra preziosa testimonianza su quanto Cesio Sabino ha fatto) sic montana tuos semper colat Umbria fontes / nec tua Baianas Sassina malit aquas (possa la montana Umbria onorare sempre le tue sorgenti, nè la tua Sarsina preferire le acque di Baia”. Indubbiamente per non invidiare queste famose acque termali ci vogliono acque altrettanto pregiate. Sarsina non ne ha mai avute. In proposito gli storici concordano nel ritenere che il riferimento sia alle acque termali di Bagno di Romagna, conosciute e sfruttate già nell’antichità e in quel tempo appartenenti al territorio sarsinate. Piergiorgio Pellicioni LA GENS ARRECINA E L’ACQUEDOTTO DI RIMINI Il nome di un Marcus Arrecinus Clemens compare per due volte fectus fabrum che solitamente, nel periodo giulio-claudio, su materiali romani provenienti dal territorio riminese; nel priviene a chiudere il cursus honorum ascendente della carriera mo caso su di una fistula aquaria rinvenuta il secolo scorso nei equestre, mentre nella nostra iscrizione troviamo tali funzioni pressi di P.ta S. Andrea, oggi non più esistente, nel secondo caso militari espresse prima, in formula inversa, di quelle municipali; su di un coronamento marmoreo di cippo, ritrovato nel 1972 un uso frequente, questo, nelle titolature municipali del I sec. durante lavori agricoli nella zona di Spadarolo. d.C., in cui il ribaltamento cronologico delle cariche ottenute è Ciò potrebbe confermare l’ipotesi della esistenza di un ramo indicativo della volontà di esprimere in prima linea le mansioni riminese della gens Arrecina, per quanto la mancanza della più importanti raggiunte, ovviamente, alla fine della carriera. menzione relativa alla tribù di appartenenza, in ambedue i casi, Difatti, in seconda linea, appaiono qui i titoli municipali ottenuci permetta di andare solo per induzioni, senza che si possa ti da Arrecino Clemente ad Ariminum, quali quelli di duoviro, giungere ad una sicura identificazione del nostro personaggio, tresviro ed augure. invitandoci altresì ad ulteriori, caute ipotesi rispetto a quelle Il duovirato è la più alta carica municipale e ad Ariminum, per il fino ad oggi espresse. I secolo d.C., appare già coperta in più casi conosciuti. Se nel caso della fistula (pezzo di tubazione in piombo) ci sono Dunque il nostro Arrecino Clemente ha seguito una carriera conservati solo i tria nomina, qualcosa di più sul personaggio, municipale regolare, comune nella sequenza delle funzioni a ammesso ma non concesso che si tratti della medesima persona, più personaggi locali, a prescindere dalla presenza in prima o lo si può dedurre dalle titolature della dedica di Spadarolo, ove seconda linea del tresvirato; ma il vero problema, attualmente compare il ricordo di M(arcus) Arrecinus M(arci) f(ilius) [---] / ancora in discussione, è quello di inquadrarne correttamente Clemens tri(bunus) mil(itum) leg(ionis) III la figura nel gruppo di più omonimi personaggi della gens Cyren (aicae) / et leg(ionis) XXII praef(ectus) fabr(um)II vir Arrecina. III vir aug(ur) / B(accho) et S(ilvano) v(otum) s(olvit) l(ibens) Il primo M. Arrecinus Clemens noto, di nascita equestre, fu m(erito). prefetto del pretorio sotto Caligola, carica che sembra aver Da quanto espresso sembreraggiunto in età mediamenrebbe doversi trattare di quel te alquanto avanzata e che, Marcus Arrecinus Clemens, secondo Svetonio, partecipò figlio dell’omonimo prefetattivamente alla congiura to del pretorio dell’anno 41 contro Catilina. d.C., futuro cognato dell’imDel figlio di costui, secondo peratore Tito, il quale sposealcuni quello citato nella rà in prime nozze la sorella iscrizione incisa sulla base di costui, Arrecina Tertulla. del donario riminese, quel Il cursus honorum, riferito poco che sappiamo ci è nella iscrizione, ci ricorda le brevemente espresso da un funzioni relative alla carriera passo di Tacito ove si dice equestre del personaggio ed che, nonostante fosse riualle sue mansioni nell’amscito a raggiungere il rango bito politico amministrativo senatoriale (probabilmente del municipio ariminense. in virtù del matrimonio Appare subito chiaro che, della sorella Tertulla con in qualità di cavaliere, l’imperatore Tito) ricevette Arrecino ha ottenuto, nel solo il comando delle coorti corso della carriera militare, pretorie. per due volte, consecutive o Della carriera di M. meno che esse fossero, il triArrecinus Clemens junior bunato, prima nella legio III Puteale di Maccaretolo, culto idrico e culto di Apollo, Bo, Mus.Civoco (chiamiamolo così per semCyrenaica, poi nella legio plificazione) conosciamo XXII (Deiotariana). alcuni ulteriori dati grazie ad una iscrizione pescarese. Che si tratti, in quest’ultimo caso, della legione Deiotariana Qui compare correttamente la tribù di appartenenza, ovvero la (così chiamata da Deiotaro, re di Galazia, che la costituì con Camilia, dove erano iscritti i cittadini di Pisaurum, e Arrecino funzioni, strutture ed equipaggiamenti simili a quelli dell’eserciClemente presenta i titoli di console per la seconda volta, di to romano, e che venne fatta stanziare in Egitto, ad Alessandria, legato imperiale nella Hispania Citerior e di pretore urbano. dopo la morte di Aminta, nel 25 a.C.) sembra potersi desumere, Dunque una carriera fulminante, ben diversa la quella espressa con sicurezza, dal fatto che, per circa settanta anni, essa rimase dai titoli della dedica riminese, anche se nel corso del primo sel’unica legione ad essere indicata con l’ordinale XXII, fino a colo è nota la presenza di un altro rampollo di famiglia equestre, che, nel 43/ 44 d.C., non venne creata la legio XXII Primigenia, figlio di un prefetto del pretorio, passato poi all’ordine senatocon campo a Mogontiacum, rendendo così necessaria una agriale, ovvero C. Tullius Pompoianus Firmus console nell‘anno gettivazione supplementare che distinguesse le due legioni for84 d.C. nite del medesimo ordinale; cosa che sulla nostra iscrizione non L’Arrecinus pisaurense ricevette il primo consolato probabilcompare, inducendoci a ritenere che la dedica fosse stata incisa mente nel 73 d.C., andò poi in Spagna come legato fra l’81 e quando non vi era ancora possibilità di confusione, esistendo l’85, ottenne il secondo consolato forse nel corso dello stesso una sola legio XXII, ovvero la Deiotariana. anno 85 e trovò infine improvvisa morte nella condanna fattagli Occorre anche ricordare che, tra il 43 e il 44 d.C., la legio III comminare da Domiziano, non sappiamo con quale specifica Cyrenaica e la legio XXII Deiotariana vennero stanziate nel accusa, malgrado una loro antica amicizia. medesimo accampamento a Nicopolis, in Egitto, e che il tribuÈ possibile, come in genere supposto, che possa trattarsi dello nato militare di Arrecino Clemente potrebbe essere letto, seconstesso M. Arrecinus Clemens del donario riminese che abbiamo do parte della dottrina, non come espressione di due successive visto tribuno militare a Nicopolis nel 43/ 44 d.C., carica che è mansioni, ma comunemente riferito nel medesimo periodo ad generalmente posta a finale coronamento della carriera di un ambedue le legioni, unite nel campo di Nicopolis. cavaliere, quindi di una persona non certo in giovane età, per di Al termine del tribunato, Arrecino copriva le funzioni di prae- 11 LA PIADA O PIÉ 12 più a trenta anni di distanza? Si è anche detto che l’Arrecino prefetto del pretorio del 41 d.C. giunse a questa carica in età già avanzata ed inoltre il figlio di costui, il futuro cognato di Tito, ebbe i natali, secondo recenti calcoli, fra il 30 e il 33 d.C.; in questo caso risulterebbe del tutto fuori luogo immaginare una carica di Arrecinus junior in qualità di tribunus militum nel 43 d.C. Se così fosse si potrebbe ipotizzare che il personaggio della dedica riminese sia in effetti Arrecinus senior, prefetto del pretorio nel 41, per quanto possa certo lasciar perplessi la mancanza di un simile titolo nella iscrizione di Spadarolo. Né quest’ultima è precedente alla acquisizione della carica e, ad ogni modo, vi è un esempio, nel corso della prima metà del I sec. d.C., di un altro prefetto del pretorio che nel proprio cursus honorum non accenna a questa carica bensì a quella di tribunus militum il che potrebbe fornirci un secondo termine di paragone. L’Arrecino Clemente del titolo pisaurense reca correttamente la menzione della propria iscrizione nella tribus Camilia, mentre nella iscrizione riminese tale fondamentale chiave di giudizio ci viene purtroppo a mancare, anche perché l’integrazione Aniensis, cioè la tribù di Ariminum, non ha finora riscontro in alcuna conosciuta titolatura della gens Arrecina. Una famiglia, questa, di ristretta area genealogica (Tusculum, Bovillae, Rubi, Aricia, Latium vetus in genere, poi Pisaurum ed un isolato caso in Apulia), di rango equestre, che solo in alcuni casi, come quello dell’Arrecino di Pesaro, ha raggiunto cariche ed offici destinati al solo rango senatoriale. È pensabile che dall’originario ceppo latino, la famiglia si sia scissa, a cavallo fra il I a.C. ed il I d.C., in più rami collaterali, fra cui quelli di Pisaurum e di Ariminum, legati apparentemente, questi due, da rapporti di filiazione fra l’Arrecino della dedica riminese e quello della pisaurense. Secondo recenti impostazioni non esisterebbero elementi sufficienti per simile constatazione, ed i due rami della famiglia risulterebbero avere solo un lontano rapporto di parentela, sicché al ramo emiliano apparterrebbero solo due esponenti, quali il tribuno di Nicopolis ed un M. Arrecinus Gemellus, prefetto della cohors I Aquitanorum veterana sotto Domiziano, mentre il parallelo ramo pesarese ottenne cariche ed uffici di più alta responsabilità nella persona del console dell’anno 73 d.C. Da quanto si è fin qui detto si potrebbe giungere ad una ulteriore proposta di riconoscimento, non definitiva né certa, fin quando ulteriori ritrovamenti riminesi menzionanti il nostro personaggio non rechino il fortunato, per noi, ricordo della tribù di appartenenza, l’Aniensis, per delineare senza dubbi o incertezze l’esistenza di un avviato ramo riminese della famiglia. Si potrebbe dunque supporre, constatando che l’Arrecino Clemente del titolo riminese da Spadarolo sia il medesimo prefetto del 41 d.C., padre dell’Arrecino Clemente, cognato di Tito, console del 73 e dell’85 d.C., che anche Arrecinus senior fosse iscritto nelle liste pisaurensi della tribus Camilia, nonostante la presenza di una dedica a lui estesa in territorio ariminense, con cariche municipali di alto livello, fino al duovirato, che presupporrebbero viceversa una sua appartenenza alla lista amministrativo-sociale propria di Ariminum. In sintesi si potrebbe supporre una situazione del genere: M. Arrecinus Clemens senior, da Pisaurum, già tribuno militare di due legioni in Egitto e prefetto del pretorio sotto Caligola, per elementi a noi ignoti ma desumibili forse da estesi interessi patrimoniali nel territorio ariminense, ebbe modo di ricoprire le più alte cariche pubbliche di Ariminum; M. Arrecinus Clemens junior, senatore e console, è probabilmente il personaggio cui occorre far risalire l’omonimo nome sulla fistula aquaria da porta Sant Andrea. Difatti il suo secondo consolato fu in coppia con L. Baebius Honoratus, già curator aquarum imperiale ed egli stesso rimarrà per un certo periodo adiutor alla cura aquarum, il cui responsabile fu, per la tarda fase domizianea, M. Silius Aviola. Dario Giorgetti Ho rinvenuto, tra le solite carte di miscellanea, questi appunti che trascrivo per i nostri lettori. Non sono certo di avere sempre decifrato correttamente il testo e pertanto chiedo venia se le notizie non sono esatte. La tradizionale pizza romagnola che il Pascoli italianizzò nella voce piada, non è quella fatta con pasta lievitata del pane ecc. cotta in padella col grasso di maiale. La tradizionale, è quella detta in te test ben nota in tutta l’alta Romagna ed anche in quella parte della bassa che sta fra Ravenna e Forlì e che veniva usata nei pasti quale surrogato del pane. A Nord di Ravenna era presso ché sconosciuta per lo meno nei comuni di Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo ed anche altri, ove invece andavano sotto lo stesso nome molte altre varietà italianizzate nei vocaboli: pizza, schiacciata, crescente ecc. ed, in dialetto, dette tutte indistintamente piè, con l’aggiunta di un aggettivo per distinguere le une dalle altre. Mi permetto di elencare i tipi qui in uso avvertendo che quasi tutte, lungi dall’essere un surrogato del pane, rappresentavano 1’aspirazione dei bambini golosi (e non solo dei bambini) e alcune si avvicinano piuttosto a ciò che usiamo chiamare: paste, biscotti, tortelli e simili. Sono queste: Pié fata cun l’alvadur, cioè di pasta lievitata, quella appunto che si faceva quando si produceva il pane in casa. Oggi tutte le famiglie non usano più fare il pane in casa e possono, quando vogliono, procurarsi un po’ della pasta lievitata dal più vicino fornaio o produrla in proprio con i lieviti per dolci. Piè messa in tla gardèla. Ha punti di contatto colla piada pascoliana perchè senza lievito e sostituisce il pane. Questa si faceva appunto quando mancava il pane per il pasto, fra il vecchio che era finito ed il nuovo che si sarebbe impastato nella immediata mattina, e non si voleva chiedere il pane in prestito al vicino di casa. È lievemente salata e si cuoce sulla graticola o piastra ollare. Piè d’farena ed’ castegn (specie di castagnaccio come la precedente solo che la farina è metà di frumento e metà di castagne e, beninteso, non è salata. Piè cun i brasulén. Spessore oltre un dito. Si faceva quando s’impastava il pane specie se vi erano bambini da accontentare. L’impasto è lievitato e si intride unendo all’acqua un po’di grasso di maiale e mischiando poi cubetti di pancetta o di prosciutto. La forma è generalmente ovale con punte ai bordi che vi si praticavano stringendo un po’ d’impasto tra due dita. Veniva poi superficialmente incisa colla punta di un coltello in modo da formare vari spicchi che, a cottura avvenuta, si staccano con la più semplice pressione delle dita. Lo strutto che è nell’impasto fa sì che la piada riesca assai fragile e acquisti, nella cottura, un bel color dorato. Piè sota a la burnisa. Questa si faceva per lo più quando, per una ragione o per 1’altra, si aveva disponibile nel camino molto fuoco minuto frammisto a cenere cioè burnisa. Salata, spessore un buon dito, si seppellisce fra la detta burnisa in modo che abbia fuoco sotto e sopra. È molto indigesta e mangiandola è necessario aver sempre pronto il bicchiere e la mezzetta del vino a portata di mano. Si consuma calda. Raffreddata è quasi impossibile mangiarla. Piè fretta cun a gli ov. Impasto come la precedente ma con le uova. Molto più sottile, salata, fritta nel grasso. Meglio se mangiata calda. Cotta deve essere ancora pastosa, cioè non secca. Piè fretta dolza. Come la precedente. Si mette lo zucchero invece del sale, si impasta oltre che con uova anche con un po’ di latte; la sfoglia sarà molto più sottile e si frigge fino a quando è ben consistente. Piè solida. Impasto del pane, formata con 4 o 6 pezzi a mandorla uniti fra loro e spalmati abbondantemente di sale. Si vendeva calda nelle osterie per invitare a... bere di più. gff GIOVAN BATTISTA MORGAGNI Chi studi la biografia di quest’uomo (Forlì, 1682) eccellente in tutti i rami dello scibile, avverte come la complessa e poderosa opera alla quale egli deve la sua fama sia stata resa possibile da una lunga meravigliosa preparazione. Ancora giovanissimo, fu discepolo egregio della Scuola anatomica bolognese e allievo fedele di quel grande medico Antonio Maria Valsalva al quale si devono gli studi più importanti e più originali sull’anatomia dell’orecchio. Al suo maestro il Morgagni conservò una gratitudine profonda; ne scrisse la vita e raccolse tutte le sue osservazioni e tutte le sue lettere per illustrare i suoi meriti. Le pagine scritte al Morgagni sono una cosa commovente, una relazione intima fra due scienziati, dell’amore filiale, dell’ammirazione profonda che il Morgagni nutriva per il suo maestro al quale riconosceva gran parte di quanto egli stesso sapeva. A Bologna, dove presto ebbe l’incarico dell’insegnamento anatomico, pubblicò i suoi primi studi nel 1711, ebbe la cattedra di medicina teorica a Padova nel 1715, assunse l’insegnamento dell’anatomia e rimase fermo al suo posto fino all’anno in cui quasi novantenne lasciò contemporaneamente la vita e 1’insegnamento. Il Morgagni fu veramente il tipo migliore e direi quasi più rappresentativo dello scienziato italiano, per la geniale intuizione della verità, per la visione che oggi sembra profetica delle nuove vie della scienza. A questa genialità stupenda egli congiunse la perfetta rettitudine del carattere, la specchiata onestà della vita, la scrupolosa dirittura nelle ricerche. Ma non solo nelle discipline mediche si manifestò la sua profonda cultura e la sua attività feconda. Studiosissimo degli antichi classici, scriveva il latino con perfetta scioltezza ed eleganza e si occupò diffusamente e con grande competenza dell’opera di Cornelio Gelso; archeologo eruditissimo. Trattò in un bel libro ripubblicato un secolo fa, i problemi archeologici ; studiò con costanza la botanica, la fisica, la chimica: non vi fu problema scientifico del suo tempo che egli non si soffermasse a studiare, con quel profondo desiderio di sapere, con quell’acuta indagine critica, con quella tenace volontà di riuscire che dovevano condurlo a costruire quella che fu l’opera fondamentale e decisiva della sua vita. L’opera alla quale egli deve la sua rinomanza, De sedibus et causia morborum per anatomen ingatis, dedicata cioè a ricercare le sedi e le cause delle malattie per mezzo dell’anatomia, è scritta in forma di lettere indirizzate a un suo allievo. Il Morgagni si rivela in quest’opera quale egli fu, essenzialmente e fondamentalmente un maestro. Il suo libro non è un trattato nel quale l’autore voglia esporre in forma dottrinaria le sue teorie o far mostra del suo sapere, ma è l’opera di un vecchio ed esperto studioso che, giunto al termine della sua vita operosa, raccoglie con animo sereno e con critica severa i risultati delle sue osservazioni, dei suoi studi, dei suoi ragionamenti, e li coordina così da formarne quasi un testamento, per lasciarne l’eredità ai suoi scolari. Egli non dimentica mai che il medico deve soprattutto cercare di guarire il malato; egli pone sempre in relazione le osservazioni dell’anatomico con quelle del clinico: confronta sempre l’anatomia patologica con quella normale, stabilisce, con sicura intuizione, le vie, il metodo, le leggi della ricerca. Il medico deve esaminare sempre con la massima cura, con la più grande attenzione sì che nessun organo e nessun particolare sfugga all’osservatore; deve tener presenti le cause delle malattie e i fenomeni analoghi già osservati; egli deve insomma, con le sue ricerche, mettere in luce la storia della natura col mezzo delle osservazioni oggettive. Egli fu dunque non solo un grande anatomico e un osservatore sagace, ma un pensatore geniale il quale seppe, ponendo uno vicino all’altro i fatti della vita e della morte, trarre le conclusioni, e, quando non seppe trarle, ebbe la franchezza di dichiararlo con molta semplicità. Fu il primo ad abbandonare il sistema fino allora seguito dell’osservazione singola del caso per costruire tutto un metodo di ragionamento critico perfettamente fondato. L’anatomico in lui non soverchiò il medico, 1’umanista e il letterato completarono la cultura del matematico e del fisico; egli dimostrò con la sua vita e con la sua opera come il medico che studia e che osserva possa essere anche ad un tempo 1’artista che pensa e che discerne e che è tutto pervaso dall’ ammirazione profonda per le bellezze della natura. Egli fu dunque per eccellenza un sintetico che procedette cautamente per le vie dell’analisi: in un’epoca nella quale le vie della ricerca erano ancora malsicure e i medici, tendevano alla costruzione di sistemi imbevuti di misticismo, fu il Morgagni a mettersi, e a mettere la scienza sul fondamento della realtà. Principe e fondatore dell’anatomia patologica fu universalmente chiamato e acclamato dai contemporanei e dai posteri: ma chi riesamini oggi la sua opera, dopo tre secoli, e veda quali siano state le tracce incancellabili che essa ha lasciato, può giustamente affermare che quel grande italiano merita un posto eminente accanto ai più grandi pensatori e agli scrittori più fecondi. Egli fu non solo il grande Maestro della Scuola anatomica padovana che da lui trasse il vanto maggiore, ma Maestro delle generazioni di medici e studiosi che seguirono con devota ammirazione, il suo insegnamento. Generalmente si afferma, e fino ad un certo punto è vero, che col mutar dei tempi e col progredire delle scoperte, mutano, anche nel campo delle scienze mediche, le concezioni e le dottrine: ma il metodo fondamentale, 1’indirizzo del pensiero scientifico, clinico e anatomico come fu insegnato dal Morgagni, l’affermazione dello stretto nesso esistente tra i fenomeni della vita e quelli della morte e dello studio necessario di questi fenomeni, sono rimasti immutati nei tempi e ad essi si associa, nella storia, il nome di Giovanni Battista Morgagni. * 13 LA SCUOLA FAENTINA NELL’EPOCA RIVOLUZIONARIA 14 A pochi mesi dall’incursione francese del generale Augereau in Romagna e con i fermenti rivoluzionari ormai diffusi in città, il Consiglio faentino degli Anziani delibera, nella seduta del 17 dicembre 1796, su proposta dei fratelli Laderchi e suggerimento del pittore Felice Giani, l’istituzione di una scuola di disegno, un vero corso professionale utile tanto agli artisti quanto agli artigiani o ai «fabbricatori di qualunque specie». Ma l’apertura ufficiale della scuola professionale sarà rinviata a tempi più propizi e di maggiore stabilità politica, quando la nuova amministrazione repubblicana, dopo la vittoria francese di Marengo, costituirà le prime scuole elementari rionali e riordinerà l’istruzione municipale. Con la sconfitta delle truppe pontificie al ponte sul fiume Senio il 2 febbraio 1797, i francesi entrano in città ed insediano la prima municipalità repubblicana che innalzerà sulla piazza centrale, dopo pochi giorni, il simbolo del nuovo regime democratico: l’albero della libertà. Seguiranno nei mesi successivi provvedimenti eversivi dell’antico regime, in particolare contro il clero e gli ordini religiosi, nonché manifestazioni e celebrazioni allegoriche inneggianti alla libertà, laicità e uguaglianza dei cittadini che coinvolgeranno tutti i ceti sociali urbani, compresi gli alunni del Seminario. Del vivace dibattito sull’istruzione pubblica che caratterizza il periodo della Repubblica Cispadana poi Cisalpina, testimoniato succintamente dagli articoli delle Costituzioni del 1797 e 1798, non si conserva traccia alcuna nell’archivio faentino, tranne l’organizzazione di «feste nazionali per mantenere la fraternità tra i cittadini, e per affezionarli alla costituzione, alla patria e alle leggi», come quelle organizzate in occasione dell’inaugurazione del primo Arco trionfale al Bonaparte fuori Porta Imolese, del pranzo patriottico sulle logge superiori della piazza centrale e altre ancora celebrate in varie occasioni per infiammare lo spirito civico della popolazione. Ai dipendenti pubblici è richiesto il giuramento di fedeltà repubblicana, pena la Studio del pittore Tommaso Minardi decadenza dall’incarico ed agli insegnanti delle scuole municipali, del Seminario e del Borgo è imposto l’obbligo di dettare e spiegare agli alunni il “catechismo civico” del nuovo governo democratico sui doveri e sui diritti dei cittadini e sulla morale repubblicana, e anche le disposizioni sul nuovo calendario rivoluzionario francese. Nel clima di esaltazione rivoluzionaria si afferma che i giovani sono nati per servire la patria, quindi la loro educazione è un problema pubblico, cioè politico, e non più un semplice interesse privato. Gli eccessi ideologici di questa commistione tra educazione e politica saranno compendiati dai catechismi rivoluzionari, dagli accesi dibattiti che si svolgono nei Circoli e da tante altre manifestazioni pubbliche rivolte all’educazione civile del popolo, con sermoni enfatici e retorici impreziositi da reminescenze classiche, ma spesso astrusi e incomprensibili al soggetto popolare da educare. La Repubblica Cisalpina nel 1798 riuscì tuttavia ad elaborare un piano generale di pubblica istruzione che ripartiva le scuole in primitive (elementari biennali, gratuite, a spese dei Comuni) da istituirsi capillarmente nelle parrocchie, intermedie (secondarie di primo grado, in ogni dipartimento), centrali (secondarie di secondo grado, nei capoluoghi di dipartimento), ma salvo una parziale attuazione in alcune città lombarde, la riforma scolastica non andò in porto sia per le spese eccessive che comportava sia per l’invasione degli eserciti austro-russi del 1799 che pose fine alla Repubblica Cisalpina. A Faenza l’organizzazione scolastica municipale preesistente sopravvisse, pur con qualche intervento coercitivo ed aggiustamento, nel corso del triennio, poiché la riforma della pubblica istruzione richiedeva «l’opera di lunghe indagini e di tempi tranquilli» per essere introdotta uniformemente in tutta la Repubblica, come affermava l’Amministrazione Centrale dell’Emilia fin dal 24 ottobre 1797 nell’annunciare la riapertura di tutte le scuole, secondo i metodi abituali consolidati dalla tradizione. Il 4 novembre da Milano, Pietro Severoli comunica precipitosamente alla Municipalità la designazione di Faenza a capoluogo del dipartimento del Lamone, approvata il giorno precedente dal Direttorio esecutivo e dallo stesso Bonaparte, ed esprime orgogliosamente il desiderio suo e di Dionigi Strocchi di insediarvi presto «un liceo capace ad educare ed istruire tutta la gioventù del suo dipartimento ed abilitarla al grande istituto nazionale che darà campioni alla Repubblica; e ci riusciremo». Nonostante i precisi suggerimenti sulle fonti di finanziamento di una simile opera, sostanzialmente i beni del Seminario, l’ambizioso progetto venne rinviato a tempi più stabili e favorevoli. Intanto fin dal mese di luglio si sta procedendo alla raccolta e custodia dei libri, documenti e memorie conservate nei conventi soppressi affidandone la responsabilità nei primi tempi a Dionigi Strocchi e a Francesco Conti; mentre l’individuazione, la raccolta e la custodia di quadri, sculture e stampe delle numerose chiese e corporazioni religiose soppresse è affidata al maestro di disegno Giuseppe Zauli e a Pietro Piani che sono tenuti ad inventariare le numerose opere d’arte o a sostituire con copie o con opere di scarso valore i quadri asportati ritenuti di maggior pregio. Avendo la Municipalità previsto l’istituzione di una Galleria destinata alla raccolta delle opere d’arte e allo studio del disegno, ma non avendo ancora individuato il locale adatto a tale scopo, l’Amministrazione dipartimentale del Lamone nel 1798 interviene più volte per avvertire dei rischi che corrono tali opere nel trasporto. per invitare alla vigilanza nel controllo puntuale dei conventi onde evitare cessioni clandestine o trafugamenti. Come sembra sia accaduto, negli anni tempestosi a cavallo dei due secoli, dalla denuncia presentata nel 1803 alla Municipalità da Dionigi Strocchi e G. A. Ricciardelli, i due membri della Commissione sopra le pubbliche scuole, che lamentano la scomparsa dei migliori pezzi della raccolta artistica affidata alle cure del professore Giuseppe Zauli, e il ripetersi recente di tale incuria. Concludono i denuncianti con una supplica: «Vi raccomandiamo quegli avanzi che vi sono, e che servir devono a rianimare la Scuola delle Belle Arti, forse unico patrimonio che non potrà mai rapire all’Italia alcuna invasione nemica, e tanto più da coltivarsi in questa nostra Comune, quanto più che altrove si osserva una naturale disposizione negli studiosi che vi si sono applicati. L’evento, che segnò però il passaggio traumatico dal vecchio sistema educativo basato ancora sul modello dei Gesuiti al nuovo ancora da elaborare e definire, fu la chiusura improvvisa del Seminario diocesano il 30 luglio 1798 che squilibrò l’assetto educativo faentino generando un vuoto temporaneo recuperato solo col tempo. Infatti, alla presenza del rettore don Vincenzo Villa, del rappresentante dell’Amministrazione dipartimentale del Lamone, Francesco Ginnasi, e di un notaio che redasse il verbale della chiusura forzosa, l’agente dei beni nazionali Carlo Bianconcini prese possesso dell’edifìcio e di tutti i suoi beni, destinati dal governo repubblicano al finanziamento della pubblica istruzione gestita dai Comuni. Dopo un anno scolastico particolarmente travagliato che aveva visto ridursi a poche unità il numero degli studenti esterni e diminuire notevolmente gli interni, incarcerare come sovversivi alcuni docenti, imporre ai seminaristi la conoscenza del catechismo rivoluzionario e innalzare l’albero della libertà nel cortile interno, resa infine obbligatoria la partecipazione degli studenti-seminaristi al Circolo Costituzionale nell’ex chiesa di S. Stefano, si poneva fine d’autorità ad un’istituzione, tra le più fiorenti e rinomate in Romagna, che aveva dato lustro e prestigio alla città di Faenza, ben oltre i confini regionali. Giuseppe Dalmonte TERRE DI CONFINE TRA ROMAGNA E MARCHE NELL’EPOCA CISALPINA Difficoltà di transito e commercio Negli anni di transizione tra ‘700 e ‘800 l’ampio circondario riminese e il relativo litorale che giungeva fino alle prime propaggini di quello ravennate rifletteva i caratteri dello sviluppo territoriale dell’intera Romagna; particolarmente vivace nei centri abitati posti sull’antica via Emilia e in quelli situati lungo la fascia costiera. Un simile sviluppo territoriale non sembra potesse sempre ricollegarsi all’entroterra del vicino territorio marchigiano sede di attività agricole modeste all’epoca cui ci si riferisce. Nonostante questo, durante l’età moderna l’area marchigiana, e al suo interno quella montefeltrana, intrattenne costanti rapporti con la confinante Romagna sia per soddisfare le più banali necessità comunitarie che per consuetudini e relazioni maturate nei secoli. Questi contatti vennero mantenuti nonostante varie difficoltà e talvolta a queste si aggiunsero persino incomprensioni e diffidenze derivate da attriti campanilistici. Il Montefeltro era collegato al mare da un territorio, il riminese, che fino all’entrata delle truppe francesi in Italia faceva parte della Legazione di Romagna e che, economicamente, non differiva da altri Stati dell’Italia settentrionale annoverando numerosi terreni “ben coltivati”1. Questi ultimi costituivano, assieme a proprietà agricole di altri luoghi, il fiore all’occhiello di uno Stato, quello pontificio, gravato da numerose terre incolte. In questo contesto il riminese e gli opposti territori marchigiani sebbene fossero entrambi uniti amministrativamente dalla sottomissione al Pontefice erano la causa di evidenti, seppur talvolta effimere, rivalità. Nel periodo compreso tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX sec. le infrastrutture e le attività economiche locali dovettero subire l’impatto con una nuova realtà politica: la creazione nel Nord Italia della Repubblica Cisalpina e l’incamerazione in essa dell’intera Romagna. Venne così creata la barriera doganale (1797) tra il territorio riminese e quello marchigiano, che limitò sensibilmente il transito di uomini e merci che fino ad allora si era mantenuto inalterato. Questa linea di demarcazione ostacolò anche spostamenti di diverso genere fra cui quelli delle famiglie contadine in cerca di migliori condizioni lavorative. Alquanto significativa è una lettera dell’11 gennaio 1800 che determinava come solo dopo numerose precauzioni fosse stato concesso al «signor Gaspare Fontevecchi»2 lo spaccio «anche col mezzo di terze persone a lui destinate» delle bollette di macina. E si annotava che il «giorno quindici» dello stesso mese doveva assolutamente cessare, «pena di contrabbando», l’attività del detto spacciatore. Nell’agosto del 1800 il governo Cisalpino inviò alla municipalità riminese un estratto dove erano ufficialmente definiti i confini del dipartimento del Rubicone con lo Stato della Chiesa. Questa disposizione governativa anche se chiaramente rispondeva alla volontà di precisare quali fossero le rispettive competenze terri- toriali dello Stato nascondeva l’intento di regolamentare indirettamente i movimenti ed i commerci che interessavano le aree di confine. Interessante è un articolo che toccava uno dei principali punti dolenti della questione. Quello cioè del superamento della frontiera tra il contado riminese e quello marchigiano: «Li corrieri ed officiali che [...] saranno spediti ad Ancona» o che seguiranno il percorso inverso «prenderanno la strada di Ferrara per Ravenna, ed in seguito terranno la strada maestra: potranno condurre seco le loro vetture e bagagli, purchè siano muniti di passaporti». Da queste righe non si evince certo un drastico cambiamento rispetto al passato ma in realtà vi erano difficoltà non solo riguardo a particolari disposizioni doganali, ma anche dovute all’interferenza di problemi di vario genere, non fra ultimi l’incomprensione e la reciproca intolleranza dei funzionari statali posti ai due lati della frontiera. Esemplare è una lettera che Giovanni Cisterni, delegato del comune riminese, inviava da Ancona ai suoi responsabili il 21 Settembre 1800. Costui, incaricato di provvedere ad una partita di grani giunta nel porto del capoluogo marchigiano e destinata a Rimini, informava i suoi mandatari di alcune difficoltà sorte improvvisamente: «Non ho mancato di fare tutti i sforzi possibili per ottenere da questo governo l’ estrazione per la via di terra, mediante le opportune licenze, facendo conoscere la provenienza del grano, la libertà del commercio ed altri oggetti»3. Ma nonostante questo suo comportamento osservava: «Non mi è riuscito ancora di vincere la durezza di questo delegato, non già per alcuna raggione opportuna, ma per cattivo animo contro i sentimenti ed il Governo repubblicano». Il Cisterni, comunque testimone che relazioni commerciali tra Romagna e Marche continuarono a verificarsi nonostante la divisione politico-amministrativa, si era quindi imbattuto in un funzionario che riversava contro le attività destinate alla città riminese i propri rancori rivolti a tutto il governo repubblicano. È probabile che costui coincidesse con una persona legata a valori tradizionali, e politicamente conservatori, completamente opposti a quelli a cui lo Stato Cisalpino intendeva ispirarsi. È anche ipotizzabile che i sentimenti del funzionario pontificio fossero condivisi da altri suoi colleghi, e fosse ugualmente espresso, seppure con opposte motivazioni, da alcuni impiegati dell’amministrazione riminese. Che queste osservazioni non riguardassero dei fatti singoli e limitati ad alcune coincidenze, ma degli atteggiamenti diffusi all’interno di due amministrazioni vicine territorialmente ma non ideologicamente, sembra essere dimostrato dalle parole del Giusdicente di Rimini, sig. Bianconcini. Costui, il 30 Luglio 1800, annotava: «Molto io ho 15 16 fatto per l’ osservanza della legge disponente la libera circolazione dè generi accennata alle comuni», ma nonostante questo, affermava, ancora non si era riusciti ad attuare il provvedimento, e inoltre «alcuni individui, qui stanti in figura abusiva di municipali, o di altri funzionari del cessato governo, che la fanno da despoti promisero l’ esecuzione di detta legge»4. Le parole del sig. Bianconcini hanno in questo caso un valore particolarmente significativo. Si perviene infatti a conoscenza che gli addetti della precedente amministrazione papalina, benché congedati dai loro compiti, non solo continuavano ad influenzare le pratiche amministrative più comuni, ma anche che le ostacolavano sensibilmente. L’uso della parola “despoti” ha quindi in questo caso un significato particolarmente negativo, attribuito a persone in grado di disporre di una autorità svincolata da quella governativa. Tuttavia va sicuramente ricordato che la diatriba in questione si sviluppò all’interno di un problema, quello della circolazione dei grani, di non facile soluzione e che anche in passato aveva dato luogo a vivaci e complicate discussioni. Concludendo il Bianconcini si rammaricava che questi avvenimenti ostacolassero il normale svolgimento delle attività comunitarie ed equiparava i funzionari nemici a dei volgari banditi: «tutto si lavora dai perfidi nemici, e dai briganti per opprimere li onesti cittadini». Si può quindi osservare che i problemi legati al transito, e più generalmente alla mobilità, del circondario riminese, e anche fra quest’ultimo e il territorio marchigiano, oltre ad essere connessi con difficoltà oggettive se si considerano le disastrate condizioni del sistema viario settecentesco furono indiscutibilmente complicati dall’atteggiamento e dalla disponibilità di alcuni funzionari. Sarebbe interessante, ma anche difficile, individuare in questi casi quanto influì sul comportamento degli impiegati pontifici della “Marca” il sentimento di avversione nei confronti dei vicini riminesi. Un sentimento che trovava certamente origine negli atriti campanilistici esistenti tra due popolazioni confinanti, ma che era esasperato anche da altri elementi. Questo sentimento era infatti condiviso dalle persone culturalmente più preparate del circondario riminese, fautrici di un sentimento elittario che, quasi paradossalmente, si saldava con elementi della cultura popolare, essenzialmente contadina, con la quale aveva in comune “un universo di valori”5. Alessandro Buda 1 L.Dal Pane, La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia, Milano, 1932, p.39. 2 Archivio di Stato di Rimini ( d’ora in poi ASR ), B22, Lett. di “Pellegrini I.R. Commissario” alla Reggenza riminese, Ravenna, 11 Gennaio 1800. La lettera è firmata da Pietro Paolo Fagnani, segretario. 3 ASR, B30, Lett. di “Giovanni Cisterni alla MdR”, Ancona, 21 settembre 1800. 4 ASR, B25, Lett. di “Il giusdicente Bianconcini alla MdR”, San Mauro, lì 11 termidoro Anno VIII Rep. (30 Luglio 1800). 5 E.Grassi, Regionalismo ed eclettismo ne “La Romagna di Gasperoni e Grilli (1904-1928)”,in “Romagna arte e storia”, Anno II, n° 4, Gennaio-Aprile 1982, pp. 5-7. E’ zoch-periodico di attività culturali fondato nel 2002 da D. Franchini e G.F. Fontana Agosto 2006, numero 22 Autorizzazione del Tribunale di Bologna n.° 6718 Direttore : Daniele Franchini Direttore responsabile : Gian Franco Fontana Redazione: Santerno Edizioni sas di Gian Franco Fontana e C. Via IV novembre, 7 40026 Imola BO E mail : [email protected] Fax 0542.35629 Stampa: Offset Ragazzini & C. - Faenza - 0546 28230 Questo numero della pubblicazione è edito con il solo contributo dei soci del Tribunato. In questo numero scritti di: Aureliano Bassani, Domenico Berardi, Alessandro Buda, Giuseppe Dal Monte, Gian Franco Fontana, Odette Gelosi, Dario Giorgetti, Piergiorgio Pellicioni, Francesco Serantini. Le fotografie sono dell’archivio Gian Franco Fontana ©2006 Spedizione in Abbonamento Postale D. L.353/2003 conv. L.27-02-2004 n°46 art. 1 comma 1 DCB Bologna MACCHIETTE FORLIVESI D’ALTRI TEMPI In ogni tempo, in ogni città, vi sono state e vi sono macchiette, alcune ripugnanti, altre simpatiche; tutte interessanti. Poche gioie e molti dolori: sorridono e schiamazzano, ma sincere sono le lacrime che versano. Coi loro lazzi e sberleffi provocano le risa della folla che li schernisce. Non hanno più una psiche, ma soltanto un otre da riempire. E si riempiono non di alimenti, ma di alcool. L’ alcool ne affretta, la fine, ma ne accentua la vitalità. Cabùsa Fu muratore, poi urlatore dei vini dei proprietari delle vigne. In seguito, ubriaco di professione. Tutta la strada era sua ed i monelli vedendolo procedere a zigzag gli davano la baia. Egli tentava di inseguirli e cadeva; i furfanti allora cominciavano a bersagliarlo con gli oggetti più disparati. Piccolo, roseo, rotondo sembrava una botticella. E poiché il vino lo agognava sempre, glie ne facevano ingerire una quantità enorme a mezzo d’un imbuto e poi premendogli il ventre glie lo facevano rimettere dalla bocca come fosse una fontanella a getto continuo ! Un bruto era certamente lui, ma bruti ancora di più gli altri. Mort tré volt Figura alta, olivastra, taciturna. Sembrava una y rovesciata. Per ben tre volte, in brevissimo tempo, fu dichiarato morto ma sempre risuscitò. I monelli per deriderlo gli gridavano: « Mort tre volt » e lui ad inseguirli e a minacciarli con un nodoso randello, che spesso gli portavano via con sua grande disperazione. L’ ultima volta che si ammalò, fu dichiarato guaribile in pochi giorni invece morì per davvero. Infallibilità dei giudizi medici! Bertaccini lassa la birèna Era un ometto smilzo e tutto nervi. Per un’ ingiustizia subita, volle soffocare nel vino il suo dolore e perciò divenne il ludibrio degli sfaccendati, giovani ed adulti. Bastava gridargli : « Bertaccini lassa la Biréna » per farlo andare su tutte le furie. Il lazzo gli ricordava l’origine di tutte le sue sventure. Accusato, ingiustamente, d’aver tentato di rubare una birèna (tacchina) dall’aia d’ un colono, non ebbe più pace. Tale e tanto accoramento, invece di suscitare una ondata di compassione, fu causa della perenne beffa che l’accompagnò sino alla . morte. Le folle, a volte, sono spietate sino alla crudeltà. Schignot Singolare figura di uomo alto, roseo, ben piantato. Non fu schernito dalla plebaglia. Volle e seppe essere il più straccione di tutti i poveri. Girava con una sportaccia sotto il braccio sinistro ed un vestito tutto a brandelli che gli lasciava vedere le carni. Non cercava e non voleva elemosine. Viveva con quanto raccoglieva dai rifiuti delle ortolane. Non parlava mai con nessuno; tanti lo ritennero muto invece in gioventù era stato uomo elegantissimo, brioso e faceto dicitore. Era stato sarto, tagliatore di valentia indiscussa e visse a Parigi ove guadagnava molto denaro. Sempre vestito inappuntabilmente di nero, cilindro e scarpe lucide, colà fece innamorare una giovane ereditiera che si suicidò per tema di non essere corrisposta. L’ elegantone senza rimorsi e senza colpe, ne provò però tale strazio che rimpatriò e volle diventare 1’uomo più vergognoso della sua terra. Ogni tre anni abbandonava i luridi cenci e riappariva elegantissimo: si recava a Parigi per rendere omaggio alla tomba di colei che non l’aveva compreso. Poi ritornava, rivestiva i cenciosi indumenti e riprendeva la sua vita di randagio solitario. La sua triste storia, forse risaputa, incuteva rispetto e pietà anche nei monelli. Ancora oggi, per i più vecchi, «Schignot» è sinonimo di miseria a brandelli.
Scarica