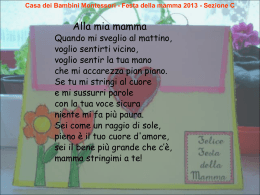leggi, scrivi e condividi 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it NEREA RIESCO ALL’OMBRA DELLA CATTEDRALE Prima edizione: maggio 2010 visita www.InfiniteStorie.it il grande portale del romanzo Traduzione dallo spagnolo di Claudia Marseguerra Titolo originale dell’opera: El elefante de marfil © 2010, Nerea Riesco © 2010, Random House Mondadori S.A. ISBN 978-88-11-68181-6 © 2010, Garzanti Libri s.p.a., Milano Gruppo editoriale Mauri Spagnol www.garzantilibri.it PROLOGO La partita sembrava non voler finire. Il rintocco delle campane e il profumo di latte bollito e pane tostato ricordarono loro che era l’hora prima e non toccavano cibo da quando si erano seduti davanti alla scacchiera. Quel posto aveva l’aria clandestina delle antiche catacombe romane. Sui lunghi tavoli disposti attorno alla sala si mescolavano, senza ordine apparente, incartamenti, libri, mappe e annotazioni che coprivano in parte le scacchiere allineate, tutte in fremente attesa di trasformarsi ancora una volta in campi di battaglia. Gli spessi muri di pietra erano decorati con affreschi che ritraevano scene profane: l’evoluzione della Giralda nel corso del tempo, navi in balia delle onde, duelli tra cavalieri, roccaforti assediate… forse per questo i fratelli dell’ordine lo chiamavano «il Krak dei Cavalieri». I due avversari si guardarono di sbieco. Il re bianco era in pericolo. La minaccia dell’intrepida regina nera lo teneva immobilizzato dietro due pedoni e un cavallo, ma l’attacco era dirompente e non si sapeva quan3 to avrebbe potuto resistere ancora. Il giocatore più giovane trasse un sospiro, nel tentativo di dominare l’ansia. Sollevò l’alfiere nero con la massima delicatezza, lo strinse tra l’indice e il pollice e, sicuro, andò a depositarlo su una casella. Un sorriso impercettibile gli illuminò il viso. Ormai ne era certo: il suo nemico non aveva più scampo. «Scacco matto», annunciò lentamente, cercando di non peccare d’orgoglio per la soddisfazione. «Non c’è dubbio, fratello», replicò il commendatore dell’ordine. «Avete vinto tutte le partite. Siete il migliore.» «Vi ringrazio per il complimento», si schermì il ragazzo. «Non si tratta di un complimento, ma di semplice giustizia. Possedete un talento innato per gli scacchi. Vi osservo sin da quando eravate bambino. La mia missione è trovare il migliore e voi lo siete. Ci serve il migliore per riuscire a vincere… e io scelgo voi.» «Quando? Dove? Chi sarà il mio rivale?» «State calmo», mormorò il commendatore posando una mano sulla spalla del giovane. «Non ho ancora risposte a tali domande. Una sola cosa è certa: un giorno o l’altro saremo chiamati a giocare quella partita… e dovremo vincerla.» 4 1. Il giorno del terremoto Il terremoto si scatenò il giorno di Ognissanti. Come tutti gli anni, i sivigliani approfittavano dell’occasione per rispolverare casacche di velluto e mantelle di pizzo e abbigliarsi di nero dalla cima del cappello fino al più profondo dell’anima, tanto per rendere manifesto il proprio disdegno per l’effimero. Il rituale della giornata consisteva nel far visita ai defunti con un bel mazzo di fiori, ragguagliarli sugli ultimi avvenimenti familiari e sociali e infine recarsi alla messa delle dodici assumendo un’aria devota. Quindi non restava che attendere l’ora della merenda, momento in cui i mortali si dedicavano a divorare soffici bignè ripieni e ossa dei morti alle mandorle, che se nell’aspetto volevano ricordare ciò che ispirava il loro nome, al palato conservavano intatta la dolcezza della crema pasticcera. Quel giorno Siviglia si era risvegliata avvolta in una coltre di nebbiolina impalpabile. Le persone sbucavano all’improvviso come ombre dagli angoli brumosi, camminando in silenzio perché il freddo dell’autunno 5 non si infiltrasse dalla bocca. Sembravano seguire tutti un itinerario ben concertato, una coreografia studiata con cura che li divideva in gruppi: chi al cimitero del Prado de San Sebastián, chi a los Pobres, a los Canónigos, all’Eclesiástico o ancora al San José en Triana… Doña Julia, la giovane vedova de Haro, non poteva certo essere da meno. Attorno alle nove era uscita dalla sua casa-stamperia in calle Génova stretta al braccio di mamma Lula, la domestica di colore che ricordava al servizio della sua famiglia sin da quando aveva l’uso della ragione. La domestica, quella mattina, si era destata con il cuore in subbuglio. «Oggi finisce il mondo», aveva annunciato con un sospiro rassegnato mentre accostava il vassoio della colazione al letto della signora facendo ondeggiare il suo enorme didietro. «Se continui a dire cose del genere, non puoi lamentarti se poi la gente ti evita», l’aveva rimproverata doña Julia prima di sgranocchiare controvoglia una fetta di pane tostato. In città si diceva che mamma Lula fosse approdata al porto di Siviglia a bordo di una nave di schiavi che sapeva di avorio e sopraffazione e che provenisse da un villaggio africano di nome Yoruba, culla del vudù. Pare che allora avesse un aspetto orribile, i capelli arruffati pieni di pidocchi, pustole suppuranti negli occhi e sulle labbra, e che emettesse strani versi degni di una creatura selvaggia. Stando alle voci, il padre di doña Julia, il rispettabile farmacista Juan Nepomuce6 no Gil de la Sierpe, l’aveva scovata durante una delle sue solite passeggiate nei dintorni del porto di Mulas in attesa che una nave proveniente dalla Nuova Spagna portasse una medicina miracolosa in grado di curare, una volta per tutte, le febbri malariche che tendevano ormai a insediarsi stabilmente in città. Alla vista di quella povera ragazza nera in piedi su una cassetta di legno, con uno straccio sudicio a coprire le vergogne e i polsi e le caviglie incatenati a un collare di ferro arrugginito, si era impietosito all’istante mentre il negriero di turno ne decantava le qualità quasi vendesse un sacco d’orzo. Aveva pagato la somma richiesta e se l’era portata a casa senza badare alle proteste della moglie. Dopo un bel bagno e con abiti decenti indosso, si erano accorti che non doveva avere più di quattordici anni, che non aveva idea di come si usassero le posate e che l’unica parola che continuava a ripetere con un minimo di chiarezza era «Lula». Doña Julia, che a quell’epoca di anni ne aveva appena cinque, si era innamorata subito della nuova venuta. L’aveva presa per mano ed erano scomparse entrambe al piano di sopra. Nessuno aveva saputo più nulla di loro per le successive due ore. Le avevano chiamate a gran voce, cercandole sotto i letti, in soffitta, nella dispensa. La madre di doña Julia aveva rinfacciato al marito di aver portato dentro casa una cannibale abituata a mangiarsi i bambini bianchi con contorno di piselli, «Oh, povera bimba mia, poverina, poverina…». finché il giardiniere non aveva notato una 7 scia di vestiti che andava dalla cucina al patio sul retro. E proprio lì avevano ritrovato le due ragazzine, nude come mamma le aveva fatte e sporche di fango fino alle orecchie, intente a parlottare in un idioma incomprensibile, ridendo a crepapelle e mangiando a manciate la terra dei vasi. «Guarda cos’hai combinato con la tua mania della compassione!» aveva urlato la donna al marito mentre sollevava la figlia per un braccio coprendola con il suo scialle. «Dobbiamo disfarci al più presto di questa creatura mostruosa… o trasformerà Julia in una selvaggia. La voglio fuori da questa casa, subito!» La fermezza della moglie sembrava aver convinto Juan Nepomuceno ma la piccola Julia, quando aveva visto che le toglievano la sua nuova amichetta, aveva cominciato a piangere e a disperarsi diventando tutta rossa, si era buttata a terra e nessuno riusciva a farla rialzare perché tirava morsi e calci a chiunque le si avvicinasse. In mezzo a tutti quegli strepiti, pianti e singhiozzi, l’unica cosa chiara era che, se la ragazza se ne fosse andata, lei si sarebbe buttata nel fiume. E così alla fine si erano convinti a tenere in casa la schiava nera. Con il passare degli anni, mamma Lula aveva imparato a parlare spagnolo con accento andaluso ed era diventata cameriera di Nostra Signora degli Angeli nella confraternita dei Negritos. Preparava un gazpacho insuperabile, aggiungendo un tocco personale di arance amare, e a furia di esercitarsi con coltello e forchetta aveva smesso di rappresentare un pericolo per 8 sé e per gli altri. Ma la gente la guardava con diffidenza, soprattutto a causa dei commenti malevoli che diffondeva la signora Gil de la Sierpe alle riunioni di società, in cui garantiva che la sua domestica africana nascondeva sotto il letto una bambolina di stoffa trafitta da spilli con cui riusciva a procurare terribili dolori di pancia a chiunque le stesse antipatico. Mamma Lula era una buona osservatrice. Da più di una settimana notava lo strano comportamento dei cani, che passavano la notte ululando alla luna; degli uccelli, che facevano il nido nei punti più alti dei campanili delle chiese ed erano volati via con le piume arruffate lasciando i loro piccoli a becco asciutto; oppure dei cavalli, che si imbizzarrivano, gli occhi spiritati, a ogni tentativo di mettere loro il morso. Anche Juan il Bisognoso aveva perduto il senno la sera prima. Si era inginocchiato a recitare una preghiera angosciante, in piena calle Génova, aggrappandosi alle gonne delle signore che gli passavano accanto e giurando che migliaia di persone erano destinate a morire. Non si era dato pace neppure dopo la decisione delle guardie di intervenire: gli avevano mollato un paio di ceffoni e, siccome non c’era verso di calmarlo, avevano finito per rinchiuderlo nelle prigioni di Triana finché non gli fosse passato l’accesso di follia. «Oggi finisce il mondo», ripeté decisa mamma Lula mentre camminava accanto alla sua signora in direzione della cattedrale per assistere alla messa di Ognissanti. «Lo so perché gli animali si comportano in mo9 do strano. Gli asini sono testardi, i cani abbaiano come forsennati…» «Non mi dire!» replicò doña Julia portandosi la mano sinistra alla guancia in un teatrale gesto di sorpresa. «Gli asini sono ostinati e i cani non fanno che latrare? Che cosa strana! Attenzione, attenzione…» «Gli storni sono volati via. Sono tre giorni che non se ne vede più neanche uno e…» «Oh, adesso basta, santo cielo! I tuoi vaneggiamenti mi stanno esasperando. Se non smetti di dire tutte queste assurdità ti faccio rinchiudere nell’ospedale dei Santi Cosma e Damiano… sai, mi hanno assicurato che sono bravissimi con le domestiche matte come te.» Mamma Lula decise di mordersi la lingua nonostante l’inquietudine che la divorava. Continuò a camminare in silenzio e salì i gradini di accesso alla chiesa misurando con la coda dell’occhio la collera della sua signora. Giunta all’altezza del portone d’ingresso, doña Julia accelerò il passo e spinse uno dei battenti. Allora mamma Lula attese un istante, stringendo il suo cesto di vimini con le braccia incrociate, la fronte aggrottata e il labbro inferiore più sporgente del solito. Lasciò andare avanti la sua signora. «Sì, sì… chiamami pure matta», mormorò tra sé prima di attraversare la soglia. «Ma vedrai che oggi finisce il mondo.» Mamma Lula odiava non dire l’ultima parola quando era certa di avere ragione. 10 Entrarono nella cattedrale dalla porta del Perdono, seguite dallo sguardo inquisitorio delle statue dei santi Pietro e Paolo. San Pietro era collocato sulla sinistra, con l’aria severa, i capelli scarmigliati e le chiavi del cielo in mano. Accanto a lui si apriva la piccola inferriata attraverso cui si avvisava il parroco di somministrare l’estrema unzione ai fedeli intenzionati a lasciare questo mondo in orari scomodi. San Paolo, dal canto suo, stringeva l’elsa di una spada nella mano destra, mentre teneva la sinistra nascosta dietro la schiena in una posa da spadaccino baldanzoso. Ma la cosa più strana era che quella mano celata fra le pieghe del suo abito sembrava allungarsi miracolosamente per poi ricomparire ai piedi della figura, a sostegno della pedana. I due apostoli, con l’arcangelo Gabriele, la Vergine annunciata e il bassorilievo con la cacciata dei mercanti dal tempio (a contraddire la tradizione popolare secondo cui la gradinata della cattedrale fungeva da mercato) costituivano la cornice cristiana in cui si inseriva quell’ingresso ibrido, il più antico della chiesa. Oltre la soglia si entrava in un mondo mestizo, un chiostro fitto di aranci che in altri tempi era servito da sahn, da corte della moschea. Qui i fedeli musulmani facevano un tempo le abluzioni in una vasca centrale proveniente dalle antiche terme romane. Le diverse culture del Mare Nostrum intrecciavano le loro strade nel patio degli Aranci di Siviglia. Le due donne proseguirono in diagonale, schivan11 do i frutti caduti, fino alla porta della Lucertola, dove immancabilmente mamma Lula guardava verso l’alto. «Lucertola, lucertola», esclamò toccandosi la testa con l’indice e il mignolo della mano destra. La poverina, assai superstiziosa, considerava un gravissimo errore lasciare un coccodrillo essiccato appeso al soffitto della cattedrale sin dai tempi in cui il sultano d’Egitto l’aveva spedito in dono al re Alfonso X, chiedendogli la mano della figlia Berenguela. Il re Saggio aveva rifiutato la proposta matrimoniale ma si era tenuto il coccodrillo, diventato in poche settimane sempre più pigro per colpa del profumo di zagara e del tepore estivo. L’animale aveva imparato a nutrirsi dalla mano dei suoi guardiani e dopo mangiato amava riposare all’ombra di un platano nelle placide sere dei palazzi reali. Alcune cronache riferiscono addirittura che dimenasse la sua enorme coda di rettile quando vedeva avvicinarsi il re, quasi fosse un cagnolino da salotto. E tutti quanti si erano affezionati a tal punto a lui che, alla sua morte, avevano deciso di impagliarlo e appenderlo al soffitto della cattedrale come portafortuna. Oltrepassarono la porta della Lucertola per immergersi nell’oscurità azzurrata della chiesa, scalfita appena dalla fioca luce che filtrava dalle vetrate. Proseguirono in linea retta sul lastricato di marmo bianco e nero, superando sulla sinistra l’ingresso della Giralda, la porta dei Bastoni, la cappella di San Pietro, la cappella reale… Esattamente alle spalle della cappella mag12 giore si trovava il mausoleo della famiglia López de Haro. Doña Julia lasciò il braccio di mamma Lula e le chiese di tenerle il mazzo di bignonie rosa colte quella mattina stessa nel patio di casa. Quindi estrasse dalla tasca della sopragonna la chiave per aprire il cancello che proteggeva la cappella funeraria. Ma prima di farlo avvertì il bagliore degli occhi vitrei di san Giovanni Evangelista, che ne presidiava l’altare con il volto beato del discepolo preferito di Gesù. Il suo defunto sposo era un fervente devoto del santo, non solo perché era divenuto il patrono dei tipografi dopo la stesura del quarto vangelo; lo ammirava per il fatto di aver sopportato con eroico stoicismo l’immersione nel calderone di olio bollente ordinata dall’imperatore romano Domiziano. Secondo l’illuminato giudizio del signor de Haro, ciò stava a dimostrare che i tipografi erano una sorta di martiri votati al sacrificio, perseguitati sin dalle origini della cristianità perché colpevoli di lasciare prova scritta delle verità più scomode. Eppure, nonostante l’ottima reputazione di san Giovanni, ogni volta che doña Julia vedeva il contorno netto di quella sagoma di maiolica avvolta nel velluto rosso, con le sue matasse di capelli veri, i gioielli dai vetri colorati e la boccuccia socchiusa su cui le labbra e la lingua brillavano spudorate per via dello spesso strato di vernice scarlatta, non riusciva a cancellare dalla mente l’immagine delle donne dissolute che vivevano nei bordelli del porto. Distolse lo sguardo e girò la chiave nella serratura. 13 Il cancello stava per aprirsi quando il pavimento della chiesa prese a dondolare quasi fosse una zattera che galleggiava su un lago di olio. Doña Julia fu colta da un violento attacco di nausea e si aggrappò all’inferriata. «Il Signore abbia pietà di noi e perdoni i nostri peccati, amen!» Mamma Lula si segnò con una rapidità straordinaria. Il movimento durò solo qualche secondo, ma il silenzio che ne seguì sembrò interminabile. I presenti si guardarono incerti nella speranza che qualcuno potesse dare una spiegazione logica a quanto era appena accaduto, ma nessuno osò aprire bocca. La sensazione di vertigine si diluì piano piano e i fedeli cominciarono a dubitare che il suolo avesse tremato davvero. Doña Julia aprì il cancello della cappella ed entrarono. Prese degli stracci e una bottiglia di acqua saponata dal cesto che portava mamma Lula e si misero tutt’e due a lucidare la pietra che copriva il sepolcro di suo marito quasi stessero spolverando la credenza di casa. Terminato il lavoro, doña Julia tolse i fiori secchi dai vasi che custodivano l’immagine di san Giovanni Evangelista e li cambiò con quelli che teneva in mano la domestica. Li sistemò come se stesse ravviando una pettinatura e, quando le sembrò che facessero un bell’effetto, trasse un lungo sospiro. Si girò a osservare le lettere incise sulla lapide. Avrebbe voluto colmare i suoi pensieri di immagini pie, in onore del defunto e delle sue virtù terrene, formulando magari an14 che una preghiera, ma tutto ciò che le veniva in mente erano le numerose faccende da sbrigare quel giorno. Si rassegnò alla certezza di non avere altro da fare in quel posto. Eppure rimase immobile, in silenzio, raccolta in preghiera davanti alla tomba. Non voleva che proprio in una festa così solenne la vedessero uscire troppo presto dalla cappella in cui il suo sposo riposava per l’eternità. Trascorso un intervallo di tempo che giudicò prudente, si fece il segno della croce, uscì con mamma Lula e richiuse a chiave il cancello. Ripresero l’attitudine di prima, la vedova sottobraccio alla domestica, e camminarono l’una accanto all’altra in direzione della cappella maggiore per andare a occupare un buon posto. Trattandosi di una giornata speciale, la messa sarebbe stata officiata da padre Zacarías, il poeta cieco, famoso per l’ardore dei suoi sermoni. Il predicatore contava su un’ampia folla di devoti che lo seguivano ovunque, quasi fosse un visionario onnipotente. In città c’era chi garantiva che la sua cecità fisica lo aiutasse a vedere con gli occhi dell’anima, rendendolo cento volte più ricettivo rispetto ai comuni mortali. La sua fama era talmente vasta che doña Julia aveva commissionato a un giovane copista sempre seduto in prima fila la trascrizione dei suoi sermoni più ispirati: la stamperia si sarebbe incaricata di pubblicarli in fascicoletti affinché le persone in grado di leggere avessero la possibilità di acquistarli, studiarli, sviscerarli e assimilarli nell’intimità della propria casa. E se qualcuno 15 si perdeva l’ultima omelia del padre poeta non doveva certo farsene un cruccio: ben presto l’avrebbe sentita recitata in musica agli angoli delle strade grazie ai libretti messi in vendita dalla vedova de Haro. Quel sabato padre Zacarías salì sul pulpito con aria rassegnata. «Fratelli», esordì quasi in lacrime. «Sarei davvero felice se potessi assicurarvi che tutti i defunti, di cui oggi celebriamo la festa, sono stati assunti in cielo.» Fece una pausa, cambiò espressione e lanciò un grido che riuscì a scuotere un fedele appisolato in terza fila. «Ma non posso! L’essere umano è così pieno di presunzione, arroganza, vigliaccheria… Ecco perché esiste la punizione. L’inferno!» tuonò agitando il pugno sopra la testa. Le donne rimasero senza fiato, mentre gli uomini spalancarono gli occhi e si afferrarono alle ginocchia con mani rigide. Ma le omelie seguivano un ritmo ben preciso che alternava sapientemente severità e rassicurazione. Quando padre Zacarías percepiva che i fedeli erano al colmo della disperazione, riprendeva fiato, allungava quel momento di carezzevole angoscia, assumeva un’espressione più tranquillizzante e concludeva che non si dovevano perdere le speranze. Doña Julia conosceva a memoria le formule dei suoi sermoni, perciò ormai non se ne lasciava impressionare. Era una donna concreta. Credeva con decisione che Dio l’avrebbe apprezzata di più se gli avesse parlato personalmente almeno cinque minuti al giorno, anziché ascoltare ogni momento le preghiere al16 trui. Ma nella certezza che ben pochi sarebbero riusciti a condividere le sue opinioni, se ne stava seduta in seconda fila per farsi vedere da tutti. In quel punto era a un tiro di sasso dall’officiante e i fedeli delle panche vicine erano testimoni del suo cipiglio severo, degno riflesso della sua anima afflitta per la morte dello sposo. E dagli ultimi posti riuscivano tutti a riconoscere la sagoma dello chignon castano allineato con simmetria quasi geometrica al suo collo sottile. Doña Julia era inconfondibile anche da lontano. Vestita sempre rigorosamente di nero, alta, snella, il viso ancora fresco come un frutto di stagione, la schiena ben diritta, indizio, a sentire i maligni, di un’anima arrogante celata dietro una facciata di carità e devozione. Quando padre Zacarías arrivò a parlare della resurrezione dei morti, a lei venne uno sbadiglio. Cercò di nasconderlo con il dorso della mano, ma alla fine le sfuggì un suono simile al lamento di un gattino. Dalla prima fila si girarono. Mamma Lula tirò un gran sospiro e le diede una pacca sulla spalla fingendo di consolarla. Alcuni lo scambiarono per un gemito di tristezza in ricordo dell’anziano sposo mancato cinque anni prima e la guardarono con occhi compassionevoli. Lei annuì in segno di ringraziamento. In realtà doña Julia non vedeva l’ora che la messa finisse. Aveva mille cose da fare in tipografia: ultimare una relazione sugli scontri avvenuti in plaza de Ceuta fra le milizie di re Ferdinando VI e la setta maomettana, ristampare la zarzuela Il giudizio di Paride e il ratto di 17 Elena, nonché l’epistola del conte Nolegar Giatamor a proposito dell’ultima strigliata di tonti e balordi… Voleva tornare a casa, sfilarsi le scarpe e sedersi nel patio a gustare l’intenso aroma dei gerani, che le ricordava immancabilmente l’odore dei libri antichi. Da lì poteva osservare indisturbata l’andamento della stamperia. Adorava il suono ritmico della nuova pressa ordinata da Genova, vero e proprio gioiello della tecnologia moderna, sconosciuta a Siviglia prima di allora: dotata di molle che aiutavano a velocizzare i tempi di sollevamento della lastra metallica, era in grado di produrre all’incirca duecentocinquanta stampe all’ora. Grazie a questo nuovo acquisto, la sua sarebbe diventata la prima stamperia della città. Ma più di tutto le piaceva inseguire l’ombra di León che si mescolava agli altri lavoranti. Intuire la curva del suo mento, il colore azzurro mare dei suoi occhi, la muscolatura nervosa delle sue braccia. All’inizio era stata attenta a non farsi scoprire dal ragazzo, ma ormai non aveva più timore che lui si sentisse osservato e si girasse verso di lei. Quando León si accorgeva che la signora, immobile nell’ombra, lo fissava mentre si affaccendava qua e là, con l’espressione dura della padrona che controlla il lavoro dei suoi sottoposti, anche lui si fermava e sosteneva il suo sguardo. Non era una sfida: piuttosto, si trattava di una domanda. Gli occhi di doña Julia lo affascinavano, e lui voleva scoprire a tutti i costi come mai la donna emanasse quel bagliore palpitante che solo lui credeva di perce18 pire. Nella loro battaglia di sguardi lui finiva quasi sempre per soccombere e chinare il capo, intimidito, tornando a dedicarsi alle proprie faccende con un mezzo sorriso sulle labbra. Quando León distoglieva gli occhi, lei ne approfittava per riprendere fiato. Nessuno sapeva da dove venisse quel ragazzo. Era spuntato dal nulla qualche mese prima, avvolto in un alone di mistero. La prima volta che era stato notato in città, si aggirava nei dintorni della cattedrale con un’aria da marinaio alla deriva. Aveva i capelli lunghi, d’un biondo quasi bianco, forse per colpa dell’aria salmastra e del sole di mezzogiorno, ed era così bello da suscitare turbamento. Chi parlava con lui faticava a sopportare il magnetismo di quegli occhi color del cielo e finiva molto spesso per guardare a terra, farfugliando parole incomprensibili. León era una di quelle persone nate per essere ricordate da chiunque lo incontrasse. La figura da statua greca, i silenzi, i movimenti lenti e precisi non facevano che ribadire la sua condizione di creatura indecifrabile che intimidisce i codardi e affascina gli intrepidi. I più malevoli giuravano che León fosse sceso da una nave che issava una bandiera nera decorata con un teschio e due tibie incrociate agli ordini del pirata Calico Jack. Ma gli uomini del brigantino a bordo del quale era arrivato a Siviglia, una sera, si erano ubriacati in una taverna del porto e avevano riferito la storia raccontata da lui stesso durante la traversata: nato nell’isola di Malta, gli ottomani lo avevano rapito cambiandogli il nome da 19 León in al-Asad, suo equivalente in arabo. Era stato proprio questo a mettere in guardia i più pessimisti. Le allusioni a navi pirata, soldati turchi e mari in tempesta avevano riportato alla memoria gli episodi dell’anno 844, quando i vichinghi avevano risalito il Guadalquivir con i loro lunghi capelli dorati e l’indomito carattere nordico per saccheggiare e distruggere la città in meno di una settimana, approfittando della buonafede dei sivigliani. «Questo giovane non è delle nostre parti», borbottavano i più anziani. «Sarà meglio controllarlo.» Doña Julia ricordava alla perfezione la prima volta che l’aveva visto. Quel giorno Cristóbal Zapata, responsabile della stamperia, era dovuto uscire per risolvere alcune faccende e in quel momento spettava a lei sostituirlo. Non avrebbe mai più dimenticato l’immagine di quel da corsaro che varcava la porta del suo laboratorio: non si era mai sentita così intimidita dall’avvenenza di qualcuno. «Sto cercando don Diego de Haro», si era presentato entrando nella stamperia. «Mi chiamo León. León de Montenegro.» Dopo averlo squadrato dalla testa ai piedi, gli aveva spiegato: «Arrivate troppo tardi. Mio marito è morto cinque anni fa. Posso esservi di qualche aiuto?». Lo sconosciuto era parso stupito, ma ben presto aveva tratto un respiro profondo e ripreso a parlare. «Sto cercando lavoro.» «Questa è una stamperia», aveva precisato lei cam20 biando atteggiamento. «Vi intendete dell’arte della stampa?» «Posso imparare.» Proprio in quel periodo, il compositore che lavorava da una vita per il signor de Haro cominciava a perdere la vista per l’età. Confondeva le l con le f e queste con le j, mentre le mani gli tremavano ogni giorno di più. Quando lavorava al cavalletto su cui si poggiavano le casse dei caratteri per formare le righe di testo da stampare, era costretto a mettersi seduto perché gli tremavano le ginocchia. Doña Julia lo osservava da un bel po’, e si era convinta che fosse giunto il momento di sostituirlo. Ma il mestiere di compositore richiedeva un’esperienza che derivava da un lungo periodo di apprendistato. I compositori erano l’anima delle tipografie, perché applicavano lo stile della casa, dovevano essere esperti degli aspetti tecnici, conoscere a menadito l’ortografia… I compositori erano copisti. Le loro responsabilità e funzioni somigliavano a quelle degli amanuensi durante il medioevo: prima dovevano leggere un frammento del testo originale, poi impararlo a memoria e quindi riscriverlo. L’unica differenza era che nell’antichità si riproducevano i brani con la penna d’oca, mentre attualmente si utilizzavano i caratteri di metallo. «Sapete leggere e scrivere?» si informò doña Julia, guardando León con aria di superiorità. «In quattro lingue», rispose lui senza arroganza. 21 «A me serve che lo facciate in castigliano e senza errori d’ortografia.» Doña Julia aveva preso il ragazzo come apprendista compositore senza pretendere alcuna referenza e gli aveva permesso di sistemarsi nello scantinato con la scusa che serviva un uomo in casa ventiquattr’ore al giorno. Quando Cristóbal Zapata era tornato e aveva appreso della decisione presa da doña Julia, era andato su tutte le furie. Come maestro di stamperia sin dai tempi del signor de Haro, spettava a lui decidere chi assumere, nonché proteggere l’attività e la signora come un fedele cane da guardia. Si era messo a farle la morale, sostenendo che non giovava alla reputazione di una donna, e meno che mai di una vedova rispettabile, mettersi sotto il tetto un ragazzo di origini incerte con un corpo da Adone. «Io sono la proprietaria di questa stamperia», gli aveva rinfacciato lei con gli occhi accesi di una passione che mastro Cristóbal non le conosceva. «E qui dentro agisco come mi pare e piace!» Non erano mai più tornati a parlare di León, e ben presto doña Julia aveva dimenticato l’insinuazione del suo dipendente circa le possibili malignità dei vicini per la presenza di quel nuovo aiutante che accendeva una scintilla di luce nelle sue giornate grigie. La sera, dopo cena, mamma Lula e doña Julia si sedevano a chiacchierare nel patio sul retro, in attesa che arrivasse il sonno. Ogni tanto chiedevano a León di far loro compagnia. Allora lui si metteva comodo e 22 iniziava a raccontare dei porti asiatici che sapevano di curry e di pesce salato. Parlava di una tribù africana dove gli uomini erano più alti della luna, di un’altra in cui non si alzavano di due palmi da terra, e ancora di quella che conosceva la formula magica per ridurre le teste dei nemici alla forma di una castagna secca. Una volta aveva raccontato a mezza bocca di quando i turchi lo avevano rapito ad appena quindici anni con l’intenzione di trasformarlo in un soldato del sultano, della sua apparente rassegnazione a quel destino e delle straordinarie somiglianze tra i giannizzeri e gli ordini cristiani dei monaci guerrieri. «La traduzione del mio nome in arabo è Asad.» «Asad? L’ho pronunciato bene?» aveva chiesto doña Julia. «Perfetto. In realtà mi sono chiamato così per tanti e tanti anni… finché non sono riuscito a scappare.» «È un bel nome», aveva mormorato lei guardandolo fisso negli occhi. Mamma Lula ascoltava le storie epiche di León con il cuore in lacrime e senza metterle in dubbio, per quanto assurde potessero sembrare. Quel ragazzo le ispirava simpatia. Riconosceva all’istante i reietti della società, dal momento che anche lei faceva parte di quella ristretta minoranza. Sapeva che la maggior parte dell’umanità era composta da individui volgari, per lo più intimiditi dalla presenza di quelle poche creature straordinarie che abitavano il pianeta. Invece doña Julia era convinta che le storie di León 23 fossero semplicemente frutto della sua fantasia, ma la cosa non le interessava affatto. Tutto quell’universo d’oltremare che sgorgava dalla bocca dello straniero, indispensabile per godersi la sua compagnia e riempire le lunghe serate sempre uguali, la divertiva comunque. Giudicava il proprio mondo così vuoto che l’immaginazione era diventata la sua unica via di fuga. Per doña Julia i regni di favola erano stati sempre più reali della casa dei vicini. Una menzogna appassionante riusciva a commuoverla molto più di una verità tiepida. Poco prima che la cattedrale cominciasse a oscillare quasi fosse sul punto di sgretolarsi, mamma Lula percepì il movimento tellurico nelle proprie viscere. Un insieme armonioso di voci e organo stava per intonare il Kyrie chiedendo pietà al Signore, quando la domestica nera afferrò doña Julia per il polso e la trascinò sotto l’altare. Quindi le si pose accanto e la protesse con il suo corpo baciandole la nuca e farfugliando una litania incomprensibile sotto gli occhi attoniti di tutti i fedeli. Nessuno ebbe il tempo di stupirsi, perché un brontolio proveniente da ponente si impossessò della chiesa e le vibrazioni strapparono alle pareti un rumore assordante, simile a uno stridore di denti. Il disastro iniziò alle dieci in punto. Le campane della Giralda suonavano da sole, come impazzite. Le panche dell’edificio si agitavano noncuranti del peso dei fedeli seduti, mentre la gente in piedi cadeva sen24 tendosi mancare la terra sotto i piedi. Il pulpito minacciava di staccarsi dalla sua colonna e un paio di chierichetti si precipitarono barcollando da padre Zacarías per aiutarlo a scendere le scale. «Apocalisse, Apocalisse, Apocalisse», strepitava lui sbracciandosi alla ricerca del crocifisso, che, normalmente collocato sull’altare maggiore, ormai giaceva a terra, e agitandosi sulla pedana a pochi centimetri dalle teste di mamma Lula e doña Julia. Qualcuno raccolse la croce e la porse al parroco cieco. Egli vi si afferrò e per un attimo parve ritrovare la calma. Il parapetto in pietra che adornava l’esterno si sgretolò contro le volte della crociera e una pioggia di calcinacci rovinò sul pavimento della chiesa. L’ambiente prese a riempirsi di polvere, avvolgendo gli astanti in una densa nuvola terrosa che impediva di vedere a un palmo dal naso. In seguito si venne a sapere che a precipitare erano state le pietre della cupola, che da quel momento in poi rimase ferita a morte. Chi si trovava all’interno cercava di uscire, temendo che padre Zacarías avesse ragione e si trattasse davvero del preludio dell’Apocalisse: nessuno voleva morire schiacciato sotto uno spesso strato di pietre. Al contrario, chi era fuori non pensava ad altro se non a entrare a tutti i costi, nella certezza che il Signore avrebbe sicuramente protetto la cattedrale con la sua mano onnipotente. Le porte furono assalite da una folla immensa di gente terrorizzata. Chi gridava, chi sospirava, chi si abbracciava, chi pregava… 25 La terra impiegò cinque minuti ad assestarsi, e quando ebbe finito emise una specie di gemito languido che diede luogo a un silenzio stridente. Una tranquillità polverosa che piano piano si diluì in un rivolo di piccoli gemiti, di invocazioni a Dio, tra vagiti di bambini, urla di adulti, piagnistei di bigotte che aumentarono di volume fino a raggiungere un frastuono assordante intriso di angoscia. Un clamore di voci disperate chiedeva all’unisono misericordia, pietà e confessione. Una ballata triste e dolente che stringeva il cuore. Doña Julia e mamma Lula se ne stettero rintanate nel loro nascondiglio, per paura che il cataclisma non fosse ancora terminato. Lasciarono che il polverone si diradasse, come la loro agitazione, e poi uscirono strisciando tra i calcinacci. Uno di essi colpì doña Julia nel fianco. Quando fece per toglierselo di dosso, si accorse che si trattava di una pietra circolare a forma di moneta gigante con un diametro poco più grande di un palmo, decorata con un bassorilievo che sul momento non riuscì a distinguere con chiarezza. Se la portò al petto e la tenne stretta neanche si trattasse di un’ancora di salvezza. Tornò a sentire mamma Lula tirarla con forza; avanzarono entrambe come sonnambule, più per intuito che consapevolmente, cercando una scappatoia nella penombra della chiesa. La luce fioca si rifletteva dall’alto filtrando attraverso i rosoni delle vetrate, raggi timidi in cui galleggiavano minuscole particelle di polvere. Percepirono un debole 26 chiarore di fronte agli occhi, in fondo al lugubre tunnel in cui erano immerse. Si diressero in quella direzione barcollando, fecendosi strada a spintoni per guadagnare l’uscita, insinuandosi tra i corpi degli altri fedeli che si erano trasformati in irriconoscibili fantasmi impolverati, intontiti dalla sorpresa e dalla paura. Nessuna delle due aveva proferito verbo dall’inizio del cataclisma. Una volta all’aria aperta, si guardarono l’un l’altra alla luce del giorno come se si vedessero per la prima volta. Si tastarono il viso, le spalle, la pancia, per verificare di essere tutte intere. Allora mamma Lula tirò fuori dalla tasca della sopragonna un fazzoletto di lino, lo avvolse intorno all’indice e al medio, lo bagnò di saliva e sfregò le macchie di sporco sulle guance di doña Julia, proprio come faceva tanti anni prima, quando era una bimba affidata alle sue cure. Ma ormai la sua signora era troppo adulta per queste cose: si allontanò con passo incerto, mettendosi in disparte. Guardò verso l’alto. Oltre il velo grigio del cielo poteva intuire il disco solare che lottava per affermare il suo bagliore. La presenza del sole le aveva sempre suscitato un’indescrivibile sensazione di rinascita. Tirò un profondo sospiro, ancora abbracciata alla pietra che aveva tratto in salvo fra le macerie della chiesa. Chiuse gli occhi e una smorfia simile a un sorriso le si dipinse sul viso insudiciato. Era viva. Viva. «Sono viva!» esclamò emozionata. «Andiamo via!» le urlò mamma Lula scrollandole 27 le spalle per riportarla alla realtà. «La torre sta per crollare!» Erano uscite dalla porta dei Bastoni e un gruppo di persone indicava una fessura che si apriva nel corpo della Giralda. Sembrava quasi che un’ascia di dimensioni enormi avesse colpito il muro aprendo una ferita dal corpo delle campane giù fino ai primi balconi. Nel frattempo, la voce priva di dolcezza di padre Zacarías risuonava stentorea. L’uomo camminava brandendo il crocifisso sopra la testa, seguito da un traballante corteo di fedeli, quasi stregati dall’eccezionale forza di quel corpo ormai sessantenne. La cecità l’aveva reso immune al panico. Marciava senza esitazione verso la piazza, ordinando a tutti di seguirlo perché non aveva alcuna intenzione di lasciare in sospeso la messa che il terrore aveva osato interrompere. «Sta per rompersi in due!» gridò qualcuno indicando la Giralda. «Torniamo a casa prima che ci cada in testa una campana», suggerì con dolcezza mamma Lula a doña Julia. «Ti sei sbagliata, visto? Il mondo non è finito. Siamo vive, te ne rendi conto? Vive!» esclamò lei sorridente. «Certo, certo. Su... torniamo a casa.» «Sono viva, sono viva, sono viva», ripeteva doña Julia con gli occhi persi nel vuoto e lo sguardo inebetito, lasciandosi guidare dalla domestica. 28 La mattina seguente León si alzò presto. Brillava ancora qualche stella in cielo quando uscì dalla stamperia stando attento a non fare rumore. A quell’ora in giro non si vedeva un’anima e il gioco di luci e ombre rendeva più cruda la devastazione che il terremoto si era lasciato alle spalle. Guardò sui due lati della strada, si diresse verso destra, in direzione di plaza de San Francisco, e giunse all’altezza del carcere reale, ridotto a un cumulo di macerie. I detenuti avevano approfittato del crollo dei muri per fuggire lontano da quel recinto immondo che li aveva tenuti pigiati l’uno contro l’altro per anni. León proseguì per calle Sierpes lasciando che l’aria frizzante del mattino gli rinfrescasse le idee. Accarezzava la croce ottagonale d’oro che portava al collo e che il Gran maestro gli aveva consegnato prima di inviarlo a Siviglia. La sua vita sembrava guidata da un Dio folle che ogni poco si contraddiceva prendendo decisioni diverse circa il suo destino. Aveva buona memoria, perciò ricordava alla perfezione la sua infanzia sull’isola di Malta, sotto la protezione degli Ospedalieri dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Erano stati loro a raccontargli le sue origini misteriose: lo avevano trovato abbandonato il giorno di San Leone Magno sulla porta della fortezza quando era ancora un neonato, dentro una cesta di vimini, avvolto in una cotta su cui era ricamata quella stessa croce a otto punte: il 29 simbolo dell’ordine ospedaliero dall’anno 1048, quando dei mercanti di Amalfi avevano ottenuto dal califfo d’Egitto il permesso di costruire a Gerusalemme un ospedale in cui assistere i pellegrini di qualsiasi fede o razza in visita alla Terra Santa. La croce aveva quattro bracci delle stesse dimensioni, con otto angoli e otto punte. Solo i cavalieri dell’ordine portavano quella croce sugli abiti. Se uno dei frati aveva commesso peccato con qualche ragazza dell’isola e quella creatura era figlio suo, di sicuro nessuno lo confessò mai. Gli Ospedalieri lo avevano nutrito con molliche di pane inzuppate nel latte cullandolo con i canti gregoriani del mattutino. Gli avevano insegnato a giocare a scacchi; a leggere e scrivere in latino, perché potesse comprendere la Bibbia; in italiano, perché potesse trattare con gli isolani; in castigliano, perché secoli prima l’imperatore Carlo V aveva ceduto in feudo all’ordine l’arcipelago di Malta senza rinunciare alla sua sovranità. Era cresciuto immerso in una pace infinita, convinto che avrebbe trascorso lì il resto della sua vita esaltando la gloria del Signore e difendendo la cristianità con il nome di fra León. Ma a soli quindici anni il suo destino aveva mutato direzione. I temuti giannizzeri, la fanteria dell’impero ottomano, avevano organizzato la loro abituale caccia ai giovani cristiani, detti devshirmeh. La tattica consisteva nel navigare nei pressi della costa mediterranea scrutandola con attenzione per se30 lezionare ragazzi agguerriti e forti, adatti alla lotta. Avevano catturato León sulla spiaggia, quasi al tramonto. Non avrebbe dovuto essere lì: se l’era svignata per andare a cercare telline. Gli piaceva vedere la scia di bollicine che lasciavano sulla sabbia quando l’onda si ritraeva, scavare fino a trovare la preda, consegnarne una borsa piena al cuoco perché le condisse con vino bianco, aglio e prezzemolo, e mangiarle all’ora di cena. Troppo impegnato per vedere arrivare i giannizzeri, quando se n’era accorto si trovava già legato mani e piedi nella buia stiva di una nave e sentiva parlare una lingua sconosciuta. Da quell’istante la sua vita era cambiata. I giannizzeri lo avevano portato in una scuola dove lo avevano addestrato a maneggiare le armi, gli avevano fatto studiare le tattiche militari, gli scacchi, la letteratura, la matematica. Lo avevano incoraggiato a convertirsi all’Islam, senza costrizioni ma con la garanzia che tutto sarebbe diventato più facile. Sin dall’inizio sembrava assimilare bene una religione estranea che glorificava un unico Dio al di sopra di ogni cosa, in cui si doveva rispettare il prossimo e condannare i crimini, mentre le buone azioni sarebbero state ricompensate. Quella fede non gli sembrava poi così diversa dalla sua. Si era lasciato crescere solo i baffi perché la barba era proibita, aveva giurato che il corpo dei giannizzeri era la sua casa e il sultano il suo vero padre su questa terra. 31 Era divenuto così forte, così severo, sembrava davvero tanto convinto che dopo il primo periodo di addestramento era stato nominato giannizzero a tutti gli effetti, a soli diciannove anni. Tempo dopo, quando finalmente i suoi superiori, fidandosi di lui, avevano abbassato la guardia, era riuscito a mettere in pratica il piano di fuga programmato da anni. Atteso il calare della notte, aveva rubato una goletta dal porto. L’aveva scelta perché era un’imbarcazione abbastanza solida da sopportare le onde di mille tempeste e abbastanza leggera da richiedere la presenza di una sola persona al comando. Aveva navigato per giorni e giorni mangiando i pesci crudi che riusciva a pescare, dormendo quando riusciva, temendo da un momento all’altro di veder comparire all’orizzonte una nave ottomana con un equipaggio pronto a tagliargli il collo per il tradimento del sultano. Quando ormai aveva dato fondo alle riserve di acqua dolce, una fregata lo aveva visto navigare alla deriva. Lo avevano trovato svenuto, seminudo, sul ponte della goletta: bruciato dal sole del Mediterraneo, con le labbra consumate dalle febbri e in preda al delirio, pregava senza sosta in latino di essere restituito ai suoi fratelli dell’isola di Malta. Adesso che era ormai in salvo, passeggiando per le strade di Siviglia, pensava che il suo destino sembrava ondeggiare come le correnti marine. 32
Scarica




![Felaco_elaborato7[1]..](http://s2.diazilla.com/store/data/000084584_1-c0d32aa64ea920109a8a507124e0b22f-260x520.png)