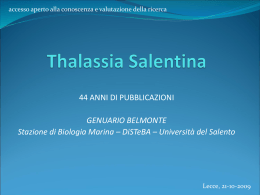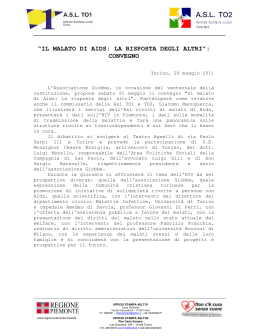2015 4 2015 4 SCRIPTA EDIZIONI Ricche Minere Rivista semestrale di storia dell’arte Anno ii, numero 4 Dicembre 2015 Direzione e redazione Cannaregio 5243 30121 Venezia [email protected] | www.riccheminere.org Direttore Giuseppe Pavanello Comitato scientifico Francesco A bbate · B ernard A ikema · I rina A rtemieva · V ictoria A very · R osa B arovier · Jean C lair Roberto Contini · Keith Christiansen · Alberto Craievich · Giovanni Curatola · Miguel Falomir Faus Massimo F erretti · A lvar G onzález -Palacios · A ndreas H enning · L arissa H askell · H ugh H onour Claudia Kryza -Gersch · J ustyna Guze · S imonetta La Barbera · D onata Levi · S téphane Loire E nrico Lucchese · Lauro Magnani · Anne Markham Schulz · Giuseppe Pavanello · Nicholas Penny Louise R ice · S erena R omano · P ierre R osenberg · S ebastian S chütze · P hilip S ohm · N ico S tringa Michele Tomasi · Alessandro Tomei · · · · · · Ogni articolo presentato alla Redazione sarà sottoposto a doppia revisione anonima ‘cieca’ e al vaglio del Comitato Scientifico. I volumi da recensire vanno spediti a: Submitted manuscripts undergo Double Blind Peer Review. Books for review must be sent to: Ricche Minere, Cannaregio 5243 - 30121 Venezia [email protected] Impaginazione Scripta edizioni, fotolito Luca Toffalori Amministrazione e pubblicità Scripta edizioni via Albere 18, 37138 Verona [email protected] Ogni numero: Italia, euro 29,00. Estero, euro 29,00 + euro 10,00 contributo spedizione Abbonamento annuale (due numeri): Italia, euro 50,00 Estero, euro 50,00 + euro 20,00 contributo spedizione Autorizzazione del Tribunale di Verona Registro stampa n. 2007 del 16 dicembre 2013 Versamento a mezzo bonifico bancario: Cassa Rurale Alta Vallagarina – Agenzia Besenello IBAN: IT67E0830534350000000056963 Nella causale specificare “rivista Ricche Minere” e inserire indirizzo di spedizione, completo di codice di avviamento postale, nome, cognome e codice fiscale per la fatturazione Direttore responsabile: Enzo Righetti © 2015 Scripta edizioni ISSN 2284-1717 ISBN 978 88 98877 48 5 Sommario Contributi Giorgio Fossaluzza Per Giovanni Bonconsiglio ritrattista...........5 Paola Betti Spigolature su Coli e Gherardi, “amici e compagni svisceratissimi”........19 Francesca Stopper La bottega al San Lorenzo Giustinian, “Orefici di primo credito, e fama” tra Venezia, Roma e Gerusalemme................................41 Giuseppe Pavanello Gli stucchi veneziani del Settecento: le fonti e le opere (III).................................61 Scritti per Antonello Cesareo (parte prima) Adriano Amendola Una proposta per Nicolas de Largillière...... 107 Maria Barbara Guerrieri Borsoi Novità su Lorenzo Masucci..........................113 Maria Celeste Cola Gioacchino Varlè, Andrea Vici, Vincenzo Pacetti e “l’affare delle gloriette” di Loreto..........................120 Alessandro Spila “Come si possa in nuove forme fare un lodevole uso de’ ritrovati de’ nostri maggiori”. Cenni su Giobbe, Piranesi e le antichità dei principi Colonna.......126 Matteo Borchia Sulle due cornici di Paolo Spagna a Stoccarda.................................................. 132 Elisa Debenedetti Uggeri, Rossini e la scuola panniniana............................. 138 Ricordo di Antonello Cesareo...................... 93 Bibliografia di Antonello Cesareo............... 96 Attualità Laura Bartoni Foreign artists in 17th century Rome: dynamics of settlement and integration strategies........................ 98 Christian Sapin, Les cryptes en France. Pour une approche archéologique, IVe-XIIe siècle (Tancredi Bella) ............................................... 149 5 Giorgio Fossaluzza Per Giovanni Bonconsiglio ritrattista Il primo catalogo sistematico dell’opera di Giovanni Bonconsiglio detto il Marescalco assomma circa quaranta numeri, ma comprende non più di due ritratti sicuri1. È firmato solo quello ritenuto l’Autoritratto (fig. 1) della Pinacoteca Capitolina in Roma2. Databile alla metà degli anni Novanta del Quattrocento mostra il pittore, all’apparenza non ancora trentenne, determinato in una restituzione di sé veritiera e concisa. Quanto a psicologia rivela autoconsapevolezza e certo volitività: l’indole, come ben esprime lo sguardo, non è di un compiacente ma neppure di uno spavaldo. Nello stile si è còlto l’adeguamento alla linea antonelliana conforme alla declinazione più matura di Alvise Vivarini, quando alla bottega partecipa il giovane Basaiti, o si è stabilito il confronto a date ìmpari con i primi esempi di Lotto per quanto essi siano d’introspezione più complessa e mirino a un sentire più elevato3. Tali corrispettivi dimostrano, in particolare, come sia assente in Marescalco la ricerca di un’astrazione formale e, in luogo delle trasparenze che contribuiscono a generarla, egli prediliga gli effetti dell’incidenza della luce in superficie, su una materia cromatica corposa e, quindi, meno soggetta a essere sensibilizzata. In questo emerge come sostanziale il magistero e il confronto prossimo con Bartolomeo Montagna all’insegna dell’esperienza lombarda, la quale si è supposto persino con- divisa4. Forte di tali requisiti di stile fondati sull’osservazione mediata di Zenale, Bramante e Bramantino, concentrati a un’altezza qualitativa ineguagliata nella Pietà ora al Museo Civico di Vicenza, il Marescalco si presentava poco dopo sulla scena lagunare. La migliore ribalta per dar prova da ‘foresto’ della sua specifica ricerca e, a un tempo, per aprirsi a una pronta ricettività. Lo dimostra, notoriamente, la pala dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca del 1497, ora documentata dai due frammenti delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e della Collezione della Banca Popolare di Vicenza ai quali si appoggia stilisticamente l’Autoritratto5. Da allora il Marescalco si adegua, in realtà, alla linea belliniana anche nel suo meccanismo divulgativo dei soggetti devozionali e persino in termini che possono risultare regressivi quanto a invenzione. È quanto rivela in apertura del nuovo secolo, ad un tempo, la poco nota Sacra famiglia e i santi Zaccaria e Giovannino (fig. 2), un’opera firmata del Museo Regionale di Messina, aggiornata ai modi di Boccaccino e da porre a confronto con la più tarda versione su fondo unito già Humphrey Ward a Londra6. All’Autoritratto della Pinacoteca Capitolina si è aggiunto da ultimo il singolarissimo Ritratto di giovane donna al leggìo (fig. 3), già in collezione Bodmer, una brillante attribuzione che corregge quella precedente a Giovanni Francesco Caroto7. L’anomalia tipolo- 1. Giovanni Bonconsiglio, Autoritratto. Roma, Pinacoteca Capitolina 19 Paola Betti Spigolature su Coli e Gherardi, “amici e compagni svisceratissimi”* In seguito all’eccellente intervento di Denis Ton – che pochi anni or sono ha finalmente fornito una ricostruzione esaustiva del catalogo e della personalità stilistica dei lucchesi Giovanni Coli e Filippo Gherardi – si presentano qui, a ulteriore integrazione, alcune novità su opere e documenti relativi alla coppia di affiatati artisti1. Dopo una prima formazione in patria nell’ambito dell’Accademia aperta da Pietro Paolini intorno alla metà del Seicento, seguendo l’esempio di numerosi concittadini loro predecessori – Guidotti, Paolini, Pietro Testa, Paolo Biancucci – questi si trasferiscono a Roma, all’epoca punto di riferimento imprescindibile per l’acquisizione di qualsiasi aggiornamento culturale, per studiare con Pietro da Cortona, capofila del barocco romano. Con lo scopo di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, in seguito i due, che sarebbero diventati amici e collaboratori inseparabili, si spostano a Venezia, dove eseguono un ciclo di tele di contenuto allegorico per la biblioteca benedettina di San Giorgio Maggiore. Qui osservano con particolare attenzione i grandi pittori del Cinquecento, Tiziano, Tintoretto e soprattutto Veronese, di cui si procurano anche alcuni originali, indice, questo, oltre che della loro ammirazione, del desiderio di assimilarne la tecnica e i valori formali. Il mondo artistico lagunare, ricco di stimoli e spunti di riflessione, avrebbe determinato profonde modifiche sul loro modus operandi soprattutto quanto all’uso del colore e della luce. Rientrati a Roma, proseguono la propria carriera ottenendo prestigiose commissioni – spesso grazie all’intercessione di influenti prelati loro concittadini, il cardinale Francesco Buonvisi e Giovan Battista Spada – come l’affresco della cupola di San Nicola da Tolentino con la gloria del santo titolare, della galleria del palazzo Colonna – dove la scena principale nella volta, dall’intenso coinvolgimento emotivo, è realizzata con una cromia sfarzosa di chiara memoria veneziana – e la serie di tele per il soffitto di Santa Croce dei Lucchesi, la chiesa della folta comunità lucchese di stanza nell’Urbe, riscuotendo unanimi consensi. Approvazione che addirittura avrebbe indotto l’esigente regina Cristina di Svezia a tentare, peraltro invano, di accaparrarsi l’esclusiva del loro operato dopo essere rimasta colpita dall’armonioso intervenire “insieme in una medesima figura e in una medesima testa”, come, per primo, riferisce il marchese Giacomo Sardini nella biografia dei due pittori2. Tra il 1668 e il 1672 Coli e Gherardi conducono il primo lavoro di destinazione pubblica per la città natale, i tre quadri richiesti per ornare il presbiterio di San Tommaso in Pelleria, ristrutturato pochi anni prima e decorato di stucchi su progetto dell’architetto di educazione borrominiana Giovanni Maria Padredio, attivo nello stesso torno 1. Giovanni Coli e Filippo Gherardi, Trinità in gloria, particolare. Lucca, cattedrale di San Martino, catino absidale 41 Francesca Stopper La bottega al San Lorenzo Giustinian, “Orefici di primo credito, e fama” tra Venezia, Roma e Gerusalemme Una coppia di Torciere in argento, eseguite a Venezia, fiancheggia l’altare maggiore della chiesa del Santissimo Salvatore a Gerusalemme (figg. 1-7). Assegnate alla bottega al San Lorenzo Giustinian, sulla base delle fonti1, occupano un posto di indiscusso rilievo nel panorama dell’oreficeria veneziana del XVIII secolo. Tra i pochi manufatti d’ambito veneto di quest’epoca a esser stati presentati in un contesto internazionale – nel 2013 facevano mostra di sé all’esposizione Trésor du SaintSèpulcre. Présents de cours royales européennes à Jérusalem, allestita presso il Château de Versailles e la Maison de Chateaubriand a Châtenay-Malabry – le Torciere sono state oggetto d’indagine da parte di valenti studiosi2. Eppure il loro luogo di conservazione, prestigioso quanto remoto, ha indirettamente relegato nell’ombra l’attività di questa officina orafa, fra le prime alla metà del secolo, insieme alle botteghe al Trofeo, al Trionfo di Santa Chiesa, al Premio e all’Honnestà. Appare perciò di qualche interesse presentare alcune testimonianze sull’insegna al San Lorenzo Giustinian per fare luce sulla sua produzione, la committenza cui era soggetta, e le sue alterne fortune. Prenderemo le mosse dalle opere gerosolimitane che, tra gli esiti più felici della stagione rococò, attestano le qualità artistiche ed esecutive, cui pervenne la ditta orafa. Le Torciere mostrano caratteristiche tipo- logiche affini alla forma di candelabro più diffusa all’epoca, trasposta in dimensioni monumentali. Innalzate su piedi incentrati sull’elemento della conchiglia – emblema rocaille –, si caratterizzano per una base sagomata a facce leggermente incavate, che si orna di campiture a graticcio su cui spiccano cartigli asimmetrici, delimitati da tralci di palma, volute, inserti vegetali e conchiglie, e inghirlandati da una corona inclinata, che racchiudono rispettivamente lo stemma francescano, la Croce di Gerusalemme e l’iscrizione “anno do. mdcclxii” (fig. 4). Sugli spigoli del basamento siedono gli Evangelisti, accompagnati dai loro consueti attributi, eccetto San Marco, protettore di Venezia, cui è riservata una posizione di rilievo sulla cornice che separa il piede dal fusto (figg. 1, 5-6). E, ancora, riccioli a fusione, ispirati al vocabolario delle conchiglie e delle spume marine – repertorio che impronta di sé l’intera superficie dei manufatti –, profilano il margine superiore della base (fig. 7). Il partito decorativo delle Torciere si arricchisce nel nodo a vaso, su cui poggiano le personificazioni delle Virtù teologali, di targhe sagomate che racchiudono episodi della Passione di Cristo, separati, sui lati minori, da coppie di cherubini. Microsculture angeliche con gli strumenti della Passione sono disposte sui lati minori del rigonfiamento del balaustro che include altri bassorilievi della Via Crucis. Quest’ultimo elemento, rastremandosi, si 1. Bottega al San Lorenzo Giustinian, Coppia di torciere, particolare. Gerusalemme, chiesa del Santissimo Salvatore 61 Giuseppe Pavanello Gli stucchi veneziani del Settecento: le fonti e le opere (III) “Im Pallast Duodi”: si è riportato, nel primo contributo sugli stucchi veneziani del Settecento, il testo di Johann Caspar Füssli relativo agli interventi di Carpoforo Mazzetti Tencalla (e di Abbondio Stazio) nei palazzi veneziani1. Il pensiero non può andare inizialmente che al Duodo, l’edificio celebre in parrocchia di Santa Maria Zobenigo affrescato da Francesco Fontebasso, nel quale, peraltro, come s’è rilevato, non esistono decorazioni in stucco, anche se l’indagine in quell’enorme fabbricato non è ancora del tutto completa e assai difficilmente lo potrà essere in modo capillare. Si può proporre comunque un’altra interpretazione di quel passo, orientata su un diverso edificio identificabile con quel “Duodi”: il Contarini-Michiel a San Barnaba, com’è comunemente chiamato, nel quale sono presenti estesi interventi decorativi in stucco. Del ramo Duodo di San Barnaba era infatti nel Settecento quel palazzo, a partire dal 1698, quando Camilla Michiel si sposava con Francesco Duodo di Alessandro, mentre la proprietà totale dell’immobile risale al 1733, grazie all’acquisto della parte prospiciente il rio2. L’edificio è noto agli studi sullo stucco veneziano settecentesco fin da anni lontani, ed è anzi stato talvolta ritenuto come uno dei più significativi complessi realizzati nel secolo XVIII – generalmente riferito ad Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencal- la, oppure al nipote di quest’ultimo, Carpoforo junior –, anche per esemplarità e commistioni di tematiche, presentando, fra l’altro, elementi che corrispondono a una certa immagine di una società che fantasticava di alcove, di boudoir, di ‘ridotti’ e così via3. C’è un problema in merito. Nel mezzanino ci si imbatte nella cosiddetta stanza d’alcova, uno degli ambienti più noti di tal genere, con caratteri così ‘veneziani’, alla Molmenti e Damerini maniera, tanto da indurre a qualche perplessità. Anzitutto, la struttura4. Cosa ci fanno quelle aperture laterali curvilinee, a lato dell’arcata centrale, sul luogo dei tradizionali ‘retret’, in cui sono posti elementi d’arredo ligneo in bianco e oro con vasi alla sommità di curiosa conformazione? Un insieme indubbiamente eclettico. Inoltre: perché nell’atrio a pianoterra ci accoglie, a lato dell’accesso alle scale, un putto in atto di sollevare un tendaggio, posto su un frammento di timpano arcuato con nappe? Come un biglietto da visita di quanto ci attende salita la scala: è un Settecento immaginario che ci si squaderna, da “tempo felice”, come si è più volte rilevato (figg. 2-5), nella volontà di essere, per così dire, più casanoviani di Casanova, in linea con le istantanee neo-settecentesche di un Favretto o di un Bressanin5. Del resto, tutta l’Europa sedotta dagli scritti dei Goncourt sognava un nuovo ‘Settecento’, a colorazioni diverse, dal rosa al nero. 1. Decorazione di soffitto con il Ratto di Europa. Venezia, palazzo Duodo-ContariniMichiel Scritti per Antonello Cesareo (parte prima) 93 Ricordo di Antonello Cesareo (L’Aquila 1971 - Trento 2013): “A gentleman of probity, knowledge and real taste” Mi si presentò, un pomeriggio di tanti anni fa all’Istituto di Storia dell’arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, un giovane studioso formatosi all’Università La Sapienza di Roma per parlare di neoclassicismo e di progetti editoriali. Si era laureato sotto la guida di Elisa Debenedetti su Gavin Hamilton, tema attraente quanto difficile, con tutto quanto comporta di quello che oggi si definisce sistema delle arti, dall’archeologia alla pittura, dalla committenza, al collezionismo, al mercato. Non si può dire che ad Antonello Cesareo mancasse il coraggio, al pari dell’entusiasmo, che aveva al massimo grado, come la voglia di emergere. Da quel colloquio scaturì l’idea di pubblicare ampia parte del suo lavoro su Hamilton nella rivista della Cini «Saggi e memorie di storia dell’arte». Avevo preso la decisione di tornare alla grafica delle prime annate, con sopraccoperta fregiata di un’illustrazione. Quando glielo dissi, prese subito l’iniziativa di chiedere lui stesso un fotocolor, pur costoso, di un quadro di Hamilton da apporre sulla rivista come un sigillo dei suoi studi sull’artista scozzese. E così avvenne: era il n. 26, uscito nel dicembre 2003. Il saggio supera le cento pagine e in copertina comparve il Giove e Giunone di Holkham Hall. Diventerà prassi negli scritti di Cesareo includere nel titolo una frase d’epoca, spesso in inglese – qui : “A gentleman of probity, knowledge and real taste” e lo era lui stesso –, lingua che conosceva molto bene e che gli permetteva di essere qualificato punto di riferimento per gruppi di viaggiatori inglesi e americani in visita a Roma. Era aquilano e aveva, verso la sua città, un attaccamento fortissimo, e non occorre insistere sulle sue angosce dopo il terremoto in Abruzzo del 2009. Alla sua terra ha dedicato più di un intervento, a partire dall’articolo apparso nel «Bollettino d’arte» (2003) sulle Storie di Mosè nel casino Branconio. Coerente, vinto il dottorato di ricerca alla Sapienza, la scelta di occuparsi della collezione di Lord Arundel; così come, partendo da Gavin Hamilton, era automatico concentrarsi pure su Canova: studi che costellano a intermittenze la sua attività scientifica, dall’articolo apparso su «Neoclassico» (2002) sino al volume, uscito nel 2012 su Antonio Canova e l’Accademia di San Luca; per non parlare della sua assidua presenza ai convegni di Possagno. Consequenziale, riconoscendo la qualità dei suoi contributi, la decisione della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di attribuirgli nel 2013 le funzioni di Professore associato nell’Università. Artisti romani e artisti d’oltralpe: è fitto il dialogo che viene a intrecciarsi, in contributi apparsi in riviste – «The Burlington Magazine» compreso –, quindi in atti di convegni e in cataloghi di mostre. Gli stranieri: Hamilton, Arundel, ma anche Tho- 98 Laura Bartoni Foreign artists in 17th century Rome: dynamics of settlement and integration strategies 1. Rome, Archivio Storico del Vicariato, Sant’Andrea delle Fratte, Status Animarum, frontispiece The greater part of studies on foreign artists residing in Rome in the 17th century used as privileged sources data from parish registers, preserved today in the Archivio Storico del Vicariato in Rome, and made available as early as the mid-20th century by the pioneering research of Johannes Godefridus Hoogewerff, Jacques Bousquet and Friedrich Noack for, respectively, the Flemish and Dutch, French, German communities1. A major source for the study of the population in general, preserved alongside the Registers of Baptisms, Marriages and Deaths of the various Roman Parishes, is the Status animarum (fig. 1), a ‘census’ of the resident population within each parish boundary carried out during Easter time, with religious purposes and social control2. Compared to the work carried out by the earlier scholars, recent projects have included the importance of completing a wider examination of the registers, which take into account the entire population, since it is only by analysing the whole context in which a single artist was living, that one can fully understand both his personal and his working life3. In fact, alongside details of age, provenance and occupation, the Status animarum contains precious information about types of dwelling, fellow tenants and on the neighbourhood which, together with the information provided by the Registers of Marriages and Baptisms, allow us to in- vestigate the network of social relationships and how they reflected on professional life. The present research takes into account that area of the city which, in the second half of the Seventeenth century, as is welldocumented, saw the greatest concentration of artists and craftsmen, with a substantial foreign presence: the area of the ‘Tridente’, between piazza del Popolo and piazza di Spagna, included in the parishes 107 Adriano Amendola Una proposta per Nicolas de Largillière La mostra su Nicolas de Largillière (Parigi 1656-1746) svoltasi al Musée Jacquemart-André nel 2003 ha riacceso l’attenzione degli studiosi su questo importante protagonista della ritrattistica francese a cavallo fra Sei e Settecento1, dopo i fondamentali studi di Myra Nan Rosenfeld, curatrice dell’insuperata monografica di Montréal del 1981 2, e di George de Lastic3. Largillière appare indagato sotto la lente d’ingrandimento e, in particolare, colpisce la sua mutevole capacità di dialogare con il ritrattato che si mostra spesso in posa ufficiale, quasi protocollare, con il tre quarti e lo sguardo fisso verso lo spettatore, nell’ambiente a lui caro, oppure all’aperto in atteggiamento più disinvolto e amichevole, mondano. In alcuni dipinti sembra anticipare soluzioni formali care ad Anton von Maron, un artista che appartenne a generazioni successive, nato a Vienna nel 1731, cui l’amico Antonello Cesareo ha dedicato molti studi incentrati sulla ricostruzione della carriera e la lettura della progressione stilistica nella ritrattistica settecentesca4. Il francese riuscì, come von Maron, a ottenere una produzione pittorica di grande interesse per la varietà delle sue tele, frutto della richiesta di una committenza sempre più esigente e della salda formazione artistica. Quest’ultima vide nel viaggio di formazione e nel soggiorno all’estero una tappa fondante; nel caso precipuo di Largillière si svolse a partire dal 1668 ad Anversa, presso lo studio di Antoine Goubeau e poi in Inghilterra dove l’artista rimase quattro anni, tra il 1675 e 1679, quale allievo dell’italiano Antonio Verrio, divenendo ben presto amico di Sir Peter Lely5, seguendo dunque rotte ben precise. A Largillière mancò la tappa italiana, consuetudine per l’epoca, ma l’artista non ne risentì potendo con tutta evidenza in Inghilterra come in patria disporre di molta pittura di maestri italiani sulla quale esercitarsi, basti pensare alle collezioni di Lely6, di Colbert, di Charles Le Brun e delle famiglie reali7. La fortuna di Largillière consistette, come ha ben delineato Pierre Rosenberg, nell’aver suscitato grande ammirazione per la propria opera, in un periodo nel quale il genere del ritratto appariva mutevole e messo in discussione dalla preponderante pittura di storia. Il nome di Largillière, secondo lo studioso, è sinonimo di tutta la produzione francese di quegli anni, grazie alla sua non comune longevità e all’agiatezza consolidata8; l’artista da solo produsse del resto nel corso della sua carriera circa 1.200 tele9. Scorrendo il catalogo delle sue opere, un dettaglio ha colto la mia attenzione, apparentemente sfuggito alla storiografia. In due composizioni, una natura morta e un ritratto, il francese inserisce significativamente una piccola effigie, eseguita su rame, dalla connaturata preziosità; oggetto molto diffuso tra i ranghi dell’aristocrazia. Per il 113 Maria Barbara Guerrieri Borsoi Novità su Lorenzo Masucci* Grazie ad alcuni studi recenti conosciamo oggi un po’ meglio l’attività di Lorenzo Masucci che seguì le orme del padre Agostino con minor talento e fortuna, ma con riconoscimenti ufficiali importanti – fu accademico di San Luca e Virtuoso al Pantheon –, che ne attestano l’apprezzamento nel panorama dei pittori romani di fine Settecento1. Si formò presso il padre, quando questi era all’apice del successo garantitogli dall’essere l’ultimo erede ‘ufficiale’ della pittura marattesca, che declinava in forme ormai presaghe dell’incipiente neoclassicismo. Nel sesto decennio del secolo, Lorenzo Masucci era già attivo per le chiese romane: nel 1756 eseguì per la chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte il Riposo durante la fuga in Egitto, opera forbita e ben condotta anche nella resa del paesaggio2. Probabilmente poco dopo ricevette l’incarico di dipingere un quadro per la chiesa del Santissimo Nome di Maria, verosimilmente grazie all’interessamento paterno. Per questo edificio ecclesiastico Agostino aveva infatti realizzato una celebre Educazione della Vergine a opera di sant’Anna, donata al pio sodalizio nel 1757, le cui vicende erano tuttavia iniziate assai prima. Nel 1749 Ignazio Collotti aveva commissionato all’artista un dipinto che avesse come figura principale sant’Anna, e gli aveva versato 150 scudi, morendo poco dopo. Agostino Masucci portò a termine l’incarico, offrendo alla chiesa il valore eccedente la cifra ricevuta, purché il quadro, in loco già nel 1750, risultasse inalienabile3. Nel 1750 la decorazione della chiesa del Santissimo Nome di Maria era composta inoltre da due quadri di Nicolò Ricciolini, uno dei quali sostituito nel 1755 da un dipinto di Stefano Pozzi4, cui si aggiunse, nel 1757, anche una tela di Antonio Nessi, allievo – come Pozzi – di Agostino Masucci, che verosimilmente in questi anni fece affidare al figlio Lorenzo la pala con i Santi Pietro e Paolo, già citata al suo posto nel 17635. Si tratta di un’opera che ci interessa da vicino poiché – come vedremo – a distanza di molti anni Masucci ne eseguì una seconda versione da inviare nelle Marche. La tela si caratterizza per il forte scorcio, leggermente forzato, della testa di san Pietro, intento a osservare la colomba dello Spirito Santo che lo sovrasta, e immemore della presenza dei fedeli, ai quali invece si rivolge la maestosa figura di san Paolo. L’angelo sulla sinistra è atteggiato in una posizione ricorrente nei quadri di Masucci: colto in una sorta di rotazione che media tra la visione laterale e quella da dietro. Sullo sfondo è raffigurata la basilica vaticana, che conferisce un aspetto più arioso a questa sorta di ritratto di corte dei due apostoli. Gli anni Sessanta segnano un significativo aumento delle opere pubbliche di Masucci. Nel 1762-63 fu completamente ristruttu- 120 Maria Celeste Cola Gioacchino Varlè, Andrea Vici, Vincenzo Pacetti e “l’affare delle gloriette” di Loreto Il rinnovamento settecentesco della basilica lauretana, affidato nel corso del 1788 ad Andrea Vici1, costituisce uno dei cantieri più rappresentativi della cultura vanvitelliana di fine secolo e di quel nuovo linguaggio architettonico, elaborato da Murena, Toma2, Piermarini e Vici3, che pose al centro della produzione progettuale l’esercizio del disegno e la conoscenza delle arti figurative. Era stato del resto presso Francesco Appiani a Perugia e più tardi presso Stefano Pozzi a Roma che Andrea Vici si era formato4, imparando a conoscere l’arte del disegno e della pittura in uno degli studi più aperti e internazionali della città, frequentato in quegli stessi anni da Brenna e Quarenghi. L’apprendistato nella bottega di Pozzi, in contatto almeno dal 1744 con Luigi Vanvitelli, aveva avuto un ruolo decisivo nella formazione di Vici che al suo maestro aveva continuato a guardare fino alla fine della sua lunga carriera di architetto. L’esito più fecondo delle nuove personali ricerche architettoniche, frutto della totale assimilazione degli insegnamenti di Pozzi e Vanvitelli, fu il cantiere di Loreto dove Vici riuscì a unificare brillantemente il carattere vanvitelliano delle cappelle5 con il linguaggio neoclassico dei mosaici e degli elementi scultorei. Il lungo rapporto di collaborazione e di amicizia tra Andrea Vici e Vincenzo Pacetti6 (fig. 1) aveva avuto inizio nel settembre del 1785, quando l’architetto di Arcevia grazie al voto di Pacetti aveva ottenuto l’accademicato di San Luca7. Da quel momento il legame tra lo scultore romano e Andrea Vici che, tornato a Roma dopo aver trascorso diversi anni a Napoli e nelle Marche aveva visto riconosciute le proprie qualità con la nomina nel 1782 di primo architetto della Fabbrica di San Pietro, si era consolidato intorno a una serie di commissioni prestigiosissime e alla stretta collaborazione all’Accademia di San Luca. Nel 1797 Pacetti era stato eletto alla guida dell’istituzione romana, affiancato nella carica di segretario da Andrea Vici che ebbe un ruolo chiave nella gestione dell’Accademia in coincidenza di quel delicato momento economico che, se da una parte aveva visto, per mancanza di fondi, la soppressione dei Concorsi Clementini e Balestra8 aveva spinto dall’altra Vici alla formulazione di un “codice di architettura”9. In rapporto con i principali esponenti della cultura architettonica romana degli anni ottanta del XVIII secolo, Vincenzo Pacetti aveva avuto del resto da sempre con architetti, eruditi e disegnatori un legame profondo e stimolante che gli appunti del suo Giornale restituiscono con l’immediatezza di una scrittura a metà tra le note di un libro mastro e le annotazioni di un diario10. Nel 1781 Andrea Vici era stato nominato “Architetto di tutte le fabbriche, edifici e fortificazioni della S. Casa” di Loreto e nel 1788 aveva ricevuto l’incarico di disegnare i nuo- 126 Alessandro Spila “Come si possa in nuove forme fare un lodevole uso de’ ritrovati de’ nostri maggiori”. Cenni su Giobbe, Piranesi e le antichità dei principi Colonna Il ripetuto interesse sulla figura dell’imprenditore edile Nicola Giobbe, fra i maggiori attivi a Roma nella prima metà del XVIII secolo, ha recentemente chiarito molti aspetti sulla figura del primo mecenate e “maestro” di Piranesi. L’attenzione storiografica si è spesa principalmente nell’approfondirne il profilo di singolare collezionista, bibliofilo, studioso e teorico d’architettura1. Requisiti di assoluto spicco se associati alla sua posizione di tecnico, per quanto ricco, sempre collocato nel rango delle maestranze quale semplice muratore. Per la completa comprensione del personaggio s’impone tuttavia un’analisi aggiuntiva del suo operato professionale, al quale molti passi della celebre dedica piranesiana del 1743 necessariamente sembrano riferirsi2. Nella brillante carriera emerge sicuramente la lunga attività spesa per la famiglia Colonna. Il sodalizio con i principi romani vede origine almeno dal 1696 quando il padre Antonio ottiene dall’allora abate Carlo Colonna, neo-eletto Maggiordomo dei Palazzi Apostolici, l’appalto per la facciata della cattedrale di Frascati3 che darà il via al duraturo rapporto fra i Giobbe e l’istituzione dei Sacri Palazzi4. Negli stessi anni (dal 1698) il contestabile Filippo II affida ad Antonio la conclusione del cantiere della grande galleria di palazzo Colonna5 divenendo capo mastro muratore dell’Eccellentissima Casa, carica che mantenne sino alla morte (1733) per poi trasmetterla al figlio. Alla luce di quanto sappia- mo oggi sul personaggio non desta particolare stupore il ritrovamento, fra le molteplici carte degli archivi Colonna a firma di Giobbe, di una quietanza a tergo di un conto per lavori nel vasto circuito del palazzo ai Santi Apostoli riportante: “Io sottoscritto ho ricevuto dall’Ill.mo Sig. D. Girolamo Colonna un quadro rappresentante un paese dipinto da Musieur Orizzonte e accordato il prezzo in scudi quaranta, e questi in conto de lavori fatti, e da farsi. Suo servitore in fede questi 3 ottobre 1743. Nicola Giobbe”6. Tale scambio tuttavia, oltre a segnalare il rapporto con il futuro cardinale Girolamo II e a fornirci notizie sulla possibile provenienza di uno dei due dipinti di Jan Frans van Bloemen della collezione Giobbe7, appare emblematico del duplice ruolo di costruttore e allo stesso tempo intenditore d’arte e collezionista che l’impresario comasco rivestì nel lungo rapporto professionale con i Colonna. Attività che vide impegnato il giovane Nicola, sin dagli anni dell’apprendistato paterno, in grandi manifestazioni artistiche del tempo. Oltre alle opere edilizie e al mantenimento continuo dei vasti possedimenti colonnesi nell’Urbe8, Nicola ebbe modo di formarsi a tutto tondo in differenti imprese di particolare rilievo. A cominciare dall’allestimento della quadreria e della statuaria nella galleria del contestabile, sino alle annuali messe in scena degli apparati effimeri per la Chinea di cui i Giobbe si fanno carico a partire dal 1721 per tutte le 132 ricche minere - 4/2015 Matteo Borchia Sulle due cornici di Paolo Spagna a Stoccarda Il 18 gennaio 1775 fece il suo ingresso a Roma il duca del Württemberg Carl Eugen, accompagnato da un ristretto seguito e da Franziska von Hohenheim (1748-1811), la donna cui era legato dal 1771 e che avrebbe sposato nel 1785. A più di vent’anni dal suo primo soggiorno nell’Urbe, avvenuto nella primavera del 1753, il duca aveva scelto di fare ritorno nella città papale proprio nel periodo in cui era ancora in corso il conclave seguito alla morte di Clemente XIV. Sembra che la speranza di assistere all’elezione del nuovo pontefice costituisse il motivo principale di questa nuova discesa in Italia. Dopo una breve tappa a Roma, durante la quale ebbe modo di incontrare alcuni porporati appositamente usciti dal conclave, Carl Eugen si diresse a Napoli. Qui trascorse una decina di giorni, ammirando i resti di Pompei ed Ercolano e le residenze reali di Portici e Caserta. Tornò quindi a Roma il 6 febbraio, riprendendo le visite ai principali monumenti della città. La tanto attesa elezione del nuovo pontefice avvenne mercoledì 15 febbraio: il duca fece visita a Pio VI quello stesso giorno e una seconda volta prima di allontanarsi da Roma il 18 del mese. Dal diario di viaggio del sovrano tedesco si ricava la cordialità con cui il papa lo intrattenne in entrambe le occasioni1. L’evidente ristrettezza dei tempi non permise al pontefice di consegnare al gradito ospite le opere che tradizionalmente veni- vano regalate ai sovrani stranieri in visita a Roma. Fu solo dopo la partenza del duca che si provvide a inviare a Stoccarda i donativi papali. A seguire l’intera vicenda fu l’agente romano di Carl Eugen, il partenopeo Paolo Bernardo Giordani (1710 circa - 1781)2, nello stesso periodo occupato a seguire le numerose commissioni che il sovrano aveva fatto a scultori e scalpellini durante le frenetiche giornate trascorse in città. Le relazioni inviate periodicamente da Giordani alla propria corte, oggi conservate presso l’Hauptstaatsarchiv di Stoccarda, permettono di ricostruire per intero la vicenda, dai primi contatti con gli artisti coinvolti fino alla spedizione dei doni papali. Fu solo alla fine di marzo che vennero definite le opere da inviare al duca del Württemberg. Giordani, nel corso di un incontro col cardinale Alessandro Albani e con monsignor Giovanni Archinto, maggiordomo papale, propose l’idea di un “tableau de mosaique, qui selon la coûtume sera garni d’une corniche de metal dorè, et justement me dit le Maggiordomo, qu’il y en avoit un de Guido Reni d’un Ecce-Homo, mais qu’il êtoit un peu petit”3. Il 5 aprile furono aggiunte alcune precisazioni: “On me dit, que le S.t Pere vous à destinè un tableau de mosaique de Guido Reni, qui represente Jesus Christ couronè d’epines, et un’autre de tapisserie de la S.e Vierge de Charles Maratta […]”4. Già pochi giorni più tardi, 138 ricche minere - 4/2015 Elisa Debenedetti Uggeri, Rossini e la scuola panniniana I preziosi suggerimenti di Rodolfo Lanciani, sparsi fra manoscritti e cartelle custoditi presso la Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, ci permettono di intravedere in alcuni artisti della fine del Settecento e dei primi decenni dell’Ottocento una filiazione stilistica da Gian Paolo Pannini; e di raccogliere, di questi stessi, una ricca produzione di vedute panoramiche dei sette colli di Roma. Si direbbe che l’archeologo rivolga un’attenzione particolare al famoso quadraturista emiliano, e soprattutto al figlio di questi, Francesco, dai cui discendenti acquistò molti esemplari della sua collezione, dando loro quasi maggior rilievo che non alla contemporanea grafica piranesiana. Consideriamo due olii su tela di Pannini senior, del 1749, ora conservati a Sanssouci e commissionatigli en pendant da Federico II di Prussia, raffiguranti la Veduta del Foro Romano dal Clivo Capitolino e Roma dalle pendici di Monte Mario (fig. 1)1: del primo sopravvive una copia in acquerello con minime varianti del figlio e un’incisione di Volpato da disegno dello stesso, e del secondo soltanto l’acquaforte degli stessi autori, del 17792. La medesima veduta poi, in formato molto più piccolo, fu riprodotta pressoché identica in una incisione di Giovanni Battista Cipriani (conservata nell’album BiASA, Roma XI.42) e ne venne anche ricavata una stampa: un grande pa- norama inciso da Giovanni Trevisan sempre nel 1779 e pubblicato dalla Calcografia Camerale3. Stampa che decretò il vasto successo di questa immagine, usata sino alla fine del secolo per corredare libri illustrati e guide di Roma; tanto che lo stesso Cipriani ne ricavò l’acquaforte, datata 1797, che apre il suo volume Vedute principali e più interessanti di Roma. Nello stesso album Roma XI.42 si trovano “i sette colli di Roma” (uno mancante) di Bartolomeo Pinelli, accanto a una interessante pagina di alberi dai rami nodosi e fronzuti che si intrecciano fra di loro di Angelo Uggeri. A quest’ultimo Lanciani attribuisce grande importanza, tanto che in BiASA Roma XI.61 si trovano altre tavole sempre a lui riconducibili4. Si tratterebbe di fogli precedenti a quelli delle Giornate pittoriche degli edifici antichi di Roma e dei suoi dintorni, mai presi in considerazione e non permeati da quella sorta di follia antiquariale che attraversa le Journées; tenendo anche presente come lo stesso Cicognara giudicasse l’opera completa dell’abate milanese come “non priva di qualche cosa di buono anche se vi si sarebbe bramato un ordine migliore e una più scrupolosa diligenza”5: vi si è individuata una chiara ascendenza nordica, che si mantiene costante anche nei disegni a queste anteriori cui abbiamo accennato6. Sussidio a entrambe le serie è comunque un prezioso Taccuino 149 Christian Sapin, Les cryptes en France. Pour une approche archéologique, IVe-XIIe siècle Paris, Picard, 2014, 316 pp., 398 ill., col., euro 76 ISBN 978-2-7084-0965-1 Il titolo della recente monografia di Christian Sapin, Les cryptes en France, forse opzionato per ragioni innanzitutto confinate alla diffusione del prodotto editoriale, non rende giustizia all’auctoritas di un libro che non è affatto – se non nell’ultima porzione – una panoramica esclusivamente riferita al territorio francese, come invece si crederebbe di primo acchito1. Il volume è in realtà molto di più. Si tratta nello specifico di un audace studio della cripta medievale tout court: delle sue origini, del suo molteplice utilizzo, dell’evoluzione morfologica e della sua scomparsa storica. Certo, il punto d’osservazione rimane la Francia – inevitabile – e il terreno di gioco è in buona parte quello. Senza dubbio è una summa sull’argomento, tutt’altro che superflua, ed è anche un saggio equilibrato e solido, che non lesina approfondimenti puntuali e in certi aspetti inediti e che intercetta a buon diritto gli studi medievalistici italiani. Le cripte altomedievali e romaniche, specie d’ambito francese, non sono di sicuro sconosciute nello scenario degli scritti di storia dell’arte medievale e di archéologie du bâti. Questo libro tuttavia, accuratamente pubblicato nelle raffinate edizioni Picard ed esteticamente piacevole anche per l’elegante impaginazione, riconsidera globalmente il tema, per di più alla luce delle ultime campagne di scavo archeologico e di restauro architettonico, proponendo aggiornate interpretazioni, talvolta precisando fasi e datazioni per lo stesso complesso monumentale e provando così a rileggere fatti e fenomeni, messi a confronto in serrate griglie cronologiche e tipologiche ben più che meramente regionalistiche. Sviluppo di indagini di lunga articolazione, condotte – si constata nel Préambule – a più tranches nel corso degli ultimi decenni, lo studio di Sapin mostra uno spessore scientifico d’eccezione ma non ha di certo la pretesa di essere esaustivo. Questo libro non lo è e non poteva esserlo: forse è bene tenerlo presente da subito, nell’accingersi a sfogliarne le pagine. Le ricerche presentate vogliono d’altronde inserirsi esplicitamente in un quadro di apporti ben più ampio, cui l’autore fa continuo riferimento. Eppure del tutto originale è per alcuni versi il taglio del volume, chiarito sin dalle prime battute e poi snocciolato via via. Attraverso analisi ex novo o tramite la rilettura critica di casi archeologici già acclarati, il lettore è introdotto in un percorso a ritroso nello spazio e nel tempo alla riscoperta di modelli architettonici per mezzo di esempi significativi, apparentabili non soltanto geograficamente, nell’Europa tra IV e XII secolo. Quest’opera rivela innanzitutto un’intelligenza interpretativa di fatti storici, di impianti planivolumetrici, di resti archeologici e perfino di semplici e nude pietre, alimentata da un rigore metodologico che è frutto di un vero lavoro d’équipe, condotto insieme a esperti in materia, in prevalenza attivi presso il Centre d’études médiévales di Auxerre, e non solamente2: una compagine di studiosi, che si crede opportuno menzionare anche per il contributo offerto al volume tramite molte elaborazioni grafiche finora inedite o mediante rappresentazioni di restituzione, utili a suffragare le ipotesi ricostruttive di assetti oggi parzialmente perduti (fig. 2). Le indagini pubblicate affondano peraltro in un’aggiornata bibliografia internazionale, forse dall’autore troppo sintetizzata, alla quale saldamente si ancorano, ben inteso franco-centrica sì, ma non dimentica di alcune fra le ricerche in questi anni condotte quantomeno in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Belgio e Inghilterra. E questo è un altro merito del volume: una messa a punto, € 29,00
Scarica