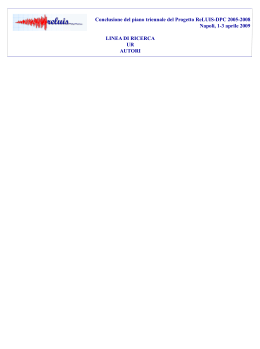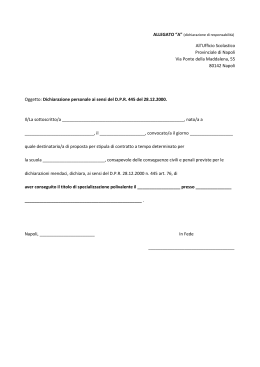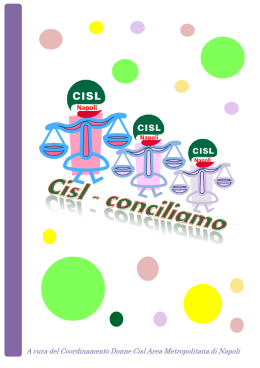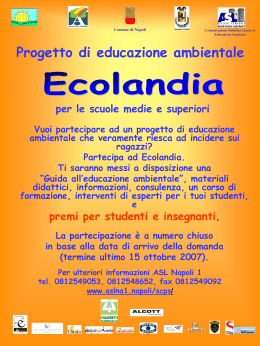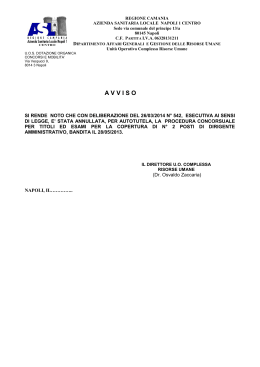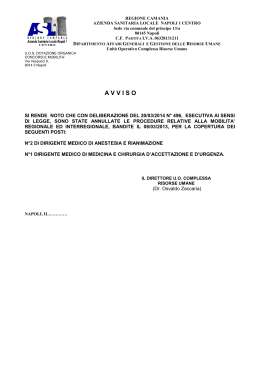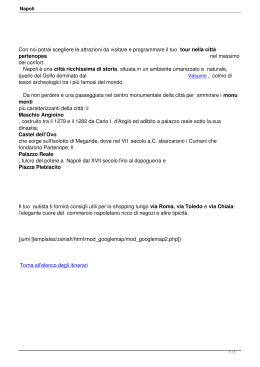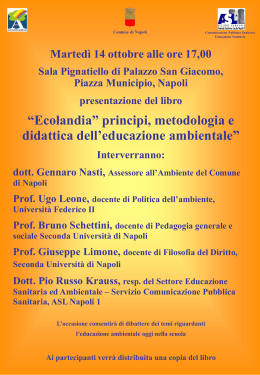Addio, Napoli La grande mutazione negli anni di Bassolino, le sue illusioni, le ragioni del suo successo e della nostra delusione. a cura di Lo straniero Questo libretto è il frutto di una discussione durata negli anni tra i collaboratori napoletani di “Lo straniero” e altri collaboratori meridionali. Hanno lavorato tecnicamente alla sua preparazione: Vittorio Avella, Stefano De Matteis, Peppe Esposito, Alessandro Leogrande, Emanuela Nicolcencov, Sara Maisano, Alberto Romano, Enzo Stoccoro. Chiunque desideri ricevere copie dell’opuscolo o riprodurlo può scrivere a: [email protected] Ringraziamo sentitamente Mimmo Paladino per l’illustrazione di copertina. Napoli, giugno 2003. www.lostraniero.net Sommario 5 Dieci anni di gloria Goffredo Fofi 15 E adesso, senza barbari? Maurizio Braucci 24 Dai margini Giovanni Zoppoli Dieci anni di gloria di Goffredo Fofi L a grande mutazione napoletana è avvenuta negli anni Novanta dello scorso secolo, in concomitanza con “l’era Bassolino”. Se la nostra analisi è esatta, quello che Pasolini temeva è accaduto. Le ragioni per cui egli prediligeva in Italia Napoli su ogni altra città, la sopravvivenza di un popolo e di una sua specifica cultura capaci di resistere alle lusinghe della omologazione, non hanno più corso: anche Napoli è irrimediabilmente, definitivamente “mutata”, ed è diventata una città comune e conforme. A ottenere questo risultato non è stata solo la borghesia nazionale e internazionale, per il tramite dei rovesciamenti economici e dei modelli consumistici, e non sono state le idee correnti nella società italiana del tempo (verificabili giorno per giorno, nella loro atroce continuità e ipocrisia, sulle colonne dei principali quotidiani, in testa a tutti il luogo centrale delle nuove voghe e degli eterni giochi, “la Repubblica”) ma proprio la sinistra, e per essa, alla sua testa, il sindaco del rinnovamento che aveva fatto della conquista “della normalità” (bisogna pur riconoscergli tutti i suoi meriti) la propria bandiera. Nella prima metà degli anni Novanta, almeno Dieci anni di gloria nel Sud, si era potuto sperare in una rinascita della società meridionale tutta, che finalmente liberata dalla soggezione ai modelli settentrionali (che erano anche quelli dei “comunisti”, progressisti per eccellenza e i più tenaci sognatori dell’adeguamento ai modi in cui la società italiana “matura” amava rappresentarsi) e riconquistata a una dimensione civilmente utopistica e progettuale, sembrava avere molto da offrire alla comunità nazionale e non solo a quella, in fatto di modelli di convivenza e di accoglienza, in fatto di civiltà. Più preparata di altri luoghi del mondo, per antica tradizione e mediterranea centralità, al nuovo muoversi del mondo. La ricerca di nuovi modelli era infatti impellente, o avrebbe dovuto esserlo almeno per la sinistra nel tempo lungo del “crollo dei muri” a Est, mentre, nell’Est vicino come in quelli lontani e nei Sud, il contrasto tra le condizioni di vita degli abitanti del pianeta, cioè ancora tra ricchi e poveri, era diventato più evidente e insostenibile che mai per i più poveri, irrequieti, oppressi. Costoro hanno dunque cercato, e cercano in ogni modo, di raggiungere le nostre sponde, per fermarsi tra noi o per attra5 versare il nostro paese verso altri Nord nella convinzione di trovarvi, se non un regno ideale, almeno dei luoghi di possibile, di onorevole sopravvivenza. Anche per Napoli il problema dell’immigrazione è diventato importante, e se è meno vistosa che altrove la presenza, nel mezzo di una vociante ed estroversa varietà di nuova e più ricca plebe, degli stranieri, rispetto a città dove le destinazioni appaiono fisicamente maggiori, essi però ci sono, sono tanti, e si organizzano in proprie comunità scavando le proprie nicchie in un mercato del lavoro ancora semiclandestino e soggetto a troppi ricatti sia economici che sociali, cioè “politici”. In questo senso, però, la novità storico-sociale maggiore del decennio 1990-2000 non ha riguardato tanto Napoli, e neanche la Sicilia o tutte le regioni dell’arco tirrenico, ancorché esposte al mare e assolutamente “mediterranee”, bensì l’Adriatico e lo Ionio, ieri e di nuovo oggi porta all’Oriente, e luogo degli scambi e intrecci di civiltà più intensi e più duraturi. E anche, sul momento, più tragici. La Storia con la esse maiuscola ha riguardato – riguarda – soprattutto le zone più marine del nostro Est, per arrivi, benché osteggiati, irrefrenabili, e per mille traffici di tipo economico che si sono riaperti con l’Est: l’Est ex “sovietico”, e più in basso il Sud-Est, e quell’Asia Minore che è anche, però, terra di passaggio per chi arriva fin qui dalle più lontane lande della “Maggiore”. Alla degradata condizione della metropoli partenopea non avevano saputo dare risposta né i movimenti degli anni Settanta né il loro pallidissimo esito municipale dei fiacchi anni della giunta Valenzi, rappresentante un Pci ancora forte e però sempre confuso tra grandi ambizioni e piccoli, abituali, stupidi interessi di parte, con tutte le loro conseguenze dei piccoli cabotaggi e delle intermediazioni tattiche che non potevano, dovunque e comunque, localmente e nazionalmente, che aprire il passo – e nell’uni6 co caso di un governo nazionale pienamente di sinistra, proprio negli anni Novanta – al ritorno trionfante delle destre. Questo avverrà anche a Napoli, forse, chissà, prima o poi. È dubbia la previsione, tanto sono consustanziali alla situazione le giunte di sinistra campane, nel Comune e nella Provincia di Napoli e, nonostante o grazie a Bassolino, nella Regione Campania. Esistevano allora, negli anni Settanta, e ancora negli anni Ottanta e negli anni che hanno preceduto lo scontro Mussolini-Bassolino e il così pessimamente utilizzato trionfo bassoliniano, delle condizioni per proporre, inventare, attuare qualcosa d’altro e di meglio, e soprattutto esistevano tensioni sociali identificabili in ceti e categorie tradizionalmente tenuti lontani da ogni possibilità concreta di incidenza sul destino della città, come sul proprio immediato destino. C’era da un lato un “sottoproletariato” che tale non era, proletariato marginale di un mercato del lavoro da sottosviluppo, soggetto alle imprese del Nord e ai locali imprenditori speculanti sull’arte d’arrangiarsi e le sue possibili varietà non infinite, attirato dalla malavita per fisiologica necessità ma non necessariamente catturato dalla malavita, se non in minima parte, semmai a essa soggetto e aspirante ad altro di più sicuro e più degno; c’era una piccola borghesia variegata e decentrata, non solo statale e municipale, fragile nelle sue volontà e nei suoi caratteri, capace di ideologizzare a proprio uso e consumo e di affiliarsi cambiando rapidamente bandiera a chi le offrisse più sicurezza, ma tuttavia decentrata e difforme, al suo interno confusa, sulle cui componenti migliori o sui cui interessi più sani sarebbe stato possibile operare con risultati decorosi, e che sarebbe stato dunque possibile “egemonizzare” se si fossero avuti progetti di riscatto e di richiamo non solo elettoralistico; e c’era perfino una parte di borghesia stanca di essere tutta e solo parassitaria, legata ai carri del Nord e dei clien- telismi che si dipartivano dai grossi potentati statali, anche partiti, e interessata a sperimentare una sua possibile, perlopiù inedita, capacità di elaborazione, col gusto dell’azzardo. E c’erano infine, c’erano ancora, istituzioni non completamente soffocate e soffocanti – soprattutto la scuola – sulle quali era possibile far leva: su molti insegnanti nelle medie e inferiori, sugli studenti e molti insegnanti nelle superiori, e nell’Università. La quale Università, luogo abituale di grandissima corruzione perché d’importanza centrale in ogni gestione del potere nel caso di alcune facoltà (Diritto, Architettura e Ingegneria, e accessoriamente Medicina), aveva in altri ambiti personalità di rilievo non trascinate del tutto nei vortici della complicità, e studenti che speravano, che credevano ancora in un loro positivo ruolo nell’opera di cambiamento. Anche sulla scia, sia pure flebile e progressivamente conquistata al peggio nella sua smania di collocazioni dentro o ai margini dei poteri politici e mediatici, di un ’68 che a Napoli era stato meno ideologico che altrove e più radicato che altrove nei bisogni e nelle pieghe di una società più affamata, e che insomma appariva nella sua migliore e maggior parte più concreto del ’68 nazionale. M a la politica era davvero una “cosa sporca”. L’abbiamo appreso sulla nostra pelle, nella nostra ostinazione a occuparci non da politici della “cosa pubblica” in nome dei non-privilegiati, dei nuovi nati, dei nuovi ospiti, e insomma di tutti quei “minori” che non hanno voce in capitolo e che non contano, stimolandoli all’autorganizzazione quand’era il caso, e semplicemente difendendo i loro diritti quando non erano in grado di difenderli da soli. Quest’operazione è quanto mai inattuale anche nei movimenti, che in Italia sono pervicacemente votati a entrare nella politica, a servirla o a servirsene, a farsi politica rinunciando, come Dieci anni di gloria forse è da sempre nella storia della nazione, a un ruolo non soltanto propedeutico o accessorio alla politica. Di questa operazione, però, che è di sollecitazione delle (poche) forze positive in campo, di critica della politica e più in generale del potere e di ogni potere, ci è sembrato che il paese, e Napoli, avessero soprattutto bisogno. Attenti alle trasformazioni di un humus culturale e sociale, si tratta in definitiva di saper assumere le proprie responsabilità di preoccupati della cosa pubblica, però renitenti nei confronti di quell’occupazione della cosa pubblica che caratterizza i politici e, a maggior ragione, in pianta più stabile, i burocrati di carriera. Si parla qui per un giro di persone che venivano dai movimenti e non hanno scelto la politica come loro percorso fisso, proprio perché la politica si faceva mestiere e queste persone, anche se tante si sono perse per strada risucchiate dal “particulare” e dal “tengo famiglia” di eterna tradizione, queste persone si sono presto ritratte disgustate dalla conoscenza dei modi della politica – anche di quelli dei gruppi, delle minoranze la cui aspirazione non era e non è quella di testimoniare una diversità e operare per e con il basso, credendo in una democrazia del basso, ma si collocava nella progressiva farsa della rappresentanza o della caccia al “successo” personale e alla carriera istituzionale. Nel corso del tempo, si può forse dire che l’ultima speranza di un’adesione alla politica di cui non ci si dovesse poi vergognare sia stata proprio la battaglia per Bassolino sindaco, non certo per i suoi aspetti folklorici (gli scontri televisivi, con la contrapposizione BassolinoMussolini…) o per il tradizionale revanscismo della sinistra sempre frustrata nella sua aspirazione a occupare i piani alti della politica e di lì programmare, decidere, premiare, e soprattutto, alleandosi, occupare. Non ci siamo tirati indietro, ci siamo assunti per un certo tempo qualche responsabilità, e poi 7 c’è stato chi si è “incastrato” nel sistema, e talora infognato, o chi si è allontanato senza clamore, senza vergognarsi del poco che erano riuscito a fare, ma ovviamente con un sano ribrezzo nei confronti, ancora una volta, dei politici. Vanno riconosciuti a Bassolino tutti i suoi meriti di volpe della politica, ma nell’unico modo di intendere la politica che, al dunque, anche la sinistra ha dimostrato di conoscere e di volere – che è quello eterno della manovra, dell’alleanza, della clientela, della retorica e della menzogna “in nome di”. Anche Bassolino, semplicemente ha tradito (come d’uso nei comunisti) le speranze riposte nelle sue parole. Egli resta, è accorto quanto basta per sopravvivere a venti e maree, e nella sostanza non ha mai voluto essere altro da ciò che è: mediatore tradizionale di interessi di gruppi forti (per carità, se lo sono abbastanza, se si agitano abbastanza, anche gli interessi di gruppi “di sinistra” o che rappresentano la base e ceti sociali non privilegiati). Allievo egregio del compagno Togliatti “il migliore”, ben più delle pompose e nefaste cariatidi del “manifesto” e dei loro allievi, saltabeccanti tra giornalismo e istituzioni, Bassolino “sa come muoversi”. Intuisce, previene, sa “stare al mondo”. Ma, in sostanza, non sembra aver mai nulla da dire di proprio che non sia, per l’appunto, nel senso di un’antica astuzia nel cavalcamento delle nuove mode e situazioni. Grazie a lui e al suo primitivo staff di collaboratori – molti via via allontanati o allontanatisi, alcuni con risentimento nei suoi confronti – la città è davvero cambiata rapidamente e rapidissimamente. Quel che non era accaduto nei decenni precedenti, la “mutazione” consolidata negli anni Ottanta nel resto d’Italia, è accaduto a Napoli nel decennio di Bassolino; e per una sinistra velleitaria e meschina ma non ancora del tutto “laicizzata” secondo vocazioni più o meno “democristiane”, è stato il trionfo. Ma, e lo si è già detto ma merita di insisterci, questo 8 trionfo, questa mutazione, ci sono stati anche altrove. Un paragone con Bari, amministrata dalla destra, sarebbe illuminante: stesso percorso e velocità anche maggiore, ma con la differenza che lì davvero si giocano carte grosse per il futuro. La riapertura delle “porte dell’Oriente”, l’altra sponda dell’Adriatico, la tradizione levantina di una borghesia particolarmente aggressiva e amorale (l’intellighenzia appresso: e c’è da strabiliare seguendo voltafaccia e carriere di coloro che fino a ieri occupavano cattedre di marxismo italico dandoci lezioni di materialismo dialettico) fanno di quella mutazione qualcosa di terribilmente vivo, dagli esiti ancora non tutti realizzati, anzi incombenti, e forse oggi ancora insospettabili. Non ha bisogno del turismo, Bari, per mutare arricchire crescere! La stagione che ha preso il nome dai sindaci, quando il Sud pareva potesse dare a tutto il paese esempi di novità e di invenzione – liberato dalle sudditanze e dai sentimenti di inferiorità accortamente intrattenuti dalla cultura sabauda, fascista, democristiana, comunista – e di affrontare tempi nuovi come nuovi progetti e nuove concezioni dello sviluppo, del progresso, della democrazia, è stata davvero breve. Essa è stata osteggiata da molto statalismo, e forse con più acrimonia che da ogni altro potere proprio dai compagni di partito di Bassolino, a cominciare da D’Alema, che del Sud andava diventando un competente affarista. Ma non è colpa di D’Alema, se le strade scelte per Napoli, in presenza di un’economia mondialmente mutata, sono state solo quelle, molto a passo coi tempi, della terziarizzazione turistica. L’intelligenza di Bassolino e dei suoi consiglieri più arditi (o più “borghesi” o più “vili”, a seconda dei punti di vista) non è in discussione: la mutazione che hanno intravisto per Napoli dopo un breve periodo di un tentennante saggiar l’ambiente locale e il paesaggio nazionale, andava nella direzione vincente. E seguire quella direzione, la meno rischiosa e l’unica forse vincente a tutti gli effetti, compreso quello del “ritorno d’immagine” che è sempre stato l’assillo numero uno del sindaco e dei suoi accoliti, ha voluto dire lasciare in secondo piano tutte le altre, considerandole comunque meno importanti. Se un progetto partiva o non partiva, se da esso nasceva qualcosa di buono o di non buono, questo contava sempre meno rispetto all’insieme. E l’insieme era l’immagine, il “Maggio” perenne della vendita dell’immagine (e talvolta della sostanza) di una Storia e di una Civiltà. La città che doveva tornare a esser vivibile per i bambini? La lotta alla camorra? Il traffico? La giovane criminalità? Il “genocidio” morale di un ceto sociale fondamentale come era stato il cosiddetto sottoproletariato e la “cultura del vicolo”? I progetti variamente pedagogici? La lotta all’abusivismo? Ai motorini selvaggi? Allo smog? Alla monnezza? Aria fritta, al solito. Quel che contava era l’immagine. E allora, certo, riapertura dei “monumenti”, degli spazi, dei vicoli a nuovissimi frequentatori; ripulitura generale, imbiancamento e disneylandizzazione come nel resto d’Italia, da Bergamo a San Gimignano, dai luoghi leghisti a quelli comunisti, come dovunque, come è nel vento… Si potrebbe rifare la storia di questa politica, e c’è chi l’ha fatta (vedi Maria Federica Palestino, miraNapoli, edizioni Clean, con un saggio di Vincenzo Andriello, che è uno dei pochi libri, nella infinita produzione cartacea napoletana autoreferenziale di questi anni, degno di consultazione). Con conclusioni non meno sconsolate delle nostre, anche se meno abbacchiate, e senza quella sensazione di sconfitta definitiva di antiche e alte speranze che il vecchio meridionalismo non-comunista ci aveva prospettato, di una morale della politica, di una dimensione diversa e più armonica della democrazia e, più ancora, dell’umano e del sociale. (Non-comunista, sia chiaro, non in rapporto Dieci anni di gloria alle speranze e alla generosità della base comunista, ma rispetto ai tatticismi e dottrinarismi dei vertici). La scelta di campo dell’immagine, la politica decisamente e americanamente post-moderna dell’immagine hanno avuto più fasi, ma non è così importante, ci pare, distinguere, sul piano della cosiddetta “cultura” intesa da tutti come cultura-spettacolo e cultura-merce, o procacciatrice di movimento economico attorno a eventi e monumenti – tra una linea Nicolini e una D’Agostino e una Furfaro. La prima puntava all’evento spettacolare di dignità culturale (vera o presunta, comunque convalidata dai media e dai loro critici-funzionari), la seconda si attestava tradizionalmente sull’intervento “alla democristiana”, a pioggia, e sulla costruzione di una clientela politica tradizionale; la terza si trascina con scarsa autonomia, rinunciando via via alle sue migliori ambizioni, diciamo “pedagogiche”, e si limita a gestire e mediare tra le maggiori forze in campo, e il modello è ancora democristiano e clientelare, come ha fatto con il Mercadante. Sarebbe più importante analizzare, nel decennio dal 1992, altre scelte e tappe, da Bagnoli a Secondigliano, da Barra ai Quartieri Spagnoli. Ma ogni iniziativa – anche le migliori e benvenute, che comunque ci sono state e sono molte – è sempre stata ricondotta sotto il segno di quella politica, prima culturale che economica e sociale, e certamente oggi economica e sociale in quanto culturale. Due eventi sinbolo vanno però ricordati: la liberazione dalle auto di Piazza Plebiscito con la magnifica scadenza della Montagna del Sale di Mimmo Paladino, il cui significato fu evidente, di liberazione e riappropriazione di uno spazio storico da parte della città e di festa della città; e il nuovo disegno di Piazza Dante, spazio neutro e non-luogo, da luogo che era, per volontà di Bassolino e sul progetto di una micidiale scenografa per i ricchi di sinistra e di destra, Gae Aulenti. 9 Parliamo ora di un ceto che ci è stato a cuore e che abbiamo avuto la ventura, anzi la fortuna, di conoscere bene, il cosiddetto sottoproletariato. Parliamo della sua morte, piangendola; perché è in essa la morte della storia e identità più forte che la città abbia avuto nel corso almeno degli ultimi, lunghissimi secoli. Napoli è cambiata, perfino gli scugnizzi sono cambiati. Quando anni fa Pasolini scriveva la sua “lettera a Gennariello”, un ideale interlocutore-ragazzo, pensava e sceglieva ovviamente qualcuno che la sua lettera potesse leggerla e meditarla, ma parlava a Gennariello anche in nome di quelli che non l’avrebbero certamente letta. Ipotizzava ancora un incontro, uno scambio tra due Napoli “positive”, quella di una piccola borghesia che tra mille difficoltà e separatezze riuscisse a emanciparsi dai modelli imposti dal potere (consumismo e conformismo, in definitiva) e a farsi carico di un processo di trasformazione positiva, aperta, e quella di un proletariato marginale, abitualmente detto sottoproletariato, tenuto lontano da quasi tutto e spesso destinato, per la sopravvivenza, alla malavita. Erano gli anni Settanta turbolenti e confusi, ma nei quali ancora albergava la speranza: emancipazione e omologazione sembravano e non erano un’alternativa radicale; e invece la storia ci ha dimostrato che potevano andare insieme. Napoli è mutata fortissimamente nel decennio bassoliniano in concomitanza con un cambiamento che ha investito un po’ tutto il Sud. Un cambiamento forte c’è stato per effetto della maggior circolazione di denaro e l’uscita allo scoperto di un ceto sociale, appunto la piccola borghesia, appunto i “gennarielli”, che si è modernizzata e messa al passo e ha abilmente e irresistibilmente invaso pressoché tutto. Come dovunque nel Centro-Nord, prima che a Napoli o a Bari o a Reggio. A Napoli questo ha comportato cambiamenti vastissimi. Proviamo a soffermarci sul più evi10 dente, che riguarda appunto il sottoproletariato, cioè quel proletariato di cui abbiamo detto fatto di artigiani, di lavoranti a domicilio per ditte del Nord, di industriosi lottatori per il pane quotidiano della famiglia, e anche, va da sé, di attratti dal sottomondo paracamorristico o camorristico; il sottoproletariato è stato aggredito e rinchiuso dentro spazi più ristretti, il centro gli è stato tolto e, nei vicoli del Decumano Maggiore e perfino delle “roccaforti” che sono state i Quartieri Spagnoli e la Sanità, sono arrivati e si sono insediati gli intellettuali e artisti (perlopiù, come dovunque, intellettualini, artistini) e i “mercanti da turisti” (non più artigiani ma rivenduglioli), come è accaduto in tante altre città prima che a Napoli. Il sottoproletariato non è più un ceto importante e inventivo, centrale. E poco è rimasto da questo “genocidio”, per dirla alla Pasolini, di un intero ceto che, poco alfabetizzato, aveva dato alla storia di Napoli due cose fondamentali sul piano delle arti come il teatro e la canzone: Viviani, Eduardo, Totò eccetera e la sceneggiata, e i musicisti ed esecutori di una splendida storia canora. È incomparabile questa storia a quella assai misera della cultura scritta, del romanzo per esempio, con rarissime eccezioni (il solito Ferito a morte) almeno fino a… un decennio fa. Quella storia ha dato alimento a centinaia di film, inchieste, articoli, canzoni, luoghi comuni che è senza paragone con altri ceti di altre città e regioni, esclusa… la mafia siciliana, nella storia dell’Italia unita. E non c’è più, oggi, questa cultura. È diventata una variante della nazionale fiacchezza dell’immaginario e della comune volgarità, televisione assistendo. Confinato, aggredito, il sottoproletariato dei vicoli è diventato una tragica minoranza variamente assediata, soprattutto da interventi di tipo poliziesco e militare. Perché sì, il sottoproletariato è diventato una ristretta realtà assai pericolosa: sostanzialmente ricco, per traffici illeciti e soprattutto la droga, ma culturalmente deprivato dalla sua identità, esso è caduto in una sorta di isteria aggressiva e autodistruttiva. Gli “scugnizzi” per primi: non più bambini e adolescenti poveri e inventivi, ma isterici consumisti (in giro a modo loro) su micidiali motorini senza legge (che le autorità si guardano dal condizionare) o in gruppi che, quando il terreno o l’ora sono propizi, potrebbero farsi capaci del peggio. Sono questi gli effetti più vistosi del “genocidio” di un ceto, sono queste le nuove realtà urbane con cui il potere dovrà fare i conti ora e in futuro. Il folklore non c’entra, e non c’entra più neanche Pasolini. La produzione culturale e artistica napoletana è ricchissima anche oggi, ma come lo è in ogni parte del paese o quasi. Ai giovani si dà una laurea e si moltiplicano corsi di tutto, scuole di tutto ma fuori dalla scuola istituzionale, distrutta dal suo ceto pedagogico quanto dai suoi ministri, a cominciare, prima della Moratti, dai suoi Berlinguer e De Mauro e dai “pedagogisti di sinistra” del modulo e del quiz. Si dice ai giovani di essere “creativi” e che è facile essere “creativi”. Le Università sfornano ovunque, a Napoli come altrove, masse di giovani molto ignoranti e molto presuntuosi. Non gli si dà il lavoro, però gli si dà “la cultura” e l’illusione della facilità, una sensazione di quasi onnipotenza… Col tempo, la loro disillusione crea dei cinici o degli spostati. Ma su questo non vogliamo insistere, anche se ne varrebbe la pena poiché, appunto, la produzione culturale e artistica abbonda e, priva di strumenti di selezione critica – nella decadenza o morte della critica e di una selezione operata dal mercato, poiché assai più del mercato contano la protezione e il finanziamento degli enti pubblici e l’inserimento per cooptazione clientelare nel grande circuito delle iniziative spettacolari – non può che produrre una proliferazione di graziose scemenze o di deprecabili idiozie. Dieci anni di gloria Romanzo, teatro, cinema, musica, e quel che si chiama “belle arti”, e fotografia, non hanno mai sfornato così tanti artisti e opere come nella Napoli dalla seconda metà degli anni Novanta, ad libitum. Ma che artisti? e che opere? Negli anni del “rinascimento” molto di buono nasceva o si consolidava, dai primi film di Martone, Consicato, Capuano, ai primi romanzi di Montesano, Braucci, a spettacoli memorabili come Rasoi a fotografi come Biasiucci e pochi altri, all’ultima grande produzione musicale di Bruni e Palomba e poi agli Alma Megretta, alla maturità di Nino D’Angelo, alla nascita di un’editoria di portata nazionale con L’Ancora del Mediterraneo e altre più piccole iniziative, ai primi Galassia Gutenberg presto appassiti nel familismo liguoriano, eccetera eccetera – e sorprendeva l’Italia, e si sintonizzava, partendo da qui, con quanto di egregio si produceva lontano da Roma, a Palermo, a Torino, a Milano, a Lecce. Ma da allora, anno dopo anno, la qualità si abbassava e abbassava mentre aumentava a dismisura la quantità delle opere insignificanti, velleitarie, consolatorie, nel flusso di una sottocultura costernante. Si è partiti, nel “rinascimento”, coi giovani di Rasoi – una riflessione storica e poetica del basso di un ceto di cui si auspicava il riscatto – e si finisce con i vecchi, i vecchissimi di Napoli milionaria, filodrammatica miliardaria che avrebbe dovuto celebrare i dieci anni del trionfo bassoliniano e ne rivela tutti i tradimenti, le miserie, le impotenze. In questi anni, dunque, mentre fioriscono le parodie della napoletanità, una piccola borghesia vorace di tutto si appropria risibilmente della tradizione e del passato delle classi subalterne, che sembrano peraltro ben felici di svenderle e semmai mimarle assieme alle contadinelle desimoniane con appartamento o villa a Posillipo. Queste parodie sono perfettamente consone alla cultura del berlusconismo, che 11 come si è detto ha fin troppe affinità con un certo bassolinismo, ma qualche artista ha cercato di “uscire” dal ricatto di Napoli e azzardare un’altra modernità che non quella balorda offertagli dalla città, e rifiutare una ormai fastidiosissima – perché più falsa che mai – autoreferenzialità quasi d’obbligo per il successo locale e per quello nazionale. E se ha fallito nell’impresa, perché? Penso ad alcune opere interessanti proprio per il loro coraggio: i film di Pappi Corsicato (Chimera) e di Nina Di Majo (Inverno), gli ultimi dischi degli Almamegretta (Quattro quarti, Imaginaria) dove più forti erano gli impulsi ad altri suoni e armonie, o disarmonie. Il film di Corsicato non ha un retroterra napoletano evidente, quello di Di Majo è ambientato in una Roma-Europa; le radici se ci sono non vengono mostrate, non si fa leva su di esse e non le si mette in mostra, non si vuole usarle per una comunicazione facile facile. Si tratta di opere importanti, lodevoli, significative, ma come astratte ed esangui. Troppa distanza? O troppa poca? (questo non implica una vera distanza fisica degli autori, un loro radicarsi altrove, sia pure per mezzo come è di ogni sradicamento attuale). Quel che questi artisti hanno capito è che la tradizione soffoca invece di liberare, e che non c’è più nessuna “casa” possibile se non il pianeta – e dunque neanche un “ritiro a casa” plausibile. Che nella “casa” che ci è data ci si può stare solo con un piede dentro e uno fuori, se proprio ci si vuol stare. Il loro tentativo di volare secondo un’altra ispirazione e altre immagini o suoni è stato punito con un relativo insuccesso, e certamente con il disinteresse da parte della città. E con una forte incomprensione critica, in generale, anche altrove, perché dagli artisti napoletani ci si aspetta sempre una dose massiccia di umori (e colori) locali. A Napoli viene meglio accettata, anzi esaltata, la post-modernità di facciata e che viene da fuori. Il caso dei Natali di piazza 12 Plebiscito è esemplare: solo il primo anno, con la Montagna del Sale, si intuirono delle strade possibili (ma era anche il primo anno di Bassolino, cioè di una speranza in ben altre trasformazioni, poi velocemente svampita), mentre l’ultimo, con le “capozzelle”, ha dimostrato anche ai ciechi come la città ormai non abbia più la vecchia identità, e abbia dimenticato lo ieri e non subisca più nessun fascino della cultura che peraltro ha contribuito ad ammazzare. Una lezione amara, mi pare, su un avvenuto distacco. Opere come Inverno, Chimera, Imaginaria eccetera non sono “istituzionali” e sono partite da altre esigenze, diverse anche da quelle che mossero tanti anni fa le fatiche degli Amelio, dei Vitiello e Neiwiller, del primo Martone eccetera, che erano, da dentro una sorta di stagno, degli aneliti al nuovo. C’è una strada da consigliare, una strada “giu- sta”? Sono gli artisti veri a dover uscire dalla loro prigione e a dover trovare le strade più fertili (o anche le più mortali, perché no?), ma che non possono essere che strade ardue, di negazione più che di affermazione, o di affermazione attraverso la negazione. Di opposizione in un paese privo di opposizione, in cui, e si parla anche per Napoli, i volti e i corpi di una delle civiltà meno omologate del mondo fino appena a ieri si sono rapidissimanete adeguati allo standard delle masse solitarie dell’occidente producendo democratiche somiglianze, piattezze, clonazioni. La classe dirigente napoletana di oggi ha tutta la stessa faccia, destra, centro, sinistra, ben pochi si distinguono nella massa che noi possiamo ben chiamare “loro”. Il popolo napoletano di oggi comincia ad avere anche qui un’unica faccia. È un “loro” cui ahimé apparteniamo a volte anche noi, se non altro nei modelli e nelle pratiche di molto consumo e nella soggezione, per quanto ricalcitrante, alla produzione di massa che propongono “loro” (dirigenti) e i “loro” (piccoli borghesi all’arrembaggio, dovunque dilaganti e corrodenti). Da questi “loro”, e anzitutto dal “loro” classe dirigente monocolore, è sempre più indispensabile distaccarsi. Per poter ragionare, anzi per poter vivere senza vergognarsi di noi stessi. Questo trionfo di mediocrità, questa voluttà del cosiddetto nuovo è stato narrata meglio che da ogni altro da Giuseppe Montesano, che nel suo ultimo romanzo Di questa vita menzognera (il titolo viene da Blok: “Di questa vita menzognera / cancella l’untuoso rossetto /…/ e anche non vedendo l’avvenire, / di’ no ai giorni del presente”) racconta il progetto di trasformare Napoli in Eternapoli di un’oscena ricca famiglia di dominatori napoletani, i Negromonte, alleata a un presidente e un potere certamente berlusconiani. Il progetto è la costruzione di “un enorme parco tematico” in cui “ricostruire la vita di un tempo” a uso dei turisti di tutto il mondo. “Bisognava ricostruire la vita dell’antica Neapolis, della città angioina e della città spagnola, e su quei palcoscenici far recitare la storia”. E ancora: “Il potere centrale, l’esercito e le televisioni nazionali restavano nelle mani del Presidente, il governo dava il Sud in concessione ai Negromonte e agli altri imprenditori e in cambio riceveva la massima fedeltà. Era una forme di outsorcing, no?” Non siamo così lontani dai progetti che possiamo chiamare “bassoliniani”, e questo, purtroppo, Montesano dimentica di dire: che la sinistra non ha oggi sul fondo idee di sviluppo e di progresso diverse da quelle della destra, anche se restano delle differenze nella gestione, in parte e solo in parte e non grande. Per il momento, la sinistra napoletana sta attenta a consolidare le sue clientele e l’ultima sua grande invenzione – imitatrice d’America anche questa, va da sé – è la fondazione di lobbies. Ha cominciato Amato Lamberti, presidente della Dieci anni di gloria provincia, a convocare con appelli roboanti attorno a sé come lobby e di pressione, per lui base elettorale, una pletora di associazioni del cosiddetto volontariato (ormai dilagate sul territorio a occupare ogni piccolo spazio in attesa di ogni piccolo o grande finanziamento, associazioni di cui conta solo la interna burocrazia e perdono di peso e di senso gli scopi sociali dichiarati); Rifondazione è una lobby, a Napoli, da sempre; e si è precipitato Bassolino a fondare la sua, la più lustra e soddisfatta e sicura di tutte. Sono morti i partiti, si va verso una democrazia presidenziale, e le lobbies sono il modo di riciclare i gruppi di potere locali e collegarli a quelli nazionali e sovranazionali, trasversali. Quante lobbies in Italia, a destra al centro a sinistra e fittamente intrecciate tra loro, ed economiche e sindacali e culturali variamente corporative! e quanta corsa a entrarvi o a fondarne di altre! E quante mafie, camorre, ’ndranghete, e quante mescolanze tra buona e mala vita, quanta amoralità e immoralità politica, sociale, culturale! Finché il modello regge, l’adesione di massa gli sarà garantita, dentro l’unico ceto vincitore e avvolgente della piccola borghesia con laurea e diploma. D ue conclusioni possibili, per noi: La prima è l’abbandono del campo, nella convinzione che la sconfitta delle prospettive di una civiltà migliore non solo sui piani dei consumi sia definitiva, per Napoli e forse per l’Italia. Bisogna saper perdere, e ci siamo abituati. Ma al loro gioco non ci staremo. Resteremo pronti a farci in quattro se ci sarà ancora bisogno di noi pochi “volontari” senza associazioni e senza prebende, ma diffidando ormai di ogni potere, di ogni politica, e anche, è bene dirlo, di ogni sinistra o centro o destra! La seconda, l’interesse che permane per i margini, per le periferie, per i “lontano dal centro”, che a Napoli vuol dire ancora – ma è prevedibi13 le non sempre perché anche qui il modello allarga le sue braccia – disagio, disparità, e in qualche modo novità, come dovunque nelle altre grandi città d’Italia e d’Europa. Di due realtà cerchiamo in quest’opuscolo di dare testimonianza: quella del vecchio ceto che è stato Napoli e ha vissuto il suo centro, e che è ormai scompaginato e cacciato, o corrotto; e quella delle periferie, che è più mobile e vitale di quanto non si pensi, benché oggi sottoposta a dirompenti mutazioni che sono destinate a cambiarne ogni assetto. Le periferie si allontanano, ma non scompaiono, anzi crescono. Il più e meglio che possiamo fare è forse, ancora e sempre, “rompere le scatole”, e cioè affermare il nostro diritto di tener gli occhi bene aperti su ciò che è politica e cultura, nella città E adesso, senza barbari? che pur da nomadi abitiamo e che è il nostro punto di riferimento primario, anche se non più una vera “casa”. Difendiamo il nostro diritto di critica dell’esistente. Continuiamo a “non fidarci degli occhi” e a voler vedere oltre le apparenze, e capire oltre le chiacchiere e oltre la chilometrica kermesse di eventi e altri eventi e altri eventi, talmente quotidiani oramai da meritare il nome di rumore di fondo. Addio, Napoli. E soprattutto, addio trionfante stoltezza dell’immagine, addio politica e sogno di democrazia dal basso. Il mondo cambia e cambierà ancora. Cose da fare ce ne sono tante. Non è più tempo di perderlo, il tempo, appresso al superspettacolo di una città che ha voluto essere uguale a mille altre, nella comunanza della stessa stupidità. di Maurizio Braucci E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? Era una soluzione, quella gente. (Konstantinos Kavafis) I l popolo di Napoli non è più “più popolo di un altro”. Rileggendo saggi e romanzi che tanto fanno archivio della natura proletaria di questa città, ci si accorge che ormai non è più possibile guardare a quelle pagine se non da un’altra sponda, lontane testimonianze di un modus vivendi. Se dal caos della città si levano suonerie di cellulari, rombi di scooters, getti di paraboliche e altri deflussi, che accompagnano grida dialettali e gesticolazioni teatrali, possiamo chiederci se qualcosa è cambiato? Certamente osserviamo delle mutazioni, ma sono tali da trasbordare oltre il normale greto di necessari adeguamenti sociali e farci parlare della fine di una certa condizione? Credo di sì, che si possa e anzi si debba provare a farlo. Il sospetto che ne viene è che il proletariato, popolo più popolo che altrove, sia in definitiva estinto. 8 ottobre 2001. In un parco del centro storico napoletano si mettono in scena, per la regia di 14 E adesso, senza barbari? Mario Martone, I dieci comandamenti di Raffaele Viviani. Una scelta logistica per far rivivere nel loro alveo naturale e naturalistico le dieci dannazioni di don Raffaele. Grande afflusso di pubblico, da ogni parte della città in prevalenza esponenti della classe medio-borghese, ma si coglie l’entusiasmo e la curiosità degli abitanti della zona popolare. L’intento generoso del regista è che i popolani si riconoscano in scena, che si osservino in un’ambientazione del dopoguerra, che esclamino in pratica “quelli siamo noi” oppure “quelli erano i nostri” a seconda dei casi. In effetti, la partecipazione dei residenti è notevole se commisurata alla loro proverbiale indolenza: essi ritengono di star ospitando sul “loro” territorio qualcosa di importante mentre si dovrebbe trattare di qualcosa che li rappresenta. Eppure l’aria è priva di catarsi, la proiezione di sé è vaga, nebulosa anziché essere immediata e istintiva come ci si attendeva. Gioca forte, invece, un’altra aspettativa: la presenza da alcuni giorni di grossi camion con la scritta Rai, la televisione che riprende l’evento e che lo mostrerà dilazionato attraverso “l’apparecchio per tutti”. I commenti sono per le “brave persone” accorse a vedere lo 15 spettacolo da altre zone della città, una borghesia che raramente si concede qui; per l’attrezzatura della Rai sono prova che qualcosa di “ufficiale” si sta svolgendo presso di loro. Lo spettacolo in sé passa in secondo piano, non è sufficiente, pochi si riconoscono nella matrice dell’opera e, chi cerca in essa un motivo di identificazione, lo coglie senza troppo interesse, già soddisfatto dal riguardo borghese e dall’attenzione televisiva. Due mesi più tardi saranno lieti di riconoscere sul piccolo schermo il parco del loro quartiere, reso bello dalle luci e dall’ingegno scenografico. Un parco che normalmente disdegnano, che vedono come un affronto alla loro privacy e alla abituale struttura ippodamea dei vicoli, covo di schiamazzi e di pericoli, che si rifiutano tassativamente di frequentare per il passeggio, questo parco sarà per una notte luogo di interesse televisivo e borghese, per tornare a essere un corpo estraneo che si farebbe meglio a “spostare da un’altra parte” perché “non ce lo meritiamo”, “perché non lo sanno gestire”, “perché è inutile”. Il Parco Ventaglieri è una delle opere cittadine più belle della ricostruzione del dopoterremoto. Se in passato la napoletanità è stata rappre- sentazione dell’ingegnosa sopravvivenza di una comunità e dei suoi valori, oggi, questa comunità disintegrata prosegue, senza esserne troppo convinta, una recita a memoria di se stessa. Una tradizione di miseria è giunta al termine, ma persistono invece i suoi gesti, le sue parole, in una parodia identitaria che ha abbandonato la solidarietà tra poveri e persino il rifugio della famiglia, sostituendoli con la competizione e il ricatto. Oggi, l’accesso al consumo è garantito a tutti, indipendentemente da quanta parte del reddito venga sottratta alle spese primarie a vantaggio di quelle superflue o accessorie. A Napoli ormai la miseria non esiste più di quanto non esista in altre città, ma permane la 16 miserabilità di una disorganizzazione del vivere e del gestirsi quotidiani da parte dei ceti inferiori, una cultura dello spreco delle proprie risorse di tempo e di energia, in diseconomie dei nuclei familiari per cui, mentre aumentano i beni consumati o posseduti non aumenta l’accesso a servizi chiave dello sviluppo sociale. Finanziarie domestiche, microcrediti, usura e altre forme di dilazione permettono di detenere beni che il consumatore razionale, a parità di reddito, non metterebbe nel suo paniere di acquisti. Come sempre, gran parte di questo virtuale aumento della propensione al consumo viene rivendicato dai giovani e va a pesare sull’indebitamento familiare: abbigliamento, scooters, automobili. A questo si affianca la crescita dell’indebitamento (esistono per questo, talora, anche collaudate modalità di frodo attraverso prestanomi o mediatori che percepiscono parte del ricavato), creando un’illusoria partecipazione ai modelli di vita celebrati dalla pubblicità televisiva e da altri prosseneti del consumismo. L’oggetto di turno genera nel giovane proletario un piacere più entusiasta e nevrotico di quello del piccolo borghese, poiché è vissuto come conquista civile e non solo sociale. Al mondo, la merce soddisfa gran parte dei bisogni d’identità delle masse e, in un contesto come quello napoletano ad alto tasso di disoccupazione giovanile, le cose acquisite dai giovani dei ceti bassi, a scapito dell’equilibrio economico familiare, riempiono il loro tempo con la celebrazione di quel fatuo con cui la società si è offerta e che essi hanno preso terribilmente sul serio. A queste condizioni, l’inavverata emancipazione crea un maggiore attaccamento a quella tradizionale “cultura di fuga dalla povertà” nata come risposta alle sfide lanciate dalla propria storia. Oggi ne permane un certo patrimonio rappresentativo, privato però della comunità, delle sue relazioni, delle sue regole. Questa “schizofrenia” culturale, che si realizza nella vita quotidiana con una torbida contrapposizione tra mutazione sociale e permanere di vecchi modelli di sopravvivenza, fa ancora percepire, ad esempio, l’illegalità come una prassi necessaria a ridurre gli ingiusti effetti della distribuzione delle ricchezze. Ma nessuno a Napoli “ruba più per mangiare”, il delinquere, oggi, è per la maggior parte motivato dalla brama di benessere e di lusso o cerca di rimediare ai devastanti comportamenti diseconomici ordinari, tant’è che in esso si è smesso di fingere che nessun fine possa giustificare certi mezzi. Così, mentre in passato un proletariato, forte di una cultura unitaria di lingua e di pensiero, viveva le sue tremende sfide nel rifugio di una morale condivisa, oggi i suoi componenti, come quelli del mondo occidentale, agiscono agli ordini di una immoralità privata. Di comune rimane lo spettro di una civiltà regionale, il cui solo effetto è di preservare il colore nelle discrasie delle moderne condizioni di vita. Le piazze del centro storico affollate di giova- ni, deliri di scooters che sfrecciano tra i passanti mentre questi a loro volta si infilano con perizia tra costellazioni di auto parcheggiate e in sosta, cerchi concentrici di comitive disposte intorno ai monumenti, postazioni combinate in base a regole e rituali sociali quasi ferrei, schiamazzi, motori, musiche, accelerazioni, frangersi di bottiglie. Flussi densi e incerti di persone si incanalano e confluiscono da strette vie, contendendole alle auto con grande attitudine alla sopportazione: carne, ossa, vestiti, chassis, veicoli, telai, carrozzerie e rumore, rumore, rumore, in un unico ribollente crogiuolo delimitato da cantoni, facciate di antiche case e meandrici vicoli a ridosso. La zona storica e turistica, che si incunea tra i quartieri di residenza popolare e di antica intersocialità, interdetta ai veicoli durante il giorno, perde la sua carica di zona pedonale a partire dalle ore serali, quando E adesso, senza barbari? accoglie il consumo giovanile del tempo libero. Comportamenti eteronomi della modernità globale si acciuffano con i residui caratteri naturali dei giovani napoletani, usi della città stabiliti dal passato si intrecciano con aspirazioni e disagi di un presente europeo fatto di privilegi e contraddizioni. Quest’area della città fa da sfondo al conflitto tra corpi e veicoli e a quello sociale tra garantiti e non, e mentre questi ultimi si accostano con spirito bellicoso agli utenti dei bar e dei locali, i primi dimostrano indifferenza o cinismo, e la trasversalità delle classi che qui si radunano è mediata dalle nevrosi di condizioni di vita nuove per tutti. La tensione sociale raggiunge i suoi picchi di violenza in quei punti, crescenti, dove l’identificazione con una cultura della reciprocità si sgretola. La storia, un passato codificabile nel linguaggio e nei costumi, trasuda dallo schema urbanistico stringente, lo spazio è insufficiente e il consumo del tempo dunque massificato. Si sta a ridosso degli incontri e degli scontri, degli idrocarburi e del Thc, prossimi al delirio o all’odio. Inevitabilmente due città si fronteggiano in quell’unica che le accomuna: l’indolenza abitudinaria della piccola e media borghesia giovanile si spende nei locali e nei punti di ritrovo in cui celare o ostentare la propria appartenenza mentre il protagonismo catastrofico dei sottoproletari sbandiera e organizza il nulla o l’incidente. In questa commistione di massa serpeggiano le sistematiche incursioni di gang di giovanissimi (15-20 anni) che si organizzano in sella ai loro scooters, provenienti dai quartieri limitrofi o dalle zone periferiche, dopo aver quasi sempre convogliato i loro soldi nell’acquisto di palline di coca, si esercitano sulla folla o contro solitari passanti. Si tratta per loro di spendere la notte secondo le note della noia e dell’alienazione. Rigorosamente maschi, indumenti casual griffati, aggregati nel branco, esaltati 17 dalle merci che possiedono, talvolta armati di coltello, trasportano nelle serate dei week-end il modello degli ultras da stadio. Il loro scopo è turbare (poiché essi stessi sono turbati), di umiliare e se necessario picchiare. Cercano di imporre la loro presenza in contesti che li rifiutano o da cui si sentono esclusi, sbandierando le proprie merci come affermazione sociale, eletti dalla pubblicità a una parità nei consumi a cui non corrisponde niente in termini di diritti e di cultura, mediocri parvenus del disagio sullo sfondo del cinico moralismo generale. Noia, nevrosi e una cultura della forza e dell’astuzia compatibile con le droghe eccitanti modellano il comportamento di questi giovani dentro la schizofrenia del loro ambiente sociale di appartenenza. Sono i figli di una breve estate del benessere dovuta agli affari illeciti o alle chimere dell’indebitamento, hanno assaporato un’agiatezza estemporanea e ne sono stati corrotti senza avere alcuna difesa, dai loro padri hanno appreso l’avidità, dalle loro madri il disordine, dai loro amici un narcisismo sfrenato. In un’apparente coerenza, questi elementi vengono tenuti insieme dalla lingua, emblema della loro cultura, ma una lingua sempre più privata, in cui si va interrompendo la funzione di trasmissione di valori. Confusi dalla cocaina e dalla velocità, disinteressati anche ai diktat del mass cult, preparano la strada al dolore della maturità, quando dovranno accettarsi per il loro non contare niente. Ma intanto non si può che “lasciarli fare” poiché nulla intorno è di un’integrità tale da fargli giustificare una variazione in corso d’opera, che del resto non avrebbero la forza di realizzare e che il contesto gli impedirebbe. N apoli è da sempre due città: quella del dialetto e quella della lingua, con un largo territorio intermedio che autoregola i suoi processi di valicamento sociale. La prima città adopera 18 naturalmente il linguaggio che rappresenta la sua vita quotidiana, la seconda cerca di ricollocarsi linguisticamente in un panorama più ampio, anche extranazionale, e di sfuggire una realtà che ha generato codici e valori autonomi. La Napoli decantata da Pasolini e definita da Elsa Morante una grande civiltà si è sviluppata come comunità chiusa, autonoma, ma capace di metamorfosi e di rielaborazioni che le hanno permesso la sua persistenza in termini di cultura e identità. Dalla sua cultura di fuga dalla povertà, essa ha capitalizzato un patrimonio di risposte alle sfide esterne che ha saputo tenere in equilibrio per secoli questa comunità su un codice ferreo, stratificato e complesso: “Era l’assoluta naturalezza con cui i napoletani vivevano questo codice che li rendeva stranieri al potere e a chi in qualche modo vi appartenesse. Si trattava di un universo ‘reale’ dentro un universo che, rispetto a esso, era ‘irreale’: anche se questo secondo in realtà rappresentava il logico corso della storia. Il rovesciamento di prospettiva del napoletano che vede il mondo dall’interno del suo universo reale ma astorico, è uno scacco della storia.” (Pasolini, Uomini colti e cultura popolare). È chiaro come questa anomalia dovesse essere percepita all’esterno come carattere essenziale della civiltà locale, divenendo poi, nel bene e nel male, l’idea comune della napoletanità. A dispetto di una borghesia che, mentre era incapace e disinteressata ad assumere un ruolo sociale attivo sul territorio, si ribadiva ben disposta a farsi europea anche per non identificarsi con quell’universo “reale e illogico” che l’avrebbe privata dei suoi privilegi, della sua lingua e della sua ambizione al potere (in pratica, del suo senso). La lotta di classe napoletana è stata caratterizzata anche dalla sfida delle classi non proletarie per affermare il proprio privilegio sociale sul piano culturale, di fare in modo che davvero la cultura dominante fosse quella di classe. Tolta la bellezza della natura che, fino al trionfo dell’industrializzazione, apparteneva a tutti, l’attenzione dei visitatori stranieri che hanno scritto di Napoli è sempre caduta sui suoi aspetti popolari, ignorando il ruolo della borghesia locale che infatti talvolta si è ricavata un ruolo di anfitrione che le è poi rimasto. Questo ha generato spesso la reazione rancorosa degli intellettuali locali che inscenavano, su tale volontà di potenza frustrata, la tragicommedia del conflitto tra Ragione e Natura. Lo spettacolo della plebe napoletana ha da sempre minacciato l’identità della borghesia, tant’è che il rinascimento recente, datato con l’ascesa di Bassolino, ha badato bene a cancellare il centralismo dei proletari (che intanto lo erano sempre meno) dall’immagine cittadina, di rifare il look alla città secondo i valori e gli emblemi del ceto medio. Tutte le parole d’ordine di normalità, legalità e vivibilità celavano le aspirazioni borghesi di riappropriazione di un territorio su cui mai avevano potuto dominare e che invece ora potevano provare a ridisegnare col consenso degli stessi abitanti dell’altra città. Il tentativo di amministrare una trasformazione nel prevalere di una rivalsa civile è stato uno degli atti più stupidi che la borghesia abbia mai tentato, con un effetto peggiorativo che oggi sta sotto gli occhi di tutti. Dall’esercizio del potere, la borghesia ha saputo ricavare nell’ultimo decennio un savoir faire amministrativo e politico tale da iniziare finalmente quella normalizzazione così essenziale al suo prestigio e alla sua identità. Lo scopo era di portare il territorio verso dinamiche di sviluppo e di modernizzazione equivalenti a quelle nazionali e cioè globali, di allinearsi alla norma della borghesia metropolitana italiana e oltre, generando contraddizioni e limiti che potessero essere ammortizzabili dentro il costo di un modello sociale più ampio, meno imputabili agli amministratori locali. Nella prima metà degli anni Novanta, a Napoli, la gestione della modernizzazione è diventata impresa E adesso, senza barbari? dell’Amministrazione Comunale, rispecchiando in tal modo la visione della priorità della categoria politica su tutte le altre. Ma è stato un errore, pagato caro, ritenere che ciò che avveniva in modo collettivo e diffuso dovesse fermarsi nella forma politica che la trasformazione stava avendo, cioè nei suoi risultati elettorali. Sia perché la politica non poteva fare scelte che fuoriuscissero dalle logiche del consenso e del mantenimento del potere, sia perché un solo piano d’azione non poteva sostituirsi a quelli dei tanti gruppi e persone che avevano cooperato al mutamento. La classe politica ha perso di vista, al solito, il suo ruolo di stimolo delle migliori forze umane in gioco, per le quali vi era una innegabile esigenza di potenziamento e di formazione. L’obiettivo di “normalizzare” la vita quotidiana è l’effetto di una visione megalomane che possa soddisfare le esigenze identitarie e politiche dei ceti che si sono trovati, per affinità o direttamente, al potere. Il tema della normalizzazione ha ridotto la questione della trasformazione al solo piano tecnico e burocratico, azzerando l’aspetto culturale (l’insieme dei valori). Alla fine, le possibilità di trasformazione, fiorite dal basso in modo molteplice, sono state sequestrate dalla politica, con la convinzione che il dominio di pochi fosse una condizione risolutiva. Bisogna chiarire che dire oggi che il popolo napoletano non è più “quel popolo” non significa che non esiste più un proletariato o che i fenomeni della povertà si siano del tutto dileguati. Bisogna tener conto degli effetti di una collocazione della città in un panorama di sviluppo economico e sociale voluto dalla classe politica per soddisfare i propri bisogni di adeguamento storico, e certamente il livello del benessere è aumentato (siamo pur sempre nel mondo occidentale dei privilegiati) e parte del proletariato è oggi leggibile come piccola borghesia. Più del benessere è però aumentato il consumo e la propensione a esso da parte dei 19 ceti bassi, come del resto la perfetta orchestrazione tra televisione e merce ha saputo disporre, mutando nel profondo i codici culturali e trascinando i napoletani poveri verso la schizofrenia di cui si è parlato. Anche quella cultura della povertà, per la quale l’indigenza era vista come un accadimento fatalistico che poteva riguardare ogni membro della comunità e dava vita perciò a una spontanea solidarietà tra gli individui, cede il posto a una idea della povertà come inabilità economica, e quindi come giusta punizione sociale. Il popolo e la sua cultura, pur permanendo formalmente, hanno smesso di essere quella “tremenda alternativa” alla modernità di cui scrisse Pasolini, divenendo oggi vuoto rumore e gesti senza azioni. Francesco potrebbe chiamarsi anche Ciro ma non sarà mai un elemento di spicco di nessuna parte della società, legale o illegale che sia. Francesco (o Gennaro, se volete) è un ragazzo legato a doppio filo alle prospettive della sua famiglia, una famiglia napoletana del ventunesimo secolo, stretta tra un’era che finisce e un’altra che va. Francesco ha 23 anni e il peso di una cultura molto strutturata per cui la vergogna è più temibile della colpa, e in cui l’apparire è da secoli la chiave delle relazioni sociali. A Napoli, città che sta cambiando mentre è già cambiata, ragazzi come Francesco vivono in un conto alla rovescia di cui la società ha premuto lo start e che trova accelerazione e alimento nel loro istinto di autodistruzione. Oggi quello che questa gioventù consuma è acquistabile sul mercato, quello che le rassomiglia appare sugli schermi tv e questo gioco narcisistico che banalizza le energie del futuro, quando si imbatte in contesti contraddittori pieni di vitalità e di dolore come sono ancora i bassifondi napoletani, può diventare una rapida roulette russa secondo le regole di un degrado metropolitano “moderno”. Francesco è un ragazzo non solo fragile, infran20 to dalle botte ricevute in famiglia, unico riparo di affetti ma anche di ricatti e catene, piegato da un genitore difficile che ha forgiato un ragazzo altrettanto difficile stretto oggi tra cocaina, furti, galera e un autolesionismo giunto a vari tentativi di suicidio. Ciò che dà ritmo alla sua gioventù incendiata sono solo i soldi, i soldi che servono ad acquistare e non a mettere su o a capitalizzare, i soldi che devono essere spesi parlando lo slang dialettale del quartiere, a una spanna dalla camorra senza mai appartenervi, ma sapendone abbastanza da poter evitare guai durante i propri illeciti. Sono i soldi per comprare vestiti, scooter o auto, serate dispendiose a “pariare” (divertirsi) e tanta coca, coca, coca che oggi a Napoli è la droga del maschio bianco ghetto-style. Il suo è un ghetto culturale, dove il consumismo ha fatto completamente presa sui giovani, dove i valori tradizionali legano alla certezza del passato ma incagliano ogni manovra strategica verso il futuro, mentre la modernità si impone con le sue mode improvvise e tiranniche, creando salti comportamentali ipocriti e schizofrenie tutte determinate dal e rivolte al consumo. Ofanità è una parola inventata a Napoli, che sempre è stata riferita a quel “pare brutto” della morale partenopea da commedia di Scarpetta, ma oggi ofanità è il “pare brutto” riferito alla povertà, è la necessità di sembrare, di apparire, potenziata dai soldi e dalle proposte confezionate del mercato. Per i giovani è questa la spinta vitale, il senso di affermazione che a Napoli diventa reazione alla molteplicità degli stimoli, molti dei quali conflittuali, portati dell’ambiente. Bisogna avere soldi, poter spendere, con voli nel lusso di un momento, lasciando gli interessi agli usurai o alla prigione di Stato, nulla mutando nel proprio patrimonio culturale e morale poiché esso conferisce appartenenza e identità a chi è inadeguato di fronte alla modernità e può entrarvi solo come consumatore. Ma i giovani dei bassi di Napoli non vi entrano come i neri dei ghetti americani, emarginati da un centro che li domina, essi rassomigliano a quei giovani metropolitani delle banlieues parigine che recano con sé il ricordo e la rabbia di un’identità araba, contrapposta a quella europea, come ideologia di una diversità non accettata. Anche se a Napoli è più la ferocia che la rabbia a regolare le tensioni nelle zone calde, esiste un equivalente peso del passato, un patrimonio di codici che accompagna l’esordio dei giovani nella massa dei consumi occidentali. Tali codici sono serviti per un millennio alla sopravvivenza di un popolo cittadino (e regionale) in risposta alle continue sfide di invasioni e malgoverni, con una capacità di mediazione che ha sempre mirato a soddisfare le proprie ortodossie estetiche e morali, cedendo alla controparte la conduzione della Storia. Ma tali codici diventano oggi il punto di scontro con chi a queste conquiste socio-economiche è approdato con maggiore gradualità e protagonismo: gli abitanti dell’altra città. Perché se Napoli è almeno queste due città, ambedue cercano di imporsi a scapito dell’altra o si ignorano profondamente. La prima è privilegiata, minoritaria ma legata a un ben più vasto ambito di informazioni e di risorse, mentre l’altra è precaria ma pur sempre forte della sua autoreferenzialità culturale. È in questa seconda città che Francesco risiede con la sua storia, è qui che si ambientano le sue corse verso il nulla, adornate di orpelli che celano il vuoto di possibilità e di ambizioni. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli ci sono regole fisse ma senza che nessuno le imponga, non sono le regole dettate da un clan, sono quelle sperimentate da una comunità in cui ognuno ha fatto dell’altro un fattore fondamentale per vedere se stesso. E Francesco viene educato in una famiglia a pezzi, in cui non mancano le botte per tutti e magari le improvvise riappacificazioni, in cui nessuno spiega ai bambini cosa fare e come farlo, ma lascia che essi vedano cosa fanno gli E adesso, senza barbari? altri bambini del vicolo. A casa sua Francesco non ha alcuna garanzia, alcuna intimità, gli affetti sono dati per scontati e raramente praticati, nella sua famiglia c’è un vincolo invisibile (e, in realtà, inesistente) che lega l’uno all’altro e tutti poi alla comunità intorno. E al di sopra di questa comunità non vi è nulla se non un contesto nebuloso, incerto, di cui diffidare poiché non ha corpo, non è vicino e non parla la stessa lingua. Questa stretta rete asfissiante, chiusa e impenetrabile dall’esterno, indigente ma spinta al consumo per reagire a quel senso di morte che l’accompagna, questa rete è un contesto adatto per il malaffare e allora Francesco può mettersi d’accordo con il clan per vendere coca nel quartiere, chiedendo il permesso al clan e cedendogli una quota perché “mio padre sta in galera e la famiglia ha bisogno”. Ma la famiglia è un pretesto, i soldi servono alla propria gioventù senza futuro. Si va avanti a creare relazioni insufficienti, con dentro il dolore di sapere di avere imboccato una direzione sbagliata perché somiglia a quella di chi picchia Francesco da quand’era bambino e che se ora non lo può fare è solo perché spesse mura di cemento lo separano dal resto del mondo. E questo dolore si fa tormento, perché ragazzi come Francesco hanno una grande sensibilità, hanno l’amarezza di chi ha subito conosciuto cosa vuol dire “stare sotto” e patire. L’unica terapia comprensibile resta per lui la droga, la coca che ben si sposa con quel senso di potenza che la propria comunità richiede per affermarsi: e allora venderla, consumarla, sottraendosi allo sguardo delle auto azzurre che sfilano ogni tanto nel quartiere a sirene spiegate. In questo modo si fanno tanti soldi, quanti mai se ne sono visti e mai se ne vedranno con un lavoro onesto, se pure lo si trovasse per miracolo. Giungeranno, invece, le auto di proprietà dello Stato e delle robuste manette e un magistrato che magari, alla terza occasione, si farà inflessibile. E tanto astuta è quella comuni21 tà da cui Francesco viene, che anche il carcere, che le appartiene come luogo mentale, diventa un valore, un elemento del proprio curriculum utile a costruire identità per chi un’identità deve cercarsela tutti i giorni. Il carcere non ha ovviamente nessun effetto correttivo, rinchiude per un certo periodo un corpo tra mura dove le regole sono le stesse del ghetto, dove la vicinanza forzata con gli altri dà vita a strategie terribili e codici folli. Da lì si entra e si esce, in una inesorabile statistica, aspettando ennesimi mandati, pendolando quel corpo tra il ghetto e il carcere, tra il carcere e il ghetto. Eppure, conoscere Francesco significa conoscere un pezzo di storia, conoscere una maschera forgiata da tante esperienze pesanti, un corpo piegato da infinite negazioni. Conoscere Francesco significa conoscere ciò che la società ha fatto di un ragazzo e che lo stesso ragazzo ha continuato a fare di sé, significa avere davanti due occhi veri che inquadrano il mondo alla ricerca di un bene di cui ha sentito vagamente parlare senza mai sperimentarlo. Nella realtà il suo corpo è carne da macello, e forse un giorno sarà lui stesso a provvedere, mentre oggi resta schiacciato nelle porte di una fortezza per privilegiati che si asserraglia sempre di più nel suo angolo, illudendosi che così il male resti fuori per poi scoprire che il vero spettro sta all’interno e continua a mietere vittime. Eppure Napoli è una città che cambia, in fondo è già cambiata e si è quasi messa al passo con le tendenze tipiche delle metropoli italiane. L’inizio di questa trasformazione è datato con la prima affermazione della giunta Bassolino nel ’93, con l’inaugurazione della legge dell’elezione diretta del sindaco, con il partito dei sindaci che parve inaugurare una gloriosa stagione per alcuni comuni del sud. È innegabile che dal punto di vista tecnico una classe dirigente più responsabile sia riuscita a strappare il testimone alle bande di quel malgoverno che a Napoli era diventato modello e costume, ma è innega22 bile allo stesso tempo che il suo affondo nella condizione sociale e culturale sia stato molto timido o solo delegato alla generale modernizzazione garantita dal generale sviluppo. A Napoli “il rinascimento” ha significato un politico di razza ma dei blandi amministratori, chiusi dentro un sistema che consuma per il proprio mantenimento al potere parte dei vantaggi ottenuti dal consenso della collettività. La ricerca del consenso è andata quindi a scapito di un oculato uso delle risorse politiche, economiche, sociali e culturali, nel tessuto ostico della città, alla luce della quale l’accusa di aver svolto pure operazioni di facciata (la cosiddetta politica di immagine) non è data dal prevalere di canoni spettacolari e mediatici, per le quali le amministrazioni succedutesi in quasi dieci anni hanno sempre trovato condiscendenza e comprensione, ma per aver vincolato i vantaggi di queste manovre in primis alla propria immagine e alle esigenze di mantenimento del potere, e solo in secondo luogo a quelle di una saggia amministrazione. Questa accusa è valida per tutta la politica e per tutti i suoi uomini, è lo stesso meccanismo politico-elettorale che la porta con sé. Ma per un contesto così complesso e stratificato come quello napoletano, questo vincolo è risultato troppo condizionante. In pratica, la necessità di ampliare o mantenere alleanze e carriere politiche, il luogo comune della priorità di consenso di alcune categorie (commercianti, lobbies finanziarie eccetera), la natura burocratica degli apparati tecnico-amministrativi rivolta alla propria salvaguardia, la qualifica politica o mediatica, più che progettuale, di gruppi e associazioni operative, la pletora dei clientes e dei questuanti insieme ad altri contingenti fattori hanno smussato la punta dei progetti, pure presenti e tenuti in conto, intesi a perforare il tessuto sociale. Ne è conseguito, con rare eccezioni, che le politiche mirate al rinnovamento socioculturale sono giunte alla fase realizzativa dopo troppe mediazioni e troppe polarizzazioni interne che le hanno allontanate e intimidite rispetto agli obiettivi. Tali politiche sono state poi misurate con troppe concessioni alla loro spendibilità in termini di consenso e di immagine per i loro promotori e attori, sacrificando la valutazione delle loro effettive incidenze sulla società e trascurando di tastare il polso agli utenti meno garantiti. È mancata (e oggi non sorprende più questa mancanza) quell’assunzione di rischi che, se da una parte può disinteressare talune categorie dominanti, dall’altra può avere effetti moltiplicativi di consenso sul lungo periodo proprio su quelle basse fasce, a Napoli assai consistenti, oltre chiaramente a un guadagno etico e civile. Tuttavia, se oggi Napoli è alla sua terza e consecutiva amministrazione di sinistra è perché E adesso, senza barbari? essa ha lavorato per il mantenimento del consenso attraverso tattiche e alleanze, logorando però questa strategia nell’irrisolta questione di quei ceti ancora lontani da una condizione di emancipazione, continuando a regalarli al populismo di una destra che a Napoli è molto più di destra che altrove. Se la vittoria della sinistra a Napoli fu salutata come inversione di tendenza ma anche come speranza di moralità dentro un contesto amorale o immorale, oggi la mutazione culturale del popolo (cioè dei bassi ceti, ma non solo) è stata affidata alla sola modernizzazione dei consumi. Questioni morali e culturali (in senso antropologico) sono state tarate dal desiderio di rivalsa della classe media, e, in generale, la ricerca di trasformazione ha avuto un segno solo materialistico e autoreferenziale. 23 Dai margini di Giovanni Zoppoli L a progressiva privatizzazione dello stato sociale portata avanti in questi anni dai governi nazionali ha ridisegnato analisi, progetti e pratiche cittadine. La delega al privato di interi pezzi dell’intervento pubblico ha spesso consentito di raggiungere sacche del disagio e qualità del servizio prima sconosciuti. Negli anni Novanta le associazioni, le cooperative sociali e le altre aggregazioni sociali hanno preso a sobbarcarsi di un lavoro quantitativamente e qualitativamente molto grande, dove non era più possibile un impegno part-time. In crisi sono stati messi soprattutto i gruppi storicamente improntati sul modello volontaristico, associazioni cattoliche o centri sociali occupati che fossero. Il requisito principale per occuparsi di “sociale” è diventato sempre più l’essere ferrati nella burocrazia e nelle reti di potere, rendendo velleitario ogni tentativo di fare comunità. Molte sono state le piccole associazioni (anche quelle radicate e antiche) che in questo decennio hanno dovuto scegliere tra lo snaturarsi o il morire. Spesso sono state costrette ad affiliarsi ad altri enti meno attenti alla sostanza, ma che Dai margini precedentemente erano stati più accorti nello scegliersi le relazioni “giuste”, nel maneggiare adeguatamente la burocrazia, nell’acquisire insomma maggiore dimestichezza con le leggi del mercato della miseria e dell’emarginazione. C’è chi (in pochi) è riuscito a mantenersi integro trasformando il proprio impegno civico anche in attività lavorativa remunerata. E chi nella ricerca dichiarata della purezza ha finito per degenerare in una sfrenata schizofrenia. Tutto questo a Napoli ha assunto connotati esasperatamente tribali, per la storica faziosità (di stampo familistico prima che aziendale) dei suoi gruppi. E quando ormai la simbiosi tra partiti e terzo settore aveva raggiunto livelli di asfissia irreversibile, le vicende si sono fatte ancora più intricate per la rappresentazione collettiva di “roccaforte della sinistra” che si è data del governo cittadino (in una città dove la destra riesce a essere addirittura più becera e criminale di quella nazionale). Fatto sta che a Napoli a un certo punto è sembrato che l’unico modo di concepire il cambiamento fosse quello che passa per le associazioni e per il sistema 25 che le tiene in vita, quello dei finanziamenti pubblici, dei progetti formali, dei bandi. Quello del “servizio” e dell’“utenza”. Del resto con la scomparsa di industria e agricoltura per l’economia cittadina oltre a turismo e servizi non rimaneva molto altro. Negli ultimi tempi i movimenti nati attorno ai temi della globalizzazione hanno contribuito a riportare al centro del dibattito cittadino approcci e questioni ormai accantonate, rendendo ancora più marcata la distanza tra le ricette internazionali e le pratiche locali di molti politici napoletani. Per riprendere un filo a noi è stato utile cercare il collegamento tra chiaccherate fatte nell’ora di spacco con contrabbandieri nostalgici, maestre perseveranti, ribelli indomiti, abitanti corsari, coloni arricchiti… Componendo ragionamenti e ripartenze attorno a quanto ancora determina esistenze individuali e collettive. DISMISSIONI Del contrabbando, dell’industria, delle fabbriche Contrabbando Andata. Prendiamo la tangenziale. In macchina oltre a me e a un ex contrabbandiere c’è Lucia, una ragazza sui 40 anni dalla vocina stridula che viene dall’Ucraina. A mille metri dal casello di Pozzuoli l’ex contrabbandiere tira un sospiro, “Basta che arrivo qua e già comincio a respirare. Non senti com’è diverso?”. Arriviamo in una villetta del litorale Domizio, dove l’ex contrabbandiere vive con la sua famiglia da oltre dieci anni. Lucia va al piano di sopra e noi scendiamo giù, in tavernetta. Il racconto. Sono entrato nelle sigarette con un gruppo di persone con cui ero uscito di galera. Di stare sotto a un padrone non c’era voglia e così andammo da certa gente che conoscevamo 26 a Posillipo. Gli dicemmo: “nui vulimmo fà ’e sigarette”. Era l’83. Così entrammo nelle sigarette. Noi eravamo un gruppo che faceva politica. Altri contrabbandieri se li spendevano nei locali i soldi. Noi aiutavamo i compagni in carcere. Là c’erano i comitati di lotta. Lotta Continua, i Nap, Autonomia Operaia… Molti contrabbandieri ne facevano parte. Tu considera che in ogni quartiere a un certo punto c’erano almeno dieci realtà di base, tra Pci, Lotta Continua, Anarchici... Chi ci viveva nei quartieri era in qualche modo orientato da questi centri e il contrabbando era il modo che molti avevano trovato per non stare né sotto al padrone né dentro alla Camorra. Insomma mettemmo un piccolo capitale e cominciammo a lavorare con le sigarette. In Svizzera si facevano le contrattazioni tra le case produttrici come la Philip Morris e gente potente di Napoli che comprava le quote e le portava in Yugoslavia. Una volta che le casse di sigarette erano arrivate in Yugoslavia piccole strutture autonome, come la mia, compravano il proprio carico e lo sbarcavano in Puglia. Sulle coste della Yugoslavia c’erano delle vere e proprie colonie di napoletani, molti erano latitanti. E che si fidavano di fare! Loro l’hanno inguaiata la Yugoslavia. Una volta che il carico lo avevi comprato era il tuo, nel bene e nel male. Quella del contrabbando era un’organizzazione molto complessa: c’era chi portava gli scafi, chi commerciava all’ingrosso, chi al dettaglio… Chi vendeva, chi comprava, era proprio un mercato. Dalla Puglia a Napoli sull’autostrada succedeva di tutto. A volte la Finanza buttava il sale, a volte ti trovavi a scappare a 200km all’ora su una Fiesta modificata. Bisognava inventarsi di tutto, dal finto carro funebre alla falsa autoambulanza, alle altre mille scappatoie che trovavamo. E proprio questo era il bello, una lotta continua dove l’arma più importante era l’ingegno. Attorno al contrabbando lavoravano un sacco di persone, c’era un indotto imponente. In primis le officine meccaniche, che si inventavano le modifiche più strabilianti. I frutti del contrabbando andavano per lo più nell’economia del vicolo ed è su quel tipo di comunità che il contrabbando si reggeva. Prima che la Yugoslavia diventasse il punto di smercio, le sigarette arrivavano a Napoli con gli scafi. E se ti trovavi a Mergellina, anche che non c’entravi niente, davi una mano a scaricare. Era qualcosa di grande, attorno a cui lavoravano almeno mille persone. Io mi sono levato da mezzo quando non mi stimolava più. È stato verso gli inizi del ’90. Vedevo che non c’erano nell’aria più i meccanismi giusti. Le sigarette iniziarono a scarseggiare. Arrivavano sigarette strane dalla Polonia, dalla Turchia. Mancavano alcuni tipi come le Merit. Il flusso cominciava a scarseggiare, lo sentivi a naso. Si cominciarono a fare molte ipotesi. Fino ad arrivare al 2000, quando le sigarette non arrivavano proprio più e i prezzi di quelle poche che c’erano diventarono altissimi. Molti vendevano addirittura le sigarette comprate dal tabaccaio. Quasi contemporaneamente i tabaccai misero le macchinette che permettevano di comprare le sigarette anche di notte e poi i contrabbandieri smisero di esistere. Perciò è finito il contrabbando. Perché le sigarette non arrivavano più. Venivano bloccate già in Yugoslavia. Io penso che le cose là sono cambiate quando si è cominciato a ragionare in termini di guerra e non di politica. E quindi hai capito? La fine del contrabbando non è stato un fatto traumatico, ma una cosa lenta durata quasi un decennio. Tu considera che con il contrabbando potevi arrivare a guadagnare pure 30 milioni al giorno. Molti avevano messo su una vera e propria fortuna e si erano già aperti un’altra attività parallela, legale o illegale. Chi un negozio, chi un bar, chi una produzione di cd contraffatti. La gente ha avuto il tempo di abituarsi. Dai margini Quei pochi che sono andati a istituzionalizzarsi (nei corsi degli Lsu o simili) sono quelli che già facevano oltre al contrabbando altre attività per lo più legali o a nero, ad esempio dipendenti pubblici o lavori in fabbrica. Molti sono andati a lavorare al nord. Altri si sono immessi nel flusso di danaro che è arrivato con il turismo, ad esempio vendendo noccioline e vino sulle bancarelle. Infine, un 20% su per giù, sono entrati a far parte della Camorra o hanno iniziato a spacciare droga. In ogni caso la povertà in questi ultimi anni è aumentata di molto, guardati in giro. È una cosa di cui ci accorgeremo sempre di più. I contrabbandieri erano una forza enorme. Era una rete formata da mille piccole strutture autonome ma interdipendenti. Era un esercito senza testa. Avevano un senso dell’organizzazione di cui non erano nemmeno loro coscienti. E tutto si alimentava con il tabacco che scorreva dentro le vene. Quando è venuto meno lui è crollato tutto. Un’intera generazione di contrabbandieri, di semiribelli, oggi non esiste più ed è rientrata nei meccanismi di passività, di annullamento della personalità. Ritorno. Lasciamo la tavernetta. Salite le scale, c’è di nuovo Lucia, che in queste tre ore ha fatto le pulizie. L’ex contrabbandiere le dà 20 euro e dopo ci accompagna alla Cumana. Bagnoli Fino a due, tre anni fa a Bagnoli di immigrati non se ne vedevano quasi per niente. Adesso invece durante l’estate, la domenica soprattutto, ucraini e altra gente dell’est fanno quello che un tempo facevano i napoletani. Prendono la Cumana o la Metropolitana e vengono a Bagnoli a farsi il bagno. Sai i napoletani di 30, 40 anni fa? Quelli col ruoto, la pasta al forno, l’ombrellone, un figlio da qua uno da là uno da sotto… Questi sono più sobri, in verità, rispetto ai napoletani. Meno pasta al forno, meno figli. 27 In aggiunta ai napoletani che a Bagnoli sugli scogli continuano a farsi i bagni. Paolo, abitante di Bagnoli Io a Bagnoli ci sono arrivata nel ’76. Una delle cose che contribuì a cambiare la fisionomia del quartiere fu il bradisismo dell’84. Si sentiva il rumore della solfatara e poi la scossa e noi ogni volta scendevamo giù con tutta la classe e aspettavamo che finisse. Il bradisismo però andò a incidere su una situazione che già era di precarietà diffusa. Perché in Italsider i licenziamenti erano già iniziati da qualche anno, molti erano in cassa integrazione e con il cambiamento della fabbrica mano mano cambiava attorno tutto il quartiere. Con il bradisismo le famiglie cominciarono ad andare via da Bagnoli, spesso verso il litorale Domizio spinte anche dalla fabbrica che là gli proponeva di andare. Gabriella Giardina, maestra Molte sono state le cose apparentemente inspiegabili accadute in questi dieci anni. Per esempio il sito dove un tempo c’erano gli stabilimenti dell’Eternit era un’area completamente inaccessibile, inquinata al punto da non potercisi avvicinare. Un anno e mezzo fa, nel giro di sei mesi, il Comune ha dichiarato che era stata bonificata e ci ha fatto il concerto di Pino Daniele. Come si sdogana un’area che fino a qualche giorno prima tutta la città aveva immaginato come pericolosa? Facendo cantare Napule è a Pino Daniele. La memoria della gente si lega agli eventi: là un tempo ci sono stati gli operai morti. Oggi c’è Pino Daniele. Magari comincia un po’ a diminuire il terrore che la sola parola “Eternit” incute. Al concerto è andata un sacco di gente e si è alzato un gran polverone. La Società di bonifica in realtà aveva rimosso i corpi grossi, i tubi e i manufatti in cemento amianto. Ma tu sai che la cosa più pericolosa dell’amianto sono le polveri, che 28 sono volatili e che magari se le trovano sul tetto le signore del quartiere accanto, e nemmeno lo sanno. Nei programmi di Bassolino Bagnoli, da quartiere inquinato e periferico, doveva diventare l’area turistica della città. Quando presentò il suo piano su Bagnoli, in cui si prevedevano innanzitutto lo smantellamento e la bonifica degli ex siti industriali, Bassolino dichiarò che sarebbero bastati i tempi previsti dal finanziamento. E cioè sette o otto anni. Ne sono passati quasi dieci e se lo smantellamento è in parte avvenuto, la bonifica invece si potrebbe dire che non è mai veramente iniziata. Non si vedono segni tangibili di nessuno degli elementi riqualificanti dichiarati all’inizio. Il porto turistico, gli alberghi… Quello che era un muro attorno alla fabbrica è ancora un muro. La gente non sa niente di quanto sta succedendo. Sanno che si sta facendo qualcosa, ma se gli vai a chiedere cosa, ormai non lo sa più. Secondo me una delle occasioni che si è persa in questi anni è stata quella d’inventarsi la Fabbrica della Bonifica. La Bagnoli s.p.a., la società inizialmente incaricata per la bonifica, ereditò alcune centinaia di operai precedentemente impiegati nelle fabbriche dismesse. Dal primo piano di bonifica a quello attuale, che è passato sotto la gestione di una nuova società, la Bagnolifutura, gli operai ereditati sono stati sempre considerati come un fardello scomodo. Non si è mai pensato a un vero programma di formazione nel campo della bonifica dei siti inquinati, cosa che avrebbe consentito alla città di dotarsi di una forza lavoro preziosa. Così la vicepresidente della Bagnoli Futura pochi mesi fa dichiarava ancora con soddisfazione di essere riuscita a mandare a casa altri 70 di questi operai. Alle previsioni iniziali che garantivano la creazione di un migliaio di nuovi posti di lavoro hanno finora corrisposto nuove casse integrazione per centinaia dei vecchi operai. La cosa che lascia maggiormente sconcertati è che opposizione sociale e controinformazione a Bagnoli sono praticamente inesistenti. Rifondazione Comunista, che occupa postazioni di potere (in Città della Scienza come nella Circoscrizione, di cui ha la presidenza) è in piena linea con la maggioranza che governa la città. Anche i pochi comitati di base che esistono si mobilitano più che altro su questioni specifiche, spesso molto private. Sia nell’ultima giunta Bassolino che in quella Jervolino tutto il dibattito politico è stato così dirottato solo sulla questione dei nuovi fondi che dovevano arrivare, e che il Governo non voleva sbloccare… senza mai riuscire a parlare in maniera sostanziale del Piano Urbanistico Esecutivo, cioè di quello che forse un giorno si realizzerà. Almeno oggi sarebbe importante riuscire a evitare quanto è successo fin ora: che il procedere della bonifica serva soprattutto ad attivare i meccanismi di speculazione immobiliare e gli appetiti della camorra. Quando per anni tutti i giorni leggi sui giornali del parco, del porto, degli alberghi… senti ai telegiornali del parco, del porto, degli alberghi… è naturale che le attenzioni del mercato immobiliare si concentrano su quest’area e che tutta la questione rischia di ridursi a qualche metro cubo di cemento in più. Mauro Forte, Collettivo politico Facoltà di Architettura di Napoli Una casa a Bagnoli oggi costa anche quattro volte tanto rispetto a 8 anni fa. Sono le regole del mercato immobiliare che in questo momento stanno incidendo con forza sul ceto sociale di Bagnoli e molta è stata la gente “espulsa”. Gente che fino a un decennio fa viveva in una delle zone più insalubri della città e pagava 200 mila lire al mese, ora dovrebbe sostenere un fitto di 2 milioni e non può permetterselo. Tieni conto che molte case popolari a Bagnoli danno sul mare. So’ case stupende. Bagnoli è comoda per i collegamenti della Cumana e Dai margini della Metropolitana. E poi c’è il mare. Molti erano riusciti a comprarsi la casa popolare di cui erano stati inquilini. Se oggi io immobiliare mi presento a un prepensionato dell’Italsider e per una casa che lui aveva comprato per quattro lire gli offro 300 milioni, il prepensionato secondo te che fa? Se ne va. Con cento milioni si compra una casa a Villaricca, o a Castelvolturno o a Marano e gli altri 200 milioni gli servono a integrazione del reddito o per risolversi qualche problema, per esempio a sistemare i figli. Ma questo è un flusso cominciato oramai da anni. L’effetto annuncio ha cambiato l’intera economia del quartiere. Tu partivi da un costo della vita bassissimo, proprio di uno dei quartieri più popolari di Napoli. Oggi il costo della vita a Bagnoli si è quasi allineato con il centro. Ovviamente, in questo modo, a quello che era prevalentemente un quartiere operaio stanno subentrando impiegati e professionisti. Cioè un ceto medio che a Napoli aveva l’esigenza di restare, o di tornare. Un ceto medio magari anche con discrete possibilità economiche ma che probabilmente nelle zone bene, come Posillipo e via Dei Mille, non ci riesce a stare con comodo, agiatamente. Un ceto insomma consistentemente più alto rispetto a quello storico del quartiere, ma non la Napoli “bene”. Quella sa i posti dove deve andare e Bagnoli non sarà mai concorrenziale con quelle zone là. Paolo, abitante di Bagnoli A oriente Ersan si era imbarcato clandestinamente nel porto di Monravia, in Ghana. Per mesi aveva progettato quella fuga lavorando intorno al porto. Aveva esaminato a lungo tutte le operazioni, i movimenti delle navi. Per il giorno della partenza aveva fatto la sua scorta di provviste. Acqua e biscotti che avrebbe nascosto nelle tasche larghe senza alcun altro bagaglio. La partenza il 3 marzo 2002. Ersan 29 prende posto sulla nave nascondendosi in un container, sulla prua dell’imbarcazione. Dopo 7 giorni di viaggio le provviste finiscono mentre la nave resta in avaria per un giorno intero nelle acque spagnole. Ersan non può uscire a prendere la sua quotidiana boccata d’aria a causa dei marinai. “Quando poi la nave iniziò a muoversi feci il segno della croce”. È il 13 marzo 2002 e la nave attracca nel porto di Napoli. “Io guardo fuori dal container e vedo la grande montagna”. A mezzanotte del 14 la nave attracca. Ersan sceglie il momento più opportuno per uscire dal container e scappa dalla nave. “Non vedendo nessuno scesi nel porto, ma qualcuno mi notò e iniziò a urlare ‘CLANDESTINO!!!’. Allora iniziai a correre nel porto, tra i containers. Scavalcai un muro mentre c’era un altro uomo che mi stava per acchiappare. Dall’altra parte del muro trovai un piccolo fiumiciattolo, lo passai e mi nascosi per un paio d’ore sotto un ponte. Più tardi iniziai a camminare, trovai un altro muro, lo scavalcai ed ero finalmente uscito dal porto. Trovai il percorso dei binari, lo seguii e vidi le intersezioni delle strade, le macchine che correvano, iniziai a sentire freddo. Comunque continuai la mia corsa e mi fermai alla fine fuori a una chiesa”. La fuga di Ersan è avvenuta attraverso via Brecce, già via di fuga per i duemila soldati nolani che secoli fa scappavano da Palepoli per ripararsi nella loro città. L’attuale stato di Via Brecce è quello di una strada fantasma. Perduto il rapporto naturale col fiume che la costeggiava è oggi disseminata dei vari impianti petroliferi in dismissione. Una strada ombra frequentata da camion e prostitute. Costeggiata da depositi di containers. Gli immigrati vengono qua a occupare containers e siti industriali dismessi, più che le case. Stanno quel poco che basta per trovare una sistemazione più decente da una qualsiasi altra parte. Luisa Venruso, Via Margine, tesi di laurea 30 Ponti, binari, sopraelevate, capannoni e residui industriali segnano l’altra area industriale della città, quella più antica, nella zona orientale di Napoli. A differenza di Bagnoli in quest’area non c’è mai stata un’unica fabbrica, ma un insediamento più frammentato e stratificato, con le continue dismissioni e trasformazioni produttive che si sono succedute nel corso di due secoli. È da circa un ventennio che alle dismissioni non hanno più corrisposto nuovi insediamenti. Quando si parla di zona orientale si parla comunque di quartieri molto diversi. Su quartieri come Ponticelli, più che la dismissione industriale ha inciso il fatto di aver potuto offrire in passato una grande quantità di suolo agricolo, quindi libero. Molti abitanti del centro e di altri quartieri sono venuti a viverci, tra disfunzioni amministrative e occupazioni abusive, dando vita alla più grande 167 di Napoli dopo Scampia. Nei piani delle amministrazioni progressiste quest’area doveva in qualche modo conservare la sua natura industriale, puntando su nuovi insediamenti di quella che oggi si chiama industria pulita, cioè un’industria compatibile con un tessuto urbano abitato. Ma questo per il momento rimane solo un progetto. Come il grande parco verde che dovrebbe sostituire il cuore del vecchio insediamento industriale e servire da collegamento con il resto della città. Francesco Ceci, sociologo urbano GLOSSARIO MINIMO Solidarietà A Napoli esistevano circa 8 insediamenti rom da oltre 20 anni. Alla prima giunta Bassolino questi insediamenti creavano essenzialmente due problemi. Duemila persone accampate senza acqua e luce, in baracche fatte d’immondizia, si trovavano in una zona troppo visibile di Scampia e l’opinione pubblica iniziava a farsi pressante. Il piano di riqualificazione del quartiere non riusciva a partire e una delle colpe, si diceva, ce l’avevano i rom: l’asse mediano non apre perché sotto ci sono i rom, l’Università non viene perché sotto alla Metropolitana ci sta il campo nomadi… Dopo 7 anni di inerzia, dopo gli incendi appiccati a uno degli accampamenti per mano di alcuni abitanti del quartiere, nel luglio 1999 l’amministrazione progressista non potè più stare a guardare. Malgrado gli avvertimenti di molte associazioni, Bassolino accelerò la costruzione già iniziata da alcuni mesi, ma bloccatasi, di un megacampo stretto tra un carcere e una strada a scorrimento veloce, sormontato dai tralicci dell’alta tensione e lontano un chilometro dalla prima fermata d’autobus. Un anno dopo circa 800 rom, i più vistosi, vi vennero trasferiti. Non potendo vantare molto altro rispetto al quartiere, in campagna elettorale Bassolino sfoggiò il “primo villaggio rom autorizzato della Campania”, grossa prova di Solidarietà dei cittadini di Scampia e dell’amministrazione comunale verso il popolo rom. Autogestione Una volta costruito, il campo viene completamente abbandonato a sé stesso per oltre due anni, salvo dare qualche centinaio di milioni alle associazioni del terzo settore. Tra i motivi c’è anche quello dell’estrema litigiosità dei partiti di maggioranza che non riescono a mettersi d’accordo e lasciano l’assessorato alle politiche sociali praticamente vacante per quel paio d’anni, il periodo di transizione da Bassolino a Jervolino. Il Comune viene meno a tutti gli oneri di gestione del campo. Bastano pochi mesi perché la polveriera che si è creata esploda. Degenerano in breve tempo relazioni e strutture del villaggio. Quasi una metà dei rom, anche per il clima di panico diffuso dalla Bossi-Fini che incombe, va via dal campo e dalla città dove viveva da decenni. Espulsioni in guanti bianchi, di questo alle giunte di sinistra bisogna dar Dai margini merito (parliamo sempre delle giunte comunali ovviamente, che almeno il coraggio di fare delle scelte l’hanno avuto. Perché Regione e Provincia invece sulla questione rom non hanno saputo fare proprio niente di sostanziale). Serve ancora una volta una tragedia perché il Comune ritorni al campo. Il 6 maggio 2002, durante la festa di S.Giorgio, al villaggio ci sono degli scontri dove due bambini e tre adulti rimangono feriti. La giunta progressista ancora una volta non può più stare solo a guardare. Anche se ora non sa proprio più che pesci prendere. Il responsabile delle politiche sociali dichiarerà: “abbiamo sbagliato ad affidarci all’ ‘autogestione’ come metodo di conduzione del villaggio” (“Corriere del Mezzogiorno”, mercoledì 8 maggio 2002). Partecipazione Ancora i rom La giunta Bassolino accompagnò l’apertura del campo con una delibera chiamata “patto di cittadinanza sociale”. In realtà di questa delibera ne sapeva qualcosa solo il Comune, un paio di associazioni e un paio di rom chiamati a fare le comparse. Non ne sapevano niente né il resto dei rom, né tanto meno i cittadini napoletani. In ogni caso, anche se ne fossero stati messi a conoscenza non avrebbero proprio saputo a cosa partecipare. I primi erano stati nascosti in un posto desolato, i secondi non li vedevano più e il Comune si era volatilizzato. Prima della segregazione nel villaggio autorizzato, su questa questione c’erano stati momenti rari quanto preziosi di attivazione di una parte di rom e di alcune associazioni cittadine. Si erano avviati dei percorsi dentro e fuori ai campi, si erano studiate soluzioni e avanzate proposte. Uno degli effetti più immediati dell’apertura del villaggio è stato il completo annientamento di questi processi di partecipazione. Quel che ne rimaneva è presto degenerato attorno alla possibilità di lavorare nei progetti comunali. I rom 31 più attivi, una famiglia che da mesi denunciava la situazione disastrosa del campo, dopo gli scontri di S.Giorgio fu costretta ad abbandonare villaggio e città. Nemmeno un mese prima questa famiglia era riuscita a incontrare l’assessore alle politiche sociali, Raffaele Tecce, a chiedergli aiuto perché sapeva di essere in pericolo. Quello stesso assessore, in un convegno pubblico organizzato nella Facoltà di Architettura (Le rose di giugno, 8 giugno 2002) incalzato dalle domande sul perché si fossero lasciate degenerare a quel modo le cose nel campo e perché nessuna tutela fosse stata garantita a questa famiglia, dichiarò: “Sono contraddizioni interne al popolo che vanno risolte dal popolo stesso”. Racconti del Com.p.a.re Partecipazione 2 La guerra delle piazze “Piazziamoci” è un coordinamento formato da una ventina tra associazioni di base, scuole, comitati, parchi privati, nato sull’onda di un convegno sulla sicurezza organizzato a Scampia dal Dun (Dipartimento di Urbanistica di Napoli). In quel convegno ci dicemmo che oltre ai grandi piani di riqualificazione era possibile tentare delle operazioni più piccole ma più coinvolgenti, che potevano realizzarsi in tempi relativamente brevi, con spese non eccessive e la partecipazione della gente. Con il Dun individuammo uno spazio e pensammo di cominciare da quello. Là c’era parecchio passeggio e l’idea era di progettare e costruire in quello spazio una piazza assieme alla gente. Scampia è strana perché ci sono delle forme di aggregazione, ma sono tutte chiuse. Ci sono scuole che magari lavorano fino alle 10.00 di sera, però dentro. Le parrocchie che lavorano parecchio, attività frenetiche, ma dentro, sempre dentro. Noi avevamo bisogno di luoghi di aggregazione spontanea e i luoghi per l’aggre32 gazione spontanea sono le piazze e le strade. A Scampia le uniche piazze che esistono sono quelle dello spaccio di droga e le strade sono delle autostrade a cui manca la segnaletica. Ci sarebbe la villa Comunale, ma quella chiude alle 17.00 e poi non ci va nessuno. Così ci mettemmo a lavorare a quest’idea della piazza, che chiamammo “La piazza dei Giovani”. Facemmo un’assemblea a cui invitammo anche il Comune. L’amministrazione non aveva capito bene quello che gli proponevamo e venne con tutte le carte del piano di riqualificazione, che voleva spiegarci tutte le cose che erano in cantiere. Noi ascoltammo e poi cambiammo il tiro, riuscendo in qualche modo a fargli accogliere il nostro progetto e a strappargli un impegno. Da quel momento concentrammo tutte le nostre attività in quello spazio. Per oltre un anno lavorammo con scuole, associazioni, parchi e le altre realtà del territorio per far passare quest’idea della piazza. Parallelamente il Dun (a cui il Comune aveva commissionata una serie di cose a Scampia, tra cui questa) portava avanti nelle scuole la progettazione partecipata dello spazio, realizzando con i bambini disegni e plastici. I risultati di questo lavoro vennero presentati il 4 luglio. Aldo Bifulco, Comunità di Base del Cassano, circolo La Gru Prima dell’estate scorsa, un anno fa ormai, avemmo l’incontro con l’architetto Martinelli, preposto dal Comune a seguire il piano di riqualificazione del nostro quartiere. Ci illustrò quello che si prevedeva che si sarebbe realizzato anche in tempi piuttosto brevi. Ci disse che loro stavano già intervenendo su un’altra area, tra la Villa Comunale e la Metropolitana. Là avevano intenzione di creare un’altra piazza, “La piazza della socialità”. Avrebbero realizzato un lungo percorso, una sorta di passeggiata, con una serie di servizi e uno spiazzo appunto chiamato piazza della Socialità. Nelle loro intenzioni su questa “passaggiata” sarebbero sorti anche negozi di un certo pregio, visto che a Scampia fino a ora ci sono quasi solo alimentari. Capii che nella piazza della Socialità volevano realizzarci anche una sala cinematografica. Noi ne abbiamo già una comunale, all’interno del complesso che ospita anche la sede della Circoscrizione. Esiste da oltre dieci anni ma non sono mai riusciti a metterla in funzione. A ogni modo questa piazza se la stava costruendo il Comune, senza nessun dichiarato intento partecipativo. Poi Martinelli ci parlò di un’altra piazza ancora che si doveva realizzare, alla testa della Villa Comunale. Un paio d’anni fa su quello spiazzo c’era stata un’altra iniziativa, anche questa guidata dal Dun, coinvolgendo i bambini delle scuole nella realizzazione di plastici e disegni perché si orientasse l’amministrazione nella realizzazione di quella piazza. Il lavoro didattico fu tutto realizzato e consegnato alle autorità, ma anche di quella piazza non se n’è fatto ancora niente. Ora sembra che gli abbiano dato una destinazione, ma totalmente sganciata dal progetto urbanistico che era venuto fuori con i bambini. La “piazza degli eventi” dovrebbe chiamarsi questa qua. Noi stemmo ad ascoltare, poi ricominciammo a insistere per la nostra piazza, perché il Comune realizzasse quello che era uscito dalla progettazione partecipata. Avevamo investito energie, sollecitato speranze, motivazioni. L’architetto alla fine ci disse che sì, questa cosa poteva partire anche di lì a pochi mesi, sempre che avessimo avuto da parte dell’amministrazione l’impegno a mettere in bilancio questa spesa. La possibilità c’era. Allora noi prendemmo contatti anche con la Circoscrizione, con l’assessore. Tanti sì, sì, sì... e poi invece il bilancio è passato senza la nostra voce di spesa. Se ne parla per il prossimo piano finanziario, ci dissero. Adesso abbiamo ricominciato a bussare di nuovo, ma risposte non ce ne stanno. Noi non abbiamo Dai margini altri strumenti se non quello di cercare di far prendere impegni solenni alle amministrazioni nei momenti pubblici. Non abbiamo mollato la presa. Ernesto Mostardi, “Fuoricentro Scampia”, periodico on-line SCAMPIA È il quattro luglio 2002. Nella sede del Dun si presentano i risultati della progettazione partecipata fatta con il Coordinamento Piazziamoci. Il responsabile del Dun lamenta l’assenza del committente del progetto, il Comune di Napoli. Tutto il lavoro viene sapientemente illustrato ma c’è un problema. Mancano i fondi per realizzarlo. Un signore sui sessant’anni si alza. Ha un gilè e un aspetto composto e morigerato. Diventa rosso in volto e si sfoga: “Basta, sono vent’anni che ci studiate addosso. Vi ringraziamo, ma adesso basta, per favore basta!” Una Vela Io credo veramente che a noi ci devono fare solo una puntata di Quark addosso e poi stiamo a posto! Veramente delle Vele hanno vivisezionato proprio tutto. Ti dico la verità. Io dei miglioramenti nel primo mandato Bassolino li avevo visti anche a Scampia. È chiaro che c’è stata l’urgenza di fare il centro di Napoli, però di riflesso qualcosa si è vista pure qua. Tipo che sono aumentati i pullman, hanno finalmente finito la Villa Comunale che andava avanti da vent’anni (che poi non ci va nessuno alla Villa Comunale, ma questo è un altro discorso). In breve tempo quella cosa che era la Metropolitana e che tutti ormai dicevano che non esisteva veramente, l’hanno finita. La Metropolitana che sta a Scampia quando venne aperta la gente diceva: “qua 3 giorni e salta tutto”. Invece guai a chi la tocca, ce la si difende quotidianamente e con i denti. 33 Io abito nelle Vele dal maggio dell’80, quindi prima del terremoto. Poi è venuto il terremoto e di fronte al terremoto che ci vuoi fare? Però mò so’ passati vent’anni e stiamo ancora a quel livello là! La mia è una delle Vele che non hanno buttato giù e all’interno ancora non ci sono gli ascensori, non arriva la posta, non ci sono le luci. Il caso vuole che al 16° piano ci abitano per lo più persone anziane che o se la fanno a piedi o rimangono reclusi a vita. Io la mattina scendo, vado a lavoro, torno a casa la sera. Siccome noi facciamo tutti quanti questo, a casa mia non ci sta mai nessuno e il postino non sa dove mettere la posta, perché non ci sono le cassette. Io mi sono dovuto fare la casella postale, perché i documenti dell’Università, i documenti del Cnr, i documenti della macchina… è un macello! I miei rapporti con gli altri abitanti delle Vele sono buoni. Buon giorno e buona sera. “Chill’ è n’u bravo guaglione, s’ fà i cazzi suoi”, dicono. Si parla del Napoli, e quindi c’è poco da ridere. Spesso mi dicono; “tu sì strunz’!” Perché? gli chiedo io. “Perché vai a lavorare un mese intero e pigli 2 milioni. A me 800 mila lire me le danno in una settimana. Sì è vero che hai studiato, però….” Che gli rispondi a uno così? Però sicuramente la stragrande maggioranza di quelli che stanno nelle Vele è gente che scende la mattina e si fa un mazzo tanto per lavorare onestamente. Nel mio palazzo ci saranno qualcosa come 1.200 famiglie. Io ne conosco sì e no un 5%. Antonio, velista Droghe Penso che il mercato dell’eroina non poteva estendersi oltre un certo livello, per motivi sociali ed economici. Quel mercato ha un suo equilibrio, tra persone che consumano ogni giorno, altre che consumano saltuariamente, un certo numero che integra l’eroina o la cocaina col metadone preso nei servizi. E come succede in ogni forma di mercato quando c’è un settore che si stabilizza, le forze economiche 34 che vi sono collegate e hanno bisogno di ampliare il loro volume di affari provano a indurre nuovi bisogni, introducono nuove sostanze per nuovi target di clienti. Il cobret ad esempio, che non è altro che eroina da fumare, ha rappresentato soprattutto all’inizio un modo per reclutare nuovi consumatori. Molti lo avevano confuso con il “fumo” in generale, con le droghe leggere che non portano assuefazione. Venivano ai servizi abbastanza disorientati dalla “rota” inattesa, perché non sapevano che era eroina. Si trattava, e si tratta, di persone per lo più integrate, che vivono spesso con un senso di fastidio lo stato di dipendenza. Oltre al cobret c’è poi tutta l’area dei consumatori delle piazze, del consumo di droghe per così dire voluttuarie come l’ecstasi. Questi consumatori hanno una differenza che si nota rispetto ai tossici storici. Non vengono ai nostri servizi, perché li vedono targati un po’ “eroinomani” ed hanno ragione. Loro si considerano diversi dagli altri e hanno spesso un pregiudizio forte rispetto ai tossicodipendenti. Non li accolgono nel loro gruppo, tendono a differenziarsi. Gli anni Novanta sono stati così caratterizzati da una sperimentazione da parte delle persone, realizzata attraverso le logiche del consumo di merci, per di più vendute in un circuito di illegalità che peggiora il livello di informazione e rende particolarmente pericoloso il consumo. C’è stato in definitiva un sostanzioso aumento del volume complessivo del consumo di sostanze stupefacenti illegali per la venuta di nuovi prodotti e nuovi consumatori. Stefano Vecchio, psichiatra dei servizi sociali del Comune di Napoli In questi ultimi dieci anni le associazioni a Scampia sono venute fuori come i funghi. Trovi associazioni dappertutto. Con alcune io ci ho lavorato anche e ho capito che se uno ci vuole restare si deve mettere là, tranquillo, in fila e nun’adda rompere ’o cazzo a nisciuno. Perché si romp ’o cazzo, se vai a dare fastidio n’a vota ’e cchiù, il primo nemico diventa proprio quell’associazione. Tra le tante sicuramente l’associazione più antica e più potente a Scampia resta quella propriamente chiamata Camorra. Le attività principali della Camorra, tra Scampia e Piscinola, restano la droga e l’edilizia. Non so quale di più. Le attività di spaccio in questi anni sono rimaste pressoché invariate. Anche se di drogati con le siringhe dentro al braccio se ne vedono un po’ di meno per le strade. Il cambio c’è stato nella manovalanza perché oggi vengono preferiti i minori per spacciare. Si cercano come il pane. Nel mio rione, negli ultimi 2 anni, non si è più venduta la droga. Io ho cercato più ragioni. Una è sicuramente che gli ex, i veterani, i ragazzi di 26-27 anni che una volta spacciavano e si bucavano in questo rione, oggi se li vai a piglià a uno a uno, a parte magari qualcuno che è morto o si è affiliato, la stragrande maggioranza si è trovata una forma alternativa per sopravvivere. Nel mio caso è stata quella di andare a vendere la biancheria per dentro ai paesi. Qualcun altro semplicemente ha pigliato un triciclo, s’e messo sopra e ha cominciato a vendere la frutta. Comunque sempre cose ai margini della legalità. Il perché non lo so. Io ne ho dato una giustificazione di presa di coscienza, nel caso mio. Però se poi voglio piglià a Gennarino, a Toppitop, a Ettoruccio, a Mimmo che probabilmente non hanno avuto questa presa di coscienza, non lo so qual è a molla. Sicuramente una cosa è certa, ognuno di noi si è fatto almeno 8-9 anni di carcere. Almeno. Trovandosi poi con niente in mano. Cioè ti trovi che hai fatto tanti anni di carcere, sofferenza a tutta forza, sapere che tua moglie, tua madre viene sotto al carcere tutti i giorni, per anni, per che cosa poi? Per non trovarti neanche una lira e stare sempre tutto fatto. Dai margini Nel momento in cui uno o due di noi ci siamo levati da mezzo, c’è stato una specie di effetto a catena. Quando io sono uscito da carcerato, e mi ricordo che erano usciti pure Mimmo e Ettoruccio, i ragazzi del rione mi ricordo che ci aspettavano come fossimo dei miti, quelli che dovevano essere liberati per avviare le attività all’interno del rione. Pure io quando ho cominciato cercavo qualcuno che l’aveva fatto prima di me come persona da seguire. Qualcuno che mi dava delle sicurezze, mi spiegava come si fa come non si fa… come ti devi stare accorto alle guardie. Per esempio mio nipote aspettava me e mio fratello per fare questa sorta di piccola organizzazione. Nel momento in cui sto mio nipote ha capito che noi non ne volevamo sapere più, c’è rimasto proprio male. Non trovando più questo riferimento i ragazzi stessi si saranno fatti qualche domanda: “Questi per non farlo più…” Un ragazzo poi se le fa queste domande. Infatti poi alle volte che ci mettiamo a parlare qua giù, loro mi chiedono ancora: “ma poi perché ti sei levato da mezzo? Io non ci posso pensà!”. E senti a me, e senti a Ettoruccio e a quell’altro e a quello ancora… e vedi che poi, per quanto possa essere preso dal sistema, uno dice aspetta un momento, famm’ verè buono. È difficile da spiegare. Questo è un rione dove la gente non si vuole rassegnare a non tenere le 10 lire in tasca e siccome la via legale ha tutte le sue difficoltà, qua sembra che l’unica sia quella illegale. Ma pure il giovane che si avvicina all’illegalità ha bisogno di un punto di riferimento. È come se questi ragazzi avessero trovato un vuoto avanti a loro. Un 3 anni fa ci stava un piccolo boss appena uscito da galera. Siccome lui in questo rione già c’aveva avuto una piazza di spaccio, chiamò a me e mi chiese di poter avviare di nuovo l’attività. Io non gli potevo dire di no, perché il no è un rifiuto e comunque ti può portare delle conse35 guenze. Cercai di arginare la cosa, di trovare un modo di dirgli no senza dire no. Un giorno stavo con la busta piena di magliette e calzettoni per andarli a vendere e lo incontrai. Che fai, che non fai…? E mi vede con questa busta in mano. Quando l’aprì subito s’accorse che era ’na cosa di sti guaglioni che vanno a vendere. “Ah questa è la fine che hai fatto? A vennere cazettini e magliette?!?!” Mi disse. Io non risposi, dissi e ch’aggia fa? E ho continuato per la strada mia. A quel punto lui si rivolse ad altri ragazzi del rione. Stranamente nessuno si mise. In questo rione qua siamo 160 famiglie e tra i figli di queste famiglie non ne trovò nemmeno uno. Tant’è vero che lui chiamò ragazzi da altri rioni per venire a spacciare qua. Roba di 5-6 giorni e furono arrestati tutti quanti. Loro non tenevano nessun tipo di appoggio dentro al rione, non conoscevano a nessuno, dovevano stare per forza là in mezzo. Per cui bastava che entrasse una pattuglia e se li faceva subito. Mentre io che sono del rione appena ne vedevo una me ne fuggivo sopra, dalla signora del piano di sopra. Questo riguarda una realtà molto piccola, che è quella del rione mio. Era stata una delle piazze più forti di tutta la 167, penso. In media qua si levavano 3mila bustine al giorno solo di eroina. Gaetano Di Vaio, abitante di Piscinola Stili di vita I. Il consumo mensile di una famiglia media di Scampia, di quelle che conosco io, composta da madre padre e due figli, è intorno ai 2 milioni di lire. Due milioni col debito però. Poi ci stanno le feste, i battesimi le comunioni i matrimoni. 7 o 8 milioni è in genere il costo di un battesimo o di una comunione. I matrimoni costano pure di più. Per fare tutto questo la maggior parte ricorre ai debiti. Se sei un dipendente comunale fai un debito sulla busta paga. Se non sei protestato fai una cambiale. Se no ti rivolgi agli usurai, che ti fanno un tasso d’inte36 resse che è praticamente del 120% annuo. L’usura qua è diffusa e accettata nell’immaginario collettivo. È come il Banco di Napoli. Può essere la signora del piano di sopra. Un disoccupato che non ha altra strada può rivolgersi solo a lui. Per fare questo mestiere però bisogna essere gente avida, tirata, perché non ci vuole molto a passare da usuraio a usurato. Questa è gente che se vai a casa e la trovi col piatto a tavola manco ti chiedono se vuoi favorire. II. Come campano qua a Scampia? Va bè, ci sono molti che fanno gli impiegati e pure qualche professionista. Quelli stanno però dentro ai parchi chiusi. La parte di persone che potrebbero fare i manovali quasi tutti emigrano. Partono la domenica sera e tornano il venerdì. Vanno a lavorare nel Nord Italia, ma anche in Abruzzo, in Umbria. Questa cosa non è più vista drammaticamente come una volta. Si mettono da parte i sentimenti. Io so che quando una persona parte (siccome molti del rione la domenica sera mi vengono pure a salutare) lo so che stanno male, lo so benissimo. Solo che queste cose sono diventate talmente diffuse che non se ne parla più. E poi questi non è che vanno e si sistemano. Per lo più partano con ditte napoletane e spesso lavorano comunque a nero. Un’altra parte si arrangia con mestieri da ambulante. L’annientamento del contrabbando qua ha portato effetti disastrosi. Fino a 5 anni fa da qua alla piazza di Piscinola ci stavano due fruttivendoli. Oggi ce ne stanno 5 e 3 di loro prima vendevano le sigarette. Molti degli ex contrabbandieri che conosco vivono così. Altri o sono andati nella camorra o vanno a rubà. Perché, per esempio, per fare il fruttivendolo non è come mettere la bancarella con le sigarette. Quando vai al mercato se non sei una persona scetata tu compri male e poi non riesci a vendere come si deve. Non è come con le sigarette che tu prendi 10 stecche le metti sopra alla bancarella e vendi. Poi ci sono quei giovani che non fanno proprio niente. Cioè si alzano la mattina verso le 11.00, scendono un poco in mezzo alla via a fare una chiacchierata, se ne vanno fuori al biliardo e così passano le giornate intere. Nell’ozio, come si dice. Solo che questo poi si ripercuote sulle famiglie, perché sti guaglioni pretendono comunque. Ci sta per esempio mio cugino che passa la vita a chiedere il giubbino della Nike, ’e scarpe che costano tanto… La madre è terrorizzata dall’idea che il figlio possa compiere qualche reato. Perché poi fuori al biliardo si frequentano ragazzi diversi. C’è il tipo che magari non ha mai fatto il guaio ma anche quello che comunque li fa. Ci sta comunque un’amicizia. E la mamma fa i debiti per comprargli il giubbino firmato, per mandarlo ogni 15 giorni dal barbiere perché si deve rifare le basette. Cose che fino a pochi anni fa non esistevano proprio. Gaetano Di Vaio, abitante di Piscinola III. Le poche case che trovi tra Scampia e Piscinola ormai i prezzi sono altissimi. Intorno alla metropolitana i prezzi sono più che raddoppiati. Anche perché poi qua si era venuto a sapere che dovevano fare l’Universtità e tutta un’altra serie di cose che si dovevano fare. Conosco situazioni di persone che sono state buttate fuori dalle case in cui abitavano da 3040 anni. Alcuni dei vecchi proprietari, negli ultimi 4-5 anni, hanno venduto le abitazioni a persone che facevano parte di organizzazioni camorristiche, o almeno che si vantavano di farne parte. I nuovi proprietari, laddove avevano avuto informazioni negative sull’inquilino che per esempio era disoccupato, gli hanno dato un tempo di scadenza e se questo non lo rispettava si presentavano o lo sbattevano fuori con tutti i mobili. Questo è successo verso la fine dell’estate scorsa e per il momento che io sappia i casi così sono ancora pochi. Un abitante anonimo perché non si sa mai Dai margini CASE Storie zingare La famiglia rimase così nei giardinetti per tutta l’estate. I giardinetti sono popolati da filonari, mamme con bambini e, soprattutto, da colf e badanti dell’est che si godono il dopo lavoro sotto un pergolato. La piccola folla di colf e badanti ucraini, russi, polacchi viene puntualmente circondata da stormi di vecchietti napoletani rinati, agghindati e passati a lucido per fare acchiappanze. Molti ci riescono e poi li si vede andare in giro per la città come ragazzetti con l’innamorata sotto al braccio. La macchina in cui la famiglia dormiva si era definitivamente rotta. Il padre aveva chiamato un meccanico che era venuto a vederla. Il meccanico gli aveva detto che lui non la poteva aggiustare che su quel marciapiede non poteva rimanere che doveva chiamare qualcuno per farsela trainare fino a casa. Il padre gli aveva risposto che quella era la sua casa. Il meccanico gli disse che non sapeva che fare e si prese 50 euro. Per fortuna d’estate fa caldo e la famiglia può dormire su un materasso nei giardinetti. Ma la gente, si sa, è malpensante e chiama vigili e forze dell’ordine ogni volta che qualcuno la molesta. Pronta la pattuglia di vigili assieme a un furgoncino della nettezza urbana arriva e si prende il materasso. Ma la famiglia ne trova un altro, sempre nell’immondizia. A volte piove, anche d’estate e la famiglia passa la notte sotto qualche balcone a ripararsi. Per due mesi abbiamo cercato case tutti i giorni. La famiglia era andata a chiedere aiuto agli altri rom che in questi anni ne avevano trovata una al centro storico, ma senza risultati. Il padre aveva cominciato a comprare il giornale degli annunci e poi insieme telefonavamo. Quando telefonavo io, dicevo di essere della Consulta Comunale per le problematiche rom, che come Comune avremmo potuto fare da mediatori rispetto a tutte le problematiche presenti e future. Era vero, face37 vo parte di questa Consulta costituita dal Sindaco in persona, Rosa Russo Jervolino. E la Consulta tra gli scopi avrebbe avuto anche questo di trovare case ai rom per favorirne l’uscita dal megacampo. Solo che la Consulta si era riunita una sola volta e di fatto non serviva a niente. Io mi spacciavo per la Consulta quando proprio non sapevo che cosa dire più. Il problema era che tutti i possibili proprietari appena sentivano la parola extracomunitario iniziavano a tergiversare, quando poi pronunciavo “slavo” (perché a dire rom o addirittura zingaro non mi azzardavo neppure) dopo un po’ mi attaccavano la cornetta in faccia. Per 4 mesi cercammo una casa. Ne vedemmo tante. La prima era una stanza umida e senza finestre dove fino a poco prima ci viveva una famiglia italiana di Montesanto. Volevano 650mila lire al mese. Quel giorno il padre s’era vestito di tutto punto, con tanto di capelli tirati a brillantina. Il padre è uno alto, robusto, baffetti sottili, io l’ho sempre creduto un divo di Hollywood in incognita. Era emozionato, era la prima casa che vedevamo. Non vollero fittargliela. Ne vedemmo un’altra, altre 3, altre 6, altre 9… sempre più o meno per 600mila lire al mese. Stanze uniche, spesso garage rifatti con tanto di saracinesca come porta e un quadrangolo interno in mattoni come bagno. Le uniche che riuscimmo a vedere furono quelle del centro di Napoli. Sul litorale domizio o in zone un po’ più distanti dalla città la famiglia non voleva proprio trasferirsi. La famiglia vive soprattutto dell’elemosina e il giro di relazioni, di aiuto e protezione, ce l’ha a Napoli. Ma la fortuna degli zingari la fanno i figli, si sa. Se no perché ne farebbero tanti? E la famiglia di figli ne ha uno, ma che vale per 7. Il vicino di bancarella del padre è un senegalese che vende cd contraffatti. Il figlio diventa suo amico. Stanno spesso insieme, lui va a vedere le partite di calcio a casa loro e fanno festa insieme. Spesso mi racconta delle cose strane che mangia, che vede, che sente dai senegalesi. Lui che fino a un mese 38 fa quando vedeva un negro cominciava a urlargli ingnominose improperie, ora sembrava davvero innamorato di questo senegalese e dei suoi amici. Il resto della giornata il figlio gioca a pallone con i ragazzi del Vomero, o va al bar di fronte alla villa Floridiana dove la famiglia si appoggia. Sembra che qua al Vomero il figlio sia rinato. Il proiettile che gli si è ficcato nell’addome durante gli scontri di S.Giorgio è ormai acqua passata. Trascina ancora un po’ la gamba ma il suo umore non ha niente a che vedere con quando stava al campo. Il dubbio mi viene: che non ci troviamo tutti in uno dei progetti sull’intercultura del Comune? Comunque il senegalese che abitava da quasi due anni in un vico del centro, 3 stanze condivise con una ventina di altri connazionali, ha le credenziali giuste e inizia a cercare casa alla famiglia. Dopo nemmeno un mese gliela trova e la famiglia può trasferirsi. È una stanza unica anche questa, con sopra la dicitura su marmo “Municipio di Napoli. Vano non adibibile ad uso abitazione”. Ma finalmente ora la famiglia ha un posto dove passare l’inverno. Passa un giorno e Roberto lo trovo che gioca a pallone in una piazzetta restaurata che i bambini indigeni hanno subito trasformato in campetto di calcio. Può iscriversi anche a scuola. Il primo giorno lo rimandano a casa perché c’è appena stato il terremoto e le scuole napoletane si scoprono pericolanti. Rimarrà chiusa almeno per una settimana. Ancora una settimana di calcio intensivo. Racconti del Com.p.a.re Pianura Pianura è il quartiere abusivo per eccellenza. Si chiama così perché sta nella piana ed era una terra di lavoratori agricoli. Diventa metropoli, ovvero quartiere periferico di una grande città, quando viene invasa dal cemento intorno agli anni ‘70. Cominciarono dai costoni, quelli che salgono verso i Camaldoli e che ora sono quasi interamente costruiti e non condonati. I pianuresi in genere hanno un’idea di città che si fa da sé e per sé, che non ha niente a che vedere con la città amministrativa. Considera che qua in pochissimi hanno chiesto il condono. Due dati. A Pianura la camorra è molto presente e forte. Pianura è stata storicamente un serbatoio di voti per la destra. In questo quartiere c’è un insediamento storico di sudamericani, colf e badanti per lo più, sparsi un po’ su tutto il territorio. Nel centro storico di Pianura ci vivono invece molti africani. Il centro storico è antico, fa parte di quei ‘casali’ storici amati e studiati dai cultori della morfologia degli insediamenti. E non è abusivo. Gli italiani non ci stanno quasi più. Nel terremoto dell’80 molti degli antichi casali dei centri periferici vennero dimessi perché se ne cadevano a pezzi. Alcuni furono ristrutturati e altri no, ma quasi tutti divennero edifici pubblici perché espropriati e chi ci abitava venne ricollocato in altri alloggi. Gli africani di cui ti parlavo sono dislocati in tre insediamenti, di cui il più numeroso sta in uno dei casali non ristrutturati. Come gli altri anche questo è costituito da un insieme di casette alte 2 piani, chiuse a corte e non essendo ristrutturato dispone di appartamenti tipici di come si viveva 60 anni fa. Sotto avevano la cantina o la stalla per le mucche e sopra la casa cui si arrivava con la scaletta esterna. Il bagno se c’era stava giù. Gli immigrati ora occupano sopra e sotto e sono di base in 25 con un bagno. Per bagno intendo solo la tazza. Il casale è completamente sfracellato, con i solai che se ne cadono e i muri spaccati. È così disastroso anche perché loro lo lasciano cadere a pezzi. Hanno continue minacce di sgombero dal Comune per cui dicono io non mi aggiusto il tetto se no spendo i soldi e poi mi cacciano pure. È un circolo vizioso. La maggior parte di questi africani lavora a Quarto, un Comune vicino. Vanno a offrirsi nella piazza all’alba per lavorare in campagna o nei cantieri o per i tanti piccoli lavoretti che possoDai margini no servire. Per cui per nessuno di loro è stata richiesta la regolarizzazione. Chi si mette a regolarizzare qualcuno che serve un giorno sì e sei no? In molti qui ci abitano fissi da oltre 15 anni. Ci vivono anche due famiglie italiane, 2 ragazze con i figli. Ma possono essere 25 come 150. Cioè c’è un nucleo più o meno stabile e quando arrivano nuovi connazionali questo casale è il primo posto dove trovano ospitalità. Funziona insomma da centro di prima accoglienza informale. Ilaria Vitellio, che svolge attività di ricerca presso il Dun. Il comune di Napoli è uscito dallo stato di dissesto economico solo nel dicembre 2002, anche in virtù dei soldi, reali o presunti, dei condoni edilizi. “Adesso il Comune potrà finalmente vendersi il patrimonio immobiliare” (“Corriere del Mezzogiorno”, 8 dicembre 2002) fu allora il primo commento ufficiale. Già da diversi anni la proprietà immobiliare che era in qualche modo sottoposta a controllo pubblico (come quella della Società Risanamento e dell’Istituto Autonomo Case Popolari) aveva cominciato a venire (s)venduta ai privati. Nel caso della Società Risanamento l’acquirente è stato il Gruppo Pirelli, che questa operazione la sta facendo anche nel resto d’Italia. È andato così scomparendo anche a Napoli il sistema di garanzie pubbliche rispetto al mercato delle case. E per molti questo è un bene, viste le condizioni in cui il patrimonio pubblico versava. L’edilizia pubblica a Napoli è stata sempre caratterizzata da manutenzione pessima e da imbrogli di ogni tipo da parte di amministratori, inquilini, proprietari. Decine di mancate scuole, ospedali, polifunzionali, biblioteche... di proprietà degli enti pubblici se ne sono rimasti a marcire anche in questi ultimi dieci anni, intrappolati tra l’ignavia delle pubbliche amministrazioni e le mire incrociate che i privati avevano su quegli stabili. 39 TERRE DI LAVORO (Da un’inchiesta fatta l’anno scorso con Marco Carsetti e Domenico Chirico) Stavo a Napoli, mi hanno indirizzato a Villa Literno. Ci sono andato. C’era una scuola che avevano iniziato a costruire e non l’hanno finita. Praticamente erano solo i pilastri e il tetto ed eravamo 2-300 immigrati quasi tutti africani. Io mi ricordo benissimo come chi trovava un cartone era fortunato. Fortunatissimo. Un cartone per dormirci sopra. Il pomeriggio quando chiudevano i negozi andavamo tutti quanti a cercare i cartoni. Io l’ho trovato dopo 2 sere e sono stato fortunato. I negozianti, quelli che vendono elettrodomestici, li vendevano agli extracomunitari. Vendevano i cartoni che di solito si buttano. Per farci le docce, quando avevamo i soldi, c’erano alcuni barbieri del paese che si prendevano 7-10mila lire per doccia. Lassad Castelvolturno Dovremmo rifarci al boom degli anni Cinquanta, a quel tipo di sviluppo sociale ed economico che portò la gente a desiderare la seconda casa, realizzando con la seconda casa l’illusione di una condizione sociale di tipo diverso. Da lì partì la corsa alla villa a mare, e non solo a Castel Volturno, ma in tutt’Italia. Il litorale Domizio era una zona tipicamente mediterranea, vicina a Napoli e a Caserta, e ancora quasi interamente vergine. Si edificava senza regole, così com’era possibile; non si facevano strade né si realizzavano altri servizi. Si è costruito anche in zone paludose. Si è creato per il più povero degli acquirenti la più sgangherata delle case. Finché a un certo punto a questo fenomeno più vacanziero della seconda casa non si è associato un altro fenomeno, quello del bisogno abitativo. La periferia di Napoli – specialmente a seguito del terremoto dell’80 – aveva bisogno di alloggi. A poco a poco assistemmo in 40 quegli anni a un imponente spostamento di popolazione dall’hinterland napoletano e anche da quello casertano verso il litorale Domizio. In un clima politico di assoluta connivenza e assenza di piani regolatori da parte dei Comuni, i costruttori hanno avuto la possibilità di determinare le sorti di questa o quell’amministrazione, oltre che dell’intero litorale. Il flusso migratorio di napoletani ha interessato – oltre ai paesi della fascia Domiziana – anche quelli dell’interno. Basti pensare a Marcianise, S.Marco Evangelista, S.Nicola, comuni che si trovano a 13-15 minuti da Napoli, e che in effetti sono molto più vicini al centro di Napoli rispetto a quartieri come Pianura, Fuorigrotta, S.Giovanni. Per molti aspetti questi paesi erano anche più vivibili. L’hinterland napoletano si è così spostato verso la “Terra di lavoro”, occupando e includendo le fasce più contigue. Castel Volturno, in effetti, è un esempio tipico di espansione incontrollata, perché è la zona al limite tra due province, quella di Napoli e di Caserta. Di lavoro, allora, ce ne fu davvero in abbondanza e così a Castelvolturno e sul resto del litorale Domizio arrivarono molti extracomunitari. Sbarcavano per lo più a largo di Ischitella, e venivano importati per lo più dalla Camorra. Vi sono stati scontri tra la camorra locale e le mafie nigeriane, ganesi… per lo sfruttamento della manodopera straniera. Intorno agli anni Ottanta ci furono grandi sparatorie, con molti morti e feriti. Alla fine si raggiunse una specie di pax mafiosa, che li portò all’accordo sulle percentuali di sfruttamento (per la prostituzione, per il collocamento al lavoro, per lo spaccio della droga…). Le prostitute, ad esempio, pagano alla camorra locale la tangente per il posto occupato sulla strada, e a quella nigeriana il “pizzo” sul guadagnato. Fin tanto che la cementificazione selvaggia è andata avanti i rapporti tra stranieri e italiani sono stati più o meno passabili. La visibilità degli extracomunitari era solo quella che dava loro il cantiere. È stato quando l’edilizia abusiva si è bloccata, più per saturazione del mercato che per altro, che sono iniziati i problemi. Una grande massa di manodopera rimasta senza lavoro si riversò per le strade, in cerca del miglior offerente, diventando improvvisamente visibile. Gli ex operai edili cominciarono a raggiungere i loro fratelli immigrati che lavoravano nelle campagne dei dintorni, dove la richiesta di braccianti era invece in forte aumento. Dormivano per la maggior parte in una zona interpoderale che poi verrà conosciuta come il “ghetto di Villa Literno”. Quello a cui verrà dato fuoco in seguito. Fu a questo punto che la camorra, per parte sua, si aggiornò e variò l’offerta. All’edilizia abusiva e al collocamento nelle campagne, sostituì il più redditizio mercato dello spaccio della droga e della prostituzione. Mercati che esistevano già prima ma in forma più ridotta. Per quanto riguarda la prostituzione il litorale offre una vetrina di 30 Km, la strada Domiziana. Avere le prostitute tutte insieme conveniva, così il cliente poteva scegliere meglio. Ma era una cosa estremamente fastidiosa per chi lungo quella strada ci abitava. L’essere diventato uno dei più grossi centri di spaccio della droga e della prostituzione del Mezzogiorno; la mancanza di servizi e infrastrutture; la generale crisi economica e la trentennale invivibilità del territorio… gli autoctoni attribuirono automaticamente tutto questo alla presenza immigrata. Soprattutto i commercianti, che diedero inizio a continue manifestazioni contro “i neri”. Anche se tutti sapevano che la maggior parte dei “contestatori” erano poi quelli che fittavano le case agli immigrati. E con notevoli vantaggi: se in un appartamento ci va una famiglia di italiani ne ricavi un normale pigione; ma se ci metti 20 stranieri e li fai pagare 100 mila lire a persona, è ovvio che conviene molto di più. Ci fu un momento in cui Dai margini Castelvolturno esplose come una torre di Babele: quando al fabbisogno dell’extracomunitario si associò quello del disoccupato napoletano, del senza casa che veniva dalla periferia e che da questa zona si aspettava una sistemazione, una prospettiva. I bisogni dell’extracomuniatrio straniero e quelli dell’extracomunitario italiano si sono scontrati anziché fondersi. Anche il commerciante, che spesso era un piccolo esercente o il disoccupato, avevano ragione a fare rivendicazioni rispetto a un territorio ridotto in quello stato. Solo che le facevano contro gli extracomunitari, invece di mettersi insieme per rivendicare una politica diversa. Raids notturni contro i neri, incendi d’auto, occupazioni stradali, sit-in davanti alla caserma dei Carabinieri, uccisioni… un vero impazzimento! Ma già allora era chiaro – lo hanno poi confermato alcuni processi e rapporti della polizia – che dietro a tutto questo c’era chi soffiava sul fuoco e strumentalizzava gli immigrati per combattere l’amministrazione comunale. Eppure la mia amministrazione aveva contenuto e ridotto il fenomeno della criminalità legata agli immigrati clandestini. Io li avevo i dati e sapevo come andavano le cose. Il Ministero ci stava dando una grossa mano. Da 13mila che erano nel ’93, nel giro due anni i clandestini presenti sul territorio li avevamo portati ad essere 34mila. Ma questo non era stato sufficiente perché gli immigrati ormai erano diventati un problema ideologico e uno strumento di lotta politica. Il Centro di accoglienza da noi aperto, uno dei primi d’Italia, era diventato il simulacro di tutte le ostilità. La popolazione di residenti iscritti all’anagrafe di Castelvolturno è di circa 18mila unità. Mediamente ci sono 40mila presenze al giorno, che durante l’estate arrivano quasi a centomila. Se Castelvolturno è diventata un luogo ideale per l’immigrazione clandestina è stato sì per la posizione geografica ma anche e secondo me soprattutto perché era un litorale 41 di seconde case: disponibilità alloggiativa ma principalmente un panorama di desolazione imperante per la maggior parte dell’anno. Durante l’inverno il litorale domizio è disperatamente vuoto e per una certa parte è vuoto anche d’estate. In una città 13mila persone le si notano, dove si nascondono? Le seconde case invece sono state – e restano – come un bosco nel quale è stato possibile nascondersi, senza dar fastidio e senza correre il rischio di venire scoperti. Mario Luise, sindaco di Castelvolturno dal ’70 al’ 71, dal ’71 al ’76 e dal ’93 al ’97. Braccianti I primi a incominciare a lavorare nelle aziende so’ stati i zingari. Intorno al 1980. Stevano delle aziende che non trovavano manodopera e hanno cominciato a piglià i zingari. Ca chilli po’ ce jevn. Sig. Aldo, proprietario di un’azienda bufalina Con me hanno lavorato albanesi, algerini, tunisini. Solo i marocchini no. Mi trovo male a lavorare con loro. Perché prima erano ragazzi che ti capevono, avevano di bisogno. Adesso manco loro ne aveno di bisogno. E allora pattuisceno, il tabacco se mi dai tanto lo faccio, si no lo lasco. È capace che fatta una raccolta ti lasciano il tabacco ’ncopp ’e piante. Perché vonno più soldi. Fanno il ricatto. Questo è un ricatto l’operaio col padrone. Se non ci fossero gli excomunitari non si potrebbe più lavorare il tabacco. No, non riuscite a prendere un italiano neppure si facciate la richiesta al collocamento. No, non è che è duro. È sporco. È sporco nel senso che quando avite maniato ’o tabacco v’ potite lavà ’e mani ’e tutte manere che sò sempre amare. Nun putite mangià n’u morso ’e pane. Verite che ’e mani s’ fanno ’e o colore ’e ’stà tazza, più scuro. Nere. Franco, ex bracciante agricolo, attualmente proprietario terriero 42 A Napoli di agricolo non restano che i nomi di alcuni quartieri come Pianura, Scampia, Vomero. La produzione agricola, che serve anche la città, è altrove. L’area che va da Napoli a Caserta, conosciuta come le “Terre di lavoro” rimane una delle zone più fertili d’Italia, malgrado lo stupro sistematico e costante perpetrato nei decenni su questo territorio. Un quarto della produzione italiana di frutticoltura viene da queste terre. I pomodori che l’avevano resa famosa assieme agli immigrati sudafricani che li lavoravano, oggi sono quasi scomparsi. Tra le cause molti agronomi indicano una virosi seguita all’introduzione di sementi americane. La produzione si è così spostata principalmente su ortofrutta e oro bianco, la mozzarella. Sempre più terreni cambiano destinazione trasformandosi in pascoli per bufale, su spinta anche delle organizzazioni camorristische che di affari ne capiscono e sanno che in questo settore il mercato è in forte crescita, con richieste crescenti da ogni parte del mondo. Mentalità e tempi del lavoro rimaste ferme a un secolo fa, si confrontano con leggi di produzione avanguardistiche. È recente una normativa che prescrive la meccanicizzazione di tutti i processi di produzione della mozzarella. Nonostante l’alta produttività dei terreni però l’economia agricola delle Terre di lavoro è tutt’altro che florida. I motivi sono essenzialmente tre. La cementificazione selvaggia e il diritto successorio hanno portato a una polverizzazione estrema dei fondi agricoli, finiti per diventare terreni di estensioni esigue per di più sparsi in giro per la regione. L’incapacità degli agricoltori locali ad aggregarsi ha loro impedito di organizzarsi per la commercializzazione del prodotto. I mercati del Nord Italia vengono così in queste terre a rifornirsi direttamente, trovando prodotti di buona qualità e a prezzi modici, a cui a volte mettere il proprio marchio. Questo oltretutto è un fattore che priva il territorio della ricchezza di un indotto che attualmente nelle Terre di lavoro praticamente non esiste. L’introduzione di cultivar estere, che oramai hanno sostituito quasi del tutto le sementi italiane, comporta il pagamento di costi altissimi per le royalty che in genere sono americane, francesi, olandesi, israeliane. “La Provincia di Napoli per anni è stata una dei primi produttori di patate autoctone. Oggi penso che non abbia un solo Kg di patate fatto con seme nostrano” dice il tecnico agrario Sergio Di Stasio. Tutto questo fa enormemente alzare i costi di produzione per gli imprenditori che, non sapendo ridurre gli altri, hanno potuto ribassare solo quelli del lavoro. Cosa che è stata possibile anche grazie alla grossa disponibilità di manodopera straniera che a un certo punto si era resa disponibile sul territorio e che oggi costituisce almeno il 60% della forza lavoro impiegata in agricoltura. Per lo più a nero e clandestina. Anche se quello che attualmente spinge gli imprenditori agricoli a rivolgersi alla manodopera straniera non è neanche più tanto il costo del lavoro. Le 10 mila lire che dieci anni fa erano la paga di una giornata, oggi cominciano a diventare una retribuzione vicina alla diaria minima sindacale. Quello che spinge gli italiani a rifiutare il lavoro agricolo e gli imprenditori a scegliere l’immigrato, è ormai principalmente un elemento giuridico-burocratico e uno relazionale. A un clandestino non si pagano contributi e costi previdenziali, se si ammala o si fa male non accampa pretese. Un immigrato è una delle ultime persone ancora disposte ad accettare un rapporto lavorativo fatto di urla in testa e sottomissione. E così le piazze come quella di Marano, di Villa Literno, di Quarto, dove fino a 50 anni fa si raccoglievano i manovali italiani per offrire le proprie braccia, in questi ultimi 20 anni si sono riempite di nuovo ma di extracoDai margini munitari. Oggi alla selezione di piazza subentra sempre più il fenomeno del caporalato immigrato. Per gli stranieri appena arrivati in Europa un territorio come quello delle Terre di Lavoro e un settore economico come l’agricoltura, sono stati un buon posto dove nascondersi per i primi tempi. Ma non appena riuscivano a trovare qualcosa di meglio cambiavano settore produttivo e zona geografica. Hanno così potuto avvalersi della manodopera immigrata anche le tante fabbrichette con le più svariate produzioni. Molti napoletani, allettati da una forza lavoro tanto appetibile, si sono lanciati verso avventure imprenditoriali grandi e piccole, spaziando dall’agricoltura all’edilizia, alla produzione e al commercio di ogni genere di merce. Alcuni anni fa a Casale la camorra emanò un editto: debbono andar via tutti gli immigrati. Di qualsiasi razza, di qualsiasi colore. Via da Casal di Principe entro 7 giorni. Per fare questo minacciarono i proprietari delle case eccetera. Veramente ci fu la fuga. Gli immigrati fecero le valigie e andarono via. Però in quei giorni, proprio mentre gli immigrati andavano via, scattò un meccanismo particolare. Da parte degli imprenditori, dei commercianti, dei distributori di benzina, che incominciarono a porsi il problema. Ma se questi vanno via, io come faccio? Chi mi scarica la roba dal camion, chi mi lavora alla pompa di benzina, chi mi va ad accudire il bestiame in campagna? Chi mi va a zappare la terra? In effetti questa reazione bloccò l’editto. Provocò anche il coraggio di denuncia da parte di qualcuno. Di fronte a un soggetto come la camorra che insomma, nelle nostre realtà, non consente spazi di libertà. Eppure il vedersi all’improvviso privati di uno strumento fondamentale per la propria struttura economica provocò la reazione. Renato Natale, medico di Castelvolturno 43 FOLKLORE Economia Napoli, come molte altre città, ha seguito la strada del cosiddetto marketing urbano. Cioè vendere il prodotto “città” sul mercato degli investimenti internazionali. La competizione internazionale è il criterio guida di tante politiche cittadine. Politiche che tendono ad accentuare tutto quello che può servire ad attrarre investimenti dall’esterno. Il turismo è una componente di questo tipo di economia urbana e per questo una torsione turistica molto forte è stata data alle politiche culturali. Ad esempio l’impostazione di marcata impronta civile che aveva “monumenti porte aperte” nell’anno di fondazione, è stata poi sopraffatta dalle esigenze di promozione del turismo. Nella stessa direzione sono andate le scelte sulle grandi infrastrutture, come l’aereoporto o la Metropolitana: rendere la città attrezzata per reggere i rapporti con l’esterno ed essere in grado di consentire una forte movimentazione di persone dentro la città. Anche questa era una condizione indispensabile al marketing urbano. Questo tipo di politica funziona però quando una città è forte, perché comporta un problema di equilibrio tra coesione interna e capacità della città di proporsi nella competizione. Ora mi sembra che questa coesione interna a Napoli sia molto precaria, e che si sia fatta troppa poca attenzione per farla crescere. Certo è sempre difficile distinguere le responsabilità del governo nazionale da quelle dell’amministrazione cittadina. E anche in quest’ambito bisogna riuscire a individuare l’insieme di forze interne che governano la città oltre a quelle più propriamente politiche. Solo per citare, il ceto accademico-professionale, la proprietà immobiliare, oltre all’onnipresente camorra. Mi sembra che questi e altri gruppi sociali abbiano conservate immutate cultura e influenza. Ad esem44 pio la lievitazione dei prezzi dei suoli (che in aree come quella orientale ha contribuito ad allontanare nuovi insediamenti industriali) io non penso che sia avvenuta semplicemente a causa delle politiche urbanistiche del Comune. La speculazione immobiliare tiene in ostaggio immobili e aree, è gente che aspetta e quando non riesce a incidere direttamente sulle scelte urbanistiche, riesce poi a vanificarle di fatto ricorrendo a meccanismi d’inerzia, nell’aspettativa di una crescita continua dei valori dei propri immobili. A ogni modo di investimenti nella città se ne sono attirati ben pochi. Per esempio ci sono i call center delle grandi compagnie telefoniche, ma poco altro di veramente qualificante. I piani di riqualificazione delle periferie da Scampia a Pianura, a Ponticelli, a S. Giovanni stentano a produrre effetti significativi e in molti casi non sono proprio partiti. Più in generale, facendo attenzione a fatti strategici (ad esempio a come si è arrivati a perdere il Banco di Napoli, con la conseguente accelerazione del carattere periferico della città rispetto al sistema economico e finanziario internazionale) verrebbe anzi da dire che Napoli in questi ultimi anni si è addirittura indebolita. Francesco Ceci, sociologo urbano Educazione Prima era difficile reperire l’esperto di botanica o di informatica che sapesse lavorare con i bambini. Il cercarlo, programmare con lui e avviare i laboratori aveva un piacevole aspetto artigianale e di ricerca. Oggi invece c’è una grande offerta che viene fatta alla scuola. Però io ho la sensazione che la scuola si trovi di fronte a una specie di supermercato dove andare a fare la spesa e vedere quale offerta ti piace di più. Quindi per forza è molto superficiale. Non hai più la possibilità di dire ho una serie di competenze interne e le utilizzo per tutta la scuola. Questo è quello che stiamo vedendo noi a scuola. È più difficile ottenere finanziamenti per fare funzionare un progetto interno e vengono favoriti tutti i progetti che utilizzano pacchetti esterni già confezionati. Gabriella Giardina, maestra A Napoli molte delle sperimentazioni pedagogiche che hanno avuto un senso hanno ruotato attorno a tentativi di mescolanza. Erano sperimentazioni che funzionavano proprio grazie alla presenza di bambini e adolescenti di contesti sociali e culturali differenti. Alla base esisteva un progetto pedagogico che era essenzialmente anche politico, perché voleva trasformare le condizioni strutturali del vivere comune. Molti di questi progetti si avvalevano degli strumenti offerti dell’educazione attiva e venivano portati avanti da movimenti più o meno interni alla scuola, come l’Mce (Movimento di cooperazione educativa). Si basavano sulla pedagogia popolare ed erano intrisi della volontà di riscatto dei ceti più deboli, senza un modello di società ben definito a cui arrivare ma piuttosto volendo tentare di costruirne uno nuovo. Erano esperienze per lo più minoritarie, spesso in contrasto anche con lo stesso Pci che magari un suo modello ce l’aveva. Sicuramente costituivano tentativi di resistenza e andavano verso la costruzione di un qualcosa di alternativo rispetto ai modelli dominanti. La ricerca pedagogica a Napoli sembra essersi fermata a quelle sperimentazioni, a vent’anni fa. Alla scuola media statale Lombardi alle Fontanelle o all’esperienza del 73° circolo di Bagnoli e a quella della Mensa dei Bambini proletari a Montesanto. Eppure malgrado i decenni di omologazione lo stato di separatezza tra napoletani non ha subito grosse modifiche, anzi si è per molti versi accentuato con l’aggravarsi del senso di Dai margini frustrazione di una fetta consistente di città. Separatezza che più che dalle condizioni economiche dipende oggi dalla possibilità di accesso ai circuiti legali e istituzionali, rimasti prerogativa di una minoranza. In più oggi a Napoli ci sono gli immigrati, che spesso appartengono al ceto medio per estrazione sociale e culturale, ma che condividono con gli ex proletari il marchio di estraneità e l’impossibilità di accedere ai circuiti ordinari. Trovandosi ai margini più estremi gli stranieri rendono maggiormente visibili atrocità e contraddizioni del vivere comune. Proprio per questo possono essere un punto di partenza per riprendere discorsi interrotti. Se in alcune scuole il dibattito pedagogico sta ripartendo è anche grazie a loro. Quando cioè invece di accanirsi sul bambino straniero, le scuole sono riuscite a vedere l’inadeguatezza delle strutture e dei modelli pedagogici di un’istituzione che a distanza di un secolo non era ancora riuscita a risolvere i problemi dell’educazione di massa, a partire dalle questioni legate al dialetto. Il fallimento della scuola pubblica ha fatto però presagire rinunce pericolose, nuove preferenze di separatezza piuttosto che di mescolanza. Anche per i bambini stranieri le cose non sono iniziate troppo bene, barcamenandosi le tendenze educative tra esotismo della differenza e pietismo (secondo gli insegnamenti di quella che qualcuno chiama pedagogia del couscous). Oggi un modello di città c’è ed è pure forte. E l’educazione in questi anni ha avuto essenzialmente il compito di assimilare a questo modello chi ancora resisteva, che fosse minore a rischio o straniero. Avercene uno da recuperare è diventato medaglietta al valore da appuntare sul curriculum. Spesso quest’educazione si è avvalsa degli strumenti della pedagogia popolare. Cosa di cui non si potrebbe che essere felici, se non fosse che tra la deriva new age e la nuova funzione che 45 era stata loro assegnata, questi strumenti hanno rischiato di diventare contenitori vuoti, offerta di consumo per bambini iperstimolati, iperimpegnati e allevati sin da piccoli a narcisismo esasperato e attività salottiera. In una città dove “la strada” veniva sempre più demonizzata e per i bambini non esistevano che pochi recinti dove starsene attaccati al guinzaglio. Dove la vita vera scorreva all’insegna della reclusione di una cameretta giochi o di un campo-ghetto per rom. È sembrato insomma che quelli che furono un tempo gli strumenti della pedagogia popolare e libertaria fossero stati addomesticati per il mantenimento dello status quo. E che venissero accantonati insegnamenti preziosi di maestri come Colin Ward, Pasolini, Danilo Dolci o (senza andare troppo lontano) Felice Pignataro con il suo storico carnevale di Scampia: l’educazione è principalmente il risultato delle relazioni instaurate con le persone (i propri coetanei innanzitutto) e le cose (la casa, il palazzo, la città) con cui si entra in contatto durante l’intero arco di una vita. LO STRANIERO è una rivista mensile nata a Roma nel 1997, fondata da Goffredo Fofi con un nutrito gruppo di collaboratori. Si occupa di arte cultura società. Ha privilegiato e continuerà a privilegiare settori fondamentali per il nostro agire: movimenti e istituzioni, pubblico e privato, centri e periferie, maggioranze e minoranze, civiltà e natura, Italia e mondo, vecchio e nuovo, paure e speranze dell'umanità. La globalizzazione, la pace, l'immigrazione, l'educazione e l'espressione artistica – teatro, fotografia, fumetto e arti visive, letteratura, cinema… Nelle migliori librerie un numero 7,00 euro Abbonamento a dodici numeri: 60,00 euro per l’estero: 120,00 euro sostenitore: a partire da 120,00 euro numeri arretrati: 14,00 euro versamenti: on-line www.contrasto.it conto corrente postale n° 47440029, intestato a: Contrasto Due srl, via degli Scialoia 3, 00196 Roma vaglia postale Beneficiario: Contrasto Due via degli Scialoia 3; Agenzia di pagamento: P. T. Roma 40 Carta SI, Visa, Master Card inviare o comunicare n° carta di credito, scadenza, intestatario, importo. Spedizione in abbonamento postale Redazione: via degli Scialoia, 3 - 00196 Roma tel: 06-32828231; fax: 06-32828241 e-mail: [email protected] 46 www.lostraniero.net
Scarica