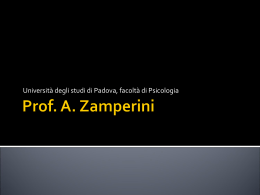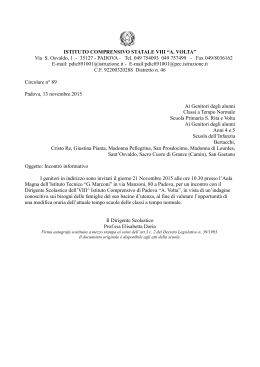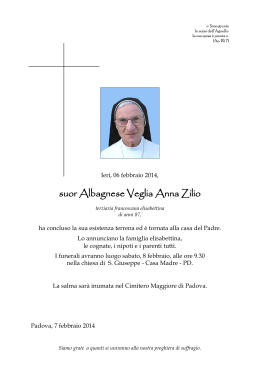comune di rovolon Rovolon STORIE DI UNA COMUNITÀ DEI COLLI EUGANEI cier r e gr afic a | co m une di rovo lon Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al sostegno di Edito dal Comune di Rovolon durante l’Amministrazione del Sindaco Francesco Baldan © Copyright 2011 Comune di Rovolon Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna, Verona www.cierrenet.it ROVOLON STORIE DI UNA COMUNITÀ DEI COLLI EUGANEI a cura di Claudio Grandis Con contributi di Cristina Capodaglio, Renzo Forestan, Carla Frasson, Claudio Grandis, Manfredo Manfredini, Vittorio Miotto, Stefania Montemezzo, Aldo Pettenella, Don Antonio Pontarin, Francesco Tognana, Scuola Secondaria di primo grado di Rovolon comune di rovolon cier r e gr a fi c a | co m une di rovo lon Per le immagini fotografiche: - Archivio Comunale di Rovolon, pag. 34, 35, 38, 39, 58, 59, 126, 127, 185, 211, 220, 246 - Archivio Parrocchiale di Bastia, pag. 64, 108, 111, 113, 114, 117, 118 - Mario Bortolami di Padova, pag. 234 - Rino Fiocco di Rovolon, pag. 17, 29, 101, 106, 107 - Renzo Forestan di Rovolon, pag. 57, 61, 140, 165, 168, 172, 174 - Fabiola Gagnolato di Rovolon, pag. 94 - Claudio Grandis di Selvazzano Dentro, pag. 18, 20, 21, 37, 56, 62, 63, 76, 80, 83, 90, 186, 190, 191, 197, 207, 209, 237 - Manfredo Manfredini di Padova, pag. 226, 227, 229, 230, 231, 232 - Vittorio Miotto di Rovolon, pag. 150, 151, 152, 155, 156, 157 - Ottorino Paccagnella di Rovolon, pag. 77, 84, 104, 130 - Francesco Perencin di Padova, pag. 12, 60, 136, 164, 192, 224 (in basso) - Mario Saggiorato di Rovolon, pag. 91, 128 - Scuola Secondaria di primo grado di Rovolon, pag. 210, 240, 242, 243, 244, 245 - Marta Segato di Rovolon, pag. 206 - Giuseppe Trevisan di Cervarese S.C., pag. 16, 31, 36, 47, 67, 81, 93, 97, 98, 102, 120, 133, 166, 182, 183, 189, 212 (in alto), 214, 222 - Aldo Zanellato di Padova, pag. 22, 71, 74, 75, 85, 123, 147, 159, 170, 178, 187, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 212 (in basso), 213, 221, 223 - Foto esposizione mostra fotografica di Carbonara, pag. 124, 125, 129, 132, 205, 241 - Associazione Le Fontane di Carbonara, pag. 208 Con un grazie particolare a tutti coloro che hanno contribuito e collaborato. Indice 7 9 Saluto dell’Amministrazione Comunale Presentazione L’AMBIENTE E LA STORIA 15 27 47 51 55 71 87 93 95 Claudio Grandis Rovolon: una comunità tra colline e pianura Francesco Tognana Dal villaggio medioevale alla villa: insediamenti, castelli e strutture fortificate Claudio Grandis I boschi Carla Frasson Il bosco della Carpaneda Stefania Montemezzo Case vecie e campi magri. Vivere contadino e sviluppo delle colture agricole a Rovolon in età moderna Cristina Capodaglio Il Comune di Rovolon nell’Ottocento Claudio Grandis Il mulino di Rovolon Claudio Grandis Il mulino di Carbonara Aldo Pettenella Altri promessi. Storia padovana del secolo XVI SUL FILO DELLA MEMORIA 139 149 159 La seconda guerra mondiale a Rovolon La mia gioventù. Ricordi di Vittorio Miotto Il monumento ai caduti 6 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei 165 171 Renzo Forestan Storia e vita contadina Renzo Forestan Un rito della campagna: le rogassion MONUMENTI E PALAZZI 177 197 201 207 209 213 215 217 219 221 223 225 227 231 233 241 Don Antonio Pontarin La chiesa di San Giorgio di Rovolon La chiesa di Santa Maria di Bastia La chiesa di San Giovanni Battista di Carbonara Villa Papafava alle Frassanelle Villa Tosi, Priuli, Fogazzaro, Faggion a Lovolo Villa Barbaro, Marchesi, Pierantoni Villa Da Rio, Rubini, Canal Villa Da Rio, Soranzo, Schiavinato Villa Lion, Fardigo, Fasolo Villa Lippomano, Barbarigo, Martinengo, Montesi Villa Ottavia Villa Papafava, Casiraghi detta “Il Palazzetto” Villa Manfredini Renzo Forestan Il complesso rurale di via Loredan Claudio Grandis Ca’ Costigliola Scuola Secondaria di primo grado di Rovolon I capitelli della devozione popolare Saluto dell’Amministrazione Comunale Rovolon è un paese tranquillo, mollemente adagiato fra la pianura e le pendici dei Colli Euganei, un posto dove è bello vivere sia per la splendida cornice paesaggistica, sia per il clima di amicizia e di collaborazione che si respira nelle numerose feste e manifestazioni culturali ed enogastronomiche. Gli abitanti ovviamente vivono il presente, vedono il paese com’è ora, con i suoi quartieri, le piazze, le rotonde, le scuole e le zone artigianali e industriali, ma ignorano tutto della storia e delle tradizioni del posto in cui vivono, soprattutto i nuovi arrivati; gli abitanti tradizionali comunque hanno una memoria storica che non supera le due generazioni, oltre le quali tutto svanisce nella nebbia del passato. Negli ultimi dieci anni l’Amministrazione Comunale ha cercato di far conoscere il territorio attraverso molte iniziative, fra cui un aggiornato Sito Internet e la realizzazione di un DVD intitolato “Colori e Sapori di Rovolon”, ma ha messo in cantiere anche l’ambizioso progetto di un libro che raccontasse ai cittadini la storia, le tradizioni e le vicende vissute di coloro che nei secoli hanno abitato e trasformato questi luoghi, rendendoli a noi incantevoli come li vediamo oggi. Il lavoro che finalmente vede la luce rappresenta la prima ricerca storica scritta in modo organico ed approfondito sul Comune di Rovolon e sulle sue frazioni di Bastia, Carbonara e Lovolo ed è il risultato di una lunga e faticosa gestazione di meticolose ricerche negli archivi comunale, parrocchiali e di Stato. È quindi doveroso da parte nostra un vivo ringraziamento agli autori dei singoli studi, a Don Antonio Pontarin per la documentazione che ci ha messo a disposizione e a Claudio Grandis, che, con l’ammirevole pignoleria propria del ricercatore coscienzioso, ha coordinato ed assemblato tutto il lavoro. Poiché è più facile amare ciò che si conosce, speriamo che questo libro, che consideriamo come la ciliegina sulla torta del nostro mandato amministrativo, possa aprire la mente del lettore, soprattutto se giovane, e stimolarla alla conoscenza della storia e delle tradizioni del suo paese. Presentazione «Rovolon è luogo antico, già sede di podestà, culla della omonima famiglia medioevale, alla quale apparteneva il castelletto Delle Rocche. Ne rimane superstite a sinistra, sotto il Monte Madonna cupo di boschi (sulla sommità il Santuario della Madonna, col piccolo monastero benedettino), una torretta che si drizza su uno scheggione. La parrocchiale di S. Giorgio risale al tempo dei longobardi (sec. VII-VIII). Fu ricostruita nel sec. XV dai monaci di Santa Giustina, restaurata nella metà del passato secolo [XIX] e manomessa, da poco accorti interventi, nel 1911. Bella la vista che si gode dal sagrato. A sinistra l’osteria Fasolo, in un curioso edificio secentesco con portichetto interno» [Callegari, 1973, p. 331-332]. Come una pennellata di fresco colore, le parole di Adolfo Callegari così dipinsero nel 1931 il capoluogo del nostro comune ai lettori della Guida dei Colli Euganei. Un affresco che ancor oggi si presenta intatto allo sguardo curioso sia del turista occasionale sia del residente che in questa terra riconosce la propria patria. Pochi dati sintetici riassumono una storia più che millenaria, incisa sulle pietre, sul disegno agrario, sulle case antiche disseminate tra i clivi delle ultime propaggini degli Euganei. La pianura aperta a settentrione si svolge anche ad occidente verso le colline beriche, tagliata dall’alveo dello scolo Bandezzà, secolare linea di confine tra il territorio padovano e quello vicentino. Gli uomini che in quest’area si sono insediati hanno trasformato lentamente un paesaggio originariamente boschivo e ricco d’acque in fertile pianura, lasciando nei nomi di luogo la memoria dell’antica geografia. Rovolon, Carbonara e Bastia riportano infatti proprio alla vegetazione di questa terra: piante di rovere, carbone di legna e recinto fortificato interamente realizzato con grossi pali, come un fortino del Far West cinematografico. Il bosco è rimasto sopra gli abitati di Rovolon e Carbonara, attorno alla vetta del Monte Grande e del Monte della Madonna e tuttora avvolge le basse colline di Frassanelle, del Serèo, del Viale, dello Spinazzola e del Matello. L’economia rurale e quella silvo-pastorale hanno dominato nel tempo la vita d’intere generazioni, spesso alle prese con proprietari esigenti, monasteri onnipresenti e calamità inattese. Le pagine di questo libro raccontano alcuni momenti di questa lunga vicenda umana, indugiando su alcuni aspetti del passato, quelli cioè che più di altri hanno lasciato memoria scritta, non solo sulle carte del tempo. Alcuni racconti e le testimonianze di altrettanti protagonisti trovano spazio nelle pagine di questo libro: poiché anch’esse sono memoria, cronaca di un vissuto che il tempo trasforma e fa divenire storia. Nel passato di una comunità affondano le radici del presente e la genesi 10 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei di quanto ci sta attorno. Sono le fondamenta del nostro essere, del nostro ritrovarci attorno a valori comuni, a luoghi conosciuti, a persone familiari. Non può essere diversamente. Senza citare consumati aforismi e celebri frasi sull’importanza della storia, qui è sufficiente ricordare che una comunità è viva, ha un suo volto, ha una sua identità proprio perché ha una sua storia. L’intento di queste pagine è principalmente questo: far rivivere momenti ed episodi che il tempo ha inesorabilmente sepolto, senza tuttavia cancellarli o distruggerli. Vicende, momenti che sono stati solo riposti nei grandi contenitori della memoria quali sono soprattutto gli archivi. Da questi depositi, amati da chi fa ricerca, oscuri forse a tanti, provengono le notizie che qui si presentano. Gli autori hanno attinto soprattutto negli archivi parrocchiali, in quelli cittadini della Curia Vescovile e in quelli, forse più noti, dello Stato, sia di Padova sia di Venezia, senza, ovviamente, tralasciare quello comunale recentemente riordinato e inventariato. Un archivio, quest’ultimo, nato all’indomani dell’Annessione del Veneto al Regno d’Italia (1866). Il libro si presenta suddiviso essenzialmente in tre parti. Nella prima sono sviluppati i temi legati all’ambiente e alla storia; nel secondo la storia corre sul filo della memoria del secolo appena trascorso. Nella terza sono i monumenti e gli edifici di maggior pregio a occupare le pagine del volume. Nell’insieme radunano tre decine di capitoli, alcuni brevi, altri più estesi. Gli autori che hanno contribuito alla redazione di testi sono diversi, ciascuno tuttavia esperto dell’argomento trattato, sia che si tratti della ricostruzione delle vicende castellane, sia che si affronti la storia dei boschi di pianura o dei mulini ad acqua di via Palazzina. Ma sono soprattutto le vicende del secondo millennio ad essere qui ricostruite perché è solo dal X secolo dopo Cristo che disponiamo di documenti scritti in grado di farci conoscere e scoprire eventi e momenti del passato di Rovolon. È tuttavia doveroso sottolineare che la vicenda umana nel nostro territorio ha inizio molti secoli prima: purtroppo l’avarizia dei ritrovamenti archeologici impedisce la ricostruzione di un quadro puntuale e preciso degli insediamenti, degli abitati, del popolamento della zona. La Carta Archeologica del Veneto, che raccoglie tutte le notizie ufficiali sui ritrovamenti avvenuti nella nostra regione, compresa Rovolon, riporta appena cinque “schede” archeologiche, cioè quelle corrispondenti ai numeri 209, 210, 211, 212, 213 del Foglio 50 - Padova del III volume della serie. Illustrano ritrovamenti di materiali sporadici, che gli esperti hanno datato lungo un amplissimo arco temporale capace di snodarsi dal XXXV fino al II millennio avanti Cristo: tempi lontanissimi che ci riportano alla preistoria dell’uomo veneto. Le schede edite nella Carta Archeologica illustrano con le seguenti parole quelle scoperte archeologiche. 209. Carbonara – Monte della Madonna. «Dalle falde occidentali del Monte della Madonna e precisamente dal pianoro della chiesetta di S. Pietro, proverrebbero materiali litici di tecnica clactoniana rinvenuti alla fine del secolo scorso [XIX] e negli anni ’50 [del XX secolo]. Verifiche in situ durante la primavera del 1960 consentirono la raccolta di altro materiale, tra cui un nucleo poliedrico e un raschiatoio trasversale, oltre a molte schegge. La tipologia dei reperti, in assenza di un più preciso contesto stratigrafico, può ricondurre genericamente al paleolitico medio (ante XXXV millennio a.C.)». rovolon, sto rie di una comunità dei colli euganei 11 210. Carbonara – Monte Mottolon. «Dalle falde occidentali del Monte della Madonna e precisamente dal pianoro della chiesetta di S. Pietro, proverrebbero materiali litici di tecnica clactoniana. La tipologia dei reperti, in assenza di un più preciso contesto stratigrafico, può ricondurre genericamente al paleolitico medio (ante XXXV millennio a.C.)». 211. Carbonara – Colle di S. Pietro. «Agli inizi del ‘900, presso un fossato ai piedi del colle di San Pietro, a circa metri uno di profondità, si rinvenne una sepoltura di inumato supino, con la testa ad ovest e braccia conserte sul petto. Alle braccia portava due armille bronzee. Sempre nella stessa area, circa 35 anni prima, era stata rinvenuta un’altra sepoltura di inumato, senza corredo». 212. Bastia – Fondo Randi. «Si ha notizia del rinvenimento nel fondo Randi, in seguito ad arature, di un pugnale in selce, triangolare con base ad alette e codolo triangolare molto ristretto, attribuibile all’eneolitico (seconda metà III – inizio II millennio a.C.)». 213. Colombara Trevisana. «È stato rinvenuto durante i lavori di aratura, un pugnale in selce con codolo ottenuto a ritocco piatto, bifacciale, coprente, riferibile all’eneolitico (seconda metà III – inizio II millennio a.C.)». Materiali litici, cioè in pietra, di tecnica clactoniana, una parola che prende origine dalla località Clacton-on-Sea, nell’Essex (Gran Bretagna), ove era attiva un’industria di selci nel Paleolitico inferiore. Da questa area archeologica provengono numerosi manufatti consistenti in utensili di selce levigati e in sassi scheggiati, alcuni dei quali si possono classificare come ascia corta. In altre parole nel territorio di Rovolon vivevano uomini preistorici abili nella lavorazione della pietra di selce, impiegata – possiamo immaginare – nella caccia. Purtroppo le sporadiche scoperte, tutte occasionali e non provenienti da scavi sistematici, si limitano ai tempi più lontani della presenza umana sui Colli Euganei, vale a dire a migliaia e migliaia di anni fa. Nulla sappiamo invece degli insediamenti più recenti risalenti, ad esempio, all’età romana, cioè a cavallo dei secoli che accompagnarono la nascita di Cristo e l’origine del nostro attuale calendario. L’assenza di reperti c’impedisce di ricreare l’habitat dell’uomo che precedette la nascita delle comunità attuali, quelle, in altre parole, documentate dalle pergamene del X secolo. Superfluo rilevare che i documenti scritti fotografano una realtà viva, radicata, presente nella zona. Ma da quanti anni, da quanti secoli? Forse mai lo sapremo, anche se di certo è che il territorio di Rovolon nel X secolo era popolato da tempo, abitato forse da una manciata di famiglie, in grado, tuttavia, di dar vita ad una comunità religiosa bisognosa di una chiesa materiale, di un edificio sacro ove ritrovarsi, pregare, discutere e ricevere i sacramenti. Da questo incontestabile dato, dal legame della chiesa di San Giorgio all’antica comunità benedettina di Santa Giustina di Padova ha inizio il nostro viaggio: un viaggio alla scoperta di un passato e di un ambiente nel quale, quotidianamente, il nostro passo ripercorre sentieri e memorie di una comune identità. L’AMBIENTE E LA STORIA Claudio Grandis Rovolon: una comunità tra colline e pianura L’attuale comune amministrativo di Rovolon è nato nel 1806 con la riforma voluta da Napoleone Bonaparte. Il decreto emanato per il territorio francese nel 1805 venne esteso l’anno seguente anche all’Italia settentrionale quando l’Austria lasciò, momentaneamente, il Veneto. Rovolon, come tutti gli altri comuni moderni della Provincia, riunì attorno al suo baricentro diverse località che fino ad allora erano rimaste autonome, quali Bastia e Carbonara. Altre contrade minori come Costigliola, Granza Frassanella, Granza Santa Giustina, Granza di Vegrolongo e Vegrolongo del Bosco si aggiunsero al nuovo mosaico territoriale. Di lì a qualche anno poi, il catasto napoleonico avrebbe tracciato anche precisi confini, ponendo fine alle tante discussioni che, fino ad allora, avevano animato le contese di campanile. Come tutte le realtà politico-amministrative tracciate a tavolino, anche Rovolon si trovò a fare i conti con delle scelte, per terre estromesse dai nuovi confini o per aree estranee incluse nel perimetro comunale, che allora lasciarono perplessi non pochi capi famiglia, rimasti ancorati all’antico regime veneziano cessato nel 1797. Per ragioni pratiche, infatti, i confini del nuovo comune furono delineati seguendo di norma i perimetri delle proprietà fondiarie più estese, soprattutto di quelle poste lungo presunti confini antichi. In diversi casi coloro che delinearono i nuovi confini non tennero in considerazione gli antichi vincoli, come nel caso dell’abitato di Montemerlo che da sempre era legato a Rovolon: anziché includerlo nel nostro comune fu unito a Cervarese Santa Croce, località con cui in passato poco aveva avuto da spartire. Così pure singolare e incomprensibile rimase la divisione in due comuni dell’area del Vegrolongo, la vasta superficie su cui s’estendeva il grande bosco. Da sempre quella grande macchia arborea costituiva un’unità ben definita inspiegabilmente tagliata in due parti, con quella ad oriente assegnata a Cervarese e quella di ponente a Rovolon. La scelta di nominare Rovolon capoluogo era comunque il riconoscimento dell’importanza che la comunità, raccolta attorno alla pieve di San Giorgio, aveva avuto in passato, nonché del ruolo dominante che, ancora agli inizi del XIX secolo, continuava a ricoprire. Rovolon, infatti, assieme a Galzignano, Arquà e Monselice è stata per secoli una delle comunità più vive ed importanti dell’intero distretto collinare. Sono i documenti disseminati tra XIII e XIX secolo a testimoniarlo. Giusto per fare qualche esempio, in un excursus lungo ben sette secoli, possiamo iniziare dai verbali delle vicinie, cioè le riunioni dei capifamiglia (dei vicini) sui quali poggiava l’autorità comunale già allo scadere del XII secolo. 16 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Alcuni anni or sono è stato pubblicato il «Liber» di S. Agata di Padova, un voluminoso codice in pergamena, tecnicamente detto cartolario, contenente molti atti notarili dello scomparso monastero di S. Agata e Cecilia di Padova. Tra i documenti raccolti in questo libro vi è il verbale di una riunione tenutasi il 6 agosto 1262 «in villa Roboloni sub porticu caminate de dicta villa». A quest’adunanza furono presenti ben centoquattordici persone, tutte nominate una per una, compresi prete Guglielmo, rettore della chiesa di Carbonara, il chierico Gerardo e l’arciprete Savarisio della chiesa di San Giorgio. Sindaci e procuratori del comune di Rovolon erano allora Ugolino notaio, Galvano de Çone, mastro Enrichetto e Rolando Musio. In «plena vicinancia ad sonum tabule more solito» (nella riunione convocata al suono di una tavola come si era soliti fare), all’unanimità dei centoquattordici presenti fu deliberato un accordo con il monastero di S. Agata relativo al bosco detto Viglanicus. Un manto d’alberi che copriva ben 250 campi, delimitati a mezzogiorno dalla fossa Nina. Un bosco che nei documenti dei secoli seguenti sarà identificato con il toponimo di Vegrolongo.1 Ciò che qui più interessa, al di là delle vicende del bosco, è l’autonomia, la potestà che allora quei capifamiglia seppero manifestare. Una comunità cioè che già allora, attraverso questo atto deliberativo, manifestava la piena sovranità sul territorio in cui era insediata e che superava le pendici collinari del monte Grande e della Madonna per estendersi oltre la fossa Nina, proseguendo fino al corso del Bacchiglione. La comunità di Rovolon sin dal XIII secolo fu inserita nell’elenco delle ville che dovevano concorrere nei lavori di manutenzione e riparazione di argini, ponti e fossati. Gli Statuti del comune di Padova (libro IV, posta 985) imposero la manutenzione di un argine che dal ponte di Tencarola arrivava a Santa Maria Maddalena Nuova, cioè l’attuale via San Giovanni da Verdara nella zona nord di Padova. Oltre a Rovolon nell’elenco furono inclusi altri quaran- La sede Municipale con il Monumento ai Caduti. rovolon : una com un ità tr a colline e pianur a 17 tacinque villaggi, ma non Carbonara né Bastia. La successiva norma (detta tecnicamente posta) n. 1006 stabilì invece che i lavori di periodico riassetto della strada che da Ponte di Brenta conduce a Vigonza, e fino ai mulini di Stra, dovevano gravare sui villaggi compresi fra Teolo e Villafranca; Rovolon, in questa circostanza, fu inclusa tra Noventa Padovana e Lissaro. Ma l’onere maggiore che fu allora stabilito per il nostro villaggio, commisurato alle risorse umane ed economiche, riguardò la quantità di carri e alimenti che dovevano essere assicurati all’esercito comunale padovano. Un obbligo in vigore già nei primi anni del XIII secolo ma che, per ragioni di equità, fu rivisto dal podestà padovano, il milanese Ottone de Mandello durante il suo secondo mandato. Negli anni 1234-35 venne stabilito «in fatto di carri, che venivano dati ai capi dei centenari della città di Padova negli eserciti», un diverso carico, adducendo come motivazione – quanto mai attuale – che in molti casi l’onere era stato fissato «per odio più che per grazia», tanto che alcune ville «venivano alleviate o per favore o dietro denaro». La nuova ripartizione si preoccupò inoltre d’indicare con precisione il centenaro (contrada di Padova) nel quale andavano condotti carri e uomini. Rovolon fu inclusa nel centenaro del Duomo e l’onere fu fissato in dodici carri più un carro di pane. Nello stesso gruppo fu inclusa Selvazzano con sei carri e uno di pane, Tramonte con sette carri e uno di pane, Teolo e Villa con dieci carri e tre di pane, Carbonara con tre carri, Costa con due carri, Castelnuovo con tre carri, Luvigliano con quattro carri e, infine, una non ben identificata località chiamata Villa Maioris (forse Selva Maggiore) gravata di appena tre carri. La sede Municipale in una cartolina del 1943. 18 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei A Rovolon fu assegnato dunque l’onere più gravoso. Se lo confrontiamo con il carico militare di tutti gli altri villaggi del Padovano, scopriamo che si contano sulle dita di una mano quelli con un aggravio maggiore del nostro villaggio: Montagnana, che di carri ne doveva fornire diciassette, Conselve con dodici e quattro di pane, Tribano con dodici e due di pane, Pernumia con sedici carri e quattro di pane. Gli Statuti della città naturalmente si preoccuparono di includere Rovolon anche nella periodica ricostruzione e nella manutenzione del ponte di Tencarola, l’unico attraversamento pubblico sul Bacchiglione a monte di Padova. I villaggi caricati di questo onere furono in tutto due dozzine, praticamente quelli disseminati lungo le strade Montanara (Padova-Teolo) e Scapacchiò, fino a comprendere Torreglia (posta numero 1086).2 Va detto in proposito che il vecchio ponte di Tencarola, tutto di legno, necessitava dell’integrale ricostruzione in media ogni venticinque anni, in quanto i pali e le stilate di sostegno non duravano per un tempo maggiore. Un onere che veniva assolto o con la tassazione monetaria e l’affidamento ad una ditta per la ricostruzione, o, nelle annate di scarso raccolto, con la partecipazione attiva di tutti coloro che ne erano gravati, provvedendo a tagliare e condurre legname fino al ponte, a demolire il vecchio manufatto fatiscente, a piantare pali e a realizzare la carriera di transito per uomini e mezzi. L’ultima ricostruzione cui furono obbligati a partecipare tutti i comuni della vicaria di Teolo, in conseguenza di una desolante annata agraria, risale al 1795: quell’anno il governo, di fronte alla prospettiva di dover finanziare la ricostruzione, acconsentì che i villaggi della vicarìa di Teolo provvedessero in proprio sia a procurare i «duecento e trenta roveri» sia a condurli dal bosco della Carpaneda sino a Tencarola.3 Ritornando agli Statuti del comune di Padova, va detto che Rovolon doveva Una suggestiva panoramica di Rovolon in primavera, “con i ciliegi in fiore”, come recita la didascalia. rovolon : una com un ità tr a colline e pianur a 19 – stando al dispositivo della posta n. 1091 – costruire e mantenere anche «i ponti della propria villa, del proprio territorio e confine ben solidi, alti e spaziosi, sicché le acque vi possano ben scorrere».4 Ad eccezione del concorso nell’allestimento dell’esercito padovano, tutti gli oneri imposti dagli Statuti di Padova gravarono sul nostro comune dagli inizi del XIII fino all’alba del XIX secolo, quindi per ben sei secoli ininterrottamente. A questi gravami si aggiunsero nel corso del XV secolo i tagli e le condotte del legname per l’Arsenale di Venezia, onere anch’esso cessato solo con la fine della Repubblica Serenissima (1797). La nostra comunità, tuttavia, nel gestire il territorio si trovò ripetutamente alle prese anche con altri problemi legati alla viabilità, agli eventi inattesi, alla gestione del patrimonio della collettività di cui già si è fatto cenno per il bosco Viglanicus. Il 12 febbraio 1436, ad esempio, il comune di Rovolon concluse un accordo con i monaci di Santa Giustina. Domenico di Guidotto e Giovanni di Maliganda, decani del comune, assieme agli altri uomini del paese concessero a frate Beltrame, che nella circostanza agiva in nome e per conto del monastero benedettino di Santa Giustina di Padova, l’uso di una strada detta Cestedo che si snodava nei pressi della casa che la comunità religiosa possedeva nella zona. In questo edificio confluivano i prodotti agricoli che i contadini versavano all’agente del monastero a titolo di canoni d’affitto: poter disporre di un comodo accesso non poteva che agevolare le consegne. Per maggiore efficacia la concessione fu ratificata dal Consiglio del comune di Padova il successivo 22 aprile. Nel documento, rogato dal notaio Giovanni Belengeri il 12 febbraio, incontriamo nella veste di testimoni prete Bartolomeo, rettore della pieve di San Giorgio, Donato del fu Andrea da Cusano, Marchesino del fu Giovanni Giacomo da Vicenza, Giovanni del fu Pietro d’Albania e infine Giorgio del fu Antonio da Adria.5 Non sempre però gli eventi che la comunità dovette affrontare riguardarono la gestione del patrimonio comunale. Altre vicende ben più gravi s’affacciarono negli stessi anni in cui fu concluso l’accordo con Santa Giustina per la strada detta Cestedo. In un anno imprecisato, ma subito dopo il 1439 Bartolomeo Rizo e Manfredino Bertolati decani ville Rovolonis, a nome e per conto Il territorio di Rovolon nell’ultima edizione (1969) della Carta d’Italia al 25.000 dell’Istituto Geografico Militare. 20 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei della comunità, depositarono all’Ufficio padovano dei Riformatori ai fuochi un’istanza affinché fosse rivisto l’insopportabile carico fiscale assegnato nel 1431. A giustificare la richiesta vi erano alcune mutate condizioni del villaggio, che in poco tempo l’avevano profondamente cambiato. Nell’arco di appena sei anni, scrissero i decani, ben undici capi famiglia non erano più a disposizione del villaggio, o perché morti, come nel caso di un certo Bussos, Guido da Ronca, Allegro de Ungarello, Nicolò Zago, Zuan de Tofan, Zuan di Domenico Malciade e Domenego Menexello, o perché emigrati altrove. Da Rovolon, infatti, se n’era andato a Teolo il fabbro Ognibene di Domenico, mentre Antonio da Solagna si era trasferito a Conselve; così pure Antonio del Rizo aveva lasciato Rovolon per andare ad abitare a Padova. Un altro uomo di comun, infine, di nome Domenico de Guioto, era divenuto nel frattempo famiglio dei «frati de Santa Giustina», per cui non era più soggetto a concorrere al carico fiscale e alle corvè del villaggio. Ma il motivo più grave che aveva indotto la comunità a depositare la supplica presso gli honorandi deputati era dovuto agli eventi occorsi nel 1439. In quell’anno Venezia aveva perso momentaneamente il controllo della Terraferma Veneta e le truppe milanesi dei Visconti erano entrate nelle province venete: i villaggi privi di difesa furono in tal modo saccheggiati e depredati. Anche «villa Rovolonis [fu così] depredata ad inimizis illustrissimi domini nostri, et in numerabilles bestie, bovine et cavaline fuerunt depredate per inimicos predictos». In altre parole i nemici della Repubblica Serenissima portarono via da Rovolon buoi e cavalli, tanto che non rimasero nel paese animali da lavoro sufficienti per le operazioni agricole e per le altre incombenze che gli Statuti di Padova continuavano ad imporre. Una terza ragione illustrata nella supplica dei decani riguardava l’anzianità e l’impotenza di ben otto capifamiglia «ultra sexaginta». Si trattava di Antonio Beco, Nicolò de Bortolamio Buxanegra, Domenico Drago, un certo La sommità di Monte Madonna con il santuario mariano e l’abitato di Rovolon, in una cartolina illustrata del 1940. rovolon : una com un ità tr a colline e pianur a 21 Toffas, Pietro de Rolandis, Uliviero Bozato, Antonio de Guio e Piero da Spiran. Senza il loro apporto l’onere fissato nel 1431 sarebbe stato ripartito su un numero minore di membri del villaggio diventando in tal modo per tutti insuportabilis. Non conosciamo l’esito di quella supplica, ma possiamo qui solo ricordare che in quei decenni centrali del secolo XV le campagne padovane furono colpite da una pesantissima crisi alimentare ed economica e da un impoverimento generale delle terre coltivate: vicende simili, infatti, si riscontrano anche in altre località, a volte con esiti ancor più tragici e devastanti per la locale popolazione.6 La comunità locale ebbe più volte rapporti anche con l’abbazia di Praglia. L’episodio più singolare riguarda il santuario di Monte della Madonna. All’alba del Cinquecento il comune propose al monastero di prendersi cura dell’antica chiesa, poiché su di essa vantava antichi e incontrastati diritti. Prese avvio una trattativa prima con il beneficiario del santuario, il padovano nonché abbreviatore apostolico Francesco Candi, e poi con gli homines proprio di Rovolon. Scrive in proposito padre Callisto Carpanese: «Favorevolmente colpiti da quanto era accaduto nella chiesa di Carbonara ad opera dei monaci di Praglia e desiderosi di dare nuova vita anche alla loro chiesa del Monte, [gli uomini del comune di Rovolon] rivolsero ripetute istanze al monastero perché volesse prendersi cura di questa chiesa, così come aveva fatto con quella di Carbonara. Le trattative si protrassero per qualche anno. La comunità di Praglia, in un primo tempo, non voleva aderire alla domanda. Venne fissato, alla fine, un incontro tra i delegati del comune di Rovolon e alcuni monaci. Esso si tenne il 26 marzo 1508 “in Spiran [Carbonara] ne la gastaldia del monastero di Praia, nella camera de supra, nova …”. Il monastero era rappresentato dall’abate d. Modesto da Padova e dai cellerari d. Cipriano da Verona e d. Bernardo da Cremona, mentre per il comune di Rovolon si presentarono Battista Bacerla, Eustachio de Tofani, Pasquale Albanese, Pietro Buson e Pietro Baron, muniti di speciale mandato, con atto rogato dal notaio Giacomo dal Bò in data 19 dello stesso mese». L’incontro si concluse positivamente, tanto che i monaci chiesero di poter disporre di un maggior spazio attorno alla chiesa: la delegazione comunale rispose affermativamente, così che, formalizzate istanze e assensi, venne concessa all’abbazia «una petia de buscho posta in la dicta cima, nelle infrascritte confine». L’accordo lasciò alla discrezione dei monaci la decisione se La Madonna degli alpini venerata nel santuario di Monte della Madonna. 22 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei acquistare l’area oppure prenderla in affitto. Il 16 giugno 1508 una bolla di papa Giulio II pose fine ai diritti del beneficiario Francesco Candi, il quale ottenne in cambio un vitalizio annuo di 10 ducati d’oro a carico dell’abbazia di Praglia. Il successivo 26 novembre, una domenica, di fronte e poi all’interno del santuario il notaio Giacomo dal Bò stese il verbale della presa di possesso alla presenza di numerosi fedeli, dell’abate, del priore, di una decina di monaci, del cappellano di S. Giorgio di Rovolon e di sei testimoni provenienti da Padova, Teolo, Rovolon e Zovon. Da quel giorno la chiesa entrò a far parte a pieno titolo del patrimonio del monastero. La vicenda dei primi anni del secolo XVI ebbe un seguito negli anni Sessanta del Novecento: il giorno 11 settembre 1962 il comune di Rovolon donò all’abbazia di Praglia 11.430 metri quadrati di terreno (tre campi alla misura padovana) che, uniti ad altri più modesti appezzamenti ceduti dalla famiglia Valmarana e dalla Curia vescovile di Padova, consentirono all’antico monastero di completare l’opera di recupero del santuario mariano sul colle della Madonna. 7 Accanto alle decisioni prese sul destino di luoghi sacri e venerati, la vita del comune di Rovolon fu tuttavia segnata dal gravoso onere dei continui lavori pubblici imposti dagli antichi Statuti. Un peso che divenne sempre più insostenibile a partire dal XV secolo, quando la fame costrinse tanti piccoli proprietari a cedere le proprie terre ai nobili veneziani, acquirenti spesso esentati dal pagamento di oneri fiscali e sovente non soggetti al concorso nelle opere pubbliche. Il mondo dell’antico comune rurale di Rovolon, così come i tanti altri villaggi della vicarìa di Teolo, è scolpito in un vocabolario che oggi stentiamo a ritrovare. Parole come fazioni pubbliche, ville, comunità di capifamiglia, decani, vicinìe, sembrano appartenere ad un mondo incomprensibile, privo di significato, di dimensione: eppure erano queste a costituire il dizionario secolare su cui si fondava il senso dell’appartenenza, dell’identità. La riforma del 1805 sull’ordinamento dei comuni, che come detto fu introdotta Le scuole comunali di Carbonara in una cartolina spedita da Bastia il 9 agosto 1947. rovolon : una com un ità tr a colline e pianur a 23 nel Veneto l’anno seguente, diede vita ad un profondo mutamento organizzativo e territoriale che, nato in età medievale i secoli della dominazione veneziana (XV-XVIII) seppero consolidare. In quei lunghi secoli dell’età moderna Rovolon e altre due dozzine di villaggi situati nel quadrante occidentale padovano fecero parte di un distretto chiamato vicarìa di Teolo. La sede istituzionale e fisica era nell’edificio costruito proprio nel cuore del borgo collinare, ancor oggi riconoscibile per la torre centrale e la ripida scalinata d’accesso aperta sull’arco del fronte principale. L’antica denominazione di “Palazzetto dei Vicarì” si deve al fatto che qui risiedeva il capo della vicarìa, cioè un membro della nobiltà padovana appositamente eletto. L’incarico durava di norma dodici mesi. Per l’espletamento del mandato il vicario poteva contare su di un articolato organigramma che qui si ripropone riprendendo parole usate nel 1794, allor quando la vicarìa dovette difendersi dall’accusa di non aver provveduto alla manutenzione di un ponte abusivo costruito dalle famiglie padovane Da Rio e Abriani a Bastia. Il processo era stato intentato dai Provveditori all’arsenale di Venezia, preoccupati di mantenere in perfetta efficienza gli accessi al bosco demaniale della Carpaneda. Essendo privato e per di più abusivo l’onere della conservazione del ponte non poteva ricadere sugli uomini della vicaria. Scrisse dunque il cancelliere in risposta ai quesiti posti dai giudici veneziani: «Viene dal Consiglio Generale della città di Padova eletto per vicario uno de suoi cittadini, il quale ivi come capo assiste e rissiede per la giudicatura delle differenze civili, quando però non ecceda il Giudizio una tal summa limitata; et ogni anno il primo di maggio questo si muta. «Vi assiste un cancilier per annotar ogni atto occorrente, e per quegl’incombenti che ricerca la carica. «Sono aggionte a questi otto persone elette dal Consiglio di Vicarìa, ed è formato dalli degani, et un Consiglio per villa, e quattro sono col titolo di cattaveri, e quattro di deputati, che vengono scielti dalli comuni soggetti, et ogni due anni si mutano, in guisa che ogni anno ve ne sono quattro de nuovi, e quattro de vecchi. Ha uno con titolo di nonzio che serve per un anno e questo interviene, come rappresentante di vicarìa, in ogni Conseglio che si fa di Territorio in Padova e rifferisce ogni operazione, per le necessarie notizie di volta in volta. «Vi è un avvocato, et un procurator per le liti. «Vi sono quattro comandadori per l’assistenza al detto vicario per la dispensa degl’ordini, e proclami al Serenissimo Principe, et Eccellentissimi Pubblici Rappresentanti, et altre occorrenze, et esecuzioni del vicariato. «Vi è la Camera de Pegni, che se ben di poca rilevanza, e poco necessari, et si custodisce da un cameriere a conservazione de Pegni». Sempre in occasione di quel processo avviato nel 1794 gli avvocati della Vicarìa elencarono le spese, le obbligazioni e gli aggravi più essenziali cui dovevano sottostare i villaggi del distretto di Teolo. Anche in questo caso lasciamo la penna agli scrittori di allora: «In primo capo la condotta de roveri, et olmi del Bosco della Carpaneda, ed altri particolari che vengono tagliati, alla quale è tenuta la sola Vicarìa concorrervi per la metà che è molta. 24 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei «Seconda. Vi è quella dei tolpi tutti, che sono tagliati d’ordine pubblico nella stessa Vicarìa, e per questo altri non vi concorrono, ma tutto si fa a spese di essa Vicarìa, che è considerabile. «Terzo. Vi è l’obbligo di tenir in acconzio, e far da nuovo al bisogno li ponti di legno di Tencarola, sopra il Bachiglion, e di Trambache ove passa la Tesina, che fra ferramenta e legnami la spesa non è poca. «Quarto. Si ha l’obbligazione di rifar, e mantenir, le coronelle delli arzeri del fi ume Brenta e Bacchiglione per lunga tratta di paese, et a posti destinatili, che viene d’incomodo, ed aggravio non poco. «Quinto. Il cavamento de ghebbi diversi, e ripari di fosse, e strade, che porta aggravio, e spesa annuale, e non è alle altre certo inferiore. «Sesto. L’obbligazione di mantenir per l’armar di numero 218 soldati, o 12 offiziali, pagar l’affitto alla Comunità di Este per la Casa del Capitanio delle Ordinanze, Camera dell’Armamento, Consolato di Vicarìa, pagar li soldati alle Mostre Generali, et un schiopetto per tenere le armi in acconcio per servizio delle milizie stesse. «Settimo. Il mantenimento delle fabbriche, casa del detto vicario, loza pubblica, e sala del conseglio, cancelaria, e casa del comandador e le pubbliche strade. «Ottavo. La spesa di alcuni annui livelli perpetui in summa di lire 204 e soldi 10 che si pagano per le fabbriche sudette alli NN. HH. KK. Mocenigo e Contarini, et a signor Capodelista, oltre l’affitto annuo di lire 180 e soldi 15 alla Comunità di Este per la Casa delle armi, e corsaletti delle cernide. «Nono. Spese de salariati diversi, e per la quantità come nel capo 13 sarà distintamente dichiarito, con la qualità che sarà espressa, ad uno per uno. «Decimo. Spese de liti, che si convengono fare, e per estrazioni, e per giurisdizioni, e per mantenimento de privilegi, tanto contro patroni, e comuni soggetti, quanto anche alcuna volta contro lo stesso territorio, e ministri di quello pretendenti inferiori pregiudizi, e danni alla Vicarìa medesima. «Undecimo. Vi sono poi le spese per libri, carta, stampa, rate, comandamenti, et altre diverse. «Duodecimo. Gli alloggi delle milizie, galeotti, guastadori, in tempo di bisogno, come occorse nell’ultima passata guerra, e carri, tavolazzi per l’esercizio delle cernide, et alcune altre per la dispensa delli libretti delle dadie a comuni, aggiustar dell’Orologgio, e tenir netto il Consiglio, loza e camere, etc.» L’elenco si chiude ricordando ai Provveditori dell’Arsenale che oltre alle dodici voci sopra elencate ve ne sono altre che nella circostanza non vengono riportate «per non moltiplicare il tedio all’Eccellenze Vostre», ma che saranno debitamente illustrate in un altro capitolo della lunga memoria difensiva. Una memoria che meriterebbe di essere interamente pubblicata, ma che l’economia di questo lavoro non consiglia. Qui dobbiamo tuttavia ricordare che tra le opere di maggior aggravio vi erano la tassazione esosa, la continua manutenzione delle strade Montanara (Padova-Teolo), Scapacchiò (Tencarola-Bastia), Cavalcaressa (Zovon-Cortelà) e parte della Mestrina (PadovaVicenza), la pulizia dei ghebbi, cioè degli alvei dei fossi principali, la condotta delle roveri. Un riparto che la Vicarìa aveva ripetutamente rivisto in relazione alla forza economica e sociale di ciascun paese, come ben ricorda Domenico rovolon : una com un ità tr a colline e pianur a 25 Piasentin, degano della villa di Rovolon, in un intervento verbalizzato il 19 settembre 1763.8 Nel Consiglio della Vicarìa vi era dunque un rappresentante anche di Rovolon; nelle sedute si dibattevano i comuni problemi che interessavano i ponti, i fabbricati, le strade, gli argini, gli scoli e soprattutto la condotta delle roveri dai boschi al porto di San Martino della Vaneza. Argomenti che dalla Vicarìa venivano fatti propri dai capifamiglia di ciascun villaggio nelle periodiche riunioni dette vicinìe. Peccato che i registri contenenti i verbali di quei dibattiti, su cui il cancilier annotava «ogni atto occorrente», siano scomparsi dopo il 1880 dall’archivio comunale di Teolo dove erano custoditi e dove Bartolomeo Cecchetti, soprintendente archivistico, ebbe modo di esaminarli, inventariarli e pubblicarne la sommaria consistenza. Si trattava di ben 128 registri che raccoglievano i verbali delle riunioni tenutasi tra il 1420 e il 1815, più altre 17 “buste” (contenitori d’archivio) di Atti del periodo della Repubblica Veneta, compresi fra gli anni 1500-1796.9 La perdita di quei registri, di quei documenti, c’impedisce di raccontare tanti eventi che dal Quattrocento fino allo scadere del Settecento coinvolsero e videro protagonista anche Rovolon. Il rammarico per la memoria perduta non ha tuttavia intaccato l’animo di una Comunità e il senso di appartenenza che ancor oggi è vivo nel cuore di ognuno. Note 1. Il «Liber» di S. Agata di Padova (1304), a cura di Giannino Carraro, con Nota di diplomatica di Gian Giacomo Fissore, Padova (ed. Antenore – Giunta Regionale del Veneto – Fonti per la Storia della Terraferma Veneta, 11) 1997, p. 136-142. 2. Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, a cura di Andrea Gloria, Padova (Tip. F. Sacchetto) 1873, libro IV, p. 319-338. Degli Statuti esiste anche un’edizione in lingua italiana: Statuti del comune di Padova, traduzione Guido Beltrame, Guerrino Citton, Daniela Mazzon, Cittadella (Ed. Biblos) 2000, p. 372-395. 3. Archivio di Stato di Venezia (= ASVe), Savio Cassier, b. 440, fasc. 15, ripreso da Claudio Grandis, L’ultima ricostruzione del ponte sul Bacchiglione in età veneziana (1795), in Claudio Grandis, Tencarola pagine di storia, con un contributo di Guido Beltrame, Padova 1996, p. 47-62. 4. Statuti del comune di Padova libro IV, p. 339; nell’edizione tradotta (Statuti del comune) si veda alla p. 395. 5. Archivio di Stato di Padova (= ASPd), Corona, gener. 7484, partic. 1670. 6. ASPd, Estimo 1418, tomo 353, polizza n. 51, c. 190r. Vicende analoghe a Rovolon sono ricostruite da Claudio Grandis, Corte al tempo della dominazione veneziana, in Corte bona et optima villa del Padovano, a cura di Raffaella Zannato, Piove di Sacco (Art&Print) 2007, p. 90- 94. 7. Callisto Carpanese, Il santuario del Monte della Madonna nei Colli Euganei, Abbazia di Praglia 1987, p. 30-32, 152. 8. ASVe, Fisco processi. Serenissima Signoria, III, b. 125, processo n. 464. 9. Bartolomeo Cecchetti, Statistica degli archivi della regione veneta, Venezia 1880, vol. I, p. 150. 26 Particolare della mappa disegnata da Annibale Maggi nel 1449, il documento cartografico più antico del territorio padovano. Al centro, circondata dall’anello d’acqua della Fossa Nina, è riconoscibile la “Bastia de Revolon”. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Francesco Tognana Dal villaggio medioevale alla villa: insediamenti, castelli e strutture fortificate In un giorno d’agosto del 1252, corse voce a Padova che “per i castelli del Pedevenda” – così erano chiamati i Colli Euganei in età medioevale – “ovunque essi fossero”, era stato visto il fuoco ardere a lungo intorno alle merlature bruciando vividamente graticci e munitiones, strutture lignee più facilmente combustibili. La notizia risultò in seguito priva di fondamento. È vero tuttavia che così munito doveva apparire anche il fianco del monte di Rovolon alle truppe di Ezzelino Da Romano, il noto “tiranno”, quando, appena pochi anni prima, marciando verso Monselice, passavano per confinia Rovolonis1. Lo sviluppo dei castelli a Rovolon è inserito nell’ambito di un fenomeno più ampio, detto incastellamento, il quale condizionò l’intero Occidente europeo a partire dal IX secolo e per tutta l’età medioevale nella sua dimensione geopolitica, culturale e socio-economica. Questa eccezionale proliferazione di strutture fortificate si manifestò con ritmi, forme e per motivi diversi nelle varie regioni d’Europa. Molteplici sono anche i lemmi del linguaggio fortificatorio – castrum, castellum, castelletum, castellarum, turris, roca, mota, bastia, per citare solo quelli che incontreremo nel prosieguo del nostro discorso – i quali rinviano a una morfologia dei manufatti altrettanto diversificata. Limitatamente all’Italia settentrionale si sono potute contare almeno circa cinquecento attestazioni di nuovi siti fortificati solo entro l’anno Mille. Per il Veneto, nell’arco dell’intero Medioevo, una prima stima complessiva condotta per i territori di Padova, Vicenza e Treviso, annovera oltre trecento agglomerati umani che coincidevano con un castello o ne ospitavano uno. Nella sola area dei Colli Euganei si contano una sessantina abbondante di strutture fortificate. Tra queste si distingue il sistema fortificato che metteva capo a Rovolon e trovava compiutezza nella vicina Carbonara con ben quattordici attestazioni riportate tra XIII e XIV secolo, delle quali cinque rinviano espressamente a un castrum/castellum. Per il territorio dell’odierno comune di Rovolon, che comprende le frazioni di Carbonara e di Bastia e si estende per circa 28 km2, significa teoricamente una fortificazione ogni 2 km2. Ciò significa che in età medioevale Rovolon era un’area densamente incastellata2. Non vi sono invece testimonianze scritte di strutture fortificate nell’area di Rovolon tra il X e l’XI secolo, nonostante sussistessero le premesse per una precoce militarizzazione del territorio, dettate da una situazione di incertezza dovuta alle incursioni ungariche documentate a nord e a sud dei Colli Euganei e da un contesto geopolitico complesso dove interessi di forze diverse convergevano nella stessa area di frontiera. Sul comparto nord-occidentale dei Colli Euganei premevano infatti le istan- 28 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei ze del vescovo e del capitolo di Verona da una parte, del vescovo di Vicenza dall’altra. Gli uni attestati a Montegalda, Boccon, Cinto e Villa di Teolo, l’altro a Zovon, Boccon, Fontanafredda, Teolo e, appunto, Carbonara. In questa cornice il vescovo di Padova, nell’ambito di una politica di ristrutturazione dei confini del territorio diocesano, e forte di un privilegio imperiale del 911 che gli consentiva di erigere castelli ovunque necessario, con l’esenzione fiscale per quei luoghi dove fossero già stati costruiti, ribadiva le sue prerogative su Rovolon, allora in diocesi di Padova ma inserita nell’ambito del comitato vicentino sotto il profilo amministrativo, attraverso concessioni ad enti ecclesiastici ed ad uomini fedeli ad esso collegati. Alcuni esempi: il monastero di Santa Giustina di Padova, “monastero episcopale…strettamente unito e incorporato alla Chiesa patavina”, nel 970 ricevette in dono dal vescovo Gauslino il diritto di decima e del quartese (cioè la decima parte del raccolto e la quarta parte della medesima) sulle pertinenze del villaggio di Rovolon e della sua pieve. Altro esempio: nel 976 Nantkerio, vassallo del vescovo, otteneva, per mezzo dei canonici di Padova, della terra nella contrada Prada di Rovolon. Ed ancora: a riprova dell’interesse stringente dell’episcopio patavino su questo settore dei Colli Euganei, dietro un’azione giudiziaria intentata nel 1077 dal clero della cattedrale di Padova e dagli arcipreti e preti delle pievi di Monselice e Rovolon per ottenere il banno regio (cioè il potere di costringere, giudicare e punire proprio della massima autorità pubblica) in difesa di decime, quartesi e immobili in dotazione ai rispettivi luoghi di culto, sarebbero da intravedere dirette responsabilità del vescovo o di suoi “aderenti”, come studi recenti hanno sostenuto con fondate ragioni. D’altra parte, in questo periodo, tutt’intorno a Rovolon iniziavano a vedersi i primi segni dell’incastellamento. Al castello di Monselice (VI secolo) si aggiunsero quelli di Arquà (X secolo) e Castelnuovo (XI), ma anche Este e Rocca Pendice, attestate solo a partire dal XII secolo, erano quasi certamente state allestite in età precedente3. Eppure, al di là di possibili vuoti documentari, l’incastellamento ha lasciato tracce nelle fonti scritte relative a Rovolon solo a partire dalla prima metà del Duecento. Si tratta per lo più di toponimi i quali rinviano a uno sviluppo fortificatorio già concluso o almeno definito nelle sue principali forme al momento dell’attestazione e che sono riportati nella documentazione relativa alle vicende del patrimonio fondiario di realtà signorili di matrice religiosa e laica che gravitavano su Padova: il monastero urbano di Santa Giustina, il monastero di Santa Maria di Praglia e la discendenza dei conti di Vicenza e di Padova (questi ultimi erano discendenti dei dogi Candiano di Venezia e a cavallo dei secoli X e XI ricoprirono, appunto, la carica di conte, cioè di delegato dell’imperatore, vale a dire di rappresentante della massima autorità pubblica nell’amministrazione della giustizia, nella riscossione delle imposte, nell’organizzazione militare del territorio). Il fenomeno dell’incastellamento si manifesta nella fase di consolidamento e di massima espressione di queste tre realtà in termini di presenza fondiaria e di esercizio di poteri giurisdizionali tra XII e XIII secolo, con esiti di cui resta traccia ancora nel secolo seguente. Il monastero di Santa Giustina, forte della donazione del 970 fatta in suo da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 29 favore dal vescovo Gauslino e confermata dai suoi successori con ulteriori elargizioni, incrementò la propria base fondiaria a Rovolon a partire da lasciti e donazioni della famiglia Da Rovolon avvenuti nella prima metà del XII secolo. Della famiglia si conservano labili tracce nella documentazione scritta, le quali riconducono, sembra, a legami importanti con la realtà vassallatica vescovile veronese e padovana, tra antenati (Erzoni/Ingoni) e più prossimi parenti (Tanselgardi), e rinviano ad una ancora relativa disponibilità fondiaria. Il monastero entrava anche nella piena disponibilità del diritto di decima su Rovolon del quale erano titolari i de Orlano (presumibilmente Orgnano, nel Trevigiano), antica famiglia dell’aristocrazia della Marca Veronese Trevigiana, che ne fece espressa rinuncia a favore del monastero nel 1192. Nel 1261, tramontata la dominazione ezzeliniana, nell’ambito del riassetto delle proprie sostanze, il monastero era impegnato a riprendere sotto il proprio diretto controllo le proprietà di Rovolon, e precisamente quelle ubicate nel castello. Come sappiamo da documentazione di metà Trecento ma che rinvia a un periodo anche precedente, il monastero si era radicato in loco anche attraverso una rete di vassalli, tra i quali spiccavano gli Schinelli, eredi dei conti di Vicenza e di Padova e coinvolti a loro volta nella vicenda dell’incastellamento locale, come vedremo4. Il monastero di Santa Maria di Praglia, fondato e patrocinato all’inizio del XII secolo dai Maltraversi, lontani parenti degli Schinelli, nel 1154 comprava mansi a Costa dai Da Limena, vassalli degli stessi Maltraversi5. Il cenobio fa la sua comparsa tra i proprietari terrieri di Rovolon e di Carbonara almeno dagli anni Settanta e Ottanta del XII secolo6. Da allora l’ente religioso accrebbe la propria base fondiaria grazie ad acquisti, donazioni e ad una sapiente opera di valorizzazione e colonizzazione del territorio, dai singoli appezzamenti ai più consistenti organismi fondiari, come quella curtis di Carbonara citata solo dal 1205 ed epigono del tradizionale modello di organizzazione agraria – il sistema curtense, appunto, articolato nella pars dominica, cioè l’insieme di terre che il padrone (dominus) teneva sotto la propria gestione diretta, e nella pars massaricia, l’insieme di fondi assegnati a coltivatori dipendenti – adottato anche nei Colli Euganei nel X secolo, almeno a Zovon, Boccon, Cinto, Villa di Teolo, a Petriolo di Monselice e anche nella vicina Lovertino7. A corroborare la crescente infl uenza del monastero sul piano politico e socio-economico locale erano diritti giurisdizionali propri di una signoria territoriale che l’ente religioso deteneva a Carbonara almeno all’inizio del XIII secolo. Tali diritti si manifestavano nel 1205 “cum omni honore et districta et signoria” cioè con la facoltà di costringere (costringere a obbedire, a prestare eventuali servizi militari, a pagare i tributi) e di punire (e quindi di chiamare in tribunale). Il Bastia in una cartolina illustrata del 1943. 30 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei loro esercizio era collegato al possesso di una motta (mota), un complesso fortificato di cui si darà conto in seguito8. La componente laica del potere signorile era rappresentata dalla discendenza dei conti di Vicenza e di Padova: i Conti e gli Schinelli per la linea padovana, i Maltraversi Da Castelnuovo e i Maltraversi Da Lozzo, castelli dei Colli Euganei vicini a Rovolon, per la linea vicentina. L’attestazione di più rami della stessa famiglia in loco induce a pensare ad una presenza del clan comitale a Rovolon anteriore all’articolazione nei due rami principali, padovano e vicentino, avvenuta nella seconda metà dell’XI secolo. Di fatto membri della famiglia sono ricordati attivi in quest’area solo a partire dalla metà del XII secolo con Alberto figlio di Maltraverso, l’eponimo del ramo vicentino, confinante nel 1147 con i beni del monastero di Santa Giustina. Il consolidamento della loro posizione a Rovolon sembra corrispondere invece al “ritiro dalla scena” dei Da Rovolon e dei de Orlano, ai quali erano forse legati per parentela e interessi. Infatti, risulta sibillino che nel 1226 i discendenti di Manfredino conte (del ramo dei Conti, appunto) dichiarassero tra i beni ereditati un fondo “eorum de Rovolone, in quo habitabant, et descendebant” e che Zordanino, fratello di Manfredino conte, si appellasse anche “Da Orgnano” per i diritti vantati su quel castello del Trevigiano9. Nel 1174 Alberto Terzo dei Conti, zio dei predetti, riceveva a titolo di feudo dal vescovo di Padova un terreno a Rovolon da lui precedentemente posseduto e ceduto al presule in cambio di terreni in città10. È significativo che per irrobustire la loro presenza a Rovolon i Conti ricorressero al vescovo, il più antico possessore di beni a Rovolon, e allo strumento del feudo il quale, creando un rapporto gerarchico tra il dominus (cioè colui che concedeva il feudo) e il vassus (il vassallo, colui che riceveva il beneficio), tramite la superiore autorità del vescovo, non limitava ma anzi conferiva veste legale al L’abitato di Rovolon con la chiesa circondata dalla mura del cimitero (in basso a sinistra) e la rocca in una mappa del XVIII secolo. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 31 potere del suo vassallo. La dimensione e il peso specifico del dominio signorile della famiglia a Rovolon possono essere colti a pieno nel corso del XIII secolo e sono da mettere in stretta relazione alle prerogative del casato sul castello e alla disponibilità delle strutture fortificate collaterali da parte dello stesso. L’eredità di Manfredino conte, alla quale si è accennato sopra, vedeva il grosso di beni e di clientele nel contado concentrato soprattutto a Rovolon: 51 nuclei familiari che costituivano altrettante masnade ( “bande armate” al seguito di un signore), 36 vassalli detentori di altrettanti feudi, 7 vassallatici, censi (affitti) e servizi d’opera (corvées) sulle terre del signore, dovuti dai contadini locali, oltre ad un centinaio di unità immobiliari cui è da aggiungere il possesso di interi mansi (poderi) e del monte di Rovolon (monte della Madonna). Eco di tanta ricchezza e influenza si riflette in una cronaca medioevale la quale ricorda che i Conti di Padova e gli Schinelli “montem Rovoloni posederunt”. Gli stessi Schinelli si appelleranno nel XIV secolo anche Da Rovolon e cronache del secolo seguente li avrebbero definiti, seppur tardivamente “Comites Rovolonis sive Schinelli”, a sancire il vincolo tra la famiglia e il villaggio11. Essi vigilavano i centri nevralgici di controllo del territorio: li ritroviamo confinanti, ad esempio, nel 1232 nella contrada del Castello con i Maltraversi Da Castelnuovo e Da Lozzo e nel 1261 precisamente nel castello e ancora nel 1287 nelle contrade del Castelrotto e di Vigonovo, località anch’esse fortificate12. La vitalità del potere signorile di queste famiglie ancora nel tardo Duecento trova conferma nel Liber possessionum13, una sorta di “catastico”, di inventario di beni, di Adelmota dei Maltraversi Da Castelnuovo, progenitrice di quei Papafava Da Carrara che nel XIV secolo, entrando in possesso anche delle sostanze in Rovolon di Caterina Schinelli sposata Papafava, ricostituivano almeno in parte l’unità patrimoniale della famiglia comitale in loco14. Dal “catastico” La piana che dagli Euganei si stende verso i Berici. 32 Dettaglio della “Gran Carta del Padovano” (1780) di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. In evidenza i rilievi collinari, la viabilità e i principali proprietari della zona. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei risulta che la signora possedesse oltre mille campi tra Rovolon, Costa e Carbonara, in gran parte forieri di censi e prestazioni dovuti dai livellari ivi insediati, cui si sommano quasi un centinaio di unità immobiliari, alcuni feudi, dieci masnade nonché la piena disponibilità di “duas partes sive medietatem comitatus totius ville Rovolonis et eius districtus et duas partes seu mediatatem roche et castellarii” (due parti o metà di tutto il comitato del villaggio di Rovolon e del suo distretto e due parti o metà della rocca e del castellaro). Con quest’ultima espressione si precisava lo spazio del dominio della signora (domina), il quale abbracciava un ambito territoriale che superava i confini delle proprietà della nobildonna e si estendeva, per la “quota” che era dovuta, su tutto il villaggio, il territorio e la sua popolazione. I diritti comitali che le spettavano, eco lontana dei poteri connessi alla funzione pubblica delegata ai suoi antenati su tutto il comitatus di Vicenza e di Padova e di cui si è detto, o da ricondurre ad investiture successive, di cui peraltro non resta traccia, si erano all’epoca ormai “territorializzati”. Essi si erano cioè concentrati in una zona dove la famiglia aveva un maggior numero di possessi e dove all’epoca, il potere di coercizione e di comando, di origine pubblica, non era esercitato solo sui suoi coltivatori, ma su un territorio circostante più esteso delle sue proprietà e su tutti i contadini che a vario titolo lo occupavano, fossero essi dipendenti del signore o lavoratori di terre altrui o piccoli possessori che coltivavano la propria terra. E l’esercizio di tali poteri risultava intimamente connesso al possesso della struttura fortificata che ne era, per contro, l’espressione e il simbolo materiale. Il dettaglio documentario che un pronipote di Adelmota, Giacomo di Rinaldo Papafava Da Carrara, possedesse ancora nel 1324 “quartam partem totius comitatus Carbonarie et cum suis districtibus et Coste secundum quod habebat dicta domina Adelmota” (la quarta parte di tutto il comitato di Carbonara e di Costa con i loro distretti secondo quanto spettava alla signora Adelmota”) precisa quale fosse il volume e la consistenza del potere signorile della nobildonna15. Queste forze signorili si muovevano in un’area di frontiera caratterizzata da una situazione ambigua e di parziale compromesso sotto il profilo geopolitico ancora nel tardo XIII secolo. Se Rovolon e Carbonara erano ormai passate entro quell’epoca sotto la sfera di infl uenza padovana rispondendo sia al sistema fiscale del Comune della Città euganea e sia, sotto il profilo religioso, alla sua diocesi, la chiesa di Costa ricadeva in diocesi di Vicenza (1297) benché il suo territorio aderisse al distretto padovano (1333). A ciò si aggiunga anche che parte delle sostanze di Adelmota nella zona di Rovolon sconfinava nel distretto vicentino lambendo le proprietà del comune di Vicenza16. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 33 Alcuni fatti permettono di misurare il livello di tensione che poteva scaturire dalla “convivenza” di tanti soggetti con interessi distinti in un territorio dagli “incerti” confini. Al 1268 risale la notizia di un giudizio intentato dal monastero di Santa Giustina contro Benedetta moglie del fu Michele Schinelli, i suoi figli e il comune di Rovolon forse per la “distrazione” di alcuni beni del cenobio da parte degli Schinelli appoggiati dalla comunità locale. Altro fatto: all’indomani della dedizione di Vicenza a Padova nel 1266, la partecipazione di Ansedisio e Bartolomeo Schinelli al complotto ordito dai Veronesi contro Padova nel 1279 andrebbe letta anche come risposta alla rinvigorita attività legislativa del Comune di Padova, volta a un controllo più serrato del contado a scapito di enclave di autonomo potere feudale. Le norme intendevano regolare l’esercizio dei poteri dei signori limitandone di fatto i margini d’azione e prevedevano nel 1276 l’istituzione di un podestà di contado anche per Rovolon e, appena due anni dopo, inquadravano nell’ordine comunale nella città di Padova le prerogative dei domini (signori) Da Castelnuovo e Schinelli in materia di polizia nel distretto rurale di Rovolon, a loro soggetto17. Se eminenti ragioni strategiche di dominio e di presidio del territorio sono dunque alla base dell’incastellamento, la definizione di aree di potere signorile e il consolidamento della trama dei castelli si palesano anche a Rovolon, come altrove in Italia e in Europa tra XII e XIII secolo, in relazione a dinamiche di carattere demografico e di concentrazione della forza lavoro in prospettiva della colonizzazione dell’ambiente e della valorizzazione del territorio. E in questo senso la struttura fortificata, quale espressione materiale del potere dei signori, diventa centro di coordinamento di terra e di uomini. Per tutta l’età medioevale, l’habitat locale fu caratterizzato da una diff usa macchia boschiva. Si distinguevano la vasta area “buskiva, palludiva et aquiva” a Gazzo di Carbonara, il bosco di Mardelugo, sempre a Carbonara, quello della Carpeneda nella zona di Bastia, gli oltre duecentocinquanta campi di bosco detto Viglanico a Rovolon con alberi di varia qualità: rovere, faggio, frassino, cerro. Lo sviluppo delle potenzialità agricole del territorio si evince dalla diff usione di toponimi che rinviano al disboscamento quali Ronchaya, in Runchis, in Roncha, in Ronchole, in contrata que dicitur vigris e alla bonifica e alla messa a coltura che sono ricordate in espressioni come in Novoledo, in Pratonovo o in Pranovo, in contrata que dicitur Campilongi, in Campis plantatis, in Camporeo. Specifiche colture sono richiamate da nomi di contrade e luoghi Carbonara in un rilievo topografico del 1828 elaborato per il trasferimento dell’antico cimitero in altro luogo. 34 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei detti Persicaria, Perara, Vignola, Preulivera. Ad esse si aggiungevano coltivazioni di frumento, numerosi vigneti di uva schiava e garganica e oliveti. In una siffatta realtà agricola, fertile e prospera dove il contadino era tenuto a “ bene laborare, arare, seminare…segare, lodamare, fosatos cavare”, i signori predisponevano spazi appositi per l’immagazzinamento e lo “stoccaggio” in vista dell’uso o del commercio dei prodotti nei mercati locali e in città. Il monastero di Praglia aveva una canipa a Costa mentre Bonaccorso Schinelli ne possedeva una a Rovolon. La persistenza di ampi specchi lacustri, confermata in vari toponimi (contrata Bagnolo, contrata Bagnara, in Ysolis, in Gurgo, Palusello, Palus Teçure, una palude a Rovolon, un’altra a Carbonara, un’altra ancora “di Faedo”), garantiva l’attività piscatoria. Lungo i canali si sviluppava l’attività molitoria (supra rostas, recitano puntualmente i documenti che ricordano anche una casa cum molendino). Corsi d’acqua detti “calti” incidevano le valli dei colli. Altri percorrevano la pianura antistante le pendici dei colli di Rovolon (contrata Spirani intus ambas foveas, contrata Spirani ultra foveam con la degora comunis, tra Rovolon e Carbonara, contrata rialis Çovonis, rium Carbonarie, contrata que dicitur canalis a Rovolon, in Fossepoye, a latere superiori de fossatum Braydolini, ultra foveam, fossatus bastardus). Questi ultimi erano utilizzati come vie del commercio locale in collegamento con la principale via di comunicazione tra Padova e Vicenza, il fi ume Bacchiglione: noti erano il navilium, il navilium medium, la fossa Nina o “de Pedevenda”. Contemporaneamente essi segnavano il confine naturale tra il Padovano e il Vicentino (fossatum quod est intus confinia civitatum Padue et Vicentiae; navilium confinium). Pur in presenza di una serie di passaggi, ponti (numerosi i rinvii a ponte; a ponte novo, a ponte de pria, a pontesellis; in Silva de Ponte; a Ponte fratalie), vie arginate o rialzate ai margini del perimetro collinare, si era di fronte a una realtà lacustre di difficile accesso, reso ancor più arduo da frate (cioè fratte, terra lasciata volutamente intricata e cespugliosa), la quale offriva una prima difesa naturale sicura per i villaggi e le strutture L’antico abitato di Rovolon. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 35 fortificate allestiti nelle zone d’altura e lungo le pendici collinari (si ricordino i toponimi in Monte, in Monte Rovolonis, in Monte Viale, in Montesello, in Pindisella, solo per citarne alcuni)18. Parallelamente allo sviluppo agricolo vi fu un’espansione demografica che raggiunse i suoi massimi livelli nel XIII secolo. Essa si fondò su solide basi, come prova il villaggio (villa) di Rovolon con la sua chiesa, attestati sin dal X secolo come un nucleo abitato sostanzialmente definito, che denota un ambiente relativamente ben popolato dall’Alto Medioevo. Tale crescita lasciò tracce evidenti nella conformazione dell’abitato e nel tessuto insediativo del territorio (campanea Rovolonis) con una quantità di siti, località, contrade abitate, in gran parte non documentate prima del XIII secolo (oltre un centinaio i toponimi attestati nella sola Rovolon e più di una cinquantina quelli riportati complessivamente per Carbonara e Costa)19. La pieve di San Giorgio di Rovolon, dotata di un palazzo porticato (nel 1287 un atto è rogato infatti sub porticalli caminate ecclesie Sancti Georgi) si affacciava sulla piazza (plathea ecclesie Sancti Georgi) e dava nome a una contrada dove abitava anche Bonaccorso Schinelli. Il portico della “caminata” del villaggio era il luogo di incontro della comunità riunita in assemblea (1261). Punti di riferimento per la popolazione locale erano anche altri luoghi rurali di culto o centri di ricovero per malati e viandanti ai quali rinviano toponimi come a Sancto Andrea o in contrata Sancti Andree o in contrata que dicitur hospitalis e ab hospitale Sancti Iacobi e l’insediamento eremitico della chiesetta di Santa Maria de summitate montis Rovolonis. A una località detta “vigo” (forse il nucleo antico dell’insediamento) si sommarono nuove realtà abitate dette espressamente “Vigonovo” e “Canove”20. Anche la vicina Carbonara, che nel X secolo ospitava dei “casali” (insediamenti agricoli accentrati di dimensioni ridotte forse collegati a forni per la legna, come suggerisce la stessa voce Carbonaria), nell’arco di due secoli aveva assunto le forme del villaggio, con propria chiesa dedicata a San Giovanni La pianura verso i Berici ripresa dalle colline di Rovolon. 36 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Battista (1190), forse con altri luoghi minori di culto (alla fine del XIII secolo presso Carbonara è menzionato “un luogo detto Santa Giustina”, in omaggio alla patrona della città di Padova, come era uso anche altrove nei Colli Euganei e nel Padovano – ne sono esempio le pievi di Santa Giustina di Teolo, di Pernumia, di Santa Giustina di Monselice, di Pernumia, di Santa Giustina in Colle, quella vicentina di Montegalda, ma in diocesi di Padova, e la chiesa di Santa Giustina di Laurano presso Este – o forse in riferimento alle sostanze dell’omonimo monastero urbano fortemente radicato a Rovolon) e con tanto di porte d’accesso al paese (a capite ville, a portis Carbonarie e in Bagnara a portis). Questi ultimi elementi permettono di immaginare la fisionomia di un paese limitato forse da fossati, terrapieni, palizzate di legno21. Solo a partire dal 1154 si ha notizia di un altro villaggio tra Rovolon e Carbonara. Si chiamava Costa e prendeva il nome della sua ubicazione a mezza costa sul monte, appunto. Il villaggio era dotato di una chiesa dedicata a san Pietro (1226) e tra i suoi edifici si poteva riconoscere una casa (domus) di Bonaccorso Schinelli (1288)22. Una sorta di gerarchia tra i villaggi vedeva Rovolon distinguersi per la presenza della pieve, sede di fonte battesimale e cuore della vita religiosa locale, per consistenza dell’abitato (il dato relativo al patrimonio di Adelmota dà 60 nuclei edificati a Rovolon, 8 a Carbonara, 12 a Costa), per numero di fuochi (175 quelli di Rovolon, 16 e 10 quelli di Costa e di Carbonara, rispettivamente) e di vicini, cioè di capifamiglia (nel 1262 Rovolon ne contava ben 105) nonché per numero di carri che i villaggi erano tenuti a fornire alla milizia comunale di Padova per il trasporto di vettovaglie e pane (13 Rovolon, 3 Carbonara), dati che illuminano, complessivamente, sul processo di crescita demografica e di valorizzazione ambientale. Nei tre villaggi il solido nucleo abitato formatosi attorno alla chiesa si risolveva senza soluzione di continuità in un tessuto insediativo a maglie larghe tra cortili con alberi da frutto e viti, campi, prati, boschi e un edificato, composto da case “murate” in pietra o laterizio, quelle La pianura attorno a Frassanelle. A destra è riconoscibile la villa Papafava. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 37 più solide, o in paglia, le altre, ma tutte sostenute da elementi in legno con tetti in coppi o di paglia23. Alla materia prima con cui erano costruiti gli edifici rinviano toponimi come a Calcara, in Caal(c)e Carbonarie, Terralba o a Terre blanche, ma anche il riferimento a cave di pietra in contrada Riçago e le strutture dove la materia prima era lavorata (Fornaxe, in Fornaxe, monte Vallis Fornacis, in Valle Fornacis, in Villa Coste seu Fornaxe, in confinibus Coste in contrata que dicitur Fornaxe; in Fornaxe de Costa, in Riva de Fornaxe, sempre a Costa)24. È su questo “impasto di terra e di uomini”25 che si definì il tessuto della maglia fortificata di Rovolon, in forme articolate che non corrispondevano necessariamente solo a dimore nobiliari ma che potevano prevedere, nell’ambito dello spazio munito di difese, anche case e aree coltivate eventualmente affittate o concesse dal signore a propri livellari. Noto alle fonti a partire dal XIII secolo, nel 1232 il castello di Rovolon dava il nome a una contrada del villaggio (contrata castelli…in villa Rovolonis) dove convergevano gli interessi fondiari di vari esponenti della famiglia comitale (Schinelli, Da Castelnuovo e Da Lozzo)26. Le successive notizie relative al castello forniscono invece informazioni sull’ubicazione del sito fortificato e sulle dimensioni del manufatto. Alla data del 1297 tra le pertinenze del castello vi era la chiesa di San Pietro (ecclesia de Rovolone o Monte Sancti Petri de castro de Rovolone). La chiesa dipendeva dalla pieve di San Leonzio di Lozzo e rientrava nell’ambito della diocesi di Vicenza retta nel primo Duecento dal preposito Nicolò Maltraversi Da Castelnuovo, il potente canonico padovano congiunto Da Lozzo e divenuto vescovo di Reggio Emilia27. Per la sua posizione risulta degna di nota l’attestazione “sul monte di Rovolon” di una contrada di San Pietro, dove avevano beni il monastero di Santa Giustina (1269) e i discendenti dei conti di Vicenza e di Padova28. Il riconoscimento della chiesa di “San Pietro del castello di Rovolon” con quella di San Pietro in Costa di Carbonara promosso in studi recenti, e il toponimo Costa attestato in territorio di Rovolon suggeriscono la possibile ubicazione del castello di Rovolon29. D’altra parte il villaggio di Costa, pur con una propria area di pertinenza (confinia Coste) e una certa autonomia (nel 1333 la comunità locale si riuniva “in plena et comune vicinancia”), ancora nel tardo Quattrocento rientrava nel territorio di Rovolon e la sua chiesa – identificabile con l’ ecclesia Coste Sopra, Villa Papafava a Frassanelle in una cartolina illustrata degli anni Venti del secolo scorso Sotto, Carbonara agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. 38 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Rovolonis confermata da Papa Urbano III al Capitolo della Cattedrale di Santa Maria di Vicenza nel 1186 – fu annessa a quella di Carbonara solo negli anni Venti del Cinquecento30. Non resta però alcuna esplicita testimonianza di un castello di Costa sebbene l’inedita notizia di muralee antique e di una domus di pertinenza dei Papafava in Costa (1483) illumini sulla possibile presenza di un qualche manufatto di una certa solidità. Per contro, il toponimo Castei indica oggi un’area compresa tra il “Castellaro” e la chiesa di San Giorgio di Rovolon, al lato del sentiero per Sella Fiorine località tra il Monte Grande e il Monte della Madonna31. Non si può escludere, in conclusione, che il riferimento tardo duecentesco al castello (e alla sua chiesa intitolata a San Pietro) rinvii al tessuto insediativo locale incardinato su un complesso sistema fortificato allestito in qualche forma a difesa dell’abitato, tanto che la chiesa di San Pietro era detta anche “de Rovolone”, tout court. Del castello si conoscono solo parziali dimensioni: in castro vi era un sedimen del monastero di Santa Giustina, un fondo con casa o destinato ad averla (1261) e confinante con i beni degli eredi di Ugolino Schinelli; sempre in castelo vi era un quarto di terra coltivata ad oliveto (tardo XIII-primo XIV secolo) di Adelmota dei Maltraversi32. La pluralità di soggetti cointeressati nell’area di pertinenza del castello denuncia l’importanza per i diversi signori di poter intervenire nel controllo del manufatto e dell’area circostante. Altro elemento fortificato di rilievo era la rocca. Dal catastico di Adelmota essa risulta ubicata nel villaggio di Rovolon (rocha est in villa predicta Rovolonis, precisa la fonte): la rocca marcava lo spazio di un potere signorile ingombrante che faceva sentire tutto il suo peso nella vita quotidiana della comunità. Il toponimo “Sotto la rocca” (De subtus rocha) palesa di riflesso la posizione soprelevata del manufatto fortificato. Quest’ultimo inoltre definiva attorno Il “Castèo dée Roche” al “Casteàro” di Rovolon: resti di struttura fortificata. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 39 a sé uno spazio noto al tempo come la “contrada detta la Rocca” (contrata que dicitur Rocha). Coordinato alla rocca ma da essa distinto era il castellaro, spazio fortificato circoscritto e ben definito: terreni di Adelmota erano infatti ubicati in castellaro de rocha o in castellaro. La toponomastica locale conserva ancora oggi memoria di questi apprestamenti fortificati. Casteàro è uno spuntone roccioso dove sorgeva il Castèo dée Roche, di cui sono ancora visibili i resti, e si erge poco a sud del centro del paese, alla base del fianco settentrionale del Monte Grande33. Il castello e la rocca di Rovolon non furono esperienze fortificate isolate. Nel 1287 le fonti parlano di una “contrada del Castelrotto” (in confinio ville Rovolonis…in contrata Castrirupti), la quale aveva tra i suoi confinanti un membro della famiglia comitale, Bonaccorso Schinelli. Il toponimo, con le varianti contrata de Castello roto o del Castelo roto attestate tra XIV e XV secolo, rimanda a una struttura fortificata all’epoca già in rovina34. Il castelrotto era un manufatto distinto dal castello, che infatti sembra ancora efficiente nel tardo Duecento. Il castelrotto era ubicato verosimilmente sul dosso più alto del Monte Viale, dove è attestato il toponimo “Castaròto” e dove sono ancora visibili i resti di una fortificazione. In riferimento a questo luogo, emergenze recenti, risalenti alla seconda metà del XX secolo, e la relativa documentazione hanno messo in luce un “largo spiazzo sulla cime del colle” e “un’antica torre…di forma quadrata” con “sbocco a metà del monte tramite passaggio sotterraneo” con la precisazione che “anche la gente del posto tramanda questo particolare” ed “opere in muratura di difesa della torre”; anche la bibliografia più recente menziona “sopra una sorte di vallo…i resti di un muro circolare che chiude un breve rialzo dal quale si innalza la base di una torretta”35. Con ridotte potenzialità militari, lo spazio fortificato del castelrotto che si esten- Il “Castèo dée Roche” al “Casteàro” di Rovolon: la muratura rimasta. 40 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei deva per almeno due campi e dieci piedi, appartenuti ad Adelmota e passati ai suoi discendenti, era coltivato a vite e ulivo36. Inoltre la distinta menzione del castelo roto e di un castrum fractum nella contrata Castrifracti a Rovolon in un documento del 1373, che riporta la dote di Caterina Schinelli sposa di Giacomo Papafava, suggerisce l’esistenza, forse, di un secondo manufatto al tempo ormai anch’esso in fase di destrutturazione37. Segno del consolidamento della maglia fortificata è anche la menzione nel tardo Duecento di un castellarum Canove e di un castello de Chanova, un agglomerato fortificato sorto in corrispondenza di un preesistente nucleo abitato, menzionato solo agli inizi del secolo come di recente formazione e dove aveva terreni la famiglia comitale. Nel castello di “Canove” Adelmota aveva un casa “murata” con tetto di coppi, un fienile/ricovero (teza), un’aia e un orto abitata da livellario. E anche i suoi eredi vi possedevano campi ed edifici, puntualmente ubicati in ora Canove supra chastelo Chanove (1324)38. Al 1354 risale la menzione di un castrum Berlina, una struttura adibita forse a prigione e sempre in territorio di Rovolon, probabilmente in corrispondenza della contrada “Costa Berline”, attestata nel 140639. Un documento del 1373 ricorda quindi una rocca con torre di solida fattura posta in posizione sopraelevata nell’ambito di una proprietà di cento campi di bosco sul colle della Vallalta di Rovolon, un ripiano alla base del versante nord del Monte Grande e di pertinenza del monastero di Santa Giustina (“una rocha cum una turri de muro cum centum campis nemoris supra montem de la Valalta de Rovolone”) e che sembra conciliasse funzioni militari e esigenze di coordinamento della vasta proprietà rurale circostante40. Infine, nel 1394 nella contrada Vigonovo di Rovolon, località nota almeno dalla metà del secolo precedente, vi era una mota. Rilievo più o meno arti- Dettaglio della carta militare austriaca del 1798. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 41 ficiale che fondava le proprie potenzialità fortificatorie su terra et aqua e che all’occorrenza poteva servire da rifugio ai locali, la motta dava a sua volta il nome a una contrada (contrata mote) estesa, appunto, tra macchie boschive, terre dissodate (vigre) e corsi d’acqua che le fonti ricordano con i termini fovea, fovea Vicinovi, fovea Savarini e fossatum Brardulini41. Il processo di incastellamento coinvolse anche la vicina località di Carbonara con fortificazioni di forme apparentemente più ridotte che avrebbero sostenuto le potenzialità di attacco e di difesa dei vicini castelli di Rovolon, creando con essi un unico articolato “distretto di difesa”. All’inizio del XIII secolo le fonti citano, come si è accennato, una motta del monastero di Praglia a Carbonara, alla quale afferiva l’esercizio di poteri signorili e che, dotata di orto e collegata alla dimora (domus) del loro possessore (1216), di Albrigetto de Luca, uomo vicino al monastero, dal quale l’aveva ricevuta in permuta, doveva sembrare una struttura a metà “tra azienda agricola e fortezza” e rappresentare così, per il suo possessore, un segno di distinzione sociale42. Tra la fine Duecento e il secolo successivo si infittiscono le notizie di manufatti fortificati, più o meno in relazione con la motta del monastero. Al 1296 risale la prima attestazione di una “contrada del Castelletto” (contrata Castelleti) dove il monastero di Praglia possedeva un bosco sito precisamente ubi dicitur Castelletum (1308). Il toponimo sub Plano castelleti, dove Adelmota dei Maltraversi aveva dei terreni, denuncia la posizione sopraelevata del luogo che ospitava il manufatto. Casteéto è chiamato oggi un promontorio pianeggiante con il gruppo di case sottostanti verso la strada provinciale a sud del centro abitato di Carbonara. Parziali riferimenti alle dimensioni delle pertinenze del castelletto e del paesaggio agricolo circostante si deducono inoltre dalla menzione, tra i beni della stessa Adelmota, di tre campi a viti e ulivi in Plano casteleti e di altri tre, sempre coltivati a vite, ubicati nel castelletto (in casteleto). I terreni erano lambiti da corsi d’acqua (caaltum in castelletto o caaltos de casteleto) e attraversati da strade di campagna (via de chasteleto)43. Nel territorio di Carbonara altre due erano le fortificazioni che facevano capo ad Adelmota e ai suoi eredi, il castelletto di Casarse (casteleto de Casearse) e quello di Bagnara (castelletto de Bagnara) – declivio quest’ultimo sotto il pianoro di San Pietro in Costa, che da ponente si estende verso Zovon, a sud di Carbonara – al cui interno gli stessi possedevano terreni. Il castelletto di Bagnara, in particolare, dava il nome a due contrade, la contrata Chasteleti e quella Plani chasteleti di Bagnara, appunto, espressioni che richiamano la conformazione del sito fortificato44. I primi segni di sofferenza del sistema fortificato di Rovolon si manifestarono, come si è visto, sin dalla seconda metà del XIII secolo. Di ciò rimane traccia in espressioni come “castelrotto” e in altre risalenti al XIV secolo e con simile significato come “castrum fractum” o “castelletto de Casearse” . Gli esiti dell’incendio appiccato al villaggio e al castello di Rovolon nei travagliati momenti delle guerre con gli Scaligeri (1312) avrebbero reso necessario il rinnovo della chiesa di Costa (1314)45. La parallela menzione di strutture fortificate ancora efficienti nel XIV secolo ed altre in fase di destrutturazione sin dalla seconda metà di quello precedente, sembra confermare che il settore nord- 42 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei occidentale dei Colli Euganei fosse un’area strategica per la sua posizione di confine e, per questo, oggetto di attenzioni speciali volte ora a potenziare ora a recare danno al suo impianto fortificato. Nel tardo XIV secolo, anche a Rovolon appare un nuovo tipo di sito fortificato, la bastia. Il vocabolo, noto in Italia e in Francia dal XIII secolo, indicava una struttura fortificata allestita sommariamente con tavole, travi, assi di legno, cinta da terrapieni circondati da fossati ed eventualmente munito di altre torri lignee e rinvia al termine “imbastire”, edificare in fretta, realizzare una struttura precaria, allestire provvisoriamente una difesa. Tra XIV e XV secolo, periodo di massima diff usione del nuovo modello fortificatorio in area padano-veneta, nell’ambito di strategie militari di signorie cittadine, impegnate a espandere il loro potere su scala regionale, volte a valorizzare i grandi centri fortificati di dimensioni semiurbane, le “terre murate”, le bastie risultavano particolarmente efficaci sul piano militare. Allestite a sostegno di siti fortificati preesistenti o in zone relativamente isolate in appoggio al movimento degli eserciti, i nuovi manufatti erano piazzeforti provviste di soldati, armi e vettovaglie e basi strategiche di attacco/difesa adatte a incursioni e scorrerie. In area euganea si contano le quattro bastie costruite nel primo Trecento durante la guerra scaligero-carrarese-veneziana in corrispondenza delle porte del solido complesso fortificato di Monselice (San Giacomo, San Salvaro, San Michele e “accanto al monte”) e, al lato opposto dei Colli, dagli anni Sessanta dello stesso secolo, quella di San Martino della Vanezza allestita presso il castello, vicino al fi ume Bacchiglione46. Quella di Rovolon fu eretta molto grande e forte nel 1386, quando infuriava la guerra tra gli Scaligeri, signori di Verona e i Carraresi, signori di Padova. Costruita presumibilmente a partire dal maggio di quell’anno, quando le truppe scaligere si accamparono presso Rovolon per meglio controllare la frontiera tra il Padovano e il Vicentino e nella speranza di ottenere maggiori successi di quanti ne avevano avuti stando nella Scodosia di Montagnana più a sud, la bastia portò molto danno alle montagne Padoane, cioè i Colli Euganei. Già nell’agosto del 1386 la fortificazione fu sottratta con la forza (per forza) dalle truppe inviate da Francesco Da Carrara47. Nel 1392 la bastita Rovolonis, lambita da una “fovea acquosa” con argini da entrambe le parti, posta nel distretto padovano, e detta “la fossa de la Nina seu la Vaneça” che scorreva vicino al fi ume Bacchiglione, era ancora ben riconoscibile all’orizzonte di un paesaggio piatto e paludoso48. Nel 1402 la bastia era un avamposto militare ancora attivo a presidio del territorio circostante al comando di un capitano49. Dal XV secolo, ormai sotto il dominio di Venezia, furono le città a giocare un ruolo strategico nella scacchiera geopolitica che mirava ad orizzonti più vasti di scala sovraregionale. Tale politica accentuò la destrutturazione del tessuto fortificato di cui si erano avvertite le prime avvisaglie già nel secolo precedente. Il lento abbandono o il riuso di antiche fortificazioni lasciò spazio all’affermarsi della grandiosa “civiltà di villa” e alla diff usione anche nei Colli Euganei di dimore padronali, case di villeggiature in luoghi ameni “per vincere l’afa, il caldo torrido e la pesantezza del clima cittadino”50 e che permettevano di seguire i lavori agricoli, la riscossione degli affitti, la raccolta dei prodotti, dando forma, ad esempio, ormai in piena età moderna, a quelle da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 43 “fabbriche dominicali” con annessi rurali di Niccolò Coletti al Castèaro de Cristofanon di Rovolon (1756) o ad esiti architettonici di particolare fascino e bellezza come le ville Ottavia, Da Rio, Lion e ancora Barbaro , Lippomano, Papafava, Priuli51. Note 1. FIORESE (2004), p. 318-319; 150-151. 2. SETTIA (1984); BORTOLAMI (2004); CASTIGLIONI (1994); TOGNANA (2006-2007). 3. CDP, I, doc. 27, p. 40; doc. 52, p. 76; doc. 53, p. 78; doc. 55, p. 80; doc. 62, p. 87; doc. 67, p. 96; doc. 69, p. 102; doc. 70, p. 103; doc. 101, p. 136; doc. 93, p. 123; doc. 97, p. 131; doc. 101, p. 136; doc. 117, p. 153; doc. 126, p. 162; doc. 146, p. 182; doc. 239, p. 266; doc. 274, p. 300; II, doc. 71 p. 58; doc. 767, p. 74; l’espressione citata tra virgolette si trova in FASSERA (1980), p. 11; BORTOLAMI (1988); BORTOLAMI (1996); BORTOLAMI (2003); MONETI (1995); MONETI, DRAGHI (1997), p. 175; MONETI (2000); COLLODO (2006), p. 24-25. 4. CDP, I, doc. 55, p. 80; doc. 98, p. 132; doc. 129, p. 165; doc. 187, p. 216; II - 1, doc. 50, p. 41; doc. 136, p. 112; doc. 360, p. 274; doc. 377, p. 287; doc. 455, p. 339; doc. 485, p. 359; doc. 523, p. 381; II - 2, doc. 655, p. 6; doc. 840, p. 116; COLLODO (2006), p. 13-14; CAVALLARI (1965); ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7424, part. 1602; CASAZZA (2008), doc. 153, p. 302; doc. 184, p. 364; RIPPE (2003), p. 131, 150. 5. CDP, II -1, doc. 611, p. 437; BORTOLAMI (1999), p. 232. 6. CDP, II - 2, doc. 1085, p. 258 ; RONCARATI (1962 -1963). 7. BORTOLAMI (1999), p. 240; COLLODO (2006), p. 12 -13; cfr. nota 3. 8. RONCARATI (1962-1963), doc. 86, p. 154. 9. CDP, II - 1, doc. 485, p. 359; II - 2, doc. 1158, p. 300; CASTAGNETTI (1981), p. 187189; DONDI OROLOGIO, (1802-1817) I, p. 129-138; BORTOLAMI (1985), n. 21, p. 8-9; ASPd, Diplomatico, 10628-917; 10. CDP, II -2, doc. 1158, p. 300. 11. BLASON BERTON (1972), p. 50; PAGLIARINI (1990), p. 243. 12. ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7401, part. 1578; CASAZZA (2008), doc. 153, p. 302; AGSLA, Archivio Papafava, codice 35, doc. 10. 13. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26. 14. PAPAFAVA DEI CARRARESI (2005), p. 16. 15. BP, Documenti Carraresi - BP 990 I, doc. XXX. 16. GLORIA (1873), 912, p. 304-305; 955, 957, p. 311; 985, p. 319; 1006, p. 32 1 ; SELLA (1941), p. 112-113, 253; AGSLA, Archivio Papafava, codice 36, doc. 4; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 57 v. 17. CASAZZA (2008), doc. 73, p. 154; HYDE (1985), p. 197-200, 209-210, 274-275; GLORIA (1873), 326-332, p. 105-107. 18. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 1 v., 2 r. v., 3v., 4 r., 5 r. v., 6 r., 7 v., 9 r. v., 10 r., 14 v., 15 r. v., 16 r. v., 18 r., 20 r., 21 r., 22 v., 23 r., 24 v., 27 r., 28v., 33 r., 40 v., 41 r., 44r., 46 r., 50 r., 54 v., 56 v.; codice 35, doc. 9, 10; CARRARO (1997), doc. 27, p. 136; BORTOLAMI (1999), p. 242, 245. 19. CDP, I, doc. 55, p. 80; doc. 239, p. 266; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26; COLLODO (2006), p. 21. 20. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 6v., 8 r., 10 r., 19 r., 51 r.; codice 35, doc. 4, 9, 11, 12; ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7401, part. 1578; Diplomatico, part. 2508 (1271, dicembre 20); CARRARO (1997), doc. 27, p. 136; RIGON (1987) p. 131. 21. CDP, I, doc. 67, p. 96; ASPd, Corporazioni soppresse, S. Maria di Praglia, b. 3, “catastico” del Marchettani, f. 121 v. - 124 v.; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 24 r. v., 38 v., 40 v., 56 r.; BARZON (1955), p. 43-84. 22. CDP, II, doc. 611, p. 437; BORTOLAMI (1999), p. 232; ASPd, Corporazioni soppresse, S. 44 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Maria di Praglia, b. 3, “catastico” del Marchettani, f. 121 v. - 124 v.; AGSLA, Archivio Papafava, codice 35, doc. 13. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 4 r., 5 v., 6 v., 7 v., 8 r. v., 10 r. v., 12 r, 13 r. v., 15 r., 18 r. v., 19 r., 21 r., 22 r. v., 23 r. v., 24 r., 25 r. v., 26 r. v., 27 v., 29 r., 29 v., 30 r. v., 31 r., 32 r., 33 r. v., 34 r., 39 r. v., 40 r., 41 r., 42 r. v., 43 r., 44 r. v., 46 r., 48 r., 49 v., 50 r., 51 r. v., 52 r. v., 53 r. v., 54 r. v., 55 r., 56 r., 57 v; BP, Codice Statutario “Carrarese” - BP 1237, f. 241 -244; 249, 259; GLORIA (1873), 1011-1022, p. 325-327 ; BORTOLAMI (1983), p. 197-200; CARRARO (1997), doc. 27, p. 136. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 3 r., 18 v., 24 r., 41 v., 46 r., 53 v., 54 v.; ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7713, part. 2208, c.26; Diplomatico, part. 2508 (1271, dicembre 20). BORTOLAMI (2003), p. 28. ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7401, part. 1578. SELLA (1941), p. 253; RIGON (1987), p. 144-146; CRACCO (1988), p. 75. ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7712, part. 2207, c.82 v.; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 6r, 7 r., 8 v., 46 r., 57 v. CARPANESE (1985), p. 82-83; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 2 r. AGSLA, Archivio Papafava, codice 36, doc. 4; codice 26, f. 8 v.; codice 13, fasc. 29, f. 2 v. - 26 r.; RIGON (1985), p. 71-73; CARPANESE (1985), p. 82-83; SCARMONCIN (1999), doc. 14, p. 24; CARRARO (2010), p. 61-74. AGSLA, Archivio Papafava, codice 13 f. 2 v., 10 v., 14 v., 26 r. ; MAZZETTI (1999), p.42. CASAZZA (2008), doc. 153, p. 302; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 7 v. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 3 r., 33 r. v., 57 r.;ASPd, Notarile, 34, f. 213 r.;MAZZETTI (1999), p. 42. AGSLA, Archivio Papafava, codice 35, doc. 10; codice 36, doc. 10; ASPd, Notarile, 167 (notaio Traversari),f.291 r. Documenti storici del Comune di Rovolon presso la sede municipale, n. prot. 7445 (anno 1973); MAZZETTI (1999), p. 51. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 12 v., 13 v., 52 v. ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, b. 287, II, f. 1 r. - 2. v.; HOLZER (1997), p. 30-33. ASPd, Corona, Santa Giustina, gen. 7401, part. 1578; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 10 v., 12 r., 34 r., 51 v., 52 r., 57 v., 58 r; BP, Documenti Carraresi - BP 990 I, doc. XXX. ASPd, Notarile, b. 167 (notaio Meiorino Rustighela), f. 55 r.; AGSLA, Archivio Papafava, codice 36, doc. 12. ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, b. 287, II, f. 2 v. ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, b. 220, vol. F, f. 2 r. - 4 v. RONCARATI (1962-1963), doc. 82, p. 145; doc. 86, p. 154; doc. 109, p. 199; doc. 110, p. 201; doc. 121, p. 223; doc. 160, p. 236; SAMBIN (1961), p. 21. ASPd, Diplomatico, part. 3800 (anno 1296); Coroporazioni sopporesse, Santa Maria di Praglia, b. 165, f. 144 r.; f. 244 v.; AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 38 v., 39 r, 40 r. v., 56 r. v., 58 r.; ACVPd, Feudorum, VI, f. 9 r. AGSLA, Archivio Papafava, codice 26, f. 28 v., 39 r., 41 v.; BP, Documenti Carraresi - BP 990 I, doc. XXX. MUSSATI (1727), col. 425; ASPd, Diplomatico, part. 5239. DU CHANGE, 1 (1954); SETTIA (1986) e (1980); p. 599; GALLO (1988), p. 100-101; ASPd, Notarile, b. 204, f. 299 r. GATARI (1931), p. 246; 256. ASPd, Notarile, b. 6, f. 113 r. PASTORELLO (1915), p. 262. GRANDIS (2005), p. 206. ASPd, Foro Civile, b. 209, f. 205 r. - v.; dis. 70 A; ZUCCHELLO (2001), p. 445-453. da l v il lag g io a l la ‘ v il la ’ 45 Legenda Archivio Curia Vescovile di Padova = ACVPd Archivio di Stato di Padova = ASPd Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova = AGSLA Biblioteca Civica di Padova = BP Codice Diplomatico Padovano (vedi bibliografia) = CDP busta = b. documento = doc. foglio = f. generale = gen. pagine = p. recto = r. verso = v. Fonti e Bibliografia di riferimento A. BARBERO, CH. FRUGONI, Dizionario del Medioevo, Roma-Bari 1998; A. BARZON, Padova cristiana. Dalle origini all’anno 800, Padova 1955; De viris illustribus familiae Transelgardorum, Forzatè et Capitis Listae, a cura di M. BLASON BERTON, M. SALMI, Roma 1972; Città murate del Veneto, a cura di S. BORTOLAMI, Cinisello Balsamo (MI) 1988; S. BORTOLAMI, Da Carlo Magno al 1200, in Diocesi di Padova, a cura di P. Gios, Padova 1996, p. 49-116; S. BORTOLAMI, Este da città romana a città medioevale: appunti per una storia delle difese murarie, in Città murate del Veneto, p. 65-71; S. BORTOLAMI, I castelli del Veneto medioevale tra storia e storiografia, “Archivio veneto”, ser. V, 163 (2004), p. 227-260; S. BORTOLAMI, Fra “alte domus” e “populares homines”, in Storia e cultura a Padova nell’età di Sant’Antonio, Convegno internazionale di studio (Padova-Monselice, 1-4 ottobre 1981), Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1985, pp. 3-74 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, XVI); S. BORTOLAMI, Il Paesaggio euganeo ai tempi del Petrarca, in Francesco Petrarca e il Veneto, Atti del Convegno di studi (Padova e Arquà Petrarca, 18-19 ottobre 2002), Padova, 2003 p. 25-56; S. BORTOLAMI, L’età dell’espansione (sec. XI-XIII) e la “crisi” del Trecento, in I Benedettini, p. 17-34; S. BORTOLAMI, L’età medioevale, in Storia di Padova dall’antichità all’età contemporanea, a cura di G. GULLINO, Sommacampagna (VR), 2009; S. BORTOLAMI, Un grande patrimonio monastico medioevale: formazione, consistenza e conduzione dei possessi di S. Maria di Praglia (1107-1448), in ID., Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali, Roma, 1999, p. 227258; CALAON, “Incastellamento” nei colli Euganei: progetto di ricerca e risultati preliminari, “Terra d’Este”, XI (2001), p.17-58; L’Abbazia di Santa Maria di Praglia, a cura di C. CARPANESE, F. TROLESE, Cinisello Balsamo (MI) 1985; C. CARPANESE, La chiesa campestre di San Pietro di Costa, in L’Abbazia di Santa Maria di Praglia, p. 82; Il “Liber” di Sant’Agata di Padova (1304), a cura di G. CARRARO, Padova 1997; G. CARRARO, Monachesimo e cura d’anime. Parrocchie ed altre chiese dipendenti del monastero di S. Maria di Praglia in Diocesi di Padova (sec. XII-XVIII), Padova 2010, p. 61-74; Il ‘Catastico verde’ del Monastero di S. Giustina di Padova, a cura di L.CASAZZA, saggi introduttivi di L. CASAZZA, F. G. B. TROLESE, Roma 2008; A. CASTAGNETTI, I Conti di Vicenza e di Padova dall’età ottoniana al Comune, Verona 1981; B. CASTIGLIONI, I castelli degli Euganei, “Padova e il suo territorio”, 52, (1994), p. 22-25; V. CAVALLARI, Cadalo e gli Erzoni, “Studi storici veronesi Luigi Simeoni”, XV, 1965, p. 29-170; S. COLLODO, Ricerche sugli assetti territoriali dei Colli Euganei nel medioevo, “Terra d’Este”, 31 (2006), p. 7-55; S. COLLODO, Il ceto dominante padovano, dal comune alla signoria (secoli XIIXIV) in ID., Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca, Fiesole 1999, p. 37-46; G. CRACCO, Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311), in Storia di Vicenza, II, l’età medioevale, Vicenza 1988, p. 73-138; I Benedettini a Padova e nel territorio padovano attraverso i secoli, Saggi storici sul movimento benedettino a Padova Catalogo della mostra storico-artistica nel XV centenario della nascita di san Benedetto, a cura di A. DE NICOLO’ SALMAZO, F. G. TROLESE, Padova 1980; F. DONDI DALL’OROLOGIO, Dissertazioni sopra l’istoria ecclesiastica di 46 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Padova, I, Padova, 1802-1817; CH. DU FRESNE DU CANGHE, Glossarium medie et infimae latinitatis, voll. 10, (rist. anast. Graz, 1954); P. FASSERA, Il monachesimo benedettino e i suoi inizi a Padova e nel territorio padovano, in I Benedettini, p. 1-16; Vita e Morte di Ezzelino Da Romano (Cronaca), a cura di F. FIORESE, s.l. 2004.; D. GALLO, Per la Storia di Monselice nel medioevo: dal ‘castrum’ alla ‘terra murata’, in Città murate del Veneto, p. 79-102; G. e B. GATARI, Cronaca carrarese (A. A. 1318-1407), a cura di A. MEDIN, G. TOLOMEI, in RIS2, XVII, 1, I, Città di Castello 1931; Codice Diplomatico Padovano. Dal secolo sesto a tutto l’undicesimo, a cura di A. GLORIA, Venezia 1877; Codice Diplomatico Padovano. Dall’anno 1101 alla Pace di Costanza (25 giugno 1183), prima e seconda parte, a cura di A. GLORIA, Venezia 1879; Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, a cura di A. GLORIA, Padova 1873; C. GRANDIS, I Colli coltivati nei secoli dell’età veneziana, in I Colli Euganei, p. 168-207; F. HOLZER, Rovolon, amore per una terra, Padova 1997; J. K. HYDE, Padova nell’età di Dante, Trieste 1985; B. KHOL, Padua under the Carrara, 1318 -1405, Baltimor-London 1998; A. MAZZETTI, I nomi della Terra. Toponomastica dei colli Euganei, Verona 1999; A. MONETI, Nuove ricerche archeologiche nell’area sommitale del castello di Este, “Terra d’Este”, 19 (2000), p. 41-52; A. MONETI, Le rocche di Este e la Chiesa di Santa Maria in castello. Le ricerche archeologiche degli anni 1994-1996, “Terra d’Este”, 10 (1995), p. 99-126; A. MONETI, A. DRAGHI, Un secolo di archeologia medioevale nel castello di Este, “Archeologia medioevale”, XXIV (1997), p. 173 -181; MUSSATI, De gestis Heinrici VII Caesaris Historia Augusta, a cura di L. A. MURATORI, in RIS, X, Mediolani 1727; B. PAGLIARINI, Cronicae, a cura di J. GRUBB, Padova 1990; A. PAPAFAVA DEI CARRARESI, Memorie di famiglia, in Padova carrarese, a cura di O. Longo, Padova 2005, p. 15-17; Il copialettere Marciano della Cancelleria Carrarese, gennaio 1402-gennaio 1403, a cura di E. PASTORELLO, Venezia 1915; A. RIGON, Richerche sull’eremitismo nel padovano durante il XIII secolo, in Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII, a cura di G.G. MERLO, Torino 1987, p. 125-162; G. RIPPE, Padóue et son contado (Xe-XIII siècle). Société et pouvoirs, Roma 2033; N. RONCARATI, L’abbazia benedettina di S. Maria di Praglia (Padova) dalle origini alla riforma del sec. XVI (con una silloge di 271 documenti inediti dal 1185 al 1235), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, rel. P. SAMBIN, a.a. 1962-1963; P. SAMBIN, Documenti inediti dei monasteri benedettini padovani (1183-1237), I, S. Michele di Candiana, Padova 1961; Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII-XIV. Venetiae-Histria Dalmatia, a cura di P. SELLA, G. VALLE, Città del Vaticano 1941; I documenti dell’Archivio Capitolare di Vicenza (1083-1259), a cura di F. SCARMONCIN, nota introduttiva di F. LOMASTRO e G.M. VARANINI, Roma 1999; I Colli Euganei, a cura di F. SELMIN, Sommacampagna (VR) 2005; G. SERGI, Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno, in Curtis e Signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali, a cura di G. SERGI, Torino 1993, p. 7-24; A. A. SETTIA, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli 1984; A. A. SETTIA, Castelli Euganei, in I Colli Euganei, p. 117-139; A.A. SETTIA, Crisi della sicurezza e fortificazioni di rifugio nelle campagne dell’Italia settentrionale, in Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranèen au Moyen Âge, Colloque orgnaisé par la Casa de Velásquez et l’École Française de Rome (Madrid 24-27 novembre 1985), a cura di A. BAZZANA, Mâcon, p. 263-269; A.A. SETTIA, Fortificazioni collettive nei villaggi medievali dell’Alta Italia. Ricetti, ville forti, recinti, “Bollettino storico - bibliografico subalpino”, LXXIV (1976), p. 527-617; A.A. SETTIA, Motte e castelli a motta nelle fonti scritte dell’Italia settentrionale. Dati e problemi, in Mélanges d’archeéologie et d’histoire médiévales en l’honneur du Doyen Michel de Boüard, Genève 1982, p. 371-383; A.A. SETTIA, Motte nell’Italia settentrionale, “Archeologia Medievale”, XXIV (1997), p. 439-444; A.A. SETTIA, Tra azienda agricola e fortezza: case forti, “motte”e “tombe” nell’Italia settentrionale. Dati e problemi, “Archeologia Medioevale”, VII (1980), p. 31-54; F. TOGNANA, L’incastellamento medioevale nei Colli Euganei. Insediamenti, società e poteri, tesi di Dottorato di Ricerca in “Storia (antica, medioevale, moderna e contemporanea)” - XVIII ciclo, Università degli Studi di Padova, supervisore Prof. S. BORTOLAMI, 2006-2007; E. ZORZI, Il territorio padovano nel periodo di trapasso da Comitato a Comune. Studio storico con documenti inediti, “Miscellanea della Deputazione di storia Patria per le Venezie”, s. IV, III, Venezia 1930; Ville venete la Provincia di Padova, a cura di N. ZUCCHELLO, Venezia 2001, p. 445-453. Claudio Grandis I boschi Il territorio comunale di Rovolon si stende per 27,56 chilometri quadrati e comprende oltre al piano, dominato dall’abitato di Bastia, l’estremo lembo collinare euganeo su cui si sviluppano le tre località di Frassanelle, Carbonara e Rovolon. Osservando i versanti delle colline del Sereo, Viale, Grande, Madonna, l’occhio è attratto dal manto boschivo interrotto qua e là da radi squarci su cui spuntano vecchie case costruite nei secoli passati. Gli alberi della flora euganea attraggono per la dolcezza che da lontano anima il cuore. Il piano, invece, spoglio e marcato geometricamente da strade e fossati, argini e coltivi induce a pensare che qui l’agricoltura abbia radici profonde, capaci di perdersi nel buio del lontano Medioevo. I documenti ci raccontano invece una storia diversa. Il paesaggio del piano, che dall’unghia collinare si spande verso lo scolo Bandezzà oltre il quale inizia il Vicentino, è frutto di una recente trasformazione del suolo, di un mutamento radicale e profondo conseguente alla scomparsa di varie quanto estese macchie di bosco planiziale. Una parola strana – planiziale – inconsueta eppure familiare ai botanici. Planiziale vuol dire pianura. Il territorio della pianura di Rovolon, infatti, fu a lungo ricoperto di boschi, in particolare di querce, farnie, roveri e olmi. È avvincente leggere, nei documenti che dal XIII giungono al XIX secolo, il continuo rinvio alle La pianura fra Euganei e Berici un tempo popolata dai boschi di rovere. 48 Il testo iniziale della Parte presa dal Consiglio dei Pregadi il 20 febbraio 1598 in materia di boschi, inserita nella Novissima Veneta Statuta stampata a Venezia nel 1729. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei piante di rovere e scoprire che il tema dominante non è tanto quello della produttività dei terreni agricoli quanto, piuttosto, la preoccupazione di non distruggere irrimediabilmente questa singolare risorsa. Tutti questi boschi di quercia avevano un proprio nome di battesimo: Carpaneda, Vegrolongo, Carpi, Labixeto, Spexa Catena, e quanto mai singolare è che nel loro sfruttamento trovano origine toponimi (i nomi di luogo) quali Fossona, Bastia, Carbonara e Lovolo. Com’è possibile vien da chiedersi? Qual è il legame di nomi apparentemente estranei al lessico botanico. Carpaneda ci riporta al Carpino, all’essenza diff usa della nostra area euganea. Curiosamente però, almeno dal XV secolo, Carpaneda fu uno dei principali boschi del demanio statale veneziano: dietro a questo nome si nascondono secolari vicende tutte comunque annodate attorno alla singolare preoccupazione di uno sfruttamento razionale, controllato, ecosostenibile. In altre pagine di questo libro è narrata, per sommi capi, la vicenda secolare di questo bosco. Non lontano dalla Carpaneda, contiguo sul perimetro di levante, si sviluppava il bosco del Vegrolongo: un nome che significa terreno non dissodato, non coltivato, un’estesa superficie che superava il confine attuale per ammantare anche parte dell’odierno comune di Cervarese Santa Croce fino ai margini del castello di San Martino della Vaneza. Fossona dal canto suo è un nome che ha origine proprio dallo sfruttamento di questi due boschi. Per facilitare la condotta dei pesanti tronchi di rovere dal bosco all’imbarco situato all’ombra del castello di San Martino, nel 1676 il governo veneziano approvò il progetto e finanziò l’opera di allargamento dell’alveo dello scolo Nina, corso d’acqua allora chiamato anche fossa Martina e, anticamente conosciuto come Naviglio di Pedevenda. Ebbene quella poderosa opera idraulica trasformò il fossato in una fossona, come ricorda il perito padovano Francesco Alberti incaricato di dirigere i lavori nel 1676. Nel nome Fossona vi è dunque memoria di questo singolare evento seppur oggi si fatica a comprendere il collegamento della fossa Nina con il Bacchiglione per l’interramento del tratto iniziale, proprio tra il castello di San Martino e il rettifilo di via Scapacchiò.1 Ai boschi, alla ricchezza di legname ci riporta anche il toponimo Bastia, una fortezza, un luogo di difesa costruito con il legno, con i tronchi, come i fortini dei vecchi film western americani. La disponibilità di legname consigliò gli ingegneri militari delle truppe scaligere di abbattere gli alberi anziché estrarre trachite o cuocere laterizi per dar vita alla bastita. Così innalzata la difesa divenne luogo di ricovero delle truppe per gli attacchi alle postazioni carraresi. i b oschi 49 Così pure Carbonara, al limitare del pendio di Monte della Madonna, ci ricorda che qui vi erano le carbonaie, le cataste di legna ricoperte di argilla per produrre carbone. Se a Carbonara convergeva legname dai Colli, è pur vero che dai pendii giungevano anche tronchi di pezzatura diversa, raccolti nel cuore dei boschi della contigua pianura. In Lovolo, infine, è rimasta memoria di un animale oggi scomparso che popolava questi boschi: il lupo.2 Nomi di luogo che rimembrano paesaggi scomparsi, popolati da attività e quotidianità che difficilmente si possono immaginare. Il boscaiolo, il saltaro (cioè il custode dei boschi), i carrettieri, i fabbri, sono figure che siam soliti ricondurre ai grandi manti boschivi delle Prealpi e delle Alpi. Il radicale cambiamento, capace di lasciare, come detto, solo qualche traccia nella toponomastica inizia nella seconda metà del XV secolo. Proprietari dei boschi di Rovolon, da data che non ci è nota, erano i monaci di Nonantola (in provincia di Modena) che attraverso il controllo sul priorato di San Leonardo di Padova il 20 gennaio 1470 disposero la concessione a lunga scadenza dei boschi ad Andrea Dandolo di Venezia; in precedenza, nel 1464, avevano parimenti concesso a Ludovico Palazzolo e a Bernardo Maraspina, una superficie complessiva stimata in quasi 1300 campi padovani, equivalenti oggi ad oltre cinquecento ettari.3 Il bosco di Vegrolongo scomparve invece per il continuo taglio voluto dal governo veneziano. Migliaia e migliaia di tronchi furono abbattuti nell’antico bosco di proprietà del monastero di Sant’Agata e Cecilia, del monastero di San Benedetto, delle famiglie Calza e Buzzacarini.4 Nonostante i tagli ripetuti e continui delle piante, capaci di far scomparire ettari su ettari, all’alba del XIX secolo il comune di Rovolon vantava ancora un’estesa superficie di bosco. All’interno del Dipartimento del Brenta, i tecnici rilevarono che i comuni euganei erano ammantati per una superficie complessiva di oltre 12.450 campi. A Rovolon se ne contavano più di 1278, pari cioè a poco più della decima parte di tutti i boschi euganei. Nella lista, a precedere Rovolon, al primo posto v’era il comune di Vò con 2661 campi (quindi il 21,37% del totale), poi quello di Cinto Euganeo con altri 1785 campi, cioè il 14,34% e al terzo posto il comune di Torreglia dove si concentravano altri 1739 campi. Il censimento eseguito allora tenne distinti i campi di bosco dello Stato, da quelli dei comuni e pubblici stabilimenti e infine quelli di proprietà esclusiva dei privati. La maggior concentrazione di superficie demaniale era proprio a Rovolon dove i terreni a bosco di proprietà pubblica comprendevano ben 532 La facciata della chiesa monastica di Nonantola (Modena). I monaci di questa antica abbazia erano in parte proprietari dei boschi della piana di Rovolon, gestiti attraverso il priorato di San Leonardo di Padova. 50 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei campi, cioè il 42% del totale. Nessun altro comune dell’allora Dipartimento del Brenta superava i 200 ettari di superficie demaniale, segno questo del notevole interesse e dell’attenzione che il governo centrale riservava al nostro territorio. Ma in questo quadro un ruolo importante lo ricopriva anche l’autorità comunale. I boschi della collettività s’estendevano per quasi 60 campi padovani, pari cioè a 23,09 ettari attuali.5 Una superficie che nel 1850 era ancora saldamente iscritta nel patrimonio comunale, e tale rimase per tutto il XIX secolo.6 La superficie a bosco era suddivisa in prese cioè in zone, distinte con un numero romano. Queste prese, seguendo un rituale le cui origini si perdono nella notte dei tempi, venivano assegnate alle famiglie di Rovolon, con un contratto della durata settennale, scaduto il quale le prese venivano affidate ad altre famiglie, seguendo un criterio a rotazione di cui ci sfuggono, per ora, le modalità. Le carte del nostro archivio comunale ricordano che porzioni del bosco nel 1929 furono affittate a mezzadria ad Antonio Veronese, Aldo Martini, Rino Graziani e altri fino al 1950, mentre un’altra presa fu affidata nel 1925 a Giuseppe Zattarin. Una memoria più triste ci ricorda invece che la seconda guerra mondiale provocò non pochi danni, soprattutto per i ripetuti furti di legname nel 1945.7 Note 1. Claudio Grandis, Il paesaggio scomparso. Acque, mulini, boschi e cave al tempo della dominazione veneziana (Secoli XVI-XVIII), in Cervarese S. Croce. Profilo storico di un comune del Padovano tra Bacchiglione e Colli Euganei, a cura di Alberto Espen e Claudio Grandis, Cervarese S. Croce (Biblioteca Comunale – Il Prato ed.) 2004, p. 113-118. 2. Dante Olivieri, Toponomastica veneta, Venezia-Roma (Istituto per la collaborazione culturale) 1961 (rist. Firenze 1977), p. 71. 3. Devo alla cortesia di Giannino Carraro la segnalazione dei contratti stipulati dal priorato di San Leonardo conservati in Archivio di Stato di Padova, Notarile 3337, c. 601; Giannino Carraro, La parrocchia di S. Leonardo di Padova dipendenza nonantolana (sec. XII-XVIII). Fondazione, sviluppo, soppressione, «Benedictina», anno 50 (2003) fasc. M 1, p. 35-38, p. 82-86. 4. Manca a tutt’oggi uno studio puntuale e completo sui boschi del Padovano, vera risorsa scomparsa nel corso dell’età veneziana per l’intenso sfruttamento decretato dal governo della Serenissima. Basta scorrere i due inventari, quello del 1568 del perito Surian [Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Provveditori sopra boschi, vol. 130, c. 225240] e quello di Alvise Bembo del 1588 [Archivio di Stato di Padova (ASPd), Boschi, busta 7, c. 199-290 – Rovolon è alle c. 261v-266v] per avere un quadro territoriale preciso delle numerose macchie di bosco che popolavano l’intera provincia. Purtroppo anche i documenti sono dispersi: oltre alle quattordici buste di carte raccolte nel fondo Boschi dell’ASPd, per svolgere un’accurata ricerca di quanto è accaduto nel corso dei secoli XVI-XVIII c’è bisogno di un’indagine attenta su diversi altri fondi documentali prodotti dagli uffici che, seppur con competenze diverse, in passato amministrarono il patrimonio boschivo provinciale. 5. ASVe, Provveditori sopra boschi, registro 172 “Riassunto di tutti i boschi esistenti nel Dipartimento del Brenta”. 6. ASPd, Censo stabile, Rovolon, vol. 311-316, in particolare il vol. 313, partite 162, 170, 203. 7. Archivio Comunale di Rovolon, buste 10.1.6 (Vertenza Bonino Francesco per la strada vicinale del bosco, anno 1876) e 10.1.9 (bosco comunale, affittanze e danni). Carla Frasson Il bosco della Carpaneda Il bosco della Carpaneda si trovava nel confine tra il territorio padovano e il vicentino: riprendendo le parole di alcuni tecnici che lo visitarono nel 1574 ricadeva giuridicamente «nella villa di Revolone, nella contrada di Vegrolongo et della Bastia». Il suo sviluppo era di «forma più lungo che largo, perché è lungo da levante a ponente, circa 1132 pertiche et è largo da tramontana a mezo giorno circa 250 pertiche, talché la circonferentia saria miglia tre et un quarto».1 Il bosco della Carpaneda inoltre era «morbidissimo e bello di publica ragione»,2 motivo per cui il suo legname veniva riservato all’Arsenale di Venezia. Si trattava di una superficie boschiva molto estesa, circondata da un profondo fosso all’esterno del quale s’elevava il relativo argine; entrambi, fosso e argine, erano stati fatti costruire dalla Serenissima «acciocché le acque esteriori non intrassero, in detto boscho et li animali non vi andassero a pascolare et farvi danno».3 Il pericolo maggiore, per la Carpaneda, era costituito dalla penetrazione e dal ristagno delle acque che facevano marcire i legni. Il bosco, infatti, s’estendeva tra il corso della Fossa Nina o Naviglio Vecchio a levante, e la Fossa Bandezzà a ponente: quest’ultima divideva il territorio Padovano dal Vicentino.4 Le due fosse erano sempre colme di detriti e avevano argini insufficienti a sopportare le piene d’acqua che, uscendo dall’alveo del Bacchiglione, si spandevano nel Padovano. Ad aggravare la situazione ci pensavano poi i vicentini: «al tempo delle excrescentie – scrivono ancora i periti nella relazione del 1574 – sogliono tagliar li arzeri di essa fossa in tre lochi»5 portando danni gravissimi alle campagne padovane, ma soprattutto al bosco il cui fondo era «basso e concavo onde ogni poca di pioggia lo tiene tanto bagnato e morbido che sta molto tempo ad asciugarsi».6 Per questo nella Carpaneda si poteva trovare una «grandissima quantità di legnami di roveri, olmi e semenzali buoni» e ancora «bellissime macchiate di semenzali seminate in alcune piazzette», e così pure «gran quantità di legnami non buoni, né per venir buoni, come busi, saettati scavezzati, morti e cavati».7 L’arginatura e lo scavo delle due fosse Nina e Bandezzà e la costruzione di un argine più alto attorno alla Carpaneda, saranno le soluzioni invocate in più occasioni. Il 17 marzo 1559 il perito Domenico dell’Abaco, inviato da Giustiniano Foscarini, capitano di Padova, per un rilevamento sul posto a causa di alcuni tagli fatti nell’argine della Carpaneda, propose di scavare la fossa Bandezzà per una spesa di ducati 2373; la fossa Nina, per altri ducati 2100; di allargare il fosso e di arginare la Carpaneda per ulteriori ducati 600.8 La stessa soluzione venne indicata nel 1574 dai periti che compirono sopralluoghi nella zona, tutti incaricati di pronunciarsi sulla controversia sorta tra il 52 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei monastero di Praglia e i signori Da Rio.9 La proposta avanzata nel corso del XVI secolo fu condivisa anche da Francesco Valdagni che, diversi decenni più tardi, cioè nel 1655, compose e pubblicò un memoriale sul bosco. Il lavoro era il frutto della sua lunga esperienza nella veste di capitano ai boschi, per questo venne intitolato Osservazioni e ricordi sopra il bosco della Carpaneda ed altri boschi circonvicini nella vicaria di Teolo. Ben conoscendo la realtà dei luoghi e delle istituzioni, nel testo dato alle stampe Valdagni sottolineò che tali opere di scavo e di arginatura, interessando un bosco demaniale, andavano addebitate ai «comuni circonvicini senza spese pubbliche».10 Valdagni ben conosceva le condizioni che allora regolavano i rapporti tra il vicariato di Teolo, il distretto Padovano e l’autorità centrale. Un paio di secoli prima, il 18 febbraio 1457, era stato siglato un concordio, approvato dal governo veneziano il successivo 6 aprile, in virtù del quale gli uomini che abitavano nella vicarìa di Teolo dovevano provvedere gratuitamente non solo a tagliare le piante e a condurre i tronchi dal bosco all’imbarco, situato sotto la torre del castello di San Martino, ma pure ad accollarsi l’onere della manutenzione delle strade, dello scavo periodico dei fossati di scolo, del rincalzo e del ripristino degli argini. Dovevano inoltre assicurare la stabilità dei ponti di pubblico transito, come quello di Tencarola, e sottostare ad altri eventuali obblighi straordinari dovuti agli effetti d’inattese avversità atmosferiche, quali erano allora in particolare le esondazioni. Lo scolo delle acque nelle due fosse vicine rimase per secoli l’insoluto problema della Carpaneda e questo spiega l’abbondanza di documenti rimasti nei nostri archivi. Sono carte che attestano i numerosi tentativi, spesso falliti, promossi dal Capitano di Padova, dai Provveditori all’Arsenale, dal Vicario di Teolo e dal governo centrale di risolvere una questione annosa.11 A partire dal secolo XVII la ricerca di una soluzione duratura verrà affidata ai retrat- Il bosco della Carpaneda nella carta militare austriaca del Veneto di Anton Von Zach (1798). i l b o sco de l la ca rpa n e da 53 ti (originaria denominazione degli attuali Consorzi di bonifica), come quello di Lozzo che nel 1615 costruirà un nuovo argine nella Bandezzà, poiché quello esistente era stato rovinato dalle acque l’anno precedente;12 o come quello di Ottoville, che in più occasioni sarà protagonista nel rimediare ai disordini e ai danni provocati dalle acque nel bosco stesso.13 Alla Carpaneda ulteriori danni furono inferti dai proprietari dei terreni vicini, i quali illegalmente praticavano tagli nei già disastrati argini delle due fosse Nina e Bandezzà e, in maggior misura, facevano boccaroli e tagli nell’argine del bosco. Nei sopralluoghi compiuti nel 1574, ad esempio, i periti ne contarono ben ventotto.14 Per mantenere le terre asciutte, i proprietari vicini di nascosto incidevano gli argini creando dei condotti attraverso i quali facevano affl uire le acque: il bosco le riceveva, avendo un piano posto ad una quota altimetrica più bassa di quello della campagna circostante. Come se non bastasse i tecnici nei loro sopralluoghi constatarono che, dalla parte dei padovani, il «terreno delli arzeri della fossa era stato portato in molti lochi per terrazzare», cioè era stato asportato per coprire avallamenti nelle loro proprietà private.15 Nel 1588 il provveditore sopra i boschi, Alvise Bembo, riportò nel suo Catastico (un vero e proprio inventario delle piante di rovere e olmo) che a Vegrolongo di Rovolon vi era «un bosco de la Serenissima Signoria chiamato il bosco della Carpaneda … Il suo fondo è buonissimo, lontano dal fi ume Bachigion circa quatro miglia. Li legni, che sono in esso – precisava nella sua relazione – non s’hanno numerati, né bolati, stimando ciò più tosto perdita di tempo, et cosa superfl ua, essendo bosco publico nel quale non vi può praticar alcuno, ne può esser tagliato non solamente roveri ma neanco altra sorte di legname. Basta [sapere] che in esso vi sono roveri in gran quantità, et di bellissima sorte, essendo la maggior parte di grossezza di quattro in cinque piedi, et più, con pur assai semenzali et olmi». A suo giudizio, dunque, le condizioni di demanialità e di tassativo divieto di accesso erano ottime garanzie per la conservazione della preziosa macchia cedua. I cinque e sei piedi equivalevano rispettivamente a metri 1,75 e 2,10 attuali.16 Sul finire del XVIII secolo, quindi due secoli più tardi, nel verbale di consegna dei boschi del distretto Padovano il nostro bosco demaniale, unico ad essere iscritto tra quelli di prima classe, fu così descritto: «Un solo bosco di Pubblica Ragione esiste nella Provincia Padovana, e quest’è il Bosco della Carpaneda, in villa di Bastia, vicariato di Teolo. Questo bosco è di figura quasi rettan- Nel 1655 il Capitano dei boschi Francesco Valdagni pubblicò un opuscolo dal titolo Osservazioni e ricordi sopra il bosco della Carpaneda, inserendovi questa mappa topografica della Carpaneda, incisa da Giacomo Ruffoni. L’orientamento del Nord è in basso. 54 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei golare bislunga; di campi 265; di terreno dolce; piantato interamente di soli roveri. Nell’ultima curazione del 1794 vi si sono recise piante n. 1316, delle quali ne sono entrate nella Casa dell’Arsenale n. 337, e agli usi sociali se ne sono somministrate n. 356; le altre si sono devolute al Magistrato alle legne. Le piante, che esistono tutt’ora in questo bosco, dai piedi 3 di circonferenza fino alli piedi 5, ascendono al numero di 4.000, tutte marcate di color rosso ad oglio; e quelle di circonferenza minore di piedi 3, si calcolano all’incirca 14.000; oltre essere ben provvedute di novellami e tenere pianterelle». Duecentosessantacinque campi padovani sono equivalenti ad oltre 100 ettari attuali, più precisamente più di un milione di metri quadrati attuali.17 Tra le ultime memorie del bosco è il caso di ricordare quella di Andrea Gloria, risalente al 1862, che descrivendo Bastia ricorda che la Carpaneda «appartiene allo Stato. Intorno al quale scrive il Cittadella [1605] – Bastia che fu terra, ov’è il bello bosco del Carpaneo carico di quercie (quasi piccola Hircina) di campi 333 che scolano nella fossa della Nina e Bandessà e Bacchiglione per commodità di condurre li legni all’arsenale di Venetia e contiene il Vegrolungo copioso di lepri, volpi, lupi e tal’hora orsi e cinghiali».18 Questi ultimi selvatici son tornati dalle nostre parti, ma della Carpaneda, purtroppo, con le roveri e gli olmi è rimasto solo un labile ricordo. Note 1. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 310v. 2. Francesco Valdagni, Osservazioni e ricordi sopra il bosco della Carpaneda ed altri boschi circonvicini nella vicaria di Teolo, Padova 1655. 3. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 310v. 4. Si veda il disegno inserito nell’opera di F. Valdagni. 5. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 311r. 6. Valdagni, Osservazioni e ricordi, s.p. 7. Valdagni, Osservazioni e ricordi, s.p. 8. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 166-167. 9. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 310-314. 10. Valdagni, Osservazioni e ricordi, s.p. 11. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 164r. 12. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 108, c. 334. 13. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 109, c. 77-105. 14. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 311. 15. ASPd, S. Maria di Praglia, b. 107, c. 311. 16. ASPd, Boschi, b. 7, c. 245v. 17. ASVe, Provveditori ai boschi, b. 89, fasc. 1 “Catastico de’ Boschi di Prima e Seconda classe esistenti nella provincia Padovana”. 18. Andrea Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova 1862, vol. II, p. 85. Stefania Montemezzo Case vecie e campi magri. Vivere contadino e sviluppo delle colture agricole a Rovolon in età moderna Adagiato sui declivi collinari e ai piedi del Monte Grande e del Monte della Madonna, nella parte più settentrionale dei Colli Euganei, il territorio di Rovolon è l’estrema propaggine del territorio padovano, prima di entrare in terra vicentina. Le due diverse realtà di cui si compone, pianeggiante e d’altura, sono dal punto di vista agrario assai differenti. In pianura trovano la loro naturale posizione colture di tipo cerealicolo, quali frumento, segale, miglio e orzo. Le zone collinari, invece, sono contraddistinte da tratti boschivi e coltivazioni quali vite e ulivo. Una tale differenziazione era naturale, seppure l’Italia settentrionale seguisse nei metodi le tendenze europee, in particolare in un mondo agrario caratterizzato da metodi di lavorazione della terra arcaici e da una forza lavoro essenzialmente umana e animale. Il periodo che si prenderà in considerazione in questo contributo è definito come Età moderna. Questo arco di tempo si colloca fra la scoperta dell’America (1492) e la Rivoluzione Francese (1789), un momento di importante cesura per l’Europa e il Veneto. I fattori essenziali del cambiamento furono, da un punto di vista politico, le conquiste di Napoleone e la successiva annessione del Lombardo – Veneto all’Austria. Dalla fine del Settecento, inoltre, si vede l’inizio della rivoluzione industriale che, partendo dall’Inghilterra, portò a innovazioni tecniche che, con tempi e modalità diverse, sconvolsero l’aspetto agrario del vecchio continente, non essendo più l’agricoltura il principale settore dell’economia per percentuale di persone occupate. produttività e lavorazione Tra ’500 e ’700 il settore trainante dell’economia fu, dunque, l’agricoltura. È sufficiente pensare che circa l’80% della popolazione vi era impiegato. Il problema fondamentale era la produttività, che si legava a svariati fattori, talmente pericolosi da essere definiti “i cavalieri dell’apocalisse”, ovvero epidemie, carestie e guerre. Anche il verificarsi di uno solo di essi era sufficiente a mandare in crisi la produzione agricola di un’intera annata. Purtroppo, molto spesso si verificavano in contemporanea o in sequenza ravvicinata. Di frequente succedeva che una guerra avesse il potere di provocare una carestia, causata generalmente delle scorribande e incursioni degli eserciti per 56 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei procurarsi il vitto. Proprio a causa delle scarse condizioni igieniche dei soldati e della malnutrizione della popolazione, dovuta alla carestia, vi era una forte possibilità che si verificasse un’epidemia, che andava a colpire per primi gli individui più deboli, cioè anziani e bambini. Anche quando non vi era un evento catastrofico, come appena descritto, le rese dei coltivi erano estremamente basse. Per tutta l’Età moderna, in Italia, per quanto riguarda i cereali si ottenne appena 6,3 volte il seme utilizzato per la semina, per un raccolto medio per ettaro che si attestava sui 5/7 quintali, seppur con differenze notevoli tra le diverse zone. Per un raffronto, basti pensare che oggigiorno la resa media è di 41,4 quintali per ettaro. I motivi di un tale basso rendimento si possono rintracciare negli strumenti tecnici utilizzati, che non permettevano di piantare i semi alla necessaria profondità, alla scarsa concimazione e al persistere della rotazione triennale. Questo metodo prevedeva che i campi fossero divisi in tre settori: il primo coltivato con il frumento, a semina autunnale; il secondo ad avena e legumi, a semina primaverile; l’ultima parte sarebbe stata destinata al riposo, il cosiddetto «maggese». Il sistema funzionò inizialmente, alzando le rese, permettendo una migliore distribuzione temporale del lavoro contadino e lasciando a disposizione dell’allevamento il campo incolto. L’anno di riposo tuttavia non era sufficiente a fornire al terreno le sostanze azotate, sottratte dal frumento, e ciò comportava un costante impoverimento dei terreni che non andava a vantaggio dei raccolti. La soluzione più adatta, già attuata in alcune zone della penisola e nei Paesi Bassi, era la rotazione quadriennale, che prevedeva l’introduzione nel ciclo delle piante foraggere, utili anche all’allevamento stabile. Il sistema prevedeva che due parti del terreno fossero coltivate a cereali, una a legumi e l’ultima lasciata non incolta, ma a giardino (con le piante da foraggio). Il nuovo metodo avrebbe esteso la dimensione della terra coltivabile e aumentato considerevolmente la fertilità del suolo. A partire dall’Ot- Una panoramica su Rovolon in una cartolina illustrata del 1949. c as e v e cie e ca m p i m ag ri 57 tocento questa innovazione arriverà anche nelle zone venete. L’avversità alle innovazioni che si riscontro sul territorio suggerisce che la preferenza andava verso la coltivazione di carattere estensivo più che intensivo: vi era maggiore interesse a mantenere le medesime rese e, in caso di necessità di cereali, si sarebbe ricorsi semplicemente all’estensione del coltivo. Il clima era un elemento importante per la resa del suolo, così come il tipo di terreno. Sulla parte collinare del comune vi era molto spesso il problema della siccità: il suolo trachitico combinato ai pendii faceva in modo che l’acqua piovana defl uisse velocemente verso le valli, dove era rapidamente assorbita dai terreni tufacei. In questo modo le zone collinari di Rovolon soffrivano la siccità, che poteva compromettere la raccolta della frutta e la vendemmia. Il basso livello tecnologico delle pratiche di lavorazione infl uiva pesantemente sul raccolto e provocava variazioni annuali anche molto pesanti. Un cambiamento, seppur minimo, poteva provocare scompensi, a causa delle basse rese delle coltivazioni, danneggiando l’intera economia rurale e non garantendo il minimo di sussistenza per la popolazione. L’incremento demografico avvenuto tra XI e XII secolo, aveva inoltre portato alla specializzazione delle aziende agricole nella sola coltivazione dei cereali, eliminando le attività silvo – pastorali, quali pesca e caccia, che nei secoli precedenti avevano integrato l’alimentazione contadina. Questa trasformazione portò l’area a essere mag- Bastia. La corte della famiglia Forestan. 58 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei giormente esposta alle carestie. Queste ultime indicavano in effetti la penuria di cereali che erano divenuti il maggiore alimento nella dieta dei contadini e delle fasce di popolazione più povere delle città. coltivazioni e alimentazione La diligenza a Bastia in un’istantanea di fine Ottocento. La produzione agricola era, dunque, fortemente legata alle condizioni naturali, in particolare in periodi in cui il lavoro dei campi era caratterizzato da una tecnologia poco sviluppata e dalla mancanza di concimazione dei suoli. Dal XII secolo si andò sempre più intensificando la coltivazione dei cereali, che si stima potessero fornire tra l’80% e il 90% della razione calorica giornaliera. Il pane si poneva allora al centro dell’alimentazione europea, un po’ come il riso era, ed è, al centro di quella cinese. I cereali, in particolare quelli che producevano una farina panificabile, divennero il prodotto da coltivare per eccellenza. Come in buona parte d’Europa, i prodotti che più si ritrovavano nella campagna padovana erano: il grano e i farinacei di vario tipo nelle zone pianeggianti con terra bonificata; la vite, che si trovava nell’alto Medioevo sia in piano che in collina, ma che divenne poi coltura specializzata sulle alture, assieme all’ulivo; il lino, nelle zone in cui vi erano acquitrini e paludi. Non va dimenticato anche il manto boschivo, che ricopriva le colline e parte del suolo pianeggiante di Bastia. Il frumento era considerato il cereale nobile per eccellenza, nonostante un calo nella produzione durante la crisi alto medievale che aveva momentaneamente portato alla sua sostituzione con la segale (pianta meno delicata da coltivare). Ideale per la produzione di farina adatta alla panificazione, era il cereale maggiormente coltivato nel padovano. Nel Veneto, era molto spesso accompagnato da un’altra pianta: il sorgo. Importato dall’Oriente, in particolare dalla Siria a cui deve il suo nome, era utilizzato già in epoca romana. Era considerato, tuttavia, un grano povero e generalmente destinato dai romani al foraggiamento degli animali. In Veneto, e nel padovano in particolar modo, il sorgo trovò la sua terra di elezione e iniziò a essere coltivato per la dieta quotidiana, soprattutto degli strati più poveri della popolazione. Con questo grano minuto era prodotta, in particolare, una prima specie di polenta di colore grigio, a differenza della giallina prodotta col miglio nel Medioevo. Nel XVI secolo, a seguito dell’introduzione del mais importato dalle Americhe, il sorgo non fu più seminato. Miglio e segale erano coltivati, ma in misura inferiore rispetto a frumento e sorgo. Molto più raro era l’orzo, mentre avena e farro erano totalmente assenti. I coltivatori, inoltre, tendevano ad accompagnare ai cereali delle leguminose, come le fave. Assimilate ai grani grossi, potevano essere ridotte in una farina adatta alla produzione di panificati. Per i cereali era utilizzata una rotazione triennale intensiva, che alternava alle c as e v e cie e ca m p i m ag ri 59 piante invernali, quali frumento e fave, quelle primaverili, cioè sorgo e miglio. I contratti agrari, e in qualche caso gli statuti comunali, evidenziano che l’interesse per i grani grossi (come frumento e orzo) era soprattutto dimostrato dagli abitanti dei centri cittadini. Essi, infatti, preferivano cereali che fornissero farine fini e panificabili. Il mondo rurale dimostra invece una predilezione per i grani minuti, come il sorgo, più adatto a preparazioni come la polenta. Si andò allora specializzando nelle campagne padovane una produzione di grani pregiati per le città e una di grani più rustici per gli abitanti del contado. Per il suo carattere pregiato, il frumento era spesso utilizzato per il pagamento degli affitti, come nel caso di Antonio Bertoldo di Rovolon che dichiara che per campi dui in la contra de Fondorizzo delli qualli pago de livello stara tre formento all’anno alli eredi del quondam signor Rinaldo Papafava.1 Dal Cinquecento vi fu la graduale introduzione della coltura del mais. Inizialmente coltivato a fianco degli altri cereali, piantato a margine dei campi o come alternativa al campo incolto, divenne sempre più l’alimento base della popolazione rurale. In un primo tempo non fu tenuto in particolare considerazione dalla classe nobile, tanto da non essere nemmeno menzionato nei contratti agrari. In seguito, invece, soppiantò gradualmente il sorgo. Ciò fu possibile soprattutto grazie alla sua alta resa: a metà Seicento il rapporto semente/prodotto era di 1 a 15, mentre il frumento stava a un rapporto di circa 1 a 5, con differenze secondo le zone. Il formenton giallo, dunque, se inizialmente concepito come integrazione alle altre colture, divenne in seguito essenziale per il sostentamento della popolazione rurale prima, e cittadina poi. Non producendo una farina panificabile, fu sostituito al sorgo per la produzione della polenta, che divenne l’alimento base della dieta veneta. La forte produttività portò all’estensione dei coltivi e alla limitazione degli spazi destinati alla pastorizia e all’allevamento animale, con un conseguente calo dell’assunzione di proteine da parte dei contadini. L’alimentazione rurale divenne in molti casi mono – maidica. La dieta a base di polenta però cominciò a creare problemi di salute alla popolazione. Il mais, infatti, se non opportunamente integrato con alimenti freschi, inibiva l’assimilazione di vitamine del gruppo B, come la niacina (vitamina P.P., che significa Pellagra Prevention). La mancanza di tale vitamina, oltre a causare un abbassamento delle difese immunitarie e una maggiore esposizione alle malattie epidemiche, faceva ammalare gli individui di pellagra. Quest’ultima è responsabile di un quadro clinico definito delle tre D (demenza, dermatite e diarrea) e se non opportunamente curata con il reinserimento nella dieta Un antico lavabo nella casa “Colombara” di Monte Sereo. 60 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei della niacina, porta in molti casi alla morte entro pochi anni. Fu soprattutto con l’Ottocento che la popolazione veneta cominciò a patire le conseguenze di un’alimentazione a base di polenta di mais. Il pane, che in campagna era nero e raffermo, e la polenta di solito si accompagnavano con delle zuppe, fatte con i prodotti dell’orto, come cavoli, rape e legumi secchi (piselli, fagioli e fave). Quando ve n’era possibilità, vi si aggiungeva del pollame (galline, polli e capponi) o del maiale, i quali non essendo tassati erano molto spesso allevati dalle famiglie nel proprio cortile, anche se non in quantità tali da garantire ai contadini un sufficiente apporto di lipidi e proteine nella dieta. Per capire quanto questo piccolo allevamento era diff uso è interessante osservare come fosse utilizzato dai contadini per pagare, in parte o del tutto, gli affitti agrari. Nel 1615 Alvise Bonfio del fu Camillo dichiarò di possedere la meta d’una casa de muro coperta de coppi con colombara et cortivo serado de muro posta in Villa de Revolon in contrà de mollini la quale confina con una roda et meza de mollini in detta Villa et contra confinano alla detta casa, la via comune Marc’Antonio Corsato et le raggioni del sopradetto Illustrissimo signor abbate Papafava sono affittuari al presente a domino Francesco Schio, et si cava ogni anno denari ducati trentasei, formento stara quaranta, computa la casa sopradetta, ovi numero cento, capponi para uno, pollastri para doi, galline para numero doi.2 Uno scorcio della campagna, oltre l’ingresso di un rustico. La quantità di prodotti avicoli in questione era abbastanza alta, questo fatto suggerisce che la famiglia fosse ben rifornita di pollame. La vite beneficiò per prima delle opere di bonifica sostenute dai monaci benedettini, potendo crescere su terreni in condizioni non ottime, purché non paludosi. Tuttavia, dal X e XI secolo, con l’aumentare della popolazione e la destinazione delle zone pianeggianti alla coltivazione dei cereali, la vite fu spostata sui pendii più dolci dei colli, pur rimanendo ovviamente presente anche in altre zone della pianura, quali alcuni tratti della riviera del Brenta e nei pressi di Padova. Nel settore settentrionale degli Euganei, la vite non sembra essersi attestata prima del XII secolo a causa della posizione meno adatta. Il versante di Rovolon, essendo esposto a nord, era troppo freddo. Il terreno di origine vulcanica rese, inoltre, almeno inizialmente, più complicata la crescita della pianta. La ripresa economica cittadina in atto spingeva tuttavia i proprietari terrieri e i piccoli coltivatori ad aumentare la produzione di beni destinati al mercato come appunto cereali e vino. In questa pro- c as e v e cie e ca m p i m ag ri 61 spettiva si inserisce lo sforzo operato dai contadini per adattare la pianta a un clima non favorevole. I contratti agrari stipulati tra proprietari del terreno e contadini, i livelli in particolare (di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), dimostrano che fin dall’alto Medioevo i conduttori tendevano da un lato a migliorare la qualità delle viti, e di conseguenza dell’uva, tramite la potatura dei rami che venivano definiti “superficiali”; dall’altro a incrementare la coltivazione dei vitigni, tramite imposizioni inserite proprio nei contratti. Dal tredicesimo e soprattutto quattordicesimo secolo la vite divenne una risorsa fondamentale per l’economia collinare, che sviluppò progressivamente uve tipiche. Secondo i Catastici dell’epoca, le uve che dominavano il panorama euganeo erano due: le vigne sclavae e quelle garganicae. La prima era bianca, con maturazione precoce e riusciva ad adattarsi a tutto il territorio collinare. La seconda era invece meno diff usa, anche se aveva il vantaggio di produrre vini che invecchiavano bene. La sempre maggiore estensione dei vigneti e la specializzazione produttiva presuppongono la presenza di ben sviluppati mercati vinicoli in città. Seppur prodotto nelle campagne, infatti, il vino veniva consumato soprattutto nei centri urbani. Le fonti rivelano come i consumi rurali della bevanda alcolica fossero piuttosto bassi. Il contadino beveva con ogni probabilità solo nelle occasioni di festa e non durante i periodi lavorativi. In campagna, inoltre, il consumo riguardava i vini di qualità Un antico aratro con vomere a collo d’oca nella corte Forestan al Vegrolongo. 62 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei inferiore: le élites preferivano i bianchi delicati, lasciando alle fasce di popolazione più povere le qualità rosse più nutrienti. Una polizza presentata nel 1615 conferma questa situazione, dicendo: Si paga ogn’anno de livello sopra li campi delle Pacagnole al magnifico signor Teodoro Bacho lire dodici affrancabili et sopra tutti li beni per un lasso de Bortolamio Corsato si paga ogn’anno mastello uno vin dolce de monte alla veneranda fraglia del Santissimo Nome di Cristi di Padova.3 La bevanda per eccellenza delle campagne rimaneva dunque l’acqua, che poteva essere di sorgente o di pozzo. L’ulivo fu un’altra coltura specializzata dei colli. Pur affiancando la vite nelle coltivazioni, era molto più complicato da coltivare. Innanzitutto, necessitava di almeno 20 anni per giungere a completa maturazione e poter cominciare a dare i suoi frutti, contro i 5 delle viti. Inoltre, era molto più sensibile ai forti sbalzi di temperatura. La spremitura delle olive era poi assai più complicata di quella dell’uva e richiedeva un maggiore investimento di capitali nei macchinari. Erano i ricchi proprietari a incentivare la coltivazione della pianta, sostenendone anche i costi iniziali. L’olio era destinato principalmente all’illuminazione, soprattutto nelle case dei ricchi e in città (nel mondo rurale si usava l’olio di lino) e durante le liturgie nelle chiese e nei monasteri. Nel territorio di Rovolon gli ulivi si trovavano principalmente sul versante nordorientale, più esposto al sole e meno soggetto alle forti gelate. La produzione locale non era tuttavia paragonabile a quella di altre zone collinari, come Arquà e Monselice, che avevano una posizione più adatta. Alcuni documenti suggeriscono che nelle zone più acquitrinose del comune Il monastero di Santa Giustina di Padova, che tanta parte ebbe nella gestione delle terre e nella vita religiosa di Rovolon e Bastia. c as e v e cie e ca m p i m ag ri 63 vi fosse spazio per l’introduzione della coltura del lino. Questa produzione mobilitava tutte le forze familiari, in particolare nel momento della raccolta e successivamente delle lavorazioni che avrebbero portato alla filatura e alla tessitura. La produzione era tuttavia minima e con un significato economico relativo. Le fonti non riferiscono con precisione i luoghi dove si trovavano le piantagioni. Oltre alle coltivazioni selezionate, nelle zone collinari erano molto presenti gli arbusti ad alto fusto. A quote inferiori si trovavano in generale i querceti, di roveri e farnie, mentre a quote superiori vi erano i faggeti. Sin dall’Età romana il manto boschivo cominciò a essere “manipolato” dagli abitanti che inserirono, al posto del faggio, il castagno. Studi recenti sull’economia collinare hanno dimostrato che la pianta trovò la sua posizione ideale proprio a Rovolon, perché riparata dai venti del sud che non avrebbero favorito il suo sviluppo. Il castagno era utile sia per il legno, particolarmente adatto alle costruzioni in quanto resistente e di media durezza, sia per i frutti, da cui si ricava un’ottima farina. Sempre in epoca romana cominciò un forte processo di disboscamento, che tuttavia s’interruppe durante l’alto Medioevo, a causa della recessione demografica, che fece calare la necessità di legname come anche di nuovi terreni da mettere a coltura. La tendenza ebbe un’inversione dal XII secolo. Con la rinascita delle città e il ripopolamento delle campagne crebbe la domanda di legname, sia da ardere che per uso costruttivo, e di derrate alimentari, con l’estensione dei terreni a coltura per aumentare la produzione agricola. I nomi di località attualmente in uso che rimandano alla presenza di antichi boschi sono molti: Rovolon, che probabilmente indica la forte presenza di roveri; Frassanelle richiama la presenza di frassini; Carpaneda indica grandi Il monastero di Praglia. Fino al 1806 fu proprietario di una vasta azienda agricola a Spirano e della chiesa di Carbonara. 64 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei c as e v e cie e ca m p i m ag ri 65 distese di carpini, albero ad alto fusto facente parte della stessa famiglia delle betulle. In parallelo al disboscamento avveniva l’opera di bonifica del suolo a valle, promossa dai monaci benedettini, reso così coltivabile. Del naturale manto boschivo non rimane oggi quasi più nulla, essendo stato quasi totalmente manipolato dall’uomo. Oltre al castagno, nel territorio erano certamente presenti alberi da frutto, di cui però si hanno scarse notizie. La dieta contadina era integrata da frutta fresca o essiccata, ma è difficile dire in quali quantità e varietà. L’allevamento del bestiame conobbe nei secoli dopo il Mille un forte sviluppo. Ciò avvenne per le esigenze dell’agricoltura (tiro dell’aratro, trebbiatura, concimazione dei terreni), del trasporto e dell’artigianato tessile; ma anche per il consumo alimentare di carne, latte e formaggio. In Età medievale nei contratti i proprietari affidavano il bestiame agli allevatori. Questi avevano il compito di provvedere ai pascoli e governare le bestie. I contratti sono chiamati di «sòccida». Allo scadere del contratto il bestiame era diviso fra il proprietario (soccidante) e il pastore (soccidario) in modo variabile e in base al precedente accordo, ma solitamente a metà. Il bestiame pascolava generalmente nelle terre comuni o nei campi a maggese. Il principale animale da tiro utilizzato era il bue. Nei campi trainava l’aratro pesante, con il vomere in metallo, che rivoltava le zolle ed ebbe una notevole diff usione a partire dal secolo XI. Le innovazioni tecniche (come la ferratura e un nuovo tipo di collare che non “strozzava” gli animali durante il tiro) introdotte tra XIII e XV secolo, migliorarono le possibilità di impiego del cavallo quale animale da tiro. Questi fattori concorsero a produrre un incremento delle rese. La crescita demografica che si stava realizzando nel periodo provocò un’estensione della cerealicoltura a scapito dell’allevamento. L’allevamento dei grossi capi, quali buoi, mucche e cavalli si ridimensionò a favore di pollame, ovini e suini. forme della proprietà e contratti agrari Nel 970 il territorio di “Revolone” e la cappella di San Giorgio, assieme a Tribano, Pernumia, Conselve, Arre, Maserà e Monselice, furono ceduti dal vescovo Gauslino all’Abbazia di Santa Giustina di Padova.4 In particolare erano ceduti decime e quartesi. Questi erano un contributo, la decima parte del reddito, che tutti i parrocchiani dovevano pagare al clero locale. Un quartese (quarto di decima) era assegnato al pievano, mentre il rimanente era destinato alle attività di assistenza ai credenti e al mantenimento del luogo di culto, nel caso di Rovolon la cappella di San Giorgio. Nei secoli successivi, dopo le ulteriori conferme dei vescovi padovani a Santa Giustina (Orso nel 1014, Burcardo nel 1034, Ulderico nel 1064), molte zone di Rovolon pervennero nel patrimonio di Praglia, monastero che andò affermandosi e acquisendo terre grazie alle continue donazioni dopo il 1117. L’opera dei monaci benedettini, prima di Santa Giustina e successivamente di Praglia, si rivelò fondamentale soprattutto nel dissodamento e nella bonifica delle zone adiacenti Carbonara e Bastia, che avevano terreni difficilmente coltivabili a causa dell’ eccessiva La Memoria del turbine abbattutosi a Bastia il 17 agosto 1756 che causò in parrocchia ben nove morti e il crollo della chiesa appena ricostruita. Lo stesso turbine distrusse anche la copertura del Palazzo della Ragione a Padova. 66 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei durezza del suolo. All’inizio del quindicesimo secolo i monaci benedettini ingrandirono le loro proprietà nella zona di Rovolon, subito dopo la conquista veneziana e le relative confische dei terreni ai nobili padovani compromessi con i Da Carrara. Nel 1441 l’Abbazia di Santa Giustina acquistò, nelle vicinanze di Rovolon, la località detta “la Costa”. Ricevette poi una donazione di terreni, consistente in 700 campi padovani, posti nella zona del Vegrolongo. Secondo le fonti il territorio era soprattutto boschivo e acquitrinoso, quindi non coltivabile a meno di non essere bonificato, operazioni che i monaci svolsero assoldando braccianti locali. Sorse così una corte benedettina, affidata a un gastaldo che rispondeva dell’andamento degli affari. La gestione amministrativa era rimessa invece nelle mani di un rettore, anch’egli monaco, che dimorava in quella che oggi è conosciuta come Villa Ottavia, e ubicata sulla strada che attualmente si chiama Via Torre, ma che all’epoca era conosciuto come “palazzo della Costa”. I due monasteri mantennero i loro diritti sulle pievi di San Giorgio e su quelle delle frazioni sottoposte fino al 1806 quando, assieme alla conquista francese, vi fu la soppressione napoleonica di tutti i beni di diritto ecclesiastico. Dal 1405 il territorio di Rovolon, come tutto il resto del padovano fino all’Adige, cadde sotto il dominio veneziano. Le autorità della Dominante favorirono l’insediarsi di patrizi veneziani e la conseguente creazione di vasti possedimenti, controllati da uomini e famiglie fedeli alla Serenissima. I nobili lagunari cominciarono, come già era accaduto in altre zone del padovano come la riviera del Brenta, a costruire sui colli sfarzose ville che spesso si ponevano al centro di grandi possedimenti coltivati. In tali possedimenti le aree boschive andavano diminuendo a favore di coltivazioni cerealicole o viticole. Nel territorio comunale mantennero tuttavia le proprie possessioni i Papafava. A causa della loro parentela con i Carraresi, signori di Padova sconfitti dai veneziani, la famiglia rischiò la confisca di tutti i beni. Riuscendo però a dimostrare che i possedimenti sui Colli Euganei erano frutto non della parentela con la famiglia Da Carrara, ma della discendenza dagli Schinelli, signori feudatari di Rovolon, mantennero le loro proprietà. Le soluzioni adottate dai veneziani per la gestione della Terraferma rispecchiano il metodo di dominio che la Repubblica aveva con successo già sperimentato nei suoi possedimenti oltremare, ma in contrasto con gli altri stati regionali della penisola. Seppur con modifiche e adattamenti fatti dalle magistrature di riferimento rimasero in vigore gli statuti già esistenti per regolare la vita delle comunità di villaggio. La Repubblica promosse inoltre ulteriori diboscamenti e dissodamenti dei terreni, oltre a mantenere attivo il sistema di canalizzazione che arrivava direttamente in laguna attraverso il Bacchiglione. Nella gestione del sistema amministrativo, fiscale e giudiziario i veneziani mantennero l’impostazione dei governi comunali. Questa prevedeva una netta divisione tra campagna e città, con la supremazia della seconda sul contado. Rispettando poi una consolidata tradizione, Venezia accordò alle città esenzioni e privilegi non concessi invece agli abitanti del territorio. A livello fiscale, Venezia assegnava le imposte da pagare, decise di volta in volta in base al fabbisogno, già ripartite tra i diversi «corpi»: «Città», «Clero» e «Territorio». La ripartizione delle somme dovute dai corpi fiscali non era inizialmente sog- c as e v e cie e ca m p i m ag ri 67 getta a mutamenti. Con il passare del tempo il sistema, che già doveva essere a favore degli abitanti della città, venne perdendo il suo equilibrio quando i cittadini andarono acquistando sempre più beni in campagna, rendendo proprietari di second’ordine, quando non mezzadri e lavoranti, gli abitanti dei borghi rurali. Lo scompenso che si veniva a creare ricadeva in larga parte sulle comunità rurali, che vedevano invariata la quota di tributi ma con una base imponibile che si andava riducendo. Un tale sistema portava i contadini a contrarre forti debiti, costringendoli a indebitarsi o con un usuraio, cittadino, oppure con i maggiori possidenti del luogo. Dalla fine del Cinquecento la Repubblica veneziana, che aveva interesse a una buona gestione della fiscalità, andò riequilibrando la situazione. Strumento fondamentale per la riscossione delle gravezze era l’estimo. Era una procedura che stimava la capacità contributiva del soggetto d’imposta, tramite la valutazione della base imponibile (rappresentata da reddito capitalizzato più che dai beni posseduti) al netto delle detrazioni che si potevano ottenere. Gli estimi dei tre corpi, di cui si è detto sopra, rispecchiavano, se sommati, la capacità contributiva del padovano. L’estimo aveva la peculiarità di mostrare più i beni di un territorio che quelli di una persona. Questa fonte è dunque preziosa per comprendere come fosse costituita la proprietà di un certo territorio. Ma come funzionava questo sistema, peraltro complesso e abbastanza lungo? Quando si andava a «fare estimo» chiunque possedesse beni immobili o potesse vantare utili di qualsiasi natura doveva presentare una polizza, corredata di nome e cognome, contrada e luogo di residenza. Inoltre doveva dichiarare: - tutte le proprietà fondiarie, descritte nei particolari; - i beni immobili di proprietà e il loro uso; - le attività svolte, mercantili e artigiane, con il «capitale di traffico»; - gli eventuali livelli e censi. Le polizze venivano poi registrate nella cancelleria per formare i libri dell’estimo. Partivano successivamente dei controlli per verificare la qualità delle possessioni e attribuire loro un valore accertato. Tale valore era indicato in «lire d’estimo», che rappresentavano la quota da pagare all’interno del totale dei contributi dovuti da un «corpo». Nel 1615 donna Caterina Pegoraro dichiarava nella sua polizza per i tre presidenti dei corpi: Filari di viti sui declivi Euganei. 68 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Cattarina Pegorara rellita quandam Battista possede li sottoscritti beni come appare per sua polizza con suo giuramento per lei presentata sotto di 20 giugno 1615 numero 10292. Campi tre in circa arativi et zappativi con un campo de vegro, con una casa de muro coperta de copi quale ha per suo uso, confina da una la via comune, dall’altra Gasparo Fattore, dall’altra li padri di Santa Giustina, dall’altra Marc’Antonio Corsato paga de livello perpetuo al signor Antenore Bonfio Lire dodici, una gallina et un pollo et il quartese al curato di Carbonara. Quartieri de terra arrativa in detta villa senza piante confina da una il signor Steffano Nani dalle altre due il signor Marsolio Papafava, dall’altra il detto Corsato et lo tiene per suo uso paga de livello perpetuo al signor Carlo Genoa lire sette all’anno. Espedita in lire doicento et dieci fano di estimo £ire 0, soldi 2, denari 15 La donna, all’atto della dichiarazione, descrive minuziosamente tutte le proprietà e le fonti di reddito. Questo punto era fondamentale al fine di pagare la giusta quota di tributi e non incorrere in sanzioni da parte dell’autorità. Tuttavia, si tendeva generalmente a svalutare davanti all’autorità il vero valore dei propri beni, per cercare di pagare una quota inferiore di tasse. Una volta inseriti in questo registro e appurata la consistenza delle proprietà, i pubblici ufficiali passavano all’assegnazione della quota da pagare, espressa in lira d’estimo. Nel 1518 Galeazzo Facchin fu inserito nel registro d’estimo in questo modo: 200 Galeazzo Fachin del q. Zuane Piero 400 Lorenzo Conforto del q. Toma Agnol suo fradello 0 campi quattro terra con una casa paga livello a miser Bernardin Spiciale stara otto fromento et paro uno galline 47 campi dui in monte paga livello a miser Francesco Papafava £ 1 . 14 una galina 0 campi tri terra arativa parte paludiva in pianta in monte paga livello a miser Bernardin Spiciale stara otto fromento et paro uno galline 200 Marco del q. Bertio Carmignan 228 campi sei proprii 0 una casa con campo mezo ara6 L’uomo viveva con i due fratelli Conforto a Rovolon, dove era registrato. Come si può vedere, oltre a possedere una casa, di cui non conosciamo la consistenza materiale lavorava soprattutto su terreni concessi a livello da un tale Bernardino speziale (rivenditore di spezie del villaggio) e dal nobile Francesco Papafava. Il livello era versato parte in contanti e parte con galline e frumento. L’integrazione del pagamento con prodotti in natura non è occasionale. Gli estimi del comune sono ricchi di esempi che confermano la frequenza di questo costume. Dopo aver delineato le caratteristiche della giurisdizione e delle forme di proprietà del territorio di Rovolon, è importante capire quali fossero i contratti che permettevano la coltivazione dei terreni da parte dei contadini. Nelle campagne padovane del Sei e Settecento sono presenti diversi tipi di c as e v e cie e ca m p i m ag ri 69 conduzione dei terreni. Innanzitutto vi era la piccola proprietà contadina, molto presente soprattutto tra Cinque e Seicento. L’aumento demografico mise in crisi questa tipologia di azienda, che andò così diminuendo a favore dei grandi possedimenti. L’indebitamento contadino in seguito all’incremento dei prezzi e la penetrazione di capitale cittadino nel contado, aveva messo in crisi i precedenti equilibri. Le proprietà di grandi dimensioni appartenevano alla classe nobiliare o ecclesiastica. La gestione dei terreni avveniva secondo modalità differenti. La prima prevedeva la conduzione diretta, tramite l’assunzione di braccianti. Questi erano contadini senza terra che vendevano per un salario la propria forza lavorativa ed erano impiegati di solito nella pars dominica, di stretta pertinenza del signore. Per i terreni più vasti, la terra era concessa a famiglie di coltivatori liberi. Un contratto agrario molto diff uso era la mezzadria. Si trattava di un accordo che prevedeva la compartecipazione di spese e ricavi da parte del proprietario e del contadino. Il primo concedeva al secondo il terreno, gli attrezzi, i concimi e, in alcuni casi, l’abitazione. Il mezzadro prestava la propria mano d’opera per tutte le attività agricole e curava la manutenzione ordinaria dei fondi e dei muri di sostegno. Il livello era un altro contratto presente nelle campagne venete. Nei territori del padovano la sua durata era di 29 anni e nella maggior parte dei casi veniva rinnovato divenendo di fatto perpetuo. Il contratto prescriveva la quantità di olio, di frumento, di vino che il colono doveva versare come pagamento per la concessione del diritto di sfruttamento della terra. Il proprietario non aveva alcun vincolo verso il concessionario, né interveniva nelle spese di coltivazione o miglioramento: si riservava solo il riconoscimento giuridico formale della proprietà. Per questo motivo i contadini erano tenuti a versare ulteriori contributi al concedente, a dimostrazione dell’ascendenza feudale dell’istituto. L’agricoltore agiva comunque in maniera autonoma. Il terreno non poteva essergli sottratto e il canone non poteva essere modificato. Egli, inoltre, poteva vendere il suo diritto o trasmetterlo per successione. Il rapporto impediva, in genere, ogni innovazione delle colture, per non pregiudicare il canone di fitto. Inoltre, seppure avesse interesse ad aumentare la produzione, il contadino non possedeva risorse sufficienti per apportare le migliorie necessarie ai fondi che gestiva. Un ulteriore forma di rapporto contrattuale era il livello francabile. Quest’ultimo aveva la funzione di rappresentare un prestito mascherato. In Età moderna non era, infatti, possibile prestare una somma di denaro e ricevere un interesse sulla stessa, poiché vietato dalla normativa religiosa. Il bisogno di ricorrere al credito era, dunque, stato soddisfatto attraverso un piccolo stratagemma. Se un contadino necessitava di una somma di denaro, vendeva il proprio appezzamento di terreno a un ricco proprietario. Quest’ultimo gli pagava la somma pattuita, poniamo 100 ducati, ma gli concedeva immediatamente a livello lo stesso campo con la promessa di affrancarglielo (di qui francabile) dopo un certo periodo (normalmente 29 anni), tramite il pagamento della stessa somma. Ogni anno, per tutta la durata del contratto, il contadino gli avrebbe dovuto inoltre versare un canone pari a 5 ducati. La somma 70 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei rappresentava, così, un modico interesse del 5% l’anno, su base ventinovennale. Durante il Cinquecento e i primi decenni del Seicento, l’incremento demografico, associato all’aumento dei prezzi, aveva, infatti, contribuito al continuo frazionamento della piccola proprietà contadina, mettendo gli agricoltori nella condizione di non riuscire soddisfare i debiti precedentemente contratti e costringendoli a trovare vie legali per ottenere denaro a prestito. A Rovolon un contadino poteva comunque coltivare in parte la terra di sua proprietà, avendo poi altri terreni concessi a livello. Nell’estimo del 1518 risulta che: 50 6 26 Beni de Baptista Cozante over sui heredi una casa de muro con un quartiero de terra propria campo uno boscho proprio campi doj terra paga livello a miser Hanibal Papafava £ 4 all’anno7 Battista Cozante possedeva, oltre a una sua casa in pietra, evenienza non del tutto usuale per l’epoca, un quartiero (cioè poco più di 900 metri quadrati) e un campo boschivo di proprietà. Oltre a questo, aveva due campi a livello da Annibale Papafava, nobiluomo e ricco possidente residente a Frassanelle. Questo breve excursus sul vivere contadino nelle terre di Rovolon, tra basso Medioevo ed Età moderna, sia permesso di ricostruire alcuni fra gli aspetti dei problemi più significativi di un territorio che, fra permanenze e lente trasformazioni, si avvicina alle soglie dell’Età contemporanea. Note Amintore Fanfani, Storia economica, Torino (UTET) 1970, I, p. 541. Più in generale si rinvia a Daniele Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma (Istituto per la collaborazione culturale) 1961; Giorgio Borelli, Questioni di storia economica europea tra Età moderna e contemporanea, Padova (CEDAM) 2001; Lorena Favaretto, L’istituzione informale. Il Territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento, Milano (Unicopli) 1998; Jean Louis Flandrin, L’alimentazione contadina in un’economia di sostentamento, in Storia dell’alimentazione, a cura di Jean Louis Flandrin e Massimo Montanari, Roma-Bari (Laterza)1997, p. 465-489; Igino Michieli, I Colli Euganei. Vicende economiche e sociali, Padova (Società Cooperativa Tipografica) 1965; Massimo Montanari, La società medievale di fronte alla carestia. Osservazioni preliminari con particolare riguardo all’Italia padana, «Società e Storia», VI (1983), p. 379-385; Gérard Rippe, Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle). Société et pouvoirs, Rome (École Française de Rome) 2003, p. 603. Archivio Stato di Padova (ASPd), Estimo 1575, reg. 98, c. 167v. ASPd, Estimo 1615, reg. 181, c. 77v. ASPd, Estimo 1615, reg. 181, c. 77v. Rizieri Zanocco, Decime e quartesi in diocesi di Padova alla luce dei documenti, Padova (Antoniana) 1951, p. 104-105. 5. ASPd, Estimo 1615, reg. 181, c. 81v. 6. ASPd, Estimo 1518, reg. 347, c. 12r. 7. ASPd, Estimo 1518, reg. 347, c. 11v. 1. 2. 3. 4. Cristina Capodaglio Il Comune di Rovolon nell’Ottocento Dopo la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797 e la parentesi napoleonica, il Veneto viene annesso all’Impero austro-ungarico nel 1815 e resterà sotto il dominio austriaco fino al 1866. Seguirà poi l’annessione al Regno d’Italia. Al di là delle vicende politiche che hanno infl uenzato anche la vita del nostro comune, quello che interessa scoprire è quale fosse la condizione di vita della popolazione di Rovolon nel corso dell’Ottocento. Non è sempre facile, tra dati statistici e relazioni, far luce su questa realtà. Il comune di Rovolon, in una descrizione dedicata alle notizie cronologiche e statistiche del territorio di Padova nel 1818 risulta suddiviso nelle parrocchie di “Carbonara, con le contrade di Carbonara in piano e in monte, Bastia, con le contrade Castigliana, Granza Frassanella sotto Revolone, Revolon con le contrade Revolone in piano e in monte, Granza S. Giustina sotto Revolone, Vegrolongo, Granza di Vegrolongo, Vegrolongo del bosco”. 1 Ma di cosa viveva chi abitava in queste contrade? Nell’Archivio di Stato di Venezia si trovano i preziosi “Atti preparatori per il catasto austriaco”, di cui le Notifiche Generali, redatte negli anni 1826-1829, forniscono un quadro dettagliato per ogni singolo comune. Anche per Rovolon abbiamo quindi una descrizione di quale fosse la realtà economica e Uno scorcio di Rovolon ripreso in via Principessa Jolanda sul finire del XIX secolo. 72 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei le condizioni di vita della popolazione in quei primi decenni dell’Ottocento. Prevaleva naturalmente l’agricoltura, come principale attività economica, e la destinazione colturale dei terreni fu allora così riepilogata: Catasto austriaco 1826-1829 qualità di coltura pertiche censuarie (1000 mq.) aratorio aratorio arborato arboreto prato pascolo bosco valle argine incolto, zerbo orto brolo giardino fabbricati vari totale 1.451 12.284 2.258 4.048 464 4.881 101 366 16 51 196 14 294 67 26.491 Nella pianura di Rovolon predominavano i terreni l’aratorio arborato vitato. Su questi terreni, destinati alla semina tradizionale, l’avvicendamento delle colture prevedeva due anni a frumento e uno a granoturco, per i fondi migliori, mentre per quelli di minor qualità due anni a frumento, uno a “sorgo turco” e uno a riposo. Il contadino doveva preoccuparsi di concimare il campo, spargendo il letame sui campi, calcolato in media tra 6 e 8 carri di letame. Di fatto però il letame disponibile in realtà era insufficiente e bastava soltanto a concimare un terzo o un quarto della superficie totale coltivata dell’intera superficie agraria, con una conseguente minor resa delle colture. In genere si seminavano in ogni campo arativo due staia e mezzo di frumento (equivalenti a 72,45 litri), da tre quarti a uno staio di granoturco (cioè da 22 a 29 litri), un quarto di staro (7,25 litri) di sorgo turco. La resa, a seconda dell’ubicazione dei terreni, se in piano o in monte, variava come riportato in tabella: frumento granoturco sorgo rosso piano monte sacchi 2,5 a staia 4 sacchi 6 a staia 1,5 sacchi 4,5 a staia 2 sacchi 1,5 a staia 3 sacchi 2 a staia 1 e 1/4 - i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 73 Nelle parti più basse predominava il prato, dove, a seconda dei terreni, si praticavano uno o due tagli. I pascoli posti in pianura offrivano una migliore qualità di fieno rispetto a quelli in monte. Di solito i pascoli non venivano affittati, ma dato che non esistevano né prati privati, né prati comunali, vi avevano accesso le pecore del comune. In caso queste fossero state in numero insufficiente, i pastori montani avevano il diritto di portarvi le loro pecore, mantenendo così viva l’antica consuetudine del pensionatico, con grave danno dei proprietari. La servitù del pascolo era limitata dal 29 settembre al 17 marzo di ogni anno. È certa la presenza di pastori montani provenienti dall’Altopiano di Asiago, che ogni anno sostavano a Carbonara, come risulta dai registri parrocchiali: nel 1854 e 1860 Maddalena Marin e Bortolo Dalla Bona, pastori domiciliati a Gallio ma in sosta a Carbonara, fecero battezzare i loro figli in parrocchia.2 Nel novembre 1864,3 invece, Bortolo Tagliaro, nato a Gallio nel 1834 e là dimorante, di professione pastore, sposò Giovanna Marin, pastora di Gallio, anch’essa in sosta nella parrocchia di Carbonara. Il comune di Rovolon, ancora ai primi del Novecento, come descritto nel Regolamento dei pastori vaganti, permetteva il libero pascolo dal primo novembre a tutto il mese di marzo, dal levare al tramontare del sole, previa richiesta al proprietario del pascolo.4 Il sistema di locazione più usato nelle campagne era l’affitto in denaro, data l’esistenza di grandi proprietà soprattutto in piano, e si articolava tra la partizione, adottata per le aziende di maggiori dimensioni, e l’affitto misto con canoni in natura (prodotti della campagna) e partizione. A Rovolon l’affitto in denaro era praticato sia dai privati che dalle amministrazioni pubbliche, in genere su una possessione a podere completo. Al proprietario l’onere di pagare tutte le tasse (prediali, provinciali, comunali, consorziali) e le spese per la manutenzione degli edifici; all’affittuale la consegna delle decime e dei quartesi (era prevista la questua a favore dei cappellani, dei campanari e degli organisti) nonché le spese per lo scavo e la pulizia dei fossi interni alla campagna. Consuetudine antica e radicata poi la consegna delle onoranze, costituite da polli, capponi, galline, carne di maiale (in poca quantità), che in certi casi poteva corrispondere al 2- 3 % del valore dell’affitto. L’affitto di una possessione, sia in piano che in monte, comprendeva anche il caseggiato rurale e il canone variava dalle 28 alle 50 lire il campo, per il piano, dalle 35 alle 40 lire per i piccoli appezzamenti in monte, e dalle 25 alle 30 lire per un campo zappativo; per il bosco ceduo invece l’affitto medio si aggirava tra 5 e 6 lire il campo. Qualche agricoltore praticava anche il sistema di partizione: cioè veniva prelevata una parte (da cui l’espressione partizione) pari alla metà del raccolto di frumento, granoturco e uva. Il colono disponeva invece di tutta la legna ricavata dai campi ed era proprietario del bestiame. Era anch’esso, comunque, tenuto a pagare le onoranze in polli, galline e capponi. Alcuni proprietari, ma solo in piano, adottavano il sistema di affitto in generi e partizione: l’affitto in generi ricadeva sui prodotti del suolo (frumento e granoturco), mentre la partizione si limitava al vino. L’affittuale mirava quindi a procurarsi il frumento e il vino per poter pagare il canone d’affitto, senza badare al fatto che la coltivazione di tali prodotti fosse più o meno adatta alla natura dei terreni. 74 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei I proprietari di vaste estensioni di terra adottavano di norma il sistema della conduzione dei terreni “ad economia”, per cui i lavori venivano svolti da lavoratori salariati, chiamati obbligati. Questi, in cambio delle giornate di lavoro, ricevevano il granoturco e la possibilità di poter zappare il granoturco per 1/3 del suo prodotto (dai 3 ai 4 campi); per la pulitura e messa in granaio del frumento ne ricevevano uno staio ogni undici staia di raccolto; abitavano infine nelle case appartenenti ai proprietari terrieri versando in cambio un canone d’affitto. Accanto ai lavoratori obbligati c’era il bovaio, a cui si assegnava un salario in generi e denaro, che consisteva in 10 staia di frumento, 10 di frumentello, 30 di granoturco, 173 lire venete e la possibilità di abitare gratuitamente una piccola casa. Nelle possessioni condotte ad economia, servivano abbastanza spesso anche lavoratori assunti a giornata, o per un periodo limitato di tempo, dopo averne pattuito il compenso. Nella stagione della potatura, dei raccolti, per lo scavo dei fossi e la formazione di cavedagne, servivano sempre lavoratori, che venivano anche da altri paesi, con i quali si stipulavano dei contratti. In genere i giornalieri guadagnavano a giornata, per le spese ordinarie e meno faticose, da 14 a 20 soldi, per il taglio del fieno da lire 1 a lire 1.10, per la mietitura del frumento, invece, il compenso andava da 2 lire e 10 lire giornaliere oltre al vino grosso e ad alcuni anche il cibo. I prodotti agrari principali del comune di Rovolon erano allora il frumento, il granoturco, l’uva, il fieno, la legna da fuoco, le castagne e un po’ di olive, prodotti che, tranne il vino, erano tutti di qualità mediocre. Il vino, il frumento, tolta la parte per le semine e quello consumato in paese, le castagne e la frutta si vendevano a Padova o ai mercanti di Venezia. Il granoturco veniva consumato in paese mentre il fieno serviva per le bestie. Un visitatore che fosse passato per Rovolon nella seconda metà dell’800 avrebbe visto “in sui dossi di queste colline frutteti e viti sceltissime, e molti castagni, che pregiansi di migliore qualità dopo quelli di Calaone”.5 Il vino era dunque L’antica chiesa di Carbonara. i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 75 l’unico prodotto che godeva di una certa rinomanza ed era fonte di denaro. Il vino prodotto veniva venduto e in casa si beveva la graspia, una bevanda ricavata dalle vinacce. L’uva prodotta era in maggioranza nera e, a seconda della diversità dei terreni, era di qualità differente. Se ne produceva anche di bianca pari al 10-15% della produzione di uve nere. In annate ordinarie, nella prima metà dell’800 si producevano, calcolando l’uva già ridotta in mosto, dagli 8 ai 10 mastelli per vigneto. I campi sul monte avevano bisogno di molti lavori, come la concimazione, che veniva fatta trasportando letame a spalla, la zappatura e la potatura delle viti. Accanto al vecchio vigneto, quando questo non produceva più, se ne piantava uno nuovo, togliendo a poco a poco le viti vecchie. La nuova piantagione dava un buon prodotto solo dopo 12, 16 anni, a seconda dei terreni, dal momento in cui era stata piantata. Molto spesso vicino ai filari di vite venivano piantati alberi da frutto che erano fonte di cibo per la famiglia del contadino, in particolari fichi, ciliegi, meli. Il terreno tra i filari veniva lasciato a prato oppure anch’esso coltivato: si seminava frumento e granoturco, oppure si piantavano ortaggi e fagioli.6 C’era poi il bosco, da sempre fonte di legna, che serviva sia per essere bruciata, sia per ricavare pali di sostegno per le viti o per la costruzione di botti. La legna era fonte di guadagno perché veniva venduta ai vari commercianti per essere smerciata a Padova o a Este o nei paesi vicini. La legna eccedente veniva utilizzata per fare del carbone che veniva venduto in zona. Ancora nei primi decenni del ‘900 restavano le tracce dei pojatti, i luoghi dove la legna lentamente diventava carbone.7 I boschi erano in maggioranza di castagni e rovere, sottoposti a rigidi controlli. Erano sia privati, per la maggior parte, sia comunali e appartenenti all’erario. Il comune nel 1826 era proprietario di un bosco di 75 campi e mediante asta pubblica ne vendeva il taglio. Il taglio del bosco veniva fatto ogni 7 anni. Dai castagneti si allevavano polloni per Villa Giro in una cartolina degli inizi del Novecento. 76 La copertina dei Capitoli normali del contratto di affittanza dell’Amministrazione Fogazzaro-Biego, stampata a Vicenza nel 1900. Il testo contiene i patti che i contadini di Rovolon dovevano rispettare quando prendevano in affitto le terre di Matilde Fogazzaro, sposata con il conte Alvise Biego di Vicenza. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei la costruzione di botti, che si tagliavano ogni 14 anni (chiamati doali); per il resto si ricavava legna da fuoco, cioè fasci e fascine. Dal bosco, in particolare dai castagni, si ricavavano i pali che servivano a sostegno delle viti. Esistevano anche dei boschi speciali, come il bosco forte della Carpaneda, di regio diritto e altri due boschi privati sui quali il governo esercitava dei diritti speciali per cui il proprietario godeva solo del taglio dei cespugli e di quello di cui la regia direzione permetteva il taglio, ogni 18-20 anni nelle aree dove il bosco era troppo denso. Questi boschi erano in piano, in posizione abbastanza comoda per il trasporto del legname, che avveniva spesso via acqua. Oltre allo Stato, era proprietario di boschi anche il monastero di Santa Maria di Praglia, che li concedeva in affitto a pezzi, chiamati campi. Nel 1817 ad esempio, il monastero cedeva in affitto ad Andrea e Pietro Zattarin di Carbonara, due boschi, denominati il primo la Barbana, di 10 campi circa, di 3 anni e il secondo la Castagnola, di circa 2 campi e di 4 anni d’età. L’affitto era di 8 lire venete il campo. Al momento del taglio del bosco, ossia al compimento dei 7 anni di età, l’affittuale doveva chiedere il permesso del taglio al monastero. Anche il comune cedeva in affitto il bosco, suddiviso in prese.8 Nel 1876 gli affittuari di tre prese boschive comunali, fecero domanda per il taglio anticipato del bosco, di 6 anni, anziché 7, impegnandosi a pagare anche l’ultimo anno di affitto. Il comune accordò il permesso del taglio, dato che avrebbe ricavato in più i soldi della nuova affittanza, sicuramente aumentata nel valore del canone d’affitto.9 Il comune, inoltre, mediante asta pubblica, vendeva il taglio del bosco, ad esempio per le prese del Monte della Madonna.10 L’affitto del bosco veniva concesso anche per la sorveglianza diurna e notturna, per impedire i furti di legna, come era avvenuto con Giuseppe Zattarin, che per 21 anni (dal 1906) aveva avuto in affitto le 16 prese boschive di proprietà comunale, poste sul Monte della Madonna.11 Il Monte della Madonna, infatti, era chiamato anche Monte comun. Questa la situazione economica della prima metà dell’Ottocento, che racconta una vita di difficoltà giornaliere per ricavare qualche soldo e un duro lavoro sui campi e sui vigneti. Ci si mettevano poi anche le annate di cattivo raccolto, come nel 1853-1854, che fu di grave carestia.12 La zona dei Colli Euganei ne risentì molto e anche a Rovolon, nei mesi invernali, quando non era possibile per molti contadini trovare lavoro, si verificarono quei fenomeni tipici del periodo come le questue, ossia un assembramento di persone senza lavoro che si recava dai notabili del paese a chiedere da mangiare.13 A Rovo- i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 77 lon il 2 e 3 gennaio 1854 circa 30 contadini si recarono, muniti di forche, bastoni e badili dal conte Papafava, a chiedere lavoro e granoturco. L’agente della famiglia fece loro preparare della polenta che i contadini mangiarono, per allontanarsi poi tranquillamente. Il giorno seguente, circa 40 individui si recarono dal possidente Giovanni Gritti e, minacciando il gastaldo Michele Zaso di incendiare la casa, pretesero della farina di sorgo turco; gli stessi si recarono poi da Matilde Fogazzaro, altra grande possidente del comune, allora minorenne, dove ricevettero 2 sacchi di sorgo.14 La miseria era tale che andarono in crisi anche i matrimoni: in quel 1854 se ne celebrarono appena uno a Rovolon e tre a Carbonara. La situazione economica e sociale non subì cambiamenti di rilievo nei successivi cinquant’anni. Nella seconda metà dell’Ottocento i terreni classificati aratorio arborato vitato costituivano la qualità predominante dei terreni; seguivano, per estensioni ben più ridotte i pascoli, l’oliveto e il castagneto.15 Come mostra il prospetto che segue, nel 1860 a Rovolon sono registrati sette proprietari terrieri titolari ciascuno di più di 600 pertiche di terra e dove la pertica metrica equivale oggi a 1000 metri quadrati: Matilde Fogazzaro Conte Alessandro Papafava Nobile Leopardo Martinengo Erario civile ramo boschi Giovanni Gritti Cavaliere Lodovico Folco-Zambelli Francesco Gasparini 4596 = mq. 4.596.000 = ettari 459,6 2897 = mq. 2.897.000 = ettari 289,7 1750 = mq. 1.750.000 = ettari 175,0 1704 = mq. 1.704.000 = ettari 170,4 1130 = mq. 1.130.000 = ettari 113,0 918 = mq. 918.000 = ettari 91,8 752 = mq. 752.000 = ettari 75,2 Più della metà della terra era ancora di possesso nobiliare estesa al piano e frazionata al monte, con un’estensione media di 5 ettari per la frazionata.16 La situazione economica era stazionaria: le coltivazioni non erano cambiate e il frumento, il vino, la legna da fuoco, le castagne superavano i bisogni locali e continuavano ad essere venduti sul mercato esterno. Erano invece insufficienti i foraggi per il bestiame, il granoturco, i fagioli e il riso.17 La scarsità di foraggi rappresentava un grosso problema perché non permetteva l’allevamento estensivo del bestiame. Quest’ultimo, poi, oltre a servire per il lavoro nei campi, forniva il letame per la concimazione dei terreni, ma la cronica insufficienza non permetteva un’adeguata concimazione con la conseguente riduzione delle rese agricole. All’indomani dell’Annessione del Veneto all’Italia (1866) fu diramata una Il fratello di Rebecca Vanni con la consorte agli inizi del Novecento. 78 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Circolare da parte del Regio Ministero dell’Agricoltura intesa a conoscere la situazione della proprietà fondiaria nei diversi comuni della Regione. Il 15 ottobre 1868 Angelo Rossi, agente del nobile Alberto Papafava e rappresentante del comune di Rovolon nel Comizio Agrario di Padova, rispose ai numerosi quesiti formulati da quella Circolare. Analizzando le risposte fornite emerge che nel nostro comune i passaggi di proprietà nell’ultimo triennio (18651868) erano stati insignificanti, per cui non era possibile stabilire se la proprietà fondiaria tendesse a concentrarsi o a dividersi; molti dei proprietari del comune – rilevava l’agente Rossi – difettavano più o meno del capitale bisognevole per la coltura e per il miglioramento delle loro terre. Rossi, da esperto delle campagne qual era, segnalava inoltre che i conduttori della terra nel procurarsi il denaro non solo più a forte interesse, lo facevano con grosse difficoltà e con infinite brighe e spesa, tanto che nel maggior numero dei casi – concludeva – tornerebbe loro più conto vender piuttosto parte del fondo. La liquidità monetaria, ricordava ancora l’uomo di fiducia dei Papafava, era uno fra i più gravi ostacoli che inceppano il progresso dell’agricoltura locale e nazionale … I braccianti, specialmente d’estate, si trovano in numero piuttosto inferiore al bisogno; non si nota però in essi tendenza spiegata ad emigrare in città; solo pochissimi proprietari in comune hanno migliorato in parte gli antichi sistemi di coltivazione, gli altri fecero assai poco, vanno però imitando i buoni esempi.18 Sul delicato versante delle bonifiche, Angelo Rossi, scrive: «Non già terreni incolti, ma alcuni tratti di prato naturale vennero sconsigliatamente dissodati in Comune. La irrigazione poi non sarebbe qui possibile che a prezzo di un’opera quanto utile altrettanto grandiosa, per derivare l’acqua dal Bacchiglione, come accennai sulle mie proposte. Anche di prosciugamenti nulla affatto si fece. E sì abbiamo in comune un’estesissima valle che con poca spesa e con molto interesse potrebbe venire artificialmente prosciugata; ma sgraziatamente la maggior parte di questa valle appartiene ad un ricco proprietario (vicentino)». La relazione diretta al Ministero dell’Agricoltura così concludeva: «Nessun importante mutamento si è fatto in comune riguardo alla estensione delle terre coltivate a cereali, legumi, viti. I principali prodotti agricoli del comune esposti in ordine della loro importanza sono: vino, frumento, granoturco, seta e frutti. Il risultato dei raccolti in questo ultimo triennio fu nel complesso abbastanza buono». L’andamento dell’annata agricola nel 1868 ci viene descritto sempre da Angelo Rossi: «La primavera che corse oltremodo calda e asciutta, fu molto propizia alla fioritura ed all’allegamento della frutta, alla ultimazione dei lavori di terra e soprattutto alla seminagione del granoturco, la quale giammai venne eseguita in condizioni migliori. Scarso fu il primo taglio del fieno per la soverchia siccità come scarso altrettanto fu l’ultimo per causa opposta, in compenso però la stagione estiva fu così favorevole alla produzione d’ogni sorta di foraggio, che questo in complesso si calcola più che sufficiente all’ordinario consumo. Il prodotto dei bachi, relativamente alla poca coltivazione che se ne fa in comune, fu soddisfacente. Le buone riproduzioni pareggiarono i cartoni originali. Fallirono completamente le poche sementi indigene, quelle del Portogallo e di ogni altra razza non giapponese. Abbondante pure i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 79 sarebbe stato il raccolto di frumento se i guasti enormi del cosiddetto riscaldamento non lo avessero più tardi decimato. Io sono d’avviso che si avrebbe potuto facilmente prevenire questo infortunio, se il grano liberato dall’umido del suo involucro colla più sollecita trebbiatura, fosse stato disseccato e giornalmente spalato in granaio, come io e tanti facemmo. L’uva, mercé alle ripetute diligenti solforazioni ed a favorevoli circostanze di sua maturazione, si mostrava assai bella e prometteva in qualità in compenso alla quantità alquanto inferiore dell’ordinario; ma la grandine del 29 agosto e le susseguenti continue piogge distrussero in parte e guastarono questo prezioso prodotto oltre a ciò, la troppa elevata temperatura all’epoca della vendemmia fu di non lieve danno alla buona e regolare fermentazione per le quali cose anche la qualità del poco vino ottenuto in quest’anno, non può essere certo molto soddisfacente. Copioso fu il raccolto del granoturco, tanto al colle che al piano. La seminagione del frumento, avversata dalle incessanti piogge, riuscì per ogni rapporto cattiva».19 Per quanto riguarda la produzione di vino20 i dati per quegli anni riportano: a) ettari coltivati a viti 1405,00; b) vigne ettari 125,00; c) altre colture nell’intermezzo dei filari, ettari 1280,00; d) quantità d’uva (in miriagrammi) 110.000,00; e) prodotti per ettaro in miriagrammi 76,56; a vigna 80,00; f ) ettolitri di vino prodotti 6.000,00. La produzione di vino avrebbe potuto essere di migliore qualità, ma la realtà di Rovolon rientrava nella media della provincia di Padova, che figurava, negli anni ’70 dell’800, fra le ultime nella graduatoria che considerava la produzione e la qualità del vino. Se ne duole, in proposito, un osservatore che scrive: «È cosa questa che stringe il cuore a tutti coloro che hanno percorso i nostri Euganei e che avranno assaggiato perfino nella capanna di qualche contadino, un vinetto limpido, aureo, pieno di spirito, tale da inebriare un modesto bevitore con pochi bicchieri. Quel vino, confezionato da mani intelligenti, potrebbe centuplicare di valore, facendo concorrenza a molti dei migliori vini esteri!».21 Sempre di quegli anni, una relazione del 1871, elaborata per descrivere le condizioni della viticultura e della vinificazione nel circondario di Padova, lamenta che: «Se da una parte dobbiamo godere che nel nostro Distretto siasi in via di progresso, per quanto riguarda la coltivazione della vite, tanto nella scelta delle migliori qualità di uve, che sostituendovi a marito l’oppio al noce, come pure estendendosi sempre più la formazione dei vigneti a palo secco, dall’altro canto dobbiamo rammaricarci come purtroppo si pensi soltanto ad aumentare la quantità e poco a migliorare la qualità del prodotto. Difatti, tranne qualche raro coltivatore del Distretto che attende alla fabbricazione del vino coi nuovi metodi, la maggior parte continuano negli antichi ottenendo così un prodotto poco duraturo, non atto a sostenere viaggi, e quindi da doversi vendere al più presto possibile a prezzi che non stanno in relazione colle cure usate per averlo. Fra coloro che progredirono piaceci ricordare il Signor Angelo Rossi agente del Nob.Co. Papafava Alberto in Rovolone. Causa di un tal lento progredimento in siffatto ramo di agri- 80 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei coltura è dato dalla poco coltura agricola dei nostri proprietari, dalla crassa ignoranza e dalla mancanza dei mezzi nei coloni».22 La povertà fra i contadini era molto diff usa e c’era chi cercava di industriarsi come meglio poteva: a Carbonara ad esempio, chi viveva sul monte raccoglieva e poi vendeva altrove una polvere ferruginosa composta di frantumi di trachite nera e quarzo che si adoperava per asciugare gli scritti.23 Tale “spolvero” si depositava a valle del piccolo ruscello alimentato da una sorgente naturale, che serviva agli usi della popolazione. Quest’acqua però, se assaggiata, aveva un sapore che ricordava il solfato di magnesio. C’era chi ne aveva suggerito l’analisi da parte dei chimici, dubitando della buona qualità di quest’acqua, tant’è che gli abitanti di Carbonara che ne facevano uso affermavano che, bevuta a digiuno, purgasse il corpo. Altra fonte di acqua dolce nel comune si trovava nel sito denominato Fontana Coperta, una piccola fontana d’acqua che dava origine ad un modesto rio che scendeva nello scolo Comune e quindi nello scolo Nina. Come sottolineato nel 1851 sulla situazione idrografica degli Euganei «i Colli quanto sono copiosi di acque termali o minerali, altresì sono scarsi di acqua dolce, la quale basta appena agli usi della popolazione».24 Nonostante la miseria, gli abitanti di Rovolon vengono descritti come gente “di mente svegliata, arguti nel raziocinio e belli di figura”.25 La situazione divenne più critica nell’ultimo trentennio dell’800: nel 1874, ad esempio, centinaia di contadini e braccianti con le loro famiglie erano in una tristissima condizione, senza alcun mezzo di sostentamento, in particolare senza granoturco. Il comune avviò quindi una serie di lavori di costruzione di strade per dare lavoro ai padri di famiglia indigenti.26 Negli anni seguenti la situazione non migliorò: si fecero sentire le conseguenze della crisi agraria che aveva investito prima l’Europa e poi l’Italia e il Veneto fu duramente colpito, con il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, in particolare del frumento e del Il forno da calce della ditta Quagliato ripreso in una cartolina illustrata spedita da Bastia il 29 agosto 1912. i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 81 granoturco, cioè i prodotti prevalenti della regione. In seguito alla crisi, che veniva a sommarsi all’arretratezza dell’agricoltura e alle tasse troppo gravose, nel distretto di Padova diminuì costantemente il numero dei piccoli proprietari. Un fenomeno che indusse non pochi piccoli proprietari, residenti sul monte, a vendere la terra e a diventare braccianti. Quando nel 1882 furono pubblicati i risultati dell’Inchiesta Agraria “Iacini”, così chiamata dal parlamentare che la promosse e diretta a conoscere le reali condizioni di vita dei contadini in Italia, l’immagine che ne emerse fu di tragica criticità. Emilio Morpurgo, incaricato di svolgere l’inchiesta per il Veneto, descrive le condizioni dei contadini del comune di Rovolon come “molto infelici”. Le abitazioni erano malsane, esposte al freddo dell’inverno e al caldo estivo, col pavimento di terra, e le famiglie, numerose, costrette a vivere in spazi angusti. Molte delle case occupate dagli affittuari erano ridotte in tristi condizioni, perché i proprietari erano restii ad intervenire per la loro manutenzione. Anche dal punto di vista morale i giudizi sul modo di vivere della popolazione del comune risultavano “abbastanza sfavorevoli” soprattutto se confrontati con i costumi delle popolazioni montane.27 A testimoniare queste tristi condizioni e la scarsa alimentazione v’è il fatto che nel 1882 nel comune si registrarono 52 pellagrosi.28 La pellagra, definita come la malattia della miseria, era causata dal mangiare granoturco deteriorato. Negli anni 1889-1894, definiti gli anni più critici dell’economia italiana, anche nel Padovano la situazione economica si aggravò notevolmente, creando le condizioni per possibili sommosse. Nel 1891-92 a Rovolon c’era ancora un centinaio di braccianti senza lavoro.29 L’introduzione di nuove macchine agricole stentava a diffondersi. Gli unici casi in cui si introdussero alla fine dell’800 le nuove e costose macchine (erpice snodato, estirpatore, seminatrici, falciatrici, spandifieno, trebbiatrici meccaniche e a vapore) erano limitati alle grandi tenute, per iniziativa di qualche proprietario illuminato. Tra questi c’era il conte Alberto Papafava nelle sue terre di Cervarese e Rovolon. L’agricoltura era l’unica attività svolta dalla popolazione. Le uniche industrie censite nel comune nel 1890 non offrivano un lavoro fisso per tutto l’anno: c’erano le sei cave di trachite, chiamata masegna, utilizzata per selciati e lavori edilizi,30 che davano lavoro a 27 operai; due fornaci da mattoni, tegole e calce, che davano lavoro a 15 adulti per circa 190 giorni l’anno; una fabbrica di botti La fornace Quagliato oggi. 82 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei e tini dove lavoravano 4 operai; una fabbrica in cui si lavoravano trecce di paglia che dava occupazione a 13 operai. Nel comune c’erano poi nove telai per la tessitura di lino e canapa e tre per la lavorazione di materie miste.31 Il conte Papafava possedeva un maceratoio per la canapa di notevoli dimensioni.32 La popolazione di Rovolon Ma quanti erano gli abitanti del comune due secoli fa? Chi erano tutte queste persone che faticavano e sudavano del lavoro dei campi? I due prospetti che seguono offrono un quadro complessivo del numero di residenti censiti in circostanze diverse, con l’indicazione della crescita e della contrazione (indicata col segno - ) della popolazione. Popolazione residente anno residente 1747 1846 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1625 1819 2204 2891 3408 4208 4843 4882 4682 4654 3858 3472 differenza 194 385 687 517 800 635 39 -200 -28 -796 -386 Crescita della popolazione per singole frazioni anno Rovolon Bastia Carbonara 1822 1841 1871 1881 1901 1911 1921 788 762 883 1132 948 1118 1244 590 725 757 1005 1565 2017 2293 639 571 364 751 895 1073 1306 Totale 2017 2058 2204 2891 3408 4208 4843 Da questi dati vediamo come ci sia stata una crescita lenta, ma costante, dalla metà del Settecento a quella dell’ottocento (1% annuo). Sappiamo che nel i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 83 1822 c’era un medico, il dott. Luigi Chiarellati di Teolo, che serviva le parrocchie di Rovolon e Carbonara, mentre nessun medico a Bastia. A Carbonara c’erano 3 levatrici, 1 a Bastia e a Rovolon (bravissima e che esercita senza mercede).33 Nella seconda metà dell’Ottocento si ebbe un notevole aumento demografico, come in tutta Italia, dovuta principalmente alla diminuzione del tasso di mortalità, soprattutto quello infantile; la crescita della popolazione del comune continuò fino agli anni venti del Novecento, dovuta anche all’arrivo di nuove famiglie che acquistarono le terre vendute da famiglie nobili (i conti Donà Dalle Rose, gli eredi Martinengo, i Camerini, i Folco-Zambelli). La popolazione aumentò in particolare nelle frazioni di Carbonara, che quadruplicò la sua popolazione e Bastia, che la triplicò. Il maggior sviluppo si è avuto quindi nelle frazioni in piano, dove c’erano maggiori probabilità di trovare un podere in affitto o un lavoro come salariato. Nei decenni successivi al 1931 la popolazione del comune è diminuita, con un’accentuata tendenza all’invecchiamento: in particolare dal 1951 al 1963 la diminuzione registrata è del 19%, dovuta all’esodo verso il capoluogo, Padova, dall’isolamento e dalla scarsità di risorse.34 L’insediamento della popolazione è sempre stato prevalentemente sparso (88%), in quanto le case contadine si trovano di norma ai margini o nel cuore dei poderi coltivati. Com’è noto l’attività agricola condizionava la vita sociale. I matrimoni, ad esempio, fino ai primi decenni del secolo scorso si celebravano nel periodo invernale, prevalentemente in novembre, cioè al termine dell’annata agricola quando la famiglia aveva raccolto un po’ di denaro, e in febbraio, prima d’iniziare l’attività nei campi. L’età media dei celibi e delle nubili al primo matrimonio è attorno ai 25-27 anni per gli uomini, 22-23 anni per le donne.35 Ci si sposava con persone abitanti nella stessa frazione o nelle altre frazioni del Cartolina postale pubblicitaria della ditta Fratelli Marin titolare di forni da calce a fuoco continuo a Bastia. Il biglietto reca il timbro postale del 14 agosto 1920. 84 1950. Rebecca Vanni a lato del classico “tino” usato nei forni da calce. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei comune; se un coniuge era forestiero, proveniva in genere da un vicino paese dei Colli o della provincia di Vicenza, come Albettone o Montegalda. Quando si sposava, la donna andava a vivere in casa del padre dello sposo, aggregandosi alle famiglie dei fratelli dello sposo. Questa convivenza non doveva certo essere facile, come testimoniano le tante interviste fatte agli abitanti del comune. Per quanto riguarda l’istruzione, il dato del censimento del 1871 ci dice che l’analfabetismo era diff uso: su una popolazione di 2204 persone, ben 1664 non sapevano né leggere né scrivere, degli altri appena 60 sapevano solo leggere e 480 erano in grado di leggere e scrivere. Con la costruzione delle scuole elementari in tutte e tre le frazioni del comune, tutti cominciarono ad andare a scuola, almeno fino alla terza elementare. Dobbiamo tener conto che i bambini cominciavano a lavorare molto presto, aiutando nel lavoro dei campi, e che spesso le famiglie non avevano i mezzi sufficienti per comprare i quaderni e i libri per la scuola. Alcuni documenti, come ad esempio le relazioni per le visite pastorali da parte del vescovo nelle parrocchie, fanno luce sulla vita di quei tempi. Il parroco di Carbonara, Pierantonio Valente, nella relazione sulla parrocchia redatta per la visita pastorale del vescovo Modesto Farina del 17 settembre 1822, lamenta che «gli adulti amano poco l’insegnamento della Dottrina Cristiana, ma sono assai dediti al vino».36 Cento anni dopo, le cose non sono cambiate: nella visita pastorale del 6 aprile 1921 il prete di Carbonara, Giovanni Bernardini, parroco dal 1911, riporta che predomina il vizio del vino e lamenta che non c’è Schola cantorum, nonostante si sia provato più volte, spendendo anche denaro: a suo avviso il fallimento dell’iniziativa era dovuto alla mancanza «d’istruzione, di spirito di sacrificio e soprattutto – concluse – per l’abbondanza di spirito di vino». Anche il prete di Bastia nel diario della visita del 4 aprile 1921 riporta come vizi della popolazione il “turpiloquio, la bestemmia e in parte l’ubriachezza”.37 Allo stesso tempo ci dice che la popolazione sente vivamente la religione, che i sacerdoti sono rispettati e che il parroco ha infl uenza, oltre che sulla vita spirituale, anche negli affari domestici, sui quali viene quasi sempre consultato. Negli anni Venti, dopo la prima guerra mondiale, si diff usero anche nelle campagne le idee socialiste (nel 1921 venne fondato il Partito Comunista i l co m un e di rovolon n e ll’otto c ento 85 Italiano). A Bastia, nel 1922, vi è una lega rossa (anche se il prete dice che è in dissoluzione e quasi tutti gli aderenti desiderano mettersi sotto la bandiera bianca); a Carbonara il prete si lamenta che l’attività dell’associazione, per le giovani del Sacro Cuore di Gesù, che conta 120 iscritte, analoga alle Figlie di Maria, da un anno è sospesa «perché la più parte, nel famoso maggio 1920, si sono lasciate trascinare dall’idolo bolscevico, si sono ascritte alla lega rossa, hanno preso parte a cortei anche fuori di parrocchia al grido di rivoluzione, con canti sovversivi, accompagnate da giovinastri e dalla bandiera socialista, dando un miserabile esempio di follia, di degenerazione e di ignoranza. Però, siccome fallì completamente il programma bolscevico, e molti e molte si sono ravveduti, si spera entro l’anno di ricostruire su solide basi la detta congregazione». La conferma che gli abitanti della parrocchia di Rovolon dovessero ogni giorno scontrarsi con la miseria ci viene dalla testimonianza del parroco che lamenta le difficoltà di frequentare la dottrina cristiana la domenica da parte di molti bambini: «Data la stagione, o troppo caldo o troppo freddo, la scomodità della chiesa, la difficoltà della strada e la mancanza di indumenti, la frequenza non sempre è confortante». Se le fonti scritte ci forniscono pochi, anche se illuminanti, dati che possiamo interpretare, le fonti orali, il racconto di chi è cresciuto e ha vissuto a Rovolon nella prima metà del secolo scorso, ben ci restituisce le condizioni di vita di quegli anni. Una condizione che ben si coglie dalle interviste ai vecchi del paese, interviste in grado di far emergere la fatica per il lavoro, le usanze, i riti, la miseria e la fame. Frasi e racconti che hanno confermato quanto i tanti documenti scritti ci consentono di comprendere, ma con lo spessore dell’anima che il freddo documento cartaceo non sa esprimere. E a conclusione di questo mio tentativo di ricostruire la vita nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento della popolazione di Rovolon, mi piace riportare la frase conclusiva di una intervista: “e vedo che sémo vegnù grandi o stéso”. 38 Note 1. Almanacco per l’anno 1819 contenente le più interessanti notizie cronologico-statistiche della città di Padova e suo territorio, n. II, Padova, Tipografia Penada, 1818. 2. Archivio Parrocchiale di Carbonara (= APC), Libro dei battezzati. Anni 1828-1900. 3. APC, Libro dei matrimoni. Anni 1816-1871. 4. Archivio comunale di Rovolon (=ACR), Deliberazioni consiliari. Anni 1900-1905, Regolamento dei pastori vaganti. Il giardino di villa Giro agli inizi del Novecento. 86 5. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Antonio Mastromarino, La vite nell’economia agricola dei Colli Euganei, «Rivista del Comune di Padova», n. 5 (maggio 1934). 6. Marino Berengo, L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’Unità, Milano (Banca Commerciale Italiana) 1963, p. 232-243. 7. APC, Cronistoria. Anni 1938-1945. 8. Archivio di Stato di Padova (=ASPd), Corporazioni religiose soppresse, S. Maria di Praglia, b. B, fascicolo 11, interno 1, 25 aprile 1817. 9. ACR, Deliberazioni consiliari. Anni 1872-1877. Boschi, taglio anticipato delle tre prese XI, XII, XIV. 10. ACR, Deliberazioni consiliari. Anni 1882-1887. Vendita taglio boschivo. 11. ACR, Cat. 10, classe I. Estratto dalla deliberazione presa dal podestà di Rovolon, 1928. 12. Antonio Keller, Prodotti agrari e cenni sull’agricoltura della provincia di Padova, Padova 1884. 13. Piero Brunello, Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli, 1814-1866, Padova (Marsilio editori) 1981, p. 108. 14. ASPd, Presidio luogotenenziale, b. 104, I 3/125. 15. Andrea Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova (Tip. Prosperini) 1862, (ristampa anastatica, Atesa editrice, Bologna 1984), vol. I, p. 92-95. 16. Keller, Prodotti agrari e cenni sull’agricoltura, p. 7. 17. Keller, Prodotti agrari e cenni sull’agricoltura, p. 52. 18. «Il Raccoglitore», serie II, anno VI, 16 marzo 1869, p. 275. 19. «Il Raccoglitore», serie II, anno VI, 16 novembre 1868, p. 76. 20. «Il Raccoglitore», serie II, anno VII, 1° marzo 1869 (Statistica dei vini anno 1867), p. 228. 21. «Il Bacchiglione», 29 maggio 1873, n. 64, p. 2. 22. «Il Raccoglitore», serie II, anno VIII, 14 gennaio 1871. 23. Gloria, Il territorio padovano, vol. II, p. 80. 24. Statistica agraria della provincia di Padova, Padova 1873. 25. Gloria, Il territorio padovano, vol. II, p. 83. 26. ACR, Categ. 10, classe I, Progetti di strade, anno 1874 27. Emilio Morpurgo, Le condizioni dei contadini nel Veneto, in Atti della Giunta per l’Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola, 4. Relazione sulla 11 circoscrizione (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno e Udine), parte I, Roma 1882, p. 351-352. 28. Oddo Arrigoni degli Oddi, La pellagra nella provincia di Padova, Padova 1883, p. 77. 29. Giulio Monteleone, Note sulle condizioni economiche e sociali della città e provincia di Padova dopo l’Unità, Padova (Società Cooperativa Tipografica), 1969. 30. Gloria, Il territorio padovano, vol. I, p. 94. 31. Ferdinando Cavalli, Le condizioni industriali della provincia di Padova, 1890, (ristampa anastatica, Bologna, Li Causi editore, 1984), p. 34. 32. Pier Franco Gaslini, Cronache padovane di vita economica, Padova (Banca Popolare di Padova e Treviso) 1954, p. 135. 33. La visita pastorale di Modesto Farina nella diocesi di Padova, 1822-1832, a cura di Pio Pampaloni, Roma (Edizioni di storia e letteratura), 1983, p. 210. 34. Igino Michieli, I Colli Euganei. Vicende economiche e sociali, Padova (Società Cooperativa Tipografica) 1965, p. 196. 35. Dati ricavati dalla consultazione nell’APC del Libro dei matrimoni. Anni 1821-1900 e 1901-1928 e nell’Archivio Parrocchiale di Rovolon, Libro dei matrimoni. Anni 1792-1909 e 1910-1929. 36. La visita pastorale di Modesto Farina, p. 211. 37. La visita pastorale di Luigi Pellizzo nella diocesi di Padova (1912-1921), a cura di Liliana Billanovich Vitale, 2 voll. Roma 1975 (Edizioni di storia e letteratura. Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa), vol. 1, p. 91-106. 38. Intervista a Tranquillo Alban, 13 ottobre, Bastia. Claudio Grandis Il mulino di Rovolon Lungo via Palazzina, di fronte all’abitazione della famiglia Facchini, si scorge una vecchia costruzione sepolta dal tempo e dalla vegetazione. Un’antica casa, abbandonata decenni or sono che più nulla dice del suo passato, sia per la semplicità costruttiva, sia per le ridotte dimensioni. Eppure se si apre il vecchio Catasto elaborato nella metà del secolo XIX, grosso modo centosettanta anni fa, si scopre che proprio in corrispondenza di questa vetusta costruzione funzionavano tre distinti mulini ad acqua. Pochi anni prima un tecnico, l’ingegnere Pietro Neri, era stato incaricato dai proprietari, i fratelli Francesco e Alessandro Papafava, assieme ad un capomastro falegname di nome Francesco Pavan detto Barichella, di stimare il loro esatto valore. Dovendoli affittare la perizia serviva per avere precisa consapevolezza di quanto valevano sul mercato delle attività produttive. Quella relazione, scritta nel 1834, rimane uno dei documenti più preziosi per la storia del mulino di Rovolon e, più in generale, per le ruote ad acqua dei Colli Euganei. In essa infatti vi è la minuziosa descrizione dell’opificio con le dimensioni espresse in metri, l’indicazione delle singole parti e l’essenza arborea del legname impiegato per costruirlo.1 I mulini collinari erano diversi da quelli che macinavano in pianura lungo i canali o immersi nelle acque dei grandi fi umi, come il vicino Bacchiglione o l’imponente Adige. I mulini degli Euganei avevano una specificità che li distingueva dagli altri presenti nella provincia di Padova: la loro ruota, infatti, non era a pale bensì a cassette, a coppe, da cui la denominazione di mulini a coppedello. Erano detti anche mulini del Maltempo, poiché, a differenza di quelli a pale, andavano a seconda del tempo. In altre parole solo quando v’era abbondanza d’acqua, in grado di assicurare il funzionamento per l’intera giornata e anche la notte seguente, essi garantivano la produzione di farina. Diversamente se ne stavano fermi in attesa del “maltempo”, cioè della pioggia che portava acqua nei calti di alimentazione generando preziosa energia idraulica. I mulini euganei, come del resto tutti quelli del tipo a coppedello, erano dotati a monte di una grande vasca, di un invaso artificiale simile ad uno stagno, che si riempiva raccogliendo le acque dei calti, cioè dei torrenti delle nostre colline. L’invaso era detto gorgo e si estendeva in media tra i trecento e i seicento metri quadrati. Spesso era profondo e pericoloso, tant’è che le mamme erano solite minacciare i bambini, affinché non si avvicinassero ai gorghi, con il racconto della presenza misteriosa di fate, di esseri soprannaturali pronti a rapire i piccoli che si fossero affacciati sull’acqua. Era un modo ancestrale, una metafora efficace, per allontanare il rischio di veder cadere, mortalmen- 88 Il mulino a coppedello disegnato per l’opera di Vittorio Zonca, Novo teatro di machine et edificii, stampato a Padova nel 1607. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei te, nell’acqua i propri figli, notoriamente curiosi di tutto ciò che è insolito e sconosciuto. Il mulino di Rovolon apparteneva dunque alla tipologia degli impianti a coppedello ma ricalcava al suo interno, nei meccanismi di funzionamento e di trasmissione del moto dalla ruota idraulica alle macine, l’antico mulino romano, documentato sin dai primi secoli dopo Cristo nelle colline del Gianicolo, la zona trasteverina di Roma. Un ingranaggio meccanico, infatti, trasformava un giro della ruota idraulica in quattro, sei, otto fino a quattordici giri della macina: una velocità in grado di assicurare la trasformazione dei duri chicchi in soffice farina. Ma a Rovolon le ruote che giravano furono per secoli ben tre e tutte alimentate dalla stessa acqua. Fortuna vuole che del nostro mulino sia rimasto un prezioso disegno, stampato in un libro scritto da Vittorio Zonca e pubblicato dopo la sua morte nel 1607. L’incisione che accompagna la descrizione mostra ben bene come l’acqua del calto Figaro, raccolta nel gorgo soprastante il mulino (laddove oggi prospera un vigneto), condotta con un apposito canale giungesse in prossimità del mulino raccolta in tre distinte canalizzazioni (gorne) capaci di riversare equamente l’acqua su altrettante ruote idrauliche a cassetta, o coppe. Collegato ad ogni ruota, attraverso un robusto albero disposto orizzontalmente, l’ingranaggio (detto scudo, o scù) era innestato al lubécchio (un cilindro a forma di lanterna), a sua volta solidale alla macina superiore: in questo modo la trasmissione del movimento meccanico passava dalla ruota alla mola che, così girando, triturava i cereali trasformandoli in soffice farina.2 Abbiamo detto sopra che nel 1834 il mulino apparteneva ai fratelli Papafava. Ma da quanto tempo? e da quanto il mulino macinava lungo via Palazzina? La domanda, oltre che lecita, ci appare doverosa anche per una curiosa ragione che fra poco spiegheremo. Durante il governo della Repubblica di Venezia nel Padovano (1405-1797) fu deciso di rivedere e di censire tutte le concessioni d’acqua. La ragione partiva dalla semplice considerazione che l’acqua è un bene pubblico e quindi appartiene a chi ha il potere sul territorio. L’acqua che movimentava mulini, segherie, folli da panni, folloni, pistrini per l’olio, magli per battere il ferro e il rame o, ancora, per triturare gli stracci di fi bra vegetale da cui ricavare la carta, era un diritto esclusivo dello Stato, quindi – nei secoli XV-XVIII – del governo di Venezia. Nel 1556, a seguito dell’attivazione di un nuovo ministero (allora si chiamava Magistratura, da non confondere con il concetto attuale e con il significato che oggi noi diamo a questa parola) detto i l mul in o di rovolon 89 dei beni inculti, fu deciso di redigere un catastico, cioè un inventario, un censimento generale di tutti coloro che utilizzavano, a vario titolo, le acque pubbliche. Ognuno doveva pertanto dimostrare che da almeno trenta anni utilizzava ininterrottamente sorgenti, corsi d’acqua, canali, fi umi per ricavarne energia idraulica o per irrigare i terreni coltivati, oppure, ancora, per alimentare fontane private, riempire abbeveratoi o risaie. Dal censimento furono esclusi solo i pozzi domestici. A quell’ordine tutti dovettero attenersi, presentando, all’Ufficio dei beni inculti, i titoli, cioè i documenti, le carte, gli atti notarili, le denunce dei redditi (allora dette polizze d’estimo) in grado di dimostrare da quanto tempo le acque erano sfruttate. Nel 1684 Francesco Papafava, proprietario del «molin a copedello sopra l’acqua dei gorghi», non fu in grado di produrre documenti più antichi del 1541. Poiché il provvedimento governativo era datato 10 gennaio 1560, i tre decenni di sfruttamento non erano documentabili. Fu così che Francesco dovette inoltrare una supplica per ottenere una nuova concessione d’acqua. I magistrati incaricati dell’esame furono tuttavia clementi e riconobbero che se anche i documenti non andavano oltre il 1541 si poteva comunque sostenere l’antichità del «possesso di dette tre rode da molino».3 In quello scorcio del XVII secolo i Papafava non trovarono tra le carte del loro archivio, né in quelle dell’Archivio generale dell’Ufficio dell’estimo di Padova, altre pezze giustificative in grado di dimostrare che a Rovolon un mulino era attivo ben prima del fatidico 1541. A soccorrere Francesco non fu d’aiuto nemmeno una dettagliata pubblicazione di Pietro Saviolo stampata a Padova nel 1667: pur riportando le rendite dei mulini dell’intera provincia sin dal 1431, Rovolon non figurava nell’elenco.4 Eppure scorrendo le denunce presentate all’Estimo (l’Ufficio incaricato di tassare i beni immobili di Padova e Provincia) a partire dal 1418, un mulino a Rovolon compare sin dal 1427. Non tra i beni Papafava, bensì fra quelli della chiesa parrocchiale di San Giorgio. Nell’elenco, ricchissimo e lunghissimo dei beni denunciati da prete Pietro, troviamo infatti nella lista dei livelli, un sedime di mezzo campo con una casa coperta di coppi e con una tezza (tettoia) di pali e con «una posta molendini». Era situata nella contrada detta Peraria e rendeva, in forza del contratto d’affitto a lunga scadenza (il livello poc’anzi ricordato) unitamente ad un’altra pezza di terra di vigne schiave poste nella contrada Bagnolo, uno staio di frumento, uno di miglio, una spalla di maiale (cioè un prosciutto), una focaccia e un paio di galline. Dalla pur breve descrizione ricaviamo anche il nome del conduttore del mulino e del vigneto: Stefano Bronzato.5 Il documento non ci consente di stabilire se contrada Peraria è divenuta in Schema di funzionamento del mulino idraulico dei Colli Euganei. 90 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei seguito l’odierna via Palazzina: di certo è, comunque, che un mulino da antica data macinava a Rovolon. Attorno al suo edificio si muoveva allora una clientela che non sappiamo se continua e costante, visto che le ruote e le macine giravano solo quando v’era disponibilità d’acqua. Il canone di locazione pagato dal mugnaio appare infatti modesto se rapportato agli affitti versati per la conduzione di analoghi impianti di macinazione situati in pianura. Ma, come già abbiamo detto, si trattava di macine che giravano solo quando le condizioni del tempo lo consentivano, quando cioè l’abbondanza d’acqua assicurava la spinta necessaria sulle grandi ruote in legno. E per quanto grande possa essere stato il gorgo che lo alimentava – nel 1810 copriva una superficie di 730 metri quadrati – una volta svuotato le ruote si fermavano. Negli stessi volumi dell’Ufficio padovano dell’Estimo vi sono anche altre testimonianze di mulini: nel 1468 è Bartolo Bozato a denunciare la conduzione di un molin roto con un’area di ben sei campi di terra circostante. Vent’anni più tardi, più esattamente il 13 ottobre 1487, Bartolomeo del fu Curso fu indicato come il gestore del mulino precisando che era «exempto per la persona per lo privilegio de molendinariis» e che era titolare di vari beni a Rovolon tra i quali un quartiere di terra «cum uno molin da Mal Tempo proprio». Nello stesso elenco, infine, tra i beni degli eredi di messer Bartolomeo da Soncin si ritrovano «campi dui parte araura e parte cum una caxa e … uno molin» che – riporta il documento – in precedenza era nell’elenco dei beni di Corso Bozato.6 I documenti custoditi negli archivi di Padova e Venezia, purtroppo, sono in grado di fornirci un quadro piuttosto povero sulla storia del nostro mulino. Abbiam detto che già negli ultimi decenni del XVII secolo l’impianto apparteneva ai Papafava: a questo dato possiamo aggiungere che nel Catastico dell’Ufficio dei beni inculti non v’è traccia di un mulino di proprietà della chiesa di San Giorgio di Rovolon. Possiamo ipotizzare – ma con le dovute Il moderno mulino di Bastia in una cartolina illustrata viaggiata agli inizi degli anni Venti del secolo scorso. i l mul in o di rovolon 91 cautele – un passaggio di proprietà tra i due soggetti (chiesa nella veste di venditore e Papafava in quello di acquirente) anche se ci appare strano che un simile evento non abbia lasciato traccia nel ricco archivio dei nobili padovani. Possiamo verosimilmente ipotizzare più una sottrazione, lenta quanto irreversibile, da parte dei Papafava nei confronti della chiesa, come all’epoca – tra XVI e XVII secolo – accadde anche in altri contesti, come quello di Cervarese dove le monache di Sant’Agata di Padova, proprietarie di una quota del mulino galleggiante nel Bacchiglione, ad un certo momento si ritrovarono incapaci di riscuotere i loro canoni livellari per la lenta, quanto losca, sottrazione nell’utilizzo del mulino da parte della potente famiglia Trento.7 Dobbiamo rilevare che la contrada Peraria non compare, almeno dal XVII secolo, nei paraggi del mulino a meno che l’antico toponimo, per corruzione lessicale, non sia divenuto la Priaria ricordata in documenti successivi. L’impianto, stando alle dichiarazioni rese da Michele Albanese e Antonio Visentin, rispettivamente il 4 marzo 1543 e il 18 novembre 1546 era infatti collocato nella «contrà del Molin over Priara» prossima alla contrada del Gorgo, ai margini di terreni detenuti dal monastero di Santa Giustina. La contrada del Molin, ricordano alcuni testimoni oltre un secolo dopo, era detta anche Savellon, un toponimo che ci conduce a Monselice dove il locale stradario contempla tuttora via Savellon Molini.8 La discendenza di Francesco Papafava si estinse verso la metà del XVIII secolo, così che i beni tutti transitarono in un ramo collaterale rappresentato in quel momento dall’omonimo Francesco (1714-1790), figlio di Giacomo e Maria Antonia Mussati. Alcuni documenti del XIX secolo illuminano brevi momenti di vita del nostro mulino. Al 21 maggio 1800 data l’affittanza con la quale la Commissaria Papafava – creatasi per la morte prematura di Giacomo avvenuta il 26 agosto 1785 – cedette al mugnaio Pietro Fasolo e ai suoi fratelli la «posta de’ mollini di rode tre, con sue caselle, e casa d’abitazione con un pezzo di terreno contiguo» di 1400 metri quadrati. In cambio ai Fasolo fu chiesto un affitto di 946 lire di cui 68 in onoranze. Una serie di clausole stabilì obblighi e diritti reciproci in merito alla conservazione dei fabbricati e degli impianti di macinazione. Solo in caso di «terremoto e fulmine che incendiasse o rovinasse» il mulino la ricostruzione rimaneva a totale carico dei Papafava. I Fasolo nei pressi del mulino c’erano già nel 1792 e più tardi, nel 1805, figurano nella veste di conduttori. Il canone era rapportato all’attività: se confrontato con impianti delle medesime dimensioni situati in pianura, risulta infatti di appena un quinto a riprova della contenuta attività, nonostante l’indiscutibile rilevanza della sua presenza per l’intero abitato collinare.9 Dal censimento napoleonico del 1810 proviene l’esatta articolazione planimetrica dei tre fabbricati sorreggenti le ruote, del gorgo e della vasca «per raccolta dell’acqua», della superficie di sessanta metri quadrati, ubicata a valle dell’acqua stessa uscente dalle coppelle dell’ultima ruota. Da rilevare che la vasca d’acqua per uso di molino di 730 metri quadrati situata a monte in contra- Giustina Michelazzo con i figli a Carbonara. S’iniziava sin da ragazzi ad andare al mulino, spesso per macinare pochi chili di cereali. 92 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei da della Persegara, non apparteneva ai Papafava bensì a Domenico Miotti del fu Leonardo. Sintomatici pure i toponimi raccolti allora dagli agrimensori nell’area: Molini, Gorgo, Molino di Mezzo, Molino di Sopra, Molino di Sotto, Fontana Figaro, a conferma del ruolo di caposaldo topografico assunto dal sito molitorio. Nel 1826 i tecnici incaricati dall’Ufficio del Censo rilevarono a Rovolon due «molini da biada», notizia questa che fa il paio con le quattro ruote segnalate nel 1862 da Andrea Gloria nel suo Territorio padovano illustrato.10 La quarta ruota era collocata in un edificio ben più a valle della posta dei Papafava e apparteneva alla famiglia Miotto detta Munaro; le testimonianze orali degli abitanti del luogo ricordano che essa girò fino al 1954, a ridosso del fabbricato oggi abitato dalla famiglia Medè. Le macine di questo impianto ottocentesco vennero vendute poco dopo al mulino elettrico di Carbonara mentre la ruota idraulica fu trasportata in un luogo imprecisato per servire da mezzo pubblicitario.11 La stima più volte ricordata del 1834 ci presenta nella veste di mugnai Andrea Martini e il figlio Giovanni, capostipiti della secolare generazione che lungo tutto il secolo XIX condurrà i mulini; solo nel 1914 le ruote a coppedello cesseranno di girare, abbandonate da Giovan Battista Facchini, l’ultimo mugnaio morto nel 1939. Note 1. Devo alla cortesia della famiglia Facchini la messa a disposizione del prezioso documento. 2. Vittorio Zonca, Novo teatro di machine et edificii, Padova 1607 (ristampa anastatica, con premessa e note di Carlo Poni, Milano – Il Polifilo ed. – 1985), p. 21-24. Claudio Grandis, I mulini ad acqua dei Colli Euganei, Este (Parco Regionale dei Colli Euganei) 2001. 3. Archivio di Stato di Venezia (= ASVe), Provveditori sopra beni inculti, b. 389 “Investitura d’acqua alla famiglia Papafava 6 sett. 1684”. 4. Pietro Saviolo, Compendio delle origini et relazione delli estimi della città di Padova, Padova (eredi di Paolo Frambotto) 1667, p. 262. 5. Archivio di Stato di Padova (= ASPd), Estimo 1418, vol. 297, c. 131r. La descrizione del mulino, molto più dettagliata rispetto alla polizza del 1427, si trova anche in un altro inventario dei beni della chiesa di Rovolon redatto nell’anno 1437 (ASPd, S. Giustina, b. 180, filza E.P. P.19, c. 7v). 6. ASPd, Estimo 1418, vol. 353, polizza n. 46 (13 ottobre 1487). 7. Claudio Grandis, Il paesaggio scomparso. Acque, mulini, boschi e cave al tempo della dominazione veneziana (Secoli XVI-XVIII), in Cervarese S. Croce. Profilo storico di un comune del Padovano tra Bacchiglione e Colli Euganei, a cura di Alberto Espen e Claudio Grandis, Cervarese S. Croce (Biblioteca Comunale – Il Prato ed.) 2004, p. 69-86. 8. Claudio Grandis, I mulini di Bagnarolo, in Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto, a cura di Antonio Rigon, Monselice (Comune e Canova ed.) 1994, p. 415-428. 9. ASVe, Censo provvisorio. Notifiche della provincia di Padova. 1805, b. 119, num. 9822. 10. ASVe, Censo provvisorio (c.d, Catasto austriaco). Atti preparatori, b. 36, num. 4. Andrea Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova (Tip. Prosperini) 1862, (ristampa anastatica, Atesa ed., Bologna 1984), vol. II, p. 83. 11. Le informazioni provengono da interviste orali eseguite da chi scrive nel febbraio 1999. Claudio Grandis Il mulino di Carbonara Sono numerosi i mulini dei Colli Euganei per i quali si ignora la data di costruzione, visto che le attestazioni che ne documentano l’esistenza di norma si riferiscono a ruote già in funzione. La loro comparsa nelle carte antiche ci riporta spesso ad atti di compravendita, a denunce dei beni posseduti, a permute e a concessioni idrauliche rilasciate a conferma del loro sfruttamento. A volte capita d’incontrarli tra i confini di altri immobili, segnalati incidentalmente da toponimi come Contrà del Mulino o Rio Molino. In questo contesto viene spontaneo chiedersi quali siano state le ragioni che hanno dato origine a questi impianti e quali le motivazioni di fondo che hanno favorito la nascita delle due dozzine di poste molitorie, capaci di macinare per secoli sui pendii Euganei. Di certo l’analisi della loro distribuzione sul territorio collinare evidenzia una presenza maggiore sul versante occidentale rispetto a quello orientale: su questo fronte, infatti, s’allineavano i mulini di Mezzavia, Battaglia, Pontemanco, Rivella e Bagnarolo che potevano beneficiare della disponibilità idrica assicurata dall’idrovia Padova-Monselice. Tra le carte dell’ufficio veneziano dei Provveditori sopra beni inculti è rimasta memoria di ben quattro concessioni rilasciate per la costruzione di altrettanti nuovi mulini nell’area dei Colli Euganei: Carbonara 1664, Montegrotto 1675, Valsanzibio 1678 e Faedo nel 1768. Di questi, tuttavia, solo quello di Valsanzibio ebbe fortuna mentre degli altri sono rimasti solo sporadici ricordi. A que- Carbonara oggi. Nel 1663 il nobile veneziano Bartolomeo Paruta chiese al governo la concessione per costruire un nuovo mulino, a poche decine di metri dalla chiesa. 94 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei sto elenco va poi aggiunto il mulino del Molian costruito nel 1610 a Villa di Teolo in anni in cui non era ancora tassativa e obbligatoria la concessione governativa per piccole ruote. La richiesta di costruire un mulino a Carbonara fu presentata dal nobile veneziano Bartolomeo Paruta, figlio del defunto Marc’Antonio, il 7 settembre 1663. Nelle intenzioni del richiedente vi era quella di «poter construire un molino da macinar grano nel vicariato di Teolo, territorio padovano nella villa di Carbonara con l’acque d’una fontana detta della Castagnara», posta sul versante settentrionale del Monte della Madonna, da riconoscere, forse, nella fontana del Moretto delle mappe attuali, tra beni di Marcantonio Corsatto, a valle, e del nobiluomo Trevisan a monte. Nel disegno dello stato dei luoghi, elaborato dal tecnico dell’ufficio veneziano Iseppo Cuman il 10 gennaio 1663 more veneto (cioè l’anno 1664), si può ricavare la posizione che Bartolomeo Paruta scelse per installare la nuova ruota da macinare. Il fabbricato era previsto a poche centinaia di metri dalla chiesa di Carbonara, lungo quella che oggi è chiamata via San Giovanni Battista. Dell’effettiva costruzione, del funzionamento e della durata del mulino purtroppo nulla sappiamo: l’unica cosa certa che ci è rimasta è la ricevuta del versamento di 40 ducati, richiesti dal governo veneziano per l’investitura, effettuato dal richiedente il 10 marzo 1664. Il silenzio sul nuovo impianto è confermato anche dalle carte dei Provveditori all’arsenale di Venezia, incaricati di annotare tutte le autorizzazioni concesse ai proprietari dei mulini per tagliare le roveri necessarie alla fabbricazione degli alberi delle ruote idrauliche: nel registro delle località, purtroppo non compare Carbonara, segno che il mulino, se attivato, non ebbe lunga esistenza. Nota Carbonara in una istantanea di fine anni ’50. Quanto si conosce della vicenda sul mulino di Carbonara è ripreso da Claudio Grandis, I mulini ad acqua dei Colli Euganei, Este (Parco Regionale dei Colli Euganei) 2001, p. 65, 7273. I documenti sono in Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra beni inculti, b. 385, mentre il disegno predisposto per la concessione è nel medesimo fondo, rotolo 342, mazzo 14, disegno 7. Aldo Pettenella Altri promessi. Storia padovana del secolo XVII La storia che vi racconto è tratta per intero da un fascicolo processuale conservato nell’Archivio di Stato di Padova*. Altri documenti (di natura amministrativa, fiscale, notarile ecc.) sarebbero in grado di fornire informazioni su molti dei personaggi implicati: ma li ho sfiorati appena quanto basta per accertarmene. Quanto al processo aperto contro Teodoro Boattin, all’uccisione sua e del suo amico Scoin, o al procedimento a carico di Ottavio Bellacato che portò al suo arresto – fatti che han radice esterna rispetto a quelli qui narrati, ma li intersecano in momenti cruciali – non ne resta traccia nei fondi padovani relativi alla giustizia criminale: ne sopravviveranno probabilmente in sedi diverse. Insomma, queste pagine ricapitolano la prima tappa di un lavoro interrotto, e non andrebbero mostrate in pubblico. Ma siccome non so se e quando mi rimetterò a cercare notizie su questi casi e queste persone, tanto vale che li faccia conoscere a voi così come io oggi li conosco. Del resto non sono uno storico, solo uno che ama le storie; e mi accontento, ambizioso obiettivo minimo, che chi legge ne ricavi qualche piacere. L’attentato rapto 1 La vicenda di questo capitolo, semplice antefatto di quelle narrate nei successivi, occupa una settimana di mezzo settembre di 340 anni or sono. Ve la racconterò cominciando dal suo ultimo atto, l’unico che attirò l’attenzione di molte persone, e si sviluppò a partire dalla piazza di Bastia di Rovolon venerdì 15 settembre 1656. Dico piazza ma intendiamoci: piazza vera non può esserci, se neppure c’è, e non ci sarà per i successivi tre secoli, vero paese. C’è piuttosto un nodo di strade, e nel luogo della fortificazione medievale che lo presidiava, da tempo distrutta e rievocata fino ad oggi nel toponimo, c’è la chiesa parrocchiale; la reggono i frati di Santa Giustina, massimi proprietari di terre in questa zona che una bonifica ancor lontana dal compimento ha già cominciato a costellare di corti e boarie. Ci sono nei pressi della chiesa i servizi di base richiesti dall’importante incrocio viario: l’osteria di Francesco “Fabio” Falda e di sua moglie Maria, e un’officina di fabbro ferraio, l’equivalente per l’epoca di un moderno meccanico d’auto. Di una terza bottega conosco il nome del gestore, Anzolo “Michieletin” Albanese, non la specialità merceologica. Ci sono poche altre abitazioni, fra cui qualche residenza di campagna di proprietari cittadini. 96 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Sono le nove di mattina. Una ragazza esce dalla casa delle signore Gazze incamminandosi frettolosa in direzione di Padova; Paulo Toffan, boaro al servizio della stessa famiglia, la vede dalla piazza e si precipita a dar la campana a martello, lascia poi l’incombenza di sonare al primo che accorre e si lancia all’inseguimento. Nel trambusto pochi notano un tale che si allontana veloce dall’osteria attraverso i campi. Forse anzi sono due. Quanto agli altri presenti, tutti si fanno a guardare ma non si mobilitano (in termini tecnici, non si sollevano); il solo “Michieletin” si unisce al boaro, più per curiosità che per dargli man forte, come vedremo. Toffan raggiunge la ragazza e l’afferra per un braccio. La giovane si lascia cadere a terra, «Copeme, amazzeme, non voglio tornar a casa» grida, ma altre urla son quelle che arrestano il boaro: «Cospettazzo di Dio lascialla andare! Lascia star quella putta sangue di Dio che tu non sai con chi habbi che fare! Ricordati che tu l’hai fatta a Gio Batta Breo, che ti farò trar in terra [= ti farò ammazzare] né me lo scorderò1». Il giovanotto che così minaccia e si nomina è lo stesso che è corso via poco fa precipitosamente dall’osteria: strepita ora da un prato prossimo alla strada, spalleggiato da un compagno silenzioso. Ha l’archibugio in spalla e non lo spiana, anche perché non occorre. Tre o quattro uomini di Bastia, lì presso impegnati a sterrare un fosso (che fa anche da confine comunale) e chiamati in soccorso da Paulo Toffan, si guardano in faccia (uno ha per soprannome Faccia di rospo: particolare che non potevo tacervi), si aggrappano con prontezza e giudizio ad un cavillo giuridico (la donna è già oltre il confine del Comune), e non volsero solevarsi. “Michieletin” non mostra minor buon senso. Il boaro molla la presa. La ragazza si alzò, si andò ad unire con detto Breo e poi partirono. Dissolvenza. 2 Questa scena, svoltasi in piena luce ed al cospetto di numeroso ancorché passivo pubblico, è l’acme drammatico dell’episodio intitolato Attentato rapto della Sig.ra Anzoletta Gazza con bestemie. Delle bestemmie sapete tutto: sono quelle che avete letto qui sopra – così si bestemmiava allora, niente porchi, ma è l’intenzione che conta. Della Anzoletta (nata intorno al 1640, e figlia del q. Simon Gazzo, gentiluomo padovano morto intorno al 1650: i cognomi si declinano per numero e genere) conoscerete un po’ alla volta parecchio: basti per ora sapere che non è lei la fanciulla che avete visto scappare. La fuggitiva è una certa Laura, di cui abbiamo anche il cognome (o il soprannome di famiglia, quella forse dei “Ciuci”: in cerca di una grafia che lo renda degno di comparir su carta il notaio inquirente e verbalizzante scriverà invariabilmente Laura Chiuchia). È al servizio delle signore Gazze (cioè di Chiara, la vedova di Simon, e di Angela) si può dire per nascita, essendo figlia della massara cui le signore affidano la loro casa di Padova (in via dei Tadi, vicino al ponte) quando loro sono in villa. Potrebbe avere più o meno l’età della padroncina, 16-17 anni, ed essere, nella misura concessa dai ruoli rispettivi, una sua amica: tutto il suo comportamento nei giorni precedenti è alt ri p rom e ssi 97 stato improntato a quei modi confidenti e disinvolti cui dà diritto l’amicizia, non la dipendenza. Ma è nato poi il forte sospetto, per non dire la certezza, che si sia lasciata comperare dal nemico, ed abbia agito d’intelligenza con lui. Il nemico è, ovviamente, il Breo. 3 Non sappiamo quanti anni abbia Gio Batta Breo: attribuiamogliene, per immaginarcelo meglio, tra i venti e i trenta. Qualcuno si riferirà a lui come a quel putto Breo, ma questo non è appellativo che possa aiutarci più di tanto a determinarne l’età (indica piuttosto la condizione di celibe e di figlio di famiglia, come oggi toso). Per sottolinearne gli umili trascorsi si ricorderà di lui che è stato nolegin (variante nolecio, cocchiere di piazza), ma ora ha fatto passi avanti: è vendifen, gestisce cioè con il padre un magazzino e rivendita di fieno in città, in contrà del Ponte dei Ta’ dentro la mura vecchia, proprio dirimpetto la Sig.ra Chiara Gazza. Lui si definirebbe un mercante. Inoltre tiene in affitto dal Cardinal Bragadin alcuni campi con abitazione discosto dalla villa di Bastia circa tre miglia, in quel di Saccolongo. I gentilhuomeni del medesimo rango della famiglia Gazzo sottolineano vivacemente la sua condizione inferiore, di artegiano, di plebeo, di vilan; ma i lavoratori di campagna e di città non tralasciano, parlandone, il Signor davanti al nome. Gli affari devono andargli bene, i soldi non gli mancano. Aggiungerò che è piuttosto conosciuto fra persone di ogni ceto. Il sabato che segue al famoso venerdì viaggia in carrozza da Saccolongo a Padova: altre due carrozze in due distinti momenti lo incontrano. Rapido incrociarsi d’occhiate attraverso i finestrini e quattro ragguardevoli signori padovani lo ravvisano e posso- La campagna ai piedi delle colline. 98 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei no testimoniare (uno di questi, quando si dice la combinazione, si chiama Nicolò Verdabio: cfr. par. 10). Orbene, il giovane Breo ha messo gli occhi sulla giovanissima dirimpettaia, la nobile Angela Gazza. «Sapendo lui non essere suo pari et che mai mi sarebbe capitato in pensiero che costui la pretendesse non che di dargliela», dirà la madre, signora Chiara, «s’è andato imaginar di rapirla, non havendo riguardo alla sua conditione, che è d’artegiano, alla mia, che è di cittadina; et sapendo questo anco, che mia figlia havrà di dote circa ducati quindeci mille, tanto maggiormente è andato pensando d’effettuare questa sua mala intentione». 15.000 ducati! Gran bella dote, decisamente. Ma forse la parola non è qui usata in senso tecnico. La ragazza è, per quel che si comprende, l’erede unica dei beni paterni. Tanto per dire, di cento trenta campi piantati e videgati in villa di Arè (Arre) con un palazzo con tezze di muro, con tutti li mobili di ogni qualità, nonché la dimora di Padova. Quanto basta per evitare l’interrogativo: era bella l’Anzoletta?, al quale non avremmo comunque elementi per dare risposta. Sul suo aspetto ci dobbiamo contentare di due parole in tutto, che contestualizzerete a suo tempo, sana et gagliarda. 4 Campi coltivati nei pressi di Monte Grande. E dunque, l’artegiano Gio Batta Breo s’è andato imaginar di rapire la gentildonna. Impresa assai arrischiata, commentava il Manzoni a proposito dell’illustrissimo don Rodrigo che aveva fatto analogo disegno su Lucia Mondella, operaia; eppure, se ci pensate un momento, il disegno era analogo solo in apparenza e il plebeo padovano rischiava meno del nobile milanese. Nel caso del Breo, sempre che avesse davvero in mente rapire la ragazza (ma non è da escludere che sperasse piuttosto in un suo consenso a fuggire con lui: cfr. par. 7), il sequestro non aveva altro scopo che quello di forzare lei e la sua famiglia ad accettare il matrimonio. Il che, anche sul piano delle conseguenze legali, poteva fare una grandissima differenza2. Non voglio dire che i rischi mancassero, ma potevano essere ragionevolmente messi in bilancio a fronte dei benefici sperati. Il progetto di rapimento non è comunque la prima mossa documentata del Breo. Qualche settimana prima dei fatti che stiamo raccontando aveva offerto, a tu per tu, ad un uomo di fiducia delle Gazze, il boaro che già conosciamo, 100 ducati per guadagnare la sua mediazione nella richiesta di matrimonio alt ri p rom e ssi 99 (con 100 ducati, per intenderci, si comperavano sei buone vacche). Forse Paulo Toffan ritenne poco affidabile la promessa; forse l’acuto senso dell’onore proprio e altrui che esprimeva a parole era proprio sincero; fatto sta che non riuscì ad immaginarsi nelle vesti di chi proponeva una simile mésalliance alla padrona, donna, temo, incline a furie tempestose. Rispose che non facieva di queste attioni. «Lui mi disse che era poca cosa, et che ero coglion a non pigliar tanti soldi che in vita mia non ne guadagnerò tanti; le replicai che stimavo più il poter andare in ogni loco come huomo da bene che il far assai denaro et non poter andar per tutto». Che il Breo, trovata chiusa la strada col Toffan, sia riuscito ad aprirsene una con Laura Chiuchia è, a posteriori, facile deduzione. La spedisce da Padova a Bastia (fino a Saccolongo l’avrà portata lui in carrozza), lunedì 11 settembre, a fare un’improvvisata alle padrone. Le quali, come previsto, la invitano a fermarsi, la fanno anzi mangiare quotidianamente a tavola con loro. La sua missione? Preparare il terreno, per esempio lasciando cadere nella conversazione che li mercanti havevano belli cavalli, belle carrozze, et che le loro mogli havevano belle zogie e simili; ma soprattutto, convincere l’Anzoletta ad uscire a spasso con lei, in campagna, a uva, a insalata. 5 Fra quel lunedì e quel venerdì Gio Batta Breo si fa vedere spesso a Bastia, non lontana come sappiamo dalla campagna che ha in affitto; sta generalmente dall’oste, con la famiglia del quale è in evidente dimestichezza, e il cui esercizio dista poco più che un trar di sasso dalla casa delle Gazze. Fa in modo di incontrarle e di salutarle mentre vanno in chiesa. Si saprà poi che per alcuni giorni (sicuramente il mercoledì e il giovedì) ha tenuto a sua disposizione nelle vicinanze, in questa o in quella corte, una carrozza e dei compagni. Di questi uno è stato riconosciuto: è suo fratello, il Breo pittor, e con lui c’è anche la moglie. Un pensiero indiscutibilmente gentile verso la candidata al rapimento. Il mercordi mattina, 13 settembre, il boaro Toffan lo vede, in un formenton, confabulare con Laura Chiuchia, ed è pregato poi dal Breo stesso di non andare a dirlo in giro: curiosissima gaffe, si vede che il Breo credeva l’altro suo amico più di quanto non fosse. Il buon Paulo, geloso dell’onore delle padrone e già al corrente delle ambiziose mire del personaggio, si mette in allarme rosso. Avverte la signora Chiara: badi a non lasciar uscire l’Anzoletta, guardi che la Chiuchia dev’esser venuta per trapolar fuori di casa detta Sig.ra Angela, che il Breo di sicuro era ivi per menarla via. Chiara Gazza investe la Chiuchia: «Ho qualche ombra che tu sij venuta qui per qualche cativo fine, non ne son certa, che se ne fossi certa ti taglierei le treccie, ma guarda bene come tu tratti, perche vedi come tratto teco tenendoti alla mia tavola». La Chiuchia: «Dio guardi Sig.ra, come trovasti mai di queste cose, sono venuta a spasso» e parole simili. E nonostante questo, Laura Chiuchia (con cui il Breo tiene contatti frequenti tramite l’ostessa Maria) riesce alfine a far uscire l’Anzoletta nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre la madre è a letto indisposta, alla volta del brollo qui 100 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei attaccato alla casa che è però loco apperto. «La Chiuchia», deporrà l’Angela, «mi disse: “Andiamo un poco avanti qui in campagna a mangiare dell’uva”, ma io non volsi andare, et m’abatei casualmente guardar verso una pezza di nostro formenton poco discosto dal nostro brollo sudetto, et vidi due nel mezzo detto formenton... Bisogna [che il Breo] havesse concertato con lei che mi guidasse a quella parte per prendermi poi et menarmi via». Anzoletta, così racconta, alla vista dei due uomini tornò in casa di corsa. La servetta, accortasi che non poteva fare la botta che haveva dissegnato e che era ormai scoperta al di là di ogni possibile diniego, la mattina seguente a tre hore di sole si partì di casa correndo verso Saccolongo, scatenando con la sua fuga l’impulsiva reazione del boaro; il seguito ci è noto. 6 Questo è praticamente tutto, per quanto riguarda l’episodio in questione. Tutto, cioè niente. Certo la temerità di un vendifen aspirante alla mano di una gentildonna poteva risultare di per sé scandalosa quanto un rapimento, o più: si rileggano su questo le parole della madre (par. 3). Non ho poi dubbi che la corruzione di una domestica, indotta per denaro a tradire i padroni, fosse considerata un atto detestabile, un’infamia. Questo sotto il profilo del comune sentire di allora. Ma sotto il profilo, come noi diremmo, della rilevanza penale, era davvero accaduto qualcosa? L’intenzione, se c’era, non era neppur diventata un tentativo di rapimento, né aveva prodotto altre azioni criminose che le bestemmie, la minaccia di morte gridata a Paulo Toffan, il porto d’arma. Bestemmie: non trascurabile imputazione, ma temibile in realtà soprattutto per vagabondi, marginali, magnaccia, ubriaconi, gente di mala vita, perché contro di loro poteva valere quale precisa fattispecie di reato e consentire una condanna severa, a punizione di un insieme di condotte tanto poco definibili penalmente quanto socialmente indesiderabili3. Minacce: proferite, è vero, in presenza di testimoni, ma perseguibili solo se il boaro se ne fosse querelato, il che non avvenne. Armi: cosa da non darsene pensiero, quando si tratti di arcobuso longo portato all’esterno di città e luoghi murati. Ci voleva sì una licenza4 (che il Breo avrà probabilmente avuta): ma anche a non averla, la pratica universale era di girare con lo schioppo in spalla (schioppo da osellare, precisavano invariabilmente gli interessati). Altro par di maniche era mostrarsi con archibusi curti, con pistole alla cintura; ma, le avesse pur avute in quell’occasione il nostro uomo, un opportuno soprabito, la gabanela, le nascondeva, e nessuno poté dire di avergliene viste. E comunque: bestemmie, minacce ed armi avrebbero potuto, se mai, essere imputate unicamente a Gio Batta Breo. Invece non contro di lui soltanto, ma anche contro Laura Chiuchia, in seguito a denuncia presentata il 20 settembre 16565, vien formato presso il Maleficio di Padova un processo affidato al nodaro Prosdocimo Fanton. Spesi senza fretta alcuni mesi, sentiti numerosi testimoni, viene deciso (23 novembre) il cauto arresto della Chiuchia (di lei soltanto: al suo nome nessuno alt ri p rom e ssi 101 mai premetterebbe Signora), che peraltro fallisce (10 febbraio 1657: notate la solerzia). Sia la donna che il Breo sono il 21 febbraio citati ad informar, e poiché non obbediscono un nuovo proclama intima loro il 29 aprile di presentarsi alle prigioni per difendersi. L’ultima nota di questa sezione dell’incartamento registra, in data 28 giugno, una richiesta del Breo di poter disporre, prima di presentarsi, di un altro mese per provvedere ai suoi affari: formula consueta e normale pratica dilatoria6, che un’incuria opportunamente incentivata poteva trasformare in soluzione definitiva. Sta di fatto che, quando circostanze impreviste imposero di spolverarlo (cfr. par. 27), il fascicolo dormiva ormai da nove mesi un sonno che non presentiva risveglio. 7 Gio Batta Breo faceva l’amore all’Anzoletta in via dei Tadi, dal portone del magazzino alla finestra di fronte? La signora Chiara: «Signor no, perché tengo sempre le fenestre serate et sto pochissimo a Padova». Ma via, Signora... Con che occhi guardava l’Anzoletta al corteggiatore? Attraverso occhiali di ceto sicuramente: improponibile come marito. Lei poi non era una nobile impoverita, come sappiamo. Detto questo, che restasse da dire qualcos’altro? L’ipotesi che il giovanotto non le dispiacesse ha qualche appiglio. Non molto evidente, in verità; ma a questo dovrà ricorrere chi, nel corso dei prossimi capitoli, maturasse qualche simpatia per la ragazza, per non vedere con soverchia tristezza quel che le accadrà fra diciotto mesi. Torniamo alla sera di giovedì 14 settembre, quando Anzoletta Gazza vide due uomini in attesa tra gli alti fusti del mais, a poca distanza dalla casa da Un panorama di Rovolon circondato da alberi in fiore, alla vigilia della II guerra mondiale. 102 Le colline di Monte Grande e di Monte della Madonna. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei cui Laura Chiuchia l’aveva finalmente convinta ad uscire. Li vide anche un abitante di Bastia, Giacomo “Andrian” Zambon. Lei dice che scappò subito indietro, e se noi vogliamo crederle nessuno ci impedisce di farlo: anche il testimone la vide andare verso casa sua (sebbene, dalle parole che usa, non sembri propriamente una fuga), ma non può precisare se prima ella avesse o no incontrato più da vicino quei due. Quel che voglio insinuare è che forse la loro vista non fu per Anzoletta quella sorpresa che lei ci vuol far credere: potrebbe darsi che lei fosse uscita apposta per vederli, o meglio per vedere uno dei due (è uscita, ricordiamolo, dopo che il Toffan aveva già messa in guardia la madre), e gli avesse davvero parlato. E magari il Breo, nella speranza di persuaderla a scappare con lui, se non quel giorno il giorno dopo, perse l’occasione di portarla via con la forza. Spingerebbe a pensarlo la parola di un’altra testimone, assai meno estranea ai fatti, sospettata anzi di complicità e dunque meno credibile nelle sue affermazioni: l’ostessa Maria. La quale ammette spontaneamente (e non so perché dovrebbe mentire su questo) di aver portato alla giovane gentildonna la richiesta di un abboccamento da parte del Breo. Sostiene che Angela ha rifiutato di uscire perché la madre era a letto ammalata; che a questo punto la Chiuchia di sua iniziativa si è offerta a lei, Maria, di portar fuori la ragazza con pretesti (qui, ovviamente, la sua versione non ci convince affatto); che quella sera stessa il Breo le ha confidato che l’Anzoletta era pronta a scappar di casa insieme a lui. Davvero l’uomo era tornato con questa convinzione dal colloquio (se l’aveva ottenuto), o cercava solo di tranquillizzare l’ostessa, convincendola che non ad un ratto stava dando mano, ma ad una fuga d’amore? Oppure è costei che vuol convincere l’inquirente d’averlo creduto? Interrogata se la Signora Anzoletta poi fosse d’accordo di fuggir con il Breo, l’ostessa Maria rispose con molto buon senso: «Io non lo so, ma se fosse stata d’accordo poteva fugire, che non v’era chi potesse tenirla». Possiamo anche noi, visto come sono andate le cose, escludere che Angela fosse pronta a fuggire alt ri p rom e ssi 103 con il Breo; uscire, però, era uscita. E forse solo quando fu rientrata seppe di non voler correre la fascinosa avventura, si pentì dell’audacia propria, si spaventò dell’altrui, diede alla madre la versione che sappiamo (cfr. par. 5), finendo di inguaiare la serva già sospettata. Un comportamento incauto, incoerente, contraddittorio, propenso a scaricare su spalle altrui la propria parte di responsabilità, non sarebbe per questo meno plausibile: anzi, vorrei quasi dire. 8 Aggiungiamo un paio di notizie sulle azioni del Breo successive a quella mattina del 15 settembre 1656. Il nostro è un pianificatore, avrà altre occasioni di dimostrarlo, né successo né insuccesso possono coglierlo di sorpresa, e la sua ritirata non è una rotta disordinata. Nell’abitazione di Saccolongo riunisce i compagni della fallita impresa (la Chiuchia, il fratello con la moglie, un altro huomo scarmo d’ettà d’ani 36 in circa non meglio identificato), e per prima cosa scrive una lettera compitissima (il giudizio è suo) alla signora Chiara Gazza chiedendole un colloquio; poi una seconda al suo carissimo ms. [messer] Fabio oste di Bastia (questa è acclusa agli atti processuali, l’altra no), perché metta bone parole con la signora Chiara se questa lo mandese a trovare per fargli lecer la letera7, e perché lo raggiunga a Saccolongo onde potergli discorrere abocha. Il giorno dopo tornerà a Padova in carrozza (cfr. par. 3). Il processo avviato contro di lui non lo allontana dalle occupazioni e dai luoghi consueti. Risulta che dia ricetto, oltre che a Laura Chiuchia, ad un servitore delle Gazze: entrambi corrotti da lui, entrambi smascherati, si sono rifugiati presso quij vilani nominati li Breij8. Risulta anche che continui a frequentare Bastia, ad infastidire ed a preoccupare le Gazze, appoggiandosi logisticamente non più all’osteria, ma alla casa del frate della chiesa della Bastia, vicina a quella delle S.re Gazze che non vi è altro che la strada in mezzo, a far l’amor con la S.ra Anzola se bene essa non voleva consentirgli; et lui per mezo di quel frate procurava insinuarsi in casa di dette donne, anzi per questa causa le dette donne s’inimicarono con detto frate9. Parecchi mesi dopo, nella notte che precede un’alba di cui riparleremo (quella di lunedì 25 giugno 1657), movimenti d’ignoti figuri presso la casa destano allarme, sempre che vogliamo prender per buona questa informazione di fonte sospetta10. In altra occasione un contadino confessa d’essere stato pagato (doi scudi d’argiento) dall’indefettibile Gio Batta perché gli procuri alcuni effetti personali di Anzoletta (una cordella, o vero una scarpa) per poterle fare un strighamento. Una casa resta senza donna ed un’altra senza uomo 9 A Padova, in un palazzo di via san Pietro (contrà di San Piero), abitava allora 104 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei un ramo dell’importante famiglia dei Bellacati (anche Belacati, Pellacati, Pelacati: sono fortemente tentato di vedere nelle diverse forme del cognome altrettanti sforzi d’allontanamento da un originario Pelagatti, che direbbe bene di un’inclinazione riaffiorante qua e là nella discendenza. Ai Bellacati piaceva comunque il loro cognome, che ricorre nelle loro generazioni anche come nome proprio). Un Bellacato dottor, un Alvise medico, fratelli, si erano trasferiti a Padova da Brescia verso la metà del ’50011, e il primo dei due è l’antenato dei personaggi che incontreremo. Non potevano vantare una nobiltà araldica comparabile con quella dei Gazzo, che discendevano da un Manfredino podestà di Padova nel 1206 o amavano crederlo e farlo credere, ma erano forse anche più ricchi. Accolti a pieno titolo nel novero della nobiltà cittadina, sedevano da un secolo quasi nel Maggior Consiglio e da decenni partecipavano alle cariche più alte12. Il 20 febbraio 1657, cinque mesi dopo i fatti esposti nel primo capitolo, nella casa di via san Pietro muore Camilla, moglie di Ottavio Bellacato. Il vedovo è sulla sessantina, e non si sente troppo bene neanche lui. Gli amici che vanno a trovarlo (i nobili signori Daniel Boromeo e Francesco Giusto) lo trovano a letto, prostrato dalla perdita subita e più ancora dalla preoccupazione per la sua casa rimasta senza governo. A questo si rimedia facilmente, gli suggeriscono: fai sposare tuo figlio Bellacato (dev’essere sui 15-16 anni; di poco più piccolo è Girolimo o Momolo, figlio naturale di Ottavio e pure convivente). Mio figlio? Scherzate! È troppo giovane. Le putte non voglion vecchi, gli ribattono, e giù subito a fare elenchi di possibili candidate. L’idea buona viene al Giusto, che sta di casa vicinissimo alla dimora padova- Anni ’50 del secolo scorso. La famiglia di Giovanni Paccagnella, con la moglie Bruna Giona che tiene in braccio il figlio Oreste e, a lato, Rebecca Vanni. Davanti i due figli Orfeo e Orlando. alt ri p rom e ssi 105 na dei Gazzo: chiedere l’Anzoletta. «Fra le altre – deporrà – le nominai questa putta Gazza, dicendogli che sarebbe stata un buon partito per il giovine, rispetto che anco haveva la madre, donna di buon spirito, et che sarebbe stata atta a governar la sua casa». Tutti i presenti a quel colloquio insistono volentieri sulla tesi dei due piccioni con una fava, che appare come il peso che fa pender la bilancia; nessuno invece riferisce che si sia fatto cenno all’ingente eredità destinata a seguire la fanciulla: ça va sans dire, letteralmente. I Boromeo erano un po’ parenti della Chiara Gazza (un Antonio Boromeo è nominato come suo cognato), anche se non risultano rapporti fra lei ed il signor Daniel; in ogni caso, non è costui che si incarica della trattativa, anche perché per aver la putta bisogna parlare non con la madre, ma con lo zio Teodoro Boattin, e dunque un compadre di questo, il Sig.r Nicolò Verdabio, sarebbe stato buon mezzano, come quello che altre volte haveva tratato anco con il Sig.r Ludovico Frecimelega (Frigimelica, famiglia padovana di primissimo piano) per questa putta Gazza, negotio che non si era poi concluso. 10 Del già nominato Nicolò Verdabio (cfr. par. 3), egli pure abitante nella stessa contrà dei Giusti e dei Gazzo, nodaro ottimamente piazzato nell’élite, membro del Maggior Consiglio, solito ricoprire incarichi pubblici, non sento il bisogno di dirvi altro; si sappia comunque che appartiene alla considerevolissima schiera di notabili cittadini solidale coi Bellacati nel corso delle vicende che seguiranno. Di Teodoro Boattin dirò subito tutto quel che posso. È invariabilmente designato come cognato della signora Chiara; faccio l’ipotesi che sua moglie Marietta, cui si accenna casualmente nel processo, sia la stessa persona di una Marietta Gazza zia dell’Angela (altra apparizione di striscio). Teodoro avrebbe sposato insomma la sorella del padre dell’Anzoletta. Era lui quello che haveva in custodia la detta giovine et la madre anchora, secondo Daniel Boromeo: questo significherà, per come lo intendo io, che pupilla e patrimonio gli erano stati legalmente affidati in tutela, e poiché la dote a suo tempo portata da Chiara non era scorporata dai beni della figlia (cfr. par. 15), anche la vedova di fatto dipendeva da lui. Credo che la casa di Bastia dove abitano spesso le due donne sia del Boattin, anche se per la maggior parte dei testimoni è la casa delle Sig.re Gazze. Lui stesso ci abita, così come a Padova abita nella casa di via dei Tadi (questa sicuramente facente parte dell’eredità paterna di Angela). Nell’episodio del primo capitolo non appare mai, salvo che per un accenno contenuto in una frase del fido boaro, da cui risulta momentaneamente assente – e tocca infatti al Toffan in quella circostanza sostenere la parte dell’uomo di casa. È invece sicuramente a Bastia fra l’inverno e la primavera del ’57, insieme alle parenti. Se qui avete sussultato sorpresi avete fatto benissimo: a Bastia in febbraio, in marzo? Non son mesi da starsene in campagna, quelli, clima cattivo, fango dappertutto, pochi lavori, niente raccolti, e poi c’è il carnevale: ma il nostro piccolo nucleo ha altro per la testa che balli e maschere. Te- 106 Villa Manfredini ripresa sul finire del secolo XIX per una cartolina illustrata. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei odoro Boattin è stato proclamato per l’inquisitione, e teme di essere arrestato; anzi, la Chiara Gazza haveva mandato fuori di casa (da quella di via dei Tadi) il meglio che vi fosse, per tema che capitassero gli sbirri per retenir il Sig.r Boatino13. Dal che si trarrà conferma che realmente la Chiara, donna di buon spirito, sa governare una casa con previdenza (prevede facilmente per esempio che gli sbirri si contenterebbero di portar via al posto del proclamato ogni cosa di valore): niente di preciso si ricava invece sul genere di guai giudiziari in cui il Boattin si trovava. Riunendo gli sparsi accenni che sono in questo incartamento, posso però dire qualcosa della sua battaglia procedurale. Al nostro doveva essere stato intimato, come si usava di frequente (l’abbiamo visto già per il Breo), di presentarsi alle carceri per far le sue difese (e nel frattempo si stava dentro): naturalmente, presentarsi non si usava con altrettanta frequenza (visto anche questo), e, fidando nella lentezza e trascurataggine degli apparati repressivi (visto), si lasciavano scadere i termini prescritti, e intanto si frapponevano appelli, richieste di un nuovo termine (visto), ecc. Un nuovo termine (cioè la proroga della data ultima per la presentazione) effettivamente il Boattin lo ottenne quella primavera, credo a maggio; se era, come normale, di un mese, scadeva in giugno, e Teodoro visse abbastanza da giocare la carta successiva: non un giorno di più, come vedremo. Non so quali fossero i rapporti quotidiani fra la Chiara e il cognato. Burrascosi, secondo una testimone14, intenzionata però a presentare la Sig.ra Gazza come un caratteraccio lunatico e insofferente: mai lo lasciava star col dirli che voleva levarsi da quella casa, che non voleva star sotto l’obbedienza di alcuno e (voleva) retirarsi da sua posta, et per tal causa ogni giorno se gridava. Fosse anche stato così, sta di fatto che era lui l’unico uomo a cui la vedova potesse appoggiarsi. Per tutto il seguito di questa storia nessun altro parente, e del resto nessun’altra persona che appartenga al suo ceto, muoverà un dito o dirà una parola a suo sostegno. Magari la madre Gazza era davvero un essere insopportabile e aveva rotto i rapporti con tutti; magari lo scontro in cui si troverà coinvolta apparirà al parentado troppo impari per arrischiarcisi (Chiara sosterrà che lei e sua figlia erano abbandonate da parenti per spavento). Certo un simile isolamento fa impressione, in una società come quella, in cui relazioni di consanguineità, solidarietà di stirpe, alleanze di famiglia costituiscono obblighi cogenti e insostituibili garanzie. Questo isolamento dalla parentela vale anche per il Boattin, che a Padova, dove non può farsi vedere, necessiterebbe di assistenza per la sua vicenda alt ri p rom e ssi 107 processuale e dice testualmente «li mieij parenti non me ne posso valer di cossa alcuna». Non sembra però privo di appoggi fra le persone che contano, a Padova e a Venezia: allude in un’occasione alla protezione dell’Ill.mo S.r Marco Priulli suo S.re; oltre che compare del Verdabio è poi amico, per esempio, di Gasparo Scoin, che ha casa al ponte di San Zuanne ed appartiene alla crema della società cittadina, quella fra cui turnano le cariche (era per quell’anno membro del Consiglio dei Sedici, anche se la mattina di domenica 24 giugno 1657, tenete a mente la data, venne sostituito in tale incarico perché destinato ad assumerne uno diverso in luglio). 11 Fra Nicolò Verdabio (pregato dal Giusto e dal Boromeo) e Teodoro Boattin si sviluppa fra marzo e maggio una regolare corrispondenza. Quattro lettere del secondo sono accluse al processo, ed il loro argomento principale, ma nient’affatto unico, è la trattativa di matrimonio. Le due Gazze, informate della proposta, mostrano un acconsentimento non entusiasta («la Sig.ra cugnata ne meno mia nezza non ga dispiaciuto») e nessuna fretta di concludere («come sarà quetatto questo mio negotio – i problemi giudiziari, naturalmente – o in bene o in male... si tratterà et spero che si possi affetuare il tutto»). Fra le altre cose che dalle lettere del Boattin si ricavano almeno due vanno ricordate. Una già l’accennavamo: non sono terminate le preoccupazioni a causa di Gio Batta Breo, e Teodoro, in esilio dalla città, soffre di non poter seguire da presso gli sviluppi del processo istruito contro costui, perche si tratta della reputatione. L’altra è che i Bellacati sono per lui qualche cosa di più di un nome noto: «Sa bene li ll.mo S.r Ottavio che li son servitor vechio, che quello non facesse per La villa di Frassanelle allo scadere del secolo XIX. 108 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei luij non lo fareij per niuno, che sia sichuro che quello dependerà dalla mia volontà farò tutto aciò resta servito». L’ultima lettera, del 14 maggio, dichiara l’intenzione del Boattin (cui il nuovo termine restituiva libertà di movimento) di venire a Padova con le donne, «et se sequirà quel tanto che converà»: non sa dire quando, perché lui è in cattiva salute e le due Gazze sono impegnate a dirigere il grande bucato di primavera, il primo dei due annuali («come starò melglio delli miei piedi et cossie che mi butano la febre adosso et che queste gentildonne habiano fenito la sua lisia veremo»). Uno dei due impedimenti, credo, si protrasse troppo a lungo, e la proroga doveva essere scaduta quando il Boattin si decise a recarsi a Padova: forse per questo ci andò da solo, e arrivò giusto fino a casa di Gasparo Scoin, abbastanza vicino all’ingresso della città per chi veniva dalla parte dei colli Euganei. Qui, nella dimora dell’amico, in una sera che è probabilmente quella di sabato 23 giugno 1657, incontra Ottavio Bellacato accompagnato da Nicolò Verdabio. Del colloquio, è da presumere, sarà stato testimone anche il padron di casa. Secondo Ottavio Bellacato e Nicolò Verdabio in tale occasione il negotio fu concluso e la ragazza venne promessa, anche se non si mise nulla su carta, rimandando la scrittura nuptiale al momento in cui anche le Gazze fossero presenti. Sono abbastanza incline a prestar loro fede su questo: mi piacerebbe però che tale accordo esclusivamente verbale fosse stato confermato dal Boattin e, perché no, dallo Scoin. Questo non fu, ahimè, possibile. Sta di fatto che in quel medesimo incontro, essercitando la confidenza di parente, esso Boatino pregò il S.r Ottavio che li facesse sicurtà in forma all’officio dell’inquisitione, intendendo presentarsi, e già la mattina dopo il Bellacato ghe fece la sicurtà de ducati 300 de ritornar all’obbedienza della Giustizia: insomma (e questo viene sottolineato quasi implicita conferma del patto concluso), impegnò i suoi soldi e il suo nome per garantire dell’intenzione del Boattin di presentarsi, rimettendolo così temporaneamente al riparo dall’arresto. Bastia. Festa dei catechisti e delle catechiste diplomati nell’anno 1938. alt ri p rom e ssi 109 Esemplare sollecitudine, come vedete; credo del resto che quella domenica mattina Ottavio Bellacato si trovasse già in centro, in zona uffici, per partecipare alla seduta del Consiglio maggiore (cfr. par. 10) in cui fu eletto un nuovo deputato al posto di Gasparo Scoin il qual doverà entrare in Banca15. Restituito dopo mesi, grazie a tale cauzione, alla libertà di mostrarsi per le strade di Padova, Teodoro Boattin quel pomeriggio stesso fece quello che avremmo forse fatto voi ed io, uscì a passeggio con l’amico Scoin; e nei pressi del ponte di San Giovanni, per ragioni che non so, da chi non so, l’uno e l’altro furono trucidati a schioppettate. Forse uno dei due è morto soltanto perché era in compagnia dell’altro, forse no. Intorno a questo assassinio, che certo Padova intera commentò a lungo, non ho trovato altro che gli avari accenni contenuti in questo incartamento. E pensate che rabbia: le allusioni sono tanto asciutte proprio perché nessuno si dilunga sopra un fatto di cui si è già tanto parlato, di cui tutti sanno tutto. 12 Di quel che vi ho raccontato fin qui sono abbastanza sicuro, anche se le Gazze negheranno alcuni particolari di non poco conto (diranno, ad esempio, di essere state perfettamente all’oscuro della trattativa di matrimonio: ma perché il Boattin avrebbe dovuto tacere con loro, e scrivere intanto al Verdabio di aver avuto il loro consenso?). Da qui in poi, non sono sicuro che alcune cose siano accadute davvero, e quanto ai non pochi fatti indiscutibili, essi sono interpretabili, e vengono interpretati dai protagonisti, in opposte maniere. Fra le diverse interpretazioni ho le mie preferenze, ma anche quando la plausibilità sembra stare nettamente da una parte (e non sta mica sempre dalla stessa, ma nell’essenziale da una sì), non voglio rinunciare a mostrarvele entrambe. Separatamente, però: vi racconterò insomma due storie diverse, una dopo l’altra. La prima delle due è quella che avreste sentito dalla bocca di Ottavio Bellacato, o di Bellacato Bellacato, suo figlio e promesso sposo di Anzoletta, o di uno dei loro numerosi e altolocati amici. Un avvenimento stravagantissimo 13 «Mentre si ritrovassimo il S.r Ottavio et io in casa del Turchetto in questa città capitò nova che era stati interfetti li S.ri Theodoro Boatino et Scoino di nome Gaspare. Ciò da me inteso dissi al medesimo S.r Pellacato che non vi era tempo da perdere se lui desiderava d’haver la putta per suo figliolo, come gli era stato promesso da suo barba Boatino, perche sapevo che vi eran altri che la pretendevano d’haverla con violenza». Come se il diffondersi della notizia che un’ereditiera era rimasta senza protettore dovesse avere l’effetto stesso del sangue che si spande in acque tropicali pullulanti di squali; e su questo neanche voi, quando avrete letto la storia, vi 110 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei sentirete di dar torto a Francesco Giusto. È lui infatti che parla così, e l’ombra minacciosa evocata è naturalmente quella di Gio Batta Breo (riferimenti alle insidie provenienti da quella parte erano contenuti nelle lettere del Boattin). Con sorprendente rapidità agiscono ora Ottavio Bellacato e i suoi amici, decisi ad arrivare a Bastia prima che la nova vi giunga dalla città16. L’omicidio era avvenuto nel pomeriggio, lo avranno appreso ad un’ora ormai troppo tarda per una partenza immediata: ma la sera stessa Ottavio ottiene dall’allora Capitano di Padova, Angelo Giustinian, suo singolar Sig.re (intendo che il nobile padovano avesse un particolare rapporto di clientela col nobile veneziano, individuale o familiare che fosse il legame), che gli faccia aprir le porte nell’alba la matina seguente. «Et così – restituisco la parola a Francesco Giusto – la mattina a bon hora partissimo da questa città in quattro [con due servitori cioé], et passassimo d’avanti alla casa [la residenza di campagna] del S.r Nicolò Verdabio à Tencarola, al quale raccontassimo l’accidente della morte di quelli due S.ri, lo pigliassimo in carozza come quello che haveva tratato il negotio della putta con suo zio et ci portassimo tutti alla Bastia». Ognuno dei nostri ha, com’è naturale, il suo schioppo con sé; stavo per dire che solo un frate avrebbe viaggiato senza, ma non lo dico, perché mi sono venuti in mente i nomi di un paio di frati che viaggiavano con. A Bastia tutto è tranquillo: nella casa di Teodoro Boattin, da poche ore quondam, ancora si dorme. Chiara Gazza si mise in un pianto grande alla nuova della morte del cognato («che apunto non havevo altri che facessero per me se non quel solo et unico parente», dirà, e con ragione), ma, quetate le lacrime, altra è la questione che urge. Il povero Teodoro, che il Signor l’abbia in cielo, aveva promesso l’Angela a Ottavio Bellacato per moglie di suo figlio; Nicolò Verdabio, lì presente, può testimoniarlo; è avvenuto questo con loro consenso, ratificano madre e figlia l’operato del parente? Tutti i membri della spedizione padovana riferiranno la risposta di Chiara quasi con le stesse parole: «Che se il S.r Teodoro fosse visciuto e si fosse pentito, ad ogni modo esse non si sariano mai pentite». Più o meno questa è anche la versione di Gio Batta Bonetti, altro compare del Boattin che era venuto a trovarlo a Bastia, da Vicenza dove risiedeva, a prender meglio aria perché convalescente da una malattia, e si trovò presente all’incontro17. Mentre è in corso questa visita (avvenuta, se i miei calcoli son giusti, lunedì 25 giugno 1657) arriva un fachino da Padova con una lettera della famiglia Scoin che, oltre a portare l’ormai superflua tragica notizia, chiede istruzioni e denari per la sepoltura di Teodoro Boattin. La Chiara non ha liquidi, Ottavio cava di tasca 4 o 5 zecchini e li passa al Verdabio, che manda ad un amico tramite il messo medesimo soldi e istruzioni (il defunto riposerà nella tomba di famiglia dei Gazzo, nella chiesa di sant’Agostino ora scomparsa, presso l’attuale riviera Paleocapa). Altri denari Ottavio dà a Chiara per far tuor su il racolto, che era in stato; le lascia infine in prestito uno dei due servitori che aveva condotto seco, Pompeo Patella, che possa sovrintendere ai lavori della campagna (non c’è traccia in alt ri p rom e ssi 111 quest’occasione della presenza di Paulo Toffan, chissà che fine ha fatto), ma soprattutto che possa vegliare su quella casa restata senza uomo («perche dubitavano che detto Breo capitasse a fargli qualche insulto essendo morto il suo cognato»). È Chiara stessa a chiederlo, che se potesse si trasferirebbe immediatamente a Padova (a questo punto probabilmente riferisce d’essere stata spaventata proprio quella notte da gente che si aggirava presso la casa: cfr. par. 8), ma come si fa?, con il raccolto da seguire, con la residenza di città praticamente sguarnita di mobilia, e senza disporre di abiti adatti al lutto... 14 Nelle settimane successive più volte per vario tramite (e con lettere scritte, pare, dal Bonetti) la signora Gazza comunica con Ottavio, si fa mandare altri soldi, chiede un incontro ufficiale tra i novizi. Una nuova spedizione consente l’incontro, che assume i caratteri propri degli sponsali, di un rito di sposalizio nel senso antico, extraecclesiastico, del termine: alla presenza dei consueti Giusto e Verdabio avvengono il gesto del toccamano, un regalo di gioielli (una gargantiglia, una collana cioè, ed una vereta con un diamantino), il bacio. Al termine di questa visita, o, meno probabilmente, di una spedizione successiva, le due donne salgono in carrozza con i nuovi parenti (per la precisione, il giovane promesso sposo, in serpa, carozzava personalmente) e via tutti a Padova, con grande alegrezza, e con soste lungo la strada nelle ville di amici che si felicitano, brindano, augurano. Le due donne, vi meraviglierete, non smontano a casa loro, ma a casa dei Bellacati, inaugurando una convivenza che va da quella seconda metà del luglio ’57 al 17 marzo 1658. 15 Da subito, o quasi, i due giovani promessi cominciano uniti andare al letto. Sul loro affiatamento abbiamo in tutto poche intenerite parole di un amico di famiglia: «Vedevo questo gentil homo [Bellacato Bellacato] ...che molto amava la S.ra Anzoletta destinatagli per isposa, alla quale faceva carezze che Bastia. Bambini e bambine della Prima comunione fatta nel maggio 1938. 112 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei parevano fossero puttini»; puttini magari no, ma non fanno 35 anni in due. Ad una più ufficiale cerimonia nuziale in forma religiosa naturalmente si pensa, ma senza fretta: anche perché la Chiara Gazza, avanti che fosse sposata la S.ra Anzoleta sua figliola, teneva a risolvere una questione patrimoniale. Dai beni ereditari della figlia voleva in qualche modo scorporare ciò di cui era personalmente proprietaria, cioè la sua dotte e controdotte: come in effetti fece (direi alla fine d’agosto), assistita dal dottor Pochini (già Avocato del q. S.r Boatino suo congionto) e dal S.r Paulo Gragnoti proccurator, con l’incaminamento di quegli atti che si potranno veder nei pubblici registri. A sentire Ottavio Bellacato la Chiara agì in perfetto accordo con lui, che non voleva se non le sue sodisfationi. Lo contraddice (involontariamente, penso) il suo amico Giusto, che ricorda di aver cercato di mediare un vivace conflitto fra i due, e di aver parlato alla donna «per divertirla dall’intentione che haveva di voler ella star in casa del S.r Ottavio e manezar la sua dotte come gli paresse, che il S.r Ottavio non si contentava volendo contribuirghe un tanto all’anno». Tanto era disgustata la signora che minacciava di andarsene da quella casa portando seco la figlia, promessa o non promessa. Comunque sia, il pagamento di dotte, o, per essere più esatti, l’assicurazione del suo valore in beni stabili, l’ottenne. Veramente neanche Ottavio nega che ci siano stati momenti di tensione e minacce di sfascio della nuova famiglia: ma li riconduce ad altro motivo. La Gazza madre avrebbe voluto raddoppiare gli sposalizi, e impalmare personalmente lui, il Bellacato padre: in questo senso su di lui faceva pressione valendosi degli offici del giovane Bellacato. Al che rispose che essendo vecchio, né buono per donne, né bene asciutte le lacrime di sua moglie, non poteva in questo satisfarla. Sarebbe stata questa ripulsa a mandare in furia la madre, a farle esprimere il proposito di menar via la figlia. Se vuole andarsene lei, padrona, le si manda a dire, ma la Sig.ra Anzoletta era gia destinata in moglie al S.r Bellacato... e sopra la fede di matrimonio haveva dormito 40 e più notte con esso: non era il dover che la levasse. Troppo giusto, troppo evidente. Parve che la sudetta Sig.ra Chiara si acquietasse. Parve, ma da qui, ci vuol dire Ottavio, covò in lei l’avversione per quell’unione e per quella convivenza. Più o meno in quel periodo si trasferiscono in ca’ Bellacata dalla residenza di Bastia diversi mobili (la parola aveva un senso più ampio di quello odierno: si tratta qui soprattutto di biancheria), di cui si fanno valutazione ed elenco con l’aiuto di un tecnico stimador di monte (dei pegni), e la Chiara, ufficialmente investita del governo, riceve chiavi e liste dei mobili di casa. 16 Verso la fine d’agosto, o all’inizio di settembre, la Chiara vuole essere portata con la figlia nella villa che i Bellacati hanno a Tremignon, vicino a Piazzola, ove haveva inteso haver belle cose. Le due donne vi si trattengono con molto gusto e molto a lungo (aggiungeremo che è il momento della seconda lisia dell’anno, da farsi entro la fine della bella stagione), a periodi con qualcuno dei Bellacati, a periodi sole. Ottavio Bellacato, in particolare, alt ri p rom e ssi 113 deve seguire i suoi affari nelle numerose campagne che possiede (ha, per esempio, un’altra villa con relative pertinenze a Vigonza, nonché terre date in affitto all’Arcella e altrove), e deve inoltre recarsi a Conselve, di cui è stato eletto vicario. Di sicuro in settembre, diciamo verso o dopo la metà del mese, lo sposo Bellacato Bellacato è lì con Anzoletta, visto che la ragazza resta incinta. Quando ne sarà stata certa, e l’avrà comunicato? Non prima di novembre, si può supporre. Et essendo di già la Sig.ra Anzoletta resa gravida, la verità è che esso S.r Bellacato haveva deliberato per ogne buon termine di convenienza di voler che il S.r Bellacato suo figliolo sposasse la Sig.ra Anzoletta privatamente in detta villa; al che, se bene esso S.r Ottavio ne fece molte instanze, non volse mai condescendervi la Sig.ra Chiara, dicendo che essendo sua figlia gentildonna voleva che fosse sposata in città, il che causò dilatione di matrimonio. Due cose avvengono quasi contemporaneamente poco prima di Natale: le Gazze tornano a Padova (il 20 o il 21 dicembre), e Ottavio Bellacato viene arrestato e messo in prigione. Il che, dato il calibro del personaggio, autorevolissimo in Padova e investito proprio in quei mesi di un vicariato, deve discendere da imputazioni di gran peso, legate forse ai suoi incarichi pubblici. Per la terza volta un caso estraneo alla vicenda che qui si narra ne incrocia il percorso, e per la terza volta devo rammaricarmi di averne finora cercato invano altre tracce archivistiche. Se dispiace alla vostra curiosità, figuratevi alla mia. La detenzione comunque non divertì punto Ottavio dalla sua rissolutione, perché fece elevar un mandato episcopale, il Carneval del 1658, perché potesse essa Sg.ra Anzoletta sposarsi privatamente, et sarebbe seguito se la Sig.ra Chiara non si fosse oposta, dicendo che vol aspettare che il S.r Ottavio esche di prigione. Bastia. I catechisti e le catechiste diplomate nell’anno 1937 mostrano orgogliose la pianeta rossa con lo stemma vescovile, ricevuta quale premio per il terzo posto raggiunto nella graduatoria diocesana. 114 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei 17 Di prigione il signor Ottavio non uscirà più: ci morirà l’estate successiva, ma questo per ora nessuno può saperlo. Basta però la notizia del suo arresto a riaccendere mire e trame della vecchia nostra ostinatissima conoscenza, Giò Batta Breo. Così almeno ricostruirà i rapporti causali e temporali Bellacato Bellacati, lo sposo, nei suoi capitoli, esposizione ordinata per punti di fatti e circostanze su cui si chiede l’escussione di testi (era naturalmente opera di avvocati). Alla forzata assenza da casa del vecchio corrisponde l’introduzione di una presenza nuova, quella di una tal Gasparina che prende a frequentare quotidianamente le Gazze in qualità di cameriera non residente. Indovinate che cosa aveva fatto costei, che già era stata al servizio del Boattin, nell’intervallo fra la morte del vecchio padrone e l’assunzione del nuovo impiego? Ma era stata alle dipendenze del Breo, naturalmente: più come amante, si aggiunge, che come serva. Come sua agente in ogni caso viene insinuata nella casa stessa Bellacata e posta al fianco delle nostre donne, ed introduce alla loro dimestichezza pure una complice, una tal dona detta la Secha, moglie del cogo dei SS.ri Frizimelega, con la quale abita lì presso. Per questo doppio tramite il Breo si lavora le Gazze. Le loro seduzioni rinfocolano facilmente in Chiara l’avversione per la casa Bellacata e il desiderio di una piena indipendenza, così che tutte e tre si danno a pressare la giovane Anzoletta perché si convinca a mollare lo sposino e a cambiar sorte. La ragazza resisteva, che lei non si voleva partire dalla casa del S.r Pellacato in alcuna maniera perche lo teniva in conto de padre... che non voleva assolutamente far una cosa tale, che credeva esser amata e reverita da tutti, che non era di dovere usargli un affronto tale. Curioso che manchino, fra questi argomenti (stiamo seguendo, ve lo ricordo, la versione dei Bellacati), i due che ai nostri occhi sarebbero i più forti: voglio stare col mio sposo, e aspetto un figlio da lui. Bastia. Il gruppo delle missionarie ripreso nel 1938. alt ri p rom e ssi 115 L’assedio comunque non si allentava. Gasparina e la “Secca”, può testimoniarlo una vicina, uscendo al mattino di casa scherzavano fra loro: «Andiamo a conzar la testa alla S.ra Anzoletta», quasi volessero dire: a pettinarle il cervello. La testa della signora Anzoletta non è docile da conzare, se prestiamo fede a coloro che nel corso stesso dell’episodio cui tra breve assisterete (v. par. 18) la videro afflitta e mesta... pianger dirottamente, dimostrando contro sua voglia esser guidata dalla Sig.ra Chiara sua madre. Anche ad altre attività si dedicano, a quanto pare, la Gasparina e la “Secca”. Per esempio asportano a più riprese dalla casa, con la connivenza della signora Chiara, viveri e biancheria. Ma soprattutto, è da presumere, mediano un fitto scambio di messaggi fra la Chiara e il Breo. Trascorre intanto il carnevale sfiorando appena la casa il cui padrone è incarcerato. Una sera entrano in casa alcune maschere, le più belle maschere che si possi vedere, a scherzare con le signore. A posteriori si riterrà che fra di loro ci fosse il Breo. «Un sabbato de sera in tempo de quadragesima [il primo sabato di quaresima cadde quell’anno il 9 marzo: questa, o quella del 16, sono le uniche date possibili] ...capitorno alcuni sonadori sotto le nostre finestre», racconta Orsola, massara dei Bellacati; «sentij la S.ra Chiara dir verso sua figliola: vedito figliola che belle musiche, se dio vorà ghe ne haverai quante vorai... Io poi le dissi se conoscevano quelli sonadori, la S.ra Anzoletta me rispose: forse che sì che li conosco». 18 Alcuni mesi fa il S.r Bellacato Bellacato fig.lo del S.r Ottavio contrasse sponsali con la S.ra Anzoletta Gazza, et le donò conforme il costume de sposi una gargantiglia di gioie, le toccò la mano, la tradusse a casa come moglie, et havea già elevato mandato episcopale per poterla sposar in casa, che subito non si essequi per la prigionia del S.r Ottavio padre del sposo. Essendo in questo stato le cose, è seguito avenimento stravagantissimo; un tal Batta Breo, artigiano temerario sopra il credere, et che altra volta faceva il vago con la detta Anzoletta, le tese insidie et tentò rapirla, presa occasione opportuna dalla prigionia del sodetto S.r Ottavio, hieri, 17 del corente, ha con maniere infami fatte portar la Sig.ra Anzoletta et madre di lei in una casa vicina alla Bellacata scortandole con vinti in circa tutti armati d’arcobugi longhi et curti, et poi entrato in essa casa, che è della Sig.ra vedova Benedetti, ardi per forza far poner li cavalli della medesima sudetta sotto la carrozza, et quelle condusse dove più le piacque. Questo fatto gravissimo per tanti riguardi ha commossa la città tutta, vedendo un’artiggiano tanto ardire di levar con altissima ingiuria dalla casa di conspicuo gentil’huomo una giovane gentildonna sposa del figliolo; qual sij le conseguenze che succeder possono ben le comprende la somma sapienza di Vostra Eccellenza (il Podestà di Padova, cui è indirizzato lo scritto steso per conto di Bellacato Bellacato in data 18 marzo 1658), ma perché eccesso gravissimo resti con suprema autorità et con pena adeguata severamente punito nelle persone del raptore et compagni et complici, pertanto humilissimo il S.r Bellacato sposo supplica Vostra Eccellenza a restar servita di portare con sue questa sincera espressione di fatto all’Eccellentissimo 116 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Consiglio di Dieci a fine che si degni quel gran Sacrario delegare con autorità e rito a Vostra Eccellenza, o agl’Eccellentissimi Rettori con l’Eccellentissima Corte, il caso e tutte le cose connesse e consequenti... (l’iter qui auspicato si svolse in effetti sollecitamente, e già il primo d’aprile il processo era stato delegato dal Consiglio dei Dieci ai Rettori di Padova). L’idea dell’accaduto che vi siete fatti leggendo queste righe necessiterebbe subito di chiarimenti e correzioni di non poco conto. Non basterebbe a darveli un altro scritto che reca la stessa data e che vi risparmio, la denuncia portata all’officio del Malefficio da Zamaria Trevisan, capo di cento della Parrochia di San Pietro (l’equivalente in un distretto cittadino del degano in un paese): non basterebbe per l’ottimo motivo che la denuncia è ispirata dalla fonte medesima e dalla medesima intenzione dell’altro documento, pur evitando una palese falsità in quello contenuta (che il Breo avesse cioè fatto portar, con quel po’ po’ di scorta, le due Gazze in casa Benedetti). Il nodaro Giacomo Maggione, cui toccò, a seguito di tale denuncia, di avviare una prima istruttoria, si fece certamente un’idea più chiara dei fatti interrogando quel giorno stesso la signora Livia vedova Benedetti e la sua servitù. Sulla base soprattutto di queste testimonianze (prudenti, ma nel complesso abbastanza neutre) vi racconterò a suo tempo (v. par. 26), per sommi capi e per quanto possibile, quel che plausibilmente successe nella tarda mattina del 17 marzo 1658, domenica di pioggia. Ma il proposito che ho rispettato in questo capitolo era quello, ricorderete, di darvi una versione di parte; e voglio che dei fatti in esso narrati sentiate adesso l’altra, quella delle Gazze. Una tribulacion sopra grande 19 Torniamo a Bastia di Rovolon e a quell’ora di prima mattina del 25 giugno 1657, quando l’arrivo di Ottavio Bellacato e dei suoi quattro compagni sveglia la casa in cui le Gazze stanno dormendo. «Son il corvo delle male nove, perché vi do avviso esser statto hieri a 20 hore... amazzato il S.r Theodoro Boatino vostro cognato», esordisce il Bellacato. Già la vista in casa sua di tanti uomini armati d’achibuggi lunghi et curti18 aveva spaventata la signora Chiara, facendole sospettare qualche tradimento, o altro male; la notizia la sbigottisce del tutto, e scoppia in dirotto pianto misurando in un lampo la sua nuova solitudine e la sua nuova debolezza: «non havevo altri...». «Il Pellacato mi disse», continua Chiara, «che apresso quella disgratia le veniva ancor lui passione [traduciamo: che il lutto era anche suo], perché esso S.r Theodoro avesse promessa mia figliola per moglie a S.r Bellacato di lui figlio». Le due donne cadono dalle nuvole: questa è in merito la prima parola che sentono. «Ma lui repplicò esser questo verissimo, e lo fece anco attestare da quei altri S.ri, che coadiuvavano in persuadermi». Propone addirittura che le gentildonne traslochino subito in casa sua. «Noi povere donne timide», dirà Anzoletta Gazza, «non havessimo modo alt ri p rom e ssi 117 di opponersi a quanto lui asseriva perché oltre l’esser huomo et con quattro compagni haveva in aggionta lui et gli altri gli archibusi alla mano et il sig.r Ottavio in aggionta haveva le pistole18, alli altri non le vedessimo perché havevan le gabanelle»: insomma, di mettere in dubbio le sue parole non han coraggio. La madre finì col rispondere «che non sapeva cosa alcuna di questi tratati, ma che se era destinato dal S.r Dio quel matrimonio, ghe penserebbe e gli haverebbe mandat’a dire». Le donne resistono però, in quella giornata, sul punto del trasferimento. Quasi in risposta a questo (e non dunque a protezione da temute insidie del Breo: su queste non si troverà una parola nelle dichiarazioni delle Gazze) Ottavio lascia di sua iniziativa in casa loro il suo servitore armato: «per dar al mondo ad intendere d’haver lui preso possesso di casa mia, e levar forsi ad altri [al Breo?] il modo di trattarsi per matrimonio di mia figliola», dice Chiara19. Qualcuno, inspirato forsi da pietà (il servo stesso, secondo Chiara; gente di fora via, secondo altri) moltiplica le apprensioni delle signore Gazze commiserandole, perché erano cativi questi Pellacati, e però dovevano temere d’andar loro in casa. Sono angosciate, le due donne, «Povere noi, che sarà di noi, andar in casa di gente non conosciuta, e non haver alcun del cuore», eppure in quella casa vanno davvero, forse un mese dopo quella mattina di giugno. Il passaggio in ca’ Bellacata non vien preceduto, nel loro racconto, da sponsali di sorta, il che rende una decisione del genere ancora più difficile da spiegare: loro parlano di impossibilità di resistere alle pressioni di Ottavio – soprattutto dopo che egli, agli occhi del mondo, le aveva già compromesse insediando il suo salariato in casa loro. Ribadisce Angela: «Ero necessitata dalla reputazione, havendomi lasciato il sig.r Bellacato in casa un suo soldato quando vene a Bastia. Religiosi in posa il 13 luglio 1937 in occasione della prima messa solenne del parrocchiano don Ampelio Montemezzo. Da sinistra a destra in prima fila: padre Eusebio o.f.m., don Ampelio - sacerdote novello, il parroco e un sacerdote ferrarese. In piedi: il chierico Ottorino Tubaldo, don Antonio Forestan, don Antonio Fraccaro - cappellano, don Vittorio Furlan. 118 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei trovarmi, e con questa forma fece conoscere al mondo il possesso che haveva sopra di me». Le due donne si troverebbero già dunque su di un piano inclinato difficile da risalire, necessitate dal bisogno di recuperare la reputazione a compiere atti che le faranno scivolare via via più lontane da tale obiettivo. Qualche cosa che nella deposizione delle Gazze manca, e trapela invece da quelle dei testimoni da loro stesse indicati, può aiutarci a comprendere appena un po’ di più: andare in casa di Ottavio Bellacato parve alla Chiara e a sua figlia il male minore (semplicemente per la condizione loro di donne indifese, senza più parenti che facessero per loro, o per qualche meno indefinita minaccia?). È certo che non usò lui (il Bellacato) alcuna forza, né di parole né di fatti; la servitù di casa ricorda le parole della padrona quel giorno, fra le lacrime, che «bisognava che andasse... con li Bellacati perché era sola, essa S.ra Chiara, né sapeva a che banda buttarsi per li fatti suoi». 20 Roma. Un gruppo di parrocchiani di Bastia in pellegrinaggio alla Città Eterna. Nella nuova casa e nella nuova condizione Chiara appare, attraverso le sue parole stesse, occupata immediatamente ed essenzialmente da un problema: mettere al sicuro la sua dote, facendosela garantire dalla figlia su beni immobili. L’Angela prontamente condescese a domanda così giusta. Ne abbiamo già parlato, e conosciamo all’incirca tempi e modi in cui questa faccenda si concluse. Avevamo anche già intuito che su questo punto era nato un robusto litigio col vecchio Bellacato. Ora apprendiamo che Ottavio fece dire in proposito ad Anzoletta che guardasse a non far niente, perché ne sarebbe per provare una cattiva vita. Anzoletta, proprio come un anzoletto, voltatasi à guardar il cielo, disse: «Pazienza, Sig. ra madre, non dubitate, che se mi scorticassero voglio farvi la quietanza». Ad ogni alt ri p rom e ssi 119 buon conto, per far venire in casa il Grignoti ed il Pochini (cfr. par. 15), le donne aspettano che sia fuori la città il vecchio insieme col figliolo, per mettere all’ordine di andar a Conselve, cioè per preparare il suo soggiorno colà in veste di vicario (cfr. par. 16). Conselve dista pochi chilometri da Arre. Forse in quell’occasione il Bellacato fece una visita che gli stava a cuore: «vene a Arè il vechio, il S.r Ottavio,... ch’era puoco tempo ch’era vicario a Conselve, e si fece riconoscere per padrone dei beni di quelle S.re perché fece me e gli altri lavoratori fatticar nel cavar fossi alle possessioni della sig.ra Chiara, onde da questo argomento che possi haversi impadronito anco del resto della sua robba», racconta Pasqualin Ferro, affittuale delle Gazze. Come padre dello sposo di Anzoletta Ottavio assume de facto l’amministrazione dei suoi beni, nonché quella di alcune chiesure, sempre ad Arre, di proprietà di Chiara, e riscuote da quel momento tutte le loro entrate. Se vogliamo a questo punto parlare anche di faccende minori, perché Chiara non è donna da passarci sopra, ella ricorda che poco dopo, avendo fatta portare la sua roba da Bastia, di essa fu fatta valutazione attraverso persone scelte da Ottavio, «senza l’inserimento di alcuno che facesse per me, che poi finita la stima di tutta detta roba la mandò subito a Conselve, per fornire la casa del vicariato suo». Ma non sono queste ormai le preoccupazioni dominanti delle due donne: non sarebbe tempo di pensare alle nozze? Ad altro pensa il giovane Bellacato («lasciò star d’andare a dormire con mia figliola, tenendo in più veneratione la sua puttana»20). Ottavio, in questo agosto-settembre, va su e giù da Conselve, ma promette che lo sposalizio presto si farà; anzi la stessa faccenda dei mobili di Bastia trasportati prima a Padova e poi nella sede del vicariato era stata in origine presentata come trasloco del corredo per la sposa: «mandò alla Bastia... per portar in città le nostre robbe ciò è biancarie e fornimenti della casa d’ogni sorte volendo far la stima alla putta, e sposarla al suo figliolo». Invece Ottavio e Bellacato portano le donne a Tremignon, nella loro villa, dove si celebrerà intanto il rito della lisia; dopo qualche giorno se ne vanno per essitar del frumento, promettendo di tornare di lì a poco per la celebrazione di quell’altro rito. «In loco di ritornarvi, non s’è più veduto né il vechio né il figliolo né altri di casa». 21 La vita delle due signore in villa (ci rimarranno, lo sappiamo, fin oltre la metà di dicembre) assume di giorno in giorno, nella relazione che esse ne fanno, i caratteri da incubo dell’esistenza in un lager, quasi una sadica punizione per l’affare della dotte di Chiara; e ricorderà del resto anche Angela che Ottavio le aveva «fatto dire... che se io facevo quietanza alla Sig.ra Madre per il suo mariozzo mi voleva [far] fare una vitta da cani: in somma non mi à promesso se non la verità». Sono lì con i loro abiti leggeri da estate, ma la stagione avanza ed il clima si fa precocemente invernale. Mancano in villa provviste di mangiare, di legne, sale 120 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei e di tutto quello che fa di bisogno al sostentamento d’una casa, massime d’inverno così rigoroso; restano senza esito le richieste di soccorso che fan pervenire ai Bellacati attraverso i contadini della villa. Da questi sono state costrette a tior ad imprestito il cibo, «passendoci nel viver di raveti la sera e la mattina de verze, che si può dire spiantassimo tutto quanto vi era in quell’orto». La loro odissea di fame, di freddo e di abbandono è assai ridimensionata dalla deposizione di una testimone da loro stesse prodotta21, ma che le due patissero non v’è dubbio, lasciate com’erano in quell’attesa interminabile, a pianger la loro mala fortuna, et maledire chi era causa di queste crudeltà e tirannie, con Angela certa ormai della sua gravidanza che si chiedeva se le nozze promesse sarebbero arrivate mai, e quando pensava di no certo si disperava, e quando pensava di sì non so quanto se ne consolasse. Forse in quel periodo (più tardi, secondo il racconto della madre) la ragazza si ammala, tanto che finisce per trovarsi in letto quasi stroppiata. 22 La facciata della chiesa di Bastia. L’arresto di Ottavio Bellacato appare a Chiara come una speciale provvidenza di Dio mirata al loro ristoro: e subito in effetti viene a prelevarle dalla terra d’esilio il giovane Momolo. Ma del rientro nel palazzo di via san Pietro non avran motivo di rallegrarsi: pessimi maltratamenti, una vera reclusione («non lasciandoci mai uscir di casa ne anco per andar alle chiese»), comportamenti ingiuriosi («conducendoci il S.r Bellacato sotto li occhi diverse volte meretrici, strappazandoci con parole di tutto dispregio»). Ora che Angela è incinta ed ha più che mai bisogno di farsi sposare la condotta di Bellacato Bellacato, che ne ha in pugno la sorte, si fa nei suoi riguardi insopportabile22. Torna sì (non si sa per quanto) a dormire con lei, e con l’occasione, secondo la madre, l’empì di male di rogna, scolamenti et altri sporchezzi, sempre che non l’avesse fatto prima, com’è opinione di Angela, la quale aggiunge all’elenco il mal francese: auguriamole che almeno questa, che ha tutta l’aria di essere un’autodiagnosi, non risultasse poi confermata. Alle quotidiane, imploranti richieste la risposta, da dilatoria che era, si fa apertamente ricattatoria: il giovane Bellacato è stufo di giocare a carte coperte e dichiara fuori dai denti che se vuol essere sposata la ragazza deve prima fargli donazione formale dell’intero patrimonio. «Quando io mi vedevo crescere il ventre, essendo gravida di lui, lo stimulavo perché si facesse questo matrimonio: mi rispondeva che non voleva far cosa alcuna, se non le donavo il mio. Io le rispondevo che non volevo alt ri p rom e ssi 121 privare la creatura che havevo nel ventre ne la mia persona della propria robba, e lui mi rispondeva che non voleva far altro, et gettava il mandato episcopale su la tavola et diceva: Vedetelo là, quella è la licenza di sposarvi, ma cospettonazzo, e sanguinazzo, con l’aggionta di Dio, io mai vi sposerò se non mi fatte questa donatione». O, se preferiamo sentirla raccontare dalla bocca della madre, «altro non mi rispondeva che d’esser matta e inspiritata, e finalmente nel repplicarli queste instanze, messe mano in scarsella dicendo: Ecco qua il mandato per il sposalizio, ma non voglio farlo, voglio andarmene a forbir il cullo, se volete che la sposi voglio che mi facci donatione di tutto il suo». Stiamo seguendo qui, non lo dimentichiamo, la storia come le Gazze la raccontano: ma, indipendentemente dalla sua verità, qual è la sua logica? Che ai Bellacati interessassero i beni di Anzoletta e non altro l’avevamo capito subito (lei poveretta ci è arrivata poi, dal tono con cui dice: «veramente conosco che la mia robba mi ha fatto fortuna, et li SS.ri Bellacati solo sopra quella designavano e di quello erano invaghiti»). Ma non bastava sposare la ragazza? Questa dev’essere stata, in effetti, la loro prima intenzione: forse è stata modificata nell’attimo stesso in cui appresero della morte di Teodoro Boattin, forse nel corso del mese che separa tale decisiva circostanza dall’inizio della convivenza, o forse persino più tardi. Sta di fatto che nella mutata situazione videro l’opportunità di avere i beni più direttamente e più pienamente. Angela, anche da maritata, sarebbe rimasta proprietaria della sua eredità paterna; non avrebbe potuto disporne liberamente, sarebbe stata sotto la tutela del marito (così credo, almeno), ma l’amministrazione di quest’ultimo sarebbe stata a sua volta sottoposta a vincoli precisi. I figli di Angela e di Bellacato sarebbero a tempo debito diventati padroni di quella robba, Bellacato mai. Dal punto di vista della strategia patrimoniale della famiglia non faceva differenza. Dal particolare punto di vista di Bellacato, ed anche di suo padre Ottavio, la differenza era straordinaria. 23 Il nuovo soggiorno a Padova (durerà, come sappiamo, tre mesi meno tre giorni) non significa neppure, nel racconto delle Gazze, la fine dei disagi materiali. Fin dal loro primo ingresso in casa dei Bellacati le entrate delle loro campagne son rimaste nelle mani di costoro, e loro due sono al verde, tanto che devono farsi prestare poche lire da qualche affittuale che adesso, a Carnevale, va a trovarle per portar loro le tradizionali onoranze di pollame: benedette onoranze, perché anche di vitto han scarsità, per non parlar d’altro. «Io addimandavo al Sig.r Bellacato, che credevo essere mio novizo, qualche suffragio sì per il mangiare come per vestirmi», racconta Angela, «e lui sempre su le sue mi rispondeva che cospetazo... non haverei havuto niente se non li facevo la donatione». Intanto le condizioni di salute della ragazza si aggravano, ed essa si trova «in statto così deplorabile,... che dubbitando io [Chiara, naturalmente] potesse intravenirgli anco la morte, perché si era ridotta imobile et a segno che io la voltavo con li lenzuoli, dissi però a lui [B. Bellacato] che si raccordasse di Dio, 122 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei la sposasse come haveva promesso, acciò che non la morisse in quel peccato mortale e che andasse a ca’ del diavolo». Che la meschina sia proprio malridotta non lo sappiamo soltanto da lei e dalla madre, perché anche altre persone l’han vista in quel periodo: la Teresia, per esempio, da Carbonara (un miglio discosto da Bastia), filatrice di lino, solita lavorar per le Gazze («secondo mi davano da lavorare li portavo il fillo, et ne tollevo il lino a far dell’altro»). È andata con un’amica a trovarle a Padova, a febbraio, portando loro in omaggio la prima insalata selvatica dell’anno, quei ramponzoli che ancor oggi negli Euganei si ricercano come una ghiottoneria: «vedendo la Sig.ra Anzoletta in statto totalmente diverso da quello che godeva in villa, dove era sana et gagliarda, e qui in città la vidi piena di rogne e di male, che teneva tutti due i brazzi appesi al collo, mi fece compassione... veramente era in una cadrega imobile, che bisognava sua madre le dasse il bocon in bocca, poiché non poteva meno tener un pirone in mano». Si teme che possa disperdere, abortire; una levatrice è chiamata a visitarla e le fa con l’occasione un rimedio da onzersi, penso per le infezioni cutanee (rogna) di cui soffriva. 24 Angela, sofferente ed angosciata, si dibatte in una trappola che la tien prigioniera più assai che le stanze da cui non la fanno uscire. La sua reputatione le è stata tolta, e solo chi gliel’ha strappata può restituirgliela con il matrimonio: riuscire a farsi sposare è l’unico obiettivo cui può tendere, e la gravidanza deve darle motivi ed urgenze in più per volerlo raggiungere. Perché non fa donatione di tutto il suo, perché non cede al ricatto? Il giovane Bellacato, che un’aquila non doveva essere, era sicuro che si sarebbe sottomessa alle sue condizioni. Perché lei non l’ha fatto? Voi l’avrete già capito, l’avevo capito già anch’io, ma facciamolo dire a lei: «Dio le [= a Bellacato] ha levato il cervello, et ha permeso che lui habbi multiplicato tanto verso di me le ingiurie, disperandomi che potessi recuperare l’honore, che mi son risolta a partire da casa sua, e certo eleggerei prima la morte che tornargli». Disperandomi che potessi recuperare l’honore: non ha ceduto perché aveva perso ogni speranza che cedere potesse servire. Il mandato episcopale che il suo promesso le sventolava sotto il naso era, l’aveva capito, solo uno specchietto per allodole, e non credeva che Bellacato l’avrebbe sposata, quando lei si fosse piegata al ricatto. Anzi, cominciava a pensare che una volta impadronitosi di tutto il suo l’avrebbe volentieri lasciata morire, se la malattia o il parto l’avessero condotta in pericolo di vita («se partorivo in casa sua certo sarei morta»), o temeva che l’ammazzasse addirittura («altro non era ricercarmi la donatione che il volermi privar di vita con morte violenta»). Rifiutarsi di sottoscrivere la donazione doveva apparirle in quei giorni, prima ancora che una difesa dei diritti del nascituro (v. par. 22), l’unica garanzia possibile per la sua stessa vita: finché non ho fatto la donazione non gli conviene che io muoia. alt ri p rom e ssi 123 La Gasparina deporrà, liberi noi di crederle, di esser venuta a conoscenza di una conversazione fra Bellacato e Momolo, in cui quell’ebete del fratello maggiore chiedeva al minore una consulenza di diritto patrimoniale (Momolo doveva raccontarla in giro per casa come quella barzelletta che era): «Una mattina il Sig.r Girolimo disse alla mia presenza che suo fratello l’haveva ricercato se, morendo la Sig.ra Anzoletta, le restaria la robba, non havendola sposata, e lui le disse di no». 25 Nella versione che ne danno le Gazze, la loro uscita da casa Bellacata è solo la fuga da qualcosa, non verso qualcosa, un puro riflesso di autoconservazione. «Non potendo più mia figlia insistere alle tiranidi d’huomini così crudeli... e vedendosi anco avvicinata al parto con pericolo di perdere la vita senza confessione né comunione, si rissolse di partire, e ancorché io la suadessi di distrarsi da questo pensiero, non volle assentire: uscì una mattina come disperata, la seguitai anch’io per non abbandonarla. Andassimo dalla S.ra Benedetti con gasparina23 nostra camariera, quale mandassimo a trovar il S.r Z. Batta Breo, come amorevole del q. S.r Boatino, perché venisse a levarci da quella casa, dubbitando che se incontrassimo nei Pellacati ne potessero amazzare. Non lo trovò a casa, ma ben due dei suoi soldati [servitori], che non li conosco né so li suoi nomi, quali vennero a casa della Benedetti, la quale imprestataci la sua carozza partissimo; e mentre erimo in piazza del Castello s’incontrassimo nel Il centro di Bastia con il vecchio Ufficio Postale in una cartolina illustrata spedita nell’estate 1931. 124 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei S.r Breo medesimo, che vene accompagnarci fino al ponte de legno, prendendo alloggio in casa d’un nobile non so chi sia. E la mattina andassimo a Venezia, facessimo ricorso nell’Eccellentissimo Consiglio di Dieci...». Lasciatemi per ora soltanto sottolineare in rosso quei due “Sior” davanti al nome del Breo: chi li avrebbe potuti immaginare, un anno e mezzo prima, in bocca a Chiara! Non un lieto fine, ma poteva finir peggio 26 In bicicletta davanti alla chiesa di Carbonara, negli anni dell’ultimo dopoguerra, quando il campanile attendeva ancora la cuspide. Vi avevo promesso una più attendibile ricostruzione del fatto clamoroso del 17 marzo 1658, che abbiamo sentito raccontare in modi tanto diversi dalle due parti in causa. Eccovela. È mezzogiorno passato. La vedova Benedetti, signora Livia, è andata con la sua carrozza alla predica al Domo. Quando bussano al suo portone una domestica pensa che sia lei di ritorno ed apre subito; entrano senza neanche dire si può Chiara ed Angela Gazze, accompagnate da una cameriera (la Gasparina). Abitano lì accanto, han fatto solo pochi passi sotto i portici. La padrona è in casa? Sarà qui a momenti. «Andorno di sopra nella salla e mi ordinarono che non dovessi aprire la porta della strada se non sapevo a chi». La vedova Benedetti arriva e si meraviglia di sentire che è attesa di sopra dalle Sig.re Bellacate (dice proprio così): non sono evidentemente abituate a frequentarsi. Le due fecero una grandissima scusa per quell’invasione, e dichiararono all’attonita vicina di essere scampate via perché non erano sposate et che volevano Giustizia essendo malissimo tratate, et che aspetavano una carozza. La Gasparina era intanto uscita dalla stanza: rientra per dire alle padrone che la carrozza non è disponibile, ma è arrivata parte delli huomeni per riceverle. Tutte e tre si volgono alla Livia, chiedendo che presti loro la sua vettura. Ma quella nelle liti familiari dei vicini non ha intenzione di immischiarsi: «Io le dissi di no, né che volevo adosarmi questo negotio». Al rifiuto della vedova la Gasparina ridiscende e fa entrare in casa due uomini armati, che riattaccano di mano propria i cavalli da poco staccati alla carrozza che è ancora nel cortile e ordinano di tornare in serpa al tremante cocchiere della Benedetti. Assicurano a quest’ultima che non subirà alcun danno et di breve il caroziero sarebbe ritornato in dietro con li cavalli et carozza, fanno salire in vettura le Gazze e la loro cameriera, e via: non dall’ingresso principale, ma da quello posteriore, drio la mura (casa Benedetti si estendeva, come si comprende facilmente, fra le attuali via san Pietro e riviera A. Mussato, incorporando alt ri p rom e ssi 125 dalla parte di questa una porzione delle mura medievali). Uno dei due uomini precedeva la carrozza; quando questa uscì, altri tre la tolsero in mezo. Tutti e cinque sono intabarati nei loro feraroli, sotto i quali il povero caroziero («a pena ardivo alzar l’occhi per paura») intuisce gli schioppi imbracciati a canna in basso. Dove si va? a S. Maria di Vanzo, al Torresino diremmo oggi, per le riviere e il Castello. Intanto ribussano a casa Benedetti, dalla parte di via san Pietro. Stavolta, ovvio, prima di aprire la servitù chiede chi è. «Gio Batta Breo», vien risposto. Noi che lo conosciamo abbiamo già notato questa sua spavalderia, di dir forte il suo nome e cognome in situazioni compromettenti. Non lo conosce invece la signora Livia, che equivoca: «Pensando io che fosse qualche hebreo che volesse parlarmi, ordinai che fosse aperto, et uno si affaciò sopra la mia porta della strada ricercando se quelle donne fossero partite, et li fu risposto di sì; il quale disse di non voler altro» e se ne andò. Due compagni erano al suo fianco: un drappello che vegliava su quel lato, il più pericoloso, e che, accertatosi della riuscita dell’operazione, correrà a raggiungere la vettura procedente a passo d’uomo (può ben essere a piazza Castello, probabilmente attraverso un percorso interno alle mura antiche). Nessuno o quasi vede la carrozza col suo corteggio: è domenica, piove ed è l’ora di pranzo, le strade sono deserte. Quel che si ricava da questa ricostruzione ha un significato non equivoco: nessun rapimento è avvenuto, piuttosto una fuga minuziosamente predisposta e coperta da un robusto ed accurato dispositivo militare. Siamo lontani dalla cifra di vinti in circa tutti armati, ma gli otto uomini dai nervi calmi e ben appostati che contiamo attraverso le testimonianze sono una forza sufficiente ad arrestare qualunque reazione proveniente da casa Bellacata; ottimamente svolti i compiti di collegamento dalla staffetta Gasparina. Probabilmente davvero all’ultimo momento una carrozza che era prevista viene a mancare. Vi sembrerà forse indizio di organizzazione approssimativa; ma, com’è noto, ogni buona previsione deve tener conto dell’imprevisto, e più dell’incidente colpiscono la decisione e la prontezza con cui vien trovato il rimedio. Tutto il carattere dell’azione, rapida, pulita, senza strepito, è quasi da corpi speciali, direbbe mio figlio che guarda la televisione; se non condividete, è perché v’è mancata l’occasione di farvi un’idea di che pasticcioni fossero in genere i giovanotti dell’epoca, quando si trovavano un archibugio in mano. Davanti al vecchio campanile di Carbonara, negli anni tra le due guerre. 126 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Sulla meta della carrozza disponiamo di indicazioni insieme molto precise e molto misteriose. Oltre il ponte che da piazza Castello conduce verso il Torresino (ponte di S. Maria di Vanzo), la carrozza svolta per l’attuale via Tiso di Camposampiero dietro l’acqua che va in Cademia (piazza Accademia Delia), e passato quelli segadori di pietre si ferma ad una casa che al presente vene fabricata. Nel palazzo in costruzione (proprietà di un nobile di cui nessuno dirà il nome, e che del resto non era tenuto a saper nulla della faccenda) le donne trascor- Lettera del sindaco di Rovolon del 26 agosto 1870 al Commissario Distrettuale di Padova sull’ampliamento della chiesa parrocchiale di Carbonara reso necessario «da eminenti riguardi di religione, di moralità e di pubblica igiene in forza della raddoppiata popolazione». Con la missiva si comunica l’impossibilità di contribuire alla spesa essendo il comune «uno dei più miserabili che appena può sostenere le spese d’obbligo imposte dalla legge» alt ri p rom e ssi 127 rono il pomeriggio e la notte: la mattina dopo partono per Venezia, con il Breo. Nella Dominante la Chiara domanderà giustizia per sé e per la figlia alla suprema autorità del Consiglio dei Dieci. 27 A partire dalla denuncia del capo di cento della Parrochia di San Pietro, dalla 128 Giustina Michelazzo con la figlia all’alba degli anni Sessanta del secolo scorso in una casa a Carbonara. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei contemporanea istanza di Bellacato Bellacato al Podestà, dal ricorso di Chiara Gazza al Consiglio dei Dieci si incrociano azioni legali, che vengono unificate pochi giorni dopo nel processo delegato ai Rettori di Padova. Causa assai complessa, insieme penale e civile, generatrice d’un ponderoso incartamento, cui fu allegato, su richiesta dei Bellacati, anche il fascicolo relativo all’attentato rapto del settembre 1656, quello del primo capitolo. Sul piano penale, i Bellacati agiscono contro il raptore della promessa sposa (il Breo), i suoi non identificati compagni e gli altri complici (la stessa madre Gazza, Gasparina, la “Secca”); le due gentildonne chiedono che i Bellacati siano puniti per l’inganno e per le angherie che le hanno costrette a subire, e per l’usurpazione che han compiuta di quanto era loro. Sul piano civile, le Gazze chiedono di essere reintegrate nel possesso dei loro beni stabili e mobili di cui la controparte s’è impadronita, e rimborsate per le entrate che sono state loro sottratte. Non seguirò passo passo la vicenda giudiziaria, che si prolungò almeno fino all’estate del 1660: ho già posto a rischio eccessivo le mie competenze nelle pagine precedenti, temo che alle sciocchezze che già mi saranno scappate ne aggiungerei di troppo grosse scendendo sul terreno tecnico-procedurale, e poi comincerete ad averne abbastanza. Per dirvi subito come andò a finire: sul piano penale, il processo manca di qualsivoglia conclusione (non è impossibile che le parti abbiano ritirato le rispettive querele). Su quello civile la vittoria delle Gazze fu piena almeno in via di principio: Chiara rientrò subito in possesso dei suoi immobili, per quelli di Angela fu il 15 aprile 1658 estratto a sorte et elletto Daniel Sala (uno dei Sedici del Consiglio minore di quell’anno) che li amministrasse con carità et amorevolezza a gli avantaggi della medesima; per il recupero delle entrate, del bestiame, dei mobili perduti dovettero penare di più, e non so se riebbero tutto. Risultato comunque mirabile: alla prospettiva di vedere in altra forma puniti i loro avversari è probabile che le nostre gentildonne non avessero mai veramente creduto, data la disparità di forze fra le due parti. 28 Chiara Gazza, in data 7 aprile 1658, 20 giorni dopo la fuga, rivolge una supplica ai Rettori affinché la provvedano di avvocato: poiché, spiega, «non ho potuto ritrovarne alcuno che non si dichiari preocupato [già impegnato, cioè] alt ri p rom e ssi 129 dalla parte dei miei prepotenti adversarij, o per rispetti [per paura] della loro formidabil tirannide non poter ne voler diffendermi». Ci guarderemo bene dal prenderla alla lettera: sarà già successo anche a voi di pensare che la signora sapeva mentire con disinvoltura ammirevole, e qui è chiaro il suo scopo di impressionare i giudici a proprio favore. Direi che la mossa doveva esserle stata suggerita dal Pochini, già avvocato del defunto cognato, che per non fare uno sgarbo aperto ai Bellacati avrà preferito farsi incaricare dai Rettori del patrocinio di Chiara piuttosto che assumerselo liberamente: e lo penso perché l’“estrazione a sorte” di un avvocato, avvenuta l’8 aprile, vide uscire proprio il suo nome (non chiedetemi come avrà fatto), e perché la vecchia volpe, ottenuta in tale occasione per maggior coadiutamento la nomina al proprio fianco di un secondo avvocato, Gasparo Todiscato, seppe far sì che fosse poi sempre il nome di questi a comparire in tutte le occasioni (riservando a sé, immagino, compiti di regia). Ma, se anche son giuste queste supposizioni, proprio se queste supposizioni sono giuste, salta agli occhi il peso di un “fattore ambientale” che gioca ad intero vantaggio dei Bellacati, nonostante che questi stiano passando i loro guai, tanto che Ottavio la sua ricostruzione dei fatti davanti al Cancelliere pretorio la fa estratto dalle Carceri ove per altra causa s’atrova. Forse le Gazze qualche alta protezione l’avevano a Venezia (Teodoro Boattin, ricorderete, pensava d’averne); quando non ce l’avesse avuta Giovan Battista Breo, affittuale del cardinale Bragadin. Ma a Padova l’isolamento di Chiara, priva d’appoggi nell’ambito del suo parentado e dell’intera sua classe, è totale. Sei illustri membri della miglior società padovana sfilano a deporre chiamati dai Bellacati (sei perché basta così, per carità, ma ce n’erano in lista almeno il doppio): ad essi le Gazze non han da contrapporne, del loro ceto, uno che sia uno. Possono far venire contadini e gastaldi, filatrici di lino e servi: le stesse persone che si ricordavano di loro quand’erano in ca’ Bellacata, Carbonara. In gruppo davanti alla chiesa. 130 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei dove non risulta che una sola Sig.ra degna di questa sigla sia passata mai per dar loro un salutino. Una solitudine da lebbrose: si dirà che dipendeva dalla poco onorevole condizione in cui si trovavano in quella casa; sarà, ma le radici son più vecchie. Comunque dobbiamo riconoscere che le mosse di Chiara, o di chi la consiglia, sono molto abili, a cominciare da quella di appellarsi direttamente al Consiglio dei Dieci, invocando la sua protezione sopra due sventurate che hanno lasciato in casa dei loro traditori la robba e la reputatione, due povere donne nobilmente nate, deboli per il sesso, abbandonate da parenti per spavento, destituite da ogni sussidio humano, una delle quali deflorata, mai sposata,... strappazzata dal Pellacato per il corso di dieci mesi continui con il più turco trattamento che mai sia stato usato nel mondo, nonché gravida. Pensate che andandosene dalla casa delle loro tribolazioni le due Gazze presero con sè alcuni gioielli (sono quelli, io credo, che Bellacato Bellacato regalò all’Anzola il giorno del “toccamano”, quel “toccamano” di cui le due gentildonne non sanno nulla). A sentir loro, non portarono nient’altro con sè, solo le strazze che ancora indossano, che non vagliono tre gazete (a sentire i Bellacati, invece, tramite il lavoro da formichine della Gasparina e della “Secca” gli avevano già prima più o meno svaligiato la casa). Bene, proprio mentre lamenta la radicale miseria sua e della figlia incinta, spogliate, annientate, rimaste senza una mica di pane per alimento, di quei gioielli (che saranno stimati quasi 700 lire) la Chiara fa un bel pacchettino, e lo spedisce al Consiglio dei Dieci: «questi, non dati come regali di marito, non ricevuti come indegni pagamenti di concubito, si presentano con integerrima ingenuità a’ piedi dell’Eccellenze Vostre». 1964. Festa di famiglia per il venticinquesimo anniversario di matrimonio di Giovanni Paccagnella e Bruna Giona. alt ri p rom e ssi 131 29 Volete sapere che ne è stato della creatura che Angela aveva in grembo? Vorrei saperlo anch’io. Quel che so dirvi è che il 5 giugno 1658 Angela si dichiara prossima a sgravarsi (facendo conto che abbia partorito entro quel mese ho ipotizzato al par. 16 la data del concepimento). Se il parto sia andato bene, se il bambino sia o no rimasto con la madre, chi lo sa. Un’altra cosa posso dirvi invece con sicurezza. Il 13 novembre 1659 Angela si confessa, nero su bianco, ...intieramente sodisfatta della somministracione [amministrazione] de suoi beni, fatta dall’Illustrissimo Sig.r Daniel Salla Comesario elletto dalli Illustrissimi Eccellentissimi Retori; adesso, avendo alfine reseutto tutta la roba di sua ragione...si chiama paga sotisfatta in fede. Il bigliettino reca poi: «Io Gio Battista Breo maritto di essa S.ra Anzoletta ho fatto il presente di propria mano per non saper lei scrivere». Avesse lei saputo scrivere, non avremmo magari neanche saputo che si era sposata col Breo. Avremmo dovuto accontentarci di supporlo, lavorando sui materiali forniti dalle contrapposte versioni che abbiamo ascoltato e provando a migliorare l’interna plausibilità della nostra storia. 30 Quanto all’avvio della vicenda, mi piacerebbe moltissimo poter avanzare l’ipotesi che i Bellacati, messi gli occhi sull’eredità dell’Angela Gazza, avessero colto al volo l’occasione che la morte del Boattin offriva loro per precipitarsi a Bastia, millantare un’inesistente promessa che nessuno poteva più smentire, trascinare le Gazze nella loro trappola. Il che sarebbe fondamentalmente quel che le due signore vogliono far credere. Non mi dispiacerebbe spingermi più in là, ed insinuare che essi potessero aver avuto una qualche parte nell’uccisione del povero Teodoro, o anche solo che sapessero in anticipo che essa sarebbe avvenuta, il che spiegherebbe meglio la fulmineità della loro mossa del 25 giugno 1657. Purtroppo non posso far niente di tutto questo, perché le lettere di pugno del medesimo Teodoro, che il Verdabio consegna all’inquirente (cfr. par. 11), me lo impediscono. Ho preso in considerazione, naturalmente, l’ipotesi che si tratti di falsi, ma non riesco a crederci. Chi avesse architettato e realizzato una simile impostura sarebbe stato diabolicamente bravo (sarà forse l’invidia che proverei per un simile romanziere che mi vieta di prender sul serio l’ipotesi della sua esistenza). Le lettere mi sembrano troppo vere, troppo attraversate da un disordine di preoccupazioni estranee alla trattativa matrimoniale ma inevitabili per il povero Boattin coi guai che si ritrovava, per considerarle una costruzione a posteriori di altra persona. Escluso a malincuore questo quadro, seducente ed impossibile, dirò che per la prima metà del ’57 quello disegnato da parte dei Bellacati mi sembra nelle linee di fondo assai più credibile di quello tracciato dalla controparte. In altri termini, sono incline a credere che la trattativa matrimoniale si sia effettivamente svolta con il consenso delle signore Gazze; che esse, rima- 132 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei ste improvvisamente prive dell’uomo di casa, abbiano proceduto sulla via già tracciata senz’altre esitazioni forse che quelle ispirate dalle chiacchiere raccolte nel frattempo (queste sì plausibili) sulla cattiveria dei Bellacati; che gli sponsali ci siano effettivamente stati; che nella decisione delle due donne di partir da Bastia e di prender dimora a Padova non nella casa Gazza ma in quella Bellacata molto abbiano pesato i timori (saranno anche stati soprattutto della madre, questo non cambia nulla) per le insidie del Breo, che minacciavano di mettere definitivamente Angela fuori di un mercato matrimoniale degno di lei. 31 Ancor meno credibile è quanto raccontano le Gazze sulle modalità della loro fuga, e su questo non occorrerà che mi dilunghi. Le evidenti bugie circostanziali non devono però distrarre dalla verità sostanziale che le loro parole contengono. La loro fuga non sarebbe in alcun modo comprensibile se non fosse suggerita dall’esasperazione, dalla disperazione e dalla paura, da quella condizione d’animo su cui le parole di Angela, più di quelle della madre, ci hanno aperto spiragli eloquenti: ma anche da una lucidità a caro prezzo conquistata. Che Bellacato Bellacato intenda sposare la ragazza, né lei né sua madre possono più crederlo; ma ormai, fosse anche possibile, non lo vorrebbero loro. Tanto che neppure in sede processuale, quando la strategia scelta dai loro avversari offrirebbe l’appiglio per spingerli a quel matrimonio (la promessa costituita dagli sponsali era una cosa seria), appaiono mai sfiorate dal dubbio: «mi son risolta a partire da casa sua, e certo eleggerei prima la morte che tor- Carbonara. Corteo nuziale degli anni Sessanta del secolo scorso. alt ri p rom e ssi 133 nargli» (Angela); «più presto che ritornar in detta casa, si contentiamo andar lemosinando per le strade» (Chiara). Io son convinto che la prigionia del vecchio Ottavio rovinò in effetti un piano che aveva ottime probabilità di riuscita, e che era senz’altro farina del suo sacco. Fosse stato in casa, non credo che avrebbe permesso al figlio di ostentare disgusto e disprezzo per Angela fino al punto da rendere del tutto inverosimile l’intenzione di sposarla, e intollerabile l’idea di sposarlo: avrebbe magari architettato un gioco delle parti, in cui sarebbe toccato a lui esercitare una pressione sul fronte patrimoniale, ed al figlio render credibile il compenso su quello matrimoniale; in ogni caso avrebbe proceduto con un po’ di cervello. Invece Bellacato Bellacato, per quante istruzioni potesse ricevere dal padre carcerato, dovette all’atto pratico cavarsela da solo, e il cervello Dio glielo levò, ammesso che mai gliel’avesse dato. Così la ragazza e la sua robba presero la fuga. Solo che non fu un salto nel buio: Angela saltò piuttosto sull’unica sponda che provvidenzialmente ancora si offriva al suo sguardo, perché quella che appariva in migliori momenti come sciagura da scongiurare si era mutata in una via di scampo. Non so se fu effettivamente il Breo a ritessere i rapporti con le due gentildonne tramite Gasparina; loro stesse, aperti gli occhi fino in fondo sui termini re- Vigneti a Frassanelle. 134 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei ali e spietati della situazione in cui si trovavano, avrebbero potuto prendere l’iniziativa, e magari lo fecero. Bruciata com’era nel ceto sociale a cui apparteneva, minacciata come si sentiva (non credo senza ragione) nella sua stessa sopravvivenza, Angela si adeguò alla sola prospettiva che le restava. Se il sacrificio fu più della madre che suo, tanto meglio per lei. Al Breo in ogni caso, come il citato biglietto testimonia, non fu costretta a fare donatione di tutto il suo. Quanto al Breo, neanche per lui quella decisione rappresentava un puro beneficio a costo zero. Lui non era mica il contadino nascosto in fondo ad una campagna, pronto per modico compenso a far da marito alla concubina di cui il padrone si fosse stufato: era uno che voleva girare per Padova col Signor davanti al nome. Direte che qui il compenso non era modico, e se lo disse certo anche lui: nella strategia di una famiglia plebea in ascesa l’occasione che gli si presentava, e che aveva caparbiamente, lungamente inseguita, era troppo preziosa per lasciarsela sfuggire, e lui, non abbiamo dubbi, sapeva pensare in prospettiva. Il costo immediato, per imbarazzante che fosse, gli sarà sembrato più che accettabile, e se ne sarà caricato con quello spirito stesso che lo spingeva, nei momenti in cui temeva d’aver paura, a dire a voce alta: Gio Batta Breo. NOTE 1. Qui e in ogni successiva occasione cito senza modificare l’ortografia, limitandomi a svolgere molte abbreviazioni e a ritoccare con moderazione la punteggiatura. 2. Non che il consenso di una ragazza ad una fuga d’amore, o le intenzioni matrimoniali di un rapitore, cancellassero il reato: la logica della legislazione – veneziana e non solo – tutelava innanzitutto l’onore e la volontà della famiglia della donna. Piuttosto, di fronte a un ratto o a una fuga, purché riuscissero, la famiglia stessa avrebbe probabilmente evitato di mettere la cosa nelle mani della Giustizia. 3. Cfr. R. Derosas, Moralità e giustizia a Venezia nel ’500-’600. Gli Esecutori contro la bestemmia, in G. Cozzi (a cura di), Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), Roma 1980, pp. 456 sgg. 4. Cfr. C. Povolo, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII, in G. Cozzi (a cura di), Stato società e giustizia..., cit., pp. 221-223. 5. La storia della denuncia è divertente. «Denontio io Francesco Vacchin degano della Villa di Revolone come il giorno di venere... Ms. Batta Breo vene alla Bastia», ecc.: ma Francesco Vacchin, interrogato come di prassi all’atto della consegna della denuncia, dichiara candidamente: «Io non so dir cosa alcuna, solo che la S.ra Chiara Gazza (i)eri mi fece chiamare... et mi diede questa denoncia in mano acciò la portassi alla Giustizia». 6. Cfr. C. Povolo, Aspetti e problemi..., cit., pp. 221 sgg. 7. L’Anzoleta, apprenderemo esplicitamente, non sapeva scrivere (cfr. par. 29); più o meno analfabeta sarà stata anche la madre, che vedremo ricorrere ad altri per farsi scrivere lettere (cfr. par. 14). 8. L’espressione, come la notizia, è tratta dalla lettera di T. Boattin a N. Verdabio del 18 marzo 1657 (cfr. par. 11). Del servitore di cui si parla non sappiamo altro. 9. Deposizione di Francesco Giusto (cfr. par. 9). 10. Ne parla ancora il Giusto. La notizia sembra fatta apposta per giustificare l’urgenza che Chiara Gazza avrebbe mostrato di lasciare Bastia (cfr. parr. 13 e 14). 11. Una genealogia della famiglia è in Prove di nobiltà, ASP, b. 9, fasc. 32. 12. Cfr. P. Ulvioni, La nobiltà padovana nel Sei-Settecento, in “Rivista Storica Italiana”, anno 103 (1992), fasc. III, pp. 803 e 807. alt ri p rom e ssi 135 13. Testimonianza di Francesco Giusto. 14. Orsola figliola di Vendramin Bottazzo, massara e probabile concubina di Ottavio Bellacato (cfr. nota 20). 15. Atti del Maggior Consiglio, b. 26, ASP. La Banca in questione è quella del Monte di Pietà, che fungeva anche da tesoreria cittadina. Per alcune vicende ad essa relative in quegli stessi anni vedi P. Ulvioni, La nobiltà padovana..., cit., pp. 812-816. 16. Se però i misteriosi movimenti notturni cui si accenna alla fine del paragrafo 8 ci furono davvero, potrebbe darsi che la notizia fosse già uscita dalle mura urbane la sera precedente. 17. Questo Bonetti non è figura facilmente definibile: raggiunto dalla notizia della morte del suo compare in casa di lui, rimase fra ’57 e ’58 almeno a periodi a fianco delle Gazze, ma con veste e nome più di servitore che di amico di famiglia. Nel processo compare come teste citato dai Bellacati e si uniforma nella sostanza alla loro versione. 18. La questione se oltre allo schioppo, ammesso con naturalezza, Ottavio avesse quel giorno anche archibusi curti non è oziosa come sembrerebbe a noi, già se ne parlava (cfr. par. 6). L’esibizione di pistole alla cintura era il contrassegno, si può dire, del malintenzionato temerario, e costituirebbe, se fosse qui comprovata, un elemento forte di quell’atmosfera initimidatoria che le Gazze vogliono rendere palpabile. 19. In verità neppure i testimoni chiamati (ed istruiti, si può crederlo) dalle Gazze appaiono su questo punto del loro stesso parere: secondo la Catti, allora massara a Bastia, il servo Pompeo viene lasciato ad effetto che serva di sicurezza alle donne medesime, e che nisuno non andasse a dar loro molestia, e perché anco potesse attendere ai fatti della campagna. 20. Si trattava veramente, per quanto posso ricostruire, di una ragazza che era concubina abituale di suo fratello Momolo. La casa dei Bellacati apparirà, nella memoria di Angela, come un publico postribolo, in cui il vechio mantiene una puttana nominata orsola, et Girolimo suo figliolo più piccolo, che deve haver 15 anni in circa, tiene una putazza detta maria che deve haver tanti anni quanto lui, con la quale anco ha comercio il sig.r Bellacato, et questi SS.ri tutti tre non si guardavano punto di farsi vedere a tutti di casa ad essercitar atti venerei con quelle sue donne, come basi et mille altri sporchezi vituperosi: in somma in quella casa non si fano altro che disoluteze, né mai da alcuno si parla di confessarsi né comunicarsi né di andare a messa. 21. Maddalena, donna al loro servizio già ai tempi di Bastia che le ha seguite nel nuovo domicilio ed accompagnate anche a Tremignon, ricorda che alle volte li mandavano li Bellacati quello che li bisognava per viver, ciò è carne, luganeghe, sisiole [giuggiole], e li giorni de pesse alcuna volta anco pesse, e delle volte non vi era né anco il sale; pane e vino però sempre ve n’era... et qualche volta si mangiava delle rave e delle verze, così fra pasto. Quanto agli habiti però è vero che erano li leggeri da estate, e se bene li mandassimo a dire che ne capitassero vestiti d’inverno per quelli contadini secondo venivano a Padova... mai li hanno mandato cos’alcuna, onde pattivano fredo, stavano però al fuoco. 22. Secondo Gasparina, lo sposo avrebbe dato in un’occasione ad Angela un fiancone (un colpo violento) per il quale stette molto male e credeva di disperdere (abortire). In altra occasione, racconta sempre Gasparina, «vene il sig.r Girolimo figliolo minore à casa con schizeto d’Aquarosa, il quale schizeto preso dal fratello maggiore mi tirò tutta l’acqua nelle spale, e poi con della orina schizetò la Sig.ra Anzoletta Gaza, che si levava dal letto et si calzava: quella Sig.ra si contaminò tutta, ma non ardì parlare, et esso sig.r Bellacato la minchionava... diceva che le pareva di veder un diavolo, e mille altre cose simili». Anzoletta, che a questo episodio accenna, di altri non se la sente di parlare: «altri vituperij che non dirò se dovessi perdere la vita». 23. Lascio qui, come ho fatto nella nota 20 per Orsola e Maria, l’iniziale minuscola del nome proprio: sono grafie assai rare nelle molte carte di questo processo, e non è forse senza significato che in questi tre casi si applichino a donne, serve di mestiere e più o meno esplicitamente indicate come concubine dei padroni. SUL FILO DELLA MEMORIA La seconda guerra mondiale a Rovolon L’eco della Grande Guerra non si era ancora spento quando il 10 giugno 1940 il Capo del governo italiano firmò la dichiarazione di guerra alla Francia e all’Inghilterra. Gli eventi che seguirono sono rimasti scolpiti nella memoria d’intere generazioni: quella dei padri e delle madri che videro partire i propri figli verso fronti ignoti e luoghi sconosciuti; quella dei giovani chiamati alle armi, in un’età compresa tra trentacinque e vent’anni, parte della quale non fece più ritorno al paese natio; quella dei nipoti che durante l’infanzia e l’adolescenza hanno ascoltato i tanti racconti dei protagonisti con le innumerevoli vicissitudini sofferte per la guerra e per tutti gli effetti che essa provocò. A distanza di settant’anni da quel tragico e funesto evento, val la pena riprendere le parole e i racconti di alcuni testimoni, soprattutto per ricordare, a chi l’avesse dimenticato, quanto preziosi siano la pace e la libertà, assieme ai valori della solidarietà e della civile convivenza. Nelle pagine che seguono è stata raccolta la vicenda autobiografica di un anziano che in divisa visse in prima persona, sul fronte, la disastrosa occupazione della Russia: ottantamila uomini furono inviati con l’ARMIR (acronimo di Armata Militare Italiana in Russia) sulle gelide steppe dell’Est europeo con l’unica motivazione di voler estirpare il bolscevismo e il comunismo. Di quella generazione di giovani italiani, solo ventimila fecero ritorno dopo la lunga marcia del gennaio 1943, in mezzo alla neve e con temperature di ben venti gradi sotto zero. Basta leggere Il sergente nella neve, del compianto Mario Rigoni Stern, per capire quale tragedia si è consumata in quelle lontane terre bagnate dal Don. Rimanendo a Rovolon dobbiamo qui accennare ad alcuni episodi accaduti negli anni di guerra, soprattutto dopo l’otto settembre 1943. A ricordarceli sono le relazioni scritte dai parroci che allora guidavano le comunità di San Giorgio di Rovolon, Santa Maria di Bastia e San Giovanni Battista di Carbonara. Quelle relazioni, che narrano quanto accaduto entro i limiti di ciascuna parrocchia, furono espressamente richieste nel giugno 1945 a tutti i parroci della Diocesi dal vescovo mons. Carlo Agostini. Solo nel 2007 sono state rese note, grazie all’opera infaticabile di don Pierantonio Gios, nel poderoso volume Guerra e Resistenza. Le relazioni dei parroci della Provincia di Padova.1 Le riprendiamo, in parte, nelle righe che seguono accompagnate e integrate da alcuni documenti emersi nel riordino dell’Archivio comunale. Tra questi documenti un paio sono d’indubbio interesse, non fosse altro perché riflettono i problemi e le difficoltà dell’immediato dopoguerra. In quella temperie di speranze per la fine del confl itto, a guida del comune liberato dai nazi-fascisti il 29 aprile 1945 fu scelto il conte Novello Papafava. Un personaggio di rango 140 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei e un intellettuale unico, un liberale capace di assumere, pochi anni dopo, la Presidenza della RAI, Radiotelevisione Italiana. Della guerra, degli effetti nefasti che la popolazione subì, accanto alle ferite mai del tutto rimarginate per chi ha perduto affetti e familiari, oggi rimane un quotidiano testimone: il Monumento ai caduti sulla piazza antistante il Municipio. Non un documento muto, celebrativo, bensì un segno della memoria capace di rinnovare il ricordo del tributo di sangue e di vite umane che accompagna ognuno dei nomi scolpiti sul bianco marmo. Rovolon Nomi che non ritroviamo nelle relazioni dell’arciprete don Achille Marchiori (nato a Cittadella del 1888), di don Anselmo Bernardi e di don Antonio Costa. Dei tre religiosi il più sintetico nel riferire gli eventi al vescovo Agostini fu proprio l’arciprete di Rovolon. Alla richiesta di quanti sfollati giunsero in parrocchia don Achille rispose: «Il numero degli sfollati in parrocchia è stato fluttuante: al massimo sono arrivati a 375, quasi tutti provenienti da Padova, una famiglia dalla Sicilia e due da Napoli. I prigionieri di guerra – aggiunge – furono 25; gli internati in Germania 35. Fra gli sfollati: 11 famiglie povere. A favore di queste furono erogate £. 500 e generi in natura come frumento, granoturco, fagioli, patate, legna, grasso di maiale eccetera, forniti generosamente dai parrocchiani». Alla richiesta di quanto fu fatto in materia di assistenza spirituale il reverendo sacerdote precisò telegraficamente che «furono fatte speciali funzioni religiose per gli sfollati e particolari istruzioni ai fanciulli». Su quanto accadde nel territorio parrocchiale durante il movimento delle truppe, don Achille si limitò a registrare l’occupazione delle ville Papafava e Montesi, prima dalle truppe tedesche e successivamente da quelle inglesi, Foto di gruppo con milizia fascista, riconoscibile dai distintivi sul berretto. la se con da g ue rr a m on diale a rovolon 141 non mancando di sottolineare che «purtroppo non mancarono tresche e balli». La parrocchia, fortunatamente, non subì né bombardamenti né mitragliamenti, perché nel territorio non vi era «alcun obiettivo militare» e non vi erano «arterie di traffico». Pure la chiesa non soffrì danni, fatta eccezione per la requisizione della «campana grande del peso di Kg. 1050 e la campanella di richiamo del peso di Kg. 35». Oggetti immediatamente sostituiti al termine della guerra «con slancio unanime di tutto il popolo», in grado di raccogliere ben 170.000 lire per acquistare una nuova campana grande. La relazione, datata primo agosto 1946. si concludeva con la dichiarazione che chiesa, casa canonica e casa della Dottrina non ebbero a subire bombardamenti, come pure «nessun danno ebbero a soffrire i sacerdoti».2 La laconica relazione di don Achille, una delle più brevi dell’intera serie e una delle ultime ad essere consegnata al cancelliere vescovile, denota l’assenza di annotazioni nel registro cronistorico di quanto andava accadendo negli anni del confl itto a Rovolon, in palese inosservanza delle direttive impartite dal vescovo Agostini a tutti i parroci della Diocesi ben prima dello scoppia della guerra. Redigere puntualmente il libro Cronistorico era un dovere canonico disciplinato da precise direttive sinodali e al di là della semplice registrazione degli eventi, aveva lo scopo di conservare memoria della vita religiosa e materiale di ogni comunità cristiana. Bastia Un compito che assolse invece con diligenza don Anselmo Bernardi (classe 1913) a Bastia. Diversamente dal confratello di Rovolon, il parroco di Santa Maria della Neve il 31 luglio 1945 riferì al vescovo un quadro molto più ricco, articolato e puntuale di quanto successo soprattutto a partire dall’otto settembre 1943. Sembra di essere in un altro paese, in una località lontana chilometri e chilometri da Rovolon. Scrive don Anselmo. I primi anni di guerra non portarono conseguenze gravi alla parrocchia, a parte i richiami e la partenza dei giovani per la guerra. I soldati che complessivamente nel periodo bellico prestarono il loro servizio militare si possono dire 260. All’otto settembre 1943 molti di essi tornarono alle famiglie né più ripartirono. Però già una trentina erano stati fatti prigionieri e portati nei campi di concentramento in tutto il mondo. Altri 35 furono purtroppo internati in Germania, aggiungendosi così ad altri 5, che già vi erano rimasti per motivi di lavoro. Durante tutta la guerra non vi furono morti sui campi di battaglia; tre soldati rimasero dispersi e sulla loro sorte non si possono fare illusioni le famiglie. In Germania morirono come prigionieri un giovane e un uomo sposato. Col primo bombardamento di Padova il 16 dicembre 1943 in parrocchia incominciarono ad affluire vari sfollati o sinistrati dalla città e dal suburbio di Padova. Coi successivi bombardamenti altri se ne aggiunsero fino a raggiungere il numero approssimativo di 500. Si allogarono come meglio poterono nelle varie famiglie; anche la casa della Dottrina e la canonica furono da essi occupate. Tra gli sfollati c’erano dei ricchi, ma anche dei poveri. Si cercò di fare in modo che i ricchi aiutassero i poveri. Fu pertanto subito costituita una speciale San Vincenzo, di signore sfollate e parrocchiane, le quali avessero da interessarsi ai bisogni delle famiglie sfollate. 142 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei L’opera fu davvero provvidenziale e riuscì a fare gran bene, compresa sempre più ed appoggiata dai parrocchiani e dalle autorità comunali. Si poterono così assistere tutte le famiglie bisognose, che successivamente raggiunsero il numero di 30. Furono distribuiti effetti letterecci, indumenti, medicinali, buoni ed ogni altra cosa che fosse necessaria. Il bilancio complessivo della San Vincenzo per gli sfollati si può valutare a Lire […]. La pia associazione non si è ancora sciolta e lavora con frutto anche oggi a vantaggio delle poche famiglie sfollate ancora rimaste; però le consorelle oggi sono tutte parrocchiane, giacché le sfollate sono ritornate in città. Alla domanda sull’assistenza spirituale offerta ai soldati al fronte, il parroco di Bastia garantì di avere inviato lettere nelle varie solennità dell’anno, sia con comunicazioni personali, sia con contatti diretti alle famiglie dei militari. Ogni sabato in parrocchia si celebrava la messa del soldato, divenuta del prigioniero e dell’internato dopo il fatidico otto settembre 1943. Per prevenire gli orrori dell’invasione e del passaggio della guerra venne fatto solenne voto al Sacro Cuore di Gesù con l’impegno di celebrare ogni venerdì una funzione. Al termine della guerra quel voto si sciolse con l’acquisto di una statua del Sacro Cuore, opera dell’artista padovano Luigi Strazzabosco e con una solenne e sentita celebrazione tenuta il primo luglio 1945. Anche gli sfollati trovarono conforto spirituale e assistenza morale, oltre a quella materiale, tanto che diversi bambini si avvicinarono alla prima comunione. Sul comportamento delle famiglie giunte a Bastia don Anselmo rilevò in alcuni un contegno «un po’ libero in fatto di moda», ma non tale da generare scandali. Dannoso e grave invece l’atteggiamento dei militari in transito. «Furti e rapine in quantità furono commessi dai tedeschi in ritirata: biciclette (anche quella del parroco con la sua macchina da scrivere), buoi, cavalli, carretti, biancheria, eccetera furono portati via: poco fu poi recuperato», annota amareggiato don Bernardi. Il ballo, tuttavia, rimaneva lo scandalo numero uno, in grado di generare una «moda indecente, contro ogni altro pericoloso divertimento». Nonostante le battaglie verbali contro la moda dilagante le prediche non riuscivano a far argine. Il pensiero della guerra veniva momentaneamente accantonato proprio con le feste e il ballo, di cui gli sfollati spesso ne erano i frequentatori più convinti. In quegli anni iniziava il sostegno politico alla Democrazia Cristiana – scrive sempre don Bernardi – e si combatteva la cellula comunista che faceva proseliti soprattutto fra gli operai della cava di calcare della ditta Marin. Gli eventi bellici registrati a Bastia sono così narrati dal parroco. Durante la battaglia aerea del 28 dicembre 1943 caddero in parrocchia di Bastia varie bombe che causarono la morte dell’uomo cattolico e confratello del Santissimo, Scacco Cesare, colle sue bambine: Pia di anni 4 e Silvia di anni 5. Fu un dolore per tutta la parrocchia. Il 4 gennaio di quest’anno durante il passaggio di varie formazioni una bomba seppelliva il giovane Brocca Natale di anni 18. I tedeschi in ritirata di notte, credendo di essere attaccati dai partigiani, spararono in direzione della campagna dilaniando il bambino Baldin Franco di 5 anni. Altre vittime non vi furono, quantunque i mitragliamenti siano stati assai numerosi durante la guerra e specialmente durante la ritirata. Non mancò un bombardamento a farfalla, il 21 marzo di questo anno [1945]: vi perirono tre soldati tedeschi, ma nessun parrocchiano. I danni materiali alle opere parrocchiali riguardarono i vetri e il tetto della chiesa colpiti dal bombardamento a farfalla del 21 marzo 1945. In anni così la se con da g ue rr a m on diale a rovolon 143 difficili, tuttavia, la comunità seppe costruire il cinema “Alessandro Manzoni” «opera grandiosa e tanto utile alla parrocchia. Fu compiuta in 4 anni di lavoro e colla spesa complessiva di Lire 533.000», sottolineò soddisfatto ed orgoglioso don Bernardi nella sua relazione. Nella parte personale la relazione del parroco di Bastia contiene questa testimonianza. Il 23 novembre 1944 elementi delle SS italiane e della Muti, unitamente a due parrocchiani di Bastia, arrestarono e tradussero alla Casa di Pena di Padova il reverendo cappellano di Bastia, don Gelindo Rizzolo. Egli era imputato di disfattismo con la sua predicazione, di antifascismo, di aver sobillato i giovani a non presentarsi alla leva. Il parroco fece tutto il possibile per affrettarne la scarcerazione e il 23 novembre dello stesso anno il sacerdote fu dal comando della SS tedesca affidato a sua Eccellenza monsignor vescovo perché da lui fosse messo in luogo quasi di prigione in cui Denuncia dei danni subiti dall’ingegnere Veronese durante la ritirata dei tedeschi, datata 3 maggio 1945. 144 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei non potesse, a loro giudizio, essere nocivo. Durante la prigionia il sacerdote non ebbe particolari maltrattamenti; fu interrogato senza violenze; ma dovette rimanere in una cella fredda ed umida con un trattamento da carcerato. Al parroco riuscì con difficoltà di confortarlo con una sua visita. Al parroco sembra di poter dichiarare che il contegno del suo cappellano non giustificava l’arresto e la prigionia: il sacerdote, antifascista di vecchia data, qualche volta nella predicazione e nella conversazione pronunciò qualche parola di disapprovazione della violenza, dell’odio e anche della politica fascista: questo specialmente dispiacque, ma non doveva certo essere motivo sufficiente per una cattura. Il parroco personalmente ritiene, durante il periodo bellico, di aver sempre tenuto un contegno ispirato alla prudenza, astenendosi da qualsiasi politica e coltivando soltanto il bene delle anime. Ciò non toglie che abbia avuto qualche noia dalle truppe tedesche di presidio: ma in complesso il suo contegno non fu criticato. Si occupò sempre e con tutti i mezzi di far del bene a quanti ebbero maltrattamenti ed arresti e, grazie a Dio, in parrocchia non vi furono incidenti gravi e dolorosi. Se qualche parola fu detta contro di lui dopo la liberazione, è motivata dal suo contegno riservato durante la guerra, in confronto con quello del cappellano, e specialmente dell’aver interposto i suoi buoni uffici, in nome della carità cristiana, a favore dei fascisti che furono tratti in arresto con delle accuse manifestamente ingiuste, anzi assurde. Ora sembra che tutto sia tornato alla normalità. A chiusa della relazione, il parroco esprime al Sacro Cuore di Gesù la sua riconoscenza perché durante il flagello la parrocchia fu preservata da gravi calamità e prega perché le sofferenze passate servano a bene dell’avvenire.3 Un avvenire di speranza fu il lascito di don Anselmo, in seguito divenuto parroco di Bassanello in Padova e dei suoi amati barcari, e più tardi primo direttore del nuovo Seminario Minore a Tencarola. Chi l’ha conosciuto serba in cuore il ricordo di un uomo pacato e sensibile, attento e premuroso. Settembre 1947. Il conte Novello Papafava, primo sindaco di Rovolon dopo il 25 aprile 1945, a Frassanelle con la moglie e, al centro, lo storico Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 Capo di Sorrento 1957). la se con da g ue rr a m on diale a rovolon 145 Carbonara Non molto diverso dalla relazione del parroco di San Giorgio di Rovolon ci appare il resoconto di don Antonio Costa, parroco di Carbonara. Sugli sfollati giunti in parrocchia il giudizio amaro si accomuna al disappunto per la scarsa frequenza alla chiesa: «il 10% ascoltano la santa messa alla domenica, una percentuale ancora più bassa adempì al precetto pasquale; i furti furono all’ordine del giorno». La parrocchia visse momenti difficili non solo per i 139 sfollati ma pure per i 105 tedeschi «fermatisi per sei mesi nella frazione di Lovolo». La relazione di don Antonio, datata 25 luglio 1945, riferisce poi della battaglia aerea svoltasi sul cielo di Carbonara il 28 dicembre 1943. Lasciamo al testimone la penna. Più di cento velivoli inglesi contro un numero molto maggiore di tedeschi si contendevano il primato. Gli inglesi, visto la mal parata, cercarono di fuggire e per essere più lesti cominciarono a scaricarsi delle bombe che portavano. Dieci bombe caddero alle Valli, attorno alla casa di Padovan Silvio, e per miracolo non si lamentarono vittime. La casa subì molti danni e per parecchi mesi fu inabitabile e intanto i componenti la famiglia (nove persone) si alloggiarono in varie case, accolti caritativamente dai buoni. Sui rastrellamenti tedeschi compiuti nella zona settentrionale dei Colli Euganei il parroco annota ancora. Due furono i rastrellamenti sul Monte della Madonna, ma senza esito perché gli sbandati fecero tempo a fuggire. Due pure furono le visite notturne dei così detti ribelli: una l’8 luglio 1944 dal fittavolo di Cogo “Miotello Giuseppe” e portarono via una cavalla con biroccino e finimenti col lasciar detto che sarebbero ancora tornati e che il padrone preparasse ottantamila lire. L’altra visita notturna ebbe luogo il 25 luglio da Pierantoni Antonio, il quale dovette consegnare una schioppa da caccia a due canne e poi del denaro. I fatti più gravi, infine, accaddero negli ultimi mesi del ’45. Scrive ancora don Antonio Costa. Nessun sacerdote ebbe a soffrire per ferite o allontanamento; solo un secolare, contadino, Soranzo Riccardo d’anni 42, da Lovolo il 28 aprile ore 10 fu ucciso nei suoi campi e non si sa il motivo. Il danno più grande alle persone venne il 4 gennaio 1945, giorno nel quale si videro passare centinaia di veicoli e si crede che alcuni furono colpiti dalla contraerea di Verona e nella fuga verso Padova una formazione di sette bombardieri volò sopra questa parrocchia lasciando cadere una bomba a Lovolo dove seppellì un ragazzo di 17 anni da Bastia di cognome Brocca e poi ne lasciò cader una in via Palazzina colpendo in pieno la casa colonica di Veronese Giordano, abitata dagli affittuali Rinaldi e rimasero morte cinque persone: nonna Oliviero Angela d’anni 58; mamma Sgarabottolo Albina d’anni 32; figli Rinaldi Luciana d’anni 10, Silvano d’anni 8, Ermenegildo d’anni 6. Quanti disastri portò questa inutile guerra e quanto forse dobbiamo soffrire ancora. Ci aiuti Iddio buono e misericordioso.4 Tra 1943 e 1945: gli ultimi venti mesi Gli eventi narrati da questi autorevoli testimoni trovano riscontro anche tra le carte dell’archivio comunale. Una nota del 21 settembre 1944 segnala al Prefetto di Padova che gli sfollati registratisi a Rovolon furono complessiva- 146 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei mente 607 di cui 255 maschi e 352 femmine. Dei bombardamenti sul paese troviamo eco in un telegramma datato 28 dicembre 1943, che testualmente recita: «Ore 14,40. Ecc. Capo Provincia. Seguita battaglia aerea precipitato apparecchio caccia tedesco – punto – Pilota salvatosi facendo uso paracadute – punto – Sgancio bombe apparecchio nemico provocato danni abitazioni et tre vittime et un ferito. Commissario Prefettizio Rovolon». Il tragico evento della morte dei tre membri della famiglia Scacco trovò eco nei quotidiani del tempo, che descrissero brevemente anche la cerimonia funebre che ne seguì. Delle fortificazioni realizzate nella zona per difendere il movimento delle truppe troviamo invece riscontro in un manifesto, fatto stampare in dieci copie dal commissario prefettizio del comune di Rovolon il 15 marzo 1945. Questo il testo: Municipio di Rovolon MANIFESTO Il Militar Kommandantur 1004 ha disposto che attorno alle opere di fortificazione militare, sistemi di trincee e simili, e precisamente per un raggio di 50 metri, il terreno debba rimanere incolto, come campo libero di tiro. Qualora il terreno venga coltivato con piante di bassa vegetazione (fino a 30 cm. di altezza), allora è sufficiente uno spazio libero del raggio di 20 metri. Il predetto Comando precisa che tutti i danneggiamenti eventualmente arrecati a tali impianti dovranno essere riparati a spese dei responsabili e, qualora questi non fossero identificabili, a spese del Comune Rovolon, 15 marzo 1945, XXIII Il Commissario Prefettizio (Amedeo Lotto) Al termine della guerra – come ci ricorda la minuta di una lettera datata 5 giugno 1945 – le fortificazioni tedesche furono smantellate, tanto da far scrivere al Sindaco che «esistono in Carbonara di Rovolon circa 60 quintali di legname ricavato dalla demolizione delle opere di fortificazione militare e raccolta dal locale Comando dei patrioti, legname che – conclude la missiva – ai sensi delle disposizioni pervenute, non può essere assegnato se non a seguito di ulteriori disposizioni». Tra le carte dello stesso archivio si conservano elenchi di animali da tiro e di effetti personali rubati durante la ritirata tedesca: furti che misero in seria difficoltà i contadini, impossibilitati ad effettuare i lavori agricoli richiesti dalla stagione. Eventi che ricalcarono un passato mai dimenticato, come la fortezza di legname (la bastita medievale) e, giusto cinque secoli dopo, il saccheggio e le rapine compiute dalle truppe viscontee nel 1439. Allora la sottrazione di animali da lavoro mise in ginocchio un intero paese. La storia, come si può intuire, ripete il suo corso con i protagonisti, cioè gli uomini, che non perdono la se con da g ue rr a m on diale a rovolon 147 occasione per manifestare tutta la loro miseria. Quanto accadde al termine del confl itto lo troviamo descritto in alcuni resoconti redatti nel maggio 1945: «Il Comune venne liberato il giorno 29 aprile, nelle prime ore del mattino tra l’entusiasmo della popolazione», recita la Relazione sulla situazione creatasi a seguito dell’avvenuta liberazione e quella stessa mattina gli aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale costituirono, con concorde deliberazione, la nuova amministrazione comunale. A comporla furono il Co. Dr. Novello Papafava dei Carraresi, nominato Sindaco; l’ingegnere e professore Alessandro Veronese, nella veste di Vice-Sindaco; Giuseppe Manfredini, con funzioni di assessore; Gino Fasolo, anch’esso nominato assessore; Giuseppe Benato, figlio di Antonio Modesto, pur esso assessore; e infine Giuseppe Zattarin di Massimiliano, anch’esso assessore. La ricostruzione materiale fu dura. Gli effetti di quei tragici anni continuarono a lungo a ripercuotersi sulla popolazione, come ci ricorda l’ultimo tragico resoconto, con cui chiudiamo questo capitolo. È tratto da una nota del 17 dicembre 1946. Al sindaco di Vicenza vengono inviati i nomi dei “fucilati dai nazifascisti”, un elenco che riportiamo così come fu stilato in quella nota: Pasqualin Luigi di Natale e di Rinaldi Giuseppina nato a Rovolon il 29.11.1925; Montemezzo Aldo di Ettore e di Toniato Gilda nato a Mossano il 18.6.1924; Navarin Massimiliano di Giacomo e di Nardo Teresa nato a S. Angelo di Piove il 6.12.1925. Tutti residenti in questo Comune, vennero arrestati dalle S.S. tedesche perché sospettati di appartenere a formazioni partigiane e perché renitenti ai bandi di chiamata alle armi della Repubblica di Salò. Rinchiusi nella casa di pena di Padova e considerati ostaggi vennero dopo pochi giorni portati a Vicenza e fucilati per rappresaglia.5 I tragici frutti della violenza della guerra. Note 1. Pierantonio Gios, Guerra e Resistenza. Le relazioni dei parroci della Provincia di Padova, Selci-Lama (PG) (Editrice «Pliniana»), 2007. 2. Gios, Guerra e Resistenza p. 395. 3. Gios, Guerra e Resistenza p. 39-42 4. Gios, Guerra e Resistenza p. 145-146 5. I documenti sono tutti custoditi nell’Archivio comunale di Rovolon. Bastia. Le scuole comunali in una cartolina spedita nel 1953. La mia gioventù. Ricordi di Vittorio Miotto Nacqui il 10 gennaio 1920. Fui chiamato alle armi il 13 marzo 1939 dall’Esercito Italiano, avevo 19 anni. Fui assegnato al 4° Reggimento Autieri di Verona. Da lì fummo inviati al distaccamento di Bolzano, dove rimanemmo per un periodo di addestramento; successivamente rientrammo alla sede di Verona. Era già il 1940. Lì venne formata un’Autosezione composta da 24 autocarri (OM 137), 48 autieri, (dei quali facevo parte anche io), un meccanico, un motociclista, un Capitano e un Sergente: totale 52 militari. Ci mobilitarono per la guerra: facevamo parte del Quartier Generale Divisione Pasubio. La guerra ebbe inizio l’11 giugno 1940. Ci mandarono al fronte francese ma, quando arrivammo, la Francia capitolò perché i Tedeschi erano già arrivati a Parigi. Dal Piemonte ci trasferirono a S. Pietro del Carso, in Istria. Ci fecero entrare successivamente in Jugoslavia: l’Italia infatti aveva dichiarato guerra alla Jugoslavia. Entrammo in Jugoslavia e guidammo per 60 ore consecutive, senza dormire perché bisognava arrivare a Sebenico. La Jugoslavia capitolò e i suoi soldati scapparono tutti a casa, disertando. Rimanemmo a Sebenico per circa 40 giorni poi ci fecero rientrare a Verona. A Verona giunse Mussolini, noi sfilammo davanti a lui con la nostra Autosezione e tanti altri Reparti facenti parte della Divisione Pasubio. Del discorso da lui pronunciato ricordo particolarmente questa frase: “a noi è concesso l’onore di andare a combattere in Russia contro il bolscevismo a fianco dei camerati tedeschi”. Erano le tre del mattino del 22 giugno 1941 quando Hitler iniziò l’invasione dell’Unione Sovietica. Noi Italiani eravamo alleati con i Tedeschi. Mussolini e l’Esercito Italiano decisero di mandare un Corpo Spedizione Italiani in Russia (C.S.I.R.), composto da varie Divisioni, compresa la Pasubio di cui facevo parte, e quindi il 14 luglio 1941 partimmo. Caricammo autocarri, ecc., alla stazione Porta Nuova di Verona per raggiungere il fronte russo e combattere a fianco dell’alleato tedesco contro i Russi. Scendemmo a Suceava, in Romania, da lì attraversammo su strada i Carpazi, catena montuosa della Romania, per raggiungere l’Ucraina e quindi inoltrarci nel fronte russo, ove affrontammo i primi combattimenti col nemico: FU GUERRA. La Russia fu sorpresa dall’attacco tedesco in quanto aveva stipulato patti d’alleanza con la Germania. Hitler il sabato fece bombardare i campi di aviazione, distruggendo moltissimi aerei russi, e la domenica successiva presentò la dichiarazione di guerra alla Russia. L’aviazione russa subì moltissime perdite di forze aeree. Sulla scia dall’entusiasmo delle vittorie ottenute in Europa, Hitler invase Polonia, Cecoslovacchia, Olanda, Belgio, Francia, ecc., accumulò un enorme 150 Vittorio Miotto con Danilo Rubini a Sebenico nell’ex Jugoslavia il 18 aprile 1940. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei bottino di guerra a spese di tutti questi paesi, ma non valutò sufficientemente il pericolo di attaccare una nazione caratterizzata da un territorio vasto che comprende 2000 km di fronte, ambienti impervi con poche strade asfaltate (in maggioranza carreggiate di campagna, sterrate: quando pioveva le macchine slittavano e si mettevano di traverso, scivolando verso il ciglio della strada). Le vetture che avevano necessità di proseguire, nel fango fino al mozzo, riuscivano a percorrere 1 km in un giorno; un pantano impossibile: vedere per credere! Bisognava aspettare due o tre giorni per ripartire dopo la pioggia. Quindi la macchina da guerra subiva un arresto. Quanto alle ferrovie, i treni russi correvano su binari di 130 cm mentre i treni in Europa correvano su binari di larghezza inferiore, per cui bisognava stringere tutti i binari per far sì che i treni nostri potessero entrare per portare i rifornimenti alle truppe operanti. Hitler invio le proprie Armate a sprofondare nel pantano nell’autunno 1941. Incredibile la situazione che si era creata a causa di tutto questo impantanamento! La rapida avanzata delle truppe tedesche e alleate fecero sì che i raccolti di grano e altro rimanessero abbandonati a marcire nei campi. I Russi subirono gravissime perdite di uomini, fatti prigionieri o morti in combattimenti e sotto i bombardamenti degli Stukas tedeschi. Nelle città si soffriva la fame perché non c’erano mezzi di sostentamento. I Russi, prima di ritirarsi, portavano via tutto, non lasciavano nulla al nemico che avanzava. In una località vicino al Mar Nero, di cui non ricordo il nome, esistevano dei magazzini ove si raccoglieva grano, granoturco, avena, ecc.; circa una ventina di capannoni immensamente grandi e ognuno di questi conteneva migliaia di tonnellate di grano. Un mese, prima dell’avanzata tedesca, i russi appiccarono il fuoco a tutti i capannoni che erano colmi. Dopo mesi, andai anch’io lì a caricare del frumento bruciato per portarlo ai molini a Stalino, dove veniva trasformato in farina. Era inverno ed eravamo in una sacca, accerchiati dai Russi, e non arrivavano né posta né viveri, così ci davano da mangiare pane fatto con la farina del frumento bruciato. In seguito riuscirono a rompere l’accerchiamento e tutto ritornò normale. In guerra ogni giorno era buono per aspettarsi di tutto; al ritorno non si pensava mai perché tanta era la distanza e il pericolo era costante. Non si era sicuri neanche di notte perché d’estate, gli aerei lanciavano in cielo i bengala che illuminavano a giorno per ore ed ore vastissime zone, mentre loro giravano sopra e lanciavano bombe incendiarie che continuamente emettevano bagliori ad intermittenza. E noi sotto, in attesa dello sgancio di bombe. Ave- la m ia g iov e n tù 151 vamo il cuore in gola dalla paura di essere colpiti! D’inverno, quando il tempo lo permetteva, c’era “Pippo”, un aereo che la notte ci volava sopra per bombardare dove gli sembrava più opportuno. Quindi, si dormiva con molta ansia e paura, con i nervi a fior di pelle. La nostra Autosezione (la 137 Autosezione Pesante) fu sempre impegnata nei trasferimenti, trasportando tutto quanto era necessario: ospedali da campo, forni per panettieri, uffici del Comando Divisione, uomini, viveri, munizioni e quant’altro. Percorremmo un’infinità di chilometri su quelle strade che erano carreggiate sterrate di campagna, che con un po’ di pioggia si trasformavano in fango scivoloso ed impercorribile. Superammo tantissime difficoltà dovute all’ambiente impervi grazie anche all’esperienza che avevamo fatto. Subimmo bombardamenti, attacchi aerei svariate volte; per fortuna ce la siamo cavata. Parliamo ora del clima russo L’inverno in Russia è quanto di peggio uno possa pensare, da non augurare a nessuno! L’inverno 1941-42, quando eravamo là noi, il termometro raggiunse i 50°C sotto zero. Erano 120 anni che non si verificava un inverno così freddo, dicevano i Russi. Con l’avanzata estiva si arrivò al Bacino del Donez. Noi, con la nostra Autosezione, ci accampammo a Gorlowka, dove si trovavano le miniere di carbone. Con quel maledetto freddo, continuammo sempre il nostro servizio di rifornimento alle truppe. Si correva su una lastra di ghiaccio spessa 60-70 cm in continuazione, utilizzando il solo cambio e pochissimi freni. Mettere in moto le macchine al mattino era un problema dato il grande freddo. Delle 24 macchine si utilizzava prima quella che aveva la batteria in condizioni migliori, dopo aver fatto un foro nella camera di aspirazione si faceva aspirare attraverso questo foro la fiamma di fuoco ottenuta da uno straccio imbevuto di gasolio a cui era stato dato fuoco. Con questa, che si utilizzava per prima si trainavano le altre finché si mettevano in moto. Una volta in moto, si metteva l’acqua nel radiatore e si doveva tenere il motore sempre acceso perché se si spegneva si ghiacciava. Alla sera, quando si spegneva il mezzo, si toglieva l’acqua per poi rimetterla alla mattina successiva dopo averlo messo in moto. La strada era un’unica pista tenuta aperta a suon di pale e badili, con la neve ai lati alta 3-4 metri. Alla gente che lavorava per spalare la neve si congelavano il mento, il naso, le sopracciglia; ho visto cose incredibili dovute al freddo. I morti come cadevano rimanevano pietrificati dal grande freddo. Le bufere di neve duravano 8 e anche 15 giorni e quindi sommergevano tutte le piste. La 137a autostazione dove prestò servizio militare Vittorio Miotto. 152 Soldati italiani in Russia nel 1942. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Il 2 febbraio 1942 rischiai anch’io di essere sommerso dalla neve in una di queste bufere; ne uscii per puro miracolo. Andammo a caricare della carne a Stalino e nel fare ritorno ci imbattemmo in una di queste bufere di neve che poi durò 15 giorni e coprì tutta la pista. La neve che continuava a cadere era ormai così alta sulla pista che copriva il cofano della macchina e si divideva sul vetro. Ad un certo momento facevamo fatica a tenere il volante. Se non ce l’avessimo fatta ad arrivare all’accampamento, durante il tragitto saremmo stati sommersi da 4-5- metri di neve, lontani da tutto, e quindi saremmo morti poiché il vento e la neve, che durarono giorni, avevano sommerso e cancellato tutta la pista. Arrivammo a Gorlowka a mezzanotte. Dio fece che arrivammo vicino al nostro accampamento ma andammo fuori pista e ci piantammo. Intervennero i nostri compagni e con un’altra macchina ci tirarono fuori. Faceva un freddo cane! Quando si parla di inverno russo sarebbe meglio dire “inferno” russo, considerato quel freddo siberiano che raggiunse 40-50°C sotto zero. Ho visto l’orrore della guerra. Prigionieri russi, a migliaia, camminare sulla neve, sfiniti, stanchi, esausti, dover continuare la marcia verso le retrovie; i più deboli, vecchi anche di 60-65 anni, non gliela facevano più e rimanevano indietro. Gli sparavano un colpo di pistola alla nuca: cadevano morti sulla neve e rimanevano lì marmorizzati dal freddo. Se li prendevi per un dito li alzavi stecchiti come baccalà! Ho visto Ebrei costretti a scavarsi la buca con piccone e badile e, una volta raggiunta la profondità di 2 metri, con un colpo di pistola alla nuca uno alla volta cadevano morti dentro alla fossa. Ho visto le deportazioni di massa. I Tedeschi emisero un’ordinanza per cui tutte le donne dai 18 ai 60 anni dovevano presentarsi alla stazione il giorno X; venivano caricate nel treno e deportate in Germania ai lavori. C’era tanta fame diff usa, specie nelle città, non si trovava nulla per sfamarsi; inoltre si nutriva solo chi collaborava con i Tedeschi: a questi davano da mangiare mentre a chi non lavorava non davano nulla. I Russi soffrirono tanto la fame in questa situazione bellica. Figuratevi che trainando a mano la slitta sulla neve, col freddo, facevano decine di chilometri nelle retrovie e tornavano con degli arbusti secchi che mangiavano tritati fini con un po’ di grasso. Non avevano nulla da mangiare. Se avessero avuto quello che le nostre mamme davano da mangiare ai maiali qui in Italia sarebbe stata una festa per loro! Ho visto chiese trasformate in magazzini, svuotate, ecc… Loro erano devoti alla Madonna, i quadri però li tenevano nascosti dietro al cassone della farina perché era proibito tenerli esposti. Quando il nostro cappellano militare, nei giorni di festa, quando era possibile, celebrava la messa la m ia g iov e n tù 153 al campo, si vedevano molti Russi avvicinarsi e unirsi a noi per assistere alla Santa Messa. Nei paesi, lo “Starosta il Podestà” aveva la radio e tutte le famiglie vi erano collegate tramite altoparlanti: tutti erano obbligati ascoltare notizie che voleva lo Starosta. Quando si avanzava si trovava gente impaurita perché gli si diceva che noi gli avremmo tolto il cuore, gli occhi e gli avremmo tagliato le mani. Noi di solito, in estate, dormivamo all’interno dei mezzi ma quando cominciò il freddo, si requisiva una stanza alle famiglie russe, ci si sistemavamo in gruppi di 4. Loro ci mettevano a disposizione la stanza ma rimanevano in atteggiamento ostile e diffidente perché erano piuttosto impauriti. Io, nel tentativo di modificare questo loro atteggiamento, offrii parte del mio rancio ma non lo accettarono poiché avevano paura che fosse avvelenato. Insistei perché mangiassero ma loro mi fecero capire che prima dovevo assaggiarlo io. Le famiglie russe che conobbi erano come noi, buona gente. La Russia in quei tempi risultava un paese dal quale non trapelavano all’esterno notizie che la riguardavano, di nessun tipo. Non c’era turismo, solo relazioni diplomatiche tra Ministri degli Esteri. Sono convinto che Hitler non abbia tenuto conto dell’ambiente impervio e del clima terribilmente rigido dell’inverno russo, con temperature che arrivavano a 40-50°C sotto lo zero. A settembre cominciarono le piogge miste a nevischio, a ottobre piogge e impantanamenti a non finire. Novembre brutto, con neve, nebbie, ecc. A dicembre il grande e terribile freddo. La pianura russa è ondulata e formata da piccole collinette; la neve, d‘inverno, fa tutto un livello sicché nelle bassure raggiungeva anche i 4-5 metri. Si doveva aprire una pista per recarsi da un posto all’altro ma quando arrivava una bufera di neve, che durava anche 8-15 giorni, cancellava tutto e bisognava rifarla; la gente con i badili e ai lati argini (di neve) alti 4-5- metri. A maggio, quando cominciò lo scongelamento, l’acqua correva dappertutto e spesso trovava lo sfogo, ma dove non lo trovava, creava delle pozzanghere come laghetti lunghi anche 500-600 metri, poco profondi ma che noi dovevamo oltrepassare per non interrompere i rifornimenti. Ai primi di giugno 1942 iniziò l’avanzata e, dopo aspri combattimenti contro i Russi nella sterminata steppa del Caucaso, le nostre truppe raggiunsero il fi ume Don e si accamparono sulla riva destra del fi ume. Per arrivare attraversammo campi minati pericolosissimi; gli artificieri nella prima macchina facevano saltare le mine e tutti dovevamo scrupolosamente seguire sulla carreggiata le impronte della prima macchina, altrimenti c’era il rischio di saltare in aria. Attraversammo zone paludose con strade fatte con tronchi di alberi uniti con ganci alla testa; e questo per 10-15 km. Il Caucaso è un’immensa steppa sterile, brulla con carreggiate di campagna. Le case erano fatte con pali, sterco e terra, il tetto era di paglia e i pavimenti di terra. Di solito composte di due vani, un terzo occupato da una grande stufa, con spazio sopra per dormirci d’inverno quando fa freddo e c’è tanta neve. I pozzi erano una buca per terra, con del legno ai lati dell’imboccatura e, per attingere l’acqua, un palo messo a bilanciere con una catena in punta. I mulini erano a vento e dislocati sulle alture. Si trattava di zone primitive nelle quali ti 154 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei sembrava di essere ai confini del mondo. Questo per quanto riguarda le steppe del Caucaso. Le città invece erano posti più evoluti, ma lontane centinaia di chilometri l’una dall’altra. I paesi invece, distavano 30-40 km l’uno dall’altro. Dopo un anno di guerra, i Tedeschi avevano perduto per morti e congelamento, feriti e prigionia più di un terzo dei loro soldati impegnati al fronte russo. Così per le truppe loro alleate. Durante il secondo anno di guerra, e precisamente nel luglio-agosto 1942 furono mandate in Russia anche le Divisioni Alpine, Julia, Tridentina, Cuneense e la Vicenza che, unite alle nostre, formarono l’8^ Armata Italiana chiamata “ARMIR”. Trasportai io stesso dalla stazione di notte, diversi alpini fino al fronte sul Don, ove si schierarono a fianco delle nostre truppe. Durante l’estate 1942, la 6a Armata tedesca, composta da 260.000 uomini motorizzati e modernamente armati, entrò a Stalingrado verso il Volga e i pozzi di petrolio. Fu accerchiata dai Russi e, nonostante una strenua lotta, non riuscì a rompere l’accerchiamento. Ricevette l’ordine da Berlino di resistere ad oltranza, poiché sarebbe stata rifornita via aerea ma poi sopraggiunse l’autunno ed il tempo avverso e ciò non fu possibile per il grande freddo. Dopo aspri combattimenti e stretti nella morsa dell’accerchiamento, i soldati rimasero senza rifornimenti. Furono annientati dai Russi; gli ultimi superstiti sconfitti si rifugiarono negli scantinati, fatti tutti prigionieri e ridotti alla fame. Noi eravamo a Ogalev, un paese sull’ansa del Don. Era dicembre. Una sera arrivò l’ordine di andare fuori di pattuglia perché c’erano infiltrazioni di pattuglie russe, una cosa mai accaduta a noi autieri. Uscimmo per l’intera notte, faceva freddo e c’era un po’ di nevischio. Al mattino, quando rientrammo, mi sentivo male, faticavo a respirare e non sentivo più i piedi per il freddo. Chiesi di essere visitato e mi portarono all’ospedale da campo italiano, che era nella scuola del paese. Sentivo i cannoni sparare vicino e il via vai dei nostri soldati che arrivavano feriti dal fronte. Io non mi rendevo conto della gravità perché ero notevolmente debilitato. Un mattino entrò il Capitano medico e dette ordine a due infermieri di vestirmi e di coricarmi in un’autocarretta assieme ad altri due ammalati. Quando mi misero nell’autocarretta, passò una squadriglia di aerei Rata russi che mitragliavano a bassa quota. Li vidi, saranno stati una ventina, sentii bene i colpi sul ghiaccio ma per fortuna non mi colpirono: misi la testa fra le braccia ed implorai Mamma!!! I Russi, dopo aspri combattimenti e con forze preponderanti, riuscirono a passare il Don e a travolgere le nostre linee facendo molti morti e prigionieri. Passati gli aerei che mitragliarono, salirono in macchina il Capitano, un Tenente cappellano e un Sergente autista e ci incamminammo per il ritorno, su pista di neve che in qualche tratto era alta anche 4-5 metri. Si correva piano perché la pista era innevata; ad un tratto, finimmo la benzina. Ci accorgemmo di un fusto che qualcuno aveva scaricato per alleggerirsi; avevamo così la fortuna di rifornirci e di continuare il viaggio. Arrivammo dopo un lunghissimo percorso lungo una pista tutta innevata a Voronezh ove il Capitano mi consegnò a due soldati della Croce Rossa, raccomandandomi a loro perché avevo polmonite, pleurite e un congelamento ai piedi. Nelle retrovie erano spaventati perché sapevano che i Russi avevano sfondato le nostre linee. Mi lasciarono tutta la m ia g iov e n tù 155 la notte al freddo, seduto per terra in un corridoio; al mattino ero di ghiaccio e mi portarono in un letto; per riscaldarmi un po’ stetti con la testa sotto le coperte fino al mattino successivo. Dopo due giorni mi caricarono in treno e fui trasferito a Kharkov, in un ospedale da campo italiano. Rimasi lì una settimana; mi fecero varie visite e decisero di rimandarmi in Italia. Così, il 31 dicembre 1942, mi caricarono sul treno ospedale n. 18, con i vagoni riscaldati, coperte e assistenza italiana. Non mi sembrava vero, dopo tante sofferenze! Alla sera del 31 arrivammo alla stazione di Kiev e il treno rimase fermo per tutta la notte perché fuori c’erano i partigiani Rossi. Un cappellano militare camminava per il corridoio del treno con la corona in mano e diceva: ”Ragazzi preghiamo perché fuori ci sono i partigiani”, sentivamo infatti sparare dei colpi. Finché, al chiarore del mattino, il treno ripartì e arrivammo in Italia il 6 gennaio 1943 e fui ricoverato all’Ospedale Macchi di Varese Campo dei Fiori. Al ritorno, quando il treno arrivò a Bolzano i soldati che potevano farlo scesero dal treno e baciarono il suolo italiano, quello della propria Patria. Io non ci riuscì perché ero troppo debole, ma l’avrei fatto volentieri. Dai finestrini i civili italiani ci lanciavano fiori, cioccolato, sigarette. Quando il treno che ci portava entrò nella stazione di Varese vedemmo un’infinità di persone con le foto dei loro cari che erano stati mandati in Russia, che chiedevano se qualcuno avesse notizie di loro. Noi lasciammo il fronte nel momento in cui i Russi avevano sfondato le nostre linee:questione di ore e saremmo caduti prigionieri anche noi. La mia salvezza la devo al Comandante dell’ospedale che al momento di –“si salvi chi può” – all’arrivo dei russi, mi fece fuggire con lui altrimenti io, con polmonite, pleurite e congelamento ai piedi, sarei rimasto lì e quindi sarei stato fatto prigioniero il che avrebbe voluto dire morte, come successe a tanti miei compagni che non fecero più ritorno. Quando ci penso, tuttora ringrazio sempre Dio di avermi aiutato a tornare. Eravamo partiti in 52 della 137 Autosezione Pesante; ritornammo in meno di 10. Tutti gli altri o caddero in combattimento o furono fatti prigionieri e quindi morirono nei campi di concentramento di freddo, fame e malattie che li ridussero a larve umane; furono seppelliti in fosse comuni, assieme ad altri soldati di e nazionalità diverse. Molti non fecero più ritorno alle care famiglie. Caddero sotto atroci combattimenti; colpiti da fuoco nemico in un deserto di neve e ghiaccio, con temperature di 30-40°C sotto zero, o fatti prigionieri; e furono così tanti che io e tutti quelli che a questa guerra parteciparono non potremo mai dimenticare! Io tornai dal fronte in barella con un treno ospedale, non avevo nulla, solo la vita, che era tutto. Arrivato all’ospedale di Varese, quando sentii il rintocco delle campane ebbi una grande emozione, come se fossi rinato. Erano 18 Gli effetti del bombardamento aereo a Gorlowka, in Russia, nel 1942. 156 Cimitero di soldati italiani a Gorlowka (Russia) il 1° gennaio 1942. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei lunghi mesi che non lo sentivo e ciò mi ridiede tanta serenità. Alla prima visita medica, chiesi alla crocerossina cortesemente di procurarmi un foglio di carta, una busta, un francobollo e una penna per informare i familiari che ero ricoverato all’ospedale di Varese. Lei gentilmente mi portò tutto subito e io scrissi a casa visto che da parecchio tempo non avevano mie notizie. Quando arrivai dal fronte pesavo 39 kg, sulle mie gambe non si vedevano più muscoli dei polpacci, si notava bene l’osso. Mio padre mi raggiunse subito e l’incontro fu immensamente commovente! Partimmo per la Russia nel 1941 e in Italia c’era ogni ben di Dio. Tornammo nel 1943 e trovammo un’Italia in gran parte distrutta dai bombardamenti, c’era poco da mangiare, da vestire, tutto si acquistava con tessera, anche le sigarette. Non c’erano auto, tranne che per il medico e il veterinario; biciclette poche e non si trovavano i copertoni; mancava perfino il sale. Se trovavi qualcosa era al mercato nero. Io partii che avevamo un grande magazzino di tessuti strapieno, ritornai ed era vuoto. Tutto era stato distribuito con le tessere e non più rifornito perché non c’era più nulla: una disperazione! Pane, carne, vestiario, sigarette, ecc: tutto con la tessera. Mancava tutto, non c’era più nulla nei negozi. Gli Americani sbarcarono in Sicilia. L’8 settembre 1943, Badoglio firmò l’armistizio con gli Americani per far cessare la guerra dal momento che non avevamo più nulla e continuavano i bombardamenti sulle città che distrussero tutto poiché quando venivano a bombardare le nostre città gli aerei americani erano centinaia. Quando il Gen. Badoglio firmò l’armistizio con gli Americani, erano arrivati a Montecassino e sbarcati ad Anzio. Il governo Mussolini cadde, ad opera degli stessi componenti. Con la firma dell’armistizio sottoscritto dal Gen. Badoglio, che con la caduta del governo aveva assunto il comando, i Tedeschi si sentirono traditi e immediatamente presero posizioni ostili contro gli Italiani; disarmarono ed arrestarono i nostri soldati ovunque fossero e li trasferirono in campi di concentramento in Germania, assieme anche a molti civili. L’8 settembre 1943, molti Tedeschi si trovavano già in Italia per il fronte di Montecassino ma mandarono altri rinforzi e presero possesso di tutto. Perciò passammo da alleati ad invasi, sotto i loro cannoni. Fu un periodo molto nero e brutto per l’Italia! Si appropriarono di tutto ciò che faceva loro comodo. Si portarono in Germania migliaia e migliaia di bovini svuotando tutti i nostri allevamenti in Emilia, in Polesine e in Veneto. Passavano per Montegalda in gruppi di 500-600 quasi ogni giorno, diretti alla stazione di Poiana, dove caricavano capi di bestiame sul treno e li spedivano in Germania. Caduto il governo, Mussolini si nascose in un rifugio sulla Maiella. Hitler lo la m ia g iov e n tù 157 mandò a prendere con un elicottero; i soldati tedeschi fecero un blitz, lo rapirono e lo portarono a Berlino da Hitler. Poi, non so come, ritornò in Italia e il partito fascista fu ricostituito da volontari e fanatici simpatizzanti che collaboravano con i Tedeschi, e quindi contro gli stessi fratelli italiani. Facevano rastrellamenti e quelli che venivano presi venivano inviati nei campi di concentramento in Germania. Durante l’occupazione tedesca, dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, trascorremmo un periodo nerissimo, molto pericoloso e difficile. Non si dormiva mai a casa propria per paura dei rastrellamenti, non c’era più nulla, mancava tutto, non c’erano mezzi di trasporto; se vedevano qualcosa per le strade gli aerei americani mitragliavano. Di notte Pippo girava e sganciava bombe, anche bombe a farfalla antiuomo. Alla sera c’era il coprifuoco. Vivemmo momenti tremendi di guerra fratricida. Furono uccisi molti uomini, furono impiccati anche alle piante, successe di tutto. Dopo aver già combattuto una guerra, ci si trovò in questa situazione, in un’Italia distrutta dai bombardamenti e in una miseria assoluta. Dalle città moltissimi sfollarono da parenti o amici in campagna. Altri fuggirono in montagna per salvarsi e costituirono dei gruppi di partigiani per difendersi. Passavano flotte di 300-400 aerei, fortezze volanti americane, bombardieri che andavano a bombardare in Germania, sganciavano migliaia di tonnellate di bombe. Io avevo anche un fratello, Federico, classe 1913, che partecipò alla guerra in Africa durante lo stesso periodo: fu fatto prigioniero dagli Americani e mandato in America. In seguito, fu fatto rientrare in Italia a guerra finita. Al suo ritorno arrivò a Livorno e io andai a prenderlo con mezzi di fortuna perché non c’era altro modo. Io in guerra in Russia e Federico, mio fratello, in guerra in Africa: pensate ai nostri poveri genitori e fratelli! Per fortuna, ritornammo tutti e due. Il 25 aprile 1945 arrivarono dal sud gli Americani a liberarci con i loro carri armati, autoblindo e mezzi corazzati. Tutta la gente era contenta, in festa per la liberazione da questa infame situazione. I Tedeschi fecero saltare il ponte sul Bacchiglione a Montegalda, durante la ritirata. Si ritirarono non senza fare ancora morti fra gli Italiani. Si presero tutto quello che faceva loro comodo: cavalli, carrette, buoi, carri, biciclette, tutto ciò che trovarono e guai ad ostacolarli perché uccidevano con la massima facilità. “Al nemico che fugge fai i ponti d’oro”. Questa è l’esperienza che feci in guerra! Il periodo dell’occupazione tedesca, con il ricostituito partito fascista, fu un periodo di guerra fratricida: morti, deportazioni, bombardamenti, miseria; non c’era più nulla. Gli Americani passarono con le loro truppe corazzate a liberarci, ci portarono il sole della libertà, tanto desiderata! Alla fine della guerra prima di andarsene lasciarono in Italia tutto il loro parco di autocarri di cui ci servimmo per cercare di fare ripartire qualche attività, perché non avevamo nulla, dopo un periodo così lungo di guerra. Grazie al Piano Marshall, ci inviarono gratuitamente viveri per gli ospizi e per i bambini degli asili, per tanti anni dopo la fine della guerra. Le decorazioni militari di Vittorio Miotto. 158 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Nel 1939, in pieno regime fascista, fu ordinato a tutte le famiglie di offrire alla Patria il ferro che avevamo (anche le inferriate), il rame che tutte le famiglie avevano (perché si usava molto in cucina all’epoca) e l’argento (chi ne possedeva). Ricordo che anche mio padre ne offrì 120 grammi oltre che agli oggetti in rame di famiglia. Nel 1940, durante la guerra fu ordinato dal “Partito” di offrire alla Patria tutte le fedi nuziali in oro delle spose. In ogni paese veniva effettuata la raccolta e nessuno aveva la possibilità di sottrarsi perché la stessa era controllata e se qualcuno si fosse sottratto sarebbe stato segnalato come avversario del Partito Fascista, e ciò sarebbe stato grave perché tutti dovevano essere fascisti e seguire il Partito. L’Italia è un paese che non ha materie prime. Alla fine della guerra, le nostre industrie erano in gran parte distrutte ed avevano esaurito ogni scorta. L’America ci mandò di tutto: ferro, cotone, lana, gomma, caffè e quant’altro per far sì che ci riprendessimo economicamente e che le nostre industrie ripartissero. In un paese distrutto, gli Italiani si rimboccarono le maniche e si misero a lavorare intensamente per la ricostruzione. E ce l’abbiamo fatta, fino ad arrivare ad essere fra i primi del mondo nelle competizioni automobilistiche e motociclistiche e, inoltre, la nostra Fiat è presente in tutti i settori: auto, trasporti pesanti, treni, navi, aerei, mezzi per movimento terra, ecc… Molte e molte altre industrie si ripresero e ne sorsero di nuove che fecero onore al nostro Paese, esportando all’estero i loro prodotti. Anche l’agricoltura si è molto sviluppata rispetto a una volta. Sono stati forniti di mezzi nuovi che hanno dato ai contadini altre possibilità. Devo anche aggiungere che sono brava gente, laboriosa ed ingegnosa; hanno trasformato l’ambiente, in particolar modo i Colli, in fertili vigneti che offrono un ottimo prodotto. Ho fatto un po’ il riassunto di quello che ho vissuto durante il periodo della guerra 1939-1945 e post-guerra. Descrivere dettagliatamente tutto quello che ho vissuto è cosa impossibile perché sono stati tanti e tanti i pericoli che ho corso e mi rendo conto che sono stato tanto e tanto fortunato ad essere uscito miracolosamente da quell’inferno. Quando ci penso, trovo la forza di affrontare il futuro poiché la mia sorte sarebbe potuta essere quella dei tanti e tanti Italiani che non hanno fatto più ritorno. Bastia, 28.12.2008 Il monumento ai caduti Il monumento ai caduti eretto di fronte al Municipio di Rovolon in una cartolina spedita nel 1934. 160 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei i l monum e n to a i ca duti 161 ELENCO DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE Benato Arturo di Vittorio Bonello Filippo di Giovanni Breda Alban di Giovanni Bressan Girolamo di Francesco Bressan Virginio di Francesco Bressan Pietro fu Luigi Broetto Giuseppe di Gio Batta Callegaro Pasquale di Antonio Cazzoli Attilio di Antonio Dal Zotti Antonio fu Pietro Dalla Costa Floriano di Stefano Dalla Valle Carlo fu Giuseppe Fasolo Antonio di Luigi Forestan Attilio di Luigi Forestan Francesco di Luigi Forestan Angelo di Gaetano Frigo Olinto fu Zacaria Franchin Pietro fu Luigi Goldin Vittorio di Giuseppe Gomiero Ferruccio di Giuseppe Lazzaretto Emilio di Sante Michelazzo Giovanni di Antonio Mantovan Cesare di Pietro Mantovan Giovanni di Pietro Manfrin Sereno di Isidoro Menaldo Valdemiro di Modesto Miola Tullio di Valentino Miotto Luigi fu Lorenzo Miotto Verecondio di Luigi Marchi Marcello fu Giovanni Muterle Egidio fu Gaetano Nardin Bortolo di Pietro Pegoraro Vittorio di Pietro Polito Pietro fu Antonio Perin Antonio fu Giovanni Povoleri Ernesto di Giuseppe Regazzi Luigi di Giuseppe Regazzi Michele di giuseppe Rotuli Venanzio di Ignoti Rubini Arturo di Alessandro Rizzi Giovanni fu Florindo Specian Grazioso di Antonio Serra Giovanni di Ciro Trevisan Domenico di Lorenzo Vedovato Giuseppe fu Enrico Vomiero Girolamo di Giuseppe Veronese Massimo di Luigi Varotto Luigi di Giuseppe Veronese Abramo fu Francesco Zabarella Luigi fu Serafino Zilio Antonio fu Angelo Zambolin Riccardo di Giovanni Zambolin Vittorio di Giovanni Zattarin Luigi fu Antonio Zattarin Giuseppe di Fedele Zattarin Riccardo Bovo Riccardo di Domenico Carraro Giuseppe di Bortolo Donadello Benvenuto fu Antonio Furlon Gino fu Antonio Galasin Florindo di Luigi Giurin Romolo di Vottorio Raimondo Albino di Antonio Specian Clemente di Antonio Toffan Domenico di Luigi Zordan Bentivoglio di Pietro Zavattiero Giuseppe di Mariano Ambrosini Fioravante fu Agostino 162 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei i l monum e n to a i ca duti 163 ELENCO DEI CADUTI NELLA GUERRA 1940-1945 MILITARI Albanese Paolo di Giovanni Canton Umberto di Antonio Colombo Vittorio di Giovanni Fiocco Rino di Giovanni Giacomin Battista di Giovanni Magagnin Giorgio di Oreste Mandruzzato Giuseppe di Luigi Mantovan Nerino di Luigi Michelazzo Ottorino fu Felice Montemezzo Augusto di Gelindo Neri Domenico di Luigi Palladin Lorenzo fu Stefano Romanato Decimo fu Giuseppe Taccon Modesto fu Clemente Taccon Paolo fu Clemente Toniolo Augusto di Rodolfo Turetta Rino di Angelo PARTIGIANI Montemezzo Aldo di Ettore Navarini Massimiliano di Giacomo Pasqualin Luigi di Natale Pavanello Ugo fu Adolfo Militare Trevisan Mario CIVILI Baldan Franco di Giovanni Brocca Natalino di Giuseppe Marcato Geremia fu Giuseppe Olivetto Angela fu Leonardo Rinaldi Ermenegildo di Gino Rinaldi Luciana di Gino Rinaldi Silvano di Gino Scacco Cesare fu Marcantonio Scacco Pia fu Cesare Scacco Silvia fu Cesare Sgarabottolo Alba fu Luigi Soranzo Riccardo fu Luigi Zambolin Antonio fu Giuseppe DISPERSI Brigadini Ottorino fu Angelo Busato Matteo fu Pietro Cecchetto Bruno fu Riccardo Michelazzo Francesco di Quirino Sanvido Benedetto fu Bortolo Sbicego Silvio di Antonio Bregolato Antonio di Domenico Bernardini Paolo fu Luigi Carlan Alcide fu Rita Ziggiotto Giuseppe fu Silvio Ziggiotto Tullio fu Silvio Renzo Forestan Storia e vita contadina Un’intervista a Luigi Forestan* Ci siamo recati in via Loredan dove abbiamo avuto una simpatica conversazione con il più vecchio abitante della contrada, cav. Luigi Forestan, effettuata quando era ancora in vita, la persona più idonea a darci utili informazioni della località su ricordi e fatti personalmente vissuti o ricostruiti in base ai racconti dei vecchi. Sono fatti e ricordi tipici di usanze e costumi che rispecchiano condizioni di una vita contadina semplice, densa di sacrifici e umiliazioni e che certamente i magri prodotti della terra a stento riuscivano a soddisfare le più modeste esigenze di una vita che a malapena si potrebbe dire normale. Le cose che il cav. Forestan ci ha raccontato sono tante e tantissime altre certamente ne avrebbe da dire che un libro intero forse non basterebbe. Ci hanno colpito specialmente notizie e fatti riguardanti il periodo della prima guerra mondiale, dove il posto era trasformante in luogo di riposo per i soldati che tornavano dal fronte. Nei granai e nei locali dell’abitato si alternavano per brevi periodi di tempo 250- 300 soldati che poi ripartivano per dar posto ad altri. Nella ritirata tedesca dell’ultima guerra poi, in seguito all’incendio di un carro armato carico di esplosivi sulla strada comunale Campanella, la colonna germanica in ritirata scelse come alternativa, obbligati nella fuga, la via Loredan e quindi gli abitanti dovettero assistere inermi al passaggio dei tedeschi attraverso la corte. Questi portarono via il bestiame, i carri e le biciclette. Furono giorni di grande paura e terrore, vissuti nella solidarietà e dividendo fame e miseria con la gente sfollata dalla città che qui aveva trovato ospitale rifugio. Tanti e tanti ricordi del duro lavoro nei campi dove * Sindaco di Rovolon dal 1959 al 1961. Luigi Forestan tiene l’aratro con vomere a collo d’oca. 166 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei non esistevano certamente le comodità dei moderni attrezzi agricoli. Fu un grande avvenimento quando si iniziò a trebbiare il frumento con la macchina a vapore; la falciatrice meccanica trainata dai buoi per esempio, alleviò moltissimo il lavoro dei contadini quando l’erba doveva essere falciata tutta a mano. I ricordi poi del gran cantare che si faceva una volta durante i lavori e specie nel periodo della vendemmia; le lunghe serate inver nali trascorse nel tepore delle stalle dove i vecchi o gente di passaggio che veniva a “far filò”, raccontavano storie e avvenimenti che venivano poi tramandati continuamente, travisati a volte e ampliati con particolari inventati. Esiste un patrimonio di storie e di favole che sarebbe veramente interessante poter riscoprire. Le domande rivolte al cav. Forestan sono state fatte senza uno schema preciso, tuttavia speriamo di dare lo stesso un’idea di come si svolgeva la vita in questo agglomerato di case dagli inizi di questo secolo. (In corsivo le domande – R = risposta) Da quanto tempo abita qui? R. Io sono nato qui nel 1906, ma mio nonno e mio padre si sono stabiliti qui nel 1888, provenienti da Grisignano di Zocco. Erano fittavoli di 120 campi e i proprietari di questa tenuta che comprendeva in realtà ben 800 campi erano i signori Regensburger, austriaci stabilitisi qui forse nel periodo del Regno Lombardo Veneto. La tenuta si estendeva fino sotto il territorio di Cervarese S. Croce. Quando suo nonno si è stabilito qui, questi edifici erano già tutti costruiti? R. Sì, ed all’aspetto si presentavano già vecchi. Esisteva anche all’ingresso in corte una fornace di mattoni e tegole in piena efficienza; mancava però il forno del pane, costruito verso il 1921 dopo che i signori Regensburger hanno Filare di gelsi nella campagna di Rovolon. sto ria e v ita con ta dina 167 venduto questa loro proprietà ai signori Perazzolo. C’era invece il telaio per tessere, molto vecchio e che è stato da pochi anni bruciato. La tela, per lo più canapa e lino veniva tessuta per uso domestico o per qualche vicino che ne facesse richiesta, il quale pagava l’uso del telaio un tanto al “braccio” di tela tessuta. Come vi comportavate davanti ai padroni Regensburger? R. Dovevamo tenere un contegno umile, rigoroso, sottomesso. Il padrone Ottavio Regensburger aveva un aspetto nobile (non aveva però titoli nobiliari), aveva studiato molto, leggeva due o tre giornali alla settimana e fumava 12 sigari di marca Virginia al giorno. Come si svolgeva la vita di voi contadini quando eravate fittavoli di Regensburger? R. C’era sempre da temere ad avere “i padroni in casa” come si suol dire. Infatti una volta mio fratello si era fatto fare una giacca che a vista dei padroni sembrava troppo elegante per le nostre condizioni; quella giacca suscitò un mezzo scandalo e si dovette riportarla dal sarto perché la raggiustasse e apparisse così più adeguata alle nostre condizioni sociali. Dovevamo pagare un affitto molto caro; in più nel contratto dovevamo mantenere due cavalli per i padroni con il nostro fieno, dovevamo dare un pollo per campo (le cosidette “onoranse”), una giornata lavorativa alla fornace per ogni campo e altre spese gravose. Nonostante tutto questo, noi Forestan, con sacrifici che è facile immaginare, siamo riusciti a sopravvivere, mentre i Regensburger sono falliti... quelli lavoravano a consumare. I Regenscurger sono andati via da qui nel 1920. Come si svolgeva la vita dei Regensburger? Che tipo di famiglia era? R. Facevano una vita da gran signori! Andavano 3-4 volte alla settimana a Padova in “landò”, specialmente lui il signor Ottavio; spesso andavano in visita dai conti Barbaro, dai conti Giro a Rovolon, dai conti Papafava. Qui a casa loro c’erano sempre pranzi: compleanni, onomastici, anniversari vari... 15-16 grossi pranzi all’anno. Alla sera non uscivano mai, forse per paura. Avevano inoltre un “bel” difetto però: non controllavano il loro fattore. Infatti, il fattore se per esempio comprava un Kg. di carne di vitello per il padrone ne comprava un Kg.e mezzo per la sua famiglia e naturalmente il conto da pagare era per Regensburger, ciò potrebbe sembrare un esempio banale, ma dietro questo, come si sa, correva tutto il resto. Ottavio Regensburger aveva una figlia sposata al dott. Piozzi. Dal matrimonio nacquero quattro figli a una figlia; questi studiarono tutti in città ma purtroppo non riuscivano negli studi e arrivarono a 40 anni senza avere un impiego. Anche questa è stata una causa della rovina dei Regensburger. Il dr. Piozzi morì abbastanza giovane e quindi i figli assieme alla madre chiamata “la paronsina”, ritornarono a vivere qui. In seguito tre di questi figli Nini, Ottavio e Pino si sposarono e andarono a vivere per conto proprio, ma però molto spesso tornavano qui con le rispettive famiglie e si fermavano anche per 7-8 mesi vivendo alle spalle del nonno. 168 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Quante persone vivevano pressa poco in questa corte? R. In questa corte vivevano all’incirca 40 persone senza contare i padroni. Quali contatti avevate con il centro del paese? R. Io, personalmente ero sempre in giro, il resto però della gente che abitava qui andava in paese solo la domenica, a piedi, per la Messa al mattino e il Vespero al pomeriggio. Chi se lo poteva permettere, si fermava in osteria per bere mezzo litro di vino ma poi subito a casa. Durante la settimana sempre a casa. Lavorare e a letto, non c’erano le attrattive e le comodità del giorno d’oggi, purtroppo! Come trascorrevate qui il tempo libero d’inverno e d’estate e soprattutto di sera? R. Di sera in inverno si faceva un grande “ filò” nella stalla; le donne filavano, gli uomini giocavano a carte e usavano come moneta i fagioli. Ad ogni fagiolo corrispondeva una certa quantità di denaro. Alla fine del gioco però quando si facevano i conti dei fagioli vinti, tutti avevano fagioli in più ! ! ! Si raccontavano storie, fatti successi, visti e sentiti di recente, la stalla era quasi un centro di informazione. In estate invece ci si sedeva alla sera al centro della corte dove c’era uno spiazzo erboso. Anche li si rimaneva fino alle 10,30-11, chiacchierando, raccontando qualche storia o barzelletta e facendo qualche bel canto. Vi era una atmosfera di allegria specie fra i giovani. Quando lei era piccolo come trascorreva il tempo? R. Allo scoppio della guerra 1915-18, avevo 9 anni, e ho dovuto subito incominciare a lavorare i campi con mio nonno e mio fratello, perché mio padre e i suoi 5 fratelli che vivevano con noi, erano tutti in guerra. Due di questi sono morti e dispersi, mio padre è tornato mutilato, solo due sono rimasti sani, uno dei quali ancora vivo è residente a Bosconero (TO). Eravamo sempre sui campi, facevamo naturalmente quello che potevamo, data l’età. Il Signor Carlotto in corte Forestan. sto ria e v ita con ta dina 169 Mi ricordo però che non vedevo l’ora di avere un po’ di tempo libero perché ero sempre pieno di sonno e di stanchezza. Ecco, il nostro tempo libero lo trascorrevamo a dormire. Ci parli dell’Orco. R. Forse una volta qualcuno ha visto un fantasma, un po’ lontano da qui ma sempre in questa campagna. Allora per distinguere l’appezzamento di terreno, questo è stato chiamato “Orco” e ancor’oggi lo chiamiamo così. Sapete, l’Orco era qualcosa che vedevi per un momento e poi appena chiuso l’occhio, non lo vedevi più. A quei tempi però, penso che la gente avesse avuto spesso lo stomaco vuoto e quindi vedessero facilmente i fantasmi, oppure bevessero il vino con la “fogara” come si suol dire qua, e per questo vedevano l’orco. Un altro appezzamento di terreno, non lontano da qui, lo chiamano ancor oggi “traverso de canon” a ricordo dei primi cannoni antigrandine sistemati su quel posto. Cannoni ideati da un certo don Candeo, parroco di Mestrino e costruiti qui a Bastia dalla ditta Tubaldo. Come si spostava la gente qui una volta? R. La fidanzata di mio padre, cioè mia madre, da ragazza abitava qua vicino, ma poi si trasferì ad Albettone. Mio padre, il giorno del matrimonio, è andato a prenderla a piedi, si sono sposati alle 10 ad Albettone e quindi il corteo nuziale a piedi ritornò qui, dove fecero il pranzo di nozze sotto il portico. Mi hanno raccontato anche che dopo quella bella camminata di quindici chilometri!, hanno mangiato e bevuto molto volentieri e con appetito! Una volta non c’erano annunci, bomboniere, confetti. La vita era molto più semplice, si aveva meno esigenze e spesso eravamo più felici di adesso. Abbiamo sentito parlare dei resti di un cimitero esistente nella zona. Ci può dare qualche notizia in merito? R. Non lontano da qui una volta è stato scavato un fosso profondo. È stato proprio lì che durante i lavori sono affiorati resti mortali: ossa di braccia, di gambe, teste, pezzi di lapide. Mio padre trovò questi resti che furono poi messi in cassette e portati nel cimitero in paese. Comunque è certo che qui esisteva realmente un piccolo cimitero. I resti non si sa di chi fossero, le lapidi rinvenute non avevano iscrizioni. Probabilmente, la presenza della chiesetta, di tanta gente e tante case che si trovavano nel circondario di questa corte e la lontananza dal paese, giustificano il fatto che la gente sepolta fosse di questa zona. Che cosa era la “ boaria”? R. La “boaria”, oltre all’edificio adibito a stalla con fienile e portico che comunemente si intende, era l’insieme degli animali che si legavano davanti l’aratro. Erano tre, quattro, anche cinque coppie di buoi, mucche, vitelli. Gli animali erano muniti dal giogo. La prima coppia era attaccata all’aratro, la seconda coppia era unita alla prima con un timone mobile (“timonsèo”) e così via. Due persone guidavano le bestie, un altro teneva l’aratro. Si era almeno in tre persone. La boaria si usava così numerosa, perché era difficile arare in quanto la terra qui è molto argillosa. 170 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Come si faceva il bucato una volta? (A questa domanda ha risposto la moglie signora Vittoria). R. Una volta si faceva il bucato ogni 6 mesi. Questo per quanto riguardava lenzuola, federe, tovaglie, ed era chiamato “lissia grande”. Si lasciava la biancheria da lavare in acqua per un giorno; si faceva un primo lavaggio e poi si buttava sopra acqua bollente e cenere; il giorno dopo si lavava e alla sera si gettava sulla biancheria ancora acqua calda e cenere, infine il giorno seguente dopo aver lavato e risciaquato si stendeva al sole. Adoperavamo due grandi mastelli di legno con due grandi tavole da lavare che conserviamo ancora in cantina. Facevamo inoltre un bucato settimanale, per la biancheria normale di tutti i giorni. Non c’era inoltre nessun detersivo, solo un pò di sapone spesso fatto in casa. È emigrata molta gente da qui? R. Non molti. I primi sono emigrati per lavorare altre campagne, perché qui si era in troppi. Circa 20 anni fa alcuni miei cugini sono emigrati in Piemonte, alcuni per lavorare la terra, altri hanno cambiato “mestiere” e sono andati nelle fabbriche. Attualmente anch’io ho due figli sposati che lavorano in fabbrica a Torino Riguardo le costruzioni che vediamo qui, è stato demolito molto in questi ultimi anni? R. Qualcosa è stato demolito: la fornace da molti anni, poi da non molto tempo la casa del cocchiere, il cancello di ingresso in corte, il forno. Al loro posto sono state costruite due case nuove: una dove abito io e quella dove abita mio nipote. Sapete, penso che a tutti piaccia abitare in case decenti. Qualcuno può dire che abbiamo deturpato l’ambiente, forse, in parte è vero. D’altra parte non si può restaurare case con locali bassi, umide e malsane senza dover spendere un sacco di soldi. Bastia. Viale della Posta in una cartolina viaggiata nel 1933. Si parla oggi della riscoperta di una nuova forma di turismo. Quella di trascorrere le vacanze, d’estate per esempio, in campagna. Intendiamo cioè quello che i giornali chiamano “Agriturismo”. Lei ad esempio se si presentasse l’occasione metterebbe a disposizione o restaurerebbe dei locali da affittare a persone che ne facessero richiesta? R. Personalmente, no. Renzo Forestan Un rito della campagna: le rogassion La pia tradizione delle Rogazioni (da latino rogatio, rogationis, cioè preghiere, richieste), si perde nella notte dei tempi. In epoca dove l’economia e la vita erano prevalentemente di tipo agricolo, la processione a carattere penitenziale, accompagnata da preghiere e canti propiziatori, era tutta intesa a favorire la fecondità della terra e il buon raccolto. Nell’antico culto cattolico le rogazioni si distinguevano in maggiori, celebrate il 25 aprile e minori celebrate nei tre giorni antecedenti il giovedì dell’Ascensione. Anche se con il Concilio Vaticano II, con la riforma liturgica, queste pie tradizioni sono state abbandonate e lasciate a libere e generiche suppliche a Dio per le comuni necessità dell’uomo o come atto di ringraziamento, noi abbiamo ancora la fortuna di ricordarle e celebrarle secondo la tradizione dei nostri padri. Ma ha ancora senso oggi in tempi moderni dove tutto sembra si possa ottenere anche senza l’aiuto divino, celebrare un simile rito? Ma certamente sì!... Le preghiere e le benedizioni invocate sui campi, sui raccolti, sulle case devono essere intese innanzitutto sulle persone, che oggi ancor più di ieri lavorano ancora sui campi, ma anche nelle fabbriche o negli uffici. Auspichiamo che dall’aridità degli animi, sempre più immersi e a volte vittime del mondo tecnologico, parta ancora il coraggio di fermarsi un po’ per osservare la natura come bellezza del creato, dove i fiori del campo o il canto degli uccelli che non seminano e non mietono, lodano e ringraziano Dio. “A fulgure et tempestate libera nos Domine, a flagello terremotui... libera nos Domine!” Si ripeteva cantando in queste occasioni. E oggi quante tempeste (anche se non metereologiche) affl iggono l’uomo moderno? Quanti terremoti familiari affl iggono la vita delle nostre case? Fermiamoci un po’, e in mezzo a questi campi fioriti guardiamo verso l’alto e umilmente proviamo a dire grazie per quello che siamo e che abbiamo, in quanto noi da soli “Siamo niente, mentre Lui è tutto”, come soleva ripeterci, per chi si ricorda ancora, la nostra compianta suor Battistina della Scuola materna. È bello non dimenticare le tradizioni dei nostri padri che si affidavano sempre alla Provvidenza. Nell’imminenza del pericolo, con gesti e segni particolari (come accendere la candela benedetta della Candelora, bruciando nella “fogara” l’ulivo benedetto il giorno delle Palme e intonando il rosario e recitando giaculatorie come “Gesù, Giuseppe, Maria salvateci”, oppure “Santa Barbara benedetta, tien lontan el ton e la saetta”), si mettevano un badile e un rastrello in forma di croce sull’aia e intanto il parroco usciva di chiesa per benedire il tempo e il campanaro si metteva a suonare le campane a distesa. 172 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Purtroppo il Padre Eterno non sempre ascoltava le suppliche dei contadini, perché ovunque dai resoconti storici dei parroci o dalle cronache del tempo abbiamo descrizioni di disastri e morte. Il freddo invernale, la siccità estiva, la grandine, le “moeste”, con trombe d’aria e uragani, quante volte nei secoli passati distruggevano interamente i raccolti seminando miserie e disperazione su tante famiglie. Da cronache dell’epoca viene riferito che il 3 maggio 1672 si manifestò un fiero turbine che distrusse tutto in diversi comuni … nei paesi di Bastia e Rovolon si fece un solenne voto a Sant’Antonio… «di far festa di precetto tutti li martedì di maggio, in perpetuo, e di far messa cantata in ognuno di tali giorni, accioché con l’intercessione di sudetto santo, Iddio tenga lontano le tempeste». Maggio ancor oggi, infatti, può colpire duro, con la grandine che nasce dagli sbalzi repentini della temperatura e con le “moeste” frequenti nei giorni dei “setoni” 7/17/27. A conclusione di questa rogazione, che in questo luogo [la corte Forestan Carlotto Zaffari, ex oratorio della corte benedettina al Vegrolongo dei monaci di Santa Giustina di Padova] si ripete ogni anno da secoli, vogliamo ringraziare tutti i partecipanti e in particolare il nostro parroco don Claudio, che anche quest’anno con la celebrazione della Santa Messa, ha voluto tener vivo questo oratorio assicurando la protezione celeste sulle nostre campagne e sulle nostre famiglie, certi che la Divina Provvidenza non ci abbandonerà quando con cuore umile e sincero la invocheremo. Maggio 2009. Le crosete in corte del Vegrolongo. u n rito de l la ca m pag na Un componimento di Ignazio Canesso Le Rogassion No tanti ani fà, la festa de l’Assension la gera de preceto co la so procession. E senpre de che’l dì la vegnéa conpagnà dal deto che dizéa: Pensa o no pensa, de zoba vien “La Sensa”. Che gera anca la tradission e gera belo, de magnare la lingua de porselo. Propio el dì de la Sensa, par no pèrdare l’usansa. I tre dì prima de sta festività, se fazéa le Rogassion co solenità. Zo dal leto a le quatro e mesa, pa èssare a le sinque in cesa. Prima, messa e pregare e dopo, fora a cantare. Se intonava le “tanìe” de i santi, pa invocarli tuti quanti. E via par trosi e caresà, a benedire i canpi, da la tenpesta e sicità. El paroco parlava in latin, noaltri no capìvimo on s-ciantin. Quando el lezéa: “... da fulgore et tempestate, et conservare digneris... “, a noaltri tosi i òmani dizéa; “... Ghio capio! No bisogna goastare ignari.” Ogni raquante case on altareto, co crosete e soto qualche oveto. 173 174 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei El sagrestan li rancurava, e tuti de longo cantava. Tanti passando, vardava co devossion, tuta sta zenle in procession. Chi se segnava, chi la testa calava. Tuti pregavimo el Padreterno, fiduciosi del so aiuto, par passar ben istà e inverno. Ignazio Canesso Le crosete da benedire. MONUMENTI E PALAZZI Don Antonio Pontarin La chiesa di San Giorgio di Rovolon Dalle origini al xvi secolo Nella storia della diocesi di Padova la pieve di San Giorgio di Rovolon occupa un posto di tutto rilievo, sia per l’antichità del luogo sacro sia per lo stretto legame che per lungo tempo mantenne con il monastero padovano di Santa Giustina. È datato febbraio 970 il primo documento che la nomina espressamente: ecclesiam unam quae est aedificata ad honorem sancti Georgii in loco dicto Robolone cum terris et omnibus decimis quae ibidem pertinent et totam decimam que dare debetur famulis sanctae Iustinae sive in montibus sive in vallibus.1 Si tratta della donazione fatta dal vescovo padovano Gauslino al monastero di Santa Giustina. La chiesa, edificata in onore di San Giorgio – questa la traduzione del testo latino – si trova nel luogo detto Rovolon e viene ceduta ai monaci con le sue terre e tutte le decime che le spettano, nonché quelle dovute dai famuli (cioè i lavoratori) del monastero di Santa Giustina per le terre che coltivano, poste sulle colline e nelle valli. L’edificio sacro, descritto nell’antica pergamena, in quella seconda metà del decimo secolo era in piena attività. Per l’ordinamento ecclesiastico del tempo figurava tra le pievi della diocesi, in altre parole era una chiesa matrice, dotata di un fonte battesimale, da cui dipendevano le cappelle dei paesi circostanti. È noto che per i primi secoli del secondo millennio solo nelle pievi fu amministrato il sacramento del battesimo, vero rito d’iniziazione per i cristiani. In quello scorcio del X secolo le pievi situate ad occidente di Padova si contavano sulle dita di una mano e, di norma, erano situate nel cuore dei villaggi più antichi e popolosi. Condizioni tutte che ritroviamo nella pieve di San Giorgio e che – indirettamente – testimoniano il ruolo trainate, importante, primario del villaggio di Rovolon rispetto agli abitati dell’intera area che dagli Euganei s’estendeva ben oltre il Bacchiglione e fino a Montegalda. Le pievi della diocesi di Padova, ricorda un altro documento di cent’anni dopo (14 marzo 1077), erano proprio a Montegalda e Rovolon, a Lissaro, Arino, Caltana, Conselve, Cona, Tribano, Maserà, Albignasego, Abano, Torreglia, Galzignano, Luvigliano, Curtarolo e Sarmazza. Nell’elenco del 1077 non compare la pieve di Selvazzano poiché a quel tempo apparteneva alla diocesi di Vicenza: un legame che verrà reciso solo nel 1818.2 Nel documento del 14 marzo 1077 è ricordato un certo Giovanni nella veste di arciprete di San Giorgio; suoi successori furono più tardi Achille, che incontriamo in pergamene datate 8 e 24 luglio 1204 e ancora il 22 settembre 1216;3 Galzignano, attestato da uno scritto del 1° maggio 1218;4 Carlo, che troviamo 178 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei in un documento del 12 aprile 1232 assieme a prete Cono, e ai chierici Paolo, Todisio e Ventura,5 a conferma che nella pieve di San Giorgio viveva una comunità canonicale di sacerdoti e chierici. Nella deliberazione assunta dagli uomini di Rovolon il 6 agosto 1262, per il destino del bosco Viglanicus, il rettore di San Giorgio risulta essere domino Savarisio: al suo fianco il chierico Gerardo e prete Guglielmo presbitero ecclesie de Carbonaria.6 Nella decima papale del 1297 – così è chiamata la straordinaria riscossione voluta da papa Bonifacio VIII (1294-1303) per finanziare il primo Giubileo dell’anno 1300 – il rettore di San Giorgio di Rovolon, l’arciprete Pasquale, fu esentato dal versare la propria quota poiché non percepiva alcun reddito (excusatus quia nichil percepit) mentre i suoi collaboratori, cioè i chierici Zambono, Federico Capodilista e Ivasio, furono tassati per 20 soldi ciascuno, sia per la prima sia per la seconda rata. Somme modeste se rapportate alle imposizioni richieste, ad esempio, ai rettori delle chiese di Valsanzibio, Teolo, Zovon e Galzignano, ma in linea con la povertà che allo scadere di quel XIII secolo si registra a Bastia, Montemerlo, Carbonara, Boccon, Castelnuovo e Cortelà, tutte chiese esentate dall’obolo papale per le ridotte entrate di cui potevano beneficiare.7 Eppure il patrimonio della pieve di San Giorgio non era per nulla irrilevante. All’indomani della conquista veneziana del novembre 1405 anche le comunità religiose furono obbligate a presentare la loro “denuncia dei redditi”, chiamata allora “polizza d’estimo”. L’arciprete di Rovolon ottemperò a quell’obbligo fiscale denunciando un elenco, lunghissimo, di beni immobili detenuti dall’ecclesia Sancti Georgii de Revolono. Una lista datata 7 agosto 1427 comprendente ben tredici “sedimi”, cioè modeste estensioni di terra su cui sorgevano altrettante abitazioni coloniche, disseminati in una dozzina contrade. Case affittate che rendevano all’arciprete canoni in denaro e in generi alimentari (polli e galline). Tra queste costruzioni v’era la domo de cupis con teiete de paleis, (una casa in muratura con il tetto in coppi e una tettoia di pali La chiesa di San Giorgio di Rovolon sul finire dell’Ottocento, prima dei lavori eseguiti nel 1911. la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 179 in legno) edificata su mezzo campo di terra, unita ad una posta molendini, cioè un mulino.8 Pietro, rettore dicte ecclesie Sancti Georgij de Rovolono, in quell’agosto 1427 ebbe il suo bel daffare nel compilare l’elenco, nel descrivere uno ad uno gli appezzamenti di terra posseduti, nel precisare contrade e località, estensione delle superfici, nomi dei fittavoli e, soprattutto, quanto quel patrimonio rendeva in denaro e altri generi. Seppur divise tra beni esclusivi, livelli (contratti a lunga scadenza), vigne, prati, terre arative, terre vegre, cioè non coltivate, e decime, le unità elencate furono ben centoquarantaquattro. Erano per lo più modesti, anzi modestissimi appezzamenti di terra estesi mezzo o un quarto di campo, alternati a prese de olivariis, cioè piccole macchie di ulivi, o, ancora, a fazzoletti di coltivi popolati di vigne schiave, palestre e pergole. Altre terre erano invece a prato, nelle contrade Fontana Coperta, Fontaniva, Oltre Fossa, Lovare, Costa. In questo paesaggio agrario del XV secolo non mancano i boschi, i ronchi, i prati serati (le cesure) e, nelle aree di pianura, le paludi. In coda alla lista delle terre, prete Pietro aggiunse il mobilio e gli arredi sacri della chiesa: bonarum ecclesie. Al primo posto pose un messale pulcrum (splendido), poi un calice altrettanto pulcrum de argento, seguito da un paramento ricamato. Precisò poi che l’altare era ornato di varie tovaglie, che sull’ambone vi era un palio e che davanti all’ancona (forse una tavola dipinta racchiusa in un’inquadratura architettonica) vi era una tenda (cortina). Due le campane in funzione sul campanile mentre una terza, piccola, era usata in chiesa ad levandum Corpus Xristi, cioè durante la consacrazione. A queste tre s’aggiungeva un piccolo campanello che accompagnava l’Eucarestia quando veniva condotta fuori della chiesa. Assieme agli oggetti sacri il nostro diligente rettore Pietro si preoccupò d’includere anche i beni mobili della canonica: un torchio per l’uva, tre botti (vegetes), due casse, un letto e una catena usata nel camino per cucinare. Forse dimentico di alcuni oggetti sacri, o perché custoditi nella canonica, aggiunse il possesso di un salterio usurato (frustum), di un libro grande per il canto, in cui era inserto un graduale, e un libro per benedire. Ritornato in cantina completò l’inventario includendo un tino grande e uno piccolo per pestare l’uva, tre stari per misurare il frumento, una cotta (ampia tunica) bianca di tela e, infine, un tabernacolo in argento ad portandum Corpus Xristi sine pede, cioè privo di basamento.9 Ricordato che, dopo prete Pietro, nel 1436 rettore della pieve di Rovolon era prete Bartolomeo,10 va qui sottolineato che sul finire del secolo XV San Giorgio divenne parrocchia monastica a tutti gli effetti. Le vicende che portarono a quel cambiamento e alla ricostruzione materiale dell’edificio sacro, le seguiamo passo passo attraverso i documenti del tempo. Rovolon diventa parrocchia monastica: cronaca di un evento Con propria “Bolla” emanata a Venezia il 19 settembre 1499 il cardinale Giovanni Borgia, legato della sede apostolica per l’Italia, decretava – in perpetuo – l’unione, l’annessione e l’incorporazione della chiesa parrocchiale di Rovo- 180 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei lon alla mensa abbaziale di Santa Giustina.11 L’atto di curia (il legato in quella circostanza agiva come una sorta di Curia Romana itinerante), di fatto, accoglieva un’esplicita richiesta del monastero di Santa Giustina e coronava una serie di interventi da tempo coordinati a tal fine. I motivi che avevano spinto a questa soluzione erano molti, parte enunciati nei documenti e parte facilmente intuibili, e li vedremo man mano in seguito. Quello più insistentemente messo in campo era legato alla fatiscenza della chiesa di San Giorgio. L’edificio sacro era di certo in cattivo stato: non sappiamo a quando risalisse la costruzione poiché nel testamento dell’undici aprile 1324 il notaio Zambono aveva lasciato «solidos viginta parvorum annuatim in perpetuum ad refactionem ecclesie S. Georgii de Rovolon»12. La quantità e il tipo di lascito fanno tuttavia pensare più ad una manutenzione ordinaria che ad una ricostruzione materiale dell’edificio sacro. Ad un rifacimento del tetto pensava l’abate Bernardo da Piacenza quando, in una lettera del 14 marzo 1466, sosteneva che la spesa per l’indennizzo di prete Antonio da Fermo era stata generata dalla rovina totale della chiesa, in quanto le travi per la copertura erano già state tolte. I lavori dovevano quindi esser pagati con i proventi del beneficio, proventi che l’abate temeva allora di dover invece destinare al prete cacciato. Una qualche riparazione comunque fu fatta se Giovanni Albanese lasciava poco dopo nel suo testamento «lire 20 a la chiesa per lavuriero», cioè per i lavori.13 Quando, domenica 20 settembre 1495, salì a Rovolon il vescovo Pietro Barozzi, la chiesa era ancora quella vecchia e il vescovo la riconciliò secondo il rito canonico assieme al cimitero circostante perché era stata violata; al pomeriggio cresimò parecchi fedeli.14 Purtroppo la scarsa cronaca15 non dice di più: il luogo sacro era stato violato, non interdetto (per esempio per questioni di decime), c’era stato quindi probabilmente un fatto di sangue di cui non sappiamo nulla.16 Il vescovo quella sera restò certamente ospite dei monaci i quali, il lunedì successivo (festa di San Matteo apostolo), lo accompagnarono al Vegrolongo a consacrare l’altare e la chiesa campestre ivi costruita dal monastero «per comodità dei contadini che abitano lì attorno». Il giorno dopo, martedì 22, il vescovo Barozzi salì alla chiesa della Madonna del Monte, non senza essersi prima fermato a S. Antonio del Covolo e averne consacrato l’altare. Si resta stupiti che ad un tale infaticabile consacratore sia sfuggita la chiesa di S. Maria della Bastia da poco costruita; eppure deve esserci passato vicino, se non proprio davanti, scendendo da Rovolon per il Vegrolongo. Il monastero di Santa Giustina mirava di certo a ricomporre la parrocchia a suo modo: la vecchia chiesa di S. Giorgio per la collina, vicino alla corte della Costa, e la nuova cappella al Vegrolongo, nella zona ormai popolata e ampiamente messa a coltura e nel cuore della grande tenuta agricola in piano del monastero. Rimaneva naturalmente la giurisdizione unitaria della vecchia chiesa madre. In questo disegno la chiesa, sorta nella zona cerniera di Bastia, era fuori posto, era cioè una prioria con funzione del tutto devozionale e privata. Ma la logica topografica del monastero non coincideva del tutto con i movimenti spontanei del paese, nel quale Santa Giustina era sì l’elemento principale, ma non l’unico. La chiesetta del Vegrolongo fu dedicata a S. Vincenzo Fer- la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 181 rer, domenicano spagnolo, grande predicatore morto a Vennes (Francia) nel 1419, canonizzato dal papa spagnolo Callisto III nel 1455. Non sappiamo le ragioni di questa scelta certo non corrispondente alla pietà popolare che ben presto cambiò il titolo alla chiesa con quello del più amato santo protettore S. Sebastiano.17 All’attivismo dei monaci corrispose in modo singolare la totale “assenza” dell’arciprete di Rovolon, Andrea dal Bò, del quale nemmeno il nome compare negli atti della visita; di certo questo sacerdote era avanti con l’età e da qualche anno ormai si stava ventilando un suo ritiro concordato con i monaci: la trattativa era giunta proprio allora alle ultime battute. Della cosa essi parlarono senz’altro con il vescovo che, buon amico dell’abazia di Santa Giustina, non creò difficoltà. Dal 1480 circa arciprete a Rovolon era prete Andrea dal Bo, originario di Monselice. La sua storia è alquanto singolare: si era inizialmente sposato e solo in un secondo momento, rimasto vedovo, aveva ricevuto l’ordine sacro, ottenendo dall’abate di Santa Giustina il governo della parrocchia di Rovolon. In tal ufficio aveva manifestato particolare impegno nel riordinare la gestione del beneficio parrocchiale. Nel 1488 approntò un nuovo inventario dei beni posseduti dalla chiesa di San Giorgio distinguendo, in successione ordinata, le varie voci, cioè i possedimenti che erano in capo all’arciprete e che questi faceva lavorare; i quartesi spettanti di diritto alla chiesa; i beni immobili concessi in affitto.18 In quelle circostanze il notaio Giacomo, figlio e amministratore dell’arciprete Andrea dal Bò, aveva chiesto ai monaci, verosimilmente a conoscenza delle intenzioni del padre deciso a lasciare il beneficio, ben sessantadue campi, vale a dire più di un terzo dei terreni parrocchiali da lui stesso inventariati Veduta della chiesa di San Giorgio alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso. 182 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei nel 1488. La lista della richiesta, manco a dirlo, contemplava i terreni migliori: un pezzo di oliveto, un prato, un bosco e discrete campagne di terra seminativa (quattordici e dieci campi) e altro ancora in varie zone del paese, con facoltà di scambi e aggiustamenti «per megio accomodarme».19 I monaci gli avevano fatto capire che non intendevano svendere il beneficio; il notaio Giacomo il 15 febbraio 1494 presentò così un secondo elenco di richieste molto più contenuto, non senza mancare di rilevare che, in passato, gli era stato promesso di più. Nell’occasione si sarebbe pertanto accontentato di undici campi e mezzo (una pezza di otto e altre unità minori: un campo di bosco alla Guiza, mezzo campo dietro casa sua).20 Si intende, credo, che la terra sarebbe stata data in godimento e non in possesso, ma a lui, e non al padre, il quale nel contempo era intenzionato a domandare una pensione annua di 60 fiorini d’oro di camera. Una pensione da assegnarsi sopra le rendite della mensa abbaziale di Santa Giustina a decorrere dal momento della sua rinuncia.21 Le schermaglie economiche andarono per le lunghe e sembra quasi che solo allora si scoprì che il beneficio di S. Giorgio era particolarmente ricco: secondo un prospetto compilato dal notaio Giacomo dal Bò la chiesa riscuoteva 104 staia e mezzo di frumento a titolo di canone di fitti, altri 48 staia da canoni parziari e ulteriori 96 staia dal quartese; 120 staia costituivano l’entrata di grani minuti (cereali quali il miglio, il sorgo, il panico, ecc.); 100 erano i mastelli di vino che venivano raccolti dai vigneti gestiti direttamente e da quelli raccolti per quartese e 201 lire e 15 soldi per canoni in denaro e onoranze.22 Abbiamo detto che si era alle ultime battute quando il vescovo Barozzi giunse a Rovolon. Il venerdì della stessa settimana, 25 settembre 1495, l’abate Gaspare Giordani da Pavia dopo aver informato il Capitolo monastico sulla si- Viti alle pendici di Monte Grande. la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 183 tuazione della chiesa di S. Giorgio, autorizzò il monaco Antonio dei Sulimani ad impetrare dal papa quella parrocchia in commenda nella sua persona.23 Due mesi dopo il notaio di fiducia del monastero salì a Rovolon e nella chiesa di S. Giorgio scrisse finalmente l’atto di procura con il quale Andrea dal Bò incaricava tre personaggi, che allora si trovavano a Roma,24 a presentare, a suo nome, la resignazione del beneficio di Rovolon a favore del sacerdote Antonio Solimani, riservandosi tutti i redditi della parrocchia fino alla sua morte. Presenti in chiesa, come testimoni, vi erano in quella circostanza solo due poveri braccianti (laboratores) immigrati: Antonio Fachin da Belenzona e Pietro Baron da Martinenyo.25 Il 10 settembre 1495, in mezzo a questo fervore di impegno – non sappiamo se si estendesse anche alla vita spirituale della parrocchia – successe il colpo di scena: prete Andrea dal Bò rinunciò, tramite procuratore, nella mani del padre abate al governo della parrocchia, o meglio, per essere più precisi, rinunciò alla carica di arciprete, ma non al beneficio che, anzi, riservava a sé in vita sua. È così che il 25 settembre successivo, l’abate concesse licenza a don Antonio Solimani, monaco di Santa Giustina, di chiedere alla curia romana l’investitura in commenda della chiesa di San Giorgio. La tormentata gestione della parrocchia tra XV e XVI secolo La resignazione in Curia, cioè la rinuncia fatta presso la curia romana e non all’autorità che lo aveva concesso, rendeva il beneficio pienamente disponibile per concessioni in commenda da parte della curia stessa, aggirando in tal modo possibili contestazioni e con piena facoltà di cedere in beneficio stesso Terreni coltivati ai piedi dei colli. 184 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei a una persona determinata, scelta dal resignante all’atto della sua rinuncia, com’è nel nostro caso. I documenti furono subito inviati a Roma, accompagnati da una lettera informativa per chi doveva curare la pratica.26 Essa riprende parola per parola le motivazioni esposte negli atti ufficiali ed altre ne aggiunge: il parroco è vecchio, ha ben settantacinque anni (qualche mese prima, chiedendo la pensione si era presentato come ultraottantenne, ma l’età allora era un fatto opinabile), la parrocchia è posta in loco montano e il ministero che dura da diciotto anni gli costa ormai troppa fatica; il beneficio è carico di debiti per le tasse imposte dal governo della Serenissima, per le decime straordinarie, per la trascuratezza del predecessore e per le grandinate insistenti cadute negli ultimi anni; la chiesa sta cadendo ed ha bisogno di esser rifatta, così pure la canonica, ma non ci sono soldi. L’arciprete sa che il monastero di Santa Giustina è ricco ed è solito restaurare le chiese in rovina ad esso affidate, inoltre possiede molte terre e case contigue a quelle della parrocchia. Da quest’ultima poi percepisce le decime mentre il quartese rimane alla parrocchia stessa ed insomma «tutto è talmente mescolato che più non si potrebbe», pertanto sarebbe ottima cosa, vantaggiosa per l’una e per l’altro, che la parrocchia venisse annessa, unita e incorporata al monastero. Il parroco perciò ha deciso di rinunziare chiedendo l’assegnazione vita natural durante dei redditi parrocchiali per il sostentamento suo e dei suoi servi, tolto ciò che è necessario al culto e ai ministri: tali redditi non superavano gli ottanta ducati. La pratica fu sbrigata velocemente in dicembre: don Solimani ottenne con la bolla di papa Alessando VI, Religionis zelus, la chiesa di San Giorgio e si affrettò a spedirla da Roma assieme ad una procura al padre cellerario don Modesto da Padova e a prete Antonello da Crema, rettore della chiesa di La chiesa di San Giorgio tra il verde di Monte Grande. la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 185 S. Antonio del Covolo, perché ne prendessero possesso a suo nome.27 A questo punto la parrocchia era retta per la seconda volta nella sua storia da un monaco benedettino. Nel caso precedente si era trattato di una breve reggenza dovuta a circostanze straordinarie, ora invece si intendeva assegnarle stabilmente una nuova situazione giuridica. Il monastero, così rassicurato, mantenne le promesse e diede il via ai lavori di ricostruzione totale della chiesa, tanto da risultare ormai finiti negli ultimi mesi del 1499. Prete Andrea dal Bò si godette ancora per qualche anno il beneficio parrocchiale fino agli inizi del 1499,28 mentre il monastero teneva saldamente la parrocchia che, resa vacante da Antonio Solimani, fu conferita il 22 giugno 1498, dall’abate Simone da Pavia, ad un altro monaco, cioè don Andrea da Piacenza.29 Da qualche parte si avanzarono dei dubbi di fronte ad un simile modo di procedere, ma una decisione del governo di Venezia ingiunse ai rettori di Padova di dare il nulla osta alla immissione in possesso del monaco.30 La soluzione raggiunta presentava ancora qualche punto debole e doveva essere perfezionata. L’anno dopo parve giunto finalmente il momento opportuno per condurre in porto una volta per sempre tutta la storia. Dopo la morte del vecchio arciprete il beneficio era davvero libero e inoltre si trovava a Venezia il cardinale Giovanni Borgia, legato della Sede apostolica per l’Italia e quindi munito di tutti i poteri, oltre che perennemente affamato di prebende. Bastarono pochi giorni e il monaco don Andrea, parroco da un anno appena, fece una nuova e spontanea resignazione in curia nelle mani del legato e contemporaneamente il monastero di Santa Giustina presentò la richiesta formale di incorporazione e unione alla parrocchia, già ventilata, come si ricorderà, ma non ottenuta nel 1495. In questa occasione il legato concesse quanto richiesto.31 Come già detto, dopo neppure tre anni, vi fu un nuovo cambio del titolare della parrocchia: in forza del diritto di collazione e della dispensa apostolica ottenuta con la bolla Religionis zelus, l’abate Simone da Pavia conferì il governo della parrocchia al monaco di Santa Giustina don Andrea da Piacenza.32 Si arriva così all’ultimo punto di un piano, già collaudato a Villa del Bosco, parrocchia non lontana da Correzzola (da non confondere con la Villa del Bosco di Praglia, oggi conosciuta con il toponimo di San Biagio), su cui il monastero esercitava, per antica consuetudine, il diritto di collazione, vale a dire il diritto di scegliere il parroco senza l’intervento dell’autorità vescovile.33 Don Andrea da Piacenza rimase a Rovolon appena un anno: nel 1499 la Artigiani al lavoro per la costruzione del pulpito della chiesa di Rovolon nel 1927. 186 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei parrocchia era di nuovo priva di rettore «per libera rinuncia all’ufficio fatta spontaneamente nelle nostre mani e da noi accolta...», come si legge nel documento del legato apostolico.34 Tutta l’operazione, che mirava all’unione della chiesa di Rovolon con il monastero di Santa Giustina, giunse così in porto per la presenza a Venezia, in quel settembre 1499, proprio del legato della sede apostolica romana per tutta l’Italia, il cardinale Giovanni Borgia. Nelle sue mani don Andrea da Piacenza compì quell’atto (conosciuto in diritto canonico con il termine giuridico di Resignatio in curia) in forza del quale, lasciando libero del titolare un beneficio ecclesiastico – nel nostro caso quello della parrocchia di Rovolon – lo si rimise a completa disposizione dell’autorità centrale della Chiesa affinché questa potesse scegliere un nuovo titolare. Contemporaneamente alla Resignatio in curia di don Andrea, il monastero di Santa Giustina presentò al legato apostolico una petizione, cioè la richiesta formale di unire chiesa e beneficio di San Giorgio al monastero. Da tempo immemorabile il monastero di Santa Giustina esercitava il diritto di collazione ogni qualvolta la parrocchia di Rovolon rimaneva priva del suo arciprete, o per cause di morte o per trasferimento in altra sede o, come abbiamo visto sopra, per la rinuncia da parte del titolare. Prima del 1499 il prete, investito dal monastero dell’ufficio di arciprete di Rovolon, diventava parroco a tutti gli effetti, con una reale autonomia di azione rispetto al monastero, anche nella gestione dei beni della chiesa. Ora il monastero, ottenuta l’unione-annessione della chiesa e del beneficio alla mensa abbaziale, diventa esso stesso il titolare della parrocchia con la facoltà di scegliersi preti secolari riconosciuti idonei alla cura d’anime dall’autorità vescovile, amovibili, ai quali il monastero assicura un compenso annuo di 30 fiorini d’oro. Per quanto riguarda il beneficio della chiesa di S. Giorgio il legato autorizzava Cartolina dei primi anni Settanta con le tre chiese del comune di Rovolon. Bastia è ancora priva del campanile. la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 187 il monastero ad appropriarsene liberamente, a tenerlo in perpetuo e ad impiegare ogni reddito e provento di esso per gli usi e le utilità della chiesa e dei monaci. L’argomentazione accampata dal monastero in appoggio alla richiesta fu di ordine economico e si riferiva all’esborso, nella fabbrica della nuova chiesa di S. Giorgio, di ben 350 ducati quando i frutti, le rendite ed i proventi del beneficio parrocchiale non superavano il valore annuo di 60 ducati. E siccome il procedimento adottato dal monastero, pure inoppugnabile dal punto di vista del diritto, conservava anche allora tutta l’apparenza dello stratagemma, la bolla si preoccupa, ricorrendo in abbondanza a formule usuali, ad assicurare il monastero con la più larga assoluzione da ogni genere di scomunica, sospensione e da ogni altra censura ecclesiastica in cui potesse trovarsi “innodato”. Niente potrà più annullare l’unione tra la parrocchia di Rovolon e il monastero di Santa Giustina, né sarebbero state più possibili altre resignazioni in curia. Alla fine c’è la nota del conto pagato dal monastero per ottenere il privilegio: 60 ducati di annata, tanto quanto era secondo la stima più stretta l’ammontare delle rendite annuali del beneficio parrocchiale di Rovolon. Una volta ottenuta la bolla pontificia di unione della chiesa al monastero, i monaci ebbero fretta di darvi esecuzione; addirittura tirarono in campo l’obbedienza: «Volentes uti filli oboedientes bullas unionis ... executioni mandare».35 Il mercoledì 25 settembre 1499, sei giorni dopo l’appuntamento di Venezia, fu convocato il Capitolo per designare la delegazione incaricata di prendere possesso della chiesa di Rovolon.36 Alla riunione furono presenti come testi due laici: mastro Bartolomeo, mastellaio della contrada di Ognissanti, e Domenico detto Beffa, mugnaio della contrada di Pontecorvo. Nel verbale del capitolo monastico fu inserita una preziosa notizia: la chiesa, di cui il monastero stava per entrare in possesso, era quella «fabbricata recentemente dai padri nella villa di Rovolon ... dedicata a S. Giorgio, là dove per l’addietro c’era la vecchia chiesa parrocchiale, la quale minacciava totale rovina, anche quella chiamata con il titolo di S. Giorgio». Il martedì primo ottobre giunse a Rovolon una delegazione di alto livello; dal capitolo dei monaci erano stati «constituti, creati, et specialiter electi, ordinati et deputati»:37 l’abate Simone da Pavia, il decano Girolamo, il cellerario Girolamo Bellomi da Venezia ed altri tre monaci. A presenziare in qualità di testi furono chiamati due sacerdoti, cioè prete Antonello «de Scachis», priore di S. Antonio del Covolo, e prete Pasquale de Rossi, cappellano della chiesa di S. Giorgio. Alla Il centro di Bastia in una cartolina spedita nel 1937. 188 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei stesura dell’atto era presente anche Giacomo dal Bò, il figlio notaio dell’arciprete Andrea dal Bò, a quel tempo già defunto, ed un certo ser Peregrino Zuchelo: di fatto gli unici rappresentanti ufficiali di Rovolon. Oltre a questi, nell’atto si leggono i nomi anche di tre artigiani: magister Pietro del fu Giovanni, marangon originario dal lago di Como ma abitante a Padova nella contrada di San Canziano; magister Battista del fu Baldassare, anch’esso da Como e residente a Padova nella contrada di San Giorgio; magister Lorenzo lapicida del fu mastro Giovanni Trevisan della contrada padovana di San Prosdocimo. Verosimilmente si tratta di tre artigiani addetti alla fabbrica della chiesa: l’opera di costruzione doveva essere ancora in corso. Ma prestiamo attenzione al solenne rituale impiegato nel rispetto della consuetudine per significare il cambiamento dell’arciprete per la chiesa di Rovolon: «Entrati spontaneamente di persona, pacificamente e quietamente e senza incontrare opposizioni, dimostrarono di prendere in reale tenuta il corporale possesso della chiesa di S. Giorgio della villa di Rovolon toccando le estremità dell’altare maggiore e le tovaglie di lino esistenti sopra lo stesso altare, salendo nello stallo, mediante il suono delle campane, aprendo e chiudendo le porte della detta chiesa, entrando e uscendo così pure con altri atti». Se oltre ai testimoni ufficiali, Giacomo dal Bò e Peregrino Zuchelo, abbiano assistito come spettatori casuali altri parrocchiani non lo sappiamo: in caso affermativo non poco deve essere stato il loro stupore vedendo lo svolgimento di un cerimoniale del genere. Tra le parrocchie del monastero di Santa Giustina Ora importa sottolineare come questo atto di unione non fosse un episodio isolato, ma facesse parte di una strategia più generale seguita sia dal monastero di Santa Giustina, sia da quello di Praglia. Lo dimostrano a sufficienza alcuni dati. Prete Antonello «de Scachis», presente alla presa di possesso in qualità di teste, era reduce da un’analoga vicenda: investito nell’anno 1464 del beneficio di Villa del Bosco e della commenda della chiesa di Concadalbero, il 30 giugno 1488 faceva la “resignatio”, cioè formale rinuncia alla parrocchia, così che il rettorato delle due chiese era assunto dal monaco Ambrogio da Lodi. Questa svolta radicale nella conduzione della parrocchia era stata preparata dal monastero già due anni prima con la richiesta al papa del privilegio «di porre nel beneficio di S. Nicolò di Villa del Bosco, quando si fosse reso vacante, solamente monaci dello stesso cenobio, rimovibili a sua discrezione e l’autorizzazione a rendere l’effettivo servizio attraverso cappellani secolari o regolari».38 In altre parole nel caso della parrocchia di Villa del Bosco, nel cui territorio il monastero aveva vasti possedimenti, si era fatto un po’ il collaudo del procedimento adottato poi a Rovolon. Per quanto riguarda Praglia, nel 1507, su esplicita richiesta del monastero, papa Giulio II concesse ai monaci la chiesa di Carbonara con tutti i beni e i diritti.39 Su sollecitazione dello stesso monastero, nel 1517, una bolla di Leone X unì, annesse e incorporò in perpetuo la parrocchia di Tramonte al monastero di Praglia, rafforzando una dipendenza preesistente.40 Alcuni anni la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 189 prima, nel 1508, papa Giulio II aveva affidato, sempre all’abbazia di Praglia, la chiesa della Madonna posta sul monte omonimo ceduta dal comune di Rovolon, i cui beni confinavano con quelli del monastero.41 L’ultimo passaggio di chiesa-beneficio al monastero di Santa Giustina riguardò la parrocchia di Legnaro, nel 1557.42 Il più delle volte questo genere di petizioni veniva giustificato con motivazioni di ordine spirituale e religioso, quale lo stato di abbandono in cui versavano l’edificio della chiesa e la cura delle anime. Ma il fatto che le parrocchie oggetto di simili petizioni fossero caratterizzate dalla presenza di vasti possedimenti fondiari dei due monasteri entro i confini del loro territorio, fa pensare che non sia mancato l’intento di conglobare insieme due ordini di cose: la potestas in spiritualibus con la potestas in materialibus, il controllo delle anime e quello dei corpi. Nel caso di Rovolon sembra abbastanza evidente il peso del movente economico. Che la prospettiva di un affare non sia stata assente in tutta l’operazione di incorporazione della chiesa-beneficio di San Giorgio al monastero, lo dimostra il seguito dei fatti. Anzitutto una parte delle terre della chiesa confinava da tutti i lati, o quasi, con le proprietà del monastero,43 mentre una parte dei campi che componevano l’ex beneficio arcipretale fu utilizzata dai monaci come materiale di scambio. Il monastero riuscì in tal modo a dare compattezza ai suoi possedimenti nel territorio di Rovolon, altrimenti mortificati dalla frammentarietà di tante piccole “chiusure” che, a guisa di corpi estranei, ne interrompevano la continuità. Non a caso dall’agosto 1502 all’ottobre 1504 si portarono a termine ben sei operazioni di permuta.44 È vero che la bolla di unione risaliva al settembre 1499, ma per dar corso alle sue direttive bisognava attendere la scadenza dei contratti d’affitto in cor- Il territorio di Rovolon con filari di viti che scendono verso il piano. 190 Lo stemma di Santa Giustina sopra il portale d’ingresso della pieve di San Giorgio. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei so. Del resto prete Andrea, pur avendo rinunciato all’ufficio, si era riservato il beneficio “in vita sua”: solo alla sua morte fu pertanto possibile stipulare delle convenzioni tra monastero ed erede, cioè il più volte ricordato notaio Giacomo dal Bo, così che ogni divergenza fosse appianata.45 Intanto i lavori di ricostruzione erano finiti e il vescovo Barozzi che aveva visitato la vecchia chiesa poco prima della sua demolizione, ritornò a Rovolon a consacrare la nuova, domenica 24 aprile 1502, giorno successivo alla festa di San Giorgio, che come noto cade il 23 aprile. Santo che rimane il titolare della parrocchia e dell’altar maggiore, mentre vengono almeno in parte cambiate le dediche degli altri due altari; in tutti e tre gli altari il vescovo inserisce “preziose reliquie” come era sua abitudine ed insieme le reliquie trovate nei tre altari precedenti distrutti, reliquie di santi ignoti «quorum nomina ignorantur, scripta sunt autem in libro vitae», come dice il verbale: bell’esempio di rispetto per la tradizione, se non di scrupolosa critica storica.46 In seguito all’organica unione al monastero di Santa Giustina, la parrocchia di San Giorgio divenne cappellania di San Giorgio: è così che la troviamo nominata in qualche atto del monastero di quegli anni.47 Come si andò configurando il rapporto tra monastero e preti incaricati in qualità di cappellani-vicari della cura d’anime? Dopo tre anni di rodaggio il monastero sentì il bisogno di stendere un regolamento col quale fissare – in alcuni punti – diritti e doveri, sempre comunque nei limiti di un rapporto di chiara dipendenza.48 Anzitutto i nuovi rettori furono obbligati a compiere tutti gli atti in capo ad una chiesa con cura d’anime, seguendo in tal modo la consuetudine de la cura de le anime e lo costume de la parrocchia. Fu stabilito che la cura principale, vale a dire l’azione direttiva, fosse svolta dai due cappellani a turno e con cadenza settimanale: «una septimana l’uno et una l’altro». Uno dei due scendeva la domenica a celebrare nella chiesetta di S. Vincenzo o S. Sebastiano al Vegrolongo. Quanto al delicato capitolo della remunerazione fu stabilito poi che: «dividano tra loro tutti gli incerti che pervengono a dicta chiesa per metà equalmente». Dal canto suo il monastero garantì a ciascuno dei due cappellani, a titolo de salario all’anno et a rason de donno, 18 ducati d’oro, un moggio di frumento e dieci mastelli de vin de pian. L’ultimo punto, molto chiaro nella sua formulazione, stabilì che in caso di comportamento cattivo – Dio non lo voglia e noi non lo crediamo – fosse «in libera facultà et potestà del ditto padre abate ... dare commiato et licenziare» sia uno solo sia entrambi i cappellani anche «infra annum, non obstante che l’anno del accordio non fusse compiudo». Il 1° novembre 1502 fu sottoscritto un patto fra due preti. Il padre don Eusebio da Modena, abate di Santa Giustina, accettò per suoi cappellani nella chiesa di San Giorgio di Rovolon, prete Giovanni Rossi da Padova e prete Alessandro Fabris da Ferrara. I patti, che in quella circostanza furono siglati, non erano la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 191 tutti di facile esecuzione: la norma infatti prevedeva la cura d’anime esercitata communiter et promiscue (insieme e promiscua);49 una pratica che ben presto si rivelò poco praticabile a causa di interminabili discordie. Il visitatore monastico – che per conto dell’abate visitava periodicamente la chiesa – Nicolò Galerio nella visita pastorale del 1587, di fronte a questa insostenibile situazione disporrà la creazione di una nuova parrocchia nel luogo di Bastia: solo così verrà posto fine alla difficile coabitazione dei due cappellani. Vari fattori segnarono negativamente la cura d’anime affidata ai due cappellani: in più di un caso si ha l’impressione che il monastero assumesse sacerdoti un po’ ad occhi chiusi, in altre parole pescando nel “mercato” che la manovalanza clericale offriva, visto che non di rado si trattava di personale ecclesiastico eterogeneo e dalla provenienza più disparata. Un modo di procedere che riservò all’abate, vero signore di San Giorgio di Rovolon, più di un inconveniente, soprattutto nel corso di quel tormentato XVI secolo. Imbarazzante, in quanto accaduto in pieno clima di riforma post-tridentina, fu il caso di prete Piero detto Gobbi e prete Francesco de Paoli, inquisiti nella visita abbaziale del luglio 1575: ebbene il primo si trovava a Rovolon da non più di tre anni e l’altro da soli cinque mesi, sufficienti comunque per farsi segnalare negativamente agli occhi dell’abate. Da rilevare che prete Pietro detto Gobbi con molta probabilità aveva sostituito quel Marco Targa che al visitatore vescovile del 1572 diede prova di saper leggere il latino del messale senza capirlo.50 Per tutto il corso del XVI secolo si registrò inoltre una forte mobilità di cappellani curati, dovuta verosimilmente al fatto di essere persone dipendenti, continuamente sottoposte alla vigilanza del monaco-rettore che risiedeva nel vicino palazzo della “corte benedettina”. I rettori della parrocchia di San Giorgio erano infatti rimuovibili in qualsiasi momento da parte dell’abate. Un esempio di quelle movimentate vicende si registra nella visita pastorale compiuta nel 1579. Il padre abate di Santa Giustina nel controllare le condizioni dell’abitazione dei due curati, di proprietà dell’abbazia, venne a sapere che in una parte dell’edificio abitava un nipote del curato, che allora era prete Ludovico. Il nipote era sposato, circostanza sulla quale l’abate si riservò di riflettere; in seguito avrebbe fatto conoscere al rettore le sue decisioni.51 Qualche mese più tardi l’abate di Santa Giustina ritornò a Rovolon e in quella circostanza impartì alcune direttive intese ad accentuare la dipendenza della chiesa dal monastero padovano. Anzitutto, sotto pena di privazione del beneficio don Ludovico non doveva più tenere né ospitare la cognata sposata nelle case di proprietà del monastero, tanto meno nella casa parrocchiale. In secondo luogo invitò il curato a procurare un predicatore per l’ormai immi- Tabernacolo del XV secolo nella pieve di San Giorgio. 192 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei nente tempo di Quaresima: una volta individuato avrebbe dovuto chiedere comunque l’assenso all’abate. Infine, a salvaguardia della giurisdizione del monastero sulla parrocchia di Rovolon, aggiunse un altro richiamo: quando fosse stato necessario amministrare i sacramenti, prete Ludovico doveva valersi soltanto «delle suppellettili esistenti nella sua chiesa di San Giorgio e nella chiesetta di San Sebastiano, soggette alla giurisdizione spirituale del monastero e non delle altre chiese».52 È probabile che nella circostanza l’abate alludesse alla chiesa di Santa Maria della Bastia, allora officiata dai Servi di Maria; pare di capire la natura dell’infrazione commessa dal curato Ludovico: in date circostanze, per necessità o per comodità, egli andava a prestito di qualche arredo liturgico dal religioso che officiava la chiesa della Bastia e magari, qualche altra volta, in quella chiesa avrà celebrato la S. Messa o qualche sacramento. L’abate con quella decisione impose un taglio netto ad una forma di cooperazione, verosimilmente per timore che potessero ingenerare confusioni di carattere giurisdizionale sulle chiese dipendenti dall’abbazia. Note 1. Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l’undecimo, a cura di Andrea Gloria, Venezia (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di Storia patria) 1877, doc. 55, p. 81. 2. Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l’undecimo, doc. 239, p. 266. Francesco Selmin, Selvazzano. Documenti di storia, Selvazzano (Centro Sociale di Educazione Permanente) 1972, p. 40-48. 3. [Ireneo Daniele], La diocesi di Padova nel 1972, Padova (Tip. Antoniana) 1973, p. 478; Archivio di Stato di Padova (= ASPd), Pergamene, generale 8928 e 7396. 4. ASPd, Pergamene, generale 8506. 5. ASPd, Pergamene, generale 11048. 6. Il «Liber» di S. Agata di Padova (1304), a cura di Giannino Carraro, con Nota di diplomatica di Gian Giacomo Fissore, Padova (ed. Antenore - Giunta Regionale del Veneto - Fonti per la Storia della Terraferma Veneta, 11) 1997, p. 136. 7. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae-Histria, Dalmatia, a cura di Pietro Sella e Giuseppe Vale, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana - Studi e testi, 96) 1941, p. 111-114, num. 1323-1350. 8. Si veda in questo libro il capitolo dedicato al mulino di Rovolon. 9. ASPd, Estimo 1418, vol. 297, c. 131r-132v. 10. ASPd, Pergamene, generale 7484. 11. ASPd, Corona (provenienza monastero di Santa Giustina), generale 7659, part. 1881, collocazione CCCLX, “Bolla di unione di San Giorgio di Rovolon al monastero di Santa Giustina, datata 1° ottobre 1499”. 12. [Daniele], La diocesi di Padova, p. 478. 13. L’evento dovrebbe collocarsi tra il 1467 e il 1469. 14. Pierantonio Gios, L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-1507), Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana) 1977, p. 125 n. 20. 15. Archivio della Curia Vescovile di Padova (=ACVPd), Visitationes, III, c. 390. Si tratta della più antica visita pastorale di cui si abbia memoria, se si eccettua quella del vescovo Marco Nigro (domenica 8 settembre 1465). 16. Gios (L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi, p. 133 n. 35), riporta un caso analogo che riguarda la riconciliazione della chiesa e del cimitero di Camponogara «propter eff usionem sanguinis» di cui era responsabile Bernardino Nardini. 17. Forse fu un omaggio al papa regnante, Alessandro VI (al secolo Rodrigo de Borja y la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 193 Doms, in italiano Borgia), nato a Játiva (Valencia) nel 1431 ed eletto pontefice nel 1492. Era nipote di Callisto III (1455-1458) e a Roma morì nel 1503. Il notaio Giacomo dal Bò fu attivo a Padova tra il 1454 e il 1513 (ASPd, Notarile, vol. 2925, 2926, 2927, 2928). ASPd, Corporazioni religiose soppresse. Monasteri della città. Santa Giustina (= ASPd, S. Giustina), b. 137, filza C.R P.II, c. 253 “Contro il comune di Rovolon per causa di spese nelle riparazioni della chiesa e del campanile” (senza data, ma evidentemente anteriore alla richiesta seguente). ASPd, S. Giustina, b. 180, filza E.P P.19, c. 107 “Atti contro l’arciprete di S. Giorgio di Rovolon e contro comune di Rovolon per la chiesa di S. Giorgio di Rovolon e S. Maria della Bastia”. ASPd, S. Giustina, b. 137, filza C.R P.II, c. 238r: brutta copia senza data di petizione indirizzata a Beatissime Pater (il papa); lo stesso testo in bella copia a c. 232 con indirizzo Reverendissime Domine, cioè all’abate. L’arciprete si presenta qui più che ottantenne e oppresso da malattia e vecchiaia. ASPd, S. Giustina, b. 137, filza C.R P.II, cc. 239-240. È da notare che l’arciprete in questo momento non coltiva più cereali in proprio: gli bastano ad abundantiam quelli raccolti come canone e quartese. Nella medesima filza, alle carte 258 e 260 (tra le quali è stata inserita in altro tempo la lettera formante la c. 259) c’è un bilancio più tardo, fatto in occasione della visita dell’abate Giovanni da Trento nella domenica 3 luglio 1575 (Cfr. ASPd, S. Giustina, b. 183, filza E.P P. 25, c. 46). Le spese sostenute furono queste: ai due sacerdoti in cura d’anime il monastero passa lire 223 e 4 soldi di salario, 24 staia di frumento, 4 di miglio, 4 di sorgo, 8 di legumi, 20 mastelli di vino, 25 libbre di carne salata, 25 libbre di formaggio, un carro di fieno e uno di paglia. Le entrate sono così calcolate: a) 12 ducati di reddito complessivo da 13 campi (seminativi, prati, vigneti) in vari luoghi; b) 20 campi di bosco, “li quali so inutili” perché vi si potrebbe cavar legna ogni 10 anni ma con tanta spesa, “che non si fa le legne”, perciò reddito zero; c) canoni riscossi da trentatre affittuari: 79 lire e 3 soldi, 7 moggia, cioè 84 staia, di frumento, 6 paia di polli e 6 di galline; d) il quartese parrocchiale che rende 5 moggia (= 60 staia) di frumento, 2 moggia (= 24 staia) di cereali di varietà diverse, uno staio di sorgo, 8 staia di legumi e 25 mastelli di vino. Le due voci principali, denaro e frumento, danno in totale rispettivamente lire 153, soldi 11 e 12 moggia (= 144 staia). La base fondiaria era stata evidentemente modificata e il tutto era gestito ora dal monastero, pur conservandosi memoria di una certa distinzione. ASPd, S. Giustina, mazzo 577 “Instrumenti diversi in pergamena” (1405-1567), pergamena n. 127. Estensore il notaio Lorenzo Violato. A questo punto erano state scartate altre possibili soluzioni, compresa la pensione in fiorini per Andrea dal Bò, soluzioni di cui resta traccia nelle minute di petizione sempre in ASPd, S. Giustina, b. 137, filza C.R P.II, c. 238r: vi si chiedeva l’autorizzazione per l’abate ad assegnare la chiesa, in caso di vacanza, ad un monaco di Santa Giustina. Antonio Solimani acconsente come cellerario ad una permuta di terre del beneficio parrocchiale di Rovolon il 19 dicembre 1493, nella fattoria del monastero (ASPd, S. Giustina, b. 180, filza E.P P.19, c. 97v). Al momento del Capitolo egli era assente, forse già a Roma per imbastire la pratica. Sono: Stefano Capponi da San Geminiano, canonico di Massa e sollecitatore presso la Curia, Nicolò da Barchinova priore del monastero ferrarese di S. Marco, ora a Roma nel monastero di S. Paolo in urbe e il sig. Innocenzo de Leis, avvocato in Curia. ASPd, S. Giustina, b. 180, filza E.P P.19, c. 108: atto del 27 novembre 1495, in copia fatta dallo stesso notaio rogante Lorenzo Violato. ASPd, S. Giustina, b. 137, filza C.R P.II, c. 255. La bolla è in ASPd, S. Giustina, mazzo 577, “Instrumenti diversi in pergamena” (14051567), pergamena n. 128 datata 16 dicembre 1495; per la procura sempre in ASPd, S. Giustina, vol. 8 (Annali, tomo VIII, anni 1429-1550), c. 749 in data 11 dicembre 1495. Sulla figura di prete Antonello da Crema si veda Giuseppina De Sandre Gasparini, Contadini, chiesa, confraternita in un paese veneto di bonifica. Villa del Bosco nel Quattrocento, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana) 1979, p. 119-112 e p. 139-144. 194 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei 28. Continuano ad essere a suo nome i contratti d’affitto di terre parrocchiali (si vedano i contratti del 31 dicembre 1496, alla presenza di prete Lodovigo cappellano e del 24 aprile 1497). Si vedano anche in ASPd, S. Giustina, b. 180, filza E.P P.19, c. 62: «Pagamenti facti ale decime per la ghiexia de messer S. Zorzi essendo rectore messer prete Andrea dal Bò», che arrivano fino al 14 agosto 1498, con due versamenti di lire 26 e soldi 2 ciascuno. Prete Andrea continuò a pagare le tasse come fruitore effettivo del beneficio. Il 17 aprile 1499 è invece il monaco Andrea da Piacenza rettore della chiesa di S. Giorgio che affitta per tre anni una terra della chiesa (ibidem, c. 101). Su Carbonara: Antonio Rigon, La parrocchia di S. Giovanni Battista di Carbonara, in L’Abbazia di Santa Maria di Praglia, a cura di Callisto Carpanese e Francesco Trolese, Milano (Silvana Editoriale) 1985, p. 71-73. 29. ASPd, S. Giustina, mazzo 577, “Instrumenti diversi in pergamena” (1405-1567), pergamena n. 130. 30. ASPd, S. Giustina, vol. 8 (Annali, tomo VIII), c. 761 in data 28 giugno 1498. 31. ASPd, Corona (provenienza monastero di Santa Giustina), generale 7659, part. 1881, collocazione CCCLX, “Bolla di unione di San Giorgio di Rovolon al monastero di Santa Giustina, datata 1° ottobre 1499”. Nel documento vengono citate la resignazione di don Andrea e la petizione dei monaci. Alla bolla sono stati poi uniti, così da formare un solo rotolo, anche il mandato per la immissione in possesso e l’atto d’immissione citati qui di seguito. Il procedimento seguito dai monaci per acquisire anche il beneficio parrocchiale, inoppugnabile sotto il profilo del diritto canonico, manifestava già allora tutta l’apparenza di un esplicito stratagemma tanto che nella “bolla” del cardinale Borgia ci si preoccupò, ricorrendo in abbondanza a formule usuali, di proteggere il monastero da ogni possibile ricorso. Nel testo della bolla, infatti, si coglie pienamente la volontà di tutelare il proprio operato e quello del monastero contro ogni genere di scomunica, sospensione e da ogni altra possibile censura ecclesiastica. 32. Per quanto riguarda la gestione dei beni immobili, che doveva assicurare una rendita tale da garantire la sopravvivenza dell’arciprete, va rilevato che prete Andrea dal Bò aveva provveduto a redigere un accurato inventario, dimostrando attenzione e diligenza: una cura che facilitò in quei frangenti l’acquisizione da parte del monastero dei beni stessi. Un patrimonio che, liberamente detenuto dal monastero, consentiva di impiegare il reddito e i proventi per le necessità e i bisogni della chiesa e dei monaci. È curioso rilevare che l’argomentazione accampata dai benedettini di Santa Giustina in appoggio alla richiesta fu di ordine squisitamente economico: era stato lo stesso monastero a impegnare nella costruzione della nuova chiesa di San Giorgio ben 350 ducati – e quindi non la comunità civile come spesso accadeva in altri luoghi – mentre i frutti, i redditi ed i proventi della chiesa parrocchiale non superavano il valore annuo di 60 ducati. 33. I casi di ricostruzione o di nuova costruzione di chiese parrocchiali da parte dei comuni sono diversi, qui ricordo quello di Galzignano, avvenuto nel 1674, che comportò uno sforzo finanziario e un indebitamento del locale comune rurale, risolto con l’alienazione di parte del patrimonio immobiliare (boschi e terreni coltivati) della collettività (Claudio Grandis, Il comune di Galzignano e la famiglia Giavarina, in Comune di Galzignano Terme, Inaugurazione della nuova sede municipale in palazzo Giavarina, Galzignano Terme 2007, p. 19-21). 34. Vedi sopra alla nota 31. 35. Cfr. sopra nota 31. 36. Così è detto nel verbale della immissione in possesso. 37. Mandatum ad capiendam possessionem. 38. Missio in possessionem. 39. Si confronti per questa vicenda quanto scrive Giuseppina De Sandre Gasparini, Contadini, chiesa, confraternita in un paese veneto di bonifica, p. 109-112 e 139-140; la citazione è da p. 140. 40. Rigon, La parrocchia di S. Giovanni Battista di Carbonara, p. 71 41. Giuseppe Tamburrino, La parrocchia di S. Giorgio di Tramonte e di S. Maria di Praglia, in L’Abbazia di Santa Maria di Praglia, a cura di Callisto Carpanese e Francesco Trolese, Milano (Silvana Editoriale) 1985, p. 63-67. la chie sa di sa n g iorg io d i rovolon 195 42. Callisto Carpanese, Il Santuario del Monte della Madonna nei Colli Euganei. Tra storia e cronaca, Abbazia di Praglia 1987, p. 25-38. 43. ASPd, S. Giustina, mazzo 338, fasc. III, c. 1v-2r (copia siglata 322). “D: Chiese, n. 3 privilegi. Scritture, ecc. appartenenti al possesso delle chiese soggette al monastero” 1131-1749. Breve di papa Paolo IV del 19 novembre 1557; mazzo 553, fasc. 2, c. non numerata dove si legge: «Il Santo pontefice Paolo IV unisce al monastero di Santa Giustina la chiesa parrocchiale di S. Biasio di Legnaro talmente che sia lecito al padre abate e monastero prendere possesso di detta chiesa, ritenere perpetuamente le di lei entrate e convertirle in uso proprio e della detta chiesa; nec non farvi esercitare la cura d’anime per due preti secolari ad ognuno 60 ducati di Camera». 44. Il dato emerge dalla lettura dell’inventario steso nel 1488. Una situazione durata nei secoli seguenti come attestano vari documenti in cui terreni del monastero sono in prossimità della chiesa di San Giorgio. A titolo di esempio si veda la perizia di Antonio Turcato del 1787 che descrive un appezzamento di oltre cinque campi di terra diviso in due pezze di cui una «di ragione delli reverendi padri di Santa Giustina di Padova» e l’altra posseduta «dal reverendo signor arciprete», terre che si trovavano in contrà delle Roche, cioè di fronte alla chiesa di San Giorgio oltre la strada che tuttora la costeggia (ASPd, Notarile 6726, c. 157r). 45. ASPd, S. Giustina, vol. 8 (Annali, tomo VIII), c. 789, 793-795. 46. ASPd, S. Giustina, vol. 4 (Indice alfabetico per materia delle scritture del monastero, tomo IV, lettere P-Z), sub voce Rovolon – chiesa, in data 1500, 15 luglio. 47. ACVPd, Visitationes, III, c. 394. La curia padovana era naturalmente rimasta esclusa da tutto il tramestio dei quegli anni. 48. ASPd, S. Giustina, busta 553, carta sciolta segnata 120: “Pacti fatti con la cappellania di S. Giorgio del 1° novembre 1502”. Nella stesso contenitore vi è anche il “Libro dei capitoli della Scuola della Morte eretta nella chiesa di S. Giorgio di Rovolon” (1649). 49. ASPd, S. Giustina, busta 553, carta sciolta segnata 120. 50. Claudio Bellinati, La Pieve di Rovolon. Notizie e cenni storici dalle visite pastorali, in Franco Holzer, Rovolon amore per una terra, Padova (ADLE edizioni) 1997, p. 36-37. 51. ACVPd, Visitationes, X, c. 296v, contiene il verbale della visita del vescovo Federico Corner effettuata a Rovolon il 1° luglio 1587. Il riassunto di quella visita è in Bellinati, La Pieve di Rovolon, p. 37-38. 52. ASPd, S. Giustina, busta 183, filza E.P P. 25, “Visite delle chiese di S. Matteo, S. Giuliana, S. Daniele, S. Giorgio di Rovolon, S. Martino dei Ronchi ed altre, con inventari, esami e decreti dei superiori” (1534-1699). Visita abbaziale alla chiesa di Rovolon del 7 maggio 1579. 53. ASPd, S. Giustina, busta 183, filza E.P P. 25, visita abbaziale alla chiesa di Rovolon del 28 gennaio 1580. Sulla chiesa di S. Giorgio: Francesco Giovan Battista Trolese, S. Giorgio di Rovolon una chiesa donata a Santa Giustina di Padova cenni storici di un rapporto secolare, in in Franco Holzer, Rovolon amore per una terra, Padova (ADLE edizioni) 1997, p. 4763. I verbali di visita dell’abate sono in ASPd, S. Giustina, busta 183, filza E.P P. 25, c. 41 (1546); c. 45 (1582); c. 46-50 (1575); c. 103 (1579); c. 129 (1580); c. 169 (1587); c. 178 (1588); c. 230 (1699). Numerose notizie sulla vita della parrocchia sono anche nel lavoro di Ludovico Francesco Maschietto, «Ut grex dominicus salubriter regatur, conservetur et custodiatur». Visite pastorali degli abati di S. Giustina in Padova alle parrocchie dipendenti (1534-1791), Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana) 1998. La chiesa di Santa Maria di Bastia Nel toponimo Bastia è rimasto impresso il ricordo della fortificazione in legno eretta sul finire del XIV secolo. Bastia ha la stessa radice linguistica di bastone, bastonare. Pure bastire ci riconduce a questa matrice, tant’è che nel lessico medievale voleva dire “munire di bastia”, steccato: un documento del 1319 relativo a Montefiascone (in provincia di Viterbo) a tal proposito recita: «fecit bastiri per quosdam sticchones ligneos pro una roccha inibi facienda».1 Per la storia del territorio che oggi fa capo alla nostra Bastia è dunque inutile cercare tracce più antiche seguendone il nome di luogo. Questo spazio fisico in passato doveva essere indicato con altre denominazioni, verosimilmente una delle tante che ritroviamo citate nei documenti su Rovolon risalenti al XII e XIII secolo. Lasciamo tuttavia ad altri ricercatori scoprire l’antica denominazione del luogo, partendo dalle pagine che in questo libro Francesco Tognana ha dedicato alle strutture fortificate del territorio comunale e in particolare quelle riservate proprio a Bastia. Questa breve premessa ci sembra doverosa prima di raccontare, per sommi capi, la vicenda delle quattro chiese edificate a Bastia, per la semplice ragione che il tempio dedicato a Santa Maria della Neve (S. Mariae ad Nives de Bastia, recita ufficialmente il Bollettino diocesano di Padova), con il compatrono San Mauro, occupa proprio il luogo fisico della bastia, cioè della struttura fortifi- La vecchia chiesa di Bastia, demolita per far posto all’attuale. Nella pagina a fronte: la chiesa nel 1928. 198 La vecchia chiesa di Bastia in una cartolina illustrata spedita il 28 febbraio 1927. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei cata medievale. L’interramento cui è stato sottoposto il tratto di fossa Nina (detta anche Fossa Martina, scolo Fossona o naviglio di Pedevenda), non ci consente di cogliere l’unicità del sito, di questo spazio, di questa isola vera e propria sulla quale nel corso del XV secolo fu deciso di costruire un tempio sacro. Tempio che per oltre un secolo non fu riservato agli abitanti di Rovolon, che lentamente erano andati popolando la pianura ritagliata tra Monte Sereo e il grande bosco della Carpaneda, bensì al culto mariano promosso nella zona dall’ordine dei Servi di Maria di Padova. L’oratorio al centro dell’anello d’acqua creò in tal modo un quadro, uno scenario, che nella visita abbaziale del 14 dicembre 1646 indusse il cancelliere notarile ad annotare che la chiesa ed il cimitero erano «circondati a fovea» e accessibili «per ponte super foveam constructum». Nel tempio e nel luogo delle sepolture si giungeva dunque attraversando un ponte gettato sopra la fossa d’acqua che perimetrava e definiva l’intero spazio sacro. Un ponte dotato anche di una porta per impedire l’ingresso agli animali vaganti, come i cani che non di rado nei cimiteri tendevano a scavare sulle sepolture alla ricerca di ossa; o degli ovini che brucavano l’erba tra le tombe con l’immaginabile strascico indecoroso che lasciavano al loro transito.2 Proprio in questo luogo i frati serviti di Padova costruirono una chiesa dedicata a Santa Maria, loro grande protettrice. La definizione esatta di questo Ordine, fondato da sette mercanti fiorentini nel 1233, è infatti “Servi di Maria” per la particolare devozione alla beata Vergine. A Padova l’Ordine approdò nel corso del Trecento. Nel 1372, per volontà di Fina Buzzacarini, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara, venne costruita una nuova chiesa sull’area del demolito palazzo abitato del traditore Nicolò da Carrara; chiesa che fu consegnata ufficialmente ai Serviti il primo novembre 1392.3 Nel mentre a Bastia l’Ordine edificò un piccolo, modesto tempio mariano, al Vegrolongo i monaci di Santa Giustina eressero un oratorio in onore di S. Sebastiano (noto e invocato a protezione delle pestilenze, spesso in coppia con S. Rocco), ponendolo alle dipendenze della chiesa di S. Giorgio di Rovolon. Poiché la pieve di S. Giorgio e l’oratorio di S. Sebastiano dipendevano entrambe da S. Giustina, e fisicamente si trovavano agli antipodi del la chie sa di sa n ta m a ria bastia 199 territorio parrocchiale, l’abate del monastero dispose che vi fossero due sacerdoti dimoranti nella medesima casa canonica di Rovolon. A loro era affidata la cura d’anime e l’obbligo di alternarsi nella conduzione delle due chiese e nella pratica religiosa: una promiscuità che divenne confl ittuale per le disagiate condizioni di strade e ambiente. Lo scontro violento e aperto tra i due sacerdoti indusse l’abate di Santa Giustina a proporre lo smembramento dell’antica parrocchia di S. Giorgio. Fu così che, ufficialmente il primo luglio 1587, Bastia assunse la veste di vera e propria parrocchia, non più dipendente da Rovolon. Il decreto vescovile che ne sancì la nascita, offrì tuttavia ai monaci di Santa Giustina, titolari della cura d’anime, la facoltà di richiedere ai Serviti di Padova «ecclesiam Sanctae Mariae della Bastia», al posto di trasformare S. Sebastiano in parrocchia per la posizione periferica del tempio rispetto al grosso dell’abitato. L’istanza fu accolta e il 10 ottobre 1590, si rese così esecutiva la volontà pastorale. Da quel momento gli uomini e il comune di Vegrolongo, tutti i parrocchiani che abitavano nelle case oltre la fossa Martina, presenti e futuri nessuno escluso, dovevano essere considerati comunità parrocchiale di S. Maria della Bastia, staccati di fatto e di diritto perché «separati ac dismembrati» dalla chiesa di S. Giorgio di Rovolon. La nuova comunità iniziò a frequentare la chiesa che i serviti avevano edificato nel 1470, per la posizione più comoda rispetto al periferico oratorio S. Sebastiano. All’abbazia di S. Giustina rimase il diritto di nominare il parroco, come avvenne, ad esempio, nel 1645 con l’elezione a rettore di don Cherubino da Padova, monaco professo e decano del monastero che assunse l’incarico con un salario di 100 ducati annui.4 Il tempio di S. Maria purtroppo crollò nel 1667; ricostruito, fu nuovamente travolto dal turbine del 17 agosto 1756, quello che devastò la copertura del Palazzo della Ragione a Padova. Come ricorda una memoria custodita nella canonica di Bastia, il violento fortunale fece crollare gran parte della chiesa e uccise il cappellano, don Pietro Graziani di quarant’anni, i due figli minori del campanaro Pietro Marcato e altri sei parrocchiani, due dei quali adolescenti. Nel breve volgere di un anno sorse un terzo edificio, inaugurato il 6 La chiesa con il fossato circostante in una cartolina spedita il 16 agosto 1941. 200 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei novembre 1757. Le ridotte dimensioni e gli insufficienti ampliamenti attuati nel corso del Novecento, indussero la comunità parrocchiale a progettare un nuovo tempio più ampio. Il 19 marzo 1949 fu così benedetta la prima pietra della quarta chiesa di Bastia, con la conseguente demolizione di quella settecentesca. I lavori si conclusero alcuni anni dopo permettendo la benedizione del nuovo tempio il 1° maggio 1954.5 Solo più tardi prese avvio l’erezione del nuovo campanile, l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere innalzato nel quadrante ovest di Padova. Note La vecchia chiesa in una cartolina illustrata inviata da Bastia il 6 ottobre 1911. 1. Pietro Sella, Glossario latino italiano. Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1944 (rist. anastat. Modena 1979), p. 61. 2. Archivio di Stato di Padova (= ASPd), S. Giustina, b. 137, filza C.R P.II, c. 187. 3. Ruggero Maschio, S. Maria dei Servi, in Padova. Basiliche e chiese, a cura di Claudio Bellinati e Lionello Puppi, parte prima, Vicenza (Neri Pozza editore) 1975, p. 239. 4. ASPd, S. Giustina, b. 137, filza C.R. P.II, c. 185. 5. [Ireneo Daniele], La diocesi di Padova nel 1972, Padova (Tip. Antoniana) 1973, p. 103 La chiesa di San Giovanni Battista di Carbonara Gli studiosi che in passato si sono occupati delle principali vicende di questa chiesa e della relativa parrocchia sottolineano concordemente la stretta dipendenza che essa ebbe con il monastero di S. Maria Assunta di Praglia; una dipendenza che iniziata nel 1507 si concluse giusto tre secoli più tardi, nel 1806, con la prima soppressione dell’antica abbazia benedettina. Cenni di una sua esistenza ben prima di quel fatidico 1507, provengono da un documento del 17 dicembre 1198: quel giorno l’abate do Praglia Alberto concesse ad un certo Offredino di Rafaldino alcuni terreni da coltivare, con delle viti soprastanti. Erano appezzamenti del monastero situati a Carbonara e uno di questi confinava con diritti (ius) della chiesa di San Giovanni di Carbonara.1 A quella data, dunque, la chiesa esisteva già ed era titolare di alcuni beni che ne costituivano il beneficio, un patrimonio, tuttavia, di cui ignoriamo completamente la consistenza. Da tempo nella zona il monastero di Praglia deteneva beni immobili; beni che le antiche pergamene mostrano trasferiti a contadini attraverso l’istituto contrattuale del livello, un affitto di lunga durata, di norma ventinovennale, spesso rinnovabile alla scadenza. Vicino alla chiesa i monaci erano proprietari di terre già al debutto del XIII secolo, come ricordano due compravendite rispettivamente del 24 luglio 1204 e 23 giugno 1205, e due livelli stipulati in Carbonara «apud ecclesiam» (presso la chiesa) il 28 marzo 1210.2 La prima attestazione di un presbitero a servizio della parrocchia de Carbonaria proviene dal verbale steso il 6 agosto 1262 in occasione della cessione del bosco Viglanicus alle monache di Sant’Agata di Padova fatta dagli uomini del comune di Rovolon. Nel lungo documento tra i primi nomi ad essere registrati dal notaio appare infatti «domino presbitero Guillelmo ecclesie de Carbonaria». Di questo sacerdote nulla di più sappiamo, ma la sua vicinanza ai due altri preti di Rovolon, in quel giorno d’agosto, sembra dimostrare non solo lo stretto legame della cappella di Carbonara alla pieve di San Giorgio, ma pure la diretta appartenenza della parrocchia al più ampio territorio di Rovolon.3 Altre frammentarie notizie sulla chiesa di Carbonara si raccolgono dalle registrazioni delle decime papali del 1297 e del XIV secolo. In quelle circostanze fu incluso nel libro dei pagamenti il nome di prete Fino, ma a margine fu annotata l’espressione «excusatus», esentato. A Carbonara, accanto al rettore troviamo, sempre in quell’anno, anche il chierico Castelnovus pur esso scusato dal pagamento, verosimilmente, è da pensare, per la miserevole rendita che il beneficio procurava. In un estimo seguente del XIV secolo alla chiesa di San Giovanni Battista 202 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei fu imposto il pagamento di un’imposta sull’entrata di 20 lire di piccoli, ben poco se confrontato con quelle di Boccon, che era di 30 lire, o di Galzignano calcolata in 50 lire.4 Carbonara era allora l’unica dipendenza della pieve di San Giorgio di Rovolon, sorta a servizio di un piccolo villaggio dedito alla produzione del carbone di legna, un’attività che sappiamo esser stata proibita dal Comune di Padova con uno specifico provvedimento del 1267.5 Ma la piccola realtà demografica, insediata sull’unghia occidentale del Monte della Madonna, ben presto finì nell’orbita del monastero di Praglia, che sul finire del XV secolo prese l’iniziativa di acquisire la chiesa da tempo decadente e in stato di abbandono, tanto da non essere nemmeno nominata nei verbali della visita compiuta nella zona dal vescovo Barozzi nel 1495.6 Va comunque ricordato in proposito che in precedenza, soprattutto dalla metà del XIV secolo, Praglia visse una crisi profonda e uno spopolamento dell’abbazia, cessato solo con l’adesione avvenuta nel 1448 alla congregazione De Unitate, detta anche di Santa Giustina e, ancora, dell’Osservanza e più tardi Cassinense.7 Nell’ambito della vasta opera di rinascita e di riorganizzazione dell’ampio patrimonio fondiario del monastero euganeo si colloca dunque anche l’acquisizione della cappella di San Giovanni Battista di Carbonara. Come si svolsero i fatti è noto da tempo, sia per lo studio compiuto da Antonio Rigon nel 1985,8 sia per la recente (2010) messa a punto di Giannino Carraro dedicata alla cura d’anime del monastero di Praglia tra XII e XVIII secolo. In quest’ultimo lavoro si possono leggere anche i diversi verbali delle visite abbaziali compiute alla chiesa di Carbonara e scorrere l’elenco dei sacerdoti che ressero la parrocchia tra il 1527 e il 1839, dei quali ci è rimasta memoria nelle carte dell’antico archivio monastico.9 Tornando alle vicende di quell’acquisizione, di quell’unione con Praglia del 1507, dobbiamo ricordare che l’evento fu possibile per la nomina a procura- Carbonara in una cartolina illustrata degli anni Trenta del secolo scorso. la chie sa di sa n g iova n n i batt ista di c arbonar a 203 tore del monastero dell’abate di Santa Maria di Saccolongo, al quale fu dato mandato di trattare la cessione del beneficio ecclesiastico con il commendatario Lelio da Teramo in cambio di un congruo risarcimento. L’abate commendatario di Saccolongo, Girolamo Sambuci, raggiunse lo scopo con l’intervento di papa Giulio II, di cui il molisano Lelio era «scriptor et familiariis». Praglia s’assunse l’onere di ricostruire la chiesa e di riordinarne il patrimonio. Un’operazione che vide, pochi anni più tardi, il coinvolgimento anche della vicina chiesa di San Pietro in Costa, e che, di fatto, permise all’abbazia di Praglia di controllare e gestire le due chiese, frequentate soprattutto dai coloni che lavoravano le terre monastiche gravitanti sulla vasta corte agricola di Spirano e Vegrolongo. In quel XVI secolo il monastero pragliese deteneva nella zona un patrimonio fondiario stimato in 215 campi di terra «valliva e paludiva».10 Divenuta propria dipendenza, il monastero provvide alla ricostruzione dell’edificio sacro e alla nomina del rettore. Nel 1532 iniziarono anche le visite pastorali da parte dell’abate: nella circostanza a reggere la parrocchia vi era prete Matteo, un frate predicatore teutonico. I verbali di quelle visite fotografano le condizioni dell’edificio, degli arredi sacri, del comportamento dei rettori, ma soprattutto la rinascita di una chiesa e di una piccola comunità religiosa viva e presente. Sono «homeni da ben» e vivono cristianamente, annota il curato Giovanni Crescenzio, nativo di Arquà, in occasione della visita compiuta dall’abate Giulio da Mantova l’otto agosto 1599.11 Condizioni che si perpetuano anche nei secoli seguenti e che dimostrano come il monastero fosse interessato non solo allo sfruttamento dei terreni che gravitavano attorno alla chiesa, ma pure al comportamento morale dei contadini occupati nei campi. Tra le norme delineate nei primi decenni del XVI secolo per disciplinare i contratti agrari – note agli studiosi col termine di capitula – per la conduzione delle aziende agricole, i monaci di Praglia in- Carbonara in una cartolina viaggiata nel novembre 1941. 204 Carbonara in una cartolina illustrata spedita nel luglio 1936. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei serirono tra i patti anche il rispetto della famiglia. Litigi, insulti, bestemmie, separazioni coniugali, matrimoni di giovani senza il consenso dei genitori, mancanza di rispetto agli agenti del monastero, erano motivo di annullamento dei contratti agrari e di cacciata dalle terre monastiche.12 L’etica e la morale dovevano servire da esempio quotidiano, felicemente coniugato alla pratica religiosa, alla frequenza ai sacramenti. Era dunque la povertà materiale che a volte impediva l’allestimento e un migliore decoro della piccola chiesa di San Giovanni Battista, e non certo il convincimento religioso, come si coglie dalle relazioni abbaziali. Il monastero continuò ad esercitare il diritto di collazione, cioè la scelta del parroco di Carbonara, alternando a monaci altri sacerdoti secolari, fino al 1770 allorquando il parroco divenne inamovibile. La chiesa nel frattempo fu decorata e abbellita con gli altari laterali in pietra che nel 1696 sostituirono quelli in legno.13 Agli inizi del XVII secolo gli uomini habili erano in numero di duecento, se diamo fede ai dati forniti da Andrea Cittadella; lo stesso autore riporta anche le dimensioni della chiesa: 28 piedi di lunghezza per 16 di larghezza, pari cioè a 10 metri per 5,70 attuali.14 Dimensioni rimaste pressoché invariate fino all’alba al 1912. Dalla visita vescovile compiuta nel giugno 1747 dal vescovo padovano, il cardinale Carlo Rezzonico, futuro papa Clemente XIII (17581769), ricaviamo alcuni dati sulla popolazione: 485 anime di cui 324 adulti e 161 minori.15 Dopo la soppressione del monastero di Praglia decretata nel 1806, per tutto la chie sa di sa n g iova n n i batt ista di c arbonar a 205 il secolo XIX l’amministrazione materiale della chiesa venne curata dal Regio Erario, cioè dallo Stato, prima austriaco e poi italiano. Nel 1827-28 su progetto dell’ingegnere ed architetto Valeriani, fu realizzato il nuovo cimitero, abbandonando definitivamente l’area delle sepolture adiacente alla chiesa, un’area ripetutamente ricordata nelle visite abbaziali.16 Dal 1806 al 1929 la chiesa di Carbonara fu dunque proprietà dello Stato, in quanto confiscata al monastero di Praglia. All’alba del Novecento s’iniziarono i lavori per la costruzione di un nuovo edificio sullo stesso luogo del precedente. Il progetto, elaborato nel 1883 dall’ingegner Menegoni, inizialmente accantonato venne ripreso nel 1912 e con rapidità incredibile già il 9 febbraio 1913 il parroco don Giovanni Bernardini, con l’assenso del vescovo, fu posto nelle condizioni di benedire la nuova chiesa, celebrarvi la Santa Messa cantata e svolgere la processione eucaristica. Altri lavori e altri ambienti s’aggiunsero in seguito: a ricordo dei caduti della Grande Guerra fu costruita una cappella in onore di Sant’Antonio, inaugurata il 9 ottobre 1921. Il 2 maggio 1931 il vescovo Elia Dalla Costa consacrò la chiesa mentre solo il 21 novembre 1943 prese avvio la costruzione del nuovo campanile, benedetto dal vescovo Girolamo Bortignon il 3 agosto 1957.17 Note 1. Giannino Carraro, Monachesimo e cura d’anime. Parrocchie ed altre chiese dipendenti del monastero di S. Maria Assunta di Praglia in diocesi di Padova (sec. XII-XVIII). Con edizione delle visite abbaziali, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana – Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, XXXIV) 2010, p. 61. 2. Carraro, Monachesimo e cura d’anime, p. 61-62. 3. Il «Liber» di S. Agata di Padova (1304), a cura di Giannino Carraro, con Nota di diplomatica di Gian Giacomo Fissore, Padova (ed. Antenore – Giunta Regionale del Veneto – Fonti per la Storia della Terraferma Veneta, 11) 1997, p. 136. 4. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae-Histria, Dalmatia, a cura di Pietro Sella e Giuseppe Vale, Città del Vaticano (Studi e testi, 96) 1941, p. 113, num. 1335 e p. 187 n. 2186. 5. Andrea Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova (Tip. Prosperini) 1862, (ristampa anastatica, Atesa editrice, Bologna 1984), vol. II, p. 79. 6. Pierantonio Gios, L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-1507), Padova (Istituto per la storia ecclesiastica padovana) 1977, p. 125 n. 20. 7. Callisto Carpanese, Cenni storici. Dal 1448 al 1980, in L’abbazia di Santa Maria di Praglia, La cuspide del campanile in costruzione. L’opera verrà inaugurata dal vescovo di Padova il 3 agosto 1957. 206 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nubi all’orizzonte: una veduta del panorama mattutino da una collina di Carbonara. 15. 16. 17. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei a cura di Callisto Carpanese e Francesco Trolese, Milano (Silvana Editoriale) 1985, p. 17-19. Antonio Rigon, La parrocchia di S. Giovanni Battista di Carbonara, in L’abbazia di Santa Maria di Praglia, a cura di Callisto Carpanese e Francesco Trolese, Milano (Silvana Editoriale) 1985, p. 71-73. Vedi sopra alla nota 1. Carla Frasson, Il monastero di Praglia nel secolo XVI. Conduzione agraria e bonifiche, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Magistero, relatore prof. Aldo Stella, a.a. 1978-79, p. 128. Carraro, Monachesimo e cura d’anime, p. 342-345. Frasson, Il monastero di Praglia nel secolo XVI, p. 94-95. Rigon, La parrocchia di S. Giovanni Battista di Carbonara, p. 71. Andrea Cittadella, Descrittione di Padova e suo territorio con l’inventario ecclesiastico brevemente fatta l’anno salutifero M.D.C.V, edizione a cura di Guido Beltrame, Conselve (Veneta Editrice) 1993, p. 118. Rigon, La parrocchia di S. Giovanni Battista di Carbonara, p. 72. Il dato è desunto da una copia del verbale redatto nel 1828, che riporta in copertina i dati progettuali, tratto dall’Archivio comunale di Rovolon ma di cui ignoro la collocazione. [Ireneo Daniele], La diocesi di Padova nel 1972, Padova (Tip. Antoniana) 1973, p. 165. Nel territorio comunale di Rovolon sono presenti diversi edifici di pregio costruiti nel corso dei secoli per l’iniziativa dei privati e per l’intraprendenza delle comunità benedettine, in particolare delle due abbazie di Santa Giustina di Padova e Santa Maria di Praglia, interessate a dare un’organizzazione adeguata e funzionale alle esigenze produttive delle vaste tenute agricole detenute nella nostra zona. I casi più noti sono villa Ottavia, in via Torre n. 18, e la “corti benedettine” di Spirano e Vegrolongo. L’Istituto regionale per le ville venete ha censito a Rovolon una decina di fabbricati meritevoli di tutela e di attenzione: sono tutti classificati con la qualifica di “ville venete” e ognuno di questi è contraddistinto con una sigla alfa-numerica. Nell’ordine essi sono: PD436 – villa Barbaro, Marchesi, Pierantoni in via Ca’ Marchesa; PD437 – villa Da Rio, Rubini, Canal in via Monte Sereo; PD438 – villa Da Rio, Soranzo, Schiavinato in via San Giorgio 9; PD439 – villa Lion, Fardigo, Fasolo in via San Giorgio 51; PD440 – villa Lippomano, Barbarigo, Martinengo, Montesi in via Monte Sereo 75; PD442 – villa Ottavia in via Torre 18; PD443 – villa Papafava dei Carraresi in via Frassanelle; PD444 – casa Papafava, Casiraghi detta “Il Palazzetto” in via Spinazzola 20; PD 445 – villa Tosi, Priuli, Fogazzaro, Faggion in via Lovolo 56. Palazzi e fabbricati di notevole valore storico e architettonico che meritano attenzione e che conferiscono prestigio al territorio in cui sorgono. Di questi complessi riproponiamo qui il testo che accompagna la loro descrizione iconografica nel volume stampato su iniziativa della Regione Veneto nel 2001. Un elenco integrato da altri tre fabbricati di particolare pregio che non figurano nella lista dell’Istituto regionale. Iniziamo con la villa più giovane, seppur nel nome dei proprietari conserva il legame più antico con il territorio di Rovolon: villa Papafava a Frassanelle. Villa Papafava alle Frassanelle L’imponente complesso è formato da più corpi: la villa, le vicine cappelle, le adiacenze rustiche, il tempietto jappelliano, una serie di fattorie, tutto inserito in un ampio parco. La villa e le cappelle sorgono in cima alla collinetta ai cui piedi si elevano le amplissime adiacenze, mentre gli altri edifici sopra elencati sono integrati all’interno del parco romantico che li ha utilizzati spesso come punti di fuga prospettici. La famiglia Papafava, che è presente in zona sin dal Cinquecento* con parecchie proprietà terriere e costruzioni, edifica su alcune preesistenze il suo palazzo: lo troviamo inserito già nella “Gran Carta del Pa- La villa Papafava a Frassanelle. 208 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei dovano” di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1780. Nelle forme attualmente visibili viene sistemato dal conte Alessandro Papafava nel 1822, che ne è proprietario e architetto. L’edificio ha pianta quadrata e si sviluppa su tre piani; agli angoli quattro simmetriche torrette, elevate sopra la quota del volume centrale di un piano e coperte da un tetto a piramide, completano la costruzione. Decisamente lineare, la villa ha le aperture dei fronti simmetriche, impostate su una tripla luce nel volume mediano e doppia nelle ali; porte e finestre sono architravate, con semplice profilo: solo quelle del primo piano presentano un decoro aggettante sopra l’architrave. Tutto il pian terreno ha l’intonaco reso a conci di bugnato liscio che termina su una modanatura marcapiano aggettante ripetuta anche alle quote soprastanti. L’immobile poggia su un terrazzamento lastricato, circondato da un basso muretto, sul lato ovest vi prospetta anche la cappella: citata nelle visite vescovili del 1680 e 1696 era dedicata a Santa Marina e viene menzionata sino al 1822; l’altra chiesetta, ad essa simmetrica, è stata costruita solo per motivi decorativi. Alla base del colle vi sono gli annessi e le scuderie. Il tempietto di Giuseppe Jappelli è in pieno stile neoclassico, impostato su un solo piano; ha la pianta rettangolare e copertura a capanna che forma il timpano triangolare in facciata. Al centro due colonne con capitello ionico formano il loggiato, mentre i lati, decorati a conci lisci, sono aperti in una monofora architravata priva di cornice. All’interno, tripartito, è ora inserita un’abitazione. Sempre allo Jappelli si deve la sistemazione del parco, con lo scavo del laghetto e la costruzione della grotta artificiale, oltre al disegno dei percorsi ed alla piantumazione di nuove essenze arboree. Alla base della collina sorgono gli annessi, un lungo corpo porticato, occupato dalle scuderie cui fa seguito una corte chiusa, con edifici variamente adibiti, principalmente elevati di due piani con ampie soffitte a volume unico coperte da splendide capriate lignee. In una parte della campagna di pertinenza sul versante opposto è stato inserito un campo da golf, con tutti i servizi necessari. Uno dei due oratori del cortile di Villa Papafava. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete - Marsilio) 2001, p. 450, PD443] * In realtà negli Estimi di Padova la presenza dei Papafava nella zona è attestata sin dal primo Quattrocento [ndc]. Villa Tosi, Priuli, Fogazzaro, Faggion a Lovolo La recinzione ovest del complesso, formato da più corpi: la villa padronale, l’oratorio, le adiacenze rustiche e la torre colombara, segna il confine tra la provincia di Padova e quella di Vicenza. I dati d’archivio attestano qui una proprietà Priuli sin dal 1661, quando, in una Condizion aggiunta, Cornelia Corner relitta (vedova) di Zuanne Priuli per i figli Alvise e Marco, dichiara in Vegrolongo sive Carbonara una «casa dominicale con cortivo, orto e brolo di campi 5», oltre a beni in altre località. Nel 1740 Ludovico Priuli dichiara in Lovolo: «casa dominicale con chiesa, barchesse, stalle, tezze, orto e brolo», elencando il complesso praticamente così come appare ancor oggi. La datazione della costruzione è stata posta da alcuni studiosi tra il 1625 ed il 1635, con una attribuzione progettuale a Baldassare Longhena dovuta principalmente all’impostazione planimetrica della villa stessa: mancano a tutt’oggi documenti d’archivio che possano avvallare tale ipotesi.1 Alla villa, preceduta dall’ampio giardino cintato si accede attraverso un portale in ferro su pilastri; recentemente restaurata ha pianta rettangolare, elevata di due piani più le soffitte, mostra una sopraelevazione timpanata centrale in entrambi i fronti. Il prospetto principale è esposto a sud, impostato su un’area centrale, con Il prospetto centrale di villa Priuli, Fogazzaro a Lovolo agli inizi del Novecento, ripreso in una cartolina spedita da Matilde Fogazzaro nel dicembre 1913. 210 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei notevole apparato decorativo, corrispondente all’androne passante ed ali più semplici che terminano in spigoli marcati da una serie di conci rustici sovrapposti da terra fino alla cornice di gronda: quest’ultima, potentemente modanata, aggetta di molto rispetto al filo della facciata. Le ali hanno finestre rettangolari, con le soglie e gli architravi collegati da fasce marcapiano lisce; sono prive di decoro agli stipiti. Il sottotetto presenta piccole finestrine rettangolari, assiali alle aperture sottostanti, e ugualmente decorate. La partizione mediana ha il portale d’ingresso archivoltato con cornice a bugnato e, ai lati della lunetta, un finestrino quadrato secondo uno schema che ricorda la serliana. I piani soprastanti sono aperti in loggiati: il piano nobile ha un triplo fornice a pieno sesto, con piedritti a bugne e poderose agrafi in chiave, aperto su un terrazzo in pietra a colonne poggiato su mensoloni; la sopraelevazione delle soffitte sostituisce i pilastri a bugne con paraste lisce ed il terrazzo con balaustra, e trasforma in architravate le tre aperture; sopra i capitelli vi è l’architrave ed il timpano triangolare. Quest’ultimo ha segmenti poderosamente modanati e reca uno stemma nobiliare al centro. Il prospetto posteriore è caratterizzato dall’aggetto del volume nel quale è inserito lo scalone monumentale, a doppia rampa con spigoli decorati da conci sovrapposti. All’interno tre arcate immettono alle due rampe ed al corridoio voltato, mediano, che porta al portoncino archivoltato, con cornici a bugne; due finestre quadrate lo affiancano mentre triple aperture stanno ai piani soprastanti, piccole al sottotetto; un timpano triangolare, con cornici a dentelli, definisce il volume. Ai lati semplici finestre architravate, alcune tamponate, completano il prospetto Inserita allo spigolo nord-est del fabbricato vi è l’adiacenza che, oltre un vano porticato e due stanze, ancora parte dell’abitazione, si allunga verso est con corpi di fabbrica a funzione abitativa e porticati ad uso agricolo, vol- vi l la tosi, p riul i, fo ga zzaro, faggion a lovolo 211 tando poi, con un altro lungo fabbricato, verso sud. Ai limiti esterni, a sud-est del giardino, sorge l’oratorio dedicato alla Immacolata Concezione, costruito nella prima metà del Settecento e citato nelle visite pastorali del 1777; mostra all’interno un bell’altare marmoreo. Gli interni della villa mantengono i pavimenti in terrazzo veneziano originali anche nelle soffitte, e dato inusuale e certamente pregevole, si conserva anche un camino originale in pietra nella stanza a nord-ovest del pian terreno. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 452, PD445] Nota del curatore 1. Dai registri catastali si rileva che nel 1840 titolare della villa era Giuseppe Fogazzaro del fu Mariano. Oltre al palazzo padronale a Rovolon deteneva una superficie complessiva di ben 4.362,84 pertiche metriche, pari a 4.362.840 mq. di terra, cioè oltre 436 ettari attuali, per una rendita di 12.272,69 lire austriache. Nel 1846 Giuseppe acquisì altri immobili fino a raggiungere la superficie di 5.054,97 pertiche metriche, per una rendita di 13.361,13 lire austriache. Nello stesso 1846 si aprì la successione per la morte del proprietario: a subentrare nella proprietà furono i figli Francesco, il sacerdote Mariano, Angelo, Caterina e Teresa. L’anno seguente morì anche Francesco così che il 10 marzo 1853 buona parte dei beni situati a Rovolon pervennero alla figlia Matilde Fogazzaro: la superficie si era nel frattempo ridotta a 4.620,67 pertiche metriche, per una rendita di 13.560,54 lire austriache. Una superficie destinata comunque ad aumentare, visto che nel 1894 l’estensione della proprietà di Matilde era di 5.123,56 pertiche metriche per una rendita di 14.909,13 lire austriache. Maritata con il cav. Dott. Alvise Biego del fu Antonio, Matilde era solita soggiornare a Lovolo, in considerazione anche dell’area esclusiva che circondava il palazzo padronale capace di estendersi per ben 9.700 metri quadrati (Archivio di Stato di Padova, Censo stabile, Rovolon, vol. 313, partite 237, 248). Tre istantanee dal complesso di Villa Tosi a Lovolo. 212 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Due immagini di Villa Papafava. Villa Barbaro, Marchesi, Pierantoni Il complesso della villa è stato ampiamente rimaneggiato e restaurato dopo l’acquisto da parte degli attuali proprietari. Dalla documentazione disponibile si evince che il complesso, che ha impianto databile al XVIII secolo, era di proprietà della contessina Matilde Barbaro ed era formato da un corpo padronale, pur di modeste dimensioni, barchesse ed annessi rustici vari oltre ad una chiesetta, posta discosta dai restanti edifici ed un parco piantumato da circa 200 secolari querce, ora scomparso. La chiesetta è l’edificio che ha subito minori manomissioni: si presenta con quattro lesene in facciata, disposte simmetricamente, che sorreggono il timpano triangolare decorato da uno stemma centrale in marmo, il portale di ingresso è architravato, con cornice, e sormontato da una finestra termale semicircolare. Alcune superfetazioni postume, costruite sul lato oltre la stanzetta dell’originaria sacrestia, ne hanno sconvolto l’impianto molto regolare. La barchessa ha ampie arcate a pieno sesto su pilastri a pian terreno mentre piccole finestrine quadrate illuminano il soprastante granaio. La villa, rimaneggiata, mantiene l’impostazione planivolumetrica alla veneta, con vano centrale e stanze ai lati*. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 445, PD436] * Nella carta militre austriaca di Anton Von Zach del 1798 il complesso è indicato con la legenda “Case Papafava” [ndc] Ca’ Marchesa a Bastia in una cartolina spedita nel settembre 1907. Villa Da Rio, Rubini, Canal Questo complesso, citato da Alessandro Baldan1 come di proprietà della famiglia Da Rio nel 1543, è parte dell’edificato agricolo sviluppatosi in seguito alla fondazione benedettina quattrocentesca della “Corte di Vegrolongo”. La costruzione si sviluppa secondo due assi ben distinti: l’orizzontale delle barchesse e degli accessori ed il verticale della colombara. La barchessa si presenta con una simmetria di facciata molto accentuata: si notano le due grandi aperture a sesto ribassato, che indicano i passaggi carrabili che attraversano l’intero edificio, e la porta d’ingresso centrale centinata con tre finestrelle rettangolari ai lati, disposte simmetricamente. Il piano superiore è caratterizzato da tre aperture centinate, poste al centro della costruzione. Sopra la cornice modanata di gronda la copertura è a due falde a capanna. Un annesso rustico di dimensioni minori, ma con le stesse caratteristiche forometriche della barchessa, finestre centinate ed entrata archivoltata, sembra quasi annunciare la verticalità della colombara. Questa si presenta come una costruzione massiccia su pianta quadrata, con un’elevazione di cinque piani fuori terra. Fasce marcapiano ed archetti pensili sottolineano i piani alti che si collocano al di sopra dell’altezza del corpo padronale della villa. Sul prospetto principale della colombara le finestre esistenti sono disposte ai lati della costruzione. La villa padronale si presenta come una costruzione molto compatta, elevata di due piani più le soffitte e costruita in aderenza alla torre, priva di decoro a sottolinearne il suo valore agricolo. Altre costruzioni più tarde completano il complesso. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 445, PD437] Note 1. Alessandro Baldan, Ville venete in territorio Padovano e nella Serenissima repubblica. Documentazione – iconografia – testimonianze, Abano (Aldo Francisci Editore) 1986, p. 433434. Nella pagina a fronte la Colombara di villa Da Rio. Villa Da Rio, Soranzo, Schiavinato L’immobile è citato per la prima volta in un documento del 1532 di Galeazzo da Rio come «casa di muro per uso». Alessandro Baldan riporta una polizza di poco successiva, 1543, in cui Ludovico da Rio dichiara in contrà Bastia over Saltixello: «campi 6 di broli, orti, cortivo per mio uso e dei lavoratori con abitazion sopra di muro, colombara, chiesura e teza con pegorile per uso lavoranti». L’immobile, poggiato ad un terrazzamento lungo il declivio collinare, ha l’ampio brolo cintato da un muro verso monte, mentre verso valle, oltre il salto del terrazzamento suddetto, si apre la campagna di pertinenza. L’edificio, le cui adiacenze addossate ad est sono state restaurate e parzialmente trasformate, si presenta con il fianco libero con la base contraffortata, simile ad un fortilizio, e con aperture varie, ed a vario livello, protette da inferriate in ferro battuto. Come cita la relazione allegata al decreto di vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939, la villa presenta «una distribuzione interna molto particolare, fatto che la rende piuttosto anomala rispetto alla classica pianta di villa veneta»: osservando i prospetti infatti si notano luci poste in maniera disordinata a causa dell’alternarsi, negli interni, di stanze alte e di mezzanini. Spicca comunque, nel fronte verso la valle, una trifora centrale architravata, con luce mediana resa da una portafinestra e finestre ai fianchi, contornata da una cornice modanata in pietra di Nanto. Le altre aperture sono regolarmente piccole nelle soffitte e più ampie nel piano nobile: qui hanno la cornice in pietra con la soglia leggermente sporgente e l’architrave modanata assoggettante. L’ingresso, verso il giardino, ha portale architravato con cornice in pietra decorata. L’immobile è coronato da una cornice di gronda a dentelli in laterizio intonacati, sotto il cornicione. Negli interni si mantengono le travature lignee alla sansovina, parte ancora con decori originali. Al piano terra si conserva un camino in pietra ed un portale, sempre con cornice modanata in materiale lapideo. La scala è ad una sola rampa, in pietra, e porta ai vani soprastanti; tra essi particolare è una stanza voltata a botte ribassata, mentre un’altra mantiene un camino con mensole in pietra lavorata sulla cui cappa è dipinto un cavallo impennato con cavaliere. Tale decorazione è stata raffrontata con il riquadro raffigurante “Antenore Vincitore” di Gualtiero Padovano, attivo tra il 1520 e il 1535. La decorazione delle pareti del salone passante è costituita da una fascia a grottesche in cui sono putti, alcuni inseriti in finti oculi ovali; sotto tale fregio, finte architetture con colonne sormontate da piccoli capitelli a formare un pergolato in prospettiva con viti e putti che spiccano gli acini; sullo sfondo si vede un paesaggio con edifici, alberi, uccelli; un sovrapporta presenta una Nella pagina a fronte villa Da Rio vista da via San Giorgio. 218 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei figura di donna seduta. Un’altra stanza ha un fregio sotto il soffitto con paesaggi e grottesche. Le varie decorazioni sono state attribuite da Giuseppe Fiocco all’ambito di Gualtiero Padovano, i putti invece alla mano di Domenico Campagnola. Il prospetto di villa Da Rio su via San Giorgio. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 446, PD438] Villa Lion, Fardigo, Fasolo Malgrado la sua collocazione nell’abitato di Rovolon la villa non ha perduto né la propria leggibilità né le proprie caratteristiche di casa, certamente di villeggiatura, riusalente, secondo lo storico Gianni Degan, al XVII secolo. La mancanza di annessi rustici evidenti ed il carattere austero della facciata prospiciente la chiesa del paese fanno di questa villa un singolare manufatto di grande impatto, «un oggetto concluso in sé». La forometria presenta i classici cinque assi in facciata con i contorni delle aperture in conci bugnati in trachite. L’asse principale è determinato dall’entrata archivoltata, anch’essa con bugne di trachite, la loggia al primo piano sopra il salone centrale passante aperta su una balaustra in pietra, le due finestre al secondo piano collocate in mezzeria e un piccolo foro tondo al centro nonché la “piegatura” del profilo esterno della facciata. Il tetto è a due falde ma non è reso evidente nella facciata principale. I due oculi ellittici, ai lati al secondo piano, sottolineano le aperture architravate sottostanti. Il fronte volto ad ovest si apre su di un piccolo cortile e dà accesso al ristorante, inserito nel fabbricato*. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 447, PD439] * Nel 1787 la proprietà dell’area è indicata dal perito Antonio Turcato tra i beni della famiglia padovana Dottori (ASPd, Notarile 6726, c. 157r) [ndc] Villa Lippomano, Barbarigo, Martinengo, Montesi I dati d’archivio partono da una Condition del 1661 per «metà di una casa dominicale tenuta per mio uso», in Cereo, resa da Francesco Lippomano. Nel 1689 la proprietà passa ad Antonio Barbarigo, dalla cui famiglia prima dell’Ottocento viene venduta ai Michiel. L’imponenza di questa villa colpisce per la sua originalità nell’ambito del panorama dei Colli Euganei e delle ville coeve. Data la presenza del pendio, i due fronti differiscono di molto nel numero di piani: uno verso il monte e tre verso valle, oltre alla sopraelevazione di un intero solaio nelle due torri che abbracciano il volume centrale, secondo un modello spesso presente in territorio vicentino nel Cinquecento. Tutte le finestre presentano cornice ed hanno le soglie e gli architravi collegati da fasce marcapiano che sottolineano la partitura orizzontale del fabbricato. La forometria, simmetrica, presenta i classici sette assi che si evidenziano 222 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei di piano in piano in maniera diversa. Al piano terra l’asse principale è reso evidente da un’unica apertura archivoltata centrale mentre le finestre, disposte simmetricamente ai lati, sono quadrate e in numero di tre per lato, equidistanti fra di loro. Il primo piano ha le finestre aumentate di numero, sono ben nove e diventate rettangolari con aumento dell’altezza; le tre centrali si raggruppano attorno all’asse principale. Al secondo piano oltre all’aggiunta di oculi, al di sopra delle finestre architravate poste nei lati, si assiste alla trasformazione delle tre aperture centrali in una trifora archivoltata resa da portefinestre aperte su di un terrazzo in pietra. Le due torri laterali superano di un piano l’altezza del volume mediano sottolineando, con gli alti camini, l’impulso verticalizzante già enfatizzato dalla gradinata che collega il terreno al basamento della costruzione. Il fronte opposto, ad un solo piano al centro e con ali a due livelli, si apre in un loggiato a tre fornici architravati su colonne cui si sovrappone, sopra la modanatura dell’architrave, una sopraelevazione culminante in un timpano aperta in una monofora archivoltata e raccordata da volute al tetto. Anche in questa facciata, aperta in oculi ai lati del loggiato e sopra le finestre architravate, cornici, fasce marcapiano e conci, in corrispondenza dei tre distinti volumi, segnano la muratura. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete – Marsilio) 2001, p. 447-8, PD440] Villa Montesi vista da via Roma. Villa Ottavia Le notizie della villa risalgono alla metà del Quattrocento, 1441 per l’esattezza, quando i monaci benedettini di Santa Giustina di Padova acquistano il terreno, e le fabbriche in esso presenti, da Giovani Parasini per farne la sede amministrativa della “Corte di Vegrolongo”, sita in pianura. Passata in mano ai Pasetti durante l’Ottocento, l’immobile è poi acquistato dalla famiglia Negro attorno al 1970; attualmente è proprietà della signora De Fabi Pezzani Lucilla. Accanto alla villa signorile sorge una barchessa, mentre una colombara ed un annesso rustico completano gli edifici inseriti nell’ampio parco. La villa padronale, i cui caratteri stilistici si ascrivono alla metà del Cinquecento, si eleva, a pianta rettangolare, per due piani più le soffitte su un’area cantinata. I fronti simmetrici sono scanditi da cinque assi di aperture, variamente rese. Verso il giardino l’accesso è attraverso un portale architravato, con cornice a listelli, posto al termine di una scalinata; gli si affiancano due finestre e, a seguire, altre due monofore illuminano le stanze ai lati dell’androne passante. Al piano superiore il centro del prospetto è marcato da una trifora archivoltata, con lunette cieche, incorniciata da listelli scanalati e con ghiere a doppia modanatura in pietra tenera. Due monofore simili stanno ai lati, in asse con Villa Ottavia in una cartolina stampata alla fine del secolo XIX. 224 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei le luci sottostanti; il sottotetto è illuminato da cinque finestrine quadrate. Sopra tali aperture vi è una fascia dipinta a spicchi, simile ad una serie di archetti ciechi e, oltre, si incontra lo sbalzo della travatura di sostegno del tetto. Il fronte opposto a nord, pur simmetrico, sostituisce le monofore voltate del piano nobile con simili finestre architravate e trasforma in centinate le aperture delle soffitte. Ad est è addossato il corpo con il loggiato. Ad ovest, sopra un pian terreno aperto al centro in un portale architravato con finestre ai lati ed un mezzanino, si incontrano cinque fornici a pieno sesto, poggiati su colonnine con capitello vagamente corinzio; ai lati è aperta una singola luce su muratura piena. Il soffitto del loggiato è a travatura lignea. Di fianco alla villa si eleva la barchessa, un edificio più simile ad un chiostro monastico che ad un corpo rustico, con arcate a pieno sesto poggianti su colonne rastremate e voltata a crociera su peducci. Il fianco opposto alla villa ha un fornice a pieno sesto sormontato da un oculo circolare. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete - Marsilio) 2001, p. 448-9, PD442] Il cortile e la torretta di villa Ottavia. Casa Papafava, Casiraghi detta “Il Palazzetto” L’edificio in oggetto era parte delle proprietà della famiglia Papafava dalla costruzione, attorno alla metà Settecento, sino al secondo decennio del Novecento. Passato da allora attraverso più mani è stato recentemente acquistato, e restaurato, da Alberto Casiraghi che vi risiede. “Il Palazzetto” è un edificio molto semplice, impostato su base rettangolare ed elevato di due piani più le soffitte su un seminterrato visibile, data la pendenza del terreno, sul fronte esposto a nord, secondario, mentre il prospetto principale guarda a sud; per la sua costruzione sono stati evidentemente utilizzati i materiali disponibili, al tempo, in loco e ripristinati, per quanto possibile, durante il restauro. Il fronte principale si presenta scandito da cinque assi di aperture, simmetricamente reso rispetto al centro, impegnato a pian terreno dal portale di ingresso, architravato, al quale sono affiancate due aperture in corrispondenza delle due stanze laterali. Il piano superiore ripete le luci architravate mentre il sottotetto ha tre soli piccoli finestrini e due finti fori per mantenere la simmetria del prospetto. Il retro essendo esposto a nord è stato impostato con un numero inferiore di aperture, ridotte a tre per piano. In origine le scale erano due, ora ne resta una sola, quella centrale, in pietra; al primo piano l’una smontava in un camerino e la seconda partiva da un secondo piccolo vano affiancato e saliva alle soffitte. Al pian terreno le due stanze presentano originali camini in pietra in stile Luigi XVI, che confermano l’ipotesi di datazione dell’immobile al Settecento. Il vano delle soffitte è a volume unico, con tetto a capriate in legno; il seminterrato è aperto verso tre lati, il quarto, a sud, è addossato al pendio: originariamente era adibito a cucina e a magazzino. Il tetto è a quattro falde collegate nel colmo. Un fienile, presente nel terreno di pertinenza, è stato riattato ed adibito a deposito. [Tratto da: Ville venete: la Provincia di Padova, a cura di Nicoletta Zucchello; responsabilità scientifica Sergio Pratali Maffei, Pierluigi Fantelli; saggi introduttivi Guglielmo Monti, Giuseppe Gullino, coordinamento Maurizio Gasparin, Venezia (Istituto regionale per le ville venete - Marsilio) 2001, p. 451-2, PD444] 226 Due signore di casa Manfredini all’inizio del Novecento. Ritratto di famiglia in casa Manfredini, all’alba del secolo scorso. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Villa Manfredini Villa Manfredini si trova in via Loredan ed è identificata alla partita catastale n. 1000317, mappale 6 del foglio 8 del catasto del comune di Rovolon. L’accesso padronale è in via Roma al n. 53 e il secondario, oramai in disuso, in via Loredan n. 1. È attualmente proprietà dei marchesi Manfredini discendenti da un’antica famiglia nobile, propaggine dei Duchi Ravennati, le cui origini risalgono al 752. Come si evince dallo studio dei catasti storici il manufatto faceva parte di una vasta proprietà intestata alla nobile famiglia veneziana dei Loredan (o Loredani come si legge nel sommarione del catasto napoleonico del 1810)1 ed era una “casa di villeggiatura”, nota come “Palazzo Loredani”, contornata da un orto, un brolo, dei pascoli e degli aratori vitati e con un’adiacente “casa da massaro” divenuta poi “casa colonica”. Alla morte del nobile Girolamo Loredan, probabilmente nel 1844, l’intera proprietà, dietro compromesso datato 24 aprile 1844 viene assegnata in eredità ai tre fratelli Mario, Adelaide e Colomba. Il palazzo e la casa colonica vengono quindi divisi in tre parti, subendo così una prima ristrutturazione. I fratelli Mario e Adelaide Loredan nominavano l’ingegnere civile Piero Neri di Padova,2 mentre Colomba Loredan nominava l’ingegnere civile Giuseppe Sacchi anch’esso di Padova, affinché compilassero l’asse della sostanza da dividersi. Essi debbono di questa sostanza formare tre parti uguali. Inoltre per la confezione dell’asse e pel conguaglio delle parti si abbia ad aver riguardo al valore attuale delli fondi, che nelle divisioni debbasi avitare e togliere tutte le possibili servitù e promiscuità … con l’obbligo però che a ciascuna parte sia assegnata una porzione delle fabbriche. La perizia di stima così redatta, in data 26 ottobre 1844, riporta lo stato di fatto dell’intera proprietà Loredan e per quanto riguarda il Palazzo dà una descrizione dei vari ambienti con le loro caratteristiche principali. Varie si susseguono negli anni le compravendite, fino a quando tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento, le tre parti di ricongiungono, acquistate nel tempo da Francesco Pedrotta fu Pietro, livellario dei Loredan, che a sua volta il 28 ottobre 1886 venderà l’intera proprietà alla nobile Teresa Tretti fu Giovanni Battista, maritata con il marchese ingegnere commendatore Marco Manfredini. Agli inizi del Novecento i nuovi proprietari interverranno con alcuni miglioramenti: • alzando di poco la casa, aumentando l’altezza delle finestre in modo da rendere vivibile il piano superiore. In alto Marco Manfredini, in basso la moglie Teresa Tretti. 228 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei • La parte della barchessa sul lato sinistro della casa dove vi era il portone per l’accesso ai campi viene ridotta, spostando il cancello di passaggio fra la corte e via Loredan incernierato da un lato sulla casa e dall’altro sulla barchessa, più a sinistra, e costruendo in due fasi successive un piccolo edificio, a ridosso della casa con le finestre a bifora al piano terra e rotonde al piano superiore. • Modificando l’ingresso dalla corte alla casa con una “bussola” di accesso e tre scalini. • Eliminando la porta, che dal salone dava in via Loredan e probabilmente spostando il muro che divideva il fondo del “salone”, costruito per dividere in tre parti la proprietà del nobile Girolamo Loredan, creando una sala da pranzo e dando una maggiore profondità alla sala d’ingresso. • È probabile che in quel periodo la facciata della casa venga dipinta con fasce orizzontali di vario colore, rendendo una migliore prospettiva all’insieme. • Il giardino viene ridisegnato, seguendo lo schema italiano, con un’ellisse, dove l’asse principale è in continuazione del lungo viale d’ingresso. Negli anni 1920-25 verrà costruita la scuderia (presente nel catasto aggiornato nel 1929) all’ingresso del giardino, un edificio “merlato” con un gran portone di legno, dove entravano i cavalli e le carrozze, il quale riporta le finestre sotto merlatura rotonde, tipo quelle del piccolo edificio già citato a lato della casa. La corte dove venivano svolte le attività agricole, ora è stata ridotta in modo consistente, nel 1973, in quanto la fabbrica di vasi crescendo di dimensioni chiese, con il consenso dell’amministrazione comunale, ed ottenne, di aumentare la sua presenza sul territorio acquistando i campi a lato della casa: la zona che un tempo era agricola è stata quindi trasformata in industriale, eliminando la corte con i campi e riducendo quindi il valore storico della zona. Note del curatore 1. La famiglia veneziana dei Loredan era presente a Rovolon già nel 1648, come ricorda un verbale della vicarìa di Teolo del 28 settembre 1648. Quel giorno nella sala del Consiglio venne accolta la supplica del nobile Marco Loredan intesa a scorporare le terre di proprietà dal comune di Vegrolongo, entro cui ricadevano, in quello di Granza di Santa Giustina; al termine del dibattito la richiesta fu accolta con quarantatre voti a favore e tre contrari. Gli immobili di Marco Loredan in precedenza appartenevano alla nobil donna veneziana Isabetta Falier (ASPd, Santa Giustina, vol. 116, c. 115). 2. Seppur poco noto, Pietro Neri, figlio di Giovanni, fu un abile professionista di Padova, città in cui nacque nel 1793. Collaboratore, e forse discepolo, di Giuseppe Jappelli, fu tecnico di fiducia della famiglia Papafava, da cui ricevette diversi incarichi, tra cui la redazione della preziosa perizia sui mulini di Rovolon del 1834. Va ricordato per essere stato il progettista della facciata neogotica di palazzo Romanin Jacur in piazza Antenore a Padova (ASPd, Fogli di famiglia 1806-1816, n. 29, n. 3152/H). vi l la m a n fre din i 229 Data 22/02/2005 Spett. IL GAZZETTINO, ho letto a pagina VII de “ IL GAZZETTINO” di Martedì 22 febbraio “LE ALTRE NOTIZIE” la morte dell’imprenditore Genero. Vi ringrazio di aver ricordato che tale fabbrica artigianale sia stata condotta da Vincenzo Manfredini, ma mi fa piacere metterVi al corrente della storia di tale attività, che tra l’altro è un pò la storia di un periodo di vita di Bastia di Rovolon. Mio nonno, el Marchese, (n.16.08.1883 m.11.09.1968 nato a Padova in Via Galileo Galilei ex Vignale al civico n°17), così viene chiamato dalla gente, il Marchese Manfredo Manfredini. Dotato di una forte personalità e di instancabile capacità creativa. La sua vita comincia presto, perché la sua mamma la Nobile Teresa Tretti muore nel 1901, lasciandoli la proprietà di Bastia di Rovolon. Fu il 7° patentato di Padova, tanto che ebbe la medaglia d’oro dell’A.C.I. come pioniere delle guida. Appassionato di meccanica, a Padova, impiantò in Riviera Albertino Mussato, un’officina ed anche una falegnameria. Ma la sua passione era la campagna di Bastia di Rovolon. Chiese alle autorità dell’epoca circa il 1920 che venisse portata in Bastia la stazione dei Carabinieri, cosa poi avvenuta. Inoltre si faceva mandare i giornali dell’epoca, e una volta letti, li lasciava al buon Carletto che provvedeva a portarli in paese la sera creando così la cultura della lettura anche nei paesani. È sempre per la sua passione di attività quasi febbrile che nel 1925 fu al centro di quei progetti di trasformazione della vita agricola in industriale, cominciò a progettare l’elettrificazione del comune di Bastia di Rovolon come Selvec (una ramificazione della SADE Società Adriatica Di Elettricità) a portare i 10.000 Volt dalla Cabina dei fratelli Marin attraverso il monte Sereo fino a 200 metri dal centro di Bastia e li costruì la prima sottocabina, trasformando il 10.000V in 220-127 Volt. Passò poi a prolungare le linee elettriche a Rovolon. Non fu facile far capire ai contadini di allora i vantaggi che avrebbero avuto, tanto che alcuni si opponevano all’impianto dei pali nei loro campi, anche se si cercava sempre di impiantarli ai confini. Il 1929, fu un anno molto freddo con temperature molto al di sotto della media e per il Marchese fu una “debacle”; ci fu la recessione industriale e le materie prime aumentarono di molto il loro costo, il rame, (cioè i fili che utilizzava per il trasporto della corrente elettrica) passò da 1 lira a 8-9 lire al Kg. Nel 1928 impianta tremila viti da uva nei campi dietro la casa di Bastia di Rovolon, circa 20 campi padovani, ma con il freddo del 1929 morirono tutte. Sempre nel 1929 per aver scritto un articolo sulla Gazzetta del Veneto contro quota 90, criticando un discorso fatto a Pesaro da un personaggio (forse Starace) del regime Fascista fu incriminato come antifascista, e confinato a San Severino Lucano. L’albergo dove alloggiava era in fondo al paese, composto di tre stanze al piano superiore, ed il piano terra aveva una cucina con il pavimento di terra battuta, inoltre vi era un maiale che entrava ed usciva a suo piacimento. Per fortuna tale confino non durò 230 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei a lungo, solo tre mesi. Successivamente andò a Salerno dove si fece ricevere dal Prefetto di allora Prof. Ottavio Dinale, nativo di Badoere in provincia di Treviso. Successivamente tornò a casa in Bastia di Rovolon agli arresti domiciliari per sei mesi. Continuò l’ampliamento delle linee elettriche ad altri comuni. Fu la volta di Lovolo, Albettone, poi Bosco di Nanto. Tutto questo fu fatto con l’ausilio del bravo ed indimenticabile Carlo Pressato, detto Carletto, instancabile lavoratore di una onestà insuperabile. La storia racconta che Carlo Pressato incontrò il Marchese all’età di 14-16 anni. Gli si era forata una gomma della vettura e per cambiarla aveva chiesto a questo ragazzo, di sostituirla, cosa che il buon Carlo fece rapidamente, tanto che il Marchese gli chiese se voleva lavorare con lui. Mentre faceva questo, per allora, grande impresa di civiltà, non trascurava la sua passione per l’agricoltura, fece i primi esperimenti sui cereali, in questo caso, frumento. Erano le nuove produzioni di grano senza riste e con meno altezza e più precoci, cioè si maturavano circa un mese prima del tempo previsto e con una quantità di prodotto superiore al grano prodotto precedentemente. Partecipa alla cosiddetta “Battaglia del grano” voluta da Mussolini, tanto che in quel periodo l’Italia riuscì a non importare più grano dall’estero. Alleva mucche lattifere e galline ovaiole “Livornesi” coltiva la viticultura e partecipa a mostre a Bresseo e a Padova di uve pregiate meritandosi una diecina di premi e di attestati ancora esistenti. Più tardi circa nel 1938 incominciò la produzione di vasi ed attrezzi agricoli; quali l’erpice, lo sgranatoio, il torchio da uva, la diraspatrice, la pigiatrice eseguita dal bravo Carletto. Infine si accorse che la terra dei campi era un’ottima argilla per fare vasi da fiori, ed altri oggetti, e così impiantò la “ceramica”. Prima fece un forno poi un secondo detto “muffola” per poter cuocere i vasi dipinti dalla figlia Teresa, nella zona oggi ancora chiamata “Officina Privata” poi la trasferì nella corte della casa oggi in parte non più dei Manfredini, facendosi aiutare dal figlio. Quando il figlio Vincenzo (detto Enzo), tornò a casa dalla prigionia, in quanto combattè con i Leoni di Giarabub in Africa nella seconda guerra mondiale, fu fatto prigioniero e dopo l’onore delle armi, per la strenua resistenza che opposero ai soldati Inglesi, fu deportato in India, gli affidò la ceramica che condusse per parecchi anni, passando dal lavoro del vasaio con il tornio in legno costruito nell’officina di casa, a quello delle macchine automatiche. La ceramica divenne poi una fabbrica artigianale con il nome di VIMA. (Vincenzo Manfredini), poi venduta a causa di un enfisema polmonare causato dal periodo di prigionia al Sig. Attilio Genero. El Marchese fu amico del Conte Novello Papafava dei Carraresi e del giornalista direttore del giornale “La Libertà” (sotto il patrocinio de “Il Gazzettino”) Giuseppe Della Torre, che successivamente sarà chiamato da Benedetto XV alla direzione a Roma dell’Osservatore Romano. Ringrazio dell’eventuale spazio concesso ed invio cordiali saluti. Manfredo Manfredini (nipote) Renzo Forestan Il complesso rurale di via Loredan Al turista che si aggira nei dintorni di Bastia alla ricerca di vecchie case rurali, via Loredan offre materiale degno di destare in lui curiosità e interesse. In questa via si trova infatti un agglomerato di case, alle quali si giunge attraverso un viale, lungo 800 metri, fino a non molti anni fa alberato da due file di gelsi e fiancheggiato da due fossati. Al termine di questo viale rettilineo si giunge ad un grande cortile, di forma rettangolare, di circa 50 metri per 70, circondato per tre lati da edifici. Fiancheggiano l’entrata al cortile due costruzioni quasi nuove, che contrastano nettamente con il resto del sobborgo che si presume abbia all’incirca trecento anni. Lungo il lato sinistro del cortile sorge una grande stalla, la cui facciata è formata da cinque arcate in cotto. Attualmente l’edificio è suddiviso in tre diverse proprietà. Di fronte all’apertura del cortile si trova un caseggiato lungo circa 70 metri, suddiviso in due costruzioni, contrastanti nettamente per lo stile, infatti quella di sinistra era l’antica casa (ora disabitata e crollata) dei fittavoli, formata da circa dieci locali. Il piano terra, visto dal cortile, si presentava con un lungo porticato, a tre campate orizzontali. Nel sottoportico era situata l’antica stalla dei cavalli, una cantina, quella dei fittavoli, e una scalinata in pietra che conduceva ai granai e che si può considerare particolarmente interessante, data l’età in cui si presume sia stata costruita l’abitazione. Sotto detta scala si trovava un locale dove anni fa si poteva ammirare un antico telaio per la tessitura della tela. Adiacente a questo, sulla destra, oggi troviamo un edificio più alto, ancora in buone condizioni, che è usato dagli attuali proprietari. Si nota una lunga facciata costituita da sei arcate e un grande sottoportico pavimentato con lastroni di trachite, dove cinque colonne, due tonde e tre quadrate, sorreggono due granai, uno anteriore per il granoturco e uno posteriore per il frumento, lunghi circa 30 metri. Sotto il primo arco si trova un locale, adibito a deposito per le macchine agricole, ma che al tempo degli antichi proprietari costituiva la rimessa della carrozza e del calesse. Nella parte posteriore dell’edificio, a una profondità di circa 2 metri, si trova una cantina, lunga quanto i granai, e ancor oggi parzialmente usata a questo scopo. La trebbiatura effettuata nella corte della casa Manfredini. 232 Zappatura della terra davanti a villa Manfredini. rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Sul lato destro di questo caseggiato, sorge l’antica casa padronale, composta da circa quindici locali, ora restaurata e abitata da due famiglie. Il restauro rispecchia abbastanza fedelmente le linee architettoniche originali della casa, sebbene sia evidente un certo contrasto. Il lato destro del cortile è privo di edifici e attualmente c’è un grande vigneto, che fino a trenta anni fa costituiva il così detto “brolo” o “broeto” dei padroni (frutteto). Sulla destra, nella parte anteriore, rimangono ancora dell’antico caseggiato la chiesetta del 1777 e i resti della vecchia casa del fattore, ora adibita a pollaio. L’ingresso in corte era delimitato da un grande cancello in ferro battuto, i cui cardini erano fissati ai pilastri col piombo. Su una lapide in pietra erano incise le iniziali R.O. (Regensburger Ottavio) antico proprietario; inoltre sulla stessa lapide c’erano delle iscrizioni che a ricordo di persone espressamente interpellate non si è mai riusciti a decifrare. Perfino il vescovo di Padova Carlo Agostini in visita pastorale alla chiesetta, incuriosito da tale lapide, non era riuscito a capire cosa fosse scritto. Sulla sinistra esisteva l’antica fornace di mattoni, mantenuta in funzione per circa centodiciannove anni e che terminò di funzionare allo scoppio della prima guerra mondiale. Da informazioni certe di persone ancora viventi sappiamo che questa fornace dava lavoro a circa trenta operai e che produceva circa 60.000 mattoni e 20.000 tegole ogni fornaciata. I mattoni e tegole erano siglati R.O (Regensburger Ottavio). Il tempo di cottura per i mattoni era di otto giorni e in un anno si facevano circa sei o sette fornaciate. All’estrema sinistra esisteva la casa del cocchiere dei proprietari terrieri. A destra del cancello esisteva il forno del pane costruito circa novanta anni fa dai signori Perazzolo che avevano acquistato la proprietà dai Regensburger nel 1920, un edificio adibito a deposito per attrezzi agricoli, quindi la chiesetta e la casa del fattore. Esiste ancora un sotterraneo, attualmente completamente interrato e di cui non siamo risusciti a sapere l’uso al quale effettivamente serviva. Questo sotterraneo parte dalla casa dei vecchi proprietari ed arriva, attraversando tutto il lungo cortile, sotto la chiesetta. Durante la seconda guerra mondiale sappiamo con certezza però, che qui veniva nascosto il frumento per evitare eventuali requisizioni. Sulla destra, dove si trovava l’antico giardino, ora sorgono disordinatamente alberi. Nella corte si trovavano tre pozzi, ancora in funzione e una grande vasca, a forma di parallelepipedo, ricavata da un unico blocco di pietra che era l’antico abbeveratoio per il bestiame. Claudio Grandis Ca’ Costigliola Il 30 ottobre 2010 l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha inaugurato il recupero architettonico di Ca’ Costigliola, un antico insediamento rurale che affonda le sue origini nel tardo Medioevo. Situato nel comune di Rovolon, al confine con i comuni di Teolo e Cervaerse Santa Croce, sorge su una piccola altura che domina la valle attraversata dallo scolo Rialto. Dopo esser stato, nel corso dei secoli XV-XVII, di proprietà della nobile famiglia veneziana dei Boldù, il complesso rurale pervenne alla famiglia padovana Zambelli, in seguito divenuta Folco-Zambelli per il matrimonio dell’ultima discendente, Matilde, con il nobile vicentino Lodovico Folco. La famiglia mantenne la proprietà dell’immobile per lungo tempo e trasformò radicalmente i due iniziali fabbricati nel complesso che oggi possiamo osservare. Agli inizi del Novecento, Ottavio, erede di questa famiglia, suddivise la grande campagna circostante e nel 1926 cedette l’intera azienda agricola al fattore Girolamo Trova, il quale, a sua volta, la rivendette ai nobili da Camposampiero. Questi ne conservarono il possesso fino al 1971, anno in cui Antonietta legò il bene alla chiesa parrocchiale di Villa del Conte. Con la riforma del Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, nel 1992 lo splendido complesso agricolo è passato all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero che ne ha curato e sostenuto l’intero recupero. La presenza della famiglia Zambelli fu rilevante per l’intero territorio ad ovest di Padova tra XVI e XX secolo. Le pagine che seguono ne ricostruiscono un breve profilo. La famiglia Zambelli tra Padova e Venezia Tra i più famosi musei di Venezia spicca la raccolta statale allestita nelle Gallerie dell’Accademia. Chi vi entra, dopo aver visitato le diverse sale piene di capolavori mozzafiato, si ritrova in un ambiente molto ampio ricavato nella parte elevata di un’abside e della relativa navata antistante; poco oltre la sala, discesi alcuni gradini, s’imbocca l’uscita dell’incomparabile quadreria. Soffermandoci sull’ambiente molto ampio solo l’occhio esperto coglie la singolarità della volta, seppur in alcuni casi agevolato dalla lettura delle guide più scrupolose, come quella di Giulio Lorenzetti che a tal proposito scrive: «La chiesa di S. Maria della Carità, soppressa nel 1807, è l’edificio che, sebbene dimezzato nell’interno dall’architetto Giovan Antonio Selva per essere destinato superiormente a Galleria, e al basso ad aule dell’Accademia di Belle Arti, conserva più che gli altri, all’esterno, il primitivo suo insieme costruttivo». La descrizione dello studioso veneziano non s’arresta tuttavia a questo stringato 234 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei giudizio, in quanto prosegue con un’ulteriore aggiunta di notizie e di curiosità sull’Accademia di Belle Arti e sulla sua singolare Galleria.1 Il riferimento alla chiesa di S. Maria della Carità che qui abbiamo ripreso non è affatto casuale in quanto ha un significato preciso nella vicenda prosopografica della famiglia Zambelli: in questa chiesa, infatti, il 29 aprile 1783 si celebrò l’apoteosi di una fortuna, di una scalata sociale rincorsa quanto meno per un paio di secoli. Quel giorno, in questa chiesa, s’unirono in matrimonio Matteo Zambelli, figlio di Giovan Giacomo e di Caterina Maria Giovanelli, e Lucchesa Maria Priuli, a sua volta figlia di Marcantonio I° e di Eugenia Donà.2 Lucchesa era discendente diretta di una delle famiglie patrizie più importanti della città lagunare. Tra i suoi antenati poteva vantare ben tre dogi: Lorenzo (1556-1559), Girolamo (1559-1567) e Antonio (1618-1623), e numerosi altri illustri personaggi che avevano occupato cariche importanti nell’amministrazione dello Stato e della Chiesa. Senza dimenticare cronisti, come il diarista Girolamo Priuli (1476-1547) – omonimo del doge – autore dei Diarii che documentano la vita quotidiana di Venezia a cavallo tra la fine del XV e i primi anni del XVI secolo,3 e musicisti come Giovanni Priuli (1575 ca – Vienna 1629), organista prima a S. Marco e poi alla corte di Ferdinando II° d’Austria, considerato uno dei più apprezzabili esponenti dello stile concertato di scuola veneziana. Matteo Zambelli coronava il sogno cullato dagli antenati sin dal 27 dicembre 1648, cioè da quando, versando 100.000 ducati d’oro, i fratelli Giovan Giacomo (1602-1673) e Pietro Zambelli (1605-1653) avevano ottenuto dalla Repubblica il titolo di Nobil Uomini (NN.HH) veneti.4 Un salto notevole, mal condiviso dall’antica aristocrazia lagunare costretta suo malgrado ad aprire le porte del patriziato pur di raccogliere denaro da destinare agli armamenti militari, nel durissimo frangente della difesa di Candia dall’assalto degli ottomani. Quell’anno il governo offrì la possibilità a quanti erano disposti ad Veduta del complesso di Ca’ Costigliola dopo il restauro. c a’ costig l io la 235 acquisire il titolo di patrizi: una proposta che trovò ben sessantasette nuove famiglie pronte a versare quanto richiesto. Famiglie che nel corso degli ultimi due secoli si erano arricchite sia in Terraferma sia nella capitale con commerci ed usura. L’ingresso di così tanti nuovi, ricchi e potenti clan costrinse la vecchia oligarchia a rivedere ruoli e spazi, compiti e gradi. Da quel dicembre 1648 la nobiltà veneziana non fu più la stessa e le diverse famiglie ormai in declino, o al tramonto di fortunate genealogie, non avrebbero avuto più occasioni per risorgere. In quello scorcio di metà Seicento la famiglia Zambelli risiedeva a Padova da quasi tre secoli per cui l’acquisto del titolo e dell’arma araldica impose il trasferimento della dimora ufficiale a Venezia.5 A Padova risiedeva in una casa situata al Vòlto della Malvasìa, nel cuore del quartiere Sant’Andrea, un luogo che nel tempo ne dettò anche il soprannome (Zambelli “dal Volto”); la tomba di famiglia era posta invece nella chiesa di San Francesco Vecchio.6 Nel corso del XVIII secolo poi la residenza padovana si spostò nella contrada di Santa Maria Iconia, nel popolare quartiere del Portello,7 luogo presso il quale si trovava anche la dimora Priuli stabilmente occupata per tutta la prima metà del XIX secolo.8 A Venezia la nuova abitazione fu scelta nel sestier di Santa Croce, nella parrocchia di San Giacomo dall’Orio: qui un sotoportego e una corte recano ancora oggi il toponimo Zambelli.9 Nell’omonima chiesa di San Giacomo riposa invece l’ultimo discendente maschile della famiglia: Pietro Zambelli, nato il 21 novembre 1786 (giorno della Madonna della Salute, da sempre veneratissima a Venezia) e morto l’undici agosto 1809. Un freddo marmo bianco, che ricopre la tomba al centro della cappella absidale dell’Addolorata, 10 ne riassume la breve vita nella seguente epigrafe: petro. zambellio. / unico. matthaei. et. luchesiae. priuliae. filio. / patritio. veneto. iuveni. egregiae. indolis / ingenii. et. memoriae. praestantia. aeximio / latinis. tuscisque. litteris. apprime. edocto / gallico. et. theutonico. idiomatibus. musicesque / studiis. exculto. pietate. in. deum. in. parentes / praecipua. charitate. in. amicos. mira. benevolentiae / praedito. morum. suavitate. et. integritate / singulis. exoptatissimo. in. aetatis. flore / heu. inopino. funere. erepto. moestissimi / parentes. monumentum. p. p. / obiit. iii. idus. augusti. mdcccix. annos / natus. xxii. menses. viii. dies. xx. Pietro ebbe solo una sorella, Matilde, nata il 30 giugno 1800 e morta il 22 luglio 1855, che sposò il conte vicentino Lodovico Folco Leonardi portando in dote l’intero patrimonio di famiglia: dal loro matrimonio nacquero quattro figli, cioè Francesco Pietro nel 1827, Pietro Giuseppe nel 1828, Matteo Francesco l’anno seguente e Lucchesa nel 1830. Con il matrimonio il padre della sposa dispose che gli stemmi delle due famiglie fossero uniti e che si mantenesse l’antico cognome unendolo a quello dei Folco. In precedenza, vale a dire il 1° marzo 1820, con sovrana risoluzione la famiglia Folco aveva ottenuto la riconferma di nobiltà momentaneamente cancellata dalla rivoluzione napoleonica.11 236 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei Abbiamo detto della residenza padovana della famiglia Zambelli tra il Vòlto della Malvasìa e la parrocchia di Santa Maria Iconia. Un antico manoscritto custodito nell’Archivio di Stato di Venezia narra le origini più antiche del casato e indugia sull’origine bergamasca dei capostipiti. Il loro arrivo a Padova si colloca al 1372, cioè negli anni della signoria di Francesco da Carrara il Vecchio (1350-1384), e la loro fortuna è fatta coincidere con il commercio di vini – la malvasìa in particolare – nei pressi dell’omonimo Vòlto.12 Su di loro scrive in proposito il padovano Giovanni Barbo nel 1585: «Quelli dal Volto vennero di Bergamasca, et erano poveri et vennero a Padova et cominciarono con li denari delli Rologi […] a far la mercanzia presso il Volto e delli Relogi et il padre di messer Zuan Giacomo, che hora vive, et di Varisco e fratelli, ch’è morto, portava dell’oglio in piazza a vender et era poverissimo, esso poi tolse ad affitto una di quelle botteghe dalli Rologi, e cominciò a far mercantia con li denari d’esci Relogi, talché sono diventati ricchissimi».13 Le carte d’archivio svelano, dietro la facciata di un incessante commercio, anche un traffico rilevante di prestiti in denaro, favorito da un’incredibile liquidità. Un’attività che consentì alla famiglia di tradurre le fortune finanziarie in cospicui e sempre più numerosi immobili. Terre, case, palazzi, soprattutto tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del successivo, andarono ad allungare la lista del patrimonio familiare. Tra gli edifici di maggior spicco figura il palazzo dominicale di Tencarola, affacciato al Bacchiglione e in prossimità del ponte, oggi adibito a scuola materna, proprietà delle suore dell’Istituto Madame Clair. L’edificio mostra due splendide serliane (porta centrale arcuata contornata da finestre con sopraluce a foro quadrato e con l’architrave allineato alla chiave di volta dell’arco della porta).14 Nell’estimo del 1615 sono ben 477 le partite elencate, dove per partita s’intende ogni singolo bene immobile in grado di produrre reddito. Un patrimonio disseminato dentro e nei sobborghi della città; nel quadrante occidentale gravitante attorno alle pendici euganee di Teolo; nella Saccisica che da Fossò scende ad Arzergrande, senza dimenticare località come Monselice, Camposampiero, Limena e Conselve.15 Soffermandoci su alcuni esponenti della famiglia, un personaggio di spicco, anche per la società padovana di allora, fu nella seconda metà del XVI secolo Varisco Zambelli “dal Vòlto”, figlio di Lorenzo, intraprendente ‘banchiere’ capace di prestare denaro a privati e a pubbliche istituzioni. Il 29 marzo 1571 lo troviamo impegnato a concludere un importante accordo con l’Università dell’Arte della Lana di Padova, impossibilitata a pagare la “tansa del galeotto”: per assolvere all’imposizione fiscale l’Università ricorse ad un prestito di 300 ducati, che Varisco concesse a fronte dell’istituzione di un livello di lunga durata sul “purgo delle Garzerie”. Il contratto comportò la retrocessione del purgo all’Università sotto forma di affitto (cioè il livello) a fronte di un canone livellario “de ducati 18 d’oro”, in pratica un interesse annuo sul prestito del 6%. Quattro anni dopo Varisco si accordava con il nobile veneziano Alessandro Donato per permutare questo diritto in cambio di sette campi di terra posti a Selvazzano; da un successivo atto del 13 agosto 1577 si apprende poi che il fratello di Varisco, Giovan Giacomo, aveva accettato la dichiarazione resa dal Donato di aver riscosso dagli Zambelli il livello di 18 ducati per l’anno in cui il livello stesso era stato permutato.16 c a’ costig l io la 237 Prima del 1594 Varisco esce dalla scena economica padovana, sostituito dal figlio Lorenzo, definito in alcuni documenti Magnificus. Quest’ultimo nel 1604 appare nelle vesti di procuratore di Gaspare Dondi dall’Orologio, figlio del defunto Galeazzo, e nel 1608 di un altro Dondi di nome Galeazzo, a sua volta figlio del defunto Giovanni Antonio. I rapporti con i Dondi dall’Orologio, come ricordano sopra le parole del Barbo, non furono comunque di sola rappresentanza. Nel 1611 assieme ai fratelli, non nominati nel documento, Lorenzo risulta creditore per parte della dote di Clotilde Strassoldo vedova di Federico Dondi dall’Orologio,17 mentre in precedenza, esattamente nel 1588, Lorenzo, assieme a Bernardin Verdabio, aveva indossato le vesti di gastaldo dell’Università dell’Arte della Lana, una carica d’indubbio prestigio per la Padova del tempo.18 Un altro Varisco, figlio di Lorenzo, negli anni tra il 1607 e il 1622 rivestì la carica di esattore generale della Cassa Fiscale del Territorio,19 mentre il fratello Giovan Giacomo, prima del 1581, fu tra i protettori dei frati cappuccini. Assieme a Paolo Bevilacqua e Giovanni Longo, Giovan Giacomo concorse nell’acquisto di un appezzamento di terreno alla porta di Santa Croce, contiguo al convento cappuccino istituito nel 1550, per poi donarlo ai frati al fine di consentire loro la costruzione di «una bella chiesa in sito differente dalla prima». La cessione del terreno permise nella circostanza anche l’ampliamento della struttura conventuale.20 Nei primi anni del XVII secolo si osserva una gestione familiare e consociativa del patrimonio, efficacemente sintetizzata da Andrea Cittadella nel 1605 che definisce gli Zambelli «principalissimi mercanti della città».21 La famiglia del resto, come molte altre dello stesso rango, non mancò poi di stringere affari e rapporti anche con il mondo ecclesiastico e con le istituzioni religiose della città. All’origine vi sono prestiti, spesso ipotecanti immobili, altre volte acquisti mascherati da prestiti giustificati dall’insolvenza altrui. Un esempio è Le valli di Costigliola sommerse dall’acqua esondata dallo scolo Rialto. 238 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei dato da Varisco che il 27 maggio 1606 acquista all’asta, esperita dalla Camera fiscale di Padova, il livello del debitore Paolo di Crassi, istituito sul mulino, di proprietà della Sagrestia maggiore del Duomo di Padova, galleggiante nel campo (specchio d’acqua) di Pontemolino.22 In un’altra circostanza, invece, la famiglia procede all’acquisto di diritti su terreni posseduti dalle monache di Sant’Anna di Padova situati in località Brentelle di Sotto.23 La fame insaziabile di terre naturalmente finì col generare anche numerosi contrasti con le comunità religiose quali San Prosdocimo, San Pietro, S. Agata e Cecilia, e il monastero di Praglia. Intrecci, vertenze legali che tuttavia non impedirono alla famiglia Zambelli di ottenere dalla Chiesa cattedrale di Padova l’assegnazione della «decima e ragion di decimare nella villa di Tencarola et altri luoghi circonvicini».24 Le vicende che si snodano lungo tutta l’età moderna meriterebbero uno spazio ben maggiore di questa breve nota. Il matrimonio celebrato il 29 aprile 1783 tra Matteo e Lucchesa Priuli costituì il sigillo più luminoso sulla famiglia Zambelli. La fortuna patrimoniale di Matteo è ben nota da tempo. All’alba dell’Ottocento, nei comuni di Selvazzano e Teolo egli concentrava qualcosa come 996 ettari di terreno agricolo interamente dato in affitto a coloni.25 Per il solo comune di Selvazzano il sommarione napoleonico censì una superficie fondiaria di oltre 175 ettari, pari a 454 campi alla misura padovana: un decimo dell’intero territorio comunale.26 Delle vicende familiari che seguirono già abbiam detto. Qui dobbiamo solo ricordare che Matteo Francesco Folco Zambelli Leonardi (un cognome, quest’ultimo, aggiunto nel 1816) soggiornò a lungo a Tencarola e che, essendo uno dei maggiori proprietari fondiari, nel 1866 ricoprì la carica di primo sindaco di Selvazzano Dentro dopo l’Annessione del Veneto all’Italia unita. Dal suo matrimonio con la nobil donna vicentina Gabriella Branzo Loschi, vennero alla luce ben undici figli. Con la morte di Matteo, avvenuta a Selvazzano il 13 settembre 1897, gli eredi nel 1899 si divisero l’intero patrimonio stimato dai periti incaricati in lire 1.284.135,12 equivalenti oggi ad oltre cinque milioni di €uro.27 Tra quei beni erano inclusi i cinque campi, tre quartieri e settantaquattro tavole della «Montagnola, composti da terre prative in contrà della Costigliola con casa rusticale, con caneva, stala e tezza».28 Note 1. Giulio Lorenzetti, Venezia e il suo estuario. Guida storico - artistica, Trieste (Lint) 199911 (1a ed. Venezia 1926), p. 650. 2. Archivio di Stato - Venezia (= ASVe), Avogaria di Comun, matrimoni con notizie dei figli, IX, c. 318. 3. I Diarii di Girolamo Priuli, 5 voll. a cura di Antonio Segre e Roberto Cessi, «Rerum Italicarum scriptores», vol. XXIV (1912-41). 4. Camillo Freschot, La nobiltà veneta, o’ sia tutte le famiglie patrizie con le figure de suoi scudi et arme, Venezia 17072, p. 438; Marco Barbaro - Angelo Maria Tasca, Arbori de’ patritii veneti, in ASVe, Miscellanea codici, I - Storia Veneta, 17, t. VII, p. 297. 5. Freschot, La nobiltà veneta, così descrive l’arma della famiglia: «Porta d’azzurro con una fascia vermiglia, il capo caricato d’un huomo nascente vestito di rosso, e che sostiene nelle mani stese due gigli d’oro, e un terzo giglio d’argento in punta dello scudo». c a’ costig l io la 239 6. Sandra Faccini, Lineamenti della scultura nella chiesa di S. Francesco Grande - Appendice III, in Il complesso di San Francesco Grande in Padova. Storia e arte, Padova (Associazione Culturale Francescana di Padova - Signum), 1983, p. 227. 7. È in questa casa che il 16 agosto 1788 muore Giacomo Zambelli, padre di Matteo, suocero di Lucchesa Priuli e nonno di Matilde. Brevi note biografiche sono in: Giuseppe Gennari, Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova dall’anno 1739 all’anno 1800, introduzione, note ed apparati di Loredana Olivato, 2 voll., Cittadella (Rebellato editore) 1982-1984, p. 503-4. 8. Archivio di Stato - Padova (= ASPd), Atti comunali, b. 684, n. 676 (anno 1827). 9. Giuseppe Tassini, Curiosità veneziane. Ovvero origini delle denominazioni stradali di Venezia, Venezia (Filippi Editore) 2009 (1a ed. 1863), p. 748. 10. Antonio Niero, Chiesa di S. Giacomo dall’Orio. Venezia, Venezia (Tip. L. Salvagno) 19902, p. 72. 11. Federico Schröder, Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie venete, Venezia 1830-31, vol. I, p. 330-331; vol. II, p. 465. 12. ASVe, Miscellanea codici, I serie, n. 153 (già Miscellanea codici 929), “Catastico Zambelli”, 1372-1624. 13. Giovanni Barbo, Delle case nuove dei cittadini padovani dell’anno 1585, ms. della Biblioteca Civica di Padova, B.P. 707 II, Araldica famiglie varie. 14. Claudio Grandis, Note per una storia della famiglia Zambelli, in Tencarola pagine di storia, Padova 1996, p. 63-78. Silvia Gonella, Un esempio di architettura minore in Terraferma veneta: Ca’ Folco-Zambelli a Tencarola (PD), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1999/2000, relatore prof. Ruggero Maschio. 15. ASPd, Estimo 1615, b. 75, c. 1-41. 16. Maria Borgherini, L’arte della lana in Padova durante il governo della Repubblica di Venezia. 1405-1797, Venezia (Deputazione di storia patria per le Venezie - Miscellanea di Studi e Memorie, vol. X) 1964, p. 95. 17. Biblioteca Civica di Padova, Fondo Dondi dall’Orologio, tomo 9, n. 39; tomo 10, nn. 13, 26 e 47. 18. Borgherini, L’arte della lana, p. 148. 19. ASPd, Archivio Civico Antico, Cassa del territorio, b. 20, 21, 22 e 141. 20. Angelo Portenari, Della felicità di Padova, Padova 1623 (rist. anast. Sala Bolognese 1973), p. 467. 21. Andrea Cittadella, Descrittione di Padova e suo territorio con l’inventario ecclesiastico brevemente fatta l’anno salutifero MDCV, edizione a cura di Guido Beltrame, Conselve (Veneta editrice) 1993, p.124. 22. ASVe, Provveditori sopra beni inculti, b. 398, investitura ai fratelli Zambelli del 3 settembre 1737. 23. Grandis, Note per una storia, p. 74-76. 24. ASPd, Corporazioni religiose soppresse, monasteri della città, S. Prosdocimo, b. 23; b. 49, n. 237; S. Pietro, catastico vol. 2, c. 286, 712, 718; S. Agata e Cecilia, b. 42 n. 9; Notarile 4388, c. 498-499. 25. Giovanna Trevisan, Proprietà e impresa nella campagna padovana all’inizio dell’Ottocento, Venezia (Regione del Veneto - Giunta Regionale) 1980, p. 32, 53, 57; ASVe, Demanio statistica, reg. 38, c. 112-116. 26. ASVe, Sommarione del catasto napoleonico, Selvazzano Dentro, n. 135. 27. Contratto divisionale rogato dal notaio Giovanni Da Ponte fu Girolamo, repertorio n. 413 del 26 settembre 1899. La morte di Matteo è così ricordata dal contadino dantista di Selvazzano Giuseppe Toffanin detto Bepi Badèle: «Nel 13 settembre 1897 di mercordì – sepolto il 15 settembre … - moriva il Conte Folco Matteo di Vicenza con tenuta in Selvazzano di anni 74 lasciando molti millioni che ai quali era molto attacato, ma morì» (Beniamino Bettio, Trecento anime disperse. Tessere di storia della comunità di Rubano, Parrocchia S. Maria Assunta in Rubano (Padova) 2007, p. 349). 28. Così è descritta la “possessione detta la Costigliola” in ASVe, Censo provvisorio. Notifiche della provincia di Padova, b. 209, n. 15109. Scuola Secondaria di primo grado di Rovolon I capitelli della devozione popolare* Abbiamo condotto una ricerca storico linguistica sul capitello e abbiamo scoperto che questa parola ha numerosi significati e non solo quello che comunemente si crede nella zona in cui viviamo. Generalmente il capitello si identifica in un elemento architettonico strutturale di origine antichissima e universalmente diff uso, avente lo scopo di raccordare la struttura verticale (colonna, pilastro, parasta, anta) con la struttura sovrastante (architrave, arco). Nella sua forma più semplice e più diff usa consta di una lastra interposta tra colonna, pilastro e travatura e trova esempi praticamente in tutte le tecnologie edilizie. Nel Veneto i capitelli indicano tabernacoli e presentano caratteri omogenei. Per quanto riguarda la documentazione scritta le ricerche sono state condotte direttamente per il territorio alla scoperta di tabernacoli, alberi, pali, nicchie, che tuttavia stano scomparendo con gli ultimi rappresentanti di quel mondo agrario antico che si muove con i capitelli. Il nome capitello ha un nesso con il latino “caput” nel valore topografico della parola, cioè nel senso di capo, estremità, incontro di vie. Carbonara. Un vecchio capitello lungo via San Giovanni Battista. Nella pagina a fronte: il capitello all’inizio di via Ponte Valli a Bastia, costruito con alcuni elementi architettonici della vecchia chiesa parrocchiale. 242 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei i c a p ite l l i de l la de vo zione popolare 243 Documenti, dall’alto Medioevo in poi, nominano con locuzione, “in capite”, tali punti ai quali, di frequente, corrispondeva ed ancora corrisponde l’insediamento di centri abitati, il convergere di confini, l’inizio di una via. Questo è confermato dal fatto che i capitelli stavano e ancora stanno all’incrocio delle vie. Occupano lo stesso sito che già era occupato dal “compitum” pagano (con questo termine era indicato, nell’antichità, tanto il ricovero del sacro, che il convergere delle vie), anche questo riferito al culto dei “lares compitales o viales”, poteva essere cappella, edicola, altare. Nella città di Padova se ne trovano relativamente pochi, ma nel nostro paese, sono invece presenti un po’ ovunque. Ad un primo momento l’immagine è quella di un edificio di piccola mole dal tetto a punta, aperto sul davanti o sorretto da colonnine o pilastrini, destinato ai fedeli e sorto per loro iniziativa, contenente la raffigurazione di un personaggio sacro e inserito, per lo più, in uno spazio aperto e rurale. Un tempo si proponevano come possibili forme di tipologia del capitello anche croci e alberi sacri. È chiaro che a questo punto il capitello rappresenta il segno più tangibile della devozione dell’uomo. Nei capitelli è maggiormente rappresentata la Vergine, poi Cristo, ma se la raffigurazione di Maria rappresenta sempre la madre, per il figlio le cose vanno diversamente. Più che il personaggio sembra importante la sua funzione: Cristo bambino, Cristo coronato di spine, che porta la croce, Cristo deposto; lo stesso vale per i santi. Nella pagina a fronte, in alto a sinistra: Frassanelle, capitello al “Palazzetto Rosso”; in alto a destra: Bastia, capitello in via San Mauro; in basso a sinistra: Bastia, via Ponte Valli; in basso a destra: Carbonara, in via San Pietro. In questa pagina, in alto a sinistra: Bastia, oratorio in via Ca’ Marchesa; in alto a destra: Carbonara, in via San Giovanni Battista. 244 rovolon, storie di una comunità dei colli eu ganei A Padova i santi che compaiono sono di due categorie, i primi sono quelli che in città ci sono fisicamente e vi hanno operato; i secondi sono quelli la cui devozione è stata introdotta da varie cause, ma non dalla loro personale permanenza. Il grande leader è S. Antonio cui fanno seguito gli altri tre protettori della città: S. Prosdocimo. S. Giustina, S. Daniele. I santi dentro le mura risultano legati alla storia cittadina, a devozioni popolari, a ordini religiosi, a funzioni o protezioni civiche, inoltre vi sono anche angeli, immagini religiose e allegoriche. La forma tipica del capitello urbano-padovano è quello sotto i portici, nei sottarchi, tra un portico alto e uno basso. Come sono fatti? Solitamente il materiale è pietra tenera, terracotta e ceramica invetriata. La loro comparsa è un fatto antico; di sette sono però state ritrovate le tracce. Come sono nati? Dalla riconoscenza per grazia ricevuta, per protezione presente o futura, in memoria di qualcuno, per celebrazioni di eventi comuni, per celebrazioni di una comune solidarietà. Il capitello può ammalarsi e morire come è sorto o vivere in simbiosi con la comunità umana. Quando tale comunità si degrada, cambia, emigra, il capitello è come una mummia ridotta a reperto archeologico. * In occasione della 11a “Festa della birra” che si è svolta a Rovolon dal 15 al 28.07.1993, il Comitato festeggiamenti ha coinvolto gli alunni della scuola media “A. Manzoni” di Bastia in una ricerca storica sui capitelli della devozione popolare disseminati nel territorio comunale. Lo scopo principale della ricerca è stato quello di scoprire la devozione nel nostro territorio attraverso queste testimonianze alcune delle quali risalgono al XVII secolo. Tutta la documentazione ha costituito una interessante mostra esposta nella sala nell’asilo di Rovolon: in quella circostanza il Comitato, alla presenza delle autorità comunali e dei dirigenti del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha premiato e ringraziato studenti e docenti delle scuole per l’ottimo lavoro svolto. i c a p ite l l i de l la de vo zione popolare 245 Nella pagina a fronte, in alto: Carbonara, Capitello in via Manzoni; in basso: Bastia, quartiere Garibaldi. In questa pagina, in alto: Bastia, capitello in via Pozzetto; in basso: Bastia, oratorio in via Monte Sereo. Foto aerea di Bastia, al centro la sede municipale. Finito di stampare nel marzo 2011 da Cierre Grafica via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (VR) tel. 045 8580900 fax 045 8580907 www.cierrenet.it
Scaricare