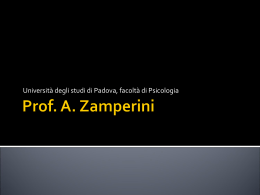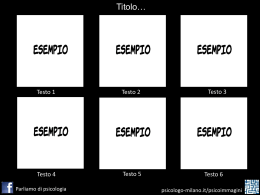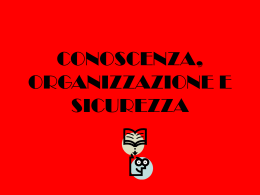Università degli Studi di Padova Corso di Laurea in Infermieristica Insegnamento di Psicologia Clinica Docente: dott.ssa Margherita De Masi DEFINIZIONI Psicologia: “discorso intorno all’anima” Studia il funzionamento psichico negli aspetti: • cognitivo • affettivo •comportamentale Corrisponde in medicina alle conoscenze relative alla fisiologia. Su tale funzionamento vi sono vari MODELLI INTERPRETATIVI • Comportamentista • Cognitivista • Sistemico-relazionale • umanistico-esistenziale-fenomenologico • Costruttivista, ecc. • Psicoanalitico-psicodinamico (nelle varie diramazioni). Vi sono, inoltre, diversi AMBITI OPERATIVI • Psicologia Clinica e di Comunità • Psicologia del Lavoro (organizzazione, • • • orientamento, selezione, formazione) Psicologia dello sviluppo (sv affettivo-cognitivosociale-morale da 0 a 25 anni) Psicologia forense: problematiche nella pratica giudiziaria. Si distingue: “psicologia giudiziaria”: imputabilità e attendibilità; “Psicologia criminale”: riabilitazione detenuti. Psicologia Generale, Psicologia Sociale, Psicobiologia, Psicologia fisiologica, neuropsicologia, PPsicofisiologia, ecc. Psicopatologia: processi patologici a carico delle diverse funzioni psichiche (cognitive, affettive, comportamentali). Corrisponde in medicina alla patologia o fisiopatologia. Neurologia: branca della medicina che studia i processi patologici del SNC e del SNP di natura organica. Psichiatria: branca della medicina che studia e classifica le malattie mentali e i disturbi psichici in cui si manifestano le alterazioni psicopatologiche. Vi sono criteri di classificazione diversa (categoriale, dimensionale) una volta distinte in: Nevrosi, Psicosi, Patologie Borderline. All’interno della psichiatria: 1) Psichiatria Forense, 2) Etnopsichiatria. Neuropsicologia: branca della neurologia che studia le relazioni tra aree cerebrali e funzioni cognitive (rapporto tra lesioni cerebrali localizzate e funzioni linguistiche, simboliche e senso-motorie). Psicoterapia: terapia con mezzi psicologici, diversa a seconda del modello di riferimento anche se lo strumento è lo stesso: linguaggio verbale e non. Psicofarmacologia: terapia con sostanze psicotrope. Psicologia Clinica: si occupa del comportamento umano e del funzionamento mentale con lo scopo di migliorare l’adattamento dell’individuo. Lo fa favorendo le risoluzione di disagi e conflitti derivanti dalle difficoltà di armonizzare bisogni, affetti, desideri del mondo interno ed adattamento al mondo esterno. “Klinè”= letto, atteggiamento di ascolto verso il malato. Dunque Clinico: Luogo della cura, operare a stretto contatto col malato. Ci sono più psicologie cliniche a seconda del modello di riferimento In termini generali la Psicologia Clinica si definisce come “…la disciplina che comprende l’insieme delle conoscenze e delle competenze psicologiche utilizzate per affrontare i problemi dell’adattamento e i disturbi del comportamento sul piano della ricerca, della prevenzione, della valutazione psicodiagnostica, dell’intervento psicoterapeutico” Tombini G. (a cura di), 1994, p.3. Psicologia Clinica a orientamento psicodinamico “sulla base di una comprensione dinamica della mente e del comportamento umano, ha come sua competenza specifica quella di comprendere il soggetto nella sua individualità e di aiutarlo (se possibile, utile e necessario) a risolvere in maniera più o meno adeguata disagi e problemi derivanti dalla sua difficoltà nell’armonizzare bisogni, affetti, desideri del mondo interno ed adattamento esterno…” Musatti C., 1988. Psicologia medica: branca della psicologia che studia le reazioni psico-affettive all’esperienza di malattia (non psichica) e alle sue conseguenze sul piano interno ed esterno. Psicosomatica: studia le relazioni tra mente e corpo, affetti e soma. A differenza della psicologia medica che studia gli effetti dell’evento malattia sul mondo psicoaffettivo del soggetto, la psicosomatica tiene in considerazione le variabili emotive ed esperenziali sullo stato di salute-malattia del corpo. Psicodinamica: insieme di teorie che vedono la psiche e il suo funzionamento dato da forze in equilibrio e/o in contrasto che determinano l’espressione di comportamenti, affetti e pensieri. Psicoanalisi: teoria e scienza che interpreta fenomeni psichici sulla base del riconoscimento dell’inconscio e sulla base di certi assunti (conscio-inconscio; Io-EsSuperio). La psicoanalisi oltre che un modello teorico, è anche una specifica tecnica di intervento terapeutico. Il modellopsicoanalitico-psicodinamico • Modello strutturale delle pulsioni: Freud • Psicoanalisi interpersonale: Sullivan, Fromm • Klein: tra il modello pulsione e quello delle relazioni oggettuali • Modello strutturale delle relazioni oggettuali: Fairbairn, Winnicott • Psicologia dell’Io: Hartmann, Mahler, Kernberg • Psicologia del sé: Kohut Sigmund Freud • Partito da soggetti con patologie: continuità • • • • normalità-patologia: stessi processi sottostanti. Ricostruzione processi evolutivi dell’infanzia da ricordi, sogni, rappresentazioni interne dei pazienti. Importanza esperienze infantili e quelle traumatiche Ricerche su trauma rimosso: scoperta inconscio e costruzione del modello psicoanalitico. Determinismo psichico. Aspetto genetico: stadi • Aspetto metapsicologico: • • • Punto di vista dinamico Punto di vista economico Punto di vista topico: prima topica: inconsciopreconscio-conscio; seconda topica: Es-IoSuperio. Principi: di piacere, costanza, realtà Pulsione: fonte, scopo, oggetto, pressione. La pulsione “è un concetto al limite tra psichico e somatico” Freud, 1905 (Tre saggi sulla teoria sessuale); è sessuale ed aggressiva Metodo: libere associazioni, analisi dei sogni, transfert, (lapsus, atti mancati, dimenticanze). Teoria topografica:Prima Topica • Conscio: materiale psichico di cui siamo • • consapevoli, tollerato, non pericoloso. Preconscio: materiale psichico di cui il soggetto è inconsapevole (ricordi penosi, per antipatia), ma richiamato alla coscienza con sforzo di volontà (nome sulla punta della lingua). Inconscio: materiale psichico di cui il soggetto e inconsapevole anche se fa uno sforzo di volontà, non tollerato e fonte di angoscia se cosciente (sogni, lapsus, dimenticanze). Viene fuori solo in analisi. Teoria Strutturale:Seconda Topica Es: è inconscio, dato da pulsioni libidiche (vita, sess.) ed aggressive (odio, morte). Le prime: base della sessualità, spinta ad amore, creazione, azione. Le seconde: spinta originaria a distruzione, morte. Alla coscienza i “derivati pulsionali” uguali o diversi da pulsioni. Il desiderio legato alle pulsioni può essere soddisfatto o no Funziona secondo: “principio di piacere” Pulsione ≠ istinto Istinto: biologico, serve all’integrità somatica, deve essere soddisfatto. Pulsione: tra corpo e mente, serve all’integrità psichica, può essere soddisfatta come no. Superio: morale, senso del limita. Deriva da introiezione regole genitoriali. La parte inconscia in conflitto con pulsioni Parte conscia: regole, doveri. Spesso specchio della parte inconscia: se rigida, la morale sarà rigida. A volte non è così: cosciente elastica, incosciente rigida (impotenza, frigidità,ecc). Io: è in contatto con la realtà, media tra mondo interno ed esterno. Funziona secondo il “principio di realtà” : rimandare il soddisfacimento della scarica. Parte conscia: funzioni dell’Io (intelligenza, memoria, percezione, ecc). Parte inconscia: meccanismi di difesa. Il mondo reale, l’Es, il Superio esprimono le proprie richieste all’Io: angoscia per l’io. Pericoli Es: pulsioni e desideri (angoscia nevrotica) Pericoli del mondo esterno: perdita lavoro, ecc (angoscia reale) Pericoli Superio: inibisce l’io coi sensi di colpa (angoscia morale) In che modo l’Io riduce l’angoscia? 1) soluzione realistica al problema (lavoro sicuro) 2) ricorre a meccanismi di difesa. L’io avverte (3° teoria dell’angoscia) pericolo di perdere controllo su pulsioni inconsce inaccettabili. Il pericolo deriva anche da proibizioni genitoriali, superio. Affetti segnale: 1) Paura: pericolo esterno; reazioni somatiche (attivaz. SNA) e psichiche (lotta, fuga) 2) Angoscia: pericolo interno, inconscio. La lotta è interna: conflitto. Esprime un timore profondo, mentre l’ansia il sintomo manifesto. Paura: presenta reazioni somatiche e psichiche utili ad avvertire le fonti del pericolo e ad evitarle: acutizza i sensi, rende precisi ed attenti i processi ideativi che si focalizzano sul pericolo, favorendo la messa in atto di difese. Reazioni difensive di fronte al pericolo esterno: 1) lotta; 2) fuga. Si accompagnano a modificazioni fisiologiche del SNA simpatico (ipersecrezione ormonale surrenalica, iperglicemia, tachicardia, iperpnea, ipertensione arteriosa). Lotta: eliminazione pericolo. Fuga: mantenere una certa distanza di sicurezza dalla fonte di pericolo. Entrambe le risposte attenuano la minaccia riducendo la paura. Angoscia: segnale di allarme di pericolo interno. Non può utilizzare le due reazioni difensive usate per il pericolo esterno. Non si può fuggire da se stessi o attaccare ciò che viene dall’intrapsichico in cui c’è già una lotta tra parti di sè: conflitto). La scelta della difesa la fa l’Io che media tra realtà esterna, realtà interna e tra parti diverse del mondo interno. L’Io usa i meccanismi di difesa: “processi automatici e inconsci” che • eliminano ogni fonte di pericolo interno, quindi di • • angoscia; Proteggono l’integrità psicologica del soggetto; Si trovano in ogni soggetto in gradi e intensità diverse, a seconda della maturità, sono rigidi o no, di stadi cronologici più antichi o no. Casi in cui paura e angoscia si confondono sono dati dalle reazioni ansiose alla malattie somatiche o dalle fobie. Nelle malattie somatiche il pericolo è interno (idea di corpo) che ha caratteristiche di pericolo esterno (corpo). Interno ed esterno in relazione al sé somatico e psicologico. Nelle fobie il pericolo è esterno, ma si tratta di uno spostamento di un pericolo interno. Teoria dell’angoscia di Freud: • Angoscia deriva da libido non soddisfatta. Dopo posta in relazione con rimozione • Angoscia deriva dal trauma della nascita • Angoscia segnale di pericolo dell’Io che mobilita le difese Altri affetti segnale Depressione segnala una perdita imminente reale o fantasmatica di un oggetto amato o del suo amore o della sua approvazione. Stato affettivo messo in relazione con il “lutto” da Freud. Si tratta della depressione. Essa implica la pulsione aggressiva: aggressività introiettata tesa a colpire l’oggetto perduto che ci ha abbondonati e che dopo il lutto è stato introiettato. Ciò è dovuto alla presenza di precedenti sentimenti ambivalenti (amore-odio) verso l’oggetto perduto, sentimenti riferiti a problematiche precoci (fase separazione del b. dalla madre nel primo anno di vita) Senso di colpa segnala la disapprovazione del superio e delle norme genitoriali introiettate. In patologia promuove le nevrosi. Vergogna segnala il pericolo di venir giudicati non all’altezza di una certa immagine di sé, inadeguati. In patologia è in relazione con patologie narcisistiche.
Scarica