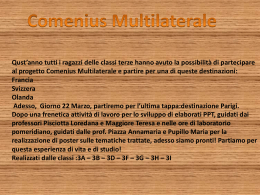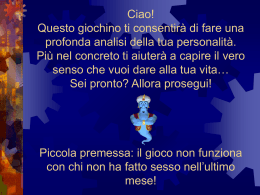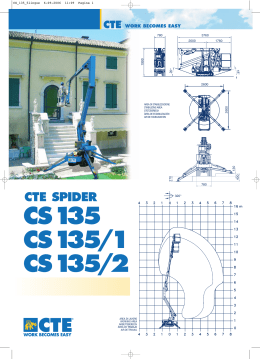Chiara Favati IN UNA CESTA DI VIMINI Chiara Favati, In una cesta di vimini, narrativa Ci spiavamo nascosti dietro spigoli di fili d’erba. Avevamo ancora la paura di una vita non vissuta attaccata alle scarpe sporche. Fra le collane di azzurri del cielo, spiavamo ciò che si nasconde dietro quell’arioso velo... a ripensarci adesso, vedo tutto così chiaro. Tu venivi dalla città, dai giardini pettinati di un parco pubblico periferico. Avevi una casa dove, per ogni qualità di biscotto, c’è una scatola diversa; e le foto nelle cornici restano a guardarti con lo stesso sorriso dolce per anni. Ti avevano abituato a rifare il letto appena alzato, ed a sognare sui libri senza rifiutarti poi di vivere la vita. Un giorno sognai di te, sognai che tuo padre ti negava un gioco sconnesso, e poi porgeva alle tue piccole mani un pupazzo-dolcetto-qualcosa di buono; diceva che quel dono non era per consolarti del divertimento demolito, ma affinché tu potessi perdonarlo. È stato uno di quei sogni che insegnano qualcosa. Tu venivi dalla città, io da un bosco di foglie secche. Una vita passata a giocare a nascondino fra alberi grandi e piccole chiese infrascate; una vita nelle chiacchiere dei venti. Pestando speranze, fanghiglia e funghi, correvo nei trapunti attutiti dei muschi, e non sentivo il suono della stabilità. Era una vita strana, così strana rispetto alla vostra. Sono stata fragile, come un guscio d’uovo nel nido di un uccellino predato. Sono come mio nonno che sognava una vita risolta, risorta -ogni mattino- in un obliquo di bruma e alba. Gli altri in casa mia non lo so cosa sognano, se sognano ancora… Ci penso anche adesso in questo prato, che, a volte, temo non sia poi così enorme. Ci penso anche adesso, mentre la memoria si sfolla. Sento solo un vuoto dentro, e non so se ignorarlo, provare a riempirlo, tentare di allargarlo fino a che non sia capace di ingoiarmi… come una di quelle sconosciute tane di animale. Siamo cresciuti per mano, con il ritmo di ritardatari fili d’erba. Tu che vivevi con tutti i pori della pelle, ed io (con i miei quattro ossi messi in croce) amavo fino allo strenuo. Condividevamo la forma degli occhi, così grandi da rendere infinito quell’ogivale prato sovrastato dall’Appennino. Così tanti dettagli entravano ed uscivano dai nostri occhi, quasi perdevamo di vista la strada della vita. Il suo senso che non era più il nostro. Riuscivi a farmi credere in questo, disegnandomi amuleti nei palmi delle mani (arrese sotto il cielo). E quando adesso piango, ripercorrendo le mie tristezze, le mie nostalgie impaurite per la diversità di cellule e ideologie che ci portiamo addosso, che imponiamo all’altro, tu… non te ne vai. Non ti stacchi dal mio fiato. Le lacrime, dici, sono belle. 1 Hai una voce senza rumore, mi ricorda il ritmo del pulviscolo che vola nel mio sottotetto celebrale, guardiano di bauli e di astrolabi stanchi, di conchiglierie comprate al mercato di Marradi in giorni freddi. Quasi tu avessi la certezza nascosta –ma viva!– in una cesta di vimini, sotto coltri di coperte a scacchi. “Sarebbe facile essere felici se…” Baci le mie tempie di nervo e terrore. Anche tu senti lo spiffero del vento che ci strappa calore, amore. Stringersi per offrire a quell’aria fluida meno morsi sui nostri corpi. Le tue carezze per la mia pelle, per il profumo resistente del campo. “Siamo anche-ora qui”. 2
Scaricare