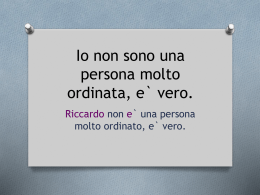GERARDO SINATORE DALLA STEPPA A MONTELEPRE Vicende di guerra e di pace dai ricordi di Giacomo Gambino 2011 1 2 Ho servito la Patria in guerra e in pace. Grazie, Italia, per il privilegio che hai voluto concedermi. Ten. Giacomo Gambino (79° Reggimento Fanteria Divisione “Pasubio”) 3 4 Premessa Quanto è scritto nelle pagine che seguono è tutto fondamentalmente vero; l’unico inconveniente è costituito dal fatto che dopo più di sessanta anni le date, le località, i nominativi, e quant’altro, possano non essermi rimasti esatti in memoria. Chiedo venia, per questo, ai lettori, ed allo stesso Gerardo Sinatore che ha dovuto, per oltre un anno, districarsi tra le più diverse comunicazioni da me inviate, in modo discontinuo (vivo lontano), ed in tempi notevolmente diversi. Quale il fine propostomi allorché ho deciso di raccontare qualche tratto di vita vissuta? Nessuno, in modo assoluto, se non il desiderio, quasi un dovere, di rendere omaggio a quanti, in tempi a noi vicini, hanno sacrificato la vita per questa Italia (prima e seconda guerra mondiale, resistenza, missioni di pace all’estero); accomunati tutti ai patrioti, passati prima di loro alla storia, i quali con le armi, con gli scritti, con le sofferenze del carcere ed addirittura con il sacrificio della vita, hanno saputo portare il Paese all’unità, sotto un’unica bandiera. Il 17 marzo p.v. è il giorno stabilito per solennizzare il magnifico evento; facciamolo con l’intento di essere tutti degni dell’eredità di amore verso la Patria, avuto 150 anni fa. Giacomo Gambino 5 6 Introduzione Già… dalla Steppa a Montelepre, passando per Elbasan, il fascinoso ombelico d’Albania. Ho sempre voluto una vita piena, intensa, per saziare la mia licoressia di emozioni. Di forti emozioni. Emozioni poderose che soltanto il rischio può offrire; ed il rischio ha bisogno di opportunità, di eventi, di possibilità per assumere il suo aspetto ingannevole. Ha bisogno di un tavolo da gioco al quale sedersi con la “realtà” perché se non c’è realtà non c’è rischio. Ma realtà non significa verità, anzi. Realtà significa menzogna ed il vero giocatore è colui che ricerca la verità nella menzogna, è colui che scommette contro la realtà, sempre. E la cerca in ogni dove, continuamente, a costo di dilaniarsi il cuore, sconquassarsi la mente, ferirsi la carne, “perdersi d’animo”... Ed in questo atteggiamento di azzardi, alcuni hanno visto in me moti di revanche, altri, una mia via di fuga dal labirinto dell’infanzia, altri, ancora, la fascinazione della morte e dell’amore. Nel mio caso tutto questo c’entra quanto c’entrano i pacifisti con la pace ed i soldati con la guerra. Se qualcuno oggi mi chiedesse, così come se me lo avesse chiesto ancora ieri, qual è stato il più grande amore della mia vita, gli risponderei: “la mia vita”; e se mi chiedesse chi è stato il più grande amore della mia vita gli direi: “la vita”; e se ancora mi chiedesse cos’è per me l’amore? Gli ribatterei che “…è ciò che non si può avere né dare se non c’è l’azzardo, se non c’è mai stata alcuna partita con se stessi”. A tal proposito, io ritengo che non può esservi amore se non c’è rispetto e conoscenza, come non può esservi alcun bene senza giustizia. 7 Spesso mi chiedo chi sono e cosa sono stato. Ma ancora non trovo una risposta, come non la trovo alla domanda se sono un pavido o un coraggioso, se sono un incosciente o un valoroso oppure se sono un ottimista o un miracolato. Mi accontento di aver semplicemente vissuto. Quando qualche amico, ascoltando la mie storie, esclama compiaciuto: “…sei stato davvero fortunato!” Io, non rispondo subito, sorrido, guardo il dorso delle mie mani bianche e incanutite, poi: ”.. perché sono scampato alla morte o perché ho fatto la guerra? Ma al gioco, è più fortunato colui che rischia o colui che ha paura di perdere?” Leonardo Sciascia, uomo di origini siciliane come lo era, forse, originariamente la mia famiglia, ricevendo un premio disse: “L’Occidente è privo di un autentico senso della morte… di una vera coscienza dei limiti. Attribuisce assai poco valore alla vita, alla qualità dell’esistenza…” Voleva dire che c’è una fuga continua dalla morte, che c’è un netto rifiuto della morte, che più si è “civilizzati” più si rifiuta la morte mentre, nell’antichità, vita e morte erano poste sullo stesso piano ed avevano entrambe un identico “valore”. Oggi la morte non ha alcun valore ed ancor meno la vita, l’esistenza. Oggi vale tutto ciò che non ha valore e la morte equivale a non essere mai esistito: se abbiamo terrore del dolore ricorriamo subito al medico e gli affidiamo interamente la nostra vita anziché a Dio, come se la “vita” fosse governata dalla scienza dell’uomo che, a distanza di milioni di anni, della “vita” ne sa poca cosa perché dell’amore, di eros, philos e agape, non ne sa assolutamente nulla. Aveva ragione il filosofo Emil Cioran, mio coetaneo, quando affermava: “La scienza è l’elusione della saggezza in nome della conoscenza del mondo”. Altra verità sulla quale credo e nessun vero giocatore scommetterebbe un soldo, come su queste altre sue parole: “la vita è qualcosa di meglio di un’avventura… Nella vita tutto dipende dalle 8 esperienze che abbiamo fatto, dallo spessore che le esperienze hanno o non hanno avuto e, se esse sono un fatto solo intellettuale, non hanno valore…”. Ora, però, vi racconterò come sono approdato a queste mie conclusioni. 9 10 Parte Prima Capitolo I Giovinezza e arruolamento volontario Sono nato a Torre Annunziata in provincia di Napoli, il 20 agosto del 1920, dove ho vissuto sino all’età di 6 anni. Torre Annunziata, la “Grande Torre Annunziata”, la capitale dei “maccaroni”, era la seconda città della Campania e, per quel che ricordo, lo era sicuramente in bellezza con quel mare che rendeva, con la sua vista scintillante, tutti felici. Lo stesso mare che fece dire a Goethe, il poeta viaggiatore, nel suo “Viaggio in Italia”: “Tutti coloro erano felici d’abitare in quei luoghi, alcuni affermavano che senza la vista del mare sarebbe impossibile vivere. A me basta che quell’immagine rimanga nel mio spirito”. Per me è stato davvero così. All’età di sette anni sono andato a vivere a Nocera Inferiore, l’antica Nuceria della Valle del Sarno. Papà, che era un caporale dei Carabinieri, di quelli con il bicorno napoleonico e lo sguardo austero, vi era stato trasferito per motivi di servizio. Era l’anno 1927. L’anno in cui, a detta del mio maestro delle elementari, in America, Carlo Lindbergh, a bordo dello Spirti of Saint Louis, trasvolava in solitaria l’Oceano Atlantico per atterrare a Parigi dopo circa un giorno e mezzo di volo; l’anno in cui, nella stessa civilissima America, stavano per essere giustiziati gli italiani Sacco e Vanzetti; il sesto anno dell’Era fascista; l’anno in cui ancora faceva sentire la sua aura floreale l’Art Decò mentre nasceva l’OVRA, la polizia segreta del Regime che preannunciava una nuova epoca, non proprio facile, per tutti quelli che, come mio padre, erano fieri di appartenere all’Arma fedele dei Reali Carabinieri. Allora, più 11 di oggi, la Real Arma veniva particolarmente impiegata per debellare la malavita. Infatti, l’ordine che il Primo Ministro Benito Mussolini aveva appena dato ai 60.000 Carabinieri del Regno era stato chiaro e forte: “Liberatemi da questa delinquenza con ferro e fuoco!” Ciò era da tradursi in: “Dovete battervi a costo della vostra vita!”. E, in pochissimi mesi, soltanto nella zona dell’allora provincia soppressa di Caserta, chiamata “Mazzoni”, erano stati arrestati all’incirca 1.700 affiliati alla malavita e, nel territorio di Aversa, altri 1.300 al prezzo di un olocausto di diverse “giubbe nere” nel mentre in terra di Sicilia, il Prefetto Mori ed il Giudice Giampietro mettevano sotto scacco la mafia che prorompeva da Bolognetta, Marineo, Misilmeri, Piana dei Greci, Santa Cristina, Termini Imerese, Patti, Belmonte, Piana dei Colli, Corleone, Casteldaccia, Bagheria, etcetera. Ero ancora piccino, però ricordo molto bene lo sguardo che mia madre rivolgeva a papà ogni qualvolta usciva da casa. Quell’atmosfera familiare è come se mi fosse penetrata nelle ossa, nelle vene, senza mai più dileguarsi. Ricordo che un pomeriggio papà leggeva la “Domenica del Corriere”. Io giocavo con una palla di pezza. Lui era seduto su uno sgabello quando all’improvviso, trasecolando, esclamò: «Che onore!» Poi, ripose la tazzina di caffè nelle mani di mamma che lo fissava senza proferire parola. Lui, avvertendo sulla pelle quello sguardo compassionevole, le disse: « Senti… senti cosa dice il Corriere, Rosa, ascolta: “…gli omicidi commessi dalla mafia in quei piccoli e graziosi centri siciliani assommano, negli ultimi sei mesi, a ben 300… sono caduti nello svolgimento del proprio dovere i carabinieri:…, …, etc.” Hai sentito! Sono stati ammazzati dieci carabinieri, dieci… come cani! Ci sta pure chillu povero Ciruzzo, te lo ricordi?» Mamma gli rispose: «… con onore, Vero? Ma mo’ chi glielo restituirà il padre a quelle povere creature?». Papà abbassò lo sguardo continuando a leggere, lasciando che le parole di mamma volassero al vento, gli scivolassero addosso 12 come sempre, senza degnarle di alcuna risposta. Fortuna è stata per papà che Nocera e l’intera Valle del Sarno erano in quel tempo luoghi molto, ma molto più tranquilli dei Mazzoni e della Sicilia. Fortuna è stata anche la nostra perché, sebbene fossimo in otto, nonostante le ordinarie avversità del tempo, siamo cresciuti in sanità. Eravamo sei fratelli e due sorelle, io ero il primo, il “fratello maggiore”. Ed, essere il “maggiore”, “’o primmo”, come si dice nel mio dialetto, significava molto. Designava una responsabilità. Significava essere “responsabile” verso tutta la famiglia, verso mia mamma ma soprattutto verso i fratelli. Significava proteggerli, provvedere a loro - per quanto possibile - specialmente nelle lunghe assenze di papà ed, inoltre, voleva dire essere già “pronto”, malauguratamente gli fosse accaduto qualcosa, a sostituirlo in pieno, prendere il suo posto. Non mi spaventava la responsabilità, ma vivere con l’ansia che un giorno o l’altro qualcuno avrebbe potuto bussare alla porta di casa per comunicarci che papà era caduto “nell’adempimento del proprio dovere”, mi faceva crescere in perpetua tensione fortificandomi precocemente. Mamma, che si chiamava Rosa, è stata un grande punto di riferimento per tutti noi, specialmente per me. Mai ha consentito che facessi dei sacrifici per i miei fratelli. Era originaria di Boscotrecase. Boscotrecase, in quella che fu una volta la “Grande Torre Annunziata”, insieme a Pompei e a Boscoreale costituiva il territorio di Torre. Io, ho sempre tentato di emulare mio padre. Ne subivo il suo fascino e quello della sua divisa nera. Spesso, quando rincasava di sera, lo spiavo per vederlo sfilare dalla fondina la lucidissima pistola Glisenti per estrarne il caricatore. Poi, prima di addormentarsi, lo sorprendevo mentre la riponeva nella fondina e quindi sulla sedia ai piedi del letto sotto un cumulo di cose: guanti, mantellina, bandoliera, giberna, calzoni, giubba, bicorno, etc., assicurandosi che nessuno di 13 noi potesse scorgerlo. A proposito di papà, vorrei riportare un fatto campanilistico - tratto dal “Risorgimento Nocerino” del 27 ottobre del 1929 - che lo vede coinvolto e farà sorridere sicuramente i tifosi di calcio nocerini: “Dal 1920 al 1930 la Salernitana non era mai riuscita a battere i cugini Nocerini, mentre questi l’avevano sempre spuntata sul campo sportivo militare di Salerno. Eppure, era necessario sfatare la tradizione!... Questo era il pensiero assillante dei dirigenti e sportivi salernitani che, per rafforzare il prestigio della Società, nominarono Presidente onorario del sodalizio il console Riccardo Gambrosier comandante la Legione Aquila di Salerno! (c’è da aggiungere che in questi dieci anni di lotte sportive fino allo spasimo furono escogitati, da ambo le parti, tutti i mezzi, leciti ed illeciti, pur di far prevalere la propria superiorità). La Nocerina, prevedendo le mosse nemiche dato che le due società dovevano disputare nel medesimo girone centro meridionale il campionato di 1ª Divisione aveva parato il colpo affidando la presidenza onoraria al Colonnello Pavone del 30°, famoso e leggendario comandante degli Arditi, superdecorato della guerra di redenzione 1915-1918. La lotta fra due angeli tutelari, sempre cortese, si svolgeva nei limiti della propria autorità: Pavone forte del suo passato di grande condottiero… Gambrosier, fortissimo del suo presente che lo induceva ad imperare, ma non la spuntò mai! Don Riccardo era molto buono, affabile ed incapace di far del male… Ma la divisa, gli stivaloni lucidissimi e tant’oro sul berretto… gli davano un aspetto marziale… un’euforia superiore di comando. Le due squadre si presentarono in Piazza d’Armi a parità di punteggio, tonificate da una grande preparazione tecnica e morale, da una battaglia di volantini, con i comizi nei caffè e all’aperto. Il campo era gremitissimo e nella piccola tribuna di legno le due schiere dei tifosi erano 14 pigiati come sardine in barile. Nella tribuna d’onore riservata alle autorità il Colonnello Pavone, circondato da una schiera di Ufficiali aspettava gli ospiti!... Il Console Gambrosier non si fece attendere: seguito da capimanipoli, centurioni e militi fece l’ingresso in tribuna! Facevano ala al reparto Gigino Schiavo ed Aniello Barba i quali non riuscivano a nascondere l’imbarazzo fra il dovere di militi e la passione di grandi tifosi della Nocerina! Don Riccardo fu ricevuto dal Colonnello Pavone, ufficiali e dirigenti con tutti gli onori militari e sportivi e mentre un trombettiere tifoso salernitano suonava l’attenti, una voce tuonante e roboante, gridò: <Per il Console Gambrosier… Eia! Eia!...> quando il grido fu coperto da un pernacchio sonoro, stridente e tanto potente che fece sussultare tutti! Vi fu uno sbandamento generale e molte risate contenute; Don Riccardo si fece pallido e tremante; un’offesa simile non poteva passare impunita e, con grande autorità ordinò ai suoi militi di arrestare subito il villano. Il Colonnello Pavone, un poco seccato per l’incidente non perse la calma, poggiando una mano sulla spalla del Console disse laconicamente: < Signor Console, è una pernacchia “sportiva”, che non lede la sua personalità; se poi ci tiene a punire quel grande maleducato incosciente spetta a me a dare degli ordini, perché, qui, comando io!> Ciò dicendo ordinò al caporale dei Carabinieri di servizio in tribuna di scovare il colpevole! Per il caporale dei Carabinieri Giovanni Gambino, socio della Nocerina, vecchia volpe che conosceva i suoi polli non vi erano dubbi! Detentore assoluto di quel primato era uno solo a Nocera! e per giunta suo amico e collega (sic):il Presidente della sezione locale dei Carabinieri in congedo! Per calmare i nervi degli offesi, ordinò ad un suo carabiniere di servizio sotto la tribuna di arrestare un tale che scappava… Era un povero ammalato del Manicomio di Nocera, ospite fisso del campo sportivo… sempre pronto ad assumersi tutte le responsabilità altrui incoscientemente! Don Peppino Belsito, il vero reo, 15 sgusciando inosservato dal cancelletto della rete metallica, entrava nel recinto di giuoco assumendo la veste di tutore dell’ordine, con gesti e parole suadenti cercava di calmare gli animi mentre il caporale Gambino serio e rigoroso, gridò: <Il primo che parla e fa un gesto, lo porto al fresco!>Di rimando la voce rauca di don Antonio Petrosino, il più calmo tifoso della Nocerina, colui che non gesticolava, non fiatava ma che soffriva come Tantalo, esclamò: <Con questo caldo, un po’ di fresco è l’ideale…>. E Gambino, il finto accigliato, rispose: <Tu stai zitto e giù le mani, altrimenti ti trascino fuori dal campo…> Tutti risero di cuore. Il primo tempo finì a rete inviolate. Il secondo tempo si svolse al cardiopalma fra azioni pericolose alternate poi, su errore di Ceresoli, spintosi all’attacco, la Salernitana passò in vantaggio fra lo sgomento dei tifosi locali. La tradizione era finalmente sfatata! Gambrosier all’impiedi, petto in avanti, salutava fascistamente i suoi giocatori; mentre il Colonnello Pavone abbassando il sottogola del berretto e gesticolando con le mani, come per correre all’assalto gridava:<Forza Molossi, all’assalto, avanti, avanti, alla riscossa!> All’incitamento del Comandante i Molossi Nocerini attaccarono furiosamente mentre in tribuna vi fu una bolgia infernale: <Arrembaggio! Arrembaggio!> si gridava. Il caporale Gambino non sapeva più chi mantenere poi, seccato, trascinò fuori dal campo don Antonio Petrosino e ritornato in tribuna, ammonì:<Chi più vuole andare al fresco?> Nel mentre, esplose un boato di applausi e grida accompagnato da gesti e segni poco ortodossi dei più accesi tifosi! La Nocerina aveva pareggiato ed i suoi Molossi attaccavano sempre più furiosamente costringendo i Salernitani ad una difesa affannosa. Intanto, il bicorno di Gambino era volato dalla tribuna e questi, girandosi, rivide don Antonio Petrosino che, rientrato da un buco sotto la staccionata era livido come un gambero rosso, aveva gli occhi fuori dall’orbita, il volto paonazzo e stringeva i pugni in alto 16 in segno di trionfo gridando verso Gambino: <Chisti so’ goll! Chisti so’ goll!> che abbracciò. <Al fresco!> gridò una voce canzonante. <Altro che fresco, questo lo porto al manicomio… al manicomio…> rispose Gambino frastornato e felice.” Mio padre, che si chiamava Giovanni, è stato un buon padre ma devo riconoscere che è stata mamma a sostenermi a scuola. Lo devo a lei se ho potuto frequentare il Ginnasio e poi l’Università di Napoli. E’ stata lei, sempre lei, che in quei momenti di sbandamento adolescenziale mi ha instancabilmente incoraggiato a portare a termine gli studi, a laurearmi, trasmettendomi una visione del futuro entusiasmante. Il suo sogno era di vedermi “avvocato” per difendere i deboli ma, soprattutto, per tenermi lontano dal “giogo delle armi”. Il giogo delle armi. Già, è così che mi diceva. Soltanto da adulto ho capito cosa volesse significare. Con la sua esperienza di vita e senza scuola aveva capito che l’arma in sé rende schiavi, sottomessi a un destino spesso non piacevole. Un concetto che non ho mai condiviso perché per me “servire” la mia Terra è stato sempre un grande onore ed essere sottomesso al mio destino, una vera missione di vita. Mantenermi a scuola non è stato affatto facile né per lei né per mio padre: otto figli da crescere non è certo come fare una passeggiata! Le sarò sempre riconoscente, soprattutto perché mi ha consentito di essere la persona che volevo, l’uomo che oggi sono anche se, con suo dispiacere, le armi, sono stato costretto ad impugnarle ugualmente. Al destino non si può chiedere quando, citando il titolo di quel film paganese di Guido Maria Valetta. Mamma, spesso dissimulava con papà affinché avessi il necessario per preservare la mia dignità ma senza però toglierlo ai miei fratelli. Papà era una persona buona ma troppo presa dal suo senso del dovere che lo faceva apparire, ai nostri occhi, spesso burbero ed incomunicabile. Di mamma credo di averne ereditato l’ardore e lo spirito di 17 sacrificio, di papà lo smisurato senso del dovere e l’amore per la propria terra che chiamava, gonfiando il petto come un pavone, “Patria”. Sono anni che non ascolto più questo termine: “Patria”. Al solo suono di questa parola che significa “terra dei padri”, ai miei tempi, chiunque era pronto a portare, e con orgoglio, la mano sul cuore, pronto a strapparselo, pronto ad offrirlo in sua salvezza senza indugio alcuno. In questo istante, mentre scrivo la parola “cuore”, il pensiero vola alle mie sorelle… a Pasqualina… ed alla bellissima e cara Teresina… Prima di iniziare qualsiasi racconto è necessario, da parte mia, far conoscere come, tanti italiani, pur nella sconfitta delle armi, hanno onorato l’Italia sui campi di guerra. Forse è terribile sapere di poter morire a vent’anni, ma è proprio questo sapere che nobilita ancora di più i caduti, i mutilati, i prigionieri, ed anche, se un po’ meno, quanti, indenni, hanno potuto far ritorno a casa, proprio come me. Dunque, l’8 aprile del 1939 inizia l’occupazione italiana in terra d’Albania ed il 23 agosto dello stesso anno la Germania attacca la Polonia: Varsavia capitola dopo soltanto ventisette giorni. Il 10 giugno del 1940 l’Italia entra in guerra. Io ho vent’anni e mi arruolo volontario. Mi affiorano i ricordi del Ginnasio, del “Gian Battista Vico” di Nocera Inferiore (Sa) allora collocato in un fatiscente stabile nel rione Vescovado. Nell’androne era posta in tutta evidenza una lapide degli studenti morti in guerra. Come un carosello rivedo il Preside Di Lorenzo; il suo Vice e zelante insegnante di latino professor La Mura; il professor Faiella che per farmi impegnare nello studio è costretto ad appellarmi “Ciucciariello di Pantelleria”; il severissimo e burbero “prof” di matematica Cantone. Poi, come un flash rivivo un episodio particolare: il professor Cantone un lunedì entra in aula e, ieratico, annuncia alla classe intera: “Tra di voi ci sono due 18 traditori della Patria!” Noi ci guardiamo l’uno negli occhi dell’altro sbigottiti e curiosi di scoprire i “colpevoli”. Poi il silenzio si rompe ed il “prof” fa due nomi che echeggiano nell’aula come una condanna a morte: “… sono Giacomo Gambino ed Arturo Bove, vergogna!”. Io tremo. Mi assale il panico e poi d’istinto con un fare quasi minaccioso anzi disperato esclamo: “Non è vero!” Ma lui, serafico, invitandomi a sedermi ribatte: “…sabato scorso, dopo l’appello tu e Bove siete scomparsi dall’adunata degli Avanguardisti…è vero?!” Ed io: “Si, ma…”. “Niente ma!” Replica il “prof” che battendo la mano sulla cattedra ci preannuncia un provvedimento in corso. Provvedimento disciplinare che non è mai arrivato grazie all’intervento del professore di religione, il canonico Mancino, nominato poi Vescovo e che rincontrai nel 1948 quando mi rivelò il retroscena: “Sapessi che bugia ho dovuto raccontare nel Consiglio d’Istituto per non farti espellere da tutte le scuole d’Italia… e sai perché? Perché quel sabato ti ho sorpreso giocare a pallone proprio a quell’ora…” Mi ridesto dal ricordo e come d’incanto mi trovo alla Scuola Allievi Ufficiali di Complemento Fanteria di Salerno (20ª Zona Militare Territoriale). La guerra non mi spaventa e quando guardo quel mare salernitano dalla chiesa dell’Annunziata, non posso fare a meno di incantarmi come un bambino. Quella vasta distesa azzurra mi porta con la memoria alle nostre piccole scampagnate allo scoglio di Rovigliano. Alle nostre ammuine. Mamma ci controllava a vista perché non facessimo “guai” e, con quell’abito scuro a fiori minuscoli che la copriva fin sotto i polpacci, ci inseguiva sull’arena umida per ricondurci sotto la sua ala protettrice. Ci contava con lo sguardo come il pastore conta le sue pecorelle. Era bella, giovane, dolce, pur avendo imbarazzo a dimostrare la sua tenerezza che malamente mascherava con quei modi spicci nel dialetto che amo tanto. Appena distolti gli occhi 19 dal mare, però, ancora penso a lei, ma con la preoccupazione di recarle dolore. E’ lei il mio “dolore”, non il rischio che avrei eventualmente corso per la mia vita, quello non mi recava alcuna dolenza, né tormento. Adesso comprendevo meglio mio padre. Sono stranamente tranquillo anzi, direi impassibile, indifferente, ma non spensierato, e se posso confessarlo, nemmeno incosciente, nonostante ho l’età propria che, con l’incoscienza, ci va splendidamente a nozze. Mi sento “coscientemente vivo” e il pensiero di un presumibile combattimento credo che amplificherebbe ancora di più quello stato di interiore felicità, di strano eccitamento che io chiamo semplicemente, vita. Per chi ha studiato il greco, mi sento stranamente pervaso da quello che gli antichi chiamavano agape: l’amore universale. So che il mio “destino” è difendere la mia terra, la mia gente, la mia famiglia, e il pensiero di ciò mi fa sentire un “prescelto”: se non avessi provato quel “sentimento” non sarei mai riuscito ad anestetizzare la mia anima indomita, anelante di giustizia e di libertà né di godere di quella strana felicità che si mostra a coloro che si sentono protagonisti nel mondo, parte operosa di esso. Sia ben chiaro, non mi sento un salvatore ma so di compiere qualcosa di buono nel bene. Il mio concetto di libertà prescindeva dalla disciplina; libertà per me significava ed ancora significa fare della propria vita ciò che è “giusto”, ed il “giusto” è quello che mi è stato insegnato da mio padre con l’esempio, e da mia madre con la pazienza. Alla fine del corso allievi ufficiali sono nominato sottotenente ed assegnato al 31° Reggimento di fanteria di Napoli dove faccio domanda di essere inviato in zona d’operazioni. Intanto sono stato insediato presso il Comando Deposito di Maddaloni, “sempre e dovunque forte e fedele” come recita il motto scritto all’ingresso della caserma. Neanche il tempo di cucire i gradi sulla divisa che arriva l’ordine di mettermi in treno e raggiungere il Porto 20 di Brindisi; ho preso l’accelerato Napoli-Foggia e per la prima volta ho viaggiato sui velluti della prima classe. Ero vestito in tenuta da campagna e nello scompartimento una signora anziana mi squadrava di continuo, fin quando mi ha chiesto se ero un avanguardista o un giovane fascista. Quando le ho detto che ero un ufficiale dell’esercito, con destinazione Brindisi, al fine di imbarcarmi per l’Albania, è scoppiata in un pianto dirotto perché impressionata dalla mia giovane età; forse ai suoi occhi dovevo sembrare proprio un bamboccione. A Brindisi mi imbarco sulla motonave “Campidoglio” insieme ad un centinaio di compagni d’armi. Il convoglio è formato da sei o sette navi, non ricordo con esattezza, c’è anche un cacciatorpediniere di scorta forse della XV Squadriglia, ed un idrovolante, un Savoia-Marchetti S.M.79, lo stesso tipo di aeroplano pilotato dal Maresciallo Balbo. E’ il 7 novembre. I primi freddi del ’41 sono sopraggiunti insieme alle bombe che, a mezzanotte e cinque minuti spaccati, prima di prendere il largo, scrosciano sull’intera città di Brindisi in un diluvio fatale mentre i siluri sfrecciano a pelo d’acqua come squali incarogniti scoppiando nelle pance delle nostre navi. La Royal Air Force aveva sventagliato una formazione di feroci bimotori Beufort che, provenendo dall’isola di Malta, avevano avuto la missione di radere al suolo le fortificazioni portuali e la flotta in mare prima di far ritorno al loro quartier generale. Che Dio li abbia in gloria. Quei ragazzi erano davvero dei diavoli. L’incursione termina all’alba dell’8 novembre e, quando finalmente sento che le montagne d’acqua non si sollevano più, come il Mar Rosso di Mosè, sbatacchiandoci, il boato deflagrante delle bombe ed il rombo dei motori è svanito insieme all’ululato forsennato delle sirene antiaeree e alle urla dei civili, il mio orologio segna le cinque e dieci. Mi segno con la Croce e volgo lo sguardo in quel cielo albeggiante, 21 adesso totalmente sgombro. Anche le nuvole sono scappate lasciando che l’aria si squarciasse per inghiottire il fumo rossastro e fuligginoso dei roghi che divorano gli ultimi resti della città in ginocchio. Certo è, che un augurio migliore di buon viaggio non avrei proprio potuto averlo! Nonostante ciò, la mia indolenza non ha subito ripercussioni, non ha spalancato la bocca della paura ma si è trasformata in ansia, la stessa che ha pervaso gli anni della mia infanzia e dell’adolescenza: l’ansia dell’evento fatale, della “grande responsabilità”. Se quel bombardamento era stato da me vissuto, in quelle interminabili cinque ore, come se non fossi stato lì, ora che tutto era finito, o meglio, ora che avevo la contezza che tutto iniziava, mi sentivo investito più che mai di responsabilità enormi verso il Regno, gli Italiani e la mia coscienza che gridava qualcosa che non comprendevo ma molto simile a ciò che precede la “vendetta”. Oggi penso ancora a quello stato emotivo incomprensibile, a quel sentimento minaccioso inaspettato, ma so che è stato l’alimento del coraggio che mi ha consentito, alla fin fine, di portare integra la pelle a casa. Qual è lo stato che precede la vendetta? Il fuoco della sopravvivenza o il gelo della rassegnazione. Io non volevo sopravvivere, volevo soltanto vivere. Palpitare. In conclusione, affrontiamo il viaggio. Il mio plotone si è scosso dall’inatteso battesimo di fuoco e ha preso a canticchiare con la voce dell’inquietudine: « Son finiti i giorni lieti degli studi e degli amori o compagni, in alto i cuori e il passato salutiam. È la vita una battaglia, è il cammino irto d’inganni, 22 ma siam forti, abbiam vent’anni, l’avvenire non temiam, Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza! Della vita nell’asprezza, il tuo canto squilla e va! Non più ignava né avvilita resti ancor la nostra gente, si ridesti a nuova vita di splendore più possente…» Dopo aver cantato con loro mi apparto a guardare i marosi dall’oblò nel mentre ogni cosa dentro di me si confonde all’altra. C’è burrasca, ma è più quieta di quella dentro di me. Il “caporale di giornata”, addetto alla distribuzione del cognac, si avvicina porgendomi una borraccia. Bevo tutto d’un sorso quel liquido incandescente che mi scivola nelle budella come argento vivo. Mi riavvicino ai miei con una espressione tranquillizzante. Li fisso negli occhi ad uno ad uno e gli rinnovo l’ordine di tenere ancora le scarpe sempre slacciate sino all’approdo. Qualcuno sussurra qualcosa, ha il suono di un’imprecazione. Li scruto in silenzio e come d’incanto tutto tace, poi sorrido. Scoppia una risata collettiva e vedo sui loro volti finalmente un po’ di luce, una luce dalla quale traggo tutta la forza di cui ho bisogno. Ne sono consolato. Al mio fianco c’è Vietri, il mio amico napoletano che insiste sempre nel ricordarmi che è un parente di Raffaele Viviani. Con Vietri ho già condiviso, prima di imbarcarci, ore goliardiche all’osteria del porto di Brindisi. Con la sua simpatia di napoletano verace aveva invitato a cena, a spese mie, due ballerine che si erano appena esibite per noi soldati. Era la vigilia del bombardamento. Per tenere i ragazzi su di morale Vietri racconta, profittando della risata generale, ciò che aveva 23 fatto prima di imbarcarsi ma senza coinvolgermi più di tanto e ci riesce talmente bene da strappare oltre alle risate anche sospiri… Allora intervengo ordinando di raggiungere subito il suo posto. Vietri mi conosceva molto bene ed aveva compreso il mio richiamo. L’allegria fa sicuramente bene ma quando si dice “donna”, in quella situazione, si dice “danno”. Molti dei ragazzi si addormentano, altri sembrano rilassati. L’odore nauseante della nafta bruciata unita al rollio costringe i più delicati a farsi spazio fra la truppa per correre a vomitare. Attraversiamo il Canale d’Otranto diretti a Durazzo. Lo scandaglio misura una profondità di 4.000 metri. Nessun sommergibile in avvistamento né navi nemiche. Ad ognuno di noi è stato comunque consegnato un salvagente. Un salvagente che non avrebbe tenuto a galla neanche un pacchetto di sigarette. Ho riso tra di me per non piangere, Ci avviciniamo alla costa di Durazzo. Nel porto c’è un’autocolonna di mezzi di trasporto e di mezzi pesanti che ci attende. Ma c’è anche un nostro piroscafo semi affondato che mi fa dubitare della tanto nostra sbandierata potenza aerea e navale. La prossima meta è Tirana. Nel trasbordo pare di scorgere un mio concittadino: Giovanni Della Casa, di Nocera Inferiore. (Salvo errore di tempo e di luogo, perché il mio ricordo risale ormai a settant’anni fa.) Un vero campione di ping pong. Quante partite avevamo fatto da ragazzi e quante rivincite gli avevo chiesto quando frequentavamo la Società sportiva Nocera a Santa Chiara. Giovanni era davvero un asso a tennis da tavolo ma io mi rifacevo alla grande sul campo di calcio, ero considerato un attaccante veloce e concludente. Lo chiamo d’istinto: “Giovanni! Giovanni! Della Casa! Giovanni Della Casa!” Non mi sente. Il suo elmo scompare tra le migliaia di milizie che vanno e vengono come formiche operose. Arriviamo a Tirana attraverso una vallata ciottolosa. Il porto, come quello di Durazzo, è pieno di operai Italiani che lavorano 24 al suo ampliamento riparando i danni dei bombardamenti. Ovunque mi giro odo parlare in dialetto barese o in quello napoletano, ascoltare questi dialetti mischiati sembra quasi di essere a Torre, al mio paese d’infanzia. Sui pennoni e dai balconi sventolano gigantesche bandiere rosse con un’aquila nera a due teste tra due fasci littori. Elbasan Finalmente arriviamo alla meta: il 136° Distretto Militare di Elbasan. La campagna greco-jugoslava è iniziata il 6 aprile dal fronte nord Sloveno-Croato e da quello sud Albanese. Mi presento al Comando. Sono un ufficiale con il grado di sottotenente: “Sottotenente Giacomo Gambino al rapporto, Signore!”. Nell’attesa di essere destinato al Fronte il Comando mi incarica di occuparmi di polizia. Nell’accettare le consegne offro subito la mia disponibilità per la prima linea. Mi affidano un plotone armato di moschetto. Il territorio pullula di partigiani che, appostati sulle montagne, creano scompiglio soprattutto tra i civili. I cecchini sono invisibili, costanti e silenziosi come le gocce che scavano la roccia. Dalle informazioni che ho assunto so che le truppe partigiane sono manovrate dal combattente Enver Hoxha che ha fondato in clandestinità il Partito del Lavoro che diventerà, poi, la guida del movimento di liberazione nazionale del popolo albanese. Sento tanta energia dentro di me. Quanto darei per conoscere questo Hoxha… Forse sarà per il pane e lardo che mangio da quando sto qui ma scalerei quelle montagne pietrose per andarlo a scovare e prendere i suoi ribelli a calci nel culo pur di mettere fine a quello stillicidio assassino per poi finalmente raggiungere il Fronte, la prima linea. Combattere finalmente faccia a faccia con il nemico. Dopo neanche un mese, il tempo di ambientarmi, mi presento di nuovo a rapporto al Comando Truppe di Albania a Tirana per rafforzare la mia disponibilità per la prima linea anzi negli Arditi, il corpo speciale d’assalto. 25 26 Il perché? Ho sempre ammirato Gabriele D’Annunzio, l’impresa che concluse vittoriosamente a Fiume aveva accompagnato, come una leggenda, la mia infanzia. Da adulto ne ho, poi, potuto apprezzarne il coraggio, il valore e l’amore per la vita forte quanto quello per una morte onorata decantata attraverso il motto: “O la vittoria, o tutti accoppati”. D’Annunzio era un’anima sensibile ed impavida. Un letterato ed un soldato. Nelle more degli spostamenti il mio desiderio non viene assecondato a causa della capitolazione della Grecia e così ritorno al 31° Reggimento. Il Comando Superiore delle Forze Armate è retto dal Generale Alessandro Pirzio Biroli. La campagna dura soltanto dieci giorni, grazie alla forze dell’Asse, con la resa incondizionata della Jugoslavia. E’ il 17 aprile. Sul Fronte Greco-Albanese la consistenza del magazzino per il Fronte è precaria: viveri di riserva, nulla; equipaggiamento, minimo; indumenti di lana, zero; munizioni, poche; armi, esaurite tutte le disponibilità; materiale del genio, praticamente nullo; materiale sanitario, insufficiente. Insomma, in Albania non c’è ormai più niente ed io svolgo attività di polizia sentendomi per nulla utile alla causa. Il Fronte è di 250 chilometri presidiato da 160.000 uomini di cui 100.000 in linea ed io, con il mio moschetto, sono tra questi 60.000 e “rondo” per mantenere l’ordine mentre potrei benissimo essere là. Mi sembra di sognare. L’11 dicembre del 1941 Benito Mussolini, da Piazza Venezia, dichiara guerra agli Stati Uniti d’America. L’Albania, già occupata dal 7 aprile del 1939, era stata unita al Regno d’Italia soltanto il 12 aprile del ‘41 quando, nello stesso anno, con la disfatta della Jugoslavia anche parte del Kosovo e della Macedonia vengono arrogate all’Albania. Non ho mai dimenticato il tempo trascorso in Elbasan, perché 27 è proprio lì che ho cominciato a preparare il primo esame “Storia del diritto romano” in circostanze di certo originali. Vivevamo in tenda e le lucerne di ordinanza non mi permettevano la sera, di avere luce sufficiente per leggere il mio librone; la luce elettrica esisteva in un bel locale, di quelli che da circa cinquant’anni sono stati aboliti, al quale era permesso accedere dalle 21,00 in poi agli ufficiali, con diversi turni, uno per la truppa ed un altro per i sottufficiali, nel corso della giornata. Mi sembra che il prezzo di ingresso, consumazione inclusa, fosse di 20 lek, ossia circa 25 delle nostre Lire e così unendo l’utile al dilettevole mi sono preparato per l’esame. I prodotti erano esclusivamente italiani e senza volere scendere in disamine moralistiche o sociologiche, devo dire che le ragazze del locale si preparavano a riprendere l’anima ed i sentimenti di donna alle 21,00 della sera, cantando o ballando o parlando con noi, dopo avere indossato gli abiti più belli. E’ proprio vero che con il male può sempre coesistere anche il bene. La guerra al Fronte è finita. Ricevo l’ordine di imbarcarmi sulla motonave “Città di Marsala” per raggiungere di nuovo Brindisi. Vi permango un paio di mesi perché in attesa di nuova destinazione. Sono ancora un “volontario” altro che “traditore della Patria” come accusava il vecchio professor Cantone! In questa bella città c’è stato il maggior numero di vittime civili causate da bombardamento aereo in Italia dall’inizio della guerra. Le bombe l’hanno sfigurata e quasi tutti i brindisini si sono spostati nelle località viciniore. E’ una città fantasma. Cammino tra le macerie e ne resto profondamente scosso. “Ad Elbasan i civili si stavano battendo per riottenere la propria terra ed io li fronteggiavo, adesso impreco per ciò che è stato fatto alla mia Patria e non so più da che parte mi trovo…” 28 29 dico tra me. Poi, mi rendo conto di indossare ancora la divisa, di essere un soldato, di aver scelto di esserlo e impongo, a me stesso, di non dimenticarlo mai più. Mentre cammino per recarmi al Comando, passo dinanzi all’osteria. Penso alle ballerine, alle orecchiette al sugo, allo schiamazzo delle risa di Vietri che echeggiano nella mia mente con durezza. Arrivo alla base. Un ufficiale superiore mi comunica di presentarmi al Comando. Mi presento sull’attenti e appena finito di esclamare le mie referenze l’alto ufficiale mi consegna l’ordine di assegnazione al 79° Reggimento fanteria, Divisione “Pasubio”. E’ l’ottobre del 1942. Il 1º maggio 1942 era stata costituita l’8a Armata, conosciuta meglio come A.R.M.I.R., ossia: Armata Italiana in Russia. L’A.R.M.I.R., affidata al comando del Generale Gariboldi il 9 giugno comprendeva la mia Divisione, la “Torino”, la 3° Celere “Principe Amedeo duca d’Aosta” ed il raggruppamento CC.NN. “3 Gennaio” con i Gruppi “Tagliamento” e “Montebello”, già presenti sul suolo russo ed inquadrati nel XXXV Corpo d’Armata (C.S.I.R.), le Divisioni “Sforzesca”, “Ravenna”, “Cosseria” e il Raggruppamento CC.NN. “23 Marzo” con i Gruppi “Leonessa” e “Valle Scrivia”, inquadrati nel II Corpo d’Armata e le Divisioni “Julia”, “Cuneense” e “Tridentina”, costituenti il Corpo d’Armata Alpino, inizialmente destinato ad operare sulle montagne del Caucaso. A queste forze era stata aggiunta la Divisione “Vicenza”, formata da 2 Reggimenti di Fanteria, con compiti di presidio nei territori occupati. La Divisione 3° Celere aveva inglobato anche la Legione Croata. Queste erano le forze radunate e schierate in Russia dalla seconda decade del giugno 1942. Da una località di mare a pochi chilometri dal porto di Brindisi raggiungo il convoglio ferroviario: destinazione Ogolew. Salgo sul vagone. Con gli altri aspettiamo che faccia buio. Finalmente è notte e si parte. Tutto tace. Ogni tanto penso 30 a quella devastante incursione aerea, al mio battesimo di fuoco a Brindisi. Mi segno con la Croce. So che questa è la mia battaglia. So che il Fronte sul Don non è Elbasan. Sono stipato con altri nella tradotta. Siamo soltanto un paio di ufficiali ai quali è stato riservato un angolo insieme al marconista, al caporale di sanità e al Cappellano. Nel vagone dinanzi al mio ci sono i muli che, ogni qualvolta circumvola un aereo, cominciano a menar calci creando un fracasso indicibile, drammatico, scuotendo le nostre coscienze assopite dal futuro. A notte è cupa e lenta.. Il treno avanza attraversando tutta la Penisola, con fatica s’inerpica su per le Alpi: il Brennero, l’Austria, la Germania. All’alba, in una stazione tedesca, abbellita con fiori e drappi rossi con croci uncinate, ci attende una fanfara sparuta che ci “incoraggia” con le sue note wagneriane per colmare i vuoti “ideali” degli “Italiani brava gente”. Le ore passano, ma arrancano come il treno. Dal finestrino vedo campagne immense, bellissime, villaggi con chiese dalle cuspidi nere, alte ed appuntite. Poi la Polonia. Il corso di un fiume con le sue acque d’acciaio. Sugli occhi dei ragazzi è già stampata, nitida, l’immagine della nostalgia. Il vagone nel quale viaggio è un carro bestiame con tanto di paglia sul tavolato per tenerci caldi. I ragazzi, circa una sessantina, viaggiano sulla paglia distesi, a terra, senza parlare. Ascoltano il rumore delle rotaie che alimenta i loro ricordi, “visioni” che appaiono dinanzi agli occhi di ognuno: la donna amata, la casa, i genitori, gli amici, un dramma famigliare lasciato al suo destino, la guerra …. Il pasto giornaliero consiste in un limone, quando possibile, e poi la solita pagnotta a testa, gallette, una scatoletta di carne di manzo. L’acqua scarseggia. Il carro ferroviario puzza di afrore e di piedi sudati. L’aria è consumata. Fetida. Tra tutto ciò, la cosa che però trovo, nonostante la sua problematicità, ancora goliardicamente divertente è quando dal treno in movimento buttiamo via ogni specie di rifiuti e udiamo le imprecazioni degli altri che sono nel vagone dietro al nostro 31 con il portellone semi aperto. A venti anni non è mica un peccato ridere, no? Spesso il lungo convoglio si ferma per dare precedenza ad un altro treno. Il binario qui è unico. Entriamo in terra di Ucraina. Il rumore delle rotaie sui binari adesso non è più sufficiente per ingannarci ancora alimentando le nostre “visioni”. Ciò che ci appare è il prologo di ciò che ci aspetta e reca il volto degli stenti e della morte: carri armati sventrati, vagoni di treno ancora fumanti carbonizzati, case in rovina incenerite, carogne di animali ghiacciate, uomini morti senza sepoltura con qualche arto che emerge, rigido, dalla neve fangosa. Nonostante ciò, nell’attraversare l’Ucraina, ho fatto una grande conquista. Durante una sosta del convoglio mi avvicino ad alcuni contadini del luogo che stavano lavorando la terra. Il popolo ucraino è fatto di gente semplice e cordiale, anzi gentile, davvero molto garbata e, al primo impatto, senza ancora avvicinarmi, mi avevano già dato l’impressione di essere accolto come un messia, un “liberatore”, non come un nemico nonostante avessi la mano sull’arma. Ecco che mi vengono incontro in tre, gioviali, per niente avviliti ed impauriti. Così altri contadini con i miei commilitoni che sono scesi dal convoglio per sgranchirsi le gambe e sciogliere un po’ di neve nella gavetta per poi bere. I poveri contadini offrono uova, polli, patate in cambio di sigarette, utensili o quel poco che ritengono di poter scambiare. Mi avvicino ai tre con fare marziale e comincio a parlare in italiano con un’espressione per niente rilassata. Ero certo che non capissero un’acca di ciò che dicevo; invece, con mia meraviglia, si mettono a ridere, mi disarmano con il loro fare disincantato e mi rispondono nella loro lingua assolutamente incomprensibile. La cadenza di quella lingua non mi suona ostica. Mi rilasso ma tenendo ancora la mano destra poggiata sull’arma. Quando sono vicini a me mi consegnano un cucciolo di cane. Rimango per un istante stranito. Sono davvero confuso. Che gente, mi trovo nel loro paese, li abbiamo assediati e loro mi trattano da 32 amico! E la guerra? Cos’è la guerra, allora? Perché non mi offendono? Perché non fanno correre il loro sputo dalle loro bocche avvilite anziché del sorriso? Se quella fosse stata la patria che avrei dovuto difendere, la mia Patria, come mi sarei comportato io? Forse la guerra serve a comprendere il mondo, gli uomini, il principio divino di giustizia? Ma dov’è il bene e dove il male? Io stavo andando al Fronte perché credevo in quello che facevo. Perché sapevo di essere dalla parte giusta. Stavo difendendo la mia Nazione, porca miseria! Mi sento a tratti felice ma allo stesso tempo meschino. Non lo so perché. La paura non è mai riuscita a farmi barcollare, la “pace” invece sì. Specialmente adesso. Comunque, mi avvicino ancora a quei tre ucraini che sembrano una famigliola di braccianti e dico. “Grazie!”. In effetti mi stavo avvicinando a loro proprio per quel cucciolo che vedevo saltellare tra le loro gambe e la mia intenzione era di barattarlo. E’ un bel pastore tedesco, un cane-lupo come lo chiamiamo noi italiani, con un musetto magnifico ed un pelo lungo e morbido marrone sul dorso e nero nei fianchi. Quando me lo ritrovo tra le braccia mi sento l’uomo più felice del mondo… “Grazie! Grazie! Grazie!” Ripeto loro come un ebete. E loro “Bud’ laska… druh”. Dicevano. “Prego, amico”, ma io non conoscevo ancora quelle parole che avrei ancora ascoltato, nonostante la guerra. L’unica parola che conoscevo era snih, neve. Non ho nulla con me se non un po’ di danaro che consegno alla giovane donna imbacuccata che mi ha porto il cucciolo. Mi congedo da loro mantenendo l’aplomb di ufficiale, faccio qualche passo indietro con il cucciolo tra le braccia, poi mi fermo e vado di nuovo loro incontro e li saluto con affettuosità, quasi un abbraccio. All’unico uomo che è con loro, di circa una quarantina d’anni con barba lunga e baffi folti, offro la sigaretta che ho tra le labbra ancora spenta e all’anziana un santino della Madonna di Pompei che lei bacia abbassando lo sguardo su di essa. Mi riavvio verso il vagone. Il cuccioletto 33 intanto latra ed io gli rispondo: ”Certo che lo so come ti chiami, ti chiami Don, perché questo sarà il tuo nome”. Questa, è stata una delle più grandi “conquiste” della mia vita: il cucciolo che mi leccava per manifestare il suo affetto, quella gente che ancora mi salutava come se fossimo amici e ci saremmo rivisti più tardi, la comprensione delle parole “guerra”, “giustizia”, “umanità” ma anche di Bud’ laska, e druh che presto riudirò nonostante la guerra. Soltanto adesso, però, posso scrivere con mio grande rammarico che le truppe italiane ritorneranno in quel luogo dopo pochi giorni dalla mia partenza, ma non da amici: il 2 novembre, il giorno dei morti, il 79° della Pasubio, combatterà angolo per angolo contro una resistenza tanto accanita quanto disperata, occupando Gorlovka. Prima di aver superato l’Ucraina, il ”granaio d’Europa”, avevo incrociato migliaia di civili, uomini e donne, che lavoravano alla strada ferrata per allargarla, comandati con veemenza da militari tedeschi che sbraitavano e cani lupo affamati, ma il convoglio non si era fermato. Abbiamo proseguito ancora per qualche dozzina di chilometri in treno e poi siamo scesi tutti. Un’autocolonna di camion Bianchi modello Miles ed una quindicina di motocarri a tre ruote Benelli ci attendevano. Ma non siamo saliti tutti quanti. Io con un quarto di convoglio siamo destinati a percorrere circa duecento chilometri a piedi, nella neve, per raggiungere il Fronte. Il treno aveva dovuto obbligatoriamente fermarsi proprio perché i binari russi erano più grossi di quelli europei. Iniziamo la lunga marcia cantando. Marciamo notte e giorno, giorno e notte, perdendo così la voglia di cantare e non solo. Siamo stremati ed infreddoliti. Che culo che hanno avuto i compagni di convoglio. E’ il pensiero che invade la mente di tutti noi. Desideriamo un cantuccio caldo. Tutto intono a noi sembra deserto. Una visione metafisica. Un “non mondo”, quasi un sogno, il sogno della realtà. Quella visione diventa ancora per 34 me più strana, anzi incomprensibile, quando metto a fuoco quelle migliaia di civili che ho incontrato prima sulla strada ferrata. Indossavano una casacca, quasi uguale per tutti, ma che si differenziava per il simbolo che vi era cucito sulla schiena: una grande stella gialla, un triangolo rosso, o nero, oppure verde… Odo ancora le grida veementi degli alleati e l’abbaiare dei cani lupo affamati tenuti al guinzaglio. All’istante avevo pensato che fossero simboli. del campo di lavoro e che quei civili fossero prigionieri russi invece erano ebrei, uomini e donne in giovane età. Ma quel ricordo si era fissato nella mia testa senza svanire. Chissà perché. Raggiungiamo stanchi ma soprattutto straniti per l’effetto del gelo che ha indebolito la percezione dei nostri sensi, le sponde del Don. Il nostro umore è a terra. Siamo esausti. Molti soldati si sono ammalati. Altri tremendamente depressi e piangono come bambini. Giunti al fiume, in gran parte ghiacciato, facciamo subito la conoscenza del nostro “nemico russo” che è appostato sull’altra sponda. Il bagliore dei mortai illumina a sprazzi il bianco manto. A quest’ora della notte la temperatura sfiora i quaranta gradi sotto lo zero. Beviamo un po’ di brodaglia calda allungata con del cognac e qualche tubero sminuzzato. Alle prime luci dell’alba, all’alzabandiera, comprendiamo finalmente dove siamo: un paesaggio algido, bianco, surreale, uniforme. Bianco, e poi bianco e poi ancora bianco, così gli alberi, la terra che calpestiamo, le alture, i piccoli corsi d’acqua, l’aria che respiriamo a fatica, ed il cielo. Tutto bianco. Anche le nostre uniformi sono bianche e gelide. Chi ha indossato l’elmo senza il passamontagna per troppo tempo ha rischiato il coma per assideramento. I Russi, silenziosi ed appostati al di là del fiume, stanno conducendo la loro guerra, la guerra del freddo. Il Don, nel luogo in cui siamo, ovvero al “Blocco Sud” è largo circa mille metri. Ogni tanto parte un’offensiva nemica accompagnata da salve di mortai per sondare le nostre forze e poi silenzio ed ancora silenzio. Dopo pochi giorni mi rendo 35 conto che il nostro equipaggiamento non ci avrebbe consentito una lunga resistenza in quel territorio dalla temperatura siberiana. I Cosacchi indossano giacche imbottite, pantaloni grossi, copricapo in pelliccia e soprattutto scarpe calde ed impermeabili che non erano per niente paragonabili ai miei stivali di cuoio già utilizzati e sperimentati sul Fronte Albanese. Lo sapevano anche i nostri Comandanti superiori, il Generale di Divisione Guido Boselli e quello di Brigata Davide Borghini pur convinti che ce l’avremmo fatta per il dispiegamento delle forze impiegate. Al termine di tutti gli spostamenti, la posizione definitiva dell’8a Armata sul medio Don risulta la seguente: la “Tridentina” a Nord, con la 2a Armata ungherese sul lato sinistro, poi la “Julia”, la “Cuneense”, quindi la “Cosseria”, la “Ravenna”; qui lo schieramento dell’8a Armata viene interrotto dalla 298a Divisione tedesca, per riprendere con la “Pasubio”, la “Torino”, la “Celere” e la “Sforzesca”; a conclusione dello schieramento verso Sud, con alla sua destra la 3a Armata romena. Quindi, l’8 a Armata presidia la parte del Don insieme alla 298a Divisione tedesca seguita dalla “Torino”, la “Celere” e la “Sforzesca”. Il giorno successivo all’arrivo mi presento al mio ufficiale superiore, il Comandante di Compagnia Capitano Fiorini, di Grosseto. A lui è affidato il Blocco Sud che comprende Krassnogorowka, Ogolew e Abrassomowa. Intanto avevo affidato “Don” ai miei soldati. Le piogge invernali sono iniziate e le piste sono pantani di ghiaccio sporco. Il 79° è distribuito sui presidi 3,4 e 5 del Caposaldo “Zeta”, il più avanzato, dove si scava sempre per predisporre i ricoveri, indispensabili per sopravvivere a quelle temperature glaciali. Il caposaldo “Zeta” è un’ansa del Don di quella grande linea curva che strategicamente è stata chiamata “Cappello Frigio” ma non per ricordare la Rivoluzione Francese né tantomeno Napoleone e la sua disastrosa disfatta nella Campagna di Russia del 1812 ma 36 37 proprio perché quella linea, così tracciata, assomiglia molto a quel misterioso copricapo frigio eletto a simbolo della libertà che un po’ assomiglia al nostro cappello di Pulcinella. A rapporto, Il Capitano Fiorini mi affida parte del Caposaldo “Zeta”. Il mio compito è quello di conquistare giorno dopo giorno quote di quella vasta linea di Fronte. Dopo pochi giorni mi accorgo che il mio compito si è ridotto a mantenere quella linea di Fronte, la mia quota, a non cederla. Il decimo giorno capisco invece che c’è poco da fare nonostante si ripetono con metodo, isolati attacchi russi simili a fastidiose punture di zanzare, che nonostante la loro insidia indifendibile vengono puntualmente respinti dai miei. Nel respingerli, si aprono però su altre sponde, nuovi varchi a favore del nemico. Ho preso posto con il mio plotone in uno dei fossati-trincea. Sono sovrappensiero ed infreddolito pur certo che dopo il Don la guerra finirà. Come ho già detto, nell’aria aleggia questa specie di presagio perché i nostri comandanti, influenzati dai rispettivi comandi generali, tendono a sottovalutare l’Armata Rossa e pensano che la dura campagna estiva aveva stremato i Russi rendendoli incapaci di offenderci in “grande stile”. Ed allora, continuo a far scavare trincee, fossati anticarro e a stendere reticolati, per rendere le mie quote inespugnabili. “Don”, il mio piccolo “Don”, fa i turni di guardia con le sentinelle ed è davvero molto attento. Un vero soldato, sempre sul chi va là. Il mio miglior soldato. Un “volontario di guerra”, felice di esserlo, proprio come me. Il turno di guardia dura dai 15 ai 20 minuti circa per evitare assideramenti ma “Don” ne fa moltissimi al giorno e, quando è stufo, torna da me per avere qualche coccola, specialmente quando sa di aver svolto bene il suo compito: spesso, abbaiando, mette in allerta le guardie che si assopiscono per il freddo e, quando ringhia, significa che qualcuno sta tentando di avvicinarsi alla linea più del consentito. La nostra trincea è una buca di circa due metri di profondità coperta da foglie, rami, 38 tronchi, ed ha un unico varco per accedervi o scappare. Nel caso di un attacco massivo siamo destinati a fare la fine dei topi in trappola. “Avessimo almeno con noi qualche “madrina di guerra” per riscaldarci tutto sarebbe più sopportabile…”, disse un caporalmaggiore di sanità. Abbozzo il mio solito sorriso. Con il Capitano Fiorini c’è stata subito una certa empatia. Gli piace la mia compagnia perché riesco sempre a sdrammatizzare, specialmente nei momenti cruciali, tanto che gli riportai anche l’istanza del caporalmaggiore di sanità. Non mi rispose ma dopo qualche minuto disse: “Ma avete cominciato a familiarizzare con questa gente? Ci sono tanti villaggi ospitali, qui”. Il mio Capitano non è caduto al Fronte ma da civile. E’ morto circa 15 anni dopo la guerra per una terribile malattia: un tumore al cervello. Anche allora, prima di morire, sono riuscito ancora a farlo sorridere… Al funerale ha avuto gli onori militari da un reparto di soldati comandati da un ufficiale; i compagni di guerra Gambarotta, già Generale paracadutista a suo tempo alfiere del nostro Reggimento, poi Rinaldo Migliavacca, io e qualche altro non siamo mancati per dargli l’ultimo addio. Chissà se la mia guerra avrà mai fine… In trincea, più che mai, non ho mai avuto un solo attimo di smarrimento, di normale paura, ma ripeto, non è, la mia, incoscienza. Credo che qualunque ufficiale abbia provato quello che ho provato io e comprenderebbe le cose che intendo. La responsabilità che hai per la vita degli uomini che ti vengono assegnati non ti consente di pensare a “te”: dal tuo esempio, dalla tua volontà, dalla tua prontezza, dal tuo coraggio dipendono la vita e la morte di ognuno di loro. In quel “buco” la posta ci perviene ogni 5 o 6 giorni. Ai miei genitori racconto solo frottole per non farli penare. La più incredibile è quella che ho scritto stamattina. Ho detto loro che sono in “fureria”, che sono al calduccio nelle retrovie, in amministrazione, e sono costretto 39 a fare lo scribacchino. So, comunque che, conoscendomi, mai mangeranno la foglia. Se avessi fatto la guerra da scribacchino non so se avrei preservato quel po’ di coraggio che ancora credo di avere. Sicuramente avrebbe saziato la viltà che credo ognuno di noi abbia. In verità, faccio davvero lo scribacchino, ma per i miei soldati in trincea. Quelli che vedo murati, come foche, nel profondo di un lago, da una lastra di ghiaccio. Quelli che non hanno bisogno di parlare per raccontarmi il mondo che vedono, quello in cui stanno vivendo e dal quale vorrebbero uscire, loro malgrado, ma non ce la fanno. E non faccio soltanto lo scribacchino; l’aliquota degli analfabeti era notevole in quei tempi. Gli leggo anche la posta che ricevono. Ma questo, è un compito molto più difficile. Vorrei scrivere invece ai miei genitori, ai miei fratelli e sorelle che mento ai miei ragazzi. L’ho fatto più di una volta. Ma sono costretto a farlo. A loro “racconto” ciò che vogliono ascoltare, non lo leggo dalle lettere che ricevono. Perché venire a conoscenza, in guerra, che un tuo caro è passato ad altra vita può anche portarti a quel tipo di eroismo che si chiama suicidio oppure a disinibirti talmente da metter in pericolo la vita dei tuoi compagni… Nonostante, penso che i miei ragazzi mi vogliano bene, cari mamma e papà. Vorrei anche confessarvi che la peggiore delle punizioni che ho inflitto loro è stato un calcio in culo e quella che ho inflitto a me è stata non pensarvi sempre. I ragazzi che si sono poi battuti ad Arbusov, nel Tcertkowo, in prima linea, venivano per lo più dai Carceri Militari. I miei da quello di Gaeta. Nessuno può immaginare che “scorza” da “delinquenti” avessero! Sicuramente per essere stati condannati qualcosa avevano pur fatto: forse avevano tentato di disertare, di rubare qualche coperta, si erano probabilmente sbronzati, avevano disatteso agli ordini impartiti, avevano litigato tra di loro o “semplicemente” avevano alzato la voce con un superiore. In effetti, stavano già conducendo una 40 guerra, una loro guerra, ancor prima che scoppiasse la guerra, quella vera, quella dal suono rintronante e terribile di Seconda Guerra Mondiale. Quella per la quale esistevano tante ragioni per giustificarla ma nessuna era valida, direbbe oggi uno di voi lettori. Io invece, da militare e da ufficiale dicevo, quella per la quale esistevano tante ragioni valide ma nessuna veniva utilizzata per non farla. In effetti, non è la guerra che uccide gli uomini, sono gli uomini che inventano la guerra per uccidere. Ancora mi sforzo a comprendere il delitto per il delitto ma la “storia” non mi ha dato mai una mano per dissuadermi. Perché allora ho scelto di essere un soldato? Sembra banale o pura demagogia, ma questa mia risposta trova concretezza in questo nostro mondo: ho scelto di essere un soldato per difendere, per difendere ciò che amo, la mia gente e la mia terra. Come mi piacerebbe ripetere a tutti quelle parole che ascoltai in un colloquio e se non sbaglio furono pronunciate dal Cristo: “…quando non avevate nulla, vi mancava forse qualche cosa?”. Ritornando ai miei soldati “galeotti”, il Duce aveva deciso di offrire loro una possibilità: la guerra in prima linea in cambio della pena condonata. Chi aveva accettato era in trincea a meditare su ciò che aveva fatto. Chi non aveva accettato era in cella tra le bombe a meditare su ciò che non aveva fatto. Comunque, in questo fosso gelato oltre al freddo ci morde la fame e con la fame i pidocchi. Questi animaletti diabolici, più del freddo e della fame, sono diventati il nostro passatempo preferito. Cacciarli è un sollievo gratificante. La caccia ai pidocchi consiste, oltre all’offensiva di “prima linea” mediante lo schiacciamento con le unghie dei pollici, nel bollire gli indumenti infestati con l’acqua ricavata dalla neve sciolta in grossi bidoni. A dirlo sembrerebbe a dir poco semplice, ma non lo è. In primis perché non possiamo accendere fuochi per non farci localizzare dai Russi ed in secundis perché le 41 nostre divise per asciugare ci impiegano una vita. Per quanto riguarda i miei soldati-galeotti, posso serenamente dichiarare di non essermi mai interessato di prendere visione dei loro fascicoli, non mi incuriosisce per nulla scoprire di quali colpe e crimini si sono macchiati in tempo di pace. Sono stati affidati a me ed essi si sono affidati interamente a me, la loro vita è nelle mie mani. Ciò è sufficiente per poter offrire, qualora ce ne sia bisogno, la mia vita in cambio della loro salvezza. In guerra si sviluppano delle dinamiche emotive forti dove nulla conta se non l’amicizia, il rispetto, la comprensione. Certo è che sono in grado di affermare che, se mi inviano in un campo di concentramento a svolgere il mio compito di ufficiale, la Corte Marziale decreterà sicuramente la mia condanna a morte perché il secondo giorno farei evadere tutti i prigionieri, specialmente se sono donne, bambini e vecchi… Ma questa è un’altra cosa ed un’altra storia: io non sono a Buchenwald ma se pure mi avessero ordinato, da militare, di andarci, senza alcun dubbio se avessi saputo ciò che oggi so di Buchenwald, avrei volontariamente indossato la casacca da “traditore” mostrando il mio petto al plotone di esecuzione pur di non commettere le empietà che sono state commesse e che da soldato riconosco che siano state commesse. Ma sono al Fronte e non ho, grazie a Dio, il compito di fare il boia ma dare istruzioni a veri soldati o meglio, a soldati veri. Già, perché questi “condannati” dotati di un coraggio selvaggio non hanno accettato un baratto ma un’occasione di riscatto e di espiazione. Per rimanere bene in argomento anticipo già quanto mi è accaduto quasi alla fine della ritirata: Ero stato da qualche giorno ricoverato in un ospedale militare dove, mi sembra, d’aver incontrato l’amico dottor Rocco Fasciani, quando sono arrivate le prime bordate dell’artiglieria avversaria. La ripresa del ripiegamento è stata immediata e le prima sosta, la sera, è avvenuta in una località chiamata Iasinovataia, mi sembra. Con cinque o sei commilitoni abbiamo passato la 42 notte in un fienile ed appena arrivata l’alba mi sono preparato per la partenza. Con non poca meraviglia ho notato tre giovani russi che dormivano beatamente poco lontano; un sottufficiale che li conosceva mi ha riferito che non erano né partigiani, né militari, non erano nemmeno armati, che si nascondevano al fine di non essere inviati in un campo di concentramento, anche se ancora molto giovani. In quei giorni anche i tedeschi erano in ripiegamento, per il ché non avrei saputo a chi consegnarli anche se, dimenticando che avrebbero potuto ucciderci mentre dormivamo, e non l’avevano fatto, nulla mi avrebbe consentito un atto di simile gravità verso tre minorenni; sono ancora adesso orgoglioso per la decisione presa. Ritornando al Caposaldo “Zeta”, il mio Caposaldo, ormai abbiamo davvero poco da difendere, altro che inespugnabile! L’offensiva russa è precisa e tenace e noi, come aveva previsto il nemico, cominciamo ad indebolirci sempre di più. Tale debolezza, che non ha attaccato la nostra personale forza ma l’intera strategia di guerra, è evidente dai movimenti confusi dell’A.R.M.I.R. e dai numerosi buchi nel Berretto Frigio. I cecchini nemici si sono asserragliati a cento metri dal Don. Sono invisibili come lo era Hoxa in Albania, come lo sono i loro colpi che centrano con una abilità disarmante nonostante il gelo fitto e la neve offuschino l’aria rendendola opaca più della nebbia bassa del Po. Le notizie si susseguono. L’ultima dice che a Tcertkowo truppe motorizzate sovietiche hanno circondato una delle colonne della nostra Armata passando attraverso la breccia creatasi nel Fronte e adesso stanno imperversando nelle nostre retrovie. Io, continuo a tenere la mia linea comunque ben serrata ma non senza problemi. Dio mio… è accaduto anche che muovendomi più di una volta in avanscoperta, verso il Don, mi sono ritrovato solo sulle sue sponde. Allora, sono ritornato indietro e ho preso 43 a calci in culo quel manipolo di tartarughe che, nel seguirmi strisciando o avanzando carponi, si sono trovati imbucati in montagne di neve con le estremità degli arti congelate. Come è accaduto, pure, che per incutere timore e far acquisire loro il giusto “slancio” - calato non tanto dal fuoco nemico ma dai bollettini informativi del Fronte - ho dovuto mostrargli minacciosamente, avanzando come un coccodrillo, la mia Beretta d’ordinanza pur consapevoli quanto me che mai l’arma avrebbe sparato per il gelo ma sicuramente gliela avrei lanciata senza scrupoli come un martello. Ma quelle mia sortite non hanno provocato l’effetto atteso. Allora sono avanzato impugnando un badile ed ecco che i miei hanno finalmente ritrovato il vigore e il coraggio e mi hanno seguito come i lupetti seguono la mamma-lupa per non disperdersi sognando di mordicchiarle il seno e godere del tepore delle sue membra impellicciate. Intanto, il mio “Don”, il mio piccolo lupo, ha imparato più alla svelta di loro e nelle avanzate mi precede, spesso mortificandomi e suscitando tanta ilarità tra quei “galeotti” redenti. Spesso mi viene di strangolarlo o di prenderlo a calci come faccio con la mia amata ed irridente marmaglia. Nonostante, il mio Plotone, quello dei galeottiredenti, è considerato uno dei più ben addestrati perché in grado di portare al Comando sempre informazioni delle linee nemiche. Informazioni ben dettagliate relativamente ai movimenti di truppe e di mezzi in corso. Per essere ben dettagliate significa che si spingono oltre rischiando la vita più di quanto loro è richiesto. In effetti, chi può accusarli di fermarsi prima o dopo quel limite immaginario che diventa concreto soltanto quando vi cadi ferito o morto? Ciò che ancora non mi spiego è come fa il mio “Don” a distinguere la divisa nemica dalla nostra, forse dall’odore di vodka… Chissà... Ma pensandoci bene come non avrebbe potuto il mio “Don”, soldato effettivo della “Divisione cane” non riconoscere il nemico? E’ così che chiamano i Russi la nostra Divisione, la 44 45 “Divisione cane”, “Division Sabaca”, per le mostrine con la Lupa romana sulle nostre giubbe. E’ il 10 dicembre e l’8ª schiera 220.000 uomini e 7.000 ufficiali, un soldato ogni sette metri. Il bollettino di guerra ci informa che tre giorni prima gli Americani sono stati bombardati dai Giapponesi a Pearl Harbour. Il giorno successivo, l’11 dicembre, le unità sovietiche iniziano la strategia di sfiancamento, comincia la così detta ”Operazione Saturno”. Sfondano il settore della Divisione Ravenna logorando la tenuta dell’ansa di Ogolew e la nostra quota che è estesa per circa 25-30 km con più di cinque divisioni. Resistiamo per quattro giorni con il panico negli occhi. Il 15 dicembre viene sventrato, in forza, tutto il Fronte presidiato dalla Pasubio. Le fanterie russe lasciano centinaia di caduti italiani sul terreno, o meglio sulla neve che diventa purpurea e brilla alla luce fioca del crepuscolo, e il nostro 79° è diventato, per usare un’espressione cara agli storici moderni, “una vigna sotto la grandine”. Raccolgo tutte le mie forze, faccio appello al mio carattere ottimista per tenere tutti vicini e sotto controllo. Tento di placare gli umori. Non è facile. Mi arriva l’ordine di prepararmi al peggio. Il giorno dopo, il 16 dicembre l’Armata Rossa mette in campo le forze pesanti terrestri e quelle aree, in massa. E’ un inferno. Grida, sussulti, imprecazioni, terrore. Cominciamo a ripiegare ed il 17 siamo al Pianoro “W” di Krasnojarowka. Qui, mi assegnano altri soldati che, in quel tumulto di sangue, di urla, di fuoco e di tuoni, hanno perso le proprie posizioni. Alcuni sono feriti gravemente e li affido alle cure sanitarie, altri mistificano malori che non hanno e ferimenti che invece sono medicabili. Li guardo negli occhi, uno ad uno. Sono stanco e confuso non meno di loro ma non posso né devo mai dimostrarlo. Chiedo ad ognuno il nome ed il reparto di provenienza. Faccio una cernita per tipologia 46 di “personalità”. Divido quelli più timidi ed impauriti dai gradassi ed imprudenti in modo che possa poi assegnare loro un ruolo confacente alla propria indole e soprattutto confacente al momento che stanno vivendo. Tutti sappiamo che per il peggio al momento non c’è fine nonostante si continui a dissimularlo ad ogni livello. Sono trascorsi non più di due mesi e annaspiamo dal primo giorno d’arrivo nel ventre putrefatto della guerra alla ricerca di una via d’uscita che non sia più drammatica di quella presagita. E’ arrivata l’ora di tentare di riportare il culo a casa, ma con onore. Ci seppelliamo ancora in una tana-trincea. Il sottosuolo russo è gelido e pieno di topini un po’ più grandi degli scarafaggi. Viviamo in simbiosi con queste creaturine orripilanti. Mentre mangio se ne ammucchiano a dozzine e dozzine e me le trovo nelle tasche, nel passamontagna ed in ogni piega degli indumenti perché cercano un cantuccio caldo. Per stare al caldo siamo costretti adesso a bruciare il carburante a rischio di farci individuare e finire sotto il tiro dei mortai. Quando non siamo attaccati, e di giorno accade non molto spesso, faccio preparare le armi e studio il nemico per piazzare l’artiglieria. Ma i colpi arrivano da ogni parte. Con l’aiuto dei muli ci arrivano dei pentoloni di zinco, qualcuno li cala nella tana per farci nutrire e resistere ancora. Contengono tutto ciò che si presume potesse bastarci per un giorno: caffè, un cucchiaio di cognac per uno, un po’ di pasta, del brodo di minestra. Ma tutto diventa gelido tanto che siamo costretti a rompere il cibo con le baionette. I pacchi partiti dall’Italia, che le famiglie inviano ai soldati sul Fronte, che contengono spesso indumenti, castagne, fichi secchi, farina e pane si fermano chissà dove. Siamo isolati dal resto del mondo. Nessuno sa più niente di noi, di ciò a cui stiamo andando incontro. Intanto, l’attacco delle truppe siberiane è, in rapporto di uomini, di 1.000 a 30. Allo stato delle cose, ho un soldato ogni 20 metri e per giunta armato soltanto di moschetto. Abbiamo finito la pomata anticongelante per 47 ingrassare gli scarponi ormai ridotti a pezze bagnate. Molti soldati avvolgono ai piedi lacerti di coperta con dentro paglia per evitare l’assideramento e quindi l’amputazione di qualche dita. Indossano i passamontagna e guanti grigioverdi di lana ridotti a stracci. Molti non hanno neanche più i contenitori porta maschera antigas né gli elmetti in quanto se ne sono liberati durante il ripiegamento. Sono dotati soltanto di giberne per le munizioni e di dragona per il fodero della baionetta. Non c’è più una linea continua, compatta. Gran parte della linea è facilmente attraversabile. Dice una canzone russa contadina: “Sièrp i mòlot, smièrt i gòlod” (Falce e martello, morte e fame). Io ripeto in mente, invece: “Sono giovane e son forte, non mi trema in petto il cuore: sorridendo vo alla morte pria di andare al disonor!” Dopo tre giorni di resistenza ha inizio la ritirata vera e propria, sono le cinque e dieci del 20 dicembre. Ricevo l’ordine che all’indomani, il 21 dicembre del 1942, aliquote della Divisione Ravenna e della mia Divisione la Pasubio dovranno aggregarsi al grosso della colonna preceduta dalla 298a Divisione tedesca. Ancora, marciamo difendendoci anche dai partigiani sdraiati con i loro fucili puntati, dietro agli ammassi di pietre di chiese incenerite e dietro alle isba occupate. Vorrei catturarne uno per poter calzare, soltanto per un giorno, i suoi caldi valenchi, ovvero gli stivali di feltro ampi, tipici dei contadini. 48 Distintivo Fronte Russo 49 Parte Prima Capitolo II La ritirata. E così inizia la nostra ritirata sulla direttrice ArbusowkaCercowo. Ma lasciare la linea del Fronte, posta sulla riva ovest del Don, mi comporta qualche perplessità in base al seguente ragionamento: se avessi abbandonato il caposaldo, (il caposaldo va difeso fini alla morte), sarei incorso in gravi conseguenze di natura disciplinare od addirittura penale, mentre se non avessi seguito i reparti in ritirata (un ordine personale in tal senso però non mi è mai pervenuto), sarei venuto meno al più elementare obbligo di obbedienza. Il problema si è risolto da solo quando, prima dell’alba, la nostra artiglieria, ritenendo, esattamente, che nessun reparto italiano fosse rimasto sulla linea del fiume, ha iniziato un intenso fuoco di sbarramento proprio su di noi. Acquisita la certezza di non poter più ritardare la soluzione della questione, ho chiamato il collega Vincenzo D’Argenzio e gli ho consigliato di assaltare gli assedianti che dormivano ancora vicino ai fuochi della notte, mentre noi eravamo all’addiaccio, e di correre poi verso la nostra artiglieria; io con gli altri soldati mi sarei occupato di tenere a bada gli eventuali, assonnati inseguitori. Tutto si è risolto per il meglio con poche perdite, però difficile è stato far cessare il fuoco amico, “alzo zero”, gridando a squarciagola: “Italiani! Italiani!”. Inutile dire che ormai avevamo di fronte le armate siberiane non più impegnate a contrastare i giapponesi, le 50 stesse che nell’inverno del ’43 hanno annientato la VI armata tedesca a Stalingrado. E per essere meno superficiale devo chiarire che l’indimenticabile amico D’Argenzio non voleva lasciare il caposaldo (ormai non più esistente) per il che gli ho dovuto gridare più volte: “Via… vai via; guida i tuoi soldati, ho detto che ti ordino di lasciare la linea immediatamente! Adesso”; sono circa le quattro del mattino. E lui, come intontito dalle cannonate mi dice: “…E tu?”. “Ascolta…” gli ripeto “…io rimango per coprirti le spalle e poi, Dio volendo, ti raggiungerò. Adesso va’..”. Non saprei, oggi, se sono stato l’ultimo a lasciare il Fronte, ma penso di si, perché se qualcuno vi si fosse attardato sarebbe stato spazzato via dai proiettili delle artiglierie italiane e russe. Dopo di me, veramente, l’ultimo è stato il mio cane soldato, Don, che mi ha seguito zigzagando veloce come una lepre, tra gragnole di colpi, ed una volta salvi, ci siamo rifocillati con una scatoletta di carne di manzo divisa a metà in parti uguali. 51 Parte Prima Capitolo III Rientro al Comando Battaglione. Prima di raggiungere il comando, sito in un grosso capannone perché il vecchio rifugio ormai era saltato, ho notato che in una isba a pochi metri dal sentiero, stazionavano una decina di militari; mi sono avvicinato ed ho gridato loro di ritirarsi perché l’ultima resistenza, (la mia) era saltata e che non aveva ormai alcuna protezione; ancora inascoltato mi sono avvicinato di più, tanto da vedere un ufficiale medico che, senza scomporsi, mi ha fatto segno di proseguire, perché lui non avrebbe mai potuto lasciare quei ragazzi, feriti, senza assistenza. Avrei voluto chiedergli chi era, il suo cognome, ma il momento e le circostanze difficili mi hanno consigliato di lasciar perdere. Sono arrivato così dal mio comandante, Maggiore Tedeschi, il quale senza nemmeno farci riposare ci ha spedito per un’altra destinazione così ben descritta nel diario storico della Divisione Pasubio, mi sembra a pag.287, dal seguente contenuto: “…il morale non è per nulla scosso e tutti si augurano di ritornare presto sulle vecchie posizioni come avvenne, nel Natale 1941, nel settore della Celere. Una falla rimasta aperta sul Fronte del II/79 a nord di quota 156,0, viene chiusa immettendo in linea il battaglione ferrovieri: specializzati che sono pronti a battersi come fossero di fanteria. Altre infiltrazioni si verificano fra il limite di settore delle CC.NN. e Monastyrschischina dove i russi affrontano alcune 52 unità di mitraglieri della “Torino”, in afflusso verso le alture sud del bastione di Getreide, che li arrestano. Verso le ore 13,00 il Capitano Fiorini, salito sulla copertura di un ricovero, riferisce che a circa un kilometro, vede una massa di sovietici che stanno avanzando in direzione dei battaglioni tedeschi. Tutto il personale occupa subito le trincee e viene impartito l’ordine solo su comando ma uno dei mitraglieri, purtroppo, apre il fuoco prematuramente per cui i russi, che non si erano accorti della presenza di unità in quel tratto, si ritirano sul pendio verso il paese e, dopo circa mezz’ora, attaccano la 7^ compagnia fucilieri anche da nord, nord-ovest minacciandola di accerchiamento. Nessuno si perde d’animo bensì si entusiasmano tutti. Il Capitano Romagnino al centro, il Capitano Fiorini con i Sotto Tenente Grervisari e Grazioli sulla sinistra ed i Sotto Tenenete Pileri, Sasso, Santagapita e Gambino sulla destra, si prodigano continuamente da un punto all’altro. La spinta nemica è fortissima, ma i difensori continuano a sparare mirando accuratamente per evitare lo spreco di munizioni. Un porta arma del Capitano Fiorini, ferito alla fronte, rifiuta di essere aiutato per non sottrarre un combattente alla difesa e questo episodio s’inquadra in tanti altri che evidenziano quanto sia elevato il morale dei combattenti. Verso le ore 14.30 l’avversario, appostato a circa trecento metri dalle linee avanzate, lancia il solito grido di <Hurrà, hurrà,hurrà!> come se stesse assalendo. Nello stesso momento una quarantina di italiani escono dalle trincee al grido di “Savoia!” trascinando tutti gli altri anche a sinistra. Ma il nemico è troppo lontano e la neve, alta circa venticinque centimetri, affievolisce l’impeto degli assalitori per cui l’episodio si chiude a vuoto”. Dalla vicenda, sempre salvo errore, siamo usciti vivi solo Fiorini, Sasso ed io, ma tutti e tre feriti: Fiorini alla spalla, Sasso 53 alla mano ed io alla gamba destra, solo di striscio; il primo a cadere è stato Pileri; colpito alle gambe, e accanto a me, mentre armi in pugno lanciamo ambedue il nostro “Savoia!” uscendo dalla trincea in risposta all’ “Hurrà!” dei russi. Rientrato poi in Italia ho comunicato alla famiglia Pileri tutto lo svolgimento dei fatti. Senza più munizioni, quelle poche che avevamo trascinato sulla neve legate ad una corda od addirittura alle cinghie dei pantaloni, sono finite e così con i pochi superstiti sono ritornato al comando; inutile descrivere la commozione del nostro Maggiore, che ho in seguito rivisto, per l’ultima volta durante il ripiegamento mentre cercavo invano di forzare la opposizione avversaria messasi di traverso sulla pista. Il mio Maggiore è su di una carretta, forse ammalato o ferito, l’ho avvicinato e mi sono permesso di consigliargli di proseguire a piedi se voleva avere qualche possibilità di salvezza; mi ha ringraziato e poi non l’ho più incontrato, neanche dopo il rientro in Patria. Mi auguro con tutto il cuore che sia rimasto vivo, anche se prigioniero. Il 22 dicembre, ad Arbusowka, la valle battezzata con il nome incoraggiante di “vallone della morte”, affrontiamo un nuovo e massiccio attacco sovietico. Gli sciatori delle Truppe Siberiane fanno incursioni veloci come saette e seminano morte e terrore. Ho paura di perdere il controllo dei miei uomini. Ho ordinato di resistere. L’ordine che abbiamo ricevuto tutti noi è tassativo: “Morire sul posto”. Penso a mio padre, a quando l’allora Primo Ministro Benito Mussolini aveva appena dato ai Carabinieri l’ordine di liberare il Regno dai malfattori a costo della propria vita. E’ una grande confusione: Truppe Siberiane, partigiani e adesso dobbiamo difenderci anche dalla nostra artiglieria che ci spara addosso alla cieca. Siamo circondati. Arrabbiati. Delusi. Io con altri uomini siamo rintanati in una conca e udiamo i colpi dei temibili razzi Katjusa - piazzati a 54 circa sette chilometri dalla nostra postazione - esplodere a vista che espandono nell’aria tumultuosa milioni di schegge di ghiaccio e di fuoco incandescente. Mi hanno detto che questi razzi, così tremendi, hanno preso questo nome da una canzone popolare che narra di una giovinetta che si affligge di malinconia per il suo amore partito per la guerra. Poveretta lei ma poveri anche noi costretti a pensare ad una canzone d’amore che ci giunge con il brivido della morte. Sono giorni cruciali, questi. I caduti non si contano più. Non ci dicono nulla ma so che sono circa 20.000 in due giorni. Mi decido di muovermi dall’appostamento per avere contezza della situazione, nel mentre cerco di proteggere il mio spostamento dalle schegge, mi tuffo sotto un cumulo di caduti, forse tra di loro c’è sicuramente qualcuno che ho conosciuto… Non mi lascio impressionare né impietosire, non posso farlo. Aspetto ancora un poco e poi mi rialzo. Nel mentre, un attacco ravvicinato mi sorprende. Mi trovo esposto da ogni lato, l’unico riparo per la grandinata di schegge è una balka piena di cadaveri e lì ho potuto salvarmi. Abbiamo come ospedale da campo un muro diroccato ed attorno a quel muro, abbiamo sistemato, solo illusoriamente, al riparo le nostre centinaia di feriti, militari di ogni grado, compreso il fior fiore dei nostri comandanti. Ma il muro disastrato non ha protetto i nostri compagni dalle grinfie della morte; un sacco di munizioni lanciatoci dagli aerei tedeschi, appeso ad un paracadute, che non si è aperto, è terribilmente esploso sul nostro improvvisato ospedale; tutt’intorno un vuoto di neve bruciata, ma la cosa più impressionante è stata la caduta dall’alto, ancora per qualche minuto dopo lo scoppio, di un miscuglio di braccia, gambe, cappelli, divise; perfino un mulo ancora legato ad una slitta è venuto dal cielo causando, disgraziatamente, ancora qualche vittima. Poveretto anche il mulo! 55 Ho raccolto tra le macerie un colbacco di pelo che mi ha aiutato non poco a difendermi dal freddo; purtroppo poi l’ho perso nell’ultimo tratto di ritirata, avvenuto in modo straordinario, come racconterò più innanzi. Rottura accerchiamento Arbusowa Solo un evento straordinario avrebbe potuto salvarci senza essere massacrati o catturati; e l’evento si è verificato. Un soldato, che poi si è chiarito essere un carabiniere, è montato in groppa ad un cavallo bianco (il colore lo ricordo benissimo) e, sventolando una bandiera tricolore si è lanciato verso i russi, appostati a qualche centinaio di metri, gridando: “Savoia, avanti Savoia! Viva l’Italia!”. (altri particolari li racconterò meglio più avanti). Non abbiamo potuto permetterci, a questo punto di vedere il nostro eroe sacrificarsi da solo, lo abbiamo seguito e protetto con le nostre armi, gli assedianti si sono ritirati verso al cima dell’altura, la strada per Cerkowo è stata aperta. Tutto ha il sapore di un romanzo, sembrava “Beau geste” uno dei personaggi di Percival Christopher Wren. Ma la straordinarietà di tutti gli eventi è stata un’altra: arrivato a metà costa ho notato uno sgabuzzino, in uso di solito ai contadini per custodire gli attrezzi di lavoro, ho abbattuto la porta di legno marcio con un calcio, e con non poca meraviglia vi ho trovato un militare dai lineamenti mongoli, molto marcati, in procinto di ricaricare una mitragliatrice onde continuare a spararci alla spalle. Gli punto il fucile alla testa proprio in mezzo alla fronte, sono preso da una furia indicibile e gli grido di lasciare l’arma: “Ruki Vverkh! Ruki Vverkh! Ruki Vverkh! Hands up! Mani in alto!”. L’uomo indossa in colbacco di 56 astrakhan ed ha dei bellissimi stivali di foca; quando alle mie spalle è arrivato un collega ufficiale, il russo si è buttato a terra come un sacco di patate camminando carponi come se fosse ferito, fino ai piedi dell’ufficiale italiano sopraggiunto. Chi era costui? Il mio caro commilitone Giuseppe Marcialis del 31° Rgt Ftr, anch’egli venuto in Russia con l’81° Rgt Ftr della Divisione “Torino” cosa che ignoravo, essendo noi due partiti dall’Italia in tempi diversi; qualche secondo per salutarci con un gesto, nemmeno abbiamo potuto stringerci la mano, e poi gli eventi hanno avuto il seguente svolgimento: Marcialis mi guarda, anzi mi invoca con gli occhi, senza fiatare, come se tentasse di scacciare via dai miei occhi quel demone che sembra essersi impossessato delle mie facoltà. Allontano con violenza, dal soldato, la mitragliatrice e tento di smontare l’otturatore mentre Marcialis lo tiene sotto tiro. L’arma è malandata e non avrebbe mai sparato. Un vero rottame. Forse il mongolo stava tentando di aggiustarla ecco perché non aveva sparato al nostro sopraggiungere. Mi placo. Lo guardo e scaravento quel ferro vecchio alle mie spalle. Mi avvicino e gli porgo una mano per aiutarlo a rialzarsi sempre con l’arma puntata. E’ davvero ferito a una spalla e trema. Ha avuto paura ma adesso sogghigna e mi dice ripetutamente “Druh… druh… druh…” (Grazie… grazie… grazie…). Fa per alzarsi e mette una mano sulla propria gamba per aiutarsi e nel mentre lo fa, dal fianco si scorge il calcio di una Luger tedesca che sporge dalla giubba impiumata. Alla vista dell’arma un giovanissimo ufficiale, che non ho mai visto e che forse si è unito a noi per proteggere il carabiniere a cavallo, preso dall’isteria della paura gli spara due colpi alla nuca con la sua Beretta. Io e Marcialis non abbiamo il tempo di renderci conto di nulla. Restiamo come sconcertati, esangui, nel mentre il giovane e sprovveduto ufficiale cade in un pianto dirotto. Non l’ho rivisto mai più. Spero che abbia potuto riconciliarsi con la propria coscienza. 57 Appena ho incontrato Marcialis, una ventina di anni fa, a Sala Consilina, la prima cosa che mi ha detto è stato proprio questo: “Ricordi ancora quel mascalzone cosa ha fatto?”. E’ il momento dei saluti e il caro Marcialis si è premurato, vedendomi camminare a fatica, di raccomandarmi di andare al più presto in ospedale. La ferita si è poi rimarginata da sola. Ritrovo Vincenzo e con il manipolo di soldati ci organizziamo per raggiungere la Compagnia all’indomani. Ormai tutto è evidente, porca la miseria! Siamo vicini all’annientamento totale. Il nemico brucia le nostre bandiere e quelle di altri Reggimenti. Io, D’Argenzio insieme a pochi soldati resistiamo con accanimento, sembriamo dei forsennati. Abbiamo perso qualsiasi facoltà di discernimento. Non so se ad agire è lo smarrimento o l’istinto di sopravvivenza. O sono due termini della medesima sostanza? Se dovessi affermare che avevo paura di morire posso serenamente dichiarare che a morire non ci pensavo proprio. Penso invece a quel povero mongolo e anche al giovane ufficiale che porterà per tutta la vita il peso di quella cruda uccisione. Penso a Marcialis che spero ancora di incontrare. Sono ore che resistiamo, non abbiamo neanche il tempo per guardarci in faccia. Mastichiamo qualche galletta in silenzio, ruminiamo accovacciati come antilopi della steppa e spariamo appena è visibile un macchia scura nella foschia. Il vento ci ha gelato il naso e le labbra sono spaccate e sanguinanti. Bruciano da morire. Siamo assediati da molte ore. Piovono granate a dirotto. La gamba scotta. Facciamo il brindisi di Natale con la neve sciolta e poi impartisco ai miei un nuovo ordine per sottrarci da quello stillicidio che si trasforma, minuto dopo minuto, in morte certa. Dico di dividersi in gruppi di due e di rincontrarci giù nella valle di Tcertkowo appena la nebbia si abbassa ancora e la tempesta prende a soffiar più forte. Con un’azione a sorpresa io con i miei uomini riusciamo a bucare l’accerchiamento favoriti 58 appunto dalla nebbia che adesso sfiora il suolo imbiancato e dalla tempesta che ci rende totalmente invisibili. Stanchi ma soddisfatti e quasi felici siamo in viaggio verso Tcertkowo come stabilito, a sud-ovest. E’ il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre del 1942, ancora combattiamo ma siamo davvero felici. Tanto felici. Ebbri. Appena giunti ci uniamo alla Colonna che stava riposandosi e rifocillandosi nella rada nei pressi del villaggio. Mi presento al mio Comandante e faccio rapporto. Mi da una pacca sulla spalla e dice. “Bravi i miei magnifici sette! Ma bisogna tenere ancora duro, Tenente Gambino…”. A tarda sera la colonna è nuovamente circondata ma da truppe motorizzate che, passate attraverso una delle brecce create nel Fronte, imperversano nelle nostre retrovie creando non poche difficoltà ed altri caduti. Ci viene impartita ufficialmente la ritirata, o meglio il “Si salvi chi può”, ma con “dignità”. E’ l’una. Una dignità che valse la scomparsa di 80.000 Italiani tra caduti e prigionieri. Altro che “mangiapatate”, i Russi sono dei bravi combattenti. La Colonna si sbriciola. Sembriamo tanti sbandati anzi, lo siamo. Lo sono anche i nostri fedeli muli che si ostinano a seguire l’uno o l’altro conducente. Io e i miei uomini infiliamo nelle tasche della giubba un pezzo di pane nero. Do ordine di bruciare qualsiasi cosa potesse essere utile al nemico e di camminare sparpagliati ma sempre a vista. Raggiungiamo a piedi, ed alcuni bestemmiando, una località in collina, attraverso una piccola foresta. C’è un’isba, una casa agricola cosacca. Dall’altura vedo serpentoni d’uomini che, in fuga come noi, cercano la salvezza. Vola un aereo a bassa quota e li dissolve come polvere. La nostra isba è riparata da una macchia di betulle, aceri e querce, grazie a Dio. Il velivolo militare non ci avvista e, con una manovra, scompare in alto tra la foschia densa come panna. L’isba sembra abitata. Busso alla porta. Non siamo gli unici a presentarci in questo modo 59 in casa del “nemico”. Ma il nemico è gente ospitale, semplice, laboriosa. La Russia è stato da sempre un paese di grandi popoli e di prodi guerrieri è stata la terra dei Sarmati, degli Sciti, dei Peceneghi, dei Tartari di Kublai, degli Strelizi di Ivan il Terribile, dei Cosacchi di Pietro il Grande ed anche piazza di coraggiose quanto sanguinose rivoluzioni civili. Nell’immediato retrofronte le truppe vivono nelle isbe e coabitano con la popolazione civile. Su qualche muro c’è ancora un vecchio volantino lanciato da caccia russi che dice: “Pieriehodìte s étim pròpuskom cifre front… etc…” (“Passate con questo pezzo di carta attraverso il Fronte… vi garantiamo la vita, un buon trattamento e il ritorno in patria dopo la guerra”). Rimango ancora una volta basito. Non so darmi alcuna spiegazione di ciò che leggo. Le isbe hanno tetti vegetali e pareti di fango, le finestre e la porta di betulla. Mi apre una babuska, una simpatica vecchietta con l’aria mite ed incappucciata da cima a fondo. Entro per prima e dico “Privet…”, “Salve…” e con molta diffidenza lancio uno sguardo circospetto nel mentre i miei uomini spiano dall’esterno attraverso le fessure degli scuri delle finestre. Faccio un passo avanti. Mi trovo in un unico grande ambiente dall’odore di legna bruciata, pervaso da un tepore che è sprigionato dalla grande stufa posta al centro di esso. Il pavimento di legno scricchiola al passo dei miei stivali inzuppati. Intorno alla stufa, un’intera famiglia - una coppia anziana, una signora ed un bambino – e due soldati italiani che al mio incedere scattano, si fa per dire, sull’attenti. Sono malmessi. Tra di essi due ufficiali della Divisione Cane, la mia stessa Divisione: e così ritrovo ancora D’Argenzio e Sasso che curano altri tre militi feriti. Vado verso di loro e li saluto. Mi rispondono con un cenno sfuggente seppur cortese, senza guardarmi. L’atmosfera, in apparenza cordiale è molto tesa. Mi avvicino ai feriti per vedere se ne conosco qualcuno ed in quali condizioni versano. Hanno gli occhi bendati. Sono della 60 “Celere”. Do ordine ai miei di entrare. Nel mentre i soldati entrano io esco un attimo fuori e sospiro. Il vento punge il mio viso come se fosse fatto di migliaia di aghi cocenti. In profondità c’è un kolkos, significa che in quel luogo c’è ancora vita. Il kolkos è una fabbrica. Sulla costruzione fatta di mattoni impastati con argilla, paglia e sterco e pitturati con la calce, si staglia una gigantesca stella rossa con falce e martello ed il verso di quella canzone: ”sièrp i mòlot, smièrt i gòlod” (falce e martello, morte e fame). Intorno al kolkos alcuni pruni selvatici dai quali, probabilmente, i contadini ricavano quell’ottimo liquore. Mi rilasso. Poi rientro. Una bella donna dai caratteri somatici del volto molto forti mi viene incontro. Ha degli occhi azzurri, sgargianti, gioiosi. Porta annodato sulla nuca uno scialle nero con fiori gialli. Senza parlare mi trascina prendendomi per mano vicino alla stufa e fa cenno di togliermi gli stivali. Cosa che faccio subito. Poi, mi porge un pizzico di maquorka (tabacco). E’ come se mi avesse letto nel pensiero. Una grande boccata di fumo mi avrebbe del tutto estraniato dalla guerra che fuori continuava a mietere i suoi semi umani, corpi dilaniati e congelati, senza che alcuno più si avvilisse. La morte è parte della nostra grande famiglia, più della vita che fatichiamo per tenerla vegeta. Un vecchietto barbuto dalla voce possente e gli stivaloni tiene in braccio un piccino e tenta di infilargli un basco di lana grezza. Non mi guarda ma mi porge la sua pipa accesa che sfumica più della stufa. Gli porgo la mano e dico: “Grazie…”. So che capisce la mia lingua. Il vecchio annuisce. “Stasera ho conosciuto davvero Babbo Natale” dico tra me, “… non si sa mai..” Ai piedi dello stufone, un paio di pani di torba che attendono di essere bruciati. Alle spalle, un rialzo di legno sul quale giacciono stuoie di lana morbida di svariati colori. Sono i letti. Su una di esse due soldati feriti vi sonnecchiano. Sembrano sbronzi. Muovono le labbra e le smorfiano senza parlare. Uno dei miei soldati mi chiede se c’è tra di noi 61 qualcuno che ha ancora del sale, del pane (klieba) o del miglio. Capisco dallo sguardo che è stato “Babbo Natale” a indirizzarlo da me. Tiro fuori il mio pane nero ed un po’ di cognac. E’ tutto quello che ho. Sono ancora in piedi. Mi siedo dinanzi alla stufa e vi resto senza parlare. Sono come assente, svuotato. Odo i feriti lamentarsi ed in quel momento se potessi, porterei loro un medico od almeno un infermiere pur di vedere alleviate le loro sofferenze. Al sopraggiungere del crepuscolo mi alzo. La donna dagli occhi azzurri fissa me ed un mio soldato. All’improvviso degli scoppi ci scuotono. Poi avvertiamo dei bagliori. Spio dagli scuri della finestra. Sono pallottole traccianti di carri blindati. E’ l’Amata Rossa che passa al setaccio tutto il territorio. So che tra un paio di giorni questo posto non sarà più sicuro, soprattutto per noi. La notte scende e ci avvolge come un manto fatato. I miei uomini hanno mangiato patate bollenti servite dalla bella zinca, la bella signora dagli occhi marini. Io non ho fame, ho lo stomaco chiuso ed ho timore di un assalto nemico. Sposto la sedia massiccia vicino alla finestra. Prendo il fucile e lo metto con il calcio a terra, tra le mie gambe. Appoggio una mano sulla canna e sulla mano vi sostengo il mento. La mia ferita è rimarginata ma ancora pulsa. Mi duole. La donna mi porta una coperta sbrindellata e la pone sulle mie spalle. Un gesto d’amore. Tutto tace. All’alba mi trovo con la fronte gelata vicino alla finestra ed il fucile con la canna puntata in petto. Ancora dormono tutti. Qualche ferito si lamenta: “Casa mia… acqua… voglio andare a casa…”. Altri proiettili traccianti annunciano il giorno ma lo scoppio adesso è ravvicinato. Sveglio tutti. Grido ai miei di prepararsi a partire e subito. La famigliola, la bella zinca la babuska e Babbo Natale saltano dalle stuoie. La zinca mette un recipiente di metallo sulla stufa per la Tiòplaia vodà, (l’acqua calda). Mi avvicino alle spalle di Sasso e di D’Argenzio e di un cappellano che nella notte si era unito a noi, che forse non si sono mai addormentati. 62 Sono vicini ad uno dei feriti. E’ un ragazzo e sembra non farcela. Rinnovo il mio invito a lasciare l’isba ma non mi danno retta. Lo prego: “Cappellano, Cappellano…”. Rimangono di spalle. Non si scompongono. Solo il cappellano mi dice: “Tenente, faccia ciò che ritiene più giusto… è quello che stiamo facendo anche noi…, porti in salvo questi ragazzi…”. Abbandono la casa ed il mio ultimo sguardo é prima per il ragazzo in agonia e poi per la donna amorevole. Quel Cappellano credevo che fosse don Enelio, don Enelio Franzoni. Ho saputo più tardi che don Enelio e un ufficiale medico erano invece già stati catturati e trasferiti al lager di Tambow. Dopo la guerra don Enelio mi ha raccontato le turpitudini dei quattro lager nei quali era stato deportato in tre anni. Si è ricordato di quell’episodio ma mi ha anche confermato che i Russi quella mattina non arrivarono all’isba e che sulla data mi ero sbagliato perché era stato fatto prigioniero ad Ogalew il 16 dicembre nel mentre celebrava e quell’episodio dell’isba forse risaliva all’11 dicembre ad Ogalew. Purtroppo ho tutto nella mente, oggi ho circa 90 anni e mi sono sempre rifiutato di scrivere di queste cose per evitare una certa confusione fra date e località. Chiedo scusa! Con don Enelio Franzoni ci siamo visti per alcuni anni alla terza domenica di settembre a Cargnacco, ed un giorno di febbraio presso il cimitero monumentale di Milano. Sono andato, con altri reduci, suo ospite a Bologna quando lì era parroco. Mi ha raccontato che la chiesa di San Lorenzo in Torino, tutte le sere, suona le campane a morto, con dodici rintocchi, a ricordo delle 12 Divisioni distrutte nella campagna di Russia. Rammento ancora il giorno in cui con don Enelio e con il presidente dell’U.N.I.R.R. Melchiorre Piazza, siamo stati al cimitero di Novara per l’inaugurazione delle dodici colonne 63 erette a ricordo del sacrificio delle nostre dodici Divisioni dell’A.R.M.I.R.. Il nostro amato Presidente in quella occasione ha reclamato, senza mezzi termini, perché erano state dimenticate le colonne per ricordare i caduti delle camicie nere; sarei curioso di sapere se gli amministratori di Novara hanno poi rimediato all’errore (!). Certo è, però, che quel 22 dicembre ad Arbusow il Carabiniere a cavallo che ci trascinò all’attacco e poi su per l’altura era il valoroso Giuseppe Plado Mosca e molto probabilmente il miraggio del cavallo senza cavaliere non era un miraggio. Ora che metto bene a fuoco ricordo anche un altro episodio avvenuto in un’isba: aspettavamo che si aprisse un varco per avere via libera; era la notte dell’uscita da Cerkowo. Non ricordo il giorno. D’Argenzio mi chiede di ritornare all’isba per riscaldarci ancora. Il suo pensiero fisso era la stufa. Lo metto in guardia del pericolo, pure se non ce n’è bisogno e gli dico che se fossimo ritornati indietro ci avrebbero presi. Glielo raccomandai più volte. Non mi ascoltò, cocciuto come era. Io continuai la marcia con i pochi ragazzi che erano restati con me. La paura che fosse fatto prigioniero si avverò, purtroppo. Nel mentre eravamo ad una certa distanza ho visto dei lampi verso l’isba. E poi il fumo, tanto fumo. Scontò tre-quattro anni di prigionia. A guerra finita, nel ‘50, D’Argenzio, con mia somma gioia si rifece vivo e rintracciandomi mi comunicò di avermi spedito del vino pugliese, della sua terra, per bere alla sua salute e brindare alle nostre vicissitudini. Ma, in verità, quel vino non l’ho mai ricevuto... Probabilmente si era fermato nelle mani di qualche corriere avvinazzato. Ho, poi, ancora rivisto D’Argenzio ed ogni qualvolta, non credendo di non aver mai ricevuto quel vino, mi ha sempre rinfacciato d’averlo fatto dormire, in guerra, sempre a terra nel mentre io dormivo sulle calde stuoia dai colori accesi. Era un 64 65 modo tutto mio per tenere la disciplina nei reparti ormai disorientati ed in continua tensione. In una di quelle isbe dove abbiamo trascorsi molti giorni, la figlia di un padrone di casa si era innamorata perdutamente del mio sergente maggiore. Ricordo il viso delicato di quella ragazza che mi implorava di non partire o meglio di non partire portando con me il suo amato. Era più che evidente che tra i due ci fosse del tenero. Eravamo fuggiaschi, non accontentai i due colombelli, anche se la ragazza asseriva che non saremmo andati se non incontro ad una fine certa. Quel sergente maggiore non l’ho mai più rivisto né ho avuto sue notizie. Sarà stato, forse, uno di quella lunga lista di “dispersi” che si sono fatti una famiglia in terra sovietica. Un’isba bianca tra i girasoli con tanti piccoli cosacchi. E’ questo che mi piace pensare. Oppure dare corpo alla verità: non potevo rendermi complice della sua diserzione. Non potevo infliggere ad un mio uomo una condanna come la pena di morte prevista per tale viltà. Il sergente maggiore mi ha seguito rispettando gli ordini e dopo un giorno ho perso le sue tracce... Ricordo adesso che Sasso, il giovane ufficiale di Trieste, era con noi in quell’isba ed era gravemente ferito: aveva una mano e tutti e due i piedi incancreniti. Lo avevo affidato alle cure del padrone di casa che gli salvò quella mano ormai putrescente, con continui impacchi di miele, ma non lo salvò dalla amputazione di parte dei due piedi. Maledetta Steppa! Uscito da Cerkowo continuo la marcia verso Ovest. Una pista battuta dove avanziamo ancora tra due fronti nemici. Fischiano pallottole da destra e sinistra. Scorgo tra la neve un uomo con le gambe tranciate. E’ un sergente molto giovane. Mi chiama… Poi, mi implora di finirlo. Ha le gambe maciullate, forse è stato un cingolato. Non ce la faccio a sentirlo gridare, pregare, imprecare, vederlo soffrire come un cane. Estraggo l’arma, gliela punto alla tempia senza contatto. Lo guardo 66 negli occhi. Esito. Ripongo l’arma nella fondina e mi siedo nella neve con un tonfo, vicino a lui. Tento di tenerlo in vita. Gli parlo. Parlo dell’Italia, del sole, del mare… della sua casa… Odo il rumore di un motore. Glielo riferisco con entusiasmo. Mi sorride. Il suo sguardo ancora oggi scava il mio cuore sino a farlo sanguinare. Non posso restare più in questo posto. Voi cosa avreste fatto? Io ancora non lo so per quale scelta avrei potuto optare: Finirlo? Abbandonarlo? Scappare? Desideravo che vivesse ma non era possibile. Il sangue sgorga dai monconi come una fontana. Scava la neve formando una pozza sempre più profonda dai colori mutevoli, porpora, scarlatto, rosa… Prego Iddio affinché lo tolga dalle mie mani per prenderlo tra le sue. “Io non sono un boia!” Gli grido senza voce. Come se mi avesse ascoltato Dio lo sottrae al mio sguardo e quando abbasso gli occhi sul Sergente vedo il suo volto ricoperto di neve. Ha gli occhi chiusi e dalla bocca aperta schiuma gelo di morte. Mi segno con la Croce, copro il corpo con il suo cappotto ed il viso con l‘elmetto. Sono scosso. Confuso, umiliato, perso. C’è intorno a me una confusione enorme, grida, bestemmie, invocazioni, pianti. Non so se sono nella mia testa o fuori da essa. All’improvviso compare un giovanissimo soldato. Biondo, capelli rasati ben pettinati, una divisa linda e pinta, scarpe ben lucidate, camicia e cravatta in ordine. Non una sgualcitura. E’ vestito come se venisse da una festa o vi si dovesse recare. Di tutto punto. Avanza silenziosamente verso di me. Vedo quell’immagine e sento lo zigolare della neve sotto i suoi passi leggeri. Io sono seduto a gambe aperte vicino al mio Sergente. Il soldato biondo mi parla. Parla italiano. Mi dice di prendere dal suo tascapane qualche scatoletta, delle gallette. Ce l’ha a tracolla. Non rispondo. Non gli dico né si né no. Allora toglie il tascapane e me lo porge. Eseguo i suoi ordini in silenzio. Lo fisso. Estraggo il cibo. Gli porgo il tascapane ma non c’è nessuno. Non è un sogno. Ci sono ancora le orme fresche sulla neve e tra le mani 67 68 69 ho il suo tascapane che, per giunta, è come nuovo d zecca. Me lo infilo a tracolla e continuo la mia strada. Adesso sono solo. I ragazzi hanno continuato la loro strada. Glielo ho ordinato io. Il cibo del tascapane mi consente di recuperare un po’ di energie e per tre giorni non ho patito la fame. Ma chi è? Chi era? Ancora me lo chiedo... Era impossibile per un soldato, pure se fosse stato tenuto interamente in naftalina, avere la divisa e gli stivali così in ordine. Senza alcun segno di sporco, di sgualcitura, di bagnato. Eppure non ho mangiato sogni in quei tre giorni, ma carne e gallette. Ho sempre creduto ad un angelo custode, non so voi. Al vostro posto comincerei a pensarci. Sono in perfetta salute mentale ed anche fisica. Dopo una decina di giorni da quell’evento mi imbatto in un gruppo di partigiani. Sono in cinque, forse sei. Non so cosa fare. Arriva alle mie spalle un Seniore della Milizia che indossa un berretto alpino con lo stemma della “Tagliamento” e mi indica un parabellum tra la neve dietro di me, lo prendo. E’ carico. E mi metto a sparare con una precisione ed una inflessibilità disarmante che mettono in fuga quei malcapitati. Sono in ginocchio per mirare meglio. Mi alzo, mi giro. Sono solo. Ci credete, allora, agli angeli custodi? Io sì, perché non riuscirò mai a capire come il mio salvatore sia potuto scomparire in pochi secondi nella steppa con un orizzonte visivo libero per centinaia di metri. Voi siete liberi, liberi di non crederci. Di recente, e precisamente il 31.12.2010, la trasmissione di Rai Uno, Superquark, ha raccontato una delle più incredibili imprese delle esplorazioni: quella di Ernest Henry Shackleton (lo stesso dal quale prende il titolo la bellissima canzone di Franco Battiato) che nel 1914 ha fatto la prima traversata a piedi dell’Antartide. Il diario dell’esploratore ed i racconti dei suoi due compagni (Tom Crean e Frank Worsley), hanno riferito che nell’ultimo 70 tratto di strada, per raggiungere il porto delle navi baleniere (di Stromness, in Georgia), hanno viaggiato guidati da un quarto uomo, uno sconosciuto, poi scomparso, prima dell’arrivo. Nessuno dei tre ha saputo definirne la provenienza, come io, a distanza di sessantasette anni, non mi sono ancora capacitato della identità dei due miei benefattori prima segnalati. Gennaio del ’43. Il mio fermo desiderio è quello di non alzare mai le mani in segno di resa, “Piuttosto la morte”, continuo a ripetere tra me. Da casa mi dividono ancora 3000 chilometri. Ogni giorno è un giorno da vivere anzi da sopravvivere. Sono solo ma so che non lontano ci sono residui di truppa in movimento verso la salvezza. I Reparti, ormai, separati costituiscono un’armata di profughi e cadaveri. Siamo armati soltanto della volontà di voler rivedere i nostri affetti e trasciniamo la nostra anima, ghiaccia come i nostri arti, con la forza della disperazione. Mentre sono preso dai miei pensieri, atterra una Cicogna (aereo tedesco) che è venuta a prelevare un generale tedesco ferito. Il pilota scende. Gli vado incontro e gli chiedo se posso affidargli una lettera da spedire, appena possibile. Aspetta che io la scrivo. Intanto, controlla il suo aereo che fa fumo. “Cosa non va?” Gli chiedo. Mi risponde che è tutto a posto e che il nemico non vuole proprio mollarci. Gli consegno la lettera ed una scatoletta. L’ultima. Dopo qualche ora incontro parte della mia piccola brigata. Intanto la Cicogna è decollata mantenendosi a bassa quota. Alzo gli occhi. Nel cielo latteo sopraggiungono, come partoriti dalla foschia, tre aerei russi. Sventagliano raffiche di mitragliatrice ai nostri piedi. Dalla macchia, laterale alla pista, vengono fuori altri militi che vi hanno trovato rifugio e si uniscono a noi che, correndo, ci ripariamo in un capanno quasi sovraccaricato dalla neve. Ancora urla. Tronche. Senza eco. Urla che cadono taciute nella neve. Poi una voce nitida: “Signor Tenente…! Tenente Marcialis!” Un disperato soldato 71 cerca il “suo” Tenente. E’ il mio amico Marcialis. Da lontano noto un cumulo, un uomo semicoperto con fasci di grano ai piedi ed una mezza coperta addosso che quasi carponi tenta di raggiungerci. “Marcialis è vivo! E’ vivo!” Grido con tutto il fiato che ho in corpo. Gli corro incontro sotto la pioggia di piombo. Non me ne importa di niente. Marcialis deve vivere. Raggiungo il ragazzo che adesso sorregge Marcialis ed insieme lo portiamo in salvo reggendolo per le braccia. Il capanno si è sfondato e proseguiamo attraverso la macchia a piede lento. Per lunghi ed interminabili chilometri trasciniamo il buon Marcialis che è mezzo assiderato. Mi implora di lasciarlo dove siamo, comprendendo il nostro sforzo immane. Ma io gli grido di andare a farsi fottere. Vuole che ci salviamo, ma a cosa sarebbe valsa la nostra vita se l’avessimo lasciato crepare? Dopo un giorno di stenti finalmente troviamo un varco. Nella linea italo-tedesca, che è al di là del varco, scorgo dei mezzi. In realtà un reparto corazzato tedesco ci è venuto incontro ed ha aperto un varco per farci defluire verso Starobek (?). Alcuni automezzi del nostro esercito hanno accolto i molto feriti, mentre noi altri, giustamente, ancora in piedi, siamo stati esclusi dalla salvezza. Dopo avere sistemato il mio amico Marcialis mi sono allontanato per cercare un riparo per la notte. I mezzi sembrano in buono stato. Dico al resto di attendermi. Mi aggiro come un cane digiuno tra quei miseri resti. Mi inoltro nella linea. Vedo una dacia. La raggiungo. Sfondo la porta. E’ abbandonata. Forse ci vive un medico o uno studente di medicina a giudicare dai grossi volumi con le copertine di carta pecora bianca che trattano di scienza. Preparo nella dacia un rogo con quei volumi che adesso servono, più di quanto avrebbe potuto immaginare il vero proprietario, a salvare qualcuno. Accendo il piccolo rogo per far riprendere, con il calore, il mio fisico stremato. Sul tavolame del pavimento c’è un passaggio, una 72 botola, che porta ad un piccolo antro. E’ gelido. Spero e prego che non sia abitata da qualche profugo o dai proprietari perché li avrei trovati sicuramente rinsecchiti. Faccio una fiaccola ed illumino l’antro. E’ deserto. Scendo giù per la scaletta. Ci sono alcune patate quasi marce. Le arrostisco sulla fiamma. Mi rifocillo, dormo per tutta la notte. Esco poi dalla casa e mi dirigo ad ovest, ormai sono solo. Più che solo sino a quando, dopo un paio di giorni, incontro i reparti russi, le avanguardie, che lavorano attorno ai loro automezzi piuttosto malconci. Io, anziché scappare, mi insinuo tra di loro. La mia divisa è a brandelli, irriconoscibile. Ho strappato mostrine e gradi. Porto il colbacco russo sopra il passamontagna e per questo non possono vedere i miei lineamenti italiani. Gironzolo con un fare idiota. Da scemo del villaggio. Gli ironici russi mi scambiano per un suonato cencioso e mi danno del pane ed una scatoletta di carne, poi mi scacciano via come un lebbroso gridando, prendendomi in giro. Mi unisco al gruppo con quel poco di viveri. Continuo la marcia seguendo le indicazioni militari, verso Ovest. Non incontro nessuno sino a quando, per mia buona sorte, vedo un camion tedesco. Ci sono dei soldati che armeggiano vicino al motore. Mi avvicino agli Alleati e chiedo un passaggio specificando le mie credenziali. I Camerati me lo concedono. Ho le orecchie tanto gelide da aver paura di toccarmele, sembrano sbriciolarsi come sottilissime lastre di ghiaccio. Mi sdraio finalmente su un parafango, perché l’automezzo è strapieno mentre altri prendono posto dietro, appesi al cassone con i piedi sulla predella. Raggiungiamo le linee tedesche. La salvezza, ci appare ora come un sogno immacolato più del bianco di quella neve ed i nostri occhi vedono oltre. Vedono finalmente casa. Volete sapere di “Don”? “Don” è scappato. E’ voluto restare a casa sua. Lo immagino tra le braccia di quella zinca dagli occhi azzurri coccolato dal calore del suo cuore. Mi spiace soltanto di non riuscire a ricordare quando 73 esattamente e dove l’ho perso. Alle 20,00 del 2 gennaio 1943, della colonna partita Makarow vi transitarono solo 10 ufficiali, 125 soldati, da un autocarro ed un cannone da 75 mm. Buona parte dei superstiti poté riunirsi a Werowka. A Gomel, tappa finale per la salvezza, arrivarono solo 1.500 uomini della mia Pasubio, che a pieni organici ne contava circa 12.000, perché altri suoi elementi, assieme a reparti delle Divisioni Ravenna e Cosseria accerchiati in Tcertkowo non erano riusciti a sganciarsi. L’armata del Don è ricordata come l’Armata Scomparsa. I miei “compagni di guerra” sono stati fatti prigionieri e molti, deportati nelle carceri russe. Pochi, sono i sopravvissuti. “L’Armata Italiana, composta da 200.000 uomini di età media di poco superiore a vent’anni, trasportati su circa 700 treni è ritornata a casa con meno di 17 …” (da “L’armata scomparsa” di Arrigo Petacco edito da Mondadori). Io, sono rientrato a Brescia con un treno ospedale e subito ricoverato all’ospedale militare. Dopo qualche mese ero di stanza nella zona Bosco bonito di Villa Literno (Ce) al comando di un plotone fucilieri, chiamatovi dal colonnello Mazzocchi, comandante in guerra del 79° Rgt Ftr, e mio difensore, quando qualche mia intemperanza, bellica, ha scatenato la reazione dell’artiglieria nemica: una volta l’intero II Btg è rimasto senza rancio per due giorni perché le cucine e le vettovaglie erano saltate in aria. Ho ricevuto, dai miei stessi commilitoni, più di una stramaledizione, perché tutto era successo dal fatto che io avevo portato fino alle trincee i militari, nuovi arrivati, per la via più breve, ma più esposta, e non per quella più lunga ma più sicura. Comunque non abbiamo subito perdite umane, ma solo le attrezzature di cucina e le pentole. La descrizione delle sofferenze, dei dolori, dei lutti di una 74 guerra, ci fa augurare che mai i nostri figli, né quelli degli altri, amici o nemici, abbiano da viverne un’altra. Però la guerra, per amore di verità, non è solo abbrutimento, violenza, imbarbarimento fisico e morale, ma può anche donare una dose di buoni sentimenti a chi non li ha, o migliorare quelli che innegabilmente, ognuno di noi già possiede. Le poesie del professor Marcialis, già tenente, un valoroso soldato ed ufficiale, invocano dal Signore dei Cieli una sola grazia: “Mai più sia strage, mai più sia guerra Ti prega e invoca ogni anima pia e Tu o buon Dio, dì < Così sia!>” (dalla poesia “Arbusow”), oppure “Da quelle zolle, da quei silenzi eterni ancora ieri squarciati dalla guerra, al cielo sale un canto di perdono. Pace fratelli, al mondo, pace, pace. La quiete avrà chi in quella terra giace” (dalla poesia “Cerkowo”). Poesie tratte dall’antologia “Luci” di Giuseppe Marcialis, edizione Libroitaliano, 1996. All’inizio di febbraio 2011 mi è stata segnalata altresì un’altra poesia che aggiungo alle due prima citate, delicata e commovente al punto da far venire le lacrime a qualsiasi lettore: C’è qualcosa di molto peggiore della morte. Ed è il dubbio. Io resto qui. Addio. Stanotte mi coprirò di neve. E voi che ritornate a casa pensate qualche volta a questo cielo di Cerkovo. Io resto qui con altri amici in questa terra. E voi che ritornate a casa sappiate che anche qui, dove riposo, in questo campo vicino al bosco di betulle, verrà primavera. (Giuliano Penco, 1943 - letteredon.wordpress.com) 75 76 Chi me l’ha regalata? Il nipote del Sergente Maggiore Stefano Porino, della Divisione Torino, la stessa di Marcialis, disperso sul Fronte Russo il 17 gennaio 1943; è riuscito a localizzarmi tramite internet, è venuto a trovarmi, ha citato, dati, nominativi, e accadimenti con una precisione impressionante. Il suo nome è Andrea Bertola, ma la cosa che più mi ha sorpreso è la constatazione che tanti altri giovani sono appassionati, quanto lui, a conoscere le vicende vissute dai genitori, dai nonni, dagli zii tanti anni fa. La passione che mette nella ricerca è la dimostrazione evidente che l’amore per la Patria (e per la verità) può essere nel nostro Dna più di quanto a volte immaginiamo. E poi, lontano da casa viene acquisita una serie di sentimenti prima sconosciuti, la nostalgia della Patria e delle famiglie lontane, la solidarietà verso quanti hanno condiviso pericoli e disagi non lievi, in definitiva si diventa diversi da come si era tra i banchi di scuola o nel lavoro dei campi o in altre attività. La conferma di quanto detto, qui di seguito cerco ancora di dimostrare: La nostalgia: è quasi un dolce malanno, un’ansia che ti prende se per qualche giorno non arriva la posta, la lettera dei genitori, della fidanzata, degli amici; la chiamata della posta è più importante dell’arrivo del rancio, bisogna aver osservato la delusione e la sofferenza di quanti non hanno ricevuto notizie dall’Italia. Tale sofferenza la pativo anch’io, più che per me, per i miei analfabeti dai quali ero stato eletto scrivano, come ho spiegato più addietro. La solidarietà o ancora meglio la fratellanza: ogni qualvolta ho dovuto scegliere un soccorritore per riportare nella nostra trincea un ferito, ho vissuto sempre, con angoscia, il dubbio 77 della scelta; perché tutti si sono offerti, con decisione, volontari e gli esclusi hanno vissuto l’esclusione quasi come un’offesa, pur consci che il soccorso, più di una volta, si è risolto tragicamente per il soccorritore e per il soccorso. Anche io ho goduto abbondantemente di ogni specie di solidarietà ogni qualvolta sono stato comandato per il servizio di ispezione alla linea, con tratti coperti ed altri scoperti, per la gioia dei cecchini sempre pronti a fulminarti; ho dovuto a volte impormi per andare io avanti onde evitare che il portaordini di turno con un guizzo cercasse di sopravanzarmi, al fine di attirare su di sé le prime reazioni dei fucilieri avversari. Il carattere: al ritorno dalla guerra non sei più lo stesso individuo, sei più sicuro di te, il che non è poco, e se sei stato al comando di qualche unità, hai imparato ad essere padre, fratello, confessore, infermiere, scribacchino-segretario, consolatore di quanti, pochi o molti, l’esercito aveva affidato alla tue cure. Desidero ricordare, anche se fuori tema, che anni fa in Merano, sulla ringhiera del fiume Passirio, fra tanti lucchetti lì lasciati legati dai congedati, ne ho trovato uno con accluso questo biglietto “Siamo qui arrivati giovani dodici mesi fa, ora partiamo uomini perché siamo fieri di essere alpini”; non nego di essermi commosso, ed anche questo episodio è rivelatore di un carattere che prima non avrei forse avuto. Ed inoltre un episodio occorsomi nel settembre del 1943, a conferma di quanto prima detto, vi racconto: andavo con il marito di una mia cugina da Torre Annunziata a Boscotrecase, camminando sulla massicciata della ferrovia circumvesuviana perché le strade normali erano assolutamente impraticabili a causa dei bombardamenti subiti, quando nei pressi del cimitero di Torre Annunziata ho notato un rapinatore che 78 depredava tranquillamente passanti con la minaccia di una pistola. Visto quanto accadeva ho pregato il mio compagno di viaggio di tornare indietro, non per rinunziare a quanto ci eravamo prefissati, ma per andare ad armarci della sua pistola d’ordinanza (anch’egli era stato richiamato alle armi) al fine di contrastare a qualunque costo il comportamento intimidatorio del delinquente. Siamo tornati, io armato, nonostante le raccomandazioni pacifiste del mio parente, deciso a non subire un oltraggio vergognoso da parte di un bandito da strapazzo, dopo di avere contrastato in tante occasioni, addirittura gli attacchi della stessa Armata Rossa. Il malvivente, che si è reso conto delle nostre, o meglio delle mie intenzioni, quando ci ha visti ritornare si è allontanato verso la campagna lasciandoci libero il passaggio. Ha avuto più buon senso lui, di me, perché ha evitato che da un eventuale scontro potesse derivarne la morte di qualcuno. E sempre in tema di cambiamento di carattere devo francamente raccontare ancora qualcosa: Verso l’anno 2000 sono stati uccisi barbaramente, non ricorso se bruciati o scaraventati dall’alto di un edificio, comunque fatti fuori in modo disumano, due soldatini dell’esercito Israeliano, allora, come oggi, in lotta con i palestinesi; l’omicidio mi ha commosso ed indignato per il ché ho inviato all’Ambasciata di Israele a Roma le condoglianze, regolarmente corrisposte con i normali ringraziamenti; però ho fatto ancora di più: appena ho potuto mi sono recato a Roma, sono riuscito a farmi ricevere nei locali dell’Ambasciata ed ho avanzato, ad una incredula impiegata, la singolare richiesta di essere ospitato solo e soltanto a mie spese, in un Kibbutz sito in qualsiasi posto del deserto o delle zone più calde del conflitto, come 79 soldato semplice, senza alcun riguardo altresì per la mia non più giovane età. Ricordo bene che entrando in ambasciata sono stato preso in consegna dal personale addetto alla sicurezza e poi introdotto nella sala del pubblico, posta subito alla sinistra del portone di ingresso; per dare maggiore tranquillità a colui a cui ero andato ad esprimere i miei Desiderata, ed anche al fine di non sembrare un individuo fuori di testa, né un marito voglioso di allontanarsi dalla moglie, ho portato con me la mia amata consorte. Dopo aver avuto il certo, anche se cortese, diniego per quanto richiesto, ho avanzato l’idea di parlare anche con l’Ambasciatore, il ché non è potuto accadere dato che l’Ambasciatore si trovava in Svizzera per svolgere il suo mandato altresì in quella Nazione. Se m’avessero accontentato oggi avrei quasi dieci anni di anzianità, a costo zero, nel glorioso esercito di Israele. La Bandiera: tre mesi fa, in tempi non sospetti, il giorno 7 settembre 2010 ho scritto di un meraviglioso episodio riguardante il Tricolore, per il quale sono stato solo spettatore, in verità, nella steppa russa, del quale non ero stato preciso circa la data o la località. Avevo attribuito il tutto al comandante dell’VIII Rgt. Artiglieria, Div. “Pasubio”, anziché al colonnello Ugo De Simone, Comandante del 120° Rgt. Artiglieria motorizzata (Notiziario U.N.I.R.R. n. 96 ottobre 2007 pag. 5). Ho rimediato all’errore con successive missive ai Comandi ed alle autorità interessati, solo per amore di verità, e non altro: …omissis “Riordinando vecchi documenti, di circa 70 anni fa, relativi al 80 tempo in cui ho avuto il privilegio di svolgere (volontario), il servizio militare, prima in Albania, 31° Reggimento fanteria, Divisione “Siena” e poi in Russia, 79° Reggimento fanteria, divisione “Pasubio”, ho rinvenuto lo scritto (fotocopia) di autore ignoto, col quale viene ricordata che il giorno 18 Aprile del 1943, in Verona, hanno sfilato i reduci della mia divisione, preceduti dalle bandiere del 79° e 80° fanteria e dallo stendardo dell’ 8° Reggimento artiglieria. La menzione dello stendardo ha risvegliato in me un magnifico ricordo, anche se non posso essere preciso sulle date, sulle località, e sulle stesse modalità di quanto è accaduto. Questo: Durante la ritirata dal Don, in piena steppa, un gruppo di militari, mi sembra artiglieri, schierati nonostante la confusione e le circostanze causate dalla lotta inevitabile, tra chi, (noi), in ritirata cercava di sfuggire dall’accerchiamento, e l’Armata Rossa che mirava ad un’opposta conclusione, ha difeso, disposti in cerchio, di 3 o 4 ufficiali, forse con lo stesso colonnello Comandante del Reggimento, che smontavano, o facevano a pezzi, il drappo del loro vessillo, al fine di riportarlo in Patria, con maggiore probabilità di riuscita, anche se diviso. Essendo il sottoscritto, in quel momento, libero da altre incombenze, ho ritenuto di schierarmi a fianco dei commilitoni, di sicuro intenti a sacrificare la loro stessa giovane vita, pur di evitare l’onta della perdita della bandiera. Rammento bene che sulla steppa è sceso, all’improvviso, difficile dire come e perché, un silenzio inusuale per i tempi e i luoghi dei combattimenti; potrei dire che solo un miracolo ha potuto onorare il meraviglioso evento, facendo tacere gli scoppi, le urla, i lamenti, le imprecazioni proprio di ogni scontro di 81 guerra. Quale il motivo di questa missiva? 1. conoscere se quanto raccontato è, eventualmente, menzionato nel diario storico della divisione Pasubio (allegato n° 2), e se esatto che proprio l’8° Reggimento Artiglieria ne sia stato protagonista; io sarei portato per l’affermativa, dato che la direttrice di ritirata dal Don (Arbusow,Cerkowo),fino all’uscita dall’accerchiamento, è stato la stessa della mia; 2. in caso affermativo poter essere ospitato presso il Comando dell’ 8° Artiglieria, al fine di poter rendere omaggio, ne sarei orgoglioso, allo stendardo per il quale sarei stato deciso, ma francamente non è stato necessario, a sopportare qualsiasi sacrificio. Per tale evenienza potrei raggiungere il comando prima detto, in Persano, nei primi giorni del prossimo novembre, dato che dovrò venire in provincia di Salerno in occasione della commemorazione dei defunti”. Invio doverosamente copia di questo scritto alle presidenze del Nastro Azzurro, dell’UNIRR, dell’ UNUCI, associazioni alle quali mi onoro di essere iscritto. In attesa di cortese risposta, invio i dovuti ossequi. Cergnago, 7 settembre 2010 Ten Giacomo Gambino” Ed inoltre: … omissis “Gli allegati n.1- 2 - 3, alla presente, servono a chiarire che, per l’evento descritto n ella mia missiva del 7 settembre 82 2010, il protagonista è stato il Comandante del 120° RGT Artiglieria Motorizzata, e non quello dell’8° RGT Artiglieria della Divisione “Pasubio”. Rimedio all’errore, avendo rinvenuto il fascicolo del 4° trimestre del 2007 del Notiziario UNIRR, contenente l’articolo del Tenente Giuseppe Basso, relativo agli episodi de quibus; il predetto è stato prigioniero di guerra con il Tenente Cappellano militare Don Enelio Franzoni, con il Tenente Luigi Esposito, con il Tenente Salvatore Silipo, con il Sottotenente Angelo Palmestina, tutti in forza al 79° RGT FTR, il mio, amatissimi colleghi, in guerra, e fraterni amici nel dopoguerra. Di Giuseppe Basso ho conosciuto la innata gentilezza, e per quanto mi riguarda, la disponibilità a fornirmi informazioni e documenti relativi a vicende belliche da me dimenticate, o ignorate; in occasione del raduno annuale allora organizzato dall’UNIRR, in Sanremo, mi ha fatto conoscere l’elenco dei militari italiani, deceduti in prigionia, permettendomi di avere contezza, finalmente, della morte o della sopravvivenza dei miei commilitoni. Approfitto per segnalare a Basso, ed all’UNIRR, che il soldato protagonista di quanto raccontato alla colonna due, di pagina 5, dell’allegato n.3, è stato il Carabiniere Plado Mosca Giuseppe, Medaglia d’oro al V.M. con una meravigliosa, meritata motivazione. Un quadro, esposto nel museo storico dell’Arma, in Roma, inviatomi dal Generale Rocca, allorquando era presidente della magnifica Istituzione, descrive meglio di tante parole la grandezza di quanto è accaduto; è doveroso, a questo punto, anche se fuori tema, segnalare che il Generale, da giovane ufficiale, ha meritato la Medaglia d’oro al V.M., per il 83 comportamento, seguito da gravi ferite, tenuto in un conflitto a fuoco con le brigate rosse, in tenimento di Acqui Terme (AL). Nel quadro il cavallo montato dal Carabiniere Plado, è stato dipinto di colore scuro, ma i miei ricordi me lo riportano dal colore bianco, e non gravato dalla sella. Comunque il grido, quasi disumano, “Savoia!”, accompagnato dallo sventolio frenetico della bandiera tricolore, da parte del nostro eroe, hanno esaltato quanti, me compreso, appostati nelle vicinanze, attendevano il soccorso da una divisione tedesca, mai però arrivata; in definitiva, è stato spezzato l’accerchiamento, l’avversario è stato messo in fuga, la strada verso Cercowo è stata liberata. La conclusione, per quanto sopra raccontato, senza alcun fine, se non quello di amore per la verità e con esclusione assoluta di qualsiasi captatio benevolentiae, è la seguente: onore e riconoscenza per gli artiglieri e per i carabinieri prima menzionati, quelli sfortunati che hanno dovuto combattere una guerra impossibile da vincere, e quelli venuti dopo, meno sfortunati, ma ugualmente orgogliosi di servire la Patria in divisa. Basta assistere alla sfilata del 2 giugno, festa della Repubblica, per ammirare, emozionati, con quanto orgoglio i nostri soldati sfilano al seguito del loro tricolore ed anche nostro, per sempre. Sarei grato all’UNIRR se potessi ricevere l’indirizzo del mio commilitone Giuseppe Basso. Cergnago, 6 ottobre 2010 Distinti saluti Tenente Giacomo Gambino” Raccontare certi eventi può aiutare a comprendere ancora 84 meglio come sia stato possibile non dimenticare certi valori pure nella sofferenza di una vissuta tragica sconfitta. 85 86 87 88 89 90 Parte Seconda “Nel breve periodo trascorso al Comando del Nucleo Mobile di Montelepre, il tenente Giacomo Gambino ha dimostrato di possedere belle doti di Ufficiale coraggioso ed animatore, offrendosi volontario per i servizi più rischiosi ed assolvendo incarichi di fiducia al comando di un reparto speciale di volontari impiegati nella lotta contro il banditismo”. (Montelepre (Pa), 1949 – Firmato: il Col.Ispettore Toscano) Dopo la Guerra, tenevo lezioni sul Codice Penale alla Scuola Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza di Caserta. L’insegnamento mi gratificava, vedere quei ragazzi strabuzzare gli occhi alle mie enunciazioni mi divertiva. Avevo un metodo di insegnamento tutto mio. Volevo essere certo che i principi cardini di quella disciplina si saldassero nelle zucche di quei futuri tutori dell’ordine che provenivano, per lo più, dal Sud: da famiglie modeste con basso grado di cultura e benessere. Allora creai virtualmente il “libro sacro dello Stato” dove il “reato” era comparato, per poterlo sostanziare, al “peccato”. Io che ero stato sempre un discente pessimo adesso ero diventato un docente intransigente pur se comprensivo. Esordivo così alle mie lezioni: “Il Reato è un Peccato”. Poi, invitavo gli allievi ad estrarre dai Dieci Comandamenti quelli che potevano essere prefigurati come reati: “Non uccidere”, “Non rubare”, “Non pronunciare falsa testimonianza”, etc. Ed infine spiegavo: “…non rubare è un peccato grave verso la società….ed è perseguibile d’ufficio, invece, uno schiaffo, è un reato perseguibile a querela di parte…” 91 Il mio metodo ebbe successo e nel giro di pochi mesi ero già sulla bocca di tutti i miei ragazzi ed anche su quella degli allievi di altri corsi, in modo molto lusinghiero. Un giorno, mentre ero in pausa, mi sovvenne un articolo che avevo letto su “Epoca”, allora lavoravo al Consorzio Agrario. L’articolo era imperniato su un giovane bandito siciliano, quasi mio coetaneo, di nome Salvatore Giuliano detto “Turiddu” che rapinava e taglieggiava senza uguali. Quell’articolo era stato pubblicato nel periodo natalizio e ricostruiva un assalto ad una camionetta dei Carabinieri. Da quel momento, sì proprio da quel momento, la fama di Turiddu crebbe indicibilmente: non c’era quotidiano e non passava un solo giorno che non si parlasse di lui sino a quando con la strage di Portella della Ginestra non solo si guadagnò la prima pagina ed un servizio di una dozzina pagine ma divenne un vero e proprio caso “politico”, un caso di Stato anzi un fatto internazionale. Già, l’unità d’Italia stava franando proprio da dove era iniziata la sua “unificazione”. Ed io, che avevo lasciato la mia famiglia per incontrare l’avvenire, mi ero arruolato volontario per partecipare a due cruente campagne di guerra per difendere l’onore della mia Patria, mi ero laureato tra stenti e sacrifici “sotto i bombardamenti”, avevo superato l’esame di Stato di procuratore legale, avevo trovato un’occupazione dignitosa per sostenermi ed avevo ripreso i libri di scuola per poter trasferire le mie conoscenze accademiche e le mie esperienze di vita a quei giovani… adesso avevo come l’impressione che tutto fosse stato invano per la testa calda di un guaglione o meglio di un picciotto. Il giorno prima avevo visto, sulla copertina della “Tribuna illustrata”, una scena dipinta ad acquarello di corpi di militi riversati in una pozza di sangue ed un titolo: “La legge dell’inafferrabile bandito Giuliano” o una cosa del genere. Nel mentre facevo lezioni avevo ancora fissata nella mente quell’immagine e vedevo i miei ragazzi 92 93 muoversi nelle sedie, carichi di energia. Quasi leggevo ciò che volessero dirmi: “… abbiamo scelto questo lavoro per amore dell’ordine, per stare tra la gente a salvaguardia della legalità e della loro sicurezza, non tra i banchi di scuola…”. Quasi sbandai. Mi fermai e li guardai negli occhi. Galeotto fu quel giorno perché come l’alta marea mi fluì nella testa la preoccupazione per loro, per la loro giovane vita: “… e se qualcuno di questi ragazzi fosse inviato proprio lì, a Montelepre? Quanto durerebbe il loro entusiasmo? Piuttosto che saperli freddati da quel banditello…”. Seduta stante decisi di lasciare l’insegnamento per andare a vedere di persona chi fosse costui. Quindi, trascorsi un paio di giorni per meglio valutare il mio proponimento, decisi irrevocabilmente di inoltrare domanda di messa a disposizione per il Comando Forze Repressione Banditismo. E così fu. Ebbene, è luogo comune la “lentezza” dello Stato italiano, la famigerata “burocrazia”… vero? Fandonie! Devo sconfessare questi luoghi comuni da vero testimone: all’indomani dell’inoltro ero già imbarcato sul traghetto Napoli-Palermo! Mi viene ancora da ridere al pensiero di come accadde tutto così precipitevolissimevolmente! E qui inizia la seconda parte della mia memorabile esperienza ma, prima di addentrarmi in quella che fu “cronaca” o meglio “cronaca di banditismo”, anche se non sarei molto d’accordo a definirla così, vorrei dare qualche informazione per poter ricostruirne il clima. In questo clima, seppur con infiniti dubbi, con apparizioni e “visioni”, entrano ed escono partiti politici, movimenti indipendentisti, uomini di governo, servizi segreti, mafia, massoneria, rappresentanti dell’esercito americano, inglesi… Pertanto, non credo che si possa parlare di cronaca ma è a tutti gli effetti, parte della storia d’Italia, della nostra Storia. Tutto è cominciato nel settembre del 1943, il 2 settembre 94 allorché, per una piccola partita di grano di circa un quintale, ecco che fu ammazzato un Carabiniere. Da quel momento prese forma quella che noi oggi chiamiamo “lotta allo Stato” (almeno stando ai fatti che dichiarò Giuliano). Spero che saprete che, in quel tempo, i Carabinieri e gli altri servitori dello Stato non possedevano le famose “tessere” per poter ottenere generi alimentari. Giuliano, che da questo momento in poi chiameremo, così come lo chiamavo io, semplicemente “Turiddu”, era un “precario” al servizio dello Stato e svolgeva mansioni di addetto alla manutenzione delle linee telefoniche della società Posta e Telegrafo (oggi Poste Italiane) di Montelepre. Indossando il classico berretto da postino lo si vedeva molto spesso gironzolare nelle periferie a riparare fili e pali danneggiati. Era, nel vero senso della parola, ma senza avere la benché minima volontà di offendere, un poveraccio ovvero, uno che viveva “alla giornata”. Uno di quei giorni che sembrano come altri nell’arsura ancora estiva, due Guardie Campestri accompagnate da due militi dell’Arma, l’hanno fermato all’uscita dell’abitato di Montelepre con una partita di grano di circa un quintale. Turiddu aveva cercato di dare delle spiegazioni giustificandone il possesso. Ma vanamente perché la pattuglia era convinta di averlo beccato in fragrante e, per il reato di contrabbando, era previsto l’arresto immediato. D’altronde, tutti i contrabbandieri facevano così ed il mercato nero era diventato un grosso affare malavitoso. Turiddu che sicuramente era consapevole di quanto gli stava accadendo, senza perdersi d’animo, pregando un carabiniere di ascoltarlo, estrasse dalla tasca posteriore dei calzoni un documento. Quel documento comprovava la sua mansione di operaio presso la società dei Telegrafi. Pertanto, anziché condurlo al Presidio americano che era il luogo da dove perveniva il grano, decisero di estendergli una denuncia e lasciarlo a piede libero. Ma il destino non accettò il compromesso: nel mentre un carabiniere scriveva la denuncia, le Guardie Campestri 95 allontanatesi qualche metro, scorsero quattro muli stracarichi di grano tirati a forza da quattro uomini non riconoscibili per la distanza. Erano contrabbandieri. Gli uomini scapparono lasciando il carico che fu bloccato all’istante dalle Guardie Campestri. Turiddu, invece, rimase momentaneamente solo e, nell’agitazione totale, tentò la fuga ma cadde, dopo una decina di metri, sotto il fuoco dei tutori dell’ordine. Due colpi lo raggiunsero stramazzandolo al suolo. La pattuglia quindi si riaddensò intorno a lui e ad uno dei carabinieri fu ordinato di finirlo (come riferirono alcuni invisibili testimoni più tardi). Ci fu un momento di indefinibile situazione. I contrabbandieri erano in salvo chissà dove ed il carabiniere ebbe qualche esitazioni nello sparargli. Esitazione che diede a Turiddu il tempo di estrarre dallo stivale una rivoltella e ferire gravemente l’indeciso tutore dell’ordine. Poi, stando sempre a varie testimonianze, si disperse, con l’aiuto non si sa di chi, tra le colline che cingevano Montelepre. Si disse che per circa un mese avrebbe combattuto tra la vita e la morte. Chiaramente non morì. Alla vigilia del Natale del ’43 Montelepre fu letteralmente accerchiata da un migliaio di carabinieri per scovarlo. Durante l’operazione furono arrestate un centinaio di persone ma di Turiddu non fu trovata neanche l’ombra. Tra quelle persone c’era anche il padre che fu malamente pestato in pubblico. Si disse ancora che Turiddu avrebbe visto ogni cosa dal suo nascondiglio (una grotta) e, prima che i carabinieri avessero lasciato Montelepre, aveva imbracciato un mitra sventagliando, alla cieca, centinaia e centinaia di colpi sulle camionette ferme nella piazza. Malauguratamente, a guardia dei mezzi militari, c’era un milite che, nella raffica, rimase morto stecchito. Da quel momento Turiddu era diventato, per tutti, un mito, un vero eroe e quindi per tenere sempre fede alla sua fama, nel ‘44, esattamente nel mese di febbraio, liberò otto monteleprini dal carcere di Monreale e con questi formò la sua inafferrabile banda. Ed ecco che entra 96 in scena la politica: nel maggio del ‘45 gli furono conferiti i gradi di colonnello ed il comando della Sicilia ovest dell’Esercito Volontario per l’Indipendenza dell’isola, dell’E.V.I.S. dove la “s” finale sta per “Sicilia”. E alla fine di quell’anno ebbe inizio una vera e propria guerra alle istituzioni condotta a colpi di guerriglia. Oggi chiameremmo quegli interventi armati “atti terroristici”: fu attaccata la caserma dei carabinieri di Bellocampo e poi quella di Montelepre. In effetti, il primo attacco fu condotto contro la caserma di Monreale e per difendersi da un contrattacco, gli stessi otto uomini che furono poi liberati da Turiddu, avevano rapito il Vescovo andandolo a prelevare direttamente al Vescovado. Dopo questi eventi non ci fu più pace: carceri, caserme, avamposti e blocchi venivano debellati a colpi di mitra nel mentre lo Stato rispondeva a quel fuoco con gli obsoleti moschetti. La cosa più pittoresca è che questi assalti vedevano in prima riga il colonnello Giuliano Turiddu nella sua divisa gallonata preceduto dallo sventolio epico di una bandiera a strisce verticali gialle e rosse, la bandiera dell’E.V.I.S. Ma la storia italiana aveva già vissuto questi gravi momenti con altri famosi colonnelli come, ad esempio, il colonnello Michele Arcangelo Pezza alias il temibile brigante fra’ Diavolo. Inizialmente, in verità, più che agire Turiddu avrebbe voluto soltanto sottrarsi alla giustizia e le sue azioni erano mosse, appunto, dalla necessità di non farsi catturare poi, con la morte del carabiniere, tutto era tracollato senza via d’uscita. Nell’immediato dopoguerra la lussureggiante isola di Trinacria era invasa da grassatori e la “mafia”, che era già esistente da qualche secolo, ovvero da quando era nata la necessità di approvvigionamento d’acqua potabile, non poteva permettere che i propri affari venissero disturbati, né che stranieri alleati o non alleati che fossero presidiassero le coste, né che i contadini potessero accampare speranze sull’assegnazione 97 delle terre incolte o pretese sulla mezzadria, idee “bislacche” (per la Mafia) quest’ultime appena promosse attraverso disegni di legge dall’allora Ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo (sostituito poi da Segni). In vero, la “potenza” della mafia era garantita dalla gestione delle coste e delle terre demaniali e, in un certo qual modo, anche da quelle dei baroni ai quali veniva prospettata una “reciproca” protezione “politica”. Pertanto, facendo mie le parole di Tancredi ne “Il Gattopardo”: “bisognava cambiare tutto (ma) per non cambiare nulla”. Quindi, la mafia in una sorta di patto invisibile quanto autocratico si impegnava a tenere “pulita” l’Isola e, un giorno sì un giorno no, faceva ritrovare, quasi sempre all’alba, un paio di banditelli ricercati, belli e accoppati. Quando prima ho fatto accenno alla storia d’Italia dicendo che da questa “storia” entravano ed uscivano partiti politici, movimenti indipendentisti, uomini di governo, servizi segreti, mafia, massoneria, rappresentanti dell’esercito americano, inglesi, etc… mi riferivo al fatto che proprio ciò, tra tanti “se”, tanti “ma” e tanti “boh?” elevò la figura di Turiddu a “dignità” politica. In effetti, a mio modesto avviso, Turiddu era entrato, seppur inizialmente inconsapevolmente, nella lotta di potere che vedeva coinvolte la Democrazia Cristiana da una parte (con le varie alleanze occulte domestiche e forestiere e, dall’altra, il Fronte Popolare (PSI, PCI, PSIUP) con a volte le stesse, a volte altre alleanze occulte domestiche e forestiere. Perché, questi due blocchi politici, pur avendo trovato un compromesso attraverso il governo di unità nazionale, sotto sotto tentavano di crearsi disagi reciproci per poter costruire un nuovo governo imperniato non su idee politiche spurie, ma, questa volta, radicali. Ovvero, la Democrazia Cristiana, vicina alla Chiesa e in quanto tale per “fede” antitotalitaria, tesseva per avere un governo moderato di ispirazione “cristiana” ed il Fronte Popolare (convinta che nella D.C. ci fossero residui fascisti), popolare e laico. Capito il gioco, il buon Turiddu, 98 intelligente, coraggioso ma soprattutto perspicace, vista l’attenzione che aveva il governo democratico degli U.S.A. (che sosteneva le forze democratiche moderate italiane) per le sue azioni “rivoluzionarie” si incuneò nella lotta politica e già sostenendo idealmente la Sinistra, decise di rendere le sue azioni “utili alla lotta” ma conseguendo, però, anche vantaggi personali in termini economici e di “potere”. Ecco che si buttò a capo fitto in doppi, tripli e quadrupli giochi che portò con coraggio ed utilità avanti (Turiddu per un certo periodo aveva cominciato a fare veri e propri comizi politici anticomunisti, del tipo: “Siciliani, se volete la libertà annientate sbirri e comunisti”) sino a che comprese di essere molto più vulnerabile di quanto pensava di non essere, in un gioco molto ma molto più grande di lui che lo aveva, ad un certo punto della storia, del tutto disorientato, confuso. Già…, si rese conto, seppur in ritardo, di essere soltanto una pedina e neanche una delle principali. Ne ebbe conferma quando capì che tra tutte le parti, tra tutte le innumerevoli parti, con cui negoziava o stringeva accordi c’era sempre di mezzo (o meglio, di sotto) la mafia ed un vero siciliano sa, nel più profondo, che la mafia, per chi vuole raggiungere “un” potere senza chiederne il permesso, è una piramide con pareti vischiose e letali come le fauci di un serpente. Quindi, in un modo o nell’altro, aveva firmato la sua condanna a morte, senza appello. Buscetta dirà però, più tardi, anzi tardissimo, che Turiddu era già organico alla “famiglia di Montelepre”, era un suo “uomo d’onore”. Dai rapporti era emerso invece che la Mafia l’aveva avuto per un tempo lunghissimo “…sotto osservazione per studiarne un suo utilizzo” (cioè un uso senza che ne fosse consapevole). La prudenza della mafia molto probabilmente era dovuta al fatto che Turiddu era già un “assassino di Carabinieri” nel mentre gli equilibri politici oscillavano tra monarchia e separatismo (filo-americano e filo-inglese). Intanto, subito dopo il tentativo di arresto per 99 contrabbando, si era schierato con i separatisti di Finoccharo e, attraverso i manifesti del tipo “A morte gli sbirri succhiatori del popolo siciliano, viva il separatismo e la libertà!”, volle esporre al pubblico ludibrio le forze dell’ordine perché reduci del Fascismo. E’ così “Muoia Sansone con tutti i Filistei!” ed il 1° maggio del 1947 nei pressi della Piana degli Albanesi vicino Palermo ed esattamente nella vallata di Portella della Ginestra, mentre si svolgeva la Festa del Lavoro e correvano i festeggiamenti per la vittoria del “Blocco del Popolo”, Turiddu, o meglio il colonnello Giuliano, indossando l’uniforme dell’E.V.I.S. diede ordine di fare fuoco sulla folla. Nella valle vi erano radunati un migliaio di persone per lo più contadini e loro familiari, 11 furono falcidiate a morte dalle raffiche di mitra e 27 ferite. Dopo circa tre mesi Turiddu fece pervenire ai giornali una comunicazione con la quale confessava lo scopo “politico” della strage. Confessione “sconfessata” dal ministro Mario Scelba che per alcuni storici (vicini alle idee di sinistra) è stato attualmente individuato come il personaggio chiave del “Mistero di Portella”. La strage, stante a voci molto dissonanti (soprattutto oggi) che circolavano in quel periodo, anche se non ne sono convinto, fu effettuata per smantellare una certa architettura politica (DC-USA-MAFIA?) affinché la responsabilità cadesse proprio su di essa. In effetti, da un “certo” punto di vista, sul piano tattico, c’è anche una “logica” (del terrore): le azioni terroristiche del genere sono utilizzate per far ricadere responsabilità sul fronte avverso. Bestiale ma è così. Alla domanda “cui prodest?” (a chi giova?) deve sempre seguire una risposta “spontanea”, a chi giova? All’avversario. E questo era il clima. Clima reso ancora più focoso con la successiva azione compiuta da Turiddu a Partinico contro la tenenza dei Carabinieri nel mese di dicembre dello stesso 100 anno. Dimenticavo alcuni particolari. L’E.V.I.S., dopo un po’ sarà annientato con quattro schioppettate dal nostro esercito in una località chiamata San Mauro, vicino Catania. In merito alla mafia-connection vorrei evidenziare che quando le Forze U.S.A. si prepararono allo “sbarco”, per non sprecare forze e risorse come era avvenuto per gli Inglesi, avevano stretto, sul territorio, delle alleanze con alcuni capipopolo attraverso mafiosi italo-americani. Infatti, il colonnello Poletti, Charles Poletti, già vice Governatore dello Stato di New York e nominato per l’occasione Governatore Militare d’Italia aveva arruolato allo scopo, con il ruolo di “Traduttore e Guida”, niente po’ po’ di meno che un certo Vito Genovese, il vice di Lucky Luciano. Don Vito negli U.S.A. era latitante in quanto accusato di essere stato il mandante - dalla procura di Nuova York - dell’omicidio Boccia commesso nel ’37. Tra l’altro, era già noto che don Vito non accettava compensi ma soltanto rimborsi spese. Conveniva, no? Per onore della cronaca va anche detto che don Vito farà ritorno negli U.S.A. per sottoporsi al processo. Ne uscirà “a testa alta” per mancanza di testimoni (vennero tutti assassinati!). Comunque, appena sbarcati, gli Americani capirono di aver commesso degli errori in quanto furono accolti dai siciliani con grande festa, una festa riservata ai loro liberatori. Intanto, Vito Genovese aveva brigato con l’amico Poletti per far nominare a capo dei magazzini generali dell’esercito un certo Max Mugnani (già noto trafficante di droghe), se ricordo bene il cognome, che oltre a trafficare nel mercato nero con i beni americani ben pensò anche di inondare clandestinamente il territorio di ottima morfina conseguendo guadagni impensabili che irrobustirono la mafia e gonfiarono le tasche di don Vito, di don Calò (Calogero Vizzini) e di don Peppi Jencu (Genco Russo) i capi dei capi della cupola. Delle undici bande “sciolte” presenti sul territorio siculo ne rimase soltanto una, quella di Turiddu. 101 Detto ciò, inizio la seconda parte della mia memorabile esperienza. E’ il 1949. Arrivo di mattina all’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia di Palermo (che diventerà dopo pochi giorni ed esattamente il 26 agosto: C.F.R.B. ovvero il Comando Forze Repressione Banditismo con a capo il Colonnello dei Carabinieri Ugo Luca). Mi riceve l’Ispettore Capo Ciro Verdiani (che dopo manterrà una posizione apicale sino al suo “defenestramento” avvenuto dopo circa un anno). Mi guarda, poi continua a scrivere alcuni documenti. Mentre scrive, a testa bassa mi chiede: “Tenente Gambino, allora… cosa vogliamo fare?” E nel mentre, mi infila il suo sguardo negli occhi come una lama. Di me sa già tutto, il mio carattere testardo, la fede per la Patria, il coraggio provato con azioni di guerra encomiabili e la mia precisione con le armi da fuoco. Lo so perché in altro incontro avuto con il colonnello Luca se ne farà menzione insieme al mio rapporto di servizio. Senza indugio, muto, con lo sguardo gli chiedo di potermi sedere. Annuisce. Mi siedo e dico sommessamente: “Vengo dalla Steppa… e sono qui per mettere a disposizione la mia esperienza… mi piacerebbe conoscere molto da vicino quel Robin Hood chiamato Turiddu, il re di Montelepre e mi riferisco al famigerato Salvatore Giuliano, Signor Ispettore.” E poi, continuando: “Se mi da sei o sette uomini decisi, vorrei operare fuori… dagli schemi… conosco le tecniche di guerriglia che ho potuto praticare prima ad Elbasan e poi durante la ritirata del Don… Il territorio lo imparerò molto presto… non ho neanche bisogno di camionette ma di cavalli… soltanto cavalli… ecco… io…vorrei creare una banda, Signor Ispettore… voglio integrarmi nello scenario ed attirare l’attenzione del guaglione … sempre se lei trova questo mio pensiero valido… “. “Mhhh…” Mi fa Verdiani chiudendo la cartella spalancata sulla scrivania e togliendosi, con un gesto lento, gli occhiali: “…intanto è pronta una macchina per te. Ti scorteranno un paio di uomini fino a Montelepre”. Ed io, sempre con compostezza: “Grazie, Signor Ispettore!”. 102 Non lasciando passare dal mio tono alcuna flessione emotiva. “Ah…Gambino…” Riprendendo il discorso, Verdiani alza il tono. Io ero già alla porta e la stavo aprendo per uscire:“… un ordine ed una raccomandazione: prima di ogni azione, di qualsiasi azione, gradirei ricevere un dispaccio telefonico minuzioso di qualsiasi attività…. Scusami ancora, quando arrivi a Montelepre fammi inoltrare pure l’elenco di tutto ciò che ti occorrerà, indumenti, armi… per quanto riguarda gli uomini <decisi> vedrò di fare del mio meglio…” Socchiudo la porta salutandolo questa volta con un sorriso soddisfatto. L’Ispettore intanto aveva disposto l’auto per me nel primo pomeriggio. Nell’attesa, contento del colloquio, faccio un giro per sgranchirmi le gambe ma soprattutto per pensare al da farsi. Mi trovo così, senza volerlo, proprio ad una fermata della corriera. C’è una vecchia carcassa azzurra con il motore acceso che traballa per le forte vibrazioni come la prima lavatrice di mia moglie, con un cartello”PalermoMontelepre”. Ne chiedo, al conducente, l’orario di partenza. Ho giusto il tempo di ritornare al Comando, raccattare le mie quattro cose e recarmi spedito alla fermata. Arrivo. Mi guardo intorno e salgo. Pago il biglietto, poi mi accomodo in fondo. La corriera è semi vuota ma parte in perfetto orario. Mi gusto il paesaggio solare dal finestrino. Colline aride o coltivate si alternano alla mia vista. Quelle incolte hanno il colore dell’oro mentre le altre sembrano, con tutti gli appezzamenti ben delimitati, delle coperte con toppe arancioni, gialle e verdi di tutte le gradazioni. Il ciglio della strada è infoltito da alti fichi d’india stracolmi di “nanasse” verdi e vermiglie. Dopo alcune ore scorgo un cartello blu bucherellato ed arrugginito con la scritta “Montelepre”. Appena scendo dalla corriera, alla fermata, quattro poliziotti in divisa mi vengono incontro agitati. Avevano ricevuto un telegramma da Palermo e mi stavano aspettando lì da più di un’ora. Erano preoccupati, anzi allarmati. Insomma, pensai, come primo biglietto da visita si 103 può dire che ho reso bene l’idea di chi sono, non è stato forse il modo migliore ma sono così. Intanto mi rendevo conto di aver creato un piccolo scompiglio a Palermo non avvisando il dirigente della mia partenza anticipata per Montelepre, per essere arrivato dopo più di un’ora da solo e con la corriera! Comunque, come se niente fosse accaduto, faccio un saluto militare ed ordino di caricare le mie quattro cose sull’auto amaranto e di partire di gran carriera per Montelepre. Indosso una leggerissima giacca estiva di colore beige (l’unica estiva del mio guardaroba civile) e la rivoltella, che per abitudine ho sempre portato all’ascella (alla cintura mi consuma i pantaloni), faceva capolino sfacciatamente dai revers sgualciti. L’autista, appena monto in macchina, mi fa notare rispettosamente che l’arma è molto evidente e mi informa del pericolo che avrei sicuramente corso a Montelepre e dintorni facendomi vedere in giro in quel modo. Non rispondo. Con un cenno lo ringrazio. Arrivo al mio Reparto. Mi presento a tutti: ufficiali, sottufficiali, agenti. Chiedo del mio alloggio per sistemare i bagagli ma prima però esprimo il “desiderio” di poter visionare i fascicoli sulle bande locali ma soprattutto su Salvatore Giuliano e company. In un istante il tavolo traboccò di pile polverose di fascicoli legati come soppressate e di caterve di foto segnaletiche e pezzi di giornali. Mi passa la voglia di vedere l’alloggio. Mi siedo, e comincio a sfogliare i documenti nei vari fascicoli intestati a Salvatore Giuliano, a Gaspare Pisciotta (cugino e luogotenente di Giuliano), a Nunzio Badalamenti, ai loro familiari e ad altri uomini della banda, schedati o semplicemente segnalati, uno ad uno. Infine, prima di finire ciò che avevo cominciato a fare rendendomi conto che non ce l’avrei mai fatta a visionarli tutti, chiedo di avere, appena possibile, una cartina dell’intera zona di pertinenza ed un binocolo. Non pranzo e ne approfitto per parlare con gli uomini che avrebbero fatto parte della mia pattuglia, ad uno ad uno, così come avevo fatto in passato in guerra, per 104 avere informazioni generali ma soprattutto per verificare il loro stato di servizio e la loro indole. Dai rapporti che avevo sfogliato era emerso che dal 1943 al 1949 il “banditismo” era “invincibile”. O meglio, la “banda Giuliano” era invincibile ed il suo giovane capo (aveva 26 anni) “inafferrabile” e che gli scontri si susseguivano senza interruzioni ed avevano mietuto, sino al giorno in cui lo stavo leggendo, decine e decine di vittime. Fino alla strage di Bellolampo, avvenuta il 19 agosto (di quell’anno, 1949) la sola Arma dei Carabinieri aveva contato tra i suoi militi quasi cento morti caduti nei conflitti a fuoco e nelle varie scaramucce. Mi alzai e agli uomini presenti dissi senza remore come avremmo operato da quel momento in poi, come ci saremmo abbigliati e in quale modo ci saremmo spostati. Riferii anche del mio colloquio con l’Ispettore Verdiani, ma questo già lo sapevano perché messi a conoscenza dal dirigente dell’Ufficio dell’Ispettorato Generale di Palermo nella medesima giornata. Dopo una settimana ottenni quanto richiesto per la mia squadra anzi per la mia “banda”: indumenti civili, tascapane, e vari mitra nuovi di zecca. In poco più di un mese conoscevo quel territorio, vasto ed impervio, come le mie tasche. Eravamo ormai affiatati. Scorazzavamo a piedi sospettosi, diffidenti ed irascibili come veri banditi. Nessuno sapeva chi fossimo. “Quasi” nessuno. I miei uomini, che avevo addestrato sul linguaggio anche gestuale da adottare nelle diverse circostanze, sembravano mafiosi incalliti, con “coppola” sulle ventitré, camicie larghe, tascapane a tracolla e calzoni tenuti su con una cintura di cuoio sottile che fermava la rivoltella (non d’ordinanza, ovviamente) sporgente come un carciofo dalla vita con l’impugnatura di corna di bue; io sembravo un gangster siculo-americano, capelli impomatati, stivali, fazzoletto rosso annodato al collo, bandoliera e fucile (tirato a lucido) incrociati a tracolla. Quando mi guardavo allo 105 specchio a volte credevo di essere davvero un fuorilegge, cosa che mi confermavano, giorno dopo giorno, gli sguardi atterriti degli avventori, fossero stati contadini, pastori o cittadini che spesso incontravamo durante le nostre avventurose “perlustrazioni” effettuate sempre a piedi. Il cavallo non era in dotazione ma mi veniva “involontariamente” fornito da chi, innocente o colpevole, vistici da lontano lasciava la cavalcatura e scappava per la montagna. Alcuni erano i fornitori dei viveri per i latitanti. In effetti, la nostra presenza era una continua sfida e costituiva per chi avesse la coscienza sporca una seria minaccia e per Giuliano, per il nostro Turiddu, un vero oltraggio, un reato di lesa maestà compiuta ai danni del re di Montelepre. Ed era questo l’effetto che volevo sortire, volevo che uscisse prima o poi con il naso fuori dal suo nascondiglio. E, per provocarlo, lasciavo le tracce tipiche di chi dice “se ti incontro sei un uomo morto”. Stavamo facendo terra bruciata intorno a lui. Tutte le notti perquisivamo le abitazioni conosciute dei componenti dalla banda, da cima a fondo creando scompigli nel cuore della notte, spaventando padri, mogli, figli e parenti. Alcune volte anche procurando danni alle cose (sedie, tavoli). Volevo che di noi si parlasse. Ho dormito nella sua stanza, nella stanza di Turiddu, nel suo stesso giaciglio, in segno di sfida. E, al mattino successivo mi facevo notare, spavaldo e da solo, con il mio mitra a tracolla e nei miei abiti da “straccione” a prendere un caffè in un bar o nel circolo ricreativo sulla via principale di Montelepre, oppure in sella a qualche cavallo, scortato dagli uomini della squadra. Ricordo che un giorno, dopo tanto tempo, il farmacista di Montelepre, venuto a sapere chi realmente poi fossi, bontà sua, mi chiese di essere più prudente ed in modo alquanto delicato mi espresse tutta la sua “preoccupazione” perché “ancora” passeggiavo dinanzi alla vetrina della sua bottega. Non so se fosse realmente preoccupato per la mia vita o per la sua. Tutto ciò che facevamo doveva spingere Turiddu 106 107 a capire di avere a che fare con gente tosta, che fossimo una banda venuta dalla costa per appropriarci di parte di quel territorio. Ma poi compresi che mi stavo sbagliando. Turiddu non era assolutamente “solo”, neanche quando si diceva che lo fosse. Precedeva sempre le nostre azioni correndo ai ripari. Era riuscito, sin a quel momento, sempre ad evitarci. Per lui muoversi era molto più facile, godeva dell’appoggio incondizionato degli abitanti, e poi compresi anche di altre forze, di vere forze, misteriose che lo ponevano in posizione di assoluto vantaggio e protezione. Scorazzava per sentieri, campagne, colline e montagne con la sua banda senza che mai ci fosse qualcuno che l’avvistava. Nonostante, ero riuscito però, con mia grande soddisfazione, ad invertire comunque l’ordine delle cose. Da cacciatore era diventato, almeno per la mia squadra, preda. E sapeva anche questo. Sapeva di essere braccato senza posa. Sapeva sempre tutto di tutto. Ogni suo spostamento seguiva una logica di guerra, avanguardie, retroguardie, fiancheggiamenti, trappole. Nonostante tutto il trono del cosiddetto “re” comincia a scricchiolare perché il bandito si ritrova con la casa di abitazione requisita, con la stanza da letto e lo stesso letto occupato da me, con la mortificazione di vedere violate, tutte le notti, le abitazioni dei suo complici dalle nostre severe perquisizioni, seguite da urla ed imprecazioni di ogni genere, ben ascoltate e potute quindi giudicare dal vicinato; il senso di tutto non voleva essere una bravata, ma solo il fine di volere segnalare agli abitanti di Montelepre il principio di una non lontana caduta del loro re. Il che non si è realizzato anzitempo per puro caso, quando ha tentato di tornare in paese. Tutto si è svolto così: Una notte ci eravamo appostati sotto Montelepre nella speranza che, presidiando quel passaggio obbligato, avessimo potuto incontrarlo. Avevamo delle informazioni molto riservate. Ma commisi un errore. Avevo fatto venire anche il cane poliziotto 108 che, come sempre, aveva precedentemente fiutato i vecchi indumenti di Turiddu sotto la guida del suo addestratore. Ore ed ore di attesa. L’alba intanto cominciava a mostrare il suo bagliore dorato. Il cane all’improvviso diede segni di inquietudine. Sempre di più. Abbaiava senza tregua dirigendo il suo lungo muso ad ovest. C’era odore di Turiddu nell’aria e, a meno che Turiddu non fosse stato soltanto una leggenda, quegli abbai adesso dimostravano che era nei pressi, in carne ed ossa. Ordino a tre dei miei di posizionarsi come stabilito e ad altri tre di raggirare il luogo in modo tale da sorprenderlo alle spalle. Avevo raccomandato di sparare esclusivamente al mio segnale, soltanto a quel segnale che conoscevano bene. All’improvviso il cane si svincola dalla presa del suo addestratore e con un balzo si tuffa nella penombra. I miei lo raggiungono a mitra spianato pronti a far fuoco. Dinanzi a loro due pastorelli a piedi, uno dei quali reca una pecora sgozzata riversa sulla spalla. Erano impietriti dal terrore. Il cane ringhiava come se stesse spiccando un balzo per attaccare quello con la pecora. Raggiungo i miei e tiro un gran sospiro di sollievo. Avevo evitato il peggio non ordinando di fare fuoco. Ma prima di lasciar passare quei ragazzi mi salta alla mente un dubbio. Li interrogo. Dapprima sono molto paterno poi divento un demone e li accuso di un omicidio immaginario che sarebbe stato compiuto da loro qualche minuto prima. Questo espediente ha sempre funzionato con chi ha da nascondere qualcosa e quel qualcosa che loro nascondono è proprio Turiddu, che li aveva pagati e “convinti” a fare quello che avevano fatto cioè, passare da quel luogo, a quell’ora, con quelle modalità, ovvero con la pecora fresca sanguinante, per attirare il cane e quindi passare indisturbato con i suoi uomini alle nostre spalle. Ho lasciato andare i ragazzi felice di non avere ucciso due innocenti, ma deluso perché mi era sfuggito dalle mani Turiddu il “re di Montelepre”. Ancora qualche avventura da raccontare: 109 Un giorno, dopo una fitta settimana di vagabondaggio per le alture e le radure, mi trovavo a Terrasini (Pa) sul terrazzo della caserma a prendere il sole quando un mio uomo mi informa che c’è un pastore che ha urgente bisogno di parlarmi. Scendo la scala di gran lena e interrogo il pastore il quale, guardandomi con molta diffidenza e paura, mi “segnala” che sopra l’acquedotto di Cinisi c’era un tizio che un anno prima gli aveva ucciso il figlio. Dalla descrizione mi è parso di riconoscerlo. Se fosse stato quello che immaginavo che fosse, era un latitante ed anche gregario saltuario della banda Giuliano. Io, in quel momento, ero in brache di tela, avevo dei sandali ai piedi ed indossavo, fuori dai pantaloni, una camicia aperta. Alla notizia, l’adrenalina ha cominciato a correre all’impazzata insieme al mio cuore e alla mia mente. Ho quindi preso la pistola d’ordinanza e me la sono infilata dietro la schiena, nella cintura, insieme a quella “irregolare” e poi ho infilato al collo un binocolo al fine di sembrare un turista. Per non perdere altro tempo, ho chiesto ad un mio uomo di essere accompagnato in fretta con la jeep. Siamo arrivati a Cinisi in una manciata di minuti. Ho ordinato all’autista di nascondere l’auto distante dall’acquedotto e di seguirmi a piedi, ad una distanza di trenta metri, come se stesse passeggiando per cavoli suoi. Non gli ho dato altre spiegazioni o istruzioni. L’uomo segnalatomi è lì, di fronte all’acquedotto. Ha una giacca piegata sul braccio. Potrebbe nascondere un’arma. Si muove con circospezione, fissa la strada di sotto. Appena mi scorge si mette a parlare con una delle donne che sono lì a raccogliere le mandorle. Mi avvicino per coglierne i lineamenti, è proprio colui che immaginavo che fosse. Mi avvicino percorrendo il sentiero di collina parallelo. Noto che mi sta guardando ed allora con il binocolo mi giro dalla parte opposta e poi mi allontano qualche metro dalla mia posizione per fargli capire che ero in altre faccende affaccendato. L’uomo si rilassa ed io avanzo nuovamente sino 110 a raggiungere la distanza di tiro della pistola. Intanto, il mio autista appoggiato ad un muretto a secco lo fissa di spalle. E’ allora che il bandito si volta quasi di scatto come se avesse visto qualcosa di istintivamente sospetto. A quella reazione, dal livello inferiore della collina, il mio autista gli intima di avvicinarsi a lui e questi, strattonando la donna a pochi passi da lui si nasconde, prima che io estraggo la pistola. Ci siamo trovati a distanza di pochi metri entrambi con le armi spianate, ci siamo guardati negli occhi impossibilitati a fare fuoco perché avremmo dovuto colpire prime le cinque o sei donne affaccendate a raccogliere la frutta. La fuga del malfattore giù per la collina, è stata possibile perché con i miei sandali ai piedi non ho potuto attuare alcun inseguimento. Ritorniamo quindi a Terrasini mentre per tutto il tragitto non faccio altro che redarguire il mio uomo per non aver seguito sino in fondo le istruzioni anche se, in un certo qual modo, ha fatto del suo meglio e si era preoccupato per me. Prima però ero passato per la caserma dei carabinieri di Cinisi, mi sono fatto mostrare le foto segnaletiche per poter dare un nome a quel volto, ed ho raccontato tutto nei minimi particolari. Il Maresciallo ha ascoltato tutto con stupore e allo stesso tempo si è complimentato per l’intraprendenza per aver portato con me un solo uomo. Dopo qualche giorno mi arriva l’ordine di prendere il comando del Nucleo Mobile di Polizia di Montelepre. Ed eccomi a capo dell’unità operativa posta nel luogo più pericoloso, in termini assoluti, del territorio italiano. Dopo aver retto il comando di Montelepre posso dire che nella mia vita ce l’ho sempre messa tutta per essere utile agli Italiani e per proteggere la mia amata Italia. Come ogni cosa che finisce anche questa giunge al termine. Però devo confessare che sono incazzato nero per molte cose che non sono riuscito a capire. Avevo scoperto, durante le mie azioni, un luogo dove la banda di Turiddu andava a rifornirsi di viveri, 111 medicinali ed altro. Quel luogo era in un’azienda agricola molto nota, con duemila capi di bestiame. Si diceva che fosse riconducibile ad un mafioso. Ed i fatti si sono svolti così: Una Guardia Campestre con la quale spesso mi ero incontrato in campagna, parlando del più e del meno, con finta meraviglia, mi ha informato che un bracciante agricolo, pur avendo pochi mezzi, aveva organizzato le nozze di sua sorella spendendo molo danaro, affittando addirittura, per la cerimonia nuziale, il costoso salone da ballo di un barone del luogo. Capito il messaggio, dopo qualche giorno, mi sono messo alla ricerca del soggetto che al mattino portava in giro per la città le capre, per vendere il latte appena munto, mentre per il resto della giornata lavorava in un’azienda agricola molto importante. L’ho fermato ed ho cominciato il primo interrogatorio; niente. Il secondo giorno qualcosa ho ricavato e così nei giorni successivi, fin quando la sua reticenza è finita, per il timore di essere imputato di qualche grave reato. Mi ha riferito che nell’azienda in cui operava alcuni latitanti si presentavano a volte, al fine di fornirsi di viveri, di medicinali, e di biancheria, il tutto a spese del suo datore di lavoro. Per saperne di più o meglio, per far sapere che sapevo mi sono recato presso l’abitazione del proprietario dell’azienda agricola. Lui non c’era. C’era sua moglie che con formale cortesia, seppur snob, mi ha detto che il marito era andato in mattinata a Roma per affari e rispondendo ad altre mie domande che sarebbe tornato presto e che a Roma ci andava spesso. Dopo alcuni giorni da quella mia ultima iniziativa ogni mia attività è stata bloccata. Avevo invano passato intere notti al freddo onde potere intercettare il soggetto dal quale avevo interesse a captare qualche utile informazione. Sono stato isolato ed incaricato di compiti “amministrativi”. Seguivo delle pratiche. Volevano forse che facessi lo scribacchino, e non quello che avevo sempre fatto. Non subito, ma in seguito ho cominciato a considerare due ipotesi non troppo strampalate: 112 1) che potesse esserci qualche segnalazione di pericolo per la mia persona, dato che mi ero sempre dato da fare per il lavoro con impegno tale, da poter far desiderare a qualcuno la mia eliminazione fisica; 2) che, a mia insaputa, già organizzata la trama per la eliminazione di Turiddu, si rendesse necessario tenere da parte un manovratore scomodo, che avrebbe potuto mandare a monte la riuscita dell’operazione. Per l’una e per l’altra ipotesi sono ugualmente contento, per la prima, riconoscente, per la seconda, ammirato, certo che non avrei saputo fare di meglio; tanto più che avevo sempre immaginato una sfida all’Ok Corral senza mai tener conto abbastanza della possibile perdita di qualche vita, la mia compresa. Il lavoro d’ufficio era una condizione che avevo sempre rifiutato ed anche una vergogna per me: io, imboscato, mai! Dopo una decina di giorni o meno, all’inizio del 1950, come se Dio avesse ascoltato i miei gemiti di noia ed orrore, mi arriva una comunicazione: ho vinto il concorso per le Imposte Indirette al quale avevo partecipato quando insegnavo a Caserta e sono chiamato a prendere servizio a Cuneo. Mi viene voglia di ricordare Totò che per dimostrare la sua perizia ed esperienza dice in quel vecchio film “… ho fatto il militare a Cuneo”. Io, il militare l’ho fatto dappertutto e a Cuneo ci andavo per dimenticare i luoghi in cui avevo servito la mia Patria… Adesso mi restava da fare un’ultima cosa, rassegnare le mie dimissioni, ma nelle mani di colui che io ritenevo essere il più valoroso, il colonnello Luca al quale strinsi con onore la mano insieme al mio commiato, seppur lasciandolo a bocca amara per una mia parola detta tra i denti, nel momento in cui mi chiese: “auguri per Cuneo…ma qual è il vero motivo?” Ed io: “… l’odor di tradimento…”. Abbiamo letto da certa stampa che: “In cambio dell’impunita`, in poco tempo, alcuni degli uomini più fidati di Salvatore Giuliano vennero catturati o uccisi. 113 Per eliminarlo fisicamente ricorsero al tradimento di Gaspare Pisciotta (e Nunzio Badalamenti ufficialmente arrestato), che lo eliminò nel sonno, in una casa colonica chiamata “Villa Carolina”, ubicata tra Pioppo e Monreale. La mattina del 5 Luglio 1950 il suo corpo venne trovato a Castelvetrano crivellato di colpi. Aveva 27 anni”. A questo punto sento il dovere di esprimere la mia personale certezza, anche se fuori tema, sulla magnifica figura del mio ex-comandante, colonnello Luca, capo del C.F.R.B. (Comando Forze Repressione Banditismo), essendo stato in servizio alle di lui dipendenze nel IV Gruppo Squadriglie, fino ai primi di gennaio del 1950, quando prestavo servizio in un grosso centro della Sicilia, a grande intensità mafiosa e criminale; qui le esigenze di lavoro richiedevano una particolar presenza del Nostro comandante, il che mi ha consentito di accompagnarlo più di una volta in qualche incontro di lavoro od istituzionale. Tali circostanze mi hanno permesso di conoscere abbastanza la personalità del mio capo, e viceversa, e nel contempo di stabilire con lui un rapporto di cordialità e di rispetto; abbiamo spesso parlato dei nostri trascorsi di guerra e di vita, con la massima sincerità. Una volta mi ha raccontato un episodio che non dimenticherò mai: Era stato in un campo di prigionieri o di internati, non rammento né dove né quando, e con quale ruolo, allorché pur non essendo medico aveva dovuto operare un uomo che stava morendo, sembra di peritonite, assistito solo da un infermiere. Tanto mi ha fatto pensare alle grida di quel povero disgraziato, operato da mani inesperte, ma non mi sono permesso di dire alcunché; è stato lui capace, era troppo furbo, di intercettare quanto mi passava per la testa e senza spiegarmi altro ha chiuso il colloquio con un significativo sorriso. Comunque scrivo di un comandante di eccezionale carisma e di indiscusso valore; viaggiava da Palermo, sede del comando, 114 fino ai reperti limitrofi, sempre e solo con l’aiutante maggiore, allora capitano, Antonio Perenze, degno in tutto del suo comandante, nonostante le insidie ed i pericoli costituiti da tanti malfattori. Sei mesi dopo le mie dimissioni ho appreso dei risultati ottenuti dal C.F.R.B. con la sconfitta definitiva del bandito e del banditismo, senza perdere un solo uomo, e ciò ha aumentato in me l’orgoglio di essere stato comandato da un simile ufficiale; una parte della stampa, di allora, ha ritenuto di criticare l’importanza di una operazione di polizia magistrale, ma questo non ha toccato in modo assoluto la statura del personaggio. E che dire del mio primo superiore il dottor Ciro Verdiani, capo dell’Ispettorato di P.S. della Sicilia, investigatore di fama, prodigo di consigli e di attenzioni per il mio lavoro. Non era tranquillo per avermi concesso di costituire la banda di irregolari che avevo voluto, perché temeva il rischio per un eventuale conflitto a fuoco, specie di notte, con le altre forze di polizia operanti sul territorio. E la di lui previdenza ha avuto due concrete realizzazioni: Con la mia squadra tornavo dalla montagna dopo una settimana di vagabondaggio (si dormiva sotto gli alberi, all’addiaccio), nel mentre arrivava la corriera proveniente da Palermo, o da Trapani, non rammento. Stanchi l’abbiamo fermata, tra la curiosità dei viaggiatori, siamo saliti a bordo e subito abbiamo scorto dal finestrino un individuo che, armato di mitra, camminava nel terreno posto in fondo d una scarpata; abbiamo fatto fermare l’automezzo e ci siamo precipitati giù, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare perché il soggetto era già corso via; gli abbiamo anche sparato per fermarlo, ma ormai era lontano. Sfortunatamente per noi, l’episodio era stato notato dalla non lontana caserma dei Carabinieri, dalla quale normalmente veniva controllato l’arrivo della corriera e così cinque o sei militi sono arrivati al comando di un giovane vice 115 116 brigadiere per arrestare noi ritenuti fuorilegge. Meno male che quei ragazzi avevano ancora in dotazione il moschetto, se avessero avuto i mitra ci avrebbero sterminati. La sparatoria è durata una decina di minuti finché, riparati stesi a terra dietro gli alberi, abbiamo levate le camicie e le abbiamo sventolate gridando che ci arrendevamo (non era servito il grido che eravamo poliziotti). Ci hanno arrestati e portati in caserma senza tante domande, e lì dopo aver chiarito tutto, siamo stati ospitati per la notte con gentilezza. Poco tempo dopo l’arresto è venuto da parte di una pattuglia, in divisa, della polizia: eravamo nei pressi di uno scalo ferroviario (io però li avevo già notati) quando siamo stati circondati ed obbligati a deporre le armi senza poter profferire parola; per fortuna nessuna sparatoria perché, edotti dalla precedente esperienza, abbiamo senza indugio alzato le mani in segno di resa. Il fatto che il Verdiani, come il successore, siano stati sottoposti a qualche critica postuma, mi ha fatto capire che non tutti sanno in quali difficoltà i due hanno dovuto operare; il primo ha dovuto affrontare due entità, delinquenza e mafia alleate, il secondo ha isolato la delinquenza dalla mafia, la quale oltretutto cominciava ad essere stanca, per i suoi fini, del bandito e dei banditi. Comunque entrambi sono stati per me punti di riferimento di altissimo valore. Prima di concludere mi è caro però ricordare la squadra di “straccioni” che tanto mi ha aiutato nel fare il lavoro commessomi, mostrando coraggio e sopportando sacrifici notevoli; non ricordo tutti i loro nomi, purtroppo, che brutta cosa la vecchiaia! Almeno due, mi sono rimasti impressi: - Il brigadiere Maimone che, salvo errore, ho saputo essere stato ferito in conflitto a fuoco con i banditi nei primi giorni dell’anno 1950 poco dopo la mia partenza; era coraggioso e per me era “l’esploratore”, nel senso che andava in ogni luogo, di giorno e di notte, da solo, per attingere ogni specie 117 118 di notizia utile, anche se difficile, presso pastori e contadini. Vestiva come noi altri, da bandito, ma per lui era più facile essere creduto tale altresì per lo stesso aspetto fisico, bruno, tarchiato, dall’aspetto più di un arabo che di un bianco. Mi sembra di sapere che abbia prestato servizio per lungo tempo, in modo eccellente, presso la Questura di Roma in compagnia di un cane, Dox, da lui personalmente addestrato. - La guardia Troisi, ancora giovane, dotato di notevole intuito investigativo, capace di captare benevolenza tra tutti gli strati sociali, finalizzata sempre, e solo, ad acquisire notizie utili per il suo lavoro; così una volta mi ha presentato un sacerdote, un’altra una prostituta, un’altra una pseudo-fidanzata, i quali dopo avere dichiarato il loro desiderio di collaborare finivano con l’esternare il loro interesse per la riscossione di una taglia, di cui formalmente io ignoravo l’esistenza. Le più recenti notizie di stampa riportano che, una fonte autorevole: “Salvatore Ingroia, procuratore aggiunto di Palermo, con un articolo pubblicato il 29 gennaio 2011 smentisce che il test del Dna sul cadavere di Salvatore Giuliano ne abbia confermato l’identità, come scritto da alcuni giornali. Per il magistrato, le analisi sono in corso e l’ipotesi della sostituzione di cadavere resta aperta. In particolare, Ingroia smentisce che sia già emersa la compatibilità tra il Dna estratto dal cadavere riesumato a ottobre a Montelepre e quello dei congiunti del bandito usato per la comparazione” Come chiamare tutto ciò se non “Mistero buffo”? Devo confessare che non ho avuto grandi risultati a Montelepre ma, a parer mio e non soltanto, alcune cose utili le ho fatte: ho eliminato l’uso delle auto (tutti a piedi, per lo più) onde evitare quel pericolo mortale che si chiama “agguato” pronto 119 a scattare in ogni curva di quelle colline ed ho aiutato le forze dell’ordine a riappropriarsi del territorio quasi perduto, con la tecnica appunto dell’agguato, consistente in appostamenti, specie notturni, in determinati, usuali punti di passaggio. In definitiva, nell’obbligare i banditi a sentirsi prede e non cacciatori. Ho stillato nei miei collaboratori fiducia nelle proprie possibilità facendogli scoprire un coraggio che non credevano di avere il quale viene fuori quando si è nel giusto e poi che nessun nemico è invincibile. Infine, ho salvato sicuramente molte vite. Comunque, ho sempre svolto ogni incarico con coscienza, scienza e fede. Grazie ancora a tutti coloro che hanno fatto qualcosa per me, ai miei genitori, all’Esercito Italiano, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri che ha accolto nella sua grande famiglia mio padre, mio zio e mio fratello e a tutti quanti hanno contribuito alla mia crescita di uomo e di vero Italiano. Viva l’Italia! 120 Bandiera dell’EVIS (Trinacria) 121 122 GIACOMO GAMBINO è nato a Torre Annunziata (Na) il 20 agosto del 1920 da Giovanni, militare della Real Arma dei Carabinieri e da Rosa Malvone. All’età di 6 anni si è trasferito a Nocera Inferiore (Sa) dove ha frequentato il Liceo Classico “Gian Battista Vico”. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi d Napoli “Federico II” appena terminata la Guerra (1939-1945). Ha partecipato, in qualità di ufficiale, alla Campagna di guerra sul Fronte Greco-Albanese (Elbasan) e a quella sul Fronte Russo (Don) nella Seconda Guerra Mondiale; per quest’ultima, è stato insignito di Croce di Guerra al Valor Militare (Pianoro W di Grasnorowca. Don, 14 dicembre 1942). Così motivata: “Già distintosi sotto intenso fuoco di armi automatiche e di mortai nemici, non esitava, alla testa dei suoi uomini, a portarsi avanti e riconquistare, a colpi di bombe a mano, nostre postazioni avanzate presidiate da nuclei nemici, che con efficaci tiri di armi automatiche ci causavano gravi predite”. Croce al Merito di Guerra, Croce di Ferro di Seconda classe della Wermacht (esercito tedesco), datata 17 aprile 1943. Prima di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, (G.U. 7.7.1950 Nr. 153) ha svolto mansioni di insegnante alla Scuola Allievi Guardie di P.S. di Caserta e ha partecipato, nel 1949, alle operazioni per la cattura del bandito Giuliano in Sicilia. Ha conseguito nel 1945 l’abilitazione di Procuratore Legale ed è stato Dirigente Ispettore Capo delle Imposte Indirette in Lombardia. Ha pubblicato “La tutela delle garanzie sui beni immobili nel Diritto di Famiglia” edito da Mereghetti-Brescia, nel 1976; “Formulario giuridico-fiscale della famiglia” e “Eredità. Chi sarà il proprietario dei tuoi beni?” con l’avvocato Carlo Masera editi dalla F.A.G.-Milano, nel 1977. Ha tenuto, inoltre, conferenze in moltissime scuole d’Italia sulla “Armata Scomparsa” e sulla “Lotta al Banditismo”. L’ultima del 4 novembre 2010, su invito del Comune di Sala Consilina, così 123 riportato dal sito www.ondanews.it: 04/11/2010 - Giornata del 4 Novembre: “Anche i comuni del Vallo di Diano e del Cilento hanno celebrato oggi la ricorrenza annuale del 4 novembre, giornata dedicata alle Forze Armate e alla commemorazione dei Caduti in guerra. In particolare questa mattina nell’aula magna delle scuole elementari di Via Matteotti le delegazioni degli studenti degl’Istituti d’Istruzione Superiore di Sala Consilina, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del mondo istituzionale e religioso e della società civile salese, hanno incontrato l’Avvocato Giacomo Gambino, membro dell’Associazione Nazionale Nastro Azzurro dei decorati al Valor Militare, dell’U.N.U.C.I (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) e dell’U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia), per ricordare il prof. Giuseppe Marcialis, Sindaco di Sala Consilina negli anni 1969-70, deceduto il 20 ottobre 2007. Entrambi condivisero l’esperienza della guerra in Russia: il professor Marcialis, ferito in un’azione di guerra, fu tratto in salvo dall’avvocato Gambino. L’incontro è stato preceduto dai saluti del dirigente scolastico Carmelo Setaro e del sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari. La testimonianza di Gambino è stata particolarmente toccante. Ha parlato del suo rapporto non solo di commilitone ma soprattutto di amicizia con il professore Marcialis. I due dopo aver combattuto altre guerre avevano scelto di partire come volontari per il fronte russo in qualità di ufficiali. L’intervento si è concluso con un invito agli studenti presenti nella Sala a battersi sempre per la pace perché nessuna guerra può essere giustificata da un motivo valido. La giornata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa in Piazza Umberto I e con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti per la Patria”. (Erminio Cioffi) Ed, inoltre, è stato recentemente invitato da Simone Cristicchi, tramite l’amico Andrea Bertola, a partecipare allo spettacolo “Li romani in Russia” che terrà prossimamente a Milano, con lo scritto così 124 formulato: “Venerdì 4 marzo sarò con lo spettacolo al Teatro Parenti di Milano. Se riesci a venire, con il signor Gambino, sarò felice di invitarlo e accoglierlo sul palco alla fine dello spettacolo.” 125 126 Indice Premessa di Giacomo Gambino pag. 5 Introduzione pag. 7 Parte Prima Capitolo I Giovinezza e arruolamento volontario Elbasan pag. 11 pag. 25 Capitolo II La Ritirata(Don) pag. 50 Rientro al Comando Batt. Rottura accerchiamento Arbusowa pag. 52 pag. 56 Capitolo III Parte Seconda Montelepre Biografia 127 pag. 91 pag. 123 Edizione S&T Impaginazione di Sinàtora & Turner adv www.sinatoraturner.com Finito di stampare nel mese di marzo 2011 128
Scaricare