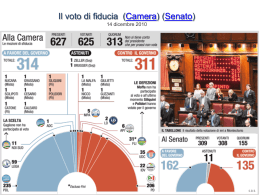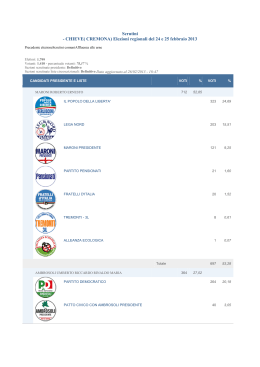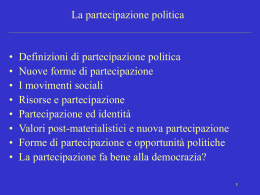RASSEGNA STAMPA martedì 27 maggio 2014 ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA INTERESSE ASSOCIAZIONE ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO L’UNITÀ AVVENIRE IL FATTO REDATTORE SOCIALE PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE ESTERI del 27/05/14, pag. 20 Il fronte anti-Ue potrebbe raggiungere 140 seggi, ma non supera quota 20% e si ferma sotto i timori della vigilia Largo allo scontento a Strasburgo: indignati, euroscettici, perfino neonazisti fanno il loro ingresso nell’assemblea I partiti tradizionali, pur perdendo voti, si spartiranno i posti di comando. I Popolari mantengono la maggioranza relativa Ma saranno costretti a trattare. Il primo vertice è andato male: la partita del dopo elezioni è appena cominciata I socialisti frenano l’onda populista ora è battaglia per la Commissione ANDREA BONANNI BRUXELLES . Il Parlamento europeo fa largo allo scontento che ribolle nella pancia di un un’Unione sottoposta a sei anni di durissima crisi economica. Tutti i partiti tradizionali perdono qualcosa. La destra populista e i movimenti anti-austerity guadagnano seggi. Ma sostanzialmente gli equilibri politici della nuova Europa non variano di molto. Il dato più rilevante, oltre all’avvento dei movimenti di protesta e populisti, è il sostanziale calo dei conservatori del Ppe, che però resta il partito di maggioranza relativa. In un parlamento che passa da 766 a 751 deputati, il Partito popolare perde 61 seggi fermandosi a quota 213. I socialisti perdono 7 deputati e sono secondi con 190 seggi: il tracollo dei francesi e degli spagnoli è quasi completamente compensato dal successo del Pd di Matteo Renzi e dei socialdemocratici tedeschi di Martin Schulz. I liberali perdono 19 seggi e si fermano a quota 64. I verdi ne perdono 4 ed eleggono 53 deputati. I conservatori euroscettici, principalmente inglesi, ne perdono 11 e hanno 46 deputati. L’estrema sinistra guadagna 7 seggi e arriva a 42, compresi i tre italiani della lista Tsipras. Guadagnano sette deputati anche gli anti-europei dell’EFD, il gruppo della Lega Nord, che salgono da 31 a 38. E aumentano i non iscritti, contenitore dove nella precedente legislatura si ritrovavano i pochi eurodeputati eletti dal Front National e dallo UK Independence Party, che arrivano a 41 seggi. E poi c’è la valanga dei nuovi movimenti di protesta, che si presentano per la prima volta a Strasburgo eleggendo 64 deputati. Tra questi ci sono i grillini italiani, gli indignati spagnoli, la femminista svedese, i neonazisti greci e pure l’unico neonazista tedesco. Se si mettono insieme i nuovi arrivati, i non iscritti e gli euroscettici dell’EFD si arriva a 143 deputati. Ma non tutti sono anti-europei. Non lo sono, per esempio, i greci di Potamos e verosimilmente neppure gli spagnoli di Podemos. Comunque i centri studi concordano sul fatto che il fronte anti-Ue potrebbe raccogliere circa 140 eletti, sia tra le file della destra populista sia tra quelle dei protestatari a vario titolo. Anche così, siamo comunque al di sotto del 20 per cento: meno di quanto facevano temere le previsioni della vigilia. Se anche a questi si dovessero aggiungere i conservatori britannici, saremmo comunque al di sotto del 25 per cento: meno di un quarto dei deputati eletti. L’onda lunga della paura e della protesta, dunque, non travolge le istituzioni europee. Anche perché, arrivata nell’emiciclo di Strasburgo, si frammenterà in rivoli e rivoletti. 2 Marine Le Pen formerà un gruppo politico, contando sulla Lega e sull’estrema destra olandese, austriaca e fiamminga. Non faticherà a trovare altre due formazioni per mettere insieme i venticinque deputati di sette Paesi diversi necessari per la costituzione di un gruppo parlamentare. Tuttavia né Grillo, né lo Ukip di Farage vogliono aver niente a che fare con la Le Pen: troppo di destra e troppo razzista. Farage, che dovrebbe portare 24 deputati, potrebbe avere difficoltà a trovare compagni di strada di altri sei Paesi e lancia messaggi a Grillo. Ma, come al solito, non si capisce ancora da che parte vorrà stare il Movimento Cinque Stelle. Ad ogni modo la formazione di un terzo gruppo anti-euro, oltre all’EFD e a quello di estrema destra della Le Pen (che però non vuole i neonazisti), appare problematica: se ci si arriverà, sarà probabilmente il frutto di un assemblaggio di forze eterogenee che difficilmente potranno dare un contributo politico coerente. Il risultato paradossale è che il successo degli anti-euro avrà ripercussioni sull’Europa più attraverso gli sconvolgimenti che produrrà in due Paesi chiave come la Francia e la Gran Bretagna, destabilizzando la prima e accelerando l’uscita della seconda dall’Ue, che attraverso i deputati al Parlamento europeo. Sul fronte opposto, i quattro partiti europeisti hanno già avuto i primi contatti per formare una maggioranza in grado di governare l’Unione. Popolari, socialisti, liberali e verdi perdono tutti qualche seggio, ma possono comunque contare su una vastissima maggioranza parlamentare del 70 per cento. Tutti e quattro hanno escluso qualsiasi dialogo con le formazioni populiste e anti-euro e dunque sono condannati a intendersi. Ma un primo incontro, nella notte di domenica, tra Jean-Claude Juncker e Martin Schulz pare sia finito male. Juncker, che sarà il primo a cercare di formare una maggioranza, insiste sul proprio diritto alla presidenza della Commissione come candidato del partito più forte. Ma ieri la Merkel, pur complimentandolo per la vittoria, ha accuratamente evitato di schierarsi esplicitamente in suo favore. La Cancelliera oggi vedrà i suoi alleati socialdemocratici e questa sera incontrerà a Bruxelles gli altri capi di governo europei. La partita del dopo elezioni è solo alle battute iniziali. del 27/05/14, pag. 20 Bruxelles, ipotesi grande coalizione Spuntano i nomi degli outsider Maggioranza cercasi, presidenti cercasi. E meno male che questa volta non c’è un caso Buttiglione. Nel 2004, le elezioni nella Ue si tennero a metà giugno, e a metà ottobre ancora si litigava sulla composizione della nuova Commissione Europea: Rocco Buttiglione, commissario designato alla giustizia, aveva fatto alcune dichiarazioni critiche sui gay, e perciò l’Europarlamento gli aveva posto il veto. Oggi, nel 2014, proprio la volontà di avere decisioni rapide ha fatto anticipare il voto europeo a maggio: ma non sarà lo stesso facile trovare una coalizione di maggioranza, né il nuovo presidente della Commissione Europea, che per la prima volta spetterà al Parlamento indicare. I negoziati ufficiosi sono già in corso. Questa mattina, si riuniranno i presidenti dei gruppi parlamentari uscenti. Stasera, arriveranno a Bruxelles i capi di Stato e di governo dei 28 Paesi, per partecipare a una «cena informale», cioè a un vertice del Consiglio Europeo appena meno solenne del solito, che parlerà anche (o soprattutto) del futuro capo della Commissione. Nelle settimane seguenti, si continuerà a negoziare. Per il 24 giugno dovranno essere formati tutti i gruppi politici. E per il 26-27 giugno, quando si terrà il Consiglio Europeo vero e proprio, si conta di aver concordato una soluzione, per i capi 3 della Commissione, dell’Europarlamento, del Consiglio dei ministri Ue. L’Europarlamento si riunirà poi a inizio luglio. Sulla carta, oggi tutto sembra chiaro. Il primo partito d’Europa è il Partito popolare europeo, il Ppe, con 213 seggi e il 28,36% dei voti. Il suo candidato alla presidenza della Commissione è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, e dunque Juncker dichiara oggi: «Come candidato di punta del partito maggiore, io ho vinto l’elezione». Non accetterà di farsi da parte per favorire un altro candidato Ppe, aggiunge, e cercherà di formare una maggioranza «filo-Europa» con verdi, liberaldemocratici e socialisti: argine contro la marea degli antieuropeisti alla Le Pen. Ma il suo principale rivale, il tedesco Martin Schulz, socialista democratico, forte dei 190 seggi ottenuti dal suo partito con il 25,3% dei voti, non ha ancora riconosciuto la sconfitta. E la scelta del presidente della Commissione richiede una maggioranza assoluta di 376 voti, su un totale di 751 deputati. Anche Schulz, dice, cercherà di formare una maggioranza, sulla lotta alla disoccupazione giovanile o alle frodi fiscali. Per aderirvi, Juncker potrebbe chiedergli in cambio una posizione più morbida sul Trattato di libero scambio fra Ue e Usa, considerato troppo liberista a sinistra, o una spinta decisa alla liberalizzazione dei servizi sul mercato interno. Angela Merkel avrà un ruolo di grande mediatrice e prova a lanciare un ponte tra i due schieramenti, assicurando che occorre rilanciare «competitività, crescita e lavoro». Nessuno lo dice apertamente, tutti lo pensano: l’ideale per Bruxelles e Strasburgo è ancora una grande coalizione Ppe-Pse sul modello tedesco, per garantire la stabilità, il cammino delle riforme. E per frenare quelli che già vengono chiamati «gli Unni», i barbari alle porte, i vari Farage o Le Pen. Questa coalizione richiederebbe 403 seggi, il 54% dei voti: margini sottili, percorsi da equilibristi. Come altri, del resto: per convincere Schulz a farsi da parte, Juncker potrebbe garantirgli la successione a Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio Europeo, ormai vicino alla scadenza. E non sono ancora del tutto esclusi gli «outsider», i candidati esterni: Christine Lagarde, matrice Ppe, direttore generale del Fondo monetario internazionale, o Helle Thorning-Schmidt, socialista, primo ministro della Danimarca. Luigi Offeddu del 27/05/14, pag. 1/35 La Ue e la sindrome del Re di Francia TIMOTHY GARTON ASH IL GIORNO della presa della Bastiglia nel 1789, re Luigi XVI scrisse sul suo diario rien. Pochi leader europei avranno digitato la parola “niente” sui loro iPad ieri. MA ESISTE il pericolo che in risposta al grido rivoluzionario risuonato nel continente effettivamente non facciano nulla. Il rien di oggi ha un volto e un nome. Si chiama Juncker. Jean-Claude Juncker. Sarebbe un disastro se i leader europei rispondessero scegliendo come presidente della Commissione Europea Juncker, lo Spitzenkandidat del maggior gruppo politico del nuovo parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, di centrodestra. L’astuto lussemburghese è stato a capo di un governo nazionale Ue più a lungo di qualsiasi altro nonché presidente dell’Eurogruppo nel periodo peggiore dell’eurocrisi. Benché possieda notevoli doti di politico e sia abile nel concludere accordi incarna però tutto ciò che di infido il voto di protesta, da destra a sinistra, associa alle remote élite europee. Possiamo dire che Juncker è il Luigi XVI dell’Ue. 4 Il pericolo sta anche nei verosimili sviluppi nel Parlamento europeo. L’evoluzione più probabile è una sorta di grande coalizione implicita dei maggiori gruppi politici, centrodestra, centrosinistra, liberali e (almeno su alcune tematiche) i Verdi, allo scopo di tenere a bada tutti gli anti-partiti. Se altri sei dei partiti più xenofobi e nazionalisti accetteranno la guida della trionfatrice Marine Le Pen del Fronte Nazionale francese occultando le differenze per dar vita ad un gruppo riconosciuto in seno al parlamento, otterranno finanziamenti (dalle tasche dei contribuenti europei) e una posizione più forte nel processo parlamentare, ma non ancora voti sufficienti a sopraffare una grande coalizione centrista. Siamo sicuri che sia un bene? Nel breve periodo sì. Ma solo se la grande coalizione poi sosterrà una decisa riforma dell’Unione Europea. Si dovrebbe partire, simbolicamente, da uno stop al consueto pendolarismo tra la spaziosa sede di Bruxelles e quella lussuosa di Strasburgo — la Versailles dell’Ue — al costo stimato di 180 milioni di euro l’anno. Se però la grande coalizione implicita non produrrà risultati più fedeli ai desideri di tanti europei nell’arco dei prossimi cinque anni, non farà che rafforzare il voto anti Ue alla prossima tornata elettorale. Perché dell’insuccesso saranno ritenuti responsabili tutti i partiti tradizionali. L’unico lato positivo di questo guaio di dimensioni continentali è che per la prima volta dalla elezione diretta del parlamento, nel 1979, nel complesso l’affluenza alle urne non è apparentemente diminuita. Il dato varia in misura notevole da paese a paese — in Slovacchia è stato stimato al 13 per cento ma in Francia, ad esempio, sono andati a votare molti più elettori rispetto all’ultimo scrutinio. Si è finalmente visto quello che i filo europei predicano da tanto tempo: i cittadini europei attivamente impegnati nel processo democratico europeo. Ma, per somma ironia, lo fanno per votare contro l’Unione. Qual è il messaggio lanciato dagli europei ai loro leader quindi? Lo ha riassunto in maniera perfetta il disegnatore satirico Chappatte, in una vignetta che rappresenta un gruppo di dimostranti che reggono un cartello con su scritto “Scontenti” — e uno di loro urla col megafono nell’urna elettorale. Gli Stati membri sono 28 ed esistono 28 varianti di scontento. Alcuni dei partiti di protesta vittoriosi sono realmente di estrema destra: in Ungheria, ad esempio, Jobbik ha ottenuto tre seggi e più del 14% dei voti. La maggior parte, come l’Ukip vincente in Gran Bretagna, attingono elettori a destra e a sinistra, puntando su sentimenti nazionalisti e xenofobi, tipo “riprendiamoci il mostro paese” e “troppi stranieri, pochi posti di lavoro”. Ma in Grecia il grosso del voto di protesta è andato a Syriza, partito di sinistra e antiausterity. Simon Hicks, dall’alto della sua competenza riguardo al Parlamento europeo ha individuato tre principali scuole di scontento: i nordeuropei estranei all’Eurozona (britannici, danesi); i nordeuropei interni all’Eurozona (quei tedeschi che hanno procurato parecchi seggi al partito anti euro Alternative für Deutschland); gli europei del Sud interni all’Eurozona (greci, portoghesi). Restano fuori gli europei dell’Est, molti dei quali sono scontenti a modo loro. Il fatto che lo scontento giunga al problema da angolazioni diverse rende più arduo affrontarlo. La politica dell’eurozona che sognano gli elettori di Syriza è l’incubo di chi ha votato Alternative für Deutschland. Ma c’è una cosa che accomuna tutti: la paura per le opportunità dei loro figli. Fino a circa dieci anni fa generalmente si presumeva che per la generazione successiva le cose sarebbero andate meglio. L’“Europa” rientrava in una storia più ampia di progresso. Ma un sondaggio Eurobarometro degli inizi dell’anno ha rivelato che più della metà degli intervistati è convinto che i bambini di oggi avranno maggiori difficoltà nell’Europa di domani rispetto al presente. C’è già una generazione di laureati europei che si sente derubata del futuro che secondo le previsioni li attendeva. Sono gli appartenenti alla nuova classe sociale dei precari. 5 In un momento così drammatico per l’intero progetto europeo vale la pena di ritornare agli esordi al Congresso d’Europa del 1948, in cui il veterano paladino della Pan-Europa, Richard Coudenhove-Kalergi, così ammonì i cofondatori: «Non dimentichiamoci mai, cari amici, che l’Unione Europea è un mezzo, non un fine». Vale oggi come ieri. L’Unione Europea non è fine a se stessa. È un mezzo al fine di garantire al suo popolo una vita migliore — più prospera, più libera, più sicura. Ora bisogna quindi concentrarsi fortemente sui risultati. Basta con gli interminabili dibattiti istituzionali. L’interrogativo non è “più o meno Europa?” ma “più o meno cosa?”. Ad esempio, serve più mercato unico nel settore dell’energia, delle telecomunicazioni, di Internet e dei servizi, ma forse meno politica determinata da Bruxelles per la pesca e la cultura. Bisogna assumere qualunque iniziativa produca anche solo un posto di lavoro per un disoccupato europeo. La burocrazia che fa perdere il lavoro va eliminata. Non è il momento di gente come Juncker. È il momento di chiamare in Commissione europea tutti i talenti, sotto la guida di un presidente di provata capacità, come Pascal Lamy o Christine Lagarde, totalmente dedito al compito di convincere le legioni degli scontenti che esiste un futuro migliore per i loro figli e che quel futuro è in Europa. Ecco cosa dovrebbe accadere. Ma accadrà? Ho la terribile sensazione che in futuro gli storici possano dire delle elezioni del maggio 2014 “furono il campanello d’allarme cui l’Europa non seppe reagire”. ( Traduzione di Emilia Benghi) Del 27/05/2014, pag. 13 Pp e Psoe giù, Madrid premia gli indignados È andato tutto come previsto, in Spagna, in questa tornata elettorale per eleggere il parlamento europeo. O almeno, quasi tutto. Confermata la crisi del bipartitismo, con una sconfitta sonora per i due principali partiti dell’arco costituzionale, il partito di governo, il Pp, e il principale partito di opposizione, il Psoe, che insieme perdono 5 milioni di voti, scendendo sotto la soglia del 50%. E, come previsto, a beneficiarne sono state le formazioni intermedie, come Izquierda Unida, cresciuta di quasi il 10% e Uniòn Progreso y Democracia (+6,5%), mentre Ciutadans si affaccia in Europa con la conquista di due seggi. Il Partido Popular festeggia a denti stretti la reiterata primazia tra i partiti, ma perde ben 7 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2009, e ancora di più rispetto alle politiche del 2011. I socialisti scendono al minimo storico, con appena il 23% dei suffragi e si preparano alla celebrazione di un congresso straordinario per il prossimo mese di luglio. Un anticipo sulla tabella di marcia che guardava alle primarie per eleggere il nuovo leader del partito non prima del prossimo autunno. Riconoscono la sconfitta il segretario Alfredo Pérez Rubalcaba e la capolista Elena Valenciano, una sconfitta tanto più bruciante perché avvenuta dopo tre anni di governo in cui i popolari hanno dilapidato gran parte del bottino elettorale del 2011, grazie alla gestione anti- sociale della crisi, i tagli ai diritti sociali e di cittadinanza e gli scandali di corruzione che hanno investito il partito di governo. Il Psoe cede quote di elettorato alla sua sinistra, con l’affermarsi di nuove formazioni e la crescita di quelle più note, e flettono in alcune aree del Paese da cui un tempo invece attingevano a piene mani, come la Catalogna. La vera novità nel panorama politico spagnolo è rappresentata dall'affermazione di Podemos, di orientamento progressista: ha conquistato 5 seggi nel parlamento europeo, con un discorso costruito dal basso e attraverso le reti sociali, orientato alla rigenerazione democratica del sistema. L’astensione invece, contrariamente ai timori della vigilia, si è mantenuta a livelli «fisiologici», attorno al 46%, 6 addirittura con un leggero aumento di partecipazione sul 2009. Soprattutto in Catalogna sono andati a votare, oltre il 10% in più rispetto alle precedenti europee, quando appena il 37% si era recato alle urne: un voto per l’Europa, con uno sguardo rivolto ad un’altra consultazione, quella che si vorrebbe celebrare per decidere del proprio futuro come nazione. Così in Scozia, dove si è avuto un aumento di votanti del 6%, ed una data di referendum sull’indipendenza già fissata e concordata con il governo inglese per settembre. In Catalogna esce rafforzato lo schieramento per la celebrazione del referendum, oltre il 55% dei suffragi. È soprattutto Esquerra Republicana a capitalizzare il sentimento indipendentista, diventando per la prima volta, dai tempi della Seconda Repubblica, primo partito, con il 23,7% dei consensi. Ha basato la sua campagna sull’attrazione del catalanismo che non si sente più rappresentato dal Psc, il partito socialista catalano e ha proposto nella sua lista Ernest Maragall, ex-dirigente Psc e fratello di Pasqual Maragall, il sindaco delle olimpiadi di Barcellona ed ex-presidente della Generalitat. Relegando, così, Convergència i Unio' al secondo posto, con il 21,9% dei voti. Terzi i socialisti catalani, con poco più del 14%. Per un autunno che, in Catalogna, vivrà una nuova fase nella campagna per il diritto a decidere. Del 27/05/2014, pag. 4 Galassia Tsipras, dalla “periferia” soffia il vento dell’alternativa Europarlamento. La crescita del Gue/Ngl, il gruppo più a sinistra nell’emiciclo di Strasburgo. Guidano la carica Syriza e gli «indignados» spagnoli, ma anche l’exploit irlandese... E non sarà crociata antitedesca, grazie ai voti della Linke Jacopo Rosatelli Un dato è certo: nel nuovo Europarlamento il gruppo più a sinistra nell’emiciclo (Gue/Ngl) sarà molto più grande che nella legislatura precedente. In una tornata elettorale contraddistinta dall’avanzata dei populisti xenofobi, il risultato della «galassia Tsipras» rende il quadro un po’ meno fosco. Un fatto politico che i media mainstream tendono consapevolmente a occultare, o a falsificare mettendo destra e sinistra alternativa nello stesso sacco euroscettico. Ma che è necessario tenere in considerazione, per molte ragioni, tra le quali una delle più importanti è che tale dato permette di capire meglio il clima politico nei Pigs, i Paesi sottoposti – in varia misura – ai «piani di salvataggio» targati troika (Commissione Ue, Bce, Fmi). Il vento della sinistra, infatti, soffia decisamente dalla «periferia»: la delegazione più numerosa (in termini assoluti) del gruppo sarà quella spagnola (10 membri), seguita da quella greca (8). E se si considera la quantità di deputati in relazione alla popolazione, spicca l’exploit degli irlandesi (4 sul totale di 11), e va registrata la buona performance portoghese (3 su 21). La risposta all’austerità, dunque, non arriva da destra, ma da quelle forze che si sono battute negli ultimi anni contro il massacro dei diritti sociali. Con eccezione del Portogallo, alla crescita delle sinistre di opposizione corrisponde un arretramento dei socialisti, spesso e volentieri artefici insieme ai conservatori dei disegni neoliberali orchestrati da Bruxelles, Francoforte (e Berlino): clamoroso è il già notissimo caso greco, ma significativo appare anche l’indebolimento del Psoe in Spagna. Nei Paesi centrali dell’Unione, Germania e Francia, le forze della sinistra alternativa hanno sostanzialmente mantenuto le posizioni che avevano: la Linke (al 7,4%) manda 7 deputati 7 a Strasburgo, il Front de Gauche (al 6,3%) ne invia 4. La guida della resistenza all’austerità è dunque appannaggio delle «periferie», ma la forza – in termini assoluti – della Linke consente di mantenere un equilibrio «centro-periferia» necessario a far sì che la critica alle politiche dominanti non assuma toni da crociata «anti-tedesca». Gli assetti di potere nella Ue potranno essere alterati davvero solo dalla spinta delle sinistre «periferiche», quella greca in testa, ma l’alternativa alle attuali politiche non potrà fare a meno del contributo delle «vittime della crisi» che abitano numerose anche il Paese geoeconomicamente dominante, la Germania. Strati sociali che la Linke riesce, anche se con fatica, a rappresentare. Le forze che, dopo questo voto, comporranno il Gruppo della Sinistra unitaria/Sinistra verde nordica (è questo il significato per esteso di Gue/Ngl) sono omogenee nel loro rifiuto dell’austerità e dell’Europa della tecnocrazia, ma diverse per storia, profilo ideologico, e forma organizzativa — e per il dettaglio non trascurabile che non tutte sono inquadrate nel Partito della Sinistra europa (Se) di Tsipras. Oltre alla differenza che è inscritta nel nome del gruppo (la «Sinistra verde nordica» comprende, ad esempio, il Ps olandese, anch’esso premiato dalle urne), va considerato che nella «Sinistra unitaria» convivono forze che vogliono «un’altra Ue» insieme a organizzazioni che criticano alla radice il processo d’integrazione. Spesso, come nel caso di Grecia e Portogallo, si tratta di partiti diversi dello stesso Paese: le tesi sull’Ue di Syriza (al 26%) non sono quelle dei comunisti ortodossi del Kke (6%), e lo stesso vale per il Bloco de Esquerda (4,6%) e il Pcp (12,7%). Punti di vista distinti (e talvolta distanti) che si ritrovano nelle varie correnti di Izquierda unida, della Linke e del Pcf. Forze che, pertanto, sono interessate a mantenere «unito nelle differenze» il Gue. Cifre definitive sulla consistenza di ciascun gruppo parlamentare ancora non ci sono, perché di molti neoeletti ancora non si conosce l’affiliazione: la competizione per diventare terza forza a Strasburgo è, dunque, ancora aperta. Oltre al contributo italiano — sperato ma in dubbio fino all’ultimo — a fare vincere la medaglia di bronzo alla sinistra potrebbero rivelarsi decisivi, alla fine, gli spagnoli di «podemos», l’autentica sopresa del voto iberico di domenica (8%). Dei 10 deputati in arrivo dalla Spagna, la metà sono loro: combattivi indignados che nel giro di pochi mesi, sotto l’abile regia del giovane politologo e mediattivista Pablo Iglesias, hanno costruito — prevalentemente attraverso la rete — un capolavoro politico. Forti del risultato acquisito, i partiti che formano il Gue/Ngl dovranno ora porsi il difficile problema di riuscire a penetrare nella terra incognita dell’Europa centro-orientale che fu realsocialista: le sfide del futuro si chiamano Polonia, Ungheria e Romania. Del 27/05/2014, pag. 7 Tsipras dal presidente: ora elezioni anticipate Grecia. Syriza sbaraglia tutti e conquista anche l’Attica È scontro in Grecia sulle elezioni anticipate. Il premier Antonis Samaras difende lo status quo, il leader del partito della sinistra radicale Syriza, Alexis Tsipras, forte del risultato di amministrative e soprattutto europee che ribalta la situazione, è di tutt’altro parere. Ieri lo ha ribadito al presidente della Repubblica ellenica Karolos Papoulias da cui è stato ricevuto. Alle europee Syriza ha ottenuto il 26.57% contro il 22.75% del partito del premier, Nea Dimokratia. È il primo partito greco. 8 Nelle regionali Syriza ha conquistato l’Attica con il 50,83% (la più grande regione del Paese sarà governata ora da Rena Dourou) e Ie isole Ionie. Ha perso invece Atene: il suo candidato ha preso il 48.4% contro il 51.6 del sindaco uscente appoggiato dal Pasok. del 27/05/14, pag. 23 Discorso del presidente pesantemente sconfitto “L’Ue troppo lontana, è diventata incomprensibile” Ma le riforme del governo Valls non si fermeranno Resa dei conti anche tra i conservatori dell’Ump Chiesta la testa del leader Jean-François Copé coinvolto in uno scandalo di false fatturazioni Hollande si assolve: “Colpa del rigore” ANAIS GINORI DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI . «L’austerità ha finito per scoraggiare l’Europa». Il giorno dopo il trionfo del Front National, François Hollande parla in televisione per cinque minuti. Il presidente socialista prende atto del risultato definito “doloroso”, in cui il Ps è precipitato al 14%, minimo storico, mentre il Fn vola al 25,4% e l’Ump si attesta al 20,4%. «Un elettore su quattro ha votato per l’estrema destra», sottolinea Hollande. «L’anti-europeismo va avanti ovunque, ma è proprio in Francia, paese fondatore dell’Unione europea, dove l’estrema destra è arrivata largamente in testa». Hollande usa più volte il termine «sfiducia» nei confronti di Bruxelles, cita «l’amore per la Francia», lancia segnali agli euroscettici di casa, riconoscendo che il funzionamento dell’Ue deve diventare «più semplice, chiaro, efficace». «L’Europa — continua — appare lontana, è diventata incomprensibile». Nel suo discorso televisivo registrato all’Eliseo ieri pomeriggio dopo una riunione di crisi con alcuni ministri, il capo di Stato paventa un ridimensionamento dei poteri dell’Ue, così come chiedono gli elettori sovranisti del Fn. «L’Europa deve ritirarsi laddove non è necessaria» commenta Hollande, prima di ribadire la sua fierezza di essere europeo. Un esercizio difficile e che non convince. Il Presidente prova a dare un senso di urgenza al cambio chiesto dal voto. «I francesi non possono attendere». Poi però fa capire che non ci saranno modifiche al programma di governo di Manuel Valls, ovvero le riforme economiche per favorire la lotta alla disoccupazione. In casa socialista è scoppiato il panico, tanto che ormai i sondaggisti si scatenano per trovare un successore all’impopolare leader. Valls viene indicato come un buon candidato per le presidenziali del 2017 dal 49% dei francesi. Sconfessato per ben due volte dalle urne in meno di due mesi, alle amministrative e alle europee, Hollande oggi arriva a Bruxelles in una posizione sempre più debole e scomoda. Il terremoto delle europee ha aperto la resa di conti anche dentro all’Ump. Il presidente, Jean-Francois Copé, è pesantemente invischiato nello scandalo Bygmalion, un giro di false fatturazioni con soldi del partito finiti nelle tasche di amici. Oggi si riunisce l’ufficio politico che chiederà la sua testa. Come se non bastasse, ieri la sede dell’Ump è stata perquisita dalla magistratura mentre l’avvocato di Copé ha cominciato a chiamare in causa Nicolas Sarkozy. Le ambizioni dell’ex Presidente potrebbero essere cassate dalle nuove accuse dei suoi rivali. 9 del 27/05/14, pag. 19 Farage mette nell’angolo Cameron Verso la scelta: dentro o fuori dalla Ue? LONDRA - «Ma quale uomo da pub?» Cameron è in grave difficoltà. Per la prima volta nella storia i conservatori sono il terzo partito e per la prima volta da 100 anni né i tory né i laburisti vincono le elezioni nazionali. E' un colpo durissimo quello che lo Ukip ha assestato al sistema politico britannico: è in testa con il 27,49% dei consensi e ha 24 parlamentari europei eletti. Ma il premier cerca di guardare al domani e soprattutto alle elezioni generali del 2015. Allora comincia a punzecchiare Nigel Farage che è riuscito nell'impresa di dipingersi come il prototipo dell'inglese medio: l'inglese dell'Esso, moderato deluso e benestante, il lavoratore che lavora e si concede la pinta di birra serale. Mossa abile. Però, altro che borghese ordinario. Dice David Cameron del leader Ukip: «E' un consumato politico, un tattico molto bravo». E con qualche scheletro nell'armadio. Tipo quelle «grandi note spese» rivendicate in qualità di parlamentare europeo. E quella strana storia della moglie a libro paga, sempre del parlamento europeo. I risultati del test europeo costringono i tory (con 7 seggi in meno) a rimodellare le strategie di breve e medio termine. Nel Sud inglese e nelle Midlands orientali, le terre dei conservatori, lo Ukip marcia oltre il 30% e David Cameron prova a prendere subito le contromisure, il primo pensiero va quindi a Nigel Farage ma la battaglia di fondo, per lui, resta quella contro i laburisti. Oggi è convinto che la corsa a Downing Street, nel 2015, si giocherà imbracciando l'arma dell'euroscetticismo e del referendum (sì o no all'Europa) nel 2017. Così crede di depotenziare lo Ukip e di mettere nell'angolo i laburisti che tergiversano. «La domanda semplice sarà: volete David Cameron, il premier che convocherà il referendum sull'Europa o volete Ed Mitiband che preferisce lo status quo?» L'onda dei movimenti euroscettici sembra dare una mano a Cameron. La lettura del voto che offre il leader tory è evidente: senza una ridiscussione dei trattati Londra se ne va e l'Unione muore. E' il momento di spingere, cavalcando i messaggi dell'elettorato britannico e continentale, così da recuperare la dissidenza suggestionata dallo Ukip e da stanare i laburisti, i quali sull'Europa sono in imbarazzo perché spaccati fra prudenti euroscettici e convinti sostenitori. Per Cameron è un silenzio che non paga. Di conseguenza affonda. Ma Ed Miliband (secondo partito col 25,4% e 20 seggi) è convinto che la lettura dei numeri sia diversa. Non è a causa dell’euroscetticismo che ha mancato il pieno. I consensi perduti a favore di Nigel Farage hanno altre motivazioni: sono la mancanza di sicurezza sociale, la sanità pubblica a pezzi, il lavoro minacciato. Il leader laburista continua a tenere bassi i toni contro Nigel Farage e quasi non ne pronuncia il nome. Risorge dal mutismo persine Tony Blair per il quale «le sfide del ventunesimo secolo non si vincono agitando gli spettri dell'Europa cattiva e degù' immigrati » e per il quale occorrono risposte forti allo Ukip. Ed Miliband, invece, sì limita a ripetere che il messaggio lo ha capito ma la sua strategia per arrivate a Downing Street fa leva sul malcontento per i servizi pubblici tagliati e per l'assistenza ai più deboli ridimensionata. «Sull'Europa non cambiamo posizione» e resta reticente. Laburisti e conservatori, barcollando impostano due percorsi diversi di «salvezza». Nigel Farage un'idea precisa l'ha già: sfidare i tre leader (Cameron, Miliband e Clegg, il libdem sull'orlo del collasso con appena il 6,8% e io seggi su li perduti) che sono come «tre pesci rossi boccheggianti fuori dall'acqua», poi puntare a 20 o 30 collegi sicuri del Sud e nelle-Midlands inglesi nelle elezioni per Wesrminster e diventare lui l'ago della 10 bilancia negli equilibri politici. Duella subito coi tory il 5 giugno nelle elezioni suppletive per uno scranno ai Comuni, in un collegio del Nottinghamshire, fortino conservatore. E va al cuore dell'impero laburista preannunciando il lancio del manifesto programmatico dello Ukip dal Doncaster, nello Yorkshire, il collegio, guarda caso, di Ed Miliband. Ha il vento in poppa e sta consolidando la sua dote di popolarità. Fabio Cavalera del 27/05/14, pag. 19 La tentazione razzista del populismo E’ allora che la democrazia è a rischio di JEAN MARIE COLOMBANI Le elezioni europee hanno dunque avvantaggiato il Front National, n partito della famiglia Le Pen ha raccolto l'adesione di s un francese su quattro. Stando al rumore mediaticopolitico nazionale, si ha l'impressione di essere all'indomani di uno scrutinio presidenziale, come testimoniano il tono magniloquente dì Marine Le Pen — «pronta ad assumersi le proprie responsabilità»—e soprattutto la sua richiesta di scioglimento dell'Assemblea nazionale, a condizione tuttavia che esso sia accompagnato dall'introduzione della proporzionale. Difficile quindi astrarsi dalla macchina che suscita emozioni. Ma ciò non impedisce di osservare lo scrutinio in modo diverso. La posta in gioco — inutile ricordarlo — era la composizione del Parlamento europeo. E, a partire da questa, il colore politico e il programma del futuro presidente della Commissione europea. La destra conserva una maggioranza relativa e rivendica quindi la presidenza, perdendo però 60 seggi. Globalmente, la sinistra progredisce. E i partiti eurofobi, euroscettici ed estremisti non hanno sfondato come ci si attendeva: se si aggregassero, il che è politicamente impossibile (per esempio Ukip, Uk independence party, rifiuta di allearsi con il Fn, che giudica «antisemita »), essi raggiungerebbero un totale di 150 deputati, o poco meno, e non sarebbero quindi in grado di sconvolgere il funzionamento del Parlamento, né di distruggere le istituzioni europee dall'interno, come alcuni avevano l'ambizione di fare. In effetti, l'avanzata di questi movimenti è sensibile soprattutto in Francia, ma anche in Austria, in Danimarca o in Ungheria, Paesi in cui l'estrema destra continua a progredire; e in modo spettacolare anche in Gran Bretagna, con il «trionfo» dell’Ukip. L'esempio austriaco mostra del resto che la spiegazione secondo cui questi risultati sono dovuti alla crisi è insufficiente, poiché in Austria c'è il pieno impiego. I punti in comune sono da ricercare nella parte più pericolosa, quella che vede l'avvicinarsi mite, al grande movimento anti-élite che percorre il nostro continente. Quando queste due correnti si congiungono, allora sì, la democrazia è in pericolo. Ma relativizzare l'emozione non esclude di misurare l'impatto politico dello scrutinio. La differenza di cultura è qui determinante: in Gran Bretagna, la vittoria dell’Ukip non induce nessuno a reclamare le dimissioni di David Cameron, il cui partito finisce al terzo posto, mentre il suo alleato liberal-democratìco è sul punto di scomparire. Il voto europeo è un voto dì sfogo. In Francia, invece, è la legittimità del suo Presidente e del suo governo a essere subito messa in causa. Tuttavia, in ognuno dei Paesi in cui si verifica l'ascesa di gruppi politici estremi, c'è da aspettarsi conseguenze sulla linea di condotta delle politiche europee. Anche se è chiaro che l'accertazione da parte di David Cameron di un referendum prò o contro l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ha legittimato la mossa dell’Ukip. Allo stesso modo, in Francia, la richiesta di Nicolas Sarkozy di sospendere gli accordi di 11 Schengen (per sostituirli con uno Schengen 2...) è giunta in aiuto del tema centrale del Fn, l’immigrazione. Ma verosimilmente c'è da attendersi da parte dei Paesi interessati un inasprimento delle rivendicazioni nei confronti di Bruxelles, sebbene sappiamo che tale gioco è perfettamente ipocrita, poiché Bruxelles decide solo quello che i governi hanno deciso. Occorre ricordare che in Francia solo quattro francesi su dieci hanno partecipato al voto. Per cui, quando si annuncia che il 30 per cento dei giovani ha votato per il Fn, si tratta del 30 per cento su un totale del 40 per cento. Non è la stessa cosa. Fra questi votanti, il 40 per cento hanno dichiarato che la loro scelta era determinata da motivi nazionali. Il che dovrebbe smorzare gli ardori di coloro che pretendono di aprire subito la crisi politica! Mentre l'elettorato del Fn fa blocco e resta mobilitato da uno scrutinio all'altro, quello dei partiti prò-europei stavolta si è spaccato, si è sparpagliato in una quantità dì liste. Astensione e dispersione dovrebbero dunque equilibrare la lettura del voto. Tanto più che in Francia le votazioni decisive, che siano locali o nazionali, avvengono sempre con scrutinio maggioritario a due turni, il che obbliga a rinunce o al riavvicinamento tra i due turni, mentre nelle elezioni europee si votava in un solo turno e con la proporzionale integrale. Resta il fatto che l'interpretazione stessa del voto produce a sua volta una realtà politica. Ed è questa che occorre guardare in faccia. Sul piano nazionale, si tratta dì sapere se la Francia non sia sul punto di passare dal bipartitismo (alternanza fra la sinistra e la destra) al tripartitismo. Con un'opinione pubblica divisa globalmente in tre terzi, sinistra, destra, estrema destra. E' certamente qui il principale insegnamento delle elezioni di domenica. E' infatti sorprendente constatare che questo risultato, con il Fn in testa, da parecchi mesi era annunciato dai sondaggi d'opinione. E' quindi con cognizione di causa che alcuni si sono astenuti e altri hanno votato con risolutezza per il Fn. Di fronte alle sfide che deve affrontare il Paese - riordino dei conti pubblici e riforma delle strutture per ristabilire la competitività - sinistra e destra dovrebbero rispettarsi di più. Ebbene, l'una e l'altra passano la maggior parte del tempo, quando sono all'opposizione, a delegittimare l'avversario. Fu così nei confronti di Nicolas Sarkozy, ed è così oggi, ancora di più, nei confronti di Francois Hollande. Questo gioco di delegittimazione permanente porta immancabilmente a legittimare il voto Fn. Per il governo francese, il paragone con la situazione italiana è crudele. A. Roma esiste certo un effetto Renzi che ha condotto al relativo fallimento del Movimento 5 Stelle e alla nettissima vittoria del partito del Primo ministro. Mentre in Francia, malgrado la popolarità del nuovo premier Manuel ValIs, le otto settimane da quando è stato nominato non sono bastate a recuperare un sia pur minimo moto di fiducia. Cosicché lo scioglimento dell'Assemblea nazionale potrebbe in effetti intravedersi. Non perché Francois Hollande deciderebbe dì obbedire a Marine Le Pen. Ma perché un numero sufficiente di deputati socialisti, che si sono già manifestati contro Manuel Valls, sono più vicini all'estrema sinistra che al loro stesso governo. Essi reclamano un cambiamento di politica allorché il governo ha una sola cosa da fare: reggere. Il governo è impegnato in una politica di riduzione della spesa pubblica che, sappiamo, richiede tempo per produrre risultati. Ma di fronte all'impazienza degli elettori dì sinistra, alcuni deputati vogliono passare a una fase di ridistribuzione che oggi è impossibile. Non è quindi da escludere che rifiutino di votare i testi proposti da Manuel Valls, per esempio quelli che mirano alla riduzione delle spese pubbliche, obbligando così il Presidente della Repubblica, in mancanza di una maggioranza in Parlamento, a pronunciare lo scioglimento dell'Assemblea. Per l'opposizione, infine, la riprovazione è manifesta. Anche se la lezione delle municipali non deve essere dimenticata (l’Ump e i suoi alleati centristi sono la sola forza dì alternanza), l’Ump è oggi molto scosso. Gli effetti del voto sono davanti a tutti. La presidenza di Jean-Francois Copé è messa fortemente in questione, in particolare da 12 Alain luppé e Francois Fillon, che sono soprattutto due possibili candidati dell’Ump all'elezione presidenziale del 2017, al posto di Nicolas Sarkozy. Su questo fronte, la battaglia non fa che cominciare. (traduzione di Daniela Maggioni) Del 27/05/2014, pag. 6 Vincono i nazionalisti fiamminghi, e ora puntano all’indipendenza Belgio. L’Nva di de Wever, borgomastro di Anversa, è il primo partito. Molti consensi soffiati all’estrema destra (alleata di Lega e Le Pen) sul tema immigrazione Guido Caldiron Una foto del leader nazionalista fiammingo Bart de Wever e un titolo segnato dall’inquietudine: «Una vittoria senza garanzie». È la prima pagina dal maggiore quotidiano del paese, Le Soir, a fissare in una sola immagine tutta l’incertezza che accompagna il dopo-voto del Belgio. Nel paese che ospita il cuore politico della Ue, dove oltre che per le europee i cittadini si sono recati alle urne anche per rinnovare il parlamento nazionale e i due parlamenti regionali della Wallonia e delle Fiandre, il domani porta con sé molte domande senza risposta. Come annunciato da tutti i sondaggi, la Nieuw-Vlaamse Alliantie, la Nuova alleanza fiamminga guidata dal borgomastro di Anversa Bart de Wever è il primo partito delle Fiandre, con oltre il 33% dei consensi, ma è allo stesso tempo, in percentuale, anche il partito più votato dell’intero Belgio, con il 18,5%, visto che la maggior forza politica del sud francofono del paese, il Partito socialista del premier Elio Di Rupo non è andata oltre il 10%. Così, ieri mattina presto, de Wever è stato il primo leader politico ad essere ricevuto da re Filippo – per altro esponente di una monarchia filo-francese che gli ultrà fiamminghi hanno sempre detestato –, all’apertura delle consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo. L’esponente nazionalista fiammingo, ciò che aveva da dire, l’ha però già urlato nei comizi della campagna elettorale: «Il Belgio di un tempo è finito, d’ora in poi più che all’ennesima riforma federale si deve pensare a un nuovo assetto, una confederazione tra due paesi distinti che a Bruxelles trattano ciò che gli rimane di comune». Una piattaforma essenziale che però più di un fiammingo su tre ha deciso di sostenere nelle urne. Perciò, il paradosso potrebbe essere che de Wever accetti ora di guidare l’esecutivo di un paese, il Belgio, che in realtà vorrebbe smembrare. O che, come accadde tra il 2010 e il 2011 quando Bruxelles rimase per 500 giorni senza un governo, giochi allo sfascio, rifiutandosi di governare insieme ai rappresentanti dei partiti walloni. In ogni caso, ed è l’ipotesi più accreditata, come politico più popolare delle Fiandre, de Wever potrebbe anche accontentarsi di continuare, come ha fatto negli ultimi quattro anni, a sparare sull’esecutivo belga, capitalizzando nel frattempo il malumore e l’insoddisfazione di una larga parte dei fiamminghi. I timori del momento non hanno però solo a che fare con i toni indipendentisti da sempre sostenuti dalla Nieuw-Vlaamse Alliantie. L’ulteriore affermazione del partito nazionalista si è infatti compiuta soprattutto a scapito dell’estrema destra del Vlaams Belang, partito legato alla Lega e a Le Pen, che ha perso ben 15 eletti su 25 nelle Fiandre. E molti osservatori segnalano come per recuperare questa fetta dell’elettorato, de Wever abbia reso sempre più muscolare il suo discorso sull’immigrazione. Se l’indipendenza fiamminga resta il cuore del programma dell’Nva, 13 i suoi esponenti promettono infatti anche una stretta su migranti e richiedenti asilo, un drastico taglio ai sussidi per i disoccupati e una riduzione generalizzata del welfare. Non solo, a confortare gli elettori estremisti, c’è la stessa biografia di Bart de Wever, cresciuto in una famiglia ipernazionalista: negli anni Quaranta suo nonno era segretario del Vlaams Nationaal Verbond, partito separatista in odore di collaborazionismo con gli occupanti nazisti – fenomeno che fu piuttosto esteso tra i fiamminghi –, mentre i suoi genitori militavano nella Volksunie che ne aveva ripreso il testimone negli anni Settanta. Del 27/05/2014, pag. 7 Caporetto per la destra lusitana, ma i socialisti non ridono Portogallo. Astensione al 65%. Il rinnovamento senza retoriche rottamatorie premia i comunisti (12,7%) Goffredo Adinolfi Ancora una volta a vincere le elezioni in Portogallo è stata l’astensione, in crescita rispetto alle scorse europee: ben più della metà degli aventi diritto, il 65%, non ha votato. Certo, la destra responsabile di quei tagli rimedia una delle peggiori sconfitte della sua storia. Alleati, il Partido Social Democrata (Psd) e il Centro Democratico e Social Partido Popular (Cds/Pp) si fermano al 27,7%, 13 punti percentuali in meno rispetto alle europee del 2009. Il punto però è che alla disfattadella destra non corrisponde una netta affermazione del Partido Socialista (Ps) che si è fermato al 31%, + 5% rispetto al 2009, ma lontanissimo dal 44% ottenuto nel 2004 e soprattutto lontanissimo dall’ottenere i voti necessari per raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi alle prossime elezioni politiche del 2015. Antonio Costa, artefice di quella grande vittoria e ora sindaco di Lisbona, è l’unico, tra le figure di spicco del Ps a mostrare preoccupazione per un risultato molto al di sotto delle aspettative e per un partito che appare ai più sprovvisto di un vero progetto alternativo a quello del centro destra. Che la sinistra europeista fatichi a riscuotere consensi lo si può anche vedere dal sensibile ridimensionamento del Bloco de Esquerda (Be), il partito che con maggiore convinzione ha appoggiato la candidatura di Alexis Tsipras alla presidenza delle Commissione Europea e ha fatto della democratizzazione delle istituzioni europee il suo principale cavallo di battaglia. Aveva preso il 10% nel 2009, il 5% alle legislative del 2011 e ora è ulteriormente sceso al 4,5%. Certo non ha giovato la scissione “a destra” guidata da Rui Tavares, già eurodeputato del Be, che si è presentato con una sua lista di stampo verde-ecologista, il Livre, che ha sottratto un 2,5% dei voti, una parte dal Ps e un’altra dal Be. Non stupisce quindi il risultato ampiamente positivo del Partido Comunista Português (Pcp) che, fin dagli inizi, si è mostrato contrario a qualsiasi cessione di porzioni di sovranità a Bruxelles. La voglia di recuperare integralmente la propria sovranità spiega solo in parte un balzo che porta dal 7,5%, ottenuto alle politiche del 2011, al 12,7% alle europee di quest’anno. Oggi il Pcp è un partito forte, coeso e, soprattutto, è riuscito, senza traumi o retoriche rottamatorie, a darsi una leadership nuova, giovane e dinamica. Folgorante poi è il successo di un outsider, António Marinho Pinto, ex presidente dell’ordine degli Avvocati che, alla testa di un micropartito, il Partido da Terra, balza dal 0,67% al 7,1% e ottiene, grazie esclusivamente al suo carisma personale, un seggio al parlamento di Strasburgo. In conclusione si può dire che la caporetto della destra lusitana c’è stata ma che l’emorragia di voti è stata comunque bloccata senza che si verificasse un 14 collasso. La sinistra, globalmente intesa, è in decisa crescita (alle scorse politiche del 2011 era al 40, alle europee del 2009 al 47 ora è al 50%) ma è divisa in tre tronconi inassimilabili: quello formato dal Ps e da Livre (socialdemocrazia), il Be (sinistra critica) e il Pcp. I cosiddetti partiti mainstream, quelli che in questi decenni si sono avvicendati al governo– Ps, Psd e Cds/Pp — insieme ottengono meno del 60% (se compariamo con le precedenti elezioni europee c’è una perdita secca del 10%. –20% rispetto alle politiche del 2011). I portoghesi sembrerebbero avere trasformato in un comportamento di voto coerente l’insoddisfazione che hanno espresso nei confronti del modo in cui funziona la democrazia (pari solo a quella dei bulgari e dei rumeni). Il dato non è entusiasmante, perché senza un progetto alternativo credibile e con le elezioni politiche alle porte l’orizzonte più probabile sembra quello di una grande coalizione tra i tre grandi sconfitti: Ps, Psd e Cds/Pp. del 27/05/14, pag. 25 Dall’ondata dei populisti euroscettici alla leadership della Merkel Ecco come cambiano gli equilibri nel Vecchio continente: “Sono necessarie nuove risposte, a cominciare dalla sicurezza sociale” Il sociologo tedesco lancia l’allarme: “In Francia il trionfo della Le Pen può portare alla fine della Ue” La nuova Europa secondo Ulrich Beck “Ora si è spezzato il dogma dell’austerity” ROBERTO BRUNELLI VIVERE o morire, questa è oggi la scelta europea. È un bivio fatale, dice Ulrich Beck il giorno dopo lo tsunami populista uscito dalle urne del Vecchio Continente: da una parte la fine del “dogma dell’austerity”, dall’altra la stessa sopravvivenza della Ue. Per il sociologo tedesco si apre una partita difficilissima, che però ha un nome solo: quello dell’Europa dei cittadini e della crescita, quello di un’Europa a cui dare finalmente un volto. Che non potrà più essere quello di Angela Merkel. PROFESSOR Beck, siamo di fronte a risultati molto diversi tra loro. I socialisti vincono in Germania e in Italia, ma subiscono una débacle in Francia, i populisti trionfano in Francia e Gran Bretagna, ma si fermano altrove. Che bilancio si sente di fare? «Se la prospettiva è quella del futuro del continente, allora bisogna dire che il risultato più pesante è quello della Francia, con il trionfo di Marine Le Pen. È di tali proporzioni da non poter essere considerato solo un avvertimento. Non deve essere sottovalutato, perché può venire meno l’appoggio di Parigi al processo europeo. La conseguenza può essere la fine della Ue, se non altro perché senza la Francia non è possibile uscire dalla crisi. Per quel che riguarda la Gran Bretagna c’è invece da notare che nessuno dei partiti tradizionali si espresso con nettezza a favore dell’Europa. Se ne deduce che non è consigliabile rubare le parole d’ordine agli euroscettici. L’elettore preferisce l’originale». Ma quello dei populisti non è un blocco omogeneo. Sono improbabili alleanze tra i vari Ukip, Front National, grillini e Jobbik. Il che rende i populisti meno forti a Strasburgo rispetto al risultato delle urne... «Sì, non ci potrà essere un gruppo parlamentare unico, né sono probabili altre forme di coordinamento. Ed è un fatto importante, che dà modo di difendersi da quella che io 15 chiamo la “critica paradossale” dei populisti. Però ripeto: il risultato dimostra anche che l’Europa in quanto tale non viene compresa dalla gran parte dei cittadini». In Germania gli euroscettici dell’Afd si sono fermati al 7%. Si può dire che in qualche modo Angela Merkel assorbe in sé il populismo tedesco? «In effetti, alla radice i risultati tedeschi sono incoraggianti. I grandi partiti favorevoli all’Europa hanno consolidato la loro maggioranza, i numeri dell’Afd tutto sommato non sono tali da destare preoccupazione. È vero, questo ha anche a che vedere con quell’attitudine della cancelliera che io ho chiamato il “merkievellismo”, ossia la capacità di difendere da una parte gli interessi nazionali e dall’altra di assumere in sé le paure dei cittadini, dando l’impressione di prenderle sul serio. Ma ora la vera partita che si apre è quella del futuro presidente della Commissione: che si tratti di Juncker o di Schulz, è fondamentale che sia rispettata la decisione degli elettori. Abbiamo la possibilità di dare, in qualche modo, un volto all’Europa. Sarebbe fatale se venissero messi in campo altri candidati, espressione di negoziati sotterranei. La spinta democratica che comunque viene da questo voto verrebbe distrutta, creando nuove delusioni tra gli elettori. Al centro di questa partita c’è proprio la cancelliera. Quando vedremo che l’Europa può avere un volto nuovo, vedremo che non sarà quello della Merkel. È stato anche un voto contro l’austerity... «Non a caso la Merkel ha già “relativizzato” la sua agenda di tagli. Lo fa con molta astuzia, legando gli apparenti successi del rigore ad un allentamento delle catene, come si è visto anche nel recente viaggio in Grecia. Poi ambedue i candidati presidenti hanno detto chiaramente che se eletti la loro priorità sarà il lavoro. Schulz ha messo in campo un’ampia gamma di iniziative, mentre quelle Juncker rimangono proposte convenzionali, ma sia l’uno che l’altro partono dal presupposto che il problema non sia più l’euro, ma la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, la politica sociale. È un tema che prima non c’era». Mica mi vorrà dire che è diventato ottimista? «Ma no, le categorie di ottimismo e pessimismo si sono solo spostate e mischiate. Quello che è certo è che si è spezzato il dogma dell’austerity. Ci saranno nuovi investimenti a favore dei paesi più colpiti dalla crisi, in una specie di cocktail che mette insieme tagli e investimenti. È fondamentale sapere quale risposte dare anche a chi oggi si mette fuori dal progetto europeo». Molti commentano oggi che l’Europa è spaccata in due. «Certo, e non da ieri, per esempio tra i paesi dell’Ue che stanno dentro l’eurozona e quelli che non ci stanno, perché tutte le decisioni importanti vengono prese esclusivamente dai primi. L’altra spaccatura riguarda le diseguaglianze, tra gli europei di serie A e quelli di serie B che non fanno i loro “compiti a casa”. Quello di cui c’è bisogno oggi è una prospettiva di sicurezza sociale, non solo su base nazionale ma su base comunitaria. Trasformare finalmente l’Europa delle élites nell’Europa dei cittadini: è questa l’unica via». Del 27/05/2014, pag. 9 In Egitto plebiscito annunciato per il generale golpista Sisi Il voto. Al via le «elezioni» presidenziali, bassa l'affluenza. Il leader della giunta militare rivendica il ruolo svolto in Libia Giuseppe Acconcia 16 È difficile immaginare come viva un autocrate le ore precedenti la sua incoronazione. Eppure sta per realizzarsi il piano (o roadmap) per guidare l’Egitto, cominciato con l’inattesa ascesa di Abdel Fattah Sisi a leader delle Forze armate nel luglio 2012. Si vota per la sesta volta in tre anni ma l’entusiasmo delle presidenziali del giugno 2012 è svanito. 400mila poliziotti e soldati sono stati dispiegati nel paese mentre le università, centro delle contestazioni, sono chiuse da giorni. Non si rincorrono le decine di simboli originali dei partiti, nati in fretta, dopo le rivolte di piazza Tahrir nel 2011. La città è ora tappezzata del volto di Sisi, affiancato a una stella e una bandiera. Di fatto, è tornato il culto della personalità, archiviato dopo l’arresto di Mubarak. E così dilaga la mania per l’ex militare, che, messi a tacere i dubbi di alti generali sulla diretta partecipazione in politica, guida il paese già dal giorno del colpo di stato del 3 luglio 2013, quando il presidente eletto, Mohammed Morsi, è stato arrestato. Tuttavia, una maggioranza silenziosa, che non ha votato al referendum costituzionale (fermo al 36% di affluenza), prova un profondo malessere per la vittoria annunciata di Sisi. «Queste elezioni sono una farsa. Non meritano neppure di essere raccontate perché sono poco più di uno spettacolo mediatico», ci spiega Mustafa Sakr, che boicotterà i seggi. Le pratiche di Sisi nulla hanno a che vedere con la democrazia: dal massacro di Rabaa al Adaweya che ha causato quasi mille morti agli arresti sommari di islamisti (oltre 41mila secondo fonti indipendenti); dalla legge anti-proteste, che ha messo alla sbarra i principali leader dei movimenti giovanili all’approvazione della Costituzione che permette processi militari contro i civili. Il colpo di grazia al pluralismo è venuto con la legge elettorale per le parlamentari, presentata la scorsa settimana. «Fermerà la formazione di partiti politici perché la metà del parlamento sarà scelta tra candidati indipendenti», ci ha detto Khaled Dawud del partito di opposizione Dostur. E così, se le gigantografie dell’uomo forte occupano lo spazio pubblico, in alcuni quartieri sono apparsi inequivocabili schizzi di una pittura rosso sangue a sottolineare la vera natura del nuovo raìs. Grandi tendoni alle porte del palazzo del re Farouk a Abdin hanno raccolto testimonianze a favore dell’uomo, responsabile dei test della verginità su 17 contestatrici nel marzo 2011. In assenza di alcun dibattito televisivo e di un vero confronto su temi o programmi, le sparute immagini dello sfidante, il nasserista Hamdin Sabbahi, affiancato da un’aquila, e i minuscoli assembramenti dei suoi sostenitori sembravano sempre passibili di punizione. In un’intervista al manifesto dell’agosto 2013, Sabbahi promise, se eletto, di promuovere la «redistribuzione della ricchezza»; eppure la sua candidatura sembra solo legittimare l’ascesa del faraone. Sisi è già pronto a guidare il Nord Africa: incassato l’appoggio del presidente russo Vladimir Putin, ha promesso che volerà in Arabia saudita come primo atto dopo la sua elezione e che si occuperà di Libia. Negli ultimi giorni di campagna elettorale ha pesato il golpe libico di Khalifa Haftar, Sisi ha chiaramente ammesso di voler evitare che il paese continui ad essere un covo di «estremisti e milizie», attribuendo la responsabilità del caos ai Fratelli musulmani libici. Il traffico di armi nella «terra di nessuno» tra Libia ed Egitto, preoccupa l’esercito egiziano, pronto ad annientare le milizie islamiste, dopo l’accordo tra il generale Haftar e la brigata 17 febbraio, vicina all’esercito regolare libico. Eppure l’Egitto ha abituato il mondo a sorprese inaspettate. I crimini di Sisi potrebbero convincere giovani giudici a formulare incriminazioni contro l’ex generale. I primi segnali emergono dalle accuse mosse contro il premier ad interim, voluto da Sisi, Ibrahim Mahleb. Secondo un report, reso noto dal sito indipendenteMada Masr, che inchioda i Mubarak per corruzione e concussione, anche Mahleb, ex dirigente della Arab Contractors, avrebbe distratto milioni di fondi pubblici dalle casse dello stato. Ma per il momento prosegue solo la repressione degli islamisti, dopo le oltre 700 condanne a morte disposte per gli scontri dell’estate scorsa, la Corte di Mansura ha condan17 nato all’ergastolo 54 islamisti, tra cui giovani del movimento Studenti contro il golpe, per assalto alle forze di sicurezza. Infine, con gli appelli delle moschee a recarsi in massa alle urne, resta solo il dubbio di come si comporterà la base elettorale dei salafiti. Mentre i leader del movimento (che ottenne il 25% nel 2012) sostengono Sisi, molti simpatizzati, galvanizzati anche dall’invito al boicottaggio del noto sheykh Youssef Qaradawi, potrebbero non andare a votare. del 27/05/14, pag. 36 Nel regno di Boko Haram Bottino di guerra, spose o schiave dei soldati: nessuno sa dove siano le duecento liceali rapite il 14 aprile nel villaggio di Chibok. Di sicuro l’inaccessibile foresta di Sambisa è diventata il covo della setta islamica responsabile del sequestro Qui nel cuore della Nigeria si gioca la sfida col terrore PIETRO DEL RE DAL NOSTRO INVIATO CHIBOK SONO arbusti tondeggianti, con poche foglie grigiastre ma irti di spine lunghe e affilate come coltelli. «Qui non ti avventuri neanche con un carro armato: bastano questi cespugli a proteggere gli uomini di Boko Haram», dice Mohammed, camionista di 28 anni, indicando la fitta boscaglia che ricopre ogni cosa, dai bassi crinali che si stagliano in lontananza alle gole e ai crepacci tagliati nel granito. L’inaccessibile foresta di Sambisa, migliaia di chilometri quadrati tappezzati di questa macchia taglientissima, un tempo riserva di caccia dei coloni inglesi, è diventata l’inespugnabile covo della setta islamica che la notte del 14 aprile scorso ha sequestrato nel villaggio di Chibok oltre duecento liceali, facendo scoprire al mondo le atrocità della guerra in corso in questa remota e poverissima regione del nordest della Nigeria. «Le tengono nascoste là dentro, e soltanto noi possiamo salvarle perché siamo i soli a conoscere le insidie di Sambisa», aggiunge Mohammed, con un passamontagna calato sul viso nonostante il vento incandescente. Lo incontriamo a Chibok, dove è venuto a reclutare uomini per una piccola milizia di autodifesa, composta di commercianti, allevatori e disoccupati esasperati dalla folle violenza di Boko Haram e dall’incapacità d’intervento dell’esercito nazionale. Alla periferia di questo malconcio agglomerato, in cui le case sono per lo più costruite con muri di fango e ricoperte da pezzi di lamiera, Mohammed ci porta a visitare ciò che resta del collegio delle liceali rapite cinque settimane fa. Con il tetto scoperchiato dalle bombe, i vetri infranti e i registri dati alle fiamme, più che dalla furia degli islamisti l’edificio sembra essere stato danneggiato da un terremoto. In realtà, nessuno sa dove siano le liceali, né se le tengano ancora tutte assieme o divise in piccoli gruppi per nasconderle più facilmente. Secondo alcuni, Boko Haram le avrebbe portate oltre confine, in Camerun o nel deserto del Niger. Altri credono invece che le soldatesche islamiche se le siano già spartite come bottino di guerra, per sposarle o, più verosimilmente, per farne schiave sessuali. Come dice un generale del Pentagono, cercarle in questa regione equivale «a trovare un ago in un pagliaio». Ma quale miglior nascondiglio di una selva così ostile come quella di Sambisa, che comincia a infoltirsi fino a diventare impenetrabile soltanto a pochi chilometri da Chibok e che confina con le brulle 18 montagne del nord del Camerun? È un’ipotesi che suggerisce un governatore locale, e che ha convinto alcuni consiglieri militari statunitensi inviati dal presidente Barack Obama a dar manforte allo sgangherato e brutale esercito nigeriano. Dice ancora Mohammed. «Se i sudditi della corona britannica andavano a Sambisa per sparare alla iena e al leopardo, noi daremo la caccia alle belve di quella setta maledetta». Per il terrore di nuove rappresaglie, a Chibok nessuno parla con gli stranieri. Ma nonostante i ripetuti attacchi dei jihadisti, c’è ancora chi resiste, chi non è scappato verso Maiduguri, capoluogo dello stato di Borno. Non è così in molti altri villaggi, ormai interamente abbandonati, che incrociamo lungo le strade del feudo di Boko Haram, simili a piste sabbiose, un tempo trafficatissime ma oggi spaventosamente vuote. Ogni cittadina assaltata dalla setta islamista è come una piccola Dresda, dove la sofferenza si misura con lo sconcertante grado di distruzione delle case, dei mercati, delle scuole, delle chiese o delle moschee. In un villaggio contiamo decine di macchine bruciate, in un altro, di cui non riusciamo a trovare neanche il nome sulle mappe, le fiamme appiccate dai guerriglieri non hanno risparmiato una sola abitazione. «Attaccano sempre alla stessa maniera: incendiano le case, che sono spesso capanne e che quindi ardono come fiammiferi, e sparano all’impazzata contro la popolazione. Poi, razziano tutto ciò che possono». Solo la settimana scorsa, nello stato di Borno, hanno aggredito una mezza dozzina di villaggi, tra cui Shawa, Alagarno, Chukku, ogni volta uccidendo non meno di trenta persone, tutti civili. Ieri, l’ultima incursione: a Kamuyya, dove i terroristi hanno sparato sulla folla, falciando quaranta vite. A questi morti vanne aggiunte le centocinquanta vittime — quasi tutte donne — delle autobombe esplose martedì scorso al mercato di Jos, città al centro del Paese, alla cerniera tra la Nigeria musulmana e quella cristiana. Boko Haram è nata nei quartieri soffocati dalla miseria e dalla disoccupazione di Maiduguri, città di più di un milione di abitanti. In quelle zone, dove la polizia non mette piede da anni, la setta può ancora contare su molti appoggi. Tuttavia, nel resto di Maiduguri i blindati dell’esercito pattugliano giorno e notte. Al contrario, i villaggi sperduti in queste desertiche praterie sono totalmente indifesi, e la nascita di squadre di vigilantes simili a quella di Mohammed ha reso i jihadisti ancora più crudeli. «Lo scorso anno, il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha decretato lo stato d’assedio nei tre stati (Yobe, Adamawa e Borno, ndr ) dove imperversa Boko Haram, inviando dal sud i suoi soldati più efferati, quelli che avevano combattuto e sedato la rivolta nel delta del Niger. Con quali risultati? Nessuno, salvo che adesso siamo vittime sia della spietatezza degli islamisti sia di quella dell’esercito», dice un anziano dallo sguardo affilato che incontriamo a Mubi. Il suo racconto dell’ultima incursione delle forze di sicurezza è un pugno nello stomaco. «I soldati hanno raggruppato una ventina di ragazzi, quasi tutti adolescenti, e li hanno poi fatti sdraiare a terra. Pochi minuti dopo ho sentito i colpi della mitragliatrice. Col pretesto che simpatizzavano con Boko Haram, li hanno ammazzati tutti. Tra di loro, c’era anche mio il mio nipotino. Ma perché lo hanno fatto? Perché? ». La conseguenza delle feroci rappresaglie dell’esercito è che la popolazione ha smesso di denunciare gli uomini di Boko Haram, e che parte di essa si è arruolata tra le fila della setta. I militari hanno allora creato milizie locali, chiamate “civilian joint task force”, il cui solo scopo è di incoraggiare la delazione. Ma temuti quanto esecrati, i militari nigeriani non sono più soli, perché da una decina di giorni sono accorsi nella capitale Abuja squadre di 007 da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Cina e Israele. Riportare a casa le studentesse è diventata una battaglia globale. Tuttavia, il giorno in cui il nascondiglio delle studentesse dovesse essere individuato c’è il rischio che i generali nigeriani decidano unilateralmente di lanciare un’operazione avventata che non potrà risolversi altrimenti che in un bagno di sangue: com’è già accaduto in passato per altri ostaggi anche le liceali di Chibok verrebbero immediatamente freddate dai loro carcerieri. 19 Nonostante l’indubbia “cristianofobia” della setta islamista, questa non è una guerra religiosa tra cristiani e musulmani, perché nella maggioranza dei casi i carnefici sono gli estremisti salafiti e le vittime quei musulmani più moderati che a loro avviso non applicano la sharia con sufficiente rigore. In un Paese dove la crescita è da anni superiore al 7 per cento, che è diventato la prima economia del Continente nero superando un paio di mesi fa il Sudafrica, ma dove oltre la metà dei suoi 160 milioni di abitanti vive in povertà assoluta, i cristiani sembrano un bersaglio collaterale. Come spiega l’ex capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Martin Luther Agwai, la piaga Boko Haram non si risolve con le armi: «Il problema è politico, sociale ed economico. Se negli stati del sud del Paese il 90 per cento delle donne è alfabetizzato, in quelli del Nord la cifra scende al 5 per cento. E nelle università nigeriane solo il 10 per cento degli studenti proviene dai 12 stati settentrionali, dove la setta islamica recluta i suoi guerriglieri tra le legioni di giovani disoccupati ». Fatto sta che secondo Human rights watch dall’inizio dell’anno il bilancio degli attentati compiuti da coloro che il Nobel Wole Soyinka ha soprannominato i “macellai della Nigeria” supera i mille morti. «Non ne possiamo più di questi islamisti indiavolati, per questo abbiamo deciso di unirci», sbotta il camionista Mohammed. «Il nostro gruppo conta già 500 uomini e siamo determinati a liberare la nostra terra». Già, ma con quali probabilità di farcela? 20 INTERNI del 27/05/14, pag. 4 Il premier e i primi effetti del voto sulla coalizione Cosa potrebbe cambiare negli equilibri interni al governo E se Lupi optasse per Strasburgo, Renzi dovrebbe cambiare una casella Forte in Europa e senza avversari in Italia, da oggi ricomincia la luna di miele tra Renzi e il Paese, perché il risultato delle Europee ha di fatto resettato il suo rapporto con l’opinione pubblica che tre mesi di governo sembravano aver logorato: d’altronde non era mai accaduto che il voto decretasse un solo vincitore. Ma c’è un motivo se il premier ha scelto di non enfatizzare la vittoria, se ha detto che «Grillo non va sottovalutato». È vero che il tramonto del berlusconismo e il netto ridimensionamento dei Cinquestelle gli offrono la chance di aprire un lungo ciclo politico, ma la «febbre» del malcontento potrebbe tornare a salire rapidamente se non ottenesse al più presto dei risultati a Roma come a Bruxelles. Non c’è dubbio quindi che il leader del Pd voglia accelerare sulle riforme, ed è consapevole che i suoi competitori non abbiano la forza né la voglia di cambiare la sua agenda, però sa di dover attendere che la polvere della competizione elettorale si posi, così da capire gli effetti del voto sugli equilibri delle forze alleate e avversarie. Effetti che potrebbero già modificare la squadra di governo e imporre a breve dei «cambi in corsa», al di là del rimpasto ipotizzato dopo il semestre europeo: se Lupi decidesse infatti di lasciare il ministero delle Infrastrutture per sedere a Strasburgo, Renzi sarebbe chiamato a operare una sostituzione di peso nel suo gabinetto. È impensabile che Alfano, in tal caso, non chieda per un rappresentante del suo partito la guida di quel dicastero, cosi come è presumibile una trattativa con il premier. Certo, nessuna altra forza potrà vantare pretese, visto che Scelta civica è ridotta a prefisso telefonico, ma è anche vero che i rapporti di forza tra Pd e Ncd da domenica sono mutati e i Democratici potrebbero tentare di forzare la mano. Renzi tuttavia non ha interesse a rompere l’incantesimo nella sua coalizione, le parole di «gratitudine» rivolte ieri al Nuovo centrodestra dimostrano che il suo intento è di rassicurare l’alleato, unico «superstite» della mattanza elettorale, ma che - uscito debole dalla prova del voto - teme in prospettiva di venire soffocato dall’abbraccio. Non a caso Alfano ha provato a divincolarsi, dicendo che «il governo non è un monocolore Pd». In ogni caso, ecco un primo effetto del test europeo, perché è evidente che se Lupi optasse per l’Europa, lo farebbe con l’intento di dedicarsi a tempo pieno di Ncd e del processo di ricostruzione del centrodestra. Un processo nel quale - per quanto possa apparire paradossale - Renzi è parte attiva. Abile nel tenere un piede nel campo di Agramante, il leader dei democrat si è finora garantito il rapporto con Berlusconi sulle riforme, garantendo così al Cavaliere una centralità nell’area moderata che al momento impedisce il progetto di ricostruzione. È un’Opa camuffata, quella di Renzi, mentre tra la «generazione dei quarantenni» di quel che fu il Pdl, si lancia i primi segnali. Tra le invettive reciproche degli esponenti forzisti e di Ncd dopo il voto, non è sfuggita l’apertura di Fitto autentico acchiappa preferenze azzurro - alle primarie. «Almeno una cosa concreta», ha commentato Alfano. Il resto si vedrà, le Regionali saranno fra un anno... La lunga marcia nel deserto che attende il centrodestra si fa più complicata proprio per la presenza sul sentiero di Renzi, che per un verso tiene nella maggioranza di governo Ncd e per l’altro tiene nella maggioranza per le riforme Forza Italia, alle prese con un dilemma: 21 se assecondasse il premier nel progetto di revisione istituzionale, gli consegnerebbe almeno il successo alle prossime elezioni politiche; se rompesse, se ne assumerebbe la responsabilità, offrendo al capo del Pd la possibilità di denunciare chi vuole far restare l’Italia «nella palude» e di andare al voto anticipato nel ruolo della «vittima». Sia chiaro, il premier mira a durare sfruttando la propria capacità attrattiva, e punta a costituire quel nuovo «arco costituzionale» di cui sarebbe l’artefice. Anche la manovra di accostamento ai grillini va letta in questo senso, in attesa di vedere come reagiranno i gruppi parlamentari dei Cinquestelle, dove il malcontento finora era stato tacitato dalla campagna elettorale. Al momento è necessario che la polvere della competizione si posi, prima che Renzi acceleri di nuovo, con un occhio alle riforme e uno alle manovre per il Colle, argomento affrontato nelle segrete stanze e tenuto al riparo per non bloccare la stagione costituente. Ma se il Parlamento dovesse davvero far sul serio e modificare la Carta, la corsa per il Quirinale (già iniziata) si aprirebbe ufficialmente. Francesco Verderami del 27/05/14, pag. 1/4 Nazionale e personale ovunque primo partito ILVO DIAMANTI LA GEOGRAFIA politica dell’Italia è cambiata. Dopo oltre cinquant’anni di fratture territoriali, dalle elezioni sono emersi due partiti, meglio, due soggetti politici, “nazionali”. Il Pd. PRIMO partito in Italia. Alle regionali, ha conquistato il Piemonte e l’Abruzzo. Alle europee, ha quasi doppiato il principale antagonista, ottenendo oltre 5 milioni più del M5s. Anch’esso partito “nazionale”, per distribuzione del voto. Il PD di Renzi. Un “post-partito” personale. Il PD(R) ha superato la soglia del 40%. Mai raggiunta da un partito di sinistra, neppure nella Prima Repubblica. Fino a ieri, e anche nel 2013, la base elettorale di Centrosinistra era addensata nelle regioni dell’Italia centrale. Nella “zona rossa”, come viene definita ancora oggi. Riflesso della frattura anticomunista che ha segnato il comportamento politico degli italiani. Riproposta, ad arte, da Silvio Berlusconi, per chiudere gli avversari dentro gli antichi steccati. In una condizione di “minoranza”. Ma quell’epoca è finita. E il PD si presenta come un partito nazionale. Il primo in quasi tutte le province italiane. E la sua crescita ha coinvolto non solo le province e le regioni del Centro. Ma, anche e soprattutto, territori ostili alla Sinistra. Come il “mitico” Nordest. Nelle province tradizionalmente più bianche del Veneto (bianco). Treviso, Padova, Verona, infatti, il PD è cresciuto in misura più elevata rispetto alla media nazionale. Perché è riuscito a intercettare il consenso e la fiducia di ceti sociali da sempre lontani e ostili nei confronti della Sinistra. I ceti medi autonomi, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti. D’altronde, in un sondaggio di Demetra (per Confartigianato), condotto presso un campione di circa 800 artigiani veneti, nelle settimane precedenti il voto, il 34% degli intervistati annunciava che avrebbe votato per il PD. Un anno fa, un sondaggio condotto sul medesimo campione aveva dato esiti molto diversi. Visto che, allora, il partito più votato dagli artigiani risultava il M5s. Ecco, questo mutamento dà il segno della svolta a cui abbiamo assistito il 25 maggio. La geografia elettorale del voto di domenica, infatti, mostra come la crescita del PD sia largamente speculare rispetto alle perdite del M5s. In altri termini, buona parte dell’avanzata del PD, rispetto a un anno fa, è avvenuta nelle aree dove il M5s è arretrato maggiormente. Il Nordest, appunto. (Dove ha ripreso fiato la Lega.) Inoltre, molte province “di sinistra”: di Toscana, Umbria e Marche. Alcune province della 22 Sicilia. Il M5s, inoltre, ha perduto dove è cresciuta maggiormente l’astensione. Nel Sud e in Sicilia, anzitutto. Ma anche nel Triveneto (e in particolare, in Friuli-Venezia Giulia). Il M5s stesso, comunque, si conferma attore del nuovo bipartitismo italiano. Accanto al PD, che ne costituisce il riferimento dominante. Insieme, i due partiti, oggi, rappresentano quasi i due terzi dei voti (validi). Ma la differenza fra i due, oggi, è che il PD ha quasi il doppio dei voti rispetto al M5s. E ne ha guadagnati oltre due milioni e mezzo, rispetto a un anno fa. Mentre il M5s ne ha perduti quasi tre. Il risultato del Pd, d’altronde, è stato sicuramente favorito da Grillo e dal M5s. Che hanno concentrato la campagna elettorale “contro” Renzi. In questo modo, hanno trasformato la competizione in un referendum “personale”. Pro o contro Renzi. Pro o contro Grillo. Usando la leva della “sfiducia”, Grillo ha, così, canalizzato verso Renzi la domanda di “fiducia” che, anche se frustrata, è diffusa, nel Paese. Nelle zone e nei settori sociali “produttivi” del Nord. Ma anche nei mondi periferici, battuti dalla crisi economica. Così, il PD, unico partito rimasto sul territorio, ha potuto avvantaggiarsi della propria presenza organizzata. Ma anche della “fiducia” personale nei confronti di Renzi. Immune dal virus “anticomunista”. Non a caso, un sondaggio di Demos (per il Gazzettino) nello scorso aprile rilevava un grado di fiducia verso Renzi , fra gli elettori del Veneto (già democristiano, poi leghista e infine pentastellato), del 57%. Il più elevato ottenuto da un presidente del consiglio negli ultimi vent’anni. Berlusconi compreso. Berlusconi, appunto. Insieme a FI, appare periferico e quasi marginale. Presente soprattutto in alcune province del Sud. Lontano dalle origini, quando rappresentava la borghesia milanese e lombarda alla conquista di Roma. E se i partiti di Centro-destra, insieme, pesano ancora molto (circa il 30%, come ha osservato Luca Ricolfi), il declino di Berlusconi li rende privi di identità. Da ciò la differenza e la continuità rispetto alle elezioni dell’anno scorso. Che erano politiche, non va dimenticato. Anche se la campagna elettorale, in queste elezioni europee, è stata giocata, quasi per intero, su questioni politiche “nazionali”. Dal voto di febbraio di un anno fa erano uscite tre grandi minoranze politiche. Ora, invece, si confrontano una grande maggioranza di governo, il PD di Renzi. E una minoranza di protesta, il M5s. Tutto il resto è sfondo. L’elemento di continuità e di stabilità, invece, è nella discontinuità e nell’instabilità del voto. L’anno scorso, rispetto alle elezioni politiche del 2008, oltre il 40% degli elettori cambiò partito, o meglio, schieramento. Quest’anno non sappiamo ancora di preciso quanti siano i voti “infedeli”. Ma sono un’ampia quota degli elettori. Perché la fedeltà di voto non è più una virtù. E il cambiamento è divenuto regola. Così ogni elezione diventa un’occasione di confronto. Aperto. Dove non è possibile prevedere l’esito. Renzi, per questo, è atteso da un compito duro. Cambiare il Paese per convincere gli elettori. Ora, di certo, ha più forza per provarci. del 27/05/14, pag. 3 Riforme prima dell’estate Si parte da lavoro e burocrazia Il premier vuole sfruttare il successo per diventare il presidente di tutti Fabio Martini Era stata una battuta molto lusinghiera, quella che Barack Obama aveva usato con Matteo Renzi in un colloquio a tu per tu due mesi fa e, per la verità, il ciarliero presidente del Consiglio non l’ha mai propalata. Disse il presidente degli Stati Uniti, sui divani di Villa Madama: «Matteo, tu puoi diventare un modello in Europa». Quella frase impegnativa 23 deve essere tornata alla mente di Renzi in queste ore, adesso che il premier - forte di un mandato popolare impetuoso - vede aprirsi davanti a sé un orizzonte arioso. Come spendere questo bonus, questo surrogato europeo che lo ha finalmente legittimato a palazzo Chigi? In queste ore, chiacchierando con i suoi collaboratori più stretti - Graziano Delrio, Luca Lotti, Maria Elena Boschi - ha messo a fuoco e deciso il ruolino di marcia da qui alla pausa estiva di inizio agosto. Tre missioni ben scandite e che si possono riassumere in una espressione che Renzi non ha usato, ma che le racchiude: diventare il presidente di tutti. Un profilo che, ieri durante la conferenza stampa a palazzo Chigi, per la prima volta Renzi ha assecondato: nel suo completo grigio ferro e con le sue parole di comprensione per tutti, per Berlusconi, per i parlamentari cinquestelle e persino per Beppe Grillo. E rimuovendo qualsiasi trionfalismo, ha sublimato questo aplomb ecumenico con una battuta: «Basta con quell’atteggiamento di superiorità della sinistra verso chi la pensa diversamente». Una battuta che, senza citarlo, ha alluso all’intoccabile Enrico Berlinguer che, a suo tempo, teorizzò la superiore diversità dei comunisti. Nella stagione che si è aperta ieri la prima mission decisa da Matteo Renzi è quella di provare a stringere un asse dentro il partito, con una pacificazione con la minoranza e la nomina di un presidente di quella area. Seconda missione, le riforme: «il cambiamento che abbiamo promesso deve arrivare in tempi ancora più veloci di quelli che avevamo immaginato» e dunque «accelerazione» su tre riforme chiave (Pubblica amministrazione, lavoro, Senato), aperte al contributo di tutti, «anche dei parlamentari del Cinque Stelle». Con una possibile pausa di riflessione (ma non sine die e comunque non dichiarata esplicitamente), sulla legge elettorale. Terza missione: un ruolo protagonista della «nuova» Italia in Europa. Nella partita delle nomine in vista per i vertici europei, Matteo Renzi non intende rivendicare poltrone per l’Italia e per il Pd primo partito del Pse, ma comunque vuole far valere la «golden share» all’interno del Partito socialista europeo, facendo valere nella trattativa con i capi di governo una realtà fino a pochi mesi fa inimmaginabile: il Pd, assieme alla potente Cdu tedesca, è diventato il partito-leader all’interno della Ue. Tre missioni che spostano al 2018 l’«orizzonte» del governo, in questo modo soffocando (almeno per ora) ogni tentazione del premier verso le elezioni anticipate. Il «nuovo» Renzi ha cominciato a vedersi in azione due notti fa. Appena è diventato chiaro il trionfo elettorale, il presidente del Consiglio è entrato nel suo ufficio nella sede del Pd, ha lasciato le porte aperte, consentendo a tutti, anche a quelli della minoranza, di entrare, mischiandosi in un’unica squadra. E infatti Renzi, più tardi, ha detto in conferenza stampa: «Mi ha fatto piacere vedere al Nazareno un gruppo dirigente, c’era una foto di gruppo». Gesto simbolico che prelude all’offerta della presidenza a Gianni Cuperlo? O si glisserà su soluzioni, la parlamentare Valentina Paris, meno impegnative? Una cosa è certa: alla minoranza non saranno offerti incarichi pesanti, come l’organizzazione o gli enti locali. A Renzi stanno a cuore tutte le riforme, una in particolare. Quella del lavoro «va accelerata» con l’approvazione del ddl delega perché «su questo punto giochiamo larga parte della nostra credibilità internazionale». In compenso, sapendo che il terremoto del 25 maggio è destinato a rallentare il passo della legge elettorale, Renzi ha intenzione di rialzare l’asticella su tutte le altre riforme, a cominciare da quella del Senato. Perché come ha confidato lui stesso, il boom elettorale ha messo nelle sue mani, una pistola spenta che può diventare fumante in qualsiasi momento: basta minacciare i riottosi con la prospettiva delle elezioni anticipate. Uno scenario che per gli avversari del Pd, da due giorni, è diventato uno spettro. 24 Del 27/05/2014, pag. 2 Renzi ovunque, il non voto aiuta Analisi. Confronto tra i voti assoluti delle europee e delle politiche del 2013. L’astensione «droga» i risultati. Scelta civica è sparita e l’area di governo non è cresciuta di molto. Il boom della Lega al centrosud. Con questi risultati e il "Consultellum" il Pd non avrebbe la maggioranza alla camera. Il presidente del Consiglio «convince» molti delusi grillini ed ex berlusconiani. Per la sinistra continua l’emorragia dei consensi Andrea Fabozzi Un successo distribuito in maniera omogenea in tutta l’Italia peninsulare, più contenuto nelle isole. Nel confronto con le elezioni politiche del febbraio 2013 il Pd guadagna oltre due milioni e mezzo di voti (2.526.827; +29%), anche se in quindici mesi si sono persi per strada 6 milioni e 363mila elettori. L’analisi dei voti assoluti consente di perimetrare meglio successi e sconfitte, e di fare qualche ipotesi sugli spostamenti dell’elettorato. Con l’eccezione di Sicilia e Sardegna, dove guadagna solo 90.835 voti (+13%), il partito democratico cresce in maniera simile in tutte le circoscrizioni: +449.561 voti nel mezzogiorno, + 542.598 al centro, +579.874 al Nord est e +863.959 al Nord ovest. Renzi dunque guadagna meno al sud dove l’astensionismo è percentualmente più forte (-1.144.956 elettori; –20%) e di più al Nord ovest (+36%) dove l’astensionismo è assai più contenuto (-1.253.524 elettori; –9,9%). Una possibile spiegazione è che il Pd abbia riconquistato una parte di elettori in fuga dal Movimento 5 stelle. Voti già del Pd che si erano allontanati l’anno scorso, e che sono stati recuperati strappandoli alla tentazione astensionistica. Parallelamente il Movimento 5 Stelle perde in maniera costante i suoi quasi tre milioni di voti (-2.898.541; –33%), si va dal –431.333 del sud al –679.093 del Nord ovest. In maggioranza sono voti rifluiti nell’astensione, assieme alla gran massa dei delusi del Pdl. Ma il movimento di Grillo ha restituito elettori anche ai leghisti. Il partito di Salvini recupera ovunque rispetto all’anno scorso (+296.022 a livello nazionale, +21,3%). Ma mentre la crescita nelle regioni tradizionali è solo buona (+5% al Nord ovest; +25% al Nord est), sono clamorosi i risultati per così dire «fuori casa». Segno evidente che nelle elezioni per l’europarlamento la campagna estremista di Salvini, più grillino di Grillo, ha pagato. Non sono numeri grandi, ma in Sicilia le camicie verdi sono cresciute di 16.467 voti quando ne avevano solo seimila (+270%), discorso simile al centro dove hanno acquistato 90.745 voti (quasi il triplo del 2013). Si tratta di voti di chiara protesta, un’alternativa per i grillini delusi rispetto alla fuga dalle urne. Alternativa limitata, si può stimare che solo il 10% dei grillini in fuga sia passato (o tornato) alla Lega, il resto tra Pd e astensione. Renzi ha senz’altro recuperato qualcosa anche dagli elettori berlusconiani. Troppo grande il tracollo del Pdl per escludere un passaggio del genere, del resto teorizzato a più riprese dal presidente del Consiglio. E così ieri mattina l’ex Cavaliere si è ritrovato a contare ben 3.260.970 ex elettori (-44,5% rispetto al 2013), di cui appena la metà rintracciabili nei nuovi fan di Alfano (il ministro dell’interno guida un partito essenzialmente meridionale, soprattutto calabro-siciliano). Anche il Pdl ha perso in maniera abbastanza costante in tutte le circoscrizioni, si va dai –400.136 voti delle isole (-46,7%) ai –730.880 del Sud (36%). Tra i tanti spostamenti c’è anche un partito che è scomparso. Si tratta della ex Scelta civica, oggi Scelta europea. Tramontato senza gloria l’astro di Mario Monti, in quindici mesi la formazione si è trovata a perdere praticamente tutti i quasi tre milioni di voti che aveva raccolto assieme al fu movimento di Fini. Voti, tanti voti, che è ragionevole andare a cercare dentro il successo del Pd, anche se in parte saranno finiti anche ad 25 Alfano. La circostanza induce a un altro ragionamento che ridimensiona un po’ il successo di Renzi: tra i voti persi da Scelta civica e quelli guadagnati dal Pd il saldo è negativo. E se si può dire che l’area di governo ha guadagnato, è solo in forza della new entry del Nuovo centrodestra, domenica al suo primo test elettorale. In definitiva per Pd, Scelta europea e Ncd i voti in più rispetto al 2013 sono 939.467, non uno di più. Anche per la sinistra che ieri festeggiava il superamento della soglia di sbarramento, e dunque l’elezione di tre europarlamentari, i calcoli vanno fatti con qualche attenzione. Quella riassunta dalla candidatura di Alexis Tsipras è una formazione tutta nuova, ma se un paragone si deve cercare bisogna considerare i risultati che l’anno scorso hanno ottenuto la lista Ingroia (che aveva dentro come partiti Rifondazione, Comunisti italiani e Italia dei Valori) e Sinistra ecologia e libertà. Ai voti ottenuti domenica da Tsipras vanno così aggiunti i pochi guadagnati da Italia dei Valori che ha corso (male) in solitaria. E allora si scopre che il saldo è negativo anche rispetto alla non brillante prestazione delle ultime politiche. Si sono persi 571.524 voti in tutta Italia (-30,8%) con punte al Sud (-237.642 voti; –44,5%) e nelle isole (-94.285 voti; –48%) e un’emorragia più contenuta al Nord ovest (43.726 voti; –11%). Anche molti voti della sinistra, dunque, sono finiti al Pd di Renzi. In questo dimostrando ancora una volta che il fatale richiamo del voto utile — in questo caso contro la minaccia di Grillo — funziona sempre. Anche quando non è fondato su un pericolo che si dimostra (alla conta dei numeri) reale. Estendendo per la sinistra lo sguardo all’indietro a cinque anni fa si vede che i voti persi tra due elezioni europee sono addirittura quasi un milione, circa il 50%, ma quello era decisamente un altro mondo. Si può anche guardare il bicchiere mezzo pieno: l’assurda soglia è comunque superata e la gran parte dei voti che mancano rispetto alla somma dell’anno scorso si possono probabilmente attribuire al tracollo dell’Idv, allora con Ingroia e che oggi appare come un partito esaurito. Questa dunque una prima analisi possibile sulle grandezze assolute. Si può a questo punto fare un passo in avanti, immaginando che il risultato delle europee spinga Renzi a forzare la mano e a voler tentare di riequilibrare anche il parlamento italiano. Dove i numeri sono quelli dell’anno scorso e il trionfatore di ieri è costretto ancora a venire a patti con Forza Italia. Il sistema con cui si è votato domenica per mandare i rappresentanti italiani a Strasburgo non è molto diverso da quello lasciato in piedi dalla Corte Costituzionale nella sentenza con la quale ha stroncato la vecchia legge elettorale. Applicare i risultati di ieri al «Consultellum» è poco più di un gioco perché le circoscrizioni sono totalmente diverse e le motivazioni con le quali si andrebbe al voto politico lo saranno possibilmente di più. Ma, insomma, i risultati non potrebbero essere troppo diversi da questi: alla camera dei deputati con le percentuali di ieri il Pd potrebbe ottenere 266 seggi, 136 il M5S, 109 Forza Italia, 39 la Lega, 29 il Ncd, 27 la lista Tsipras e 23 i Fratelli d’Italia (in coalizione, altrimenti resterebbero fuori). Risultato: il Pd per avere la maggioranza dovrebbe allearsi sia con Tsipras che con Alfano. Improbabile. La riforma della legge elettorale resta d’attualità. del 27/05/14, pag. 16 Il Pd fa il pieno anche nei municipi Ecco i sindaci già eletti nei capoluoghi Un abbraccio ai nuovi sindaci. Il messaggio via Twitter di Matteo Renzi arriva nel giorno in cui il Pd ha l’evidenza, dopo la vittoria alle elezioni europee, di avere fatto filotto anche alle amministrative. A dirlo è il risultato conseguito nei 4.095 comuni in cui si votava per 26 rinnovare sindaci e consigli comunali. Su 27 capoluoghi di provincia il Pd ha ottenuto 7 sindaci eletti al primo turno, a cui vanno aggiunti altri 11 candidati più votati al primo turno e, dunque, con elevate probabilità di essere eletti in occasione del ballottaggio, fissato per l’8 giugno. Motivo per cui il premier ha avuto gioco facile nel complimentarsi attraverso un tweet, «da collega (sindaco, ndr ) conosco la bellezza di un mestiere così delicato». Del resto, tra le città interessate dall’elezione del nuovo sindaco c’era anche la sua Firenze. Nel capoluogo toscano la corsa del fedelissimo Dario Nardella si è conclusa con una vittoria netta con quasi il 60% dei consensi. Il successo conseguito a Palazzo Vecchio non è isolato, anche nel resto della Toscana il Pd ha visto eleggere i propri candidati nei principali Comuni. A Prato, Matteo Biffoni non ha faticato a battere lo sfidante di Forza Italia Roberto Cenni (58,18% contro 28,71%). Stesso esito a Empoli, dove Brenda Barnini è stata eletta al primo turno (53.84%). A Livorno per sapere il nome del nuovo sindaco sarà invece necessario attendere il risultato del ballottaggio. Il candidato del Pd, Marco Ruggeri, ha ottenuto il 39,97% dei voti, a fronte del 19% di Filippo Nogarin (M5s) e del 16,38% di Andrea Raspanti (Lista Civica). Quest’ultimo, intercettando molti voti di simpatizzanti dell’ex Pci, ha impedito a Ruggeri di passare al primo turno, un finale senza precedenti nella rossa Livorno. Il grillino Nogarin andrà, dunque, al ballottaggio con Ruggeri. Spostandosi al Sud lo sguardo di commentatori e politici si è focalizzato su Bari. Ossia l’altra grande città, insieme a Firenze, dove gli elettori erano chiamati a scegliere il sindaco. Nel capoluogo pugliese lo spoglio, iniziato alle 14 come nel resto di Italia, fin da subito è proseguito a rilento. Antonio Decaro, candidato sindaco per il Pd, non ce l’ha fatta al primo turno (49,3) e, quindi, andrà alla sfida dell’8 giugno contro Mimmo Di Paola (Forza Italia). Tornando alle città dove il partito di Renzi ha ottenuto subito l’elezione del primo cittadino vanno registrati i successi di Luca Vecchi, che è stato eletto a Reggio Emilia con il 56,38%, Comune dove ha svolto l’incarico di sindaco fino allo scorso anno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. Oltre a Vecchi gli eletti al primo colpo sono stati Tiziano Tagliani (sindaco a Ferrara con il 55,5%), Davide Drei (Forlì, 54,8%), Matteo Ricci,(Pesaro, 60,5%), Nicola Sanna (Sassari, 65,5%). A Modena il Pd Giancarlo Muzzarelli va al ballottaggio contro il 5 Stelle Marco Bortolotti (49,7% contro 16,3%). Sul filo Antonio Battista a Campobasso con 49,9% contro il pentastellato Roberto Gravina (20,3%). Sul versante del centrodestra il carniere è misero. Al primo turno l’unico candidato che ha avuto la meglio sul suo avversario è stato l’uscente Guido Castelli, che guidando una lista civica fiancheggiata da una coalizione più che eterogenea con Forza Italia, Ncd e Fratelli d’Italia è stato rieletto sindaco di Ascoli Piceno (58,5%). L’altra bandierina il centrodestra l’ha piazzata a Teramo. Qui il sindaco uscente, Maurizio Brucchi, ha ottenuto la riconferma seppure alla guida di una lista civica. Più faticosa la corsa alla rielezione per Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, vice presidente dell’Anci e giovane leva in ascesa di Forza Italia, che non è riuscito a superare la soglia del 46,5%. Così, l’8 giugno dovrà battere il candidato del Pd, Massimo De Paoli (36,5%), per ottenere il secondo mandato. Nel 2009 va ricordato che Cattaneo aveva prevalso al primo turno con oltre il 54% dei voti. Al ballottaggio dovrà correre a Bergamo pure Giorgio Gori. L’ex manager tv vicino a Renzi non è infatti riuscito a passare al primo turno. Con il suo avversario, Franco Tentorio (Forza Italia e Fratelli d’Italia) si è chiuso con un vero testa a testa (45,5% per Gori, 42,1% per Tentorio). Un ultimo dato vale infine per la Lega: il partito di Matteo Salvini, a dispetto di un buon risultato alle Europee, non ha piazzato nessun sindaco nei Comuni capoluogo di provincia. Andrea Ducci 27 del 27/05/14, pag. 16 Le comunali confermano l’avanzata del Partito democratico, che strappa Prato e Campobasso. Forza Italia e alleati tengono Ascoli e Teramo Al Pd subito dieci città tra i sedici ballottaggi c’è la sorpresa Livorno In Toscana M5S contro centrosinistra. Doppio turno anche a Padova e Bergamo, dov’è in vantaggio Gori MAURO FAVALE ROMA . Si partiva 16 a 13 per il centrosinistra. Finisce, per ora, salvo ballottaggi, 10 a 3. Le amministrative nei 29 comuni capoluogo chiamati al voto confermano il trend nazionale che ha caratterizzato le Europee con una valanga per Pd e alleati che si confermano al primo turno a Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Pesaro, Sassari e Firenze, strappano al centrodestra Campobasso e Prato, e vanno al ballottaggio, invece, quasi ovunque, da Bari a Bergamo, da Livorno a Pavia, da Vercelli a Potenza, da Cremona a Urbino, passando per Verbania, Foggia, Caltanissetta, Perugia, Terni e Padova. Il centrodestra mantiene, invece, Ascoli e Teramo e Tortolì, nell’Ogliastra. Per il resto, per avere un quadro preciso degli equilibri di forza nei Comuni, bisognerà attendere due settimane e il secondo turno di voto. Per ora si può dire che i ballottaggi confermano per lo più uno scontro tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle, alle Comunali, si gioca il secondo posto col centrodestra e a sorpresa, balza in avanti a Livorno. Lì, dove il sindaco era sempre stato eletto al primo turno, riesce a tenere Marco Ruggeri, candidato del Pd, sotto al 50% costringendolo al ballottaggio con Filippo Nogarin: «Vinceremo — dice — come è successo a Parma con Pizzarotti che partiva dal 16%». Lui, intanto, si tiene stretto il suo 19%. E se Livorno sarà la riedizione dello scontro emiliano, inedito è il ballottaggio a Padova tra Lega e Pd che ha governato il capoluogo veneto per 10 anni con l’ex ministro Flavio Zanonato. A contendersi la sua eredità saranno Ivo Rossi, Pd, e Massimo Bitonci, capogruppo del Carroccio al Senato. Evitato per un soffio, invece, il secondo turno a Modena, da sempre roccaforte rossa: qui Gian Carlo Muzzarelli ha superato l’asticella del 50% di una manciata di voti, risparmiandosi una pericolosa sfida tra due settimane col grillino Marco Bortolotti. A Campobasso e Prato, per ora, gli unici cambi di segno. Nel comune molisano Antonio Battista del Pd, supera di poco il 50% tenendo a distanza il candidato grillino. In quello toscano il centrosinistra torna al governo dopo 5 anni: il sindaco uscente si ferma sotto al 30%, lasciando campo libero al renziano Matteo Biffoni. Renzianissimo è anche Dario Nardella che raccoglie dall’attuale premier il testimone di sindaco di Firenze: per lui 59,5% e vittoria al primo turno. A Bergamo, invece, non è riuscita l’impresa a un altro ex collaboratore di Renzi: Giorgio Gori va al secondo turno in vantaggio di tre punti, 45% a 42%, sul sindaco uscente Franco Tentorio. L’otto giugno i risultati finali. 28 del 27/05/14, pag. 14 Un voto pd su 10 viene da Grillo M5S tradito da quasi metà elettori La consultazione europea ha avuto l’effetto di un terremoto che ha modificato il panorama politico in profondità. La nettissima vittoria del Partito democratico, per la prima volta su tutto il territorio nazionale (è infatti il primo partito in tutte le province italiane con le eccezioni di Isernia, Sondrio e Bolzano), è una assoluta novità. Va però ricordato che la partecipazione è stata bassa (58,7%) e che mancano circa 7 milioni di voti che si erano espressi alle Politiche 2013 e che non si sono presentati alle Europee di domenica. Di questo bisogna tener conto: si tratta di un segnale di grande forza che va però consolidato nel voto politico. In valori assoluti il Pd guadagna circa 2,5 milioni di voti, dato tanto più rilevante se si considera la bassa partecipazione attuale. In termini assoluti, il dato del partito guidato da Matteo Renzi (11.172.861 voti) resta inferiore a quello ottenuto da Walter Veltroni (12.095.306 voti) alle Politiche del 2008. Il Pd non è poi l’unico partito che fa crescere i propri elettori rispetto alle scorse elezioni politiche. Fratelli d’Italia, pur non riuscendo a superare la soglia, ottiene un ottimo risultato, conquistando circa 340.000 elettori in più; una buona performance è ottenuta anche dalla Lega, i cui elettori crescono di circa 270.000. Le perdite. In valori assoluti Scelta Europea paga uno scotto pesantissimo: aveva (considerando anche Fare e Centro democratico) circa 3.372.000 voti, ne perde più di tre milioni. Grosso modo altrettanti ne perde il Movimento 5 Stelle. Infine Forza Italia, per la quale i raffronti sono più difficili. Dovremmo infatti considerare l’area vasta di Pdl, Fle e Udc confrontata con i dati di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra-Udc. I voti persi in questo caso sono circa 2.300.000, con una Forza Italia ridotta ai minimi termini e l’area di centrodestra che non riesce a mantenere i voti ottenuti dalla sola Udc alle Europee del 2009. Ma quali sono gli spostamenti di voto rispetto alle scorse Politiche? Analizziamoli sulla base di circa 9000 interviste pesate in base ai risultati effettivi del voto. Il Pd gode di un elevato tasso di fedeltà: quasi 80% di chi lo aveva votato nel 2013 conferma il proprio voto alle europee. Pochi i flussi in uscita: prevalentemente verso l’astensione, qualcosa verso sinistra e verso il M5S. Il Pd ottiene inoltre voti dal centro (Scelta Civica e Udc+Fli), dal Movimento 5 Stelle e da sinistra mentre più contenuti sono i flussi che provengono dal Pdl. In sostanza Renzi svuota il centro e recupera parte importante del voto che nel 2013 era transitato verso Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha un basso indice di fedeltà: solo poco più della metà degli elettori 2013 conferma il proprio voto alle europee. Forti le uscite verso l’astensione e verso il Pd. La scelta di replicare una campagna contro tutti non paga. Il recupero di Renzi su questo elettorato è dovuto ad almeno tre aspetti: la capacità di presidiare alcuni dei principali temi simbolici di Grillo (costi della politica, peso della burocrazia, rinnovamento della macchina amministrativa); la proposta di governo e di rapporto con l’Europa (riforme a tambur battente senza subalternità alla Commissione Europea) e il coraggio personale. Forza Italia ha una fedeltà bassissima; più di un quarto degli elettori 2013 si rifugia nell’astensione, alcuni scelgono il Pd, poco più del 10% gli altri partiti di area (Ncd, Fdi, Lega). La coalizione Ncd-Udc Ppe fatica a convincere i propri elettori potenziali: poco arriva dal Pdl e anche i flussi da Udc e FLI sono contenuti mentre lo stesso si può dire di quelli che arrivano da Scelta Civica. In sostanza il superamento della soglia avviene grazie alla tenuta di una parte limitata dell’elettorato senza capacità di conquista apprezzabile. La Lega ottiene il proprio ottimo risultato grazie innanzitutto alla 29 fedeltà dei propri elettori, che per il 70% confermano il proprio voto da un’elezione all’altra, e alla capacità di conquistare voti dal Pdl e in parte dal M5S. Salvini ha quindi convinto il proprio elettorato e ha saputo convogliare parte dei delusi di Grillo e degli sfiduciati verso Berlusconi. Infine la lista Tsipras che supera la soglia di sbarramento grazie agli afflussi di voto dalla sinistra del 2013 ma anche da fuoruscite dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Infine vale la pena di analizzare la composizione degli elettorati dei principali partiti, perché qui scopriamo alcune sorprese. Limitiamo l’analisi a tre aspetti: l’età, la condizione professionale e il rapporto con la religione. Nelle fasce d’età più giovani il Pd diventa il primo partito, cambiando profondamente il profilo che avevamo visto. Anche se è insidiato ancora dal M5S, che supera il Pd nella fascia dai 35 ai 44. Quindi Renzi è riuscito a conquistare un voto critico come quello dei più giovani a scapito di Grillo. Per le professioni il Pd conferma il proprio appeal su ceti medi, pensionati e studenti, ma conquista anche le casalinghe e i ceti elevati. Il suo primato è insidiato nelle fasce sociali dove la crisi morde in maniera più evidente e più forte è il disagio: tra i lavoratori autonomi e i disoccupati il Movimento 5stelle è il primo partito, sia pur di misura. Forza Italia conferma le proprie difficoltà: tra ceti elevati e lavoratori autonomi il consenso è basso, le punte di attrazione maggiore si hanno tra le casalinghe e i pensionati (dove Forza Italia è al secondo posto) e tra i disoccupati. Infine il voto cattolico. Il Pd ottiene la percentuale più elevata tra i fedeli che frequentano assiduamente le funzioni religiose, il punto più basso tra chi invece a messa non ci va mai. Il contrario di quanto storicamente avveniva storicamente per i partiti della sinistra. Il Movimento 5stelle ha i suoi punti di forza tra i non cattolici e il suo punto più basso tra i fedeli assidui. Gli altri dati sono più prevedibili: Forza Italia meglio posizionata tra i cattolici che frequentano solo mensilmente le funzioni, Ncd e Lega più votati dai cattolici fedeli, Tsipras dai non cattolici. Il voto europeo manifesta quindi un’elevata trasversalità del Pd sia in termini politici che in termini sociali. Si è aperta una nuova fase che si presenta molto fluida. Ma il consenso degli elettori «liquidi» va conquistato e riconquistato ad ogni consultazione. Luca Comodo Del 27/05/2014, pag. 1 Una sfida per tutti Norma Rangeri I poveri sondaggisti anche questa volta avevano immaginato un altro mondo (l’astensione a valanga, il testa a testa tra Renzi e Grillo…), ma a parziale discolpa della loro inaffidabilità bisogna dire che sono stati sommersi, più che dal ridicolo, da una vera e propria onda anomala, apparsa a una certa ora della notte accanto alla casella del Pd: 40,8%. Quando un partito in un anno quasi raddoppia c’è molto da capire ma una cosa è chiara: siamo di fronte a un risultato elettorale che cambia i connotati a tutto il sistema politico. Il primo e unico riferimento storico del nuovo partito pigliatutto è la balena bianca democristiana, capace di salire così in alto da contenere tutto l’arco costituzionale, dalle sinistre dei Bodrato e dei Granelli alle destre dei Forlani e degli Andreotti. Questo Pd ha ingoiato in un solo boccone il 10% dei montiani con annessi cespugli (da Casini in giù) insieme a brandelli berlusconiani, portandoli nella stessa casa dei Fassina e dei Civati. Poi, come nella più collaudata tradizione democristiana, ha messo nelle tasche di dieci milioni di italiani 80 euro, biglietto da visita recapitato il venerdì per la messa elettorale della domenica. 30 In realtà questa febbre a 40 realizza la famosa vocazione maggioritaria di Veltroni, con ex dc e ex pci nucleo centrale di un trasversalismo destinato a produrre una mutazione genetica. Ha la febbre alta il paese che, dopo Berlusconi, dopo Grillo conferma l’anomalia italiana affidandosi al leader vincente, alla stabilità di governo. Da oggi abbiamo davanti una sfida per tutti. A cominciare dall’uomo solo al comando che deve governare tenendosi in equilibrio sull’imponente onda anomala che egli stesso ha sollevato, dimostrando di saper gestire un sostanziale monocolore: la cura prevede le riforme costituzionali di stampo presidenzialista, i sindacati al tappeto con l’imposizione del lavoro precario per tutti. Da domani Renzi non potrà più tirarsi fuori dai disastri del paese addebitandoli ai suoi rottamati predecessori. Il populismo di governo ha pagato più del populismo di opposizione, e dunque è una sfida anche per Grillo. L’ex comico ha lavorato per il nemico provocando la reazione del “voto utile” contro le urla e gli insulti. Molti, a sinistra, preoccupati di disperdere il voto, si sono turati il naso e hanno votato Pd per scampare un pericolo maggiore. Grillo deve scegliere se continuare a invocare improbabili caroselli intorno al Quirinale, se insistere con la politica del “vaffa” o traghettare i sei milioni di voti (un potenziale grandissimo) in una strategia parlamentare capace di trasformare la forza elettorale in alleanze, battaglie e obiettivi concreti. In Italia come in Europa. Il trionfo renziano è, infine, una sfida per la sinistra di Tsipras. Dopo aver vinto la scommessa europea con i tre parlamentari italiani eletti a Strasburgo, ora le donne e gli uomini che in pochi mesi hanno creato questa esperienza politica dovranno capire come collocarsi nell’inedito scenario italiano. L’analisi del voto rileva un potenziale molto al di là della sofferta soglia del 4% (il 5 a Palermo, l’8 a Bologna, il 6 a Roma il 9 a Firenze), testimoniato anche dal consenso ai candidati (molti i giovani) e ai capilista. Senza maratone televisive, forti del prestigio personale e delle lotte sul territorio hanno oltrepassato le 30 mila preferenze. Vincere controcorrente è un buon segno. del 27/05/14, pag. 10 Lo sfogo dell’ex premier: “Se vogliono provare a rottamarmi si accomodino, vediamo se hanno i numeri e la forza per farlo” Forza Italia allo sbando Berlusconi teme fughe mentre parte l’opa di Fitto Telefonata a Renzi: “Il patto sulle riforme tiene” Forse slitta la direzione, cerchio magico sotto accusa CARMELO LOPAPA ROMA . La resa dei conti è appena iniziata. E sotto accusa, per la prima volta, assieme al suo “cerchio magico”, finisce proprio il leader. Fughe sono date per imminenti al Senato, Berlusconi non sa come venirne fuori e tra i fedelissimi è forte il timore per una sorta di “opa” che il trionfatore Raffaele Fitto, tra i pochi di questa campagna, potrebbe lanciare nell’ufficio di presidenza di domani. Che infatti potrebbe slittare. «Complimenti Matteo, ma dovresti pur ringraziarmi: hai visto come sono stato bravo? In questi ultimi giorni ti ho fatto campagna elettorale» dice Berlusconi chiamando al telefono il premier e alludendo al suo «argine anti-Grillo», a suo dire vincente. Poi il discorso si fa serio. E il leader forzista garantisce che su legge elettorale e riforma del Senato loro ci 31 saranno, eccome. A quel tavolo il partito di opposizione resta aggrappato quasi con la forza della disperazione. Non a caso, prima dell’ex Cavaliere, era stato già Denis Verdini a contattare il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini per ribadire che la «strada delle riforme è spianata». Solo che le condizioni, ora più di prima, le detterà Matteo Renzi. A Silvio Berlusconi la portata del disastro era chiara già da un pezzo, quando in mattinata proprio Verdini, il “re dei numeri”, lo ha chiamato inviandogli i report sulla Waterloo forzista. Il leader è già uno straccio, smarrito, ma la reazione è rabbiosa. «Provino pure a rottamarmi, se hanno la forza e i numeri. Qualcuno pensa davvero di poter guidare Forza Italia senza di me?» si è sfogato l’ex Cavaliere quando a ora di pranzo ad Arcore siedono tutti i figli, Piersilvio e Marina, Barbara, Eleonora e Luigi. Con loro anche Giovanni Toti, capolista neo eletto nel Nordovest, e Niccolò Ghedini. Forza Italia è un partito allo sbando e lui non ha stavolta una soluzione da proporre. Ricominciano così a circolare voci su fughe imminenti al Senato, trattative ripartite di un gruppetto di forzisti con l’Ncd di Alfano, che ha superato per un pelo lo sbarramento. È proprio quel che teme l’ex premier: il fuggifuggi post disastro. Nei colloqui privati alza il tiro anziché giocare in difesa. Fa sapere di sentirsi «offeso» da quel 16 e passa per cento: «Ancora una volta ho dovuto fare tutto da solo, sono stato lasciato a combattere senza alcun aiuto, senza poter parlare, col divieto di andare in giro». Ma la vera incognita riguarda il futuro. «Non posso consegnare a Marina un cumulo di macerie» è stata una delle considerazioni del day after. La stessa primogenita, raccontano, ha rafforzato in queste ore la convinzione che sia meglio lasciar perdere la politica, almeno per ora. In realtà Berlusconi non ha alcuna voglia di mollare la presa. La nota diffusa nel pomeriggio è un segnale soprattutto interno, con cui prende atto della sconfitta ma avverte che i conti vanno fatti con lui. Scrive di un «risultato inferiore alle attese», ma che dipende dalla sua condizione di «uomo non libero». Come tante altre volte però garantisce che ripartirà dal risultato «negativo». Per concludere: «La mia stella polare resta l’unità dei moderati ». La prima vittima sacrificale sembra sia predestinata: il responsabile dei “club” Marcello Fiori, additato come uno degli ingranaggi della macchina che hanno toppato. La scheda inviata dalla sede di San Lorenzo in Lucina ad Arcore ha rassicurato fino a un certo punto: i tre milioni di voti persi da Forza Italia in un anno — nella lettura di Verdini — sarebbero finiti per metà nel mare dell’astensionismo, il restante milione e mezzo così distribuito: 900 mila voti al Ncd, 300 mila ai Fratelli d’Italia e 300 mila alla Lega. Solo una manciata attratti da Renzi. Il Transatlantico è semideserto e tra i pochi forzisti che si aggirano c’è allarme. Solo Luca D’Alessandro ironizza: «Quaranta per cento Renzi, sedici noi, il partito dei moderati e delle riforme insomma ha il 56 per cento». Ma non è aria. Verdini chiama Fitto e lo prega di non alzare i toni, ora che ha stravinto. Ma i fedelissimi sono entrati in fibrillazione quando “Mr. 284 mila voti” si è presentato in sede a Roma nel pomeriggio e da lì ha rilasciato decine di interviste tv. Maria Rosaria Rossi e Francesca Pascale vengono ritenute da molti tra le principali responsabili della débacle, loro la scelta di chiudere la campagna in una sala da 500 posti a Milano, di evitare le piazze. «Berlusconi si faccia da parte» lo invita un vecchio conoscente come Giuliano Urbani. «Il partito ormai è governato dai porta-Dudù» attacca l’uscente non rieletta Susy De Martini. «Sbagliate le liste, servivano i big» conclude la fedelissima Michaela Biancofiore. Come Giancarlo Galan: «Abbiamo perso consensi e molta fiducia del nostro elettorato». Il rischio è che la resa dei conti scatti subito. Non a caso, non sono ancora partite le convocazioni ufficiali per l’ufficio di presidenza di domani. 32 del 27/05/14, pag. 11 Salvini: pronti a dialogare con Silvio «Se il centrodestra fa il centrodestra, vince in tutta Europa. Se fa da stampella al centrosinistra, perde. Se non ha il coraggio di cambiare, perde. Se non passa per un vero ricambio, perde». Matteo Salvini trae la sua conclusione da tali premesse: «Offro a Silvio Berlusconi la possibilità di ricominciare un dialogo già da domani mattina. Spero di vederlo entro la fine della settimana a firmare con noi i nostri sei referendum, primo fra tutti quello per l’abolizione della riforma Fornero». Perché l’obiettivo resta «quello della ricostruzione del centrodestra. E io spero proprio che gli eurodeputati di Berlusconi e Alfano non si siedano con la Merkel perché chi sta con la Merkel non può essere alleato con la Lega». Una Lega che si sente pronta ad essere la «capofila» del nuovo progetto. Risultati a ieri sera? Berlusconi avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare allo show pro referendum. Anche se i leghisti prima di proclamarlo ufficialmente attendono qualche rassicurazione in più. Perché tra Berlusconi e Salvini ci sarebbero stati soprattutto i complimenti al giovane leader leghista. Mentre sul punto della firma ai sei referendum leghisti, i contatti sarebbero infatti avvenuti tra non meglio definiti sherpa berlusconiani e Roberto Calderoli. Quel che si apprende dalla Lega, è solo che «Berlusconi è arrabbiatissimo». Il successo leghista archivia le Europee 2014 con un dato (6,16%) che nei numeri non rende conto fino in fondo della soglia psicologica attraversata: per i padani è il Rinascimento. Ancor più dolce perché Matteo Salvini, sia pure grazie alla presenza in tutte le circoscrizioni, è il candidato eletto che ha preso più voti di tutte le europee: 387.504 voti di cui 222.720 nella circoscrizione Nordovest e 108.661 nel Nordest. Da qui, parte la sfida che a Salvini sta più a cuore: quella per Milano. «Da domani — annuncia — comincio la lotta per cacciare Pisapia». Con una staffilata ad un altro possibile candidato di un centrodestra riunificato, il ministro Maurizio Lupi: «Mi fa piacere che lo sconosciuto Salvini abbia ottenuto un numero di preferenze 5 volte tanto rispetto al ministro Lupi». Più vicine le prossime regionali in Veneto: «Zaia ha lavorato benissimo e squadra che vince non si cambia. Anche se è presto per parlare di questo». E pazienza se le regionali sono ben più vicine delle amministrative di Milano. Quanto al sindaco di Verona Flavio Tosi, ha già fatto sapere che intende rinunciare all’euroseggio: rientrerà l’uscente Mara Bizzotto da Bassano del Grappa. Ma il gioco delle opzioni non è uno scherzo. Salvini è il primo degli eletti in tre circoscrizioni. A seconda di quello che sceglierà, rimarrà fuori il pavese Angelo Ciocca, il tessitore delle euro alleanze Lorenzo Fontana, oppure Mario Borghezio. Perché grazie al sostegno delle destre della Capitale, il leader degli indipendentisti padani è infatti riuscito ad essere il secondo dopo Salvini nella circoscrizione centro: «Ho lavorato come un pazzo — ha detto — e credo che a Roma questo si sia visto». Cosa sceglierà Salvini? Vicino a lui, il ragionamento è questo: «Fontana è indispensabile. Ma anche a Borghezio, nella sua proiezione non solo nordista, è difficile rinunciare». E intanto, i padani si preparano al più importante dei ballottaggi, quello per Padova, dove il capogruppo al Senato Massimo Bitonci (31,5%) tallona Ivo Rossi (33,7%) , il «reggente» della città dopo l’abbandono di Flavio Zanonato per il ministero allo Sviluppo del governo Letta. Marco Cremonesi 33 del 27/05/14, pag. 12 LA SINISTRA CON TSIPRAS Spinelli: “A Strasburgo dialogo con i 5 Stelle” ALBERTO CUSTODERO ROMA . Aderiranno al gruppo della sinistra europea Gue, ma saranno possibili «convergenze con i grillini». Accusano Renzi di aver abbandonato «parole di sinistra come uguaglianza e rappresentatività », di aver «divorato l’elettorato di destra». E di aver trasformato il Pd «in qualcosa che somiglia alla vecchia Dc». Insomma, i tsiprasiani italiani, capeggiati da un’agguerrita Barbara Spinelli, si definiscono sì «una sinistra radicale». Ma si considerano molto di più: «Direi — sentenzia Spinelli — che la lista Tsipras è la sinistra italiana». Invocano il miracolo per aver superato lo sbarramento del 4 per cento per una manciata di voti, circa 8 mila, appena lo 0,3 per cento. I più votati sono risultati, paradossalmente, i due candidati che non avevano chiesto i voti (perché avevano detto di non essere interessati al seggio europarlamentare), Moni Ovadia — circoscrizione Nord-Ovest — e Barbara Spinelli — al Centro e al Sud. I due, come annunciato in campagna elettorale, si dimetteranno per lasciare il posto ai tre primi esclusi, Curzio Maltese, Marco Furfaro ed Eleonora Forenza Maltese. «Non so ancora dove andrà Grillo nel parlamento europeo — commenta Spinelli — e quale sarà il peso reale dei suoi candidati, ma credo che i parlamentari del M5S hanno molta voglia di imparare e agire democraticamente con un’opposizione ben fatta. Su alcuni punti discussi a Bruxelles saranno possibili convergenze ». Ma è ancora l’intellettuale a smarcare in Italia la sinistra radicale europea di Tsipras da quella riformista di Renzi. «Renzi — spiega — è a capo di un partito in piena mutazione antropologica: ha divorato l’elettorato di destra. Ma il Pd somiglia molto alla Democrazia cristiana. Renzi ama paragonarsi a Blair, ma il premier inglese ha salvaguardato lo Stato sociale. Ho molti dubbi che presidente italiano lo farà». Spinelli attacca al cuore Renzi, sul piano ideologico. «La linea vincente del Pd decisa nelle stanze dei dirigenti ha abbandonato una seria di parole tipiche della sinistra, e dietro le parole ci sono sempre dei concetti, una lunga storia, un impegno. Sono scomparse parole come uguaglianza e rappresentatività, relativa al tema della legge elettorale». Incalzata dalle domande, precisa: «Questo non significa che non ci siano forze di sinistra nel Pd, come il gruppo di parlamentari contro la legge di riforma del Senato. E il gruppo di Civati». Per il leader di Sel Vendola, «il voto ha espresso una straordinaria domanda di cambiamento che si è riversata su Renzi. Il segretario Pd la deve giocare per cambiare davvero le politiche in Europa, altrimenti non si potrà pensare di aver cambiato musica davvero». Fra gli esclusi, l’ex leader dei “disobbedienti” Luca Casarini, Giuliana Sgrena, la giornalista del Manifesto rapita in Iraq e liberata a costo della vita dal funzionario del Sismi Nicola Calipari. E la candidata altoatesina Oktavia Brugger. Del 27/05/2014, pag. 1-15 E’ tornata la sinistra Sandro Medici 34 Quattro zero tre. Ce lo ricorderemo, questo numero. Con sollievo, certo. Ma ancora più incolleriti per questo sbarramento elettorale ingiusto e bastardo, pensato e agito proprio per eliminare quelli come noi. Quelli che come noi sentono il bisogno di esprimere e praticare una politica altra, estranea alle liturgie di palazzo, insofferente alle appartenenze coatte, desiderosa di libertà e democrazia. Per la lista «L’altra Europa» era una soglia materiale ma anche psicologica. L’abbiamo superata per un sospiro, ma l’abbiamo superata. Avremo i nostri eletti nel parlamento europeo e, quel che più conta, abbiamo avviato un progetto molto più largo e ambizioso. Il progetto di riaprire una prospettiva di sinistra nel nostro paese, in un paese che l’ha intenzionalmente liquidata o forse solo smarrita. Ora comincia l’avventura; domenica notte ne è stato il sofferto preludio. Da qui in poi si fa sul serio. Si ricostruisce un senso e anche un immaginario che negli ultimi decenni sono stati sistematicamente impoveriti, scarnificati, fino a polverizzarli del tutto. E lo si fa nel fuoco della battaglia politica, bruciandosi le mani e masticandone il fumo. C’è da scoprire insieme una nuova forma della politica, inventando il come si fa e praticando il come si deve. Esattamente come, pur tra imperfezioni e incompiutezze, si sono mossi i comitati elettorali della nostra lista (che elettorali non sono stati del tutto). Costruendo pezzo per pezzo un embrione di soggettività politica, tra vecchi militanti e giovani attivisti, tra persone apparse o riapparse e debuttanti assoluti. È l’intelaiatura su cui far poggiare questa coalizione tra forze politiche e forze sociali, che al più presto ha bisogno d’incamminarsi in un processo aggregante, miscelandosi ancor più di quanto sia successo in campagna elettorale e soprattutto accogliendo chi finora ha preferito guardarci da lontano. C’è insomma da superare il rischio che, finita la corsa elettorale, in alcuni possa affiorare la tentazione di tornare ai propri ridotti, a quei blocchi di partenza da cui, a volte con fatica, si era partiti. Un rischio che non si elimina attraverso quei diplomatismi, spesso stucchevoli, che nel passato hanno finito per opacizzare anche le intenzioni migliori. Al contrario, si tratta di convogliare questo prezioso patrimonio politico unitario direttamente nel circuito delle pratiche politiche, nel vivo delle lotte. Sul modello del movimento per l’acqua pubblica, “troppo” impegnato nella battaglia referendaria per dilungarsi in confronti e discussioni. Vivere insieme campagne politiche, obiettivi da raggiungere, risultati da conseguire consolida le relazioni e ammorbidisce gli spigoli. Un processo di ricomposizione si ricompone ricomponendosi. È per questa ragione che i più adatti (i più titolati) a condurre, gestire la nuova fase sono proprio i comitati ex-post elettorali. Che dovrebbero rivendicare questa funzione, anche a costo di autoconvocarsi e così imprimere le necessarie accelerazioni. La Fenice rinasce se non ha le ali impolverate, se può slanciarsi in volo senza le zampe appesantite. Del resto, l’urgenza d’intraprendere un nuovo cammino è innegabile. A ricordarcelo sono gli stessi risultati elettorali, e non solo nostri, anzi soprattutto quelli degli altri, con un partito democratico all’inizio di un ciclo ancora più dannoso di quanto finora abbia lasciato vedere. Unico partito in Europa che contiene in sé, senza ulteriori apporti, quel modello di larghe intese che continuerà a produrre miserie e ingiustizie. E verso cui è indispensabile contrapporre una corposa battaglia di opposizione. 35 LEGALITA’DEMOCRATICA del 27/05/14, pag. 29 L’ex ministro del governo Monti arrestato su ordine dei pm di Ferrara. L’accusa è peculato: distratti tre milioni Ma su di lui indagano altre due procure: Roma per associazione a delinquere e corruzione, Lugano per riciclaggio I soldi per l’Iraq sui conti svizzeri di Clini LUIGI SPEZIA MARIA ELENA VINCENZI FERRARA . Tre milioni di euro del ministero dell’Ambiente che invece di aiutare l’Iraq vengono ritrovati in Svizzera, sui conti privati del direttore generale di quel ministero e di un suo socio. Corrado Clini, che dell’Ambiente era diventato anche ministro con il governo Monti, è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia tributaria di Ferrara e si trova ora agli arresti nella sua casa di Roma. I pm Nicola Proto e Filippo Di Benedetto l’accusano di peculato per essersi impossessato di una “provvista” prelevata da 54 milioni di fondi stanziati per l’Iraq, finita in Svizzera dopo un giro di triangolazioni tra Europa e paradisi fiscali caraibici e una banca di Dubai. Una girandola di passaggi che non sono riusciti a nascondere la destinazione finale di 3 milioni e 200 mila euro: Lugano, in «posizioni finanziarie direttamente riconducibili agli indagati», come si è espresso il comandante della Guardia di Finanza di Ferrara, Sergio Lancerin. Un milione sul conto di Clini e gli altri due su quello del suo socio, l’ingegnere Augusto Pretner di Padova. Non è finita. Altre due procure sono al lavoro sui finanziamenti del ministero dell’Ambiente. Corrado Clini risulta essere indagato anche dalla procura di Roma, dove il pm Alberto Galanti conduce insieme ai finanzieri del Gruppo speciale spesa pubblica un’altra inchiesta, per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, su finanziamenti sospetti del ministero dell’Ambiente per la realizzazione di opere all’estero, dalla Cina al più vicino Montenegro. Un’inchiesta che fa pensare all’esistenza di un vero e proprio sistema di cui ciò che è emerso a Ferrara sarebbe solo la punta di un iceberg. Inoltre parallelamente indaga anche una terza procura, la procura federale svizzera di Lugano, per riciclaggio di denaro. Il finanziamento del ministero dell’Ambiente, interamente approvato da Clini con decreti a sua firma tra il 2007 e il 2011, era stato disposto a favore di un consorzio iracheno impegnato nella bonifica di una zona paludosa nella zona dello Shatt el Arab, alle foci del Tigri e dell’Eufrate. È una zona dove gli studiosi collocano l’Eden biblico ed Eden è il nome che la Finanza ha dato alla sua operazione durata più di un anno, giá parzialmente nota pochi mesi fa quando Clini venne sentito a Ferrara e disse che «eventuali distrazioni di denaro nulla avevano a che fare con la mia persona e il mio ministero». Tutto è nato in Olanda, dove la struttura investigativa europea Eurojust aveva segnalato anomali flussi di fatture da una societá olandese, la Gbc, ad uno studio di ingegneria di Ferrara. Si è scoperto così lo strano viaggio di quei tre milioni, quando la Gbc ha emesso false fatture a favore del consorzio che ha ricevuto i finanziamenti in Iraq, Nature Iraq, di cui facevano parte anche lo studio di ingegneria di Padova, quello di Ferrara e la ong Iraq Foundation di New York. Il denaro di ritorno dall’Iraq, i tre milioni sospetti, non si è più mosso dall’Europa, anche quando sono entrate in scena societá nei paradisi fiscali caraibici come Saint Kitts and Nevis o le Isole Vergini Britanniche. 36 del 27/05/14, pag. 29 Il grand commis dell’ambiente e quei trent’anni di ombre e potere CORRADO ZUNINO «UN EFFICIENTE ministro dell’Industria», disse di Corrado Clini il verde Angelo Bonelli quando tentò di spiegare l’attivismo feroce del medico di Latina — nel frattempo diventato ministro dell’Ambiente del governo Monti — per inertizzare le indagini dei magistrati di Taranto e lasciare aperte le cokerie dell’Ilva. Sulla fabbrica siderurgica c’è sempre stata quella intercettazione tanto temuta e mai spiegata davvero. Il grande corruttore dell’Ilva per conto della famiglia Riva, il capo delle relazioni esterne Girolamo Archinà, nel 2010 disse al telefono: «Corrado è un uomo nostro». Clini è stato direttore generale all’Ambiente per vent’anni, ma sempre ha negato di essere lui quel Corrado. Poi, però, altre due telefonate sono emerse dai file di procura rendendo più difficili le spiegazioni. Ivo Allegrini, direttore per una vita dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, a un certo punto consulente Ilva, rivelerà al confidente Archinà: «Ci pensa il nostro amico Corrado che adesso ha la delega su tutte le direzioni generali ». E in un’altra chiamata Allegrini aveva voluto sapere se il gruppo dirigente Ilva era stato informato degli interessi «dell’amico Corrado» in Brasile. A 67 anni, quattro figli, per l’ex ministro sono arrivati i domiciliari nella sua casa dietro piazza Navona, centro storico pregiato della capitale dove ama ascoltare Freddie Mercury. È uno dei cinque immobili che Clini possiede, poca cosa negli anni di governo rispetto ai ventitré fabbricati del premier Monti e i novantasei del sottosegretario Guido Improta. Medico del lavoro specializzato in igiene e sanità pubblica, Senior research fellow a Harvard, oggi Clini è ancora il direttore generale dello Sviluppo sostenibile al ministero dell’Ambiente. A Venezia, dove iniziò nel 1978 a tessere, giovane socialista, la rete di conoscenze, lo ricordano protagonista alla fine degli Ottanta: migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi sversati in Libano da aziende lombarde stavano rientrando a Marghera con la nave Jolly Rosso. Clini rassicurava tutti: «Bruciando due copertoni si provocherebbero danni maggiori». Nel gennaio del 1990 accompagnò Giorgio Ruffolo nell’area Acna di Cengio, Savona industriale: i rifiuti dell’azienda di coloranti sono riemersi in queste stagioni nel Casertano di Gomorra. «Non esiste alcun ritardo nei lavori», disse il dirigente sulla bonifica in corso. La chiusura lavori è prevista per quest’anno, ne sono passati ventidue. Da direttore generale, Clini ha gestito i 300 miliardi di lire per il risanamento dell’area Enichem di Manfredonia e nel 1993 ha dato corpo al suo curriculum di conflitti di interesse entrando nel consiglio di amministrazione dell’Enea, che da lì a poco avrebbe preso in carico diversi controlli ambientali. Nel 1996 la procura di Verbania lo ha indagato per l’inquinamento prodotto dall’inceneritore della svizzera Thermoselect. Un impianto pilota, non serviva autorizzazione preventiva dello Stato. I vertici dell’azienda vennero condannati in Cassazione per lo sversamento di cianuro nei torrenti vicini, il direttore Clini — difeso dall’avvocato Taormina — chiese e ottenne di trasferire il processo al Tribunale di Roma: archiviato. Nel 2007 il grand commis dell’Ambiente è stato pubblicamente sbertucciato da padre Alex Zanotelli, comboniano in missione in una baracca della discarica di Korogocho, Kenya: Clini aveva finanziato con 721 mila euro pubblici (solo per lo studio di fattibilità) una società italiana, la Eurafrica, per farle risanare trenta ettari di veleni. Il ministro Pecoraro Scanio scoprì che il direttore della società napoletana, zero dipendenti, era un mercante d’armi e fermò il progetto da 30 milioni. Clini trattò Zanotelli con disprezzo: 37 «Forse disturbiamo the lords of pauperty , i benefattori di professione che vivono sulla miseria dei disperati». Da ministro dell’Ambiente il dottore ha lasciato prosperare alle Finanze una società — Sogesid — utilizzata per le bonifiche. La Sogesid è riuscita a dare, solo nel 2011, 203 consulenze esterne per un costo di 4,5 milioni di euro. In trasferta in Calabria, confessò imbarazzo per la doppia veste in conflitto: «Sono qui e devo cercare di tenere due cappelli in mano». Clini era ministro e pure presidente del Consorzio per l’Area science park di Trieste: la sua società doveva formare trenta giovani calabresi e poi incassare 30 milioni dal suo ministero. Suggerito, un mese dopo avrebbe lasciato la presidenza privata. Pantagruelico, il ministro Clini è riuscito a portare in Brasile, alla tre giorni di conferenza Rio+20 del giugno 2012, una delegazione monstre , degna dei socialisti della sua gioventù. D’altronde il maestro politico, riconosciuto e rivendicato, è stato Gianni De Michelis. 38 INFORMAZIONE Del 27/05/2014, pag. 15 Due proposte serie sulla questione Rai Viale Mazzini. Il servizio pubblico non può essere immaginato solo a base di tagli. RaiWay per esempio può diventare un asset nazionale che cambierà, allargandole, le basi della comunicazione Sergio Bellucci Fino agli ultimi giorni della campagna elettorale si è riaperta la questione Rai, ma quello che stupisce è il generale silenzio politico intorno a una vicenda determinante per il futuro della nostra democrazia. Se il tema della Rai, infatti, fosse riducibile a quello del destino di qualche decina di migliaia di persone, potremmo derubricarlo a fatto di natura sindacale, un problema occupazionale o di ristrutturazione come quello di Alitalia, di Telecom, di Poste, dell’Ilva, della Fiat, dell’Electrolux, della Lucchini, dell’Alcoa, delle miriadi di aziende del Veneto. Il ruolo e l’esistenza di un servizio pubblico radiotelevisivo forte e autonomo connota, invece, la qualità di una democrazia. E pensare che il Pd aveva anche scelto di portare nel cda di viale Mazzini due persone indicate come espressione di associazioni proprio per segnalare il tema complessivamente «democratico» del servizio pubblico radiotelevisivo! Invece nessuno scatto di orgoglio interno, di chi è lì in rappresentanza della famosa «società civile», per richiamare l’attenzione di associazioni, cittadini, politici e spiegare cosa significa la riduzione degli spazi della Rai. Nessun lancio di una strategia alternativa per rinnovare le radici di un servizio pubblico che ha perso la propria finalità e prosegue per inerzia. Nessuna voglia di sperimentare, nell’era della crossmedialità, nuovi confini e nuove modalità comunicative. Nessuna mobilitazione esterna a difesa di un bene primario come quello di una comunicazione sganciata da interessi imprenditoriali e finalmente autonoma dai partiti. In questa situazione nessun segnale dal management Rai. Nessun rilancio di strategia o la volontà di uscire dal tran tran della discussione sui contratti di Vespa, Fazio o di Sanremo. Nessuna indicazione di strategia per il futuro del paese nel nuovo scenario della comunicazione digitale, quindi, né del management aziendale, né dell’attuale governo. Solo tagli o tentativi di far cassa. Una democrazia è tale, dovremmo averlo appreso, se i flussi di comunicazione sono liberi e non “arginati” in confini precostituiti, se la produzione culturale mantiene non solo la sua funzione intrattenitrice ma la sua funzione critica, proprio come l’informazione. Non basta essere il tg più visto o dare «per primi» la notizia. La missione è creare, costantemente, occhiali nuovi, critiche non mediate. E la sinistra ha un’idea di cosa sia la spina dorsale comunicativa di un paese democratico? Ha percezione che se si perde questa battaglia perderemo l’ultima arma in grado di opporsi alla logica «dell’industria di senso» che è in grado di omogeneizzare e sussumere ogni aspetto comunicativo e triturare la percezione del presente e piegare a sé ogni futuro? Oggi bisogna dire di no al governo, ma indicare una strada alternativa. Prendiamo il «problema Raiway», la società che controlla le frequenze radiotelevisive. È uno dei principali tesori dell’azienda, insieme alle «teche», ed è fondamentale anche per la nuova fase del settore delle Tlc. Le esigenze di copertura dei nuovi servizi a banda ultralarga necessitano di frequenze di trasmissione e chi metterà le mani su quell’azienda non lo farà certo per garantire una migliore gestione dell’attuale ruolo che svolge per la Rai. Ma c’è una strada alternativa che è anche in grado di riaprire un processo strategico per il paese. Separare RaiWay dalla Rai e costruire, intorno al quel nocciolo di competenze e impianti, 39 una «Azienda Pubblica di Rete» che spinga il paese verso il futuro digitale. Una volta scorporata, tale azienda, dovrebbe garantire per un lungo periodo, diciamo 10–15 anni, la diffusione gratuita del segnale della Rai e in seguito farlo solo al prezzo di costo industriale garantito dall’Agcom. In tale azienda potrebbero confluire tutte le reti, oggi esistenti, che vogliano essere dismesse dagli attuali gestori, spingendoli a tornare «fornitori di servizi», aderendo alla ispirazione «europea» che vedeva una incompatibilità tra chi possiede le reti e chi pensa e produce i contenuti. Analoga proposta andrebbe fatta a Telecom Italia creando le risorse, tecniche ed economiche, per dotare il paese della rete di nuova generazione, pubblica e neutrale. L’azienda diventerebbe così un asset nazionale con un patrimonio strategico in grado di attirare risorse di natura obbligazionaria, anche privata, e sulla quale far convergere le risorse della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione della banda ultra-larga necessaria per riprendere il terreno di un nuovo modello di sviluppo. Questa società non solo sarebbe in grado di fare sviluppo di qualità al proprio interno, ma anche di garantire un salto generalizzato nella qualità dell’occupazione dell’intera economia italiana che approderebbe, finalmente, all’era digitale in tutti i settori come è avvenuto in tutti i paesi avanzati. È una necessità strategica e politica che parlerebbe non solo al nostro paese, ma rappresenterebbe una risposta alla possibile decisione americana di intraprendere lo sviluppo del web a due velocità. Non solo, una tale infrastruttura potrebbe garantire standard di privacy e di trasparenza nelle nostre comunicazioni di nuova generazione che sono sempre più necessari per garantire le nostre libertà nelle società digitali. E potrebbe garantire spazi di sperimentazione sociale all’utilizzo di quel bene comune così prezioso che sono le frequenze e le reti di comunicazione. Sarebbe una ipotesi alternativa percepibile, in grado di legare la battaglia per una qualità nuova e più avanzata della nostra democrazia al tema di un nuovo modello di sviluppo, in grado di connettere l’innovazione digitale nella produzione classica ma anche di estendere esperienze legate a nuove forme di organizzazione della vita sostenibile come le economie a Km0, i GAS, le filiere corte, i makers, le tecnologie 3D. Per questi e altri cento motivi, la discussione sul futuro della Rai non può essere lasciata solo ai dipendenti dell’azienda e assume una valenza politica generale. Serve un tavolo di tutti i soggetti interessati che si riunisca al più presto. 40
Scaricare