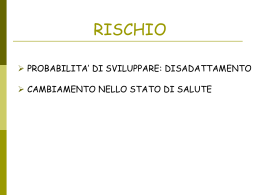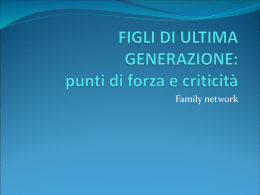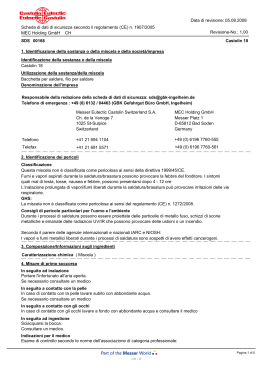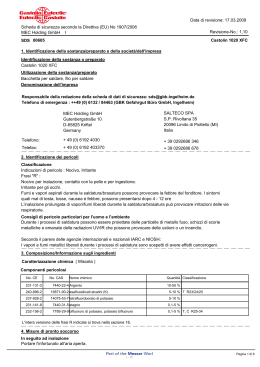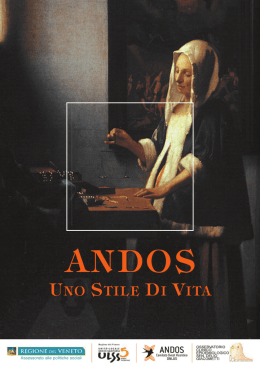Adolescenti e comportamenti rischiosi tra fisiologia e patologia dello sviluppo A cura di AnnaMaria Benaglio Bergamo 16/10/2010 IDENTITA’ L’identità è quel processo attraverso cui l’adolescente può assumere su di sé funzioni di protezione, sostegno, regolazione emozionale, adattamento, responsabilità originariamente assunte dalle figure di attaccamento primarie Compiti di sviluppo 1. L’acquisizione di un modo autonomo di pensare, essere, interpretare la realtà 2. La costruzione di un’immagine di sé integrata che includa il proprio corpo cambiato, le nuove pulsione e stati emozionali 3. La separazione dai genitori: costruire legami significativi al di fuori del contesto famigliare, elaborare un modo di pensare e di sentire le vicende della vita in modo anche differente da loro 4. L’ acquisizione di una identità sessuale: accettazione del corpo sessuato, sentirsi a proprio agio in esso come presupposto per la costruzione di rapporti eterosessuali soddisfacenti 5. La mentalizzazione delle emozioni: utilizzo del pensiero e del linguaggio come modo per dare un nome alle emozioni, poterle riconoscere, descrivere, comunicare, pensare 6. La costruzione di un proprio progetto di crescita che passa attraverso il bisogno di conoscersi, di sperimentarsi, di esplorare, di incontrare gli altri anche come persona sessuata 7. L’ acquisizione di un sistema di valori ed una coscienza etica autonoma come guida del proprio comportamento 8. La costruzione della propria identità sociale come cittadino appartenente alla comunità sociale più ampia. Le condotte rischiose Agite prevalentemente dai maschi: • i comportamenti dell’area antisociale:gli atti di vandalici, la violenza negli stadi, la violenza sessuale, i furti, gli atti di bullismo. • il consumo e lo spaccio di sostanze legali ed illegali • la guida spericolata • le fughe da casa • il t.s. • il gioco d’azzardo Agite prevalentemente dalle femmine: • I rapporti sessuali non protetti • Le gravidanze non desiderate • I disturbi della condotta alimentare Fattori Cognitivi Un atteggiamento mentale favorevole al consumo Una sottovalutazione dei rischi connessi all’uso Una sopravvalutazione delle proprie capacità di controllo La normalizzazione del fenomeno Significati Affettivi La trasgressione L’ appartenenza al gruppo dei pari La regolazione emozionale Il restauro narcisistico Il fronteggiamento di eventi critici Un atto comunicativo Fattori Rischio Possono essere definiti come quelle condizioni legate all’individuo, ai suoi contesti relazionali (famiglia, scuola, gruppo, comunità) la cui presenza é associata ad una maggiore probabilità di sviluppare comportamenti disadattivi. La probabilità che dei comportamenti disadattivi compaiano aumenta in seguito al numero, intensità, durata dei fattori rischio (Effetto cumulativo). Fattori Protettivi Sono quelle variabili legate all’individuo ed alle sue relazioni che possono aiutare a fronteggiare efficacemente le situazioni avverse e contrastano il peso dei fattori rischio Fattori rischio e fattori protettivi Individuo Scarse abilità sociali Caratteristiche di personalità: Basso livello di autostima Depressione Impulsività Aggressività e ostilità Stili di vita fuori casa La presenza di eventi stressanti Fattori sociodemografici (sesso ed età) Positivo senso di sé Una certa stabilità emotiva Abilità sociali Capacità di problem solving Flessibilità e resilienza Fattori rischio e Protettivi Famiglia Problematiche psichiatriche e/o di tossicodipendenza L’abuso sessuale e la violenza in famiglia Un ambiente famigliare conflittuale La presenza di carenze educative Una genitorialità inefficace Legami famigliari positivi Il supporto emotivo e l’assenza di un giudizio estremamente severo e critico Un’attenzione non invasiva al comportamento dei figli e alle loro attività con i pari La definizione di regole chiare La definizione di ruoli e aspettative chiari Fattori rischio e fattori protettivi Gruppo pari Affiliazione con pari che usano sostanze o agiscono comportamenti devianti Scarse abilità sociali Rifiuto da parte dei pari Coinvolgimento in un gruppo di pari che manifestano norme e attività positive Abilità sociali (capacità di relazione e di comunicazione interpersonale, assertività, capacità di prendere decisioni) Fattori rischio e fattori protettivi Scuola L’ insuccesso scolastico (scarsa performance scolastica, l’assenteismo, l’abbandono) Un clima scolastico disorganizzato, caotico L’assenza di una politica scolastica chiara riguardo ai consumi Comportamenti di isolamento o aggressività in classe Un ambiente scolastico supportivo ed accogliente Il successo scolastico Partecipazione attiva dei ragazzi, loro coinvolgimento nelle relazioni e decisioni Una scuola che accoglie l’esigenze formative dei ragazzi anche sul tema delle sostanze Fattori rischio e fattori protettivi nella Comunità Comunità caratterizzate da norme che consentono o promuovono il consumo di sostanze Comunità ad alto tasso di alienazione o criminalità Comunità deprivate socialmente e culturalmente Comunità attente ai problemi dei giovani ed educanti Comunità che favoriscono il legame con le istituzioni ed il senso di appartenenza Comunità che promuovono l’impegno sociale e religioso Indicatori di rischio • • • • • • • • • • Il consumo delle sostanze (modalità, quantità, tempo, durata) L’età di prima iniziazione Il grado di esposizione alle condotte rischiose Il coinvolgimento in attività microcriminali (furto, spaccio) Gli incidenti stradali o lavorativi correlati all’assunzione di sostanze Le segnalazioni pervenute dalla Prefettura o dall’ Autorità Giudiziaria Il n° di ricoveri ospedalieri Il fallimento o l’abbandono scolastico e lavorativo La progressiva perdita d’interessi Il progressivo isolamento sociale Andrea 17 a Inviato da U.S.S.M. per un procedimento di messa alla prova in seguito ad una accusa per spaccio risalente all’ottobre dell’anno precedente. La messa alla prova prevedeva le seguenti prescrizioni: svolgere lavori socialmente utili, svolgere alcune ore lavorative, frequentare il Sert. per una presa in carico con controlli dei metaboliti delle sostanze stupefacenti nelle urine o nel capello Si presenta ordinato e curato nella persona e nell’aspetto, si mostra corretto nella relazione. Appare nei modi di fare e dal suo racconto ingenuo ed infantile. Dall’ anamnesi tossicologica risulta aver iniziato l’uso di tabacco all’età di 14 anni, cannabinoidi ed alcol all’età di 16 a. Il padre svolge un lavoro che lo tiene lontano dalla famiglia per l’intera giornata, la madre gestisce un’attività in proprio. A riferisce un buon rapporto con la madre, con lei riesce ad avere un buon dialogo e si sente capito ed un rapporto conflittuale con il padre da cui si sente svalutato e continuamente ripreso “anche quando fa le cose bene”. Dalla raccolta della anamnesi famigliare traspare un abuso alcolico del padre ed un rapporto conflittuale dentro la coppia genitoriale. E’ il terzogenito di tre fratelli maschi; lui è il più piccolo, con il primogenito ha una differenza di età di circa 14 anni , con il secondogenito di circa 10. Riferisce una rapporto significativo con il fratello maggiore che per A. ha sempre svolto una funzione di padre sostituto (lo riprendeva, incoraggiava quando c’era bisogno, lo coinvolgeva in attività, ecc.). Il fratello maggiore si è sposato circa 1 a e mezzo fa. Ha frequentato per un anno la scuola professionale che ha abbandonato perchè non aveva voglia di studiare. Alle elementari si descrive come un bambino timido, chiuso che veniva preso in giro dai compagni anche per una vicenda famigliare che lo aveva fatto vergognare molto. Ciò appare abbia procurato ad A. una profonda rabbia narcisistica che ha cercato di elaborare in modo depressivo attraverso il pianto e l’isolamento o in modo depressivo/aggressivo prendendo a pugni i muri. Il soggetto è stato in cura per un certo periodo di tempo presso la NPI. Nella ricostruzione dell’evento spaccio e consumo d sostanze emerge una forte dipendenza dal gruppo. L’iniziazione al consumo viene descritta in questo modo: A acquista l’’H. e lo porta nel gruppo per essere iniziato all'uso, lui non era capace. Ho fatto l’ipotesi che portare il fumo dentro al gruppo significava per G presentarsi con una sorta di biglietto da visita facilitante l’ingresso nel gruppo . Questa esperienza è continuata nel tempo, con A. ho riflettuto sui vantaggi e svantaggi di questa esperienza. La consapevolezza degli svantaggi è stata successiva al fermo. La percezione dei vantaggi è stata immediata, insita nell’esperienza stessa; essi avevano a che fare con una dimensione fortemente emotiva in cui la razionalità non aveva spazio. I vantaggi emotivi ricostruiti riguardavano: essere ricercato e desiderato dal gruppo "mi sono fatto degli amici…. mi venivano a cercare per andare alle feste,per giocare a calcio.." ; il restauro narcisistico ed elaborazione rabbia narcisistica "mi sentivo un idolo…un grande....tutti mi dicevano grazie, mi sentivo più coraggioso ai miei occhi e a quelli degli amici”; “prima mi dicevano: non hai coraggio di fare 2 tiri....non sei capace.. sei un coglione".
Scarica