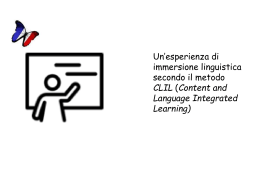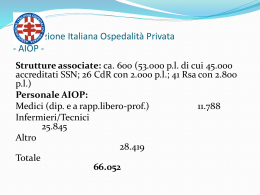Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana Anno IV - N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Da Bava Beccaris a Violante Milano, maggio 1898 La “Carta di Chivasso” Fiabe e leggende del Piemonte Il giuramento di Pontida 16 La Libera Compagnia Padana Quaderni Padani Casella Postale 55 - Largo Costituente, 4 - 28100 Novara Direttore Responsabile: Alberto E. Cantù Direttore Editoriale: Gilberto Oneto Redazione: Alfredo Croci (caporedattore) Corrado Galimberti Gianni Sartori Alessandro Storti Alessandro Vitale Spedizione in abbonamento postale: Art. 2, comma 34, legge 549/95 Stampa: Ala, via V. Veneto 21, 28041 Arona NO Registrazione: Tribunale di Verbania: n. 277 Periodico Bimestrale Anno lV - N. 16 - Marzo-Aprile 1998 I «Quaderni Padani» raccolgono interventi di aderenti alla “Libera Compagnia Padana” ma sono aperti anche a contributi di studiosi ed appassionati di cultura padanista. Le proposte vanno indirizzate a: La Libera Compagnia Padana. Da Bava Beccaris a Violante - Brenno Milano, maggio 1898: la grande paura della rivoluzione - Romano Bracalini 1 La “Carta di Chivasso” - Ettore Micol 3 22 Venti di secessione nella Milano di fine ‘800 - Candida Terracciano 25 La Padania e i nuovi Paesi dell’Est (2) - L’emergere della Slovenia - Alessandro Vitale Alba gu bra! - Flavio Grisolia 28 32 Fiabe e leggende del Piemonte: un patrimonio di cultura - Massimo Centini 37 Il giuramento di Pontida tra leggenda e realtà - Elena Percivaldi I nomi della nostra gente Biblioteca Padana 45 55 58 Da Bava Beccaris a Violante L’ eterna Italia non cambia mai. Da Claudio Marcello a Federico II, fino alla storia più recente è una continua catena di sopraffazioni e di violenze italiane contro i padani e contro tutti quelli che vogliono autonomia e libertà. La morte risorgimentale delle antiche autonomie storiche ha costituito anche la fine delle libertà dei popoli padano-alpini e l’inizio del loro sistematico sfruttamento economico e della loro sopraffazione culturale in una misura e con una sistematicità che neppure i più tirannici degli oppressori stranieri (nel senso di “non italiani”) avevano mai in precedenza esercitato. L’unità è stato un atto militare violento voluto da pochi maneggioni, da circoli massonici e da una dinastia di mascalzoni. La sua fragile e artificiosa esistenza è stata difesa e tenuta in vita con violenze di ogni genere e con trucchi politici ed elettorali: i cosiddetti “plebisciti”, il suffragio limitato, i listoni fascisti, i brogli e il consociativismo della prima repubblica, i trucchi delle leggi elettorali “su misura” nella seconda. Ma si sono soprattutto usati cannoni, baioAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 nette, manganelli e manette. C’è un lungo e doloroso filo che collega la feroce repressione di Genova del 1849, quella di Bronte del ‘60, alle sanguinose violenze di Torino del ‘64, la decennale guerra di repres- sione nel Meridione (chiamata con patriottico cinismo “lotta al brigantaggio”), le giornate milanesi del ‘98 e tutti gli altri episodi minori avvenuti nel mezzo. Non è naturalmente finita lì: si è passati con tricolore baldanza alle decimazioni della prima guerra mondiale, ai coQuaderni Padani - 1 dici e ai confini fascisti contro ogni aspirazione autonomista, alle azioni dei servizi in Sudtirolo, alle manganellate agli allevatori, alle bastonate ai “serenissimi” e all’utilizzo liberticida della magistratura e di tutti gli orpelli fascisti come il Codice Rocco. Si è sempre trattato di porcherie perpetrate “in nome del popolo italiano” e sotto il tricolore che ha perso il valore di vessillo di libertà che aveva sulle barricate milanesi del 1848 e che è durato pochi giorni, vittima dell’abbraccio mortale dei Savoia e del mortifero regime italione che hanno creato. Per poter scatenare tutto il suo potenziale repressivo, il regime deve poter contare sulla connivente adesione di numerosi poteri forti. Nel ‘98 c’erano la struttura centralista e militarista dello stato, la mafia, la massoneria e il padronato più retrivo. Questi avevano la complice connivenza delle alte gerarchie ecclesiastiche e giocavano sull’imbarazzata e ambigua perplessità delle sinistre. Oggi le connivenze sono diventate aperta adesione e le perplessità sono scomparse fra i cosiddetti progressisti che si sono entusiasticamente impegnati nella cogestione del potere portando in dote la antica e preziosa dimestichezza con la più brutale e sanguinaria violenza comunista. Succede così che oggi siano i Violante e i Napolitano a minacciare l’impiego dell’esercito contro gli indipendentisti padani, che siano i questurini di mestiere, i comunisti di vocazione, i parassiti mediterranei nella necessità di salvaguardare l’organismo putrido su cui prosperano e si ingrassano. Nel 1898 il primo a sparare sui cittadini inermi è stato uno sbirro, un certo Viola, detto “il calabrese”: non c’è niente di nuovo sotto il tricolore. Ma, al di là di queste loro consuetudini da duello rusticano e da regolamento di conti camorrista (che collega con coerenza Remo con Ligato) che gli permette di essere forti solo con i deboli, gli Italioni non hanno neppure più a disposizione quella caricatura di forza militare che avevano nel ‘98. L’esercito che era scappato a Custoza e che aveva dato così ignobile prova di perizia militare in Eritrea era, almeno, ancora in grado di sfogare la propria bellicosità su dei cittadini inermi e - come ricordano con un po’ di imbarazzo le cronache - con due sole perdite: un militare vit- 2 - Quaderni Padani tima di una schioppettata accidentale di un commilitone e un soldato che si era rifiutato di sparare sulla folla e che fu fucilato dopo un frettoloso processo per insubordinazione. Il primo di una lunga serie di decimati e fucilati che costituisce la tradizione più solida dell’esercito italione, da Caporetto all’otto settembre. Oggi non c’è più neppure un esercito, a meno che non si voglia considerare tale quel simulacro brulicante di generali maneggioni, trafficoni o collusi con la malavita, stipato di “scampati alla disoccupazione” e di guerrieri di fureria. Non sappiamo quanti soldati di leva sarebbero disposti a sparare sui propri fratelli padani o - se italiani - a “morire per Gallarate” e per difendere una unità di cui si leggono solo e sempre più i limiti e di cui sfuggono le connotazioni ideali, se mai ce ne sono state. Si dice che Ferdinando delle Due Sicilie (dello “Re Bomba”) abbia commentato l’adozione delle nuove uniformi del suo esercito dicendo: “Vestiteli di rosso, vestiteli di blu, scapperanno sempre allo stesso modo!” Certo oggi ci sono milioni di parassiti disposti a qualsiasi abiezione pur di conservare i loro vantaggi, le loro pensioni fasulle e le loro rendite politiche; più di uno di loro sarebbe anche disposto a far roteare famigliari coltelli o a dare fondo ad antiche dimestichezze con agguati e lupare; ma forse nessuno sarebbe disposto a rischiare la pelle o anche solo una parte di essa. Non è lì che i più alacri difensori della patria unità possono trovare le loro truppe. Si devono rivolgere alla solita manovalanza parallela, alle “guardie bianche” che compaiono ad ogni crisi di regime: ma anche lì il mercato sembra piuttosto asfittico. Oggi che anche i più gagliardi patrioti di Lotta Continua o di Prima Linea sono appesantiti dalla galera o intordelliti dal potere. Non gli resta perciò che contare su bande di maghrebini o di albanesi (che stanno assoldando e importando con grande tempismo) che sono i loro parenti più prossimi ma che hanno anche gli stessi difetti mediterranei. Sono bravi nello stupro, nella violenza individuale e di gruppo, nel latrocinio e nel saccheggio ma che di fronte a pericoli veri si comportano con la stessa gagliardìa dei soldati di Re Bomba. Brenno Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Milano, maggio 1898: la grande paura della rivoluzione di Romano Bracalini Le cinque giornate alla rovescia I primi tumulti scoppiarono allo stabilimento Pirelli. Erano giunte notizie di gravi scontri in altre città, e gli operai, spontaneamente, cessarono il lavoro e si riversarono fuori della fabbrica. L’atmosfera si andava scaldando rapidamente; qua e là si udivano grida ed esortazioni alla rivolta. I lavoratori formarono capannelli concitati. La tensione crebbe maggiormente, e i più eccitati decisero di muoversi, quando si seppe che erano stati richiamati i soldati. “I richiami di classi” scrisse Eugenio Torelli Viollier, fondatore e direttore del Corriere della Sera, “avvennero già al tempo dei disordini in Sicilia, poi della guerra d’Africa, e sempre suscitarono fermento e qualche volta disordini abbastanza gravi, perché la legge è veramente barbara, e prova l’indifferenza crudele della classe borghese circa i bisogni del popolo...” L della campana a martello. La gente parlava con i monosillabi tragici, coi gesti che facevano sobbalzare il pensiero, con l’atto finale della mano in aria che traduceva l’impotenza e la minaccia.” Venerdì 6 maggio 1898, cominciavano le “cinque giornate alla rovescia”, come le avrebbe definite Carducci. L’insurrezione popolare del 1898 fu il pretesto che il governo cercava per dare una definitiva lezione alla “canaglia”, che da un capo all’altro della Penisola era scesa in piazza per protestare contro il caro-vita. Per la prova di forza era stata scelta Milano che essendo la città più progredita e fiera avrebbe costituito per l’intero Paese un monito e un esempio. L’aumento del dazio in seguito alla guerra ispano-americana aveva fatto salire il prezzo del pane da 22 lire e 58 centesimi a 25 lire al quintale, e a un operaio non bastavano due ore di lavoro per comprarne un chilo. Ma il marchese Alessandro Guiccioli, teorico della a scintilla dell’insurrezione milanese (come cinquant’anni prima contro gli austriaci) era partita da Pavia. “Pavia come Sesto Fiorentino e come Soresina” annotava Paolo Valera, fondatore dei periodici La Plebe e La Folla e autore del libro Le terribili giornate del maggio 1898, “aveva avuto i suoi ciottoli innaffiati di sangue dalla strage militare. Il povero Muzio Mussi, il figlio del vicepresidente della Camera, era stramazzato al suolo a ventitré anni e la notizia ferale, propalata dai giornali, passava sui nervi della cittadinanza come una scarica di indignazione. In mezzo alle piazze, lungo le vie, si temeva e si presentiva la fucilata. La conversazione sentiva del momento. Era una conversazione animata, con- Sabato 7 maggio: le truppe entrano da Porta Nuova - Giusepcitata, che lasciava udire un po’ pe Serralunga Langhi Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 3 maniera forte, aveva annotato nel suo diario che il rincaro del pane era solo un pretesto e che la piazza si preparava alla rivoluzione. Il governo Rudinì, incapace di fronteggiare la situazione, richiamò sotto le armi 40.000 uomini e chiese al Parlamento l’approvazione di leggi straordinarie. Gli uomini politici più avveduti non mancarono di criticare quella decisione. “A mio parere” scrisse Giovanni Giolitti, “fu allora un errore il credere che si trattasse di un grande movimento politico e sovversivo, mentre si trattava di un’esplosione di malcontento. Ma perdurava ancora nelle classi dirigenti uno stato d’animo paurosissimo di qualunque agitazione popolare e delle sue manifestazioni, e il governo, rispecchiando tale sentimento, si lasciò andare a provvedimenti eccessivi. Così fu proclamata, o proposta all’autorità locale la proclamazione dello stato d’assedio in province e luoghi dove non c’era alcun pericolo...” Benedetto Croce aggiunse che: “... in nessun luogo, e neppure a Milano, i tumulti ebbero una preparazione politica insurrezionale, con direzione e guida da parte di socialisti e repubblicani; e che essi furono veri e propri moti incomposti di non molti popolani, con molte donne e ragazzi, senz’armi, senza combattimenti e resistenze; come, del resto, è dimostrato dal fatto che la forza pubblica ebbe, a Milano, in quelle tre giornate due soli morti: una guardia di pubblica sicurezza, colpita, per non essersi ritratta in tempo, da una scarica della truppa, e un soldato del quale neppure fu chiaro che fosse stato ucciso dai tumultuanti...”. La camarilla di corte cercava pretesti, spiegava il socialista Arturo Labriola, “ebbe invece una ragione. E quale! I dinieghi della giustizia, le sopraffazioni amministrative, l’incuria delle autorità, confluenti col rincaro del prezzo del pane, lo scredito in cui era caduto il governo e la mancata azione moderatrice d’un clero, che si sentiva trattato da nemico; tutto ciò produsse i tumulti della primavera del 1898 nell’Italia meridionale, e furono tumulti che conservarono sempre la stessa impronta...”. Dappertutto “folle fameliche, senza preconcetti o intuizioni politiche, scendevano in piazza per chiedere alle autorità qualche provvedimento contro il rincarato prezzo del pane, e poscia, per necessità naturale, trascorrevano a grida o minacce contro questa o quella rappresentanza delle autorità. Dappertutto trovarono sulla loro strada soldati in armi, che, senza intimazioni legali, o con intimazioni precipitose, di cui non si capiva il senso, sparavano freddamente sulle folle inermi. Cominciò allora quella pra4 - Quaderni Padani tica scellerata degli eccidi proletari, che manifesta l’enorme inciviltà del presente vivere italiano, e perché il Paese non si rivoltò mai contro l’uso delle armi sugli inermi, e perché le autorità non compresero quanto fosse svergognato, e perché gli stessi democratici parvero volessero giustificarlo e perché gli ufficiali dell’esercito, che si addossavano la responsabilità di quei facili macelli, non sentirono o non dimostrarono mai il disagio dell’ufficio loro, il quale doveva essere tanto maggiore se non avessero pensato che la storia militare del nostro esercito ricorda purtroppo soltanto sconfitte e molte di esse nemmeno confortate dalle solite illusioni che la pietà nazionale usa talvolta con gli eserciti sconfitti...”. Ecco dunque emergere impellente il desiderio di rivincita di un governo che “come tutti i deboli aveva il culto della forza”. “Ora è tutta una smania di reazione” rifletteva Francesco Saverio Nitti “quasi che le leggi violente (...) non fossero ragione di maggior discredito...”. Al giovane Nitti la strada imboccata dal governo pareva completamente sbagliata, anche dal punto di vista “di chi voglia mantenere lo statu quo (e non si può mantenere)”. La crisi del regno umbertino veniva da lontano. Ad Adua s’erano infranti i sogni di gloria di Crispi che re Umberto aveva dovuto allontanare per calmare l’opposizione. Ma non era bastato quel repentino e previsto cambio della guardia per risollevare le sorti della monarchia. L o spirito repubblicano, dopo il tramonto dell’utopia mazziniana, sembrava risorto in regioni come la Toscana e la Lombardia, che non si erano mai distinte per dedizione ai Savoia. “Una parte notevolissima della borghesia lombarda è repubblicana”, aveva riconosciuto il deputato monarchico Siliprandi, “essa vanta tradizioni patriottiche indiscutibili, abilità grandissima di procedimenti. L’utopia mazziniana è quasi spenta nelle nostre province, ma il positivo pensiero di Carlo Cattaneo vive robusto e spontaneo tanto che molti lo nutrono inconsciamente. Essa è magnifica pianta che facilmente alligna e cresce rigorosa nel campo lombardo. Tradizione monarchica nazionale in queste province non vi fu mai; sede recente di una repubblica rivoluzionaria e guerriera, vissuta poi per cinquant’anni in ribellione perenne, fornitrice di pressocché intieri repubblicaneggianti eserciti volontari, durante la guerra del risorgimento italiano, lo spirito di resistenza è cosa facilissima a destarsi in esse...”. Non andava dimenticata Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 una data che proprio in quei giorni assumeva va- nerale, li ha ingigantiti non soltanto nell’immalore di simbolo: cadeva nel 1898 il cinquantena- ginazione, ma nella realtà. Hanno avuto paura rio delle Cinque giornate. L’avvenimento era sta- gli operai, che abbandonarono alcuni stabilito appena ricordato, mentre la monarchia sabau- menti alle prime intimazioni dei malintenzionada aveva festeggiato in pompa magna il cinquan- ti; ebbero paura gli industriali che chiusero gli tesimo anniversario dello Statuto. Umberto ap- stabilimenti - ed erano in maggioranza - ove gli pariva esitante e “forse non propenso allo spargi- operai avevano continuato a lavorare; ebbe paura mento di sangue”; di fronte al crescere del movi- la borghesia, che si immaginò che il giorno della mento popolare, Giolitti aveva detto che non si liquidazione fosse giunto; ebbero paura le autopotevano scegliere che due vie: «O la repressione rità che non si fidavano della resistenza dell’esero la libertà». Ma sul re influivano gli uomini po- cito. La paura gettò sulla strada tutti gli operai litici più reazionari del suo circolo, e la regina di Milano, la paura fece ammazzare un centinaio Margherita ripeteva che non si poteva scendere a di persone, e ferirne più o meno gravemente papatti con i partiti rivoluzionari che dall’estrema recchie centinaia; la paura ha fatto credere in sinistra chiedevano una democrazia repubblica- tutta l’Italia che la nostra città fosse a due dita na e socialista: aveva già in mente la lezione che dalla catastrofe; la paura ha fatto sì che siamo il siciliano Rudinì, abbandonato ogni scrupolo fuor della legge, e che sia stata sospesa ogni lilegalitario, fu ben lieto di dare a maggio all’odia- bertà, ogni guarentigia costituzionale...”. Un’ata Milano. Non la Sicilia, come aveva creduto nalisi obiettiva, che faceva giustizia di ogni forCrispi, era da considerarsi il centro della prote- zatura e propaganda di parte. Da essa emergeva sta popolare, ma Milano con la sua concentrazio- la responsabilità degli industriali che avevano ne industriale e la sua organizzazione operaia. quasi costretto gli operai allo sciopero, ma anche Rudinì si dimostrava più accorto politico del suo l’irresponsabilità dei “capipopolo”, che avevano predecessore, ma non per questo rese un miglior gettato olio sul fuoco, però appariva troppo semservigio alla Corona. plicistica la diagnosi Individuata la città da Bersaglieri in via Moscova - Luca Comerio di Domenico Farini, colpire, il nuovo preche aveva sentenziasidente del consiglio to: “Il seme sparso da aveva chiamato a racAmilcare Cipriani a colta le forze conserCavallotti germovatrici e reazionarie glia!”. “identificandole con er le sue oneste il governo e con il considerazioni, suo programma”. Torelli Viollier si L’8 luglio 1896, alla meritò il rispetto dei Camera, rivolgendosi democratici, ma si atai deputati socialisti tirò l’odio della borminacciosamente ghesia più retriva che esclamò: «Di qui non non esitò ad accusarsi passa». La borghelo di tradimento. Nel sia si sentì rassicuranuovo rapporto di ta. Non ne condivise forza, creatosi con il gli umori e le paure sorgere dei partiti Torelli Viollier, conche non avevano fatservatore illuminato, to la “rivoluzione nache all’indomani delzionale” - il repubblila sanguinosa represcano e il socialista sione scriveva a Paandavano ricercate le squale Villari: “I moti cause profonde del di Milano furono cosa malcontento e della meno spettacolosa di rivolta. “Il partito requello che s’è creduto pubblicano” osservaqui e fuori. Li ha inva Torelli Viollier, “è gigantiti la paura ge- P Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 5 forte; in questi ultimi refrattari al socialianni ha guadagnato smo, perché contaditerreno da una parte, ni, ragazze, tutti rozne ha perduto dall’alzi e ignorantissimi. tra. Fatto sta che ora è il È forte, a causa più minacciato ed i principalmente delle suoi operai hanno molte relazioni della dato il maggior conpopolazione milanese tingente ai rivoltosi, con due repubbliche: mentre gli operai, la Svizzera e l’Argenistruiti e disciplinatina. La facilità del vitissimi sono stati vere in Svizzera, la tutti al loro posto. Il maggiore agiatezza, motivo è questo, che la libertà assoluta che gli operai che hanno vi si gode, la leggeuna certa cultura rezza delle imposte salvo gli scalmanati sono il troppo evidenche tutti i partiti te contrasto con hanno - capiscono quanto si vede in Itache il socialismo non lia, perché le persone Resti di barricata al ponte di via Moscova è maturo per una riche non possono anvoluzione. Il loro dare a fondo delle cose non ne restino impressio- programma è che bisogna organizzarsi, disciplinate. Il partito repubblicano fu indebolito di narsi, istruirsi; ed intanto contentarsi di piccole molto dallo sviluppo delle idee socialistiche, che vittorie contro gli industriali, ottenendo migliohanno screditato la repubblica non meno della ramenti di salari, diminuzione di ore di lavoro, monarchia e volto le menti degli operai ad alte definizione precisa dei loro diritti, tutela dei mete; ma fu ringagliardito dagli scandali banca- compagni nelle contestazioni coi principali, ecri, dall’assoluzione di grossi colpevoli, dalle por- cetera. Avendo ottenuto notevoli vantaggi su cherie del Crispi, dalle piaghe del parlamentari- questo terreno, forti della coscienza che la forza smo...”. Nell’elenco dei mali che avrebbero por- del numero è per loro, non hanno idee rivoluziotato allo scontro di piazza, si intravedevano gli narie immediate...”. Gli anarchici non costituiantichi vizi che avvelenavano la vita nazionale vano un pericolo, non erano per Torelli Viollier con la malapianta della corruzione, della fazione che “un contingente di teppa, ossia i pregiudicae dell’interesse di parte. Già allora il milanese, e ti, i delinquenti nati, i giovanotti prepotenti il lombardo in genere, “era il popolo”, diceva To- sempre pronti a menar le mani e a distruggerelli Viollier “che più facilmente s’accende per le re...”. Repubblicani, socialisti e anarchici, “tutta questioni di moralità nella vita pubblica; anzi in gente pronta a gridare ed a tumultuare”. “Sparquesta materia è propenso a malignazioni e so- gere il malcontento”, era stata la parola d’ordine spetti eccessivi. Ogni lira che si spende dallo Sta- lanciata dai capi socialisti all’ultimo raduno teto inutilmente, è da ogni milanese considerata nuto a marzo all’Arena di Milano nel giorno delcome toltagli di tasca: non c’è altro popolo che la commemorazione della Statuto. “Ma che i soabbia più vivo il concetto del rapporto che passa cialisti volessero la rivoluzione ora, e che la cosa tra le spese dello Stato e la fonte delle entrate. fosse preparata sia da loro, sia dai repubblicani è Cavallotti, che era milanese e che conosceva i un sogno della paura”. E la rivoluzione che “non suoi concittadini, insisté in tutta la sua vita sulla c’era finì per essere un fatto reale”. Rudinì era ‘questione morale’, usandone e abusandone, a passato dalle parole ai fatti. Proclamato lo stato danno di furfanti e anche di galantuomini...”. d’assedio, con l’approvazione del re e i dubbi di Quanto ai socialisti “hanno fatto molta strada da Zanardelli, il generale Fiorenzo Bava Beccaris, una mezza dozzina d’anni. Il Pirelli, non più di comandante del III Corpo d’Armata di Milano, tre anni fa, a me che mi lagnavo dei progressi un duro piemontese che aveva combattuto nelle del socialismo fra i miei operai, diceva con la guerre d’indipendenza, “sfogò i suoi perversi soddisfazione di chi essendo sotto l’ombrello ve- istinti di iena. Milano fu insanguinata”. In piazza de piovere sugli altri, che gli operai suoi erano del Duomo ordina ai suoi soldati il dest-riga. 6 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Nella sua tenda sul sagrato siede al tavolo del co- bustibile alla catasta che aspettava lo zolfino. Inmando di battaglione “ben disposto geometrica- vece la metropoli lombarda ha avuto Vigoni, Nemente, con un corridoio per le staffette che por- gri, Minozzi, Prina, Winspeare e Bava Beccaris, tano le notizie più incredibili”. Bande armate regi lenoni che vedevano in ogni aggruppamento scendono dalla Svizzera, contadini calano dalla di operai masse di rivoltosi o di congiurati, imBrianza verso Milano, armati di forche e bastoni, becilli feroci che avrebbero sterminato tutti costudenti arrivano da Pavia, perfino i cappuccini loro che non fossero caduti ai loro piedi a implodel convento di Monforte si appresterebbero alla rare la vita...” “rivolta anarchica”. Bava Beccaris non si scompone, chissà poi se sarà tutto vero; a ogni modo embrava una giornata uguale alle altre; i miniente paura: “Quando il vecchio soldato comanlanesi non fanno subito caso ai soldati, tanto da, colpite”, e ricorda la ricetta di Cavour: “Sii sono abituati a vederne in piazza d’Armi, fuspietato ma svelto, se vuoi accompagnare all’in- turo corso Sempione, dove le reclute normaldignazione di chi perde l’ammirazione di chi mente compiono evoluzioni ed esercizi. Non algiudica...”. Disegna sulla carta le manovre che la larmano ancora i reggimenti che attraversano la truppa deve compiere per imbottigliare i rivolto- città in assetto di guerra. Son sempre tanti i solsi e schiacciarli sulle loro barricate, antico ricor- dati a Milano, l’esercito è la “pupilla” del re, il pido di un’insurrezione non meno cruenta ma più lastro della monarchia, e il regno umbertino, leonorevole per l’avversario. Sulle vie e sulle piaz- gato alla Triplice alleanza, si dichiara orgogliosaze della Milano popolare, da porta Volta a corso mente militarista. Ma con le ore il via vai di solGaribaldi, s’addensano squadroni di cavalleria dati diventa frenetico, la gente capisce; “gli uni con la sciabola sguainata e i bersaglieri con la guardavano in faccia gli altri e tutti sentivano pallottola in canna; giungono frattanto i rinforzi l’inquietudine dell’Italia agitata dalla fame...”. che Bava Beccaris ha richiesto: 38 battaglioni di Come ogni mattina le grandi fabbriche intorno a linea, 13 squadroni di cavalleria, 9 batterie da Ponte Seveso avevano aperto i battenti e gli opecampagna. È sicuro che a Milano troverà la glo- rai erano sciamati al posto di lavoro. Uscirono ria che gli è stata negata sui campi di battaglia col fischio a mezzogiorno, avevano lavorato con del risorgimento. Bava Beccaris ha ragione: la disattenzione chiacchierando molto sugli avveplebe milanese, affamata e disarmata, non varrà nimenti, nelle parole di ciascuno inquieti presal’armata di Radetzky. La cronaca di quella prima gi. I lavoratori si radunarono in via Galilei, e la giornata prosegue, e Paolo Valera la rievoca, con massa si ingrossava sempre più, giungendo matono un po’ enfatico, sulla scorta di testimonian- no mano quelli della Pirelli, della Stigler, della Grondone, dell’Elvetize dirette: “Nei sobborghi, dov’è più fitta A Porta Ticinese dopo la cannonata - Giuseppe ca e quelli degli altri stabilimenti vicini. In la popolazione operaia, Serralunga Langhi poco tempo s’era racsarebbe bastata un po’ colta una massa di diedi retorica calda per mettere sottosopra il cimila persone. Si disangue cittadino che scuteva animatamente, alcuni operai e paspumeggiava nelle vene. Con tanta irritaziorecchi ragazzi distrine che si andava accubuivano il manifesto stampato la sera prima mulando per i quartiedal partito socialista, ri di ora in ora, a ogni “manifesto redatto daltelegramma che anla penna turatiana”, nunciava che il goverma Filippo Turati, fonno curava, dappertutdatore del partito soto, lo stomaco vuoto cialista, uomo misuracon la balistite, Milano to e di buon senso, avrebbe avuto bisogno non credeva alla rivodi uomini prudenti che luzione. Egli aveva avessero saputo, con compreso l’intrinseca dolcezza, togliere e debolezza di un’insurnon aggiungere com- S Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 7 rezione improvvisata e non gli era parso il caso di rischiare. Improvvisata lo era fino a un certo punto, essendo essa il prodotto di errori che risalivano ad anni precedenti. Ma in quel maggio era certo la fame a scatenare la ribellione a lungo sopita; Napoleone Colajanni la definì “rivolta dello stomaco”. Tuttavia i moti del ‘98, osservava lo stesso Colajanni, assunsero anche il carattere più generale della protesta politica; e i tumulti contro il caro-pane si accompagnarono alla richiesta, sorretta dai socialisti, dell’abolizione del dazio doganale sul grano e del dazio di consumo sulla farina, e per la gestione municipale dei forni; assunsero infine il carattere di lotta per la libertà, e questo, specie a Milano “dove il rincaro del pane era stato nel complesso meno gravoso che altrove, perché i salari erano più elevati e la disoccupazione meno diffusa”. La repressione governativa fece il resto “accentuando il carattere politico degli avvenimenti e rendendoli memorabili come esempio di operazione reazionaria di vasta portata col pretesto di reprimere la rivoluzione imminente”. Il 4 maggio 1898, due giorni prima della rivolta, Filippo Turati, rispondendo a Gaetano Salvemini che esortava il partito socialista ad assumere la guida dell’insurrezione, scriveva: “Le cose che tu mi dici non sono da matto; e balenarono anche a noi, come puoi immaginarti. Ma tu dimentichi che il partito è quello che è: esso ha un dato indirizzo, buono o sbagliato che sia, e non si può dittatoriamente imprimergliene un altro. Questa sarebbe l’ora dei repubblicani, se esistessero. Purtroppo, inoltre, l’unità d’Italia è un mito. Quando si muove Milano, è per un ‘concetto’, sia pur grossolano: Napoli, Roma e il Meridione non rispondono. Quando si muovono quest’ultimi è per istinto la fame - e non risponde Milano. Così il cerchio non è chiuso mai. La monarchia in Italia è forte, come in Austria, della debolezza, dei contrasti, e delle disparità del Paese. Italia unita sarebbe monarchia finita. Io non credo a questi moti, e vorrei sbagliare. Ma non ci credo. E non mi sento di assumermi responsabilità gravissime per uno scopo che non vedo chiaro e che, nelle Sabato 7 maggio: Palazzo Saporiti in corso Venezia - migliori ipotesi, sarebbe una delusione. Achille Beltrame Se i repubblicani ci fossero, certo la massa operaia e noi tutti li aiuteremmo. Ma non possiamo né crearli né prendere il loro posto...”. Salvemini lamentò l’eccessiva prudenza di un partito sempre incerto nell’idea di “abbattere lo Stato e di riformarlo”, e scrivendo il 27 maggio a Carlo Placci espresse chiaramente il suo dissenso: “E così s’è avuto quel che s’è avuto. La massa, che aveva quell’istinto rivoluzionario, che mancava anche a noi, sentì che il momento buono era venuto e si precipitò nella lotta. E il nostro partito, invece di precipitarsi anch’esso nella lotta e dirigerla a uno scopo, pretese di fermarla sempre per la solita idolatria della legalità, e quando non poté fermarla si astenne. Così la massa, che sostenuta e diretta da noi sarebbe stata invincibile, fu vinta; e ora noi paghiamo le spese. E ben ci sta. Chi nel momento buono si astiene dalla lotta, rinuncia a tutti i vantaggi di una possibile vittoria e si assicura tutti i danni di una certa sconfitta. L’avvenire è degli audaci e dei risoluti, non dei critici. Se il nostro partito il 2 maggio, quando il governo era ancora incerto e quando volevo io, fosse intervenuto nella lotta, oggi avremmo avuto in Italia la repubblica, il 8 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 ritiro dall’Africa, l’accordo commerciale colla Francia, la diminuzione delle spese militari. Non sarebbe stato il socialismo, ma sarebbe stato il benessere. Invece c’è quello che c’è. E la colpa è tutta nostra...”. Salvemini forse esagerava le possibilità di una vittoria proletaria e il ruolo di guida che assegnava al partito socialista; probabilmente l’insurrezione del ‘98 non era l’occasione rivoluzionaria che il Paese attendeva; ma aveva ragione d’essere deluso dal ragionamento di Turati che rinunciava all’azione dandone per scontata la sconfitta. Chi predicava la rivoluzione sembrava volesse dire Salvemini - aveva almeno il dovere di tentarla. Le masse erano disorganizzate, aveva obiettato Turati. Ma la borghesia, incerta e paurosa, lo era altrettanto; in questa parità, Salvemini vedeva l’opportunità di tentare, perché il tempo lavorava per la borghesia e la rivoluzione sarebbe divenuta un mito irraggiungibile. In quel pomeriggio del 6 maggio gli operai milanesi, riuniti fuori dalle fabbriche, si passavano i volantini che “riassumevano le miserabili condizioni del proletariato”. Dalla caserma Trotter uscì un plotone del 57° Fanteria con l’ordine di disperdere i manifestanti. Due agenti della squadra volante di pubblica sicurezza, un certo Rossi e Domenico Viola, detto “il calabrese”, si avvicinarono ai distributori, gli strapparono i volantini dalle mani e ne arrestarono due. Gli operai protestarono; uomini e donne si misero a gridare: «Molla! Molla!». Ma il Viola, “che era il Prina della bassa forza” dice il Valera, “tirò via con la sua preda fino in via Napo Torriani, fermandosi al numero 24, sede della questura di quartiere. «Io ero sul posto» mi disse un testimone oculare, capo sala in una sezione dello stabilimento Pirelli. «Alcuni compagni mi invitarono a trovare il mezzo di liberare gli arrestati, i quali erano seguiti da una moltitudine di tre o quattromila persone. Avviandomi presso la sezione di questura trovai Carlo Della Valle, l’omino che amministrava la Lotta di Classe e si poteva dire l’anima del partito. Ci trovammo in via Vittor Pisani e andammo senza indugio a parlare col delegato. Intanto di fuori si urlava e si scagliavano sassate incessanti contro lo stemma al di sopra dell’entrata. Dicemmo al delegato che i ragazzi arrestati erano dello stabilimento Pirelli e che secondo noi non avevano commesso che qualche ragazzata. E il delegato ci promise che dopo aver consultato il questore, sarebbero stati messi in libertà. Uscimmo mentre i fischi degli stabilimenti chiamavano al lavoro. Il largo del Trotter e le vie adiacenti erano gremite. Ci avviammo verso Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 l’edificio dei sordomuti e al largo del Trotter vedemmo venire il Viola, con la rivoltella in mano, seguito da altri sei o sette poliziotti in borghese, che tenevano in mano lo stesso strumento della civiltà moderna. I cagnotti in borghese saltavano da una parte all’altra, puntando le bocche da fuoco alla faccia delle donne e degli uomini, minacciandoli e dicendo loro ingiurie che facevano impallidire e rimescolare il sangue: Mascalzoni, Vaianne!».” C’è allora un momento di confusione, di tensione. Uno dei poliziotti, impossibile dire se il Viola o un altro, si avventa contro una ragazza, la Marietta, che agita un foulard rosso e le assesta un colpo in fronte con il calcio della pistola. La ragazza comincia a gridare con quanto fiato ha in gola: «Assassini! Assassini!». Con il viso rigato di sangue continua a gridare come un’indemoniata, tentando di afferrare il poliziotto che l’aveva colpita. Alcuni compagni la trattennero, e la portarono nello stabilimento per farla medicare nell’ambulanza interna. Quelli che l’accompagnarono tornarono subito fuori perché la massa degli operai che era all’esterno gridava che si doveva smettere di lavorare e proclamare lo sciopero. Il direttore dello stabilimento, Emilio Calcagni, e l’ispettore dell’ordine interno, Cavalli, correvano da una parte all’altra raccomandando la calma e supplicando di dare ciascuno il buon esempio riprendendo il lavoro. Restarono in fabbrica soltanto pochi operai, la maggioranza andò fuori a gridare: «Abbasso i birri! A morte Viola!», che era l’agente “esecrato in tutto il quartiere per il suo carattere malvagio e violento e perché si diceva da tutti che era stato lui a menare il calcio del revolver sulla fronte dell’operaia...”. Arrivò poco dopo Filippo Turati, che parlò agli operai: «Come deputato del vostro collegio, invoco da voi calma e pazienza. Non la pazienza dell’asino, intendiamoci, ma una pazienza di alcuni momenti, affinché in nome vostro, se lo consentite, noi possiamo trattare con le autorità per la liberazione dell’arrestato...». L’arrestato si chiamava Angelo Amadio, detto “el pompierin”, di diciannove anni. Turati tornò dopo mezz’ora con l’espressione delusa: «Sentite, compagni. Noi abbiamo saputo che ormai questore e prefetto non possono farci nulla. L’arrestato che fu trovato coi sassi in mano..» («No, non è vero», lo interruppero alcune voci) «...credo anch’io» riprese Turati «anzi mi auguro che non sia vero. Ma ora è nelle mani del procuratore del re ed io mi recherò da lui». Ma Turati aveva cose più importanti e urgenti da spiegare agli operai: Quaderni Padani - 9 «Ascoltate ora un mio consiglio, o compagni. Qualunque possa essere la risposta, ve lo dico in coscienza, non dovete insistere. Questo non è il giorno...». Un operaio lo interruppe: «E quand l’è ch’el vegnarà donca el dì?». «Ho detto che questo non è il giorno, perché tutto è preparato per le più feroci repressioni. Il popolo deve essere abile e scegliere lui il giorno in cui si crederà preparato e organizzato alla vittoria. Non è oggi il giorno per la battaglia di piazza...». Seguirono e queste parole grida, interruzioni, disapprovazioni. Turati concluse: «Sono del parere che dobbiamo limitarci a una cosa per volta. Oggi dobbiamo liberare un nostro compagno, insistiamo per la sua liberazione...». Mentre Turati parlava, furono visti soldati entrare alla chetichella nel cortile della fabbrica. Lì giunti cominciarono a caricare i fucili. Le uscite furono bloccate da un cordone di quattro file di soldati. Il fischio delle sei liberò tutti dall’angoscia. Su circa tremila operai, quelli che avevano accolto l’invito del direttore a rientrare in fabbrica non erano più di ottocento. Tutti insieme si avviarono verso casa. Tegole e sassi contro i birri e la mitraglia Intanto il plotone 57° Fanteria, uscito dalla caserma Trotter, sta attraversando il piazzale Andrea Doria e si dirige in via Napo Torriani con i fucili a “crociat-et”. Dimostranti occupano il marciapiede opposto alla caserma di polizia; e molti curiosi sono fermi a dieci metri di distanza dalla truppa, che all’alt del comandante ha preso posizione. Qualche dimostrante, uscito dal gruppo, raccoglie un sasso e lo scaglia contro lo stemma questurino. Azioni isolate, senza intenzioni provocatorie nei confronti della truppa; ma un sasso colpisce un soldato, ed è come un segnale. C’è uno squillo di tromba, e il gruppo dei dimostranti si scompone in un’ondata di paura, poi un fuggi fuggi generale, e già si sente nell’aria la prima scarica di fucileria, “il ran ran che spaventava, che infuriava” ricordano i testimoni “che sollevava grida disperate da tutte le parti e lasciava in aria una nube bianca in un silenzio sepolcrale”. Come Marietta poche ore prima, qualcuno ripete il suo grido: «Assassini! Assassini!». N on era stato possibile capire se avessero sparato per primi i soldati o i poliziotti. Si vide il Viola sbucare chissà da dove “con la bocca spalancata in un ghigno feroce e la rivoltella puntata verso i dimostranti”. Si udì uno sparo, unico e secco, e l’operaio Silvestro Savoldi, sor10 - Quaderni Padani preso e bianco in volto, vacillò e cadde “col sangue che gli usciva a flotti dalla tempia sinistra...”. Il suo assassino non fece in tempo a tornare sui suoi passi “perché una palla all’inguine lo stese al suolo cadavere”. Da chi fu colpito il Viola? La folla non aveva armi. Si saprà più tardi che “il questurino voltatosi per ritornare di corsa sotto la porta pare fosse stato colpito dalla rivoltella di un collega che lo aiutava a sfollare con le palle di piombo”. Qualcuno affermò anche che “il Viola aveva sparato proprio tra lo squillo e la carica, come un’incitazione, un avviso di far fuoco...”. Comunque fosse la folla non aveva avuto il tempo di mettersi in salvo. Dopo le tre scariche di fucileria, alcuni compagni raccolsero Savoldi, lo sollevarono per i piedi e le ascelle chiamandolo dolcemente: «Silvestro! Savoldi!». Non c’era più nulla da fare: “egli guardava, con gli occhi istupiditi dalla morte che lo invadeva, senza rispondere. Lo riprendemmo e ci avviammo verso il Ponte Seveso per vedere se era possibile farlo medicare nell’infermeria dello stabilimento Pirelli. Ma la porta era chiusa e la linea dei soldati non ci permetteva di avvicinarci allo stabilimento...”. Viene deciso di metterlo sul tram che proprio in quel momento stava venendo verso di loro, ed era diretto al Duomo. “Fu una cosa pietosa. Scomodammo la gente e, sorreggendolo davanti e di dietro, riuscimmo a tirarlo sulla carrozza, adagiarlo lungo il cuscino, e mettergli la testa insanguinata sulle ginocchia di uno di noi. Il tram non si era ancora mosso che il Savoldi tirò un sospiro lungo che ci andò al cuore e chiuse gli occhi. Il tram andava e le nostre mani palpavano sul suo cuore come se avessimo voluto che continuasse a battere e a mantenersi caldo. Ma la pelle andava raffreddandosi e quando fummo in piazza Mercanti, il medico ci mandò via con una parola: «Morto!». Il padre di cinque o sei figli era morto. E noi, angosciati, ricaricammo il primo cadavere delle giornate di Milano sul tram che andava a porta Volta e dal luogo di sosta lo portammo a braccia, al cimitero monumentale.” In altri scontri, in varie parti della città, sono rimasti sul terreno donne e uomini, due dei quali moriranno prima dell’alba. La repressione di Bava Beccaris è solo all’inizio. Re Umberto si trova a Torino con la consorte Margherita, la quale saprà degli scontri mentre assiste alla commemorazione dello Statuto a palazzo Madama. Dopo la proclamazione dello stato di assedio, che qualcuno avrebbe voluto estendere ad altre città del Regno, il telegrafo era stato tagliato e i dispacci venivano solo da Roma. La priAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 ma notizia era stata tanto di guadagnato, portata da alcuni fugche bruciando, sacgiaschi da Milano e cheggiando e pren“non creduta, e poi dendo a quelli che confermata da un diposseggono, avranno spaccio del generale qualche tempo buono, Dal Verme il quale o di godimento. Infine disse che si era sentito credo che tutte le teoil cannone a Milano, rie socialiste stanno da vicino Novara...”. sfumando ora e La regina Margherita confondendosi nel bascriverà al generale gliore sanguinoso delOsio, ex istitutore del l’anarchia...”. Stava lì principe Vittorio il vero pericolo: un Emanuele, suo figlio, brigantaggio organizche quello che l’aveva zato su vasta scala in maggiormente imtutta Europa che pressionata era “la po“avrebbe richiesto ca reazione nelle permolto tempo prima di sone benpensanti di riuscire a batterlo”, e Milano, l’assoluta concludeva: “Hanno mancanza di energia, provato da noi perché di difesa e di reaziosiamo in fama di avere ne...”. Quell’atteggiaun governo debole ed mento riprovevole e hanno voluto far vederinunciatario della re quello che sanno borghesia ambrosiana fare per intimorire”. si spiegava, a parere Scena della Rivoluzione Milanese Con Domenico Farini della sovrana, con aveva insistito nel “l’eccessiva ricchezza che rammolliva i popoli, guasto dell’opinione pubblica di Milano, “dove il perché i milanesi non pensavano ad altro che ai fremito da una parte e la paurosa inerzia dall’alloro denari, al modo di fare e a quello di non tra, lasciavano temere presto nuovi conflitti”. perderli...”, ma trovava curioso che proprio que- Fortuna che c’era l’esercito! Ed era certa che né st’ultimo sentimento, per lei assolutamente le- Rudinì, né Bava Beccaris l’avrebbero delusa. La gittimo, non ispirasse “la voglia di menar le ma- regina poteva star tranquilla. I soldati della guarni”. Non risparmiava nemmeno quelli che con nigione avevano ricevuto ordini perentori e chiadisprezzo chiamava i “monschasc”, i monzesi. Le ri: “Al comando dato, la truppa farà fuoco. Gli ufavevano riferito che il municipio si era rifiutato ficiali e i soldati stiano preparati...”. di dare alloggio a due reggimenti che volevano l 17 maggio Milano proclama lo sciopero gemettersi di stanza a Monza. Se era vero, “quel rinerale. Dalla Manifattura tabacchi, in via Mofiuto è il culmine della viltà, perché sarebbe la scova, le sigaraie escono cantando l’inno dei paura che vince la paura; cioè la paura di malcontentare la plebe che fa vincere il desiderio di lavoratori. Inutilmente il sindaco Vigoni ha affisesserne difesi...”. Era convinta che “la sedizione so un manifesto che invita la cittadinanza a stardi Milano non era che il prologo della rivoluzio- sene a casa o al lavoro. Corre per la città un frene che sarebbe scoppiata in Europa. Illuse per mito rivoluzionario, a porta Volta si alzano le anni, le masse avevano forse capito di essere sta- prime barricate. Torelli Viollier è testimone delte ingannate dai caporioni e che l’età dell’oro e l’esaltazione collettiva, da cui non si attende nuldell’uguaglianza non sarebbe venuta; però riu- la di buono. “Gli esaltati scesero per le strade per nendosi nelle loro assemblee avevano capito an- fare la rivoluzione, seguiti dai ragazzi e dalle rache un’altra cosa, e cioè che erano numerosissi- gazze. Ma la grande maggioranza degli operai, mi, e che tutti insieme potevano diventare una socialisti e non socialisti, quelli che hanno l’età grande forza. Così avevano pensato di mettere in del giudizio, non era punto in queste idee, ed ansubbuglio il mondo per qualche mese, che sarà zi era tranquillamente al lavoro...”. davanti all’a- I Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 11 bitazione di Torelli Viollier, c’era una casa in costruzione dove lavoravano una cinquantina di muratori. Dalla strada un gruppo di ragazzi gli gridarono di sospendere i lavori e di unirsi a loro. Dalle impalcature i muratori rispondevano: «Andèe via, lazzaroni!». Ma sopraggiunse l’ingegnere e dichiarò sospesi i lavori. Altrettanto avvenne in quasi tutte le grandi fabbriche, “in parecchi stabilimenti non ci fu nemmeno l’eccitazione dello sciopero; e furono i ‘principali’ che spontaneamente cacciarono gli operai in strada, dopo aver loro pagato la settimana (era sabato). Nelle tipografie dove si stampavano i giornali quotidiani, e dove i principali erano perciò interessati a continuare il lavoro, nessun operaio scioperò”, nonostante che “gli operai tipografi fossero un nucleo socialista organizzatissimo”. In corteo le sigaraie, circa un centinaio, percorsero con “marcata lentezza” e cantando via Palestro. Dietro veniva un drappello di cavalleria, “con le teste dei cavalli quasi sulle spalle delle ultime file delle cantatrici impavide”, e ancora dietro un centinaio di operai. In corso Venezia il corteo delle donne si allargò, e la cavalleria riuscì a passarvi in mezzo e al trotto si allontanò oltre porta Venezia. Fu allora che alcuni operai fermarono dei tram per metterli attraverso la strada e impedire così alla cavalleria di tornare indietro. Ma i tram non bastavano a erigere barricate; uomini e donne entrarono nella portineria di palazzo Saporiti, presero dei mobili e li portarono in strada. Nel trasporto molti vetri andarono in frantumi; qualcuno approfittò per impadronirsi di qualche oggetto, “ma l’appartamento del marchese non fu toccato”. Dai Giardini pubblici fu vista arrivare la truppa di fanteria; parecchi rivoltosi salirono sul tetto di palazzo Saporiti e gettarono sassi quando i soldati giunsero a tiro. I carabinieri fecero fuoco, un ragazzo fu ucciso sul tetto, un altro mentre scappava nei Giardini pubblici. Quel giorno ci fu anche un morto tra i soldati, ucciso - si disse da un comignolo lanciato in via Torino. Incidenti, tutto sommato, di non eccessiva gravità, e tali comunque da non ritenere che sarebbero degenerati fino a trasformare Milano in un campo di battaglia. All’inizio i soldati, benché messi sull’avviso, non si attendevano nessun ordine di attacco, “dappertutto assistevano ai disordini con l’arma al piede”. I rivoltosi erigevano barricate a venti metri dalle file dei soldati, e ai cittadini che protestavano per quell’ingombro al transito dei pedoni e delle carrozze, gli ufficiali rispondevano 12 - Quaderni Padani che “non avevano ordini”. Contro di loro i rivoltosi lanciavano le “più oltraggiose ingiurie”, gli ufficiali e i soldati non rispondevano, “sembra avessero ordine di sparare soltanto se attaccati. Difatti fecero fuoco soltanto quando, in qualche punto, cominciò la sassaiola...”. Per strada erano scesi moltissimi curiosi, per godersi lo spettacolo della rivoluzione, “perciò quando la truppa cominciò a sparare caddero parecchi innocenti”. I curiosi “discutevano con i rivoltosi; discorrevano con i soldati, davano consigli, motteggiavano, chiedevano chiarimenti ai costruttori delle barricate”. La grande maggioranza dei rivoltosi, osservò Torelli Viollier, “era composta di donne o ragazzi”. Con la giornata di sabato l’insurrezione era da considerarsi come terminata. Con questa convinzione Torelli Viollier si avviò al giornale, e sul Corriere di domenica scrisse che “il movimento non dava segno di organizzazione né di direzione. Non c’erano più armi da fuoco, non bombe, non disegno tattico, non capi. Non erano tagliati i fili del telegrafo, né quelli del telefono, né quelli della luce elettrica, non tagliate le ferrovie. Al tiro a segno c’erano 450 fucili che non furono toccati.” La rivoluzione non c’era, e tutto sembrava finito. Ma quella domenica mattina, senza una ragione, il cannone sparò a porta Ticinese. Il generale Bava, ossessionato dall’idea che di lì potessero arrivare gli studenti di Pavia, aveva ordinato il fuoco; parecchi morirono sulla porta di casa. La notizia di presunte bande armate, organizzate da Amilcare Cipriani, provenienti dalla Svizzera e dalla Francia, era servita al Rudinì per giustificare l’intervento militare. L’esemplare repressione doveva avvenire per forza. Bava Beccaris aveva giudicato la situazione “gravissima”. Non così Torelli Viollier che chiamò il caporedattore e gli disse di sopprimere tutte le notizie allarmanti e di scrivere che l’insurrezione era vinta dappertutto. «Non voglio» spiegò Torelli Viollier «che domani mattina il Corriere di Milano porti alle province notizie che incoraggino la rivoluzione...». La cavalleria a gran galoppo scorrazzava per la città, bastò la falsa notizia che un ufficiale era stato ucciso con una fucilata sparata da una finestra in corso Garibaldi per suscitare l’inconsulta reazione. I soldati accorsero a porta Garibaldi, crivellarono le case di colpi, uccidendo due donne che erano a letto. Verso mezzogiorno si sentì un terribile fuoco di fucileria, poi due cannonate verso Monforte. Racconta Paolo Valera: “I soldati tiravano sulle case e sui passanti e la popolazione suburbana si è destata come di soprasAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 salto e ha chiuso i negozi, come se un esercito di “se ne udì un altro più fragoroso”, fu vista come teppisti fosse stato alla porta cittadina, e ha chia- una colonna di fuoco in una nube bianca passare mato tutti i bimbi nella strada e ha chiuso tutte fulminea per corso Como, “sprigionando scintille porte che ha potuto con il frastuono delle le, perdendo lungo il tragitto corpi solidi che stanghe che sprangano e con le chiavi a due percotevano il selciato ed esplodevano con rumandate come quando si va a dormire. Pareva more infernale”. che avessero letto il Corriere della Sera e l’ingiunzione di Bava Beccaris: «A casa! A casa!».” hi non aveva visto non poteva farsi un’idea Tuttavia il popoloso quartiere di porta Garibaldi della paura: si “gridava, si piangeva, si alzanon restò completamente deserto; in giro restavano le mani, si invocava il Signore e la Marono circa un duecento persone. Al dazio c’erano donna, si imprecava, si urlava dalla disperazione una quarantina di soldati disposti in due file co- e dalla paura. Chi cadeva rovesciato dalla furia di mandati da un capitano degli alpini. Cessata l’e- chi scappava, chi era in terra che si contorceva co della fucilata alla Foppa, qualcuno si avvicinò dagli spasimi e chi non dava segni di vita. Sparaai soldati. «Udite» disse il capitano «andate via. to il secondo colpo, soldati e cannoni se ne sono Io sono un militare e ho ordini che devo seguire, andati senza voltarsi indietro...”. Era già sera, ricordatevi che mi riavutasi dallo spapreme la mia pelle vento la gente s’era più della vostra!». data ai soccorsi. Sembrò che avesse “Fra le scene comparlato ai sordi; eramoventi è quella di un uomo che s’è no per lo più ragazzi staccato dalla moche “non vedevano glie e si è inginocalcun male a stare lì chiato tutto piancon le mani in sacgente a baciare i tre coccia”. Allora il camorti distesi dapitano “li fece insevanti alla casa nuguire a baionetta in mero 27, del corso canna da pochi uoComo. Non li conomini col sergente fin quasi al margine sceva, non li aveva mai veduti, ma la della via De Criloro fine lo aveva stoforis”: e siccome straziato. Giù, in “la ragazzaglia ritorginocchio, in ginava dietro i soldati il sergente rifece la nocchio, a baciare, corsa due o tre vol- Sabato 7 maggio: le prime barricate - Giuseppe Ser- a baciare i poveri cristi ammazzati te”. Giungeva intan- ralunga Langhi to un distaccamento come cani in mezdi artiglieri a cavallo con due pezzi di cannone, zo alla strada! E come ho veduto baciare, così ho “uno dei quali venne piazzato sotto il voltone del veduto intorno ai cadaveri persone con il cappeldazio con la bocca rivolta in direzione dello scalo lo in mano che dicevano di volerli vendicare. merci”. Un tenente dei bersaglieri parlò con il Erano parole, parole, parole! Nessuno li ha vencapitano degli alpini; poi gli artiglieri tolsero il dicati. Quanti erano? Tutti possono interrogare i cuoio che copriva la culatta del cannone, e “poi registri dell’istituto di via Paolo Sarpi, dove sono in un attimo si udì una terribile esplosione fatta stati trasportati. Sul piazzale dello scalo merci si come di una striscia di fuoco avvolta in una den- sono messi tutti sulla barella improvvisata quatsa nube di polvere...”. I curiosi se la diedero a tro morti e sette o otto feriti; sul cavalcavia della gambe, nessun morto o ferito, “era stata una strada ferrata si sono raccolti due cadaveri e tre feriti. Le vittime del cavalcavia sono state concannonata a salve, una cannonata per ridere”. Così i curiosi di prima tornarono sui loro pas- dotte alla guardia medica di via Borsieri. Fra si, nuovamente vicino ai soldati convinti che questi ultimi era un repubblicano-intransigente, “non facessero del male a discorrere in strada”. Arusi Carlo, di ventisette anni, abitante in via Non erano passati tre minuti dal tiro a salve che Borsieri, 10; un povero giovane di ventiquattro, C Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 13 sposo da una settimana, e anche della via Borsieri, 12, e una bambina di sei anni, di via Mazzini, 6”. Note scritte da Paolo Valera in base alla testimonianza di un operaio che si trovava sul luogo. Alla seconda cannonata, quella micidiale, l’uomo era corso sul piazzale dello scalo e s’era trovato davanti al macello, “gambe, mani, quasi staccate; corpi con buchi sanguinosi di cinque centimetri di diametro”. Allora, raccontò, “mi sono dato al lavoro della Croce Rossa e sono rincasato come un macellaio. Guai se in quel momento mi avessero arrestato. Mi avrebbero condannato a quarant’anni di galera. Tuttavia, più tardi, nella stessa sera, io ho dovuto sentirmi dare del vigliacco da gente che accusava i socialisti di aver messa in piedi la rivoluzione, senza avere poi avuto il coraggio di tirar fuori le armi...”. Non solo i reazionari applaudirono a quell’indegno massacro. Anche i poeti devoti alla Corona composero versi in lode dell’esercito. Guido da Verona scrisse il Canto Civile per denunciare i capi socialisti definiti “mercanti sleali del favore popolare”, e inneggiare ai “Belli soldati dal tricorno a piuma”, difensori dell’ordine sociale turbato dai provocatori e dalla plebaglia: A quando, a quando sbuca dai più luridi vichi una masnada contando l’inno del lavoro armata di stocchi, di tenaglie, di randelli. Il poeta, discepolo di Gabriele d’Annunzio, ce l’aveva soprattutto con quelle popolane che si ergevano sulle barricate e con gesti sguaiati provocavano i “poveri soldati”: La donna, volta a lor schiere disciolse i lacci del corsetto e nude mostrò le poppe con lusinga oscena. Giunge dalla campagna l’aiuto dei ribelli? Guido da Verona non ha dubbi: Una brigata forte che speme di saccheggio a l’urbe alletta. E quanto agli studenti di Pavia in arrivo a Milano per la rivoluzione, così scrive: Viene da l’Ateneo la folle schiera ebbra di un nuovo nume a cui l’antico senno dei libri, non placò la fiera mente né l’empia voluttà di sangue. Con toni e accenti diversi, ma anch’egli rivolto a Milano, Giovanni Pascoli il libro pindarico Odi e Inni, dedicato ai giovani. L’ode Nel carcere di 14 - Quaderni Padani Ginevra conteneva l’inno «Pace», composto “per i tristi fatti del 1898”, e dedicato alla regina Margherita, che “in un giorno di maggio fu veduta inginocchiarsi in una chiesa e piangere e pregare...”. A entrambi rispose l’antimonarchico Lucini: Maggio di sangue, cantiam la clemenza delle mitragliatrici, Maggio d’obbrobrio, cantiam il coraggio dei paurosi armati, contro all’inermi: o Maggio rosso cantiam li Haynau italici, per le città lombarde. Maggio d’odio, noi segnerem le case della morte plebea ricche case per la riscossa estrema, Maggio, il regalo a voi venga augurale di questo fratricidio; o benigna Corona; Corona ben’armata ecco l’omaggio. Dei rantoli morenti e delle grida delli sgozzati. Q uella domenica il cannone tuonò per otto ore. La Valpetrosa divenne il rifugio delle persone che capitavano in via Torino, già in mezzo alla bufera dalla mattina tra colpi di fucile e scariche di mitraglia. Era un luogo stretto e riparato; e la gente scampata alle palle vi entrava trafelata e bianca come il latte. Uomini e donne esterrefatti, senza parole, senza capire cosa stesse succedendo. “Balbettavano” riferisce Valera “monologavano, parlavano come a se stessi. Alcune donne entravano con il grembiule in testa come se avessero voluto proteggersela dalla grandine di piombo che prorompeva e saltellava per le tegole o schiantava imposte o andava sulle muraglie col fracasso di una sfuriata di pam pam! Coloro che avevano paura o fretta di rincasare sostavano per assicurarsi se erano illesi o vivi e riprendevano la rincorsa per la piazza San Sepolcro...”. Alcuni raggiungevano, correndo piegati in avanti, fino all’estremità della via e sporgevano la testa in via Torino, allungando il collo da una parte e dall’altra per vedere che “cosa avvenisse e dove il fuoco era più assassino”. Il combattimento era ovunque accanito, alla pari si sarebbe detto e impegnativo per entrambi i contendenti. Così non era: al fuoco della truppa, ormai come impazzita, feroce e incontrollata, s’opponevano lanci di pietre, urla e maledizioni, che sembrava avessero il potere di rallentare la marcia dei soldati che sparavano tenendo il fucile all’altezza della cintura. Si sentiva il fragore delle tegole che si frantumavano e degli spari ora siAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 multanei, ora isolati. I colpi isolati “davano l’idea della caccia all’uomo”. A sinistra di piazza del Duomo, mentre fischiavano le pallottole, qualcuno tentava il saccheggio dei negozi. Vetrine con la merce esposta andavano in frantumi, e i ladruncoli lesti ad afferrare tutto ciò che potevano, fracassando con spranghe di ferro le imposte chiuse con il lucchetto. “Si sentivano i crack del legname che si schiantava e il frastuono dei vetri rotti con le punte delle imposte o con i pugni nudi addirittura”. Nessuno ci faceva caso, chi intento a sparare, chi a ripararsi dalla micidiale gragnola, e “nell’aria infuocata dalla guerra di strada si perdeva di vista il ladro e non si vedeva l’eroe”. La gente scappava, si chiudeva in casa, si alzava sulla città l’odore acre della balistite, i soldati a cavallo facevano evoluzioni terribili, al ritmo cadenzato e solenne del cannone, la fucileria crepitava quasi all’unisono, tale da sentirne un unico boato, poi un breve silenzio rotto soltanto da grida di terrore e dai rantoli dei moribondi. I fuggiaschi riempivano i solai, le cantine, le stanze più lontane dal pericolo, mentre “gli inquilini degli abissi più profondi della vita sociale, i ladri, gli sciacalli di quelle giornate, continuavano a esercitare la loro professione senza neppure darsi pensiero del diavolerio militare. La paura degli altri era il loro coraggio...”. A pochi passi si moriva, “e loro si imbottivano di camicie, mutande, merletti, di cianfrusaglie, di quello che capitava loro per le mani”. C’era chi tornava sui suoi passi, non soddisfatto dell’ignobile vendemmia, per raccogliere uno degli ombrelli caduti dalla vetrina dei fratelli Guarneschelli. Un ragazzo “lo raccolse e senza affrettare il passo se lo trascinò dietro come uno a zonzo, voltando nella via che conduce in piazza Sant’Alessandro...”. Valera paragonò l’imperturbabilità del ladruncolo a quella di Gavroche, “quando involava la giberna di cartucce ai soldati per portare le munizioni ai camerati sulle barricate”. A destra di piazza del Duomo “il pam pam degli spari s’era come allontanato”. Pareva che i soldati facessero fuoco marciando verso il Carrobbio, anche il lancio delle tegole e dei coppi dai tetti era diminuito, “non era più così tempestoso”. Anche gli spari erano diminuiti, dall’alto non cadevano che poche tegole che si rompevano sul selciato con rumore. Poche ore dopo non vi fu che silenzio, e chi ebbe la ventura di passare di lì capì che la battaglia doveva essere stata disperata. “Pareva che i cittadini avessero consumato l’ultimo coppo prima di lasciarsi ammazzare. Tutto il selciato era Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 letteralmente coperto di pezzi di tegole, di coppi infranti, di sassi, di cocci, di rottami, di polvere rossa...”. I soldati erano in agguato sotto le porte, addossati ai muri, “con gli occhi ai tetti e il fucile pronto a far fuoco...”. In via Palla, l’immagine della Madonna doveva aver fatto da bersaglio a qualche alpino. Un proiettile a balistite l’aveva colpita sotto il braccio bruciando l’orlo del foro. “La balistite” commentava Valera “distrugge anche la religione o la superstizione incastrate nelle muraglie delle case. Pam! È meglio che le palle buchino i corpi delle madonne dipinte che delle madonne vive...”. I l fuoco era ricominciato in via San Maurilio, tra piazza Duomo e il Carrobbio. Evidentemente i soldati s’erano imbattuti in un covo di resistenza o in una barricata in via Torino. Non era una barricata. Di nuovo piovevano dai tetti mattoni e tegole che si spezzavano sulle muraglie, sulle botteghe, sui marciapiedi, come una pioggia incessante. Nella casa c’era ancora la portinaia, una donna alta con la faccia allungata. Stava sull’uscio tutta spaventata, “non aveva mai visto salire e scendere tante persone, tremava a ogni interrogazione. Le fu chiesto se sapeva che cosa andasse a fare tutta quella gente che aveva veduto scomparire nel budello buio di sotto, ma la povera donna rispondeva che non ne sapeva nulla. Era una giornata di tribolazioni che il Signore le aveva mandato per punirla di qualche peccato...”. Sopraggiunsero altri, e la donna, pur tremando, non impedì l’accesso a quegli uomini stravolti che cercavano un luogo sicuro per picchiare in testa ai soldati. Li vide scomparire sulla seconda scala. La ringhiera del ballatoio all’ultimo piano comunicava con una grande terrazza “sulla quale gli inquilini salgono a distendere al sole la biancheria che lavano dabbasso nel lavello della pompa”. Dalla terrazza era facile salire sul tetto più basso e poi su quello più alto, correre da una casa all’altra, “riparandosi dietro i comignoli tutte le volte che ci fosse bisogno di salvarsi dalle palle micidiali...”. Erano saliti lassù in un numero enorme, pareva impossibile che il tetto potesse reggerli tutti. Si aveva l’impressione che l’edificio tremasse, erano invece i corpi in equilibrio, l’uno accanto all’altro, qualcuno imprecava: «Su, su, sta su...», e giù un’orribile bestemmia. Altri scendevano, venivano giù tutti insieme “ingorgandosi nella strettura, come se avessero avuto paura di venire colti col documento sulle braccia di essere stati sui tetti. Tanto più si avvicinavano al piano inferiore, quanto più il ruQuaderni Padani - 15 more delle loro scarpe si attutiva e diventava lugubre. Pareva la discesa di gente che andava al patibolo...”. Quella scena si impresse nelle mente di un testimone: “Guardavo istupidito e lasciavo passare il gruppo che sorreggeva il giovine che incadaveriva a ogni gradino, che moriva con la faccia bianca come la farina, con gli occhi smorti che si travolgevano, con le guance che assumevano la durezza del marmo, con le labbra che si scoloravano e diventavano violacee, e si aprivano per lasciar passare l’alito della vita”. I compagni del povero giovane gridavano: «Su, su, facciamo presto, non ci deve morir tra le braccia, portiamolo altrove...», perché “nessuno voleva sul piano un pomo che potesse diventare la sventura di tutti”. Gli uomini che portavano il moribondo avevano “la camicia fatta a ventriera carica di sassi, ed erano saliti e discesi con i proiettili della strada che non avevano potuto consumare”. I soldati di Bava Beccaris avevano capito il loro gioco; ed erano saliti sui tetti anche loro, dall’altra parte della via, e a colpi di balistite li avevano fatti scappare. Gli insorti uscivano sulla strada “rossi” come se fossero usciti da un forno, e si sbandavano correndo a rotta di collo. Solo i due che reggevano per le ascelle il ferito non si curavano altro che di lui. Camminavano adagio col moribondo, scuotendolo perché si risvegliasse da quella torpida agonia, facendolo apposta traballare e sussultare, e dicendogli di stare in piedi se non voleva essere arrestato, andavano via “come tre amici, braccio sotto braccio”, ma il ferito non sentiva più, la testa reclinata e le gambe penzoloni, i piedi “urtavano contro i sassi, sfioravano il suolo, si piegavano, puntavano nei solchi dell’acciottolato come piedi morti...”. E il testimone che tante volte aveva visto la morte, restò impressionato “da quell’uomo calato da un tetto e sorretto da combattenti e fatto andare per le strade con un fusto di carne morta”. Il cadavere che “cammina e piega su se stesso con la testa che va da una parte e dall’altra toglie il respiro. Si allibisce come in mezzo ai fantasmi dell’incubo notturno...”. Il trionfo di Bava Beccaris e l’assassinio del re A mezzogiorno di domenica 8 maggio s’era diffusa la voce che dal convento di Monforte erano partite alcune fucilate. Sul piazzale fu posto il cannone che aprì una breccia nel muro del convento e uccise tre dei quaranta mendicanti che a quell’ora aspettavano la distribuzione della minestra. I soldati entrarono attraverso il varco e un frate che medicava un ferito si prese 16 - Quaderni Padani un colpo di baionetta nella spalla. Il mendicante Luigi Cerina raccontò più tardi: «Le turbolenze dei primi due giorni mi avevano insegnato un po’ di prudenza. Dopo la sollevazione di porta Ticinese, consigliai i frati a sospendere la distribuzione della minestra. Dicevo loro che la ragazzaglia avrebbe potuto mischiarsi coi mendicanti e far nascere qualche cosa di grosso nel convento. I frati, buoni, isolati dagli avvenimenti, pensavano più allo stomaco dei loro ospiti che alla perturbazione cittadina. Essi si credevano lontani mille miglia dalle operazioni militari. Così non furono del mio parere, e bisogna convenire che non avevo tutti i torti. Chiudere il cancello ai mangiaminestra era facile...». I l racconto proseguiva: “Ma dove avrebbero trovato da mangiare tutti questi poveri cristi la cui esistenza era basata sulla tazzina calda che dava loro il convento? Sospendendo la distribuzione, avevano poi paura di venir biasimati e di contribuire, senza volerlo, a dare combustibile alle barricate. I cenciosi, la cui maggioranza era composta di giovani, avrebbero potuto fare del baccano e abbandonarsi come gli altri al malfare. Questo solo pensiero dava loro i brividi. Ad ogni modo mi dissero: «Voi, Cerina, che li conoscete tutti, resterete al convento». E, dicendomelo, mi affidavano le chiavi del cancello d’entrata, coll’ingiunzione di non lasciar entrare che forestieri e pitocchi. I forestieri sono i frati che passano da Milano e sostano al convento una notte o due prima di riprendere il viaggio...”. Bava Beccaris non aveva voluto attender conferme o ulteriori chiarimenti; certo che il convento si fosse trasformato in fortilizio ribelle aveva comandato il fuoco, e poi l’assalto come a porta Pia. Uno dei mendicanti venne raggiunto da una palla, mentre finiva di vuotare la ciotola sotto il portico della chiesa. “Stava mangiando seduto sulle calcagna. Rovesciato, supino, si agitava come se avesse avuto le convulsioni; era vecchio, bassotto, sciancato. Alloggiava presso qualcuno in via Stella.” I mendicanti, presi dal panico, “si erano pigiati nell’andito e calcati gli uni sugli altri lungo l’entrata del convento. Tutti insieme facevano compassione. I proiettili cadevano da ogni parte e noi non avevamo per coprirci che le nostre mani e per proteggerci che le nostre preghiere. Le donne coi bimbi piangevano e nascondevano la testa delle loro creature con le braccia. Gli uomini cercavano di ficcare la faccia tra le spalle degli altri. Con lo spavento, la lotta per la conservazione della propria esistenza Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 era divenuta generale e accanita. Ciascuno di noi I prigionieri furono legati e messi in fila: dacercava di mettersi più al sicuro che poteva, vanti i padri, dietro i frati laici. I mendicanti eraspingendosi innanzi, magari brutalmente, facen- no in coda a tutti. La voce dell’ufficiale faceva dosi largo coi pugni chiusi, risospingendo i più “accapponare la pelle e le sue parole passavano audaci che prendevano gli uomini e le donne per nelle orecchie come potenti schiaffi”. Il Cerina le spalle per aprirsi la via verso la postierla. La ebbe l’impressione che il capitano volesse farli scarica, che ci fece sussultare sul suolo, finì per fucilare in massa. “Ci credeva dei rivoltosi, finti incalzarci tutti a cercare un rifugio al di là del- mendicanti, falsi frati truccati per la rivoluzione. l’assito. Si gridava come disperati. «Oh, Signore! Parecchi della comitiva erano sulle ginocchia e Oh, Madonna! Salvateci! Salvateci! Ci ammazza- pregavano con la sollecitudine della gente che no! Salvate i poveri diavoli che non hanno fatto non ha tempo da perdere o si sente la morte alla nulla di male!» Un’altra scarica, che mi parve schiena.” I soldati sfilavano davanti a “questo una cannonata, ci fece perdere la bussola. Infu- esercito di piangenti col fucile a baionetta in riati dal parossismo, non ci furono più riguardi canna puntato verso il loro petto”. I poveretti si né per un sesso, né per l’altro. Si spingeva e si sforzavano di mantenersi calmi, “ciascuno aveva calcava come si poteva. La postierla subiva le on- paura che un grido, un gesto facesse prorompere date impetuose senza cedere. Allora diventammo tutte quelle bocche di fuoco in una volta sola...”. tutti pazzi: «Aprite! Aprite! Ma non era facile stare in siOh Dio, si muore!»” La canlenzio, in quell’atmosfera di nonata aveva mandato tutto terrore; “c’era una donna in frantumi e il Cerina, capo che aveva due piccini attacriconosciuto dei cenciosi, cati alle vesti, che piangevariuscì a rifugiarsi in fondo no, e un altro al seno che alla cantina, scendendo a strillava...”. precipizio le scalette buie. Dinanzi alle baionette alcuni Vi trovò due frati che trecominciarono a sentirsi mamavano come foglie; giunle. Fu allora che una voce sero altri mendicanti. Nesgridò: «Fermi! Fermi!». Era suno fiatava. Il cannone taun tenente di fanteria che ceva. Si sentivano soltanto entrava col revolver in mafucilate qua e là. Poi sentino. «Capitano, cosa fa? Non rono i soldati che “sacravede che sono tutti poveri?» mentavano sotto i portici”. La gente si rianimò e tutti Il Cerina ebbe paura di trodissero in coro: «Grazia, varsi lì, a un tratto credette grazia, scior tenente», altri di essersi messo in trappola lo chiamavano maggiore. e di restare lì secco come «Dio lo benedica! Dio gliene un coniglio. Mendicanti e renda merito! Che Dio el frati erano appiattiti, l’uno Il feroce monarchico Bava Beccaris ghe daga del ben!» addosso all’altro, senza il Scortati dai soldati, mendicoraggio di fiatare, quando una voce dall’alto canti e frati, in fila e legati, furono avviati alla della scala intimò: «Arrendetevi! Arrendetevi!», prefettura di Monforte. Tra loro c’erano vecchi ripeté il capitano. Il Cerina si fece coraggio: «Co- che si trascinavano a stento e una decina di rasa vuole che rendiamo, signor capitano? Semm gazzi piccoli. “Lo spettacolo era miserevole” tutt poveritt». Il Cerina fu afferrato per un brac- scrisse Torelli Viollier. Ma i giornali conservatori cio, trascinato su per la scala e buttato in mezzo fecero l’elogio di Bava Beccaris, che aveva persoagli altri già radunati sotto il portico in mezzo ai nalmente seguito con il binocolo la gloriosa presoldati. Il convento venne perquisito da cima a sa del convento. L’Illustrazione italiana scrisse fondo: snidavano quelli che erano riusciti a tro- che “Bava aveva sorpreso il mondo per la rapivare un nascondiglio e cercavano le armi. I men- dità dei provvedimenti...”. Alle cinque ogni comdicanti “furono palpeggiati fino ai capelli”, e per battimento era cessato, e Bava Beccaris telegrafò fortuna nessuno di loro aveva in tasca un coltel- al re che la sommossa era stata domata. lo. I soldati arrivavano con qualche frate o qualIl generale Bava Beccaris non sapeva ancora che “pidocchioso” scovato chissà dove. esattamente il numero dei morti, ma “sicuraAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 17 mente erano meno di quel che si diceva”. Se ne sarebbero contati almeno un centinaio, con 450 feriti e si sarebbero contati 800 arrestati, tra cui Anna Kuliscioff, Filippo Turati, lo stesso Paolo Valera. Finì in carcere l’intera redazione del giornale repubblicano L’Italia del Popolo; il Secolo, foglio radicale, venne soppresso, nonostante non avesse condiviso l’entusiasmo dei rivoltosi, e il suo direttore, Carlo Romussi, insieme al gerente Emilio Gerar- La Chiesa e il Convento di, fu arrestato. Stessa dati - Icilio Calzolari sorte toccò al direttore dell’Osservatore cattolico, don Davide Albertario, che il 6 maggio aveva scritto: “Ah! Canaglie, voi date piombo ai miseri che avete affamato e poi vi lanciate contro i clericali...”. Altri esponenti politici dell’estrema sinistra furono condannati sulla base di semplici indizi e ridicole supposizioni: l’onorevole Dino Rondani a 16 anni di reclusione per “aver tentato di istituire a Milano una repubblica federale”; l’onorevole Luigi De Andreis, repubblicano, a 12 anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per essere stato trovato in possesso di “un piano generale d’insurrezione”; in realtà l’Andreis, ingegnere e direttore tecnico della società Edison di Milano, aveva con sé il grafico del percorso tranviario milanese contrassegnato con le lettere: “F” e “B” che furono interpretate “Fuoco” e “Bombe” e che significavano invece “Fognature” e “Bocche d’incendio”. Torelli Viollier non potè fare a meno di esclamare: «Vedo cose che mi ricordano i Borboni!». Il 10 maggio Bava Beccaris, nominato commissario straordinario della città di Milano, vietò la circolazione di biciclette, tricicli e tandem e “simili mezzi di locomozione”, e sciolse la Società Umanitaria, covo, a suo dire, di sovversivi e rivoluzionari. Quello stesso giorno lo stato d’assedio venne proclamato anche a Napoli. Vennero militarizzati i ferrovieri e gli impiegati dello Stato, in modo che entrambe le categorie fossero 18 - Quaderni Padani sottoposte alla legge militare in caso di sciopero. Furono chiuse le università di Roma, Napoli, Padova e Bologna; disciolte le camere del lavoro, le banche contadine, le associazioni filantropiche, enti e organizzazioni cattoliche. La regina Margherita non trattenne la propria soddisfazione. “Ammirevole, come sempre aveva scritto al generale Osio - il comportamento dei soldati, che forza mirabile che ha quella disciplina militare! È quella che dei Cappuccini bombar- mantiene tutto ciò che c’è di buono, di sano, nell’anima dell’Italia. Gloria e onore all’esercito...”. Era orgogliosa che nella Germania di Guglielmo II, altro campione di libertà, il comportamento dell’esercito avesse fatto grande effetto e “ci ha fatto salire in stima”. Nessun accenno ai morti rimasti sulle strade, nemmeno agli innocenti assassinati per caso. La sua gratitudine andava ai soldati, “ai quali per sentimento, per indole e sangue”, voleva già bene prima, ma ora quando ne vedeva uno “sentiva rallegrarsi il cuore e inumidirsi gli occhi, tanto son bravi e tanto loro deve il Paese...”. L’esercito si meritava una ricompensa; e anche il suo eroico condottiero. C osì il 6 giugno, a un mese dall’inizio della repressione, il re conferì motu proprio al generale Bava Beccaris la croce di grand’ufficiale dell’Ordine militare di Savoia “per rimettere” diceva la motivazione “il servizio che Ella rese alle istituzioni e alla civiltà e perché Le attesti con il mio affetto la riconoscenza mia e della Patria”. Si congratulò con Bava Beccaris, nominato senatore il 16 giugno, anche il cardinale Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano, che ai primi spari aveva abbandonato la città. Il 10 maggio, da Asso, dove si era rifugiato, gli scrisse una lettera: “Lontano dalla città fin da sabato u.s. quando non potevo prevedere i luttuosi fatti, che misero in tanta costernazione codesta cittadinanza, sento il dovere ed il bisogno di significare all’E.V. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 che provvidamente tiene il governo della provincia militarmente, la sincera e piena mia adesione agli alti sentimenti di ordine di giustizia ai quali si ispira nel compiere il gravissimo suo ufficio e di rinnovarle gli ossequi ed i voti espressi già nel telegramma di stamani. A questo atto per me doveroso, mi permetto di aggiungere una preghiera a favore dei padri cappuccini trattenuti in custodia alla prefettura. Conosco le buone disposizioni tanto del prefetto che di Vostra Eccellenza: ne sono grato assai assai, e ne piglio sicura fiducia per chiedere il più presto rilascio di questi religiosi e specialmente dei religiosi sacerdoti. E rendendole anticipati ringraziamenti di questo atto di clemenza, che darà sempre maggior prestigio alla autorità di V.E., mi reco ad onore di confermarmele”. Il cardinale si meritò la sferzante risposta di Bava Beccaris: “Io deploro vivamente che una male augurata combinazione non abbia permesso all’E.V. di trovarsi in città durante i dolorosi giorni ora trascorsi. Sarebbe stato di somma utilità che il clero milanese, ricevendo un diretto impulso da chi siede sulla cattedra di Sant’Ambrogio e di San Carlo, avesse pronunciato, senza ritardo, una parola di pace, ed offerto il suo ministero per abbreviare una cruenta lotta fratricida”. Ma quelle parole, perfino dignitose, non riscattavano l’autore della strage. Tuttavia Bava Beccaris non era stato che lo strumento della repressione, così come Rudinì era stato l’interprete di una politica reazionaria che andava oltre la volontà del suo ministero. Era ciò che aveva sostenuto Gaetano Salvemini che, con lo pseudonimo di “Un Travet”, scrisse su Critica Sociale: “La reazione in Italia non è un fenomeno improvviso, legato con la nascita e la morte di un ministero, ma emana perennemente da una causa superiore alla volontà dei singoli ministri, causa immanente in tutta la nostra organizzazione politica, senza la cui eliminazione nessun progresso ordinato e sicuro è possibile”. Salvemini voleva dire, in altre parole, che la tentazione reazionaria in Italia era latente in ogni governo, anche in quelli che si ammantavano di progressismo, perché era insita nella prassi politica di un Paese nato male e troppo in fretta, con forti squilibri culturali e sociali, arretrato e manicheo, che esaltava la democrazia ma quotidianamente la negava, come talvolta capitava a coloro che se ne erano dichiarati paladini. L’aveva dimostrato Rudinì, che aveva stabilito un’alleanza con la sinistra radicale, e a suo tempo con Felice Cavallotti, “bardo della democrazia”, e aveva finiAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 to per comportarsi peggio dei governi più dichiaratamente di destra che l’avevano preceduto. Taluni, come Napoleone Colajanni, attribuivano questa anomalia ad “alte sfere”, ossia al re cui si faceva risalire la responsabilità della reazione “logica conseguenza della politica militarista”, favorita dalla corte e dalla casta al potere. Non c’è dubbio che lo scontro politico e sociale tra movimento operaio e monarchia fosse voluto e ricercato proprio da quest’ultima poiché, come aveva detto la regina Margherita, la Corona non poteva accettare compromessi. Ma indebolita dai conflitti sociali, dagli scandali e dalle sconfitte militari in Africa, con un consenso sempre più ristretto e con un movimento popolare che cresceva e le era ostile, essa non avrebbe potuto raccogliere la sfida senza ricorrere ai governi della sciabola e degli stati d’assedio. Tuttavia i fatti del ‘98 rivelavano non la forza ma la debolezza del regno umbertino. Il sindaco di Milano, l’ingegnere Giuseppe Vigoni, non era fuggito dalla città, ma aveva fatto ben poco per impedire la carneficina. Eugenio Torelli Viollier era andato a trovarlo a palazzo Marino, domenica pomeriggio. Aveva sentito il bisogno di sfogarsi, e appena lo vide gli disse: «S’ella non interviene finiremo per coprirci di ridicolo e di vergogna». Gli disse che «la città era tranquilla, e ch’era indispensabile egli agisse presso le autorità militari per far cessare un macello che non faceva che vittime innocenti». Tentò di persuaderlo che la rivoluzione era stata esagerata. «Quanti soldati sono caduti?» chiedeva a riprova Torelli Viollier. «C’è stato un solo morto, solo un ufficiale ferito, pare, di coltello e poco più di mezza dozzina di soldati feriti da sassi.» «Dall’altra parte, si hanno 500 persone tra morti e feriti» aveva continuato Torelli Viollier. «I rivoltosi non avevano altre armi che i sassi, e tegole da cui l’esercito si è difeso con molta facilità, occupando una casa a destra e una a sinistra, e mandando qualche soldato a far fuoco dai tetti. Difatti le tegole hanno ucciso quell’unico soldato e ferito nessuno. È stato un movimento di poca canaglia, e di donne e ragazzi, che furono facilmente dispersi...». Non c’era stato un incendio, avrebbe spiegato più tardi al professor Villari, «né devastazione, salvo qualche tram tolto dalle rotaie per far le barricate, né saccheggio, tranne qualche piccola cosa da casa Saporiti. Non c’è stata violenza fatta ad alcuno. E sì che sabato, domenica e lunedì i sobborghi sono stati in mano agli insorti, o meglio sarebbero stati Quaderni Padani - 19 nelle loro mani, se ci fossero stati insorti...». Ma il sindaco Vigoni, pavido e irrisoluto, non si era sentito di interferire nell’operato dell’autorità militare che aveva assunto i pieni poteri in città, e non mostrò di gradire le civili esortazioni del direttore del Corriere. Viollier non poté dire quel che pensava nemmeno sul suo giornale; la versione dei fatti che doveva essere diffusa era quella suggerita dall’autorità. “Non potei parlare sul Corriere come piaceva a me, anche perché capivo che non era quello il momento d’indebolire l’autorità; ma non volli neanche parlare come piaceva agli altri. Perciò quando mi furono comunicati i telegrammi di felicitazioni del re (ahimè!) e di Rudinì al Bava, il secondo dei quali lo lodava per il ‘rigore’ dimostrato, rifiutai di stamparli, e rifiutai l’indirizzo dei cittadini al Bava, che lo esortavano a perseverare nel ‘rigore’. E rifiutai di aprire la sottoscrizione a favore dei soldati morti e feriti (un morto e sei o otto feriti). Purtroppo della truppa non si può essere soddisfatti, per quanto riguarda i capi: mancarono i viveri tanto che il Bava dovette domandare il sussidio dei cittadini per nutrire i soldati, e lo spreco delle munizioni fu spaventoso...”. Gli ufficiali sottolinearono altre manchevolezze: “insufficienza del servizio di informazioni, d’avanscoperta, aspetto cencioso delle truppe, eccetera, ma in queste materie non sono competente. Certo è che i soldati e capi mancarono affatto di sangue freddo...”. I giornali italiani pubblicarono fandonie e esagerazioni, per ignoranza e stupidità. Torelli Viollier non se ne meravigliò: “la borghesia è stata feroce nel giubilo per la vittoria ottenuta, com’è ora feroce la reazione. Si sono gettate duemila persone nel carcere ammucchiandole nei cameroni del Castello, ove non c’è spazio sufficiente perché potessero stendersi a terra la notte, e dando loro una pagnottina di pane al giorno. Si sono soppressi una dozzina di giornali, si sono sciolte e si sciolgono tutte le associazioni operaie di qualunque genere. Ora si fanno i processi militari e, come io prevedevo, non viene fuori nulla di serio, nulla che significhi rivoluzione a mano armata...”. Il tribunale aveva calcato la mano contro quegli imputati che erano conosciuti come socialisti. E il pubblico ministero, in uno dei tanti processi, aveva sostenuto “essere indizio grave l’iscrizione di un imputato alla Camera del Lavoro”, e non bastò che questi rispondesse: “È vero, ma la Camera del Lavoro era il nostro ufficio di collocamento. Senza ricorrere a lei non potevo trovar lavoro: ha cinque figli”, perché l’ispettore di P.S., incari20 - Quaderni Padani cato della censura preventiva, fece cancellare dai verbali la spiegazione dell’operaio. “Siamo dunque in pieno colpo di stato fatto a beneficio della borghesia contro il popolo” concludeva amaramente Torelli Viollier “ossia di una classe contro l’altra, dell’oppressore contro l’oppresso. Tutta la stampa europea c’è contraria. Ma la borghesia non vuol sentire parole che le riescano sgradite. Il Corriere è stato già brutalmente ammonito per un articolo in cui, sa Dio con quanta dolcezza di espressione, esortava i giudici d’istruzione del Tribunale militare ad essere miti e a non trascinare in giudizio persone di cui non fosse accertato il reato, giacché il pubblico dibattimento non aggiunge nessun lume a quello raccolto in istruttoria...”. Brutti tempi, si viveva nel sospetto e nella paura; ogni buona intenzione veniva travisata. Torelli Viollier aveva scritto un articolo per dire che “non si poteva migliorare la situazione del Paese se non diminuendo le spese...”. L’avesse mai detto! Tutta la stampa conservatrice gli saltò addosso dicendo che il Corriere spingeva il popolo a far le barricate. Torelli Viollier non si lasciava mettere il bavaglio facilmente, ma vista la situazione preferì lasciare il Corriere. Era il 1° giugno 1898. Due giorni dopo, libero da impegni e da ogni forma di censura, scriveva al Villari la lettera famosa che terminava con queste parole: “Siamo, a parer mio, in giorni d’incomparabile bruttezza e nulla ricordo d’analogo dacché ho l’età della ragione”. M a il sangue versato a Milano chiedeva vendetta. S’incaricò di compierla Gaetano Bresci, un giovane tessitore toscano emigrato negli Stati Uniti, al quale era capitato di leggere l’incauto messaggio che il re aveva inviato a Bava Beccaris. La ferita di Milano non si rimarginò facilmente; ma essa servì a richiamare l’attenzione del Paese su una realtà politica e sociale che finora era stata negata o ignorata. I moti di maggio furono una sorpresa per tutti, per i socialisti che li avevano ispirati e poi sconfessati, per la destra reazionaria che aveva visto concretamente profilarsi il nuovo temibile nemico. La borghesia aveva vinto, ma ognuno sentiva che la partita era stata rinviata. La gravità delle misure che furono adottate era perciò proporzionale all’importanza che il governo volle dare all’insurrezione. Negli eccessi dell’autorità politica e militare Croce vide “la convulsa trepidazione della parte reazionaria, la quale, con eccitata fantasia, immaginò e sparse nel Paese una terrificante leggenda dell’abisso aperto, della rovina a cui si Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Cavalleria a Porta Romana era miracolosamente scampati, del pericolo a cui si era trovata esposta l’esistenza dello Stato e quasi dell’intera società...”. Fu invece un generale ravvedimento, e giustamente Croce attribuì al ‘98 il merito di aver costretto le forze cosiddette costituzionali (ossia la Sinistra e la Destra d’origine risorgimentale) a individuare al loro interno i conservatori e i progressisti. Destra e Sinistra tornavano ad avere un significato dopo essere state per tanti anni due correnti del grande partito liberale costituzionale, sempre più eguali tra loro e irriconoscibili. “Si faceva strada nelle menti” concludeva Croce (e il ’98 in questo fece da grande catalizzatore) che “la libertà non era un concetto borghese o di classe, ma è il campo con grandi e secolari fatiche spianato e assicurato dai maggiori spiriti dell’età moderna per lo svolgimento delle lotte civili e l’incessante umanamento dell’uomo...”. Il ‘98 “fu l’ultimo conato di governo autoritario” e la premessa della “restaurazione liberale”. Gaetano Salvemini deluso ma non domo non rinunciava alla lotta. Nel febbraio 1899 scriveva al Arcangelo Ghisleri, repubblicano: “Ora noi dobbiamo creare l’ambiente in cui in seguito bisognerà manovrare. Io per me ho deciso la mia strada. Aspetterò con tutta la pazienza possibile; resterò sulla breccia a lottare per far prevalere la tattica, che sola per me è deAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 gna di qualche sacrificio. Se nel mio partito prevarranno le mie idee - e spero molto che così debba essere - bene! se no, uscirò dal partito socialista ed entrerò nel partito repubblicano a patto che butti a mare i Bovi, i Socci, i Barzilai e tutti i simili somari. Se neanche questo sarà possibile, mi ritirerò sotto le tende e mi metterò a scrivere un libro sulle rovine di Ninive e di Babilonia [...]. Sento che i profughi capitanati dall’Olivetti preparano ogni giorno nei caffè di Lugano i piani della futura rivoluzione [sic] italiana. Roba da far ridere, se non ci fosse da disperare della serietà dei redentori d’Italia. Vado ruminando un lavoro sul Libro dei Profeti, gli darò per epigrafe la sentenza di Cattaneo: ‘Però se v’erano molti d’uomini d’animo repubblicano in Italia, essi non avevano dottrina repubblicana’. Il che mutatis mutandis va a cappello per i socialisti [...]. Ti confesso che non approvo l’aria da Silvio Pellico, che si dà il Valera nei ricordi di Finalborgo [la prigione ligure dove era stato rinchiuso]. Descrivendo a colori troppo neri la vita di carcere, si finisce col diffondere la paura e lo scoraggiamento. Questo popolo è così fiacco e vigliacco che non gli parrà vero di scusarsi del suo dolce far niente col pericolo di andare a marcire in galera...”. Sui provvedimenti di Rudinì il governo si divise. Il ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli, contrario fin dall’inizio allo stato d’assedio, chiese ulteriori sanzioni contro i cattolici; ViscontiVenosta, al contrario, ritenne esagerati i provvedimenti contro di loro. C’era voluta la follia liberticida di Rudinì per trasformare in “rivoluzionario” un partito come quello cattolico che per sua natura era per la moderazione e l’ordine. Il dissidio si rivelò insanabile: Zanardelli, CoccoOrtu, Gallo, Sineo e Visconti-Venosta diedero le dimissioni; Rudinì tentò un rimpasto, e alla Camera propose cinque disegni di legge, tendenti a rendere permanenti i provvedimenti repressivi varati durante i tumulti di maggio. Ma la maggioranza della Camera gli votò contro. Rudinì si rivolse al re chiedendogli lo scioglimento delle Camere e l’approvazione per decreto reale del suo programma. Umberto, incerto come sempre, era pronto ad accettare il colpo di stato che il presidente del consiglio gli proponeva, ma Domenico Farini, presidente del Senato, lo dissuase. Rudinì dovette dimettersi. Il 28 giugno 1898 il re diede l’incarico al generale Luigi Pelloux, che con l’appoggio iniziale di Zanardelli e Giolitti formò un governo più spostato a sinistra, il penultimo del regno umbertino. Quaderni Padani - 21 La “Carta di Chivasso” di Ettore Micol I l 19 dicembre 1943, nel pieno della guerra di occupazione, quando già i soldati tedeschi e repubblichini controllavano L’Italia del Nord, a Chivasso, non lontano da Torino, si incontrarono sei cittadini e intellettuali, futuri protago- nisti nella lotta partigiana, per discutere sulla ricostruzione post bellica e post fascista delle loro Valli. Ne nacque la Dichiarazione dei Rappresentanti delle Popolazioni Alpine, meglio conosciuta come “Carta di Chivasso” che, ancora oggi, Dichiarazione dei rappresentanti delle Popolazioni Alpine Noi popolazioni delle vallate alpine CONSTATANDO Che i venti anni di mal governo livellatore ed accentratore sintetizzati dal motto brutale e fanfarone di «Roma doma» hanno avuto per le nostre valli i seguenti dolorosi e significativi risultati: a) - OPPRESSIONE POLITICA attraverso l’opera dei suoi agenti politici ed amministrativi (militi, commissari, prefetti, federali, insegnanti) piccoli despoti incuranti di ogni tradizione locale di cui furono solerti distruttori; b) - ROVINA ECONOMICA per la dilapidazione dei loro patrimoni forestali ed agricoli, per l’interdizione della emigrazione con la chiusura ermetica delle frontiere, per l’effettiva mancanza di organizzazione tecnica e finanziaria dell’agricoltura, mascherata dal vasto sfoggio di assistenze centrali, per l’incapacità di una moderna organizzazione turistica rispettosa dei luoghi; condizioni tutte che determinarono lo spopolamento alpino; c) - DISTRUZIONE DELLA CULTURA LOCALE per la soppressione della lingua fondamentale locale, laddove esiste, la brutale e goffa trasformazione dei nomi e delle iscrizioni locali, la chiusura di scuole e di istituti locali autonomi, patrimonio culturale che è anche una ricchezza ai fini dell’emigrazione temporanea all’estero; AFFERMANDO a) - che la libertà di lingua come quella di culto è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità umana; b) - che il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie di questo diritto individuale e collettivo e rappresenta la soluzione del problema delle piccole nazionalità e la definitiva liquidazione del fenomeno storico degli irredentismi, garantendo nel futuro assetto europeo l’avvento di una pace stabile e duratura; c) - che un regime federale repubblicano a base regionale e cantonale è l’unica garanzia contro un ritorno della dittatura, la quale trovò nello stato monarchico accentrato italiano lo strumento già pronto per il proprio predominio sul paese; fedeli allo spirito migliore del Risorgimento DICHIARIAMO quanto segue: a) - AUTONOMIE POLITICHE AMMINISTRATIVE 1 - Nel quadro generale del prossimo stato italiano che economicamente ed amministrativamente auspichiamo sia organizzato con criteri federalistici, alle valli alpine dovrà essere riconosciuto il diritto di costituirsi in comunità politico-amministrative sul tipo cantonale; 2 - come tali ad esse dovrà comunque essere assicurato, quale che sia la loro entità numerica, almeno un posto nelle assemblee legislative regionali e nazionali; 22 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 mantiene una sua forte attualità e costituisce un momento di testimonianza e condanna per un’occasione che la neonata repubblica italiana ha saputo soltanto perdere o snaturare. Parliamo di questo con uno dei protagonisti di allora, Gustavo Malan, nella sua casa di Torre Pellice. L’idea era di condurre un’intervista, ma, alla prima domanda, l’anziano professore si impadronisce del discorso con la forza e l’autorevolezza di chi sa di poter guardare ad un passato di uomo libero. Lasciamolo, dunque, parlare... “A Chivasso eravamo in sei: due di Torre Pel- lice, Osvaldo Coisson ed io, due da Milano, Mario Alberto Rollier e Giorgio Peyronel, due da Aosta, Emile Chanoux ed Ernest Page. La località era stata scelta perché comoda per il treno. Fummo ospitati dal geometra Pons, parente della moglie di Peyronel. Eravamo d’accordo che, se fossimo stati fermati, avremmo accampato la scusa di un atto notarile. Era assente Federico Chabod, che pure era stato fra i promotori dell’ incontro, per via della sua scelta fondamentalmente troppo italiana che lo aveva messo in dissenso con Chanuox. Anche Binel, di Aosta, da poco uscito di prigione, non era potuto venire. 3 - l’esercizio delle funzioni politiche ed amministrative locali (compresa quella giudiziaria) comunali e cantonali, dovrà essere affidato ad elementi originari del luogo o aventi ivi una residenza stabile di un determinato numero di anni che verrà fissato dalle assemblee locali. b) - AUTONOMIE CULTURALI E SCOLASTICHE Per la loro posizione geografica di intermediarie tra diverse culture, per il rispetto delle loro tradizioni e della loro personalità etnica, e per i vantaggi derivanti dalla conoscenza di diverse lingue, nelle valli alpine deve essere pienamente rispettata e garantita una particolare autonomia culturale linguistica consistente nel: 1 - diritto di usare la lingua locale, là dove esiste, accanto a quella italiana in tutti gli atti pubblici e nella stampa locale; 2 - diritto all’insegnamento della lingua locale nelle scuole di ogni ordine e grado con le necessarie garanzie nei concorsi perché gli insegnanti risultino idonei a tale insegnamento. L’insegnamento in genere sarà sottoposto al controllo o alla direzione di un consiglio locale; 3 - ripristino immediato di tutti i nomi locali. c) - AUTONOMIE ECONOMICHE Per facilitare lo sviluppo dell’economia montana e conseguentemente combattere lo spopolamento delle vallate alpine, sono necessari: 1 - un comprensivo sistema di tassazione delle industrie che si trovano nei cantoni alpini (idroelettriche, minerarie, turistiche, di trasformazione, ecc.) in modo che una parte dei loro utili torni alle vallate alpine, e ciò indipendentemente dal fatto che tali industrie siano o meno collettivizzate; 2 - un sistema di equa riduzione dei tributi, variabile da zona a zona, a seconda della ricchezza del terreno e della prevalenza di agricoltura, foreste o pastorizia; 3 - una razionale e sostanziale riforma agraria comprendente: a) l’unificazione per il buon rendimento dell’azienda, mediante scambi e compensi di terreni e una legislazione adeguata della proprietà famigliare agraria oggi troppo frammentaria; b) l’assistenza tecnico-agricola esercitata da elementi residenti sul luogo ed aventi ad esempio delle mansioni di insegnamento nelle scuole locali di cui alcune potranno avere carattere agrario; c) il potenziamento da parte delle autorità locali della vita economica mediante libere cooperative di produzione e consumo; 4 - il potenziamento dell’industria e dell’artigianato, affidando all’amministrazione regionale cantonale, anche in caso di organizzazione collettivistica, il controllo e l’amministrazione delle aziende aventi carattere locale; 5 - la dipendenza dall’amministrazione locale delle opere pubbliche a carattere locale e il controllo di tutti i servizi e concessioni aventi carattere pubblico. Questi principî noi rappresentanti delle Valli Alpine vogliamo vedere affermati da parte del nuovo stato italiano così come vogliamo che siano affermati anche nei confronti di quegli italiani che sono e potrebbero venir a trovarsi sotto il dominio politico straniero. Chivasso, 19 dicembre 1943. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 23 Tutti noi, tranne Page, poi diventato senatore democristiano, facevamo capo al Partito d’Azione che, comunque, non era direttamente interessato all’iniziativa. Insisto nel richiamare il Partito d’Azione perché era quello che, allora, sosteneva un programma autenticamente federalista, inserito in ambito europeo, dove i problemi delle autonomie avrebbero trovato spazio e respiro. Noi eravamo ben coscienti di rappresentare i Valdostani e i residenti della Valli Valdesi: due componenti delle Alpi Occidentali di cultura e lingua franco provenzale ed occitana, anche se, allora, il tema dell’Occitania non era messo in particolare rilievo. Pur con questa premessa, intendevamo indicare una strada che avrebbe potuto essere percorsa anche da altri popoli alpini e sarebbe stata un’indicazione per tutta l’Italia. All’ inizio della riunione fu letta una lettera di Chabod, ascoltata in educato silenzio dai Valdostani che, come detto, non condividevano le posizioni dello storico. Emile Chanoux, che mi era vicino, espresse il suo desiderio: la “République des Alpes” che non guardava alle frontiere attuali. Io concordavo con lui... Si partì da un documento preparato da Rollier che, insieme con Chanoux, fu il protagonista della giornata. La stesura finale, come ovvio, fu il risultato di qualche compromesso ma, nella discussione, non si registrarono reali divergenze. Oggi, a distanza di più di cinquant’anni, qualcosa della carta andrebbe rivisto e riformulato, anche se il senso delle rivendicazioni che contiene è ancora, e più che mai, attuale. Io fui incaricato della stampa del testo in Italiano - ne esiste una copia in Francese - e mi rivolsi alla Tipografia Alpina di Torre Pellice che, sebbene situata di fronte al comando nemico e perquisita per ben undici volte, non cessò di pubblicare, durante tutta la Resistenza, gran parte degli scritti del Partito d’Azione. 24 - Quaderni Padani Formalmente, la Dichiarazione dei Rappresentanti delle Popolazioni Alpine è all’origine dell’autonomia valdostana. Non ebbe effetto nella Valli Valdesi perché osteggiata dalla chiesa ufficiale, nelle persone, soprattutto, del Moderatore Sommani e del suo vice Nisbet che temevano che i Valdesi fossero ritenuti poco italiani e che questo danneggiasse il lavoro di evangelizzazione. L’unico a non condividere queste argomentazioni fu Erik Rollier, anche lui membro della dirigenza della chiesa, che manifestò il suo dissenso con una lettera poi pubblicata su “Nouvel Temps”. Alla Costituente, per merito di Tristano Codignola, deputato di Firenze, la Carta fu presente, insieme con altro materiale preparato dal citato Rollier e da mio fratello Roberto Malan, e contribuì ad ispirare l’articolo 6 (La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche). Qualcuno, oggi, dice, non si sa con quanto fondamento, che abbia contribuito anche al nascere delle Comunità montane e dell’ordinamento regionale italiano.” Con questo ha termine l’intervista a Gustavo Malan. Al momento di salutarlo gli chiedo ancora qualcosa della sua vita. Mi dice di essere stato, nella Resistenza, vice Commissario di guerra del secondo raggruppamento Giustizia e Libertà del Piemonte. In seguito ha fondato ed animato l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino. Fra i suoi allievi un uomo destinato a contare molto nella lunga lotta per la libertà, Marco Formentini. Non è mia intenzione chiudere con un commento. Mi limiterò ad osservare come l’Italia della ricostruzione non abbia capito nulla delle generose proposte che le venivano dai suoi uomini migliori. Forse, la mala bestia fascista non era del tutto scomparsa con la Liberazione. Forse, qualcuno, allora, si illudeva che bastasse cambiare qualche nome per lasciare tutto com’era... Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Venti di secessione nella Milano di fine ‘800 di Candida Terracciano “C’è una moltitudine di gente, la quale sente, senza dirlo in forma solenne, che la incredibile baraonda avente nome governo d’Italia, mostro accentratore e distruggitore, confusionario e parassita non finirà mai se non quando il regime del paese sia conforme alla storia, all’indole delle diverse regioni, all’interesse esclusivo del popolo e al senso comune” “- Stato di Milano - vuol dire la Lombardia governata dai lombardi, senza che nelle cose loro, non aventi relazione con ciò che concerne l’amministrazione generale dello Stato (armi, poste, dogane ecc.), altri abbia il diritto di mettere il naso. E quel che vuol dire: - Stato di Milano - vuol dire - Stato di Piemonte, di Venezia, di Toscana, di Roma, ecc. - Stato di Milano - vuol dire amministrazione e finanza casalinga, fatta da gente che conosce il paese” “Lo Stato di Milano con meno impiegati, meno militari, meno parassiti, meno ladri dello Stato d’Italia” (dall’Italia del Popolo, 16-17 Febbraio 1895). Questa citazione è tratta da “Crispi e lo Stato di Milano” (Milano, Giuffrè 1972), lo studio storico che il prof. Fausto Fonzi scrisse nel 1965 indagando magistralmente, con una minuta e precisa analisi, tre anni di vita politica milanese, dal 1894 al 1896. Ed è sempre da questo volume che trarrò gran parte delle notizie che seguono. Percorrere le pagine scritte dal prof. Fonzi, per chi crede nei valori del federalismo e della libertà, è un po’ come scoprire le nostre radici più vicine nel tempo, ma le più lontane dalla nostra conoscenza. È come se per noi padani, da quella fine secolo, fossero trascorsi cent’anni di solitudine. Ed in mezzo ci stanno la monarchia socialista del Giolitti “ministro della malavita”, il Fascismo tra due guerre sciagurate ed infine clericali e comunisti tra scomuniche e compromessi. Tutto quello che poteva mistificaAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 re e cancellare la memoria di un passato non lontano è avvenuto. Per questo è emozionante scoprire che fino all’inizio di questo secolo, per i primi quarant’anni di storia unitaria, lo spirito di Carlo Cattaneo, perchè di questo si tratta, non aveva cessato di vivere nella mente e nel cuore di molti Lombardi. Fino ad esplodere in modo sconvolgente nel 1895 e nell’anno seguente contro Francesco Crispi “cotesto cinico cafone siciliano, specchio di tutte le abiezioni e di tutte le corruttele, che ha per sè tutto quanto il Mezzodì, tutta quanta la Vandea italiana” (F. Turati in Critica Sociale, 16 gennaio 1895). Cercherò di spiegare con le parole di Giuseppe Colombo, fondatore della Edison e del Politecnico, e con una pagina tratta dallo studio del prof. Fonzi i motivi di tanta avversità nei confronti del politico siciliano: “L’agricoltura, l’industria, il commercio sono oppressi dall’imposte più che in qualunque altro paese dell’Europa civile; non si potrebbe chieder loro di più senza pericolo. D’altra parte non si fa sosta nelle spese, per alimentare una politica fastosa all’estero e all’interno. Non potendo sopperirvi con nuove imposte, che la Camera non consentirebbe, si è inaugurata senza ritegno la politica dei debiti” (citato in “Federalismo e Autonomia” di C. Petraccone, Bari 1995). E qui, a completamento, ritengo conveniente riportare un pagina del prof. Fonzi che, con esemplare chiarezza, individua una serie di motivazioni che attraversano tutti gli schieramenti politici milanesi nella comune avversione nutrita nei confronti di Crispi: “La protesta di Colombo, che rappresentava gl’interessi della ricca e operosa nuova borghesia industriale, non rimaneva isolata, perchè le imposte soffocavano anche i piccoli proprietari e i commercianti e finivano per recar danno anche al proletariato, cosicché dai moderati alla Colombo ai radicali alla Mussi, agli operai e socialisti (desiderosi anch’essi dello sviluppo industriale), il grido ormai unanime dei milanesi era “Basta con le tasQuaderni Padani - 25 se!”. Né a questo portavano soltanto motivi economici (né certo soltanto il gretto egoismo municipalistico di chi lamentava i denari succhiati a Milano per beneficare Roma, Napoli o Palermo), perchè ci si rifiutava anche di sostenere con denaro lombardo una fastosa politica di prestigio, di pericolosa arroganza nei rapporti internazionali, di avventure coloniali dispendiose e ingiuste. “Dovevano forse i milanesi pagare perchè si accrescessero gli armamenti e si facesse guerra alla Francia? L’antifiscalismo milanese voleva pure ostacolare una politica estera che non soltanto era dannosa al commercio, ma sembrava indirizzata in senso contrario a quella Francia, cara, per i ricordi del secondo impero e della liberazione del ’59, a moderati come Negri o Visconti Venosta; cara agli ambienti radicali repubblicani e massonici per le stesse tradizioni rivoluzionarie di chi ricordava il pensiero di Cattaneo e Ferrari e aveva ancora fiducia nell’eroe delle barricate milanesi del ’48, nel banchiere, cittadino francese, Enrico Cernuschi; cara pure tanto ai cattolici più anziani, partecipi dei sentimenti del vecchio scrittore che moriva nella loro città, di Cesare Cantù, quanto ai cattolici più giovani, che già nella Francia vedevano attuarsi l’incontro fra valori cristiani e politica democratica. Né i milanesi volevano pagare le spese di conquiste africane, che apparivano moralmente e politicamente riprovevoli, economicamente improduttive. L’antifiscalismo era quindi alimentato dal pacifismo e dall’amore di libertà, ma pure da pregiudizi e da risentimenti che offrivano la base psicologica per l’affermazione di tendenze autonomistiche o dichiaratamente federaliste” (pagg. 351, 352). L’avversione per Crispi si trasformò, durante le campagne elettorali per le amministrative del febbraio e per le politiche del maggio ’95, in aperta e violentissima polemica nei confronti del governo centralista romano e dei politici meridionali . E non bastano certo le concitate parole del radicale milanese Cavallotti al radicale napoletano Bovio “non ci è lo Stato di Milano (...) ma ovunque e sola l’Italia unita da vincoli indissolubili” a far dimenticare le astiose polemiche fra le due Italie, che avevano già messo a nudo scottanti questioni; che avevano dato pubblicità e rilievo ad antichi risentimenti e municipalistiche passioni dalle conversazioni familiari e dai privati carteggi ora dilaganti sulle colonne della stampa quotidiana” (Fonzi, pag. 356) 26 - Quaderni Padani Soprattutto dalle pagine de L’Italia del Popolo, il quotidiano diretto da Dario Papa, espressione dei neorepubblicani federalisti tanto lodati da Salvemini, partirono poderose bordate alle quali rispondevano con virulenza da Roma e da Napoli giornali come La Riforma ed Il Mattino. Nel clima arroventato del momento non andarono immuni da pesanti sarcasmi anche fatti privati come le nozze della figlia di Crispi . E nei mesi seguenti le elezioni la polemica divampò nuovamente violentissima anche sui festeggiamenti per il venticinquennale della presa di Roma, contrapponendo repubblicani federalisti contro repubblicani mazziniani. E poi sulle mire espansionistiche in Africa contrapponendo in questo caso i leaders socialiti Turati e Labriola. Ed infine sulla mancata riforma del catasto dei terreni che provocava sperequazioni tra Nord e Sud, a vantaggio di chi non è difficile immaginare. Fin troppo facile accostare in certi casi fatti recenti quale i criteri di finanziamento per il giubileo, l’evasione dell’Ici eccetera. Evito di proposito di riportare citazioni di quelle polemiche, spesso esilaranti per il lettore, poiché questo articolo vuole essere soprattutto uno stimolo a leggere direttamente e per intero il testo del prof. Fonzi. La battaglia tra Milano e Crispi si risolse in una sconfitta del Dittatore siciliano: con l’aiuto dei cattolici transigenti Crispi ebbe la meglio nelle elezioni amministrative di febbraio; quando però alle politiche di maggio tale aiuto venne meno, egli subì una disastrosa sconfitta e la “Lega della Libertà” ottenne a Milano 5 seggi su sei. Le elezioni di maggio misero inoltre in luce che gran parte della Padania (fatta eccezione per la Liguria) era contraria alla politica di Crispi, segnando così una prima profonda spaccatura nell’unità politica della penisola. Ma l’umiliazione più cocente Crispi la subì dai milanesi all’indomani della sconfitta africana di Abba Garima, che aveva provocato la morte di quattromila soldati italiani e di un numero imprecisato di abissini. Il 3 marzo ’96 le notizie della sanguinosa sconfitta provocarono manifestazioni in molte città, ma soprattutto a Milano dove “la folla si è portata davanti al municipio, e il sindaco Vigoni inizia un discorso con le parole: Mai come oggi io mi sento legato a voi, ma non riesce a proseguire. È il repubblicano Taroni che comunica ai dimostranti che il sindaco trasmetterà a Roma i desiderata di tutti i milanesi: cioè la fine della Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 guerra in Africa e le dimissioni del governo” (Fonzi, pag. 519). Il 5 marzo Crispi annunciò le sue dimissioni. Mi avvio verso la conclusione dell’articolo e a questo punto sono d’obbligo alcune considerazioni. Il lettore si chiederà sicuramente: ma di tanto agitarsi dei milanesi per la propria autonomia che ne fu? Innanzitutto dobbiamo dire che Dario Papa, eroe positivo di tutta la vicenda, uno dei principali attori di quella stagione, inizialmente monarchico e garibaldino, convertito al republicanesimo da Alberto Mario - il discepolo di Cattaneo - e da una permanenza di due anni nell’America del Nord, morì pochi mesi dopo gli avvenimenti di cui trattiamo. Si potrebbe tuttavia dire che questo è solo un fatto personale, anche se ci spinge a pensare che sono prorio i migliori ad andarsene presto. Rimangono invece da fare considerazioni politiche di carattere generale. E quindi cedo ancora una volta la parola al prof. Fonzi poiché le sue osservazioni sono così limpide che il tentare di parafrasarle o riassumerle sarebbe sciocca presunzione. “Milano ha vinto, ma non è certo sconfitta l’Italia, perchè l’opposizione lombarda era sostanzialmente diretta solo contro la politica interna ed estera del ministero Crispi. E dopo la caduta di questo perdono vigore anche le tendenze regionaliste, che nel 1895 sembravano dominanti nell’opinione pubblica e nella classe poitica milanese (...). “Si è scritto che a Milano, come in tutta l’Italia i moderati e i ceti conservatori furono dapprima trascinati dalla Estrema Sinistra nella campagna per le autonomie regionali e si ritrassero in un secondo momento, perchè spaventati dai successi elettorali dei socialisti, indebolendo così sensibilmente il fronte autonomistico (...). “Credo piuttosto che in Lombardia (...) perse mordente l’aspirazione allo Stato di Milano principalmente perchè la sconfitta di Crispi apriva la via ad una più larga affluenza dei lombardi nella vita dello stato Italiano. La polemica ultramilanese aveva infatti tratto alimento dalla volontà di affermazione politica della Lombardia e del suo capoluogo, che si sentiva sacrificato dall’indirizzo meridionalistico a ragione o a torto attribuito al governo Crispi. Perchè ora i milanesi avrebbero dovuto insistere nella richiesta dell’ordinamento regionale, se quell’affermazione era possibile in ben più larga misura con l’esercizio di una diretta influenza sull’opera del governo centrale sottratto alla “banda Crispina” Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 ed efficacemente controllato dalle forze politiche della Lombardia e del Piemonte? Nella nuova situazione politica non riacquistavano validità e forza gli argomenti che avevano giustificato dopo l’unità la “dittatura temporanea” piemontese lombarda? Se il duello tra Milano e Crispi si era concluso con la vittoria del Nord laborioso, pacifico e liberale, non si apriva la possibilità di utilizzare ancora il regime accentrato per favorire un’opera di progresso economico e civile, destinata certo a produrre benefici per l’intera nazione?” (Fonzi pagg. XXIII, XXIV). Val la pena di riportare anche una nota a pie’ di pagina riferita a queste ultime considerazioni del prof. Fonzi: “La rinuncia ad un’azione ‘liberatrice’ e la conquista invece di una posizione ‘dominatrice’ da parte dei milanesi dovevano deludere quei meridionali, come Colajanni, Salvemini o Ciccotti che da Milano avevano atteso con fiducia il riscatto dell’intera penisola ed in particolare del Mezzogiorno”. Anche in questo caso non mancherà al lettore la possibilità di fare considerazioni forse amare sulla più recente storia dello stato italiano e sul comportamento politico dei popoli della Padania. Il prof. Fonzi, partecipando vent’anni fa ad un seminario presso l’Università Statale di Milano, ebbe modo di tenere una relazione poi pubblicata nel volume Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea. Dopo aver recensito alcuni studi riguardanti la crisi di fine secolo a Milano, apparsi successivamente al suo, ebbe a concludere con parole che oggi più che mai dobbiamo far nostre; e non me ne voglia il lettore se chiudo con un’ultima citazione, ma, lo ribadisco per chiarezza, questo articolo ha la pretesa di essere soltanto una modesta e spero almeno in parte riuscita recensione di un libro che merita di essere letto, studiato e diffuso: “Quindi per concludere, vorrei osservare che molto lavoro è stato fatto, ma dell’altro lavoro attende soprattutto i ricercatori lombardi e milanesi quali voi siete, per le necessarie indagini su alcuni piani dello sviluppo storico finora trascurati, eppure indispensabili non soltanto per meglio comprendere il quadro generale nazionale del “decennio di sangue” (che sempre più appare non solo come la tragica conclusione dell’Ottocento, ma pure come fecondo laboratorio di progresso per il nostro secolo), bensì anche per capire veramente il significato della successiva storia di Milano e dell’intera Italia. Auguri dunque per il lavoro che compirete”. Quaderni Padani - 27 La Padania e i nuovi Paesi dell’Est (2) L’emergere della Slovenia di Alessandro Vitale A ncora recentemente la questione della Slovenia e delle relazioni da tenere con questa comunità politica che non da molto ha conquistato l’indipendenza è tornata alla ribalta. Ogni volta che ai suoi confini c’è una manifestazione governativa, ogni volta che viene sventolato il tricolore a Trieste da parte delle minoranze cacciate ed espropriate nel Paese slavo meridionale dopo il Secondo conflitto mondiale, si torna a parlare della Slovenia (e in Slovenia si trema), sebbene spesso a sproposito. Eppure, i rapporti con questo Paese, che ha dimostrato una straordinaria dignità ed un’ammirabile compostezza nel processo di liberazione dalla falsa “federazione” jugoslava a predominanza serba, devono per forza essere visti con la lente del nazionalismo ottocentesco italico, che ha portato a stragi di massa durante tutto questo secolo, come mai se ne erano viste prima nella storia? L’ottica padana, in base alla quale possono essere interpretati i necessari rapporti da tenere con questo piccolo ma attivo Paese, in realtà stravolge in pieno la mitologia nazionalista, con tutte le sue gravi e distruttive ricadute revansciste, annullandone anche il potenziale conflittuale, che va a tutto svantaggio sia economico che politico di un’area come quella padana e che non corrisponde minimamente ai bisogni e alle aspirazioni delle popolazioni sia padano-alpine che slovena. Slovenia e Padania: un rapporto naturale Quanto si era sottolineato in merito ai rapporti fra Croazia e Padania(1) vale ancor più e a maggior ragione per i rapporti che possono svilupparsi fra Padania e Slovenia. Innanzitutto anche la Slovenia, come la Croazia e oggi la Padania, ha presentato fin dai primi momenti dell’Indipendenza, l’esigenza di rimanere saldamente ancorata all’Europa, esprimendo la potenzialità di riequilibrio e di spostamento del baricentro europeo più a Sud, in un’Europa che diventa sempre più “nordica” e che taglia fuori aree a grande potenziale di sviluppo come quella padana (strangolata dalla zavorra di uno Stato na28 - Quaderni Padani zionale corrotto e inefficiente, che ne succhia come una sanguisuga le risorse e la soffoca sotto una cappa grigia di ipertrofia legislativa e di voracità fiscale) o quella dei Paesi di nuova indipendenza che registrano oggi una notevole ripresa in termini di sviluppo, come quella slovena. Entrare in Europa per la Slovenia significa completare la fuoriuscita dalla balcanizzazione forzata dello yugoslavismo serbocentrico. Anche un bambino si accorge subito che per sua natura la Slovenia si pone come interlocutrice “naturale” di un’area a tassi di sviluppo omogeneo come quella padana e che quest’ultima è diventata un punto di riferimento imprescindibile per la Slovenia, con la quale non può che avere interessi convergenti. La Padania dal canto suo necessita della massima apertura verso l’esterno, superando quanto più possibile le chiusure statali e protezioniste che si sono ormai fuse con il protezionismo europeo, responsabile del “blocco continetale” che ha tendenzialmente chiuso le porte ai Paesi dell’Est liberati dalla cappa soffocante del nazionalismo socialista e del blocco politico-militare ex sovietico. Si può parlare dunque di “complementarietà naturale” fra Padania e Slovenia. In questo quadro stride fortemente la vergognosa ostinazione con la quale per lungo tempo gli apparati dello Stato italiano hanno cercato di escludere la Slovenia dall’adesione alla UE: una chiusura che significa innazitutto blocco delle politiche liberoscambiste e di libera circolazione di beni, capitali e uomini, che Paesi recentemente liberati come la Slovenia sono portati ad adottare. La Slovenia è al primo posto attualmente fra i Paesi dell’Est europeo per prospettive di sviluppo economico e sociale.(2) La sua apertura verso l’esterno, necessaria per sfuggire all’autarchia, troppo costosa in seguito alla riduzione del mercato (1) Si veda “Quaderni Padani” 9 (gennaio-febbraio 1997). (2) “Economist” (March 25-31, 1995). Si veda anche World Bank Global Economic Prospects and the Developing Countries 1995. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 interno seguita alla secessione, è orientata naturalmente sia verso l’area germanica che verso quella padana. Gli interessi convergenti in termini economici corrispondono ad un’interdipendenza economica reale, spontanea e non fittizia, com’è quella inter-governativa e diretta dagli Stati nazionali. Questa interdipendenza reale però continua a scontrarsi con gli ostacoli nazionalistici, che interferiscono pesantemente con l’interazione libera e negli accordi fra aree compatibili. Come non mai oggi sono possibili legami diretti fra la Padania e la Slovenia, partendo dalle esigenze reali della collaborazione e superando, anche da parte slovena, la sciagura dell’intendere la cooperazione solo fra Stati nazionali e in via inter-governativa. La tentazione di interagire solo con Roma rimane certo forte oggi per un Paese che ha guadagnato uno status sovrano riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia il potenziamento dello scambio di informazioni e di esperienze, necessario sia per la Padania che per la Slovenia, finisce per incagliarsi nelle secche di contenziosi nazionalistici ancora aperti, ma che in realtà non sono risolvibili con quei metodi. Solo una collaborazione a trecentosessanta gradi e a tutti i livelli, in un ambito nel quale la Slovenia fosse integrata nel sistema regionale europeo-meridionale del quale la Padania finirà per assumere il ruolo trainante, potrebbe porre fine a dispute inconcludenti e figlie del nazionalismo ottocentesco, del quale sono una grave eredità. Naturalmente il caso di Trieste è una questione a parte. Tuttavia il revanscismo nazionalista, frutto avvelenato di pur sacrosante rivendicazioni, utilizza metodi rivendicativi vecchi d’un secolo, del tutto inconcludenti, a tutto vantaggio delle classi politiche romanocentriche e interferisce con le potenzialità che Padania e Slovenia insieme sarebbero oggi ormai in grado di sviluppare. Soltanto il rifiuto dell’estrema nazionalizzazione dei problemi ancora aperti a causa dello spostamento forzato delle popolazioni, uno degli “sport” prefetiti dal totalitarismo del XX secolo, (con gli strascichi di violenza inaudita a danno dei diritti individuali, che ha comportato), sarebbe in grado di superare l’impasse che paralizza l’integrazione e lo sviluppo di aree così complementari come quella padana e quella slovena. Padania rimangono estremamente gravi. Gli ostacoli frapposti alla libera circolazione dei beni e delle persone innanzitutto provoca elevati costi per lo sviluppo di un Paese in delicata fase di riforma, come la Slovenia.(3) La Slovenia oggi, data anche l’attenzione internazionale per il tema, è molto più attenta alla questione della protezione delle minoranze etniche. Dal punto di vista economico il processo di riforma della proprietà è già nella sua fase conclusiva. Le piccole e medie aziende sono tutte in mano privata e questo settore è fortemente emergente. Gli indicatori economici del Paese sono molto soddisfacenti. Basta pensare che il PIL pro capite in Slovenia, piccolo Paese con 2 milioni di abitanti collocati in un’area di poco più di 20.000 km2 è attualmente superiore a quello dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale e persino superiore a quello di due Paesi membri dell’Unione Europea. Se si guarda al tasso di crescita si constata un fatto qusi incredibile: il tasso sloveno è quasi del 5%, mentre negli Stati Uniti, anche a causa del proliferare dello statalismo nel corso dei decenni e della conseguente iper-regolamentazione, soffocante per lo sviluppo e il dinamismo economico, si aggira solo intorno al 2 - 2,5%. Il volume degli investimenti stranieri è in rapida crescita, anche perchè gli investitori stranieri hanno la possibilità di trasferire liberamente i loro profitti e di reimpatriare altrettanto liberamente i capitali investiti nel Paese. Il trend macroeconomico è favorevole: il tasso di inflazione annua è basso, a fronte dell’alto tasso di crescita. Già nel 1995 il tallero sloveno è divenuto convertibile all’estero. La struttura del commercio estero è già moderna: inoltre la Slovenia è in grado di esportare il 60% del suo PIL. Il suo mercato è internazionalmente competitivo. Questa imponente trasformazione economica, non va dimenticato, è avvenuta parallelamente al processo di conquista dell’Indipendenza. Nonostante le difficoltà iniziali la Slovenia ha recuperato terreno con una grande rapidità. La capacità di adattamento, l’ingegnosità della gente, le nuove opportunità per l’iniziativa privata hanno deteminato la stabilizzazione e rimesso in piedi l’economia.(4) La Slovenia è parte integrante dell’Europa cen- Scelte padane e fioritura slovena Gli ostacoli che le politiche statali e nazionalistiche continuano a porre al libero sviluppo delle potenzialità slovene e della collaborazione con la (3) Perchè questo avvenga è ben spiegato in Nijkamp P. Preface to Ratti R., Reichman S. (Ed) Theory and Practice of Transborder Cooperation Basel, Frankfurt a. M. 1993. (4) Dichiarazioni recenti di Janez Kocijanic, Presidente della socialdemocrazia slovena. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 29 trale e non di quella balcanica, ma continua ad essere un crocevia di interazioni economiche e politiche, di influenze di varie civiltà e punto d’incontro di molte correnti economiche e culturali che animano l’Europa intera. Tuttavia la logica della cooperazione transfrontaliera con le regioni padano-alpine è stata ostacolata a più riprese (come nell’esperienza dell’Alpe Adria, partita nel 1976) in particolare da Roma e dal suo dirigismo nazionalista fortemente penalizzante, che ha provocato serie ricadute in termini di risultati oggettivi. Eppure quella logica ha ottenuto oggi un impulso formidabile dalla caduta della contrapposizione fra blocchi in Europa. L’aspetto più interessante del regionalismo contemporaneo è rappresentato sempre più dalle “regioni transfrontaliere”, cioè da quegli ambiti regionali che pur essendo attraversati da confini internazionali scoprono di possedere caratterisitche comuni spesso più forti del vincolo nazionale, soprattutto in campo economico, ma anche ambientale e culturale. Le regioni transfrontaliere, osteggiate generalmente dagli Stati nazionali hanno già accumulato in Europa un’esperienza consistente. Alle regioni transfrontaliere si oppongono però ancora ostacoli di ordine giuridico (regole giuridiche restrittive, istituzioni cooperative private di personalità giuridica, dichiarazioni di intenti come unico metodo di lavoro attualmente possibile), istituzionale (centralizzazione degli Stati nazionali, i quali considerano di competenza esclusiva le relazioni esterne; il fatto che le istituzioni cooperative sono investite di funzioni puramente consultive; la mancanza di strutture idonee per gestire i rapporti transfrontalieri), politico (reticenza dei governi nazionali, assenza di volontà politica nello spazio transfrontaliero), economico (obbligo di passare dallo Stato nazionale per il trasferimento di fondi, problemi generati dal cambio monetario), socio-economico (differenti livelli di sviluppo) e culturale (esistenza di stereotipi nazionali negativi; differenza linguistica). Tuttavia oggi pensare in termini di grandi regioni economiche a sviluppo convergente è diventato più possibile che mai. Le scelte padane, una volta constatate le potenzialità slovene e della collaborazione con un Paese che grazie all’Indipendenza ha potuto fare passi da gigante, non possono più essere soggette alla vecchia logica dello Stato nazionale, divenuto un fardello paralizzante ed eccessivo, e alle sue pretese dirigiste. Ormai il confronto e il conflitto possono essere trasformati in cooperazione e integrazione: gli in30 - Quaderni Padani teressi padani e quelli sloveni vanno solo in questa direzione.(5) Ostacoli italiani alla cooperazione-integrazione fra Padania e Slovenia. I rapporti bilaterali fra Italia e Slovenia, nonostante le dichiarazioni d’intenti governative, rimangono con tutta evidenza in una fase di stallo. Non solo, ma l’Italia è stata, com’è noto, il principale ostacolo per la Slovenia sulla strada per l’adesione alla UE. La contradditorietà, la schizofrenia italiana alimenta le paure slovene di veder risorgere un nazionalismo unitarista molto radicato com’è quello italiano, che non solo è servito da modello all’unificazionismo serbo a partire dal XIX secolo (la Serbia, cosa che si dimentica spesso e volentieri, ha sempre aspirato a diventare “il Piemonte dei Balcani”, che unificasse la Penisola balcanica come in Italia aveva fatto il Piemonte: i risultati si sono visti nella ex Yugoslavia), ma che, incontrollabile com’è per le sue caratteristiche centralizzate, è una costante minaccia per i Paesi limitrofi, soprattutto se ancora legati a contenziosi storicamente mal risolti. Gli ostacoli italiani all’integrazione slovena hanno finito per innescare un grave processo di ghettizzazione nell’Est europeo di un Paese come questo, che ha firmato accordi di libero scambio fino ad oggi solo con i Paesi del Gruppo di Vyshegrad e con i Paesi Baltici. Certo, la sola integrazione nell’Unione Europea non sarebbe sufficiente a soddisfare in pieno le potenzialità della crescita attuale slovena. La UE è composta sempre più da un cartello di Stati nazionali che mantengono intatte tutte le loro antistoriche frontiere e gran parte dei loro protezionismi interni ed esterni. In questo ambito non si affermano nuovi rapporti qualitativi fra regioni europee a sviluppo compatibile. Tuttavia già questo passo sarebbe importante. Invece della libertà e del mercato, delle pari opportunità e dello sviluppo, della cooperazione e dell’integrazione, della tolleranza e della convivenza, della considerazione per le diverse culture dei popoli, delle identità reigionali, (5) Come ha scritto Milan Kucan, Presidente della Slovenia: «I processi di integrazione si snodano attraverso le frontiere degli Stati e nè uno splendido isolamento autogratificante, nè un’esclusione forzata sono più possibili all’interno dell’Europa. Dipendiamo l’uno dall’altro e dal dialogo in comune. La Slovenia non si è incamminata lungo l’impegnativa strada dell’indipendenza per isolarsi nell’autarchia, bensì nella determinazione di garantire la propria esistenza, sicurezza e sviluppo all’interno di un’Europa libera da muri e divisioni». Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 nell’ottica nazionalista continua a prevalere la rivalsa insensata e la retorica delle vittorie mutilate. L’ “interesse nazionale” se ne infischia del favorire relazioni che si affermano nelle cose e nel processo storico e preferisce il muro contro muro, distruttore di risorse e di potenzialità, nonostante tutti gli “ammorbidimenti” e i “giri di valzer” del gioco diplomatico. Come fa la Slovenia (che pure dovrebbe al più presto mettere mano alla delicata questione dei beni appartenenti a minoranze allogene, “abbandonati”, nazionalizzati o sequestrati), ad essere d’accordo con una politica che persegua vantaggi di parte e che faccia risorgere i fantasmi del passato e la disuguaglianza e/o la mancanza di reciprocità internazionale, con il pretesto di rettificare “ingiustizie storiche”? E di esempi di mancanza di reciprocità fra Italia e Paesi dell’Est europeo ce ne sono a bizzeffe.(6) Perfino le sollecitazioni in senso collaborativo con la Slovenia, manifestate nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Italiana, non sono state prese in considerazione.(7) Questo fatto dimostra in modo lampante che a Roma non sono tanto gli interessi degli “italiani” (padani) penalizzati a suo tempo in Slovenia a costituire una priorità, ma interessi nazionalistici di altro genere. Forse anche perchè venivano auspicati superamenti e maggiore permeabilità dei confini nazionali, autentico ostacolo per la collaborazione-integrazione regionale, che va di pari passo con la cultura della convivenza, l’identità multiculturale e lo sviluppo economico, vantaggioso per tutti, padani e sloveni. La realtà dei rapporti padano-sloveni oggi. Le popolazioni venete e friulane che vivono in Slovenia, ma anche in Istria, convivono pacificamente con le popolazioni istro-slovene o croate. Basta recarsi sul posto per averne una conferma. I matrimoni misti sono molto diffusi e soprattutto fra i giovani il bilinguismo è una realtà normale. Ragazzi e ragazze slovene lavorano in Padania e sposano volentieri giovani veneti e friulani. I residui dei rancori che hanno soffocato per decenni, prima e dopo il Secondo conflitto mondiale, questa ampia regione a sviluppo compatibile e complementare in Europa, non presentano residui significativi soprattutto fra le giovani generazioni. Quei rancori, quelle ostilità che hanno avvelenato tanti rapporti erano infatti il frutto avvelenato di due nazionalismi contrapposti e parimenti intolleranti: quello italiano, che ha comportato l’italianizzazione forzata degli slavi (8), Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 operata dal fascismo, i cui strascichi hanno continuato a manifestarsi per un lunghissimo periodo, e quello titoista-socialista yugoslavo, che ha violato sistematicamente i diritti individuali delle minoranze padane presenti in territori forzatamente yugoslavizzati. I giovani padani e quelli sloveni sempre più però sentono che questi ferrivecchi dello statalismo nazionalista ottocentesco e novecentesco, del totalitarismo che ha infangato e devastato l’Europa, stanno uscendo dalla storia. Essi non vogliono ereditare nulla degli odi fomentati dal nazionalismo fascista e comunista che ha dissanguato i decenni passati. La Padania che nasce e la nuova Slovenia non possono godere dei frutti della loro laboriosità e inventiva se fra le ruote si trovano i pali del nazionalismo statalista. I giovani padani si accorgono sempre più che la classe politica romana ha continuato a strumentalizzare i dolori patiti dai padani nella ex Yugolavia (dopo averli provocati con il suo imperialismo a partire dall’inizio del secolo), così come i ragazzi sloveni escono progressivamente dall’ottica del nazionalismo di stampo ottocentesco che con le sue spire cerca ancora di avvolgere perfino le nuove Indipendenze dell’Est europeo, area in cui tanti danni ha provocato fino ad oggi. E sentono in forma embrionale, quasi d’istinto, che una nuova Europa, la loro, costruita su basi totalmente diverse da quelle degli Stati nazionali aggressivi e tendenzialmente sempre totalitari, può essere costruita oggi sulle basi della cooperazione e dell’integrazione, senza l’aiuto o piuttosto la nefasta interferenza di vecchie generazioni incancrenite nei miti nazionalisti, funzionali solo ad una ristretta classe di politicanti e ad un esercito sterminato di burocrati, per mantenere i quali continuano a sopravvivere gli Stati nazionali. (6) Un esempio impressionante è quello dei visti concessi ad alcuni cittadini dei Paesi dell’Est. Si prenda, tanto per fare un esempio, il caso dei Paesi Baltici. La Lituania ha abolito nel gennaio del 1994 l’obbligo di visto per i cittadini italiani che vogliano recarsi sul suo territorio. Con totale assenza di reciprocità, fino ad oggi l’Italia continua a mantenere l’obbligo di visto per i cittadini lituani che vengano in Italia, nonostante si tratti di cittadini di cultura pienamente europea e addirittura a stragrande maggioranza cattolica. A fronte di questa situazione, per un accordo internazionale, per i cittadini dell’Uganda non c’è obbligo di visto! (7) Si può vedere a questo proposito l’articolo di Maurizio Tremul, Presidente dell’Unione Italiana, su “Acque & Terre” 3 (1995) pag. 10÷12. (8) Sulla italianizzazione degli sloveni si vedano le brillanti pagine di Sergio Salvi L’Italia non esiste. Camunia, Firenze 1996, pp. 177-206. Parimenti si vedano quelle relative alla reazione nazionalista e imperiale slava (pagg. 217÷224). Quaderni Padani - 31 Alba gu bra! di Flavio Grisolia C hi tra coloro e sono molti, che andati a vedere il film “Braveheart”, spinti dal fascino del personaggio, in lotta come noi per la liberazione del suo popolo, non ricordano l’urlo di guerra, al termine di un indimenticabile discorso, lanciato dall’eroe scozzese? “Alba gu bra!” Gridava Wallace-Mel Gibson in Gaelico, a cui facevano eco le schiere d’armati, pronte a lanciarsi nella mischia. Alba, l’antico nome della Scozia, precedente all’arrivo in quelle terre dei Gaeli d’Irlanda e dei Vichinghi di Norvegia. Nome quindi da riferirsi con ogni probabilità ai Pitti, così definiti per l’uso di dipingersi il volto in combattimento, popolo contro il quale si infransero vanamente le legioni romane e che Tacito nella “Vita di Giulio Agricola”, definisce anche Caledones, o Britanni, detti altrimenti Pritanni o Preteni. La citazione più antica in merito, ci viene però da Plinio, che attribuisce il termine Albion all’intera Gran Bretagna. La mia curiosità comunque su questo nome, non nasce col film, che in ogni caso mi facilita l’introduzione dell’argomento, bensì dal mio essere Ligure e Padano e quindi abbastanza aduso al termine Alba, che sul nostro territorio ha senz’altro dei rifermenti storici e toponomastici molto importanti. Gli scrittori dell’antichità ci riportano infatti diverse città liguri con tale nome, cominciando da Strabone che nomina Albingaunon (Albenga) e Albion Intemelion (Ventimiglia), definendole come gli insediamenti a mare (epoikiai) degli Ingauni e degli Intemeli, anche Plinio nomina le due città, sotto la forma però di Album Ingaunum e Albintimilium, quest’ultima alla stessa maniera di Tacito, mentre Mela ci fa pervenire Albingaunum per Albenga. Ancora Plinio riporta il nome di Alba Pompeia (Alba) e altre due città dell’antichità: Alba Heluorum, oggi Aps in Provenza e Alba, l’attuale Arjona in Spagna, hanno questo nome. La discordanza tra le desinenze, può forse essere giustificata dall’interpretazione greca di termini liguri non riproducibili foneticamente 32 - Quaderni Padani e dalla seguente latinizzazione direttamente dal Greco; è difficile infatti spiegare come possano i nomi etnici Ingauni e Intemeli, dare al genitivo Ingaunum e Intimilium, invece di Ingaunorum e Intemeliorum, come ad esempio riporta correttamente in un suo passo Livio. Tutto ciò ci spinge ad affermare, che ci troviamo di fronte a toponimi, sicuramente preromani, che traggono origine da una base *albo- o *albio- o *alba, senza che si possa approfondire maggiormente la sua forma originaria. L’alternanza tra Albion e Alba, vista in precedenza per indicare la Gran Bretagna e poi la Scozia, perfettamente identica a quella presente in Liguria, potrebbe però essere il tentativo di latinizzare il Ligure, riportando nella forma neutra della II decinazione, -um (nominativo singolare), -a (nominativo plurale), un originario *-ion, *-a, anche se non è affatto da escludere che gli scrittori latini, abbiano mediato tale nome direttamente dal Greco. Ancora su Alba, va ricordato che il primo re scozzese Kenneth I Mc Alpin (figlio di Alpin), incoronato nell’843, ha in ogni caso un nome derivante da Alba/Albion, così come già riporta Strabone, allorquando annota che Albion equivale ad Alpeion, da cui se ne deduce che anche le Alpi traggono da qui la loro denominazione. In termini linguistici si potrà dire che da una occlusiva sonora (b), si è passati ad una sorda (p), secondo una tendenza che è già manifestata nell’antichità dai Sabini, che dicevano “Alpum” per “Album”. Qualcosa di simile è riscontrabile nella parola “Pen”, presente nel Gallese col significato di capo, testa e nell’antico Ligure con una divinità, quella delle vette (monti Appennini, monte Penna, ecc.), con chiare similitudini quindi col termine gallese e con altrettanto evidenti relazioni con concetti di virilità e fertilità maschile e “Ben”, che in Scozia contraddistingue tutta una serie di monti, probabilmente sacralizzati dai Pitti/Caledoni. L’evidenza del collegamento, potrebbe venirci dal fatto che nel nord dell’Inghilterra esistono i monti Pennini, con un nome cioé, che non può Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 non rifarsi in qualche modo alla divinità ligure. La variante fonetica sarebbe perciò partita nell’Europa del sud-est, o comunque nella sua parte orientale, per diffondersi poi nell’area nordoccidentale, fermandosi però ai confini scozzesi, allo stesso modo delle legioni romane. Esiste quindi o se non altro è ipotizzabile un rapporto tra i Liguri dell’antichità e le contemporanee popolazioni della Gran Bretagna? Certamente sì, ma non su comunanze celtiche, come qualcuno potrebbe pensare. L’arrivo degli Scoti dall’Irlanda, popolazione parlante l’antico gaelico, lingua d’origine celtica, non può in ogni caso essere anteriore al V secolo e solo la loro vittoria sui Pitti/Caledoni e i Vichinghi delle Higlands, fece sì che trascorsi alcuni secoli, la loro lingua venisse parlata dalla totalità degli abitanti del regno. A conferma di ciò, restano le incisioni ogamiche, in una lingua non indoeuropea, che gli studiosi attribuiscono ai Pitti e che pare fu parlata nella Scozia orientale, almeno sino all’XI° secolo e forse oltre, per poi sparire, sostituita come detto dal Gaelico. A tal proposito sono di grande interesse, i lavori di due studiosi: Henri Guiter e Krutwig-Sagredo, che analizzando la trentina di frasi in ogamico, riferibili ai Pitti, tuttora rinvenute, ipotizzano un collegamento linguistico col Basco, sulla base di somiglianze che non possono certo essere casuali. Tutto ciò confermerebbe in sostanza, quanto nell’antichità scrisse Tacito, sempre nella “Vita di Giulio Agricola”, allorquando afferma che i Siluri di Britannia, provenivano dall’Iberia e d’altra parte sappiamo benissimo, che la stessa tradizione irlandese, narra di frequenti contatti con questa regione. Il rapporto con gli antichi Liguri è dato soprattutto dalla parola “Belaskuanuk”, che oltre a essere praticamente identica all’antico nome basco Belasko, cioè corvo, basato su una radice “bel”, che significa nero, scuro, mostra in maniera inconfondibile, il più noto dei suffissi liguri: -asco/a. In aggiunta a ciò, vi sono nomi propri, suffissi e temi verbali, che oltre che con l’antico Ligure, trovano riscontri in antiche lingue pre-latine e che con quest’ultimo, avevano diversi punti di contatto, come l’Etrusco e il Retico. Toponimi galiziani come Alba, Alban, Albeiros, completano il quadro, tantè che giustamente lo Schulten vede in essi un origine ligure e li associa all’Albion britannica, allo stesso modo di come Schmidt e Bosch Gimpera, conAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 siderano la penisola Iberica il centro d’irradiazione di un’antica cultura neolitica, che durante l’Età del Rame, raggiunse la Gran Bretagna, caratterizzandosi per la presenza del vaso campaniforme e di particolari pratiche religiose e che essi attribuiscono ai Liguri. D’altra parte una parentela tra Liguri, Baschi e le altre popolazioni della penisola Iberica, è gia indicata nell’antichità da Erodoto (circa 485 ÷ circa 425 a.C.) ed è stata poi ripresa nel secolo scorso da diversi studiosi, tra cui Luigi Schiapparelli (Le Stirpi Ibero-Liguri. Torino, 1880), si veda inoltre quanto riporta lo scrivente ne: “L’Origine delle Identità Padane”, su:” Quaderni Padani n. 10”. Ancora Henri Guiter, propone un affascinante parallelo tra il nome pittico Eneko, riportato dalle scritture ogamiche e formato con l’aggiunta del suffisso genitivo -ko sul nome Ene, il nome del capo dei Caledoni Angus, altrimenti scritto Aengus, Onegus, Enegus e il fondatore del regno di Navarra, anch’egli Angus. A rafforzare tali paralleli, vi è il fatto che il condottiero pitto e quello basco, affrontano la battaglia decisiva, rispetivamente contro gli Angli e contro i Castigliano-Asturiani, nello stesso giorno di S. Andrea. La leggenda inoltre narra che nell’819, prima dello scontro, nei pressi di Edimburgo, apparve nel cielo una croce di S.Andrea, a cui il capo caledone si era rivolto in preghiera la notte precedente: emblema che da allora campeggerà sulle loro insegne ed è tutt’oggi presente nella bandiera scozzese. Il riscontro attuale di Eneko sarebbe McInnes, cioè figlio di Innes, che in Gaelico si scrive Aonghais, rivelando quindi evidenti riscontri con Angus, molto più espliciti nella pronuncia attuale, pronuncia che all’epoca doveva probabilmente essere unica, tenendo inoltre presente che Pittico, Gaelico e Inglese, hanno grafie completamente diverse. Ancora per restare in tema, Krutwig-Sagredo, fa discendere il nome di uno dei più importanti clan scozzesi, se non il più importante, quello dei Campbell, nemico accerrimo degli Higlanders d’origine scandinava, da Gan-bel, che in Basco significa “Montagna Nera”, il che coincide col fatto che questo clan occupa i territori attorno a Black Mount, vale a dire la stessa cosa detta in Inglese. A questo proposito giova ricordare che clan in Etrusco significa figlio e che infatti i clan scozzesi, erano costituiti dai discendenti di un unico capostipite, non erano quindi altro che Quaderni Padani - 33 “Confraternite”, cioè quella che era l’espressione associativa socio-sacrale, che fin dai tempi più remoti, ha costituito l’ossatura principale delle comunità liguri e che in forme in parte alterate, è comunque giunta sino a noi, come appunto i clan scozzesi. È evidente che con ciò, si vuole affermare che questa parola, appartiene all’antico sostrato ligure e che risulta quindi un prestito di questa lingua all’Etrusco, così come tutti quei termini, che sono comuni a lingue apparentemente distanti tra loro, come il Leponzio, il Retico, il Venetico, il Gallico e lo stesso Etrusco, ma che potrebbero interessare anche lingue molto più lontane, come ad esempio il Lituano, l’Iberico, il Germanico e appunto il Pittico. Un’ulteriore esistenza di un’origine ligure delle antiche popolazioni della Gran Bretagna, ci viene dall’analisi dei nomi delle tribù ivi esistenti, ai tempi di Giulio Cesare, nomi come: Atrebates, Brigantes, Catavellauni, indicano un evidente origine ligure (vedi: Nino Lamboglia, La Liguria Antica. Milano: Garzanti, 1941 Emilio Sereni, Comunità Rurali nell’Italia Antica. Roma: “L’Erma” di Bretschneider, 1971 Flavio Grisolia, L’Origine delle Identità Padane. Milano: Quaderni Padani n. 10, 1997) e sono posizionabili temporalmente, tra dell’Età del Bronzo Finale e l’Età del Ferro, quindi collegabili con ogni probabilità ai flussi dei “Campi d’Urne”, che ebbero ancora una volta protagoniste popolazioni liguri e che interessarono l’attuale Inghilterra. Dei Siluri abbiamo già detto e il loro arrivo in Gran Bretagna, è forse anteriore alle tribù menzionate e ciò li avvicina a quelle del nord, con le quali avevano in comune l’abitudine di colorarsi il volto prima dei combattimenti. Sempre nell’area centro-meridionale, ricaviamo il nome di due città che ci riportano al mondo ligure, con Camulodunum, la cui radice *Camulo, è identica all’antico nome di Camogli (Camulo) e Segontium, la cui radice *Segos, è presente in numerosi toponimi ibero-liguri come: Segesta Tigulliorum (Sestri Levante), Segubia, Segosa, Segontia, Segesama, Segida, Segusium (Susa) e negli etnici dei Segobriges e dei Segovellauni. Nell’area dell’antica Caledonia, un possibile collegamento potrebbe esistere tra l’attuale Loch Tulla, situato nel territorio dei Campbell e l’antica tribù reto-ligure dei Tuliassi, localizzata nel Trentino. Non conosciamo il nome delle tribù pittiche, ma già il solo nome Caledones, riportato da Ta34 - Quaderni Padani cito e Plinio, potrebbe aprire spiragli interessanti, come sempre Krutwig-Sagredo ci propone, allorché avvicina questo nome al basco “Kara”, che indica colore, lo scambio l/r è comunissimo anche nel Ligure antico e moderno, così come l’incertezza tra a ed e, è una caratteristica delle popolazioni preindoeuropee ed è ampiamente documentata per Liguri, Iberi ed Etruschi. Resta comunque il fatto che letto come “Karadones”, il termine assume lo stesso identico significato di “Picti”, cioè dipinti, vale a dire la traduzione latina dell’originale nome di quelle popolazioni. Anche qui è possibile ritrovare un antico legame col mondo ligure, dato che ancora oggi nelle aree montuose della Padania occidentale: Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, la strega è chiamata “masca”, o “ bazora”, quest’ultimo termine derivante dal Latino “bassaris”, vale a dire baccante. Nel Ligure moderno inoltre “masca” vuol dire guancia, il che spiega ad esempio l’origine della parola maschera, il cui etimo è stato sino ad oggi incerto e che ritroviamo in forma originaria in “Maskara”, contrazione di “ MaskaKara”, vale a dire guancia/e colorata/e. Ora, poichè sappiamo che una delle caratteristiche delle baccanti, era quella di dipingersi il volto, appare chiaro che quest’ultimo termine, contratto in seguito ulteriormente in “Masca”, per il noto fenomeno, presente anch’esso nel Ligure moderno, della caduta dell’erre intervocalica, non può che appartenere all’antico Ligure, che come già notavo, nel più volte citato: “Le Origini delle Identità Padane”, doveva essere assai simile al Basco suo contemporaneo e a molte altre lingue dell’Occidente Europeo, che non a caso gli scrittori classici, consideravano interamente abitato dai Liguri. Un’ulteriore conferma di questa ipotesi, giunge dall’Irlanda, dove la presenza dei Pitti è ricordata dalla tradizione e dove ritroviamo un Loch Measca, che giustamente è stato tradotto in Inglese in Lough Mask, mentre l’originale riporta integralmente il classico suffisso ligure asca. Chi scrive inoltre, si è formato l’intima convinzione, che sicuramente non convincerà tutti, che il modo di dire “fai la cara”, che si insegna ai bimbi col gesto di accarezzare le guance, nella Padania occidentale, tragga in effetti la sua origine dall’antica parola ligure, derivando dal gesto dei valorosi guerrieri, di colorarsi appunto le guance, spalmandosi il colore con le mani; se infatti la parola derivasse dal latino Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 “carus” e non viceversa, sarebbe più logico dire lo, riportando un’opera del greco Posidonio, ci “fai caro” al maschile e non “cara”, che infatti informa. sta ad indicare l’atavico ricordo di un gesto di Per quanto concerne la presenza celtica in tutt’altro significato. A questo proposito giova Gran Bretagna, prima dei Gaeli, mi voglio rifarammentare, ancora ai tempi di Giulio Cesare, re a quanto scrive Barry Raftery, ne “I Celti. Mila presenza nell’attuale Poitou in Gallia, dei lano: Bompiani, 1991”, che fungeva anche da Pictones, che ricalcano perfettamente, latiniz- catalogo alla mostra di Palazzo Grassi a Venezandolo, ma conservandone integralmente il zia: “Non è affatto certo come e quando le isole senso, il Caledones/Karadones prima detto e della Gran Bretagna e dell’Irlanda siano divenche potrebbero rappresentare un residuo delle tate celtiche: in effetti è tutt’altro che chiaro popolazioni della Media Età del Bronzo, in una anche che cosa significhi esattamente il termiregione che Fiesto Avieno, nell’“Ora Marit- ne “celtico” nel contesto insulare.” E in seguitima”, definisce come originaria dei Liguri, che to: “Nel complesso però la cultura materiale poi a suo parere, giunsero oltre le sconosciute dell’Età del Ferro insulare, ha carattere essenisole Oestrymnicae, nell’Atlantico occidentale, zialmente locale, e nella documentazione ardove l’aria diventa gelida per il freddo, in una cheologica si distinguono poche importazioni terra, che dovettero abbandonare a causa delle identificabili. continue lotte contro i Celti, migrando verso È chiaro che il semplice modello dell’invasiosud. Ciò confermerebbe in sostanza, l’i- La battaglia di Culledon tra Inglesi e Scozzesi. Questa lotta fu paragonapotesi dell’espansio- ta a quella tra Celti e Romani, in particolare a quella che sedici secoli ne ligure durante i prima contrappose Vercingetorige a Boudicca “Campi d’Urne”, un cui flusso migratorio, sarebbe risalito dal Golfo di Biscaglia sino alla Britannia, dopo aver raggiunto l’antica Armorica (Bretagna e Normandia). Che i Liguri fossero in contatto con la Britannia sin dai tempi più antichi, è inoltre confermato da una “Via dello stagno” (il metallo che col rame da origine al bronzo), che dalla Cornovaglia, discendeva sino all’estuario della Gironda, nel già citato golfo di Biscaglia, per poi risalire la Garonna, pervenendo poi alla valle del Rodano (dove i Liguri sono attestati in epoca storica) e al Mediterraneo, attraverso la depressione di Carcassone; così come Diodoro SicuAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 35 ne non è da solo adeguato per spiegare il complesso mutamento culturale che, con una pluralità di aspetti, portò, nel corso dell’ultimo millennio a.C., a “celtizzare” le isole. È probabile, inoltre che l’elemento dominante nella composizione etnica della popolazione “celtica” dell’Età del Ferro, tanto in Gran Bretagna come in Irlanda, abbia le sue radici nell’Età del Bronzo indigena. Da cui: “Spade, foderi e altri oggetti in bronzo attribuibili alla cultura di Hallstatt C (circa VIII sec. a.C.), attestano che altre parti della Britannia, specialmente il sud-est, erano in stretto contatto con l’Europa di Hallstatt, ma l’assenza di sepolture e di insediamenti stranieri, sottolinea la natura insulare di questo orizzonte culturale in Gran Bretagna”. E sulla Scozia, durante il periodo di La Tène (III sec. a.C.): “La Scozia, specialmente sugli altipiani e sulle isole, si diversificò dalle aree della Gran Bretagna per le sue fortificazioni con massicci bastioni in pietra, spesso con strutture di sostegno in legno, e per lo sviluppo unico dei suoi impressionanti brochs, torri circolari in pietra con cortile interno e abitazioni. Le case, dove sono state riconosciute, erano in generale circolari, evidenziando radici culturali nella Tarda Età del Bronzo”. Come a dire che etnicamente parlando, il concetto di “celticità” è praticamente inesistente o perlomeno indimostrabile. Arrivati a questo punto, si rende neccessario fare un tentativo di sintesi, sicuramente non esaustivo delle problematiche messe in campo. Alcuni elementi, che ci riportano alla presenza di un antichissimo sostrato, probabilmente riferibile al Neolitico e al periodo del “Campaniforme” nell’Età del Rame, che sembra accomunare Liguri, Baschi e Caledones, pur nella differanziazione delle culture locali, possono oggettivamente essere accettati e intesi come nascita e sviluppo di una comune cultura europea, la cui origine è comunque legata agli apporti fondamentali dell’area definita della “Mezzaluna fertile” (Anatolia, Medio Oriente) e della Transcaucasia. In seguito coi “Campi d’urne”, a partire dalla Media Età del Bronzo, l’elemento ligure tende a differenziarsi maggiormente dall’iberico-basco, arrivando a coinvolgere le popolazioni della Britannia meridionale e probabilmente anche quelle della Caledonia e dell’Irlanda. In questa fase si gettano le basi per la nascita nell’Europa centrale di un’unità proto-celtica, che acquisterà compattezza culturale, a partire dall’Hall36 - Quaderni Padani statt C e costituirà un onda di riflusso verso occidente, a partire dalla fine del VII, inizi VI sec. a.C. Questo periodo che vedrà oltre a intensi scambi commerciali, anche spostamenti etnici, arriverà a coinvolgere la Padania centro- settentrionale nel IV sec. a. C. e la Britannia meridionale tra il III e il I sec. a.C., lasciando quindi fuori da questi flussi la Scozia e i Caledones, che propio per questo, insieme a una parte dei Liguro-Padani e ai Baschi, manteranno l’antica cultura originaria. I Caledoni in seguito, riusciranno a evitare anche l’occupazione romana, che comunque per i Liguro-montani di Padania e i Baschi, grazie all’asperità dei luoghi abitati, risulterà assai attenuata, permettendo il perdurare delle antiche tradizioni. Per i Liguri di Padania, questo comporterà però, lo snaturamento della lingua, che acquisterà caratteristiche romanze, anche se va detto, che molti vocaboli dell’antico idioma, resteranno nella lingua moderna, in aggiunta a quelli che il Latino prima e l’Italiano poi, prenderanno in prestito dal Ligure. La nascita di una visione ideologica della storia a partire dall’Illuminismo, che di fatto diede origine al fenomeno della “Celtomania”, evento al quale non fu certo estranea la Massoneria, per i suoi intenti anticristiani e anti-romani e la “Classicità” greco-romana, vista come fonte di ogni forma di civiltà da noi posseduta, sono state le due scuole di pensiero, che hanno troppo a lungo relegato nell’oblio, la vera storia dei nostri Popoli. Non è certo quindi un caso che oggi, col venir meno della menzogna giacobina e con la conseguente profonda crisi degli stati-nazione, i diretti discendenti delle più antiche comunità d’Europa: i Baschi, gli Scozzesi e i Padani, reclamino a gran voce quello che nessuno storico di regime, ideologia da salotto o stato centralista, gli potrà mai negare: la rivendicazione della loro identità e della loro libertà. Senza una forte idea di identità non si costruiscono le nazioni. Senza alte motivazioni spirituali, da associare a rinnovati concetti di Patria e Comunità, non si arriva al supremo sacrificio di se stessi, in nome di una totale fedeltà al proprio Popolo. Tutto ciò dovrà esser ben tenuto a mente, dai molti che oggi chiedono l’indipendenza della Padania, il monito di William Wallace è quantomai presente. ALBA GU BRA! Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Fiabe e leggende del Piemonte: un patrimonio di cultura Note per un appproccio scientifico alla tradizione orale di Massimo Centini F iaba e leggenda: due generi che spesso sono considerati immagine del tempo perduto, posti in relazione alla retorica, al gusto un po’ romantico del tempo perduto e come tale ambito ed evocato da chi si perde tra le prerogative contemporaneee. Noi siamo convinti che questi due importanti “contenitori” di tradizione siano depositari non solo di valori -sui quali ovviamente si possono avanzare molte istanze, in quanto spesso espressione tipica del periodo in cui una certa opera ha visto la luce - ma offrono soprattutto delle importanti indicazioni culturali, in gran parte non correrabili ad un ambito ristretto. Infatti, molti motivi della fiaba e della leggenda piemontese non sono prerogativa della terra pedemontana, ma possono essere rintracciati in formalizzati simili di paesi anche molto lontani. Questa antologia nasce quindi proprio dall’intenzione -con tutti i limiti delle antologie- di suggerire al lettore, non solo piemontese naturalmente, una piccola selezione di un’ampia tradizione popolare originale. Tradizione che se pur forte di questa sua originalità tipicamente locale, non può non rivelare i suoi legami con un patrimonio simbolico più ampio, comune a molta della cultura orale. Pur non potendo approfondire in questa sede i numerosi aspetti filologici connessi al tema, cominciamo gradatamente a definire alcune specifiche metodologiche. Il problema maggiore consiste nel separare nitidamente la fiaba dalla leggenda: anche se, come vedremo, i due generi hanno caratteristiche precise, spesso nel patrimonio orale i due nuclei narrativi si amalgamano “prestandosi” tipi, funzioni e motivi, rendendo così complessa non solo l’identificazione di genere, ma anche la ricostruzione dell’effettiva genesi del testo (1). Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Nella leggenda troviamo un materiale narrativo molto vario che nell’essenzialità descrittiva, in più occasioni, fa riferimento a una realtà localmente verificabile e spesso supportata dall’aspetto e dalla morfologia del luogo. Quasi sempre alla vicenda si sovrappone il velo del fantastico, che innesca diversi riflessi archetipici, capaci di condurre oltre il limite del possibile attraverso strade apparentemente accessibili all’uomo, anche se naturalmente disseminate di ostacoli che le rendono simili a un percorso iniziatico. Il “fantastico istituzionalizzato” della leggenda è il depositario dell’origine primigenia di certi motivi che si sono consolidati nella narrazione popolare, ma che hanno anche subito una trasformazione strutturale, in qualche caso devastante, dovuta agli inserimenti culturali più recenti. Nel tentativo di ricostruzione filologica della leggenda, si deve quindi operare un attento scavo stratigrafico dei vari livelli semantici della narrazione. Certo, la principale articolazione verbale della leggenda, ha subito anche adattamenti, dovuti a mutazioni di diversa origine che non sempre siamo in grado di isolare. In primo luogo non bisogna dimenticare che certe leggende sono un materiale multivalente, in cui al percorso primitivo della storia è possibile assegnare più significati, spesso opposti. Inoltre la cosiddetta “morale” è stata in molte occasioni adattata dai narratori, in accordo con quelli che erano i loro preconcetti pedagogici e moralistici. Le leggen(1) Cfr. V.Ja Propp, Morfologia della fiaba, Torino 1966; V.Ja Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, Torino 1972; V.Ja Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, Roma 1981; S.Thompson, La fiaba nella tradizione popolare, Milano 1967. Quaderni Padani - 37 de, pur descrivendo avvenimenti per molti versi eccezionali, spesso fanno riferimento ad una realtà localmente verificabile nel tempo. Inoltre, la leggenda può svolgere un’importante funzione di mito locale, supportando dei rituali simbolici di diverso tipo in tensione tra sacro e profano. Una certa tradizione agiografica sorregge la leggenda sulla fondazione di un santuario, il culto di un martire cristiano, “spiega” la presenza di alcuni aspetti naturali inquietanti, che vengono indicati come espressioni della lotta contro il paganesimo. Di contro troviamo anche tutto un fiorire di leggende storiche che traggono origine da vicende oggettive e verificabili, ma che risultano interpretate e collocate in modo soggettivo nel contesto del collettivo. La leggenda a sfondo storico risponde invece a due tendenze opposte, da un lato allontana i fatti verso il passato e dall’altro li avvicina al presente: è l’angolo di lettura a condizionare l’interpretazione e di conseguenza la funzione pedagogica assegnata al racconto. La laicizzazione della morale, ha comunque nelle leggende un ruolo fondamentale, destinato a dotare questi formalizzati di una notevole po- tenzialità dialettica, in quanto si avvale di un apparato simbolico che permette di interpretare un certo mito con l’ausilio di essenziali riferimenti a misteri e domande da sempre compagni del genere umano. “Tra i fattori più attivi che concorrono alla formazione delle leggende si deve indicare il patriottismo nella sua forma familiare locale o nazionale. Se in certi casi questo sentimento ha contribuito alla conservazione della verità storica, più spesso è stato una delle cause dell’alterazione di questa verità” (2). Molto spesso nella leggenda il luogo dove si svolge un certo avvenimento è indicato con una notevole precisione, a differenza della fiaba, in cui il territorio è sempre generico, evocato principalmente per le sue specifiche simboliche. Nella leggenda il luogo è quello “dietro la cascina”, o in un punto ben precisio del bosco, o della montagna che tutti conoscono. Di contro “la fiaba non ci dice nulla della città o del villaggio nel quale l’eroe è cresciuto. Al contrario, di preferenza, ce lo mostra proprio nel momento in cui l’abbandona e si avventura per il mondo” (3). I fatti straordinari narrati nelle leggenda, sono (2) A.van Gennep, Le origini delle leggende, Milano 1992, pag.163. Molto spesso, nella tradizione popolare, i contenuti della fiaba e quelli della leggenda finiscono per confondersi: abbiamo quindi una chiara indicazione delle effettive influenze tra un genere e l’altro. Connessioni tipiche che sono frutto del sistema narrativo della tradizione orale, di cui abbiamo numerose tendenze in molte culture tanto diverse tra loro. Se pur sotto certi aspetti un po’ datata, può essere di indubbio interesse rivedere la categorizzazione dei generi narrativi popolari, così come è stata suggerita dal van Gennep: “per favola si intende una narrazione in versi con personaggi animali dotati di qualità umane o che agiscono come se fossero uomini. In prosa questa narrazione è detta racconto di animali. La fiaba è una narrazione meravigliosa e romanzesca, il cui luogo d’azione non è identificabile, e con personaggi non individuabili, che risponde a una concezione infantile dell’universo e che presenterà una indifferenza morale asoluta (...) nella leggenda il luogo è indicato con precisione, i personaggi sono individui ben determinati, le loro azioni hanno un fondamento che sembra essere storico e sono di qualità eroica. Infine il mito è, per sintetizzare, una leggenda localizzata in regioni e tempi fuori dalla portata degli uomini e con personaggi divini”, Op.Cit., pag. 36-37. (3) M.Luthi, La fiaba popolare europee. Forma e natura, Milano 1979, pag. 27. 38 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 localmente creduti possibili, verificatisi in un tempo lontano, ma non troppo, spesso sono correlati a figure mitico-storiche (dai martiri tebei a Napoleone), nell’insieme la struttura narrativa risulta abbastanza armonica, anche perché prodotto originalmente connesso all’oralità. Nella fiaba invece gli schemi strutturali e i nuclei tematici sono fissi, in qualche modo prevedibili: “il repertorio delle fiabe è internazionale, analogie legano la Nuova Zelanda alla Russia e agli Indiani d’America. Fiabe simili sono presenti in popoli tra i quali l’esistenza di rapporti è indimostrabile. Da un punto di vista scientifico è dunque corretto studiare leggende entro àmbiti culturali e geografici più ristretti; per la fiaba è addirittura privo di senso studiarla nell’àmbito di una sola nazione, figurarsi nei limiti di una regione! Un fenomeno di vastità mondiale non è corretto studiarlo all’interno di uno spazio delineato, trascurando tutti gli altri luoghi della terra”(4). La fiaba, più della leggenda, ha uno stretto legame con l’universo del culto e della religione (5): in essa sopravvivono motivi simbolici connessi alle tradizioni di un passato remoto, caratterizzato da tradizioni rituali in cui erano attive forme rituali oggi totalmente scomparse. Alcuni mirati parallelismi etnologici hanno offerto ai folkloristi delle stimilanti opportunità per scorgere all’interno di un formalizzato orale, tracce di cultura in certi casi addirittura preistorica. La nota teoria romantica dei Grimm (6) individuava, nelle fiabe e nelle leggende, frammenti di miti spesso molto antichi, attraverso i quali le civiltà arcaiche assegnavano una fisionomia ai fenomeni naturali (7). L’ipotesi più recente del Gaster (8), secondo la quale esisterebbero effettivi rapporti fra alcuni racconti mitologici della Mesopotamia che datano millenni e la narrativa popolare, ha consolidato, pur correggendole, le tesi dei Grimm. E così scopriamo che nelle fiabe e nelle leggende potrebbero essere individuabili non solo antiche tracce della mitologia, ma forme rituali trasliterate simbolicamente all’interno del racconto. Ad esempio, le prove che il protagonista di una vicenda deve superare (topos ricorrente nella tradizoone orale popolare) potrebbero essere la reminiscenza di antichi riti di passaggio caratterizzanti il ciclo della vita umana e ancora presenti anche nel folklore occidentale (9), come indicato dal van Gennep (10). Emblemtico in questo senso il lavoro di Propp, che oltre all’impareggiabile analisi formale delle fiabe, ha anche indicato precise chiavi di lettura per porre in relazione questa parti- (4) G.Arpino - G.L.Beccaria, Fiabe piemontesi, Milano 1982, pag.18. (5) “Tutte le religioni non sono altro che il rispecchiamento fantastico nella mente degli uomini di quelle forze esterne che li dominano nella loro vita quotidiana, un rispecchiamento nel quale le forze umane assumono la forma di forze sovraumane. All’inizio della storia subiscono questo rispecchiamento innanzitutto le forze della natura. Presto però accanto alle forze della natura intervengono anche le forze sociali, forze che si contrappongono all’uomo e lo dominano e che risultano, inizialmente, incomprensibili ed estranee e in possesso di quella visibile inevitabilità che è propria delle forze naturali. I riti fantastici, nei quali inizialmente trovarono riflesso soltanto le segrete forze della natura, assunsero successivamente attributi sociali e si posero come immagini di forze storiche”, C.Marx - F.Engels, Opere, vol.XIV, pag.322. (6) Cfr.J.W.Grimm, Kleinere Schriften, Berlino 1879: Le fiabe del focolare, Torino 1985; G.Fornelli, Introduzione all’opera di J. e G.Grimm, Torino 1938. (7) “Le note opposte dai Grimm in queste loro opere diedero poi fondamento allo studio e all’utilizzazione scientifica di questo antico patrimonio indigeno nuovamente recuperato. Muovendo dalla considerazione di questi geniali monumenti dell’erudizione tedesca e della naturale e mai diminuita considerazione in cui essi furono sempre tenuti da parte degli studiosi, si spiegano ugualmente le condizioni degli studi e delle ricerche dei racconti popolari in Germania”, L.Machensen, Gli studi sul patrimonio narrativo (in Germania), in “Lares”,X, 1939; cfr.G.Cocchiara, Storia del folklore in Italia, Palermo 1981, pag. 60-61. (8) Cfr.I.G.Gaster, Le più antiche storie del mondo, Milano 1978. (9) “Il termine folklore, per il quale in Italia si usa anche la grafia folclore, venne impiegato per la prima volta in Inghilterra nel 1846 a designare il complesso di quelle che in precedenza si chiamavano popular antiquities o antiquitates vulgares (...) In Italia e altrove (p. es. in Francia) il termine folklore è stato ed è invece impiegato in una accezione un po’ diversa: si è ristretto l’ambito storico geografico, circoscrivendo agli strati popolari delle società evolute ed escludendone i popoli primitivi, e si è allargato l’ambito tematico, includendo oltre i fatti della cultura spirituale ed orale i fatti della cultura materiale. Folklore insomma diviene l’equivalente di tradizioni popolari, che è a sua volta l’espressione con cui si designa il complesso dei fatti cultrali che appaiono popolarmente connotati e cioè propri dei volghi o degli strati subalterni dei popoli civili”, A.M.Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo 1974, pag.62. (10) Cfr. A.van Gennep, I riti di passaggio, Parigi 1909. Lo studioso aveva così tentato di raggruppare tutte le sequenze cerimoniali che accompagnano il passaggio da una situazione a un’altra e da un mondo (cosmico o sociale) ad un altro, distinguendo al loro interno tra i riti di separazione, di margine e di aggregazione, senza intenti semplficatori, ma per mettere ordine nella complessità dei fatti folklorici, cfr. prefazione di C.Bernani all’edizione italiana, Milano 1991, pag.5. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 39 colarissima tradizione narrativa e l’universo del mito e del rito, con stimolanti occasioni per azzardare agganci alle culture genericamente deifnite “primitive”. Secondo Propp, “il mito e la fiaba differiscono non per la loro forma ma la loro funzione sociale. La funzione sociale del mito non è d’altra parte sempre la stessa ma dipende dal livello di cultura del popolo (...) Il mito non può essere distinto dalla fiaba dal punto di vista formale. La fiaba e il mito (in particolare i miti dei popoli preclassici) coincidono talvolta in misura così piena che in etnografia e nella scienza del folclore questi miti sono spesso chiamati fiabe”(11). In sostanza, come anche il lettore inesperto avrà modo di comprendere ad una prima epidermica analisi del testo, pur constatando la persistenza di un sostrato comune e diffuso, le fiabe e le leggende sono fenomeni culturali di difficile collocazione, soprattutto perché nate come prodotti da raccontare e non da scrivere. Inoltre, prima di essere fissate e in qualche modo unificate dai folkloristi del secolo scorso, le fiabe e le leggende erano la risultan- za di un articolato processo di elaborazione collettiva. Il rapporto testo/gruppo sociale è stato da sempre il catalizzatore nell’opera di diffusione di una certa opera, proposta tenendo ben presenti quelle che erano le necessità pedagogiche all’interno di un contesto in cui il testo era soprattutto strumento comunicativo. Sullo zoccolo duro costituito da motivi ricorrenti fortemente archetipizzati (12), ogni narratore ha saputo creare un itineraio simbolico adatto ad armonizzare il proprio patrimonio tra- (11) V.Ja Propp, Op.Cit., Roma 1981, pag. 27-28. (12) Non entriamo nel merito dell’ampia questione psicoanalitica connessa alla fiaba: ci limitiamo a segnalare che la scuola freudiana interpreta le fiabe come espressione di un desiderio represso, molto simile al sogno. Fra gli studiosi jnghiani in questi testi sarebbero rinvenibili le espressioni più chiare dell’inconscio collettivo “residui psichici di innumerevoli avvenimenti dello stesso tipo”. Archetipi richiamati dalla memoria nei casi in cui nella nostra mente riaffiorino situazioni tendenti ad evocare situazioni primigenie. “La cultura dominante preferisce fingere, soprattutto quando si tratta di bambini, che il lato oscuro dell’uomo non esista, e professa di credere in un’ottimistica filosofia del miglioramento. La stessa psicoanalisi è vista come un sistema per rendere facile la vita: ma non era questo l’intendimento del suo fondatore. La psicoanalisi fu creata per consentire all’uomo di accettare la natura problematica della vita senza esserne sconfitti o cercar di evadere dalla realtà. Freud prescrive che soltando lottando coraggiosamente contro quelle che sembrano difficoltà insuperabili l’uomo può riuscire a trovare un significato alla sua esistenza. Proprio questo è il massaggio che le fiabe comunicano al bambino in forme semplici: che una lotta contro le gravi difficoltà della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell’esistenza umana, che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta avversità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e alla fine uscire vittorioso”, B. Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanaliti delle fiabe, Milano 1977, pag.13-14. Inoltre non si deve dimentica che, anche solo una valutazione epidermica, ci permette di scorgere all’interno del territorio narrativo della fiaba e della leggenda una marcata impostazione pedagogica, tendente a svolgere un ruolo educativo molto spesso fortemente moralizzante. In questo universo fatto di allegorie e di continui rilanci simbolici, i personaggi non sono ambivalenti, sono buoni o cattvi, non c’è ambiguità e tutto si svolge secondo una limpidezza formale che con la sua apparente elementarietà invoca la limpidezza primigenia. Il contrasto tra Natura e Cultura pur essendo molto chiaro, e segnatamente posto in evidenza come una dicotomia forzata, non esclude la presenza di una diffusa volontà di rinsaldare questa separazione, per molti aspetti del tutto innaturale. 40 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 dizonale alle necessità della collettività (13). Per una buona conoscenza dei prodotti della tradizione narrativa popolare è quindi necessario non soffermarsi solo sul testo (che spesso giunge al lettore attraverso molteplici trascrizioni non sempre fedeli e non nella lingua originale (14)) ma far riferimento alla società in cui questi formalizzati si sono affermati. Infatti “lo studio limitato ai soli temi letterari è insufficiente: se da qualche anno si arrivati a possedere conoscenze più precise in materia di letteratura cosiddetta popolare, questo è avvenuto perché l’etnografia e lo studio delle civiltà hanno fatto rapidi progressi, grazie ai quali si è potuta modificare l’interpretazione degli elementi che agiscono nei temi (...) In breve, la conquista più importante dell’etnografia e del folklore in campo letterario in questi ultimi anni, consiste nell’avere messo in luce questo fatto: la produzione letteraria detta popolare è un’attività utile, necessaria per il mantenimento e il funzionamento dell’ordine sociale, e questo a causa del suo legame con altre attività di tipo materiale. So- prattutto ai suoi inizi, questa produzione è un elemento organico, e non, come si credeva, un’attività estetica superflua, un lusso”(15). Il complesso corpus di fiabe e di leggende è passato di generazione in generazione attraverso la tortuosa strada dell’oralità, lungo la quale ha subito varianti e modificazioni. Nate per essere raccontate con tutto il corredo di elementi dialettici tendenti ad accentare la funzione del testo (la gestualità, la voce, i riferimenti a personaggi e situazioni locali, ecc.), fiaba e leggenda erano originariamente dirette ad un pubblico che in particolari occasioni ritualizzate, partecipava alla narazione, fino a sentirsi parte della vicenda e, sotto certi aspetti, garante della storicità (16). La raccolta di questo patrimonio, se da un lato ha fatto si che una parte importante della tradizione locale non andasse perduta, ha anche ridotto notevolmente il suo valore rituale, scenico, evocativo. Per una corretta valutazione delle fonti, il Vansina indicava un metodo che, ancora oggi, spesso si ferma a livello di teoria: “le diverse fasi (13) La ripetitività di motivi e situazioni narrative, di caratteri e di associazioni simboliche che può essere riscontrata nei testi folklorici risulta facilitare in misura determinante le operazioni di analisi comparativa, l’individuazione delle regolarità, l’elaborazione di modelli generali. Questi caratteri del folklore non dipendono dalle limitate capacità creative o dal modesto livello culturale delle narrazioni popolari, “ il fatto è, piuttosto, che tale genere dei testi viene prodotto per motivi e in vista di utilizzazioni che sono in gran parte profondamente diverse da quelle che, per esempio, muovono l’autore di un testo letterario. Ciò che anzi da un punto di vista semiotico è più rilevante, è il fatto che i testi folklorici non costituiscono il risultato di una creazione individuale bensì il prodotto di un processo di produzione collettivo”, G.Ferraro, Per una semiotica del folklore, Torino 1978, pag.1-2..14) “Il primo requisito (nello studio delle fonti orali,n.d.a.) sarà quello di conoscere la lingua nella quale l’informazione fornita dalle tradizioni è redatta, in quanto senza una tale conoscenza non se ne potrà cogliere il significato. E’ praticamente impossibile raccogliere tradizioni in una lingua diversa da quella in cui sono state trasmesse. Questo è ovvio nel caso dei testi fissi, ma è vero anche per i testi liberi. Se l’informatore deve tradurle in una seconda lingua incontrerà difficoltà di traduzione perché i concetti che vuole esprimere non esistono nella cultura della seconda lingua, o perché non riesce a rendere le sfumature della lingua madre nella lingua straniera. La sua traduzione sarà imperfetta”, J.Vansina, La tradizione orale, Roma 1976, pag.256. Va ancora sottolineato che tra le numerose teorie di N.Chomsky, forse il linguista contemporaneo più acclamato e più criticato, merita un posto di rilievo il concetto di “competenza linguistica”, cioè l’insieme di conoscenze implicite che un parlante-ascoltatore ideale di una comunità linguistica omogena mette in opera nel produrre frasi nella lingua di quella comunità (cfr. N.Chomsky, Saggi linguistici. La grammatica generativa trasformazionale, Torino 1969). Se si completa questa nozione in senso sociolinguistico la si arricchisce di una serie di abilità extralinguistiche correlate; ad esempio il saper produrre messaggi adeguati alla situazione, il saper utilizzare anche linguaggi non verbali (gesti, atteggiamenti del volto, distanza dall’interlocutore), il saper comprendere le valenze socioculturali del messaggio. Si giunge così al concetto di “competenza comunicativa”, cioè la capacità di produrre e capire messaggi all’interno di una comunità, conoscendo ed utilizzando tutte le sfaccettature dell’atto comunicativo: capacità tipica del narratore di storie della nostra cultura popolare (cfr. G.Berruto, La sociolinguistica, Bologna 1979). Quando si analizza un prodotto linguistico come la fiaba e la leggenda, così ricco di valenze sociali della comunità che l’ha prodotto, risulta perciò fondamentale il possesso di una competenza adeguata relativa al contesto, cioè solo un cosiddetto “parlante nativo” ne potrà cogliere tutti i significati e le implicazioni. Diversamente l’analisi sarà sempre parziale e si tralascerà comunque qualche aspetto che, per chi ha prodotto il messaggio, doveva essere importante. (15) A.van Gennep, Op.Cit., pag.33-34. (16) Secondo il Beccaria fiaba e leggenda erano una sorta di rito riterato che “nasceva ogni sera, era destinato a tempi e momenti precisi di riti-riunioni comunitarie: le veglie, i lavori di gruppo come la spogliatura della meliga, la tessitura, il filare la canapa o la lana; e, in Piemonte, soprattutto d’inverno, che era momento di riaggregazione sociale, momento di interruzione dell’impegno del lavoro all’aria aperta, dopo il periodo caldo dell’estate, ch’era il momento della dispersione, del lavoro a tempo pieno. Il periodo freddo era vissuto nelle nostre valli con particolare intensità rituale. Il rito del narrare era necessario al mantenimento e al funzionamento dell’organizzazione sociale, perché la fiaba non poteva essere raccontata in un momento qualsiasi della giornata, ma faceva parte di atti proprii a rilassare dalle fatiche quotidiane”, G.Arpino- G.L.Beccaria, Op.Cit., pag.39-40. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 41 di una ricerca sulle tradizioni orali sono le seguenti. Innanzitutto lo studio della lingua e della cultura del popolo di cui si vuole rintracciare il passato. Secondariamente, lo studio generale del fenomeno della tradizione nel suo ambiente. Dopo di che si effettueranno alcuni sondaggi per ritrovare i differenti tipi di tradizioni, le loro caratteristiche e in particolare i loro modi di trasmissione. Si sarà quindi in grado di stabilire un piano di lavoro metodico, procedendo da una raccolta sistematica di tutte le fonti o stabilendo un campione che fornisca una linea di ricerca da seguire” (17). Le società colte sono società letterate a differenza di quelle rurali in cui prevale l’oralità come unico mezzo di trasmissione della tradizione. Il contrasto tra Cultura e Natura si estrinseca anche nel contrasto tra parola scritta e parola detta: nella prima rintracciamo una fissità considerata espressione della regolarità e razionalità, nella seconda una variabilità continua, che è indice di instabilità. Quando le “culture colte”, quelle “non primitive”, hanno cominciato a guardare alle “culture altre” con crescente curiosità, attratte dal loro esostismo o da altri aspetti comunque sempre condizionate da interpretazioni eurocentriste, hanno privilegiato le fonti scritte (18) delle culture indagate. In principio, solo da parte di alcuni studiosi è stata avvertita la necessità di guardare al patrimonio orale come ad un contenitore di cultura di grande importanza, del quale non si poteva fare a meno nell’ambito di uno studio sistematico di una tradizione studiata. Un racconto ripetuto, non una testimonianza singola, riportato sotto forma di narrazione da numerosi rappresentati di una comunità, può anche essere considerata tradizione, fonte da cui trarre precise indicazioni sulla cultura indagata. Quindi, la ripetitività di un testo, al pari della scrittura, è garanzia della sua affidabilità, ma soprattutto del suo effettivo ruolo all’interno di una comunità. “Solo il perdurare nel tempo e la conseguente approvazione della comunità trasformeranno in tradizione tutte quelle forme di espressione orale che vengono trasmesse di bocca in bocca, di padre in figlio, nella riunioni collettive e nelle manifestazioni rituali” (19). I folkloristi che per primi si sono rivolti con una certa attenzione critica al patrimonio orale piemontese, non sempre, per concreti limiti di impostazione metodologica, sono stati in grado di riferirsi a sistemi di raccolta sistematici e organici. Ma a loro va senza dubbio il merito di aver tratto dall’oblio del tempo un patrimonio di grande valore e importanza. Anche se come annotava Italo Calvino “un Grimm italiano non venne alla luce”, la ricerca e la raccolta delle testimonianze orali ha nel nostro paese una sua tradizione (20). Più specificatamente, per quanto riguarda il Piemonte, va detto che pur non possedendo l’ampio materiale caratterizzante altre regioni (21), in terra pedemontana si andarono conformando alcune indagini di notevole impegno filologico. La prima citazione va a Costantino Nigra, che nel 1888 pubblicava Canti popolari del Piemonte (22). Lo studioso piemontese pose in (17) J.Vansina, Op. cit., pag. 271-272. (18) Sulla problematicità di definire con precisione i parametri di un testo scritto all’interno di culture “altre”, di cui non siano noti tutti gli aspetti socio-antropologici, cfr.G.R.Cardona, Antropologia della scrittura, Torino 1981. (19) M.Aime, Prefazione alla collana, Favole, Xenia Edizioni, Milano 1993, pag. IX. (20) Cfr. I.Calvino, Introduzione a Fiabe italiane, Milano 1968. (21) Sono toscane e siciliane le antologie di tradizione narrativa popolare (generalmente fiabe) che Calvino considerava “le più belle che l’Italia possieda”: G.Nerucci, Sessanta novelle popolari montalesi (Pistoia), Firenze 1880; G.Pitrè, Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, Palermo 1875. (22) Ristampato da Einaudi nel 1974. 42 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 rilievo la valenza etnografica del testo popolare, utilizzando il metro dell’analisi comparata destinata a dimostrare come numerose opere della tradizione popolare avessero un identico sostrato culturale. Un’altra importante documentazione sulle tradizioni narrative piemontesi, dalla quale hanno attinto molti studiosi, è la raccolta di Giuseppe Ferraro, costituita nel 1869 a Carpeneto Monferrato. Sono 127 fiabe raccolte in un manoscritto che è stato per generazioni di ricercatori, da Comparetti ad Arpino, un documento di ineguagliabile valenza storica (23). Delle traduzioni effettuate dal Ferraro se ne avvalse il Comparetti, che accolse alcune di quei formalizzati nella sua antologia Novelline popolari italiane (1875). Fino ai primi anni del XX secolo non si hanno testimonianze di raccolte organiche di fiabe e leggende del Piemonte; di fatto però non mancarono studi specifici diretti ad approfondire l’origine di alcune tradizioni verbali, con l’intenzione di porne in rilievo gli aspetti etnografici, il tutto in linea con quelle che erano le prerogative antropologiche del periodo. Contando su accurate, sepur momentanee, valutazioni presentate nell’“Archivio per studio delle tradizioni popolari” (24), condizionate da un rigore filologico che ancora andava affinando i propri metodi di indage etnografica, fino alle romantiche interpretazioni della Savi Lopez (25), che pur cedendo sotto il peso di una sorta di anarchia metodologica, non ha mancato di suggerire delle strategie di riflessione per andare oltre l’apparenza, la raccolta sistematica del patrimonio orale piemontese segnava il passo. In tempi più recenti, ricerche coordinate con l’ausilio di metodi di studio più calibrati e attraverso una matura indagine sul campo, hanno permesso la raccolta di testimonianze dell’oralità, certamente in gran parte non più vivide come quelle del secolo scorso, se pur dotate di tutta una serie di elementi caratterizzanti, indicati come segni rilevatori per gli studiosi delle scienze sociali. Antropologi, sociologi, semiologi e studiosi delle lingua hanno tratto da queste ultime vive voci della storia popolare delle indicazioni di grande importanza culturale, che vanno al di là dell’epidermiche valenze testuali. La fiaba e la leggenda possono quindi dire ancora molte cose sui nostri rapporti con il mito e con il rito, sulla nostra necessità di avvalerci di traietorie apparentemente impossibili per dare Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 un volto e un nome agli archetipi. Ma soprattutto, il grande patrimonio della tradizione orale, anche quando si analizza quello circoscritto ad un’area specifica, rivela un’universalità, un bisogno di correlare le vicende, anche la più banale e quotidiana, ad un meccanismo più ampio, ad un sostarto che ci rende consapevoli di rincorrere un po’ tutti le stesse mete, sfuggendo le identiche angosce. In definitiva, fiaba e leggenda, anche quando provengono da luoghi così lontani da risultare privi di ogni possibile collegamento, rivelano soprattutto di possedere un ruolo fondamentale: danno a chi li ascolta “una prospettiva di universalità, vale a dire il sentimento di essere nel cosmo” (26). Da piccoli “miti in miniatura” si trasformano così in segni sempre più nitidi della nostra storia: tracce ormai incancellabili di una cultura antichissima. Bibliografia ❐ Alessio G.C. (a cura), Cronaca di Novalesa, Torino 1982. ❐ Arietti A. - Pitrè G., La storia di re Crin, novella popolare piemontese, in “Archivio per lo studio della tradizioni popolari”, 1882. ❐ Arpino G. - Beccaria G.L., Fiabe piemontesi, Milano ❐ Bertino S., Guida alle Alpi misteriose e fantastiche, Milano 1980. ❐ Boccazzi Varotto A., I racconti della stalla, Ivrea 1975. ❐ Boccazzi Varotto A., Racconti in terra di vigne. Storie e leggende di Langhe e Monferrato, Ivrea 1976. ❐ Brero C. (a cura), Legende popolar piemontèise, Torino 1974. ❐ Brero C. (a cura), Conte, fàule e legende piemontèise, Torino 1977. ❐ Brofferio A., I miei tempi, Torino 1861. ❐ Calvino I., Fiabe Italiane, Torino 1956. (23) La raccolta di G.Ferraro, Racconti popolari monferrini, è conservata presso il Museo delle Arti e Tradizioni popolari di Roma, (mss, 131-140, 1860). Allo stesso autore si deve anche una raccolta di Canti popolari monferrini (Torino 1870). (24) Cfr. A.Arietti - G.Pitrè, La storia di re Crin, novella popolare piemontese, in “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari”, 1882, pag. 424-429; D.Carraroli, Leggende, novelle e fiabe piemontesi in “Archivo per lo studio delle tradizionipopolari”, 1907, pag.68-83. (25) Cfr. M.Savi Lopez, Leggende delle Alpi, Torino 1889, ristampa anastatica a cura di M.Centini, Piemonte in Bancarella, Torino 1993. (26) G.Dolfini, Sulla universalità della fiaba, in AA.VV., Tutto è fiaba, Milano 1980, pag.33 Quaderni Padani - 43 ❐ Carraroli D., Leggende, novelle e fiabe piemontesi, in “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari”, 1907. ❐ Collino L., Leggende e figure piemontesi, Torino 1930. ❐ Comparetti D., Novelline popolari italiane, Torino 1875. ❐ Cosio T., Roche Sarvan e Masche, Coumboscuro 1984. ❐ Del Boca L., Valsesia. Storia, tradizioni e leggende, Ivrea 1981. ❐ Di Giovanni G., Usi, credenze e pregiudizi del canavese, Ivrea 1975. ❐ Farinetti C., Vita e pensiero del Piemonte, in Canti, novelle, tradizioni delle regioni d’Italia, Milano 1925. ❐ Ferraro G., Racconti popolari monferrini, Ms. 131-140, Museo delle arti e Tradizioni popolari di Roma, 1869. ❐ Ferraro G., Canti popolari monferrini, Torino 1870. ❐ Gerardi A., Giaveno.Nei suoi monumenti, nella sua arte, nelle sue leggende e nei suoi ricordi, Giaveno 1977 ❐ Majoli Faccio V., L’incantesimo della mezzanotte. Il Biellese nelle sue leggende, Milano 1941. ❐ Majoli Faccio V. L’insidia del meriggio. Il Biellese nella tradizione, Bologna 1953. 44 - Quaderni Padani ❐ Milano E., Dalla culla alla bara. Usi natalizi, nuziali e funerei della provincia di Cuneo, Torino 1925. ❐ Milano E., Nel regno della fantasia. leggende della provincia di Cuneo, Torino 1931. ❐ Nigra C., Canti popolari del Piemonte, Torino 1854 (Torino 1957). ❐ Perrot M.M., Valli Chisone e Germanasca, Torino s.d. ❐ Pons T., Vita montanara e folklore nelle valli valdesi, Torino 1978. ❐ Rua G., ‘L canarin. Una fiaba piemontese, in “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari” 1887. ❐ Ruggiero M., Tradizioni e leggende della valle di Susa, Torino 1970. ❐ Savi Lopez M., Le valli di Lanzo. Bozzetti e leggende, Torino 1886. ❐ Savi Lopez M., Le leggende delle Alpi, Torino 1889 (Rist.Anast. Piemonte in Bancarella, Torino 1993). ❐ Terracini B.A., Esercizi di traduzione dai dialetti del Piemonte, Torino 1924. ❐ Thesauro E., Historia dell’Augusta città di Torino 1679. ❐ Treves E., Leggende piemontesi, Milano 1931. ❐ Virgilio A., Voci e cose del vecchio Piemonte, torino 1917. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Il giuramento di Pontida tra leggenda e realtà di Elena Percivaldi Introduzione lina (fautrice degli Svevi). Alla morte di Corrado Ogni anno ormai è un’abitudine per molti pa- III, nel 1152, Federico era stato scelto per metdani ritrovarsi insieme sul prato di Pontida per tere fine a questi contrasti e riportare un po’ di rinnovare un giuramento che tanti secoli fa, se- stabilità e un miglioramento all’immagine imcondo la tradizione il 7 aprile 1167, vide i rap- periale, sempre più sbiadita. E Federico era l’uopresentanti delle città lombarde allearsi contro mo giusto al posto giusto: descritto da tutti coun comune nemico, l’imperatore Federico Bar- me una persona molto autoritaria, cercò da subarossa, oppressore delle libertà comunali. bito di rilanciare il ruolo di un Impero che, soPurtroppo, a quanto sembra, quello storico prattutto in Italia, stava perdendo sempre più terreno è stato da poco acquistato per essere tra- terreno a favore dei Comuni. Nel Nord Italia, insformato in area edificabile. Un evento a cui tut- fatti, le città non avevano mai smesso si essere ti noi eravamo profondamente legati rischia di non poter essere più celebrato. Di esso ci rimarrà forse solo la memoria. Cerchiamo allora di ripercorrere la storia del giuramento di Pontida per stabilire cosa effettivamente accadde quel giorno di primavera del lontano 1167. Le fonti del tempo non sono chiare o addirittura tacciono, cosicché è difficile districarsi tra realtà e leggenda. Il giuramento, indubitabilmente, ci fu. Tuttavia non siamo sicuri del luogo dove avvenne. La tradi- Cartina della Padania con le città aderenti alla Lega Lombarda zione ci suggerisce il nome di Pontida. Ma la verità è ancora lontana dall’esse- punti di riferimento economico, politico e culturale (2); grazie alla enorme espansione econore definitivamente stabilita. mica in atto tra il X e l’XI secolo, accanto alla tradizionale aristocrazia fondiaria che aveva la Perché un giuramento tra comuni? Prima di parlare di Pontida, è forse utile fare sua base nella proprietà terriera, si erano svilupqualche passo indietro per vedere brevemente pati nuovi ceti sociali, costituiti da mercanti, argli antefatti storico-politici che portarono i Co- tigiani, banchieri, notai. Erano ceti ricchi e inmuni ad opporsi con fermezza all’imperatore tedesco (1). Federico I Hohenstaufen, detto il Barbarossa, discendeva dalle schiatte di Baviera e di ( ) Per una biografia dell’imperatore e per la storia di questi Svevia ed era stato messo sul trono proprio per anni si possono consultare Ferdinand Opll, Federico Barbapacificare queste due casate, da anni in lotta per rossa (Genova: ECIG, 1994) o anche Franco Cardini, Il Barbarossa. Vita, Trionfi e Illusioni di Federico I Imperatore il potere. Le contese avevano in pratica causato (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1985). la spaccatura della Germania in due fazioni, la ( ) Si veda Henry Pirenne, Le città del Medioevo (Bari: Laterguelfa (seguace della parte Bavarese) e la ghibel- za, 1974). 1 2 Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 45 fluenti che, approfittando della lontananza dell’imperatore e delle difficoltà in cui versava la sua autorità, iniziarono presto a rivendicare molte di quelle funzioni di governo che spettavano al potere centrale. Le lotte per il potere in Germania avevano favorito queste spinte autonomistiche, e i Comuni padani erano riusciti ad esercitare di fatto (se non ancora di diritto) molti poteri, erodendoli dall’autorità imperiale. Tra la fine dell’XI e la prima metà del XII secolo molte città padane si erano costituite in Comuni creando un’apposita magistratura collegiale, il consolato (3). Alla vigilia dell’incoronazione del Barbarossa, i Comuni imponevano tasse, esercitavano diritti di mercato, amministravano la giustizia e controllavano le vie di comunicazione. Tra di essi, Milano aveva ben presto conquistato l’egemonia e imponeva la sua autorità anche sulle città circostanti. Soprattutto erano i Lodigiani, la cui città i Milanesi avevano distrutto poco prima, a non poterne più sopportare la prepotenza. Due messi di Lodi si recarono pertanto dal Barbarossa a Costanza e lo pregarono di intervenire contro Milano: fu così che egli decise di scendere in Italia per riconquistare il controllo della situazione e per riprendersi tutte quelle regalie che i Comuni gli avevano strappato. A Roncaglia, nel 1154, proclamò solennemente i suoi diritti, distrusse Asti, Chieri e Tortona che gli si opponevano e si recò a Roma dove, dopo aver rimosso la magistratura comunale approntata dall’“eretico” Arnaldo da Brescia, fu incoronato da papa Adriano IV. Nel 1158, di nuovo a Roncaglia, assistito da quattro dottori di diritto dello Studium di Bologna, il nuovo imperatore rivendicò tutte le regalie che gli spettavano, in particolare il diritto di batter moneta, di imporre tasse, di nominare magistrati e di riscuotere i proventi delle condanne. Soprattutto, proibì le leghe e le alleanze tra i Comuni (4). Le città che rifiutarono questi provvedimenti furono distrutte. Milano fu assediata nell’inverno 1161-1162 e, costretta a capitolare, fu rasa al suolo, i suoi abitanti dispersi. Ma proprio a questo punto le stesse città che avevano chiesto l’intervento del Barbarossa contro Milano si accorsero della gravità della situazione: rischiavano di perdere tutte le proprie libertà. Dopo la vittoria di Federico infatti, tutti i Comuni (anche quelli a lui alleati) avrebbero dovuto restituirgli tutte le regalie - pena il pagamento di forti somme - e sottostare alle angherie dei podestà e dei messi imperiali. Si creò così un forte movimento di opposizione da parte dei Comuni, al quale aderì anche il papa Alessandro III, da sempre avversario dello Svevo e ora timoroso del suo potere. Il Barbarossa reagì deponendo il pontefice e sostituendolo con un antipapa di sua creazione, Vittore IV, ma Alessandro, ottenuto l’appoggio di altre potenze straniere preoccupate della forza di Federico, si alleò coi Comuni che nel frattempo si erano stretti in varie coalizioni. Nel 1164 i Comuni veneti avevano creato la Lega Veronese (5), e nel 1167 alcuni di quelli lombardi avevano formato la Lega Cremonese con l’intento di far ritornare i Milanesi nella loro città - provocando così l’imperatore (6). Questo patto fu sancito, secondo la tradizione, il 7 aprile 1167 nel monastero di Pontida, una località del bergamasco. Le due leghe poi si riunirono, dando vita alla formidabile Societas Lombardiae, il primo dicembre dello stesso anno (7). (3) Pisa nel 1081, Asti nel 1095, Arezzo nel 1098, Genova nel 1099, Pistoia e Ferrara nel 1105, Cremona nel 1112, Lucca nel 1115, Bergamo nel 1117, Bologna nel 1123, Mantova e Piacenza nel 1126, Modena nel 1135, Verona nel 1136,ecc. Si veda P.Brezzi, I Comuni cittadini: origini e primitiva costituzione (Milano: ISPI, 1939). Per ciò che concerne Milano, il primo atto che menziona la presenza del consolato (e quindi, ufficialmente, del Comune) è del 1095 (si veda l’edizione ne Gli Atti Privati Milanesi e Comaschi a cura di Cesare Manaresi): si tratta però di un atto privato, col quale il prete milanese Ariberto promette al vescovado di Cremona la cessione dei diritti su una curtis e su un castrum a Bariano. Il primo documento “ufficiale” del Comune in cui compare il termine consules è invece del 4 luglio 1117: lo si veda ne Gli Atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di Cesare Manaresi, Milano 1919, pagg. 3 ÷ 5. (4) Il testo della dieta di Roncaglia è pubblicato nei Monumenta Germaniae Historica, nel volume contenente le Friderici I Constitutiones, documento n. 176, a pag. 246. In particolare, il comma 6 relativo al divieto di fare alleanze tra città e città, tra persona e persona e persino tra persona e città recita così: Conventicula quoque et omnes coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, inter civitatem et civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus et in preteritum factas cassamus, singulis coniuratorum pena unius librae auri percellendis. Si veda anche M.G.H., DDF I, pagg. 237 ÷ 240. (5) Partecipavano Verona, Venezia, Vicenza, Padova e Treviso. (6) Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova, Ferrara e, ovviamente Milano. Si veda la bellissima raffigurazione in bassorilievo del ritorno in città dei Milanesi oggi conservata al Museo del Castello Sforzesco e che nel 1171 adornava l’arco di Porta Romana. (7) L’elenco delle 16 città aderenti: Milano, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Piacenza, Parma, Bologna, Modena, Verona, Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Mantova, Ferrara. Ad esse se ne aggiunsero via via altre, altre ancora parteciparono solo saltuariamente. 46 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Nove anni dopo, il 29 maggio 1176, a Legnano, la Lega Lombarda avrebbe clamorosamente sconfitto il Barbarossa e lo avrebbe costretto a più miti consigli. Qualche breve nota sul monastero Il monastero di Pontida fu fondato da Alberto da Prezzate, un uomo appartenente ad una ricca famiglia lombarda di cui si hanno notizie fino al 1095, anno della sua morte. Di lui non si a molto: dopo la sua scomparsa, la sua figura fu subito mitizzata; l’unica biografia del tempo fu compilata alla fine del XII secolo ma è andata perduta. Tuttavia esistono quindici documenti nell’archivio del monastero di S.Bassiano che lo citano, e possediamo il suo sarcofago (databile alla prima metà del XII secolo, di fattura borgognona) e una dedica autografa di Alberto ai suoi confratelli di Pontida. Il monastero fu fondato l’8 novembre 1076: Alberto da Prezzate donava al monastero di S.Pietro in Cluny un terreno arativo sito in Pontida sul quale era fabbricata una chiesa in onore della Vergine Maria, di S. Il Carroccio alla battaglia di Legnano, particolare di un dipinGiacomo e dei Santi Bassiano e to di Massimo d’Azeglio Nicola, con case, massarici, vigne, prati, pascoli, selve, selve di castagni, al fine gamo, un’arteria molto battuta sin dall’epoca di costruirvi un monastero ( 8). Il priorato di tardo antica. Proprio grazie alla sua collocazione Pontida all’interno dell’ordine cluniacense è ac- geografica, questa località diventa presto un cettato da Ugo di Cluny nel 1088, anno in cui lo centro di forte interesse per le famiglie milanesi, stesso Ugo nomina Alberto priore del monaste- anche in virtù della sua posizione di confine tra ro. Da allora, è un continuo susseguirsi di dona- il contado milanese e quello bergamasco, che le zioni da parte soprattutto di ricche famiglie mi- dà importanza come zona strategica. Famiglie lanesi, che rimpinguano il patrimonio del mo- come i Da Vicomercato, i Da Carcano e i Da Benastero e lo rendono assai ricco: i suoi possedi- sana fanno al monastero numerose donazioni menti travalicano l’Adda e si estendono nel Bre- fondiarie e contribuiscono attivamente alla sua sciano, nel Lecchese, nel Cremasco e persino nel vita e alle sue fortune. Uno degli atti più embleLodigiano.I vescovi di Lodi e Cremona inoltre fanno dono di decime. Questa prosperità per) Si veda la carta di donazione in Bruel, IV, pagg. 608 ÷ mette ai monaci nel 1095 di consacrare, grazie (610, n. 3494. Interessante notare che Alberto da Prezzate all’opera del vescovo di Piacenza, la nuova chie- professava di “ex natione mea lege vivere longobardorum”, sa di S.Giacomo. cioè seguiva come la maggior parte dei suoi conterranei Pontida si trova sulla strada tra Brivio e Ber- contemporanei la legge longobarda. 8 Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 47 matici che testimoniano l’attenzione dei Milanesi per il monastero è costituito dalla concessione dell’esenzione dagli oneri e dalle gravezze al convento di S. Giacomo nel 1119 (9): per l’occasione, tutti i Milanesi si radunarono nel vecchio teatro per sancire una azione che doveva essere soprattutto politica, fatta allo scopo di ingraziarsi i monaci di Pontida. La manovra si rivelò efficace: durante il periodo che precedette la distruzione di Milano ad opera del Barbarossa, infatti, mentre molte altre città lombarde cercarono di ostacolare il “capoluogo”, Pontida rimase ad esso fedele. Del resto, Milano era per i monaci un centro economico molto importante, dato che già dal 1130 essi vi possedevano una casa (cioè un avamposto per permettere lo sfruttamento delle vie commerciali e dei mercati cittadini). Il monastero di Pontida infine si dimostrò più volte un rifugio sicuro per i fuoriusciti Milanesi: sembra infatti che lì morisse uno dei capi patarini fuggito alla repressione, e che durante l’assedio di Milano, nell’inverno 1161-62, vi si rifugiasse nientemeno che Pinamonte da Vimercate, uno dei personaggi-chiave della Lega anti-Barbarossa. Tutti questi fatti sono molto importanti: proprio la longa manus dei proprietari fondiari e delle élite milanesi su Pontida e la fedeltà più volte dimostrata a Milano dai monaci avrebbe fatto cadere la scelta del luogo del famoso giuramento su questa quasi sconosciuta località del contado bergamesco e l’avrebbe fatta diventare il punto di partenza del riscatto dei Comuni contro l’imperatore tedesco. Pontida e la Lega tra strumentalizzazioni risorgimentali e celebrazioni nazionaliste Durante il Risorgimento, tutta la storia della Lega Lombarda fu esaltata dai “patrioti” italiani come una prefigurazione e un esempio da seguire in vista della liberazione dallo straniero: allora si trattava di battere il Barbarossa, ora era il momento di cacciare fuori gli austriaci. Pontida divenne per tutti il simbolo dell’unità e dell’indipendenza nazionale; poeti, librettisti d’opera, romanzieri, musicisti, artisti di ogni genere colsero questo ed altri episodi significativi della lotta dei Comuni contro l’imperatore per riaccendere negli animi l’amore per la libertà. L’alfiere di questo sentire fu senz’altro Giovanni Berchet. Nel 1829 pubblicò, nella raccolta Fantasie, anche la celeberrima ballata Il Giuramento di Pontida. Vi raccontava il sogno del poeta che vede, come in una visione, i rappresentanti dei Comuni lombardi radunati sulla 48 - Quaderni Padani piana mentre si giurano reciprocamente fedeltà e promettono di far fronte comune contro il nemico: L’han giurato. Gli ho visti in Pontida Convenuti dal monte, dal piano. L’han giurato; e si strinser la mano Cittadini di venti città. Oh, spettacol di gioia! I Lombardi Son concordi, serrati a una lega. Lo stranier al pennon ch’ella spiega Col suo sangue la tinta darà (10). Al di là della retorica, questo componimento è una delle tante testimonianze della scarsa qualità poetica dei nostri verseggiatori romantici; tuttavia, se il risultato artistico (con buona pace di quanti, come il Mazzini, la consideravano un capolavoro) lascia un po’ a desiderare, pienamente riuscito fu l’intento: i versi diventarono subito popolarissimi e si diffusero un po’ ovunque. Appellarsi agli ideali di riscatto di una libertà e di un’indipendenza calpestate era la carta vincente per infiammare gli animi delle folle. Ecco come Giuseppe Garibaldi concluse il suo discorso, fatto ai bergamaschi il 3 agosto 1848 allo scopo di incitarli alla rivolta contro lo straniero: “Bergamo sarà il Pontida della generazione presente e DIO vi condurrà a Legnano!” (11). Qualche anno dopo, il 7 giugno 1859, l’“eroe dei due mondi” volle visitare di persona il monastero e, forse ricordando il suo discorso bergamasco, esclamò: “Oh quante volte pronunziai il nome di Pontida, rievocando la sua con altre glorie d’Italia per infiammare gli animi de’ miei compatrioti e de’ miei volontari!” (12). (9) Si veda l’edizione del documento nel vol.I de Gli Atti del Comune di Milano... cit., pagg. 5 ÷ 6. L’originale dell’atto è andato perduto, ma esso ci è noto da due passi delle “Storie” del Calco e del Corio, riportati da Manaresi nell’ed.cit. (10) Giovanni Berchet, Il Giuramento di Pontida, vv. 17-24, in Opere, a cura di M.Turchi, Napoli, 1972. (11) Giuseppe Garibaldi, Proclama ai Bergamaschi, (da G. Locatelli Milesi, Garibaldi per Bergamo e i Bergamaschi, in Bergomum 28, 1934, pagg. 97 ÷ 99) citato in D.Paolo Lunardon, o.s.b., Il Giuramento di Pontida (Pontida, 1967, s.e.), pagg. 92 ÷ 94. Riporto un altro brano del proclama: “Quando le città lombarde, stanche di gareggiar tra loro, o di sopportare le infami angherie degli imperatori tedeschi (che si alleavano all’una per combattere o manomettere l’altra) s’accorgevano delle insidie di quei sudici padroni, alzavano un grido di unione e di fratellanza, lasciavano l’aratro e giuravano in Pontida di non viver servi, schiacciavano come rettili in Legnano le nefande soldatesche del barbaro”. (12) Citato in D. Paolo Lunardon, o.s.b., op. cit, pag. 92. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Anche se non vedono Pontida protagonista, si possono citare , per farsi un’idea del clima di quegli anni, le innumerevoli opere teatrali (tra cui spicca La Battaglia di Legnano (13) di Giuseppe Verdi su libretto di Salvatore Cammarano), i romanzi (come La Lega Lombarda (14) di Massimo D’Azeglio), le poesie (celeberrima La Canzone di Legnano (15) del Carducci), i quadri dello stesso D’Azeglio, di Francesco Hayez e di Amos Cassioli (16). Ormai in tutte queste rivisitazioni di storico c’era ben poco, mentre grande spazio si lasciava all’immaginazione e all’esaltazione eroica dei personaggi che avevano partecipato agli even- L’assalto a Crema del 1159 in cui il Barbarossa aveva fatto ti. Pontida e la Lega Lombarda legare degli ostaggi alla torre d’assalto erano diventate leggenda. Spesso e volentieri, poi, agli artisti si univano gli storici, del convento di Pontida, seguito da squadre d’arpreoccupati di fornire solide basi alle argomenta- mati delle vicine città. Veniva a ricondurli entro zioni unitariste e patriottiche. Ecco un assaggio le mura e a rialzarle. - Tre anni dopo, la potenza di un brano di Luigi Tosti, abate benedettino co- e la perseveranza di Federico erano finalmente me i monaci di Pontida, ma napoletano: “Il dì domate sul campo di Legnano (...)” (18). settimo di aprile dell’anno 1167 fu il tempo, la A unità ormai conquistata, lentamente i motivi Badia di S. Giacomo di Pontida il luogo destina- patriottico-risorgimentali vennero meno. Ma alla to a’ salutari congressi. Monaci di S. Benedetto fine del secolo stava di nuovo tirando una brutta abitavano quella famosa Badia. Fortunati Mo- aria. Stavano nascendo in tutta Europa le spinte naci, deputati dai Cieli ad ospiti della raminga nazionaliste che avrebbero di lì a poco condotto libertà d’Italia ! Essi avevano ricevuto nel V se- il continente alla “grande guerra”, all’avvento colo dalle mani del Romano S.Benedetto sul delle dittature, del nazismo e del fascismo. Nel Monte Cassino il codice della Romana libertà, 1900 fu inaugurata la famosissima statua di Alnel XII lo restituivano alla patria nella Badia di berto da Giussano a Legnano, opera di Luigi ButPontida” (17). Onestamente, neanche il “nostro” ti. Era una sinistra prefigurazione di quanto staCarlo Cattaneo seppe evitare la retorica, anche va per accadere. Nel 1914 scoppia la guerra. Si se, da buon lombardo, le sue parole sono assai confronta la lotta di tanti secoli prima contro il meno vuote ed ampollose: “Dopo che per cinque Barbarossa con “il grandioso aggruppamento di anni (i Milanesi) ebbero sofferto i più gravi disa- popoli che combattono contro gli Imperi Cengi, apparve un giorno fra i loro tugurj un frate trali” (19): il 7 aprile 1918, in occasione della (13) Si legga la recentissima edizione del libretto in: Giuseppe Verdi, Tutti i libretti d’opera, vol. I, a cura di Pietro Mioli (Roma: Newton Compton, 1996), pagg. 282 ÷ 302. L’opera andò in scena per la prima volta a Roma, al Teatro Argentina, il 27 gennaio 1849. (14) Massimo D’Azeglio, La Lega Lombarda (Pavia: Astra, 1993). Fu pubblicata incompiuta e postuma nel 1871. (15) Giosue Carducci, La Canzone di Legnano, nell’edizione nazionale delle Opere (Bologna: Zanichelli, 1935-40). (16) Ad esempio, di Amos Cassioli si veda il dipinto La Battaglia di Legnano del 1870 conservato a Firenze, presso la Galleria di Arte Moderna, oppure di Massimo d’Azeglio il quadro, con lo stesso soggetto, conservato a Palazzo Pitti, sempre a Firenze. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 (17) Luigi Tosti, Storia della Lega Lombarda illustrata con note e documenti (Montecassino, 1848) riportato, in un più ampio stralcio, da D.Paolo Lunardon, o.s.b., op. cit., pagg. 83 ÷ 86. (18) Carlo Cattaneo, Storia della Lombardia, cap. XXII (Milano: Rusconi, 1992), pag. 101. L’opera è del 1844. (19) Il Patto di Pontida. Commemorazione del 7 aprile 1918 in onore degli studenti caduti per la patria (Bergamo, 1918), citato come i brani seguenti in D. Paolo Lunardon, o.s.b., op. cit., pagg.124 sgg. L’avvenimento ebbe luogo per iniziativa del Comitato Provinciale dell’Unione Generale Insegnanti Italiani e della Lega Anti-austro-tedesca in occasione dell’anniversario del giuramento. Quaderni Padani - 49 commemorazione in onore degli studenti cadu- tria: “Pontidae nomen, Italiae omen” ( 24). È ti per la patria tenuta a Pontida, l’allora Mini- chiara, dopo tutte queste esagerazioni retoristro delle Finanze Filippo Meda esclama: “Pon- che, la difficoltà di appurare cosa sia effettivatida è la volontà, Legnano l’azione: e significa mente successo in quel lontano giorno di tanti che la vittoria non sorride a chi non agisce; ma secoli fa. Per cercare di stabilirlo, dovremmo che non si agisce in modo da conseguire la vit- provare ad interrogare le fonti coeve. Nel farlo, toria se non si sia prima voluto, fortemente vo- però, si rimane piuttosto sorpresi: quasi tutte luto - giurato di volere - come i nostri padri parlano di un giuramento tra città “lombarde”, della Lega fecero. (...) Lo si ripeta dunque an- ma nessuna nomina neanche in modo indiretto cora una volta, e voli l’ammaestramento dal il monastero di Pontida. chiostro di Pontida a tutta l’Italia: è l’ora del cimento estremo: prepariamoci tutti con pu- Le nostre fonti sul giuramento di Pontida rezza di cuori, con fermezza di animi, con fede Quasi tutte le cronache sono concordi nel dire alta e sincera nella giustizia e nel diritto; così e che nell’anno 1167 alcuni Comuni lombardi denon altrimenti i petcisero di stringere ti dei nostri soldati un patto di alleanza diverranno un baper difendersi meluardo insormontaglio dal Barbarossa. bile contro il quale Il milanese Sire verranno a frangersi Raul ad esempio le rinnovate cupigracconta che un digie alemanne” (20). procuratore dell’imQueste parole sono peratore venne a satanto più significatipere che i Veronesi ve perché sono proavevano stretto un nunciate pochi mesi patto con alcune prima della vittoria città lombarde; il decisiva di Vittorio monaco Ilarione, Veneto. Dello stesso biografo di Galdino tono gli interventi (l’arcivescovo di Midi altri luminari dellano tra i primi prol’epoca, tra cui motori della riscosFrancesco Torraca Miniatura della Cronica di Giovanni Villani rappre- sa) racconta che i ( 21 ), Isidoro Del sentante una battaglia con il Carrocio in secondo pia- Lombardi decisero Lungo (22) e addirit- no di ribellarsi all’imtura Guglielmo peratore ricostruenMarconi, che afferma risoluto: “Dal ricordo sto- do Milano, da lui rasa al suolo nel 1162; lo stesrico di Pontida e di Legnano togliamo ammae- so dice il vescovo Sicardo di Cremona (25). stramento per vieppiù unire i nostri cuori e le Il vescovo Ottone di Frisinga, zio del Barbarosnostre forze in questi epici momenti, così da sa e autore delle importantissime Gesta preparare una pronta definitiva Legnano che Friderici, morì nel 1158 e non potè parlare della liberi la nostra terra dal barbaro oppressore fi- Lega Lombarda; lo fece però il suo segretario e no ai suoi naturali confini”(23). Pontida è per continuatore Rahewino: “I Cremonesi, i Bresciatutti il momento supremo del riscatto della Pa- ni, i Milanesi che avevano fatto rientro in città, i (20) Ibidem, p. 124. (21) “Di contro alla non solo rinnovata, ma di tanto cresciuta rabbia tedesca, questi devon essere il sentimento e il proponimento di ogni buono italiano; magis quam gloriosam mortem cum libertate incurrere, quam vitam miserandam servitute servare (meglio incontrare una morte gloriosa con libertà che serbare una vita miseranda con servitù)”. Ibidem, p. 128. (22) “Roncaglia, Pontida, Legnano, Costanza, appartengono alla storia, da secoli tramontata, dei Comuni e dell’Impero 50 - Quaderni Padani germanico: ma nella storia, oggi più che mai viva, della nazionalità nostra, chiamata ai supremi cimenti contro lo stesso nemico di allora, quei nomi assumono un significato che anche la critica deve riconoscere idealmente legittimo”. Ibidem, p.130 (23) Ibidem, p.128. (24) “Il nome di Pontida è d’augurio per l’Italia”. (25) Di queste testimonianze non ho potuto prendere visione diretta; cito pertanto da D.Paolo Lunardon, o.s.b., op.cit., pp.27-28. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Lodigiani, i Bergamaschi e i Mantovani, confederatisi con i nemici dell’Impero, si ribellarono” (26). L’anonimo autore degli Annales Mediolanenses Minores la prende un po’ più alla larga: “Nel mese di Novembre 1166 l’imperatore Federico entrò in Lombardia, giunse a Brescia e devastò tutti i campi e le coltivazioni nei dintorni di Brescia e Bergamo, fino ai monti. Poi lasciò Roma con l’esercito, incendiò il portico e un’ala della Basilica di San Pietro e assediò la città; dopo che molti da ambo le parti ebbero trovato la morte e dopo aver ricevuto degli ostaggi, se ne andò. A questo punto (e siamo nel 1167) i Lombardi tutti insieme strinsero vicendevolmente un’alleanza e giurarono. L’imperatore tornò allora a Pavia e cercò di sciogliere i patti e il giuramento dei Lombardi. E poiché non ci riuscì, se ne tornò in Germania” (27). Un po’ diverso il resoconto dell’Annalista guelfo di Piacenza: “Il giorno giovedì 27 aprile 1167 le città della Lombardia stipularono insieme un giuramento, e i Milanesi immediatamente se ne tornarono in città, ricostruirono Tortona e innalzarono Alessandria” (28). Il giuramento viene perciò messo in rapporto con il rientro dei Milanesi nella loro città dopo che questa era stata rasa al suolo dal Barbarossa nel 1162. Riecheggia o è riecheggiata in queste parole anche la narrazione dello stesso avvenimento fatta da Muzio di Modoetia (Monza), ghibellino e quindi di parte opposta: “Giovedì 27 aprile 1167 le città della Lombardia fecero insieme un patto; i Milanesi tornarono subito nella loro città, riedificarono Tortona e costruirono Alessandria” ( 29). La corrispondenza è quasi letterale. En- trambi questi cronisti e l’Annalista milanese (30) pongono nella stessa data il ritorno dei Milanesi; tuttavia quest’ultimo non concorda con gli altri due circa la data del giuramento, che viene invece lasciata nel vago. Non parla del giuramento ma solo (e con toni patetici) della rientrata dei Milanesi un altro Annalista indigeno: “Nel frattempo, dopo che molti profughi avevano trasportato le loro cose alcuni nelle vicinanze di Milano, altri a Como, altri a Novara, altri a Pavia, altri a Lodi, altri ancora in campagna, arrivarono per primi i Bergamaschi e poi i Bresciani e i Cremonesi, il 27 aprile 1167, e li ricondussero in città. Dopo questo fatto, l’arcivescovo Galdino, che si trovava dal papa Alessandro, giunse il 5 settembre” (31). Ma il più loquace di tutti, dato che ci racconta anche il contenuto del patto, è l’Anonimo continuatore di Acerbo Morena, di Lodi come il suo precedessore. La sua opera ci è giunta in svariati codici; proprio per questo episodio abbiamo due diverse redazioni, una più lunga, l’altra più sintetica, entrambe sostanzialmente concordi. Ecco il suo resoconto nella versione più estesa: “I Milanesi, poiché erano oppressi molto di più degli altri Lombardi e dato che non ritenevano di poter liberarsi né vivere in nessun modo, alla fine si incontrarono con i Cremonesi, i Bergamaschi, i Bresciani, i Mantovani e i Ferraresi. Dopo che tutti si furono radunati, e dopo essersi raccontati a vicenda tutte le angherie e i soprusi che venivano loro imposti dai procuratori e dai rappresentanti dell’imperatore, decisero che, in caso di necessità o in mancanza di altra scelta, sarebbe stato meglio morire con onore piuttosto che continuare a vivere in modo così basso e ( 26) “Cremonenses, Brixienses, Mediolanenses ad locum suum reversi, Laudenses, Pergamenses, Mantuani hostibus imperii confederati rebellant”. Rahewini Gesta Friderici Imperatoris. Appendix, in Monumenta Germaniae Historica (M.G.H.), Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 1912, pagg. 349. (27) “A.D. 1167. de mense Novembris dominus imperator Federicus intravit in Lombardiam, et venit Brixiam, et devastavit blavas et arbores Brixie et Pergami usque ad montes. Et deinde abiit Romam cum exercitu, et combursit porticum et alam Sancti Petri et obsedit Romam, multorum ab utraque parte nece accepta et acceptis inde obsidibus recessit. Et iterum Lombardi se invicem iuramento insimul pacti sunt. Et imperator Papiam reversus est; et conatus est solvere iuramenta et pacta Lombardorum. Et cum hoc facere nequiverit, in Alamaniam reversus est”. Annales Mediolanenses Minores, in M.G.H., Scriptores (SS), vol. XVIII, pag. 395. (28) “1167. die Iovis 3.Kal. Madii civitates Lombardie insimul concordiam fecerunt, et Mediolanenses statim intus civitatem redierunt, et Terdonam et Alexandriam levaverunt et rehedificaverunt “. Annales Placentini Guelfi, in M.G.H., SS vol. XVIII pag. 413. (29) “1167. die Iovis, 4 Kalendas Madii, civitates Lombardie insimul concordiam fecerunt, et Mediolanenses statim intus civitatem redierunt, et Terdonam rehedificaverunt, atque civitatem Alexandrie hedificaverunt”. Mutii de Modoetia Annales Placentini Gibellini, in M.G.H., SS vol. XVIII. (30) “Et eodem anno (sc. 1167) in die Iovis, 5 Kal. Maii Mediolanenses intraverunt in suam civitatem cum auxilio Brixiensium et Pergamensium et Cremonensium” (“E nello stesso anno giovedì 27 aprile i Milanesi entrarono nella loro città con l’aiuto dei Bresciani, dei Bergamaschi e dei Cremonesi”). Annales Mediolanenses Minores, cit., pag. 395. (31) “Interea cum iam multi res suas exportassent, alii iuxta civitatem Mediolani, alii Cumas, alii Novariam, alii Papiam, alii Laudae, alii ad villas, venerunt Pergamenses primum et Brixenses et Cremonenses 1167, quinta febria, 5 Kal.Madii, et introduxerunt eos in civitatem. Post haec vero Galdinus, qui erat cum papa Alexandro, venit 5 die Septembris”. Annales Mediolanenses, in M.G.H., SS vol.XVIII, pag. 377. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 51 disonorevole. Dunque tutti insieme giurarono e strinsero un patto col quale ogni città aderente si impegnava a soccorrere le altre qualora l’imperatore, i suoi procuratori o i suoi rappresentanti avessero voluto senza motivo angustiare o danneggiare qualcuna di esse. E lo giurarono con fermezza, mantenendo salva tuttavia - così dicevano apertamente - la fedeltà all’imperatore (...) Finita la riunione, tutti se ne tornarono a casa soddisfatti” (32). In tutte le fonti esaminate finora, mai una volta si fa il nome di Pontida. E neanche la data del patto corrisponde a quella tradizionale: non il 7, ma il 27 aprile 1167. Di quest’ultimo giuramento inoltre non possediamo nemmeno il testo originale (33), ma ne conosciamo il contenuto grazie al continuatore di Acerbo Morena. Chi fu dunque a tirare fuori il nome di Pontida e a stabilire il 7 aprile 1167 come data dell’epico raduno? Il primo fu il milanese Bernardino Corio nella sua Historia Patria (Storia di Milano) apparsa nel 1503. Dice infatti il Corio: “Per il che Milanesi, li quali più che veruno altro de Lombardia erano aflicti in modo che fugire non ardivano né stare potevano, deliberarono de fare uno concilio inscieme con Cremonensi, Bregamaschi, Bressani, Mantuani e Ferraresi, li quali al septimo d’aprile in el templo di Sancto Iacobo in Pontida nel Bergamascho convenendosi, furono recitate per ciascuno le recevute ingiurie, le quale sopportandole, cognosceano più non pote- re vivere, per il che ad ogniuno pareva essere melio con honore una sola volta morire che sotto di tanta tyrannide vivere” (34). Da questa narrazione attinge dichiaratamente Carlo Sigonio, storico modenese, nel 1584: “Sistemate queste cose, i rappresentanti di ogni singola città si ritrovarono il 7 aprile presso il monastero di Pontida, tra Milano e Bergamo. (...) Quindi con decisione comune conclusero un patto con questo motto, che cioè avrebbero difeso con le armi comuni la propria libertà” (35). La narrazione dello storico milanese in particolare riecheggia abbastanza vistosamente quella del continuatore del Morena, ma retrocede la data di una ventina di giorni. Perché questa discrepanza con le fonti? Impossibile stabilirlo con certezza. O il Corio possedeva un manoscritto della cronaca con una trascrizione della data erronea (ipotesi tuttavia paleograficamente poco giustificabile) oppure attinse da una fonte a noi ignota o andata perduta nel corso dei secoli. Questa ipotetica fonte doveva comunque essere sparita poco dopo l’utilizzo da parte del Corio se Ludovico Antonio Muratori nel Settecento non la conosceva (36). Fatto sta che dal Corio in poi Pontida entrò nella tradizione. Poiché nessuno parla di Pontida prima di lui, è difficile dire se ci sia da credergli oppure no. Nella prefazione della sua opera egli sostiene che la verità è l’anima della storia e afferma di aver curato con diligenza le fonti utilizzate e gli avvenimenti narra- (32) “Mediolanense namque, cum multo magis quam alii Longobardi ita opprimerentur, quod nullo modo evadere aut vivere posse puterent, tandem cum Cremonensibus et Pergamensibus atque Brixiensibus seu Mantuanis ac Ferrariensibus colloquium fecerunt. Qui omnes cum insimul coadunati fuissent ac mala et incomoda, a procuratoribus imperatoris et missis sibi illata, vicissim inter se retulissent, melius esse cum honore mori, si opporteret et aliter fieri non posset, quam turpiter et cum tanto dedecore vivere, statuerunt. Quapropter illi statim fedus omnes inter se inierunt et concordiam. Atque pactum, hoc videlicet quod unaqueque civitas adiuvaret alteram, si imperator aut eius procuratores vel missi aliquam iniuriam vel malum amplius sine ratione eis inferre vellent, firmiter inter se firmaverunt ac iureiurando, salva tamen, sicut dicebatur palam, imperatoris fidelitate, corroboraverunt.(...) Quo quidem sic peracto, omnes leto animo ab ipso colloquio separati sunt”. Anonymi Laudensis Continuatio Acerbi Morenae, in M.G.H., SS vol.XVIII. Questa la versione contenuta nei codici B 4 e 5. La versione dei codici A 1 e 2 è più sintetica, ma sostanzialmente uguale. Riguardo al mantenimento della fedeltà all’imperatore, essa riporta che il giuramento era valido “salva tamen semper imperatoris omni fidelitate, quam sibi per hoc pactum infringere nullatenus intendebant” (“fatta salva tuttavia sempre la completa fedeltà all’imperatore, che essi non intendevano infrangere per nessun motivo a causa di questo patto”). Ibidem. (33) Non esiste infatti nessun atto ufficiale che contenga il testo del giuramento del 27 aprile, né tantomeno di quello ipotetico del 7 aprile 1167: gli unici atti ufficiali sulla Lega Lombarda relativi la 1167 sono di un non meglio precisato giorno di marzo, del 22 maggio, del 27 maggio, del 1 dicembre e del 28 dicembre. Si veda l’edizione ne Gli Atti del Comune di Milano ... cit. (nella raccolta, gli atti n. 50, 54, 55, 56 e 57). Tutti i documenti relativi alle assemblee della Lega sono contenuti in questa raccolta, ma sono editi anche in Cesare Vignati, Storia Diplomatica della Lega Lombarda (Milano: P.Agnelli, 1866). (34) Bernardino Corio, Historia Patria (Storia di Milano), Torino: UTET, 1978 (Classici UTET, vol. 1, pagg. 228 ÷ 229). (35) “Quibus rebus compositis singularum legati civitatum VII Idus Aprilis ad Pontidense monasterium inter Mediolanum et Bergomum convenere (...). Itaque communi consilio foedus in hanc sententiam percusserunt, se communibus armis libertatem defensuros”. Carlo Sigonio, Historiarum De Regno Italiae ab anno 570 ad annum 1200 libri XX, libro XIV, 777. (36) Si veda su ciò quanto detto in Gian Luigi Barni, Storia di Milano, vol. IV, (Fondazione Treccani, 1954), pagg. 83 ÷ 84, e bibliografia fornita alla nota 5. (36) Si veda su ciò quanto detto in Gian Luigi Barni, Storia di Milano, vol. IV, (Fondazione Treccani, 1954), pagg. 83 ÷ 84, e bibliografia fornita alla nota 5. 52 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 ti. Tuttavia più di una volta si sofferma a raccontare episodi assolutamente poco attendibili e particolari biografici pressoché inventati. Chi ci impedisce di pensare che anche per Pontida non abbia fatto lo stesso? Comunque la si pensi, bisognerebbe tener conto del fatto che il Corio, vissuto alla corte Sforzesca, fu incaricato di scrivere la storia di Milano da Ludovico il Moro, che mise a sua disposizione gli archivi (37). Il Corio potrebbe in effetti aver preso visione di un documento autentico per noi perduto. Un’altra fonte ingiudicabile dal punto di vista dell’attendibilità è il brano, contenuto in Il papa Alessandro III riceve il messo del Barbarossa. Affresco un codice oggi irreperibile, di Spinello Aretino che conteneva un catalogo di vescovi milanesi e che fu utilizzato ai tempi di rio): l’enigma resta così senza soluzione. S. Carlo Borromeo per ricostruire la storia della La situazione oggi: un problema irrisolvibile? diocesi. Al nome di Oberto Pirovano, vescovo Purtroppo dunque non esiste alcun documenappunto ai tempi della costituzione della Lega to autentico che provi l’esistenza del giuramenLombarda, si legge: “Questo arcivescovo, uomo to di Pontida. Ma se ciò è vero, lo è altrettanto di somma prudenza, dopo aver tenuto una riu- che non esiste alcun documento che provi il nione con le città confinanti nella chiesa di contrario (39). La questione dunque non è affatto S.Giacomo di Pontida, nel Bergamasco, allo risolta, né, temiamo, lo sarà mai. scopo di promuovere la ricostruzione della Un sussulto a dire il vero lo si ebbe, ed in piecittà di Milano, portò felicemente a termine il na tempesta risorgimentale, nel 1854, quando, suo desiderato progetto, ma, raggiunto in anti- mentre si stavano eseguendo degli scavi nei cipo dalla morte, non potè portare a termine la pressi del monastero di Pontida, venne alla luce sua iniziativa” (38). Il codice originale che con- una testimonianza che sembrava fugare ogni teneva questo scritto è introvabile, malgrado le dubbio circa la veridicità storica dell’avvenimenaccurate ricerche fatte alla Biblioteca Vaticana; to. Si trattava di quattro lapidi antiche che recatuttavia esso fu riprodotto e dato alle stampe vano la seguente iscrizione: I lapide: “Federaprima dello smarrimento del manoscritto. Non tio/longobarda/Pontide”; II lapide: “Die/VII apriè perciò possibile oggi controllare l’esattezza e lis/MCLXVII”; III lapide: “Sub ausp./Alexandri l’attendibilità della testimonianza (l’unica rela- III/P.M.”; IV lapide: “Monaci/posuere” (40). tivamente antica oltre a quella fornita dal CoInutile dire che intorno al ritrovamento si sca(37) Si veda l’Enciclopedia Italiana, vol. XI, pagg. 411 ÷ 412 sub voce “Corio, Bernardino”. (38) “Hic Archiepiscopus, summa prudentia, conventu habitu in Ecclesia S.Jacobi de Puntida agri Bergomensis de instauranda iterum Urbe Mediolani cum finitimis civitatibus, votum sui desiderii feliciter implevit: sed morte preaventus non potuit perfrui desideriis optatis”. Citato in D.Paolo Lunardon, o.s.b., op. cit., pag. 45. (39) Interessante ciò che sostiene Locatelli Milesi quando afferma che il giuramento non ebbe luogo a Pontida, ma a Bergamo “davanti all’ingresso secondario di S. Maria Maggiore, di facciata al lato della Cattedrale (...). Questa la stoAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 ria: ma la leggenda persiste a ritenere che la Lega Lombarda sia stata fondata a Pontida”. S. Locatelli Milesi, La Bergamasca, Bergamo, 1942, pag. 269, citato in D. Paolo Lunardon, o.s.b., op. cit., pag. 34. Una precisione davvero notevole quella del Locatelli, che ricostruisce il luogo nei minimi dettagli. Su quali basi però, non ci è dato sapere. (40)” Lega Lombarda di Pontida. Giorno 7 aprile 1167. Sotto la protezione di papa Alessandro III. I monaci posero”. Si veda la riproduzione delle lapidi in Gian Luigi Barni, op. cit., pagg. 82 ÷ 83. Esse si trovano ancora oggi presso il monastero di San Giacomo di Pontida. Quaderni Padani - 53 tenò una vera e propria bagarre di eruditi, storici, patrioti e cultori di memorie locali. Tuttavia fu presto dimostrato che le lapidi, incise con lettere gotiche, erano assai più tarde: l’unica cosa che documentarono fu che la leggenda di Pontida nacque e si diffuse successivamente all’evento. Oggi però molti sono disposti ad ammettere la veridicità storica del giuramento di Pontida. Tra questi, c’è il D. Paolo Lunardon, o.s.b., che arreca tutta una serie di possibili argomenti a favore (41): oltre a fatti storici e a parentele, ricorda la stretta relazione che esisteva tra questo monastero della bergamasca e la città di Milano. La posizione ufficiale della storiografia resta comunque una non-posizione: la maggior parte degli storici più quotati si limita ad ignorare l’avvenimento (42) oppure dà ad esso uno scarsissimo rilievo. Questo atteggiamento del resto non ci stupisce più di tanto, soprattutto se teniamo presente il modo in cui generalmente sono trattati gli argomenti, i fatti e i personaggi che hanno fatto la storia della Padania a partire dalle epoche più remote: quasi sempre oggetto di una visione storiografica distorta e faziosa, lontani dall’essere valorizzati in tutta la loro importanza. Di questo modo di fare storia anche Pontida è stata vittima. Malgrado infatti manchino prove inoppugnabili e definitive, alcuni studiosi ne rifiutano la realtà storica (43). Chissà perché, Pontida andava bene solo quando (come durante il Risorgimento o l’epoca nazionalista) poteva essere usata come simbolo di unità nazionale: non importa se si commetteva un falso storico clamoroso nello spacciare i rappresentanti dei Comuni riuniti sulla piana come i progenitori di Cavour, Mazzini, Garibaldi e compagnia bella. Quei guerrieri medievali infatti non solo non avevano (né potevano avere) alcun concetto di unità nazionale - dato che per loro il termine “patria” era applicabile al più alla città di origine, ed anzi spesso c’era dell’astio non solo tra abitanti di città tra loro vicine, ma anche tra abitanti della città e rustici del contado da loro dipendenti - , ma probabilmente, per tutta una serie di motivi storici, economici, culturali e, perché no, d’interesse, dall’averlo se ne guardavano bene. La volontà di falsificare la storia - o perlomeno di distorcerla - ha fatto sì che la Padania per secoli non conoscesse veramente il proprio passato. Anche per questo, dunque, far luce su Pontida è un’impresa. Oggi più che mai, inoltre, è un rischio. Qualcuno infatti ha pensato di riportare in auge il giuramento per uno scopo sicuramente più consono allo spirito originario dal quale e per il quale era nato: la volontà da parte di singoli popoli oppressi di lottare contro il proprio oppressore. Un simbolo, dunque, di libertà, che può mettere a repentaglio un castello di carta creato a tavolino in meno di un secolo e mezzo e che oggi si rivela in tutta la sua drammatica fragilità. Anche se nessuno è in grado di dire la parola definitiva su tutta la questione, che il giuramento sia avvenuto proprio a Pontida, malgrado il silenzio secolare delle fonti - che peraltro, si sa, sono spesso soggette a mutilazioni, scomparse e distruzioni più o meno volontarie -, secondo noi è assai probabile. Un indizio importante è dato anche dagli ottimi rapporti tra la città di Milano e il monastero, vero e proprio baluardo nei momenti di riscatto, rifugio dei fuoriusciti che lottavano per la riconquista delle libertà cittadine. In qualunque modo la si pensi, per noi è bello pensare che un giorno di primavera di oltre otto secoli fa un manipolo di uomini coraggiosi decise di unirsi per mettere la parola “fine” allo sfruttamento e alle prepotenze di cui erano vittime. In questo senso, forse - e indipendentemente dalla veridicità storica dell’episodio - Pontida e la Lega Lombarda possono ancora insegnare qualcosa ai padani d’oggi: fin tanto che essi rimasero uniti, non vi fu mai nemico abbastanza potente in grado di opporsi alle loro forze. (41) Si leggano tali argomentazioni in D. Paolo Lunardon, o.s.b., op.cit., pagg. 35 ÷ 53. (42) Ad esempio, Ferdinand Opll, op.cit, ma anche il volume di A.A.V.V., Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania (Bologna: Il Mulino, 1982), in particolare il saggio di G. Fasoli, Aspirazioni cittadine e volontà imperiale. Lo stesso vale per Ruddph Wahl, Barbarossa (Torino: Einaudi 1945). Propensi ad ammettere la realtà storica di Pontida sono Giorgio Giulini, il Momigliano e molti altri. Si legga anche il bellissimo libro di Claudio Roveda, Pontida. Abbazia della Concordia (Pavia: Editoriale Viscontea, 1997). Recentemente, lo storico Ludovico Gatto in due suoi libretti di grande divulgazione: L’Italia dei Comuni e delle Signorie (Roma: Newton Compton,1996), p.41 e Il Medioevo (Roma: Newton Compton, 1994), p.52. Lo stesso fanno molti manuali scolastici. Franco Cardini riporta la tradizione ma la considera leggenda tardiva: Franco Cardini, Il Barbarossa, op. cit., pag. 274 e, in generale, La vera storia della Lega Lombarda (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1991), passim. E si potrebbe continuare... (43) Ad esempio il Barni, op. cit., pag. 84 (e nota 1). 54 - Quaderni Padani Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 I nomi della nostra gente L’impruntu da sc-ciavitü u l’è u parlà a lengua di opresùi (Il marchio della schiavitù è parlare la lingua degli oppressori) Padani delle ultime generazioni sono stati rapinati anche dei nomi (e a volte dei cognomi): spesso italianizzazioni banalizzanti o nomi del tutto estranei alle nostre culture hanno sostituito nomi antichi e amati. Anche il ridarsi nomi nostri o battezzare i nostri figli con nomi padani è un segno forte di libertà. I Continua l’opera di informazione con l’onomastica Ligure: a ogni nome in toscano (in corsivo), viene affiancata la versione con grafia originaria, seguita dalla grafia unificata padana. La grafia ligure è stata redatta con la collaborazione di Flavio Grisolia, quella padana da Antonio Verna. Achille - Chille - Chìle Adelaide - Adelaide, Delaide - Adelàide, Delàide Adele - Adele - Adéle Adelina - Adelinn-a - Adelìnn-a Adolfo - Duurfu - Dùrfu Adriano - Adriàn - Adriàn Agnese - Agneise, Gneise - Agnéise, Gnéise Agnesina - Agnesinn-a - Agnesìnn-a Agostina - Agostinn-a - Agustìnn-a Agostino - Östin - Oustìn Alberto - Öberto - Oubértu Albino - Albìn - Albìn Alessandro - Lisciandro - Lisciàndru Alessio - Alescio - Alésciu Alfonso - Arfonso - Arfùnsu Alfredo - Alfredo - Alfrédu Alice - Lice - Lìce Amalia - Malia - Màlia Ambrogio - Ambreuxo, Breuxo - Ambröju, Bröju Amedeo - Medeo - Medéu Ampelio - Ampegi - Ampégi Andrea - Andrïa - Andrìia Angela - Angënn-a, Angienìn - Angéenn-a Angelina - Angiolinn-a - Angiulìnn-a Angelo - Angën - Angéen Anna - Netta - Néta Annetta - Ninna - Nìna Annunziata - Nonçi‚ - Nunsià Antonia - Tònia, Toniëta - Tònia, Tuniéeta Antonio - Antögno - Antóognu Apollonia - Polònia - Pulònia Arturo - Arturo - Artüru Assunta - Sùnta - Sùnta Attilio - Tillio - Tìliu Barbara - Barboa - Bàrbua Bartolomeo - Bertomelin - Bertumelìn Bastiano - Bastian - Bastiàn Battista - Battista, Titta - Batìsta, Tìta Battista - Baciccia, Baciccìn - Bacìcia, Bacicìn Beatrice - Bice - Bìce Bendetta - Beddin - Bedìn Benedetta - Benedetta - Benedéta Benedetto - Benedetto, Beneito - Benedéru, Beneitu Berenice - Nice - Nìce Bernardo - Benardo - Benàrdu Biagio - Biaxo - Biàju Bianca - Bianchin,Gianca - Bianchìn, Giànca Camilla - Camilla, Lilla - Camìla, Lìla Camillo - Camillo, Lillo - Camìlu, Lìlu Carla - Carla - Càrla Carlo - Carlo, Carlìn - Càrlu, Carlìn Carlotta - Carlòtta - Carlòta Carmelina - Carmelinn-a - Carmelìnn-a Carmelo - Carmelo - Carmélu Carmen - Carmen - Càrmen Carola - Carola - Càrula Carolina - Carolinn-a - Carulìnn-a Caterina - Cataenn-a, Cataen, Catin - Catèenn-a, Catèen, Catìn Cecilia - Çeçilia - Sesìlia Celestina - Celeste, Celestinn-a - Celéste, Celestìnn-a Cesare - Cesare - Césare Chiara - Ciaea, Ciaenn-a - Cièea, Cièenn-a Cipriano - Çeprian,Çeprianìn - Sepriàn, Seprianìn Clelia - Crelia - Crélia Clotilde - Cotirde - Cutìrde Colomba - Comba - Cùmba Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 55 Colombano - Combàn - Cumbàn Cosimo - Cöximo - Coojimu Costante - Costante - Custànte Crispino - Crispìn - Crispìn Cristina - Cristinn-a - Cristìnn-a Cristoforo - Cristoffa - Cristùfa Damaso - Dàmaso - Dàmasu Damiano - Damiàn - Damiàn Daniele - Danê - Danè Davide - Davidde, Daviddìn - Dàvide, Davidìn Desiderio - Dexidëio - Dejidéeyu Domenica - Minica - Minica Domenico - Menego - Ménegu Donato - Donòu - Dunòu Edoardo - Doardo - Duàrdu Elisabetta - Lizabetta - Lisabéta Emma - Emma - Éma Enrichetta - Enrichetta, Richetta - Enrichéta, Richéta Enrico - Ricco - Rìcu Ernesta - Nesta - Nésta Ernesto - Nesto - Néstu Eugenia - Genia - Génia Eugenio - Eugenio, Genio - Eugeniu, Géniu Eusebio - Zeuggio - Sögiu Fanny - Fanny - Fàny Felice - Feliçe, Feliçìn - Felìse, Felisìn Felicina - Feliçinn-a - Felisìnn-a Felicita - Feliçita - Felìsita Ferdinando - Nando - Nàndu Filippo - Feippo, Feippìn - Feipu, Feipìn Flavio - Fravio - Fràvio Fortuna - Fortunn-a, Fortonìn - Furtùnn-a, Furtunìn Fortunato - Fortunòu - Furtunòu Francesca - Cicca, Cicchina - Cìca, Cichìna Francesco - Françesco, Françeschin - Franséscu, Franseschìn Francesco - Cesco, Checco, Checchin - Céscu, Chécu, Chechìn Gaetano - Gaitàn - Gaitàn Gaspare - Gaspaen - Gaspèen Gerolamo - Giömin - Gioumìn Geronima - Giònima, Mominn-a - Giònima, Mumìnn-a Giacinta - Giaçinta, Giaçintinn-a - Giasìnta, Giasintìnn-a Giacinto - Giaçinto - Giasìntu Giacomo - Giacomo,Giacomìn - Giacumu, Giacumìn Gilberto - Gilberto - Gilbértu Gioacchino - Gioachìn - Giuachìn Giorgio - Zorzo - Sòrsu Giovanna - Gioana, Gioanetta, Gioaninn-a 56 - Quaderni Padani Giuàna, Giuanéta, Giuanìnn-a Giovanni - Zane - Sàne Giovannina - Zäninn-a - Saanìnn-a Giulio - Giùlio - Giùliu Giuseppe - Giöxeppe, Beppe, Pippo - Gioujépe, Bépe, Pìpu Giuseppina - Giöxeppinn-a, Beppinn-a Gioujepìnn-a, Bepìnn-a Gregorio - Grigheu - Grigöö Guglielmo - Ghigermo - Ghigérmu Ignazio - Ignaçio - Ignàsiu Ilario - Läio - Làaiu Isabella - Zabella - Sabèla Isidoro - Ixidòu - Ijidòu Laura - Laura - Làura Lazzaro - Lazzao, Lazzaen - Lasàu, Lasèen Lorenzina - Loensinn-a - Luensìnn-a Lorenzo - Loenso - Luénsu Luca - Lucco - Lücu Lucia - Luçïa - Lüsìia Luigi - Loigi, Gigi, Gitto - Luìgi, Gìgi, Gìtu Luigia, Luisa - Giggia - Gìgia Luisa - Luigia - Lüìgia Maddalena - Nanàn - Nanàn Manuela - Manoela, Manoelinn-a - Manuéla, Manuelìnn-a Manuele - Manuelo - Manuélu Marcello - Marçello, Marçellin - Marsélu, Marselìn Marco - Marco - Màrcu Margherita - Margaita - Margaìta Marianna - Mariann-a - Mariànn-a Marina - Marinn-a - Marìnn-a Martino - Martìn - Martìn Massimo - Mascimo - Màscimu Matilde - Metirde - Metìrde Matteo - Mattê, Mattelin - Matée, Matelìn Mercedes - Mercede - Mercéde Michele - Michê - Michée Natale - Natalìn - Natalìn Natalina - Natalinn-a - Natalìnn-a Nicoletta - Colletta, Collettinn-a - Culéta, Culetìnn-a Olcese - Orçeise - Urséise Palmira - Parmira - Parmìra Pantaleone - Pantalìn - Pantalìn Paola - Paola - Pàula Paolo - Paolo - Pàulu Pasquale - Pasquaen - Pascuèen Pasqualina - Pasquinn-a - Pascüìnn-a Pellegrina - Pellegrinn-a - Pelegrìnn-a Pellegrino - Pellegro - Pelégru Pietro - Pëo, Pedrìn - Péeu, Pedrìn Prospero - Pròspeo, Prospoin - Pròspeu, ProAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 spuìn Riccardo - Riccardo - Ricàrdu Rocco - Rocco - Rùcu Rodolfo - Rodorfo - Rudùrfu Romeo - Romê - Rumée Rosa - Reuza - Rösa Salvatore - Sarvatû - Sarvatù Saverio - Xavêio - Javéeyu Sebastiano - Bastiàn - Bastiàn Serafina - Serafìnn-a - Serafìnn-a Serafino - Serafìn - Srafìno Severino - Severìn - Severìn Silvestro - Silvestro - Silvéstru Silvio - Sirvio - Sìrviu Simone - Scimùn - Scimùn Sisto - Scisto - Scìstu Stefano - Stéva, Stea - Stéva, Stea Susanna - Susànn-a - Süsann-a Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Teodolinda - Teodolinda - Teudulìnda Teodora - Teodôa - Teudùa Teodoro - Teodôu - Teudóu Teresa - Tëxa - Téeja Tito - Tito - Tìtu Tommasina - Maxinn-a - Majìnn-a Tommaso - Tomaxo, Maxo - Tumàju, Màju Uberto - Uberto - Übértu Ugo - Ugo - Ügu Umberto - Umberto - Ümbértu Vincenzo - Viçenso, Viçensin - Visénsu, Visensìn Violante - Violante - Viulànte Violantina - Violantinn-a - Viulantìnn-a Vittoria - Vittôia - Vitùia Vittorio - Vittòio - Vitòiu Zaccaria - Zaccaia - Sacaìa Zeminiano - Zemignàn - Semignàn Zita - Sitta - Sìta Quaderni Padani - 57 Biblioteca Padana Franco Monteverde, Sovranità e autonomie mediterranee Genova e la Liguria Firenze: Vallecchi Editore, 1997 Pagg. 268, L. 27000 La Padania, come molti hanno già avuto modo di notare, è uno splendido mosaico di popoli diversi determinati a restare uniti nella lotta: uno di questi popoli, e uno dei più antichi, è quello ligure, che solo recentemente è tornato agli onori delle stampe dopo un lunghissimo tasso di tempo in cui troppo pochi sono stati i testi dedicatigli. Tra i protagonisti del “revival linguistico” va annoverato senza ombra di dubbio Franco Monteverde, studioso serio e appassionato della propria terra, cui ha regalato numerosi scritti. L’ultimo in ordine di tempo è, appunto, Sovranità e autonomie mediterranee - Genova e la Liguria, libro a tutto tondo su ciò che resta della Superba. Fin dall’incipit risulta chiaro dove Monteverde voglia arrivare: si inizia infatti sottolineando il declino che la Liguria ha subito negli ultimi due-trecento anni, declino evidente nel Päxo (oggi conosciuto come Palazzo Ducale) che, se fu negli anni passati la sede dei Magnifici e il simbolo universalmente riconosciuto dell’unità e della ricchezza del popolo ligure, nel 1998 è ridotto a ospitare mostre e convegni che, con tutto il rispetto, rappresentano solo una caduta di stile rispetto ai tempi andati. Perché, si chiede Monteverde, al Päxo non si è affidato un 58 - Quaderni Padani compito “istituzionale”, ad esempio ospitare la sede della Regione Liguria? Forse per sottolineare come, accanto alla morte di istituzioni funzionali come quella della Genova che fu, assistiamo solo alla nascita di strutture, come le Regioni, prive di un reale potere e quindi ridotte a inutili apparati burocratici? Monteverde passa poi a esaminare nel dettaglio l’etnia ligure, il cui tratto fondamentale va rintracciato nel darsi da fare da un lato, e nello spirito fazzioso che da sempre anima i genovesi dall’altro. “Per un ligure darsi da fare non costituisce fatica e pena, né il lato notturno della storia dell’uomo, né, tanto meno, un ostacolo al raggiungimento della felicità, ma rappresenta il centro della vita, il primo dovere al quale un uomo non può sottrarsi, se intende vivere libero”: solo così si spiega come sia stato possibile per i liguri, figli di una terra inospitale e avara, andare alla conquista del mondo (una conquista fatta non con le armi ma con il denaro) fino a diventare, a un certo momento della storia, la vera e propria cassaforte dell’Europa. Ma soprattutto i liguri hanno saputo elaborare un sistema giuridico di common law (analogo a quello britannico e americano di oggi) in cui era del tutto assente il concetto di “diritto pubblico”: ogni problema poteva essere ricondotto a una faccenda di “diritto privato”, da risolvere con accomodamenti, arrangiamenti, risarcimenti. Solo da queste premesse poteva nascere uno “stato” come la Repubblica di Genova (che era quanto di più lontano possa esistere dagli stati moderni accentratori, tassatori e pianificato- ri): uno stato che, per tutta una serie di motivi, poteva ben essere definito esempio di tolleranza e di stato di diritto (anzi, dei diritti) per tutti. Sono pochissime le guerre combattute dalla Repubblica: questa infatti aveva scelto una politica di neutralismo e si limitava a fornire mercenari a chiunque fosse in grado di pagarli. Anche quando Genova si è trovata direttamente coinvolta in conflitti, le armi sono state l’extrema ratio: si è preferito infatti sempre seguire fin dove possibile la strada della trattativa e dell’accordo finanziario (tutte le colonie genovesi erano state regolarmente acquistate, e nessuna conquistata...), anche perché, vista l’intensa e redditizia attività dei mercanti e degli armatori, i soldi non mancavano. Il vero declino della Liguria comincia con le invasioni napoleoniche, che portarono e imposero dei modelli nuovi e del tutto innaturali: il che ebbe solo l’effetto di spaesare completamente i Liguri e di tarpare le ali a quanti intendevano darsi da fare alla vecchia maniera. Con l’unità d’Italia, poi si ebbe il disastro e il tracollo: a istituzioni leggere, neutrali e liberoscambiste si sostituì uno stato forte e guerrafondaio, centralizzato e burocratico. Si mutò radicalmente l’impostazione economica della Liguria: ad un’economia basata sullo scambio e sul commercio si sostituì un’economia industriale, oltretutto imperniata sulla grande industria di stato e, quindi, sull’assistenzialismo. Chiaramente questo, in un primo tempo, ebbe effetti positivi, poiché portò denaro e benessere: ma tali effetti sono stati brevi e hanno lasciato solo spazio alla miseria e alla disoccupazione attuali. Anno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Biblioteca Padana Non si può pretendere di cambiare, dall’oggi al domani, un’intera economia naturale creata con secoli di sforzi, sacrifici e impegni, un’economia che per di più non chiedeva affatto di essere cambiata, perché funzionava. Finita la rievocazione storica, si passa ad esaminare l’attualità (sottolineando l’importanza della Lega Nord, di cui pure l’autore non condivide alcune impostazioni, nell’aver abbattuto un ceto politico parassitario e nell’aver riportato al centro del dibattito le vecchie “piccole patrie”). In particolare Monteverde sostiene, con una certa preoccupazione, che l’Italia ha creato una immensa nomenclatura burocratica, passata poi quasi per osmosi, alla politica: e questo rappresenta un grave pericolo per tutti, poiché è tipico della mentalità del burocrate stabilire il primato della procedura sull’individuo, mentre invece procedure, leggi e istituzioni dovrebbero essere unica- mente poste al servizio e a tutela del cittadino. La burocrazia ha creato un mostro irriformabile, che va senza esitazione eliminato. La via per liberarsi di un simile moloc è, secondo l’autore, quella della città stato: bisogna ricondurre il tutto a una federazione, su basi volontarie, delle varie comunità presenti nel nostro paese, in maniera tale che vengano messi in comune alcuni (pochi) poteri, mentre tutto il resto è demandato all’autogoverno delle comunità locali. Un modello simile a quello fornitoci dalla Repubblica di Genova, che aveva visto unirsi alla grande Genova tutta una serie di cittadine minori, senza che nessuno dominasse o imponesse le proprie tasse agli altri: il che va di pari passo con la globalizzazione dei mercati, che ha reso piccolo il mondo e, favorendo la circolazione dei beni e delle merci (per utilizzare una tipica distinzione marxiana), ha portato vantaggi enormi a tutti coloro che ne hanno saputo approfittare e, parimenti, è stata causa di enormi disagi per chi, come l’Italia, si è fatto interprete di politiche protezionistiche e illiberali. Una sola valutazione ci divide da Monteverde, che comunque si è ancora una volta distinto per il proprio coraggio e la propria onestà intellettuale: lo studioso ligure auspica infatti una sorta di “Italia bis” che sappia riconoscere e valorizzare le autonomie locali. Noi invece all’Italia non ci crediamo più: al contrario, chiediamo che finalmente venga riconosciuto ai Padani il loro diritto a costruire nuove istituzioni, indipendenti e sovrane, che sicuramente saranno rispettose dei nostri diritti e delle nostre libertà. Giò Batta Perasso Carlo Beretta, Toponomastica in Valcamonica e Lombardia Milano: edizioni del Centro Camuno, 1997 vulgare in tutto il mondo i principi della toponomastica lombarda, con riferimenti anche ad altre aree padane, rapportandole con altre discipline “umane” come l’archeologia, la paleontologia e la semiologia. Beretta, tra l’altro, ha collaborato con il noto genetista Luca Cavalli-Sforza, arrivando ad interessanti risultati che fanno meglio intendere la centralità dell’area padana rispetto all’Europa e all’Eurasia. “Toponomastica in Valcamonica e Lombardia” individua soprattutto in “idronimi” e “oronimi” i nomi geografici da noi più diffusi, rispettivamente ispirati al fatto che nei pressi del paese vi era un fiume o un colle. A questo proposito prevalgono radici germaniche come “berg”, che significa “monte”, e radici e desinenze di origine celtica, come “ago” e “ate”. Interessante la distribuzione del finale in ATE in Lombardia, come si evince dalla tavola a pag. 102: mentre in provincia di Sondrio non ne possiamo riscontrare alcuno, a testimonianza della prevalente origine retica della Valtellina, troviamo la provincia di Milano maggiormente coinvolta (30 località), seguita nell’ordine da quelle di Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Pavia. Andrea Rognoni È uscito un libro prezioso, frutto di anni di faticosa ricerca da parte di un personaggio di vastissimi orizzonti scientifici ed umanistici, il professor Claudio Beretta del circolo filologico di Milano. Veste e struttura del volume meritano già di per sé un elogio in virtù della bifrontalità: tutti i capitoli, compresi quelli più tecnici, sono tradotti in inglese. L’apparato iconografico è ricco e significativo. L’inedita funzione del lungo e sostanzioso testo è quella di diAnno lV, N. 16 - Marzo-Aprile 1998 Quaderni Padani - 59
Scarica




![Giornata di Spiritualità []](http://s2.diazilla.com/store/data/000458504_1-d7672bb620994f69796c071cf91b2a05-260x520.png)