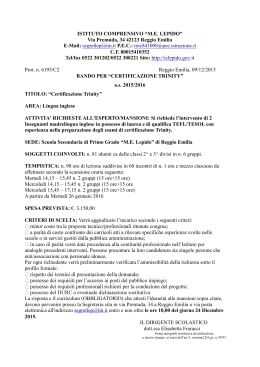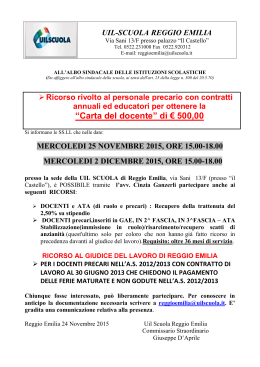R i c e r c h e S All’interno: Ettore Borghi, Riflessioni su un anniversario Alberto Ferraboschi, Il «bardo» della montagna reggiana: Gian Lorenzo Basetti e la democrazia radicale tra Otto e Novecento Francesco Paolella, Antisemitismo italiano di Stato Rodolfo Mattioli, Tre ragazzi uccisi. L’eccidio di Gavassa, Reggio Emilia, 22-23 aprile 1945 Lorenzo Capitani, «Vado al Moro». Documenti e testimonianze Hermes Grappi, Osvaldo Salvarani, «Un socialista weberiano» Matthias Durchfeld, Intervistiamo… la nostra storia. I Ragazzi di Vezzano Alessandra Fontanesi, Come insegnare la storia della Shoah? Una riflessione sul contenuto, sul metodo e sulla formazione dei formatori Valda Busani, Le ragioni e le modalità della ricerca Luciano Casali, Terrorismo fascista, recensione a M. Storchi, Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra Recensioni Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004) art. 1 c. 1 DCB - Reggio Emilia Andrea Paolella, «Io e Giovannino Guareschi: due emiliani internati militari in Germania». Intervista a Gaetano Montanari RS Ricerche Storiche Giorgio Boccolari, Un Archivio «che parla tanto di lui». La documentazione cartacea e multimediale di Cesare Zavattini RS n. 106 Ottobre 2008 Alfio Moratti, Amos Conti, 8 giugno 1916. L’affondamento del «Principe Umberto». Strage di soldati reggiani rivelata grazie agli Albi della Memoria RS t or i c h e € 13 0 ,0 RS RS Anno XL RICERCHE STORICHE N. 106 aprile 2008 Direttore Ettore Borghi Rivista semestrale di Istoreco (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Direttore Responsabile Carlo Pellacani Vice Direttore Mirco Carrattieri Coordinatore di Redazione ed editing Glauco Bertani Comitato di Redazione: Michele Bellelli, Lorenzo Capitani, Alberto Ferraboschi, Alessandra Fontanesi, Fabrizio Montanari, Francesco Paolella, Ugo Pellini, Massimo Storchi, Antonio Zambonelli Direzione, Redazione, Amministrazione Via Dante, 11 - Reggio Emilia Telefono (0522) 437.327 FAX 442.668 http://www.istoreco.re.it e.mail: [email protected] Cod. Fisc. 80011330356 Prezzo del fascicolo Numeri arretrati il doppio Foto di copertina: Cimitero militare Casello n. 44, Sagrado (GO). Tratta da «Così lontana, così vicina. Reggio Emilia e i reggiani nella Grande Guerra», 1-30 novembre 2008. Polo Archivistico, Via Dante 11 Reggio Emilia – Università ModenaReggio, Via Allegri, 9 Reggio Emilia. Fonte: Archivio privato Brugnoli Foto sfondo sezioni: tratta da: come sopra € 13,00 Abbonamento annuale € 20,00 Abbonamento sostenitore € 73,00 Abbonamento benemerito € 365,00 Abbonamento estero € 50,00 I soci dell’Istituto ricevono gratuitamente la rivista I versamenti vanno intestati a istoreco, specificando il tipo di Abbonamento, utilizzando il Conto Corrente bancario BIPOP-CARIRE n. 11701 oppure il c.c.p. N. 14832422 La collaborazione alla rivista è fatta solo per invito o previo accordo con la redazione. Ogni scritto pubblicato impegna politicamente e scientificamente l’esclusiva responsabilità dell’autore. I manoscritti e le fotografie non si restituiscono. Stampa GRAFITALIA – Via Raffaello, 9 Reggio Emilia Tel. 0522 511.251 Fotocomposizione ANTEPRIMA – Via Raffaello, 11/2 Reggio Emilia Tel. 0522 511.251 Editore proprietario ISTORECO Istituto per la Storia della Resistenza Registrazione presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 220 in data 18 marzo 1967 Con il contributo della Fondazione Pietro Manodori Indice Editoriale Ettore Borghi, Riflessioni su un anniversario 5 Ricerche Alberto Ferraboschi, Il «bardo» della montagna reggiana: Gian Lorenzo Basetti e la democrazia radicale tra Otto e Novecento Francesco Paolella, Antisemitismo italiano di Stato Alfio Moratti, Amos Conti, 8 giugno 1916. L’affondamento del «Principe Umberto». Strage di soldati reggiani rivelata grazie agli «Albi della Memoria» 27 Documenti Giorgio Boccolari, Un Archivio «che parla tanto di lui». La documentazione cartacea e multimediale di Cesare Zavattini 67 Memorie Andrea Paolella, «Io e Giovannino Guareschi: due emiliani internati militari in Germania». Intervista a Gaetano Montanari Rodolfi Mattioli, Tre ragazzi uccisi. L’eccidio di Gavassa, Reggio Emilia, 22-23 aprile 1945 Lorenzo Capitani, «Vado al Moro». Documenti e testimonianze Hermes Grappi, Osvaldo Salvarani, «Un socialista weberiano» Didattica Matthias Durchfeld, Intervistiamo… la nostra storia. I ragazzi di Vezzano Alessandra Fontanesi, Come insegnare la storia della Shoah? Una riflessione sul contenuto, sul metodo e sulla formazione dei formatori Alessandra Fontanesi, Le attività didattiche di Istoreco a.s. 2007-2008 Note e Rassegne Valda Busani, Le ragioni e le modalità della ricerca Eletta Bertani, recensione a V. Busani – «C’era freddo dentro il cuore di tutti…» Ricerca sui fatti del 1° gennaio 1945 a Scandiano ed Arceto Luciano Casali, Terrorismo fascista, recensione a M. Storchi, Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-46) Ettore Borghi, Una disputa settembrina Come si cambia un logo Recensioni 9 47 91 101 113 119 125 131 143 147 151 153 159 163 167 3 Editoriale Riflessioni su un anniversario Ettore Borghi 4-11 novembre 1918. Le date della pace per le innumerevoli famiglie in lutto, sparse nell’immenso mondo contadino europeo, che avevano visto aggiungersi alla miserabile fatica e all’umiliazione, inflitte quotidianamente da un ceto proprietario avido ed arrogante, un enorme tributo di sangue per una causa che non era la loro. Per altri, per i Paesi ufficiali, per le classi dirigenti e per il ceto medio – tuttavia deluso dalle promesse fatte ma non mantenibili – fu l’ora della vittoria, o della preparazione per l’immancabile rivincita, che l’esperienza della grande mattanza faceva presagire sarebbe stata ancora più luttuosa. Governi europei insensibili agli sviluppi della cultura e ai valori nuovi di giustizia e di solidarietà avevano irresponsabilmente giocato alla guerra per obiettivi in generale risibili rispetto al tremendo sacrificio di vite umane. E non meno colpevole era stata l’enorme dissipazione di ricchezza economica, in gran parte sottratta ai bisogni veri dei cittadini, in primo luogo della classi lavoratrici, la cui povertà oggi non è più immaginabile, almeno se si pensa alle possibilità di sperpero goduta dalla società occidentale dopo i vari boom del secondo dopoguerra. Una catastrofe provocata da futili motivi, quasi si fosse rimasti fermi alla logica delle guerre di devoluzione della Francia assolutista: allargamento dei confini, un pezzetto alla volta, inteso come compito fondamentale dello Stato, a costo di esaurirne le risorse e di scavare voragini di debiti. L’immagine di parrucconi che ci rimandano le fotografie della conferenza di pace sono il lampante emblema di ciò che quei governanti avevano nella testa. Non è per caso che rimanessero inascoltati gli avvertimenti dell’unico genio presente alle trattative, quel John Maynard Keynes che era vicino al circolo di Bloomsbury, dunque anche a Bertrand Russel, che aveva scontato in prigione il suo pacifismo. Poi, negli anni Venti, fu di moda scrivere di tramonto dell’Occidente e di 5 decadenza dell’Europa, ma erano esercizi di filosofi e filosofanti, che di quella decadenza indicavano la causa in lontananze metafisiche. Vennero in seguito a galla altre facce e altre divise: non più marsine e colletti duri, ma stivaloni e camicie di svariato colore. Non più bastoni da passeggio (ormai li usava soltanto Charlot nei suoi film) ma manganelli e pugnali. Sono fenomeni che si diffonderanno quasi esclusivamente in Europa, ma quella guerra fu anzitutto una guerra europea. Una mente razionale, per fare un solo esempio, non riesce a giustificare il fatto che giovani neozelandesi venissero dagli antipodi per morire in una penisola sconosciuta sul Mar Nero. Vale a dire che il conflitto divenne mondiale grazie alla partecipazione di due imperi fatiscenti almeno in parte europei e di un impero, col suo centro a Londra, ancora ignaro di essere agli sgoccioli. Solo tardi l’intervento di un quarto impero ancora agli albori, ma già pronto ad imporre al mondo la sua egemonia culturale e politica, oltre che la sua moneta... Un facile ragionamento controfattuale potrebbe suonare così: niente guerra, niente fascismo, nazismo, stalinismo. Perché la Grande guerra fu anche il principale laboratorio del totalitarismo: mobilitazione di tutta l’economia nazionale sotto un’unica guida e per un solo obiettivo; censura e dispiego di una propaganda mendace; le critiche viste come disfattismo e tradimento. L’accostamento fra «guerra totale» e totalitarismo è insomma molto più di un gioco di parole. 6 Foto tratta dalla mostra «Così lontana, così vicina. Reggio Emilia e i reggiani nella Grande Guerra», 90° Prima guerra mondiale; 1-30 novembre 2008. Polo Archivistico, Via Dante 11 Reggio Emilia – Università Modena-Reggio, Via Allegri, 9 Reggio Emilia. Fonte: Archivio privato Brugnoli. 7 Ricerche Il «bardo» della montagna reggiana Gian Lorenzo Basetti e la democrazia radicale tra Otto e Novecento Alberto Ferraboschi Premessa: la tradizione democratica del collegio appenninico Riconosciuto all’alba del Novecento come il patriarca della democrazia radicale italiana, Gian Lorenzo Basetti fu una personalità di punta del radicalismo emiliano con profonde radici sul territorio reggiano. Ricostruire, seppur per brevi cenni, la longeva vita parlamentare di Gian Lorenzo Basetti1, deputato del collegio della montagna reggiana dal 1874 al 1908, consente di fare luce su alcuni aspetti legati al fenomeno del «notabilato democratico» che caratterizzò in misura non secondaria la democrazia radicale italiana ottocentesca2. Infatti, la vicenda della circoscrizione elettorale di Castelnovo ne’ Monti di cui Basetti fu l’espressione politica per oltre trent’anni rappresenta per certi versi il caso paradigmatico di quei collegi «non competitivi» in grado di generare lunghe carriere parlamentari destinate a traguardare la svolta del passaggio tra Otto e Novecento3. Nel contempo la vicenda parlamentare di Basetti, eletto ininterrottamente e sostanzialmente senza competizione nel periferico ed appenninico collegio di Castelnovo ne’ Monti, pone con forza il problema del rapporto tra pianura e montagna (e città-campagna) all’interno del territorio reggiano; si tratta di una questione di lunga durata che allunga le sue ombre fino al periodo novecentesco dell’Italia repubblicana4 e che è destinata a tradursi sul piano politico in un’alterità di fondo tra il collegio della montagna e le altre circoscrizioni della provincia, dando vita ad una «anomalia» nella geografia 9 Gian Lorenzo Basetti elettorale reggiana segnata nel passaggio tra Otto e Novecento dal predominio moderato e poi dall’egemonia socialista5. Questa alterità della montagna nel secondo Ottocento si nutriva di una tradizione antigovernativa, minoritaria ma costantemente attiva nel periodo preunitario6, che trovava alcuni riscontri significativi nell’endemico fenomeno del brigantaggio, ancora presente in età napoleonica7, e nella mobilitazione antiestense durante i moti insurrezionali del 18218. Innestandosi all’interno di un processo di lunga durata, nella fase postunitaria il controverso rapporto tra pianura e montagna finì per assumere i tratti di una contrapposizione socio-politica tra l’universo della piccola proprietà terriera della montagna, in gran parte di orientamento democratico, e la borghesia del capoluogo che costituiva il blocco sociale di riferimento di una delle principali roccaforti del moderatismo italiano9. Anche per questi motivi la vicenda parlamentare di Basetti si intreccia indissolubilmente con la fisionomia socio-economica ed ambientale del territorio montano. In effetti, la montagna reggiana aveva le sembianze di un vasto collegio rurale con una struttura tipicamente contadina, fondata in gran parte sulla piccola proprietà10, dove l’incidenza di alcune malattie come la pellagra11 e il colera (una patologia che ancora all’inizio del ’900 infestava le valli appenniniche «seminando terrore tra le popolazioni»12) così come l’analfabetismo generalizzato13 e l’altissimo indice di mortalità infantile 10 generavano uno stato di prostrazione e di diffuso malessere cui corrispondeva un sostanziale immobilismo delle amministrazioni locali. Non a caso il più autorevole giornale del moderatismo reggiano, «L’Italia Centrale», nel 1866 scriveva che nella montagna nostra, in modo speciale, vi sono comuni i quali difettano di tutto; che vennero formati a casaccio da persone le quali subirono l’influenza di alcuni signorotti i quali non mirarono ad altro che a fare i propri particolari interessi a danno del pubblico bene. È cosa strana ma però vera, che molti di questi comuni sono affatto privi di strade che mettano al Capo Luogo, e che in causa della mancanza di persone che sappiano leggere e scrivere, sono amministrati o barbaramente o da clericali14. In effetti, come ricordava la commissione della Provincia istituita per redigere il progetto di una rete stradale della montagna15, i rilievi appenninici risultavano in gran parte isolati dal momento che il territorio presentava «pochi transiti appena someggiabili nella stagione estiva, di difficile accesso poi nella stagione delle piogge, e di impossibile varco in quella delle nevi»16, Peraltro, questo quadro nel passaggio tra Otto e Novecento non subì significativi cambiamenti se si considera che nel 1917 il comune di Ligonchio, «la cenerentola della montagna» secondo l’eloquente epiteto di Meuccio Ruini17, era ancora isolato essendo sprovvisto di una strada carrabile. Nella congiuntura postunitaria al tradizionale risentimento per l’arretratezza e lo stato di abbandono del territorio montano risalente al periodo estense18, acuito anche dal fallimento dei progetti ferroviari transappenninici19, si aggiungeva l’insofferenza per l’introduzione della leva obbligatoria e per la politica di risanamento finanziario attuata dal governo centrale, destinata a manifestarsi con virulenza in occasione dei moti provocati dalla tassa sul macinato. Infatti, sulla scia delle manifestazioni di protesta contro l’aumento del prezzo del pane che attraversarono la penisola tra il 1869 ed il 187020 la montagna reggiana fu teatro di forti spinte contestatrici legate alle bande repubblicane dei fratelli Manini e Pomelli che portarono alla ribalta l’esistenza di un diffuso malessere sociale che tendeva ad ammantarsi di tinte ideologiche di stampo democratico21. In particolare, questi fermenti politici avevano trovato un importante punto di coagulo nei mercati e nelle tradizionali fiere della montagna22, così come in alcune forme della sociabilità laico-repubblicana, consentendo la politicizzazione di quella parte della società che non viveva chiusa nei propri abitati sparsi. Infatti, come ha osservato Marco Fincardi in una popolazione che generalmente proiettava la propria identità in parrocchie isolate, i ritrovi laici – nella scarse osterie e locande o nei rarissimi caffé esistenti – permettevano a gruppi informali radicali, collegati con le reti associative della pianura, di essere determinanti per quell’élitaria opinione pubblica montanara che cercava nei municipi e negli scambi extralocali la propria dimensione politica. Era 11 questo l’ambiente che aveva permesso alle bande guerrigliere del 1869 e 1870 di agire impunemente, tra la complicità della popolazione23. Dunque, anche attraverso queste forme di socialità, nella travagliata fase di costruzione della nazione, tra le popolazioni appenniniche si era fatta strada la consapevolezza che i nodi da risolvere andavano affrontati con una rappresentanza politica in grado di conciliare le antiche aspirazioni delle collettività della montagna reggiana con le nuove istanze di riforma sociale incarnate dalla democrazia risorgimentale24. In effetti, il collegio appenninico di Castelnuovo ne’ Monti in età liberale per certi versi rappresenta il caso emblematico di una comunità locale che si pone «contro» l’assetto scaturito dai rivolgimenti risorgimentali e dà corpo a questa limitata ribellione attraverso la scelta di deputati delle forze democratico-progressiste25, a dispetto della persistenza di significative componenti filo-duchiste26. Il collegio si caratterizzò infatti per le connaturate forti venature di antiministerialismo restando in mano alla democrazia radicale a partire dal 1861 con l’elezione di Angelo Brofferio27 e poi di Giovanni Grilenzoni28, quindi di Leopoldo Cattani Cavalcanti29 ed infine grazie alla longeva vita parlamentare di Gian Lorenzo Basetti, deputato radicale per circa 34 anni consecutivi, tra il 1874 e il 1908, concludendo dunque la lunga fedeltà al «bardo» della montagna reggiana solamente con la scomparsa del deputato. In questo modo l’ampia circoscrizione elettorale30, anche a causa della sua fisionomia economica e sociale31, ancora alla fine dell’Ottocento risultava scarsamente permeabile all’influenza socialista32, costituendo una fedele roccaforte della tradizione radicale tanto da fregiarsi dell’appellativo di «cittadella della libertà»33. 2. Un caso di notabilato democratico: Gian Lorenzo Basetti Esponente di una famiglia di solide tradizioni risorgimentali con diffuse radici sul territorio reggiano e parmense34, a partire dai trascorsi garibaldini35 e dalla matrice democratica Gian Lorenzo Basetti interpretò essenzialmente in chiave antiministeriale la diffusa insoddisfazione delle popolazioni della montagna reggiana per l’esito del processo risorgimentale e la critica verso l’«opprimente» centralismo statale36. Membro di quel folto gruppo di medici che caratterizzò la classe politico-parlamentare dell’estrema sinistra italiana37, grazie anche all’esercizio disinteressato dell’attività professionale, Basetti era una personalità molto nota nella montagna reggiana, trasponendo anche sul piano professionale l’impegno della democrazia per i temi della questione sociale38. Pertanto, in un contesto in cui il sistema elettorale risultava fortemente condizionato dalla capillare egemonia notabilare, la candidatura di Basetti alle elezioni politiche del 1874 secondo la stampa locale «era sorta spontanea senza che alcun individuo possa vantarne l’idea o la paternità» in quanto il «Dott. Gian Lorenzo Basetti meritatamente raccoglie e trovasi circondato dalle simpatie 12 dell’intero paese»39. In effetti, come scriveva «La Minoranza» il nome di Basetti era «circondato da un aureola di carità» dal momento che «la sua vita passata è una continua sequela di tributi offerti alla carità, offerti al popolo»40. Dunque, grazie anche all’appoggio del portavoce «ufficioso» della massoneria reggiana, il giornale «La Minoranza» che non aveva mancato di elogiare l’«ingegno, la filantropia e l’amore alla libertà» del medico di Vairo, la candidatura di Basetti si era affermata come quella di un «degno ed indipendente rappresentante, che non decamperà mai dalla condotta tenuta dai nostri precedenti deputati, col benefico vantaggio di conoscere a fondo i nostri bisogni per essere famigliare di questi luoghi»41. Pertanto, con il sostegno decisivo del principale centro dell’associazionismo radicale della provincia, la «Società Garibaldi dei Reduci delle patrie battaglie»42, a ridosso della consultazione elettorale si costituì un apposito comitato espressione delle gerarchie notabilari della montagna reggiana (L. Fiori, A. Rabotti, G. Ferrari, dottor G. Rabotti, C. Bellini, dottor E. Rubini, dottor Notari, L. Leonardi, dottor Monzani, F. Pallaj)43 che propose la candidatura-protesta di Basetti44. Infatti, in occasione della prima candidatura a Castelnovo ne’ Monti nel 1874 Basetti era rappresentato come «un giovane di rare qualità» in grado di interpretare la delusione della società locale per un governo che aveva tradito le idealità risorgimentali, perseguendo una politica incapace di rispondere agli interessi generali della nazione e rendendosi responsabile di un pesante fiscalismo «di cui non trovasi esempio nei più barbari tempi dell’evo medio»45. In questo quadro, nonostante l’appoggio prefettizio46 e la propaganda del legittimismo clericale per il candidato ministeriale, Basetti dopo un ballottaggio con Vincenzo Baroni venne eletto alle elezioni politiche dell’8-15 novembre 1874 sulla scorta di una legittimazione originata in misura significativa dalla collocazione professionale e dalle benemerenze patriottiche e risorgimentali. Infatti, se il medico garibaldino al primo turno ottenne 102 suffragi contro i 158 del candidato ministeriale al ballottaggio ebbe 164 voti47 passando così sui banchi della Camera dei Deputati come «eloquente bandiera di protesta e di profondo malcontento»48. In effetti che il consenso espresso dal collegio montano a Basetti fosse anzitutto mosso dalla protesta è ben evidenziato dal fatto che nelle successive consultazioni del 1876 lo stesso candidato riuscì rieletto sulla scia del successo della campagna a sostegno della lega per l’abrogazione della tassa sul macinato49, una delle numerose iniziative di mobilitazione dell’opinione pubblica sui grandi temi nazionali tipiche della strategia comunicativa democratica ottocentesca50. Alle elezioni del 1876 Basetti poté beneficiare dell’effetto dell’impegno profuso nella campagna contro l’impopolare legge sul macinato, presentata sul piano locale dalla stampa radical-progressista come la manifestazione della «riscossa» della montagna e, per contro, etichettata dai moderati come una «eccentricità radicale, almeno ben trovata per ottenere del chiasso»51. Assurto agli onori della cronaca nazionale e locale per la battaglia politico-parlamentare contro la tassa sul macinato, Basetti rimase sostanzialmente senza competitori nel suo 13 collegio fino agli albori del Novecento, non solo per la perdurante incapacità dei moderati di individuare un candidato in grado di contrastarlo ma anche a causa dell’influenza piuttosto limitata del partito socialista nel territorio appenninico. Se, infatti, alle elezioni del maggio del 1880 i moderati presentarono nel collegio di Castelnovo ne’ Monti un candidato di bandiera e Basetti venne eletto con 309 voti, alle elezioni del 1882 – effettuate con il sistema dello scrutinio di lista a suffragio allargato – i radicali si allontanarono dai liberali progressisti per condividere la causa del «grande e santo ideale dell’emancipazione delle plebi»52 sostenuta dal giornale «Lo Scamiciato», riuscendo in tal modo ad eleggere due loro candidati: Gian Lorenzo Basetti e Gilberto Govi53. Feudo elettorale del deputato radicale con le proprie roccaforti nel castelnovese, minozzese54 e ramisetano55, anche nella travagliata congiuntura di fine secolo quando Basetti fu chiamato a presiedere la sezione provinciale dell’anticrispina Lega per la difesa della libertà56, il collegio appenninico ribadì la fedeltà al suo deputato; infatti, dopo la conferma del 1890 e la plebiscitaria vittoria del 1892, Basetti anche nel 1895 grazie al sostegno del nucleo storico «basettiano»57 riuscì ad imporre la propria supremazia sconfiggendo l’agguerrita candidatura del professor Azzio Caselli, medico ed esponente di spicco del moderatismo reggiano del tardo Ottocento58. Al di là dell’irriducibile spirito antigovernativo che caratterizzava i comuni della montagna nella stagione postunitaria59, il radicamento del medico di Vairo trovava risposta nella struttura elitaria del suffragio elettorale che, mediato dai contatti personali e da ramificate clientele, tendeva a trascendere l’appartenenza politica per affondare nel familismo e nel protagonismo dei singoli. In effetti, ancora nel 1892 Basetti nel suo collegio era considerato «l’uomo di tutti i partiti»60 come doveva riconoscere anche «L’Italia Centrale»: per antica consuetudinaria apatia e un po’ anche per la sfiducia generata da reiterati disinganni, le questioni politiche non hanno molta presa su questi abitanti, nella gran maggioranza amanti dell’ordine, della quiete e del lavoro … ed i voti che altre volte, sia a scrutinio di lista, sia a collegio uninominale, vi ha riportato il Basetti, erano più che altro dovuti al nome suo e della famiglia e più ancora alla ridicola leggenda, ormai completamente sfatata, ch’egli sia stato l’autore dell’abolizione del macinato e del calo nel prezzo del sale61. Si registra in sostanza l’espressione di un consenso di carattere plebiscitario, segno evidente dell’utilizzazione e del funzionamento di un sistema notabilare in funzione di mobilitazione dell’elettorato e di coinvolgimento del voto cui non erano estranei neppure i parroci nonostante la nota appartenenza massonica del deputato radicale62. In effetti, malgrado gli accesi toni anticlericali della «Minoranza» nel deputato radicale anche diversi preti della montagna riconoscevano non già un pericoloso «sovversivo» quanto un vero e proprio «benefattore» in virtù non solo dell’attività filantropica svolta come medico ma anche dell’opera prodigata a Montecitorio a favore degli interessi locali63. Oltre 14 a seguire da vicino alcune questioni legate al territorio reggiano (come la legge sulla perequazione fondiaria nel compartimento modenese)64, Basetti fin dagli anni ’70 patrocinò progetti di dotazioni infrastrutturali e di potenziamento delle linee di comunicazione della montagna reggiana (ad esempio, per quanto riguarda la spinosa questione delle strade della montagna in occasione del disegno di legge riguardante la costruzione delle strade provinciali65, a proposito del progetto della nuova strada Vezzano-Casina66 o ancora per la provinciale della Val d’Enza con i ponti presso Vetto e Selvanizza) esercitando il tradizionale ruolo del notabile come punto di incontro tra stato e società civile (e tra centro e periferia) sicché ancora nel 1895 a poche settimane dal voto lo storico foglio moderato scriveva: nel collegio dove il Basetti ha radici da 22 anni e amicizie quasi feticiste – dove si è creduto, per oltre un quadrilustro, che a lui si dovesse l’iniziativa di tutte le riforme agognate e l’attuazione delle poche ottenute, che da lui, dalla sua opera parlamentare si dovessero aspettare il latte e il miele scorrenti nei ruscelli e uno stato che, invece di esiger tasse, pagasse emolumenti: lassù dove la fedeltà alle persone difficilmente si spezza67. Se dunque ancora all’inizio degli anni ’90 il deputato radicale poteva beneficiare di una riconosciuta legittimazione di stampo comunitario, nel passaggio tra Otto e Novecento tramontarono le condizioni politicoamministrative che avevano consentito a Basetti di costruire la sua brillante carriera parlamentare. In effetti, con l’aprirsi del XX secolo, il prepotente sviluppo del movimento socialista destinato a rendere Reggio Emilia la «capitale» del socialismo municipale italiano, la crisi del liberalismo ed il progressivo ingresso dei cattolici nello scontro per il potere locale, avevano trasformato profondamente le circostanze nelle quali era abituata a muoversi la democrazia ottocentesca e lo stesso Gian Lorenzo Basetti. In particolare, la crescente polarizzazione del sistema politico reggiano d’inizio Novecento, segnato dalla contrapposizione dell’identità di classe fra forze borghesi e proletarie, aveva ristretto lo spazio politico del radicalismo, rendendone sempre più evidente la condizione di subalternità nei confronti dell’ormai chiara egemonia del partito socialista. Questa tendenza, connessa anche alle trasformazioni socioeconomiche, aveva portato ad una radicalizzazione dello scontro politico destinata a culminare nel 1904 quando si confrontarono nel reggiano da un lato l’eterogeneo «blocco d’ordine» clerico-moderato della cosiddetta «Grande Armata» e dall’altro lato la compatta organizzazione del partito socialista. Nonostante questa situazione di forte polarizzazione, alle elezioni politiche del 1904 Basetti riuscì ad imporre la propria candidatura sul socialista Ferdinando Laghi, originario di Ramiseto e professore all’università di Parma68 nonché «grande proprietario della nostra montagna»69 a scapito tuttavia di un significativo slittamento del medico garibaldino verso l’area socialista. Se, infatti, il collegio 15 di Castelnovo ne’ Monti fu l’unica circoscrizione della provincia dove il partito socialista non presentò un proprio candidato indirizzando i voti su Basetti70 tuttavia l’anziano parlamentare dovette subire il crescente condizionamento dei suoi grandi elettori, rappresentati ormai non più solamente dal notabilato della montagna ma anche dalla potente organizzazione socialista. In questo contesto, l’elevata partecipazione alle elezioni (la consultazione del 6 novembre 1904 fece registrare una delle percentuali più alte di votanti nel collegio dal 1861 con 2603 unità, pari al 70 percento dei votanti) ed il responso elettorale del 1904 che sancì la combattuta vittoria di Basetti sul candidato della «Grande Armata», Francesco Gualerzi, con 1425 voti contro 1077 – con proporzioni dunque ben diverse dalle precedenti affermazioni plebiscitarie – erano i segnali inequivocabili del tramonto di un’era. Infatti, pur essendo riuscito ad avere la meglio, la tradizionale posizione notabilare di Basetti era risultata logorata ed inevitabilmente incrinata dalla mobilitazione antisocialista organizzata dalla «Grande Armata»; come non mancò di osservare anche «L’Italia Centrale», l’appoggio dell’ex deputato liberale di Correggio, Giovanni Martini, al candidato ufficiale dei liberali, Francesco Gualerzi, favorì sensibilmente lo schieramento clerico-moderato dal momento che Martini «abitando qualche mese dell’anno sulla nostra montagna e dimostrando un certo interessamento alle laboriose popolazioni, s’era formata una buona base» che riversò sul candidato della «Grande Armata»71. Ma soprattutto era ormai divenuto troppo evidente e per certi versi «compromettente» il collateralismo di Basetti con il partito socialista, in particolare dopo lo sciopero generale del 1904, sicché diversi grandi elettori preferirono togliere il proprio sostegno ad un candidato ritenuto eccessivamente accondiscendente verso i socialisti: «oggi non è più un mistero nemmeno per gli elettori della montagna del contegno tenuto dall’on. Basetti, dell’azione da lui esplicata in favore dei socialisti; oggi essi sanno che hanno un candidato appoggiato con tutte le forze dai socialisti; un candidato legato a doppio filo coi peggiori sovversivi»72. D’altro canto l’esplicito appoggio del partito socialista a Basetti, testimoniato anche da una campagna elettorale compiuta insieme al socialista Alessandro Cocchi, incrinò sensibilmente l’immagine di un leader in grado di imporre la propria legittimazione comunitaria. Infatti, al di là dell’accusa mossa a Basetti di avere tradito la vecchia militanza democratica per accaparrarsi i voti socialisti73, non c’è dubbio che l’ultima affermazione elettorale di Basetti se da un lato confermò il radicamento del potere notabilare del «signore» della montagna reggiana74, dall’altro lato evidenziò i limiti e l’inevitabile snaturamento di una prassi politica destinata a fare i conti con le nuove forme organizzative del partito di massa in un’area a forte egemonia socialista. Non a caso il sostegno elettorale socialista avrebbe trovato un riscontro nel comportamento parlamentare tenuto da Basetti nel corso della XXII legislatura quando il medico parmense appoggiò in diverse circostanze le posizioni socialiste, come in occasione della mozione presentata nel maggio del 1906 da Enrico Ferri e Cabrini sulla necessità di 16 provvedimenti legislativi per la prevenzione degli eccidi proletari75, suscitando l’immediata condanna degli «uomini d’ordine» reggiani: nella grottesca levata di scudi per il disarmo della forza pubblica, i socialisti ebbero alla Camera il concorso ed il voto del deputato Basetti. Era troppo naturale! Dopo il suo atteggiamento all’epoca dello sciopero ferroviario, anche il progetto che significa la dedizione allo sciopero generale doveva avere il suo appoggio! Gli uomini d’ordine, chiamati alle urne per la lotta provinciale, si ricordino nei mandamenti di montagna di questo contegno del loro deputato76. 3. Conclusioni Espressione della prima generazione della democrazia emiliana uscita dalle lotte risorgimentali, Basetti rappresenta un protagonista di rilievo di quel notabilato democratico in grado di affacciarsi all’apertura del XX secolo quando il «risveglio» politico ed ideologico del radicalismo italiano portò alla creazione di una struttura nazionale di partito77. Peraltro, il ruolo di «decano»78 e di notabile di livello nazionale del radicalismo italiano assunto dal medico garibaldino all’alba del Novecento79 era l’esito di una lunga militanza politica con profonde radici sul territorio. Deputato di lungo corso della montagna reggiana, Basetti nel corso del secondo Ottocento riuscì a convogliare all’interno di una prospettiva politico-ideologica il profondo disagio sociale del territorio appenninico, realizzando un percorso di politicizzazione della società locale capace di saldare le prospettive politiche portatrici di riforme con le istanze del contesto territoriale. In effetti, come si è avuto modo di ricordare, la legittimazione antisistema del medico parmense faceva leva in misura non secondaria sulla forte identità e sullo spirito rivendicativo della montagna reggiana come annotava polemicamente anche «L’Italia Centrale» osservando che quella di Basetti «è una candidatura a cui il corpo elettorale è fedele più per lo chauvinisme della “piccola patria” che per le idee, contro alle quali, noi combattiamo colla convinzione più sincera»80. A partire da una strategia comunicativa che fin dagli anni ’70 si strutturò intorno alla questione della contrapposizione tra paese legale e paese reale81, la carriera parlamentare di Basetti si fondò principalmente sulla capacità di interpretare e sollecitare le aspirazioni dell’elettorato della montagna reggiana, riconosciuto come «interprete sapiente dei bisogni del paese reale»82, contribuendo all’acquisizione di una prospettiva sempre meno locale dei problemi che affliggevano la realtà appenninica; in effetti, grazie anche alla «crociata» contro la tassa sul macinato indetta in nome degli «Abitanti dei monti reggiani»83, la principale eredità politica di Basetti come rappresentante del collegio di Castelnovo ne’ Monti è individuabile nella capacità di dare voce alla questione del «riscatto» della montagna che la recente unificazione italiana sembrava aver negato, creando le premesse affinché il problema dello sviluppo delle zone montane 17 potesse essere trasferito sul più alto palcoscenico nazionale. Tale eredità, infatti, sarebbe stata raccolta nella tarda età giolittiana dal cattolico Giuseppe Micheli84, e dal radicale Meuccio Ruini85; se Micheli, successore di Basetti nel collegio di Castelnovo ne’ Monti alle elezioni del 190886 si distinse come un sostenitore di interventi a favore della montagna87, Ruini, presentatosi alle elezioni del 1913 come delfino ed erede del nume tutelare della democrazia reggiana ottocentesca88, nelle vesti di rappresentante del collegio appenninico si affermò come strenuo assertore della cosiddetta «questione montanara» nell’Italia del primo dopoguerra89. COLLEGIO ELETTORALE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (1874-1904) DATA ELETTORI VOTANTI VOTI BASETTI VOTI AVVERSARI O DISPERSI 8.11.1874 543 345 (64%) 102 158 (Baroni V.) 71 (Cattani Cavalcanti) 15.11.1874 5.11.1876 543 602 264 (49%) 389 (65%) 164 271 16.5.1880 618 365 (59%) 309 6.11.1892 5033 1490 (30%) 1436 21.3.1897 3267 1097 (34%) 942 3730 2603 (70%) (*) 26.5. 1895 3.6. 1900 6.11.1904 3257 3291 2459 (75%) 1153 (35%) 1227 1099 1425 98 (Baroni V.) 103 (Baroni V.) 44 (Ferrari A.) 4 (Bonfadini R.) 1181 (Caselli A.) 13 (voti dispersi) 0 1077 (Gualerzi F.) (*) Nelle legislature XV, XVI, XVII compreso nel collegio di Reggio Emilia. Fonte: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Le elezioni politiche al parlamento subalpino e al parlamento italiano. Storia dei collegi elettorali dalle elezioni generali del 17-27 aprile 1848 a quelle del 21-28 marzo 1897, Roma, parte II, p. 163; ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica delle elezioni generali politiche 3 e 10 giugno 1900, Roma, Tipografia Nazionale, 1900, p. 71; ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica delle elezioni generali politiche 6 e 13 novembre 1904, Tipografia Nazionale, Roma 1904, p. 68. Sulla figura di Gian Lorenzo Basetti, nato a Vairo nell’Appennino parmense nel 1836 e morto a Parma nel 1908, cfr. G. Micheli, In memoria di G. Lorenzo Basetti, Stab. Tipografico A. Zerbini, Parma 1908; R. Marmiroli, Gian Lorenzo Basetti. Medico garibaldino e deputato radicale, Nuova Poligrafica reggiana, Reggio Emilia 1962; F. Bojardi, Gian Lorenzo Basetti. La tassa sul macinato, Analisi, Bologna 1987; Id, Anniversari da non dimenticare, in «L’Almanacco» 1986/8-9, pp. 3841; D. Morini, In parlamento per 34 anni, in «Tuttomontagna», 2006/127, pp. 60-61. 2 Sul fenomeno del notabilato democratico cfr. E. Mana, Democrazia dentro e fuori il Parlamento 1 18 a fine Ottocento, in «Studi Storici», 1996/4; Id., La democrazia radicale italiana e le forme della politica, in M. Ridolfi (a cura di), La democrazia radicale nell’Ottocento europeo, Feltrinelli, Milano 2005, p. 204; G. Orsina, Senza chiesa né classe. Il partito radicale nell’età giolittiana, Carocci, Roma 1998, pp. 206-209. Più in generale, all’interno dell’ormai vasta produzione storiografica sulla questione del notabilato e sul ruolo dei notabili nell’età liberale cfr. L. Ponziani (a cura di), Le Italie dei notabili: il punto della situazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001; per alcune indicazioni di tipo metodologico sull’«idealtipo notabilare» cfr. P. Pombeni, Autorità sociale e potere politico nell’Italia contemporanea, Marsilio, Venezia 1993, pp. 66-73. 3 Cfr. F. Bonini, P. Manichini, Elezioni senza competizione: l’esperienza del secondo uninominale italiano (1892-1913), consultabile all’indirizzo <www.studielettorali.it>. 4 Sul rapporto tra strutture socio-economiche del territorio appenninico e sviluppi politici dell’area appenninica nel secondo Novecento alcuni spunti sono rinvenibili in cfr. P. Alberghi, Quarant’anni di storia montanara. L’Appennino reggiano-modenese dal fascismo alla rinascita, Modena, 1980. 5 Cfr. F. Bonini, I collegi elettorali reggiani, in «Memoria e Ricerca», luglio 1994, p. 42. 6 «La stessa borghesia castelnovese più in vista, del resto, si recava a studiare all’università di Pisa, come Feliciano Monzani, che ne venne cacciato nel 1842 per aver aderito a moti studenteschi sovversivi. Ma erano movimenti, appunto, segreti. La popolazione castelnovese rimase ancora sostanzialmente affezionata al Duca, e a Francesco IV in particolare (il cui busto in gesso campeggiava nella sala consiliare), come artefice di un rilancio del Comune e dei suoi commerci quale mai più si verificherà dopo l’unificazione d’Italia, nel 1859. Al dire della stessa polizia estense, Castelnovo era sempre stato un paese molto quieto “e si era sempre comportato con la massima prudenza e subordinazione in ogni cosa”», G. Giovanelli, P. Ielli, Castelnovo ne’ Monti. La fiera di San Michele mille anni di commerci nell’Appennino reggiano, age, Reggio Emilia s.d., p. 106). 7 Cfr. L. Pucci, Indagini sul brigantaggio nel Dipartimento del Panaro e del Crostolo, in M. Berengo, S. Romagnoli (a cura di), Reggio e i territori estensi dall’Antico Regime all’Età napoleonica, Pratiche Editrice, Parma 1979, vol. I, pp. 271-294; O. Rombaldi, A. Cenci, Le montagne del Duca. L’Appennino Estense dall’ancién regime all’Unità d’Italia (1796-1859), La Nuova Tipolito, Felina (RE) 1998, pp. 123-126. 8 «Nel corso dei preparativi clandestini dei moti del 1821, quando in ogni ducato si reclutavano uomini che potessero dar man forte alle sollevazioni piemontesi, il dottor Carlo Franceschini di Burano di Castelnovo Monti, uno dei capi dei movimenti insurrezionali reggiani e montanaro di grandi doti umane, assicurò di aver reclutato, durante un suo lungo viaggio attraverso i nostri paesi, ben 2000 uomini pronti ad unirsi a Ciano ai montanari parmigiani» (A. Manari Fiorini, Due garibaldini dell’Appennino reggiano, in «Reggio Storia», 1982/17, p. 62). Al riguardo, anche Giuseppe Giovanelli ha osservato che «non si può dimenticare che, proprio sulle strade dei mercanti che andavano al Genovesato e in Toscana, vennero introdotte nel reggiano, passando appunto da Castelnovo, le idee del risorgimento rivoluzionario. Non sembrerà strano che la polizia ducale sospetti il passaggio da Castelnovo del “famigerato avvocato Mazzini”. Chi nella Carboneria reggiana deteneva nel 1820 il titolo di “Colonna” e poi di “Pontefice” era appunto il castelnovese Carlo Franceschini; chi ricevette l’adesione nella società segreta del martire di Rubiera don Giuseppe Andreoli, fu – secondo quanto appurato dal processo statuario di Rubiera – il dottor Carlo Fattori di Scurano, località allora appartenente al comune di Castelnovo» (Giovanelli, Ielli, Castelnovo ne’ Monti. La fiera di San Michele mille anni di commerci nell’Appennino reggiano, cit., p. 106). 9 Sulla configurazione socio-politica delle élites reggiane della stagione postunitaria sia consentito fare riferimento a A. Ferraboschi, Borghesia e potere civico a Reggio Emilia nella seconda metà dell’ottocento (1859-1889), Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. 10 Cfr. A. Balletti, G. Gatti, Le condizioni dell’economia agraria nella provincia di Reggio nell’Emilia, Tipografia Calderini, Reggio Emilia 1886, pp. 32-34. 11 Cfr. Manari Fiorini, Due garibaldini dell’Appennino reggiano, cit., p. 62. 12 Infatti, «L’Italia Centrale» nel 1904 polemizzando con Basetti si chiedeva: «dov’era, lui medico, quando il colera aveva terrorizzato in parte queste popolazioni?», (Nel collegio di Castelnuovo 19 Monti, in «L’Italia Centrale», 4 novembre 1904). 13 «Malgrado questo ottimo risultato il numero delle scuole non corrisponde ancora a tutti i bisogni delle popolazioni, in specie nei paesi della montagna dove le frazioni essendo discoste dal centro del Comune nel quale per legge è aperta la scuola, questa non è frequentata o lo è in numero limitatissimo dai frazionisti; e per verità chi ha praticate quelle dirupate strade comprende facilmente che i genitori mal si dispongano a mandare alla lontana scuola particolarmente le figlie quando nell’estate il sole vi è cocente, e più ancora quando le nevi alte e ghiacciate rendono maggiormente pericoloso il passaggio di quegli alpestri gioghi. Eppure è d’uopo estendere la istruzione pubblica nella più larga cerchia, e per la montagna io credo che tornerebbero utilissime le Scuole Miste fatte dalle maestre anche nelle frazioni più popolate (Atti del Consiglio Provinciale di Reggio nell’Emilia, Sessione ordinaria dell’anno 1868, Relazione sulla visita fatta dal Reggente la Prefettura di Reggio nell’Emilia ai Comuni della Provincia letta al Consiglio Provinciale nella seduta pubblica delli 6 settembre 1868, Tipografia Davolio, Reggio Emilia 1869, p. 465). 14 Notizie della città, in «L’Italia Centrale», 9 giugno 1866. 15 Lo stato deficitario del sistema delle comunicazioni della zona montana reggiana indusse la Deputazione provinciale fin dal 1864 a fare istanza al Ministero competente affinché proponesse alla Camera una legge per aprire nuove vie di comunicazioni e migliorare quelle esistenti nella parte montuosa della provincia di Reggio. Inoltre, nel 1865 venne istituita una commissione per la redazione di un piano per la rete stradale della montagna la quale nella sua relazione conclusiva osservava che «la nostra Provincia se può dirsi a sufficienza provvista nella parte piana di strada rotabili che in ogni luogo di essa concorrono allo sviluppo della territoriale ricchezza, non altrettanto può asseverarsi per la parte montuosa» (Atti del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia. Sessioni straordinarie e ordinarie dell’anno 1866, Tipografia Davolio, Reggio Emilia 1866, p. 255); più in generale, sulla questione della viabilità nel territorio appenninico dopo l’Unità cfr. G. Badini, Il Cerreto e la sua strada. Un futuro con radici antiche, Provincia di Reggio Emilia, 2006, pp. 88-89. 16 Ivi, p. 256. 17 Cfr. M. Ruini, Lo sviluppo economico della provincia di Reggio Emilia, Tipografia Artigianelli, Reggio Emilia 1917, p. 41. 18 «La Commissione medesima toccò i veri e reali bisogni della parte montuosa di questa provincia, la quale, tacendo anche di tutti gli altri elementi che tendono alla floridezza di un territorio e che dall’Estense Governo furono negletti, venne pel principale di essi che è quello delle strade, lasciata in un totale abbandono» (Atti del Consiglio Provinciale Sessioni straordinarie e ordinarie dell’anno 1866, cit. p. 33). 19 Sulla questione dei collegamenti ferroviari tra Reggio Emilia e la Toscana nei primi decenni postunitari e in particolare sull’importanza attribuita alla «strada ferrata» per lo sviluppo del territorio appenninico sia consentito fare riferimento a A. Ferraboschi, I progetti ferroviari transappenninici dell’Ottocento tra Reggio Emilia e la Toscana, in Comune di Castelnovo ne’ Monti, L’Appennino: un crinale che univa e unirà, La Nuova Tipolito, Felina (RE) 1999, pp. 263-286. 20 «Quando, nel 1869, entrò in vigore la tassa sul macinato la struttura organizzativa mazziniana del movimento operaio si mostrò disorientata di fronte alle violente, e spesso spontanee, manifestazioni di protesta che si svilupparono in gran parte del paese contro l’aumento del prezzo del pane provocato dall’imposta sulla macinazione dei cereali, introdotta dal governo Menabrea per sanare il disavanzo del bilancio. I moti del macinato, che provocarono oltre 250 morti, un migliaio di feriti e poco meno di 4000 arresti, pur ideologicamente ambigui, furono l’occasione per portare alla ribalta dell’opinione pubblica l’esistenza di un diffuso malessere sociale la cui pericolosità, per la classe dirigente liberale, andava individuata non tanto nel processo di scollamento tra ceti popolari e istituzioni, quanto nelle potenzialità politiche eversive che ciò avrebbe potuto comportare» (F. Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale 1861-1901, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 117). 21 «In montagna i disordini maggiori scoppiano a Vezzano, dove almeno 200 abitanti, provenienti anche dalle borgate vicine, costringono alla fuga il segretario comunale e bruciano le schede 20 della denuncia del bestiame; ma soprattutto a Casina, dove una parte della Guardia Nazionale, guidata da Domenico Ferrari e dallo stesso capitano Montruccoli, ha fatto causa comune con gli insorti, e persino il chierico Scolari finirà arrestato. Qui, diversamente che nel resto della provincia, la forza militare non riuscirà a riprendere, con rapidità il controllo: ancora nel febbraio, infatti, tra i monti di Casina e S. Polo, scorrazzano bande armate che assaltano i mulini, rubando gli introiti della tassa di macinazione. Si tratta di giovani dissidenti mazziniani che, insofferenti degli indugi del maestro e contro la volontà dei capi locali, hanno sposato la protesta contadina e, spentasi l’agitazione, si sono buttati alla macchia, forse con l’intenzione di dare inizio a forme di guerriglia, trasformando il moto contadino in una “romantica rivendicazione repubblicana”» (S. Spreafico, La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, Cappelli, Bologna 1982, vol. I, pp. 542-543). Sull’episodio che, secondo Sandro Spreafico, «ha quasi il sapore di un dissenso della nuova generazione guidata da Filippo e Secondo Manini» cfr. R. Cavandoli, Per una bibliografia sulle lotte del macinato, in «Bollettino Storico Reggiano», a. III, luglio 1970, fasc. 8, pp. 10-12; F. Manzotti, Le bande Manini e Pomelli nel reggiano (1869-1870), in «Atti e memorie deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», s. VIII, vol. X, 1958, pp. 152-164; A. Balletti, Storia di Reggio Emilia dal 1859 al 1922, Diabasis, Reggio Emilia 1996, pp. 85-87. 22 «Ma a Castelnovo la tassa toccava anche i commercianti perché penalizzava esasperatamente il commercio delle granaglie, tradizionale punto di forza dei mercati settimanali e soprattutto della fiera di San Michele. La lotta all’iniquo balzello contribuì così a trasformare l’immagine tradizionale della fiera da ribalta dell’autorità ad arengo della politica di popolo. I comizi in fiera divennero una consuetudine castelnovese largamente partecipata da tutta la montagna, i cui abitanti impararono qui ad esprimere opinioni e soprattutto dissensi, a costituirsi in forza politica, a premere sul governo e sulle amministrazioni locali per rivendicare diritti e per fare comunque sentire la loro voce» (Giovanelli, Ielli, Castelnovo ne’ Monti. La fiera di San Michele mille anni di commerci nell’Appennino reggiano, cit., p. 116). 23 M. Fincardi, Campagne emiliane in transizione, clueb, Bologna 2008, p. 59. 24 Come ha scritto Giuseppe Giovanelli «se vi furono screzi tra la popolazione montanara e il nuovo governo, essi presero qui lo spunto principale, non certamente in un partito clericoduchista, enfatizzato dal governo per giustificare le misure contro le libertà e i beni della chiesa. E in seguito il malcontento potè attizzarsi anche nell’emarginazione economica e politica della montagna, privata di tutte quelle iniziative che proprio il governo ducale aveva già progettato, come la costruzione della ferrovia che doveva risalire l’alta Val di Secchia e, valicato l’Appennino in galleria, biforcarsi a Metra per La Spezia e Lucca. Sui malcontenti del 1860, ebbe invece buon gioco la propaganda mazziniana e garibaldina la cui ideologia, in pochi anni, arriverà a proporsi come alternativa alla religione stessa» (G. Giovanelli, Cervarezza. Nove secoli di vita in una comunità del Monte Ventasso, La Nuova Tipolito, Felina (RE) 1993, p. 51). 25 Di diverso avviso Odoardo Rombaldi per il quale «la linea democratica ed anticlericale» del collegio si configura essenzialmente come «una reazione alla tradizione antirisorgimentale e duchista di una parte dell’elettorato della montagna» (O. Rombaldi, Giuseppe Micheli, cattolico, deputato di Castelnovo Monti, in «Il Pescatore Reggiano», anno 1987, p. 91). 26 Come ha scritto Sandro Spreafico a proposito delle elezioni politiche del 1865, «il partito “dei tratti di corda” conta sull’Appennino numerose roccaforti: rapporti allarmanti giungono da Castelnovo Monti, dove il successo dei “neri” o “austriacanti” è stato notevole, grazie anche al lavoro di don Tommaso Gatti, di don Leonardo Leonardi, del sindaco Pignedoli; da Carpineti, dove i moderati non hanno potuto presentarsi ed i repubblicani sono stati sopraffatti, confermando i rapporti di polizia che vogliono il repubblicanesimo montanaro del tutto atipico, semplicemente protestatorio, utilitaristico e male organizzato; da Villaminozzo, i cui liberali giudicano una “gran vergogna che s’abbia a dire che un Turri possa entrare in parlamento”» (Spreafico, La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, cit., vol. I, pp. 516). Al riguardo Giuseppe Giovanelli ha osservato che «forse non mancò neppure una certa volontà punitiva nei confronti di una popolazione che, per ignoranza o perché ammaliata dai benefici di Francesco IV, conservava ancora una pur bassa ma significativa percentuale di duchisti, che esponenti della polizia e della prefettura non mancarono certo di esagerare» (Giovanelli, Ielli, Castelnovo ne’ Monti. La fiera di 21 San Michele mille anni di commerci nell’Appennino reggiano, cit., p. 115). 27 Angelo Brofferio (1802-1866) fu eletto al ballottaggio alle elezioni del 3 febbraio 1861 ottenendo 129 voti contro i 94 dell’avvocato Carlo Baroni. In Parlamento si schierò a favore di Rattazzi e contro Farini e Minghetti. 28 Il mazziniano conte Giovanni Grilenzoni (1796-1868) fu eletto alle elezioni del 29 ottobre 1865, ottenendo 116 voti contro i 105 del clericale Giuseppe Turri. Grilenzoni si dimise in seguito dall’ufficio di deputato il 29 gennaio 1866 a seguito della polemica con Nicomede Bianchi innescata dalla pubblicazione di carte riservate tratte dagli archivi estensi (due suppliche presentate dal Grilenzoni a Francesco V per ritornare in patria, due lettere del 1848 contro l’annessione al Piemonte e una lettera del maggio 1862 con la quale Grilenzoni rinunciava al domicilio nella sua città). 29 Leopoldo Cattani Cavalcanti (1813-1882) fu eletto alle elezioni del febbraio 1866 ottenendo 92 voti contro i 77 del maggiore Andrea Spezzani. In seguito venne rieletto nel collegio appenninico alle elezioni del 1867 e del 1870. In parlamento si schierò con il governo solo durante il II ministero Rattazzi e quelli retti da Cairoli. 30 In base alle disposizioni legislative del 1891, che sancirono il ripristino del collegio uninominale, il collegio di Castelnuovo Monti comprendeva i comuni di Castelnuovo Monti, Vetto, San Polo, Ciano d’Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Casina, Carpineti, Villa Minozzo, Toano, Busana, Collagna, Ramiseto e Ligonchio; per la configurazione montuosa del territorio, l’elettorato risultava legato essenzialmente alla piccola proprietà terriera, alla pastorizia e al mondo contadino. Per quanto riguarda la morfologia sociale ed economica della circoscrizione elettorale di Castelnuovo ne’ Monti diverse informazioni sono reperibili in A. Duri (a cura di), Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, Statistica generale della provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1910. 31 «La frantumazione in piccole proprietà di puro sostentamento, la rarità del lavoro bracciantile e di attività terziarie, l’attaccamento al principio di autorità e alla chiesa erano tali che si poteva considerare un miracolo, in verità dovuto all’astensionismo dei clericali, che il Basetti potesse essere eletto per tanti anni» (A. Zavaroni, La linea la sezione il circolo. L’organizzazione socialista reggiana dalle origini al fascismo, Quorum, Reggio Emilia 1990, p. 68). 32 Cfr. Socialismo e socialisti della montagna, in «L’Italia Centrale», 28 settembre 1893. 33 «Questo nostro Collegio per antica e costante tradizione fu chiamato Cittadella della libertà [corsivo nell’originale], dimostriamo con solenne manifestazione che l’aforismo non fu immeritato. L’uomo che si rese benemerito, conservando intatta la nostra bandiera, e che condivise le nostre aspirazioni fu il dott. Gian Lorenzo Basetti» (Ai cittadini elettori, in «La Minoranza», 13 maggio 1880). 34 Lo zio paterno Atanasio (1798-1888), valente e stimato medico chirurgo del quale seguì le orme professionali fu coinvolto nei moti risorgimentali del 1831 e pertanto costretto all’esilio in Corsica ed a Corfù dove esercitò la professione medica promuovendo la costruzione della casa per esuli e patrioti «Exoria». Cfr. Bojardi, La tassa sul macinato, cit., pp. 12-14. 35 Dopo essersi laureato in medicina e chirurgia Basetti nel giugno 1866 si arruolò nel corpo dei volontari garibaldini, partecipando così alla terza guerra d’indipendenza con l’incarico di medico di battaglione a Bazzecca. Nel 1867 fu al seguito di Garibaldi nella campagna dell’agro romano a Mentana e a Monterotondo. Sulla partecipazione alle imprese garibaldine di Basetti cfr. Marmiroli, Gian Lorenzo Basetti, cit., pp. 12-17; Micheli, Il memoria di G. Lorenzo Basetti, cit., pp. 4-6. 36 «Appartenente alla sinistra, vota con il Governo durante le presidenze Cairoli, si sposta successivamente all’opposizione, che mai abbandona, se non in rari casi, durante il Governo Zanardelli» (M.S. Piretti, G. Guidi (a cura di), L’Emilia Romagna in parlamento, Centro ricerche di storia politica, 1992, vol. II, p. 27). 37 Cfr. E. Mana, «Formare una democrazia illuminata e pensante». Il discorso agli elettori dell’estrema sinistra (1875-1900), in «Quaderni Storici», 2004/117, p. 716. 38 Cfr. Bojardi, La tassa sul macinato, cit., p. 15. 39 Nostre corrispondenze, in «La Minoranza», 4 ottobre 1874. 40 Nostre corrispondenze, in «La Minoranza», 11 ottobre 1874. 22 «La Minoranza», 18 ottobre 1874. Sul rapporto tra Basetti e la Società «Garibaldi» cfr. Fincardi, Campagne emiliane in transizione, cit., p. 59. 43 «La Minoranza», 24 gennaio 1875. 44 «Attendenti sempre a proseguire nella via intrapresa, e volendo serbare incolumi le gloriose tradizioni del nostro Collegio, curanti più dei generali interessi della Nazione che teneri dei peculiari bisogni, per ritemprare e rendere più alacre e fervida l’opera del nuovo Parlamento, abbiamo fatta risoluzione di designarvi a candidato un giovine di rare qualità fornito, e zelantissimo della fortuna e prosperità di questa nostra cara patria, il dott. Gian Lorenzo Basetti» («La Minoranza», 1 novembre 1874). 45 Ibidem. 46 «Cessi una volta il governo, e più le autorità provinciali di ingerirsi, e brogliare nelle questioni elettorali e curino più diligentemente gli ufficii loro demandati, che non subiranno di questa sorta disfatte!» (Nostre corrispondenze, in «La Minoranza», 22 novembre 1874). 47 Cfr. Piretti, Guidi (a cura di), L’Emilia Romagna in parlamento, cit., vol. I, p. 270. 48 «La Minoranza», 18 ottobre 1874. 49 Occorre precisare che nel 1876 Basetti venne eletto nei collegi di Castelnovo ne’ Monti e Langhirano, optando per il collegio della montagna reggiana cfr. Micheli, In memoria di G. Lorenzo Basetti, cit., p. 3. Sulla «crociata» intrapresa da Basetti per l’abolizione della tassa sul macinato è d’obbligo il rinvio a Bojardi, La tassa sul macinato, cit.. 50 Cfr. Mana, La democrazia radicale italiana e le forme della politica, cit., in particolare p. 201. 51 La lega contro il macinato, in «L’Italia Centrale», 10 gennaio 1877. 52 «Lo Scamiciato», 22 ottobre 1882. 53 Sull’importanza delle elezioni politiche del 1882 e le sue ripercussioni sul contesto reggiano cfr. F. Cammarano, Consorteria moderata e propaganda socialista. Reggio Emilia dall’immobilismo sociale alla cultura politica, in P. Pombeni (a cura di), All’origine della «forma partito» contemporanea. Emilia Romagna 1876-1892: un caso di studio, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 140-146. 54 Cfr. Spreafico, La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, cit., vol. II, p. 277. 55 Cfr. Rombaldi, Giuseppe Micheli, cattolico, deputato di Castelnovo Monti, cit., p. 90. 56 Cfr. Marmiroli, Gian Lorenzo Basetti, cit., p. 19. 57 Alle elezioni del 1895 tra i sostenitori di Basetti figuravano il sindaco di Castelnovo ne’ Monti, avvocato Domenico Notari, il dottor Gaetano Rabotti, Geminiano Ferrari, il dott. Enrico Amorosi, Vittorio Rabotti e il dottor Eleardo Rubini (Nel collegio di Castelnuovo Monti, in «L’Italia Centrale», 18 maggio 1895). 58 Per un profilo biografico di Azzio Caselli (1847-1898), medico chirurgo reggiano, cfr. U. Bellocchi (a cura di), Reggio Emilia. Vicende e protagonisti, Bologna, Edison, 1970, vol. II, p. 376. 59 Cfr. Cammarano, Consorteria moderata e propaganda socialista. Reggio Emilia dall’immobilismo sociale alla cultura politica, cit., p. 173. 60 «L’Italia Centrale», 28 settembre 1892. 61 Nel collegio di Castelnuovo Monti, in «L’Italia Centrale», 23 maggio 1895. 62 «Ch’egli fosse sinceramente amato dai montanari del reggiano, lo dimostra, non solo l’ininterrotta elezione, spesso senza competitori, ma anche il fatto che per lui votavano gli stessi preti, pur sapendolo garibaldino, e quindi piuttosto anticlericale» (R. Marmiroli, Gian Lorenzo Basetti, cit., p. 18). Sulla benevola posizione di parte del clero della montagna nei confronti di Basetti cfr. Spreafico, La chiesa di Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, cit., vol. II, p. 320. 63 «Gian Lorenzo Basetti non diede la caccia, e non ne aveva bisogno, ai voti degli elettori; i quali se gli professano singolare stima, altrettanto gli portano affetto. Ed è una vera festa in Castelnovo ne’ Monti, quando egli vi si reca; e ben a ragione, essendoché non è solamente il Deputato che va ad interessarsi dei bisogni del suo Collegio, ma ben anco il filantropico Medico, che vi accorre ad impartirvi le instancabili sue cure, ch’egli prodiga con piuttosto unico che raro disinteresse» (Il deputato Basetti, in «La Minoranza», 23 dicembre 1877). 41 42 23 Cfr. Perequazione fondiaria, in «La Minoranza», 18 dicembre 1879. Cfr. Strade provinciali governative, in «La Minoranza», 28 febbraio 1975; Nostre corrispondenze, in «La Minoranza», 16 maggio 1875. 66 «La Minoranza», 16 maggio 1875. 67 La risposta delle urne nella nostra provincia, in «L’Italia Centrale», 28 maggio 1895. 68 Cfr. R. Marmiroli, Socialisti, e non, controluce, La Nazionale, Parma 1966, p. 245. 69 Nel collegio di Correggio, in «L’Italia Centrale», 30 ottobre 1904. 70 «Mentre il partito dei Ferri, dei Prampolini, dei Turati, ecc. ha ovunque portato candidati proprii, nel collegio di Castelnuovo Monti ha non solo lasciato libero il Basetti, ma ha imposto a tutti i socialisti della montagna di votare per lui» (Nel collegio di Castelnuovo Monti, in «L’Italia Centrale», 3 novembre 1904). 71 Il comitato elettorale di Gualerzi poteva contare su un’articolazione territoriale diffusa sull’intero collegio: a Castelnovo Monti (Bellini Ciro, Rabotti Vittorio, Fiori Lorenzo, dottor Francesco Gatti, Cavalieri Mario, Ferrari Giuseppe, Cagni Giuseppe), a Busana (dottor Federico Manenti), a Vetto (Corradi Francesco), a Carpineti (dott. Enrico Manodori), a Casina (Rossi Francesco), a Toano (dott. G.B. Baroni), a San Polo (Curti Massimiliano, Bolondi Eugenio), a Quattro Castella (cav. Gustavo Cipriani, Prospero Toschi, Bertolini Tommaso, Del Monte Vittorio), a Collagna (Orlandi Domenico, Bertoni Giuseppe), a Ramiseto (Pagliai Bartolomeo). 72 Nel collegio di Castelnuovo Monti, in «L’Italia Centrale», 3 novembre 1904. 73 «Gittata come sdrucita zimarra la vecchia toga di democratico, si avvolge nell’ampia clamide socialista e non si vergogna di farsi portare dai nuovi apostoli, buttando a mare i vecchi amici per accapparrarsi i favori dei nuovi e più clamorosi compagni» (Nel collegio di Castelnuovo Monti, in «L’Italia Centrale», 4 novembre 1904). 74 Come evidenziò «L’Italia Centrale» il partito socialista preferì sacrificare «un fedele compagno, iscritto al partito, piuttosto che molestare l’on. Basetti nel suo collegio» (Ibidem). 75 Cfr. Piretti, Guidi (a cura di), L’Emilia-Romagna in parlamento, cit., vol,. I, p. 148. 76 Il compagno Basetti, in «L’Italia Centrale», 12 maggio 1906. 77 Sulla vicenda della nascita del partito radicale italiano nel 1904 cfr. Orsina, Senza chiesa né classe, cit. 78 Si veda a questo proposito il profilo di Basetti tratteggiato da Stefano Magagnoli, ritratto come «decano, guida e capo spirituale della Sinistra, svolse la sua opera con grande discrezione, senza mai intervenire nel dibattito parlamentare», ed al quale si rimanda anche per una contestualizzazione della figura di Basetti all’interno della classi dirigenti emiliane cfr. S. Magagnoli, Ėlites e municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia del primo ’900 (Modena, Reggio Emilia e Parma), Bulzoni, Roma 1999, p. 272. 79 «Ormai era assurto a statura nazionale ed era considerato come il patriarca del suo partito, che lo volle alle cariche maggiori» (Marmiroli, Gian Lorenzo Basetti, cit., p. 27); sul ruolo di Basetti all’interno del partito radicale ed in particolare nella fase di fondazione del partito radicale italiano allorché al parlamentare originario dell’Appennino parmense venne offerta la presidenza del congresso nazionale cfr. Orsina, Senza chiesa né classe, cit., pp. 157-177. 80 Per le nuove elezioni, in «L’Italia Centrale», 1° settembre 1892. 81 «Ciò che adesso più ci rattrista e addolora sarà fra non molto nient’altro che un doloroso ricordo nella storia italiana, se colla unione di tutte le forze vive della Nazione, il paese reale cesserà di trovarsi in continua opposizione col paese legale [corsivo nell’originale]» («La Minoranza», 14 maggio 1876). Cfr. anche «La Minoranza», 3 maggio 1880. 82 «A questa fede e alla coraggiosa iniziativa vostra, si deve la parziale scomparsa della più crudele fra le imposte, quella sulla fame; e a voi si dovrà ben altro, se continuerete ad essere, come foste sempre, gli interpreti sapienti dei bisogni del paese reale [corsivo nell’originale]» («La Minoranza», 9 maggio 1880). 83 Lega contro la tassa del macinato, in «La Minoranza», 24 dicembre 1876. 84 Per un inquadramento della personalità di Giuseppe Micheli (1874-1948), genero di Basetti ed importante esponente del movimento cattolico emiliano e nazionale, tra i numerosi lavori disponibili, cfr. Giuseppe Micheli dalle sue carte dai suoi libri, Ministero per i beni e le attività culturali, Biblioteca Palatina di Parma, Museo Bodoniano, Comitato per le celebrazioni per i 50 64 65 24 anni della morte di G. Micheli, Biblioteca Palatina, Parma, 1999. 85 Sulla figura di Meuccio Ruini (1877-1970), esponente di spicco del radicalismo italiano e uno dei protagonisti della vita politica nazionale del XX secolo sino agli anni Cinquanta e in particolare dell’elaborazione della Costituzione, all’interno dell’ormai ampia letteratura cfr. S. Campanozzi, Il pensiero politico e giuridico di Meuccio Ruini, Giuffrè, Milano 2002. 86 Vale la pena di segnalare che le elezioni del 1908 ed il vincolo di parentela che univa Micheli a Basetti, si prestano a diverse considerazioni sul fenomeno della continuità e persistenza dell’attività notabilare e la sua trasmissione in ambito familiare. Sulla elezione nel 1908 di Giuseppe Micheli nel collegio Castelnuovo ne’ Monti cfr. Rombaldi, Giuseppe Micheli, cattolico, deputato di Castelnovo Monti, cit. 87 La vita politica di Giuseppe Micheli e la sua azione in favore della montagna sono strettamente legate nella fase iniziale al settimanale «La Giovane montagna» da lui fondato a Parma nel 1900 con l’obiettivo di dare voce alle popolazioni dell’Appennino parmense e di promuoverne insieme lo sviluppo economico, sociale e politico. In seguito, come ha osservato Oscar Gaspari «dall’ottimismo positivista, evidente nelle prime annate della “Giovane montagna”, di uno sviluppo che sarebbe giunto inevitabilmente con ferrovie e strade e con l’applicazione di moderne tecniche colturali, Micheli, e la rivista con lui, è passato a sollecitare e programmare un intervento attivo e specifico dello Stato in favore della montagna» (O. Gaspari, La montagna. Alle origini di un problema politico (1902-1912), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1992, pp. 42-43). Sull’azione di Micheli a favore della montagna cfr. N. Michelotti, L’Appennino emiliano e il suo promotore Giuseppe Micheli (1874-1948), in Comune di Castelnovo ne’ Monti, L’Appennino: un crinale che univa e unirà, cit., pp. 141-149. 88 Sul punto sia consentito di rinviare ad A. Ferraboschi, Meuccio Ruini e la vita politicoamministrativa a Reggio Emilia nell’età giolittiana, in «RS-Ricerche Storiche», 2006/102, pp. 29-50. 89 Dopo la costituzione da parte di Ruini del Comitato degli amici della montagna al quale aderirono un centinaio di deputati di collegi montani di tutta Italia e di diverso orientamento politico, l’attivismo di Ruini nel promuovere la questione montanara avrebbe trovato uno sbocco istituzionale con la nascita nel 1919 del Segretariato della montagna. Sul ruolo fondamentale esercitato da Ruini nell’impostare una moderna politica a favore della montagna cfr. Gaspari, La montagna. Alle origini di un problema politico (1902-1912), cit.; Id., Il segretariato per la montagna (1919-1965). Ruini, Serpieri e Sturzo per la bonifica d’alta quota, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1994. 25 Antisemitismo italiano di Stato Francesco Paolella «Mussolini ha dichiarato a Emil Ludwig: “Non esiste alcuna razza pura. Il fatto comico è che nessuno dei sostenitori della pura razza tedesca era tedesco: Gobinaeu era francese; Chamberlain inglese; Woltmann ebreo”. Se l’antisemitismo diventasse necessario alle necessità del fascismo italiano, Mussolini, peggio di Machiavelli, seguirebbe Gobinaeu, Chamberlain e Woltmann e parlerebbe, anche lui, di razza pura»1. Citando la celebre intervista di Mussolini a Emil Ludwig2, in cui, fra l’altro, il dittatore sostiene la non-esistenza dell’antisemitismo in Italia, Camillo Berneri esprime in Il delirio razzista (1935)3 un giudizio originale sulla natura dell’antisemitismo fascista (e di Mussolini in particolare), giudizio che ci è utile per introdurre alcune fra le principali questioni legate alle leggi razziali, introdotte in Italia ormai settanta anni fa, nell’autunno del 1938. Le leggi furono l’apice del periodo detto della «persecuzione dei diritti» (1938-1943), che precedette quello della «persecuzione delle vite» (1943-1945), nel quale anche in Italia gli ebrei conobbero la deportazione e lo sterminio, di cui fu per molti versi la premessa necessaria. Berneri, pensatore libertario fra i più originali del Novecento, nel 1935 era già da quasi un decennio esule all’estero. Con piglio giornalistico, egli riuscì, quasi «in diretta», a rendere il montare del razzismo nella Germania nazista, sottolineando come «il fascismo, trionfo dell’irrazionale, ha fatto propri i miti più screditati dell’etnologia prescientifica»4 e riconoscendo le capacità espansive e la pericolosità di questo fenomeno a livello continentale. Il giudizio di Berneri su Mussolini, espresso solo due anni prima della svolta italiana verso il razzismo di Stato, è importante, come giustamente nota Alberto Cavaglion, perché ci ricorda un fatto oggi da più parti messo in discussione: Mussolini non fu un 27 antisemita dogmatico, almeno fino alla metà degli anni Trenta. Berneri, in altre parole, ci invita a non sopravvalutare le convinzioni di Mussolini a proposito dell’antisemitismo. Berneri fa un ragionamento opposto a quello che oggi si tende a fare. Non dice: Mussolini è in pieno delirio razzista. Non vi era infatti in Italia, almeno fino al 1935, un razzismo dottrinale nella mente del duce, né in chi gli stava vicino ... Se così fosse stato, come oggi alcuni sostengono, la domanda da farsi dovrebbe essere la seguente: perché aspettare così tanto per emanare leggi contro gli ebrei che avrebbero potuto essere emanate già nel 1933-1934? Il sentimento di Mussolini verso gli ebrei era invece a quel tempo oscillante, sottomesso al mutevole quadro internazionale, ondivago5. Se è sicuramente sbagliato, come vedremo meglio in seguito, ridurre le leggi razziali fasciste a pura imposizione nazista, è anche vero che non bisogna cadere nell’estremo opposto, dipingendo Mussolini come un teorico dell’antisemitismo e riducendo alle sue convinzioni la storia dell’antisemitismo italiano. Intendiamo qui, d’altra parte, offrire qualche spunto proprio per collocare l’antisemitismo fascista all’interno della più ampia storia del razzismo italiano, pur, come si diceva poco fa, senza voler in alcun modo negare le responsabilità di Mussolini e del fascismo nell’ideazione e nell’applicazione della legislazione antiebraica. All’epoca il corpus delle leggi antiebraiche venne compreso nella definizione “leggi per la difesa della razza”, assieme ai provvedimenti legislativi razzistici promulgati a partire dal 1937 contro le popolazioni indigene delle colonie africane (e alle precedenti e contemporanee disposizioni pronataliste, demografiche e matrimoniali). Esse vennero anche denominate ufficialmente “leggi razziali”, dizione apparentemente oggettiva e incolore, ma che in realtà presupponeva l’adesione del legislatore e della popolazione al razzismo stesso6. Tale passaggio da ideologia e teoria «scientifica» a legge, a norma – caratteristica, questa, di tutto il razzismo del XX secolo – merita molta attenzione. Anche in Italia fu possibile tradurre quel «delirio» in leggi apertamente discriminatorie e persecutorie, o, per meglio dire, in una complessiva «legislazione antiebraica»7, la quale, non lo si dimentichi, fu in buona sostanza applicata dalle istituzioni italiane e approvata, o quantomeno tollerata, dalla grande maggioranza della società italiana. Antisemitismo scientifico Una premessa indispensabile per il nostro discorso riguarda lo stesso termine «razzismo». Negli ultimi venti anni gli studi sul razzismo italiano, e specialmente 28 sull’antisemitismo, hanno avuto una notevole intensificazione. Nel 1988, cinquantenario dalla promulgazione delle leggi, è apparsa la pubblicazione integrale di tutta la legislazione antiebraica8, mentre l’esposizione bolognese dedicata a La menzogna della razza (1994)9 ha dato origine a diverse ricerche e, in particolare, alla creazione, sempre a Bologna, di un «Seminario permanente per la storia del razzismo italiano» (trasformato nel 1999 in «Centro studi sulla teoria e la storia del razzismo italiano») ed alla conseguente apparizione di diversi saggi10. Questo gruppo di ricercatori si è dato la finalità essenziale, come ha ricordato Alberto Burgio, uno dei fondatori, di documentare la inconsistenza della mitologia autoassolutoria (il “mito del bravo italiano”) per ciò che specificamente attiene alla rilevanza del razzismo nella cultura e nella storia materiale del nostro paese. Autorevolmente accreditata da una parte della storiografia e difesa dai custodi ufficiali delle glorie patrie, questa mitologia narra di un processo di formazione dello Stato nazionale immune – unico nel contesto occidentale – da quella peculiare modalità di nazionalizzazione della cittadinanza consistente nella etnicizzazione (razzizzazione)11. Un’origine «di lungo corso» dell’antisemitismo italiano (e occidentale12), prima ancora che fascista, va collocata nella storia più complessiva del razzismo italiano. L’Italia, non diversamente dagli altri paesi occidentali, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, vide l’affermazione di ideologie e pratiche razziste, rivolte tanto contro nemici interni (i diversi gruppi di «degenerati» e «deviati», come i folli o i delinquenti, ma anche contro le donne, i meridionali, e tutte le altre «classi pericolose») e contro i nemici esterni (via via tedeschi, slavi, africani). Gli ebrei divennero la «perniciosa sintesi di tutte queste dimensioni, ossimori viventi: nemici al tempo stesso esterni e interni; incarnazioni della modernità e di un passato intramontabile; popolo primitivo e ipercivilizzato; nazione straniera e cosmopolita; alfieri del socialismo e della plutocrazia»13. Per riconoscere questa prima, fondamentale, continuità nel razzismo italiano, bisogna disporre di un quadro analitico che tenga conto di una definizione di razzismo più ampia e più complessa di quella tradizionalmente considerata (ossia come ideologia legittimante la sola discriminazione contro i gruppi umani storicamente e razzisticamente considerati come «razze»). Lo stesso gruppo bolognese ha inteso così sintetizzare la questione, definendo il razzismo come insieme di ideologie caratterizzate da una delle due seguenti procedure logiche: a) trascrizione (non necessariamente consapevole né esplicita) in chiave naturalistica di caratteristiche storicamente determinate (differenza culturale e/o ineguaglianza sociale): è il caso del differenzialismo culturalista (nelle sue varianti linguistiche, religiose, etnoantropologiche), del «razzismo di Stato» (razzizzazione dell’avversario politico o del nemico bellico), del razzismo sociale (social-darwinismo, eugenetica, “razzismo di classe”, razzizzazione della devianza); l’antisemitismo costituisce una forma eminente di questo primo insieme, in quanto ha a proprio fondamento sia 29 elementi di carattere culturale sia ragioni di ordine politico e socio-economico; b) valorizzazione (ancora una volta non necessariamente consapevole né esplicita) della diversità naturale: è il caso del sessismo (razzizzazione della donna) e del razzismo coloniale14. In questo quadro è possibile riconsiderare tutta una serie, davvero vasta ed intricata, di «razzismi italiani», e, in particolare, di teorie scientifiche (antropologiche, psicologiche, biologiche, criminologiche), rivolte a «difendere la razza» (la società, la nazione, la stirpe) dai pericoli interni ed esterni di contaminazione, di degenerazione. «Se per un verso questo arsenale ideologico riprende tratti comune alla discussione occidentale (prima fra tutti l’ossessiva evocazione del rischio degenerativo), dall’altra parte presenta caratteri specificamente italiani sullo sfondo di questa mescolanza tra teorie antropologiche e morfologiche (“biotipologiche”) che negli anni del fascismo determina il varo di campagne di “bonifica umana” e di “ortogenesi” e ne affida la gestione alla corporazione medica»15. Nell’Italia degli anni precedenti l’avvio del razzismo di Stato, la cultura scientifica, e quella medica in particolare, presentava, come cifra largamente presente, una versione indigena di razzismo. «Era un razzismo che vedeva con entusiasmo nelle iniziative sanitarie del regime un progetto strategico di miglioramento della “razza italiana”, che a quest’ultima attribuiva volentieri qualità speciali, superiori»16. Qui vogliamo prendere in considerazione qualche esempio dell’influenza dei saperi scientifici nella storia del razzismo italiano (e dell’antisemitismo in particolare). Quello delle relazioni fra psichiatria e razzismo è un caso esemplare del coinvolgimento della cultura scientifica italiana nella formazione e diffusione dei pregiudizi razzisti. A questo proposito, è importante valutare quanto i saperi medico-psichiatrici pesarono nella legittimazione delle discriminazioni. Il razzismo contro gli anormali, specifico del XX secolo, è nato dalla psichiatria ... Portabandiera della protezione biologica della specie, la scienza psichiatrica cova il razzismo di Stato contro gli anormali. Con la “caccia ai degenerati” gli ospedali si gonfiano, ma è subito evidente che l’internamento non è il mezzo più adatto a rispondere a una missione che non è curare la malattia, ma prevenire i pericoli inscritti aleatoriamente in ogni stato di anormalità. Per questa via si giunge alle politiche eugenetiche dell’inizio del XX secolo ... Innestando il razzismo contro gli anormali su quello etnico e in particolare antisemita, il nazismo produrrà una vasta legislazione di stampo biopolitico, con un’escalation delle politiche eugenetiche che sfoceranno in programmi di eutanasia selvaggia17. L’Italia non ha mai conosciuto, è bene specificarlo, programmi di «eutanasia selvaggia», ma sarebbe un errore pensare che il nostro Paese sia stato estraneo ai fenomeni sopra descritti, e, in particolare, al dibattito scientifico che li ha accompagnati e sostenuti. Proviamo a chiederci, come già ha fatto, fra gli altri, Michel Foucault, «come mai la psichiatria abbia potuto funzionare così bene, 30 e spontaneamente, sotto il fascismo ed il nazismo ... Perché pressoché l’intera corporazione psichiatrica, in Italia, è stata coinvolta nell’allestimento del discorso razzista?»18 Tale questione, ancora poco affrontata dalla storiografia19, è stata al centro di un convegno, Il sapere le la vergogna. Psichiatria, scienza, cultura nelle leggi razziali del 1938, svoltosi nel 1998 e organizzato dal «Centro di documentazione di storia della psichiatria» di Reggio Emilia. Per ricostruire la storia del rapporto fra saperi bio-medici, scienze umane e razzismo, non si può non risalire almeno fino alla metà dell’Ottocento. La psichiatria, in particolare, a partire dalla teoria della degenerescenza, combinata con i “saperi sull’ereditarietà”, ha potuto dar luogo ad una nuova forma di razzismo, un nuovo razzismo, o una sua nuova modulazione, che è essenzialmente uno strumento di difesa interna della società “contro i pericoli che la corrodono dall’interno”, e ciò attraverso “l’eliminazione del pericolo biologico” ed il rafforzamento ‘direttamente legato a tale eliminazione’, della specie o della razza20. La traduzione giuridica del «delirio razzista», di cui parla Berneri, va inquadrata nell’ambito della nascita moderna del bio-potere, ossia della «presa in carico della vita» (in senso biologico) delle popolazioni da parte del governo, una presa in carico che si è espressa soprattutto con la creazione di «dispositivi biosicuritari», rimedi, appunto, contro la degenerazione, la malattia sociale, contro tutti i pericoli per la stirpe, in nome dei principi di una «medicina sociale». Anzi, considerando in particolare l’antisemitismo, si ebbe l’invenzione di una vera e propria «psicopatologia della razza ebraica». Perlomeno a partire dagli anni Settanta del secolo scorso [l’Ottocento] l’antisemitismo che nella sua originaria genesi teologica aveva funzionato da matrice di tutti i razzismi, come è stato detto, è diventato l’oggetto di un investimento medico-psichiatrico, e l’ebreo è stato sottoposto ad un processo di progressiva patologizzazione psichiatrica. La totalità dell’esperienza dell’ebraismo, in particolare di quello askenazita, viene ricodificata alla luce delle categorie della patologia mentale: dalla circoncisione alle pratiche e regole sessuali, dai matrimoni endogamici (identificati con vere e proprie relazioni incestuose) alle particolari caratteristiche dell’esperienza mistica di determinati movimenti religiosi in seno all’ebraismo, all’uso “corrotto” del linguaggio21. Gli ebrei dovevano rappresentare, una volta acquisita «scientificamente» una gerarchia fra le razze, una deviazione ad un tempo biologica e morale, fisica e mentale. L’apice dell’alleanza fra saperi medico-scientifici e sociali da una parte, e politica e diritto dall’altra, si ebbe proprio con l’affermazione dell’antisemitismo fascista. Non sarà allora un caso se la psichiatria si avvierà nel corso dell’Ottocento a diventare una “scienza sociale”, destinata a formare la base e ad assumere il carattere 31 di una “funzione di stato”, come uno dei direttori del S. Lazzaro [il manicomio di Reggio Emilia] aveva scritto nel 1910, ed è alla “trasformazione fisica e psichica della razza”, come dirà un medico del S. Lazzaro nel 1934, che il ceto medico si candida, perché “la difesa più strenua dell’individuo e della stirpe è funzione di governo, epperciò è funzione politica” e dopo l’avvento del regime fascista, scrive un altro medico nel 1927 finalmente ci si incammina a fare “della difesa e del perfezionamento della razza l’idea dominante, l’idea-scopo”22. L’obiettivo era quello di dare vita ad una vera e propria «medicina politica»23. La legislazione contro gli ebrei del 1938 venne a collocarsi nel quadro di un duplice sviluppo. Da una parte il potenziamento degli orientamenti popolazionistici che il regime fascista aveva assunto con sempre maggiore decisione a partire dalla seconda metà degli anni Venti, come condizione preliminare e non soltanto come corollario della sua politica di potenza; dall’altra, l’avvio di una politica di tutela della razza come conseguenza della conquista coloniale in Abissinia e dell’incontro con popolazioni africane che non poteva non porre il problema della “contaminazione” della popolazione italiana con gli indigeni24. A partire dagli inizi del Novecento, anche l’Italia conobbe l’espansione di un movimento eugenetico, spinto dagli sviluppi della medicina e delle scienze sociali (come la demografia e la statistica). Il nesso eugenica-razzismo è stato ad esempio approfondito in due studi italiani recenti25, da quali emerge l’influenza che via via assunse il problema della «difesa della razza», in un contesto (non dimentichiamo coloniale) sempre più attento al dato demografico e che progressivamente slittò dagli aspetti soltanto quantitativi a quelli qualitativi, ponendo le basi per politiche di discriminazione razziale e di apartheid. In sintesi, «il razzismo riveste un ruolo importante in una discussione dei problemi della popolazione sotto il fascismo per almeno due ragioni: la prima è che la politica razzista influì su parecchie variabili demografiche (nuzialità, fecondità e migrazione); la seconda, che il razzismo fu visto in quel periodo come parte della più ampia “politica demografica” e ad essa fu anche legato sotto il profilo istituzionale»26. Si trattò di un percorso che ebbe un momento fondamentale di ufficializzazione con il cosiddetto Discorso dell’Ascensione, tenuto da Mussolini alla Camera il 26 maggio 1927. Vi leggiamo: È evidente che in uno Stato bene ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo posto ... La razza italiana, il popolo italiano nella sua espressione fisica, è in periodo di splendore o ci sono dei sintomi di decadenza? Se il movimento retrocede quali sono le possibili prospettive per il futuro? Questi interrogativi sono importanti non solo per medici di professione, non solo per colore che professano le dottrine della sociologia, ma soprattutto per gli uomini di governo27. Un secondo intervento mussoliniano nella stessa direzione, di poco 32 successivo, fu la prefazione al libro dello statistico Richard Korherr, Regresso delle nascite: morte dei popoli28. Qui Mussolini – nota Roberto Maiocchi – assume un tono catastrofico: i dati demografici dimostrano che i paesi più evoluti sono entrati un una fase di regresso e si profila un mutamento dei rapporti di forza tra le varie razze; “negri e gialli sono dunque alle porte? Sì, sono alle porte e non soltanto per la loro fecondità, ma anche per la coscienza che essi hanno preso della loro razza e del suo avvenire nel mondo”. L’Italia non sfugge al pericolo della denatalità e bisogna correre ai ripari con una legislazione che stimoli la natalità ... Con questo scritto diveniva ufficialmente parte dell’ideologia del fascismo l’equazione numero = forza, veniva autorevolmente lanciata la parola d’ordine della crescita quantitativa degli italiani e, suo corollario inevitabile, apparivano condannate senza scampo le pratiche neomalthusiane di controllo delle nascite29. Divenne prioritaria una lotta contro le «malattie sociali», attraverso una campagna per la natalità (contro l’aborto e il celibato), bonifiche rurali, una lotta ai danni dell’urbanesimo, ed attraverso una educazione fisica e sessuale di massa. Statistici e demografi favorevoli alla politica nativista non si limitarono a fornire supporti per teorizzare la prolificità della popolazione italiana e all’occorrenza contribuire ad aumentarla; essi sposarono in pieno anche la retorica del regime che operava l’equazione prolificità uguale popoli giovani, costruendo su di essa la contrapposizione e la polemica con i popoli vecchi e senescenti, che erano le più antiche democrazie e le potenze coloniali con le quali voleva ora misurarsi l’Italia nel suo impeto di conquistare un impero30. D’altra parte, furono soprattutto gli studi antropologici di africanistica ad essere un serbatoio di stereotipi, materiale per consacrare nell’immaginario, ancora prima che nella legislazione, l’esistenza di una distanza incolmabile fra le razze (e la superiorità di quella «bianca»). Si pensi all’opera di Lidio Cipriani, antropologo a Firenze, per anni impegnato in Africa, dove raccolse una notevole quantità di materiale fotografico. Fu anche fra i firmatari del documento Il fascismo e i problemi della razza (il cosiddetto Manifesto degli scienziati razzisti), pubblicato nel luglio del 193831. Sul finire del 1937 l’edificio razzista è in piena costituzione. L’antropologo Lidio Cipriani si è ormai acquistato il ruolo di ideologo di riferimento del regime per le questioni demografiche africane; il varo della legislazione contro le “unione miste” dà ragione alla sua impostazione teorica dei rapporti tra “bianchi e neri” in colonia, e gli articoli su “Gerarchia” ne sanciscono il riconoscimento ufficiale. Tra i numerosi progetti e lavori che ha in cantiere uno riguarda la presenza di soggetti di colore in Italia che, secondo la sua visione razzista della realtà, costituiscono una vera minaccia alla purezza della popolazione bianca32. 33 La legislazione razzista del 1937, oltre ad essere prodromo a quella antiebraica dell’anno successivo, segnò il passaggio da una «semplice» politica coloniale razzistica ad una politica razzistica «pura». Fu il ministro per le Colonie, Alessandro Lessona, a rendere concreta questa volontà discriminatoria e a dare valore giuridico a tutte le forme non istituzionali di razzismo, presentando ai suoi colleghi, il 4 gennaio 1937, un progetto di legge che prevedeva il divieto – sia nel territorio del Regno, sia nelle colonie – di tenere «relazioni d’indole coniugale» tra un cittadino italiano e un suddito dell’aoi (Africa orientale italiana). Il progetto fu approvato e pubblicato il 19 aprile di quell’anno (rdl 880/1937), con il titolo Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi, punendo con la reclusione da uno a cinque anni i rapporti di «madamismo». Questa scelta si inserì in una campagna già avviata contro il meticciato, venne poi perfezionata da parte dei governatori ed ampliata da successive norme33. Nel 1940, quando già le leggi antiebraiche erano in vigore da quasi due anni, vi fu l’emanazione delle Norme relative ai meticci (rdl 822 del 13 maggio 1940): «la ratio della legge consiste essenzialmente nel negare la qualifica di cittadino al meticcio; essa anzi nega la figura stessa del meticcio per assimilarlo in ogni circostanza al nativo»34. Nel 1938, quando il razzismo era ormai divenuto parte essenziale della politica interna e della propaganda del fascismo, il regime iniziò una politica di espulsioni dall’Italia, perché «la presenza di persone di colore integrate o in via d’integrazione nella società italiana avrebbe rappresentato un evidente, sfacciato segnale dell’incapacità del regime ad applicare i principi razzisti tanto ostentati»35. Dobbiamo ora analizzare per un momento, alla luce dei rapporti già emersi fra eugenica e razzismo, dei diversi razzismi del fascismo. Dopo che già Renzo De Felice aveva proposto la distinzione fra razzismo biologico e razzismo spirituale, è stata avanzata più di recente, con non poco successo, una suddivisione dei razzismi fascisti tra razzismo biologico, nazional-razzismo e razzismo spirituale (o esoterico)36. Si tratta di una partizione puramente «ideale», perché gli scritti razzisti mostrano il riferimento contemporaneo a più forme di razzismo. Essa pesò soprattutto per determinare le diverse tecniche di definizione dei soggetti da perseguitare, di chi, cioè, dovessero essere considerato ebreo: Relativamente all’individuazione dei perseguitandi, si può schematicamente riepilogare che, in questa tripartizione, la prima tendenza – il razzismo biologico – rappresentava una sorta di posizione mediana tra la tendenza nazional-razzista, incline a tener maggiormente conto degli eventuali “meriti” nazional-fascisti che degli ottavi di sangue, e la tendenza esoterico-tradizionalista, secondo il cui approccio fobico anche una ridotta parte di cosiddetto “sangue ebraico” costituiva un attentato alla sanità dell’individuo e della società tutta37. Comunque sia, la differenza essenziale è nel modo di considerare l’influenza dell’ambiente e dell’ereditarietà sulla razza38. A dividere il razzismo biologico, 34 materialista, da quello spirituale (o «dell’anima») era, in estrema sintesi, la diversa risposta alla seguente domanda: a quale base agganciare il concetto di razza? Se il razzismo biologico si fondava su un fondamento organico (il sangue), e il nazional-fascismo prediligeva i concetti di nazione e di stirpe, il razzismo esoterico-tradizionalista si affidava all’anima, a uno spirito atavico, che soltanto gli iniziati avrebbero potuto afferrare. Il razzismo biologico (fra i cui esponenti c’erano Guido Landra e Telesio Interlandi, direttore del periodico «La Difesa della razza») proponeva l’autoevidenza dell’esistenza biologica delle razze, un punto di vista che possiamo trovare, fra l’altro, anche nel cosiddetto Manifesto degli scienziati razzisti: «Le razze umane esistono» (punto 1); «Esistono grandi razze e piccole razze» (punto 2); «Il concetto di razza è concetto puramente biologico» (punto 3); «Esiste ormai una pura “razza italiana”» (punto 6)39. Fra i problemi che si trovarono di fronte i propugnatori del razzismo biologico, ci fu quello di individuare una classificazione, capace di fare ordine fra le universali «mescolanze razziali», oltre alla difficoltà di dimostrare il nesso fra dato biologico e dato culturale, tra dato somatico e dato psichico. Anche il razzismo biologico non riuscì a sottrarsi ad una ambiguità di fondo, comune a tutte le diverse posizioni razzistiche. Prendiamo ad esempio un articolo di Eugenio Fischer, apparso su «La difesa della razza» del 5 novembre 1939: «Le razze sono dati assolutamente reali. La razza non è una finzione teorica. Le razze sono gruppi con definiti geni uguali ... Ai ceppi ereditari dell’uomo appartengono anche quelli delle sue qualità spirituali. La ricerca delle coppie, la ricerca psichiatrica e la ricerca genealogica hanno pienamente dimostrato che, anche per tutte le qualità spirituali, talenti, attitudini, e così via, i geni costituiscono sempre il fondamento»40. Il razzismo biologico, proprio per la sua impostazione, fece molta fatica a radicarsi nel panorama italiano. Il nazional-razzismo fu, invece, per lungo tempo quello prevalente nel nostro Paese. Può sembrare a tutta prima una forma più blanda di razzismo, perché faceva riferimento a concetti quali la nazione, la stirpe, ovvero la cultura, le tradizioni, la lingua di un popolo. La cultura diventava in questo caso, però, una «seconda natura». I nazional-razzisti sostenevano l’esistenza di una comunità culturalmente e storicamente (e non biologicamente) determinata, ma non per questo meno degna di essere «difesa» e distinta dalle altre. «Secondo i nazional-razzisti, solo chi è nato in Italia da genitori italiani e da progenitori italiani, ha respirato da sempre aria italiana, si comporta da italiano ... Entra in gioco il concetto di stirpe, che – giocando sull’ambiguità della parola sangue, la quale può essere intesa in senso sia letterale sia figurato – introduce un’idea di discendenza biologica nel concetto di civiltà»41. Troviamo anche qui un’ambiguità di fondo, visto che era comunque necessario riferirsi sia al biologico, sia allo spirituale. Tra razzismo biologico e nazional-razzismo esisteva un movimento di reciproca contaminazione: mentre il primo doveva richiamarsi ai valori spirituali, culturalizzando il sangue, per 35 affermare una gerarchia fra le razze, il nazional-fascismo doveva ricorrere ad una naturalizzazione dello stesso sangue per dare senso all’esistenza della razza. Abbiamo infine il razzismo esoterico-tradizionalista, rappresentato in Italia soprattutto dall’opera di Julius Evola e che, nel corso del tempo, diede un peso crescente al dato biologico42. Al nazional-razzismo, Evola rimproverava di aver banalizzato l’idea di razza con quella di comunità nazionale. D’altra parte, la razza dei biologisti non era immune da una democratizzazione, una volgarizzazione. Essere ebrei è per Evola uno stigma ben più profondo e indelebile di quanto non riconoscano i nazionalisti. Specularmente, essere ariani (o, meglio, arii) è una condizione che va ben al di là dell’appartenenza a una certa comunità nazionale ... Inoltre, degradare il concetto di razza a quello di popolo (o di nazione) significa automaticamente negare il carattere aristocratico dell’arianesimo che, nell’ottica del razzismo esoterico, è oltre che un fatto biologico (arii si nasce, non si diventa) – un principio di elezione spirituale altamente selettivo43. Evola cercava di svincolarsi dal principio materialistico della «razza del sangue», per sottometterla alla «razza dello spirito». La «razza dello spirito» è una visione del mondo aristocratica, guerriera, irriducibilmente opposta alla visione del mondo moderna, egualitaria, razionalistica e giudaica44. Le leggi antiebraiche Volendo comprendere il contesto in cui nacquero le leggi antiebraiche del 1938, oltre a quanto detto sinora, occorre tenere in considerazione anche diversi altri elementi, di natura più strettamente politica (di politica interna e di politica estera). Negli anni fra il 1935 ed il 1937, ci fu il periodo di transizione del regime verso pozioni antisemite sempre più manifeste e coerenti. Da una parte, l’ebraismo italiano si erano mostrato sempre indisponibile a perdere la propria peculiare identità (in ciò scontrandosi con la minoranza interna degli «ebrei fascistissimi»). Gli ebrei italiani non erano integralmente «fascistizzabili». Essi, in altre parole, non sapevano corrispondere all’immagine di «nuovo italiano», che il fascismo voleva diffondere. La carta dell’antisemitismo fu usata per rivitalizzare dall’interno l’identità collettiva del Paese, investendo, per una più decisa «fascistizzazione», su un modello razzista di società (e ricuperando – non lo si dimentichi mai – il profondo e mai sradicato antigiudaismo cattolico45). Gli ebrei dovevano servire a materializzare il nemico (e questo meccanismo sarebbe stato utilizzato dal fascismo soprattutto negli anni di guerra). L’antisemitismo (fondato anche sull’equazione di «ebraismo = antifascismo») doveva rivestire il ruolo di grande mito collettivo, con cui far emergere sempre e ovunque la pericolosità e la nocività degli ebrei, e contribuendo a diffondere una vera e propria psicologia di guerra. 36 Sicuramente influì nelle decisioni del regime, soprattutto sui tempi della genesi delle persecuzioni, la politica di avvicinamento alla Germania nazista, ma soprattutto per la scelta di campo che il fascismo volle fare. Il regime decise di schierarsi contro il campo delle democrazie occidentali, liberali, che dipingeva deboli, soggiogate dal dominio ebraico e che, anche in ambito coloniale, avevano favorito la «contaminazione razziale» (erano proprio gli anni dell’«impero fascista»). La spirale antisemita in Italia non era, del resto, un fenomeno isolato. Negli anni Trenta pressoché tutta l’Europa conobbe l’aumento, in modi sempre diversi, dell’antiebraismo e della sua legittimazione. La normativa persecutoria introdotta dal nazismo in Germania a partire dal 1933 fu da un lato un prodotto e una testimonianza di tale processo, e dall’altro un forte stimolo al suo ulteriore sviluppo, perché mostrò al continente che era tecnicamente, politicamente e moralmente possibile legiferare contro i propri cittadini ebrei. Detto ciò, va riaffermato che non sono stati reperiti o localizzati documenti o indizi che testimonino interventi diretti o indiretti di Berlino, negli anni Trenta, affinché altri Stati adottassero legislazioni similari46. Le leggi antiebraiche non furono materia d’importazione dall’estero (ossia dalla Germania), ma il risultato di una scelta autonoma e prettamente politica del fascismo, con una deliberata finalità antiebraica. È bene ricordare ancora che la promulgazione di quelle leggi non fu l’esito di un complesso processo teorico-ideologico47. Colpisce, infine, la (relativa) brevità della transizione italiana, che, partendo da casi isolati, sporadici, periferici (piccoli torti, vessazioni, minacce), giunse ad un antisemitismo generalizzato ed indifferenziato. Quest’ultimo poté diffondersi grazie ad una progressiva (anche se non omogenea) opera di propaganda48. Soprattutto dal 1937 la pubblicistica e l’editoria si affiancarono alla stampa già apertamente antisemita (come «Il Regime fascista» di Roberto Farinacci), espressione di un’anima già da sempre presente nel movimento fascista. Qui vogliamo citare almeno il libro Gli ebrei in Italia di Paolo Orano: «Pressoché unico compito del volumetto fu quello di assegnare la qualifica di irriducibili nemici dell’Italia fascista totalitaria (da tempo attribuita agli ebrei sionisti) anche agli ebrei “ebraizzanti”, cioè a quegli ebrei che non si caratterizzavano unicamente per l’osservanza della ritualità religiosa ebraica, bensì conservavano un’identità ebraica e una qualche coscienza collettiva e quindi, tra l’altro, soccorrevano i profughi tedeschi, criticavano la Germania nazista, contestavano l’alleanza tra le due dittature»49. Il 16 febbraio 1938 fu emessa l’Informativa diplomatica n. 14, che può essere considerata il primo documento ufficiale dell’antisemitismo fascista. Vi si legge: Il Governo fascista non ha mai pensato, né pensa di adottare misure politiche, economiche, morali contrarie agli ebrei in quanto tali, eccettuato beninteso nel caso 37 in cui si tratti di elementi ostili al Regime ... Il Governo fascista si riserva tuttavia di vigilare sull’attività degli ebrei venuti di recente nel nostro Paese e di far sì che la parte degli ebrei nella vita complessiva della Nazione non risulti sproporzionata ai meriti intrinseci dei singoli e all’importanza numerica della loro comunità50. Pochi mesi dopo fu la volta del già ricordato documento teorico Il fascismo e i problemi della razza; il 6 ottobre, il Gran consiglio del fascismo intervenne con una Dichiarazione sulla razza, in cui fu data la prima definizione di «appartenente alla razza ebraica», volendo, con questa formula, definire l’appartenenza come fatto puramente biologico e non identitario o religioso: Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue: a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori dell’ebraica, alla data del 1° ottobre XVI51. Per stabilire con ragionevole certezza una definizione giuridica di «appartenente alla razza ebraica», gli uffici procedettero a sviluppare una vera e propria «casistica del sangue», approntando una complicata indagine fra alberi genealogici. Il sistema classificatorio al dunque varato definiva la “razza” di una persona innanzitutto sulla base della “razza” dei suoi genitori e in secondo luogo – se essi appartenevano a “razze” diverse – sulla base dapprima della nazionalità dei genitori stessi e poi delle caratteristiche individuali delle persone in oggetto. Questo sistema veniva applicato anche per definire la “razza” di ciascun genitore e così a ritroso – se necessario – per alcune altre generazioni, sino a raggiungere un momento (mai definito pubblicamente) nel quale si dava per scontata la coincidenza tra religione cristiana e “razza ariana” e tra religione ebraica a “razza ebraica”. A differenza di quello nazista, il sistema fascista non prevedeva una categoria apposita per i “misti”: una persona cioè era classificata “di razza ebraica” o di “razza ariana”52. In questa sede, per ovvie ragioni, non possiamo ricostruire tutti i passaggi che, tra il 1937 ed il 1938, furono di necessaria preparazione al varo della legislazione antiebraica. Si procedette ad allestire gli apparati burocratici, che sarebbero poi stati deputati a gestire le persecuzioni. A questo proposito, nel luglio del 1938 ci fu la trasformazione dell’Ufficio centrale demografico nella Direzione generale per la demografia e la razza, mentre in agosto nacque, presso il ministero della Cultura popolare, un apposito Ufficio studi per i problemi della razza. «La prima (nota come Demorazza e in settembre affiancata da un Consiglio superiore per la demografia e la razza) effettuò il lavoro di pre-elaborazione e poi di gestione della normativa razzistica; il secondo (talora indicato come Ufficio razza) operò principalmente nei campi 38 dell’orientamento, della propaganda e della documentazione, organizzando tra l’altro in varie città, a partire dal 1941, il Centro per lo studio del problema ebraico»53. La burocrazia statale fu un supporto indispensabile per l’attuazione del disegno antisemita. Le leggi e le disposizioni amministrative furono applicate con solerzia, capillarmente, segno di una sostanziale adesione o, per lo meno, di una generalizzata indifferenza verso le politiche antisemite54. Nei primi nove mesi del 1938 Mussolini, assieme agli uffici deputati, si impegnò nell’elaborazione della legislazione antiebraica, in modo che questa risultasse coerente con lo stile e gli obiettivi del fascismo. In questo periodo il modello di persecuzione da seguire fu modificato diverse volte, soprattutto in rapporto alle esenzioni da accordare. Ad influire sulle opinioni di Mussolini, furono sicuramente i risultati del censimento speciale degli ebrei italiani e stranieri, svoltosi il 22 agosto 1938. Gli ebrei furono individuati e schedati. L’operazione, gestita dalla Demorazza e importata su criteri razzistici, portò ad accertare che nel Regno vi erano 58.412 residenti nati da almeno un genitore ebreo o ex ebreo, suddivisi in 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi ... Di essi, 46.656 (37.241 italiani e 9.415 stranieri) erano “ebrei effettivi” (cioè erano iscritti a una comunità ebraica o comunque avevano dichiarato di appartenere all’ebraismo) e 11.756 appartenevano a varie categorie, le più cospicue delle quali erano quella di coloro che si erano distaccati dall’ebraismo (circa duemilaseicento) e quelli dei figli non ebrei di matrimoni “razzialmente misti” (poco più di settemila)55. Mussolini mostrò ben presto la convinzione di poter avanzare molto nella direzione dell’arianizzazione della società italiana, senza dimenticare, a questo proposito, che il fine ultimo della legislazione antiebraica era allora quello di «liberare» l’Italia dagli ebrei, costringendoli all’espatrio (ed espellendo gli ebrei stranieri). Ai primi di settembre fu emesso il provvedimento legislativo (rdl 1381/1938), in cui si prevedeva l’espulsione degli ebrei stranieri e la arianizzazione della scuola pubblica (rdl 1390/1938 e rdl 1630/1938). Tra il 7 ed il 10 novembre il Consiglio dei ministri approvò le misure di ordine generale (rdl 1779/1938). In dicembre e negli anni successivi vi furono ulteriori provvedimenti, soprattutto disposizioni di tipo amministrativo, dedicati, di regola, a perfezionare nei diversi ambiti l’indirizzo generale. Tutte queste norme erano state scritte in esclusiva funzione antiebraica, tranne quella (rdl 1728/1938) che vietava i matrimoni tra un italiano «di razza ariana» e persona di altra razza. Tutte le leggi furono sottoscritte dal re, Vittorio Emanuele III e vennero approvate dalle Camere (la Camera all’unanimità; il Senato, di nomina regia, a larghissima maggioranza). La legislazione divise i cittadini italiani in due categorie: ebrei e non ebrei. Ciò rappresentò la rottura del patto di cittadinanza, così come si era affermato nel processo risorgimentale. Il fascismo volle estromettere gli ebrei dalla vita sociale del Paese. Le leggi del 1938 intesero perseguitare gli ebrei, togliendo 39 loro le possibilità concrete di sopravvivere, colpendo innanzitutto il diritto di proprietà ed il diritto al lavoro. Tutti gli ebrei, che erano impiegati pubblici e assimilati (rdl 1728/1938) furono allontanati: oltre che dall’esercito, vennero licenziati da tutti gli uffici e da tutte le mansioni (poste, vigili del fuoco, trasporti, ministeri, etc.). Contestualmente, si iniziò un’opera simile per gli impieghi privati, espellendo gli ebrei anzitutto da quelle attività che interessavano la «difesa della nazione», anche solo ausiliarmente (quindi, ad esempio, dalla fiat, dai cantieri navali, dalla Compagnia generale di elettricità). L’espulsione colpì i dipendenti di banche ed assicurazione ed anche i liberi professionisti. «Tra il 1938 e il 1942 fu loro precluso il rinnovo ed il rilascio di licenze di attività subordinate ad autorizzazione di polizia (tra le altre, quelle turisticoalberghiere ed il commercio ambulante); nel 1939 furono sostanzialmente esclusi dalle professioni autonome regolate da albi, ossia quelle di medico, ostetrica, veterinario, avvocato, ingegnere, geometra, agronomo»56. Anche per i beni posseduti si svolsero appositi censimenti. I divieti sulle proprietà riguardavano il possesso, anche parziale, di aziende commerciali o industriali che interessavano la difesa della nazione (furono escluse le società per azioni). Per i beni immobili furono fissati dei limiti: cinquemila lire di estimo per i terreni e ventimila lire per i fabbricati urbani. I beni ulteriori dovevano essere ceduti all’egeli (l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare), dietro rimborsi erogati in titoli di Stato trentennali. La Legge 1728/1938 disciplinava anche la cosiddetta «discriminazione» (riferita, in questo caso, a una distinzione fra ebrei ed ebrei, e non fra ebrei ed ariani). Si trattava di una limitata esenzione da parte delle persecuzioni, per alcuni nuclei familiari ebraici. Esse riguardavano le famiglie «un cui componente fosse caduto in guerra o per la causa fascista o (anche se deceduto prima del novembre 1938) avesse acquisito particolari “benemerenze” di ordine bellico (volontario, ferito, decorato), politico (iscrizione al pnf prima del 1923 o nel secondo semestre del 1924, cioè prima della costituzione del governo Mussolini o subito dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti) di altro “eccezionale tipo”»57. Gli ebrei discriminati, rispetto agli altri, potevano godere di condizioni più vantaggiose in merito al possesso di beni immobili e di aziende ed avevano qualche concessione nel caso fossero stati liberi professionisti (potevano cioè avere anche clienti non ebrei). La discriminazione non era automatica. Ci furono circa 9000 domande. A gennaio 1943 ne risultavano accolte meno di 3000. L’unica modifica alle norme di novembre fu la Legge 1024/1939, per la procedura di «arianizzazione». Essa prevedeva che una persona potesse dimostrare di avere un genitore (o un altro ascendente) biologico diverso da quello registrato negli atti ufficiali di nascita. Date le sue caratteristiche, questa proceduta fu di fatto utilizzata solo da persone di religione cristiana inizialmente classificate «di razza ebraica», le quali volevano essere riconosciute miste per poter poi essere riclassificate «di razza ariana»58. Come è facile immaginare, questa «pratica», che si svolgeva davanti a un vero «tribunale della razza» e 40 che coinvolse un numero assai limitato di persone (circa 160 al 1942), non va intesa come un addolcimento del dispositivo persecutorio, ma soltanto una deroga per casi eccezionali. I perseguitati furono, secondo un’ipotesi a partire dai dati del censimento di agosto 1938, circa 51.100, di cui 46.656 «ebrei effettivi» e 4500 non ebrei (cioè cattolici o altro). 39.000 circa erano italiani. Si può ipotizzare che, nell’autunno del 1938, ci fossero circa 3100 ebrei stranieri «regolari», e che 8100 fossero invece obbligati a lasciare l’Italia. Il regime vietò l’ingresso di ebrei stranieri a scopo di residenza. Con il passare del tempo, si iniziò a preparare l’internamento in campi di tutti gli ebrei stranieri non autorizzati a risiedere, con il fine di procedere poi alla loro emigrazione59. I primi provvedimenti, a settembre, riguardarono la scuola e l’università. Questa scelta non fu (o non fu essenzialmente) dettata da ragioni di ordine pratico (l’imminente inizio dell’anno scolastico), ma da una precisa esigenza politica. La priorità era quella di «bonificare» l’educazione nazionale, l’educazione dei nuovi fascisti, dalle pericolose influenze della «cultura giudaica» e, ancora, per mobilitare per prime le giovani generazioni. Nella scuola e nelle università vennero adottate le seguenti principali misure contro le persone o le presenze “di razza ebraica”: 1) esclusione (ossia espulsione dei già presenti e divieto di nuovi accessi) degli studenti dalle scuole elementari e medie frequentate da alunni “ariani” (gli esclusi potevano frequentare le scuole di enti cattolici, se battezzati, o – laddove fossero state istituite – le “speciali sezioni” di scuola elementare statale o le scuole delle comunità israelitiche; queste concessioni furono determinate dalle volontà governativa di non corrodere il principio della scolarità obbligatoria); 2) esclusione degli studenti dalle università (con la temporanea eccezione, originata da considerazioni relative agli accordi internazionali di reciprocità, di coloro che – italiani o stranieri, ma non tedeschi – erano già iscritti nell’anno accademico 1937-38 e non erano fuori corso); 3) esclusione degli insegnanti dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (a eccezione delle eventuali scuole ebraiche o “speciali”); 4) esclusione degli impiegati dalle scuole, dagli uffici ministeriali, ecc.; 5) divieto di adozione nelle scuole medie dei libri di testo redatti, commentati o riveduti da autori “di razza ebraica”, anche se in collaborazione con autori “ariani”, e di quelli contenenti riferimenti al pensiero di ebrei morti dopo il 185060. È facile comprendere quanto gravi furono le conseguenze anche per il mondo culturale e scientifico italiano. Vennero licenziati più di cento fra direttori e maestri elementari, quasi trecento fra presidi e docenti di scuola media (170 nei licei e alle magistrali, più di cento negli istituti tecnici). Dalle università vennero cacciati quasi cento fra professori ordinari e straordinari, ed almeno trecento persone fra assistenti e liberi docenti61. Più in generale, e con il passare dei mesi, si accrebbero le persecuzioni nel mondo culturale (in senso lato) ed editoriale. Al di là dei casi personali (di favoritismo o di corruzione)62, non vi furono veri episodi di disapplicazione delle leggi (nella scuola come altrove). Nei primi mesi dall’entrata in vigore 41 delle leggi, le case editrici smisero di pubblicare nuovi libri di ebrei e si iniziò a procedere al ritiro dei testi già in commercio. Già nel 1938 gli ebrei erano stati di fatto allontanati dalle redazioni di giornali e riviste, mentre a dicembre furono bloccate le pubblicazioni della stampa ebraica. «Pittori e scultori ebrei vennero esclusi dalle mostre e censurati e videro improvvisamente sconvolte le loro relazioni professionali ... Gli ebrei furono anche espulsi da tutte le accademie e società scientifiche della penisola (i soci italiani e stranieri allontanati furono almeno 672; l’Accademia dei Lincei ne allontanò 30, mentre l’Accademia d’Italia non ne aveva mai accolti) e venne loro vietato – se non discriminati – l’accesso alle biblioteche pubbliche»63. Furono colpiti anche egli ebrei che lavoravano nel teatro, nel cinema e nel mondo della musica. Le opere di autori ebrei furono eliminate dai cartelloni delle stagioni di lirica e prosa, dai programmi delle trasmissioni radiofoniche e dai cataloghi delle case discografiche. È importante notare che, in molti casi, questi divieti erano originati da disposizioni amministrative e non da apposite leggi. Emerge il carattere perfettamente deduttivo di molte proibizioni rispetto al principio generale razzista, secondo il quale gli ebrei erano nemici della nazione, anche in assonanza, talvolta in un senso molto generico, con i più diffusi pregiudizi antisemiti. Citiamo soltanto alcuni esempi. Agli ebrei era vietato essere agenti d’affari, agenti di brevetti, commercianti di preziosi, piazzisti, mediatori, tipografi, fotografi, raccoglitore di rottami metallici e di metalli, raccoglitori, venditori di indumenti militari fuori uso. Non potevano vendere oggetti antichi, oggetti d’arte, oggetti sacri, libri, articoli per bambini, articoli di cartoleria. Non potevano vendere carburo di calcio, non potevano condurre autoveicoli di piazza. Non potevano avere la licenza di pescatore dilettante né il porto d’armi. Non potevano detenere né vendere apparecchi radio. Non potevano essere amministratori o custodi di palazzi abitati da ariani, non potevano affittare camere ai non ebrei. Non potevano pilotare aerei, non potevano allevare colombi viaggiatori, non potevano essere poveri (cioè iscriversi agli appositi elenchi, per usufruire dell’assistenza pubblica). Agli ebrei fu vietato appartenere anche alle associazioni ricreative (come alla Società della protezione degli animali) e sportive (sia professionali, sia dilettantistiche)64. C. Berneri, Mussolini grande attore. Scritti su razzismo, dittatura e psicologia delle masse, Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2007, pp. 176-177, corsivo nel testo. 2 Cfr. E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, Milano 1932, pp. 75-76. 3 Il libro uscì in spagnolo, con il titolo El delirio racista, a Buenos Aires. Venne tradotto per la prima volta in italiano nel volume Mussolini «normalizzatore» e Il delirio razzista, edito dall’Archivio Famiglia Berneri nel 1986. Noi citiamo dalla nuova edizione, curata da Alberto Cavaglion. 4 Ivi, p. 174. 1 42 A. Cavaglion, Introduzione a Berneri, Mussolini grande attore, cit., p. 21. Il riferimento qui ci pare andare, in particolare, a G. Fabre, Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita, Garzanti, Milano 2005. 6 M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Einaudi, Torino 2002, pp. 4-5, corsivo nel testo. 7 «In termini letterali, la dicitura “leggi antiebraiche” denomina solo l’insieme dei provvedimenti legislativi veri e propri (regi decreti legge, leggi, ecc.). Dopo che la storiografia ha ricostruito il rilevante ruolo – non solo attuativo ma anche complementare e innovativo – svolto nella persecuzione dai provvedimenti amministrativi (le “circolari” e gli altri provvedimenti ministeriali), tale dizione e quella di “legislazione antiebraica” sono state sempre più riferite dagli storici all’insieme dei provvedimenti persecutori» (ivi, p. 5). 8 Cfr. M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi in Id. (a cura di), 1938 le leggi contro gli ebrei, fascicolo speciale de «La Rassegna mensile di Israel», vol. LIV, 1988/1-2, pp. 49-167. 9 La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 27 ottobre-10 dicembre 1994. Cfr. il catalogo della mostra a cura del Centro Studi Furio Jesi (Grafis, Bologna 1994). 10 Cfr. A. Burgio, L. Casali (a cura di), Studi sul razzismo italiano, Clueb, Bologna 1996; A. Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, Il Mulino, Bologna 1999. 11 Burgio, Per la storia del razzismo italiano in Burgio (a cura di), Nel nome della razza, cit., pp. 9-10, corsivo nel testo. 12 Cfr. E. Traverso, La violenza nazista. Una genealogia, Il Mulino, Bologna 2002, in particolare il cap. IV, Classificare e reprimere, pp. 123-155. 13 Ivi, p. 10. 14 A. Burgio, Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano in Burgio, Casali (a cura di), Studi sul razzismo italiano, cit., pp. 20-21, corsivi nel testo. 15 Burgio, Per la storia del razzismo italiano, cit., pp. 11-12. Il tema della degenerazione è davvero, assieme alla nozione di ereditarietà, al centro del discorso razzista degli ultimi due secoli. Cfr. D. Pick, Volti della degenerazione. Una sindrome europea. 1848-1918, La Nuova Italia, Firenze 1999. 16 R. Maiocchi, Scienza e fascismo, Carocci, Roma 2004, p. 154. 17 P. Di Vittorio, Psichiatria in O. Marzocca et al. (a cura di), Lessico di biopolitica, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 244-249. Per il «razzismo contro gli anormali», il riferimento d’obbligo è a M. Foucault, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, Milano 2000, in particolare pp. 260-286. Cfr. anche P. Chiantera-Stutte, La distopia biopolitica: la rappresentazione della comunità nelle strategie biopolitiche del Terzo Reich in L. Cedroni, P. Chiantera-Stutte, Questioni di biopolitica, Bulzoni, Roma 2003, pp. 81-205. Sul rapporto fra psichiatria e nazismo, cfr. B. Müller-Hill, Scienza di morte. L’eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente, 1933-1945, ets, Pisa 1989; A. Lallo, L. Toresini, Psichiatria e nazismo, Ediciclo, Portogruaro 2001; D. Fontanari, L. Toresini, Psichiatria e nazismo. Atti del Convegno internazionale, San Servolo 9 ottobre 1998, «Fogli di informazione», Pistoia 2001; C. Marta, La scienza dello sterminio nazista. Antropologia, igiene della razza e psichiatria in F. Soverina (a cura di), Olocausto/Olocausti, Odradek, Roma 2003, pp. 65-78. Sulla storia dell’eugenetica, cfr. A. Pichot, La société pure. De Darwin à Hitler, Champs-Flammarion, Paris 2000. Sul movimento eugenetico in Italia, cfr. C. Pogliano, Scienza e stirpe: eugenica in Italia (1912-1939) in «Passato e presente», 1984/5,, pp. 61-95; C. Pogliano, Eugenisti, ma con giudizio in Burgio (a cura di), Nel nome della razza, cit., pp. 423-442; C. Mantovani, Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni Trenta, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004; F. Cassata, Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia, Bollati Boringhieri, Torino 2006; A. L. Simonnot, Igiene ed eugenismo nel XX secolo in «Rivista sperimentale di freniatria», 2008/1, pp. 47-60; B. Massin, L’eutanasia psichiatrica sotto il III Reich. La questione dell’eugenetica, ivi, pp. 61-86. 18 M. Bertani, La vergogna del sapere. Un’introduzione in Il sapere e la vergogna. Psichiatria, scienza, cultura nelle leggi razziali del 1938. Convegno Internazionale di studi. Reggio Emilia, 5 43 20–21 novembre 1998, Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria, Reggio Emilia 2002, p. 10. 19 «Mentre però in Germania è stato svolto un notevole lavoro di ricerca per portare alla luce le responsabilità politiche della psichiatria istituzionale, in Italia, ove si eccettui la citazione del clinico neuropsichiatra Arturo Donaggio tra i firmatari del “Manifesto degli scienziati razzisti” del 1938 ... non sembra che sia stata dedicata attenzione storiografica al ruolo svolto dalla psichiatria italiana nella formazione dell’humus culturale che poté alimentare il razzismo nazionalistico fascista» (F. Giacanelli, Tracce e percorsi del razzismo nella psichiatria italiana della prima metà del Novecento in Burgio (a cura di), Nel nome della razza, cit., p. 390, corsivo nel testo). 20 Bertani, La vergogna del sapere, cit., p. 10. 21 Ivi, p. 18. «Anche in Italia assistiamo alla messa a punto, da parte della corporazione medicopsichiatrica, di un complesso apparato clinico-teorico e istituzionale destinato a consentire di fare ciò che le diverse antropologie dell’epoca non riuscivano a fare se non al prezzo di una evidente falsificazione scientifica, vale a dire trascrivere nell’anima i segni della differenza razziale che il corpo non riusciva a contenere, attraverso l’invenzione (o meglio la reinvenzione, dopo la sua produzione all’interno del discorso patristico) di una figura: quella della psicopatologia ebraica, quella della malattia (dell’anima) giudaica. Ecco perché, in primo luogo, diventa necessario fissare il principio bio-tassonomico secondo il quale “tutte le varietà o razze umane non si differenziano soltanto per i loro caratteri fisici, ma altresì per quelli mentali”» (M. Bertani, Folli, psichiatri, ebrei al San Lazzaro di Reggio Emilia tra Ottocento e Novecento in V. Marchetti (a cura di), L’applicazione della legislazione antisemita in Emilia Romagna, Il Nove, Bologna 1999, p. 25). 22 Bertani, La vergogna del sapere, cit., p. 12. 23 «“E avviene così che la medicina individuale e quella delle stirpi, procedendo, mettan capo alla medicina politica, funzione di governo”. Di qui la necessità di delineare i nuovi compiti di uno “stato coordinatore”, che interviene sulla “polivalenza biologica e psicologica” dominante in Italia in base all’imperativo di proteggere nella sanità della stirpe la sanità della razza” (P. Petrazzani, 1930)» (ivi, p. 13). 24 E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 22. 25 Cfr. G. Israel, P. Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, Il Mulino, Bologna 1998; R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo fascista, La Nuova Italia, Firenze 1999. 26 C. Ipsen, Demografia totalitaria. Il problema della popolazione nell’Italia fascista, Il Mulino, Bologna 1992, p. 253. Cfr. anche A. Treves, Le nascite e la politica nell’Italia del Novecento, led, Milano 2001; A. Treves, Demografi, fascismo, politica delle nascite. Nodi problematici e prospettive di ricerca in «Popolazione e storia», 2003/1; G. Dalla Zuanna (a cura di), Numeri e potere. Statistica e demografia nella cultura italiana fra le due guerre, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2004. 27 B. Mussolini, Discorso dell’Ascensione. Il regime fascista per la grandezza d’Italia. Pronunciato il 26 maggio 1927 alla Camera dei deputati, Roma 1927, p. 11. 28 R. Korherr, Regresso delle nascite: morte dei popoli, Littoria, Roma 1928. Oltre a quella di Mussolini, questa traduzione presenta una prefazione di Oswald Spengler. 29 Maiocchi, Scienza e fascismo, cit., pp. 144-145. 30 Collotti, Il fascismo e gli ebrei, cit., p. 30. 31 «Presentato come opera di un “gruppo di studiosi fascisti ... sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare”, in realtà steso da Guido Landra, con la consulenza di alcuni altri, sulla base di precisi orientamenti comunicatigli direttamente il 24 giugno da Mussolini e di ulteriori indicazioni di Alfieri [Dino Alfieri, ministro dell’Educazione popolare]» (M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 20072, p. 162). 32 G. Gabrielli, Africani in Italia negli anni del razzismo di Stato in Burgio (a cura di), Nel nome della razza, cit., p. 203. Cfr. N. Labanca, Il razzismo coloniale italiano, ivi, pp. 145-163; A. Del Boca, Le leggi razziali nel regime di Mussolini in A. Del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi (a cura di), Il regime fascista. Storia e storiografia, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 329-351. 33 «Il decreto dell’aprile del 1937 non era che il primo passo della codificazione del razzismo contro gli indigeni. Portata ancora più ampia ebbe infatti la legge del 29 giugno 1939 n. 1004, che 44 prevedeva il nuovo reato di “lesione del prestigio della razza” e prescriveva pertanto sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana”. Ma che cosa si doveva intendere per “lesione del prestigio di razza”? Era questo anzitutto, secondo la legge, “l’atto del antivo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana” ... La nuova legge non riguardava soltanto gli aspetti delle relazioni sessuali, ma aveva un campo d’intervento praticamente senza confini, sia che il cittadino si fosse piegato a un rapporto di dipendenze di un nativo, sia che frequentasse luoghi (esercizi pubblici, cinematografi, ecc.) riservati ai nativi, sia che desse pubblico scandalo mostrandosi in stato di ebbrezza in luogo riservato ai nativi o in luogo pubblico» (Collotti, Il fascismo e gli ebrei, cit., p. 38). 34 Ivi, p. 39, corsivo nel testo. 35 Gabrielli, Africani in Italia negli anni del razzismo di Stato, cit., p. 207. 36 Cfr. M. Raspanti, I razzismi del fascismo in Centro Studi Furio Jesi (a cura di), La menzogna della razza, cit., pp. 73-89 e V. Pisanty, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, Bompiani, Milano 2006, pp. 102-140; per una discussione cfr. A. Cavaglion, Due modeste proposte in Burgio (a cura di), Nel nome della razza, cit., pp. 379-386. 37 M. Sarfatti, Il razzismo fascista nella sua concretezza: la definizione di «ebreo» e la collocazione di questi nella costruenda gerarchia razziale, ivi, pp. 322-323 (corsivi nel testo). 38 «Da un lato, il razzismo “biologico”, che ha il suo organo principale nella rivista “La difesa della razza”, proporne un’eugenica “mendeliana”, ereditarista, che suggerisce al fascismo di adottare la via germanica, prematrimoniale obbligatoria; dall’altro lato, il razzismo “nazionalista” predilige un’eugenica “lamarckiana” o ambientalista, ostile al modello nordico e concepita sostanzialmente come un prolungamento e un approfondimento del più ampio progetto di bonifica e di potenziamento demografico della nazione avviato dal regime» (Cassata, Molti, sani e forti, cit., p. 220). 39 Cfr. M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Zamorani, Torino 1994, pp. 18-19. 40 Fischer, La realtà della razza, cit. in Pisanty, La difesa della razza, cit., p. 117. 41 Ivi, p. 104, corsivo nel testo. 42 «Anche il razzismo esoterico-tradizionalista ... sviluppa un proprio discorso sul tema dell’ereditarietà, rivelando singolari convergenze, in materia eugenica, con le posizioni del razzismo biologico» (Cassata, Molti, sani e forti, cit., p. 252). Su Evola, cfr. F. Germinario, Razza del sangue, razza dello spirito. Julius Evola, l’antisemitismo e il nazionalsocialismo 1930-1943, Bollati Boringhieri, Torino 2001; F. Cassata, A destra del fascismo. Profilo politico di Julius Evola, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 43 Pisanty, La difesa della razza, cit., p. 121. 44 «Tale visione del mondo [quella moderna] si identifica con lo “spirito semitico” il quale – come un “acido” o un “bacterio” – da millenni corrode e intossica lo spirito (prima) e il sangue (poi) della civiltà occidentale» (ivi, p. 122, corsivi nel testo). 45 Cfr. P. Stefani, L’antigiudaismo. Storia di un’idea, Laterza, Roma-Bari 2004. D’altra parte, grande fu l’influenza che ebbe per la crescita dell’antisemitismo, la stipula nel 1929 del Concordato con la Chiesa cattolica, così come sulla creazione del nuovo Statuto delle Comunità ebraiche (1931), momento culminante di quella che Michele Sarfatti ha chiamato la «persecuzione della parità dell’ebraismo», essendo questo divenuto ormai soltanto un «culto ammesso». 46 Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, cit., p. 9. 47 «Nonostante questa volontarietà, essa non sembra essere stata preceduta da riflessioni particolarmente dense; il processo di crescita dell’antisemitismo in Europa, in Italia, nel fascismo e in Mussolini aveva trasformato le decisioni operative al riguardo da rilevanti a banali» (Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., p. 120). 48 Cfr. N. Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, Bompiani, Milano 2005, in particolare pp. 148-157. 49 Ivi, p. 137. Cfr. P. Orano, Gli ebrei in Italia, Pinciana, Roma 1937. 50 Citato in Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei, cit., p. 18. 51 Citato in ivi, p. 188. 45 Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., p. 169. Ivi, pp. 158-159. 54 «Nessun dubbio che le leggi razziali abbiano scosso le coscienze e gli italiani non abbiano eguagliato i tedeschi “in ferocia”. Eppure esse furono applicate. Ci fu una giurisprudenza. E anche se oggi possiamo consolarci avvertendo come “negli interstizi dell’ordinamento fascista abbiano trovato spazio forme di cauta opposizione e prassi interpretative ed applicative volte a contenere la portata devastante della legislazione razziale”, è impossibile non riconoscere che giurisprudenza, dottrina e prassi amministrativa si muovono complessivamente “nel solco di un’adesione incondizionata ai motivi ispiratori della politica antisemita del regime”» (Quaglioni, Le leggi razziali e le «incertezze» dei diritti umani in Il sapere e la vergogna, cit., p. 43). 55 Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., p. 160. 56 Ivi, p. 205. Cfr. M. Sarfatti, Il lavoro negato. Dati e spunti di riflessione sulla normativa antiebraica in Italia in «Qualestoria», 1989/1, pp. 33-42. 57 Ivi, p. 177. 58 Ivi, pp. 173-174, corsivo nel testo. 59 «L’internamento, minacciato dal governo sin dagli inizi della persecuzione, appare deciso il 16 maggio 1940. Nei giorni seguenti Mussolini stabilì che gli ebrei stranieri dovevano essere internati in campi a loro riservati, cioè separati, e fece informare ufficialmente l’Unione delle comunità [ebraiche] che inizialmente gli uomini sarebbero stati internati in campi di concentramento e le donne e i bambini sarebbero stati internati in comuni, per essere poi tutti “accentrati in una località dell’Italia meridionale e precisamente a Tarsia (provincia di Cosenza), dove dovranno restare anche a guerra ultimata per essere trasferiti di là nei paesi disposti a riceverli”» (ivi, p. 188). Cfr. C. S. Capogreco, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (19401943), Einaudi, Torino 2004. 60 Ivi, pp. 211-212, corsivo nel testo. Cfr. D. Adorni, «Il furbissimo giudeo»: legislazione razziale e propaganda nella scuola fascista in B. Maida (a cura di), I bambini e le leggi razziali in Italia, Giuntina, Firenze 1999, pp. 35-63. 61 Cfr. R. Finzi, L’università italiana e le leggi antiebraiche, Editori Riuniti, Roma 2003. 62 «In alcuni casi, l’aiuto al singolo amico stimato venne dato da personalità che appoggiavano la legislazione emanata contro tutti gli ebrei (il maggiore intellettuale del regime, Giovanni Gentile, non espresse alcuna protesta contro le leggi, delle quali fu sostenitore o complice, ma si profuse nell’aiuto a un suo protetto)» (Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, cit., p. 41, corsivi nel testo). 63 Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., p. 216. 64 Cfr. S. Giuntini, Sport e fascismo: le leggi razziali del 1938 in «Patria indipendente», 1995/10-11, pp. 43-44. 52 53 46 8 giugno 1916 L’affondamento del «Principe Umberto» Strage di soldati reggiani rivelata grazie agli «Albi della memoria» Alfio Moratti Amos Conti Roma 9 giugno 1916, notte. Il laconico lancio dell’Agenzia Stefani1: Piroscafo Italiano con truppe affondato nel Basso Adriatico. Ieri verso il tramonto due sommergibili nemici hanno attaccato nel basso Adriatico un nostro convoglio composto da tre piroscafi trasportanti truppa e materiale e da una squadriglia di cacciatorpediniere. I sommergibili, contrattaccati prontamente, riuscirono nondimeno a lanciare i siluri di cui uno colpì il “Principe Umberto”, che affondò in pochi minuti. Nonostante i mezzi di salvataggio di cui il convoglio disponeva e il pronto soccorso di altre navi in crociera, le perdite, non ancora precisate, si ritiene ammontino a circa metà dei militari imbarcati su quel piroscafo2. Il comunicato è rilanciato da un giornale reggiano3, senza precisare che nell’affondamento del trasporto truppe sono dispersi in mare anche 53 reggiani della città e della provincia, militari che, inquadrati nel 55° reggimento di fanteria, si apprestano a fare ritorno in patria dall’Albania. Nessuna successiva notizia dell’avvenimento viene pubblicata dai giornali locali nelle settimane successive fino alla comparsa, sul «Giornale di Reggio» del 47 Il piroscafo «Principe Umberto» 10 luglio, di un necrologio4 della famiglia in memoria del capitano di fanteria Mario Saccozzi, che, annunciandone la scomparsa in mare nell’affondamento del «Principe Umberto», conferma indirettamente la tragica fine dei nostri concittadini5. Gli italiani in Albania ed il salvataggio dell’esercito serbo Le truppe italiane sono in Albania già dal 1914 quando l’Austria, che ha ricevuto nel 1878 il mandato di amministrare temporaneamente la Bosnia e l’Erzegovina, ha rapidamente stabilito nell’intera penisola balcanica un’estesa rete d’interessi commerciali e ha istituito scuole e missioni religiose che esercitano un’attiva propaganda a proprio favore. L’Italia è evidentemente interessata all’altra sponda dell’Adriatico, dove pretende di stabilire «un primato italiano» sull’Albania. Il 30 ottobre del 1914 ritiene opportuno occupare con una compagnia da sbarco di marinai e un’unità di sanità militare l’isola di Saseno, un isolotto di poco più di quattro chilometri di lunghezza e due di larghezza, davanti al porto di Valona. Seguendo le decisioni delle potenze europee del 1914, all’inizio della guerra, l’Albania è un principato di 850.000 abitanti con capitale Durazzo, governata da un sovrano di etnia tedesca, il principe Guglielmo di Wied. In realtà vi regna una completa anarchia ed il governo legittimo è insidiato da 48 tutte le parti. Nei mesi successivi la situazione rimane assolutamente incerta e ai primi di dicembre del 1915 ricominciano importanti disordini. L’Italia invia allora un corpo speciale, forte di tre divisioni, destinato ad occupare i porti di Durazzo e di Valona, la città che sorge di fronte alla costa pugliese a quaranta miglia marine da Otranto6. È una misura precauzionale per lo stato di assoluto caos che regna in Albania dove gli agenti austriaci e turchi soffiano velatamente sul fuoco per spingere gli albanesi contro i serbi, ma in pratica ne risulta un’occupazione definitiva; da parte italiana è una mossa ardita, ma anche di un indubbio pericolo. Infatti, anche se il governo italiano ha ottenuto dagli Alleati, come ricompensa della sua entrata in guerra a fianco delle potenze dell’Intesa, la promessa della sovranità assoluta su Valona e il suo hinterland e la protezione dell’Albania centrale, che è uno stato indipendente mussulmano con Durazzo capitale, sono ancora validi i deliberati della conferenza di Londra che ha istituito il regno di Albania del principe Guglielmo di Wied. Ciò almeno in attesa della fine della guerra. Frattanto, nel novembre del 1915, l’esercito serbo sconfitto, sfuggito all’accerchiamento, è in completa ritirata verso l’Albania, tallonato e premuto dalle divisioni bulgare7 che a ovest impediscono il suo congiungimento con gli alleati, oltre che tormentato dai partigiani albanesi, spesso inquadrati da ufficiali austriaci. Quel che resta dell’esercito serbo, circa 140.000 uomini, presenta una scarsa consistenza militare effettiva. Molti soldati serbi durante la ritirata si sono sbandati e hanno gettato le armi. Una forza ancora omogenea è la cavalleria con 13.000 uomini con 10.000 cavalli; fra le unità ancora organizzate anche un reparto della scuola sotto ufficiali, comandata dal colonnello Ritnich, formata da molte migliaia di sedicenni. Alla costa adriatica arriveranno comunque anche dieci cannoni, che sono tutto quel che resta dell’artiglieria serba. Secondo il racconto del Tedeschi vi sono anche degli italiani, mentre pure fra i prigionieri austriaci c’è qualche ufficiale di etnia italiana dei territori irredenti, arruolato nell’esercito austriaco. L’esercito e la marina italiani, nel corso della fine di dicembre del 1915 e dei primi due mesi del 1916, compiono il drammatico salvataggio delle decine di migliaia di superstiti dell’armata serba sconfitta dalle truppe austro-germaniche e bulgare e consegnano alla storia una delle pagine più importanti della prima guerra mondiale. L’ultima pagina di una delle più rilevanti imprese, quella che il ministro inglese Balfour definisce una delle migliori prove del buon successo delle operazioni marittime nel Mediterraneo, «…il trasporto dell’esercito serbo, dovuto soprattutto all’energia ed all’efficacia della Marina Italiana»8. Il successo dell’intervento, riconosciuto anche a livello internazionale, viene enfatizzato negli anni successivi anche dal regime fascista. Una traccia di ciò è offerta dalle immagini stampate sulle copertine dei quaderni scolastici ancora a fine anni Trenta. 49 50 Fonte: Archivio di Stato (RE). Pubblicazione concessa dal Ministero BAC - Archivio di Stato - Reggio Emilia - 51 Autorizzazione n. 11/2008 L’operazione salvataggio, tendente a riportare le forze serbe in linea di combattimento contro l’Austria, si conclude indirizzando a Valona, ancora a piedi, una parte dei fuggiaschi con la protezione di reparti dell’esercito italiano. Alla fine di febbraio del 1916, poiché è stato completato il salvataggio dei serbi, mentre gli austriaci e i bulgari avanzano in Albania, le truppe italiane abbandonano Durazzo e San Giovanni di Medua, dopo avere dato alle fiamme tutto ciò che non è possibile imbarcare, ripiegando poi per mare su Valona, ritenuta la chiave dell’Adriatico, dove sono state apprestate le necessarie opere di difesa dietro alla Voyussa. L’esercito italiano rimane quindi in Albania per impedirne la completa conquista e appoggiare i movimenti antiaustriaci che lottano per l’autonomia albanese, mentre le navi italiane proseguono nel loro impegno per la vigilanza e il pattugliamento delle acque e come scorta ai piroscafi addetti al trasporto di rifornimenti e di soldati9. Il 55° reggimento di fanteria Nel 1916, il 55° reggimento di fanteria dell’esercito italiano, insieme al gemello 56°, costituisce la Brigata di fanteria Marche10. Per tradizione il reggimento ha la sua sede storica a Treviso, dove fra l’altro ha la sua caserma ed un monumento che lo ricorda e dove, ancora oggi, viene commemorato in particolar modo l’avvenimento dell’8 giugno 1916. Nelle sue compagnie sono presenti anche molti soldati emiliani, in particolar modo bolognesi e reggiani, specie nel primo e nel secondo battaglione11. Nel maggio 1915, all’inizio del conflitto, il reggimento è destinato al fronte del Cadore, dove partecipa valorosamente ai combattimenti sul Monte Piana e nei mesi successivi sul Sabotino12. È in Albania, dal febbraio del 1916, per partecipare con i suoi tre battaglioni alla difesa del porto di Valona, un presidio essenziale per il salvataggio dei superstiti dell’esercito serbo. A Durazzo, infatti, dove al momento è concentrata la maggior parte degli scampati alla terribile marcia verso la costa, è molto pericoloso tentare l’imbarco sulle navi italiane e alleate, che incrociano al largo, poiché dalla vicina base navale austriaca delle Bocche di Cattaro i sommergibili possono facilmente attaccare i convogli. Le colonne serbe sono quindi indirizzate a piedi, con la protezione dei soldati italiani e l’appoggio durante il percorso delle parrocchie ortodosse, al porto di Valona. Secondo il racconto del colonnello Meneghetti, allora ufficiale del III battaglione, che ne riporta diffusamente nella sua pubblicazione la storia, «i compiti principali del reparto sono tre: 1° guardar la stretta di Dorza dalle provenienze d’oltre Voyussa e da quelle di Tepeleni; 2° lavorare alle opere del campo trincerato lungo la sponda della Voyussa e sul Coston di Dorza; 3° far propaganda d’italianità fra la popolazione indigena»13. Nel giugno del 1916 il 55° reggimento, in occasione dell’offensiva che 52 gli austriaci hanno iniziato in maggio sugli altipiani, la «Spedizione punitiva» (Strafexpedition), viene richiamato in patria dall’Albania come rinforzo ai combattenti nel Trentino. Sempre secondo il racconto del Meneghetti, il 7 giugno, l’intero reggimento è accampato vicino al ponte di Drasciovizza e un aereo austriaco lascia cadere alcune bombe senza cagionare danni. La sera dell’8 giugno il reggimento si sta apprestando all’imbarco sul piroscafo «Principe Umberto» per il rientro in patria. Prosegue il racconto di Meneghetti: «Nella giornata dell’8 si fece l’imbarco al porto di Valona, sopra due piroscafi: sul Principe Umberto il comando del reggimento, i battaglioni I e II e le compagnie 11a e 12a del III (complessivamente 2540 uomini di truppa e 65 ufficiali); sul Ravenna il comando del III battaglione, le compagnie 9a e 10a, tutto il carreggio e le salmerie reggimentali. Alle ore 19 il convoglio sciolse gli ormeggi dai pontili 1 e 2, con la scorta di quattro caccia». Secondo una notizia fornita dal «Corriere della Sera», fanno parte del convoglio anche altri tre trasporti truppe: il «Re Vittorio», lo «Stampalia» e lo «Jonio». Il piroscafo trasporto-truppe «Principe Umberto» Il natante, appartenente alla Società navigazione generale italiana (ngi), è stato costruito a Palermo dai Cantieri navali riuniti. Varato il 31 marzo 1908, entra in servizio il 13 maggio 1909 sulla linea sudamericana, al comando del capitano Enrico De Barbieri. Presenta 7929 tonnellate di stazza lorda e 4202 di stazza netta e le sue due macchine sviluppano una forza di 9000 cavalli e una velocità di diciotto nodi. Insieme al «Regina Elena» e al «Re Vittorio» è impiegato, dal giorno del suo varo, sulla rotta Genova-Rio della Plata. Secondo la descrizione che ne fa in un suo libro Tomaso Gropallo, questa serie di navi che è stata battezzata «Serie Regale», può trasportare cento passeggeri di prima classe, 124 di seconda e milleduecento emigranti14. Dall’inizio del 1916, insieme alle altre due navi della serie, fa parte della flotta mercantile adibita al trasporto truppe e alterna viaggi fra Salonicco e la Libia. La tragica sera dell’8 giugno 1916 A circa quindici miglia dal porto di Valona, a sud-ovest di Capo Linguetta, a quaranta miglia marine da Otranto, il convoglio è attaccato da due sottomarini austriaci. Il tratto di mare è estremamente pericoloso, già teatro dell’affondamento nel dicembre del 1915 del trasporto «Re Umberto» e del cacciatorpediniere «Intrepido» per urto contro mine disseminate dal sommergibile tedesco uc-14. 53 L’area di affondamento del «Principe Umberto» Nonostante l’azione delle siluranti di scorta, il sottomarino U-boat U-5 della marina austriaca15, comandato dall’Oberleutnant Friedrich Schlosser (18851959), riesce a lanciare due siluri: uno passa a pochi metri dallo «Jonio», l’altro invece colpisce in pieno il «Principe Umberto», che affonda in cinque minuti, mentre la maggior parte degli imbarcati è sottocoperta. Un incrociatore italiano si aggiunge ai cacciatorpediniere nell’inseguimento dei sommergibili, che però riescono ad allontanarsi indisturbati. Malgrado che tutte le imbarcazioni di bordo siano rapidamente poste al soccorso dei naufraghi «delle dieci compagnie e dei comandi e dei servizi del 55° reggimento imbarcati sul piroscafo silurato, poterono essere tratti in salvo 766 uomini di truppa e 13 ufficiali, dei quali solo uno superiore (il maggiore Saibante) e due soli capitani (Ghirardi e Covra)». Proprio il capitano Covra, undici giorni dopo l’affondamento, secondo lo scritto di Meneghetti, già ampiamente citato, così ricorda: «sullo specchio d’acqua debolmente illuminato dalla luna, non si vedevano che ombre nere che lottavano con la morte; il silenzio del mare tranquillo era rotto dalle voci che imploravano aiuto, che disperatamente invocavano la mamma, la moglie, i figli». Periscono complessivamente 1774 uomini di truppa e cinquantadue ufficiali, senza contare i naufraghi dell’equipaggio. I reggiani dispersi in mare sono 53. I reggiani del «Principe Umberto» I soldati reggiani della città e della provincia che perdono la vita in mare, sono soprattutto militari di truppa. Fra essi, infatti, vi è un solo ufficiale, il capitano Mario Saccozzi, nato in realtà a Modena nel 1886 da famiglia di Correggio, ma residente a Reggio dove il padre è Direttore del Manicomio Giudiziario16. Fra i ricoverati dell’istituto vi è anche l’allora famoso brigante Musolino, che invia al suo direttore una commossa missiva di condoglianze, anche se ovviamente in vari punti delirante ed incomprensibile. La trascrizione del documento è riportata in Appendice A17. Mario Saccozzi 55 Ricordo funebre di Mario Saccozzi Come sottotenente in servizio permanente effettivo (spe), Saccozzi è assegnato, come primo incarico, al 55° reggimento di fanteria, che allora costituisce il presidio di Reggio Emilia, poi sostituito dal 66°. Già nei primi mesi di guerra combatte sull’Isonzo e dopo una breve interruzione per malattia, è di nuovo reintegrato nel 55° con il quale va incontro al tragico destino del 56 «Principe Umberto». Il fratello Eugenio, anch’egli combattente nella grande guerra, lo ricorda con una forte emotività in una delle sue poesie raccolte in un volumetto18. Poco si conosce degli altri militari reggiani periti del naufragio. È stato peraltro possibile, grazie agli «Albi della Memoria», ricostruire l’elenco completo dei caduti [si veda tab. A] e rintracciare le fotografie di diversi soldati [vedi Appendice B], alcuni estratti dello stato di servizio militare (foglio matricolare), oltre a qualche notizia da lontani parenti. Lina Davoli, ad esempio, ha donato una foto e fornito notizie dello zio caduto, caporale Dante Davoli, mentre Franca Carretti ha ritrovato una foto del nonno Arturo Carretti, soldato correggese. Le notizie di alcuni dei dispersi nell’affondamento sono riportate anche nel fascicolo «In Memoriam», edito dal Municipio di Reggio Emilia nel 191919. La poesia di Eugenio Saccozzi, dedicata al fratello Mario 57 Tab. A - La lista dei 53 caduti reggiani del «Principe Umberto» Caduti Comune Ballabeni Pietro Fabbrico Baroni santevilla minozzo BEGHI GEMINIANO SCANDIANO BIGI ARNALDO GUALTIERI BIZZARRI AUGUSTO SAN MARTINO IN RIO BOLIOLI BONAVENTURA COLLAGNA BORCHINI GISBERTO REGGIO EMILIA BOTTAZZI ADELCHI CADELBOSCO SOPRA CAMPANI NATALE SCANDIANO CAPITANI GIUSEPPE VILLA MINOZZO CARRETTI ARTURO CORREGGIO CASOLI ABERALDO CADELBOSCO SOPRA CATELANI SILVERIO CASALGRANDE CATELLANI ALFREDO REGGIO EMILIA CECCARELLI MICHELE ARCA CASTELNOVO MONTI COCCONCELLI DEMETRIO POVIGLIO COLORETTI NARCISO VILLA MINOZZO CONTI ASCARINO CIANO D’ENZA CORNIOLI PIETRO CARPINETI CORRADINI ARTEMIO REGGIO EMILIA CORRADINI GIUSEPPE BIBBIANO DALLAGLIO CLINIO SAN POLO D’ENZA DALLARI UMBERTO AMI REGGIO EMILIA DAVOLI DANTE REGGIO EMILIA DAVOLI GIUSEPPE CAVRIAGO DONELLI ARISTODEMO SANT’ILARIO D’ENZA Età 20 24 22 24 26 21 26 28 21 26 27 21 24 28 23 22 22 21 22 20 30 22 25 22 21 27 Caduti FERRARI PIETRO FERRARI RICCARDO FONTANESI ARTURO GALEOTTI GIOVANNI GOMBIA MEDARDO GRADELLINI UMBERTO IEMMI LUIGI INCERTI GIACOMO LUCCHI GIUSEPPE MARTELLI SANTE NOTARI LUIGI PANCIROLI CIRO PIFFERI AUGUSTO PRAMPOLINI ADELFO PRINI DOMENICO PUGLIA GIUSEPPE RABITTI UMBERTO RIVI RICCARDO SACCANI LINO SACCOZZI MARIO SARTORI NINO UGO SCHIATTI PIETRO SELIGARDI PRIMO TONDELLI ERMINIO ZANICHELLI AMILCARE ZANICHELLI ANTONIO ZINI MARIO Comune SCANDIANO GUASTALLA CADELBOSCO SOPRA CAMPAGNOLA NOVELLARA REGGIO EMILIA LUZZARA ALBINEA CASALGRANDE BORETTO VIANO REGGIO EMILIA CASTELLARANO SCANDIANO TOANO LIGONCHIO REGGIO EMILIA CASTELLARANO POVIGLIO REGGIO EMILIA BIBBIANO ALBINEA REGGIO EMILIA CORREGGIO GUASTALLA GUASTALLA NOVELLARA Età 28 20 20 26 25 23 26 22 20 20 28 21 22 22 24 22 22 23 27 30 21 25 21 21 21 21 22 I caduti del 55° non sono però dimenticati. Una sezione del museo civico della città di Treviso è intitolata congiuntamente al Risorgimento ed al 55° reggimento, mentre nella Caserma «Medaglia d’oro Serena» di Dosson (TV) è stato eretto un monumento dedicato ai caduti del reggimento stesso. Infine, il sacrificio dei quasi duemila caduti in mare viene ricordato, con una cerimonia celebrativa, alla quale partecipano anche alcuni parenti dei soldati reggiani, in occasione del cinquantenario dell’evento il giorno 8 giugno 1966, con ampio risalto sulla stampa locale20. Il tributo pagato dai giovani soldati reggiani in questo solo fatto di guerra appare di una consistenza numerica veramente inusitata. Un caso che per la comunità reggiana sembra fortunatamente rimasto unico nel corso del conflitto. La dimensione di una tale tragedia collettiva non era però mai giunta prima d’ora a conoscenza dell’opinione pubblica, complici i limiti e le restrizioni del sistema informativo del tempo. Ogni famiglia toccata ha vissuto ovviamente in solitudine la perdita del proprio caro, senza occasione di momenti di onoranza 58 La commemorazione del cinquantenario, «Gazzettino di Treviso», 9 giugno 1966 59 e memoria collettiva, che almeno avrebbero potuto gratificare il cuore e lenire la sofferenza dei congiunti ed enfatizzare il monito per le nuove geneazioni. Agenzia di stampa fondata a Torino nel 1853. Con l’avvento del fascismo divenne la «voce del regime». 2 «Il Corriere della Sera», 10 giugno 1916. 3 «Il Giornale di Reggio», 11 giugno 1916. 4 Il testo del necrologio recita: «Disperando ormai che il loro amato figlio e fratello Mario Saccozzi, Capitano del 55° Reggimento Fanteria, abbia potuto sottrarsi alla dura sorte toccata a quei forti che nel siluramento della nave “Principe Umberto” furono vittime della rabbia insidiosa del nemico, il padre dott. cav. Augusto Saccozzi, la madre Amelia Bertesi, i fratelli Gino, Eugenio, Gastone, la sorella Gisella danno il triste annuncio della sua morte». 5 Già due giorni prima della comparsa del necrologio, sullo stesso quotidiano dell’8 luglio, compare un trafiletto che con il titolo: Per un caro concittadino scomparso, adombra la possibilità che il capitano Mario Saccozzi sia perito nell’affondamento del «Principe Umberto». Ancora nessun cenno della tragedia degli altri soldati reggiani. 6 E. Bertotti, La nostra spedizione in Albania (1915-1916), Società Editrice Unitas, Milano 1926. 7 E.C. Tedeschi, Virtù contro furore (da Adrianopoli a Belgrado), Edizioni C.A. Bontempelli, Roma 1915. 8 P. Giordani, La marine italienne dans la guerre européenne pour l’Armée Serbe, Ed. Alfieri & Lacroix, Milano, 1917. 9 A. Quattrini, I marinai italiani e l’esercito serbo, Edizioni Ufficio speciale del ministero della Marina, Roma 1918. 10 Nelle sale espositive dell’Associazione Arma di cavalleria di Reggio Emilia è conservato un manichino in uniforme grigio verde, con le mostrine bianco azzurre della brigata Marche. 11 Si veda: «Il Museo Virtuale della Certosa – Museo del Risorgimento», Bologna, all’indirizzo Internet: http://certosa.cineca.it/1/eventi.php?ID=126&TBL=EVENTI STORICI (versione agosto 2008). 12 W. Schaumann, Monte Piana, Ghedina-Tassotti Editori, Bassano del Grappa 1986. 13 N. Meneghetti, Un battaglione sacro. Il III del 55°, Tipografia «La Commerciale», Conegliano 1929. 14 T. Gropallo, Navi a vapore e armamenti italiani: dal 1918 ai giorni nostri, Mursia editore, Milano 1976. 15 Alias: Imperiale e Regia Marina da Guerra (k.u.k. Kriegsmarine = kaiserliche un königliche Kriegsmarine). 16 E. Paterlini Brianti, La grande guerra nella memoria reggiana, Biblioteca di Reggio Storia, 2006. 17 Il documento è pubblicato per gentile concessione della nipote Amelia Saccozzi Guidetti, che ha fornito anche altra importante documentazione sul congiunto capitano Mario Saccozzi. 18 E. Saccozzi, I canti dell’eroe, Luigi Bonvicini-Editore, Reggio Emilia 1921. Le xilografie che corredano il volume sono opera dell’altro fratello Gino Saccozzi, pittore. 19 Pubblicazione «In Memoriam», editore Municipio di Reggio Emilia, 13 aprile 1919, per i tipi della Cooperativa lavoranti tipografi. 20 «L’Avvenire d’Italia-Marca Trevigiana», edizione di Treviso del 29 maggio1966 e «Gazzettino di Treviso», 9 giugno 1966. 1 60 Appendice A Lettera di Giuseppe Musolino al dottor Augusto Saccozzi* 7 luglio 1916 Ill.mo sig. Direttore, Prego la S.V. con tutta la sua famiglia di alleviare il suo dolore; anzi di non pensare affatto più alla sua morte di martire, ma soltanto alla sua bella anima che ci attende in cielo. Mi deve scusare la S.V. se non le scrissi in questi giorni, non sapeva il disastro sicuro. Anche il Cappellano ieri sera mi aveva assicurato che non era successo niente; io sebbene non ci ho creduto pure dovette aspettare S.V. per assicurarmi con certezze. Perciò dunque mi deve scusare la S.V. anche per la lettera che scrissi a mia sorella il primo di questo mese, non sapeva il disastro altrimenti non ci avesse scritto o se scrivevo, scrivevo molte lettere di condoglianze alla mia famiglia. Anzi la prego SV di scrivere subito una lettera di condoglianze alla mia famiglia, comunicarle il disastro a mia sorella Anna. Immaginatevi in che modo viaggiava il capitano, che cosa aveva andato a fare in Albania, se lo aveva mandato qualcuno, tutto insomma dobbiamo sapere, se lo han tradito, se dobbiamo vendicarlo. L’altra cosa che desidererei dalla di S.V. di mandare questo fascicolo di lettere mie, a nato Salvatore Musolino, essendo che a Santo Stefano di Aspromonte noi abbiamo un amico di molta fiducia e desidero che questo amico leggesse tutto il fascicolo delle lettere che scrissi a lei ed al cappellano. In altro caso se non mandaste il fascicolo, non importa, purché lo fare sapere le cose più importanti, la distruzione dei nemici e ridurre subito Roma in cenere. (spiegandole la causa necessaria, irreparabile). Se poi le volete mandare il fascicolo di tutte le lettere, le dite, non appena il mio nemico o abbia letto me lo deve subito restituire. Le dovete dire alla mi famiglia che subito voglio la morte di tutti i nemici italiani, che la guerra deve cominciare dal Piemonte di Roma, che subito voglio distrutto Roma e aboliti i piemontesi nemici. La ringrazio S.V., la saluto con tutta la sua famiglia, il pittore, le raccomando il conforto con tutta la famiglia ripeto, le accerto la riconoscenza dell’onesto glorioso sangue sparso del suo figliolo, le accerto che io lo sto piangendo fratello, suo Musolino Giuseppe. *Trascrizione. Giuseppe Musolino, conosciuto come il «u rre dill’Asprumunti», ferocissimo bandito calabrese, responsabile di almeno dieci omicidi e condannato all’ergastolo, trascorre molti anni della sua detenzione nel manicomio criminale di Reggio Emilia, dove muore il 22 gennaio del 1956. Appendice B Le foto di alcuni caduti Arturo Carretti Il foglio matricolare di Arturo Carretti Adelchi Bottazzi Dante Davoli Abelardo Casoli Giuseppe Davoli Pietro Ferrari Riccardo Ferrari Pietro Schiatti Adolfo Prampolini Documenti Un Archivio «che parla tanto di lui» La documentazione cartacea e multimediale di Cesare Zavattini Giorgio Boccolari* L’Archivio di Cesare Zavattini, definitivamente approdato alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, costituisce un «caso» a sé stante nell’ambito degli archivi di persona1. La caratteristica saliente di questo straordinario lascito culturale è costituita dalla vastità e complessità dei materiali che lo compongono. Essi sono, infatti, contrassegnati dall’interazione tra ambiti diversi – cinematografia, letteratura, teatro, poesia, diaristica, epistolografia, pubblicistica – per non citare che le tematiche di maggiore rilevanza. Note critico-biografiche Cesare Zavattini compare sulla scena della letteratura italiana negli anni ’30 con un nuovo umorismo poetico, così personale e suggestivo, che diventerà un genere a sé stante. Ma la poetica e lo stile di Zavattini scrittore hanno un’altra non secondaria caratteristica: il rapporto con due importantissimi mezzi di comunicazione di massa, il giornalismo (dal quale «Za»2 proviene) e il cinema (nel quale la sua carriera ha toccato il vertice con risultati di risonanza e influenza internazionali). L’interscambio giornalismo-letteratura-cinema non è casuale, alla sua base *Curatore dell’Archivio Cesare Zavattini (d’ora in poi ACZ), Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia. 67 c’è la sensibilità straordinariamente moderna3 dell’uomo Zavattini, un artista per il quale la componente dell’immaginazione ha sempre avuto un peso determinante pur essendo essa alimentata da una continua attenzione alle concrete esperienze degli uomini. Nel giornalismo e nel cinema egli ha espresso e nutrito il suo prorompente bisogno di presa diretta con la realtà e, al tempo stesso, ha tratto una lezione tutta moderna d’innovazione del linguaggio e di efficacia comunicativa. Za è stato per molti aspetti un precursore. Perennemente giovane (Forever young, per dirla con Bob Dylan), dotato di eccezionale vitalità, spinto da un continuo bisogno di ricerca e di sperimentazione, Zavattini, anche per un suo personale stimolo a rinnovarsi, ha sempre dimostrato la straordinaria capacità di esprimere ogni volta qualcosa di nuovo in tutte le svariate attività alle quali si è applicato. Nato nel 1902 a Luzzara (Reggio Emilia), esordì nel 1927 come giornalista alla «Gazzetta di Parma»4. Nel 1930 si trasferì a Milano. Dopo alterne vicende, la sua carriera giornalistica ebbe un’ascesa galoppante5. Nel 1935 assunse la direzione di «Cinema illustrazione», poi del «Secolo illustrato» e di «Grandi firme» (1937-38). Vera macchina d’idee, fu conteso dai maggiori editori italiani. Dopo una prima esperienza alla Rizzoli, nel 1936 venne assunto da Mondadori come direttore editoriale di tutti i periodici, compreso il settore «Walt Disney» del quale s’interesserà in prima persona creando storie «a quadretti» che costituiscono ancor oggi un must tra i comics italiani. Instancabile inventore di giornali e rubriche, nella pubblicistica del tempo anticiperà settimanali e formule giornalistiche oggi divenute usuali6. Nel 1941 inizierà la collaborazione con la rivista «Primato». Poi una pausa di qualche anno e la guerra. Nel 1950, riprenderà l’attività pubblicistica varando sul settimanale «Epoca» la rubrica Italia domanda (frutto di un suo progetto proposto a Bompiani già nel 1947). Nel 1958, verrà assunto nuovamente da Mondadori come consulente editoriale per le testate giornalistiche. Molte furono le iniziative editoriali e giornalistiche nel dopoguerra, anche se non sempre i suoi progetti si poterono realizzare7. Intanto, con un travolgente successo, erano usciti i suoi primi libri, tutti editi da Bompiani: Parliamo tanto di me (1931), un genere d’umorismo inedito nella nostra letteratura8, e I poveri sono matti (1937), che fu definito «uno dei libri più sconcertanti usciti negli ultimi 25 anni». Dello stesso periodo furono anche i primi soggetti cinematografici (il primo in assoluto, Darò un milione9, è del 1935). Anche in questo campo, Zavattini inventò qualcosa di nuovo, dando l’avvio ad un tipo di commedia brillante, allora insolito nel cinema italiano, che coglieva garbatamente una certa psicologia della gente semplice. Durante la guerra uscirono altri due libri: nel 1941, Io sono il diavolo e, nel 1943, Totò il buono, che costituì una tappa fondamentale nell’evoluzione di Zavattini. In questo stesso periodo (nel 1940 si era trasferito a Roma), la tematica dei suoi soggetti e sceneggiature si rinnovò ancora, assumendo ambientazioni più precise che indagavano criticamente il mondo borghese come 68 Cesare Zavattini, Giaci Mondaini, Darò un milione, soggetto cinematografico del film uscito nel 1935, diretto da Mario Camerini, pubblicato come supplemento alla rivista «Cinema illustrazione» nel settembre dello stesso anno. (Archivio Cesare Zavattini [acz], Biblioteca Panizzi [bp], Biblioteca speciale zavattiniana – Reggio Emilia) in Quattro passi tra le nuvole del 1942 e in I bambini ci guardano del 194410. Spazzato via il fascismo nel grande sommovimento sociale dell’immediato dopoguerra, ecco prorompere lo Zavattini uomo di cinema. Un’epoca gloriosa del cinema italiano, il neorealismo, che Za esportò andando personalmente a divulgarne i postulati e anche a proporlo sperimentalmente in Spagna, a Cuba e in Messico, ebbe il suo segno determinante. Tra gli anni ’40 e ’50 nessuno riuscì a dare alla cinematografia un apporto maggiore del suo, sia dal punto di vista teorico sia da quello artistico. Miracolo a Milano (1950), il film tratto dal romanzo Totò il buono, è ancor oggi tra i capolavori della cinematografia italiana riconosciuti in tutto il mondo, un’opera frutto dello straordinario tandem creativo che egli costituì col regista De Sica11. Alla sorprendente collaborazione di due personalità tanto complementari vanno ascritte, in buona misura, lo slancio, le tematiche e il successo del neorealismo che annovera tra i suoi capisaldi altre tre loro opere d’eccezione: Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Umberto D. (1951)12. In questi quattro film è condensato il momento più alto e genuino della poetica e della concezione cinematografica di Zavattini: l’amore per la realtà popolare, sempre sentita con viva solidarietà per gli umili, i diseredati, le vittime d’un ingiusto sistema sociale; le forme di approccio con questa realtà, a volte favolistiche (Miracolo a Milano), a volte sentimentali (Sciuscià e Ladri di biciclette), a volte asciuttamente realistiche (Umberto D.) – il cinema concepito come un grande strumento civile che parla ai sentimenti e alla coscienza del pubblico fuori da ogni sfruttamento commerciale. Creatore assiduo, Zavattini diventò l’animatore di un dibattito che coinvolse tutto il mondo cinematografico. Si batté contro ogni censura che limitasse l’espressione artistica (esemplare su questo tema la commedia del 1958 Come nasce un soggetto cinematografico)13, proponendo forme di produzione che tendessero a svincolare il cinema dai condizionamenti commerciali. Realizzò film che si prefiggevano di riportare immediatamente la realtà sullo schermo come L’amore in città del 1953 – un film sui generis poiché l’idea iniziale era quella di redigere una sorta di rivista cinematografica semestrale chiamata «Lo Spettatore» di cui questa pellicola avrebbe dovuto essere il primo numero – o I misteri di Roma14 del 1963, esperimenti coi quali anticipò la candid-camera, il cinema-verità, il cinema-inchiesta15.. Erano le prove generali di un genere di film, quello «saggistico», che non avrà soverchia fortuna nel nostro Paese; esso comprenderà anche il film-viaggio, il film-lampo16 il film delle confessioni, controverso filone utilizzato per Siamo donne. Sempre nell’ambito della sperimentazione lanciò l’idea dei «cinegiornali della pace», si dedicò ai «cine-giornali liberi», per avviare un cinema politico con autonomi circuiti di diffusione17. Culminata alla metà degli anni ’50 la grande stagione del neorealismo, riaffiorarono i suoi interessi letterari18. Oltre a un «diario» apparso per anni su «Cinema nuovo», pubblicò alcuni libri, tra i quali: Non libro più disco (1970)19, un’altra personalissima confessione sugli interrogativi angosciosi posti dalla 70 Copertina della rivista «Il soggetto cinematografico», 1° agosto 1951 con la foto di una scena del film Umberto D. Soggetto e Sceneggiatura di Cesare Zavattini, regia di Vittorio De Sica, Umberto D. ottenne la Nomination all’Oscar per il miglior soggetto nel ’57. La storia di Umberto D Zavatini l’aveva depositata alla siae nel 1948 col titolo Un uomo e il cane. (acz, bp, Biblioteca speciale zavattiniana – Reggio Emilia) realtà di quel tempo; una raccolta di poesie in dialetto luzzarese, Stricarm’ in d’na parola (trad.: Stringermi in una parola, 1973)20; La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini (1976)21, un’opera che, come il Non libro, era scritta con un linguaggio che conteneva spunti della letteratura sperimentale coeva alla Roberto Di Marco (Gruppo ’63)22 ed era anche, contestualmente, quella della lacerazione della nostra cultura. Ma Zavattini, sperimentalista lo fu a tutto tondo. In qualche modo innovatore lo sarà nei primi libri e per i «raccontini» che confluiranno in Io sono il diavolo pubblicati su «Tempo» tra il luglio del ’40 e l’agosto del ’41, o in quelli che per tre anni dal ’36 al ’39 uscirono nella rubrica «Cinquanta righe circa» sul settimanale satirico «Marc’Aurelio». Ed è indubbio che sperimentalista lo sia stato veramente se solo si pensa ai testi presentati nella rubrica – da lui inventata e curata – «Domande agli uomini», apparsa sul settimanale «Vie nuove» tra il 1956 e il 195723, elaborati che volevano essere un approccio letterario al Neorealismo, fino all’ardita e anticipatrice sperimentazione della scrittura, nella forma dei «Telegrammi», articoli brevissimi di una rubrica a sua firma, comparsa tra il 1978 e l’83 sul quotidiano «Paese Sera»24. All’inizio degli ottant’anni, diresse – era il 1981 – impegnandosi come regista, un suo lungometraggio, La veritàaaa25, un film che avrebbe dovuto essere interpretato da Roberto Benigni26 e che poi ebbe per attore protagonista lo stesso Za. Il soggetto, la cui prima versione risaliva al 1962 e l’ultima al 198127, è conservato assieme agli altri in archivio. È un enorme cumulo di annotazioni, stesure, abbozzi, variazioni, appunti, dichiarazioni e materiali preparatori che, a sistemazione avvenuta, potranno fornire la storia di un film definito «testamentale e irripetibile»28. Zavattini si spense a Roma il 13 ottobre 1989. La sua salma venne traslata nel cimitero di Luzzara, suo paese natale, dove è sepolto. L’Archivio: note di carattere generale L’Archivio di Cesare Zavattini si formò e si consolidò a Roma, nella storica abitazione dell’artista, al civico 40 di via Sant’Angela Merici. Di qui sarà avviato già dal 1991 il trasferimento alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. L’importante lascito è ora depositato presso la biblioteca reggiana grazie alla sensibilità dei figli Arturo e Marco, ai rapporti che nel corso degli anni erano stati allacciati dallo scrittore luzzarese con intellettuali, artisti, amministratori pubblici ed uomini politici della sua terra ma anche, è doveroso sottolinearlo, grazie all’impegno del direttore della Biblioteca Panizzi, Maurizio Festanti29. Una convenzione stipulata fin dal 1990 tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Reggio Emilia30 e gli eredi Zavattini, diede inizio ufficialmente al trasferimento dei materiali31. Organizzato in prima istanza, per comodità di consultazione e d’uso, da colui che l’aveva prodotto (Cesare Zavattini), l’Archivio è stato poi oggetto di un paziente e preziosissimo lavoro di controllo e cura scientifica ad opera del figlio Arturo. 72 L’entità davvero sorprendente dei suoi carteggi dà conto della vastità dei rapporti epistolari zavattiniani, ma anche della qualità dei contatti e delle relazioni con personalità del mondo della cultura, dell’arte, della politica e del cinema che egli riuscì ad intessere. Dapprima, all’epoca del servizio militare a Firenze (1929), incontrò gli scrittori e i poeti del caffé «Le giubbe rosse»; trasferitosi a Milano allacciò una vastissima rete di conoscenze grazie anche al suo lavoro nelle case editrici Rizzoli e Mondadori, ebbe quindi altri incontri determinanti negli anni ’40 a Roma, grazie all’attività cinematografica, nella stagione d’oro del Neorealismo e via via nella lunga e fervente opera artistica e d’impegno politico-culturale del dopoguerra. Zavattini coltivò, infatti, uno stretto rapporto con le proprie carte, tanto che si potrebbero individuare alcuni momenti periodizzanti per la vita dell’Archivio in riferimento alle varie fasi, spesso concatenate, della sua poliedrica attività. È così possibile affermare che dal 1940, quando arrivò nella capitale, il lavoro di archiviazione si fece più ordinato e sistematico. Alla conclusione del conflitto mondiale, s’impegnò nella costituzione di un fondo dei lavori cinematografici, poi, conclusa l’esperienza del neorealismo, rivolse progressivamente maggiore al lavoro letterario, alle numerose stesure delle sue opere, ma anche alle svariate attività cui proficuamente si dedicò. Per sistemare «fisicamente» la gran mole delle carte prodotte e per sbrigare la fitta corrispondenza che intratteneva, si avvalse dell’aiuto di vari collaboratori: Amleto Micozzi (che collaborò con lui negli anni ’50), Pierluigi Raffaelli e diversi altri, dattilografe comprese. Subito dopo la sua scomparsa, il figlio Arturo cercò di dare un senso logico alla sistemazione dei diversi documenti che nondimeno erano già stati, sia pur sommariamente, ordinati dal padre. Valeria Faletra (coadiuvata da Paola Trasciatti), per conto della Regione Emilia-Romagna, riordinò e redasse una prima bozza dell’inventario della Raccolta dei lavori cinematografici. Quindi, Chiara Daniele, all’epoca direttrice dell’Istituto Gramsci di Roma, si occupò della primissima parte dell’inventario dei carteggi zavattiniani, inventario che venne però continuato e concluso dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, grazie all’apporto di vari collaboratori32. I documenti mancanti Nonostante la vastità e la ricchezza dell’archivio zavattiniano, affinché l’informazione su questo importantissimo lascito sia riportata in tutti i suoi diversi aspetti è necessario rilevare alcune significative ma non certo vitali carenze, in parte segnalate dallo stesso Zavattini. Si tratta delle testimonianze documentali relative alla sua prima nodale «stagione» letteraria che lo vide frenetico recensore e scrittore dai connotati solo apparentemente umoristici. Sarebbe ragionevole aspettarsi tracce più consistenti di questo lavoro di scrittore, soprattutto in riferimento ai «tre libri»33, se solo si pensa al modo di procedere di Za, che rivedeva e riduceva costantemente i suoi testi, creando, così, diverse versioni 73 dei manoscritti e/o dattiloscritti originali; documenti che non sono stati rintracciati, se non in minima parte, nell’archivio, sebbene adeguate informazioni su questi stessi siano reperibili da altre fonti ivi conservate34. D’altronde la prima parte della vita dell’artista luzzarese fu molto travagliata, sia per i cambi di residenza (che in genere hanno un peso rilevante nella conservazione dei documenti personali), sia perché anche Za, come molti intellettuali ed artisti del Novecento, dovette attraversare, fortunatamente senza gravi danni personali, eventi drammaticamente significativi come il turbine fascista e la seconda guerra mondiale. Ma c’è un’altra forse più convincente motivazione cui Zavattini ha fatto talvolta cenno in alcune lettere, sia pure soltanto di sfuggita. Probabilmente nel 1937, ma la data non è certa, Za bruciò «nel giro di un’ora in non so in quale caldaia» (scriveva a Matelda Feltre nel 1973), una cassa di documenti, epistolari e non, per il timore di una perquisizione da parte della polizia fascista. Avevano poco prima arrestato un parente di Carlo Bernari (al secolo Carlo Bernard), tale Peirce, antifascista, e temeva, per quel tanto di «fronda» che c’era nel carteggio con lo scrittore napoletano d’origine francese, di subire analoghe conseguenze35. Non sono noti i criteri – se ve ne furono – con cui bruciò quelle carte. Lui stesso disse, comunque, che dovette o volle farlo in tutta fretta. Sicuramente non ponderò accuratamente l’operazione. È certo che tra quelle carte vi fosse anche una lettera di Benedetto Croce che cercò poi disperatamente36. Tra i testi che non hanno, per ragioni in gran parte ignote, una sufficiente testimonianza nelle carte dell’Archivio, c’è il Non libro più disco, opera assai più tarda (1970) rispetto ai Tre libri, della quale non sono reperibili versioni precedenti, revisioni o altra documentazione, a parte i sempre numerosi «eco della stampa». Un’altra attività di un certo spessore artistico e di notevoli potenzialità, ma per anni assai poco considerata e di conseguenza scarsamente documentata è quella dei fumetti. Zavattini se ne occupò – com’è stato scritto – in punta di penna, in forma quasi clandestina. La situazione della cultura italiana dell’epoca (anni ’30) e un certo antiamericanismo connaturato al regime fascista che si opponeva ai fumetti come espressione della corruzione culturale d’Oltreoceano37, influenzavano anche un anticonformista come Zavattini. Lo stesso Pavese, che nel 1933 aveva tradotto per l’editore torinese Frassinelli Le avventure di Topolino, di un allora sconosciuto «Walter» Disney, non si firmò, considerando «frivola» la pubblicazione38. Ciononostante, l’estro artistico innato non impedì a Zavattini di ottenere anche in questo settore, che sottovalutò almeno fino al primo dopoguerra, importanti risultati. Fu a partire dal 1936 che Za si accostò al «fumetto», dettando i soggetti ad una dattilografa nei ritagli di tempo dal suo ufficio di direttore editoriale alla Mondadori. In questo modo diede vita ai cicli di «Saturno»39 e di «Aeroporto “Z”»40, ai quali fecero seguito il fumetto a contenuto sociale «Zorro della metropoli»41, «La primula rossa del Risorgimento»42; nel dopoguerra creò «Un uomo contro il mondo»43 e numerosi altri che furono spesso soltanto 74 «Paperino e altre avventure», a. 2., n. 18, 28 aprile 1938. Contiene una puntata della storia zavattiniana a fumetti: Dino e Dario alla caccia di Will Sparrow, il pirata del cielo (acz, bp, Raccolta dei fumetti – Reggio Emilia) 75 ideati e poi sviluppati da collaboratori della casa editrice Mondadori, «storie a quadretti» delle quali oggi si possono fare solo ipotetiche attribuzioni di paternità. Se il fumetto di fantascienza era nato con l’apparizione della prima striscia di Buck Rogers, ideata da Philip Francis Nowlan nel 1929, cui fece seguito nel ’34 Flash Gordon di Alex Raymond, la risposta italiana arrivò proprio da Cesare Zavattini nello speciale de «I tre porcellini» del 31 dicembre 1936 con Saturno contro la Terra (testi di Zavattini e Pedrocchi, disegni di Scolari)44. In questo approccio ai fumetti per la Mondadori, Zavattini sviluppò la suddetta fortunata serie di «storie» nelle quali espresse sottili tematiche pacifiste non colte dal regime fascista che, di conseguenza, non censurò. La «fortuna» della saga di Saturno indusse Mondadori, per il tramite della «Helicon» italiana, un’organizzazione creata negli anni Trenta per promuovere il fumetto nazionale all’estero, a tradurre in inglese le avventure di Rebo, il protagonista dell’epopea saturniana, al fine di imporre il fumetto fantascientifico autarchico in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Si ha la certezza che anche negli usa, quattro numeri di Saturn against the earth siano stati pubblicati nei «Future Comics» tra giugno e settembre 1940. La politica estera italiana, in considerazione dello stato di belligeranza in atto, bloccò l’ambizioso progetto mondadoriano45. Ma non è tutto. Oltre all’America latina, nella quale pare che i fumetti di Saturno avessero conosciuto una qualche diffusione – particolarmente in Argentina, Brasile e Messico – strisce con le nuvolette ideate da Za uscirono sicuramente in Francia e, forse, anche in Spagna e Portogallo, sebbene in questi ultimi due casi si tratti per ora unicamente di supposizioni46. Di quest’ampia attività nell’archivio zavattiniano restano solo alcuni carteggi e poco altro, purtroppo non i soggetti47. Peraltro un bombardamento nel 1944 rase al suolo la sede della «Helicon»; andò così perduto anche l’Archivio della società che avrebbe potuto chiarire molte cose, anche quale tipo di diffusione essi ebbero all’estero48. Un ulteriore aspetto assai poco conosciuto dell’attività zavattiniana è quello degli esordi nel mondo cinematografico. Per svariate ragioni, non ultima la manchevole documentazione dovuta anche all’eccezionalità del periodo – la guerra e l’immediato dopoguerra – questa fase artistica oltre ad essere scarsamente documentata è anche poco nota ed un po’ sorprendente. A Roma, infatti, l’esordio di Zavattini nel grande cinema avvenne in gran parte nell’ambito della Orbis prima e dell’Universalia poi, due case di produzione legate direttamente al Vaticano49. Nell’archivio zavattiniano, di questa vasta e importante attività artistica per la cinematografia cattolica (che lo ha visto impegnato in primis assieme a Diego Fabbri), restano soltanto pochissime tracce, recensioni e/o annunci di film o di progetti di film, per lo più in ritagli di giornale (Echi della stampa)50. Il luogo comune secondo il quale Za sarebbe stato di orientamento radicalmente contrario, pensando alle sue successive frequentazioni dell’Intellighenzia marxista italiana ed internazionale (ebbe persino rapporti 76 personali con Fidel Castro e Che Guevara), trova – e non qui soltanto – una secca smentita. È scontato, comunque, che carenze di documentazione caratterizzino il complesso della sua attività per il cinema (di scrittore e non solo) essendo stata essa, com’è ormai consueto affermare, «vasta e disseminata». A questo proposito la Biblioteca Panizzi, che conserva e intende valorizzare sempre più l’archivio zavattiniano, s’è prefissa il compito di individuare le opere a stampa, non soltanto italiane, che hanno pubblicato suoi soggetti e sceneggiature, e di procedere alla mappatura dei luoghi (archivi, biblioteche generaliste o istituti culturali specializzati come gli archivi e le biblioteche delle cineteche, ecc.) che posseggono carte relative ai lavori cinematografici di Za, al fine di fornire, attraverso il sito Web <www.cesarezavattini.it>, informazioni precise e dettagliate su tutto quanto può illustrare la sua attività cinematografica. Topografia dell’Archivio Subito dopo la morte di Zavattini, il suo Archivio era costituito da alcuni fondi speciali monotematici51, tre dei quali molto vasti, ordinati per comodità da lui stesso in modo autonomo: si trattava dell’Epistolario, della Raccolta dei lavori cinematografici e degli Articoli di giornali e riviste: i cosiddetti «Echi della stampa». Oltre ad una cospicua raccolta fotografica, c’era – ed è in corso il riversamento su ausili informatici – una sezione di Documenti «audio e video» che, per la loro natura e per i supporti non consueti, almeno in riferimento agli archivi tradizionali, erano stati collocati a parte. Questi ultimi conferiscono all’Archivio quel carattere di multimedialità che è una delle caratteristiche peculiari dell’opera zavattiniana. Ma il «cuore» dell’Archivio, quello «storico» e più tradizionale rappresentato dalle «sudate»52 Carte di Za, si componeva di documenti che sono stati suddivisi in «titoli» e che collocati in «contenitori bianchi di cartone»53, rappresentavano l’unica grossolana unità di misura del medesimo54. Ora che lo stesso è collocato all’interno della Panizzi, vi fa idealmente parte una Raccolta di dipinti acquisita dal Museo civico reggiano, che illustra compiutamente il percorso pittorico di Zavattini, mentre è complementare una Biblioteca specializzata fornita di tutte le opere di e su Zavattini, compresi gli spogli dei periodici, nelle varie, numerose edizioni italiane e straniere. Il riordino All’inizio del lavoro d’inventariazione dell’Archivio, preceduto, come da prassi, dalla consueta operazione di «riordino», si è constatato come esso fosse «condizionato» e sommariamente ordinato: l’Archivio era stato suddiviso in «titoli» la quasi totalità dei quali era stata attribuita dallo stesso Zavattini55. Con l’avvio della catalogazione, ci si è resi conto che l’archivio zavattiniano aveva adempiuto egregiamente al compito di «autodocumentazione» del suo «produt- 77 tore»: Zavattini aveva sistemato le proprie carte per poterle riesaminare, per avere memoria di quanto aveva prodotto, in funzione di lavori successivi ed anche per lasciare una traccia non formale della propria opera. I problemi connessi alle operazioni di riordino e inventario Per redigere l’inventario descrittivo dell’Archivio si sono incontrate molteplici difficoltà; le più rilevanti derivate dal numero elevatissimo e dalla varietà dei materiali che lo compongono. In questo senso, ancora una volta, la puntuale opera di decodificazione delle carte operata dal figlio Arturo è stata illuminante e risolutiva. Delle diverse sezioni in cui era originariamente suddiviso l’Archivio, due, come abbiamo accennato in precedenza, erano già in gran parte ordinate (l’Epistolario e la Raccolta dei lavori cinematografici); l’altra, quella degli «Echi della stampa», lo era più sommariamente ed ha avuto un iter più laborioso. Tutto il resto era da fare56. L’Epistolario Uno dei fondi speciali espunti dall’Archivio e schedati a parte è quello dei carteggi, il cui catalogo informatizzato permette oggi di accedere al ricchissimo Epistolario zavattiniano. Tra le lettere dei corrispondenti e le minute di risposta, l’ordine di grandezza sopravanza le centomila unità. L’Epistolario annovera moltissimi nomi prestigiosi; vi sono registi, attori, critici, direttori artistici, produttori, politici, uomini di cultura, artisti, scrittori, editori, ecc.57 – da De Sica a Blasetti, da William Wyler a Pier Paolo Pasolini, da Giorgio Strehler a Dario Fo, Renato Rascel, Totò, Arnoldo Mondadori, Valentino Bompiani – ma anche numerosi nomi meno celebri o addirittura sconosciuti, che scrivevano a Za per i motivi più disparati: il giudizio su una loro opera, una recensione, una richiesta di denaro, una raccomandazione. Nel complesso le lettere costituiscono un lascito spirituale di vastissima portata e ci propongono un sorprendente «spaccato» della società e, soprattutto, della cultura italiana (e non solo) del secolo scorso. I lavori cinematografici Un altro fondo speciale, catalogato a parte, è quello dei lavori cinematografici. Acquisito dalla Biblioteca Panizzi già nel 199258, esso si compone di materiali in gran parte inediti e di varia lunghezza. In generale, oltre ai soggetti, sono presenti sceneggiature, trattamenti, scalette, note di lavorazione, note bibliografiche, filmografia ed altra interessante documentazione complementare. Zavattini si distinse per la produzione copiosissima di soggetti, oltre che di sceneggiature cinematografiche, e per il tenace impegno volto alla rinascita 78 Fotobusta del film Ladri di biciclette (1948), soggetto di C. Zavattini, sceneggiatura di C. Zavattini in collaborazione con altri. Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1950. (acz, bp, Raccolta dei manifesti – Reggio Emilia) del cinema. Ben sapendo di dover fare i conti con la realtà (il mercato), Za lo ha sempre considerato una forma d’arte duttile e popolare ed uno strumento utile al rinnovamento civile della società. Za iniziò a scrivere soggetti cinematografici, lo abbiamo accennato all’inizio, già dalla metà degli anni ’30. I soggetti dei film più celebrati – I bambini ci guardano (1944), Sciuscià (1945), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950), Umberto D. (1951)59, Il tetto (1956), per menzionarne solo alcuni – sono quelli del filone neorealista, una corrente cinematografica della quale, com’è noto, egli fu tra i padri fondatori ed uno dei teorici più accreditati60. I lavori cinematografici di Zavattini, raccolti in fascicoli e conservati in Archivio sono oltre duecentoventidue, di cui solo 64 realizzati. In realtà la sua produzione fu molto più vasta. I film nei quali è documentabile un determinante contributo zavattiniano, quelli della cosiddetta filmografia esaustiva, furono assai più di centocinquanta. Senza dimenticare, come ha scritto di recente Tullio Kezich, quell’incredibile «officina di riparazione di film in panne» che fu nel tempo la sua casa romana, valutazione che amplierebbe di molto questa stima61. Nel complesso, il Fondo si compone approssimativamente di oltre die- 79 cimila pagine (soggetti e sceneggiature prevalentemente presentate in cartelle dattiloscritte, in molti casi con preziose annotazioni autografe di mano dello stesso Zavattini). A questa raccolta si sono aggiunte ora le recensioni ai film e alcuni nuovi soggetti che erano dispersi. Un esempio: Elisabetta Castiglioni62, nel completare uno studio su Renato Rascel, ha rintracciato presso l’Archivio del famoso attore in Roma, il soggetto scritto da Zavattini in collaborazione con Bollero, Pietrangeli e Vergano, dell’Erede di Don Chisciotte, un lavoro che non figurava nell’archivio zavattiniano. La stessa studiosa ha poi scovato un’ulteriore versione a stampa del Don Chisciotte, il cui originale è conservato all’interno di un’altra raccolta documentaria a Cesena, nell’archivio Pietrangeli63. Nello stesso Archivio è conservata la copia di un altro soggetto zavattiniano non realizzato: La grande vacanza. Oltre a questi testi la Castiglioni64 ha recuperato anche una nuova versione, mutila, del soggetto dell’Ultimo eroe (mai realizzato in film), scritto da Zavattini in collaborazione con A.G. Majano, G. Gentilomo e D. Meccoli, che contiene alcune modeste ma ugualmente interessanti variazioni rispetto all’originale. Sulla base dei suoi studi, la Castiglioni ha anche scoperto che un fantomatico soggetto zavattiniano, intitolato Lo Schiaffo, è stato inglobato nel soggetto del Giudizio universale. Quel soggetto, infatti, avrebbe dovuto essere interpretato da Rascel, mentre nel film, la parte, quella del cameriere, è affidata a Nino Manfredi65. Alla categoria dei soggetti mancanti in Archivio, perché Za non figura tra gli autori accreditati e tuttavia è certo il suo impegno, accanto a numerosi film cubani e messicani, vi sono pellicole molto note come Roman Holiday (Vacanze romane) di William Wyler (1953), al quale Za ha fornito indicazioni decisive66, A Farewell to Arms (Addio alle armi) di Charles Vidor (1957) nel quale collaborò alla stesura dei copioni e alla sceneggiatura67, L’oro di Roma di Carlo Lizzani (1961), Alta infedeltà (1964) di vari registi, Promise at dawn (Promessa all’alba) di Jules Dassin (1971), ecc. L’attività giornalistica: gli «Eco della stampa» S’è già detto che tra i materiali depositati presso la Biblioteca Panizzi negli anni scorsi, un settore particolarissimo è costituito dagli «Eco della stampa»: articoli di e su Cesare Zavattini, raccolti dagli anni ’30 ad oggi, che sono stati ordinati cronologicamente per giorno, mese e anno. Questi materiali sono molto importanti se si pensa alle informazioni che possono fornirci sul poco documentato periodo pre-bellico e se si considera che si tratta di una rassegna stampa che rende conto e contestualizza oltre cinquant’anni di traboccante produzione zavattiniana, non tutta adeguatamente documentata. Negli «Echi» troviamo le recensioni dei Tre libri, quelle relative a pellicole ora pressoché introvabili (come Miracolo a Pompei68 ed altre minori), le recensioni critiche alle mostre di pittura, i puntuali commenti ad ogni benché minima attività, anche quelle solo annunciate e che poi non ebbero una realizzazione prati- 80 ca. Per questo motivo è in corso d’opera, grazie ad un finanziamento dell’ibc (Istituto per i beni culturali) della Regione Emilia-Romagna, un progetto di «scansione» di una scelta degli Echi più significativi, per consentire ricerche a tutto campo. La Raccolta dei dipinti La Collezione Zavattini è un fondo «aggregato», costituito da centoventi dipinti acquisiti dal Museo civico reggiano69, che abbracciano tutto l’arco temporale del lavoro artistico di Za. La ricerca on line sul sito Web dell’artista luzzarese permette di visualizzare i dipinti in ordine cronologico, di conoscerne il titolo, il periodo e le tecniche di realizzazione. L’autoritratto, i temi religiosi, i funeralini, la contaminazione con la parola scritta, l’esaltazione della fisica e della metafisica dei materiali usati, il senso dell’incompiutezza dei suoi quadri, sono una costante della sua pittura70. Le opere sono in perfetta sintonia con l’intera fisionomia della sua multiforme attività. Dal punto di vista pittorico, Zavattini non è facilmente collocabile in scuole e tendenze, e lui stesso non amava che ciò venisse fatto71. Egli rappresenta un unicum che solo alla lontana può evocare, per analogia, i casi, anch’essi isolati, di un Maccari, un Baj o un Moreni. Za mostrò in questo campo anche un altro aspetto della sua indole: il collezionismo. In tale veste seppe essere del tutto originale: da un lato mettendo insieme una straordinaria raccolta di libri d’arte (circa 3500) che costituiscono un corpus a sé stante, di enorme valore bibliografico e documentario, dall’altro costituendo, con pazienza, perseveranza e un pizzico di bizzarria, una sorta di collezione universale di quadri di piccolo formato, nella quale convogliare un numero estesissimo di artisti. Grandi artisti per piccole dimensioni, è questa la formula applicabile alla sua celebre raccolta 8 x 10, che annoverava oltre 1500 quadretti, tutti delle stesse identiche ridotte dimensioni e tutti articolati secondo i soggetti richiesti da lui stesso: un autoritratto e un tema libero72. La collezione minima73, che giunse ad annoverare la quasi totalità degli artisti italiani del ’900, così come la più generale produzione pittorica, sono ampiamente documentate nel catalogo descrittivo dell’archivio zavattiniano. Il settore fotografico La sezione fotografica dell’Archivio è composta da diversi materiali: vi si trovano le fotografie dell’opera pittorica di Zavattini; i ritratti dedicati a Zavattini da fotografi famosi (Avedon, Berengo Gardin, William Klein, Duane Michals, Zanca, ecc.); le foto di Luzzara, della Bassa Padana e del Po, ma soprattutto le foto di album di Zavattini, di proprietà della famiglia: ad oggi ne sono state riprodotte svariate centinaia. Una parte di queste foto saranno rese 81 visionabili e «scaricabili» dal sito Web. Spicca in questo ambito il rapporto tra il grande fotografo Paul Strand – pioniere della fotografia «artistica» del Novecento – e Cesare Zavattini. Un incontro fortunato, incentrato sulla transizione dalla progettualità cinematografica a quella letteraria. In qualche modo il rapporto sperimentale tra Strand e Za costituirà lo spartiacque tra il cinema narrativo di vecchio tipo e il nuovo cinema che si definiva «saggistico». L’incontro avrebbe dovuto condurre alla realizzazione di una collana di libri (titolo: «Italia mia») per Einaudi, della quale uscì purtroppo un solo volume Un paese (su Luzzara) di Strand e Zavattini, appunto74. Si trattava di un libro davvero esemplare, concettualmente complesso, nato dall’incontro con il cinema, una sintesi tra libro e film75. La Biblioteca zavattiniana La Biblioteca speciale di Cesare Zavattini è sostanzialmente un «centro di documentazione» aggregato all’Archivio e relativo alle opere di e su Za. I libri provengono in buona parte dalla Biblioteca che si trovava nella casa romana dell’artista. Intesa come biblioteca d’autore (ed anche come centro di documentazione dell’opera di Za), cinque sono le caratteristiche della raccolta reggiana: a) sono qui conservati tutti gli esemplari delle sue opere, nelle diverse edizioni, che l’autore medesimo aveva raccolto. Sempre provenienti da Roma sono conservati i testi svariatissimi scritti da altri che illustrano le sue attività. Di questi ultimi una buona parte era stata acquisita dallo stesso Zavattini e collocata nella propria biblioteca privata (nel complesso, tra opere sue o su di lui, ve ne sono circa quattrocento); b) la raccolta è arricchita da tutti i volumi usciti dopo la sua morte e da altri testi su di lui (circa trecento); c) v’è poi una collezione di fumetti che pubblicano le sue storie avventurose, poco più di un centinaio di fascicoli, oltre a diverse opere attinenti la fumettistica zavattiniana (circa 150 testi); d) vi sono inoltre decine e decine di tesi di laurea su di lui e sulla sua opera; e) sono consultabili inoltre alcune centinaia di numeri sparsi di riviste con saggi o altri scritti (raccontini, poesie, ecc.) di e su Zavattini (circa trecento numeri); f) sono state infine acquisite alcune annate, pur non complete, di periodici da lui diretti o sui quali teneva rubriche o scriveva: da «Cinema Nuovo» a «Tempo», dal «Giornale delle meraviglie» a «Settebello», da «Novella» al «Milione». La consultazione dell’Archivio Dal sito Internet dell’Archivio, che è rintracciabile all’indirizzo: <http:// www.cesarezavattini.it>76, è possibile attivare un collegamento (link) con i cataloghi informatizzati dei fondi speciali (Carteggi, Lavori cinematografici, Collezione dei dipinti). Esiste già, inoltre, l’Inventario analitico/descrittivo di 82 tutto l’Archivio77. Per ora è soltanto ad uso interno; presto sarà consultabile nel sito della Biblioteca Panizzi e in quello specifico di Cesare Zavattini. L’Inventario è già, comunque, uno strumento indispensabile per coloro i quali chiedono consulenze per ricerche del più vario genere: la redazione di opere a stampa, saggi per riviste, tesi di laurea, ecc78. In sostanza l’Archivio, che, non va dimenticato, si compone anche di una nutrita serie di preziosi manifesti, di locandine e fotobuste cinematografiche, dà conto della straordinaria attività di Zavattini il quale, oltre che pittore sensibilissimo, scrittore, soggettista di fumetti e soprattutto soggettista e sceneggiatore cinematografico, fu – lo abbiamo citato di sfuggita – commediografo (nel ’59 a Venezia debuttò la sua commedia Come nasce un soggetto cinematografico allestita dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Milano)79, poeta, animatore culturale in Italia e all’estero ed anche promotore di cooperative culturali80. Nel 1955, a coronamento di un impegno non certo effimero, gli venne assegnato il «Premio mondiale per la Pace»81; nel 1978, nel corso della trasmissione radiofonica Voi ed io. Punto e a capo, da lui diretta e condotta, pronuncerà la famosa «parolaccia» (Cazzo!) proferita in diretta nella puntata del 25 ottobre ’76, la prima nella storia dell’emittenza pubblica. Oggi può apparire eccessivo, eppure essa rappresentò la cartina al tornasole di un mutamento ormai consolidato nel costume italiano e segnò una svolta nell’ambito della rai-tv. Proprio sui suddetti mass-media divenuti centrali nella vita di oggi e sulla sua opera innovativa nell’utilizzazione dei medesimi, è di prossima uscita un volume di Gualtiero De Santi. Dopo la sua apertura al pubblico, l’Archivio – un «libro aperto» che è un patrimonio della città – sta diventando sempre più un eccezionale strumento di ricerca e di studio, non soltanto su Zavattini e la sua opera, ma anche, indipendentemente da Za, sulla storia artistica, culturale sociale del secolo scorso82. 1 Solo in tempi relativamente recenti gli archivi di persona hanno acquisito una peculiare importanza; in passato essi venivano preferibilmente smembrati o più spesso distrutti. Nel primo caso se ne conservavano soltanto gli scritti più importanti. (Cfr. Specchi di carta. Gli archivi di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, Fondazione Ezio Franceschini, Firenze 1993, p. 9). 2 In questa forma abbreviata lo hanno sempre chiamato affettuosamente amici ed estimatori. 3 Gualtiero De Santi scrive che una delle virtù della scrittura zavattiniana è «l’esperienza della modernità» (Cfr. G. De Santi, Una parola moderna: Zavattini scrittore. Atti della giornata di Studi, Reggio Emilia, 25 ottobre 2002, Aliberti, Reggio Emilia 2005, p. 80). 4 Cfr. Zavattini 1928 (Corsivi per la «Gazzetta di Parma» 1926/1928), proposta di lettura del Collettivo di studio itc, a cura di G. Negri, Gruppo cooperazione editoriale, Suzzara 1973; Dite la vostra. Scritti giovanili, pref. di V. Fortichiari, a cura di G. Conti, Guanda, Parma 2002. 5 È illuminante a questo proposito il libro di M. Carpi, Zavattini direttore editoriale, pubblicato a Reggio Emilia nel 1° numero della collana dei «Quaderni dell’archivio» (cfr. M. Carpi, Cesare Zavattini direttore editoriale, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi-Archivio Cesare Zavattini-Aliberti, 2002). 6 Ibidem. 7 Cfr. «Il disonesto»; «Italia domanda», ecc. 83 Scrittore non sempre facile da inquadrare nelle «correnti» che il Novecento riconobbe, autore singolarmente critico verso la società, osservata tanto nei suoi aspetti dolorosi quanto in quelli umoristici, Zavattini costituì un fenomeno particolarissimo nell’ambito della letteratura italiana del secolo scorso. (Cfr. W. Mauro, Reale e «surreale» in Zavattini, in Letteratura italiana. Novecento, collana diretta da G. Grana, Marzorati, Milano 1979, pp. 5435-5440). 9 Cfr. Darò un milione, [di] G. Mondaini, E. Patti, I. Perilli, C. Zavattini, in «Cinema illustrazione», v. 10., nn. 35-37 (28 ago.-11 set. 1935). 10 Cfr. Filmografia, ad vocem, in <www.cesarezavattini.it >, gen. 2008. 11 Cfr. G. Aristarco, «Zavattini-De Sica», in P. Nuzzi (a cura di), Una vita Za, Guanda, Parma 1995; G.P. Brunetta, «Zavattini e De Sica = 1 + 1 = 1», in G.P. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, Laterza, Roma-Bari 1991. 12 Cfr. Filmografia, ad vocem, in Cesare Zavattini, <www.cesarezavattini.it>. 13 Il cui testo venne pubblicato a Milano da Bompiani nel 1959. 14 C. Zavattini, I misteri di Roma, a cura di F. Bolzoni, Cappelli, Bologna 1963. 15 Tra le opere, di cui si possiedono varie versioni e studi preparatori, è interessante il progetto per il film mai realizzato sull’attore Maurizio Arena, che all’epoca – 1962 – stava attraversando un’inarrestabile parabola discendente. Si trattava di quel tentativo di cinema-verità, che Zavattini non riuscirà mai a concretizzare compiutamente. Il progetto del film avrebbe dovuto essere attuato in collaborazione tra l’allora giovane regista Dino Bartolo Partesano e Marco Zavattini. Nelle carte della «Panizzi» che comprendono molte versioni del progetto, l’opera – il cui titolo è La cavia – è sottotitolata A carte scoperte, ma reca anche altri otto titoli che rispecchiano differenti ma convergenti approcci: Il gallo, Biografia di un amatore, Il suo film, La pelle dell’orso, Fino in fondo, L’anima al diavolo, Mille amori, A. [cioè Arena] e La nobiltà. 16 Cfr. il film a episodi L’amore in città (1953) e l’episodio Storia di Caterina, soggetto di Za, regia dello stesso in collaborazione con Francesco Maselli. 17 Cfr. T. Masoni, P. Vecchi (a cura di), Cinenotizie in poesia e in prosa. Zavattini e la non-fiction, Lindau, Torino 2000 18 Cfr. la bibliografia «essenziale» delle sue opere, pubblicata, oltre che sul sito Web, nel volume di M. Carpi, Cesare Zavattini, direttore editoriale, op. cit. 19 C. Zavattini, Non libro + disco, Bompiani, Milano 1970. 20 Cfr. C. Zavattini, Stricarm’ in d’ na parola, Scheiwiller, Milano 1973. Un libro che Pasolini definì «bello in assoluto». [Cfr. C. Zavattini, Poesie. Nota di P.P. Pasolini, Tascabili Bompiani, Milano 1985 (la citazione è in ultima di copertina)]. 21 C. Zavattini, La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini, Bompiani, Milano 1976. 22 Cfr. <http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Di_Marco> (luglio 2008). 23 Cfr. C. Zavattini, Domande agli uomini, Le Lettere, Firenze 2007. 24 Detta ricerca rappresentava una concreta ma a lungo ignorata maturazione del suo sperimentalismo linguistico e formale, che si esplicava nello stile di una «lettera breve» con la quale Za si prefiggeva di dare «giudizi icastici e satirici sulla pelle degli avvenimenti politici e parapolitici». Essa trovò il proprio approdo nei testi pubblicati sul quotidiano romano dal 1978 al 1983 e ripubblicati in coda al saggio della Gargiulo (cfr. M.L. Gargiulo, La «parola mutilata»: Stratagemmi letterari in Cesare, in «Palazzo Sanvitale», 2005/13-14). 25 Za lo definì «Film da camera» e molti critici lo considerarono il suo testamento spirituale. (Cfr. C. Zavattini, La veritàaaa, Milano, 1983). 26 In una lettera inviata a Soler, giornalista della tv spagnola, nel 1979, Za precisava che Roberto Benigni, interprete mancato del suo La veritàaaa, «è un giovane comico che sta ottenendo un crescente successo nel nostro paese». 27 Cfr. O. Caldiron, Za regista, in P. Nuzzi (a cura di), Le opere e i giorni di Cesare Zavattini, vol. 1. Giornalismo, letteratura, cinema, Edizioni Bora, Bologna 1997, p. 243n. 28 Cfr. O. Caldiron (a cura di), Cesare Zavattini, Edizioni Cinecittà Estero, Roma 1990, p. 50. In testa al frontespizio: ministero del Turismo e dello Spettacolo . 29 Già sulla rivista «IBC Informazioni» del 1988, Zavattini vivente, si adombrava la possibilità dell’acquisizione da parte di un’istituzione pubblica (la reggiana Biblioteca Panizzi), dell’archivio di Za. (Cfr. N. Pisauri, Lussuria e devozione, in «IBC», mag.-ago. 1988, p. 21). 8 84 Nel numero di maggio 1990 la rivista «Bolaffi Arte» annunciava che «il Comune di Reggio Emilia ha approvato l’acquisizione del suo Archivio …». 31 Acquisizioni di archivi di persona, di fondi documentari o di classiche raccolte di manoscritti – con il comune denominatore delle origini reggiane o dell’attività svolta in sede locale dai personaggi che li hanno prodotti – non sono un evento raro per la Biblioteca Panizzi. Per una visione d’insieme delle acquisizioni di manoscritti e di fondi archivistici della «Panizzi», si veda R. Marcuccio, Il documento manoscritto nella biblioteca pubblica di ente locale. Patrimonio, esperienze e progetti della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, in «Biblioteche Oggi», 2002/1, pp. 12-22. 32 Oltre a chi scrive, Carla Bisi, Silvia Friggeri, Giorgia Giovanelli, Silvia Pastorini, Vanna Porta, Giovanna Porta Del Longo, Manuela Marchesi e particolarmente Edmea Camurri, sono le persone che hanno contribuito all’inventariazione delle lettere e all’inserimento dei loro dati nel programma informatizzato, oggi catalogo dei carteggi di Za. 33 C. Zavattini, I tre libri: Parliamo tanto di me, I poveri sono matti, Io sono il diavolo, Bompiani, Milano 1955. 34 Cfr. Archivio Cesare Zavattini, Inventario descrittivo, ad vocem. 35 Oltre che in originale nell’Epistolario, il testo di questa lettera si trova anche in C. Zavattini, Una, cento, mille lettere, a cura di S. Cirillo, Bompiani, Milano 1998, p. 304 (minuta n. 186 a Matelda Feltre, Roma, 7 luglio 1973). 36 Testimonianza di Paolo Nuzzi, gennaio 2008. 37 Il regime fascista prima e i due principali partiti di massa del dopoguerra poi osteggiarono i fumetti in quanto sottoprodotto culturale della società americana [Cfr. M. Juri, Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra americanismo e antiamericanismo (1935-1955), Eum, Macerata 2007]. 38 Cfr. G. De Rienzo, Pavese, vagabondo di città e collina, in «Corriere della Sera», 15 giugno 2008, p. 33. 39 Sceneggiato da F. Pedrocchi e disegnato da G. Scolari (in «I tre porcellini» e poi in «Topolino», 1936-1938). 40 Sceneggiato da Pedrocchi e illustrato da Kurt Caesar (in «Topolino», 1940). 41 Sceneggiato da G. Martina e disegnato da W. Molino («Paperino», 1937-1938). 42 Illustrato da P.L. De Vita (in «Paperino», 1938-39). 43 Sceneggiato da M. Gentilini e disegnato da Scolari («Topolino», 1947-48). 44 In realtà, nel 1935, un anno prima di Saturno contro la terra, era uscito un altro fumetto di questo genere, tutto italiano. Si trattava di S.K. 1, una striscia disegnata per «Topolino» da G. Moroni Celsi. Partita nel 1935, S.K. 1 era in realtà una space-opera largamente ispirata, o meglio, in larga misura copiata, da Flash Gordon: la matrice comune era lo spostamento su altri pianeti di esseri e mondi tipicamente mitologici. Nonostante il contesto fantascientifico, gli studiosi sono abbastanza concordi nel collocarlo nella categoria «fantasy». Si trattava di una delle più autorevoli incursioni del fumetto italiano nel territorio della science-fiction. Zavattini resta dunque il primo autore di fumetti di fantascienza veri e propri. 45 R. Baccani, L. Tamagnini, Saturno alla conquista del continente americano, in «Fumetto», 2006/57, p. 23. 46 Testimonianza di L. Tamagnini, vice presidente anafi, direttore di «Fumetto», agosto 2008. 47 È stata comunque ormai completata l’acquisizione, da parte della Biblioteca Panizzi, di tutti i fascicoli originali contenenti i suoi fumetti. 48 Testimonianza Tamagnini cit. 49 Negli anni ’40 in ambiente cattolico erano nate due case cinematografiche: la Orbis e l’Universalia. L’Orbis ebbe un parto tribolato tra il ’43 e il ’44; si costituì grazie all’impegno del drammaturgo cattolico Diego Fabbri e di Luigi Gedda, dirigente dell’Azione cattolica. Fabbri, che stava lavorando al soggetto, La casa dell’angelo, convinse Zavattini e De Sica a legarsi alla nuova casa cinematografica e, riflettendo con Za sul medesimo soggetto, confezionarono La porta del cielo (1944). Con essa, Fabbri e Gedda «recluta(ro)no Zavattini come sceneggiatore» mentre De Sica garantiva la sua collaborazione alla Casa cinematografica gradita al Vaticano. (Cfr. E. Lonero, A. Anziano, La storia della Orbis-Universalia. Cattolici e neorealismo, pref. di D.E. Viganò, Effatà 30 85 editrice, Cantalupa [TO] 2004, p. 69) Il secondo film fu Il testimone realizzato nel 1945, sceneggiato da Fabbri e Zavattini, cui ne seguiranno numerosi altri, sia per l’Orbis sia, in seguito, per l’Universalia che l’aveva assorbita. Za scriverà poi, con Fabbri e Soldati, il soggetto del cortometraggio «Chi è Dio?» che avrebbe dovuto essere il primo di una serie di operette catechistiche a scopo didattico (mai realizzate). 50 Su questo particolare aspetto mi permetto di rinviare a G. Boccolari, Tracce di religiosità nell’attività artistica zavattiniana. Appunti per una prima ricognizione sul tema, in «L’Almanacco», 2007/48-49, pp. 103-129. 51 «Sub-fondi». 52 Ci si riferisce qui al grande lavoro di revisione delle sue opere. Spesso le migliaia di pagine prodotte, al momento della pubblicazione si riducevano a un centinaio o poco più. 53 I «contenitori» avevano le seguenti dimensioni: 35 x 28 x 10 cm. 54 Le «carte» comprendevano i seguenti «titoli»: Neorealismo; La Veritààà; Cuba; Mexico; Io e Van Gogh; Come nasce un soggetto cinematografico (teatrale), Fare una poesia alla vigilia della guerra; Ipocrita; Al macero; Le cento parole; anac; La notte che ho dato uno schiaffo a Mussolini; I misteri di Roma; Diario (materiali preparatori, «Paese Sera»); Diario cinematografico; Poesie; Un paese; Un paese – Italia mia; Un paese vent’anni dopo; Straparole; Riandando; Lettere da Cuba; Viaggetto sul Po; Voi ed io (Za e la radio); Il disonesto; Italia domanda; Italia mia (Televisiva) 1975; Ligabue TV; Cinegiornali liberi (C.L.); Za e la Pace; Asiago [“Discutiamo Zavattini”, Convegno, 1975]; Gazzetta di Parma; Zavattini: La leggerezza del pensiero [Convegno di Urbino 1990]; The children of Sanchez; Cooperazione culturale; Cronache da Hollywood; Circolo romano del cinema (Circolo Italiano del Cinema); Archivio storico audiovisivo del movimento operaio; Gli altri; Manifestazioni su Za; Manifesti e locandine di mostre e manifestazioni su Za; Recensioni film Za; Recensioni sull’opera letteraria; Materiali vario; Fotografie; Premi; Tesi di laurea; 8 x 10; Le voglie letterarie; Giornale «Contro»; L’Italia che legge; Naifs; Luzzara; Padania; Za pittore; Za-Gregoretti; Ciao Za-Zavattini in España; Das Wunde[r] von Mailand; Hommage a Cesare Zavattini-30 ans du cinema italienne; Cesare Zavattini (Mostra antologica, Milano 1989); Carte intime e familiari; Manifesti; Totò il buono (manoscritto originale). 55 Tranne alcune eccezioni relative a materiali raccolti dopo la sua scomparsa. 56 L’Archivio è stato schedato da due validissime ricercatrici: Chiara Boschini e Francesca Cervi. 57 P. Mattei, In 300 lettere la sua personalità, la sua filosofia, in «Avanti!», 8 ottobre 1988. 58 Sui soggetti cinematografici si veda C. Zavattini, Basta coi soggetti!, a cura di Roberta Mazzoni, Bompiani, Milano 1979; su quelli della Raccolta reggiana, cfr. G. Boccolari, I soggetti cinematografici di Cesare Zavattini conservati nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, in «Diviso in due». Cesare Zavattini: cinema e cultura popolare, Diabasis, Reggio Emilia 1999, pp. 153-162. 59 Che i film siano materia di studio non solo per la storia del cinema ma anche per quella della cultura, è ormai fuori discussione. Stupisce pertanto la puntigliosità e lo spirito di rivalsa che un personalità di grandissime qualità e cultura come Tatti Sanguineti, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Giovannino Guareschi, mette in campo contro Zavattini. Il vecchio Za ha un curriculum che non teme smentite e per quanto i due scrittori padani si amassero e talvolta, com’è naturale in persone della loro tempra, fossero in disaccordo, il loro non era certo un rapporto minato dalla querelle sollevata da Sanguineti. Infatti, in uno smaliziato saggio sulla cinematografia del dopoguerra che ha al centro la vicenda guareschiana, quest’ultimo azzarda che Zavattini abbia tratto lo spunto per il soggetto di Umberto D. da uno o due raccontini dell’autore di Don Camillo. Tesi interessante, se fosse vera, poiché non sminuirebbe Za (che ha, comunque, prodotto un soggetto autonomo, straordinariamente bello e commovente), ma anzi esalterebbe le sinergie artistiche e le contiguità etniche e culturali (basso-padane) dei due scrittori. In realtà detta tesi appare invece il frutto di un’interpretazione smaccatamente «guareschicentrica» della storia del cinema di quel periodo, interpretazione la cui autenticità sarebbe addirittura confermata da una prova assai poco convincente di un ex collaboratore di Za, secondo il quale tra le opere che Zavattini conservava nella sua stanza da lavoro c’era, in un cassetto, anche il libro incriminato. (Cfr. T. Sanguineti, Umberto D. è la mamma di Guareschi: da Umberto D. a Dina M., in E. Bandini, G. Casamatti, G. Conti, (a cura di) Le burrascose avventure 86 di Giovannino Guareschi nel mondo del cinema, mup, Parma 2008, pp. 279-283). 60 Per uno sguardo più generale a questo sub-fondo cfr. l’inventario descrittivo della Raccolta dei Soggetti cinematografici dell’acz nel sito Web di Za. 61 L’apposizione di una targa commemorativa sulla facciata della sua storica abitazione per iniziativa del comune di Roma, è stata segnalata da Tullio Kezich nel «Magazine» del «Corriere della Sera» dell’8 dic. 2005 con un articolo dal titolo Non dimentichiamo Zavattini, che trasformò la casa in un’officina di riparazione dei copioni in panne. Kezich ricorda come il suo appartamento sia stato «per decenni la Mecca di tutti i cinecatecumeni, oltre a funzionare come un’officina di riparazione di copioni in panne. Straordinario inventore di soluzioni narrative e personaggi, il padrone di casa era un impareggiabile “play’s doctor”: un tocco qui, un’ideuzza là, qualche battuta di rinforzo e il film da fare era salvo». 62 Cfr. E. Castiglioni, Percorsi interrotti: i progetti che Rascel non ha realizzato, Roma, Mirabilia, 2000; E. Castiglioni (a cura di), Renato Rascel: immagini di scena, Mirabilia, Roma 2000. Laureata in Lettere, è stata dottoressa di ricerca presso l’Università «La Sapienza» di Roma. Autrice di vari siti su Rascel <www.renatorascel.it>; <www.italiamemoria.it/rascel/rascel.htm>; ecc. 63 Cfr. C. Zavattini, L’erede di don Chisciotte, in Lampi d’estate e altri soggetti, a c. di A. Maraldi, Prem. di U. Pirro, Cesena, «Il ponte vecchio», 1997, pp. 79-93. 64 Cfr. E. Castiglioni, Renato Rascel: il comico in trasformazione, Tesi di dottorato, coordinatore F. Marotti, Tutor Renzo Tian, Roma, Università degli studi «La Sapienza», 2000, 2 voll. 65 Cfr. Boccolari, I soggetti cinematografici, cit., pp. 155-156. 66 Cfr. la lettera di Za a W. Wyler, Roma 15 gennaio 1952. 67 Cfr. lettera inviata da David O. Selznick, produttore, a C. Zavattini il 14 luglio 1957. 68 Za farà il commento e lo speaker in questo cortometraggio uscito nel ’49. (Cfr. G. Gambetti, Cesare Zavattini. Guida ai film, Icom, Roma 1994, p. 198). 69 Zavattini iniziò a dipingere nel 1938. Nel 1943 vinse il premio della galleria del Cavallino «Scrittori che dipingono» prevalendo su Montale, Ungaretti, Moravia, Gatto e Buzzati, avviando così una lunga stagione espositiva siglata da numerose mostre in Italia e all’estero. (Cfr. R. Barilli (a cura di), Una vita Za. Le opere e i giorni di Cesare Zavattini. Dipinti 1938-1988, Guanda, Parma 1995). 70 S. Parigi, Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, Lindau, Torino 2007, pp. 99-105. 71 «Zavattini inventò un suo mondo, descritto col gusto narrativo di chi conosce bene l’arte del raccontar storie, un mondo illuminato dal sole del grottesco e scosso dai venti della caricaturalità, un mondo in cui tutto parla e si parla con l’idioma del bambino adulto che conosce la poetica aristocraticità dell’imperizia, quella del «barbaro» colto ed ammiccante, capace di abbattere con un soffio l’edificio della tradizione classica dell’arte occidentale». (G. Gigliotti, Il caso Zavattini, in Festival Internazionale dei Cinegiornali liberi, Reggio Calabria, 1999). 72 Fu nel ’40 il critico Raffaele Carrieri a far dono a Zavattini di una piccola tela di Campigli (Le cucitrici) ed a fornirgli involontariamente l’idea di dar vita al progetto collezionistico più curioso d’Italia, che contava nomi illustrissimi come quelli di De Pisis, Matta, Donghi, Cagli, D’Orazio, Scordia, Brindisi, Clerici, Franchina, Depero, Vacchi, Zancanaro, Messina, Crippa, Dottori e tanti altri. 73 Cfr. E. Gribaudo (a cura di), La raccolta 8 per 10 di Cesare Zavattini, Edizioni d’arte Fratelli Pozzo, stampa, Torino 1967. 74 Cfr. Un paese (testo di C. Zavattini, fotografie di Paul Strand), Einaudi, Torino 1955; Un paese vent’anni dopo (testo di C. Zavattini, fotografie di G. Berengo Gardin), Einaudi, Torino 1976; P. Strand, C. Zavattini, Paul Strand, Cesare Zavattini. Lettere e immagini, a cura di Elena Gualtieri, Reggio Emilia, Luzzara, Bologna, 2005. 75 Cfr. Parigi, Fisiologia dell’immagine, cit., pp. 281-282. 76 Ibidem. 77 Esiste anche il catalogo della Biblioteca speciale ora solo ad uso interno. 78 Per richieste d’informazioni via e-mail l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: archivio. [email protected] 79 Sull’attività teatrale di Zavattini cfr. C. Jandelli, Zavattini fra cinema e teatro, Bulzoni, Roma, 87 2002; S. Burani, Cesare Zavattini: Teatro Za, Università di Bologna (facoltà di Lettere e Filosofiadams), a.a. 2006-2007, relatore G. Liotta. 80 Sull’attività culturale cfr. G. De Vincenti, Za animatore culturale, in P. Nuzzi (a cura di), Cesare Zavattini, Una vita in mostra. Giornalismo Letteratura Cinema, Bora, Bologna 1998, vol. 1. 81 Cfr. Archivio Cesare Zavattini, «Za e la Pace» in <www.cesarezavattini.it>. 82 Tutto questo grazie ad un catalogo analitico (inventario descrittivo) che presto sarà pubblicato nel sito Web di Za e in quello della Biblioteca Panizzi. 88 Lettere del pittore Giorgio Morandi al «collega» Zavattini. (acz, bp, Epistolario – Reggio Emilia) Memorie «Io e Giovannino Guareschi: due emiliani internati militari in Germania» Intervista a Gaetano Montanari Andrea Paolella «Una piccola arca di Noé navigante in mezzo a un diluvio di malinconia e dentro ogni specie di esseri: dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale» G. Guareschi, Diario clandestino Gaetano Montanari è nato a Reggio Emilia il 28 aprile 1924. Lavora presso la ditta «L’Enologica» e poi presso le Farmacie comunali riunite. Militare a Bologna è stato internato militare in Bassa Sassonia dal 9 settembre ’43. Collabora, dal primo numero, al mensile diretto da Ivano Davoli, «Stampa reggiana». L’intervista è stata raccolta a Reggio Emilia il 10-11 giugno 2008. Partiamo da lei. Che cosa ha fatto prima della guerra? A tredici anni ho iniziato a lavorare come garzone presso L’Enologica, ditta attrezzata per la vendita di prodotti di vinificazione. Ho fatto le scuole elementari e poi, dopo un anno d’inattività, mi sono iscritto ad un corso per corrispondenza ginnasiale di cinque anni. Dopodiché, ho continuato il liceo classico sempre per corrispondenza. Cinque di ginnasio e tre di liceo. Quando mi ero preparato per sostenere l’esame per passare dalla scuola privata a quella pubblica, Vittorio Emanuele III mi mandò una cartolina d’invito per difendere 91 Gaetano Montanari la patria. Avevo 19 anni. Nel frattempo ho lavorato alle Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia. Avevo tempo di lavorare. Degli anni del fascismo ricordo il «sabato fascista» che era mezza giornata di riposo per chi lavorava. Dovevamo presentarci presso la sede politica del Fascio, il cui segretario era Vittorio Rossi. Penso che l’abbiano fucilato. Si tenevano lezioni di politica e si facevano delle marcette. Ci parlavano sempre del duce, della madre del duce e dei figli del duce. Quando eravamo entrati in guerra volevano farci odiare Francia e Inghilterra. Se non andavi, dovevi bere olio di ricino. Per le festività nazionali facevamo le adunate in Piazza d’Armi dove ora c’è la Banca d’Italia. Eravamo costretti a stare lì fino a che non ci davano il rompete le righe. Mi ricordo quando venne Starace: dovevamo stare lungo le strade. Io ero a San Pellegrino e lo avevo visto spuntare da Porta Castello a piedi. Durante la guerra, il governo italiano aveva stanziato una forte somma per risanare il Borgo Emilio. Mussolini era venuto lui stesso a Reggio Emilia pilotando l’aereo. In auto era arrivato in via Nobili e io ero lì perché mi avevano precettato. C’era un frate e Mussolini, uscito dalla macchina, prese il cordone del frate e lo baciò. Guardando le case del Borgo Emilio si era messo le mani sugli occhi. Aveva visto che non era stato fatto nulla e nemmeno avevano cominciato i lavori. Montò subito dopo sull’auto e andò via. La casa dove abitavo e dove abito ancora adesso, in via Bedogni, era nel 92 quartiere di Rosta Vecchia. Qui c’era il mulino della Rosta che funzionava ad acqua, macinava frumento, diventò poi oleificio, l’oleificio andò male e poi ci costruirono dei condomini. C’erano delle case che erano abitate da povera gente, gente che abitava in condizioni penose, proprio povera gente e via via sono state demolite e ricostruite. Per divertirci andavamo ai baracconi [Luna park, NdR] e ai veglioni, dove si ballava. Andavo a vedere la Reggiana e di quella squadra ricordo il portiere Corazza. Pietranera, che era un gerarca fascista, per aumentare il tifo ci faceva entrare senza pagare. Ricordo un ReggianaParma. La Reggiana perdeva 2 a 0 alla fine del primo tempo. Avevano aperto le porte e lo stadio si era riempito. La Reggiana aveva poi vinto per 3 a 2. Ci mettevamo sempre dietro le porte. Degli amici che frequentavo prima della guerra, ricordo uno che è rimasto sotto le bombe degli aerei che hanno colpito la stazione nel gennaio 1944 e sono morti lui, suo padre e la sorella. Abitavano ai margini della stazione, proprio attaccato. Ci trovavamo sempre a casa sua e ci sarei rimasto anch’io se non mi avessero chiamato alle armi prima. Che cosa ricorda del periodo militare fino all’8 settembre? Venni chiamato alle armi il 5 luglio 1943. Eravamo in forza all’aeroporto di Bologna perché stavano organizzando i primi battaglioni antiparacadutisti. L’8 settembre avevamo da poco fatto il giuramento, cioè avevamo percorso la tappa che riguardava il car, il primo addestramento. Appartenevamo all’aeronautica ma le istruzioni le ricevevamo dalla fanteria. In una mattina del mese di luglio eravamo in circonvallazione a San Giovanni in Persiceto, in riposo. Vediamo sopra di noi una massa di aerei. Nessun allarme. Noi ragazzi li salutavamo con le bustine bianche. Cinque minuti dopo su Bologna ha grandinato. Pensavamo fossero dei nostri. Usava il bombardamento a tappeto. Le bombe cadevano orizzontali e le sganciavano molti chilometri prima facendole planare. Ci fu il 25 luglio che non ci toccò molto. Arrivò l’8 settembre e il 9 avevamo la caserma circondata. Fin dalla mattina ci veniva chiesto chi voleva combattere con loro. Nessuno aderì. Che cosa ricorda dell’8 settembre e del viaggio verso il campo di prigionia? Ci avevano disarmato. Avevamo buttato i fucili e le baionette in un mucchio. La sera del giorno 9 ci avevano incolonnati e a piedi, da San Giovanni in Persiceto, ci avevano condotti fino al Settimo cavalleria a Bologna, di notte. Alle prime luci del giorno siamo arrivati a Porta Saragozza, caserma 10° Lancieri. Rimanemmo dieci giorni e passava di tanto in tanto un frate che ci diceva: «Ragazzi abbiate fede, gli americani sono sbarcati a Cesenatico». Cercava inutilmente di infonderci coraggio. Poi un bel mattino ci svegliarono e, con lo zaino in spalla, ci portarono alla stazione centrale di Bologna, all’Arcoveggio, dove c’era un carro bestiame ad attenderci. Ci caricavano dicendoci: «Salire! 93 Salire!» Terminato l’imbarco, avevano chiuso gli sportelli e ci eravamo trovati in 56 privi di acqua e viveri. Ricordo di aver visto la città di Padova. Non si andò da Bolzano ma da Pontebba e poi da Villach in Austria. Il viaggio era durato 48 ore, il treno ogni tanto si fermava per dei convogli di truppe tedesche in giro. Mi ricordo che avevano aperto le porte e fecero bere e bevvi un litro d’acqua in un fiato. Ci diedero una scatoletta di pesce fatto a Bari, vomitante, quasi un emetico. La fame è brutta ma la sete è peggio, si sentono le budella che si stringono. Eravamo sempre seguiti dalle sentinelle. Un paio sono morti ma non nel nostro vagone. Eravamo arrivati a FallingBostel StammLager dove erano concentrate truppe e reparti da tutto il mondo e noi eravamo gli ultimi. I prigionieri americani avevano il diritto a un pacco di cinque chilogrammi della Croce rossa settimanalmente, mentre noi no, non ci consideravano prigionieri di guerra., ma imi, Internati militari italiani. Noi italiani, come i russi non avevamo niente, nessun aiuto. E quali erano le condizioni igieniche del campo? Dei tanti mezzi di cui i tedeschi disponevano per convincere e costringere gli internati a collaborare, c’era anche l’assoluta mancanza d’igiene, che sarebbe meglio chiamare sporcizia. Una sporcizia che non nacque dalla trascuratezza da parte dei militari per mantenersi puliti, bensì dall’assoluta mancanza di mezzi, anche quelli più comuni ed elementari per evitarla. I tedeschi volevano i pidocchi, le pulci e le cimici. Volevano che i poveri indumenti di cui gli internati disponevano, cadessero a pezzi; che le maglie, le mutande, le calze, le camicie, i pantaloni e le giubbe venissero indossate per settimane, per mesi, senza poter disporre di un ricambio o dei più semplici mezzi per poterli lavare, come acqua e sapone. Tale situazione andò peggiorando con l’andar del tempo. I nostri aguzzini volevano rendere sempre più insopportabile la vita agli internati e spingerli a mettere quella maledetta firma di adesione in calce alle loro richieste e che noi, nonostante tutto, non sottoscrivemmo mai. Come erano le condizioni di vita del campo? Che cosa ricorda delle sentinelle? Al campo lavoravo in fonderia, si facevano turni di dodici ore. C’era il turno di dodici ore di giorno e quello di dodici ore di notte. Mi ammalai di appendicite e mi trasferirono in infermeria, non è che stessi meglio, ma almeno avevo un lenzuolo e non della paglia. Mi aveva operato un chirurgo slavo prigioniero di guerra. Mi avevano messo su un tavolo e come bende usavano la carta igienica. Rimasi in quel campo fino al mese di ottobre. Venni trasferito a Wietzendorf. Le condizioni di vita non erano migliorate, erano tremende. Ci bombardavano gli alleati e per poco non ci lasciavo la pelle. C’erano i problemi della fame e delle botte. Ho visto uno dei nostri soldati obbligato da una sentinella a chinarsi in terra con le ginocchia e doveva tenere un mattone 94 sollevato per ogni mano. Ogni volta che il mattone cadeva il tedesco gli dava un botta sulla schiena con il calcio del fucile, ma non so che colpa avesse avuto. Oppure ti legavano a un palo per ore. C’erano anche i parassiti, pidocchi grossi come piselli e di notte avevamo le cimici, che scendevano solo di notte, per riempirsi di sangue ed erano grosse come scarafaggi. Mangiavamo un mestolo di sbobba al giorno e non si capiva se era sabbia o rape e un filone di pane nero da dividere in sette, fatto di farina di pioppo e altre porcherie. Solo il sabato e la domenica, a Wietzendorf, distribuivano una minestra d’orzo. Gli internati soffrivano molto di questa situazione: i casi di anemia perniciosa, difterite, pleurite, tubercolosi e tifo petecchiale non si contavano. All’aeroporto di Bologna pesavo 67 chili, nel Natale del ’43, dopo tre mesi di cura, ne pesavo 44. A Wietzendorf non si lavorava. Sapevamo di un lager dove in un settore erano tenuti dei bambini con l’ordine di tenerli in vita per uno scambio di prigionieri sennonché, non consapevoli di quel che succedeva, facevano chiasso e cantavano e al Deutsch Führer i bambini davano fastidio perché turbavano il placido sonno digestivo. Fece incolonnare i bambini nel loro grembiule bianco in direzione del cimitero, ma gli innocenti credevano di fare una bella passeggiata in campagna e si avviarono ridendo tenendosi per mano, osservando meravigliati gli alberi, l’azzurro del cielo, gli uccelli. Una bambina si staccò dalla mano della compagna per raccogliere un fiore sul ciglio della strada. Due mitragliatrici li attendevano a una svolta e li sterminarono tutti e settecento. Non si sa da dove venissero. Nonostante tutto non dimenticavamo di essere uomini ed era quello l’importante. Le calorie pro die si aggiravano attorno alle 500, da notare che il fabbisogno giornaliero per un uomo di 70 chilogrammi è di 1600 Calorie. Guareschi prima pesava 89 chilogrammi poi si è ridotto a 45 chilogrammi. Fino alla Liberazione eravamo rimasti lì, a Wietzendorf, siccome erano presenti ufficiali, si facevano corsi di storia e concorsi, come quello di poesia vinto da Porfirio. C’era Gianrico Tedeschi, attore tuttora in voga nonostante i suoi 88 anni. Mancavano le forze per fare attività fisica. Quando venne Guareschi da Benjaminow le cose erano cambiate per la sua verve. Sapevamo chi era Guareschi perché nel ’43 aveva pubblicato il suo primo libro con la casa editrice Rizzoli. Sempre nel ’43 era nata Carlotta, la sua prima figlia. Coppola era un bravo fisarmonicista, un ottimo musicista e Guareschi scriveva favolette e Coppola le musicava. Erano riusciti a costruire una radio che trasmetteva alle baracche spettacolini e varietà tramite un altoparlante di fortuna. In un altro campo c’era radio Caterina costruita dal tenente Martignago e dal sottotenente Oliviero. Oliviero era un ingegnere elettronico e rubando la dinamo di una bici di un sergente tedesco, con pane raffermo e rame era riuscito, non so come, a ricevere fin da Berlino, Bari e Londra. Lui stesso faceva da antenna. Le foto del nostro campo erano fatte da Stefano Vialli, che con sé aveva un rotolo nuovo e fece riprese del campo quando non si vedevano in giro 95 Statua di Giovannino Guareschi in bicicletta – Fontanelle di Roccabianca (PR) tedeschi. La pellicola è stata salvata da un frate che la teneva legata ad una coscia. Lui ha fatto foto anche al campo di SandBostel. Aveva rischiato molto: lo avrebbero sicuramente impiccato. Vialli con quelle foto ha pubblicato anche un album. Dire tutta la vicenda significa dire tutto e dire niente. Significa aver partecipato al più grande caos di popoli e di razze della storia, tra i milioni di vittoriosi e vinti della seconda guerra mondiale fra gli orrori del lavoro nelle miniere, gli spasimi della fame e del freddo, delle malattie e dei parassiti. Il migliore scritto sull’argomento è per me quello del comandante di vascello 96 Gerhard Schreiber, IMI nei campi di concentramento del terzo Reich [Roma 1997]. Grazie a Giovannino Guareschi, Gianrico Tedeschi, Arturo Coppola e molti altri, nessuno di noi restò qual era: e chi non divenne più ipocondriaco, era diventato più buono. Ha perso qualche amico durante la guerra? Ad Hallendorf, campo di prigionia, avevo perso Renato Cappelli, che era aviere. Era un emiliano buono e generoso, un ragazzo di vent’anni. Era nel pieno della giovinezza ma la morte non conosce pietà. L’avevamo portato al cimitero sulla collina. Davanti alla fossa il cappellano giunse le mani in segno di preghiera. La sentinella ordinò l’attenti ed esplose un colpo di fucile verso l’alto. Il cappellano prese, allora, una zolla di terra umida e nera e la depose sulla salma. Calato nella buca i tedeschi si erano ripresi la bara. Un altro mio amico, Giovanni Ferrari, invece è morto sotto un bombardamento mentre lavorava lungo una ferrovia in Germania e una bomba l’aveva preso in pieno. Che cosa ricorda del viaggio di ritorno? Al ritorno viaggiavamo sempre su carri bestiame con i portelloni aperti, però avevamo anche dei viveri. A Mittenwald, ai confini con l’Austria, in una caserma di alpini tedeschi, eravamo rimasti due o tre giorni, un posto bellissimo sulle Alpi dove gli alleati avevano attrezzato un campo per la disinfestazione degli ex-internati, usavano una pistola caricata a polvere ddt. Ci infarinavano i capelli, ascelle e pube per due volte, a distanza di dodici ore. I pidocchi sono rimasti in Germania. Ci lasciarono a dodici chilometri da Verona, vicino a Pescantina, perché i treni non arrivavano fino in stazione. C’erano bus e vetturette destinate a Milano. Per Reggio Emilia c’era un furgone di partigiani di Guastalla e ci avevano condotti lì. Avevano camere con dei letti ma preferimmo tornare subito a casa. Arrivammo a Reggio in piazzetta Sant’Agostino, dove una ragazza prendeva nota di tutti gli arrivi. Ero tornato con Bolognesi, un amico di Canali. Non avevo notizie di casa. Ero andato in via Campo Marzio, da una mia zia. Ci avevano aperto. Ci fecero dormire lì, al mattino eravamo andati verso casa. Mio padre veniva in bici lungo viale Risorgimento, lui poi è andato ad avvisare i genitori del mio amico a Canali. Suo padre era venuto col carretto a prenderlo. Io non riuscii a dormire su un letto per due mesi; ero talmente abituato a dormire sul duro che andavo a dormire sul tavolo in cucina, a letto non riuscivo a stare. Dopo la guerra mi sono messo a lavorare in proprio ed eccomi qui. Guareschi al ritorno non era assieme a me: era partito per l’Italia a settembre. Parliamo dei suoi compagni di prigionia. Vi incontrate ancora? Eravamo tutti amici. Il primo maggio di quest’anno eravamo in quattro dell’ex-campo di Wietzendorf. Si festeggia ogni primo di maggio la nascita di 97 Giovannino Guareschi. Arrigo Bompiani di Bologna di anni 93, Astro Gambari di anni 88, Di Masi Torello, il dottor Carlo Alberto Borsari di anni 88, di Salsomaggiore. Dormivamo in castelli di quattro file, di notte spegnevano le luci nella camerata e c’erano problemi a ritrovare il posto se andavamo in bagno. Ci toccava aspettare l’alba. Oltre a Guareschi e Tedeschi, altri internati meritano un ricordo: Cappelletti, Golzio, Sinopoli e i fratelli Betti che organizzarono giornali parlati e conferenze, costituirono cori e diedero vita a corsi universitari di diritto, sociologia, politica e lingue. Ricordo Novello che diceva: «Io sono ripetente!» Lui era stato capitano degli alpini durante la Grande guerra ed era stato in campo di prigionia austriaco. Abbiamo lasciato in Germania 55.000 morti, gli ammalati di tbc scendevano al Brennero e li conducevano subito al sanatorio. Nei primi quattro mesi abbiamo avuto migliaia di morti perché non sono riusciti a superare il trauma. Il Grande diario di Guareschi è la nostra storia. Lo vedevo scrivere, prendere appunti. Al campo aveva scritto le Favole di Natale. Dopo la Liberazione ci trovavamo tra tutti gli appartenenti alla stessa arma. Diversamente da me, lui era tenente d’artiglieria. Ha più visto Guareschi dopo la guerra? Lui lavorava a Milano. Ci telefonavamo. Io poi lo seguivo sempre attraverso il «Candido». L’avevo visto a Brescello mentre girava il film Don Camillo e a Reggio Emilia quando ebbe il dibattito con il sindaco Bonazzi. Dopo la Liberazione avevamo soprattutto il problema del lavoro. Ai raduni degli ex-internati ho conosciuto i figli. Eravamo più di quaranta, ora siamo rimasti in quattro di cui un novantatreenne. Che cosa ne pensa della manifestazione del centenario di Guareschi? Lui è stato un pacificatore. A noi rincresceva disturbarlo, con tutte le vicende che lo riguardavano, come quella faccenda con De Gasperi. La saga di Don Camillo e Peppone è per me un’opera letteraria di grande rilevanza, mi ricorda De Amicis. I letterati non lo tenevano in considerazione. È necessario scrivere nel modo più semplice possibile perché tutti possano capire e Guareschi ci ha insegnato questo. La manifestazione del centenario, anche per intervento del precedente governo, è riuscita coi fiocchi e le frange. Hanno costruito una bellissima statua di Guareschi in bicicletta. I figli, oggi, hanno un archivio importante. Che cosa mi dice di Natta, suo compagno di prigionia? Sandro Natta era al campo ma non ci ho mai parlato. È rimasto con me fino all’8 febbraio del ’45, poi è stato trasferito. Aveva scritto un libro ma il partito, per i primi sette anni, non glielo aveva fatto pubblicare. Oltre Natta c’era Setti, terzino dell’Ambrosiana. A FallingBostel c’era la nazionale belga al completo 98 ma le prendeva sempre dai nostri che erano tutti buoni giocatori. C’era anche il corridore francese Masson che aveva avuto un permesso per poter uscire in bicicletta e farsi duecento chilometri per tenersi allenato. Fece un po’ di fortuna dopo la guerra. 99 Tre ragazzi uccisi L’eccidio di Gavassa, Reggio Emilia 22-23 aprile 1945 Rodolfo Mattioli* Tre ragazzi uccisi. Alcune questioni preliminari Sulla quantificazione del drappello della Wehrmacht che circondò Casa Marchetti a Gavassa, frazione del forese del comune di Reggio Emilia, ci troviamo di fronte a due testimonianze, entrambe dirette e credibili: una afferma che a circondare la casa fu un nutrito gruppo di soldati. È una testimonianza ragionevole, dal momento che se fossero stati solo cinque o sei non si capisce come mai un numero più o meno uguale di partigiani, forse nascosti nelle vicinanze, se la sia data a gambe, lasciando catturare e poi trucidare alcuni loro compagni. Tuttavia, un testimone diretto, allora poco più che decenne, afferma di aver visto un gruppo, composto da cinque o sei tedeschi con i partigiani ammanettati, muovere per vie traverse. Quindi è possibile che i soldati che circondarono la casa si siano successivamente divisi in due o tre tronconi, onde prevenire spiacevoli sorprese: un’avanguardia, un centro con i prigionieri, e una retroguardia, che marciavano a un centinaio di metri l’uno dall’altra. * Il redattore di queste note, basandosi sulle testimonianze dei genitori, confrontate con quelle di alcuni parenti delle altre vittime e di abitanti della zona, nonché sui dati e con l’assistenza determinante dei ricercatori dell’Istituto Storico della Resistenza (istoreco) di Reggio Emilia, in particolare nella persona di Mario Frigeri, è il nipote per parte di madre di Bruno Spaggiari. In esse non è difficile distinguere ciò che è stato effettivamente appurato, da ciò, che, per forza di cose, si può solo, alquanto approssimativamente, immaginare. 101 L’altra testimonianza afferma che alcuni soldati motorizzati procedettero per la strada e altri a piedi per strade traverse. Inoltre, proprio nei giorni 2223 aprile, sono documentati numerosi scontri tra tedeschi in ritirata e squadre partigiane. Pertanto, la presenza di tedeschi, in drappelli più o meno numerosi che sopraggiungevano a ondate, era ancora consistente. Ci sono, tuttavia, aspetti che continuano a non trovare spiegazioni convincenti. 1) L’efferatezza del crimine. Non pare si trattasse di ss, ma di soldati della Wehrmacht. Certo, dai tedeschi, specie in quei frangenti, ci si poteva aspettare di tutto, tuttavia le modalità dell’esecuzione non sono consuete e fanno pensare che quel «di più» di sadica violenza abbia una motivazione particolare, per quanto non sia stato possibile appurare quale. Si è parlato di un’avanguardia di motociclisti isolati che precedevano il drappello e che alla vista di un gruppo, presumibilmente di partigiani, fecero dietro front per avvertire la squadra che seguiva. È possibile che siano stati bersagliati e anche feriti, magari uno dei due, ucciso. Dal loro punto di vista, i tedeschi in ritirata probabilmente non si capacitavano delle imboscate dei partigiani, dal momento che stavano sgombrando il paese; dall’altra parte, sebbene fosse chiaro che la Germania era ormai vicina alla disfatta, non ci si aspettava un epilogo tanto rapido della guerra. Pertanto, i partigiani ritenevano di dover neutralizzare il maggior numero possibile di tedeschi. Gli scontri sopra accennati e le perdite che certamente avranno causato potrebbero spiegare la inaudita ferocia dei tedeschi. 2) Perché Walter Manzotti, la cui famiglia era anch’essa sfollata da Roncadella nelle vicinanze di Casa Marchetti, non fuggì in mezzo ai campi come, secondo le testimonianze, fecero altri? Conosceva la zona, era giovane, allenato, difficilmente i tedeschi lo avrebbero raggiunto, ammesso che avessero avuto voglia di rincorrerlo col rischio di incappare in qualche imboscata. Comunque, è possibile che avesse un motivo particolare per rifugiarsi a Casa Marchetti, magari per avvertire Bruno Spaggiari e gli altri che c’era un pericolo imminente o che c’era stata una spiata. Mia madre ne accennò a suo tempo, ma l’ipotesi rimase senza una risposta. Se l’accerchiamento non avvenne semplicemente per la volontà di acciuffare Walter Manzotti, resterebbe da spiegare perché i tedeschi presero di mira proprio Casa Marchetti. Avevano, forse, appreso che il fratello maggiore di Bruno Spaggiari, Augusto ricopriva un incarico importante nella 26a Brigata Garibaldi? È possibile, ma è più probabile che in quei momenti si facesse piuttosto quello che capitava. 3) Tutte le testimonianze (indirette), tranne una, riferiscono che non erano solo gli scarponi a emergere dalla fossa, ma anche le teste (fracassate). Ci fu chi disse, addirittura, che fossero staccate dal corpo e poste sopra la fossa a mo’ di macabro trofeo. A proposito degli scarponi di Walter Manzotti, che possono aver fornito ai tedeschi la prova della milizia partigiana dei giovani e del favoreggiamento di Luigi Zinani, è stato fatto presente che il padre di Manzotti, calzolaio, era stato precettato dai tedeschi: questo renderebbe la 102 cosa abbastanza verosimile. Ma perché, allora, i tedeschi si presero la briga di ricoprire parzialmente i cadaveri? Per nascondere il misfatto? Impensabile, dal momento che furono visti condurre via i prigionieri, che il luogo dove vennero custoditi era noto e che furono udite le urla dei torturati. Un’ipotesi, diversa, attribuisce a questa macabra scelta la volontà dei soldati tedeschi di lasciare dietro di sé un monito «esemplare» alla popolazione. Allora, la spiegazione più congruente ritorna ad essere quella di mia madre, confermata da un testimone indiretto, che da ragazzo (aveva, all’epoca dei fatti, superato da poco i dieci anni) raccolse i racconti dei «grandi»: furono sepolti ancora vivi per essere successivamente massacrati a colpi di vanga o di piccone. Non sembra neppure attendibile che le torture avessero lo scopo di far loro confessare nascondigli, nominativi o postazioni partigiane: in quel particolare momento è, perlomeno, dubbio che i tedeschi avessero tempo e modo per andare a caccia di partigiani; se ne incontravano sulla loro strada era un conto, altrimenti c’era anche il rischio che il cacciatore venisse cacciato. È possibile, invece, che le torture (siccome erano udite nelle vicinanze, in particolare dalle donne della casa più prossima, quindi la notizia poteva essersi diffusa) avessero in realtà lo scopo, oltre a quello di sfogare la loro rabbia, di sfidare i partigiani nascostisi nei dintorni. Come a dire, vediamo cosa sapete fare per i vostri compagni, oltre che scappare. Che furono loro inflitte torture, in misura diversa, sembra accertato. Ma che tipo di torture? Si «limitarono» a schiaffi, pugni, calci o li sottoposero a vere e proprie sevizie? Purtroppo, alcuni indizi lasciano supporre che tale limite fu oltrepassato. Una donna, allora staffetta partigiana, riferisce che i fratelli, pure partigiani, videro i cadaveri che presentavano ferite da taglio. Che tipo di ferite? Secondo un testimone indiretto, allora poco più che decenne, le zie, che abitavano in prossimità di Casa Marchetti, hanno udito a lungo durante la notte, loro malgrado, urla strazianti. Un pugno, un calcio, una ferita può certo provocare un urlo, non uno strazio continuato. Tra i tanti, ancora un interrogativo permane: come mai, in un lasso di tempo così lungo – circa 24 ore – in un momento di disgregazione dell’esercito tedesco, nessuna squadra partigiana ha tentato di salvarli? Una squadra, anche esigua, di gente decisa, con una perfetta conoscenza dei luoghi, poteva infliggere gravi danni anche a un numero soverchiante di tedeschi, o perlomeno tentare uno scambio, contrattare il rilascio. I famigliari di due partigiani non sono riusciti a contattare nessuno? Ci s’illuse forse che, alla fine, li avrebbero portati con loro a mo’ di ostaggi e che un’eventuale azione poteva essere differita e tentata successivamente? Nessuna di queste domande può oramai ricevere una soddisfacente risposta. In qualche punto le testimonianze sono risultate discordanti (come del resto i referti della polizia mortuaria, i registri parrocchiali, i dati d’archivio). Perlopiù, concordano sul fatto che sono stati massacrati a colpi di vanga, piccone o simili. Ma i referti presso la polizia mortuaria parlano genericamente di armi 103 da fuoco. A chi dare credito? I referti sono estremamente generici, non dicono quanti colpi hanno subito e neppure in quale parte del corpo, non sono firmati. Chi li ha redatti? Dove? Qual era la prassi in quei convulsi momenti? Non è possibile sapere. Magari qualche funzionario per humana pietas ha preferito redigere un certificato generico. Oppure, ancora, in simili circostanze, a redigerli è stato un funzionario della polizia mortuaria nel suo ufficio, che non ha neppure visto i cadaveri e ha compilato burocraticamente un modulo. Del resto, non sono pochi i casi accertati di analoghe difformità. È mai possibile che la memoria collettiva si sia inventata una tale efferatezza? Per quale oscuro motivo? Che bisogno c’era di aggiungere, a quelli effettivamente perpetrati, altri immaginari? Coloro che videro i cadaveri riferirono della inaudita ferocia del massacro; altri si rifiutarono persino di parlarne, accompagnando il rifiuto con un gesto tristemente eloquente. D’altra parte, almeno per Luigi Zinani, sembra certo che fu colpito con un colpo alla testa, e non è da escludere che anche gli altri siano stati, infine, colpiti per assicurarsi della loro morte o anche per semplice sadismo. È possibile, seppure meno probabile, che il più determinato dei tre, confidando ingenuamente in cuor suo nella vendetta del fratello maggiore, sia stato proprio il ragazzo, Bruno Spaggiari. Potrebbe aver urlato in faccia ai suoi aguzzini: «Vigliacchi! Ve la prendete con gente inerme, ma mio fratello con la sua squadra vi ammazzerà tutti». Oppure, che nei momenti cruciali sia emersa la solidità contadina di Luigi Zinani. O spinti dal dolore e dal terrore e, magari, anche da vaghe promesse si siano accusati l’un l’altro. O, piuttosto che, avendo capito fin dall’inizio qual era la loro sorte, per quanto possibile in simili frangenti, si siano confortati a vicenda. È possibile che l’ordine dell’esecuzione sia stato diverso, anche se sembra verosimile che sia avvenuto in sadica sequenza. Ognuna di queste possibilità non modifica il senso di questo tragico episodio. Chi scrive era a conoscenza del racconto di sua madre da molti anni, ma quello che ha reso farraginoso la ricostruzione della vicenda è stato, forse, proprio la sua reticenza a testimoniare quei fatti nella loro immediatezza. Forse si sarebbe potuto documentare ogni aspetto di questa tragedia. Non si è mai potuto sapere chi fossero i membri di quel drappello, né se abbiano raggiunto la Germania e siano rimasti impuniti o se, invece, abbiano concluso la loro criminale esistenza nel corso di altre vicende belliche. In cuor suo, l’autore, di queste note, si augura che si siano ricongiunti con le loro famiglie, e che ogni notte abbiano sognato quei tre ragazzi, sepolti vivi e massacrati a picconate, con i volti dei loro figli. Il racconto È domenica, sono circa le 10 del mattino. La giornata è limpida. A casa Marchetti, una casa colonica, sulla strada che da Villa Masone porta a Gavassa, a circa un chilometro dalla via Emilia, vivono la famiglia Zinani, che 104 lavora il podere, e la famiglia del mugnaio Guido Spaggiari. Gli Spaggiari, dopo la costituzione della Repubblica sociale nel centro-nord, vi sono sfollati dalla propria abitazione sulla via Emilia, diventata assai pericolosa a causa dei bombardamenti alleati che hanno distrutto o danneggiato varie abitazioni, con morti e feriti. Da poco gli americani hanno sfondato la Linea gotica e i tedeschi hanno dovuto ritirarsi disordinatamente. Nei giorni precedenti le strade erano intasate da colonne di tedeschi in ritirata che si portavano dietro tutto quello che potevano portare dell’armamento, più tutto quello che avevano razziato, animali per il traino e per sfamarsi. Ormai dunque è finita, i tedeschi se ne sono andati o se ne stanno andando. Ma non tutti sono passati. Ci sono i ritardatari, gli sbandati, o forse anche reparti speciali di retroguardia. Improvvisamente nei dintorni di Casa Marchetti le cose precipitano. Alcuni partigiani e non, gli uomini adulti insomma, cercano rifugio in mezzo all’erba alta dei campi. Arriva trafelato Walter Manzotti, classe 1923, partigiano della 76a brigata sap: via via, nascondiamoci c’è un rastrellamento. Lui e Luigi Zinani (1913) si nascondono nel fienile e ritirano la scala a pioli. Ma i tedeschi hanno intravisto la corsa di Manzotti, o, come asserirono altri, hanno notato la scala a pioli mentre veniva ritirata; comunque hanno intuito qualcosa. La casa viene circondata da un gruppo nutrito di soldati. Non sono ss, sono soldati della Wehrmacht. Che cosa succede? I tedeschi non dovrebbero avere una certa premura? Le minacce saranno state le solite: se i «banditi» non si consegnano incendiamo la casa; facciamo kaputt tutti quanti, e simili. Nonostante le suppliche della madre, che gli dice di starsene nascosto, come sta facendo suo padre, chiuso in un armadio, il garzone da barbiere Bruno Spaggiari, classe 1930, staffetta partigiana della 76a brigata sap, scende sotto il porticato (non è certo se prima o dopo l’accerchiamento). A me non faranno niente, risponde con spavalderia giovanile. Ma perché si mostra tanto sicuro? Perché correre un rischio così elevato? Si dice che non bisogna fissare un cane negli occhi, se non si vuole essere aggrediti: Bruno, per quanto giovane, non poteva passare per un innocuo ragazzino (portava già le brache lunghe, alla «zuava» com’era di moda allora; la foto ricordo ce lo mostra come un bel giovanotto; aveva già la ragazza): quale poteva essere allora la fonte della sua (eccessiva) sicurezza? Lui faceva il barbiere; è dunque probabile che i tedeschi, specie quelli che da tempo presidiavano stabilmente la zona, andassero da lui, che ci avessero pure scherzato; forse, durante i mesi dell’occupazione tedesca, si recava a fare i capelli direttamente al comando di zona. Quando la casa è stata circondata, avrà pensato di sfruttare, per sé e per gli altri, le sue buone relazioni con qualche soldato di sua conoscenza? qualcuno a cui magari avevano precedentemente offerto da bere o da mangiare? O forse intendeva semplicemente andare ad aprire bottega, come si usava allora, anche di domenica mattina e alle volte pure nel pomeriggio? Oppure recarsi direttamente, con gli strumenti del mestiere, a casa di qualche numerosa famiglia contadina, 105 M I LUOGHI DEL FATTO Prato Via e llin be Ga Masone C. Marchetti come pure si usava a quei tempi, a raggranellare qualche lira? Aveva con sé un lasciapassare del comando tedesco? Gli hanno trovato qualcosa di compromettente nella borsa degli attrezzi? Purtroppo quella volta non c’erano, o non c’erano solo, i tedeschi che si facevano sbarbare da lui, c’erano anche quelli che scendevano, sconfitti, decimati, dalle montagne. Ma perché i tedeschi si dirigono proprio a Casa Marchetti? Per aver notato Manzotti correre, ammesso che effettivamente l’abbiano notato, o cercavano qualcuno in particolare? Magari, il fratello maggiore di Bruno, Augusto Spaggiari, dapprima Intendente, poi ispettore di btg. con incarico organizzativo della 26a brigata Garibaldi, che tuttavia si trovava ancora in montagna tra i reparti combattenti? Scambiano Bruno per Augusto? Si ventilò l’ipotesi di una spiata. Si trattò di una vendetta? L’ipotesi appare, tuttavia, non confermata. Sembra, invero, che ci fossero stati nelle vicinanze ripetuti scontri e che alcuni partigiani fossero riusciti a riparare proprio nei dintorni. Era Walter Manzotti uno di questi? Fu riconosciuto? Comunque sia, la casa è circondata: catturano Bruno Spaggiari e costringono Manzotti e Zinani a scendere dal fienile sotto minaccia di incendiare tutto, insomma di fare un macello. Forse, Walter Manzotti cerca di salvare il compagno, gli fa cenno di star zitto e scende da solo; oppure scende per primo Luigi Zinani, che, non essendo partigiano, stava nel fienile a fare il suo lavoro; spera così di convincere i tedeschi e di salvare il compagno; i tedeschi però non si lasciano ingannare e continuano a minacciare; magari anche con la lusinga, che, se scendono tutti, non faranno loro alcun male. Il fratello di Luigi Zinani sfugge alla cattura nascosto in un buio sottoscala. Altrettanto il padre di Bruno Spaggiari, nascosto in un armadio. Le donne e i bambini spiano con angoscia dalla finestra della grande cucina. Ma i tedeschi non hanno tempo per fare una perquisizione in piena regola e si «accontentano» dei tre giovani. Poi? Hanno già deciso la loro sorte? O li perquisiscono e trovano loro addosso qualcosa di compromettente, come scarponi in dotazione alla Wehrmacht e pensano che siano il frutto di un’azione partigiana? Fatto sta che li catturano, li ammanettano e li costringono ad andare con loro. Urlano che, se qualcuno tenta di seguirli, ammazzano tutti. Le mamme però non possono rassegnarsi, li seguono per un tratto (o si recano al Casello per un vano tentativo di intercessione), supplicando di lasciarli andare; soprattutto la madre di Bruno Spaggiari, che appunto è solo un ragazzo, non ha nemmeno quindici anni; la madre di Luigi Zinani assicura che il suo figliolo non ha a che fare con la lotta armata, che non si è mai mosso da casa, che bada solo a fare il suo lavoro. I tedeschi le respingono, le minacciano con il mitra, e minacciano di fucilare immediatamente i giovani se non se ne tornano indietro. Magari le rassicurano pure. Li hanno presi solo per farsi insegnare la strada, come ostaggi per prevenire imboscate, per portarli in Ger- 108 mania. Forse hanno detto la stessa cosa anche ai giovani. Non hanno l’aria di scherzare, quando le minacciano con il mitra, le respingono e le gettano violentemente per terra. Forse sono i giovani stessi a rassicurale: perché cercano di illudersi essi stessi, o semplicemente perché vogliono evitare un sacrificio inutile. Così li vedono allontanarsi nel tremolio delle immagini che diventano via via più evanescenti. Probabilmente i tedeschi si dispongono in gruppi per raggiungere il «Casello delle due secchie» dove è previsto il raggruppamento. Alcuni avanti, altri al centro con i prigionieri, altri ancora di retroguardia. Percorrono, per strada e per traverse, circa tre chilometri, fino a Gavassa. È ormai l’una. I tedeschi sono stanchi e affamati. Si fermano al «Casello», dove è previsto il raggruppamento, per riposare, mangiare, decidere il da farsi. Sono carichi d’odio e di paura. Bevono. Riusciranno a raggiungere la Germania? Devono prima raggiungere, poi traversare il Po. Forse, quando hanno abbandonato le postazioni della Linea gotica sull’Alto Appennino, erano assai più numerosi; forse i partigiani, cercando di sbarrare loro la via del ritorno, li hanno decimati. Poi ci saranno quelli che li aspettano ancora al di qua e di là dal Po. Per catturarli, per ucciderli, loro che sono accorsi a combattere a fianco dell’Italia in Libia, in Grecia, in Sicilia. Odio e furore. Si fa notte, una notte d’inferno. Poi, in qualche indicibile modo, arriva anche il mattino. I tedeschi sanno che non possono fermarsi oltre. E intanto cosa farsene dei tre? Mica possono tirarseli dietro in eterno, così, magari, se loro finiscono male, quelli se la cavano. È venuto il momento di regolare i conti. Fuciliamoli e facciamola finita. Ma qualcuno non è d’accordo: no, troppo comodo, no! Vi faccio vedere io come si trattano i questi banditi traditori. Nei casolari vicini ricominciano a sentirsi delle urla strazianti, miste a pianti e a imprecazioni. Forse vogliono far confessare loro qualcosa. Vogliono che denuncino dove sono nascosti gli altri partigiani, dove sono appostate le squadre che li spettano per sbarrare loro la via della ritirata. Ma non ha molto senso. Semmai solo per umiliarli, per mettere alla prova la loro resistenza. I tedeschi non hanno tempo per dar la caccia ai partigiani, ora sono loro ad essere cacciati. No. Deve trattarsi di una pura orgia di efferata violenza. Nella casa più vicina due donne sono costrette ad ascoltare quelle urla disperate che sembrano non finire più. Si tappano le orecchie e corrono di qua e di là chiuse nella loro stanza con le finestre socchiuse, cariche di orrore e di paura. Ma portarsi le mani alle orecchie non serve, sembra quasi che lo strazio aumenti. Ogni tanto abbassano le mani, spiano dalle fessure degli stipiti. Forse finalmente è finita. No, solo una breve tregua e si ricomincia. Guardano dalle fessure. Orrore. I tedeschi non li hanno ancora ammazzati, li costringono a scavarsi la fossa. Distolgono lo sguardo, ma non ce la fanno. Sembra loro di impazzire. Non possono guardare, non possono ascoltare, ma neppure staccare gli occhi, chiudersi gli orecchi. La scena si svolge in lontananza, loro non vedono bene i particolari. Non vedono il sangue misto a pianto che riga i loro volti, non vedono quante volte, colpiti dal calcio del mitra o dalle baionette 109 innestate, cadono a terra supplicando di finirli; non distinguono le invocazioni a Dio e alla mamma, magari anche le imprecazioni di chi li maledice e predice loro l’inesorabile vendetta dei compagni partigiani. Ma perché imporre alle vittime di scavarsi la fossa, visto che, si suppone, dovrebbero avere una certa fretta? Perché non abbandonare i cadaveri così come sono? Forse per nascondere il crimine? Impensabile. I corpi rimarranno parzialmente e sommariamente ricoperti. Ma allora? Una sola spiegazione sembra verosimile: per infliggere loro una preventiva prolungata insostenibile tortura psicologica. Le fosse non sono abbastanza profonde, ma il tempo stringe. Finalmente il martirio è alla fine. Ora gli spareranno una raffica di mitra, loro cadranno dentro e stop. Ma, santo Dio, proprio ora che si preparavano a festeggiare la fine della guerra e la vittoria contro il nazi-fascismo! Cercano di non guardare, aspettano il colpo di grazia. Ora non urlano più. Singhiozzano sommessamente. Qualcuno sente i pantaloni bagnarsi e questo gli procura un breve attimo di sollievo. I tedeschi sghignazzano soddisfatti. Ma perché non si decidono? Maledizione! Proprio ora che si respira finalmente aria di libertà, che le ragazze, come accade in primavera, indossano quei loro abitini leggeri, che ne mettono in evidenza la grazia. Carla, Maria, Simonetta si staranno chiedendo perché ieri non si sono fatti vivi; si sentiranno offese. Quei tre mascalzoni ce la pagheranno, sì, gliela dobbiamo proprio far pagare! Ma i veterani della compagnia hanno un’idea migliore. A forza di botte scaraventano il più determinato, Walter Manzotti, nella fossa, e costringono gli altri due a ricoprirlo, lasciando però fuori la testa. I due si rifiutano, ma una tempesta di violenza si abbatte su di loro. Magari anche promesse: lui è l’unico responsabile); facciamo kaputt solo lui. Walter Manzotti stesso vuol farla finita, li prega di eseguire. Se hanno ancora lacrime per piangere, piangono. Poi è la volta del più giovane, Bruno Spaggiari, e questa volta tocca al contadino Luigi Zinani adempiere all’ingrata mansione. Terminato il «lavoro» Luigi Zinani viene assassinato con un colpo alla tempia. E a lui devono proprio pensare i tedeschi. Ma non tutti hanno la stessa tempra. Qualcuno ha lo stomaco in disordine, dice di doversi allontanare per una urgenza. Altri si guardano intorno a mo’ di sentinelle, il più lontano possibile. Un veterano prende la vanga, la soppesa, è robusta e ben equilibrata. Si dirige quindi sul più giovane, Bruno Spaggiari. Gli appoggia la lama sulla testa, per prendere le misure, come si fa con l’accetta quando si spacca la legna. La alza in alto… il colpo non parte. Magari sbaglia di proposito il primo fendente: il divertimento non può finire così presto. Pietà, grida il compagno, lui non c’entra, prenditela con me, cane rognoso. I tedeschi si scambiano occhiate d’intesa l’un l’altro e ridono: non avere fretta, bandito, noi accontentare te presto. Bruno Spaggiari chiude gli occhi, insacca la testa, per quello che può, come si fa quando ci si aspetta uno scappellotto, ma poi non ce la fa, deve riaprirli, li apre e li richiude, li riapre e di nuovo li richiude: vede degli stivaloni davanti a sé, vede il verde della campagna in una giornata di sole, 110 vede in cielo il disegno di qualche nuvoletta inoffensiva, poi chissà, vede, non vede gli spruzzi di sangue che inondano la terra, gli stivali degli assassini, il volto dei compagni. «Visto come si fa?», dice il veterano agli altri che ridono. Sono ubriachi? Di odio e di paura sicuramente sì. Il secondo deve dimostrare che è bravo quanto e più del primo. Walter Manzotti non impreca, non urla più, trova solo la forza di piangere sommessamente mentre cerca di infilare la faccia nel terriccio, per trovare rifugio nella grande madre Terra. «Partigiano, bandito, traditore! Pensavo che mi sarei divertito di più» gli urla l’assassino nel fendere il colpo. Nella casa vicina le donne si stendono sul letto. È finita, se si può considerare finito un incubo che non può non accompagnarci ancora, e per sempre. Nota personale Non ho conosciuto lo zio Bruno: quando è stato ucciso avevo meno di tre anni. Inoltre, da circa un anno i miei si erano trasferiti a Villaguardia di Como. Mio padre lavorava allora alla Candele Maserati, fabbrica considerata strategica dai tedeschi; perciò era stata dislocata in luogo considerato più protetto e più vicino alla Germania, per sottrarsi alle continue interruzioni della produzione dovute ai bombardamenti alleati. Pertanto non eravamo presenti all’epoca dei fatti, e i miei genitori appresero della tragedia solo al ritorno da Villaguardia, un paio di mesi dopo circa. Io non l’ho conosciuto, ma lui sì. Mi hanno raccontato che, ragazzino dodicenne, faceva la faccia feroce in prossimità della mia nascita e nei miei primi mesi di vita: «gli faccio qui, gli faccio là, ecc.». Ma, poi, quando riteneva di non essere osservato, veniva a coccolarmi e a giocherellare in vario modo per tenermi tranquillo, magari soffiando leggermente nella sua inseparabile tromba. Ho conosciuto invece lo zio Augusto, ma, purtroppo, non mi ha mai parlato della sua militanza partigiana e neppure di questi fatti, né io, ancora purtroppo, l’ho mai interpellato in merito. Nel 1946, aveva avuto un figlio, che aveva chiamato Bruno, come il fratello assassinato. Ma quel nome non gli ha portato fortuna perché, due anni dopo, il poverino è morto di malattia e ora è sepolto nel cimitero di Villa Masone nella stessa tomba dello zio. Augusto Spaggiari è morto a quarant’anni, per infarto, quando io ne avevo circa venti. L’ho conosciuto come un uomo forte e deciso, ma chissà quale tarlo roditore ha accompagnato il resto della sua vita, fino a portarlo alla prematura scomparsa. 111 «Vado al Moro» Documenti e testimonianze a cura di Lorenzo Capitani Con questo titolo, nel maggio dello scorso anno scolastico, si è svolta, al Liceo Scientifico «Aldo Moro» di Reggio Emilia, un’iniziativa che ha inteso ricostruire il contesto storico e politico che portò nel 1978 l’allora 2° Liceo Scientifico a darsi un’intitolazione così significativa, proprio a pochi mesi dal tragico epilogo del rapimento di Aldo Moro. Nell’intitolazione di una scuola c’è sempre qualcosa che merita di essere indagato, poiché il microcosmo che essa rappresenta può spesso illuminare un momento, un passaggio di una vicenda culturale mai del tutto secondario nella storia di una comunità. La chiacchierata di una mattina, con diverse testimonianze di docenti presenti nei momenti decisionali relativi a quella scelta, ha messo in evidenza elementi così interessanti che ci hanno spinto ad una ricostruzione più meditata, che ci piace proporre in questa sede, come piccola riflessione storica su un momento delicato della vita della nostra città. Va detto innanzitutto che si arrivò a quella decisione, nell’ottobre del 1978, dopo una discussione assai vivace del Collegio Docenti, molto diviso al suo interno, con motivazioni politiche e culturali che attraversavano trasversalmente i vari schieramenti. Chi erano quei docenti, che cosa rappresentava quella scuola nella geografia formativa di Reggio, perché tante discussioni e tante opposizioni, come giudicare infine quella scelta oggi a trent’anni di distanza? Ci sembrano domande di un certo interesse, anche per ricavare uno spaccato attendibile dell’origine di un Istituto che da allora ha occupato un posto sempre più rilevante nel sistema scolastico reggiano. In questo numero pubblichiamo due documenti che rappresentano in un 113 certo senso l’origine e la conclusione della storia: la formale richiesta in sede di Consiglio provinciale, da parte di Gustavo Simonelli, a nome della Democrazia cristiana, di intitolare il 2° Liceo Scientifico ad Aldo Moro (seduta del 16 maggio 1978), la comunicazione del presidente Parenti al Consiglio provinciale di una lettera del preside del Liceo con la comunicazione della decisione del Collegio dei professori (seduta del 21 novembre 1978). Pubblichiamo altresì una prima vivace testimonianza di Ugo Pellini, allora giovane insegnante alle prese con un dibattito che si fece presto incandescente. Nel prossimo numero presenteremo altre interviste e testimonianze, con le quali ci ripromettiamo di offrire un quadro più esauriente. Naturalmente chi volesse mettersi in contatto con la redazione per contributi o informazioni sarebbe il benvenuto. Documenti documento 1 Provincia di Reggio Emilia Palazzo Salvador Allende Verbale delle Deliberazioni del Consiglio provinciale Seduta del 16 maggio 1978 Sessione straordinaria [...] oggetto: Comunicazioni: varie ed eventuali: ... Lettera del gruppo DC con richiesta di intitolare una scuola alla memoria dell’on. Moro ... PRESIDENTE: Pur ricordando che abbiamo commemorato la figura dell’On.le Aldo Moro e del barbaro assassinio di cui è stato vittima nella seduta congiunta del Consiglio Provinciale e del Consiglio comunale tenuta nella sala del Tricolore desideriamo ancora ricordare la sua lata [sic] figura e reiterare e riconfermare l’omaggio di tutto il Consiglio Provinciale, di tutti i suoi gruppi ed il proponimento che anche nel nostro Consiglio si abbia a seguire il suo alto insegnamento. 114 A proposito della scomparsa di Aldo Moro diamo comunicazione di una lettera pervenuta dal gruppo democristiano che dice: «Al Signor Presidente, ai signori capigruppo del pci, psi, psdi del Consiglio Provinciale, a nome del gruppo della Democrazia Cristiana della Provincia avanzo formale richiesta di intitolare una scuola della nostra Amministrazione (il 2° Liceo Scientifico) alla memoria dell’On.le Aldo Moro recentemente e tragicamente scomparso. Sarebbe questa la testimonianza più efficace da parte della nostra Amministrazione per onorare lo statista barbaramente trucidato dalle brigate rosse». Chiedo che della presente richiesta [sia] informato il Consiglio Provinciale nella odierna seduta convinto dell’adesione della Giunta e dei gruppi consiliari alla presente proposta porgo rispettosi ossequi. Simonelli Gustavo [...] documento 2 Provincia di Reggio Emilia Palazzo Salvador Allende Verbale delle Deliberazioni del Consiglio provinciale Seduta del 21 novembre 1978 Sessione straordinaria [...] Ho il piacere di dare – inoltre – lettura di una lettera pervenuta dal Preside del Liceo Scientifico II che soddisfa anche la proposta del gruppo democristiano a suo tempo. «Egregio Signor Presidente, ho il piacere di comunicare che il collegio dei professori di questo Liceo nella seduta del 16 ottobre u.s. ha deliberato a maggioranza di accogliere la proposta avanzata dai gruppi consiliari provinciali relativa alla intitolazione del II° Liceo Scientifico all’Onorevole Aldo Moro. Assicuro la S.V. che questa presidenza avvierà per quanto le compete tutte le pratiche necessarie affinché la delibera trovi concreta attuazione nel più breve tempo possibile». [...] 115 Testimonianze Ugo Pellini Il nome del Liceo Moro Nell’autunno del 1978 fu convocato il Collegio dei docenti dell’allora Liceo scientifico 2° di Reggio Emilia, per decidere sul nome da dare a questo Istituto, nato appena tre anni prima da una divisione con il Liceo scientifico «Spallanzani», orami diventato troppo grosso e numeroso. La divisione dei due Licei non era stata né semplice né indolore; si era optato per la scelta personale di ogni singolo docente a partire dall’anzianità di servizio con il risultato che i docenti più anziani avevano optato per lo Spallanzani, quelli più giovani si erano ritrovati tutti nel Secondo Liceo. In realtà alcune scelte personali avevano fatti sì che i docenti di sinistra avessero scelto di stare con i «giovani». Erano i tempi delle grandi «passioni politiche», del «compromesso storico», del «terrorismo» e della forte politicizzazione nella scuola. Da pochi mesi era stato assassinato l’onorevole Aldo Moro e l’Amministrazione provinciale aveva richiesto al Liceo scientifico 2° che la scuola fosse intitolata all’insigne politico democristiano. I docenti di quel collegio erano poco più di una trentina: le classi erano in calo visto che la scuola giovane era poco conosciuta e i reggiani preferivano iscrivere i loro figli al più collaudato «Spallanzani». Come un po’ in tutte le scuole di quel periodo vi erano, sia tra i docenti che tra gli studenti, grossi scontri tra «conservatori di destra» e «rivoluzionari di sinistra»; non mancavano, ma erano meno visibili, i «moderati». In un’aula dell’edificio, allora in via Franchetti, il preside Barozzi, conosciuto in città come esponete dell’ucim (Unione cattolica insegnanti medi), presentò e caldeggiò la proposta della Provincia, naturalmente sottolineando la figura di Aldo Moro e facendo presente l’importanza della scelta che stavamo per fare. Al momento della discussione si scatenò la bagarre: questo nome fu subito contestato da insegnanti noti come extraparlamentari di sinistra, come si diceva allora, che misero in evidenza come fosse prematuro dare un giudizio su un onorevole democristiano, da tempo considerato come esponente di un «regime» e con tanti scheletri nell’armadio. Ricordiamo che al tempo del rapimento di Moro si erano battuti due schieramenti: «il partito della fermezza» che non voleva riconoscere politicamente le br e quello di che voleva che fosse salvata la persona trattando con i terroristi. In campo, anche se molto minoritaria, c’era anche la posizione di che diceva «né con lo Stato, né con le br». A questo punto intervennero con vigore due insegnanti legati al pci (partito comunista italiano) affermando che questa decisione era importante per la democrazia del nostro paese, che tutta la città ci guardava, e che se avessimo risposto negativamente alle richieste della Provincia avremmo fatto il gioco dei brigatisti. A loro diedero man forte anche altri insegnanti legati alla Democra- 116 zia cristiana che sottolinearono l’importanza della democrazia e del massimo sacrificio di uno dei loro massimi esponenti. Era la riproposizione in collegio docenti del compromesso storico. Non del tutto inaspettatamente intervenne a questo punto un docente noto per le sue posizioni conservatrici che espose pacatamente le sue idee: era assurdo dare il nome di un Liceo scientifico ad un personaggio, anche se importante, che non aveva nulla a che fare con la cultura scientifica e suggerì, in alternativa a Moro, il nome di Cartesio. Un’altra insegnante, nota per la sue posizioni «moderate», propose il nome di Giovan Battista Venturi, uno scienziato reggiano conosciuto per le sue scoperte nel campo della fisica. La discussione proseguì però sui binari «politici»; ci fu anche chi polemizzò dicendo che se le br avessero ucciso Berlinguer (segretario del pci) invece che Moro molti non si sarebbero posti il problema di discuterlo ed accettarlo; ci furono altri interventi sul «personaggio Moro»: c’era chi ne sottolineava i pregi e chi i difetti. Alla fine, visti gli scontri anche personali, fu richiesto che la votazione fosse fatta a scrutinio segreto; prevalsero di poco (credo sedici contro quattordici) i favorevoli al nome Moro e dall’anno scolastico successivo il Liceo assunse il nome di Liceo scientifico «Aldo Moro». Sulla base degli interventi è probabile che votarono a favore gli insegnanti legati al pci e alla dc (i sostenitori del compromessi storico) contro quelli legati ai cosiddetti gruppi extraparlamentari di sinistra e gli insegnanti più tradizionalisti o di destra. Io, al mio primo collegio in quella scuola, non intervenni e votai contro. 117 Osvaldo Salvarani «Un socialista weberiano»* Hermes Grappi Siamo qui riuniti sorretti dalla consapevolezza che la memoria è un prezioso patrimonio dei sopravvissuti. Però, sappiamo che questa ricchezza è deperibile perché è esposta non solo alla dialettica del ricordo ma, purtroppo, anche all’amnesia. Oggi, sfortunatamente, i riflettori sono puntati su un’immagine dilatata del presente. Ciò conduce ad una pericolosa svalutazione del passato e di chi è depositario dell’esperienza del passato stesso. È fuor di dubbio che chi non ricorda, non vive! Ecco perché vogliamo ricordare, evocare, il Comandante partigiano Aldo – Osvaldo Salvarani. L’inadeguatezza delle mie parole per assolvimento del compito affidato, la povertà delle locuzioni, non potranno, di certo, annebbiare la sincerità del vostro e del mio autentico sentimento di affetto, di gratitudine e davvero di ammirazione e stima per il caro amico e compagno scomparso. A nome dell’istoreco, vogliamo qui riconfermare la solidarietà e il cordoglio ai famigliari dello scomparso: allo stimato figlio dottor Carlo, ai giovani nipoti Daniele e Anastasia e ai fratelli Sabatini – figli dell’amata sorella. Non ho incontrato Aldo durante la guerra partigiana perché operavo in città *Pubblichiamo il testo che Hermes Grappi ha letto all’assemblea dei soci di istoreco, il 9 maggio scorso, in memoria di Osvaldo Salvarani Aldo 119 nella 76a sap – III Btg, in condizioni davvero non meno rischiose dei partigiani in montagna. Ho, invece, conosciuto Osvaldo immediatamente dopo la liberazione. E particolarmente in questi ultimi cinque lustri, ho avuto la fortuna di avere con esso un’assidua e costante frequentazione in occasione di conviviali, e fecondi, incontri settimanali in compagnia degli straordinari e compianti: Marta Ferrari, Vittorio Cavicchioni, Loris Malaguzzi, Athos Porta ed altri. Ho dunque avuto l’opportunità di poter, d’appresso, apprezzare le qualità etiche, umane ed ideali di Osvaldo Salvarani. Figlio di un socialista prampoliniano – (custode della Cassa di risparmio) Osvaldo Salvarani – allorché costretto dalla funesta guerra di Mussolini – a venticinque anni – con il grado di tenente di fanteria – fu sul fronte grecoalbanese nel 1940-41 e successivamente dopo quattro anni – nel giugno del 1944 – senza alcuna cartolina di precetto – fu tra le formazioni partigiane nella montagna reggiana. 1940-1944. Dalla guerra fascista, alla lotta armata Uno snodo; uno scarto; un mutamento che rappresenta, in modo paradigmatico, l’inevitabile sconfitta del nazi-fascismo e l’inizio di una profonda ed incisiva svolta storica del nostro paese. Dunque una fulminea e straordinaria accelerazione della storia che ha mutato l’esistenza di generazioni. La scelta – che ha attraversato quel presente di Osvaldo – non fu imposta, né obbligata ma libera, coraggiosa (oltreché rischiosa) ancorché non riconducibile ad una precedente militanza clandestina in un partito antifascista. Scelta esclusivamente determinata dai suoi sentimenti democratici liberali e dunque sostanzialmente in coerenza con gli ideali socialisti prampoliniani del padre Dante. Lassù… in montagna – dopo una grave crisi delle formazioni partigiane – a seguito del potente e disastroso rastrellamento tedesco avvenuto nell’estate del 1944, il cln provinciale – precisamente il 5 settembre 1944 – procedette alla costituzione di un Comando unico militare – zona montana – anche per contenere pericolose spinte frazionistiche che si erano manifestate tra le formazioni garibaldine e Fiamme Verdi. A tale scopo, dopo pochi giorni, Osvaldo Salvarani fu nominato capo di stato maggiore del medesimo comando. Il professor Giuseppe Giovanelli, nel suo interessante libro La 284a Brigata Fiamme Verdi, commenta così quella nomina: «Osvaldo Salvarani, un elemento tale che svolgerà per esperienza militare e onestà personale un ruolo equilibratore e legalitario». Qui, in guisa icastica, sono giustamente riconosciute qualità che accompagneranno costantemente tutta la vita e l’attività pubblica, amministrativa e professionale di Osvaldo – svolta con particolare discrezione. 120 Nei confronti dei fatti delittuosi, accaduti nella nostra provincia, immediatamente dopo la Liberazione, per responsabilità di partigiani, Osvaldo Salvarani, nel silenzio di molti, il 7 ottobre 1945, sull’organo dell’anpi «Volontario della libertà», ebbe il coraggio di condannare duramente i responsabili degli omicidi scrivendo tra l’altro: «Altri partigiani hanno dunque disonorato il nostro nome, insozzando ed infangando la memoria dei compagni caduti»… e proseguendo… «Contro coloro che sbagliarono e commisero violenze e rapine si prendano provvedimenti energici, si consegnino alla giustizia e si rendano di pubblica ragione». Ottobre 1945. Quanta preveggenza e attualità! Vi è qui singolare e straordinario esempio dell’autenticità della lotta partigiana, dell’onestà di un suo bravo comandante. Vi è qui una bella testimonianza di un antifascista democratico, inflessibile, severo nemico di ogni illegalità. Immediatamente dopo la Liberazione, a seguito dell’insistenza dell’indimenticabile sindaco di Reggio, Campioli, Osvaldo assunse la responsabilità di assessore alle Imposte tributi al Comune e, alle prime elezioni amministrative libere, si presentò nella lista di sinistra come indipendente. Nello stesso periodo, Osvaldo inizia il suo impegno professionale nel movimento cooperativo reggiano come direttore della Federcoop, successivamente direttore amministrativo del Consorzio cooperativo ferrovie reggiane, poi direttore della Banca cooperativa popolare di Reggio, indi presidente della stessa. Per il suo prestigio professionale e serietà fu pure chiamato da aziende private a svolgere la funzione di sindaco revisore. In breve; nella sua lunga, capace e stimata vita professionale, Osvaldo, non si staccò mai dal suo totale servizio per le strutture pubbliche e cooperative, proseguendo il suo impegno ed interesse per l’anpi e l’istoreco. Questa fu la sua cifra etica. È la stessa del figlio: apprezzato dottor Carlo. Non può sfuggire che nelle scelte del padre Osvaldo e nel figlio Carlo vi è il segno del weberiano principio dell’«etica della responsabilità». È fuor di dubbio che la comunità reggiana deve molto a Osvaldo Salvarani; esemplare patriota antifascista a tutto tondo. Opportuno e doveroso dunque il proposito della giunta di Reggio di consacrargli una via. Pure, bene ha fatto Massimo Storchi a dedicargli l’ultima sua pregevole opera: Il sangue dei vincitori. Osvaldo ci ha lasciato una preziosa eredità. Questo tesoro è la ricchezza del nostro presente. Noi vogliamo costruirlo con affetto e riconoscenza. Ci conforta ricordare la straordinaria lucidità mentale di Osvaldo mantenuta sino all’ultimo istante. Ciò non gli ha mai fatto apparire la vecchiaia più ingrata della morte, almeno sino alla scomparsa dell’amata consorte: Caterina Bertolini. Osvaldo era ben cosciente e amareggiato perché viviamo in epoca galleg- 121 giante, ondeggiante, povera di punti saldi di riferimento e solidi ancoraggi. Malauguratamente viviamo in un paese impaurito, diviso, chiuso in se stesso e pervaso da un’indecente tolleranza morale e di colpevole indulgenza nei confronti di molte insulsaggini. Viviamo in un paese sommerso da insopportabili anomalie e schiacciato da un colossale conflitto di interessi. Vi è chi tenta di distruggere il nostro passato: la Resistenza, l’antifascismo persino il Risorgimento. Davvero tentano di rubarci la verità, e anche con becero populismo, deturpare i nostri valori umani. Ma non ci riusciranno perché i nostri ideali, i nostri valori, la nostra storia ha saputo dare all’Italia uomini come Osvaldo Salvarani e Ermanno Dossetti, dai quali abbiamo ricevuto e conserviamo un nobile testimone. 122 Autunno 1944 – Il Comando unico delle formazioni partigiane reggiane. Osvaldo Salvarani Aldo è il secondo da sinistra Didattica Intervistiamo… la nostra storia I Ragazzi di Vezzano* Matthias Durchfeld Il film Ragazzi di Vezzano è il titolo di un breve film documentario, realizzato da istoreco in collaborazione con la classe 3aB della scuola media «Angelo Manini» ed il comune di Vezzano, nell’ambito del progetto di storia contemporanea «Intervistiamo... la nostra storia», svoltosi nella primavera 2008. La trama Tramite interviste a tre protagonisti/testimoni, gli studenti raccontano la storia del gruppo antifascista di Vezzano «Soccorso Rosso», dei numerosi arresti fino alla fuga collettiva dal carcere di Reggio Emilia, il San Tommaso, il 15 ottobre 1944. Dall’ottobre 1943, alcuni gruppi di ragazzi raccoglievano contributi destinati alle famiglie dei prigionieri politici ed ai primi partigiani. Inoltre si riunivano per leggere la stampa clandestina antifascista. Ma l’Ufficio politico investigativo (upi) della gnr (Guardia nazionale repubblicana) era riuscita ad infiltrare un informatore, loro compaesano, nel gruppo. E così, nell’aprile *Ragazzi di Vezzano, 2008, regia Nico Guidetti, istoreco 2008, è disponibile presso il Comune di Vezzano e presso Istoreco. 125 1944, i ragazzi antifascisti del «Soccorso Rosso» di Vezzano sul Crostolo venivano quasi tutti arrestati. Le percosse, le fucilazioni per rappresaglia e le minacce di essere deportati in Germania portarono i componenti del gruppo a tentare, una volta passati dal carcere dei Servi a quello di San Tommaso, un’evasione collettiva. Dopo il fortunato esito del loro piano, tanti dei ragazzi di Vezzano raggiunsero le formazioni partigiane operanti in montagna. È l’unica fuga di gruppo riuscita di cui si abbia memoria. Il progetto 2008 A tutt’oggi, solo un articolo di Guerrino Franzini, comparso sul numero 7-8 di «RS-Ricerche Storiche» nel lontano 1969, raccontava dell’evasione dei detenuti antifascisti dal carcere di San Tommaso. Un storia praticamente dimenticata. Era il momento giusto, quindi, per riscoprirla e documentarla con i nuovi mezzi di comunicazione, rendendela fruibile alle generazioni di oggi. La storia dei Ragazzi di Vezzano, per la sua particolarità e ricchezza di dettagli, ha consentito di costruire sia un percorso storico-didattico sia un percorso storico-culturale, che andrà ad arricchire non solo le «esperienze didattiche» della Media di Vezzano ma anche l’archivio del Comune, a futura memoria. Ripercorriamo gli aspetti più importanti della storia su cui è stato costruito il progetto didattico: •I prigionieri vezzanesi vennero arrestati esclusivamente per reati di opinione. Gli studenti hanno potuto rendersi conto delle ingiustizie che furono commesse durante il periodo della dittatura fascista e della guerra anche nel territorio di Vezzano e dei sacrifici che la generazione dei loro nonni, se non addirittura dei bisnonni, ha dovuto affrontare per porre le basi di una società più giusta e democratica. •Gli studenti hanno avuto l’opportunità di affrontare i temi quali «il tradimento», «il carcere», «la tortura». Si sono misurati, poi, su questioni delicate e complesse quali il «coraggio di non piegarsi», «la forza della solidarietà» e con i protagonisti/testimoni hanno condiviso la gioia della Liberazione. •I prigionieri vezzanesi conobbero in carcere il partigiano Natale Romagnoli, personaggio centrale del progetto scolastico con istoreco nel 2007. Per gli studenti esisteva, quindi, un contesto storico conosciuto e una continuità didattico-educativa. •Il Comune ha potuto cogliere l’occasione di produrre delle videointerviste di alta qualità professionale per il proprio archivio. Oggi, quindi, è in pos- 126 I testimoni ad una finestra del carcere San Tommaso sesso di nuovi documenti per lo studio della storia e della memoria della persecuzione fascista a Vezzano e dei vezzanesi che aderito al movimento partigiano reggiano. •Il Comune ha prodotto un film documentario in collaborazione con i protagonisti e nei luoghi storici. La realizzazione Dopo alcune lezioni di introduzione storica e programmazione delle interviste, gli studenti hanno svolto piccole ricerche all’Archivio comunale e nel Polo archivistico-istoreco. Successivamente si è passato alle tre videointerviste con i protagonisti/testimoni. L’impegno della professoressa Bruna Lolli, la pazienza del videomaker Nico Guidetti e la piacevole naturalezza degli intervistati ne hanno fatto per gli studenti delle lezioni di storia davvero particolari. Sicuramente ha giocato a favore dell’attenzione degli studenti la possibilità di accedere alla storia, quella «seria», tramite il racconto di un atto di disobbedienza, con aspetti avventurosi come la fuga da un carcere. La stessa motivazione ha funzionato anche durante la visita, insieme ai protagonisti/testimoni, all’ex-carcere di San Tommaso, luogo della loro detenzione e della fuga. I problemi Rimane sempre difficile accordare i tempi della scuola con le necessità di un progetto che coinvolge un alto numero di persone esterne. Questa complessità, d’altronde, è uno dei punti a favore dello stesso progetto, possibile solo con persone che non si arrendano alla routine scolastica. Altro problema è stato quello della «timidezza» degli studenti. Davanti alla telecamera accesa, diveniva difficile convincerli a partecipare attivamente alle interviste. Questa difficoltà crediamo non sia da risolvere a tutti i costi, ma semplicemente da tenere in considerazione, agendo a piccoli passi, senza imposizioni o forzature. I risultati Oltre all’obiettivo principale dello studio del ’900, sono stati raggiunti diversi altri risultati: •Gli studenti hanno conosciuto il luogo dell’archivio e si sono avvicinati alla storia orale, al lavoro con i testimoni. 128 •Hanno prodotto materiale documentaristico e partecipato alla costruzione di uno strumento complesso come un vero e proprio film. •Hanno scoperto il fascino e la forza del «fare» in prima persona, piuttosto che consumare passivamente del materiale storico confezionato da altri. •Sì è, infine, sperimentato l’incontro intergenerazionale. A testimonianza del successo di tale dialogo, il 23 giugno 2008, vi è stato un evento pubblico a conclusione del progetto. Alla proiezione del film erano presenti tutti: i «ragazzi» di ieri e quelli di oggi. Accanto a loro un’ampia parte della cittadinanza, il sindaco, Paolo Pagnozzi, e la presidente della Provincia, Sonia Masani. Raramente, possiamo dire con soddisfazione, si è notata una presenza così numerosa di studenti e genitori durante l’annuale commemorazione della strage della Bettola. Generazioni a confronto 129 Il Muro dei nomi – 76.000 ebrei, di cui 11.000 bambini, deportati dalla Francia dai nazisti con la collaborazione del governo di Vichy Come insegnare la storia della Shoah1? Una riflessione sul contenuto, sul metodo e sulla formazione dei formatori Alessandra Fontanesi Una grande opportunità, personale e professionale, quella che mi si è presentata il maggio scorso: poter inoltrare la candidatura per frequentare il corso di formazione universitaria, per docenti in ruolo francesi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, presso il Mémorial de la Shoah di Parigi. Un’occasione fornitami da uno dei maggiori storici contemporanei, e maestro di umanità, Georges Bensoussan: responsabile scientifico della Revue de l’Histoire de la Shoah. Il corso che si è svolto a Parigi dal 6 al 12 luglio 2008, ovviamente in lingua francese, nasce con la finalità di dotare i docenti di lettere, storia, geografia e filosofia dell’«attrezzatura» culturale, storica e didattica per poter affrontare nel modo più opportuno l’insegnamento della Shoah, il genocidio del popolo ebraico, nelle scuole di ogni ordine e grado. Poiché in Francia, sia l’insegnamento del secondo conflitto mondiale sia quello della Shoah (così come in letteratura i testi di Primo Levi), fanno parte dei curricoli delle classi terminali e intermedie dei vari ordini di scuola. Una grande opportunità è stata anche quella di potermi confrontare con i colleghi francesi, scambiare opinioni sui rispettivi sistemi scolastici e sulle esperienze svolte su questo preciso argomento: l’impressione ricevuta è largamente positiva. I professori con cui mi sono trovata più in stretto contatto 131 si sono rivelati per preparazione, motivazione e qualità dei progetti sull’insegnamento della Shoah già realizzati – compresa l’organizzazione di un viaggio della memoria ad Auschwitz con i propri ragazzi – decisamente qualificati. Non ultima nota a favore del sistema educativo d’Oltralpe: l’età media dei corsisti era fra i trenta e i trentacinque anni, fra cui docenti venticinquenni neoimmessi in ruolo. Venendo alla struttura del corso parigino, si può affermare senza dubbio che sia stato rilevante per qualità e tipologia degli interventi dei relatori: oltre a Bensoussan stesso, Henry Rousso, Denis Peschanski, Katy Hazan e Joël Kotek fra gli altri per un totale di quarantasette ore di docenza comprese le visite al Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme2, la visita guidata all’esposizione permanente del Mémorial de la Shoah, e quella al campo di concentramento di Drancy3, nella banlieue parigina, «anticamera della morte» per migliaia di deportati ebrei dalla Francia ai campi di sterminio situati nella Polonia occupata. La natura del corso prevedeva di mettere a conoscenza l’insegnante della metodologia dell’insegnamento della Shoah a 360°: quindi durante l’Université d’été abbiamo avuto la chance di incontrare e parlare con alcuni sopravvissuti delle persecuzioni antisemite durante il secondo conflitto mondiale e, alcuni di loro, reduci dai campi. Donne e uomini, un tempo bambini perseguitati, che ormai da molti anni svolgono il loro «lavoro» testimoniale: Ida Grinspan, Henri Borlant e Larissa Cain. Le sessioni di studio sono state poi magistralmente coordinate e condotte da Philippe Boukara e, dal responsabile della Formazione docenti del Mémorial de la Shoah, Iannis Roder, docente di storia e geografia in una scuola «media» (collège) della periferia parigina. Perché insegnare la Shoah: questioni di metodo e contenuto Perché un corso universitario sull’insegnamento della Shoah? Per i francesi, dal punto di vista della costruzione della memoria nazionale e della ricerca storica, la «scoperta» della Shoah come evento storico che colpisce – nella terra dei diritti dell’uomo – cittadini francesi considerati ebrei da leggi dello Stato di Vichy e cittadini stranieri risiedenti su suolo francese sempre considerati di «razza» ebraica per le ragioni di cui sopra, diventa oggetto storico a partire dagli anni ’80. Per una serie di coincidenze internazionali e per il processo a Klaus Barbie a Lione4, fortemente mediatizzato, e che conduce nelle case di tutti i francesi le storie di uomini, donne e bambini perseguitati e uccisi in quanto ebrei. Da lì la «scoperta» di un’altra memoria e un’altra storia, oltre a quella cristallizzata e reificata della Résistance, e di un’altra deportazione: quella che andava alla ricerca di uomini, donne e bambini per «eliminarli dalla faccia della terra» in quanto nemici tout court per il semplice fatto di essere nati, e non per aver commesso presunti crimini. Dagli anni ’90 a oggi, un lavoro lungo, 132 Il campo di concentramento di Drancy, alle porte di Parigi, anticamera della morte del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau travagliato e coraggioso, ha coinvolto oltre che storici dell’età contemporanea, anche la République – lo Stato francese – che ha infine posto rimedio ai molti anni di oblio nei confronti della Shoah, ammettendo anche la complicità del «cosiddetto» governo dello Stato francese di Vichy nella persecuzione degli ebrei. Lavoro non privo di scogli che ha portato, per ciò che concerne l’educazione dei futuri cittadini francesi, all’inserimento dell’insegnamento della storia della Shoah nei programmi scolastici, con consigliabile visita sui luoghi di memoria; un insegnamento che non sia solo un approfondimento del periodo del secondo conflitto mondiale. Da qui nasce ovviamente l’idea di saper insegnare la «catastrofe» del popolo ebraico in modo adeguato. Perché insegnare la Shoah instancabilmente? Perché a volte «privilegiarla»? In questo momento di hypermnésie della memoria della Shoah, come l’ha chiamata Bensoussan, ossia di esaltazione della memoria del genocidio del popolo ebraico, c’è ancora bisogno di insegnarlo? Risposta: sì, ma ciò che emerge dal messaggio acquisito all’Université d’été è soprattutto la necessità di studiarla bene, e quindi di insegnarla altrettanto bene. Scientificamente. Ragionando per comparazione non posso che riferirmi qui al panorama italiano dove, quasi in antitesi al «modello» francese, la scientificità e il lavoro 133 storiografico – non solo in riferimento all’ambito specifico della Shoah – lasciano spesso il posto alla sovraesposizione memoriale e quindi, emotivaemozionale, di ciò che è stato il genocidio degli ebrei. In Italia, a partire dagli anni ’90, e nel corso del decennio successivo5, si assiste alla grande esplosione dell’insegnamento della Shoah fortemente legata all’esperienza del racconto del testimone, alla presa di parola di chi ha vissuto sulla propria pelle gli eventi. E oggi, lo studio delle fonti e/o delle maggiori ricerche riguardanti il tentativo quasi riuscito di distruzione degli ebrei d’Europa, è marginale per chi sceglie di affrontare il tema in classe. È vero, parafrasando la direttrice dell’Istituto di Rimini, Laura Fontana, che da anni si batte per affrontare il tema con uno studio serio e metodico delle fonti, che c’è dell’approssimazione6. In Italia si pensa ormai troppo spesso di risolvere lo studio della Shoah con un «pellegrinaggio» nei luoghi (che sono sempre e quasi solo Auschwitz, inserendo a volte la visita del campo come una tappa mordi e fuggi all’interno di una gita scolastica) o con l’emozione suscitata dall’ascolto della testimonianza, senza contestualizzazione. È vero anche che, nelle rete degli Istituti, rare sono le esperienze approssimative. Tuttavia credo che, per superare l’impasse, il metodo francese di formare il formatore, avendo tutti i presupposti di sostegno statale che servono – insegnamento della Shoah nei programmi, riconoscimento della formazione docenti, valorizzazione di progetti didattici – sia la strada da seguire. Non da ultima rimane la questione: perché insegnare la Shoah? Perché, e ritorno ai riferimenti francesi citando ancora una volta Bensoussan, è un crimine commesso contro ogni essere umano e non solo contro il popolo ebraico7. Basterebbe questo per mettersi al lavoro. Perché si tratta di un genocidio. E si tratta di genocidio, lo sappiamo bene, quando si vuole eliminare un popolo dalla faccia della terra uccidendo anche la sua progenie – i bambini – e coloro che assicurano la discendenza, le donne. Entrare nella specificità del crimine commesso dai nazisti, e dai collaboratori fascisti, significa che la storia del genocidio non deve essere banalizzata ma esaminata nelle sue cause e radici, messa in contesto. La storia del genocidio del popolo ebraico può essere paragonata, ponendo i giusti termini di paragone: se ne dimostreranno in questo modo la vastità del crimine commesso, l’unicità dei milioni di vite umane perse e il fatto che i nazisti – e tutti i loro collaboratori – siano riusciti nel loro tentativo di cancellare un popolo, una cultura, delle usanze, delle credenze, dei saperi nell’Europa del XX secolo. Ancora sul metodo Affrontati i motivi per cui è consigliabile che i futuri cittadini acquisiscano la «lezione» proveniente dall’evento storico in questione, acquisito che sopra ogni cosa vale la precisione e la conoscenza delle fonti – ma questo per ogni periodo a cui ci avviciniamo – resta ancora qualcosa da dire sul metodo e sulle 134 motivazioni all’insegnamento. Il metodo. Rincuora aver ritrovato le strategie di approccio che anche istoreco, mutatis mutandis, utilizza nelle proposte didattiche: dalle lezioni, alle proposte didattiche sino al più ampio progetto di Viaggio della Memoria annuale, lo sforzo è sempre stato quello di lavorare intrecciando più livelli: storia, memoria, territorio. Dalle specifiche proposte di lavoro della Université d’été da svolgersi con i ragazzi, escono suggerimenti preziosi. Decostruire i pregiudizi: un assunto di base e un metodo per procedere. Qualsiasi siano le proposte didattiche che si vogliono svolgere con gli alunni, si deve tener conto del contesto di insegnamento – della classe – partendo proprio dalle domande «scomode» degli alunni. Quelle domande basate sul pregiudizio antiebraico che ormai non serpeggiano più tra i banchi ma sono spesso esplicitate; affermazioni che il docente deve essere in grado di smontare proprio grazie alla buona preparazione sull’argomento. Certo, oggi nelle classi francesi affermazioni che poggiano su pregiudizi antisemiti sono più frequenti che nelle classi italiane, tuttavia può capitare anche qui, e occorre gestire la situazione approfondendo proprio la storia di quel cliché. Non passando oltre. Uno dei cliché più ricorrenti è: «Perché gli ebrei non hanno fatto nulla, perché si sono lasciati massacrare?». Per smontarlo occorre analizzare il concetto di «vittima», definizione utilizzata oggi in modo troppo diffuso e trasversale; si pensi nuovamente al caso italiano in cui l’uso politico della storia del secondo conflitto mondiale inserisce tutti (fascisti, resistenti e perseguitati) in questa salvifica definizione. In secondo luogo. Gli ebrei non sono tutti vittime e non lo sono sempre stati storicamente; insegnando la loro storia e la loro cultura – che non coincidono metonimicamente con la storia della Shoah – questo è evidente: quella del popolo ebraico è una storia di persecuzioni secolari ma anche di resistenze e aggressioni sin dai tempi antichi. Esemplificando: per smontare il cliché ebreo-vittima, nel periodo storico che abbiamo preso in considerazione, basterebbe parlare delle varie forme di resistenza attuate in condizioni estreme durante le varie fasi di persecuzione all’Est: dal ghetto di Varsavia al centro di sterminio di Sobibor, fino alla rivolta dei Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau che il 4 ottobre del ’44 fecero esplodere il complesso di camera a gas e crematorio n. IV. Tornando alle proposte di lavoro: si è già detto sopra quanto l’intreccio storia/scientificità, memoria e luoghi sia capitale anche nell’insegnamento della Shoah appreso al Mémorial. Con alcune specificità: non mi soffermerò sulla bibliografia consigliata di cui troverete ampi riferimenti sul sito del Mémorial, preferisco approfondire l’approccio ai luoghi e l’uso della testimonianza. Partendo da quest’ultima, l’indicazione è netta: che sia «un buon testimone», una voce che racconti la propria storia – e solo quella – e ci accompagni nei suoi ricordi. Noi insegnanti dovremo preparare prima i ragazzi all’ascolto di una testimonianza, con un’adeguata contestualizzazione storica; saremo sempre 135 noi a dipanare i ricordi che a volte distorceranno la realtà storica, perché la memoria è viva e in continua mutazione. Noi, ancora una volta, avremo il compito difficile di incanalare l’emozione scatenata dalla testimonianza in una motivazione allo studio, in seguito più distaccato, dei fatti. Perché alle emozioni si colleghino fatti storici ben precisi. Altro consiglio fondamentale: partire dalla storia e non dalla memoria, partire dai documenti e arrivare poi alle fonti orali. E cercare di essere il più distaccati possibile nell’affrontare la storia della Shoah proprio per non lasciare adito e non indugiare in pietismi dannosi o, peggio, in spettacolarizzazioni del dolore che banalizzerebbero il fatto storico. Ricordiamoci spesso che stiamo facendo storia. Sui luoghi. Visite auspicabili e non imprescindibili; viaggi sul luogo sempre all’interno del «fare storia» e non vissuti come un pellegrinaggio catartico. I luoghi dove gli eventi si sono svolti: saranno da decriptare, a volte da leggere ex novo perché immersi nell’oblio, a volte segnati da stratificazioni di memorie. Sui luoghi con i documenti, con le fotografie (quando esistono), a volte con il racconto del testimone che si intreccia alla narrazione storica sempre in primo piano e che è il fil rouge per i nostri studenti. Le microstorie. Un altro approccio didattico consigliato è quello di riutilizzare le microstorie di deportazione attraverso una serie di strategie laboratoriali da realizzare in classe. Metodo conosciuto e utilizzato ma che, rispetto all’insegnamento della storia della Shoah, è particolarmente importante a causa del tentativo dell’ideologia nazista (spesso raggiunto nei campi8) di disumanizzare «l’ebreo». Restituire quindi un nome, un volto, ricostruire un percorso, il numero di convoglio, ritrovare gli ultimi documenti o biglietti scritti dal deportato prima della partenza nel vagone bestiame, tutta questa analisi ha lo scopo di smontare le grandi cifre e renderle umane. Poiché i sei milioni di persone assassinate durante la Shoah sono uno+uno+uno… sino a sei milioni, sino a restituire cioè dignità a un essere umano deportato per la sola colpa di essere nato. In conclusione Capiamo bene in questo contesto quanto sia rilevante il ruolo del docente. Quanto sia rilevante la sua preparazione, la sua attenzione ai percorsi e alle strategie che deve essere in grado di elaborare e mettere in atto. Questa consapevolezza nata durante l’Université d’été al Mémorial de la Shoah di Parigi, mi pare, in prospettiva, fondamentale: la centralità della formazione del docente. Concetto estendibile a ogni ambito di insegnamento, eppure così poco centrale nel discorso educativo nazionale. Diciamo la verità: vedendo il ruolo a cui è stata relegata la scuola italiana dalla metà degli anni ’90 a oggi, non è possibile essere troppo ottimisti per il futuro. Tuttavia, lo sforzo di rendere più autonomi i docenti attraverso l’aggiorna- 136 mento prima e la formazione poi, e meno «appoggiati» a un esperto del settore, è sempre stato l’intento che muoveva e muove la rete degli Istituti storici. E su questo, la volontà di indietreggiare non c’è: se il Ministero confermerà le risorse (comandi) anche per gli anni a venire, le proposte formative di istoreco per i docenti, sui temi della Shoah e più in generale sulla storia ’900 e l’educazione alla cittadinanza, non potranno che rivestire il ruolo fondamentale che già hanno nella programmazione delle attività dell’Istituto. Il fine a cui tendere è un insegnante autonomo nelle conoscenze che utilizzi l’istituzione storica come risorsa e non come «stampella». Una bella scommessa. L’unicum e l’humus Vorrei ritornare su un concetto già precedentemente espresso e che prendeva spunto da una frase di Bensoussan: la Shoah è un crimine diretto contro ogni essere umano e non solo contro il popolo ebraico. Frase, quest’ultima, che mi permetterei di modificare in questo modo: la Shoah è, ad oggi, il crimine più efferato commesso contro l’umanità. Ed è allo stesso tempo, sempre parafrasando lo storico francese, un avvenimento senza precedenti, ma non senza radici. Un unicum che ha delle spiegazioni: ideologiche, storiche, sociali. Chi vuole intraprendere la strada dell’insegnamento di questa storia sa che deve mettere in grado i propri alunni di andare ad indagare quelle radici, di ritrovarle nella storia europea del pregiudizio antigiudaico9, humus del moderno antisemitismo e delle scienze biologiche inneggianti al bio potere e alla eugenetica della fine del XIX e inizio XX secolo. Deve essere consapevole che non potrà più limitarsi a inserire una videocassetta o risolvere la Storia con una Testimonianza, sa infine che il solo «andare ad Auschwitz» non vaccina contro il razzismo. Poiché sono i presupposti del «disastro» da esaminare: la spiegazione dei meccanismi antidemocratici sottesi alle ideologie naziste e fasciste, la base del consenso nazista, le ragioni del fatto che il crimine più efferato commesso da esseri umani verso loro simili sia stato realizzato non da barbari ma dalla nazione più civilizzata e tecnologicamente avanzata dell’Europa in quel momento. Spiegare, analizzare, studiare, comparare in un esercizio metodico e critico senza fine. Provare a rendere consapevoli noi stessi, e i nostri studenti, di quel crimine forse può renderci cittadini migliori. Le Mémorial, c’est quoi? Il Mémorial de la Shoah, Musée et Centre de Documentation Juive Contemporaine è un museo, memoriale e archivio sulla storia delle persecuzioni antisemite in Francia nel periodo 1940-44. La storia del centro di studio, divulgazione e didattica della Shoah a oggi più importante in Europa, è complessa. 137 Il Mémorial de la Shoah, visto dall’aula didattica, la vetrata è composta da stelle di David La composita struttura attuale (museo-memoriale-centro documentazione) è figlia di periodi storici diversi. Il cdjc: il Centro di documentazione ebraica contemporanea è creato a Grenoble, ovvero in zona di occupazione italiana prima dell’8 settembre ’43, per «raccogliere le prove della persecuzione degli ebrei al fine di testimoniare e di chiedere giustizia alla fine della guerra»10. Nonostante l’occupazione nazista, le persecuzioni e deportazioni, alla fine del conflitto i responsabili del cdjc, aiutati anche dalla Resistenza francese e dopo essersi trasferiti nella capitale, riusciranno a raccogliere numerosi e rilevanti archivi dei carnefici: le carte del Commissariato generale per gli Affari ebraici di Parigi, quello dell’ambasciata e dello Stato maggiore tedeschi, della Delegazione generale del governo di Vichy a Parigi e le carte fondamentali dell’Ufficio antiebraico della Gestapo. Il lavoro di ricerca, riordino e pubblicazione inizia dopo la guerra, animato – fra gli altri – da Léon Poliakof e dal fondatore del cdjc Isaac Schneersohn. Il Centro di documentazione sarà consultato poi durante i procedimenti contro imputati nazisti a Norimberga e in altri processi in Germania, Francia e in quello contro Eichmann in Israele, nel 1960. Nel 1980 il cdjc fornirà alla giustizia francese il documento (il famoso «telex d’Izieu») che permette di procedere all’incriminazione di Klaus Barbie durante il processo di Lione, documento che consentì la condanna all’ergastolo del capo della Gestapo lionese per crimini contro l’umanità. Oggi gli archivi sono consultabili al terzo piano dello stabile del Mémorial de la Shoah in Rue de Geoffroy l’Asnier a Parigi (il catalogo è in Internet). Il Mémorial du martyr juif inconnu: nasce dall’idea del fondatore del cdjc, Isaac Schneersohn, che voleva consacrare un luogo e una tomba alle vittime della Shoah. Un’idea non subito ben accolta da un parte della comunità ebraica francese che temeva un ripiegamento sul passato, idea che trovò tuttavia piena realizzazione nel 1953 quando la prima pietra sarà posata su un terreno donato dall’amministrazione parigina. Il Mémorial sarà inaugurato tre anni dopo davanti alle delegazioni provenienti da tutto il mondo e con cinquanta delegazioni di comunità ebraiche venute da ogni dove. Si tratta del primo memoriale per le vittime del genocidio ebraico creato dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Di lì a poco anche lo stato di Israele creerà Yad Vashem a Gerusalemme, con lo scopo di preservare il ricordo e il nome delle vittime della Shoah. Nel 1957 vengono deposte nella cripta del Memoriale del martire ebreo ignoto le ceneri di alcuni campi di sterminio e del Ghetto di Varsavia. All’indomani della costruzione di questo Mémorial anche il cdjc si trasferisce a Parigi: insieme creeranno negli anni un struttura in grado di fare ricerca, divulgazione e sostegno all’insegnamento della Shoah. A partire dagli anni ’90 si svolgono qui importanti celebrazioni quali la commemorazione della rivolta del Ghetto di Varsavia, il 27 gennaio e la Giornata nazionale della Deportazione che in Francia è il 16 luglio. Il Mémorial de la Shoah11: sorge alla fine del 2004, voluto dal consiglio di 139 amministrazione del Mémorial du martyr juif inconnu e cdjc con il sostegno dello Stato francese, della Città di Parigi e della regione Île de France, proprio per fornire uno spazio idoneo per la trasmissione della storia e memoria del genocidio del popolo ebraico. Viene ristrutturato un edificio in cui troveranno spazio le attuali sale di consultazione del Memoriale, la mediateca con le interviste dei sopravvissuti alla Shoah, l’esposizione permanente sulla storia della Shoah, dell’occupazione e del Governo di Vichy in Francia posta in un più ampio contesto europeo che parte dalla storia delle persecuzioni antigiudaiche. Infine davanti all’edificio è costruito il Muro dei Nomi, su cui sono incisi i nomi dei 76.000 ebrei deportati dalla Francia, di cui 11.000 bambini. «Shoah è una parola ebraica che significa catastrofe, disastro, distruzione. Il termine compare più volte nel testo biblico, e quindi faceva parte del vocabolario ebraico rivitalizzato dai primi sionisti in Palestina. Essi lo utilizzarono per denominare la persecuzione antiebraica nazista già all’inizio del 1937, poi nel corso del 1938, con riferimento alla condizione degli ebrei in Austria dopo l’annessione alla Germania in marzo e al pogrom tedesco di novembre, e infine negli anni seguenti, con riferimento ormai all’annientamento fisico di milioni di ebrei europei», M. Sarfatti, La Shoah in Italia, Einaudi, Torino 2005. 2 Per maggiori informazioni consultare il sito Internet <www.mahj.org>. 3 «Nel giugno del 1940, gli occupanti [tedeschi, NdR] vi riuniscono i prigionieri di guerra francesi, prima di inviarli in Germania. Poi dal 20 agosto 1941 al 17 agosto 1944, Drancy diventa il principale campo di internamento e transito per la deportazione degli ebrei dalla Francia. … Sugli 80.000 uomini e donne che vi furono internati, 67.000 saranno inviati verso i centri di sterminio, prevalentemente Auschwitz-Birkenau. Solo 2500 persone sopravvissero». P.J. Biscarat, Les enfants d’Izieu 6 avril 1944. Un crime contre l’humanité, Ed. Le Dauphiné, 2003 (Traduzione della redattrice) 4 Il 4 luglio del 1987 il capo della Gestapo di Lione Klaus Barbie è condannato all’ergastolo per aver commesso crimini contro l’umanità. Barbie non solo ha torturato e fatto deportare Jean Moulin, il capo delle ffi – la resistenza interna francese – morto nel vagone bestiame a causa delle sevizie; è stato anche colui che ha fatto deportare i quarantaquattro bambini ebrei della Colonia di Izieu (Isère) e i sette adulti che si prendevano cura di loro, condannandoli a morte certa nei campi dell’est Europa. 5 La legge che istituisce il 27 gennaio Giorno della Memoria della Shoah e delle deportazioni è del 20 luglio 2000, le celebrazioni iniziano dal gennaio 2001. 6 Cfr. L. Fontana, Viaggi della memoria: pellegrinaggi laici?, Newsletter Istituto Storico di Rimini, 2008/ 4. 7 «La distruzione degli ebrei d’Europa fu dal principio alla fine un fatto storico. La messa in luce delle sue origini culturali e politiche ancora la Shoah alla storia universale, contribuisce a far comprendere a ognuno di noi che questa tragedia non è solo degli ebrei ma di noi tutti», G. Bensoussan, Europe une passion génocidaire, p. 22, Mille et une Nuits, Paris 2006 (trad. dalla redattrice). 8 Il processo di disumanizzazione del deportato è rintracciabile nei documenti nazisti laddove i prigionieri sono denominati Stück (pezzo), nel momento dell’immatricolazione all’ingresso del campo di concentramento per coloro che erano destinati all’eliminazione tramite lavoro (nel campo di Auchwitz-Birkenau la matricola è impressa nella carne, come un marchio, con il tatuaggio), nel momento della selezione che tratta gli internati solo come numeri di cui deve tornare il conto, ecc. E ancora prima si veda tutta la propaganda razzista dei nazisti finalizzata alla comparazione degli ebrei a insetti o animali perché considerati Untermeschen, sottouomini. 9 «La distinzione fra l’antigiudaismo della Chiesa e l’antisemitismo contemporaneo è una rico1 140 struzione del dopoguerra che punta a sdoganare la Chiesa, e con lei l’Europa, di un crimine perpetrato dalla Germania nazista assistita dai suoi innumerevoli complici, anche se è vero che questo distinguo ha iniziato a operare già dalla presa del potere da parte dei nazisti nel 1933. “È la Chiesa che ci ha insegnato che gli ebrei sono un pericolo terribile” gridava nell’ottobre del 1938, a Bologna, il capo fascista Roberto Farinacci in un discorso relativo alle relazioni fra la Chiesa e gli ebrei». G. Bensoussan, Europe une passion génocidaire, p. 18, Mille et une Nuits, Paris 2006 (trad. della redattrice). 10 Per maggiori informazioni consultare il sito Internet <www.memorialdelashoah.org>. 11 Per uno studio comparato sul come fare memoria e storia del genocidio del popolo ebraico attraverso il confronto fra alcuni memoriali si veda A. Minerbi, M. Sarfatti, L’era dei musei della Shoah. Sei recenti allestimenti, in «Italia contemporanea» 2007/249. 141 Le attività didattiche di Istoreco a.s. 2007-2008 Alessandra Fontanesi L’attività della sezione Didattica di Istoreco si esprime nella proposta «Prendi il tempo» – lezioni, attività, laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, nella formazione per adulti di origine straniera – coordinando-realizzando il progetto «Ora che siamo a Reggio Emilia», fornendo consulenza storico-didattica ad altre Istituzioni e collaborando trasversalmente con gli altri componenti dell’Istituto (editoria, esteri, Giovani ricercatori reggiani, ecc). Prendi il tempo «Prendi il tempo» racchiude, come già detto, le varie proposte di lezioni, laboratori, viaggi e consulenze didattiche riguardo la storia contemporanea e in particolare quella del ’900, che la sezione e i suoi collaboratori offrono alle scuole e ai docenti di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Emilia. Le richieste di collaborazione con la sezione Didattica non solo provengono ormai da tutto il territorio provinciale ma, in certi casi, anche da fuori provincia. Particolarmente significativo è stato il lavoro di proposta formativa ai docenti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado che hanno contraddetto il pensiero corrente riguardo la scarsa volontà degli insegnanti a partecipare a progetti di aggiornamento, seguendo in buon numero agli incontri con esperti, le presentazioni di libri e le attività laboratoriali proposte dalla sezione Didattica dell’Istituto. Il numero complessivo di docenti contattati attraverso le nostre attività sono circa trecento, mentre gli studenti circa tremila, tenendo conto di una media di venticinque alunni per classe. 143 Sono in particolare da ricordare i progetti: «La Costituzione disegnata» con l’Istituto d’arte «G. Chierici»; «La storia della Costituzione Italiana» con la scuola secondaria di 1° grado «Pertini»; l’aumento delle richieste riguardanti le attività di visite guidate inerenti «Reggio Ebraica» (cimitero e ghetto) e «Storia in città». Ora che siamo a Reggio Emilia «Ora che siamo a Reggio Emilia», percorsi di cittadinanza attiva per adulti di origine straniera, alla sua seconda edizione, è coordinato dalla sezione Didattica dell’Istituto. Utilizzando le date di feste e ricorrenze significative per la storia del ’900 si sono affrontati quest’anno i seguenti temi: l’emigrazione italiana dei primi del ’900, i simboli dello Stato repubblicano e in particolare la nascita del vessillo tricolore, il razzismo, i diritti delle donne, la Resistenza e la costruzione dello Stato democratico, la Repubblica e le sue istituzioni. Marcando ogni incontro con l’analisi dell’articolo della Costituzione italiana i cui contenuti riguardavano i temi dell’incontro stesso, e ricordando in questo modo l’anniversario del 1948. Spesso le attività si sono rivolte anche a cittadini reggiani non stranieri ottenendo un buon successo, a dimostrare che l’educazione alla cittadinanza attraverso la storia locale, o la storia del territorio, è argomento interessante per molti. Il progetto l’anno prossimo cambierà aspetto e contenuti e non sarà probabilmente più la sezione Didattica a coordinarlo. Consulenza ad altre istituzioni «Consulenza ad altre istituzioni», la sezione Didattica, insieme alla sezione Esteri, ha svolto consulenza per i contenuti storico-divulgativi degli eventi del festival della repubblica partigiana di Montefiorino intitolato «Zona libera», che si è tenuto dal 1° al 15 giugno nel territorio della ex repubblica partigiana. Per l’organizzazione di queste proposte ai vari Comuni, la sezione Didattica ha collaborato con l’Istituto di Modena; i comuni della provincia reggiana coinvolti sono stati Ligonchio, Villa Minozzo e Toano. Le attività proposte sono state: presentazione del portale e del progetto era, presentazione del libro Sentieri Partigiani e attività ad esso correlate, conferenza di presentazione dell’evento «Mondiali antirazzisti», creato per la prima volta nel 1997 nel territorio della «Repubblica». La attività di consulenza e collaborazione con il museo memoriale Maison d’Izieu, importante luogo di memoria e di storia della regione francese Rodano-Alpi, ha portato a creare una giornata di formazione per docenti francesi ed europei che la sezione Didattica di Istoreco ha concepito e realizzato per lo scorso 29 ottobre. In questa giornata, i colleghi francesi e di altre nazioni europee hanno conosciuto i laboratori creati dalla sezione Didattica dell’Istituto 144 e, in particolare: Storia in città – percorsi guidati sulla storia della del secondo conflitto mondiale a Reggio Emilia e Reggio Ebraica – storia della presenza ebraica a Reggio Emilia. Le attività sono state svolte in lingua francese. La sezione Didattica collabora poi con la sezione Esteri per quanto riguarda i contenuti pedagogici del progetto «Viaggio della Memoria», coopera con il progetto «giorno», è attiva nella redazione della rivista «RS-Ricerche storiche» e sta sviluppando la ricerca nel proprio ambito specifico mettendo in cantiere nuovi strumenti didattici per i prossimi anni scolastici, augurandosi che il comando venga riconfermato. 145 Note e Rassegne Le ragioni e le modalità della ricerca* Valda Busani 18 luglio 2007: annunciata il giorno prima sui giornali, si tiene una «commemorazione delle otto persone prelevate a Scandiano il 1° gennaio 1945». Nell’iniziativa manca il riferimento ad Adriano Montanari. È promossa da consiglieri comunali del Polo-AN di Scandiano, presso le ciminiere dell’ex fornace di Ca’ de Caroli, dove qualcuno ritiene siano stati distrutti i corpi. I promotori lo danno per certo. Sono presenti una ventina di persone, tra cui alcuni familiari degli scomparsi. Si prega in loro memoria. Si posiziona una grande croce, si depongono fiori. E alla fine, in diversi – tutti giovani – salutano i «camerati scomparsi» urlando il saluto fascista a braccio teso. Sono presente anch’io. Con alcuni altri cittadini/e di Ca’ de Caroli, assistiamo a distanza e in silenzio. In mano teniamo cartelli su cui abbiamo scritto «La democrazia nasce dalla Resistenza. No al fascismo». Perché ci sembra evidente che quello a cui assistiamo non è una semplice commemorazione dettata dalla pietas. Il dolore delle famiglie, il loro diritto a ricordare i propri cari, ad avere risposte sulla loro sepoltura, diventa pretesto per uno dei tanti momenti di revisionismo storico a cui ci stiamo purtroppo abituando. Pretesto per sminuire le responsabilità storiche, etiche e politiche del fascismo. Per dire che «erano tutti uguali», fascisti e partigiani, in una lettura sfuocata in cui il torto e la ragione si confondono. Dimenticando che sono quei partigiani che hanno riconquistato la libertà di parola per tutti/tutte noi. Anche per chi ne abusa, fino a fare apologia di fascismo. *Pubblichiamo la postafazione contenuta in Valda Busani, «C’era freddo dentro il cuore di tutti….». Ricerca sui fatti del 1° gennaio 1945 a Scandiano ed Arceto, Istoreco-Comune di Scandiano, Scandiano 2008, pp. 116 s.i.p. 147 In alcuni firmiamo un esposto al Sindaco e ai carabinieri, per chiedere di accertare se ci siano state violazioni di legge nello svolgersi della manifestazione, e in particolare in quel saluto fascista. A vederlo urlato da ragazzi, si sente un nodo allo stomaco. La croce viene poi rimossa, per intervento del Sindaco. La sua collocazione, come la manifestazione, non era autorizzata. Nei giorni seguenti, articoli e polemiche sui giornali. Mi chiama il Sindaco, propone di condurre una ricerca storica per ricostruire i fatti del 1° gennaio ’45. Per capire chi sono quelle persone prelevate dai partigiani, quali ruoli e responsabilità ricoprivano nel fascismo locale, quale era il contesto di allora, cosa accadeva a Scandiano in quei tempi. Per ricostruire come sono andate le cose. Pare anche a me il solo modo serio di affrontare la questione: la ricerca della verità storica, per quanto possibile oltre sessant’anni dopo. Qualunque essa sia. Senza reticenze, senza timori. Perché della verità non si deve avere paura. «La verità è sempre rivoluzionaria» ho letto a vent’anni nelle pagine di Antonio Gramsci. E anni dopo, nelle pagine di Gandhi: «La verità non danneggia mai una causa giusta». E che la Resistenza sia una causa giusta credo sia fuori discussione. Almeno per me. Resta però il bisogno di conoscere meglio, di capire di più. Anche le ombre, e non solo le luci. Anche le zone grigie, forse inevitabili in tempi tanto oscuri e tragici. Senza rimuovere niente. Perché è la rimozione che consente – e ha consentito – mistificazioni e deformazioni ideologiche. Inizia così questa ricerca. Sui libri, innanzitutto, che raccontano e documentano la lotta di Liberazione nella provincia reggiana e nello scandianese. Sui documenti, sulle carte originali, sui giornali dell’epoca. Nell’archivio storico del Comune, in quello di istoreco, nel fondo «Sereno Folloni», negli archivi privati di «Amleto Paderni» e «Bruno Lorenzelli», protagonisti della resistenza nella V zona. Fogli, a volte sottili di carta velina, scritti a penna, a matita, o con macchine da scrivere, nel vivo della lotta, nel tumulto degli eventi. Meraviglia la volontà, la capacità, la determinazione di documentare il più possibile i fatti, di lasciare traccia di quanto sta accadendo, di dar conto di tutto, mentre si sta combattendo, mentre si cerca di sfuggire al rastrellamento o all’arresto. Non so raccontare l’emozione di tenere fra le mani il piccolo foglietto, piegato e ripiegato fino a farlo diventare minuscolo perché possa passare clandestinamente di mano in mano, che Gianfletter Ottorino Vecchi – di cui ho sentito raccontare in famiglia fin da piccola – scrive alla madre dal comando tedesco in cui è prigioniero e torturato, e da cui uscirà solo per essere trucidato. Ai documenti si decide di aggiungere le voci. Le testimonianze di coloro che hanno vissuto i fatti. A partire dai familiari delle persone prelevate. Contatto coloro che è stato possibile rintracciare. Non tutti sono disponibili a raccontare. Perché il dolore è ancora vivo, non si riesce a tradurlo in parole, si ha paura di risvegliarlo. Perché sono passati tanti anni, ed è inutile riparlare di cose che non si possono più cambiare. Perché da tempo si cerca solo di dimenticare. 148 E anche perché c’è diffidenza, quasi ostilità. L’iniziativa viene da un’amministrazione comunale «di sinistra», la parte «avversa», quella di cui non ci si fida, con la quale non ci si vuole incontrare. Sono sentimenti ed emozioni da rispettare: il dolore, le ferite aperte, e anche le diffidenze, i rifiuti. Qualcuno invece accoglie l’invito a raccontare, attorno a un tavolo con il registratore acceso. Raccontare è quasi liberatorio, si ha l’impressione che si aspettasse da tempo l’occasione per farlo. «È la prima volta che vengono a chiedere come è stato. Fino adesso non è mai venuto nessuno…». È come se si sentisse di poter dare dignità al proprio vissuto, di poter finalmente dar voce alla propria esperienza, dopo averla a lungo tenuta nel silenzio, nel privato delle proprie famiglie. Anche qui c’è dolore, naturalmente. A volte rielaborato quasi con serenità, attraverso i lunghi anni trascorsi, nella consapevolezza che «la guerra era fatta così!». A volte ancora raggrumato in un nodo difficile da sciogliere, che alimenta la domanda forte di individuare e «denunciare» i responsabili, o presunti tali. Nascono così le scelte diverse. Quella di «fare i nomi» dei partigiani ritenuti gli autori dei prelevamenti, e di chiederne la pubblicazione, in una sorta di «risarcimento» a posteriori, dovuto alla memoria dei propri familiari. E quella, invece, di pronunciare i nomi durante il racconto, decidendo però di non pubblicarli, per riguardo a queste altre famiglie, quelle dei partigiani, per non provocare altri dolori. Scelte differenti. La ricerca le rispetta entrambe, riportando il racconto come i testimoni chiedono che venga riportato. Le altre voci raccolte sono quelle dei partigiani, «…allora ci chiamavano ribelli non partigiani…» e di chi ha sostenuto la lotta di Liberazione. Nessuno dei partigiani chiamati in causa per i fatti di cui si parla, è ancora tra noi. I partigiani intervistati erano nel servizio informativo o in sap operanti sul territorio scandianese, o nelle brigate garibaldine della montagna. Non hanno partecipato alle azioni del 1° gennaio, non appartenevano ai distaccamenti coinvolti. Anche qui c’è molto dolore. Per i compagni persi a vent’anni, uccisi mentre si combatteva fianco a fianco. Per quelli arrestati e trucidati dopo torture tremende, di cui ancora oggi non si riesce a parlare senza piangere, «…l’arresto di Tognoli l’ho proprio vissuto di persona…». Per tutta la violenza che si è dovuta vivere, subire, e a volte praticare. Per avere visto uccidere, e per aver dovuto uccidere. Per le ferite che questo lascia nell’anima, anche a distanza di tanto tempo. Per le ferite del corpo e dello spirito, quando, a soli diciotto anni, si è stati nelle mani dei nazisti e dei fascisti per settimane, e il paradosso è che si era scelto di entrare nel Servizio di informazione e non in altri gruppi, proprio per non doversi trovare nella necessità di usare le armi: «Io, di andare a uccidere, proprio no…». Si comprende allora perché, per alcuni di loro, quell’esperienza vissuta «faceva parte di una cosa, sotto un certo aspetto, da dimenticare, come una sofferenza interna che volevo cacciare … le ingiustizie e tutto quello che è successo in quel periodo … perché quando parlavi dei ragazzi del paese, certo alcuni erano fascisti, altri partigiani, ma erano tutti ragazzi, li conoscevi, ci eri andato a ballare e se ci ripensi ti viene 149 proprio voglia di dire “chiudiamo”, perché ci si logora, è un dolore ancora profondo … Dopo la Liberazione parlammo poco di fatti accaduti»*. E poi «uno non sapeva quello che facevano gli altri… la riservatezza era la base della struttura, molto importante, perché sotto le torture non si resisteva…». Forse per queste ragioni, nessuno dei partigiani intervistati riferisce una conoscenza diretta dei fatti del 1° gennaio ’45. Né delle modalità dei prelevamenti, né dei partigiani che potrebbero averli effettuati, né della sorte dei fascisti scomparsi. Le loro testimonianze non sono quindi riportate per esteso. Ma i loro racconti hanno contribuito a ricostruire il contesto, il clima di quei giorni terribili. A verificare fatti, date, riscontri. A ricostruire i profili, le singole personalità, i differenti modi di agire. A comprendere meglio la complessità dell’organizzazione clandestina del movimento partigiano, anche la sua spontaneità e improvvisazione, la difficoltà a governarlo pienamente. A volte confermano circostanze già documentate dalle carte, o da altre testimonianze. Non aggiungono altri elementi. Difficile dire se davvero non sanno, o se scelgono di non raccontare. Resta il dubbio di una chiusura, a difesa di un’immagine della Resistenza che sentono oggi minacciata. Di un silenzio, con il quale si pensa di proteggere la memoria di quelli che non ci sono più. Di un imbarazzo a parlare anche delle zone d’ombra, di quello che forse si vorrebbe non fosse accaduto. «Vedi, delle cose malfatte purtroppo ne sono capitate, perché in una guerra può succedere…». E forse si pensa che sia meglio continuare a rimuoverle piuttosto che affrontarle. È una scelta che si può comprendere, rispettare, anche se non la si condivide. Insieme al Sindaco – mentre la ricerca procedeva – abbiamo incontrato le persone coinvolte: non solo i familiari degli scomparsi che hanno accettato di raccontare. Anche i familiari dei partigiani chiamati in causa dalle testimonianze: figli e figlie spesso nati/e dopo la guerra, non hanno vissuto i fatti di cui si parla. Informarli della ricerca in corso, del possibile coinvolgimento dei loro padri, ci è sembrato un gesto di rispetto dovuto. Anche qui abbiamo incontrato dolore, a volte smarrimento. Ma da tutti/tutte anche comprensione e sostegno. La ricerca non ha alcuna pretesa, ovviamente, di essere esaustiva. Ci sono domande che rimangono aperte. A partire da quelle sul destino dei corpi delle persone prelevate e uccise. Forse qualcuno potrebbe – anche oggi, a distanza di oltre sessant’anni – contribuire a fare maggiore chiarezza. Sarebbe un gesto di pietas e solidarietà umana. Che potrebbe contribuire a voltare pagina, mettendo fine alle strumentalizzazioni. Restano, naturalmente, tutte intere le responsabilità storiche e politiche, anche quelle dei singoli. Restano le differenze tra chi fu col fascismo e chi scelse di dire no. Non sono uguali i «ragazzi di Salò» e i ragazzi che andarono in montagna. «Si vuole la pacificazione generale per tutti, ma … noi abbiamo lottato per liberare, voi per opprimere». * Testimonianza di Gaspare Denti. 150 Proprio in ragione di questa differenza, fondamentale e prima di tutto etica, si può e si deve avere il coraggio e la capacità di continuare a ricercare la verità dei fatti. Che non sta banalmente nel mezzo, ma dolorosamente in profondità. V. BUSANI – “C’era freddo dentro il cuore di tutti….”. Ricerca sui fatti del 1° gennaio 1945 a Scandiano ed Arceto recensione di Eletta Bertani È questo il primo volume di una collana: «Scandiano Storie» che il Comune ha promosso per dare continuità alla ricerca su se stessa di una comunità «che vuole raccontarsi per conoscere meglio il processo di formazione della propria identità politica e culturale» (dalla presentazione di Nadia Lusetti, assessore alla Cultura), cosa peraltro che già sta facendo in diverse forme e linguaggi. La ricerca di Valda Busani affronta un nodo intricato, doloroso e controverso della guerra di Liberazione a Scandiano, il prelevamento da parte dei partigiani, il primo gennaio 1945, di nove fascisti, sei uomini, due donne, un ragazzo di diciassette anni, che non faranno più ritorno. Un episodio, questo, che lacererà profondamente nel tempo quella comunità, sarà oggetto della ricorrente richiesta dei familiari di conoscere la fine dei loro congiunti, alimenterà dure contestazioni ed accuse alla Resistenza e sarà alla base (come altri eventi della guerra di Liberazione) di una polemica politica ancora viva e anche di palesi strumentalizzazioni. Da qui, come ricorda il Sindaco nella premessa, la scelta del Comune di «cercare di fare piena luce sui fatti» partendo da due assunti: la consapevolezza del ruolo essenziale della Resistenza per la conquista della libertà e della democrazia e la convinzione che «la verità storica, quale che essa sia, non deve fare paura». Valda Busani affronta il difficile compito della ricerca della verità su quegli eventi con onestà intellettuale e profondo senso etico, con uno sforzo rigoroso di ricostruzione dei fatti e del contesto storico in cui essi sono accaduti, utilizzando tutte le fonti a disposizione (precedenti scritti e testimonianze, documenti di archivi pubblici e privati, raccolta di testimonianze dell’una e dell’altra parte, ivi compresi i racconti di alcuni dei familiari delle vittime). Parte dei documenti utilizzati è pubblicata nel volume come appendice documentaria alla ricerca. Spiega essa stessa, nella postfazione, le ragioni e il contesto da cui è nato il suo lavoro: il bisogno di andare più a fondo nella ricerca della verità, di scavare più profondamente in una vicenda che ha lacerato la comunità di Scandiano, è stata fonte di grande dolore e sofferenza, è stata anche all’origine d’inaccettabili strumentalizzazioni politiche, volte a denigrare e delegittimare nel suo insieme la Resistenza, i suoi protagonisti, le sue forze portanti. È un lavoro di scavo che parte da alcune domande fondamentali: chi erano le persone scomparse, quali i loro ruoli nel movimento fascista locale, perché vennero prelevate, quale il contesto in cui i fatti accaddero, quale posizione sui fatti assunsero i responsabili del cln locale e provinciale e quale, se ci fu, la dialettica al loro interno? L’autrice cerca di dare risposta a queste domande riconoscendo anche con umiltà che non a tutte è stato possibile rispondere, anche per la grande distanza dagli eventi e la scomparsa di tanti protagonisti. 151 Particolarmente importante ed interessante nel lavoro della Busani la ricostruzione, attraverso lettere e fonti documentali, della dialettica interna al mondo della Resistenza e della sua catena di comando su quanto accaduto, la ricostruzione delle posizioni assunte nel cln di Scandiano dalle diverse forze politiche che lo componevano. Da esse emerge chiaramente lo sforzo di «governare» uno scontro drammatico, di darsi criteri e regole rispetto alla individuazione e punizione dei fascisti responsabili di colpe gravi, un codice etico rigoroso ispirato a criteri di giustizia rispetto all’uso della violenza (si vedano le chiare direttive dei cln al riguardo). Sforzo, questo, tanto più meritorio in quanto compiuto nel contesto drammatico della guerra e della occupazione tedesca, dei rastrellamenti, degli arresti, delle rappresaglie, del durissimo prezzo di sofferenze, sacrifici e sangue pagato sia dai partigiani che dalla popolazione civile. Ma emerge anche la difficoltà del cln a governare e controllare i comportamenti di gruppi di partigiani o singoli uomini, alcuni dei quali agirono in modo autonomo, sfuggendo talora al controllo e compiendo azioni in contrasto con le «regole» chiaramente fissate. In questa chiave di lettura la ricerca approfondisce ed interpreta all’interno del dramma collettivo, due vicende particolarmente controverse e dolorose: l’uccisione di Pietro Lasagni, un giovane di 16 anni e mezzo, collaboratore delle sap, ritenuto spia, e di Bice Sacchi, gestore del magazzino monopoli di Scandiano. A nostro avviso, nell’insieme, e pur nella difficoltà di dare una risposta univoca alla domanda fondamentale sulle responsabilità delle uccisioni, la ricerca offre tuttavia di questo contesto complesso nuovi elementi di conoscenza e chiavi di comprensione e di interpretazione. L’autrice non si limita, infatti, a «registrare» i fatti e le situazioni, non li isola, ma li colloca all’interno di un processo storico, che ricostruisce nella sua complessità e nel suo senso complessivo, aiutando così a «comprendere», non certo a giustificare. In tal modo, mentre da una parte non assume mai una posizione falsamente equidistante, neutrale, ma ha e dichiara un preciso punto di vista sulle ragioni e sui torti, dall’altra, nel contempo, va in profondità nella ricostruzione dei fatti, evitando le semplificazioni e le giustificazioni a priori. Merito della ricerca è anche di avere dato il giusto spazio e valore alla dimensione umana e personale del dramma, dando voce, oltre che alle testimonianze dei partigiani, anche alle ragioni e ai sentimenti dei familiari delle vittime, ascoltati con rispetto sincero del proprio dolore e dei propri sentimenti. Come giustamente ricorda Massimo Storchi nell’introduzione, le persone coinvolte sono viste oltre e al di là della propria collocazione politica ed ideologica negli eventi, si dà loro voce nella loro integrità e complessità e anche contraddittorietà di esseri umani. Una qualità in più, a nostro avviso, di questa ricerca, il cui senso complessivo è riassunto perfettamente nelle frasi scelte dall’autrice per introdurla: «La verità si troverebbe nel mezzo? Nient’affatto. Solo nella complessità» (A. Schnitzler). «La verità non danneggia mai una causa giusta» (Mahatma Gandhi). 152 Terrorismo fascista* Luciano Casali 1. Il libro prende in esame, soprattutto attraverso documenti interni al regime di Salò, confessioni, memoriali, testimonianze, materiale processuale relativi alle violenze di cui furono protagonisti i fascisti repubblicani, i processi cui furono sottoposti, le loro condanne in prima istanza e le successive risultanze, di assoluzione, grazia, riduzione delle pene. Nelle pagine conclusive (pp. 268-275) troviamo infine l’elenco completo dei 243 fascisti repubblicani che furono condannati dalla Corte di assiste straordinaria di Reggio Emilia: 54 condannati a morte, quattro all’ergastolo, sette a 30 anni di detenzione e via scemando, per un totale di 3117 anni di reclusione. Delle 54 condanne a morte ne furono eseguite sei. È un libro estremamente documentato, ricco di notizie spesso tremende (si pensi alle molte pagine dedicate alle orribili torture inflitte ai prigionieri in mano all’Ufficio politico investigativo, alle violenze inumane commesse a Villa Cucchi, pp. 133-160), ma dal quale possiamo trarre anche notizie di carattere più generale, valide a comprendere il senso e il comportamento più generali della Repubblica sociale italiana e non solo nella provincia di Reggio Emilia. E ci pare opportuno partire proprio da queste. 2. Siamo convinti che, nello studio della Resistenza e degli avvenimenti italiani del periodo 1943-1945, ancora molto lavoro sia necessario portare avanti a proposito di quella che possiamo definire una «terza componente». In effetti molto è stato studiato e scritto a proposito delle scelte e del comportamento dei partigiani; da qualche anno è cominciata un’importante analisi delle vicende interne della Repubblica sociale e, *A proposito di M. STORCHI, Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-46), Aliberti editore, Roma-Reggio Emilia 2008, pp. 285. La recensione di Casali è uscita in «Storia e problemi contemporanei» dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, Ancona, n. 47/2008. Si ringrazia la Rivista per la gentile concessione. 153 attraverso i nuovi documenti che sono stati messi a disposizione a Roma nell’Archivio centrale dello Stato, diventa sempre più chiaro il comportamento dei dirigenti di Salò a tutti i livelli (centrale e nelle singole province) e si cominciano ad evidenziare i loro contrasti e le loro tendenze politiche e militari. Viene smantellata la «leggenda», da loro creata e diffusa, di avere contribuito con la loro presenza e attività, a consentire un più tranquillo impatto con l’occupazione tedesca, ad avere evitato stragi e conflitti ben maggiori che i nazisti avrebbero causato alla popolazione italiana se non ci fossero stati gli uomini di Salò. Ancora poco tuttavia sappiamo della gente che restò diciamo così nel mezzo: che non si schierò apertamente né con gli uni né con gli altri. Già molti anni fa ci chiedevamo quale politica del consenso avevano messo in atto i fascisti e i partigiani e avevamo cercato di verificare attraverso quali tecniche propagandistiche e di comportamento avevano tentato di mobilitare l’opinione pubblica, di catturare il favore, l’adesione o l’astensione della popolazione1. Non c’è bisogno di sottolineare più di tanto l’importanza che è andata assumendo la propaganda nell’età contemporanea, nei confronti della società di massa. In un libretto pubblicato, nel 1927, negli Stati Uniti e intitolato appunto Propaganda, Edward Bernays si diceva convinto della necessità di intervenire con appropriati «suggerimenti» (così lui li chiamava) per aiutare la gente a scegliere sia i prodotti industriali sia i prodotti politici, senza sostanziale differenza nelle tecniche di presentazione degli uni e degli altri. Scriveva Bernays: Nella nostra organizzazione sociale attuale, l’approvazione del pubblico risulta cruciale per qualsiasi progetto di grande rilievo. Da cui deriva che un movimento, anche degno di tutti gli elogi, non può che fallire se non ottiene di imprimere la sua immagine nella mente pubblica … Oggi i leader che si installano nel potere … hanno la necessità di conseguire l’approvazione delle masse, per cui ricorrono alla propaganda, un mezzo che appare sempre più poderoso quando si tratta di conseguire tale approvazione2. Di questo erano ben consapevoli anche i politici. Lo stesso Adolf Hitler nel 1925 scrivendo il suo Mein Kampf dedicava al tema della propaganda numerose pagine e sottolineava come indispensabile per la conquista e il mantenimento del potere il ricorrere ai mezzi di comunicazione di massa, a tutti i mezzi di comunicazione di massa, a cominciare da quelli più moderni e quindi più efficaci. Philip Cannistraro nel suo libro che dedica all’argomento e che intitola proprio La fabbrica del consenso prende in esame con molta attenzione il rapporto fra fascismo ed opinione pubblica e ci descrive con molti particolari l’utilizzazione dei mass media durante i vent’anni del regime, ma non può non rilevare che comunque, nonostante l’impegno, dalla seconda metà degli anni Trenta e soprattutto con lo scoppio della seconda guerra mondiale, il fascismo non riuscì più a trovare slogans o parole d’ordine adeguate: il consenso andò rapidamente decrescendo e crollando; la fiducia andò scomparendo e non solo a seguito dei risultati disastrosi della guerra. E di questo i fascisti si resero perfettamente conto e se ne resero ancor più conto nel settembre 1943 quando si trovarono di fronte ad un problema che andava risolto con la massima celerità e che non poteva mancare nei suoi risultati, pena il fallimento 154 completo dell’iniziativa cui stavano dando vita: presentare agli italiani la loro nuova creatura, la Repubblica sociale, ed ottenerne l’approvazione, il consenso, l’adesione. Nonostante i magnifici manifesti di Boccasile, non appariva facile ottenere l’approvazione degli italiani alla continuazione della guerra; lo slogan principale che venne lanciato, quello di mantenere fede alla parola data e di rimanere fedeli ai «camerati germanici», non poteva prescindere dal fatto che la guerra appariva agli italiani irrimediabilmente perduta, che gli anglo-americani avanzavano lungo la Penisola, che i bombardamenti colpivano disastrosamente le città che erano senza alcuna difesa reale. Come scrive Massimo Storchi: «Con la Repubblica di Salò l’uso della violenza diventa la norma per il controllo dell’ordine pubblico e per le diverse forze di polizia incaricate di tutelarlo» (p. 147). Per un libro appena uscito, abbiamo scelto il titolo di La politica del terrore3, volendo significare con ciò che lo strumento attraverso il quale i fascisti di Salò cercarono di conquistare il controllo del territorio e dei cittadini non fu tanto quello della propaganda, che ormai ritenevano fallito o insufficiente per riprendere rapidamente il consenso e l’adesione al nuovo Stato che stava nascendo, ma fu semplicemente e direttamente l’arma del terrore. Certo – e riprendiamo ancora le parole di Massimo Storchi – «l’uso della violenza era stato frequente durante il regime fascista. Le bastonature e la somministrazione di olio di ricino erano proseguite per gli avversari più ostinati anche nel corso del Ventennio» (p. 147); basti pensare al comunista forlivese Gastone Sozzi, ucciso nel carcere di Perugia nel 1929 o al comunista reggiano Aderito Ferrari «morto» al confino nel 1937 e l’elenco potrebbe allungarsi. Ma va ricordato che questi metodi violenti nel corso del Regime venivano adottati solo nei confronti degli avversari irriducibili, dei sovversivi che non si lasciavano domare e che normalmente venivano messi in atto lontano dagli occhi dell’opinione pubblica e di nascosto; semplicemente per eliminare chi ostinatamente non accettava l’ordine imposto. Nei mesi di Salò invece la violenza diventò uno strumento esplicitamente utilizzato di fronte all’opinione pubblica, divenne l’arma principale per mantenere tranquilla la maggioranza della popolazione; si trattò di un terrore voluto e costruito, non nascosto: rastrellamenti, saccheggi, incendi, stupri, uccisioni di donne, bambini e anziani con i corpi degli ammazzati che venivano lasciati per giorni esposti nelle piazze alla vista dei passanti affinché costituissero un ammonimento, affinché tutti potessero vedere che cosa significasse non essere d’accordo, o semplicemente non obbedire in silenzio. Mancò, nell’esecuzione di questi atti, qualsiasi riflessione politica più ampia, qualsiasi tentativo di costruire alleanze, di convincere i cittadini: c’era semplicemente la rappresaglia più ampia, la ricerca del silenzio dei cittadini attraverso l’uso esplicito del terrore. Si colpiva – e sono ancora parole di Massimo Storchi, pp. 57-58 – alla cieca, senza considerare le conseguenze immediate degli atti che si compivano. Si pensi all’uccisione di don Pasquino Borghi nel gennaio 1944: la fucilazione di un sacerdote, al di fuori di ogni legge vigente e delle regole concordatarie, troncava sul nascere ogni possibile collaborazione con la Chiesa reggiana e con i cattolici reggiani4, ma costituiva un monito estremamente pesante e facilmente intuibile da parte di tutti i cittadini reggiani: non c’era rispetto per i sacerdoti, figuriamoci per gli «altri». Non si facevano neppure 155 considerazioni di carattere psicologico: l’uccisione dei sette fratelli Cervi nel dicembre 1943 determinò l’immediata nascita del mito dei sette fratelli, partigiani ed antifascisti: un effetto esattamente opposto a quello che si sarebbe voluto raggiungere. 3. Sono tremende le testimonianze di coloro che nell’estate 1945 raccontarono le sevizie cui erano stati sottoposti davanti al Tribunale, durante il processo tenutosi contro Attilio Tesei e gli uomini che con lui si erano occupati di portare avanti gli «interrogatori» a Villa Cucchi (pp. 153-155). Ave Formentini, al tempo ragazza diciottenne, afferma di essere stata legata nuda su due tavolini con la testa in basso, gli arti fissati alle gambe degli stessi tavoli, quelli inferiori divaricati, di esservi rimasta per ore; di avere avuto i capezzoli stretti e attorcigliati da un paio di pinze, sì da soffrirne poi per sei mesi, di essere stata unta sul sesso con materiale non identificato e di avere avuto aizzati su di esso due cani che avidamente e a lungo la leccarono; il supplizio venne ripetuto il giorno dopo. Altri, già ridotti in condizioni pietose per precedenti torture, furono sottoposti, mediante congegni appositi, a scariche di corrente elettrica in parti sensibili del corpo. Ennio Formentini nelle orecchie; Enzo Gorini nelle orecchie, nel naso, nella lingua, negli organi genitali; altri ancora ebbero, quale ultimo e massimo tormento, dopo ore e ore di precedenti torture, la compressione forte e protratta dei testicoli a forza di mano e con bastoncelli. E si potrebbe continuare. Giampaolo Pansa nelle sue numerose e recenti pubblicazioni non si chiede perché, dopo la Liberazione, ci furono casi – anche abbastanza numerosi – che videro i fascisti repubblicani fatti segno della furia vendicativa popolare e furono uccisi; semplicemente descrive gli episodi, suggerendo o affermando esplicitamente che si trattava di uccisioni aberranti che facevano parte di una precisa strategia politica comunista tesa a preparare un momento rivoluzionario e togliere credibilità alla democrazia appena nata. Possono indubbiamente esserci state anche esecuzioni a carico di giovani repubblicani che non erano stati particolarmente impegnati nell’attività portata avanti da Salò, ma resta indubbiamente il fatto che il clima creato dagli uomini della Repubblica sociale, l’ordine mantenuto tramite una feroce politica del terrore e della tortura, possono farci capire (anche se ovviamente non giustificano) l’atmosfera che si determinò e che indusse la gente comune a giustiziare alcuni di coloro che maggiormente si erano adoperati per il consolidamento dello Stato neofascista. È evidente che la gente, dopo ciò che era stata costretta a subire, esigeva giustizia, a costo di farsela (erroneamente) con le proprie mani. È proprio a proposito di questo che Massimo Storchi nel suo libro (pp. 24-48) ci offre alcuni dati che sono di grande interesse. Se nell’aprile 1945, nelle giornate immediatamente successive all’insurrezione e alla Liberazione, i morti fascisti furono in provincia di Reggio Emilia 315, nel corso del successivo mese di maggio scesero a 167 (di cui 109 nei primi 15 giorni di maggio) e in giugno si assistette a sole cinque uccisioni; ma proprio il 6 giugno si era aperto, presso la Corte di assise straordinaria di Reggio, il processo contro Cesare Pilati ed altri dirigenti dell’Ufficio politico repubblicano. Come osserva giustamente Storchi, l’azione della Corte di assise servì nell’immediato a smorzare il clima di furore popolare, ricondusse il desiderio di giustizia nell’alveo delle 156 istituzioni, sottraendolo al rischio della vendetta diffusa o privata, operò egregiamente da valvola di sfogo, dopo che già alla metà di maggio la stessa prefettura aveva fatto l’esplicita richiesta (che ovviamente fu respinta) di poter procedere immediatamente e senza processi alla fucilazione dei nove responsabili dei maggiori crimini commessi nel corso della repressione antipartigiana, nella convinzione che atti esemplari di giustizia avrebbero contribuito largamente a sdrammatizzare la situazione. L’avvio dei processi si accompagnò alla fine degli atti di violenza sommaria, in quanto si ritenne che la giustizia potesse venire garantita dalla ripresa delle istituzioni dello Stato democratico e ad esse ci si affidò. 4. Nell’esaminare i processi subiti dai principali criminali fascisti reggiani5, Storchi ricostruisce con ricchezza di documenti la loro attività e dimostra l’importanza che ebbe la politica del terrore per mettere in piedi la Repubblica sociale italiana e per tentare di consolidarla in seguito. Nella sua ricostruzione ci troviamo di fronte a due periodi soprattutto durante i quali i fascisti repubblicani, nonostante una difficile situazione interna e il protrarsi di numerosi conflitti fra camerati per mantenere e occupare i posti del potere6, esplicarono ampiamente un’attività di tortura, uccisione, distruzione di case e incendi, violenze di tutti i generi. Questi periodi furono i primi mesi subito dopo la nascita della Repubblica, quando i fascisti optarono per l’arma della violenza come principale strumento per occupare il potere, non ritenendo adeguata l’arma della propaganda per ottenere un sia pur silenzioso consenso; e i mesi fra l’autunno 1944 e l’inverno 1945. Ci troviamo di fronte ad uno stillicidio quotidiano di violenze, che furono ben note allo stesso Mussolini che non aveva esitato a chiedere ai fascisti delle province di intervenire ripetutamente e senza scrupoli con l’arma delle rappresaglie e delle fucilazioni per debellare il ribellismo7. Non è privo di significato che lo stesso Mussolini avesse sollecitato ad uccidere italiani per semplice rappresaglia e non perché avessero commesso qualche delitto più o meno esecrabile e chiedesse di esserne tempestivamente informato; ma il libro di Storchi ci dimostra che i fascisti reggiani – e anche quelli di altre province, come ha mostrato il libro sull’Ufficio politico investigativo del Partito fascista repubblicano di Bologna pubblicato nello scorso ottobre8 – non attesero o non avevano bisogno di una sollecitazione di Mussolini per torturare e uccidere i cittadini inermi. Siamo dunque di fronte ad una documentazione che ridistribuisce (se così possiamo dire) le responsabilità delle stragi e delle violenze durante il periodo 1943-1945: se fino a qualche tempo fa si ritenevano i soli nazisti responsabili del clima di violenza sulle popolazioni civili creatosi in quegli anni; ora i nuovi studi rendono sempre più evidente una co-partecipazione fascista, una co-responsabilità degli uomini di Salò che anzi furono i principali riposabili del clima generalizzato di terrore e di paura che venne radicato e diffuso fra la gente comune nel corso di quei venti mesi. 1 S. Carli-Ballola, L. Casali, Alla ricerca del consenso. La stampa fascista e antifascista nel 1943-44, in «Linea Gotica 1944», Angeli, Milano 1986. 2 Edward Bernays, Propaganda, Melusina, Barcelona 2008, passim. 3 L. Casali, D. Gagliani (a cura di), La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia Roma- 157 gna, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2008. 4 Si vedano le lettere del vescovo di Reggio alle pp. 189-198. 5 Alle pp. 217-265 i testi completi delle sentenze relative ai cinque processi più significativi. 6 Per i contrasti interni al pfr reggiano, si vedano soprattutto le pp. 98-102. 7 Cfr. Casali, Gagliani (a cura di), La politica del terrore, cit., pp. 318-321 e passim. 8 R. Sasdelli (a cura di), Ingegneria in guerra. La Facoltà di Ingegneria di Bologna dalla Rsi alla Ricostruzione 1943-1947, clueb, Bologna 2007; ne abbiamo parlato su «Storia e problemi contemporanea», n. 47, pp. 201-202. 158 Una disputa settembrina Ettore Borghi Quando usciranno queste pagine sarà quasi certamente svanita dalla memoria la disputa settembrina sul fascismo italiano, suscitata nientemeno che da due cultori del calibro di Alemanno, sindaco di Roma, e di La Russa, ministro della Difesa (o dobbiamo dire, in pectore, «della guerra»?). Nel frattempo altri temi, sintomo ed eco di una politica fatta di improvvisazioni e di cinica spregiudicatezza, avranno goduto ad ondate successive le loro quarantotto ore di pubblicità, rivolta ad un’opinione pubblica distratta e disposta a lasciarsi guidare per mano verso crescenti livelli di assuefazione a soluzioni autoritarie e di sostegno entusiastico alle decisioni del Capo. Non varrebbe dunque la pena tornarci sopra, se non fosse che certe dichiarazioni strillate da personaggi, ahimé, istituzionali (che è eufemistico considerare solo «simpatizzanti» e nostalgici del fascismo) hanno avuto, e non sarà l’ultima volta, il potere di costringere alla risposta molti storici autentici e qualche giornalista informato e serio, sopravvissuto alla grande omologazione. Ecco allora l’ennesima necessità di replicare l’abicì della questione, una fatica di Sisifo a cui solo il nostro paese, in tutta l’Europa che ha praticato o subito regimi di stampo fascista, sembra essere condannato. Poiché certi discorsi non sono lapsus, ma atti deliberati di persone doppiamente responsabili – in quanto adulte e in quanto investite di funzioni pubbliche – ne consegue che dobbiamo intenderli come sintomi rivelatori di una realtà che va riconosciuta come tale, per quanto sia dura: la presenza nella nostra società di una diversificata gamma di pulsioni autoritarie, estranee od ostili ai principi costituzionali, non come fenomeno marginale, ma come processo eversivo già in atto, in forma solo in apparenza dolce. Ormai non è più il caso di parlare di «memorie divise», ma di riflettere sul riproporsi di una grave frattura nella vita pubblica italiana, che si manifesta in modi meno riconoscibili, ma non senza analogie con quella degli anni Venti del secolo scorso. E i riferimenti alla storia «riveduta e corretta», provenienti da diversi pulpiti nazionali e periferici, fungono da sonde, pretesti e parole d’ordine, perciò sarebbe imprudente considerarli nell’ottica collaudata del «passato che non passa». In punto di storiografia, se di questo si trattasse, non dovrebbe esserci disputa: ba- 159 sterebbe riferirsi ai risultati – almeno i molti non controversi – dell’enorme bibliografia disponibile, e non ci sarebbero dubbi sul senso complessivo del progetto hitleriano di un «nuovo ordine europeo», sull’avventata partecipazione ad esso dell’Italia fascista, nonché sulla devastante macchina di distruzione e di sterminio dispiegata per realizzarlo. Inevitabili le conclusioni: a) lo scatenamento della guerra fu di per sé un crimine; b) quella decisione non fu, nella storia di quella Germania e di quella Italia, un evento accidentale, ma lo sbocco logico della concezione del potere e delle relazioni fra i popoli intrinseca a quei regimi. Non una pratica, ma la pratica distintiva, la loro ragion d’essere; c) in caso di vittoria delle forze dell’Asse l’Europa, sotto l’egemonia della Germania nazista, sarebbe stata fondata – per usare le limpide parole di Enzo Collotti – «programmaticamente, e non solo di fatto, sulla disuguaglianza politica, razziale, economica e sociale tra i suoi componenti» (vedi L’Europa nazista, Giunti 2002, p. 394). Allora sarebbe bene sbarazzarsi dei finti problemi che si avvalgono di un linguaggio pseudofilosofico, come la determinazione di che cosa sia stato «male assoluto» e che cosa no, quesito su cui non si vede come possa dare risposta un’indagine storica (o si pensa che possa risolverlo l’autorità politica per mezzo di un decreto?). In questa stessa luce sembra a chi scrive una regola di prudenza evitare concetti estremamente vaghi come «modernizzazione» a proposito della politica fascista in Italia (sarebbe stata la sua parte «buona»). E ricordando la lezione di Salvemini, espressa nell’introduzione al suo libro sulla Rivoluzione francese, evitiamo di attribuire valore sostanziale a concetti astratti, facendoli diventare gli attori della storia. Non «il fascismo», ma l’Italia nel periodo fascista è stata responsabile delle leggi razziali e della guerra di aggressione a fianco della Germania hitleriana. La necessità di quell’Italia di fare i conti con se stessa era chiara a una lucida minoranza che – si vedano gli scritti di Dionisotti recensiti in altra parte di questo fascicolo – scorse i caratteri di una guerra civile («un primo atto») già nello scontro fra italiani e italiani nella guerra di Spagna e individuò nell’assassinio dei fratelli Rosselli l’evento simbolico che imponeva di proseguirla («oggi in Spagna, domani in Italia»). Si trattava, per lo spirito «giellista», di andare più a fondo rispetto alla semplice sparizione delle forme più vistose e riconoscibili della politica fascista, risalendo anche alle radici, agli aspetti di continuità fra la società prefascista e il regime pienamente spiegato. Questa riflessione sarebbe stata la condizione indispensabile per prevenire il riemergere delle pulsioni autoritarie, antidemocratiche, razziste già presenti nell’Italia liberale (si pensi al razzismo antislavo ben documentato da A. Kersevan in un lavoro recensito su queste stesse pagine) e poi portate a trionfale attuazione nel periodo mussoliniano. Scaricare tutto su un astratto «fascismo» (la malattia passeggera, secondo certe interpretazioni crociane, indulgenti anche verso la monarchia), magari insistendo soprattutto sul suo periodo di maggiore affinità con gli occupanti nazisti, sarebbe invece stato, come in effetti fu, il prodromo di una rapida autoassoluzione e di un’efficace strategia di rimozione e di oblio delle più diffuse responsabilità (il «consenso» di cui parlano autorevoli storici). Nel drammatico dopoguerra altri, i due maggiori partiti di massa, videro, forse con qualche ragione dalla loro parte, diverse urgenze, e furono aperte le porte ad una «conciliazione» che avrebbe dovuto trovare il suo sigillo nella condivisione dello 160 spirito repubblicano e costituzionale. Come si sa, l’immediato riorganizzarsi del (neo) fascismo fu una prima smentita di queste attese, ma di ben altro peso è stata – possiamo dirlo col senno di oggi – la persistente indifferenza o estraneità di molti (non solo singoli, ma pubbliche istituzioni e diverse forme di magistero) al progetto di rinnovamento radicale della società iscritto nella Costituzione. Oggi che questa estraneità si manifesta nelle parole e negli atti di chi sta al governo, non sorprende la dilettantesca, ma nondimeno pericolosa, «revisione» della nostra storia recente. A cui sarà bene contrapporre uno sforzo di conoscenza che allarghi anche le frequentazioni «nostre» (non dico degli storici di professione, che non hanno bisogno di questo invito). Per fare un solo esempio, ci si sforzi di vedere la nostra Resistenza nel quadro europeo, alzando lo sguardo oltre il cortile di casa. Tanto per dire, cerchiamo di vedere le ragioni e i sacrifici degli «altri» partigiani, quelli che in Grecia e in Jugoslavia combatterono contro l’esercito italiano aggressore e occupante. Impariamo (si legga l’equilibrato volumetto di Maria Verginella, Il confine degli altri, ed. Donzelli), e vedere noi come feroci prevaricatori. Diamo una mano alle voci che da tempo lavorano a decostruire la favola dell’«italiano brava gente». Se non altro, scopriremo qualche riscontro efficace dell’effettiva continuità fra il fascismo «veramente cattivo» di Salò e quello «bonario» e «più complesso» (Alemanno dixit) che lo aveva preceduto. 161 Come si cambia un logo Pubblichiamo la richiesta della casa editrice Rizzoli per ottenere dal nostro Istituto l’autorizzazione all’uso del logo «partigiani in cammino» per il libro di Giampaolo Pansa, I tre inverni della paura. E la nostra risposta. Ogni commento è superfluo, lasciamo al lettore la valutazione. Il logo La foto Corrispondenza e.mail 11 marzo 2008 allegato: copertina Pansa.jpg oggetto: c.a. Vanni Orlandini, da Rizzoli Gentile dott. Vanni Orlandini, come d’accordi presi le invio la copertina di Pansa, in particolare mi servirebbe sapere a chi rivolgermi per ottenere l’immagine in alta risoluzione, per pagare i diritti 163 dell’immagine e per inserire i crediti sulla copertina. La ringrazio fin da subito per la collaborazione e attendo sue notizie domani, in tarda mattinata Cordiali saluti XXXXXXX Risposta di Istoreco Reggio Emilia, 12 Marzo 2008 Gent.ma Sig.ra XXXXXXX Prot. n° 065-08/VO/lr Gentile Signora XXXXXXX, abbiamo preso visione della bozza di copertina per il libro-romanzo di Giampaolo Pansa, recante una immagine di proprietà istoreco. Il libro, 1ª versione Purtroppo non possiamo accogliere la Vostra richiesta perché l’immagine stessa costituisce il logo della Sezione Esteri di istoreco, dei Viaggi della Memoria, dell’organizzazione delle iniziative sui Sentieri Partigiani e dell’organizzazione di stage ai quali partecipano decine di giovani italiani e stranieri. Non è quindi pensabile che attorno a tale logo possano esserci iniziative che interferiscano o, perlomeno, confondano o coinvolgano, seppure indirettamente, iniziative che è bene, anzi necessario, restino separate e ben individuabili. Pertanto, l’utilizzo dell’immagine proposta per la copertina del libro di cui la Vostra mail, non è da istoreco autorizzata. Qualora interessino altre immagini del nostro catalogo fotografico, si prega di segnalarlo allo scopo di esaminare assieme il possibile utilizzo autorizzato. Cordialmente. p. Istoreco f.to Il Direttore (Vanni Orlandini) 164 e. mail 22 aprile 2008 Gentile dottor Orlandini, come d’accordo le invio la copertina del libro. In attesa di un suo gentile commento. XXXXXXX Il libro, 2ª versione 165 Recensioni M. Fincardi, Campagne emiliane in transizione, 88-491-2931-1, 18 € clueb, Bologna, 2008 ISBN 978- Questa raccolta, che ripropone saggi pubblicati tra il 1990 e il 2006, molti dei quali inediti in Italia, integra e prosegue il discorso avviato da Fincardi nel 2001 con La terra disincantata, proponendo una storia della «bassa» padana tra ’800 e ’900 che demolisce molti luoghi comuni non solo storiografici. Quella dello studioso guastallese è, infatti, una storia delle campagne che supera l’ottica economicistica, quella naturalistica, quella etnologica, per indagare il paesaggio sociale e le forme di sociabilità, le rappresentazioni culturali e i riferimenti simbolici, le modalità di politicizzazione e le strategie di rivendicazione. È una storia regionale, incentrata sulle aree emiliane, che non ragiona in termini di scansioni amministrative o di distretti economici, né tantomeno di tradizioni astoriche, bensì indaga pratiche e rappresentazioni proprie di un’area specifica per cogliere a questo livello, al quale appaiono con notevole densità e definizione, i passaggi della grande storia. È una storia della transizione verso la contemporaneità, vista però non come un’astrazione nominalistica o un processo imposto dall’alto, bensì quale risultato della complessa interazione tra vincoli strutturali, risorse simboliche e scelte individuali. Fincardi ci dice essenzialmente che l’immagine delle campagne italiane come immobili e passive appendici delle città, entrate nella storia solo con la prima guerra mondiale, deve essere totalmente rivista. Innanzitutto, perché ci sono campagne molto diverse tra loro: particolarmente marcata è la distinzione tra quelle mezzadrili, effettivamente più statiche, e quelle bracciantili, le quali svolgono invece una parte attiva della modernizzazione del paese. In particolare Fincardi ipotizza qui, a partire dalle sua analisi sull’area tra la va Emilia e il Po, l’esistenza di una «Italia mediana», non geograficamente contigua, ma storicamente coerente, che proprio grazie alla forte presenza bracciantile sviluppa una peculiare dinamicità. In questo contesto il confine tra città e campagna tende sempre più a sfumare, man mano che il movimento di uomini, di merci e di idee diffonde ambizioni e soluzioni «moderne». Alla base di questa evoluzione si trova certo l’azione omologante dello Stato, che agisce tramite la scuola, la leva, il fisco, le elezioni, le poste, i lavori pubblici (molto belle le pagine sui cantieri di bonifica); ma anche l’apertura dei mercati, compreso quello del lavoro; e soprattutto lo svilupparsi delle reti di relazione e comunicazione. I braccianti sono spesso costretti alla pluriattività o all’emigrazione: in entrambi i casi entrano in contatto con realtà nuove, che impongono loro uno sforzo di adattamento e insieme aprono nuovi orizzonti mentali e materiali. Appaiono in questo senso molto stimolanti le pagine che l’autore dedica a questa «realtà popolare in movimento»: i «precari» dell’epoca (ambulanti, stagionali, girovaghi), vettori di culture extra-locali; i meccanismi di emulazione e competizione nella 167 gara a «modernizzarsi» che coinvolgono i giovani nelle campagne padane di fine secolo (si pensi al loro comportamento sessuale sorprendentemente «laico»); le botteghe, le aule e le osterie come luoghi di trasmissione molecolare di una mentalità posttradizionale. Oltre alle occasioni di evasione, contano le risorse disponibili: Fincardi incentra la sua attenzione sui modelli di sociabilità, ricreativa e poi rivendicativa, che i braccianti mutuano dal contatto e dall’interazione con il mondo piccolo-borghese. In particolare le forme dell’associazionismo antagonista, dalle società di reduci garibaldini ai gruppi radicali, fungono da matrici per quelle contadine: di qui la forte politicizzazione e sindacalizzazione dei braccianti padani (a loro – ci ricorda l’autore – e non al proletariato di fabbrica del triangolo industriale si devono le lotte più accese e i risultati più consistenti della storia italiana); ma anche il paradossale effetto nazionalizzante che esercita su di loro la scelta internazionalista, proiettandoli su una scala diversa da quella paesana e ponendoli a confronto con problemi e strumenti del tutto diversi da quelli propri del mondo di antico regime (Fincardi parla provocatoriamente di una «nazionalizzazione concorrente»). Questo impianto analitico e l’approccio interpretativo che ne deriva, suggeriscono spunti euristici anche sulla storia che segue: è proprio guardando alla vitalità dell’Italia mediana, culla degli estremismi di ogni colore, che si possono, infatti, cogliere meglio le strategie di affermazione del fascismo agrario, la sua premura nello «sbracciantizzare» l’area padana, la sua mitopoietica di un «ruralismo» neutralizzante, il suo collateralismo alle forze della reazione. Così anche si può capire la funzionalità allo sviluppo di quella linea rossa che congiunge, pur attraverso non trascurabili discontinuità, il socialismo prampoliniano (ma anche – sembra dire Fincardi – il sindacalismo rivoluzionario) al riformismo postbellico; con una lettura del «modello emiliano» imperniata sul paradosso di una cultura di parte che diventa matrice di civismo. E ancora si possono proporre interessanti considerazioni sull’oggi e sulla drammatica situazione di un nuovo bracciantato, quello dell’immigrazione, che al contrario di quello qui in esame, manca di una cultura associativa e di luoghi di contiguità con il moderno tali da far intravedere per lui una promozione sociale (senza la quale peraltro, ci dice l’autore – non può esservi sviluppo). Si tratta dunque di un libro denso e ambizioso, per questo non sempre facile e talvolta discutibile, ma sempre assai stimolante, anche per chi non si occupa di storia rurale: tra teatrini di paese e parroci disperati, vi si ritrovano, infatti, luci e ombre della nostra storia profonda. Mirco Carrattieri L. Baldissara (a cura di), Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei «lunghi anni Settanta», L’Ancora del Mediterraneo, Napoli-Roma, 2008, pp. 571, 30 € Il volume che raccoglie gli esiti di una ricerca promossa dal Centro Studi R60 affronta il problema di una lettura storiografica degli anni Settanta, letti attraverso 168 l’osservatorio reggiano, osservatorio privilegiato per la ricchezza e la complessità dei fenomeni politici e sociali che in quegli anni seppero esprimersi proprio nella nostra provincia. Un decennio di grandi movimenti sociali, di trasformazioni antropologiche e anche, purtroppo, di un’esplosione della violenza politica che ebbe proprio nel nostro territorio uno dei suoi punti di elaborazione ed avvio. Gli anni Settanta letti come come frattura cronologica, segnata dalla crisi del modello capitalistico e dalla crisi della politica incapace di dare risposte adeguate alle istanze di partecipazione innescate dalle lotte studentesche ed operaie. Un periodo di grande dinamicità per affrontare il quale, come Baldissara suggerisce nella introduzione (corredata anche da una «bussola bibliografica» di grande utilità), è necessario «volgere lo sguardo a quegli anni come a delle rapide, attraverso le quali lo scorrere dei processi storici viene repentinamente accelerato, e dove la pendenza e la velocità imprimono un vorticoso rimescolamento ai fenomeni sociali e politici, alle dinamiche economiche ed istituzionali, provocando il precipitare di quei processi verso esiti poco prima ancora inaspettati e inimmaginalbili, aprendo nuovi scenari e mutando i fondamenti su cui poggia l’ordine della società». Ma la lettura che le varie ricerche propongono assume una dimensione necessariamente allargata, per approfondire il periodo in questione anche alla luce di un percorso avviato nel dopoguerra e che trova nella svolta del 1959 il suo punto di accelerazione quando il pci con la Conferenza regionale, che segnò l’adesione, pur in sensibile ritardo, alle posizioni dell’VIII Congresso nazionale del 1956, accettò di governare lo sviluppo, la «grande trasformazione», non solo tramite quel corporativismo municipale che si esprimeva in promozione localistica e protezione comunitaria ma perché si capì subito (o quasi) che la crescita economica era nello stesso tempo la precondizione necessaria dell’emancipazione delle classi popolari e il tramite di avvicinamento tra classe operaia e ceti medi. Una scelta che riesce a conciliare l’identità comunista con la modernità dirompente, riuscendo a costruire quel «modello emiliano» che, non a caso viene proposto come esempio/alternativa ad una crescita che produca lacerazioni, fratture e ingiustizie sociali. La ricerca si snoda attraverso tre grandi filoni tematici (economia e società, sindacato e istituzioni, politica e culture) che riescono ad attraversare gran parte dei fenomeni che la provincia reggiana seppe esprimere in quegli anni in termini di innovazione e capacità di progetto, dalla ristrutturazione industriale allo sviluppo della piccola impresa, dalla centralità del «comune democratico» alla crisi economica e i ritardi del sindacato, dalla militanza nella stagione dei movimenti alla elaborazione di innovative politiche culturali in sintonia con quanto di più avanzato si stava producendo nell’effervescente scenario internazionale. (ms) D. COLOMBO, L’estate delle magliette a strisce. Luglio 1960, la rivolta contro Tambroni, Sedizioni, Milano 2008, 14 € Diego Colombo, corrispondente dalla Brianza per il «Corriere della Sera», nel suo libro L’estate delle magliette a strisce narra degli scontri di piazza e delle rivolte del luglio 1960, delle tre settimane che sconvolsero il Paese. 169 L’autore dà un taglio giornalistico all’opera cercando di rimanere il più possibile fedele ai fatti, coinvolge in medias res il lettore, lo catapulta nel clima teso di un’Italia che, a quindici anni dalla Liberazione e mentre erano ancora in vita e attivi quasi tutti i suoi protagonisti, viene travolta dal ciclone del governo Tambroni formatosi con i voti decisivi del msi, erede diretto del fascismo. Non si tratta di semplice cronaca degli eventi, il libro ripercorre i dolorosi avvenimenti che funestarono quell’estate dando risalto alle testimonianze dei suoi protagonisti, i ragazzi delle magliette a strisce ma anche i partigiani e gli operai. In quegli anni, in cui avveniva la grande trasformazione italiana del boom economico, i giovani erano visti come avulsi dall’impegno politico o marginalmente toccati dalle questioni di partito, «nelle cronache dei giornali indossavano jeans lisi, portavano i capelli lunghi, giravano in vespa, avevano il mito dell’America … a differenza dei loro padri, ogni ora trascorsa in fabbrica era un’ora rubata all’unica cosa che li interessava davvero, essere giovani. Non erano iscritti al sindacato ... Ma quando c’era da scioperare non si tiravano indietro … La politica ci stava nella loro vita. Senza esagerare però…» (pp. 81-82). Questi giovani sono il fulcro della «Nuova Resistenza», la generazione a cui molti di noi avrebbero voluto appartenere; l’autore stesso, l’8 agosto 2008 durante la presentazione del libro a Reggio Emilia (organizzata da «Pollicino Gnus» in collaborazione con istoreco), la definisce la «generazione dei suoi vent’anni», non è un dato cronologico ma si tratta della mitizzazione di un gruppo di giovani capaci di esprimere il loro dissenso. Una generazione consapevole, infatti il «mito della Resistenza aveva fatto breccia tra i figli della guerra. I più giovani, quelli nati appena prima o durante il secondo conflitto mondiale, erano cresciuti a pane e antifascismo…» (p. 87). I ragazzi delle magliette a strisce sentirono la necessità di scendere in piazza per rinnovare la lotta antifascista e per contrastare Tambroni che, con la sua politica («Quo tua te virtus: fin dove ti condurrà il tuo valore»*), diede inizio al processo di legittimazione del msi che decise di tenere il VI congresso a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, dal 2 al 4 luglio 1960. È evidente che questi avvenimenti politici riaprirono le ferite lasciate dagli orrori del secondo conflitto mondiale, che avevano visto contrapporsi partigiani e fascisti. Il discorso di Pertini alla vigilia degli scontri ne è la conferma: «Io nego che i missini abbiano il diritto di tenere a Genova il loro congresso … Si tratta, del resto, di un congresso che viene convocato qui non per discutere ma per provocare e contrapporre un passato vergognoso ai valori politici e morali della Resistenza … Difendiamo la Resistenza» (pp. 27-28). Parola chiave è «Nuova Resistenza», infatti Colombo cita un articolo di Carlo Levi uscito su «Vie Nuove», intitolato proprio La Nuova Resistenza, nel quale si fanno coincidere le manifestazioni di piazza con una nuova lotta di Liberazione che ebbe inizio a Genova e in breve si diffuse in tutta Italia: le piazze si riempirono di giovani a Licata, a Roma, a Reggio Emilia, a Palermo e a Catania. Gli scontri furono duri e l’autore li descrive, senza tralasciare alcun particolare, attraverso gli occhi di coloro che vissero in prima persona le cariche e la violenza delle forze dell’ordine, dei parenti e gli amici delle vittime, di coloro che sono stati condannati al carcere perché sovversivi. I capitoli «Quaranta minuti di sangue» e «Martiri straccioni» sono interamente dedicati all’eccidio di Reggio Emilia, si tratta della minuziosa cronaca 170 dei fatti, della descrizione dei suoi protagonisti, ovvero giovani e partigiani che scesero in piazza per evitare il ripetersi della storia. Lauro Farioli, Marino Serri, Afro Tondelli, Emilio Reverberi, Ovidio Franchi sono cinque delle dodici vittime di quell’estate tragica e nel contempo rivelatrice di una «Nuova Resistenza», intesa come momento nuovo ma anche di continuità con la Resistenza del secondo conflitto mondiale. L’antifascismo del luglio 1960 si esaurì con la caduta del monocolore Tambroni a dimostrazione che i giovani protagonisti di quell’estate erano motivati e consapevoli, ognuno di loro con la sua storia ha contribuito a rendere quella generazione unica. Loredana P. Cicciù * P.G. Murgia, Luglio 1960, Sugar, Milano, 1968, p. 53, nota 13. L. BINCOLETTO, L. SMANIOTTO, Il fronte a casa nostra. Il Basso Piave nelle immagini e nei ricordi della Grande Guerra, Biennegrafica, Musile di Piave (VE) 2008, pp. 223, s.i.p. Il volume offre una ricostruzione degli eventi bellici che sconvolsero l’area del Basso Piave a partire dall’ottobre 1917, fino alla cessazione delle ostilità. La disfatta di Caporetto e la rapida avanzata austriaca trasformarono in campo di battaglia città e paesi che erano rimasti a lungo di retrovia. Una marea umana di reparti italiani in ritirata investì in particolare le cittadine di San Donà di Piave (VE), sulla riva nord, e della vicina Musile, su quella sud, attestandosi ad estrema difesa proprio sulla linea del fiume ed ingaggiando combattimenti continui con le forze austriache avanzanti. Il successo nella battaglia per fermare l’esercito austriaco sul fiume impose ai luoghi rivieraschi un tributo imponente di distruzione e morte. Intere cittadine quasi completamente distrutte furono il tragico lascito dei mesi del «fronte a casa nostra». Tante furono anche le vittime fra gli abitanti e migliaia i civili in fuga, profughi in lontanissime località della penisola. Il lavoro dei curatori del volume, presentato a Musile unitamente ad una mostra commemorativa, riporta con notevoli dettagli e pregevole efficacia la cronaca delle operazioni sulla scala locale, con dovizia di immagini fotografiche e mappe dei luoghi, oltre a numerosi racconti di militari protagonisti e civili testimoni di quei drammatici momenti vissuti dalle comunità al centro della narrazione. Dalle pagine emerge poi uno sconosciuto e sorprendente aggancio reggiano. Si tratta della parte del lavoro che descrive il ruolo avuto dal giovane concittadino Ettore Borghi, ingegnere allora ufficiale del Genio, nelle azioni di abbattimento dei ponti sul Piave, estremo tentativo di arrestare l’avanzata austriaca. La descrizione delle operazioni è molto precisa e corredata, fra le altre, da inedite immagini riprese da un album fotografico redatto dall’ufficiale reggiano ed ora in possesso ereditario dell’omonimo nipote, che lo ha messo a disposizione dei curatori e del pubblico. I ponti sul Piave fatti saltare dalla 20a Compagnia minatori, comandata da Borghi, il giorno 9 novembre 1917 fra i comuni di San Donà e Musile furono due, uno ferroviario ed uno stradale, come documentano le diverse fotografie scattate dallo stesso Borghi ed ora pubblicate nel lavoro in rassegna. La cronaca originale dei brillamenti risale ai racconti di testimoni diretti degli eventi, raccolti nel primo dopoguerra in un 171 memoriale di storia locale ad opera di monsignor Costante Chimenton, professore del seminario di Treviso. Fra le testimonianze raccolte dal Chimenton nel suo memoriale, edito per la prima volta a Treviso nel 1928, spicca quella del tenente ingegner Leonardo Trevisiol, appartenente alla stessa compagnia minatori comandata dal capitano Borghi e partecipante alle azioni. La sistematica distruzione dei ponti attuata in quei giorni lungo tutto il corso del fiume fu un contributo importante nel blocco dell’incalzante azione austriaca, che ormai rischiava di dilagare nella Pianura padana. Dalle posizioni consolidate l’esercito italiano potè poi ripartire alla controffensiva nel giugno dell’anno seguente, battaglia del Solstizio, per giungere all’epilogo vittorioso il 4 novembre 1918. A conclusione appare senz’altro doveroso esprimere un particolare apprezzamento per un lavoro che, al merito di un’efficace ricostruzione degli eventi nell’area interessata, associa un’altrettanto efficace sollecitazione di interesse e di monito relativamente alla tragedia umana e materiale delle guerre, rivolto in particolare alle nuove generazioni. Anche lo sviluppo e l’approfondimento delle ricerche storiche su base locale possono sicuramente trarre significativi stimoli da una lettura del volume. Amos Conti A. Mammi, La stagione ostile, comuni di Scandiano Casalgrande, Rubiera, Castellarano, Baiso, Viano 2008, pp. 157, s.i.p. Il professor Mammi ha raccolto decine di testimonianze e interviste di ex deportati militari e lavoratori coatti civili e dei loro parenti al fine di ricostruire la realtà della deportazione in una zona nevralgica della provincia reggiana quale il distretto delle ceramiche. Una ricerca (nata per volontà dello spi-cgil della zona fra il Secchia e il Tresinaro) dettagliata e paziente attraverso tutti i comuni del comprensorio, svolto anche con l’ausilio delle carte delle associazioni di ex combattenti e internati al fine di ricostruire anche una sorta di mappa volta a conoscere quanti residenti nel territorio hanno vissuto la terribile esperienza della vita nei campi di concentramento nazisti. Non tutte le interviste fatte sono state pubblicate nel volume, ma la scelta non è stata fatta in base a criteri per così dire «commerciali», bensì, come tiene a sottolineare l’autore nella sua postfazione, in base alla possibilità di tracciare un profilo coerente e completo dell’interessato. Non solo la sua esperienza di deportato, ma anche la sua vita precedente e quella successiva, per chi ne ha avuto la possibilità. Molto interessante è il taglio che si è voluto dare al libro: non la classica domandarisposta delle interviste, ma qualcosa di diverso, di più accattivante per il lettore. Senza nulla togliere alla veridicità delle testimonianze raccolte, l’Autore ha scelto di esporle in forma narrata, come tanti racconti di un’esperienza che per tutti ha avuto tratti inevitabilmente comuni e al tempo stesso per tutti è stata così unica e personale. In tal modo gli intervistati diventano quasi i veri autori del libro con le loro storie, gli aneddoti, le speranze e le paure vissute durante la loro stagione ostile. In maniera diretta e inequivocabile raccontano, i protagonisti, di «aver rubato le patate ai maiali», di aver avuto la vita salva grazie ad un orologio, di aver pianto per la fame, di essere sopravvissuti alle terribili grotte di Kahala. Ma c’è anche chi è tornato a casa da Mauthausen 172 cinquant’anni dopo, dentro una piccola cassa. In appendice sono stati pubblicati numerosi documenti e fotografie sul lager di Kahala, sui comitati di aiuto ai prigionieri rimpatriati, gli intervistate e anche alcune lettere scritte a casa durante la cattività. (mb) G. CASTAGNETTI, I racconti del Crostolo. Storie, memorie, fantasie, Dea C. editrice, Montecavolo (RE) 2007, s.i.p. A prima vista, Castagnetti si muove sul piano dell’aneddotica, fra bozzetto, evocazione e curiosità. Una più attenta lettura consente però di cogliere nel libro un lavoro di precisa identificazione di un luogo (l’area lungo il Crostolo aggrumata attorno all’istmo sottile che collega le due sponde: la passerella per ciclisti e pedoni di via Premuda) e di una stagione (i decenni che precedono l’esplodere del boom economico ed edilizio). Un territorio bipartito dalle esigue acque del torrente, ma strettamente connesso nella stessa toponomastica, d’ispirazione risorgimentale e soprattutto garibaldina (a Goito, Pastrengo, Marsala, Milazzo fanno simmetrico riscontro Calatafimi, Volturno, Curtatone, Castelfidardo, per limitarci a pochi esempi). Periferia ancora ieri, se non fosse che la prossimità del cimitero monumentale ne ha fatto da sempre qualcosa di più di un borgo separato, piuttosto uno dei punti focali nella rappresentazione del territorio comunale da parte di tutti i reggiani. Alle persone e agli atti di quella stagione l’Autore si rivolge bensì da narratore, ma con lo sguardo dell’antropologo e dell’archeologo. Sa, infatti, di descrivere il «mondo di ieri», di cui nelle pagine introduttive si fa esplicita guida per il lettore. Dell’archeologo coltiva l’attenzione per gli oggetti della vita quotidiana (gli attrezzi da lavoro, la suppellettile, gli indumenti, i cibi e le bevande, o piuttosto il lambrusco, universale bevanda-conforto delle vite grame). Dell’antropologo possiede la capacità d’immersione, la disponibilità a compiere indagini sotto forma di esperienza partecipata. È questa la matrice di un raccontare che non è narrazione di fatti, ma narrazione di narrazioni. Appare cioè, in filigrana, una comunità intessuta di relazioni faccia-afaccia, dove il ricordo qualche volta caricaturale e il frequente commento (talora anche malizioso e pungente) della figura o dei comportamenti altrui sono merce quotidiana che non nuoce, anzi sottolinea la sostanziale solidarietà e simpatia nei rapporti interpersonali. Il vicinato, insomma, come convivenza effettiva, essendo di là da venire la mera condivisione dell’indirizzo e del codice postale, propria delle più recenti «folle solitarie». Ovviamente non manca, in Castagnetti, un sorvegliato, personale piacere del narrare, coltivato per passione e affinato alla scuola di scrittura creativa della professoressa Iris Ruozzi, a cui l’Autore riconosce il merito di «accompagnare per mano alla conoscenza e alla pratica» gli allievi della benemerita Università dell’età libera. (eb) 173 M. PELLEGRI, Parma 1943-1945. Le ferite della guerra e la rinascita della città, mup Editore, Parma 2006, pp. 300, s.i.p. Cronaca per immagini, ci sembra la definizione più appropriata per il lavoro di Marco Pellegri. La cronistoria delle incursioni aeree sulla città di Parma e dintorni, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, viene scandita grazie a sintetiche descrizioni e corpose serie di immagini, tutte di notevole suggestione e capaci di evocare nel lettore la drammaticità degli eventi. Lo scopo di testimoniare uno dei flagelli più odiosi della guerra, quello dei bombardamenti aerei, appare senz’altro raggiunto. La forza evocativa delle foto colte sul campo, quasi in tempo reale con gli eventi, offre ai cittadini di oggi e alle nuove generazioni, in special modo, l’opportunità di incidere in modo indelebile nella memoria collettiva, di poter rivivere in ogni momento una tragedia umana e materiale di proporzioni impensabili per chi non sia stato testimone diretto e cosciente. Rivivere la storia, raccogliere il monito! Il lavoro, dopo le opportune premesse sulle prime fasi della guerra, accompagnate dalle immagini di una città ancora integra nel suo tessuto urbano, caratterizzato da importanti edificazioni storiche, procede con la descrizione particolare dei cinque bombardamenti aerei alleati di tipo pesante, o strategico, subiti da Parma nel breve volgere di due mesi, fra il 23 aprile ed il 22 giugno 1944. Due mesi che registrano la devastazione di numerosi quartieri del centro urbano, provocando circa quattracento vittime fra i civili. Gli obiettivi dichiarati dagli Alleati sono sempre lo scalo ferroviario, i ponti e le infrastrutture connesse, ma l’imprecisione dei colpi non risparmia nulla e nessuno ed ogni volta pagano i civili. La stampa locale attribuisce gli attacchi alla volontà degli Alleati di colpire la popolazione e giunge a pubblicare un’invettiva contro il celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini, concittadino, colpevole di essere emigrato negli Stati Uniti e di appoggiarli nella loro guerra criminale. La descrizione dei singoli eventi è corredata dalle immagini delle distruzioni nei quartieri maggiormente colpiti, con una particolare evidenza per gli edifici storici e di culto. Molte foto riprendono al tempo stesso i cittadini. Donne ed uomini accorsi sui luoghi distrutti, che appaiono attoniti, sbigottiti di fronte al quell’incomprensibile scempio delle proprie case, della propria città, della propria storia. Altre foto poi ci riportano alle precipitose fughe dalla città in occasione degli allarmi: un esodo di massa destinato a ripetersi quasi ogni giorno in una sorta di caotica transumanza. Le parti conclusive del volume, oltre a descrivere in breve le fasi finali del conflitto, rappresentano con altrettanta efficacia le fasi della ricostruzione, ponendo a confronto le immagini dei luoghi colpiti con quelle della ricostruzione. Un aspetto che infine avrebbe meritato adeguato rilievo, essendo l’occasione propizia, è quello delle vittime civili, per le quali si riportano solo dati numerici. Dare un nome e, per quanto possibile, un volto a queste vittime innocenti del conflitto, avrebbe contribuito a meglio onorarle e a scolpire il loro sacrificio nella memoria di tutti. Ciò senza nulla togliere alla pregevole sostanza dell’opera ed alla capacità di coinvolgere emotivamente il lettore di altre città; un’opera che ogni città colpita dovrebbe poter annoverare nel proprio corredo storiografico. Amos Conti 174 C. Dionisotti, Scritti sul fascismo e sulla Resistenza, Einaudi, Torino 2008, pp. LXVIII-276 25 € Se volete prendere le distanze dalle malinconiche polemiche seguite alle recenti celebrazioni dell’8 settembre, ma contemporaneamente ritrovare un terreno solido a cui ancorare il disgusto per ogni operazione di disinvolta svalorizzazione di quanto abbiano significato nella storia d’Italia l’antifascismo e la Resistenza, troverete ora in libreria un insperato soccorso dalle parole di un grande Maestro degli studi italiani, per usare le parole di Carlo Ossola. Da tempo annunciati, infatti, escono ora questi scritti di Carlo Dionisotti, recuperati integralmente da Giorgio Panizza, che, in un’ampia e circostanziata introduzione, non si limita a contestualizzare i testi raccolti, ma riesce ad offrire un quadro assai stimolante del retroterra culturale e politico nel quale essi hanno preso vita. Così la fisionomia di questo filologo piemontese, formatosi a Torino nel gruppo di Giustizia e libertà insieme con Aldo Garosci, «cospiratore latente» come egli stesso avrebbe detto di sé e del collega Arnaldo Momigliano, capace di coniugare rigore degli studi storici e letterari con un antifascismo radicale ed appassionato, esce quanto mai viva e stimolante. Come ricorda Massimo Raffaeli in un acuto commento su «Alias» (supplemento del sabato del «Manifesto» del 2 agosto 2008), «allievo del nazionalista e fascistissimo Vittorio Cian, con assoluta dignità e senza mai recedere dal proprio antifascismo, Dionisotti aveva trascorso gli anni apicali del regime fra le carte degli autori umanistico-rinascimentali, presto divenendo il massimo fra gli specialisti di Bembo e Machiavelli … i mesi della occupazione tedesca li aveva trascorsi a Roma cercando rifugio nelle sale della Biblioteca Vaticana da cui trasse l’edizione, vibrante di spirito civile, della Orazione ai nobili di Lucca, di Giovanni Guidiccioni, il testo che rimanda alla violenta sollevazione popolare del 1531 contro una oligarchia tirannica e corrotta». Una sorta di legittimazione storica della stagione della Resistenza. L’impegno diretto sulla stampa di partito durerà i pochi mesi successivi alla Liberazione, prima del trasferimento in Inghilterra, ma sarà sufficiente a consolidare nello studioso di straordinario rigore l’impegno a vigilare anche da lontano contro ogni appannamento del giudizio storico e politico sul ventennio. Cinque le sezioni del volume: i testi redatti in clandestinità, fra il ’42 e il ’44, gli scritti successivi, testi per la radio e le prime forme della stampa libera, abbozzi di progetti editoriali, pagine degli anni Sessanta (con passaggi di grande interesse sia sui pericoli del neofascismo missino sia su alcune approssimazioni nei richiami alla Resistenza da parte del movimento studentesco), due ultimi interventi sui pericoli ricorrenti nella storia italiana di eterni trasformismi. Impossibile in questa sede ripercorrere le tappe di un pensiero, che pure emerge in modo molto nitido, nonostante la eterogeneità dei testi raccolti. Siano consentite due sottolineature: il nesso tra una cultura storica e letteraria, che cerca di individuare le difficoltà originarie di un Paese dalle tradizioni civili complesse e problematiche, e un antifascismo radicale e conseguente, debitore della grande lezione politica e morale di Piero Gobetti, con l’approdo ad un giudizio inappellabile del regime, con le sue pretese di dominare la storia e la sorte degli individui (indicativi a questo proposito i 175 commenti sulla vicenda Gentile, inquadrata nel contesto di una lotta senza quartiere tra tirannia e libertà), l’amore per la scuola e la formazione, considerati come veri antidoti ad ogni tentazione totalitaria. Non mancano su questo punto, negli scritti più vicini a noi, osservazioni critiche e disincantate sulla caduta del livello degli studi e sui pericoli delle approssimazioni culturali. Anche contro queste derive, il richiamo alla Resistenza si fa voce alta ed appassionata, ben lontana dalle tentazioni della retorica. In un testo del 1965, a proposito delle polemiche storiche e politiche per «non aver saputo e potuto coronare l’opera della Resistenza con un’Italia più sana, più schietta, più nuova», Dionisotti invita sommessamente e laicamente considerare la sostanza, per certi versi straordinaria, di quella rivolta di popolo, che pure ci ha lasciato tanti problemi insoluti, da cui si deve partire per un nuovo slancio, pure in tempi così diversi. «La storia aspra e pronta della Resistenza, irriducibile ai miti retorici, ai belletti e agli impiastri letterari che purtroppo ricoprono tanta parte della storia d’Italia, pare fatta apposta per aiutarci a vivere questo pezzo di vita che ci resta: una vita anche aspra e pronta e senza illusioni, ma non senza l’incanto di una maggiore libertà e di una maggiore giustizia nella convivenza umana». Lorenzo Capitani R. ATKINSON, The Day of Battle. The War in Sicily and Italy 1943-1944, Little/ Brown, London 2007, 35 £ Queste sporadiche note a margine non intendono essere una recensione, né l’impossibile riassunto dei contenuti del libro, ma è sperabile che riescano egualmente a suggerire quanto utile ed interessante ne sia la lettura. Il taglio è quello classico del candidato al premio Pulitzer: la gamma delle fonti è vastissima (la sola selezione riportata in bibliografia occupa trenta pagine molto fitte, mentre la lista completa è fornita online). Però la predilezione per la voce diretta dei protagonisti (diari, lettere) consente al racconto di evitare sia la farragine del lavoro «accademico» sia la tecnicità impersonale delle storie «ufficiali» di parte britannica e americana, che pure sono più volte usate. Qualcosa di più, insomma, della seria divulgazione, ma con esiti altrettanto avvincenti. L’opera si rivolge principalmente ad un pubblico anglosassone per parlargli di una lunga campagna militare svoltasi in Italia, e proprio questo lato presenta agli occhi del lettore italiano una serie di piacevoli sorprese. Innanzi tutto appare insolitamente accurata – nelle pagine di un non «italianista» – la grafia della toponomastica e delle espressioni della nostra lingua integrate nel testo. Data la notevole frequenza di nomi e frasi in italiano il tasso delle sviste, molte delle quali veniali, è infatti quasi trascurabile. Ancor maggiore simpatia suscita la folta serie di richiami alla storia della Penisola, in epoca classica, medievale e recente, che l’Autore, senza trascurare le storie di Livio o i grandi miti letterari omerici e virgiliani, presenta ai suoi presumibilmente ignari lettori, seguendo il lento procedere del fronte che semina lutti e paesaggi lunari in quella terra di vigne e di ulivi e di echi del passato. Non solo «le mura e gli archi», ma le grandi figure (Benedetto a Montecassino, Tommaso ad Aquino…), i costumi e le genti. 176 Alla sofferenza del nostro popolo meridionale, che più volte negli undici mesi minuziosamente raccontati (luglio 1943-giugno 1944) raggiunge il livello di vera e propria catastrofe, Atkinson rivolge molta attenzione, per lo più attraverso le parole dei testimoni (militari e giornalisti non ancora embedded nel senso attuale del termine). Sono tragedie collettive che toccano una miriade di città martiri (Adrano, Messina, Bari, le «piccole Stalingrado» come Ortona e Cassino…), ma anche singoli episodi indimenticabili, come quando in una casa colonica della campagna avellinese un plotone in avanzata scopre una donna dal volto di antica pergamena che veglia su quattro figli uccisi dalle bombe, o quando, ad Anzio, in una stalla vengono scorte e immediatamente liberate sei donne incatenate e in procinto di essere messe a morte perché scoperte in possesso di cibo procurato al mercato nero di Roma. Se si guarda bene al contesto, persino nel termine gergale «Dago», con cui spesso nelle loro lettere gli americani in divisa designano noi italiani, è dato rilevare più compartecipazione e simpatia che non l’originario dileggio. Ovviamente una grande cura e un’attenta riflessione vengono dedicate alle due tragedie a noi più note (anche se non ci si può troppo illudere sulla stravagante memoria degli italiani: intermittente, al fondo familistica e media-dipendente). Alla distruzione di Montecassino è dedicata una lunga analisi, che ne rivela i retroscena e ne denuncia il doppio errore, umanitario e strategico. Le uccisioni e gli stupri di gruppo commessi dalle truppe coloniali comandate dal generale Juin sono narrati anche nello specchio dell’indignazione espressa da molti Alleati, come quel cappellano militare che, nel denunciare i fatti a Clark, gli scrive che gli uomini della sua formazione erano più disposti a sparare sui Goumiers che sui tedeschi. Un altro aspetto del nostro Paese che costituisce un’amara scoperta e un tema ossessivo nei diari e nelle lettere di chi lo veniva scoprendo a proprie spese è la natura del territorio: i fiumi a carattere torrentizio (Rapido, Volturno…) ma soprattutto i rilievi della dorsale appenninica. L’orografia della penisola, entro certi limiti propizia alla guerra partigiana, si rivela nella guerra ordinaria un’esasperante successione di ostacoli che favoriscono chi si difende e condannano gli attaccanti a gravissime perdite. Per molti comandanti inglesi e americani la situazione sembra riprodurre gli incubi della Grande Guerra, in cui la maggior parte di loro aveva compiuto le prime esperienze. Nella sua prospettiva, il racconto di Atkinson è, per così dire, «dalla parte degli Alleati», nel senso che di loro si colgono molto attentamente le voci e i giudizi dei capi militari e politici, ma spesso, in forma ricorrente quando la fonte è interessante, anche quella dei testimoni di rango intermedio o dei soldati semplici, mentre la parte germanica è studiata limitatamente alle figure dei comandanti (Kesserling, von Senger und Etterlin, von Mackensen…) e ai loro rapporti con Berlino. Non c’è però nel libro niente di apologetico o di encomiastico, anzi vengono alla luce con chiarezza i limiti personali (l’intemperanza di Patton, la vanità di Clark, la scarsa considerazione in cui alcuni generali americani tenevano Montgomery) ma soprattutto quelli organizzativi e strategici, come la carente coordinazione fra le diverse armi, marina, aviazione, fanteria, truppe corazzate, che ebbe esiti catastrofici nelle operazioni di sbarco, e fu occasione primaria di gravissime perdite a causa di quello che, con l’attuale eufemismo, si chiamerebbe «fuoco amico». Quello che si scopre con chiarezza è che nella guerra la strategia non viene ap- 177 plicata, ma sperimentata per la prima volta. La Sicilia, Salerno, Anzio fanno scuola, in corpore vili, per lo sbarco in Normandia. Ma la guerra fa scuola anche in un altro senso: non si parte con la voglia di uccidere, la si assimila strada facendo, come desiderio di rivalsa per i mesi vissuti – scrive il corrispondente di guerra Ernie Pyle – like an animal (come un animale), in un mondo estraneo dove ogni cosa è anormale ed instabile. L’esperienza delle morti e delle mutilazioni dei compagni, unita al terrore delle esplosioni e all’incubo dei cecchini, genera desideri di vendetta, con la stessa forza con cui le notizie da casa, in cui trapela la sorte delle città tedesche bombardate a tappeto, esasperano la già feroce determinazione della parte germanica. Il racconto si conclude con la liberazione di Roma, obiettivo simbolico subito espulso dalle prime pagine dall’immediatamente successiva operazione Overlord, con la quale il fronte italiano cessava di avere un valore primario agli occhi dello stesso Churchill, che ne era stato un ostinato fautore. Ma nell’Epilogo viene abbozzato il seguito e, soprattutto, viene fornito il bilancio degli «undici mesi» per il nostro Mezzogiorno. E questo è un quadro forse non abbastanza presente alla nostra coscienza di posteri più attenti a un’altra storia, quella che ebbe come teatro il Nord. Basti pensare alle mine disseminate (mezzo milione la stima solo per le dieci miglia fra Ortona e Orsogna). E poi il vanto del Regime, l’area bonificata delle paludi Pontine, di nuovo allagata e preda della malaria, così come la stessa Cassino. Paesi fantasma (come San Pietro) non più risorti nel luogo delle loro rovine. Diffusione massiccia di tifo, epatite, meningite, tubercolosi. Per questa tragica storia, che accomuna una delle pagine più dure del nostro passato alla sorte di tutta una generazione sacrificata (ogni continente ebbe combattenti e caduti in Italia) non si può dare miglior commento delle parole antiretoriche pronunciate dal generale Lucian Truscott, il successore di Clark al comando della Quinta Armata, nel cimitero americano di Nettuno in occasione del Memorial Day 1945. Egli promise che se si fosse imbattuto in qualcuno, specialmente se uomini di età, che giudicasse gloriosa la morte in battaglia, avrebbe dato loro una sistemata (he would straighten them out). Ettore Borghi F. CASSATA, Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e politica, Carocci, Roma 2006, pp. 225, 18 € Il libro ricostruisce la carriera di Corrado Gini, demografo, statistico e sociologo, la cui opera si è strettamente intrecciata alla politica demografiche del fascismo, soprattutto fino alla prima metà degli anni Trenta. Fra la metà degli anni Venti ed il 1932, Gini è presidente dell’istat e del cisp (Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione) e, «forte del proprio rapporto diretto e personale con Mussolini, mantiene una sostanziale egemonia nella “costruzione scientifica” della politica demografica del regime» (p. 13). Senza dubbio, l’opera dello studioso di Motta di Livenza è importante nell’affermazione della campagna popolazionista del regime (e nella compilazione del celebre Discorso dell’Ascensione, tenuto da Mussolini nel maggio del 1927). 178 Così Cassata sintetizza la posizione di Gini nell’ambito dei rapporti fra la sua scienza e la politica durante il ventennio: «Gini può sostenere la politica natalista non in quanto militante politico, ma in quanto scienziato. In secondo luogo, l’adozione del paradigma della “popolazione” contro quello della “società” consente una neutralizzazione scientifica del discorso ideologico, attraverso cui si realizza una legittimazione incrociata fra il campo scientifico e quello politico, basata, più che sul reciproco sostegno, sulla tendenza alla confusione degli ambiti. In questa prospettiva, a un “Mussolini statistico” spesso finisce, dunque, per accompagnarsi un “Gini politico”» (p. 54, corsivo nel testo). Cassata è già autore di un volume sull’eugenetica in Italia (Molti, sani e forti, Torino 2006), dal quale pure emerge la preminenza dell’opera giniana nella scuola italiana di eugenica «latina e fascista». L’autore del libro deve molto alle ricerche dedicate al rapporto fra demografia e fascismo, a firma di Carl Ipsen (Demografia totalitaria, Bologna 1992) e di Anna Treves (Le nascite e la politica nell’Italia del Novecento, Milano 2002). (fp) E. GENTILE, Fascismo di pietra, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 272, 16 € Il libro di Emilio Gentile, storico del fascismo fra i più noti ed apprezzati, anche oltre confine (basta scorrere, per averne conferma, le traduzioni nella sua bibliografia), è un’ottima introduzione allo studio del rapporto fra fascismo e architettura (come fra fascismo e urbanistica), lungo tutto il Ventennio. L’oggetto della ricerca, puntualmente sostenuta dalle fotografie, è segnatamente la città di Roma ed il modo in cui la capitale venne considerata dal movimento fascista (poi partito, poi regime) e dal duce in particolare. A dire il vero, «il fascismo delle origini odiava la Roma reale del suo tempo. Fu Mussolini ad innestare nel fascismo nascente il mito di Roma. Quando giunsero al potere, i fascisti avevano adottato il mito di Roma, ma continuavano a detestare la Roma reale» (p. VII). Il movimento fascista non era nato «sotto il segno» di Roma e della romanità. «Il termine “fascismo” non aveva ascendenze romane, perché derivava non dal fascio littorio ma dal termine “fascio” inteso come sinonimo di associazione, in uso nel linguaggio della sinistra» (p. 42). La parte più interessante (solo all’apparenza eccentrica rispetto all’argomento del volume) è quella dedicata al grande tentativo (fortunatamente fallito), portato avanti dal regime, di compiere (specie dopo l’Etiopia) una vera e propria «rivoluzione antropologica», rendendo gli italiani come (ma senza alcuna nostalgia) i legionari dell’antico impero romano. «La rigenerazione degli italiani, il fascismo universale, Roma capitale della nuova civiltà: sono questi i fondamentali motivi che ispirarono la più grandiosa ambizione imperiale di Mussolini, quella di diventare immortale nella storia quale fondatore di un nuovo modello di Stato e un nuovo stile di vita» (p. 198). Merita attenzione, in conclusione, il fatto che per Roma non valesse il principio fascista della lotta all’urbanesimo (anche in nome della sanità della stirpe). Solo la capitale poteva svilupparsi, secondo la «vitalità» delle metropoli moderne. Francesco Paolella 179 M. GUARINO, I soldi dei vinti, Luigi Pellegrini editore, Cosenza 2008, pp. 368, 20 € Mario Guarino è giornalista, fa dunque parte di un mondo che produce un’ingente massa d’informazioni destinate a durare per breve tempo, incalzate dalle ondate successive, con i ben noti effetti di obliterazione per accumulo o per sostituzione. I non molti lettori di periodici e le folle degli spettatori televisivi soggiacciono quindi al rischio di una rappresentazione frammentaria del presente e di un evanescente ricordo del passato anche prossimo. Guarino ha però al suo attivo un non piccolo numero di libri, che toccano alcuni dei più scottanti temi della storia italiana recente, da una tempestiva inchiesta su Berlusconi (1994), a un’indagine sui rapporti fra Vaticano e finanza, alla biografia di Licio Gelli … Fatti ben documentati, argomenti di persistente attualità, scrittura «in presa diretta». Anche questo volume ha un taglio giornalistico, come dichiara sin dal titolo, che gioca ironicamente con recenti successi di fantastoria. Non è quindi raccomandabile tanto per la scoperte di documenti inesplorati o per la ricchezza di particolari inediti, quanto piuttosto per l’accurato riordino dell’intera materia, a beneficio di tutti noi, smemorati o distratti. I soldi dei vinti segue le vicende dell’oligarchia fascista, o collegata al fascismo da affinità culturale ed interessi materiali, nell’Italia monarchica, nella repubblica di Salò e, infine, nella repubblica democratica. Di questa classe dirigente vengono alla luce le strette connessioni fra poteri ed incarichi pubblici, affarismo, sperpero e appropriazione privata delle risorse di tutti, una realtà che la propaganda fascista, coi suoi effetti d’immagine estesi oltre il crollo del regime e in parte tuttora diffusi, cercava di celare dietro l’esibizione retorica della devozione «virile» e assoluta al Capo e alla Causa. L’Autore ci guida in una folta selva di storie personali, che nell’insieme suggerisce molto più di una semplice ipotesi sulla sostanziale permanenze nel tempo degli stessi gruppi di potere, al di sotto della sottile scorza delle mutate forme politiche (monarchico liberale, dittatoriale, democratico repubblicana). Banche, grandi mezzi d’informazione, proprietà industriale, alta dirigenza dello stato e alte cariche militari, sono spesso nelle mani delle stesse persone o gruppi, caratterizzati dalla scarsa propensione o dalla dichiarata ostilità verso i principi di eguaglianza, pur quando siano presenti nelle astratte norme giuridiche e vengano formalmente omaggiati. È in particolare dopo la Liberazione che la continuità, non già dello Stato in astratto, ma della concreta titolarità degli effettivi poteri, prendendo forza dall’amnistia e dal fallimento dell’epurazione, produce il ritorno in sella dei «vinti» – o in forma gattopardesca o nel ruolo di mai domi – per niente disturbati dal vento del Nord. Gli anni della dittatura sono segnati dalla possibilità per i pochi eletti di partecipare a una grande abbuffata, spettacolo oltraggioso in quell’Italia poverissima, in cui il peso della debolezza imprenditoriale e dell’asfittica offerta di consumi grava sulla classi lavoratrici, costrette alla moderazione salariale e messe ulteriormente in difficoltà dalla «prestigiosa» difesa della lira. La nota dominante nel comportamento dei gerarchi è il conflitto d’interessi: accaparratori di cariche, spesso dotati di propri organi di stampa (molti di loro, come il duce, provengono dal giornalismo), sono regolarmente al centro di un rapporto fra 180 spesa pubblica e affari privati, svolgendo il comodo e profittevole ruolo di controlloricontrollati, o di committenti (per la parte pubblica) di commesse a società in cui hanno personale interesse. Gli sperperi connessi alle insensate operazioni coloniali (grandi opere, forniture belliche), mentre spolpano le risorse pubbliche sono alla base d’ingenti fortune private. Mondo finanziario e mondo industriale (una concentrata oligarchia di famiglie tempestivamente schierate a favore del fascismo e aduse già nell’epoca liberale a giovarsi della protezione statale) partecipano al banchetto, salvo rifugiarsi sotto l’ala protettrice dello stato nei momenti di crisi. Non sono esenti dall’offrire facili guadagni a beneficio di pochi individui nemmeno le opere, come Cinecittà e l’industria cinematografica in genere, che pure sono indizio di una lucida capacità di cogliere l’importanza di questo nuovo settore (peraltro ben sfruttato mediante la propaganda dei cinegiornali). Nella repubblica di Salò vi è una coincidenza perfetta fra gli artefici delle più bieche crudeltà e la rapina sistematica come ragion d’essere delle loro azioni. La persecuzione degli ebrei, ad esempio, vede particolarmente attive le più efferate bande (Carità e Koch in primo piano) che primeggiano nella razzia dei beni ebraici (quadri, tappeti, opere d’arte, ma anche i più elementari oggetti di uso personale) e nella successiva appropriazione a personale beneficio, in violazione delle stesse norme emanate in materia dallo stato fantoccio! La cancellazione delle colpe operata dalla cosiddetta amnistia Togliatti (in realtà atto collegiale del governo De Gasperi) restituendo la libertà ai responsabili dei delitti comuni o politici (anche «ordinariamente efferati»!) lascia generalmente nelle loro mani, o in quelle dei loro eredi, anche il maltolto (oltre a funzioni e gradi negli impieghi civili e militari). La quasi immediata costituzione del msi è indizio certo che la volontà di pacificazione che stava alla base di quelle decisione venne interpretata dai beneficiari sostanzialmente come atto di debolezza da parte dei «vincitori» e come frutto della propria rinnovata capacità di condizionarne le scelte e di rimanere nel gioco, grazie anche alle più disparate relazioni ancora in vita con enti e personalità (anche religiose) molto influenti. Perché, dimostra chiaramente l’Autore, la storia di un neofascismo corpo estraneo rispetto al sistema di potere della «prima» Repubblica, indenne da divisioni interne e immune dagli scandali finanziari e dai versamenti occulti propri di quella stagione altro non è che un mito propagandistico (Guarino cita, fra l’altro, i rapporti di denaro con un giovane Berlusconi e con un navigato Licio Gelli negli anni Settanta). Citando Giorgio Galli, Giorgio Bocca e Paolo Sylos Labini, l’Autore afferma in conclusione che c’è un’evidente linea ereditaria fra l’affarismo predatorio attuato dai gerarchi sin dagli anni Venti e quello che appare trionfante nella politica attuale. Ed è curioso che questa tesi di una linea di continuità sia messa in discussione dallo stesso Editore dell’opera, che, nella pur elogiativa introduzione affidata a Saverio Di Bella, prende le distanze sia da tale valutazione sia, più in particolare, dall’affermazione che «il virus principale del berlusconismo» consista nel «denaro come valore assoluto della vita». Ci si domanda se gli stessi rilievi sarebbero stati formulati se il libro si fosse stampato soltanto qualche mese più tardi. Ettore Borghi 181 A. KERSEVAN, Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943. Nutrimenti, Roma 2008, pp. 287, 18 € Quello del «confine orientale» è uno dei tanti aspetti della storia del nostro Novecento su cui le prese di posizione di ordine politico (o addirittura «istituzionale») e le ricerche di natura propriamente storica hanno costituito un intreccio pressoché inestricabile. Ma in nessun altro caso si è assistito a una vera e propria campagna organizzata, con una strategia di lungo periodo, da un ben individuato settore dello schieramento politico (quello neo, post o filofascista), i cui sforzi sono stati coronati da un innegabile successo: far sì che un episodio relativamente circoscritto di displaced persons e di contropulizia etnica fosse considerato dall’Italia ufficiale un evento inaudito, capace di assumere, data la sua eccezionalità, il valore di simbolo e di memento per tutta la comunità nazionale. L’obiettivo di far diventare senso comune un punto di vista a dir poco parziale esige la messa in opera di sistematici interventi almeno a due livelli, uno esplicito e apparentemente arduo (imporre una propria «narrazione», a dispetto della crescente disponibilità di contrastanti ricostruzioni scientifiche), uno più implicito, favorito da preesistenti convinzioni di generica, ma diffusa matrice «culturale» o scolastica (assumere a propria premessa un insieme di sottintesi per così dire «etici», connessi con l’ideologia nazionalista e militarista, dando per scontata la loro universalità). Sotto questo secondo profilo risulta essenziale la neutralizzazione, o «naturalizzazione» etica della guerra, da cui consegue la non imputabilità dell’iniziativa bellica e di tutte le sue conseguenze (senza fare eccezione neppure per quella guerra 1939-45, deliberata a meno di una generazione dalla grande carneficina del primo conflitto «mondiale», come se nessuna lezione si dovesse trarre da quella colossale ecatombe di giovani maschi e dalla somma di dolori indicibili delle popolazioni civili, una tragedia tale da far pronunciare allo stesso Kaiser, non certo un cuore tenero, il celebre Ich habe es nicht gewollt, non ho voluto che questo accadesse). Ma una simile elusione delle responsabilità per lo scatenamento del conflitto non impedisce di caricare, con apparente paradosso, di senso etico i comportamenti individuali al suo interno, sottoponendoli alle stesse categorie che la tradizione militare ha storicamente codificato come assoluti valori o disvalori: gerarchia, disciplina, obbedienza agli ordini senza discussioni, disponibilità ad uccidere contro «codardia», comprensione o «fraternizzazione» verso il «nemico» (inclusi i civili in territorio occupato), «disfattismo», ecc… La quasi generale accettazione di questo capovolgimento di giudizio che subiscono i comportamenti considerati doverosi nella vita civile allorché si passa alle prerogative e agli obblighi «normali» dei militari (purché «regolari», debitamente inquadrati e in divisa, esclusi dunque i «ribelli», guerriglieri e resistenti) trova il terreno preparato dalla tradizione didattica di histoire bataille, imperversante per generazioni e tuttora largamente operativa in quegli insidiosi artefatti che sono i manuali scolastici. Il valor militare e la fedeltà alle insegne e alle alleanze vengono esaltati indipendentemente dalla causa per cui si manifestano, così per esempio El Alamein è un vanto, il desiderio di «tornare a baita» degli alpini del sergente maggiore Rigoni Stern un sentimento soltanto umanamente giustificabile, la gioiosa autoconsegna di interi reparti italiani agli Alleati dopo lo sbarco in Sicilia un imbarazzante episodio da dimen- 182 ticare (su questo punto sono di grande interesse le lettere e testimonianze dei militari angloamericani raccolte da Rick Atkinson in The Day of Battle. The War in Sicily and Italy 1943-1944, London 2007). È insomma il «campo» militare, attore ed arbitro allo stesso tempo, a dettare la misura del lecito, dell’illecito e del tollerabile, sulla base di una tradizione consolidata che assegna allo stesso campo la scansione del tempo delle armi attive e della fine delle ostilità (non c’è pari diritto per il ribelle, anche in casa propria, o per il civile che impugni le armi fuori dalle regole). Basti pensare alla pratica impunita di «passare per le armi» gli ostaggi nei territori occupati: gli ostaggi vengono uccisi senza essere processati proprio perché innocenti rispetto al fatto per cui si sanziona la rappresaglia. Stanno qui le principali premesse dell’assolutoria indulgenza verso i propri criminali di guerra che caratterizzerà il dopoguerra italiano, in misura forse superiore a qualsiasi altra situazione europea, Germania adenaueriana compresa. (Si veda comunque, su questo tema, la ricerca di Filippo Focardi, Criminali di guerra in libertà, Carocci, Roma 2008 e il commento di Enzo Collotti alla mostra Die Moerder sind unter uns allestita a Ulm nel cinquantenario del processo tenutosi in quella città contro dieci imputati per l’uccisione in massa di ebrei lituani: sta in «il manifesto», 7 giugno 2008). Da parte sua, la «narrazione» (a modesto avviso dello scrivente termine più proprio dell’equivoco ed inflazionato «memoria», che gli storici farebbe bene a lasciare a discipline più competenti, limitandosi per proprio conto alla consolidata declinazione al plurale di questa parola) si articola in una pluralità di livelli, che realizzano, nel complesso, la più completa decontestualizzazione del fenomeno comunemente detto «delle foibe e dei profughi giuliano-dalmati». Il primo livello discende dalla suddetta «naturalizzazione» della guerra, e consiste nell’isolare quel singolo, indiscutibile dramma (come fatto «caldo») dalla miriade di altrettanto crudeli sofferenze patite dalla nostra e dalle altre genti, in divisa o in abiti civili. La tradizionale storiografia militare ci mette del suo, rivolgendosi alle guerre con uno sguardo tecnico, attento all’oggettività delle strategie, al bilancio delle perdite e dei mezzi impiegati, all’accurata stesura e ricognizione delle mappe. Poiché la rappresentazione reale dell’intera catastrofe, piombata con pari violenza sulla parte «vinta» e su quella «vincitrice», sarebbe insopportabile per chiunque, allora ci si può rifugiare nel vecchio adagio per cui una morte è una tragedia, un milione di morti una statistica. A questo isolamento, per così dire «spaziale», se ne affianca uno temporale: non ci sarebbero antecedenti, tutto verrebbe a nascere fuori dalla storia, unicamente espressione della brutale barbarie «slava» intensificata della disumana ideologia «comunista». Guarda caso – come ben sa il lettore del lavoro di Alessandra Kersevan – lo stesso schema della propaganda fascista degli anni 1941-1943, volta a giustificare dapprima l’aggressione ad uno stato sovrano (la Jugoslavia), poi il suo smembramento e infine la criminale repressione di ogni forma di resistenza. Tutto culmina – ancora una volta in piena continuità con la propaganda dell’Italia fascista – nella connotazione soltanto ideologica della Resistenza jugoslava (comunista, «titina»), separandone le ragioni dalla complessiva Resistenza europea (o, forse, mirando a bollarne una per sminuire il valore delle altre). Sparisce la storia della gestazione tutta italiana della Croazia di Ante Pavelič e la copertura della sua politica antisemita e antiserba; scompare del pari l’annessione, a guerra in corso, di città croate dalmate 183 e della provincia di Lubiana, con l’italianizzazione forzata (in effetti un gravissimo progetto di pulizia etnica) della popolazione slovena; scompaiono il pugno di ferro in Montenegro e l’annessione del Kossovo all’Albania «italiana». Con questa sequenza di magie è possibile occultare la realtà di una grande guerra di liberazione nazionale, alla quale, ma anche questo sembra un oggetto rimosso, dopo l’8 settembre si unirono decine di migliaia di italiani in armi, col contributo di almeno 20.000 caduti. Ma quegli antecedenti sono indispensabili – dimostra la Kersevan in modo perentorio – per comprendere la genesi e la natura dei Lager italiani (tema, questo sì, a lungo latitante nell’Italia repubblicana, ma ormai ampiamente documentato da una serie di ricerche, fra cui fa spicco l’opera fondamentale di Carlo Spartaco Capogreco). Kersevan ci obbliga a riflettere sulla questione del confine orientale come questione italiana, come problema che investe l’identità storica della nostra nazione. A partire dai suoi connotati razzisti, che il regime fascista esaspera, ma che sono ampiamente presenti ed operanti già nell’Italia postrisorgimentale e liberale. Con questo fardello, si deve constatare con rammarico, l’Italia repubblicana non ha mai regolato i conti. Poiché è un’imbarazzante verità la lunga persistenza dello stereotipo negativo dello «slavo», sia nelle proclamazioni «teoriche» volte a negarne storia e cultura, sia nell’imposizione forzosa di svariate forme di persecuzione delle espressioni linguistiche e culturali di sloveni e croati, spacciate per elargizione della propria «superiore» civiltà alle popolazioni «allogene» e alloglotte di mano in mano annesse con l’espandersi dei confini nazionali (dal 1866 al 1941). Ma nessun atto di pieno, ufficiale riconoscimento di questa lunga serie di soprusi è venuto dalla Repubblica («nata dalla Resistenza», sottolinea Kersevan con giustificato sarcasmo), tanto che, per fare soltanto un esempio, nessun uomo politico italiano è mai andato nell’isola di Rab, per rendere omaggio alle vittime di un campo (formalmente d’internamento, nei fatti di sterminio) in cui la mortalità fu superiore a quella di Buchenwald! L’ottica razzista con cui l’Italia affronta la questione del confine orientale offre un osservatorio di grande importanza per riflettere, come si è detto, su aspetti non secondari di continuità fra l’epoca liberale e quella fascista, ma soprattutto per mettere in dubbio, se mai qualcuno volesse insistervi, la distinzione fra un fascismo relativamente tollerante (autoritario, ma non totalitario), prima dell’8 settembre, e il truce e criminale fascismo repubblicano. Basti qualche esempio, preso sporadicamente. Già all’indomani dell’annessione della «Venezia Giulia», cioè in epoca liberale anche se il territorio era amministrato da un governatore militare, vengono allontanati i funzionari sloveni, croati, tedeschi: impiegati pubblici, ferrovieri, maestri sono sostituiti con personale proveniente da altre regioni. Questi provvedimenti, intensificati poi dal fascismo e accompagnati dai crescenti limiti imposti alla stampa e alla lingua materna, «furono la causa di un primo grande esodo dalla regione, che interessò circa centomila sloveni e croati, che si rifugiarono nel Regno di Jugoslavia o emigrarono in altri paesi» (p. 23). Tralasciando le abbastanza note, bieche gesta dello squadrismo triestino, basterebbe esaminare un parziale elenco degli atti d’imperio compiuti dal regime fascista per avere sotto gli occhi un quadro coerente di sostanziale genocidio culturale: «italianizzazione dei nomi e dei toponimi; divieto di parlare la propria lingua nella scuola e negli uffici; chiusura di giornali, biblioteche e istituzioni culturali slovene e croate; spostamento di dipendenti 184 pubblici «allogeni» in altre parti del regno e loro sostituzione in loco con elementi di sicura «italianità»; distruzione degli enti economici e finanziari sloveni e croati … requisizione delle terre di contadini sloveni e croati attraverso la persecuzione fiscale e loro assegnazione tramite l’Ente delle Tre Venezie a contadini provenienti da altre regioni» (p. 27). Di eccezionale rilievo (data anche la relativamente esigua popolazione) sono le cifre che riguardano la giustizia negata, sommaria e «speciale». «Dei 978 processi del Tribunale Speciale – ricorda Kersevan – ben 131 furono celebrati contro sloveni e croati della Venezia Giulia. Di 47 condanne a morte, pronunciate da questo tribunale fascista, ben 36 riguardarono sloveni e croati, e 26 furono eseguite». Analoghe considerazioni possono farsi per le migliaia d’internati e confinati negli anni Trenta. «Il confino di polizia fu il mezzo repressivo forse più efficace per la persecuzione “etnica”, perché poteva essere comminato in via amministrativa, cioè direttamente dalla polizia senza intervento della magistratura» (p. 29). Se queste erano le premesse, non sorprendono i caratteri crudelmente repressivi assunti dall’occupazione militare italiana (1941-43) in terra slovena, croata e montenegrina. Alla durezza dei fascistissimi alti comandi dell’esercito si intrecciava e sovrapponeva, in un intricato gioco di competenze e di scaricabarile sugli oneri, il fanatismo dei nostri Gauleiter, a capo dell’amministrazione civile dopo l’annessione delle nuove province: rapina dei beni, cancellazione dell’identità culturale, condanne gravissime per ogni forma di opposizione, e anche di semplice relazione famigliare o di vicinato con i sospettati di far parte della Resistenza. Possiamo dunque concludere che Kersevan giustifica con abbondanza di fatti documentati l’espressione «pulizia etnica» da lei usata nel sottotitolo del libro. È avvilente constatare che la condizione degli «italiani per annessione» (cioè degli abitanti jugoslavi delle province di Lubiana, Spalato e Cattaro), anziché avvantaggiarsi dell’elargita cittadinanza, divenne peggiore rispetto a quella in cui versavano le altre popolazioni militarmente occupate. In modo particolare, agli oltraggi e alle persecuzioni già subite dagli «allogeni» nella Venezia Giulia in tempo di pace venne ad aggiungersi la conseguenza, per gli internati nei campi, di non poter essere tutelati dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni umanitarie internazionali, dal momento che la loro sorte veniva a configurarsi come «questione interna». In termini crudi, ciò significava letteralmente morte per fame, freddo, malattia di centinaia d’innocenti, specialmente donne, anziani e bambini. La famigerata circolare 3C, emanata il primo marzo 1942 dal generale Roatta, ed illustrata da una vasta gamma di documenti della II Armata da lui comandata, consente di equiparare in tutto e per tutto, semmai con qualche crudeltà gratuita in più, l’azione repressiva italiana in terra slovena a quella dei nazisti nell’Italia occupata dopo l’8 settembre. Essa prevedeva, riassume l’Autrice, «la fucilazione di ostaggi da prelevare soprattutto fra gli arrestati ritenuti comunisti, la fucilazione degli uomini adulti dei paesi presso i quali fossero avvenuti atti di sabotaggio nei confronti dell’esercito italiano o dei collaborazionisti, la deportazione del resto della popolazione, donne, vecchi, bambini, l’incendio dei villaggi attuato dai reparti chimici, con i lanciafiamme, il bombardamento dei villaggi» (p. 56). È su questa base che i Lager italiani si popolano d’innocenti, cui la miseria dei 185 parenti rimasti liberi impedisce di inviare sufficienti soccorsi alimentari o vestiario (ma non mancano i casi d’intercettazione dei pur modesti invii: pane, frutta secca, e della stessa corrispondenza). Studiosa del campo di Gonars, Kersevan estende in questo volume la sua analisi a tutto l’universo concentrazionario italiano. È un lavoro che prosegue la grande opera di Capogreco (e le molte altre ricerche disponibili, di cui di volta in volta si dà conto), ma con propri aspetti di originalità. Grazie anche all’uso di un particolare tipo di nuove fonti (come le lettere delle vittime che la censura tratteneva, ma che il maniacale scrupolo burocratico accoglieva in archivi, ora accessibili, di copie conformi) l’Autrice induce il lettore a prendere coscienza della soggettività e della dignità di quell’umanità avvilita, dà voce alle persone (indimenticabili i diari dei bambini sopravvissuti) e fa rivivere la loro vicenda sottraendola alla neutralità delle pur drammatiche, e non ignorabili, statistiche. Di queste testimonianze, così come di molti documenti ufficiali, o di private fonti memorialistiche anche di parte italiana, il volume incorpora una messe abbondante, ma la grande bravura espositiva dell’Autrice rende questi inserimenti una componente perfettamente integrata nel testo, evitando al lettore il faticoso rinvio alla note, che pure non mancano ma sono limitate alle esigenze funzionali e alle necessità di correttezza scientifica. È augurabile che, in tempi di revisionismo politicamente incorretto, opere come questa entrino a far parte dei riferimenti indispensabili per l’autocoscienza civile e per il superamento di quell’oblio programmato che è cominciato assai presto, all’indomani stesso della Liberazione. Ettore Borghi S. WEIL, Manifesto per la soppressione dei partiti politici, Castelvecchi, Roma 2008, pp. 69, 7 € Che cosa comporta scrivere la storia di un partito? Più che la descrizione di un’ideologia (tanto più aleatoria quanto più «radicale») e di un sistema di potere e di corruzioni, è soprattutto la descrizione di una disciplina per i militanti (e, immancabilmente, d’immoralità, eresie, processi, ecc.). Sembra che non siano passati tanti anni, da quando, nel 1950, «La Table ronde» ha pubblicato questo manifesto di Simone Weil, poi inserito fra Les Écrits de Londres et dernières lettres (Gallimard 1957). Nei loro commenti alla prima pubblicazione (compresi nel presente volume), André Breton ed Alain hanno riconosciuto facilmente il partito comunista come obiettivo principale delle riflessioni della Weil. Ad esempio, scrive Alain: «Il partito comunista si è incaricato di portare alla perfezione la decadenza e la nullità di un partito ... Ci si accorgerà per prima cosa del fatto che questo partito non ha alcun pensiero, fatto che dimostra una stupidità che non è in rapporto con la comune stupidità, ma che la supera di gran lunga» (p. 62). Solo polemica à la Guareschi (il che sarebbe comunque qualcosa, nel clima del 1950)? Solo antistalinismo? No, perché fra le pagine della Weil si scopre una puntuale descrizione di ciò che il partito (meccanismo diabolico, arma profana per provocare 186 passioni collettive, tradimento radicale della ricerca del vero e del giusto) ha iniziato a rappresentare in questa parte di mondo negli ultimi due secoli. La democrazia, il principio di maggioranza, le istituzioni rappresentative, non sono di per sé un bene (anzi sono un male pressoché puro, essendo il ribaltamento del rapporto mezzi-fine). Sarebbero strumenti buoni se permettessero a verità e giustizia di vincere materialmente gli errori e i crimini. Ma che cos’è un partito? «Un partito politico è una macchina per fabbricare passione collettiva. Un partito politico è un’organizzazione costruita in modo da esercitare una pressione collettiva sul pensiero di ognuno degli esseri umani che ne fanno parte. Il fine primo e, in ultima analisi, l’unico fine di qualunque partito politico è la sua propria crescita, e questo senza alcun limite» (p. 31). Quale militante può negare di vivere, soprattutto al giorno d’oggi, in un contesto, il partito appunto, governato da questi principi? Ogni partito è un progetto totalitario. Il veleno (la «lebbra» secondo la Weil) partitico è (era) ormai evaso dalla sua sede iniziale, diffondendosi nulla cultura, nella religione. Ovunque si milita. «Anche nelle scuole non si sa più stimolare il pensiero dei ragazzi se non invitandoli a prendere partito pro o contro un determinato pensiero. Si cita una frase di un grande autore e si chiede loro: “Siete d’accordo o no? Sviluppate i vostri argomenti”» (p. 55). Chi parla a nome di un partito, chi s’impegna a rappresentarlo, non è mai in buona fede, non può che mentire. Che cos’è il punto di vista comunista, socialista, liberale? Dove s’impara? Il partito ha una penalità sua propria, che minaccia e fa parlare ogni suo membro, specie se deputato alla propaganda, come un comunista, un socialista, un liberale. È, per la Weil, il magnifico conforto del non dover pensare. «Un uomo che aderisce a un partito ha verosimilmente visto nell’azione e nella propaganda di quel partito cose che gli sono parse giuste e buone. Ma non ha mai studiato la posizione del partito relativamente a tutti i problemi della vita pubblica. Entrando a far parte del partito, accetta posizioni che ignora. Sottomette così il suo pensiero all’autorità del partito. Quando, poco a poco, conoscerà le posizioni che oggi ignora, le accetterà senza esaminarle» (p. 48). L’oppressione clericale è stata il vero modello della disciplina di partito. Ed è vero che i partiti comunisti hanno realizzato questo straordinariamente. Quindi, non resta che la soppressione (o, come propone André Breton, la «messa al bando») dei partiti, non con un inutile atto di forza, ma attendendo il salvifico disinganno dei servi (che sono sempre di più) e degli onesti militanti (che paiono ormai destinati all’estinzione). Francesco Paolella J. KASPER, E. MANFREDOTTI (a cura di), Perdonare, le tragedie dimenticate, Marietti 1820, Genova-Milano 2007, pp. 206, 24 € Il libro è una raccolta di tracce attorno al tema del perdono, alla luce della storia del Novecento (e in maniera particolare della Shoah). Gli autori, filosofi oppure scrittori, riescono a fondere i propri linguaggi proprio per mettere in difficoltà il linguaggio, il potere delle parole, della legge, della politica, davanti allo «scandalo» del perdono. 187 Secondo le curatrici del volume, «Imprescrivibile, il perdono non può nemmeno essere normalizzato dal diritto, che come ordinamento è finalizzato alla regolamentazione sociale, ovvero al controllo della vita» (p. 7). Il perdono è anche ciò che mette a nudo il tempo, ciò che lo sovverte; il perdono è libertà inutile. Qui vogliamo riferire soltanto sul testo dell’intervista, rilasciata da Jacques Derrida a Michel Wieviorka per «Le Monde des Débats» una decina di anni fa e qui tradotta. Il punto di partenza del filosofo è il mettere a fuoco la proliferazione delle scene pubbliche di pentimento e di perdono, in relazione al più ampio movimento per il «dovere della memoria». E bisogna far bene attenzione a non confondere il perdono con la scusa, l’amnistia, la prescrizione, la riconciliazione, e con tutte le altre possibilità che riguardano il mondo del diritto e della politica. «Vi è sempre un calcolo strategico e politico nel gesto generoso di chi offre la riconciliazione o l’amnistia» (p. 28). Quando il perdono diventa «normalizzato», pubblicizzato, politicizzato e così via, esso perde in purezza. «Il perdono non è, non dovrebbe essere né normale, né normativo né normalizzante. Dovrebbe restare eccezionale e straordinario, a prova dell’impossibile, come se interrompesse il corso ordinario della temporalità storica» (p. 21, corsivi nel testo). D’altra parte, e ponendosi in alternativa per questo sia rispetto a Jankélévitch (cfr. Perdonare?), sia ad Hannah Arendt (cfr. Vita activa) – alla quale la studiosa Olivia Guaraldo dedica un bel saggio in questo volume – per Derrida è possibile perdonare soltanto l’impossibile. Il perdono deve restare una «follia dell’impossibile». «Immaginate dunque che io perdoni a condizione che il colpevole si penta, faccia ammenda, chieda perdono e quindi sia cambiato attraverso un nuovo impegno, e che da quel momento non sia più lo stesso che si era reso colpevole. Si può ancora parlare di perdono in questo caso? Sarebbe troppo facile da entrambi i lati: si perdonerebbe infatti una persona diversa dal colpevole stesso» (pp. 26-27). Francesco Paolella M. MASTROGREGORI, I due prigionieri. Gramsci, Moro e la storia del Novecento italiano, Marietti 1820, Genova 2008, pp. 340, 22 € Il lavoro di Massimo Mastrogregori, nella sua chiarezza espositiva, dovuta senz’altro alla sua origine di lezioni universitarie, non solo offre spunti di acuta riflessione sulle condizioni dei prigionieri Gramsci e Moro, ma al contempo delineando sinteticamente i loro profili, e biografici e di pensiero, disegna il contesto storico in cui essi vissero. L’uno prigioniero delle carceri fasciste, l’altro prigioniero-ostaggio dei terroristi delle Brigate rosse. I due prigionieri, infatti, è un saggio di storia comparata che dei due uomini politici «offre un ritratto, un’analisi del contesto storico e un’interpretazione dei testi che scrissero nel carcere: Quaderni e Lettere di Gramsci, Memoriale e lettere di Moro» (p. 7). Intenti rispettati in pieno e, direi, superati. Noi aggiungeremmo che, grazie all’ampio apparato di note critico-bibliografiche in cui sono indicati percorsi di lettura e di approfondimento sulle due figure di intellettuali-uomini d’azione unito, come si diceva, alla chiarezza espositiva anche il neofita riesce a raccapezzarsi. Nel senso che, alla fine del «viaggio» nella storia dell’Italia del Novecento, l’ipotetico neofita sa chi 188 era Gramsci e sa chi era Moro, e soprattutto si rende conto dell’Italia e monarchicofascista e repubblicana. Del fascismo e del comunismo italiano, visto, giustamente, quest’ultimo attraverso le lenti della Russia rivoluzionaria e della relazione fra essa, il pci e Gramsci in un intreccio non sempre limpido. Dell’Italia repubblicana, di cui Moro fu un artefice. Eletto alla Costituente, nelle liste della dc, fece parte della commissione dei 75 e del comitato di 18 persone che scrisse il testo della Costituzione. Lavoro costituente, che per Moro fu, come, in altri contesti, per tanti altri giovani intellettuali passati attraverso il fascismo, la palestra per la democrazia. «Fu per lui [Moro] – scrive l’A. – un’esperienza importantissima, assolutamente fondativa. Qui c’è, indubbiamente, una frattura. Nasce qualcosa di nuovo, questa è storia nuova rispetto alla formazione cattolica e fascista di Moro. È in questo momento, alla Costituente, che nasce il Moro che pensa la democrazia» (pp. 87-88) Aspetto non indifferente per la storia successiva della giovane repubblica. Il passaggio dal centrismo democristiano degli anni ’50 all’ipotesi di governo con il partito socialista vide il sanguinoso luglio ’60 con il tentativo autoritario di Tambroni, poi sconfitto; l’estate del ’64 con il piano golpista «Solo», che al centro sinistra voleva mettere la parola fine, e che Moro, riuscì ad impedire, sacrificando, però, le potenzialità riformatrici dell’accordo coi socialisti di Nenni. Infine, il tragico epilogo con il suo sequestro avvenuto, il 16 marzo 1978, alla vigilia di un passaggio storico: l’ingresso del pci nell’area di governo. Infatti, «il problema fondamentale degli anni ’70, visto dalla fine degli anni ’60, è che cosa fare con i comunisti. La soluzione di Moro è quella di aprire, così com’era stato fatto coi socialisti, anche ai comunisti, tendendoli però sotto controllo». (p. 101) Ma chi sono i carcerieri di Moro, presidente della dc? Solo le br? «La domanda – scrive l’A. – riguarda anche le responsabilità, come nel caso di Gramsci, non di chi imprigiona il dirigente politico, ma di chi non fa abbastanza per liberarlo, di chi lo tiene in carcere … [Come nel caso di Gramsci] anche nel caso di Moro ci si può chiedere se non ci sono stati anche altri carcerieri, oltre alle br [come per Gramsci, che oltre al fascismo anche il partito italiano e quello russo per le note vicende del dissenso del Sardo nel ’26, non lo volevano libero] egli chiede in parte delle sue lettere, uno scambio di prigionieri, che fu rifiutato dal fronte della fermezza e discusso da quello della trattativa (pp. 153-54) … [come Gramsci che] dall’inizio alla fine … continuerà a pensare che una possibilità sarebbe quella di essere scambiato con altri prigionieri – in ciò si comporta proprio come Moro, almeno in apparenza» (p. 232). Glauco Bertani A. TORRE (a cura di), Le carte delle immagini, Ediesse, Roma 2008, pp. 300, 15 € Gli archivi sono composti da molteplici materiali dalle differenti tipologie, prodotti contestualmente alla realizzazione e alla fruizione di audiovisivi, come per esempio soggetti e sceneggiature, fotografie, manifesti, scalette, contratti e molto altro. Si tratta di fonti spesso sommerse per le quali generalmente non sono previsti interventi adeguati di acquisizione e ordinamento, poco utilizzate dai ricercatori che si avvalgono di fonti audiovisive. 189 La pubblicazione affronta i temi dell’uso e della conservazione di questi materiali. I criteri guida che ci vengono proposti per affrontare la lettura sono fondamentalmente due: il primo sostiene che questa documentazione, eterogenea e composita, può fornire indicazioni utili ai ricercatori e può portare a ripercussioni sul piano economico e giuridico. Pertanto, deve essere conservata e valorizzata. Il secondo afferma, sulla base della natura documentaria del materiale, che la disciplina archivistica può essere vantaggiosamente impiegata dagli archivi d’immagini in movimento al fine di mettere in relazione la documentazione audiovisiva, cartacea e iconografica conservata. Il saggio si divide in tre parti, la prima sezione è dedicata al contributo che i documenti cartacei ed iconografici connessi ai prodotti audiovisivi possono apportare agli studi umanistici, con particolare riferimento all’impiego di questi materiali per la contestualizzazione delle fonti cinematografiche e televisive. La seconda sezione si occupa dell’ordinamento archivistico e della conservazione di questa particolare tipologia di documentazione. La terza sezione affronta il tema dei giacimenti di documenti presenti sul territorio, ovvero archivi di aziende, di persone e di associazioni attive nel campo cinematografico e televisivo. (lv) 190 Finito di stampare da Grafitalia, Reggio Emilia nel novembre 2008
Scarica