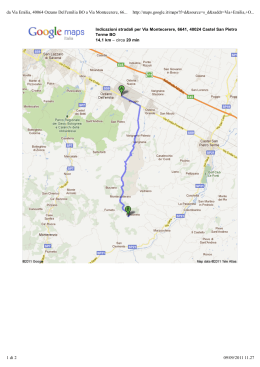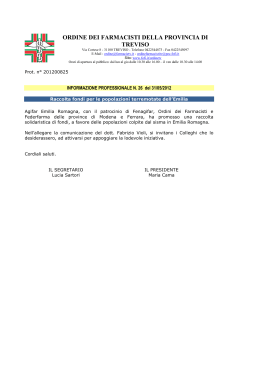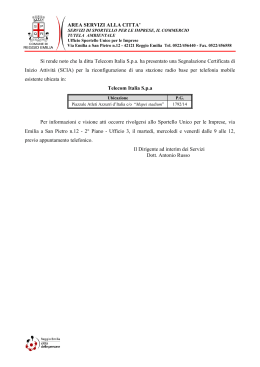Marta Folcia ERAVAMO UNA FAMIGLIA Ad Alberto, Fabio e Dario “La vita è cosparsa di tanti triboli e può recare tanti mali che la morte non è il male peggiore” Napoleone Bonaparte Capitolo 1 La Bovisa, situata a nord di Milano, fuori porta, e delimitata storicamente dai binari della ferrovia, negli anni Trenta si presentava agli occhi del visitatore come una zona agreste e tranquilla, fatta di campi coltivati, caseggiati bassi posti a quadrilatero su cortili pavimentati a ciottoli, ai quali si accedeva attraverso ampi portoni ad arco. C’erano le cascine, dove venivano allevate le giovenche che fornivano il latte fresco a tutta la zona; la più grande era quella dei Rosati, con una ventina di capi di bestiame, costruita in mattoni rossi e ampi fienili in bella vista. Poi le osterie, col pergolato sul retro e il gioco delle bocce, in cui ancora si rideva e si cantava, ignari di essere sull’orlo di un abisso profondo, l’odore del vino mischiato a quello dei sigari. E i terreni di proprietà delle famiglie patrizie, dati in affitto ai contadini per la coltivazione, terre ordinate, odorose di ortaggi umidi e di erbe profumate. Ma non mancavano, sulla via Degli Imbriani, i bei palazzi storici d’inizio Novecento, e le industrie, situate nella parte più settentrionale del rione. Quella domenica di maggio del 1938, festa dell’apertura del mese mariano, erano state allestite molte bancarelle, più degli anni addietro. La fiera, brulicante di gente, si stendeva dal piazzale Lugano, sulla strada sterrata, fino allo spiazzo della chiesa parrocchiale. Era da poco terminata e i venditori ritiravano le merci invendute: nell’aria stagnava il profumo del croccante e dei tortelli di mele fritti nell’olio bollente; la gente si avviava verso casa, le donne chiacchierando e mostrando le cose acquistate, i ragazzi giocando e scherzando tra di loro. Erano le ultime ore di spensieratezza; l’indomani, tutti sarebbero tornati alle occupazioni quotidiane, molti di loro al duro lavoro dei campi. Il paesaggio era pennellato dai 7 toni rosati del tramonto, le cime degli alberi mosse da una brezza leggera. Le rondini volavano basse e il rintocco delle campane annunciava la messa vespertina. Elena, la maggiore dei cinque fratelli della famiglia Boschi, si avviò verso casa accanto alle sorelle, Bianca e Matilde. Erano molto simili nell’aspetto, lei e Bianca: due zingarelle dalla pelle ambrata, i capelli folti e scarmigliati sulle spalle, gli occhi scuri e mutevoli; ma Elena aveva qualcosa in più: un lampo di malizia nello sguardo catturava le occhiate maschili. Matilde stava gustando la sua montagna di zucchero filato. Era diversa dalle sorelle: di una bellezza molle e quieta, nelle fattezze delicate e nei colori chiari ricordava la nonna paterna. Bianca aveva notato lo sguardo sfuggente di Elena, il pallore del suo viso; la sorella non aveva spiccicato parola per tutto il tempo, non si era neppure guardata attorno per cercare Ermanno, col quale sarebbe convolata a nozze il prossimo mese di settembre. Non lo si vedeva da parecchi giorni a casa e Bianca non ne conosceva la ragione, perché la sorella, di solito aperta e ciarliera, da qualche tempo si era chiusa in un silenzio impenetrabile. Sapeva tuttavia che, prima di recarsi alla fiera, agghindata con la camicia bianca e la gonna grigia della festa, era andata alla canonica per un incontro col parroco. Qualcosa di certo bolliva in pentola. Attraversarono i campi che si stendevano tra gli orti della Ghisolfa e la loro abitazione, affondando gli zoccoli nell’erba già alta e fresca; passarono davanti al parco della villa dei Visconti di Morzone, ma a causa della vegetazione alta e rigogliosa era visibile solo la torretta di mattoni rossi. Matilde guardò attraverso le grate del cancello e non vide anima viva. Rodolfo, il figlio maggiore del conte, che era solito arrivare alla residenza estiva il sabato mattina a cavallo, era già ripartito per impegni urgenti. Matilde era riuscita a intravederlo il pomeriggio mentre, impettito sul suo baio, faceva il giro del parco. Le fu impossibile celare un sussulto che già le ghermiva il fiato, tramutandolo in sospiro. 8 Le ragazze entrarono nel cortile della loro abitazione. Dalla vicina osteria del Leon D’Oro arrivavano i canti sguaiati degli avventori e le melodie pizzicate sul mandolino dal forestiero che ogni domenica, nella bella stagione, sedeva fuori, a suonare le più famose arie napoletane. Ormai lo conoscevano tutti, lo chiamavano el Napuli e gli davano una moneta o qualcosa da mangiare. Elena lasciò le sorelle, finse di non sentire i richiami delle amiche e ignorò persino le feste di Chito, il cane nero da lei stessa trovato e accudito un paio di anni addietro, fino a farselo suo. Salì in casa, sperando di non trovare sua madre e poter rimandare la conversazione ad altro momento. Di solito la domenica, a quell’ora, Emilia era impegnata a dare una mano alla cognata Nora al Leon D’Oro, stipato di uomini pronti ad alzare il gomito oltremisura, prima che venissero ghermiti dalle consorti e portati a casa quasi di peso, passo dopo passo. Quel giorno invece sua madre era in casa e l’aspettava con ansia. La ragazza sapeva che stavolta non l’avrebbe scampata. «Allora… cosa ti ha detto don Alfonso? Sono ore che aspetto di sapere.» «Mi ha detto che devo fare quello che mi sento. Nessuno mi può forzare. Neanche voi.» Elena si era accasciata su una poltrona, lo sguardo al pavimento. Una pena sottile negli occhi inquieti offuscava la sua bellezza ridente e un po’ selvaggia. La madre le si era seduta davanti, su uno sgabello, implacabile nel voler a tutti costi affrontare l’argomento: «Elena, ascoltami» cominciò Emilia con voce implorante. «Perché ti sei messa in testa di mandare all’aria il matrimonio? L’Ermanno ti vuole bene, si è impegnato con te. Potrebbe avere tutte le ragazze che vuole, lo sai. Ma lui vuole te. È un bel giovane, serio, e la sua famiglia è benestante. Noi al confronto siamo dei poveretti e tu vuoi buttar via l’occasione della tua vita, di andare a vivere bene, in una casa dove non ti mancherà nulla? Sognavo per te una vita meravigliosa e adesso... mi vuoi guardare in faccia e dirmi cosa ti 9 succede? Non ti sarai mica presa la scuffia per qualche squinternato che ti ronza attorno! Pensavo che anche tu volessi bene all’Ermanno.» Il suo tono era affettuoso e accorato; l’intento, quello di far riflettere con le buone maniere una figlia che, nelle ultime settimane, sembrava aver perso la ragione. «Gli volevo bene… gliene voglio ancora, ma come a un fratello. Le cose sono cambiate. Capita» rispose in tono secco. Emilia avvampò, e stavolta andò su tutte le furie: «Ma chi ti credi di essere? Solo perché sei belloccia e i ragazzi per strada ti guardano, pensi di fare quello che ti pare e piace? E no, cara! Ti sei presa un impegno quando il Rovelli è venuto a chiedere al babbo la tua mano, hai detto subito di sì, mi pare. Era quello che volevi, e adesso tu l’Ermanno te lo sposi. Abbiamo speso soldi per il corredo, impegnato la sarta per l’abito e i Rovelli hanno comprato il mobilio per la vostra camera nuziale. E che mobilio! Ti pare che gli andiamo a dire “ci dispiace, il matrimonio non si farà, Elena ha cambiato idea”? Tu sei fuori di testa, cara mia!» Elena scoppiò a piangere e corse nella camera in cui dormiva con le sorelle. Emilia non la trattenne. Benedetta ragazza, pensava fuori di sé. Un po’ stramba lo era sempre stata, ma il fatto di voler buttare all’aria il matrimonio a pochi mesi dalla data, proprio non le andava giù. E poi Ermanno le piaceva. Suo padre era un commerciante di tessuti, la madre, donna colta e raffinata, si ventilava venisse da una famiglia nobile. Avevano una bella casa grande, circondata da un giardino ricco di piante. No, non c’erano scuse: Elena andava convinta. Forse erano solo i normali timori di una sposa prima dell’evento. Poteva trattarsi di questo, ma occorreva parlarne. I suoi pensieri vennero interrotti da Giulio e Cosimo, entrati rumorosamente in casa, seguiti dal padre, alticcio e preda dell’euforia domenicale. Arnaldo fino a quel momento non si era accorto dei ripensamenti della figlia; era uno uomo buono ma rude, dedito al lavoro nei campi e a qualche bicchiere di vino con gli amici, la sera e la domenica, all’osteria 10 del Leon D’Oro, gestita da suo fratello Ercole e suo unico svago. Del resto, era meglio che non trapelasse nulla per il momento, altrimenti chissà che polverone avrebbe suscitato. Emilia servì la cena, mangiò velocemente la sua scodella di minestra e con una scusa andò in camera a vedere Elena. Era a letto raggomitolata sul fianco, la faccia rivolta al muro: sembrava dormisse, per cui la lasciò in pace. Prese una sedia e si sedette davanti alla bella statuina in gesso di Maria Bambina in culla, posizionata sul cassettone sotto la campana di vetro, come sempre faceva quando aveva qualche grazia particolare da chiedere, cose di donne, certa che la Vergine Maria l’avrebbe esaudita. Guardò il dolce volto dell’infante, circondato da tele preziose e merletti, e iniziò la sua preghiera accorata. «Domani...» disse alla fine Emilia, a mezza voce. «Domani affronterò la questione e cercherò di convincerla, fosse l’ultima cosa che faccio.» Ma la notte portò consiglio. La mattina, dopo aver preparato la colazione sul tavolo, si avvolse di buonora in uno scialle e si avviò verso la canonica. Mancavano dieci minuti alle sette. La messa feriale del mattino era alle sette e mezza e don Alfonso avrebbe avuto tutto il tempo per parlare con lei di Elena, a costo di tirarlo giù dal letto. Che diamine! Una madre aveva pure il diritto di sapere cosa passava per la testa della figlia, e il parroco di certo conosceva la verità. Si sedettero nella sacrestia, in due poltrone tappezzate di broccato che a Emilia mettevano soggezione solo a guardarle. Aleggiava ancora nell’aria l’odore d’incenso della funzione vespertina. «Benedetta donna» esclamò il parroco sbuffando ed estraendo l’orologio a catena dal taschino della tonaca. «È questa l’ora di venire a parlare? Ho la messa tra poco e tu mi fai perdere tempo!» «Manca più di mezz’ora alla messa e si tratta di una cosa molto urgente. Don Alfonso… io non ci dormo più. La Elena è decisa a rompere il fidanzamento con l’Ermanno Ro11 velli. Vi rendete conto? Dopo aver fatto il diavolo a quattro per sposarsi al più presto, adesso non lo vuole più neanche vedere. Cosa andiamo a dire ai genitori? Ditemelo voi! È una tragedia, don Alfonso, una tragedia!» Alle lacrime isteriche di Emilia, il parroco ebbe un moto di impazienza. «Eh, suvvia, che esagerazione! Son cose che capitano, no? Non mi pare il caso di fare tutto questo baccano. Se la Elena non vuole più… non vorrai mica costringere tua figlia a sposarsi e rischiare di vederla infelice per una vita! I Rovelli se ne faranno una ragione, che diamine! Piuttosto, deve prendere il coraggio a due mani e dire all’Ermanno la verità. Quel ragazzo ne sta uscendo pazzo, con tutti questi misteri.» Emilia si mise sulle difensive. Era una donna fortemente ancorata alla fede e rispettosa dei ministri della Chiesa, che considerava un tramite nel suo rapporto con Dio. Ma il bene dei figli aveva sempre il sopravvento. Non mancò quindi di far valere le sue ragioni, in modo animato. «Quale verità, don Alfonso? Eh no, voi adesso parlate, perché io non ne so nulla e come madre ho il sacrosanto diritto di sapere. Accidenti se ho il diritto!» Un leggero rossore si diffuse sul volto del parroco. Si era lasciato troppo andare e ora si vedeva costretto a entrare nel merito di una cosa che, a dire il vero, destava anche in lui qualche perplessità. «Beh, io non so se posso. Tua figlia mi ha fatto delle confidenze, sono questioni delicate, risolvetele tra di voi, una buona volta. Io posso semmai intervenire in un secondo momento, a decisione presa, per un consiglio, un aiuto.» «Decisione presa… consiglio… aiuto… si può sapere di cosa state parlando? Cosa sono tutti questi misteri? Elena vi ha forse parlato in confessione?» chiese lei inchiodando il suo sguardo sul parroco. A quel punto il prete, che non brillava per determinazione, avrebbe sparato volentieri una bella bugia e tutto si sarebbe chiuso lì. Ma non lo fece. «No, non era in confessione, ma…» «E allora forza, don Alfonso, cosa aspettate a parlare? Io 12 non me ne vado senza aver saputo la verità.» «Ma perché non chiederla a tua figlia, la verità? Lei deve parlare, santo cielo! A voi e ai Rovelli; non è mica una cosa di cui vergognarsi, anzi…» «Lei non parla. Dice solo che i suoi sentimenti per l’Ermanno sono cambiati. Ma io non ci credo.» Don Alfonso fece un lungo sospiro, riguardò l’orologio e si decise. «Ebbene… la tua Elena ha la vocazione religiosa. Sì, sì, lo so che può sembrare inverosimile, conoscendo la ragazza, ma sembra proprio decisa. Mi ha chiesto di trovarle un convento che l’accolga, ma questo è prematuro. Bisogna prima capire bene come stanno le cose.» Se un fulmine fosse caduto sulla testa di Emilia, la donna sarebbe rimasta meno folgorata. Proruppe allora in una risata incredula: «Vocazione religiosa? La Elena! Ma se ha cominciato a quindici anni a guardare i ragazzi! E mancava poco che le dovessimo mettere i freni in bocca, come ai cavalli, per non farla correre troppo. Non è possibile, don Alfonso, io non vi credo... deve esserci dell’altro, forse qualcosa di cui neppure voi volete parlare.» Il parroco fece per alzarsi. «Quand’è così, io non so che altro dirti. Che il buon Dio ti aiuti, Emilia, e buona giornata.» «No, no, aspettate. Non volevo mettere in dubbio la vostra sincerità. Ci mancherebbe! Se questa è la verità, spiegatevi meglio. Vi prego.» «Figliola, le cose nella vita possono cambiare. Succede!» proferì il parroco in tono grave. «E se questa è la volontà di Dio, né io né te possiamo farci nulla. Nessuno può andare contro questa decisione, mia cara. Sarebbe un sacrilegio. Elena, a quanto pare, ha ricevuto una grazia bellissima e tu dovresti essere contenta. Dobbiamo ringraziare il Signore per questo. E comunque non è una cosa da prendere alla leggera, beninteso, bisognerà parlarne, magari fare una capatina dal Vescovo, capire bene.» 13 «E il Signore… non poteva fargliela un po’ prima questa grazia della vocazione? Ci saremmo risparmiati un sacco di rogne.» «Ti metti a bestemmiare adesso? Vai, vai, che ho la messa e mi devo ancora vestire.» Emilia, stordita e senza parole, si avviò verso casa, stringendosi nello scialle, lo sguardo a terra. Sentiva freddo nelle ossa, anche se il sole era già tiepido. Passò davanti al Leon D’Oro con gli occhi bassi; non mise neppure dentro la testa per salutare la cognata, già di buonora alle prese con il brasato per il mezzogiorno. Attraversò il cortile assorta nei suoi pensieri e non udì il richiamo dello stracciaiolo che, appostatosi in un angolo del cortile, le ricordava una promessa. «Sciura Emilia, alura… gavì i robb vech de damm o no? E un quei catanaj…» Erano già usciti tutti; sulla tavola i resti della colazione. Tirò un sospiro di sollievo all’idea di non dover dare spiegazioni, almeno per quella mattinata. Aveva bisogno di starsene da sola e pensare. Il suo sogno di maritare la figlia maggiore con un bravo giovane che la facesse vivere bene e in agiatezza si stava sgretolando sotto i suoi occhi. Lei aveva già preso la sua decisione, era chiaro, e contrastarla in quel progetto non sarebbe stato opportuno. Qui non c’erano di mezzo solo Elena, Ermanno e i Rovelli ma… nientemeno che Dio! Dio Onnipotente, che non poteva essere contrariato nella sua volontà, pena chissà quale giusto castigo su di lei e sulla sua famiglia. Era una situazione senza via d’uscita. Si aprì piano una porta ed Elena apparve sulla soglia, gli occhi rossi e gonfi di chi ha pianto a lungo. Emilia si alzò e la raggiunse. Le afferrò le mani, tenera e disarmata. «Il parroco mi ha detto tutto. Ma… è proprio vero che vuoi farti monaca? Che novità è questa, e cosa aspettavi a dirmelo? Dal parroco ho dovuto sapere la verità, figlia mia!» «Mi spiace…» «Ma tu sei sicura? È una decisione da cui non si può tornare indietro, lo sai. Devi pensarci ancora, prenderti del tempo.» Elena abbozzò un sorriso stanco e impacciato. In quel14 l’ambiente contadino, scarso di opportunità, dove Emilia e la sua famiglia vivevano, un gruppetto di case in cui tutto era in comune e il pane non era mai sicuro, una notizia come quella era di solito accolta con grande gioia. Una figlia in convento, al sicuro, lontana dai sacrifici e dagli stenti, a casa una bocca in meno da sfamare, era una grazia di Dio. Emilia era una donna evoluta, seppure semplice e non istruita, e ciò che le stava più a cuore era la felicità dei figli. «Sì, mamma, adesso sono sicura. Scusami se non te ne ho parlato prima, avevo le idee confuse e poi mi è mancato il coraggio. Pensavo che avresti fatto di tutto per impedirmelo e sarebbero nate discussioni a non finire. Voglio andare in convento, al più presto. Nessuno potrà farmi cambiare idea.» Si abbracciarono e piansero, madre e figlia, per due ragioni molto diverse, ma accomunate da una sensazione di profondo sollievo per essere finalmente riuscite a parlare con chiarezza. Dal cortile arrivava il vociare delle donne impegnate a stendere i panni al sole, le risate dei bambini, le grida dei venditori ambulanti che offrivano la loro mercanzia. La vita scorreva tranquilla, fuori, incurante del tormento che agitava il cuore delle due donne. Tutto è compiuto, pensò Elena. La vocazione era un argomento che nessuno, neppure Ermanno, avrebbe osato contestare. Seguirono giornate tristi e taciturne. Arnaldo aveva accolto la notizia col senso innato di fatalità che gli era proprio. Solo per un attimo aveva spalancato le due fessure celesti nella faccia rugosa e cotta dal sole. Non nutriva ambizioni, né per sé né per i figli, la sua vita era concentrata sul lavoro dei campi, il resto era tutto nelle mani di Dio. I fratelli reagirono con distaccato cinismo. Sono cose di femmine, dicevano facendo spallucce. Chi più soffrì per la decisione di Elena, oltre la madre, furono Matilde e Bianca. Matilde adorava la sorella maggiore e l’idea di non vederla più la rendeva infelice. Bianca perdeva invece la sua confidente, la sua amica del cuore. Dopo molte discussioni, durante le quali Emilia e Arnaldo si erano palleggiati l’ingrato compito di accompagnare Ele15 na a informare i Rovelli, decisero di andare insieme. Lo fecero la domenica seguente, dopo la messa. «Potevi andare sola da quelli là» recriminò Arnaldo, a disagio nel vestito della festa, mentre si recavano a casa di Ermanno. «L’idea di vedere la faccia di quel fascista borioso… e la moglie, poi! Una gatta morta che non le cavi neanche una parola.» «Non ti dispiacevano quando la Elena si doveva sposare. Tutta adesso salta fuori la verità, ma guarda un po’!» «Quell’uomo non è pulito. Ha fatto fortuna grazie alle sue conoscenze altolocate nel regime. Ho ben visto io certi tipi uscire dalla sua azienda. Chissà che imbrogli.» Emilia alzò le spalle. Clotilde e Osvaldo Rovelli avevano intuito già da tempo che il matrimonio sarebbe saltato: da diverse settimane i due non si vedevano, dopo l’intenzione della ragazza di prendersi una pausa. Non lo immaginavano possibile, tuttavia, per una ragione così grave e imprevedibile. La madre reagì col glaciale atteggiamento che le era usuale; dalla sua espressione trapelava un carico di pensieri non manifesti, ma a lungo meditati, forse una sfiducia insinuatasi nella sua mente ben prima che i fatti si palesassero. Del resto, non era mai stata contenta di quel matrimonio: per il suo unico figlio avrebbe preferito una ragazza del loro stesso rango sociale, anche per escludere il dubbio che lei lo sposasse per interesse. Aveva mostrato in diverse occasioni il suo scontento, ma Ermanno era stato irremovibile sul fatto che Elena fosse la donna della sua vita. Il padre si comportò invece in modo estremamente conciliante, soprattutto quando si parlò delle spese sostenute dai Rovelli per i mobili della camera nuziale. «Non preoccupatevi per questo» li rassicurò. «Di fronte a una vocazione religiosa, non possiamo che adeguarci alla volontà di vostra figlia e… di Dio.» Ermanno ed Elena non proferirono parola per tutto il tempo; non si guardarono neppure in faccia. Dal volto terreo di entrambi trapelava una sofferenza profonda. Solo più tardi, nella solitudine di ciascuno, diedero sfogo alla loro dispera16 zione. Prima di alzarsi per andarsene, Elena estrasse dalla borsetta la piccola scatola con l’anello regalatole da Ermanno e lo appoggiò sul tavolo. Clotilde Rovelli, con uno scatto immediato, fu oltremodo lesta ad afferrarlo e riporlo in tasca, per paura che il figlio – colpito nell’orgoglio – proponesse alla ragazza di tenerselo. Dopo un laconico saluto ai Rovelli, se ne tornarono a casa in un gelido silenzio. Ora le speranze di Emilia erano proprio crollate: fino all’ultimo aveva sperato in un ripensamento da parte della figlia. Un giorno il parroco mandò a chiamare Elena, e le comunicò che l’Ordine delle Canossiane avrebbe accolto volentieri una giovane ragazza come novizia nel convento di Settignano, in Toscana. I voti sarebbero stati conferiti dopo aver valutato la vocazione religiosa della nuova venuta, in base alla sua condotta e in tempi da stabilire. Se Elena era proprio decisa a compiere questo passo, era un’occasione da non perdere. Raramente le ragazze venivano accettate in così breve tempo e per don Alfonso, che aveva messo una buona parola presso la superiora del convento, si trattava di un Ordine di tutto pregio, che si distingueva per la sua dinamicità e per le iniziative sociali a cui era dedito. Prima però occorreva il benestare del Vescovo di Milano. Elena si recò all’Arcivescovado, un bel Palazzo settecentesco di fianco al Duomo, verso la fine del mese di giugno, accompagnata da Emilia. Aveva indossato una camicia bianca e aveva raccolto i capelli sulla nuca, la chioma sciolta le conferiva un’aria troppo sbarazzina e un po’ selvaggia. Per la verità avrebbe dovuto essere accompagnata da entrambi i genitori, ma Arnaldo se la svignò alla grande. «Figurati se perdo una giornata di lavoro per ’ste bambanate» disse a Emilia quando seppe della richiesta. «Andate voi, no? Io cosa posso dire al Vescovo più di quanto già non direte voi? La lingua non vi manca di certo e se quella là è proprio decisa, saprà far valere le sue ragioni.» «Che discorsi!» protestò Emilia. «La vocazione di tua figlia sarebbe una bambanata, per te?» 17 «Non dico questo. Ma io ai preti proprio non so cosa dire. Se mi fanno delle domande sul catechismo, non ricordo niente, son passati troppi anni. Tu invece sei pane e chiesa, e di certo farai più bella figura di me.» Emilia gettò subito la spugna, perché tanto sapeva che nulla avrebbe potuto far cambiare idea al marito. Vennero ricevute dal vicario del Cardinale, un anziano prelato il cui viso sembrava un teschio ricoperto di pelle, gli occhi stinti e acquosi s’intravedevano attraverso due fessure e, mentre parlava, le mani rinsecchite e solcate di vene bluastre si muovevano in un imbarazzante tremolio. Rivolse a Elena alcune domande sui dieci comandamenti, sui sette peccati capitali, sulle virtù cardinali e i precetti della chiesa. Rispose a tutte in modo corretto: in quei tristi giorni di attesa, era uscita pochissimo di casa e aveva avuto tutto il tempo di imparare a memoria un libro che le aveva fornito don Alfonso. «Bene» proferì il prelato con sussiego, quasi soppesando le parole. «Vedo che la ragazza è preparata sulla catechesi e, mi sembra, sicura della sua vocazione.» Parlò poi da solo con Emilia, ponendo questioni sulla famiglia, a cui lei rispose con la prontezza usuale e anche con qualche bugia, quando si trattò di sviscerare la frequentazione della chiesa da parte del marito e dei figli maschi. «Riferirò al nostro esimio vescovo» concluse alzandosi, «e riceverete una risposta al più presto.» Tutto andò secondo le previsioni. Elena partì un sabato mattina di luglio; la mamma la osservava dalla finestra col cuore triste e la sensazione tangibile di qualcosa di celato. Il babbo la portò alla stazione col calesse. Elena aveva chiesto che nessun altro della famiglia la accompagnasse, per evitare troppe lacrime. Quelle nascoste bastavano. Quando il cavallo partì, si voltò a guardare la sua casa, nella luminosità del mattino. L’avrebbe rivista solo cinque anni più tardi, devastata dalla guerra. Non aveva più incontrato Ermanno dal giorno della visita ai genitori. Davanti alla villa dei Rovelli i suoi occhi indugiarono a lungo: le persiane della camera do18 ve il ragazzo dormiva erano ancora chiuse. Una sola parola le sovvenne abbassando la testa: «Perdonami...» sussurrò a mezza voce, senza riuscire a trattenere un fremito malinconico, che aveva già il sapore definitivo e amaro dell’addio. Chito seguì il calesse per un lungo tratto, poi si fermò e rimase, mugolando, a guardare Elena che si allontanava fino a scomparire. 19 Capitolo 2 La vocazione religiosa di Elena rimase a lungo un mistero. Le meno convinte di questa decisione furono Emilia e le figlie, ma nessuna di loro osò mai esternare i propri dubbi, quasi fosse sacrilego, a quel punto, mettere ancora in discussione una chiamata di Dio. La rottura del fidanzamento e la partenza della ragazza avevano generato molti pettegolezzi, nella corte. Emilia intuiva e captava spezzoni di discorsi, soprattutto quando si recava al lavatoio della roggia, luogo in cui, riunite a svolgere un lavoro che non richiedeva certo molta concentrazione, le donne si abbandonavano senza ritegno alle chiacchiere più sfrenate, nella molle calura estiva e tra una strizzata di panni e l’altra. Si accorgeva poi di come interrompessero i loro discorsi quando lei arrivava, col suo secchio di biancheria da lavare, portandoli su argomenti più banali. Qualcuna tra le più anziane aveva tuttavia la faccia tosta di alludere, di tanto in tanto, allo spinoso argomento in modo più aperto, parlando vagamente di queste coppie moderne che si prendevano e lasciavano con eccessiva facilità, o addirittura alla validità di certe vocazioni religiose improvvise, che celavano chissà quali misteri. Ai miei tempi… Emilia, a queste illazioni, non aveva mai replicato. Se ne stava buona, mordendosi la lingua, gli occhi chini sul bucato, speranzosa che l’interesse per ciò che era accaduto nella sua famiglia scemasse da solo. E così avvenne. Ben presto, ci fu altro di cui parlare. Emilia aveva l’abitudine di svegliarsi molto presto. Preparava la colazione ai figli e soprattutto al marito, che di primo mattino andava al verzé a vendere i suoi ortaggi. Lei si prendeva una tazza di latte col pane raffermo e poi, quando tutti 21 erano usciti, si concedeva mezz’ora di riposo a letto prima di iniziare la giornata. Non per dormire, ma per coordinare i pensieri sulle incombenze della giornata, rivolte sempre e soltanto alla famiglia: pur standosene a casa, lei lavorava col marito, studiava coi figli, affrontava la vecchiaia col nonno. Tutto ruotava attorno a lei, e si caricava sulle spalle anche i problemi altrui. La sera precedente, a tavola, c’era stata una grossa discussione sul futuro di Cosimo, deciso a iscriversi all’università, alla Facoltà di giurisprudenza. Arnaldo aveva trasecolato. Non erano mancati i pugni sul tavolo e le voci concitate, ma quel ragazzo caparbio era deciso nelle sue intenzioni, a costo di andarsene da casa. A Cosimo era sempre piaciuto leggere e aveva cominciato presto, addirittura alle medie: libri per ragazzi e classici trovati, immersi nelle ragnatele e odorosi di muffa, nello scantinato della trattoria di zio Ercole. Provenivano dalla moglie, che li aveva ricevuti in eredità dai figli di un’anziana signora benestante, presso la quale aveva lavorato come domestica prima di sposarsi, assieme a diversi scatoloni pieni di cose delle quali disfarsi: tazzine spaiate risalenti a preziosi servizi di caffè, bicchieri di cristallo di finissima fattura – ma qualcuno sbeccato, vasi di fiori art decò. E per l’appunto, tantissimi libri. Fu tutto ciò che Nora aveva portato a Ercole in dote. I libri erano stati riposti nello scantinato per i figli che sarebbero arrivati, ma la prole rimase nel mondo dei sogni e i libri finirono tra le mani di Cosimo. Fu lì che nacquero la sua passione per la letteratura, la decisione di iscriversi al liceo e quella di continuare a studiare. «Andare all’università costa caro, e qui già si fatica a tirare avanti» disse quella sera Arnaldo, tutto concitato. «E poi che bisogno c’è? Il lavoro già ce l’hai, io non aspetto altro che tu mi dia una mano nella terra. Con il tuo aiuto si potrebbero migliorare tante cose, magari col tempo acquistare qualche macchina e lasciare a casa un po’ di ragazze. Ma tu… chissà cosa pretendi dalla vita. Te set un malnat!» «Non voglio fare la tua fine» rispose Cosimo. «Sgobbi 22 dalla mattina alla sera senza mai concederti uno svago. Dimmi un po’, hai mai visto il mare? Sei mai andato a un cinema? Hai mai comprato un vestito nuovo alla mamma?» «Cosimo, adesso esageri...» lo avvertì Emilia, in apprensione per la piega che la discussione stava prendendo. Era intenta a sbucciare una mela, che divise come d’abitudine in spicchi più o meno uguali, da passare alle persone riunite attorno alla tavola: in quell’occasione, prima al nonno, poi al marito, ai figli e infine a se stessa, rispettando gerarchie e affetti familiari. Nel passare la porzione a Cosimo, gli lanciò un’occhiata eloquente. Quel ragazzo era il suo orgoglio e la sua pena: impetuoso di natura, pronto alla collera ma anche dolce e disponibile, quando era il caso di esserlo. Le ricordava tanto suo padre, anch’egli proiettato per anni – ma senza successo – verso una vita migliore. «Lasciami parlare, mamma. Non è solo per avere di più che voglio studiare. Voglio studiare perché mi piace, cosa c’è di strano in tutto questo?» Arnaldo aveva ascoltato senza più proferire parola, nel cuore tanta amarezza. Ma come dare torto a Cosimo? Le sue ragioni erano sacrosante. Così si alzò e uscì, troncando la discussione, come spesso faceva quando era messo alle strette e non sapeva cosa rispondere. Tanto avrebbe finito per cedere e Cosimo era ben consapevole di questo. Il nonno aveva tentato un paio di volte di intervenire, ma da qualche tempo la sua parlantina non era più tanto sciolta e a quell’ora, dopo la cena, le palpebre già cominciavano a divenirgli pesanti. Il mattino seguente Emilia, accovacciata nel suo letto, ripensando a quella discussione si sentiva inquieta. Lei capiva bene le esigenze del figlio. Era un ragazzo sveglio e intelligente, e al liceo aveva subito l’influenza del suo professore di lettere, un uomo di cultura che spingeva i ragazzi, soprattutto quelli come Cosimo, confinati in una realtà sociale chiusa e priva di stimoli, a evolversi e cercare strade diverse. Ma il marito non la pensava così: la sua famiglia aveva coltivato la terra per generazioni; era un lavoro pesante, 23 tuttavia assicurava il pane a tutti. A lui bastava e riteneva che i figli dovessero pensarla allo stesso modo. Emilia veniva da una famiglia ancora più povera, e sposando Arnaldo aveva compiuto un saltello sui gradini della scala sociale. Tuttavia, aver frequentato solo le scuole elementari e sapere a malapena leggere e scrivere, erano da sempre i suoi grandi crucci. Quei pensieri confusi, all’improvviso, vennero interrotti da una voce allarmata: «Emilia, Emilia, ven giò subit per piesé, la Caterina la sta mal, par che l’è dré murì…» Che diamine, chiamino il dottore se la Caterina sta male, pensò. Lei cosa poteva farci? Possibile che le vicine reclamassero puntualmente il suo intervento? Se la vita in comune del cortile a volte le piaceva, come le sere d’estate quando le donne, finalmente libere dai loro impegni, si radunavano a chiacchierare con qualche lavoretto in mano, profittando delle giornate più lunghe mentre i ragazzini giocavano e i mariti erano all’osteria, c’erano pure dei momenti in cui avrebbe preferito vivere in uno di quegli appartamenti del centro città in cui ognuno si fa i fatti suoi. Quella mattina, di sicuro, avrebbe preferito starsene tranquilla a pensare ai suoi problemi, ma infilò ugualmente gli zoccoli e scese di malavoglia. La vicina, in fondo alle scale, l’aspettava col viso terreo. Fece subito cenno alle case dove dormivano le ragazze venute dalla bassa Pianura Padana, quelle che lavoravano le terre date in affitto ad Arnaldo dai Visconti di Morzone, e disse sottovoce: «Emilia… la Caterina… è stata male tutta la notte. Ha forti dolori al ventre. Vai te a vedere, io ci sono già stata ma non so cosa fare. E poi mi fa impressione vederla soffrire a quel modo.» Salì una rampa di scale decrepite fino al primo piano del caseggiato basso e malridotto che chiudeva la corte a quadrilatero. Le ragazze erano già tutte uscite; il lavoro dei campi iniziava quasi all’alba, d’estate, e i letti delle camerate erano già in ordine. In una di esse, sul fondo, Caterina, scarmigliata e col volto disfatto, smaniava in preda a forti 24 dolori. Come la vide, Emilia colse nello sguardo della ragazza un lampo di paura. «Andate via! Cosa ci fate voi qui? Lasciatemi morire.» «Caterina, che discorsi sono questi? Dove hai male?» Per tutta risposta la ragazza scosse la testa con violenza, poi la fece ricadere sul cuscino, esausta. Emilia le tastò la fronte, alzò le coperte e una visione terrificante si presentò ai suoi occhi: era in una pozzanghera di sangue e si teneva la pancia con le mani. Dalla prima occhiata, doveva essere incinta di almeno sette mesi. «Oh misericordia. Tu stai per partorire! Di quanti mesi sei?» «Sette… forse.» Le carezzò la fronte madida di sudore. «Vado a chiamare la levatrice, con tutto il sangue che hai perso non c’è un minuto da perdere. Tu stai buona, fai dei bei respiri profondi e cerca di calmarti. Adesso sistemiamo tutto.» «Non parlatene con nessuno…» la supplicò, e giù un altro grido di dolore. La signora Silvia assisteva da una vita le puerpere del rione, tutti la conoscevano e l’apprezzavano per la sua competenza e per il fatto che non si faceva mai pagare. Di che cosa campasse, nessuno lo sapeva. Era una specie di istituzione: un donnone opulento con una faccia paciosa e sempre sorridente. Ma quando vide le condizioni della Caterina, il suo viso cambiò espressione. Si fece portare teli puliti e acqua calda. A lungo manovrò tra le cosce della ragazza, che nel frattempo sembrava essersi quietata e addirittura pareva dormisse, di un sonno stremato e innaturale. Emilia, rincantucciata in un angolo della camera col rosario in mano, snocciolò a mezza voce qualche preghiera, che andava a mischiarsi alle sue elucubrazioni: «Ave Maria gratia plenam… com’è che non ci siamo ac- corti che la Caterina era incinta? Benedette ragazze… così giovani, costrette a lavorare lontano da casa e dalla famiglia, spesso in balia di qualche malcapitato ... Santa Maria, mater Dei… e se quella povera figliola morisse? Mio Dio, fa che non capiti una cosa del genere, per l’amor del cielo ... 25 in saecula saeculorum, amen.» E se la vedeva davanti la Caterina, mattacchiona e un po’ attaccabrighe ma buona come il pane, quando saliva la sera per portare un piatto di minestra alle compagne e loro l’accoglievano festose, come se portasse chissà che. Le preghiere concitate di Emilia non sortirono effetto. Quando il piccolo uscì dal grembo di sua madre, non ci fu alcun vagito. Emilia si avvicinò e osservò la levatrice ripulire, con le lacrime agli occhi, il corpicino minuto e senza vita di un maschietto sottopeso. «Non mi abituerò mai a queste cose» proferì Silvia con tristezza, avvolgendo il piccolo in un lenzuolo. «È una cosa che mi prende il cuore e lo stomaco. E questa ragazza, così giovane, è salva per miracolo, sempre che non sorgano complicazioni nelle prossime ore. Ma ha un fisico forte, dovrebbe cavarsela.» «Nessuno di noi sapeva che era incinta, Silvia, ve lo giuro» sussurrò Emilia. «Altrimenti l’avremmo aiutata e non avremmo certo permesso che continuasse a lavorare fino all’ultimo. Forse le sue compagne erano al corrente ma tra loro, si sa, quando non vogliono far sapere una cosa sono brave a tenersi la corda.» Silvia alzò le spalle, rassegnata: «Ah, stì tusann! Fanno i loro comodi e poi si trovano inguaiate, lontano da casa per giunta. E per non rimetterci i soldi della paga, si fasciano il ventre fino a scoppiare. Poi succedono i disastri. Ma… anche quei mascalzoni che se ne approfittano! Dovrebbero castigarne qualcuno, una buona volta. Dare l’esempio, così ci pensano due volte prima di calarsi le braghe!» Silvia provvide a portare in chiesa il corpicino per una benedizione e per essere affidato agli addetti alla sepoltura. Per tre giorni Caterina ebbe la febbre alta e le due donne si alternarono ad assisterla, lasciando fuori le altre della corte, per evitare pettegolezzi. Poi migliorò, aprì gli occhi e chiese dell’acqua fresca; ma era esausta e priva di forze. Al quinto giorno si sedette sul letto, il viso disfatto, i capelli scuri 26 appiccicati sulla fronte, lo sguardo allucinato. «Caterina, il bambino…» iniziò Emilia sottovoce. «Lo so che è morto. Me lo sentivo ancora prima che nascesse, mentre stavo male. È meglio così. Non sarei stata una buona madre e non avrei saputo come mantenerlo. Il mio piccolino adesso riposa in pace e non dovrà soffrire. Almeno fossi morta anch’io.» «Caterina… chi è il padre?» «Non c’è nessun padre.» «Almeno dobbiamo informare la tua famiglia, così te ne stai a casa per un po’ e ti riposi. Tornerai a lavorare quando sarai più in forza. Ti terremo il posto, te lo prometto, a costo di sostituirti io.» Emilia le parlava con dolcezza, con serenità, come una madre. «No, vi prego, non dite nulla alla mia famiglia. Mio padre mi prenderebbe a legnate, se sapesse. Qualche giorno e mi sarò rimessa, e tutto sarà come prima. E tornerò a lavorare. Io ho bisogno di guadagnare, per aiutare i miei genitori, i miei fratelli.» Caterina veniva dal mantovano, una zona depressa, soffocata da una grave crisi, ed Emilia non volle insistere. Erano problemi che lei ben comprendeva. Curò con amore quella ragazza che tanto le ricordava la sua Elena, partita per il convento. L’assisteva, di nascosto da Arnaldo, le portava da mangiare cose che neppure lei e la sua famiglia mangiavano: frutta, verdura fresca e anche un po’ di carne. Era come se si sentisse responsabile per quanto le era accaduto. Caterina non era mai stata trattata meglio in vita sua e non scordò mai quei giorni in cui, per la prima volta, sentì che qualcuno si preoccupava per lei e voleva il suo bene. Neppure nei giorni che seguirono ci fu verso di farle rivelare chi fosse il padre del bambino. Si chiudeva in un mutismo ostinato quando Emilia, punta dalla curiosità di sapere, andava sull’argomento. Un pensiero ben preciso prendeva forma nella sua mente: il responsabile poteva essere qualcuno che viveva lì, nella corte, magari uno dei suoi figli. Cosi27 mo aveva vent’anni, Giulio diciotto; erano due bei ragazzi e le donne non disdegnavano certo le loro attenzioni. Quelle figliole, sole e a portata di mano, erano delle prede facili. Pensandoci bene, le era spesso capitato di vedere l’uno o l’altro intrattenersi nel cortile... Lei conosceva bene la vita di quelle ragazze: era stata una di loro, anni prima. Nativa del pavese, pressata dalle precarie condizioni economiche della sua famiglia, si era presentata un giorno a Cesare Boschi, il padre di Arnaldo, quando già aveva ventisette anni, per essere assunta a lavorare le terre che il vecchio aveva in gestione dai Visconti. Non più giovanissima, quindi, secondo i canoni dell’epoca, e pronta a mettere da parte i suoi sogni di ragazza e il ricordo di un giovane tenente partito per la Grande Guerra senza più dare notizie di sé, per qualcosa di più concreto. Il vecchio Cesare, padre di Arnaldo, la squadrò ben bene dalla testa ai piedi, come quando doveva acquistare un cavallo. Ma la decisione venne presa come sempre da Agnese, sua moglie, la regiura, come veniva chiamata in dialetto la mamma nella casa patriarcale, solo in apparenza relegata al ruolo subalterno di donna di casa, in realtà vera sovrana della famiglia, a cui spettavano tutte le decisioni importanti. Aveva gli occhi fissi su un rammendo in quell’istante, ma aveva udito e visto ogni cosa. Alzò appena lo sguardo verso Cesare e fece un cenno con la testa, in modo asciutto e deciso. Fu così che Emilia venne arruolata nel gruppo delle ragazze; ma Agnese, alla vista di quella sana e prosperosa ragazza dal sorriso che incantava, era andata con le intenzioni ben oltre il lavoro nella terra. I fratelli maschi di Arnaldo, tre, erano già tutti sposati: due erano emigrati in America e mandavano una lettera di tanto in tanto, con le descrizioni delle terre sterminate che attraversavano con le loro carovane colme di mercanzie. Il terzo era Ercole, quello della trattoria, maritatosi con Norma a poco più di vent’anni. Rimaneva Arnaldo, non più giovanissimo e ancora in casa, taciturno, solitario e dedito a null’altro che al lavoro nei campi. Agnese se lo lavorò ben bene con l’arte della diplo28 mazia. Il figlio non era certo un Adone ma era un brav’uomo, lavoratore e onesto, e a Emilia dirgli di sì, quando con molta modestia le aveva chiesto di sposarlo, le era venuto naturale. Del resto ad Arnaldo, manovre materne a parte, la ragazza era piaciuta da subito e la sua presenza al campo sembrava avergli procurato una sorta di risveglio alla vita. Il tempo che intercorse tra il suo arrivo e il matrimonio, un anno circa, Emilia lo passò nella casupola assieme alle ragazze e ne colse tutti i problemi legati alla solitudine, al loro desiderio di riscattarsi da una vita dura e priva di prospettive. Orbene, il fatto accaduto a Caterina fu il suo pensiero costante nei giorni che seguirono. Ma che fare? Mai avrebbe osato esternare i suoi dubbi al marito e tanto meno ai figli. Certi argomenti non venivano trattati in famiglia, chiedere spiegazioni su una questione così delicata era fuori discussione. L’ansia di conoscere la verità le attanagliava il cuore. Se il responsabile era uno dei suoi figli, allora il piccino morto diventava il suo nipotino e lei avrebbe potuto piangerlo e pregare per lui. Una sera, a tavola, approfittò dell’assenza delle due figlie. Erano al Leon D’Oro ad aiutare la zia a servire una cena importante. Prese coraggio e parlò. «Ho una cosa che mi pesa sul cuore» disse piano. Tutti la guardarono con curiosità. «La Caterina... la scorsa settimana ha partorito un bimbo morto. Povera ragazza! Ha anche rischiato la vita. Aveste visto in che condizioni era. Vorrei proprio sapere chi è quel mascalzone che l’ha messa incinta e poi se l’è filata. Se voi sapete qualcosa…» E così dicendo, osservava le reazioni dei figli. «Mi dispiace per la Caterina e per il piccino» fece Arnaldo. «Però… queste ragazze! Non le tiene a freno nessuno. So io cosa succede la sera sui prati dietro la palazzina e sui fienili delle cascine.» I ragazzi si scambiarono un’occhiata sorniona e sorrisero, un po’ imbarazzati. Non era usuale sentire il babbo parlare di certe cose. 29 «Cosa vuoi dire adesso?» gridò Emilia, indignata. «Che la colpa è solo sua? Che se l’è cercata? Voi uomini fate i vostri comodi e poi la colpa è sempre delle donne!» «Io non ho goduto i favori della Caterina, se è questo che pensi. L’avrò vista sì e no due o tre volte, da lontano. E poi, non è neanche il mio tipo» fece Cosimo tranquillo. «Siamo in tanti alla Bovisa, perché pensare a noi due?» ridacchiò Giulio, che aveva compreso dove la madre voleva andare a parare. «Ci sono anche i figli del conte se è per questo, o il conte stesso. Si sa che a lui piace la carne fresca!» «Tacete una buona volta!» si alterò Arnaldo. «Chi diavolo ti dà il diritto di dire certe cose? Noi non sappiamo nulla. E non andiamo in giro a immaginare chissà che sui padroni, ci manca anche di perdere le terre per cose che non ci riguardano.» Ma nella corte, quando iniziò il passaparola e la cosa fu risaputa da tutti, nacque un vespaio di illazioni. Qualcuna osò persino, in un modo all’apparenza casuale, chiedere alla levatrice a chi somigliasse il piccino. Altre giuravano di aver visto la Caterina con questo o quello, ma nessuna di loro arrivò alla verità. E fu il secondo mistero di quell’estate. Caterina si rimise in sesto e tornò a lavorare. Era piena estate, c’era tanto da fare: raccogliere gli ortaggi di stagione e sistemarli nelle ceste che Arnaldo all’alba portava al verziere col calesse; raccogliere il grano in fascine, dopo la mietitura; estirpare le erbacce che invadevano i coltivi. Le ragazze partivano presto, con un cappello di paglia in testa per ripararsi dal sole cocente, vestite di cotonina leggera, la scorta di acqua in un fiasco di vino. Ridevano e cantavano nel breve tragitto fino ai campi. E nella luce morente del giorno, se ne tornavano a casa, stanche, affamate, la pelle arrossata dal sole. In autunno, a semina conclusa, sarebbero rientrate al loro paese con un gruzzolo di banconote nascosto nel seno; alcune di loro dopo aver perso, tra i cespugli di lavanda o sui prati freschi delle notti estive, qualcosa di sé che avevano fino allora gelosamente custodito. Spesso nella lusinga di una vita migliore, che non sarebbe mai giunta. 30 31 Capitolo 3 Passarono alcuni mesi prima che Elena si decidesse a scrivere una lettera a casa. La tratteneva il fatto di non poter raccontare tutta la verità. E la verità non riguardava soltanto i motivi che l’avevano spinta a farsi suora, ma anche la sofferenza per aver lasciato Ermanno, la casa, la famiglia, per aver dato una svolta così radicale alla sua vita, in contrasto con i suoi sogni di sempre, una sofferenza manifestatasi come un fiume in piena dopo l’arrivo al convento. Ciò nonostante, il suo orgoglio la sosteneva e le permetteva di continuare a far fronte ai doveri della vita monastica con lealtà. Nel frattempo, Emilia si rivolgeva al parroco per avere notizie della figlia. «Sta bene, sta bene, non preoccuparti» rispondeva lui. «Sono in contatto ogni settimana con la Madre superiora del convento di Settignano e chiedo sempre sue notizie. È in buona salute e si comporta bene.» «Se almeno scrivesse una lettera, sarei più tranquilla. Sarebbe come sentire la sua voce.» E un giorno di ottobre la lettera arrivò, indirizzata alla sorella Bianca. Le preoccupazioni di Emilia aumentarono, però, giacché al suo intuito di madre non sfuggiva la tristezza che trapelava dal suo scritto. Cara Bianca, finalmente trovo il modo e il tempo di scriverti, dopo gli sforzi per abituarmi a questa nuova vita. Quando sei animata da una passione interiore tutto ti sembra possibile, poi l’impatto con la realtà si rivela ben altra cosa e devi fare i conti con sentimenti e sensazioni che mai avresti immagi- 32 nato di provare. Sto bene di salute. Le mie consorelle sono buone con me e non ho nulla di cui lamentarmi. Per il momento mi occupo del guardaroba delle suore. Cucio, rammendo, ricamo e stiro. Stiro anche i paramenti dei preti della parrocchia e le tovaglie dell’altare. Forse più avanti avrò qualche lavoro di maggiore responsabilità, perché scrivo bene e so fare di conto. La Madre superiora è una donna energica, ma anche sensibile e comprensiva. Ha un portamento fiero e umile al contempo, non dimostra gli anni che ha, sessantacinque da quanto ho capito, e da ragazza deve essere stata molto bella. Quando sono arrivata, ho avuto un lungo colloquio con lei, seduta dinanzi alla sua scrivania: voleva accertarsi della mia vocazione. Le sue ultime parole sono state: “qualsiasi cosa ti abbia spinto fin qui, sappi che dovrai essere coerente con la tua scelta e amare Dio”. È ciò che cerco di fare, con coraggio e onestà, ma ho tanta nostalgia di casa, di te e di tutti gli altri. Come state? Il babbo lavora sempre tanto? Parla qualche volta di me? E quel matto di Cosimo si è poi iscritto all’Università? Il babbo non vorrà sentire ragioni su questo argomento, e mi pare di sentire le sue proteste. E la mamma? Si è un po’ consolata della mia partenza? Come sta il nonno? Fa sempre ammattire tutti? Quando sono partita avevo portato con me delle fotografie, ma non ho potuto tenerle. Mi hanno requisito tutto, anche alcuni libri e la lettera di addio che mi hai infilato in valigia quando sono partita. È la regola del convento: veniamo staccate da tutto ciò che ci lega alla nostra vita precedente. Così mi sono sentita sola, figlia di nessuno, senza radici, come se la mia esistenza fosse un libro di pagine bianche tutte da riscrivere. Ora la Madre mi ha dato il permesso di ricevere delle lettere da casa, non molte, solo una di tanto in tanto. Quindi scrivimi, ti prego. Attenderò con ansia e mi parrà di essere con voi. Un abbraccio. Tua Elena. 33 P. S. Ti prego: se puoi, dammi notizie di Ermanno. Dimmi solo se sta bene e cosa fa. Bianca aveva riposto la lettera in un cassetto, dopo averla letta a tutta la famiglia e aver volutamente tralasciato l’ultima richiesta di Elena. Rimasta da sola in casa, Emilia l’aveva cercata e trovata. La rilesse più volte, traendo le sue conclusioni. «Quella ragazza non mi convince» disse la sera al marito mentre erano a letto. «Avrà pure la vocazione religiosa, ma è triste e le manca la famiglia, si sente. E il fatto di chiedere notizie dell’Ermanno poi, cosa vuol dire? Ci pensa ancora, è chiaro! È stata una decisione troppo affrettata. Avrei dovuto impuntarmi. Ma ormai è cosa fatta e non mi resta che pregare per il suo bene.» «Ma sì, avrà un po’ di nostalgia, è normale, cosa ti tormenti? Lei è al sicuro e di certo mangia meglio di noi. Dai… dormiamo, che l’alba è vicina.» Bianca lavorava alla fabbrica del tabacco e per raggiungerla doveva percorrere una strada che passava proprio davanti alla casa di Ermanno. E una sera, di ritorno dal lavoro, lo incontrò. Ermanno la scorse già da lontano e per alcuni, brevissimi istanti gli parve di vedere Elena. Per la prima volta, dopo quanto era accaduto, si trovavano faccia a faccia; ci fu un attimo di imbarazzo, nessuno parlava per primo. «Come stai?» fece lei, notando che era dimagrito, eppure bello come al solito, con quegli occhi azzurri e la capigliatura bionda pettinata all’indietro, come si usava in quegli anni. «Non ti ho più visto in giro. E neanche la domenica all’Arena. Non ci vieni più?» «Io… sì, sto bene. Normale, insomma. Ai giochi dell’Arena… beh, ultimamente non ne avevo voglia. Hai notizie di Elena?» «Sappiamo che sta bene e che la direttrice del convento è contenta di lei. Per ora è novizia, tra qualche mese prenderà i voti.» 34 Ermanno alzò le spalle guardando altrove, come se la cosa non lo interessasse più di tanto e Bianca avesse detto fin troppo. Poi si girò verso di lei, le guardò i capelli: erano uguali a quelli di Elena, folti e scuri, un po’ scarmigliati sulle spalle, e gli occhi gli scesero sul seno florido, che sembrava scoppiare sotto la camicia. Spesso aveva preso in giro Elena per questo motivo, ma solo Dio sapeva quanto quel seno lo mandava fuori di testa. Addirittura gli sembrò di sentire addosso a Bianca il suo stesso profumo, un misto di erba e fiori di lavanda. Un’ondata di sofferenza lo avvolse, ma il suo orgoglio gli impediva di essere sincero. Veniva da un periodo difficile, Ermanno: per molte settimane aveva rifiutato il cibo ed era caduto in uno stato di profondo abbattimento. La madre aveva fatto del suo meglio per denigrare Elena e tutta la famiglia, dopo il voltafaccia improvviso a pochi mesi dalle nozze. Quel fidanzamento non l’aveva mai convinta del tutto ed era arrivata la conferma ai suoi dubbi. Gli diceva: «Quella non era certo degna di te. Come può una donna dire di voler bene a un uomo fino a decidere di sposarlo e poi scoprire di avere la vacazione religiosa? Non c’ha nulla in testa, te lo dico io.» Ma queste argomentazioni non lenivano certo la sua sofferenza. Elena era stata il suo primo amore, con lei si era immaginato una vita; i suoi baci gli sconvolgevano i sensi, il suo carattere, estroverso e aperto al mondo, colmavano le sue lacune di ragazzo timido e introverso, cresciuto all’ombra di una famiglia rigida e fortemente attaccata alle tradizioni. E ora pensava che nessuna donna al mondo avrebbe mai potuto prendere il suo posto. Bianca captò gli sguardi del ragazzo su di sé e nel suo intimo si compiacque. Non le passò per la testa che quegli sguardi non fossero rivolti a lei ma a ciò che in lei, Ermanno, ritrovava della sorella. «Fai sempre questa strada la sera?» le chiese dopo qualche attimo di silenzio. «Sì, è la più breve.» «Allora magari ci si incontra.» 35 «D’accordo! Di solito io arrivo qui attorno alle sei.» Parlavano di cose banali, Bianca ed Ermanno, quando si incontravano la sera, apparentemente in modo casuale. A volte facevano un tratto di strada assieme, allungando il percorso per arrivare alla casa di lei, e la ragazza cominciò a pensare che lui la corteggiasse. Poiché quelle attenzioni la lusingavano, quando usciva dalla fabbrica si aggiustava i capelli e si stendeva un velo di cipria sul viso. Quanto Elena era passionale e istintiva, tanto Bianca era concreta e solida nelle sue aspettative; pensando alla sua vita futura, a un suo auspicato matrimonio, le considerazioni di carattere economico avevano un peso non indifferente nei suoi pensieri. Accarezzava l’idea di sposare un uomo che la esentasse da tutti quei lavori manuali che sfiancavano sua madre da mattina a sera, lei lo vedeva bene, come il bucato alla roggia, lo stiro, le pulizie della casa e spesso della stalla. Ermanno poteva rispondere anche a queste esigenze, oltre a essere attraente. Il fatto che fosse stato il fidanzato di sua sorella, poco importava. La scelta di Elena era ormai definitiva e valeva la pena di lavorare su quel progetto. Del resto i rapporti tra i due non tardarono a divenire più intimi, in modo quasi automatico, senza che sentimenti e intenzioni venissero palesati in modo aperto e soprattutto senza che Bianca, presa nel suo calcolo, si fermasse un attimo ad analizzare ciò che Ermanno cercava in lei. Mia cara Elena, che gioia immensa ricevere tue notizie: tutti contenti, mamma, papà, Matilde e quei diavoli dei nostri fratelli, che non smettono mai di stupirci. Cosimo si è iscritto alla Facoltà di giurisprudenza. Alla fine l’ha avuta vinta sul babbo, dopo tante discussioni, promettendogli il suo aiuto nel lavoro. Te lo immagini nostro fratello andare in tribunale vestito con la toga e difendere la gente? Ma io penso che la sua ambizione sia anche di cambiare vita, di ambire a qualcosa di meglio, e in questo lo capisco. Giulio ha finito quest’anno il liceo come sai, ma non ha alcuna intenzione di continuare a stu- 36 diare e ha già incominciato a lavorare nei campi. Al mercato la mattina vanno assieme, lui e il babbo, e per il babbo è un bell’aiuto, tant’è che il suo umore è cambiato ed è meno brontolone del solito. Ieri i ragazzi hanno fatto uno scherzo al nonno. Gli hanno regalato un nuovo paio di occhiali e lui, dopo averlo provato, ha detto che ci vedeva benissimo e li ha pure ringraziati. È uscito tutto contento per andare dal barbiere. Ma gli occhiali non avevano le lenti e quel buon diavolo, mentre gli faceva la barba, se n’è accorto: glieli ha puliti ben bene passando un panno attraverso la montatura. Tutti i presenti nella bottega hanno riso come matti, ma il nonno è tornato a casa arrabbiatissimo e ha minacciato di diseredare i colpevoli. Diseredare da cosa, poi? Non possiede una lira, da quanto ne sappiamo. Quanto abbiamo riso, Elena mia, e più noi ridevamo e più il nonno ne usciva matto dalla rabbia. Matilde sembra assorta nei suoi pensieri, nei suoi sogni. Noi la consideriamo ancora una bambina, ma è cresciuta. È bella, le è spuntato il seno e i ragazzi la guardano. Io continuo il mio lavoro in fabbrica e mi sono fatta nuove amiche. Spesso usciamo insieme la domenica, ma devo fare attenzione a non tornare dopo le sei, altrimenti la mamma si arrabbia. Domenica scorsa abbiamo preso il tramvai e siamo andate in Duomo a vedere la principessa Maria José, in visita a Milano col suo bel Principe. Era molto semplice, con un impermeabile blu sopra un abito bianco profilato coi pizzi. In testa un basco. Lui era in borghese e sembrava uno qualunque. C’era tantissima gente e una calca pazzesca. Poi ci siamo concesse una cioccolata da Passerini. Che prezzi! Due lire per una cioccolata. Ma sapessi quant’era buona! Non ho detto nulla al babbo, sai bene come la pensa sui soldi. Ora immagino che vorrai sapere dell’Ermanno. Lui ha molto sofferto per la tua decisione, ma ora sembra stare meglio. Lo vedo spesso la sera, tornando a piedi dalla fabbrica, impegnato in qualche lavoro nel suo giardino. Ci fermiamo a chiacchierare. Mi manchi tanto sorella. Soprattutto mi mancano le nostre 37 risate della sera, prima di addormentarci. Mi raccomando, scrivimi più spesso che puoi. Ti abbraccio. Tua, Bianca. Da qualche tempo al Leon D’Oro avvenivano accese discussioni tra gli avventori, soprattutto la sera, quando avevano più tempo a disposizione e la parlantina sciolta dai bicchieri di vino tracannati. Parlavano della situazione politica, delle mire espansionistiche ormai palesi della Germania in Europa, in un’atmosfera da leggenda nibelungica, il susseguirsi di blitz che portavano all’annessione di molti territori, come l’Austria, la cui conquista era stata annunciata da Hitler stesso via radio, con la sua voce stizzita e sibilante, e di quegli eventi che si sarebbero poi rivelati determinanti per lo scoppio della guerra. Alcuni, soprattutto coloro che avevano vissuto la Grande Guerra e ancora ricordavano le orrende trincee scavate nel fango, imprecavano a quell’odiosa alleanza con Hitler, che di sicuro avrebbe portato anche l’Italia al conflitto. Questione di tempo. Altri, in preda a una maggiore euforia, già ipotizzavano le prime mosse dell’Italia in caso di un conflitto: chi scommetteva su Malta, dove la base navale britannica minacciava i collegamenti con la Libia; chi gli stretti di Suez e Gibilterra, anch’essi in mano agli inglesi, che imprigionavano il nostro mare. Altri si dichiaravano certi che i primi obiettivi sarebbero stati Nizza e la Savoia, per ricongiungerle alla madrepatria. Ercole si dichiarava un comunista convinto e contrario al regime. Benché non avesse studiato, ma solo letto tutto ciò che gli era capitato tra le mani, era considerato l’intellettuale della famiglia, ben diverso dall’indole qualunquista del fratello Arnaldo, disinteressato a tutto ciò che accadeva attorno a lui, se le cose non lo riguardavano da vicino. Era rimasto affascinato dagli scritti di Marx e Lenin, anche se molte cose non le aveva capite. Tuttavia era convinto che la società andasse livellata, senza più ricchi né poveri, togliendo dove più c’era per dare a chi non aveva. Parlare male del regime e della società che lo sosteneva era il suo pas38 satempo preferito. Ma le sue convinzioni, a ben vedere, erano più teoriche che pratiche, e molto in contrasto con i suoi personali interessi di oste, soprattutto quando la sera avvenivano in trattoria le gustose e ben remunerate cene di personaggi vicini al regime che lui, non andando troppo per il sottile, non mancava di omaggiare e accogliere con doveroso ossequio, mentre la Nora dava il meglio di sé in cucina. Gli affari erano affari, e quando si trattava di aumentare la paga al garzone che lavorava per lui, riusciva sempre a trovare qualche scusa per rimandare la cosa a tempi migliori. In quelle discussioni, comunque, Ercole la faceva da padrone, infervorandosi e dimenticando quanto fosse pericoloso esternare in pubblico le sue idee. Tutto ciò durava finché la moglie, abbandonato il riordino della cucina, raggiungeva i presenti e ricordava con piglio deciso le regole esposte nel cartello appeso alla parete, che proibiva le discussioni politiche in pubblico e in qualsiasi esercizio commerciale. «Volete finirla?» chiedeva minacciosa. «Se non la smettete e non cambiate argomento, vado a chiamare le guardie della milizia e allora state freschi tutti quanti.» Ercole la guardava con occhi di fuoco ma uno alla volta, intimoriti dal fare risoluto della padrona, gli astanti tornavano a sedersi ai loro tavoli per riprendere il gioco del tressette, certi che prima o poi, con l’aria che tirava, per quelle dispute qualcuno l’avrebbe pagata cara. A queste discussioni partecipava spesso anche Cosimo, di passaggio alla trattoria. Ercole andava molto d’accordo col nipote, ma quando il ragazzo cominciò a mostrarsi troppo simpatizzante per il regime, forse influenzato da certi compagni del liceo, i loro rapporti iniziarono a incrinarsi. Cosimo, grazie alla sua istruzione e alla parlantina sciolta, aveva sempre la meglio sullo zio, provocando spesso applausi da parte dei presenti, le cui idee non erano mai ben chiare e finivano per applaudire chi risultava più convincente nelle sue esposizioni. E le voci divenivano ogni sera più concitate, anche se poi tutto finiva con un’alzata di calici. Chi pagò, come era prevedibile, fu proprio Ercole. Una 39 mattina si presentarono alla trattoria due Camicie Nere chiedendo del proprietario. L’uomo stava coprendo il campo di bocce sul retro del locale, l’inverno era ormai alle porte e ghiaccio e neve avrebbero potuto compromettere il terreno liscio sul quale le bocce dovevano scorrere come olio. Ispezionarono a lungo la bottega, cantina compresa. Gli chiesero le generalità e gli fecero molte domande, inutili peraltro, perché di lui sapevano già vita e miracoli. Norma se lo vide portar via così com’era, senza neanche cambiarsi le scarpe: per accertamenti, dissero, giusto qualche ora, che non si preoccupasse. La donna abbassò la saracinesca, avvisò Arnaldo di quanto era accaduto e si barricò in casa, disperata e furiosa al contempo, abbandonandosi a tutte le possibili congetture. Al vicinato fece sapere che il marito aveva una brutta influenza, e neppure lei era in forma. Le ore divennero giorni, tre per l’esattezza, e quando ormai era decisa a recarsi alla questura per avere informazioni, Ercole si presentò a casa una mattina: aveva l’aspetto di chi non se l’era passata troppo bene. Sembrava smagrito, pallido e gli doleva di brutto la pancia. Dai suoi indumenti arrivava un lezzo disgustoso. «Niente, niente» minimizzò lui, ostinato e orgoglioso. «Sto bene, non preoccuparti. Non è successo niente. Sai cosa ti dico? Il vento cambierà, eccome se cambierà. E allora gliela farò pagare a quelli lì, porco d’un diavolo, fosse l’ultima cosa che faccio...» Per qualche giorno non ci furono discussioni, nessuno gli chiese nulla e del resto l’aspetto emaciato convalidava la versione dell’influenza. Ma tutti conoscevano la verità, perché alla gente della corte non sfuggiva nulla e i segreti avevano di solito vita brevissima. Non passò un mese che si riprese a discutere nel chiuso del Leon D’Oro. Magari a voce un po’ più bassa, ma si ricominciò, per la disperazione di Nora. 41 Capitolo 4 Quell’anno l’inverno fu rigido, cadde molta neve ed Emilia ebbe il suo bel daffare a tappare gli spifferi per non disperdere il poco calore della casa. Disponevano di una stufa a legna in cucina e riscaldare l’intero appartamento era impossibile. I panni li lavava in casa, nella tinozza grande di zinco, la stessa usata per il bagno personale. Andare alla roggia non se ne parlava, faceva troppo freddo, le vasche del lavatoio erano gelide e dal tetto pendevano i candelotti di ghiaccio. Per i letti si usava lo scaldino con il carbone rovente, e sotto le coperte c’era un tepore piacevole, ma la mattina l’acqua del catino per lavarsi aveva una patina di ghiaccio sulla superficie. Il nonno si buscò la polmonite. Volle essere curato solo con i cataplasmi di semi di lino, le medicine erano un veleno a suo dire, ma se al contatto del torace li sentiva troppo caldi esigeva che fossero messi a rinfrescare fuori dalla finestra per qualche istante, e finiva per tollerarli quando ormai erano freddi e inutili. Dopo diversi giorni di trepidazione da parte di tutta la famiglia, guarì la sua polmonite da solo, grazie alle sue potenti difese naturali. Un po’ tutti, però, uscirono stremati dal gravoso impegno di accudirlo. Tornò arzillo più che mai e riprese a fare ammattire tutti con le sue pretese. A rendere l’atmosfera di quell’inverno ancora più cupa erano i venti di guerra che soffiavano sull’Europa. Arnaldo lavorava poco dopo la semina, e passava più tempo al Leon D’oro ad aiutare Ercole nella gestione della trattoria. In cambio riceveva qualche derrata che, con le sue entrate, non poteva permettersi. Qui ascoltava i commenti sulla guerra ormai inevitabile e rientrava a casa preoccupato, preda di foschi pensieri. Cosimo invece tornava dalla Facoltà di giu42 risprudenza e dalle assemblee dei GUF, i Giovani universitari fascisti, carico di entusiasmo all’idea che di lì a poco anche l’Italia sarebbe entrata in guerra. All’Università Cosimo aveva fatto amicizia con Leonino, il figlio minore dei Visconti di Morzone. Da tempo fascista convinto, anche per l’atmosfera che respirava in casa, il ragazzo era di carattere sbruffone e borioso. Viziato in famiglia e convinto di saperla lunga in fatto di politica, intratteneva i suoi nuovi compagni, dall’alto della sua autorità nobiliare, sulle tematiche della guerra, ormai considerata imminente e vista come un’epopea trionfante che avrebbe dato lustro a un’Italia ancora relegata tra i paesi meno importanti e più poveri d’Europa. Le sue esternazioni, intrise di scontato lirismo, avevano subito avuto una certa presa su molti ragazzi, tra cui Cosimo, anche grazie all’alto lignaggio dell’amico che lo poneva in una posizione di superiorità intellettuale. Cosimo, ambizioso e determinato, si lasciò influenzare dal giovane conte, e forse il fatto di provenire da un basso rango sociale giocò la sua parte. Si iscrisse al Guf e cominciò a frequentarne le assemblee. «Te set un tangher» lo apostrofò una sera Arnaldo a tavola, di fronte all’entusiasmo di Cosimo su un eventuale conflitto. «Tu non sai niente della guerra, non l’hai vissuta, e ti assicuro che non è una passeggiata. E una guerra adesso sarebbe ancora peggio dell’altra. E poi, quell’Hitler, l’è el diaul. T’el disi mi, il diavolo in persona. Mussolini non l’ha ancora capito e quando lo capirà sarà tardi. Dobbiamo farci delle scorte di cibo, perché quando le cose vanno male e c’è il parapiglia, non si trova più neanche il pane.» «E con che soldi ci facciamo le scorte?» chiese Emilia più concreta. «Se entriamo in guerra sarà una cosa brevissima» disse Cosimo con la sicurezza e la spavalderia dell’inesperienza. «La Germania è forte, sta già ottenendo successi nel nord Europa e, con l’Italia al fianco, vincere sarà un gioco da ragazzi. Il nostro paese diventerà una grande potenza e tutti staremo meglio. Ma occorre che Mussolini muova le chiap43 pe, sta perdendo troppo tempo, anche se… sono sicuro che lui le idee chiare ce l’ha, e sa già dove andrà a colpire una volta entrati in guerra.» Arnaldo scuoteva il capo sfiduciato, ma non voleva gravare con le sue preoccupazioni l’atmosfera familiare. Verso la fine di febbraio, quando già s’intuivano nell’aria le prime avvisaglie della primavera, Emilia ricevette un biglietto dalla contessa Adelaide Visconti: “Vi prego di farmi visita domani pomeriggio alle sedici, possibilmente accompagnata da una delle figliole. Conto sul vostro riserbo. Grazie”. «Ci sarà sotto qualcosa. Di quella gente io non mi fido» fu la prima reazione di Arnaldo alla notizia. «Cosa vuoi che ci sia sotto» replicò Emilia spazientita. «Vorrà chiedermi di dare una mano alla servitù che si porta da Milano nelle pulizie di primavera alla villa, come l’anno scorso del resto. Però non capisco perché portare una figliola.» «Vengo io» disse Matilde tutta eccitata. Ma Emilia sembrava titubante all’idea di portare con sé la figlia più piccola. La contessa Adelaide, moglie del conte Giovanni Visconti di Morzone, era una donna minuta, pallida, col viso da topo. La si vedeva poco in Bovisa, preferiva starsene nel suo palazzo del centro, più confortevole e meglio riscaldato, d’inverno. Compariva ogni anno attorno al mese di marzo, per dare aria alla villa e prepararla all’arrivo, durante la bella stagione, del marito, dei figli e dei parenti, per una passeggiata fuori porta o per una battuta di caccia. Non era nobile di nascita; era figlia di un industriale famoso nel settore farmaceutico. Il conte Giovanni non l’aveva certo sposata per la sua avvenenza e neppure per amore, ma per la cospicua dote che si era portata appresso, dando così una boccata d’ossigeno alle finanze precarie del casato dei Visconti di Morzone, ramo cadetto dei Visconti, signori di Milano prima degli Sforza. D’altronde al padre di Adelaide, uomo concreto e pratico, non era parso vero che qualcuno chiedesse in sposa la sua unica figlia, non più giovanissima e per nulla piacente, per di più un personaggio di tutto rispetto capace 44 di dare lustro e fama alla sua azienda. Così, dopo un po’ di trattative, si celebrarono le nozze, prestigiose e pompose come si conveniva a due casate importanti, anche se per origini diverse. Cosa ne pensasse Adelaide di questo matrimonio non si seppe mai: era una donna taciturna, schiva e accomodante. Qualcuno ventilò che, prima di incontrare il conte, fosse stata innamorata di un operaio dell’azienda paterna; questo legame però sarebbe stato reciso sul nascere dalla famiglia, per questioni di opportunità. E così passò da uno stato di sottomissione all’altro, dal padre al marito. Dal matrimonio nacquero due figli maschi, Leonino e Rodolfo, i quali avevano preso dal padre la prestanza fisica, per loro fortuna, ma a dire della gente, anche l’arroganza e la boria. Emilia e Matilde indossarono il loro abito migliore e si presentarono alle sedici in punto alla villa. Una cameriera le fece entrare: donna Adelaide se ne stava seduta in salotto, riscaldato da un grande camino in marmo, la testa piccola incassata nel collo, i piedi appoggiati su uno sgabello, gli occhi su un ricamo. Matilde vedeva l’interno della casa per la prima volta e si guardava intorno con soggezione, ma anche con un certo batticuore all’idea di incontrare Rodolfo. L’aveva visto alcune volte l’estate precedente, mentre arrivava da Milano in sella al suo cavallo, e aveva iniziato a pensare con insistenza al ragazzo. Ormai ricorreva in modo frequente nelle sue fantasie. Poi una sera di luglio, nella luce dorata del tramonto, mentre si svolgeva l’annuale festa della mietitura sull’aia, Rodolfo era arrivato, e i suoi occhi ardenti si erano fermati su quella ragazza delicata, dagli occhi dolci e intrisi di un’ingenuità affascinante. Una lunga tavola poggiata su due cavalletti era stata imbandita con piatti di salumi e formaggi, verdure fresche tagliate, pane a fette e vino genuino, che la gente spillava direttamente dalle botti. Le donne avevano preparato delle torte prelibate, soprattutto la famosa torta paesana, fatta col pane raffermo imbevuto nel latte e cosparso di cioccolato. Quando il sole calò e iniziarono le danze al suono di una fisarmonica e di un mandolino, Rodolfo invitò Matilde a ballare. 45 «Come ti chiami?» le aveva chiesto. «Mi chiamo Matilde. E voi siete Rodolfo Visconti. Io vi conosco.» Lui annuì e furono le uniche parole scambiate tra i giovani. Alla fine del ballo le sorrise, stampò un bacio fugace sulla guancia e si allontanò di fretta, quasi gli fosse precluso mischiarsi alla gente di stato sociale così basso. Era stato per Matilde il giorno più bello della sua vita. Ma ora, davanti alla contessa, si sentiva intimidita e impacciata. «Sedetevi, sedetevi pure» fece Adelaide indicando due poltrone rivestite in broccato azzurro. La casa era tutta arredata in tinte pastello, come si addiceva a una residenza estiva. «Onorina, porta del tè per favore. E qualche biscotto; io non mangio di certo, sono per la ragazza. Voi Emilia preferite il caffè? A me piace tanto, ma non lo posso bere. Mi fa male allo stomaco.» «Grazie contessa, non si deve disturbare, per me fa lo stesso.» «Ma quanto è cresciuta questa ragazza! È proprio una bella signorina. Ti chiami Elena, non è vero?» «No, lei è Matilde. Elena è l’altra mia figliola, più grande. Si è fatta suora l’anno scorso.» «Ah, che grazia vi ha fatto il Signore; che bella cosa avere una figlia suora. Io avrei tanto voluto avere una femmina, ma il buon Dio non me l’ha mandata. E i miei figlioli, Rodolfo e Leonino… li vedo così poco. Studiano e seguono gli affari del padre, quando sono liberi amano divertirsi: si sa, sono ragazzi. E io sono sempre tanto sola.» Matilde, a sentire nominare Rodolfo, avvampò; per fortuna Adelaide non se ne accorse. Arrivò Onorina reggendo un vassoio e sorbirono il tè in silenzio. Poi la contessa arrivò al dunque. «Emilia, io stimo molto la vostra famiglia, siete persone ammodo. Ho sentito che le vostre figliole sono brave nel cucito e nello stiro e a me serve appunto una ragazza per queste mansioni, per tutto il periodo estivo, qui alla villa. Ma non è solo questo. Se avanza un po’ di tempo, e di sicuro ne avanza, vorrei che mi leggesse qualcosa. A me piace tanto 46 leggere, purtroppo però la vista da qualche tempo mi crea problemi. Gli occhi mi si affaticano dopo poche pagine e devo smettere. Col ricamo, ahimè, è la stessa cosa. Mi hanno riferito che tutti i vostri figli hanno studiato, le ragazze alle magistrali, i maschi al liceo, e questa è una bella cosa. La paga sarebbe interessante, naturalmente. Se Matilde fosse disponibile…» Matilde abbozzò subito un sorriso di accettazione, ma Emilia frenò: «Devo prima parlarne con mio marito, contessa. Matilde ha finito la scuola l’anno scorso e ancora non abbiamo deciso cosa farà. Non so se lui ha già altri progetti per lei.» «Mamma, io sono sicura che il babbo non avrà nulla da ridire» disse Matilde con tono quasi supplichevole. Emilia la fulminò con lo sguardo. «Meglio parlarne con tuo padre, figlia mia. Comunque, grazie contessa per aver pensato a noi.» «Va bene, ma datemi una risposta al più presto. La ragazza mi piace, ci terrei molto. Onorina, accompagna le signore alla porta!» Lasciata la villa, Matilde diede sfogo alla sua rabbia: «Non potevi accettare subito? Cos’è questa storia di chiedere il permesso al babbo, non fanno comodo anche a lui un po’ di soldi in più? Si lamenta sempre che fatichiamo a campare! Chi mi dice che la contessa nel frattempo non cambi idea?» Era disperata e le veniva da piangere. «Tranquilla, la contessa non cambierà idea. E sentire il parere di tuo padre mi sembra il minimo.» «Tu non ci tieni, di’ la verità. È per via dei ragazzi. Voi mamme siete tutte uguali, vi mettete in mente chissà cosa, fosse per voi non dovremmo neppure respirare. Ma io sono adulta ormai, ho diciotto anni e so bene quello che faccio. E poi devo trovare un lavoro, cos’ho studiato a fare sennò?» «Chiudi quella boccaccia. Non puoi sapere quali pericoli si nascondono nelle case dei signori. A loro… è tutto concesso. Sempre. E comunque stai buona, sentiremo cosa dice il 47 babbo. Non c’è fretta.» C’era un proverbio a quei tempi: la faccia del re piace anche agli anarchici. E Arnaldo, oltre a non essere anarchico, non disdegnava certo la faccia del re, quella stampigliata sulle banconote. Così non vi fu alcuna discussione: Matilde si presentò dalla contessa la settimana successiva per iniziare il lavoro, pulita, agghindata, i bei capelli biondi raccolti sulla nuca. Non dovette fare alcuno sforzo per risultare gradita. Matilde era una ragazza aperta e sempre sorridente, e se in famiglia aveva a volte dei guizzi di ribellione, con i suoi superiori era oltremodo rispettosa. I suoi occhi chiari, il suo sorriso solare, e quel senso di purezza interiore che la sua persona emanava, conquistarono presto la contessa e il resto della famiglia. Rodolfo si accorse di lei il sabato successivo e i suoi ritorni estemporanei divennero da quel giorno più frequenti. Intanto Bianca teneva Elena aggiornata sulle novità della famiglia: Mia cara sorella, ho una bella notizia da comunicarti. Matilde ha trovato lavoro come addetta al guardaroba presso la contessa Adelaide Visconti. Ma non è tutto: quando è libera dai suoi impegni lavorativi, le tiene compagnia e legge per lei. A volte pranzano perfino assieme, e da quel che racconta ha avuto modo di gustare delle vere prelibatezze. Donna Adelaide la paga bene e l’adora. Spesso la chiama anche la domenica e nostra sorella è molto contenta, perché nei giorni di festa arriva il figlio Rodolfo, di cui si è perdutamente innamorata. La vedessi! La nostra piccolina sembra vivere ormai su un altro pianeta. Il babbo non si è accorto di niente; la mamma invece, cui nulla sfugge, è molto contrariata. Ha paura che Matilde finisca per soffrire. Vedremo cara sorella, ti terrò aggiornata. Sabato c’è stato il raduno delle Giovani Italiane all’Arena. Quanto mi sei mancata! Ho dovuto indossare la tua divisa perché la mia è diventata piccola, soprattutto la gonna. Soliti giochi con i cerchi e le bandiere; poi la corsa e il salto. 48 Avessi visto i ragazzi maneggiare il moschetto: quest’anno ce n’erano di bellissimi! C’era anche l’Ermanno, ma sembrava non essere in vena. Chissà se faremo ancora di questi saggi, dicono che i tempi stanno cambiando e ben altre cose si profilano all’orizzonte. Attendo tue notizie e ti abbraccio. Tua Bianca. La risposta di Elena non tardò ad arrivare: Mia cara Bianca, scusami se ti rispondo solo ora, ma ho cambiato sede e la tua lettera mi è stata recapitata con ritardo. Ora mi trovo a Castelferro, in Emilia Romagna. Se il posto è meno bello, mi consola il fatto che in linea d’aria sono più vicina a tutti voi e un giorno, chissà, magari vi sarà possibile venirmi a trovare. Dalla finestra della mia camera potevo osservare lo splendore delle colline toscane, le distese dei campi coltivati come una tavolozza di colori, sentire d’estate il canto delle cicale nelle ore più calde, i grilli sul calare della sera. Nel buio osservavo il vagare delle lucciole. Tutto questo leniva la mia nostalgia. Qui è tutto più. . . piatto. La mia finestra dà sul paese; mi ricorda tanto la nostra Bovisa, case basse attorno ai cortili, cascine, tettoie dove si ripongono gli attrezzi dei campi. Il convento dove mi trovo ora è in realtà un asilo per bambini orfani o abbandonati. Sapessi quanta pena mi fanno, Bianca mia! Di giorno mi occupo di loro, li aiuto a mangiare, li faccio giocare, li accudisco, la sera li metto a letto insieme alle mie consorelle. La maggior parte ha perduto il babbo e la mamma, spesso per condizioni di indigenza e povertà. Altri sono figli di ragazze madri. Sono così belli, vedessi. Ma nei loro occhi c’è tanta tristezza. Mi chiedo perché a questi bambini è riservata una vita tanto difficile, e cosa ne sarà di loro quando saranno più grandi. . . Sono contenta per Matilde e spero il meglio per lei. Anche qui si parla di bufere in arrivo e ognuno la pensa a modo suo. Io, per mia fortuna, ho troppo daffare per occuparmi di 49 queste cose e mi limito a pregare Dio che protegga il nostro paese e la nostra famiglia. Spero di ricevere presto tue notizie. Troverai il mio nuovo indirizzo sulla busta. Un abbraccio a tutti voi, la vostra Elena. Fu quell’estate che Cosimo, contagiato dal fermento che animava i suoi amici del GUF, si arruolò volontario per raggiungere il Corpo di Spedizione Oltre-Mare Tirana, già di stanza in Albania dall’aprile del ’39. I soldati erano sbarcati in più punti del paese, senza incontrare particolare resistenza da parte dell’esercito albanese. Di fronte alle novità che ogni giorno si profilavano e agli sfolgoranti successi della Germania, non stava più nella pelle e si accontentò di una guerra secondaria, pur di accelerare i tempi. La cosa era in aria da diverse settimane e una sera, a tavola, diede la notizia ai genitori. «Avete sentito parlare del Patto d’acciaio?» chiese Cosimo per controbattere alle rimostranze di Emilia. «La guerra è vicina, quel patto vincola l’Italia a intervenire al fianco della Germania. Mussolini sta ancora tergiversando e io non capisco perché. Ma sarà questione di mesi, statene certi. Tanto vale che parta volontario e in questo momento al distretto cercano per l’Albania.» «L’esercito italiano non è preparato, e Mussolini lo sa bene» obiettò Arnaldo. «Balle! La Germania provvederà presto a fornirci i mezzi militari e le materie prime necessarie per fronteggiare Francia e Inghilterra. Gli esperti stanno preparando la lista di tutto quello che occorre, credetemi. E comunque io mi sono già iscritto, sono andato proprio oggi al distretto in corso Monforte. Avrei dovuto avvisarvi prima, lo so, ma ho voluto evitare discussioni inutili.» Arnaldo non dibatté più di tanto la questione, sarebbe stato inutile, conoscendo la caparbietà di Cosimo, e comunque era solo un’anticipazione sulla chiamata che presto o tardi sa50 rebbe giunta. Ne era cosciente anche lui. Emilia invece aveva da tempo intuito le intenzioni del figlio. La sua partenza la gettò nel più cupo sconforto. Avrebbe accettato una chiamata alle armi, su quello non c’era santo che potesse intervenire, ma addirittura anticipare i tempi e andare volontario, questo non le andava giù. Contava molto su quel ragazzo: sveglio e intelligente, aveva sempre sopperito alle carenze di Arnaldo, che era un buon diavolo ma spesso assente e poco avveduto sui problemi pratici della famiglia. Cosimo era la sua forza, la sua sicurezza, un palo a cui aggrapparsi quando la vita sembrava divenire troppo complicata. Un altro membro della famiglia che si allontanava, un’altra spina nel suo cuore di madre. «Stai bene in divisa» gli disse la mattina della partenza, ponendo del cibo nel suo tascapane. E lo guardò allontanarsi, cercando di soffocare quel desiderio materno, istintivo e selvaggio, di proteggere la propria progenie dai pericoli e dalle insidie. Avrebbe voluto piangere, ma riuscì a trattenersi. Rodolfo trascorse tutta l’estate alla villa, con la scusa di dover controllare più da vicino i proventi del raccolto. Il conte Giovanni ne fu felice: la decisione del figlio lo esentava dal compito ingrato di esaminare i conti. Inoltre teneva compagnia alla madre, e lui poteva restarsene a Milano, dedito alla sua vita libertina. A differenza del fratello, Rodolfo aveva una natura mite e riflessiva. Adorava leggere ed era un sognatore. Non amava parlare di politica, detestava d’istinto il regime, ma non faceva nulla per osteggiare o combattere chi lo difendeva. Non era agnostico, la sua mente era attratta da altre cose e considerava l’occuparsi di politica una perdita di tempo in grado di sviarlo da ciò che gli interessava davvero. Per natura introverso, taciturno, a volte sfuggente, era consapevole di essere considerato uno sfaticato, viziato e borioso come il fratello Leonino, ma tutto ciò non corrispondeva alla realtà. Rodolfo, cagionevole di salute da piccolo, era cresciuto solo, affidato ai precettori, lontano dai coetanei, e questo aveva 51 fatto di lui un ragazzo emotivo, che riversava tutta la sua sensibilità nella poesia e nella musica. Alla contessa Adelaide non era di certo sfuggito l’interesse che il figlio e la piccola Matilde nutrivano l’uno per l’altra. Era felice di avere i due giovani accanto a sé durante le lunghe e pigre giornate di calura estiva, e cercò di ignorare la cosa, per non incrinare l’atmosfera di serenità che si respirava alla villa. Il tempo avrebbe sistemato le cose e se era destino che i due ragazzi dovessero intraprendere una relazione seria, lei non si sarebbe di certo opposta. E poi vedeva Rodolfo allegro come non lo era da tempo. Il pomeriggio, dopo la lettura, Adelaide invitava il figlio a suonare qualcosa al pianoforte, mentre Onorina serviva il tè con i biscotti. Il ragazzo suonava i suoi pezzi classici preferiti, i notturni di Chopin, le sonate di Beethoven, brani che bene si addicevano ai suoi stati d’animo tormentati, mentre Matilde lo guardava estasiata. «Adesso permettete a Matilde di prendere una boccata d’aria» diceva lui rivolgendosi alla madre, «altrimenti potrebbe stancarsi troppo e aver bisogno di un periodo di riposo. E in questo caso voi dovreste rinunciare alla sua compagnia.» «Hai ragione, figliolo. Sto bene con voi giovani e perdo la cognizioni del tempo. Accompagna tu la nostra Matilde a fare un giro nel parco, è una così bella giornata. Ma non più di un’ora, mi raccomando, che dobbiamo finire il capitolo di “Delitto e Castigo”, prima che se ne vada.» Era una corsa sfrenata quella dei due giovani attraverso i vialetti impervi del parco, tra grida e risate che anticipavano l’arrivo alla grotta in fondo al giardino, vicino alla scuderia, immersa nella frescura di una piccola cascata. Matilde si appoggiava al muro della parete più nascosta; Rodolfo la raggiungeva. Le scioglieva i capelli, le accarezzava il viso, la riempiva di baci. Non era mai stato innamorato in vita sua; l’amore, come lui lo intendeva, lo aveva mitizzato nei suoi componimenti poetici, nelle interpretazioni dei suoi brani musicali preferiti, considerandolo una sorta di subli52 mazione dell’essere, che nulla aveva a che vedere con l’approccio sessuale. Matilde rispondeva ai canoni di questa concezione platonica dell’amore. Lei, similmente, in quei frangenti si godeva la pienezza di una felicità improvvisa e inaspettata. Accanto a Rodolfo si sentiva al sicuro. Era facile per lei amarlo, ma non appena si allontanava dalla villa per tornarsene a casa, l’afferrava tutta l’insicurezza della sua condizione. Quanto sarebbe durato quello stato di grazia? Forse poche settimane, con l’arrivo dell’autunno e il ritorno di Rodolfo a Milano, dove il padre avrebbe di certo fatto sentire la sua voce autorevole su quella relazione impossibile. In parte andò davvero così. Agli inizi di ottobre Rodolfo fece rientro a casa con la madre; doveva riprendere gli studi e aiutare il padre nell’amministrazione delle proprietà. Si era già concesso troppo tempo libero, e poi era scoppiata la guerra in Europa, “guerra-lampo” la definivano gli opinionisti che difendevano il regime. Hitler aveva invaso la Polonia; Francia e Inghilterra erano in procinto di intervenire in difesa del paese aggredito. Per l’Italia, fosche previsioni si alternavano a entusiasmo e ottimismo su un futuro che tuttavia non poteva che apparire incerto. Il conte Giovanni, fascista convinto ma scettico su un eventuale conflitto, malgrado le giornate fossero ancora tiepide e soleggiate, pretese che la famiglia si trovasse riunita a Milano, per ogni evenienza e decisione che riguardasse un possibile allontanamento verso un posto più sicuro. Rodolfo tornava alla villa la domenica pomeriggio per stare con Matilde. Le nuove preoccupazioni avevano distolto l’attenzione delle rispettive famiglie su quel legame inopportuno e sbilanciato sotto il profilo sociale. Tutto passava in secondo piano rispetto ai problemi e agli sconvolgimenti nell’aria. E Matilde aveva ottenuto il permesso di incontrare Rodolfo la domenica pomeriggio, a patto che non rientrasse dopo le diciotto. Emilia non se l’era sentita di negare alla figlia questa possibilità, la vedeva innamorata, e impuntarsi sarebbe stato un invito a mentire. Arnaldo ignorò la cosa e lasciò fare alla moglie. Ma fu in 53 quel periodo che iniziò per Matilde quell’inquietudine profonda che l’avrebbe dilaniata, una guerra personale per lei ben più dura di quella che stava per iniziare. Lontano da Rodolfo, i fantasmi della gelosia iniziarono a carpire la sua mente con ossessione, portandola a dubbi e sospetti. Quando si incontravano, studiava a lungo la sua espressione, il suo comportamento, e vedeva in ogni più piccolo dettaglio un segno di allontanamento da parte del ragazzo, di disamore, di diminuito interesse nei suoi confronti. L’ansia la divorava, a scapito della sua innata dolcezza. Una domenica, a bordo della sua Balilla, il giovane conte arrivò più tardi dell’ora consueta. Aveva la barba lunga e l’aria stanca. «Scusa il ritardo. Ho fatto tardi ieri sera e questa mattina non riuscivo a svegliarmi.» «Dove sei stato?» «Sono rimasto a casa. C’è stata una festa per il compleanno di mio padre. C’era molta gente, personaggi politici anche, mio padre voleva sondare le intenzioni e gli umori sulla guerra… ho bevuto un po’ e…» Matilde si sentì esclusa dalla sua vita. Una scintilla di gelosia feroce divampò in un attimo e sbottò in una scenata che lasciò il ragazzo basito. Non era abituato a esternazioni così violente da parte sua, di solito tendente ad accettare il suo comportamento e le sue spiegazioni. A dargli fiducia. Ma un tarlo odioso rodeva ormai da tempo la mente della ragazza, convinta che a Milano Rodolfo avesse, accanto a una vita che lei non poteva condividere, ai suoi amici, ai suoi interessi, anche altre donne. E una morsa le serrava lo stomaco e i suoi sorrisi non erano più schietti e solari come un tempo. Il suo sguardo era offuscato da una nota di sfiducia profonda. «Che ti prende, Matilde? Stai cambiando, e non mi piace» disse una domenica sera Rodolfo, dopo un pomeriggio silenzioso e carico di tensione. «Se non ti conoscessi bene direi che sei gelosa. Se è questo che ti rode, non ne hai motivo. Lo sai che ti voglio bene.» 54 «E se anche lo fossi? Le cose sono cambiate, io ora sono esclusa dalla tua vita.» «Non sei esclusa, viviamo più lontani, tutto qui.» «Se tu mi volessi bene come dici, verresti alla villa più spesso, anche durante la settimana. In fondo cosa ti costerebbe? Invece ti vedo solo la domenica per qualche ora.» «Anche a me piacerebbe trascorrere più tempo con te, ma ho le frequenze all’università e gli impegni con mio padre. Sono molto occupato.» «Non è solo questo. Tu sei cambiato, a volte sei freddo, scostante, sembri assorto in altri pensieri. Se c’è un’altra donna, devi essere sincero. Io ti lascerò andare, senza fare scenate, te lo prometto. Questa incertezza non la sopporto.» «Non sono scontante e non c’è un’altra donna. Sono preoccupato. Non c’è scampo, presto l’Italia entrerà in guerra. Hitler conosce bene le condizioni del nostro esercito e ha concesso del tempo, lo chiamano “patto di non belligeranza”, ma durerà poco, credimi. La guerra-lampo potrebbe rivelarsi una catastrofe. Matilde, il mondo non ruota attorno a noi due. Voi qui, in campagna, siete fuori dalla mischia, non vi arrivano molte notizie e riuscite ancora a vivere con un po’ di distacco. Io non ci riesco. Non ti rendi conto che ci aspettano tempi durissimi?» Scosse il capo, poi riprese con aria sfiduciata: «Adesso è inutile parlare di queste cose. Dai, siediti vicino a me e fammi un sorriso.» Si pentiva, Matilde, dopo questi discorsi che stentava a comprendere, dei suoi capricci frivoli e privi di consistenza. Eppure non appena arrivava a casa, dopo la partenza di Rodolfo, al pensiero che un’altra settimana sarebbe trascorsa prima di poter stare di nuovo con lui, sentiva il cuore a pezzi e il suo unico desiderio era di estraniarsi per dare sfogo alla sua tristezza. Per Emilia, la sofferenza ormai palese della figlia minore costituiva una conferma ai timori che fin dall’inizio aveva nutrito su quel rapporto. La bella favola del principe che sposa la ragazza povera solo di rado andava a compimento 55 nella realtà. Aveva tentato più volte di parlarne con lei, per capire meglio, per poterla aiutare, ma era troppo chiusa nella sua angoscia. Una domenica di marzo, dopo una settimana di elucubrazioni sofferte, Matilde ebbe l’idea di cambiare strategia. Si vestì con cura, un tailleur grigio attillato prestatole da un’amica più grande sopra una sottoveste di seta guarnita di pizzi, comprata da Elena per il matrimonio e rimasta sepolta in un cassetto. Si passò il rossetto sulle labbra per la prima volta in vita sua e si acconciò i capelli in modo diverso. Dimostrava più anni di quelli che aveva. Rodolfo, sul momento, apprezzò quel cambiamento, ma dichiarò che la preferiva vestita in modo semplice e senza rossetto. Lei era bella così, non aveva bisogno di artifici per piacergli. La ragazza si adombrò, sicura tuttavia che il ragazzo avrebbe apprezzato la sorpresa che aveva in serbo per lui. I due giovani fecero come al solito un giro nel parco. Rodolfo parlava in modo concitato della situazione, ma Matilde non l’ascoltava; i suoi pensieri erano altrove. C’era un vento freddo e pungente. Entrarono nella villa, Rodolfo andò a prendere della legna, accese il fuoco nel camino e, nel bagliore delle fiamme, Matilde iniziò a togliersi i vestiti. Slacciò la giacca con gesti lenti, abbassò la gonna. Rimase in sottoveste, un sorriso ammiccante e grottesco a incorniciarle il volto, e lo sguardo carico di provocazione. Il suo corpo appariva spigoloso, il viso pallido e scarnito. C’era voluto tutto il suo coraggio per arrivare a questo, il coraggio della disperazione. «Cosa stai facendo?» l’apostrofò lui in malo modo, dopo il primo attimo di stupore. «Voglio fare l’amore con te. È questo che manca al nostro rapporto, ora ho capito. Così non dovrai più andare con altre donne. E io non sarò più gelosa. Ora saremo come marito e moglie e tutto sarà perfetto.» Rodolfo si portò le mani al viso in un gesto di sconforto. «Rivestiti subito, per cortesia.» «Non ti piaccio?» 56 «Non mi piace il tuo modo di fare. Quando voglio fare l’amore con una donna sono io a prendere l’iniziativa. E questo comportamento non ti appartiene, non è da te. Rivestiti, ti prego» ribadì lui con durezza. Ci fu un attimo di gelo e di disagio. Poi gli occhi di Matilde si riempirono di tutta l’umiliazione, la vergogna, il senso di frustrazione provati in quei brevissimi istanti. Ebbe un brivido, si abbassò e raccolse la gonna caduta ai suoi piedi. S’infilò la giacca e cominciò a piangere. Tutto era perduto: Rodolfo l’aveva rifiutata e questa era la prova tangibile che non l’amava più. E lei ora non aveva neppure il coraggio di guardarlo in faccia. «Matilde... tu mi piaci, mi piaci tantissimo, dovresti averlo capito ormai» disse lui più dolcemente, avvicinandosi e afferrandola per le braccia. «Non volevo offenderti, ma non hai bisogno di spogliarti per me. Il nostro rapporto è al disopra di tutto questo. Se anche avessi un’altra donna, non sarebbe la stessa cosa. Con te è diverso e ti voglio come sei, non voglio un’altra Matilde. Un giorno, se questa guerra ce lo permetterà, saremo insieme e allora fare l’amore sarà una cosa bella e naturale. Ma adesso no, tu sei molto giovane e il nostro legame è ancora privo di concretezza. Non è il momento e tu non sei pronta. Lo capisci questo?» Matilde non capiva. E le parole di Rodolfo erano solo una conferma ai suoi dubbi, ai suoi timori. Aveva parlato di un’altra donna, anche se in termini di supposizione; quindi la possibilità esisteva e questo la distruggeva. Sorseggiò adagio la tazza di tè che il ragazzo le aveva portato affinché si riscaldasse. Rimase accovacciata sul divano, in silenzio, mentre lui, per distrarla dalla sua mortificazione e al contempo sfogare i propri timori, aveva ripreso a parlare della complicata situazione europea, dell’aggravarsi della crisi in seguito all’aggressione della Finlandia da parte dell’URSS, conseguenza di un patto, segreto e scellerato, tra Hitler e Stalin, da sempre proverbiali nemici. Elogiò la coraggiosa resistenza dei finlandesi, che a differenza di altre popolazioni non si erano subito piegati. Di come la sua famiglia la 57 pensasse in proposito, dell’entusiasmo del fratello Leonino, pronto ad arruolarsi e, per contro, delle sue perplessità. Per Matilde erano argomenti astrusi, non li capiva, non suscitavano in lei alcun interesse e la voce di Rodolfo che, implacabile, insisteva a volerla rendere partecipe della situazione, altro non era che un fastidioso sottofondo alla sua angoscia. Si sentiva esausta e non vedeva l’ora di tornarsene a casa. Quella sera andò subito a letto, senza toccare cibo. Attese la domenica successiva in preda a un’ansia divorante, con il proposito di godersi la giornata e allontanare tutti i fantasmi. Ma la mattina, di buon’ora, Rodolfo le fece recapitare un biglietto: quel giorno non sarebbe venuto. Era trattenuto a Milano da impegni inderogabili. Si dispiaceva molto, ma non poteva essere altrimenti. Si sarebbero visti la domenica seguente e avrebbero recuperato il tempo perduto; anzi, se la giornata fosse stata bella, sarebbe arrivato il mattino e avrebbero pranzato insieme nel parco. Per Matilde fu un colpo durissimo. Era la prima volta che succedeva e malgrado le promesse contenute nel messaggio, attribuì il fatto al suo comportamento della settimana precedente. E poi, quei millantati impegni inderogabili, di domenica, erano di certo una bugia. Non le riuscì di starsene con le mani in mano e chiese l’aiuto della sorella. «Ho sentito che oggi te ne vai in centro con le tue amiche» le disse decisa. «Voglio venire con te.» «Non vado con le amiche» rispose Bianca sottovoce per non farsi sentire dalla madre. «Mi vedo con l’Ermanno e voglio essere sola con lui. Non puoi venire.» «E io mi devo incontrare con Rodolfo. Oggi non può venire alla villa e mi ha chiesto di raggiungerlo a casa sua. La mamma non deve sapere niente, mi devi aiutare. Partiamo insieme da casa, e una volta arrivate in centro ci dividiamo e ci troviamo per il ritorno.» Bianca ebbe un moto di stizza. «Tu sei matta. Se poi qualcosa va storto, la colpa è mia. No cara, già devo dire una bugia per me, due sono troppe. E poi è una responsabilità che non mi prendo.» 58 «Se non mi aiuti dico alla mamma che ti vedi con l’Ermanno e che l’altra sera eri con lui sul fienile della cascina dei Rosati. Ti ho visto mentre tornavi a casa, tutta spettinata, e ti ripulivi il vestito.» Bianca non riconosceva la sorella: determinata, ostile, lo sguardo carico di livore. «Se la mamma viene a sapere che ti sei incontrata col Visconti a Milano, a casa sua poi, magari da soli... uccide te e me che ti ho tenuto la corda» cercò di farla ragionare. «E sappiamo bene che in questa casa le bugie hanno le gambe molto corte.» «Prendere o lasciare, sorella. Andare a spifferare che tu e l’Ermanno siete amanti sarà questione di minuti.» Partirono da casa alle due del pomeriggio. Pioveva a dirotto e faceva freddo, malgrado fosse marzo inoltrato. Presero un tram sferragliante e raggiunsero il centro di Milano in un silenzio carico di tensione e di timori. Si separarono davanti al Broletto. «Alle cinque e mezza, qui, in questo punto, mi raccomando! Non farmi pentire di averti aiutata» esclamò Bianca, ancora arrabbiata. Matilde raggiunse il palazzo dove, all’ultimo piano, in un magnifico attico che occupava tutto il perimetro dello stabile di via Cusani, vivevano i Visconti di Morzone. Dal basso si potevano vedere le piante sempreverdi di cui era ornato il terrazzo con vista sul Castello Sforzesco. Si appostò in un angolo nascosto, non lontano dal portone d’ingresso. Non era sua intenzione salire a cercare Rodolfo, non ne avrebbe mai avuto il coraggio, ma voleva restare per vedere se entrava o usciva dal palazzo. In tal caso, se fosse stato solo, l’avrebbe chiamato, per potergli parlare, anche per un breve istante, scusarsi per il suo comportamento della settimana precedente, guardarlo negli occhi e capire se era ancora adirato con lei. Passarono due ore senza che nulla accadesse. L’umidità e il vendo freddo le penetravano le ossa, sentiva male alla gola e le sue gambe erano deboli. Fu tentata di allontanarsi, rifu59 giarsi in un bar e bere qualcosa di caldo in attesa di Bianca. Si sentiva debole, da molti giorni mangiava pochissimo e sempre controvoglia, pur di tenere buona la madre. Era ancora indecisa sul da farsi quando il portone si aprì. Uscirono alcuni ragazzi in gruppo, belli, eleganti. Il primo che riconobbe fu Leonino, parlava a voce alta e rideva alla battuta di un amico; dietro di lui c’era Beatrice, la bella cugina, figlia di un fratello del conte Giovanni. Matilde l’aveva vista due volte durante l’estate, in occasione di una sua visita alla villa. Era alta, elegantissima, in un impermeabile chiaro col collo di pelliccia, i biondi capelli raccolti in una treccia. Dietro di lei, Rodolfo le parlava in un orecchio, appoggiandole una mano sulla spalla. Tutti assieme si diressero verso il Duomo. Fin dalle domeniche in cui Beatrice era venuta alla villa, vestita da amazzone per una cavalcata nel parco, Matilde aveva provato nei suoi riguardi una forte gelosia. Aveva percepito l’affetto che Rodolfo nutriva per la cugina, la complicità che li legava. “Siamo cresciuti insieme”, aveva detto il giovane parlando di lei. “È l’unica persona della famiglia che apprezzo davvero e a cui sento di voler bene”. Ma a Matilde non era sfuggito neppure l’interesse che i conti nutrivano per la nipote e, dai discorsi della contessa, le era parso di comprendere che sarebbe stato loro desiderio darla in sposa a uno dei figli. Immersa nel periodo più felice della sua vita, Matilde aveva presto dimenticato quegli episodi. Adesso invece, dopo ciò che aveva visto, i timori che da tempo l’angustiavano acquistavano concretezza. Vagò come un automa nelle vie del centro, come se il tempo si fosse fermato. Non sentiva più freddo, le sue gambe si muovevano ormai per inerzia, non sapeva dove si trovasse. Coordinare i pensieri le risultava difficile. Percepiva solo la figura di Rodolfo, sorridente, dietro la cugina, la sua mano appoggiata sulla spalla, e subito dopo il suo sguardo ostile su di lei, svestita, la domenica precedente. Si sentì indegna e umiliata. Cosa si era aspettata da quell’uomo? Che l’amasse, che la sposasse? Folle era stata, e illusa, lei povera figlia di 60 contadini, senza un soldo e non certo bella come Beatrice. Giunta in piazza Mercanti, davanti alla Loggia degli Osii, soffocata dai pensieri negativi e priva di forze, si accasciò a terra. La pioggia le infradiciava i vestiti, ma le sue percezioni si dissolvevano piano, fino a non sentire più nulla. Venne trovata dopo alcune ore, dalle guardie che facevano la ronda serale nel centro di Milano. 61 Capitolo 5 Mia cara Elena, questa volta la mia lettera non ti porta buone notizie. Siamo tutti molto preoccupati per Matilde. È gravemente malata. Una forma virale ai polmoni, dicono i medici, faticosa da debellare a causa dello stato di grave debolezza in cui versa il suo fisico. Se in un paio di settimane non migliora, verrà condotta in un sanatorio e là dovrà rimanere a lungo. Oh, Elena mia, sapessi! È stata trovata priva di sensi nel centro di Milano, dalla ronda, mentre noi a casa rischiavamo di impazzire per la preoccupazione di non vederla arrivare e non sapevamo più a che santo votarci. Io sapevo che doveva incontrare Rodolfo Visconti, ma non era la verità. Lui non ne sapeva nulla e quella domenica era impegnato in una riunione familiare per decidere la divisione di alcune terre di loro proprietà. Quando ce l’hanno portata a casa era priva di sensi e bagnata fradicia. Pensavamo stesse per morire. Ora è molto debilitata a causa della febbre persistente e parla pochissimo. È per questo che non le abbiamo ancora chiesto spiegazioni sui motivi di quella bugia. Rodolfo è venuto a trovarla. La mamma si vergognava tantissimo a farlo entrare nella nostra casa, ma lui aveva occhi solo per Matilde ed era sconvolto. Non ti so dire come finirà questa storia. Ti terrò informata e penso che la tua Madre superiora, considerando la situazione, non si arrabbierà se ti invierò qualche lettera in più per darti notizie della tua sorellina. Ti abbraccio. Tua Bianca che sempre ti rimpiange. 62 Bianca aveva aspettato Matilde fino alle sei, quel pomeriggio. Poi, pensando che si fosse fatta accompagnare da Rodolfo, preoccupata per le conseguenze e piena di rabbia verso la sorella, era tornata a casa, convinta di trovarla lì. Ma Matilde non c’era e la verità venne fuori. Arnaldo l’aveva guardata con occhi di ghiaccio ed era stata la sola reazione. Emilia era andata su tutte le furie e incapace di starsene con le mani in mano, aveva mandato Giulio a cercarla. Pioveva a dirotto. Il ragazzo arrivò fino alla fermata del tram; incontrò degli amici e chiese loro se avessero visto la sorella. Nulla. Matilde arrivò a casa alle nove di sera, in braccio a un carabiniere, priva di sensi. Il resto fu un susseguirsi di mosse per soccorrerla. Il fatto che Rodolfo non fosse colpevole dell’accaduto emerse solo la domenica seguente, quando venne a cercare Matilde per il solito appuntamento domenicale. Ora tutti vivevano come sospesi, in attesa di vedere nella ragazza un miglioramento che ridesse un po’ di speranza alla famiglia. Emilia non l’abbandonava. Si inginocchiava a lato del suo letto e pregava con fervore la Madonna. Cercava di nutrirla con qualche cucchiaino di brodo o della frutta, le metteva delle pezze fresche sulla fronte, la toccava e la carezzava, come se in quel modo potesse infonderle un po’ della sua vitalità. Ma Matilde sembrava aver perso la voglia di vivere. Passavano i giorni. Bianca continuava il suo lavoro alla fabbrica del tabacco; non per molto, perché presto i tedeschi l’avrebbero requisita per organizzarvi un comando. Ermanno seguiva il lavoro del padre nel commercio di tessuti: di lì a qualche mese avrebbero chiuso i battenti per mancanza di lavoro. I due ragazzi avevano da tempo iniziato una relazione, all’insaputa delle rispettive famiglie – con la sola eccezione di Matilde. Si vedevano di nascosto, anche se Emilia, col suo naso lungo, aveva fiutato qualcosa. Ma se Bianca era piena 63 di entusiasmo e vedeva la possibilità di realizzare il suo sogno di sposare un uomo che rispondesse alle sue aspettative, e di cambiare la sua vita in meglio, per Ermanno quella relazione sembrava una sorta di laconico ripiego: chi meglio di Bianca, così simile alla sorella, poteva sopperire alla mancanza di Elena? C’erano momenti in cui questo meccanismo diveniva palese persino a Bianca stessa: le richieste di portare i capelli in un certo modo, il regalo di una particolare boccetta di profumo, la sua preferenza per certe camicie bianche... Tuttavia lei, più concreta e meno sensibile di Matilde, accantonava quel pensiero insidioso e accettava i comportamenti di Ermanno con serena rassegnazione. A Bianca importava restare al suo fianco e farsi sposare. Occorreva dare tempo al tempo e avere pazienza. Per questa e altre ragioni, alcune delle quali ben poco razionali, preferiva per il momento non accennare alcunché a Elena, nella fitta corrispondenza che oramai avevano intrapreso: Cara Bianca, che brutte notizie mi dai! Non volevo credere a quanto è successo a Matilde. Prego per lei ogni giorno, che il Signore la benedica e le faccia ritrovare la salute. Io sto bene, grazie a Dio e per mia fortuna, perché qui c’è tantissimo da fare e arrivo a sera esausta. Le cose si sono complicate. In questo territorio ci sono delle comunità ebraiche, con gente che ha sempre condotto una vita attiva dal punto di vista professionale e persino politico. In conseguenza delle leggi razziali, si sono visti abbandonati da amici, colleghi, datori di lavoro; molte fabbriche chiudono, alcuni stanno perdendo il posto e pensano di emigrare; non avendo un punto di riferimento cercano un rifugio per i loro figli, soprattutto i più piccini. Così ora non ci sono soltanto orfani, ma anche bambini ebrei, condotti al convento dai genitori costretti a lasciare l’Italia. E qualcuno pensa che in futuro le cose diventeranno ancora più difficili. Questi bambini, abituati a vivere in famiglia, fanno molta fatica ad 64 ambientarsi qui e soffrono per la mancanza dei genitori. A volte di notte li sento piangere, e vorrei tanto fare qualcosa per loro. Mi sento così impotente. . . ovunque volga lo sguardo vedo sofferenza e tribolazioni. E ora, le notizie su Matilde mi procurano altro dolore. Tienimi informata, ti prego. Tua, Elena. In aprile Matilde venne condotta in sanatorio. L’infezione polmonare non accennava a guarire. Qui veniva curata al meglio e trascorreva le sue giornate tra il letto e la poltrona. Emilia andava a trovarla a giorni alterni e si consolava all’idea che fosse in buone mani. Il tempo avrebbe sistemato ogni cosa, del resto i medici non erano pessimisti. Col tempo Matilde si era chiusa in un mondo suo, del quale solo lei possedeva la chiave. A nessuno era permesso entrare. Un mondo fatto di pezzi di vita vissuta prima che tutto accadesse. Tempi spensierati. E questo iniziò a bastarle. Persino Rodolfo, oggetto del suo grande e sofferto amore, sembrava divenuto un estraneo. Tra loro non ci fu mai un chiarimento sul malinteso di quella domenica. Eppure Beatrice era per lui null’altro che una cara cugina, e le pretese dei genitori che loro si sposassero, cosa ben vista soprattutto per motivi economici, erano sempre state eluse da entrambi con divertita determinazione. Ma questo Matilde non lo seppe mai. Era come se la sua mente avesse rimosso il ricordo doloroso di quella domenica e la malattia avesse preso il sopravvento sulla sua stessa esistenza. Il 10 giugno di quell’anno, dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini annunciava in un’atmosfera quasi delirante l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania, contro Francia e Gran Bretagna. Le piazze erano tappezzate di bandiere e gremite di gente; tanti italiani non vivevano quel momento col timore legato all’annuncio di un conflitto, ma in trepidante attesa, certi che la guerra sarebbe stata breve e 65 vittoriosa. In realtà aveva inizio uno dei capitoli più dolorosi della Storia. Solo chi aveva vissuto la Grande Guerra accolse la notizia con angoscia e paura. Dopo soli cinque giorni ci fu il primo bombardamento su Milano. Gli aerei decollavano da basi posizionate nell’Inghilterra meridionale, durante le ore notturne; attraversavano i cieli della Francia – già in mano ai tedeschi, varcavano le Alpi e piombavano sulla città attorno alla mezzanotte, per poi far ritorno alle loro basi. Venivano colpiti i punti strategici: le fabbriche, i depositi di munizioni, le linee ferroviarie. Prima del loro arrivo, il cielo si illuminava a giorno per brevi istanti: erano i bengala lanciati dagli aerei di ricognizione, che indicavano ai veivoli successivi gli obiettivi da colpire. Non furono molte le vittime, nei primi tempi. Le cose sarebbero peggiorate nei mesi a venire. Al suono dell’allarme antiaereo Arnaldo e la famiglia si rifugiavano, assieme ad altri inquilini, in un ampio scantinato posizionato sotto la corte, a cui si accedeva attraverso una botola e una scala a chiocciola pericolante. Il rifugio era stato liberato, per l’occorrenza, da tutto il ciarpame e dalle masserizie che conteneva di solito. Nessuno sapeva se quel luogo fosse proprio sicuro; in caso di bombardamento massiccio delle case schierate all’intorno, avrebbero fatto comunque la fine del sorcio, ma la zona non passava nulla di meglio. Portavano con sé i pochi soldi e i preziosi che avevano in casa, o le cose a cui tenevano di più. Era un fatto nuovo per loro, dovevano farci l’abitudine, e poiché all’avvio della guerra la sirena che indicava l’inizio dei bombardamenti era uguale a quella che ne indicava la fine, ci furono molti malintesi. La cosa avrebbe anche potuto suscitare qualche risata, se non ci fosse stato di mezzo il problema di salvare la pelle. Chi in casa Boschi creava maggiori difficoltà in quei momenti era il nonno, il quale, duro d’orecchi e con un ronfare che sovrastava gli altri rumori, non sentiva mai la prima sirena. «Regiù» implorava Emilia, svegliandolo e scansandogli le 66 coperte, «dobbiamo scendere al rifugio, svelto. Tra poco sganciano le bombe. Su coraggio, infilatevi giacca e ciabatte e datemi il braccio.» «Che bombe?» rispondeva infuriato. «Voialtri siete tutti scemi, io non ho sentito nessuna sirena. Un corno che mi muovo di qui. Vattene a dormire, che ne hai bisogno!» Un paio di volte era intervenuto Arnaldo e l’avevano portato giù al rifugio di peso, accolto dagli applausi dei vicini. Poi si stancarono di quella lotta estenuante e lo lasciarono dormire placido nella casa vuota. La seconda sirena, invece, per qualche strana ragione la sentiva benissimo. Solo che per lui quella era la prima, e quando gli altri tornavano in casa con animo rasserenato, pretendeva di scapicollarsi fino al rifugio. Il resto della notte lo passavano a spiegargli, ai limiti dello sfinimento, che il pericolo era passato e non era più il caso di abbandonare la casa. Quell’estate, dopo un anno di assenza, Caterina tornò a lavorare per Arnaldo. E poiché Giulio aiutava il padre nella terra, i due avevano occasione di incontrarsi spesso. Nacque un’amicizia che si trasformò presto in un sentimento più profondo. Caterina aveva un fisico prorompente, e questo le conferiva un’aria sensuale e trasgressiva. Ma sul suo viso si leggevano ingenuità e dolcezza, in contrasto con l’aggressività del suo corpo. Il trauma del parto non l’aveva cambiata. Giulio non aveva mai avuto una donna e non osava farsi avanti, si sentiva goffo, insicuro, malgrado più volte avesse notato lo sguardo di Caterina su di lui, quasi un invito a parlare. Non erano le dicerie su di lei a frenarlo, bensì il timore di non essere all’altezza di una donna che già conosceva il gioco della seduzione, e i relativi pericoli. Ma una sera, entrato al Leon D’Oro per un saluto agli zii, vide Caterina uscire dalla cucina, avvolta in un grembiule bianco. Due volte la settimana la ragazza, nei giorni in cui c’erano più avventori, arrotondava la sua paga servendo ai tavoli e lavando i piatti. Si guardarono e si salutarono. Lui aspettò che lei finisse il 67 suo turno di lavoro e uscirono insieme, a passeggiare nella serata calda e nel chiarore della luna piena. Le ore notturne trascorse nello scantinato, mentre da lontano tuonavano i bombardamenti, avvicinarono i due giovani. Fu lei a prenderlo per mano una sera e, dopo alcuni giorni, a posare le sue labbra su quelle del ragazzo, in modo lieve. Fu uno smarrimento colmo di languore per entrambi, da non potersi arrestare. E quella sera, nella tregua molle del loro desiderio, lei gli parlò della sua triste esperienza di due anni addietro. Non rivelò il nome del padre del bimbo che aveva perduto, era acqua passata e Giulio, ragazzo timido e un po’ introverso, cui non pareva vero di avere finalmente una ragazza da portare fuori la domenica e con cui programmarsi un futuro, non aveva bisogno di risposte. Emilia aveva accettato la cosa, anche se per Giulio avrebbe preferito una giovane senza alcuna esperienza. Una domenica mattina le due donne si incontrarono fuori dalla messa, per la prima volta. «Signora Emilia… volevo scambiare due parole con voi, se non vi disturbo» disse la ragazza arrossendo. «Come stai?» chiese l’altra con tono neutro. «Non ti abbiamo visto la scorsa estate.» Si era fatta bella, un po’ più in carne, lo sguardo limpido e sereno, i lunghi capelli sulle spalle. «Ho preferito starmene a casa. Sapete... dopo quella brutta esperienza. Ho aiutato mio padre nei campi, ma ora al paese la crisi si è aggravata e mi sono decisa a tornare, per guadagnare qualche soldo per la mia famiglia. Signora… io vi devo ringraziare; non l’ho fatto a suo tempo perché ero troppo arrabbiata e non mi andava di parlare con nessuno. Volevo dirvi che siete stata molto buona con me. Neppure mia madre mi ha mai trattato così.» «Eh, troppo dolore per una ragazza così giovane. E chi avrebbe dovuto pagare per questo, non ha pagato.» Caterina ignorò queste parole, e preferì cambiare argomento: «C’è un’altra cosa che vi voglio dire. Voi sapete che io mi 68 vedo con Giulio, stiamo spesso insieme e ci vogliamo bene, o almeno io gliene voglio tanto. Voi conoscete il mio passato, eppure non vi siete opposta; avete accettato la cosa, da quello che Giulio mi racconta, anche se forse per vostro figlio avreste preferito una ragazza diversa. Nessuna madre lo avrebbe fatto, ve lo dico io.» Emilia si strinse nelle spalle. «Non ti ho mai giudicato. So quanto sia dura la vita per voi ragazze sole, a lavorare lontano da casa. Ciò che mi preme è che tu ora sia sempre sincera con Giulio e non lo faccia soffrire.» Caterina, in un impeto di commozione, abbracciò Emilia. Lei rimase sorpresa e un po’ turbata, ma il gesto le piacque e ricambiò con qualche affettuoso colpetto sulla spalla. Poi si salutarono, entrambe convinte di essersi lasciate troppo andare. Rodolfo quell’estate partì per il fronte. Non si arruolò volontario, attese la chiamata, al contrario di Leonino, già partito per il Nord Africa da alcune settimane per raggiungere l’esercito italiano stanziato in Libia, dopo che il maresciallo Rodolfo Graziani aveva dato inizio alla “campagna nel deserto”. Rodolfo non era convinto della guerra. Fu il suo gruppo di amici a trasmettergli un po’ di entusiasmo, d’altra parte lo stato di inedia in cui Matilde era caduta, e la sensazione di non poter fare più nulla per lei, mitigarono il dolore della partenza. Doveva muoversi, darsi daffare se non voleva cadere lui stesso in quello stato di apatia che ben conosceva, perché già vissuto in passato, quando la sua emotività, la sensazione tangibile di vivere nell’incomprensione altrui, il sentirsi estraneo al mondo, lo avevano sprofondato in un lago di smarrimento. Matilde era perduta per sempre, lo sentiva in modo chiaro. La dolce fanciulla che aveva aperto un varco di speranza per una vita diversa da quella che la rigida e partigiana educazione familiare gli aveva prospettato, ormai non esisteva più. Anche se fosse guarita, le loro strade si sarebbero ine69 sorabilmente divise. Pianse Rodolfo, il giorno in cui per l’ultima volta soffermò lo sguardo su quel collo esile, sulle mani dalle dita affusolate, sul profilo rivolto a un orizzonte lontano e non ai suoi occhi, come invece avrebbe voluto. Era consapevole che, anche se la guerra lo avesse risparmiato, nulla sarebbe tornato come prima. Ermanno partì più tardi, col secondo scaglione, da volontario, destinazione Grecia. Lo annunciò una sera a Bianca, seduti sul muretto che delimitava la sua casa con il parco dei Visconti. Era una bella sera tiepida, il cielo era magma di fuoco. «Non aspetto neppure la chiamata, Bianca. Tanto prima o dopo arriverà. Ho deciso di arruolarmi, partirò tra una settimana o due al massimo.» «Perché tutta questa fretta?» Ermanno alzò le spalle. «La fabbrica di mio padre sta chiudendo, lo sai, non ci sono più ordinativi, ma non è solo questo. Non so cosa gli sia capitato, lui non ha più la testa per seguire gli affari. Grazie a Dio i miei genitori non hanno problemi economici e possono campare. Ma io? Non mi va di starmene con le mani in mano mentre il mondo è in fiamme. Almeno faccio qualcosa per il paese.» Bianca divenne di marmo. Una partenza volontaria non se l’aspettava proprio. «E io? Non hai pensato a me?» «Certo che ho pensato a te, che dici? Ma tu hai la tua famiglia. E poi… dicono che sarà una guerra brevissima. Vedrai, tornerò presto.» Ci fu un attimo di silenzio sospeso. Poi sbottò: «Sposami!» «Cosa?» «Sposami! Prima di partire. Mi faresti felice. Pensare a te come mio marito quando sarai lontano, sarà l’unica consolazione. Non dirmi di no, ti prego.» «Di questi tempi… ti sembra il momento di pensare al matrimonio?» 70 «Ti voglio bene e per me il momento è giusto. Che problema c’è? Ci frequentiamo da un po’ ormai. E poi… beh, io ti ho dato molto... tutto. Di me stessa, intendo.» Ermanno non seppe replicare. Mentre si rotolava sui fienili con Bianca non aveva mai pensato a questo, agli obblighi morali che ne sarebbero derivati. E troppi pensieri confusi vorticavano ora nella sua testa, troppo sfinimento causato dagli eventi degli ultimi due anni, inaspettati, quando tutto sembrava chiaro, all’insegna della felicità e del vivere sereno: la perdita di Elena, mai veramente accettata, la guerra, la chiusura della fabbrica, lo strano atteggiamento del padre. Bianca s’infilò svelta nelle sue incertezze. «E dai» disse sorridendogli. «Perché no? Noi due siamo fatti per stare insieme.» Ermanno non ci pensò più di tanto. Non stette neppure ad analizzare i suoi sentimenti, non c’era il tempo, tutto stava girando in senso contrario rispetto a quelle che erano state le sue aspettative. Si sposarono una mattina del mese di settembre, di buon’ora, con una cerimonia semplice, alla sola presenza di due testimoni, amici di Ermanno. Bianca indossò un soprabito blu appartenuto a Elena, si pettinò con cura e uscì senza farsi vedere dalla madre. Non era certo il matrimonio che aveva sognato, ma diventare la moglie di Ermanno prima che lui partisse per la guerra era per lei una questione urgente. In futuro le cose con i suoceri si sarebbero aggiustate e lei sarebbe entrata a far parte della famiglia Rovelli a pieno titolo. Misero al corrente le rispettive famiglie a nozze avvenute. I genitori di Ermanno, alla notizia, concentrati com’erano sugli ultimi avvenimenti politici e le difficoltà in cui versava la fabbrica, non fecero commenti e neppure ne fece Arnaldo, convinto ormai che i giovani stessero perdendo la ragione e che a nulla sarebbero valse le sue recriminazioni. Emilia ci rimase malissimo. Aveva vagheggiato per le sue figlie un matrimonio in pompa magna, quello che lei non aveva avuto. Chiese a Bianca se fosse incinta. Non lo era. E allora perché tanta fretta, e quelle cose fatte di nascosto? Bianca si limitò a rispondere che non voleva intro71 missioni in quella decisione. E ora si sentiva felice e appagata. I due sposi trascorsero le notti successive in una stanzetta sopra il Leon D’Oro, messa a disposizione dagli zii. La mattina, quando scendevano in trattoria, era pronta per loro una bella colazione che ancora non risentiva del razionamento dei viveri. Per Bianca furono ore felici e intense, per Ermanno non troppo diverse da quelle che avevano scandito gli ultimi due anni, trascorsi con la sensazione di non essere lui il vero artefice della propria esistenza, semmai un ignoto burattinaio che ne muoveva i fili; un uomo trascinato dagli eventi, privo della forza necessaria per riprendere il controllo della situazione. Partì in un giorno di pioggia. Stava bene in divisa e Bianca era fiera di lui... suo marito. Dalle finestre della corte, molte donne occhieggiavano da dietro le tende, facendo illazioni su quel matrimonio improvviso e sospetto. «Quando pensi di informare Elena?» chiese Emilia, mentre Ermanno saliva sul sidecar di un amico per raggiungere il distretto militare e agitava la mano per salutare. «Di che cosa? Del fatto che Ermanno parte per il fronte?» «Del matrimonio, no?» «Non so» rispose Bianca titubante. «Non ci ho ancora pensato.» «Eh già, tu non pensi mai! Tu fai sempre le cose a casaccio, pensi solo a te stessa.» «Cosa vuoi che importi a Elena se io ho sposato l’Ermanno? Lei ormai è suora e non c’entra più niente con queste cose!» Gli occhi di Emilia lanciavano fiamme. «Cosa c’entra se è suora? È tua sorella, no? Vorrai pure informarla del tuo matrimonio! Con l’Ermanno per di più. È una questione di chiarezza e onestà, mi pare.» In realtà Bianca ci aveva pensato eccome, prima di convolare a nozze, con non poco disagio e apprensione. Soprattutto da quando aveva saputo, attraverso una lettera che proprio Elena le avevo spedito in quei giorni, che la cerimonia per l’assunzione dei voti definitivi, fissata per il maggio di 72 quell’anno, era stata rinviata a data da stabilire per problemi legati alla guerra. Era possibile un ripensamento da parte di Elena, su Ermanno e sulla sua vocazione, se avesse saputo della loro intenzione di sposarsi? Ed Ermanno, dal canto suo, come avrebbe reagito a questa eventualità? Bianca non si faceva illusioni: sarebbe stato ben felice di tornare tra le sue braccia. Nel suo intimo, era consapevole che l’amore tra Elena ed Ermanno era un fuoco solo in apparenza spento; un alito di vento avrebbe potuto facilmente ravvivarlo. E anche dopo, a matrimonio avvenuto, l’assillava il timore per il modo in cui la sorella avrebbe reagito alla notizia; l’avrebbe tacciata di poca chiarezza e lealtà nei suoi confronti, certamente. Ermanno invece non si era posto il problema; gli bastava il sottile, maligno compiacimento che scaturiva dal senso di rivalsa. Dopotutto, lui si era consolato in fretta, e per di più con la sorella della sua ex fidanzata. Bianca scrisse presto a Elena. Le parlò delle lettere di Cosimo dall’Albania, del fidanzamento di Giulio con Caterina, della partenza di Ermanno per la Grecia. Parlò dei bombardamenti su Milano, dei problemi legati alla guerra. Ma non accennò al matrimonio. Si ripromise di farlo nella lettera successiva, cosa che non avvenne. E nemmeno nelle lettere seguenti. Anche Cosimo entrò a far parte del massiccio gruppo di militari, venti divisioni in tutto, spedito in Grecia per la campagna che le truppe del Regio Esercito italiano, partendo dalle basi albanesi, si accingevano a intraprendere, entrando in territorio ellenico a fine ottobre 1940. Fu una cosa che colse tutti di sorpresa: la Grecia! Una nazione amica, si diceva, oltretutto governata da un dittatore di sentimenti filofascisti. Se le donne della corte erano ben lontane dal chiedersi quali fossero le motivazioni di Mussolini per portare il conflitto in questo paese, limitandosi a scuotere il capo di fronte all’apertura di un terzo fronte nei Balcani, al Leon D’Oro sembravano avere tutti le idee molto chiare: 73 «Quel Mussolini è sempre l’ultimo a sapere delle conquiste di Hitler» disse Ercole una volta, sottovoce. «Adesso è lui che vuole coglierlo di sorpresa. Occuperà le isole dell’Egeo, vedrete, per dominare il Mediterraneo.» E le discussioni non finivano mai. Cosimo scrisse una lettera a casa, attraverso la posta militare: stava bene ed era contento del trasferimento ormai imminente, perché in Albania i combattimenti erano finiti e si trattava solo di organizzare le basi e di tenere a bada la popolazione e gli insorti. In Grecia invece c’erano altri territori da conquistare, per controbilanciare il peso assunto dalla Germania con le recenti vittorie e per rafforzare la presenza italiana nel Mediterraneo. A Cosimo non mancava l’entusiasmo; quella guerra assurda e sbilanciata sotto il profilo militare, i cui risvolti non avrebbero tardato a palesarsi, proprio in Grecia, non l’aveva ancora deluso. In realtà le isole c’entrarono ben poco, perché la guerra si svolse principalmente sulle montagne brulle e impervie dell’entroterra, in condizioni durissime per il clima freddo e le carenze degli equipaggiamenti. Cosimo, che a sentir parlare della Grecia si era immaginato pianure verdeggianti non lontane dal mare, si trovò ad arrancare per giorni nel fango sotto una pioggia a catinelle, privo di indumenti di lana e scarpe adatte. Si ferì a un polpaccio durante un’azione per la conquista della cittadina di Konitsa e visse l’inferno. Fu costretto a marciare con le stampelle, aiutato dai compagni. E poi la febbre causatagli dall’infezione, le notti in branda al freddo, sotto tende che facevano acqua da tutte le parti, viveri e medicinali insufficienti... I soldati italiani, disorientati dalla reazione spavalda e imprevedibile dei Greci, furono presto costretti ad arretrare sul confine albanese con disastrose ripercussioni sul morale delle truppe. Il tutto si svolse in pochi giorni. Gli strilloni del Corriere della Sera arrivavano fino alla Bovisa con le notizie della disfatta italiana in Grecia. A Emilia e a Bianca sembrò di impazzire. Sì recarono al distretto per avere notizie, ma era troppo presto, ancora non si conoscevano i nomi dei soldati rimasti sul campo. La ferita 74 alla gamba fu invece la salvezza di Cosimo: rimase a lungo in un ospedale da campo nelle retrovie, fino a nuova destinazione. Da lì, dopo poche settimane, riuscì a mandare un dispaccio a casa dicendo che, nonostante il problema alla gamba, ora stava abbastanza bene ed era curato. Ma il suo morale era a terra, aveva visto morire molti compagni, e stava cominciando a pensare che quella guerra fosse un errore madornale. E un nuovo, imprevisto sentimento, a lui di solito così spavaldo e restio alle mollezze, iniziava a straziargli il cuore: la nostalgia di casa. A Ermanno le cose andarono diversamente. Giunto in Grecia quando le operazione erano già state avviate, non fece in tempo a combattere e rimase nella retroguardia in attesa di nuovi ordini. Anche dal fronte africano, dove gli Inglesi avevano sferrato una violenta offensiva, le notizie erano pessime. Tutto ciò fece cambiare l’umore in modo radicale in coloro che la guerra l’avevano sempre sostenuta e il malcontento e le preoccupazioni per il futuro iniziarono a serpeggiare anche tra i civili. 75 Capitolo 6 Matilde, ancora ricoverata al sanatorio, si buscò una polmonite e fu la fine. Un pomeriggio Emilia andò a trovarla e la trovò febbricitante e debilitata. La suora del reparto l’avvisò che gravi complicazioni erano intervenute nel suo stato di salute già precario per l’infezione che da tempo minava i suoi polmoni. Difficilmente avrebbe superato il mese. Quel giorno la donna, svuotata e col cuore a pezzi, restò accanto alla figlia fino a sera, non si aspettava un responso così drastico o forse il suo cuore di madre l’aveva sempre rifiutato. Si decise ad allontanarsi solo quando un’inserviente l’avvisò che l’ospedale stava chiudendo i battenti. Perse il treno per Milano e trascorse la notte all’aperto, nel parco del sanatorio, coricata su una panchina. Erano tempi in cui la perdita di un figlio era molto frequente, anche in tenera età. Per molte malattie non c’erano le cure e la guerra, con la difficoltà di reperire i farmaci, stava peggiorando la situazione. Sembrava che una sorta di rassegnato fatalismo pervadesse l’animo delle persone di fronte a queste morti premature, ma Emilia era diversa per carattere, per cultura. Per Emilia l’ingiustizia di una giovane vita che se ne andava, dopo il dolore per partorirla, i sacrifici per crescerla, i sogni e le speranze perdute, era un pugno nello stomaco. Aveva lei stessa perso dei fratelli piccoli, e ogni volta si era stupita di fronte alla rassegnazione pacata dei genitori i quali, una volta sepolto il bimbo, se ne tornavano alle loro occupazioni come nulla fosse. Ma ora, seduta accanto alla figlia, mentre riandava ai ricordi legati alla vita di quella bimba vispa, alla sua adolescenza spensierata, alla giovinezza colma di speranze, comprendeva che l’atteggiamento dei genitori non era indiffe76 renza o eccesso di rassegnazione. Era pudore dei sentimenti. Mostrare il loro dolore lacerante era una debolezza indegna. La sofferenza, quella vera, andava vissuta nell’intimo, anche tra familiari. Matilde morì una notte tra la domenica e il lunedì. La famiglia l’aveva vista viva per l’ultima volta proprio di domenica, in visita al sanatorio, il viso privato di ogni reazione, solo il pallore che preludeva alla fine. Venne portata a casa, tutti versarono le lacrime consone al carattere di ciascuno. Arnaldo si chiuse in un silenzio ostinato per giorni. Si vedeva davanti, con ossessione, quella bimbetta che ogni sera gli correva incontro, appena varcava la soglia di casa: lui troppo stanco per prenderla in braccio e le sue mani troppo ruvide per carezzarla. Si limitava a sorriderle. Un giorno parve che i suoi occhi si dischiudessero sulla verità. Si riempirono di lacrime all’improvviso, guardando Emilia. E disse: «È dura da sopportare. Non sono sicuro di farcela.» Poche parole, che per Emilia valevano più di qualsiasi discorso. Gli fece una carezza sulla testa, contravvenendo alla legge non scritta che vietava attimi di debolezza e gesti affettuosi, specie in presenza di estranei. «E invece dobbiamo farcela, i nostri figli dipendono da noi» disse decisa. Ma anche lei, lacerata dal dolore, avrebbe voluto lasciarsi andare, non vedere nessuno, addormentarsi per non svegliarsi più. Al termine del funerale, presente tutto il rione, Emilia venne avvicinata da una donna velata di nero. Sulle prime non la riconobbe. Era la contessa Adelaide. «Non ci sono parole, Emilia cara» le disse afferrandole una mano. «Una ragazza così giovane, solare. È un’ingiustizia. Mancherà tanto, a tutti noi. Ho scritto subito a Rodolfo, speriamo che riceva la mia lettera, lui deve sapere. Non è giusto che nutra speranze inutili. Io le volevo davvero bene, come a una figlia.» «Grazie contessa.» Si limitò a questo, Emilia, incapace di proferire altre paro77 le. Non poteva buttarsi già alle spalle la convinzione che la storia con Rodolfo Visconti avesse giocato un ruolo nella morte della figlia. Troppa sofferenza aveva visto nei suoi occhi, troppe paure, anche se create da lei stessa, dall’insicurezza che nutriva su quel rapporto. Sul cassettone della camera da letto c’era una lettera scritta da Rodolfo, inviata dal fronte e arrivata troppo tardi. Forse un giorno l’avrebbe letta e avrebbe capito. Ma non ora. Fu il parroco ad avvisare Elena della morte della sorella, attraverso una telefonata, con parole gravi, seppur permeate dalla serena rassegnazione della fede. E a casa giunsero da lei poche righe: Cara mamma e carissimi tutti, la notizia mi è giunta da don Alfonso. Non ho parole per esprimere il mio dolore. Non c’è consolazione a questa tragedia, né per voi né per me. Posso solo pregare che il buon Dio accolga la mia sorellina e che a noi dia il conforto nel saperla serena in Paradiso. Sono troppo angosciata per scrivere, perdonatemi. Vi abbraccio tutti e vi voglio bene. Vostra Elena. A distanza di due mesi morì nonno Cesare, il regiù, per una banale caduta. Si ruppe qualche osso, si mise a letto e non si alzò più. Lo trovarono morto una mattina, nel suo letto, meravigliati che alle otto non avesse ancora reclamato la sua colazione con l’usuale tono perentorio. Tutti erano ancora frastornati dalla morte di Matilde e quella del nonno passò attraverso una serena rassegnazione. A Emilia nacque qualche senso di colpa per l’insofferenza spesso provata di fronte alla prepotenza del suocero, pretenzioso e un po’ tiranno, fino ad arrivare a chiedersi, data la veneranda età, perché mai il Signore non lo chiamasse a sé e li lasciasse vivere in pace. Ora che era stata esaudita, quasi rimpiangeva quella presenza solida e concreta, quel pilastro che reggeva la famiglia e le conferiva un senso, testimone di un passato che 78 si andava perdendo giorno dopo giorno. Molte cose erano cambiate nella loro vita in seguito alla guerra. Quel desco quotidiano a cui ognuno di loro sedeva, uno accanto all’altro e alla stessa ora, nella buona e nella cattiva sorte, col sole e con la pioggia, d’estate e d’inverno, emblema di quella forza vitale e incrollabile che univa la famiglia, non esisteva più. Ognuno sembrava vivere nella sua individualità, nello sforzo di far fronte alle difficoltà, alle paure, ai dolori. Le derrate ortofrutticole prodotte da Arnaldo con la coltivazione delle terre dei Visconti venivano ora requisite, poiché era lo Stato che ne organizzava la distribuzione secondo la necessità dei comuni. Tutto avveniva tramite il razionamento, che fu graduale. Già nell’ottobre del ’40 era entrata in vigore la limitazione del pane; la carne e altri generi quasi sparirono dal mercato. Emilia trasecolò quando si trovò nelle mani una tessera gialla chiamata “Carta annonaria individuale”. Benché Arnaldo trovasse sempre il modo di recuperare qualcosa dalla terra o tramite il fratello che gestiva la trattoria, le loro cene divennero più scarne e frugali di quanto già non lo fossero. Seduti a tavola, si controllavano il pane a vicenda, nella speranza che a qualcuno ne avanzasse un pezzo. Emilia si sacrificava per il marito e per Giulio, che dovevano essere in forza per lavorare, e per Bianca, che era giovane e doveva nutrirsi. Spesso fingeva una mancanza di appetito per cedere agli altri la sua razione. E poi c’erano i bombardamenti, a interrompere i loro sonni. Ogni notte, il Bomber Command inglese sganciava le sue bombe su Milano, soprattutto sulle realtà produttive, ed era angosciante udire in lontananza il susseguirsi delle esplosioni e il rumoreggiare della contraerea. Tra i velivoli più temuti c’era Pippo, un misterioso caccia che, volando basso per evitare la contraerea, andava a colpire bersagli alla cieca. Qualcuno ventilava che fosse in realtà un aereo dell’Asse, inviato per gettare discredito sugli Alleati. Ma questa era solo una leggenda. Era una vita instabile, fatta di alti e bassi, di paura per quanto poteva succedere e sollievo per averla un’altra volta 79 scampata, ma soprattutto di tanta trepidazione per la sorte di chi era al fronte. Nel frattempo si profilava l’estensione della guerra verso la Russia. L’inizio di quella sciagurata campagna non coincise per gli italiani con l’invasione da parte di Hitler dei territori sovietici, il che alimentò le discussioni del Leon D’Oro. C’era di mezzo l’eterno nemico dell’occidente per eccellenza, due ideologie contrapposte, e le cose si facevano complicate. C’era chi, solo a sentire nominare l’URSS, veniva invaso dalla paura, e chi invece vedeva in questa guerra un’occasione per avvicinarsi a quel paese misterioso, che prospettava uno stile di vita diverso. «Sapete cos’ha detto Churchill» domandò una sera Ercole durante una discussione. «Se Hitler fa guerra all’inferno, noi ci alleiamo col diavolo . Avete capito? E chi se lo immaginava che gli inglesi si sarebbero schierati con la Russia?» «L’è la fin del mund!» esclamò un avventore del locale. «Una guerra tra giganti e noialtri in mezzo. Io l’ho vista bene la Guerra del 15-18, ci ho anche rimesso un piede, porco mondo, per il congelamento in trincea! E speravo proprio di non vederne più.» «E quel cretino di Mussolini che va a offrire aiuti alla Germania!» aggiunse Ercole abbassando la voce più che poteva. «La Russia dispone di un’attrezzatura che noi neanche ce la sogniamo. E quelli mica scherzano. Se i nostri soldati dovranno andare a combattere lì, sarà una catastrofe, ve lo dico io.» «Cosa ti scaldi, Ercolino? Tanto Hitler gli aiuti li ha rifiutati» obiettò uno strampalato professore di lettere in pensione. «Nei libri di storia, un giorno, si parlerà solo dell’annessione della Russia alla Germania. È ciò che vuole. L’Italia sarà fuori, come al solito.» «Annessione della Russia alla Germania? Uè prufesur, ven giò da la pianta. Non ci credo mica tanto a ’sta cosa. E scommettiamo che Hitler ci ripensa? Tempo qualche mese e qualche legnata alla Wehrmacht e l’Italia dovrà mandare le truppe in aiuto… vedrete se non andrà così.» Ercole aveva visto giusto. Già nell’estate, di fronte alla 80 sorpresa dell’atteggiamento aggressivo e indomabile dell’URSS, Hitler capitolò e in Italia si formò il CSIR, Corpo di spedizione italiana in Russia, formato da tre divisioni. Ermanno, di stanza in Albania, venne arruolato nella divisione Pasubio. Bianca fu informata con un telegramma e iniziarono i suoi patemi, all’idea che il marito combattesse in un paese così lontano. Verso la fine di settembre le fu recapitata una sua lettera, che non la rincuorò affatto: Mia cara Bianca, finalmente riesco a scriverti, poche righe perché il tempo a disposizione è poco. Io sto bene, ringraziando il Signore, ma le notizie in generale non sono buone. Il viaggio è stato terribile: più di 2000 chilometri, fino alla Romania, per raggiungere le postazioni italiane. E poi, una volta riunite le divisioni, il percorso per arrivare alle trincee, sotto una pioggia battente e su strade fangose. Un incubo. Il cattivo tempo ha rallentato le operazioni, alcune settimane fa siamo finalmente riusciti a prendere contatto con i Russi e sferrare i primi attacchi, peraltro con discreto successo. Ma la cosa che più mi preoccupa, Bianca cara, è la situazione pazzesca degli armamenti, scarsi e male equipaggiati, pochi automezzi a disposizione, il carburante e i rifornimenti limitati. E pensa che siamo solo all’inizio e tra non molto l’inverno sarà alle porte. E qui dicono che l’inverno non scherza. Molti soldati richiedono ai parenti in Italia l’invio di materiale. Se potete mandate qualche maglia di lana e magari qualcosa da mangiare, roba secca che non si guasta subito. E voi come state? Continuano i bombardamenti di notte? Comincio a pensare che da questa guerra non sarà tanto facile venirne fuori. Tu comunque sii serena, mi manchi. Ti scriverò appena possibile. Un bacio. Tuo Ermanno . Durante i mesi invernali Ermanno scrisse con relativa regolarità. C’erano degli avanzamenti e delle conquiste da parte dell’Asse, ma tutto avveniva in condizioni di grande 81 difficoltà. Alla fine il CSIR, dopo un inverno difficile, si ritrovò sfiancato e nel giugno del 1942 venne sostituito dall’ARMIR, più consistente ed efficace. Molti soldati tornarono in Italia. Ermanno, che sognava il rimpatrio, non fu tra loro. Era in buone condizioni fisiche e poteva continuare a combattere. Fu una grossa delusione per lui, già stanco di quella guerra, e per Bianca, che in un suo ritorno ci aveva sperato. Riuscì a mandare notizie a casa fino a che non iniziò quella sciagurata marcia dell’Asse attraverso la Russia che portò al blocco di Stalingrado, dove la guerra fu combattuta per mesi con indescrivibili perdite e sofferenze. Ermanno rimase ferito a una gamba, ma parve riprendersi; le conseguenze di quella ferita, in apparenza banale, si sarebbero manifestate più tardi, durante la ritirata. Nella primavera del 1942 arrivò una lettera di Cosimo da Cefalonia. Le sue truppe, lasciata l’Albania, avevano raggiunto la Divisione Acqui per porre un presidio nella maggiore isola greca dello Ionio. Solo il massiccio intervento della Germania nel ’41 aveva capovolto le sorti della battaglia e la bandiera con la croce uncinata sventolava sul Partenone. La nazione fu quindi sottoposta a occupazione e spartizione dei territori. Agli Italiani venne assegnato il controllo delle isole Ionie, tra cui appunto Cefalonia. Cosimo descriveva la bellezza del luogo, le montagne brulle che circondavano le insenature, il mare dai toni viola e turchese, i tramonti di fuoco, le vallate verdeggianti di pini e betulle, visibili all’interno dalle strade sterrate. Non aveva mai visto nulla di più bello. Raccontava anche della cordialità della gente verso i conquistatori italiani. Si lamentava tuttavia per l’inattività a cui era costretto. Assegnato al controllo e allo smistamento di un deposito di armi, avrebbe preferito combattere, tuttavia fu proprio su quell’isola che Cosimo visse uno dei periodi migliori della sua vita, grazie all’incontro con Akylina, una giovane ragazza greca figlia di pescatori. Arrivò un giorno al comando, scalza e vestita di un abito di cotonina leggera a fiori. Alternando parole in greco e in italiano, raccontò trafelata come, due giorni prima, di notte, 82 qualcuno avesse rubato la barca di suo padre. E ora l’uomo non poteva andare a pescare e la famiglia non sapeva di che vivere. Sembrava disperata. I soldati si guardarono l’un l’altro con aria interrogativa, chiedendosi cosa mai potessero fare per risolvere quel problema. A qualcuno venne da ridere, ma la ragazza era graziosa, portava capelli lunghissimi, neri, fino alla vita, aveva un fisico asciutto e abbronzato e due occhi pieni di luce. Lasciarla andare via senza darle una speranza, era parso a tutti una crudeltà, e fu proprio Cosimo ad alzarsi dalla scrivania, avvicinarsi e rassicurarla che avrebbero fatto il possibile per ritrovare la barca. I loro sguardi si incrociarono e Akylina gli sorrise. Si fece spiegare dove abitava e le promise che a breve l’avrebbe aggiornata sulle loro ricerche. Alcuni soldati scandagliarono le coste della zona di Cefalonia da loro presidiata e, dopo alcune perlustrazioni, venne avvistata in una piccola baia una barca che corrispondeva alle descrizioni di Akylina. E scoprirono la verità: un balordo, che viveva di espedienti sull’isola, l’aveva presa per andarsene a pescare, e l’aveva poi lasciata su quella spiaggia nascosta e accessibile da terra attraverso un sentiero impervio, pensando di poterla tenere a disposizione. Fu così che Cosimo si recò dalla ragazza. Viveva in una piccola casa bianca in collina, circondata da un orto e da un frutteto. I genitori accolsero il militare con rispetto, lo fecero accomodare e gli offrirono fichi freschi appena colti e una bevanda a base di Ouzo. Il padre non smetteva di ringraziarlo per aver ritrovato la sua barca, Akylina lo guardava silenziosa e riconoscente. Lo invitarono a tornare. I greci erano cordiali con gli italiani e intrattenevano spesso rapporti di amicizia con loro. Gli italiani, d’altro canto, presso queste famiglie semplici e generose finivano per sentirsi come a casa. E tra i due ragazzi nacque un amore vero, il primo per entrambi, di certo un sentimento nuovo per Cosimo, abituato a confondere l’amore con le sensazioni che gli suscitavano le ragazze belle e compiacenti del bordello di via Fiori Chiari, a Milano. Fu un amore di passione e tenerezza, seppur permeato di tutta l’incertezza della situazione che 83 stavano vivendo, nemici ma innamorati, in guerra ma pieni di speranza. Akylina era una ragazza semplice e ingenua, non si aspettava nulla di più dalla vita di quanto già avesse, amava Cosimo d’istinto, senza timori per il futuro e vivendo il presente con gioia. E Cosimo amò di lei proprio la sua genuinità, quel sentirla sua al di là di ogni considerazione che non fosse dettata dall’affetto. Intanto a Milano le cose volgevano al peggio. Una mattina d’estate, Arnaldo stava lavorando nella sua terra quando un amico, proprietario di un appezzamento di terreno nella vicina Dergano, lo raggiunse. Gli raccontò che il suo garzone si era ammalato e aveva bisogno di un aiuto per la consegna delle ceste di ortaggi al verzé entro mezzogiorno. Arnaldo non ci pensò su due volte. A un amico non si nega un piacere, anche se di lavoro ne aveva parecchio: Giulio era ancora al mercato e di garzoni aiutanti non se ne trovava uno, erano tutti partiti per la guerra. Si mise in sella alla sua bicicletta e con l’amico raggiunsero il campo. Avevano appena iniziato a caricare le ceste, borbottando tra loro sui tempi difficili, quando un fragoroso boato li colse di soprassalto e una nuvola di fumo nero apparve in lontananza, proprio sopra il terreno di Arnaldo. “Le bombe, le bombe!” si sentiva gridare in lontananza. I due si avviarono correndo verso la Bovisa. Mano a mano che si avvicinavano, la confusione cresceva. Seppero da un ragazzo, fermo con la sua bici a osservare la scena sul ciglio della strada principale, gli occhi lacrimanti e un fazzoletto sulla bocca, che due bombe erano cadute in prossimità del terreno di Arnaldo. Era difficile a dirsi, non si vedeva nulla, si udiva solo il vociare della gente, le urla delle donne; il fumo nero e spesso penetrava negli occhi e nella gola. Emilia corse fuori, sapeva bene che a quell’ora Arnaldo doveva essere al campo. Urlò il suo nome, più volte, ma nessuno la sentiva e la nebbia densa le impediva di capire bene cosa fosse accaduto. Le prese il panico, inciampò nel gradino di un marciapiede e cadde. Venne soccorsa da una vicina. 84 «Coraggio Emilia, forse Arnaldo non era al campo, l’ho visto io una mezz’ora fa allontanarsi in bici» la rassicurò. «Signur, guarda giò una bona volta…» aggiunse rivolgendo gli occhi al cielo. Iniziarono a gridare assieme il nome dell’uomo. Nel parapiglia generale, Arnaldo udì la voce di Emilia, ma non riusciva a vederla. La chiamò a sua volta, con voce strozzata. «Emilia, sono qui… sono qui… sono vivo.» Ci volle del tempo perché il fumo cominciasse a diradarsi. Poi il sole riapparve, velato dal pulviscolo. Arnaldo ed Emilia si ritrovarono così, immobili, apparendo l’uno all’altra man mano che la luce rischiarava lo spazio intorno a loro. Si abbracciarono senza aggiungere una parola, Emilia ridendo nel pianto, entrambi felici di essere al mondo. Infine videro lo scempio del loro terreno: una voragine spaventosa l’aveva ridotto a un cratere fumante, la terra era sprofondata assieme ai detriti dell’esplosione. Rimasero a guardare annichiliti, increduli, circondati dai vicini e dagli abitanti del rione che tentavano, per quanto erano riusciti a vedere, di raccontare il fatto, descrivendone i particolari, il boato tremendo, la paura, la sensazione di morte. Seguì la ricerca spasmodica di vittime che, ringraziando il cielo, non ce ne furono. Solo qualche piccola ferita o contusione provocata dalla caduta di calcinacci, in seguito allo spostamento d’aria. Suonavano le campane quando, uno alla volta, tutti iniziarono a dileguarsi. Un temporale roboante, sul far della sera, condusse le polveri e i detriti ancora fluttuanti nell’aria a depositarsi sul terreno sventrato e sui tetti delle case. 85 Capitolo 7 Un sabato mattina, dopo mesi di disperazione durante i quali Arnaldo aveva inutilmente tentato di trovarsi un lavoro per sbarcare il lunario, Emilia si armò di coraggio: con indosso il vestito della domenica, prese il treno e si recò a Caronno, nel varesotto, dove la contessa Adelaide e la sua famiglia erano sfollati. Non era certo avvezza ai viaggi, ma il bisogno estremo dà la forza per affrontare qualunque difficoltà. Fu una sua decisione quella di chiedere aiuto alla contessa; Arnaldo non era d’accordo, troppo orgoglioso per andare a chinarsi davanti ai padroni e convinto che il viaggio della moglie non avrebbe sortito alcun effetto. La contessa dimorava in una cascina ristrutturata, molto ampia, con un giardino incolto sul davanti e l’aia sul retro. Al suono del campanello apparve la vecchia Onorina, conosciuta in tempi migliori. «Non so se la contessa se la sente» disse rivolgendosi a Emilia con sguardo compassionevole. «Sapete, dopo quello che è successo…» Emilia pensò che la donna alludesse alle bombe cadute nel terreno di proprietà del Visconti e, trovando eccessivo il suo scrupolo per una cosa che di certo non cambiava la vita di quei sciuri, insistette per incontrarla. La vecchia contessa apparve sulla soglia dell’ingresso, vestita di nero, sul viso un pallore cadaverico. Già magra in passato, sembrava divenuta l’ombra di se stessa, gli occhi impastati di pianto. «Emilia cara, è un piacere vedervi» proferì afferrandole le mani. «Siete buona a venire fin qui per condividere con me questo dolore atroce. Ma voi, voi sapete cosa vuol dire perdere un figlio, dopo la fine della povera Matilde che ancora 86 porto nel cuore.» E scoppiò a piangere, portandosi un fazzoletto alla bocca. Emilia rimase paralizzata. Dunque alla contessa era morto un figlio, in guerra di certo, ma quale dei due? Rodolfo o Leonino? E ora come faceva a spiegarle che non ne sapeva nulla e che era venuta per altre ragioni? Prese la cosa alla larga: «Non voglio stancarvi, contessa Adelaide, vi vedo molto provata, ma se parlarne con me vi fa stare meglio...» Si accomodarono in salotto e Onorina servì un tè bollente. Ne avevano bisogno entrambe. Poi la contessa iniziò il suo resoconto: «Quando morì la vostra Matilde, ricorderete che Rodolfo era già partito per la campagna di Grecia. Con le amicizie di mio marito, voi mi capite, avrebbe potuto starsene a casa, magari rispolverando un vecchio problema alla gamba destra di quando era piccolo, e non aveva camminato per mesi. Ma fu irremovibile, volle partire a tutti i costi. Ricevetti alcune lettere dal fronte, poi più niente. Pregavo ogni giorno tutti i santi in paradiso che vegliassero su quel figliolo che è sempre stato la mia consolazione. Ma poche settimane fa… un carabiniere… un documento… la notizia terribile. Oh, Emilia, non ce la faccio!» «Coraggio contessa, coraggio, non lasciatevi andare così. La famiglia adesso ha bisogno di voi. Stiamo tutti vivendo momenti tremendi, ma non dobbiamo perderci d’animo. Ditemi, che ne è dell’altro vostro figliolo, il conte Leonino?» Adelaide si soffiò il naso e assunse un’espressione sconsolata. «Lui ha combattuto in nord Africa per un tempo brevissimo. Era partito volontario. Sapete, lui è di sua natura una testa calda, credeva nel regime, ci crede tutt’ora e quella guerra di espansione la vedeva come una cosa grandiosa. Ma venne rimandato a casa presto, col sospetto di aver contratto la malaria. Invece era solo un’influenza. Questa è stata la sua fortuna perché anche là, avete sentito? Massacri su massacri da parte degli inglesi. Ora Leonino è qui in Italia, in un co87 mando del regio esercito, ma pensiamo che lo manderanno presto da qualche parte. Mio marito invece è a Milano, non vuole mollare gli affari e con tutti quei bombardamenti sono in ansia anche per lui. Che brutta vita è mai questa, cara Emilia, sentirci impotenti per i nostri cari. E che guerra orribile stiamo vivendo. L’avreste mai immaginata una cosa simile, il giorno in cui veniste assieme a Matilde?» Ricominciò a piangere sommessamente, ed Emilia le si sedette accanto, circondandole le spalle in un gesto di consolazione. Anche se di estrazione sociale diversa, erano due mamme, accomunate dalla pena più grande. Poi Emilia affermò a malincuore di doversi congedare. Adelaide l’abbracciò. Era già sulla porta quando la contessa la trattenne, afferrandola per un braccio. «Non ho neanche chiesto della vostra famiglia, perdonatemi, ma non ci sto più con la testa. Ditemi: come state? Come ve la cavate senza il terreno?» A Emilia batté forte il cuore. «Di salute stiamo bene, grazie a Dio, ma per il resto… Arnaldo non ha ancora trovato un lavoro e la nostra vita è difficile, non lo nego; sopravviviamo coi pochi risparmi e col poco che mio cognato Ercole riesce a passarci quando va a comprare le derrate per la trattoria. Ma è ben poca cosa, credetemi.» «Ma cosa aspettavate a dirmelo, benedetta donna! E io che ho parlato tutto il tempo dei miei problemi.» Sembrò raccogliere le idee in silenzio, poi disse: «Stasera stessa parlerò con Giovanni e una soluzione la troveremo, ve lo prometto. Se non ricordo male la nostra famiglia ha un terreno non lontano dalla Bovisa, in zona Niguarda. Si potrebbe affittarvi quello… ma ribadisco, devo sentire mio marito, e farò il possibile per convincerlo, anche se in questo momento lui non prende iniziative di alcun genere. Certo non sarebbe vicino a casa, il vostro Arnaldo dovrebbe alzarsi più presto la mattina, tuttavia…» «Ma cosa volete che sia, contessa, alzarsi prima al mattino! Di questi tempi, i sacrifici ormai non si contano più.» 88 «Beh, intanto aspettate un momento, non andatevene» concluse Adelaide animandosi e lasciando la stanza in tutta fretta. Tornò dopo poco con una vecchia sporta della spesa, nella quale aveva riposto del pane come Emilia non ne vedeva da tempo, un pezzo di formaggio stagionato e un salame. «Non posso accettare, contessa. Non potete privarvi voi per…» Adelaide la zittì: «Non fate storie e andate. È il minimo, dopo tutto quello che la vostra famiglia ha fatto per noi. Ma attenzione che non vi rubino la sporta, oggi come oggi c’è da aspettarsi di tutto.» Le perorazioni della contessa Adelaide andarono a buon fine e Arnaldo ottenne in affitto il terreno promesso, con l’agevolazione che solo dopo il primo raccolto avrebbe pagato la pigione al Visconti. Lavorò sodo, da mattina a sera, spaccandosi le braccia col solo aiuto di Giulio e Caterina, per riuscire a dissodare il terreno – rimasto a lungo incolto – prima dell’inverno, e prepararlo così alla semina. Quella terra arida e scura avrebbe dato i suoi frutti, ne era certo. Ma l’inverno fu comunque durissimo per la famiglia, ancora senza proventi del raccolto, e con la penuria della maggior parte dei generi necessari alla sopravvivenza. Fu durante quell’inverno, in prossimità del Natale, che morì Osvaldo Rovelli, il padre di Ermanno. Non fu ben chiaro di quale male soffrisse, ma il suo aspetto aveva perso tutta la baldanza di un tempo, lo si vedeva poco in giro; lasciava la casa per raggiungere la fabbrica, suo rifugio per l’intera giornata, infagottato in un vecchio pastrano e incurvato su se stesso, e dimostrava molti più anni di quelli che aveva. Il suo viso sembrava minato dall’angoscia. Da tempo la fabbrica versava in cattive acque. Il lavoro era pesantemente diminuito, i tessuti preziosi e i tendaggi che per lungo tempo avevano arredato le sontuose dimore di gerarchi e illustri personaggi politici, a fronte di una dedizione assoluta al regime, dall’inizio della guerra non erano più richiesti e lui, senza più il lavoro che lo teneva occupato almeno per qual89 che ora al giorno, era sprofondato in uno stato di apatia profonda; cominciò a nutrirsi in modo disordinato e ad alzare troppo il gomito per il suo fegato già da tempo compromesso. La moglie era sfollata in Valtellina presso una sorella, fin dai primi bombardamenti su Milano. Il corpo del Rovelli venne trovato in fabbrica dal portalettere: seduto alla scrivania, gli occhi sbarrati in un’espressione trafelata. Per la morte del marito, Clotilde Rovelli non versò una lacrima; mantenne sul volto l’usuale espressione scorbutica e altezzosa, solo parzialmente coperta dal velo nero, ma gli organizzò un funerale coi fiocchi, all’altezza del prestigio familiare di cui avevano sempre goduto: le bambine vestite di bianco con la candela in mano sul davanti, impegnate nei canti alla Vergine, i ragazzini che reggevano le corone floreali, seguiti dalle donne, e per finire gli uomini. Poi chiuse casa in modo definitivo e la bella villa dei Rovelli, attorniata dal rigoglioso giardino e finemente decorata sulla facciata, si trasformò presto in un rudere dall’aspetto sinistro, divorato da una vegetazione che allungava i suoi tentacoli fino al tetto e al cancello. 90 continua... Il nostro progetto La Factory editoriale I Sognatori (avviata formalmente nella tarda primavera del 201 3) costituisce un modello evoluto di casa editrice, fondato sul concetto di cooperazione e aiuto reciproco. Se in una casa editrice tradizionale l’editore svolge il suo lavoro col solo supporto di una redazione interna e ogni scrittore pensa a sé – spesso senza conoscere gli altri autori e relativi libri, nella Factory l’editore e gli scrittori sfumano i ruoli e collaborano tra loro in perfetta sinergia. Pur nel rispetto delle competenze specifiche (l’editore si assume ogni obbligo di natura economica, per esempio) e dell’individualità, il singolo si impegna per il gruppo ed è a sua volta consapevole di ricevere aiuto dal gruppo. Editore, autori e collaboratori discutono assieme, decidono assieme, agiscono assieme. Non esiste nulla di simile in Italia, proprio per questo il progetto viene seguito con curiosità da migliaia di persone fin dall’inizio. Entusiasmo e dinamismo si pongono come base per due obiettivi: rinnovare lo scenario stantio dell’editoria nazionale e combattere l’indifferenza che circonda libri e autori di gran valore, attraverso un approccio che vuole mediare imprenditorialità moderna e recupero di un associazionismo “dal basso” che altrove è ormai ridotto a banale parodia. Sito: www. casadeisognatori. com Facebook: I Sognatori - Factory Editoriale Twitter: I Sognatori Factory @CasaSognatori Blog autori: lastranafamiglia.wordpress. com © 2015 I sognatori, Lecce ISBN 978-88-95068-61-9 Vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera senza previo consenso dell'Editore. Ogni riferimento a fatti o persone esistenti è da intendersi come frutto del caso.
Scarica