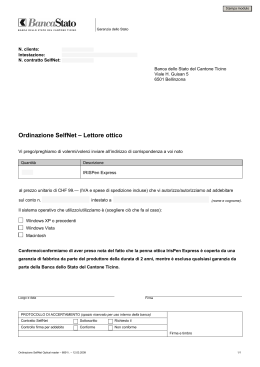02. 2010 Percorsi di ricerca Working papers Laboratorio di Storia delle Alpi - LabiSAlp Percorsi di ricerca Working Papers Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSAlp Percorsi di ricerca 2/2010 Indice Adriano Bazzocco, Censura e autocensura in Ticino durante la seconda guerra mondiale 5 Mark Bertogliati, Proteggere, riservare, amministrare: tutela dei boschi nella Svizzera Italiana (XIII– XVIII sec.) 13 Stefania Bianchi, Parte chi impara l’arte. I Cantoni e la formazione di cantiere: appunti di percorso per una sintesi d’insieme 21 Christiane De Micheli Schulthess, Tremona-Castello. Scavi 2000-2008 e ultimi aggiornamenti 31 Manolo Pellegrini, Vincenzo Dalberti e le rivoluzioni dell’Elvetica e della Mediazione al sud delle Alpi (dal tramonto dell’Ancien Régime al 1814) 41 Mattia Pelli, Catene, identità, diversità. Il caso Monteforno e lo studio dell’immigrazione italiana in Svizzera attraverso le fonti orali 53 Francesco Scomazzon, Repressioni, collusioni e mutua assistenza tra Italia e cantoni meridionali della Confederazione Elvetica (1925-1945) 65 Annamaria Valenti, “Ricondurre il perduto al bene”. Delinquenza minorile e rieducazione dell’infanzia traviata: dibattito e nascita di una Magistratura per i minori nel Canton Ticino (18561941) 75 Graziella Zannone Milan, Antonio Croci 1823-1884. Architetto ticinese tra tradizione e cultura cosmopolita 87 I contenuti degli articoli sono di intera responsabilità degli autori. Essi non possono essere riprodotti senza la loro autorizzazione. LabiSAlp, USI-Accademia di architettura CH-6850 Mendrisio 3 Percorsi di ricerca 2/2010 Censura e autocensura in Ticino durante la seconda guerra mondiale Adriano Bazzocco Il primo periodo dell’articolo 55 della Costituzione federale del 1874 – rimasta in vigore fino al 1999 – recita: «È garantita la libertà della stampa». La libertà di stampa è un pilastro delle democrazie perché consente la libera formazione delle opinioni. Senza libertà di stampa non c’è democrazia. La Costituzione, dunque, tutela gli organi d’informazione dalle interferenze e dalle censure dello stato. Il contrario di quanto accade nelle dittature, dove la stampa è piegata al servizio di chi detiene il potere e la sua funzione principale è di accrescere il consenso. I regimi totalitari seppero cogliere e sfruttare a pieno le grandi potenzialità dei diversi mezzi a disposizione nell’età della comunicazione di massa: la stampa scritta, la fotografia, il cinema e, l’ultimo ritrovato tecnologico, la radio. L’elevato grado di popolarità che raggiunsero fu possibile, in gran parte, proprio all’uso sapiente degli organi d’informazione e delle tecniche dello spettacolo. Oltre a controllare saldamente i propri mezzi di comunicazione, i regimi totalitari avevano in qualche modo la pretesa di orientare a loro favore anche gli organi d’informazione degli stati democratici allo scopo di estendere la loro sfera d’influenza; a maggior ragione se, come la Svizzera per l’Italia, questi erano confinanti, legati da una parentela linguistica e culturale e ospitavano una folta colonia di propri cittadini. Mussolini mal sopportava che nella vicina Svizzera si potesse criticare liberamente la sua persona, il suo governo, le istituzioni fasciste e monarchiche; e lo irritavano in modo particolare gli articoli ostili che apparivano su giornali ticinesi, perché scritti in italiano e dunque facilmente diffondibili anche nella penisola. Le questioni di stampa assunsero così un’importanza crescente nelle relazioni tra Italia e Svizzera, dando parecchio lavoro alle rappresentanze diplomatiche. La salita al potere di Hitler, nel 1933, e il progressivo avvicinamento tra la Germania nazista e l’Italia fascista crearono un’atmosfera d’assedio e di accerchiamento ideologico. Le potenze dell’Asse, che miravano a imporre il loro dominio sull’Europa, moltiplicarono gli interventi diplomatici sul governo federale per indurlo a disciplinare gli organi di stampa, generalmente ostili nei confronti delle nuove dottrine totalitarie. I più acerrimi oppositori dei fascismi furono le testate socialiste e comuniste, che non lesinavano i toni forti e le intemperanze verbali. La virulenza della stampa di sinistra, ma anche di diversi fogli democratici, esponeva la Svizzera al rischio di ritorsioni da parte di Germania e Italia. Di fronte alla situazione internazionale sempre più tesa e alle crescenti pressioni dei governi autoritari, il Consiglio federale adottò, nel 1934, un decreto che prevedeva alcune limitazioni della libertà di stampa. I provvedimenti emanati in virtù di questo decreto furono poco numerosi e generalmente di lieve entità. Fino allo scoppio della guerra furono richiamate all’ordine circa due dozzine di redazioni, alcune ripetutamente, e sospese temporaneamente due testate per tre mesi. In Ticino l’unico giornale ammonito, in più occasioni, fu l’organo del Partito socialista Libera Stampa 1. 1 Il tema della censura negli anni precedenti la seconda guerra mondiale non è mai stato approfondito. Alcuni aspetti sono trattati nel rapporto del Consiglio federale sulla politica in materia di stampa stilato al termine della guerra: «Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur le régime de la presse en Suisse avant et pendant la période de guerre de 1939 à 1945 (du 27 décembre 1946)», in Feuille fédérale, n. 2 (16 gennaio 1947), pp. 109-432. Anche il rapporto stilato da Karl Weber su incarico della Commissione mista dell’Associazione della stampa svizzera e dell’Associazione svizzera de- 5 Percorsi di ricerca 2/2010 Neutralità e libertà di stampa Nel 1938 la marcia dell’Europa verso la guerra subì una forte accelerazione a causa della politica di aggressione della Germania, impossessatasi dell’Austria e poi dei Sudeti. Nel clima di tensione internazionale e paura la disponibilità a tollerare i toni sopra le righe e gli articoli suscettibili di esporre la Svizzera agli attacchi delle vicine potenze dell’Asse diminuì sensibilmente. Non a caso proprio nei mesi precedenti lo scoppio del conflitto furono decretate le uniche due misure di sospensione delle pubblicazioni in virtù del decreto del 1934, che colpirono il Journal des Nations e la Schweizer-Zeitung am Sonntag. Con la prospettiva di una guerra imminente si aprì un intenso dibattito sul significato e sulla porta della neutralità. Quali obblighi implicava la neutralità? E, soprattutto, quali conseguenze aveva sulla libertà di stampa? Le Convenzioni dell’Aja del 1907 concernenti i diritti e i doveri delle potenze neutrali in caso di guerra – in vigore ancora oggi – impongono alla Svizzera di non partecipare in alcun modo al conflitto e di garantire l’uguaglianza di trattamento degli stati belligeranti per quanto riguarda le esportazioni di materiale bellico. Le norme concernono esclusivamente l’ambito bellico. Inoltre, la neutralità è un rapporto di diritto internazionale tra due stati, l’uno neutrale e l’altro belligerante, che non riguarda gli individui. Lo stato neutrale non è responsabile dell’atteggiamento dei suoi cittadini. Soltanto lo stato, e non i cittadini, può commettere atti contrari alla neutralità. La libertà di stampa, dunque, non sottostà ad alcuna disposizione limitativa. Eppure era chiaro a tutti che la sola osservanza degli obblighi imposti dal diritto della neutralità era insufficiente, soprattutto nel delicato settore della stampa. In effetti, quale credibilità poteva avere per i regimi totalitari l’atto formale di dichiarazione della neutralità della Svizzera, se la maggior parte dei suoi organi d’informazione, specchio dell’orientamento dell’opinione pubblica, erano loro apertamente ostili? Il 16 ottobre 1938, in un discorso tenuto a Locarno in occasione dell’inaugurazione del lungolago a lui intitolato, il consigliere federale Giuseppe Motta, ministro degli affari esteri, affrontò la questione del rapporto tra libertà di stampa e neutralità: […] piaccia o non piaccia, – gli Stati hanno il diritto di darsi il regime che giudicano per essi migliore. Nessuno ha il diritto d’ingerirsi nelle loro vicende interne. Ogni ingerenza forestiera nella vita d’un altro Stato è contraria al diritto internazionale. Stati con regimi essenzialmente diversi possono convivere insieme ed essere amici. Fare d’ideologie opposte segni di lotta e quasi cause di guerra è pensiero aberrante non quasi dissimile da quello che tendesse a risuscitare in pieno secolo ventesimo le guerre nefande di religione! Lo spirito di parte non è un’inclinazione dell’animo umano che s’applica soltanto alla politica interna. Essa può manifestarsi nella polita esterna producendo danni irreparabili. Non già che io pretenda o desideri l’uniformità delle opinioni, il conformismo politico, il timorato silenzio su quanto avviene da noi e intorno a noi. La libertà di stampa ha da rimanere integra e nessuno ha pensato mai di comprimerla o diminuirla. Ma fra libertà e licenza, fra opinione e ingiuria corre un divario che indica alle persone consce della loro responsabilità quanto è lecito e quanto è illecito. La neutralità, che ci è stata felicemente riconosciuta, è dottrina dello Stato, non dell’individuo, ma impone anche all’individuo il dovere imperioso della misura e della riflessione 2. gli editori di giornali contiene una parte relativa agli anni prima della guerra: K. Weber, Die Schweiz im Nervenkrieg: Aufgabe und Haltung der Schweizer Presse in der Krisen- und Kriegszeit 1933-1945, Berna, 1948. Sul periodo della seconda guerra mondiale l’opera di riferimento resta la tesi di dottorato di Georg Kreis pubblicata negli anni Settanta: G. Kreis, Zensur und Selbstzensur. Die schweizerische Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg, Frauenfeld, 1973. Nell’ambito dei lavori della Commissione indipendente d’esperti Svizzera-Seconda guerra mondiale (comunemente nota come Commissione Bergier) Kreis ha pubblicato due ulteriori saggi sul regime di stampa in materia di rifugiati e di negoziati economici internazionali: G. Kreis, Zensurregime und Flüchtlingspolitik 1939-1945, in K. Imhof, P. Ettinger, B. Boller, Die Flüchtlings- und Aussenwirtschafspolitik der Schweiz in Kontext öffentlichen politischen Kommunkation 1938-1950, Zurigo, 2001, pp. 481-496; G. Kreis, Zensurregime und Wirtschaftspolitik 1939-1945, in Ibidem, pp. 437-480. 2 G. Motta, Testimonia Temporum. Discorsi e scritti scelti, Serie terza 1936-1940, Bellinzona, 1941, pp. 94-95. 6 Percorsi di ricerca 2/2010 Secondo Motta la convivenza in spirito d’amicizia tra democrazie e dittature era senz’altro possibile. Occorreva però limitare gli scontri ideologici e non immischiarsi negli affari altrui, perché lo «spirito di parte» in materia di politica estera avrebbe esposto la Svizzera a gravi rischi. Motta si oppose con fermezza a derivare dalla neutralità dello stato ai sensi del diritto internazionale una neutralità dell’individuo. Tuttavia, se sul piano dei principi difese risolutamente la libertà di stampa, al lato pratico si sforzò al massimo di imporre agli organi d’informazione una severa disciplina. La neutralità morale degli individui era contraria ai principi di uno stato democratico che riconosceva la libertà d’opinione. Tuttavia, in considerazione della situazione straordinaria di grande pericolo, i cittadini erano invitati ad allinearsi volontariamente alla concezione ufficiale della neutralità 3. La censura militare Se, nella seconda metà degli anni Trenta, i provvedimenti nei confronti dei giornali furono sporadici e lievi, allo scoppio della guerra i controlli divennero sistematici e le maglie della censura si restrinsero. L’8 settembre 1939, il Consiglio federale emanò in base ai pieni poteri conferitigli dall’Assemblea federale un decreto riguardante la sicurezza del paese in materia d’informazione. Il primo articolo recitava: «Le commandement de l’armée est chargé, pour assurer la sûreté intérieure et extérieure du pays et maintenir la neutralité, de surveiller la publication et la transmission d’informations et d’expressions, notamment par la poste, le téléphone, le télégraphe, la presse, les agences de presse et de renseignements, la radio, le film et l’image, et de prendre des mesures nécessaires. Il désigne les autorités militaires et civiles chargées de cette tâche» 4. La sorveglianza degli organi d’informazione fu affidata alla Divisione stampa e radio dello Stato maggiore dell’esercito che, lo stesso giorno, diffuse un vademecum con tutti i divieti previsti. Nelle prime settimane di sorveglianza censoria vi furono incomprensioni e malintesi. Dopo alcune discussioni, anche molto accese, tra autorità militari e rappresentanti degli organi di stampa, il 6 gennaio 1940 la Divisione stampa e radio emanò «i principi di controllo della stampa» che, approvati da Consiglio federale e Parlamento, costituirono le linee direttrici valide per tutta la durata della guerra: 1. Le citoyen suisse a droit à des informations par la voie de la presse. Les renseignements doivent être aussi complets que possible et dépourvus de tout parti-pris. 2. Tout journal peut exprimer son opinion et émettre son jugement pour autant que ses sources soient sûres et qu’il s’abstienne de toute offense. 3. La critique est permise pour autant qu’elle s’exerce de manière objective et mesurée. 4. En ce qui concerne les événements extérieurs, la presse suisse doit les apprécier du point de vue suisse. Elle ne doit pas se faire l’interprète de la propagande étrangère. Toute influence étrangère doit être bannie. 5. Dans la mesure où l’arrêté fondamental [il vademecum diffuso l’8 settembre 1939] en autorise la diffusion par la presse, les bruits et les pronostics doivent être nettement désignés comme tels. La presse suisse doit s’abstenir de donner des conseils à l’étranger et de lui «faire la leçon». 6. Conformément à l’arrêté fondamental, est interdite toute discussion susceptible de compromettre notre neutralité 5. Sull’evoluzione del concetto di neutralità alla vigilia e durante la seconda guerra mondiale cfr. E. Bonjour, Histoire de neutralité suisse, vol. VI, pp. 149-164. 4 Arrêté du Conseil fédérale assurant la sécurité du pays en matière d’informations (du 8 septembre 1939), un’ampia raccolta delle istruzioni e degli atti legislativi relativi alla censura è conservata nel Fondo Libera Stampa presso l’Archivio di Stato del Cantone Ticino (ASTi), Fondazione Pellegrini-Canevascini, Fondo Libera Stampa, 15.4. 5 Principes de contrôle de la presse, Stato maggiore dell’esercito, Divisione stampa e radio, 6 gennaio 1940; ASTi, Fondazione Pellegrini-Canevascini, Fondo Libera Stampa, 15.4. 3 7 Percorsi di ricerca 2/2010 Le nuove disposizioni stabilivano una distinzione netta tra politica interna e politica estera: se sulle questioni di rilevanza nazionale la libertà di stampa restava quasi integralmente garantita e i giornalisti potevano continuare a esprimersi anche con toni rudi, in materia di politica estera era richiesta la massima cautela per non urtare i suscettibili regimi totalitari. Occorreva restare imparziali riportando i fatti in modo oggettivo senza emettere giudizi e soprattutto senza calare lezioni. Editori, giornalisti, scrittori, redattori radiofonici, registi, fotografi ecc.: tutti gli attori del settore della comunicazione erano tenuti a conformarsi a questi principi basilari. La Divisione stampa e radio fu strutturata in base ai settori da sorvegliare nelle seguenti unità: Sezione stampa svizzera, Sezione stampa estera, Sezione libraria, Sezione informazione, Sezione cinema, Sezione telegrafo e telefono, Sezione radio, Sezione posta. Oltre all’organizzazione basata su criteri funzionali, il plurilinguismo svizzero imponeva anche una ripartizione degli incarichi di sorveglianza secondo la regione linguistica. Nei circondari territoriali militari furono dunque istituiti servizi incaricati di verificare sistematicamente gli stampati pubblicati nella rispettiva regione. L’Ufficio stampa ticinese Per la sorveglianza della stampa ticinese fu costituito un Ufficio stampa aggregato al Circondario territoriale militare 9b, la cui giurisdizione si estendeva a Ticino e Mesolcina. La direzione di questo servizio fu affidata al capitano Antonio Antognini, che in civile rivestiva la carica di deputato federale (fino al 1943 in Consiglio nazionale, in seguito in Consiglio degli Stati) e di presidente del Partito conservatore democratico ticinese (PCDT, l’attuale PPD). L’Ufficio stampa era composto, oltre che dal caposervizio Antognini, dall’avvocato Emilio Rava, in veste di supplente, da Amedeo Boffa, redattore di Popolo e Libertà, in qualità di collaboratore, e da quattro «lettori»: Felice Rossi, giornalista di Avanguardia, Basilio Biucchi, redattore del Corriere del Ticino, Camillo Beretta, avvocato, già redattore de Il Cittadino, e Augusto De Maria, redattore del Giornale del Popolo. Se consideriamo la composizione politica del gruppo, notiamo che non rispecchia gli equilibri parlamentari né cantonali né federali, bensì è sbilanciata verso destra: tre conservatori (Antognini, Boffa, De Maria), due liberali radicali (Rava e Beretta), un ex esponente della Lega nazionale ticinese (Biucchi), un liberale democratico (Felice Rossi) e nessun socialista. La prevalenza di esponenti orientati verso destra non deve stupire. La censura ha lo scopo di imporre equidistanza di giudizio sui due blocchi belligeranti per garantire il rispetto della neutralità. La minaccia proviene però dagli stati totalitari, dunque l’Ufficio stampa nasce soprattutto con il compito di smussare le critiche degli oppositori al fascismo italiano e al nazismo. La stragrande maggioranza degli interventi dell’Ufficio stampa riguardarono, infatti, articoli critici nei confronti delle potenze dell’Asse o elogiativi nei confronti degli Alleati. Oltre alla squilibrata rappresentanza politica, altro aspetto che balza all’occhio nella composizione dell’Ufficio stampa è l’apparente incompatibilità tra l’incarico censorio che i collaboratori erano chiamati a svolgere e le rispettive funzioni ricoperte nella società civile. Antonio Antognini è presidente del PCDT e come tale direttamente collegato al quotidiano Popolo e Libertà, organo ufficiale del partito. I giornalisti Biucchi, Rossi, Boffa e De Maria scrivono sui rispettivi fogli che, nel contempo, devono sorvegliare. Per di più Augusto De Maria da marzo 1940 è anche presidente dell’Associazione della stampa ticinese. Controllori e controllati sono le stesse persone. Questa sovrapposizione di ruoli all’apparenza inconciliabili è stata in realtà espressamente voluta e ricercata. Le autorità preposte alla censura si sono sempre sforzate di coinvolgere nel modo più ampio possibile gli operatori dei media. L’idea era di integrarli in un sistema di controllo autogestito che facesse leva sul senso di responsabilità personale nel nome – come recitava la martellante propaganda – degli «interessi superiori del paese» e della «difesa della Patria». Lo spirito dell’attività della censura non era repressivo, bensì collaborativo. 8 Percorsi di ricerca 2/2010 Antognini e il suo supplente intrattenevano frequenti contatti con tutte le redazioni per informare, spiegare, convincere. Le sanzioni erano inflitte soltanto quale ultima ratio. I censori dell’Ufficio stampa di Bellinzona erano chiamati a controllare gli 86 giornali e periodici pubblicati nel Cantone Ticino e nella Mesolcina, tra i quali soprattutto i sette quotidiani ticinesi: Corriere del Ticino (tiratura: 7.500 copie), Giornale del Popolo (7.300), Gazzetta Ticinese (2.200), Popolo e Libertà (7.500), Il Dovere (6.800), Avanguardia (1.000) e Libera Stampa (3.500). Di norma il controllo degli articoli di giornale avveniva sotto forma di censura a posteriori, con la verifica delle notizie a pubblicazione avvenuta. Altre forme di comunicazione come le fotografie, i film, le réclame, determinate trasmissioni radio ecc. sottostavano invece a censura preventiva. Spesso gli autori richiedevano di propria iniziativa il controllo preventivo dei testi per evitare complicazioni. In caso d’infrazione ai divieti, le sanzioni andavano dall’ammonimento ufficiale, nei casi più lievi, fino al sequestro dell’edizione oppure, ma assai più raramente, alla sospensione temporanea delle pubblicazioni. La sorveglianza censoria dell’Ufficio stampa del Circondario territoriale 9b diede luogo a 856 interventi di vario tipo, 156 sanzioni e tre casi di sospensione delle pubblicazioni 6. Gli argomenti più controversi e maggiormente soggetti a divieti erano quelli riguardanti la politica estera e la tutela dei segreti economici e militari. Le maggiori infrazioni riguardavano le critiche che potevano minare il prestigio dell’esercito, oppure la diffusione d’indicazioni in violazione al segreto militare, ad esempio dettagli sulla dislocazione della truppa, gli effettivi, i comandi e le istallazioni militari oppure commenti sull’attività dei tribunali militari, sulle misure per la difesa dello stato, sulle decisioni dei vertici militari. Gli argomenti nettamente più delicati, che diedero luogo alle sanzioni più gravi, furono quelli riguardo alla politica estera, ad esempio, la scelta unilaterale delle notizie a favore di un blocco belligerante, l’offesa di stati o governi stranieri, le critiche infondate nei confronti di stati stranieri, la diffusione di propaganda straniera, i consigli e le «lezioni» impartite a stati stranieri. Invece, fintanto che non metteva a repentaglio l’unità e la volontà di difesa del paese, il dibattito sulla politica interna non era sottoposto ad alcuna limitazione. Le notizie sull’andamento della guerra Gli articoli più delicati, che diedero luogo alle sanzioni più gravi, erano quelli che riferivano sull’andamento della guerra. L’11 luglio 1940 Libera Stampa e il foglio radicale democratico Avanguardia pubblicarono un resoconto su uno scontro nel Mediterraneo tra forze navali italiane e inglesi sfavorevole all’Italia. Libera Stampa aveva intitolato il pezzo «BATTAGLIA NAVALE NEL MEDITERRANEO. Navi italiane colpite e in fuga». Due giorni dopo, il capitano Antognini intimò ai due giornali un severo richiamo per aver trasgredito alle direttive della censura che prescrivevano, in nome della neutralità, di riferire le notizie sull’andamento della guerra con equidistanza di giudizio rispetto ai due blocchi belligeranti. Gli articoli di Libera Stampa e Avanguardia furono prontamente rilevati anche dalla Regia Legazione d’Italia che inviò una dura nota di protesta a Berna. Contemporaneamente dai giornali italiani, saldamente controllati dal regime, si levarono voci di protesta per denunciare le ripetute violazioni della neutralità da parte della stampa svizzera. A questo punto, messe sotto pressione, le autorità superiori di Berna decisero di sospendere Avanguardia per tre settimane e Libera Stampa per due. In tal modo fu 6 Cfr. rapporto finale sull’attività dell’Ufficio stampa durante la mobilitazione di Antonio Antognini, Archivio federale di Berna (ARF), E 5724 (-), vol. 1. 9 Percorsi di ricerca 2/2010 inasprita di molto una sanzione che era già stata ufficialmente decisa e comunicata. E a nulla valsero i ricorsi interposti delle due testate antifasciste 7. L’attività dei censori e i provvedimenti di censura furono dunque piegati a logiche politiche contingenti. L’incisività e il livello repressivo della censura svizzera non dipesero dai tanto proclamati, quanto astratti principi di osservanza della neutralità, ma furono calibrati piuttosto in base al grado di minaccia esterno, alla capacità dei regimi totalitari di esercitare pressioni. Nella prima fase della guerra, quando la Germania e l’Italia incutevano grande paura, il controllo censorio fu più forte. Mentre nella seconda fase, con l’avanzata delle truppe Alleate su tutti i fronti, le maglie della censura si allentarono notevolmente. Le misure di sospensione delle pubblicazioni inflitte a Libera Stampa e Avanguardia indussero le redazioni a maggiore prudenza, anche perché la sospensione delle pubblicazioni era dannosa sotto il profilo economico, poiché rischiava di causare una perdita di abbonati. Sanzioni così pesanti non furono più decretate. Un’unica altra sospensione delle pubblicazioni, ma solo per tre giorni, fu imposta a Libera Stampa nell’aprile 1941. Le notizie sui profughi e sulle persecuzioni Altro ambito tematico sottoposto a provvedimenti di controllo censorio fu quello della politica d’asilo. Quanto e che cosa si poteva scrivere sui giornali riguardo alle persecuzioni e all’afflusso di fuggiaschi? Se si sfogliano i giornali dell’epoca, si nota come quest’argomento così cruciale fu trattato in pochi articoli, spesso scialbi e laconici comunicati ufficiali emanati dal Comando territoriale di Bellinzona. Tutti i reportage e le fotografie sui passaggi alla frontiera e sull’internamento furono vietati o sottoposti a censura preventiva. Il controllo censorio si estendeva a immagini apparentemente innocue: la redazione di Illustrazione Ticinese fu richiamata all’ordine per aver pubblicato, il 20 novembre 1943, la fotografia di un internato senegalese che saliva sorridente la scaletta del circo Knie per assistere allo spettacolo 8. La censura impedì o limitò anche la diffusione di notizie sulle persecuzioni in corso oltre confine. Il 9 ottobre 1943 Libera Stampa pubblicò un articolo dal titolo «La persecuzione degli ebrei anche in Italia». Il pezzo riferiva della persecuzione antisemita in corso nella regione del lago Maggiore. Si parlava di una trentina di ebrei assassinati e dei loro corpi gettati nel lago. Questa pubblicazione costò a Libera Stampa un ammonimento per aver riferito «asserite atrocità che sarebbero state commesse dai tedeschi contro gli ebrei dell’Alta Italia» 9. In realtà l’informazione era esatta: l’eccidio vi era stato, e più precisamente nella località di Meina. È interessante notare che, nonostante il regime di censura, questa informazione girava in Ticino da diversi giorni. Già il giorno dopo l’eccidio di Meina, il 23 settembre 1943, il rifugiato politico italiano Filippo Sacchi annotava nel suo diario: «corrono proprio oggi per Locarno le più nere voci sopra eccessi della soldataglia tedesca: scorribande, saccheggi, un’intera famiglia con donne e bambini trucidati in una villa a Meina, ecc.»10. Un altro ammonimento dello stesso genere fu inflitto al foglio Edilizia svizzera che, il 6 gennaio 1944, aveva ripreso un articolo dal giornale Su questo episodio cfr. G. Kreis, Problemi della stampa in un paese neutrale: esempi di conflitto fra la stampa ticinese e la censura durante la seconda guerra mondiale, in «Archivio Storico Ticinese», 48 (1971), pp. 327-342. 8 Cfr. Rapporto settimanale n. 47 del Capo Ufficio stampa 9b, 28 novembre 1943, ARF, E 4450 15, vol. 10. 9 Cfr. Rapporto settimanale n. 41 del Capo Ufficio stampa 9b, 18 ottobre 1943, ARF, E 4450 15, vol. 10. 10 F. Sacchi, Diario 1943-1944. Un fuoriuscito a Lugano, Bellinzona, 1987, p. 21. 7 10 Percorsi di ricerca 2/2010 della Resistenza italiana Avanti! nel quale si parlava di «ebrei gettati come cani in fondo al lago o schiacciati in vagoni piombati» 11. Il controllo su questo genere di notizie aveva lo scopo di prevenire complicazioni nelle relazioni diplomatiche, di impedire che trapelassero in Italia informazioni utili ad altri che intendessero tentare la via della Svizzera o, al contrario, ai loro aguzzini nazisti e fascisti preposti alla sorveglianza della frontiera, di tutelare l’anonimato dei rifugiati e infine di non turbare lo stato d’animo della popolazione 12. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 ripararono in Ticino, oltre a svariate migliaia di militari allo sbando e profughi razziali, numerosi intellettuali, scrittori e giornalisti che contribuirono con saggi, articoli di giornale, conferenze e attraverso i contatti personali con le élite locali a sprovincializzare e svecchiare la vita culturale del cantone. Questa intensa e ricca stagione culturale, che durò fino al rimpatrio dei profughi in Italia nell’estate del 1945, ha lasciato un segno molto forte nella memoria storica del Cantone dando luogo a molti approfondimenti in sede storiografica. Occorre però ricordare, quando si affronta questa importante pagina di storia ticinese, che questi profughi ottennero notevoli spazi d’espressione nella stampa e nell’editoria ticinese soltanto perché nell’autunno 1943 era chiaro a tutti che la guerra l’avrebbero vinta gli Alleati e, dunque, le maglie della censura erano oramai allentate. Le strategie del dissenso Inevitabilmente la sorveglianza censoria sollecitò lo sviluppo di controstrategie per dare comunque sbocco a opinioni e giudizi. I modi per dar forma al dissenso furono diversi e non mancavano di originalità. Innanzitutto presero a circolare giornaletti e fogli volanti pubblicati alla macchia. Alcuni favorevoli all’Italia e al fascismo, come Libertà, sedicente «Foglio indipendente d’informazione della Svizzera italiana», pubblicato in due edizioni nell’agosto 1944 e nel gennaio 1945, pieno d’invettive contro la Svizzera e le sue istituzioni 13. La maggior parte degli stampati clandestini erano però d’intonazione antifascista, ad esempio un volantino diffuso sul finire dell’autunno 1943 a firma «Il Popolo ticinese» che chiedeva di accogliere tutti i profughi italiani e semmai di allontanare i «fascisti imboscati». Diversi stampati di questo genere sono conservati negli archivi della polizia cantonale o delle guardie di confine 14. Notevole fortuna ebbero storielle, barzellette e componimenti poetici anti-italiani, soprattutto quelli che schernivano l’esercito. Il 18 dicembre 1940 il consolato generale d’Italia a Lugano riferiva a Roma su alcune storielle in circolazione nel Cantone Ticino per ridicolizzare i rovesci dell’esercito italiano nella campagna di Grecia, ad esempio questo scambio di battute tra un ticinese e un italiano: «– Sapete che non si riesce a trovare un paio di peduli? – Veramente? – Già, li hanno comperati tutti i soldati italiani per scappare meglio». Sempre sulle disfatte dell’esercito italiano fu diffuso un volantino con una poesia intitolata «Albania»; la prima strofa recitava: «E su pei monti dell’Albania/ o come è bello scappar via/ del greco l’eco rimbomberà/ l’Italiano scapperà/ lasciando al suolo tanti cannoni/ e un po’ dei vostri caporioni» 15. Le canzoni, le poesie, le barzellette e più in generale l’atteggiamento derisorio e Cfr «Richiami e interventi presso giornali», registro n. 3, ASTi, Fondo PCD-PPD. Sulla censura in materia di rifugiati cfr. Kreis, Zensurregime, cit. 13 Cfr. la lettera del sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica sociale Serafino Mazzolini al delegato commerciale svizzero Max Troendle, 14 novembre 1944; Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Roma (AMAE), RSI, Affari politici, busta 87, e l’appunto per il duce del Ministero degli Affari esteri della RSI, 21 aprile 1945, Archivio Centrale dello Stato di Roma (ACS), SPD, CR 1943-1945, busta 76. 14 Archivio del Comando del Circondario IV delle guardie di confine, Lugano e ASTi, Fondo Polizia politica. 15 Comunicazione riservata dal Ministero degli Affari Esteri alla Regia Legazione di Berna, Roma 31 marzo 1941; AMAE, Affari politici 1931-1945, Svizzera, busta 23. 11 12 11 Percorsi di ricerca 2/2010 di ostilità della popolazione ticinese fu oggetto di continue note diplomatiche di protesta da parte della Legazione d’Italia a Berna. La polizia svizzera dava seguito alle proteste inasprendo la sorveglianza e, se i colpevoli erano identificati, le condanne prevedevano alcuni giorni di carcere. Il modo più plateale di dissentire consisteva nell’applaudire o fischiare nell’oscurità delle sale cinematografiche durante la proiezione dei cinegiornali sulle attualità di guerra a dipendenza se le notizie erano contrarie o favorevoli alle potenze dell’Asse. Nel gennaio 1942 furono esposti negli atri e nelle sale cartelli indicanti il divieto assoluto di manifestare e fu disposta l’accensione immediata delle luci e la sospensione delle proiezioni in caso d’incidenti. Il 3 febbraio 1942 Libera Stampa difese in un articolo il diritto al «libero fischio in libera repubblica». Al solito, l’articolo non sfuggì all’occhio vigile del console generale d’Italia a Lugano che presentò una nota di protesta. L’Ufficio stampa di Bellinzona impartì a Libera Stampa un ammonimento con l’ordine di pubblicare una rettifica per confermare la fondatezza e la necessità del provvedimento deciso dalle autorità militari. In questo contributo si è spiegato per brevi cenni perché è nata l’esigenza di applicare la censura, com’è stata istituita, chi se ne occupava e, con alcuni esempi, in che modo operava. Quale giudizio trarre dall’attività della censura? Ecco il bilancio che stilava il capitano Antognini a fine guerra nel suo rapporto conclusivo: È difficile dare un giudizio esatto sull’efficacia e sul funzionamento del controllo della stampa. Il servizio ha evitato abusi dannosi per la sicurezza nazionale. Nessuno è in grado di valutare esattamente la portata e l’estensione degli inconvenienti evitati. Il tenore violento che molti giornali avevano assunto prima dello scoppio della guerra in materia internazionale, raffrontato con la moderazione che è subentrata dopo l’inizio del conflitto, può dare una base generica per giudicare l’efficacia del controllo della stampa, il quale, se non ha potuto evitare tutte le pubblicazioni indesiderabili, ha però attutite quelle più pericolose 16. Se alcune voci critiche furono ricondotte alla moderazione, la maggior parte dei giornalisti ritenne doveroso adeguarsi per non nuocere alla patria. La censura fu vissuta in generale come un male necessario per la salvezza del Paese. Concepita quale strumento per garantire la neutralità, ma di fatto finalizzata a modificare l’orientamento della stampa e dell’opinione pubblica allo scopo di non urtare i suscettibili e minacciosi regimi totalitari, la censura rientra in qualche modo tra le concessioni della Svizzera a favore delle potenze dell’Asse per mantenere il Paese al di fuori del conflitto. 16 Rapporto finale sull’attività dell’Ufficio stampa durante la mobilitazione di Antonio Antognini, ARF, E 5724 (-), vol. 1. 12 Percorsi di ricerca 2/2010 Proteggere, riservare, amministrare: tutela dei boschi nella Svizzera Italiana (XIII-XVIII sec.) Mark Bertogliati Introduzione Nella storia i motivi che portarono all’istituzione di provvedimenti di tutela dei boschi sono così numerosi e vari che risulta arduo riassumerli in poche righe. Nell’arco alpino i più importanti furono, senz’altro, assicurare un’adeguata protezione dai pericoli naturali, fornire una sufficiente riserva di legname e altre risorse forestali, oppure ancora permettere la ricrescita degli alberi dopo un taglio. Non di rado e in altre epoche si trovano però anche altre motivazioni come, ad esempio, la regolamentazione della caccia o della raccolta dei frutti, il mantenimento di barriere vegetali poste a confine, la protezione di acque e sorgenti o il miglioramento del clima. È interessante notare come molti termini ancora oggi impiegati per definire porzioni di bosco più o meno ampie si riferiscano, in origine, alla delimitazione giuridica di un appezzamento di terreno. La forte impronta utilitaristica nella percezione del bosco e delle sue risorse è ben visibile, ad esempio, nella radice di alcuni termini in seguito ampiamente utilizzati per definire la superficie boschiva. È il caso, rilevante, dei termine «foresta» 1 e «selva». Nella Svizzera Italiana le espressioni «fabula», «gazium» e «tenso» 2 furono sovente impiegate, nel passato, per identificare vari tipi di provvedimenti volti a disciplinare il godimento di beni comuni 3. Nella toponomastica ticinese sembra prevalere il significato di bosco protetto, almeno sulla base di quanto riportato dagli autori che si sono chinati sull’analisi di questi nomi di luogo e dagli informatori locali che hanno collaborato alla raccolta dei dati sul terreno. Per analizzare i concetti specifici riguardanti il bosco protetto può essere utile partire dalla distribuzione sul territorio di questi toponimi, ricostruibile per il Canton Ticino grazie alle indagini svolte a partire dagli anni ‘60 e ‘70 dall’ex Centro di Ricerca per la Storia e l’Onomastica Ticinese (CRT) e oggi depositate presso l’Ufficio del Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) a Bellinzona. Potendo disporre, per le varie epoche, di un rilievo sistematico e uniforme sul territorio delle menzioni di boschi protetti nei documenti, si po- 1 «En latin forestare signifiait mettre au ban, exclure. La forêt était à l’origine un espace sur lequel, explique Littré, on avait prononcé un ‘ban’ (…). Ainsi, pour ce qui est du mot qui nous intéresse ici, ce que définissait à l’origine le mot forêt, ce n’était pas un espace fermé (ce qui pourrait être le cas si ce mot dérivait de forum), mais la délimitation juridique, l’interdit, la réserve d’usage: dès son origine, ce mot évoque donc une volonté, une décision, une option des hommes, un choix de zonage; c’est un espace dont la vocation a été imposée et non un fait naturel; c’est un aménagement» (R. Bechmann, Des arbres et des hommes. La forêt au moyen-âge, Parigi, 1984, pp. 25-26). 2 Il Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) ha finora identificato 221 toponimi riconducibili a «gaggio», 87 «fabula» e 20 a «tensa» (citato in I. Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, Bellinzona, 2006, p. 42). 3 Per un approfondimento sull’origine di questi termini v. C. Salvioni, Della voce fáwra e del monte Paráwla, in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana (BSSI)», anno XVI, n. 11-12, Bellinzona, 1894, pp. 223-228; E. Bontà, La Saltarescia, Bastono, in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana (BSSI)», anno XXVI, n. 2, Bellinzona, 1951, p. 96; S. Vassere, G. M. Staffieri, Repertorio toponomastico ticinese (RTT): Muzzano, Bellinzona, 1998, p. 41. 13 Percorsi di ricerca 2/2010 trebbe senz’altro operare ben altri confronti e trarre considerazioni più precise. Forse si scoprirebbe che, a ben vedere, di boschi ad uso vincolato ne sono sempre esistiti, a sud come a nord 4. Proteggere Conciliare tra loro le molteplici funzioni del bosco costituisce ancora oggi una delle sfide più importanti nella politica forestale. Certo non fu scontato in passato, quando il bosco e le sue risorse ricoprivano un ruolo centrale per le comunità locali. In una società a beni limitati, che si alimenta prevalentemente di legna e biomassa e, come dirà qualcuno, procede in definitiva ad energia solare, la necessità di disporre in modo esclusivo di risorse forestali si situa tra le esigenze prioritarie. Oggi, come nel passato, la difesa contro i pericoli naturali è un aspetto di cruciale importanza per la popolazione dell’area alpina. La funzione protettiva diretta del bosco contro la caduta di valanghe, frane e massi fu certamente riconosciuta e sperimentata già in epoca remota dalle comunità locali, specialmente nelle valli superiori più esposte ai pericoli naturali e dove la presenza di boschi di ragione comunitaria è ancora oggi più marcata. Proprio laddove le calamità naturali si abbatterono con particolare violenza, furono adottati provvedimenti apparentemente rigidi che escludevano quasi ogni tipo di utilizzazione 5. La costituzione di boschi protetti rimase per secoli uno degli strumenti più importanti a disposizione delle comunità delle valli alpine, almeno fin dal XIII. secolo. Tuttavia lo scopo dell’istituzione di vincoli allo sfruttamento delle risorse forestali non fu, evidentemente, solo quello di garantire un’adeguata protezione a insediamenti, rive e strade maestre. Una gestione razionale e oculata delle risorse boschive e, a seguito dell’incremento dei prelievi e dei traffici di legname, la ricostituzione del patrimonio forestale, costituivano ulteriori e importanti motivazioni. Occorre distinguere – e non è sempre facile – tra tipologie diverse di provvedimenti: da quelli apparentemente più rigidi ad altri più «flessibili», da interventi puntuali ed episodici su zone particolarmente sensibili a limitazioni più estese nel tempo e nello spazio. Dall’analisi dei documenti che istituiscono o riconfermano boschi protettori (nell’Ottocento si dirà poi «boschi sacri»), emerge talvolta un indissolubile legame tra il vincolo imposto e il manifestarsi negli anni addietro di catastrofi naturali di una certa importanza, spesso con grande impatto emotivo e danni consistenti a terre e infrastrutture 6. Eventi tragici come quello di Broglio non sono infrequenti nella storia delle valli alpine. Gli Statuti di Valmaggia del 1624 statuivano che «nissuno commune della giurisdittione di detta Communità puossi poner ne metter in favole alcuna singolare persona (…) salvo per defendere le terre ò comunanze delli predetti luochi ò comuni» 7. Si tratta di un provvedimento importante almeno per due motivi. Il primo senz’altro in relazione agli avvenimenti Probabilmente nelle zone collinari e pedemontane poste a sud, vista la diversa conformazione del paesaggio ed evoluzione in termini di modalità di sfruttamento del territorio, la presenza di boschi protetti dovette vieppiù diradarsi nel corso dei secoli (probabilmente assai presto) parallelamente alla riduzione dell’area forestale e all’incremento della proprietà privata. 5 In quelli sopra la Faula di Cavergno, contemplati nell’ordine del 20 gennaio 1526 (Ordini del Comune di Cavergno, libro I pp. 1-18, manoscritto di L. Martini), si proibiva il taglio di piante e rami e la raccolta di legna verde e secca, come pure lo «scodere» ghiande dai roveri (aggiunta del 1549, libro I, p. 34). 6 È il caso, ad esempio, della seppure poco estesa vicinanza di Broglio dove, tra il 1668 e il 1777, furono costituite almeno 12 «faule» temporanee o permanenti. Proprio nel 1667 una valanga provocò importanti danni e vittime nel comprensorio, a causa della quale si imposero provvedimenti straordinari di tutela di alcune aree boschive (Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, cit., p. 45). 7 A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Val Maggia (Maiental). in «Rechtsquellen des Kantons Tessin», 11. Heft. Separatabdruck aus der Zeitschrift für schweizerisches Recht, Neue Folge, Band XXVIII (vol. 28). Basilea, 1909, p. 107. La stessa norma è presente con minime variazioni negli Statuti di Lavizzara, del resto quasi identici nei contenuti. 4 14 Percorsi di ricerca 2/2010 catastrofici che dovettero prodursi con particolare insistenza in Valle Maggia tra il 1500 e il 1600 8. Un secondo motivo è, con ogni probabilità, legato alla volontà di contrastare una dinamica in atto di messa a tutela di appezzamenti boschivi, forse anche privati, da parte delle comunità locali, ree di eccedere nel limitare o proibire l’accesso ai boschi ai singoli 9. Le cause di questo processo sono, almeno in parte, da attribuire ad un accresciuto fabbisogno di spazi e risorse a fronte dell’importante aumento demografico in atto tra il XVI. e il XVII. secolo e ad una dinamica di esclusivismo nell’accesso al godimento dei beni comuni che discuteremo più avanti. L’impressione generale, per tornare sul discorso dei boschi protettori, è che il rispetto degli ordini, anche di quelli più rigidi e severi, subisca un calo drastico negli anni seguenti la loro promulgazione e sia inversamente proporzionale al fabbisogno di risorse da parte dei singoli. Di fatto i frequenti abusi imponevano sovente misure straordinarie e la conferma a scadenze regolari dei provvedimenti per mezzo del «giuramento». Come dimostrato per la Valle Maggia e il Moesano, anche per i boschi protettori più importanti era sempre necessario riconfermare o irrigidire i provvedimenti, poiché gli abusi e le trasgressioni dovevano essere numerosi, situazioni certamente favorite dalla connivenza di autorità «di milizia» 10. Non erano infrequenti, ad esempio, le amnistie concesse ai trasgressori 11. Si tratta, tuttavia, di una questione ancora aperta che coinvolge, su una scala ben più ampia, oggetti di dibattito storiografico come il reale valore degli ordinamenti rurali oppure la percezione dei pericoli naturali. Resta, infatti, da appurare in quale misura queste disposizioni lasciassero spazio all’interpretazione 12. Si tratta inoltre di valutare il ruolo del diritto statutario nella globalità di un ordinamento giuridico composto da vari elementi, non da ultimo la consuetudine, che poterono non di rado condizionare l’applicazione del diritto scritto 13. Spesso, nell’ambito della storia forestale, si focalizza l’attenzione sullo strato arboreo, mentre anche altre risorse ricoprirono un’importanza vitale nel mondo rurale alpino. La necessità di garantire sufficiente foraggio per lo sverno del bestiame e un buon quantitativo di strame (indispensabile per costituire lo stallatico utilizzato nella concimazione di prati e coltivi), imponeva una gestione stratificata dei boschi, anche di quelli posti a protezione degli insediamenti. Al contempo vi era anche l’esigenza di prolungare nel bosco il pascolo del bestiame durante l’inverno, per cui le utilizzazioni possibili erano varie e molteplici. La regolamentazione delle attività socio-economiche imponeva, pertanto, un’attenzione particolare anche per questi aspetti e, quindi, non ci deve stupire più di tanto il carattere in apparenza estemporaneo di taluni provvedimenti 14. Dovendo assolvere esigenze sul breve termine è perciò comprensibile che i soli strumenti a disposizione delle autorità locali fossero un’interdizione più o meno temporanea o, al limite, una regolamentazione delle utilizzazioni. L. Martini, La transumanza e l’alpeggio in Valle Bavona, Locarno, 2003, pp. 33-37. Mansueto Pometta individua addirittura in questa norma specifica la volontà di controllare anche gli scarsi appezzamenti boschivi privati, trovandone ulteriore conferma nelle delimitazioni dei boschi protetti. Le denominazioni «ogni sorta di boschi» sovente presenti nelle antiche terminanze potrebbero, sempre secondo Pometta, riferirsi anche al regime di proprietà e non unicamente alla natura qualitativa (M. Pometta, L’intervento dello stato nella gestione dei boschi privati. in «Actes du Congrès international de sylviculture», Vol. III, Roma, 29.4 – 5-5-1926, p. 120). 10 V. i già citati esempi delle faule di Cavergno e di Broglio. Sul Moesano v. A. a Marca, Acque che portarono, Prosito, 2001, pp. 64-66. 11 Per il caso di Soazza del 1675 v. C. Santi, Boschi e legname a Soazza, in «Folclore svizzero», anno LXV, fasc. 4-5, Basilea, 1975, p. 44. 12 A. Schuler, Die Alpenwälder: Heilige Bannwälder oder Land- und Holzreserve? in «La découverte des Alpes», fasc. 12, 1992, p. 111. 13 P. Caroni, Dal dedalo statutario, in «Archivio Storico Ticinese», a. XXXII, n. 118, 1995, pp. 127-128. 14 In una sua analisi sui «boschi tensi» del Moesano, lo storico Andrea a Marca osserva come «d’altronde questi non costituirono mai una categoria definitivamente stabilita, né si posero in assoluto contrasto con la superficie sfruttabile. (…) Insomma, era un insieme composito, dinamico e relativamente aperto» (a Marca, Acque che portarono, cit., p. 66). 8 9 15 Percorsi di ricerca 2/2010 Riservare La centralità del bosco si afferma con forza subito dopo i primi grandi dissodamenti che poi diedero origine all’insediamento tradizionale alpino così come lo conosciamo oggi. Liberate le aree necessarie al pascolo del bestiame e all’agricoltura di sussistenza, il bosco acquista confini più o meno stabili 15. Abbiamo visto come la salvaguardia degli insediamenti fu certamente tra le prime preoccupazioni delle comunità di valle, enti di origine antichissima che nell’area alpina godettero probabilmente sempre di una certa autonomia nell’uso della proprietà comune 16. Tuttavia le comunità, al di là delle esigenze dettate dalla minaccia incombente dei pericoli naturali, furono ad un certo punto chiamate a proteggere il bosco, non fosse altro che per gestire l’espansione di quella che, storicamente, è considerata la prima utilizzazione conflittuale, cioè il pascolo 17. Si può assumere che, in questa prima fase di sperimentazione degli usi e funzioni del bosco dove certamente si produsse una rilevante riduzione della superficie boschiva, furono presi i primi e importanti provvedimenti di tutela, benché non in forma scritta. Tra il XII. e XIII. secolo, nell’arco alpino, la pressione dell’uomo sul bosco aumentò in modo consistente 18. Le ragioni delle controversie attorno all’uso del bosco non sono, perlomeno in una prima fase, esclusivamente da ricondurre a fattori demografici. A partire dalla fine del XII. secolo si ebbe il progressivo affermarsi dei comuni rurali. In questo periodo, anche nella Svizzera Italiana, i comuni rurali raggiunsero un’ampia autonomia nell’amministrazione dei propri territori, svincolandosi dalle autorità feudali e, in seguito, dotandosi di statuti riconosciuti dalle autorità sovrane. Questa autonomia si manifestò attraverso la facoltà di emanare ordinamenti sul godimento di alpi, pascoli e boschi 19. Il caso del Comune di Olivone è, in questo senso, particolarmente illuminante, poiché è ben visibile una volontà di estendere i propri possedimenti fondiari e giurisdizionali anche oltre i propri confini «naturali» 20. In Leventina la nascita dei comuni rurali (qui dette «vicinanze») risale almeno all’atto di spartizione degli alpi del 23 maggio 1227. La suddivisione delle competenze di natura politica ed economica si concretizzò, nei secoli a seguire, nella nota struttura organizzativa costituita, al livello superiore, dalla comunità di valle scendendo poi via via alle vicinanze, alle degagne ed ai vicinati 21. Tuttavia questo passaggio di consegne dalle antiche comunità di valle ad unità amministrative più piccole non fu certo rapido, né fu privo di strascichi. In Leventina, come anche altrove, persistettero per secoli le cosiddette «pezze comuni», ossia boschi indivisi che andavano sfruttati con il consenso di tutti gli enti interessati, spesso da più degagne contemporaneamente. T. F. Günter, Die Entwicklung der Waldnutzung in der Landschaft Davos, in «Bündnerwald», n. 34, 1981, p. 548. L’ampiezza dell’autonomia variava tuttavia a livello regionale, nelle Tre Valli ambrosiane Leventina, Blenio e Riviera, poste sotto l’influsso di Milano, fu certamente più importante che altrove (v. Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, cit., p. 35). 17 G. Berruti, L’uomo e il bosco: una storia di mille anni nelle valli bresciane, Brescia, 2001, p. 9. 18 Ibid., pp. 9-10; G. Cherubini, L’Italia rurale nel basso Medioevo, Bari, 1996, p. 19. 19 K. Meyer, Blenio e Leventina: da Barbarossa a Enrico VII: un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo, Bellinzona, 1977, pp. 49-50. Già nel 1237 i vicini della degagna di Osco fecero mettere per iscritto diversi accordi relativi a diritti di vicinato, riguardanti l’uso collettivo di alpeggi, pascoli e boschi di loro spettanza (G. Chiesi, Il Medioevo nelle carte, Bellinzona, 1991, p. 69). 20 L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze bleniesi all’inizio del XIII. secolo: evoluzione del possesso fondiario, comportamenti sociali, uso di violenza e mezzi di pacificazione, in «Materiali e Documenti Ticinesi (MDT)», Serie III Blenio, fasc. 3, Bellinzona, 1981, pp. 120-124. 21 F. Viscontini, Uno sguardo attorno ai fatti di Leventina del 1755: alcuni aspetti poco esplorati di una protesta d’Antico regime, in M. Fransioli, F. Viscontini (a cura di), La rivolta della Leventina: rivolta, protesta o pretesto?, Locarno, 2006, pp. 85, 160. Il passaggio a questo tipo di struttura, la quale prevedeva una partecipazione su più livelli alla vita comunitaria, è attestata anche in numerose altre regioni della Svizzera Italiana e dell’arco alpino (cfr. a Marca, Acque che portarono, cit., p. 31). 15 16 16 Percorsi di ricerca 2/2010 È il caso del Bosco grande di Osoglio («ul Bòs’c’ grant»), una vasta pecceta appartenente a Dalpe, Faido, Gribbio e Chiggiogna. Negli archivi delle quattro terre si contano a decine i documenti e gli atti inerenti questo comparto boschivo, i primi a cavallo tra XV. e XVI. secolo. Liti di confine, delitti, abusi e vertenze attorno alla spartizione dei proventi dei frequenti tagli si protrarranno ancora fino alla seconda metà dell’Ottocento, culminando con la divisione del 1879 22. Già nel Cinquecento, tuttavia, alcune porzioni di questo bosco sono menzionate come «infaurate» (protette, «riservate») a favore di singole terre o degagne 23. Ancora nel 1769 i vicini di Dalpe e Cornone (formanti una degagna) rilevano come i vicini delle comunità di Faido, Chiggiogna e Gribbio abbiano ciascuna le proprie faure «separatamente nel Bosco Grande di Osoglio» e, in accordo con le altre degagne, statuiscono che «nel luogo di dentro de Riazzo» sia loro assegnata una faura 24. Assistiamo dunque ad un progressivo insorgere di liti e vertenze riguardanti boschi e confini che portano, in molti casi documentati a partire dall’inizio del XIV. sec., all’istituzione di «fabule» 25. Gli esempi d’istituzione di boschi protetti sono numerosi, taluni chiaramente legati a eventi catastrofici prodottisi negli anni precedenti 26. Nell’archivio comunale di Davos la prima «lettera di bando» è attestata nel 1496, dopodiché si susseguono fino al 1800 ben 28 provvedimenti di questo genere, solo 4 dei quali chiaramente motivati da ragioni di pubblica sicurezza. Tutti gli altri possono essere ricondotti alla volontà di affermare diritti esclusivi su determinate porzioni di bosco oppure escluderne l’accesso ai non originari del luogo 27. Il fatto di poter godere in piena autonomia di un bosco costituiva, di per sé, una motivazione importante per richiedere la «faura perpetua» di una zona boschiva. Questo anche perché poi, in caso di abuso, era concesso all’ente proprietario pignorare il maltolto ed affibbiare ammende ai contravventori. Oltretutto, anche quando una faura era assegnata ad un unico ente, vi era poi sempre chi pre- Verbale sulla demarcazione dei boschi del Comune o Patriziato di Faido, Dalpe, Gribbio e Chiggiogna, 1879; Archivio Patriziale di Faido. 23 Ad esempio a favore dei vicini di Gribbio che «jam annis preteritis fecerunt unam fabulam in nemore de Uxolio ubi dicitur pro usu et reparatione ac conservatione eorum terre de Gribio» (V. F. Raschèr et al., Registri delle documentazioni (Materiali Ex CRT), Archivio Degagna di Gribbio, 1537/VI/2, doc. 27). 24 Ibid., Archivio Patriziale di Dalpe (Libri e Registri), 1769/IX/21. 25 La «fabula» è, in questo senso, la facoltà, da parte di un comune rurale, di emettere norme di godimento su beni collettivi, tra cui evidentemente il bosco. In una sentenza arbitrale rogata a Faido il 18 giugno 1313 viene stabilito, a favore dei vicini di Tarnolgio (Mairengo), il diritto di «tensare» e «infaurare» il bosco (poi faura) di Düsbina, con la facoltà di pignorare e infliggere ammende (v. Ibid., Archivio Patriziale di Calpiogna, 1313/XI/18). Nel 1322 i vicini di Quinto e Ranorencho giungono ad un compromesso con quelli di Varenzo ai quali si attribuisce a titolo perpetuo un comparto boschivo precedentemente comune e ne viene data la facoltà di governarlo come gli altri «gacii» della vicinanza di Quinto (R. Zeli, Voce Boscá, in «Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana (VSI)». Volume II. BÒ – BZÖGN, Lugano, 19711991, p. 760). Quasi sempre il riscatto dei boschi indivisi avviene dopo vertenze talvolta lunghe e complesse ma necessarie per far valere uno stato di diritto a favore di una o l’altra comunità. Questo è il caso, ad esempio, della vertenza fra i vicini di Scruengo (territorio di Quinto) e quelli di Altanca, a proposito dei «gazii et fabule situate supra lochum de Scruencho» che devono proteggere le terre sottostanti dal pericolo delle valanghe (Rascher et al., Registri delle documentazioni, cit., Archivio Patriziale di Altanca, 1473/XII/4; trascr. integrale in L. Brentani, Codice diplomatico ticinese: documenti e regesti, Volume IV, Lugano, 1954, pp. 232-238). 26 R. Zeli, Voce Bosch s. m. Bosco, in «Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana (VSI)», Volume II. BÒ – BZÖGN, Lugano, 1971-1991, pp. 778-779. 27 A Davos, oltretutto, disposizioni e circostanze particolari favorirono in seguito un vivace processo di spartizione dei boschi, con conseguenze variamente nefaste per l’economia forestale della zona. Ancora oggi più dell’80% della superficie boschiva di Davos è in mano a privati, percentuale incredibilmente alta per una comunità alpina (Günter, Die Entwicklung der Waldnutzung, cit., pp. 550-551). 22 17 Percorsi di ricerca 2/2010 tendeva diritti su di essa 28. In realtà ancora nel XIX. secolo non si raggiunge, in questo senso, un definitivo equilibrio e continuano a persistere antichi diritti di godimento e situazioni ingarbugliate 29. Tuttavia, già nel XVI. secolo, la soluzione delle vertenze attorno ai diritti sui boschi permette alle singole comunità di concentrarsi su quello che sarà il loro principale compito nei secoli a venire, ossia regolamentare il godimento dei beni comuni a vantaggio dei vicini. Amministrare Tra il XVI. e il XVII. secolo si produce una vera e propria «era degli ordinamenti forestali» 30. La diffusione dei provvedimenti a tutela di appezzamenti forestali nella prima Età moderna è una dinamica ben documentata in varie regioni della Svizzera Italiana, dalla Vallemaggia alla Val Poschiavo. Nel Moesano i primi «boschi tensi» sono menzionati negli Statuti di Calanca del 1469. Negli archivi moesani si possono attestare tra il 1491 e il 1665 almeno una ventina di documenti riguardanti la «tensa» di boschi comunali 31. Si apre una fase nuova che prelude a importanti cambiamenti nell’organizzazione interna delle società rurali. Abbiamo visto come, durante tutta l’Età moderna, non si interrompano il frazionamento o l’«infauramento» di boschi ad uso promiscuo, processo visibile nelle continue vertenze tra le comunità e presente soprattutto in Leventina. Tuttavia, a partire dalla metà del XVI. secolo e più decisamente in seguito, le istituzioni di boschi protetti non sono più apparizioni episodiche, ma vanno a costituire col tempo complesse strutture formate da comparti boschivi «liberi», altri parzialmente accessibili e altri ancora intangibili 32. Il bosco accresce sempre più la sua valenza come bene amministrativo e finanziario. Diviene pertanto uno scopo prioritario per le comunità e le autorità superiori fronteggiare presunte, pronosticate o reali penurie di risorse, senza cessare al contempo di soddisfare il mercato e le esigenze della popolazione locale. La proliferazione di ordinamenti e disposizioni specifiche riguardanti la gestione del bosco può, almeno in parte, essere messa in relazione con l’incremento demografico e gli sviluppi politici, sociali ed economici prodottisi tra la fine del Medioevo e la prima Età moderna. Abbiamo tuttavia visto come a livello regionale vi fossero, comunque, alcune differenze dovute ad eventi straordinari o scelte autonome di gestione del territorio da parte delle comunità locali. Ovunque, in ogni ca28 «- Ai vicini di Corzoneso e Scaradra viene concessa la licenza di stabilire la limitazione del taglio e dello sfruttamento dei boschi e pascoli compresi nella zona sopra descritta, sul versante destro della valle. - La medesima facoltà viene loro concessa per la zona situata sul versante opposto. - I vicini di Corzoneso e Scaradra non dovranno limitare alcun pascolo o bosco contro la volontà dei loro convicini né dei vicini di Leontica e di Comprovasco.» (Reg. nr. 358; 1349/II/7, in «Materiali e Documenti Ticinesi (MDT)», Serie III Blenio, fasc. 18, Bellinzona, 1995, p. 821). 29 Esempio significativo del persistere di diritti promiscui sul bosco è quello della Val Calanca. Qui una spartizione definitiva dei boschi fra i singoli comuni avverrà solo nel 1866 (A. Bertossa, Storia della Calanca, Poschiavo, 1937, pp. 124126, 282). 30 Come viene definita, per la storia forestale tedesca, da Radkau e Schäfer, concetto senz’altro applicabile anche alle nostre latitudini benché in un contesto socio-politico e con risvolti molto differenti (J. Radkau, I. Schäfer, Holz. Ein Naturstoff in der Technikgeschichte, Reinbeck b. Hamburg, 1987. p. 101). V. anche J. D. Parolini, Zur Geschichte der Waldnutzung im Gebiet des heutigen Schweizerischen Nationalparks, Diss., Zurigo, 1995, p. 31, nota 69. 31 a Marca, Acque che portarono, cit., p. 64. 32 Un esempio interessante di struttura stratificata è quello già proposto della Val Poschiavo, dove nel «Libro apartato de’ Tensi» son menzionati ben 53 comparti boschivi sottoposti a vari gradi di tutela, dai «tensi liberi» (sic!) ai «tensi irremissibili». Qui è visibile la volontà da parte delle autorità di garantire un’ampia e adeguata protezione di insediamenti, terreni e vie di transito contro i pericoli naturali e, al contempo, amministrare al meglio il patrimonio boschivo (v. R. Tognina, Origine e sviluppo del comun grande di Poschiavo e Brusio, Tesi di laurea, Losanna, 1975, pp. 131-132). 18 Percorsi di ricerca 2/2010 so, l’esigenza di utilizzare aree sempre più vaste per soddisfare il crescente fabbisogno interno in termini di risorse, dovette probabilmente portare a nuove regolamentazioni e limitazioni. Vi sono però anche altri elementi che contribuiscono a identificare l’accumulo dei provvedimenti di tutela come una macro-dinamica, pur con ovvie disparità a livello locale e regionale. Uno di questi è la problematica dei requisiti per l’acquisto del «vicinato» 33. Se fin verso la fine del Medioevo i requisiti posti per poter essere ammessi al godimento dei beni comuni erano, generalmente, piuttosto blandi (riassunti nella maggior parte dei casi nel domicilio), ecco che soprattutto a partire dal XVI. secolo (ma talvolta anche prima) le comunità locali dell’arco alpino svizzero assumono vieppiù un carattere di rigido esclusivismo a scapito dei «forestieri» e non originari del luogo 34. Anche l’incremento delle limitazioni d’uso sul bosco potrebbe ascriversi a questo tipo di dinamica. Un altro aspetto da approfondire è quello legato al taglio dei boschi a scopo commerciale. Già nel XIII. secolo è attestato un importante sfruttamento dei boschi nella Svizzera Italiana. Per quanto riguarda le regioni sudalpine il più importante polo d’attrazione delle risorse forestali, soprattutto il legname, fu per secoli la Lombardia. È accertato che, in modo particolare a partire dalla seconda metà del Quattrocento parallelamente allo sviluppo delle aree urbane di pianura, divenne interessante lo sfruttamento dei boschi anche nelle valli più remote 35. Già nei primi ordinamenti forestali a noi pervenuti sono presenti norme che vietavano l’alienazione delle «faure» a scopo di esportazione. Il fatto che già a cavallo del 1500 i tagli venissero effettuati in zone discoste, sta a significare non solo che i boschi situati in posizioni più comode erano già stati sfruttati, ma pure che vaste aree forestali nei pressi degli insediamenti dovevano già essere poste sotto tutela. In seguito, durante il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, il consumo di legname d’opera e combustibili (carbone e legna da ardere) andò progressivamente aumentando e, certo, ne dovette fare le spese anche qualche bosco protetto. Tuttavia si è già sottolineato come in molti casi risulti difficile classificare i boschi in base al tenore dei provvedimenti di tutela. Pertanto è probabile che molte delle «faure» alienate prima dell’Ottocento dovettero costituire, in realtà, delle riserve di legname pronte per essere sfruttate 36. In Leventina, forse più che altrove, vigevano disposizioni severe che disciplinavano, ma certo non escludevano, l’esecuzione dei tagli 37. Sul taglio, il trasporto e il commercio del legname vi sarebbe molto da riferire, ma per fortuna su questi temi si sono chinati molti autori negli ultimi anni ed a loro si rimanda 38. Conclusioni Si può vedere, dunque, come per diverse motivazioni si delinei, tra Medioevo e prima Età moderna, un sistema complesso e differenziato di regolamentazione e limitazione dell’uso del bosco da parte delle comunità locali sudalpine, allo scopo di gestire i rischi (penurie di risorse e pericoli naturali), Qui inteso come statuto di appartenenza al comune rurale e diritto al godimento dei beni comuni. P. Caroni, Le origini del dualismo comunale svizzero, Milano, 1964, pp. 64-65 e 260. 35 Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, cit., p. 47; L. Martini, Il taglio e la fluitazione dei boschi valmaggesi dal 1200 al 1900, in G. Buzzi (a cura di), AERT: Vallemaggia, Vol. 1, Bellinzona, 1997, p. 220. 36 v. ad esempio la vendita dei boschi giacenti nella «fauolla, sotto Osadigo, della sgrussia in dentro e Ryay» fatta a Cipriano Giudice di Giornico nel 1627 (Raschèr et al., Registri delle documentazioni, cit., Archivio Degagna di Osadigo, 1627/XI/25). Un altro appezzamento della stessa faura, affacciata sulla Valle di Chironico, fu venduto a Giacomo Francesco Bonenzo di Locarno nel 1640, il quale cedette poi la concessione al Consigliere Giouan Pedretti di Chironico nel 1651 (Ibid., Archivio Degagna di Osadigo, 1640/VI/30 e 1651/III/9). 37 Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, cit., p. 50. 38 a Marca, Acque che portarono, cit.; Martini, Il taglio e la fluitazione dei boschi valmaggesi, cit. 33 34 19 Percorsi di ricerca 2/2010 soddisfare le necessità locali, ma anche per escludere determinate cerchie della popolazione dal godimento dei collettivi e garantire la ripresa del bosco dopo i frequenti tagli, importanti fonti di reddito per le comunità. Per un approfondimento sulle norme specifiche degli ordinamenti forestali si rimanda alle pubblicazioni citate a margine 39. A proposito della valenza di queste disposizioni e dei vincoli che esse comportano per gli usi del bosco, è utile ricordare come a rigor di termini una regolamentazione non sia, nella storia del diritto, una limitazione 40. Ciò soprattutto in riferimento all’apparente discontinuità riscontrabile nei provvedimenti di tutela del bosco. La presenza di una norma non è, inoltre, garanzia della sua applicazione, al massimo può esserlo di una volontà o di un’intenzione. In fase di ulteriore approfondimento e critica delle fonti potrà esserci utile tenere conto di questi aspetti. Oltre all’applicazione delle norme suscitano particolare interesse anche altre questioni, riguardanti ad esempio la problematica della memoria del rischio e della percezione dei pericoli naturali, i rapporti tra abusi e controllo sui boschi, come pure gli equilibri e le sovrapposizioni tra interessi privati e collettivi nella tutela dei boschi. Si tratta di temi che, con ogni probabilità, potranno essere analizzati con migliore profitto indagando su scala locale. Zeli, Voce Bosch s. m. Bosco, cit., pp. 764-802; R. Ceschi, Nel labirinto delle valli: uomini e terre di una regione alpina: la Svizzera italiana, Bellinzona, 1999, pp 26; Ceschi, Il Bosco del Cantone Ticino, cit., pp. 42ss.; a Marca, Acque che portarono, cit., pp. 61 ss. 40 Caroni, Le origini, cit., p. 65. 39 20 Percorsi di ricerca 2/2010 Parte chi impara l’arte I Cantoni e la formazione di cantiere: appunti di percorso per una sintesi d’insieme Stefania Bianchi Premessa: il contributo che qui si propone considera uno dei filoni tematici che ricorrono nel progetto di ricerca in corso ovvero I Cantieri dei Cantoni. Mete, opere, relazioni, vicissitudini di una famiglia di migranti della valle di Muggio (XVI-XVIII). Nel contempo vuol essere una riflessione che guarda in termini più generali al fenomeno delle relazioni di bottega nell’ambito della trasmissione delle competenze che sin dal medioevo hanno fatto degli «artisti dei laghi» i testimoni della storia edilizia delle città. A tal proposito nel corso degli ultimi anni gli studi che hanno per oggetto l’attività di cantiere delle maestranze della regione dei laghi hanno messo in luce, oltre a confermare alcune caratteristiche delle catene migratorie come dato di fatto acquisito, le capacità imprenditoriali di alcune famiglie che non hanno fatto della bottega solo il luogo per eccellenza dove si tramandano conoscenze, ma ne hanno fatto un’azienda a tutto tondo che va dall’organizzazione di cantiere alla più specifica divisione del lavoro. In quest’ottica formazione, committenza e viaggio si giustificano vicendevolmente, a vantaggio di un’articolazione dell’operare che nel corso del Settecento poggia sempre più sulla specializzazione. Imparare per guadagnare Accartare, contrarre pacta ad artem, accordare, prendere in donzena, essere discipuli o garzoni di carta, sono i termini che ricorrono negli statuti dell’arte e negli atti notarili per qualificare il rapporto e le regole dell’apprendistato 1. Quale sia il mestiere che si conosce e quindi si può trasmettere, e rispettivamente il mestiere che si intende apprendere, l’obiettivo implica la partenza per mete che procedono lungo le rotte migratorie privilegiate dall’una o dall’altra famiglia di artigiani- artisti, e che danno vita a una filiera per cui l’allievo a sua volta consegnerà il suo sapere ad altri giovani garzoni. Le circostanze e le connotazioni a monte del contratto d’apprendistato, e le implicazioni che il legame maestro-allievo potevano avere, si traducono in vicende che vanno aldilà del mero accordo iniziale, come si vedrà di volta in volta attraverso la voce di alcuni protagonisti dell’aristocrazia dell’emigrazione. 1 Fra i saggi che trattano l’argomento, per la specificità del contenuto segnaliamo M. Dubini, I “pacta ad artem», una fonte per la storia dell’emigrazione in Col bastone e la bisaccia per le strade d’Europa.Migrazioni stagionali di mestiere dall’arco alpino nei secoli XVI-XVIII, Bellinzona, 1991, pp.73-81; C. Sibilia, La formazione delle maestranze nel paese dei «Magistri comacini», in S. Della Torre (a cura di), Il mestiere di costruire, Como 1992, pp.15-28; A. Decri, La presenza degli Antelami nei documenti genovesi, in S. Della Torre, T. Mannoni, V. Pracchi (a cura di), Magistri d’Europa. Eventi, relazioni, strutture dell’emigrazione di artisti e costruttori dei Laghi lombardi, Como, [1997], pp. 407-432. 21 Percorsi di ricerca 2/2010 Non di rado il processo della trasmissione delle competenze si trasformava anche in alleanze familiari, quando la figlia del maestro si accasava con l’apprendista ormai emancipato che continuava a collaborare nei cantieri avviati dal suocero. A proposito dei Cantoni, Pietro (1648-1700) sposa in prime nozze l’unica figlia di Marc’Antonio Grigo di Muggio, subentrandogli negli appalti, come amava ricordare nei suoi appunti Simone Cantoni 2. Lo stesso accade per i Carloni, per i Barberini, … nonché tra Michele Cereghetti e Albino Agustoni. Dall’atto notarile che pone fine agli accordi tra i due in cui si premette «essendo che alcuni anni fa Antonio Cereghetti q. Taddeo di Scudellate mandasse un suo figlio per nome Michele a Roma sotto custodia e raccomandazione del sig. Albino Agustoni q. Gio. Batta di Cabbio, architetto, abitante in Roma al fine di farlo perfezionare nell’arte della pittura, con la promessa fattagli di compensarlo e pagarli le spese necessarie che avesse fatto. Essendo che in conformità sia stato da detto S. Albino somministrato al detto Michele, mentre ha atteso et imparato l’arte, il dinaro che bisogna per vitto e vestito et altro per il spatio di cinque anni et mezo, quale è asceso sino alla somma de scudi trecento cinquanta moneta romana … Essendo che dopo questo per volontà di Dio sia stato concluso matrimonio tra detto Michele con la S.ra Anna Maria figlia del detto S. Albino, e per dote detto S. Albino habbi promesso dargli tutto quello che potrà et convenirà al suo stato et grado et massime li beni esistenti qui in patria», se ne ricava che Michele in un sol colpo impara il mestiere, si accasa e consolida le sue proprietà in patria. In effetti il testo del documento prosegue dimostrando che dai costi sostenuti dal maestro vanno detratti i denari spesi dal padre del Cereghetti per gestire dette proprietà, per cui il debito si riduce a scudi 257, debito che Albino abbona traducendolo in assegnazione dotale 3. Ovviamente l’aspetto finanziario è quello che più importa ai contraenti, ma non era il solo perché il desiderio di affermazione è motivo ricorrente nelle lettere così come il compiacimento per essere apprezzati da dogi, senatori, principi, vescovi e padri gesuiti; e l’importante è che «è meglio di avere una bona professione che di avere del denaro perché a volte il denaro si consuma e la virtù resta sempre in sé» 4. E se è vero che a Roma anche gli sciocchi si raffinano, Francesco Giorgioli da Venezia racconta “mi trovo contento aver visto questa belisima cita e particolarmente tante bele piture e non perdo un minuto di tempo in mitarle», mentre i Cantoni si portano a casa un pezzo di Strada Nuova, rendendo genovese la loro abitazione a Cabbio, perché imparare significa appunto anche imitare 5. Comunque chi accarta un giovane lo fa come investimento da tutelare perché l’apprendistato deve rendere in prospettiva, fidando sulla fedeltà dell’allievo che poi sarà l’assistente nei cantieri, anche per molti anni, come afferma Gaspasre Schinetti: «sono da circa vinti anni ch’io mi accordai con mr. Bartolomeo Laghi a imparare l’arte del scarpelino in Pilza nel Regno di Boemia e stetti in casa loro per il spacio di cinque anni e dopo anche finito il tempo ch’io ero accordato ho sempre lavorato sin l’anno passato con essi loro» 6. Ma, considerato l’animo umano, questa devozione per il maestro-mentore non è una certezza; c’è sempre il rischio che i segreti del mestiere fuggano a vantaggio di un’altra compagnia di artigiani, i «becchi cornuti» che costituiscono la concorrenza. Archivio di Stato del Cantone Ticino (in seguito ASTi), Cantoni-Fontana 15/98, appunti del Cantoni ricavati dal Soprani, Le vite de’ Pittori, Scoltori, et Architetti Genovesi e de’ forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti degli stessi, Genova, 1674. 3 ASTi, Notarile, Rusca 504. 4 Cfr. A. Pfister, Spunti e considerazioni sulla formazione di Domenico Gilardi, in P. Angelini, N. Navone, L. Tedeschi (a cura di), La cultura architettonica italiana in Russia da Caterina II a Alessandro I, pp. 367-384, p. 369. Nello stesso tomo si veda anche N. Navone, Prassi di cantiere e orientamento empirista. Note sulla formazione degli architetti Adamini, pp. 385-394, in particolare p. 385 e relativa bibliografia. 5 Cfr. R. Merzario, Anastasia, ovvero la malizia degli uomini, Bari, 1992, p. 13; S. Bianchi, La casa Cantoni di Cabbio, Mendrisio, 2003. 6 Cfr. G. Martinola, Lettere dai paesi transalpini degli artisti di Meride e dei villaggi vicini (XVII-XIX), Lugano, 1963, p. 193. 2 22 Percorsi di ricerca 2/2010 I primi anni l’apprendista non produce ma consuma risorse come scrive a casa Pietro nel 1758 al padre Francesco Maria «ho inteso che avete acordato il giovine nipote del signor Giuseppe Maraino di Chiasso, cosi venendo questo sarano tre giovini mentre ne ò preso un altro tre mesi scorsi et siamo in gran spesa esendo caro il vito e sapete che guadagnio si pol fare cosi vi serve di aviso aciò vi sapiate a regolare…; qui in Genova siamo sete a mangiare et tre a guadegniare cosi vi lasio considerare». Inoltre occorre fare attenzione a mantenere i giusti equilibri relazionali in patria e all’estero, senza però l’ossessione di ridurre il tutto all’ambito familiare; anzi negli accordi studiati sembra prevalere il principio per cui la formazione non si fa necessariamente all’interno del nucleo familiare, ma i padri, che professino la stessa disciplina o che comunque operino nello stesso ambito, tendenzialmente preferiscono collocare i figli presso colleghi o persone con cui hanno dei legami parentelari o d’amicizia e stima. Non mancano però le eccezioni; ad esempio Lorenzo Bernasconi, pur essendo il figlio di Alessandro, mugnaio e factotum della famiglia Cantoni di Cabbio, malgrado lo stretto legame di fiducia e di amicizia, il figlio lo manderà ad imparare l’arte a Petritoli nella marca d’Ancona, presso Francesco Maria Canturio di Morbio Inferiore. Infatti lo affida o meglio, come recita l’atto rogato l’8 aprile 1751, lo consegna in dozzina per quattro anni al Canturio «ad effetto che il medesimo lo istruisca nella professione di scultura sia stuccho, lo mantenghi per li suddetti anni quattro gli alimenti necessarij ed in caso di malattia lo faccia assistere a spese sue per quindici giorni. … In oltre il medesimo Bernasconi si obbliga pagare e rimorsare al detto signor Canturio tutte quelle spese che egli farà per provedere li vestidi ferri ed altri stromenti si per il disegno come per la professione necessarij». Il padre poi si impegna a pagare in quattro rate lire 400 di Milano; non avendole ipoteca gli immobili compreso un aratorio vignato con piante di castagno. Concluso l’accordo cinque giorni più tardi Lorenzo giunge a Petritoli e poi dopo due anni scompare senza preavviso 7. Se ne deduce che dare una formazione ai figli è un impegno finanziario che vale i propri beni, che il giovane viene spedito all’estero per farsi le ossa e che non tutti gli apprendistati andavano a buon fine, fatto che non impedirà a Lorenzo di seguire più tardi i Cantoni a Genova dopo essersi accasato nel 1756 con Marta, figlia di Giuseppe Cantoni. Per scongiurare il rischio che il garzone s’involasse, al momento dell’accartatio presenziava anche un mastro artigiano o un congiunto che prestava sigurtà impegnandosi a risarcire il maestro se i patti non venivano rispettati. Accadeva che le cose venissero ricomposte nell’ambito delle relazioni familiari; a proposito del cognato, da Colonia, Stefano Melchion scrive «per non rovinarlo nel suo fiore di imparare mi son risorto di far quelo che non mi credeva mai di fare, cosi mio cognato è venuto di me à presentarzi con dire che saria ritornato a finire per il suo tempo et che se non è venuto avanti son stati male persone che ne ano insinuato si che io li ò di novo acetato et questo lo fato perche si diporta bene nella vertu et per lafeto che porto a VS.» 8. Certo per l’apprendista l’avere legami di parentela era garanzia di maggior indulgenza di fronte alle scappatelle. Altrimenti per essere risarciti si procedeva per vie legali con tanto di testimoni, come dimostra nel 1619 la deposizione di Martino Ferrari, chiamato in giudizio per sostenere la causa del suo datore di lavoro «io so che Antonio Mazzetti di Gio Ba era accartato con mastro Bernardo Cantone all’arte del fabro muraro, e per quanto intesi con sigurtà di Gerolamo Lavinia, e so che detto Antonio si è partito dal suo maestro senza licenza di detto suo maestro anzi contro sua volontà hora sono deciotto mesi in più e quando si partì Cfr. ASTi, Canturio 3; 1751 adì 8 aprile in Cabbio. L’obbligazione segue il contratto e il documento si conclude con il confesso da parte del Canturio, 31 gennaio 1754, di aver ricevuto i saldi dell’apprendistato. 8 Cfr. ASTi, Oldelli 25 G-M, Colonia 21 settembre 1711, lettera indirizzata a Giovanni Oldelli, parzialmente trascritta in Martinola, Lettere, cit., p. 90. 7 23 Percorsi di ricerca 2/2010 fu il sabbato di ramo oliva o la domenica delle palme 1618 che fu al 7 di aprile che il sabato di ramo olivo che viene saran due anni ...” 9. Dal canto suo l’apprendista, poiché la formazione è onerosa, ricerca il maestro migliore per diventare a sua volta maestro con i vantaggi salariali che ciò comporta. È il caso di Giuseppe Petondi di Castel San Pietro, fratello del più celebre Gregorio, architetto artefice di Strada Nuovissima 10, che si specializza nello stucco sotto la giuda di Francesco Maria Cantoni, un maestro per cui porterà sempre affetto e ammirazione; la sua è una vera e propria specializzazione che segue un apprendistato concluso con un certo Bolla che lo presenta; a sua volta il Petondi nel 1761 porta con sé a Genova Carlo Chiesa di Sagno che comincia la sua formazione a 17 anni 11. Con lo stesso spirito Stefano Melchion segue Francesco Monsenco di Lugano, dicendo che ha fatto il possibile per andare con lui «perché lui è vertuoso, ma con licenza del mio padrone» 12. Il maggior guadagno, la miglior vita, ovvero un buon pasto e bei vestiti 13, sono infatti da sempre le forze di attrazione e di spinta del meccanismo migratorio aldilà di tempi e luoghi. Chi parte, riferito all’ambito geografico della migrazione di cantiere, non parte solamente perché in patria scarseggia il lavoro, oggetto di spinta, ma perché ambisce alla qualità del lavoro, magari al successo professionale, subisce l’attrazione delle città e di ciò che va oltre la valle o la sponda del lago. Infatti, nelle terre patria degli artisti dei laghi, per chi parte c’è chi arriva a faticare su briciole di campi che però valgono oro e sono il risultato tangente delle fortune racimolate con l’emigrazione. Dalla Valle Maggia, dalla Val di Blenio, dalla Mesolcina, dalla Val Verzasca ma anche dalla val Brembana, giungono pastori, carbonai, e soprattutto manodopera contadina perché le donne dell’aristocrazia dell’emigrazione non si tolgono la pelle di dosso per lavorare i campi mentre gli uomini sono lontani e neppure portano la cavagna, perlomeno le donne di casa Cantoni 14. Ecco perché l’apprendistato è un investimento. In termini di salari, ad esempio, a Genova nei primi anni del Settecento un maestro da muro al giorno guadagna almeno 38 soldi (che equivalgono intorno alla metà del secolo a 47.6 soldi della lira di Milano), un lavorante 22 (ovvero 27.6 soldi) mentre, a casa, in valle di Muggio, eccezionalmente si ricevono 30 soldi per arare il minuto (cereali primaverili), una lira per lavori di muratura eseguiti da un mastro, 12 soldi per potare e far le siepi, 10 soldi per perticare o spaccare un castagno, 5 soldi per segare il fieno o raccogliere frutti, fino ai miseri 4 soldi al giorno che vengono dati alle donne per zappare il grano 15. Qualcun altro e qualcun’ altra, venuti dalle valli sopracenerine o dalla bergamasca, fanno questi lavori, ma appena è possibile i figli vengo- Archivio di Stato di Genova (in seguitoASGe), Notai antichi, Celesia 5963. G. Bozzo, Lomellini Stefano, via Cairoli, scheda del sito Genova: le strade nuove e il sistema dei palazzi dei rolli, Genova, 2006. 11 ASTi, Notarile, Maggi 2694. 12 Cfr. ASTi, Oldelli, 25 G-M, Candia 1695, lettera indirizzata ad Alfonso Oldelli, parzialmente trascritta in G. Martinola, Lettere, p. 82. 13 Nelle lettere la qualità dell’abbigliamento è una preoccupazione, così come il compiacimento per un buon pasto o per essere stati alla tavola di personaggi illustri. Secondo Merzario cibo e vestiario sono i valori che prevaricano anche il concetto di guadagno perché sono qualità che tutti possono vedere (R. Merzario, Adamocrazia.Famiglie di emigranti in una regione alpina, Bologna, 2000, p. 39). 14 Cfr. Bianchi, La casa Cantoni, cit., p. 36 e lettera di Francesco Maria alla moglie, Genova 30 giugno 1726 «Vi dico che la chavagna non volio che la portatte lasiatemi lavorare io in dieci giorni o guadagniatti £ 120» (Archivio privato). 15 Per calcolare il rapporto lira genovese e lira milanese si è tenuto conto dei cambi indicati per la prima metà del Settecento dagli stessi Cantoni; invece per la comparazione salariale cfr. ASTi, Notarile, Rusca 607, Conti della tutela degli eredi di mastro Marco Agustoni di Morbio Inferiore, 29 marzo 1719. 9 10 24 Percorsi di ricerca 2/2010 no avviati ad altre professioni, alimentando questo processo osmotico di partenze e arrivi che continua fino all’ Ottocento16. D’altro canto il viaggio è una spesa certa e consistente e quindi ancora una volta occorrono garanzie di successo che sono delle ipoteche che servono a pagarlo. Chi parte ha una meta precisa che corrisponde a una committenza precisa per chi va per il mondo esercitando la sua arte; e chi parte spesso parte grazie anche al sistema creditizio sviluppato dalle maestranze che facilmente ricorrono a piccoli prestiti o debiti contingenti 17. Questo aspetto è evidente nelle partite d’estimo dei mastri della valle di Muggio: debiti e crediti, in somme contenute ma vicendevolmente numerosi, convivono nell’intreccio di chi prende a prestito e a sua volta è creditore verso altri. Un viaggio di andata e ritorno a Genova, secondo quanto scrive alla fine del Settecento Giovanni Antonio Maggi di Castel San Pietro, costa 190 lire di Milano 18, mentre per raggiungere Napoli da Genova a Rocco Cantoni servono quasi 300 lire genovesi, quanto nel 1758 ha guadagnato per lavori di stucco eseguiti nel palazzo di città e nella residenza alla marina di Cornigliano per l’illustrissimo Giacomo Filippo Durazzo 19, per cui il guadagno in terra partenopea sarà quel che sarà, come scrive a casa nel 1769. Giovanna, vedova di Bernardo San Michele di Arogno, nel 1710 apre un’obbligazione di scudi 48 di Lugano che servono in parte per comperare grano, in parte per mandare il figlio Battista di 17 anni in Germania ad imparare l’arte dello stucco da persona esperta 20. Altrettanto fa Caterina Cantoni, rimasta vedova di Pietro nel 1700, alienando la masseria della Porteglia per poter finanziare, fra le altre cose, il viaggio d’apprendistato del figlio Giuseppe che segue la famiglia Alviggi di Caneggio sulle fiere di Sulmona 21. Sempre fra i conti di famiglia c’è un saldo al prete di Genestrerio che ha anticipato i soldi per il viaggio di Antonio Cantoni, fratello del citato Pietro che fa da garante. Queste spese a volte sono coperte da mirati legati testamentari che, secondo le volontà di Carlo Spinelli, serviranno al nipote Michele per pagare un professore «che avrà cura di istruirlo» 22, perché l’istruzione è il sale del fenomeno migratorio 23 e imparare, a cominciare dal saper leggere, scrivere e far di conto, è il presupposto per lasciare il paese con un minimo bagaglio d’autonomia che in campo pratico è dato dagli insegnamenti invernali che i maestri, rientrati in patria, riuscivano a dare. Tempo e denaro La durata poi dell’apprendistato e l’età di chi principia ad imparare non seguono regole che possono essere ricondotte ad una tipologia omologante, come sembra essere consacrata da una diffusa biblioCfr. S. Bianchi, Partir per Genova. Il contributo di alcune maestranze della Valle di Muggio al settecentesco rinnovamento edilizio della città. L’esempio dei Cantoni: una prima indagine in atti del convegno Cantieri e manodopera, Roma 2008, MEFRIM, pp. 287-299 e relativa bibliografia. 17 Ovviamente non si tratta di una strategia di categoria ma di una prassi del processo migratorio. Fra gli studi più significativi sul tema per l’area alpina, ricordiamo il pionieristico lavoro di L. Fontaine, Histoire du colportage en Europe XVe – XIXe, Lione, 1984; quindi A. Fornasin, Terra, credito ed emigrazione commerciale in Carnia durante l’età moderna, in G. Ferigo, A. Fornasin (a cura di), Cramars, Tavagnacco, 1997, pp. 153-180 e A. Fornasin, Ambulanti, artigiani e mercanti. L’emigrazione dalla Carnia in età moderna, Verona, 1998; A. Arru, Reti locali, reti globali, in A. Arru, F. Ramella (a cura di), L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea, Roma, 2003, pp. 90-95. 18 ASTi, Maggi, 2. 19 Archivio Durazzo Pallavicini Genova (in seguito ADGe), Durazzo 481, 30 dicembre 1758. 20 ASTi, Notarile, Roncaioli 128, 2 gennaio 1710. 21 ASTi, Notarile, Ceppi 2018, 15 marzo 1712. 22 ASTi, Notarile, Maggi G.A. 2694. 23 Cfr. R. Merzario, Famiglie di emigranti ticinesi (secoli XVII-XVIII), in «Società e storia», n. 71, 1996, p. 45. 16 25 Percorsi di ricerca 2/2010 grafia; lo stesso si può affermare riguardo ai ritmi stagionali di partenza e ritorno che per l’emigrazione di cantiere non sono certo annuali 24; anzi le assenze per molti sono durature anche perché, come poc’anzi si diceva, il viaggio rappresenta una spesa importante. Non si sprecano i guadagni soprattutto se sono pochi ma si consegnano a chi per tutti torna in patria con lettere, polizze, mandati di pagamento, procure per atti notarili, scarpe, vestiti, reliqui, oggetti d’arte e persino delizie del palato25. Chi rientra, rientra per tutta la comunità, residente spesso in specifici quartieri cittadini 26, e all’interno dei nuclei parentelari ciò avveniva a turno o secondo lo stato civile del migrante: gli scapoli che non intendono accasarsi con una fanciulla conterranea o i maritati con la moglie al seguito tornano occasionalmente e non sempre neppure al tramonto della loro vita 27. Le somme che si mandano in patria sono spesso modeste ma essenziali per chi le attende. Così scrive Carlo Sassi da Spoleto ad Alessandro Bernasconi, affidandogli le rimesse dei suoi lavoranti che lui dovrà consegnare alle mogli o ai parenti: “Signor mio compare servirà la presente a caramente salutandola con tutti di sua casa. Io partii di questa città la setimana vanti carnevale e sono ritornato qui il dì 26 del mese caduto e nella mia partenza della marca mi e stato dato da quelli miei lavoranti commisione di mandare alle loro moli questa quantita e soma di denaro e o stimato bene inviarli a VS e poi consegniarli a chi speta secondo qui soto scrivo; in primo loco il sig. Pietro Cantoni mio cugino mi pone di far recapitare nelle mani di Vs zechini n.o 5; Mastro Giovani Ganazi (Gienazzi) a sua moglia 2; ala molia di mastro Gulielmo Codoni 2; Mastro Marcantonio Fontana a sua molia 3; alla molia di mastro Carlo Fabrizio Fontana 2; a Domenico Agustoni di Casima 3; al padre di Pietro A. Camponovo deto il Pavoleto di Cabio 4; e più un zechino direto al Sig. Simone Bernasconi di Riva S. Vitale, e questo lo lasiara nele mano dela signora Marta Vincenti che il detto Simone viera a prenderselo, e piu alla figlia di mastro Michele Maggi di Casima abitante in casa di [....] di Mendrisio altro zechino 1; e piu altri due datomi dal signor Tognieto Maggi di Casima e favorirà consegnarli a Antonia Maggi mia comare e sua molie, che in tuto fanno la soma di zechini 25 tutti pagati e subito che Vs li avera ricuti e pagati favorira darmene rincontro per mia quieta (quittance). Favorira salutarmi la mia molia alla quale non li mando niente suponendomi non abia di bisognio e favorira dirli che io sto atendendo la mia risposta». La partenza dal paese implicava invece altre consegne e fra queste l’accompagnare sui luoghi di lavoro i giovani principianti che, come abbiamo visto per Lorenzo Bernasconi, dovevano raggiungere dopo giorni di viaggio il loro maestro. Dunque l’apprendistato è una scelta progettuale per circostanze ed aspettative, con accordi che evolvono nel tempo così come le competenze richieste nei cantieri. La regola stabilisce per i maestri da muro una formazione di 5 anni; tuttavia i diversi pacta ad artem consultati mettono in luce situazioni specifiche che dipendono dal grado di apprendimento, dal tipo di mestire edilizio che si intende imparare, dall’età del garzone. Il contratto può durare sino a 6-7 anni, quando l’alunno è piuttosto giovane ed inesperto per cui, o gli anni sono sufficienti a farne un valente artigiano, oppure per il datore 24 La durata dell’assenza tenderebbe ad essere determinata dal grado di specializzazione; cfr. L. Lorenzetti, Razionalità, cooperazione, conflitti: gli emigranti delle Alpi italiane (1600-1850), in A. Arru (a cura di) Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza, Roma, 2008, pp. 181-209, in particolare p. 185. 25 Per quel che concerne la Svizzera italiana cfr. R. Ceschi, Rusticità e urbanità. Circolazione di uomini e mercato di devozione, in L. Damiani Cabrini (a cura di) Seicento ritrovato, Milano, 1996, pp. 13-24; S. Bianchi, Nostalgia del gusto e gusto della memoria, in «Storia delle Alpi», n. 13, 2008, pp. 43-60. 26 L’immagine che Martinola dà di chi emigra per la prima volta, ovvero di uomini perduti, senza riferimenti (Lettere dai paesi transalpini, p. XI) appare obsoleta, così come le interpretazioni di partenze e ritorni. Cfr. Arru, Ramella, L’Italia delle migrazioni interne, cit., p. XIV; E. Canepari, Occasioni di conoscenza in Arru, Ramella, L’Italia delle migrazioni interne, cit., p. 304. 27 Sono gli isolati, i solitari, cui fa riferimento Arru, Ramella, L’Italia delle migrazioni interne, cit., p. XXIV. Parallelamente c’è chi invece tornava per garantire il «fuoco acceso», cfr. L. Lorenzetti, R. Merzario, Il fuoco acceso, Roma, 2005, in particolare l’omonimo capitolo. 26 Percorsi di ricerca 2/2010 di lavoro il contratto si rivela un cattivo investimento, come da casa viene ripetutamente ricordato a Francesco Maria Cantoni affinché si decida a fare la carta per un giovane, Pietro figlio del Pasquale Bossi di Monte, che è già suo allievo, per un tempo sufficientemente lungo affinché il lavoro degli ultimi anni sia già redditizio. Ma se l’allievo è piccolo si preferisce rifiutare l’accordo come avviene per altro fanciullo di Monte, Giuseppe Piotti, perché, scrive il Cantoni, «quanto al figlio del signor Lazaro intendo che è tenero d’età e perciò non siamo in caso d’acartarlo»; di fatto Giuseppe ha, secondo lo stato d’anime contemporaneo alla lettera, 10 anni, un’età per cominciare che per altre professioni è già avanzata. 28 Parimenti vi sono anche contratti di formazione, o meglio post-formazione, che si potrebbero equiparare agli odierni master. Gli interessati sono maggiorenni e la durata dell’apprendistato è di due anni o poco più, come figura in diversi atti del notaio genovese Giovanni Andrea Celesia 29. Quanto ai compensi che spettano ai maestri, si passa da una realtà cinquecentesca che, come si dirà, si richiama agli statuti dell’arte, ai modelli contrattuali settecenteschi che vedono il maestro responsabile di ogni cosa in cambio di un vero e proprio salario, a meno che l’alunno non sia di gran talento, come Lorenzo Andreazzi, desideroso di imparare l’arte dello stucco, di cui Giovani Oldelli scrive «vedendolo che è di buon genio che imparerà bene io li promisi di insegnarlo per quatro ani senza donzena e darli uno scudo alla settimana per il costo, se vuol soparmiare si pol vanzare di comprar scarpe e calzete ….. se la signora comare vol promettere lei per il tempo io lo acorderò, altrimenti lo lascierò seguitar la quadretura» 30. Per dare un altro esempio della tipologia dell’apprendistato di stuccatore nel Settecento, torniamo all’accartatio, per altro retroattiva perché stipulata praticamente al termine del contratto, di Pietro Bossi. Francesco Maria Cantoni «s’obbliga per se o suoi figli insegnare l’arte e professione di stuccho, alimentarlo per anni sei e mezzo, somministrarli tutto il bisognevole per l’esercizio del disegno, procurargli la lavatura e la accomodatura della biancheria, curarlo o farlo curare a sue proprie spese in caso, che Dio non voglia, si ammalasse per giorni otto e non altrimenti. Con questa libertà ed intelligenza che ogni volta che il signor Cantone non havesse modo d’impiegare detto signor Bossi nella succennata professione, oppure li convenisse per le sue particolari urgenze andare altrove, o venire in patria, possa il medesimo consegnarlo alla custodia e scuola di altre persone e professori fuori dei suoi figli, egualmente atte e perite» 31. Per tutto ciò le richieste di compenso potevano essere rilevanti, fino a 750 lire per quattro anni, e tali da far desistere l’interessato che con po’ di fortuna trovava un’altra collocazione 32, o da far dire al genitore «io non sono in gardo di pagare donzena et senza donzena VS pratende la locacione di sete ani in questo io mi pare che VS si potrebe contentare di sei in quanto al vistito io li mandaro in Genova bene vestito», come ripetutamente scrive nel 1726 Carlo Fontana detto il Castellano di Muggio a Francesco Maria Cantoni che porterà con sé a Genova uno dei figli, Bartolomeo. Anche in questo Dubini, I «pacta ad artem», cit., indica come estremi 8-25 anni, però senza riferimenti al tipo di professione. ASGe, Notai antichi, Celesia 6001 e 6002; oltre agli accordi citati nel testo segnaliamo, ad esempio, che nel 1635 Giovanni Battista Ceresola prende quale apprendista per due anni Agostino Bulla di 18 anni e lo stesso fa Giacomo Spazio con Stefano Barberini, pure di 18 anni. 30 A differenza delle altre lettere del fondo Oldelli citate dalla fonte, qui si fa fede alla trascrizione del Martinola, perché non è stato possibile reperire nel citato fondo né questa, né altre presenti nel suo saggio. 31 ASTi, Canturio 3, Cabbio 16 agosto 1760. «Per l’altra parte Santino Bossi a nome del fu Pasquale (nel frattempo il padre è morto) e di Domenico altro figlio, dimorante in Nizza di Provenza»; fa da garante ed é pronto ad indennizzare il Cantoni se Pietro si dilegua. 32 È il caso di Giuseppe Oldelli , potenziale allievo dei Gilardi a Mosca che non può permettersi la cifra da loro richiesta; più tardi ha la fortuna di essere assunto da un certo architetto Bova, senza contropartita. Cfr. ASTi, Oldelli 25 N-O, Mosca 26 febbraio 1811, parzialmente trascritta in Martinola, Lettere, cit., pp. 158-159. 28 29 27 Percorsi di ricerca 2/2010 caso la mancata corrispondenza della donzena si traduce in un accordo di lunga durata, cosicché l’allievo emancipato restava a lavorare per il maestro almeno finché questi non avesse recuperato i soldi che gli sarebbero spettati, come dimostrano i conti dei cantieri liguri. Così il maestro poteva concentrarsi su più progetti, fidando che l’esecuzione degli stucchi sarebbe stata garbatamente realizzata. Nel corso del Settecento le competenze diventano raffinate, sia per quel che riguarda le responsabilità nell’edificazione sia nell’allestimento del decoro, a tal punto che il concetto di lavoro d’équipe organizzato in forma piramidale, con una precisa divisione dei compiti, è pienamente risolto. Fra le opere architettoniche che sono il risultato di questa pianificazione da parte dei Cantoni e dei «patriotti» che lavorano con loro vi sono i più noti palazzi di Strada Nuova e senz’altro Palazzo Ducale. Qui troviamo quale architetto Simone Cantoni, Gaetano Perucchi capocantiere, Innocenzo Bossi capomastro e, per il decoro i Pozzi e i Cantoni, nonché altri stuccatori con cui i Cantoni si dividono l’appalto secondo l’abilità esecutiva 33. Simone Cantoni per le opere d’ornato da realizzarsi suggerisce «Conviene altresì che le qualità dei medesimi intagli siano distribuiti a norma dell’abilità di ciaschedun stuccatore riuscendo tutti meglio chi in una cosa chi in un’altra, e però crederei che le scanellature dei quadri fussero fatte da Pietro e Rocco Cantoni; … tutti i fusaroli e perle siano lavorati dal loro giovane Svanascini….” altro apprendista che comincia a mettere in pratica le sue abilità 34. Le regole dell’arte Punto fermo aldilà di età o durata sono i reciproci diritti e doveri cui si attengono anche i nostri notai nel redigere atti secondo gli usi della città ligure, regole di inveterata consuetudine che non è neppure necessario ricordarle tutte perché si fa capo ad una consolidata tradizione che risale agli antelami. Quando Antonio Agustoni di Cabbio qd Taddeo da una parte e Pietro di Valle Maggia del fu Giovanni Rampinelli di Cabio nel 1563 si accordano, leggiamo che hanno così convenuto: «detto Pietro debba stare con mastro Antonio per anni tre e mezzo a imparare l’arte del muro nella città di Genova e che in detto tempo mastro antonio si impegna a dare i debiti alimenti e vestimenti come se soleno dare per il padrone al garzone in Genova, eccetto le camise e scosali. Sarà pure tenuto a dare a Pietro £ 14 di Genova in robe o denari, e donargli uno scudo d’oro e i feramenti secondo gli ordini di Genova sopra tal arte disponenti. Inoltre dovrà dargli i soldi per il vitto del viaggio. Detti tre anni e mezzo si cominciano con le calende di marzo» 35. E quali sono questi usi imprescindibili dall’Arte, la corporazione dei maestri muratori, in cui i Lombardi sono sempre più dominanti a tal punto che nel 1518 vengono a costituire un ente distinto rispetto ai genovesi, corporazione in cui sono affiliati i cosiddetti Svizzeri e Spagnoli 36. Secondo quanto riferisce Di Raimondo nel suo saggio dedicato ai maestri muratori lombardi a Genova 37, chi voleva apprendere l’arte doveva restare al fianco del maestro prescelto per almeno cinque anni, impegnandosi a sottostare alla sua volontà, perché durante il tempo dell’apprendistato il maestro si assumeva la responsabilità di supplire il genitore. In quest’ottica si impegnava a fornire al discepolo la conoscenza e l’esperienza necessarie alla sua formazione. Quindi l’apprendistato per esse- ASGe, Camera Finanze 2785, 1778-1784, Conti di cantiere. G. Martinola, L’architetto Simone Cantoni (1739-1818), Bellinzona, 1950, pp. 38-40. 35 ASTi, Notarile, Fossati 357, 18 gennaio. 36 Gli Spagnoli sono le maestranze intelvesi, così identificate anche dopo il 1713. Cfr. A. Di Raimondo, Maestri muratori lombardi a Genova 1596-1637, Genova, 1976, pp. 7-8. 37 A. Di Raimondo, Ibidem, in particolare pp. 7-12. 33 34 28 Percorsi di ricerca 2/2010 re considerato valido doveva essere certificato legalmente con l’atto notarile conosciuto col termine di carta. All’atto pratico poi, come si è visto nei precedenti esempi, doveva anche mantenerlo di vitto, alloggio e vestiario, e proprio questo aspetto ha dato vita alla formula che ricorre nella redazione dei contratti di prendere in donzena o dozzina 38. Inoltre vanno messi a disposizione i ferri e le competenze di mestiere che vanno dalla modesta quadratura per lapicidi e piccapietre, all’arte della pittura architettonica per i frescanti 39. Infine, anche se l’apprendistato è concluso, il maestro resta conunque il garante delle abilità acquisite come dimostra l’attestato rilasciato ufficialmente a Carlo Antonio Maderno di Capolago che è stato con Giovanni Andrea Manni di Rovio per apprendere l’arte «o professione di scoltura intaglio o quadratura di marmore e tal accordio fu fatto per anni sei che fini l’anno 1702, et che detto Carlo habbi sempre osservato detto accordo con l’esser sempre stato et lavorato assiduamente …. et che si sia sempre deportato da giovine da bene, et d’honore et fedelmente et che in detto tempo habbi appreso sotto detto Giovanni Andrea Manni la suddetta arte nella città di San Remo della Serenissima Repubblica di Genova» 40. Maestri e discipuli E per tornare ai Cantoni, tre periodi in particolare li vedono nella veste di formatori. Un primo importante si situa intorno agli anni tra Cinque e Seicento: è il momento degli architetti, discendenti ed eredi del patrimonio culturale di Bernardino Agustoni detto Cantoni da Cabio, collaboratore dell’Alessi alla basilica di Carignano e pianificatore di Strada Nuova. Questi Cantoni sono contemporanei ad un’altra figura significativa della storia architettonica della città, Bartolomeo Bianco. Anche i Bianco come Agostino e Pier Francesco Cantoni hanno studenti, provenienti perlopiù dal ponente ligure, probabilmente già dei mastri che completano la loro formazione di architetto o perlomeno di capo d’opera presso queste personalità che emergono nel panorama urbanistico secentesco della Superba 41. Il secondo importante momento cade intorno alla metà del Settecento, quando l’apparato stucchivo viene a dominare le scene decorative incorniciando le opere a fresco; per i Cantoni plastificatori, per i loro collaboratori e per i loro garzoni si aprono i cantieri in cui il gusto francese è imperante. In questo periodo storico che vede il rifiorire di residenze cittadine e il sorgere di ville di delizia lungo il litorale ligure o sulle colline che attorniano Genova, i lavori in corso concomitanti richiesti da alcuni importanti committenti, quali i Durazzo e i Brignole, non possono essere trascurati, e anche in questi cantieri gli apprendisti non sono necessariamente dei giovinetti imberbi. L’assunta importanza della decorazione a stucco nelle dimore della nobiltà rinnovate vede, protagonista con i figli, Francesco Maria Cantoni che nella tradizione di famiglia rappresenta la svolta e fa dei Cantoni di Cabbio non più dei valenti capidopera o architetti ma degli specialisti nell’ornato. Francesco Maria (1699-1772) e i figli Pietro e Rocco, contano fra i loro allievi i già citati Bartolomeo Fontana di Muggio che in età matura lavorerà nei cantieri di Palazzo Ducale, Giuseppe Petondi, già Cfr. F. Cherubini, Dizionario milanese-italiano, Milano, 1839, p. 437. Un esempio a tal proposito è il contratto fra il pittore Camillo Fontana e Carlo Pellegata che consegna il figlio Giuseppe in ASTi, Oldelli 25 A-G, agosto 1786. 40 ASTi, Notarile, Franchini 2051, Mendrisio, 3 gennaio 1714. 41 A conferma della reputazione di questi architetti ricordiamo che Pier Francesco nel 1625 subentra quale Architetto Camerale a Bartolomeo Bianco, e che entrambi sono artefici dei palazzi di vai Balbi. Cfr. A. Di Raimondo, L. Muller Profumo, Bartolomeo Bianco e Genova, Genova, 1982; C. Di Biase, Strada Balbi a Genova, Genova, 1993; L. Leoncini (a cura di), Palazzo Reale di Genova. Studi e restauri 1993-1994, Genova, 1997. 38 39 29 Percorsi di ricerca 2/2010 ricordato, autore-scenografo dell’intero oratorio di Nostra Signora di Castello a Savona 42, Giuseppe Bossi di Monte e Carlo Fiandra di Castel San Pietro, raccomandato dalla famiglia dei Pozzi pittori e plastificatori con cui i Cantoni si sono apparentati dal momento che Pietro Cantoni ha sposato Zefirina Pozzi di Francesco 43. E poi lo Svanascini di Muggio, già attivo a Palazzo Ducale, che pure ritroviamo fra le maestranze che rinnovano Palazzo Rosso 44, altro rappresentante di una famiglia che con i Cantoni ha legami sia familiari sia di cantiere, specialmente nelle opere di costruzione o ristrutturazione realizzate per la potente famiglia Brignole; ed altri di più difficile identificazione presi per la sollecitazione di parenti o amici, presenze fugaci quanto quelle di collaboratori, forse precedenti allievi, cui si accenna nelle lettere o nelle note di conto delle giornate fatte. Il terzo momento è il segno nuovo dei tempi, rappresentato da Gaetano Cantoni. Nato a Genova dal capo d’opera Pietro intorno alla metà del secolo45, fratello del più noto Simone, completa la sua formazione presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti da poco istituita. Quindi nell’ambito dei numerosi incarichi pubblici che gli vengono attribuiti, nel 1807 è nominato Accademico di merito per la classe di architettura della stessa accademia che aveva frequentato e di cui sarà pure il direttore dal 1811 al 1814 46. Anche in questo caso la logica della continuità conferma questa vocazione di famiglia che però ora si confronta con i nuovi percorsi del sapere 47. E se apprendistato, famiglia e cantieri, sono per il passato gli ingredienti indissolubili per assicurare nel tempo la fortuna o meglio il successo di alcuni casati, la cultura delle accademie e poi dei politecnici si traduce in percorsi e destini nuovi di chi parte per imparare l’arte. Sulla figura e l’opera di Giuseppe Petondi di prossima pubblicazione il saggio di Luce Tondi, nel volume dedicato ai restauri di Nostra Signora di Castello in Savona, dal titolo I Petondi di Castel San Pietro, dalla Valle di Muggio alle corti d’Europa. 43 ASTi, Archivio Torriani, 266, lettere di Pietro Cantoni scritte al suocero (1772-1773). 44 Bianchi, Partir per Genova, cit., p. 294. 45 Secondo il Poleggi (cfr. Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1975, ad vocem) l’anno è il 1743, mentre in Simone Cantoni architetto, Milano, 2003, p. 350, N. Ossanna Cavadini indica il 1745. Per ciò che concerne cantieri e formazione si veda E. De Negri, Intorno ai Cantoni: capi d’opera e architetti a Genova a fine Settecento e la ricostruzione di Palazzo Ducale, in «Quaderni di storia dell’architettura», 2000, pp.103-120. 46 S. Rebaudi, L’architetto Gaetano Cantoni e la Parrocchiale di Pieve di Teco, in «Genova. Rivista del Comune», n. 11, 1943, pp. 22-26; Poleggi, Dizionario, cit., ad vocem. 47 N. Navone, L. Tedeschi (a cura di), La formazione degli architetti ticinesi nelle accademie di Belle Arti italiane fra il XVIII ed il XX secolo. Una prima indagine (di prossima pubblicazione). 42 30 Percorsi di ricerca 2/2010 Tremona-Castello. Scavi 2000-2008 e ultimi aggiornamenti Christiane De Micheli Schulthess 1. Introduzione e storia delle ricerche La collina denominata Castello (CN 1373, 718/083; ca. 650 msm), a nord dell’attuale villaggio di Tremona, è stata interessata da ricognizioni sul terreno e fotografie aeree fin dal 1988. Nel 1991, la fortuita scoperta di un ripostiglio monetale diede il via a una serie di ricerche sistematiche. Si procedette successivamente allo scavo di sette trincee conoscitive (1991-1993), a un’indagine geofisica (1992) e alla documentazione delle strutture emergenti tramite rilievo fotogrammetrico (1998). Nel 1999 venne fondata l’Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto (ARAM), il cui scopo principale è l’indagine sistematica del sito di Tremona-Castello. Le ricerche hanno permesso di definire che l’insediamento archeologico complessivo comprende: - il sito multiperiodico sulla collina di Castello (Fig. 1); - la necropoli della seconda Età del Ferro e d’epoca romana in zona Piasa, con 42 tombe; - il riparo sotto roccia e il crepaccio sulle pendici settentrionali della collina di Castello. Fig. 1. Rilievo delle strutture indagate nel 2000-2008 (nero), in fase di scavo (grigio scuro) e ipotizzabili dalla situazione in superficie (grigio chiaro) Fonte: Archivio ARAM - rilievi Ch. De Micheli Schulthess e GEOFOTO SA, Sorengo. Le indagini preliminari avevano rivelato che la collina è stata interessata dalla frequentazione umana a partire dal Neolitico, con continuità durante le epoche del Bronzo e del Ferro, il periodo romano, l’Alto e il Basso Medioevo. L’insediamento medievale, in particolare, risultava non aver subito alcun rimaneggiamento o distruzione in epoca moderna in quanto la continuità insediativa sembrava essersi interrotta nel Basso Medioevo. Non è a tutt’oggi chiaro se l’insediamento di Castello costituisse l’antecedente dell’attuale villaggio di Tremona. Le notizie storiche a riguardo sono scarse e manca un 31 Percorsi di ricerca 2/2010 riferimento preciso al sito. Solo quattro sono i documenti finora riferibili a Tremona 1 - anche se non tutti si riferiscono forse proprio a Tremona-Castello. Il primo, in ordine cronologico, è una notitia iudicati data a Milano nel marzo 864, in cui erano coinvolti il monastero milanese di Sant’Ambrogio e tre fratelli di Bissone per una proprietà in quel luogo. Vi viene citato un testimone, indicato come «… us de Tremona», il cui nome non è però più leggibile. Il fatto che il testimone potesse essere identificato con il luogo di provenienza lascia dedurre che, attorno alla metà del IX sec., Tremona fosse non solo un centro abitato, ma fosse anche noto ai presenti nel giudizio milanese. Il secondo documento è una cartula vendicionis giunta in copia sincrona, data a Mendrisio nel marzo 1033. In essa Arderico di Mendrisio vendeva al prete Arnolfo dello stesso luogo beni in diverse località, fra cui è citato il castrum di Tremona. Questo documento riporta, per la prima volta, la chiara citazione del nome della collina di Castello e fornisce indizi volti alla comprensione dell’aspetto del territorio e dell’organizzazione del lavoro agricolo dell’area che faceva capo a Tremona. Il terzo documento è un breve recordationis date sentencie del settembre 1170, giunto in copia del XIII secolo, dove si cita il montes de Tremona. Si tratta di una sentenza arbitrale nell’ambito della lite fra i Comuni di Como e di Milano circa i confini del Seprio e i relativi ambiti di pertinenza dei due Comuni. Dal documento, il montes de Tremona sembra rientrare nell’area di pertinenza comasca. Un quarto documento, nuovamente una cartula vendicionis, del 1426, menziona un terreno «sub castellum». Esso risale però a un’epoca in cui, almeno secondo le informazioni raccolte nel corso dell’indagine archeologica del terrazzo inferiore, l’insediamento è già distrutto e abbandonato da tempo. La collina costituisce l’ultima elevazione del gruppo del Monte San Giorgio prima della Pianura Padana ed è una rocca naturale costituita da dolomia e dolomia brecciata di origine giurassica. La sua sommità è costituita da due terrazzi che si estendono su un’area di ca. 3’500 mq, su cui si distribuiscono i resti degli edifici e della cinta difensiva dell’insediamento medievale. La sua posizione, che permette di controllare la zona di Mendrisio, l’estremità meridionale del Ceresio e ampi tratti del Comasco e del Varesotto, e i suoi versanti piuttosto ripidi, fanno della collina di Castello un luogo privilegiato per l’insediamento umano. Le sue pendici settentrionale e orientale sono caratterizzate da bruschi e notevoli salti di quota, mentre quelle occidentale e meridionale sono più dolci e caratterizzate dalla presenza di piccoli terrazzi. Sul versante nord, all’esterno della cinta muraria, un terrazzo è delimitato sul suo lato orientale da un profondo crepaccio. La sua esplorazione ha rivelato una massiccia presenza di ceramica pre- e protostorica e, seppur più esigua, anche di materiali d’epoca romana. Resta aperta la domanda sull’approvvigionamento d’acqua, raggiungibile solo ca. 200 m più a valle, di cui manca traccia sulla collina. L’intera area è parte del comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nel 2003 quale patrimonio mondiale dell’Unesco. 2. L’indagine del terrazzo inferiore (scavi 2000-2008) Nel 2000, l’associazione ARAM, in collaborazione con il Department of Archaeology and Prehistoric Studies dell’Università di Nottingham (GB) e con l’Ufficio dei beni culturali del Canton Ticino, Bellinzona, e sotto la direzione di Alfio Martinelli, diede inizio allo scavo sistematico del terrazzo inferiore dei due che costituiscono la sommità della collina di Castello. L’area di ca. 1’500 mq ha restituito parecchi edifici d’epoca medievale con un gran numero di reperti ed ha permesso di ritracciare M. Basile Weatherill, Appunti per una storia di Tremona, in Martinelli A. (a cura di), Tremona-Castello. Dal V millennio a.C. al XIII sec. d.C., Firenze, 2008, pp. 42-43. 1 32 Percorsi di ricerca 2/2010 la storia della frequentazione della collina fino al Neolitico. Lo scavo ha inoltre evidenziato la multiperiodicità della frequentazione della collina, le cui attestazioni sono consistenti soprattutto per il Neolitico, l’Eneolitico, il Bronzo finale, la prima Età del Ferro e il Basso Medioevo. Presenze durante la seconda Età del Ferro, la Romanità e l’Alto Medioevo sono attestate, ma con tracce più sporadiche. Il villaggio medievale, protetto da due cinte murarie, sorte probabilmente a breve distanza l’una dall’altra, rimase in uso dalla seconda metà del X sec. fino alla seconda metà-fine del XIII sec. d.C. 2.1. Preistoria e protostoria Reperti in selce, pietra verde levigata, cristallo di rocca e ceramica permettono di attestare una frequentazione della collina almeno durante tutto il Neolitico e di riconoscere le fasi del Neolitico Antico (Gruppo dell’Isolino, 5350-4800 a. C.), del Neolitico Medio (Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, 4800-3800 a. C.) con, del Neolitico Recente (Cultura di Lagozza, 3800-3300 a. C.) e del Neolitico Finale (Cultura dei Vasi Campaniformi, 2600-2200 a. C.)2. Non sono state rinvenute tracce sicure di un’occupazione del sito già nelle fasi più antiche del Neolitico, mentre un focolare, riferibile al Neolitico Medio, permetterebbe di documentare forse anche un’occupazione vera e propria a partire da quel periodo. La maggior parte dei reperti in selce, inoltre, è costituita da materiale locale, proveniente dal Monte San Giorgio o dal Monte Generoso; non si escludono però anche fonti di approvvigionamento di materia prima più lontane. L’Età del Rame è documentata da reperti in selce, di provenienza locale, e pietra. È anche attestata la Cultura del Vaso Campaniforme con diversi frammenti di ceramica. La successiva Età del Bronzo è scarsamente documentata fino alle sue fasi finali, quando la continuità insediativa riprende e continua durante tutta la prima Età del Ferro con reperti appartenenti alla Cultura di Golasecca (XI-V sec. a. C.). Necropoli o tombe isolate distribuite sul territorio cantonale indicano una frequentazione stabile del territorio durante la prima Età del Ferro. A Tremona la maggior parte dei materiali fittili risale proprio a questo periodo e rientra pienamente nella Cultura di Golasecca con recipienti in ceramica grossolana per uso domestico, contenitori per derrate alimentari e bicchieri in ceramica fine. Gli stessi livelli hanno restituito fibule in bronzo e un gran numero di strumenti in selce, a testimoniare che questo materiale continua ed essere in uso a Tremona anche durante l’Età di Ferro. La seconda Età del Ferro ha lasciato scarse tracce sulla collina, dove sono stati rinvenuti reperti in ceramica e metallo. Fra essi vi è la moneta più antica raccolta sul sito, una dracma in argento povero insubre con leggenda ρικοι 3. La presenza di un insediamento stabile nella zona è però confermata dai ritrovamenti nella necropoli in zona Piasa, a ovest dell’attuale villaggio, dove sono state riportate alla luce venticinque tombe a cremazione riferibili alla fase finale del periodo La Tène. 2.2. L’epoca romana La mappa dei ritrovamenti d’epoca romana nel Mendrisiotto 4, così come le vicine regioni del Comasco e del Varesotto, evidenzia numerose presenze sia nelle località lungo le sponde del Ceresio che A. Martinelli, Conclusioni, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., pp. 481 ss.; B. Cermesoni, Nota preliminare sui materiali neolitici e eneolitici, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., pp. 459 ss. 3 E. Arslan, Le monete di Tremona, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., p. 358. 4 P. Donati, Carta dei ritrovamenti romani nelle attuali terre del Canton Ticino, in «Quaderni di Numismatica e Antichità Classiche», n. 10, Supp. 1981, pp. 11 ss.; C. Simonett, Necropoli romane nelle terre dell’attuale Canton Ticino, Bellinzona, 1967-1971, pp. 33-43. 2 33 Percorsi di ricerca 2/2010 nelle aree collinose più lontane dal lago. La romanizzazione del Mendrisiotto, dovuta alla vicinanza di centri come Como e Milano, sembra accusare un leggero ritardo rispetto a quella delle regioni attorno al Verbano. Nei corredi funerari mancano, infatti, materiali tardo-repubblicani, presenti invece, pur sporadicamente, nelle necropoli del Locarnese. Lo stretto legame con Como è attestato dalle iscrizioni funerarie, menzionanti la carica pubblica di quatuovir in questo municipium, rinvenute a Riva San Vitale e Ligornetto, e quelle da Stabio e Gravesano, riguardanti quella di sevir 5. Le stesse iscrizioni indicano la presenza, nel Mendrisiotto e nel Locarnese, di persone appartenenti alla tribù Oufentina, di cui faceva parte Milano e che includeva anche il territorio di Como. Infine, l’iscrizione da Riva San Vitale ci informa che il vicus era abitato dai Subinates 6. I ritrovamenti, come spesso accade nel resto del Cantone e nelle zone limitrofe, sono prevalentemente da ascrivere all’ambito funerario. Accanto alle necropoli importanti per numero di sepolture come quelle di Stabio-Vignetto (49 tombe) e Melano (33 tombe), vi sono quelle che contano al massimo una decina di tombe e molte sepolture isolate. I corredi funerari situano cronologicamente le sepolture fra il I e il IV/V sec. d.C. Il rito predominante, come è tradizione nel mondo romano, è la cremazione, mentre l’inumazione viene in genere riservata alle sepolture più tarde. Non mancano però concrete tracce di insediamenti, finora identificati a Castel San Pietro, Mendrisio, Morbio Inferiore e Stabio. Nel caso di Mendrisio, inoltre, le indagini ancora in corso potrebbero rivelare, per la prima volta, l’effettiva estensione di una villa romana nel Sottoceneri. A Tremona, come nei vicini comuni di Besazio, Meride, Rancate e Stabio, le tracce della presenza romana sono numerose. Già alla fine dell’Ottocento veniva segnalata la scoperta di un ripostiglio di cinque monete di II e III sec. d.C. lungo la strada per Sant’Agata, mentre alcune sepolture romane contenenti fittili e monete di III sec. d.C. furono riportate alla luce in zona Piasa, nel porre le fondazioni della Sala Sociale, ora Sala della Musica 7. I successivi ritrovamenti riferibili all’epoca romana si situano nella stessa zona Piasa, a ovest del villaggio odierno. Accanto alle tombe della seconda Età del Ferro, la necropoli in zona Piasa conta diciassette sepolture databili fra il I e il V sec. d.C. Le sepolture rinvenute a Tremona-zona Piasa attestano due importanti riti funerari: quello della cremazione secondaria e quello dell’inumazione. La cremazione secondaria implica la presenza di un ustrinum distinto dal luogo di sepoltura, nel quale spesso vengono trasportati anche i resti del rogo. A Tremona le sepolture analizzate non sono in semplice fossa, ma presentano tutte elementi di protezione come l’anfora segata e le cassette in laterizi, in pietra o in pietra e laterizi. Le offerte sono generalmente collocate nella tomba al momento della sepoltura. Anche le due inumazioni, d’epoca più tarda rispetto alle cremazioni, sono delimitate Il quatuovir si occupava di amministrare la giustizia e curava gli edifici pubblici e le strade. Il sevir era un magistrato di grado modesto, col compito di mantenere l’ordine nelle città e nei villaggi. Durante il periodo imperiale questa carica era generalmente rivestita da plebei o liberti. 6 Ch. De Micheli Schulthess, Aspects of Roman Pottery in Canton Ticino (Switzerland), BAR International Series 1129, Oxford, 2003, p. 16. 7 Questi materiali venivano però già dati come dispersi nel 1947 (A. Ortelli, Contributo alla conoscenza dell’archeologia del Mendrisiotto, in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», Serie 4, Anno 22, 1947, pp. 190-201). 8 La pratica incineratoria non costituisce il rito originario presso i Romani, ma si diffonde rapidamente tanto da diventare il rito predominante almeno fino alla metà del II sec. d.C. Successivamente, si assiste ad un costante aumento dell’inumazione, rito che si impone definitivamente durante i secoli III-IV d.C. (F. Airoldi, Le incinerazioni in età tardoromana: caratteristiche e diffusione del fenomeno, in M. Sannazaro (a cura di), Ricerche archeologiche nei cortili dell’Università Cattolica. La necropoli tardoantica, Atti delle giornate di studio, Milano, 25-26 gennaio 1999, Contributi di Archeologia 1, Milano, 1999, pp. 115-124). Il Canton Ticino presenta una situazione particolare (De Micheli Schulthess, Aspects of Roman Pottery, cit., pp. 14-16). Nelle necropoli romane del Sopraceneri il rito predominante è l’inumazione. Le cremazioni sono rare e sembrano limitarsi alle zone con maggior contatto diretto con il mondo romano. Nel Sottoceneri, invece, la cremazione è il rito predominante dall’Età del Ferro e continua ad esserlo fino al II sec. d. C. 5 34 Percorsi di ricerca 2/2010 da embrici o embrici e lastre di pietra posti a coltello 8. A sud della necropoli sono state riportate alla luce anche alcune suspensurae, forse appartenenti a una villa o altra costruzione di tipo civile che, con la loro presenza, ne definiscono il probabile limite meridionale 9. Sulla collina di Castello il periodo romano è invece finora attestato solo da oggetti privi di contesti stratigrafici sicuri, che non hanno permesso di collegarli a fasi d’occupazione o strutture vere e proprie 10. Non si tratta però neppure di ritrovamenti sporadici, ma essi vanno riferiti con buone probabilità ad attività insediative di tipo civile o militare. Il gruppo di reperti più consistente è costituito dalle monete. Le ricerche hanno restituito un probabile asse in bronzo romano-repubblicano e venticinque monete in bronzo databili fra il II e il IV sec. d.C., alcune delle quali rinvenute nei livelli medievali. La loro presenza, in particolare negli strati di livellamento, sembra confermare un’occupazione della sommità della collina anche in epoca romana. Restano però ancora da definire l’ubicazione delle strutture e la natura dell’occupazione. Fra gli altri reperti d’epoca romana si contano la protome di una statuetta bronzea raffigurante Mercurio, genericamente databile fra la seconda metà del I e il II sec. d. C., dei frammenti di ceramica comune e in particolare di vasi a listello databili nel III-IV sec. d.C., e alcuni oggetti in metallo e pietra. In particolare, un frammento di lastra in Porfido Verde Antico di Laconia (Grecia) potrebbe attestare l’importanza degli scambi in epoca romana. Il quadro generale riguardante gli insediamenti d’altura dell’Italia settentrionale indica una preferenza per l’ambiente collinare, in prossimità delle principali vie di comunicazione. La maggior parte degli insediamenti, che si sviluppano sulla sommità dei rilievi fra i 300 e i 600 msl, copre una superficie di 1’000-6’000 mq. Se, almeno nel caso dell’Italia nordorientale, raramente si riscontra una vera e propria continuità insediativa nel tempo fra l’età preromana e quella romana o fra l’età romana e quella medievale, è frequentemente attestata la continuità insediativa nello spazio, con la rioccupazione del sito e l’eventuale riuso delle strutture. Dalla seconda metà del VI sec. d. C., in particolare, sono attestate tipologie abitative semplici, che spesso si inseriscono su resti di precedenti costruzioni più articolate e di dimensioni maggiori 11. Il sito di Tremona-Castello presenza forti analogie con gli insediamenti d’altura 12. Si sviluppa infatti sulla sommità di una collina a quota 640-650 msl e occupa una superficie di ca. 3500 mq. La presenza di ceramica d’insediamento d’epoca romana, unitamente ad altri reperti coevi, rende ipotizzabile un’occupazione in questo periodo, che trova conferma anche nella necropoli e nei resti di strutture rinvenuti in zona Piasa. Una concentrazione di oltre dieci monete proviene dalla zona dell’attuale accesso al sito, dove venne rinvenuta anche la maggior parte della cera-mica. Ciò sembrerebbe indicare il settore nord-ovest del pianoro inferiore dell’insediamento medievale come il più interessato, almeno per ora, dalla presenza di materiale d’epoca romana. Dal pianoro superiore, ancora poco investigato, provengono però anche alcune monete e la chiave in ferro. La datazione delle monete, riferibili 9 L’uso di situare le necropoli a ridosso di un rilievo è osservabile anche in numerosi altri casi nel Canton Ticino (De Micheli Schulthess, Aspects of Roman Pottery, cit., p. 26). 10 Ch. De Micheli Schulthess, Reperti romani dalla necropoli e dal sito di Tremona, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., pp. 423444. 9 G. Bigliardi, L’insediamento fortificato d’altura nel Caput Adriae: dati distributivi e problemi di continuità cronologica, pp. 138 ss.; C. Magrini, Tipologie abitative e tecniche costruttive negli insediamenti d’altura nell’arco alpino orientale fra Tarda Antichità e Altomedioevo, pp. 153-162. Entrambi i contributi in G. Cuscito, F. Maselli Scotti (a cura di), I borghi d’altura nel Caput Adriae. Il perdurare degli insediamenti dall’Età del Ferro al Medioevo, Atti del Convegno Internazionale di Trieste, 5-6 dicembre 2003, Trieste, 2004. 10 Ch. De Micheli Schulthess, Reperti romani dalla necropoli, cit., pp. 423-444. 11 Bigliardi, L’insediamento fortificato, cit., pp. 138 ss.; Magrini, Tipologie abitative, cit., pp. 153-162. 12 F. Masselli Scotti F., Muggia Vecchia: le frequentazioni più antiche, in Cuscito, Maselli Scotti, cit., pp. 15 ss., con l’esempio di Muggia Vecchia. 35 Percorsi di ricerca 2/2010 ai sec. I-IV d.C., corrisponde a quella della ceramica, per la quale, considerata l’estrema frammentarietà dei pezzi, è spesso difficile proporre una datazione più precisa. 2.3. Il Medioevo I caratteri dell’insediamento L’insediamento medievale si estendeva sui due terrazzi che costituiscono la sommità della collina. Fra il 2000 e il 2008 fu investigato il terrazzo inferiore, dove furono riportati alla luce ventisette edifici (Fig. 2). Quindici edifici sono disposti su tre file orientate est-ovest, mentre gli altri si allineano rispettivamente sul limite meridionale e su quello sud-occidentale dell’insediamento. L’attuale disposizione degli edifici è quella relativa alla fase finale dell’insediamento. L’analisi delle congiunzioni dei muri hanno, infatti, permesso di verificare che gli edifici delle file interne si sono sviluppati da ovest verso est e che il villaggio è stato costantemente ampliato e l’ubicazione del suo accesso è cambiata più volte. Fig. 2. Veduta dall’alto del settore indagato nel 2000-2008 Fonte: Archivio ARAM, fotografia A. Martinelli. Gli indizi forniti dalla stratigrafia dell’insediamento e dai reperti hanno permesso di distinguere diverse fasi dell’insediamento medievale. La prima presenza insediativa stabile confermata è situabile, grazie ai ritrovamenti monetali fra la prima metà del X e prima metà dell’XI sec., confermati dalla datazione al radiocarbonio dei piani d’uso più antichi di due edifici. In questa fase, alcuni degli edifici investigati sono già presenti, ma si tratta generalmente di edifici isolati. La cortina muraria è leggermente sotto il margine del terrazzo e l’accesso è probabilmente sul lato nord-ovest della collina, lungo il terrazzo superiore. Questa fase non corrisponde alla prima fase insediativa medievale in assoluto, perché alcuni edifici sembrano essere già essere stati soggetti a dei rimaneggiamenti. La presenza dell’opera di difesa inserisce Tremona-Castello nel periodo d’intenso incastellamento avvenuto nell’Italia settentrionale a seguito della grande instabilità politica del periodo. Fra la seconda metà dell’XI e prima metà del XII sec. si assiste a una fase di abbandono o distruzione delle strutture, attestata dall’accumulo di materiale di crollo negli edifici e che rialza il piano della Strada Ovest di ca. 50 cm. Nel corso della seconda metà del XII sec. il villaggio viene ricostruito e ampliato fin quasi alle dimensioni attuali, chiudendo gli accessi nei muri meridionali degli edifici delle file interne e aprendone di nuovi nei muri settentrionali. L’insediamento viene provvisto di una nuova cinta muraria lungo il 36 Percorsi di ricerca 2/2010 margine del terrazzo e il suo accesso è spostato nella metà sud-ovest del terrazzo inferiore. La presenza di un numero cospicuo di monete fa risalire la fase di massima espansione di TremonaCastello alla metà-fine del XII sec., periodo che coincide con anni di relativa tranquillità e di grande sviluppo economico di Milano e di Como, dopo la pace di Costanza. Durante il XIII sec. si hanno pochi cambiamenti. L’accesso, sempre sul lato occidentale, viene spostato nel punto di contatto fra i due terrazzi demolendo un edificio e corrisponde a quello attuale. In un momento successivo, il precedente accesso viene trasformato prima nell’officina di un fabbro e poi in un’abitazione. Dai reperti e dai dati di scavo, la fine dell’occupazione del terrazzo inferiore si situa nella seconda metà o alla fine del XIII sec. Uno strato d’incendio, che ha interessato tutti gli edifici investigati e nel quale sono stati rinvenuti numerosi attrezzi di lavoro e notevoli quantità di cereali carbonizzati, lascia supporre un abbandono improvviso del villaggio. La massiccia presenza di punte di freccia nel settore sud-occidentale del terrazzo inferiore, il più facilmente attaccabile, suggerisce un attacco dall’esterno. La fine di Tremona, dopo la metà del XIII sec., può rientrare nel nuovo periodo d’instabilità provocato nell’Italia settentrionale dalle lotte fra i Visconti e i Torriani; furono coinvolte anche le terre del Ticino quando i Visconti conquistarono Bellinzona e distrussero Mendrisio nel 1242. I reperti 13 Caratteri generali La lunga frequentazione del sito e il suo probabile abbandono repentino hanno permesso il recupero di un gran numero di oggetti relativi alla suppellettile domestica. Sono molto ben rappresentate le diverse classi di materiali con una sola eccezione – la ceramica– che manca quasi completamente fra i reperti raccolti sul pianoro inferiore. Questo fatto è di per se eccezionale, poiché la ceramica è, generalmente, la classe di materiale meglio rappresentata su qualsiasi sito archeologico. La zona non mancava di depositi d’argilla, il cui sfruttamento è attestato dall’epoca preistorica fino a quella moderna 14. A compensare la mancanza di ceramica, sono invece stati rinvenuti frammenti di pietra ollare, appartenenti al gruppo dei talcoscisti dell’area alpina centrale, riferibili soprattutto a recipienti tronco-conici. Sono lavorati al tornio orizzontale e l’assenza di rifiniture decorative li colloca cronologicamente nel Basso Medioevo. È interessante rilevare che quasi tutti i frammenti presentano tracce di fumigazione, confermando così il loro impiego per la cottura dei cibi; numerosi sono quelli che mostrano interventi di riparazione con fili metallici e i relativi forellini passanti. Accanto alla pietra ollare sono presenti anche i frammenti di vetro verdastro riconducibili a bicchieri, coppette e lucernette pensili. È plausibile l’ipotesi che, al posto del vasellame ceramico, venissero utilizzati recipienti in legno e cesti per la conservazione e il consumo dei cibi. L’indagine archeologica ha finora restituito quasi 2’000 reperti in metallo. Si tratta di oggetti in ferro (90%), in lega di rame (9%) e in altri metalli come l’argento, lo stagno e il piombo (1%). Il loro stato di conservazione, grazie alle particolari caratteristiche del terreno, è generalmente ottimo ed ha quindi permesso una loro chiara identificazione. La tipologia degli oggetti è estremamente variata ed è riconducibile a un villaggio fortificato ma occupato da persone dedite alle tipiche attività che caratterizzano una piccola comunità rurale: chiodi e borchie, strumenti per la lavorazione del legno e della 13 14 Per una discussione dettagliata delle diverse classi di materiali, cfr. la monografia di Martinelli, Tremona-Castello, cit. Formaci di laterizi a Besazio e a Riva San Vitale. 37 Percorsi di ricerca 2/2010 pietra, per il cucito e la lavorazione della pelle, coltelli, attrezzi per il lavoro nei campi, acciarini, portacandele, ganci, ferri di cavallo e di bue, finimenti, serramenti, strumenti da pesca, oggetti per l’abbigliamento, sonagli, anelli, applicazioni per stoffa o cuoio. Gli oggetti per l’abbigliamento e la persona rinvenuti a Tremona comprendono le fibbie, i bottoni, gli anelli da dito, gli spilloni e gli elementi da applicare su stoffa, cuoio o legno. Le fibbie e fibbiette sono il gruppo più numeroso. Realizzate in ferro e lega di rame, venivano usate sia per l’abbigliamento (abiti e calzature) o l’armamento sia per i finimenti degli animali. Se il numero di reperti in lega di rame o in altri metalli è piuttosto limitato rispetto a quelli in ferro, essi sono di buona qualità e fattura. Parecchie fibbie in lega di rame sono decorate al punzone. Tre fibbie, inoltre, presentano anche resti di doratura con foglia d’oro e di inserti in pasta vitrea. La somiglianza nello schema generale di questi tre oggetti lascia supporre la mano di uno stesso artigiano. Il rinvenimento di una pietra di paragone, usata per analizzare il contenuto d’oro e di altri metalli nobili, e di oggetti relativi alla lavorazione dell’argento e delle leghe di rame lasciano ipotizzare la presenza, almeno occasionale, di artigiani specializzati. Malgrado la posizione strategica del sito, se si escludono le punte di freccia, sono invece piuttosto limitate le armi, costituite da punte di lancia o giavellotto, spade e pugnali con i relativi accessori. Le punte di freccia, la cui attribuzione all’arco o alla balestra è per alcuni tipi ancora aperta, rappresentano la categoria di reperti in ferro numericamente e qualitativamente meglio rappresentata a Tremona, con diciassette diversi tipi comprendenti le tipologie militari dal X al XII secolo. Sono stati anche rinvenuti oggetti reperti pertinenti alla lavorazione sul posto del ferro, delle leghe di rame, dell’argento, del piombo e dello stagno. Nel caso specifico del ferro, le numerose scorie di fusione provano che vi veniva fuso; un piccolo ripostiglio di rottami e le barre di ferro ne indicano invece la rifusione. Si tratta di una consuetudine facilmente spiegabile, considerando che l’area in esame è totalmente priva di questo minerale. Un edificio è caratterizzato dalla massiccia presenza di scorie di fusione, di cenere e di carbone, di un focolare e di una lastra che poteva fungere da piano d’appoggio per un mantice. Fra le attività artigianali attestate a Tremona un posto di rilievo spetta a filatura, tessitura, cucito e lavorazione della pelle. Oltre alle ossa di ovini, allevati dagli abitanti del villaggio, sono infatti state rinvenute una cinquantina di fusaiole in pietra ollare o terracotta, un peso da telaio per telai verticali, dei frammenti di tempiali, dei denti di pettini da cardatura, i resti della ruota di un arcolaio, aghi di diverse dimensioni in ferro, corno e osso, ditali e lesine per la lavorazione della pelle. Un frammento carbonizzato di ruota di arcolaio conservava ancora, negli intagli per lo scorrimento del filo, fibre vegetali (ginestra marittima?) di provenienza sicuramente non locale. Con lo stesso materiale furono realizzati i frammenti di tessuto carbonizzato rinvenuti accanto a batuffoli di fibra grezza. Le monete Nel 1991, nel corso della bonifica del terreno dai bossoli abbandonati durante e dopo la Seconda Guerra mondiale, fu rinvenuto un ripostiglio di 804 monete, suddivise in 701 Denari Terzoli scodellati di Milano a nome di Enrico e 103 Denari piani Inforziati con bisanti di Cremona per Federico I, la cui emissione è praticamente contemporanea e si situa dal 1166 per Cremona e dal 1167 per Milano. Oltre a quelle del ripostiglio, sono finora venute alla luce altre 150 monete medievali, fra cui anche quattro Denari Terzoli milanesi contraffatti 15. La serie di ritrovamenti monetali a Tremona documenta un’occupazione stabile della collina dal X al XIII sec. Il numero di monete recuperate è inizialmente ridotto per la fase di X e XI sec., ma le mo15 Arslan, Le monete di Tremona, cit., pp. 357-358. 38 Percorsi di ricerca 2/2010 nete rinvenute sono piuttosto rare. La più antica emissione monetale medievale è rappresentata da un Denaro milanese di Lotario II (945-950). A esso si aggiungono, a documentare la fase di X-XI sec., due denari pavesi, uno di Lucca e una decina di denari milanesi, indicando che la circolazione monetale nella zona avveniva solo tra le emissioni monetali delle zecche italiane di Milano e Pavia (e, più isolatamente, di Lucca). Fra le monete rinvenute sul sito, vi è un’interruzione cronologica dopo i Denari milanesi di Corrado II di Franconia (1026-1039), fino a dopo la metà del XII sec., per riprendere con emissioni delle zecche di Milano, Cremona e Brescia per la seconda metà del XII sec. e di Mantova, Pavia e Bergamo per il XIII sec. Un solo ritrovamento isolato, costituito da un Sestino di Lucca di XV sec., testimonia una frequentazione successiva, ma forse solo sporadica, dell’area. Agricoltura e allevamento I numerosi resti vegetali e animali hanno permesso di capire che gli abitanti erano dediti all’agricoltura e all’allevamento del bestiame. Il materiale archeobotanico relativo all’insediamento bassomedievale è stato esaminato presso il Laboratorio di Archeobotanica del Musei Civici di Como 16. Fra i cereali sono documentati soprattutto la segale, il frumento, il miglio e il panìco. Più ridotta, ma significativa, è la presenza di sorgo, mentre orzo, farro e avena sono poco rappresentati tanto da sembrare quasi degli infestanti. Per quanto attiene alle leguminose, a Tremona sono ben attestati piselli e cicerchie; più limitata è la presenza di ceci, favino e lenticchie. La veccia potrebbe essere anche pianta infestante. La frutta proveniva quasi solo da piante coltivate. I resti carpologici attestano la presenza di castagne, noci, nocciole, uva, nespole e pere. La raccolta di frutti selvatici è attestata solo dalla presenza di alcune corniole. Numerosi frammenti lignei combusti, presenti come rami e come pezzature maggiori, testimoniano l’uso di legno di conifere e di latifoglie per realizzare scaffalature o parti di mobili (conifere e castagno, presente in quantità maggiori rispetto a oggi), manici di attrezzi (frassino) o graticci. Semi, frutti e cariossidi sono stati rinvenuti nell’esteso strato d’incendio che sigillava l’ultima fase d’occupazione dell’insediamento. La loro distribuzione orizzontale indica come solo alcuni edifici ne fossero interessati, alcuni dei quali possono senz’altro essere riconosciuto come depositi di derrate alimentari. L’assenza di spighe e la scarsità di semi di piante infestanti indicano un immagazzinamento di chicchi già pronti per le diverse preparazioni ed esclude attività di processamento dei raccolti in questi ambienti. La preminenza a Tremona di cereali “minori” come il panìco e il miglio, meno esigenti e più resistenti, ne dimostra il ruolo decisivo nell’agricoltura medievale. La tendenza a diversificare le specie, osservabile in questo periodo anche nel resto dell’Europa per i cereali, appare anche per le leguminose. La diversità di colture con modalità di semina diverse potrebbe lasciar ipotizzare la pratica della rotazione agraria. Nei campi nelle vicinanze dell’insediamento erano coltivati segale, frumento, favino, vecce e lenticchie a semina invernale, mentre miglio, panìco e sorgo vanno seminati in primavera. Piselli, cicerchie e ceci, a semina primaverile, erano invece piuttosto coltivati negli orti. Sui pavimenti delle abitazioni sono stati rinvenuti ca. 3000 frammenti di ossa pertinenti a diversi animali fra cui si riconoscono soprattutto bovini, suini e ovicaprini o pollame 17. Meno frequenti sono gli equini, i cani e i gatti. La selvaggina è attestata con ossi di cervo, capriolo, lepre e, più isolatamenE. Castiglioni, L. Peña-Chocarro, E. Rettore, Agricoltura e alimentazione in un insediamento medievale attraverso lo studio archeobotanico, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., pp. 402 ss. 17 E. Walder, I reperti ossei: resoconto preliminare, in Martinelli, Tremona-Castello, cit., pp. 390 ss. 16 39 Percorsi di ricerca 2/2010 te, di carnivori. Scarsi, ma presenti, sono i resti appartenenti a pesci. Molti frammenti recano segni di macellazione, incisioni e troncamenti, peraltro completamente assenti sulle ossa dei volatili. La distribuzione verticale dei frammenti sembra interessare tutte le fasi cronologiche, mentre quella orizzontale conferma una funzione diversificata dei diversi edifici. I resti di animali sembrano, infatti, essere più frequenti in quegli edifici dove sono stati anche rinvenuti dei focolari e sono attestate delle attività domestiche, mentre mancano quasi completamente negli ambienti identificabili come depositi. I manufatti in osso rinvenuti a Tremona sono pochi, ma significativi. Si tratta di due agorai, di due aghi in osso e in corno, un dado da gioco, di punteruoli e di manici per coltelli. 3. Nuovi aggiornamenti Dalla fine del 2008, l’indagine archeologica è stata estesa anche al terrazzo superiore della collina, dove sono stati portati alla luce altri edifici in muratura. I primi dati indicano una diversa organizzazione spaziale degli edifici, una più accurata esecuzione delle strutture murarie e la presenza di reperti finora molto rari come la ceramica medievale. I frammenti sono pertinenti a ceramica a vetrina piombifera verde, in uso a partire dal XIII-XIV sec., e a graffita arcaica attardata, riferibile ai secoli XIV –XV. Questi elementi permettono di estendere cronologicamente l’occupazione della collina, o almeno del terrazzo superiore, ai secoli XIV-XV, mentre i dati emersi dal terrazzo inferiore indicano chiaramente una distruzione e un abbandono definitivi dell’area entro la metà-fine del XIII sec. Uno degli edifici ha restituito, oltre alla ceramica invetriata verde, anche diversi bottoni in bronzo argentato e un elemento decorativo in bronzo dorato con inserti in pasta vitrea, simile nell’esecuzione alle tre fibbie con resti di doratura con foglia d’oro e di inserti in pasta vitrea dal terrazzo inferiore. Si tratta, apparentemente, di oggetti di un certo pregio, che potrebbero indicare una divisione anche sociale fra i due pianori della collina. Infine, è stato individuato e riportato alla luce un terzo accesso all’insediamento, verosimilmente il più antico (Fig. 3). Realizzato con tecnica e materiali particolarmente curati, come pietre ben squadrate e abbondanza di buona malta di calce, è stato successivamente chiuso quando un secondo accesso è stato aperto sempre nella cortina occidentale, ma verso il limite sud. La sua indagine dovrebbe permettere di individuare il piano di calpestio esterno della via d’accesso all’insediamento e i successivi piani di calpestio all’interno, risalenti al periodo in cui l’accesso era ancora in uso e alle fasi dei suoi rimaneggiamenti successivi. Fig. 3. Accesso nord, veduta da ovest Fonte: Archivio ARAM, fotografia Ch. De Micheli Schulthess 40 Percorsi di ricerca 2/2010 Vincenzo Dalberti e le rivoluzioni dell’Elvetica e della Mediazione al sud delle Alpi (dal tramonto dell’Ancien Régime al 1814) Manolo Pellegrini Oggetto della nostra analisi è la figura di Vincenzo Dalberti (1763-1849), in quanto protagonista dei profondi cambiamenti che toccarono le terre svizzere al sud delle Alpi tra il 1798 e il 1814. Prenderemo perciò in considerazione la personalità di Dalberti su un arco di tempo limitato rispetto al suo percorso di vita: dall’Ancien Régime fino alla fine del regime della Mediazione. Questo periodo temporale, nelle terre svizzere al sud delle Alpi, è ricco di innovazioni sul piano politico, innovazioni condizionate dall’influenza della Francia post rivoluzionaria del direttorio e di Napoleone e che sono al centro del nostro interesse. Prima di analizzare le prese di posizione e l’azione di Vincenzo Dalberti nel periodo dell’Elvetica e della Mediazione, cercheremo di chiarire le sue origini famigliari e sociali al fine di capire le sue scelte. A sua volta la sua biografia ci darà preziose informazioni sul contesto in pieno mutamento nel quale operava. Vincenzo Dalberti, figlio di cioccolatai di origine bleniese attivi a Milano, nacque nel capoluogo lombardo nel marzo del 1763 e lì si formò culturalmente: dapprima presso l’ateneo Arcimboldi a S. Alessandro, poi al collegio di S. Alessandro e infine alle scuole di Brera, dove terminò i suoi studi nel 1783 1. Proprio in quell’anno ebbe occasione di recarsi in valle di Blenio a Olivone, paese di origine dei suoi genitori e sottoposto al dominio di tre cantoni della vecchia Confederazione svizzera. Il padre, Giovanni Domenico Dalberti (1733-1814), pur essendo attivo a Milano, aveva ancora stretti legami con la valle: sua moglie Anna Maria Barrera (1741-1822), la madre di Vincenzo Dalberti, era nata a Olivone e aveva ricevuto in dote delle proprietà; lo stesso Giovanni Domenico Dalberti possedeva proprietà sul territorio del comune che gli permettevano di rimanere membro della vicinanza di Olivone. La vicinanza gestiva le proprietà collettiva e gli affari della comunità 2. Ciò spiega la facilità con la quale Vincenzo Dalberti fosse stato sollecitato nel 1783 a divenire titolare di un beneficio ecclesiastico legato alla vicinanza, creato nel 1740, e rimasto vacante. Dalberti accettò di assumerne l’onere in cambio di una modesta rendita, che tuttavia non era sufficiente. Il padre dovette inizialmente sostenerlo finanziariamente, poi con il suo aiuto e quello del cugino, Giovanni Pietro Dalberti (1765-1821), anch’esso attivo a Milano nella produzione e nella vendita di cioccolata, poté accrescere le sue proprietà in valle, tanto da usufruire di una rendita più elevata, che gli permetteva di vivere con un certo agio3. La presenza della famiglia Dalberti nello stesso tempo a Olivone, con il possesso di proprietà e l’appartenenza alla vicinanza, e nel capoluogo lombardo, con le attività commerciali, non era una situazione eccezionale. La famiglia Dalberti, analogamente ad altre originarie dell’alta valle, reinvestiva parte dei profitti risultanti dai commerci e manteneva un legame sociale e affettivo con il paese di origine. Un terzo delle famiglie olivonesi era dislocato nelle città del nord Italia o altrove in Europa, G. Martinola, Vincenzo Dalberti, in «Epistolario Dalberti-Usteri 1807-183», Bellinzona, 1975, p. IX. Cfr. con P. Caroni, Le origini del dualismo comunale svizzero, Milano, 1964, pp. 260-263. 3 Cfr. con la corrispondenza tra Vincenzo Dalberti e suo padre Giovanni Domenico Dalberti, in Archivio di Stato del Canton Ticino (ASTi), Fondo Staffieri, scatola 3C. 1 2 41 Percorsi di ricerca 2/2010 dove aveva interessi commerciali, soprattutto nel settore della cioccolata. Si pensi all’esempio della famiglia di Giovanni Martino Soldati (1747-1831), che aveva un emporio ad Amsterdam e interessi nel nord Italia, pur mantenendo il proprio radicamento a Olivone 4. I lavori di Luigi Lorenzetti 5 sull’emigrazione in seno alla comunità di Aquila, adiacente a quella di Olivone, confermano le indicazioni in questo senso. Non sorprende perciò che Dalberti non recise i legami con Milano, dove aveva fatto dei tentativi, ancora alla vigilia della rivoluzione del 1798, di potersi trasferire assumendo la responsabilità di un beneficio6. Soprattutto manteneva strette connessioni con l’irraggiamento culturale della città, così come con la famiglia, presso la quale si recava sovente per lunghi periodi. Progressivamente, con l’aiuto di amici milanesi che lo rifornivano, si era costituito una biblioteca personale 7 che tradiva i suoi interessi per l’illuminismo europeo, francese e lombardo soprattutto; un’edizione dell’«Encyclopédie», le opere di Rousseau, Montesquieu, Voltaire vi erano ben rappresentate, così come trovavano il loro posto quelle del Verri, del Beccaria e di Filangeri. Al contrario nella sua biblioteca erano piuttosto scarsi i testi religiosi, fatto che potrebbe sembrare un po’ anomalo, considerando che Dalberti aveva ricevuto gli ordini sacerdotali nel 1786 8. Tuttavia, se dobbiamo dar credito a Giuseppe Piazza, che lo conobbe personalmente, Dalberti non aveva una grande empatia con le gerarchie ecclesiastiche e si era ripromesso di restare semplice abate 9. Tra il 1783 e il 1798, Dalberti visse tra l’alta valle di Blenio e Milano, pronunciando messe in memoria di Onofrio Bianchini, componendo poesie e sonetti, scrivendo discorsi religiosi a forte carica morale e, a Olivone, impartendo corsi di scuola elementare 10. Occasionalmente si trovò in contrasto sia con le autorità religiose, che con quelle dei balivi della valle 11. Nel 1798, quando il regime della Confederazione dei tredici cantoni cadde in seguito all’intervento francese e venne proclamata la Repubblica elvetica, fu l’occasione per lui, come per molte altre personalità con un elevata formazione culturale, di impegnarsi nel campo politico e pubblico, campo dal quale in precedenza, per la sua origine sociale, era escluso 12. In questo senso Vincenzo Daberti era rappresentativo del suo tempo: si era costruito grazie allo studio e al merito, ma le possibilità di carriera erano per lui limitate. Gli incarichi pubblici erano riservati ai figli di notabili legati da generazioni al regime dei balivi. Proprio perché con l’avvento dell’Elvetica Dalberti si investì nel campo politico pubblico, il suo percorso biografico ci permette di analizzare l’impatto delle trasformazioni politiche indotte dalla repubblica in valle di Blenio e nel cantone di Bellinzona (prefettura dell’Elvetica) prima, e del Cantone Ticino (creato dal regime della Mediazione napoleonica) poi. Nel contempo l’approccio biografico, Cfr. R. Ceschi, Bleniesi milanesi, note sull’emigrazione di mestieri dalla Svizzera italiana , in «Bollettino storico della Svizzera italiana» (BSSI), vol. CII, Bellinzona, 1991, pp. 67-71. 5 L. Lorenzetti, Economie et migrations au XIX siècle: les stratégies de la reproduction familiale au Tessin, Bern, 1999. 6 Cfr. con la corrispondenza tra Vincenzo Dalberti e suo padre Giovanni Domenico Dalberti, in ASTi, Fondo Staffieri, scatola 3C. 7 T. Fiorini, La biblioteca di Vincenzo Dalberti, Bellinzona, 1991. 8 Cfr. con R. Ceschi, La biblioteca di un uomo di Stato, in «La biblioteca di Vincenzo Dalberti», Bellinzona, 1991, pp. 22-25. 9 G. Piazza, Vincenzo Dalberti, notizia necrologica, Lugano, Veladini, 1849, p. 4. 10 Cfr. in particolare con la corrispondenza tra l’amico Carlo Uberti e Vincenzo Dalberti, ASTi, Fondo Bolla, scatola I, cartone 3. 11 Cfr. con le lettere scritte da Vincenzo Dalberti riguardo l’affare Sozzi-Uberti tra il 1790 e il 1791, in ASTi, Fondo Piazza, scatole 37 e 38, fascicolo 1. 12 Sulla questione cfr. in particolare con R. Ghiringhelli, Les élites culturali alla fine dell’Ancien Régime, in «BSSI», volume CV, 2002 e M. Chiaruttini, Il clero della Svizzera italiana tra rivoluzione e reazione (1798-1799), in «Archivio Storico», n. 126, anno 36, dicembre 1999, pp. 89-116. 4 42 Percorsi di ricerca 2/2010 nel caso specifico, ci permette di chiarire il pensiero e l’azione di una personalità, che quel processo di modernizzazione l’ha cavalcato e promosso per quasi due decenni. L’impegno politico di Dalberti durante l’Elvetica Considerando la formazione culturale di Dalberti, il suo radicamento nel mondo urbano, la sua sensibilità per l’illuminismo e le trasformazioni provocate dalla rivoluzione francese, non dovrebbero sorprendere le posizioni da lui adottate dal febbraio del 1798. Dalberti, nell’alta valle di Blenio dove si trovava, operò affinché le autorità della valle non si mobilitassero contro la penetrazione delle truppe francesi sul territorio della Confederazione; dopo la partenza dei balivi (nell’aprile del 1798) chiese, con altre personalità dell’alta valle di Blenio, la modifica degli statuti della stessa, nell’ottica di una chiara divisione dei poteri e il suo inserimento nel quadro delle istituzioni della Repubblica elvetica 13. Entrò in conflitto con le autorità balivali e quanti, soprattutto nella bassa valle di Blenio, si opponevano al cambiamento o lo concepivano come l’avvento di un’autonomia della valle sganciato da qualsiasi potere superiore repubblicano. L’azione di Dalberti, dal febbraio al luglio del 1798, dissipa ogni dubbio su quali fossero le sue propensioni dal punto di vista politico. Ancora anni dopo quegli eventi, riconosceva l’importanza della rivoluzione del 1798 nel suo percorso personale e per l’avvenire delle terre svizzere al sud delle Alpi; nel 1805 in un discorso davanti al parlamento del cantone Ticino, dopo aver lodato lo slancio del popolo francese liberatosi dalla tirannia, si espresse in merito senza ambiguità: «Voi vi ricordate dell’entusiasmo di libertà, che si diffuse repentinamente tra di noi non solo, ma tra tutte le popolazioni e serve, e libere della Svizzera. Vi ricordate della breve lotta che dovette sostenere la risorta libertà contro la decrepita oligarchia; ed il primo trionfo dei diritti dell’uomo; e l’unione dei dominati e dominatori in una sola repubblica. Chi di noi potrebbe dimenticarsi un’epoca di tanta importanza? Chi di noi non conosce da quella il principio della nostra vita politica»14? Le comunità dell’alta valle di Blenio, al contrario di quanto affermato da Giuseppe Martinola, che vedeva Vincenzo Dalberti come una personalità isolata e non compresa dalla comunità, erano recettive alla sua azione e alle sue idee. A Olivone, lo stesso Giovanni Martino Soldati, operò con i medesimi intenti, così come il cugino di Vincenzo Dalberti, Giovanni Pietro Dalberti, nonché i notai Giacomo Piazza (1754-?) e Stefano Emma, appartenenti a famiglie caratterizzate da una forte propensione all’emigrazione e dislocate nelle città italiane. Tutti sostennero la Repubblica e assunsero cariche pubbliche nelle istituzioni dell’Elvetica con il pieno sostegno della comunità di Olivone che, tra aprile e luglio del 1798, si riunì a più riprese per discutere della nuova situazione politica e per approvare l’inserimento della valle nel quadro della Repubblica elvetica 15. L’alta valle di Blenio, proprio per la sua propensione all’emigrazione, era piuttosto aperta alle idee provenienti dal mondo urbano e di conseguenza favorevole al cambiamento. Per trovare, altrove nei baliaggi al sud delle Alpi dei cantoni di Uri, Svitto e Unterwalden, un esplicito sostegno alla Repubblica, dobbiamo rivolgere lo sguardo al borgo di Bellinzona, che contava alla fine del Settecento un migliaio di abitanti, e al suo distretto. Il governo provvisorio del distretto di Bellinzona, guidato da Giuseppe Rusconi (1749-1817), operò dall’inizio di maggio del 1798 in favore di un inserimento degli ex baliaggi dei tre cantoni (Blenio, Riviera e Bellinzona) e della Leventina nel Cfr. soprattutto con documenti del Fondo piazza, scatola XI, fascicolo 2. A. Bettelini, Vincenzo Dalberti, scritti scelti, vol 1., Bellinzona, 1933, discorso di Vincenzo Dalberti in occasione della prima festa civico religiosa, 19 maggio 1805, cit. pp.41-42. 15 Cfr. soprattutto con i documenti del Fondo Piazza, scatola XI, fascicolo 2. 13 14 43 Percorsi di ricerca 2/2010 quadro dell’Elvetica. Lo stesso Rusconi venne nominato dal direttorio, nel giugno di quell’anno, prefetto del neo costituito cantone di Bellinzona, che raggruppava quegli ex baliaggi 16. Mentre Rusconi, unitamente al commissario Emanuele Jauch (1759-1805) rappresentante nelle terre al sud delle Alpi del direttorio, ebbe un importante ruolo nell’instaurazione delle istituzioni della Repubblica del cantone di Bellinzona, Dalberti in questa fase, al di fuori della sua valle, ebbe un ruolo secondario. Da Olivone agiva con gli stessi fini, ma senza avere contatti organici con Rusconi e Jauch. A dimostrarlo una lettera indirizzata a Rusconi e scritta a nome di suo cugino Giovanni Pietro Dalberti, nella quale Vincenzo si lamentava a torto dei membri del governo provvisorio di Blenio, accusati di non voler inviare il testo della nuova Costituzione, testo che in realtà non era stato distribuito dallo stesso Rusconi, in quanto la attendeva con impazienza da Aarau 17. Dalberti poté sperare di assumere un ruolo di maggiore rilievo nel luglio del 1798, quando si svolsero, quasi ovunque senza problemi nel cantone di Bellinzona, le assemblee primarie volte alla nomina degli elettori che avrebbero dovuto eleggere i rappresentanti del cantone in seno ai consigli legislativi. Vincenzo Dalberti era stato significativamente eletto rappresentante dal proprio circolo, che riuniva diversi comuni dell’alta valle. Tuttavia le sue speranze furono vane. La Costituzione parlava chiaro ed escludeva gli ecclesiastici dalle cariche pubbliche. Giovanni Pietro Dalberti notificò l’avvenuta elezione del cugino al prefetto Rusconi sperando in un’interpretazione meno restrittiva del testo costituzionale. Rusconi rispose negativamente e chiese che si passasse ad altra nomina. Dalberti, a malincuore e nonostante l’insistenza della sua comunità, rinunciò «per amor di pace» e al suo posto fu eletto Giovanni Martino Soldati. Vincenzo Dalberti non esitò a scrivere una lettera di protesta il cui contenuto è significativo dei sentimenti che provava nei confronti della giovane Repubblica unitaria: «mais est-ce donc en vain, citoyen directeur, qu’on a proclamé dans ce pays la liberté et l’égalité? Un suisse ne sera donc plus citoyen, seulement par ce qu’il est prêtre ? Et celui qui sous l’ancien gouvernement était l’apôtre de la liberté, a présent en sera-t-il le martyr ? Il y a plusieurs années que j’ai mérité le courroux et la haine des tyrans du peuple, par mes ecrits et mes discours. J’ai le premier dans ce pays demandé la Constitution au terme du titre XII, et par là j’ai comblé la mesure de mes torts. (…) Mais quand un homme d’honneur n’est plus citoyen dans sa patrie, il n’a plus aucun droit… il n’as que le devoir d’en chercher une autre, où il puisse vivre en vrai Répubblicain» 18. Nonostante questa proclamazione d’intenti, egli restò in valle ancora diverse settimane. Nel frattempo entrarono in funzione i vice prefetti, gli agenti comunali e la camera amministrativa del cantone. Tra i vice prefetti, nominato per la valle di Blenio da Rusconi, vi era suo cugino Giovanni Pietro Dalberti e Vincenzo si decise a rimanergli accanto e a collaborare con lui informalmente. In occasione del giuramento civico, che tutte le comunità del cantone di Bellinzona prestarono alla Repubblica senza grandi inconvenienti all’inizio di settembre del 1798 - salvo che nella val d’Isone Vincenzo Dalberti scrisse il discorso che il cugino avrebbe dovuto pronunciare davanti alla comunità. Nello stesso esortava i suoi concittadini al rispetto delle leggi in quanto risultanti di una volontà popolare finalmente libera e li invitava alla pace e alla fratellanza, alla base di ogni sincero spirito repubblicano. Era la dimostrazione di quanto, nonostante la sua esclusione, rimanesse vicino agli ideali repubblicani 19. 16 Archivio federale Repubblica Elvetica, (AFS), Fondo 509, corrispondenza di Giuseppe Rusconi con il direttorio, 13 giugno 1798. 17 ASTi, Fondo Staffieri, scatola 3C/1, cfr. con, minuta di Vincenzo Dalberti di una lettera manoscritta inviata dal cugino Giovanni Pietro Dalberti al futuro prefetto del cantone di Bellinzona Giuseppe Rusconi. 18 AFS, fascicolo 347, lettera di V. Dalberti al direttorio, luglio 1798. 19 ASTi, Fondo Piazza, scatola XI/3, discorso manoscritto, composto secondo una nota dello stesso Dalberti per il cugino vice prefetto, da pronunciarsi in occasione del giuramento civico del settembre 1798. 44 Percorsi di ricerca 2/2010 Tra l’estate e l’autunno del 1798 i due cugini non si limitarono ai discorsi retorici, segno che concepivano la Repubblica anche come uno spazio dove potevano essere realizzate opere concrete. Essi collaborarono nell’istituzione di un servizio di posta nella valle, servizio inesistente e che obbligava gli abitanti a recarsi fuori dal distretto, a Biasca. Il progetto ebbe successo e dall’ottobre di quell’anno Blenio ebbe il suo servizio postale 20. A novembre, finalmente, Vincenzo Dalberti si recò a Milano e vi restò per un lungo periodo. La sua esclusione dagli incarichi pubblici era estranea alla sua decisione 21: pur collaborando con le istituzioni della Repubblica egli non aveva vincoli. La partenza dalla valle fu concomitante all’arrivo dei primi contingenti di truppe francesi nel cantone di Bellinzona, truppe che si acquartierarono in diverse località per sorvegliare la delicata frontiera con i Grigioni, che in quel momento erano sotto influenza austriaca. Proprio a causa della presenza delle truppe francesi, ma anche a causa delle velleità di reclutamento da parte del direttorio, nel periodo nel quale Vincenzo Dalberti fu assente dalla valle, nel cantone di Bellinzona la tensione crebbe. Delle resistenze si verificarono tra la popolazione, come era il caso anche altrove in Svizzera e in Europa 22: i soldati francesi sfruttavano le risorse dei paesi occupati; il reclutamento, quando era effettivo 23, sconvolgeva i fragili equilibri dell’economia famigliare e delle comunità, là dove non vi era una tradizione al servizio militare. Altre disposizioni non avevano creato invece particolari resistenze: sul piano religioso si era proceduto all’inventario dei beni ecclesiastici e si erano bloccate le assunzioni di novizi. Le decime erano state abolite senza gravi reazioni. È vero altresì che la legge sulle municipalità del febbraio 1799, che più di ogni altra avrebbe inciso nella sua applicazione sul funzionamento delle comunità locali, non venne applicata a causa della situazione di incertezza venutasi a creare con lo scoppio della guerra, nel marzo del 1799. Quando Vincenzo Dalberti rientrò in valle, nell’aprile del 1799, la situazione sia a nord che a sud delle Alpi si era fatta critica per le truppe francesi. Ciò indusse alla rivolta le comunità della Svizzera centrale, insofferenti della presenza francese. Nel cantone di Bellinzona furono alcune comunità della Leventina ad insorgere. La rivolta non si estese tuttavia negli altri distretti, anche grazie all’opera di conciliazione svolta in precedenza, tra gli interessi francesi e quelli delle comunità, dal prefetto Rusconi e da altre personalità vicine alla Repubblica, come per esempio il vice prefetto di Blenio Giovanni Pietro Dalberti. Il mantenimento della calma negli altri distretti non scongiurò l’arrivo degli austro-russi, che obbligò il prefetto Rusconi e i vice prefetti a lasciare le loro cariche. Giovanni Pietro Dalberti dovette rifugiarsi a Milano proprio quando suo cugino Vincenzo era rientrato in valle. Quest’ultimo rimase a Olivone durante tutto il periodo dell’occupazione imperiale e diede man forte all’operato di Giacomo Piazza che, come presidente del tribunale del distretto rimasto in carica, aveva assunto un ruolo amministrativo di rilievo. Nel difficile periodo dell’occupazione, Vincenzo Dalberti cercò di difendere le comunità di valle dalle esazioni dei militari imperiali. Nell’ottobre del 1799 scrisse, a nome della vicinanza di Olivone, un memoriale indirizzato al comandante delle truppe austriache a Bellinzona, nel quale chiedeva che la comunità fosse dispensata da ulteriori contribuzioni al rifornimento delle Cfr. con documenti in ASTi, Fondo Piazza, scatola XI, fascicolo 3. Cfr. con G. Martinola, Vincenzo Dalberti in «Epistolario Dalberti-Usteri 1807-1831», Bellinzona, 1975, pp. VII-XLVII. 22 Cfr. per esempio con G. Lefevbre, Napoleone, Bari, 1996; S. Woolf, Napoleone e la conquista dell’Europa, Bari, 1990 o ancora con Th. Lentz, Nouvelle histoire du premier Empire, 2002-2007. 23 Per la debole determinazione di Meyer, nel cantone di Bellinzona il reclutamento non fu effettuato come previsto nella primavera del 1799. Cfr. con la corrispondenza tra Giuseppe Rusconi e l’ispettore Meyer, gennaio-aprile 1799, in ASTi, Fondo Repubblica Elvetica, scatola 31. 20 21 45 Percorsi di ricerca 2/2010 truppe, in quanto ridotta ad una situazione di miseria 24. Ancora nel marzo del 1800 cercò di intercedere affinché le autorità austriache rimborsassero il loro debito nei confronti della comunità di Olivone. La riuscita controffensiva francese riportò le terre svizzere al sud delle Alpi sotto il controllo della Repubblica nel maggio del 1800. Vincenzo Dalberti, dal canto suo, continuò a farsi avvocato degli interessi della comunità di Olivone. In quel ruolo, in occasione della creazione delle municipalità e delle camere del maneggio nel gennaio del 1801, cercò di ottenere il riconoscimento del diritto di farne parte, pur essendo un ecclesiastico. Tale diritto gli fu di nuovo rifiutato dal prefetto Giusppe Rusconi. Impossibilitato ad assumere un incarico in seno alle nuove istituzioni, continuò caparbiamente a svolgere la sua opera pubblica in difesa degli interessi della comunità: nella primavera del 1801 si batté contro un’interpretazione troppo democratica della legge sulle municipalità del febbraio del 1799 25. Lo fece nel rispetto delle leggi della Repubblica, senza mai mettere in discussione la legalità delle istituzioni 26. Nel contempo contribuì nella valle alla formazione dei catasti e alla liquidazione dei censi, retaggi dell’Ancien Régime. Questo processo, pur essendo lento, ebbe in generale un esito positivo anche altrove nel cantone di Bellinzona. Fu finalmente la svolta moderata in seno alla Repubblica, a partire dall’estate del 1800 27, che permise a Vincenzo Dalberti di rientrare in gioco un anno più tardi. La svolta moderata ricevette linfa anche dalla ritrovata pace continentale e in seguito, dall’estate del 1801, dal concordato stipulato da Napoleone con la Santa Sede. Proprio in questo diverso contesto, il governo repubblicano e moderato dell’Elvetica si mise all’opera per elaborare una nuova Costituzione. Anche se il progetto fu rifiutato da Napoleone e sostituito da un’altra proposta, il senso del disegno del direttorio non fu ribaltato: la nuova Costituzione, pur mantenendo l’impianto centralizzato della Repubblica, dava un maggiore spazio ai notabili locali. Nel progetto costituzionale non si escludevano più gli ecclesiastici e il suffragio era limitato rispetto alla prima Costituzione della repubblica ai soli proprietari. Al sud delle Alpi si prevedeva una fusione dei cantoni di Bellinzona e Lugano in un’unica entità. Ogni cantone avrebbe dovuto elaborare autonomamente un proprio ordinamento interno. Proprio a tale scopo, nel luglio del 1801, si convocarono le assemblee primarie per nominare gli elettori, che in seguito avrebbero dovuto eleggere i rappresentanti alla dieta cantonale. Dalberti fu nominato dall’alta valle di Blenio elettore e, dagli elettori della valle, rappresentante alla dieta. Partecipò perciò ai lavori della prima dieta del cantone Ticino, nell’agosto del 1801, dieta che elaborò una prima bozza di Costituzione cantonale 28. Non ebbe un ruolo di rilievo, ma si fece conoscere e apprezzare ed assunse delle posizioni repubblicane moderatamente centraliste 29. Seguì i lavori della dieta nazionale nell’autunno del 1801, che dovevano sancire l’entrata in vigore del nuovo disegno costituzionale. Il colpo di stato federalista interruppe tale processo, ma Dalberti non risultò escluso. Nell’aprile del 1802, eletto di nuovo in seno alla dieta cantonale atta a pronunciarsi su un disegno costituzionale, questa volta di stampo federalista, venne nominato membro della ristretta commissione che ne cogitò il rifiuto. ASTi, Fondo Piazza, scatola XI, fascicolo 4, memoriale manoscritto di Vincenzo Dalberti al colonnello Strauch, comandante delle truppe austriache di stanza a Bellinzona, ottobre 1799. 25 Cfr. con la legge sulle municipalità, in Leggi e decreti della Repubblica elvetica, 15 febbraio 1799, pp. 274-303. 26 ASTi, Fondo Stato II, scatola 4, fascicolo 1., cfr. per esempio con il mandato di Simone Pizzotti presso le autorità della Repubblica, manoscritto di Vincenzo Dalberti, 24 febbraio 1801. 27 Cfr. con A. Rufer, Hélvetique (République) , in «Dictionnaire historique de la Suisse», Neuchâtel, 1928, pp. 28-60. 28 ASTi, Fondo Repubblica elvetica, scatola 41, cfr. con verbali manoscritti della dieta cantonale, 1-18 agosto 1801. 29 ASTi, Fondo Piazza, scatola XXIII, fascicolo 3, cfr. per esempio con la corrispondenza di Vincenzo Dalberti con Modesto Farina, lettere del 3 e 7 ottobre 1801. 24 46 Percorsi di ricerca 2/2010 Il naufragio della repubblica unitaria alla fine dell’estate di quell’anno non portò i distretti del cantone di Bellinzona all’insubordinazione come altrove. Confrontate alla rivolta federalista dell’agostosettembre 1802, le autorità del cantone, guidate dal nuovo prefetto Antonio Sacchi ressero il colpo e si mantennero in carica. Dopo l’intervento di Napoleone come mediatore delle diatribe interne della Svizzera, alla fine di settembre, Dalberti partecipò ad una terza dieta cantonale convocata in novembre al fine di nominare un rappresentante alla consulta di Parigi. Chiamato a far parte di una commissione ristretta, Dalberti contribuì all’elaborazione del mandato affidato al lucernese Vincent Rüttimann, nominato rappresentante degli interessi del cantone Ticino 30. Rüttimann avrebbe dovuto difendere una proposta moderata ma centralista e l’appartenenza della Leventina, rivendicata da Uri, al Ticino. La creazione effettiva del cantone Ticino nel quadro dell’Atto di Mediazione firmato da Napoleone Bonaparte, nel febbraio del 1803, aprì nuovi spazi all’ascesa politica di Dalberti; questi, forte della sua ampia cultura e della sua esperienza politica, fu eletto dall’assemblea elettorale dell’alta valle di Blenio suo rappresentante, nel primo Gran consiglio del cantone. Riunitosi in maggio, il parlamento lo elesse a membro del piccolo consiglio con il maggior numero dei voti e, in virtù di tale riconoscimento, assunse la carica di presidente del governo. Azione politica di Vincenzo Dalberti nel quadro della Mediazione e processo di modernizzazione Quale fu l’azione di Dalberti in seno alla compagine governativa al vertice dello Stato cantonale? Qual era il suo grado di adesione alla Costituzione derivata dall’Atto di Mediazione imposto da Napoleone? Quali erano i nodi conflittuali che contrapponevano Dalberti e le élite politiche? Fino a che punto possiamo definire Dalberti e altri membri dell’élite politica consapevoli sostenitori del sistema della Mediazione? La nostra riflessione dovrebbe comprendere tutto il lasso di tempo del regime della Mediazione (1803-1814), anche perché durante tutto quel periodo Vincenzo Dalberti, senza interruzione, fece parte dell’esecutivo del cantone. Tuttavia in questa sede ci occuperemo soprattutto dei primi anni del periodo della Mediazione. Vincenzo Dalberti, originario di una regione del cantone che aveva dimostrato una certa sensibilità alle istanze repubblicane, per la sua apertura alla cultura urbana tramite il fenomeno migratorio, portava in seno al governo una visione e un atteggiamento piuttosto favorevole alle istanze della Mediazione, anche se sarebbe stato più propenso ad accettare una maggiore centralizzazione del potere sul piano confederale 31. In seno all’esecutivo di nove membri si trovava in buona compagnia. Salvo l’arciprete di Riva Gottardo Zurini, praticamente tutti gli altri membri del governo, eletti nel maggio del 1803, avevano sensibilità repubblicane: Alessandro Maderni, Andrea Caglioni, Antonio Zeglio e Giuseppe Rusconi avevano tutti assunto cariche pubbliche durante l’Elvetica. Addirittura i sottocenerini Giovanni Reali, Giovanni Battista Quadri e Giovanni Battista Maggi avevano militato, nel 1798, per l’adesione delle terre svizzere al sud delle Alpi alla Cisalpina. Come presidente del governo, eletto nel maggio del 1803, Dalberti aveva dei poteri limitati, così come era limitato il tempo del suo mandato. L’esecutivo funzionava in modo collegiale e la presidenza, 30 31 S. Franscini, Storia della Svizzera italiana dal 1797 al 1802, Bellinzona, 1996, pp. 354-355. ASTi, Fondo Staffieri, scatola 1A, cfr. con lettera di Vincenzo Dalberti a Francesco Bernasconi, 27 gennaio 1803. 47 Percorsi di ricerca 2/2010 così come predisposto dall’Atto di Mediazione, 32era attribuita ogni mese ad un membro diverso del piccolo consiglio. L’azione e il pensiero di Dalberti non spiccavano, si intrecciavano a quello degli altri membri del governo, anche se egli ebbe, in momenti chiave, un ruolo importante. In particolare fu presidente del piccolo consiglio fino alla fine di giugno del 1803 e nel maggio del 1804, in concomitanza con le sedute del parlamento. In tale veste ratificò tutte le proposte di legge del governo. Durante la sessione ordinaria del parlamento del maggio-giugno del 1803, Dalberti presentò una serie di messaggi di legge volti a dare applicazione all’Atto di Mediazione. Le leggi in questione creavano nel cantone un sistema giudiziario unificato e lo organizzavano sul piano amministrativo. In campo giudiziario, la legge sull’istituzione dei tribunali d’appello fu accettata dal Gran consiglio il 26 maggio, quella sulla giustizia di pace l’11 giugno, mentre quella sui tribunali di prima istanza il 16 giugno 33. La giustizia in questo modo veniva organizzata su tre piani distinti come nella Francia napoleonica, dove erano stati creati dei dipartimenti con dei tribunali d’appello, dei circondari dotati di tribunali di prima istanza e dei cantoni, nei quali operavano i giudici di pace 34. In Ticino l’Atto di Mediazione istituiva il tribunale d’appello sul piano cantonale, i tribunali di prima istanza nei distretti e la giustizia di pace in 38 circoli. L’istituzione dei giudici di pace, pur essendo stata imposta dal regime della Mediazione, era per Dalberti e l’élite più che necessaria. Nel giustificare una delimitazione rapida e definitiva del territorio di ogni circolo, Dalberti affermava: «Questa operazione è tanto più importante dacché deve precedere la nomina dei giudici di pace, che il popolo già da molto tempo attende con impazienza» 35. Sul piano amministrativo, l’esecutivo guidato da Dalberti propose una legge, approvata nel giugno del 1803, che definiva le attività attribuite alle municipalità e, in piena autonomia rispetto a quanto previsto dall’Atto di Mediazione, introdusse la figura del commissario di governo, retaggio della Francia del direttorio 36. I commissari di governo sostituivano i vice prefetti dell’Elvetica che dipendevano dal prefetto e dal direttorio, e nel cantone erano i veri rappresentanti dell’esecutivo sul territorio. In Ticino il modello amministrativo e giudiziario francese si era imposto in virtù dell’Atto di Mediazione: l’azione di Dalberti e degli altri membri del governo, senza dissenso interno in questo caso, dimostrava la volontà di applicarne nella pratica il dispositivo, tramite proposte legislative che vennero approvate dal parlamento. In altri ambiti Vincenzo Dalberti propugnava una politica prudente e moderata volta a «prevenire i risentimenti e a soffocare i pregiudizi»37. A quella politica prudente potevano essere ricondotte, nella stessa sessione, le proposte governative di abolire le tasse sui registri, sulle patenti, sulle bevande e i beni di lusso «considerando le difficoltà della percezione delle imposizioni indirette e le gravi spese che ne emergono; considerando che si è sollevato un grido generale contro le dette imposizioni»38; nonché le proposte di ristabilire le decime, gli statuti e le consuetudini esistenti nei distretti prima della rivoluzione e di restituire ai conventi e alle corporazioni religiose i beni sequestrati durante Napoleone Bonaparte, Atto di Mediazione, Costituzione del cantone Ticino, titolo III, paragrafo 20. Cfr. con i verbali del gc. delle sessioni ordinarie VII, XIV, XVIII, maggio e giugno 1803. 34 Th. Lentz, Nouvelle histoire du premier empire, vol. III, Paris, 2007, p. 290. 35 ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, scatola 1, fascicolo 1, messaggio di Vincenzo Dalberti a nome del piccolo consiglio, 16 giugno 1803. 36 Ibidem, p. 176. 37 Cfr. con V. Dalberti, Proclama del piccolo consiglio annunciante la sua istallazione, in A. Bettelini (a cura di), Scritti scelti, vol. 1., Bellinzona, 1933, pp. 33-36. 38ASTi, Gran consiglio, Atti manoscritti, scatola 1, fascicolo 1, Vincenzo Dalberti, messaggio del piccolo consiglio al gran consiglio, 27 maggio 1803. 32 33 48 Percorsi di ricerca 2/2010 l’Elvetica. Quest’ultima proposta era indotta dallo stesso Atto di Mediazione, frutto di una politica napoleonica moderata volta a riconciliarsi con il mondo religioso. Il ristabilimento di decime e statuti era invece considerato dal governo come provvisorio, tant’è che l’esecutivo, guidato ancora una volta da Dalberti, durante la sessione ordinaria del maggio del 1804, propose con successo una legge sul riscatto delle decime 39 e per l’elaborazione di un nuovo codice civile e criminale all’altezza dei tempi 40. Lo slancio propositivo dell’esecutivo, in questo caso oltre le esigenze del rispetto dell’Atto di Mediazione, raggiunse l’apice proprio durante quella sessione ordinaria del gran consiglio: con successo Dalberti firmò una proposta di legge per l’istituzione di una scuola elementare in ogni comune e l’obbligatorietà scolastica sotto la sorveglianza dei municipi 41. Un altro disegno di legge presentato dall’esecutivo, definì le strade maestre del cantone 42. La legge completava un dispositivo adottato nell’autunno precedente, che prevedeva che il cantone si facesse carico della costruzione e della manutenzione delle strade togliendone la prerogativa ai comuni. Le autorità si avvalevano del diritto di espropriare comuni, corporazioni e particolari in cambio di un giusto rimborso. Conseguentemente anche l’incasso dei pedaggi e dei dazi alla frontiera con la Repubblica italiana, divenivano compito del cantone 43. I lavori veri e propri di miglioria presero avvio il 1 luglio del 1804. Dalberti e il piccolo consiglio, con una certa unità d’intenti, avevano agito con solerzia per dare applicazione alla Costituzione della Mediazione e per questo Dalberti stesso, ma anche gli altri membri del governo, possono essere legittimamente considerati come sostenitori del sistema napoleonico nelle terre Svizzere al sud delle Alpi. Nello stesso tempo si erano mostrati in grado di proporre innovazioni sul piano politico, sociale ed economico in modo autonomo rispetto alle imposizioni indotte dal quadro costituzionale definito da Napoleone, rivelando una sensibilità favorevole all’unificazione e alla modernizzazione del cantone. Se delle resistenze erano riscontrabili, esse venivano soprattutto dal Gran consiglio, nel quale sedevano personalità legate agli interessi locali e che non sempre assecondavano lo slancio dell’esecutivo. Dalberti, nel settembre del 1803, rassegnò le dimissioni unitamente a Giuseppe Rusconi, in seguito ad un voto del parlamento volto a concedere delle indennità ai propri membri. Nella lettera al landamano Louis D’Affry, Dalberti, oltre a denunciare l’anticostituzionalità di tale decisione, precisava: «Contre le reglement, et qui pis est, contre la Constitution, l’on meprise les propositions du petit conseil, et l’on refuse à plaisir de deliberer» 44. Dalberti e Rusconi riassunsero il loro posto in governo unicamente dopo l’energico intervento del Landamano e la marcia indietro del parlamento. L’ostruzionismo del gran consiglio nei confronti del governo giunse al parossismo nella sessione ordinaria del 1805, quando il parlamento votò un regolamento imposto al governo, che ne paralizzava completamente l’azione. Il piccolo consiglio si rifiutò di accettare l’imbrigliamento e ricorse anche in quel caso al potere discrezionale del Landamano45. Dalberti invitò i rappresentanti del cantone alla dieta a tastare il terreno per verificare se fosse possibile provocare un voto della stessa in favore Cfr. con Leggi e decreti del Cantone Ticino, 1803-1804, p. 204. ASTi, Gran Consiglio, Atti manoscritti, scatola 2, fascicolo 1, messaggio del piccolo consiglio al gran consiglio, 12 maggio 1804. 41 Ibidem, legge sulla scuola pubblica, 15 maggio 1804. 42 Verbali del gran consiglio, sessione XXI, 29 maggio 1804. 43 Cfr. con P. Borella, Le finanze pubbliche e la situazione economica del cantone Ticino nel periodo della Mediazione napoleonica, 18031814, Bellinzona, 1971, pp. 68-71. 44 ASTi, Fondo Piazza, scatola XXV, fascicolo 1, lettera di Vincenzo Dalberti al Landamano D’Affry, 30 agosto 1803. 45 ASTi, Fondo Staffieri, scatola 3E, fascicolo 2, lettera del Landamano Merian alle autorità del cantone Ticino, 14 settembre 1806. 39 40 49 Percorsi di ricerca 2/2010 dell’esecutivo del cantone 46. Il conflitto si risolse a favore del governo solo nell’autunno del 1806, con l’intervento del colonnello Hauser come emissario speciale della Confederazione. Ad indebolire l’azione del governo vi fu anche il conflitto per la capitale, che vide tra i protagonisti lo stesso Dalberti. Il contrasto che spaccava l’esecutivo non era il frutto di un presunto localismo esacerbato dei notabili del cantone; piuttosto era la conseguenza del processo di modernizzazione: la Repubblica elvetica aveva creato due cantoni nelle terre svizzere al sud delle Alpi e aveva eletto due città a capoluogo, Bellinzona e Lugano. L’unificazione dei due cantoni portò ad un conflitto per stabilire quale dovesse essere, tra questi due, il centro politico del nuovo cantone, ciò che inevitabilmente determinava la localizzazione delle periferie 47. Di fronte al reiterato tentativo delle élite politiche del luganese di modificare il dispositivo costituzionale e spostare la capitale a Lugano, Vincenzo Dalberti si batté per lo status quo ed ebbe buon gioco nel presentarsi come il difensore per eccellenza della Costituzione che si pone al di sopra delle parti: «L’acte de Médiation préscrit que Bellinzona est le chef lieu du canton Tessin. Vous reconnaissiez, dans votre sagesse, que la centralité le voulait, que le bien être des habitants du Tessin le necessitait, et que la fidelité et l’attachement que la comune de Bellinzona a constamment démontré aux Repubbliques française et hélvetique, pendant les cinq années de notre dernière Constitution, exigèrent le droit la préférence sur quelconque autre commune du canton Tessin (…). Les luganais méconnaissant vos vues ont attenté à l’acte de Mediation par des voies de séduction, et par des déliberations qui portent une empreinte esterieure légale, mais qui dans le fait ne sont que le resultat d’un esprit de parti 48». I conflitti in seno alle élite, ma ancor più, dopo il 1806, il mutare della situazione internazionale, avevano smorzato la spinta propositiva di Dalberti e dei suoi colleghi di governo. Le esigenze della Francia imperiale, legate all’acuirsi del conflitto europeo in quanto a rispetto del blocco continentale e a fornitura di truppe, spinsero il governo a concentrare i propri sforzi nel soddisfare le esigenze del potente alleato. Dalberti, nei suoi discorsi 49 di fronte al gran consiglio, non lesinò la retorica per incitare consiglieri e funzionari pubblici a prodigarsi nel reclutamento del contingente e della milizia che il Ticino doveva fornire alla Confederazione e alle guerre di Napoleone. L’occupazione italiana, a partire dall’ottobre del 1810, bloccò quasi completamente l’attività legislativa. Dalberti si mostrò disposto a cedere il Mendrisiotto 50 pur di ottenere il ritiro delle truppe del regno d’Italia. Dalberti fu pure protagonista alla caduta del regime della Medizione: partecipò alla dieta di Zurigo e al travagliato processo di elaborazione di una nuova Costituzione, che portò alla rivoluzione di Giubiasco. Tuttavia il suo ruolo negli anni dell’occupazione italiana e nel contesto della crisi del 1814 resta ancora da chiarire attraverso ulteriori ricerche. Conclusione Quali insegnamenti possiamo trarre dall’analisi del percorso biografico di Dalberti? Vincenzo Dalberti si investì a fondo durante il periodo della Repubblica elvetica in favore delle sue istituzioni e eASTi, Fondo Staffieri, scatola 3E, fascicolo 2, lettera di Vincenzo Dalberti a Andrea Caglioni e Giovanni Battista Maggi, 10 giugno 1805 e risposta di Caglioni, 12 giugno 1805. 47 Cfr. con S. Rokkan, Stato nazione e democrazia in Europa, Bologna, 2002. 48 ASTi, Fondo Piazza, scatola XXV, fascicolo 1, Lettera di Vincenzo Dalberti a Napoleone Bonaparte, primo console di Francia, 21 giugno 1803. 49 Arnoldo Bettelini, Vincenzo Dalberti, scritti scelti, vol. 1, Bellinzona, 1933, discorsi di Vincenzo Dalberti del maggio 1808 e maggio 1809. 50 Cfr. per esempio con la lettera di Vincenzo Dalberti a Paul Usteri, 11 agosto 1811, in Giuseppe Martinola (a cura di), Epistolario Dalberti Usteri (1807- 1831), Bellinzona, 1975, p. 169. 46 50 Percorsi di ricerca 2/2010 letto, nel periodo della Mediazione, ai vertici dello Stato, si prodigò per l’applicazione della Costituzione napoleonica e la costruzione delle sue istituzioni. Questa propensione al sostegno alle innovazioni politiche portate dalla Francia post rivoluzionaria, derivava da un’ampia cultura acquisita in ambiente urbano e che Dalberti portò in valle di Blenio, così come facevano altri, le cui famiglie erano dislocate. Non deve sorprendere perciò che nell’alta valle di Blenio la sua azione e i suoi discorsi incontrassero un eco favorevole. La sua comunità era probabilmente più recettiva di altre terre svizzere al sud delle Alpi, in quanto aperta al mondo urbano tramite la tradizionale emigrazione nelle città del nord d’Italia. L’analisi del percorso di Dalberti, oltre a chiarire numerose sue prese di posizione, ci permette di avere uno sguardo più sfumato sulle terre svizzere al sud delle Alpi dopo la rivoluzione del 1798. Non dappertutto vi fu resistenza alle novità e soprattutto nelle élite, pur tra le divisioni, il sostegno alla repubblica fu piuttosto condiviso. 51 Percorsi di ricerca 2/2010 Catene, identità, diversità. Il caso Monteforno e lo studio dell’immigrazione italiana in Svizzera attraverso le fonti orali Mattia Pelli Introduzione In questo articolo presenterò una prima riflessione su alcuni dei temi di principale interesse emersi nel corso della mia ricerca di dottorato relativa alle maestranze dell’acciaieria Monteforno di Bodio e sviluppati nel corso del quarto seminario per ricercatori associati organizzato tra il 2007 e il 2009 dal Laboratorio di Storia delle Alpi. Il mio lavoro di studio sull’acciaieria ticinese, intitolato «Il caso Monteforno: una storia corale tra integrazione e conflitto», copre tutto l’arco di vita dell’azienda (1947-1994) e si propone di studiare le vicende della sua comunità operaia, composta essenzialmente da lavoratori immigrati, attraverso il ricorso alle fonti orali. L’obiettivo è quello di studiare «dall’interno», attraverso l’analisi delle storie di vita degli operai, alcuni argomenti centrali al confine tra storia sociale dell’immigrazione e storia del movimento operaio svizzero, secondo la convinzione che soltanto la testimonianza soggettiva può aiutare a chiarire aspetti di queste vicende altrimenti difficilmente comprensibili attraverso le fonti classiche. La scelta della fabbrica come orizzonte della ricerca risponde all’esigenza di individuare un contesto «meso-sociale» 1 all’interno del quale la comunità costruisce la mediazione e il rapporto tra «grande storia» e storia individuale. Per l’inquadramento metodologico di questa ricerca e un approfondimento critico sulle fonti orali nel quadro della storia del movimento operaio e delle migrazioni, rinvio a precedenti articoli sull’argomento, così come per la collocazione dell’esperienza della Monteforno nel quadro dell’economia ticinese e svizzera del secondo dopoguerra 2. Stratificazione migratoria e catene migratorie Secondo Alistair Thomson, «[...] personal testimony reveals the complex weave of factors and influences which contribute to migration and the processes of information exchange and negotiation within families and social networks. [...] In migrant narratives social networks are shown to be crucial aspect of the migration experience.» 3 In questo senso la vicenda dell’arrivo da Avellino di C. R. alla Monteforno nel 1961 è interessante, «Sembra, infatti, che i risultati ottenibili con le fonti orali possano essere massimizzati se, contemporaneamente, riduciamo il campo da illuminare (passando dai grandi eventi razionalmente rilevanti alla loro manifestazione in ambiti molto più circoscritti) mentre ampliamo il tipo di soggettività dalla quale e sulla quale vogliamo essere informati, concentrando la nostra attenzione sulla memoria collettivamente elaborata da un gruppo di persone, e relativa alla loro storia comune.», G. Contini, Fonti orali e storia locale, in C. Bermani (a cura di) Introduzione alla storia orale, Odradek, Roma, Vol. II, pp. 41-60. 2 M. Pelli, Parole di migranti. Storie di vita e di lavoro nell’acciaieria svizzera Monteforno, «Storicamente», 4 (2008), http://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-pelli.htm Dipartimento Studi Storici, Università di Bologna, n. 4, 2008; M. Pelli, Fonti orali per la storia dell’immigrazione in Svizzera: una ricerca tra i lavoratori italiani della Monteforno di Giornico, in «Archivio Trentino», n. 1, 2009, pp. 5-32. 3 A. Thomson, Moving stories: oral history and migration studies, in «Oral History», 1999, Spring, pp. 24-37. 1 53 Percorsi di ricerca 2/2010 perché ci permette di cogliere lo sviluppo di una catena migratoria 4, di cui lo stesso lavoratore è stato l’iniziatore: «Io era partito dal mio paese con contratto di lavoro che doveva andare a Losanna. [...] Sono sceso a Milano, ho trovato due del paese, così, amici. Dice: “Noi andiamo a Bodio”, Bodio non sapeva neanche dov’era [ride] e là dovevamo prendere il treno per Losanna assieme a un altro.» L’emigrante aveva già in mano un contratto per lavorare nel campo dell’agricoltura in Svizzera francese, procuratogli da un amico e il viaggio era stato pagato dalla Camera del Lavoro di Avellino. Ma a Losanna, C. R. non ci arrivò mai. «“E così – dice – fermatevi a Bodio – dice – eh, ce ne sono tanti del nostro paese lì!”. [...] E per dire, mi sono fermato qui la sera, quando sono arrivato qui mi sono un po’ spaventato, ero in mezzo alle montagne [ride]. “Caspita, veramente – ho detto – ma qui dove sono?”» Il giorno dopo C. R. e il suo compagno di viaggio sono davanti ai cancelli della Monteforno a chiedere di poter lavorare: in quel periodo di grande espansione produttiva l’acciaieria aveva bisogno di lavoratori, anche perché il turn over era altissimo, dal momento che tantissimi lavoratori non resistevano più di qualche mese, alcuni addirittura non più di qualche giorno, a causa della pesantezza del lavoro. «Però loro [i dirigenti], visto che noi eravamo della bassa Italia, non conoscendo le fabbriche e tutte quelle cose lì, non è che ci pigliavano volentieri a lavorare. Erano i primi che arrivavamo qua negli anni ‘60 dalla bassa Italia.» Ma i due insistono e finalmente riescono ad ottenere un posto in acciaieria e a quel punto si pone il problema di fare arrivare in Ticino il resto della famiglia. La prima ad arrivare, nel 1962, è una sorella non ancora maggiorenne: «Non ero sposato. Mi sono portato una sorella che aveva 14-15 anni a dire “almeno mi prepara un piatto di pasta asciutta”, perché allora non è che potevi andare in un ristorante...» Qualche mese dopo la sorella trova lavoro in un’impresa di abbigliamento della zona e C. R. propone ai suoi genitori di lasciare l’azienda agricola al paese e di raggiungerlo in Svizzera, ciò che avviene nel 1963. In Italia, affidati ai nonni, restano due fratelli piccoli in età scolastica che si ricongiungeranno con il resto della famiglia qualche tempo dopo. Il lavoratore della Monteforno diventa il vertice di una catena migratoria che si allarga anche ai cugini: «Tutti poi li ho portati qua. E mi ricordo quando siamo partiti dal paese amo fatto un pullman solo dalla nostra famiglia, dal paese alla stazione, eravamo 20 persone, tutte della stessa famiglia» Ma il ruolo di capofamiglia assunto da C. R. non sempre viene riconosciuto dai fratelli ai quali ha aperto la strada dell’emigrazione: «Qualcuno può anche non, come si dice, non tiene neanche in considerazione questo perché adesso le cose vanno troppo bene, capito, e allora... “Mica dobbiamo tenerti obblighi a te perché ci hai fatto...” […]. Però io gli faccio sempre la battuta. “Eh – dice – se non erano qua erano lì”, loro dicono così, però Celentano dice: “Sono qua ma sono lì” [ride]. 4 Sul concetto di catena migratoria e sull’utilizzo del concetto di «network» nella ricerca sociale si veda F. Piselli (a cura di), Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali, Roma, 1995. 54 Percorsi di ricerca 2/2010 “Però siete qua adesso, perché se non venivo io qua, non eravate qua”. E siamo tanti, tanti, tanti.» Alla domanda sulle motivazioni che lo hanno spinto all’emigrazione, C. R. ci offre uno spunto di riflessione importante, perché accanto alla spiegazione economica – che si potrebbe definire classica – l’ex operaio introduce un elemento ulteriore di comprensione: «Come ha deciso di partire per la Svizzera? Mah, praticamente noi quel periodo lì ci siamo tirati dietro un po’ uno con l’altro, no, tra amici, così, perché io avrei anche potuto star lì, per esempio avevamo un’azienda agricola, non è che avevamo proprio bisogno di venire qua. Guadagno con l’agricoltura c’era pochissimo... Stavamo bene, c’avevamo tutto, però... la vita dell’agricoltura era quella, era dura. Io volevo che... vedere un altro sistema di lavoro, che si guadagnava qualcosa in più, che lì non ci mancava niente, però come giovane, non c’era possibilità di divertimento, si lavorava... si sa bene l’agricoltura com’era». Questa testimonianza conferma l’orientamento assunto dai più recenti studi sulle migrazioni che mettono l’accento sulle scelte soggettive degli individui: non solo, dunque, la spinta economica, ma anche la giovane età, la voglia di vedere il mondo, di toccare con mano le novità portate dal boom economico di cui si è soltanto sentito parlare e il bisogno di sottrarsi alle rigide regole sociali in vigore nell’Italia rurale. Molto interessante è il racconto di A. D., ex operaio della Monteforno (classe 1944), di origine sarda, perché ci restituisce, attraverso una narrazione vivida e ricca di particolari, il «mito delle origini» sull’arrivo nell’acciaieria di una nutrita comunità di lavoratori dell’isola, chiamati in Ticino attraverso un’attiva politica di reclutamento compiuta dalla direzione della fabbrica. I sardi della Monteforno hanno una storia a sé: il loro approdo in Ticino si inserì nella nuova fase dell’emigrazione da lavoro che si sviluppò a partire dalla fine degli anni ‘50, quando cessarono le migrazioni tradizionali dall’Italia settentrionale verso l’estero 5. Con lo sviluppo del boom economico che investì soprattutto l’Italia del Nord, ad arrivare furono soprattutto lavoratori meridionali. È utile ricordare che il 1956 fu l’anno centrale dell’emigrazione italiana verso i paesi europei; due terzi dei 200 mila espatriati dalla vicina Penisola giunsero in Svizzera. «Le racconto come sono arrivati i primi sardi alla Monteforno. Il primo è stato mio fratello. È arrivato da Tula. È partito tutto dal 1960, poi i sardi hanno cominciato nel ‘61 ad arrivare qua. Nel ‘60 avevo due sorelle che lavoravano all’ospedale distrettuale di Faido. La grande, Mariangelica, la seconda Giuseppina e tra le tante degenze è capitata la moglie del signor Carlo Franscini [allora capo del personale alla Monteforno]. Io avevo qua due fratelli che lavoravano. Le due sorelle erano venute qua per lavorare. Il primo fratello che è venuto a Faido è venuto nel ‘58 ed era partito dalla Sardegna per andare in Francia, è andato in Francia con altri tre amici, dopo 6-7 mesi non gli andava più, anche per lo stipendio, lavorava come contadino, poi ha sentito che in Svizzera cercassero lavoratori. E allora sono venuti a Faido A Faido ha iniziato a lavorare con un’impresa di pittura. Dopo un po’ è venuto anche mio zio e l’altro mio fratello, il grande, che adesso è in Sardegna. Mio zio lavorava alla galvanica, che adesso è a Biasca. La moglie ne parlò con Franscini e Nicola ha cominciato alla Monteforno, nel 1960, e qui è cominciata la storia dei sardi alla Monteforno. Ha cominciato mio fratello e subito dopo mio zio. Inizio primavera del ‘61 alla Monteforno cercavano manodopera. Normalmente prima arrivavano i bergamaschi, i bresciani e anche i napoletani. Quando il direttore [della Monteforno] ingegner Morini ha saputo che c’erano due sardi alla Monteforno, durante la guerra lui comandava una brigata, era tenente, e sotto i suoi ordini aveva diversi sardi. E disse al Franscini: “Carlo tu devi andare in Sardegna, i sardi sono operosi, obbedienti, è gente onesta”, anche se non sempre è vero, intendiamoci [ride]. Non esistono studi approfonditi sull’immigrazione italiana in Ticino nel secondo dopoguerra. Per alcune notizie su questa vicenda si rimanda a S. Toppi, La crescita economica (1945-1975): la ricerca di aperture e l’avvento del terziario, in R. Ceschi (a cura di), Storia del Cantone Ticino. Il Novecento, Bellinzona, 1998, pp. 615-640. 5 55 Percorsi di ricerca 2/2010 Morale: il signor Franscini parla con mio fratello e in primavera, mese di aprile del ‘61 è arrivato al mio paese, a Tula, era prima di Pasqua. Da Tula poi ha fatto una riunione, poi sono andati ad Oscheri, che è il paese che ha dato più manodopera alla Monteforno. E da li poi c’e stato tutto l’insieme: Tula, Oscheri, Telti, Pattada. Quando sono partiti, quel giorno, io facevo l’apprendistato all’Inapli, sono passati a salutarmi e ho sempre presente le parole del Franscini. Siccome da lì a pochi mesi avevo gli esami finali, mi disse: “Antonio, quando hai finito, voglio che tu sia dei nostri alla Monteforno”. Io ho finito gli esami. Quando li finii ero andato a Porto Torres alla petrolchimica perché avevano chiesto quattro diplomati, solo che né a me né a un altro non ci hanno presi perché eravamo troppo giovani. Avevo neanche 17 anni. Finito le elementari avevo fatto tre anni di apprendistato alle professionali. Finiti gli esami, il 15 settembre sono partito dalla Sardegna. Venne mio fratello a Genova a prendermi, il 16 sono arrivato, il pomeriggio ho visitato la Monteforno, mi sono presentato a Franscini e il 17 settembre ho iniziato alla Monteforno.» In questo spezzone di un’intervista durata più di due ore si intrecciano molti motivi narrativi, in un’alternanza continua tra il piano informativo e quello dell’interpretazione soggettiva, tra racconto dei fatti e racconto di una vicenda rivista in luce quasi mitica. Da una parte troviamo la precisa ricostruzione dello sviluppo di una catena migratoria che ha come anello terminale la Monteforno: le sorelle – già in Svizzera, impegnate in un lavoro di cura presso un ospedale 6 – incontrano casualmente la moglie del capo del personale che inserisce uno dei fratelli, Nicola, alla Monteforno. L’avvio del movimento in direzione dell’acciaieria inizia – nella ricostruzione di A. D. – in ambito familiare, ma poi da lì si propaga all’esterno, fino a coinvolgere, più in generale, i sardi, che vengono ingaggiati attraverso vere e proprie campagne di reclutamento nell’isola da parte del capo del personale dell’acciaieria. La spiegazione dell’avvio di questa particolare ondata migratoria si basa sulle conseguenze di un incontro fortuito, ma come può il caso giustificare i sacrifici imposti da una vita di emigrazione? Ecco allora entrare in campo il «mito fondativo» che in qualche modo orienta il racconto di A. D., dandogli una direzione, un senso. Il direttore della fabbrica, l’ingegner Morini, italiano di origine, ha comandato una brigata di sardi nell’esercito, ne conosce l’operosità, il valore: così la presenza di Nicola, primo sardo a lavorare alla Monteforno e fratello dell’intervistato, diviene lo spunto per ingaggiare altri abitanti dell’isola. Difficile pensare che lo sviluppo straordinario della comunità sarda della Monteforno, giunta a contare circa 300 operai su un migliaio di lavoratori in totale, sia legato solamente ad una preferenza sentimentale del direttore, ma è certo che questo «mito fondativo» (tra l’altro largamente diffuso tra i lavoratori sardi intervistati e ripreso anche da molti ex dirigenti della fabbrica) funziona come elemento esplicativo, dando in qualche modo senso anche alla scelta di partire per la Svizzera dello stesso A. D. Xenofobia e partecipazione L’arrivo dei fratelli piccoli di C. R. in Ticino dà luogo ad uno spiacevole episodio, che da solo rende bene l’atmosfera di rifiuto in cui gli immigrati italiani erano costretti a vivere. «E così ho portato qui la mia famiglia che poi i miei fratelli e le mie sorelle, quando sono andato a prenderli non potevano stare qua perché mio papà non aveva ancora raggiunto il momento di poter tenere qua la famiglia. Però allora sai era In questo caso sono le donne al vertice della catena migratoria: un elemento di analisi importante, che ci ricorda come una parte significativa dell’immigrazione italiana in Svizzera (e in Ticino) fosse composta da donne e come queste abbiano spesso avuto un ruolo da protagoniste nella vicenda migratoria di intere famiglie. Purtroppo però la storia dell’immigrazione italiana in Svizzera è stata molto poco studiata con una prospettiva di genere. 6 56 Percorsi di ricerca 2/2010 tutto... Però se pescavano che uno teneva la famiglia, ti mandavano via... […] Neanche a farlo apposta uno che abitava in casa dove ero io, conosceva tutte la mia situazione perché lavorava in ufficio lì alla Monteforno... Sai, non ci potevano tanto vedere, perché noi allora eravamo un po’ mal visti dagli svizzeri qua, questo era uno svizzero... Ha rapportato alla polizia, la polizia è venuta a controllare, tutte queste storie qua e mio fratello, mia sorella e mia mamma dovevano andarsene via. È stata una tragedia un po’. Allora dopo io alla fine cosa ho fatto: mi sono messo in mezzo il prete di Bodio, che conoscevo, era bravissimo, Don Emilio... veramente abbiamo fatto figurare che noi tutta la famiglia eravamo qua, mio fratello, mia sorella e mia mamma, qui abbiamo fatto una lista di tutti perché poi allora era già cominciato a venire mio zio, arrivava qui tanti, abbiamo fatto una lista di tutti questi parenti e amici, che mio fratello non potevano stare in Italia, abbiamo fatto una domanda direttamente alla polizia, al comando di polizia di Lugano, sempre tramite questo Don Emilio, e così ci hanno concesso un permesso speciale... cioè, poi sono venuti a vedere anche le condizioni dove si abitava, perché poi questo qua gli aveva raccontato un po’ a modo suo le cose, così, sai, per venire un po’ incontro a noi, perché a noi ci guardavano male queste persone, sai quei patrizi patrizi... nei paesi qui allora era così.» I lavoratori italiani erano costantemente nel mirino della popolazione locale che non vedeva di buon occhio gli stranieri, sotto esame perfino in fabbrica. In questo caso il delatore è un impiegato ticinese della Monteforno, ciò che di rimbalzo ci può dare un’idea di quelli che potevano essere i rapporti tra impiegati (ticinesi) e operai (italiani) all’interno dell’acciaieria. Questa testimonianza ci restituisce però anche l’immagine della permeabilità delle leggi svizzere sull’immigrazione, molto restrittive ma che erano spesso aggirate a livello locale (in questo caso dal segretario comunale), così come la presenza di reti di solidarietà (la Chiesa) alle quali gli immigrati potevano fare riferimento. I lavoratori arrivati in Ticino dal Sud Italia tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60, la «seconda ondata», furono quelli che dovettero fare fronte alla marea xenofoba che trovò in James Schwarzenbach il suo leader. A partire dalla metà degli anni ‘60 il discorso anti-immigrati si rinforzò, fino a sfiorare la vittoria nel 1970 con una iniziativa popolare che – se fosse passata – avrebbe significato la partenza forzata di circa 300.000 immigrati. Gli immigrati hanno vissuto questo momento della storia svizzera come una grande ferita, ancor oggi difficile da dimenticare. Racconta G.C., ex operaio Monteforno, sardo: «Nel 1970 c’è stato il voto su Schwarzenbach… Mi ricordo che ho fatto una promessa: “sono convinto che il referendum non passerà, ma se dovesse passare a San Vittore, paese di 4-500 persone dove vivo, io me ne vado”. A San Vittore non è passato. Io dicevo “con questo referendum la gente dice se ti vede bene o se ti vedono male. Se in un piccolo paese più della metà della gente ti vede male, perché dovrei restarci?”» Uno degli elementi più interessanti che emergono nell’esplorazione della percezione dell’ostilità da parte degli indigeni nel racconto degli immigrati è la scoperta che questi hanno spesso avuto un atteggiamento attivo di reazione, molto lontano dalla passività con la quale spesso vengono dipinti anche da chi è solidale con il loro punto di vista. Gli immigrati hanno inventato delle risposte che sono interessanti da studiare proprio perché l’organizzazione politica era loro preclusa e spesso il sindacato era tutt’altro che sensibile al tema della discriminazione. S.G., operaio sardo che ha lavorato alla Monteforno tra il 1964 e il 1981, racconta quella che si potrebbe catalogare come «reazione simbolica» al maleficio Schwarzenbach: «Ero qui [alla Monteforno] io e un bergamasco, ed era... c’era l’esito delle votazioni su Schwarzenbach, che era l’ultima. Allora a noi interessava il Ticino perché cominciamo a guardare [sul giornale i risultati], paese per paese [...]. E vado a leggere valle Maggia [una valle del Ticino]. [...] Allora leggo Cevio, Cavergno, Linescio. Però, guardavo... Leggo questo paese: 27 votanti, 27 “no”, tutti contro l’iniziativa, il 100%, e dico con questo mio amico che adesso purtroppo non c’è più: “guarda qui, questo paese!” [Lui] dice: “Perché?”, “27 votanti 27 no”. Ho detto: “Andiamo lì, parliamo col sindaco, il segretario comunale, il prete e organizziamo una cena”, ho detto io. E un bel giorno, un lunedì della settimana dopo, partiamo, e arriviamo a Linescio [...] lasciamo la macchina in qualche posto dove... E incrociamo in particolare donne di una certa età, 50-60 anni, 40, però tutte, puntualmente, ci sorridevano 57 Percorsi di ricerca 2/2010 e salutavano. L’opposto di quello che dicevo prima. All’inizio qui quando io salutavo, perché m’è capitato, mi infastidiva però era così, dicevo “Buongiorno o buonasera” e anziché rispondere giravano la faccia dall’altra parte. Queste no. E allora dico a questo mio amico: “Ma hai notato una cosa? Qui ci salutano tutti, ci sorridono”. “Boh, cioè, cosa ne so...” “Mah - dico - ci guardiamo in giro vediamo se c’è qualche bar, entriamo a bere qualcosa e poi... Cominciamo a chiedere, non...” E infatti vediamo un bar, no, entriamo e c’era una vecchia con altre due un po’ più giovani. Appena entrati “Buonasera”, “buonasera”. [ride] Oh, insomma: “Qui è il paese delle meraviglie!”, dicevo io con questo. Vabbé. Intanto ci siamo ordinati da bere e comincio a chiedere: “Il sindaco... chi è?” “Mah - dice - si chiama Sartori”. Dico, “Ma in Comune non c’è?” “No no - dice - lui in Comune non c’è mai, perché ha una cava, lavora lì e...” E questa vecchia poi a un certo punto mi dice: “Voi venite dalla Monteforno”. [Ride, mima la faccia stupita] “Come dico - e come fa lei a saperlo?” “Eeeh, le voci girano.” “Ma porca miseria, ma non è possibile”. “E comunque – dico – può indirizzarmi più o meno dov’è questa cava, perché avrei bisogno di parlare...”. “Sì, sì - dice - non è... non è difficile dice - intanto beva tranquillo che dopo glielo spiego io.” Vabbé. Finiamo di bere, abbiamo offerto qualcosa anche a loro queste donnette che erano lì, e poi dice: “Dovete fare quella stradina là, dopo la curva, vedete che c’è la cava, eccetera, no?” Arriviamo lì, come siamo scesi dalla macchina vediamo un uomo che si stacca e ci viene incontro. Ci viene incontro, è arrivato lì e dice: “Voi venite dalla Monteforno.” Dico “Ma ce l’ho scritto qui?” [indica la fronte, ride] Dice: “Guardi che è già da qualche giorno che circola questa voce che c’erano delle persone interessate a venire a Linescio per fare qualcosa a seguito di quello che è stata la votazione”. E in effetti dico: “Si, è così, volevamo parlare con lei, il segretario comunale, il prete e organizzare una cena.” E dice: “Guardi che qui a Linescio non c’è questa possibilità [per mancanza di un luogo adeguato]” perché poi in Monteforno la cosa si stava allargando: “vengo anch’io, vengo anch’io, vengo anch’io!” Insomma abbiamo dovuto prendere un pullman poi per... [ride] E organizziamo questa cena a Cevio. Mai fatta una cena così, ma non tanto in quello che abbiamo potuto mangiare o anche bevuto, perché poi in quelle situazioni anche nel bere si eccede, ma per quello che ne è derivato come... amicizia, come conoscenza, come discussione, ma ognuno sembrava che si preoccupasse dell’altro: “Tu cosa fai?” Non lo so, magari diceva “Però vorrei cambiare”, “guarda che la possibilità c’è”, a dipendenza di quello che diceva. Ecco, ne era derivata una sorta di rispetto reciproco, di quasi amicizia proprio improntata al... al miglior consiglio da dare a quell’altro, no? Io lo davo a quello lì, quello lì lo dava a quell’altro e così via [...] È stata una delle esperienze più significative da che sono qui». Le iniziative anti-immigrati rappresentarono un momento di rottura forte, che necessitava di un bilanciamento, almeno simbolico, per ritrovare la fiducia e l’equilibrio persi nella propria esperienza migratoria. Ecco allora la scoperta di Linescio, piccolo paesino sperduto del Ticino, dove su 27 votanti, 27 avevano votato contro Schwarzenbach. Quella era l’isola felice dove recuperare rapporti umani non inquinati dal dubbio, dove trovare finalmente quell’accoglienza e quella solidarietà negate nel resto del Paese agli immigrati, sottoposti a dure condizioni di lavoro, trattati come semplici fattori produttivi, dei quali liberarsi nei momenti di alta congiuntura. La cena, infine, venne organizzata e grazie al sostegno della direzione dell’azienda, che partecipò anche finanziariamente, fu un grande successo. Quello che viene sottolineato nella descrizione che ne fa Gallittu è la caduta delle barriere e la riscoperta di una comune umanità grazie alla festa ed alla condivisione. «Ognuno – racconta - sembrava si preoccupasse dell’altro. Ne era derivato una sorta di rispetto reciproco, di quasi amicizia, proprio improntata al miglior consiglio da dare a quell’altro. È stata l’esperienza più significativa da che sono qui.» G.C., immigrato sardo che abbiamo incontrato in precedenza, comincia vivendo nelle baracche, e la percezione della discriminazione è legata fin dall’inizio al suo impegno sindacale, vissuto come lo strumento per far valere la propria qualità di uomo tra gli uomini: «Mi si dice: come puoi restare in un ambiente di lavoro così brutto, così indietro dal punto di vista sindacale? Da una parte c’è il salario che arriva con puntualità e dall’altra parte quello che mi affascina è di risolvere certi piccoli problemi che esistevano, di questi lavoratori che erano in condizioni inumane. 58 Percorsi di ricerca 2/2010 Ma non tanto la vita in baracca, era un problema ma non il peggiore. [il peggio] Era il fatto di vivere ai margini dal resto della società, di essere considerati come “quelli della baracca”. Ci ho vissuto e non è che mi sentissi così differente, a disagio; il mio malessere nasceva dal fatto di essere catalogato come abitante delle baracche.» Fin dal suo arrivo nel 1969 G.C. diventa protagonista di lotte che faranno di lui un militante sindacale rispettato e intransigente, presidente della commissione di azienda durante molti anni: «Un’altra storia che mi ricordo: un mattino, la signora non ci apre la mensa, perché non c’era il latte, dunque non c’era colazione, che era prevista nel contratto. I ragazzi, sempre i soliti 13 sardi, protestano e fermano il lavoro, in silenzio, una forma di sciopero. Davanti al direttore che dice “ma se non c’è latte non è colpa della signora!” “Noi non ce l’abbiamo con la signora, diciamo che possiamo anche prendere la colazione senza latte, ci basta un sandwich farcito...”, “Ma se è soltanto questo [a detto il direttore], allora portate un cesto di sandwich per gli operai!”, e il problema è stato risolto in questo modo.» In questa prima lotta G.C. vede già tutti gli elementi che si ritroveranno in quelle più importanti alla Monteforno: il ruolo dei sardi, la fermezza dei giovani operai, la loro spontaneità che comincia ben presto a rimettere in discussione il comportamento dei sindacati in fabbrica. «Ma qui si vedeva questa volontà di questi giovani che volevano cambiare qualche cosa, che vedevano che la situazione sindacale... anche se i sindacalisti arrivavano [in fabbrica], il lavoro che facevano... Non si votava per la Commissione, c’erano questi rappresentanti dei lavoratori che erano forse nominati dal capo del personale... Mi ricordo che, con qualche amico, abbiamo voluto organizzare le votazioni. Non era facile nel ‘70-’71. Credo che la prima votazione per la Commissione l’abbiamo fatta nel 1972.» Nel 1970, con il primo sciopero «selvaggio», cominciò alla Monteforno una stagione di lotte molto radicali, che portarono in primo piano una nuova generazione di militanti in fabbrica. I protagonisti di questa ondata di lotte sono stati in maggioranza immigrati provenienti dal Sud Italia, in particolare sardi. Secondo Malik Von Allmen e Jean Steinauer, «A partir de 1970, les mobilisations et les grèves font de l’aciérie Monteforno de Bodio une véritable université du syndicalisme en mouvement.» 7 Gli immigrati dall’Italia erano prima di tutto giovani arrivati al Nord alla ricerca di un futuro differente da quello al quale erano destinanti rimanendo a casa propria: una situazione che, con le dovute proporzioni, assomiglia a quella dei grandi centri industriali italiani, confrontati a partire dal 1969 a una grande ondata di lotte dei lavoratori, come spiega lo storico Diego Giachetti : «Fu questo strato della classe operaia, composto da operai comuni, in genere di origine contadina e meridionale, di relativa o recente immigrazione, prevalentemente giovani, che connotò quel ciclo di protesta caratterizzato da una scarsa disciplina sindacale, dall’insofferenza per il lavoro, per le regole del conflitto negoziale tra sindacato e padroni, per l’ostilità e la ribellione verso la gerarchia aziendale, per le forme di lotta nuove usate [...].» 8 Le lotte iniziate nel 1970 alla Monteforno come anche nel resto della Svizzera 9 e che continueranno durante tutti gli anni ‘70, nelle quali gli immigrati ebbero spesso un ruolo di primo piano, possono J. Steinauer, M. Von Allmen, L’apport de l’immigration au syndicalisme suisse, in Les hommes, les idées, les pratiques, Genève, 2000, Tome I, p. 104. 8 D. Giachetti, Anni Sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli anni della contestazione, Pisa, 2002, p. 207. 9 Basterà qui ricordare il caso dello sciopero alla Paillard di Yverdon nel 1971; lo sciopero alla SIP di Ginevra nel 1975; quella alla Bulova-Watch di Neuchâtel nel1976. Nello stesso anno cominciò lo sciopero più importante degli anni ‘70, quello alla Matisa (Canton Vaud), durato tre settimane, seguito dallo sciopero alla Dubied di Neuchâtel, durata quasi un mese. Cfr. C. Koller, Sciopero, partenariato sociale e partecipazione. Dal contrasto all’integrazione dei mezzi d’azione sindacali, in R. Beck (a cura di), Ogni passo che fai non è vano. Uno sguardo sul sindacato FLMO. 1970-2000, Bellinzona, 2004, pp. 47-59; J. 7 59 Percorsi di ricerca 2/2010 essere interpretate come una reazione – tra le altre cose – alla pesante avanzata dei sentimenti antiimmigrati che si svilupparono in Svizzera a partire dagli anni ‘60 ? La percezione del rifiuto era uno degli elementi tipici della condizione degli immigrati, nel Nord Italia come in Ticino, e la ribellione alla discriminazione (presente in tutti i campi della vita quotidiana dell’immigrato) divenne uno dei motori delle mobilitazioni. È un’ipotesi che merita un approfondimento, ma che pare essere confermata da testimonianze come quelle di Severino Marutto, militante sindacale protagonista delle lotte dei metalmeccanici ginevrini nel 1971, che spiega a Steinauer e Von Allmen come il suo impegno militante sia nato in reazione alla xenofobia 10. Ecco dunque che si apre uno spazio di ricerca interessante: l’ipotesi di una relazione tra la condizione migrante e l’emergere di un nuovo attivismo operaio riceve un’ulteriore conferma dallo studio delle forme di partecipazione degli immigrati nel secondo dopoguerra fatto da Patrick Ireland, che parlando dello sviluppo delle mobilitazioni degli anni ‘70 in Svizzera spiega come le rivendicazioni avanzate andassero ben al di là della fabbrica, toccando la condizione di migranti di questi lavoratori: «There were a dozen strikes in 1971 alone, even more in 1972. Often they centered on economic demands, such as salary increase, opposition to layoffs, and job security; but wider issues usually came into play as well: housing conditions, opposition to the labour peace and the seasonal worker statute, and human dignity.» 11 Per questo ricercatore, gli «scioperi selvaggi» e le manifestazioni che interruppero la tranquilla quotidianità delle relazioni sindacali in Svizzera nel corso di questo periodo rappresentarono «the immigrants’ participatory form of choice» 12. Lavoro e identità migrante È in fabbrica, in mezzo a lavoratori per lo più di origine italiana, che ci si sente meno stranieri, o almeno ci si sente parte di qualcosa. Di fronte ai frequenti episodi di intolleranza nei confronti degli immigrati italiani (non erano rare – secondo gli stessi racconti degli intervistati – le risse nei locali) si mette avanti il lavoro, il proprio essere «utili» alla creazione della ricchezza del Paese ospitante, reclamando in questo modo un pezzetto almeno di legittimità. È quanto emerge dal racconto di C. R., un altro dei lavoratori intervistati, nato nel 1944 ad Aquilonia, in provincia di Avellino, alla Monteforno per 34 anni: «[...] perché la Svizzera deve pensare che l’abbiamo fatta noi, che i svizzeri tengano in considerazione gli italiani, che siamo venuti qua, che li abbiamo fatti cambiare. Perché se tu adesso vai per Biasca il vero svizzero dice “dobbiamo dire grazie agli italiani”. E c’è quelli che ci guarda ancora male, che po’ allora adesso stanno guardando gli emigranti che stanno arrivando dopo di noi e noi. Questi li devono mantenere, noi siamo venuti qui con il contratto di lavoro perché la frontiera non passavi senza contratto.» È ancora più esplicito D. D., lavoratore di origini campane, per 30 anni in acciaieria, che rispondendo alla domanda «che cos’era la Monteforno per lei» spiega: «È stata tutto per me, l’inizio della mia seconda patria 13, lì sono cresciuto, sono diventato uomo, mi ha dato e ho dato, maSteinauer, 1976: grève chez Dubied, in V. Boillat, B. Degen et al., La valeur du travail. Histoire et histoires des syndicats suisses, Lausanne, 2006, pp. 238-239. 10 J. Steinauer, M. Von Allmen, Changer la Baraque. Les immigrés dans les syndicats suisses 1945-2000, Lausanne, 2000, p. 105. 11 R. P. Ireland, The Policy Challenge of Ethnic Diversity. Immigrant Politics in France and Switzerland, London, 1994, p. 159. 12 Ibid., p.163. 60 Percorsi di ricerca 2/2010 gari se potevi lavoravi anche la domenica... Dopo il primo impatto non averi lasciato per nessun motivo, ti entra nel sangue, sarei stato lì a lavorare.» Il lavoro rappresenta per gli operai immigrati della Monteforno, il centro della propria vita: dal punto di vista materiale, visto che in acciaieria a volte ci stavano per sedici ore di fila (si lavorava anche la notte su tre turni) ma pure in un’accezione più generale. Sul lavoro si tessevano reti sociali tra colleghi che condividevano lo stesso destino, la fabbrica era una specie di piccola patria all’estero, più accogliente del Paese d’immigrazione e ognuno identificava il proprio destino con il futuro della fabbrica. A questa dichiarazione d’amore per l’acciaieria fa da contraltare la sensazione di tradimento indotta dalla sua chiusura, che rivela a D. D. quanto gli svizzeri considerino i lavoratori italiani sempre degli «stranieri», nonostante i lunghi anni passati in Ticino e il ruolo avuto nel suo sviluppo economico: «E un’altra cosa che sono rimasto [male] dopo la chiusura della Monteforno è stata un po’ la freddezza proprio, quasi del cantone in sé. […] E un altro shock l’ho ricevuto dall’autorità. Quando Dick Marty che ha fatto una riunione, che ha detto: “Guarda, eh, ormai cosa volete? Il 95% [dei lavoratori Monteforno] sono stranieri...”, come dire “vanno via gli stranieri, per gli svizzeri c’é posto...”. Da una persona di governo non... Lì è stato veramente uno shock. Ho subìto qualcosa, dico, “mah”, non l’avrei aspettato. Si è sentito tradito sia dalla gente che viveva qui... Un po’ sì, perché a pensare a quello che si è dato in questa valle, in questi paesi dove veramente come dicevo prima, tutte le persone scappano...» Dopo la chiusura della fabbrica, avvenuta ufficialmente il 31 dicembre 1994, la situazione dei quasi 300 operai che erano sopravvissuti ai licenziamenti degli anni ‘80 è difficile: il governo cantonale diede vita a un progetto di ricollocamento professionale, ma molti lavoratori – l’età media in fabbrica era allora tra i 40 e i 50 anni – ebbero molte difficoltà a trovare nuove strade: erano degli straordinari specialisti nel proprio campo, ma questa bravura era anche la loro debolezza, dal momento che in Ticino non vi erano acciaierie delle dimensioni della Monteforno. Dopo un periodo di depressione seguito alla perdita del lavoro, C. R. decise di accettare l’offerta di una ditta della zona, anche se a prezzo di una decurtazione significativa del salario. Eppure, l’importante era lavorare: «Sono stato contento andare piuttosto a lavorare, mi sono tenuto nel campo del lavoro ancora, senza arrivare... anche se il guadagno era quello che era, però sono contento.» Donne, vestiti e vita sociale. Identità allo specchio La maggior parte del loro tempo i lavoratori della Monteforno lo passavano in fabbrica: le testimonianze orali ci permettono di cogliere le complesse dinamiche relazionali che si creano sul lavoro, la cui centralità nell’esperienza migratoria ne determina la grande importanza nell’orizzonte quotidiano dell’immigrato. In fabbrica si creavano reti di solidarietà – per esempio tra compaesani – e ostilità (tra ticinesi e italiani; tra italiani del Nord e del Sud; ecc.) e si formava la comune coscienza della propria forza e della necessità dell’azione collettiva. Con i colleghi di lavoro si esciva la sera per andare a ballare nei «grotti» o per mangiare qualche cosa a fine turno. La vita sociale all’esterno della fabbrica era mediata dalla conflittualità latente presente nella società d’accoglienza nei confronti dei «taliàn», che induceva una reazione di presa di distanza e differenziazione da parte degli stessi immigrati nei confronti dei ticinesi. 13 Il corsivo è mio. 61 Percorsi di ricerca 2/2010 Le parole di C.R. ci permettono di rovesciare la nostra prospettiva e di vedere gli Svizzeri (in questo caso i ticinesi) attraverso gli occhi di questi immigrati. È infatti C.R. a portare un giudizio severo sugli indigeni, mentre solitamente siamo abituati a sentire il contrario: «Io ricordo che noi andavamo a Malvaglia - in un secondo tempo, no i primi anni - andavamo a Malvaglia a ballare. Noi dall’Italia si vestiva cravatta, vestitino, sai, bene, ci si presentava là, le ragazze ballavano con noi, non con loro che andavano con gli zoccoli di legno, che cazzo vuoi ballare? E lì le botte... E lì non ci potevano vedere perché loro non potevano arrivare, no perché erano più intelligenti [meno intelligenti] era un sistema di vita, quello è. Noi alla domenica andavamo al ristorante, ma vestiti. Loro la tuta - come la chiamano? [chiede alla moglie] - Salopette [risponde lei] - quello era la domenica, quella era il giorno di Natale e quella era in settimana. [Moglie] Poi era il modo di vestire loro... [Lui] Lasciamo stare quelli di una certa età, ma i giovani come noi che loro erano abituati così... Io sono stato cresciuto dai mie genitori, dalla scuola alla domenica andare a messa, vestirti, anche se si stava in campagna.» La differenza tra sé e gli altri si percepisce prima di tutto attraverso la differenza nell’abbigliamento e nell’attenzione ai momenti della vita pubblica, per i quali è necessario prepararsi, anche se si è lontani da casa propria e si vive in una condizione precaria. Una differenza che porta le sue conseguenze: grazie alla sua testimonianza, che corrisponde a quella di molti altri suoi colleghi, C.R. ci parla di quello che è stato uno dei conflitti principali che hanno visto opporsi questi giovani immigrati provenienti dal Sud ai ticinesi: quella per le donne. Il campo di battaglia era sovente il «grotto», dove si ballava e succedeva che, dopo qualche bicchiere di troppo, si passasse alle mani. Giovani, celibi, lontani da casa propria e soli: i lavoratori italiani della Monteforno rappresentavano per i giovani indigeni una fastidiosa concorrenza in campo sessuale. E i rapporti di amicizia o sessuali tra donne ticinesi e immigrati erano un tabù nella società del tempo, se si crede alle parole di L. M., originario di Bergamo, che ha sposato una donna ticinese : «Eh, una volta era così, anche se un italiano si sposava una ragazza. Questa qui la sentita, no? Che cosa? Lei, l’ha sentita? Una volta gli italiani che arrivavano qui e che sposavano magari una ragazza ticinese, la gente non voleva, questa l’ha sentita, la sa, no? Questa qui è storia, è storia lunga... A lei è capitato così? Sì, i suoi zii sì, l’hanno detto, i suoi zii. Glielo dicevano alla sua mamma. “Come fai a lasciar sposare la tua figlia a un italiano?”. E sua mamma invece era d’accordo... No [ride]. Era un po’... C’era una mentalità così, purtroppo era così.» Il sentimento anti-italiano era dunque profondamente ancorato nella mentalità della zona, e questo nonostante Bodio e Biasca avessero una tradizione di immigrazione piuttosto lunga 14: un sentimento che diventa più forte ancora nei confronti degli immigrati che provengono dal Sud Italia, di cui i ticinesi dicono che sono ancora più lontani da loro culturalmente. E il fatto di avere una lingua comune, l’italiano, non ha alcuna utilità, visto che sia per i ticinesi che per gli immigrati l’italiano non è che la seconda lingua dopo il dialetto. Questa inattesa prospettiva sessuata che emerge come spiegazione della conflittualità tra immigrati e indigeni nelle testimonianze orali dei lavoratori Monteforno è uno dei risultati più interessanti della ricerca attorno alla vita sociale degli immigrati fuori dalla fabbrica, in generale ricca di indicazioni e L. Lorenzetti, La popolazione di Bodio tra industrializzazione e immigrazione (1850-1930), in AAVV, Bodio. Dal villaggio rurale al comune industriale, Bodio, 1997, pp. 101-126. 14 62 Percorsi di ricerca 2/2010 spunti che per brevità non è possibile elencare diffusamente in questo articolo. Si va dall’indagine dei rapporti uomo-donna nella famiglia migrante, alla costruzione di nuove solidarietà e reti sociali nella nuova realtà dove la famiglia si trova proiettata dall’esperienza migratoria, passando per il tempo libero, le strategie matrimoniali e di educazione dei figli. Infine, ma non per ultimo, lo sguardo che gli immigrati - «ospiti» a volte indesiderati – portano sulla società ticinese offre agli studiosi della storia e della società del Ticino la possibilità di vedere, con gli occhi degli «altri», quello che spesso «dall’interno» difficilmente si riesce a cogliere. Le contraddizioni nell’atteggiamento verso i lavoratori immigrati, fonte di ricchezza eppure tenuti ai margini della vita sociale da una diffusa diffidenza sono chiare e, se da una parte ci impongono di interrogarci sulle aporie nel percorso di costruzione di un’«identità ticinese» 15, costruita spesso in negativo nel rigetto dell’altro, ci induce ancor di più al rispetto per queste vite spostate che – anche nella tempesta (o nel fuoco dell’acciaieria) – hanno trovato un nuovo, difficile equilibrio. 15 G. Pedroli, Il senso e le parole, scritti di Guido Pedroli 1952-1962, Centro Guido Pedroli (a cura di), Casablanca, 1990. 63 Percorsi di ricerca 2/2010 Repressioni, collusioni e mutua assistenza tra Italia e cantoni meridionali della Confederazione Elvetica (1925-1945) Francesco Scomazzon Introduzione al tema: confini, regioni confinarie e rapporti transfrontalieri I confini, tradizionalmente oggetto d’interesse per i geografi, sono un tema che continua ad essere di attualità, sia in relazione al loro aspetto divisorio, sia come luogo di contatto e scambio, dove percezione e spazio d’azione mutano al variare di fattori soggettivi o di parametri esterni. L’incontro di due strutture o sistemi diversi, li caratterizzano infatti come luoghi di tensione e il loro effetto unificante – determinato dal trasferimento di persone e beni (in gran parte nei due sensi) – non ne garantisce l’automatica trasformazione in un’area equilibrata. D’altronde la dilatazione dei suoi limiti geografici, culturali e sociali sono il segno di un’estensione funzionale che, ai tradizionali compiti fiscali, affianca – in Stati con opposti regimi politici – quelli di controllo e di barriera ideologica. Una prassi seguita al confine tra Italia e Svizzera nei primi decenni del Novecento, dove le crescenti divergenze politiche, accentuate dalle tensioni confinarie, finirono paradossalmente per rafforzare quei preesistenti legami sociali ed economici di Lombardia e Piemonte con il Ticino. La continuità della sua struttura democratica rese infatti il cantone luogo prescelto di rifugio per gli esuli italiani, il cui antifascismo era ovviamente fonte di preoccupazioni per un regime ancora in fase di consolidamento. La storia dell’antifascismo italiano è quella di due mondi apparentemente lontani e distinti, costituiti anzitutto da una resistenza interna ridotta per molto tempo a esigui gruppi clandestini che ritrovarono centralità soltanto dall’autunno 1943, nonché da un antifascismo in esilio, quello dei fuorusciti, eredi spirituali degli esuli risorgimentali, ai quali i primi rimproveravano con il ripiegamento all’estero, l’incapacità nel comprendere l’evoluzione della società italiana. Di fatto l’emigrazione politica giocò un ruolo altrettanto fondamentale quanto la dissidenza interna, entrambe in contatto attraverso corrieri, scaltri passatori e un’anonima schiera di valligiani che, regolarmente piegati da cicliche crisi economiche, facevano dei traffici confinari una risorsa alle loro magre e sofferenti esistenze 1. Attività parallela ai flussi migratori generati dalla progressiva radicalizzazione del regime, e che determinarono – soprattutto nella Francia di Poincaré – lo sviluppo di una fiorente emigrazione con uomini di punta quali Nitti, Angelo Donati, Gaetano Salvemini e il giovane Piero Gobetti, già direttore della «Rivoluzione liberale», destinato a morire esule per le gravi violenze riportate in patria 2. Tuttavia si trattava di un fuoruscitismo che non poteva prescindere da quanto si stava organizzando nella vicina Confederazione, Paese che andava delineandosi quale anello di congiunzione tra una resistenza interna e un’opposizione incentrata su una Francia la cui classe dirigente – come già accennato – non faceva certo mistero di simpatie antifasciste. In tal senso la presenza di sovversivi innestatisi sulla precedente emigrazione economica, già stabilizzata a metà anni Dieci sul Ceresio – ma anche a Ginevra, Zurigo e Basilea – garantì quell’irrinunciabile congiunzione tra gruppi clandestini E. A. Perona, A. Cavaglion (a cura di), Luoghi della memoria, memoria dei luoghi nelle regioni alpine occidentali, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, 2005. 2 P. Milza, S. Berestein, Le fascisme italien, 1919-1945, Parigi, 1980, pp. 371 e ss. 1 65 Percorsi di ricerca 2/2010 ancora attivi in patria e quadri dirigenti raccolti soprattutto nella regione parigina attorno a quella che sarebbe poi diventata la «Concentrazione di aziona antifascista» 3. Una rete di conoscenze che garantì sul finire del 1926 all’ex-deputato Claudio Treves e ai più giovani Saragat ed Emilio Zannerini, l’ingresso a Lugano e il successivo trasferimento a Parigi, dove l’anziano socialista fu poi tra i maggiori animatori della Concentrazione, dirigendone – fino a quando morì, nel 1933 – il quotidiano «La Libertà». Incidenti e connivenze di frontiera Al di là del numero abbastanza contenuto dei profughi politici italiani attivi in Svizzera che sul finire del 1929 erano appena 32, di cui 13 stabilitisi a Ginevra e solo 9 nel Ticino – la maggior parte dei quali concentratisi nel Luganese 4 – quello che preoccupava il fascismo era soprattutto l’eventuale incontrollata attività che questi avrebbero potuto svolgere in una regione tutto sommato di facile accessibilità, attraversata da boschi e colline, nonché da una miriade di paesi rifugio per sbandati o avventurieri che, alla ricerca di magre integrazioni salariali, avrebbero potuto costituire oggetto di attenzione per i più attivi propagandisti. Situazione ben nota al fascismo che non tardò a riorganizzare il sistema di vigilanza lungo l’intero arco alpino, passando da una complessiva revisione degli organi preposti alla repressione dei traffici illeciti, ad un’attenta riformulazione delle strutture amministrative periferiche. Lo smembramento e la successiva costituzione nel 1927 di nuovi enti-provincia, giustificati – come nel caso di Varese – da improbabili ragioni socio-economiche o, per l’Aostano, dal desiderio di annegare in ambienti a prevalente matrice italiana particolarismi e tradizioni locali, non rappresentarono altro che la volontà di estendere i controlli in zone strategicamente rilevanti per la stabilità interna. Un impegno di difficile attuazione non solo per le gravi mancanze, sovrapposizioni di compiti e una generale superficialità dell’amministrazione fascista, ma soprattutto per quelle inestricabili e ben collaudate complicità che garantivano taciti appoggi a scaltri faccendieri, procacciatori, nonché a cospiratori e ad antifascisti più o meno consapevoli. Il presupposto che la maggioranza delle popolazioni locali – e non soltanto di parte italiana – fosse effettivamente coinvolta in contrabbandi fiscali e politici, accentuò l’arroganza dei militi fascisti, spingendo all’opposizione individui politicamente non schierati ma che, causa le ripetute vessazioni, avrebbero potuto favorire l’espatrio di disertori o di qualche più noto sovversivo. Anche le ripetute prepotenze su ignari cittadini svizzeri, loro malgrado sorpresi a sconfinare in zone turistiche non visibilmente delimitate, diventava un pretesto per rivendicare l’autorità delle camicie nere, accentuando – come avrebbe scritto il foglio ticinese Libera Stampa – «uno stato d’animo d’insofferenza, inquietudine e ostilità. Se ne dà la colpa – riprendeva il quotidiano socialista – al temperamento, all’ignoranza o all’abuso di zelo dei signori militi fascisti, ma devono esistere invece ordini precisi che vengono eseguiti con la massima buona volontà» 5. Un sospetto poco convincente rispetto ad un abuso di potere che con il tempo avrebbe trasformato quella timida diffidenza al regime in attiva opposizione. Gli sforzi diplomatici nel ricucire le tensioni tra i due Stati – confermando i propositi di reciproca amicizia enunciati da Mussolini al Senato nel giugno 1928 – non riuscirono infatti a scardinare intrecci e connivenze di cui beneficiavano gruppi e singoli antifascisti riparati oltre frontiera. Due anni dopo, in occasione di un incidente avvenuto in territorio elvetico sul colle del Teodulo – e di fronte alle rimostranze del consigliere federale Giuseppe Motta – il diplomatico italiano Raffaele Guariglia aS. Fedele, Storia della Concentrazione antifascista 1927-1934, Milano, 1976. M. Cerutti, Fra Roma e Berna. La Svizzera italiana nel ventennio fascista, Milano, 1986, p. 179. 5 Libera Stampa, «Al confine», 16 agosto 1928. 3 4 66 Percorsi di ricerca 2/2010 vrebbe informato il ministro Grandi di quanto lo statista ticinese fosse «molto preoccupato per i continui incidenti di frontiera italo-svizzeri, che lo mettono in una situazione difficile e gli rendono assai ardua l’opera che egli svolge con reale buona volontà per eliminarne le ripercussioni. [...] Ho cercato naturalmente – proseguiva Guariglia – di diminuire l’importanza dei fatti avvenuti e di mettere in evidenza la buona fede e lo zelo dei nostri militi determinato da ragioni di sicurezza effettivamente serie, ma a V.E. non può sfuggire la difficoltà di trovare delle ragioni per giustificare un’incursione della nostra Milizia in territorio svizzero per un’ora e mezza! [...]» 6. Questi abusi innestarono tali diffidenze da avvantaggiare gli stessi gruppi antifascisti o qualche sparuto avversario del regime riparato oltre frontiera. Sfruttando corrieri interni alle proprie organizzazioni e reclutando schiere anonime di braccianti ansiosi di riscattare anni di stenti e oppressioni, si riuscivano ad arginare almeno in parte i controlli di fiduciari alla ricerca di notizie su movimenti o presunti atti terroristici. Azioni che, se portate a termine, smuovevano solo marginalmente una popolazione in larga misura afascista, e comunque – indicava il prefetto comasco Maggioni – in grado di «apprezzare l’ordine che il governo sa mantenere» 7. Atteggiamenti individualisti che Nenni avrebbe poi condannato nel marzo 1927 in una lettera a Giuseppe Donati, direttore del «Corriere degli italiani», invocando, oltre ad una più diffusa cultura antifascista, l’importanza d’inondare il Regno di stampa clandestina, «avendo presente – riprendeva l’esponente socialista – che l’antifascismo efficiente si fa al di là e non al di qua delle Alpi» 8. Un incitamento alle prime ed isolate iniziative propagandistiche, anticipate – anche rispetto alle leggi Rocco – dal richiamo a quell’unità d’azione invocata per esempio dal romanziere Mario Mariani, già animatore in Italia di un movimento «volontista» dalle finalità politiche non ben definite 9. «Ciascun sovversivo – invocava da Parigi l’antifascista – deve oggi provvedere con mezzi propri, aleatori e malsicuri che possono compromettere chi è ancora in patria. […] Bisogna organizzare del pari un servizio sicuro di frontiera che permetta facilmente a quelli che vogliono sottrarsi alle torture e all’assassinio presagito di attraversare il confine. E che permetta anche a chi, per ragioni di famiglia ed altre, intenda affrontare di tornare in Italia, di poterlo fare comodamente» 10. Di queste relazioni si avvantaggiarono quanti coinvolti nel traffico di fogli e manifesti cosiddetti sovversivi. A poche settimane dall’attentato Lucetti, il 20 agosto 1926 il Viminale informò la Prefettura di Milano dell’imminente smercio di opuscoli antifascisti pronti per essere introdotti nel Regno dai varchi di Ponte Tresa e Porto Ceresio, nell’alto Varesotto 11. Alcuni mesi dopo il Ministero dell’Interno sarebbe tornato sulla questione con una nota che lasciava intravvedere più vaste collusioni. «Da notizie fiduciarie risulta che nella tipografia Elvetica di Lugano sono in corso di stampa duecentomila opuscoli dal contenuto antimilitarista e comunista destinati ai soldati. Vi sarebbero aggiunti anche dei versi della nota Balabanoff. A Lugano affluiscono pure come centro di smistamento, altri fogli e cioè il Becco Giallo, l’Umanità e il Corriere degli Italiani, provenienti dalla Francia e destinati ad essere distribuiti in Italia. Secondo il fiduciario, si presterebbero all’importazione clandestina di detti stampati il personale ferroviario e specialmente il personale di macchina, che trove- Documenti Diplomatici Italiani (in seguito DDI), settima serie, vol. 9, n. 246, allegato. Archivio di Stato, Como (in seguito ASCo), gabinetto di prefettura 1, sc. 134. Prefettura di Como al Ministero dell’Interno, 13 agosto 1928. 8 R. De Felice, Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929), Torino, 1995, pp. 563-67. 9 Fedeli, Storia della concentrazione antifascista, cit., p. 10. 10 Archivio di Stato, Torino (in seguito ASTo), gabinetto di prefettura 1, sc. 645/2. Ministero dell’Interno alla Prefettura di Torino, 13 aprile 1927. 11 Archivio di Stato, Milano (in seguito ASMi), gabinetto di prefettura 1, sc. 1097. Ministero dell’Interno alla Prefettura di Milano, 20 agosto 1926. 6 7 67 Percorsi di ricerca 2/2010 rebbe più facilmente modo di eludere la vigilanza alla frontiera. Gli stampati sarebbero poi consegnati a persone incaricate in attesa nelle piccole stazioni, e poscia avviate per le varie destinazioni» 12. Le complicità di un ambiente ferroviario, già additato dal regime come ricettacolo di sbandati e sovversivi, vennero confermate dalle molteplici collusioni che legavano agitatori e professionisti del contrabbando a spedizionieri ed agenti di commercio. I loro bassi guadagni e le scarse prospettive di carriera – associati ad un latente antifascismo – erano infatti ragioni sufficienti perché un confidente introdotto alla stazione di Chiasso, li additasse quali «contrabbandieri, spacciatori di cocaina ed emissari di lettere sovversive. Si può affermare – sottolineava l’ignoto informatore – che quasi tutti hanno peccati sulla coscienza. Dato che sono conoscenti delle guardie di Finanza e di PS essi hanno facilità di transitare ed il controllo su loro sfugge» 13. Connivenze che assicurarono il sostegno finanziario ai familiari dei perseguitati – come dimostrarono i legami di alcuni anarchici italiani a un ferroviere bellinzonese poi arrestato a Milano nel 1929 14 – ma anche la continuità nello smercio di libelli antifascisti tra masse proletarie ormai addomesticate dal regime. Un’attività appannaggio di corrieri o funzionari, «lavoratori, in maggioranza operai, che sceglievano liberamente la “professione” del “militante rivoluzionario”, con la prospettiva quasi certa di finire davanti al Tribunale Speciale» 15, come pure da contrabbandieri legati a botteghe di anonimi antifascisti elvetici. Nell’aprile 1927 il capo della Polizia, Arturo Bocchini, segnalò alla Prefettura di Milano che Paolo Branca «domiciliato a Figino (Svizzera) sarebbe uno dei fiduciari di cui si servono i fuorusciti per introdurre clandestinamente nel Regno dalla Svizzera stampa, pieghi e lettere sovversive di propaganda antifascista» 16. Trattandosi di fogli destinati a persone poco istruite e con opinioni politiche inconsistenti se non del tutto assenti, gli effetti erano però limitati a rare occasioni di confronto che non garantivano un’efficace ripresa dell’azione politica a livello nazionale. Il pericolo della denuncia e delle delazioni quotidiane, spesso alimentate da invidie e gelosie maturate nei rapporti di vicinato o nelle frequentazioni di lavoro, facevano in modo che i volantini venissero esibiti e denunciati alle autorità dagli stessi destinatari che, magari intimamente contrari al regime, ne dimostravano però la completa sottomissione. Chi traeva invece beneficio da questa situazione era l’opposizione d’oltre frontiera, capace di richiamare nella sua orbita decine di emigranti spinti alla fuga non tanto da ragioni politiche, quanto dalle crescenti ristrettezze finanziarie. Se i trasferimenti temporanei all’estero di singoli professionisti e tecnici, veicoli di quella nuova e tanto conclamata espansione commerciale-culturale erano accettati e – nei limiti – pure favoriti dal regime, l’espatrio incontrollato indotto da ragioni economiche rappresentava invece un potenziale strumento di opposizione nelle mani del più agguerrito antifascismo 17. Non rari erano i casi di sbandati e avventurieri che, in cerca di fortuna, si imbattevano al di là del confine in reti clandestine attive nel reclutare corrieri e volontari da ingaggiare sia in quelle discutibili attività propagandistiche, sia da inviare sui vari fronti di guerra, partendo ad esempio dalla vicina penisola Iberica. ASTo, gabinetto di prefettura 1, sc. 645/2. Ministero dell’Interno ai prefetti delle province di confine, 19 ottobre 1927. Archivio Centrale dello Stato, Roma (in seguito ACS), polizia politica materia, sc. 18. Lettera fiduciaria, 2 dicembre 1929. 14 Cerutti, Fra Roma e Berna, cit., pp. 282 e ss. 15 A. Dal Pont, A. Leonetti, M. Massara, Giornali fuori legge. La stampa clandestina antifascista (1922-1943), Roma, 1964, pp. 247-51. 16 ASMi, gabinetto di prefettura, sc. 1097. Capo della Polizia alla prefettura di Milano, 26 aprile 1927. 17 P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Roma-Bari 2007, nonché A. Treves, Le migrazioni interne nell’Italia fascista, Torino, 1976. 12 13 68 Percorsi di ricerca 2/2010 Irredentismo, infiltrazioni culturali e opere d’assistenza In questo microcosmo d’illegalità le restrittive leggi federali, giustificate dal fragile equilibrio internazionale del Paese, non riuscirono ad impedire le naturali forme di partigianato o militanza a favore di uno dei fronti in lotta, e tanto meno arginarono la crescente influenza – soprattutto nei Grigioni e tra i circoli giovanili dei cantoni settentrionali – di movimenti filo-nazisti alimentati da vaghe ideologie a sfondo razzista. Un fenomeno circoscritto, ma sufficiente ad accrescere l’indecisione di Berna anche di fronte alle organizzazioni antifasciste, ben accolte per esempio da un Ticino che, sin da metà anni Venti, era soggetto alle continue spinte irredentiste di Roma 18. Ancora nel 1933, causa il progressivo «intedeschimento» del cantone, Mussolini ribadì al consigliere federale Giuseppe Motta l’importanza per il Ticino di conservare quella peculiarità italiana che, «se dovesse cambiare [...] sorgerebbe allora per l’Italia la questione della difesa della propria frontiera al Gottardo» 19. La dichiarazione, preceduta di qualche mese dall’affermazione del nazionalsocialismo in Germania, convinse Motta a riconfermare i buoni rapporti con il Regno, senza rinunciare a quel principio di netta separazione tra politica interna ed estera della Confederazione. Un equilibrio che ricalcava le posizioni già adottate a metà anni Venti, quando lo statista di Airolo non esitò a indicare i fasci italiani in Svizzera come affare interno all’emigrazione regnicola. Sottolineando l’importanza di un controllo scrupoloso, il capo del Dipartimento politico rimarcò l’opportunità di evitare tutto ciò che avrebbe contribuito a dare un carattere ufficiale a quelle organizzazioni che – così Motta avrebbe ribadito tempo dopo – «nous devons tolérer, mais qu’il sera dangereux de reconnaître» 20. Un tentativo di disarmare l’avversario con illusorie concessioni, riemerso prepotentemente all’indomani dell’assassinio di colui che per anni fu il punto di riferimento dei nazionalsocialisti elvetici, Wilhelm Gustloff. «Nous n’avons, par notre part – riprendeva il consigliere federale – pas le moindre doute sur l’opportunité de nous en tenir fermement aux principes qui nous ont guidés jusqu’au ici, d’abord vis-à-vis des organisations fascistes italiennes, puis vis-à-vis des organisations nationales-socialistes allemandes, et qui consistent à les ignorer officiellement tout en les surveillant, en pratique, avec le maximum de vigilance qu’il serait extrêmement désirable de pouvoir augmenter. C’est, à notre avis, le seul moyen de pouvoir prendre, en cas d’abus, les mesures de police qui s’imposent sans faire naître des difficultés internationales présentant immédiatement un caractère de réelle gravité» 21. Motta temeva infatti che un’ingerenza governativa nella sostituzione di Gustloff – nonché l’eventuale richiesta di affidare al ministro del Reich a Berna, Weizsäcker, la direzione delle organizzazioni naziste in Svizzera – avrebbe indotto la Confederazione a ufficializzarne il riconoscimento, impedendo di trattarle come semplici associazioni straniere a carattere privato. Ne sarebbe derivato un minor controllo e quindi una maggiore difficoltà d’intervento per le autorità federali e cantonali che, in caso contrario, si sarebbero scontrate con la Legazione di Germania 22. Il consigliere federale d’altronde non poteva smentire quanto pronunciato pochi mesi prima nell’aula del Gran Consiglio del Canton Grigioni dal deputato Christian Vieli, secondo il quale «esistendo in Svizzera il diritto F. Crespi, Ticino irredento, Milano, 2004. DDI, (VII serie), vol. 13, n. 437. Colloquio tra Mussolini e Motta, 19 aprile 1933. 20 DDS, vol. 11, n. 209 allegato. Le Chef du Département politique, Motta, au Chef du Département de Justice et Police, Baumann, 7 febbraio 1936. 21 Ivi. 22 M. Gillabert, La propagande nazie en Suisse. L’affaire Gustloff, 1936, Lausanne, 2008. 18 19 69 Percorsi di ricerca 2/2010 d’associazione, nessun provvedimento poteva essere adottato contro le formazioni nazionalsocialiste, fino a quando l’opera di queste si fosse mantenuta entro i limiti legali»23. Parole poco gradite dal ministro d’Italia a Berna, Giovanni Marchi, che imputava al piccolo Stato l’incapacità di agire con decisione «a differenza di quanto in passato ha fatto verso di noi. Gli ultimi gravi incidenti di frontiera – evidenziava il diplomatico – lo svolgimento delle recenti trattative commerciali, le timide precauzioni prese per difendersi dallo hitlerismo, generano, in tutti, la convinzione dello stato di debolezza in cui si trova la Svizzera di fronte al Reich, debolezza derivante dalla sua stessa costituzione» 24. Dichiarazioni non sfuggite a Mussolini che, in occasione della seconda assemblea quinquennale del regime nel marzo 1934, richiamò l’attenzione dell’ambasciatore Wagnière perché sollecitasse il Consiglio federale a non sottovalutare la pericolosità di quella propaganda 25. Il timore, fondato – e questa volta rinvigorito dalle prime persecuzioni antiebraiche in Germania e poi in Italia – era il risveglio di un nuovo antifascismo, impegnato ad organizzare comitati di soccorso idealmente apolitici, ma di fatto strumenti di una nuova lotta ai regimi dittatoriali. D’altronde, se è vero che la Confederazione era stata segnata in quel frangente da una discutibile politica migratoria, non di rado sfociata in incresciosi respingimenti, è innegabile il ruolo che seppe garantire – sin dagli anni precedenti il secondo conflitto – come stabile piattaforma per opere assistenziali impegnate a soccorrere quanti rimasti intrappolati sui vari fronti di guerra 26. Una presa di coscienza che avvicinò all’antifascismo avvocati, pastori protestanti e giudici federali, magari non schierati apertamente contro il regime, ma tendenzialmente contrari a guerre e conflitti internazionali. La stessa Centrale Sanitaria Svizzera, ente filantropico fondato nel 1937 a Zurigo per coordinare le azioni mediche in una Spagna piegata dalla guerra civile, lasciava intravedere forti sospetti di quella presunta apoliticità per la presenza al suo interno di noti avversari al fascismo, quali i socialisti ticinesi Borella e Canevascini, il sindaco di Giubiasco Camillo Olgiati e il locarnese Rusca. Oltretutto i suoi contatti con l’Unitarian Service Committee di Marsiglia e il Comitato Svizzero di Soccorso Operaio rafforzavano i dubbi di un’imprecisa assistenza sanitaria, sia verso i prigionieri spagnoli internati nei campi francesi vicini ai Pirenei, sia dei volontari svizzeri arruolati nelle brigate internazionali, ormai schierati contro le rigide disposizioni federali di non ingerenza 27. Quelle attività assistenziali sviluppatesi rapidamente a partire da metà anni Trenta, pur sorrette da sentimenti caritatevoli, assumevano infatti – per quell’intrinseca natura pacifista – caratteri vagamente antifascisti, segnati dalla già ricordata militanza di alcuni oppositori, e da finalità contrastanti con gli obiettivi espansionistici di Roma. Non solo quindi la Delegazione Assistenza Emigranti (DelAsEm) dal dicembre 1939 impegnata nel facilitare l’espatrio di ebrei colpiti dalle recenti normative razziali 28, ma anche diversi gruppi evangelici e la stessa chiesa cattolica rappresentavano con il loro dinamismo potenziali centri di opposizione alla dittatura. Ciò ovviamente non impedì l’estendersi di una vasta rete di contatti e collaborazioni, per esempio tra Santa Sede e diversi altri organismi deputati 23 Archivio Ministero Affari Esteri, Roma (in seguito AMAE), Affari Politici 1931-’45, Svizzera, sc. 6. Consolato generale d’Italia a Zurigo al Ministero degli Affari Esteri, 23 novembre 1934. 24 Cerutti, Fra Roma e Berna, cit., p. 393. 25 Alle dichiarazioni di Mussolini, Wagnière rispose che «dans aucune autre occasion, le Duce ne s’est montré plus cordial à l’égard de notre pays». M. Rigonalli, Le Tessin dans le relations entre la Suisse et l’Italie (1922-1940), Locarno 1983, p. 148. 26 G. Koller, Entscheidungen über Leben und Tod. Die Behördliche Praxis in der Schweizerischen Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs, in «Studien und Quellen», (22) 1996, pp. 17-106. Si veda anche Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera, Seconda Guerra Mondiale, La Svizzera e i profughi all’epoca del nazionalsocialismo, Berna, 1999. 27 N. Ulmi, P. Huber, Les combattants suisses en Espagne républicaine (1936-1939), Lausanne, 2001. Cfr. anche V. Gilardoni, G. Lazzeri, G. Petrillo, I volontari ticinesi in difesa della Repubblica di Spagna, «Archivio Storico Ticinese», n. 65-68, 1976. 28 S. Antonini, DelAsEm. Storia della più grande organizzazione ebraica italiana di soccorso durante la seconda guerra mondiale, Genova, 2000. 70 Percorsi di ricerca 2/2010 all’assistenza di rifugiati e prigionieri, a partire dalla Croce Rossa Internazionale e dalla Mission Catholique Suisse, ente sussidiario del Vaticano guidato dall’allora arcivescovo di Friburgo mons. Mario Besson 29. Era questo prelato di origini torinesi, approdato sulle rive della Sarine nei primi anni del Novecento, ad incoraggiare l’assistenza verso i profughi temporaneamente accolti nella Confederazione, rispettando naturalmente le locali autorità civili e militari, impegnate a rafforzare la coesione interna del Paese, difendendone la neutralità all’esterno. «Gardons envers les pays qui nous entourent la modération bienveillante qu’exige notre qualité de citoyens d’un pays neutre. De même que l’Eglise – così scriveva nel 1939 Besson – s’il est permis d’employer cette comparaison ne se compromet avec aucune forme de gouvernement, et quelle lasse les peuples entièrement libres de se donner celle qui lui convient davantage, ainsi nous, citoyens suisses, nous ne devons, comme tels, prendre ostensiblement ni pour ni contre aucun des régimes actuellement établis autour de nous, ce qui ne nous empêche évidemment pas de juger, d’après les principes de la morale chrétienne, les écarts et les fautes de tel ou tel régime, du tel ou tel individu. […] Dans la presse, dans les discours, dans les manifestations patriotiques, abstenons-nous de toute parole inutile, capable de blesser. Même lorsque la conscience nous oblige à déplorer telle ou telle mesure pris par quelque chef d’état, et que nous croyons contraire à la morale où dangereuse pour le bien publique, faisons-le d’une manière objective, sans oublier que ceux dont la conduite nous choque, ne sont pourtant des ennemies pour nous. Eviter de compromettre notre patrie, en nous abstenant d’être désagréables envers nos grandes voisins, c’est le première moyen de lui témoigner un véritable dévouement» 30. Un impegno che avrebbe garantito alla Confederazione la necessaria libertà d’azione ancora negli anni successivi, quando – pur con discutibili e riprovevoli azioni – avrebbe accolto generosamente migliaia di profughi politici e razziali in fuga dal rincrudimento legislativo del neofascismo repubblicano 31. Un esteso e riconosciuto impegno internazionale, che continuava ad affiancarsi a quell’indistinta maglia di conoscenze locali capaci di assicurare regolari contatti tra i due lati del confine. Percorsi tra guerra e pace L’istituzione in Italia nella primavera 1944 di una «zona chiusa», lembo di terra della profondità di circa tre chilometri lungo il confine elvetico, rappresentò agli occhi della neo costituita Repubblica Sociale una discutibile risposta a quella ramificata organizzazione di contrabbandieri e gente comune impegnati – sin dai mesi successivi l’armistizio – a trasferire oltre frontiera quanti obbligati per le più svariate ragioni a fuggire dai rigori di Salò 32. Una rete informale, un’irrinunciabile maglia di conoscenze che, rispetto alle precedenti organizzazioni interne ai partiti antifascisti – come accennato limitate ad attività propagandistiche e di appoggio sia agli avversari del fascismo, sia ai pochi emigranti clandestini diretti soprattutto in Francia – presero spesso la forma di sforzi comunitari a salvaguardia dei numerosi malcapitati. Sovente limitate ad una o due famiglie, si trattava di organizzazioni composte per lo più da contadini o pastori che, tradizionalmente afflitti da un’atavica condizione di sottosviluppo economico, non nascondevano il desiderio di arrivare il prima possibile ad una pace frutto di aspirazioni per troppo tempo rimaste inespresse. Era infatti questo desiderio di giustizia sociale F. Scomazzon, Nel centro dell’Europa, nel cuore della Svizzera. La Mission Catholique Suisse en faveur des prisonniers de guerre (1939-1945), «Bollettino Storico della Svizzera Italiana» (BSSI), vol. 9 (2007), fasc. 2, pp. 217-245; F. Yerly, Grande guerre et diplomatie humanitaire: la Mission Catholique Suisse en faveur des prisonniers de guerre (1914-1918), «Vingtième siècle», n. 58, 1998, pp. 13-28. 30 Scomazzon, Nel centro dell’Europa, cit., p. 219-20. 31 Si veda p. es. R. Broggini, Terra d’asilo. I rifugiati italiani in Svizzera (1943-1945), Lugano, 1993. 32 Sulla “zona chiusa” cfr. F. Giannantoni, Fascismo guerra e società nella Repubblica Sociale italiana (Varese 1943-1945), Milano, 1984, pp. 273-75. 29 71 Percorsi di ricerca 2/2010 a spingere masse popolari, culturalmente e socialmente isolate, in una indifferenziata e solidaristica adesione al movimento resistenziale. Un antifascismo spontaneo e silenzioso che, per esempio in Piemonte – fino all’estate 1944 sicuro collegamento tra Francia e Germania – garantì un argine ai diffusi rastrellamenti nazisti e rifugio per decine di sbandati, renitenti alla leva ed ex-prigionieri alleati. Negli undici mesi precedenti lo sbarco alleato a Tolone e Cannes, le truppe del Reich si trovarono infatti ad esercitare uno stretto controllo sui passi alpini al confine occidentale, in particolare lungo quei tortuosi percorsi che si spingevano fino ai borghi isolati della pianura padana. A Castel Azzanese, vicino Cremona, il capostazione e il consiglio comunale favorirono per esempio il trasferimento in Svizzera di 37 prigionieri internati nel vicino campo di lavoro, mentre nei pressi di Vercelli un privato cittadino pagò lautamente delle guide perché accompagnassero ai valichi elvetici alcune decine di ex-prigionieri alleati passando dal Luinese 33. Sempre dall’alto Varesotto transitarono una parte dei quasi duecento militari che, liberati nel dicembre 1943 da membri del CLN piemontese, provenivano dai campi di prigionia sparsi tra Novarese, Alessandrino e i dintorni di Mortara 34. Non pratici delle località e soprattutto di sicuri passaggi per espatriare, i soldati furono nascosti ed equipaggiati dalla popolazione locale, poi avviati verso il confine con lunghe e faticose marce non di rado attraverso i colli alpini. Un’esperienza rivissuta a fine guerra da alcuni militari neozelandesi, saliti da Biella fino a Macugnaga, poi sconfinati in Canton Vallese. «Decidemmo per la Svizzera e partimmo con la luna piena, il 16 settembre [1943]. Nella prima notte percorremmo circa trenta chilometri attraverso le risaie, non lontano da Biella. Dormimmo sotto i pini e ci rivelammo ai contadini che ci diedero del cibo […] Mangiammo e pagammo con caffè canadese e sapone prima di riprendere la strada. Pioveva, incontrammo un civile che insistette per farci dormire in una stanza fino al giorno dopo. All’alba ci consigliò di allontanarci […] Ci muovevamo speditamente ed a circa seicento metri ci fermammo in un fienile di un contadino fino alle dieci di sera. Comprammo della polenta fredda e del caffè e ci mettemmo a buona velocità per attraversare la montagna. Al sorgere del giorno fummo costretti a chiedere la strada e poi senza sostare camminammo fino alle sei del pomeriggio, raggiungendo un rifugio a duemilacinquecento metri. Là incontrammo un tirolese che parlava tedesco che ci guidò in Valsesia. Speravamo di essere lontani dalle strade, ma in realtà percorrevamo vie che correvano su per le vallate. Qui vedemmo i bandi che offrivano soldi per la nostra cattura e annunciavano la pena di morte a chi ci dava rifugio. Passammo la notte in una casa, dalla quale uscimmo all’alba per salire al Colle del Turlo, a 3000 metri e scendemmo all’ultimo villaggio italiano, Macugnaga. Fummo avvertiti da un giovane, il quale stava costituendo una banda partigiana, che i tedeschi rimanevano nel villaggio a notti alternate ed i fascisti vegliavano i sentieri […]. All’alba una fascia di nebbia ci separava dal villaggio ed era di grande conforto pensare che nemmeno il più abile segugio ci avrebbe scovato. Ritrovammo il sentiero verso le sei e salimmo. La pioggia era diventata neve; vedemmo mucchi di pietre che indicavano apparentemente una strada di contrabbandieri […]. Attraversammo il Passo Moro sopra i 3000 metri […] Un po’ più in basso, io ed il mio compagno, insieme a due altri, fummo fermati da un soldato in divisa grigio-azzurra … da vicino ci rendemmo conto che era uno svizzero … ce l’avevamo fatta» 35. Si trattava di un’assistenza che, in particolare dall’autunno 1943, avrebbe coinvolto un numero crescente di persone mosse da un senso di vicinanza ai tanti perseguitati dal neofascismo repubblicano, a partire naturalmente dai molti ebrei già vessati dalle precedenti leggi razziali. Solo pochi mesi prima lo scoppio del conflitto, un informatore fascista attivo nel Torinese segnalava che «nei piccoli centri specialmente, gli ebrei sono molto ben voluti e rispettati; i commercianti e i professionisti non hanno sentito a tutt’oggi alcuna differenza di trattamento, anzi, in generale hanno avuto attestazioni di simpatia da tutta la popolazione. E ciò accade anche a Torino stessa, salvo pochi esempi eccezionali»36. R. Absalom, Le vie della salvezza degli ex-prigionieri alleati tra santuari, assistenza popolare e Resistenza in Piemonte, in Perona, Cavaglion, Luoghi della memoria, cit., p. 177. 34 Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, Bacciagaluppi, sc. 2. Final report, p. 9. 35 Istituto Storico della Resistenza, Torino, Fulvio Borghetti, sc. 9, Diario clandestino, (1), p. 32. 36 ACS, polizia politica materia, sc. 219. Lettera fiduciaria, 19 marzo 1939. 33 72 Percorsi di ricerca 2/2010 Chi non riuscì a sconfinare, trovò infatti rifugio in una popolazione compiacente e in aiuti finanziari raccolti in territorio elvetico da organizzazioni internazionali, poi trasferiti in Italia da uomini legati a doppio filo all’ambiente antifascista e ai centri spionistici alleati sparsi per la Confederazione. Un caso emblematico era rappresentato dall’ebreo eporediese Raffaele Jona, capo partigiano delle formazioni «Giustizia e Libertà», già inviato in Svizzera dal Cln Piemontese per ottenere dalla centrale OSS di Berna lanci di armi, munizioni e rifornimenti da passare alla resistenza valdostana. Attività che avrebbe presto affiancato al trasporto di denaro. Rappresentanti della DelAsEm riparati oltre confine dopo l’armistizio affidarono a Jona, in tre distinte occasioni, notevoli quantitativi di franchi svizzeri già raccolti da organizzazioni politiche e sociali, che il coraggioso antifascista, con il rientro in Italia, provvide a cambiare e ad affidare per la distribuzione a fidati amici legati al variegato mondo del partigianato 37. Attraverso rari appunti manoscritti – oltre ad essere incompleti per ovvie ragioni di sicurezza – alcuni fiduciari compilarono dettagliati elenchi in cui figuravano, accanto ad altri anonimi collaboratori che davano così senso all’estensione della maglia organizzativa, nominativi e indirizzi delle persone soccorse, nonché la quantità di denaro versato, utilizzato appunto dai rifugiati per garantirsi una dignitosa sopravvivenza, ma anche procurarsi carte d’identità false, corrompere fascisti o aiutare i loro stessi soccorritori. Operazioni non facili per la diffidenza di molti che, pur immiseriti e senza appoggi, diffidavano uscire allo scoperto dando i propri recapiti. All’indomani dell’8 settembre i quasi duecento ex-prigionieri inglesi evasi dal campo d’internamento di Gassino Torinese vennero ad esempio assistiti – prima dell’espatrio in Svizzera – dagli abitanti locali, che li alloggiarono «a portata di mano per poter fornire loro ogni giorno vitto abbandonante, le lezioni di lingua, qualche libro di lettura, matite, carta e molte parole buone, rassicurandoli di tutta la simpatia della popolazione» 38. Un impegno che, riconosciuto nel dopoguerra, ne confermava il ruolo insostituibile nella gestione di questi ufficiosi rapporti transfrontalieri, assicurando assistenza e salvezza ad una schiera di fuggiaschi, in quel frangente rimasti intrappolati nei confine della Repubblica Sociale italiana. «Oltre la frontiera – scrisse nel gennaio 1946 un militare della Royal Army Service Corps – ho ritrovato al vita che avevo temuto di perdere [...] i miei ricordi del vostro Paese, l’Italia, sono quelli di una nera notte di vento e di pioggia che cadeva sul fianco della montagna scendendo a cascate nella valle. Dandovi un’ultima occhiata prima di passare sotto la rete di confine verso la Svizzera ho pensato: dopotutto gli uomini non sono uniti dalla razza, luogo d’origine, lingua o religione, ma dal loro comune senso di umanità. Odiavo l’Italia quando sbarcai in Calabria, ma a Milano incontrai dei veri italiani e sono fiero di averli conosciuti» 39. 37 Variegata è la storiografia riguardante i rapporti tra partigiani italiani e missioni alleate in Svizzera. Nel caso citato si fa riferimento all’opera di E. Consolo, La Glass e Cross attraverso le Alpi, Torino 1965, ma ulteriori informazioni – per esempio con riferimento al Comasco – sono ricavabili da F. Giannantoni, L’ombra degli americani sulla Resistenza al confine tra Italia e Svizzera, Varese, 2007, nonché dall’autobiografia di G. Mozzoni, La vera storia del tenente Mozzoni dal 25 luglio 1943 al 30 aprile 1945, ed. fuori commercio. 38 Istituto Storico della Resistenza, Torino, Fulvio Borghetti, sc. 1. Testimonianza di Enria Delfina, 10 giugno 1945. 39 G. Bacciagaluppi, L’aiuto del CLNAI ai prigionieri di guerra alleati, Bologna, 1990, p. 210. 73 Percorsi di ricerca 2/2010 «Ricondurre il perduto al bene» Delinquenza minorile e rieducazione dell’infanzia traviata: dibattito e nascita di una Magistratura per i minori nel Canton Ticino (1856-1941) Annamaria Valenti Premessa La storia della criminalità è un filone della storia sociale scoperto in tempi assai recenti dalla storiografia. I primi lavori risalgono ai primi anni Ottanta del Novecento e le scuole all’avanguardia sono quella britannica e quella francese, che hanno toccato in maniera approfondita molteplici aspetti della materia. Ma se per Francia e Inghilterra i lavori a disposizione sono molti e coprono un ampio arco temporale (dal XVI secolo al XX secolo), negli altri Paesi europei il numero delle opere sono decisamente minori e soprattutto non coprono il XX secolo. Per ciò che concerne la Svizzera, si tratta di una tematica relativamente nuova, che ha catturato l’interesse degli storici solo da un decennio a questa parte. Tra i lavori più interessanti, in questo senso, vanno menzionati quelli dello storico Michel Porret. Per ciò che riguarda il Ticino, l’interesse per la storia della criminalità ha attecchito da qualche anno, ma si tratta spesso di tesi di laurea che non hanno dato vita a pubblicazioni e hanno l’inconveniente di concentrarsi soprattutto sul Medioevo ed epoca moderna, trascurando il XIX e XX secolo. Riguardo al tema del mio contributo, ovvero la delinquenza minorile, le opere della storica romanda Martine Ruchat 1 costituiscono una pietra miliare. In Ticino, si tratta di un filone totalmente inesplorato, malgrado il vivo interesse sviluppato dalla storiografia ticinese nei confronti dell’infanzia. Ad averne parlato, anche se in maniera marginale, è stato solo Rosario Talarico, nel suo saggio L’igiene della stirpe 2. Il mio, dunque vuole essere un primo e timido tentativo di approccio alla tematica, che non ha la pretesa (né l’ambizione) di essere esaustivo e completo. Data la vastità del tema e delle sue molteplici correlazioni, ho scelto di limitare la mia esposizione alla ricostruzione del dibattito che si svolse in Ticino tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento, circa l’esigenza di creare un apparato legislativo specifico per i minori (1934) e soprattutto di istituire una Magistratura minorile (1941). Il tentativo è quello di illustrare le tappe di un lungo e difficile percorso, cercando di mettere in luce anche chi fossero i protagonisti del dibattito e quali le idee alla base della loro azione. Si tratta insomma di cercare di analizzare attraverso quali argomenti e vie si snodò la discussione in un contesto micro, dopo aver valutato la situazione a livello macro. Un tentativo, va sottolineato, limitato dall’esiguità delle fonti al momento a mia disposizione. M. Ruchat, L’oiseau et le cachot: une histoire de l’éducation correctionnelle au XIX siècle en Suisse romande (1800-1913), CarougeGenève, 1993. 2 R. Talarico, L’igiene della stirpe, in R. Ceschi (a cura di), Storia del Cantone Ticino. Il Novecento, Bellinzona, 1998, pp. 449474. 1 75 Percorsi di ricerca 2/2010 Delinquenza minorile: una piaga mondiale La problematica della delinquenza minorile fece la sua apparizione in occidente alla fine dell’Ottocento, sospinta dalla constatazione che in tutti i paesi europei ed extra-europei si stesse assistendo a un vertiginoso aumento del fenomeno, tanto da essere descritto e percepito come una delle più importanti e gravi piaghe sociali dell’epoca. Il problema destò l’attenzione di numerosi studiosi, dando luogo a svariate interpretazioni sulle sue possibili cause. Grazie allo sviluppo del sapere scientifico, nacquero in quel periodo una serie di teorie che vedevano in qualsiasi forma di devianza o comportamento ritenuto “antisociale» il prodotto di una combinazione di predisposizioni ereditarie e fattori socio-ambientali negativi. In particolare, la moderna teoria criminologica coniata da Ferri e Lombroso creò la figura del delinquente minorenne. Ciononostante, all’epoca dominava la convinzione che grazie al potere dell’educazione, ogni ragazzo «traviato» poteva essere redento e riportato al consorzio civile. Un pensiero la cui diffusione è stata possibile grazie alla nascita di una differente sensibilità sociale nei confronti dell’infanzia, oltre che dall’abolizione del concetto di punizione corporale che proprio alla metà dell’Ottocento fu sostituito con quello di correzione o rieducazione del delinquente. E fu proprio in un contesto intento ad andare alla ricerca delle misure idonee da adottare per reprimere la delinquenza minorile che nacque l’esigenza di istituire un apparato legislativo appositamente concepito per i minori e soprattutto di istituire organismi giuridici separati da quelli degli adulti, vale a dire i Tribunali per i minori. A livello penale, infatti, in tutto l’Occidente, per i bambini al di sopra dei dieci anni accusati di aver commesso un reato scientemente, venivano applicate le medesime procedure valide per gli adulti e soprattutto venivano giudicati dagli stessi organi. Per di più, in caso di detenzione, venivano collocati nelle medesime strutture carcerarie. La differenza risiedeva solo nella pena da scontare, più mite rispetto a quella inflitta a un adulto. Il primo Tribunale minorile fu istituito nel 1899 nell’Illinois, negli Stati Uniti. Il Juvenile Court Act aveva scopi rieducativi e allo stesso tempo punitivi: pur mantenendo le stesse procedure, stabilì che tutti i bambini sotto i sedici anni dovessero essere giudicati separatamente rispetto agli adulti e che nei penitenziari venissero collocati in celle lontane dagli adulti. La società delegava al giudice il compito di studiare il ragazzo deviante e di procedere alla sua correzione. In questo codice era prevista la probation (messa alla prova) del minore, che poteva essere affidato ad un ufficiale volontario o stipendiato 3. Nel Regno Unito il Tribunale per i minori fu istituito nel 1908 a Londra, con il Children Act: tutti gli adolescenti con età superiore ai sedici anni che si erano macchiati di qualsiasi reato o turbamento dell’ordine pubblico potevano essere condotti davanti alla corte e una volta condannati finivano nel carcere degli adulti. Questa legge abolì tuttavia la pena di morte per i minori. Tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento, tutti gli Stati si chinano sulla questione e vennero organizzati anche congressi internazionali 4. Il più significativo fu quello svoltosi nel 1910 a Washington dalla Commissione penitenziaria del Congresso internazionale, che fissò i cardini di quella che doveva essere la procedura per i minorenni. Due gli interrogativi che guidarono i lavori: «Questione prima: i giovani delinquenti devono essere sottoposti alla procedura applicata agli adulti? Questione seconda: In caso di risposta negativa, quali sono i principi che dovrebbero orientare la procedura applicabile ai fanciulli e adolescenti?» 5 S. Gallo, La giustizia penale minorile, Corso di formazione di Psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense, Associazione italiana di Psicopatologia giuridica, Roma, 2003, (rivista on-line, www.aipgitalia.org). 4 S. Zeli, Delinquenza minorile. Studio legislativo, Bellinzona, 1940. 5 Ibid., p. 21. 3 76 Percorsi di ricerca 2/2010 Il Congresso di Washington definì anche le linee guida che dovevano accompagnare l’azione degli Stati: la parola d’ordine era separazione dal mondo degli adulti. Non solo il giovane non avrebbe dovuto essere arrestato come un adulto normale, ma anche il dibattimento non si doveva svolgere negli stessi luoghi in cui si processavano gli adulti. L’anno successivo fu convocato a Parigi un congresso appositamente pensato per discutere sui Tribunali dei minori. A causa della deflagrazione del Primo conflitto mondiale, i lavori subirono una battuta d’arresto e ripresero solo nel 1924, quando la Commissione penitenziaria, riunitasi a Londra, decise di elaborare un’inchiesta tra tutti i paesi membri i cui risultati furono pubblicati tre anni dopo. Della questione si interessò anche la Società delle Nazioni, che coordinò la summenzionata inchiesta attraverso il Comitato per la protezione dell’infanzia. Tra gli anni Venti e gli anni Trenta, tutti gli Stati europei istituirono i loro tribunali dei minori e vararono un’apposita legislazione 6. Anche la Svizzera prese parte alla discussione internazionale. Dibattito e Tribunali dei minori in Svizzera Sulla scorta di quanto stava avvenendo a livello internazionale, il dibattito sul problema giuridico dei minori attecchì anche in Svizzera, dove se ne cominciò a parlare sin dalla fine del XIX secolo. I soli cantoni che all’epoca disponevano di norme specifiche e una speciale corte per i minori, erano i cantoni di Neuchâtel e Berna, che nel 1893 sottrassero i fanciulli in età scolare alla normale magistratura, sottoponendoli all’autorità scolastica. Appare evidente, dunque, il grande ruolo conferito alla scuola, dimostrando una volta in più come la questione «delinquenziale» fosse percepita una questione di pertinenza educativa più che giuridica. Si trattava di un primo timido tentativo di affrontare la problematica, anche se con scarsi risultati: questi organi, infatti, vennero abbandonati assai presto, restando inutilizzati. Ciononostante, uno dei pregi di tale movimento, fu quello di spingere all’approfondimento della problematica sul trattamento differenziato per i minori. A fornire ulteriore stimolo, furono le riflessioni innescate dall’introduzione del nuovo codice civile svizzero (1912) - che istituì una serie di importanti norme a tutela dell’infanzia - ma soprattutto le discussioni sorte nell’ambito dei lavori preparatori per il nuovo Codice penale svizzero, il quale prevedeva norme specifiche per i minori, alle quali tutti i cantoni avrebbero dovuto uniformarsi. La questione venne affrontata a livello nazionale nel 1909, su iniziativa dell’Assemblea della Società svizzera dei giuristi, che si riunì per analizzare quale fosse la situazione nella Confederazione, circa la questione dei Tribunali per i minori. Al termine dei lavori, l’Assemblea si pronunciò a favore della creazione di tali organismi nel maggior numero di cantoni possibile. A quella, seguirono numerose altre giornate di studio dedicate alla tematica. Tra i più citati dalle fonti, i tre Congressi pro tribunale dei minori che ebbero luogo a Zurigo rispettivamente nel 1912, nel 1930 e nel 1939. A sottolineare quanto l’educazione – o meglio – il potere della rieducazione fosse rilevante all’interno della discussione, va notato che tutti e tre i congressi furono patrocinati da Pro Juventute. Questi diversi simposi costituirono il luogo in cui lentamente si andò formando la nuova mentalità della classe dirigente. Un mutamento, che tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento, portò molti cantoni a introdurre nel loro apparato legislativo norme speciali per i minori. Va sottolineato che, data l’assenza di un codice In Francia il Tribunale dei Minori venne istituito nel 1912, nel 1921 in Olanda, nel 1922 in Germania. In Italia, invece, nel 1934, in pieno fascismo, anche se vi erano già interessanti disposizioni nel Codice Zanardelli (il quale stabiliva che il minore sotto i nove anni non era imputabile, però era sottoposto a misure di sicurezza se disubbidiva all’autorità paterna). Sintesi scritta sulla base di G. Borella, Il problema della delinquenza minorile nella Svizzera e nel Ticino, Mazzucconi, Lugano, 1943 (Tesi di laurea presentata all’Università di Berna, Facoltà di diritto, rel. E. Delaquis); Gallo, La giustizia penale, cit. 6 77 Percorsi di ricerca 2/2010 penale unificato fino al primo gennaio 1942, ogni cantone legiferò singolarmente, determinando l’esistenza di modelli differenti tra loro. Da un lato esisteva la realtà dei cantoni più progressisti che si dotarono di una legislazione completa. Il primo a muoversi in questo senso fu San Gallo, che nella legge di procedura penale del 1912, diede vita a tribunali speciali composti da tre membri del tribunale distrettuale e due della Commissione per la protezione dei giovani. Si procedette anche alla creazione della Jugendschutzkommission, alla quale spettava il compito di aiutare il magistrato nell’istruttoria, occupandosi in particolare dell’inchiesta sociale (ossia la valutazione delle condizioni economiche, sociali, famigliari e caratteriali del ragazzo). Inoltre, fu incaricata di sorvegliare il ragazzo liberato durante il tempo di prova, introducendo per la prima volta in Svizzera il principio di «libertà sorvegliata». A questo modello, si ispirò nel 1926 anche Appenzello esterno. Secondo in ordine di tempo, il canton Ginevra, che creò nel 1913 la Camera penale per i minorenni. Tuttavia, fu solo nel 1935 che istituì un Tribunale specializzato, formato da un presidente giurista, da un medico e da un pedagogo, conferendo inoltre anche alle donne il diritto di essere elette. 7 Per ciò che concerne Zurigo, il nuovo codice di procedura fu promulgato nel 1919 e conteneva un intero capitolo concernente i delinquenti minorenni, che definiva le pene e le misure da prendere contro ragazzi ed adolescenti. Quello stesso anno, il Consiglio di Stato zurighese istituì l’ufficio cantonale della gioventù. Stando alle fonti, però, sembra che nel 1944 il previsto tribunale non fosse ancora entrato in funzione 8; esisteva solo l’istruttore speciale, il Jugendanwalt. Sulla stessa linea di Zurigo, anche il Canton Berna, che nel 1930 istituì pure il Jugendanwalt, scegliendo volutamente di non istituire corti speciali. In alcuni contesti prevalsero soluzioni intermedie: è il caso del Canton Vaud, che nel 1939 introdusse norme di tipo materiale nel codice penale, ma senza procedere all’istituzione né di una procedura speciale né di una apposita magistratura per i minori. Fu creato anche un segretariato per i minorenni, ma completamente estraneo all’ordinamento giudiziario 9. Lo stesso valse anche per Argovia, che nel 1932 si dotò di un apparato legislativo per i minorenni, ma senza modificare né le procedure né l’organizzazione rispetto agli adulti. Vi furono poi cantoni che oltre a norme materiali, introdussero anche regole di procedura speciali. È il caso di Sciaffusa, Friburgo e Basilea. Quest’ultimo, insieme a Neuchâtel, conferì la competenza dei minori delinquenti ai tribunali di tutela. Non è un caso, dato che, come vedremo in seguito, intercorreva un legame strettissimo tra infanzia abbandonata e infanzia deviata. Il Canton Ticino fu tra gli ultimi cantoni a varare una legge e creare una magistratura separata per i minorenni, istituite rispettivamente nel 1934 e nel 1941. Vediamo secondo quali principi si sviluppò la tematica. La piaga della delinquenza minorile in Ticino e la sua repressione. Il lungo cammino verso i Tribunali dei minori. La questione della delinquenza minorile destò l’attenzione dell’intera classe politica ticinese a partire dalla fine del XIX secolo, proseguendo ben oltre al secondo dopoguerra. La problematica, su cui aleggiava una buona dose di allarmismo, era legata indissolubilmente alla preoccupazione suscitata dall’infanzia abbandonata: era in aumento, stando alla retorica del tempo, il numero dei bambini abbandonati a loro stessi, sia dal punto di vista materiale (soprattutto orfani e figli illegittimi), sia dal J. Depierraz, Les tribunaux pour enfants: le droit désirable en application du titre V du Code pénal vaudois du 17 octobre 1931, Thèse de droit, Lausanne, 1934. 8 Cfr. Borella, Il problema della delinquenza minorile, cit., p. 15. 9 Zeli, Delinquenza minorile, cit., p. 11. 7 78 Percorsi di ricerca 2/2010 punto di vista morale (figli accuditi da un solo genitore, spesso trascurati e privi di istruzione). Una preoccupazione legata alla concezione che l’infanzia abbandonata fosse l’anticamera della criminalità. A questa, occorre affiancare il timore per il decadimento morale e fisico a cui la popolazione ticinese era soggetta, generato dal diffondersi di problemi sociali come l’alcolismo, la tubercolosi e la sifilide. La modernizzazione dei costumi, inoltre, corrompeva gli antichi valori morali. La discussione, dunque, va inserita in un contesto culturale improntato alla preoccupazione per il futuro della Nazione, esposta al declino sotto ogni punto di vista. Le prime tracce di una discussione parlamentare sul problema dei fanciulli «traviati» risale al 1856 e affronta una questione che diverrà un vero e proprio leitmotiv nel dibattito, ossia l’esigenza di creare nel Cantone un apposito istituto per accogliere e rieducare i discoli 10, quei ragazzi ritenuti «difficili e irrequieti», che se trascurati sarebbero caduti nella delinquenza vera e propria. Negli anni seguenti, ad aggiungere nuova linfa alle riflessioni, fu la pubblicazione di uno studio condotto dal procuratore pubblico Brenno Gallacchi, intitolato I delinquenti minorenni. Nel progetto di codice penale svizzero. Nel diritto cantonale. Nella legislazione euopea 11. Gallacchi fu uno dei primi a sostenere che fosse oramai tempo per il Ticino di adeguare la sua legislazione in materia di minori allo spirito del tempo, chiedendo per loro un trattamento differente da quello riservato agli adulti. Le norme vigenti allora si basavano sul Codice penale ticinese del 1873, che prevedeva l’imputabilità dei fanciulli sotto i 12 anni. Per i ragazzi di età superiore, andava appurato se il reato fosse stato commesso con discernimento: in caso negativo, si decretava il non luogo a procedere. In caso positivo, invece, il minore veniva giudicato e condannato con le stesse procedure di un adulto, salvo ricevere pene più miti. Se veniva inflitta una pena detentiva, il reo veniva collocato nelle medesime strutture carcerarie degli adulti. Nel suo scritto, Gallacchi sottolineava come questo tipo di approccio fosse oramai obsoleto; occorreva dunque una modernizzazione della legislazione ticinese mettendola al passo con quanto accadeva nel resto dei Paesi occidentali e col nuovo spirito che pervadeva il diritto. Ma il contributo del procuratore ci consente di stabilire come anche alle nostre latitudini, sin dall’inizio del Novecento, fosse penetrata l’idea che alla base del fenomeno delinquenziale vi fossero fattori ereditari, oltre che di tipo socioambientale: «Come è mai possibile che da genitori che vivono in luoghi luridi, una vita di stenti senza la consolazione di un sorriso di sole e di virtù ignari delle soddisfazioni di una coscienza onesta, inconsci del valore della pubblica stima, dediti ai vizi e alle nefandezze d’una vita senza scopo morale , come è mai possibile che nascano figli virtuosi, buoni padri di famiglia, cittadini utili alla patria? Da genitori ubriaconi la legge inesorabile della ereditarietà vuole che nasca una prole viziosa col lungo e doloroso strascico di malattie degenerative. La tendenza al furto, all’assassinio è il triste retaggio che i padri corrotti lasciano ai figli innocenti» 12 Non possiamo stabilire con certezza quale influenza abbia avuto lo scritto di Brenno Gallacchi, tuttavia, l’anno seguente, ossia nel 1910, per la prima volta in assoluto si parlò esplicitamente di Tribunali minorili in Parlamento. E fu grazie all’onorevole Molo, che presentò una mozione in cui chiedeDato che una simile struttura non esisteva, il Consiglio di Stato era obbligato a inviare i fanciulli incappati in guai con la legge, oltralpe. Nel 1856, il consiglio di stato stilò un rapporto per chiedere al Gran Consiglio di dare un sussidio di 200 franchi all’istituto per i discoli di Lucerna. Nel 1840 la società svizzera di utilità pubblica aveva eretto l’istituto di Bächten, nel Canton Berna, istituto in cui venivano inviati anche i ticinesi. Tuttavia, esisteva un problema: era soprattutto un istituto per ragazzi protestanti. La società di utilità pubblica, infatti, voleva creare un istituto in un cantone cattolico “a vantaggio esclusivo dei derelitti fanciulli appartenenti alla cattolica confessione”. Qualche tempo prima, infatti, il governo aveva presentato istanza per fare ammettere un discolo ticinese, ma era stata respinta. 11 B. Gallacchi, I delinquenti minorenni. Nel progetto di codice penale svizzero. Nel diritto cantonale. Nella legislazione europea, Bellinzona, 1909, pp. 26-27. 12 Gallacchi, I delinquenti minorenni, cit., pp. 26-27. 10 79 Percorsi di ricerca 2/2010 va al Consiglio di Stato di studiare un progetto per l’istituzione di un Tribunale per i minori e di chinarsi nuovamente sulla creazione di un istituto per minorenni discoli e delinquenti, riferendone poi in Parlamento. L’iniziativa Molo ebbe il pregio di condurre alla nomina di una speciale commissione parlamentare 13, incaricata di approfondire entrambe le questioni e di elaborare un progetto. Tuttavia, rimase lettera morta. La questione dell’istituto fu riproposta tre anni più tardi, tramite una mozione presentata nel 1913 dall’onorevole Tamò, che proponeva di varare in maniera sollecita un progetto di legge “per la creazione di un istituto educativo speciale per i ragazzi discoli ed abbandonati nella scuola agricola di Mezzana». Una proposta definita lodevole da tutti i suoi colleghi, ma cassata e rimandata a tempi migliori. Il dibattito riprese e si fece più serrato all’indomani della fine della Grande guerra, incalzato forse anche dalla percezione di una recrudescenza della criminalità nelle giovani generazioni. Nel 1918 è il deputato liberale Angelo Tamburini (futuro direttore del Dipartimento dell’educazione) a riportare la questione dei tribunali al centro delle discussioni, con un’ennesima mozione. Questa la sua richiesta: «[…] visto il crescente numero dei delinquenti minorenni e la necessità di creare un ente speciale per giudicare ed educare questi adolescenti, il sottoscritto propone che il lod[evole] Consiglio di stato abbia a presentare un progetto di legge per la istituzione di un tribunale speciale composto dal Presidente del tribunale d’appello, del direttore del manicomio e di un docente e di curare poi l’educazione in un apposito reparto dell’Istituto agricolo cantonale.» 14 In coincidenza col periodo seguente alla fine del primo conflitto mondiale, aumentò anche l’attenzione e la preoccupazione della classe dirigente nei confronti dell’infanzia abbandonata, probabilmente a causa del diffuso pauperismo. Non è raro, infatti, trovare riferimenti nelle fonti dell’epoca a «bande di monelli» che girovagavano senza meta nelle città. E che esistesse una precisa equazione «bambini abbandonati» uguale «possibili delinquenti» ce lo confermano ancora una volta le parole di Tamburini: «La questione dell’infanzia abbandonata preoccupa a tempo la mente di sociologi e pubblici amministratori, ma ben poco di pratico e concreto si è concluso in Ticino. […] La precoce criminalità dei fanciulli abbandonati è purtroppo una piaga dolorosa che fa melanconicamente pensare a qual brutta sorte ci prepara l’avvenire, se tutti noi non ci preoccuperemo seriamente di redimere questi poveri paria dell’umana società. Estirpiamo dal loro cuore e dalla loro mente i vizi ed i mali in cui sono coinvolti ed un giorno essi non saranno solo riabilitati ma col senno e col lavoro diverranno utili al paese» 15 Ma per quanto nei discorsi non si cessi di fare riferimento a una situazione oramai allarmante, nelle istituzioni permaneva un forte immobilismo. Negli anni interbellici, il dibattito si fece più intenso e approfondito, arrivando a fare un salto di qualità: si vennero a toccare alcuni nodi focali giuridici della questione. Ne è un esempio la discussione sui discoli svoltasi nel 1923 in Gran Consiglio. Ad aprire i lavori l’intervento di Angelo Tamburini, che invitava la classe politica a muoversi, se si aveva a cuore il futuro della nazione: «Il diffondersi della criminalità fra i minorenni è impressionante. La piaga si propaga celermente e se lo Stato o l’iniziativa privata non pensano di porvi rimedi radicali molto si avrà a temere per le nuove generazioni.» 16 La commissione era composta dagli onorevoli Borella, Bernaschina, Molo, Rusca Mario, Felice Rossi. Cfr. ASTi, Verbali del Gran Consiglio, sessione 22.11.1909, p. 78. La commissione decise nel 1910 di accogliere la proposta Molo e venne rimandata al Consiglio di stato per lo studio e riferimento. 14 ASTi, Atti del Gran Consiglio, seduta ordinaria autunnale 28.1.1938, p. 937. 15A. Tamburini, L’infanzia abbandonata, in «Pro Juventute», 1920, n. 6, pp. 266-268, p. 267. 16 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 119. 13 80 Percorsi di ricerca 2/2010 Ma quantificare precisamente cosa significasse “celermente» e «impressionante», non è impresa facile, data la mancanza di dati statistici, in particolare di medio-lungo periodo. Le uniche informazioni a nostra disposizione sono quelle che ci fornisce lo stesso Tamburini, il quale dichiara che «i discoli nel cantone sono 80, con gli anormali arrivano a 344». In quella seduta l’onorevole Galli presentò una nuova proposta inerente alla creazione dell’istituto per i discoli, suggerendo di erigerlo ad Ascona, presso il Collegio Papio 17. L’idea era che pur utilizzando una struttura ecclesiastica, lo Stato potesse esercitare la sua autorità sull’istituto nominando un suo delegato nel Consiglio di amministrazione. Un progetto che raccolse sì il plauso del Parlamento, ma che però venne rinviato. Alla base della decisione, vi erano sì motivi ti tipo economico (occorreva stanziare quindici mila franchi annui sotto forma di sussidio), ma soprattutto – e questo era uno dei nodi fondamentali – questioni di principio giuridico. A illustrarci il punto focale della questione è il deputato Ferri, che pur essendo d’accordo con la creazione dell’istituto, chiese il rinvio sollevando un’importante problematica» [Mi] sembra che non sia data la nozione giuridica di ciò che si intenda per discolo. Si potrà privare un padre della patria potestà perché noi riteniamo che un suo figlio è un discolo?» 18. In linea con Ferri, anche il Consigliere di Stato Cattori, che vedeva una strettissima connessione tra la proposta presentata dal granconsigliere Galli e quella della riforma penitenziaria presentata nelle settimane precedenti dall’avvocato Bixio Bossi 19. Appoggiava la visione del consigliere di Stato anche l’onorevole RespiniOrelli, che sottolineò proprio l’esigenza di avere una base legale sicura su cui ancorare la decisione dell’internamento, date le sue molteplici implicazioni: «[…] Il problema trascende dalle questioni materiali. Rinchiudere un ragazzo in un collegio di discoli è diverso che rinchiudere un ragazzo in un collegio comune. L’internamento deve essere decretato da un’autorità: sia essa la famiglia, sia l’autorità tutoria, sia l’autorità giudiziaria.» 20 Il progetto sull’istituto di rieducazione, dunque, fu rimandato a tempi più maturi. Ma come spesso succedeva nel nostro Cantone, l’inerzia delle istituzioni fu colmata dall’iniziativa privata, nella fattispecie quella ecclesiastica. Nel 1926, a Riva S. Vitale, venne inaugurato l’Istituto per i discoli S. Pietro Canisio. Un’istituzione fortemente voluta dal vescovo Aurelio Bacciarini, sensibile alla problematica dell’infanzia abbandonata e della delinquenza minorile, come sottolinea l’onorevole Giovanni Tamò: «I cresciuti inconvenienti dell’abbandono dell’infanzia, la importanza di avere nel nostro cantone un istituto che provveda alla educazione dei discoli ed al loro avviamento ad un’arte o mestiere senza ricorrere a senza ricorrere ad istituti di Paesi e di altra lingua [e di altra confessione, ndr], la necessità di preparare la via ad un tribunale per i minorenni hanno persuaso sua S.E. Monsignor Bacciarini in considerazione della momentanea impossibilità dello Stato di fronte all’urgenza del bisogno ad assumersi questo difficile compito[…]» 21 La direzione dell’istituto venne affidata alla congregazione religiosa dei Guanelliani. Il suo compito era quello di dare un’istruzione elementare e maggiore ai ragazzi «ricoverati» offrendo loro anche la Nella seduta si discusse per l’istituzione di un sussidio ad un istituto per discoli (sussidio preso dal decimo della regia degli alcool); Galli propone di dare un sussidio di 3000 franchi per l’istituto dei discoli di Ascona (Papio). Istituire una borsa di studio da 200 franchi per l’intera retta annua, e fino a un massimo di dodici mila franchi da assegnare in ai discoli che devono essere ricoverati in istituto. Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 295. 18 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 295. 19 Malgrado le ricerche, non siamo riusciti a trovare alcuna traccia del testo della proposta. Non consociamo, dunque, i contenuti. 20 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 296. 21 ASTi, Fondo Dipartimento pubblica educazione, fascicolo XIX. Memoriale dell’onorevole Tamò per presentare un’ordinanza per promuovere l’erezione di un istituto per i discoli (1921). 17 81 Percorsi di ricerca 2/2010 possibilità di imparare un mestiere: tra le professioni proposte, figuravano quella di sarto, calzolaio o falegname. Lo Stato finanziava l’istituto tramite i sussidi erogati direttamente per il soggiorno dei ragazzi discoli. Sappiamo che il primo anno furono 40 i ragazzi ammessi 22, con una spesa affrontata da parte dello Stato di 500 franchi. Per il 1927 il governo stanziò nove mila franchi, che fu possibile prelevare dal fondo del decimo dell’alcol, dato che tra le missioni dell’istituto figurava anche l’«educazione, il rilevamento morale [e] l’opera di difesa contro le conseguenze dell’alcoolismo che si manifestano nell’indole e nel fisico degli adolescenti» 23. La legge sulla delinquenza minorile Gli anni Trenta sembrano segnare una svolta nel dibattito e nella concretizzazione degli interventi a favore di una legislazione speciale per i minori. Un primo passo importante, oserei dire d’avvicinamento, fu l’introduzione, nel 1931, della Legge sulla protezione dell’infanzia che istituì la creazione, in seno al Dipartimento degli interni, dell’Ufficio per la protezione dei minorenni. Oltre a ciò, si diede vita ai cosiddetti Consigli per i minori. Si trattava di organi consultivi, che avrebbero dovuto essere creati in ogni municipalità, formati da tre a sette membri, tra i quali dovevano obbligatoriamente figurare un rappresentante della Delegazione tutoria e un docente. Anche se l’organo era aperto a tutti coloro che «si dedica[va]no a indagare dove esistono pericoli morali e materiali per i minorenni» 24. Particolarmente ben accetti, per non dire auspicati, erano soprattutto medici e docenti. Anche le donne – si disse – potevano essere «utilissime», decretando la loro eleggibilità. I Consigli per i minori fungevano da organo di prevenzione sociale, poiché dovevano vigilare sulla formazione e sulla condotta dei fanciulli pericolanti, nella fattispecie i minorenni abbandonati moralmente ed economicamente, gli orfani, e gli illegittimi. Oltre a ciò, doveva essere l’istanza che proponeva «alla delegazione tutoria o alle altre autorità competenti quali provvedimenti intraprendere nei confronti di minorenni viziosi o delinquenti» 25. Tuttavia, le commissioni rimasero perlopiù una dichiarazione di intenti, poiché vennero nominate solo nei comuni più grandi. Gli anni Trenta segnarono anche il punto più alto raggiunto dal dibattito sulla delinquenza minorile, incalzato – come succedeva nel resto della Confederazione – dalle discussioni innescate dall’adozione del Codice penale federale. In questo periodo, l’idea di creare un corpus legislativo separato per i minori e i tribunali acquistò nuovo vigore. A sottolineare il fatto che si trattasse di una questione che non interessava solo una ristretta élite di “addetti ai lavori», lo dimostra il fatto che il circolo di cultura di Lugano il 23 marzo 1931 organizzò una serata pubblica dedicata alla delinquenza minorile e alla sua repressione. Relatore l’avvocato Bixio Bossi, incaricato di illustrare quali fossero i nuovi principi riformatori. Elemento non trascurabile, è il fatto che la sua relazione fu trascritta, pubblicata e divulgata attraverso L’Educatore della Svizzera italiana 26, questo per un preciso scopo: coinvolgere nella riflessione ampi strati della popolazione, soprattutto chi aveva stretti legami con la missione educativa, come ci spiega lo stesso Bossi: «[…] la quistione, la quale da un punto di vista potrebbe ritenersi chiusa ai soli studiosi di dottrine giuridiche o ai soli uomini di legge e funzionari di Stato, si allarga sino a interessare tutte le persone chiamate ad occuparsi dell’educazione ASTi, Atti del Gran Consiglio, 8.1.1923, p. 294. ASTi, Atti del Gran Consiglio, 12.9.1927, pp. 594-5. 24 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 1.6.1931, p.163. 25 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 1.6.1931, p.163. 26 B. Bossi, La delinquenza dei minorenni e la sua repressione, estratto de «L’educatore della Svizzera italiana», Lugano, 1931. 22 23 82 Percorsi di ricerca 2/2010 dei giovani.» 27 [Questo perché] “il diritto penale per i giovani poggia quasi esclusivamente, secondo la dottrina moderna, sul concetto dell’educazione, la quale comprende non solo quelli che sono già incorsi nelle violazioni delle leggi penali, ma anche i molti che per speciali condizioni di ambiente o di natura, vi incorreranno se lasciati a sé» 28 Chiaro, insomma, il nuovo indirizzo che si voleva dare al diritto minorile: abolizione della punizione a favore di una correzione e miglioramento del fanciullo, tramite l’educazione. Non andavano trascurate, però, altre misure per «riportare il giovinetto al consorzio civile»: «nel giovanetto che sbaglia si deve vedere più tosto che un colpevole, un infermo o nell’organismo fisico o nell’entità psichica, affetto insomma di un vizio che bisogna eliminare con un trattamento adeguato: trattamento clinico se si tratta di un’affezione fisica, educativo se si constata che egli è vittima di un’educazione deficiente; correttiva s’egli è affetto di un pervertimento precoce che bisogna reprimere con energiche misure di coercizione» 29 Ma l’aspetto più interessante illustrato da Bossi riguarda la consistenza del fenomeno delinquenziale in Ticino, che egli definisce «né frequente né grave». Stando ai dati da lui citati, dal 1925 al 1930 vennero condannati nel Sopraceneri circa 50 minorenni, nel Sottoceneri 22, con una media annua di 14 condanne in tutto il cantone 30. A commettere reati, inoltre, erano soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Le asserzioni di Bossi confermano il sospetto che la dilagante criminalità tra i giovani ticinesi fosse più una percezione dell’élite borghese che una realtà. Tuttavia, malgrado gli esigui numeri, in ballo c’era – secondo Bossi – una questione di principio e di modernizzazione delle strutture giuridiche. Dopo anni di discussioni e rinvii, nel 1934 si arrivò finalmente ad approvare la prima legge ticinese sulla delinquenza minorile, che sancì la non imputabilità giuridica del minorenne. Un’esigenza, quella di creare un apparato legislativo appositamente concepito per i minori, fatta propria oramai da tutti gli schieramenti politici. La legge istituì una «giurisdizione duplice», basata cioè sulla collaborazione tra procuratore pubblico e i neonati «Consigli per la correzione e l’educazione dei fanciulli delinquenti». Per ciò che riguarda questi ultimi, erano formati da un presidente (il pretore del distretto in cui era stato commesso il reato), da un docente e da un medico. Stando al progetto di legge approvato, vengono riassunti così le rispettive funzioni e compiti «il procuratore pubblico è colui che procede tramite ammonimenti castighi e applica il perdono giudiziario, tenta l’opera di redenzione del giovane o della sua rieducazione. Il consiglio è invece un organo giudicante in grado di studiare il colpevole; fa capo un magistrato che applica la legge, un docente che «conosce o può determinare l’intelligenza, le abitudini e le attitudini del prevenuto e a un medico il quale può stabilire se il giovane sia normale o meno, se esso ha bisogno di cure speciali al fine di eliminare quelle tare o anomalie fisiche o psichiche che possono essere la causa determinante di un delitto» 31 Ma la legge del 1934 non poteva che rappresentare una misura di transizione, dato che nel 1942 sarebbe stato adottato il nuovo codice penale svizzero, al quale tutti i cantoni si dovevano uniformare. Il Nuovo CPS suddivideva i minori in tre differenti categorie, sancendo per loro anche una differenziazione di trattamento: da un lato i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, per i quali erano previste solo misure educative. Dall’altro, gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, per i quali potevano essere adottate misure educative più severe, con punizioni vere e proprie, che potevano arrivare a una mulBossi, La delinquenza, cit., pp. 3-4. Ibidem. 29 Ibid., pp.6-7. 30 Ibid., p. 28. 31 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 18.12.1934, p. 328. 27 28 83 Percorsi di ricerca 2/2010 ta o al carcere fino a 1 anno. I minorenni fra i 18 e i 20 anni, invece, venivano equiparati agli adulti ma con pene più ridotte. Per loro teoricamente non era previsto il carcere, bensì l’istituto di correzione. Per questo, in ogni cantone, sarebbe dovuto sorgere una struttura adeguata. Un altro punto essenziale risiedeva nel fatto che il nuovo Codice chiedeva di procedere alla creazione di una speciale magistratura per i minori, lasciando tuttavia piena libertà in materia di procedura d’applicazione e sulle autorità competenti da designare. In questo contesto, nel 1939 l’avvocato Spartaco Zeli fu incaricato di eseguire uno studio legislativo sull’applicazione del codice penale svizzero nel Ticino, da presentare poi alla Commissione speciale istituita dal Dipartimento di giustizia. Il progetto di Zeli prevedeva che il Magistrato dei minori fosse giudice unico per tutti i minorenni fino ai 14 anni, mentre per i ragazzi compresi nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni, l’avvocato riteneva opportuno istituire un organismo diverso, poiché vi erano in gioco pene più severe. In questo caso, infatti, il magistrato veniva affiancato da altre due figure, che secondo lui dovevano essere un medico psichiatra e un docente. Quest’ultimo, poteva essere sostituito da una figura femminile, in considerazione del fatto che «la donna era costantemente impegnata in problemi pedagogici». Inoltre, Zeli considerava la presenza femminile indispensabile nell’istruttoria, soprattutto nei casi di «scostumatezza». Il giurista, infatti, riteneva per esempio che «le minorenni depravate o che sono state vittime di reati contro il buon costume, osano confessarsi solo a una donna, vera infermiera dell’ordine morale» 32. Per ciò che concerne la procedura d’inchiesta messa in atto dal giudice, era la seguente: la prima tappa doveva essere un semplice colloquio, una chiacchierata, volta a scoprire l’eziologia criminale del fanciullo. Il secondo passo, invece, era costituito dalla sua anamnesi, basata sui seguenti criteri: «L’anamnesi è da considerarsi sotto due aspetti: quello biologico e quello sociologico. 1. Criterio biologico: […] entrano in linea di conto: tare ereditarie, criminalità degli ascendenti, traumi durante e prima della nascita, età dei genitori al momento della concezione, rango nella sequela dei fratelli, sviluppo biologico ed età biologica, sviluppo sessuale, aberrazioni sessuali, particolarità somatiche (bruttezza, capelli rossi, ecc…) 2. Criterio sociologico: situazione sociale ed economica dei genitori, condizioni di abitazione, rapporti tra di loro,[….], cambiamento frequente nel mestiere e del luogo di lavoro, […], influenza del cinema o della sala da ballo, genere di lettura, rapporti sessuali.» 33 E proprio legato a quest’ultimo fattore, Zeli sottolinea ancora una volta l’importanza di avere una collaboratrice donna: «solo la donna potrà avere facilmente ragguagli dalla minorenne sulla intima sua vita, sulla condotta sessuale, sulle anomalie psichiche di questa vita, elementi tutti di somma importanza per lo studio della sua criminalità» 34. Lo studio di Zeli costituì la base del progetto di legge per la Magistratura dei minori, un progetto che venne presentato e discusso in Gran Consiglio nel 1941. Il dibattito, assai acceso, fu accompagnato da forti opposizioni, legate però soprattutto a singoli articoli o aspetti tecnici. Uno dei pochi a pronunciarsi totalmente contro la magistratura dei minori fu l’onorevole Respini, che riteneva inutile la creazione di un simile organismo, data l’esiguità dei casi in cui sarebbe stata chiamata ad intervenire. Respini non mancò di sottolineare che nei sette anni successivi all’introduzione dei Consigli per i minori (1934) in Ticino vennero celebrati solo sette o otto processi a carico di minori: trovava del tutto inutile, dunque, creare una magistratura permanente per un numero così limitato di casi. Il punto che creò maggiori divisioni fu quello sulle funzioni e i relativi requisiti che doveva possedere il giudice. In particolare, si riteneva inutile il fatto che esso potesse avesse le stesse competenze di un procuratore pubblico. L’onorevole Tamburini chiese che fosse venisse stralciato dal progetto di leg- Zeli, Delinquenza minorile, cit., p. 29. Ibid., pp. 32-33. 34 Ibid., p. 339. 32 33 84 Percorsi di ricerca 2/2010 ge il termine “laureato in legge» 35. A lui fece eco il gran Consigliere Cattaneo che vede la necessità di una formazione giuridica solo in un caso limitato: «La specializzazione in materia penale può essere compresa quando si tratti di stabilire il lato psichico di un individuo, la sua situazione mentale, le eventuali tare ereditarie, ecc., attraverso perizie di un medico specializzato appare difficilmente ammissibile» 36. Dopo una lunga discussione, il progetto di legge venne approvato, mantenendo praticamente intatto il modello suggerito dall’avvocato Spartaco Zeli. Dopo quasi cinquant’anni di proposte e progetti, dunque, nel 1941 il Canton Ticino si dotò finalmente di una Magistratura per i minorenni. L’anno successivo fu nominato il primo giudice dei minori, l’avvocato Giuseppe Bernasconi. Per ciò che concerne la costruzione dell’agognato istituto di rieducazione minorile, invece, si divette attendere il 1961, quando fu inaugurato il carcere minorile di Torricella. A mo’ di conclusione In queste brevi pagine si è cercato di illustrare le tappe che hanno condotto la classe politica ticinese a creare un apparato legislativo e un istanza di giudizio per i minori. Tuttavia, questo rappresenta solo uno dei molteplici tasselli che compongono la tematica e probabilmente non è nemmeno il più interessante. Non siamo infatti in grado di dire nulla sul funzionamento di questa macchina, né sulle figure che fu chiamata a giudicare. Nel nostro discorso, poi, rimangono scoperte svariate questioni importanti. Quella dell’educazione, per esempio. Manca infatti un’analisi approfondita che prenda in considerazione il ruolo svolto dalla scuola e dai suoi operatori. Un ruolo di igiene sociale preventiva, forse, dato che spettava proprio alla scuola segnalare alle autorità la presenza nelle classi di discoli o di “anormali del carattere», come li definiva la psichiatria. Un campo che va sicuramente indagato, ma per il quale ancora non abbiamo a disposizione fonti sufficienti. 35 36 ASTi, Atti del Gran Consiglio, 4.6.1941, p. 137. ASTi, Atti del Gran Consiglio, 4.6.1941, pp. 137-138. 85 Percorsi di ricerca 2/2010 Antonio Croci 1823-1884 Architetto ticinese tra tradizione e cultura cosmopolita Graziella Zannone Milan L’interesse per l’architetto Antonio Croci prende avvio durante gli studi all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Fino al momento dell’iscrizione all’Ecole doctorale del Politecnico di Losanna avevo svolto le indagini su aspetti puntuali dell’opera dell’architetto; ora la volontà è quella di mettere in relazione gli argomenti all’interno di una prospettiva monografica completa. Antonio Croci rappresenta senza dubbio un caso unico nel contesto lombardo-ticinese ed è stato più volte oggetto dell’attenzione di alcuni architetti e storici che però si sono occupati soprattutto della casa dell’architetto, il Carlasc a Mendrisio. Dopo la donazione dei disegni dell’architetto Croci all’Archivio di Stato di Bellinzona, da parte di Giovanni Maria Staffieri e Fabio Reinhart, ho ricevuto una borsa di ricerca cantonale per schedare e ordinare i materiali. Durante il biennio di associazione al LabiSAlp ho potuto approfondire lo studio di alcuni progetti che fanno parte del fondo catalogato. Breve biografia di Antonio Croci Antonio Croci nasce a Mendrisio il 7 aprile del 1823. Nel 1837 é ammesso alla Scuola di prospettiva dell’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), dove nel 1842 vince il primo premio al concorso di seconda classe per l’invenzione architettonica e nel 1845 ottiene l’accessit al concorso di seconda classe per il rilievo di ornamenti 1. In più fonti viene menzionato un suo soggiorno di studio a Roma, del quale fino ad ora non si ha conferma 2. Nel 1857 partecipa alla Prima Esposizione Svizzera di Belle Arti di Berna con due acquerelli: Progetto di un ponte da erigersi in Venezia e L’interno della basilica di S. Ambrogio di Milano 3. Sicuro è un suo soggiorno in Turchia, da dove rimpatria nel 1858 4. Nel mese di dicembre dello stesso anno, su diver- 1 Archivio Accademia di Brera, Elenco generale allievi ammessi alla Accademia 1841-1852, Registri della scuola di Ornato 18341847, Registri della scuola di Architettura 1834-1851, Atti dell’I. R. Accademia di Belle Arti in Milano, Milano 1843, p. 39, Atti dell’I. R. Accademia di Belle Arti in Milano, Milano 1845, p. 48. 2 Sia lo Sweizerisches Künstler-Lexicon del 1905 (p. 329), che l’articolo che Ambrogio Croci, pronipote di Antonio, pubblica sul «Corriere del Ticino» il 12 ottobre del 1937 riportano la notizia di un soggiorno di studio a Roma, nessun documento ritrovato fino ad ora lo conferma. Croci non compare nemmeno nella lista degli studenti dell’accademia braidense vincitori di un pensionato romano. 3 Verzeichniss der Kunstgegenstände auf der Schweizerischen Kunstausstellung zu Bern, Bern 1857, p. 14; Prima esposizione svizzera di belle arti, in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana» (BSSI), Serie I, XXV, (1903), n. 4-6, p. 89. 4 Secondo il Registro dei Militari, conservato all’Archivio Storico Comunale di Mendrisio, nel 1847 Croci si trovava a Costantinopoli. 87 Percorsi di ricerca 2/2010 si quotidiani svizzeri appare la notizia di Croci inventore di un sistema di locomotiva a cremagliera, progetto presentato al Consiglio di Stato ticinese 5. Nel 1937 Ambrogio Croci redige una biografia del prozio Antonio, dalla stessa si apprende che Croci soggiornò in Russia e in seguito a Izmir dove avrebbe costruito una moschea ed una sinagoga; avrebbe inoltre realizzato l’albergo Mendrisio nell’omonimo borgo, trasformato poi in ricovero per anziani, l’albergo Bellavista sul Monte Generoso ed una “villa moresca” a Cernobbio, sul lago di Como. Di tutte queste opere non si è mai trovata conferma; va ancora chiarito il ruolo di Croci nel progetto per il campanile di San Spiridon a Iasi in Romania, dove prossimamente svolgerò delle ricerche. Nella corrispondenza tra Ambrogio Croci e l’architetto di origini ticinesi Costantin Scala, si legge che Croci lavorò come assistente alla costruzione del Castello di Valrose a Nizza 6. Dopo un recente viaggio in Costa Azzurra, ho potuto accertare che il barone Paul Georgevich von Derwies acquista, nel 1867, un terreno su una collina chiamata Valrose. Decide quindi di costruirvi un castello con le relative dépendances e si rivolge all’architetto David Grimm, che già si trova a Nizza per portare a termine la cappella funeraria dello Tsarewitch Nicolas. Grimm concepisce la sistemazione dell’insieme degli edifici di Valrose, Antonio Croci, che parteciperà anche alla realizzazione del Castello di Trevano (1871-73), sempre di proprietà del von Derwies, assisterà Grimm. Tra il 1861 e il 1865, Croci si occupa della “neogotizzazione” 7 della chiesa di St. Georg a Ernen (VS) e della costruzione della chiesa di Santa Anna a Lax (VS), opere in seguito trasformate. A Mendrisio partecipa nel 1861 al concorso per l’edificazione della nuova chiesa parrocchiale, vinto da Luigi Fontana, progetta la Cappella Franchini, Villa Argentina (1873) e la sua abitazione chiamata “Carlasc” (1875). Negli anni 1871-72 secondo Ambrogio, Antonio Croci si trova in Argentina, dove incontrerà la famiglia Bernasconi che gli commissionerà la residenza estiva di Mendrisio, chiamata appunto, Villa Argentina. Tra il 1873 e il 1876, Croci collabora con gli scultori Vincenzo e Lorenzo Vela alla progettazione del monumento per Charles Frédéric Auguste duca di Brunswick a Ginevra, che non venne eseguito per problemi intercorsi con gli esecutori testamentari del duca. Il fondo in deposito all’Archivio di Stato di Bellinzona Antonio Croci muore a Mendrisio il 2 dicembre 1884 senza lasciare una discendenza diretta 8. La sua casa, da lui progettata ed abitata fino alla morte, andrà in eredità al fratello Giuseppe insieme ai documenti appartenuti all’architetto. L’archivio viene in seguito suddiviso e in gran parte disperso. Maria Aprile, moglie di Ambrogio Croci, conservava nella sua casa di Lugano le lettere che il marito aveva scambiato con l’architetto Scala di Nizza e due tavole dell’architetto: un disegno scolastico con una prospettiva di villa e un prospetto di residenza sulla Costa Azzurra dal titolo “Nizza marittima”, che furono poi donati all’architetto Fabio Reinhart9. La nipote di Antonio Croci, Concetta, che aveva una venerazione per il fratello del nonno, custodiva inoltre 20 scatole di documenti relative all’attività dell’architetto, consegnate, alla sua morte, ad una insegnante di francese di Mendrisio, la signorina Baggio. Quest’ultima, dovendo abbandonare la In «Der Bund» 13 dicembre 1858, «La Democrazia» 16 dicembre 1858 e «Gazzetta Ticinese» 18 dicembre 1858, in Archivio di Stato del Canton Ticino (ASTi), Diversi, sc. 1143 sono conservate due lettere a proposito di questo progetto, che si scambiarono l’ing. Leemann di Bienne e Sebastiano Beroldingen di Mendrisio. 6 Le lettere sono conservate nel Fondo Libreria Patria della Biblioteca Cantonale di Lugano. 7 Questo termine è stato impiegato da Walter Ruppen in Antonio Crocis Pläne zur Neogotisierung der Pfarrkirche von Ernen, «I nostri monumenti storici», 1976, 2. 8 Archivio Parrocchiale di Mendrisio, 5° Liber Mortuorum 1869-1886, 1884, no. 56. 9 Cfr. nota 6, i disegni ora si trovano in ASTi. 5 88 Percorsi di ricerca 2/2010 propria casa nel 1969, diede tutti i materiali all’antiquario Lurà di Mendrisio, che sciaguratamente li distrusse, sostenendo che “...i disegni di architettura hanno poco mercato”. Un’altra parte dell’archivio, meno consistente della prima, è stata ritrovata tra un’infinità di carte in una soffitta di vicolo Stella, a Mendrisio, e recuperato dal Reinhart. Altri disegni vennero infine ritrovati tra i rifiuti dall’antiquario Alessio Tomini di Mendrisio che, tramite un collega, li offrì alla Municipalità di Mendrisio e all’Ufficio dei Monumenti Storici di Bellinzona. Le trattative però non ebbero buon fine e i disegni furono venduti al mercatino dell’antiquariato di Lugano, dove furono acquistati il 30 settembre 1986 da Giovanni Maria Staffieri. Il nuovo proprietario, in seguito contattato dall’Ufficio dei Beni Culturali per l’acquisizione delle carte da parte dello Stato (che però rinunciò), mise a disposizione di Reinhart, studioso di Antonio Croci e già proprietario di altre carte, i disegni 10. Oggi tutti i materiali, quelli acquistati da Staffieri e quelli trovati da Reinhart, sono riuniti nel Fondo Antonio Croci conservato all’Archivio di Stato di Bellinzona. Questi pochi documenti recuperati ci fanno intuire la vastità degli interessi e dei progetti ai quali Antonio Croci si dedicò, ma solo tra le carte gettate al macero si trovano le risposte alle domande che oggi ci poniamo, carte che purtroppo sono perse per sempre. Un progetto mancato: il monumento al duca Carlo II di Brunswick Carlo II duca di Brunswick nasce nel 1804, discendente della stirpe dei Brunswick-Wolfenbüttel, rimane orfano presto e dopo un’adolescenza travagliata, arrivato alla maggiore età parte per un viaggio in Italia. Ritorna in patria dove rimane per quattro anni, nel 1830 a causa del suo malgoverno, viene scacciato dal popolo. Si trasferisce a Parigi, dove soggiorna fino allo scoppio della guerra francoprusssiana (1870-71), quando fugge in esilio a Ginevra dove muore nell’agosto del 1873 11. Uomo molto ricco, tormentato dal pensiero della morte, due anni prima di morire, decide di revocare il testamento steso a Parigi, qualche anno prima, in favore del Principe imperiale. Davanti al notaio Charles Binet, all’avvocato Charles Louis Ferdinand Cherbuliez e all’amico e suo tesoriere Georges Thomas Smith, il 5 marzo del 1871 redige un nuovo documento con le ultime volontà: lascia tutti i suoi averi alla città di Ginevra, con un’unica clausola: «[…] Noi vogliamo che il nostro corpo sia deposto in un Mausoleo, al disopra del terreno, che verrà eretto dai nostri esecutori testamentari, a Ginevra in una posizione prominente e degna. Il monumento sarà sormontato dalla nostra statua equestre e circondato da quelle di nostro padre, nostro nonno ecc., di gloriosa memoria, secondo il disegno unito a questo testamento e che imita il mausoleo degli Scaligeri a Verona. I nostri esecutori faranno costruire questo monumento ad libitum dei milioni della nostra successione, in bronzo e marmo chiamando gli artisti più celebri.[…]» 12 Le lettere che documentano queste vicende sono in possesso di Giovanni Maria Staffieri che gentilmente le ha fatte consultare in occasione della redazione di un testo, al quale anche questo scritto è ispirato, per il catalogo della mostra Archivi e Architetture. Presenze del Cantone Ticino, a cura di L. Tedeschi, Mendrisio, 1998. 11 Carlo II duca di Brunswick (Brunswick 1804-Ginevra 1873), per la biografia completa si veda: T. Dénes, Charles II Duc de Brunswick et Genève, Genève, 1973, pp. 5-32. 12 Stralcio del testamento consegnato al notaio Charles Binet a Ginevra il 6 marzo 1871, il documento originale, si trova all’AEGe (Archives d’Etat de Genève), Fonds Charles Binet. La traduzione in italiano si trova in G. Piffaretti, Il grande rifiuto ovvero la storia del monumento a Ginevra che Vincenzo Vela non poté realizzare, Mendrisio, 1990, p. 13. 10 89 Percorsi di ricerca 2/2010 Il disegno al quale si fa riferimento nelle ultime volontà, è un progetto che il duca commissiona a Londra ad Emilio Pistrucci 13 ispirato alle Arche scaligere, che lo avevano impressionato in occasione del suo viaggio in Italia 14. Fig. 1. Emilio Pistrucci, disegno allegato al testamento del duca di Brunswick, 1849 Fonte: Archives d’Etat de Genève. La notizia del legato alla città solleva una grossa polemica, mentre la stampa tedesca e francese si scaglia contro il duca, le autorità ginevrine stanno per ricevere una somma che permetterà loro di estinguere tutti i debiti e di investire in nuove costruzioni come il Grand Théâtre, l’Abbatoir, l’Ecole d’horlogerie e tante altre ancora 15. Nel mese di ottobre del 1873 un gruppo di 25 architetti ginevrini sottoscrive una petizione inviata al Consiglio municipale ed agli esecutori testamentari affinché si apra un concorso pubblico per la progettazione del monumento «[…] en donnant pour programme la partie du testament du duc concer- In T. Dénes, La vraie histoire d’un monument genevois, in «Musées de Genève», n. 132, 1973, p. 6, viene attribuito il progetto dapprima al medaglista Benedetto Pistrucci (Roma 1783 – Windsor 1855), successivamente in Le roman-fleuve d’un monument genevois, in «Revue du Vieux Genève», n. 141, 1974, p. 7, nota 1, al figlio di Benedetto Camillo Pistrucci, già autore della tomba di Eliza Alice Gates, compagna del duca, nel cimitero di Kensal Green. Il disegno allegato al testamento è invece firmato da Emilio Pistrucci nel 1849, cfr. M. Andrey, Vincenzo Vela et Genève, Mémoire de licence, Faculté des Lettres, Université de Genève, 2000, dattiloscritto, p. 25 e confermato da V. Palfi, Histoire, in Le monumet Brunswick, Genève, 2002, p. 17, nota 9. 14 Le Arche scaligere di Verona, sono un complesso monumentale funerario in stile gotico della famiglia degli Scaligeri, destinate a contenere le arche (tombe) dei più illustri rappresentanti della casata. Sono racchiuse da un recinto di ferro battuto in cui ricorre il motivo della scala, simbolo della casata. Le arche appartengono a Cangrande I, a Mastino II, a Cansignorio, ad Alberto I e a Giovanni della Scala. 15 Nelle ultime pagine del testo di Dénes, Charles II Duc de Brunswick et Genève, cit., è pubblicata una planimetria della città di Ginevra con tutte le opere pubbliche rese possibili impiegando l’eredità Brunswick. 13 90 Percorsi di ricerca 2/2010 nant le monument, et en laissant les concurrents libres de chercher la solution la plus favorable à la reussite de l’entreprise.» 16 Nello stesso periodo, in un articolo apparso sulla stampa specializzata, si dice che l’architetto Franel 17 è stato incaricato del progetto della tomba e che sarebbe in procinto di partire per l’Italia per raccogliere la documentazione necessaria 18. Gli esecutori testamentari nell’adempimento dei loro compiti, e su raccomandazione del presidente del Consiglio amministrativo Alfred Le Royer, scelgono lo scultore Vincenzo Vela 19. Cherbuliez gli scrive il 28 novembre del 1873, riporta una parte del testamento, precisa che hanno già individuato una piazza adatta al monumento, che vorrebbe invitarlo a Ginevra affinché approvi la scelta del luogo, e prosegue: «[…] Signore, essendo preoccupati di scegliere un artista eminente al quale affidare l’esecuzione dell’opera, noi abbiamo concordato la scelta del Suo nome, cittadino svizzero, artista scultore la cui fama e la cui reputazione è unanimemente riconosciuta. Con la presente vengo a chiedere se, nei termini generali esposti sopra, lei acconsente ad accettare l’alta Direzione del Monumento a S.A.R. il duca di Brunswick, cioè se acconsente ad elaborare un progetto definitivo e dettagliato e in seguito di procedere alla sua esecuzione. […]» 20 Il 5 dicembre il Vela risponde che è molto lusingato, accetta il mandato, andrà a Ginevra solo dopo aver visitato Verona, poi ritornerà a casa per il progetto che sottoporrà con un modello, così da poter essere giudicato. Lo scultore intuisce che si tratta di un incarico molto importante e che sarà necessaria la collaborazione di un architetto per il progetto del basamento del mausoleo: «[…] essendo la parte principale del Monumento, scultorea, la affidavano a me, dicendomi che se nella parte architettonica mi abbisognava un architetto dovessi io procurarmelo di mia soddisfazione, e dicendomi anche che io non avrei avuto da dipendere in questo lavoro fuorché con gli Esecutori testamentari. […] Io ho scelto per Architetto il sig. Croci di Mendrisio perché lo conoscevo molto abile in questo genere di lavoro, e in compagnia di questo Architetto andai a Verona, indi a Ginevra dove ci abboccammo coi sig. Esecutori Testamentari. […]» 21 Dopo il sopralluogo in città, Vela scrive una nuova lettera precisando che la piazza dietro la Chiesa degli Inglesi sarebbe il luogo più adatto per il carattere del monumento, rispetto a piazza delle Alpi, scelta da Cherbuliez e Smith 22. Da questo momento cominciano le difficoltà con gli esecutori testamentari, che incaricano l’architetto Viollet-le-Duc 23 di fare da consulente alla Commissione che deve decidere della collocaDénes, Le roman-fleuve, cit., p. 2. Jean Franel (Vevey 1824-Ginevra 1885), architetto, lavora dapprima con il padre poi si trasferisce a Ginevra, nonostante una serie di insuccessi gode ancora della fiducia del Consiglio municipale, cfr. Ibid. Per la biografia si veda Palfi, Histoire, cit., p. 14. 18 Journal de la Construction et de l’Industrie, numero di novembre. 19 Vincenzo Vela (Ligornetto 1820-1891), scultore di fama, per una biografia breve cfr. G. A. Mina Zeni (a cura di), Museo Vela. Le collezioni, Lugano, 2002, p. 284. 20 La traduzione in italiano della lettera si trova in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 31. 21 Estratto della Dichiarazione dello scultore V. Vela sui fatti del Monumento a S.A.R. il Duca di Brunswick per la città di Ginevra, in G. Martinola, Lettere di Vincenzo Vela, Lugano, 1940, pp. 14-15. 22 Lettera di Vincenzo Vela del 24.12.1873 riportata integralmente in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 33. 23 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (Parigi 1814-Losanna 1879), architetto francese noto soprattutto per i restauri di edifici medioevali, autore del Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854-1868). Viollet-le-Duc si trova a Ginevra per il progetto di restauro della Chappelle des Macchabées e della valutazione dell’insieme della Cathédrale Saint-Pierre, opere per le quali ambisce al mandato. Non è chiaro il motivo per il quale la questione Brunswick si protrae per Viollet-le-Duc per diverso tempo, infatti egli ne parlerà ancora nella corrispondenza del 1878 e nel maggio dello stesso anno farà un schizzo del mausoleo, cfr. L. El Wakil, Viollet-le-Duc à Genève (1874-1878), in P. Auberson, J. Gubler (a cura di), Viollet-le-Duc. Centenaire de la mort à Lausanne, Lausanne, 1979, pp. 49-50. 16 17 91 Percorsi di ricerca 2/2010 zione del monumento. L’architetto francese sostiene la scelta fatta dai mandanti e dal Consiglio municipale, forse per imbonire quest’ultimo in vista dell’assegnazione del restauro della Chapelle des Maccabées. Nel febbraio del 1874 Vincenzo Vela scrive a Cherbuliez scusandosi di non essere stato a Ginevra per incontare Viollet-le-Duc ma era occupato nel modellare il bozzetto del monumento, e aggiunge a riguardo della collocazione: «[…] J’accepte néanmoins sa décision, mais je tiens à vous dire que si j’ai choisi la place derrière l’église anglaise, c’est pour les trois motifs suivants: 1° Parce que, selon la volonté du testateur, son corps devant reposer au centre du monument, et au dessus de terre -comme c’était la coutume des Scaligeri- le monument, malgré toutes les modifications que je pourrais y apporter, aura toujours un cachet de grande austérité, qui, précisément, conviendrait à cet emplacement; 2° Parce que le poids du monument devant être très considerable, je crains que la place que vous avez choisie n’offre pas toute la resistence désirable; 3° Parce qu’enfin cette dernière palce, étant l’une des plus grandes de Genève, j’estime qu’on ferait bien de la réserver pour quelque monument d’un caractère national interéssant tout le peuple Suisse.» 24 Cherbuliez e Smith presentano un rapporto al Consiglio Amministrativo della Città di Ginevra con le seguenti motivazioni: «[…] Dopo uno studio coscienzioso delle diverse piazze di Ginevra, ci siamo decisi per Piazza delle Alpi, il luogo che più di ogni altro soddisfa le condizioni che noi dovevamo tenere in considerazione. […] Il Signor Vela, ci disse che il luogo più appropriato per accogliere il monumento è la piazza contigua a quella delle Alpi, dietro la Chiesa Anglicana tra le vie Lévrier e Bonivard, ossia l’area attualmente occupata dalla Fontana detta delle Quattro stagioni. Le conclusioni del rapporto del Sig. Vela furono comunicate alla Commissione del Consiglio Municipale tramite Vostro intermediario. Questa commissione condivise i nostri scrupoli sul cambiamento della scelta della piazza. Le condizioni chieste dal Duca e che trovavano la loro attuazione nella Piazza delle Alpi sembravano alla Commissione e a noi non più riscontrarsi e riconoscersi nel luogo proposto dal Sig. Vela. […] Di comune accordo tra la Commissione e noi venne deciso di consultare un architetto eminente, e la nostra scelta cadde sul Sig. Viollet Le-Duc, che la sua alta posizione artistica designava come perfettamente qualificato per questa mansione. L’opinione del Sig. Viollet Le-Duc, descritta nel rapporto verbale che ci fece, in presenza della Commissione, il 6 marzo 1874, fu che la Piazza delle Alpi si adattava, meglio delle altre, ad adempiere alla condizioni richieste per accogliere il Monumento del Duca di Brunswick. Tuttavia il Sig. Viollet Le-Duc stimava che non c’era necessità di attenersi in modo stretto al modello annesso al testamento. Secondo la sua opinione, il Modello e il Monumento di Verona dovevano essere imitati piuttosto che essere copiati e che esisteva l’opportunità di modificarli in vista del luogo di erezione scelto. Il Consiglio Municipale ci accordò l’autorizzazione di erigere il monumento sulla Piazza delle Alpi.» 25 Dopo la soluzione della disputa sulla piazza che accoglierà il monumento, il Vela si mette al lavoro, incarica il fratello Lorenzo 26 per l’esecuzione dei sei leoni ai piedi del basamento e invia una descrizione del monumento a Ginevra: 1. La statua equestre in bronzo rappresenta il Duca Carlo nell’istante in cui ferma il cavallo e si toglie il cappello per salutare il popolo di Ginevra. 2. Quattro genietti, due sulla parte anteriore e due su quella posteriore, tengono i capi di ghirlande di fiori che circondano il monumento. Le due aquile sostengono una corona di foglie di quercia e alloro sulla testa del padre e del nonno del Duca Carlo. R. Manzoni, Vincenzo Vela. L’homme, le patriote, l’artiste, Milano, 1906, p. 258. Seduta del 13 marzo 1874, cfr. Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 35. 26 Lorenzo Vela (Ligornetto 1812-Milano 1897), fratello maggiore di Vincenzo, scultore ornatista, per una biografia breve si veda Mina Zeni, Museo Vela., cit., p. 285. 24 25 92 Percorsi di ricerca 2/2010 3. Tutti i busti che servono da decorazione sono i ritratti dei duchi di Brunswick. 4. L’urna, all’interno del tempio, porta scolpita la spoglia mortale del Duca Carlo. L’urna sarà vuota all’interno per deporre realmente la salma del Duca. 5. Delle altre sei statue, le due in piedi rappresentano il padre e il nonno del Duca Carlo. Le altre quattro, sedute, rappresentano il duca Enrico il Leone, la madre del Duca Carlo, il Duca Giulio, che, nella storia, appare come un principe riformatore; fondò una università e la sua morte fu pianta da tutti gli abitanti del ducato. La quarta statua rappresenta la nonna del Duca Carlo. 6. Dei cinque bassorilievi, quello in mezzo rappresenta la città di Ginevra riconoscente che registra nel libro d’oro della storia l’eredità di S.A.R. il Duca Carlo di Brunswick. Quello di fianco rappresenta il Duca Federico-Guglielmo nella battaglia di Quatrebras. Il terzo rappresenta la battaglia di Jena e la morte del Duca Carlo-Guglielmo-Ferdinando. Il quarto rappresenta la morte del principe Leopoldo che stava prodigandosi per portare soccorso agli abitanti di un villaggio allagato. Il quinto rappresenta il colloquio di Lutero col principe Ernesto il Confessore. Il sesto bassorilievo è libero per collocarvi l’epigrafe. 7. La base dev’essere di granito rosso con i sei leoni di marmo. I sei stemmi alla base del monumento saranno di bronzo. I leoni, le statue, i bassorilievi, i busti verranno scolpiti in marmo di Carrara detto Ravacione, che è il più resistente alle intemperie. Sarei dell’avviso che per l’armonia e l’effetto generale del monumento si preferisca il bronzo unicamente per la statua equestre del Duca Carlo; statua che dovrebbe dominare dall’alto. Lascerei in bronzo anche i quattro genietti, le due aquile e le ghirlande di fiori. Ligornetto, agosto 1874 Vincenzo Vela 27 Fig. 2. Spartaco Vela, studio d’ambientazione per il monumento del duca di Brunswick su progetto di Antonio Croci e Vincenzo Vela, 1874 Fonte: Museo Vela, Ligornetto. Nel periodo che segue i due Vela e Croci lavorano al monumento, nell’agosto del 1874, inviano a Ginevra una serie di fotografie del bozzetto in gesso 28. Viene stilato il preventivo calcolando che il costo del monumento si aggirerà attorno al milione di franchi e per l’esecuzione saranno necessari quattro anni 29. Cfr. Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 37. Lettera di Vincenzo Vela del 24.8.1874, tradotta in italiano in ibid., p. 39. 29 Dénes, Le roman-fleuve d’un monument genevois, cit., p. 5. 27 28 93 Percorsi di ricerca 2/2010 Cherbuliez, su invito di Vela, si reca a Ligornetto per un sopralluogo, riparte contento e scrive allo scultore una lettera colma di complimenti 30. Nel mese di settembre gli esecutori testamentari sono di nuovo a Ligornetto, di ritorno a Ginevra trasmettono a Vela alcune osservazioni riguardanti il progetto: «[…] Le nostre critiche al monumento sono le seguenti: l’insieme dell’opera ci sembra pesante e uniforme. Si impone l’obbligo di correggere ciò che presenta di urtante il progetto, l’incollatura tra i sei piani inferiori dell’edificio con il piedestallo quadrato che dovrà sostenere la statua equestre. Lei ha cercato di dissimulare questa unione con una serie di aquile e di genietti che sostengono una ghirlanda di fiori. Questo ornamento non ci sembra in armonia con il carattere funerario del monumento e lo stile severo della costruzione. Eravamo rimasti d’accordo di studiare, da parte Sua, un migliore nascondimento di questo raccordo con l’aggiunta di pinnacoli gotici simili a quelli del monumento degli Scaligeri, e l’adozione di un piedestallo esagonale per la statua equestre, con pinnacoli e pignoni alla base. Eravamo rimasti d’accordo che, qualora Lei avesse trovato una felice soluzione riguardo questi punti controversi, noi avremmo inviato il Signor Architetto Franel di Ginevra, uomo competentissimo e rinomato nella sua arte.» 31 Vela risponde che l’architetto Croci sta facendo le modifiche da loro richieste e che se Franel non può andare a trovarlo in Ticino, lui potrà spedirgli i disegni sui quali si faranno le osservazioni necessarie 32. L’architetto Franel trova il tempo di andare a Ligornetto, così si esprime Vela a proposito della sua visita all’atelier: «[…] Invece di correggere il mio progetto il Sig. Franel non ci ha nemmeno guardato e mi apre una cartella dove mi mostra un suo progetto non solo, tutto diverso dal mio ma ben anco dallo stile dei Scaligeri, e torno ripetere come dissi al Sig. Franel, che era un progetto inattuabile, e mi faccio stupore dicendogli che il testamento non permette di staccarsi dai Scaligeri in questo modo. Egli, Sig. Franel mi rispose che avevano risolto di non badarci più al testamento. Benché io avessi ricevuto una lettera dal Sig. Cherbuliez che mi annunciava la visita del Sig. Franel e mi diceva di mettermi d’accordo con questo Sig. Franel che tutto sarebbe andato bene, a me mi fu impossibile andar d’accordo perché il suo progetto non poteva andare né mi piaceva, e frattanto io continuai il mio lavoro. […] A Milano affittai per due anni un locale grandioso per eseguire la parte architettonica e ornamentale. Mio fratello aveva già modellato quattro leoni colossali, io aveva terminato la statua equestre del Duca dell’altezza di metri quattro, dalla testa del cavaliere ai piedi del cavallo. Il mio architetto aveva già fatto una gran parte dei dettagli in grande per l’esecuzione in marmo, io avevo già fermati molti bravi lavoratori per eseguire questo lavoro. […]» 33 Nel marzo del 1875 Cherbuliez scrive a Vela che la sua proposta e quella di Franel verranno sottoposte ad una commissione di esperti, accompagnate da una serie di dettagli e dal preventivo dei costi. A giudicare i progetti sono chiamati due architetti parigini Joseph Louis Duc e Hector Lefuel, che criticano i lavori di Vela e Franel perché troppo distanti dalla volontà, espressa nel testamento, di ispirarsi alle Arche scaligere. A proposito del progetto di Franel sostengono che «[…] les formes rappellent, sans nulle originalité, celles que l’on applique le plus généralement. […]» 34 I due esperti concludono il loro rapporto ammettendo che il progetto di Vela è superiore a quello di Franel e propongono che sia il Vela ad occuparsi della scultura mentre l’altro dell’architettura: «[…] M. Vela est Lettera di Cherbuliez del 2.9.1874, tradotta in italiano in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 39. La visita a Ligornetto ha luogo il 19 ottobre 1874, segue la lettera di Cherbuliez e Smith del 8.11.1874, tradotta in italiano in Ibid., pag. 40. 32 Lettera di Vela del 23.11.1874, tradotta in italiano in Ibid. 33 Martinola, Lettere di Vincenzo Vela, cit., pp. 16-17. 34 Dénes, Le roman-fleuve d’un monument genevois, cit., p. 6. 30 31 94 Percorsi di ricerca 2/2010 un artiste de trop de mérite pour s’offenser de ce que nous ne saurions mettre l’architecture qu’il nous présente à la hauteur de ses belles œuvres sculpturales […] -devant seulement étudier et appliquer des détails Architectoniques sur une conception adoptée, et calculer les moyens techniques de la construction,- il est indispensable pour cette tache, d’avoir un homme spécial, versé dans la pratique; le tracé des profiles et l’étude de l’ornementation: en un mot, c’est maintenant que commence le rôle véritable de l’architecte; et si M. Vela étant chargé de l’œuvre sculpturale, M. Franel dirigeait la partie d’architecture et la construction, il nous paraîtrait que la collaboration de ces deux artistes éminents, en leur genre, devrait assurer les meilleurs résultats. […]» 35 Vela deluso è sul punto di rinunciare all’incarico, ma alla fine sottoscrive un accordo con Cherbuliez e Smith per la sola esecuzione della statua equestre, del coperchio del sarcofago e delle sei statue degli antenati del duca 36. Franel firma pure lui la convenzione attirandosi i favori degli esecutori testamentari; dopo un viaggio a Verona progetta un nuovo monumento molto simile alle tombe scaligere, che sottopone ai committenti con un bozzetto in gesso. Anche se scoraggiato il Vela lavora per un intero anno alle sculture, che vengono criticate da Cherbuliez e Smith, fino al punto di inviare un ufficiale della cavalleria austriaca a Ligornetto per l’esame della postura del cavallo della statua equestre 37. Fig. 3. Jean Franel, modello in gesso, 1876 Fonte: Musée d’art et d’histoire de Genève. Vincenzo Vela rinuncia alla commissione il 2 maggio del 1877, inviando una lunga lettera a Cherbuliez e Smith, nella quale si dice «misconosciuto e maltrattato da due compatrioti» 38. Nel novembre dello stesLo stralcio del documento si trova in N. J. Scott, Vincenzo Vela 1820-1891, New York, 1979, p. 482; questo testo riporta la cronologia completa degli avvenimenti principali della costruzione del monumento. 36 Convenzione sulle statue sul Monumento di S.A.R. il Duca di Brunswick, firmata da Cherbuliez, Smith, Vela e dall’avvocato Leone Stoppani il 5 aprile 1876. La traduzione in italiano del documento si trova in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., pp. 5456. 37 Alla lettera di Cherbuliez del 11.4.1877, era allegato il «Rapport sur la Maquette de la Statue equestre». 38 Il testo integrale della lettera, tradotto in italiano, si trova in Martinola, Lettere di Vincenzo Vela, cit., pp. 8-13. 35 95 Percorsi di ricerca 2/2010 so anno Vela scrive una dichiarazione per la Commissione arbitrale, nella quale vengono enumerate tutte le ingiustizie subite 39. La sentenza gli è favorevole, i ginevrini lo devono risarcire con la somma di 52’000 franchi 40. A mo’ di provocazione Vincenzo Vela colloca la statua equestre, ultimata nel febbraio del 1876, al centro del locale più importante della sua villa-museo: il salone ottagonale 41. Franel è ora l’unico regista, affida le sculture ad artisti francesi e svizzeri 42, il monumento del costo complessivo di 1’918’840.90 franchi oro viene inaugurato solennemente il 14 ottobre del 1879, l’iscrizione riporta: «PERFECTUM ET DEDICATUM ANNO MDCCCLXXIX OPERI PRAEFVIT IOH. FRANEL ARCHITECTUS» 43. Nonostante il progetto eseguito sia qualitativamente inferiore alla proposta del connubio Vela-Croci, è innegabile l’importanza del mausoleo per la città, non solo per la posizione quanto per le dimensioni dell’intero complesso monumentale. Nel 1880 viene dedicata una pubblicazione alla storia della dinastia dei Brunswick e del monumento che così si conclude: «[…] l’impression des amateurs éclairés ne sera pas douteuse. Ils rendront une éclatante justice aux facultés inventive et à l’érudition de l’architecte M. Franel qui, secondé par des artistes de premier ordre, s’est montré original sans s’écarter du modèle de Vérone. […] le monument Brunswick restera unique dans son genre au dixneuvième siècle. […]» 44 Dopo appena un anno dal compimento, il mausoleo presenta i primi danni, le cause vengono imputate a due terremoti e ad un inverno particolarmente rigido, ma i difetti di costruzione si fanno viepiù importanti fino alla rimozione della statua equestre, posizionata in origine sulla sommità del monumento 45. Dal 1892 il bronzo del duca a cavallo si trova sul lato destro dell’emiciclo del terrazzo rivolto verso l’hotel Beau-Rivage. Vincenzo Vela e Antonio Croci, nel loro primo sopralluogo a Ginevra avevano già messo in guardia gli esecutori testamentari sui problemi di portanza della piazza in prossimità del lago, Franel non ne ha tenuto conto, e il sottosuolo, come previsto, ha ceduto sotto l’ingente peso 46. Con la sottrazione della statua al vertice della composizione il monumento si presenta mutilato, così nel dicembre del 1890 la città bandisce un concorso per la progettazione di un nuovo coronamento, il vincitore è Eugène Jost, l’esecuzione verrà affidata a Louis Viollier, secondo classificato, nel 1893 47; la posa di un nuovo elemento terminale ha reso necessaria la ricostruzione della piramide di base. Dal 1900 il mausoleo ha subito numerosi interventi di risanamento, l’ultimo in ordine di tempo è stato portato a termine nel 2002 48. Dichiarazione dello scultore V. Vela sui fatti del Monumento a S.A.R. il Duca di Brunswick per la città di Ginevra, riportata integralmente in Martinola, Lettere di Vincenzo Vela, cit., pp. 14-20. 40 Dénes, Le roman-fleuve d’un monument genevois, cit., p. 7. 41 Cfr. Mina Zeni, Museo Vela, cit., p. 295. 42 Per la lista completa degli artisti cfr. Dénes, La vraie histoire d’un monument genevois, cit., p. 4. 43 Terminato ed inaugurato l’anno 1879, Jean Franel, ha diretto l’opera. 44 E. Humbert, Les ducs de Brunswick et le Monument de Genève, Genève, 1880. 45 In M. Koelliker, Précisions historiques relatives au monument Brunswick à Genève: une “pièce montée” de toutes pieces?, in P. Bisegger, M. Fontannaz (a cura di), Hommage à Marcel Grandjean. Des pierres et des hommes, Lausanne, 1995, p. 637-638 e 640, vengono spiegate cronologicamente le deteriorazioni subite. In occasione degli ultimi lavori di risanamento eseguiti sul monumento, la città di Ginevra gli ha dedicato una intera pubblicazione, con un approfondimento sugli interventi dell’ultimo restauro, cfr. Le monument Brunswick, Ville de Genève, Genève, 2002. 46 Dénes, Le roman-fleuve d’un monument genevois, cit., p. 4; Dénes, La vraie histoire d’un monument genevois, cit., 1973, p. 7; Koelliker, Précisions historiques, cit., p. 632. 47 Koelliker, Précisions historiques relatives au monument Brunswick, cit., p. 638. 48 Cfr. nota 45. 39 96 Percorsi di ricerca 2/2010 Dopo aver riassunto cronologicamente la vicenda della costruzione del mausoleo, ci interessa approfondire il rapporto che lega scultore e architetto. Abbiamo già riferito che Vela da principio sceglie Antonio Croci per affidargli la parte architettonica del monumento, definendolo: «molto abile in questo genere di lavoro» 49. La fiducia che Vela ripone in Croci è evidenziata in una lettera indirizzata a Cherbuliez «Dai colloqui che ebbi con l’architetto Franel e dai suggerimenti avuti dagli onorevoli esecutori testamentari di cui Lei fa parte incaricai l’architetto Croci sotto la mia direzione e abbiamo fatto un nuovo disegno migliorando l’architettura di molto dal progetto che lei ha veduto. Ora, per acquistar tempo, Le manderò Croci con tutti i disegni e Lei riunisca chi Le pare e piace. Risolva definitivamente se questi cambiamenti sono di Sua soddisfazione, diversamente Croci prima di partire da Ginevra, farà quei cambiamenti che reputerà necessari essendo lui un valente disegnatore. La prego di darmi una pronta risposta prima che Croci si metta in viaggio.»50 Come noto Cherbuliez risponderà di non mandare Croci ma che sarà Franel ad andare a Ligornetto 51. Da questo momento per insistenza degli esecutori testamentari l’architetto romando sostituirà Croci. Le critiche rivolte all’architettura si riferiscono al raccordo tra la piramide e il basamento della statua equestre che sarebbero stati mascherati dalla presenza di genietti che reggono delle ghirlande, non viene nemmeno approvata la scelta di un basamento rettangolare per la raffigurazione del duca a cavallo 52. Cherbuliez e Smith chiedono inoltre al Vela di aggiungere dei pinnacoli gotici sulla sommità della composizione. Confrontando il bozzetto in gesso e il disegno del fronte, si evidenzia la volontà di Croci e Vela di riprogettare la parte terminale per venire incontro alle richieste dei committenti. Il raccordo, che nel gesso, era una sapiente soluzione geometrica di connessione tra un esagono e un rettangolo, si è trasformato in una semplice piramide tronca a base esagonale. Ci sembra più interessante la soluzione proposta in precedenza poiché innovativa dal punto di vista spaziale e più vicina alla maniera di Croci di lavorare sulla forma esagonale risolvendo elegantemente gli inevitabili compromessi geometrici che si vengono a creare 53. Nei disegni preparatori di vari monumenti conservati al Museo Vela si intuisce la consuetudine dello scultore di avvalersi della collaborazione di architetti per opere strutturalmente complesse. I progetti risultato di una collaborazione sono maggiormente geometrici e razionali, i disegni a penna delle strutture architettoniche vengono completati a matita dal Vela per la parte scultorea 54. Questa pratica è ben visibile nel prospetto e nel particolare del coronamento del monumento Brunswick conservati a Ligornetto 55. La collaborazione tra Vela e Croci non si limiterebbe al monumento per il nobile Brunswick, ma si potrebbe ascrivere ad altri due progetti per monumenti funerari eseguiti attorno al 1875: studio per il monumento ad Angiolina Enderlin-Bianchi e progetto per una tomba. Cfr. nota 21. Lettera di Vela del 24.1.1875, tradotta in italiano in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., p. 41. 51 Lettera di Cherbuliez del 26.1.1875, tradotta in italiano in Piffaretti, Il grande rifiuto, cit., pp. 41-42. 52 Cfr. nota 31. 53 Croci ha già proposto la pianta esagonale nel Belvedere del Castello di Valrose e subito dopo la collaborazione con Vela a questo progetto, inizia il progetto della sua casa che sarà interamente basata sull’esagono. 54 Cfr. M. Degl’Innocenti, La collezione di grafica, in Mina Zeni, Museo Vela. Le collezioni, cit., p. 194. 55 Gli altri disegni relativi al progetto sono tavole tecniche, all’ASTi sono conservate 6 piante; all’Archivio del Museo Vela a Ligornetto, il fronte, la sezione, il dettaglio del coronamento e 3 piante. 49 50 97 Finito di stampare nel marzo 2010 USI-Accademia di architettura Laboratorio di Storia delle Alpi – LabiSAlp Largo Bernasconi 2 CH-6850 Mendrisio www.arc.usi.ch/labisalp
Scarica