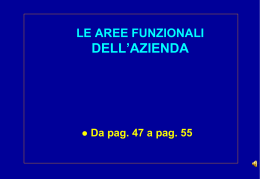RASSEGNA STAMPA venerdì 4 aprile 2014 ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA INTERESSE ASSOCIAZIONE ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO L’UNITÀ AVVENIRE IL FATTO REDATTORE SOCIALE PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA Da il Salvagente del 04/04/14, pag. 49 La laicità in scena a Reggio Emilia La laicità come metodo, cornice e piattaforma stabile attraverso cui promuovere il cambiamento reale della società. Ruota intorno a questo principio la V edizione delle "Giornate della laicità" a Reggio Emilia dall'11 ai 13 aprile. Organizzate all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da Iniziativa Laica con l'Arci di Reggio Emilia, Politela e la Fondazione Critica Liberale, le Giornate sono un momento di confronto e discussione su temi di attuatità, dal rapporto tra scienza, medicina e bioetica alla 194 e all'autodeterminazione delle donne che rischia di essere cancellata, dal Concordato e le lobby religiose al rapporto web/nuovi fondamentalismi. II filo conduttore, riassunto nel titolo "Cambiamenti: spirito critico e cittadinanza attiva", sarà declinato in 14 incontri da un folto gruppo di in intellettuali, tra cui Carlo Flamigni ,Enzo Marzo, Gianenrico Rusconi, Loredana Lipperini, Eugenio Lecaldano, Chiara Saraceno. Uno spazio è riservato a film, danza, teatro. Da Vita del 04/14, pag. VERSO IL 2015 In vista dell'Expo, il Terzo settore mette idee in cascina Nel grande cantiere dell'Expo 2015 c'è un solo edificio già in piedi. È la Cascina Triulza, una vecchia fattoria abbandonata che gli organizzatori stanno restaurando per farne il primo padiglione nella storia delle Esposizioni universali dedicato alle organizzazioni della società civile. Con un tema come quello dell'alimentazione sostenibile, l'Expo di Milano non poteva non coinvolgere il Terzo settore, e a gestire questo spazio sarà una fondazione (omonima della cascina) che già dalla lista dei soci, dalle Acli all'Arci, dalla Compagnia delle Opere a Legambiente, passando per Oxfam e Action Aid, da l'idea di voler superare con molto pragmatismo steccati ideologici e politici (58 le organizzazioni coinvolte). «Tutte le energie le mettiamo nella costruzione del programma», spiega il presidente della Fondazione, Sergio Silvotti, «non faremo scintille con artifici architettonici, vogliamo che i visitatori abbiano una chiave di lettura di come loro stessi possono comportarsi e agire un cambiamento». Ecco anche perché sono già cominciate (la prima a Milano il 18 marzo scorso) le Cali Internazionali di Idee (dal nome "Exploding your Idea! Destination Expo Milano 2015") rivolte a tutte le realtà della società civile, nazionali e internazionali, interessate a contribuire al programma culturale del Padiglione della Società Civile. Le istituzioni pubbliche e i soggetti con finalità dì lucro, che non presentano caratteristiche mutualistiche e/o solidaristiche, potranno partecipare in partenariato con una o più organizzazioni del Terzo settore. «Partecipare,-per la prima volta nella storia e con uno dei padiglioni più grandi presenti è un onore ma anche un onere. Ecco perché ci prepariamo per tempo e con impegno: vogliamo che i contenuti proposti siano all'avanguardia» sottolinea il presidente. Uno degli aspetti più innovativi infatti del modello gestionale del Padiglione è questo coinvolgimento diretto delle organizzazioni italiane e internazionali della società civile e del Terzo settore nella costruzione del Programma Culturale: esse possono proporre eventi, 2 attività culturali, espositive, convegni e momenti d'intrattenimento partecipando a specifici concorsi di idee. Lorenzo Maria Alvaro Da il Salvagente del 04/04/14, pag. 48 LAMPEDUSA CITTÀ D'EUROPA Emmaus torna a Lampedusa avendo raccolto l'appello lanciato nel 2012, a pochi mesi dal suo insediamento, dal sindaco Giusi Nicolini: "Non lasciateci soli". Il 4 e 5 aprile, nella Sala conferenze dell'aeroporto di Lampedusa,con L'Italia sono anch'io, Emmaus organizza il convegno internazionale "Lampedusa Città dell'Europa" con la partecipazione di alcuni candidati al Parlamento europeo. A questi sarà chiesto di assumere un impegno reale rispetto a temi quali immigrazione, accoglienza e cittadinanza, perché siano considerati priorità nell'agenda politica dell'Unione. Da Vita del 04/14, pag. 68 Lo Ius Soli secondo Yalla Italia di Martino Pillitteri Nuova legge sulla cittadinanza. Il gruppo di ragazzi di seconda generazione aggregati attorno al blog, hanno messo su carta la loro proposta. Molto più elastica di quanto si possa credere. E in grado di raccogliere subito il consenso di tutte le parti politiche. Seconde generazioni, 2G, nuovi italiani, generazioni 1.5, figli di migrati, nuove cittadinanze, generazione ponte. Tanti sono i tag che cercano di dare un senso al profilo culturale/identitario delle seconde generazioni (chiamarli solamente italiani no?) e tante sono le proposte di riforma della legge sulla cittadinanza che sostituisca la n. 91 del 1992 (che si basa sul principio dello ius sanguinis) assolutamente sorpassata. Sono ben 18 le proposte di riforma presentate dai partiti e della società civile. Le più importanti (e non ereditate dalla legislatura passata) sono sei: quelle firmate, rispettivamente da Pierluigi Bersani e Kalhid Chaouki (Pd); da Mario Caruso (Scelta Civica); da Carlo Giovanardi (Ned); da Mario Marazziti e Milena Santerini (Scelta Civica); da Nichi Vendola e Gennaro Migliore (Sei); e infine quella dì Iniziativa Popolare (espressione della campagna L'Italia sono Anch'io). La proposta politica più semplice e sintetica (un solo comma) è la Giovanardi: «Chi nasce nel territorio nella Repubblica italiana da genitori cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, dei quali, almeno uno sia residente legalmente da un anno in Italia, se dopo la nascita risiede legalmente in Italia, può ottenere la cittadinanza italiana a partire dalla data di iscrizione al primo anno della scuola dell'obbligo». I criteri ispiratori delle altre proposte si somigliano molto e si basano principalmente sulla residenza continuativa dei genitori in Italia e la frequenza scolastica dei ragazzi. La road map per giungere all'approvazione della riforma, nonostante un accordo complessivo è ancora incerta. La proposta che arriverà in Parlamento è un testo base che proverà a fare la sintesi tra le istanze dei partiti attualmente al governo. Nonostante le buone intenzioni, l'onorevole italo-marocchino Khalid Chaouki ci conferma che «la discussione in Commissione attività istituzionali della Camera è una priorità per ora solo a parole». D'altra parte Matteo Renzi ha sempre fatto capire che questo è un punto dei punti qualificanti dell'azione di governo. «Noi immaginiamo» ha detto il premier nel suo discorso per la fiducia davanti al Senato «con il vostro aiuto di trovare dei punti di sintesi reali che 3 permettano a quella bambina che ha 12 anni e che frequenta la quinta elementare e che è nata nella stessa città in cui è nata la sua compagna di banco, di avere la possibilità, dopo un ciclo scolastico, di essere considerata italiana esattamente come la sua compagna di banco». La redazione di Yallaltalia.it, il blog delle seconde generazioni ha formulato la proposta che trovate nelle prossime pagine. Il gruppo è composto da 35 ragazze e ragazzi e dal 2007 ha portato le istanze delle seconde generazioni nell'agenda politica e mediatica. Paradossalmente la concessione secca alla nascita, secondo il modello americano, trova pochi consensi. La maggioranza dei ragazzi di Valla Italia invece sposa la proposta di una riforma della cittadinanza basata sulla frequenza scolastica, a condizione che GÌ siano la certezza della tempistica e pochi paletti burocratici. Ma secondo loro è importante che la legge preveda anche una via d'uscita per cui sia possibile, una volta diventati maggiorenni, rinunciare alla cittadinanza italiana per non perdere quella d'origine dei genitori laddove non sia consentito il doppio passaporto. Da Asca del 03/04/14 Crotone/Comune: inaugurato l'emporio sociale ''I Cinque pani'' (ASCA) - Crotone, 3 apr 2014 - Inaugurato ql'emporio solidale ''I Cinque Pani''. Una struttura istituita nel cuore del centro storico, ma soprattutto pensata e realizzata con il cuore. Un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e volontariato possa dare risultati importanti e dare concretezza alla parola solidarieta'. Grazie all'azione congiunta di Comune di Crotone, Provincia di Crotone, Croce Rossa Comitato di Crotone, Caritas Diocesana Crotone e Santa Severina, delle Cooperative Sociali Agora', Baobab, Kroton Community e Noemi, dell'associazione di promozione sociale Arci, del Coordinamento Provinciale di Libera dell'associazione Mensa di Padre Pio del ''Cireneo'' e della fondazione ''Gustavo Caloiro e su impulso della Prefettura di Crotone nasce questo polo di solidarieta' destinato a sostenere le esigenze primarie delle fasce piu' deboli della comunita' cittadina. Un impegno comune nato a seguito di un protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2013 fortemente dal prefetto Maria Tirone, che ha visto l'immediata adesione del sindaco di Crotone Peppino Vallone e del presidente della Provincia Stano Zurlo e la partecipazione convinta di tutte le associazioni. red/mau http://www.asca.it/newsregioniCrotone_Comune__inaugurato_l_emporio_sociale___I_Cinque_pani__-1377635Calabria.html 4 ESTERI del 04/04/14, pag. 7 «La sinistra cambi o sarà travolta» UMBERTO DE GIOVANNANGELI «La cosa peggiore da fare sarebbe minimizzare la portata di ciò che è avvenuto col voto delle amministrative- Le cose vanno chiamate con il loro nome. E il nome più appropriato per dar conto di ciò che è avvenuto a sinistra è la raclée (batosta, ndr). Questa è la dimensione dello tsunami che si è abbattuto sul Partito socialista. Quel risultato non ha nulla di congiunturale, circoscrivibile a un atto di ribellione episodico. Perché alla base del raclée è l’assenza di pensiero politico da parte del Ps. Ed ora vedo che invece di affrontare di petto, e con coraggio, il tema di come riempire questo vuoto, si preferisce assecondare gli umori dell’opinione pubblica, mettendo in campo l’uomo che si pensa possa intercettarli massivamente: Manuel Valls». La raclée socialista in Francia analizzata da uno dei più grandi sociologi europei: Alain Touraine, direttore di ricerca all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. «Alla base di questa disfatta - rimarca Touraine - c’è la sottovalutazione della devastazione sociale prodotta dalla crisi e dalle ricette neoliberiste. C’è l’incapacità di prospettare e praticare una idea nuova di crescita da parte socialista. La sinistra può tornare ad essere attraente, e vincente, se saprà realizzare il tema di una nuova modernità, un nuovo progetto di sviluppo all’altezza del mercato globale e dei problemi dell’ambiente. La sinistra perde se resta legata agli anni Ottanta e Novanta». Professor Touraine come leggere la disfatta socialista alle elezioni municipali? «Di certo non come un fatto episodico. Non è stato un incidente di percorso. E nemmeno, o non solo, il frutto di un giudizio negativo, profondamente negativo, sui due anni di “non” presidenza Hollande. C’è qualcosa di più su cui varrebbe la pena di riflettere con una buona dose di coraggio e di capacità autocritica a da parte della sinistra, politica e intellettuale...». A cosa si riferisce? «Al vuoto di pensiero politico, di visione del Ps. Un vuoto che ci si è illusi di riempire abusando di categorie concettuali vetuste, quelle usate per 100 anni e che oggi non aiutano più a capire dove va il mondo. La sinistra esiste se è capace di rinnovarsi, altrimenti è destinate a recitare stancamente un copione che non attira più nessuno, soprattutto le nuove generazioni. Molto si è discusso del successo del Front National, ma il dato più inquietante per il Ps è stato quello dell’astensionismo che lo ha colpito pesantemente, un astensionismo fortissimo nei ceti popolari e tra i giovani privati di futuro. Ed ora l’onda lunga di questo distacco può estendersi al voto delle europee, tanto più che le europee sono le uniche elezioni in Francia fondate sul proporzionale e questo può favorire la frammentazione del voto». In un nostro precedente colloquio dedicato alla vittoria di Francois Hollande nelle presidenziali, lei aveva sostenuto che la grande sfida di Hollande presidente era quella di costruire una Europa «sociale », oltre il monetarismo. È ancora di questo avviso? «Sulla portata della sfida sì, resto di quell’idea, ma purtroppo devo constatare, e in questo la débacle elettorale nelle amministrative ne é una tangibile conferma, che nei suoi primi due anni all’Eliseo Hollande non è stato all’altezza delle aspettative che lui stesso aveva evocato. Soprattutto su un fronte, che reputo decisivo: quello di una nuova politica 5 economica capace di praticare l’obiettivo della crescita. Una crescita non solo quantitativa ma qualitativa. Su questo terreno faccio difficoltà a vedere segnali incoraggianti. Semplicemente, non ve ne sono stati». Il messaggio che lei ha lanciato e sostanziato nei suoi lavori più recenti, è: sinistra, riparti dalle idee. E da una visione nuova, moderna,della società. Qual è il punto di lettura innovativo che lei suggerisce? «Il discorso è più vasto e riguarda l’idea stessa di democrazia. Occorre costituire delle società che riconoscano come fondamentali i diritti, diritti che sono al di sopra delle leggi, innovando, modernizzandola, l’idea stessa di Democrazia. La lotta per l’affermazione sociale di questi diritti deve fronteggiare il predominio del capitale finanziario, che è fondato su logiche speculative contrarie a ogni diritto, ribadendo che è la democrazia, che trasforma gli individui in cittadini responsabili, la condizione prima del rilancio economico e sociale. E questa battaglia di civiltà si gioca sempre più a livello europeo». In una recente intervista a l’Unità, il candidato del Pse Martin Schulz alla presidenza della Commissione europea, ha affermato che la priorità assoluta della sinistra deve essere «lavoro, lavoro, ancora lavoro». «Questa priorità va praticata e non solo evocata, e innervata in una visione innovativa della crescita, consapevoli che l’aumento delle disuguaglianze sociali rappresenta attualmente la più seria minaccia alla stabilità e alla coesione dell’Unione europea e dei suoi membri ». Quanto ha pesato l’incapacità della sinistra di innovare le sue categorie politiche interpretative rispetto allo spiazzamento registrato con l’affermazione del Front National di Marine Le Pen? «Ha pesato moltissimo. Lungi da me sottovalutare la pericolosità dell’affermazione e del radicamento del Front National, se ha saputo cavalcare un diffuso malessere e una crescente rabbia sociale. Quello che sostengo è che questa affermazione non può essere spiegata, e combattuta, utilizzando la vecchia categoria della destra radicale, perché se così fosse non si capirebbe perché l’Fn abbia conquistato consensi nel sud della Francia, che non ha tradizioni di destra radicale, o tra settori sociali, pensionati, operai, che in passato hanno rappresentato un forte serbatoio elettorale per la gauche». del 04/04/14, pag. 10 Ungheria torna alle urne: Orban vuole la riconferma ROBERTO ARDUINI Nonostante le resistenze in patria e all’estero, il governo conservatore di Viktor Orban, dato per vincente alle elezioni legislative di domenica, ha profondamente cambiato l’Ungheria dal 2010 a oggi e secondo i analisti ha indebolito i valori democratici, grazie a una maggioranza parlamentare di due terzi e quattro anni di governo. Più che la vittoria del partito di Orban, Fidesz, gli interrogativi saranno le dimensioni della vittoria e la performance del partito di estrema destra Jobbik. Secondo gli ultimi sondaggi diffusi ieri, Fidesz è data al 36 per cento, il doppio della coalizione di sinistra, guidata dal Partito socialista ungherese (Mszp), che è attestata sul 18 per cento. Subito dopo, tuttavia, c’è Jobbik che dato al 15 per cento. Quello che uscirà dal voto di domenica, rischia di essere così un Parlamento fortemente sbilanciato a destra. E lo sarà ancor di più se l’altra formazione di sinistra, Lmp («La politica può essere differente») dovesse riuscire a 6 superare lo sbarramento del 5%, quorum necessario per entrare in Parlamento. Orban sembra certo della vittoria. Sabato, alla manifestazione per la chiusura della campagna elettorale a Budapest, ha detto di attendersi una «grande vittoria» che gli dia il mandato per affrontare una serie di ulteriori sfide per l’Ungheria, a partire da quella della creazione di posti di lavoro. Fidesz punta a ottenere di nuovo una maggioranza qualificata, superiore ai due terzi del Parlamento, che le permetterebbe di approvare leggi costituzionali senza dover preoccuparsi dell’opposizione. Una possibilità che Orban ha ampiamente sfruttato nella legislatura appena conclusa, nella quale ha approvato una nuova Costituzione, ridisegnato l’architettura dello Stato, indebolito a suo vantaggio le istituzioni di controllo terze e modificato le norme sulla libertà di stampa. Grazie alle riforme Orban, il numero dei parlamentari da eleggere è di 199 rispetto ai 386 delle precedenti elezioni. La ricetta di Orban per la vittoria è stata preparata in questi anni. Il primo ministro è stato in grado di costruire attorno a sé un’immagine di strenuo difensore della sovranità nazionale nei confronti dell’Europa e delle banche. Il primo ministro ha rivendicato una serie di riforme - dalla nazionalizzazione del pilastro privato del sistema pensionistico, alle tasse speciali imposte alle banche - che a suo dire hanno permesso a Budapest di evitare uno scenario greco, che negli anni 2008-2009 è stato più volte vicino ad avverarsi. L’Ungheria è riuscita a ripagare il prestito da 20 miliardi di euro ottenuto nel 2008 dal Fondo monetario internazionale (Fmi), dall’Unione europea e dalla Banca mondiale, senza dare l’impressione di concedere troppo alle istituzioni internazionali. E, per le elezioni imminenti, ha promesso anche di restituire qualcosa ai cittadini, tagliando i prezzi del gas e intervenendo sull’annosa questione dei mutui in valuta estera, che hanno rappresentato, in questi anni di valore basso per il fiorino ungherese, un grave peso sulle spalle delle famiglie. Argomenti ai quali la sinistra guidata dal socialista Attila Mesterhazy ha potuto opporre poco. Solo la promessa sull’innalzamento del salario minimo. La sinistra sconta il fatto di essere rappresentata da una classe dirigente ormai poco accreditata. Da qui la visibilità data ai partiti di estrema destra, populisti e ultranazionalisti. Una loro affermazione domenica suonerebbe come un ulteriore campanello d’allarme in vista delle elezioni europee. Del 04/04/2014, pag. 12 L'ULTIMA Al via la campagna elettorale, tra violenze e divisioni interne Chiara Cruciati A meno di un mese dalle elezioni parlamentari (in programma il 30 aprile), l’Iraq è stretto nella morsa di una violenta divisione interna. A Sud di Baghdad un gruppo di miliziani ha attaccato il quartier generale di un battaglione dell’esercito iracheno: almeno 12 i soldati uccisi, 40 le vittime tra i miliziani dopo lo scontro a fuoco con le forze irachene. Non è ancora chiara l’appartenenza del commando, ma probabilmente si tratta di un gruppo della galassia sempre più numerosa di sunniti islamisti. Sul piano politico, il premier Nouri al-Maliki, al potere dal 2006, sarà probabilmente rieletto con maggioranza relativa e quindi costretto a formare un nuovo governo di coalizione come il precedente, premendo sull’acceleratore della minaccia alla sicurezza. Pochi gli ostacoli politici, vista la debolezza del diviso spettro delle opposizioni, da Iraqiyya (in passato l’avversario più temibile) agli altri piccoli partiti sunniti. 7 Due giorni fa la campagna elettorale è stata ufficialmente aperta, dopo il ritiro delle dimissioni della Commissione elettorale che aveva denunciato interferenze politiche e giudiziarie e l’estromissione di alcuni candidati, tra cui l’ex ministro delle Finanze al-Issawi e membri del partito Baath. A monte una legge che impedisce la candidatura di persone «di non buona reputazione». E se la strada verso la riconferma appare lastricata di speranze per il premier sciita, i pericoli maggiori potrebbero giungere dalla fazioni sciite, nonostante l’improvviso ritiro dalla scena politica del potente avversario Muqdata Al Sadr, da sempre oppositore dell’esecutivo messo in piedi da Washington negli anni dell’occupazione militare. L’uscita di scena ha generato non poca confusione tra i 40 parlamentari del blocco sadrista Ahrar, ma non significa il totale abbandono dell’arena politica. Probabile obiettivo è mostrare la propria compagine politica come unico bastione contro la corruzione che dilania il Paese e di cui Maliki è il volto. Ahrar ha infatti annunciato la partecipazione alle elezioni, mentre Al Sadr invitava gli iracheni a presentarsi alle urne. Non sono pochi quelli che leggono nell’annuncio a sorpresa di Al Sadr un’ottima campagna di marketing: fingere un ritiro per mostrarsi come l’unico politico pulito nel mare del clientelismo iracheno. La stabilità interna resterà un miraggio e il timore è un crollo della partecipazione al voto nelle aree dove le violenze settarie colpiscono con più forza. Anbar è una di queste: la regione occidentale irachena, roccaforte sunnita e focolaio critico fin dai tempi di Saddam Hussein, è da mesi teatro di un durissimo scontro tra forze governative e milizie islamiste. Sul campo le città di Fallujah e Ramadi hanno visto l’avanzata dell’Isil, Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, formazione qaedista che ha assunto il controllo di parte della regione. Il governo Maliki ha risposto con l’esercito, sostenuto dalle milizie delle tribù sunnite locali, più intimorite dall’avanzamento di Al Qaeda che dalle politiche governative. Oltre 300mila civili sono fuggiti da Anbar, Fallujah e Ramadi sono oggi città fantasma. I primi attriti cominciano però ad apparire nella temporanea alleanza tra tribù e governo: due settimane fa il Consiglio delle Tribù di Anbar ha chiesto il ritiro delle truppe governative, come passo verso la soluzione diplomatica del conflitto nella regione. Alla voce dei capi tribali si è unita quella del Consiglio dei Governatorati della regione, che accusa il governo di bombardamenti e di una crisi umanitaria con pochi precedenti. A impedire l’avvio di un percorso di stabilizzazione interna sonole aspre divisioni tra comunità sciita e sunnita. Delle 18 province irachene sono 12 quelle in aperto conflitto con Baghdad. A muovere le opposizioni sunnite e i movimenti di protesta antigovernativi è la politica di centralizzazione del potere avviata da Maliki. La risposta dei gruppi armati si è concretizzata negli attacchi terroristici che insanguinano tutto il Paese: il 2013 è stato l’anno più cruento dall’occupazione statunitense, con un bilancio di 9mila iracheni uccisi. E il 2014 non pare da meno: i primi tre mesi dell’anno si chiudono con almeno 2mila vittime. Alla divisione tra sunniti e sciiti si aggiungono i desideri separatisti del Kurdistan iracheno che da anni combatte per la creazione di un governo regionale autonomo da Baghdad. La più recente reazione dell’esecutivo è stata la sospensione dei finanziamenti federali, come forma punitiva per la firma di contratti di vendita di petrolio all’estero da parte delle autorità curde. del 04/04/14, pag. 10 Afghani al voto sotto la minaccia dei talebani Tredici milioni di cittadini alle urne per scegliere il presidente ● Tre i candidati in lizza per la successione a Karzai ● Timori per i possibili attentati ai seggi elettorali 8 Gabriel Bertinetto Otto candidati. Solo tre con speranze di successo. Nessuno in grado di passare al primo turno. Da Kabul a Herat, da Kandahar a Mazar-el Sharif, tredici milioni di cittadini sono chiamati alle urne domani per scegliere il successore di Hamid Karzai, leader dell’Afghanistan post-talebano sin dal 2001, eletto alla presidenza nel 2004 e riconfermato nella contestatissima contesa del 2009, passata alla storia per un’overdose di brogli. Si andrà quasi certamente al ballottaggio, in maggio. Il vincitore avrà davanti a sé un compito immane, quello di gestire la transizione a una fase completamente nuova nella vita politica del Paese, che presto non potrà più contare sulla protezione militare internazionale. Gran parte dei contingenti hanno già levato le tende. Quello americano, il più consistente, conta ancora su 33mila truppe, ma a fine anno non ne resteranno che poche migliaia, con il solo compito di assistere e addestrare le forze di sicurezza locali e senza più partecipare direttamente alle operazioni. Il futuro dell’Afghanistan è un rebus la cui soluzione dipende soprattutto dal modo in cui il nuovo governo affronterà la rivolta mai debellata delle milizie fedeli al mullah Omar, capo del regime teocratico rovesciato alla fine del 2001. Abdul Ghani Ahmadzai, che i sondaggi danno in testa con il 20-25%, ha una ricetta politica che spera appetibile sia ai votanti sia ai ribelli in armi. Bisogna, spiega Ghani, continuare nonostante tutto a percorrere la strada del negoziato e indurre i talebani ad accettare il nuovo ordine istituzionale. Sa che serviranno tempi lunghi, perché lo strumento principale per piegarli, è scavare un solco fra loro e quella parte dei connazionali che sembra rassegnata a subirne di nuovo il dominio. Come? Mostrando con i fatti che lo Stato democratico funziona, non è corrotto e produce benessere generalizzato. Impresa non facile. Significa fare esattamente il contrario di quello che è accaduto sinora. Se le autorità riusciranno ad agire in quel modo, cioè con onestà ed efficienza, «credo che i talebani o aderiranno al processo politico o finiranno isolati. Ma non è il governo che può isolarli. La spinta decisiva arriverà dalla gente». Sempre che il prossimo governo riesca appunto a conquistarne la fiducia. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale, gli attacchi delle milizie integraliste si sono moltiplicati. Negli ultimi giorni kamikaze e guerriglieri hanno privilegiato obiettivi fortemente difesi nella capitale con l’evidente volontà di dimostrare ai concittadini la loro forza. Fra i bersagli colpiti, il ministero degli Interni e la sede della Commissione elettorale centrale. I talebani preannunciano altre violenze il giorno stesso del voto.. Ghani è un ex-funzionario della Banca Mondiale ed è stato ministro delle Finanze nei primi anni dell’era Karzai, prima di entrare i contrasto con lui. Oggi però si dice pronto a offrirgli un ruolo speciale di consulente, e ne loda l’operato «svolto in condizioni estremamente complicate», sottolineando come sia «il primo uomo nella nostra storia millenaria a cedere volontariamente il potere obbedendo alle leggi». Elogi volti evidentemente anche ad attrarre parte dei consensi che Karzai ha cercato di convogliare verso un altro candidato, Abdullah Zalmai Rassoul, ex-ministro degli Esteri. Quest’ultimo si è scelto come vice uno dei fratelli di Karzai, e avrebbe un bacino potenziale di sostenitori vicino al 15%. Meglio di lui, ma peggio di Ghani, potrebbe fare Abdullah Abdullah, che fu a sua volta per un certo periodo alla guida della diplomazia afghana. Quest’ultimo è destinato a fare anche stavolta il pieno dei voti fra i cittadini della minoranza tajika. Ma in un Paese in cui le affiliazioni tribali, etniche e culturali, influenzano le scelte personali più dei programmi e delle idee, il legame con la comunità tajika rappresenta per Abdullah Abdullah sia un punto di forza che il limite pressoché invalicabile alla conquista di un appoggio su scala nazionale. Un fenomeno che amareggia gli stranieri e gli afghani più sensibili al tema dei diritti umani, è il ritorno in forze sulla scena politica dei cosiddetti «signori della guerra». Sono i capi di milizie che per decenni sono stati protagonisti di una guerra civile permanente, durante la quale hanno spesso compiuto crimini efferati. Alleti o avversari a seconda del momento, degli occupanti sovietici prima, dello Stato dei mullah 9 poi, e infine delle forze americane. Protagonisti assoluti del caos a Kabul nella prima metà degli anni novanta, fra la caduta del regime comunista e l’avvento dei talebani. Alcuni puntano alla presidenza, come Gul Agha Sherzai, alias il «bulldozer» di Kandahar, o Abdul Rasul Sayyaf, l’uomo che per primo invitò Bin Laden in Afghanistan negli anni ottanta. Altri figurano come numeri due, capaci di catalizzare ampi consensi fra i loro ancora numerosi seguaci. È il caso dell’uzbeko Rashid Dostum, che affianca Ghani, e di Ismail Khan, boss di Herat. Del 04/04/2014, pag. 7 Juliano, tre anni senza verità Cisgiordania. Tre anni fa l'attore e regista ebreo-palestinese Juliano Mer Khamis veniva assassinato nel campo profughi di Jenin. Un omicidio che resta avvolto nel mistero come quello di Vittorio Arrigoni Michele Giorgio Era un pomeriggio caldo quel 4 aprile del 2011 quando Juliano Mer– Khamis uscì dal Freedom Theatre, nel campo profughi di Jenin, a bordo della sua vecchia Citroen rossa. Il figlioletto Jay e la babysitter erano seduti accanto a lui. Procedeva lentamente perchè il campo era affollato, come sempre. Dopo pochi metri un uomo con il passamontagna sbucò da un vicolo e gli disse di fermarsi. Aveva una pistola. La babysitter spaventata lo pregò di continuare, di non correre rischi. Ma lui si fermò, per chiedere spiegazioni. Juliano non fece in tempo ad aprire bocca che quell’uomo gli sparò contro cinque volte, poi tornò nel vicolo da dove era venuto lasciando il passamontagna in strada. Jay e la babysitter si salvarono, per Juliano la morte fu istantanea. Terminò così la vita dell’attore figlio di una madre ebrea, Arna, e di un padre palestinese, Saliba, che aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita a fare teatro tra i giovani profughi. Proseguendo il lavoro cominciato tanto tempo prima dalla madre, sempre nel campo di Jenin. Una storia di una donna e di bambini palestinesi desiderosi di diventare attori ma destinati, da adolescenti, a morire combattendo contro l’occupante o ad essere uccisi senza pietà, che Juliano seppe raccontare con un film bellissimo visto in tutto il mondo: “I bambini di Arna”. La morte di Juliano Mer Khamis, a tre anni di distanza, resta un mistero. Troppi interrogativi non hanno ancora avuto una risposta. Proprio come l’assassinio di Vittorio Arrigoni, ucciso pochi giorni dopo a Gaza da un sedicente “gruppo salafita”. Due omicidi distanti geograficamente eppure vicini per le trame che li avvolgono. Amici, conoscenti e sostenitori, continuano a chiedersi chi e perchè ha voluto la morte di Juliano. Di ipotesi se ne sono fatte molte. Accanto a coloro che puntano l’indice contro Israele, altrettanti lanciano accuse ai servizi dell’Autorità nazionale palestinese che avevano guardato sempre con ostilità al Freedom Theatre, oasi di libertà di espressione e di critica della situazione politica. Altri ancora sottolineano che quella libertà di espressione turbava non poco anche le formazioni islamiste più radicali che avevano messo radici nel campo e che a Juliano guardavano come a un nemico e non come a un amico dei palestinesi. L’attore, aggiunge qualcuno, si era fatto diversi nemici a Jenin. Il mistero resta fitto, con una sola terribile certezza. Tra i palestinesi del campo profughi di Jenin alcuni conoscono la verità, sanno chi ha sparato e per conto di chi. Queste persone non devono più tacere. 10 Del 04/04/2014, pag. 7 Israele-Palestina, quella farsa chiamata processo di pace Israele/ Palestina. Un futuro diverso, non è detto sia un fut uro migliore Zvi Schuldiner La farsa chiamata processo di pace è stata organizzata grazie all’orchestrazione americana e all’appoggio europeo. Tutti sembrano propensi a credere davvero nel processo, sebbene in molti sappiano che non può funzionare. Nella realtà si vuole nascondere la reale indole del processo: l’eliminazione della pace come alternativa reale e necessaria, almeno per due popoli, quello palestinese che soffre un’occupazione brutale, continuativa e quello israeliano che non sarà libero, mentre si procede a soggiogare il popolo palestinese Una vera pace non può essere stabilita in base alle diverse condizioni fissate da Israele. Ma è più conveniente ricordare che non partecipano alle discussioni due corpi simmetrici, ma piuttosto il contrario. Da un lato Israele, una vera e propria mini potenza in Medio Oriente, dall’altra parte quella che si definisce Autorità Palestinese, un’invenzione che potrebbe aver avuto qualche senso nel 1993 (quando sono stati firmati gli accordi di Oslo) che si propone di dominare la vita dei palestinesi, ma sempre sotto il controllo totale di Israele, la potenza occupante nei territori occupati. Il mediatore, gli Stati uniti, è ben lungi dall’essere un intermediario neutrale. La principale guida politica è costituita dagli interessi americani, decisamente meglio serviti da Israele che da una debole Autorità palestinese che non rappresenta alcun potere reale. L’attore principale nel processo di pace dovrebbe essere Israele perché è l’occupante che opprime il popolo palestinese e senza la predisposizione di Israele verso una vera indipendenza non si può pensare alla pace. Il governo israeliano è un governo di estrema destra che continua a costruire a rotta di collo insediamenti nei territori occupati: ogni nuova casa è un ostacolo in più ad un accordo di pace. L’esercito israeliano ha continuato con violenza a opprimere il popolo palestinese e la burocrazia dell’occupazione è un meccanismo poco discusso, ma molto efficiente per trasformare in un inferno la vita quotidiana dei palestinesi. A Gaza il «governo» di Hamas gode della presunta «indipendenza» dal totale assedio israeliano ed egiziano e la Striscia di Gaza, in passato una prigione con la presenza di carcerieri israeliani è ormai una prigione controllata dall’esterno. Repressione, provocazioni — sia israeliane, sia di organizzazioni estremiste islamiche — minacciano possibili escalation sanguinose in ogni momento. Gli eventi turbolenti in Egitto contribuiscono solo ad un isolamento crescente della presunta «indipendenza» di Gaza. Netanyahu oscilla tra estremisti di destra nel suo partito e il Partito Nazionale Religioso (Habeit Haihudi) di estrema destra. Per questo può permettersi di chiedere ai palestinesi qualcosa di assurdo: devono riconoscere Israele, non come uno Stato, ma come Stato ebraico; la definizione religiosa confessionale non ha senso, perché perfino gli israeliani non sanno bene cosa significa identità ebraica: la religione (con le sue varie correnti) o la nazione o che altro? Forse l’Italia richiede dalla comunità internazionale il riconoscimento come Stato cattolico? Il fascismo cresce e si rafforza ogni giorno. I ministri israeliani attaccano gli Stati uniti per godere del sostegno degli estremisti nel partito e le considerazioni di politica interna sono più importanti per Netanyahu e i suoi ministri della possibilità di un futuro migliore. La farsa avviene anche nelle ultime ore: l’ipotesi di liberazione della spia americana Pollard, è un atto che darà grande popolarità, permetterà la liberazione di prigionieri palestinesi e la possibilità di continuare a costruire nei Territori in una forma un po’ più discreta 11 e proseguire i negoziati che non portano a nulla. L’obiettivo di Netanyahu è semplice: collaborare ai disegni dei repubblicani, vincere le elezioni di novembre e conquistare il Senato, rendendo Obama un presidente debole che non può imporre nulla di nuovo a Israele. In pratica Netanyahu vuole andare avanti con i negoziati, ma non ha alcun interesse ad una conclusione esauriente. Una grande masturbazione, niente di più. Il terzo attore è parte della tragedia: una leadership palestinese debole, con una società civile che ha perso gran parte del potere che aveva. La corruzione è parte del motivo del malcontento costante di una popolazione oppressa che teme, con buona ragione, il tradimento dei loro leader. La prima Intifada scoppiò nel 1987 senza la previa preparazione della leadership in Tunisia, senza Arafat. La seconda scoppiò nel 2000 e divenne molto più sanguinosa quando il popolo palestinese ha cominciato a protestare non solo contro l’occupazione, ma anche contro la disperazione e il malcontento verso una leadership palestinese corrotta. La divisione profonda e violenta tra il vecchio e stanco Olp e Hamas è parte di una triste realtà di oggi e concretizza il momento difficile dei palestinesi sempre più deboli. Se tutto questo significa un futuro senza speranza per israeliani e palestinesi, è probabile che entrambi i popoli, con il cordiale sostegno americano possano affacciarsi verso un nuovo e sanguinoso capitolo. L’assenza di un futuro diverso, non può portare ad un futuro migliore. Del 04/04/2014, pag. 17 Il reportage Fra le tribù del petrolio “Mezza Libia è nostra” La Cirenaica, crocevia del business dell’oro nero, è in rivolta contro Tripoli. Dalla caduta di Gheddafi la regione è in mano ai ribelli di Ibrahim Jadran che chiedono federalismo e la loro fetta di ricavi VINCENZO NIGRO UN PEZZO del futuro della nuova Libia potrebbe essere nascosto qui, in questo villaggio di sabbia e polvere. Il vento che arriva dal deserto è un soffio freddo e sporco. Solleva sabbia bianca, fine e fastidiosa. E spazza strade che non esistono. A parte pochi chilometri di asfalto, tutto il resto è polvere bianca del deserto compressa in dossi e avvallamenti che bloccano auto, camion e umani. Non c’è Stato, non c’è polizia, solo un popolo con la sua straordinaria voglia di vivere, di sopravvivere a tutto questo. Questa è Agedabia la capitale del petrolio di Libia, il crocevia di tutti i tubi che dai pozzi della Cirenaica portano il liquido milionario verso i terminal del Mediterraneo. Come ripete Abdallah, l’architetto che ci guida e ha studiato a Perugia e Firenze, «dove finisce la logica, inizia la Libia». E infatti questa città, che come tutta la Libia dovrebbe essere milionaria, Gheddafi l’ha mantenuta nella povertà e nella devastazione assoluta. “Gdabja”, la polverosa, era quello che promette il nome ed è quello che è rimasto. Finché Agedabia si è ribellata, prima a Gheddafi e poi a Tripoli. Una famiglia con 5 giovani fratelli, torturati nelle carceri del colonnello, ha prodotto la forza misteriosa di un movimento politico. Hanno iniziato come i capi del gruppo di miliziani che il governo, dopo la rivoluzione, aveva messo a controllare i pozzi di petrolio della regione (l’80 per cento del petrolio libico è in Cirenaica). Dall’agosto del 2013 si sono ribellati di nuovo e hanno chiuso il flusso di greggio che il governo centrale vendeva senza versare un dinaro alla Cirenaica. Il giovane capo della Cirenaica “federale” è un ragazzone di 32 anni, si chiama Ibrahim Jadran. «I gheddafiani mi hanno arrestato nel 2005, quando avevo 23 anni, poi hanno 12 fermato anche i miei fratelli». Quei sei anni in carcere a Tripoli, dentro Abu Salim, il tempio della tortura gheddafiana, furono una scuola di leadership incredibile per Ibrahim e i suoi fratelli. Una fonte di legittimazione inesauribile. Alla vigilia della rivoluzione del 2011, i gheddafiani provarono a svuotare le carceri sperando di allentare la tensione. Ma Jadran in libertà immediatamente organizza la resistenza, si arma con i kalashnikov della prima caserma gheddafiana assaltata, quella di Beida, la vecchia capitale della Cirenaica di re Idriss, cuore di una regione fiera, ribelle e speciale, la “Montagna Verde”. Per scendere nelle polveri di Agedabia e incontrare Jadran si passa proprio da Beida dove si arriva in aereo da Tripoli o Tunisi. Poi si attraversa per chilometri la “Montagna Verde”, un altopiano di 600 metri alle spalle della linea costiera che da Bengasi va fino verso Derna e Tobruk. Con le piogge della primavera la regione è un’esplosione di natura, di vita, di agricoltura: trebbiatrici, campi di grano, boschi di abeti e conifere. Tutta la Cirenaica è infestata da traffici e contrabbando di ogni genere, armi, droga e migranti in entrata dal Sud e dall’Egitto. Eppure la maggioranza della Montagna Verde è tranquilla, relativamente controllata e sicura perché le sue tribù sono unite e consapevoli dei pericoli che corrono soprattutto con i terroristi integralisti di Ansar Al Sharia che hanno conquistato Derna, sul mare, e che si infiltrano a Bengasi per mettere a segno i loro attentati. Il ruolo di Jadran e dei suoi fratelli è stato determinante. Prima in settembre a Ras Lanuf hanno battezzato un “Consiglio politico della Cirenaica”, che ha prodotto poi un simulacro di governo autonomo, con un primo ministro e i responsabili di tutti gli altri ministeri, salvo Esteri e Difesa, «perché vogliamo autonomia e vogliamo far rinascere la Cirenaica, ma non vogliamo separarci dalla Libia», dice il giovane federalista. Il 16 marzo, ad Agedabia, in un gran salone Jadran ha poi riunito gli sceicchi e i capi tribù di quasi tutta la regione. È stato un inno al federalismo, ovvero all’idea che loro, le tribù della Cirenaica, possano amministrarsi da sole. Jadran riuscì a far schierare lo sceicco Nue Fathalla, uno dei capi della tribù Awad Alì, che vive a cavallo del confine fra Libia ed Egitto ed ha milioni di membri: «Combatteremo per la Cirenaica». Poi il capo dei “tabu”, i “negri” originari del Sud del paese che ovunque in Libia sono discriminati (ad Agedabia vivono in un ghetto miserabile, in cui è inimmaginabile pensare quali siano le condizioni di vita visto quello che c’è fuori). Ahmed Dalenghi, il capo dei tabu, disse «noi parliamo poco, ma siamo pronti a combattere e lo facciamo bene!». Poi abbracciò in segno di pacificazione Salam Buhavuva, il capo degli Zwia, con cui per mesi i tabu si erano scontrati a morte. La pace fra le tribù, il consenso di molti capi non significa certo l’unità di tutta la Cirenaica, ma il sostegno della popolazione per Jadran e il suo auto-governo gli hanno dato forza per trattare con Tripoli. Dopo mesi di tentativi inutili, due settimane fa la Cirenaica ha provato a vendere una petroliera carica di greggio aggirando Tripoli. Il governo centrale non è riuscito a bloccarla, ci hanno pensato i Navy Seals americani al largo di Cipro, che poi hanno restituito la nave alla capitale. Ma la provocazione di Jadran ha avuto l’effetto di accelerare la caduta del debole primo ministro Ali Zeidan. Per mesi i federalisti avevano cercato di negoziare con lui, ma quello al massimo aveva provato a comprarseli con 6 milioni di dinari e la promessa di alcuni posti di ministri e ambasciatori. Jadran aveva rifiutato sdegnato, mostrando in televisione gli assegni milionari spediti da Zeidan. Dopo il colpo della petroliera, le cose per Zeidan sono precipitate, è stato costretto alle dimissioni ed è fuggito dalla Libia. Jadran invece è ripartito con le trattative con il nuovo premier Al Thinni: e questa volta la trattativa è andata avanti. Entro pochi giorni potrebbe riaprire il primo terminal petrolifero, poi gli altri. In cambio la Cirenaica dovrebbe ricevere la sede della Banca centrale libica, il comando della forza militare che controlla i pozzi, un terzo dei ricavi del petrolio, insomma i primi assaggi di un possibile federalismo. Jadran ha dietro buona parte della Cirenaica e un’idea, quella del federalismo, che prima o poi si potrebbe rivelare l’unica soluzione 13 possibile per mettere d’accordo le tribù, le città e le milizie che oggi sono il potere vero di una Libia che non ha più Stato centrale. Tra la sabbia bianca di Agedabia forse c’è una possibilità per aiutare la Libia a reggersi in piedi: partire dal basso, dalle tribù e dalle comunità locali, invece che provare a imporre un governo centrale che, scomparso Gheddafi, avrà poche speranze di governare i popoli di Libia. Del 04/04/2014, pag. 1-16 L’«ordinario» stress dei veterani Giuliana Sgrena Se hai fatto la guerra o l’hai subita non te ne liberi più, ti resta dentro. Quante volte ho sentito citare la «guerra dentro» parlando direttamente con i veterani dell’Iraq negli Stati uniti. Quel tormento che ti rode dentro, anche quando eri convinto di andare a combattere per il tuo paese ma spesso non lo eri nemmeno. Gli orrori della guerra sono difficili da immaginare senza averli vissuti. Il segno resta. Lo indicano le statistiche dei disagi e delle malattie provocate dai «disordini da stress post traumatico». Depressioni, perdita di lavoro, rottura di rapporti familiari, suicidi, omicidi. «Non aveva dato segni di voler usare la violenza contro se stesso o contro gli altri» Ivan Lopez, il soldato che ieri, 3 aprile, ha sparato e ucciso tre persone prima di suicidarsi nella base di Fort Hood in Texas. Così ha raccontato ai media e all’opinione pubblica statunitense il capo di stato maggiore dell’esercito John McHugh. Ma Ivan Lopez (ancora una volta un latino, che inevitabilmente mi ricorda Mario Lozano), 34 anni, autista di mezzi militari, aveva passato quattro mesi in Iraq nel 2011. Quattro mesi sono pochi ma possono essere interminabili quando si vive come occupante in un paese che senti ostile mentre devi essere pronto a uccidere – e troppo spesso accade – anche senza motivo, quasi sempre senza motivo. E da quando era tornato era sotto cura per depressione, ansia e altri problemi. Lo Stress post traumatico provocato dalla guerra in Iraq e da quella che continua ogni giorno in Afghanistan è superiore a quello della «lontana» guerra in Vietnam, le cui vittime non sono mai riuscite a superarne gli effetti. Almeno 2,3 milioni di veterani delle ultime guerre soffrono di stress e depressione, il 19 per cento dei quali con danni al cervello. Ma solo il 50 per cento dei malati viene curato e solo la metà in modo minimamente adeguato (secondo uno studio della Rand Corporation). Non ci si può dunque meravigliare di quanto succede a Fort Hood, la base militare americana più grande al mondo che può ospitare fino a 50.000 soldati. E infatti non è la prima volta che assistiamo a un massacro, tanto è vero che i militari, a parte gli ufficiali, in giro per la base non dovrebbero portare armi, ma Ivan Lopez aveva il suo fucile sotto la tuta mimetica. La restrizione sulle armi è stata applicata dopo la carneficina compiuta nel 2009 da Nidal Malik Hasan, uno psichiatra che aveva ucciso tredici persone, 12 soldati e un civile in attesa di essere visitati. Nel settembre dello scorso anno altre dodici persone sono state assassinate da un ex militare della marina all’interno del Washington Navy Yark. Non solo assassini ma anche suicidi, il cui numero — vale la pena sottolinearlo — supera quelli dei soldati caduti in guerra (circa 1 al giorno, secondo i dati registrati nei primi mesi del 2012). Un’impennata nei suicidi si è registrata nel 2005, quando si è intensificata la guerra in Iraq e in Afghanistan. È così vero che il Pentagono ha dovuto istituire un Ufficio per la prevenzione dai suicidi. Recentemente, durante una visita per verificare gli effetti dello stress post traumatico su di me, mi è stato chiesto, per l’appunto, se avevo tentazioni suicide. La domanda mi ha sorpresa, ma a pensarci bene ne ho capito le ragioni. 14 Del 04/04/2014, pag. 12 Sindrome Iraq Usa. Nella base di Fort Hood in Texas un veterano dell’Iraq uccide 4 persone e ne ferisce 16, prima di suicidarsi. Ogni settimana mille militari registrano disordini psichici da stress post traumatico Giulia D’Agnolo Vallan Non ci sono ancora indicazioni circa i motivi della sparatoria nella base militare di Fort Hood di mercoledì sera. Nel corso dell’agguato hanno perso la vita quattro persone e ne sono rimaste ferite altre sedici. Si sa però che Ivan Lopez, il soldato ritenuto responsabile dell’attacco improvviso, era in cura presso un psichiatra dell’esercito e forse affetto da sintomi di disordine post traumatico. Lopez, che aveva servito nove anni nella Guardia nazionale del Porto Rico prima di arruolarsi nell’esercito, non aveva partecipato a missioni di combattimento, ma nel 2011 era stato stazionato in Iraq come camionista. L’anno seguente era stato incaricato nella Penisola del Sinai. «Era un soldato che aveva molta esperienza», ha detto di lui il capo dello Stato maggiore americano generale Raymond Odierno. Anche dopo il referto della visita psichiatrica, non ci sarebbero state ragioni di pensare che fosse incline a commettere atti di violenza, ha riferito il segretario dell’esercito John McHugh all’Armed Service Committee del Senato: i medici avevano deciso di continuare a monitorarlo e gli avevano prescritto una terapia per combattere l’insonnia, l’ansia e la depressione. Non ci sono indizi «che colleghino Lopez a nessun tipo di gruppo estremista» ha affermato ancora McHugh. Si tratta di un dato che differenzia Lopez dall’autore di un’altra strage avvenuta nella stessa base militare texana, il 5 novembre del 2009, quando il maggiore Nidal Malik Hasan, uno psichiatra dell’esercito, aveva aperto il fuoco contro soldati disarmati e impiegati all’interno del Soldier Readiness Processing Center, l’ufficio ammissioni, ammazzando tredici persone e ferendone piu’ di trenta. Le autorità Usa avevano decretato che si trattava di un atto di terrorismo. Processato da un tribunale militare Hasan (un musulmano che aveva avuto rapporti con l’Imam yemenita militante Anwar al-Awlaki, ucciso da un drone nel settembre 2011) è stato condannato a morte da un tribunale militare ed è attualmente in una prigione del Kansas in attesa di essere giustiziato. L’eco di quella strage (e di un attacco sventato, sempre a Fort Hood, nel 2011, quando un soldato musulmano in attesa di essere distaccato in Afghanistan, è stato sorpreso in un hotel vicino alla base con delle armi semiautomatiche e i componenti per fabbricare una bomba) era decisamente presente quando la notizia della nuova sparatoria è apparsa nelle news serali. La base, riferivano i giornalisti, era ancora in «lock down». Lopez, che non viveva all’interno dell’installazione militare, sarebbe arrivato armato di una Smith & Wesson calibro 45 che aveva acquistato, per uso personale, nei dintorni. L’arma non era registrata, ma ai soldati che non risiedono nella base non è richiesto di farlo. Avrebbe cominciato a sparare prima in un edificio e poi da un autoveicolo. Una volta sceso, trovatosi di fronte a un ufficiale della polizia militare, Lopez si è sparato in testa. «Qualsiasi sparatoria è grave. Questo caso, ovviamente, in più riapre la piaga di quanto è successo a Fort Hood cinque anni fa. Conosciamo questa famiglie, il servizo incredibile che rendono al paese e i sacrifici che fanno. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con l’intera comunità», ha dichiarato Barack Obama mercoledì sera. «La situazione 15 è ancora fluida ma il mio team per la sicurezza nazionale è in stretto contatto con il ministero della difesa e anche l’Fbi. Stannno lavarando per capire esattamente cosa è successo e per garantire che tutti siano al sicuro». Il presidente americano è stato poi attaccato — da destra — dalle televisioni di Murdoch. La critica è che se nella base fosse stato permesso di possedere un’arma, Ivan Lopez, si dice, sarebbe stato fermato prima della strage. Dal dipartimento per i veterani di guerra i dati relativi ai postumi delle guerre e in Iraq e Afghanistan sono estremamente preoccupanti. Secondo quanto riportato ieri da Usa Today, ogni settimana circa mille veterani registrano diagnosi positive per disordine da stress post traumatico, ottocento per depressione. Gravissimi anche i dati sul suicidio tra veterani: secondo uno studio effettuato nel febbraio 2013 si tratterebbe di una media di ventidue al giorno. 16 INTERNI De 04/04/2014, pag. 1-6 VIA LIBERA DEFINITIVA AI TAGLI Province cancellate a metà ecco le poltrone che resistono PAOLO GRISERI LA PROVINCIA è morta, viva la Provincia. Dopo anni di discussione è stata approvata la legge che «riordina» le 107 Provincie italiane. Le «riordina» perché non le abolisce. Rimarranno in piedi e, anzi, aumenteranno i loro compiti, se si deve credere ad Antonio Saitta, Presidente dell’Unione degli enti dati prematuramente per morti, in teoria il politico italiano che ieri avrebbe dovuto indossare la grisaglia delle giornate tristi. Il suo tono, al contrario, non è affatto disperato: «Devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Siamo riusciti a mantenere gran parte delle competenze che avevamo prima e a queste ne abbiamo aggiunte di nuove». Ma come? L’«area vasta», la «città metropolitana », non sono novità dirompenti nel panorama istituzionale italiano? «Qualche novità c’è ma la sostanza resta quella di prima. I nomi che lei ha citato sono solo modi diversi di chiamare le Province». «Che restano uguali, da Bolzano alla Sicilia», dice sorridendo Andrea Barducci, Presidente a Firenze. La legge non abolisce le Provincie perché le loro funzioni sono indispensabili. «Se non ci fosse più la competenza sulle strade, qualcuno i cantonieri dovrebbe continuare a pagarli », osserva Federico Bozzanca, della segreteria nazionale della Cgil Funzione pubblica. I dipendenti degli enti provinciali italiani sono 60.000. Operano in diversi settori, dalle scuole alla manutenzione delle strade, dal servizio di trasporto pubblico alle attività di tutela dei parchi. Tutti mestieri che qualcuno dovrà continuare a fare e che non si possono abolire solo perché si è deciso di rottamare le Provincie: «Nell’autunno scorso abbiamo firmato un accordo preciso con il governo», spiega Bozzanca aggiungendo che i sindacati hanno ottenuto una garanzia assoluta: il riordino degli enti locali non causerà la perdita di un solo posto di lavoro. Tutti i 60.000 rimarranno al loro posto: «Alcuni potranno essere trasferiti ad altri enti - ammette il sindacalista - ma questo non potrà causare diminuzioni dello stipendio ». Così se una competenza fosse, ad esempio, trasferita ai Comuni e se lo stipendio del dipendente comunale fosse più basso, il dipendente provinciale trasferito continuerebbe a mantenere il suo attuale compenso. Ma di trasferimenti se ne vedono pochi all’orizzonte. Quando Saitta dice di aver portato a casa un congruo numero di competenze snocciola un lungo elenco. Le future Provincie si occuperanno di viabilità (l’80 per cento delle strade italiane), trasporto pubblico su gomma, tutela dell’ambiente, pianificazione territoriale, edilizia scolastica per le scuole medie e potranno anche diventare stazioni appaltanti per i lavori pubblici dei piccoli comuni. «Se volete conclude ironico Saitta - chiamatela pure abolizione delle Provincie». Quel che invece cambierà in modo radicale sarà il sistema di elezione. I consigli provinciali e delle città metropolitane non saranno più eletti dai cittadini ma dai consigli comunali e saranno composti da consiglieri che svolgono il compito aggiuntivo in modo gratuito. Si risparmieranno in questo modo 32 milioni che corrispondono allo stipendio dei 3.700 tra consiglieri, assessori e presidenti. Un risparmio non molto significativo: il costo complessivo delle provincie italiane è di 12 miliardi. Contemporaneamente la nuova legge aumenta da 6 a 10 i consiglieri comunali dei piccoli municipi aumentando la platea 17 complessiva degli eletti di 24 mila persone. Per questo ieri dall’Anci si gioiva per «la vittoria dei Comuni». E i vertici dell’Unione delle Provincie commentano amaramente: «Con Del Rio al governo il partito dell’Anci ha allargato il numero dei consiglieri comunali risparmiando su quelli provinciali». Guerre di campanile. Gli unici che perderanno il posto saranno dunque presidenti e assessori. «Mi toccherà cercarmi un lavoro e fare il Presidente part time», osserva il fiorentino Barducci. Dal 22 giugno, quando scadrà il suo mandato, verrà prorogato «a titolo gratuito» fino a fine anno. Come farà? «Beh, siccome non ho intascato tangenti e non ho conti in Svizzera, dovrò tornare al mio lavoro di pubblicitario. La mia vita cambierà. Andrò in Provincia al termine del lavoro, alle cinque del pomeriggio». Il suo concittadino Renzi le ha fatto un bello scherzo: «E dire che quando il Presidente della Provincia era lui e io ero il suo vice aveva un’idea diversa, non pensava certo di rottamarsi. Vuoi vedere che è l’abito che fa il monaco? ». Del 04/04/2014, pag. 3 Riforme, Renzi fa il rullo Senato. Offensiva contro i dissidenti Pd: «Le primarie le ho vinte io. Vado avanti come un rullo compressore». Ma allora non parlò di senato. Divisione dei compiti con la ministra Boschi, che corre un po’ meno: «Da noi nessun ultimatum» Andrea Fabozzi Si tratta di un meccanismo previsto in altri ordinamenti come la Francia e la Germania, non è una stranezza inventata da questo governo». In prima commissione al senato Maria Elena Boschi difende il disegno di legge costituzionale del governo. E si concentra sull’aspetto più criticato, la cooptazione al senato di sindaci e consiglieri regionali in luogo dell’elezione diretta dei senatori da parte di cittadini. Cita l’esempio di Germania e Francia. Ma la prima è uno stato federale: i Lander mandano a Berlino i rappresentanti dei governi locali. E la seconda, la Francia, ha appena introdotto il divieto di cumulo tra mandato parlamentare e funzioni esecutive locali — il contrario esatto di quello che propone il governo italiano. Non solo: i francesi affidano il compito di scegliere i senatori a 150mila grandi elettori. Il genio renziano, qui da noi, immagina di riservare il privilegio a ottomila sindaci e mille consiglieri regionali. La mancate elezione diretta è il punto d’attacco della proposta di legge alternativa illustrata ieri dal senatore del Pd Vannino Chiti (non molto diversa da quella alla quale lavorava da ministro delle riforme del secondo governo Prodi). È il fronte interno del Pd: oggi una ventina di senatori, ma si tireranno dietro altri scontenti della maggioranza. «Renzi non è il verbo e noi non siamo gli infedeli. Meglio confrontarsi, ragionare nel merito», dice il senatore democratico Mucchetti. E il suo collega Mineo: «È il parlamento che deve decidere, non Renzi. Per fortuna siamo ancora senza vincolo di mandato». Se Forza Italia si sfila, se Berlusconi esce dall’accordo per la riforma del bicameralismo mollando anche la legge elettorale (che proprio dal senato deve passare), Renzi non può permettersi di perdere un voto, figuriamoci venti. Per questo il presidente del Consiglio e la ministra Boschi si dividono i compiti. Lei si occupa dei problemi in casa Pd. E conferma la disponibilità a correggere il testo in commissione, dove dalla prossima settimana si giocherà la partita vera sul ddl costituzionale, sotto la regia della presidente Finocchiaro (ieri il suo ex portavoce stroncava la riforma in un articolo sull’Unità). Persino la fretta in base alla quale bisognerebbe appro18 vare il testo del governo entro le elezioni europee sfuma un po’ nelle parole della ministra: «Nessuno vuole dare ultimatum al parlamento». Renzi invece si occupa soprattutto di Forza Italia. Riceve a palazzo Chigi Denis Verdini e Gianni Letta, ambasciatori di un Silvio Berlusconi che ha raccolto poco o nulla al Quirinale. Ne esce ostentando ottimismo: «Rispetteranno l’accordo. Sono convinto che Forza Italia voterà sia la riforma del senato che la legge elettorale». Per questo non si nega affatto a un incontro con l’ex Cavaliere in procinto di essere ristretto ai servizi sociali: «Non avrei nessun problema ad incontrarlo, ma non è previsto». Per questo non si concede nessuna prudenza nei confronti della dissidenza interna: «Si viaggia come un rullo compressore», assicura dalla televisione (Otto e mezzo). E ripete la minaccia sulla fine della legislatura: «Se non ci riusciamo io vado a casa, ma anche gli altri». Ma che al senato la sua riforma rischia tanto non può non saperlo. Renzi attacca per difenderla. «La proposta di legge dei 22 del Pd? Non ha alcuna chance», chiude il discorso. Il punto però non è quanti voti prenderà Chiti, ma quanti toglierà al ddl governativo. Per questo il segretario Pd imbroglia le carte e parte con la propaganda: «Loro vogliono mantenere l’indennità». Vero, ma la proposta Chiti taglia i parlamentari più di quanto non faccia Renzi. Il risparmio sarebbe superiore. Poi l’ultimo spot: «Il Pd ha già fatto il dibattito, si chiamava primarie, dove i candidati hanno presentato delle proposte di legge». Le primarie le ha vinte lui. Ma la legge elettorale che aveva annunciato tante volte prima del giorno dei gazebo, alla fine non l’aveva presentata affatto. E sulle riforme costituzionali si può leggere la mozione Renzi che è ancora sul suo sito: non c’è una riga. De 04/04/2014, pag. 1-14 Il male del Veneto ILVO DIAMANTI L’INCHIESTA dei magistrati di Brescia contro gli indipendentisti veneti può avere effetti pericolosi. Almeno quanto le iniziative e i comportamenti perseguiti. Perché, al di là del merito delle indagini, rischia di ridurre a caricatura un fenomeno complesso e fondato, che supera i confini della regione. È IL “male del Veneto”. Una questione che va presa sul serio. Perché il Veneto ha costituito, negli ultimi trent’anni, il sismografo dei cambiamenti e delle crisi, in Italia. A partire dai primi anni Ottanta, quando, appunto, emerse la Liga. «Madre di tutte le leghe», la definì il fondatore, Franco Rocchetta. Uno dei cospiratori, secondo i magistrati. Ora costretto agli arresti domiciliari. (Anche se non mi riesce di immaginarlo nei panni del paraterrorista.) L’insorgenza della Liga, anticipò la diffusione e l’affermazione della Lega in tutto il Nord. Ma annunciò anche la crisi della Prima Repubblica. Perché erose e, in seguito, sgretolò le fondamenta del partito che aveva governato, da sempre. La Democrazia Cristiana. La geografia della Liga ricalca, infatti, quella della DC. E segna, dunque, il passaggio di questa società dal governo all’opposizione. Anzi: all’antagonismo. Contro Roma e contro lo Stato Centrale. Sinonimi, nel linguaggio veneto e, in seguito, nordista e padano. Al tempo stesso, il Veneto interpreta, in modo aperto, l’affermarsi dei nuovi ceti medi “privati”. I piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. La Lega, prima e più ancora di Berlusconi, dà loro voce. Ne amplifica il risentimento e la protesta. Come hanno mostrato, efficacemente, Giorgio Lago e Francesco Jori, descrivendo e, in parte, amplificando la “voglia di indipendenza” espressa da quest’area. Riassunta nella formula geopolitica del Nordest. Ma in realtà sempre, saldamente impiantata sul Veneto centrale. Sul triangolo Vicenza-Padova-Treviso. Indipendenza, non secessione. Una rivendicazione 19 che, qui, non ha mai attecchito. Neppure negli anni Novanta, quando la Lega Nord di Bossi ne aveva fatto una bandiera. Anche perché Il Nord e ancor più la Padania sono contesti poco o nulla condivisi, in Veneto. Territori immaginari: la Padania. O, comunque, relativi e “dipendenti”: il Nord. Il cui significato “dipende”, appunto, geograficamente e geopoliticamente, da Roma. Per questo è rischioso, oltre che superficiale, svalutare le tensioni indipendentiste espresse dal Veneto. Perché vengono da lontano e hanno ragioni condivise. Che, negli ultimi anni, sono esplose. Basti vedere quel che è avvenuto alle ultime elezioni, nel febbraio 2013, quando il M5S ha ottenuto, proprio in Veneto, un grande risultato. Soprattutto nelle aree dove era più forte la Lega e, prima, la Liga. Il M5S: ha sfondato soprattutto le basi sociali di quest’area e dei suoi rappresentanti politici — vecchi e nuovi. Ha, cioè, conquistato il voto dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori. Primo partito fra gli artigiani veneti con, circa, il 30% (sondaggio di Demetra per Confartigianato Imprese Veneto). Per questo, l’immagine pubblica proiettata dalle inchieste giudiziarie, oltre che dal profilo approssimativo e improbabile dei presunti cospiratori, banalizza le tensioni e le rivendicazioni che covano nella società veneta. Le riduce all’alternativa, errata e pericolosa, fra la criminalizzazione e il ridicolo. In entrambi i casi, riassume il “male del Veneto” in un vizio folcloristico e “periferico”. Come il Veneto, in fondo, appare a molti italiani (ma anche a molti veneti, soprattutto alla Sinistra, che, non per caso, qui è sempre stata minoritaria). Meglio non illudersi. Anzitutto perché, come ha mostrato il sondaggio di Demos condotto su un campione rappresentativo, oltre la metà degli elettori veneti (55%) si dicono d’accordo con l’obiettivo (sollevato dal referendum) dell’indipendenza veneta. Anche se è concepita, soprattutto, come maggiore “autonomia”, maggiore capacità rivendicativa nei confronti di Roma. In parte, nella maggiore qualità dei parlamentari e della classe politica. Tuttavia, le ragioni dell’indipendenza vanno oltre. Basta scorrere i dati dei sondaggi dell’Osservatorio sul Nordest, condotti da Demos e pubblicati ogni settimana sul Gazzettino, da quasi vent’anni, per cogliere la misura della frattura con le istituzioni. Visto che il 71% dei veneti è convinto che «i cittadini di questa regione lavorano e danno molto più di quel che lo Stato restituisce loro» (Demos, aprile 2013). Mentre il 75% dei veneti intervistati (Demos, Novembre 2013) si dice d’accordo con l’idea, sicuramente inquietante, che oggi sia «necessario proclamare uno sciopero fiscale perché le tasse sono insopportabili ». È, dunque, meglio non liquidare l’indipendenza veneta con qualche battuta. Lasciando che la giustizia faccia il suo corso e risolva il problema. Il “male del Veneto” ha radici profonde e diffuse, nella società e nel territorio. Ma non va neppure confinato, come una questione locale. Sollevata dai “soliti” veneti. Abituati a lamentarsi. Il “male del Veneto”, come è avvenuto altre volte in passato, è il sintomo di un male più ampio. Riflette il disorientamento geopolitico europeo, sottolineato dalle crescenti tensioni autonomiste — in Spagna, Belgio, Gran Bretagna… Ma denuncia, soprattutto, il “male nazionale”. La frattura tra gli italiani, la politica e lo Stato, rivelata, in modo esplicito, da un sondaggio recente, condotto in ambito nazionale (Demos, gennaio 2013). Il quale mostra come oltre metà degli italiani (52%, per la precisione) si dica d’accordo con la protesta dei Forconi. Un orientamento che appare particolarmente condiviso — non a caso — nel Nordest (61%). D’altronde, tra gli arrestati c’è un leader dei Forconi. Ma il sostegno alle ragioni dei Forconi risulta elevato anche nel Mezzogiorno. Dove, peraltro, è nato il movimento (in Sicilia, per la precisione). L’indipendenza del Veneto, dunque, ha ragioni di lunga durata. Che non possono essere spiegate, in modo consolatorio, come un “vizio locale”. Perché evocano una “questione nazionale” dai contorni netti. L’indipendenza dei cittadini rispetto allo Stato e alle istituzioni. 20 Del 04/04/2014, pag. 4 Tsipras parte dal sud L’Altra Europa. Il leader di Syriza torna in Italia e lancia la campagna elettorale a Palermo ricordando Falcone e La Torre. Attacco alla socialdemocrazia francese di Hollande «che assomiglia sempre più alla destra», e all’Europa imposta da Angela Merkel: «L’euro non deve ricattare il meridione». La replica a Alfano che vuole blindare le frontiere Chiara Giarrusso È un caso che Alexis Tsipras abbia scelto Palermo per la sua unica tappa italiana? E’ un caso che il luogo che l’ha ospitato, la sede di un’associazione culturale, si chiami Biotos? No, nel capoluogo siciliano il leader di Syriza ha riconosciuto il posto in cui le peggiori condizioni per vivere (come nella sua Grecia) diventano le condizioni migliori per riportare in vita la politica. In una delle città più disamministrate d’Italia, Tsipras rilancia la «Questione meridionale», parla di quel Sud dell’Europa che la miope politica di Berlino e Francoforte intende punire per la sua povertà, ancor più che per i suoi errori. Il leader greco lancia la campagna elettorale della lista «L’altra Europa» e lo fa presentandosi non come un «calciatore acquistato per il campionato in corso» ma come guida di una sinistra che vuole ricordare all’Europa dei 28 che il processo di integrazione non può piegarsi alle logiche del profitto e dei banchieri, ma deve continuare sulla strada dei diritti per un Continente dei popoli, non dei populismi, né dell’austerity. Alle politiche dell’area Shengen, che garantiscono libertà di circolazione a merci e capitali, vietandola agli esseri umani per motivi di cittadinanza, Tsipras, da uomo del Sud, parla di coesione sociale e uguaglianza, termini ormai desueti nel circolo dei governi europei. Infatti, nelle stesse ore, a Palermo, il ministro dell’Interno Angelino Alfano, anche lui uomo del Sud, torna a parlare di immigrazione con il piglio del poliziotto: i 600 mila migranti che sulle coste africane aspettano di attraversare il Mediterraneo (secondo la stima del capo del Viminale) dovranno essere fermati dal Frontex, e l’Europa, è la linea di Alfano, «deve proteggere i propri confini». Passa qualche ora e Tsipras, che in serata ha incontrato la comunità greca di Palermo al cinema Imperia, replica: con buona pace del ministro, se tanta gente vuole venire in Europa non sarà lo spauracchio del Frontex a fermarla. Un’ Europa dei popoli non può precludere il diritto alla vita, a un domani migliore, a un lavoro, a una casa, se l’unica colpa di chi sceglie di consegnare il suo futuro a un viaggio della speranza, è quella di fuggire da guerre e miseria. Piuttosto, le politiche di contrasto hanno trasformato il Mediterraneo «in un cimitero di anime». Tsipras parla ad Alfano, ma soprattutto ai deludenti leader europei, come Francois Hollande, che a forza di assecondare i concetti dei conservatori, ha trasformato il volto della socialdemocrazia europea, «facendola sempre più rassomigliare alla destra». Per Tsipras, quella Palermo civile che si batte contro la corruzione, è un esempio da seguire. La sua seconda tappa palermitana è l’Albero Falcone, davanti al palazzo di via Notarbartolo dove abitava il magistrato ucciso dalla mafia nel ’92. L’altra tappa è la lapide che ricorda Pio La Torre, il parlamentare del Pci ucciso da Cosa nostra nell’82 insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. Un omaggio, quello di Tsipras, agli uomini della resistenza, a un magistrato antimafia e a un pacifista, che oltre trent’anni fa si battè contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso. Ed è la resistenza che Tsipras chiede agli europei contro la «barbarie» dell’Europa dei tecnocrati che ha messo in ginocchio la Grecia e l’Italia. Un segnale forte contro le politiche di Angela Merkel e il suo sogno di «un’Europa tedesca». Alla cancelliera dice che respinge «il ricatto dell’uscita dall’Euro 21 delle economie: restiamo nell’area comunitaria come membri paritari. Dobbiamo essere tutti uguali». A chi gli parla di divisioni nello schieramento che lo sostiene, Tsipras ribatte che l’unità è acquisita, ma la sinistra deve cercare nuove strade e nuova espressione». E la nuova strada che la pallida sinistra italiana pensa di aver trovato con Renzi, non commuove per nulla il capo di Syriza. Quando gli chiedono cosa abbia in comune con il segretario del Pd, si lascia andare a una battutta: l’età. Dopo un a pausa aggiunge: lui tifa Fiorentina, io Panathanaikos. Nemmeno sul calcio potranno mai trovare una convergenza. Infine, mentre sta per uscire dalla sala della conferenza stampa, incrocia Nicola Cipolla, l’ex senatore del Pci, oggi più che novantenne e più che mai battagliero. Con lui non divide l’età, ma sui valori della sinistra l’accordo è totale. 22 LEGALITA’DEMOCRATICA Del 04/04/2014, pag. 3 LA LEGGE Mafia, il voto di scambio passa alla Camera alleggerite le pene ALBERTO CUSTODERO ROMA. Riduzione della pena massima da dodici a dieci anni. Eliminata la frase relativa alla «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze delle associazioni mafiose ». Con queste due modifiche, la Camera ha approvato, con il solo voto contrario dei grillini, il ddl sul voto di scambio. I voti a favore sono stati 310, 61 i contrari, tutti del M5S. La palla passa ora al Senato dove il ddl dovrebbe essere approvato a tempi record per diventare esecutivo prima delle amministrative. Il voto di scambio finora aveva avuto scarsissime applicazioni perché prevedeva l’erogazione di denaro da parte del politico in cambio dei voti mafiosi. Un comportamento, questo, che non si verifica quasi mai in quanto i politici, in genere, si “sdebitano” promettendo appalti e posti di lavoro. La nuova norma, invece, che contempla nel patto politico-mafioso la promessa di “ogni altra utilità”, «fa chiarezza — spiega Rosy Bindi, presidente della commissione Antimafia — nell’individuare lo scambio tra potere mafioso e potere politico». L’approvazione del ddl ha incassato il plauso di Rosy Bindi, di Franco Roberti, Procuratore nazionale Antimafia («Ora la norma è perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia», ha commentato). E dell’associazione di don Ciotti Libera, che «auspica l’immediata approvazione della norma a Palazzo Madama». Ma l’abbassamento della pena massima, invocata nei giorni scorsi da Fi, e l’eliminazione della “disponibilità” (a favore della quale s’era espressa anche la magistratura), hanno alimentato una dura polemica con i grillini. Andrea Colletti, deputato 5Stelle, durante il dibattito in Aula aveva lanciato pesanti accuse. «Vorremmo sapere — aveva dichiarato — se nell’incontro di mercoledì tra Napolitano e Berlusconi si è parlato di questa norma. Sarebbe bello sapere se anche stamattina (ieri, ndr) se n’è parlato, vista l’accelerazione da Pd e Fi dopo l’incontro Renzi-Verdini-Gianni Letta. Forse dovremmo cambiare il titolo del ddl e chiamarlo “voto di scambio politico elettorale tra Renzi, Verdini e Berlusconi”». «Sono tutte falsità — replica Donatella Ferranti, Pd, presidente della commissione Giustizia — le modifiche tengono conto delle criticità segnalate dall’Anm e da diversi pm antimafia». «La pena — ha aggiunto — è stata rimodulata lasciando un tempo di prescrizione di dodici anni e mezzo. Mentre l’inciso “disponibilità” è stato eliminato in quanto criticato per eccessiva indeterminatezza». «È arrivato il tempo — ha dichiarato Bindi — di varare un Testo unico delle leggi antimafia, per il coordinamento tra le norme che ancora manca». Dall’opposizione, «soddisfatti » i forzisti che, ha spiegato il capogruppo Renato Brunetta, «hanno visto accolte le nostre proposte». Voto favorevole anche dalla Lega secondo cui però, come ha precisato il deputato Angelo Attaguile, «il ddl non basta a sconfiggere la criminalità organizzata che va colpita al cuore con il sequestro dei beni mafiosi». A questo proposito, si registra la protesta dei Prefetti (Sinpref) per il fatto che da un mese è vacante il posto di direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. 23 del 04/04/14, pag. 6 «Soldi, politica e alleanze di camorra Così comandavano i fratelli Cosentino» Nuovo arresto per l’ex sottosegretario all’Economia. Altri 12 in manette NAPOLI — In quell’area della provincia di Caserta dove la camorra casalese non ha mai smesso di gestire potere e affari anche se i grandi capi sono tutti all’ergastolo, per fare impresa ci volevano tre cose: i soldi, gli agganci politici e, appunto, la camorra. C’era un imprenditore che questa regola non voleva ficcarsela in testa, e Giovanni Cosentino — fratello del ben più noto Nicola, e con lui e con l’altro fratello, Antonio, titolare della ricchissima Aversana Petroli — dovette spiegargliela come si fa con un bambino: «Chi ha più forza quello spara... Dove ci vuole la politica c’è mio fratello Nicola; dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c’è pure la forza». Quell’imprenditore si chiama Luigi Gallo, voleva aprire un distributore di benzina a Villa di Briano, uno di quei paesi dove valgono ancora le tre regole che lui si illudeva di poter ignorare. Gliel’hanno impedito: con le intimidazioni della camorra, gli sgambetti della politica e l’insostenibile concorrenza dell’azienda dei Cosentino. Come siano riusciti a farlo lo raccontano le 220 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con la quale il giudice delle indagini preliminari di Napoli Isabella Iaselli, accogliendo le richieste del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Giuseppe Borrelli, dei suoi sostituti Antonello Ardituro e Fabrizio Vanorio e del sostituto della Direzione nazionale antimafia Francesco Curcio, ha fatto arrestare ieri l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi e i suoi fratelli Giovanni e Antonio. In totale i provvedimenti emessi dal gip sono tredici, e nell’elenco dei destinatari ci sono pure Pasquale e Antonio Zagaria, fratelli di quel Michele Zagaria che insieme con Carmine Schiavone è stato — e probabilmente ancora è — il più potente boss casalese, e che è riuscito a rimanere latitante per sedici anni prima di essere arrestato nel dicembre del 2011. Il potere assoluto dei Cosentino Dalle indagini nate proprio dalle denunce di Gallo, e condotte dai carabinieri della compagnia di Caserta, guidati dal colonnello Giancarlo Scafuri, emerge uno scenario di potere assoluto dei Cosentino. L’assoggettamento ai loro voleri era vastissimo e a svariati livelli. Non solo sulla complicità dei camorristi, potevano contare Nicola e i suoi fratelli. Anzi, se lo scenario disegnato dalla magistratura sarà confermato dai futuri sviluppi giudiziari, si potrà dire che il rapporto tra i Cosentino e i Casalesi era pressoché a livelli paritari, mentre Nicola e i suoi fratelli potevano disporre del totale asservimento di tecnici e amministratori locali, di funzionari della Q8 (assolutamente estranea alle vicende oggetto di indagine) operanti sul territorio casertano, e perfino di funzionari dello Stato. La riunione in prefettura Nel 2002 toccò all’allora sindaco di Villa di Briano Raffaele Zippo scoprire fin dove i Cosentino potevano spingersi pur di bloccare l’iniziativa imprenditoriale di Gallo, che se fosse riuscito ad aprire il distributore di benzina avrebbe impedito a loro — per le leggi vigenti all’epoca — di fare altrettanto poco lontano, rappresentando quindi una insopportabile concorrenza. Gallo stava facendo le cose in regola, e aveva perciò chiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli uffici tecnici del Comune. Fu allora che Zippo fu convocato in prefettura, dove trovò nell’ufficio del viceprefetto dell’epoca Maria Elena Stasi (successivamente eletta in Parlamento con Forza Italia e oggi tra gli indagati di quest’inchiesta) Nicola Cosentino. Ecco come l’ordinanza ricostruisce quell’episodio, 24 sintetizzando quanto messo a verbale dallo stesso Zippo: «Dopo circa due o tre mesi dalla sua elezione ricevette una telefonata dalla prefettura di Caserta nel corso della quale un incaricato lo invitò a recarsi a Caserta il giorno dopo, in quanto il prefetto voleva parlargli. Fu ricevuto da un viceprefetto donna, la quale era in compagnia di Cosentino Nicola. La donna rimase in silenzio, ma parlò il Cosentino, il quale testualmente gli disse: “Tu devi allontanare il tecnico comunale, Nicola Magliulo, perché è indiziato di reati di concussione. Questo Magliulo mi sta dando fastidio. Se mi fai questo piacere ti sarò riconoscente, posso anche darti una mano politicamente, ti sto vicino, se ti serve qualcosa vieni qua”». Il tecnico Magliulo era quello che aveva rilasciato a Gallo la concessione edilizia e non era indiziato di niente. Le pressioni dei Casalesi L’accusa principale contestata ai fratelli Cosentino è quella di estorsione per le modalità con le quali avrebbero impedito a Gallo di portare a compimento la sua impresa. I giudici parlano di «un vero e proprio sistema criminoso capace di incidere profondamente sul regolare andamento del mercato», e sottolineano come, in questo senso, si sia «rivelato decisivo il potere politico di Nicola Cosentino e quello criminale promanante dal rapporto stabile che l’ex parlamentare ha potuto vantare con il clan dei casalesi». Clan che partecipa attivamente nell’impedire a Gallo di andare avanti nei lavori per il distributore di benzina. Affamandolo prima con una richiesta estorsiva di dieci milioni di lire, e poi imponendogli imprese collegate ai casalesi per i lavori di sbancamento dell’area dove sarebbe dovuto sorgere l’impianto, e forniture di materiale edilizio a costi altissimi ed evidentemente fuori mercato. Le condizioni capestro Un modo per riuscire ad aprire il suo impianto, Luigi Gallo l’avrebbe avuto, ma sarebbe stato suo per modo di dire e soprattutto per pochissimo tempo. Perché, con la logica del più forte che ha soldi, potere politico e appoggi criminali, Giovanni Cosentino gli prospettò una serie di condizioni per lasciarlo in pace. Avrebbe dovuto, scrive il gip, «consentire l’apertura di un distributore di Gpl dei Cosentino nell’area di servizio; accettare i Cosentino quali soci e/o compartecipanti all’attività di distribuzione degli altri carburanti; estinguere una posizione debitoria del tutto estranea al rapporto fra Gallo e la Q8 a mezzo di finanziamenti che la Q8 avrebbe erogato al Gallo per il tramite dei Cosentino, che a loro volta avrebbero iscritto ipoteca sull’area di servizio, ciò anche nella prospettiva di un prevedibile inadempimento del Gallo, che avrebbe determinato il definitivo passaggio dell’area di servizio in capo ai Cosentino». Fulvio Bufi Fiorenza Sarzanini 25 RAZZISMO E IMMIGRAZIONE del 04/04/14, pag. 7 Un allarme che sa di propaganda PAOLO SOLDINI ●SECONDO IL MINISTRO DELL’INTERNO ANGELINO ALFANO ci sono «tra 300 e 600 mila persone in attesa di transitare nel Mediterraneo» per raggiungere l’Italia. Secondo l’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni nella primavera del 2011 i potenziali profughi pronti a imbarcarsi erano, sulle coste africane, 300 mila. Secondo il suo collega alla Difesa, Ignazio La Russa, invece erano due milioni e mezzo. Queste cifre vennero discusse in un Consiglio dei ministri convocato apposta e con molta risonanza mediatica. Poi si vide che invece furono meno di 30 mila quelli che si imbarcarono davvero per l’Italia (e non tutti purtroppo la raggiunsero perché molte imbarcazioni affondarono e quelli che c’erano sopra andarono ad aggiungersi ai 20 mila morti che si calcola giacciano in fondo al Mediterraneo). L’emergenza drammatica di quei giorni non fu determinata dalla massa degli arrivi, ma dalla ancor più drammatica insufficienza delle strutture di accoglienza, in primo luogo a Lampedusa, e dalla drammaticissima inefficienza del governo Berlusconi, che voleva mandare la polizia italiana in Tunisia e poi pasticciò coi permessi provvisori, riuscì a litigare con la Francia ed entrò in conflitto con le autorità dell’Unione europea, che da Roma venivano accusate di «averci lasciati soli» e rispondevano (giustamente) con aspre critiche pubbliche e procedure di infrazione. Nei mesi successivi gli sbarchi diminuirono fino ad assestarsi a 14 mila nel 2012. Alfano dovrebbe ricordare quei giorni o, se sono troppo lontani, almeno quelli in cui, da ministro al Viminale, dovette gestire un’altra emergenza dopo la spaventosa tragedia del naufragio del 3 ottobre dell’anno scorso a Lampedusa in cui morirono 328 migranti. Anche allora si disse che si stava preparando un trasferimento di «centinaia di migliaia» di profughi dalle coste africane. Nei sei mesi trascorsi da allora di queste «centinaia di migliaia» ne sono arrivati circa 13 mila, di cui 10 mila dall’inizio di quest’anno. Quasi tutti profughi politici da Siria, Eritrea e Somalia, cioè persone che comunque non possono essere respinte o rinviate indietro. Secondo le organizzazioni che studiano (seriamente) il problema, per esempio (ma non solo) Amnesty International, il Consiglio italiano dei Rifugiati, l’Unhcr e gli uffici della Direzione generale competente della Commissione Ue, si può ragionevolmente prevedere che nell’estate entrante ne arrivino il doppio, cioè 20 mila. Le stesse organizzazioni escludono invece che sia possibile stimare il numero delle persone «in attesa di transitare nel Mediterraneo». Bisognerebbe andare a contarli nelle carceri libiche e nel deserto. Alfano lo ha fatto? Ci dice quali sono le fonti delle sue informazioni? Grazie. La campagna elettorale è una brutta bestia diceva, tantissimi anni fa, un vescovo belga che chiese ai partiti del suo Paese di astenersi dall’utilizzare la paura degli stranieri e delle “invasioni” degli immigrati per procurarsi voti. A parte una formazione dell’estrema destra, gli altri lo stettero a sentire. Ma erano altri tempi ed era un altro Paese. Del 04/04/2014, pag. 21 “Traffico controllato da 500 bande” ecco il dossier segreto dei Servizi 26 FRANCESCO VIVIANO IL RETROSCENA ROMA. L’ultima radiografia dei nostri servizi segreti su quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nel Canale di Sicilia, dà risultati impressionanti. Oltre mezzo milione di persone — siriani, eritrei, etiopi, nigeriani, sudanesi e cittadini di altri paesi centroafricani — ammassati nelle “prigioni” dei trafficanti libici in attesa di essere trasferiti su “navi madre” e barconi diretti verso le coste siciliane. Anzi, verso le nostre navi della Marina Militare dell’operazione Mare Nostrum, che da mesi battono in lungo e in largo il mare tra le coste nord africane e quelle italiane. Un sos che gli 007 italiani hanno girato alla Presidenza del Consiglio, con un’analisi drammatica di quello che in queste ore sta accadendo nei paesi centroafricani e, soprattutto, in Libia l’ultimo terminale delle migliaia di disperati che fuggono dai loro paesi d’origine per guerre e fame. Attualmente, secondo le informazioni raccolte sul posto dall’Aisi e dall’Aise (i nostri servizi interni ed esteri) oltre cinquecento “Katibe”, bande paramilitari armate fino ai denti, con la complicità di poliziotti e della guardia costiera libica corrotti, gestiscono il grande business dell’immigrazione clandestina verso l’Italia. Le aree maggiormente interessate all’organizzazione delle “partenze” sono quelle intorno a Tripoli, Misurata e Bengasi dove arrivano le centinaia di migliaia di disperati provenienti da Sudan, dalla Nigeria e da altri paesi del Centro Africa e che fanno capo a due grandi punti di “raccolta” e “snodo”, l’oasi di Kufra (nel Sud-Est della Libia) e l’area di Sebah (nel Sud-Ovest). Dopo il conflitto nel Mali il Niger è diventato il principale collettore pre-libico degli africani che si muovono dai Paesi del Centro Africa e che “sbarcano” a Sebha. Sul versante orientale del continente il punto di raccolta per coloro che provengono dal Corno d’Africa, prima dell’ingresso in Libia, è la città sudanese di Khartoum. «Il primo trimestre 2014 (finora sono arrivati oltre 10mila extracomunitari ndr) vede confermata la centralità del territorio libico. Qui — annotano i nostri 007 — il territorio è tutt’ora controllato dalle “Katibe” coinvolte nella tratta finale del viaggio migratorio. Tali organizzazioni para-militari, ascrivibili alla struttura tribale libica prima, proliferate dopo la rivolta anti-Gheddafi poi, approfittano della propria capacità, anche militare, del controllo del territorio». I trafficanti sono in prevalenza somali, eritrei, sudanesi, nigeriani, maliani che una volta portato il “carico” di essere umani in Libia devono fare ricorso alla intermediazione delle “Katibe” per avere il “via libera” all’accesso alle imbarcazioni e il “nulla osta” delle forze dell’ordine corrotte. L’operazione “Mare Nostrum” che finora ha salvato dalla morte migliaia di disperati ha paradossalmente “sconvolto” il mercato dei trafficanti di esseri umani, i prezzi per pagare il viaggio — che costava fino a duemila dollari — si sono abbassati. Ciò per i minori costi sostenuti dai gestori delle reti dei trafficanti, e per le ridotte porzioni di viaggio perché “intercettati” dalle navi della Marina Militare italiana. Ma lo scenario egiziano non è meno preoccupante. I trafficanti forniscono più “servizi” rispetto a quelli libici: imbarcazioni in partenza, scafisti (soprattutto egiziani ndr) econsentonocheil pagamento della traversata sia saldato dopo l’arrivo in Italia, anche attraverso “prestazioni lavorative”. Ed è dalle coste egiziane che arriva la maggioranza dei siriani. «Quelli giunti in Italia via mare, nel 2013, sono stati oltre 11 mila, al primo posto fra i migranti in Italia». Ma l’emigrazione dalle coste nord africane verso il nostro Paese è quella più evidente. Ci sono altre centinaia e centinaia di migliaia di disperati che arrivano dall’area anatolico-balcanica da sempre collettore dei flussi migratori di Palestina, Iran, Iraq, Turchia, Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka. E poi quella più “silenziosa”, la migrazione asiatica, che si avvale di canali diversificati, in tratte aeree, terresti e via mare. Le organizzazioni che le gestiscono sono abilissime nel procacciamento di documenti falsi, di viaggio e di lavoro. Secondo il dossier dei nostri 007 l’organizzazione delle reti afghano-pakistane «ha mostrato di sapere adulterare anche i più 27 moderni tipi di passaporti di Paesi europei ». Flussi migratori che presentano rischi sanitari: i migranti africani hanno un alto tasso di malattie, polmonari ed epatiti, che sfuggono a ogni forma di prevenzione e cura mantenendo elevato il rischio della diffusione delle patologie. 28 SOCIETA’ del 04/04/14, pag. 1/18 L’Aquila, 5 anni dopo: macerie e sfollati di GIAN ANTONIO STELLA C’è un tanfo da svenire, nelle case «belle e salubri» per i terremotati dell’Aquila. L’impiegato comunale spalanca la porta e vien fuori una folata fetida come il fiato rancido di una bestia immonda. Siamo a Cansatessa, a due passi da Coppito. Dove l’Italia, cinque anni fa, pianse ai funerali dei morti del terremoto e dove accolse i Grandi del G8 chiamati a testimoniare la «miracolosa rinascita che tutto il mondo ammira». È vuoto e spettrale, il «villaggio modello» di Cansatessa-San Vittorino. Avevano cominciato a consegnarlo agli aquilani rimasti senza tetto nel gennaio 2010. C’erano Guido Bertolaso, Franco Gabrielli, il sindaco Massimo Cialente, la presidente della Provincia Stefania Pezzopane e gli alti papaveri della «Task Force Infrastrutture» delle Forze Armate che si era fatta carico del progetto. Brindisi e urrà. Certo, carucce: 1.300 euro al metro quadro per case di legno, ferro e cartongesso. Quattrocento euro in più di quanto, tolto questo e tolto quello, viene dato oggi a chi ristruttura le vecchie e bellissime case di pietra. Ma che figurone! Pochi mesi per costruirle ed eccole là, pronte: con la bottiglia di spumante in frigo. Pochi mesi e già puzzavano di muffa. Pessimo il legno. Pessime le giunture. Pessimi i vespai contro l’umidità. Asma. Bronchiti. Artriti. Finché è intervenuta la magistratura arrestando il principale protagonista del «miracolo», mettendo tutto sotto sequestro e ordinando l’evacuazione totale. Centotré famiglie vivevano lì, a Cansatessa. Quando le spostarono avevano il magone: «Siamo sfollati due volte». In via Fulvio Bernardini, via Nereo Rocco, via Vittorio Pozzo, tutti allenatori di calcio, non è rimasto nessuno. «Giardini» spelacchiati. Lampioni storti. Pavimenti semidistrutti. Piastrelle divelte. Case cannibalizzate. Docce rubate. Lavandini rubati. Bidè rubati. Mobili e materassi lasciati lì: facevano schifo anche agli sciacalli. L’abbiamo scritto e lo riscriviamo: sarebbe ingiusto liquidare l’enorme sforzo di migliaia di uomini e donne, nei mesi febbrili seguiti alla tremenda botta del 6 aprile 2009, soltanto come un’occasione di affari. E sarebbe ingiusto ricordare di Silvio Berlusconi solo le sdrammatizzazioni nelle tendopoli («Bisogna prenderla come un camping da fine settimana»), le battute alle dottoresse («Mi piacerebbe farmi rianimare da lei!») o la promessa di case con le «lenzuola cifrate e una torta gelato con lo spumante in frigo». Furono migliaia e migliaia gli aquilani che all’arrivo del gelido inverno ai piedi della Maiella, nell’autunno del 2009, ringraziarono Iddio e il Cavaliere per quel tetto sopra la testa. Non si può liquidare tutto come un business scellerato. Come se si fossero occupati dell’emergenza, degli sfollati e della ricostruzione solo faccendieri come Francesco De Vito Piscicelli, quello che la mattina del 6 aprile gongolava: «Io stamattina ridevo alle tre e mezzo dentro al letto...». Non è stato solo quello, l’intervento dello Stato a L’Aquila. E forse è davvero troppo spiccio il dossier di Søren Søndergaard, il deputato europeo della Sinistra membro della Cont, la commissione di controllo del bilancio di Bruxelles, che ha rovesciato sugli interventi d’emergenza e la ricostruzione accuse pesantissime parlando, a proposito delle case provvisorie, di «materiale scadente... impianti elettrici difettosi... intonaco infiammabile...» e di pesanti infiltrazioni delle mafie al punto che parte dei fondi per i progetti Case e Map (Moduli abitativi provvisori) sarebbero finiti a società «con legami diretti o indiretti con la criminalità organizzata». 29 Ma certo, in questi anni, è venuto a galla di tutto. Prima i conti pazzeschi di certe spese del G8: 4.408.993 euro per gli «arredi» delle foresterie dei Grandi alla caserma Coppito, 24.420 euro per gli accappatoi, 433 euro per ciascuna delle «60 penne in edizione unica» per un totale di 26.000, 500 euro per ognuna delle 45 ciotoline portacenere di Bulgari, 92.000 per la consulenza artistica di Mario Catalano, chiamato a dare un tocco di classe al G8 dopo essere stato lo scenografo (tette, culi e battute grasse) di «Colpo grosso». Poi le accuse di Libera e di Don Ciotti, tra le quali quella incredibile sull’acquisto di un numero così spropositato di gabinetti chimici, per un totale di 34 milioni di euro, che ogni sfollato nelle tendopoli avrebbe potuto produrre «fino a un quintale al giorno di pipì e di popò». E poi ancora il diluvio di leggi e leggine, regole e regolette che hanno ingabbiato L’Aquila peggio ancora dei grovigli (152 milioni di euro) di impalcature. Riassunto: nei primi quattro anni dopo il sisma 5 leggi speciali, 21 Direttive del Commissario Vicario, 25 Atti delle Strutture di Gestione dell’Emergenza, 51 Atti della Struttura Tecnica di Missione, 62 dispositivi della Protezione Civile, 73 Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, 152 Decreti del Commissario Delegato, 720 ordinanze del Comune. «Ma devo confessare poi mi sono anche stufato di tenere i conti», spiega l’ingegnere Gianfranco Ruggeri. Per non dire dei conti delle sistemazioni provvisorie: 792 milioni iniziali per le C.a.s.e. (Complessi antisismici ecocompatibili), 231 per i Map, 84 per i Musp (Moduli a uso scolastico provvisorio) e 736 mila euro per i Mep, i Moduli ecclesiastici provvisori. Troppi: fatti i conti, ammesso che abbiano accolto 18 mila persone, quelle case temporanee sarebbero costate oltre mille euro al mese per ogni ospite. Una enormità. «Credo che difficilmente queste case nuove verranno lasciate perché sono molto belle e saranno immerse nel verde», ammiccò il Cavaliere davanti ad alcune di queste abitazioni. Certo si sperava fossero un po’ meno «provvisorie». Che avessero meno magagne. Quanto all’«ecosostenibilità», un dossier di Legambiente accusa: il 43% è al di sotto di ogni soglia. Dice tutto la polemica sulle bollette arretrate che il Comune, dopo quattro anni, ha chiesto di pagare agli sfollati. «Per 60 metri quadri mi sono ritrovata una bolletta del gas di 875 euro l’anno», spiega Giusi Pitari, la docente animatrice del Popolo delle carriole, «Alla signora di sotto è andata peggio: per gli stessi 60 metri, deve pagarne 1.250 l’anno. Alla faccia del risparmio energetico!» E intanto, mentre troppe case temporanee diventano velocemente inabitabili, quelle vecchie abbattute o devastate dal sisma sono ancora in larga parte lì, in macerie. Certo, dopo cinque anni di silenzio irreale, finalmente il centro dell’Aquila è un frastuono di martelli pneumatici, rombar di camion, urla di muratori in tutte le lingue. «Il problema non sono i soldi. Ce ne sono tanti ma tanti che potremmo lavorare tutti», dice l’architetto Sestilio Frezzini che sta sistemando uno dei più bei palazzi del centro. I problemi, quelli veri, sono i lacci e lacciuoli burocratici. Anche se il Comune, dopo lo scandalo delle intercettazioni dell’ex assessore comunale Ermanno Lisi («Abbiamo avuto il culo del terremoto e con tutte ‘ste opere che ci stanno farsele scappà mo’ è da fessi…») pare avere infine accelerato. Spiega Massimo Cialente, il «sindaco antisismico» capace di resistere a tutte le scosse telluriche, partitiche e giudiziarie che da anni lo circondano, che i cantieri aperti sono 150. Il ministero dei Beni culturali abbassa: 101. Accusa Ruggeri: «Comunque troppo pochi su 190 ettari di abitazioni e 1.532 cantieri da aprire solo a L’Aquila». Dire che tutto sia fermo come due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa sarebbe ingiusto. Ma gran parte degli edifici sono ancora lì. Com’erano. Con gli armadi rimasti spalancati su ciò che resta del pavimento. Alla prefettura, finita su tutti i giornali del mondo per la foto di Barack Obama, hanno rifatto la facciata in legno e raddrizzato la scritta «Palazzo del governo». Dentro, però, è un disastro. Perfino i cavi di acciaio tesi per tenere i muri, sono pericolosamente afflosciati e le pareti minacciano di staccare. La Casa dello studente, uno dei simboli della tragedia, è 30 ancora lì. Con le stanze spalancate nel vuoto. Sulla rete di recinzione si accavallano le foto dei ragazzi morti, qualche regalino, biglietti di affetto: «Luminoso sognavi il tuo avvenire. / Un giorno diventare medico. / Curare con amore grande / i malati nel corpo e nello spirito. / Al di là del tempo, tra gli angeli / alla Vergine Addolorata / porti il dolore dei tuoi cari…». Morirono in quaranta, a Onna. Su trecento abitanti. Le macerie di via dei Martiri, la strada principale del paese dedicata alle vittime di una rappresaglia nazista e devastata dal terremoto, furono uno dei simboli della catastrofe. Cinque anni dopo, c’è all’ingresso una struttura modernissima, la «CasaOnna» progettata dall’architetto sudtirolese Wittfrida «Witti» Mitterer. Subito dopo, al posto del vecchio asilo, la Casa della cultura. Ma gli edifici che si affacciavano sulla strada sono rimasti com’erano. Macerie. Mute. Non senti lo schiocco di una gru, la botta di un martello, il cigolio di una carriola… L’unico cantiere aperto, dice l’architetto Onelio De Felice, è quello per ricostruire la chiesa: «I tedeschi sì, ci sono stati vicini. Il Comune meno. Il piano di ricostruzione, per rifare il paese com’era e dov’era, è stato fatto abbastanza in fretta. Ce l’ha tenuto fermo un tempo immemorabile, all’Aquila. Forse non volevano che noi partissimo per primi…». Eppure, sono tornate a sfrecciare le rondini, nel cielo azzurro di Onna. E tra le robinie e i meli in fiore, quelli vecchi sotto i quali quel giorno maledetto adagiarono i morti e quelli nuovi piantati tra le case prefabbricate, cantano i passeri e le cinciallegre e Matteo e gli altri bambini della nuova «materna» fanno merenda sotto disegni rossi e gialli e blu che sprizzano allegria primaverile. Matteo è il primo dei piccoli nati dopo il terremoto. Il simbolo stesso della rinascita. L’antico paese che un tempo si chiamava Villa Unda, lui e gli altri che sono cresciuti nel villaggio costruito dalla Provincia di Trento, non l’hanno mai conosciuto. Quando qualche figlioletto, così, di colpo, chiede come fosse il paese «prima», la mamma lo porta al di là della strada, dove la staccionata è tappezzata da grandi fotografie di struggente malinconia. Ogni foto, per gli onnesi, è un tuffo al cuore. La processione in via dei Calzolai, coi rampicanti che salivano per i muri. L’angolo Sant’Antonio con l’altarino coperto di fiori. La chiesetta di Sant’Anna. Via Oppieti, coi balconi che traboccavano di gerani. C’è anche una poesia di Giustino Parisse, il giornalista de il Centro che qui viveva e che sotto le macerie perse il padre e i due figli Domenico e Maria Paola: «Quanto era bella Onna prima dell’orrendo scossone. Sorta fra le acque e immersa nella verde valle dell’Aterno. Mille anni di storia e milioni di storie». Del 04/04/2014, pag. 6 Depenalizzata la coltivazione della cannabis, anzi no Droghe. La legge delega riguarda solo le violazioni commesse da istituti universitari e laboratori pubblici di ricerca che hanno ottenuto autorizzazione ministeriale alla coltivazione Alessandro De Pascale È stata inserita nel decreto «svuota carceri», che ha abrogato tutta un serie di reati minori. Con 332 voti favorevoli, 104 contrari e 22 astenuti, la Camera dei deputati ha approvato mercoledì una parziale, e ingannevole, depenalizzazione della coltivazione della cannabis, oltre che del reato di clandestinità (motivo per cui c’è stato l’ostruzionismo di M5S, Lega e Fratelli d’Italia), con l’obiettivo di ridurre il numero dei detenuti che stanno attualmente 31 affollando le strutture carcerarie italiane. Per questi due punti controversi si tratta però di una legge delega. In pratica, il governo ha 18 mesi di tempo per emanare i decreti che daranno attuazione al principio. Inoltre, per quanto attiene alla marijuana, il provvedimento in questione si riferisce soltanto all’articolo 2 del testo unico sugli stupefacenti, quello che riguarda i soggetti che hanno già un’autorizzazione alla coltivazione di sostanze psicotrope per scopi scientifici, sperimentali o didattici, concessa dal ministero della Salute. Quindi, università e laboratori di ricerca che se non rispettano «prescrizioni e garanzie cui l’autorizzazione è subordinata», non incorreranno più in sanzioni penali (fino a un anno di carcere), come è stato fino ad ora, ma solo amministrative (dunque pecuniarie). Per chi non ha l’autorizzazione ministeriale resta dunque il reato penale, come prima. Secondo alcuni, si tratta comunque di un piccolo passo in avanti che arriva dopo l’ok che il governo Renzi ha dato all’utilizzo, anche nel nostro Paese, della cannabis per scopi terapeutici. Il 10 marzo l’esecutivo aveva infatti deciso di non impugnare la legge della Regione Abruzzo, promulgata lo scorso 4 gennaio, che consente la prescrizione e l’erogazione gratuita a carico del servizio sanitario di medicinali cannabinoidi. Altre Regioni sono sulla stessa strada. 32 BENI COMUNI/AMBIENTE Del 04/04/2014, pag. 23 ABRUZZO Discarica dei veleni: “Inquinata anche la filiera alimentare” GIUSEPPE CAPORALE PESCARA. «Si ravvisa un pericolo concreto per la salute umana rispetto al rischio di ingestione di mercurio, veicolato tramite suolo, sedimenti ed acque superficiali nella filiera alimentare». Contiene una frase shock la relazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che è gli atti dell’inchiesta sull’ex polo chimico di Bussi divenuta la discarica più grande d’Europa. Secondo il rapporto richiesto dall’Avvocatura dello Stato e depositato lo scorso gennaio in Corte d’Assise a Chieti al processo contro 19 dirigenti della Ex Montedison Ausiliare (Ausimont) accusati di avvelenamento delle acque e disastro colposo, a essere contaminata non è stata solo l’acqua destinata a 700 mila persone, ma anche la filiera alimentare. «I valori medi riscontrati sui vegetali raccolti nell’intorno del sito di Bussi, nel caso dei germogli di grano, sono circa 292-561 volte superiori ai livelli di concentrazione di piombo rinvenibili nell’alimento e nei semi 158-225 volte superiori», è scritto nel rapporto che si riferisce ad analisi su pozzi inquinati poi chiusi nel 2007 pochi mesi dopo il sequestro della discarica da parte della Forestale di Pescara. «Valori medio alti di mercurio furono rintracciati nei prodotti alimentari vegetali già nel 1981 e nel 1972 fu trovato mercurio nei pesci e nei capelli dei pescatori ». «È tutto il medio Adriatico ad aver problemi col mercurio — spiega il professor Michele Amorena, farmacologo e tossicologo alla facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo che con un suo studio nel 2006 ha confermato l’elevata concentrazione di mercurio nei capelli dei pescatori — quindi l’ipotesi è che da anni sia il fiume Pescara a immetterlo, visto che riceve le acque contaminate di Bussi. E nei fanghi del dragaggio del porto sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di mercurio. Ma bisogna chiarire che non c’è un pericolo per la salute immediato, solo un aumento dei rischi specie per i feti. A essere contaminati sono quelle specie di pesci che hanno vita più lunga cioè i pesci grossi che entrano nella catena alimentare». Intanto il governatore dell’Abruzzo Gianni Chiodi ha inviato una lettera al ministro della Salute Lorenzin per chiedere una valutazione dei danni alla salute sugli abitanti di Bussi. Ieri i “movimenti per l’acqua del Forum Abruzzo” hanno tenuto un sit-in davanti all’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo per chiedere lo “Stop-Biocidio” e l’avvio immediato dell’indagine epidemiologica, l’avvio di screening sanitari su lavoratori e popolazione, oltre che realizzazione di un monitoraggio ambientale e degli alimenti su vasta scala. «Serve la trasparenza dei dati», tuona Augusto De Sanctis in prima linea con il consigliere regionale Maurizio Acerbo nella battaglia “contro la discarica di Bussi e il partito dell’acqua”. 33 del 04/04/14, pag. 6 (Roma) «Ripristinare la legalità negli edifici occupati» Il giudice dice no a Marino Respinta la richiesta di dissequestro dell’«Angelo Mai Occupato» che portava la firma del sindaco, il giudice Riccardo Amoroso osserva che, nei locali in via delle Terme di Caracalla, si sono verificate violazioni «in materia di sicurezza, tutela dei luoghi di lavoro, somministrazione di sostanze alimentari, svolgimento di spettacoli e prevenzione antincendio». E ricorda, fra l’altro, che dove c’è un occupazione abusiva, l’amministrazione rinuncia «alla gestione del patrimonio pubblico». Le motivazioni con cui il gip suggerisce (in pratica) all’amministrazione di abbandonare la via dell’emergenza abitativa affidata ai movimenti, sono riassunte in una paginetta: «Il mancato ripristino della legalità nella vicenda in esame — scrive, facendo intendere che il Comune è in buona compagnia — dipende dalle omissioni dei competenti enti territoriali». Omissioni nell’ «assegnazione degli immobili di proprietà pubblica in disuso e in stato di abbandono secondo criteri di trasparenza e rispetto delle graduatorie». Volete recuperare/valorizzare un edificio dismesso? Bene, allora fatelo secondo criteri trasparenti, dice il magistrato. Come una «gestione economica» che preveda «spese di manutenzione e ristrutturazione degli immobili che non possono essere delegate all’autogestione» abusiva. All’«Angelo Mai Occupato», secondo l’inchiesta del pm Luca Tescaroli, si sarebbe verificato un serio caso di doppia personalità politica. Dove, da un lato, i leader di sinistra (Coordinamento di Lotta per la casa) rivendicavano diritti per gli extracomunitari e, dall’altro, li convincevano - sotto la minaccia di sfratto - a lavorare per loro o a farsi pagare per conservare l’appartamento. Nell’istanza di dissequestro del sindaco «non viene neppure chiarito quale sia il rapporto fra l’associazione ‘Angelo Mai Occupato’ e l’associazione ‘Probasis onlus’ (la cui presidente Giorgina Pilozzi è tra gli indagati per associazione a delinquere, ndr ) formale assegnataria dell’immobile medesimo». Un dissequestro «avrebbe il solo l’effetto di ripristinare il pregresso stato di gestione illegale dell’attività». Anzi, per la verità, «la già disposta sospensione del sequestro preventivo (sospensiva ottenuta fin dal primo giorno, ndr ) per gli altri due immobili occupati (via della Acacie e via Tuscolana, ndr) è in contraddizione con il ripristino della legalità». Intanto si indaga sui 258mila euro versati dal Comune per una delle palazzine occupate alla proprietà. Ilaria Sacchettoni 34 CULTURA E SCUOLA Del 04/04/2014, pag. 22 L’università nel caos Aspiranti prof pioggia di sentenze contro i baroni Il Tar del Lazio piccona le graduatorie dei test nazionali di abilitazione Così i giudici sventano un’altra parentopoli E adesso il mondo della ricerca chiede al ministero: difendiamo il merito GIOVANNI VALENTINI ROMA. Fioccano le sospensioni e gli annullamenti del Tribunale amministrativo del Lazio, competente per gli atti dell’amministrazione statale su tutto il territorio nazionale, dopo la pioggia di ricorsi contro l’esito dell’Abilitazione scientifica (non didattica) per i professori universitari. In diversi i casi, i giudici del Tar hanno stabilito anche che le commissioni esaminatrici devono essere interamente ricostituite per emettere un nuovo verdetto entro 60 giorni. Un terremoto insomma - per l’Università italiana, già minata dalle sue croniche carenze e disfunzioni. All’origine della vertenza c’è la controversa introduzione ex postdei parametri di “sottosettorialità” che hanno ribaltato le graduatorie originarie, compilate secondo i criteri oggettivi e meritocratici previsti dalla riforma ministeriale. Con questo sistema, molti aspiranti che in base alle loro pubblicazioni vantavano titoli scientifici specialistici, studiosi già noti e apprezzati nelle rispettive discipline, sono stati scavalcati da concorrenti con un curriculum più generico e meno qualificato. E spesso, a favore di figli o allievi dei potenti “baroni” universitari. Ma ora le ordinanze del Tar, come in una reazione a catena, stanno praticamente azzerando la situazione in vari campi accademici. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto, per esempio, il ricorso di Greta Tellarini che aveva presentato domanda per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore del Diritto commerciale della navigazione: la sua preparazione era stata sommariamente liquidata da uno dei componenti come «accettabile », in senso spregiativo e in modo difforme dalle direttive ministeriali. E perciò è stata disposta la costituzione di una nuova commissione esaminatrice. Lo stesso Tar ha dato ragione a Marco Gentile che aspirava a diventare professore di seconda fascia per Storia medievale: in questo caso, secondo la magistratura amministrativa, i giudizi individuali di non idoneità «non sembrano raggiungere un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo». Analogamente è stato accolto il ricorso di Tessa Canella, per Scienze del libro e del documento e Scienze storicoreligiose. Il Tar ha riconosciuto un «sufficiente fumus boni iuris in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto a quello positivo reso dall’esperto nominato dalla medesima commissione». Nello stesso settore, è stato annullato il giudizio negativo su Francesco Mores: qui il fumus attiene «allo specifico profilo di conoscenza dell’esperto chiamato a esprimere il parere pro veritate nei confronti del candidato e della congruenza delle sue pubblicazioni». Ancora più paradossale il caso di Stefano Benussi che aveva presentato domanda per diventare professore di seconda fascia per la Chirurgia cardiovascolare. Il verdetto della Commissione è stato ritenuto incongruo «rispetto al numero delle pubblicazioni del candidato», considerando anche il fatto che il giudizio individuale dei singoli commissari era risultato positivo a maggioranza dei 3/5. 35 Particolarmente significativo il documento di protesta inviato al ministro dagli archeologi dell’Accademia dei Lincei, tra cui Ermanno Arslan, Salvatore Settis e Fausto Zevi. Oltre a contestare «la scelta della Commissione di abilitare un numero spropositato di candidati» (69 su 160 nella prima fascia e 241 su 553 nella seconda), si critica nel merito anche la qualità accademica dei nuovi professori: «Sono stati resi idonei candidati, la mediocrità o addirittura l’irrilevanza della cui produzione – si legge nel testo - è visibile ictu oculi a chiunque». In polemica poi con Andrea Ferretti, primario di Ortopedia all’ospedale Sant’Andrea di Roma, econ Repubblicache neaveva raccolto le dichiarazioni, il professor Paolo Cherubino ha inviato una lettera al presidente del Collegio dei professori di prima fascia di Ortopedia e Traumatologia, Sandro Giannini, e a tutti i membri, contestando le critiche alla procedura di abilitazione. Ma Ferretti ha subito replicato, ribadendo le sue valutazioni e le sue riserve sui «criteri settoriali aggiuntivi» che hanno trovato riscontro ora nelle pronunce del Tar. Sulla stessa linea, in una lunga lettera inviata a Repubblica e intitolata L’Università svilita, interviene un altro autorevole cattedratico come Davide Messinetti, già professore ordinario di Diritto civile all’Università di Firenze. A suo giudizio, i risultati di questa prima tornata della procedura per l’abilitazione nazionale «appaiono in quasi tutti i settori scientifici e disciplinari a dir poco sconcertanti». E per quanto riguarda il Diritto privato, lui stesso li definisce anche «vergognosi», riferendo un’opinione pressoché unanime dei suo colleghi. «Auspico – conclude Messinetti - che il nuovo ministro della Università voglia prendere iniziative concrete e urgenti contro questa orrenda visione, annullando in autotutela gli atti del concorso e rimuovere l’operatività di questa commissione che si è resa responsabile di tanto scempio». 36 INTERESSE ASSOCIAZIONE Da Vita del 04/04/14 Servizio Civile per tutti: è ora che l'idea sbarchi in Europa II Semestre italiano un'occasione unica L'idea di dare vita a un servizio civile europeo ha attraversato ]a storia del '900 senza diventare una proposta capace di coinvolgere davvero i giovani e questa dimensione di nicchia l'ha resa ininfluente. Se oggi si prevede con toni preoccupati il 75% di astensione dei giovani in vista delle prossime elezioni europee perché non mettere in campo un servizio civile a dimensione europea che valorizzi i risultati positivi in termini di educazione alla cittadinanza che il Servizio Civile Nazionale ha prodotto? Un servizio civile però che sia assunto dalle istituzioni nazionali e continentali come un diritto di tutti i giovani a poterlo svolgere. Un servizio civile che renda davvero tangibile quella doppia cittadinanza che da anni sta scritta sui nostri passaporti. È importante che l'iniziativa parta dai Paesi, Italia in testa, che hanno il maggior tasso di esclusione dei giovani non solo dal lavoro, ma anche dalla vita politica. Un servizio civile a dimensione europea che si integri con i programmi esistenti (servizi civili nazionali, corpi civili dì pace, servizio volontario europeo, Erasmus, corpo volontario europeo di aiuto umanitario), che recuperi sperimentazioni europee passate (programma Amicus) può essere una delle proposte che il Governo Italiano inserisce nel Semestre di sua Presidenza dell'Unione, ricercando attraverso la cooperazione rafforzata un lavoro comune con Francia e Germania, Paesi che hanno già leggi nazionali di servizio civile per iniziare il percorso dentro le istituzioni comunitarie. Questa prospettiva naturalmente sarà tanto più credibile quanto più in Italia il bozzolo del Servizio Civile Nazionale diventerà la farfalla con il Servizio Civile per tutti coloro che chiedono di farlo, aperto anche ai cittadini stranieri, in primis quelli comunitari. Licio Palazzini, Presidente Cnesc L’evento "Verso un servizio civile europeo per tutti", si intitola così il workshop organizzato da Vita con Cnesc (Conferenza nazionale enti servizio civile) e Tese (Tavolo enti servizio civile) a Torino, il 14 aprile, alla Fondazione C. Feyles Centro Studi e Formazione di via Maria Vittoria, 38. All'incontro che sarà possibile seguire in streaming parteciperanno fra gli altri Giorgio Lunelli, il padre della legge Trentina sul Servizio civile universale e rappresentanti della segreteria Pd che recentemente hanno elaborato una proposta di superamento della norma sul Servizio civile nazionale. Obiettivo dell'incontro sarà quello di stilare un documento condiviso su cui poggiare l'attività legislativa in Italia e in Europa in vista del semestre di presidenza italiano. Info: [email protected] 37 ECONOMIA E LAVORO Del 04/04/2014, pag. 5 Poletti fa muro sui 3 anni Lavoro. Il ministro: «È l’essenza della legge, non si tocca». Apprendisti, niente stabilizzazioni Antonio Sciotto Il decreto sui contratti a termine, purtroppo, per il momento sembra destinato a rimanere «precarizzante». La conferma è arrivata dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che ieri ha sintetizzato i risultati dell’incontro che si è tenuto mercoledì sera con i parlamentari del Pd. «Non è molto difficile arrivare a un ragionevole punto di intesa», ha spiegato il ministro, ribadendo successivamente i paletti che intende mettere alle modifiche. L’incontro è stato «assolutamente utile e molto costruttivo», ha detto il ministro, ammettendo che si sono contrapposte valutazioni di merito differenti, ma che si è comunque tracciato un percorso entro il quale poter ritoccare il provvedimento. «Credo che siamo nel contesto di un sostanziale mantenimento della norma così come l’abbiamo scritta e prevista ma con qualche aggiustamento di quelle parti che a seguito della discussione politica e delle audizioni si verifichi sia opportuno cambiare». Proprio per favorire le modifiche, ieri si è rinviata la scadenza per la presentazione degli emendamenti all’11 aprile. I non renziani, i più critici rispetto al decreto, hanno la maggioranza in Commissione Lavoro della Camera, ma non la useranno per causare rotture nel partito. L’accordo è insomma che si agisca per «aggiustamenti» appunto per mezzo degli emendamenti, e possibilmente senza creare assi trasversali alternativi con M5S e Sel. Due i punti di attacco individuati per una possibile correzione, anche se la minoranza Pd non ha del tutto rinunciato a modifiche più ampie: il primo riguarda la formazione pubblica nell’apprendistato; dovrebbe essere reinserita l’obbligarietà, anche per non incorrere in sanzioni Ue. Il secondo è relativo alle proroghe previste per i contratti a tempo determinato. Un punto, quest’ultimo, su cui Poletti non si sbilancia, ma per cui conferma la possibilità di una riduzione. «Sì, è un tema discutibile perché non c’è un dogma ma solo una valutazione da fare. La discussione però non è ancora iniziata», rispondeva ieri il ministro a chi gli chiedeva se fosse possibile prevedere una riduzione del numero dei rinnovi contrattuali da 8 a 6. Il governo farà invece muro sulla eventualità che si rimettano in discussione i mesi di durata del nuovo contratto a termine. «I 36 mesi è uno dei punti essenziali della norma ed è un punto non discutibile perché la sua logica è fare in modo che con le proroghe sia possibile che una stessa persona resti nello stesso posto di lavoro per tutta la durata del periodo», ha spiegato Poletti ribadendo come una riduzione da 36 a 24 mesi e la reintroduzione di una causale sarebbe «un controsenso logico». Perplessità, da parte del ministro, anche sulla richiesta, emersa nel corso dell’incontro con il Pd, di reinserire la soglia per la stabilizzazione degli apprendisti. «Personalmente sono poco convinto del fatto che siano gli obblighi che producano gli esiti – ha commentato Poletti – Se un’impresa è convinta della bontà di una soluzione stabilizza in autonomia, se non lo è interrompe il contratto un mese prima della scadenza, eludendo il problema», ha spiegato il ministro. L’iter parlamentare, secondo Poletti, sarà tranquillo: «Non mi aspetto nessun problema particolare – ha detto – La discussione è molto positiva e tutti hanno preso atto che non c’è un aut aut, prendere o lasciare, da parte del governo». Eppure un ammonimento 38 arriva: «Se qualcuno pensa di fare una cosa diversa da quello che il governo ha proposto e concordato, il governo si opporrà». Poco prima dell’11 aprile, l’esecutivo farà il punto con il relatore di maggioranza per verificare quanti e quali emendamenti prevedere anche perché, ha aggiunto infine Poletti, non è escluso che «alcuni emendamenti li debba fare lo stesso ministero», soprattutto sulla parte relativa alla congruenza della legge con le norme europee. Pd a parte (con una minoranza che ha dunque accettato di non alzare troppo i toni), la Cgil resta molto critica. Ieri la segretaria Susanna Camusso ha confermato tutti i dubbi e le critiche del sindacato sul provvedimento. del 04/04/14, pag. 9 Camusso attacca Poletti: cooperative legge da rifare Duro intervento del leader Cgil contro le coop spurie che aggirano regole, contratti e diritti ● Il decreto lavoro? «Assurdo dire che c’è poca flessibilità: ci sono aree vicine allo schiavismo» Silvia Gigli Troppe false cooperative nel mondo della logistica e dei trasporti. Troppe regole violate e dumping sulle condizioni di lavoro ai danni dei dipendenti, troppi casi di criminalità organizzata che si insinuano nelle pieghe di una legislazione non più all’altezza. Susanna Camusso non usa la mano leggera. Al X congresso nazionale della Filt Cgil, in corso a Firenze, il segretario della Cgil chiede esplicitamente «una nuova legislazione sulle cooperative». Lo chiede direttamente al ministro del lavoro Giuliano Poletti che, invitato ai lavori del congresso, non è potuto intervenire. Glielo chiede soprattutto perché fino a poche settimane fa Poletti era presidente della Lega nazionale delle cooperative e come, tale, secondo Camusso, avrebbe dovuto vigilare forse un po’ di più sul fenomeno delle coop spurie. «Ci dispiace che non sia potuto venire - ha esordito -. Ci avrebbe fatto piacere discutere con lui non solo come ministro del welfare ma come ex presidente della Lega delle cooperative. Noi veniamo da una storia comune di mutualismo e di solidarietà e continuiamo a pensare che la cooperazione sia un mondo da salvaguardare che non può confondersi con chi usa il costo del lavoro come unica variabile economica. Questo dovrebbe essere un suo quotidiano cruccio e una battaglia continua ». Ma così a quanto pare non è stato. «Avrei voluto davvero che il mondo della cooperazione fosse stato il primo a firmare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore (che è scaduto da sette anni ndr) perché solo il contratto nazionale può davvero garantire i lavoratori - ha continuato Camusso - . Ogni tanto bisogna che sia il sistema ad osare, non si possono lasciare solo i lavoratori a difendere quella grande ricchezza che è il lavoro». Per il segretario Cgil però non è troppo tardi: «serve un cambio di passo, un salto di qualità, ci vuole una nuova legislazione sulle cooperative. Se c’è stato un moltiplicarsi di forme false o spurie che teoricamente danno lavoro ma che non rispettano le regole formali c’è un buco nella legislazione. Chiediamo che sia una delle priorità». Ma Susanna Camusso non esita a ribadire la propria contrarietà, e quella della sua organizzazione, ad una visione del mondo del lavoro che cerca sempre di far profitto ai danni di chi lavora. Il messaggio chiaro e forte è ovviamente rivolto al governo Renzi al quale il segretario Cgil fa sapere, tra gli applausi della sala rossa del Palazzo dei Congressi, che «anche se in questi giorni non siamo ascoltati nelle forme tradizionali, un’organizzazione come la nostra sa come far 39 sentire la propria voce». «Il messaggio che si dà in questi giorni - sintetizza Camusso chiosando le ultime uscite di Palazzo Chigi - è quello di venire a investire in Italia, perché i contratti a termine si possono rinnovare fino a otto volte in tre anni». L’ennesima conferma che un certo tipo di politica vede solo nella precarizzazione portata all’ennesima potenza una via d’uscita alla crisi. Il riferimento è alla recente dichiarazione del premier Renzi che aveva affermato che in Italia c’è «un sistema che manca di flessibilità». «MI VENGONO I BRIVIDI» «Quando sento dire che il problema è che c’è poca flesibilità mi vengono i brividi - ha ribattuto Camusso - Non c’è un futuro di crescita se non c’è un significativo investimento industriale sulla capacità manifatturiera del Paese e invece in molte categorie cominciamo ad avere delle aree con schiavismo, anche perché tante volte incrociamo situazioni che sono organizzate per caporali, con forme di ricattabilità». Non solo. Non c’è un futuro di crescita se non si cambiano una volta per tutte le regole sugli appalti. «Dobbiamo farci promotori di una proposta di legge che ridefinisca tutto il settore e che metta al riparo il lavoratore dall’esserne l’unica vittima. In qualche caso c’è la netta sensazione che non ci sia un vantaggio imprenditoriale ma solo il vantaggio che se esternalizzi puoi fare un appalto al massimo ribasso». Il settore dei trasporti e della logistica, con il suo mondo imprenditoriale così frammentato e con una grossa fetta di manodopera straniera, spesso priva degli stessi diritti degli altri lavoratori, è un laboratorio interessante per capire i fenomeni della precarizzazione e delle esternalizzazioni. Il lavoro nero non emerge perché alla fine, per quelle due lire che li pagano, ai datori di lavoro conviene assumere. Tanto l’ingaggio è legato all’appalto. Una volta finito, tutti a casa. De 04/04/2014, pag. 1-10 LA BCE POTREBBE CREARE MONETA, SPREAD GIÙ Deflazione, Draghi pronto alla svolta ROBERTO PETRINI ROMA. La banca centrale europea dà i primi segni di voler reagire al rischio di deflazione in Europa. Se necessario, anche ricorrendo a leggeri prelievi sui depositi delle banche commerciali presso l’Eurotower o la creazione di moneta per comprare titoli sul mercato. Mario Draghi ha detto però che la banca centrale aspetta altri dati prima di decidere se e cosa fare. Lo spread Bund-Btp a dieci anni è caduto a 165 punti. MARIO Draghi, il presidente della Bce, per la prima volta alla fine del Consiglio direttivo ha lasciato intendere che l’Eurotower non esclude più di creare moneta per lanciare acquisti di titoli sui mercati, cercando di riportare l’inflazione a livelli più sani. Allo stesso tempo, il presidente italiano dell’Eurotower ha mostrato tutto il suo fastidio per la pressione che gli arriva da ogni parte perché faccia qualcosa, da quando sui prezzi nel continente è scesa una gelata. Lo si è capito quando qualcuno gli ha chiesto delle critiche per l’inazione della Bce arrivate da Christine Lagarde, direttore del Fondo monetario internazionale. Almeno in pubblico, di solito Draghi non rivela tutti gli spigoli del suo carattere ma stavolta ha scelto di farlo: «L’Fmi è stato estremamente generoso nelle sue opinioni su quello che dovremmo e non dovremmo fare», ha osservato. Prima di aggiungere, tagliente: «Vorrei che fosse così generoso anche con altre giurisdizioni, per esempio intervenendo con un comunicato il giorno prima di un consiglio della Federal Reserve». Con la Bce è successo, mentre l’Fmi per lo più evita attentamente di commentare le scelte delle autorità americane. Ma nelle parole di Draghi su Christine Lagarde, ieri, alcuni hanno letto anche una fonte 40 specifica di irritazione: la leader francese del Fmi conduce la sua personale campagna per diventare presidente della Commissione Ue, come terza forza in caso di pareggio alle europee fra i candidati del popolare e partito socialista europeo. E né Draghi né la Bce sono felici di farsi trascinare in quella corsa, nelle vesti di bersagli di critiche utili a guadagnare visibilità e prendere posizione. Lagarde però non è stata la sola a mettere pressione sulla Bce nell’ultimo mese. I prezzi in area euro crescono a marzo a un ritmo annuale dello 0,5%, in continua frenata. Dinamiche del genere rischiano di scoraggiare i privati dai consumi o degli investimenti e ieri Draghi stesso ha sottolineato che è più difficile ridurre i debiti, quando l’inflazione è così bassa. Per la prima volta, il presidente della Bce ieri ha parlato in un modo che sarebbe stato impensabile con i predecessori Wim Duisenberg o Jean-Claude Trichet. Lo ha fatto quando ha confessato che la sua «paura più grande»: essa «è già diventata realtà in una certa misura ed è una stagnazione protratta, più a lungo di quanto abbiamo nelle nostre previsioni ». In uno stallo dell’economia e dei prezzi di questo tipo, ha continuato il presidente della Bce, la disoccupazione «diventa più difficile da ridurre, o da ridurre misure convenzionali ». Mai in passato un presidente dell’Eurotower era arrivato così vicino alla visione americana, che con le mosse della banca centrale cerca di sostenere anche l’occupazione. Per la prima volta Draghi ha anche detto esplicitamente che fra queste misure «non convenzionali » ci sono anche possibili acquisti di titoli sul mercato da parte della Bce. Il banchiere centrale ha fatto capire, se sarà il caso, guarda più a portafogli compositi di obbligazioni private (di banche o imprese) che a titoli di Stato: il cosiddetto quantitative easing sembrava impensabile fino a pochi mesi fa e lo stesso Draghi ha detto ieri che fino a un mese fa il consiglio direttivo della Bce non ne aveva parlato. Non sarà imminente comunque, perché prima di arrivarci l’Eurotower può tentare altri passi meno eterodossi. Può per esempio ridurre i tassi al punto che le banche dovranno pagare loro stesse un interesse, per tenere i propri fondi depositati in Bce invece di impiegarli. Draghi in ogni caso ha avvertito che la Bce vorrà disporre di altri «punti di osservazione » prima di decidere qualunque cosa: significa che passeranno probabilmente almeno altri due mesi e, con essi, il giro di boa delle elezioni europee. E anche se i dati confermeranno che l’inflazione è troppo bassa e può diventare deflazione, per l’Eurotower gli interventi restano molto più complessi e forse meno efficaci di quanto sia stato negli Stati Uniti. In primo luogo perché le imprese in Europa si finanziano presso le banche e non sul mercato, come ha deliberatamente ricordato ieri Draghi stesso. Quindi perché le resistenze restano in Germania restano potenti. Non è un caso se ieri gli spread sono caduti, ma l’euro si è appena mosso. Per ora la Bce ha sopperito a un altro mese di inazione con nuove parole, sempre più forti. Ma ora il mercato le chiede, sempre più forte, «Show me the money». Del 04/04/2014, pag. 1-10 La bancarotta del risanamento Pensioni. Siamo indebitati, bisogna tagliare. Anzi «risanare». Allora non c’è bancomat migliore Alberto Burgio Ieri il manifesto ha pubblicato gli ultimi dati Istat sulle pensioni, che hanno suscitato il solito corteo di reazioni. Ci si indigna, si spergiura che le pensioni questa volta «non si toccano». Sta di fatto che sette milioni di pensionati (il che non di rado significa sette milioni di famiglie) campano – si fa per dire – con meno di mille euro al mese, e che altri quattro milioni stanno sotto i 1500. Soltanto un terzo dei pensionati italiani supera questa soglia, che, se 41 per un verso può apparire di per sé accettabile (la media degli stipendi italiani non ci arriva, nemmeno nel caso di dipendenti maschi indigeni, che guadagnano il 20% in più delle donne e il 24% in più degli stranieri), per l’altro resta bassissima, dato il costo reale della vita, che cresce a ritmi sostenuti nonostante l’inflazione sia ufficialmente prossima allo zero. Si può cambiare finché si vuole la composizione del paniere, si possono anche considerare nel modo dovuto i servizi essenziali. Ma la miscela tra il taglio delle pensioni e il progressivo smantellamento del welfare a cominciare dalla sanità pubblica sfugge al computo. Per non parlare di quei servizi che non sono mai di fatto entrati nel servizio sanitario nazionale, come l’assistenza odontoiatrica. Servizi che con l’avanzare dell’età diventano vitali. Senza contare un’altra cosa, di cui troppo spesso non si parla. C’è un’altra miscela, davvero esplosiva. Quella tra pensioni e disoccupazione o sottooccupazione. Quanti vecchi ormai sono costretti a mantenere i giovani in Italia, direttamente (i figli) o indirettamente (i nipoti) che non trovano lavoro o guadagnano salari da fame? Si diceva prima degli stipendi medi italiani, inferiori ai 1500 euro (in realtà, ai 1300). Ma «naturalmente» i giovani prendono molto meno. La paga media di quei pochi che hanno la fortuna di trovare un impiego stabile supera appena gli 800 euro, con picchi negativi nel Sud, nel terziario e, nuovamente, per le donne. Senza contare la prateria del sommerso, che si espande a vista d’occhio, di pari passo con l’aumento della disoccupazione. Questa è la verità, alla luce della quale si dovrebbe fare una buona volta un bilancio delle «riforme» delle pensioni, da Dini a oggi. Cosiddette riforme promosse, guarda un po’, sempre da super-pensionati aurei in flagrante conflitto d’interessi. Che, nel nome della sicurezza dei conti pubblici, si sono fatti sempre anche gli affari propri e dei loro simili, senza battere ciglio. Tutto questo per quale ragione, considerato che il bilancio dell’Inps al netto delle spese assistenziali non è mai stato in rosso? La risposta è la solita. Siamo indebitati, bisogna tagliare. Anzi «risanare». Allora non c’è bancomat migliore delle pensioni, che sono una grossa fetta della spesa e vanno perlopiù a cittadini con poco potere contrattuale. Sono almeno vent’anni che si spacciano per previsioni diagrammi addomesticati che mostrano come senza ridurre la spesa pensionistica lo Stato andrebbe in bancarotta. Il risultato è questo. Che in bancarotta ci siamo per davvero, e proprio grazie ai tagli e al «risanamento». Ma sbaglierebbe chi pensasse che siamo in mano a una manica di incompetenti, a dilettanti allo sbaraglio. Non è così. Chi ci ha governati in questo ventennio post-costituzionale e chi ancora oggi ci governa – non importa se di centrodestra o di centrosinistra – ha dimostrato di sapere il fatto suo. C’è non soltanto del metodo, ma anche molta consequenzialità e coerenza. Grazie al tanto celebrato bipolarismo, che in realtà è soltanto un centralismo mascherato. Gramsci in carcere, quando cercava di capire come funzionava il corporativismo fascista al di là della fanfara pseudo-fordista, si convinse che la sostanza della politica economica del regime consisteva nella protezione della rendita finanziaria medio e financo piccolo-borghese, ma soprattutto «plutocratica». Se guardiamo alla recente storia repubblicana, la diagnosi mantiene tutta la sua attualità. Quando si parla di debito pubblico, non si parla della gigantesca evasione ed elusione fiscale. Quando si parla di evasione fiscale, magari per criticarne la repressione nel nome di un realismo economico d’accatto, non si parla di debito pubblico. E mai ci si sofferma sulle cause di un debito privato particolarmente contenuto. Come se i vasi non comunicassero. Il risultato è che il debito viene imputato solo alla spesa e che l’unica sedicente politica economica consiste nella sua riduzione e nell’aumento della pressione fiscale sui dipendenti. Con le conseguenze rovinose che vediamo. Siamo di gran lunga il paese più iniquo e corrotto dell’Europa forte. Col record (oltre che dell’evasione fiscale) dei bassi salari, delle ore lavorate, delle disuguaglianze, della precarietà. Nonché quello che destina 42 meno risorse al sostegno del reddito e alle misure di contrasto della povertà. E che regala più soldi alle imprese private. Metà della capitalizzazione della Fiat, che nel frattempo se n’è andata dove più le conviene, è fatta di capitale pubblico. Come nell’altro ventennio, quando c’era Lui, piove sul bagnato. Chi ha già molto, accumula a spese dei moltissimi che hanno sempre meno. La qual cosa è, oltre che iniqua, anche irrazionale. Non da un punto di vista bolscevico, ma in un’ottica di buon governo «progressista». Difatti stiamo rapidamente scivolando verso la periferia dell’Europa, per non dire tra le sue colonie interne. Quanto all’iniquità, è diventata un tabù. Negli anni Ottanta, mentre si preparava l’eutanasia del Pci, si cominciò a parlare di giustizia sociale in termini diversi da quelli della tradizione marxista. Si smise di ragionare di classi e di conflitti, e si assunse la prospettiva della filosofia politica anglosassone. Fu un’operazione a perdere come si è visto, ma allora di giustizia almeno si parlava. Oggi il tema è derubricato. Bisognerebbe chiedersi una buona volta perché. E domandarsi se la giustizia sia un lusso per anime belle o un ingrediente della democrazia. Se la Costituzione possa essere rispettata quando la giustizia sociale è calpestata. E se abbia senso definirsi «riformisti» (non parliamo, per carità, di sinistra) mentre si contribuisce alla sua liquidazione. del 04/04/13, pag. 9 «Investimenti, lavoro, equità»: oggi protesta europea Marco Mongiello Oggi a Bruxelles ci saranno anche i lavoratori italiani a sfilare nel corteo organizzato dai sindacati europei per protestare contro le politiche di austerità. A poche settimane dalle elezioni del 25 maggio la Confederazione dei Sindacati Europei (Ces) ha deciso di riportare i temi sociali al centro del dibattito. «Una nuova strada per l’Europa » è lo slogan della manifestazione scritta sui volantini e rappresentata da una grande freccia che indica la via d’uscita dalla crisi e verso «investimenti, occupazione di qualità ed eguaglianza ». Nella capitale belga si attendono almeno 40.000 manifestanti provenienti da 21 Paesi europei. Dall’Italia hanno aderito all’evento Cgil, Cisl e Uil. Il corteo attraverserà la città e arriverà nel primo pomeriggio nel parco che costeggia le istituzioni europee e dove a quell’ora i funzionari in giacca e cravatta della Commissione approfittano della pausa pranzo per prendere un po’ di sole primaverile. Anche a loro i sindacalisti ricorderanno che per milioni di senza lavoro in Europa l’inverno della crisi sembra non finire mai. «Noi nel movimento sindacale non pensiamo che la crisi sia finita - spiegano al Ces - quello che dobbiamo chiederci è chi è fuori dai guai? Il sistema finanziario o le persone?». Nelle settimane scorse la Confederazione dei Sindacati Europei (ETUC nell’acronimo inglese), che rappresenta 85 sigle sindacali provenienti da 36 Paesi, ha approvato un documento in cui chiede ai governi europei un corposo piano di investimenti. Dopo cinque anni di crisi, si legge nella proposta della Ces, «vi è un urgente bisogno di prendere una nuova direzione, per ristabilire la situazione economica e creare posti di lavoro di qualità in un’Europa sociale». Da qui la proposta del sindacato europeo di «avere una prospettiva a più lungo termine » che deve passare attraverso «necessari investimenti massicci per dare alle nostre economie un nuovo inizio, basato sulla crescita sostenibile». Nel dettaglio la Confederazione europea propone «un obiettivo di investimento annuo del 2%del Pil dell’Unione europea per un periodo di dieci anni. Questo avrà l’ulteriore effetto di aumentare gli investimenti privati e di promuovere misure private di modernizzazione su 43 vasta scala. Tali investimenti potrebbero aiutare a costruire una forte base industriale, servizi pubblici di qualità, sistemi pubblici efficienti, con sistemi di welfare inclusivi, ricerca ed istituzioni educative innovative». In un video postato su Youtube e sul sito del Ces il Segretario generale dei sindacati europei, la francese Bernardette Ségol, spiega le ragioni della manifestazione: «L’austerità non sta funzionando, più di 26 milioni di europei sono senza lavoro, 10 milioni di più rispetto al 2008, 7,5 milioni di giovani non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione e in 18 su 28 Stati membri dell’Ue i salari sono crollati. In Grecia sono il 23% rispetto a cinque anni fa e 5% in meno in Gran Bretagna». Quindi, conclude Ségol, «l’Europa ha bisogno di una nuova strada e di un ambizioso programma di investimenti per creare posti di lavoro e crescita. Per questo migliaia di sindacalisti provenienti da tutta Europa dimostreranno a Bruxelles. Noi chiediamo al nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio, e alla nuova Commissione di prendere una nuova strada». Secondo il responsabile del segretariato Europa della Cgil, Fausto Durante, quella di oggi è un’iniziativa «giusta e importante, da sostenere con l’impegno e la partecipazione attiva di tutti i sindacati europei, affinché i temi dell’Europa sociale e del lavoro siano riportati al centro della discussione». 44
Scarica