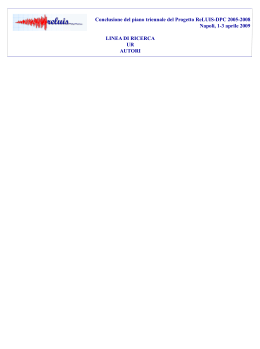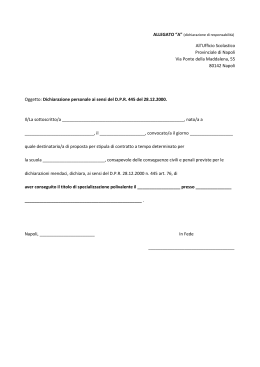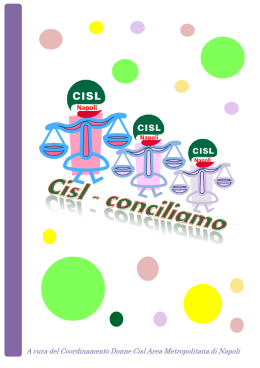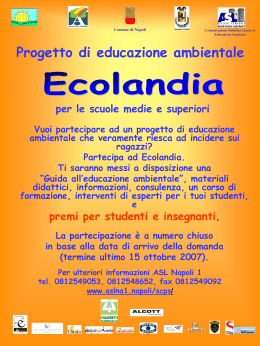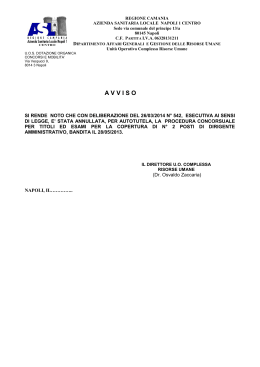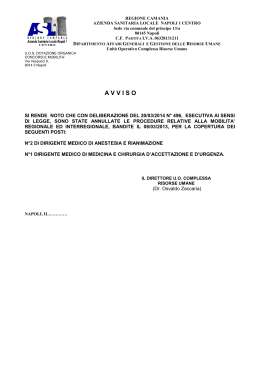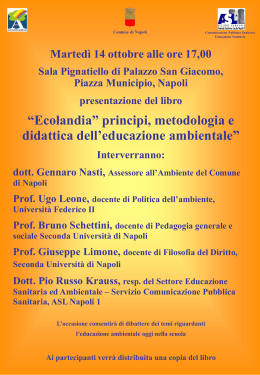fondato e diretto da Carmine Zaccaria n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida Anno XVI di Carmine Zaccaria l Presidente Napolitano non ha bisogno di difendersi, meno che meno di difese altrui. Non ha nulla da chiarire e niente da dire fuori dal contesto istituzionale. Giorgio Napolitano è uno statista, uno dei pochi che abbiamo in Italia. Forse non meritiamo un Presidente di questa statura politica, di quella dirittura morale. Il ritorno di un uomo politico che da tempo non è uomo di partito forse disturba i poteri sporchi che si annidano nei risvolti dei pantaloni di un Paese in cerca d’identità. Forse andavano bene ex banchieri, per carità degne persone, ma che in politica, quando è andata bene, non hanno combinato niente d’importante. Il punto massimo (si fa per dire!) lo abbiamo raggiunto con Padoa Schioppa, figlio d’arte, allevato all’ombra familiare delle grandi assicurazioni per passare alle grandi banche e poi su, fino alle stanze ovattate dei ministeri. Un uomo che dalle prime poppate ha succhiato affari e finanza. Che vita comoda, beato lui! Anche se la Cina non era e non è un modello, pensiamo che a Padoa Schioppa non avrebbe fatto male un poco di rieducazione nelle campagne a zappare la terra. E forse non solo a lui. Ora ci riprovano con Draghi. Un’ascesa di Draghi alla Presidenza del Consiglio qualificherebbe definitivamente, in senso negativo, il personale politico della politica italiana. Sarebbe un atto grave. Di questo sì, chiederemmo conto al Presidente Napolitano. In assenza di un centro sinistra di governo, che per ora non fa bene nemmeno l’opposizione, strane forze e nuove aggregazioni muovono alla conquista del potere in Italia. In corso c’è l’attacco all’Eni, una delle poche realtà che pensa ai destini futuri del Paese. Il tentativo di smembrar- I Segue a pag. 2 L’attore napoletano sarà impegnato con diversi spettacoli a Palermo fino a maggio 2010 NELLO MASCIA “Il teatro napoletano è l’unico che continua a produrre nuovi talenti” ^ DRAGHI? NO, GRAZIE di Paolo Montefusco ’ uno che ha vissuto da protagonista il Teatro di Eduardo. Testimone diretto dell’arte del Maestro, Nello Mascia ha fatto di quella pur breve esperienza (“Il Sindaco del Rione Sanità”, “Gli esami non finiscono mai”) un mattone importante della sua vita di attore e regista teatrale. Vita teatrale che porta avanti in maniera instancabile e che lo vede oggi impegnato a Palermo al Teatro Biondo con tre spettacoli. Allo stesso modo, forte è sempre stato il suo modo di sentire il teatro di un altro grande autore napoletano, quel Raffaele Viviani che meglio di chiunque altro ha raccontato il popolo di partenope. Tutti ricordiamo le magnifiche interpretazioni di Mascia in testi come “L’ultimo scugnizzo” o “Fatto di cronaca”. Appassionato della drammaturgia di E Cechov, Nello Mascia è una maschera capace di un impatto immediato sul pubblico, con una recitazione a volte splendidamente sopra le righe. L’attore napoletano ci regala i suoi pensieri in una lunga intervista con l’umanità, la saggezza e a volte l’ironia di cui é capace. Maestro, parliamo subito dei tuoi imminenti impegni di lavoro. Sappiamo che sei allo Stabile di Palermo e non è una All’interno Intervista a Barbara Balzerani L’epica dell’immigrazione L’arte positiva di Spiridonov La strada maestra dell’Est Negli occhi di Vittorio Mezzogiorno Intervista a Mario Porfito Erri De Luca vent’anni dopo Il sogno sax di Marco Zurzolo pag. 3 pag. 5 pag. 7 pag. 9 pag. 11 pag. 13 pag. 14 pag. 15 Spedizione in abbonamento postale 45% Art. 2 Comma 20/b Legge 662/69 Direzione Commerciale Imprese Campania. Giornale per l’estero: Tassa pagata, taxe percue/Economy/Compatto novità. Cosa porterai in scena? Infatti, non è una novità. E’ da un po’ di tempo che lavoro a Palermo, al Teatro Biondo, e ne sono felice. Farò tre spettacoli: “Le sedie” di Eugène Ionesco, con Galatea Ranzi, “La locandiera” e “Amleto”. Voglio aggiungere che il “Piccolo” di Milano per i cento anni dalla nascita di Ionesco farà una serata evento portando in scena appunto “Le sedie”, e che sarà l’unica commemorazione in Italia. Domanda ricorrente ma a te proprio non possiamo non farla. Piedigrotta a Napoli: tu hai riproposto uno spettacolo bellissimo di Raffaele Viviani. Cosa rispondi alle polemiche sugli eventuali sprechi? Vedi, non ho approfondito molto. Quello che mi sento di dire è che la Piedigrotta è un grande logo e se intorno a questo logo si costruisce un evento di carattere nazionale, da un punto di vista artistico, che lo rende esportabile, ben venga. Perché no. Napoli ha bisogno di riprendere il suo posto nell’ambito delle grandi città culturali del mondo. Con Elton John non so se ci sono stati sprechi, di sicuro c’è stato un grande ritorno d’immagine, parliamo di una grande star non dimentichiamocene. Gli sprechi sono nell’ostinazione di voler mettere persone in posti che non meritano di occupare, dove non c’è merito c’è spreco. Nove anni fa ti chiedemmo qual era lo stato di salute del teatro napoletano. Rispondesti che stava bene perché abbiamo i migliori attori. Confermi quella risposta a distanza di tanti anni nonostante il naturale cambio generazionale? Sicuramente. Anzi nel frattempo abbiamo “prodotto” fenomeni come Toni Servillo per esempio, ma anche altri. Io penso che Napoli sia costantemente vivace e che faccia senza dubbio da traino al teatro nazionale. Eppure i cartelloni teatrali negli ultimi tempi sembrano preferire i comici sdoSegue a pag. 6 2 DRAGHI?... Segue da pag. 1 la, anche se non riuscito, desta ancora preoccupazione. Berlusconi dice il vero quando parla di forze estranee e straniere che tentano di piegare l’Italia. Anche Draghi dovrebbe avere qualcosa da dirci, visto che è stato gradito ospite alla corte della Regina d’Inghilterra sul panfilo Britannia. In quel contesto è stata decisa la svendita del nostro Paese. Certo l’attuale Governatore è sceso prima che la nave prendesse il largo, ma poco importa. Vorremmo sapere cosa ha detto e ancor più cosa gli hanno detto, prima di scendere, i padroni del Vapore. Poco c’interessa se non si è trattenuto a bere il Tè delle Indie con gli amici inglesi in compagnia di convitati di pietra e non. Su tutto questo aleggiano i padroni di Soros, condannato a morte in Malesia per aver speculato al ribasso sulla moneta locale. Il compito e l’onere di mettere la parola fine a questa storia spetta al Presidente Obama. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’Opera. Obama ha cominciato bene chiudendo il discorso del posizionamento di radar e missili in Centro Europa, ma dell’opera è appena all’inizio. C’è da dire che quella dei radar era solo una delle tante cose sbagliate o interessate pensate da Bush&soci. L’ex presidente ha avuto una vita travagliata e forse prendeva queste decisioni in momenti particolari, mediati da vecchi ricordi del suo passato. Obama ha fatto meno della metà del suo dovere verso l’America e verso il mondo ritirandosi in buon ordine. Poiché ha ricevuto un premio Nobel preventivo adesso dovrebbe fare, per guadagnarselo, qualcosa di più guardando verso la Pace. Dovrebbe smantellare quelle che sono le Centrali della Destabilizzazione che si nascondono nei risvolti più segreti dei Servizi Segreti Usa. Quando questi uffici riservati smetteranno di dar fuoco alle micce in Centro Europa e in altri luoghi del mondo deputati a essere terreno di n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida scontro per motivi geopolitici e/o geoeconomici, allora avrà fatto un passo significativo verso la Pace. Il Premio Nobel che gli è stato assegnato in Svezia, in malafede o in tremendo anticipo sulla Storia, comincerebbe a essere suo veramente. Delle escort di Berlusconi, dei deliri di un imbolsito Santoro di Anno Zero (ma come ha fatto a fare questa fine?) sinceramente poco c’interessa. Ne avremmo fatto volentieri a meno. ***** In terza pagina il nostro giornale intervista Barbara Balzerani e questa scelta non può restare senza un commento. Commentare, fare domande è un terreno irto di pericoli e ostacoli. Anna Montefusco, nell’intervista che apre la recensione del suo ultimo libro, fa un’affermazione in forma di domanda: tu non sei una scrittrice qualunque. La risposta è poco più giù: è quasi una bestemmia la tua, quando mi definisci scrittrice. Infatti è un ruolo negato quello di scrittrice, da quasi tutta la grande critica, da quasi tutta la grande stampa. Come potrebbe essere una scrittrice qualunque dopo anni 21 di carcere, lunghi periodi d’isolamento e una condanna per l’omicidio Moro e della sua Scorta. Scrive in pochi mesi “Compagna luna” nella sua casa dopo il carcere, un libro pensato proprio appena i cancelli si sono chiusi alle sue spalle, questa volta con lei verso un mondo ritrovato ma definito irriconoscibile. Balzerani scrive: Quel libro è intriso di un dolore senza speranza, di un senso di solitudine piena, di uno stupore spaurito, di domande che non si aspettavano univocità di risposte, come la politica mi aveva abituata. E poi, nel nuovo libro “Perché io, perché non tu”, il naufragio del cuore nelle terre di Basilicata: la sovranità di madre terra sulle opere umane, silenzi, spazi di solitudine e la salvezza che c’è ancora se arretriamo tutti e ci fermiamo ad ascoltare. Com’è lontano tutto questo dal crepitio delle mitragliatrici. NON VOGLIO PENSARE, DUNQUE SONO La filosofia cristallina di Renè Descartes e il lassismo di pensiero della società contemporanea di Giuseppe Franza na delle peculiarità del pensiero del grande filosofo René Descartes (latinizzato come Cartesius) è la splendida chiarezza con la quale la riflessione esprime se stessa. La sua filosofia, per quanto complessa, viscerale e segnata da alcune mistificabili aporie, giunge a noi in modo così cristallino e inequivocabile da eludere a priori qualsiasi fraintendimento (se non di natura opportunisticamente retorica o faziosa). Il filosofo di La Haye diede origine ed espresse ogni sua meditazione attraverso coordinate fondatamente fisse al punto di fuga dell’evidenza. Eppure nel corso della storia abbiamo assistito a molte interpretazioni critiche, riconciliazioni, sconfessioni e rivalutazioni del pensiero cartesiano. Ciò è stato possibile in quanto la stessa autenticità teoretica cartesiana, intesa come ricerca metodologica ed esistenziale del principio universale della verità umana, resta fedele e coerente alla natura dell’uomo, ovvero alla sua infinita e opaca ambiguità. Alcuni critici, ad esempio, sostengono che tutta la filosofia moderna e contemporanea francese, dal ‘600 a oggi, sia inequivocabilmente una filosofia di matrice cartesiana e che le varie e opposte correnti di pensiero sviluppatesi non siano altro che diverse forme di cartesianismo, più o meno consapevoli. D’altra parte è impossibile non affrontare problematicamente il pensiero dell’iniziatore del razionalismo moderno, che fondò il suo metodo scientifico e filosofico basandosi sul metodo matematico, che meditò sul problema della certezza del proprio pensiero e della propria esistenza, arrivando poi a giustificare l’essere del mondo e a riconoscere l’esistenza di Dio (attraverso la prova ontologica), che postulò il suo criterio di verità in base all’innatismo delle idee e alla separazione (o meglio differenziazione) tra pensiero e materia e, così quasi a tempo perso, tra la scrittura di un capolavoro della letteratura filosofica e l’altro, fondò la geometria analitica, studiò il cosmo, il corpo umano, la psicologia e la musica umana. Descartes, come Platone e Cristo, è padre del nostro stesso pensiero. Volenti o nolenti, scopriremo in noi molte delle verità teorizzate dal filosofo francese. Il problema, naturalmente, resta quello di capire quanto Descartes abbia intuito (o svelato) della nostra verità, o quanto abbia costruito a posteriori, spingendo poi l’umanità a fare propri suoi sistemi di interpretazione e spiegazione della realtà come i più opportuni, affascinanti o compatibili da interiorizzare. Così, pare che del pensiero cartesiano non potremmo mai più liberarci, specificatamente a causa di uno dei motti più incisivi e esplicativi della storia della cultura umana: cogito ergo sum. La potenza e il fascino di questa proposizione fondamentale, per la vita, per la coscienza e per il senso del soggetto, vicino o lontano dall’oggetto esperibile, è principio di capogiri e illuminazioni, evidenza e paradossalità. In vero Descartes, legando e giustificando la veridicità e il senso della vita prima al dubbio e poi al pensiero in generale, non fece nulla di così rivoluzionario. Già il pensiero greco, in molti casi, e nel Medioevo Sant’Agostino, risolsero l’esistenza nel cogito e posero il prin- U Un ritratto di Renè Descartes cipio del sapere nella meditazione. Descartes ebbe il coraggio, o la geniale presunzione, di caricare il senso di questa supposta evidenza esistenziale fino allo spasimo teoretico. Muovendo dalla critica del sapere ricevuto, il filosofo si accorse si vivere nell’opinione, ossia al di fuori di ogni certezza assoluta. Giunto allo scetticismo, il pensatore seppe andare avanti, accettando che nella vita nulla ha senso assoluto o una garanzia di verità, neppure la vita stessa. Quella che intendiamo come la nostra vita potrebbe non essere vita, ma un errore d’interpretazione, un inganno o una bugia. Descartes drammatizzò questo dubbio nella favolosa ipotesi di un genio malvagio (Dio, l’inconscio?) che ci illude o ci abbaglia, come in un sogno, o in un incubo, dove vediamo, sentiamo e percepiamo, ma dove nessuna di queste sensazioni può dirsi reale. Di cosa possiamo, quindi, essere sicuri? Dove muore il dubbio? Per Descartes è impossibile dubitare del fatto che stiamo dubitando, che nel perderci in allucinazioni paranoiche non facciamo altro che immaginare e congetturare, e che cerchiamo di capire, ossia non si può dubitare del pensiero, che con la sua incessante e inarrestabile attività vivifica e significa l’uomo. L’esistenza è, dunque, giustificata dal pensiero. Non da cause trascendenti. Descartes, da sincero cristiano e uomo di mondo (che tutto voleva tranne che finire inquisito), difese la dottrina cristiana e fornì alcune dimostrazioni (inevitabilmente zoppicanti) dell’esistenza di Dio, ma con il cogito oltrepassò il pensiero religioso e mise a fondamento della verità e dell’esistenza dell’uomo l’uomo stesso, la soggettività. Io penso e dunque esisto, nonostante Dio, al di là di qualsiasi ragione metafisicamente esterna alla vita. E fa strano detto da un uomo di scienza e di religione. Fu facile per Galileo ed epigoni intendere il mondo attraverso lo sguardo semplificatore del cannocchiale, ossia accogliendo come realtà solo quei fenomeni quantificabili e misurabili. Descartes, seppure affascinato dalle possibilità dell’oggettività della scienza moderna, accettò la sfida del soggetto, il mistero e l’assurdità dell’errore, fondando l’esistenza nel pensiero, che è calcolo, ma anche sentimento, desiderio, fantasia, intuizione, perversione e non senso. Oggi che il pensiero scientifico impera e impone i suoi limiti di oggettività e calcolabilità alla vita pubblica e privata, che la mediocrità culturale celebra nel lassismo intellettuale la sua spensierata attività in mode e abitudini e si bea del suo diventissement, dimenticando il pensiero o svilendolo nelle sue espressioni più funzionali, pratiche e debosciate, Descartes, con il cogito, si allontana inesorabilmente dalla coscienza dell’uomo. Fa paura e fa tristezza dedicare tempo ed energia al pensiero, ai suoi più alti e autentici (e dunque pericolosi e inutili) perché, visto che la vita non vuole altro che essere produttiva, esteriore, riscontrabile, godibile e vendibile. L’intellettuale, che è pur sempre un uomo, sceglie il pensiero debole e si adegua al gusto corrente, facendo il meno rumore possibile o nascondendosi nella torre d’avorio dello specialismo più astratto e inoffensivo. L’uomo comune pensa, ma quando inizia a pensare troppo corre da un terapeuta e si fa prescrivere un quietivo che lo rimbambisca. Si cura il corpo e quando si parla di benessere tutti pensiamo alla palestra fisica, alla dieta biologica o alla lampada abbronzante, come se l’essere, appunto, fosse solo il nostro corpo e il suo bene la bellezza esteriore. Un corpo senza pensiero, però, è un cadavere. Anche se vain palestra, compra vestiti e naviga su internet. L’uomo contemporaneo si impegna a reprimere, volontariamente o involontariamente, ogni eccesso cognitivo e disprezza chi pensa troppo, chi si esclude attraverso la noiosa riflessione. Diventa fondamentale imparare a pensare il meno possibile, adeguare il contenuto di questo pensiero al pensiero comune, che semplice e disponibile è la soluzione migliore a qualsiasi dubbio cartesiano. Non si tratta si recuperare la fiducia cartesiana nella supremazia della res cogitans: anche quando la sovranità assoluta dell’io penso è stata distrutta nel Novecento il pensiero continuava a esistere, per far esistere l’essere umano. Descartes, che di dilettò anche in tudi psicologici e antropologici, avrebbe sicuramente chiosato in maniera ironica tutta la situazione, affermando che non si ha più voglia di pensare perché probabilmente non c’è più manco troppa voglia di essere davvero: sarebbe troppo impegnativo. Meglio sopravvivere o sembrare. n° 10 - Ottobre 2009 3 sussurri & grida IL VIAGGIO DELL’ANIMA DELLA BALZERANI Barbara Balzerani “Perchè io, perchè non tu” è un percorso nella memoria, un tentativo di vedere meglio le prospettive facendo un passo indietro di Anna Montefusco arbara Balzerani non è una scrittrice qualunque. La materia prima dei suoi scritti trae linfa da un vissuto estremamente drammatico. Nel suo ultimo libro, “Perchè io, perchè non tu”, sono presenti duplici aspetti, in equilibrio tra pubblico e privato, che nutrono il suo viaggio nell’anima, un lungo ripasso tra presente e passato che lei racconta con una scrittura sempre asciutta. Barbara, nella bellissima introduzione di Erri De Luca c’è una frase che colpisce e che sembra contenere un fondo di rammarico: “Senza figli ci siamo tenuti in disparte dal seguito di noi stessi”. E’ una condizione che vi accomuna. Ma tu, da donna, come hai vissuto questa negazione? Come una mutilazione. Ho vissuto molti anni con l’angoscia che avrei perso gran parte di me il giorno che avessi dovuto definitivamente smettere di pensarmi madre. Proprio nel senso fisico di sentire una vita crescermi dentro. Poi quel giorno è arrivato e ho scelto di perdonarmi, per amore di quel figlio mancato a cui avrei imposto di condividere la mia vita a metà. Non so dirti che tipo di lacerazioni mi abbia lasciato dentro, ma non mi ha reso peggiore. Adoro i bambini, il loro odore e la loro determinazione a esserci. Sono contenta quando una donna mi annuncia la sua gravidanza. Mi intenerisce sempre vedere il suo corpo fare spazio a una nuova creatura. E la sensazione di “sterile vuotezza” che descrivevo in “Compagna luna” ha lasciato il posto a un indulgente senso di mancanza, come per ogni occasione che non poteva che essere persa. Ho spesso domandato agli scrittori che ho intervistato cosa muove la loro voglia di scrivere, a quale urgenza hanno risposto. Tu non sei una scrittrice qualunque e per questo potrebbe apparire una domanda banale. Ma voglio correre il rischio e te lo chiedo comunque: quando e perché hai iniziato a scrivere? A scrivere libri ho cominciato quando ho avuto anch’io “una stanza tutta per me”. Negli anni della militanza politica c’era tutt’altro da scrivere. In carcere ho scritto riflessioni, articoli, contributi al dibattito e una tesi di laurea enciclopedica. Ma sono state soprattutto le lettere, la scrittura più libera, più rispondente al mio stato d’animo. Poi ho ottenuto il “lavoro all’esterno”, un beneficio di legge che mi consentiva di passare alcune ore del giorno fuori B dal carcere. Parte di questo tempo potevo passarlo in quella che è stata la mia prima casa dopo circa vent’anni. Lì ho scritto, in pochi mesi, “Compagna luna”, il mio primo libro, quello che più di tutti mi ha dato la sensazione di essersi scritto da solo. Era già pronto, dopo tanti anni di introspezione e di disperata anestesia. E’ venuto fuori ai primi passi fuori dal cancello del carcere dove ritrovavo un mondo irriconoscibile. Quel libro è intriso di un dolore senza speranza, di un senso di solitudine piena, di uno stupore spaurito, di domande che non si aspettavano univocità di risposte, come la politica mi aveva abituata. E’ stato un viaggio interno senza cinture di sicurezza. E’ stato lo strumento per esprimere e lenire l’angoscia, senza timore di saperla ineliminabile. E’ stato la scoperta di poter entrare in comunicazione con tante persone anche molto diverse attraverso il linguaggio universale delle emozioni, della ricerca di senso del mistero che chiamiamo vita. E’ stato la mia terapia d’urgenza. “Perché io, perché non tu” è un viaggio nella memoria sgrossato da ogni facile personalismo. Tutto ciò a vantaggio di una disamina razionale, seppur dolorosa, perennemente in equilibrio tra pubblico e privato. Cosa resta alla fine di un simile percorso? Resta il rafforzamento di un pensiero che è ancora una speranza: riuscire a vedere meglio facendo un passo indietro. Proprio nel senso della profondità della prospettiva. Noi, ormai abituati ad avere in faccia il profilo del palazzo di fronte, all’oggi senza spessore temporale, ci affidiamo alla logica astratta o alle immagini di qualche schermo. Abbiamo smesso di sperimentare, di mettere in allerta la nostra capacità di conoscenza attraverso le corrispondenze dei sensi, non ultimo l’intimo sentire. Ci siamo spinti troppo avanti e abbiamo perduto le connessioni tra i nomi e le cose. Non basta correggere qua e là. Bisogna tornare lì dove è ancora possibile tornare. Non mi interessa la memorialistica che imbalsama il passato e ne fa motivo di rimpianto delle ragioni dei propri anni migliori. Mi interessa l’andirivieni della memoria in cui le storie delle persone in carne e ossa, anche quelle micro, offrono, magari attraverso gesti semplici, l’unico codice per interpretare il presente, la politica, la cultura. Persone di cui non si parla e che non hanno voce ma che sono il vero volto del bene e del male nel nostro mondo sazio e indifferente. E anche della misura delle più odiose ingiustizie e illibertà. E’ un modo di guardare partigiano che è una condanna perché ti inchioda a non distogliere lo sguardo, a porti domande, alla ricerca di senso. Non è facile affidare la conoscenza del mondo e di se stessi e la propria condotta agli strumenti della relazione empatica con la parte più debole. Ma sono i soli occhi che possiedo e non me ne lamento più di tanto. Dedichi molte pagine alla descrizione del microcosmo femminile all’interno delle carceri, in direzione soprattutto delle detenute comuni. Una umanità variegata verso la quale hai provato curiosità e compassione. Cosa ti ha lasciato? Paradossalmente io conosco poco il carcere, nel senso che la mia è stata quasi tutta una detenzione “speciale”, condivisa solo con prigioniere politiche. Le detenute “comuni” ho cominciato a frequentarle saltuariamente solo negli ultimi anni, quando ci hanno consentito di uscire dalla nostra sezione, per lavorare anche in altri reparti o per attività collettive. Poi, quando negli anni della “semilibertà” ho condiviso la sezione con le altre semilibere, anche comuni. Ma si è trattato di una convivenza parziale perché ci trovavamo insieme solo la sera prima di andare a dormire o nei giorni di festa che, nel regime del “lavoro all’esterno”, sono giorni in cui si resta in carcere. Le nostre diversità erano innegabili e si riflettevano palesemente nel modo di affrontare la galera. Anche per la differenza notevole degli anni da passare lì dentro. A questo proposito, all’inizio della nostra “normalizzazione” c’è stato un episodio significativo. C’era stata offerta la possibilità di spostarci nella sezione comune, per accelerare il processo delle “misure alternative” alla detenzione. Siamo andate a prendere possesso delle nostre nuove celle e ci siamo rese conto che non avremmo potuto sopravvivere in quel bailamme. Noi eravamo abituate a una “disciplina” che regolava le nostre attività giornaliere e non potevamo limitarci a “far passare il tempo”. Abbiamo fatto in modo di declinare l’invito a quel vantaggioso cambio, a costo di rallentare il processo di varcare la soglia. Non sentivamo il bisogno di quel tipo di contatto. E non per snobismo ma per la difficoltà di vivere le nostre differenze in uno stato di costrizione e restrizioni. Cosa mi ha lasciato? Il carcere è un grumo dei problemi sociali irrisolti e ignorati da una società impaurita e incattivita come la nostra. Ci puoi trovare un’ampia rappresentanza di poveri cristi, di migranti, di tossicodipendenti, di sofferenti psichici. Quel pezzo di umanità mi ha lasciato soprattutto la rabbia per il costo umano e sociale della fallimentare risposta detentiva alla sola illegalità che viene punita; la conferma del peso delle condizioni sociali nelle scelte di vita, troppo spesso obbligate; la verifica della corruzione dei comportamenti, da guerra tra poveri, lì dove diventa impossibile difendere uno straccio di dignità; ma anche la possibilità di conquiste impensabili di spazi di libertà interiori lì dove vige la mortificazione del corpo. In ultimo, mi ha lasciato il ricordo di una scoperta imbarazzante: quando ero in semilibertà non riuscivo Segue a pag. 4 il libro PERCHE’ IO, PERCHE’ NON TU - BARBARA BALZERANI - DeriveApprodi 2009 di Anna Montefusco Non è un qualsiasi percorso autobiografico quello contenuto in “Perché io, perché non tu”. Perché a dare voce al proprio vissuto è Barbara Balzerani, ex Brigatista rossa negli anni cosiddetti di piombo. Prendere le distanze da questo scritto ignorandone accuratamente l’esistenza e la lettura, come posizione a prescindere, nega la possibilità di ripercorrere un pezzo di Storia drammatica che ancora esige spiegazioni e analisi approfondite. Perchè se è vero che il punto di vista muove da una angolazione personale, è anche vero che la restituzione cronologica e oggettiva di alcuni degli eventi narrati allarga la visuale su fatti innegabilmente pubblici. Individuale rimane la lunga e dolorosa introspezione che Barbara Balzerani compie attraverso le sue interrogazioni, a sottolineare la necessità di risposte ad azioni che hanno cambiato il corso della sua vita e quella degli altri. Così come individuale sembra essere l’intenzione primaria che spinge la scrittura; l’autrice si tiene lontano dal mero computo degli anni di militanza prima e carcerazione dopo, a beneficio di un diario postumo, preferendo deviare su di una più intima ricerca della verità. Da consegnare, forse, più a se stessa. E’ un lungo viaggio a ritroso quello che compie, facendo soste nei luoghi della memoria a ripescare volti e odori antichi da mescolare a un vissuto più recente. Un lungo ripasso tra presente e passato con salti temporali che sfalsano la cronologia, a ripercorrere giorni di detenzione, di infanzia e di lotta armata. La scrittura rimanda l’inquietudine dell’io narrante; rimane asciutta, essenziale, forbita mai veramente rabbiosa. Diventa più docile, quasi poetica quando descrive lo smarrimento di un luogo metafisico, tappa ultima di un viaggio di ritorno nell’anima. Serve a descrivere la terra di Basilicata, la città di Matera, a seguire le orme di Carlo Levi e le proprie...... “ Comincio a riconoscere. La città mi parla ed è anche di me che dice. Sono dunque arrivata dove sarei dovuta tornare da tanto tempo? Come pensavo di sapere da così lontano? Avrei detto di non averla mai vista, eppure somiglia a mia madre, alla fatica che ho respirato dentro di lei, agli scatti di amor proprio ferito, al travaglio con cui mi ha dato la vita. Somiglia a quello che, dal primo sguardo posato, per me sarebbe stato il modo di guardare il mondo”. Un libro che rimanda una qualità letteraria indiscutibile, al di là dei contenuti che ognuno può leggere dalla distanza che più ritiene. Decidere di non leggerlo, non misura le distanze, le amplifica. 4 n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida SOLIDARIETA’ IN PRIMA LINEA ANCHE DA NAPOLI Ricordo della Neva Inaugurata nel cuore della nostra città una sede di Medici Senza Frontiere, l’organizzazione che da oltre trent’anni opera nelle emergenze sanitarie in contesti duri i è tenuta il 16 ottobre scorso l’inaugurazione della sede di Napoli, in Vico San Pietro a Majella, dell’organizzazione “Medici senza frontiere” (Msf) alla quale sono intervenuti Raffaella Ravinetto, presidente di “Medici senza frontiere Italia” e Renato Ippolito, coordinatore del gruppo di Napoli. Msf è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo creata da medici e giornalisti in Francia nel 1971. Ogni anno Msf fornisce assistenza medica di emergenza a milioni di persone che vivono situazioni di crisi in 62 paesi del mondo con 360 progetti. L’organizzazione fornisce assistenza medica quando i sistemi sanitari locali vengono sopraffatti da eventi catastrofici quali guerre, epidemie, malnutrizione o calamità naturali. Msf dà inoltre assistenza alle persone vittime di discriminazioni o negligenze da parte dei sistemi sanitari locali o alle popolazioni altrimenti escluse dall’assistenza sanitaria. Ogni giorno quasi 27.000 medici, infermieri, logisti, esperti di acqua e fognature, amministratori e altri professionisti qualificati sono al lavoro per fornire assistenza sanitaria, in équipe internazionali composte da operatori sanitari locali e dai loro colleghi provenienti da tutto il mondo. Nel 2008, i team di Msf hanno effettuato più di 8.810.000 visite mediche, curato quasi 1.200.000 casi di malaria, vaccinato più di 700 mila persone contro la meningite. La parola d’ordine dell’Associazione è neutralità, intesa come il diritto di chiunque, al di là di ogni distinzione di razza, religione e credo politico, di ricevere aiuto. Ciò grazie anche alla totale indipendenza da qualsivoglia potere politico o economico dell’or- S ganizzazione. Forte è pure la volontà di testimonianza delle difficili situazioni che i volontari di MSF trovano nei Paesi nei quali vanno a operare. La drammatica situazione creatasi negli anni in aree come l’Afghanistan, per esempio, li ha posti spesso sotto i riflettori. La presenza di volontari di MSF in così tanti contesti di violenza (opera in 90 paesi), di esclusione sociale, di emergenza sanitaria, di violazione del diritto internazionale, nei paesi poveri ma sempre di più anche nelle ricche nazioni del mondo industrializzato sottolinea la sempre crescente necessità di una sicurezza globale fondata sulla solidarietà e la giustizia. “Da oltre un anno” - ha scritto nei giorni scorsi Alessandra Tramontano, operatrice sanitaria di medici Senza Frontiere - esiste a Napoli un gruppo di volontari che svolge attività di sensibilizzazione. Siamo molto fieri di aprire una sede in una città come Napoli, da sempre dotata di forte impegno nell’associazionismo. Ci auguriamo di portare un contributo sulle tematiche dell’azione umanitaria al vivace dibattito culturale della città. L’idea è quella di dare vita a un luogo di incontro aperto, dove sia possibile ascoltare le storie e le esperienze degli operatori umanitari di ritorno dai contesti più diversi e allo stesso tempo sostenere le attività dell’associazione”. BALZERANI Segue da pag. 3 a capire la mentalità di donne che non riuscivano a rispettare gli obblighi e perdevano in fretta il “beneficio” dopo aver tanto penato per ottenerlo. Erano tutti in salita e col vento contrario quei percorsi giornalieri di vita a metà e di galera senza mura che ciascuna doveva auto imporsi. Basti pensare al rientro serale. Ma per me era assurdo non costringersi a riuscirci, nonostante spargesse sale su troppe ferite quotidiane. Finché non ho capito, e non è stato piacevole ammetterlo, che forse erano proprio quelle donne a essere più umanamente nel giusto, proprio per la loro istintiva incapacità di scendere a patti con la disumanità di quella vita spezzata. L’ultimo capitolo lo dedichi a un viaggio che va oltre la memoria. Sembra più un viaggio nell’anima. Ripercorri i luoghi che ospitarono Carlo Levi in esilio. Cosa ha spinto i tuoi passi in quella direzione? Si, quello in Basilicata è stato un viaggio nell’anima. Lì è nato il mio ultimo libro. Finché non ci ho messo piede non avevo capito che quella era la terra del ritorno all’inizio del mio lungo viaggio di vita. La prima volta, percorrendo la Basentana, mi ha colto di sorpresa lo stacco di paesaggio. Ero entrata in un’altra dimensione, in un’altro tempo, in un’altra storia. Il racconto affidato ai colori e alle rughe sulle coste dei monti. Mai visti altrove. Ho perso l’uso della parola tanta l’intensità di quel dialogo muto. Ed era solo un assaggio. Poi i paesi abbracciati alla roccia, i calanchi, Aliano, Matera. E’ un territorio antico, quello. Porta ancora i segni della sovranità di madre terra sulle opere umane. C’è silenzio e spazi di solitudine, nonostante i segni del lavoro degli uomini. Come se gli insediamenti siano avvenuti col consenso dell’ospitante terra, a patto di riceverne sempre il permesso. Lì si può guardare e ascoltare. C’è lo spazio e il tempo per farlo. Non disturba il vuoto chiacchiericcio, né i flash continui di qualche schermo acceso. Lì c’è ancora il segno del senso e dell’essenziale. Ci sono tornata quest’anno, con il libro. Stesso tragitto e ancora il respiro trattenuto nella consapevolezza che io e quella terra non ci siamo ancora dette tutto. Forse qualche salvezza c’è ancora se arretriamo tutti e ci fermiamo ad ascoltare il respiro della gravina su cui poggia l’antica Matera. Ecco quello che intendo per fare un passo indietro e ampliare la visuale. Quella terra, dopo millenni, mostra ancora un volto antico e solo nell’ultimo suo tratto di vita ha conosciuto l’oltraggio dei bidoni seppelliti e buttati in mare. Non è inevitabile tutto questo. Si può vivere senza. Mi pare ci sia stata una certa disattenzione da parte della critica letteraria nei confronti di questo libro. E’ innegabile la Come pensarla la mia terra, che tiene la conta asciutta delle mie miserie, che segue lenta il collasso delle città di fiume, alte sul ricordo profondo dell’ultimo inverno, quando l’intemperanza degli anni mi arrese in una immagine bianca d’Europa, i treni sfilavano tenendo bene in vista l’iperbole di fumo, avrei rischiato le mani e la bellezza per un rientro in patria, avrei rischiato la voce e la gloria per il canto della ragazza magra che come un miraggio di primavera raccoglieva la fioritura dei tigli, bisogna scrivere, le dissi, per non invecchiare. Ma guardami adesso tenere le carte, il dolore raglia, come un’asina, appena gli viene concessa la vista, e le cose facili si fanno impossibili e il tempo discute i rimproveri e le temerarie previsioni mentre si arrende, si che si arrende, la mia nostalgia di casa, tra le tue braccia dimesse, tra le parentesi magre dei verbi che uso, elogio alla sopravvivenza, tienimi ancora vita, in un angolo di marzo a soddisfare le nuvole, a cantare le messe del 21 di giugno, quando divampa l’estate nelle terre di mezzo, l’Est sconfinato dove ho perduto la vista, dove ho perduto l’amore, nei colli stretti delle bottiglie, guerra è ancora guerra, radicata e profonda, violenta. Bisogna scrivere per non impazzire le dissi. Vanina valenza storica che lo stesso implica, data la testimonianza di “prima mano” di eventi tragici che hanno attraversato il Paese. Così come non si può negare una Barbara Balzerani scrittrice, in virtù di una scrittura efficace e colta come quella adoperata nel libro. C’è rammarico per questo? Disattenzione, dici. No, di più. Il libro è stato completamente ignorato dalla critica letteraria. Da questo punto di vista gli anni passati non hanno migliorato la situazione. C’è stata negli ultimi anni una campagna martellante sul tema che noi, ex brigatisti, non abbiamo il diritto di parola. E, con pochissime eccezioni, la cerchia intellettuale e giornalistica s’è adeguata alla consegna. E’ quasi una bestemmia la tua, quando mi definisci scrittrice. Qualche anno fa Antonio Tabucchi era insorto, insultando tutti quelli che mi avevano recensito come tale. C’era andato giù pesante, il professore. Ma è stato l’unico a farlo in una schiera di consensi trasversali, dal Manifesto a Radio vaticana. Oggi è calato il silenzio, almeno quello mediatico. Il rammarico è soprattutto perché mi costringe a vivere schiacciata sulla parte della mia vita che mi ha reso “famosa”, come se esistessero persone a una sola, eterna dimensione. E’ un passato che non passa il mio e che, via via, è diventato un cumulo di luoghi comuni. Qual è oggi il tuo stato d’animo nei confronti di una società che non sembra tanto distante da quella dei tuoi anni di gioventù? E’ molto distante da quegli anni e anche peggiore. I potenti della terra hanno perfe- zionato il loro dominio su tutto il pianeta, portando a compimento l’opera di rapina e di devastazione. Basti leggere i numeri di morti per fame. Poi di quelli dei morti per guerra, per malattie, per sciagure “naturali”. Ai miei tempi già c’era tutto questo ma il Vietnam vinceva, l’Africa si decolonizzava, tutto il mondo era in rivolta. Sembrava di avere il proprio destino tra le mani, in un futuro comune di liberazione che attraversava gli oceani. Oggi campeggiano sui simulacri della nostra democrazia le fotoricordo dei soldati americani ad Abu Graib, in quel carcere in mezzo al deserto dove la civiltà è nata. n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida ELLIS ISLAND E L’EPICA DELL’IMMIGRAZIONE Sull’ “Isola delle Lacrime e della Speranza” sbarcarono tra XIX e XX secolo, decine di milioni di immigrati: italiani, irlandesi, russi, ebrei, tedeschi, ucraini e tanti altri di Salvatore Casaburi attery Park è uno dei tanti polmoni verdi di New York City, proprio sulla punta estrema di Manhattan. I turisti scendono alla stazione metro di South Ferry e si avviano a fare pazientemente la lunga fila in attesa del traghetto che li condurrà sulle due isolette di fronte alla “Grande Mela”, due frammenti di terra che sintetizzano la storia degli States: Liberty Island e Ellis Island. Prima di salire sul traghetto vengono effettuati gli stessi rigidi controlli ai quali si è sottoposti per imbarcarsi su un aereo. A Liberty Island, infatti, vi è il simbolo della storia stessa degli Usa, la Statua della Libertà. Gli americani vi si recano in pellegrinaggio e si distinguono subito dai turisti, mossi invece prevalentemente dalla curiosità di osservare da vicino il gigante visto tante volte al cinema o in tv, da non sembrare più neanche vero. Dopo la sosta a Liberty Island, il traghetto fa tappa a Ellis Island, l’Isola delle Lacrime e della Speranza. Le due piccole isole riassumono l’intera vicenda degli Stati Uniti, come il Vittoriano a Roma, la Porta di Brandeburgo a Berlino o il Cremlino a Mosca. Se il gigante con la torcia ne rappresenta i principi costitutivi, il museo che occupa gran parte della seconda isoletta conserva, per così dire, il Dna di un “melting pot” senza il quale la storia degli ultimi due secoli della nazione americana non sarebbe mai stata scritta. Il Museo dell’Emigrazione di Ellis Island, da solo, vale più di mille saggi tesi a confutare l’ideologia razzista e xenofoba che oggi invade il mondo, e non solo quello ricco. I fomentatori dell’odio contro i “diversi” e gli “stranieri” dovrebbero essere obbligati, per legge, a recarsi in pellegrinaggio nei due luoghi che, più di tutti, danno il senso delle sofferenze che solo l’ignoranza e la “strategia della paura” possono provocare anche nel nostro tempo: il campo di sterminio di Auschwitz e l’ “Isola delle Lacrime e della Speranza”, Ellis Island, appunto. Sulla piccola isola di fronte a New York sbarcarono, tra XIX e XX secolo, decine di milioni di italiani, irlandesi, russi, ebrei, tedeschi, indiani, polacchi, ucraini, albanesi, cinesi, armeni e tutti gli altri che avevano attraversato gli oceani per raggiungere “la terra del latte e del miele”. B Questa migrazione è stata magistralmente narrata nel film “Nuovomondo” del regista italiano Emanuele Crialese. Il Museo di Ellis Island racconta la storia drammatica, spesso tragica, di quelli che cercarono di sottrarsi a una quotidianità fatta di fame e malattia intraprendendo un viaggio biblico attraverso gli oceani, durante il quale le epidemie e i naufragi non costituivano probabilità remote, ma un rischio da affrontare, pur di sottrarsi alla sofferenza di una vita senza pane. Erano i disperati che partivano dai porti d’Europa, d’Africa, d’Asia senza neppure conoscere la geografia del viaggio e che, in molti casi, venivano reimbarcati sulla stessa nave che li aveva portati negli States per il solo fatto di non aver capito le domande degli ispettori federali, per avere una “faccia strana” o per una diagnosi medica superficiale e disumana. Già nell’atrio del Museo dell’Emigrazione, il visitatore è profondamente scosso dai bagagli degli emigranti, messi in ordine a evocare la presenza e l’attualità delle infinite vicende umane che in quel luogo transitarono. Il fotografo Barry Moreno, nel volume “Ellis Island”, ha raccolto le immagini contenute nel Museo e narrato la storia dell’edificio che, dal 1890 al 1954, ebbe la funzione di centro di selezione, detenzione e deportazione dell’immigrazione negli Usa. Donne e uomini, vecchi e bambini, per oltre sessanta anni, furono sottoposti in quel luogo alla selezione impietosa effettuata dagli ispettori federali. Spesso i nuclei familiari venivano divisi, costringendo al rimpatrio, al “respingimento”, diversi membri, senza alcu- immigrati a Ellis Island L’EBBREZZA POETICA DI ANGELO LIPPO Con l’ultimo volume di poesie, l’autore pugliese intende riportare le questioni di oggi a una dimensione più comunicativa e partecipata che si confronta col passato uattro pagine per i titoli, quattro per la prefazione, ventuno per le poesie, due di bibliografia, una per l’indice: in tutto trentadue pagine in formato 12X16,5, lo stesso delle eleganti e semplici edizioni di Vanni Scheiwiller di Milano. Un piccolo aureo libretto di dieci nugae. In appoggio alla prima poesia, il frammento 213 di Cratino dall’Antologia Palatina. La traduzione adottata (Bevendo acqua, non potresti scrivere niente di bello) è diversa dall’originale (Un cavallo da corsa è il vino all’aedo grazioso! se beve acqua nulla mai farà di bello), ma efficace. Trasportando il discorso dalla indifferenziata terza persona alla seconda, il significato ne esce rafforzato. E’ più incisivo, più determinato, più diretto. Un confidenziale tu-io, allo specchio. In cui si rincorrono e si intrecciano motivi e timbri diversi. Si tratta di “Elogio dell’ebbrezza” del poeta tarantino Angelo Lippo, pubblicato da Edizioni Lepisma - Roma. Domina su tutti una docile e sconfinata tastiera malinconica che reca il sigillo della sofferta esperienza soggettiva che racconta, con elegante distacco, assil- Q li e sconvolgimenti interiori, pene, ansie, gioie. Struggenti alcuni abbandoni lirici: “E quando l’inverno bussa / alle porte mi cingo le spalle / di morbida lana, / e so che lunga vita mi aspetta / se tante volte le labbra / porterò al calice colmo. / Conterò allora a centinaia, / per discendenza romanica, / i boccali e la morte avrà / il sorriso buono dell’annata”. In apparenza, tonalità e modalità poetiche ci riportano a una poesia conviviale: al piacere di una composta “celebrazione ed esaltazione del vino”. Niente di più inesatto. Come nota nella prefazione Luigi Scorrano “il libro poetico di Angelo Lippo si carica di memoria remota”, è “una pausa gioiosa e pensosa” che non intende allontanare i problemi d’oggi ma riportarli a una visione più partecipata e comunicativa, ideata e composta di contro ai disvalori della società contemporanea completamente affogata nei propri simulacri. Del resto, tutta l’attività letteraria del poeta pugliese dalla produzione poetica alla critica letteraria, dalla saggistica (interessantissimo il profilo critico su Armando Meoni) alla critica d’arte, dalla collaborazione ai 5 na pietà. Un racconto fra tanti è la testimonianza di una donna, giunta negli Usa ancora bambina nei primi anni del Novecento, la quale assistette al rimpatrio della nonna imposto dagli ispettori: “Fu quella l’ultima volta che la vedemmo. Poi non ne sapemmo più niente”. Ellis Island è storia di contraddizioni, di inizi e di conclusioni, di vita e di morte, di speranze e di lacrime. “America allegra e bella, tutti ti chiamano l’America sorella...”, diceva una vecchia canzone popolare italiana della fine dell’Ottocento. A Ellis Island, di fronte agli ispettori federali, quel mito si frantumava. Gli stranieri poveri, tutti e indistintamente, erano considerati preventivamente “potenziali delinquenti e portatori di malattie”, poco importa se poi andassero a morire nelle miniere dei Monti Appalachi, nei cantieri edili di New York e San Francisco o nelle fabbriche di Chicago e Detroit. L’America è una nazione di immigrati, si dice oggi a giusta ragione. La violenza dello schiavismo rese sottomessi gli uomini e le donne dell’immigrazione forzata, la violenza di padroni senza scrupoli rese sottomessi, poi, quelli che sul suolo americano erano giunti volontariamente dopo settimane di navigazione a bordo di navi con i ponti di terza classe puzzolenti e invasi dai topi. Occorreva che quegli esseri umani fossero considerati tutti, indistintamente, “potenziali delinquenti e portatori di malattie” per poterli sfruttare meglio. Il pugliese Nicola Sacco, nel commovente discorso tenuto di fronte ai giudici di Boston che lo avrebbero condannato alla sedia elettrica, affermò: “Senza un soldo ero venuto in America, e senza un soldo volevo tornare in Italia per riabbracciare mia madre morente”. Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti morirono sulla sedia elettrica, innocenti, perchè anarchici, immigrati e italiani. Era il 1927. Oggi, per un tardivo risarcimento, lo stato del Massachusetts ricorda il loro martirio con una targa sulla Greenway di Boston. Contro gli immigrati poveri, qualunque fosse la loro terra di origine, tra Ottocento e Novecento si scatenò la reazione razzista e xenofoba, fino alla persecuzione voluta dal ministro Palmer tra il 1918 e il 1920 nei confronti di coloro che rivendicavano condizioni di vita e salari più dignitosi. “Sono tutti delinquenti, individui inferiori e incapaci di adattarsi alla nostra mentalità e al nostro modo di vivere” sosteneva Palmer, nel paventare la “red scare”, “la minaccia sovversiva rossa”. La politica xenofoba di Palmer, rendendo più deboli e privi di tutela gli immigrati, favorì la penetrazione e il potere dei gruppi criminali interni alle diverse nazionalità ed etnie. Emblematico è il caso del gangster italiano Al Capone detto “Scarface” che, spesso con la complicità di Segue a pag. 16 quotidiani pugliesi e alle riviste letterarie è stata un continuo e misurato confronto con il passato, consapevole con Friedrich Schlegel che “lo stato conflittuale del presente in contrasto con l’armonia che domina l’antico schiude la via a un’autoriflessione storica dell’estetica”. g. p. Angelo Lippo 6 sussurri & grida n° 10 - Ottobre 2009 tuati da sempre a saccheggiare, la loro storia. Il regista Mario Martone ha fatto un film sul Risorgimento. Si, ha avuto questa intuizione, d’altronde Martone è un regista molto intelligente e sensibile, ma lo ha dovuto fare con difficoltà e sforzi immani. Avrei dovuto esserci anch’io, e mi sarebbe piaciuto moltissimo, ma sfortunatamente proprio in quel periodo ero impegnato altrove. Come vivi il rapporto con la tua città in un momento in cui i suoi figli più illustri si dividono tra quelli che rimangono e quelli che scappano? Con Napoli ho un rapporto come di respingimento, vivo di respingimenti, come si fa con i clandestini. E’ una città dalla quale non ricevo risposte e che dunque non mi mette in condizione di fare il mio lavoro. Forse non rispondo ad alcune logiche, non lo so. Fortunatamente, tava il popolo mentre Eduardo si soffermava di più sulla società piccolo borghese e per questo è più vicino ad Segue da pag. 1 autori come Ibsen, per esempio. E’ considerato universalmente un autore internazionale soprattutto per la sua scelta di adottare una lingua tra il napoletano e l’italiano. La borghesia che lui racconta è spenta, vinta, una ganati dalle tv. borghesia che esce devastata dalla guerra. Le cose Il fenomeno esiste così come il rischio per quello che migliori, secondo me, Eduardo le ha fatte da “Napoli dicono, che rappresentano. Molti di costoro sono persomilionaria” in poi. naggi senza scuola, senza storia e ottengono un succesDi Eduardo hai recitato anche la commedia più so pazzesco su contenuti sciocchi. Non hanno alle spalcomica. La soddisfazione è la stessa? le un back-ground culturale ma vanno avanti lo stesso. L’ho fatto e mi sono divertito tantissimo, anche se le mie Ma questo penso sia un problema e un rischio di tutta la caratteristiche non sono propriamente di attore comico. cultura italiana. Tornando invece a Napoli, penso che La soddisfazione è uguale nel recitare testi più strettafortunatamente continui a produrre talenti. mente drammatici o comici. L’unica differenza è in una Spostiamoci sul cinema. Sappiamo che lo ami molto, risposta più immediata del pubblico, con la risata, l’apma che fai molto più teatro. Da che dipende? plauso è più frequente. Ma vedi in Italia siamo organizzati male Viviani, invece? dal punto di vista di questo mestiere. Non Viviani è forse meno esportabile perchè ti riesce di fare una programmazione molto radicato, nella lingua e nella cultura, certa perchè il cinema promette e poi non nella napoletanità. Viviani racconta il mantiene, è un po’ traditore se vogliamo. popolo, la vita della strada, le storie degli I progetti rischiano di procrastinarsi emarginati. Il periodo migliore di Viviani è all’infinito, non c’è sicurezza. quello anteguerra, del Ventennio, durante il Naturalmente non riguarda le grandi star quale esprime un concetto di rivalsa attradel cinema ma un attore professionista verso valori come la famiglia e il lavoro. che deve scegliere cosa fare in una staLe tue interpretazioni di Viviani hanno gione, sceglie quello che è più sicuro. ottenuto un particolare successo. Sono molto affascinato dal cinema, è L’esperienza di vita ti avvicina al sentiinnegabile, ma preferisco scegliere la mento che esprime questo autore? sicurezza del teatro che ha una progettuaIo nasco borghese, quindi non mi permetto lità diversa, più immediata. di uniformarmi al mondo vivianesco. Ti piacerebbe essere anche dietro la Tuttavia, le frequentazioni giovanili di macchina da presa nel cinema? amici dei quartiri popolari mi hanno sicuRegista di teatro lo sei già. ramente aiutato a capire molte cose. Mai dire mai, magari sentiamoci tra altri Una cultura che ha espresso una ricca Due immagini di Nello Mascia in scena. Qui sopra, con il gruppo di attori di “Festa di nove anni e ti dirò. Piedigrotta”. In basso, con Graziella Marina, in “Fatto di cronaca”. Entrambi i testi sono di drammaturgia è quella russa. Quale Ma continuiamo a parlare di bravi di Raffaele Viviani autore russo ami di più? registi di casa nostra. Sei stato diretto Senza dubbio Cechov, un grandissimo tra gli altri da Paolo Sorrentino. Che autore di cui sono appassionato e che non regista è? come dicevo, da tre-quattro anni lavoro a Palermo, dove esito a collocare come una delle punte più alte della Sorrentino è un genio. Credo sia il vero genio del cine- mi trovo benissimo. drammaturgia mondiale. ma e infatti, e non a caso, l’America ce l’ha rubato. Sento più rassegnazione che rabbia nelle tue parole. Chiudiamo con una curiosità: sappiamo che sei su Credo per esempio che l’”Amico di famiglia”, mirabil- Mi sono arrabbiato molto in passato per queste ingiusti- facebook. Come ti sei avvicinato a questo strumento mente interpretato da Giacomo Rizzo, meritasse una zie nei confronti dei suoi figli migliori. Oggi resta il di comunicazione? vetrina maggiore di quella che ha avuto. Ma queste sono rammarico nel vedere che non c’è più indignazione, Per gioco. Lo trovo divertente. Adesso lo uso come le stranezze del cinema. manca la spinta rivoluzionaria dell’indignazione verso un’agorà di impegno civile, per denunciare tutti i sopruPiù in generale, il cinema italiano ti piace? Una bella una stagnazione davvero preoccupante. Tutto questo ha si e gli abusi della classe dirigente. Ho interlocutori di soddisfazione la sta dando “Baaria” di Tornatore . favorito la mia scelta di andare via e di guardare la città tutte le età e in città diverse e si è creata molta vivacità. Tornatore è un regista che gira benissimo, le sue imma- da lontano. Ma questa è una storia vecchia che si ripete, Sai a volte si innescano anche discussioni forti su argogini sono davvero molto belle. Però penso che abbiamo non dimentichiamo il grande Eduardo e lo stesso menti delicati. E poi è un mezzo di comunicazione smarrito il concetto industriale di fare cinema. In Italia Raffaele Viviani che si sono sentiti traditi dalla loro comodo per me che sono sempre fuori. non esistono industrie cinematografiche, esistono delle città. Il rammarico è che altrove tutto ciò non succede. A questo proposito: come si vive la famiglia stando realtà sporadiche che nascono per necessità individuali. Le altre città i figli migliori se li coccolano, se li custo- spesso fuori? Fino agli anni sessanta era una delle industrie più fio- discono, li tengono in evidenza. Non li respingono. Ammetto di essere sempre stato un padre un po’ assenrenti, poi ci sono stati quei dieci anni squassanti dei vari Sei attore di grande spessore, con una carriera di te e di non avere avuto una vera vocazione come padre. “Pierini”, proprio negli anni della mia gioventù quando tutto rispetto. Eppure la popolarità maggiore a volte Ma sono stato un assente giustificato. Oggi comunque avrei voluto fare del cinema, ma non c’era il cinema. passa attraverso una fiction. Lo è stato anche per te sono un uomo adulto, di una certa età e anche loro sono C’era solo Pierino. con “Capri”? adulti quindi è diverso. Mettiamola sul cinema internazionale allora. E’ probabile, ma non me ne dispiaccio. Anzi sono conEcco, il cinema spagnolo per esempio è una realtà bel- tento quando per strada mi riconoscono e mi salutano. lissima. I film di Almodovar sono capolavori assoluti. Qualcuno abbracciandomi mi riconosce per “L’ultimo Ma anche il cinema francese, si mantiene sempre su scugnizzo”, molti altri per il personaggio della fiction uno standard di grande qualità. Ma voglio dire soprat- “Capri”, che tra l’altro mi sono molto divertito a intertutto un’altra cosa che non riesce a fare il cinema ita- pretare. E’ innegabile che ti riconoscono più per i perliano. I francesi ma anche gli inglesi producono due sonaggi televisivi. Uno spettacolo teatrale in un anno volte all’anno un paio di film megagalattici che si met- quante persone lo vedranno? Centomila? Una fiction tono immediatamente in concorrenza con la grande pro- viene seguita da sei sette milioni di persone. Se poi il duzione americana, facendo lavorare grandi registi e prodotto è di qualità godiamoci questa popolarità da grandi attori e attingendo a “prodotti” nazionali. Penso auditel. per esempio a un film storico inglese come “Elizabeth”. Torniamo al teatro, con gli autori che hai amato di Noi in Italia non siamo neanche riusciti a sfruttare una più: Eduardo e Viviani. Due grandissimi. Cosa li difgrande epopea come quella del Risorgimento. Pensa ferenziava principalmente? cosa avrebbero fatto inglesi, francesi e americani, abi- La differenza principale sta nel fatto che Vivian raccon^ NELLO MASCIA 7 n° 10 - Ottobre 2009 L’ARTE LIRICA E POSITIVA DI SPIRIDONOV Intervista al pittore della Yakutia che ha tenuto la sua personale a Napoli nel mese di settembre presso l’Associazione Massimo Gorki i siamo già occupati in passato della Yakutia, una regione che è cinque volte il territorio della Francia e che rappresenta 1/4 del territorio della Russia, ma con solo un milione di abitanti. Nella capitale Yakutsk vivono 300.000 persone. Ne parlammo grazie all’Associazione Massimo Gorki di Luigi Marino che portò in Italia alcuni artisti di canto di quella regione. Lo facciamo di nuovo grazie al Gorki e a quello che è il pittore più rappresentativo della Yakutia, Yuri Spiridonov, che è stato una settimana a Napoli per la sua personale, ovviamente al Gorki. Yuri Spiridonov è un artista molto stimato in Russia. Ha già esposto con successo, anche con mostre personali, in giro per il mondo e alcune sue opere sono presenti in musei importanti come il Museo Nazionale d’Arte della Yakutia, il Museo Nazionale di Sapmi (Norvegia) e il Museo Nazonale della Groenlandia. Suoi quadri fanno parte della collezione dell’Unione degli Artisti Russi. Dal 2002, Spiridonov è Presidente dell’Unione degli Artisti della Yakutia. Il suo linguaggio artistico si è sviluppato appieno intorno agli anni 80 a testimonianza anche di un rapido sviluppo di ogni genere di belle arti in Russia in quel periodo. I suoi quadri evidenziano una notevole abilità nella composizione e le varie combinazioni di colori e tecniche ne determinano la cifra artistica. In tutte le sue opere, paesaggi dal vero tuttavia spesso elaborati con l’eliminazione di alcuni dettagli oppure temi legati a tradizioni popolari, prevalgono una visione positiva e un certo lirismo. Abbiamo parlato con Yuri Spiridonov grazie all’aiuto della signora Adriana Trapani, docente di storia e letteratura russa, componente del direttivo del Gorki. Maestro, cominciamo a spiegare la scelta dei suoi soggetti. Come mai quasi sempre paesaggi? Sono nato sulle rive del mare di Laptev, Oceano Artico. Il vero Artico. E le scene rappresentano la vita degli eschimesi. Sono di etnia Yakut. E’ una nazionalità diversa da quella degli eschimesi. Gli eschimesi, geralmente,vivono sulla costa del Mare del Nord. Vivono in Canada, Groenlandia e in Alaska. In Russia vivono nel nord del Chukotka. Ho visto la loro vita, ci sono andato e ho dipinto. Ho letto leggende su di loro e così ho realizzato una serie di dipinti. Pur dipingendo dal vero lei elimina alcuni particolari. Come mai? Il fatto è che non mi interessa fotografare la realtà. Mi lascio andare, dipingo secondo il mio stile, dò ai dipinti la mia visione. I miei quadri sono riconoscibili nelle mostre di Mosca. La gente dice: C “Questo lavoro è di Spiridonov”. Torniamo ai soggetti. Ci parla di queste figure fiabesche? Come detto all’inizio, sono eschimesi. Gente che vive sulle coste dello Stretto di Bering, in Groenlandia, in Canada. E’ una piccola nazione, vivono in America, Alaska, Groenlandia, in Danimarca. In Russia, a Chukotka. E’ un numero molto ristretto di persone che è riuscito a conservare la sua storia e la sua arte. Amo le loro leggende e mi piace rappresentarle. Come nasce l’idea di queste figure? Sono rappresentazioni grafiche ovviamente di fantasia. Come loro scrivono e raccontano storie, così io dipingo. Ed è qualcosa oltre la vita, la natura. Rendo migliore ciò che realmente è. E’ vero che per lei ha molta importanza la composizione? Nei miei quadri la composizione è la cosa più importante. Chiunque può imparare a dipingere. Essere compositore è un’altra cosa. E’ creazione, è un’opera. Lei ama dare una visione positiva delle cose nelle sue opere? I miei quadri hanno una visione positiva della vita. A nord non sempre è bel tempo. Molto spesso ci sono grandi tempeste di neve, nebbia, notti oscure. È spaventoso. Ma io non dipingo questo. Dipingo solo il lato positivo. Così la gente pensa che nel nord vada tutto bene. Ma se uno vede il nord dice: “Che cosa ha dipinto mai Yuri Spiridonov?” Si riconosce in qualche corrente artistica, anche del passato? Non faccio parte di alcun movimento artistico. Lavoro autonomamente. Ma oggi sono considerato artista di punta russo. Non sono ancora stato inserito, a livello di critica, in alcuna tendenza. Sono definito un artista artico, dipingo l’Artico, il Nord, gli iceberg, il freddo intenso. I miei quadri, ripeto, sono riconosciuti alle mostre. Era già stato in Italia? La prima volta ho visitato l’Italia nel 1981. E poi l’anno scorso. E’ stato una settimana a Napoli. Cosa le è piaciuto di più e cosa di meno? Mi è piaciuto che la città abbia conservato le sue antiche tradizioni, le sue vie, le sue strade strette. L’unica cosa che non mi è piaciuta è che i giovani, invece di stare in biblioteca, guidano i motorini e non lasciano attraversare gli anziani. Credo che i giovani possano trovare svago in un altro posto, per esempio in discoteca. E non solo guidando per i vicoli per tutta la notte. Sono sicuro che nessuno di loro è venuto alla mia mostra, perché per loro non è interessante. La nostra generazione, io e voi, siamo sempre interessati alle mostre d’arte. Ma ciò è vero non solo per l’Italia. In altri paesi molti giova- ni fanno la stessa cosa. A Mosca e da noi, a Yakutsk. Cosa trova in comune tra quello che vede qui e quello che vede nel suo paese? Mi piace molto il cielo. Le albe e i tramonti. Sembra di vedere il nostro cielo e le nostre montagne. Riconosco le stesse emozioni. Il colore del cielo nel quadro fatto a Pisa della torre pendente è simile. E dal punto di vista dei caratteri? Gli italiani hanno il carattere della gente del sud. Come i georgiani, gli armeni. Noi del nord siamo un po’ lenti. Mi hanno detto che sembro un italiano, che ho un forte temperamento. Tornerà in Italia? L’Italia è la culla dell’arte. Tutti gli artisti del mondo vanno a Roma per vedere il Vaticano. Michelangelo. Anche se il territorio è piccolo, in Italia è conservata tanta arte. Spero di ritornare. Vivo molto lontano e il viaggio è molto costoso. Che programmi ha per il prossimo futuro? L’anno prossimo terrò una mostra a Mosca e a San Pietroburgo. Forse in Cina. Sogno di andare in America. Sono stato in Alaska sei volte e vi ho tenuto una mostra. Di cosa si occupa l’Unione degli artisti della Yakutzi, di cui è presidente? L’Unione degli Artisti organizza mostre, studi, laboratori per gli artisti. Organizza viaggi. Siamo un ente pubblico, indipendente dal governo.Viviamo in povertà, ma siamo liberi. Dipingiamo quello che vogliamo. Duncan Yuri Spiridonov Archeologia della letteratura a cura di Calais Borea Il brano che pubblichiamo è tratto dal volume “Prime alla scala”, edito da Mondadori nel 1981, una raccolta degli scritti musicali di Eugenio Montale. DUE OPERE DI STRAVINSKIJ di Eugenio Montale - Settembre 1938 Igor Stravinskij, presente a Venezia da qualche settimana per preparare la prima esecuzione mondiale dei suoi “Threni” dedicati alla memoria di Alessandro Piovesan, ha diretto ieri sera da pari suo due delle più significative sue opere: “Oedipus Rex” e “Le sacre du printemps”. Nulla di nuovo, come si vede, trattandosi di composizioni ormai entrate nel grande repertorio della musica moderna; ma pur sempre un avvenimento notevole per la partecipazione dell’autore, che è un direttore molto discusso anche come interprete di se stesso, per il contributo dell’orchestra e del coro della Norddeutscher Rundfunk di Amburgo e per la scelta degli interpreti vocali dell’”Oedipus”, che sono degli autentici specialisti. Come è noto, l’”Oedipus Rex”, eseguito per la prima volta nel 1927 a Parigi, è un’opera-oratorio che ha dell’oratorio la fissità e la rinuncia a ogni effetto scenico e rappresentativo, ma che ha anche molto di teatrale, nel senso che richiede un completo organico orchestrale e si fonda essenzialmente sulle classiche forme chiuse: arie, duetti, cori. Il testo è di Cocteau e per la parte latina, che è preponderante, la traduzione è di Jean Daniélou; e stasera è stato omesso del tutto il testo francese, affidato a un annunciatore. Un’analisi di quest’opera suggestiva, giudicata da molti uno dei capolavori del Maestro, esorbiterebbe dai confini di una breve notizia. Per le forme in essa adottate, il Vlad, autore di un eccellente studio su Stravinskij, parla di convenzioni «di secondo grado», il che può essere giusto, ma non è certo fatto per aprire a quest’opera la strada a una facile comprensione. Siamo evidentemente in un clima di neo-classicismo intenzionale, ed è già significativo il salto da Sofocle a Cocteau. Non mancano nell’ “Oedipus” frammenti di intensa suggestione, particolarmente nella seconda parte, ma l’effetto complessivo è che l’opera sia un saggio di ottima letteratura musicale destinato (fra pochi anni) a restare confinato negli archivi del tardo liberty. La “Sagra della primavera”, invece, scritta nel 1913, conserva una sua barbara freschezza, e se si riesce ad ascoltarla dimenticando la traccia di un balletto per cui fu scritta (il che non ci riesce facile), se ne assapora fino in fondo la rude potenza, l’ossessivo orgasmo ritmico e quel senso di disgelo, di commovimento delle oscure forze terrestri che il canovaccio tentava di portare a intenti quasi illustrativi. Stravinskij ha diretto in modo eccellente l’ “Oedipus” e con minore chiarezza la “Sagra”. Il coro e l’orchestra di Amburgo sono stati all’altezza della situazione. Forse un po’ meno i solisti: la signora Laszlo, i signori Robinson, Depraz, Oliver e Cuenod, ma è anche difficile giudicare cantanti impegnati in partiture come l’ “Oedipus” senza alcuna risorsa. Inutile dire che il successo è stato vivo e che a Stravinskij sono andate le intense acclamazioni del pubblico. 8 n° 10 - Ottobre 2009 SYROS E LA CULTURA CICLADICA Il Museo dell’isola greca ha solo cinque sale che però ben testimoniano l’importanza di quel remoto passato di Gerardo Pedicini ’isola di Syros ha un’area di 43 chilometri quadrati. Dista dal Pireo 83 miglia nautiche. È situata tra le isole Kythnos e Mykonos, al centro della base dell’arcipelago settentrionale delle Cicladi che si prolunga nel mar Egeo fino a raggiungere il vertice dell’ideale triangolo costituito dall’isola Santorini. Un lungo corridoio di mare la separa dai due lati del triangolo dove si affacciano Paros, Naxos e Ios a destra e Serifos, Sifnos, Sikinos, Folegandros e Thirassia a sinistra. Per la sua posizione geografica, fin dall’antichità Syros è stata un naturale snodo di comunicazione tra la Grecia continentale, la penisola microasiatica e l’isola di Creta: un ponte tra Oriente e Occidente. Morfologicamente l’isola si presenta montuosa a Nord e pianeggiante a Sud, dove le vallate si alternano ai campi coltivati. La zona costiera dell’isola è formata da insenature che si alternano a scoscese scogliere e da due grandi baie: Ermoupolis ad est e Finikas ad ovest. Ermoupolis può considerarsi ancora oggi il capoluogo di tutte le isole cicladi. Fu proprio nel territorio a monte di Ermoupolis, e precisamente nel villaggio di Kastri e di Kalandriani, che nel 1834 furono trovate le prime testimonianze della civiltà cicladica che, l’anno dopo, nel 1835, furono raccolte nel primo Museo Archeologico greco, ancor prima quindi che fosse costruito nel 1866 su progetto dell’architetto Ludwig Lange il Museo Archeologico Nazionale di Atene, dove, dopo l’inaugurazione del 1889, hanno trovato nuova sistemazione molte opere provenienti dai Musei di Syros, Naxos, Santorini, ecc. Attualmente il museo di Syros è ospitato nella bella costruzione neoclassica, opera dell’architetto Ziller (1837-1923), sede del Municipio, che si affaccia su piazza Miaoulis, poco distante dal bel teatro municipale Apollo, replica in miniatura del più celebre Teatro alla Scala di Milano. Sono appena cinque sale, più un piccolo spazio adibito a ufficio. Eppure in queste poche sale c’è, in nuce, tutto lo spirito della civiltà cicladica. Tre L i principali fattori che contribuirono allo sviluppo della civiltà cicladica: la posizione geografica delle isole, le loro caratteristiche climatiche e ambientali e la ricchezza delle materie prime come l’ossidiana di Melos, lo smeriglio di Naxos, il piombo e l’argento di Sifnos, il rame e lo stagno di Kythnos e Serifos, oltre al cristallino marmo di Paros e Naxos. I limiti imposti dall’ambiente naturale costrinsero gli abitanti, fin dai tempi più remoti, a volgersi verso il mare e a trasformarsi, con il passare del tempo, in esperti navigatori, abili commercianti e intraprendenti protagonisti degli scambi di materie prime, manufatti, conoscenze e idee da un angolo all’altro dell’arcipelago. Tra i reperti più rilevanti presenti nel museo segnaliamo una padella del diametro 0,20 m., la cui superficie è ricoperta con spirali incise e triangoli impressi, datata alla seconda metà del 3 ° millennio a. C.; una pisside alta 0,07 m., costituita da un vaso con due doppie alette verticali tubolari e di un coperchio rotondo, la cui superficie è ricoperta di bianco ed è decorata con triangoli neri, datata alla seconda metà del 3 ° millennio a. C.; una statuetta in marmo cicladico alta 0,35 m. che rappresenta una figura femminile appartenente al Una pisside esposta a Syros LA MACCHINA DELLE STORIE DI SCERBANENCO A quarant’anni dalla morte ricordiamo il padre del noir italiano, nato a Kiev nel 1911 da madre italiana e padre ucraino di Duncan i stupiva sempre di non essere come gli altri e sentiva addosso la sensazione di dover dare delle spiegazioni. Aveva voglia a italianizzarsi, a togliere quella k. Gli chiedevano sempre se era russo e lui a spiegare che no, che il papà era ucraino ma lui era italiano, si affannava, cercava di far capire ma sembrava, in fondo, che agli altri non importasse molto. Vladimir Giorgio Scerbanenko, il padre del genere noir italiano, nacque a Kiev, in Ucraina, nel 1911 da madre italiana e padre ucraino. Ancora ragazzo, si trasferì in Italia, inizialmente a Roma e in seguito a Milano. Per guadagnarsi da vivere dovette abbandonare molto presto gli studi e adattarsi ai lavori più disparati: fresatore, magazziniere e fattorino. In un secondo momento iniziò a collaborare con periodici femminili, dapprima in qualità di correttore di bozze, poi come autore di racconti e romanzi rosa, arrivando a ricoprire importanti incarichi redazionali e direttivi in alcuni settimanali femminili come “Novella”, “Bella”, “Annabella”. Su quest’ultimo tenne la famosa rubrica “La posta di Adrian”. Il suo esordio nel mondo del giallo avvenne nel 1940, con il poliziesco “Sei giorni di preavviso”, il primo di una serie che fu nuovamente pubblicato in “Cinque casi per l’investigatore Jelling”. Il protagonista è un archivista della polizia di Boston, Arthur Jelling, per l’appunto. La fama nazionale e internazionale, tuttavia, per Scerbanenco arrivò con la serie che ha come protagonista Duca Lamberti, figura al centro di quattro romanzi, tre dei quali portati sullo schermo rispettiva- S mente da Fernando di Leo, Duccio Tessari e Yves Boisset. “Traditori di tutti” (1966), il secondo di questi romanzi dopo “Venere privata”, nel 1968 vinse il Grand Prix de Littérature Policière. Gli altri titoli di maggior successo sono “Al servizio di chi mi vuole”, “La ragazza dell’addio”, “Milano calibro 9”, “Dove il sole non sorge mai”, “I milanesi ammazzano al sabato”, “Al mare con la ragazza”, “La sabbia non ricorda”, “Le spie non devono amare”. Il padre del noir italiano dicevamo. Scerbanenco con la sua scrittura mise fine al processo di americanizzazione che fino ad allora era stato necessario nella letteratura gialla per dare una certa dignità agli autori nostrani. Il suo ritmo incalzante, l’incredibile capacità di sintesi di molti racconti come pure la cura dei particolari, il saper catturare l’attenzione del lettore dalla prima riga e di portarlo fino al colpo di scena conclusivo, la descrizione di una umanità cinica per la quale il delitto non è l’eccezione, sono gli elementi del suo stile inconfondibile al servizio di una inesauribile fantasia narrativa. Scerbanenco era una straordinaria macchina per inventare storie, decine di storie, ogni giorno, ogni settimana, ogni anno, che potevano prendere la forma di un romanzo o restare condensate in poche pagine o addirittura in poche righe. Ne è l’esempio “Il centodelitti” che vide la luce nel 1970 e che oggi, proprio quarant’anni dopo la morte di Scerbanenco, viene ripubblicato da Garzanti. Una raffica di microromanzi fulminanti che è quasi un’“enciclopedia” del male. A comprendere meglio la figura di autore di Giorgio Scerbanco ci aiuta la prefazione al libro scritta da Nunzia Monanni, compagna dello scrittore, scomparsa a giugno di quest’anno all’età di 75 anni. L’autrice scrive: “Mi piace tipo ben noto steatopygic, con testa ovoidale obliqua e inclinata all’indietro e un lungo collo cilindrico, rinvenuta nella necropoli di Kalandriani, considerato un idoletto, datato nella seconda metà del 3° millennio a. C. ; una coppa a due anse dell’altezza 0.145 m., proveniente dalle fortificazioni dell’antico villaggio di Kastri, a imitazione di vasi simili trovati nel nord-est del Mar Egeo, datato alla fine del 3° millennio a. C.; una statuetta egizia, alta 0,43 m. di granito nero, che raffigura il sacerdote Anchapis, risalente alla 22ma dinastia (circa 730 a. C.). Numerosi sono i reperti della cultura ellenistica: una stele funeraria coronata con palmetta e con scritta Timagene Dionysos, alta 0,88 m., larga 0,51 m., un torso di Poseidon, alto 0,41 m., la scultura di marmo di Paros che ritrae un giovane in atteggiamento pensoso di particolare interesse per fattura ed eleganza e numerosi reperti di ceramica e di metallo provenienti dalla necropoli della città antica di Syros, risalenti al 4° secolo d. C. L’importanza della civiltà cicladica è testimoniata da numerose ricerche. Per quanto riguarda la statuetta in marmo, molteplici le interpretazioni degli archeologi, antropologi, storici e storici dell’arte. Attraverso una minuziosa descrizione dei reperti, Giovanni Lilliu, studioso della scultura paleosarda, d’accordo con Br. Malinovskj, J. Frazer e Ch. Zervos (Naissance de civilisation en Grèce, 1962), rileva che le forme artistiche cicladiche sono simili a quella della cultura nuragica. Quale la ragione di questa somiglianza? Alla base, c’è l’identico significato religioso. Di fatto, le statuette femminili non sono altro che la rappresentazione simbolica della Dea Madre, intesa come “tramite fra l’uomo e la divinità, fra ciò che è mortale e ciò che rappresenta l’immortalità”; testimonianza di una energia primordiale che regola l’alterna vicenda della vita e della morte. Dagli studiosi, le statuette vengono suddivise in due categorie principali: il tipo schematico “a violino” e il tipo naturalistico “canonical” a braccia conserte). Nell’attenta analisi delle forme della cultura cicladica Ch. Zervos (studioso di Picasso, a cui ha dedicato più di 20 volumi) ha riscontrato che, per alcuni grandi artisti del XX secolo come Moore, Picasso, Brancusi, Modigliani, Hepworth ed altri, la cultura cicladica è stata una costante “fonte di ispirazione” per ritornare, con rinnovata energia creativa, a esprimere attraverso essenzialità e stringatezza di forme emotività ed aspirazioni della nostra epoca. Che l’abbiano fatto rifacendosi al passato cicladico non è un caso: testimonia l’importanza che il remoto passato della cultura delle isole greche ancora suscita sul nostro animo. ricordare come Giorgio scriveva quei brevissimi racconti. Erano nati nel 1963 come ‘Il Quattronovelle’ per una rivista. I quattro racconti dovevano stare tutti in una pagina e avevano un tema diverso ogni settimana: la guerra, gli innamorati, le grandi città, avere sedici anni, vittoria!, i piccoli paesi, i sogni, le infermiere, a che servono i soldi, la moglie in vacanza. Li scriveva in un’oretta dopo cena. E’ andata avanti così per oltre due anni. I colleghi gli dicevano: ma perché sprechi delle idee così belle per dei racconti così brevi? Lui rispondeva: faccio fatica a scrivere solo quattro racconti su un tema, perché me ne vengono in mente dieci, venti, trenta e devo eliminarli. Era questo Giorgio Scerbanenco, lo scrittore che amiamo ancora oggi. Così vicino a noi per la sua passione di scrivere tutto se stesso, ogni volta, in ogni personaggio: tutti diversi eppure tutti così umani, dal più abietto al più tenero, dal più meschino al più generoso. Comunque, una parte viva di lui. E se i delitti ci sono, non sempre sono armi, pistole, mitra, bombe, coltellate alla gola. Sono anche parole, silenzi, situazioni così forti e tragiche da morire, come delitti, centodelitti”. Una famosa immagine di Giorgio Scerbanenco ^ ^ 9 n° 10 - Ottobre 2009 VERSO EST. LA STRADA MAESTRA DI UCRAINA E GEORGIA Le aperture di Putin all’occidente spesso sono mal comprese o sottovalutate. UE e USA devono capire che occorre mettere fine a una politica fatta di tentativi maldestri che creano tensioni nel vecchio continente i è riunita a Pechino La SCO - Shanghai Cooperation Organization. Della SCO fanno parte Cina, Russia, Kazakstan, Kyrgyzestan, Uzbekistan e Tagikistan. Ai lavori del vertice ha partecipato il premier russo Vladimir Putin. Dopo la riunione dei Capi di governo dell’Organizzazione, il Premier Putin ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha parlato degli effetti della crisi finanziaria globale. Un’Europa poco attenta trascura i rapporti con la Federazione Russa e la spinge sempre di più vero l’Asia, almeno per quanto riguarda la Difesa e le Fonti Energetiche. L’Importanza dell’Organizzazione di Shanghai è stata a lungo sottovalutata. Oggi possiamo affermare che non è solo mercato ma anche altro e il peso geopolitico di questa organizzazione è destinato ad aumentare. Putin guida con attenzione la Federazione Russa in questa direzione ma con occhio attento all’Europa e all’America. Le aperture del Premier della Federazione Russa verso occidente sono state tante, a volte sottovalutate o non comprese bene. Obama lascia ben sperare e quando tiene il suo Vice, Biden, lontano dalla politica internazionale, i rapporti con la Russia di sicuro migliorano. Biden farebbe bene a stare lontano dai paesi europei e in particolare da quelli della disciolta Unione Sovietica e ancor più del disciolto patto di Varsavia. Non serve alla politica estera americana un Biden bella copia di Bush. Seminare zizzania in Europa non paga e non è giusto S illudere ancora paesi che sbagliano come la Polonia che si allontana sempre più dalla propria matrice slava. Chi dice che la Polonia si sente minacciata dalla Federazione Russa, e che per questo voleva missili e radar, dice una grande e tragica sciocchezza. La Polonia sa bene che la Russia non costituisce una minaccia ma una risorsa anche sul piano della Difesa. I motivi sono ben altri. La Polonia, nobile Paese pieno di storia e di sofferenza, deve ritrovare la sua strada maestra. Bush non c’è più nello scenario geopolitico e nemmeno S.S. Giovanni Paolo II. Ora è venuto il momento di fare i conti con la storia e lasciare ad altri il maldestro tentativo di coinvolgere Ucraina e Georgia in un gioco politico e militare molto pericoloso. Le elezioni in Ucraina faranno giustizia di posizioni sbagliate e vedremo cosa verrà fuori dalle urne dopo l’ubriacatura arancione. Ancora il popolo ucraino conta i danni prodotti da questa politica stimolata dall’estero. A tutti gli uomini di buona volontà sta a cuore l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina e questa va salvaguardata con tutti gli sforzi. Non guarda in questa direzione chi, durante la guerra in Ossezia del Sud, ipotizzava di impedire il rientro della Flotta Russa a Sebastopoli. Posizioni folli! Mancano pochi mesi e la parola ritornerà al popolo, questa volta senza gli squallidi condizionamenti di oratori della domenica che si avvicendavano in Piazza Indipendenza per ingannare il popolo ucraino. Walesa questa volta farà bene a restarsene a Varsavia. LA RUSSIA POSTSOVIETICA OGGI La professoressa Tatjana Alent’eva ha tenuto un seminario presso l’Associazione Massimo Gorki sul clima politico in cui è maturato il crollo dell’URSS uale corrispondenza c’è tra la storia dell’URSS così come la conosciamo e la verità dei fatti? Quale ruolo hanno avuto i media? A questo argomento è stata dedicata la relazione della professoressa Tatjana Viktorovna Alent’eva, Docente di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università Statale Pedagogica di Kursk, ospite la sera del 12 ottobre scorso dell’Associazione Massimo Gorki. In particolare, la Alent’eva ha posto l’attenzione sul ruolo che ha avuto l’immagine negativa dell’Unione Sovietica al momento del crollo del sistema per opera di Gorbacev. Il seminario organizzato dall’Associazione Gorki, in collaborazione con l’Osservatorio Sul Sistema PoliticoCostituzionale della Federazione Russa, aveva come titolo “La Russia post-sovietica nell’attuale contesto internazionale”. E’ Luigi Marino ad accogliere e ringraziare la professoressa Alent’eva in una breve introduzione ricordando come il Gorki in tempi recenti si sia già occupato di tematiche vicine a quelle prese in esame dalla docente russa con altri convegni dedicati come a esempio la presentazione del volume “Il fallimento di Gorbacev”. Tatiana Alent’eva ha conquistato subito l’attenzione dei presenti quando ha affermato di non sapere come rivolgersi al pubblico perché “per una vita intera, vissuta in URSS, siamo stati abituati a usare un termine brillante come ‘tovarisc’ mentre è solo da pochi anni che siamo signore e signori. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti qui per l’interesse mostrato”. Ha poi parlato del suo soggiorno a Napoli: “Mi è piaciuta : Q molto la città - ha detto - perché è un luogo ricco di storia e cultura con le sue bellissime chiese e i suoi monumenti”. Autrice di un libro sulla storia americana con l’esperienza dei viaggi negli USA, la docente ha spiegato come la manipolazione dell’opinione pubblica per mezzo dei media sia servita, per esempio a creare le tensioni che portarono alla guerra tra Nord e Sud negli USA. “Ci furono motivi politici dietro quelle tensioni - ha spiegato - e fu importante creare un’opinione unica”. “Questo tipo di manipolazione - ha detto ancora - c’è stata anche in Russia e capisco che sembri strano che ciò sia successo in una nazione fatta di persone intelligenti”. E’ passata poi a esaminare il periodo del crollo del sistema dell’Unione Sovietica. “Il crollo di quella società - ha affer- Luigi Marino e Tatiana Alent’eva , al centro, al Gorki La stretta di mano tra Hu Jintao e Vladimir Putin. In alto, una cartina della Crimea mato - è arrivato all’improvviso e la gente si è trovata impreparata. Ma il percorso anti sovietico di Gorbacev è passato per forza di cose attraverso la manipolazione dell’opinione pubblica. Chi opera queste manipolazioni non svela certo i suoi scopi. Così, però, c’è il rischio che si disperda la memoria della propria storia. Ed è una perdita grave”. “In URSS - ha proseguito - aveva molta importanza lo stato sociale, c’era una politica sociale forte che garantiva il futuro a tutti. Chiunque poteva realizzare le proprie aspirazioni, l’importante era impegnarsi e lavorare e lo Stato veniva incontro. Non voglio offendere quei colleghi che parlano della mancanza di alcune libertà, dico solo che noi cittadini russi conosciamo bene la nostra storia. Vedo il periodo dell’URSS come modello di sviluppo. Negli Stati Uniti ho visto persone senza casa, costrette per strada. Anche se c’era un deficit di prodotti, in URSS esisteva la cultura del pensare prima al bene comune, poi a quello individuale”. E ancora, sulla storia dell’URSS: “Anche su Stalin si è preferito portare avanti l’immagine peggiore, senza una seria riflessione sugli aspetti positivi e negativi della sua politica. le cifre dei deportati nei gulag sono state riportate in maniera amplificata. Molte persone non erano realmente detenute, ma tenute sotto controllo. Inoltre si è creato un fattore di inganno sul concetto di proprietà pubblica”. Quindi la Alent’eva ha parlato dei fatti del 1993 che videro protagonista Boris Eltsin affermando che: “E’ stato creato il mito di Eltsin che lotta per la libertà del popolo. Tutti conoscono la famosa immagine che lo riprende sul carrarmato. Ma ci sono fonti che dicono che se avesse fallito la sua rivoluzione, gli USA gli avrebbero garantito asilo. I carrarmati spararono sulle case mentre si era detto che la popolazione non sarebbe stata in pericolo. E non è stata mai detta la verità al popolo sull’episodio della morte di un prete avvenuta durante quei giorni”. Infine, ha posto lo sguardo ai giorni nostri. “Nessuno capisce il senso - ha detto - della festa di indipendenza. Ci fu detto che con la perdita di alcune repubbliche ci sarebbero stati dei miglioramenti, ma così non è stato. L’unico risultato è che oggi molti russi vivono all’estero”. : di Carmine Zaccaria 10 n° 10 - Ottobre 2009 LA STORIA NEI DESTINI UMANI Si celebrano i cent’anni dalla nascita della contessa Daria Borghese-Olsuf’eva, un’italiana dall’animo russo che indagò sul periodo romano di Gogol’ di Alexandre Urussov ’è una Grande Storia fatta di grandi eventi: rivoluzioni, dittature, guerre sanguinarie, massacri, campi di concentramento, genocidi e deportazioni; e ci sono una miriade di piccole storie fatte di singoli destini umani. Ma proprio con questi ultimi è cucita la stoffa dei grandi eventi della Storia. Gli storici, nei loro tomi, hanno raccontato con grande dovizia di particolari vita e miracoli dei protagonisti di tali eventi, mentre i destini degli uomini comuni vengono trattati esclusivamente come “sfondo statistico”. Lenin, Trotskij, Stalin, Denikin, Kolcak, sono gli eroi della guerra civile russa, invece i milioni di vittime della Rivoluzione (uccisi, torturati, esiliati, deportati) sono solo numeri. Esistono però, destini, quasi sbiaditi dal tempo, che in un modo o nell’altro, legano fra di loro grandi eventi e storie “marginali”. E’ questo, a nostro parere, il caso della vita della contessa Daria (19091963). Daria nasce a Mosca, figlia dei conti Olsuf’ev Vasilij e Olga, in una famiglia ricca e numerosa con gloriose radici storiche in Russia. Daria cresce con suo fratello e le sue tre sorelle in una villa al centro della città (dove più tardi, in epoca sovietica, si sarebbe insediata l’Unione degli scrittori) in un ambiente acculturato e poliglotta: la madre preferiva leggere e scrivere in francese, la balia lituana, Keta, parlava tedesco e il precettore insegnava ai bambini l’inglese. La famiglia possedeva inoltre una villa a Firenze, dove la madre aveva partorito la sorella di Daria, Maria, che diventò poi una celebre traduttrice di romanzi russi in italiano. Il conte Vasilij Olsuf’ev, colonnello dell’armata imperiale in congedo, all’inizio della prima guerra mondiale, parte volontario per il fronte. Allo scoppio della Rivoluzione russa (1917) si trova con la sua famiglia in Caucaso ed entra a far parte dell’Armata Bianca, e dopo la sconfitta la famiglia riesce fortunatamente a raggiungere il porto di Taranto su una nave inglese. Daria finisce a Firenze il liceo e si iscrive all’Accademia delle Belle Arti e nel frattempo segue C corsi per infermiera. Le quattro sorelle Olsuf’ev sono carine e beneducate e ben presto diventano oggetto di attenzioni di molti pretendenti e Daria sposa il principe Junio Valerio Borghese, rampollo di una famosa dinastia fiorentina, e insieme avranno quattro bambini. All’inizio della guerra in Etiopia, la principessa va in Africa come crocerossina, mentre il marito partecipa alla guerra civile spagnola. Il 1941 è segnato da un’autentica tragedia per Daria (come per tutta la sua famiglia) poiché le sue due patrie, la Russia e l’Italia, entrano in guerra l’una contro l’altra e perchè al fronte muore il fratello ^ Daria Borghese Olsuf’eva in un ritratto dipinto dalla sorella Aleksandra Alessio, chiamato alle armi come cittadino italiano. Alla Seconda guerra mondiale partecipa anche il marito di Daria, che in qualità di ufficiale della Marina militare, affonda molte navi degli Alleati. Il soprannome “Principe Nero” ben si addice alla figura molto controversa del principe Junio Valerio Borghese, e fondatore della X flottiglia MAS, che viene processato e incarcerato nel 1947 per collaborazionismo con i tedeschi, e fino alla sua morte, avvenuta in circostanze sospette nel 1974 in Spagna, rimane un convinto fascista, nazionalista e anticomunista. Non possiamo sapere se la moglie condividesse le convinzioni politiche del marito, ma sappiamo che nel secondo dopoguerra Daria si dedica alla Letteratura, alla Storia e all’Arte, discipline per le quali mostra un notevole talento. Nel giro di diversi anni realizza delle pregevoli vedute di Roma e fa delle importanti ricerche sulla storia della città. Pubblica questi eleganti studi illustrati in un giornale della capitale, e li ripresenta nel 1954 nel libro “Vecchia Roma” (Il libro in russo è uscito recentemente a Mosca a cura di Michail Talalay). L’anima italo-russa della Borghese-Olsuf’eva trova espressione nell’opera “Gogol’ a Roma” (Firenze, Sansoni 1957). Prima delle rigorose indagini degli studiosi contemporanei, ella dimostra come fu composto a Roma uno dei maggiori romanzi della letteratura russa, “Le anime morte”. Inoltre, identifica le dimore di Gogol’ sulle rive del Tevere e presenta la scrupolosa ricostruzione dell’itinerario romano dello scrittore. È noto che in alcuni punti dell’opera di Gogol’ ci siano richiami all’Italia, e in primo luogo alla Città Eterna. Gogol’ si riferisce all’Italia come al «suo paesaggio dell’anima», e che Roma «è di una versta più vicina a Dio». E ancora: «nella Città Eterna anche la miseria ha un aspetto luminoso e sereno». «Essa è mia - egli scrisse dell’Italia - nessuno al mondo me la strapperà»... La Borghese raccoglie queste e molte altre attestazioni, presenti nelle lettere gogoliane agli amici e negli appunti dei loro diari, le traduce in italiano e le assembla con cura in una attenta composizione scientifica. Tommaso Landolfi, tra i primi a interessarsi all’opera della Borghese, scrive: «il libro è generosamente rimpolpato di sostanza umana, anche aneddotica, sì da presentarci un Gogol’ vivo, benché circoscritto nel tempo e nello spazio, e da costituire (a inesprimibile soddisfazione del recensore) lettura oltremodo piacevole”. Si potrebbe pensare che, inseguendo le tracce di Gogol’ a Roma, l’autrice stessa abbia trovato conferma del suo destino romano. Forse la valente ricercatrice avrebbe scritto molti altri libri, ma le cose andarono diversamente. Il 4 febbraio 1963 Daria Borghese muore in un assurdo incidente stradale; aveva solo 54 anni. Da parecchi anni, in Italia viene assegnato il Premio Daria Borghese al miglior libro straniero sulla storia romana. ^ luglio di quest’anno. Era molto amato dai giovani per il suo linguaggio : : : a. ur. : : : : : ^ : confino a Magadan, riuscì a ricongiungersi con il figlio. Dopo molti anni, nel 1974, Aksenov ha descritto nel romanzo “Ustione”, la sua giovinezza a Magadan nella regione di Kolyma nell’estremo nordest della Siberia, uno tra i luoghi più inospitali della Russia. Anche la madre, Evgenia Ginzburg, ha scritto un libro di memorie sulla prigionia nel lager,”Viaggio nella vertigine”, una raccapricciante testimonianza del Gulag visto da una donna. Dopo la morte di Stalin e la “riabilitazione” dei genitori, il giovane Aksenov si laurea alla facoltà di medicina a Leningrado, lavora per un po’ come medico al porto marittimo di questa città, ma già allora pensa di dedicare la propria vita esclusivamente alla letteratura. I suoi primi romanzi hanno uno strepitoso successo sopratutto tra i lettori giovani, perché sono proprio loro, i giovani, i protagonisti di queste opere; parlano come gli eroi di Aksenov, vivono esattamente come lui descrive. Ai vecchi burocrati dell’ideologia le opere di Aksenov non sono mai piaciute, anche se, a dire il vero, egli per molto tempo non ha toccato temi “politicamente sensibili”, ma il suo dissenso irrompe piano piano nella forma letteraria. Lo scrittore comincia sempre più spesso a ricorrere al grottesco, all’humour un po’ surreale e a proporre fantasmagorie di vario tipo, ignorando i dogmi del realismo socialista. E allora le sue opere, non solo in prosa ma anche come pièce teatrali, sceneggiature per il cinema, vedono la luce e arrivano ai lettori e agli spettatori con sempre maggiore difficoltà. Aksenov perde la pazienza e accetta la sfida del : Quest’estate, all’età di 76 anni, è morto lo scrittore russo Vasilij Pavlovic Aksenov (Vasily Aksionov secondo altre traslitterazioni). Dopo l’ictus che l’aveva colpito l’anno scorso, mentre guidava la sua macchina a Mosca, Aksenov ha trascorso quasi un anno in coma e poi è deceduto. Si potrebbe anche dire che a questa venerabile età succede, ma non per Aksenov! Perché lui, anche all’età di 75 anni, era e continuava a essere giovane, gioviale, creativo, pieno di entusiasmo e di inventiva. Fino all’ultimo, scriveva libri; nel 2008 ha presentato il suo ultimo romanzo “Le terre rare” e ha pubblicato una raccolta di poesie. In un’intervista raccontava di aver incominciato a scrivere un romanzo autobiografico che purtroppo non leggeremo mai. Di romanzi piccoli e grandi (uno, il “Dolce stil novo” contiene 555 pagine), Aksenov ne ha scritti una ventina, ma in Italia ne sono stati pubblicati solo tre o quattro, a cominciare da “Il Biglietto stellare”, uscito in URSS all’inizio degli anni sessanta, all’epoca del disgelo post-staliniano. Nel 2009 è stato pubblicato da Baldini Castoldi Dalai il suo penultimo romanzo “I piani alti di Mosca” e forse grazie a questo fatto Aksenov è stato ricordato con poche righe su alcuni quotidiani italiani. Nel 1937, quando Vasilij non aveva compiuto ancora cinque anni, i suoi genitori furono arrestati e condannati a 10 anni di lager per presunta attività antisovietica: era il culmine del terrore staliniano. I figli dei “nemici del popolo” finivano all’orfanotrofio. Nel 1948, sua madre Evgenia Ginzburg, una volta uscita dal lager e costretta a vivere al : : Il grande scrittore russo Aksenov, purtroppo poco conosciuto in Italia, è morto a Mosca il 6 ^ ADDIO, VASILIJ PAVLOVIC potere inviando all’estero il romanzo “Ustione” e organizzando un almanacco letterario libero dalla censura, Metropol’. Per qualche tempo il regime medita su una punizione, ma non se la sente di infliggere misure troppo repressive a uno scrittore molto amato in Russia. Gli viene dunque concesso di recarsi negli USA per un ciclo di lezioni universitarie e subito dopo viene privato della cittadinanza sovietica. Solo alla vigilia del crollo definitivo dell’URSS viene ridata allo scrittore la possibilità di tornare in patria e di pubblicare liberamente là i suoi libri. In un’intervista Aksenov ha dichiarato: “Sono un conservatore con delle idee liberali oppure un liberale con delle idee conservatrici ... Ma rinnego subito la mia patria se lì si comincia a rierigere monumenti a Stalin”. Nel 2007 ha detto di Dmitrij Medvedev, il nuovo Presidente: “E’ intelligente. Ha una mente precisa. Afferra subito il fulcro dei problemi e, in un attimo, fornisce una risposta interessante”. Addio, Vasilij Pavlovic. Vasilij Aksenov 11 n° 10 - Ottobre 2009 NEGLI OCCHI DI VITTORIO Tanta gente alla Feltrinelli di Napoli dove Giovanna Mezzogiorno ha presentato “Negli occhi”, documentario sulla vita del padre Vittorio scomparso nel 1994 di Paolo Montefusco ezz’ora prima dell’inizio, lo spazio eventi della Feltrinelli di Napoli è già pieno di pubblico in attesa. Affollati i corridoi ai lati della sala e pure il pavimento, nello spazio davanti alle file di sedie, è occupato da chi vuole fotografare, prendere appunti o semplicemente ascoltare. Quando partono le prime clip del documentario c’è grande attenzione, mentre sullo schermo passano i volti di Michele Placido, Giuliano Montaldo, Gianni Minà. Passano le strade di Napoli, scure, notturne, (“l’abbiamo voluta così, un po’ come la vedeva Vittorio”) e passa la maschera più attesa e più amata, quella, naturalmente, di Vittorio Mezzogiorno, quella di chi insieme alla figlia Giovanna, è riuscito a far sedere la gente sul pavimento di una libreria per non perdere un’occasione di saluto. Si attende giusto un po’, poi arriva lei e la platea scoppia in un applauso fragoroso. La gente vuole ascoltare il racconto e lei ha voglia di parlare, spigliata ma allo stesso tempo sorpresa e forse “travolta” da tanta attenzione. “Negli occhi” è un documentario prodotto in maniera assolutamente indipendente dalla Vega’s Project (e distribuito da 01Distribution - Home Video) e da Giovanna Mezzogiorno. In concorso, nella sezione Controcampo Italiano, alla 66ma Mostra del Cinema di Venezia, “Negli occhi” è un viaggio nella vita e nella carriera di Vittorio Mezzogiorno, scomparso prematuramente nel 1994 all’età di 52 anni. Un racconto vissuto attraverso la voce narrante di Giovanna e con le testimonianze dei tanti che lo hanno conosciuto: da Francesco Rosi a Mario Martone, da Peter Brook (che lo volle per il “Mahabharata”) a Marco Tullio Giordana, oltre ai già citati Minà, Placido, Montaldo e a tanti altri. Le riprese sono state effettuate prevalentemente a Napoli, Parigi e Roma. La regia è di Daniele Anzellotti e Francesco Del Grosso, le musiche originali di Pino Daniele. Giovanna Mezzogiorno spiega subito che il documentario è stato fatto “con gradissima fatica perchè prodotto da me e da una piccola società. Un lavoro lungo. E’ stato facile raccogliere intervi- M ste di chi aveva tanto da raccontare su mio padre, difficile è stato mettere insieme tutte queste ore di materiale per farne il racconto di una vita”. “Vittorio Mezzogiorno - ha proseguito - è partito da una piccola realtà come Cercola per diventare uno degli attori italiani che maggiormente ha lavorato con registi internazionali”. Sui motivi che l’hanno spinta a realizzare “Negli Occhi”, l’attrice ha spiegato: “Non l’ho fatto per risolvere cose lasciate in sospeso con mio padre, anche se non ho risolto ancora tutto, il mio intento è stato solo quello di raccontare delle cose di lui, su chi ha fatto della sua carriera e del suo sogno professionale una missione”. Molte le testimonianze, cosa l’ha colpita di più? “Mi ha colpito, parlando con tutti, il fatto che si sentisse forte questa mancanza. Non mi ero resa conto di quanto fosse amato mio padre, di come abbia marcato la vita di tante persone. L’impressione è stata di trovarmi di fronte a chi, non potendo parlare con lui, desiderava parlare di lui. Questo dimostra che è importante - ha detto ancora - ciò che riusciamo a far crescere negli altri, al di là di ciò che realizziamo, dei premi e tutto il resto”. Che rapporto aveva suo padre con Napoli? “Un rapporto mostruoso, fortissimo e anche doloroso. Per questo nel documentario la città appare scura, notturna. Come la vedeva lui. ‘Negli occhi’ non è, in ogni caso, un documentario triste, anche se parla di una persona che non c’è più”. Il noto critico teatrale Giulio Baffi, che ha conosciuto Vittorio Mezzogiorno, intervenuto alla serata ha spiegato: “Quelle poche volte che ci incontravamo era sempre una gran festa perchè ci raccontavamo cose che col tempo avevamo capito”. “Vittorio - ha detto - è stato uno capace di battere territori diversi, colti e meno colti, con assoluto rigore culturale e professionale”. Al momento delle domande era evidente la voglia del pubblico di manifestare il proprio affetto per qualcuno mai dimenticato (“Giovanna, posso darti del tu? Tuo padre prima di essere un grande attore, era un grande uomo”). Oltre a quanto visto nel documentario non c’erano immagini di grandi dimensioni a fare da sfondo, lo sguardo magnetico di Vittorio Mezzogiorno non campeggiava nella sala. Ma la sua è stata una presenza, non un’assenza. Ed è stato come se la gente fosse lì per vederlo entrare. UN PREMIO ALLA NAPOLI MIGLIORE Ottima quarta edizione del Premio Masaniello con una serata conclusiva ricca di eccellenze partenopee e con gran protagonista il cantante Sal Da Vinci iunto alla quarta edizione con un costante percorso di crescita di prestigio, il Premio Masaniello - Napoletani Protagonisti ha ricosso successo anche quest’anno capace, come si è mostrato, di celebrare simboli e persone che portano in alto il nome di Napoli. La manifestazione, ideata da Luigi Rispoli e Umberto Franzese con “l’idea di valorizzare il patrimonio culturale napoletano e mettere in luce il quartiere del Mercato, cuore storico di Napoli. Attraverso i riconoscimenti ai partenopei che si sono distinti puntiamo a segnalare gli esempi positivi utilizzandoli quale leva per riscoprire l’orgoglio di essere napoletani”, ha avuto anche quest’anno come cornice della serata conclusiva la Piazza e la Basilica del Carmine Maggiore, che fu teatro della storica rivoluzione del pescivendolo Tommaso Aniello d’Amalfi, che nel 1647 sfidò la nobiltà spagnola che dominava in città. Una piazza colma di entusiasmo quella del 26 settembre scorso, un pubblico che ha affollato balconi, transenne e platea per assistere alla kermesse ottimamente condotta da Lorenza Licenziati. Sul palco si sono via via avvicendate tante presenze significative tra cui il Presidente della Provincia Luigi Cesaro, gli ideatori dell’evento Umberto Franzese e Luigi Rispoli, il Presidente della Commissione Cultura della Provincia di Napoli Serena Albano, Luciano Schifone, Marcello Taglialatela, il vicepresidente del Consiglio regionale Salvatore Ronghi, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il coordinatore regionale del Pdl Nicola Cosentino, per conferire i riconosci- G menti ai prescelti votati dalla giuria presieduta da Valeria Iacobacci e composta da Adriano Aveta, Antonello Gallo, Fortunato Rossi, Marina Imperato, Mariù Iacobitti, Carla Giordano. Particolare il riconoscimento assegnato al professor Claudio Vitale, primario nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli, che riceve anche la medaglia d’argento del Presidente della Repubblica, perché nonostante un attacco cardiaco ha felicemente portato a termine un intervento chirurgico su un ammalato di tumore al cervello. Di seguito sono stati premiati: per la poesia napoletana Salvatore Cangiani, per la parlata napolitana Nicola De Blasi, per la canzone napoletana Mirna Doris, per il giornalismo il direttore del “Roma” Antonio Sasso, per impresa e progettualità Giovanni Lettieri, per l’imprenditoria Dolores Cuomo, per le belle arti Riccardo Dalisi, per l’artigianato Tiziana Grassi, per il teatro Tullio del Matto, per le scienze dell’educazione Franco Lista, per La storia proibita Marina Salvadore, per la cultura napoletana Domenico Scarfoglio, nonchè Maurizio Ponticello con una menzione speciale fuori concorso. Tutti, per gli organizzatori del Premio, sono “simboli positivi della città di Napoli e rappresentano i migliori esempi di Napoletani Protagonisti”. La serata è culminata con il concerto di Sal Da Vinci davanti a 2000 persone che lo hanno accolto come un vero beniamino. Il cantante è stato insignito di un riconoscimento speciale per la napoletanità prima di dare l’avvio all’attesissimo concerto che ha Giovanna Mezzogiorno alla Feltrinelli. In alto, giovanissima, col padre Vittorio messo d’accordo sin dall’inizio fans di tutte le età. Una festa di urla e applausi per l’artista partenopeo che con grinta ha dispiegato il suo repertorio fatto di pezzi moderni, brani in lingua partenopea, testi della tradizione colta e popolare della grande canzone napoletana, successi di Sanremo e di celebrati lavori teatrali. Finale tutto dedicato a Napoli con un video di bellezze paesaggistiche napoletane e personaggi cari al popolo: Totò, De Filippo, De Sica, Sofia Loren, Troisi, Murolo, Peppino di Capri, Nino Taranto. Non mancano le immagini dell’infanzia e dell’adolescenza di Da Vinci che portano alla conclusione l’evento salutato dai sempre suggestivi fuochi d’artificio. Sal Da Vinci. protagonista al Premio Masaniello n° 10 - Ottobre 2009 12 ERRI DE LUCA VENT’ANNI DOPO Feltrinelli riedita il romanzo d’esordio del 1989 dell’autore napoletano arricchito da un’ introduzione dello scrittore sul cammino editoriale del testo di Raimondo Di Maio l tempo è il giudice inflessibile di un testo letterario, la durata è l’unica prova certa che ne decide la validità. Mai, prima d’oggi, il tempo ha consegnato intere biblioteche all’oblio. I libri letti, o riletti a distanza di anni, che continuano a “parlarci”, resistendo al tempo trascorso dalla loro pubblicazione, sono veramente pochi. “Non ora, non qui”, il ‘fantastico’ romanzo d’esordio di Erri De Luca, ha certamente superato la sfida del tempo e oggi viene proposto “vent’anni dopo” dall’editore Feltrinelli, che lo riedita aggiungendo al testo originale del 1989 un’introduzione dell’autore nella quale viene raccontata la storia editoriale del romanzo. “Non ora, non qui” è solo uno dei tanti altri libri di De Luca che col passare del tempo hanno guadagnato un numero sempre maggiore di lettori. L’impressione è che, una volta letto un libro di De Luca, i lettori sentano il bisogno di non interrompere il rapporto stabilito con l’autore e di alimentarlo, di tenerlo vivo attraverso gli altri libri, fenomeno che raramente si registra nel nostro sistema letterario. “Non ora non qui” è «il racconto di una voce interiore», come scrive l’autore nella bella nota che adesso accompagna il volume, aggiungendo che si tratta di «una lunga lettera a mia I madre». In un testo successivo l’autore aveva scritto che si trattava del romanzo di «un figlio segregato nel corpo e nei pensieri». L’io narrante si situa in un luogo di osservazione mobile, racconta storie dell’infanzia, una dopo l’altra, una nell’altra, che ricostruisce osservando fotografie: «Finché ebbe luce negli occhi, mio padre fece fotografie», è infatti l’incipit del romanzo. Un ragazzo balbuziente che sembra annunciare il problematico diventare adulti in una città dove ancora si avverte la miseria seguita alla Seconda guerra mondiale. Sono qui anticipati i temi preferiti dall’autore: la scuola, il mare, gli Alleati, la città, temi sui quali, nei vent’anni che sono nel frattempo trascorsi, De Luca è tornato a scrivere in un laborioso approfondimento. Parte anche da qui l’analisi di certi luoghi comuni, che vengono rivisitati con la forza di un nuovo significato grazie a una scrittura che trova la sua forza nel saper consegnare a noi lettori le proprie nuove metafore. “Non ora non qui” contiene quello stile capace nel giro di una sola frase di dar fondo a complesse vicende e sentimenti. Una scrittura asciutta, che sembra procedere per cancellature, che limita la descrizione a pochi scarni elementi essenziali. Ed è soprattutto l’uso della lingua, che riesce a far riaffiorare significati della parola unici, che allora come oggi fanno di Erri De Luca una delle voci più originali del panorama letterario italiano. UN FELICE AGOSTO IN CITTA’ Le suggestioni della città vuota, e finalmente vivibile, trovano il loro miglior compimento nel “racconto” di Giovanna Castellano di Giovanna Castellano ra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, uno dopo l’altro, amici e parenti in partenza per le rispettive vacanze, mi hanno telefonato per salutarmi e augurarmi buona permanenza in città. In loro c’era un affettuoso sarcasmo, una benevola ironia per me che rimanevo in città per lavoro, senza una spiaggia su cui stendermi al sole, in auto alla ricerca di qualche distributore aperto, con una meta ben definita che era quella del luogo di lavoro. In me c’era un affettuoso sarcasmo, una benevola ironia per loro che si tuffavano su spiagge affollate, in chilometri di traffico, verso orizzonti (per definizione irraggiungibili) che, nelle loro intenzioni, li avrebbe ritemprati da un anno di fatiche. Agosto in città è una cosa bellissima: ogni giorno sempre meno auto, ogni giorno sempre meno gente, ogni giorno sempre meno stress da accumulare; e mentre i supermarket dei luoghi di vacanze sono affollati ed esosi, quelli aperti in città sono semideserti e pieni di prodotti in offerta; e mentre in vacanza si vaga alla ricerca di un parcheggio, in città si arriva e si ferma l’auto dove è più comodo. Finalmente un periodo (ahimé, breve!), di pace con se stessi. In piena notte, non per insonnia ma per scelta, spesso sono uscita sul balcone e ho sentito il caldo accarezzarmi la pelle, con uno sguardo rivolto verso il cielo e ho scoperto che, nonostante l’alto livello di inquinamento atmosferico, le stelle che si possono vedere sono ancora T tante. Il silenzio di una notte d’agosto in città, specialmente in una città come Napoli, ti fa, forse più che riscoprire, finalmente comprendere al meglio i grandi poeti della nostra gloriosa tradizione. Ti concentri qualche attimo, tieni un po’ gli occhi chiusi e ti sembra di sentire quel pianoforte che Salvatore Di Giacomo immaginava di sentire di notte suonare un motivo antico. Se poi, come è successo a me, ti capita di fare un giro ai Quartieri Spagnoli, puoi avere la sensazione, accompagnata da una struggente malinconia, di vedere il mondo di Raffaele Viviani e le sue donne amare e vitali al tempo stesso. E il sole caldissimo, il mare calmo e azzurro, l’aria che a volte è mossa da un leggero vento che ti sfiora il viso, ti fanno capire come e perché sono nati i grandi capolavori della mai troppo celebrata canzone napoletana. Il culmine di questa Napoli surreale si è raggiunto alle tre del pomeriggio del giorno di Ferragosto: una totale assenza di rumore, che è qualcosa di più significativo del silenzio assoluto, ha dato spazio a tutti i miei pensieri riuscendo a esaltare quelli belli e a mitigare l’amarezza per quelli brutti; mi è venuta un po’ di tristezza quando ho pensato che per vivere un altro momento simile avrei dovuto aspettare le nove del mattino del giorno di Capodanno. Se poi a tutto questo si aggiunge che il mio luogo di lavoro durante il mese di agosto è il Maschio Angioino dove ogni sera si svolge uno spettacolo teatrale, allora si comprende la mia gioia per essere rimasta in città. E inoltre, la rassegna teatrale che, organizzata dal Teatro Totò, si svolge ormai da diciannove anni, quest’anno è stata arricchita dalla presenza di un nuovo “attore”: nello spettacolo “Luna nera”, scritto da Gaetano Liguori (direttore artistico del Teatro Totò), ha debuttato un giovanissimo ... Gaetano Liguori, figlio di Enzo Liguori (regista dello spettacolo) che per la prima volta ha calcato le scene all’età di due mesi! Sì, sono stata proprio contenta di essere rimasta in città! Qui sopra, Gaetano Liguori, direttore artistico del Teatro Totò, con il pronipote Gaetano. In alto, una veduta aerea del Maschio Angioino, luogo del “debutto” del piccolo. n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida MARIO PORFITO Presto a teatro con “Se devi dire una bugia dilla grossa” al fianco di Patrizio Rispo, l’attore parla del suo forte impegno con l’Unicef. “L’Africa alla fine vincerà”, dice. di Paolo Montefusco nche a settembre inoltrato Napoli si ostina a regalare giornate di caldo nelle quali muoversi freneticamente in mezzo a traffico di auto e folla di pedoni. Il sole insiste a picchiare? Allora meglio un posto all’ombra, anche se l’ospite che attendiamo è Mario Porfito che dopo una lunga presenza nelle nostre case come protagonista de “La Squadra” è oggi adottato, con successo, dalla famiglia di “Un posto al sole”. Va bene un caffè all’aperto, quindi, per raccontarsi lungamente. Mario Porfito, da sempre “attore di teatro prestato anche al cinema e alla televisione”, lo fa spingendo sull’acceleratore del suo sentire umano quando parla in maniera ampia del suo impegno con l’Unicef per le popolazioni africane povere. Intanto, lo vedremo di nuovo a teatro (All’Acacia e al Totò) con “Se devi dire una bugia dilla grossa” commedia di Ray Cooney, nella quale reciterà al fianco dell’amico di una vita Patrizio Rispo. Mario, perchè la scelta di portare lo stesso spettacolo in due teatri diversi di Napoli? Perché oggi è complicato fare tournèe. Una volta col teatro allestivi una produzione e riuscivi a girare tra le città, oggi le tournèe si fanno all’interno della stessa città. Oggi vince la logica commerciale, con cartelloni basati per un 60 - 70 % su quello che passa in televisione. Una cosa che mi rattrista molto. Un tempo non era così e ci fu il noto episodio di Pippo Baudo che a teatro fece flop proprio perché la gente lo aveva tutte le sere in tv. Perchè oggi accade questo? Perchè si è radicata la curiosità di voler andare a vedere dal vivo personaggi come Fabrizio Corona il quale se facesse uno spettacolo a teatro farebbe di sicuro il tutto esaurito. Si è imbarbarito il gusto della novità, che invece il teatro è in grado di riservare ancora. In conclusione, si trova meno spazio nei cartelloni anche quando, nel nostro caso, si porta in scena un autore come Ray Cooney che non si ha spesso l’opportunità di conoscere. Cosa cambierete rispetto alle precedenti edizioni della commedia? I due precedenti storici del Sistina godevano di allestimenti miliardari. C’era un grande girevole in scena che permetteva di raccontare la storia nei vari ambienti. Noi chiaramente dobbiamo fare di necessità virtù e quindi dobbiamo scatenare la fantasia per ottenere lo stesso effetto con una scena più minimalista. Ma questo poi mette in evidenza la bravura degli attori. Ancora una volta sei insieme a Patrizio Rispo, cosa vi accomuna? Ormai siamo una coppia di fatto. Intanto, ci accomuna la voglia di fare questo lavoro divertendoci e si comincia dal fatto che siamo amici nella vita. In più, il fatto di voler proporre di Napoli un’ immagine diversa, nuova, moderna. Io e Patrizio inoltre condividiamo l’idea che ci sia un repertorio teatrale che va pensato in napoletano e poi recitato in italiano così da acquistare nuova verve, immediatezza, velocità espressiva. E poi c’è l’essere napoletani. L’essere napoletano ti consente di individuare i fuochi di una scena e di mettere via gli orpelli e una parte di teatro già troppo visto. Questa sintonia di vedute diventa scelta dei testi e condivisione anche culturale perché noi siamo tra quelli che hanno scelto orgogliosamente di restare a Napoli. Non andar via è la scelta più difficile ma anche quella che ci sta ripagando, detto con umiltà e soddisfazione, degli sforzi fatti. Rimanere a Napoli significa rappresentare questa città in modo positivo, ottimistico con quello di buono che ha. Questo come si riflette in senso artistico? A Napoli sono trent’anni che se fai Scarpetta, Petito o Eduardo vendi sicuramente lo spettacolo. Noi non vogliamo fare questo perché lo fanno in tanti e soprattutto perché siamo convinti di poter fare altro. E il dover girare in due teatri a Napoli e vendere poco lo spettacolo è il risultato di questa scelta più difficile. Oggi non c’è più l’imprenditore che rischia nel teatro, si vuole la sicurezza dell’incasso tanto da non offrire mai al pubblico una scelta più ampia. Facevi parte del gruppo storico de “La Squadra”. Cosa ti piaceva di più? “La squadra” si proponeva anche di mandare un messaggio di ottimismo. In un momento in cui impera la criminalità e il degrado sociale lo tocchi con mano, rappresentare un gruppo di persone che resistevano resistevano resistevano (e cito così un esempio di cui A vado orgoglioso) in un commissariato di frontiera con la propria onestà e la propria dirittura morale e con la propria “curiosità” verso ciò che accade in città, ci sembrava una scelta da condividere anche come messaggio. Non si trattava solo di risolvere il caso poliziesco ma di ambientarlo in modo da comprendere, senza fornire alibi ad alcuno, come e dove maturava la delinquenza. E poi, cos’è accaduto? E’ venuto un momento in cui questo sembrava importare solo a noi per cui si è deciso di operare un cambiamento radicale facendo nascere un prodotto completamente diverso e cambiando tutto il cast. Mario Porfito. In basso l’attore è tra i bambini della scuola pubblica di Gabù, in Guinea Bissau Oggi sei stato “adottato” da “Un posto al sole”. Evidentemente avevo seminato bene professionalmente. E’ una produzione che pur avendo contenuti e pubblico diverso si trova a raccontare un real drama, uno spaccato di società ambientato a Napoli (che è valore aggiunto di qualsiasi racconto) con la volontà di raccontare le vicende e le difficoltà di una vita e offrire al pubblico un’immedesimazione spontanea nei personaggi. Teatro, cinema e televisione. Cosa c’è di più nelle tue corde? Nelle mie corde ci sta il teatro. Ho iniziato con quello, l’ho fatto per 25 anni e ho avuto la fortuna di sedere al tavolo con i grandi, perché ho lavorato sei anni al Piccolo di Milano con Strelher e dopo con Giuseppe Patroni Griffi, uno dei registi che ho amato di più. Poi ho lavorato con Luca De Filippo e sono uno degli attori storici del Bellini e con Tato Russo ho un sodalizio lunghissimo. Ho avuto modo, quindi, di fare teatro di serie A. Si può descrivere l’emozione di un attore sulla scena? L’emozione più grande per un attore è quella di trovarsi davanti al pubblico e di pronunciare quella battuta che può essere detta una volta sola senza che la si possa ripetere. Se la dici bene hai il riscontro emotivo del pubblico, se la sbagli non c’è replica. Questo salto nel vuoto è la cosa più emozionante. E il cinema? Ne ho fatto tanto e mi ha sempre divertito ma dandomi ruoli di scarsa responsabilità. In più, il cinema richiede cura e la frequentazione degli ambienti giusti a Roma. Come sono stati i tuoi inizi? Faccio l’attore un po’ per caso. Ero uno di quelli che teneva banco a scuola raccontando barzellette, una specie di intrattenitore. Questo mi ha aiutato anche a scuola perché mi veniva riconosciuta la capacità di interloquire, per cui io tre cose sapevo ma le vendevo benissimo. Infatti, sono uno di quelli che è arrivato al diploma senza bocciature o rimandi grazie anche alla spigliatezza e alla velocità di espressione. Anche dopo, all’università, ho sfruttato gli inizi della carriera teatrale, con i primi contatti, per non partire militare “promettendo” ai professori, che dovevano assegnarmi l’esame, che mai avrei fatto l’avvocato. Poi la chiamata la evitai per il tragico evento del terremoto del 1980. La vera carriera come ha avuto inizio? Ho cominciato un po’ per caso, per un amico che faceva teatro a livello amatoriale e ho avuto la fortuna di non fermarmi mai. Napoli nel periodo in cui ho cominciato io, negli anni 70/80, produceva e consumava teatro in maniera autonoma. A Napoli c’erano almeno dieci compagnie di teatro: dagli “Ipocriti” di Nello Mascia a Galdieri con Ente Teatro Cronaca, a Tato Russo. Tanti spazi d’avanguardia che producevano sempre spettacoli e avevano bisogno 13 di attori nuovi. C’è stata da poco la Piedigrotta con le immancabili polemiche sui costi e sullo svolgimento. Che idea ti sei fatto? Credo che manchi una certa progettualità. Fare un concerto in piazza Plebiscito può non essere uno spreco di denaro perché si pensa sempre ad altri ricavi e avere Elton John a Napoli è senz’altro un vanto. Ma usare la Piedigrotta per avere Elton John mi sembra inutile. In questo senso mi sembra che non ci sia nessuna idea. Se Piedigrotta è l’occasione per fare sinergicamente una mostra d’arte, un microfestival del teatro, un’esperenza per poter vedere musica, aprire alla città posti in genere chiusi, ecco che diventa già più interessante e importante, senza tralasciare quelli che sono il rito e la festa. Sbaglio o alla tua carriera è mancato un musical? Si, è mancato un musical per il semplicissimo fatto che non so cantare. Suonare uno strumento e cantare in maniera quanto meno decente mi sarebbe piaciuto tantissimo. Io mi innamoro di tutte le donne che sanno cantare bene e ho grande ammirazione di tutti gli uomini che cantano bene perché sono affascinato da questa magia che è la musica in genere e infatti ascolto veramente tutto. Parliamo di te come padre. Come vivi la crescita delle tue figlie in una città oggi pericolosa come Napoli? La vivo con terrore, ma soprattuto con la paura di esercitare io su di loro un terrorismo psicologico. Stanno vivendo il momento più bello della vita, non puoi negarglielo. Ho dei ricordi bellissimi delle nottate passate in gioventù semplicemente a parlare con gli amici. Quindi non mi sogno neanche di proibire ma ritengo sia più giusto far scattare dei meccanismi critici sui comportamenti o sulle persone da frequentare. E con la televisione che guardano? Ti racconto un episodio. La mia figlia più grande qualche anno fa guardava “Il grande fratello” su Sky. Io misi il blocco al canale e pensai di aver fatto una furbata. Poi cominciai a vedere mia figlia che di pomeriggio spariva e ovviamente era perché andava a casa di un’amica a vedere “Il grande fratello”. Quindi anche lì capii che la cosa migliore era seguirla e cercare di farle capire quando certi comportamenti erano sbagliati, quando in verità da quella trasmissione si faceva solo pubblicità occulta. Sei molto impegnato nella solidarietà, con l’UNICEF. Ce ne parli? E’ una cosa della quale ho sempre piacere parlare in qualsiasi intervista e anche se non me lo chiedono io ci arrivo col discorso. E’ l’unica guerra che vale la pena combattere. Quello che mi ha “costretto” a fare un’esperienza di solidarietà e che vorrei trasmettere ad altri, senza che debbano per forza di cose farlo con l’UNICEF, è proprio il fatto che avere a questo punto della mia vita una faccia spendibile, una popolarità, che mi ha portato a fare una scelta precisa: o aprire un ristorante come fanno molti attori popolari a Roma o mettere questo a servizio di un criterio di giustizia che avvertivo. Ti hanno cercato loro? Ci siamo cercati insieme, perché avevo piacere a entrare in una cosa del genere e avevo bisogno di una onlus seria e di operatività concreta come l’UNICEF. Come è cominciata ? Abbiamo iniziato io e Patrizio Rispo insieme quando ci hanno chiesto di fare da testimonial ad alcuni eventi qui a Napoli. Quando si sono accorti che la nostra faccia era spendibile e che raccoglievamo la fiducia della gente, e quindi i fondi, spiegando bene le finalità dell’UNICEF, da Roma ci hanno proposto di diventare ambasciatori nazionali (goodwill ambassador) cosa che siamo da 4 anni. E a quel punto? Mi hanno detto di esserlo a modo mio e mi hanno portato in Guinea Bissau dove l’aspettativa media di vita è di 50 anni, dove un bambino su cinque non arriva a sei anni di età e dove attualmente è in corso una campagna di vaccinazione contro il tetano, malattia che qui da noi abbiamo sconfitto trent’anni fa ma che in quel posto è causa delle maggior parte delle morti infantili date le scarse condizioni igieniche in cui si affronta il parto. E’ un luogo in cui convivono culture e religioni diverse. E devo dire a malincuore che proprio le religioni diverse sono spesso causa di chiusura verso le conquiste della scienza. In che modo si opera in posti come quelli? Segue a pag. 14 14 sussurri & grida DEMARCO, INDAGINE SUL MERIDIONE Il libro del direttore del Corriere del Mezzogiorno “Bassa italia - l’antimeridionalismo della sinistra meridionale” analizza i problemi annosi del Sud senza cadute ideologiche di Gerardo Pedicini ndagine a tutto campo. Dalla filosofia alla letteratura, dalla storia alla sociologia, dalla antropologia alla cronaca giornalistica. Questo è “Bassa Italia - l’antimeridionalismo della sinistra meridionale” di Marco Demarco, pubblicato da Guida Editore. Uno scandaglio minuzioso, una analisi attenta, una lucida messa a punto di problemi. Senza fronzoli e senza facili vittimismi o cadute ideologiche. Tanto consente all’autore di affrontare con ferma determinatezza l’argomento e di rivoltarlo dentro fuori con il preciso scopo di mettere a nudo e superare annose questioni legate alla “questione meridionale” che nonostante impegni, accorgimenti, aggiustamenti resta ancora irrisolta. Quali le cause? Molteplici. L’autore le passa in rassegna a una a una. A partire dagli stereotipi (Roberto il Guiscardo definiva i meridionali “caccarelli e merdaçoli parvique valoris” come ci ricorda l’autore), alla attenta disamina dei pregiudizi che dall’Unità d’Italia fino a noi hanno accompagnato l’azione politica nel Mezzogiorno. Con ampiezza di vedute e argomentate intuizioni ed esplicitazioni critiche, l’autore affronta le problematiche, culturali e politiche, che non hanno consentito al Mezzogiorno di trovare una sua giusta collocazione nell’ambito della politica nazionale e, di fatto, ne hanno ostacolato lo sviluppo consentendogli di accentuare i propri errati convincimenti ideologici e culturali. Da qui, senza infingimenti e falsi vittimismi, l’interrogativo: la responsabilità del ritardo “meridionale” è ascrivibile soltanto al dirigismo politico nordista? Quali le responsabilità della sinistra meridionale, soprattutto nelle vicende politiche di questi ultimi anni? Emergenza rifiuti a Napoli (si legga, in proposito, l’appassionato racconto “I giorni della vergogna” di Marco Imarisio), distacco sempre più crescente tra istituzioni e corpo sociale, nuove forme di clientelismo, malasanità, I MARIO PORFITO Segue da pag. 13 L’unico meccanismo che ripaga è quello che definiscono, nel loro particolare idioma, il “Trabagliar camminando” cioè lavorare camminando. Girare per i villaggi, contattare in maniera capillare le varie tribù, conquistare la fiducia dei capi villaggio, far capire la tua buona volontà e mostrare con gli anni la tua operatività e la tua buona fede. Solo così puoi ottenere dei buoni risultati. All’inizio quando mi spiegavano le cose mi sembrava di ascoltare discorsi lunghi, farraginosi. Poi ho capito che i risultati arrivano solo attraverso questo tipo di lavoro, attraverso degli studi preventivi, come per esempio quello di un tipo di coltivazione che può essere innestata in modo da dare una certa autonomia economica. Occorre sempre attenzione. Adesso si sta pensando di coltivare la canna da zucchero ma bisogna vedere prima cosa succede anche all’ambiente circostante. Per questo gli studi devono essere lunghi e lenti. Qual è il contraccolpo emotivo di un’esperienza del genere? E’ quello che vivo a volte ancora adesso quando la notte mi sveglio angosciato e poi realizzo che sono le cose che vedo in Africa. E’ una sensazione che ti resta dentro e ti responsabilizza. Ancor più da padre perché rifletti quelle difficoltà suoi tuoi figli e pensi che in quelle condizioni loro non ce l’avrebbero mai fatta. Cosa hai compreso vedendo da vicino quella realtà? Andando in quei luoghi capisci che ci sono cose che si possono fare, obiettivi che si possono raggiungere, per cui mi sembra assolutamente assurda la scelta di girare la faccia dall’altra parte. Perchè ci sono i mezzi e i modi, con un piccolo sacrificio, di restituire dei diritti. Non voglio pormi su un piedistallo e parlare di elemosina o carità. Quali responsabilità avverti oltre la tua singola persona? Ecco, voglio dire che la mia generazione ha fallito. Ci troviamo davanti agli occhi uno sconquasso provocato dai cinquantenni come me. Ci troviamo di fronte al disastro ambientale, al disastro economico, al degrado dei rapporti umani e civili, a un’assenza di valori, a un attacco alle conquiste della generazione prima della nostra come la certezza di una democrazia, la certezza di una libertà di espressione, di condivisione di ideali, di destra e di sinistra. E quindi si torna al discorso dei modelli. I tuoi quali erano da giovane? corruzione testimoniano il fallimento della politica della sinistra in tutta l’area del Mezzogiorno. Di fatto, l’incapacità di istituire forme e modi nuovi di sviluppo attraverso un diverso rapporto tra istituzioni e società civile, ha ulteriormente divaricato il gap Nord-Sud. E ha portato, da un lato, a far insorgere nell’animo della popolazione meridionale la mai sopita tendenza a perseguire e coltivare il proprio particulare interesse e, dall’altro, a rispolverare nella opinione pubblica “padana” la “deriva antropologica” per giustificare il loro ricorrente ostracismo verso i meridionali. Di certo, dopo la débacle è facile e semplicistico per tutti scaricare sugli indifesi meridionali il peso della responsabilità della situazione. Un interrogativo però sorge spontaneo: quale contributo hanno dato i mass-media, gli intellettuali, le classi professionali meridionali per arginare lo slittamento? A mio parere nessuno. Come risollevarsi allora dal degrado e dallo scolla- n° 10 - Ottobre 2009 mento? Rispolverando presunte nobiltà intellettuali o rincorrendo palingenesi ribellistiche? La proposta di Demarco, condotta da uno osservatorio privilegiato: la direzione de “Il Corriere del Mezzogiorno”, è semplice e insieme efficace: se si vuole una società al passo coi tempi, bisogna che le componenti sociali cooperino tra loro e comprendano che il motore primo dello sviluppo della coscienza collettiva è nell’azione congiunta dell’intero corpo sociale. A tal proposito l’autore cita Norberto Bobbio: “Ho sempre esitato a esprimere il mio parere su una questione così complessa e controversa come la questione meridionale. Ma una cosa è diventata ai miei occhi sempre più chiara, e sempre più difficilmente confutabile: la questione meridionale è prima di tutto una questione dei meridionali”. E’ una indicazione affascinate, ma un dubbio resta: riusciremo tutti insieme a dare vita ed energia a questi nuovi scenari operativi come auspicano Bobbio e il direttore de Il Corriere del Mezzogiorno? Marco De Marco con Antonio Bassolino alla presentazione del volume a Napoli. A lato Norberto Bobbio Io mi ispiravo a Che Guevara, a Marlon Brando, a Paul Newman. Oggi il modello è Corona e un giovane pensa: se c’è lui posso esserci anch’io, mentre io guradavo in tv Brando o un politico come Berlinguer e dicevo voglio essere come lui. Ma per arrivare a quella conoscenza, a quella capacità di racconto, devo avere alle spalle una cultura, avere la capacità di esprimere opinioni diverse che siano illuminanti. Citiamo sempre Corona. Citiamo sempre Corona perché lui si è proposto come modello di una vita vincente, diciamo Corona per non dire Berlusconi, ma siamo lì. Sono i due che si propongono come esempi da seguire. Berlusconi ha detto che tutti gli italiani vorrebbero essere come lui. Io sono uno di quegli italiani che non vorrebbe essere come Berlusconi. Quindi desidero dirlo, occorre che tutti lo dicano. Ma quelli come me hanno la possibilità di dirlo, ecco, grazie a un microfono che mi mettete davanti e che mi fa parlare. E allora lo dico. Mi sembra doveroso perché se pure dieci persone condividono la mia idea queste persone non devono sentirsi sole. Torniamo a parlare dell’UNICEF. Spesso c’è diffidenza verso realtà come questa. Come mai secondo te? L’esigenza di dare fiducia a ONLUS come l’UNICEF, ma anche come AMFREF, EMERGENCY o MEDICI SENZA FRONTIERE, sta proprio nel fatto che la benficenza è diventata anche un’industria. Quando sono stato in Africa, c’erano decine di onlus che facevano finta di aiutare procurandosi lucro. Bisogna quindi sgombrare il campo da questi equivoci perché la gente spesso si mette la coscienza a posto dicendo: io non dò nulla perché tanto rubano tutto. Cosa è accaduto? Hanno fatto sì che l’Africa diventasse una discarica di tutti i prodotti che, come in Italia così nel resto del mondo, non servono più creando delle finte onlus che scaricano questa spazzatura in Africa facendola passare per beneficenza. Con quale meccanismo operano queste realtà? Facciamo un esempio: ci mettiamo d’accordo per fare una piccola ONLUS e cominciamo a raccogliere fondi. Se tu hai un amico che ha un’azienda e ti dona 30mila euro ma ti chiede la fattura per 60mila, detraendosi tutto. Tu allora vai in un negozio, per esempio, di elettrodomestici e compri roba che è fuori mercato per 30mila euro facendoti fatturare 60mila. Così fai finta di aver donato dei condizionatori in Africa. Che però consumano come una petroliera e non servono in un paese in cui non c’è l’energia elettrica come da noi. Un ospedale di lì dovebbe spegnere tutte le luci per aver un condizionatore del genere in una sala operatoria. Altro? Ho visto ambulanze nuove regalate agli ospedali. Ma ambulanze che vanno a benzina in un paese dove la benzina non c’è. Non si erano nemmeno preoccupati di vedere come funzionava la trazione in quei paesi, che hanno solo il gasolio. E’ beneficenza questa o è solo un danno? E’ ovvio che l’UNICEF dona solo attrezzature che per adeguatezza e capacità di assistenza sono ottime. Per questo occorrono degli studi prima di agire. Come sono organizzati i tuoi impegni con loro? Sono loro a dirmi dove può essere utile la mia presenza e io, in base agli impegni di lavoro, cerco di esserci sempre. Ma sono importanti anche occasioni come questa con voi, quando se ne può parlare. Perché spesso quando si legge di beneficenza si gira la pagina e a tal propostio vorrei raccontare un episodio. Prego. Io ricordo sempre un episodio legato a Giobbe Covatta che è mio amico fraterno ed è impegnato con l’AMREF, lui è bravissimo a raccontare questi problemi con leggerezza e in modo non comune, basti vedere il suo film “Muzungu”. Ebbene, nel cartellone di quel film c’era la faccia simpatica di Giobbe e, in primo piano, una bambina di colore. Andarono in pochissimi a vederlo, nonostante Giobbe in quel periodo vendesse tantissimo i libri e avesse i teatri pieni. Cosa non funzionò? Spaventò l’immagine di quella bambina. Spaventò, e questo lo analizzammo insieme, la senzazione della gente di trovarsi sotto esame, di vivere il senso di colpa della propria scarsa disponibilità. Come vedi il futuro in base alle riflessioni che abbiamo fatto? Dico che non possiamo non pensare che queste situazioni sono vicine a noi, grazie ai mezzi di oggi. E’ una pentola a pressione accesa a tre ore di aereo da noi. Penso a mia figlia: se lascio le cose come sono per guardare al mio orticello, per difendere la mia generazione, ho rovinato lei e le future generazioni perché a loro spetterà l’ingrata convivenza con una società che sarà sicuramente peggiore della nostra. Perché questa gente che non ha nulla, che è disperatata, prima o poi evaderà e invaderà, con pieno diritto, i paesi più industrializzati. E’ solo una questione di scadenze che non bisogna immaginare poi così lontane. Se volessi pensare in modo utilitaristico direi che io sono con l’Africa, sono con quelli che vinceranno perché l’Africa vincerà. n° 10 - Ottobre 2009 15 sussurri & grida IL SOGNO SAX DI MARCO ZURZOLO Il sassofonista napoletano ricorda gli esordi ed esorta i giovani a imparare dai grandi musicisti. “Un disco è sempre il risultato di un percorso” di Anna Montefusco er il grande sassofonista Marco Zurzolo vivere a Napoli è imprescindibile, dice che fa bene alla sua musica, che è fonte di ispirazione e di energia e che non ne può fare a meno. Abitare poi di fronte al Conservatorio, nel cuore del centro storico della città, dove i rumori si fondono con le note in uno strano mix sonoro deve essere il massimo per un musicista che attinge alla strada. Ed è qui che lo raggiungiamo, disponendoci, comodamente, a una piacevole e interessante chiacchierata, interrotta di tanto in tanto dalla vocina di Sofia che filtra le telefonate del suo papà. Marco, sei diplomato in flauto. La passione per il sax nasce in corso d’opera o l’avevi già prima del Conservatorio? Devi sapere che vengo da quello che fu un periodo storico-musicale molto importante per Napoli in quanto stava nascendo un movimento particolare, la Batracomiachia, un gruppo storico forse poco conosciuto del quale facevano parte Pino Daniele, Enzo Avitabile e anche mio fratello Rino. Io allora ero un ragazzino di tredici anni, partecipavo alle loro prove e mi affascinava ascoltare Enzo che suonava il sassofono. Stavo finendo le scuole medie e avrei voluto iscrivermi al Conservatorio ma i miei spinsero per il Liceo Scientifico che frequentai per circa due anni per poi stancarmi. Al Conservatorio ho studiato flauto, e non mi è dispiaciuto, anche se avrei voluto studiare sassofono, ma tieni conto che allora questo strumento non c’era nei programmi d’insegnamento. E allora come è andata? E’ andata che ho comprato un sassofono e l’ho studiato contemporaneamente al flauto, ma ovviamente di nascosto dall’insegnante perché allora quella scuola era molto severa e gli insegnanti erano molto rigidi nelle regole. Inoltre, i due strumenti erano incompatibili. L’ho studiato da autodidatta guardando suonare Enzo Avitabile e James Senese. Poi in seguito mi innamorai del jazz e ascoltavo i dischi di Charlie Parker e di John Coltrane. La mia vita era un sogno e io ero completamente immerso in questa vita molto musicale, molto interessante. In più, anche lo studio dei personaggi contribuiva alla crescita personale. Tutto questo credo che manchi ai ragazzi di oggi ed è un grosso limite. In che senso scusa? Adesso non voglio fare l’ “anziano” che regala pillole di saggezza, anche perché mi esibisco nei club e sono circondato da tanti giovani. Però penso che la velocità con la quale ottengono le cose sia un limite alla loro crescita. Oggi non c’è più l’attesa di un disco, non c’è più la ricerca. Ricordo le volte in cui uscivo con mio fratello alla ricerca di un disco sconosciuto. Oggi accendi il computer e lo trovi in pochi secondi. E’ finito il vinile ma è finito anche il cd e un ragazzino di dieci anni conosce direttamente l’MP3. Non c’è più il gusto di conservare il materiale, un cofanetto per esempio, e soprattutto non c’è più la curiosità che spingeva alla ricerca. Perché secondo te? Forse perchè non si investe più in se stessi. Troppi modelli negativi di facili scorciatoie. Penso, per esempio, a una ragazzina di sedici-diciassette anni, carina, che vede in tv o sui giornali tante coetanee che in poco tempo e senza fatica alcuna ottengono il loro “posto al sole”. La ragazzina non si impegna più in estenuanti ore da dedicare allo studio, magari al pianoforte per rimanere in tema musicale, ma guarda alla scorciatoia. Si sta perdendo tanto, ma purtroppo questi ragazzi sono cresciuti sotto il “Grande fratello” che è un surrogato del grande sogno e non so davvero dove arriveremo. Cambiamo argomento ma non tasto dolente. Come ti P è sembrata quest’anno la Piedigrotta, ti associ alle immancabili polemiche? Mi associo a chi parla di spreco. Si è fatto un unico concerto e sono stati spesi settecentocinquantamila euro. Ne avrei fatti molti di più regalando la possibilità a tanti ragazzi di conoscere tanti altri artisti internazionali e non solo Elton John. Mi associo meno a chi parla di Piedigrotta “snaturata” perché poco popolare. E’ vero Marco Zurzolo che con una festa dedicata alla Madonna Elton John ha poco da spartire, è sicuramente innegabile che la Piedigrotta nasce come evento popolare, ma è anche vero che non si può rimanere legati per sempre al passato. Il punto nodale è la conoscenza della nostra tradizione che va tramandata e preservata e la star in oggetto non la rappresenta certo, si poteva cercare in altre direzioni, ma tant’è. Ripeto: io lamento soprattutto lo spreco in direzione di un unico artista e lo spreco di danaro pubblico che poteva essere utilizzato per la crescita del nostro territorio, le altre polemiche mi interessano meno. Hai dichiarato che da Cuba, che visiti ogni anno, e da Napoli, trai grossa energia che veicoli poi nella tua musica. Dai luoghi evocati nel cd “Migranti” cosa hai tratto? Faccio una piccola premessa: oggi un giovane musicista può fare un cd in un quarto d’ora. E’ sufficiente un’apparecchiatura abbastanza adeguata come un computer, e un po’ di suoni sparsi qua e là. Ne viene fuori un lavoro anche altamente professionale per carità. Ma il disco è il percorso di una persona, come accade per un libro. In ogni mio disco c’è un vissuto, basta pensare che il mio ultimo cd è stato “7 e mezzo” e l’ho composto quattro anni fa. Pensa, sono passati quattro anni per realizzare poi “Migranti”, l’ultimo. Non è un caso. Detto questo, rispondo alla tua domanda: “Migranti” è un lavoro nella mia città verso l’Africa e verso le persone. Un altro percorso di vita vissuta, di ricerca, di altra grande energia accumulata da trasferire poi nella musica, da allargarci l’anima. L’emigrazione è una tematica attuale. Si, si parla sempre più spesso dell’Italia come di un paese non multietnico. Arrivano in ritardo. Basta ascoltare ragazzi e ragazze neri che parlano il napoletano, l’italiano. Viviamo già in un paese multietnico. E’ un momento di avvicinamento tra popoli diversi, tra le persone. Si parla sempre più spesso di razzismo, cosa per me inconcepibile. Non ho mai visto “diversità” nel genere umano e allargo il concetto anche agli omosessuali, presi di mira ultimamente. Ma poi diversi da chi? Sempre a proposito del tuo ultimo disco, c’è un omaggio a Mario Merola. Un atto dovuto? Premetto che non sono un fan dei neomelodici, ma che li ascolto. Mi interessa il loro mondo, cantano uno spaccato della mia città. Merola è stato il re della sceneggiata, un’operazione molto popolare che ha sempre funzionato. Sfido chiunque non si sia soffermato, fosse anche solo per curiosità, a guardare “O zappatore” pescato su qualche canale libero. Io l’ho fatto. Quello che mi dà fastidio, e che non trovo giusto, è che adesso nessuno lo ricordi più. Ha dato un contributo notevole a Napoli, nel bene e nel male non va dimenticato. A proposito di Napoli, sei tra quanti “stoicamente” hanno deciso di rimanere. Sei però mai stato tentato di scappare? Ti dirò che ho ricevuto proposte professionali allettanti, con dei bei guadagni. C’era la possibilità, per esempio, quando ho musicato dei film per la Rai di rimanere a Roma. Ma non ce la faccio, mi sento un uomo sperso lontano da Napoli e poi ho bisogno del mare. Sarà sporco quanto vuoi, ma quando me ne vado in giro in moto per via Caracciolo per me è la vita. I problemi sono tanti, a volte mi sento un turista in questa città, non c’è mai niente da fare. Se un ragazzo oggi vuole imparare a suonare, mancano i posti dove ascoltare la musica, mancano i club, mancano i luoghi di aggregazione dove poter fare jam-session. E’ rimasto quasi solo l’ “Around Midnight”, ma ci prendiamo per i capelli per suonarci. In una realtà così difficile la musica potrebbe porsi come strumento di salvezza o è esagerato pensarlo? Assolutamente no, ma come dicevo non ci sono le strutture adeguate, quelle deputate all’aggregazione, necessarie anche per togliere questi ragazzi dai computer e dare loro maggiori possibilità di imparare la musica. Perché io penso che la musica non si impara solo suonando a casa, bisogna “vedere” gli altri come suonano, come ho fatto io all’inizio della mia carriera. E va bene, le istituzioni sono latitanti. Ma tu ritieni di avere fatto la tua parte? Sono trent’anni che faccio questo mestiere. Il mio primo concerto l’ho fatto a diciassette anni, a Mosca con Eugenio Bennato. Più di rimanere qui, morbosamente attaccato al territorio nonostante i limiti oggettivi e senza risparmiarsi, non saprei cosa altro fare onestamente. Non fai solo questo. So che sei molto presente nel sociale e che hai molto a cuore i bambini. Per quanto riguarda le tematiche sociali, è vero che le avverto molto e sono pronto a dare il mio contributo ogni qualvolta è necessario. Per i bambini poi ho un amore particolare, ne farei altri cinquanta se avessi più soldi. E questo da sempre, non da quando sono diventato padre. Pensa che a diciassette anni, durante quel viaggio in Russia, ci esibimmo anche in Azerbaijan, a Baku. Ricordo vagamente che c’era una sorta di gemellaggio con Napoli e che questa città somigliava anche a Napoli per via del golfo. In quella occasione mi mettevano in braccio sempre bambini bellissimi, biondi, mentre io cercavo volti da scugnizzi, scuri e più interessanti. In seguito poi avrei fatto cantare bambini africani ottenendo cori bellissimi. Un’ultima domanda sulla tua collaborazione con Luca Barbareschi. E’ un uomo generosissimo, spesso maltrattato per le sue idee politiche manifeste, che mi ha offerto l’opportunità di fare la musica che voglio ma anche di esprimere il mio pensiero, e non è da poco. Abbiamo fatto questo spettacolo che si chiama “Il caso di Alessandro e Maria”, l’anno scorso ci sono state cinquanta date e a novembre saremo per una settimana a Napoli. Voglio aggiungere una cosa significativa a dimostrazione che l’intelligenza non ha colori politici: il testo dello spettacolo è di Giorgio Gaber. Pensa: un uomo di destra che porta in scena un lavoro di un uomo di sinistra. Cosa dire? L’arte è arte e basta. E permettimi anche di fare i complimenti al Teatro Bellini per la sua programmazione, è davvero una delle più interessanti che ci sia in giro. 16 n° 10 - Ottobre 2009 sussurri & grida ELLIS ISLAND Segue da pag. 5 imprenditori e politici, creò un clima di terrore nella Chicago degli anni Venti e Trenta. Proprio a Chicago, decenni prima, la politica xenofoba aveva distrutto con la violenza le forme di autotutela e di crescita culturale delle comunità di immigrati, negando loro i diritti più elementari di associazione e libertà di parola. Mentre ero in giro alla ricerca di libri sul tema dell’immigrazione negli Usa, su una bancarella della Broadway Avenue ho trovato un bel volume che racconta, attraverso le immagini, la storia dell’emigrazione italiana: “A portrait of the Italians in America” (Published by Charles Scriber’s Sons, 1982). La studiosa italoamericana Vincenza Scarpaci offre una galleria di volti e situazioni che danno visivamente il senso di una storia epica sulla quale molti xenofobi nostrani, ignoranti prima che fanatici e cialtroni, farebbero bene a riflettere. A costoro consiglio anche un altro libro: AA.VV, “Verso l’America. L’emigrazione italiana e gli Stati Uniti” (Introduzione di Salvatore Lupo), Donzelli 2005. È una lettura indispensabile per capire che c’è sempre chi, per favorirne lo sfruttamento, è pronto a definire gli immigrati “tutti delinquenti e portatori di malattie”, rimuovendo, per calcolo cinico, una storia che è stata anche la nostra. E la storia, è noto, è fatta di corsi e ricorsi. Lo aveva già capito, alla fine del XVII secolo, il grande filosofo napoletano Giambattista Vico. UNO SPAZIO PER NASCERE O MORIRE Un’ottima Margherita Buy è la protagonista de “Lo spazio bianco”, film di Francesca Comencini tratto dal romanzo di Valeria Parrella di Luisa Apicella Quante volte pensiamo che alcune cose non ci toccheranno mai? Spesso, forse troppo spesso. Eppure la nostra semplice vita può diventare straordinaria in un solo istante e richiedere da parte nostra uno sforzo inimmaginabile per andare avanti. E’ quello che succede a Maria, una donna abbastanza comune, una professoressa la cui vita è scandita da qualche nevrosi, da qualche amico, da qualche flirt. E uno di questi amori, più intenso, la porterà a rimanere incinta. Un’avventura che Maria dovrà affrontare tutta da sola perchè Pietro, il suo amante, non ne vuole assolutamente sapere. Maria non demorde, non è una donna molto forte ma non vuole lasciare andare quella vita che ha dentro di sè. La sua gravidanza, evidentemente non felice, la porta a un parto molto prematuro. La sua bimba nasce al sesto mese di gestazione. Le difficoltà a cui la piccola vita andrà incontro saranno tantissime. Chiusa in un’asettica incubatrice, sarà attaccata a tanti tubicini che simuleranno l’utero materno e la gestazione naturale. Tutta la procedura è priva di certezze. Maria in un solo istante viene catapultata in un mondo nuovo quanto difficile da sostenere, da affrontare. Inoltre è sola a sopportare questa dura realtà. Le sue amicizie sono legate soprattutto agli alunni adulti del corso scolastico serale, ma lei abbandona tutto, non se la sente di frequentare nessuno. Si rinchiude nel suo mondo fatto di ospedale e di una casa sempre meno accogliente. Non lega neanche con le mamme che come lei hanno i figli nell’incubatrice. Maria ha una fortuna, può contare su un caro amico e collega che la stimola a uscire dal guscio nel quale si è rinchiusa, ricominciando innanzitutto a tenere lezioni. Così, a poco a poco, accetta di entrare di nuovo in contatto col mondo e ben presto si accorgerà che il suo stato emotivo, più positivo rispetto a qualche giorno prima, aiuta anche Irene, la sua piccola bambina. Il confronto con le altre mamme la stimolerà ancor di più, si confronterà con loro, con le loro paure e situazioni, valutando con maggiore oggettività la propria. Ben presto la piccola Irene reagirà sempre meglio fino a superare la prima prova respiratoria senza gli essenziali tubicini. Per Maria questo avvenimento rappresenterà una grande felicità e un grande rispetto per la vita. L’amore per la sua bambina sfocerà finalmente in un gesto concreto come tenerla in braccio e accarezzarla. La storia è tratta dal romanzo di Valeria Parrella, e Cristina Comencini è una grande interprete del mondo femminile con le sue paure e le sue speranze. Margherita Buy è davvero eccezionale in questa interpretazione che conferma la sua grande abilità attorale. La pellicola è girata interamente a Napoli e impegna validi attori partenopei, tra cui Guido Caprino, Salvatore Cantalupo, Gaetano Bruno, Antonia Truppo e la bravissima Maria Paiato, già nota al grande pubblico per ruoli teatrali molto impegnativi e portati avanti con grande successo e consenso. Per la Comenicini, Maria Paiato interpreterà il ruolo del magistrato, una donna che vive sotto scorta perchè ha deciso di portare avanti indagini molto delicate in una città difficile. La vita condotta dal personaggio interpretato da Maria Paiato fa capire alla protagonista Maria-Margherita Buy, che tutti, in un modo o nell’altro, aspettiamo di nascere o di morire. SUSSURRI & GRIDA Editore: Servire Napoli - Reg. Trib. di Napoli n. 4582 del 11/11/94 Redazione e amministrazione: Napoli - Piazza Municipio, 84 Tel. 081 5522285 Fax 081 4203302 e - mail per l’Italia: [email protected] e - mail per l’estero: [email protected] DIRETTORE: CARMINE ZACCARIA Dir. Responsabile: Federico Sisimbro Vicedirettore: Paolo Montefusco Capo Redattore: Anna Montefusco Progetto grafico e impaginazione: Salvatore Pescatore Stampato a Ottobre presso Arti Grafiche Lam - NAPOLI - EDIZIONE IN RUSSO In prima pagina l’intervista a Nello Mascia, attore napoletano di grande esperienza e maschera di impatto immediato sul pubblico. Mascia è testimone diretto dell’arte di Eduardo De Filippo, col quale ha lavorato e, oltre che sul teatro del grande maestro, ha disegnato una buona parte della sua carriera sull’opera di un altro genio teatrale napoletano come Raffaele Viviani. Nello Mascia è appassionato della drammaturgia di Cechov, autore che non esita a collocare come una delle punte più alte della drammaturgia mondiale. In vista delle elezioni in Ucraina, prendiamo in esame gli scenari futuri dell’Est Europa, in particolare per la stessa Ucraina e per la Georgia, con riferimento alle politiche di UE e USA. Spazio a un’intervista al pittore della Yakutia, Yuri Spiridonov, un artista molto stimato in Russia. Ha già esposto con successo, anche con mostre personali, in giro per il mondo e alcune sue opere sono presenti in musei importanti come il Museo Nazionale d’Arte della Yakutia, il Museo Nazionale di Sapmi (Norvegia) e il Museo Nazonale della Groenlandia. Spiridonov ci spiega come nascono i suoi paesaggi artici e le sue figure favolistiche. Gerardo Pedicini scrive per noi del Museo dell’isola di Syros in Grecia. Il Museo, seppur formato solo da cinque sale, testimonia magnificamente lo spirito dell’arte cicladica e il sentimento che il remoto passato della cultura delle isole greche ancora suscita nel nostro animo. Con Salvatore Casaburi intraprendiamo un viaggio nella storia di Ellis Island, “Isola delle Lacrime e della Speranza” dove, tra XIX e XX secolo, sbarcarono milio- ni di immigrati: italiani, irlandesi, russi, ebrei, tedeschi, ucraini e tanti altri. Il Museo dell’isola, dedicato appunto all’immigrazione, racconta la storia drammatica, spesso tragica, di quelli che cercarono di sottrarsi a una quotidianità fatta di miseria intraprendendo un viaggio lungo e faticoso, attraverso gli oceani, durante il quale le epidemie e i naufragi non costituivano probabilità remote, ma un rischio da affrontare, pur di sottrarsi alla sofferenza di una vita senza pane. Ricordiamo, a quarant’anni dalla morte, Giorgio Scerbanenco, scrittore di madre italiana e di padre ucraino. Scerbanenco fu il padre del romanzo noir all’italiana, un autore prolifico dotato di grande sintesi come pure di estrema cura dei particolari. Si celebrano i cent’anni dalla nascita di Daria BorgheseOlsuf’eva, la nobildonna russa accasatasi in Italia dopo il 1917. Il suo animo russo-italiano trova espressione nell’opera “Gogol’ a Roma” (Firenze, Sansoni 1957). La Olsuf’eva dimostrò come fu composto a Roma uno dei maggiori romanzi della letteratura russa, “Le anime morte”. Richiedete SHEPOT&KRIK via e- email all’indirizzo [email protected] oppure scrivendoci a: Napoli Piazza Municipio 84 - 80133 Edizione tradotta a cura di Alexandre Urussov ^
Scarica