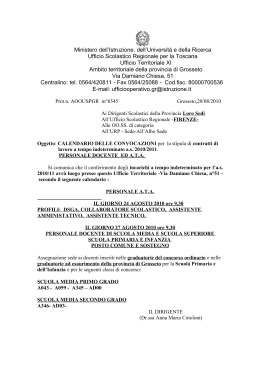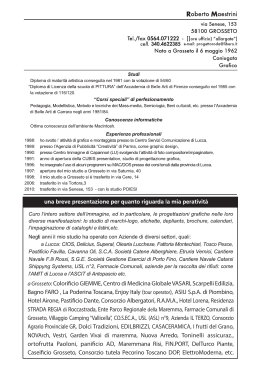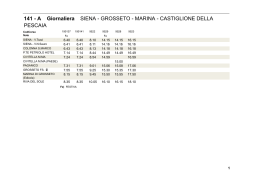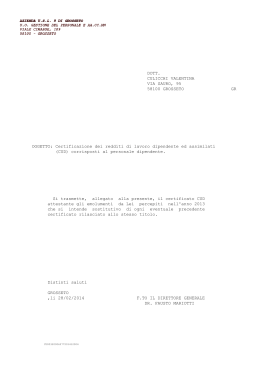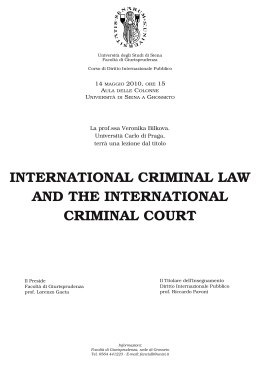INDICE
Premessa
Cap. 1 - Inquadramento normativo
Cap. 2 - La situazione demografica
Cap.2.1 - La situazione demografica attuale
Cap.2.2 - La domanda turistica
Cap.2.3 - La composizione della popolazione residente per ubicazione
Cap.2.4 - Gravitazioni ed Evasioni
Cap. 3 - I consumi
Cap.3.1 - I consumi in Italia
Cap.3.2 - I consumi nel Comune di Grosseto
Cap.4 - Le caratteristiche della rete
Cap.4.1 - Premessa
Cap.4.2 - Considerazioni Generali
Cap. 5 - Valutazioni per lo sviluppo
Cap.5.1 - Elementi economici e territoriali per l'implementazione della rete
Cap.5.2 - Specificità dell'analisi di copertura del territorio Comunale
Cap.5.3 - Considerazioni finali
Allegato Tecnico
Premessa
Qualsiasi tematica economica, si tratti della programmazione del commercio in sede fissa, come dei
pubblici esercizi, come delle "edicole", come di altri settori che presuppongono il contatto diretto tra il
distributore ed il consumatore finale, e quindi una specifica capillarità di diffusione sul territorio,
assume nel caso del Comune di Grosseto una valenza del tutto peculiare.
Numerosi fattori concorrono a delineare questa situazione; si ricordano, in modo particolare,
l'afflusso turistico, l'orografia spaziale, la conseguente caratterizzazione della viabilità, la
configurazione del bacino territoriale.
Ciò che occorre riuscire a "tarare", di volta in volta, nell'affrontare questi argomenti, è il livello di
capillarità più adeguato a incrementare progressivamente il servizio reso alla clientela residente e
fluttuante, sfruttando al meglio le intrinseche capacità di copertura del territorio di cui ogni settore è
portatore, senza creare problemi alla fruizione del territorio medesimo, per garantire una densità di
servizio e una varietà di offerta in linea con le esigenze crescenti del pubblico.
Partendo da questi presupposti, il presente rapporto costituisce la relazione tecnica di supporto alla
stesura degli strumenti di programmazione previsti dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di
"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della
Legge 13 aprile 1999, n. 108".
Lo studio fornisce infatti l'indispensabile corredo conoscitivo alla redazione del Piano di localizzazione
dei punti esclusivi di vendita e dei Criteri per l'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi, la cui
regolamentazione è contenuta in allegato. Come noto, il decreto 170/2001 ha provveduto a rivisitare in
misura sostanziale la programmazione del settore della distribuzione dei giornali e riviste,
introducendo innanzitutto una nuova classificazione, che distingue appunto tra punti vendita esclusivi e
non esclusivi, e prevedendo poi una pianificazione a livello comunale per la localizzazione dei primi, e
la stesura di criteri per la disciplina dei secondi.
Il Piano ed i Criteri assumono come obiettivo prioritario quello di fornire all'Amministrazione locale ed
alle imprese un riferimento duplice, economico e giuridico, per la realizzazione di un sistema di
diffusione dei prodotti editoriali che sappia coniugare le attese della filiera del settore (editori,
distributori e rivenditori) a quelle dei consumatori.
Si tornerà più diffusamente sugli aspetti legislativi; quello che preme sottolineare sin dall'inizio è la
peculiare struttura del settore, così come si è andata evolvendo negli ultimi anni nel nostro Paese.
I punti di vendita di giornali e riviste sono stati investiti, negli ultimi 15 anni, da alcune novità sia
tipologiche che normative:
•
•
in primo luogo, ad una persistente omogeneità merceologica (ciascuna rivendita ha
approssimativamente lo stesso materiale di un'altra, o quantomeno dovrebbe garantirla per il
rispetto del criterio delle pari opportunità di accesso al mercato) si è ormai aggiunta una minore
omogeneità strutturale: a fianco delle "classiche" edicole in chiosco (peraltro tra loro
diversificate per foggia e dimensione) esistono i "negozi" veri e propri (similari al commercio in
sede fissa), i punti di vendita misti ad altre merceologie (assieme alle tabaccherie o ai bar
ecc...), così come i punti di servizio (sotto il profilo strutturale appare eccessivo chiamarli punti
di vendita) quali le aree di servizio autostradali ed i distributori automatici di giornali. In essi la
caratteristica principale è quella di una grande ristrettezza merceologica (che assume punte di
minimo nei distributori automatici per problemi fisici).
Nel nuovo regime legislativo alle classiche strutture non esclusive (tipicamente abbinate a
rivendite di tabacchi) si aggiungono le strutture "non esclusive" conseguenti alla
sperimentazione, mentre le rivendite precedenti, che siano "miste" o promiscue o "pure", sono
comunque oggi da considerarsi esclusive.
Si assume quindi che non sia più attuale parlare semplicemente di "edicole" e che esse possano
considerarsi espressione sintetica della locuzione onnicomprensiva "punti di vendita della stampa
quotidiana e periodica".
Da cui deriva il concetto, se si condividono queste prime considerazioni, che un "Piano comunale di
localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica", e nella fattispecie lo studio che
lo supporta, debba ricomprendere al suo interno una analisi a 360 gradi, sia territoriale che tipologica,
e che debba anche essere propositivo in termini di diversificazione del servizio e quindi delle
caratteristiche del punto di vendita stesso in base alla nuova normativa, senza scindere a priori le
considerazioni attinenti i vari tipi di strutture.
Si provi inoltre a delineare il seguente elenco di differenziazioni:
a. collocazione territoriale (centrale o periferica, su asse viario importante o su via secondaria, in
prossimità di flussi particolari ecc.....);
b. compresenza con altre attività commerciali (dalla compresenza fisica nello stesso negozio, alla
compresenza in una grande struttura - es. Centro commerciale - alla semplice vicinanza ad
altri negozi ecc....)
c. conformazione fisica del punto di vendita / accessibilità (negozio, chiosco, distributore
automatico, espositore per il self-service ecc....);
d. natura della gamma offerta (solo quotidiani, tutte le testate ecc...);
e. periodo di attività (tutto l'anno, stagionale, temporanea).
Si configura quindi un triplice percorso-obiettivo per le analisi finalizzate alla pianificazione del settore:
•
•
•
un percorso quantitativo (numerico e socio economico), che riguarda la consistenza dei punti
di vendita e la loro eventuale carenza;
un percorso distributivo, all'interno del quale prende risalto la collocazione fisica delle singole
rivendite (enfasi sulle peculiarità viarie e territoriali);
un percorso tipologico, che tenga conto della differenziazione tra esclusiva e non esclusiva
riversando nelle opzioni quanto emerso nei due punti precedenti.
Le edicole (le chiameremo talvolta impropriamente in questo modo per esigenze di sintesi) hanno
dunque due grandi tematiche di riferimento:
•
•
edicola in quanto azienda produttiva, che deve quindi riferire completamente la motivazione
della propria esistenza alla capacità reddituale di remunerazione adeguata delle risorse
investite;
edicola in quanto rifornimento ad una zona o comparto del territorio, dove prende il
sopravvento l'esigenza di servizio rispetto all'esigenza di ottenere un reddito medio. Il reddito è
comunque importante, ma costituisce una integrazione.
Di solito (ma non sempre) i due casi si differenziano anche merceologicamente, essendo stato in
passato il primo generalmente rappresentato da edicola esclusiva ed il secondo dalla ex edicola
"mista".
Sotto questi aspetti, può rivelarsi proficuo mantenere, a fianco della corretta e indispensabile
ripartizione tra esclusiva e non esclusiva, anche una consistenza legata alle caratteristiche effettive
delle strutture e alla loro funzionalità.
Infatti il problema della capacità reddituale, se visto in termini di sistema complessivo e non di singolo
punto vendita, ha notevole rilevanza per tutta la filiera produttiva/distributiva dell'editoria, passando
attraverso i distributori locali della stampa.
Un elemento di distorsione in un punto della filiera rischia di mettere in crisi tutto il sistema.
Vi è poi da citare in questa premessa la ormai annosa problematica sulla presunta relazione tra
numero di punti di vendita e diffusione della stampa.
Qui i pareri divergono e mentre i fautori di una maggior numerosità dei punti di vendita propongono i
dati relativi al numero dei lettori di quotidiani in Italia (tra i più bassi in Europa), i fautori di uno sviluppo
rallentato del numero delle rivendite propendono per una più puntuale analisi del mercato attuale e
della redditività.
A nostro avviso, mentre non pare esistere una correlazione significativa tra numero di punti di vendita
e bassa concentrazione di lettori (le ragioni vere sono, semmai, più di natura culturale) è altrettanto
vero che in alcune circostanze (servizio alle frazioni o alle località periferiche per fare un esempio)
anche una redditività piuttosto scarsa del punto di vendita è da ritenersi positiva per il commerciante
che gode di economie di gestione tra il reparto "edicola" e altre merceologie possedute (l'integrazione
di reddito di cui si parlava in precedenza).
Per quanto finora premesso, nasce una serie di domande a cui trovare risposta, specificatamente su
argomenti del tipo dei seguenti:
•
•
•
quali sono i consumi nel comparto della stampa quotidiana e periodica a Grosseto?
qual è la distribuzione territoriale dei punti di vendita, e come si relaziona con gli addensamenti
residenziali e di flussi e con la viabilità?
qual è la produttività dei punti vendita e quali sono i livelli di sussistenza per tipologia?
Nei prossimi capitoli questo sarà il compito principale del presente studio.
Cap. 1 - Inquadramento normativo
Inquadramento del settore nel contesto legislativo nazionale e regionale
Appare opportuno, prima di entrare nel merito dell'esame della rete e di tutti gli elementi conoscitivi
richiesti, precisare più in dettaglio il quadro di riferimento normativo di questo settore.
Il Decreto 170/2001 ha riordinato in modo organico l'intero sistema di diffusione della stampa, in
precedenza regolamentato, a livello nazionale, dall'abrogata Legge 5 agosto 1981, n.416 e successive
modifiche.
Il Decreto, come anticipato in premessa, giunge a configurare due fondamentali tipologie di strutture;
punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
I due formati, nel complesso costituenti la rete distributiva oggetto della programmazione, sono
caratterizzati da alcune precise caratteristiche distintive.
I punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, il che significa, in
altre parole, che il rivenditore finale non può sottrarsi all'obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali
che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui
compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva.
I punti vendita non esclusivi sono invece caratterizzati dalla possibilità di porre in vendita una
(quotidiani o periodici) o entrambe le tipologie della produzione editoriale (ma solo a seguito della fase
di sperimentazione o se preesistenti), e dalla circostanza che tale vendita è fisicamente e
funzionalmente collegata ad una predeterminata attività di tipo commerciale, fra quelle previste nel
Decreto n. 170 del 2001 (articolo 2):
a. le rivendite di generi di monopolio;
b. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati
1.500;
c. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e
trattorie;
d. le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700;
e. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120;
f. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
E' opportuno qui sottolineare che la possibilità di effettuare la vendita della stampa quotidiana e
periodica in abbinamento ad altri prodotti non rappresenta affatto una prerogativa riservata ai soli punti
vendita non esclusivi.
Infatti gli stessi punti vendita esclusivi possono effettuare la vendita dei prodotti appartenenti all'intero
settore non alimentare, e ciò in virtù del medesimo titolo abilitante alla vendita di quotidiani e periodici,
così come si ricava dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 108 del 1999, anche se a titolo teorico
possono esserci delle limitazioni nel caso dei chioschi, che operano su aree pubbliche e per i quali
l'autorizzazione è specificamente destinata al settore editoriale.
In via generale comunque la qualità di punto vendita esclusivo è del tutto compatibile con l'esercizio di
attività che, dal punto di vista sostanziale, sono in realtà di tipo misto, o promiscuo.
La disciplina dei punti vendita, quelli esclusivi e non esclusivi, come si accennava appare
significativamente differenziata anche sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di
programmazione.
Per i punti di vendita esclusivi i comuni definiscono i Piani Comunali di Localizzazione, nel rispetto
degli indirizzi regionali (articolo 6 del Decreto Legislativo 170/2001) e dopo una consultazione con le
Associazioni del settore.
Per i punti vendita non esclusivi i comuni provvedono, autonomamente, alla definizione degli appositi
Criteri (articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 170/2001).
Medesimi sono invece i parametri di riferimento per la programmazione delle due tipologie:
•
•
•
•
•
densità della popolazione,
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio,
entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni,
condizioni di accesso,
esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
Riguardo questi parametri si ritiene che:
A. per esistenza di altri punti vendita non esclusivi debba intendersi in questo contesto la
considerazione della rete nella sua interezza.
B. che le differenze tra il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 1, lettera b dell'articolo 6 siano di
forma ma non di sostanza.
In particolare, il fatto che all'articolo 2 non si parla di numero delle famiglie come viene fatto all'articolo
6, e il fatto che all'articolo 6 si parla di analisi per zona o quartiere, e all'articolo 2 solo di zone, sono da
ritenersi differenze marginali a fronte di un approccio che deve essere sia quantitativo che
localizzativo, sulla falsariga di quanto già avvenuto in seguito all'emanazione del Decreto "Bersani" nel
campo del commercio al dettaglio in sede fissa.
Non possono essere oggetto di considerazione, in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme
di diffusione dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi autorizzazione amministrativa:
•
•
•
•
•
•
•
vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di
pertinenti pubblicazioni specializzate;
vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse
editi;
vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
consegna porta a porta e vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che
ha accesso a tali strutture.
A ciò si aggiungono le vendite effettuate attraverso il canale diretto editore-lettore che nel nostro
Paese, a differenza di quanto avviene in alcuni Paesi stranieri in cui le vendite veicolate attraverso gli
abbonamenti raggiungono soglie del 90 per cento del volume complessivo (Giappone, Lussemburgo,
Olanda, Finlandia), sono tuttavia al 9 per cento delle vendite complessive, pur essendo in crescita
tendenziale.
La Regione Toscana ha di recente pubblicato una Delibera di Giunta nella quale esplicita le proprie
Linee di indirizzo in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ai
sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
La scelta fatta dalla Regione è, al pari di svariate altre realtà italiane, quella di rimandare
sostanzialmente al Decreto prima menzionato, salvo qualche precisazione utile ad una più semplice
ed efficace gestione del medesimo.
In particolare, le linee di indirizzo precisano che:
•
•
•
•
•
•
•
nel Piano Comunale possono essere fissati limiti minimi di distanza tra punti vendita, anche
diversi a seconda delle zone, al fine di assicurare una equilibrata diffusione dei prodotti
editoriali;
per quanto riguarda la durata dei piani di localizzazione, … il Comune potrà sia fissare un
termine di validità limitato nel tempo sia condizionare la revisione del piano, al fine di
consentirne l'adeguamento, al variare delle condizioni demografiche, economiche e sociali del
territorio;
la titolarità dell'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo, considerato il legame
funzionale con l'attività già esistente, non può essere ceduta se non unitamente alla titolarità
dell'attività primaria o prevalente;
è invece consentito l'affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, anche
separatamente dall'attività primaria o prevalente, semprechè l'attività si svolga negli stessi
locali;
è facoltà del Comune procedere alla predisposizione dei Criteri … congiuntamente
all'approvazione del Piano di localizzazione, in quanto il rilascio dell'autorizzazione per le due
tipologie di esercizio è basato sulla verifica dei medesimi parametri;
relativamente agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, l'autorizzazione per la
vendita di soli quotidiani o soli periodici o di quotidiani e periodici è rilasciata di diritto … a
condizione che gli stessi oltre alla presentazione della comunicazione … abbiano
effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti (onere dell'accertabilità e dimostrabilità);
il decreto non prevede un termine per la presentazione della richiesta di rilascio
dell'autorizzazione da parte degli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione. La
fissazione di un termine appare peraltro opportuna in quanto finalizzata alla conoscenza della
consistenza della rete distributiva. Tale elemento assume difatti evidente rilevanza sia al fine
della predisposizione dello strumento programmatorio sia al fine della predisposizione dei
criteri.
Gli elementi sopra richiamati, e gli altri che formano parte integrante delle linee di indirizzo regionali,
saranno tenuti nella debita considerazione sia in fase di analisi che di regolamentazione.
Cap. 2 - La situazione demografica
Analisi della popolazione residente, della relativa composizione e della domanda turistica
Nel seguente capitolo ci occupiamo degli aspetti demografici relativi al Comune di Grosseto,
muovendoci in varie direzioni:
•
•
•
•
una fotografia della situazione attuale;
un'analisi della medesima tramite indicatori demografici;
proiezioni dell'andamento demografico per il futuro a medio termine;
un'analisi della domanda turistica.
Cap. 2.1 - La situazione demografica attuale
In questo capitolo si prendono in considerazione alcuni indici statistici per valutare le caratteristiche
generali della popolazione.
Per mettere in risalto la struttura della popolazione di Grosseto vicino agli indicatori a livello comunale
si sono posti gli stessi indici a livello territoriale più ampio.
fascia
d'età
0-5
6-10
11-1
4
15-2
4
25-3
4
35-4
4
45-5
4
55-6
4
>=65
Tot.
Composizione della popolazione residente per fascia d’età* (Valori assoluti)
Ambito territoriale
Provincia di
Comune
Italia
Italia centrale
Toscana
Grosseto
Grosseto
3.216.136
568.488
163.498
8.680
3.245
2.813.380
491.836
138.341
7.981
2.789
2.274.388
393.132
110.682
6.335
2.214
6.601.630
1.163.989
339.595
19.822
6.957
9.103.515
1.718.050
537.720
31.070
8.779.193
1.713.332
529.336
31.204
7.743.670
1.529.351
490.034
30.850
6.756.170
1.374.571
455.502
28.608
2.206.834
782.896
51.044
11.159.58
3
3.547.60
4
215.59
4
10.555.93
5
57.844.01
7
11.28
7
11.12
6
10.71
7
9.380
14.88
6
72.60
1
*Il dato si riferisce alla popolazione residente al 01/01/2001. Fonte Istat
Composizione della popolazione residente per fascia d’età* (dati %)
Ambito territoriale
fascia
Italia
Italia centrale
Toscana
Prov. Grosseto Comune Grosseto
d'età
0-5
6-10
11-14
5,6
4,9
3,9
5,1
4,4
3,5
4,6
3,9
3,1
4,0
3,7
2,9
4,5
3,8
3,0
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>=65
Tot.
11,4
15,7
15,2
13,4
11,7
18,2
100,0
10,4
15,4
15,4
13,7
12,3
19,8
100,0
9,6
15,2
14,9
13,8
12,8
22,1
100,0
9,2
14,4
14,5
14,3
13,3
23,7
100,0
9,6
15,5
15,3
14,8
12,9
20,5
100,0
*Il dato si riferisce alla popolazione residente al 01/01/2001.Fonte Istat
La classe di età in assoluto più rappresentata è quella superiore ai 65 anni, che raccoglie 14.886
presenze, pari ad un quinto del totale dei residenti.
La seconda classe più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, che con 11.287 presenze incide per il
15,5% sul totale.
Le due fasce di età in assoluto meno rappresentate sono quelle da 11 a 14 (3%) e da 6 a 10 anni
(3,8%).
Residenti per Kmq e indice di mascolinità per diversi ambiti territoriali
ambito territoriale
densità
Comune di Grosseto
Provincia di Grosseto
Regione Toscana
Italia Centrale
Italia
indice di mascolinità
147,3
46,5
150,5
183,7
186,9
92,2
92,5
92,8
92,6
93,9
Fonte: Istat
Il Comune di Grosseto si avvicina al territorio regionale per quanto riguarda la densità della
popolazione anche se comunque permane un dato più contenuto. Colpisce il dato Provinciale
nettamente inferiore a quello degli altri ambiti, dovuto alle caratteristiche intrinseche dell'area
Maremmana. Nel Comune di Grosseto quindi ogni abitante ha a disposizione mediamente un maggior
spazio rispetto alla regione e alla penisola nel suo insieme ma la concentrazione della popolazione è
maggiore rispetto al territorio Provinciale. Questo dato riafferma la centralità del Comune in termini di
popolazione ivi residente. Per quanto riguarda il rapporto tra i generi risulta un minor indice di
mascolinità rispetto a tutti i territori più ampi nei quali è collocato.
Indici della struttura demografica (31/12/2000).
Ambito territoriale
vecchiaia
dipendenza
struttura
ricambio
età media
Comune di Grosseto
1,80
0,47
1,052
0,63
43,6
Provincia di Grosseto
2,22
0,52
1,108
0,58
45,3
Toscana
1,90
0,51
1,030
0,63
44,2
Italia
1,27
0,48
0,912
0,87
41,1
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat
Le informazioni che provengono da una lettura complessiva degli indici di struttura demografica
sembrano essere concordi nel definire la popolazione del Comune di Grosseto come relativamente
equilibrata nella composizione interna rispetto agli altri ambiti territoriali più ampi come la Provincia e la
Regione ma in linea con le caratteristiche socio demografiche delle regioni centro settentrionali se la si
confronta con il resto della nazione.
_________________________________
[1] Gli indici a questo scopo utilizzati in questa sede sono:
L’indice di anzianità: il rapporto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni e quella di età inferiore ai 15 anni. A parità di altre
condizioni un elevato indice riflette una scarsa dinamica demografica cioè un basso indice di natalità, una diminuzione della
popolazione residente.
L’indice di dipendenza: è il peso della popolazione di età superiore ai 65 anni e di quella di età compresa tra 0 e 14 anni sulla la
popolazione in età lavorativa (età compresa tra i 15 e i 65 anni). Misura quanto il mercato del lavoro può essere sostenuto dalla
dinamica demografica.
L’indice di ricambio: è calcolato come rapporto tra la popolazione di età compresa tra 15 e i 19 anni e quella di età compresa tra i 60
e i 64. Esso indica la velocità con la quale la popolazione residente riesce a sostituire le uscite dalla popolazione attiva. In un
contesto di bassa disoccupazione (e soprattutto di piena occupazione) la capacità di un territorio di produrre reddito è tanto alta
quanto tale indice è elevato.
L’indice di struttura denota la composizione della popolazione in età lavorativa: è il rapporto tra la popolazione di età compresa tra
i 40 e i 64 anni e la popolazione di età compresa tra i 15 e i 39 anni.
__________________________________
L'età media è inferiore al dato Provinciale e regionale ma nettamente superiore al dato nazionale. Nel
territorio comunale risiedono persone mediamente più giovani rispetto la Provincia.
Il tasso di ricambio e il tasso di struttura presentano valori nettamente migliori del territorio Provinciale
e sostanzialmente allineati col territorio regionale.
Serie storiche della popolazione residente, del numero di famiglie e dell’ampiezza media
(1991-2001)
residenti
famiglie
Nucleo medio
anni
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
71.329
72.063
71.680
71.770
71.828
72.161
72453
72.539
72.752
72.872
73.172
25.778
26.395
26.613
27.016
27.457
27.937
28.456
28.908
29.276
29.727
30.488
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,4
2.4
Fonte Istat
Come si vede chiaramente dalle tabelle e dai grafici precedenti nel Comune di Grosseto aumentano la
popolazione residente ed il numero delle famiglie e diminuisce l'ampiezza media del nucleo familiare.
Questi indizi, lungi dal caratterizzare solo questo territorio, confermano le tendenze generali
riscontrabili nel Paese. La proiezione della popolazione residente, utilizzando una linea di tendenza
lineare porta a stimare in 74.000 il numero dei residenti al 2007.
Cambiamento nella composizione della popolazione residente per fascia d’età.
fascia
d'età
0-4
5-9
10-14
15-24
25-34
35-44
45-54
1991
2.557
2.810
3.626
10.276
10.560
10.596
9.941
Comune di Grosseto
2000
2.746
2.731
2.771
6.957
11.287
11.126
10.717
Variazione 1991/2000
7,4
-2,8
-23,6
-32,3
6,9
5,0
7,8
8.990
11.901
71.257
55-64
>=65
Tot.
9.380
14.886
72.601
4,3
25,1
1,9
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat
Cap. 2.2 - La domanda turistica
La seguente tabella sintetizza mediante un indicatore il livello della domanda turistica nel Comune di
Grosseto e delle macroaree in cui questo è inserito.
Arrivi turistici nella Provincia di Grosseto e in altri ambiti territoriali
Livello territoriale
Arrivi turistici per 100 abitanti
Provincia di Grosseto
Toscana
Centro
Italia
333,2
250,9
179,3
125,6
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat
L'importanza del settore turistico per l'economia della Provincia di Grosseto è evidente se si guarda al
dato degli arrivi turistici in rapporto alla popolazione; nella Regione solo la Provincia di Siena e quella
di Firenze presentano un dato superiore.
Arrivi turistici nel Comune di Grosseto
v.a.
anno
1991
1992
1993
1994*
1995
1996
1997
1998
1999
2000*
2001
variazione %
690.417
731.543
693.878
734.812
775.745
867.575
832.250
824.898
940.393
884.968
6,0
-5,1
5,9
5,6
11,8
-4,1
-0,9
14,0
-5,9
829.542
-6,3
Stima mediante media mobile centrata.
Arrivi, presenze turistiche e permanenza media (valori assoluti, anno 2001)
Provenienza
stranieri
italiani
totale
alberghieri
arrivi
presenze
34.998
314.149
339.83
4
374.83
2
1.285.40
0
1.599.54
9
extralberghieri
arrivi
presenze
123.6
984.921
62
331.0
2.069.07
48
6
454.7
3.053.99
10
7
Fonte: Istat
arrivi
158.66
0
670.88
2
829.54
2
totale
presenze
1.299.0
70
3.354.4
76
4.653.5
46
permanenza
media
8,2
5,0
5,6
L'importanza delle presenze turistiche in questo studio è rappresentata dal fatto che i turisti
contribuiscono a formare la domanda aggregata di consumi, sebbene costituiscano una "voce" meno
stabile di quella dei residenti.
Dal grafico si nota una contrazione del numero di presenze nel Comune di Grosseto negli ultimi anni,
all'interno di un più ampio ciclo di crescita che ha visto comunque un incremento importante dei flussi
nel corso degli anni '90.
Non è possibile trarre informazioni certe sul trend, ma l'andamento complessivo fa ritenere il recente
calo come temporaneo, anche alla luce del potenziale gravitazionale dei più recenti progetti di sviluppo
turistico in fase di predisposizione (Roselle, sistema museale in genere, ambiente).
Cap. 2.3 - La composizione della popolazione residente per ubicazione
Nelle tabelle presentate di seguito viene evidenziata la suddivisione in zone del territorio comunale e la
distribuzione della popolazione residente.
Zone di suddivisione del territorio comunale
UBICAZIONE
GROSSETO
CAPOLUOGO
ALBERESE
BATIGNANO
LOCALITA’ CENSUARIE
Centro storico
Periferia
Resto del capoluogo
Alberese
Alberese Scalo
Magazzini Alberese
Vallemaggiore
Batignano
BRACCAGNI
MONTEPESCALI
-
ISTIA
MARINA
GROSSETO
RISPESCIA
ROSELLE
DI
Braccagni
Montepescali
Istia
Il Colombaio
Principina a Mare
Le colonne
Pingrosso
Marina di Grosseto
Enaoli
Rispescia
Nomadelfia
Roselle
Popolazione residente nelle diverse zone del territorio comunale
Ubicazione
Grosseto Capoluogo
Alberese
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
Residenti
65.064
408
602
1.290
1.173
2.534
695
1.892
73.658
Fonte: Ufficio Anagrafe
Cap. 2.4 - Gravitazioni ed Evasioni
Le gravitazioni
Per determinare con maggior precisione la domanda aggregata per consumi nel settore esaminato è
necessario tenere conto anche delle gravitazioni.
Nell'ambito di un qualsiasi territorio si registrano degli spostamenti che determinano in certi casi, come
a Grosseto, rilevanti flussi di consumo. Gli spostamenti avvengono per vari motivi: studio, lavoro,
turismo, consumo etc….
I flussi per motivi di lavoro sono "catturati" dal concetto di sistema locale del lavoro, quelli per motivi di
consumo dal concetto di area gravitazionale. Più in generale il territorio di provenienza degli utenti di
un qualsiasi servizio è definito bacino di utenza.
A questi concetti occorre far riferimento per avvicinarsi il più possibile alla stima del vero mercato nel
settore della stampa.
Il Comune di Grosseto costituisce il polo più importante del bacino di riferimento. Per questo motivo è
inevitabilmente meta di flussi pendolari sia per motivi di lavoro che di studio.
Il totale delle gravitazioni per motivi di lavoro e studio è di 18.000 unità che, tenendo conto della quota
di acquisti effettuata abitualmente da queste categorie fuori casa (50%) si traduce in 9.000 residenti
equivalenti;
un'altra componente delle gravitazione è costituita dai flussi turistici. La grandezza utilizzata per
valutare questa componente della domanda di consumi è la presenza, cioè le giornate di
intrattenimento del turista nel territorio. Il loro numero nel 2001 ammontava a 4.653.546 unità.
Tenendo conto che il numero degli arrivi nello stesso anno è stato di 829.542, si ricava un periodo di
permanenza medio dei turisti a Grosseto di 5,6 giorni. Il numero di presenze si traduce in 14.102 clienti
equivalenti ( numero presenze : 330). In totale si sono ottenuti 23.102 clienti equivalenti dovuti a
gravitazioni di vario genere.
Le evasioni
Il Comune di Grosseto, capoluogo di Provincia e maggior Comune per popolazione residente e per
numero di servizi disponibili svolge il ruolo di attrattore prioritario. Ciononostante si registrano anche
movimenti verso l'esterno costituiti dai pendolari per motivi di studio e lavoro che ammontano a 2.839
persone e per altri motivi a 675 persone (dati Istat). Tale dato va dimezzato in considerazione del fatto
che non tutti i pendolari effettuano la loro spesa al di fuori del territorio comunale di residenza.
Le evasioni per ferie e vacanze incidono per l'8% del tempo dei residenti andando a sottrarsi al
numero dei residenti di 5.156 unità.
Gli abbonamenti, in base al trend dei recenti rapporti Fieg sono stimati incidere circa per il 9,5% sul
totale delle vendite.
Componenti della domanda aggregata per consumi
componente
valore assoluto
residenti
gravitazioni lavoro
gravitazioni studio
gravitazioni turismo italiani
gravitazioni turismo stranieri
evasioni lavoro e studio
ferie
abbonamenti
Mercato reale
74.000
12.000
6.000
3.354.476
1.299.070
-3.514
-5.920
-7.030
4.729.082
coefficiente
conversione
1,00
0,50
0,50
0,003
0,003
0,50
1,00
1,00
clienti
equivalenti
74.000
6.000
3.000
10.165
3.937
-1.757
-5.920
-7.030
82.395
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis
Il mercato reale risulta quindi essere composto da 82.395 residenti equivalenti.
Cap. 3 - I consumi
Entità di spesa, flussi e volume del venduto
Questo capitolo contiene una descrizione dei vari aspetti che riguardano la domanda di giornali e
riviste.
Nel primo paragrafo sviene presentato un quadro generale dell'evoluzione e delle caratteristiche dei
consumi in Italia. L'importanza delle informazioni di questo paragrafo sta sia nell'opportunità di
collocare la realtà Grossetana all'interno di quella del paese sia nel capire quali sono le variabili che
influenzano la domanda di consumi in questo settore. Capire in che modo tali variabili agiscono
consente di definire qualitativamente il consumo.
Col secondo paragrafo si scende a livello territoriale e si riporta la stima dei consumi in giornali e riviste
nel Comune di Grosseto. Tale stima proviene dal modello econometrico prodotto da Sincron.
Sono poi presentati i consumi e i dati di flusso propri di Grosseto e i dati sul venduto forniti dalle
agenzie di distribuzione che servono l'area in questione.
Questi dati costituiscono uno dei riferimenti normativi per poter effettuare valutazioni di opportunità per
un aggiornamento della rete di vendita, sebbene da soli non siano sufficienti a cogliere il fenomeno del
quale costituiscono un effetto dal momento che l'evoluzione delle vendite è influenzata dal trend della
popolazione residente, dalla struttura demografica, dalle abitudini e atteggiamenti, dalla disponibilità di
beni sostituti etc…. per cui non è inverosimile osservare una variazione positiva delle vendite
registrata in un biennio all'interno di un trend di lungo periodo negativo e viceversa.
Cap. 3.1 - I consumi in Italia
Le seguenti tabelle presentano una descrizione qualitativa della domanda aggregata nel settore della
stampa in Italia.
Tale grandezza viene espressa, dipendentemente dal concetto che si vuole sviluppare, in termini di
consumatori o in termini di vendite.
Nel grafico seguente si riporta la serie storica della spesa procapite totale e la quota percentuale dei
consumi per giornali, riviste e cancelleria sul totale della spesa.
Nel periodo considerato (1970-2000) la spesa procapite è aumentata quasi ininterrottamente mentre la
quota di spesa destinata agli acquisti di giornali, riviste e cancelleria è rimasta stabile o è diminuita.
Ciò consente di affermare che questo genere di consumi non è particolarmente legato al reddito.
Composizione dei consumi per merceologia (triennio 1998-2000)
Categorie di consumi
Spesa alimentare
Spesa non alimentare
Di cui per:
-comunicazioni
-TV,
HI-FI,
computer,fotografia
-Ricreazione e cultura
-servizi
ricreativi
e
culturali
1998
15,4
84,6
anni
1999
15,0
85,0
2000
14,6
85,4
2,6
2,9
3,2
0,9
1,0
1,2
0,4
0,4
0,5
2,5
2,6
2,6
-giornali,
libri
cancelleria
-vacanze organizzate
-istruzione
totale
e
2,1
2,0
2,0
0,2
1,0
100,0
0,3
1,0
100,0
0,3
0,9
100,0
Fonte: Elaborazioni Sincron su dati Fieg
La precedente tabella ripropone il concetto precedentemente esposto: il consumo di quotidiani è
relativamente "rigido" al variare della spesa totale. La quota di spesa per questo genere di consumi si
attesta nel triennio considerato sempre attorno il 2%, a differenza ad esempio della spesa per
comunicazioni, Hi-Fi dove la percentuale presenta variazioni più importanti.
La seguente tabella riporta i dati delle vendite di quotidiani nel periodo 1990-2002.
Serie storica delle vendite di quotidiani in Italia (1990-2002). Medie giornaliere
anno
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
vendite
6.808.501
6.505.426
6.525.529
6.358.997
6.208.188
5.976.847
5.881.350
5.869.602
5.881.421
5.913.514
6.073.158
6.098.058
5.887.795
∆%
0,6
-4,5
0,3
-2,6
-2,4
-3,7
-1,6
-0,2
0,2
0,5
2,7
0,4
-3,4
Fonte: F.i.e.g. La stampa in Italia 1999-2002
Fino al 1997 le vendite di quotidiani sono continuamente diminuite, poi hanno iniziato ad aumentare
rimanendo però di molto inferiori a quelle registrate nella prima metà del decennio.
Le seguenti elaborazioni consentono di riprendere un concetto al quale si è accennato nel capitolo 1,
vale a dire la quota di vendite effettuate tramite abbonamento, che in Italia è molto contenuta rispetto
ad altri paesi. Nella seguente tabella si mette in luce l'incidenza degli abbonamenti dipendentemente
dal tipo di prodotto editoriale, centrando l'attenzione sui quotidiani.
Percentuale abbonamenti sul totale copie vendute nei quotidiani(2001)
Categorie di quotidiani
Provinciali
Regionali
Pluriregionali
Nazionali
Sportivi
Economici
Politici
Media
% acquisti in abbonamento
14,9
2,8
1,5
6,8
0,2
48,9
6,6
9,0
Fonte: Fieg La stampa italiana 1999-2002
Il peso degli abbonamenti nel 2002 era attestato all'9,5%. Tale percentuale rappresenta il dato di
riferimento per completare il quadro delle "evasioni". La quota di vendite in abbonamento cambia
radicalmente a seconda del tipo di quotidiano: si passa dalla percentuale insignificante dello 0,2% dei
quotidiani sportivi al 42% dei quotidiani economici. Naturalmente vi sono situazioni intermedie ma ciò
non toglie l'elevata variabilità di tale quota. E' lecito pensare che il tipo di bisogno che soddisfa ogni
tipo di testata ne determina le modalità di acquisto, tanto da far ritenere che sotto l'unica categoria di
quotidiano ricadano beni che in realtà hanno funzioni diverse. Il livello di complessità dell'informazione
contenuta in un quotidiano potrebbe a prima vista costituire la vera discriminante tra i tipi di
informazione che ogni quotidiano fornisce (si giustificherebbero così le situazioni polari dei quotidiani
economici da un lato e quelli sportivi dall'altro). Questo è vero ma è importante anche il grado di
aggiornamento del tipo di notizia offerta. La cronaca locale, per chi ne è interessato, è la descrizione di
un'attualità in continua evoluzione, così come la situazione economica per gli "addetti ai lavori".
Diversamente lo sport e i quotidiani che genericamente si occupano dell'attualità e degli avvenimenti in
tutto il paese sono il riflesso di una realtà sulla quale è possibile rimanere aggiornati anche con
frequenza temporale più dilatata. Da qui deriva il bisogno di ricevere alcuni tipi di stampa
quotidianamente e altri tipi di giornale con frequenze inferiori. L'acquisto degli uni avviene mediante
abbonamento, l'acquisto degli altri può avvenire con l'atto d'acquisto comune a tanti altri tipi di bene,
recandosi cioè in una rivendita.
La scelta tra l'abbonamento e l'acquisto nella rivendita sono, in base a quanto si sostiene, il riflesso
della diversità dei bisogni a cui rispondono. Questo non implica che la fonte di tale bisogno non sia
unica e non sia di tipo culturale. Dal grafico seguente sembra emergere una relazione tra l'acquisto
tramite abbonamento e la domanda di quotidiani.
Da un'analisi visiva sembrano esserci due gruppi di stati: gli stati nord europei con un'elevata
propensione alla lettura (elevato numero di copie diffuse ogni 1000 abitanti) e un elevata percentuale
di acquisti tramite abbonamento (bassa percentuale di acquisti in edicola) e gli altri stati, che in base al
campione, sono gli stati extraeuropei, quelli dell'Europa mediterranea e dell'Europa dell'est.
Il coefficiente di correlazione tra le due grandezze è di circa -0,7 (intervallo di variazione {-1, +1}) e
permette di non escludere una relazione inversa tra le due grandezze.
In base a queste due osservazioni si può concludere che:
1. Il dato della bassa percentuale di abbonamenti in Italia è un dato che non caratterizza il nostro
paese ma caratterizza un gruppo consistente di nazioni.
2. Tale dato potrebbe essere in relazione con le abitudini di consumo (e quindi dipende da motivi
culturali) e solo in un secondo tempo con la struttura dell'offerta.
Solo uno studio ad hoc potrebbe rilevare un legame tra le caratteristiche della rete distributiva e
consumi, ma ciò non è oggetto del presente lavoro. Come implicazione delle precedenti osservazioni,
si può dire che, alla luce anche dei risultati di uno studio commissionato dal Ministero all'Università di
Parma sugli effetti della sperimentazione, la capillarità della rete distributiva è forse una concausa dei
bassi consumi di giornali e riviste in Italia, ma la ragione veramente decisiva è con maggiori probabilità
di tipo culturale.
Sembra esserci un percorso logico alla base delle modalità di consumo: i fattori di tipo culturale
spingono verso un aumento dei consumi di giornali e riviste; tali consumi implicano un aumento delle
vendite presso i negozi. Un ulteriore aumento del bisogno di informazione crea le condizioni per
l'abbonamento.
Questo percorso causale è però a senso unico per cui risulta impossibile sostenere, qualora vi fosse
l'esigenza, gli abbonamenti con misure come la riduzione dei prezzi né è possibile sostenere
significativamente le vendite agendo sulla rete distributiva.
Un'altra informazione utile per inquadrare meglio il rapporto con questo tipo di mezzo di
comunicazione a Grosseto è la struttura dei consumi per classe d'età.
Il seguente grafico documenta la percentuale di coloro che leggono almeno una volta alla settimana
quotidiani per fascia d'età.
Le classi d'età nelle quali è più frequente l'acquisto di quotidiani, in Italia, sono quelle intermedie. La
quantità della lettura (cioè la frequenza settimanale della lettura di quotidiani) aumenta con l'età. A
partire dai dati Fieg, nell'ipotesi che le abitudini di lettura di Grosseto siano le stesse della nazione del
suo insieme, si è calcolato il numero di chi legge quotidiani almeno una volta alla settimana nel
Comune di Grosseto. I risultati sono rappresentati dal seguente grafico.
In realtà nel Comune di Grosseto la lettura dei quotidiani è più diffusa dal momento che il numero di
copie vendute ogni 100 abitanti a livello regionale è più alto della media nazionale (ed è allineato a
quello delle regioni settentrionali). Ciò verosimilmente si concretizza in un maggior peso delle classi
d'età medie visto che l'abitudine alla lettura è fortemente condizionata anche dal livello di istruzione. In
tutti i casi, vista la struttura demografica di Grosseto e le variazioni avvenute negli ultimi 5 anni, si può
concludere che in base alle abitudini di lettura il consumo di quotidiani è destinato ad aumentare. Tale
conclusione deriva dal fatto che come visto, a Grosseto stanno aumentando proprio le classi d'età
maggiormente dedite alla lettura di quotidiani.
Cap. 3.2 - I consumi nel Comune di Grosseto
Col modello econometrico utilizzato da Sincron per calcolare la domanda aggregata di consumi è
possibile stimare il consumo per un numero elevato di merceologie per disaggregazioni territoriali fino
al livello comunale.
Il numero indice del reddito destinato a spese per consumi del Comune di Grosseto è 110.
Ciò significa che mediamente il residente nel territorio comunale spende circa il 10% in più del
consumatore nazionale.
A questo dato corrisponde, tenuto conto dell'elasticità dei consumi al reddito una spesa pro capite pari
a 133,00 Euro per la stampa quotidiana e periodica.
E' questo il dato di riferimento per le spese dei residenti e dei flussi in ingresso da parte di italiani (si è
già considerato in precedenza il diverso peso degli occupati e degli studenti).
La seguente tabella riporta i dati sulle vendite di quotidiani e periodici nel Comune di Grosseto.
Vendite della stampa periodica nel Comune di Grosseto
copie
anni
2000
2001
2002
Variazione assoluta
copie per residente
quotidiani
periodici
37,05
15,09
36,94
15,06
quotidiani
2.700.000
2.703.000
periodici
1.100.000
1.102.000
2.718.037
nd
37,15
nd
18.037
nd
+0,10
nd
0,67
nd
+0,30
nd
(2000-2002)
Variazione %
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Agenzia distributrice di zona
I dati riportati in tabella evidenziano un lieve aumento del numero delle copie vendute nell'ultimo
biennio, sebbene di entità molto contenuta.
Di seguito viene riportata la tabella che contiene i dati frutto dell'elaborazione del capitolo 3 (la
definizione del numero di residenti equivalenti) e trasformati in valore.
Composizione del mercato reale in valore (€)
composizione
residenti
gravitazioni lavoro
gravitazioni studio
gravitazioni
turismo
italiani
gravitazioni
turismo
stranieri
evasioni lavoro e studio
ferie
abbonamenti
Mercato reale
clienti equivalenti
spesa procapite
mercato in valore
74.000
6.000
3.000
10.165
133,00
133,00
133,00
133,00
9.842.000
798.000
399.000
1.351.945
3.937
133,00
523.621
-1.757
-5.920
-7.030
82.395
133,00
133,00
133,00
133,00
-233.681
-787.360
-934.990
10.958.535
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis
Cap. 4 - Le caratteristiche della rete
Descrizione della consistenza della rete distributiva.
Cap. 4.1 - Premessa
In questo capitolo vengono presentati alcuni dati di sintesi sulla rete distributiva delle riviste di
Grosseto. Le elaborazioni e i commenti, a cura di Sincron sono stati aggiornati nel mese di maggio
2004 a partire dai dati ufficiali messi a disposizione dall'Amministrazione.
I paragrafi che seguono presentano la situazione a partire da un livello generale per poi arrivare ad
una descrizione di indici utili a completare il quadro informativo della rete.
Cap. 4.2 - Condizioni generali
Nel territorio comunale esistono attualmente 71 rivendite di giornali e riviste.
In allegato viene presentato l'elenco delle rivendite completo di indirizzo, tipo di struttura e tipo di
rivendita.
Nelle tabelle esposte viene proposta la ripartizione della popolazione e dell'offerta commerciale per
zone.
Nella seguente tabella viene presentata la consistenza delle edicole divisa per località.
Comune di Grosseto: numero rivendite per ubicazione (valori assoluti)
Ubicazione
Grosseto
Alberese
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
TIPOLOGIA
Esclusiva
Non esclusiva
43
9
1
0
1
0
2
1
1
0
10
1
1
0
1
0
60
11
Totale
52
1
1
3
1
11
1
1
71
Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Comune di Grosseto: composizione per zona della popolazione residente e delle rivendite
Ubicazione
Grosseto
Alberese
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
%
v.a.
residenti
65.064
408
602
1.290
1.173
2.534
695
1.892
73.658
edicole
52
1
1
3
1
11
1
1
71
residenti
edicole
88,4
0,6
0,8
1,8
1,6
3,4
0,9
2,6
100,0
74,0
1,4
1,4
4,1
1,4
15,1
1,4
1,4
100,0
Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Al fine di una valutazione sulla distribuzione territoriale dei punti vendita è stato calcolato un indice di
densità per ogni località.
Tale indicatore consiste nel numero di residenti per rivendita. In questo modo un'alta densità della
distribuzione corrisponde ad un valore dell'indice basso.
Occorre precisare che ai fini della programmazione il valore dell'indice calcolato su tutto il territorio non
è di per sé significativo; le informazioni utili da questa analisi emergono dal confronto tra le varie
ubicazioni.
Comune di Grosseto:densità per ubicazione delle strutture di vendita.
dati
residenti per
edicola
Ubicazione
Residenti
Grosseto
Alberese
Batignano
Braccagni
Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
65.064
408
602
1.290
52
1
1
3
1.251
408
602
430
0,8
2,5
1,7
2,3
1.173
2.534
695
1.892
73.658
1
11
1
1
71
1.173
230
695
1.892
1.037
0,9
4,3
1,4
0,5
0,96
Edicole
Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Edicole ogni 1000
abitanti
Dalle tabelle che riportano la distribuzione territoriale per tipologia di rivendita si possono effettuare
alcune osservazioni e valutazioni circa l'impatto della sperimentazione. Si può osservare che l'85%
delle rivendite (quindi la categoria più presente) presenti sul territorio comunale sono rivendite
esclusive.
Per quanto riguarda la concentrazione di tipologie particolari nelle località del territorio comunale si
può osservare che 9 delle 11 rivendite non esclusive si trovano nel capoluogo e solo 1 nella frazione
Marina di Grosseto e nella frazione di Montepescali. Nel centro storico in particolare si trovano 2
edicole esclusive. Le altre edicole esclusive si concentrano nella restante parte del capoluogo e a
Marina di Grosseto. Le rimanenti sono presenti nella misura di una o due edicole nelle frazioni.
I grafici e le tabelle sopra esposti consegnano una chiara immagine della distribuzione dell'offerta e del
rapporto di questa con la domanda. E' naturalmente difficile e come verrà spiegato non razionale una
distribuzione uniforme dell'offerta nel territorio. Ci si riferisce per esempio al fatto che il luogo in cui
avviene un qualsiasi acquisto non si trova necessariamente nella zona di residenza. Così la
concentrazione dell'offerta (e il suo peso sulla distribuzione complessiva) a Marina di Grosseto è
superiore rispetto a qualsiasi altra zona.
Consistenza delle rivendite in base alla stagionalità dell’attività di vendita
Ubicazione
Alberese
Batignano
Braccagni-Montepescali
Grosseto
Istia d'Ombrone
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
annuale
stagionale
Totale complessivo
1
1
3
52
1
6
1
1
66
0
0
0
0
0
5
0
0
5
1
1
3
52
1
11
1
1
71
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Come si vede dalla precedente tabella a Marina di Grosseto quasi la metà delle rivendite sono
stagionali. In questa località si concentrano tutte le rivendite stagionali presenti nel Comune per motivi
legati al turismo balneare (stagionale).
Nella tabella della pagina seguente sono presenti i dati della consistenza per zone negli anni 1996 e
2004.
Confronto della consistenza commerciale 1996/2004 (Totale)
Ubicazione
Grosseto
Alberese-Rispescia
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Roselle
Comune
rivendite 1996
rivendite 2004
variazione
45
2
1
2
1
8
1
60
52
2
1
3
1
11
1
71
+7
0
0
+1
0
+3
0
+11
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Confronto della consistenza commerciale 1996/2004 (Rivendite esclusive)
Ubicazione
Grosseto
Alberese-Rispescia
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Roselle
Comune
rivendite 1996
rivendite 2004
variazione
45
2
1
2
1
8
1
60
43
2
1
2
1
10
1
60
-2
0
0
0
0
+2
0
=
Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio
Rispetto al 1996 il numero di rivendite è aumentato di 11 strutture non esclusive, e si sono verificati
mutamenti interni alle esclusive. Le zone maggiormente interessate da questo aumento sono state il
Capoluogo, dove si è registrato gran parte dell'aumento delle non esclusive, e Marina di Grosseto
dove si è registrato soprattutto l'aumento delle esclusive a scapito del capoluogo.
Considerando tutto il territorio comunale il numero di residenti per rivendita è passato da 1.197 del
1995 a 1.037 del 2002. Questa variazione negativa accentua l'inferiorità del numero dei residenti per
edicola rispetto ad altre realtà, sebbene non venga tenuto conto del beneficio indotto dai flussi in
ingresso in precedenza evidenziati.
Se si considerano gli 82.395 residenti equivalenti comprensivi di fenomeni evasivi e gravitazionali, si
ottiene una densità rettificata pari a 1.160 residenti per struttura.
Cap. 5 - Le valutazioni per lo sviluppo
Cap.5.1 - Elementi economici e territoriali per l'implementazione della rete
Nell'ambito del precedente piano di settore redatto da Sincron, del 1996, emergeva un dato saliente
sotto il profilo economico: la rete delle rivendite di giornali e riviste esistenti era in grado di garantire un
sufficiente equilibrio tra domanda ed offerta di quotidiani e periodici.
Occorre ricordare a questo proposito che in occasione della precedente pianificazione le rivendite
esclusive, le uniche esistenti sotto il profilo autorizzativo, venivano considerate miste o "pure" a
seconda che abbinassero o meno altre attività a quella di edicola.
Sotto il profilo economico, è possibile definire, come è stato fatto anche in passato per il precedente
piano di settore, un venduto obiettivo per esercizio; esso deve essere tale da remunerare il lavoro
impiegato a valori allineati al mercato.
Occorre a questo riguardo effettuare una valutazione sugli addetti medi per edicola, e stimare
l'incidenza dei costi in genere e del fattore lavoro in particolare nella tipologia distributiva dei giornali e
riviste.
Stimando un aggio lordo di 21.000 euro pro capite, se si considera che la media di addetti nelle
rivendite esclusive è pari a 1,8 addetti per edicola si ottiene un aggio obiettivo per impresa esclusiva
pari a 37.800 euro. Poiché l'aggio dell'edicolante incide, in base ai dati stimati a partire da varie
situazioni note in Italia, per il 19% circa sul venduto, si può indurre una stima del venduto obiettivo per
impresa esclusiva. Tramite questo procedimento si è ottenuta una stima del venduto obiettivo per
rivendite esclusive pari a 200 mila euro circa (erano 167 mila circa nelle stime del 1996; si registra
pertanto un incremento di circa il 20% nel giro di affari obiettivo).
Ipotizzato che le rivendite miste e le stagionali raggiungano, nel caso di Grosseto, un venduto pari a
circa il 50% delle esclusive (in una condizione territoriale dove il servizio e la sua capillarità divengono
prevalenti nella valutazione), e che una stima pari al 30% possa oggi essere applicato alle rivendite
non esclusive, si può stabilire il venduto obiettivo delle miste e delle stagionali in 100 mila euro all'anno
e il venduto obiettivo delle non esclusive in 60 mila euro annui.
Da notare nella tabella seguente che, oltre alle 11 rivendite non esclusive, si considerano
separatamente anche le 12 rivendite che sono risultate essere da precedenti verifiche come esclusive
in senso amministrativo, e miste sotto il profilo operativo, e le 5 rivendite stagionali, tutte ubicate a
Marina di Grosseto.
Anche oggi, pertanto, le valutazioni di carattere squisitamente economico illustrano una condizione
nella quale la rete attuale nel suo insieme, rispetto al proprio venduto obiettivo, raggiunge una
condizione di copertura soddisfacente del mercato reale, in buona parte grazie allo sviluppo delle non
esclusive.
Ulteriori autorizzazioni potranno essere rilasciate soltanto, nel caso delle esclusive, in abbinamento
con realizzazioni che creino ex novo consistenti flussi di traffico gravitazionale, e nel caso delle non
esclusive per verificate ragioni di miglioramento e capillarizzazione del servizio da rendere alla
popolazione.
Se si considera che le rivendite miste o stagionali incidano per il 50% delle esclusive e che le non
esclusive incidano per il 30%, come ipotizzato, si può trasformare la rete in rivendite esclusive
equivalenti, raggiungendo un dato pari a 54,8 strutture.
Suddividendo la popolazione stimata al 2007 per le esclusive equivalenti, si ottiene una densità di
circa 1.350 persone per edicola considerando soltanto i residenti, e di 1.504 persone considerando
anche i flussi in entrata e in uscita.
Anche sotto il profilo della densità complessiva, il mercato risulta pertanto essere coperto, se non si
considerano nuovi progetti generatori di flusso.
Se si tiene in considerazione il fatto che le spese pro capite sono state valutate pari a 133,00 euro, si
può a questo punto effettuare una valutazione sull'entità dei clienti che sono necessari al
sostentamento di una rivendita esclusiva "pura" da un lato, e di una non esclusiva o esclusiva "mista"
dall'altro.
Nel caso delle esclusive "pure", si tratta di 1.504 persone, nel caso delle miste di 752 persone e nel
caso delle non esclusive si scende a 451 persone.
Occorre allora valutare, come conclusivo elemento conoscitivo, la capillarità con la quale le rivendite
sono distribuite sul territorio, che si presenta come estremamente ampio e diversificato, e confrontare il
dato sulle densità obiettivo prima indicate con la situazione calcolata su differenti livelli di ripartizione
territoriale.
Le valutazioni che seguono scaturiscono da una rivisitazione delle densità per zona calcolate alla fine
del capitolo precedente, e da una simulazione effettuata su tutto il territorio Comunale tramite il
metodo del grafo.
Valutazioni di densità corretta (residenti/edicole)
Densità rettificata
Ubicazione
Grosseto
Alberese
Batignano
Braccagni - Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
Comune
1.524
816
602
717
1.173
373
1390
3784
1.344
Fonte: elaborazioni Sincron Polis
Le densità sono ottenute dividendo il numero dei residenti per il numero "rettificato" di rivendite; tale
numero è stato ottenuto come noto valutando un'edicola mista e una stagionale al 50%, e una non
esclusiva al 30% di un'esclusiva.
La popolazione considerata è quella residente, senza prendere in esame i flussi in entrata o in uscita.
In questo caso Grosseto Capoluogo, Roselle, Rispescia presentano una densità di rivendite minore
(numero clienti equivalenti maggiore) della media.
Le prossime elaborazioni forniranno elementi complemetari per definire meglio le scelte
programmatorie.
Cap. 5.2 - Specificità dell'analisi di copertura del territorio Comunale
In questo rapporto è stata riservata una cura particolare alle analisi socio territoriali, come richiesto
dalla legge.
Non più dunque soltanto una suddivisione per aree (quartieri) con elencazione dei punti di vendita e
della loro tipologia (consistenza), ma anche una attenzione alla collocazione "puntuale" di ciascuna
edicola.
Questo consente indagini minuziose per micro-aree, pur lasciando intatte tutte le necessarie
elaborazioni relative alla consistenza.
Si danno quindi tre momenti di lavoro:
1. aggiornamento dei dati di consistenza ed aggiornamento della collocazione fisica dei punti di
vendita;
2. formazione di un reticolo di grafo urbano (cioè di una stilizzazione del reticolo viario del
Comune) mediante la informatizzazione delle caratteristiche del grafo: lunghezza dei rami o
tratti di via, percorribilità, distanze metriche e distanze temporali, presenza di poli in quanto
punti di snodo viari oppure rappresentanti punti di servizio ecc.... Conseguentemente vi è un
riporto della consistenza di cui al punto 1 sulla matrice del grafo stesso;
3. elaborazioni sulla matrice del grafo in grado di fornire notizie finora non disponibili su:
o ampiezza dei bacini di utenza;
o
o
numero di residenti entro i bacini di utenza;
snodi eventualmente meno serviti.
Quanto qui viene necessariamente espresso in maniera sintetica necessita invece di un percorso
piuttosto lungo che, soprattutto per ciò che riguarda il punto 3 precedente, si cercherà di seguito di
chiarire:
•
•
per grafo territoriale del Comune si intende un grafo inserito in calcolatore che abbia come
rami (o archi) i tratti di viabilità e come poli i punti di incrocio tra le strade; ad essi (rami e poli)
viene associata una popolazione residente (fornita dal Comune sulla base delle sezioni
censuarie, quindi definibile minuziosamente per ciascun polo e, di conseguenza, ramo) nonchè
la presenza o meno di un punto di servizio (edicola). I rami sono poi caratterizzati da una
propria tipologia e da una propria percorribilità (velocità media di attraversamento del ramo).
Una versione del grafo è già stata utilizzata dal Comune di Grosseto per la programmazione
del commercio in sede fissa, e questo garantisce una importante uniformità di approccio tra le
varie tornate di programmazione;
con gli elementi di cui al grafo, è possibile calcolare per ciascun polo (e, specificatamente, per
ciascun polo avente una edicola) la popolazione compresa nel proprio bacino di servizio.
Con gli stessi strumenti di cui sopra è possibile tracciare i bacini di influenza di ciascuna edicola,
tenuto conto della concorrenza vicina, procedendo nel seguente modo:
•
•
•
si esamina ogni ramo di grafo uscente da ciascun polo contenente una edicola e lo si
attribuisce completamente all'edicola stessa se il polo terminale del ramo è ad una distanza
dall'edicola esaminata inferiore a quella misurabile tra il polo stesso e qualsiasi edicola
compresa nel grafo;
nei rami che non sono nella precedente condizione occorre trovare un punto di indifferenza,
ovvero un punto da cui sia indifferente dirigersi verso la prima edicola o verso l'edicola
concorrente (medesima distanza temporale). Tale punto di indifferenza consentirà di spezzare
il ramo, e la relativa popolazione, attribuendo i "pezzi" a due bacini confinanti;
una volta determinati tutti i punti di indifferenza intorno ad una edicola si traccia l'area del
bacino semplicemente collegando i punti trovati. Il contenuto informativo dell'area così definita
(in termini di popolazione ecc...) è noto.
Di seguito si propongono pertanto, a integrazione delle classiche elaborazioni riguardanti la
consistenza della rete, alcuni elaborati grafici e tabelle contenenti la definizione e quantificazione dei
micro bacini di ciascuna edicola.
La popolazione dei singoli bacini, lo ricordiamo, è indipendente dalla loro ampiezza ed estensione
temporale.
L'analisi dei bacini di utenza è strumento che consente di rilevare la completezza in termini localizzativi
della rete, nonché la sua efficacia (grado di copertura del territorio) ed efficienza (capacità di
rendimento in termini di clienti equivalenti (2) ).
Si possono avere due situazioni limite, essendo ovviamente le situazioni di maggior equilibrio quelle
preferibili:
1. pochi esercizi sul territorio, che hanno una buona capacità di rendimento (attraendo numerosi
clienti equivalenti) ma non servono sufficientemente il territorio considerato; ampie fasce di
territorio rimangono lontane dal servizio e ampi strati di popolazione, quelli con maggiori
difficoltà di spostamento, risultano disserviti. In queste condizioni si allunga il tempo medio di
accesso al servizio.
2. molti esercizi insediati in quasi ogni polo viario del territorio. In questo caso l'efficacia (o
capacità di copertura del servizio) è ottima, ma l'efficienza della rete è bassa perché non trova
sufficienti clienti equivalenti per reggere a lungo i costi di gestione. E' anche questa una
situazione che non può avere una lunga durata sfociando nella chiusura degli esercizi più
deboli.
I due casi illustrati sono teorici. Nelle situazioni reali, soprattutto grazie al governo urbanistico del
territorio, che ovviamente non consente costruzioni in ogni lungo, ed alla capacità di autoregolazione
del mercato, le situazioni tendono ad un migliore equilibrio (essendo l'equilibrio assoluto inesistente,
data la dinamica del mercato).
(2)Il cliente equivalente è, come misura, analogo all'unità di consumo cioè pari a un residente che effettui tutti gli acquisti
presso la struttura analizzata.
In una situazione necessariamente dinamica l'inserimento graduale e motivato di nuove proposte è la
migliore soluzione (graduale, perché si verifica di solito in periodi temporali piuttosto lunghi, motivato
perché contiene le attenzioni e le prescrizioni che più si adattano alla situazione specifica).
Nei prossimi grafici e tabelle si effettueranno le valutazioni dei bacini concernenti i punti vendita di
quotidiani e riviste.
Le domande a cui ci si propone di rispondere sono:
•
•
quali sono l'efficacia e l'efficienza di ciascuna delle strutture esistenti;
qual è l'efficacia complessiva attuale della rete.
Come naturale è necessario riferirsi ad un particolare momento di simulazione che comprende come
dato di riferimento quello della popolazione residente.
In questa sede si ricorda che:
•
•
•
•
la popolazione del bacino è quella totale che risiede entro i confini del bacino di utenza
indipendentemente dal fatto che vada o meno verso la struttura esaminata;
i clienti attratti sono quelli che subiscono, secondo quote ad andamento differenziato,
l'attrazione della struttura ovunque si trovino sul territorio;
il tempo di accessibilità dal bacino è la media ponderata dei tempi di accesso verso la struttura
dai poli compresi nel bacino;
il tempo di copertura è la stessa media ponderata ma da tutti i poli del territorio considerato.
Grafo 1 bacini totale area di riferimento
Grafo 2 bacini zoom
Il territorio è contraddistinto da una copertura complessiva del 96%, e da una capillarizzazione del
servizio pari all'81,4%.
Considerando le sole rivendite esclusive, l'indice di copertura è pari al 95,8%, e la capillarizzazione
all'81,9%.
Infine, le rivendite non esclusive raggiungono un indice di copertura del 70,2%, e una capillarizzazione
del servizio pari al 65,2%.
Cap. 5.3 - Considerazioni Finali
Grosseto presenta, alla luce delle analisi svolte, una situazione variegata, caratterizzata da una
densità di rivendite elevata anche a seguito della sperimentazione, ma è contraddistinta inoltre da
numerosi progetti di sviluppo che potrebbero richiedere attenzione anche sotto il profilo della
distribuzione di giornali e riviste, da un territorio molto vasto e da un livello di capillarizzazione del
servizio reso tramite le rivendite non esclusive ancora migliorabile.
La sperimentazione, in particolare, ha finito con il beneficiare nella grande maggioranza dei casi
proprio il capoluogo (9 rivendite non esclusive su 11 sono ivi ubicate), e soltanto in due casi ha favorito
un'altra realtà (Braccagni e Principina).
Tra i temi di sviluppo che possono richiedere una specifica previsione di diffusione di quotidiani e/o
periodici, si ricordano in particolare i cosiddetti "attrattori di traffico", come ad esempio la grande
struttura commerciale già oggetto di nullaosta regionale, i progetti contenuti nel Piano Strutturale in
particolare per quanto concerne la valorizzazione delle infrastrutture e della costa, i progetti contenuti
nel Piano degli Orari in particolare per quanto concerne la realizzazione di esercizi polifunzionali, che
potrebbero garantire un innovativo momento di servizio multispecializzato agli abitanti di località
altrimenti svantaggiate.
La tipologia non esclusiva, anche nella opzione stagionale, potrebbe consentire di perseguire una
strategia di programmazione in grado di rispondere a svariate necessità tra quelle descritte, mettendo
anche utilmente in "rete" i diversi strumenti programmatici di cui l'Amministrazione si sta dotando.
La tipologia esclusiva potrebbe viceversa essere utilizzata soltanto in misura mirata, nel caso di
creazione di nuovi flussi significativi.
Pur esistendo numerosi elementi aggiuntivi, rispetto alla quantità di residenti nell'area, che
determinano il successo di un'edicola (flussi particolari mossi dalla attrattività dell'area, ad es.) si può
qui introdurre un concetto utile per avere un quadro esaustivo delle potenzialità della rete che è dato
dalla sovrapponibilità di due elementi fondamentali come l'accessibilità e la densità di concorrenza
nelle vicinanze.
Analizzando la prima tabella dei bacini d'utenza, che prende in esame le rivendite esclusive e non
esclusive presenti nel Comune di Grosseto, si possono evidenziare alcuni aspetti generali:
•
•
•
•
la capacità complessiva di copertura del servizio sul territorio comunale (96%) é molto
soddisfacente;
circa il 57% delle rivendite ha un numero di clienti equivalenti superiore ai 1.000 residenti;
l'efficienza complessiva della rete distributiva è buona, infatti non sono numerose le rivendite
e/o aree particolarmente "deboli" in termini di popolazione del bacino e di clienti equivalenti. In
particolare, nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare dove abbiamo un elevato
numero di rivendite rispetto alla popolazione residente, quasi il 50% delle edicole svolge la
propria attività solo nel periodo estivo in considerazione del significativo afflusso dei turisti;
L'analisi a livello di località ha permesso di cogliere il ruolo di attrattività delle rivendite ubicate
nelle zone esterne al capoluogo.
Attrattività delle rivendite ubicate nelle località periferiche
Località
Alberese
Batignano
Braccagni
Montepescali
Istia
Marina di Grosseto
Rispescia
Roselle
popolazione bacino
(x)
832
1.248
1.608
1.599
3.292
743
2.430
clienti equivalenti
(y)
421
437
965
611
2.334
455
556
x/y
Tipo di polo
2,0
2,9
1,7
non attrattore
non attrattore
non attrattore
2,6
1,4
1,6
4,4
non attrattore
attrattore parziale
non attrattore
non attrattore
Fonte: elaborazioni Sincron Polis
Dalla tabella emerge che le rivendite situate nelle località periferiche non svolgono un ruolo di
attrazione se non nel caso parziale di Marina di Grosseto. La conclusione proviene dal confronto tra il
numero di residenti del bacino d'utenza col numero di clienti equivalenti. In un polo attrattore il numero
di clienti equivalenti è superiore al numero dei residenti.
L'indice x/y è indicativo della dispersione della clientela da un polo. Più l'indice è elevato (e superiore a
1) e maggiore è la clientela potenziale del bacino d'utenza che viene attratta verso l'esterno. La
distribuzione del servizio dovrebbe aumentare dove tale dispersione è elevata e dove la popolazione
del bacino può assicurare una redditività minima all'attività economica. In base a questi criteri
emergono come aree sulle quali puntare per una maggiore diffusione del servizio Roselle, Istia e
Batignano, oltre alla garanzia di una possibilità di integrazione nel Capoluogo;
•
•
•
•
•
•
Batignano, oltre alla garanzia di una possibilità di integrazione nel Capoluogo; l'ipotesi di
sviluppo delle rivendite non esclusive implica un incremento della capillarizzazione del servizio,
che attualmente è pari al 65,2%. Ipotizzando un incremento di un punto percentuale per ogni
anno di validità del Piano, l'obiettivo a 4 anni è quello di raggiungere una capillarizzazione del
69,2%. Ciò significa dover garantire un servizio a 2.946 persone supplementari, ovvero,
riprendendo l'indice di 451 residenti equivalenti per struttura, rilasciare sino a 7 autorizzazioni
per rivendite non esclusive nel periodo di validità del Piano e dei Criteri. Si prevede pertanto la
possibilità di concedere ulteriori autorizzazioni non esclusive nel Capoluogo, a Istia, a Roselle
e Batignano considerando le verifiche effettuate sulla densità per zona e i risultati provenienti
dall'analisi effettuata col grafo, con l'idea di recuperare, per quanto riguarda le località
periferiche, una parte di flussi di residenti che il grafo ha evidenziato in uscita;
il territorio di Grosseto è attualmente servito da una rete di rivendite esclusive che è
numericamente significativa rispetto ai residenti e ai flussi e che è distribuita in misura
adeguata rispetto alla localizzazione della popolazione. Il rilascio di ulteriori autorizzazioni
dovrà allora essere legato alla realizzazione di progetti che per le loro caratteristiche si
configurino come importanti attrattori di flussi a livello comunale o sovracomunale. Si pensa in
particolare all'Aeroporto, al Porto turistico, al Centro commerciale, alla Stazione degli autobus
e alla Stazione ferroviaria;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta regionale si fissa altresì in 4 anni il periodo di
validità del piano, consentendo poi un margine di un anno per l'aggiornamento del medesimo;
Le analisi svolte in parallelo alla elaborazione del Piano Strutturale hanno condotto a
evidenziare una suddivisione ottimale del territorio comunale in zone sotto il profilo
regolamentare: il capoluogo viene suddiviso in 3 sub zone, denominate Centro Storico (A),
Zona intermedia (B) e periferia (C). Le altre due zone sono le frazioni (D) e il restante territorio
del Comune, coincidente con la zona agricola (E);
L'elevato contenuto di immagine e di segno architettonico che caratterizza i chioschi per la
vendita di giornali e riviste richiede una attenzione particolare; a questo fine, la
regolamentazione rimanderà ad una tipologia e a dei parametri di realizzazione che verranno
messi a punto dalla Direzione Assetto del Territorio;
La Direzione citata provvederà anche a definire le superfici minime, laddove ritenute
necessarie per la migliore erogazione del servizio.
Tutte le proposte di sviluppo elencate vengono più avanti tradotte in due appositi articolati normativi
che costituiscono nel primo caso il Piano di localizzazione delle rivendite esclusive, nel secondo i
Criteri per l'autorizzazione delle rivendite non esclusive.
Allegato tecnico
Localizzazione rivendite esclusive e non esclusive nel territorio comunale di Grosseto
Grafo territoriale di riferimento ed elenco dei poli
Scarica