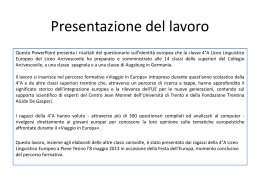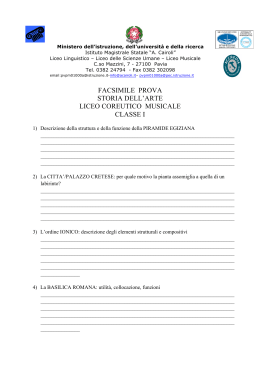Presentazione «Questo libro è una battaglia, perché la cultura non abbandoni la nostra vita e prima di ogni altro luogo la nostra scuola, rendendo il futuro di tutti noi un deserto. È anche un atto di accusa alla mia generazione, che ha compiuto alcune scelte disastrose e non manifesta oggi il minimo pentimento. Infine, è la mia personale preghiera ai giovani, perché scelgano loro, in prima persona, la vita che vorranno, ignorando ogni pressione, sociale e soprattutto famigliare. E perché, in un mondo che li vezzeggia, li compatisce, e ne alimenta ogni giorno il vittimismo, essi con un gesto coraggioso e rivoluzionario si riprendano la libertà di scegliere se studiare o no, sovvertendo tutti gli insopportabili luoghi comuni che da almeno quarant’anni ci governano e ci opprimono.» Paola Mastrocola Paola Mastrocola è nata nel 1956 a Torino. Insegna lettere in un liceo scientifico. Presso Guanda ha pubblicato i romanzi La gallina volante (Premio Italo Calvino per l’inedito 1999, Premio Selezione Campiello 2000, Premio Rapallo-Carige per la Donna Scrittrice 2001), Palline di pane (finalista al Premio Strega 2001), Una barca nel bosco (Premio Campiello 2004, Premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa 2004), Più lontana della luna (2007) e La narice del coniglio (2009); il pamphlet narrativo La scuola raccontata al mio cane (2004); i due romanzi favola Che animale sei? (2005), da cui è stato tratto l’omonimo graphic novel (2009), e E se covano i lupi (2008); la raccolta di poesie La felicità del galleggiante (2010). Disegno e grafica di copertina di Guido Scarabottolo ISBN 978-88-6088-557-9 © 2011 Ugo Guanda Editore S.p.A., Viale Solferino 28, Parma Gruppo editoriale Mauri Spagnol www.guanda.it Prima edizione digitale 2011 Realizzato da Jouve Quest´opera è protetta dalla Legge sul diritto d´autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. Non si tratta di conservare il passato, ma di mantenere le sue promesse. T.W. ADORNO, Minima moralia Una volta chiesero a Rodolfo Wilcock perché non sperava nei giovani e lui rispose: Perché conosco i loro padri. G. PONTIGGIA Noi sghembi C’era un geniale programma della Rai, si chiamava Specchio segreto e andò in onda nel 1965, poi in replica nel 1977: veniva piazzata una telecamera nascosta, e un attore interagiva con persone comuni che non sapevano di essere riprese. Il risultato erano scenette comicissime, scanzonate e surreali. Ad esempio quella in cui il regista Nanni Loy entrava in un bar, faceva finta di essere uno come gli altri, prendeva una brioche al banco e, con fare indifferente, la intingeva nel cappuccino dell’ignaro avventore che gli stava accanto. Ci sono norme dell’interazione sociale che non hanno neanche bisogno di essere scritte tanto sono scontate: non si inzuppa la propria brioche nel cappuccino altrui! Così come non si va in mutande al ristorante, e non si fa la lingua ai passanti. Non si fa, ecco, appunto. Mi sono spesso sentita così, scrivendo questo libro: come una che al bar prende una brioche e la intinge nel cappuccino di un altro. Mi sono sentita scorretta e storta, inappropriata e sconveniente, e fuori posto. Mi girava in testa un costante, opprimente «non si fa», un’autocensura preventiva che però non preveniva un bel niente, un sottile senso di colpa senza effettive colpe... Non stavo trasgredendo le normali regole del vivere civile; certo è, però, che stavo pensando cose che non bisogna pensare, né dire, né vedere. Ma io le vedevo. Come facevo a non dirle? E come facevo a non pensare le cose che mi veniva da pensare, vedendo quel che vedevo? E così, sono andata avanti. Ci ho messo un tempo piuttosto lungo, è stato un continuo andirivieni mentale, spossante. Ma sono arrivata fino alla fine. Il risultato è questo libro, diviso in tre (come la Gallia). La prima parte è descrittiva, sono le cose che ho tutti i giorni sotto gli occhi: i nostri giovani a scuola, per strada, al bar, al ristorante, nelle piazze alle tre di notte, nonstudianti, assenti, chattanti. Le cose come stanno, insomma, sotto gli occhi di tutti, ma che molti diranno che non stanno affatto, non sono, me le sono inventate: perché non è detto che vediamo le stesse cose, un albero io lo vedo verde e tu magari giallo, la realtà in sé non esiste, il mondo è interpretazione... La seconda parte è una specie di ricostruzione storica di come è andata, a partire dagli anni Sessanta fino a oggi. Un bel viaggetto da don Milani alla Gelmini. E questa sì, come negarlo?, è una mia personale ricostruzione: nel senso che molti, di sicuro, ricostruirebbero in un altro modo. La terza parte è quella a cui tengo di più. Forse ho scritto il libro per poter arrivare lì, a dire quel che vorrei. Ci penso da tanti anni. Potrei dire: sono le mie idee radicate, sulla vita, la società, i giovani, la scuola, la cultura, i libri, il futuro... A proposito, mi è parso di aver trovato niente meno che una soluzione per il futuro... Qualcosa che ha a che fare con la felicità dei giovani, la loro libertà di scelta. Insomma, la terza parte è la mia personale «modesta proposta»: in poche parole, lì vi dico come farei io se governassi l’universo, quale scuola mi inventerei. Ed è lì l’idea che non bisognerebbe avere, scorretta, inappropriata, fuori posto. L’idea sghemba, direi. Non bella dritta come le idee degli altri. Avete presente un’autostrada gigantesca e lineare dove vanno tutti avanti belli dritti, e poi invece delle viuzze laterali, oblique, stravaganti, irregolari, discrepanti, che se ne vanno chissà dove un po’ per conto loro... Ecco, idee sghembe: quelle che non dovremmo nemmeno cominciare a pensare. Idee scorrette. Direi culturalmente, più che politicamente, scorrette. Sì, esiste oggi un culturally correct ingombrante, greve. Siamo intrisi fino al midollo di idee sulla cultura e sulla scuola neutralmente buone, quiete, grigie, tranquille, che si possono cioè tranquillamente avere, che vanno sempre bene perché le abbiamo tutti, e quindi non si fa brutta figura a dirle, anzi, aprono ogni porta e non increspano mai il mare della nostra vita sociale. Idee che però, secondo me, non abbiamo mai veramente pensato. Idee ricevute, non nostre. Nel senso che le abbiamo ricevute da altri, ma non sappiamo più bene né da chi né quando. Forse erano già lì da qualche parte, pronte all’uso: una specie di prêt à penser. Le abbiamo indossate, e adesso fanno parte di noi e non le mettiamo mai più in discussione: e infatti dominano il nostro mondo. Col tempo, hanno formato strati e strati, fino a costruire una specie di cappa pesante che adesso ci opprime. Come il guscio di una tartaruga opprime la tartaruga (non a caso va così lenta...), ma le fa anche da casa. Eh sì, perché le idee comuni non nostre sono anche molto calde e protettive, rassicuranti, consolanti. Viviamo tutti sotto una cappa, come in una confortevole casa sottovetro, un enorme barattolo cosmico comune. Che però è invisibile. Non mi piace vivere sotto una cappa e fare la tartaruga. Lo trovo soffocante. Soprattutto una cappa così massiccia, stratificata da anni e anni di incrostazioni mentali collettive. Volevo provare a uscire, andare a guardare il sole, e così mi sono permessa di avere delle idee culturalmente scorrette. Anche a costo di rimanere lì, inerme, senza guscio. Insomma, ho scritto questo libro. Dico le cose che vedo e le cose che penso a partire da quelle che vedo. Tutto qui, non c’è altro. Il problema è soltanto che quel che vedo è così enorme, così fuori misura e anche doloroso, che viene da ignorarlo. Per non stare tanto male, viene da fare come se non ci fosse. Lo so. Ma guardare è un nostro dovere preciso. Guardare tutti insieme. Anche a costo di far saltare qualche pezzo della nostra quieta e così compatta esistenza. PARTE PRIMA I NONSTUDIANTI CAPITOLO UNO Scene da una gioventù 1. Test d’ingresso Da qualche anno, a settembre, subito, a partire dai primi giorni di scuola, in prima superiore, noi insegnanti d’italiano del biennio facciamo il test d’ingresso. Appena gli studenti neoiscritti prendono posto, zac, il test d’ingresso. Una volta, diciamo una decina di anni fa, non ce lo sognavamo neanche il test d’ingresso, perché era ovvio che cosa i ragazzi sapevano e che cosa no. Tanto per dire, sapevano la loro lingua, l’italiano, mediamente bene: voglio dire che erano in grado almeno di scrivere correttamente le parole, e anche di fare l’analisi logica. Invece adesso nulla è più ovvio, e nessuno di noi sa che cosa sanno e che cosa no i ragazzi che arrivano al liceo. Quindi li testiamo. Ci mettiamo d’accordo, noi insegnanti di lettere del biennio, e confezioniamo un bel test uguale per tutte le classi prime, un meraviglioso composto di dettato ortografico, esercizi di punteggiatura, analisi grammaticale e analisi logica, che somministriamo (il verbo è questo) lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le classi prime. Check-in collettivo, di massa. Risultato: neanche una sufficienza, su 25 allievi. Specifico meglio: risultato in una mia classe di prima scientifico (non vi dico di quale anno, tanto è uguale negli ultimi cinque o sei anni). Ragazzi quattordicenni, appena usciti dalla terza media, primi giorni di settembre: neanche una sufficienza. Su 25. Chiedo un po’ in giro ai colleghi di altre scuole e di altre città, per sapere se capita solo a me, e scopro che più o meno l’esito è lo stesso: una o due sufficienze per classe. Perciò, se prendiamo un liceo che abbia più o meno dieci prime con circa venticinque allievi per classe, facendo una media generosa di una o due sufficienze per classe, dovremmo arrivare a dire che su 250 allievi che entrano in prima liceo scientifico più o meno dieci o venti sono le sufficienze in italiano. Facciamo 20 buon peso, e non se ne parli più. 20 su 250. Un dieci per cento scarso. Per curiosità, pare che ai colleghi di matematica capitino disastri equiparabili: in quarta ginnasio i ragazzi non sanno calcolare il minimo comune multiplo e il massimo comun divisore. Non vorrei chiedermi perché succeda questo (anche se mi è difficilissimo non chiedermelo...). Dico solo che questi ragazzi arrivano da otto anni di scuola. Cioè, hanno passato a scuola otto anni della loro vita (senza contare la scuola materna e l’eventuale nido): cinque alle elementari e tre alle medie. Ripeto solo quel che vedo: 20 sufficienti su 250. Scusate, mi soffermo ancora un momento perché non vorrei che il dato passasse inosservato. Vuol dire che solo 20 (buon peso!) su 250 a quattordici anni sanno la grafia corretta dell’italiano, mettono la punteggiatura, riconoscono un soggetto, un predicato verbale o nominale, un complemento oggetto, e distinguono un avverbio da una congiunzione. Non stiamo parlando di capacità superiori, quali capire il senso di un libro, tradurre Tacito, interpretare le metafore di una poesia di Rimbaud o analizzare criticamente un’opera di Shakespeare. Stiamo parlando delle conoscenze di base della lingua italiana, che è la nostra lingua, che usiamo da quando siamo nati e che impariamo a scuola da quando abbiamo sei anni. Ebbene, queste conoscenze sono: assenti. Piccola considerazione: a rigor di logica, solo 20 su 250 potrebbero entrare al liceo, se il test d’ingresso valutasse davvero l’opportunità dell’ingresso al liceo. Ma non lo fa, perciò entrano tutti e 250. Benissimo. (Ma come si fa a frequentare un liceo non sapendo la propria lingua?) Però questo vuol dire (lo sottolineo solo per amor di logica) che almeno 230 allievi su 250 non sono idonei a fare quel che sono entrati a fare e dunque presumibilmente lo faranno malissimo. Chi li renderà idonei? Nessuno. Cioè, in teoria noi insegnanti di italiano del biennio. Ovvio che, invece, non ce la faremo mai: come diavolo possiamo insegnare a ragazzi che hanno quattordici anni cose tipo la calligrafia, l’ortografia e la grammatica, che dovevano imparare da bambini? Anche volendo e tristemente rinunciando al programma specifico del liceo, non ce la faremo. Son cose che han bisogno di un tempo lunghissimo, devono sedimentare e maturare dentro. Inoltre, c’è il guaio di aver acquisito abitudini sbagliate, che poi è molto arduo estirpare. A quattordici anni ormai è fatta, ognuno si tiene gli errori che fa. Molto più facile sarebbe, paradossalmente, cominciare da zero. Molto più difficile de-programmare. Siamo fuori tempo. È come se ci consegnassero un sacchetto di semi e ci chiedessero di potare i rami. Come sarebbe? I semi non sono ancora alberi, nessuno li ha piantati, come potremmo ora noi potarli? I ragazzi sono diventati altro, di sicuro qualcosa di meraviglioso, ma non alberi. Non hanno foglie, rami, radici, non hanno niente. Certo, tutto può ancora essere: possiamo provare a piantarli noi. Meglio tardi che mai. E infatti oggi al biennio questo facciamo: ricominciamo dall’inizio come se prima nulla fosse stato, spieghiamo gli accenti, gli apostrofi, le virgole, le congiunzioni, la divisione in sillabe, i nessi -gn- e -cq-. Ma ci vorrebbe un tempo lunghissimo che non abbiamo più. E infatti non otteniamo quasi niente: facendo un dettato ortografico al mese, arriviamo a fine anno con circa la metà della classe che ancora sbaglia a scrivere ce n’è e mette l’accento a un po’ invece che l’apostrofo. Quindi, arrivati al fondo del mio ragionamento, la conclusione mi sembra una sola: è evidente che sbaglio io, nessuno vuole veramente che i ragazzi sappiano l’italiano. O meglio, forse pensiamo che tanto lo sanno già: parlano! Più o meno emettono parole, quelle che sono loro sufficienti per farsi capire, che altro ci vuole? Infatti, sentite qua. Un giorno incontro per strada un amico che insegna alla facoltà di Lettere, parliamo un po’ di giovani, di esami, di test, e lui mi dice: chi se ne frega dell’ortografia, i problemi sono ben altri! Mi sento come una volta, quando ci dicevano: pensa a quanti muoiono in Vietnam, pensa alla fame nel mondo. Mi sento stupida e inadeguata a vivere nel mondo, e infinitamente inferiore a chi mi sta di fronte: come possiamo noi preoccuparci di una cosa tanto infima come un apostrofo o una virgola, quando intorno a noi tanti muoiono? Buffo, non mi ha mai preso il cuore l’ortografia, e nemmeno la grammatica: mai dato un esame specifico all’università, per dire, e mai dovuto insegnare pronomi, verbi e aggettivi. Solo che ultimamente succede che mi dispiace vedere che i ragazzi non sanno l’italiano, mi chiedo se lasciarli così o intervenire, mi vien da pensare che sia una mia precisa responsabilità correggere, per esempio, le parole scorrette. Forse sbaglio, forse la mia visione è diventata modesta e irrilevante. Sta di fatto che, negli ultimi anni, m’è toccato di fare la paladina dell’ortografia, pensate un po’! Così mi sento dire che l’ortografia è solo ortografia, una minuzia, una quisquilia, forma e non contenuto, superficie (della lingua) e non sostanza (del pensiero), buccia, scorza e non succosa polpa. Cosa importa scrivere ha con l’acca o senza, o c’è né invece di ce n’è? Vorrei dire così tante cose, che non so da dove cominciare. Dirò solo questo: una casa si comincia a costruire mettendo i mattoni dritti. Se sono storti, la casa cade. E, guarda caso, orto-grafia vuol dire proprio grafia «dritta» (dal greco orthós). Voglio parlare di questo: della capacità «costruttiva» della nostra mente, del fatto di essere capaci di scorgere in un testo una «struttura» e di riprodurla in un altro testo, orale o scritto che sia. Che poi vuol dire saper parlare, leggere e scrivere, tutto qua, solo queste tre piccole cose. Penso che l’ortografia c’entri moltissimo con la strutturazione del pensiero. Saper scrivere ce n’è nel modo giusto (cioè dritto...) vuol dire sapere che cosa si scrive, qual è il senso di quelle tre paroline: il ce, il ne, la è. Se invece si scrive c’è ne o c’è né o cé ne o cené, significa non «scorgere» quelle tre paroline, e quindi non capire quel che si scrive: non capire, insomma, perché sia giusto (ovvero dritto) che ce n’è si scriva così e solo così. Il senso, l’esattezza del senso. Esattezza era una delle sei lezioni calviniane, una delle sei cose che Calvino voleva passare nel nuovo millennio! Di lì non si scappa, per costruire. Di lì, per esempio, dall’esattezza del senso e da come si mescola col suono, si comincia a scrivere, secondo me. Comunque, dovrei smetterla. Non va bene che uno debba sgolarsi tanto a dimostrare che sarebbe meglio sapere la propria lingua piuttosto che non saperla. Essere costretti a dire cose ovvie procura un senso di nausea. Ci sono cose nella vita che avrebbero una loro intrinseca evidenza, che non sarebbe il caso di star tanto a spiegare, come invece sto facendo. Anche se, è pur vero, io le dico così a naso, solo col buon senso di una che per mestiere insegna, e scrive. Null’altro so dire, di più scientificamente provato e inconfutabile, sull’enorme importanza di ortografia e grammatica. Ho studiato altro. Perciò basta così, vedete voi se ho ragione o no. Solo una richiesta: ditemi se le devo ancora insegnare queste cose o no. Forse, se i ragazzi non sanno più l’italiano, vuol dire che la scuola non ha più ritenuto che fosse il caso di insegnare l’italiano. Forse tutti in Italia (o meglio, in Europa) hanno deciso questo: che non è più utile insegnare la propria lingua, e si sono dimenticati di dirlo anche a me, e allora io sono l’ultima a fare una cosa che non interessa più a nessuno, e quindi è bene che smetta. Vi ricordate di quell’ultimo soldato giapponese rimasto a mitragliare per aria, a cui non avevano detto che la Seconda guerra mondiale era finita? Ecco, così. 2. Nebbie mattutine Mattino presto, davanti a scuola. Preferibilmente nel periodo autunnale, se c’è la nebbia. Quest’anno siamo fortunati perché la nebbia c’è. È tornata. Meno male. Da qualche anno era sparita, gli autunni si susseguivano tersi, quasi sfacciati nella loro innaturale luminosità. Noi qui al Nord non siamo abituati al terso. Siamo nati in un posto dove per tradizione si brancola, si cammina come ciechi rasentando i muri almeno per due mesi l’anno; ci si incontra senza vedersi, e al massimo ci si tocca l’un l’altro sulla manica del cappotto per vedere se esistiamo; si attraversano ponti come sospesi nel nulla e ci piace così, ci pare un esercizio metafisico, una prova di quel che sarà la vita nell’aldilà. Secondo me crediamo molto nell’aldilà proprio per questo: perché abbiamo la nebbia. C’è chi ha la fortuna di avere il mare davanti e chi si deve accontentare dell’acquerugiola sospesa e grigia detta nebbia, va bene lo stesso, l’importante è avere ogni tanto un barlume, un accenno di infinito. Per questo sono contenta che quest’anno la nebbia sia tornata. Mi chiedo solo dove fosse andata, in tutti questi anni tersi. Otto meno un quarto. Arrivo che la nebbia è ancora fitta e avvolge completamente l’edificio, un cubo grigio come la nebbia, impossibile distinguere. Li vedo da lontano. Dapprima sono solo una massa scura informe nel bianco nebbioso fitto. Poi, avvicinandomi, mi appaiono meglio: sono gli studenti che aspettano di entrare a scuola. In tutte le scuole di Torino, d’Italia, d’Europa sono così: ammassati fuori, a parlottare, stazionare, sfumacchiare. Ombre, lemuri. Spettrali. Aspettano l’apertura delle porte. Immobili come statue, a grappoli: gruppi marmorei. Se si spostano, è di poco, qualche passetto di lato o in tondo. Sono lenti, laterali o circolari. Sonnambuli. Hanno ciuffi scomposti e occhi addormentati. Giubbotti striminziti e jeans abbassati e lunghissimi, con la stoffa che si accascia esorbitante sul collo delle scarpe. Le mani in tasca, lo zaino in spalla, i cinturoni bassi, le scarpe da ginnastica grosse, gonfie, colorate. A volte dorate. Hanno zaini obesi, spropositati, appesi a una spalla, sbattuti a terra, carichi di scritte, adesivi, mostri, piccoli peluche, «peluscini». Soprattutto le ragazze, appendono di tutto allo zaino, l’universo degli animaletti del creato ridotti in miniatura e con l’anello portachiavi: zebre, coccodrillini, dromedari, camaleonti, elefantini, asinelli, cammelli, coccinelle, gazzelle... O antilopi? Incredibile come si sia evoluta l’arte del peluche: quand’eravamo piccoli noi, c’era giusto l’orsacchiotto o, proprio per gli originali, la scimmietta e il cagnolino, stop. Invece adesso abbiamo reso peluche anche i pesci, i pappagalli, i serpenti e le lumache, animali che col pelo, a essere sinceri, hanno ben poco a che vedere, e che tutto suscitano tranne il desiderio di stringerli affettuosamente al petto la notte mentre dormiamo. Te lo vedi un serpente boa come compagno della nanna? Lo zaino novella arca di Noè, insomma. Forse questi ragazzi temono un prossimo possibile diluvio universale e si assumono l’onere di salvare gli ultimi animali della terra. Forse è una missione che sentono come propria. E si attrezzano con questi zaini-zattere, mezzi d’emergenza, arche, traghetti per i possibili salvabili viventi. Chissà. Poi con una schicchera del pollice e del medio gettano il mozzicone lontano. Quando finalmente salgono la scalinata per entrare nell’edificio grigio detto scuola, una moria di mozziconi è stesa al suolo, come un esercito sui campi di battaglia, secoli fa. Otto meno cinque, diventano un’orda. Che si sposta compatta e inesorabile, se sbagli il tempo ti travolge. Io a volte sbaglio il tempo e vengo travolta. Noi insegnanti non abbiamo il pass per l’aldilà, siamo uguali ai nostri allievi, tutti fratelli, pari. Nessuno ci fa passare, offre un varco, si scosta. Non ci vedono neanche e se ci vedono è come aver visto l’aria: non siamo nulla. Veniamo assorbiti e sospinti. Come i puledrini presi in corsa nel mezzo della mandria. Nel selvaggio West. Così mi sento le mattine che sbaglio il tempo, un puledro. Vecchio. Travolta dall’Orda procedo sospinta, inerme. Sono stretta dagli studenti-orda, a un passo, anche meno. È così che, passandoci in mezzo, li vedo. Li vedo meglio da vicino, attraverso con gli occhi i loro corpi, i giubbotti, gli zaini. E mi accorgo di quanto sono vestiti bene. Soprattutto le ragazze: jeans attillati, scarpina giusta con un po’ di tacco, cinturina viola o di lamé, golfino con scollo a V, T-shirt bordata di pizzetto, collanina di perline, fermacapelli con il fiore, orologino Armani, piccolo tatuaggio alla caviglia, minutissimo brillantino alla narice destra, maquillage, contorno-occhi, leggero fard. Ed è a questo punto che nasce in me un pensiero acuminato: penso che ci vuole tempo. Ci vuole un tempo lunghissimo a prepararsi così per venire a scuola. E ci vuole anche arte, e pazienza. E un’infinita attenzione. Di colpo mi rendo conto che è un lavoro delicato e complesso: si chiama «prepararsi per andare a scuola». Trovare le cose giuste, indossarle bene, combinare i colori insieme. Nulla lasciato al caso. I ragazzi fanno tutto questo, impiegano tutto questo tempo e pazienza e abilità, proprio per venire a scuola. Ecco, è questa frase, questa finale implicita che mi illumina: si vestono così per venire a scuola. In vista della scuola. Affinché. Al fine di. Anche i maschi, a seconda dello stile (e del censo): le mutande Calvin Klein che sporgono per mezza chiappa dai jeans, la scarpa patchwork Munich, il golfino jacquard leggermente anni Settanta, il ciuffo secco dal gel, il piumino a salami Monclair, il tatuaggio tribale sul polso. La scuola è per loro un luogo dove si arriva in tiro. Per mirare ed essere mirati, direbbe Leopardi... (Con la differenza che nella sua Recanati ci si agghindava solo la domenica, non tutti i santi giorni che Dio manda in terra!) E forse hanno ragione: cosa c’è di meglio, quale fine è più alto per l’uomo che saper intessere relazioni, stabilire rapporti con gli altri? I ragazzi vengono a scuola per socializzare, ecco perché. Allora, però, permettetemi di dire, lo zaino stona. È così pesante, con tutti quei libri. Così come stonano le nostre lezioni, le interrogazioni, i compiti in classe, i compiti a casa, quei quadernoni ad anelli pieni di appunti, esercizi, schemi... Saliamo le scale insieme. Navigo tra i loro zaini ingombranti, coperti di scritte a pennarello. Se li trascinano sulle spalle come gli antichi schiavi portavano i massi delle piramidi. Uno dopo l’altro, tra le frustate e le urla degli aguzzini. Una vita di sacrifici, di fatica, di dolore. Lo zaino infatti sì, secondo me, è proprio l’oggetto fuori posto. Stona. Troppo pesante. Estraneo, alieno. Non c’entra niente con le scarpe, i giubbotti, i capelli, i tatuaggi, gli orecchini. Allora li guardo meglio, oltre i vestiti, oltre le mani in tasca. Hanno gli occhi cerchiati, tristi, il naso pieno di sonno, le spalle curve, le braccia penzole, inerti. Lo sguardo perduto nel nulla, la bocca semiaperta, i capelli stanchi, le orecchie assenti. Anche i brufoli, chi li ha, sono scoraggiati, pallidi brufoli muti, apatici. Le mani spente. Le ginocchia amorfe. Non so. Mi sembra di capire all’improvviso, di vedere per la prima volta. Mi viene un’infinita pena, una pietà. E capisco: la scuola non va bene, fa del male a questi ragazzi, appesantisce loro la vita, gliela scolla da quella che sarebbe la loro naturale propensione alla felicità. Mi verrebbe quasi da chiedere scusa, da promettere che non lo faremo più. 3. Zero sillabe Interrogo gli ultimi quattro senza voto. Sta per finire il quadrimestre, tutti devono avere un voto in epica. La scuola funziona ancora così: l’insegnante fa lezione; gli allievi ascoltano, prendono appunti; a casa studiano sugli appunti e sul libro; la volta dopo l’insegnante interroga per vedere che cosa hanno studiato. Semplice. Si chiama scuola. Si è chiamata scuola, fino a oggi (da domani non so). Ho spiegato Omero, l’Iliade, la guerra di Troia, Schliemann, la dea Discordia. Gli dei, l’Olimpo, Paride che dà la mela ad Afrodite. Elena, la donna più bella del mondo. La bellezza per i greci. La guerra, il tradimento. Menelao. Baricco che riscrive l’ Iliade. Si può riscrivere una grande opera del passato? Cosa vuol dire? Leggiamo il suo libro. Torniamo ad Achille. È solo, è triste. Agamennone gli ha preso la schiava preferita. Perché? Lo sapete che Achille non ci voleva andare in guerra? E neanche Ulisse. I grandi eroi greci preferivano stare a casa. Cosa vuol dire? E Ettore che scappa davanti ad Achille e invece di affrontarlo si fa tre giri di corsa intorno alle mura? Che cosa è allora quel che chiamiamo coraggio, e l’eroismo? Ho spiegato l’Iliade, tutti i passi in antologia. È così. È il mio mestiere. Mi può venire bene o male, a volte viene meglio e a volte peggio, è come recitare: non è uguale tutte le sere, lo spettacolo cambia. Dipende anche molto dal pubblico. Comunque è il mio mestiere, è una cosa che so fare e mi piace. I ragazzi mi guardano. Attenti, partecipi. L’Iliade li affascina. Mi seguono. Per un’ora, due. Sono ragazzi buoni, pazienti. Non è vero che non sono interessati a niente. D’altronde, con Omero, come si fa a non venir travolti? Gli dei, gli eroi, la poesia, il mito... Sono contenta. Soddisfatta. Mi sembra che il mondo funzioni, e che io abbia una mia utilità. Io spiego, loro ascoltano. Bene. Solo che poi li interrogo. Che ci posso fare? La scuola, lo ridico, è questo: l’insegnante spiega, l’allievo studia, l’insegnante interroga e l’allievo ripete. C’è anche dell’altro, naturalmente, non temete: si discute, si scherza, si parla di tante cose. Ma il nucleo-base resta questo qua. È la scuola fondata sullo studio. Tutto normale. Il mondo (scolastico) va (ancora) così. Ebbene? Dicembre, è quasi Natale. Fuori è tutto gelato e in classe i ragazzi hanno appeso due palline colorate e uno striscione con gli auguri. È tutto molto bianco e allegro e i miei allievi, guardateli, che carini, gentili, invernali, avvolti come sono nei loro maglioni spessi. Un vero peccato che io li debba interrogare. Non avete idea di quanto mi dispiaccia, sotto Natale poi... Il fatto è che tutti devono avere il voto in italiano prima che si chiuda il quadrimestre, dunque è ovvio che interroghi quelli ancora senza voto. Mi capite, vero? Per precauzione, li ho anche avvertiti una settimana prima: siete rimasti voi quattro senza voto, ovviamente sarete interrogati. Ovviamente. Quindi li interrogo. Vengono alla cattedra lenti, portandosi la sedia. Perché si portano sempre la sedia quando sono interrogati? Deve averglielo insegnato qualcuno, certo. Ma chi, e quando? A quale epoca della loro vita passata risale questa abitudine scolastica che, personalmente, non so ricondurre a nulla? L’interrogato con sedia al seguito. È strano per due ragioni: primo, si parla meglio in piedi, lo dicono anche gli attori che la voce viene meglio se si sta in piedi (questione di diaframma); e poi, seconda cosa, si portano la sedia e non il libro di testo su cui saranno interrogati, glielo devo sempre dire io di prenderlo, e questo è molto buffo perché in un’interrogazione serve sicuramente di più il libro che la sedia. Ma andiamo avanti, non importa. Forse una stanchezza cosmica impedisce loro la posizione eretta. O forse fa più situazione colloquial-amichevole. O forse la sedia, a mo’ di coperta di Linus, dà loro sicurezza, è qualcosa di solido a cui aggrapparsi, una specie di scoglio per chi naufraga; mentre il libro, diciamocelo, questo oggetto fragile, piccolo e corruttibile (di carta!) che riparo può mai dare? Comunque, questa parte sulla sedia non c’entra niente. Chiamiamola: digressione della sedia, e finiamola qui. Non hanno studiato. Il problema è questo: non hanno studiato. Io faccio le domande e nessuno risponde. Quattro interrogati, zero sillabe. Impreparati. Non hanno studiato. Ovvio. Se uno a domanda non risponde, vuol dire che non sa. E non sa perché non ha studiato. Giusto? Giusto. E io non capisco perché. Questa è la domanda: perché non hanno studiato? Li mando a posto con 4. Impreparati, quindi 4. Potrebbe anche essere un 2, ma non me la sento. Dura poi rimediare un 2... Comunque un 4 è un 4, c’è poco da ridere. Non l’avevano previsto? Cosa pensavano potesse loro succedere non aprendo bocca all’interrogazione? Mi stupisce che di fronte a un effetto chiarissimo rispetto a una causa, loro non evitino l’effetto rimuovendo la causa. Altrimenti detto, mi stupisce che, al fine di non prendere un 4, non abbiano deciso di studiare. A fine quadrimestre. Gli unici a non avere ancora voto. Era una sfida? Non credo. Una dimenticanza? Una ribellione? Un’indifferenza? Non lo so. A meno che il 4 non li disturbi per niente... Sì, può essere questo. Sanno che poi diventa 6: è solo Natale, hai voglia!, c’è tutto il tempo di rimediare. E poi, forse siamo noi adulti (alcuni di noi adulti, non tutti!), insegnanti e genitori, che riteniamo un 4 un voto disdicevole, e riteniamo altresì una tragedia prendere un voto disdicevole. Forse per loro non è così. Forse loro sono più saggi, e sanno collocare le cose al giusto posto, sanno che cosa ha valore e che cosa no. Cos’è mai un 4 nella comoda agiatezza della loro vita, nel calore affettuoso delle loro amicizie, nella tenera bambagia famigliare e nel tiepido conforto hi-tech casalingo? Niente. Una banalità. L’increspatura di un’onda marina, il granello di polvere sul vaso di cristallo, il puntolino nero di una mosca che si posa un attimo sul parabrezza. È così? Lo chiedo ai quattro interrogati: perché non avete studiato? A volte le domande dirette sono le migliori, inutile girarci intorno: perché non avete studiato, pur sapendo che vi avrei interrogati? Zero sillabe, di nuovo. Le mie parole cadono nel vuoto, rimbombano sulle piastrelline beige delle pareti, assordano il silenzio. I quattro mi guardano con gli occhioni muti, buoni. Sono ragazzi così gentili e miti. Miti e muti. Beneducati. Quieti: nessuna battaglia increspa mai le loro menti, le loro voci, i loro gesti. Non vogliono combattere, contrapporsi, sfidare, ribellarsi. Niente. Forse sono solo, qua e là, percorsi da un sottile malessere interiore, qualche piccola nuvola alta, leggera, che poi va via. Qualche volta invece, miracolo, mi rispondono. Dicono, veementi: Ma io ho studiato, prof! Temo siano terribilmente sinceri. Temo voglia dire che non sanno studiare né capire se hanno studiato o no: credono di averlo fatto e invece non hanno neanche lontanamente sfiorato il senso di quel che vuol dire studiare. Un’altra di quelle domande che non mi devono venire s’affaccia inesorabile sul baratro: non è che per caso nessuno finora gli ha mai richiesto, né dunque insegnato, lo studio? Mi verrebbe da far loro una carezza sui capelli e dire non importa, va bene lo stesso. Ma non posso, sono la loro insegnante di italiano. Li mando a posto. Con 4. 4. Tè con biscotti Oggi vado a trovare una mia amica. Venite con me anche qui: a casa della mia amica. Ha tre figlie, dai nove ai sedici anni. Non la vedo mai perché ha sempre un sacco di impegni, tra cui far fare i compiti alle figlie. Far fare... Allora vado io a trovarla. Sta facendo fare i compiti alla figlia più grande. Le altre due sono a ginnastica. Facendo fare... Vorrei che notaste l’innaturalezza del doppio verbo fare contiguo: far fare. Stona già nel suono, figuriamoci nel significato. Sono in cucina che traducono le frasi di latino. La scena è più o meno questa: figlia sdraiuzzata sul tavolo con quadernone ad anelli semischiacciato da avambraccio sinistro, biro semimasticata in bocca, occhi semichiusi (l’apparenza è che stia dormendo sulle frasi di latino). Sopra di lei, dominante ma impotente, madre imperiosa accovacciata sulla spalla a mo’ di corvo e sbraitante frasi non in latino del tipo: lo vogliamo vedere ’sto avverbio, lo vogliamo trovare ’sto soggetto, possibile che te li debba fare io ’sti compiti, quante volte te lo devo dire che il qui non vuole l’accento, ma il verbo essere non l’abbiamo ripassato ieri per due ore, possibile che non te lo ricordi già più? E meno male che oggi le altre due figlie sono a ginnastica, mi dice la mia amica. Mi offre un tè coi biscotti. Ho una domanda: perché le mamme al pomeriggio in casa fanno fare i compiti ai figli? Perché, avendo per esempio tre figli e cominciando dalle elementari del primo fino alle superiori del terzo, passano mediamente dai quindici ai vent’anni occupate in questa mirabile-discutibile impresa (forse dannosa per i figli, sicuramente per loro stesse)? 5. Orfeo alleva le bestie feroci Torniamo in classe, ma in un’altra classe. Riproviamo in seconda, con la poesia. Magari sono più grandi, magari la poesia lirica piace di più, mi dico. Abbiamo fatto Petrarca. Per un mese, anche qui, ho spiegato. Ho detto cos’è la poesia lirica, quando nasce, dove, di che cosa parla. Ho raccontato il mito di Orfeo: Orfeo che perde la sua amata Euridice, si dispera e poi la canta per tutta la vita. Ho letto con loro qualche poesia del Canzoniere, analizzandola parola per parola. E adesso li interrogo. Ne interrogo quattro, come al solito. Trovo che quattro allievi mi occupano bene la cattedra, me la accerchiano, e io mi sento meno sola. Chiedo più o meno quello che ho spiegato e quello che c’è sul libro. Cos’è la poesia lirica, quando nasce, dove, di che cosa parla. Mi dicono che parla delle donne amate, ad esempio Laura e Beatrice, che però poi muoiono. Chiedo perché abbiamo parlato di Orfeo, cosa c’entra con Petrarca. Silenzio. Nessuno dei quattro apre bocca. Lo chiedo alla classe. Silenzio. Scorgo sul fondo una mano alzata. È di Demonte. È sempre di Demonte la mano alzata, qualsiasi cosa chieda. Perché Demonte è il primo della classe. Non è un genio, non è nemmeno particolarmente bravo, è un ragazzo assolutamente normale. Direi medio. Ma ha una caratteristica che lo rende unico: studia. Lo ripeto: STUDIA! Credo che vada a casa e, dopo pranzo, si metta seduto alla scrivania e apra i libri, li studi e faccia anche i compiti. Una cosa da pazzi, che lo rende, appunto, unico. Per questo alza sempre la mano: perché, avendo studiato, sa rispondere. Lo ignoro. Cos’altro dovrei fare? Siccome so che studia e che quindi sa rispondere, non lo prendo in considerazione. È scontato, non fa testo. Poi scorgo un altro che alza la mano, uno della massa che non studia. Miracolo! Lo faccio parlare. Mi racconta il mito di Orfeo. Dice più o meno così: C’è questo Orfeo, bo’, che di mestiere mi pare fa il pastore, bo’, uno che alleva le bestie feroci. Ama una donna che mi pare si chiama Erice, Edice...? Praticamente c’è anche un altro che è innamorato di lei, e lei poi si punge, adesso non mi ricordo... mi pare con le api, e muore. Allora Orfeo va a riprendersela all’inferno, perché è anche uno che sa cantare molto bene, però dopo lei si volta... no, mi scusi prof, lui si volta e allora non la può più riprendere, perché c’è un dio... il dio... bo’, non mi viene il nome, gli aveva detto che se si voltava... lei... sì, insomma se ne andava, non doveva voltarsi, e allora è disperato. Adesso non so voi che cosa ne pensate. Io faccio finta di niente. Non correggo. Non commento. Non voglio interrompere. Lasciamo perdere. Alla fine mi permetto solo di ricordargli che la domanda era: Cosa c’entra Orfeo con Petrarca, perché ne abbiamo parlato? Silenzio. Lo chiedo alla classe. Silenzio. La vedete? Solo la mano alzata, anchilosata, di Demonte. Va bene, arrendiamoci, facciamo parlare Demonte. Che ripete quel che ho detto a lezione: parla di assenza, lontananza, amore da lontano, il canto che risarcisce, colma l’assenza, il valore della musica, la poesia è musica, canto, la poesia lirica viene da lyra, Orfeo canta Euridice come Petrarca canta Laura, entrambi hanno perso la donna amata ma resta loro la poesia... Usa anche il pronome personale plurale loro anziché il singolare gli. Lo bacerei. Andrei laggiù al suo banco, lo solleverei di peso e lo coprirei di baci. Adoro Demonte. Lo ringrazio, abbasso il capo. Mi chiedo perché solo lui, cos’ha di diverso. Uno su venticinque, quanto fa? Il quattro per cento. È un po’ poco. Ma meno male che esiste, almeno lui. Mica per niente, è solo che Demonte mi dà la prova della mia esistenza. Mi rassicura sul fatto che esisto, cioè sono veramente arrivata in classe un tal giorno a parlar di Petrarca, e ho detto veramente le cose che ho detto, non me le sono sognate: tant’è vero che oggi lui, Demonte, me le ha ripetute tali e quali. Per questo lo ringrazio, per una mia serenità interiore. E anche perché Petrarca oggi non è morto. È grazie ai pochi Demonte che Petrarca continua, seppur blandamente, a sopravvivere. Certo, detto tra noi, si sta spegnendo: ha un colorito sempre più pallido, direi un beige cadavere tendente al diafano. Ancora un po’ e si estinguerà del tutto. Do 4 ai quattro interrogati. E 8 a Demonte. Ma sono profondamente triste, direi disperata. Vorrei una classe tutta di Demonti? Sì. So che suona spaventoso quel che dico, ma è la verità e non me ne vergogno: vorrei una classe completamente piena di Demonti, tanti piccoli Demontini tutti uguali in fila per due. E sapete perché? Perché sarebbe solo normale che chi viene a scuola, al pomeriggio aprisse i libri e studiasse. E sarebbe solo normale che un insegnante desiderasse allievi che studiano, visto che lui di mestiere insegna! Normale! Ce lo siamo scordato cos’è normale a questo mondo? Sarebbe come dire che un panettiere, visto che di mestiere fa il pane, ama molto la gente che mangia il pane e quindi lo compra da lui che lo fa! Semplice, no? Non sto chiedendo la luna. Né la luce abbagliante del genio. Io non sto dicendo che voglio in classe dei geni, io voglio ragazzi normali che normalmente, visto che vengono a scuola, aprano i libri e studino. È un desiderio vergognoso? È troppo? Poi possono farcela più o meno bene, questa è una differenza che sono perfettamente in grado di tollerare: c’è chi arriverà solo al 6 e chi prenderà 7080 anche 9. Ma la norma, la soglia al di sotto della quale nulla è tollerabile, dovrebbe essere che tutti aprano i libri e facciano questa cosa pazzesca e inverosimile di mettersi a studiare. E invece no. A mia percezione, circa il sessanta per cento dei ragazzi non lo fa: non apre un libro, non studia. O studia troppo poco. E, siccome della realtà così com’è bisogna pur tener conto, mi chiedo perché. Tutti oggi dovremmo chiedercelo. Forse i ragazzi non studiano perché non sanno di dover studiare. Mi viene il dubbio che non lo sappiano perché noi non gliel’abbiamo detto. Forse ci siamo dimenticati di dirglielo. In otto anni che sono stati a scuola prima di arrivare al liceo (cinque di elementari e tre di medie) ci siamo scordati e non gli abbiamo detto che, andando a scuola, dovevano anche studiare, e che era abbastanza necessario che lo facessero. Siamo stati distratti. O forse abbiamo pensato che era scontato e non ci piaceva dire cose così scontate. O forse abbiamo semplicemente lasciato perdere. O forse non lo pensiamo veramente che, andando a scuola, si debba studiare. Ecco perché non l’abbiamo detto: è difficile dire quel che pensiamo, figuriamoci dire quel che non pensiamo! Comunque, nessuno dei quattro ha aperto bocca. Impreparati. Li mando a posto con 4. 6. Piccola digressione sulla vergogna A volte penso a come tornano a casa i miei allievi che hanno preso 4. Quando lo diranno, e a chi. A madri indaffarate in carriera o dimesse e sconsolate, donne separate e sole che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, o signore con SUV, prestigioso marito, baby-sitter e palestra. Chissà. Lo diranno durante la cena parlando del più e del meno, o a colazione sorbendo un Nespresso, o guardando la tivù tra uno spot e l’altro. Oppure non lo diranno, confidando in madri che non guardano il diario e non vanno al colloquio con gli insegnanti. Ultimamente ho conosciuto una ragazza rumena che si chiama Madalina. Ha ventitré anni, è in Italia da un anno insieme a suo marito e al loro bambino di quattro anni. Parla già piuttosto bene. È venuta qui per lavorare. Ha un diploma di liceo e vorrebbe fare la maestra d’asilo perché adora i bambini. Non so come, parliamo di scuola. Mi dice che da noi è tutto facile e si studia poco. In Romania invece la scuola è dura e si fatica molto. Non so se sia vero, forse no. Ma il punto è che mi racconta: Io mi vergognavo a non sapere, io andavo a scuola e l’insegnante m’interrogava e se io non sapevo, io provavo vergogna. Ripete più volte questa parola: vergogna. E io penso che da noi non c’è più questa parola, è sparita dalla nostra vita. Una volta ci vergognavamo di aver preso 4. Adesso no. Nessuno si vergogna di farsi trovare impreparato, di dire che non ha studiato, di fare scena muta a un’interrogazione o di balbettare quattro frasi in croce sconclusionate. Ieri ho interrogato un ragazzo di seconda. È venuto alla cattedra con la sedia e il libro, gli ho chiesto di parlarmi un po’ di Pascoli, ha aperto alla pagina Pascoli vita e opere e ha cominciato questa difficoltosa attività, in cui ultimamente gli studenti del nuovo millennio eccellono, di parlar-leggendo-sullibro. Con nonchalance. Come se l’insegnante non fosse a un palmo da loro, gli occhi sul libro anche lui. Come nulla fosse. Un ginocchio appoggiato al bordo della cattedra, parlanosbirciano, fluttuano parole dal libro all’occhio a me, e poi da me al libro, alloro occhio abile a scivolare sulle onde. Sembrano far sci d’acqua, tanto vanno leggeri. Distesi. Bien à l’aise. Quand’è così, li lascio fare. Mi piace guardarli. Sto buona e zitta, e li guardo. Anche cinque minuti, o dieci. Alla fine, hanno letto davanti a me anche due pagine di libro, il ginocchio appoggiato alla cattedra. Ci vuol sapienza, abilità. Forse sono queste le cosiddette «nuove abilità». È lì che mi viene la parola vergogna. I nostri studenti non si vergognano. Non li sfiora mai la vergogna, per quel che stanno facendo, per come si comportano, così, davanti a tutti i loro compagni, davanti a me, che sarei, in fondo, la loro insegnante. A loro non importa che qualcuno li giudichi. Non importa del giudizio altrui, è come se sapessero che è inessenziale, non incide, non sposta un bel nulla. Forse pensano che il giudizio altrui, in fondo, sono solo parole. È vero, sono solo parole. Piovono addosso come la spuma del mare, un colpo di vento e tutti sono di nuovo asciutti. E possono solcare sereni le acque del mondo che appartiene loro. Sanno che mai andranno a fondo. Telegiornale di inizio gennaio: intervistano per strada dei ragazzi; le vacanze di Natale stanno per finire, il giornalista chiede se hanno fatto i compiti. Tutti rispondono di no: non ancora, li farò stasera, domani, dirò che non ce l’ho fatta. Sorridono, felici. A loro agio, serenamente inadempienti. Si vede che non hanno il minimo cruccio. Anche qui, non un’ombra di vergogna. I compiti si possono impunemente non fare, ma soprattutto lo si può tranquillamente dire, e anche alla tivù di fronte a milioni di telespettatori. Ma la cosa pazzesca è che accanto a loro, intervistatori, genitori e passanti sorridono, indulgenti e divertiti: anche a noi adulti va bene così, che i ragazzi evitino i compiti delle vacanze, ci piace molto questa loro aria furbesca e sfrontata, forse è per noi l’immagine stessa della giovinezza, e la contempliamo con tenerezza. E così diventiamo complici. Perché mai dovrebbero fare i compiti questi ragazzi, se persino noi adulti pensiamo che facciano benissimo a non farli? Ancora una cosa, sullo studio. L’altro giorno, nella mia ora ricevimento parenti, ricevo la mamma di un mio allievo che non studia. Ha 4 in italiano. L’anno scorso è andata così: fino a marzo non ha fatto niente, poi in casa hanno cominciato a vietargli la tivù, il computer e il motorino; la madre s’è messa ogni giorno seduta a studiare insieme a lui, e alla fine è arrivato al 6. Promosso. Quest’anno fa lo stesso: ora è inverno e lui non apre libro. In primavera si darà una mossa e, sospinto quotidianamente dal forcone materno, prenderà qualche 6 che, facendo media con i precedenti 2, farà 4 e finirà per salvarlo: sospensione a giugno, promozione a settembre. Non studia, dice la madre, non ha voglia. Lo so, rispondo, mi è evidente. Ma perché? Lo chiede la madre a me, lo chiedo io alla madre. Nessuna delle due sa rispondere all’altra. Eppure è questo il problema della scuola oggi. Inutile pensare a riforme strabilianti, investimenti generosi che ricoprano di denaro le scuole. Il denaro non è il punto, purtroppo. Inutile anche pensare a rivoluzioni copernicane dei saperi e dei metodi d’insegnamento, a miracolosi corsi di formazione per insegnanti, a futuri maestri Superman, eroi di Supermotivazione, novelli Orfei capaci di motivare allo studio anche le pietre e le bestie feroci e le foglie degli alberi che si muovono al vento. Il vero problema è che i nostri giovani, almeno quelli che vanno al liceo, non hanno nessuna voglia di studiare. 7. Pomeriggio medio-neutro Credo che il punto cruciale sia che cosa fanno i ragazzi al pomeriggio. Come passano il tempo dopo la scuola, com’è la loro vita. E qui non posso che provare a immaginare, visto che non sono insieme a loro al pomeriggio. Vi chiedo quindi, adesso, di condividere una visione: facciamo il gioco di disegnare nella nostra mente uno di loro, lo studente quindicenne medio. Il tipo base, insomma. Decidiamo che si chiama Cardo di cognome e Edoardo di nome, ma lo chiamano Dedo. Dedo Cardo fa la seconda liceo, diciamo scientifico. È alto il giusto, magretto ma ben messo, un bel viso pulito con un fil di barba ancora sparsamente rada, qualche accenno di brufolo discreto, non invasivo, capelli neretti ricciolini un po’ sugli occhi, jeansini striminzi e bassetti comm’il faut, scarpe grosse un po’ bombées, felpina neutra sul blu stinto con la zip. In classe è simpatichino, sorridente-scherzosetto. Fa lo stupido quel che basta e comincia anche, poco per volta, a dire quattro battute alle ragazze. Un po’ segue le lezioni, un po’ scarabocchia il diario, un po’ chiede di andare in bagno, un po’ chiacchiera col compagno. Nell’intervallo si strafoga di pizza, armeggia col telefonino e fa un giro in cortile sfumacchiandosi una sigaretta. Ma in generale non disturba troppo. Uno sul 9 in condotta, a volte 8 quando proprio esagera. Mediamente sul 5 nelle altre materie il primo quadrimestre, con qualche punta di 4. E poi sul 6 stiracchiato verso fine anno. Quindi promosso, in genere con uno o due debiti a settembre. Uno giusto, insomma, che si sa muovere nel mondo, che strizza l’occhio furbetto alla vita e non avrà mai grossi problemi. Inserito, estroverso, socializzato. Un classico «studente medio-neutro» di oggi. Più o meno il settanta per cento dei ragazzi di seconda liceo scientifico (i restanti, per curiosità, io li suddividerei così: un venti per cento di gente che non fa un tubo e un dieci per cento tra bravi e bravissimi). Che cosa fa Dedo Cardo nel pomeriggio? Come passa la giornata da quando esce da scuola fino a sera? Proviamo a immaginare. Venite con me, accompagniamolo mentalmente a casa, vediamo un po’: il «pomeriggio medio-neutro» dello «studente medio-neutro». Arriva, la casa è vuota. Oppure c’è la colf o la vecchia nonna che gli dice: ti ho fatto la pasta al sugo, o una mamma trafelata che è uscita dal lavoro apposta per vederlo e chiedergli com’è andata a scuola, ma ha solo mezzora perché poi deve tornare in ufficio e la sera recuperare la mezzora, quindi arriverà tardi, giusto per fare la cena, quindi se parla adesso con suo figlio tanto di guadagnato, perché poi chissà. Dedo Cardo entra, posa le chiavi, sbatte lo zaino, bofonchia un ciao, e risponde: Tutto bene. Cos’avete fatto oggi? insiste la madre, per quella vecchia faccenda del dialogo coi figli. Niente, risponde il figlio. Poi mangia, si sdraia, guarda un po’ di tivù. Poi va di là, in camera sua, si ri-sdraia, si ficca nelle orecchie l’iPod. Poi si alza, va alla scrivania, si siede, guarda lo schermo. È lo schermo del computer, e il computer abita fisso sulla scrivania e vive sempre acceso. Apre Facebook, guarda se qualcuno gli scrive, sì, qualcuno gli scrive, legge, risponde, aspetta la risposta, ri-risponde, ri-aspetta la ri-risposta. Tira fuori i libri dallo zaino, ne prende uno, lo apre, studia un po’. Poi gli citofona un amico. Scende. Fai un giro? Prende il motorino, fa un giro. Torna. Si rimette a studiare. Si ri-sdraia, ri-sente musica. Ri-chatta. Ri-apre Internet, cerca una cosa che la prof gli ha detto di cercare, la trova, la stampa. Sta per mettersi a leggerla, ma gli appare il messaggio di Chiara. Lo legge. Risponde. Aspetta. Ri-scrive. Ri-aspetta. Ri-niente: Chiara non gli scrive più. Si sdraia, sente musica. È arrabbiato. Per fortuna sono già le cinque, che culo, deve andare in palestra, a ripetizione di mate, a lezione di aikido, fa lo stesso... Esce. Prende il motorino, fa un giro in centro, un panino, benzina, sms, mms, chat, snack, Shrek, crash... Mi fermo? D’accordo, mi fermo. No, ancora questo: dopo cena il nostro Dedo esce di nuovo, studia un po’ ma poi deve distrarsi, distendersi, rilassarsi, è stanco, è stata una giornata dura, vedere gli amici gli farà bene. Va in piazza, beve una birra, due chiacchiere, torna. Niente di che. Poi studia un po’ prima di addormentarsi. Studia... guarda il libro. Ma ha sonno. Al mattino si mette la sveglia mezzora prima perché si è accorto che non ha «guardato» algebra. Guarda algebra, di fare anche gli esercizi non ha tempo, dirà che ha dimenticato il quaderno, tanto quella si beve tutto... «Quella» sono io: l’insegnante. La scuola non sta più nelle nostre vite, questo è il fatto. Ma allora io cosa ci sto a fare? Siamo andati tutti da un’altra parte, smettiamo di contarcela. Smettiamo di fingere che non sia così. Siamo onesti. Quella «quella» siamo tutti noi insegnanti, che non ci beviamo mai niente, però facciamo «come se» ce la bevessimo, e va bene così. Il patto può continuare, questo patto malefico e diabolico con i nostri studenti, che più o meno suona in tal modo: io faccio finta di insegnare e tu fai finta di studiare, io non dico niente a te e tu non dici niente a me, così io non perdo il posto e tu non perdi l’anno. Più o meno questo. Torniamo al ragazzo Dedo Cardo. La mattina la madre gli mette la scodella di cornflakes e il latte in tavola, lui fa colazione, esce, prende il motorino. Davanti alla scuola si vede con gli amici. Parlano, scherzano, fumano. Fanno mucchio in cortile, diventano quell’Orda che alle otto meno cinque non mi lascia neanche passare, zaini, piercing, peluscini appesi, l’arca di Noè, tutte quelle cose che abbiamo già detto. Poi il nostro ragazzo entra. Prima ora, dorme sul banco. Alle dieci meno un quarto appuntamento con Chiara in bagno, fanno pace, si baciano un po’. Terza ora ascolta musica, piano, manda qualche sms, legge «Gente Motori», tutto di nascosto, poi la prof lo chiama per interrogarlo, lui dice che ieri proprio non ce l’ha fatta. La prof lo chiama lo stesso, allora lui si trascina alla cattedra, i piedi trascinano la stoffa dei jeans, le mani a pugno trascinano le tasche in giù; balbetta quattro cose, fa gli occhioni, sbaglia il secolo di Omero, non si ricorda niente di Paride, fa lo stesso, prende 4, tanto poi recupera, chiede di andare in bagno, Chiara non c’è, incontra un amico, dopo vanno insieme al centro commerciale, lui si compra le scarpe coi lacci uno viola uno verde, l’altro un dvd, poi vanno da Frank a vedere se gli vende un sellino usato, la sera c’è una festa, si trovano dopo cena, solito posto... Intanto, tra una cosa e l’altra, c’è stata la scuola: due ore di mate, una di filo, italiano, latino. I prof hanno parlato, fatto lezione, riempito lavagne, sbraitato, chiesto se avevano capito, rispiegato, recuperato, interrogato, assegnato compiti e lezioni, urlato, perdonato, rimproverato. Cinque ore di parole. Dante, le equazioni di secondo grado, la termodinamica, Robinson Crusoe che incontra Venerdì, i poeti siciliani, l’io narrante, il mito della caverna, i presocratici, la consecutio... Ma cosa ci sta a fare la consecutio con la chat, le canne e i motorini? Già, le canne... In questa mia ricostruzione della vita pomeridiana di Dedo non ho toccato l’argomento. Non sono in grado di dirvi se Dedo si fa e a che livello. Ma i dati ci dicono che una forte percentuale di giovani in età liceale, tra il trenta e il cinquanta per cento, viene variamente a contatto con il mondo della droga, dallo spinello classico, alle colle, pasticche, su su fino a eroina e coca. Certo, se immettiamo anche questo nella giornata del mio studente, la storia prende un risvolto ancora più inquietante: come posso pensare di far scuola, e di incidere minimamente nella testa di un ragazzo, se la sua testa, oltre a essere mediamente programmata su altre dimensioni, è pure impasticcata? Insomma, droga o non droga, la scuola non sta più in questo mondo, nelle nostre vite, nella nostra giornata. È di troppo. Non trova spazio, è fuori posto. Fa ingombro, disturba. Distrae... Sì, la scuola distrae i nostri ragazzi. Li distoglie dalle loro abituali e più care occupazioni. I giovani sono occupati in altro. Non sono affatto dis-occupati, o non-pensanti o nonfacenti. Pensano, certo che pensano, ma ad altro; hanno altre cose da fare, altri pensieri, altri interessi. Altri divertimenti. La scuola ci prova a essere divertente, ma poi c’è sempre quel guaio che deve insegnare qualcosa, e chiedere indietro, e allora la scuola rompe quando spiega, quando interroga, quando fa compito in classe. Interrompe. Disturba. Ecco, disturba. Questo è il verbo. Disturbare. Toglie la concentrazione. I ragazzi sarebbero concentratissimi sulle loro occupazioni, giochi, amicizie, svaghi. A loro la vita piacerebbe un sacco, se non fosse che la scuola... Io ho ogni giorno nettissima la sensazione di disturbare. Quando entro in classe e chiedo silenzio e faccio l’appello, quando comincio a spiegare, quando interrogo, quando do i voti, quando faccio domande, quando correggo i compiti. Ecco, soprattutto quando correggo. Li chiamo uno per uno per spiegar loro cos’hanno sbagliato e perché hanno preso 3; riempio lavagne su lavagne per chiarire i loro errori, fare esempi, ribadire regole. E li trovo inerti, indifferenti, annoiati. La mia collega P. dice: Sono come gechi incollati al muro. Ascoltano e non ascoltano, poi tornano a posto e invece di riguardare il compito, riflettere sui segnacci rossi e capire perché e dove hanno sbagliato e mettersi a rifare le cose questa volta giuste, invece di fare tutto ciò che a me sembrerebbe normale, loro mettono il compito sotto il banco e si girano a parlare col vicino, o disegnano sul diario o ridacchiano in gruppo. Non sono cattivi, o beceri o indifferenti. Magari sono anche abbastanza interessati alle lezioni, ai libri. Ma non c’è posto, hanno semplicemente altro da fare, molto altro da fare. E allora io penso che non c’è niente da dire, è andata così, perché vedete, il fatto è questo: la correzione dei compiti è necessaria, noi insegnanti non possiamo proprio non farla, ma è anche una cosa oggettivamente noiosa, una mezzoretta in cui, anche a chiamare i migliori saltimbanchi o un premio Nobel per la letteratura, non c’è scampo: ci si annoia, e nessuno oggi è più in grado di accettare un lavoro che non sia ultradivertente, solo per la ragione che si deve fare. L’idea del dover fare una cosa solo perché va fatta è saltata, non c’è più. Ma allora cosa sto a fare io lì davanti a loro a correggere compiti di cui non gliene importa niente perché la VITA è UN’ALTRA, la LORO vita è un’altra, è un fiume immenso e meraviglioso che scorre da tutta un’altra parte, e nessuno di questi giovani è veramente lì, in classe, e io che mi affanno a correggere i loro compiti, non sarebbe meglio che me ne andassi anch’io? Siamo un Paese troppo progredito per avere ancora una scuola. Se ancora ci crediamo, aiutiamo semmai gli altri a costruirne di nuove, aiutiamo i Paesi in via di sviluppo che, proprio perché vogliono svilupparsi, sentono il bisogno di scuola e credono che imparare serva. Ma noi lasciamo perdere. Siamo già sviluppati. Abbiamo già dato. E abbiamo avuto delle ottime scuole, con grandi idee che le supportavano. L’ultima forse è stata quella di don Milani, che funzionava proprio sulla nostra povertà, sull’esistenza dei ceti bassi, contadini, nonché sul nostro analfabetismo. Eh, bei tempi quando la gente abitava ancora le campagne... si poteva pensare di istruire le persone, di farle progredire. Ma adesso, che senso potrebbe ancora avere l’istruzione? A cosa potrebbe mai servirci oggi che stiamo così bene, a parte questa piccola e passeggera crisi economica che sta turbando l’Occidente ma che sicuramente, come dicono, sta già passando e tra poco sarà bell’e dimenticata? Ci mancherebbe... Siamo tra i paesi più potenti del mondo, sediamo al G8, al G15, al G20, a tutti i G dell’universo. Che altro possiamo mai volere di più? La scuola è fatta per gente che non ha niente, o ha molto poco. Non per gente che ha la casa, la seconda casa al mare e magari anche la terza in montagna, l’auto, la moto, la barca in porto, due cellulari, due tivù, due computer, le vacanze esotiche, la colf... È fatta per gente che, appunto perché non ha niente, ha voglia di imparare e crede, per di più, che imparando potrà migliorare la propria vita, la propria condizione sociale ed economica, e persino esistenziale. Gente che pensa che studiando potrà essere addirittura migliore, e più felice. Per gente così è fatta la scuola. Non per i nostri figli, che hanno tutto, e che sono pieni di impegni. Pieni di impegni... A loro la scuola toglie tempo, prende energie, non serve a niente, e soprattutto: disturba. Vorrai mica tornare indietro, a uno stato di povertà e magari anche alle guerre?, sento già la vocina del politically correct di turno che si insinua. Neanche per sogno, siamo felici del benessere raggiunto e mai vorremmo perderlo. Dico soltanto che la scuola non ha più ragion d’essere. E quindi dovremmo smettere di fingere di farla. Tutto qui. 8. Lezioni private Dimenticavo le lezioni private. Sembra che tutti vadano a lezione privata, il pomeriggio. Oggi va così. No, non tutti, esagero. Direi la metà degli studenti liceali, forse anche meno, è che sembrano tantissimi, un vero esercito. Va anche un po’ di moda, secondo me. È molto in andare a lezione, fa chic. Credo sia diventato un simbolo di status. Fa molto famiglia bene: «bene» sia in senso economico che etico. È un po’ come dire: noi genitori ci occupiamo dei figli, non li abbandoniamo certo!, anche se, ovviamente, per ragioni di lavoro, torniamo tutti e due a casa alle otto di sera; ci importa molto della loro istruzione perché siamo gente colta, leggiamo libri e giornali, svolgiamo professioni importanti e quindi pensiamo che nostro figlio debba avere una preparazione culturale adeguata, e se la scuola (pubblica o privata) non ce la fa, non importa, ci pensiamo noi, se Dio vuole i mezzi non ci mancano. Da un punto di vista più squisitamente narrativo, va così, modello «Giovin Signore» del Duemila: il ragazzino quindicenne torna a casa, si sfila il maglioncino di cachemire, si siede a tavola dove la Michela di turno, con grembiule o senza, gli serve la pasta e la bistecca. Poi si apre la voragine pomeridiana di sms, cellu, compu, iPod e iPhone, in mezzo alla quale voragine si apre anche qualche libro e si fa anche qualche compito, perché no? Poi, alle cinque, lezione di inglese. O matematica, o latino, o greco. O tutto insieme: sono nati infatti, negli ultimi anni, dei meravigliosi luoghi specializzati in lezioni private di ogni tipo. Dei veri Multicenter o Ipermercati della Lezione Privata o banalmente Centri di Recupero, dove il ragazzino può arrivare in motorino o in macchinetta (a seconda dell’età e del censo) nel primo pomeriggio e fermarsi fino a sera: verrà restituito con i compiti fatti e le lezioni imparate, pronto per la cena durante la quale i genitori gentili e compiacenti gli chiederanno se ha fatto tutto, se si sente pronto per il compito in classe, se preferisce la pasta al pesto o alla carbonara... C’è anche la versione meno chic, perché il fenomeno della Lezione Privata Permanente attraversa anche tutto il ceto medio, non solo quello medio-alto. La variante è solo che magari ci va in autobus, il maglioncino è in semplice lambswool o felpa, di pastasciutta ce n’è una sola e se la scalda da solo, ma per il resto è uguale. Il principio comune e condiviso dalle famiglie è che il ragazzino in difficoltà si aiuta, sempre!, anche sobbarcandosi costi economici non indifferenti: l’importante è che continui ad andare al liceo, che non faccia fare alla famiglia la figuraccia tremenda di mollare e magari andare a un tecnico-professionale, pensa, coi vicini che hanno il figlio che va al classico e il quarto anno va pure in Australia perché così fa un’esperienza di studio diversa e consolida l’inglese. Si è creata una sorta di Ambizione Scolastica Famigliare (ASF o ASF-ASF a seconda dell’intensità di detto sentimento) smodata e del tutto nominale, non sostanziale: non importa niente a nessuno che cosa realmente la scuola di oggi insegni né che cosa realmente il figlio impari, ma contemporaneamente diventa importantissimo che scuola il figlio frequenta, che liceo, dove, quante e quali strade gli vengano aperte poi. Per l’estero, naturalmente, perché l’Italia è data per persa e quindi non sia mai che mio figlio studi qui, magari dietro l’angolo di casa, ignominia! Il bello è che si tratta di ambizioni che riguardano appunto la famiglia, e non il ragazzo: sono ambizioni famigliari allargate, non è l’ambizione giusta e naturale del giovane che cresce e desidera il meglio per sé; no, è la famiglia che desidera il meglio per se stessa, nell’ambito della sua cerchia sociale e «usa» la realizzazione scolastica del figlio per posizionarsi al meglio sulla scala sociale. Così, la sindrome ASF finisce con l’ammorbare di miasmi insopportabili l’aria di casa, e in particolare arriva ad ASFissiare i figli, vere vittime ignare, togliendo loro la libertà. E così, c’è mezza Italia (dei licei, naturalmente, sto parlando solo dell’Italia dei licei) che al pomeriggio se ne va allegramente a studiare, o meglio a «essere fatto studiare», se potesse esistere una sorta di passivo del verbo studiare, non so, una forma verbale in cui sia chiaro che non sono io che studio, ma vengo fatto studiare da altri, da qualcuno che gentilmente (a pagamento) mi inserisce un piccolo imbuto in gola o nell’orecchio, fa lo stesso, e di lì fa scivolare con delicatezza tutte quelle cosucce che io mi sono ben guardato dall’ingerire al mattino a scuola o dall’apprendere molto banalmente dai miei libri di testo al pomeriggio e che peraltro anche adesso, nonostante il gentile e «carissimo» imbuto, mi guarderò bene dall’assorbire. Mezza Italia che al pomeriggio, dopo la scuola, se ne va altrove a fare quello che non ha fatto a scuola e non farebbe mai a casa da solo, in questi nonluoghi (non-scuole) zeppi di gente (e di soldi) dove finalmente si supplisce alle mancanze della scuola italiana e della famiglia (non certo alle mancanze del figlio, non sia mai!), e che costituiscono quindi una sorta di Scuola Sommersa: il sommerso degli studi, una second life scolastica di cui tutti sanno ma di cui nessuno dice. Altro che Giovanni Gentile e la scuola d’élite! Lui, è vero, aveva pensato i licei come scuola per formare le élite, d’accordo. Ma mai avrebbe pensato che l’«élite di massa» avrebbe eletto i licei come unica forma possibile e auspicabile di studio per i propri figli! Mai si sarebbe sognato un’idea del genere che sembra albergare, a mo’ di striscioni da corteo, nella mente di tali genitori: Il liceo a ogni costo! O liceo o morte! Tutti per il liceo, il liceo per tutti! Avrei solo due cose da aggiungere, peraltro ovvie, e implicite in quel che ho già detto. La prima pertiene all’ambito educativo, ed è la seguente: l’abitudine, l’automatismo con cui mandiamo a lezione privata i nostri figli ha ormai definitivamente prodotto, in codesti figli, l’assoluta certezza che studiare non tocca a loro, che c’è sempre qualcuno che penserà a toglierli dai guai, e che in fondo basta avere denaro e si ottiene tutto. La seconda cosa invece mi sta ancora più a cuore, e riguarda l’ipocrisia sociale, se si può dir così, in cui viviamo immersi: ma come?, noi genitori constatiamo che nostro figlio non ce la fa, prende ogni giorno un’insufficienza, non capisce quel che sta scritto sui libri, non è in grado di studiare o semplicemente non ne ha la minima voglia, e cosa facciamo? Invece di prenderne atto e iscriverlo a un’altra scuola o trovargli altro da fare, ci incaponiamo fino all’estremo e, a suon di bigliettoni, lo supportiamo per cinque anni filati. Sì, perché non si tratta di un fenomeno temporalmente circoscritto: ormai si va a lezione privata per tutta la durata del liceo, non solo all’inizio, magari il primo quadrimestre del primo anno che come si sa può anche essere traumatico, visto che si viene dai tre anni di medie in cui non si è fatto niente. No, si va alla Scuola Sommersa Pomeridiana per cinque anni di seguito e ininterrottamente! Intensificando d’estate, perché d’estate c’è la «sospensione». Ovvero il pargolo viene ricoperto di debiti, ed esce a giugno come «sospeso». Il cosiddetto «giudizio sospeso» è l’ultima trovata lessicale per non dire rimandato. Uno dei nostri stupendi escamotage eufemistici, in cui siamo diventati abilissimi. Vuol dire che gli insegnanti sospendono il giudizio sull’allievo, vanno in stand-by per tre mesi e giudicheranno a settembre, con apposita verifichina finale. Intanto il ragazzino sospeso dovrebbe studiare tutta l’estate. La scuola gli fornisce all’uopo ben sei ore di corso di recupero estivo. Sei ore! Sei ore di recupero sono irrisorie, tutti i genitori sono in grado di capirlo. Tutti, tranne i genitori-struzzo che mettono la testa nella sabbia, esigono tale irrisorio corso di recupero e si raccontano che in tal modo il loro nonstudiante figlio recupererà, e se non recupererà sarà solo colpa nostra che non lo abbiamo fatto recuperare abbastanza. A parte gli struzzi, in genere le famiglie si attrezzano. Acchiappano il solito insegnante in pensione o volonteroso che, al mare o ai monti, in piena vacanza non fa vacanza e mette su una specie di scuoletta estiva del recupero selvaggio, beccandosi squadre di ragazzini sospesi che, dopo la giornata in spiaggia e prima della serata in discoteca, vanno lemme lemme (in motorino) a lezione privata da lui, tutti i pomeriggi, due ore al giorno o anche quattro, per tre mesi. Risultato? Promossi, non più sospesi. E così, di sospensione in sospensione, a colpi di lezioni private, si esce dal liceo e si va all’università. Dove da qualche anno sono nati i corsi di azzeramento per insegnare la lingua italiana (le solite ortografia e grammatica...) a ragazzi che non sanno parlare, leggere e scrivere. E che però hanno fatto il liceo. 9. Il problema di Torquato Tasso Andiamo in centro. Nel centro di una qualsiasi nostra città. Un qualsiasi sabato pomeriggio. Venite tutti con me, abbiamo un lavoro da fare, e di grandissimo impegno: dobbiamo osservare attentamente i nostri ragazzi. È importante. E dev’essere assolutamente e soltanto il sabato pomeriggio: non il sabato mattina o il giovedì pomeriggio per il fatto che solo il sabato pomeriggio la massa dei ragazzi esce a girellare per le vie del centro. Percorriamo dunque con loro in lungo e in largo la via principale della nostra città, dove ci sono i negozi più alla moda. Sono ragazzi dai tredici ai sedici anni, belli, brutti, ricchi, poveri. C’è di tutto, non solo liceali, anche studenti dei professionali, credo. A gruppetti, a grappoli, a groviglio. Guardiamo attentamente come sono vestiti, come camminano, come gesticolano e parlano o non parlano tra di loro, dove si fermano, cosa fanno, come si attardano, stazionano, ciondolano. Sostiamo con l’occhio sui loro capelli nero-viola tinto, i giubbotti troppo stretti, i piercing al naso, le loro ragazze strizzate nei jeans stretch, caviglie inanellate, scarpine traballanti sul tacco. Guardiamo sfacciatamente, da antropologi senza pietà, come codesti giovani procedono in massa compatta, e tagliano l’aria come un esercito lento e assonnato; come le ragazze compongono linee orizzontali a braccetto l’una con l’altra, procedendo a far barriera, a lunghi passi, sicure, truccate, pantere. Come i ragazzi, uno dietro l’altro e di lato, confusi, s’ingrappolano cambiando di continuo posto, si sorpassano, strattonano, inciampano, sbracciano, scalciano. O sostano. Sostano l’intero pomeriggio. Davanti a negozi di elettronica, bar, mercati, outlet. Anche davanti a niente, sostano e basta. Rumorosamente stanno. Ridono, sgomitano, strattonano. Si appendono ai reciproci giubbotti e dondolano, ondeggiano. Sono una corrente umana, un’acqua densa che si sposta. Oppure penetrano, le mani a pugno in tasca, nei templi dell’abbigliamento low cost. Zara, H&M. Guardiamo cosa comprano, cosa toccano, cosa provano. Ascoltiamo come parlano, gridano, mugugnano. Fanno versi gutturali, mezze sillabe. Gracchiano, ululano, grugniscono, ruttano. Ogni tanto si spintonano, si insultano, si palpano. Fumando, bevendo birra, beveroni rossi o verdi. Bene, più o meno è quel che si vede il sabato pomeriggio in centro. Siamo spietati? Sì, siamo spietati. Stiamo esagerando? Forse sì, ci piace da pazzi esagerare (è probabile che per questo scriviamo libri, anziché fare fotografie...). Adesso vi chiederò di fare un esercizio. Provate mentalmente a spostare di luogo i suddetti ragazzi del sabato pomeriggio. Travasateli tutti in una normale classe di liceo e provate a sedervi alla cattedra e a far loro lezione. O, se non vi va, immaginate qualcuno che faccia loro lezione. Ad esempio su Torquato Tasso. Avete presente Torquato Tasso? Quello della Gerusalemme liberata: Tancredi, Clorinda, Erminia che ama Tancredi ma lui non la guarda e allora lei fugge tra i pastori. Ecco, Erminia tra i pastori, classico brano del Tasso sulle antologie. Bene, provate a leggerlo a quei ragazzi-branco che abbiamo visto in centro pieni di gel, orecchini, pance nude e tatuate che stazionano davanti ai negozi di computer, vestiti, musica tecno o scarpe Armani, fa lo stesso, e che poi la notte riempiono le piazze del centro, ugualmente fermi, in piedi, ciondolanti, ma con bottiglia da scolare in mano fino all’alba. Adesso che avete spostato di luogo questi ragazzi e li avete collocati in una classe davanti a voi e avete provato a legger loro e commentare Erminia tra i pastori, siete in grado di immaginare l’impatto violento tra le loro teste e i versi di Torquato Tasso? Ecco, se siete riusciti a compiere tale sforzo di immaginazione, adesso capirete bene in che guaio si trovi la scuola italiana (e, credo, occidentale). E adesso prevedo tutta la valanga delle vostre obiezioni: 1) i giovani non sono tutti così; 2) l’aspetto esteriore non conta, i vestiti meno che mai, ci mancherebbe che dovessimo insegnare la letteratura solo a chi è ben pettinato; 3) la scuola non è mai piaciuta a nessuno (nemmeno a sant’Agostino e a Daniel Pennac, per dirne due piuttosto noti...); 4) comunque il lavoro dell’insegnante è appunto di saper trasmettere la bellezza di quel che insegna, Tasso compreso, e se non ci riesce è solo colpa sua, quindi che cambi mestiere; 5) Tasso poi! Se la scuola propina ancora Tasso, è chiaro che i ragazzi di oggi non hanno voglia di farlo... Più o meno questo. Proviamo a rispondere. Lo so che ci sono dei giovani meravigliosi che studiano molto, sono eleganti e sobri, vanno a teatro e fanno volontariato. Ma sono una minoranza così esigua che non me ne occupo, sono felice che esistano, e auguro loro tutto il bene del mondo, e ripongo anche non poche speranze in loro, credo che possano fare un gran bene al futuro che ci attende. Sono gli altri che mi preoccupano: la cosiddetta massa. E mi preoccupa soprattutto il nostro atteggiamento verso tutti questi altri, come li consideriamo e giudichiamo o non giudichiamo, e cosa pensiamo di fare visto che sono loro la massa, e noi stiamo parlando proprio della scuola di massa. O sbaglio? Vogliamo occuparci seriamente di questa benedetta massa, o insistiamo a farla esistere come mera parola, e in quanto tale continuiamo a dire che ci piace da morire e pensiamo solo a lei e al modo migliore per educarla, motivarla, «farla crescere»? La massa non è una parola, e tantomeno una parola politica da addobbare di palline ideologiche come un alberello di Natale. Ha una sua consistenza fisica enorme, è un oggetto gigantesco, ingombrante e incombente e molto complesso, che occupa in misura considerevole il mondo (in particolare il centro delle nostre città, il sabato pomeriggio). Vogliamo occuparcene davvero? In quanto all’aspetto fisico e al vestiario, provate a dirlo a Manzoni che non contano, a lui che a ogni suo personaggio ha dedicato un ritratto fisico che già appieno ne ritraeva l’anima e la vita: ritratti psico-biografici, potremmo dire. Pensate a Lucia con quella specie di corona in testa a raggiera, o agli occhi di fra Cristoforo come cavalli imbizzarriti, o alla vestaglia unta e sdrucita di quel mezzo criminale del dottor Azzeccagarbugli, o al coltello della festa e al pennacchio colorato di Renzo il giorno delle nozze. Non so, siamo sempre lì: vogliamo davvero disgiungere il significante dal significato? La nostra «forma» (l’aspetto, l’atteggiamento, il vestiario) dichiara infinite cose di noi (della nostra sostanza, o «significato») e della società in cui viviamo (lo stesso è, in un tema, per ortografia e pensiero...). Il modo in cui ci vestiamo si porta appresso molte scelte decisive, che parlano inequivocabilmente di noi: quanto tempo decidiamo di dedicare alla scelta dell’abito, al trucco, alla forma fisica; quanti soldi decidiamo di spendere per i vestiti, i gioielli, la palestra; quali vestiti scegliamo, se di marca o no, se attillati o no, se classici o glamour; quanta parte del corpo desideriamo lasciare scoperta, che décolleté, che tacchi, che mèche. Vedete che non è indifferente? Che è un segnale culturale preciso? Dice cosa ci importa davvero nella vita, e quale immagine vogliamo dare di noi all’esterno. Pensate a questi nostri ragazzi, a quanta dose di conformismo c’è nel loro modo di vestirsi, così tutti uguali, così omologati come un prodotto marchiato Ue. Da un anno all’altro si mettono i jeans larghi o stretti, la felpa col cappuccio o senza, le scarpe basse o alte, di tela o pelle, colorate o bianche: dipende da come gira la moda. Come se passasse un vento fortissimo che li cambia da un istante all’altro, tutti insieme, e li dirige, li comanda. Parola d’ordine: essere fighi. La moda: un generale che li mette in riga, come tanti soldatini dell’esercito. E se ancora non siete convinti, leggetevi il «Discorso dei capelli» di Pasolini, il primo degli Scritti corsari. Uscì sul «Corriere della Sera» nel 1973, quando eravamo ancora nel pieno dell’onda sessantottina, e tocca il tema dei «capelloni», cioè dei ragazzi di allora che contestavano ed erano politicamente impegnati e portavano, tutti!, i capelli lunghi fin sulle spalle come segno del loro dissenso e della loro volontà di rovesciare i valori borghesi. Ebbene, Pasolini conclude il suo articolo così: «Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo, ma ormai (...) la loro libertà di portare i capelli come vogliono non è più difendibile, perché non è più libertà. È giunto il momento, piuttosto, di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché servile e volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano, e si liberino di questa loro ansia colpevole di attenersi all’ordine degradante dell’orda». Secondo me, anche adesso sarebbe il momento di dire ai giovani che il loro modo di portare le mutande (siano Armani o Intimissimi) venti centimetri fuori dai pantaloni è «orribile, servile e volgare». Invece, molti dei miei coetanei diranno: cosa ce ne importa di come si vestono i ragazzi, ovvio che seguono la moda, l’andazzo del momento, s’è sempre fatto, è successo anche a noi da giovani eccetera. Può darsi. Ma non così! Una volta l’atteggiamento modaiolo riguardava pochi, oggi la quasi totalità dei giovani. Inoltre, oggi c’è infinitamente più denaro, di cui i nostri figli possono agevolmente disporre. Ma, soprattutto, l’offerta dei prodotti si è dilatata a dismisura: per vendere sempre di più, la meravigliosa giostra del consumo di massa ha ideato infinite varianti di uno stesso prodotto, ed è in grado di offrire adesso centomila prodotti tutti uguali ma diversi, per un dettaglio, una minuzia, una variante: centomila modi per «personalizzare», parola magica!, quello che in realtà è tutto miseramente uguale, standard, piatto, omologato, triste, seriale e che sembrerà invece mirabilmente unico e darà a ognuno l’illusione di essere unico e inimitabile. È il trionfo dell’optional. Il mito di una libertà di scelta che si esercita sul nulla di un bottone, un gusto, una sfumatura di colore. Finte scelte, finte libertà. I giovani sono le vittime ideali di tutto ciò. Predisposti, per la loro tenera età, a caderci come pere. Tutti hanno i peluscini appesi allo zaino, ma ognuno ha i suoi, e ogni zaino è diverso. Esiste oggi una dialettica segreta, un gioco sottile tra il seguire pedestremente la moda e, all’opposto, il tentare disperatamente di differenziarsi da tutti gli altri, di affermare (soltanto, ahimè, tramite oggetti) la propria ineguagliabile singolarità. Come un’increspatura di vento sulla piatta superficie degli oceani. Di qui, una conseguenza importante, che c’entra con Torquato Tasso: se ognuno può scegliere la sua personale versione dello stesso jeans o calzino, occhiale, stivale, cellulare o motorino, allora il tempo dell’acquisto diventa il tempo della scelta infinita, e si dilata in modo incommensurabile. C’è bisogno sempre di più tempo, per la cura di sé. Per la cura del Sé! Le cose, gli oggetti, i marchi, i dettagli, tutti i minimi segnali utili a disegnare la figura di ciò che vogliamo apparire agli altri ci occupano la mente e ci tolgono il tempo. Non si tratta più solo di comprare la marca giusta ed entrare nel tempio giusto del vestiario giusto: si tratta di stazionare ore e ore a scegliere, per personalizzarsi la vita. Per avere un’illusione di unicità: lo zaino, la cover, la suoneria, i sedili, i cerchioni, il laccio della scarpa... La domanda allora è questa: come faccio io, insegnante, a chiedere la parafrasi del Tasso (o di Dante) a ragazzi che passano ore e ore negli outlet, a cercar di essere uguali agli altri eppur diversi? O un commento su Erminia tra i pastori, o l’analisi della Ginestra di Leopardi...? O l’equazione della parabola, il teorema di Pitagora, lo sviluppo del binomio, le formule di prostaferesi...? Non è perché indossare determinati vestiti renda impossibile la lettura e lo studio, non sto dicendo una tale idiozia. È che quei vestiti, o meglio quel modo e tempo di dedicarsi al pensiero dei vestiti, sono il segnale che la vita per loro va da un’altra parte, tutta diversa da dove invece tira chi vuole spiegar loro Tasso. È il segno che per loro è più importante affermare un’identità, e possibilmente anche un’appartenenza, che riconoscersi in un compito preciso, una funzione, un qualcosa da fare. L’importante è essere, non fare; e quindi dare il segnale di quel che si è, non di ciò che si fa: vestirsi, mostrarsi, non costruire, lavorare, studiare. Non si va a scuola per fare qualcosa, ma per essere qualcuno: e i vestiti sono uno dei possibili strumenti per esprimere il proprio essere, nonché il proprio appartenere. Il comportamento dei ragazzi oggi è identity directed, e non task directed: 1 si vuole marcare un’identità, non eseguire un compito. È questa la differenza rispetto al passato. È, se vogliamo, l’ormai trito discorso su infradito e bermuda. Perché alcuni di noi – insegnanti, presidi, genitori – dicono che non va bene a maggio andare a scuola in infradito e bermuda? Non perché siamo bacchettoni moralisti, non sono i centimetri di pelle scoperta in più o in meno a turbarci. È lo stridìo tra funzione e luogo: una cosa è andare a scuola, una cosa è andare alla spiaggia. Nell’una si studia, nell’altra si fa il bagno. La «funzione» è diversa, no? E allora perché usar le pinne per ascoltare una lezione su Garibaldi? Insomma, è una questione di tempo e di scelte. Abbiamo tutti un tempo limitato, e ognuno deve scegliere dove e come impiegare il proprio. Dove mettere la testa. A cosa pensare. L’atto del pensare, appunto. Uno mette la testa un po’ dove vuole, ma se la mette in un posto, non è che poi può metterla anche in tanti altri. Abbigliarsi nel modo che ho sopra descritto presuppone un enorme tempo dedicato alla mostra di sé, una spasmodica attenzione mentale, nonché impegno rivolto a ciò. E l’attenzione o la riservo alla scelta dei pantaloni o la riservo alle parole della Divina Commedia. Fine. In quanto al fatto che la scuola non è mai piaciuta, com’èè vero! Pare che persino su antiche tavolette sumeriche sia narrata la storia di ragazzi che tirano palline d’argilla sulla testa del loro maestro. Soprattutto, la scuola non è mai piaciuta ai grandi, alle menti «eccellenti», scrittori, artisti, scienziati. Se ne raccontano di tutti i colori su quanto poco piacesse la scuola a Thomas Mann, Einstein, Picasso, Browning... È possibilissimo. Anzi, è quasi ovvio che una mente eccelsa possa trovare un po’ claustrofobico e riduttivo il piatto impegno scolastico. È anche, per certi versi, un irresistibile vezzo quello di proclamarsi, a successo avvenuto, dei somari o ribelli in età scolare: fa parte del personaggio, direi. Ma, senza andare tanto lontano, la scuola non piaceva ai nostri nonni, non piaceva ai nostri genitori e non piaceva neanche a noi. Cioè, alla maggioranza di noi. A parte una risibile minoranza davvero felice di andare a scuola che stimerei intorno al dieci per cento, l’umanità in generale ha sempre preferito far altro, uscire a passeggio, divertirsi, vedere gli amici, sentire musica, leggersi per conto suo i libri che più le andava di leggere, o anche far niente e guardare il soffitto, o prendere il sole, andare a pescare, a sciare, a correre per i prati. Tutto, tranne restare chiusi in un’aula, seduti per ore ad ascoltare uno che parla, e poi chiusi a casa al pomeriggio a studiare cose che non si ha nessuna voglia di imparare, per poi essere anche interrogati, e giudicati, e valutati, e a volte umiliati con uno stupido voto. Però, fino a qualche anno fa, le cose erano ben diverse: nessuno mai (dico nessuno della massa di noi comuni mortali) avrebbe giudicato suo diritto andare a scuola non studiando, o anche non studiare pur andando a scuola. E, soprattutto, mai avrebbe osato affermare esplicitamente e collettivamente un tale diritto. Avevamo l’idea di un dovere. L’idea che non si dovessero fare esclusivamente le cose che procurano piacere, ma che qualche cosuccia di un po’ sgradevole o faticoso o di non completamente appagante facesse normalmente parte della vita, e che non per questo la vita fosse insopportabile, anzi: avevamo mediamente un’idea molto leggera e gaia del nostro fugace passaggio sulla terra chiamato vita. E magari imparavamo anche questo: che molte cose all’inizio faticose, spiacevoli o difficili sanno poi tramutarsi in lievi, piacevoli, addirittura facili, qualora si diventi capaci di farle. Capivamo che esiste anche una felicità mentale, ed è quello stato di grazia che ci prende quando arriviamo a essere padroni di un gioco complesso, non banale, sia esso una poesia di Emily Dickinson o un teorema di geometria algebrica. Oggi invece un’intera generazione dice esplicitamente, con le parole e con i gesti (il gesto plateale e persino esibito di non studiare, in primis), che la scuola non le piace. Però non se ne sta conseguentemente a casa, no, la scuola la frequenta eccome: in fondo la ritiene un luogo ameno, dove non si sta poi così male, anzi, si vedono gli amici, si fanno quattro chiacchiere, si mostrano i vestiti nuovi e il motorino fiammante, si conoscono ragazze carine, insomma si «figheggia» un po’ in giro qua e là. Voglio dire: questa generazione a scuola ci va, sì, ma a dispetto della sostanza stessa della scuola, che sarebbe il fatto di dover studiare. Vanno a scuola e non studiano. È una specie di avversativa-concessiva: vanno a scuola ma, ciò nonostante, non studiano. Una paradossale aberrazione. Sarebbe come sedersi al ristorante e non ordinare niente, dicendo al cameriere: No grazie, guardi, stasera non mi va proprio di mangiare. Cosa pensate che direbbe il cameriere? Invece, di fronte a ciò, noi adulti ce ne stiamo sereni come un cielo primaverile: non diciamo niente, non opponiamo un gesto, una sillaba, nulla, se non un blando disappunto, un pacato «non si fa così», un benevolo «non farlo più»: di fatto accettiamo l’indolenza e la «sfaticataggine» esibita dei nostri studenti. Forse, in fondo, pensiamo che abbiano ragione, che la scuola sia davvero una pizza, una faccenda molto noiosa, una specie di tormento da cui davvero sarebbe il caso di esentare i nostri amati pargoli. Pensiamo anche, noi insegnanti, che in fondo sia un po’ colpa nostra! Abbiamo oggi maturato uno sconcertante, masochistico senso di colpa legato alla parola «motivazione»: pensiamo che se i ragazzi non studiano sia perché noi non siamo capaci di motivarli. Paroletta magica che ha fornito un meraviglioso alibi e ai ragazzi più svogliati e ai genitori più indulgenti: Eh, cosa vuoi che ti dica, sì, mio figlio non studia un accidenti, ma sai, ha un insegnante che non sa proprio motivarlo, non è capace, non lo appassiona... Ehi, genitore, e se fosse che tuo figlio non studia perché non ne ha voglia, perché ha ben altro da fare, perché è pieno di soldi, perché non ci riesce, perché è un fagnano, o perché, semplicemente, non gli piace? Queste sono le uniche ragioni che non si adducono mai, di fronte a un ragazzo che non studia. Sono ragioni vietate, indicibili, impronunciabili: sbagliate a priori. E veniamo all’obiezione sul Tasso. Perché il Tasso? Come può piacere il Tasso? Certo che i ragazzi non studiano se quel che la scuola propone loro è la Gerusalemme liberata... Mi par di sentirvi: è un autore troppo remoto, la sua opera non parla alle nuove generazioni, non ha agganci con l’attualità, non è utile, non prepara al mondo del lavoro, è noiosissima, ovvio che i ragazzi non abbiano voglia di leggerla... Ho detto Tasso per dire la letteratura. Uno dei tanti nomi che potevo fare. A me piace molto, d’accordo, ci ho messo del mio. È un discorso molto autobiografico? Sì, lo è; io penso davvero che sia bellissimo leggere Tasso, e che bisognerebbe continuare a farlo, anche se il mondo sta cambiando, anzi, proprio perché il mondo sta cambiando. Penso ci siano storie ineguagliabili nella sua Gerusalemme, ad esempio la storia d’amore tra Olindo e Sofronia. Inoltre l’ho fatto apposta a scegliere proprio lui, uno tra gli autori più «classici», ostici, lontani, vero simbolo di un passatismo perdente (intanto, mentre io lo dico, voi ponetevi la domanda: è passatismo fare oggi letteratura a scuola? E perché la trasmissione delle grandi opere del passato oggi dovrebbe essere definita passatismo e risultare perdente, chi l’ha stabilito? Non sarebbe rivoluzionario affermare che il passato non è mai passato, anzi, ci precede, ci aspetta nel futuro, in quanto eterno? I nostri autori cosiddetti classici sono classici proprio perché hanno superato il tempo: e noi oggi con quale presunzione li collochiamo nel passato, proprio loro che hanno azzerato ogni distinzione temporale?). Ovviamente, mentre voi riflettete, io sono pronta a sacrificare qualsivoglia torquatotasso sull’altare della modernità, ci mancherebbe! Si può benissimo smettere di fare questa roba, a scuola. Ok, buttiamo il Tasso nella spazzatura! Ma non è lui il problema, ovviamente. Il problema è stare. Stare fermi, permanere, indugiare, sostare su un testo, che non sia semplice e banale. Che sia difficile. Per esempio antico, lontano, impervio. E che quindi richieda una permanenza anche lunga in vista di una comprensione ( comprehendĕre vuol dire prendere insieme, abbracciare, circondare con le braccia dell’intelletto, direi, se non fosse troppo...). «Indugiare sulle parole», dice Gian Luigi Beccaria in una sua accorata difesa della filologia: «amore delle parole», appunto... 2 Mettere alla prova le proprie capacità di «permanenza mentale», si può dir così?, in vista di una comprensione: arrivare a «capire» ( capĕre, afferrare...) quel che si legge. Può essere anche Romeo e Giulietta. O un sonetto del Foscolo. O una commedia di Pirandello. O Laborintus di Sanguineti. Oppure, cambiando materia, un teorema complesso in matematica, una teoria audace in fisica, un’argomentazione sofisticata in filosofia. Possiamo benissimo sostituirlo, questo benedetto Torquato Tasso, ci mancherebbe! Anche con autori più recenti e non italiani. Melville, Faulkner, Pessoa, Mandel’štam, Yehoshua, o quella meravigliosa poetessa polacca che si chiama Szymborska e che nel 2006 ha vinto il Nobel. Possiamo sostituirlo con qualsiasi altro autore della letteratura mondiale, e possiamo anche, volendo, sostituire la letteratura con altro e far leggere opere non più letterarie, ma grandi opere del pensiero scientifico e filosofico. Possiamo far leggere Bertrand Russell, o Freud, o Einstein o Luigi Einaudi, Gramsci, Pasolini, Galileo. Il problema che resterebbe è: leggere (e studiare!) testi complessi. Decidere di prendere una pagina e starci sopra per ore. Capire, ripetere (cioè riprodurre dentro di sé), meditare, approfondire, fare proprio un pensiero, un verso, un’immagine, un’idea. È quella decisione che manca, quella scelta. La questione, quindi, non cambia: come faccio ad acchiappare il tempo, e la testa, di questi ragazzi? O volete dirmi che per acchiapparli devo rinunciare a qualsiasi... «filologia » o amor delle parole, a qualsiasi indugio sul testo, a qualsiasi libro dunque che non sia una semplice storiellina banale, visto che, qualsiasi libro io scelga per loro, non hanno voglia di leggerlo? Voglia, ma anche capacità: anche arrivassero, per una qualche forma di indagabile loro personale follia, a scegliere di leggere Tasso (o i suoi sostituti sopra menzionati), è possibile che non ce la facciano. Personalmente direi che è certo: i nostri ragazzi non hanno più la capacità di capire quello che leggono. I libri richiedono conoscenze e capacità che non sono più state attivate. I libri sono fatti di parole, e le parole impegnano. Non solo singolarmente nel loro significato e nella loro etimologia ed evoluzione storica, ma anche perché si legano in frasi e in periodi e, a seconda del modo in cui lo fanno, formano un senso, anzi, più sensi, letterali e simbolici, ovvero tutti quegli infiniti molteplici ulteriori sensi veicolati da opere che non siano solamente pura comunicazione, ma espressione di un pensiero, artistico, letterario, filosofico, scientifico; e poi ancora tutti quei sensi vanno interpretati, alla luce del tempo e dello spazio, degli eventi storici, dei cambiamenti geopolitici: vanno, insomma, collocati da qualche parte, «letti» nel senso più ampio del termine... Ma restiamo solo sul lessico. I ragazzi di oggi sono di una povertà lessicale sconcertante: possiedono poche parole per dire quel che vogliono dire; quando leggono, ne «saltano» moltissime perché non ne conoscono il significato; infine, usano impropriamente alcuni termini credendo che vogliano dire una certa cosa mentre ne vogliono dire tutta un’altra. Avere un lessico ristretto e improprio significa perdere l’aggancio con la realtà, non riuscire a tradurla in linguaggio, non esprimere i propri pensieri e non capire quelli dell’altro. Nell’era della comunicazione è un bel paradosso. Come si fa a leggere il Tasso in questa condizione? Ma anche: se non si leggono autori come il Tasso come si fa ad acquisire un lessico ricco e alto, che non sia cioè composto dalle solite duemila parole d’uso corrente? La povertà lessicale è esattamente causata dalla dismissione della lettura: non si possiedono parole, se non si legge. Le parole si attingono dai libri. I libri sono il luogo delle parole per eccellenza. Certo, le parole permeano di sé la nostra vita quotidiana e concreta. Ma le parole che usiamo per vivere sono troppo poche, e sono solo utili: informano, descrivono, chiedono, concedono. Hanno un compito preciso e, quando lo hanno assolto, spariscono nel nulla. Le parole dei libri invece hanno tempo: si fermano con noi, e ci chiedono di fermarci a nostra volta. È grazie a quella sosta che le parole entrano in noi, si sedimentano, così che le impariamo. Imparare vuol dire proprio questo: acquisire, acquistare, quindi possedere: avere la certezza di un possesso interiore, e quindi fare a meno di ogni aiuto esterno, per forza di cose estemporaneo e parziale. Non leggendo più, perdiamo le parole. Ma per leggere, dovevamo capire le parole. Svolgere a scuola un lavoro che a quello puntava, a far capire le parole di un libro, a esercitare la capacità di comprensione, letterale e simbolica e storica, nonché a strutturare logicamente il pensiero (i mattoni dritti della casa, ricordate?). Ma noi questo lavoro sulle parole non l’abbiamo più fatto. Per tante ragioni, che cercherò di dire nella seconda parte del libro, la scuola ha scelto di non far fare questo lavoro. Ne avrà fatti altri, e splendidi, chi lo nega?, ma questo no, e quindi ora abbiamo dei ragazzi incapaci di leggere Tasso (e mille altri autori complessi). E che forse per questo non lo leggono. Mi viene in mente Pascal quando dice che partecipare ai riti religiosi aiuta a diventare credenti. Geniale! Non è che vai a messa perché sei credente; vai a messa per diventarlo! Così, non è che vai a scuola perché adori leggere Torquato Tasso, vai a scuola perché un giorno tu possa leggerlo, e quindi forse adorarlo. È a forza di andare a messa che si diventa credenti! È controintuitivo, controcorrente. Spiazzante. È come dire che, a forza di non dare alternative ai nostri giovani, loro hanno preso l’abitudine di andare ai centri commerciali. Quindi adesso sono diventati «ragazzi che vanno ai centri commerciali», e di conseguenza (di conseguenza!) non studiano Tasso. Non abbiamo mai veramente, credibilmente (cioè credendoci noi stessi!) presentato dei mondi alternativi, che potessero a loro agio abitare. E adesso abbiamo pure il becco di stare a guardarli con la lente il sabato pomeriggio, scuotendo il capo e chiedendoci come fare a insegnar loro Torquato Tasso... Non abbiamo offerto nessuna alternativa all’outlet, ai videogiochi e alla discoteca. Nessun mondo che si contrapponesse a quello dello spettacolo e del consumismo e dei giochini virtuali. Bastava insegnare a capire le parole. A «stare sulle parole», fin dai primi anni di età. Ma non l’abbiamo fatto. Troppo difficile e lontano, roba per le élite... E così abbiamo privato la massa (quelli del sabato pomeriggio) degli strumenti per essere, in futuro, un po’ meno massa. Bastava riempirli di latino a partire dai dodici anni... È solo un esempio, questo del latino, e so che il discorso è già perdente in partenza, e mi porterà solo dei guai. Ma voglio farlo lo stesso. Difendere il latino oggi (non dico relegato insieme al greco in quella specie di isola felice che è ancora il liceo classico, dico il latino per tutti, obbligatorio fin dalla seconda media) è roba da kamikaze. Lo stiamo progressivamente e subdolamente, senza dirlo in modo aperto, facendo fuori: un’oretta in meno di qua, un optional di là e in pochi anni non esisterà più. A quel che vedo profilarsi per la scuola prossima ventura, il latino è proprio l’ultima cosa che avremo ancora intenzione di fare... Giusto, dicono da ogni parte: in un mondo sempre più moderno, vuoi mica star fermo a fare cose vecchie come il latino? Giusto. Il latino è roba piuttosto vecchia, come negarlo? Peccato che sia un ottimo modo per «stare» sulle parole: educa all’indugio, alla riflessione lunga, alla... meditazione verbale: stare per ore su una versione non fa bene al latino o all’antichità o alla cultura in senso generale: fa bene alla testa, attiva certe particolari sinapsi legate al mondo simbolico del linguaggio verbale, e dunque alla capacità di parlare, leggere e scrivere. La scelta di abolire o impoverire vieppiù il latino implica pertanto la decisione, colossale, di condannare intere generazioni a non saper più leggere i libri. Dico libri che non siano strettamente i bestseller degli ultimi sei mesi, ma per esempio i grandi libri del passato (Dante, Machiavelli, Tasso, Galilei), o di un passato anche recente, diciamo i libri pubblicati cinquant’anni fa (Buzzati, per dirne uno, o Fenoglio o Gadda). Difficile che se ne capiscano più le parole, e la sintassi che lega quelle parole tra di loro: saranno sempre di più libri perduti, il cui senso (letterale, non dico nemmeno quello simbolico!) sarà perduto. Almeno per questo momento (che può durare vent’anni come due secoli, non si sa). Nella sua rubrica settimanale su «Tuttolibri», il 26 giugno 2010 Gian Luigi Beccaria scrive che l’attuale evidente impoverimento del lessico presso i giovani è sicuramente dovuto, tra le altre cause, alla «conoscenza sempre più rarefatta del latino, che ha ridotto di molto l’utilizzazione di una certa parte del lessico derivato non per via diretta dalla nostra lingua madre, ma dalla tradizione scritta di quella lingua». Parole come diuturno, esiziale, inane, egro, ludico, foriero sono ormai incomprensibili. E poi aggiunge: «Si capisce perché oggi sia diventato un problema serio spiegare a scuola la nostra letteratura, specialmente quella dei secoli passati, così colma di parole del genere». Ma il problema ancor più serio è che di parole ben più comuni e usuali e quotidiane i ragazzi non conoscono più il significato; da questa incompetenza lessicale nascono, poi, i ben più gravi errori categoriali a cui assistiamo ascoltandoli alle interrogazioni o agli esami o leggendo le loro produzioni scritte. Ma va bene così. Siamo almeno consapevoli della decisione (tremenda) che si annida dietro la scelta (apparentemente giusta) di non fare più latino? Se sì, se ne siamo consapevoli, benissimo. Che però poi la vogliamo passare come scelta moderna e progressista, questo no. È una scelta regressista, semmai: nel senso che ci fa regredire rispetto al punto di civiltà e di maturità espressiva che pure avevamo raggiunto. Conservare il latino era solo uno dei modi più efficaci per lavorare sulle parole. Al fine di capirle. E quindi di leggere. Leggere qualsiasi cosa. Non solo i giornali on-line, i blog e le chat. Magari anche John Donne. Pensate un po’, il latino come strumento per leggere John Donne... è da pazzi! Eppure io la penso così. Le sue poesie non ci farebbero male, anzi, ci porterebbero la mente in alto. Solo che sono difficili, in inglese ma anche in traduzione italiana (ad esempio quella magnifica della nostra grande poetessa Cristina Campo), e quindi aver fatto un po’ di training con il latino aiuterebbe... Non vi piacerebbe che i nostri ragazzi acquisissero questo genere di capacità, in modo che così poi, da grandi, possano volare un po’ alto, magari liberi e felici al di sopra delle bieche incombenze terrene quotidiane? Leggere John Donne per esempio aiuterebbe la loro futura felicità mentale. Ecco, allora, prima di accodarvi alla schiera dei «luoghicomunisti» (seguaci dei «luoghi comuni») che si sentono tanto moderni a ridurre o abolire il latino, pensateci. E se siete genitori, prima di scegliere tanto serenamente per i vostri figli la scuola che fa il maggior numero di attività extra e che tanto modernamente fa fuori il latino a vantaggio di altre materie più o meno nuove o alla moda, siate consapevoli che proprio con la vostra scelta voi renderete impossibile ai vostri figli leggere un giorno i grandi capolavori del passato, per esempio Dante, o Shakespeare o John Donne. Almeno poi non chiedete loro di farlo: non ne saranno più capaci. E, soprattutto, non chiedetene conto a noi insegnanti. 10. L’ultimo tema A maggio in genere do l’ultimo tema in classe. Ne facciamo sei in tutto l’anno, tre per quadrimestre. Più un tema a casa ogni una o due settimane, senza contare le parafrasi e i riassunti. Dare il tema è oggi scorretto e anacronistico, lo so. Sono perfettamente consapevole del dibattito e dell’infinita polemica, e ne ho anche già parlato più volte. Ma, senza ripetere quello che penso, vorrei solo dire qui che, se mai un insegnante volesse ancora esercitare i ragazzi a scrivere, cioè volesse mai vedere che cosa pensano, a che livello di maturazione critica sono in grado di pensare e in quale forma sono in grado di dire quel che sono in grado di pensare, non potrebbe che farli esercitare a partire da un argomento (anche pretestuoso e fittizio), cosa che si chiama: tema. Davvero non vedo cos’altro potrebbe fare di meglio. Io quindi, scusate, ma continuo a dare il tema in classe. Cioè un titolo, possibilmente breve, tipo «Il mare» o «Vacanze con la nonna» o «Cosa significa viaggiare oggi»; e non dieci pagine di cosiddetti documenti, in fotocopia, da leggere e su cui esercitarsi in una ridda di citazioncine e riassuntini e copia-incollamenti vari. Risultato: 15 insufficienze (dall’1 al 5, con prevalenza di 4) su 25. Più della metà dei miei allievi insufficienti. Perché? Perché «non sanno scrivere»: frase sibillina e tranchant, scorretta e anacronistica anch’essa, che però mi pare sempre la miglior descrizione possibile del fenomeno. Non sanno scrivere. Frase anche insopportabile, che si tira dietro, come prima inevitabile reazione, la seguente: E allora insegnaglielo tu come si scrive, sei lì per questo. Peccato che non sia possibile. Non è più possibile insegnare a scrivere, a ragazzi che hanno quattordici anni e che per otto anni hanno fatto una scuola che non glielo ha insegnato. Vorrei spiegare perché non è più possibile, usando degli stralci di temi dei miei allievi di prima (opportunamente camuffati e trasfigurati). Prendiamo un tema sul viaggio, su come nel tempo si è trasformata l’idea del viaggio, da Ulisse in poi. L’argomento del tema comunque qui è irrilevante, badiamo innanzitutto a come si scrive, a quali sono le gravi incapacità. Devo premettere che sono gli ultimi temi della prima liceo, quindi sono il risultato di un anno intero del mio insegnamento. Spesso il viaggio era fatto di episodi molto tragici, come la distruzione di una nave per una tempesta, lo sbagliare della strada. Questi viaggi di Ulisse erano fatti di tristi vicende perché aveva inoltre l’ira divina contro di lui. Il viaggio poi da episodio tragico è diventato frutto di esplorazioni e scoperte di nuove terre. Nelle quali coltivare nuove piante o per trovare cose non ancora scoperte. Il brano che parla del ritorno di Odisseo l’ho trovato molto analogo a ciò che avviene nel Sabato del villaggio di Leopardi. Nell’antichità a oggi diventare eroi non è e non sarà mai facile, però c’è molta differenza. Nell’antichità l’eroismo era soprattutto in guerra come Ettore che è diventato un’eroe per Troia, perché è andato a combattere contro achille che è molto più forte di lui ma è anche un semidio perché aveva uno dei due genitori divinità e l’altro umano quest’ultimo era un eroe perché con le sue arti di guerra aveva ucciso molte persone in battaglie, però poi è stato ucciso perché aveva un punto debole al tallone. Ci sono alcune persone che hanno passato tutto questo che forse non sono neanche esistite, ma secondo la mitologia sìì Unico commento possibile, a caldo: non sanno scrivere. Siccome hanno avuto me come insegnante di italiano, e siccome va molto l’idea di valutare l’insegnante dai risultati dei suoi allievi, io dovrei come minimo essere licenziata. Ho cercato, in vari luoghi, di dire quanto sia drammaticamente impossibile ottenere che ragazzi mai abituati alla scrittura a quindici anni imparino a scrivere. Bisognerebbe farlo presente al Ministero, e anche all’Europa. Ma, detto ciò, non ho nessuna scusa: i miei allievi non sanno scrivere. Vorrei farvi notare che negli esempi sopra citati, purtroppo, non si tratta solo di errori ortografici, i quali sarebbero circoscritti e correggibilissimi. Si tratta di ben altro: mancanza quasi totale della punteggiatura, cambio di soggetto tra due frasi sintatticamente unite, improprietà lessicale, incapacità di strutturare il pensiero in frasi logicamente connesse tra loro. Nonché errori categoriali, come quando si dice che «un brano è molto analogo a ciò che avviene in una poesia», oppure che «il viaggio è frutto di nuove scoperte». Come si correggono temi tali? Ovvero, come si aiuta a strutturare il pensiero? Non certo facendo corsi o lezioni di scrittura creativa, né chiamando in classe l’esperto in materia, in genere lo scrittore di successo o il giornalista. Sono temi, questi, che non si correggono. Voglio dire: non basta una semplice correzione. Errori tali non valgono in sé, ma come grave segnale di una disabitudine cronica alla scrittura, di un costante e pervicace non-uso di tutti gli strumenti mentali che presiedono alla scrittura. Disordini del pensiero. Ma direi, più in generale, una disabitudine al pensiero, alla riflessione, allo stare (fermi) su un concetto, un’idea, un’immagine, una frase, una parola, una poesia... un oggetto (mentale o già testuale), insomma, davanti al quale sostare, contemplare: in una parola, pensare. Saper sostare davanti ai propri pensieri. Come davanti a un dipinto: per poterlo descrivere, e magari distenderlo in parole, in discorso agli altri, bisogna guardarlo a lungo, esplorarlo, indagarlo, notare i particolari. Si tratta della mente, non della grammatica: di un vuoto strutturale, quindi (quindi!) grammaticale, linguistico. D’altronde, mi chiedo: si fanno temi alle elementari e alle medie? Si esercita la scrittura, quella vera, che vuol dire riempire due o tre fogli almeno su un argomento dato? Mi risulta, da quel che mi si racconta un po’ ovunque, che si fanno tantissimi questionari, questo sì. Si viaggia su fotocopie distribuite a iosa, con caselle da crocettare, spazi bianchi da riempire, rispostine da sottolineare. Gli eserciziari degli attuali libri di testo, anche alle superiori, sono così: pieni di demenziali questionari, schede, moduli, domande. Scegli, crocetta, segna, sottolinea, completa, colloca, ricolloca, indica... (Mai scrivi, pensa, rifletti, studia...) E accanto numerini, quadratoni, livelli, linee, puntini da riempire. Non dirò mai abbastanza il mio disgusto di fronte ai libri di testo attuali. Si allevano i ragazzi a quiz (e li si valutano su quiz o test), e poi ci si stupisce che non sappiano né parlare né scrivere, cioè costruire (costruire!) un discorso? Sono temi che io chiamo, per disperazione definitoria, arrugginiti, e che non so neanche correggere. In genere mi limito a sottolineare tutto in rosso e a scrivere a lato: ruggine! Ruggine: commento da insegnante criptica e scolasticamente scorretta, lo so, i miei allievi credo che giustamente non capiscano. Ma è pura e semplice disperazione, non so cos’altro fare.3 Di fronte a temi così, mi viene una sola idea: prendere una macchina del tempo e riportare i ragazzi indietro, a quando erano piccoli. È lì che si devono piantare i pilastri su cui poi mettere le basi perché uno sappia scrivere. Ed è un lavoro che si può fare solo indirettamente, educando all’espressione del pensiero, a ex-premerlo, a tirarlo fuori in una forma che sia «leggibile» agli altri. Lo si fa leggendo poesie e racconti al bambino di un anno, lo si fa parlandogli molto, e bene; lo si fa facendolo poi scrivere e leggere, e parlare, raccontare, spiegare, direi tutti i giorni. Un’abitudine quotidiana, senza dirglielo, senza farlo vedere. Ruggine. Ruggine negli ingranaggi, segnale di disabitudine e non-uso. Si sente che questi ragazzi non hanno mai scritto nella loro vita, sono come macchine mai messe in moto, quindi arrugginite: ovvio che non possano in alcun modo funzionare. Se non li facciamo mai scrivere, come pensiamo che possano impararlo? È come se pretendessimo che uno vincesse la gara dei 400 metri a ostacoli senza aver mai fatto, nella vita, una sola ora di allenamento. Quando li prendiamo al liceo, è tardi. Si possono ancora fare solo tre cose (che si dovevano fare dalla prima elementare per otto anni di scuola!): riprendere daccapo la grammatica; fare un costante e massiccio esercizio di scrittura (non certo sei temi all’anno, come succede normalmente!); leggere molto: leggere in classe, brani e poesie dalle opere più belle della letteratura, analizzando insieme parola per parola, il suono e il senso di quel che si legge; e dare molti libri da leggere a casa, rigorosamente scelti tra i grandi. Nulla più della lettura dei grandi aiuta la scrittura: imitando s’impara automaticamente, e inconsapevolmente, a scrivere. Certo, si tratta di un apprendimento lungo e misterioso, in alcun modo monitorabile e oggettivamente misurabile... Ma, come ho detto, è tardi. Sarà difficile che si ottengano risultati soddisfacenti, se non in alcuni rari casi. E siamo tornati alla pianta: non posso pensare di piantare nella terra un rametto di quercia e, dopo un anno, sedermi all’ombra di quella quercia! 11. In treno verso il mare È la metà di giugno. La scuola è finita da qualche giorno, e io sono su un treno che mi porta in Liguria. Il vagone è pieno di ragazzi che evidentemente stanno andando in vacanza. Hanno accanto madri, nonne, sorelle più grandi. Nessuno legge. Hanno tutti in mano un aggeggio su cui smanettano, gli occhi incollati a un video, minuscolo o gigante che sia, notebook o iPhone. Alcuni si mettono a coppie o in gruppo, e giocano, o chattano o messaggiano o ridono guardando chissà che, forse qualche video su YouTube. Perché non leggono? Domanda che mi nasce automatica. È più forte di me. Mi si dirà: ma lasciali giocare e smanettare! Sono in vacanza. Sono su un treno che li porta al mare. E poi che ne sai? Magari tra un’ora son lì che leggono I fratelli Karamazov. Certo. Riconosco che l’esempio dei ragazzi non è felicissimo. Ma se andiamo la sera al ristorante, in ogni periodo dell’anno, al mare o ai monti o in città, la scena è la stessa: ragazzini seduti al tavolo, attaccati alle loro novelle «coperte di Linus» elettroniche, perduti in smanettamenti solitari su computerini, tastierine, videofonini, gli occhi magnetizzati, le piccole dita forsennate a battere, tastare, sfiorare, pigiare tasti, icone, schermi e pulsantiere varie. Non è grave che non leggano mai. È grave che per la stragrande maggioranza oggi i ragazzi vivano così compulsivamente attaccati a tasti e videate. Qualsiasi accidente dotato di schermo, telefono, tastiera, auricolare, joystick li assorbe, li estrania, li frastorna. È grave che il novanta per cento del loro tempo sia occupato da interazioni elettroniche, con interlocutori virtuali o remoti. Non siamo assatanati difensori della lettura a tutti i costi. Anzi, pensiamo che non tutti debbano leggere, e che ad alcuni possa non piacere. Se conversassero tra di loro e con gli adulti, a questi benedetti tavoli di ristorante, o su questi treni che li portano al mare, andrebbe bene lo stesso. E, più in generale, andrebbe bene anche vederli occupati in altri lavori, non so, coltivare dalie in giardino o costruire mensole per la cucina o, al mare, imparare la pesca del tonno frequentando antiche tonnare... E invece sempre queste scene desolanti e sempre uguali di giovani chattanti-smanettanti! E, accanto, adulti che li ignorano. Accanto a loro, allo stesso tavolo del ristorante, gli adulti parlano con gli amici, ridono, bevono, assaggiano pietanze. Beati. I figli li hanno fatti fuori, relegati nei loro angoli elettronici, affidati a oggetti computerizzati che fungono, anch’essi, da badante. Figli badantizzati dai computer. Come succede a casa con la tivù. Questi adulti beati che noi siamo non dicono niente, non fanno niente. Non si oppongono, anzi, agevolano, favoriscono, assecondano: in una parola, comodamente approvano. Forse ne sono addirittura fieri: pensano che sia bello avere figli così, e che sia giusto e moderno avere sulla sedia accanto, al ristorante o in treno, ragazzini tanto modernamente collegati al mondo. A questi adulti, secondo voi, importa qualcosa che io in classe ai loro figli spieghi Torquato Tasso? E che quindi i loro figli leggano Torquato Tasso? Chiedono questo alla scuola? Non credo proprio. E così i figli di questi adulti non leggono. Né in treno, né sul pullman, né al ristorante, né in spiaggia, né a casa, né a scuola, né mai. Forse non leggono perché noi a scuola non gli abbiamo più fatto Torquato Tasso. Ma forse non gli abbiamo più fatto Torquato Tasso perché al ristorante i loro genitori sono felici di vederli smanettare davanti a un microvideo pieno di figurine mobili che appaiono e scompaiono al minimo ma sapiente touch. Chissà. Chissà se nasce prima l’uovo o la gallina... E torniamo al discorso della strutturazione della mente. Se noi ai giovani non abbiamo, in otto anni di scuola, strutturato la mente, i giovani adesso non leggono libri e non sanno scrivere. Non possono più farlo, anche volendo. Possedere o no una mente strutturata: questo è il punto. È importante il verbo che ho scelto, lo ripeto: «strutturare» vuol dire fare un progetto, gettare le fondamenta, erigere i pilastri portanti, i muri, il tetto. Costruire. Avere in mente una geometria, una logica, un’organizzazione. In qualunque forma saranno in futuro prodotti, sia cartacei che elettronici, i libri richiederanno sempre un impegno enorme perché, lo ripetiamo, sono fatti di parole, e leggere significa appunto questo: tradurre dentro di sé il senso di ciò che si legge. Che poi sarebbe: capire. Quindi, perché un ragazzo a quindici anni legga (capisca!) un grande libro della letteratura, bisognava che, quando ne aveva sei, avesse cominciato quel lungo lavoro che, a partire dall’ortografia, dal lessico e dalla grammatica, gli avrebbe strutturato la mente in modo tale da renderlo adesso in grado di «leggere». Bisognava che, ancor prima, a partire addirittura da un anno, ci fosse una famiglia che si preoccupava di leggergli parole, di abituarlo al suono e al senso delle parole dei libri. Bisognava insomma che avesse intorno a sé un mondo adulto che desiderava per lui qualcosa di anche solo vagamente attinente ai libri... Voglio dire: perché un ragazzo abbia voglia di leggere, è necessario innanzitutto che lo sappia fare. Se non se ne sente capace, farà altro, non avrà certo voglia di sottoporsi a una tale devastante frustrazione. Bisogna che trovi intorno a sé un mondo che a sua volta ami leggere, o che perlomeno mandi il messaggio che è bene farlo. Se no, spiegatemi per quale ragione mai dovrebbe essere lui l’unico che lo fa. E quindi, guardandola da un altro punto di vista, ogni ragazzo che non legge è il fallimento di tutto il mondo che lo circonda. Ecco perché i ragazzi oggi vivono di chat e di vestiti e di birre o, peggio ancora, di pasticche: perché noi non abbiamo loro insegnato per davvero, e sul serio, a leggere (capire) il senso delle parole di un libro. Abbiamo avuto paura della difficoltà, e della fatica. O semplicemente eravamo occupati in altro e non abbiamo speso nessun tempo a educare i figli, per esempio all’amore per le parole e per le idee che attraverso le parole, in opere bellissime dell’ingegno umano, si sono espresse nei secoli. Noi soprattutto, noi che apparteniamo alla generazione nata negli anni Cinquanta, noi generazione del Sessantotto e dintorni, siamo i massimi responsabili: noi che siamo stati studiati come la generazione dell’autorealizzazione spinta, dei valori postmaterialisti,4 attenti soprattutto a noi stessi, identity directed, dovremmo chiedere scusa ai nostri ragazzi. Noi, che siamo stati gli ultimi ad aver ancora studiato, e non abbiamo insegnato lo studio ai nostri ragazzi... abbiamo lasciato che se ne andassero a ramengo, pur che ci lasciassero in pace, liberi di occuparci del nostro ombelico. Così adesso, di fronte a libri che li mettono davanti a ostacoli insormontabili, i nostri ragazzi scappano. Al massimo, leggono i libri dei vampiri. 12. La domanda dell’ottovolante Avrei finito, ma all’inizio di luglio 2010 sono usciti dei risultati molto interessanti di cui, tanto per completare la descrizione (rigorosamente oggettiva!) del fenomeno, non vi vorrei privare... Si tratta dell’ultimo rapporto sugli esami di Stato per la scuola superiore italiana, una ricerca condotta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) insieme con l’Accademia della Crusca su un campione, elaborato dall’Istat, di studenti in uscita dal liceo: una squadra di super esperti ha analizzato e appositamente ri-corretto i temi della maturità 2009. Sottolineo: maturità, non licenza elementare o media. Risultato: l’85 per cento fa errori di grammatica (cioè non conosce le regole della lingua italiana), il 70 per cento è insufficiente per competenza lessicale e semantica (cioè usa un lessico poverissimo o lo usa impropriamente) e quasi il 60 per cento è insufficiente per capacità ideativa (cioè non ha idee o non le sa esprimere in un discorso logicamente strutturato e compiuto). Risultato tradotto in breve: quasi nessuno sa più scrivere. O meglio, media finale: più del 70 per cento non sa scrivere. Cioè più dei 2/3 dei ragazzi che escono dalle superiori. Venti su trenta, 700 su mille. Questo vuol dire che, dopo averli tenuti a bagno per ben quindici anni (dall’asilo all’esame di maturità), la scuola riconsegna alla società dei ragazzi che, due su tre, non sanno scrivere quello che (eventualmente) pensano! Domanda finale, anche detta «domanda dell’ottovolante»: ma se questi sono i risultati di quindici anni di scuola, non era meglio andare tutti sull’ottovolante? CAPITOLO DUE Nuovomondo? 1. La fine delle parole Adesso, colpo di scena. Dopo che siete venuti a spasso con me da settembre a luglio, e avete visto le cose che vedo io, vi devo rivelare una cosa importante: non tutti le vedono come me. Ognuno ha un suo personalissimo modo di «vedere» le cose, si sa, e forse solo io la vedo come me. Ve lo devo per amor di verità, è giusto che lo sappiate: gli altri hanno in generale (non dico tutti, ma sicuramente i più) tutt’altra visione delle cose. Più o meno pensano così: il mondo è cambiato, continuerà vorticosamente a cambiare, e sempre meno servirà che qualcuno sappia ancora fare una cosa così antiquata come usare le parole. Quindi, che problema c’è? Va benissimo che i giovani non studino, non parlino, non scrivano e non leggano: grazie al progresso, non lo dovranno più fare, non servirà più. Altro che poesie di Petrarca, Torquato Tasso e latino! Ci serve un’altra scuola, nuova, diversa, moderna, al passo coi tempi. Scevra da formalismi idioti quali mettere o no uno squallido apostrofo. Premessa. Mettiamo subito in chiaro una cosa: anch’io penso che il mondo ultimamente sia enormemente cambiato, e che sempre più continuerà a cambiare. E questo non lo trovo per niente male, anzi, mi piace da morire e mi mette una gran curiosità. Quello che invece non penso è che, per il fatto che il mondo cambia, non dovremo più saper leggere, parlare e scrivere. Penso esattamente il contrario: e cioè che dovremo saper fare queste tre cosucce ancora di più e sempre meglio, proprio perché il mondo cambia. Fine della premessa. Andiamo avanti. Da parecchi anni grandi studiosi ci avvertono che è in arrivo il Nuovomondo, che un enorme Progresso tecnologicoscientifico è in atto e noi ci stiamo avviando verso un’epoca di continue e sempre più strabilianti Novità, anzi, che ci siamo già dentro fino al collo, viviamo già nel Futuro, e quindi quelli che di noi si affannano a difendere qualcosa del passato sono miopi passatisti (a volte anche razzisti e fascisti). In special modo la scuola non ha più senso che permanga immutata, deve adeguarsi al vorticoso progresso e cambiare in fretta, visto che tutto intorno a lei è già cambiato. Il linguista Raffaele Simone già nel 2000, in un libro che s’intitola La Terza Fase, sosteneva che ci troviamo «nel mezzo di grandi cambiamenti» e che con il nuovo millennio l’umanità sta entrando in una nuova fase della storia. 5 La prima fase si era aperta con l’invenzione della scrittura, e la seconda con l’invenzione della stampa. La «Terza Fase» è quella digitale, dove la scrittura e la lettura saranno sempre meno centrali. Per esempio già oggi «il senso stesso della parola leggere è molto più ampio di vent’anni fa»: non leggiamo solo sui libri, ma «vediamo» immagini, o «leggiamo» su computer, o «sentiamo» segnali «letti» da un qualsiasi supporto. «Per conseguenza» scrive Simone, «i saperi che circolano oggi, nella Terza Fase, sono meno articolati, meno sottili, e, addirittura, possono fare a meno di basarsi su formulazioni verbali. Questo fatto ha spinto alcuni a sostenere che, alla svolta tra il secolo XX e il XXI, il sapere generale si è degradato per qualità – mentre forse ha solamente cambiato natura.» In particolare, Simone rileva sì un preoccupante abbassamento delle capacità linguistiche nelle giovani generazioni, fin quasi all’afasia e al silenzio; ma distingue tra l’«atteggiamento proposizionale» di chi usa ancora il linguaggio verbale, e quindi è analitico e strutturato, colloca nel tempo e nello spazio ed è referenziale, si riferisce cioè a oggetti entità e luoghi che nomina con parole apposite; e un «atteggiamento non-proposizionale», che è generico-evocativo, referenzialmente vago, allusivo, non strutturato e non gerarchico. Questa diversità darebbe poi origine, ovviamente, a due culture: la cultura che privilegia il dire, e la cultura che privilegia il non-dire ovvero il silenzio. Naturalmente la nostra civiltà occidentale è stata sempre proposizionale e quindi si è basata su una cultura del dire (cioè del leggere e dello scrivere, basti pensare all’enorme quantità di libri accumulati dalla tradizione), ma non è escluso che ora si stia tramutando in una nuova civiltà, della non-parola, del non-dire, dove si privilegia l’esperienza rispetto all’espressione verbale. La cultura dei giovani, secondo Simone, è oggi quindi necessariamente in conflitto aperto con la cultura della scuola, dissonante rispetto a un modello che si fonda esclusivamente ancora sulla parola. «Per questo» scrive quasi alla fine del suo libro «la pratica scolastica è spesso per i giovani una sorta di finzione vera, di penitenza più o meno protratta, finita la quale finalmente si può tornare alla realtà vera e autentica, che è quella del non-proposizionale.» Si veda per esempio l’enorme valore che il mondo giovanile attribuisce alla musica come veicolo principe di espressione e allo stesso tempo di esperienza condivisa. Scuola come penitenza, dunque: scuola-disturbo, come dicevamo. Un anno dopo, nel 2001, Francesco Antinucci fa uscire un libro dal titolo La scuola si è rotta. È un cognitivista e si occupa dei processi di elaborazione, comunicazione e apprendimento delle conoscenze in relazione all’uso delle nuove tecnologie interattive. La tesi del suo libro è la seguente: la scuola occidentale scricchiola, fa acqua da tutte le parti per una ragione molto semplice e cioè per il fatto che è irrimediabilmente vecchia, si fonda ancora sui soliti e tradizionali modi di apprendimento, mentre dovrebbe fare il salto e affrontare il cambiamento. La scuola è vecchia perché si basa ancora sullo studio: «Si prende un libro, si legge, si studia e, alla fine, con più o meno fatica, si sa». Un libro è un testo scritto, la scrittura è fatta di parole, le parole sono simboli, quindi leggere e studiare sono attività che richiedono una forte dose di astrazione: «gli psicologi chiamano questo modo di apprendere ’simbolico-ricostruttivo’». Agli antipodi c’è invece il modo nuovo, «percettivo-motorio», secondo cui l’apprendimento non avviene leggendo un testo e ricostruendolo mentalmente, ma avviene attraverso la percezione della realtà e l’azione motoria. È una «conoscenza per esperienza», che si forma fuori e non dentro la mente, e per la quale non sono più necessarie doti quali la consapevolezza di quel che si fa, la concentrazione, l’attenzione, lo sforzo. Il sistema percettivo-motorio è un sistema di conoscenza antichissimo, dice Antinucci: lo abbiamo in comune con le scimmie. Mentre le scimmie, si sa, non possiedono il linguaggio verbale. Esempio di questo mirabile antico approccio alla conoscenza sarebbe il fatto – verificabilissimo, in effetti, da tutti noi oggi – che un giovane è in grado di imparare a usare Word senza leggere una sola riga del manuale, cioè provando ad agire direttamente sui tasti e vedendo che succede, mentre noi antidiluviani no, abbiamo bisogno delle istruzioni scritte. A proposito, la mamma di un mio allievo mi ha raccontato estasiata di quando a Natale in casa loro è approdato l’enorme pacco del primo computer per la famiglia: Sapesse, il mio Sebastiano che meraviglia! Noi due, mio marito e io, siamo solo stati capaci di aprire lo scatolone e togliere l’imballaggio, Sebastiano invece, avesse visto!, in tre secondi frin fran, tutto acceso perfetto, e come funzionava! Sebastiano naturalmente ha 4 in italiano. Ma, avendo io letto Antinucci, che dire a cotanta fierezza di madre? Mi sono unita all’estasi. D’altronde, suo figlio ha 4 in questa dimensione vergognosamente antiquata della scuola d’oggi, in cui si usa ancora il linguaggio verbale. Se invece la scuola fosse andata avanti come doveva e una delle verifiche previste fosse la messa in funzione di nuovi computer appena arrivati per posta, il ragazzo avrebbe 10. È colpa nostra, dunque, ragazzi, se non avete 10 in italiano. Antinucci naturalmente, prevenendo obiezioni come le mie, si premura fin dall’inizio di dire che tale portento di novità, ovvero l’apprendimento percettivo-motorio, «non è confinato a saperi pratici, all’imparare a fare, come talvolta si sente dire». Meno male. Però a dire il vero, pur leggendo il suo libro attentamente fino alla fine, non mi è riuscito di trovare un cenno a come si imparerebbe dunque una cosuccia come la Divina Commedia, in modo percettivo-motorio anziché simbolico-ricostruttivo. Per non parlare del mio Torquato... Ma, anche qui, devo aver saltato qualcosa. Anzi, no, è chiarissimo: credo che in un’ottica del genere Dante (e Tasso) salterebbe proprio del tutto, in quanto libro, in quanto cioè prodotto antiquato di una cultura che si basa ancora sul linguaggio verbale. E dunque il problema non sussisterebbe. Cioè, basterebbe abolire Dante. Per sopravvenuta inadeguatezza del suddetto, all’interno dell’innovativo sistema esperienziale di apprendimento. In effetti la proposta finale di Antinucci è che al posto della scuola nasca la «bottega», luogo dove si impara facendo e non studiando, luogo dove soprattutto verrebbero azzerati tutti i diabolici meccanismi sui quali la scuola si è sempre retta: studio sui libri, lezione frontale, appunti, compiti in classe, interrogazioni, correzione di compiti a casa e infine voti. Ovvio, dice Antinucci, che di fronte a tale sistema di «coercizione allo studio», la popolazione scolastica attuale sia «oltre modo recalcitrante»: «mi sembra assolutamente normale», dice. Ben altro invece sarebbe la bottega, dove l’apprendimento diventerebbe «attività naturale e tendenzialmente spontanea».6 Infine, Baricco. In questo mio breve e, per forza di cose, lacunoso viaggio attraverso i libri sul meraviglioso futuro che verrà, vorrei ancora segnalarvi I barbari, il saggio che Alessandro Baricco fa prima uscire a puntate su «Repubblica» nel 2006, poi in volume, con il quale ci avverte che i barbari sono arrivati. Anzi, siamo noi. Ma ci dice anche che non dobbiamo temere, perché nella storia i barbari sono sempre, più o meno ciclicamente, arrivati, e che persino Beethoven, per esempio, per noi oggi emblema della musica classica e quindi dell’idea stessa di classicità, fu giudicato un barbaro dai suoi contemporanei, quando le sue innovative sinfonie arrivarono nel mondo. I nuovi sono per definizione stranieri, cioè barbari, tutto qui. Quindi i nostri attuali nuovi giovani sono percepiti come barbari. Ma è perfettamente normale, e per nulla spregiativo. Lasciamo che sia lui stesso a presentare il suo libro: Dovendo riassumere, direi questo: tutti a sentire, nell’aria, un’incomprensibile apocalisse imminente; e, ovunque questa voce che corre: stanno arrivando i barbari. Vedi menti raffinate scrutare l’arrivo dell’invasione con gli occhi fissi nell’orizzonte della televisione. Professori capaci, dalle loro cattedre, misurano nei silenzi dei loro allievi le rovine che si è lasciato dietro il passaggio di un’orda che, in effetti, nessuno però è riuscito a vedere. E intorno a quel che si scrive o si immagina aleggia lo sguardo smarrito di esegeti che, sgomenti, raccontano una terra saccheggiata da predatori senza cultura né storia. I barbari, eccoli qua. Ora: nel mondo scarseggia l’onestà intellettuale, ma non l’intelligenza. Non sono tutti ammattiti. Vedono qualcosa che c’è. Ma quel che c’è, io non riesco a guardarlo con quegli occhi. Qualcosa non mi torna.7 Quel che non gli torna è che i barbari siano cattivi. Non sono, secondo lui, né cattivi né buoni. E quello che stiamo vivendo non è affatto l’inizio della fine, non è un disastroso decadimento del genere umano, come alcuni di noi, i nostalgicicatastrofisti ovvero gli «esegeti dagli occhi smarriti», continuano a dire. È semplicemente un cambiamento. Qualcosa che prima non c’era e adesso c’è, ma non per questo va visto come un male, anzi: si chiama novità. Ci stanno semplicemente venendo le branchie, dice Baricco, tutto qua. È quindi naturale che stiamo perdendo il dono della parola, e in particolare i giovani siano pressoché muti. Ma si tratta solo di una mutazione genetica, particolarmente accelerata negli ultimissimi anni. Solo questo. Infatti il sottotitolo del libro è Saggio sulla mutazione. Nel settembre 2010 Baricco ribadisce la sua idea con due articoli su «Repubblica», in cui afferma che secondo lui il senso non è affatto sparito in questo nostro mondo imbarbarito. Si è solo spostato. Non abita più nella profondità, dove noi dinosauri eravamo abituati a trovarlo, ad esempio leggendo libri. Abita in superficie. Sta in Google, in Wikipedia, su giornali, riviste, tivù. Dobbiamo saperci spostare noi, insomma, se vogliamo ancora trovare il senso. Smetterla di andare in verticale, e goderci una serena veleggiata sulla superficie del mare. Non parla esplicitamente di scuola Baricco, ma il suo implicito pensiero è evidente: non c’è nulla di che preoccuparsi (tanto meno il silenzio o afasia o balbettamento dei miei allievi), andremo sempre avanti, l’umanità non si sta certo estinguendo. Forse Baricco crede nelle magnifiche sorti e progressive. Beato lui. Crede, come moltissimi altri, che progredire nel tempo coincida con un progredire anche nella civiltà e sapienza. Io ho una visione più vichiana della storia e penso che si possa andare a volte avanti, a volte indietro e a volte a zigzag. Per esempio, mi sembra che opere come la Cappella Sistina, la Poetica di Aristotele, l’ Edipo re, le sinfonie di Mozart, l’ Odissea, la Divina Commedia, Re Lear, Guerra e pace, i Concerti brandeburghesi, la Primavera del Botticelli siano decisamente più sublimi rispetto alle opere che abbiamo prodotto nell’ultimo secolo, per dire, nonché di quelle che siamo in grado di produrre oggi. Non so, forse è soltanto un’opinione... È che a volte sono attraversata dal pensiero che un intero mondo se ne stia andando a pallino, diciamo il mondo che, a vario titolo, era in una qualche relazione con l’arte, con quel che abbiamo finora chiamato arte: pittura, scultura, musica, letteratura, cose così... Forse l’arte non era altro, in fondo, che una forma espressiva primitiva, destinata a essere ora soppiantata da forme più evolute: la scienza, l’elettronica, o che altro. All’arte insomma può accadere oggi quel che è accaduto al mito: di essere una breve stagione dello spirito. Nessuno più da millenni produce miti. Nessuno più, forse, produrrà nel futuro prossimo opere d’arte. Che problema c’è? Il pensiero umano si esplicherà in altre forme. Sì, è possibile. Ma prima che io mi copra di ridicolo tirando in ballo l’eterna tiritera della morte dell’arte, chiudiamo qua il discorso. Ovvio che l’uomo non tornerà a camminare a quattro zampe, e che quindi tutto questo, che ad alcuni pare una catastrofica involuzione, è solo un cambiamento. Una mutazione, come dice Baricco. Anch’io credo, come lui, che adesso abbiamo davvero le branchie. E ne sono anche immensamente felice, perché mi piace moltissimo nuotare in mare, e vedrei molto bene il fatto di essere meglio attrezzata per farlo. Sulla scuola non lo so, forse si tratterebbe di annacquarla, o meglio completamente sommergerla di quintalate d’acqua, onde rendere utili e proficue tali branchie. La conclusione è che questi tre libri (i primi due, soprattutto), peraltro mero ed esiguo campione di ben più numerosi saggi, danno ragione ai nostri giovani, al loro progressivo disuso della parola orale e scritta, e alla loro marcata predisposizione a non studiare: in attesa di conferme che solo la storia potrà fornirci, devo dire che forniscono loro un alibi perfetto. Insomma, vien fuori che, se non sanno quasi più parlare né scrivere né capire quel che leggono, è perché il mondo si sta avviando verso un’era afasica dove il linguaggio non sarà più verbale; e se non studiano più, è solo perché sanno apprendere in altri modi, più sensoriali ed esperienziali: non hanno bisogno di leggere libri né di trattenerli nella mente, perché adesso imparano vedendo, toccando, vivendo. E respirando con le branchie. 2. I born digital Nel mondo, fuori dalla scuola, regna il Web. Siamo nell’era di Internet, dell’information technology, del pc. Il computer è un dio, uno e trino: Internet, Google e Facebook. Internet: la rete planetaria di interconnessione globale, immenso scatolone che contiene tutto l’esistente, lo rende accessibile e permette di raggiungerlo attraverso legami, rimandi, collegamenti infiniti. Google: l’onnipotente motore di ricerca che va a scovare quel che vuoi. Facebook: la piazza, il mercato, il Luogo di tutte le relazioni, contatti, rapporti d’amicizia, d’amore o di lavoro. Una rete, un motore e una piazza: il Potere, il Sapere, l’Amore. Tre dee: Era, Atena, Afrodite. Con il corredo di sottodei e ninfe che popolano animisticamente l’universo-computer: Wikipedia, Google Earth, Twitter... I ragazzi sguazzano in questo universo, lo dominano: sono i signori del Web. Sono i born digital, l’ Internet generation. Una nuova stirpe di umani. Nessuno sa ancora bene come si stiano evolvendo, ma è chiaro che nulla sarà più come prima. Neuroscienziati, studiosi della Rete e della comunicazione, computer scientists, futurologi internazionali stanno studiando l’impatto che le tecnologie digitali hanno sulla mente umana e sul comportamento dei nuovi giovani. Nulla è certo. Ma pare che si tratti di un vero e proprio cambiamento antropologico. Si stanno acquisendo nuove abilità mentali: dal pensiero non sequenziale al multitasking. Pare che la diversità sia persino rilevabile clinicamente: la risonanza magnetica può ora evidenziare modificazioni alla corteccia cerebrale. Dall’ homo sapiens all’ homo videns all’ homo zappiens. Siamo di fronte a una nuova specie umana con la mente «ricablata», resistenze superiori, intrecci neuronali più complessi e un approccio non lineare al pensiero e al lavoro, reazioni più rapide agli stimoli, miglioramento dei riflessi e dei processi collaborativi...8 Se questo è vero, tutto ciò che ancora ci affanniamo stupidamente a insegnare a scuola è davvero obsoleto e patetico. Nonché obsoleta e patetica la scuola stessa. Che, quindi, andrebbe abolita o drasticamente cambiata. Per esempio, che senso avrebbe ancora l’ortografia? Perché mai incaponirsi sulla necessità vitale di un apostrofo? Cos’è un apostrofo a confronto delle innovazioni strabilianti del Web? Che senso avrebbero ancora complemento oggetto e predicato nominale, avverbi, congiunzioni, il pronome che, la sintassi dei casi, il periodo ipotetico, i pluralia tantum, Cesare che conquista la Gallia, il Sabato del villaggio da studiare a memoria? Tutto si trova nel Web, non è più necessario nemmeno avere una memoria, basta saper usare un motore di ricerca. Anche scrivere: non serve imparare a strutturare il pensiero e a esprimerlo logicamente in sequenze dotate di senso compiuto; non importa imparare a dire ciò che si pensa, ciò che si prova: nel Web esiste tutto, tutti i libri già scritti, e soprattutto i testi che planetariamente si scrivono ogni giorno e sono disponibili nei siti, nei blog, nei social network: basta accedere, avere l’indirizzo, entrare, avere la chiave, accreditarsi, digitare la password e poi si prende a destra e a manca, si fa il copia-incolla e si costruiscono testi sempre nuovi e sempre diversi. Si usa il Web, l’infinito patrimonio ora a disposizione di tutti, si manipola, si linka, si copia, si compila. Esistono le griglie, gli schemi, i fac-simile preconfezionati. Non importa nemmeno conoscere la propria lingua. Non esiste più lo scrivere corretto o scorretto: concetto desueto, incomprensibile. Quando mi affanno a correggere i loro orripilanti dettati ortografici e compiti di analisi logica, i miei allievi mi guardano allibiti: ma che problema c’è? Esiste il correttore automatico... E quando correggo i loro temi sconclusionati, affettuosamente mi consolano: non si preoccupi, prof, e quando mai dovremo saper scrivere? Anche per trovar lavoro, un curriculum lo troviamo già fatto su Internet. Sono cari e comprensivi. Ma soprattutto, hanno ragione. Non devono imparare più niente, il sapere viene loro gentilmente offerto, servito all’istante bell’e caldo, documenti predefiniti, cibo predigerito, prodotti preconfezionati. Basta cercare, trovare, scaricare. Dentro i computer, abitano dei gentilissimi correttori che molto automaticamente si prendono il disturbo di correggere gli errori. Per esempio, quando scrivo Pasolini, mi correggono in «pisolini». È un problema? Volete mica che un computer sappia chi è Pier Paolo Pasolini? 3. Marziani Il mondo dunque cambia. I giornali migrano sul Web e il libro diventa e-book. Non si tratterà solo di usare nuovi supporti: cambierà nella sostanza il nostro modo di leggere. Muteranno drasticamente i meccanismi della lettura e quindi del nostro cervello. I libri non si leggeranno certo più per intero (su video sarà così visivamente faticoso...), ma a stralci, sunti, passaggi linkati, piccole e snelle memoriette, appuntini, finestrelle. Fino a che si troverà qualcosa di sostitutivo all’azione stessa del leggere. Così dicono. Dicono tante cose del futuro, tra cui anche che sia già arrivato. L’iPad è tra noi, ne sono stati già venduti tre milioni e mezzo nel mondo, e a Natale normalmente regaleremo un porta-iPad, in pelle, o in plastica a pois, o in morbido pile. I testi scolastici da quest’anno hanno l’obbligo di essere almeno in parte on-line, i giornali e i libri hanno già tutti una loro doppia vita, un po’ ancora cartacea e un po’ già virtual-elettronica: possiamo scegliere se sfogliare pagine vere o mimare con le dita il gesto su uno schermo docilmente sfiorabile. Miracoli del touch screen, che sta a poco a poco sostituendo le normali tastiere. Nessun filo ci servirà più (né elettrico né logico), ci si collega instantly, wireless, attraverso l’aria, e presto credo anche che saremo verdi e dotati di antenne: finalmente marziani! La rivista «Newton» ha pubblicato, nel marzo 2010, un servizio su quel che diventeremo a breve, dal titolo Quo vadis homo sapiens? Leggo che avremo organi sintetici e intelligenze artificiali. Orecchi elettronici, chip cerebrali, occhi digitali, e alla nostra normale facoltà memoriale sarà aggiunta una ememory, con la quale immagazzinare dati e potenziare calcoli. Saremo uomini tecnologico-cibernetici, avremo un’interfaccia neurale tra computer e cervello, miglioreremo i processi cognitivi grazie a una esocorteccia, un’estensione artificiale del cervello composta da microprocessori, memoria di massa e software in grado di offrire un’elevata capacità di calcolo e una memoria pressoché illimitata. Secondo Ray Kurzweil, entro il 2045 potremo comprare per mille dollari un computer un miliardo di volte più potente del cervello umano. Quindi, di che ci preoccupiamo? Ovvio che non ci sarà più bisogno, come vi può apparire chiarissimo, di scuola. Non essendoci più libri, né giornali, né parole scritte, né saperi, minimi o massimi che siano; non essendoci più neanche il cervello, come potrebbe mai esistere la scuola? A che pro? Non ci sarà più nemmeno quel che oggi chiamiamo lingua, e quindi niente più lessico, grammatica, ortografia. Ci farà veramente ridere chi si affannava a sostenere l’importanza determinante di virgole e di apostrofi, di traduzione dal greco e filologia dantesca... Dobbiamo accompagnare, e non ostare. Abbandonare il diniego, accogliere il Nuovo. Come dice Baricco, quelli che ci appaiono oggi come barbari, saranno i classici di domani. Che ne sappiamo noi? Come possiamo avere la presunzione di indicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Fare Dante, continuare a leggere Tasso... Ma perché mai? Siamo davvero certi che sia bene, che sia giusto per il Nuovomondo trascinarsi appresso codesti monumenti da Vecchiomondo che, soprattutto, nessuno riesce più a leggere? Il loro peso, il loro ingombro ci deve far riflettere. Osserviamo l’aria triste e malinconica dei nostri ragazzi, quando al mattino entrano a scuola. Basta. Non vogliamo più vederli così, trascinati amorfi, infastiditi. Meglio lasciar andare, mollare, navigare... Verso i panorami stellari del futuro. Ho solo una piccola perplessità. Come una pulce che indefessa mi parla all’orecchio: ma non è che per caso tutto questo nostro invasamento collettivo sulle meraviglie del Web non è altro che il colpo finale con cui definitivamente riusciremo a estirpare l’intollerabile parola «studio» dalla scuola? E non è l’ennesimo inganno con cui stiamo handicappando i giovani? Infine: ma non è che a noi, in fondo, la scuola non è mai piaciuta ed è da almeno quarant’anni che cerchiamo di distruggerla? PARTE SECONDA BREVE STORIA DEL NONSTUDIO CAPITOLO UNO «Chiamate Roma 3131» 1. Milioni di microfoni Credo che il tempo si dipani come deve, e porti con sé una evoluzione delle idee e dei costumi che è inarrestabile e in nessun modo, e da nessuno di noi, mutabile. Lo Spirito dei tempi, il corso degli eventi... Ci sono processi che s’innescano e poi, una volta innescati, ci travalicano. Non è un’idea triste, anzi. Mi rasserena sentire di essere portata, presa in un vortice che non ho creato io, e che mi trascina insieme a milioni di altri esseri umani. Forse avrei scelto, potendo, un altro vortice. Questo sì. Un altro tempo, diverso da quello che m’è toccato. Ma a chi mai piace il proprio tempo? L’erba dei predecessori, e dei posteri, è sempre più verde. Credo che sia da circa quarant’anni che noi smantelliamo, mattone dopo mattone, la scuola, snaturandola e deviandola dal suo significato intrinseco di luogo deputato allo studio. Studio astratto, per l’esattezza. L’attuale mito del Nuovomondo, questa nostra cieca fiducia nel Futuro che verrà e nelle meraviglie della Scienza e della Tecnica, in particolare lo sfrenamento idolatrico che ci ha preso verso il Web e tutto ciò che è interattivo, non sono che l’ultimo anello di una catena lunghissima, l’ultima fede in cui ciecamente ci siamo buttati a credere. L’ultimo alibi per ammazzare definitivamente la scuola. (Il primo, almeno, quarant’anni fa, era ideologico, era il mito di una scuola democratica, da cui nessuno venisse escluso...) Così, per un minimo amor di storia, vorrei raccontarvi com’è andata. Diciamo un piccolissimo excursus da don Milani al Web. Naturalmente, secondo il mio, ristretto, punto di vista... D’altronde, come diceva Henry James, scrivere è solo esprimere un personale modo di vedere le cose. Tanto per cominciare, vi racconto una cosa che apparentemente non c’entra niente e invece secondo me è alla base di tutto. Dunque, state a sentire. Quando avevo più o meno quindici anni (l’età dei miei allievi di oggi), mi piaceva moltissimo ascoltare la radio. Ricordo che lo facevo d’estate, nelle lunghe mattine di vacanza in cui stavo a casa con mia madre. Lei cuciva, e io le stavo intorno aiutandola nei lavori di casa, chiacchierando, preparando la tavola o cuocendo le patate fritte. Ero l’esperta di casa nella friggitura delle patate. La radio era accesa e ricordo che c’era sempre musica. Canzoni, canzonette. Conoscevo tutti i cantanti di allora, e mi piacevano proprio le canzonette, tipo quelle di Sanremo. Ricordo che il bello era sperare che trasmettessero le mie preferite, meglio ancora la mia preferita, quella che in quel particolare periodo mi piaceva più di tutte e avrei ascoltato sempre. Allora non c’erano le cassette o i cd, se volevi ascoltare la tua canzone preferita dovevi aspettare che la radio la trasmettesse. Se avveniva, per me era un segnale di fortuna imminente. Per esempio pensavo che avrei incontrato il giorno stesso l’amore della mia vita, e me ne stavo con quel pensiero in testa, magari senza nemmeno uscir di casa, non pensando neanche per un momento che, così facendo, mai la mia speranza si sarebbe potuta realizzare. L’adolescenza, si sa, adora il pensiero magico... Trasmettevano anche intere commedie. Credo fossero commedie radiofoniche, testi di teatro scritti apposta per la radio. Una cosa impensabile oggi, purtroppo. Mia madre e io ce ne stavamo tutta la mattina ad ascoltare, un po’ la musica, un po’ il teatro. Poi tutto questo, di colpo, finì. Nel 1969 cominciò ad andare in onda su Radio 1 Chiamate Roma 3131. E il mondo secondo me, da quel momento, cambiò. Era una trasmissione dove succedevano alcune cose assolutamente nuove: tanto per cominciare, il conduttore parlava moltissimo, cioè non si limitava ad annunciare le canzoni, ma tra una canzone e l’altra parlava. Parlava di quel che gli pareva, senza un filo logico; diceva un po’ quel che gli veniva in mente al momento. O almeno questa è l’impressione che io ricordo, con un certo senso di fastidio: perché uno che parla senza seguire un filo, alla radio, mi ricordava le persone in treno o le amiche di mia madre in salotto, tutta gente che, per l’appunto, parlava senza avere niente di preordinato da dire, che avesse cioè un filo logico e un fine preciso. La seconda cosa nuova era ancor più straordinariamente nuova: il pubblico degli ascoltatori poteva intervenire! Poteva telefonare alla trasmissione e parlare in diretta con il conduttore (che era Gianni Boncompagni)! Chiamava Roma 3131, appunto, ed entrava nella radio dicendo anche lui quel che gli pareva, anche solo chiedendo di poter ascoltare una tal canzone e dedicarla a una tal persona. Fu l’inizio di una valanga che travolse il sistema radiofonico. In quegli anni Settanta si aprirono decine e decine di radio locali, anche dette radio libere, che si fondavano essenzialmente sul principio, nuovo, di essere accessibili, previa telefonata, agli ascoltatori. Allora non lo capii, ma adesso mi è chiarissimo: iniziava una nuova era. La gente comune, di colpo, poteva intervenire. Tutti, senza distinzione. Prima alla radio, poi via via alla tivù e sui giornali. Iniziò l’Era dell’Intervento, se posso dire così. Adesso non ci facciamo neanche più caso, perché l’intero nostro mondo si muove sull’intervento continuo e sempre possibile di tutti su tutto. Ecco, forse attualmente si salvano solo i telegiornali, ma per il resto tutto è stato amabilmente invaso dal pubblico in nome di una legge non scritta ma sacrosanta: che tutti possono intervenire, sempre e dovunque. Chiunque. Trionfo del chiunquismo. A nessuno viene negato un microfono, anzi, credo che non sia più pensabile alcun tipo di trasmissione se non basata sull’intervento diretto del pubblico. E credo che addirittura si inventino trasmissioni ad hoc, proprio per consentire alla gente di partecipare. Pensate a cose tipo C’è posta per te, Mi manda Raitre, Elisir. Pensate ai quiz, L’eredità, il gioco dei pacchi, I soliti ignoti. Amici, Grande Fratello, L’Isola dei famosi... Tutta la tivù, pubblica e privata, si basa sulla presenza della gente comune e anonima. Così come la radio e anche, in parte, i giornali. Ma non vorrei rievocare nostalgicamente i miei tempi. Non vorrei per esempio raccontarvi che la domenica pomeriggio poteva anche succedere che alla tivù ci fosse un attore sublime come Carmelo Bene che da solo in scena, su uno sfondo nero con nulla di scenografico, per un’ora filata recitava il Manfred, o le poesie dei poeti russi. Ricordo ancora l’emozione con cui restavo appiccicata al video a bermi la sua faccia e la sua voce. Credo di aver amato Majakovskij prima di tutto grazie alla voce di Carmelo Bene e alle espressioni del volto con cui accompagnava le parole. Sono cose indelebili, non basta una vita a cancellarle. C’era allora una sacralità della parola. Fosse quella dei poeti o dei cantanti di Sanremo, non importava: nessuno veniva interrotto. Nessuna telefonata in diretta di un anonimo ascoltatore osava interporsi. Ascoltatore che, poi, quale merito aveva per conquistarsi la parola? Nessuno. Solo quello d’esser stato più svelto a comporre il numero, o più fortunato a venir selezionato. E per dire poi che cosa in diretta, una volta conquistato il microfono? Niente, il suo nome, la città, forse il lavoro che fa, e magari una parolina di risposta a un quiz, un ciao, un buongiorno, un vorrei salutare mia cugina, mia nonna, la mia nuova fidanzata che si chiama Francesca... Il prodotto finale è che oggi accendiamo la radio e non sentiamo quasi più musica. Solo un parlottio diffuso e costante, un interventìo-brusio collettivo, un rumore, un vocio spesso inconsistente, nullo e nullificante. Noioso, triste. Ventiquattro ore al giorno. Qualunque sia la trasmissione, popolare o colta, sentiamo tante francesche, e salvatori e mattei che ci raccontano quel che pensano del governo o dell’opposizione, che cosa gliene pare del tal film, del tal libro, del tal attore, o chiedono come si cura l’artrite, o cosa devono fare con i loro risparmi in banca o cosa ne pensano dell’eutanasia, della droga, della camorra, della scuola... Così è alla tivù e, moltiplicato per milioni, nel magico mondo del Web, blog e social network in generale. Il male non è che tutti oggi possano dire la loro, si esprimano, trovino uno spazio per affermare le loro idee; il male è che tutti siano parimenti trattati da competenti, e che tutto quel che ognuno dice sia parimenti giudicato valido, buono, degno. Il messaggio che passa è che tutti i giudizi, le idee, i pareri, le domande, le risposte, le richieste, le analisi, le barzellette... sono sullo stesso piano. Tutti parlano, beati di poter parlare. Nessuno si chiede se quel che sta per dire abbia un senso o una sua ragione per essere detto. E, d’altra parte, nessuno giudica più chi parla, né funge minimamente da filtro. È come se nel mondo se ne fossero andati tutti, ma avessero lasciato milioni e milioni di microfoni. Una specie di landa desolata, una terra piatta desertificata, irta di esili steli neri: un immenso, smisurato deserto di microfoni. E voci che si sprigionano, senza più nessuno dietro, libere ma tragicamente sole, sperdute. Nessuno che dia la parola a nessuno, ma tutti che se la prendono. Si parla. Si parla anche se non si ha niente da dire. Forse si parla soltanto per poter dire: ce l’abbiamo fatta a parlare anche noi, a entrare in quei luoghi che una volta erano così sacri (la radio o la tivù) e che oggi lo sono ancora ma in un altro modo, in quanto luoghi pubblici, mezzo di comunicazione e quindi cassa di risonanza, palco, scena ideale per mettersi in mostra, apparire, esserci. Esserci! Forse vogliamo solo questo. Siamo affetti da una sindrome specifica che chiamerei «paura di non esserci». Abbiamo paura che nessuno si accorga di noi, coviamo il terribile sospetto che, se nessuno ci vede o ci ascolta, non esistiamo. Di conseguenza, pensiamo che per esistere ci è data una sola possibilità: essere dove sono tutti gli altri. In tivù, alla radio. O anche in coda sull’autostrada il venerdì pomeriggio di giugno per andare in Riviera a prendere il sole, e poi la domenica sera per tornare. Ci piace perché, al di là dell’oggettivo disturbo dell’essere in coda inscatolati in un’auto, proviamo il piacere immenso di essere dove tutti gli altri sono, e questo ci dà l’idea di partecipare, cioè di «far parte»: del mondo, della vita, del mare a giugno, dell’autostrada, e dei panini dell’autogrill, per i quali abbiamo una vera perversione, li conosciamo tutti e prendiamo, alternativamente, il Capri, il Bufalino, l’Apollo o l’Icaro. Bene. È tutto cominciato nel 1969 con Chiamate Roma 3131, secondo me, anche i panini dell’autostrada; con quella trasmissione, e tutte quelle che seguirono, sparirono due cose che erano fondamentali nella nostra civiltà evoluta: il valore dell’autorevolezza e della competenza. Nessuno oggi è più autorevole. Nessuno oggi è più competente. O meglio, non serve che sia competente in un suo ambito di studio o di lavoro. Non è più necessario che sappia qualcosa o che sia capace di fare quello per cui ha studiato, ha lavorato, e di cui ha esperienza. Ad esempio, non è più il critico letterario a parlare di libri, non è più colui che ha studiato Lettere, è intervenuto a decine di convegni e ha scritto decine di libri e centinaia di articoli. È l’ascoltatore Pinco Pallo che parlerà di libri, dicendo quel che pare a lui in quel momento. Noi gli abbiamo dato pari dignità, in nome di un’apertura democratica, credo. Allo stesso modo, noi conferiamo autorità in un certo ambito a qualcuno che magari se l’è conquistata in tutt’altro ambito, e viceversa. Oggi si chiede normalmente a un professore di fisica cosa ne pensa dei romanzi di Carofiglio, e a un letterato esperto di poesia russa qual è la sua opinione sull’uso del chador presso le donne islamiche, e a un’attrice di film porno un parere sull’energia eolica. O si chiede a un linguista, che per trent’anni si è occupato di punteggiatura, come risolverebbe il guaio delle carceri in Italia. È vero che il problema sta anche nel linguista, il quale dovrebbe rifiutarsi di parlare di carceri e rivendicare la sua competenza sulle virgole. Ma, si sa, la carne è debole, figuriamoci l’io narciso... In compenso, non si chiede nulla sulle centrali nucleari a uno studioso di fonti energetiche, perché al novantanove per cento è un signore sconosciuto e forse anche noioso, che abbasserebbe indicibilmente l’audience. E così non si capisce più per che cosa uno è ritenuto competente e per cosa invece no. Che cosa conta fare o studiare nella vita, e che cosa no. È tutto molto confuso, opinabile e liquido: tutto prende qualsiasi forma al momento. Il che vuol dire che, come un liquido appunto, di per sé non ha alcuna forma. Bene. Adesso proviamo a spostare questo discorso nel mondo della scuola. Pensate che tutto ciò sia stato ininfluente? 2. La perdita della soggezione Intanto, siccome tutti possono dire tutto, nessuno prova più imbarazzo a dire alcunché, o soggezione. Già, la soggezione... Ci fa orrore il solo nominarla, ci sa di tempi arcaici, servitù, timidezza. Parola che viene dal latino e inizia con sub. Sub+iăcĕo: star sotto, soggiacere, essere sottoposti. Avere soggezione: provare quel sentimento di chi sta, appunto, sotto. Sentirsi inferiori dunque, rispetto a un luogo, una persona, un evento. Soggezione è anche imbarazzo, disagio, timidezza in presenza di qualcuno che si percepisce come superiore, autorevole, importante. Ho provato sempre soggezione, da giovane. Una volta succedeva, era comune. Quando entravo in chiesa, a teatro, in una galleria d’arte, museo, libreria. Mi sentivo inadatta, incompleta. Inferiore, sì. Ma non era un male. Ero veramente, alla lettera, inferiore: ero giovane, ignorante, inesperta. Tutto mi sovrastava, soprattutto i libri. Pensavo che non ce l’avrei mai fatta, non dico a leggerli tutti, ma almeno una buona parte, e a sapere le cose che era bene sapere. Era giusto che pensassi questo, era normale: ero giovane. Invece da qualche anno abbiamo pensato che fosse un male. Così, abbiamo abbassato persone, luoghi e oggetti. I superiori sono diventati nostri pari, e così ci siamo adoperati perché certi luoghi perdessero la loro connaturata sacralità. Per paura che sembrassero quello che sono, li abbiamo mascherati facendo finta che fossero altro, qualcosa di meno esclusivo e più democratico. Li abbiamo snaturati. Desacralizzati. L’abbiamo fatto con le librerie, con la scuola e con la chiesa. A messa per esempio abbiamo iniziato a parlare in italiano e non più in latino, e a cantare con la chitarra invece di suonare l’organo. In libreria vendiamo anche cd e telefonini, e spesso facciamo anche bar e ristorante: così che non è chiaro che luogo sia, ma è evidente che non vende (soltanto) libri, ci mancherebbe! Nessun luogo al mondo doveva farci paura, sembrare un tempio, suscitare imbarazzanti sensazioni di sacralità, sembrare esclusivo, aperto a pochi iniziati. Nemmeno se, come la chiesa, si trattava di un luogo veramente sacro, e veramente riservato a pochi iniziati, altrimenti detti credenti. L’abbiamo fatto anche con gli oggetti, non solo con i luoghi. Al libro è capitata la stessa cosa: ha raggiunto tutti, ma non è più un libro, è un’altra cosa. Ad esempio, per raggiungere i neonati, è diventato un giocattolo di plastica galleggiante, che compete con le paperelle gonfiabili. È un «libro da bagno». Oppure ha dentro i giochi, i pulsanti per attivare luci e suoni, per competere con le macchinine e i robot. Anche il telefono è diventato altro e, possibilmente, mille altre cose, non solo due o tre. Anche le pagine culturali dei quotidiani sono altro: si chiamano, quando ancora esistono, «Cultura e spettacoli». E la critica letteraria ha lasciato il posto a una sorta di giornalismo culturale, attento più ai temi di un libro o all’autore-personaggio che al libro in sé. Così, questi oggetti e luoghi non fanno più paura. Non sembrano più quello che sono e, alla fine, non sono più quel che erano. Ha vinto l’idea di inclusione. Si è pensato che tutto ciò che era fuori dal comune (magari bello, grande, alto, difficile) fosse di per sé esclusivo e quindi brutto e cattivo. Era il Male. Non s’è capito che invece era solo diverso, e che la diversità arricchisce il mondo. Abbiamo avuto paura della diversità, e l’abbiamo abbinata all’idea di esclusione. Così l’abbiamo, democraticamente, fatta fuori. E a scuola abbiamo cominciato a scendere dalla cattedra, a dare del tu agli allievi e a mettere i banchi in cerchio, in modo che non ci fosse un superiore e degli inferiori, ma tutti pari, tutti amici. E a breve, ci dicono gli illuminati riformisti del futuro, non ci sarà più la cattedra, e nemmeno la classe. Tutti vagheranno liberi nello spazio, come tanti scuola-nauti dispersi, forse attaccati, con flessibili tubi (molto flessibili!) a un’astronave-madre che s’è persa nelle nebbie di un cyberspazio, ma che di lì detta le sue imperscrutabili leggi. È stata, all’inizio, un’insofferenza architettonica, credo: quello scalino in legno che sopraelevava la cattedra ci ha dato un immenso fastidio, un turbamento che presto è diventato simbolico, ha iniziato a significare molto di più di quel che era. Forse quello scalino, nella nostra testa populista, rappresentava l’Autorità, e quindi la Dittatura. E andava demolito. Nessuno ha pensato che, forse, era solo questione di praticità: dovendo guardare bene tutti gli allievi, l’insegnante «sopraelevato» poteva avere uno sguardo più comodamente disteso tra i banchi. No, era troppo semplice, troppo... letterale. E così, per amor di democrazia, abbiamo abbattuto tutti i gradini. È di lì, secondo me, che siamo arrivati al fatto che oggi nessuno studia: abbiamo cominciato a togliere lo scalino, e siamo arrivati ad accettare – sempre in nome di un principio democratico – che gli studenti non studino più, che arrivino impreparati (e seduti) a quella cattedra che non è più niente, è solo un banco un pochino più grande degli altri. Abbiamo anche, di conseguenza, iniziato a dare del tu agli studenti e a pretendere che anche loro dessero del tu a noi. (A proposito, vi ricordate Togliatti? Un giorno, nell’immediato dopoguerra, un giovane militante interrompe Togliatti allora segretario del PCI dandogli del tu, e Togliatti gli dice: «Mi aiuti a ricordare, compagno, quando io e lei ci siamo conosciuti...») Abbiamo insomma iniziato a parlare in un altro tono, a scuola, usando altri registri, più bassi. E con questo fare più colloquial-quotidiano, abbiamo di conseguenza anche preso a parlare veramente d’altro, a scegliere argomenti che fossero già nella sostanza più bassi, più facili, più alla portata di tutti: meno colti, e quindi più democratici. Non più l’allegoria medievale nella Divina Commedia, ma come si mangiava nel Medioevo, come si vestivano le donne, quando andavano in chiesa. Chissà... La cultura ci è apparsa, a un certo punto, esclusiva, maledettamente classista. Dentro di noi ha cominciato a svilupparsi sempre di più proprio questa convinzione: che la cultura sia quanto di più antidemocratico al mondo. Perciò abbiamo preso a detestarla e negarla in vari modi: camuffandola, nascondendola o travestendola con altre maschere e costumi. Le abbiamo tolto l’abito lungo e le abbiamo infilato i jeans. Nel linguaggio, nello stile, negli argomenti stessi. Così ci sembrava, di colpo e per miracolo, tutto migliore: più accessibile, più aperto, più democratico. Sì, credo che abbiamo fatto ciò in nome della democrazia; ma in un’accezione sbagliata, secondo me. Abbiamo pensato che democrazia fosse sinonimo di accessibile a tutti sempre e comunque, senza deroghe né regole. E così ci siamo giocati il sacro, la reverenza, l’idea che si debba essere all’altezza e meritevoli di un ruolo, di un luogo, di un palco, di un libro: in una parola, degni. Avrei preferito che le scuole, le librerie, le chiese non si snaturassero. E che ancora oggi si provasse, ogni tanto, soggezione. Un misto tra ammirazione e timidezza. L’idea che qualcuno ne sappia più di noi, per esempio. Il libraio, il professore, il grande scrittore, lo scienziato. Gente che sa, ha visto più cose, ha studiato più libri. Secondo me, a lungo andare la gente si stuferà degli accessi facili. E dei luoghi snaturati, e dei ruoli abbassati. E dei vestiti inappropriati. Ci stuferemo della nostra stessa ipocrisia, di questa nostra artificiosa operazione di continuo camuffamento, sempre a voler dire al nostro prossimo: non aver paura, entra, la scuola non è veramente una scuola, la libreria non è una libreria, il teatro non è un teatro. Il professore non è un professore, il genitore non è un genitore. Tutti sono nessuno, tutto è niente. Siamo uguali, siamo amici. Dovremmo smettere di attrarre gente come ai baracconi: venite venite, per di qua! La gente non ne può più del circo. E può essere che tra breve sarà attratta proprio dal contrario, e le sembreranno appetibili proprio quei luoghi che non chiamano a gran voce, che non invitano e non accolgono, ma che semplicemente, e con grande serietà, sono. Sono quel che sono e sono sempre stati, e non hanno paura di continuare a essere. Una chiesa vuota, per esempio. Mi capita a volte di entrare in una chiesa, in un’ora in cui non c’è la messa. È grande, buia e sola. Se sono fortunata, non c’è nessuno. Allora mi siedo in fondo, sull’angolo dell’ultima panca. Nella penombra a poco a poco distinguo: la statua di un angelo, Gesù crocifisso dietro l’altare, qualche lumino tremolante. L’odore di chiesa, la nostra infinita piccolezza, il senso di un dio. Scuola di massa, cultura di massa, libri di massa: tutto finto. A forza di massificare perché fosse accessibile, abbiamo operato finzioni. Tutto si è miseramente abbassato. Invece doveva rimanere com’era, della sua propria altezza: in modo che, semmai, fossimo noi – la massa – ad alzarci, per diventare più grandi. 3. Il trionfo dell’incompetenza Questa liquidità perenne in cui viviamo immersi, questo abbassamento forzato che abbiamo tanto voluto riverberano i loro effetti, ovviamente, sulla scuola e lì si fanno particolarmente gravi, proprio perché la scuola è il luogo dove dovrebbero vincere la competenza e l’autorevolezza e, dalla parte degli studenti, un minimo di soggezione. Non voglio dire che dovrebbero strisciare ai nostri piedi, né diventare tutti rossi quando ci vedono spuntare al fondo del corridoio (come capitava a noi...), siamo matti? Ci mancherebbe! Dico un’altra cosa. Vi dico quello che succede oggi, normalmente, quando per esempio in classe leggiamo Pirandello o Svevo, o Kafka o Montale. Succede che in ogni momento può levarsi la voce di un allievo che dice: a me non piace, per me scrive male, non si capisce niente, mi fa schifo, racconta storie senza senso, perché lo leggiamo? Oppure succede che, quando durante l’interrogazione di italiano sui Promessi sposi chiediamo all’interrogato di parlarci del personaggio di Renzo, egli ci dica, seduto sulla sua sedia alla cattedra: Renzo mi piace un sacco perché a quel don Rodrigo vuole anche spaccare il muso, se ci riesce! Qui son successe due cose, entrambe gravi secondo me (a parte l’uso della lingua e la capacità espressiva, andati in frantumi...). Cercherò di spiegarvele. Prima cosa: nessun autore è più autorevole, ma, in compenso, tutti gli studenti sono competenti. Ha vinto il modello radiofonico-televisivo: io ti chiedo la tua viscerale opinione, e tu mi rispondi la prima cosa che ti passa per la mente, va tutto bene. Il risultato è che chiunque può dire che Proust è un cretino, se non gli piace come scrive: pur non avendo l’autorevolezza per dirlo, è autorizzato a dirlo. Tutti i grandi autori della letteratura mondiale sono perfettamente criticabili da qualsiasi anonimo quindicenne di periferia, che non li ha mai letti e magari non sa neanche scrivere mezza pagina in italiano corretto. Non importa. Tutti sono uguali e tutti hanno libera facoltà di parola e di giudizio. Alla radio come a scuola, fa lo stesso. La cosa triste è che costoro hanno assunto la spudorata sicumera di chi ha la certezza dei propri diritti, e neanche l’ombra di un qualche dovere o responsabilità o limite. Ah l’uomo che se ne va sicuro – scriveva Montale – e l’ombra sua non cura che la canicola stampa... I loro interventi sono, appunto, s-pudorati, s-facciati. Senza faccia, senza pudore, senza freni, senza mai la minima sospensione dubbiosa. Senza soggezione... Tutti si permettono di dire, per esempio, che Tolstoj è noioso. Tolstoj, l’autore di Guerra e pace, Anna Karenina, La morte di Ivan Il’ič... Sì, è possibile che oggi il ritmo narrativo di Tolstoj (e di Stendhal, Dickens, Flaubert, Thomas Mann...) sia percepito come lento e induca a un certo qual sentimento di noia. Ma dovremmo saperne vedere le ragioni e saper affrontare e ridurre la dissonanza. Dovremmo cioè avere alcune ben precise «sapienze»: aver appreso ad esempio (e proprio a scuola!) la nozione di distanza temporale e spaziale (storica!), che è quel che ci divide da un testo del passato, e richiede quindi gli strumenti idonei a comprendere, e tradurre, tale distanza. Dovremmo, in una parola, saper «leggere», visto che leggere proprio questo è: abolire la distanza dei secoli, accorciarla, sapendo accogliere stili e ritmi diversi, parole cadute dall’uso, tematiche lontane, e sapendo tradurle cioè trasportarle nel nostro tempo, trasformandole nelle parole che usiamo abitualmente. Questo sarebbe leggere, e non far passare gli occhi su pagine, libri o videate che siano, scritte e prodotte un attimo prima per essere, all’istante, consumate. Invece noi, abitanti di questa era che chiamiamo digitale, siamo inabili a tradurre la distanza. Paradossale, in un mondo che continuamente ci invita ad accogliere e a com-prehendĕre l’altro, il diverso, il lontano, lo straniero... E arriviamo alla seconda cosa grave che, secondo me, è successa: è inesorabilmente saltato il codice. Il codice di accesso, una qualche barriera che ci poneva al di qua ed esigeva, da parte nostra, una qualche conoscenza e capacità. Esiste un codice della letteratura, una specie di chiave di accesso che ci consente di entrare in un libro e capire su quali regole si muova, e capire anche la differenza tra un libro sui vampiri e un libro di Buzzati. Per le materie scientifiche e tecniche è più facile, il codice esiste ancora: nessuno oserebbe dire la propria «opinione» su Einstein, nessuno direbbe mai che la sua teoria della relatività è stupida, o non si capisce, o non piace o è noiosa. Per Pirandello e Tolstoj invece sì, succede normalmente: chiunque può dire non mi piace. Pirandello è uno di noi, perché è solo un letterato, e il codice della letteratura è saltato, nessuno lo possiede più, tutti sono letterati, basta fare una scuola di scrittura, basta scrivere su un blog, mettere un testo in Rete. Se il mondo ti dice che anche tu puoi scrivere poesie; se il mondo (la radio, la tivù, ma anche la scuola) chiama poesie le cose che ti sei provato a scrivere, è normale che tu ti senta in diritto di denigrare Eliot, Pound, Majakovskij: lo fai perché ti senti uguale a loro. O meglio, è ancora più grave: nessuno sa che si deve possedere un codice per entrare. Non gli è mai stato detto. E così entra, e non capisce come comportarsi. Faccio un esempio: negli ultimi sei o sette anni (prima no), quando do da leggere La metamorfosi di Kafka succede questo, che i ragazzi si mettono a ridere e dicono che non è possibile, non s’è mai visto che uno si svegli al mattino e si ritrovi insetto, l’autore dà di matto, la sua storia non ha senso. Ecco, è successo che nessuno sa più leggere Kafka, perché nessuno sa più che leggere Kafka non è la stessa cosa che parlare sul pianerottolo con la vicina di casa o leggere una ricetta di cucina o guardare C’è posta per te. Bisognerebbe sapere che Kafka è letteratura, e che per leggerlo è bene attrezzarci di tutti quei mezzi (simbolici, per esempio) che ci sono necessari per leggere letteratura. Altrimenti, Kafka davvero diventa un pazzo paranoico, e la storia di Gregor Samsa una vera idiozia. Bisogna andare nei mondi con la giusta attrezzatura. Se no, è un disastro. Sarebbe come immergersi a visitare gli abissi marini con il soprabitino con cui andiamo a messa la domenica. Voglio dire che il mondo dell’arte (e quindi la letteratura, che ne è una specifica contrada) non sarà più visitabile, senza possedere il codice giusto o, peggio ancora, pensando di poter usare lo stesso codice con cui «chiamiamo Roma 3131»... Il 21 aprile 2010, su «Repubblica», è uscita una bellissima intervista al grande direttore d’orchestra Lorin Maazel, che all’età di undici anni diresse la NBC Orchestra su invito di Arturo Toscanini. Il giornalista gli chiede se secondo lui, che ha vissuto un’epoca mitica della musica, oggi si assista a un inevitabile declino. E Maazel, parlando degli artisti in generale, usa una parola secondo me determinante, e molto vicina alla parola soggezione: usa la parola «rispetto». Dice: Un tempo c’era molto più rispetto verso gli artisti in generale. Non solo compositori e direttori, ma anche pittori e scrittori. Celebrati e onorati, avevano un posto di primo piano nella società. Oggi non soltanto Toscanini o Furtwängler, ma anche Picasso non sarebbe festeggiato allo stesso modo. Perché da un lato ciascuno sente di avere qualcosa da dire: su Facebook o Twitter. Dall’altro, è maturata una crescente diffidenza verso le grandi figure e le grandi idee... Ecco, ciascuno sente di avere qualcosa da dire. E lo dice. Oggi può dirlo. E in modo molto facile, immediatamente accessibile: accende il computer, digita, clicca, entra. Entra in Internet Bookshop, per esempio, e scrive quel che gli pare su chi gli pare. «Non ci sono più maestri» dice Maazel. Ci sono, invece, i «venerati maestri» di cui diceva Edmondo Berselli nel suo libro omonimo: quelli che, in forza di un’aura mediatica che si crea intorno alla loro figura, diventano gli «intoccabili», mai più criticabili, santi, indiscutibili, autorevoli a prescindere da quel che dicono e dall’ambito in cui intervengono. Si sono, come dire, conquistati un piedestallo di cemento, da cui nessuno li smuoverà più. Ma questo è tutto un altro fenomeno, non c’entra con il «rispetto degli artisti», anzi, forse è il rovescio della medaglia: siccome sono spariti i veri maestri, noi oggi veneriamo maestri costruiti ad hoc, cioè abbiamo preventivamente costruito maestri che poi veneriamo in massa, senza più alcun barlume critico. Sono, anzi, un fenomeno di conformismo di massa, una sorta di contrappasso o contrappeso al diritto di parola universale. In un mondo in cui chiunque può far valere la sua legge, una casta di santoni che non è più possibile contraddire, qualsiasi cosa affermino. Ha vinto l’esperienza, l’emozione. Quel che provi vale molto più di quel che sai e sai fare. Non importa se dici banalità: vengono da dentro, sono il tuo vissuto e dunque hanno valore in sé. Oggi ti chiedono cosa provi, non cosa sai. Una volta, pochi scalavano le montagne. Le montagne! Dico quelle altissime, invalicabili, difficilissime, impossibili. Mi è capitato di ascoltare Reinhold Messner intervistato da Fazio a Che tempo che fa, e mi è parso lo stesso discorso che abbiam fatto fin qui. Ha detto che salire una montagna è fare una cosa inutile, una specie di opera d’arte vivente. Un gesto da cui il resto dell’umanità non riceve alcun bene, alcuna utilità. Un gesto gratuito, come l’arte. Ha detto anche che bisogna amare molto la solitudine e la fatica, per salire una montagna, saper fare sacrificio di sé. «È una sfida. Non è da tutti» ha detto Messner, e ha aggiunto: «Per fortuna! Perché il rischio della vita è enorme.» «Oggi invece, per un’idea di democraticità» ha continuato, «tutti possono salire, anche la mia segretaria. Passa per primo uno sherpa che segna la via e fissa le corde, e alla fine tira su i turisti. Ma quello, appunto, è turismo, non alpinismo. » «L’alpinismo» ha concluso «inizia dove finisce il turismo. È solitudine, tanto per cominciare.» Noi insegnanti, oggi, siamo gli sherpa che fissano le corde sulla roccia e tirano su tutti. La scuola di oggi è turismo. Non può più, in alcun modo, essere alpinismo. CAPITOLO DUE I progressisti e i deboli: la stangata 1. Donmilanismo Recentemente sono andata a Napoli, a un convegno sulla scuola. All’inizio ci hanno mostrato un video, dove due maestre facevano scenette in classe con i loro allievi: si mimava una favola, c’era la principessa con una corona di cartone in testa, poi veniva il vento e tutti mimavano l’ululato del vento, infine c’era una fattoria, e ogni bambino faceva il verso di un animale, chi il cavallo, chi la gallina, chi la pecora. Era molto divertente. Quando è toccato a me fare l’intervento, mi sono permessa di dire che avevo capito perché noi al liceo siamo costretti a fare dettato ortografico: se oggi i miei allievi non sanno né leggere né scrivere né parlare, forse è perché alle elementari s’impara a mimare tutti insieme il vento. Così ho detto. Alla fine dell’incontro, le maestre mi aspettavano fuori furibonde e mi urlavano contro con piglio deciso e fiero, tra le tante frasi, la seguente: Noi non facciamo nozionismo! Mi ha colpito molto questa frase. Intanto perché è vecchia di almeno quarant’anni e ho pensato: siamo ancora e sempre fermi lì. E poi perché mi è tornato in mente che una volta, quand’ero piccola, c’era un’enciclopedia illustrata, fatta di tantissimi volumi cartonati con sovraccopertina patinata, che si chiamava Conoscere. Non la consultavo come una normale enciclopedia, leggendomi la voce che mi serviva. La sfogliavo come un libro di favole le volte che ero a letto malata, quando avevo una di quelle belle influenze lunghe e quiete di una volta, quando non c’era fretta di guarire ma ci si crogiolava febbricitanti nelle coltri tra una spremuta e l’altra. La sfogliavo per giorni, più ore al giorno; mi prendevo tre o quattro volumi, me li mettevo accanto sul letto e uno per volta me li guardavo, pagina per pagina. Guardare un’enciclopedia illustrata. Non consultarla perché ci è utile o dobbiamo fare una ricerca o cerchiamo una cosa che non sappiamo. No, sfogliarla come un libro qualsiasi vuol dire non averne bisogno, ma prendersi soltanto il piacere dello sguardo. Ci sono pagine che ricordo ancora adesso. I pianeti in circolo in un cielo nero puntinato di bianco (la Via Lattea, suppongo), i centurioni romani, il Mar Rosso che si apre per far passare Mosè, Cesare che guida una biga e i cavalli hanno la criniera al vento, qualche ritratto di grand’uomo barbuto, Galileo o Michelangelo o Marx, i disegni pallidi a sanguigna di Leonardo, com’è fatto il motore a scoppio o la macchina a vapore. Immagini, niente di più. Linguaggio visivo, non verbale: ero l’emblema del perfetto giovane di oggi, ante litteram. Chissà cos’ho imparato, non saprei dire. Forse niente. Però quell’enciclopedia si chiamava Conoscere. Una ventina di volumi, forse più: Conoscere. Apro il Grande Dizionario UTET, e cerco la parola «nozionismo»: «Conoscenza basata o derivata soltanto dall’apprendimento di nozioni, di notizie, di dati non approfonditi e non elaborati sinteticamente, organicamente e criticamente». Conoscenza. Nozionismo è un derivato di nozione. Nozione viene dal verbo noscĕre: conoscere. Leggo alla parola «nozione»: «Qualsiasi atto o operazione conoscitiva o immagine ideale che l’intelletto si forma di un qualsiasi oggetto della conoscenza... Per Kant rappresenta il concetto puro in quanto ha la sua origine unicamente nell’intelletto ». È bellissimo leggere un dizionario grande come questo, che infatti si chiama il Grande Dizionario della Lingua Italiana. Me lo regalarono i miei genitori, pagandolo a rate. All’inizio ne usciva un volume ogni diciotto mesi, poi ogni tre anni o più. Era infinito il tempo tra un volume e un altro, per anni mi accontentavo delle parole fino alla g, alla m, p, s... Lo diresse all’inizio Salvatore Battaglia, e forse ancora oggi il dizionario viene detto «il Battaglia». Poi per anni fu Giorgio Bàrberi Squarotti a dirigerlo, uno dei miei maestri, e in redazione c’erano un sacco di miei compagni di università, qui a Torino. La redazione del Battaglia era, insomma, un vero covo di letterati, allora, negli anni Settanta-Novanta. Adesso l’opera è completa, ventuno volumi, più di mille pagine l’uno. Ogni tanto scelgo una parola e me la leggo tutta. È incredibile quel che c’è in una parola, quante cose significa, in quanti modi è stata usata nei secoli, da autori diversissimi che di volta in volta l’hanno aumentata, deviata, piegata, ammorbidita, violentata. Le parole sono la nostra storia, la storia di quel che nei secoli abbiamo pensato e di come abbiamo provato a dirlo, ogni volta in modo diverso. Coloro che sostengono con tanta allegria che il linguaggio verbale è solo uno dei linguaggi possibili e che oggi i giovani hanno altre capacità, ovvero pensano che non importa se i giovani non sanno più parlare né scrivere, perché tanto sanno fare ben altro; ebbene, costoro dovrebbero frequentare di più i dizionari, quelli grandi possibilmente, e perdersi nella bellezza delle parole. E fare le loro intelligenti e profetiche considerazioni almeno con le lacrime agli occhi, commuovendosi che tanta bellezza debba andar perduta. Avere nozione di qualcosa, dunque, vuol dire sapere. Conoscere. Il marinaio ha nozione dei venti, delle rotte, dei porti. Il contadino ha nozione dei trattori, del fieno, della trebbiatura. L’ingegnere ha nozione del cemento armato, delle fondamenta. Il panettiere ha nozione dei diversi tipi di farina, e di lievito, e di forni. L’insegnante di lettere ha nozione della grammatica e della letteratura. Non è peccato avere nozioni. Anzi, dovrebbe essere necessario, qualsiasi mestiere sia il nostro. Quindi, la scuola dovrebbe insegnare nozioni: dovrebbe condurre alla conoscenza, a che altro se no? Invece la parola nozione non ha avuto fortuna. È stata travolta da una valanga che si chiamò Sessantotto e che la sotterrò per sempre nella parola nozionismo riservandole solo odio e disprezzo. Nozionismo è, ancora oggi, una parola brutta, infame, vergognosa. Nessuno oggi conosce più la bontà e l’innocenza della parola nozione, nessuno ha provato mai a riportarla alla luce, pulendola dalle incrostazioni di terra come un vaso antico prezioso. E quelli che da sempre si occupano di nozioni, ovvero di conoscenza, gli studiosi, i professori, i maestri, fanno gli ultimi mestieri della terra, i più negletti, i meno considerati. Mi rimane il ricordo della mia enciclopedia Conoscere. Bel titolo, bel verbo... A vent’anni, squattrinata com’ero, feci l’errore di mettere l’annuncio sul giornale: VENDESI ENCICLOPEDIA CONOSCERE USATA. La vendetti subito. Non so cosa darei, oggi, per riaverla. E vorrei tentare adesso, a quarant’anni di distanza, di riesumare e rinobilitare la parola nozione. Peccato che le maestre di Napoli me l’abbiano tirata addosso, come un sasso. Succede a volte che certi libri diventino un mito. Travalicano il loro tempo e, con gli anni, diventano altro da sé, finendo per rappresentare qualcosa di esterno ai loro stessi contenuti, indipendente anche dai loro autori, qualcosa che va avanti per conto suo, si sposa allo Spirito dei tempi e fa la Storia. Credo sia andata così a due grandi del nostro recente passato: don Milani e Rodari. Un numero sempre più alto di insegnanti ha sposato le idee espresse nei loro libri, le ha fatte diventare idee di culto, l’emblema stesso di un certo modo di pensare la scuola, e più in generale il mondo. Le ha anche elaborate, e trasformate, e adattate alle proprie esigenze, al proprio modo di sentire. Ne è nato una specie di grosso pensiero collettivo identitario comune, un pensiero in cui un folto gruppo di persone politicamente affini si è alla fine totalmente riconosciuto. Tornando al mio convegno di Napoli, non so se quelle maestre abbiano letto don Milani e Rodari, ma certo, anche inconsapevolmente, mi sono sembrate impregnate di un misto tra donmilanismo e rodarismo. Nel 1967 esce Lettera a una professoressa, nel 1973 La grammatica della fantasia: l’antinozionismo ancor oggi perdurante ha queste due anime. Partiamo da don Milani. Non credo che volesse davvero una scuola che non insegna nozioni. So che nelle sue classi si studiava eccome. Semplicemente, voleva una scuola che non escludesse dall’istruzione i ragazzi meno fortunati, quelli che per origini famigliari non possedevano gli strumenti per farcela. Come dargli torto? Giustissimo. Fu una grande scuola, la sua. Ciò nonostante, noi abbiamo costruito negli anni, grazie anche alle idee di don Milani, una scuola che non insegna più nozioni. Com’è noto, il libro è la lettera che un ragazzino della scuola di Barbiana scrive alla sua ex professoressa delle medie, per chiederle di smetterla di insegnare cose lontane da lui e dai suoi compagni figli di contadini e montanari come Gianni, di smetterla di fare cose come l’Eneide, o l’ Iliade tradotta dal Monti, le poesie di Foscolo, i castelli della Loira e i problemi di geometria: sono cose inventate dai ricchi per umiliare i poveri, per farli sentire inadeguati, e perpetuare la loro posizione di privilegiati. Dice così: «Finita la lettura della posta mi chiudo di nuovo sull’ Eneide. Leggo un episodio che piace a lei. Due farabutti sbudellano la gente tra il sonno. Elenco degli sbudellati e della roba rubata e di chi gli aveva regalato una cintura e il peso della cintura, il tutto in una lingua nata morta. Non era necessario mettere l’ Eneide in programma. L’ha voluta sceglier lei. Non glie lo posso perdonare». Con buona pace di Eurialo e Niso. E di Cloridano e Medoro che vengono dopo, anche loro due farabutti, immagino... Fine: spazzati via Virgilio e Ariosto, in un colpo solo. Il libro di don Milani diventa subito mito. Si sposa con la protesta studentesca e l’ideologia comunista e cattolica di tanti insegnanti, contrari all’idea di selezione e di nozionismo fine a se stesso. Si vuole abbattere la scuola severa e classista di stampo gentiliano, ingiustamente riservata ai soli figli di papà e destinata a formare le classi dirigenti del futuro. Si lotta per una scuola più democratica ed egualitaria, capace di venire incontro alle esigenze della popolazione meno abbiente e culturalmente più svantaggiata. Ma l’insofferenza (attualissima!) di molti di noi verso le materie letterarie (e il liceo classico!) forse viene di qui, da parole come quelle che il ragazzino di Barbiana riserva all’Eneide : la letteratura è roba per ricchi, nell’ottica di una lotta di classe meglio non farla, o limitarla al massimo (e semmai stravolgerla con le analisi formali di un vecchio strutturalismo che però abbia l’apparenza di scientificità e ci metta in pace con la coscienza!), e relegarla comunque agli ultimi tre anni di liceo: poche letture, molta storia letteraria e via, il gioco è fatto. Così come molte delle posizioni antimeritocratiche di oggi trovano forse in parole come le seguenti la loro matrice «razzista» all’incontrario: «La teoria del genio è un’invenzione borghese. Nasce da razzismo e pigrizia mescolati insieme». Così c’era scritto nel libro di don Milani. E così come, infine, gran parte della nostra (attualissima!) riluttanza a fare grammatica forse prende inizio da qui: «Bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a ricrearle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro. O per bocciarlo. Voi dite che Pierino figlio del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi. Appartiene alla ditta. Invece la lingua che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo (montanaro)... Tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di lingua. L’ha detto la Costituzione, pensando a Gianni. Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione». Oggi di sicuro abbiamo più in onore la Costituzione che la grammatica: sta entrando una nuova materia nelle scuole, che si chiama Educazione alla cittadinanza, non certo Educazione alla grammatica. Ma l’idea più terribile, secondo me, si trova nel finale. Il libro si chiude con un sogno, il sogno di insegnanti nuovi e democratici che finalmente dicano ai loro allievi: «A pedagogia vi chiederemo solo di Gianni. A italiano di raccontarci come avete fatto a scrivere questa bella lettera. A latino qualche parola antica che dice il vostro nonno. A geografia la vita dei contadini inglesi. A storia i motivi per cui i montanari scendono al piano. A scienze ci parlerete di sarmenti e ci direte il nome dell’albero che fa le ciliegie».9 Vuol dire lasciare le persone come sono! Ognuno si tenga le «nozioni» che ha già, che gli vengono dalla famiglia in cui è nato: ognuno abbia, dunque, la vita che già la sorte gli ha dato. Vuol dire una scuola che non aggiunge, non eleva, non sfida. Ma si adegua, si fa uguale, si camuffa. E inevitabilmente si abbassa. E così penalizza proprio i più deboli. Tutti bassi, ma tutti uguali. Bassezza comune, mezzo gaudio? Mi sembra una vera e propria manipolazione a uso del proletariato, una distruzione programmatica e scientifica di ogni contenuto culturale che priva per sempre di cultura proprio le classi basse, le quali invece avrebbero avuto bisogno proprio di una cultura alta. A storia non ti insegno Napoleone, ma la discesa dei montanari; a latino non ti insegno la sintassi dei casi o lo stile di Cicerone o a leggere le meravigliose poesie di Orazio, ma ti chiedo solo di ripetere le parole di tuo nonno! A scienze non ti spiego la formazione dell’universo, le molecole, l’apparato digerente, l’elettrodinamica, ma il nome delle piante da frutta che hai nel tuo orto. Insomma, caro ragazzo contadino, visto che sai fare il for-maggio e sai seminare i campi, io a scuola, perché tu ti senta a tuo agio e non discriminato da una cultura che patiresti come oppressiva e classista, ti parlo solo di formaggio e di semina. Mi pare davvero ingiusto proprio nei confronti di chi s’intendeva proteggere. Com’è possibile? Insegnare ai ragazzi l’arte della semina o la potatura delle piante, la discesa dei montanari, le parole del nonno, il nome delle piante da frutta, anziché Omero e Foscolo, Cesare e Napoleone, Galileo e Einstein, Cicerone e Orazio, la formazione dell’universo, le molecole, l’apparato digerente, l’elettrodinamica...! Com’è possibile far fuori così i contenuti (le «nozioni»!)? Eppure la pensiamo ancora così: oggi più che mai si vuole questo, e lo si teorizza con l’esaltazione della metodologia, l’esecrabile vittoria dei metodi sui contenuti, dei «modi» di insegnare sulle «cose», effettive e basilari, che dovrebbero essere insegnate. Quando il ragazzino di Lettera a una professoressa s’indigna che gli venga insegnata l’ Iliade del Monti e sogna invece che gli si parli delle cose che lui conosce già perché fanno parte del suo mondo, in realtà si autocondanna a rimanere quel che è. Avremmo dovuto dirglielo, a codesto ragazzino amico di Gianni e nemico di Pierino: lui era troppo giovane per accorgersene, ma noi adulti dovevamo averne coscienza, e metterlo in guardia. Potevamo passare il messaggio opposto: che ce la poteva fare, che i contenuti alti erano la meta cui arrivare, il mezzo per cambiare la sua svantaggiata condizione di partenza. Invece, tragicamente, siamo stati d’accordissimo con lui, abbiamo concordato appieno con l’idea che sia male insegnare ai figli di contadini le nozioni, la grammatica e la letteratura, e che sia invece bene insegnar loro esattamente quel che conoscono già. Peccato, un’occasione mancata. Per non dire un crimine contro gli umili. È stato sulla scia delle parole di quel ragazzino che abbiamo cominciato (noi insegnanti, noi genitori, noi generazione degli anni Cinquanta in generale) a svalutare, se non addirittura a disprezzare, la cultura astratta, lo studio teoretico, la capacità di astrazione. E abbiamo fatto fuori a poco a poco le materie meno immediatamente utili, meno pratiche, meno vicine all’esperienza di tutti i giorni; le materie insomma più legate a un’idea di cultura fine a se stessa: la grammatica e il latino e la letteratura, per esempio. Materie astratte e «inutili» e così lontane dagli alberi da frutta, sì, è vero: ma erano materie che davano le conoscenze giuste per arrivare a una comprensione dei testi complessi, ad esempio dei capolavori del passato. Non ci abbiamo pensato? Non facendo più grammatica e letteratura, noi stavamo implicitamente togliendo ai nostri ragazzi la possibilità di capire le parole, il senso astratto, simbolico, plurivoco delle opere più alte dell’ingegno umano. Abbiamo espunto dalla scuola l’altezza e la grandezza: tutta l’eccellenza della nostra cultura. In nome di un antinozionismo che ci è parso tanto «democratico». Non è stato ingiusto proprio verso quelle classi sociali più deboli, che intendevamo proteggere e aiutare, che dovevamo «alzare»? Non abbiamo pensato che proprio a quei ragazzi era bene insegnare l’Iliade del Monti, il latino e il greco, onde dar loro l’opportunità di scegliere se restare montanari o diventare professori a Oxford? Il problema è che abbiamo continuato così fino a oggi. E oggi la maggioranza dei nostri ragazzi (anche quelli che escono dal liceo!) non è in grado di affrontare gli studi universitari: si tratta di un settanta per cento circa, che non ha le conoscenze di base e le capacità minime richieste. E che, quando ce la fa, ci riesce solo perché l’università, a sua volta, si è adattata, abbassando sempre di più i propri standard. Vi par poco? Lo ripeto, un settanta per cento di studenti universitari che non è all’altezza. Eppure il discorso prevalente (direi unico) che si sente fare ovunque, sui giornali, in tivù, ai convegni, è che la missione più importante sia di venire incontro a quei ragazzi i quali, per gravi handicap famigliari e sociali, partono in svantaggio. Bene, è un discorso giustissimo. Ma quanti pensate che siano questi poveri ragazzi svantaggiati? Al giorno d’oggi sono al massimo un dieci per cento. Allora sotto accusa non è il fatto che la scuola si occupi di quel dieci per cento: è che, per farlo, abbandoni quell’altro settanta! E pensare che c’era stato Adorno... Theodor Wiesengrund Adorno, l’autore dei Minima moralia . Qualcuno della mia generazione per caso se lo ricorda? Adorno criticava la condiscendenza per gli uomini come sono, vista come falsa virtù, come virtù piccolo-borghese: «Il borghese (...) è tollerante. Il suo amore per la gente com’è nasce dall’odio per l’uomo come dovrebbe essere». Non è che per caso la mia generazione – seguace a oltranza di don Milani – ha amato troppo i figli dei contadini per com’erano, fino a non permettere loro di diventare altro? Non è che per caso oggi Adorno darebbe del piccolo-borghese a don Milani? L’aveva compreso, Adorno, qual era il rischio. In pieni anni Cinquanta, aveva già capito che non era bene esaltare il benessere piccolo-borghese; che il consumismo di massa ci avrebbe rovinato, ci avrebbe sempre più ridotto a essere quel che eravamo, cioè massa amorfa, senza possibilità di resistenza, senza autonomia di pensiero; che bisognava invece puntare in alto, scuotere le persone. Aveva capito che l’unica possibilità reale di emancipazione era l’arte. L’arte come rivoluzione, sovvertimento. E la filosofia. Il pensiero astratto, la capacità di pensare e creare come unica risorsa dell’umanità per uscire dal vicolo chiuso del potere, dei consumi, dell’omologazione. Noi invece abbiamo lasciato che la massa rimanesse massa: questo è il mio sospetto. Se così fosse, sarebbe imperdonabile. Sarebbe come andare da antropologi a visitare i popoli primitivi e compiacerci, in nome del rispetto del diverso, del loro felice stato ancora selvaggio, uno stato in cui essi invece - i «selvaggi» – non hanno nessuna voglia di rimanere. Un punto che Lévi-Strauss, probabilmente il più grande antropologo di tutti i tempi, uno dei fondatori dello strutturalismo, aveva già colto nel 1965, in un discorso pronunciato a Washington: «La situazione dell’antropologia contemporanea offre dunque un aspetto paradossale. Un profondo sentimento di rispetto nei confronti delle culture più diverse dalla nostra le aveva ispirato la dottrina nota come relativismo culturale. Ed ecco che quella dottrina viene criticata con veemenza da quegli stessi popoli per riguardo dei quali si riteneva di averla formulata. Di più: questi popoli sposano le tesi di un vecchio evoluzionismo unilineare come se, per partecipare più in fretta ai benefici dell’industrializzazione, preferissero considerarsi provvisoriamente arretrati piuttosto che diversi, ma allora a titolo permanente». Il relativismo culturale piace molto a noi, popoli evoluti, insomma. Ma ai popoli arretrati piace molto poco essere considerati pari, e studiati come diversi, e lasciati quindi come sono: dal loro punto di vista, meglio essere giudicati arretrati, e magari aiutati a progredire... Se applicassimo questo stesso pensiero, un po’ da antropologi, alla scuola di massa che abbiamo costruito proprio su un identico relativismo culturale che potremmo chiamare «scolastico», probabilmente i ragazzini «arretrati» ci direbbero: grazie mille per il meraviglioso rispetto che dimostrate verso la nostra ignoranza, grazie di chiamarla diversità (siamo forse per voi «diversamente colti»?), ma se adesso per piacere ci fate un po’ di latino e greco, a noi non spiacerebbe, così magari riusciremmo a diventare come voi... Non gliel’abbiamo fatto, il latino e il greco, peccato. Anzi, gliel’abbiamo volutamente evitato, pensando al loro bene. La cosa buffa è che Adorno – insieme a Marcuse – era negli anni Sessanta il grande mito della sinistra (più letto Marcuse, però, che era più facile, parlava male della società capitalistica e inneggiava alla liberazione sessuale...). Comunque Adorno era un maestro per la sinistra, come lo era don Milani. Possibile che gli allora militanti di sinistra non abbiano visto la discrepanza macroscopica tra questi due maestri, don Milani e Adorno? Eppure era evidente: l’uno diceva una cosa e l’altro esattamente il contrario. L’uno diceva di alzare, l’altro di tenere il più possibile basso... Ha vinto don Milani, e non Adorno. Almeno nella scuola, colui che ha guidato (e guida ancora!?) il pensiero scolastico progressista è don Milani. Così, nella scuola ha vinto il sapere concreto, non astratto: la semina e la potatura delle piante, invece che l’arte e la filosofia. Almeno avesse significato valorizzare e incrementare le scuole professionali! Invece no, non so per quale paradossale schizofrenia, il donmilanismo perdurante dei giorni nostri promuove da anni la licealizzazione totale: mentre da un lato esalta il sapere dell’esperienza concreta, utile (i sarmenti di don Milani), dall’altro trascura, se non contrasta, proprio la scuola professionale, a vantaggio di un liceo che però, al fine di valere per tutti, è diventato sempre più generico e omologato, un surrogato di liceo che rischia di non insegnare più niente a nessuno, né l’astratto né il concreto, né l’arte e la filosofia, né i sarmenti. Ultime domande, molto personali e accorate, sul libro di don Milani: perché non si contempla mai l’ipotesi che anche un ragazzino di umili condizioni possa amare i libri, essere per natura (e non per origine sociale!) portato allo studio astratto e umanistico? perché chi ama lo studio dev’essere per definizione un figlio di papà, un signorino bene, viziato e insopportabile? perché non si ipotizza l’evenienza che un futuro grande filosofo o scrittore o artista o scienziato possa nascere nella casa di un umile pescatore? perché deve esistere un indissolubile e ignobile connubio tra amore per la cultura e censo elevato, come se solo chi ha i soldi potesse amare lo studio? Perché, insomma, continua ancora oggi e più che mai l’idea che solo i ragazzi di classe alta vadano bene a scuola? Oggi, che è esattamente il contrario: studiano poco coloro che hanno le case piene di libri, e prendono i voti migliori i ragazzi romeni, per esempio! 2. Rodarismo Nel 1973 esce La grammatica della fantasia. Con questo libro Gianni Rodari ci indica come si possa fare una scuola della fantasia dove, attraverso le parole e il loro libero gioco, i bambini arrivino a scrivere, a produrre in proprio filastrocche, favole, poesie, racconti. È l’idea di un vero e proprio metodo didattico alternativo, impostato sullo smontare e rimontare un testo, partendo dalle parole, e giocando all’infinito sul senso e il nonsenso, attraverso tutto un armamentario magico e divertente: la rima, la filastrocca, l’analogia, l’associazione tra immagini lontane, l’assurdo, il paradosso, il surreale, l’errore, la combinazione fortuita... In una parola, il gioco. Il gioco di parole, innanzitutto. È una rivoluzione. Rodari diventa il maestro della fantasia e con i suoi libri, forse anche involontariamente, forma migliaia e migliaia di maestri e maestre, in questi ultimi quarant’anni. Possiamo dire che egli ha creato la scuola elementare così com’è oggi (e forse anche l’asilo e la scuola media...). Citiamo un esempio dal suo libro, un esercizio di fantasia che si può fare in classe. Si prende una lavagna ribaltabile. Sulla facciata visibile un bambino scrive la parola «cane», sulla facciata nascosta un altro bambino scrive una sua parola, che non si vede. Poi si ribalta la lavagna e si legge la parola nascosta: «armadio». Risata generale. Perché? Perché era imprevedibile, e perché c’è distanza tra un cane e un armadio: è quel che Rodari definisce un «binomio fantastico». «Quell’armadio» scrive «facendo coppia con un cane, era una scoperta, un’invenzione, uno stimolo eccitante.» Di lì, da quel binomio, se siamo bravi uscirà una storia bellissima. La maestra conduce il gioco e i bambini allegramente partecipano. L’idea implicita nel metodo rodariano, l’idea sotterranea (ma poi neanche tanto) era che la scuola dovesse smettere di fare cose noiose tipo la grammatica, per mettersi invece a educare alla libera facoltà creatrice. Anzi, peggio: quel che Rodari esplicitamente dice è che fare cose noiose e tristi come la grammatica spegne addirittura, nei bambini, lo slancio creativo. Racconta per esempio di un gioco molto utile a favorire la logica fantastica, è il gioco delle 5 parole + 1, ovvero: il maestro dà ai bambini cinque parole in serie che suggeriscono una fiaba nota (tipo: bambina, bosco, fiori, lupo, nonna, per Cappuccetto rosso) più una sesta parola che non c’entra niente (tipo: elicottero). Andò personalmente a sperimentarlo in una classe, e sentite come lo racconta: «Ho provato a servirmene durante un incontro con certi bambini di seconda elementare piuttosto ’bloccati’ da una routine scolastica della peggior specie (copiature, dettati e simili) insomma, nelle condizioni peggiori. Avevo tentato invano di far nascere da loro una storia: impresa difficile...» 10 Che cosa ne deduciamo? Che far fare alle elementari esercizi di copiatura e di dettato è quanto mai esecrabile, vecchio e triste: è una «routine scolastica della peggior specie» che blocca e spegne la fantasia. Domanda: quante maestre pensate che, dopo una lettura simile, abbiano ancora avuto voglia di far grammatica? Era un bellissimo messaggio, quello di Rodari, soprattutto molto fascinoso: come resistergli? Il fatto è che Rodari era un grande scrittore. Voglio dire che era soprattutto un grande scrittore, e quindi naturalmente amava la fantasia e voleva «passarla» agli altri. Andava nelle classi, credo, animato da questa sua passione e cercava di cambiare il mondo, a volte ristretto, dei ragazzini chiusi in una classe a fare un lavoro che gli pareva infinitamente più triste e più misero che creare favole. Tra l’altro, lo racconta lui stesso, metteva in atto delle vere e proprie strategie antiscolastiche nei suoi incontri. Per esempio si sedeva per terra tra i bambini o montava su una sedia: «gesti necessari per rompere l’atmosfera burocratica creata dalla presenza del maestro...». Ancora oggi, e anche al liceo, vedo fare cose del genere: rompere l’assetto dei banchi, far mettere i ragazzi seduti in cerchio, sono mille i modi per dire sempre la stessa cosa: che la scuola non sta facendo scuola, che siamo tutti pari e tutti amici e che, se mai qualcosa verrà insegnato, lo si farà giocando. Era giusto quel che faceva Rodari? Non era né giusto né sbagliato: lui era lui e, ripeto, faceva lo scrittore. Anche qui: come solo don Milani poteva fare scuola «alla don Milani», così solo Rodari poteva fare scuola «alla Rodari». L’importante per lui era l’allegria, era fare una scuola divertente dove si potesse soprattutto ridere e giocare. Quel che più gli stava in odio era una scuola plumbea, triste, noiosa, che rovina gli anni meravigliosi della fanciullezza (come già deprecava Leopardi): «Nelle nostre scuole» scrive Rodari, «generalmente parlando, si ride troppo poco. L’idea che l’educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere». Le mie furiose maestre di Napoli sarebbero perfettamente d’accordo, credo. Così come è stata perfettamente d’accordo la scuola italiana (elementare) in generale degli ultimi decenni: sull’onda di un rodarismo genericamente inteso, ha cominciato a pensare che fare grammatica fosse male, e scrivere favole tutti insieme fosse molto meglio. La conseguenza diretta è stata che di colpo abbiamo ritenuto noiose materie come la grammatica, la storia, la letteratura, e abbiamo deciso quindi di non farle più, o di farle meno. O di farle senza grande convinzione. O di trasformarle in una versione più allegra e divertente: in un gioco, appunto. Così, abbiamo dato inizio alla «scuola del gioco»: la scuola è gioco, l’insegnante insegna giocando e gli alunni giocano imparando, e tutti sono felici e contenti. Il messaggio, insomma, è stato che, se non si gioca, non va bene e che tutto ciò che non è divertente è da buttare (vedi serietà, fatica, lavoro e studio: tutta roba molto disdicevole). È stato un fraintendimento? Un’esagerazione? Non lo so. Forse abbiamo permesso che si creasse un involontario corto circuito: abbiamo pensato che il verbo giocare potesse sostituire (quasi completamente?) il verbo studiare. Che il gioco fosse di per sé formativo, e da solo bastasse come migliore modalità di apprendimento e di crescita. È come se avessimo, così (senza accorgercene?), operato una frattura insanabile: da una parte il nozionismo bieco e oscurantista, e dall’altra l’aerea e allegra arte di fantasticare. Mah... Oggi la pensiamo ancora così? Siamo sicuri che debbano essere due parti contrapposte? Che fosse giusto separarle? E se la fantasia invece fosse qualche cosa di molto logico e razionale, se avesse bisogno di un pensiero strutturato e di molte conoscenze? Se la fantasia nascesse, insomma, proprio dal rigore, dalle regole, dal sapere, anche quello oggi ritenuto più piatto? Eliot diceva che non si dovrebbe cominciare a scrivere poesie prima dei venticinque anni, non prima cioè d’aver letto quei secoli di poesia che ci precedono. Ungaretti, colui che rivoluziona la poesia del Novecento sovvertendo la metrica e la sintassi tradizionale, arriva da anni di studio e di frequentazione della grande letteratura europea del passato. Approda al lampo rivoluzionario del «M’illumino / d’immenso » dopo aver conosciuto Góngora, Shakespeare, Petrarca, Mallarmé, Leopardi... Basta leggere le sue decine di saggi critici: nessun poeta è più colto di Ungaretti, che pur ci sembra tanto semplice e spontaneo! Se davvero volessimo educare alla «creatività», non dovremmo insegnare prima di tutto, umilmente, le basi di una lingua e il canone di una tradizione? Non dovremmo, prima di far scrivere un solo verso o pagina, insegnare non dico a fare le aste, ma almeno a incolonnare i numeri, scrivere in bella grafia, analizzare logicamente la lingua, riassumere, tradurre, parafrasare, studiare, nonché a leggere per anni i grandi scrittori del passato? Soprattutto oggi, che abbiamo davanti classi di ragazzi ormai muti, afasici, incapaci di esprimersi, di capire quel che leggono e di costruire un testo dotato di un minimo senso... Gramsci lo diceva nel 1932 che la grammatica era importante. Esortava a uno studio rigoroso, e difendeva le lingue antiche dall’accusa di essere aride e meccaniche: «Si ha a che fare con ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza, di compostezza anche fisica, di concentrazione psichica su determinati soggetti che non si possono acquistare senza una ripetizione meccanica di atti disciplinati e metodici».11 Diligenza, esattezza, compostezza, concentrazione... Parole che abbiamo espunto dal nostro vocabolario per sempre. È da poco uscito un libro, curato da Erminia Ardissino, che, nell’ambito della didattica, mi pare si discosti dalle posizioni solite. È rivolto principalmente ai maestri elementari e agli studenti di Scienze della Formazione, e sostiene la tesi secondo cui sia bene far leggere fin da subito, fin dai primi anni di scuola, le poesie dei grandi poeti, Pascoli e Leopardi, Saba e Gozzano, Montale e Luzi: «Per poesia non si intendono genericamente le filastrocche o i versi d’occasione, tanto usati nella scuola, ma i componimenti dei poeti italiani, che costituiscono l’espressione più alta della nostra lingua e cultura». E ancora: «Dagli studi più aggiornati, riguardanti l’apprendimento linguistico, risulta evidente che per imparare a capire e a esprimersi, nello scritto e nel parlato, non solo correttamente ma anche efficacemente, occorre misurarsi con modelli complessi. La letteratura in generale offre questa possibilità: obbliga a interpretare, individuare gli enigmi del testo, penetrare nelle sue sottili sfumature».12 La fantasia, insomma, forse è un risultato finale, non un inizio. Ed è il risultato di un lavoro lungo e rigoroso, sulla lingua, lo stile, le regole, la tradizione. Se non si maneggia il linguaggio, se non si passano anni a studiare, immagazzinare nozioni, eseguire esercizi, leggere libri, annotare pensieri, ripetere lezioni e anche annoiarsi, cosa mai si può creare? Ma questo sarebbe un discorso controcorrente e difficile, e noi spesso, un po’ vigliaccamente, preferiamo non farlo. Preferiamo dire che scrivere è alla portata di tutti, e invitiamo subito i nostri allievi a provarsi nella cosiddetta «scrittura creativa», appena sanno tenere una penna in mano, e subito li elogiamo per quanto sono bravi. Organizziamo corsi, lezioni, laboratori, stage. E concorsi! Negli ultimi venti-trent’anni c’è stato un vero e proprio boom di concorsi nelle scuole. Premi, certamina, gareggiamenti vari. Regionali, nazionali, comunali, o interni alla singola scuola, o plesso o comprensorio o circolo didattico che sia. Disegna il paesaggio, Colora le tue emozioni, Racconta una favola, Scrivi le memorie dei tuoi nonni, Componi un sonetto sul tuo gatto, Ambienta una storia all’epoca di Roma antica... Sono infiniti i temi in cui provarsi. Classi intere, migliaia e migliaia di ragazzi ogni anno occupati per mesi a prepararsi a concorsi del genere, inventando, creando, raccontando, colorando, ambientando, ritagliando, appendendo, recitando... Gli insegnanti amano molto i concorsi. Ho conosciuto, girando per l’Italia, moltissimi colleghi (perlopiù di elementari e medie) che si dedicano abitualmente ai concorsi scolastici: alcuni hanno collezionato anche dieci o venti vittorie, con le loro classi, di cui giustamente si sentono fieri. Anche i ragazzi, e le loro famiglie, amano molto i concorsi: vuol dire impostare un progetto, lavorare per gruppi, inventare insieme qualcosa, puntare a una meta, a una vittoria. Il concorso scolastico è l’emblema della scuola così come oggi ci piace: creativa, collettiva, democratica, divertente, gareggiante. Attraverso un concorso, però, si svicola tutti (insegnanti e allievi) dalla normale e noiosa programmazione didattica. Si esce, ancora una volta, da quello che è ritenuto un piatto e tedioso nozionismo per approdare alla creatività libera e gioiosa. L’insegnante, col pretesto di un concorso ad esempio sul tema dei diritti umani, può smettere di fare pedestremente il programma di grammatica e letteratura, può evitare di sudare per ore cercando di far entrare una pagina nella zucca dei suoi bambini, parola per parola, così come lo studente può smettere di spaccarsi la suddetta zucca sui libri, e tutti insieme possono invece, insegnanti e studenti, serenamente dedicarsi alla divertente e stimolante creazione di uno spettacolino teatrale – o di un grande manifesto colorato, o di un testo poetico o musicale a più voci, o di un articolo o dossier giornalistico, dipende dalla forma in cui sceglieranno di esprimersi. Molto meglio inventare tutti insieme una storia in classe che studiare i verbi a memoria o le guerre puniche. Il concorso scolastico può essere (spesso, non dico sempre!) il pretesto per un’autoaffermazione dell’insegnante, schiacciato dalla piatta e banale programmazione standard. Ed è comunque, per i ragazzi, quel che si suol dire «una fantastica esperienza», non tanto nel senso di un’acquisizione di conoscenze, bensì come esercizio di lavoro collettivo, e come momento di vita insieme. Pensiamo alla gita finale per andare a prendere il premio, con tanto di viaggio in treno, cerimonia sul palco, targhe, onorificenze, panini e canti corali. È un’esperienza: insomma, attiene al vissuto e non al libresco, e quindi di per sé è positiva. In più, è un’esperienza creativa. E la parola «creatività» ci piace da morire, da anni. È una parola ambigua e fumosa, ma molto allettante. L’abbiamo estesa a tutti, perché mal sopportiamo che solo alcuni siano in grado di «creare». L’idea di genio è troppo romantica per noi, troppo poco democratica. La scuola di massa deve, secondo molti di noi, insegnare anche la genialità che, perché faccia meno paura, chiamiamo creatività. Patrizia Valduga scrive, sul «Corriere della Sera» del 30 maggio 2010: «Creatività e poesia: sono queste, per me, le due parole chiave del nostro tempo pseudodemocratico. La prima è intesa come una sorta di inventività congenita del genere umano. Se un tempo esistevano la fantasia, l’immaginazione, l’estro, adesso c’è solamente lei, e sotto le sue insegne passano soprattutto pressappochismo, dilettantismo, velleitarismo ». Il grave è che spesso ci capita di premiare opere davvero modeste, mediocri, insignificanti o, peggio che mai, sbagliate, imperfette. Dovremmo non premiare nessuno, ma ci dispiace, ci sembra una buona occasione perduta. E allora distribuiamo comunque premi. Per affetto, per generosità, per essere amici, per far vedere che tutti ce la possono fare, per premiare noi stessi... Abbiamo le migliori intenzioni. Ma produciamo, con questo nostro comportamento, danni gravissimi: mandiamo il messaggio che sia tutto facile, e illudiamo i ragazzini di possedere abilità che invece non possiedono. Inoltre, non coltiviamo in loro alcuna capacità di giudicare, di distinguere ciò che è bello e vale da ciò che è brutto o vale poco; e togliamo loro la felicità di «diventare» lentamente, dopo anni e solo a forza di studio e fatica ed esercizio. Li derubiamo dell’attesa, di quella lenta e misteriosa meraviglia che si chiama crescere. È come se dicessimo a un germoglio di quercia alto venti centimetri: che bell’albero alto e forte sei! Quale voglia più dovrebbe avere, quel povero ramo, di metterci quarant’anni per diventare davvero una quercia? Torniamo a Adorno. Lui diceva che l’unica alternativa al consumismo è l’arte. La scuola della creatività rivendica un grande spazio per l’immaginazione nella vita scolastica dei ragazzi. È la stessa cosa? Direi di no. Adorno non rinnega il privilegio, sa che l’arte è per pochi, ma innesca la sfida, altissima: che la scuola non ha raccolto, e che era quella di educare proprio a quella altissima possibilità per pochi. Per questo suo ideale estremo, Adorno fu giudicato, dai giovani rivoluzionari sessantottini, elitario e borghese. E fu, alla fine, rifiutato. 3. Pedagogia democratica Nel 1975, due anni dopo il libro di Rodari, escono le Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, un documento di «pedagogia linguistica democratica» redatto dal GISCEL (Gruppo d’Intervento e di Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica). Nella quinta di tali tesi troviamo una critica alla pedagogia linguistica tradizionale, accusata di puntare «i suoi sforzi in queste direzioni: rapido apprendimento da parte dei più dotati di un soddisfacente grafismo e del possesso delle norme di ortografia italiana, produzione scritta anche scarsamente motivata (pensierini, temi), classificazione morfologica delle parti della frase (analisi grammaticale); apprendimento a memoria di paradigmi verbali, classificazione cosiddetta logica di parti della frase...». Traducendo in linguaggio più piano, direi che si tratta di un atto di accusa ben preciso nei confronti della scuola tradizionale, incolpata di insegnare i verbi, l’ortografia, l’analisi logica e la sintassi, per di più «ai più dotati»; di essere cioè una scuola «inefficace, parziale e nociva», utile soltanto agli «allievi delle classi sociali più colte e agiate» e non a quelli «provenienti dalle classi popolari, operaie, contadine». All’opposto, la nuova pedagogia democratica afferma: «Buona parte degli errori di lettura e di ortografia dipendono da scarsa maturazione della capacità di coordinamento spaziale, essi dunque vanno curati, dopo attenta diagnosi, non insegnando norme ortografiche direttamente, ma insegnando a ballare, ad apparecchiare ordinatamente la tavola, ad allacciarsi le scarpe (queste sono ovvietà scientifiche sconosciute alla nostra tradizionale pedagogia linguistica, che è verbalistica, ossia ignora tutta la ricchezza e primaria importanza dei modi simbolici non verbali)» (cfr. tesi 7, alla lettera f). Se ho ben capito, tradurrei così: la scuola tradizionale è verbalistica, poggia cioè ancora sulle parole, e quindi insegna l’ortografia in modo diretto, cioè insegna a scrivere le parole in modo corretto. In realtà lo fa perché è vecchia (usa le parole) e ignorante: ignora cioè certe «ovvietà scientifiche », tra le quali appunto il fatto che l’ortografia si può benissimo imparare in modo indiretto e non verbale, per esempio ballando, apparecchiando la tavola e allacciandosi le scarpe. Ha prevalso un’idea politica di scuola, in cui cultura è una parola negativa, intanto perché è ancora gentilianamente intesa come cultura solo umanistica (di qui gli sforzi attuali per dare più spazio alle materie scientifiche, in una sorta di battaglia anti-gentiliana), e poi perché è vista alla don Milani, come mero appannaggio delle classi privilegiate: solo i bravi e ricchi Pierini vestiti in giacca e cravatta scrivono le parole in modo corretto, accedono cioè alla cultura, e quindi la cultura in generale (e la grammatica in particolare) per forza diventa il nemico da combattere. Quest’ottica politica ha fortemente segnato ogni discorso sulla scuola, e ha portato al paradosso surreale per cui grandi esponenti della cultura italiana più alta, in nome di una battaglia politica, negando quasi e tradendo il loro mestiere di studiosi e scrittori, hanno aiutato a distruggere gli aspetti più squisitamente culturali della scuola: ad esempio la scrittura. È nota la battaglia di De Mauro contro il tema d’italiano. Ricordo un suo intervento a un convegno sull’insegnamento dell’italiano nelle superiori, che si tenne a Torino, dove egli sostenne che alle superiori bisognava smettere di far fare temi e cominciare a insegnare a redigere verbali. Era il 2000, eravamo in piena era luigiberlingueriana, ovvero completamente dentro la riforma del ministro Luigi Berlinguer, di cui uno dei tratti sicuramente più importanti fu la perfetta sintonia (imprevedibile davvero!) con il mondo del lavoro (una vera e propria alleanza di quel Ministero di sinistra con la Confindustria?): si voleva una scuola utile, dei saperi pratici, concreti, spendibili. Non una scuola dei saperi inutili, legati a una cultura astratta e inservibile per le imprese e i servizi. Si trattava quindi di insegnare ai ragazzi le scritture utili, quelle che il mondo del lavoro avrebbe loro richiesto dopo la scuola. Non più le scritture fumose e inutili legate all’ambito del letterario, tipo: Riflessioni sulla poesia del Foscolo, o Ritratto di me stesso, o Il significato del viaggio da Ulisse ai giorni nostri. Redigere verbali, scrivere lettere commerciali, avvisi alla clientela, documenti tecnici: questo andava fatto. (Tra parentesi, vorrei dire quanto tutto ciò fosse nell’ottica di un clamoroso abbaglio, di cui l’America per esempio si sta da qualche anno rendendo conto appieno: gli americani cercano ormai di prendere le distanze da una formazione tutta appiattita sul presente e sull’utile, immediatamente e concretamente spendibile; stanno rivalutando gli aspetti più preziosi di una cultura apparentemente «inutile», ad esempio molte imprese decidono di formare i loro manager a colpi di cultura classica, anche predisponendo periodi di studio a base di filosofia, lingue classiche, lettura dei grandi capolavori letterari; periodi di solitudine coatta, al fine di favorire al massimo la concentrazione e la meditazione, al limite della reclusione vera e propria in spazi appositamente scollegati e remoti, quali monasteri e deserti...) Credo che l’idea di De Mauro avesse una sua ragion d’essere proprio in quanto legata alle richieste (confindustriali?) del tempo. Ciò non toglie che fu un colpo mortale alla scrittura, al libero esercizio dell’espressione verbale scritta, in particolare dell’espressione che si basa maggiormente sulle capacità logico-argomentative, di costruzione e strutturazione del discorso. Il tema classico, per quanto esercizio criticabile, era comunque un ottimo campo in cui esercitarsi nella creazione di un discorso critico. Scrivere un tema voleva dire saper argomentare una tesi, essere capaci di distendere il proprio pensiero in argomenti logicamente legati tra di loro e tendenti a un fine preciso chiamato senso. Era l’opportunità di esprimersi. Invece ora si voleva una scrittura capace solo di informare, descrivere, riassumere, incollare pezzi di testo tra di loro. Infatti, la nuova modalità della prova scritta di italiano all’Esame di Stato prevede non solo un semplice titolo ovvero tema su cui scrivere, ma anche, per altre tipologie, pagine di documenti fotocopiati (brani di autori, stralci di articoli, romanzi, poesie) con note a piè di pagina, schede illustrative, notizie bio-bibliografiche. Lo studente può non sapere più nulla, tutto gli viene dato. È stato un colpo mortale non solo all’arte di scrivere, ma anche alla pratica di studiare, allo studio come capacità di trattenere e rielaborare nozioni. E quindi, al sapere. È stato l’inizio di una scuola delle verifiche e dei test, delle prove oggettive; una scuola tecnico-pratica, che mi chiedo come possa mai arrivare ad appassionare qualcuno... Sconsolante, ad esempio, per tutti quei ragazzi che siano particolarmente attratti dalla scrittura e magari anche naturalmente dotati nell’arte di esprimere i propri pensieri e sentimenti: oggi costoro sono obbligati a una scrittura scialba, tristemente utile-pratica, finalizzata a qualche uso, valutata oggettivamente, costretta in un numero di righe chissà perché prestabilito e fisso; è l’egemonia dell’articolo di giornale e del saggio breve: testi costruiti a partire da pagine e pagine di documenti forniti ad hoc, sulla base dei quali è semplicemente richiesto un riassunto, un’analisi, un collage. Oggi questi ragazzi sono infatti – basta ascoltare i loro drammatici e rassegnati resoconti — infelici e frustrati, stufi di non trovare mai alcun modo per poter provare quanto valgono ed essere quindi adeguatamente apprezzati. Ma forse costoro altro non sono che gli eredi dei Pierini tanto odiati, i potenzialmente bravi che sicuramente appartengono alle classi alte: e quindi andavano a ogni costo fermati, abbassati, annientati... Mi stupisce che negli ultimi tempi tanto si deplori lo svilimento dell’istruzione pubblica, e vanamente ci si interroghi sullo stato d’ignoranza dei nostri attuali studenti, senza trovare una risposta. Riflettiamo. Se gli insegnanti della «pedagogia linguistica tradizionale» sono stati ritenuti «esecutori del progetto politico della perpetuazione e del consolidamento della divisione in classi vigente in Italia» (così il GISCEL alla tesi 6); se fare grammatica e letteratura quindi ha equivalso a corrispondere a «fini politici e sociali complessivi della scuola di classe» (dunque non democratici...), non ci si dovrebbe stupire oggi se i nostri ragazzi non sanno né parlare né scrivere, né tantomeno ci si dovrebbe allarmare di alcun neoanalfabetismo che, anzi, dovrebbe parere perfettamente conseguente a ciò che tanto è stato desiderato e imposto. Quando la sinistra va effettivamente al governo (dal 1996 al 2001) e Luigi Berlinguer diventa ministro dell’Istruzione, i numeri dei nostri diplomati e laureati sono troppo bassi e ci fanno sfigurare con gli altri Paesi. L’Italia è in Europa, e l’Europa giudica. Bisogna trovare un rimedio, qualcosa che alzi la nostra posizione nelle classifiche. L’idea centrale della riforma Berlinguer è il «diritto al successo formativo». I giovani hanno il diritto di conseguire diploma e laurea. Se non ci riescono, se tanti non si iscrivono nemmeno e tanti altri abbandonano prima, è colpa della scuola e dell’università. Che quindi bisogna affrettarsi a cambiare. Si alzano i numeri di diplomati e laureati, ma si capovolge drasticamente il concetto stesso di istruzione: da dovere, qual era sempre stato, a diritto. Nascono di qui la riforma della scuola secondaria e il nuovo sistema universitario del 3+2, che di fatto, se non nelle intenzioni, abbassano inesorabilmente il livello di istruzione reale. È stato l’ultimo atto del cambiamento: iniziato alla fine degli anni Sessanta, il processo si conclude qui, con la riforma Berlinguer. Dopo, si sono succeduti governi di destra e di sinistra, ma nulla di sostanziale è più cambiato, le ideepilastro sono state piantate una volta per tutte. E, volendole alla rinfusa elencare, direi che sono le seguenti: l’obbligo scolastico il più possibile esteso, il tempo in classe il più possibile «pieno», la fede nelle nuove tecnologie multimediali, la predominanza del metodo di studio sui contenuti dello studio, l’importanza dell’apprendimento e non dell’insegnamento, la centralità dello studente, l’autonomia scolastica, il POF ovvero Piano dell’Offerta Formativa, elenco di tutte le attività e progetti extra che ogni singola scuola desidera offrire alle famiglie (dette Utenza), al di là delle semplici e viete e tristemente tradizionali materie di studio, diventate il simbolo di una scuola vecchia da buttare. In breve, si delinea come nuova una scuola che punti alla socializzazione e si alleggerisca dei contenuti più marcatamente culturali: era previsto, nei documenti della riforma Berlinguer, che l’insegnamento del latino fosse «affidato a resoconti in chiave moderna», che lo studio della letteratura italiana fosse abolito negli istituti tecnici (che, in compenso e paradossalmente, si sarebbero chiamati licei) e che piuttosto s’insegnasse a «saper scegliere e gustare le proprie letture». Riduzione dei contenuti, dunque, deculturalizzazione e deverbalizzazione: con vittoria conseguente delle verifiche a crocetta, delle animazioni visive e teatrali e soprattutto dei videogiochi. Maragliano, il presidente della commissione berlingueriana dei quaranta saggi, così scriveva: «Il videogioco è la più grande rivoluzione epistemologica di questo secolo. Ti dà una scioltezza, una densità, una percezione delle situazioni e delle operazioni che puoi fare al loro interno che permette di esaltare dimensioni dell’intelligenza e dello stare al mondo finora sacrificate dalla cultura astratta».13 Più chiaro di così! Se nel 1975 la Nuova Pedagogia Linguistica dice che invece di fare ortografia si deve insegnare ai bambini ad allacciarsi le scarpe, e se alla fine degli anni Novanta la commissione dei «saggi» esalta il videogioco contro la cultura astratta, credo che la direzione sia chiara: ha stravinto la scuola del fare, del saper essere, del saper stare (insieme), dello smanettamento collettivo e dell’invasamento tecnologico, non certo la scuola del sapere, delle nozioni (intese come conoscenze), della letteratura e dello studio astratto, teoretico. L’antinozionismo tanto invocato negli anni Sessanta trova qui il suo perfetto compimento, e definitivamente trionfa. CAPITOLO TRE I nuovi mostri: famiglia, Europa, Internet 1. Sotto l’ala della famiglia Oggi l’ideologia è morta, lo sappiamo. Non è più questione di destra e sinistra. Si è imposto però un certo clima, un’impalpabile atmosfera fatta di opinioni diffuse, luoghi comuni e un moralismo perbenista-progressista. Qualcosa che va al di là degli svariati esiti elettorali e dei governi che si succedono; qualcosa di meno che una vera e propria ideologia: direi «un’aria di sinistra», un certo sapore di progressismo allargato e sparso, aleggiante un po’ dovunque, e che di sinistra vera ha ormai ben poco. È come se ci si ritrovasse post-sessantottini senza aver fatto il Sessantotto, iscritti di fatto a un progressismo di maniera univoco e leggermente totalitario, a un «clima progressistico generico» a cui null’altro si contrappone. L’ideologia si è polverizzata, ma quella polverina sospesa ha impregnato di sé tutto l’ambiente circostante (l’Italia, l’Europa), ha imbevuto le menti, intriso gli animi: così che a poco a poco s’è imposto una specie di generalizzato «stato d’animo di sinistra». Un comune sentire, un conformismo mentale da benpensanti buoni e corretti, impossibile da contrastare. Così è, soprattutto nella scuola, oggi. Domina un «pensiero scolastico genericamente progressista», un muro difficile da scalfire. I suoi capisaldi sono alcuni punti cardine, direi quattro leggi indiscutibili: 1) la scuola non deve insegnare nozioni; 2) la scuola deve motivare allo studio (possibilmente divertendo); 3) la scuola deve far andare avanti tutti senza selezionare; 4) la scuola deve essere utile, e servire essenzialmente a trovar lavoro. Tale pensiero è talmente diffuso che non ha più bisogno di autori, di intellettuali che se ne facciano carico in modo esplicito: tutti ormai la pensano così. O meglio, se esiste un pensiero contrario o parzialmente non consono, non ha però la forza di manifestarsi, forse sonnecchia in qualche tana, rumoreggia blandamente, o si limita a emettere, ogni tanto, un quasi impercettibile flebile fischio. Come le marmotte in montagna, un sibilo gentile, discreto, quasi muto. In quest’aria diffusamente progressista, la famiglia di oggi ha trovato il suo perfetto habitat. Forse senza volerlo, si è trovata «naturalmente» d’accordo con la scuola del postsessantottismo progressista-europeista: per una strana combinazione delle cose, la Nuova scuola e la Nuova società del benessere scoprono tra di loro insospettabili affinità elettive. Dagli anni Novanta in poi, le famiglie possono appartenere a qualsiasi partito o corrente, possono anche non saperne niente del Sessantotto e della sinistra, mai aver letto don Milani o Rodari, mai esser scese in piazza a contestare alcunché, mai aver esaltato il ministro Berlinguer; ma sentono comunque nell’aria l’antinozionismo e l’indulgenza e il mito tecnologico, li respirano a pieni polmoni, e li cavalcano per i propri scopi del tutto individualistici e per niente politici. In poche parole, alle famiglie sta benissimo che la scuola non sia più così severa, intransigente ed esigente, che voglia essere nuova e moderna e decida, per quest’opera di autosvecchiamento, proprio di dismettere lo studio e la disciplina. Voglio dire: le giuste e profonde aspirazioni progressiste si sono, snaturandosi e polverizzandosi, inevitabilmente mescolate agli appetiti consumistico-edonistici del nuovo ceto popolar-benestante, e hanno fatto bum! Un esplosivo devastante. Negli anni Ottanta-Novanta le famiglie hanno raggiunto un certo benessere e intendono goderselo. Se la scuola dà meno compiti, se dà poche insufficienze, e se comunque poi le recupera con appositi corsi di recupero, va benissimo: la famiglia così ha più agio di andare in montagna e al mare, fare viaggi, comprare computer e telefonini, fare shopping in centro e negli outlet. Ma soprattutto, se la scuola fa meno studiare e più giocare, se la scuola diventa un centro di socializzazione dove stare insieme e trovare amici e mostrare gadget e vestiario, se quindi i figli vanno volentieri a scuola, i genitori si sentiranno sollevati: la loro spinta edonistica e narcisistica non sarà in contrasto con la vita dei figli: tutti insieme allegramente, il benessere psico-fisico-sociale è condiviso, e i figli possono dunque diventare i re del consesso famigliare, ed essere al meglio coccolati e vezzeggiati. Voglio dire che una società del piacere ha bisogno di una scuola del piacere, non certo di una scuola della sofferenza o della fatica! Cioè, se la società adulta a un certo punto ha cominciato a intendere la vita come divertimento-intrattenimento, svago perenne e ricerca della propria autoaffermazione, successo e felicità, la scuola non poteva certo rimanere una faccenda seria, barbosa ed esigente, in cui per esempio si dovesse studiare molto... (o meglio, poteva benissimo rimanere tale, ma ha scelto di no!) Faccio un solo esempio, tanto per essere un po’ concreti: se la famiglia permette al figlio (o figlia) quindicenne di tornare dalla discoteca alle quattro di mattina, e se il papà (o la mamma) si mette persino la sveglia alle tre per andare a prenderlo, che cosa pensate possa mai fare la scuola? quale impegno può pretendere, quale disciplina, quale senso di responsabilità e di autonomia? Fine del piccolo esempio. Inizia in quegli anni anche l’inversione di responsabilità: se i figli non studiano, la colpa è degli insegnanti che non li sanno motivare. Sono gli insegnanti i responsabili dell’insuccesso scolastico, e vanno infatti valutati e formati ex novo. Valutati non su quanto sanno e su come fanno lezione, ma su quanto sono bravi a innovare, sperimentare, aprire al «territorio » (famigerato territorio! chi ha inventato questa parola?). Non sono abbastanza nuovi e moderni, se non sanno divertire, se non aprono la scuola all’esterno, con viaggi di istruzione, uscite didattiche e interventi di esperti nelle classi. Tutto questo armamentario esogeno diventa la scuola preferibile ed elogiabile, la super-scuola di cui i genitori vanno orgogliosi e che ben si adatta al loro conquistato super-benessere. A nessuno importa più il solito banale insegnamento, le solite trite materie e i soliti tetri programmi. Importa l’extra, il di più, il «creativo», il divertente. A nessuno importa se al figlio viene insegnata o no, e come e quanto, la lingua italiana; importa che si faccia teatro in classe, e si vada alle mostre, e siano assicurati i viaggi di istruzione, possibilmente all’estero: quella è una scuola creativa, nuova, che apre le menti; l’altra è la scuola vecchia, inutile, noiosa. Quando ricevo i genitori dei miei allievi di prima liceo che prendono 4 nel tema e 2 in analisi logica, tocco con mano il loro disarmato stupore. Chiedo che razza di scuole abbia fatto il figlio e mi rispondono sinceri: Ma ci sembrava una scuola così buona... si facevano così tante cose divertenti... nostro figlio ci andava così volentieri... Appunto! Forse se facevano grammatica era meglio, ma tu, genitore, o eri ideologicamente d’accordo che non la facessero, o non ti sei neanche posto il problema di vedere se la facevano o no, perché a te per primo della grammatica non importava niente, tu non hai ritenuto fosse bene che tuo figlio la studiasse e quindi non l’hai mai chiesto ai suoi insegnanti. I quali, naturalmente, hanno preferito far altro, molto più divertente, ad esempio inventare favole tutti insieme o giocare al teatro. Così tuo figlio adesso è un problema squisitamente nostro, tant’è vero che ci chiedi: E adesso come si fa a venirne fuori, cosa mi consiglia? Cosa vuoi che io ti possa consigliare? Mi verrebbe da risponderti: Caro genitore, adesso abbiamo esattamente quel che abbiamo voluto, che problema c’è? Invece, siccome il problema c’è, gli facciamo i corsi di recupero, a tuo figlio, perché la legge ce lo impone. E tu lo sai, e ce lo chiedi sfacciatamente: Quando li iniziate i corsi di recupero? quante ore al giorno? per quanti mesi? Ieri il genitore non è stato per niente esigente per quel che riguardava i programmi (se n’è fatto allegramente due baffi di che cosa insegnavamo o meno al figlio), ma oggi invece è totalmente esigente per quel che riguarda tutti quei diritti che burocraticamente tutelano e vezzeggiano il figlio. Ad esempio ai consigli di classe (momento in cui, a scadenza più o meno bimestrale, gli insegnanti di una classe incontrano i genitori dei loro allievi), l’ordine del giorno è cambiato. Una volta era: la preparazione dei ragazzi, i programmi, i libri da leggere, le ricerche, lo studio, la disciplina. Oggi è: i viaggi di istruzione, i corsi di recupero, gli stage extra, le verifiche, la trasparenza dei voti, gli sportelli aperti, le ore di ascolto, l’orientamento e il riorientamento. In una parola: i servizi. L’offerta. L’infinita offerta di servizi. Che cosa di succulento offriamo al servizio dello studente e della sua famiglia. È una scuola pronto soccorso (o gastronomia) che si chiede, non una scuola di cultura: una scuola che aiuta e soccorre e medica o ingozza di leccornie, non una scuola che insegna. Una scuola che dà brioche, non semplice pane: l’extra e il superfluo, prima che le nozioni di base. Negli anni Novanta, forse sulla spinta dello slogan berlingueriano del «diritto al successo formativo», i figli cominciano a essere difesi a oltranza: tutto è loro dovuto, soprattutto il cosiddetto «successo scolastico», il fatto che escano promossi dalla scuola, e nulla sia più colpa loro. Guai all’insegnante che ancora minimamente osi vessarli con interrogazioni a sorpresa, compiti difficili o, peggio che mai, umiliarli o demotivarli con brutti voti. Si va subito a protestare dal preside fino a che sarà l’insegnante a essere, più o meno gentilmente, ripreso, e a volte anche, nei casi più fortunati, allontanato dalla classe. I genitori che sindacalmente si schierano dalla parte dei figli sono forse il fenomeno più devastante nel mondo scolastico degli ultimi vent’anni. Di lì non si torna indietro, e non si farà più nulla di buono. Di lì la scuola ha perso la sua autorità, e autorevolezza, e funzione: ha sbracato! Oggi teme continuamente le proteste e i ricorsi delle famiglie, dette «utenza». L’utente, come il cliente, ha sempre ragione (forse perché l’utente è il cliente...). Quindi la scuola si premunisce a priori, e mette in atto, a tutela di se stessa, molteplici meccanismi che io chiamerei di «preventiva assicurazione contro ricorsi». Ad esempio noi insegnanti siamo oggi obbligati a: trascrivere su un’apposita scheda i voti che diamo sul registro; controllare che tale scheda-voti sia mensilmente firmata dal genitore; avvertire il genitore (già informato dalla scheda-voti) per telefono o per lettera raccomandata che il figlio sta prendendo delle insufficienze; avvertirlo, per telefono o per lettera, che tali insufficienze potrebbero portare alla sospensione o bocciatura; avvertire verso fine maggio che tale evenienza potrebbe essere molto realistica; avvertire che tale evenienza si è davvero realizzata; quindi convocare i genitori per la pagella finale con la quale li si avverte definitivamente (ma in gran segreto, perché sui tabelloni esposti fuori è vietato scriverlo!) di quella bocciatura o sospensione ampiamente preannunciata nei mesi precedenti. Il nostro è diventato un lavoro di pre-avvertimento perpetuo. Si comincia verso ottobre a pre-avvertire la famiglia che il figlio non apre un libro. Bene. E cosa credete che succeda? Niente. Mediamente, su dieci genitori avvertiti ne arrivano due a colloquio, e in genere per mostrarsi stupiti e quasi offesi delle insufficienze che noi osiamo dare al figlio. Mai nessuno che dica al figlio: Come ti permetti di non aprire un libro? Io ti mando a scuola, e tu non apri un libro? 2. La «scuola delle competenze» E arriviamo a oggi. Anno scolastico 2010-2011, parte la riforma Gelmini che riguarda la scuola superiore e l’università. Molte proteste, molte contestazioni, quasi esclusivamente per i tagli. Tagli alla spesa, all’orario, all’organico: in una parola, tagli alla scuola. E una scuola tagliata appare, per definizione, peggiore. Adesso, mentre finisco questo libro, siamo nel pieno della protesta studentesca contro la riforma dell’università. Studenti e operai insieme in piazza, studenti e politici insieme stesi sui binari o arrampicati sui tetti o abbarbicati ai monumenti nazionali, torri, colossei, moli antonelliane. Striscioni con la scritta: RIDATECI IL FUTURO. Mi astengo da ogni commento. Mi limito a citare un pezzo dell’articolo di Michele Boldrin, docente di Economia in varie università americane, uscito sul «Fatto quotidiano» del 3 dicembre 2010: «Le piazze e le torri d’Italia che oggi si riempiono di incazzatissimi e indignatissimi rivoltosi erano vuote sei mesi fa, un anno fa, due anni fa, eccetera. Erano ancor più vuote quando, tre o quattro anni fa, il precedente ministro, tal Fabio Mussi, contribuiva con la sua arrogante ignavia al declino della nostra università». Aggiungerei solo, di mio, che tali piazze e torri erano vuote anche dieci anni fa, quando tal ministro Berlinguer istituiva lo scellerato sistema del 3+2, con il suo seguito di crediti e saperi minimi e numero minimo di pagine minime... Fu un gran colpo allo studio, quello, non c’è che dire, insuperabile! Ma non si videro, allora, studenti protestare contro i tagli allo studio, la riduzione di libri da portare agli esami. Eppure era lì che veniva loro rubato il futuro... Ma torniamo alle superiori, proviamo a vedere cosa succederà nei cosiddetti «nuovi licei» dove, senza che nessuno – pare – se ne accorga, sta avvenendo una vera rivoluzione in campo culturale, che però, non essendo imputabile a nessun ministro e a nessun governo in particolare, desta ben poco interesse. È l’Europa l’artefice di tale rivoluzione, non saprei dire esattamente chi. Mi è capitato, nel 2009, alle soglie del varo della riforma Gelmini, di fare brevemente parte di una commissione ministeriale e ricordo che, aggirandomi per il Ministero, avevo la sensazione che fosse il palazzo del Labirinto, abitato da oscuri e latenti minotauri, annidati chissà dove, rintanati in antri protetti e imperscrutabili, impegnati, di lì, a dirigere le magnifiche sorti e progressive della nostra scuola. Invisibili, imprendibili tecnocrati, signori delle nuove tecnologie e delle strategie pedagogiche, sono loro che attualmente ci governano. Minotauri occulti, che abitano, credo, i ministeri di tutta Europa, e l’Europa nel suo centro, quel Parlamento Europeo da cui lanciano, più o meno dal 2000, i loro Trattati, Consigli, Raccomandazioni per delineare (e imporre!) sempre più chiaramente la novità del secolo: la cosiddetta «scuola delle competenze». Molto se ne parla, ancor poco se ne sa. Partono solo quest’anno, alle superiori, i corsi di formazione per gli insegnanti: a breve tutti saremo formati, de-programmati e opportunamente ri-programmati al fine di «programmare per competenze». E di lì in poi nulla della scuola sarà più com’è. Di che cosa si tratta esattamente? Ve lo spiegherei così: una volta c’era la «scuola delle conoscenze», dei programmi stabiliti, delle cose da studiare e da sapere, tipo le guerre napoleoniche, la filosofia di Kant, le poesie di Pascoli, il corpo umano, le leggi di Mendel, i teoremi di Euclide, l’elettrodinamica... Le cose, signori, chiamatele come volete, nozioni, saperi, materie, discipline, argomenti, temi: «conoscenze ». Le cose da imparare. Anche solo banalmente dove sta Istanbul, per esempio, o in che secolo è nato Petrarca o che cosa dice Leopardi ne La ginestra. Cose che si insegnavano – e si pretendeva si sapessero – senza chiedersi a che pro, in vista di quali future abilità e impieghi. Adesso invece c’è la scuola nuova, «delle competenze». Dove le cose/discipline che si insegnano/imparano non importano più in sé e in senso assoluto, ma importano in quanto «utilizzabili», applicabili a un lavoro, traducibili in situazioni concrete, insomma «spendibili». Importa non il sapere, ma il fare, o meglio il saper fare: saper risolvere problemi, saper eseguire compiti, saper agire in situazioni significative, saper digitare e navigare, saper essere cittadini e soprattutto, competenza delle competenze, saper imparare: apprendere cioè quella mirabile arte del saper apprendere all’infinito, non importa più cosa se non, appunto, l’arte dell’apprendimento in sé. Il sapere tout court non importa più a nessuno, non viene acquisito in un preciso momento della vita, ma rincorso all’infinito. Per capire meglio, vi suggerisco questo: immaginatevi un gatto che insegue un topolino a cui sia stata legata una invisibile cordicella, con la quale venga perennemente spostato in avanti. Pensate al gatto, che è sempre sull’orlo di raggiungere il topo e non lo raggiungerà mai: bene, avrà comunque appreso l’arte di saper raggiungere il topo... È questo che oggi ci importa: la capacità di rincorrere un topo, non di acchiapparlo! Perché è andata così? Perché l’Europa è grande, e i Paesi sono tanti e diversi tra di loro. In uno magari si studia Dante, in un altro Goethe, in un altro si leggono solo le favole di Andersen, chissà... Come facciamo a misurare conoscenze così relative e caduche? Infatti, non le misuriamo. Eppure noi dobbiamo misurare, onde certificare: ciò che vale in Italia deve valere anche in Germania e in Danimarca, onde permettere il naturale e auspicabile trasmigrare di studenti da un Paese all’altro. Di qui il fatto che misureremo solo ciò che è misurabile: le competenze, appunto. Il saper fare e il saper imparare, i metodi e non i contenuti; le capacità verificabili: manuali, tecniche, linguistiche, psicologiche, attitudinali, civiche, sociali... Misureremo e certificheremo i cosiddetti «risultati di apprendimento», i Learning Outcomes, usando gli EQF (European Qualifications Framework), ovvero le tre CAC. Siccome non so chiamarle in altro modo, uso le loro iniziali: Conoscenze, Abilità, Competenze. Le CAC. Dovessi spiegarvi cosa sono, non saprei. Nessuno lo sa con esattezza, neanche i minotauri, credo. Posso però tradurvi quel che sembra a me d’aver capito. Le Conoscenze sono le vecchie cosiddette nozioni, i contenuti in sé, tipo le guerre napoleoniche, che cos’è l’equatore, qual è la capitale della Finlandia, l’equazione della parabola e che cosa dice Dante nel canto I del Purgatorio. Le Abilità sono ciò che l’allievo è capace di fare usando le nozioni che gli ho insegnato (immagino si tratti di saper andare a Helsinki, dopo aver acquisito la Conoscenza che Helsinki è in Finlandia; per le guerre napoleoniche non saprei...). In quanto alla terza CAC, cioè alle Competenze, be’, qui si apre il baratro delle mille definizioni minotauriche. Comunque, quel che ho capito è più o meno questo: che le Competenze riguardano il dopo, la vita futura, lavorativa ma anche affettiva, dello studente. Cioè, una volta che ha imparato le nozioni (Conoscenze) e una volta che ci sa fare qualcosa con quelle nozioni (Abilità), le Competenze dovrebbero essere il modo in cui in futuro egli saprà utilizzare e le Conoscenze e le Abilità acquisite. Leggiamo la definizione europea ufficiale di competenza: «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale». Ecco: capacità di utilizzare quel che si è appreso, quel che di astratto e inutile (il mio Torquato Tasso, per esempio) si è studiato e che rimarrebbe lettera morta, secondo l’Europa e i minotauri, se non lo si sapesse poi usare nel lavoro e nella vita anche personale... Cioè, tradotto: le competenze sono quel che tu te ne farai nella vita di Torquato Tasso. E di Napoleone, Kant, Newton. E del canto I del Purgatorio, cioè come lo utilizzerai nel lavoro e nella famiglia, per esempio con tuo fratello o la tua fidanzata. Già, che cosa te ne fai nella vita del canto I del Purgatorio? È questa la domanda centrale della rivoluzione in atto: una volta non ce lo chiedevamo, adesso sì. Una volta non pensavamo al fine e al senso e alla «ricaduta» concreta di un canto di Dante: perché per noi i canti di Dante avevano un senso e un fine in sé. La cultura era esattamente questo: qualcosa di assolutamente fine a se stesso, e dunque «utile in sé», utile a priori, utile di una sua specifica utilità, non verificabile, non misurabile, non commerciabile. Adesso invece è esattamente questo che ci fa paura. Ci fa una paura immensa e incontrollabile, non possiamo più sopportare che qualcosa abbia senso in sé e «ricada» naturalmente nella nostra vita un po’ come gli pare. Una volta, ai tempi di mio padre per esempio, si faceva studiare Dante ai futuri ragionieri e geometri, molto Dante. Non ci si chiedeva quale spendibilità avesse per il loro lavoro futuro, non ci si chiedeva in quale modo il canto di Paolo e Francesca avrebbe potuto tramutarsi nella competenza di disegnare il progetto di un condominio o controllare i conti e le fatture di una ditta. Non ce lo si chiedeva perché si sapeva che, in qualche imperscrutabile modo, sicuramente Dante sarebbe servito al geometra e al ragioniere. Dante era un sapere in sé e, secondo l’umanità di allora, produceva comunque un bene all’individuo, lo rendeva migliore, come lavoratore e come cittadino. Insomma, chissà dove mai saranno andati a cadere in noi i canti di Dante che abbiamo studiato, e amato. Non lo sapremmo dire, neanche sotto tortura. E allora? Possiamo affermare che questa indicibilità e inverificabilità congenita li renda inutili? Sì, l’Europa ci sta dicendo questo. In modo subdolo e traverso, ma lo dice. Basta leggersi le otto competenze-chiave stabilite dal Trattato di Lisbona, per capire che cosa l’Europa vuole: 1) comunicazione in madrelingua; 2) comunicazione in lingue straniere; 3) competenza matematica e in scienze e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. Spariti i canti di Dante, come potete notare. O meglio, possono esserci o no, ma sono nascosti: nelle certificazioni europee sono irrilevanti. Non importa se li sai, importa cosa te ne fai. E poi, in quale di queste otto competenze potrà mai tradursi Dante? L’ottava? E cosa vorrebbe dire «essere consapevoli » di Dante? Non so, che i minotauri ci illuminino... Andiamo ancora più addentro. Vi trascrivo il documento che una singola scuola ha approntato per la certificazione finale dell’obbligo, uno dei tanti modi possibili (ogni scuola si inventerà il suo) di interpretare e attuare le norme europee. Ecco alcune delle «competenze trasversali», che dovremo essere in grado di «misurare» per i nostri allievi: Convivenza sociale, Imparare a imparare, Operare, Interpretare l’informazione, Individuare collegamenti e relazioni, Comunicare, Risolvere problemi. Non so se sono riuscita a darvi un’idea del cambiamento in atto, e della scuola nuova che ci attende. Ma spero di sì. Nel caso vi resti qualche dubbio, posso trascrivervi la distinzione in tre livelli all’interno della competenza chiamata «Operare»: 1) sa usare strumenti e materiali, seguendo procedure standard, in contesti e situazioni simili a quelle nelle quali sono stati solitamente introdotti e usati; 2) sa usare vari strumenti e materiali in situazioni e contesti diversi finalizzandoli al raggiungimento di uno scopo; 3) sa usare vari strumenti e materiali in situazioni e contesti diversi finalizzandoli al raggiungimento di uno scopo, in seguito a un proprio progetto. Spero abbiate notato il climax ascendente, da un’abilità più modesta a una più evoluta. L’insegnante deve solo crocettare quale delle tre voci corrisponda al grado raggiunto dallo studente, e il gioco è fatto, le competenze sono «certificate». (Tra l’altro, ditemi la verità: data la genericità di tali formulazioni, secondo voi quale insegnante non sarà così benevolo da attestare a tutti il livello 3?) Facciamo un esempio. Se il ragazzo sa usare vite e cacciavite per fissare una mensola al muro, è al livello 1. Se li sa usare per uno scopo diverso, tipo avvitare il biglietto del tram al sedile perché non voli via, è al livello 2. Se poi ha un suo proprio progetto — chessò, corteggiare una compagna, e a tal fine le fa trovare una rosa avvitata al banco – è al livello 3. E fin qui, parliamo di falegnameria. Proviamo adesso a trasferire il tutto alla mia materia. Proviamo a certificare, in uscita dalla scuola dell’obbligo, a quale livello un allievo abbia dimostrato di sapere, in letteratura italiana, «usare vari strumenti e materiali in situazioni e contesti diversi finalizzandoli al raggiungimento di uno scopo»... Non c’è bisogno di commenti, credo. Forse vi chiederete: ma come ce lo siamo sognato tutto ciò? Ebbene, come spiega Giorgio Israel in vari articoli e nel suo blog, il sistema delle competenze appartiene di fatto a un ambito prima militare (era il sistema per valutare, durante la Seconda guerra mondiale, nelle Forze armate britanniche e statunitensi, le performance dei piloti a partire dal numero degli obiettivi, ovvero aerei colpiti) e poi a un ambito lavorativo-aziendale: schemi che servivano a valutare i dipendenti ai fini dell’assunzione, degli avanzamenti di carriera e dei licenziamenti. L’origine dunque della strategia delle competenze non è certo culturale o, peggio che mai, umanistica... Infine, il primo a parlare di Risultati di apprendimento fu lo psicologo americano Benjamin Bloom, in un suo libro del 1956: Taxonomy of Educational Objectives. Significa che noi stiamo scoprendo e applicando oggi una teoria di quasi sessant’anni fa, che per giunta il suo autore stesso aveva criticato quarant’anni fa (nel 1971), dicendosi sorpreso che avessero preso tanto sul serio, e mitizzato, il suo piccolo manuale! Abbiamo, cioè, orecchiato termini e concetti americani, provenienti da ambiti ben diversi da quello culturale-educativo, e per giunta anche vecchi, li abbiamo estesi a tutto il nostro sistema di istruzione e li stiamo oggi passando come novità e modernizzazione di una scuola antiquata. Bloom stesso, per esempio, ci avvertiva di non estendere la sua tassonomia a tutte le discipline, ché, anzi, ogni disciplina deve avere i suoi schemi precisi. La sua è una teoria che serve ai costruttori di test! Serve per ideare le domande da inserire nei test: è una teoria per la classificazione degli item! Avete capito? La classificazione delle prove, delle domande di un test! Siamo sicuri di voler impostare il riordino dei licei sull’importanza del numero di aerei abbattuti, sulla misurazione delle ragioni per licenziare un dipendente e sulla teoria di Psicologia dell’Educazione che ha sfasciato l’istruzione pubblica americana? Perché, almeno sul fatto che la scuola americana pubblica sia disastrosa, siamo d’accordo, spero: e anche sul fatto che dallo sfascio della scuola pubblica nasce l’enorme successo in America delle scuole e università d’élite, spesso private. Vogliamo dunque anche noi in Italia arrivare a questo, e cioè alla nascita di stupende scuole private che, almeno per i ricchi, soppiantino le sfasciate scuole pubbliche? Capisco che i Learning Outcomes siano meravigliosamente consoni alle esigenze del mercato. Facilitano, come ho detto, una equiparazione di qualifiche all’interno dell’Europa. Ma temo che stiamo facendo una scuola su misura dei test (e non viceversa!): siccome i test hanno bisogno di un materiale «oggettivamente valutabile», noi possiamo prevedere contenuti solo tecnico-formali, tipo la grammatica e il lessico. Non certo la letteratura o la filosofia. Va bene. Ma va bene (forse!) per l’istruzione tecnico-professionale, non per i licei: come possiamo applicare l’istruzione permanente allo studio umanistico? come potrebbero mai cambiare nel tempo le opere di Omero, Lucrezio, Giotto o Canova, nonché le imprese di Annibale e di Garibaldi e i miti di Platone e le categorie kantiane, come diavolo diventerebbero obsoleti argomenti simili, e come potrebbero mai necessitare di aggiornamenti? Vogliamo prevedere una distinzione per queste povere materie, così assolute e sublimemente (in apparenza) «inutili»? Insomma, possiamo (forse) certificare le competenze di problem solving a uno studente di falegnameria o di elettronica. Ma come possiamo farlo con un ragazzo che studia letteratura latina? Credo che la scuola delle competenze darà il colpo mortale a tutto ciò che ancora resta di culturale e speculativo nelle nostre scuole superiori, licei innanzitutto, spazzando via qualsiasi intento ancora minimamente volto a una trasmissione del sapere astratto e «inutile», in nome di qualcosa che sia invece immediatamente spendibile e professionalizzante. Naturalmente i minotauri e i loro accoliti si premurano in mille modi di dirci che non è vero niente, che non andrà certo distrutta la scuola delle conoscenze, anzi! che anche a loro importano moltissimo i contenuti e non sono mica così pazzi da dire che si possano acquisire competenze sul nulla, senza una base più che solida di conoscenze... Sì, certamente si insegnerà ancora qualcosa nelle scuole, ci mancherebbe! Le nuove Indicazioni ministeriali, almeno per quel che riguarda l’italiano, indicano chiaramente e sostanziosamente i contenuti di base. Non sono Programmi (parola oggi tabù), sono solo Indicazioni, ma meglio che niente: Dante e Torquato Tasso, per esempio, sono apertamente (e coraggiosamente!) «indicati». Quindi, direte voi, qual è il problema? Il problema è il messaggio. Implicito, subdolo, strisciante. Certo che si farà ancora Dante, ma si farà in vista di una competenza, si farà per un’utilità, o uso o utilizzo o spendibilità, la quale soltanto sarà misurata e quindi, di fatto, conterà. Si farà Dante non per sapere Dante, non per un gusto estetico, per un arricchimento personale e una utilità implicita: si farà Dante solo se servirà per altro, chessò, per un discorso sui diritti civili, per esempio, o per insegnare l’astronomia, estrapolando esclusivamente i versi che servono a tal fine... È questo piegare lo studio a una utilità pratica e concreta; è questo indirizzare gli anni di scuola unicamente a una meta lavorativa che mi spaventa. Mi mette tristezza. Mi verrebbe da dire ai giovani: guardate che non è così, non ci cascate. Tenetevi i vostri anni «inutili» per quel che sono: si chiamano giovinezza. Fate, studiate, leggete, senza chiedervi mai perché. Lasciatevi il gusto di scoprirlo dopo, il senso, e il fine, di tutto quel che prima avete studiato e amato. 3. Monsieur Thélot Vi propongo ora, per rilassarci, la lettura di un documento agghiacciante. È un’intervista, apparsa sul «Corriere della Sera» l’8 aprile 2010, a Claude Thélot, «uno dei più grandi esperti di problemi scolastici», che ha presieduto nel 2003, durante il mandato di Chirac, la commissione sul futuro della scuola francese. Sentite cosa dice Monsieur Thélot. Suddivido il testo della sua intervista in piccoli brani, diciamo pure che lo faccio «a «pezzi» così da non perdere neanche una delle sue parole, per me abominevoli. È importante che lo leggiamo insieme: direi che è il miglior concentrato teorico del... Pensiero Scolastico Nuovo che oggi abita le menti di chi ci governa, chiunque sia, di qualunque Paese sia e di qualunque colore politico. Vediamo cosa dice Monsieur Thélot. Scuola e professori tradizionalmente insistono sulle conoscenze: invece dovrebbero occuparsi meno di trasmettere il sapere e occuparsi più della crescita dei propri alunni, mettendoli in condizione di applicare alla realtà ciò che hanno imparato, di sviluppare la propria personalità. Il docente dev’essere prima di tutto uno «specialista» del successo dei propri studenti. Oibò. Dunque: sarebbe «tradizionale insistere sulle conoscenze ». Ci risiamo: il sapere ha senso solo se si può applicare a qualcosa, se non resta astratto ma si combina alla realtà e la serve, sa ha un fine al di là di se stesso. Se no è inutile, roba da buttare. Andiamo avanti. C’è un concetto sconvolgente nel discorso di Thélot, che spero non vi sia sfuggito: dice che i professori dovrebbero «occuparsi meno di trasmettere il sapere e occuparsi più della crescita dei propri alunni». Vi rendete conto dell’agghiacciante messaggio? Sta dicendo che trasmettere il sapere NON È occuparsi della crescita dei giovani! Che sono due cose diverse: quindi, che se insegno Dante (che è sapere, no?) non mi sto occupando di far crescere i miei allievi! Ma ci siamo bevuti il cervello, in Europa? Mi folgora all’improvviso un pensiero. Un’analogia, tragica. E capisco: sì, la pensiamo proprio così oggi, come Thélot! Mi è capitato. Mi è capitato poco tempo fa. Ero a Genova, per un ciclo d’incontri dal titolo «Scrittori di scuola». Adesso ve lo racconto. Faccio pausa, dedico un sottocapitoletto al mio racconto. Sedetevi comodi e ascoltate. Comincio il mio intervento raccontando quanto ho amato e amo la letteratura e quanto vorrei passare questo amore ai miei allievi e quanto sono felice quando mi capita che, su trenta allievi che ho in classe, riesco a contagiarne almeno uno, al punto che poi, pur avendo frequentato un liceo scientifico, arrivi a iscriversi a Lettere... Dal pubblico sento rumoreggiare. Due colleghi mi bloccano dicendomi: a) Sì, va bene, però in tutto quel che racconti non si sente mai l’amore per i ragazzi, mai... b) E gli altri ventinove allievi della classe? Evidente che non te ne curi... Sconcerto. Ci ho pensato a lungo, poi. Ho solo due considerazioni da fare. Una riguarda squisitamente la logica: se una persona dice che ama la letteratura, come si può logicamente inferirne che quindi non ama i suoi allievi? Qual è il legame logico? La seconda considerazione riguarda la scuola: ma è mai possibile che ancora si giudichi buono o cattivo un insegnante non da come e cosa insegna, ma da quanto ama l’allievo? Perché ha prevalso, nella scuola, l’aspetto sentimental-assistenziale e non quello più strettamente culturale? Perché l’insegnante migliore dev’essere oggi una specie di psicologomamma-assistente sociale e non, tanto per dirne una, qualcuno che ama Dante e basta? Perché il valore culturale di quel che un insegnante fa è l’ultimo criterio per valutarlo? A Genova ho capito meglio quanto io sia una pessima insegnante: poiché (poiché!) amo così tanto la letteratura e i libri (ne scrivo addirittura!), è implicito che non amo gli allievi. Quindi – deduzione finale – credo che uno scrittore non dovrebbe mai fare l’insegnante. Quindi io ho sbagliato tutto. (Ma anche chi organizza convegni sulla scuola con insegnantiscrittori... Non so, era già tutto sbagliato in partenza?) Torniamo a Monsieur Thélot. Dice che trasmettere ai giovani il sapere non è aiutarli a «sviluppare la propria personalità». Ma che cosa è mai la «personalità», scusate? Di che cosa stiamo parlando? Ma soprattutto in che modo io, che faccio l’insegnante e ho studiato Dante (anzi, faccio l’insegnante perché ho studiato Dante!), devo occuparmi (implicitamente!) della loro cosiddetta «personalità»? Ultima cosa, letale: «Il docente dev’essere prima di tutto uno ’specialista’ del successo dei propri studenti». Uno specialista del successo? Come dire che un altro si occupa del vostro successo, è delegato a farvi avere successo e, perché no, denaro, notorietà, fortuna... Una specie di personal trainer scolastico, allenatore, coach, manager, agente... Vorrei lasciare molto spazio bianco. È l’unico modo. Tipografico. Per dirvi, all’interno di un libro, tutto il mio sconcerto, e sconforto, e scombinamento interiore. Quel che si direbbe con l’espressione: «non ho parole». Permettetemi dunque di lasciare bianco... molto bianco... tantissimo bianco... Di qualunque successo si stia parlando, la parola «successo» non mi è mai piaciuta: sa di gara, prestazioni e riflettori, palcoscenici, foto, denari e altre terribili oscenità. In particolare in ambito scolastico, poi, l’idea che la scuola debba occuparsi di assicurare il successo ai giovani (ricordate il «diritto al successo formativo» di Berlinguer?) mi sconcerta. Interrogato su quale sia il principale problema dei sistemi scolastici europei, Monsieur Thélot risponde: L’insuccesso di troppi ragazzi: in Francia il quindici per cento dei giovani escono dalla scuola dell’obbligo con insufficienti conoscenze fondamentali e con grandi difficoltà nell’applicazione di queste nella realtà... Questo rappresenta un problema perché nella vita il successo di una persona dipende dall’acquisizione o meno di una base di competenze indispensabili. Competenze o conoscenze, Monsieur Thélot? Dica meglio quale secondo lei è il vero problema delle scuole europee oggi: le «insufficienti conoscenze fondamentali» o «l’acquisizione di una base di competenze»? O dobbiamo sospettare che lei usi indifferentemente le due parole? Inoltre, sia più onesto: lo dica che il guaio vero è l’insufficienza di conoscenze (altrimenti detta «ignoranza») e non l’insuccesso! O meglio, dica che l’insuccesso è dovuto all’ignoranza, abbia questo coraggio, e poi si chieda anche a che cos’altro mai la dobbiamo, codesta ignoranza, se non a una scuola che ha scelto di non insegnare più nozioni, e di far fuori i programmi. Poi l’intervistatore rivolge a Thélot la domanda clou: cosa intende per competenze? Risposta: Conoscenze, capacità di applicarle in diversi contesti, attitudini e atteggiamenti mentali che favoriscono l’iniziativa autonoma e la capacità di apprendere a lavorare insieme agli altri. Queste competenze indispensabili per la vita dovrebbero essere garantite a tutti i ragazzi della scuola dell’obbligo. Partiamo dal fondo: «Queste competenze indispensabili per la vita dovrebbero essere garantite a tutti i ragazzi della scuola dell’obbligo». Riflettiamo sulla parola garantite. Garantire è un bel verbo, che in genere difende il debole dai soprusi del potente. È un verbo oggi usato tipicamente dai sindacati, i quali si occupano proprio del fatto che al lavoratore vengano garantiti alcuni fondamentali diritti e sicurezze. In ambito scolastico, l’insegnante dovrebbe dunque, secondo Thélot, garantire all’allievo le competenze (ovvero la capacità di applicare le conoscenze). Vuol dire che le competenze sono un diritto. Indipendentemente da tutto, anche dal comportamento dell’«assistito»: indipendentemente dunque da quanto l’allievo abbia studiato?! E ora torniamo indietro: le competenze sarebbero quindi le conoscenze applicate, ovvero la capacità di applicare le conoscenze... Ma a che cosa, Monsieur Thélot? Risposta: «in diversi contesti». Molto chiaro, complimenti! La scuola quindi deve insegnare ad applicare quel che insegna in diversi contesti. Credo di capire nell’ambito della vita e del lavoro. Interessante... e giusto, se si trattasse solo di materie tecniche. Ma siamo sempre lì: e con le discipline umanistiche come la mettiamo? Quali competenze potremo misurare insegnando ancora (ammesso che lo faremo) Platone, Heidegger e Shopenhauer? I ragazzi come li applicheranno in diversi contesti, ovvero alla vita quotidiana e al lavoro? Ovvio che qui si attacca, senza dirlo, l’intera area umanistica del sapere: inutile, inapplicabile. Inservibile ai lavoratori del futuro. In una scuola che si vuole sempre più asservita al mondo del lavoro, ovvio che le discipline umanistiche non trovino spazio. Mi viene ancora in mente Gramsci. Per disperata e amara reazione. Gramsci difendeva (agli inizi degli anni Trenta!) il carattere assolutamente disinteressato dello studio, la lontananza della scuola da ogni fine che fosse anche solo pallidamente pratico, pensate un po’! E Giulio Ferroni, all’inizio del suo libro La scuola sospesa, ci ricorda che la parola scuola, dal greco scholé, vuol dire tempo libero, riposo, pausa, tregua... ozio! «La scuola si pone dunque» scrive Ferroni «come luogo separato, sospensione del tempo normale e creazione di un tempo particolare che non coincide con quello del lavoro e della lotta quotidiana per la sussistenza... L’attività della scuola si definisce così al di fuori di una mera funzionalità, come esercizio di libertà dai vincoli esterni, coltivazione di un tempo interno...» 14 Scuola come «esercizio di libertà», si rende conto, Monsieur Thélot? «Coltivazione di un tempo interno»: a quali contesti pensa di poterlo applicare? Lo stesso giorno dell’intervista a Thélot ma su un altro giornale («il Sole 24 Ore», 8 aprile 2010) esce un articolo di Andrea Casalegno sulle teorie di un altro guru della neopedagogia iper-occidentale, questa volta americano: Charles Fadel, responsabile Global Education della Cisco, autore del bestseller XXI Century Skills e cofondatore del P21 (Partnership for XXI Century Skills), un gruppo di quaranta aziende o enti, che ha elaborato un progetto educativo (apprezzato anche da Obama) fondato sulle nuove abilità auspicabili per il Ventunesimo secolo: pensiero critico, intraprendenza e creatività. Bisogna smettere di «impartire nozioni» leggo, «oggi il mondo è cambiato, si constata sempre più spesso che le conoscenze non servono a chi non è in grado di usarle per risolvere problemi nuovi. Sono le imprese a insistere sulla svolta. (...) Oggi le imprese non sono più disposte a insegnare il mestiere per anni, si aspettano piena efficienza sin dal primo giorno di lavoro. E i lavori cambiano: non sono più uno o due nell’arco della vita, ma dieci-quindici e saranno sempre di più. Non serve sapere, ma saper imparare». È questo il senso profondo della svolta pedagogica in atto, del passaggio dalle conoscenze alle competenze – si continua nell’articolo -, cioè a «un sapere conquistato in modo attivo attraverso la soluzione di problemi tratti dalla vita reale». È questo dunque – mi chiedo io – il senso del completo sconvolgimento in atto della scuola: si vuole che diventi solo un luogo di preparazione al lavoro? E a noi va bene questo? A tutti noi? E a chi, in particolare, va bene? Quando sento espressioni come «saper imparare» e «risolvere problemi» mi prende un senso di vuoto allo stomaco. Risulta lampante che il punto qui, oggi, è «risolvere problemi »: il mondo del futuro si apre a noi come un enorme e continuo «problema da risolvere» – per questo non ha più senso studiare, ma bisogna solo imparare a imparare. In genere quando leggo cose simili, per contrappunto, mi siedo e apro un libro, a caso. Il primo che mi viene, basta che sia un libro. Qualcosa che non c’entri col problem solving: non so, le poesie di Brodskij, la vita di Chagall, Astolfo sulla luna. Qualcosa che non mi faccia risolvere un bel niente, ma che mi porti via. Un cavallo, per esempio. Alato... È questo implicito restringimento della vita al solo ambito lavorativo (e del lavoro a «problema da risolvere»!) che mi intristisce, questo continuo e ossessivo riferimento al lavoro come unica mission, quest’idea che lavorare voglia dire... dover risolvere problemi! Poveri giovani che sono, i nostri giovani! Vorrei dir loro che la vita è mediamente molto migliore di così. Più aerea, direi, più aperta, più felice. Meno tetramente tecnico-pratica. Ad esempio è fatta anche di pensieri, idee, riflessioni, memorie, immaginazioni... «conoscenze» che non si «applicano» a un bel niente, e non servono, e non si spendono. E che, il più delle volte, non si sa nemmeno di avere. Esiste una «felicità mentale», ragazzi, uno spazio solo vostro, interiore, dove si ascolta musica, si leggono libri, si pensa all’ombra di un albero... Tutte cose molto oziose, certo. Che facevano parte, un tempo non poi così remoto, di quel che abbiamo chiamato studio, di una scuola che ancora si occupava - soltanto ! – di arricchire la vostra mente, e non in vista di un lavoro, ma della vostra felicità personale, in quanto persone... Dovreste tenerci. Dovreste rivendicare, oggi, un vostro diritto all’otium così com’era inteso dagli antichi... Ma torniamo a Monsieur Thélot, la perla della sua intervista arriva adesso, il colpo mortale, lo schianto, la bomba. In Francia – ma anche in Italia penso accada la stessa cosa – i maestri di scuola elementare hanno sempre trasmesso delle competenze ai bambini. Ma al collège (che corrisponde in Italia alla scuola media) questo risulta molto più difficile perché i docenti sono troppo concentrati sulle discipline che insegnano. Dovrebbero aiutare i propri studenti ad andare al di là della loro materia: ma la amano troppo, al punto di considerarla un fine e non un mezzo. Mi sono permessa di evidenziare tre frasi. Prendiamone una per volta: 1) I docenti sono troppo concentrati sulle discipline che insegnano. Ma cosa dice? Su cosa dovrebbero essere concentrati i docenti? Si chiamano docenti! Docent, insegnano! Non dovrebbero pensare a cosa insegnano? 2) Dovrebbero aiutare i propri studenti ad andare al di là della loro materia. Al di là? Al di là di cosa? E che cosa c’è mai al di là? Di cosa stiamo parlando? E poi cosa vuol dire aiutare ad andare al di là della materia? Starebbe a significare che se insegno la mia materia, non aiuto i miei allievi? E adesso arriva la chicca, il massimo a cui sia giunta la mente scolastica umana del millennio: 3) Ma la amano troppo, al punto di considerarla un fine e non un mezzo. Eccola la fantastica teoria finale: dunque Monsieur Thélot arriva a dire che se amo troppo la mia materia faccio il male dei miei allievi, non li aiuto, non do loro le competenze utili alla vita; che quindi un insegnante non deve amare quel che insegna, deve considerarlo solo un mezzo. Immagino che il fine sia l’allievo. Thélot non lo dice, ma io lo so. Lo so, l’ho sentito dire e l’ho letto da più parti. Sono le teorie del nuovo pedagogismo. Bisogna amare l’allievo, non la materia. Amare la materia equivale a non amare, fors’anche a odiare, l’allievo. Non so cosa dire. Non mi bastano le parole che fin qui ho imparato nella vita. Vorrei accasciarmi su un prato, una spiaggia, anche solo un pavimento e rimanere lì, per sempre. A contemplare il cielo, il passaggio delle nuvole, il sole che tramonta, il soffitto, il lampadario, una macchia sul muro che mi distragga, mi porti via, qualcuno che mi tramortisca. Il tramonto dell’Occidente. La fine dell’impero romano. La caduta degli dei. Non so, mi vengono tutte le parole della fine. Abbiamo amato molto le parole. Non so che colore politico possa avere un amore così, spero nessuno. Ma certo questo amore ha pesato non poco sul mestiere di insegnante che abbiamo scelto di fare, lo ha in qualche modo distorto. Abbiamo molto amato i libri. Le raccolte di Montale, i saggi di Gianfranco Contini, i romanzi di Tolstoj, Calvino, e ultimamente i meravigliosi libri di Irène Némirovsky. Abbiamo amato i versi di Orazio, le favole di La Fontaine, i viaggi di Gulliver, le satire di Ludovico Ariosto, le avventure di Pinocchio. Abbiamo amato molto (troppo) la nostra materia. Non dovevamo. O meglio, se proprio amavamo queste cose, avremmo dovuto avere il buon gusto di non diventare insegnanti. Per troppo amore, non avremmo dovuto fare questo mestiere. Scusateci se, nonostante l’amore, l’abbiamo fatto. 4. Salmoni E siamo arrivati al «Nuovo che avanza», la seconda idea cardine della scuola di oggi, secondo il politicamente corretto europeo, ovvero p.c.e. Siamo tornati all’inizio del libro, in realtà. Per l’esattezza al secondo capitolo della Parte prima, che s’intitola «Nuovomondo». Là avevamo descritto la cieca collettiva fede nelle meraviglie del nuovo mondo tecnologico, il Web avant tout. What a wonderful Web! Col che, il cerchio si chiude. Dico il cerchio quarantennale della «distruzione dello studio». Bene, vi sembrerà incredibile, ma è così: il ministro Gelmini ha le stesse idee del ministro Berlinguer e del suo «saggio » Maragliano. O almeno dice le stesse cose, sentite: «I videogiochi rappresentano un’opportunità per introdurre nella scuola linguaggi digitali e nuove strategie di apprendimento ».15 Come vedete, non c’entrano niente destra e sinistra, è lo Spirito dei tempi che ci governa... In altri luoghi e tempi, il ministro Gelmini aveva detto che il nocciolo sostanziale della sua riforma consisteva nel «coniugare tradizione e innovazione». Come non essere d’accordo? Di che cosa però si tratti nella realtà è oscuro. O meglio, guardando la recente realtà, sembrerebbe questo: da una parte si riducono le ore di latino, italiano, filosofia e storia al liceo; dall’altra però si introdurrà la lavagna interattiva alle elementari. Strane coniugazioni... Comunque sia, i lineamenti della Nuova scuola sono da anni chiaramente tracciati e, come appare, sia da destra che da sinistra perseguono una medesima via senza mai la minima incertezza o pausa di riflessione critica: il Nuovo. È la Nuova scuola dei Nuovi giovani e delle loro Nuove abilità. Se così è, se davvero ha vinto la Nuova pedagogia anticontenutistica e antiverbale (il Minotauro dei minotauri), tutto davvero va ripensato. Perché, sarà anche vero che i ragazzi oggi non sanno scrivere un tema, ma sanno mirabilmente scrivere sms e mail a dieci amici alla volta; non sanno disegnare a matita il progetto di una casa, ma usano da dio i programmi tridimensionali; non sono in grado di tenere un discorso per più di venti secondi, ma in venti secondi sanno digitare un messaggino lungo anche dieci righe; non sanno studiare e non possiedono più nozioni, ma sfiorando con un sol tocco l’iPhone ottengono qualunque informazione; non sanno trovare una strada o una città né consultare una carta geografica, ma attivando il navigatore satellitare arrivano ovunque senza perdersi; non hanno la minima idea di come funzioni un computer, di cosa significhi «scrivere» un programma, ma sono perfettamente capaci di far girare il software che altri — vecchi, istruiti all’antica – hanno scritto per loro. La pedagogia tecnocratica di Stato dice che va bene così. Dunque, è come dire che i ragazzi di oggi sanno tutto. Messi in condizione di usare i mezzi tecnologici, diventano onniscienti. Possiedono una strana forma di onniscienza, che definirei analfabetica, ma non importa: dobbiamo smetterla di remare contro, noi dinosauri della Scuolavecchia. Fermi, ottusi, obnubilati dal mito del passato. Dobbiamo prendere atto, e semmai renderci edotti, accompagnare anziché osteggiare o criticare codesti Nuovi Saperi, codesta Nuova Era dell’Onniscienza Analfabetica. Abbandonare il vecchio trito e ritrito. Soprattutto il nostro modo stantio e stereotipato di vedere le cose. Smettere di opporci e testardamente contrastare la corrente, manco fossimo dei salmoni che risalgono i fiumi. Loro almeno, dico i salmoni, hanno un fine socialmente molto utile, quello di depositare le loro uova prima di morire. Ma noi? 5. Nuvole sul Web Adoro le stelle. Avrei voluto studiare Astronomia, perdermi in un deserto e osservare galassie tutta la vita. Ho anche una smodata passione per i film di fantascienza, da Guerre stellari a The Day After e via così. Mi piace il futuro, non penso mai che possa arrivare per davvero, però mi piace. Mi diverte. Ma, soprattutto, mi sono innamorata dell’iPad. Questo è bene che lo sappiate: mi piace da impazzire. È accaduto l’estate scorsa sotto un ombrellone, quando un amico coetaneo ne usava uno per «sfogliare» i quotidiani, e mi ha mostrato come funziona. Ne sono rimasta abbagliata. È un oggetto affascinante. Bello, diabolico, suadente. Inoltre, è ovvio, uso da sempre i computer, fissi, portatili, e ultrapiatti; nonché il bancomat, il cellulare, l’e-mail, il telepass e il caffè a capsule da inserire nella macchina elettrica. Ho solo qualche problema con Facebook, i blog e gli sms; ma credo che sia perché mi è sempre piaciuto poco spettegolare sui pianerottoli o negli scompartimenti dei treni, quando ancora esistevano. Insomma, a parte queste minime resistenze, mi considero una persona mediamente moderna. Al passo coi tempi, come si dice. Premesso ciò, quando vedo la stragrande maggioranza dei nostri giovani perennemente occupati a smanettare e videare; quando incontro al ristorante ragazzini che passano il tempo a tormentar tastierine sul piatto e non si scostano neanche quando arriva il cameriere con la pastasciutta (quando, soprattutto, vedo che i loro genitori se ne fanno due baffi, chiacchierando rumorosamente con gli amici); quando li vedo ovunque con il pollice pulsante sul cellu o gli occhi incatenati alle micro-foto degli amici virtuali di Facebook; provo un’inquieta amarezza. Quando poi apprendo che «nel marzo 2010 è nata a Londra la prima clinica specializzata nella disintossicazione della mente infantile dalla dipendenza da Internet e videogiochi»,16 e che anche qui da noi nascono negli ospedali nuovi ambulatori dove ci si occupa di curare il «morbo di Facebook», ebbene sì, mi preoccupo molto. E me la prendo anche con tutti noi, che dovevamo dirlo forte, ai nostri giovani, che c’era un limite, che non era il caso, che esisteva anche altro: non dovevamo distrarci! Dovevamo occuparci dei nostri figli, invece di occuparli... A me sembra che non vada bene questo continuo star connessi. Ha tutta l’aria di una dipendenza. Un costante essere portati via da sé, vivere alienati, in un altrove che frastorna e toglie il permanere, mentale, nel proprio centro. Un’attività che disperde e frammenta. Mi pare (a parte le eccezioni, ovviamente) semplice intrattenimento spacciato per impegno intellettuale. Penso che stiamo prendendo un abbaglio: crediamo che le nuove tecnologie ci cambieranno la vita, il cervello e l’identità; invece forse, se usati con moderazione, sono soltanto utili e innovativi strumenti che ci permetteranno di essere meglio quello che siamo e ci faciliteranno la vita che abbiamo. È come se, quando è stata inventata l’automobile, ci fossimo piazzati lì dentro tutta la giornata, lucidando il cruscotto, armeggiando col motore, facendo chilometri. E neanche più un metro a piedi. È come se avessimo pensato, per giunta, che tutto il mondo sarebbe di lì in poi completamente e irreversibilmente cambiato e che nulla dell’essere umano e quindi della vita umana sarebbe mai stato come prima. Invece l’automobile ha solo migliorato i trasporti! Ha solo cambiato, in meglio, il nostro modo di muoverci da un luogo all’altro. Utilissima cosa. Ma si trattava solo di un’auto, un mezzo di trasporto, appunto, e l’essere umano è rimasto tal quale, non s’è radicalmente trasformato solo perché ogni tanto nella giornata si metteva al volante di una scatola semovente dotata di quattro ruote, un motore a scoppio e una luccicante carrozzeria. È rimasto un bipede, perfettamente in grado di camminare sulle sue due gambe. Allo stesso modo, dovremmo tener ferma questa certezza su di noi: siamo esseri pensanti dotati di intelletto. Ovvero, anche se nel mondo è arrivato Internet, non vuol dire che smetteremo di pensare e di studiare noi, perché tanto c’è lui che ci fa tutto! Grandiosa novità, allettante miglioramento, un notevole progresso senza dubbio, ma noi siamo noi: dovremmo stare saldi, e non, invece, farci travolgere. Tutto qui. Far scoglio. E che poi il mare intorno a noi potentemente ruggisca, e rumoreggi e s’infranga e spumeggi... Avete presente quei giganteschi fari solitari, piantati in mezzo alle acque dei mari del Nord, quelle torri poggianti sugli abissi, che reggono ondate di dieci metri e resistono, in mezzo all’ulular dei venti e al biancheggiar della marina? Ecco, questo dobbiamo essere di fronte al Nuovo multiforme che oggi quasi quotidianamente ci invade e ci frastorna: giganteschi fari piantati nell’oceano. Non voglio lanciarmi in una severa invettiva contro le macchine, da paladina di un ridicolo neoluddismo. Mi permetto solo di avere qualche perplessità. Di essere attraversata da qualche nuvola. Avete presente i cieli atlantici, dove il nitido azzurro è percorso dal passaggio continuo di nuvole a velocità supersonica? Ecco, uguale. Cieli sereni, ma percorsi da nuvole. La prima nuvola è: ma cosa fanno veramente i nostri ragazzi quando sono davanti a un computer? In genere capita questo, soprattutto se siamo genitori: forse per un generazionale senso di inferiorità, ce ne restiamo basiti e sbavanti in ammirazione davanti a questi nostri pargoli smanettanti e videoguardanti, chini per ore e muti davanti a uno schermo. Ci sembrano così moderni, svegli, interattivi, connessi, globali, precoci, geniali! Una meraviglia, che ci lascia a bocca aperta. D’accordo, lo capisco: sono i nostri pargoli. Ma proviamo a chiudere una volta questo compiaciuto spalancamento, e andiamo a guardare che cosa realmente stanno combinando su quel video i nostri geni precoci. Stanno facendo una ricerca sulle fonti energetiche, scrivono un sonetto, inventano un nuovo teorema, un programma informatico, oppure semplicemente giocano a Formula uno, o chattano con i compagni dell’asilo, o cercano un viaggio low cost per la Thailandia? A me sembra diverso usare un computer per scrivere un libro, leggere Cartesio, seguire un corso di russo on-line; oppure usarlo per ascoltare l’ultimo Ligabue, vedere una scenetta di Aldo Giovanni e Giacomo, giocare a Tetris o godersi su You Tube il filmato in cui quattro cretini provano a schiantarsi in auto contro un muro. Lo strumento è uno, ma gli usi sono tanti. E soprattutto, è diverso usare un oggetto come strumento o farne invece il fine della nostra (vuota) giornata. Ad esempio, una cosa è fare informatica, un’altra è navigare, chattare, twittare. Sarebbe bene distinguere tra creare e usare: una cosa è creare un prodotto, una cosa è esserne semplicemente utenti. Ho l’impressione che i giovani siano soprattutto consumatori e utenti. E perlopiù, usano senza capire quel che usano, cioè come è fatto quel prodotto. Informatica è calcolo, è logica; vuol dire avere una sapienza, possedere nozioni anche di altissimo livello, con cui creare, inventare programmi complessi che prima non c’erano. Chi naviga e chatta e twitta, invece, non crea un bel niente. Usa solo quello che è già stato creato, e può anche non sapere niente se non pigiar tasti, aprir finestre, sfiorare schermi, introdurre usb, dvd, cd. È di questo che siamo tanto ammirati, e di cui parliamo come strabilianti Nuove abilità dei Nuovi giovani? Io credo, a dispetto del cosmico peana del Nuovo e della collettiva infatuazione tecnologica che ci comprende, che noi italiani in generale – adulti e giovani, fa lo stesso – siamo fondamentalmente ignoranti e arretrati in fatto di tecnologie informatiche e di comunicazione, le cosiddette ICT (Information and Communication Technology). Ne sappiamo ben poco. Nella scuola soprattutto non si distingue abbastanza fra tecnologie orientate alla comunicazione, chiamiamole c-technologies, e tecnologie orientate alla conoscenza, chiamiamole k-technologies (k come knowledge). Non ci si rende bene conto che alla diffusione delle prime non corrisponde necessariamente quella delle seconde. Sul piano strettamente tecnologico il prototipo della c-technology è il telefonino, il prototipo della k-technology è il computer. Anche se smartphone e tablet avanzati come l’iPad ora cercano di ibridare le due tecnologie, i due strumenti nascono con missioni molto diverse: la missione originaria del telefonino è semplicemente di mettere le persone in condizione di comunicare fra loro; la missione originaria del computer è di consentire lo svolgimento di operazioni complesse, come l’analisi o l’elaborazione di un testo, la creazione e la manipolazione di immagini, la costruzione o l’esecuzione di programmi di calcolo. Mi sembra che il recente enorme sviluppo della Rete sia stato soprattutto una dilatazione della prima missione, quella della messa in contatto: messaggini, e-mail, Facebook, Twitter, blog, ma anche navigare, scaricare testi, musica e film. Tutte funzioni elementari e neutre, di mera trasmissione di contenuti vocali, visivi o scritti, senza il valore aggiunto delle k-technologies. La seconda missione, quella di abilitare allo svolgimento di operazioni complesse, è rimasta più in ombra. Ho letto che in Italia ci sono novanta milioni di cellulari e meno di tredici milioni di computer. Come dire che una famiglia su due non ha un computer, ma in compenso il numero medio di cellulari a famiglia è quattro: un computer ogni otto cellulari! I nostri ragazzi, quando escono da un liceo, son capaci di usare l’informatica e la Rete come strumenti di crescita della conoscenza, o solo per il divertimento e il consumo? Sanno confezionare una ricerca in meno di un’ora usando Wikipedia e PowerPoint, sanno prenotare un aereo via Internet, sono capaci di scaricare musica e film, di installare un nuovo gioco o un nuovo software, di montare un video e metterlo su YouTube. Ma non hanno la minima idea di come funzionano le telecomunicazioni, o dell’organizzazione logica di un computer. Non padroneggiano alcun linguaggio di programmazione. Non conoscono nessun software scientifico, sia esso di tipo logico, di tipo matematico, di tipo statistico. Non sanno nulla di intelligenza artificiale. Riescono a trovare informazioni su quasi qualsiasi argomento, ma non sono minimamente in grado di valutarne l’attendibilità. Navigano fra un sito e l’altro, ma raramente sanno quando approdano in un porto sicuro. In breve, fanno un uso molto basso della tecnologia. Sono utenti: piccoli impiegati ammaestrati a svolgere la loro precisa funzione, niente di più. Eppure si credono i signori del Nuovomondo (detto Web). Come ebbe una volta a dire Umberto Eco, i suoi giovani allievi mostravano una dimestichezza invidiabile sui personal computer, ma eravamo stati noi, quelli della generazione precedente, a scrivere i software che loro usavano con tanta destrezza! Insomma, riassunto della prima nuvola: forse quello che sappiamo fare è solo comunicare. Quello di cui andiamo oggi così fieri e che ci passiamo come massima innovazione del genere umano non è altro che una (probabilmente patologica) ipertrofia della nostra capacità di comunicare. Se così è, mi pare molto triste. Avevamo il sogno di una «società della conoscenza», e ora viviamo nella modesta realtà di una «società della comunicazione»: una società che ha fatto della comunicazione il suo maggior passatempo-divertimento, al punto da diventarne dipendente come da una droga. La seconda nuvola è che Internet ci dà l’illusione del sapere. Cioè, non solo non ci dà affatto il sapere (come i più credono), ma in più ce ne dà l’illusione, che è molto peggio che non darci nulla: nulla sarebbe più onesto, ecco. Col fatto che in Rete si trova tutto, basta cercare e tutte le «nozioni» sono lì a nostra disposizione, noi abbiamo maturato la convinzione che andando su Internet sapremo tutto. Digitiamo la parola chiave sul motore di ricerca, clicchiamo INVIO, subito magicamente ci appare ciò che abbiamo evocato dal nulla (come gli antichi evocavano i morti), leggiamo, «evochiamo» altre voci collegate, navighiamo di documento in documento... E alla fine ci pare di sapere tutto. E in effetti, sì, abbiamo letto e visto tanto, siamo venuti a contatto con tantissime informazioni. A quel punto, paghi e soddisfatti, usciamo, ci sconnettiamo, chiudiamo il computer e via. Abbiamo finito il lavoro. Domanda: sappiamo qualcosa? abbiamo appreso e dunque sappiamo? cioè, usciamo dalla seduta al computer con il possesso mentale definitivo di qualche cosa? Non credo. Dopo aver navigato per ore su Internet, personalmente ho la sensazione d’aver passato il tempo, e basta. Un nauseabondo senso del nulla. Novello spleen dell’era digitale. Mi par d’essere scivolata sull’acqua di un lago torpido. E mi accorgo all’improvviso di essere in grado di ricostruire ben poco di tutti i viaggi compiuti, i luoghi raggiunti, le cose viste. Non abbiamo trattenuto niente, perché ci siamo limitati a guardare, leggere, stampare: non abbiamo studiato, e quindi alla fine NON SAPPIAMO NIENTE. Guardare, leggere, stampare sono i verbi che hanno sostituito il verbo studiare: la cosa più grave è che, però, ci danno l’illusione di aver studiato. Noi usciamo da Internet con l’illusione di sapere, questo è il guaio. Voglio dire che mi par di vedere, in molti di noi ma soprattutto nei giovani studenti, una sincera autoconvinzione d’aver davvero studiato, mentre si è solo guardato o al massimo letto un libro, un capitolo, una pagina di testo. È una specie di self-deception colossale, un mega-autoinganno di massa, non saprei in che altro modo chiamarlo. Noi tutti oggi siamo sinceramente convinti di sapere, soltanto per il fatto di aver navigato qualche ora in Rete o aver stampato qualche voce da Wikipedia. Invece non sappiamo un bel niente. Se qualcuno ci chiede di ripetere quel che abbiamo letto, guardato, stampato, blateriamo un minuto al massimo e poi ci accasciamo in un silenzio da oltretomba. Per sapere, bisogna trattenere. Appropriarci delle cose, farle scendere giù nell’hardware della nostra mente, ancorarle. Studiare è questo. Aprire delle stive mentali, dove sistemare le cose. Solo se trattieni, sai. Solo se il tuo sapere «sta», ed è organizzato-strutturato in qualche tuo cassetto mentale, solo così lo possiedi. Sta nella tua ram, lo tieni, e puoi farne quello che vuoi. Internet non ci dispensa dallo studio, questo è il punto. Internet è uno strumento, può benissimo sostituire i libri e le enciclopedie, se preferiamo così. Ma le videate e le stampate, poi, bisogna studiarle allo stesso modo di un libro. Non c’è salvezza, mi spiace. Non è che, usando il supporto video, magicamente le cose si trasferiscono nella nostra mente e lì dimorano per sempre rendendoci sapienti! Magari fosse così... Questo maledetto sforzo di memorizzare e organizzare e trattenere bisogna che lo facciamo sempre e comunque. Anche perché Internet è piuttosto disorientante, direi: non ci dice mai dove siamo, è una stupenda nave che ci porta ovunque, nello spazio e nel tempo, è Star Trek: ci conduce nello spazio infinito, ma omette le coordinate. Ci porta esattamente dove noi gli chiediamo di andare, ma ci nasconde il viaggio, il percorso, le tappe. Gli diciamo: Portami a Shanghai! E lui in un attimo ci porta. Sì... ma dov’è Shanghai? Se noi non lo sappiamo, non ci serve averla trovata. Troviamo le cose che cerchiamo, ma non le collochiamo più e quindi restano per aria, inutili, volatili. In Internet sono saltati i sistemi di riferimento, è come se ci avessero preso la bussola. O cancellato gli assi cartesiani. La scuola dovrebbe dare proprio quelle coordinate, così che l’uso di Internet sia proficuo. Ma, proprio se crede nelle sue potenzialità, dovrebbe differenziarsi enormemente da quello strumento, fare il servizio opposto, direi. Dovrebbe, per esempio, favorire la concentrazione e l’immagazzinamento mentale, detto anche studio, e non illuderci, invece, che la pura e semplice navigazione libera in Rete ci esimerà dallo studio. Questo è un diabolico, imperdonabile inganno. Sarebbe come dire: non ti insegno più l’inglese, perché tanto c’è il dizionario, tu lo apri, cerchi la parola e la sai. Giorni fa un amico che insegna Statistica a Scienze della Formazione mi ha raccontato il seguente fatto. Comincia il suo corso e, per accertarsi che i suoi allievi possiedano le conoscenze di base necessarie, chiede loro quanti ricordano che cosa sia una relazione di equivalenza. Alza la mano un solo studente, e il mio amico si stupisce molto perché secondo lui la relazione di equivalenza è normalmente argomento di studio alle superiori. Quindi cambia leggermente la domanda: chiede quanti di loro, pur non ricordando l’argomento, ricordano comunque di averlo studiato al liceo. Questa volta alzano la mano quasi tutti, e sono circa un centinaio. Perbacco, dice il mio amico, ma dunque ricordate d’aver fatto una cosa, ma non ricordate la cosa? È questo il punto: da un po’ di tempo a questa parte nulla rimane nella mente, nulla si deposita. Facciamo tanti «Giorni della memoria» a scuola, e poi lasciamo che i nostri allievi dimentichino tutto... Internet li abitua a dimenticare. E la scuola uguale, continua l’opera, invece di contrastarla: a forza di verifiche ed esoneri, persegue l’arte di dimenticare. L’esonero... quale stupenda diabolica invenzione! Così funziona oggi l’università. Metti che ci sia un esame di trecento pagine da studiare. Noi esoneriamo lo studente da una parte del programma, gli facciamo portare cento pagine alla volta, così non porterà mai le trecento pagine tutte insieme, lo «liberiamo» dal tenere a memoria tutto quel testo così lungo, glielo spezzettiamo in modo che, pezzo dopo pezzo, lui sia autorizzato a dimenticare, a buttarsi dietro le spalle ogni volta la parte di programma che è già stata verificata. È un modo per liberare la ram: studiare e lasciar cadere, studiare e dimenticare. Così nulla resta. Tutto passa sopra come l’acqua, è una doccia perenne. Insomma, per poter usufruire appieno e con effettivo profitto di Internet, bisognerebbe già sapere. Aver studiato prima, possedere già una buona dose di conoscenze: altrimenti la nostra navigazione sarà per forza soltanto un vacuo vagare da un punto all’altro, come una palla da biliardo; sarà divertente, e solleticherà molto la nostra curiosità, ma difficilmente ci porterà a costruire qualcosa di solido. Chi possiede già una sua personale dispensa di nozioni, chi ha letto libri, conosce l’esistenza di certi autori, e personaggi, e fatti, e idee, allora sì che può proficuamente navigare. In realtà naviga tra le sue conoscenze, che però il mezzo gli rende molto più agevole ritrovare. Ecco, ri-trovare e non trovare: questo sarebbe l’uso migliore di Internet. O meglio, ritrovare e poi, ogni tanto, trovare anche qualcosa di nuovo. Che però si sappia collocare all’interno del già noto, e quindi sia davvero utile. Trovare ma non collocare è completamente inutile. Per questo molti della mia generazione sono oggi così entusiasti del Web: perché loro «sanno», hanno studiato, hanno fatto una scuola strutturante che ha dato loro conoscenze ben inquadrate e ben collocate nello spazio e nel tempo: certo che per loro adesso è una meraviglia usare Internet; perché posseggono le coordinate! Ma i giovani? I giovani non possono che giocare con Internet, visto il livello di scuola che gli stiamo offrendo... Vorrei spiegarmi meglio, perché mi sembra un punto fondamentale, soprattutto in relazione alle nostre capacità creative. Internet è un contenitore di conoscenze infinite, certo. Ma se io non ho studiato, non so che esistono. E se non so che esistono, come faccio a cercarle? E se non le cerco, non le troverò mai. Faccio un esempio: prendiamo una frase che esprime un mio giudizio su un piatto di verdure che assaggio al ristorante e mi pare particolarmente variopinto e trasgressivo; ebbene, io posso dire «che piatto futurista!», per analogia con lo Zang Tumb Tumb di Marinetti. Lo posso fare perché «so» il Futurismo: ma non sarà certo Internet a suggerirmi l’analogia, perché io non cercherò mai Futurismo a proposito di un piatto di verdure e quindi non arriverò in alcun modo e con nessun mezzo (se non la mia testa!) a una tale, diciamo originale, valutazione culinaria. Insomma, non è vero che Internet mi dà tutti i possibili collegamenti: mi dà quelli più linkati, e quelli più ovvi. Ma il lampo mentale, l’idea, la lampadina, mi si accende solo se io so. E i lampi migliori sono proprio tra cose le più lontane tra di loro, sono collegamenti impensati, inediti, inimmaginabili. L’epistemologa Mary Hesse ci ha spiegato come sia l’analogia il motore principale per le scoperte scientifiche, e in particolare l’analogia tra ambiti diversi del sapere: io prendo una nozione di un certo campo del sapere, la trasferisco su una nozione di tutt’altro ambito e ottengo il corto circuito, l’idea che può essere geniale.17 Ebbene, Internet non può fare questi collegamenti al posto nostro, mi dispiace. Siamo ancora noi i padroni dell’universo, almeno del nostro universo mentale. Solo sapendo, cioè avendo trattenuto e avendo riempito la dispensa o ram che è la nostra mente (cioè avendo studiato!), noi siamo in grado di collegare mondi remoti, stabilire analogie, innescare lampi. Se la nostra stiva è vuota, Internet sarà solo un meraviglioso passatempo. E siccome la questione che ci sta a cuore è proprio la capacità di pensare, avere idee nuove e saperle esprimere, io temo che, se non «sappiamo» più nulla di nostro e ci limitiamo a «passeggiare» nello spazio intergalattico di Internet, le nostre saranno solo, appunto, meravigliose passeggiate. La terza nuvola è la frammentazione. Navigare-sorvolare nel mare del Web ci porta per forza di cose a spiluzzicare frammenti di un Tutto che è perduto per sempre. Perdiamo la visione completa e lineare delle cose, e acquisiamo una visione a sprazzi. Prima tenevamo gli occhi sempre aperti e quindi potevamo agevolmente vedere le cose nella loro disposizione lineare nonché, quindi, nella loro totalità. Adesso è come se vedessimo aprendo e chiudendo continuamente gli occhi: a sprazzi. È come se arrivassimo nei luoghi dopo aver viaggiato sempre bendati. Certo, poi guardiamo con attenzione la città dove siamo capitati e siamo in grado di godere delle bellezze del luogo: ma ci siamo persi il viaggio! E ci è ormai difficile collocare le cose e gli eventi su un nastro spazio-temporale. A Shanghai ci arriviamo, come dicevo, ma non sappiamo più quali continenti abbiamo attraversato. Non so che cosa produrrà questo, nell’economia della nostra mente e dunque nella storia della nostra civiltà. Ma mi dispiacerebbe perdere la capacità di controllare e dominare il Tutto, e possedere soltanto frammentini minuscoli di quell’immenso Vetro da cui prima guardavo il mondo nella sua interezza. Se non ci danno più l’immagine intera, ma solo i tassellini alla rinfusa, mi chiedo come faremo a costruire il puzzle. Adesso sono arrivate le app, le applicazioni, e ci dicono che la musica cambierà. L’introduzione dell’iPad, come ci spiega Chris Anderson, direttore della rivista «Wired», è una rivoluzione. Lo ha intervistato Federico Rampini su «Repubblica» il 6 settembre 2010, per l’uscita del numero intitolato «The Web is dead». Ops! Dead? Sì, Anderson sostiene che adesso si userà Internet in un altro modo, entrando direttamente nel servizio che tu, a pagamento, hai scelto di attivare. Una specie di microcosmo a tua immagine e somiglianza: tutto ciò che vuoi e che ti serve al momento, racchiuso in pochi centimetri quadrati e accessibile con un semplice touch: l’orario dei treni e la vita di Beethoven, la mappa del Texas, la ricetta del coniglio in salmì e una pagina di «Tuttosport». Tocchi, e ti si apre l’universo: il tuo, miniaturizzato, «personalizzatissimo» universo! Frequenteremo giardini chiusi che ci sembreranno immensi. E secondo Anderson questa novità delle applications sconfiggerà la frammentazione e la superficialità del nostro attuale navigare in Rete: «Siamo in una transizione dall’era del multitasking, in cui facevamo troppe cose alla volta (telefonavamo guardando lo schermo del computer), a un monotasking. La nuova generazione di tavolette, i lettori digitali, ci spingono alla concentrazione». Già... Ma chi ci difenderà dall’irresistibile tentazione di un super zapping colossale, di un saltabeccare da un universo all’altro? Dal leggere un libro a sfogliare un giornale a guardare un film a scrivere una mail a prendere appunti a consultare l’orario dei traghetti a scegliere un ristorante a cercare una voce su Wikipedia a comprarci una bicicletta usata... L’iPad potrebbe diventare un meraviglioso strumento di autodistrazione continua. Un parco giochi personale illimitato. Anche utile sì, molto utile. Come un coltellino svizzero, da cui estrai dieci strumentini diversi: le forbicine, il cavatappino, la limettina, la forchettina... Puoi tagliare il legno, limare le unghie, stappare la Coca-Cola, mangiarti la pasta. Magnifico per l’emergenza, o se hai scelto una vita da boy-scout... Voglio dire: va benissimo l’iPad. Ci servirà moltissimo, soprattutto in viaggio. Ma temo possa aggravare la nostra attuale incapacità di stare fermi e concentrati su una cosa sola. Tanto per capirci, ho letto che ai ragazzi non piace più andare al cinema. Lo sapete perché? Lo ha detto una di loro, quella sedicenne che ha raccontato sui giornali, estate 2010, la sua vacanza nell’isola greca di Ios, uno dei templi della movida, dove si balla tutta la notte e si dorme tutto il giorno; ha detto che i suoi coetanei non vanno neanche più al cinema perché un film dura due ore, e loro non riescono più a stare fermi per due ore! Ecco, questo mi preoccupa. Si leggeranno comunque libri sull’iPad? Sì, certo. Ma non credo proprio che apriremo un libro a pagina 1 e lo leggeremo tutto fino a pagina 321, per esempio, mettendoci il tempo necessario. Credo che l’iPad cambierà la nostra lettura. E che i libri non saranno più libri, ma oggetti ibridi da toccare, guardare e ascoltare: libroidi o libridi.18 La lettura non sarà più un tempo di concentrazione e solitudine, ma un’esperienza collettiva, una performance, un’avventura interattiva in una iperconnessione perpetua. Andrà tutto bene? Può darsi, chi può dirlo? Ma anche altri sono, come me, cieli percorsi da nuvole. Il saggista tedesco Frank Schirrmacher, per esempio, parla di «demenza digitale di massa» e denuncia la preoccupante scomparsa di facoltà quali la memoria e la concentrazione. Nicholas Carr, lo scrittore americano esperto di tecnologie, business e cultura, ha pubblicato un saggio nel 2008 dal titolo Google ci rende stupidi?, seguito da un altro saggio nel 2010 che ha come sottotitolo «Quello che Internet sta facendo al nostro cervello», in cui esamina gli effetti negativi sulle nostre capacità cognitive, tra cui la capacità di concentrazione e di contemplazione. Eric Schmidt, il presidente di Google, candidamente ammette: «I nati digitali leggeranno molti meno libri e giornali, cosa che finirà per incidere sui loro meccanismi di apprendimento». Infine, il tecnologo cinquantenne newyorkese, post hippy ed ex guru dell’innovazione Jaron Lanier scrive You Are Not a Gadget per metterci in guardia dai pericolosi usi del Web, dall’illusoria idea di libertà e dal potere di manipolazione della realtà virtuale. Ci dice che il Web ci rende gadget, «non-persone», distrugge la nostra capacità di creare, la forza rivoluzionaria del pensiero, non è che una ricombinazione insensata di frammenti, ci fa regredire a uno stato di inciviltà e violenza, ci omologa e ci rende schiavi creando una dipendenza da cui sarà sempre più difficile disintossicarsi. È un brodo di cultura dove anonimi individui annaspano, consegnandosi a un’altrettanto anonima intelligenza superiore, una sorta di «Dio superdigitale»: Internet. Oibò... Forse celebrare oggi il trionfo del w.w.w è già roba vecchia. Gli americani si chiedono quali nefande conseguenze abbia un uso tanto idolatra del computer, e noi italiani invece qui a riempirci di gadget e a diventare beatamente gadget noi stessi. Non vorrei fossimo i soliti a cavalcare un’onda che s’è già disintegrata a riva... Mi tornano alla memoria alcune voci del passato recente e autoctono, che già anni fa si levavano a metterci in guardia e che nessuno, ovviamente, ha mai ascoltato, perché la sirena del Futuro meraviglioso che ci stava davanti era potente e fascinosa, impossibile resisterle. Lucio Russo, per esempio, nel suo profetico Segmenti e bastoncini, avvertiva del rischio di «scambiare lo strumento con il fine», si scagliava contro «chi vede nelle nuove tecnologie l’agognato strumento di riscatto degli analfabeti, che grazie all’informatica dovrebbero finalmente riuscire ad abbattere l’aborrita cultura dei libri e dei cosiddetti ’saperi verbali’», e vedeva già perfettamente che la nuova scuola di massa stava formando una massa, appunto, di semplici fruitori di prodotti, ovvero di «consumatori, oltre che contribuenti ed elettori» ovvero, ancor meglio, «consumatori evoluti, attenti cioè alle novità, capaci di mutare continuamente le abitudini di consumo». 19 E Giulio Ferroni, nel suo libro La scuola sospesa, ci metteva in guardia dalle illusioni delle «didattiche democratiche », dalle riforme «progressiste» fondate sui miti dell’autonomia e del territorio, dal «mammismo pedagogico» e dal trionfo tecnologico dell’informatica e della digitalità. E Giovanni Sartori, nel 2000, deplorava il passaggio dall’ homo sapiens all’ homo videns, avvertendo che il sapere per immagini non è per niente una conquista, ma un regresso, e che la civiltà delle immagini, attraverso televisione e Internet innanzitutto, sta distruggendo le nostre capacità di astrarre, capire, leggere significati simbolici, e quindi impoverisce la nostra cultura: le immagini possono essere informazione, ma l’informazione non è conoscenza. Diceva anche, in quel libro, che Internet è un utile strumento solo per chi ha compiuto studi astratti; i giovani invece, avendo perso ogni capacità di astrazione, non potranno che usare Internet per giocare. 20 Profeti del controfuturo: così li definirei, più che paladini del passato o nostalgici o dinosauri. A proposito, nel suo Il ritorno del dinosauro, Piero Dorfles sostiene che leggere meno libri è molto grave, che informazione e conoscenza sono due concetti ben diversi, e che ci vorrà una vera rivoluzione culturale per fermare il declino in atto. 21 Cassandre del nostro sfascio cognitivo, eroi inascoltati di un coraggioso scetticismo anti-Web. Nessuno di loro fa testo: gente ancora strutturata all’antica, così vengono perlopiù giudicati (e archiviati), poveri simbolico-ricostruttivi senza speranza. Senza branchie... Il 22 marzo 2010 esce sul «Corriere della Sera» un articolo di Sartori dal titolo Sconnessi e somari. Cita gli ultimi dati di Tullio De Mauro, secondo i quali «il 70% degli italiani è pressoché analfabeta o analfabeta di ritorno, cioè fatica a comprendere testi, non legge niente, nemmeno i giornali». E poi Sartori riassume le quattro cause che secondo lui hanno portato a ciò: lo sfascio della scuola che dovrebbe alfabetizzare e invece non lo fa più perché è caduta nelle mani dei pedagogisti (li chiama «i diseducatori degli educatori»); il «sessantottismo demagogico dei politici»; il permissivismo illuminato delle famiglie spockiane; ma soprattutto, quarta causa, la tecnologia che inneggia all’ homo novus zappiens avviato a gloriosi destini grazie alle sue Nuove abilità, multitasking in primis. Suo commento finale folgorante, sulla fede nei nuovi media: Io direi che così veniamo abituati alla «sconnessione», a un saltare di palo in frasca che equivale alla distruzione della logica, della capacità logica di pensare una cosa alla volta, di mettere questa scomposizione analitica in sequenza, e nell’accertare se un rapporto prima-dopo sia anche un rapporto causa-effetto... Il progresso della tecnica è inevitabile. Ma deve essere contrastato quando produce l’homo stupidus stupidus. Sempre più i ragazzi di oggi vivono per 12 ore al giorno in «iperconnessione » e così, anche, in «sconnessione». Sono giustamente disgustati dalla politica. Ma dovrebbero anche essere disgustati di se stessi. Cosa sapranno combinare da grandi? 6. Aspettando Godot E così, siamo arrivati alla fine del nostro breve, e molto personale, excursus storico. Siamo tornati al mito di quel Nuovomondo da cui eravamo partiti, passando attraverso le telefonate a Chiamate Roma 3131, l’antinozionismo alla don Milani, la fantasia alla Rodari, la nuova pedagogia dell’asse Berlinguer-De Mauro, le competenze dei tecnocrati europei, i tagli della Gelmini. Bene, ora ci ritroviamo esattamente alla domanda da cui eravamo partiti: e se il mito del Nuovomondo, dominato dalle fantasmagorie tecnologiche del Web, fosse l’ultimo stadio dell’inganno, lo strumento finale della distruzione, il tassello definitivo della scuola di massa antistudio e anticultura, l’ultima fede in cui ciecamente ci siamo buttati a credere e grazie alla quale ancora una volta inganneremo i deboli, l’ultimo mattone di una scuola dove la massa sarà ancora una volta illusa e bidonata: dove, cioè, le si passerà per buono un misto di infarinature e pseudo-saperi-utili lontanissimi da un vero sapere, una specie di multi-illusione sapienzial-tecnologica? La risposta per me è molto chiara (si vedano le «nuvole» suddette): sì, io credo che sia l’ennesimo inganno. Credo che il viaggio sia cominciato prima, che molte siano state le tappe dell’inganno perpetrato ai danni dei deboli, che sia stato un viaggio molto lungo e variegato e composito, ma chiaramente diretto a un’unica meta, pur con ragioni diverse e a volte anche opposte: distruggere la scuola fondata sullo studio e sulla parola, o, per meglio dire: la scuola di uno studio fondato sulla parola. Prima ciò è avvenuto su basi ideologiche, perché la parola (la grammatica, la letteratura) era considerata l’esclusivo dominio dei ricchi e dei privilegiati, e quindi andava abbattuta; ora perché è arrivato il Web, siamo tutti visivi, esperienziali, e quindi il progresso stesso ci porta di per sé fuori dal linguaggio verbale. Perché penso sia un inganno? Per una ragione molto semplice: perché, come tutti possiamo piuttosto facilmente constatare, la parola non è ancora morta. E non si sa affatto quando morirà. Potrebbe essere un’agonia lunga anche qualche decennio. E potrebbe anche non morire mai... Comunque sia, oggi a me pare che parliamo e scriviamo ancora: nonostante quel che ci dicono entusiasti i profeti del Nuovomondo, noi oggi usiamo ancora la parola, il linguaggio cosiddetto verbale. Anzi, mi risulta che sia considerato più che mai utile e vantaggioso saper parlare, come anche saper leggere e scrivere, e che convenga saper fare queste cose ai massimi livelli, e non ai minimi o il meno peggio possibile, vista la terribile competitività cui il mondo globale ci espone. Soltanto la padronanza estrema e più raffinata della parola apre ancora le porte del lavoro, del prestigio, del successo, economico e professionale. Questo vediamo oggi. Detto ciò, può anche darsi che presto smetteremo di esprimerci parlando e scrivendo, che saremo tutti visivi ed esperienziali. Ma presto quanto? Dieci, venti, cinquant’anni? Non importa sapere il momento esatto. Ma fino ad allora, fino a quando l’uomo non avrà trovato un’altra forma per esprimere (ovvero rendere visibile) il suo pensiero (non so, dei segnali corporei specifici, raggi laser, suoni gutturali, lampeggi vari o immissione diretta nel cervello altrui di flussi mentali), che cosa intendiamo fare, smettere di parlare e di scrivere? e quindi smettere di insegnare/imparare la nostra lingua? Insomma, la parola non ci è (ancora) indifferente, inutile o inessenziale. È (ancora) la rappresentazione stessa del nostro essere, la sostanza della nostra umanità, il nostro umanesimo permanente. Quindi nel frattempo, diciamo aspettando Godot, vedrei molto bene che la scuola italiana prevedesse ancora l’insegnamento della lingua italiana, in tutti i suoi più raffinati livelli e registri, fino alla letteratura, per dire. La riterrei cosa proficua, necessaria. E anche eticamente doverosa. Dico cose ovvie, e me ne vergogno. Che ci sia bisogno di affermare l’importanza di saper parlare e scrivere; che un’idea così banale sia oggi così controversa, e anche attaccata, e bollata come nostalgica e passatista e politicamente scorretta, è desolante. Eppure, quando scrivo queste cose o le dico in pubblico, molti replicano polemicamente che tutto ciò appartiene a un’idea vecchia di scuola. Non so perché siamo giunti a questo. Non so perché dire che sarebbe bene insegnare l’italiano sia oggi inteso come un ritorno alla scuola del passato. Forse qualcuno pensa che la scuola del futuro debba insegnare il mutismo o il linguaggio dei gesti, e che quindi il mondo del futuro sarà un mondo di muti gesticolanti? Può darsi che fra vent’anni — o anche solo dieci – la parola non serva più. Può darsi che tra vent’anni davvero una serie di microchip ci percorrerà le vene in lungo e in largo attivando in noi sistemi di comunicazione telepatica o accendendo fanalini lampeggianti tra i pori, per cui non sarà più necessario usare le parole. Ma oggi non è ancora così. Penso anche, in margine, che ci precedono millenni, dico millenni, in cui l’umanità ha «usato» la parola, lasciandoci opere meravigliose: stiamo attenti prima di buttare tutto a mare; chiediamoci come possiamo permetterci uno scempio simile, noi, in nome di una temporanea infatuazione collettiva per una novità tecnologica che oggi tanto ci attrae. Siamo come i bambini di fronte al nuovo gioco, attratti dalle luci lampeggianti e dai bottoni da pigiare, capaci di fare a pezzi il gioco precedente per quello nuovo? Penso che dovremmo smettere di prendere in giro i nostri giovani esaltando le loro Nuove abilità. Che poi sarebbero quelle di usare un programma, o di far funzionare – senza leggere il manuale di istruzioni — un computer o un forno a microonde. Smettiamo di ingannarli, di blandirli. Vediamo le cose per quel che sono. Analizziamoli questi loro meravigliosi messaggini: davvero ci entusiasma questo che abbiamo chiamato il «nuovo linguaggio dei cellulari»? ci entusiasma la riduzione a sillabe e crocette, la sparizione di punteggiatura e di qualsiasi nesso logico-consequenziale, l’uso di dieci parole in croce, sempre quelle, sempre le stesse? ci entusiasma che nessuno sia più in grado di conoscere il significato di parole un po’ più alte e desuete, come inane, procrastinare, contemplativo, eziologia, ameno, lungimirante? Fate la prova, interrogate i giovani, vedrete che non conoscono il significato della maggioranza delle parole presenti in un libro. Dovremmo smettere di dir loro che basterà imparare a usare il computer e avranno il mondo ai loro piedi. Dovremmo smettere di giocare con le parole invece di fare grammatica e letteratura, dovremmo smettere di far scrivere verbali o articoli di giornale invece che temi. Dovremmo cominciare a spiegare loro chiaramente, per esempio, la differenza che passa tra usare e creare, tra copia-incollare e scrivere, tra leggere un pezzo di blog di un anonimo Francesco o un racconto di Borges! Noi li stiamo allevando a diventare una massa di esecutori, con il nostro buonismo e la nostra ideologia non selettiva da assistenti sociali. Noi stiamo creando dei meravigliosi esecutori-consumatori . Noi stiamo insegnando ai nostri ragazzi, in una parola – e scusate la crudezza –, a diventare servi. Dopo tredici anni di scuola, noi consegniamo all’università ragazzi che non sono capaci di studiare, di leggere, di parlare, di scrivere. E dopo l’università, li consegniamo incapaci e ignoranti a un mondo del lavoro che invece li selezionerà eccome, e anche molto crudamente e violentemente. Non passeranno i test, non accederanno alle università migliori a numero chiuso, a stage o master all’estero, non passeranno i concorsi o i colloqui di lavoro, non faranno carriera. Noi li condanniamo a un fallimento lavorativo certo, non preparandoli come si deve. Per non selezionarli prima, li consegniamo a un mondo che li selezionerà poi, e molto più duramente: perché il mondo del lavoro è ancora irrimediabilmente vecchio, cioè – udite! — verbale, si fonda sull’uso della parola e quindi giudica ancora positivamente un tale che sappia scrivere e parlare, e negativamente uno che invece non sappia spiccicar parola e ignori l’uso scritto della lingua italiana. Non solo non li prepariamo al mondo del lavoro, ma poi ci deliziamo a consolarli, li vezzeggiamo come vittime di un sistema iniquo che non sa dar loro un lavoro. Ci dedichiamo amorevolmente a raccogliere i cocci che abbiamo prodotto noi, ovvero i loro pianti. Alimentiamo, noi carnefici, il loro vittimismo. Anzi, cavalchiamo politicamente il loro fallimento, nutrendo e fomentando la ribellione a un precariato o a una non-carriera a cui noi stessi, con la nostra scuoletta da niente, li abbiamo condannati. Credo che sia un gioco veramente perverso. E che dovremmo smettere di giocarci. Non c’è più, nelle nostre scuole, il figlio del contadino per cui era bene – o poteva sembrar bene – abbassare il livello e non fargli l’ Iliade del Monti. Né abbiamo le baraccopoli di Caracas, per cui avrebbe senso inventare anche noi quello splendido progetto che è il Sistema delle Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela, dove si insegna la musica ai ragazzini salvandoli dalla povertà e dal crimine. Adesso nei nostri licei ci sono i figli di quelli che non sono più contadini, hanno da tempo abbandonato le campagne, vivono in città nelle periferie ma hanno il telefonino l’auto il computer, e la domenica vanno al mare o, a seconda della stagione, a sciare. E ci sono i figli del ceto medio benestante, fatto di commercianti e professionisti e piccoli imprenditori, che hanno conquistato carriere, denaro e prestigio, e che partono al venerdì invece che alla domenica, e raggiungono la loro seconda e terza casa al mare o in montagna, dove magari non sciano neanche più perché c’è troppa gente, perché ci sono infatti quegli altri, gli ex contadini ora inurbati periferici, che hanno pure imparato a sciare, preferibilmente snowboard, e vanno giù come valanghe, anzi, spesso provocando valanghe. Come la mettiamo, con questa nuova società opulenta, viziata, sfaticata, che ha in mente solo i soldi, il successo mediatico, i quiz a premi, gli outlet e il weekend al mare? È ai figli di questa gente che noi insegniamo oggi, nei licei, e sono i figli di questa gente che aiutiamo a studiare il meno possibile, facendo una scuola sempre più facile e organizzando infiniti corsi di recupero per recuperarli, e infiniti corsi di orientamento per orientarli. Sono loro la maggioranza dei nostri studenti, alle superiori. Al liceo scientifico in particolare, che è diventato la scuola di base per il ceto medio perché è una buona via di mezzo: non è il liceo classico (eccessivamente impegnativo, a causa di quella maledetta accoppiata latino-greco); ma non è neanche l’istituto tecnico (ambiente troppo modesto, se non addirittura degradato). Ecco, che scuola facciamo per questo ceto sociale medioviziato, fatto di ragazzi che non aprono più un libro? A questo dobbiamo pensare adesso. Questa mi sembra la domanda che non dobbiamo evadere. Quarant’anni fa, quando le masse avrebbero avuto bisogno di una scuola di massa, noi facevamo loro una scuola d’élite (contro la quale giustamente si batté don Milani). E oggi che le masse avrebbero bisogno di una scuola d’élite, noi facciamo loro una scuola di massa, popolare, inclusiva, ma immiserita nei contenuti, alleggerita di cultura e apparentemente superdotata di mezzi tecnologici. Così sì che veramente stiamo creando una scuola classista: a forza di offrire una scuola dequalificata e vuota, a forza di non insegnare più alcuna «nozione» in nome di un’antica battaglia al nozionismo, a forza di sostituire lo studio con il gioco o con la tecnologia, noi non assicuriamo più a nessuno una solida preparazione, e così facendo azzoppiamo definitivamente proprio le classi meno abbienti e facilitiamo enormemente le classi socialmente avvantaggiate che, potendo contare su un ambiente famigliare e sociale culturalmente progredito, sono già perfettamente in grado di integrare le lacune della scuola attuale e di supplire egregiamente allo scarso e ormai inefficace lavoro di noi insegnanti. Non vedete intorno a voi come si muovono le classi alte, quali scuole scelgono per i figli? Sanno perfettamente cosa fare, evitano con grande maestria le scuole statali di quartiere, e si vanno a cercare le scuole internazionali o le scuole confessionali private o quelle rare scuole statali di qualità che ancora sopravvivono: i luoghi esclusivi, dove ancora si insegnano i contenuti, dove si fa grammatica insieme alle lingue straniere, e si fanno leggere libri e si pretende lo studio. Non ci cascano le classi alte, anche se politicamente progressiste e magari laiche: piuttosto mandano i figli dai preti e dalle suore, purché imparino ancora la calligrafia e l’ortografia, facciano il dettato e l’analisi logica, escano cioè con delle basi, una conoscenza, una cultura! In ogni città d’Italia è così, e lo sappiamo tutti quali sono le scuole che funzionano: sono uno o due licei, spesso privati, spesso a pagamento, spesso confessionali. Come mai succede questo? Ce lo siamo mai chiesto? E se sì, perché permettiamo che le cose continuino così? I giovani se ne stanno accorgendo di quel che abbiamo combinato. Oggi, come si può amaramente constatare, c’è un calo di iscrizioni alle università. I giovani hanno capito due cose entrambe tragiche: che arrivano assolutamente impreparati ai corsi universitari (non possiedono le nozioni di base e non hanno nemmeno imparato a studiare); e che, anche qualora ce la facessero, la laurea è ormai svalutata, non serve a trovare lavoro, men che mai un lavoro d’eccellenza. Quindi, è inutile iscriversi all’università, perdendo anni preziosi. Bel «successo» davvero, complimenti alla mia generazione! A chi dovrebbe poter contare su una buona scuola d’élite statale, ai figli della gente umile e povera, che lavora e a stento sbarca il lunario, noi stiamo offrendo oggi soltanto una pessima scuola di massa, condannando all’ignoranza e all’immobilismo sociale proprio coloro che più dovremmo aiutare. Con la nostra scuoletta facile e divertente, dove è vietato fare grammatica e letteratura e Dante con le note (al massimo usiamo i cd del Dante di Benigni, almeno lui è divertente e quindi motivante!), noi stiamo proletarizzando definitivamente il proletariato. Lo condanniamo a essere per sempre proletariato, e consegniamo invece il potere a quei pochi – veramente élite – che per privilegi famigliari possono studiare in scuole dove ancora insegnano a far le aste, a mettere i numerini incolonnati, e gli apostrofi al posto giusto. Strutturano la mente, costruiscono la capacità di pensiero. Cosa che poi consentirà loro di fare un ottimo liceo e di accedere alle università migliori, italiane, ma ancor meglio straniere. Un vero capolavoro classista, complimenti! Soprattutto se penso che tutto ciò è opera di insegnanti e politici di sinistra... Non so come sia stato possibile essere tanto progressisti e aver combinato tutto ciò. Non so come sia possibile ergersi a difensori delle masse e aver sistematicamente privato le masse di un’istruzione alta, e ancora oggi parteggiare per una scuola dove al primo posto ci sia la relazione, il dialogo, l’amicizia con gli allievi, e altre fumosità come: centralità dello studente, strategie di apprendimento, educazione alla cittadinanza, e non le «cose» concrete e fondamentali, matematica, storia, scienze, letteratura, arte... Le basi, le colonne, le fondamenta su cui poggiare una rigorosa e vera preparazione culturale. E adesso, per finire, in preparazione alla terza parte di questo libro dove oserò proporre una possibile alternativa, vi lascio qualche piccolo spunto per la riflessione, così, sfogliando qua e là i giornali... Il 3 aprile 2010, su «D di Repubblica», un articolo di Federico Rampini, sul tema dell’incompetenza che oggi ci circonda. S’intitola Pastorale americana, in omaggio all’omonimo romanzo di Philip Roth. Sottotitolo: I nuovi mestieri, la compatibilità dei software e il neo-analfabetismo di massa. Dice Rampini che è sempre più consueto aver bisogno di tecnici specializzati, di addetti ai servizi che sappiano risolverci un problema con la banca, con Telecom, con Internet, e che è sempre più difficile trovare gente preparata, che sappia fare bene il proprio mestiere. Racconta che a New York, dove egli vive, «l’incompetenza regna sovrana nei ’nuovi mestieri’. Il tecnico della tivù, l’addetto al call center, l’impiegato bancario sono ragazzi e ragazze inesperti. Hanno ricevuto una patina sottile di formazione, frettolosa e grossolana, poi sono stati lanciati allo sbaraglio. La prima impressione che danno è di non aver la più pallida idea di quel che dovrebbero fare. Generalmente questa è anche la seconda, terza e quarta impressione». Rampini dice che non esiste più quella professionalità seria che un tempo si tramandava di padre in figlio ed era l’arte di bottega, dice che non esistono più «artigiani fieri della loro abilità manuale», non esiste più «un’aristocrazia operaia piena di talento, tradizione, amor proprio». Oggi invece «la società si sta popolando di un esercito di poveri mercenari dequalificati e demotivati, interessati solo a cambiar lavoro pur di guadagnare qualche spicciolo in più». Rampini parla di New York, ma penso che potremmo agevolmente trasferire il discorso anche ai nostri giovani, italiani ed europei. Mi colpiscono in particolare due espressioni: la «patina sottile di formazione», con cui oggi ricopriamo i nostri giovani neoanalfabeti, mi fa pensare alle lamine sottili d’oro con cui si rivestono oggetti perché assomiglino all’oro vero; e poi l’espressione «aristocrazia operaia»: mi piace, è un ossimoro, è quel che dovrebbe essere, il senso nobile di sé e del proprio lavoro, qualunque esso sia. La cosa interessante che racconta Rampini è che nel 2000 egli già aveva notato questo fenomeno di dequalificazione artigianale, ma lo aveva preso in positivo come segnale di una «mobilità sociale in ascesa»; gli sembrava la capacità che l’America aveva di «assorbire una manodopera poco istruita e dare opportunità a tutti»: un capolavoro di apertura democratica, insomma. Ma poi dice: «Oggi ho perso l’ingenuità del 2000, e nella mia vita a New York mi vedo circondato da un mare di pressappochismo. In questa metropoli post-industriale, post-moderna, post-tutto, dove trovare una persona che ha un ’mestiere’, lo padroneggia, lo coltiva?». Ecco, padroneggiare un’arte. Coltivare un mestiere... che bella espressione. Il mestiere come pianta. Anche le idee sono piante. Tutto ciò che è veramente creazione ha bisogno di tempo, di acqua, nutrimento alle radici, sole, vento, lavoro, pazienza. Come le piante. Secondo spunto: sullo stesso giornale, lo stesso giorno, solo qualche pagina più avanti: la rubrica Si fa cosìì di Franco Bolelli. E leggo esattamente un pensiero opposto: «Per la prima volta nella nostra storia decine di milioni di umani sono - siamo – autori, produttori di contenuti. Di più ancora: ciascuno di noi è diventato un vero e proprio network, che crea, comunica, raccoglie, condivide squarci di biografie individuali, informazioni, materiali, impulsi, progetti. Ogni giorno, in istantanea diretta, dal vivo». Mi chiedo se l’autore abbia usato l’ironia o no. Qualcosa mi dice di no, non scorgo segnali di ironia. Quindi dev’essere tutto maledettamente letterale, e vero! Aiuto. Penso che io non voglio diventare un network. Penso anche che non voglio condividere squarci di biografie individuali. E qui... mi fulmina di colpo un pensiero-ricordo, anzi due: una volta c’erano le portinaie, e le verduraie e le vicine di casa pettegole, che ti mettevano a parte degli squarci biografici altrui, detti anche pettegolezzi. Non solo, una volta c’erano i treni con gli scompartimenti a otto posti, e otto persone quindi che durante ore e ore di viaggio si raccontavano le proprie vite. Poi scendevano dal treno e andavano dove dovevano andare e finita lì, di loro non sapevi più niente, ti tenevi dentro le loro storie oppure le dimenticavi subito, a tua scelta. Ecco, ho pensato che Internet copre in fondo quel bisogno lì, e che quindi forse si tratta di un bisogno primordiale eterno e inestinguibile dell’uomo: raccontarsi le proprie vite l’un con l’altro, spettegolare sulla porta di casa, in ascensore, in treno, in un negozio. Forse davvero non possiamo farne a meno. Ho solo una timida domanda, che mi nasce piano dentro, e che oso ripetere solo a voce bassissima: ma dobbiamo per forza chiamare progresso tutto questo spettegolìo mondiale solo perché avviene per via tecnologica, ed esserne per giunta così fieri? Vado avanti a leggere Bolelli. «Perché quello dei social media» scrive «è oggi il luogo al mondo dove più abbondantemente si scambiano esperienze. È il primo strumento di massa che evidenzia le unicità singolari e che nello stesso tempo mette in relazione le unicità singolari, in una proliferazione di legami fluidi, aperti, mutevoli, dinamici. Facebook ci dà la palla in mano per mostrare chi siamo: poi tocca a noi essere chi siamo, tocca a noi giocarcela.» Penso che non voglio essere una unicità singolare. Penso che non voglio contribuire alla proliferazione di legami fluidi. Mi fanno impressione, mi viene da pensare ai succhi gastrici e ai liquami delle fogne. Penso, infine, che non voglio nessuna palla in mano. E tantomeno mostrare chi sono. Con i giornali del giorno dopo va ancora peggio. E siamo al terzo spunto, 4 aprile 2010 (è pure Pasqua). Leggo un trafiletto sulla nuova edizione del libro-intervista di Tullio De Mauro e Francesco Erbani, La cultura degli italiani. L’autore della piccola recensione, Sandro Modeo, riporta i dati aggiornati «sgomentanti», dice, sul nuovo analfabetismo (il settanta per cento della popolazione) e sull’acquisto di libri e di giornali per cui l’Italia è molto al di sotto della media europea; poi informa che però De Mauro non si limita a descrivere il preoccupante disastro, ma propone anche una soluzione, «a partire da un obbligo scolastico prolungato e una maggiore diffusione di Internet». Nuvole nere si addensano nei miei cieli atlantici. Piove. Non ce la faremo mai. Se anche il professor De Mauro, come possibile rimedio per la massa dei nuovi analfabeti, propone di prolungare ulteriormente l’obbligo scolastico e di diffondere maggiormente Internet (d’accordo con la Gelmini?), allora di colpo capisco che è la fine. Inutile lottare. Tutti a scuola per anni e anni a imparare il nulla più a lungo, tutti a smanettare sul computer tra un sito e un blog, convinti di essere in un fulgido futuro. Con la lavagna interattiva, naturalmente... PARTE TERZA LO STUDIO COME SCELTA CAPITOLO UNO Togliamo il disturbo 1. Tre parole che non ci piacciono più Oggi, se parli di studio, sei subito vecchio. Pesante, lento, bacucco, fuori moda, antipatico e noioso. Studio è una parola perdente a priori: appena la pronunci, hai già perso. Non studiare invece è bello, sa di nuovo, di fresco e di gioioso. È come andar per campi a fare una merenda, o i tuffi dagli scogli, o una camicia appena lavata stesa al sole. Accettare o addirittura propugnare il nonstudio è molto più simpatico e accattivante, ti mette subito dalla parte dei giovani e degli innovatori, sperimentatori, scapigliati, avanguardisti, svecchiatori del mondo: dalla parte giusta, insomma. La voglia di non studiare viene da lontano, attraversa i secoli e forse i millenni. Potremmo dire che è connaturata all’essere umano: da sempre, e per definizione, il giovane non ha voglia di studiare; preferisce fare cose più divertenti, ed elude in vari modi l’impegno sui libri. E da sempre gli adulti variamente lo obbligano a studiare controvoglia, con minacce, punizioni, premi, raccomandazioni, occulte persuasioni. Fin qui, dunque, tutto normale. Ma oggi sta accadendo qualcosa di davvero sconvolgente e imprevedibile: anche gli adulti sono d’accordo, non è proprio il caso di studiare. O almeno, non così tanto. Non così a lungo. Non per ore. Non chini sui libri. Non da soli. Non troppo. Non sempre... Lo studio è obsoleto. È diventato una faccenda vecchia, appartiene al passato. E soprattutto, grazie alle innovazioni tecnologiche a cui stiamo attribuendo il potere taumaturgico di salvare il mondo, è inutile: se ne può tranquillamente fare a meno. Anzi, non studiare è moderno, è nuovo. Un ragazzo che non studia è figlio del suo tempo, è avanti: è il Futuro. È rock, diremmo alla Celentano. Facciamo una sosta. Dopo che ne abbiamo parlato per ben due terzi del libro, andiamo a vedere cosa significa studio. Dal Grande Dizionario UTET: « Studio: attività intellettuale e mnemonica, talvolta accompagnata da esercitazioni o applicazioni pratiche, intensa e prolungata nel tempo, volta all’apprendimento e assimilazione delle nozioni fondamentali di un settore del sapere umanistico, tecnologico o scientifico, di un’arte, di una dottrina, di un’attività meccanica, oppure, più ampiamente, degli elementi generali e basilari dello scibile, secondo le diverse materie e discipline». Seconda accezione: «Esercizio di speculazione e di elaborazione, svolto con assiduità in un campo del sapere o nell’ambito di una disciplina scientifica, letteraria, artistica, e diretto alla riflessione teorica o teoretica, all’analisi, alla ricerca, alla formulazione di dottrine o principi innovativi, alla produzione di opere originali e di valore». Accidenti! Rivediamo le parole chiave: 1) lo studio riguarda lo scibile (le nozioni); 2) lo studio ha a che fare con intelletto e speculazione; è un «guardare della mente», una «osservazione» mentale: quindi un’attività teoretica ( speculum e teoria rimandano entrambi al verbo «vedere»!), cioè fondata sulle capacità di astrazione; 3) lo studio ha a che fare con il tempo e la memoria: è legato a una durata temporale piuttosto estesa («prolungata nel tempo», «esercizio svolto con assiduità» dice il Dizionario), tanto da permanere poi nella memoria: significa «stare » a lungo su un argomento o disciplina e attivare quelle capacità che consentono di sapere senza più alcun supporto esterno, di possedere in proprio le nozioni prima «viste»; 4) lo studio infine è apprendimento, assimilazione, elaborazione ; come a dire che consiste in una sorta di «presa di possesso», secondo cui le nozioni sono fatte proprie, si depositano e si trasformano in qualcos’altro, che potrebbe anche dare origine a idee e opere originali, e di valore. Possibile riassunto, nonché traduzione terra terra, del concetto di «studio»: stare fermi per lungo tempo su un oggetto di analisi (libro o altro), fino a che la sostanza di quell’oggetto – miracolo! — si trasferisca nella nostra mente, e lì permanga a forza di memoria, e lì venga anche quasi a nostra insaputa trasfigurata in modo che diventi qualcos’altro, solo e squisitamente nostro, con cui a quel punto possiamo fare quel che vogliamo, anche per esempio creare qualcosa di nuovo e di grande. È questo studio, esattamente in questa accezione, che sta oggi abbandonando la scuola. Ci sono due parole, oggi, altrettanto brutte e perdenti: cultura e letteratura. Che non a caso sono legate alla parola studio, oltreché tra di loro. Letteratura non si usa più. Si dice, al posto suo, scrittura, o creatività. O, meglio ancora, scrittura creativa. Tutto ciò che è letterario appartiene al passato, e sa immediatamente di ammuffito e aristocratico, illeggibile e quindi invendibile. Non fa audience, non fa democrazia, non fa politically correct . È roba per vecchi bibliofili snob, frequentatori di biblioteche e ragnatele, vecchi professori in pensione, gente superata. Anche per questo Tasso non riusciamo a trasmetterlo: perché è letteratura. Per quanto ci industriamo a farlo sembrare altro, a camuffarlo, a renderlo spiritoso e divertente, Tasso questo è: letteratura. Come anche Pavese, Buzzati, Kafka: tutti autori che oggi si fa fatica a passare ai giovani. In effetti, per capire quello che scrivono, bisogna entrare in un ordine di idee diverso dalla realtà che ci circonda: bisogna entrare in un ambito simbolico, di segni astratti, che appartengono a un codice ben preciso. Il codice letterario, appunto. Se lo possiedi, bene. Se no, come abbiamo già detto, resti fuori. Anche la parola cultura non si dice più, è stata sostituita dal suo plurale: culture. L’idea vincente è che ce ne siano tante. Anzi, possibilmente che tutto sia cultura. Anche il cono gelato, la partita di calcio, la scarpa da ginnastica, la criminologia di NCIS. Un po’ è vero. Lo diceva già Rilke, quando veniva in Italia e si estasiava per le bistecche alla fiorentina: quella era cultura, per lui. E aveva ragione... Il pensiero delle culture plurali ci infonde serenità: ci leva un peso, il peso della cultura, appunto... Ciò non toglie però che, a rigor di logica, esisterebbe anche un significato ristretto e ben preciso del termine, un umile significato soltanto tecnico, letteralissimo. Cito (sempre dal Grande Dizionario UTET) alla voce cultura: «Il complesso delle conoscenze intellettuali mediante le quali una persona, attraverso un’autonoma, organica e approfondita rielaborazione, si è venuta formando e affinando intellettualmente e spiritualmente, pervenendo alla formazione della propria personalità; l’ideale di formazione umana tendente alla realizzazione dell’uomo nella sua autentica forma e natura umana; dottrina, istruzione, l’essere educato e ingentilito spiritualmente. — in partic.: Conoscenza approfondita, e frutto di costante studio, di una determinata materia». Ecco lì il famigerato «studio» che rispunta! Riassumendo, sottolineerei le seguenti parole-chiave: conoscenze intellettuali, rielaborazione, spiritualmente, educato, ingentilito... Eh sì, si parla addirittura di ingentilimento e spiritualità. Come se studiare migliorasse l’uomo... Possibile che non ci crediamo più? Eppure è così: se permettiamo ai nostri giovani di non studiare più, e se permettiamo alla nostra scuola di permettere ai giovani di non studiare più, vorrà proprio dire che noi non ci crediamo più. Oggi non si può pronunciare la parola cultura. Se lo fai, senti subito qualcosa che non va, un malessere, una nausea interiore. Vien voglia di scappare, di mettere miglia. In fondo è giusto: non bisognerebbe mai parlare di cultura! L’atto stesso di nominarla è già il segno di un fallimento. Una volta, infatti, non si parlava mai di cultura. Non ci veniva neanche in mente. Noi, dico quelli della mia generazione, non ci siamo mai sognati di parlarne. Quand’ero giovane, da nessuna parte sentivo pronunciare la parola cultura: la si faceva e basta. Ma senza saperlo, e quindi senza dirlo. Ecco perché non se ne parlava: perché la si faceva. La cultura era silenziosamente nelle nostre vite, quindi non c’era alcun bisogno di parlarne. I professori, insegnando, facevano implicitamente cultura. Noi studenti che, tornando a casa sul pullman, parlavamo di libri, facevamo cultura. Così come alla tivù e alla radio si faceva, senza dirlo mai, cultura: ad esempio, mandando in onda un dramma di Pirandello o i dipinti di Caravaggio commentati da un’austera voce fuori campo. Anche in famiglia aleggiava invisibile la parola cultura: era nell’aria. Era nelle cene davanti al telegiornale e poi al carosello, era nel fatto che c’era poca tivù, molta minestra, e si chiedeva il permesso a tavola prima di parlare, quando parlavano i grandi. I genitori erano i grandi, e se prendevi un 4 non osavi neanche dirlo perché i genitori, essendo grandi, facevano i genitori. E se volevi leggere un po’ la sera, prima dovevi lavare i piatti. E l’enciclopedia arrivava a rate, un volume per volta, per anni. Cultura? Non so, non me lo sono mai chiesto. So che i miei avrebbero voluto studiare, da giovani, ma non han potuto. Allora lo studio era per pochi. E siccome a me piaceva, hanno fatto studiare me. Sono stata la loro seconda chance, credo. Io studiavo, e loro dietro. Dietro la porta, dietro la scrivania (che non avevo), dietro le spalle. Attraverso di me, i miei libri, i miei voti. Perché studiavo? Non lo so. Non me lo sono mai chiesto. Chiedersi perché si studia è già smettere di volerlo fare, e quindi a quel punto sarebbe meglio non farlo più. Mi piaceva, era il modo migliore, per me, di passare le giornate. Mi piaceva anche farlo per loro, per i miei genitori? Non so. Mi piaceva renderli contenti di me. Ma soprattutto mi piaceva e basta: lo volevo fare io, per me, di passare le ore sui libri. Poi se la cosa rendeva contenti anche altri, ancora meglio. Magari non proprio sui libri di scuola, ma su quelli che mi compravo di nascosto perché ne ero attratta, gli Oscar Mondadori a 350 lire l’uno, o i libri bianchi dell’Einaudi che invece costavano carissimi. Non sapevo niente di nessuno scrittore, compravo a caso: Ungaretti, Cassola, Pirandello, Kafka, Bernard Shaw, Pavese... Uno dopo l’altro, senza che nessuno me lo dicesse. Quando usciva l’ultimo romanzo di Calvino o l’ultima raccolta di Montale, era una festa. Non ce lo diceva nessuno, ma correvamo a comprarli. Cos’era, cultura? Non so, ma non ero l’unica, ce n’erano parecchi come me. Ai compleanni, dai dodici anni in su, ci si regalava l’ultimo libro della Ginzburg o della Morante. Era normale. Leggere era normale. Non c’era molto altro: la politica, per chi la faceva; la domenica a sciare per chi aveva i soldi; il cinema, le feste il sabato pomeriggio a casa di un compagno, i dischi ballabili. C’era poco, forse per questo si leggeva. Non era un merito. Andava così. E quando c’era sciopero e alle otto davanti a scuola trovavamo il picchetto che non ci faceva entrare, molti di noi andavano al cinema. Allora i cinema erano aperti anche al mattino... Correvamo a vederci l’ultimo film di Godard, di Fassbinder, Pasolini, Wim Wenders, Ferreri, Fellini, Resnais... L’ultimo film di Godard! Avete presente? Vi ricordate cos’era un film di Godard? Tipo Je vous salue, Marie... C’era qualcuno che ci capisse qualcosa? Però ci piacevano da morire film così, come La voce della luna o L’anno scorso a Marienbad... Eravamo felici. Ed eravamo tanti, non certo pochi. Cos’era, cultura? Non lo so, era una parola che non sentivo mai dire. Adesso invece che non si fa più cultura, non ce n’è nemmeno un barlume nell’aria e la sola parola ci fa orrore, se ne parla tanto. Il parlare ha sostituito il fare. Se ne parla tanto perché non si fa. E se ne parla per giunta di sbieco, per dire altro: la parola cultura è diventata, per esempio, una parola politica, che c’entra più con l’economia che con i libri. È legata agli assessorati, ai tagli di bilancio, alle ricadute sul territorio. È merce elettorale, serve per contare i voti. È una macchina, uno degli ingranaggi del mercato. E si è fatta anche visibile e ingombrante: cultura oggi sono le enormi tende di plastica nelle piazze, le bancarelle di torrone e salumi, le fiere, i vari festival della mente, dell’anima, del corpo, il bookcrossing, i comitati per salvare la lettura, i panda, le foche... Comunque, è andata così. Studio, cultura e letteratura sono parole che non piacciono. I governi, le televisioni, i giornali e le scuole che abbiamo non aiutano certo. Politica, media e istruzione potevano (e dovevano!) fare da intermediari, essere i mezzi di trasporto, le cinghie di trasmissione: dovevano in qualche modo «portare» un sapere un po’ più astratto, metafisico, spirituale di tutti questi saperi concreti e grigi, servili e piatti che ci attorniano e ci assordano soltanto. Ma così non è stato. Le cinghie girano a vuoto e, semmai, trasmettono solo se stesse, in un vocìo vacuo e inconcludente. «Siamo in un’epoca che premia la comunicazione, più che la riflessione» direi, usando le parole dello storico francese Pierre Nora,22 fondatore della mitica rivista «Le Débat», nata nel 1980 con un numero sulla domanda: De quoi l’avenir intellectuel sera-t-il fait? Avvenire intellettuale, mah... Non sta morendo un bel niente, sia chiaro: non stiamo facendo il solito discorso trito sulla morte dell’arte, del romanzo, del pensiero, del mondo stesso... Per carità! Il mondo continua. S’è solo fermato un attimo. Si tratta di gusti, di mode temporanee. Nulla di che preoccuparsi: passerà. Tra qualche secolo, ne sono sicura, non ci sarà più problema: il mondo sarà tornato a leggere e a studiare, e tutto ripartirà. Soliti cicli e ricicli della Storia. Ma intanto noi viviamo adesso, e per poco: dobbiamo chiederci che cosa vogliamo fare in questo piccolo tempo che ci è dato, che scelte operare, quali battaglie sostenere. Sempre che si decida di combattere, e non di accompagnare con complicità, o di stare buoni a guardare e basta. 2. Gli ultimi maniscalchi Se non siamo più d’accordo sul fatto che sia bene studiare, allora smettiamo di farlo. Ma smettiamo tutti insieme. Io non vorrei più forzare nessuno. Lo dico più chiaro: io non vorrei più forzare i miei studenti a studiare. Non credo che sia giusto, né per i forzati né per i forzanti. La scuola poteva obbligare allo studio quando era una vera scuola, cioè un’istituzione riconosciuta da uno Stato e a cui si demandava l’istruzione e l’educazione dei giovani e con la quale, quindi, tutta un’intera società concordava. Ora non è più così. La scuola è stata lasciata sola, e ora giace inerte, abbandonata in un angolo: lo Stato la sta a poco a poco affidando all’autonomia delle Regioni, dei Comuni e finanche dei singoli Istituti; e la società vive in un altro modo, crede in altre cose e se n’è andata da un’altra parte; ha solo bisogno della scuola in senso tecnico-pratico: che tenga i ragazzi tutti i giorni occupati. La scuola è sola. Avete presente quei vagoni che vengono staccati dal treno e si lasciano sui binari morti? Ecco, il treno riparte e loro lì, morti. Io non voglio fare il vagone morto. Non lasciateci soli a fare Torquato Tasso in un mondo in cui Torquato Tasso non interessa più a nessuno: gli addetti ai lavori le ritengono cose vecchie e inutili, i ragazzi non le studiano e i loro genitori li difendono e, sotto sotto, concordano. Io non voglio più far leggere La luna e i falò, o Madame Bovary o l’ Edipo re a gente che non lo vuole fare. A ragazzi che mi chiedono con gli occhi grandi da cerbiatto se davvero è necessario leggere questi libri, e se do il voto, e se poi il voto conta, e di quante pagine è ’sto libro. Ragazzi i cui genitori mi vengono a parlare solo quando ho dato un 4 e, già che ci sono, gentilmente mi informano che il loro figliolo ha trovato veramente noioso leggere l’ Edipo re e, se potessero, mi urlerebbero: Si può sapere come diavolo le è venuto in mente di dare l’ Edipo re a ragazzi di quindici anni? Ecco, io non voglio essere l’unica e l’ultima a pensare che sia bello leggere l’Edipo re, e che a quindici anni vada benissimo leggerlo (a proposito, dovremmo smetterla di trattare i quindicenni come bambini delle elementari...). E non sono nemmeno disposta a dire che certi autori (tipo Dante, Sofocle o Tasso) si possono fare senza studiare, senza cioè uno «studio» inteso in senso tradizionale, bensì con nuovi e strabilianti mezzi, visivo-esperienziali, psico-motori, tecnologico-virtuali: io a questo inganno non mi presto. Dice ancora Pierre Nora: «È vero, bisogna resistere alla tentazione di salire sull’Aventino. Al tempo stesso, non ci si può ridurre a fare gli istrioni per catturare un po’ di pubblico ». Ecco, appunto, l’istrione no. Non sono disposta a fare scenette teatrali tutti insieme in gruppo dalla Gerusalemme liberata, andando poi a recitarle davanti ai genitori a Natale o a qualche concorso sparso per l’Italia, con tanto di gita in treno, panini e Coca-Cola. Io Torquato Tasso lo voglio fare in classe, parola per parola, e voglio poi che a casa i miei studenti lo studino, per ore, parola per parola. Si annoiano? Pazienza! Non lo vogliono fare? Bene, facciano altre scelte. Sia ben chiaro: per parte mia, io vorrei che tutti quanti studiassero. Per essere più precisa, io vorrei che tutti studiassero cose come Torquato Tasso. E Einstein, Kierkegaard, John Donne, Galileo, Aristotele (in greco) e Goethe (in tedesco). Le cose più difficili al mondo, insomma, ostiche, lontane; quelle per cui a un certo punto ti viene da mollare tutto e dici: basta, non ce la posso fare, ma poi magari dopo quattro ore o quattro giorni o quattro anni che ti ci arrovelli su, di colpo avverti che la mente ti si apre, e ce la fa!, e come per miracolo ora tu capisci, e allora ti verrebbe da ballare per la strada, e ti capita una cosa davvero eccezionale, che mai avresti immaginato: sei soddisfatto di te. La soddisfazione di sé: questo sentimento così intimo e appagante, che dal nulla e per un nonnulla ci fa sentire così bene, così a posto nel mondo... Questa sottile sensazione di far bene, di avere una funzione, di assolvere a un compito e di intravedere, attraverso le nebbie dell’esistenza, una parvenza di senso... Che sia far bene la polenta così che non attacchi, o una cena per gli amici con la tovaglia giusta e le candele, o il progetto di un ponte che non cada, un libro che resti al di là del tempo, un ricamo che abbellisca uno stupido cuscino, asfaltare bene un pezzo di strada in modo da togliere le buche e le auto non ci cadano più dentro, pulire i vetri senza lasciare aloni, studiare un capitolo di storia e poi saperlo... Non importa che cosa, importa la soddisfazione di sé. Ne capiamo forse meglio il senso dal suo contrario, quel che Seneca chiamava il displicēre sibi: dispiacere a se stessi, avere la sensazione amara di non aver fatto bene, non piacersi. È per questo che vorrei che tutti ancora studiassero, soprattutto le cose difficili. Per la soddisfazione di sé che si prova. Per quella felicità mentale, interna, solo nostra, mentale perché attiene in modo specifico al funzionamento particolare della nostra mente: come se sentissimo gli ingranaggi cerebrali lavorare, ne avvertissimo lo sfrigolio meccanico, perfino l’odore un po’ ferrigno e oliato. Una specie di gusto fisico di quell’ingegno, o meglio marchingegno, che ci portiamo dentro. Di lì non si torna indietro. Una volta che sai che puoi abitare mondi mentali, non vorrai essere altrove né fare altro. O vagherai disperso, e farai altro con una perenne insoddisfazione, e senso di incompletezza, e nostalgia per quegli altri mondi che ora sai che esistono e che sarebbero i soli che tu adesso vorresti frequentare, perché sono infinitamente più grandi di questo, estesi, liberi, disinteressati, nobili. Nulla ti darà lo stesso gusto, ed è possibile che le cose che prima ti piacevano, come guardare la tivù, chattare, navigare per ore in Internet, ti piacciano sempre meno. Ecco, questo vorrei. Per tutti. Non so a che cosa serva, ma lo vorrei. Solo che non basta che lo voglia io, o alcuni di noi: bisogna che lo vogliano tutti. Bisogna che questi benedetti «tutti» vogliano con grande determinazione questo, se no, non funziona. Non li si può forzare più di tanto, io mi sono stancata. O meglio, non si tratta di stanchezza o rassegnazione o, peggio che mai, di una resa. Si tratta del fatto che non credo più sia giusto, non credo vada bene: nessuno può forzare un altro a fare una cosa che non vuole fare, o ad andare in un posto dove non vuole andare. Nessun singolo, almeno. Ci vorrebbe una comunità: una famiglia, un Paese, uno Stato... Io non sono nessuno per convincere gli altri della grandezza di Sofocle né dell’estrema importanza (e «utilità»!) di studiarlo proprio oggi che c’è Internet e l’iPhone; e comunque non tocca a me farlo e non lo voglio fare. E poi chissà, magari hanno anche ragione gli altri a non volerlo fare. Se non gli va di leggere, che non leggano. Se non gli va di studiare, che non studino. Io non so più che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. So solo che mi sono stufata di convincere ogni giorno i ragazzi e le loro famiglie di quanto sia bello e utile leggere l’Edipo re. È una cosa triste e anche un po’ patetica. È come se qui sulla Terra fossero rimasti quattro o cinque maniscalchi, ometti rinsecchiti e caparbi che se ne stanno tutto il giorno chiusi nelle loro fucine infuocate a fondere metalli e battere col martello sull’incudine per fabbricare meravigliosi ferri da cavallo, in un mondo abitato soltanto da pigri tirannosauri addomesticati, che guardano tutto il giorno la tivù sgranocchiando patatine. Tutto un Paese di tirannosauri, neanche l’ombra di un cavallo, e loro giù ficcati incaponiti a forgiare ferri di cavallo... Sarà bizzarro? Non dovremmo dirglielo, a quei quattro maniscalchi sciagurati, di smetterla di forgiar ferri, visto che nessuno più li vuole? Non ci fa pena, non ci intristisce la loro inutile ultimità? Certo, smettere di studiare equivale a buttare via secoli di storia, di autori, di opere, di arte, di libri, di pensiero... Se ci pensiamo bene, infatti, lo studio riguarda per il novanta per cento il passato. Noi studiamo i millenni che ci precedono, e il nostro presente, per ovvie ragioni (cioè per la sua esiguità temporale) riguarda una parte più piccola del sapere. Studiare insomma soprattutto vuol dire questo: immagazzinare il passato, stivarlo e traghettarlo nel presente, per non perderlo. Altra possibile definizione di studio, dunque: decidere di non lasciare il passato nel passato, ma portarlo via con noi, nel tempo in cui noi siamo. E siamo tornati ai vagoni abbandonati sui binari morti... Se non studio, il passato lo lascio lì, in stazione. E il treno prosegue il viaggio senza di lui, in un’unica dimensione temporale: il presente. Noi vivremo sempre di più in un eterno presente, se smetteremo di studiare: abiteremo una linea orizzontale, saremo un treno lanciato a folle velocità sempre soltanto verso la prossima stazione. Ogni volta molleremo un vagoncino e ripartiremo, leggeri, tronfi del futuro che ci sta sempre soltanto davanti... Però, può essere davvero che il mondo evolva in un altro senso e vada da un’altra parte, e che dello studio potremo benissimo far senza, e che avremo altre conoscenze e altre vie per procurarcele e riusciremo a progredire in altri modi. Quindi, liberi tutti! Noi togliamo il disturbo. Fine. Smettiamo di produrre ferri da cavallo. Nessuno di noi può più obbligare i ragazzi alla pazienza, solitudine e fermezza che studiare comporta. Non possiamo storcerli e portarli dove noi pensiamo sia giusto andare. Noi non siamo eroi, né martiri né missionari. E nemmeno profeti che sanno come andrà nel futuro. Siamo solo insegnanti. Per anni abbiamo ritenuto fosse bene far studiare certe cose, e lo abbiamo fatto. Fin qui. Lo abbiamo fatto e lo stiamo ancora facendo: ogni volta incominciamo il nuovo anno con l’idea che sia il primo, e che ce la faremo. Forziamo, certo che forziamo. Abbiamo sempre un po’ forzato, è vero. Ma adesso è diverso, abbiamo troppa gente contro, direi il mondo intero: i ragazzi, i genitori, i presidi, i ministri, Monsieur Thélot, l’Europa, il Web, il nuovo iPhone 4... Non possiamo più farcela, siamo troppo soli. Ma soprattutto, ripeto, non sappiamo più se sia giusto. In questa condizione dubbiosa, preferiamo togliere il disturbo. Smettere di tirare. Nonostante le nostre fedi incrollabili, tirare ci sembrerebbe, adesso, eccessivo e sbagliato. Vorremmo non farlo. Preferiremmo di no, direbbe Bartleby... Preferiremmo che fossero i ragazzi a scegliere, e i loro genitori, e la società intera. Senza farsi più trainare con la forza. Scegliere, ecco: è un bel verbo. Ha a che fare con due parole grandi come una casa: individuo e responsabilità. 3. Carlo Martello Facciamo una deviazione. Andiamo a leggerci un canto di Dante, l’VIII del Paradiso. Siamo nel terzo cielo, il cielo degli Amanti, influenzato da Venere. Qui Dante incontra Carlo Martello. È un canto che a scuola in genere non si fa, ed è un peccato perché c’è dentro un discorso teologico-sociologico davvero interessante, un’idea di Dio e di società insieme a un’idea di vocazione individuale: insomma, un ragionamento molto particolare, molto lontano dal nostro attuale modo di ragionare, e secondo me molto utile per il momento in cui ci troviamo a vivere. L’ho riletto per caso, ma nulla è mai per caso: mi cadeva proprio a fagiuolo. E adesso ve lo racconto. Carlo Martello è il figlio di Carlo d’Angiò e il fratello di Roberto. È morto troppo presto, a soli ventiquattro anni, e di ciò molto si rammarica: se fossi vissuto più a lungo, dice, il mondo non andrebbe così male come invece di qui a poco andrà, a causa della mala segnoria di mio padre e di mio fratello. Sentendolo parlare così, a Dante viene una domanda un po’ a margine e più generale: ma come può essere che da uno stesso ceppo famigliare nascano due figli tanto diversi, uno giusto e uno degenere? E qui Carlo Martello si lancia in un lungo discorso teologico sulla provvidenza divina e sulla società giusta. Dice che Dio ha in mente un disegno ben preciso e, attraverso i cieli che ruotando adempiono la sua volontà, egli manda a ognuno di noi gli influssi più adatti a far sì che il disegno si compia. Per questo ognuno di noi nasce con una sua specifica inclinazione, impressa direttamente dai cieli. C’è chi nasce soldato come il re Serse e chi sacerdote come Melchisedèch, chi architetto come Dedalo, l’infelice padre di Icaro, e chi legislatore come il grande Solone: «un nasce Solone e altro Serse, / altro Melchisedèch e altro quello / che, volando per l’aere, il figlio perse». E tutto è bene perché risponde al suo fine, visto che Dio sa perfettamente di quanti soldati o legulei o maestri la società ha bisogno, e dispone in tal senso. Ma, attenzione, continua Carlo Martello (ed è la parte più democratica e anticlassista del suo discorso...): gli influssi dei cieli cadono a caso, senza tener conto dell’«ostello»! Vuol dire che addirittura un re, come il mitico Romolo fondatore di Roma, può nascere da un padre di oscuri natali: perché i cieli destinano a caso. È come dire il destino cieco. È come dire che a Dio importa la funzione, il fine per cui ci manda sulla terra, e non la famiglia nella quale ci manda. E adesso arriva il colpo finale, con il quale Carlo Martello spiega a Dante perché poi le società – pur così ben preordinate da Dio – non funzionano. È che, se un seme non trova il terreno idoneo, la pianta non viene bene. Se un figlio nato per fare il soldato nasce da una famiglia che lo torce a fare il prete, per esempio, quel figlio darà una cattiva prova di sé, cioè non arriverà a essere quello che doveva, quello per cui era nato. E fallirà lo scopo. E con lui la società intera mancherà il bersaglio, perché avrà un bravo soldato in meno, e un cattivo prete in più. Se invece il mondo lasciasse che ognuno seguisse il proprio naturale fondamento, avrebbe una buona società. Ma noi spesso arriviamo a distorcere le persone dalle loro personali inclinazioni e, così facendo, ci perdiamo: E se ’l mondo là giù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui, avria buona la gente. Ma voi torcete a la religïone tal che fia nato a cignersi la spada, e fate re di tal ch’è da sermone; onde la traccia vostra è fuor di strada. Ecco dove sta la colpa sociale: nel torcere l’individuo dal suo fine naturale, dallo scopo per cui era stato mandato sulla terra. Questa è la lezione di Carlo Martello a Dante. Sarebbe come dire che se noi oggi, per esempio, forziamo un giovane, che per natura vorrebbe far fotografie o coltivare alberi da frutta in collina, a diventare invece un notaio (magari per continuare l’avviata e rinomata impresa paterna), noi roviniamo non solo la sua vita, ma l’andamento dell’intera società. Lo so che, per comprendere e condividere la visione sociale del Carlo Martello di Dante, per prima cosa bisognerebbe credere in Dio. So anche che proporre oggi laicamente l’idea di una società che si regola sugli influssi dei cieli rotanti secondo un disegno divino sarebbe folle: come si può pensare che il numero di idraulici, informatici e maestri di sci ci sia imposto dall’alto? Però l’idea carlomartellesca che esista un fondamento di natura e che ognuno di noi dovrebbe seguire quello e non mancarlo mi piace molto. Può essere oggi molto illuminante, e utile per la scuola che vorremmo, per le famiglie che siamo diventate, e per quel futuro che manca così tanto ai nostri ragazzi. Chiamiamola vocazione, inclinazione, propensione... non so. Siamo pure atei o credenti, religiosi o laici. Ma il fatto di non mancare il bersaglio, il nostro personale centro, mi pare una cosa importante. CAPITOLO DUE La libertà di non studiare (... e di studiare!) 1. Obbligati e scontenti: la parascuola e l’esercito dei ragazzi «torti» Non tutti vogliono studiare. Non tutti nascono soldati o sacerdoti o studiosi. C’è anche chi nasce fabbro, panettiere, meccanico, fotografo. Perché torciamo i giovani? Perché obblighiamo tutti a studiare? Allo stesso modo, qualcuno vuole studiare. Non tutti nascono parrucchieri, cuochi, coltivatori di patate. Perché, con questa scuola «ridotta», obblighiamo costoro a non studiare, o a studiare poco e male? Quando si parla di giovani e futuro e quindi scuola e poi lavoro, in ballo ci dovrebbe essere innanzitutto la felicità. Fine ultimo dell’uomo, per Aristotele. Non la realizzazione spicciola, concreta e immediata: dove andare a lavorare, come guadagnare, quali relazioni utili usare, a che carrozzone appartenere. Qualcosa di un pochino più alto. Una domanda, prima di qualsiasi altra: «Come vivere?». Quale vita scegliere di avere. Quale vita per essere felici. Questa è la domanda che ci dovrebbe guidare, in ogni scelta, da giovani e da vecchi. L’ho presa pari pari da un’intervista al grande Tzvetan Todorov, apparsa su «Repubblica» il 4 novembre 2010 in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, La bellezza salverà il mondo, che lui stesso definisce «il mio ’romanzo’ sulla ricerca di pienezza e sull’aspirazione all’assoluto». Pienezza come compimento interiore di sé, qualità di vita, ricerca del senso. Sentite cosa dice in questa intervista: Nella vita non capita spesso di avere l’impressione di scegliere liberamente la propria strada. In tenera età obbediamo alle decisioni degli adulti che ci circondano, poi subiamo le pressioni dei nostri compagni, successivamente ci conformiamo ai modelli di comportamento offerti dalla società e ci pieghiamo alle esigenze del mondo del lavoro. Eppure, spesso inconsciamente e tacitamente, ciascuno di noi è animato da un progetto di vita, dentro di sé ha uno schema ideale che lo guida e in base al quale giudica la sua esistenza del momento. Ecco, un «progetto di vita». Uno «schema ideale». Per questo vorrei che i ragazzi potessero scegliere. Oggi invece mi sembrano tutti obbligati e scontenti. Forzati e torti. Bisognerebbe dare ai giovani la libertà di non studiare. Se non vogliono farlo, che non lo facciano. E bisognerebbe, anche, dare la libertà di studiare a chi lo volesse ancora fare. Mi rendo conto che si tratta di un discorso difficile: ma è solo che non ci siamo abituati. Non abbiamo, da molto tempo, coltivato pensieri siffatti, che quindi adesso, per disabitudine, ci paiono ardui, estranei e forse anche sbagliati. Si tratterebbe di resettare un po’ la nostra mente, incrostata di idee vecchie e luoghi comuni, e pregiudizi, e pensieri forse non pensati mai per davvero, ma raccolti in giro per anni, orecchiati, condivisi per amor di compagnia, per paura di solitudine. Si tratterebbe di riprenderci la felicità. Non parlo della felicità-lampo, l’attimo di luce ineguagliabile, altissimo ma labile e precario, quel «fil di lama» sul quale, come dice Montale, si cammina a «felicità raggiunta»; bensì di una felicità meno luminosa forse ma costante, una condizione quieta, uno stato quotidiano di calma. Una sorta di «felicità normale», se così si può dire, o ancor meglio di «normalità felice»: qualcosa per cui, insomma, siamo contenti di quel che facciamo ogni giorno. O quasi. O almeno non scontenti, ecco. Naturalmente il progetto di vita, lo schema ideale, si comincia a delineare con la scelta della scuola. Per scegliere veramente, dovremmo avere delle vere e chiare alternative. Oggi invece abbiamo una scuola ibrida, non chiara, non pulita. Non chiarita nelle intenzioni, nella direzione. Una scuola-pantano, uguale per tutti, uguale a se stessa, tutti immersi fino al collo, stessa altezza, stessa palude. Una scuola un po’ vecchia un po’ nuova, un po’ studio un po’ no, mezza tecnologica e mezza niente, né carne né pesce. Però facile, divertente, autoreggente, autogiocante, europea, americana, psico-socio-pedago-motoria. Mortoria. Un contenitore senza contenuti, ma a lunga, lunghissima scadenza. Uno scatolone, un parcheggio. Un asilo-nido, un liceo-nido. Una scuola dove si studia ancora, e con i libri, ma non si raggiunge alcuna preparazione, né per il lavoro, né per l’università. Una scuola che non forma a niente, semmai informa di qualcosa. Qualcosina. Qualcosista. Una parascuola. Come la parafarmacia, che non è una vera farmacia perché ci trovi solo lo sciroppo per la tosse, le creme solari, il collutorio per i gargarismi, i cerotti, le bende, il dentifricio alle erbe... Una scuola così va bene per la metà dei nostri ragazzi, a occhio e croce. Va bene per i ragazzi medio-benestanti che non hanno voglia di far niente, e che possono non fare niente perché tanto sono benestanti, e bene-mantenuti e bene-relazionati. Ma gli altri? Questa scuola-parascuola nega la libertà a tutti gli altri, sia a quelli che vorrebbero studiare (nel senso hard del dizionario...), sia a quelli che vorrebbero non studiare (ovvero imparare una professione manuale o tecnica). Non permette di scegliere che cosa è bene per ognuno, in vista del proprio progetto ideale di felicità. Ci sono tre macigni che, secondo me, da anni ci ottundono la mente e ci impediscono di chiarire la scuola e di permettere quindi ai ragazzi una vera scelta; due dei tre macigni sono idee sbagliate, uno è un equivoco. Cominciamo dal macigno-equivoco. 2. Primo macigno: l’equivoco del «liceo dell’obbligo» Quando abbiamo pensato alla scuola dell’obbligo, avevamo un gravissimo problema di analfabetismo da risolvere. Volevamo quindi aiutare i ragazzi delle famiglie meno abbienti a continuare a studiare, nonostante l’opposizione famigliare. Si trattava di famiglie povere, di stampo contadino o operaio, per le quali la via naturale era di instradare il più presto possibile i figli verso il mondo del lavoro, in modo da avere subito un valido aiuto, uno stipendio in più, che risollevasse un po’ le stentate condizioni di vita. Era un obbligo rivolto alle famiglie, era come dire: vi obblighiamo a mandare i vostri figli a scuola andando contro il vostro interesse economico immediato, che sarebbe quello di farli lavorare al vostro fianco. Si pensava al bene dei giovani, che con l’istruzione avrebbero potuto migliorare le proprie condizioni future, accedendo a professioni migliori rispetto a quelle dei padri. L’idea era buona. Per l’individuo, e anche per la società: si elevava l’istruzione del singolo, e si favoriva un vero e proprio ascensore sociale, per cui il figlio del contadino poteva aspirare a diventare ingegnere. L’intera società progrediva, non solo gli individui. Abbiamo fatto molto bene a batterci per l’obbligo scolastico. Abbiamo difeso i ragazzi dagli interessi spesso necessariamente miopi delle loro famiglie. Ma oggi dobbiamo fare chiarezza: una cosa è l’obbligo scolastico (o formativo che dir si voglia), un’altra cosa è l’obbligo, tutto nuovo, tutto neo-global-capitalistico, ad andare al liceo, e poi all’università, e diventare tutti ingegneri, avvocati, medici ed economisti! Inoltre, una cosa è l’obbligo ad andare a scuola, un’altra è l’obbligo a studiare: non è detto che coincidano, oggi si può benissimo andare a scuola e non studiare, per esempio. Forse è venuto il momento di accettare che qualcuno, tra i giovani che destiniamo di forza al liceo, preferirebbe davvero non studiare. Perché studiare dovrebbe piacere a tutti? Come si fa ad amare, coercitivamente poi, una faccenda così noiosa, faticosa, impegnativa? Per di più, lo studio di cose lontane, inutili e difficili. È come se obbligassimo tutti i giovani ad andare a cavallo. A sciare, suonare il piano, diventare cuochi, coltivare piante... Deve piacere. Bisogna provare gusto a fare una determinata cosa, esserci portati, avere una inclinazione... Forse qualcuno di questi forzati del liceo vorrebbe davvero fare altro: ad esempio potrebbe avere una seria e profonda inclinazione per un mestiere che non prevede anni e anni di studio astratto, magari un mestiere manuale o tecnico o di tipo relazional-comunicativo, più legato all’ambito dei servizi. Ad esempio, qualcuno potrebbe voler fare l’animatore da spiaggia, o la guida turistica, o il venditore di stivali da pesca o l’elettricista o il tecnico dei computer o il riparatore di ascensori o l’importatore di baobab... Perché forziamo questi ragazzi, deviandoli dalla loro strada? Con quale diritto imponiamo loro il martirio (peraltro inutile) del liceo+università? E con quali prospettive, poi? Molti s’indigneranno, a codesti discorsi. Ma come, diranno, abbiamo fatto tanto perché tutti andassero a scuola il più possibile e arrivassero alla laurea, e adesso li rispediamo a lavorare, condannandoli all’ignoranza e a mestieri degradati? Sarebbe un tornare indietro, un gettare la spugna, un fallimento... Credo ci sia un intrico indistricabile di equivoci, in questo equivoco che chiamerei «del liceo dell’obbligo»: l’idea che imparare un mestiere equivalga a ignoranza, e quindi, specularmente, che andare a scuola produca non-ignoranza (come si può ben vedere in giro, non è più così...); l’idea che la laurea conduca a un ottimo lavoro e che i mestieri tipo elettricista o importatore di frutti di baobab, invece, siano mestieri degradati. Mi viene da dire, per prima cosa, che può essere «degradato» anche fare l’ingegnere, dipende da come e dove lo fai; e può essere «nobile» importare la radice dei baobab, che pare sia molto benefica per la pelle, per il suo apporto di vitamine e come coadiuvante alla digestione. Ho conosciuto, in biblioteca, una bravissima giovane laureata «precaria» che sta lavorando a un saggio sul settimanale «Tuttolibri», fa il critico d’arte per vari giornali e, contemporaneamente, sta cercando di metter su una società per importare dall’Africa i frutti del baobab (solo per dire che non era solo un’immagine fantasiosa, la mia...). E, come seconda cosa, mi viene da tornare a quell’idea di «felicità normale» o quotidiana, di cui abbiamo detto: può essere che una persona si alzi al mattino felice di andare a costruire una scala nel cantiere edile dove lavora, che provi soddisfazione a misurare le altezze, a progettare il numero esatto dei gradini, la loro forma, l’angolatura, il decoro col quale s’innesteranno alla parete. Voglio dire che, se badiamo al tempo circoscritto della nostra giornata e alla nostra soddisfazione intima, si può essere felici tanto di fare il muratore quanto di fare l’ingegnere: dipende da come lo si fa e da quanto questo lavoro ci corrisponda, cioè sia consono a quel che siamo nel profondo della nostra natura. Il lavoro «circoscritto », giorno dopo giorno. Anche una felicità «circoscritta », istante dopo istante. Un tempo lungo, fatto però di infiniti presenti, così che il futuro non ci spaventi più. Ve lo ricordate lo spazzino amico di Momo, nel romanzo omonimo di Michael Ende? Davanti a un’enorme strada da pulire non ci si deve abbattere: basta considerare un metro alla volta... Ma soprattutto mi viene da dire che l’equivoco peggiore è il seguente: noi non vediamo che oggi il panorama è cambiato, e al liceo ci vanno in maggioranza i figli di famiglie abbienti! Noi pensiamo sempre alla scuola come a una opportunità per i poveri, deboli e svantaggiati. La pensiamo come un dovere, ma soprattutto un diritto. Non pensiamo mai che oggi invece – per come sono andate le cose — stiamo parlando di ragazzi che di quel diritto possono benissimo farsene due baffi. Si tratta di ragazzi che appartengono a un ceto medio-alto benestante e di medio-alta cultura; conducono vite piuttosto agiate, hanno bei vestiti, motorini e soldi; frequentano le migliori scuole ma non hanno assolutamente voglia di studiare; possiedono case piene di libri ma non ne aprono nemmeno uno; vengono a scuola controvoglia e attuano tutte le strategie possibili per passare l’anno con il minimo sforzo. È una popolazione scolastica numericamente considerevole, che ha letteralmente invaso i licei (soprattutto il liceo scientifico), che contribuisce non poco all’abbassamento del livello di istruzione reale in tale ambito di scuole, e che spesso s’iscrive all’università, scegliendo Facoltà facili e prendendo poi una delle cosiddette lauree deboli o non arrivando affatto a laurearsi. Forse questi ragazzi non hanno voglia di studiare perché sono figli di famiglie abbienti. È possibile che ci sia uno stretto, tragico nesso causale. Questi ragazzi non studiano perché possono benissimo non farlo: non incorrono in punizioni o pagamenti di alcunché, la scuola non essendo più selettiva e la famiglia non sanzionando più in alcun modo il loro comportamento. Ma soprattutto non studiano perché sanno di poterselo permettere. A loro non servirà a nulla un’istruzione, perché la loro vera missione nella vita sarà soltanto di mantenere il patrimonio famigliare che, a tempo debito, riceveranno in eredità. Questa certezza non produce in loro alcuna possibile motivazione allo studio. Sono i microereditieri della nostra epoca, o «ereditieri di massa», se così si può dire. Ereditano, ma non grossi patrimoni o imprese colossali com’era tempo addietro per i cosiddetti ereditieri. Ereditano poco, magari due appartamenti in affitto e una casa al mare, oppure un negozio e una cascina in campagna, o una piccola ditta con quattro dipendenti. Cosucce. Ma quel tanto che basterà a permetter loro di accettare un lavoro da poco con uno stipendio modesto, un reddito minimo che le rendite famigliari andranno comunque a completare assicurando una vita più che dignitosa. Si tratterà solo di mantenere e non dissipare. Sono i ragazzi del post-benessere: non appartengono a nessun boom economico, ma sono figli e nipoti di coloro che da quel boom hanno accumulato fortune più o meno grandi. Ebbene, lo studio è per questi ragazzi davvero un inutile incomodo, e nello stesso tempo un vero e proprio obbligo a cui non è possibile sottrarsi: è la famiglia che li obbliga a un percorso di studi lungo e il più possibile elevato e prestigioso, a cui loro non sono affatto propensi ma che devono in ogni caso intraprendere. La laurea serve a continuare l’impresa del padre con la dovuta targhetta (vuoi mica dirigere la ditta e non essere laureato?). Una volta era lo Stato che obbligava le famiglie a mandare i figli a scuola; adesso è la famiglia che «obbliga» i propri figli ad andare controvoglia a scuola. Nel primo caso era una forzatura a fin di bene, per il bene altrui: nel secondo caso si pensa al proprio, famigliare, egoistico bene, e al fondo c’è una vergogna sociale. Si tratta di un «nuovo obbligo», sociale e non statale, implicito, silente, dato per scontato e molto più subdolo e invadente, che poggia oltretutto su ragioni decisamente meno nobili: non è più uno Stato che vuol salvare i ragazzi sfortunati dalla strada, ma sono le famiglie fortunate che intendono parcheggiare nel modo più divertente e indolore possibile i loro vezzeggiati pargoli. Un vero capovolgimento della democrazia sull’onda del benessere, non c’è che dire! Anche se – va detto a loro difesa – cosa potrebbero mai fare se non mandare i figli al liceo? L’eccessiva licealizzazione è una conseguenza della scandalosa mancanza di valide alternative tecnico-professionali. Il risultato è che i licei sono intasati di questa nuova e particolare genia di ragazzi che non sono veri e propri studenti, perché non studiano, e che però costituiscono una parte non irrilevante di una classe di liceo. Sono finti studenti, entità fittizie, immagini virtuali, fantasmi, zombie che popolano le aule. Figurine disegnate sedute ai banchi, cartoni animati che fintamente aprono un libro, fintamente prendono appunti, fintamente parlano all’interrogazione, ma che nella sostanza non sono presenti. Non voglio dare in alcun modo un giudizio negativo di questi ragazzi, anzi, sono persone gentili e simpatiche, educate, affabili, anche rispettose. E poi, sono figli del nostro tempo, del nostro acquisito benessere e quindi ci mancherebbe che ora li rinnegassimo. Sono i nostri figli! Semmai mi suscitano una qualche compassione, così costretti a una vita (scolastica) che non è la loro. Li definirei, nel modo più neutro possibile, «studenti assenti»: non ci sono, non sono presenti, non abitano lì dove pure li vediamo, stanno altrove. A noi sembra di vederli seduti ai banchi, davanti a noi, ma non è vero, la nostra è una pura illusione ottica, un miraggio. Nessuna condanna, certo, però un punto di vista chiaro e preciso: va detto, e va saputo, che è questo genere di ragazzi che occupa oggi i licei. Bisogna prenderne atto, agire di conseguenza, e soprattutto non fare discorsi che invece pertengono a un altro tempo e a tutt’altro genere di ragazzi, che erano gli studenti di ieri e che oggi sono quasi del tutto scomparsi dalle nostre scuole. Se no, se ci ancoriamo a discorsi già fatti, a luoghi comuni che erano giusti quaranta o cinquant’anni fa, perdiamo la partita. Proviamo adesso a trarre le conseguenze di ciò che abbiamo detto. Se la maggioranza della popolazione liceale oggi è questa, l’obbligo scolastico ha cambiato profondamente significato: non vuol più dire obbligare le famiglie economicamente svantaggiate a mandare a scuola i figli il più a lungo possibile facendo il loro bene, ma vuol dire obbligare i ragazzi benestanti e svogliati a fingere di fare una cosa che non vogliono fare: studiare. In questo senso l’obbligo, da positivo che era, diventa non dico negativo ma perlomeno discutibile. Inquina la natura profonda della scuola che, secondo me, si basa sul desiderio dell’allievo di imparare, da cui e solo da cui consegue (e non viceversa!) il mestiere di insegnare. A dispetto di tutti quanti pensano che l’insuccesso scolastico e la demotivazione dei ragazzi siano da imputarsi all’insegnante, il quale dovrebbe convincere l’allievo della bontà del sapere, io credo che la vera motivazione possa essere solo interna, pertenere strettamente all’individuo, o al massimo provenire dall’ambito famigliare e sociale cui appartiene; ma non possa essere in alcun modo esterna, straniera alla propria più intima natura. L’insegnante può «incontrare» la motivazione dell’allievo e vivificarla, questo sì, ed è auspicabile che avvenga; può rendere più vera e consapevole la sua passione e aiutarla quindi a decollare: può provocarla. Ma non può farla nascere dal nulla. 3. Secondo macigno: il vilipendio del lavoro manuale L’altro macigno – intrinsecamente connesso al primo — è un’idea profondamente sbagliata che da sempre accompagna la mia generazione: che non sia bene andare a lavorare. Che il lavoro (manuale, artigianale, tecnico-pratico) sia cosa vile, umiliante, degradante. E che per questo, di conseguenza, sia obbligatorio studiare: per non andare a lavorare. Per non cadere nell’abisso infamante del lavoro. Lo studio diventa, così, forzato. Non una fortunata chance, ma una specie di tortura a cui non ci si può sottrarre, pena il disfacimento, la rovina e la disistima sociale. Tradotto, siamo oggi quasi tutti convinti che, se un ragazzo invece di andare al liceo va a fare pratica in una falegnameria, sia un fallito e un mediocre, uno scarto della società, destinato a essere infelice tutta la vita. Che solo alcuni lavori siano buoni: quelli che danno prestigio e denaro. Gli altri, quelli manuali, artigianali e tecnici, sono cattivi lavori, residuali, da lasciare ai reietti della società. Ecco perché lo studio è così svilito: perché è imposto, ed è imposto in quanto mezzo, puro strumento per acquisire qualcos’altro. Come si può amare una cosa simile? Tutti devono andare a scuola, e il più a lungo possibile: d’accordo. Ma di qui non consegue per forza che tutti debbano essere laureati, diventare ingegneri, medici, avvocati, architetti, economisti, manager... Se no, è come se una specie di legge inderogabile e indiscutibile s’imponesse, indicando a tutti e forzatamente un percorso obbligato, un’unica strada senza uscita e buia: un tunnel! Mi viene da pensare ai binari oscuri del trenino fantasma al luna park: entravamo in una specie di antro nero dove di colpo apparivano scheletri, streghe, morti viventi. E noi non potevamo fuggire, eravamo attaccati a quell’unico binario che ci portava dove voleva lui, nel buio. La cosa buffa (e paradossale) è che, proprio quando abbiamo esaltato la scelta dello studio — anzi, l’abbiamo resa l’unica scelta possibile e dunque un obbligo -, abbiamo anche smesso di pretendere lo studio dai nostri allievi: per cui oggi che tutti studiano, quasi nessuno è più capace di studiare... Anzi, peggio: oggi tutti studiano (cioè frequentano la scuola, e in particolare i licei), ma la scuola e anche l’università (avendo ridotto lo studio sempre più ai minimi termini) non valgono più niente, non preparano ad alcun lavoro, né offrono una solida cultura. Guardiamo in faccia i nostri ragazzi, e chiediamoci se sono dei condannati ai lavori (scolastici) forzati. E se per caso uno di loro volesse far altro? Non studiare, non stare a sentire me che gli parlo di Petrarca, ma andare a bottega da un fabbro e imparare l’arte del forgiare candelabri, lampadari, cancelli, o monili come il dio Efesto? Avrebbe tutto il diritto di non essere interessato alle molteplici interpretazioni critiche di Petrarca, all’origine del termine acedia, e alle implicazioni storiche dell’ amor de lonh. Perché mai dev’essere obbligato a studiare queste cose squisitamente astratte, se tutta la sua natura lo tira altrove? Non è detto che non abbia un talento, che non possa eccellere: magari non in quello a cui noi con la forza lo stiamo tirando, ma in ben altro. Cosa ne sappiamo? E perché gli usiamo tale violenza? Certo, personalmente a me piacerebbe un sacco che un fabbro conoscesse il concetto di amor de lonh: secondo me gli verrebbero meglio i cancelli. E a un orafo i monili, e a un falegname i tavoli e le sedie. Noi dovremmo davvero insegnare la poesia provenzale ai futuri fabbri, pasticcieri, decoratori, elettricisti. E l’arte di Giotto e di Van Gogh, e il pensiero di Seneca e Voltaire... Penso questo profondamente, perché non riesco a togliermi dalla testa il modello Michelangelo, e l’esempio degli artisti del Cinquecento a bottega: molti erano anche letterati e poeti, erano sapienti, erano artisti in senso totale, intrisi di cultura (di «nozioni» anche astratte, come le teorie neoplatoniche). Forse per questo l’arte del Cinquecento è stata così speciale: perché chi dipingeva cappelle o progettava cupole o scolpiva Madonne era colto e frequentava ambienti colti (la corte di Lorenzo il Magnifico, per esempio), e studiava, leggeva, conosceva le opere di Poliziano e Marsilio Ficino, discuteva di Platone e Petrarca. Mi piacerebbe che si ricreasse un mondo così. E vorrei fortemente una scuola che a questo mondo preparasse. Credo che dovremmo batterci perché le scuole professionali e tecniche vadano in questa direzione. Invece oggi tutti puntano a iscriversi alle facoltà di prestigio, per esempio a Legge, e molti di questi «tutti» s’iscrivono a Legge non perché desiderano studiare diritto o perché pensano che saranno felici di fare l’avvocato, ma perché vogliono diventare avvocati, cioè guadagnare molto e appartenere alla fascia professionale considerata «alta» della società. Eppure oggi non è affatto detto che chi studia Legge diventerà davvero avvocato, né che troverà facilmente lavoro, e nemmeno che il lavoro che poi alla fine troverà sarà così redditizio come poteva sembrare. Cioè, se anche riuscisse a diventare avvocato, non è detto che s’impiegherà presso uno studio legale, e poi, anche se fosse, ancora non è detto che guadagnerà così tanto, in un mondo in cui «tutti» hanno studiato Legge e sono diventati avvocati. A forza di volere la laurea per i nostri figli, adesso quelle professioni ambite non valgono più, non esistono, sono fittizie, sono compromesse, non assicurano più niente, né prestigio né reddito. L’università di massa non prepara più nessuno, è dequalificata, è un fallimento (soprattutto col diabolico meccanismo del 3+2). Una laurea è un pezzo di carta inerte. Per non parlare di tutti quei ragazzi che non si laureano, pur essendosi iscritti all’università... e sì, il paradosso è questo: pur avendo notevolmente abbassato il livello degli studi universitari, il risultato è che continuano a essere pochi a laurearsi. Quindi, noi spingiamo i giovani fino al liceo e alla laurea magistrale per ottenere che poi, alla fine di questa distorsione violenta che produce infelicità (non si può felicemente studiare se non lo si vuole fare, e non si può essere felici di fare un lavoro che non ci piace...), quei giovani non concludano gli studi o non trovino lavoro, e vadano così incontro a una infelicità sia esistenziale che economico-sociale. Un capolavoro! Mentre se avessero studiato da fabbro, fisioterapista, programmatore o infermiere, lavorerebbero subito e guadagnerebbero bene e, secondo me, troverebbero quella soddisfazione di sé che adesso non hanno. Il 19 luglio 2010 è stata pubblicata sul «Corriere della Sera» un’inchiesta molto interessante, il Rapporto Onel, relativa al tema «giovani e occupazione», in cui si rilevava il pericolo di una eccessiva licealizzazione dell’istruzione italiana, a scapito di quei percorsi di studio più tecnico, invece richiestissimi dalle imprese e che sarebbero utilissimi a rafforzare, con nuova linfa lavorativa, la nostra industria, il terziario e il made in Italy. Insomma, i giovani scelgono in massa un liceo che non li specializza a nessun lavoro, e «mancano» clamorosamente le professioni di cui invece oggi ci sarebbe un disperato bisogno. Ecco l’elenco delle figure professionali mancanti, che cioè si fa più fatica a trovare: infermiere, sviluppatore software, programmatore informatico, fisioterapista, farmacista, addetto logistica, addetto consulenza fiscale, progettista elettronico, addetto marketing, responsabile produzione e controllo qualità. Dario Di Vico, sulla stessa pagina del «Corriere», amaramente commenta: «In un Paese a basso tasso di occupazione come il nostro, avere i posti di lavoro e non poterli coprire forse più che un paradosso è una sciagura. La realtà è che, mentre il mercato del lavoro e le aziende guardano da una parte, i giovani e le famiglie guardano da un’altra. I primi chiedono tecnici, i secondi mandano massicciamente i loro figli al liceo». La conseguenza è drammatica sia per le imprese che per le famiglie e i loro figli, destinati alla disoccupazione o alla sottooccupazione: «La licealizzazione» continua Di Vico «ha il suo lato amaro. Alla fine del quinquennio, dopo una selezione che comunque s’è fatta più stringente, molti dei diplomati finiscono per scegliere le cosiddette lauree deboli, ovvero conquistano – spesso a costo di grandi sacrifici da parte delle loro famiglie — titoli di studio che non sono spendibili sul mercato del lavoro e che hanno una pura funzione ornamentale. Sono dei poster. Quei giovani hanno studiato per mettersi in tasca una moneta che non può comprare il posto a cui aspirano. E così la spirale liceo-laurea debole-disoccupazione finisce per ingrossare l’esercito di quelli che Giuseppe De Rita chiama ’i qualcosisti’. Ma a noi servono 2,5 milioni di tecnici qualificati». Agghiacciante. I «qualcosisti» sono coloro che sanno qualcosa, ma non si sa bene cosa. Sono i nostri giovani, un intero esercito di persone che hanno studiato «qualcosina» fino a venticinque anni e alla fine non sanno niente (di utile per un lavoro), a volte non sanno neanche che cosa hanno studiato a fare. Il 24 ottobre 2010 esce un’altra indagine simile, l’ultimo Rapporto di Confartigianato: sessantotto i mestieri presi in esame, al primo posto delle «figure professionali introvabili» in Italia gli installatori di infissi e serramenti; seguono panettieri e pastai, tessitori e maglieristi, scalpellini, gelatai, sarti e cappellai. Poi ancora: parrucchieri, cuochi, valigiai, meccanici, saldatori, camerieri, muratori... Sulle pagine di tutti i giornali, accanto a questi dati, le interviste a giovani (anche diplomati) senza lavoro da mesi, da anni: «Scusa, cosa dovrei andare a fare? Cosa fa lo scalpellino?»; «Mah, non fa per me». Un ragazzo di ventidue anni, direttore di una gelateria a Milano, conferma che è difficilissimo trovare gelatai, dice che non lo vuol fare più nessuno: «La verità è che viene visto come un lavoro umile, me lo dicono pure molti amici: come fai a fare il gelataio?» («Corriere della Sera», 24 ottobre 2010). L’Italia è il Paese in Europa che, dopo la Spagna, registra il più alto tasso di disoccupazione dei giovani tra quindici e ventiquattro anni. Tra le motivazioni: «inadeguatezza dei candidati», «ridotto numero dei candidati». Dovremmo adoperarci affinché il percorso di studi per arrivare a padroneggiare questi mestieri sia il più degno e nobile possibile: dovremmo migliorare – e nobilitare! – le nostre scuole tecniche, professionali, artigianali. Dovremmo far sì che siano non una scelta scolastica minore o perdente, ma il nostro fiore all’occhiello. Ma prima ancora, è nella nostra testa che deve avvenire la rivoluzione; dovremmo recuperare stima e ammirazione per chi è capace di costruire un tavolo, assistere un anziano, tagliare un vestito, rieducare un arto, produrre un cioccolatino, creare un gioiello, riparare un motore, un computer, un ferro da stiro. 4. Terzo macigno: l’insofferenza per i «pochi». E il sogno di una scuola-Isola Abbiamo anche il problema opposto: dovremmo «liberare» non solo quelli che vogliono lavorare, ma anche quelli che vogliono studiare. Dico studiare nel senso di fare quella cosa perversa e malata per cui uno sta per ore fermo su un libro, sottolinea, annota, memorizza, ripete, elabora, ricrea... Studiare. Anche per loro la scuola attuale, la parascuola-pantano tutta uguale e ibrida, non prevede alcuna libertà effettiva di scelta. Eppure alcuni tra i giovani, ve lo giuro, vogliono ancora studiare. È incredibile, lo so, sembrano impermeabili come anatre a tutti i mirabolanti discorsi sul Futuro e sul dio Web. Sono i cosiddetti «portati allo studio», non saprei come altro chiamarli. Ne conosco parecchi. Parecchi si fa per dire... mediamente ne incontro quattro o cinque all’anno, sui miei cinquanta, sessanta allievi. Un dieci per cento circa. Pochi, direte voi. Sì, ma possiamo raddoppiare se consideriamo anche quelli che non studiano tantissimo ma abbastanza, e hanno non un interesse smodato ma un «certo» interesse per le materie astratte, arriviamo pure a un venti per cento. E sono convinta che potremmo arrivare addirittura a un trenta per cento se la scuola (elementari e medie) alzasse l’asticella e, facendo cose difficili, coltivasse coloro che hanno tale propensione allo studio. Molti di questi invece si spengono per inerzia e per noia: una scuola che li fa giocare, che li porta fuori, che privilegia il fare esperienza, e trascura l’apprendimento teorico astratto, che evita gli argomenti e i libri più difficili e appiana e appiattisce ogni asperità non aiuta certo questi ragazzi a germogliare, anzi, li deprime e li affossa costringendoli a un livello sempre più basso. Comunque, pochi o tanti che siano, codesti «inclinati» allo studio esistono. Non sono dei piccoli geni, sono giovani normali che hanno ricevuto, non saprei dire da chi e quando e perché, questo particolare imprinting di voler studiare, e provano piacere nel farlo. Vi ricordate di quel Demonte che sa sempre tutto, alza la mano, interviene, perché a casa studia e in classe segue le lezioni? Ecco, dove li mettiamo questi bravi Demonti studianti? Che fare di quella esigua, risibile minoranza di giovani che prova piacere a stare ore sui libri e che quindi – cosa inaudita – studia? Nella scuola di oggi così facilitata, estroversa, tecnologica e giocante incontrano notevoli difficoltà a studiare. Non abbiamo mai pensato a loro. Nella nostra quarantennale battaglia contro il nozionismo e la scuola classista, li abbiamo ignorati. Quando non li abbiamo, addirittura, volutamente emarginati... D’altronde, esiste una vera e propria frattura nella storia della scuola, più o meno intorno al secondo dopoguerra. Lo racconta molto bene Adolfo Scotto di Luzio nel suo libro La scuola degli italiani. La scuola superiore era partita da un’idea risorgimentale-liberale, ed era prevalentemente una scuola della parola, incentrata in particolare sull’esercizio della traduzione come «rigoroso apprendistato all’espressione chiara, precisa, dei contenuti del pensiero e di se stessi»: era una «scuola della solitudine e dei linguaggi dell’individuo». Una scuola che ovviamente non può che collidere – continua l’autore — «con il volontarismo di una cultura politica che poggia al contrario sulla profonda convinzione che l’individuo debba abdicare a se stesso, in nome dei vincoli solidaristici, del primato del collettivo, della comunità e dell’appartenenza alla massa». La nostra scuola, dal dopoguerra a oggi, non ha fatto che abbandonare sempre più il gusto elitario della solitudine per uniformarsi ai linguaggi di massa, oggi per esempio ai linguaggi multimediali tanto elogiati. E Scotto di Luzio così commenta: «È appena il caso di ricordare che elitario non significa ’per ricchi’ ma ’per pochi’, quei pochi che scelgono di condividere la fatica di uno studio rigoroso. Questa precisazione va fatta perché la polemica antielitaria di cui è stata investita in maniera crescente la scuola nella seconda metà del Novecento ama fregiarsi di idealità sociali, di un linguaggio sentimentale che fa costante appello alla generosità, alla giustizia, alla solidarietà, e nella cultura tende a riconoscere troppo spesso il privilegio di uno stato di possesso, e quasi mai la fatica di un acquisto».23 Detto in altro modo, l’isolamento e il rigore che lo studio richiede sono stati sempre bollati come elitari e quindi ingenerosi, ingiusti, non solidali e colpevoli; non è mai stato visto come il risultato finale di una fatica e di una fede. Chi va bene a scuola, chi è il «bravo a scuola», chi studia è il nemico da abbattere. Il fraintendimento della parola élite è servito troppo spesso da alibi per coprire un’insofferenza ideologica. Eppure anche i Demonti studianti avranno ben il diritto di far quel che aggrada loro... Non vorremo mica ignorare le minoranze, proprio noi che siamo cresciuti, e viviamo, nell’era della tolleranza, della partecipazione e dell’inclusione? Sì, certo, si tratta di minoranze politicamente scorrette, scomode, scandalose, indifendibili... Sono ragazzi così bravi e quieti, così autosufficienti e baciati dalla sorte, così poco afflitti da quel «disagio giovanile» di cui tanto amiamo occuparci... È vero. Ma si tratta pur sempre di minoranze, e in quanto tali andrebbero difese e sostenute. O no? Vogliamo forse distinguere tra minoranze meritevoli e immeritevoli d’aiuto? Insomma, codesti pochi «inclinati allo studio» esistono, anche se son pochi, e io troverei davvero intollerabile non tollerarli... Le teorie alla Antinucci – vi ricordate? -, secondo cui i nuovi giovani oggi imparano in un altro modo, esperienziale e non più «simbolico-ricostruttivo», infatti, secondo me hanno proprio questo enorme handicap: non considerano per nulla, non tengono in alcun conto codesti altri giovani, pochi, che chissà perché hanno ancora un approccio logico-consequenziale, e quindi usano ancora il linguaggio miseramente verbale. Di costoro Antinucci non parla e non si cura, forse perché li considera in via di estinzione, o li dà per persi in ogni caso, destinati a essere travolti dalla nuova civiltà. Dovremmo invece secondo me considerarli eccome. Preservare un «piccolo» luogo che li contenga, e dove ancora si insegnino le materie che in nessun modo possono essere insegnate in modo esperienziale, né valutate per competenze, né misurate e certificate. Materie... come dire?, imprendibili. Volatili come la sabbia in un giorno di vento: come potresti mai misurarla? Mi piacerebbe che prevedessimo qualche sediola anche per codesti pochi «immisurabili», magari in ultima fila, così non disturbano le nonlezioni e così magari neanche li vediamo. Panche al fondo di una classe, così li trascuriamo meglio. Poche classi nel seminterrato di una scuola. Poche scuole ai margini dell’Impero... Tanto sono così radi, occupano così poco spazio... Basterà qualche isolotto sperduto, qualche scoglio, o anche solo una cameretta, o celletta. Ecco, si tratta di prevedere un luogo anche per chi avesse mai ancora voglia di studiare, e fare tutte queste altre cose desuete, inutili, marginali, ammuffite come leggere libri, concentrarsi in solitudine, scollegarsi, pensare, contemplare l’orizzonte, passeggiare sul lungomare, prendere appunti su quaderni, pensare... Gente strana, certo. Non integrata, non rappresentativa. Che però esiste. E vuole ancora andare a scuola per studiare e non per socializzare. Bizzarro desiderio! Sono ragazzi-Isola, che magari non si trovano poi così bene a lavorare in gruppo, faticano a superare i test a risposta multipla, crocettano e smanettano malvolentieri, sono selettivi con gli amici, esigenti con gli adulti, con gli insegnanti poi più che mai. Forse stanno più volentieri fermi, seduti, magari all’ombra di qualche baobab... Osservano, pensano, riflettono. Inoltre, provengono perlopiù da famiglie uguali a loro: sono ragazzi-Isola e provengono da famiglie-Isola. Gente che magari viaggia poco, non si trova benissimo nei Club Méditerranée, guarda poca tivù, legge, non va neanche tanto in palestra. Genitori che assomigliano ai loro figli, che magari da piccoli erano uguali e che oggi a loro volta passano le ore a contemplare barche all’orizzonte, o boe galleggianti, o si arrampicano anch’essi sul ramo più alto di un baobab e lì rimangono, un po’ staccati dagli altri, a inseguir chissà quali strampalati pensieri... Non sono persone cattive o problematiche: sono solo diverse. Direi avulse. Io penso che siano, questi, ragazzi da tenere in gran conto. Almeno quanto tutti gli altri... Credo che la scuola dovrebbe occuparsi anche di loro. Ho detto anche, non ho detto solo... Se invece non se ne occupa, rischia di perderseli per sempre, di averne poi bisogno un giorno come il pane, ad esempio per costruire una buona e variegata società nel futuro, e di non trovarne invece più nemmeno uno, perché li avrà dispersi, delusi, annoiati, annientati, annegati... Direi che potremmo riservare a questo genere di umanità «diversa» un luogo isolato e sperduto dove ancora possa, volendo, imparare qualcosa al suo livello... Un ramo. La frescura ombrosa di un albero. Un’isola. Ecco, potremmo chiamarla Isola, questa scuola salvata dello studio, legata ancora all’uso della parola e all’abitudine allo studio, tanto per intenderci. Scuola-Isola per isolani isolati... Basterebbe giusto qualche atollo sperduto e irraggiungibile. A questi pochi che ho in mente, infatti, non importa diventare irraggiungibili e introvabili, anzi, aborrono le connessioni troppo facili, andrebbe loro benissimo di sistemarsi un po’ lontano, al riparo dai rumori e soli. È gente che ha bisogno di silenzio e tranquillità e solitudine, anzi di questo vive, per concentrarsi. Sono ancora convinti che ci si debba concentrare per favorire il pensiero, figuratevi un po’! Il grande matematico André Weil fu sicuramente uno di loro. Sentite questa: nel 1940, quando si trovava recluso in una prigione di Rouen in attesa di essere processato per diserzione, scrisse a sua moglie Eveline: «Nella mia matematica faccio progressi superiori a tutte le mie aspettative; sono persino un po’ preoccupato, perché se lavoro così bene in prigione, non sarà il caso che mi organizzi per passarvi ogni anno due o tre mesi?». Non solo, di lì a poco un suo amico matematico coetaneo, dopo aver letto quel che di geniale Weil aveva prodotto in carcere, gli scrisse pieno d’invidia: «Non tutti abbiamo la tua fortuna di poter lavorare indisturbati...».24 Persone così hanno evidenti particolarità, che oggi noi non amiamo per niente e che a volte arriviamo a giudicare dei veri e propri limiti mentali: ad esempio credo non sappiano fare due cose contemporaneamente, tipo parlare a un compagno e scrivere una mail. Figuriamoci aprire trenta finestrine di Windows... Non sanno neanche fare un ipertesto. O una mappa concettuale. Pensate che leggono romanzi anche di mille pagine, una pagina dopo l’altra, e studiano chini sui libri per ore, invece di navigare sul Web.... Ve lo giuro, ho avuto allievi che a quindici anni s’erano letti magari tutto Victor Hugo, o il Don Chisciotte, o Moby Dick, o Guerra e pace e I fratelli Karamazov... Oggi ci piacciono così poco che o non li consideriamo neanche o li bolliamo come gli inetti di Svevo... «Scuola degli Inetti», potremmo chiamare l’Isola. Una scuola per giovani inetti, inadatti, incapaci di vivere in questo nostro mirabolante Nuovomondo. Albatros! sbeffeggiati dalla ciurma dei marinai-naviganti del Web... 5. Il discorso di Camus: elitarismo ed egualitarismo E pensare che invece l’arte, e l’arte della parola nella fattispecie, non isola mai... Parte da un isolamento, per forza di cose, che poi però approda agli altri. La voce degli artisti è la voce degli «isolati» per definizione: ma è la voce che poi rappresenta l’umanità intera. Lo disse molto bene Eugenio Montale, sessant’anni fa. Nel 1952 a Parigi, intervenne a un convegno sul tema «Isolamento e comunicazione». Il suo intervento s’intitolava La solitudine dell’artista, sentite cosa disse: Non penso che il trionfo dei nuovi mezzi tecnici sia senza importanza in un mondo che tende a un nuovo umanesimo positivo e scientifico e che si sforza di rendere migliore la vita delle moltitudini; ma ritengo che anche domani le voci più importanti saranno quelle degli artisti che faranno sentire, attraverso la loro voce isolata, un’eco del fatale isolamento di ognuno di noi. In questo senso, solo gli isolati parlano, solo gli isolati comunicano; gli altri – gli uomini della comunicazione di massa – ripetono, fanno eco, volgarizzano le parole dei poeti, che oggi non sono parole di fede ma potranno forse tornare ad esserlo un giorno.25 La mia scuola-Isola, non c’è dubbio, vuole ancora essere testardamente la scuola della parola. La scuola che, a dispetto di tutte le più recenti teorie pedagogistico-tecnocratiche, mette ancora al centro la funzione educativa della parola, e dello studio. I ragazzi-Isola che ancora credono in queste due «imprese » non ce li dobbiamo perdere per nessuna ragione al mondo. Il nostro amore per l’egualitarismo non deve mai diventare anti-elitarismo. Sarebbe un errore madornale. Se continueremo a non accettare, o meglio, a fraintendere le élite, il nostro concetto di democrazia si sgretolerà sempre di più, secondo me. Diventeremo una morta gora, tutti affossati uguali nello stesso fango, tutti alla stessa (bassa) altezza, e guai a chi alza il capo di un centimetro: subito i Caronti servi del potere «democratico» son pronti lì col remo a dargli un colpo in testa e risospingerlo ad annaspare al fondo. Vorrei che riuscissimo a guardare le cose con occhi più innocenti. Pensiamo per esempio alla lettura e allo studio, cardini della scuola-Isola: possono sembrare gesti isolati e isolanti; letteralmente è vero: sono tra le poche attività che non solo non si svolgono in compagnia, ma in cui la compagnia degli altri di norma addirittura disturba. Però poi, a pensarci bene, non è così. Leggere e studiare sono gesti a due tempi: c’è un primo tempo che ha bisogno assoluto di solitudine, e c’è un secondo tempo in cui tutto ciò che, leggendo e studiando, è maturato nella solitudine, viene messo in circolo, usato con e per gli altri. Noi invece abbiamo paura di tutto ciò che ha a che fare con la solitudine e lo scarso numero di persone: i «pochi» (a meno che non siano miserabili, o comunque oppressi) ci sembrano sempre dei privilegiati, degli eletti, e quindi detestabili. In quanto pochi, il nostro spirito naturalmente democratico, per un errore logico imperdonabile, tende a rifiutarli. Di qui l’odio per la parola élite, elitario, elitarismo che proprio questo vuol dire: «pochi». Ci sentiamo naturalmente programmati per amare i molti, cioè tutti gli altri, quelli che sono i tanti e ci sembrano quindi sfortunati e negletti: il popolo, le masse, che per definizione sono deboli, non hanno privilegi e vanno quindi aiutati. Gli altri invece non solo non ci servono a niente, ma ci fanno problema. E così noi isoliamo e rifiutiamo proprio coloro, i pochi, che potrebbero meglio aiutare i tanti, meno avvantaggiati dalla sorte. Separiamo le élite dalle masse, neghiamo quella condivisione, quel reciproco soccorso, quella naturale collaborazione (e colloquio!) che invece potrebbe avvenire. Per un equivoco sulla parola democrazia. E un altrettale equivoco sulla parola élite (e aristocrazia, e oligarchia): gli áristoi, gli olígoi non ci sono mai piaciuti, e così abbiamo condannato le masse alla loro ignoranza e ai loro limiti, e le élite alla loro gelida separatezza. Dante incontra nel Limbo i quattro più grandi poeti dell’antichità (oltre a Virgilio, che lo accompagna): Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. E – vi ricordate? – ha il coraggio di mostrarceli isolati e separati dagli altri: un fuoco di luce circonda le loro anime e così li «diparte» dal resto del mondo. Virgilio spiega a Dante il perché: dice che a loro è riservato tanto onore, da ottenere dal cielo la grazia che li «avanza », cioè li mette avanti agli altri e in tal modo li distingue, collocandoli fuori dal mondo buio dell’inferno, illuminandoli, quindi separandoli tramite la luce dal luogo dove sono immerse tutte le altre anime. Ma non basta. Esiste, nel Limbo dantesco, un luogo fisico davvero letteralmente separato e circoscritto: un castello, «sette volte cerchiato d’alte mura» e «difeso intorno d’un bel fiumicello». È il castello dei cosiddetti Spiriti Magni, ovvero i grandi del passato, coloro che hanno fatto la storia (Elettra, Ettore, Enea, Cesare, il sultano d’Egitto...) e hanno fondato la filosofia, la scienza e l’arte lasciando opere imperiture (Socrate, Platone, Aristotele, Eraclito, Zenone, Orfeo, Euclide, Ippocrate...). Costoro sono destinati a un’aristocratica eternità, insieme per sempre, al di là di ogni tempo. Passeggiano e conversano tra di loro, negli ampi spazi di quel luogo di luce. Sono un’élite? Sì, senza dubbio: sono «scelti», i pochi scelti all’interno dei molti per creare qualcosa di grande. E allora? Dante senza problema celebra – e isola! – i grandi. E dopo di lui ancora per molti secoli l’umanità ha riconosciuto i grandi e li ha venerati, onorati, ammirati (e tramandati) proprio in quanto grandi. Chissà perché, chissà come abbiamo potuto scegliere, far emergere dalla massa di tutti gli altri, discriminare... Eppure l’abbiamo fatto, quel che ancora oggi chiamiamo Umanesimo non è altro che questo: una selezione dei grandi, con i quali continuare, al di là del Tempo, un colloquio. Di qui, appunto, il Rinascimento... Il ri-nascere dell’arte sull’arte ri-trovata del passato. Un dialogo continuo tra passato, presente e futuro. Pensiamo a quel che dice Machiavelli nella sua famosa lettera al Vettori, al piacere che prova la sera quando torna a casa e può dimenticare gli impegni e dedicarsi per ore alla lettura dei grandi «antiqui uomini», smettendo la veste quotidiana piena di fango e indossando abiti regali, adatti all’altezza dello spirito: Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio; e in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio, e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni. E quelli per loro umanità mi rispondono: e non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro. Questo è stato l’Umanesimo: un continuo ininterrotto colloquio con i grandi del passato, gli unici in grado di nutrirci con un cibo che sia consono alla parte più nobile di noi, ovvero l’intelletto. Ora, i valori dell’Umanesimo ci sembrano davvero così antidemocratici? Isolare gli spiriti magni, collocarli in un ideale castello cinto di mura o frequentarli la sera, dopo una giornata di lavoro o di impegno politico, leggendo le loro opere, vuol dire davvero considerare la cultura e l’arte un mondo separato, elitario, ostile? Quando Albert Camus riceve il Nobel nel 1957, pronuncia un discorso bellissimo, in cui la questione centrale è proprio questa: come possa l’artista tenere insieme la sua inevitabile solitudine di creatore (il suo connaturato isolamento) e l’impulso a mescolarsi agli altri e ad agire per il bene collettivo. L’artista è elitario per natura, ma si sente parte di una collettività e quindi uguale agli altri, fratello. Camus dice che ricevere un premio così alto come il Nobel lo ha turbato fortemente, perché lo ha sottoposto di colpo alla luce di un riflettore troppo forte, in un momento in cui altri scrittori lottano per la libertà, e popoli interi si battono contro l’ingiustizia. Sente di «doversi mettere in regola verso una sorte troppo generosa, e riflettere sull’utilità della sua arte e in generale sul ruolo dello scrittore». Così scrive: Non posso vivere personalmente senza la mia arte. Ma non ho mai posto quest’arte al di sopra di tutto. Se mi è necessaria, è proprio perché non si separa da nessuno e mi permette di vivere, qual sono, al livello di tutti. L’arte non è ai miei occhi un godimento solitario. È un mezzo per destare emozioni presso il più grande numero di persone, offrendo a tutti un’immagine privilegiata delle sofferenze e delle gioie comuni. Essa obbliga dunque l’artista a non isolarsi; lo mette al servizio della verità, la più umile e più universale. E colui che, sovente, ha scelto il suo destino di artista perché si sentiva diverso, comprende ben presto che non nutrirà la sua arte, e la sua personale differenza, se non confessando la sua somiglianza con tutti gli altri. L’artista forgia se stesso in questo giro perenne di andata e ritorno da sé agli altri, a mezza strada tra la bellezza di cui egli non può fare a meno e la comunità da cui non può staccarsi. È per questo che i veri artisti non disprezzano niente; si abituano a comprendere invece di giudicare. E se hanno un partito da prendere in questo mondo, non può che essere quello di una società dove, secondo il grande motto di Nietzsche, non regnerà più il giudice, ma il creatore, che sia lavoratore o intellettuale.26 L’arte dunque, così come la diversità individuale che la genera e la produce, non è mai elitaria. È piuttosto un doppio movimento, un andar via dagli altri per poi tornare, un’andata e ritorno all’infinito. Una solitudine al servizio di una comunità. Se anche noi oggi volessimo recuperare questo modo di vedere le cose, forse riusciremmo a intendere in modo positivo le élite, gli albatros, gli inetti: quelli che ho chiamato isole, perché abitanti di se stessi! Prendiamo ancora un esempio. Lorin Maazel, nell’intervista già citata, afferma che il problema della musica classica oggi è «la scarsa qualità media dell’interpretazione»: non ci sono più grandi interpreti, ed è questo secondo lui che «rende la musica noiosa». Dice che la colpa è di quei critici che «fanno una guerra spietata contro tutti i giovani con idee originali». Racconta che nella generazione precedente c’erano trenta pianisti che davano recital in tutto il mondo, oggi ce ne sono almeno cinquemila ma non bastano a richiamare il pubblico. E non richiamano il pubblico – aggiungiamo noi — perché sono tutti uguali, tutti ugualmente mediocri. Di grandi direttori d’orchestra invece oggi ce ne saranno al massimo quattro o cinque, dice Maazel, mentre prima erano almeno quaranta, «e tutte stelle di prima grandezza, ognuno con la sua personalità». Oggi si punisce l’originalità, dice Maazel. Ma c’è una forte richiesta, da parte del pubblico, di una «nuova eccellenza dell’interpretazione». Eccellenza, originalità, personalità: sono parole decisive. Non possiamo continuare l’operazione di appiattimento finto-democratico. La gente si stuferà di tanta mediocrità, distribuita a piene mani e reperibile in ogni dove. Si stuferà degli accessi facili e dei luoghi troppo condivisi e affollati. Non potrà durare a lungo questo leggersi gli uni con gli altri tutti insieme appassionatamente su Facebook o Twitter. È vero che tutti oggi, grazie ai social network, possono scrivere. Ma questi benedetti «tutti» scrivono cose così noiose, scontate e banali che gli altri tutti, a lungo andare, non avranno più voglia di leggerli. Questa finta democrazia morirà per noia. La vera democrazia deve prevedere e stimolare, e favorire il più possibile, la diversità dei migliori. Non annientarla, invece, perché la detesta, non la sopporta, e fors’anche la invidia... «La democrazia concepita dagli antichi greci» continua Maazel «è qualcosa che consente ai più bravi di poter avanzare senza ostacoli, riconoscendo al contempo che c’è chi è destinato a dirigere e chi a eseguire.» Consentire ai più bravi di avanzare! Non, invece, ostacolarli il più possibile... Riconoscere la diversità dei destini individuali, a seconda delle funzioni sociali necessarie. Ecco, ci siamo arrivati: eseguire e dirigere, c’è bisogno tanto di chi dirige quanto di chi esegue. E solo un masochismo sociale, una società cieca può non vedere che il bene, per l’orchestra, è avere un bravo direttore. A patto che sia veramente bravo, però. D’accordo che ci debba essere chi dirige e chi esegue: «Solo che prima di dirigere» specifica Maazel «bisogna essere capaci di ascoltare. L’orchestra vuole essere guidata, ma anche rispettata. E solo se si dà, si può poi ricevere. Non dovrebbe essere così anche in politica?». Vorrei che riflettessimo sul verbo «rispettare»: l’orchestra vuole essere rispettata, accetta sì di essere diretta ma solo se chi dirige è così bravo da accrescere il valore di chi esegue. Ecco cos’è il rispetto. La bravura dei pochi rispetta la bravura dei molti: essere bravi ci dà il diritto di «dirigere», ma protegge anche ed esalta il lavoro di coloro che «eseguono». E solo qualcuno che sappia veramente dirigere otterrà un ritorno, riceverà cioè in cambio la bravura di chi esegue. Noi invece oggi non vogliamo che soltanto qualcuno diriga. Tutti parimenti devono poterlo fare. Se non ne sono capaci, che problema c’è? Così, stiamo costruendo un mondo tutto di esecutori, senza più direttori d’orchestra. Per affermare l’uguaglianza di tutti, neghiamo l’eccellenza di alcuni che, pure, farebbe il bene di quei tutti. Fino a che non riconosceremo che siamo un’orchestra, e che il valore di uno è la ricchezza degli altri, impoveriremo la musica del mondo. CAPITOLO TRE L’utopia delle tre scuole 1. Inclinazione e libertà Partiamo di qui: sarebbe bellissimo che ognuno seguisse la propria natura. Che capisse, per prima cosa, qual è la sua natura, che cosa è nato a fare e dove è bene che metta le sue energie. E poi a quello si dedicasse. Se i nostri giovani seguissero la loro natura, sarebbero più felici. O almeno non così tristi e annoiati e spenti, disamorati verso il presente e rassegnati verso il futuro. Ma che cos’è la propria natura? Vorrei usare la parola inclinazione. Essere inclinati da una parte o da un’altra parte. Inclinati in senso letterale, prima di tutto: pendere. Come la torre di Pisa. Uno pende verso una cosa, e un altro pende verso un’altra cosa. Pendere significa sentirsi attratti fortemente verso una direzione, luogo o cosa che sia. Un bosco, una cucina, un blocco di marmo, un quaderno a righe, una lavagna con i gessetti, un forno a legna, il mare, il calcio, le montagne altissime... A seconda del luogo verso cui ci si sente attratti ovvero inclinati, si sceglierà il proprio mestiere: guardia forestale, cuoco, scultore, scrittore, insegnante, panettiere, marinaio, calciatore, alpinista... Seguire la propria natura dovrebbe essere la cosa più... naturale. Ma non è così, perché è difficile essere consapevoli di sé ed essere certi del luogo verso cui naturalmente si pende. Dovremmo poter contare su un aiuto esterno. I genitori, gli insegnanti, gli amici: l’occhio di chi ci vive accanto può tornarci molto utile. Anche se poi, d’accordo, alla fine siamo solo noi capaci di vedere chiaramente che cosa siamo e che cosa vogliamo. O anche, montalianamente, «cosa non siamo, cosa non vogliamo»... Dovessi dare un consiglio a un giovane per aiutarlo a trovare la propria inclinazione, gli direi più o meno questo: fa’ conto di essere un animale e di doverti trovare un posto dove stare; ecco, la tana dove ti troverai meglio, il buco, l’anfratto, la conca dove la forma del tuo corpo troverà la migliore accoglienza, dove tutto il tuo essere si sentirà perfettamente contenuto e accolto e potrà sentirsi quindi a suo completo agio, quella è la tua inclinazione. È un posto, innanzitutto: il luogo dove ti senti completamente bene e dal quale non vorresti mai andare via. Può essere lo studio, se passare la giornata nel silenzio di una stanza, seduto a una scrivania riempiendoti la testa di pensieri, è la «tana» nella quale ti senti meglio accoccolato. Ma può benissimo non essere lo studio, come puoi ben capire: può essere l’acqua di una piscina, un campo di grano da falciare, l’odore di un’officina meccanica... E io ti sto dicendo questo: studia solo se lo studio è la tua tana. Se no, vai ancora in cerca e troverai altro. È più facile scovare la propria tana quando una forte passione ci guida, magari dall’infanzia, o quando addirittura si nasce con un talento innegabile, e così prepotente da dirigerci automaticamente, e quasi «autoritariamente». Lo vediamo nei bambini prodigio che a quattro anni suonano il violino o a otto sanno cantare da baritono o a quindici anni capiscono la relatività di Einstein. Lì non è possibile non percepire l’inclinazione, non vedere il disegno, e non seguire quindi la strada giusta. Lo vediamo anche, al contrario, nei ragazzi che chiamiamo ribelli, in coloro cioè che si rifiutano di seguire una via da altri tracciata o anche solo indicata, perché non è la loro. Essi sentono che non è la loro strada, e non la seguono anche se sembrerebbe una strada buona, fortunata, privilegiata. Prendiamo Giorgio Cantarini, ve lo ricordate?, il bambino che interpretava il piccolo Giosuè nel film di Benigni La vita è bella. Era diventato una piccola star. Veniva di continuo bombardato di proposte allettanti, poteva andare a Hollywood. Ma ha rinunciato. Oggi ha diciotto anni, e in un’intervista ha detto: «Sono un ragazzo normale, mica di quelli con i soldi che vanno alle scuole private. E poi la mia vera passione è un’altra». Ama il calcio: fino all’anno scorso ha giocato nella Juniores di Montefiascone, il suo paese, vicino a Orvieto. Gli piace anche suonare la batteria, e dice: «Non ho mai sentito l’impulso forte di recitare anche se, certo, è un mestiere che m’intriga. Più che farlo, un film mi piacerebbe scriverlo». 27 Sono un ragazzo normale, la mia passione è un’altra, non ho mai sentito l’impulso forte... Ecco, riconoscere la forza delle nostre passioni, là dove c’è, ma anche là dove manca. Avere il coraggio di non seguire una strada che pure ci intriga o ci lusinga, ma sentiamo non essere la nostra. E soprattutto, non avere orrore della normalità: scegliere Montefiascone invece di Hollywood. L’altro giorno in classe ho chiesto ai miei allievi: vi piacerebbe se all’interno del vostro corso di studi fossero previsti ogni tanto degli stage lavorativi, dei periodi anche lunghi in cui andate a provare un lavoro, quello che più vi attira, non so, pizzaiolo, meccanico, idraulico, assistente alla regia, fotografo, pasticciere? Ho visto i loro occhi illuminarsi. Ho accolto fiumi di parole, anche da quelli che meno avevano finora dimostrato capacità di eloquio. Molti mi dicevano il loro entusiasmo. E non era per smettere di studiare, ve l’assicuro, era sincero desiderio di fare, di sentirsi per una volta vivi, e veri. Lavorare, fare qualcosa di concreto, utile, visibile, dimostrabile... Finalmente dicibile: non più il giro diabolico del: «Cosa hai fatto oggi a scuola, figlio mio?» — «Niente, mamma». Quell’infelice e misero niente rivolto a genitori anch’essi frustrati e delusi e infelici. Basta! La possibilità di un qualcosa che finalmente si opponga a quel niente: Sì, mamma, oggi ho tornito un ferro, ho intarsiato un legno, ho imparato a servire a un tavolo, a impastare una torta, a cambiare i filtri dell’aria a un motore. Io temo davvero che abbiamo imprigionato i nostri ragazzi, con un’idea che era pur buona ma che abbiamo estremizzato, e snaturato. Credo che la follia iperegualitarista di volerci a ogni costo tutti uguali abbia creato questa massa infinita di giovani «forzati» e snaturati che ci sta di fronte. Liberiamoli! Possiamo farlo a patto di modificare il nostro modo di pensare, togliere le incrostazioni ideologiche, dare aria ai pensieri. Solo così ritroveremo la libertà e, di conseguenza, l’uguaglianza vera, che non è di fare tutti gli stessi studi, ma di avere tutti la possibilità di scegliere che cosa è bene per noi singolarmente, che cosa fa il bene di ognuno. La forza della democrazia è la somma delle forze individuali, non è l’ammasso delle debolezze collettive. Ancora questo: ieri sono andata in merceria a comprar bottoni. Conosco la merciaia da anni, ma non ci andavo da un po’. Ha un unico figlio, che si chiama Sandrino. Mi dice, fiera, che Sandrino è uscito con 10 dalle medie e che adesso lo ha iscritto al liceo. «Scientifico, perché del classico non ne ha voluto sapere, purtroppo...» dice. «E pensare che è così bravo, la professoressa gliel’ha detto che poteva farcela benissimo, ma lui niente... Mio figlio è così, una testa quadra! Pensi che se fosse per lui, vorrebbe andare a lavorare... Gli piace da matti lavorare, non farebbe altro. Pensi che noi abbiamo una casa in campagna e quando andiamo lì lui lavora dal mattino alla sera, taglia l’erba, decespuglia, fa legna... gli alberi, soprattutto, gli piacciono da morire gli alberi, non so perché. Non c’è verso di fermarlo. Invece la scuola... Va bene che è bravo, studia, fa quello che deve, prende 10... Ma non gli piace, mi dica lei che figlio!» Cosa vuole che le dica, signora merciaia? Vorrei che Sandrino fosse libero di decespugliare, se è quello che vuole fare nella vita. Diventare un tecnico del decespuglio, o un taglialegna o una guardia forestale. O un coltivatore di alberi, se gli alberi gli piacciono così tanto. O un ri-piantatore di foreste amazzoniche, che salverà il mondo, chissà... Vorrei che tutti avessero la possibilità vera di scegliere, cioè di seguire la loro natura. E quindi la verità. Di essere veri, e non finti. Non finte presenze, fantasmi, zombie. Ma giovani vivi, svegli, felici. Sono stanca di avere davanti a me ragazzi infelici, che non vorrebbero fare quel che sono costretti a fare, e non vorrebbero essere lì dove noi li costringiamo a essere. Io lo so che adesso molti diranno: bella roba, desiderare che un figlio faccia il coltivatore di alberi! Ecco sì, ma fermiamoci a considerare perché diciamo questo: stiamo veramente pensando alla felicità del vivere, o stiamo invece giudicando «socialmente» una funzione, una professione? Se così fosse, forse dovremmo cambiare non il giovane Sandrino forzandolo a iscriversi alla solita facoltà di Legge, ma cambiare la nostra mentalità, e soprattutto cambiare il sistema del lavoro in Italia: paradossalmente, ricreare le corporazioni delle arti, che come sappiamo nel Medioevo erano fortissime e nobilissime. Intagliare il legno, lavorare la lana, impastare il pane, decorare i muri... «Arti» allora, mestieri snobbati adesso. Mi si dirà: un ritorno al Medioevo addirittura! No, noi non vogliamo «tornare», noi vorremmo portare avanti una cosa del passato, portarla con noi nel futuro. Che male c’è? Poi quella cosa del passato, prendendo un’aria nuova, si trasformerà da sé, penserà lei a come diventare «moderna». Io dico solo che quella potrebbe essere la strada: creare delle forti e nobili corporazioni di Nuovi Mestieri, tutti alla pari per prestigio e guadagno, perché no?, così i giovani davvero potrebbero scegliere se fare il pasticciere o il tecnico delle tivù digitali o l’ortopedico, il cardiochirurgo, il pittore, l’amministratore delegato di una fabbrica o il direttore di uno stabilimento balneare in Versilia. Occuparsi di tivù, ombrelloni, fabbriche metalmeccaniche, operazioni al cuore o al ginocchio, scarpe e stivali, bignole allo zabaglione o pastiere napoletane: ognuno scelga di che cosa davvero preferisce occuparsi. Scelga l’ oggetto della sua vita professionale, non il denaro, la funzione sociale, il prestigio, l’etichetta da stampare sul biglietto da visita! Se vogliono essere felici, i giovani devono scegliere. Esporsi a questa difficile ma decisiva operazione che è la scelta. Scegliere se andare a scuola o no, scegliere di ascoltare le nostre lezioni, scegliere di studiare, scegliere di leggere Guerra e pace o no. Si può benissimo essere felici anche non andando a scuola, e anche non leggendo Tolstoj. Mi costa molto dirlo, ma è così, dobbiamo essere molto chiari su questo punto, con i nostri figli e con i nostri allievi. Noi non dobbiamo imporre più niente. E lo possiamo fare solo se loro, i ragazzi, si prenderanno la responsabilità di una scelta. Una cosa come lo studio astratto bisogna profondamente volerla, e sceglierla, perché funzioni. Bisogna che i ragazzi la smettano di studiare per far piacere a noi! Devono essere attirati dai libri, se scelgono di fare il liceo e poi l’università. Fare il liceo non è una scelta come un’altra: vuol dire scegliere cose particolari, come per esempio i versi di Petrarca, la meccanica quantistica, la retorica di Cicerone, i sistemi di equazioni... Vi sembrano cose normali? Ma non è finita: scegliere di studiare quelle cose lì vuol dire implicitamente scegliere la solitudine, la concentrazione, anche un pizzico di disagio, disappartenenza, diversità, estraneità al mondo circostante. I licei potranno trasformarsi quanto vogliono, diventare da tre a sei come hanno appena fatto, e anche arrivare a dodici, e riempirsi di nuove tecnologie, sparare raggi laser invece di parole, fabbricare nuovi insegnanti robot, spostarsi in astronavi attrezzate anche, ma la loro sostanza rimane questa: lo studio, e lo studio di queste cose, astratte, «inutili ». Se non vi piace, ragazzi, scegliete altro, va bene lo stesso. Siete liberi! Noi adulti ci impegniamo ad accettare quel che sceglierete, e a dirvi sinceramente che va bene lo stesso. Scegliere! La scelta è per Aristotele alla base della felicità, individuale e sociale. Il gesto politico per eccellenza. È l’unica idea che difendo, qui: che si debba essere liberi di scegliere. Liberi di seguire la propria natura. Lo studio non è l’unica attività possibile, e non è per forza la migliore. Dobbiamo smettere di pensare questo. Lo studio (astratto) è un’attività limitata a certuni, non può andar bene per tutti: è, per definizione e da sempre, consono a pochi. Piace a pochi. Pochi sono portati allo studio, se parliamo dello studio astratto e libresco. Bisogna che piaccia star soli e fermi, contemplare invece che agire, guardare e non fare. Essere, e non competere. Attendere, avere pazienza, darsi un tempo lungo. Leggere, scrivere. Son cose che devono piacere. Non possiamo imporle. Bisogna nascere – e crescere! – in un certo modo, bisogna essere diversi, anche un po’ strambi se vogliamo, per desiderare di passare ore e ore al giorno chini sui libri. Preferire leggere che veder gli amici. Stare un’intera nottata a risolvere un problema di geometria piuttosto che sbattersi in discoteca o ciondolare in piazza con una birra in mano fino all’alba. Passare una domenica di primavera a limare un sonetto anziché buttarsi al sole sulla spiaggia. E provare più felicità nel fare proprio queste cose difficili che altre più rilassanti. Ognuno deve diventare quel che è. Deve disegnarsi, trovare il suo disegno e continuarlo negli anni, un tratto di matita dopo l’altro, sempre più nettamente. E lo può fare solo attraverso le scelte (prima scolastiche e poi lavorative) giuste. È un suo dovere trovarsi. Nulla è più triste di un ragazzo che non si trova, che non compie il ritratto perfetto di sé. Che, per seguire le parole stanche e confuse degli adulti, intraprende strade sbagliate, sceglie scuole che non vuole fare, libri che non ama leggere, amici che non sono i suoi, luoghi dove non si trova bene, divertimenti che non lo divertono per niente. La vita sbagliata è quella che non è la nostra. È come indossare l’abito di un altro: necessariamente non ci starà bene addosso. O meglio, non ci staremo bene noi, dentro. 2. Ulisse o Leopardi: to twitt or not to twitt Torniamo all’idea di tana, del luogo dove ci troviamo meglio protetti, a nostro agio. Basta farsi qualche grossolana domanda orientativa. Dove ci piace andare in vacanza, per esempio: un’isola deserta o un Club Méditerranée? Che cosa ci piace di più fare, per rilassarci: una grigliata con ottanta persone o tirar giù una lenza spegnendo il motore in mezzo al mare?, sederci su uno scoglio di notte a sentir le onde, o sfidare gli amici in una gara di motocross? In quale situazione siamo noi, e in quale invece ci sentiamo pesci fuor d’acqua? C’è lo stile ascetico e lo stile conviviale. L’isola o la piazza, il deserto o il mercato, il silenzio o la folla. Introversi, estroversi. Contemplativi, attivi. Concentrazione, esplorazione. Per quanto schematico e approssimativo, si va per coppie oppositive. Sentiamo cosa dice Jonathan Franzen. Avete presente?, il grande scrittore americano, autore di Le correzioni. Per l’uscita del suo nuovo romanzo, Freedom, la «Domenica» del «Sole 24 Ore» nell’agosto 2010 gli chiede un messaggino da pubblicare, in cui dica dove si trova e come trascorrerà il ferragosto. Franzen non accetta, risponde: «Thanks, but I don’t tweet». Franzen non twitta. Ecco, altro possibile split: c’è chi ama twittare e chi no. Fa una bella differenza, non credete? Franzen — dice poi nell’intervista – è ostile alla tecnologia dei BlackBerry, ai messaggini, al cellulare, alla connessione perpetua, ovvero al nostro attuale occidentale tanto amato fast food della comunicazione, ovvero «cultura dell’ultra-brevità» di cui Twitter è solo una delle ultime trovate. Sapete una cosa? Franzen si dà al birdwatching, è possibile trovarlo accovacciato per ore in un campo deserto, che aspetta di osservare il comportamento di volo di un particolare volatile. Secondo voi vuol dire qualcosa questo, o niente? Thanks, but I don’t tweet. C’è chi ama osservare, c’è chi ama twittare. Tanto per dirne una. Ma potremmo continuare all’infinito, Franzen è solo un piccolo esempio. C’è chi preferisce fare, agire, lavorare in gruppo, viaggiare, stabilire relazioni. E c’è chi preferisce contemplare, e lavorare in solitudine e possibilmente star fermo. Chi assomiglia a Ulisse e chi a Leopardi, per dire. Ulisse: l’uomo in movimento, il viaggiatore, l’esploratore, l’uomo che va per mare e a ogni approdo sbarca e cerca, indaga, vuole conoscere. Curioso, attento, attivo. Eroe della conoscenza, come lo vuole Dante, ma di una conoscenza-esperienza, dove l’esperienza è lo strumento privilegiato, il must del proprio stile di vita. Viaggiare, esplorare, sperimentare. Leopardi: l’uomo fermo, contemplativo, seduto alla scrivania, chiuso in una stanza, semmai affacciato al balcone della casa di famiglia. Chino sui libri, aperto all’infinito dell’immaginazione. Eroe di una conoscenza tutta libresca, mentale, teorica. Vita attiva, vita contemplativa. Sarà troppo semplice, ma un po’ funziona. Anche se grossolanamente, dà un’idea. Possono aiutarci anche le immagini, le icone. Pensiamo a due statue celebri: il Discobolo, l’uomo in movimento, che si torce nello sforzo, che gareggia per lanciare il disco il più lontano possibile; e il Penseur di Auguste Rodin: il pensatore, l’uomo seduto, che raccoglie la testa tra le mani, appoggia il gomito sul ginocchio e pensa, fermo, statico, raggomitolato, avulso, sganciato dalla realtà materiale, scollegato, astratto... Ognuno dovrebbe poter scegliere la scuola, a seconda di quel che è. Ulisse o Leopardi. Discobolo o Pensatore. Azione, riflessione. Vita attiva, vita contemplativa. Estroversione, introversione. Studio applicativo-pratico, studio teorico-astratto. Le dicotomie esistono. Bisognerebbe prenderne atto, per essere più felici, sia come individui che come società. Come studenti, per esempio... Una società in cui gli individui sbagliano percorso per cecità di fronte alla propria vera natura (e gli studenti sbagliano scuola...) non può funzionare. È una società sbagliata, e infelice: «fuor di strada», direbbe Carlo Martello. La felicità sociale è la somma delle felicità individuali, dove ogni singolo ha trovato la sua strada, ha assecondato la sua natura e ha sviluppato il suo stile. Ha fatto cioè la sua scuola, per diventare il più esattamente possibile quel che voleva diventare, o meglio: quello che sentiva di essere e quindi quel che voleva diventare. 3. Le tre scuole Mi piacerebbe ci fossero tre scuole. Pulite, chiare. Mi piacerebbe che i giovani potessero scegliere fra tre direzioni ben distinte. Non sono capace di fare una proposta operativa concreta e reale. Ma posso provare a dire quello che ho in mente, in modo estremamente semplice. Una scuola per il lavoro. Una scuola per la comunicazione. Una scuola per lo studio. Ecco le mie tre scuole. Troppo semplice? Forse. Ma terrei volutamente generica la triade. Non tocca a me scendere nei dettagli di una attuazione concreta. Lo possiamo però ridire in inglese, tanto per essere più internazionali e moderni: – work-school (w-scuola): la scuola del lavoro pratico, manuale, artigianale o tecnico-operativo; per chi vuole subito imparare un mestiere; – communication-school (c-scuola): la scuola della comunicazione, della Rete, delle relazioni, dei linguaggi multimediali; per chi vuole studiare cose subito utili, e in uno stile visivo-esperienziale; – knowledge-school (k-scuola): la scuola dello studio astratto, della speculazione teoretica; per chi vuole studiare in modo ricostruttivo-simbolico. W, c, k: tre lettere per tre scuole. Vu doppia, ci, cappa. Così ognuno potrà scegliere la sua scuola, a seconda del suo «schema ideale» o «progetto di vita», come dice Todorov. A seconda di che cosa ognuno pensa di essere e di volere. Naturalmente, in vista di quella che abbiamo detto pienezza, ovvero felicità, di vita. Adesso vi presento più nel dettaglio le mie tre scuole. W-SCUOLA È la scuola per chi vuole fare, nella vita, un lavoro manuale, pratico, tecnico. Diventare artigiano, per esempio, o tecnico: geometra, informatico, meccanico. Fare, costruire, riparare. Fare con i materiali concreti: il ferro, il legno, il vetro, le vernici, la calce; oppure fare in senso più teorico: progettare, programmare, revisionare. In queste Nuove scuole tecnico-professionali, ovvero delle arti e dei mestieri, mi piacerebbe che non si insegnassero però solo le materie tecniche, quelle strettamente utili a creare le future «competenze» professionali. Mi piacerebbe s’insegnassero anche le materie inutili, quelle non misurabili e non certificabili. In queste scuole si dovrebbe insegnare (così come in tutte le altre scuole, peraltro...) ad amare la lettura, e l’ascolto della musica, e la contemplazione di opere d’arte. Non dico la storia letteraria, o le varie interpretazioni del Barocco o l’elenco delle opere del Caravaggio in ordine cronologico. No, io parlo di un’educazione estetica. Sto pensando alla persona, prima ancora che alla sua professione, sto pensando alla sua vita in generale, alla sua giornata, a quando torna a casa e si rilassa. Mi piacerebbe che potesse rilassarsi anche ascoltando Mozart. Mi piacerebbe che i ragazzi ascoltassero Mozart tutti, indipendentemente dal lavoro che hanno scelto di fare, e quindi dalla scuola che hanno scelto di frequentare: sia che uno farà l’avvocato, sia che farà il potatore degli alberi dei viali, il professore di filosofia o il panettiere. Il bagnino, il pilota di aerei o l’ingegnere o l’amministratore delegato o l’allevatore di cani da pastore, o il pastore. Non importa. Quel che importa è che sappia ascoltare Mozart, leggere le poesie della Szymborska e i romanzi di Murakami. Che lo sappia scegliere, che lo possa quindi fare se ne avrà voglia, la sera quando torna a casa. L’importante è che ne sia stato reso capace. Solo così avrà una vera, reale alternativa a tutto il resto: tivù, videogiochi, social network. Vorrei solo che ci possano essere, nella sua vita, anche i libri, le poesie, i concerti. Una verosimile possibilità. Tutto qui. Se no, se non diamo alternative, la nostra è una finta: stiamo ingannando i ragazzi. È come se a noi chiedessero, di un film inglese, se preferiamo vederlo in lingua originale o tradotto in italiano, quando nessuno ci ha mai insegnato l’inglese... Che razza di finta domanda sarebbe? Certo che oggi i ragazzi preferiscono Internet alla poesia: ma è solo perché noi non gliel’abbiamo mai fatta leggere, non abbiamo loro insegnato il codice della poesia. Ovvio quindi che ne stiano fuori e «preferiscano» altro: ma è perché non la capirebbero, dunque come potrebbero mai sceglierla. E ne sono incapaci, perché li abbiamo lasciati noi analfabeti. Sono quindi, le loro, preferenze coatte, e finte scelte. Di cui noi dovremmo sentirci molto responsabili... K-SCUOLA Questa è la scuola agli antipodi della precedente. Insieme, w-scuola e k-scuola rappresentano gli estremi. La k-scuola è la scuola «delle conoscenze». Se vogliamo, delle «nozioni» rivalutate, non osteggiate, ri-accettate, modernamente, utilmente, globalmente... È la scuola dello studio astratto. Sui libri, e con le parole, innanzitutto: è la scuola del lógos. Studio concentrato e anche, se necessario, assolutamente solitario e quindi scollegato. È la scuola dove valgono prima di tutto i contenuti: che cosa leggere, che cosa studiare, che cosa sapere. Qui non si ha paura dell’inutile: si studiano perlopiù materie sganciate dalla realtà, dall’attualità, dal presente immediato. Non si ha paura del passato né dell’inattuale, perché si sa che ci sono cose basilari senza tempo, e inattuali per definizione perché sempre attuali. E non si ha paura dell’inutile, perché si sa che le conoscenze che sembrano inutili «serviranno » eccome, magari dopo, in un tempo successivo, e sapranno loro come trasformarsi per diventare utili. Si fa insomma, in questa k-scuola, impavidamente filosofia, letteratura, latino, greco, matematica, fisica: astrazione pura. Si può usare o no il computer, ovviamente. E anche Internet, l’iPod, l’iPad, l’iPhone: non importano gli strumenti, perché si è ben consapevoli che solo di strumenti si tratta. C-SCUOLA È la scuola della comunicazione. In questo senso, è la scuola Nuova che stiamo attivando. In parte c’è già, ma è chiaro che sempre più ci sarà. È la scuola che vogliamo oggi, e che abbiamo deciso per il nostro Futuro. È la scuola che crede moltissimo nel Futuro, e pensa che ogni futuro sia sempre, per definizione, progresso. È la scuola voluta, da almeno quindici anni, dall’Europa e dalla squadra di burocrati-tecnocrati del Ministero, indipendentemente dal ministro in carica e da qualsivoglia appartenenza politica. Nella c-scuola prevale il metodo sui contenuti, e i progetti sui programmi. Agli insegnanti «si insegna a insegnare», e agli studenti si insegna a «imparare a imparare», prima di tutto. Gli obiettivi principali della c-scuola sono: la socializzazione, il lavoro di gruppo, la cooperazione, la cittadinanza, la Costituzione, la flessibilità, il multitasking e il problem solving, prima che il sapere e in particolar modo il sapere astratto e, ancora più nel dettaglio, il sapere umanistico, inutile per eccellenza. Secondo gli ultimi diktat europeistico-tecnocratici, sarà un unico, multivariato «liceo dell’obbligo», impostato sul modello europeo a sua volta desunto dal modello americano. Sarà il regno di: Internet, tecnologie, linguaggi multimediali, metodo, saperi pratici, approccio esperienziale, connessioni, videogioco, gioco, interazione, lavoro di gruppo, socializzazione, territorio, progetti, attività extracurricolari, educazioni varie (stradale, alimentare, alla cittadinanza), abilità, competenze, centralità dello studente, valutazione, misurazione, certificazione. Tanto per intenderci, no Torquato Tasso, of course... L’evoluzione ulteriore, mi dicono, sarà una scuola sempre più fondata sulle opzioni individuali, in cui lo studente entra, gira, prova, esperisce, scegliendo di volta in volta che corso o stage o modulo seguire, creandosi un suo personalissimo percorso, dopo il quale verrà valutato e certificato in base ai crediti e ai livelli di apprendimento. Può darsi che sia una buona scuola per il futuro, ed è possibile che debba rimanere l’opzione fondamentale: la vera, grande scuola superiore di massa. Non voglio esprimere nessun giudizio. Riconosco che di questa scuola, forse, può esserci bisogno, che è in linea con le attuali tendenze e bisogni, preferenze e gusti della società... Vorrei solo che non diventasse l’unica scuola! O peggio che mai, che venisse considerata la migliore delle scuole possibili! Vorrei che non fosse l’unica opzione possibile! Perciò è assolutamente necessario che le altre due scuole, la k e la w, nascano per davvero, o meglio, emergano dal pantano-marasma della parascuola con maggiore chiarezza, invece di restar soffocate e confuse le une dentro le altre, come mi sembra accada oggi in un indistinto liceo c-k mistogriglia salamoia. Vorrei insomma, lo ripeto, che la scuola italiana «si chiarisse ». E perché si chiarisca, dobbiamo risolvere qualche piccolo problema. Ad esempio la scuola professionale e tecnica potrebbe essere un’ottima w-scuola, se solo diventasse una vera possibile scelta per tutti. Adesso non rappresenta affatto una scelta per tutte le classi sociali, resta riservata a una fetta soltanto di popolazione, spesso la più svantaggiata. Deve assolutamente diventare appetibile e fascinosa anche per le classi medio-alte, essere competitiva, alzare il livello culturale, promuovendosi in ambito internazionale e prevedendo una continuazione, con corsi universitari, master, scuole estive, stage all’estero, approfondimenti e sviluppi collegati anche ad altri ambiti. Le professioni manuali e tecniche devono essere considerate alla pari delle professioni più teoriche-speculative. Diventare artigiani del legno o del ferro, elettricisti, pasticcieri, mastri cioccolatai, affrescatori di stanze deve costituire un’alternativa concorrenziale al diventare medici, avvocati, ingegneri. Così come i cardiologi o i professori di filosofia girano il mondo illustrando i loro studi, le loro idee e innovazioni, i casi clinici che hanno incontrato e studiato, così anche i fabbri potrebbero illustrare ai colleghi, italiani e stranieri, i loro esperimenti, le loro invenzioni, che so, riguardo all’arte dei cancelli di campagna per esempio... Non si vede perché no. Anche i licei dovrebbero chiarirsi. Gli attuali sei licei della riforma Gelmini sono un ibrido non chiarito, un misto di k-scuola e c-scuola, una specie di grosso, enorme «liceo dell’obbligo » o liceo per tutti, un liceo-carrozzone a chiazze: ancora un po’ impregnato di passatismo, ma già come un girasole volto al sole dell’innovazione. Un esempio per tutti: allo scientifico si continua a far latino perché non si ha il coraggio di abolirlo, ma lo si riduce a tre ore e, soprattutto, lo si relega alla sola opzione del liceo scientifico tradizionale, facendolo invece sparire nell’opzione delle «scienze applicate». Classico e scientifico potrebbero unirsi in un unico liceo, che chiamerei «liceo umanistico» o «leonardesco»: un liceo dove i saperi umanistici e i saperi scientifici siano finalmente uniti, proprio nel senso di quel che fu l’Umanesimo, e di cui forse Leonardo potrebbe costituire il più chiaro emblema. Sarebbe la k-scuola, l’unica quindi col nome liceo... la scuola-Isola, quella per gli albatros, isolati, diversi, portati allo studio e negletti. Con una speranza: che venga scelta da un numero sempre più grande di ragazzi, grazie anche a borse di studio e incentivi vari alle famiglie più svantaggiate. Ma questo è un mio personale, privatissimo sogno, e lo scrivo qui in caratteri diversi: il sogno di vedere un giorno nel cielo stormi giganteschi di elegantissimi albatros, che a milioni fanno la pernacchia ai marinai, rimasti ottusamente fermi sulla tolda della nave, con i loro pesanti stivali attaccati al pavimento... Tutti gli altri licei dovrebbero, più risolutamente e coraggiosamente, diventare quel che già sono e desiderano essere: dovrebbero cioè sempre di più caratterizzarsi come c-scuola, privilegiando decisamente i metodi esperienziali, i linguaggi multimediali, i saperi utili, le abilità relazionali e le competenze tecnologiche legate all’ambito della comunicazione e dell’interazione sociale. 4. Il problema del pugile suonato Rimane un unico, gigantesco problema: la scuola dell’obbligo, monoliticamente o quasi c-scuola, dove prevalgono le attività di relazione, la modalità del gioco, gli strumenti multimediali, i metodi esperienziali. È una scuola che va benissimo se... i ragazzi poi scelgono di continuare una scuola dello stesso stile, cioè un liceo in stile c-school, o una w-school! Ma se per caso scelgono una k-school, e cioè l’attuale liceo classico (in parte anche l’attuale liceo scientifico: dipende dalle scuole e dalle sezioni...) o quell’utopico liceo «umanistico» che abbiamo testé prefigurato, allora è dura: la c-scuola dell’obbligo non lo prepara per niente a una k-scuola! Ho conosciuto molti ragazzi che per otto anni hanno vissuto in scuole elementari e medie ricche di esperienze, laboratori, innovazioni, esperimenti; sono stati felici, divertiti, stimolati e motivati; prendevano bei voti, note di merito, lodi, encomi di gruppo; arrivavano a casa paffuti e rubicondi, entusiasti delle loro imprese epiche (di gruppo), invitando schiere di parenti alle prossime esibizioni spettacolari (balletti, teatro, musica, gare sportive). Peccato che poi ho visto quegli stessi ragazzi remare, sudare, stressarsi, insomma divertirsi decisamente meno... al primo anno di liceo. Non erano abituati. Non erano preparati. Cadevano dalle nuvole. Dicevano: ma io non ho mai studiato così. Ma qui cosa vogliono da me... Non perché avessero trovato una scuola particolarmente dura: erano solo passati dalle medie al liceo. E madri e padri e nonni disperati, angosciati, terrorizzati, pronti a sparare a vista ai nuovi insegnanti, così ottusi, retrogradi, severi, intolleranti, beceri, bestie... Molti ragazzi, nel passaggio da scuola media a liceo, soccombono, e subito dopo Natale cambiano scuola, sezione, città. Altri stringono i denti e affrontano anni di brutti voti, mal di pancia, debiti, recuperi e lezioni private selvagge. Altri ancora scelgono le scuole private, dove, dicono, si respira un’altra aria, ci aiutano, non ci massacrano. Non so dire. Però mi sembra un bel problema, cosa ne pensate? Mi sembra che abbiamo due grossi cicli di scuola che non si muovono in modo coordinato. Lo chiamerei il problema del pugile suonato. È come se un ragazzo lo allenassimo per anni a fare pattinaggio e poi lo mandassimo a fare pugilato. Come pensate che si sentirebbe sul ring, lui che sa fare solo eleganti giravolte sul ghiaccio? Il fatto è che abbiamo un liceo in stile ibrido c-k (dove tutto sommato resiste ancora un briciolo di studio astratto), e una scuola dell’obbligo che invece è prevalentemente in stile c. Bisognerebbe che il liceo si chiarisse sdoppiandosi in un cliceo e in un k-liceo. E che allo stesso modo si sdoppiasse anche la scuola dell’obbligo: da una parte le c-elementari e cmedie, e dall’altra le k-elementari e k-medie. Non abbiamo, cioè, oggi una scuola dell’obbligo k che prepari al liceo k. E non abbiamo un liceo c che continui lo stile c della scuola dell’obbligo! Abbiamo un liceo senza i necessari presupposti, e una scuola dell’obbligo senza il logico seguito. Dobbiamo assolutamente porre rimedio a questa sfasatura. Dobbiamo creare il doppio stile per tutta la durata del corso di studi, dalla prima elementare all’università! Due scuole parallele, o una divisione sezione per sezione all’interno della stessa scuola, non so. Ma soprattutto dobbiamo distinguere subito: otto anni di c-scuola (dove prevalentemente si apprende facendo esperienza), che preparano sia a una w-scuola che a una c-scuola dove si continua a imparare facendo esperienza; oppure otto anni di k-scuola (dove prevalentemente si apprende studiando) che preparano a una k-scuola dove si continua a imparare studiando. Ognuno scelga la strada. Ma che la scelga da subito, dalla prima elementare. E poi veda: naturalmente deve essere sempre possibile cambiare tipo di scuola! Crescendo si cambia, o si capisce meglio chi uno è, cosa vuole, dove va. E quindi si deve poter ri-adattare la scelta in ogni momento. Però c’è un guaio: se si sceglie fin dalla prima elementare la k-scuola, benissimo, non ci saranno grossi problemi, si potranno fare tutte e tre le scuole, w, c, k. Ma se si sceglie di fare delle c-elementari, benissimo se si faranno le superiori in una c-scuola o w-scuola, meno bene per le k-scuola, che necessitano di una preparazione idonea fin dall’inizio del percorso di studi. Detto concretamente: se a sedici anni un ragazzo vuol essere in grado di leggere Torquato Tasso (o se una famiglia vuole che il figlio sia in grado di leggere Torquato Tasso), deve pensarci prima! Deve fare una scuola che per otto anni lo metta in grado di capire poi, a sedici anni, le parole di Torquato Tasso. Se un ragazzino vuol fare il pugile, non lo mandiamo otto anni a fare danza classica. Vi pare? Insomma, per garantire a tutti la scelta di un liceo k, il meglio sarebbe fare elementari e medie in stile unico k per tutti! Così non ci sarebbe più il problema di dover fare un passaggio complicato o impossibile. Non sarebbe male, a ben pensarci, anche per un altro motivo: se la scuola dell’obbligo diventasse compattamente una k-scuola, noi daremmo ai ragazzi una preparazione di base eccellente, che li metterebbe in grado automaticamente di scegliere poi qualsiasi percorso di studi, anche il più astratto e difficile del mondo! Come dire: ragazzi, noi vi diamo una scuola dell’obbligo che per otto anni vi costruisce le basi solide della conoscenza, vi fa matematica, storia, geografia e letteratura, vi mette in grado anche di leggere un canto di Dante e capirlo (com’era nella scuola media che ho fatto io, per esempio), e poi liberi tutti! Scegliete pure di continuare così, oppure di fare un triennio di falegnameria o di informatica, e di studiare in stile esperienziale con i video, il teatro, la musica, i social network e le lavagne interattive: non ce ne importa più niente, noi le ruote della bici ve le abbiamo messe robuste, adesso pedalate un po’ dove vi pare, anche dall’altra parte del globo! 5. L’arte di osservare, ovvero la responsabilità delle famiglie Ma una scuola k per tutti e fin dall’inizio sarebbe un’utopia. Dunque bisognerebbe scegliere a sei anni il genere di scuola, almeno a grosse linee la direzione prevalente: scuola k, o scuola non-k. Sento già montare l’indignazione: ma com’è possibile? Infatti non è possibile. Nessuno a sei anni è in grado di scegliere la scuola, perché nessuno certamente è in grado di capire la propria natura, il proprio stile, la vita che vorrà avere, il mestiere che vorrà fare. È vero. Io per esempio a sei anni volevo fare il muratore, perché davanti a me costruivano un enorme condominio e io m’incantavo per ore a guardare, dal balcone di casa mia al quinto piano, i muratori che facevano il cemento, e che con la calce e i mattoni tiravano su i muri. Un vero spettacolo! Diciamo che dovrebbe essere la società stessa, nell’intera sua totalità, a dire come vorrebbe la scuola dell’obbligo; sarebbe bello che tutti gli italiani dicessero: vogliamo per i nostri figli una solida scuola di base per otto-dieci anni almeno, una k-scuola per tutti! Ma siccome questo non sta avvenendo, in questa totale latitanza della società sarà il singolo a scegliere anche la scuola dell’obbligo per tutti. Un bel controsenso, non c’è che dire... Il principio della fine, secondo me... Ma che fare? Così è. Dunque, siccome il bambino di sei anni non sceglie un bel niente, saranno gli altri a scegliere per lui. La famiglia prima di tutti, poi gli insegnanti. Bisognerà, secondo me, che subito in seconda battuta scendano in campo pesantemente e autorevolmente (cioè col peso della loro autorevolezza...) gli insegnanti. I quali ogni anno, dalla prima elementare fino alla terza media, diranno con grande chiarezza e autorità quale percorso di studi sia secondo loro, per ogni singolo allievo, il più adatto. Di anno in anno. Un monitoraggio continuo, famiglia e scuola unite. Se per esempio il pool degli insegnanti dirà che il bambino non è affatto portato allo studio astratto, la famiglia non dovrà iscriverlo a un k-liceo!, bensì seguire con grande umiltà e fiducia le indicazioni dei docenti, pensando che al bene di suo figlio essi hanno pensato, e quindi dovrà iscriverlo o a una w-scuola o a una c-scuola. Certo, nessuno le toglierà la libertà di iscrivere comunque il figlio a una difficilissima k-scuola della conoscenza, ma a quel punto lo farà a suo rischio e pericolo: più esattamente, sulla pelle del povero figliolo... Certo è che, nel mio mondo della libertà di scelta, le famiglie avranno un ruolo fondamentale e una responsabilità enorme. Dovranno interrogarsi a lungo su se stesse, su quel che amano e vogliono, sulle cose in cui credono e a cui danno più valore. Ad esempio dovranno chiedersi se vogliono che il loro figliolo capisca l’italiano di Torquato Tasso e quindi sia poi in grado di leggere o no cose come La Gerusalemme liberata. Uscendo dal solito ritornello del Tasso, se vogliono una scuola di cultura, nel senso profondo del termine. Questo vuol dire che, venendo al sodo, le famiglie italiane dovranno chiedersi se leggere La Gerusalemme liberata (cioè Dante, Shakespeare, l’algebra, Cartesio, Newton, la fisica quantistica...) è per loro una cosa importante o no, decisiva, auspicabile o invece irrilevante e forse anche deleteria. Dovranno quindi capire in che misura ritengono la letteratura (e l’arte, e la filosofia, e la logica, e la matematica...) importante nella vita loro e dei loro figli, se insomma la annoverano tra i loro valori fondamentali o no. Certo sto chiedendo molto alle famiglie: una maggiore consapevolezza e attenzione, e l’assunzione di una maggiore responsabilità, in vista di una scelta. In realtà, non è nulla di impossibile: le famiglie sono perfettamente in grado di scegliere, dal momento che conoscono perfettamente i figli, e conoscono soprattutto molto bene il loro proprio stile di vita, in particolare il tipo di educazione che hanno deciso di impartire e il patrimonio di valori su cui hanno fondato la vita famigliare stessa. Potranno quindi scegliere conseguentemente anche le scuole. Si chiederebbe loro soltanto di scegliere con una consapevolezza e chiarezza e determinazione maggiori. Tutto qui. Già oggi, comunque, è molto evidente che cosa una famiglia vuole per il proprio figlio; basta assistere alle riunioni preliminari in vista dell’iscrizione a una scuola: ci sono famiglie che s’informano sugli orari, la settimana corta, i corsi aggiuntivi; ci sono famiglie invece che vogliono incontrare i singoli docenti ai quali chiedere specificamente quali programmi intenderanno svolgere e come. Ci sono famiglie che desiderano che il figlio impari molto e incontri dei grandi maestri, e ci sono famiglie per cui l’importante è che il figlio sia sereno e sorridente e faccia tanto sport e informatica. C’è differenza o no? Io chiedo solo che tale differenza sia d’ora in poi più consapevole e responsabile. Onde evitare che poi al liceo noi riceviamo genitori stupefatti e offesi dal 4 in italiano del figliolo, genitori che non si rendono conto della loro responsabilità: quel 4, che registra ignoranze abissali e irrecuperabili in grammatica italiana, è dovuto esattamente alla scelta di scuola che loro hanno operato all’inizio per il loro figliolo. Sarebbe auspicabile che le famiglie scegliessero in base a criteri di sostanza: se si vuole, fin dalle elementari, una k-scuola o no per il proprio figlio. Che la scelta non sia invece in base al fatto se in una scuola esiste o meno la piscina, quali viaggi d’istruzione e quali gare sportive si prevedono e se si studia anche il russo. La famiglia è al centro dell’operazione-scuola, oggi più che mai. Dunque si ponga fin dall’inizio alcune fondamentali domande, visto che in prima battuta sarà lei a scegliere la scuola del figlio di sei anni. La scelta non può essere casuale, e non è irrilevante. E soprattutto discende dal tipo di educazione che già si è impartita al proprio figlio. Voglio dire che se, ad esempio, la famiglia ha lasciato che il proprio figlio guardasse per quattro ore al giorno la tivù, se gli ha regalato la PlayStation a cinque anni e il cellulare a otto, non può pensare che codeste sue scelte educative siano ininfluenti e non determinino quindi anche la scelta della scuola più idonea tra k e non k. Non si tratta di capire se i figli sono più o meno geniali, intelligenti o capre. La scelta non è in base alle doti intellettuali, né al ceto sociale. È unicamente in base allo «stile», a sua volta determinato dall’indole, dalla natura del figlio, ma anche dall’educazione impartita e dallo stile famigliare. Per questo è auspicabile che le famiglie diventino più attente, e più consapevoli. È necessario che si mettano in osservazione, che «osservino» di più: soprattutto i figli, ma anche se stesse!, e da lì facciano conseguire, responsabilmente, le loro scelte scolastiche, le quali non possono in alcun modo essere casuali, e meno che mai opposte o in contraddizione con lo «stile famigliare». Osservare se stesse. Anche le famiglie, infatti, hanno un loro carattere e stile personale. Possono essere per esempio famiglie-Discobolo, o famiglie- Penseur. Famiglie-Leopardi o famiglie-Ulisse. Dipende. Ci sono famiglie che chattano e twittano, videogiocano tutte le sere, hanno un giro pazzesco su Facebook, prenotano le vacanze in un bel villaggio turistico perché vogliono essere animate ventiquattro ore al giorno tra il tiro con l’arco e la gara dei gommoni, la serata di karaoke e salsicce alla griglia sulla spiaggia alle due di notte e finale astronomico di gruppo a guardar le stelle col cannocchiale. E ci sono famiglie che la domenica vanno in bici lungo il fiume, leggono il giornale al bar, vedono al massimo due amici per volta a cena e in vacanza scelgono di andare in una sperduta baita di montagna. Famiglie moderne, attive, interattive, curiose, spigliate, connesse, naviganti, frequentanti, viaggianti, prenotanti, last minute... E famiglie solitarie, contemplanti, pigre, leggenti, sconnesse, scollegate, ruspanti, cucinanti, cine-amanti. Naturalmente, tra l’idealtipo Ulisse-Discobolo e l’idealtipo Leopardi-Penseur allo stato puro, si devono immaginare infinite varianti, con mix diversissimi delle due componenti, tanto per le famiglie come per i singoli ragazzi loro figli. Insomma, lo shakeraggio è illimitato. Ma è difficile non vedere che la distinzione di base esiste, ed è fortissima. Si tratta davvero di famiglie e di ragazzi decisamente diversi... direi abitanti di due pianeti opposti. Inoltre, naturalmente non è detto che nasca un ragazzo-Discobolo in una famiglia-Discobolo; può essere che nasca un ragazzo-Discobolo in una famiglia-Penseur, e un ragazzo-Penseur in una famiglia-Discobolo. Per questo bisogna essere attenti, e osservare. Così come non è detto che una famiglia-Penseur voglia per i suoi figli una scuola-Penseur: potrebbe volere una scuola-Discobolo. E, viceversa, una famiglia-Discobolo potrebbe volere una scuola-Penseur. Insomma, voglio dire che non è così drastico e schematico. Il mondo è molto più complesso di come io lo sto adesso qui delineando, a colpi di scalpello. L’importante, però, è sapere più o meno di che pasta si è fatti e quindi più o meno quel che si vuole per sé e per i propri figli, così da scegliere di conseguenza, prendendo delle decisioni chiare, e il più presto possibile. Quel che non mi sembra bene è affidarsi al caso, essere distratti o peggio ancora indifferenti, lasciar fare, cedere a una mollezza irresponsabile: ogni scelta effettuata o non effettuata non dico che determina, ma certo influenza e condiziona il futuro dei nostri figli, il tipo dei loro studi, lo stile di quel che faranno. Osservare i propri figli, infine. Goethe parlava di «natura originale». Pietro Citati ha ripreso questo concetto in un articolo (apparso su «Repubblica » il 7 settembre 2010) sull’osservazione dei bambini che giocano. È agosto, Citati si trova in vacanza al mare, e osserva i figlioletti di amici: tre gemelli di nove mesi, che giocano sulla spiaggia, ognuno a suo modo. Figli degli stessi genitori dunque, ma quanto diversi! Ognuno ha una sua «natura originale», direbbe Goethe, che vien fuori dal comportamento quotidiano: il primo bambino, osserva Citati, è tranquillo e sorridente, contempla, studia, analizza con calma le cose del mondo; la seconda gemella è irrequieta e possessiva, presa da mille desideri, non sta mai ferma e di tutto vuol fare esperienza; la terza è forse la più misteriosa: rifiuta il cibo, forse perché possiede dentro di sé – dice Citati – «un mondo molecolare e microscopico, che guarda col cannocchiale rovesciato ». Proprio questo volevo dire: osservare molto, e a lungo, i bambini, ad esempio quando giocano, ci regala una magnifica vista sull’essere umano in fieri. Come capisco Citati! Io l’ho fatto per anni, da giovane: me ne andavo ai giardini, mi sedevo su una panchina davanti allo scivolo, le altalene, le sabbiere, e stavo per ore a guardar giocare i bambini. Mi sembrava di vedere, in ognuno di essi, l’umanità intera, tutte le infinite sfumature del possibile umano, così come poi si sarebbe delineato in età adulta: c’è il capriccioso violento, il passivo rassegnato, l’umile, il timido, l’arrogante, quello che già mostra attitudine al comando, quello che contempla chissà che cosa per aria e inciampa svagato in una pietra, quello che vuol fare amicizia con tutti a ogni costo, simpatico, generoso, estroverso, quello che invece piange sempre, per chissà quale sua remota e insopprimibile insoddisfazione. I gesti ci rivelano, fin da piccoli. I gesti del gioco, poi, essendo maggiormente spontanei, o comunque non mediati da riflessione alcuna, dicono moltissimo della nostra natura, di quel che già siamo e che quindi, crescendo, sempre più saremo. Basta sfogliare gli album di foto della nostra infanzia: scopriremo, in quelle immagini remote di noi, quel che siamo oggi diventati. Non so se si possa davvero scegliere lo stile scolastico più idoneo ai propri figli solo guardandoli giocare ai giardinetti... Non vorrei arrivare a dire questo... ma quasi. Sono quasi convinta di sì, che sia possibile, osservando molto i propri figli fin dai primi giorni di vita, arrivare a capire molto, e quindi anche, poi, a scegliere la scuola giusta. Comunque, l’importante è porselo, il problema di una scelta; pensare che la scuola non è ininfluente e che dunque la scelta non può essere affidata all’indifferenza del caso o alla generosità della sorte, che ci offrirà per magia la scuola giusta e gli insegnanti giusti. Noi genitori dobbiamo consapevolmente chiederci quale scuola sia la più adatta ai nostri figli, ma anche a noi genitori, al clima educativo che abbiamo già scelto e in qualche modo imposto. Dobbiamo chiederci quali siano i valori prevalenti (culturali? sportivi? relazionali?) secondo i quali abbiamo fino a quel punto condotto l’educazione e la formazione dei nostri figli. Quale sia, insomma, la scuola più consona alla nostra globale, famigliare «natura originale». 6. Padri illuminati La cosa importante, e difficile, è che tutti noi riusciamo a considerare pari le scuole w, c e k. Senza pensare invece che una sia di serie A e l’altra di serie B. Né che l’una sia al passo con i tempi e l’altra invece no, che una sia nuova e l’altra vecchia. Dobbiamo riuscire a vedere, soprattutto, che non c’è alcuna discriminazione di tipo economico-sociale: la famiglia che sceglie la scuola del lavoro o la scuola della comunicazione può essere povera o ricca, così come la famiglia che sceglie la scuola della conoscenza può essere una famiglia di operai, impiegati o professionisti del massimo livello. Non dev’essere l’appartenenza a una specifica classe sociale a determinare la scelta dello stile: è la natura del singolo individuo, la sua inclinazione, non quanti soldi ha in banca o di quale origine siano i suoi avi. Un ragazzo naturalmente inclinato allo studio astratto può nascere tanto in una reggia quanto in una baita come in un casermone di periferia. Allo stesso modo un ragazzo non incline allo studio, ma con attitudini pratiche o portato al lavoro manuale, può nascere tanto nella stamberga di un pastore quanto nel superattico del notaio. «La circular natura (...) non distingue l’un da l’altro ostello» dice Carlo Martello. L’importante è che il notaio abbia la capacità di vedere e accettare che suo figlio, negato per lo studio e desideroso di fare il tecnico audio, scelga la scuola professionale. O una c-scuola. Così come l’operaio (con opportuni aiuti, ad esempio borse di studio) consenta che suo figlio, nato per gli studi filosofici e un futuro lavoro di ricerca, scelga la k-scuola. Abbiamo voluto lo studio per tutti, ma soprattutto per i figli delle famiglie svantaggiate, perché con lo studio migliorassero la condizione sociale di partenza. Non abbiamo minimamente previsto che i figli delle famiglie avvantaggiate potessero scegliere il nonstudio! Non abbiamo previsto che qualcuno tra i giovani potesse desiderare di peggiorare, anziché migliorare la propria condizione sociale di partenza! Il fatto è che dobbiamo smettere di pensarla in termini di peggioramento. Io parlerei di mutamento, senza attribuirgli per forza un valore, negativo o positivo che sia. Non abbiamo previsto che un ragazzo di buona famiglia, con condizioni di vita anche molto agiate, potesse preferire il lavoro allo studio... era troppo per noi. Contraddiceva ogni nostro più progressista-classista pensiero. Ci sembrava una scelta impossibile, un salto indietro, un fallimento, una vera idiozia. Non abbiamo pensato che a volte non è così ovvio stabilire che cosa sia andare avanti e cosa sia andare indietro... Siamo stati corti di mente. Sprovveduti. Abbiamo, in tutti questi anni, fortemente disprezzato l’eventualità di una scelta lavorativa manuale o tecnica e non intellettuale, l’abbiamo sempre e soltanto relegata nel mondo sfortunato dei meno ricchi, dei meno colti. Abbiamo in tal modo, secondo me, oltraggiato il lavoro manuale e relazionale, e disprezzato l’artigianalità. È difficilissimo, lo so. È difficile per l’operaio fare in modo che suo figlio, se è portato allo studio, diventi ingegnere. È soprattutto una difficoltà economica la sua, vuol dire sacrifici, stenti, privazioni e una volontà ferrea, e una fede nel futuro del figlio. Ma è ancor più difficile per l’architetto accettare che il figlio voglia fare l’operatore turistico, o l’agricoltore, e se ne vada a lavorare in una fattoria a coltivare pomodori biologici. È una difficoltà psicologica, oltreché sociale. Equivale, per quel padre, a un abbassamento, a una perdita di prestigio. È una ferita all’orgoglio, al proprio narcisistico voler apparire anche e soprattutto attraverso i figli. Qualche mese fa, è morto all’improvviso il padre di un mio vecchio amico. Il quale oggi ha circa cinquant’anni, è un grande architetto, ha uno studio importante in una città del Centro Italia e insegna in varie università straniere. Suo padre faceva l’operaio alla catena di montaggio. Vorrei farvi leggere un piccolo stralcio dalla lettera che mi ha mandato: Non so se mio padre sia stato un buon padre. Cosa ne sa un figlio di che padre ha avuto e di che padre poteva avere? A me è toccato lui e per me, sai una cosa?, è stato un eroe. L’unico uomo che mi sarebbe piaciuto essere, in questa nostra epoca dove tutti si credono chissà chi e poi, se vai a scavare, nessuno ha fatto niente che valesse davvero qualcosa. Oggi che è così difficile trovare un posto o mantenere quello che si ha, mi sento un privilegiato ad avere un lavoro come il mio. Ho raggiunto una buona posizione, come si suol dire. Ma soprattutto, tu lo sai quanto mi piace il mestiere che faccio: invento, giro il mondo, insegno, è una vera fortuna. Ebbene, tutto questo lo devo a mio padre, non credere che non me ne renda conto. Un povero emigrante meridionale con la quinta elementare... Ma aveva capito che far studiare un figlio è tutto e ci ha dato dentro, ha passato quarant’anni della sua vita dormendo di giorno, quattro ore: così poteva fare i turni di notte che gli fruttavano uno stipendio maggiore, e aveva modo di fare un secondo lavoro nel pomeriggio. Solo per permettere a me di studiare, capisci? Quel poco di buono che ho fatto, se l’ho fatto, lo devo a lui. Forse non sono arrivato fin dove potevo, chissà. Mi dispiace se qualche volta mi sono tirato indietro, e ho avuto la stanchezza di non fare abbastanza. Me ne dolgo ora, di fronte alla morte di un padre cosìì.. Questa lettera esiste, e chissà quante altre simili, per fortuna. Vorrei però che da oggi esistesse anche un altro tipo di lettera, o almeno che fosse possibile anche la lettera del figlio di un grande architetto o avvocato o medico, grato al padre che gli ha permesso di diventare meccanico, o contadino o benzinaio. Siccome non conosco l’esistenza di una lettera siffatta, provo a inventarmene un pezzo. Così, perché possiate averne un’idea. Non so se mio padre sia stato un buon padre. Cosa ne sa un figlio di che padre ha avuto e di che padre poteva avere? A me è toccato lui e per me, sai una cosa?, è stato un eroe. Un uomo che non s’è fermato davanti a niente, neanche davanti a un figlio che lo ha tradito... Io, lo sai, non sono diventato quello che voleva lui. Mi ha lasciato libero, e io ho scelto la mia vita come mi pareva. Adesso che non c’è più, vorrei dirgli questo: grazie, papà, è stato il regalo più grande che potevi farmi. Io lo so che volevi che io diventassi architetto come te. Sognavi per me un grande destino. Mi avresti fatto studiare nelle università migliori del mondo. Quando ti ho detto che volevo coltivare la terra, che per me piantare un seme e veder crescere una pianta di pomodori era tutto, me lo ricordo: hai abbassato il viso. Non hai parlato per giorni... Me lo ricordo benissimo. Poi una sera, faceva ancora freddo, era forse marzo, mi hai preso da parte, mi hai portato davanti alla finestra, dove il sole illuminava un pezzo del nostro parco e mi hai detto: Fa’ quello che ti senti di fare, figlio mio. E poi hai aggiunto: Ma che sia fatto bene! Non si dimenticano cose cosìì La mia vita non è facile, ma è la vita che volevo. Sono contento di quel che faccio, e quando guardo i miei figli che mi seguono nei campi e vogliono sedersi accanto a me sul trattore, mi sembra che vada tutto bene. Non ho uno studio importante, non giro il mondo, non sono diventato né ricco né famoso. Ma mi sento felice, tutto qui... Ecco, una lettera così mi piacerebbe esistesse, prima o poi. Mi piacerebbe che avessimo tutti, da adesso in poi, la mente sgombra. Che ci prendessimo la libertà di disobbedire a ogni sorta di ideologia o idea preconcetta o aspettativa sociale o famigliare, e cominciassimo a seguire soltanto i nostri impulsi più profondi e più intimi. Credere di avere un destino. Cercare di non mancarlo. Non sbagliare la meta, il proprio bersaglio. Capire dove ci si sente più a proprio agio, quale vita è la nostra. E non pensare che la propria meta sia minore, o insulsa rispetto a quella scelta da un altro. Non esistono mete minori o maggiori. Dipende solo da come uno le persegue, e da quanto bene le raggiunge. Dipende da quanto siamo bravi a fare il lavoro che abbiamo scelto di fare in base alla nostra inclinazione naturale. Non credo ci sia molto altro da raggiungere nella vita. Saper fare bene una cosa — sia tornire le gambe di un tavolo, sia confezionare un abito o fare il pane o scrivere un libro o progettare un ponte o riparare un rubinetto o curare un malato o dipingere il mare o un vaso di fiori – mi sembra il massimo a cui dobbiamo tendere. Una cosa fatta bene, ragazzi, molto bene. Come diceva il padre architetto al figlio coltivatore: Fa’ quello che ti senti di fare. Ma che sia fatto bene! 7. Fuga verso la libertà Oggi non sappiamo quale scuola sia la migliore. Nessuna scuola oggi è migliore, o più giusta. E non esistono scelte giuste o sbagliate. Non saprei dire quale scuola sia meglio frequentare, ma penso che sia giusto scegliere. Che i ragazzi e le loro famiglie siano liberi di scegliere: tutti hanno il diritto di studiare, ma anche il diritto di non studiare, o di studiare in modo diverso. Oggi nessuno di noi potrebbe affermare con certezza che studiare in modo astratto sia ancora proficuo, e che fare per esempio il liceo classico sia il massimo. Ma nemmeno che non lo sia. Non è detto. Nulla è più certo, adesso che il mondo cambia così veloce. Nessuno sa chi sarà vincente, se colui che studierà ancora latino e greco o chi avrà scelto informatica e cinese o chi avrà cominciato, magari nel giardino di casa sua, a coltivare incroci tra le rose e le querce. Magari per esportarle a New York o a Pechino, un giorno, chissà. Soprattutto, non ha senso pensare in termini di vincenti e perdenti: l’unica cosa che conta è che ognuno cerchi di corrispondere a quel che è, di far centro arrivando al nucleo della propria natura. I cosiddetti «bravi a scuola» potrebbero non essere più i Demonti, che stanno ore e ore al giorno sui libri, seduti e fermi, e concentrati a fare una cosa sola. I nuovi bravi potrebbero essere i campioni di multitasking, quelli che sanno contemporaneamente chattare, mandare un sms, leggere una poesia, scrivere un verbale e accendere un forno a microonde. Oppure no: magari a breve torneremo ad aver bisogno di giovani che sappiano concentrarsi su una cosa sola, che ad esempio siano in grado di leggere l’opera omnia di Giordano Bruno... La mia generazione non ha amato i «bravi a scuola», quei «pochi» che, avendo passione per lo studio e i libri, si riteneva fossero destinati a diventare «la futura classe dirigente ». E non ha amato la scuola che supponeva fosse diretta a loro uso esclusivo: l’ha chiamata «la scuola che forma le nuove classi dirigenti» (ancora oggi, molti miei colleghi sparano a zero sul liceo classico...). Allo stesso modo la mia generazione, in un vortice di paradossale follia, nemmeno ha voluto che gli altri, i tanti, si dedicassero a mestieri non intellettuali. Lo trovava infamante, e li ha obbligati a studiare, a fare il liceo, tutti e male. Così, la mia generazione ha creato una scuola «neutra» e «media» nel senso di mediana e mediocre: una scuola grigia, di nessun colore, dove è impedito lo studio a chi è nato per studiare, ed è impedito il lavoro manuale a chi è nato per costruire mobili. Non è andata bene, secondo me. Credo sia stato un apocalittico errore, alla base del quale forse c’è stato uno sbagliato abbinamento: s’è pensato che i bravi a scuola (i pochi) fossero sempre e soltanto quelli di estrazione sociale alta, fortunati per nascita; e che i mediocri a scuola (i tanti) fossero sempre e soltanto gli sfortunati, i nati poveri, quelli di origine bassa. Anzi, peggio: s’è pensato che i pochi fossero bravi perché ricchi, e che i tanti fossero mediocri perché poveri. Una concatenazione logico-causale molto discutibile... Una sorta di «razzismo pedagogico»? Secondo me ci siamo sbagliati. La realtà è ben più imprevedibile di quanto l’abbiamo pensata: assomiglia molto di più a un colpo di vento, che quando arriva sovverte l’ordine delle cose e porta sempre una bizzarria. Per esempio il fatto che un ricco possa essere un uomo mediocrissimo, e un povero possa essere un genio. Credo che i «bravi» nascano un po’ dovunque, casualmente, in una famiglia o in un’altra, senza distinguere «l’un da l’altro ostello»: la cicogna non guarda dove depone il fagotto col bambino, se in uno sperduto casolare o in una reggia. È quel che dice il grande Hillman, nel suo libro Il codice dell’anima: ognuno di noi viene al mondo scegliendo accuratamente dove, in base alla missione che deve compiere: sceglie il luogo, la famiglia, l’ambiente che meglio gli consentiranno di compierla, quella sua missione. E non è affatto detto che per inventare la teoria della relatività si debba avere come padre un grande scienziato... Ognuno nasce dove deve nascere, dove meglio si completa il suo disegno. Kafka lavorava in un ufficio di assicurazioni, e Einstein all’Ufficio Brevetti. Questo pensiero dovrebbe aiutarci a superare l’odio di classe, l’invidia sociale e tutti quei cattivi sentimenti che non ci fanno onore. E che hanno finito per intorbidare anche le acque della nostra scuola. Recentemente ho deciso di far mettere le inferriate alle finestre di casa, e così mi è capitato di conoscere il signor Pandiano. È un bravissimo fabbro, già in pensione, ma fa ancora qualche lavoretto ogni tanto. È un signore bassotto e pelato, con un faccione rotondo, buono. Parla lentamente, con calma, spiega per filo e per segno come intende fare il lavoro, come vede il problema, come pensa di risolverlo. Arriva con un suo assistente, un signore più giovane, altissimo, silenzioso. Il signor Pandiano gli dice: Gino, posiziona... Gino, va’ a prendere... E Gino va e ritorna, posiziona, prende. Intanto il signor Pandiano spiega, racconta, descrive. Elenca tutte le inferriate costruite nella vita, come bisogna fissarle al muro, qual è lo spessore migliore delle sbarre, la distanza tra una e l’altra, i pro e i contro. Si siede, prende un foglio, fa uno schizzo, disegna una specie di cornice in basso, decorativa, due riccioli che s’incontrano, una piattina, un perno. È uno spettacolo starlo a guardare e ascoltare. È uno che sa. Sa il suo mestiere. Sono felice di affidare a lui, e a Gino, le mie inferriate. Sono felice che esista un signore così. Gli chiedo se i giovani oggi imparano da lui, quanti ne ha a bottega. Nessuno, mi risponde. Nessuno vuole fare il suo mestiere, vogliono tutti studiare. Vogliono tutti studiare...! E poi c’è il signor Salli. Gli telefoniamo quando siamo disperati perché il computer è morto, giace spento davanti ai nostri occhi desolati e impotenti. Fa proprio Salli di cognome, ma noi in famiglia lo chiamiamo, con immensa reverenza, Mister Sullivan. È un uomo alto e bruno, taciturno, fascinosissimo. Arriva con la sua valigetta nera rigida, bordata da lucenti paraspigoli in acciaio, e due impeccabili chiusure che fanno: clic-clac! Un, due! Mister Sullivan si siede davanti allo schermo e bofonchia: Vediamo, vediamo... Gli brillano gli occhi, gli prudono le dieci dita. Piano piano, apre una videata dopo l’altra, cliccando su infinite finestrine che appaiono miracolosamente dal nulla, una dentro l’altra peggio di una matrioska. Se ne sta lì mezz’ora, un’ora, due ore. Silenzio assoluto. Poi di colpo ci parla. Tenebroso, calmo. Ci dice qual è il problema. E noi che davamo per perso il computer, e ci vedevamo davanti un futuro fosco senza più mail, Internet, connessioni di alcun tipo... noi a questo punto vorremmo abbracciarlo. Ma lui è così ineccepibile-intoccabile... Ora prende la valigetta, fa clic-clac, estrae un dischetto, una chiavetta, un manualetto, un cavetto... e, un-due, finito, risolto, riparato. Il computer è come nuovo. L’altro giorno, infine, ero a Piacenza a leggere poesie di Petrarca. Un reading a Palazzo Farnese, insieme ai miei amici della Fondazione «Readere». Al termine mi si avvicina un giovane e mi dice: «Ecco, io voglio fare proprio questo. Il mio sogno è fare l’insegnante di lettere e leggere in classe Petrarca proprio come lei stasera l’ha letto qui». Avrà vent’anni. Lo guardo: anche a lui brillano gli occhi. Fare il fabbro, fare il tecnico dei computer, fare l’insegnante. Fare l’ingegnere, il cardiochirurgo, la hostess. Non so, c’è differenza? Uno può sognare di aprire un circuito elettronico, e l’altro un cuore. Uno sogna di diventare fotografo e un altro carpentiere e un altro ancora ballerino. E allora? Ognuno ha il suo sogno. Il ragazzo di vent’anni che mi dice che sogna di fare l’insegnante... L’insegnante! Un mestiere oggi così disprezzato, poco pagato, poco prestigioso. Non so, è un sogno piccolo? È un sogno grande? Ci sono sogni piccoli e sogni grandi, sogni di serie A e di serie B? O, in quanto sogni, i sogni sono tutti uguali, tutti parimenti degni di essere sognati? Ditemelo voi. Ditemi anche se un genitore si deve vergognare se il proprio figlio vuole diventare «solo» insegnante o fabbro... Molti ragazzi che conosco fanno Economia alla Bocconi, Ingegneria gestionale al Politecnico, master e stage di Cooperazione internazionale nelle capitali d’Europa. Sono sogni più grandi questi? E qual è il figlio migliore, di cui andare più fieri, quello che vuol fare l’insegnante nella scuoletta del suo quartiere o quello che vuol fare progetti di cooperazione in giro per il mondo? Quale ci riempie di più il cuore? Non pensate che siano meravigliosamente uguali? Insomma, noi non vogliamo più dire ai nostri ragazzi che cosa è bene e che cosa è male per loro, se sia meglio essere Archimede, Leopardi, Leonardo, Ulisse o Corto Maltese, diventare fabbri o ingegneri, avere successo o non essere nessuno, scegliere una scuola pratica o teorica, mettere accenti e apostrofi o lasciarli cadere, spaccarsi o no la testa su una versione di Tacito, andare all’estero o restare a casa, leggere i romanzi dell’Ottocento o i libri sui vampiri, o non leggere affatto e gironzolare in motorino per i campi, chattare con la propria ragazza incontrata sul Web e fare tre ore di coda all’outlet di Serravalle Scrivia. Noi ce ne stiamo zitti. Certo, avremmo qualche timida ma decisa preferenza. E in segreto, se proprio lo volete sapere, speriamo che le loro libere scelte corrispondano esattamente alle nostre timide ma decise preferenze. Dico solo questo: oggi che sta vincendo la linea dei pedagogisti e burocrati europei alla Monsieur Thélot, lo stile del nonstudio, della «Terza Fase», delle competenze, dell’apprendimento visivo-esperienziale, dei nuovi barbari, dell’ homo videns e zappiens, cerchiamo di mantenere un nostro personale punto di vista sulle cose. Cerchiamo di non omologarci, di non accettare sempre come buona la visione degli altri. D’accordo, forse non si può più imporre lo studio come unica strada all’apprendimento. Mi rattrista, ma accetto. Vi lasciamo liberi. Vorrei solo che lo studio non fosse squalificato, demonizzato, confinato come si vede oggi. Vorrei cogliere intorno a me qualche dubbio, anche in coloro che la pensano diversamente da me. Nessuno può sapere come sarà il futuro, e quale sia oggi il modo migliore di affrontarlo. Liberiamo i giovani dalla costrizione dello studio, d’accordo. Ma liberiamo anche lo studio, adesso braccato dai pedagogisti all’ultima moda: ammettiamolo ancora come possibile, diamogli una chance. Non è detto che chi oggi ancora studia, nel senso classico del termine, sia destinato al fallimento. Potrebbe anche essere il contrario... Pari dignità, che ne dite? E poi tutti ai blocchi di partenza e stiamo a vedere chi vince. Chi sceglierà la c-scuola, sarà perfettamente in linea coi tempi. Niente di male se è una scelta coerente con ciò che pensa e desidera per sé. Ma se per caso non lo fosse, sarebbe bene difendere e affermare le proprie idee contrarie: non è detto che siano sbagliate, possono essere semplicemente diverse e minoritarie. Non bisogna aver paura di essere in pochi a pensarla in un certo modo, non è detto che i molti abbiano ragione solo perché sono molti. È una sfida, mettiamola così. Chiariamo la scuola, distinguiamo in modo netto gli stili e ognuno scelga da che parte stare. Poi, chi ha filo da filare filerà. Noi vorremmo solo che ci fosse la libertà di una vera scelta. Che ognuno si prendesse il rischio della sua personale originalità: viene anch’esso da quella «natura originale» di cui dicevamo... Evitiamo il pericolo strisciante dell’omologazione, del conformarci per forza a un mondo che ci vuole tutti moderni, tutti estroversi, tutti mediatici, visivi, nonstudianti... Permettiamoci il lusso del dubbio, solo questo. Permettiamoci il lusso di una scelta contraria al pensiero dei molti. Ci vuole un certo coraggio. La libertà non è affatto una scelta facile. Erich Fromm, nel 1941, scrisse un libro dal titolo emblematico: Escape from Freedom. Fuga dalla libertà. La tesi fondamentale era che la libertà è di certo un grandissimo valore, ma è anche un peso insostenibile perché ci chiede una grande responsabilità, esige da noi che diventiamo consapevoli di quel che siamo e coerenti con la nostra natura: autentici, spontanei, e quindi vivi, attivi e felici. La libertà esige che noi troviamo la nostra vera «identità individuale», ciò che ci distingue dagli altri e ci rende unici. Ma essere unici ci fa sentire irrimediabilmente soli. E la solitudine ci toglie ogni certezza, ci ruba quella sicurezza effimera ma gratificante di sentirci uguali agli altri, uniti, partecipi. La libertà ci isola, nel senso che ci fa sentire isolati, e pertanto soli e insicuri: esclusi. Seguire la propria inclinazione, e dunque scegliere la propria vita, può mettere a repentaglio la nostra sicurezza e il nostro desiderio di inclusione. Molto più facile aggregarsi, seguire le scelte degli altri, conformarsi. Infatti, come dice Erich Fromm, l’uomo ha trovato nella Storia almeno due vie d’uscita, due modi canonici per «fuggire dalla libertà»: la dittatura e il conformismo. Per non rischiare di sentirsi solo e insicuro, l’uomo è arrivato ad accettare di vivere sotto un governo dittatoriale; oppure di fare gregge, diventare uno dei tanti, mescolarsi alla folla. Per evitare la solitudine, l’uomo può sottomettersi (come è accaduto col nazismo e il fascismo e con tutti i regimi totalitari) oppure può perdersi nella collettività e conformarsi, assumendo acriticamente i modelli altrui (come nelle attuali democrazie consumistiche, in cui ci sentiamo spersonalizzati e anonimi, e ci salviamo solo intervenendo in diretta alle trasmissioni radio e tivù, o chattando o aprendo un blog). Scegliere, invece, prendersi l’onere e il rischio di una scelta arrivando a realizzare la nostra vera autentica personalità, ci renderebbe liberi, unici e veri. È quel che auguro a chi è giovane oggi, ribaltando il titolo di Fromm: di avere coraggio, e fuggire verso la libertà. 1 Cfr. R.H. Turner,The Self-Conception in Social Interaction, New York, 1968. 2 Cfr. G.L. Beccaria, L’antico e il nuovo: le scienze umanistiche e la scuola, in AA.VV., Tre più due uguale zero. La riforma dell’Università da Berlinguer alla Moratti, a cura di Gian Luigi Beccaria, Garzanti, 2004, pag. 13. 3 Sull’arduo problema della correzione dei temi, nonché sull’inadeguatezza di certi nostri sistemi di correzione, si veda il recente libro di L. Serianni e G. Benedetti, Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti, Carocci, 2009. 4 Cfr. R. Inglehart, La rivoluzione silenziosa, Rizzoli, 1983. 5 Cfr. R. Simone, La Terza Fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, 2000. 6 Cfr. F. Antinucci, La scuola si è rotta. Perché cambiano i modi di apprendere , Laterza, 2001. 7 A. Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazione, Fandango, 2006, pag. 8. 8 Sto citando da un articolo di M. Gaggi apparso il 7 febbraio 2010 sul «Corriere della Sera». Titolo: L’era dell’homo zappiens. Sottotitolo: I ragazzi «nati digitali» sviluppano abilità intellettuali (e biologiche) diverse. Così le tecnologie «ricablano» il nostro cervello e disegnano un’altra specie. 9 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, 1967, pagg. 137-138, 125, 18-19, 140. 10 G. Rodari, La grammatica della fantasia, Einaudi, 1997, pagg. 56-57. 11 A. Gramsci, «Osservazioni sulla scuola: per la ricerca del principio educativo», in Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, 1975, vol. III, quaderno 12, pag. 1544. 12 Leggere poesia. 50 proposte didattiche per la scuola primaria, a cura di E. Ardissino, prefazione di R. Quaglia, Centro Studi Erickson, 2010, pag. 7. 13 Il brano è citato sia in G. Ferroni, La scuola sospesa. Istruzione, cultura e illusioni della riforma, Einaudi, 1997 che in L. Russo, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli, 1998. 14 G. Ferroni, op. cit., pag. 16. 15 Cfr. intervista a Maria Stella Gelmini, «Corriere della Sera», 21 ottobre 2010. 16 M. Niada, Il tempo breve. Nell’era della frenesia: la fine della memoria e la morte dell’attenzione, Garzanti, 2010, pag. 174. 17 Cfr. M.B. Hesse, Modelli e analogie nella scienza, Feltrinelli, 1980. 18 Cfr. S. Bartezzaghi, La rivoluzione del librido e D. de Kerckhove, Così il nostro testo «statico» si trasforma in una performance, «la Repubblica», 11 dicembre 2010. 19 Cfr. L. Russo, op. cit., pagg. 42-59 e 17-19. 20 Cfr. G. Sartori, Homo videns, Laterza, 2000. 21 Cfr. P. Dorfles,Il ritorno del dinosauro. Una difesa della cultura, Garzanti, 2010. 22 Cfr. intervista a Pierre Nora, «la Repubblica», 4 novembre 2010. 23 A. Scotto di Luzio, La scuola degli italiani, il Mulino, 2007, pagg. 11-15. 24 M. du Sautoy,L’enigma dei numeri primi. L’ipotesi di Riemann, il più grande mistero della matematica, BUR, 2004, pagg. 552-553. 25 Cfr. A. Scotto di Luzio, op. cit., pag. 14. 26 A. Camus, Discours de Suède, Gallimard, 1958, pagg. 12-13. 27 Intervista su «La Stampa», 3 aprile 2010.
Scaricare