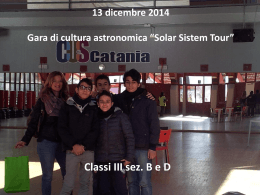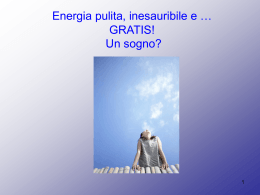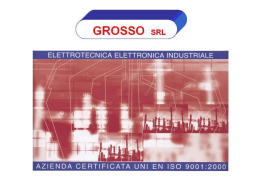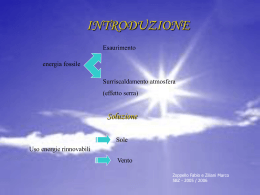Solar Energy Report Il sistema industriale italiano nel business dell’energia solare edizione 2009 www.energystrategy.it Solar Energy Report Il sistema industriale italiano nel business dell’energia solare edizione 2009 www.energystrategy.it Indice Introduzione 11 Executive Summary 13 FOTOVOLTAICO 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 La tecnologia di Paolo Silva Lo stato dell’arte della tecnologia tradizionale del silicio L’evoluzione della tecnologia del film sottile Lo sviluppo delle tecnologie del fotovoltaico “a concentrazione” Gli sviluppi tecnologici degli inverter 23 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 La normativa Il nuovo panorama a livello europeo Le tariffe feed-in in Italia: un’analisi di benchmark europeo L’impatto del Nuovo Conto Energia sulle finanze pubbliche Un quadro sugli incentivi e la normativa a livello regionale La revisione del Nuovo Conto Energia 33 33 23 24 29 29 1.3 Il mercato 1.3.1 Il fotovoltaico in Europa e nel mondo 1.3.2 Il fotovoltaico in Italia 1.3.2.1 La segmentazione del mercato fotovoltaico 1.3.2.2 La distribuzione geografica degli impianti 1.3.3 Gli sviluppi futuri del fotovoltaico in Italia 1.3.3.1 L’evoluzione attesa 1.3.3.2 Il potenziale “teorico” di sviluppo del fotovoltaico in Italia 1.3.4 La grid parity nel fotovoltaico 1.3.4.1 La definizione di grid parity e alcune ipotesi di base 1.3.4.2 Il fotovoltaico in Italia: a quando l’indipendenza dagli incentivi?72 1.3.5 Il Building Integrated Photovoltaics 76 1.3.6 Le serre fotovoltaiche 80 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 La filiera 85 Il volume d’affari del fotovoltaico in Italia 85 Le marginalità 86 I player della filiera fotovoltaica italiana 88 Area di Business Silicio e Wafer 89 Area di Business Celle e Moduli 92 Area di Business Distribuzione e Installazione 102 Area di Business Componenti e Tecnologie 105 Area di Business Finanziamento e Assicurazione 110 Dinamiche occupazionali nella filiera del fotovoltaico in Italia 112 37 SOLARE TERMICO 40 44 47 53 53 54 55 2.1 2.2 2.3 2.4 La tecnologia La normativa Il mercato La filiera 119 125 127 133 SOLARE TERMODINAMICO La tecnologia Un anno di crescita degli investimenti in sviluppo tecnologico… nonostante la crisi La struttura dei costi di un impianto parabolic trough Le potenzialità degli impianti parabolic trough: verso la grid parity? 139 68 70 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 71 3.2 La normativa 145 59 66 66 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 139 141 142 3 Indici 3.3 Il mercato 147 Metodologia 163 3.4 3.4.1 3.4.2 La filiera Il quadro internazionale: l’affermarsi delle Società di Ingegneria Solare Il solare termodinamico in Italia 153 Bibliografia 165 Elenco delle organizzazioni intervistate 167 La School of Management e l’Energy & Strategy Group 169 Le imprese partner 171 Gruppo di lavoro 4 153 157 161 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Indice delle figure Fotovoltaico Figura 1.1 Figura 1.2 Figura 1.3 Figura 1.4 Figura 1.5 Figura 1.6 Figura 1.7 Figura 1.8 Figura 1.9 Figura 1.10 Figura 1.11 Figura 1.12 Figura 1.13 Figura 1.14 Figura 1.15 Figura 1.16 Figura 1.17 Figura 1.18 Figura 1.19 Figura 1.20 Figura 1.21 Figura 1.22 Figura 1.23 Figura 1.24 Figura 1.25 Figura 1.26 Figura 1.27 Figura 1.28 Andamento dei prezzi spot dei moduli in silicio mono-cristallino Andamento dei prezzi spot dei moduli in silicio poli-cristallino Andamento temporale del rendimento medio delle celle in silicio mono-cristallino Quota di mercato al 2008 delle principali tecnologie fotovoltaiche Quota di mercato previsionale al 2012 delle principali tecnologie fotovoltaiche Trend di crescita dell’efficienza europea media degli inverter negli ultimi 5 anni Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 3 kW Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 100 kW Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 1 MW Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione dei soggetti istituzionali promotori Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione dei soggetti destinatari Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione della Regione promotrice Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 3 kW installato nel 2011 Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 200 kW installato nel 2011 Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 1 MW installato nel 2011 Andamento annuale cumulato della potenza installata in Italia dal 2005 a oggi Andamento della potenza installata annualmente in Italia Segmentazione del mercato italiano del fotovoltaico Segmentazione della potenza cumulata installata in Italia Ripartizione della potenza annua installata per segmento di mercato Potenza installata al 31/12/2009 nelle diverse Regioni italiane Segmentazione per taglie di impianto della potenza installata nelle diverse Regioni italiane nel corso del 2009 Confronto tra la potenza installata nel 2009 e nel 2008 nelle diverse Regioni italiane Potenza installata per mille abitanti nelle diverse Regioni italiane al 31/12/2008 e al 31/12/2009 Potenza installata nelle diverse Regioni italiane al 31/12/2008 e al 31/12/2009 espressa in funzione della loro estensione territoriale Evoluzione della potenza fotovoltaica installata in Italia per scenario Grid parity per un impianto da 3 kW Grid parity per un impianto da 200 kW (con scambio sul posto) www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 23 24 24 26 27 30 39 39 40 44 45 46 50 50 51 55 56 56 57 58 59 60 61 63 64 67 73 74 5 Indici Figura 1.29 Figura 1.30 Figura 1.31 Figura 1.32 Figura 1.33 Figura 1.34 Figura 1.35 Figura 1.36 Figura 1.37 Figura 1.38 Figura 1.39 Figura 1.40 Figura 1.41 Grid parity per un impianto da 200 kW (senza scambio sul posto) Grid parity per un impianto da 1 MW Renewable grid parity per un impianto da 1 MW Confronto strutturale tra BAPV e BIPV L’Altra Sede della Regione Lombardia Percentuale di impianti architettonicamente integrati rispetto al totale di impianti installati in Italia Costi dei diversi materiali per la realizzazione di facciate in edilizia Caratteristiche costruttive delle serre fotovoltaiche Principali aree di business nella filiera fotovoltaica e volume d’affari nel 2009 EBITDA margin medio delle imprese operanti nelle diverse fasi della filiera fotovoltaica Le imprese nella filiera fotovoltaica italiana Andamento della capacità produttiva installata (MW) di moduli in silicio cristallino e in film sottile a livello mondiale Capacità installata di moduli in film sottile nei principali Paesi mondiali 74 75 75 76 77 78 79 81 86 87 89 94 95 Solare termico Figura 2.1 Figura 2.2 Figura 2.3 Figura 2.4 Figura 2.5 Figura 2.6 Figura 2.7 Figura 2.8 Diffusione delle diverse tipologie di collettori nel mercato italiano per tipologia di circolazione Diffusione delle diverse tecnologie di circolazione nel mercato italiano per classi di impianto Schema di un impianto solare termico con sistema di accumulo Peso dei diversi Paesi europei nel mercato del solare termico Capacità installata (per 1.000 abitanti) nei principali Paesi europei Scenari di previsione della capacità cumulata delle installazioni solari termiche in Europa Capacità cumulata delle installazioni solari termiche in Italia Probabilità con cui il solare termico troverà applicazione nei principali settori industriali 119 120 122 127 128 129 130 131 Solare termodinamico Figura 3.1 Figura 3.2 Figura 3.3 Figura 3.4 Figura 3.5 Figura 3.6 Figura 3.7 6 Ripartizione per tecnologia degli impianti solari termodinamici realizzati e in progetto Ripartizione dei costi del campo solare per un impianto solare termodinamico con tecnologia parabolic trough da 50 MW Ripartizione dei costi del campo solare per un impianto solare termodinamico con tecnologia parabolic trough da 400 MW Localizzazione geografica degli impianti in costruzione ed in progetto Localizzazione geografica degli impianti in fase di realizzazione Localizzazione geografica degli impianti in fase di progetto Le configurazioni tipiche per la realizzazione e gestione degli impianti solari termodinamici www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 140 141 142 149 150 150 154 Indice delle tabelle Fotovoltaico Tabella 1.1 Tabella 1.2 Tabella 1.3 Tabella 1.4 Tabella 1.5 Tabella 1.6 Tabella 1.7 Tabella 1.8 Tabella 1.9 Tabella 1.10 Tabella 1.11 Tabella 1.12 Tabella 1.13 Tabella 1.14 Tabella 1.15 Tabella 1.16 Tabella 1.17 Tabella 1.18 Tabella 1.19 Tabella 1.20 Tabella 1.21 Tabella 1.22 Tabella 1.23 Tariffe feed-in (€/kWh) nei principali Paesi europei Tariffe incentivanti (€/kWh) definite dal Nuovo Conto Energia Uscite per lo Stato relative al pagamento delle tariffe feed-in per alcuni impianti “tipo” installati nel 2009 Ipotesi di lavoro adottate per ciascun impianto “tipo” relative all’anno 2009 IRR assicurato da ciascun impianto “tipo” installato nel 2009 Livello delle nuove tariffe (€/kWh) proposto da ANIE, GIFI, ASSOSOLARE e APER Potenza installata nei principali Paesi del mondo (MW) Taglia media degli impianti fotovoltaici installati in Italia (kW) Potenza e impianti installati al 31/12/2009 nelle diverse Province lombarde Potenza e impianti installati al 31/12/2009 nelle diverse Province lombarde per abitante e per estensione territoriale Potenziale “teorico” di crescita delle installazioni al 2020 in Italia per campi di applicazione Principali voci di costo per tre impianti “tipo” (residenziale, industriale, centrale) I principali produttori di silicio a livello mondiale I principali produttori di moduli a film sottile a livello mondiale I principali produttori di celle a livello mondiale I principali produttori integrati a livello mondiale I principali modulisti a livello mondiale I principali produttori integrati italiani I principali modulisti italiani I principali player nella distribuzione ed installazione Le principali imprese italiane attive nell’area di business Componenti e Tecnologie I produttori di inverter attivi sul mercato italiano Misure di sicurezza per impianti fotovoltaici installati ad altezza inferiore a 5 metri 34 38 43 49 49 52 54 59 65 66 70 72 90 93 96 97 97 98 99 101 107 109 113 Solare termico Tabella 2.1 Tabella 2.2 I principali operatori tradizionali I principali distributori “evoluti” 133 134 Solare termodinamico Tabella 3.1 Tabella 3.2 Tabella 3.3 Tariffa incentivante per il solare termodinamico Elenco e principali caratteristiche degli impianti solari termodinamici attualmente in fase di realizzazione nel mondo Le principali Società di Ingegneria Solare www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 145 151 155 7 Indici Tabella 3.4 Tabella 3.5 Tabella 3.6 8 I principali produttori mondiali di componentistica per impianti termodinamici Il Consorzio Solare XXI Il progetto FREeSUN www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 156 157 158 Indice dei box Fotovoltaico Box 1.1 Box 1.2 Box 1.3 Box 1.4 Box 1.5 Box 1.6 Box 1.7 Box 1.8 Box 1.9 Box 1.10 Box 1.11 Box 1.12 Box 1.13 Box 1.14 Box 1.15 Box 1.16 Box 1.17 Box 1.18 Box 1.19 Box 1.20 Box 1.21 Box 1.22 Box 1.23 Box 1.24 Le celle ribbon La pericolosità ambientale e la tossicità del cadmio Le smart-grid e gli inverter Il piano francese nel 2010 per il fotovoltaico Il Piano India La normativa nei Paesi dell’Est europeo Il Nuovo Conto Energia La Cina e la rincorsa alla leadership mondiale Le centrali di Montalto di Castro Il caso Lombardia EnergyGlass Lux First Solar SunPower XGroup L’accordo tra Enel Green Power, Sharp e STMicroelectronics Tecno Spot Gli EPC contractor stranieri Terni Energia Ecoware Baccini I microinverter Elettronica Santerno Zurich 25 28 31 36 37 37 38 54 64 65 79 92 94 96 98 99 102 103 104 105 106 108 110 113 Solare termico Box 2.1 Box 2.2 Box 2.3 I collettori solari a concentrazione piana ad alto rendimento L’impianto solar cooling dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca Paradigma 121 122 135 Solare termodinamico Box 3.1 Box 3.2 Box 3.3 Box 3.4 Box 3.5 Box 3.6 Box 3.7 Box 3.8 Il progetto Desertec Il Piano Obama e gli incentivi per gli impianti solari termodinamici negli USA Andasol 1 e 2 Energia Solar de Puertollano Alvarado I Ausra Archimede Solar Energy Reflex www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 144 146 148 149 149 157 158 160 9 Introduzione Il Solar Energy Report, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta a nostro avviso una tappa rilevante nel percorso di crescita dell’Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, per molteplici ragioni: • è cresciuto sensibilmente - rispetto allo scorso anno - il numero di imprese partner della ricerca, perché un insieme rilevante di specialisti del solare si è venuto ad affiancare a quelli che continuano a essere i principali operatori dell’energia nel nostro Paese; • sono stati affrontati, con quel mix di rigore metodologico e approccio manageriale che spesso caratterizza la nostra scuola, molti dei temi chiave che animano il dibattito pubblico sul futuro del settore: dalle previsioni circa il raggiungimento della grid parity agli scenari di mercato attesi in conseguenza dei “tagli” alle tariffe incentivanti, dalle ricadute occupazionali che la filiera del solare ha saputo generare negli ultimi anni all’analisi delle entrate reali per lo Stato derivanti dallo sviluppo dell’industria del solare; • è stata evidenziata con una ricerca sul campo molto accurata, svolta in partnership con le imprese e i principali stakeholder del sistema, la dinamicità dell’industria del solare in Italia: che ha saputo uscire dal novero dei mercati di nicchia, nonostante la crisi economica e le incertezze sul quadro normativo, dimostrando una buona capacità di generare valore e di contribuire alla rivitalizzazione del tessuto industriale del nostro Paese. L’augurio è che questo rapporto possa essere un utile strumento di approfondimento e riflessione per tutti coloro che sono coinvolti, a diverso titolo, nello sviluppo delle energie rinnovabili - e del solare in particolare - nel nostro Paese: per i politici e gli amministratori pubblici, cui spetta il difficile compito di bilanciare le spinte alla contrazione complessiva della spesa con l’opportunità di sostenere selettivamente quei settori ove, al di là delle pur importanti ricadute ambientali, si stanno sviluppando reali opportunità di business; per gli imprenditori e per il mondo industriale, che devono raccogliere la sfida dei tagli agli incentivi e trasformarla in stimolo virtuoso all’innovazione e all’efficientamento delle attività produttive e distributive, cogliendo anche i segnali di crescita di mercati - solo in apparenza lontani - quali quello cinese e indiano; ai ricercatori, che dell’innovazione debbono farsi promotori, puntando sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche economicamente più sostenibili. Un’ultima nota. Il Solar Energy Report 2009 non è più il solo prodotto dell’Energy & Strategy Group, ma sarà affiancato a breve dal Biomass Energy Report 2009 (ovviamente alla sua prima edizione): rapporto sullo stato del settore delle biomasse in Italia, che ha rappresentato il secondo filone di ricerca nell’anno appena trascorso. E ci auguriamo che a breve altre energie rinnovabili seguano la stessa strada. Umberto Bertelè Presidente School of Management Vittorio Chiesa Direttore Energy & Strategy Group www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 11 Executive Summary Il Solar Energy Report, giunto alla sua seconda edizione, si propone di offrire un quadro aggiornato delle dinamiche che hanno caratterizzato il business dell’energia solare in Italia nel corso del 2009, considerando le tre famiglie di tecnologie (fotovoltaico, termico e termodinamico) attraverso cui è possibile sfruttare il sole come fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica. Come nella precedente edizione del Solar Energy Report, l’intento è stato quello di considerare le molteplici prospettive, tra loro fortemente interrelate, da cui il business dell’energia solare può essere analizzato ed interpretato, a partire dalle tecnologie disponibili o in fase di sperimentazione, passando per il quadro normativo che regolamenta e incentiva le installazioni, le dinamiche dei “mercati” di sbocco, per giungere infine all’articolazione delle “filiere” industriali ed alle strategie competitive dei principali operatori. La ricerca ha richiesto anche quest’anno uno sforzo empirico molto consistente, che ha portato al censimento di oltre 900 operatori attivi sul mercato italiano, alla realizzazione di più di 100 casi di studio e di oltre 100 interviste a manager ed esperti del settore. Oltre ad offrire un aggiornamento sullo stato del business dell’energia solare in Italia, lo studio propone diverse stime ed approfondimenti su tematiche di particolare interesse ed attualità, quali il potenziale di crescita “teorico” delle installazioni di impianti fotovoltaici e solari termici nel nostro Paese, l’impatto che l’incipiente revisione del Nuovo Conto Energia potrà avere sul mercato e sulla filiera del fotovoltaico in Italia, l’evoluzione attesa dei costi degli impianti solari termodinamici. Più che riassumere esaustivamente la molteplicità degli argomenti trattati e delle analisi condotte, questo sommario si propone di offrire al lettore un esempio della varietà di prospettive adottate nel Solar Energy Report, oltre che di raccogliere in modo sintetico alcune delle principali conclusioni cui esso è pervenuto. Fotovoltaico Tra le diverse tecnologie attraverso cui è possibile sfruttare la fonte solare, il fotovoltaico continua a rappresentare quella di gran lunga più diffusa in Italia. Il 2009 ha segnato un primo passo verso la maturità del mercato fotovoltaico nel nostro Paese che, dopo il boom delle installazioni registrate nel 2007 e specialmente nel 2008, si è assestato su tassi di crescita sicuramente consistenti, soprattutto in un periodo di forte contrazione dell’economia, anche se meno dirompenti rispetto agli anni precedenti. A fronte di un aumento delle installazioni superiore al 380% tra il 2007 e il 2008, nel 2009 sono entrati in esercizio impianti fotovoltaici per circa 580 MW di potenza complessiva, con un incremento del 72% rispetto all’installato dell’anno precedente, per un volume d’affari complessivo stimabile nell’ordine di 2,3 mld €. La potenza fotovoltaica in esercizio in Italia a dicembre 2009 ha superato la soglia di 1 GW. Una dinamica simile ha interessato nel 2009 il mercato fotovoltaico in Europa, in cui sono stati installati oltre 5 GW di potenza fotovoltaica (per un volume d’affari complessivo di quasi 21 mld €), in crescita di quasi il 9% rispetto al 2008, quando le nuove installazioni avevano toccato i 4,6 GW. Se si guarda al totale installato, l’Europa ha raggiunto alla fine del 2009 circa 14 GW di potenza complessiva (pari al 65% del totale a livello mondiale) – pari a quasi sette volte l’installato in Giappone e dieci volte quello degli USA – confermandosi di gran lunga l’area geografica leader per installazioni fotovoltaiche. Dal punto di vista tecnologico, le celle fotovoltaiche di “prima generazione”, a base di silicio mono- o poli-cristallino, rappresentano ancora ad oggi la soluzione largamente dominante (sono responsabili di circa l’85% dell’installato a livello mondiale). Si tratta di una tecnologia affidabile e pienamente dimostrata dal punto di vista commerciale, con margini residui di incremento dell’effi- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 13 Executive Summary cienza di trasformazione e di riduzione del costo di produzione non particolarmente ampi (i costruttori stimano che entro il 2020 le celle in silicio mono-cristallino raggiungeranno un’efficienza del 20%, mentre quelle poli-cristalline del 18%). Maggiori speranze sono riposte invece nel thin film, che è alla base delle cosiddette celle fotovoltaiche di “seconda generazione”. Nel corso del 2009 si sono registrati ingenti investimenti sia nello sviluppo sperimentale che nell’installazione di capacità produttiva di moduli fotovoltaici a film sottile. Secondo l’indagine condotta, nel 2012 il thin film potrebbe raggiungere una penetrazione di mercato pari al 34%, su una capacità installata complessiva che raggiungerà, a livello mondiale ed in uno scenario ottimistico, oltre 45 GW. Fra le diverse tecnologie del film sottile, il silicio amorfo sembra avere le prospettive di crescita più favorevoli (si stima potrà contare per circa il 15% del mercato totale entro fine 2012), seguito dal tellururo di cadmio (12% del mercato totale al 2012). Ugualmente consistenti nel 2009 sono stati gli investimenti in ricerca, sviluppo e installazione di nuova capacità produttiva di moduli fotovoltaici con tecnologia CPV – Concentrating PhotoVoltaic – che si propone di ridurre sensibilmente il costo tecnico dell’impianto grazie ad un sistema di concentrazione della luce incidente e ad un opportuno sistema di tracking. L’interesse per i moduli CPV sta crescendo rapidamente, con investimenti complessivi nel 2009 che si possono stimare nell’ordine di oltre 600 mln € e con decine di produttori che si dichiarano pronti a dare vita ad una produzione su larga scala. Con la raggiunta maturità delle celle al silicio di “prima generazione”, una crescente attenzione è stata dedicata da parte degli operatori di mercato e dei titolari di impianti all’inverter, altro componente critico della centrale fotovoltaica, che influenza in modo sostanziale il rendimento e l’efficienza globale dell’impianto ed è essenziale nell’interfacciamento con la rete. L’efficienza di trasformazione degli inverter è uno dei parametri critici dell’intera centrale fotovoltaica e negli ultimi anni sono stati compiuti degli sforzi consistenti per incrementarne il valore, fino ad arrivare al livello di 9798% per inverter senza trasformatore e di 93-94% per quelli con trasformatore. L’analisi condotta mostra come una variazione positiva di un punto percentuale di efficienza dell’inverter possa portare ad un incremento dell’IRR dell’impianto di ol- 14 tre lo 0,5%. La sfida che i principali produttori di inverter stanno affrontando sempre più seriamente è quella di dotare il prodotto di una serie di funzionalità addizionali, che rendano l’inverter un componente capace di gestire in modo “intelligente” l’interfaccia tra l’impianto e la rete elettrica, il che rappresenta un primo passo verso l’affermarsi del concetto di smart-grid, così importante per abilitare un paradigma di generazione distribuita dell’energia elettrica in cui le fonti rinnovabili possano giocare un ruolo rilevante. La crescita fatta registrare dal mercato fotovoltaico nel 2009 in Italia nonostante la congiuntura economica negativa è da attribuire, come già accaduto nel 2007 e nel 2008, all’efficacia del cosiddetto Nuovo Conto Energia, il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica entrato in vigore nel 2007. Come previsto dal Comma 3 dell’Articolo 6 del Decreto Ministeriale del 19/02/2007, a partire dal 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato ad emanare dei decreti con cui si ridefiniscono le tariffe incentivanti l’energia prodotta da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. Il dibattito in merito alla revisione del Nuovo Conto Energia presso i Ministeri competenti è entrato nel vivo nell’estate del 2009, e sta proseguendo nei mesi in cui il presente rapporto viene redatto. La revisione delle tariffe verrà realizzata, come previsto dal Nuovo Conto Energia, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti degli impianti fotovoltaici. Le tariffe subiranno quindi una corretta e opportuna revisione al ribasso, che è giustificata sostanzialmente dal progresso tecnologico e dalle economie di scala che negli anni hanno portato ad una riduzione consistente del prezzo dei componenti chiave di un impianto fotovoltaico. La nostra analisi mostra come l’entità del ribasso avrà una ripercussione molto importante non solo, come ovvio, sul livello e sulla tipologia di installazioni che si realizzeranno in futuro nel nostro Paese, ma anche sul nascente sistema industriale italiano e sulla filiera intera. Considerato che la grid parity in Italia è ancora là da venire, a meno di alcune realtà geografiche specifiche (quali ad esempio la Sicilia, di cui spesso si parla come ormai prossima alla parità), una riduzione eccessiva delle tariffe feed-in rischierebbe di non rendere più economicamente conveniente l’installazione di nuovi impianti, interrompendo di fatto la crescita del mercato e mettendo in crisi le imprese italiane che hanno come principale sbocco il mercato interno, come verificatosi in Spagna nel 2009. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Executive Summary Chiaramente la scelta in merito all’entità del taglio alle tariffe feed-in è di natura prettamente politica e dipende da quanto le istituzioni intendono puntare sul fotovoltaico per rispettare gli impegni sottoscritti a livello europeo in tema di produzione di energia fa fonti rinnovabili. Quello che la nostra analisi mostra è che il fotovoltaico potrebbe, da un punto di vista “teorico”, contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi che all’Italia sono stati assegnati. Basti pensare che, se solo il 20% delle coperture delle serre ortofrutticole esistenti a dicembre 2008 in Italia venisse sostituita con moduli fotovoltaici da oggi al 2020, si installerebbero oltre 5,5 GW di potenza elettrica. Oltre a ciò, sono numerosi i campi di applicazione (quali le nuove edificazioni residenziali, le coperture delle superfici della Grande Distribuzione Organizzata, le superfici coperte delle aree portuali ed i terreni incolti o a scarso rendimento agricolo) che, se sfruttati opportunamente, assicurerebbero al fotovoltaico un enorme potenziale di crescita. Dal punto di vista delle dinamiche di mercato, nel 2009 si è rilevato innanzitutto un aumento significativo del peso delle centrali fotovoltaiche, di taglia superiore ad 1 MW, nel nostro Paese (le installazioni di questi impianti hanno fatto segnare una crescita in termini di potenza del 575% rispetto al 2008). Ciò è dovuto, come in parte già registrato nel corso del 2008, al fatto che molti fondi di investimento privati, italiani e stranieri, trovandosi di fronte alla mancanza, per effetto della crisi generalizzata cui si è già fatto cenno, di alternative di investimento con un profilo rischio-rendimento particolarmente favorevole, hanno indirizzato una crescente fetta delle loro risorse verso le centrali a terra, che presentano, con il sistema di incentivazione in vigore nel 2009 in Italia, un’opportunità di investimento ad alto ritorno sul capitale investito (con un IRR del 13% circa, in condizioni medie di irraggiamento) a fronte di un profilo di rischio comunque contenuto. Il mercato delle centrali è diventato a tutti gli effetti un segmento trainante in Italia, contando ben 34 impianti a terra di taglia superiore ad 1 MW installati nel solo 2009. Una seconda importante dinamica riguarda la crescita particolarmente consistente della potenza annua installata che si è registrata nelle Regioni del Sud Italia e nelle Isole rispetto al 2008, con tassi di incremento in media superiori al 98%, e con picchi del 110% e del 465% rispettivamente in Puglia e in Basilicata (la crescita media della potenza annua installata rispetto al 2008 è stata pari al 55% nel Nord Italia e del 68% nelle Regioni centrali). In parte, ciò si spiega con il fatto che le Regioni del Sud Italia, e in particolar modo le Isole, si sono dimostrate più propense nel 2009, rispetto a quelle settentionali e centrali, a stanziare incentivi complementari al Nuovo Conto Energia (quali finanziamenti a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi) per favorire l’installazione di impianti da parte di privati cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. In termini assoluti, le prime Regioni per potenza fotovoltaica installata nel corso del 2009 rimangono tuttavia, ad eccezione della Puglia, quelle localizzate nel Nord e nel Centro del Paese (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto). Questo lascia intendere che esistono ancora consistenti potenzialità di sviluppo del mercato fotovoltaico italiano, proprio in quelle aree in cui l’irraggiamento è maggiore e quindi la redditività dell’investimento più elevata. Per quanto concerne la filiera industriale, l’analisi ha permesso di stimare in più di 700 il numero di imprese che operano nelle aree di business del mercato fotovoltaico italiano nel 2009, a cui si aggiungono alcune migliaia di operatori locali, coinvolti principalmente nella fase di installazione dell’impianto. Il numero degli operatori attivi sul mercato italiano è aumentato di circa il 12% rispetto al 2008. Questo incremento della competizione è dovuto tanto all’ingresso di nuovi player italiani, quanto all’accresciuta presenza di operatori stranieri, che a seguito del ridimensionamento del mercato spagnolo, hanno cercato in Italia opportunità di crescita alternative. Questa duplice dinamica ha di fatto lasciato inalterato rispetto al 2008 il peso relativo delle imprese italiane rispetto a quelle straniere in tutte le aree di business della filiera, con queste ultime che si appropriano ancora di più del 70% del margine operativo lordo generato dal mercato italiano del fotovoltaico. Nel complesso, l’aumento di competizione sul mercato italiano ha ridotto le marginalità industriali delle imprese della filiera italiana, con un calo dell’EBIDTA Margin in media pari al 25% nel 2008 rispetto al 2007. Un’ulteriore riduzione dei margini è a detta degli operatori inevitabile nel 2009, anche se non sono ancora disponibili dati puntuali per l’anno appena conclusosi. È probabile che questo processo di maturazione del mercato italiano del fotovoltaico avvierà un processo darwiniano di “selezione” delle imprese italiane del fotovoltaico destinato (come spesso succede nei periodi di crisi) a far sopravvivere solo le organizzazioni più www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 15 Executive Summary efficienti e profittevoli, ossia le più pronte a cogliere e sfruttare al meglio le opportunità di crescita che la ripartenza dell’economia inevitabilmente moltiplicherà. Solare termico Nel corso del 2009 il solare termico in Italia non ha registrato evoluzioni particolarmente significative, sia per quanto riguarda gli sviluppi di natura tecnologica e di mercato, sia per quanto concerne il quadro normativo e le posizioni di forza relative degli operatori attivi nel nostro Paese. Nel 2009 sono stati installati in Italia oltre 350 MWth di solare termico (un valore superiore del 26% circa rispetto al 2008), cui è corrisposto un volume d’affari complessivo stimabile nell’ordine di 500 mln €. Questo ha portato la potenza solare termica installata in Italia a fine 2009 a 1,4 GWth, corrispondenti a circa 2 milioni di metri quadrati di collettori solari. La crescita del mercato registrata nel 2009 è stata inferiore rispetto al 2008 (quando la potenza installata era aumentata di oltre il 67% rispetto al 2007), ma si tratta sicuramente di un risultato ragguardevole, soprattutto se si considera l’impatto della congiuntura economica negativa. L’Italia si conferma il terzo Paese europeo del solare termico, essendo responsabile, come la Spagna, di circa il 10% di tutte le installazioni annue realizzate un Europa. Leader indiscusso rimane la Germania, con oltre il 40% delle installazioni in Europa nel 2009. Considerata la penetrazione relativa del solare termico nel nostro Paese, si registra una potenza installata di 6 kWth per mille abitanti alla fine del 2009, valore ancora sensibilmente inferiore rispetto alla media europea. Questo lascia intendere che esista ancora un significativo spazio per la diffusione del solare termico in Italia, che attende ancora di essere colmato. Tale impressione è confermata dall’analisi del potenziale “teorico” di sviluppo del solare termico in Italia. La stima condotta mostra ad esempio che, se venissero dotate di un impianto solare termico (in grado di soddisfare il 35% del fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia “media”) il 50% delle nuove unità abitative che verranno realizzate dal 2010 al 2020 in Italia, potrebbero essere installati oltre 4 milioni di metri quadrati di collettori solari (pari a circa 2,8 GWth). Considerando inoltre le promettenti applicazioni di solar cooling, se solo 16 il 2% degli immobili ad uso residenziale esistenti in Italia a fine 2008 venisse dotato, da oggi al 2020, di un’unità di rafffrescamento solare, si installerebbero oltre 30 milioni di metri quadrati di collettori solari, per una potenza frigorifera complessiva di 13 GW. Dal punto di vista tecnologico, l’analisi non rileva sostanziali evoluzioni nel peso relativo delle tre principali tipologie di collettori (scoperti, piani vetrati e sottovuoto) sulle installazioni totali rispetto al 2008, con i collettori piani vetrati che sono responsabili della parte largamente più consistente (pari ad oltre l’80%) della potenza installata a fine 2009. Per quanto concerne la tipologia di circolazione (naturale o forzata), si rileva rispetto al 2008 una leggera crescita delle soluzioni a circolazione naturale (che pesano al termine del 2009 per circa il 35% della potenza complessiva installata). Le applicazioni dominanti nel nostro Paese rimangono quelle a bassa temperatura, in cui la tecnologia solare termica è utilizzata per il riscaldamento dell’acqua sanitaria o di edifici, mentre gli usi di processo, a media temperatura, non hanno fatto registrare nel 2009 quella diffusione che gli operatori si attendevano. Le principali traiettorie di sviluppo tecnologico tracciate nel Solar Energy Report 2008 (ossia la messa a punto di sistemi ibridi termico-fotovoltaici, di collettori polimerici e di sistemi di raffrescamento solare – o solar cooling) si confermano le più importanti frontiere verso cui si indirizzano gli sforzi di ricerca e gli interessi degli operatori della filiera. Ciononostante, nel 2009 non si rilevano in Italia applicazioni su scala commerciale di queste tecnologie, che rimangono ancora confinate al ruolo di applicazioni di nicchia e a carattere sperimentale. A livello europeo si registra inoltre un notevole interesse per i sistemi solari di teleriscaldamento, che permettono di sfruttare la tecnologia solare termica su larga scala, con l’obiettivo di soddisfare parte del fabbisogno energetico di più utenze localizzate in aree e distretti ad alta intensità abitativa. Esistono nel Nord Europa diverse installazioni sperimentali e dimostrative di questa tecnologia, che si pensa possa essere particolarmente adatta alle caratteristiche del contesto italiano. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, rimangono in vigore (fino alla fine del 2011, come stabilito dalla Finanziaria 2009) sia la riduzione al 10% dell’aliquota IVA sull’acquisto dei collettori solari www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Executive Summary termici, sia l’efficace detrazione fiscale dall’imposta lorda (pari al 55%) delle spese di riqualificazione energetica, tra cui l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Queste forme di incentivazione all’installazione di impianti solari termici si confermano molto efficaci nella pratica, anche se gli operatori lamentano l’incertezza che circonda il futuro di tali agevolazioni oltre il 2011, alimentata dalla recente bocciatura al Senato di un emendamento alla Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga dell’agevolazione al 31 Dicembre 2012. L’analisi rivela infine come esista ancora un difetto di informazione sulla possibilità e sulle modalità di accesso a questi sgravi fiscali, con molti progettisti e installatori che si mostrano impreparati in merito alle procedure che il cliente deve adempiere per poterne beneficiare. Questo sicuramente rappresenta un freno ad un maggiore utilizzo di queste agevolazioni, testimoniato dal fatto che la richiesta di detrazione non viene richiesta per una percentuale non trascurabile di interventi di riqualificazione energetica (circa il 35% nelle Regioni del Sud Italia e il 20% nel Nord, nel 2009). Per quanto riguarda la filiera industriale, non si rilevano delle evoluzioni particolarmente significative nelle posizioni di forza relative e nelle strategie competitive dei principali attori, sia per quanto riguarda gli operatori tradizionali che i distributori “evoluti”. Questi ultimi sono stati penalizzati dalla “falsa partenza” del mercato delle applicazioni di processo a media temperatura in Italia, in cui sembrava potessero contare su un differenziale competitivo rilevante rispetto ai player tradizionali del comparto idrotermosanitario. Per quanto riguarda il peso delle importazioni sul mercato italiano, l’analisi mostra che nel 2009 la domanda italiana di collettori è stata coperta per circa il 65% attraverso prodotti realizzati in Paesi europei ed extraeuropei. Gli operatori italiani incontrano ancora delle serie difficoltà nel conquistare significative quote del mercato interno del solare e la competizione delle imprese straniere è particolarmente sentita. Interessante è rilevare infine che circa il 18% dei prodotti e componenti per impianti solari termici fabbricati in Italia nel 2009 è stato esportato (prevalentemente in Paesi dell’Est Europa e del Centro America). Questo è anche il risultato delle scelte strategiche messe in atto da alcuni piccoli e medi distributori “evoluti” italiani, che hanno cominciato con forza ad aggredire con i propri prodotti i mercati europei ed extraeuropei più promettenti. Solare termodinamico Il 2009 è stato indubbiamente un anno importante per il solare termodinamico, almeno per due ragioni. Innanzitutto per la decisa ripresa delle installazioni e per l’avvio di numerosi progetti per nuovi impianti, nonostante il peggioramento della congiuntura economica globale che ha penalizzato particolarmente gli investimenti capital intensive. In secondo luogo per il peso “politico” che il piano energetico di Barack Obama, neo-eletto presidente USA, ha voluto attribuire al settore, che ha portato molte imprese a “scommettere” con decisione sul solare termodinamico. Per quanto riguarda le dinamiche di mercato a livello internazionale, nel corso del 2009 la posizione della Spagna si è ulteriormente rafforzata per effetto dell’entrata in funzione di tre nuovi impianti da 50 MW l’uno, costruiti con tecnologia parabolic trough. Questi tre impianti, che rappresentano gli unici entrati in esercizio nel corso del 2009, hanno determinato un incremento del 23% della potenza installata totale rispetto al 2008, mentre il confronto delle installazioni annuali registra un +115% rispetto all’anno precedente. La potenza installata oggi a livello globale in impianti solari termodinamici è pari a 655 MW – contro i 500 MW della fine del 2008 ed i 430 MW del 2007 – e garantisce una produzione di energia elettrica annua pari a circa 1.400 GWh. Ancora più interessanti sono le stime di crescita per i prossimi anni, secondo cui la potenza installata a livello globale potrà raggiungere i 18,6 GW al 2020. In questo scenario, gli Stati Uniti avranno verosimilmente un ruolo di primo piano, con oltre 10,3 GW di nuovi impianti già in progetto, effetto in larga parte del nuovo corso della politica energetica di Obama. Nel contempo, è da attendersi un deciso balzo in avanti dei Paesi Asiatici (Cina e India in testa), che con 5 GW di installazioni attese supereranno l’Europa, dove ci si aspetta di raggiungere un livello di potenza installata al 2020 pari a 2,5 GW (ossia il 13% del totale). Dal punto di vista tecnologico, l’architettura parabolic trough continua ad essere quella più diffusa, essendo responsabile del 58% della potenza in impianti in funzione ed in progetto a fine 2009. L’analisi mostra come questi impianti siano ad oggi oggetto dei maggiori sforzi da parte degli operatori in termini di sviluppo tecnico finalizzato alla riduzione del costo dei principali componenti costitu- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 17 Executive Summary tivi e delle soluzioni impiantistiche che essi adottano. La messa in esercizio di un impianto solare termodinamico con tecnologia parabolic trough da 50 MW richiede oggi in media un investimento pari a 200 mln di € (equivalente a 5 mln di € al MW). Il campo solare (ossia l’insieme degli specchi parabolici lineari e del sistema di tubi ricevitori entro cui scorre il fluido termodinamico che serve a trasferire in turbina il calore generato dal sole) costituisce da solo circa il 54% del costo complessivo dell’impianto. A questo vanno aggiunti circa 2 mln di € all’anno per attività di manutenzione e gestione. In un’area a insolazione medioalta, l’impianto assicura per almeno 30 anni una produzione di oltre 110.000 MWh/anno di energia elettrica. Il costo di produzione dell’energia elettrica in un impianto con queste caratteristiche (tenendo conto degli effetti di “ammortamento” dell’investimento iniziale attraverso il calcolo del LEC – Levelized Energy Cost) risulta pari a poco più di 20 c€/kWh, valore ancora decisamente superiore rispetto ai 6,5 c€/kWh che rappresentano il benchmark per il costo di produzione di energia elettrica da fonti fossili. per gli impianta basati sulla tecnologia di Fresnel si in parte è smorzato nel 2009, come risultato di un certo ritardo nello sviluppo e nella sperimentazione di queste tecnologie e dei significativi passi in avanti che gli impianti solar tower e parabolich trough hanno fatto invece registrare. L’analisi condotta mostra tuttavia che esistono dei significativi spazi di riduzione del costo di produzione dell’energia attraverso impianti parabolic trough. Con la crescita della taglia media della centrale (si ritiene che la dimensione ottima dal punto di vista tecnico sia intorno ai 400 MW), l’effetto degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo attualmente in essere e l’aumento della potenza installata, con gli associati benefici in termini di economie di apprendimento e di scala, non è irragionevole ipotizzare livelli di LEC per gli impianti parabolic trough che, nel corso dei prossimi 10-12 anni, si avvicinino ai 4-6 c€/kWh, valori del tutto confrontabili con la produzione di energia elettrica da fonti tradizionali. Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, il 2009 ha rappresentato per l’industria del solare termodinamico un anno importante almeno per tre ragioni. Innanzitutto perché si sono registrati degli importanti sviluppi a livello della “cordata” di operatori (denominata Consorzio Solare XXI) che sta portando avanti il progetto sperimentale Archimede, l’impianto solare termodinamico a sali fusi da 5 MW localizzato a Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa. In particolare, Reflex darà avvio nel 2010 ad un impianto completamente robotizzato per la produzione di specchi ad elevata riflettività e con una tempra chimica, realizzata in collaborazione con la Fenzi, che ne aumenta ulteriormente la resistenza. Archimede Solar Energy – che nel marzo del 2009 ha visto l’importante ingresso di Siemens nel capitale sociale con una quota del 28% – ha investito oltre 30 mln € con l’obiettivo di avviare nel 2011 la produzione di 75.000 tubi ricevitori all’anno. In secondo luogo, il 2009 è stato un anno importante perché, grazie a 12,5 mln € messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del programma Industria 2015, si è attivata una ulteriore “cordata” per il progetto FREeSUN, che ha l’obiettivo di mettere a punto un impianto sperimentale da 1 MW basato sulla tecnologia degli specchi Fresnel. Infine perché, indipendentemente dalle due “cordate” appena citate, sono nati o comunque han- Nonostante il ruolo di primo piano che riveste oggi la tecnologia parabolic trough, il suo peso relativo si è decisamente ridotto rispetto al 2008, quando contava per il 78% della potenza totale in funzione ed in progetto. Questo è il risultato innanzitutto della crescente attenzione che la tecnologia solar tower ha ricevuto da parte degli investitori nel corso del 2009, specialmente negli Stati Uniti, ove la grande disponibilità di territori aridi e pianeggianti (condizione necessaria per una efficace disposizione degli eliostati delle torri solari) rende economicamente più conveniente l’utilizzo della tecnologia solar tower. Inoltre l’entusiasmo registrato nel corso del 2008 18 Per quanto riguarda la filiera industriale, si rafforza nel 2009 a livello internazionale il ruolo delle Società di Ingegneria Solare, ossia imprese di ingegneria con forte specializzazione e competenze scientifico-tecnologiche molto avanzate nel solare termodinamico, che mediamente hanno realizzato nel corso del 2009 margini operativi lordi superiori al 30% per le attività di progettazione e al 10% per l’ingegneria impiantistica in senso stretto. Queste imprese si sono dimostrate pronte ad investire ingenti risorse “a monte”, nell’accrescere la propria capacità di produzione di componentistica ad alto valore aggiunto (soprattutto specchi e ricevitori) e, “a valle”, nell’incrementare le proprie quote di capitale negli Special Purpose Vehicles (SPV) per gli impianti di nuova costruzione e nelle attività di gestione operativa e manutenzione degli stessi. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Executive Summary no fatto il loro ingresso nel settore del solare termodinamico nuovi operatori con il ruolo di componentisti specializzati, dimostrando la vitalità anche in questo campo del tessuto industriale italiano. In particolare, l’analisi ha messo in evidenza come esistano almeno due aree di eccellenza in cui le aziende italiane potrebbero dire la loro nel mercato internazionale del solare termodinamico. Innanzitutto la produzione di specchi, con molte imprese del nostro Paese che detengono competenze distintive nella lavorazione di spessori sottili di vetro, nello sviluppo di vernici per aumentare la riflettività dei materiali e nella lavorazione dell’alluminio. In secondo luogo le lavorazioni meccaniche ed in particolare la fabbricazione di giunti ad alta tenuta e di pompe fluidodinamiche adatte all’impiego con sali fusi. Come questo breve sommario lascia intendere, il 2009 è stato un anno di profonde evoluzioni per il business dell’energia solare in Italia, in partico- Davide Chiaroni Responsabile della Ricerca lare per quanto riguarda il fotovoltaico e il solare termodinamico. Il nostro Paese si trova inoltre di fronte a delle sfide e a dei momenti di svolta di grande importanza. La revisione del Nuovo Conto Energia può avere un impatto di grandi proporzioni sul futuro del mercato e della filiera del fotovoltaico in Italia negli anni a venire. Il sistema industriale italiano sta scommettendo decisamente sul solare termodinamico, cercando di mettere a frutto delle competenze consolidate con la speranza di cogliere le opportunità che questo mercato potrà offrire, specialmente nel bacino del Mediterraneo. Il mercato del solare termico è in attesa che alcune tecnologie promettenti (quali il solar cooling) vengano sviluppate ad un livello tale che ne permetta lo sfruttamento su larga scala. La speranza è che le analisi e i risultati contenuti in questo rapporto possano aiutare le imprese, gli investitori e le istituzioni a prendere decisioni ponderate che consentano di sfruttare al meglio le potenzialità della fonte solare per il nostro Paese. Federico Frattini Responsabile della Ricerca www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Lorenzo Boscherini Project Manager 19 IL fotovoltaico 1.1 La tecnologia 1.1.1 Lo stato dell’arte della tecnologia tradizionale del silicio Nella scorsa edizione del Solar Energy Report il capitolo dedicato alla tecnologia aveva l’obiettivo di fornire un quadro quanto più possibile esaustivo delle soluzioni disponibili per la produzione di energia elettrica da fonte solare per “effetto fotovoltaico1”. Nel presente rapporto si è scelto invece, dopo un breve quadro sullo stato delle tecnologie tradizionali (ovvero il silicio mono- e poli-cristallino), di focalizzare l’attenzione sui trend tecnologici che paiono essere maggiormente promettenti per il prossimo futuro e precisamente: Le tecnologie legate all’impiego di wafer di silicio, in forma mono- o poli-cristallina, ovvero quelle cosiddette di “Prima Generazione”, detengono attualmente circa l’85% del mercato mondiale. Hanno raggiunto già da alcuni anni la completa maturità commerciale e risultano una tecnologia affidabile e pienamente dimostrata. Occorre sottolineare a questo riguardo che godono di massima considerazione anche da parte dei maggiori istituti di credito, e questo ha consentito loro di mantenere ancora un certo vantaggio competitivo nei confronti delle altre tecnologie emergenti, quali ad esempio le celle in film sottile. Il prezzo dei moduli in silicio mono- e poli-cristallino, per effetto del rallentamento del mercato finale (si veda paragrafo 1.4.4) e della conseguente situazione di oversupply nella fornitura, ha sperimentato un crollo vertiginoso (si vedano figure 1.1 e 1.2), con una diminuzione sul mercato delle contrattazioni spot di oltre il 30% nel corso del 2009. • l’evoluzione delle performance delle celle a film sottile, ed in particolare quelle in silicio amorfo e in tellururo di cadmio e le cosiddette celle di “terza generazione”; • lo sviluppo delle tecnologie del fotovoltaico “a concentrazione”; • la crescita dell’efficienza di trasformazione degli inverter di ultima generazione ed i principali sviluppi tecnologici che hanno interessato questo componente chiave dell’impianto fotovoltaico. Figura 1.1 Andamento dei prezzi spot dei moduli in silicio mono-cristallino 3,0 2,61 $/W 2,5 2,0 1,88 1,5 1,0 0,5 1 - 09 Dic - 09 Nov - 09 Ott - 09 Set - 09 Ago - 09 Lug - 09 Giu - 09 Mag - 09 Apr - 09 Mar - 09 Feb Gen - 09 0 Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 23-30. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 23 1. IL fotovoltaico Figura 1.2 Andamento dei prezzi spot dei moduli in silicio poli-cristallino 3,0 $/W 2,5 2,95 2,0 1,97 1,5 1,0 0,5 - 09 Dic - 09 Nov - 09 Ott Set - 09 - 09 Ago - 09 Lug - 09 Giu - 09 Mag - 09 Apr - 09 Mar Feb Gen - 09 - 09 0 Figura 1.3 Andamento temporale del rendimento medio delle celle in silicio mono-cristallino 30 15 14,5 15 15,5 200 6 20 5 Rendimento(%) 25 16 16,5 17 17,5 10 5 Anche i contratti di fornitura a lungo termine sono stati in larga parte rinegoziati nel corso dell’anno a condizioni di prezzo nella maggior parte dei casi inferiori del 40-50% rispetto al picco dell’estate 2008. Ulteriori diminuzioni dei prezzi sono attese in futuro, anche se vi è un limite “naturale” al calo dei prezzi dovuto agli elevati costi e consumi energetici richiesti dai processi di ottenimento dei wafer di silicio. I costruttori stanno perseguendo miglioramenti nei processi tecnologici di fabbricazione delle celle che portano a ottenere efficienze sempre più elevate, unite a una riduzione degli spessori dei wafer di silicio. La figura 1.3 riporta l’andamento nel tempo del rendimento medio delle celle in silicio mono-cristallino. I costruttori stimano che in media entro il 2020 le celle in silicio 24 0 201 9 200 8 200 7 200 200 200 4 0 mono-cristallino raggiungeranno un’efficienza del 20%, mentre quelle poli-cristalline del 18%. Si tenga presente che alcune soluzioni già oggi hanno superato la soglia del 20%. 1.1.2. L’evoluzione della tecnologia del film sottile Se le celle cosiddette di “prima generazione” hanno ormai raggiunto la completa maturità commerciale, significative potenzialità di riduzione dei costi caratterizzano invece la tecnologia delle celle di “seconda generazione”, basate sulla tecnologia del film sottile (thin film cells). Le tecnologie fotovoltaiche a film sottile (silicio amorfo, microcristallino, micromorfo, celle CIS/ www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.1 La tecnologia Box 1.1 Le celle ribbon Nel tentativo di ridurre l’impiego di materiale per la costruzione delle celle, in particolare per eliminare gli scarti di lavorazione legati all’ottenimento dei wafers di silicio mediante taglio, sono state ideate negli ultimi anni le celle in silicio cristallino denominate “ribbon”. Gli scarti nella produzione di wafer di silicio dovuti al taglio mediante macchine utensili comporta infatti un 40-50% di perdita di materiale. La tecnologia di produzione delle celle ribbon consiste nell’ottenere uno strato di silicio poli-cristallino depositando direttamente il materiale in forma liquida su di un substrato, realizzando quindi un nastro continuo, mediante crescita capillare (edge-film growth) o laminazione. La temperatura di fusione del silicio è di 1.412°C, pertanto la scelta del materiale del substrato risulta di fatto limitata al metallo o alla ceramica. Le celle ottenute con questa tecnica soffrono di alcuni problemi dovuti agli stress termo-meccanici creati durante il raffreddamento, per gli elevati gradienti termici che si creano all’interfaccia solido-liquido (dell’ordine dei 500°C/ cm). Inoltre le velocità di avanzamento del ribbon per produrre materiale di buona qualità sono relativamente basse, attorno a 18-20 mm/min. Le efficienze raggiunte in laboratorio sono pari al 14-16% e quelle di modulo al 10-13%. Lo spessore di semiconduttore è dell’ordine dei 50-100 nanometri e si riescono ad ottenere moduli di 300-400 cm2 in cui i collegamenti sono realizzati mediante l’integrazione monolitica delle celle (monolithic series interconnection), la stessa tecnica impiegata per i moduli in film sottile. Le celle ribbon non hanno ancora avuto un significativo successo commerciale: se da un lato, infatti, consentono di contenere i costi di produzione grazie al limitato impiego di silicio rispetto alle celle cristalline ottenute a partire da wafer, dall’altro presentano rendimenti inferiori uniti a rilevanti costi del processo produttivo. Come già detto la produzione delle celle ribbon implica la risoluzione di alcune problematiche di tipo tecnico che rendono costoso il processo di fabbricazione, per cui la loro competitività si raggiunge solo con elevati volumi di produzione. Attualmente le celle ribbon detengono circa il 2% del mercato fotovoltaico a livello mondiale. CIGS, celle al CdTe) presentano essenzialmente due vantaggi principali rispetto alla tradizionale tecnologia che impiega wafer di silicio: scala industriale, tale tecnologia si presta quindi a un elevato grado di automazione con un conseguente risparmio sull’intero processo di produzione3. In molti casi si riesce a organizzare il processo industriale nella forma di una produzione in continuo, anziché in logica batch (a lotti) come avviene per il silicio cristallino. In caso di substrato flessibile, poi, si può addirittura avere un processo in nastri, denominato roll-to-roll. Per poter effettivamente ridurre i costi unitari, è in ogni caso necessario che tali tecnologie sfruttino significative economie di scala, con produzioni di almeno alcune decine o meglio centinaia di MW all’anno, obiettivo che in particolare per alcune tecnologie è già stato raggiunto. • il primo è la possibilità di realizzare dispositivi con spessori estremamente sottili di materiale attivo, tipicamente 1-2 μm di materiale semiconduttore, meno di un decimo degli attuali wafer di silicio. Ciò consente di risparmiare notevolmente sulla quantità di materiale impiegato e perciò di ridurre potenzialmente il costo finale del dispositivo; • il secondo vantaggio è rappresentato dal fatto che tale tecnologia consente di realizzare ed integrare contemporaneamente tra loro più celle in un’unica fase produttiva2 , a differenza di quanto accade per le celle di prima generazione, e su di un unico substrato di costo relativamente contenuto (vetro, fogli di materiale plastico o di metallo). Ciò permette di evitare i costosi processi di assemblaggio meccanico ed elettrico delle celle all’interno di un modulo, tipici della tecnologia basata sui wafer. Nell’ottica di una produzione su Oltre ai vantaggi in termini di costo, che costituiscono un’enorme potenzialità per il futuro, si possono evidenziare altri vantaggi che sono comuni alle varie tipologie di celle a film sottile: • in primo luogo la possibilità di realizzare una maggiore integrabilità architettonica, grazie La tipica cella a film sottile è composta da un substrato di vetro, oppure metallo o materiale plastico, sul quale vengono depositati in successione: un contatto metallico inferiore, il materiale assorbitore (semiconduttore), uno strato buffer, un contatto trasparente superiore, generalmente un ossido trasparente e conduttivo (TCO, transparent conductive oxide). Le celle vengono “disegnate” rimuovendo meccanicamente o mediante laser parte dei materiali precedentemente depositati e poi collegate in serie dallo strato di TCO. 3 Ad esempio per la realizzazione di celle in silicio amorfo, si rilevano interessanti analogie produttive con i processi per la fabbricazione di schermi piatti LCD. 2 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 25 1. IL fotovoltaico alla flessibilità ottenuta con alcuni materiali di supporto e all’aspetto estetico dei moduli; in certi casi poi si possono sfruttare le caratteristiche di semi-trasparenza, in particolare per alcune tecnologie realizzate su supporto in vetro. Da questo punto di vista si pensi all’importanza dell’industria del design nel nostro Paese, in cui le tecnologie a film sottile potrebbero avere un ruolo rilevante nel mercato del cosiddetto Building Integrated Photovoltaic (si veda paragrafo 1.3.5); • altra caratteristica è la minor sensibilità alle elevate temperature, per cui i moduli in film sottile presentano di solito un decadimento di efficienza per effetto della temperatura che è circa la metà di quello della tecnologia con silicio cristallino (valori tipici di 0,25 %/°C contro 0,5 %/°C); • infine, le celle in film sottile presentano in generale una buona efficienza di conversione della luce diffusa. A parità di potenza installata possono avere quindi un potenziale di generazione di energia superiore al cristallino classico, cioè il rapporto kWh/kW (energia annua prodotta per kW di picco installato, ovvero ore equivalenti di funzionamento) può essere maggiore di quello del silicio in determinate condizioni, come hanno dimostrato diversi test outdoor condotti da laboratori certificati. Per contro hanno rendimenti nominali sensibilmente inferiori al silicio cristallino e tendono a manifestare un decadimento più marcato delle prestazioni nel tempo (specialmente per le celle in silicio amorfo). Alcune tecnologie sfruttano poi elementi rari sulla superficie terrestre, come per esempio il Tellurio, il Gallio o l’Indio, mentre in altri casi impiegano materiali pericolosi per la loro tossicità verso l’uomo o l’ambiente, come nel caso del cadmio. Secondo la nostra indagine, nel 2012 (si veda figura 1.5) la tecnologia a film sottile potrebbe raggiungere una percentuale di mercato del 34% su una capacità installata complessiva che raggiungerà (in uno scenario ottimistico) oltre 45 GW. Fra le tecnologie a film sottile emerge con chiarezza il ruolo del silicio amorfo (che potrà contare per circa il 15% del mercato totale entro fine 2012) e delle celle al tellururo di cadmio (12% del mercato totale al 2012). Le celle al silicio amorfo (a-Si) sono una delle prime tipologie di celle a film sottile studiate4 e impiegano silicio con piccole aggiunte di Idrogeno, necessario per stabilizzare la struttura e facilitare il drogaggio (per queste ragioni spesso si usa l’acronimo a-Si:H). Il processo tecnologico di produzione del film sottile in silicio amorfo5 è efficiente e poco costoso, anche in conseguenza del ridotto spessore di silicio (circa 1 μm) necessario per garantire l’assorbimento di energia. I moduli in silicio amorfo hanno un rendimento effettivo in esercizio che non supera il 6% per una cella a singola giunzione, ma hanno il già citato vantag- Figura 1.4 Quota di mercato al 2008 delle principali tecnologie fotovoltaiche 1% 5% 2% 8% 35% 49% poli-si CdTe mono-si CIGS/CIS a-si ribbon 4 Le celle in a-Si sono impiegate da tempo per alimentare dispositivi elettronici quali ad esempio calcolatrici o orologi, mentre il primo modulo fotovoltaico in film sottile realizzato in silicio amorfo è del 1980, anno in cui è stato lanciato il primo prodotto commerciale. 5 Il processo si basa su una deposizione da fase vapore (CVD, Chemical Vapour Deposition) che avviene a temperatura relativamente bassa, circa 300 °C, e permette di depositare strati di silicio di spessore di pochi micron. 26 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.1 La tecnologia Figura 1.5 Quota di mercato previsionale al 2012 delle principali tecnologie fotovoltaiche 1% 12% 6% 38% 15% 28% gio di un migliore comportamento in luce diffusa rispetto alla tecnologia del silicio cristallino. Il silicio amorfo è infatti una forma non cristallina del silicio, la cui struttura disordinata promuove l’assorbimento della radiazione solare: spessori anche inferiori al micron sono sufficienti per avere un discreto assorbimento. Per potenziare ulteriormente questo effetto la superficie dello strato di silicio subisce poi un trattamento superficiale denominato di texturing, al fine di “intrappolare” la radiazione all’interno della giunzione. Il materiale semiconduttore allo stato amorfo dà origine d’altro canto a dispositivi instabili che degradano significativamente la loro prestazione nel tempo. Le moderne celle a-Si manifestano un decadimento di prestazioni del 15-20% durante le prime 1.000 ore di funzionamento, dopodiché il rendimento si assesta sul citato valore del 6%. Le celle a tripla giunzione con leghe di silicio e germanio raggiungono tuttavia rendimenti sino all’11%. Tra i maggiori produttori di celle e moduli in a-Si si ricordano l’americana United Solar Ovonics – Unisolar, la tedesca Schott Solar e le giapponesi Mitsubishi e Kaneka. A livello mondiale Unisolar è il secondo maggior produttore di celle a film sottile dopo First Solar (che produce però moduli in tellururo di cadmio) ed è leader mondiale nella produzione di moduli in a-Si su substrato flessibile. Le celle al tellururo di cadmio (CdTe) sono tipicamente cella a “eterogiunzione”, formate da due diversi materiali, solfuro di cadmio (CdS) e tellu- poli-si CdTe mono-si CIGS/CIS a-si ribbon ruro di cadmio (CdTe)6. In termini di prestazioni, il CdTe ha efficienze di cella (in dimensioni tipiche da laboratorio) certificate del 16,5%. I moduli commerciali più venduti, dell’americana First Solar, hanno potenze di picco di 80 W ed efficienze stabilizzate attorno all’11%. Le prestazioni e l’affidabilità sono garantite per 20 anni, ed includono lo smaltimento e il riciclo a fine vita. L’interesse per gli sviluppi tecnologici relativi alle celle al CdTe è molto elevato a livello internazionale a causa soprattutto del basso costo di produzione, cui si accompagna un discreto livello di efficienza ed una buona stabilità nel tempo. First Solar ha dichiarato di aver prodotto nel 2009 un volume pari a circa 1.200 MW/anno con costi inferiori a 0,7 €/W, circa la metà rispetto al costo del silicio cristallino. Valutazioni effettuate da osservatori accreditati stimano i costi di produzione attorno a 0,3 €/W entro i prossimi 5 anni. Le aspettative di miglioramento sono legate in primo luogo al perfezionamento dei contatti elettrici all’interno dei singoli moduli, all’introduzione nel processo produttivo di altre fasi per aggiungere ulteriori strati assorbitori, all’ulteriore contenimento dell’impatto ambientale (si veda box 1.2). È da tenere in conto però la scarsità del Tellurio, che a livello mondiale potrebbe garantire una produzione limitata a qualche GW all’anno. Nel mondo operano solo 11 produttori di celle al CdTe, fra cui i principali sono l’americana First Solar, le tedesche Calyxo e Antec e, anche se non ancora completamente operativa, l’ita- 6 Lo strato tampone o “buffer” superficiale utilizzato per queste celle (spessore 0.07-0.1 nanometri è il solfuro di cadmio (CdS), un eccellente semiconduttore che ha buone proprietà di trasparenza. Lo strato sottostante di CdTe ha uno spessore di circa 5 nanometri e viene depositato con tecniche molto semplici di sublimazione in ambiente chiuso a 400-600°C. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 27 1. IL fotovoltaico Box 1.2 La pericolosità ambientale e la tossicità del cadmio Un recente studio condotto dai laboratori americani NREL esamina gli aspetti legati alla pericolosità ambientale e alla tossicità del cadmio, sia nelle fasi di costruzione dei moduli, sia considerando il potenziale rilascio all’ambiente durante l’esercizio dei moduli stessi o durante le fasi di dismissione. I risultati mettono in luce come il problema assuma una dimensione marginale. Il CdTe non è assimilabile al cadmio metallico, poiché è un prodotto altamente stabile, ad alto punto di fusione e insolubile in acqua. Un modulo a base di CdTe contiene pochissimo cadmio, meno dell’uno per mille in peso, e meno, per metro quadrato, di un’ordinaria pila al Ni-Cd. Inoltre, come detto sopra, il cadmio nel modulo è in una forma assolutamente stabile. Nel modulo fotovoltaico il cadmio è legato al Tellurio e incapsulato, quindi la tecnologia fotovoltaica fornisce una soluzione efficace per il sequestro del cadmio. Può essere relativamente facile e vantaggioso riciclare completamente i moduli alla fine della loro vita, che comunque è di almeno 25-30 anni. Inoltre, data la loro natura, non è facile per l’utente disperdere i moduli nell’ambiente come succede invece spesso con le pile. Il riciclo dei moduli risolve completamente ogni problema di carattere ambientale. Si consideri infine il fatto che il 41,3% dell’esposizione umana al cadmio deriva dall’utilizzo di fertilizzanti, il 22% dall’utilizzo dei combustibili fossili, oltre il 16% dalla produzione di ferro e acciaio e così via fino ad arrivare a un 2,5% legato dall’utilizzo di prodotti del cadmio quali le batterie Ni-Cd. I moduli fotovoltaici al CdTe porterebbero sul mercato ancora meno cadmio di quanto non lo facciano le batterie. liana Arendi. Di fatto in questo momento la politica commerciale dei produttori è quella di rivolgersi direttamente a clienti che installano grandi impianti, per cui le applicazioni finora realizzate sono destinate a coperture di grandi edifici commerciali o a sistemi a terra con potenza superiore a 1 MW. grandi superfici a costi molto ridotti, a partire da una soluzione liquida in forma di inchiostri o paste, o attraverso semplici processi di evaporazione. È possibile quindi usare metodi tipici dell’industria della stampa riducendo drasticamente i costi energetici di fabbricazione, unitamente a quelli per l’acquisto del materiale e di processo. La gamma di celle solari organiche è molto ampia e si trova attualmente a diversi livelli di maturazione tecnologica e di ricerca: in un elenco non esaustivo, tra le tecnologie più promettenti possiamo individuare le celle dye sensitized (o DSSC), le celle totalmente organiche (anche dette plastiche), e le celle ibride organiche/inorganiche. Al momento varie realtà industriali, tra cui la Konarka Technologies, G24I, DyeSol, Aisin Seki, Hitachi e Sharp, stanno investendo risorse nello sviluppo di questo tipo di tecnologia. La vera sfida consiste nell’adattamento di processi produttivi consolidati e a basso costo, quali quelli utilizzati nell’industria della stampa, in modo da consentirne l’applicazione all’industria fotovoltaica. Occorre tuttavia notare che al momento non sono ancora disponibili prodotti commerciali: si tratta infatti di tecnologie studiate in laboratorio o in qualche caso di prototipi dimostrativi. Si stima però che i primi modelli commerciali saranno disponibili tra 3-5 anni con un costo di produzione atteso inferiore a 0,5 €/W8 . Interessanti prospettive di sviluppo sono attese anche dalle cosiddette celle fotovoltaiche “di terza generazione”. La definizione convenzionale di queste celle è piuttosto ambigua, tuttavia una prima tipologia di celle che si possono ricondurre a questa categoria sono quelle basate su tecnologie con semi-conduttori di tipo organico7 (le celle di prima e seconda generazione invece sono tutte basate su semi-conduttori inorganici). Nelle celle solari organiche la parte fotoattiva è basata sui composti organici del carbonio: tipicamente si tratta di polimeri. La struttura fondamentale di una cella organica è semplice: viene detta a sandwich ed è composta da un substrato, generalmente vetro ma anche plastica flessibile, e da una o più pellicole sottilissime, che contengono i materiali fotoattivi, interposte tra due elettrodi conduttivi di cui almeno uno trasparente. Un potenziale enorme vantaggio dei materiali fotovoltaici organici risiede nel fatto che possono essere depositati sotto forma di pellicola su Rientrano in questa categoria le celle definite di tipo ibrido, con semi-conduttore organico-inorganico. Oltre alle celle organiche rientrano nella categoria delle celle di terza generazione, anche se il loro sviluppo è attualmente ad un livello più arretrato: le celle quantum dot, le hot-carrier, le celle in silicio nano-strutturato e le celle termo-fotoniche. 7 8 28 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.1 La tecnologia 1.1.3 Lo sviluppo delle tecnologie del fotovoltaico “a concentrazione” Il fotovoltaico a concentrazione (CPV– Concentrating Photo-Voltaic) si propone di diminuire i costi di impianto attraverso la riduzione delle quantità di materiali semiconduttori impiegati per le celle, che in un impianto fotovoltaico rappresentano il costo principale. L’area coperta dal semiconduttore impiegato nelle celle, infatti, a pari potenza elettrica nominale del sistema viene sostanzialmente ridotta di un fattore pari alla concentrazione ottica. Il fattore di concentrazione varia da un valore di poche unità nei sistemi a minore concentrazione fino ad un valore prossimo a 1.000 nei sistemi a concentrazione più elevata finora studiati. I sistemi ottici di concentrazione possono essere basati sul meccanismo della riflessione (specchi) oppure più spesso su quello della rifrazione (lenti). In aggiunta alla drastica riduzione di materiale impiegato, con la concentrazione si ottiene in generale un rendimento della cella più elevato, in quanto, nonostante l’effetto negativo legato alle più alte temperature di lavoro, in queste condizioni aumenta la corrente di illuminazione che si genera per effetto fotovoltaico, quindi l’efficienza della cella. Da notare poi che, grazie alla modesta superficie di celle impiegate, risulta molto spesso interessante adottare celle di elevato rendimento, come per esempio le celle multi-giunzione, nonostante il loro costo maggiore. Da ultimo è possibile sottolineare che, a differenza dei moduli fotovoltaici tradizionali, questa tecnologia per sua natura è in grado di convertire in energia elettrica la sola radiazione diretta proveniente dal sole e necessita quindi di meccanismi di movimentazione (tracking) per ottenere l’inseguimento della radiazione solare. Per tale ragione l’applicazione degli impianti CPV risulta maggiormente indicata in zone con forte insolazione diretta, come le zone desertiche o sub-tropicali. I costruttori di moduli a concentrazione si stanno orientando su diverse filosofie costruttive: sistemi ad alta concentrazione (da 400X fino a circa 1.000X) che impiegano celle multi-giunzione basate su arseniuro di gallio (GaAs) derivate dalla tecnologia spaziale, sistemi a media concentrazione (tipicamente 10X-20X) che utilizzano celle in silicio monocristallino di elevata qualità, e infine sistemi a bassa concentrazione (2X-3X) basati su moduli convenzionali in silicio e realizzati mediante semplici specchi applicati ai lati del modulo. E’ difficile al momento prevedere quale tecnologia conseguirà in futuro i migliori risultati in termini di riduzione del costo del kWh generato, anche se si osserva come negli ultimi anni i maggiori costruttori stiano puntando su sistemi ad alta concentrazione. I sistemi ad alta concentrazione sono del tipo “Point Focus”, in cui ogni cella solare ha una sua ottica dedicata e la concentrazione è di tipo puntuale. Per questi sistemi si registra un costante aumento di efficienza, che suscita un crescente interesse verso queste tecnologie. Il record attuale di 41,6% è detenuto da una cella a tripla giunzione GaInP/ GaInAs/Ge e il trend di crescita del rendimento è circa dell’1% all’anno. Si stima che nei prossimi anni possano essere facilmente raggiunti valori di efficienza del 50%9. Le tecnologie ad alta concentrazione dovrebbero potenzialmente rivolgersi al mercato delle centrali solari, in diretta concorrenza con la tecnologia del solare termodinamico a concentrazione. A differenza di quest’ultima, la tecnologia CPV avrebbe il vantaggio di non richiedere la presenza di acqua e di aver maggior flessibilità in termini di taglia di impianto, per cui il rendimento e quindi il costo della centrale non risulterebbero legati all’effetto di scala. Il settore CPV sta crescendo rapidamente, con ormai decine di aziende che sviluppano nuovi prodotti. In questo periodo gli investimenti complessivi nel CPV sono stati nell’ordine di 1 miliardo di dollari. Nel mondo vi sono ormai decine di produttori coinvolti nel mercato del fotovoltaico ad alta concentrazione. Tra quelli che hanno dichiarato una capacità produttiva maggiore di 10 MW/anno citiamo: Amonix (USA), Concentracion Solar La Mancha (Spagna), Concentrix Solar (Germania), Emcore (USA), Green and Gold (Australia), Guascor Foton (Spagna), Isofoton (Spagna), SolFocus (USA). La sfida attuale è quella di passare dai prototipi e dalla fase dimostrativa alla industrializzazione vera e propria del prodotto e alla produzione su larga scala. 1.1.4 Gli sviluppi tecnologici degli inverter L’inverter è un componente chiave dell’impianto fotovoltaico poiché influenza il rendimento e l’efficienza globale dell’impianto ed è essenziale nell’in- 9 Tra i principali produttori di celle multi-giunzione è possibile citare Azur Space (Germania), Emcore (USA) e Spectrolab (USA) che hanno nel complesso una capacità produttiva compresa tra 100 e 300 MW. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 29 1. IL fotovoltaico Figura 1.6 Trend di crescita dell’efficienza europea media degli inverter negli ultimi 5 anni 99 98 Max con trasformatore Efficienza europea (%) 97 96 Max senza trasformatore 95 94 Media con trasformatore 93 Media senza trasformatore 92 91 Media totale 90 0 8 200 201 7 200 Gli inverter con trasformatore (o inverter stringa) sono tipicamente impiegati negli impianti di medie e grandi dimensioni e sono in grado da soli di gestire potenze da 30 kW sino da 1 MW (e in taluni casi anche 2 MW), mentre gli inverter senza trasformatore (o transformerless) sono utilizzati per gli impianti di piccole dimensioni (sino a 2030 kW di potenza). Dall’analisi della distribuzione dell’efficienza di conversione dei prodotti sul mercato emerge come la maggioranza degli apparecchi per cui siano disponibili i dati si collochi nella fascia compresa tra 93 e 94% nel caso di inverter con trasformatore, mentre per gli apparecchi “transformerless” la maggioranza si attesta su valori di efficienza del 97-98%. I ricercatori del Fraunhofer Institut di Friburgo (ISE), a fine 2009, hanno annunciato di aver realizzato inverter fotovoltaici dotati di un’efficienza pari al 98,5%. 9 6 200 terfacciamento con la rete. L’efficienza di trasformazione degli inverter è uno dei parametri critici dell’intero impianto fotovoltaico in quanto è ad essa che si deve l’effettiva produzione di energia elettrica immessa in rete (rispetto a quella generata in uscita dai moduli). Il trend di crescita dell’efficienza di trasformazione degli inverter – misurata secondo lo standard europeo10 – negli ultimi 5 anni è riportata in figura 1.6. 200 5 200 89 Questo record è stato ottenuto nel corso di un test condotto su un inverter monofase con potenza nominale di 5 kW impiegando un nuovo componente, il MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), basato sul carburo di silicio, un tipo di materiale fino ad oggi applicato nei LED bianchi che stanno rivoluzionando la tecnologia dell’illuminazione. Il team di Friburgo è riuscito a ridurre dal 30 al 50% la dissipazione di potenza degli inverter convenzionali. Inverter con un’efficienza di conversione elevata presentano normalmente anche una durata in esercizio più lunga: maggiore efficienza significa infatti minori perdite di energia “interne” e quindi componenti più raramente sottoposte a sovraccarico e quindi meno soggette al processo di logoramento. Oltre a questo, un’efficienza più alta influisce anche sui costi del sistema: un’efficienza bassa significa maggiori perdite, maggiore dissipazione di calore e quindi necessità di sistemi di raffreddamento più efficienti e quindi più costosi. Nel caso di inverter con efficienze più basse c’è quindi da considerare, oltre al “costo” per il mancato rendimento, anche il costo di componenti tecniche aggiuntive per gestire il raffreddamento. L’incremento dell’efficienza registrata negli ultimi 10 In effetti, esistono differenti modalità di calcolo dell’efficienza di trasformazione degli inverter con anche forti disomogeneità nei risultati ottenuti. Ad esempio l’efficienza “californiana” è ottenuta assegnando un peso maggiore all’efficienza di trasformazione che si ottiene in concomitanza con le ore di maggior insolazione, mentre l’efficienza “europea” effettua il calcolo in modo più omogeneo sull’intero periodo di funzionamento. Ne consegue che particolare attenzione deve essere posta in sede di confronto fra prodotti che riportino efficienze calcolate secondo standard differenti. 30 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.1 La tecnologia anni è dovuto ad una serie di avanzamenti tecnologici cui le imprese produttrici di inverter hanno dedicato gran parte dei loro investimenti in ricerca e sviluppo: • primo fra tutti si può citare lo sviluppo dell’architettura transformerless per i piccoli impianti, che ha consentito di guadagnare oltre un punto percentuale di efficienza rispetto alle “tradizionali” soluzioni a stringa per la medesima taglia di impianti; • inoltre sono stati sviluppati sistemi ad hoc per gestire situazioni di ombreggiamento particolarmente problematiche o con funzionalità aggiuntive quali l’emergency power supply. In particolare, sono stati messi a punto in questo ambito dei nuovi prodotti che consentono (attraverso particolari algoritmi) la rilevazione quasi in tempo reale di un ombreggiamento parziale dei moduli e della conseguente caduta di tensione all’interno della relativa stringa. Sulla base di queste informazioni, il sistema aggiorna la propria configurazione per mantenere livelli di efficienza elevati attraverso l’esclusione della parte di stringa del sistema solo parzialmente irraggiato. Negli ultimi anni poi sono state sviluppate soluzioni adatte al funzionamento in ambienti climatici “aggressivi”, quali per esempio le zone costiere che presentano l’annoso problema della salsedine – per le quali sono stati pensati sistemi di protezione ad hoc degli inverter – oppure le aree particolarmente calde, ove è possibile impiegare tecnologie – quali l’OptiCool System sviluppato da SMA – che permettono agli inverter di lavorare a temperature sino a 4550 °C mantenendo le medesime performance delle condizioni nominali;11 • infine, uno sforzo significativo è stato compiuto per l’ottimizzazione del design del sistema complessivo. Sono principalmente tre gli aspetti di progettazione su cui si è agito: (i) la capillarità dei sottocampi, in cui si divide il “campo fotovoltaico” – a ciascuno dei quali corrisponde un inverter – che dovrebbero avere caratteristiche il più possibile omogenee sia in relazione alla qualità dei moduli sia in relazione alle diverse condizioni ambientali (quali ad esempio il mismatching12). Il guadagno in termini di efficienza di sistema che si può raggiungere con una buona suddivisione del sistema in sottocampi può variare dal 3 al 5%; (ii) il corretto dimensionamento dell’impianto (ovvero la definizione della lunghezza delle stringhe) che può portare a guadagni che vanno dallo 0,5% al 2% sull’efficienza complessiva del sistema; (iii) l’introduzione della configurazione “master-slave”13 – di cui è stata recentemente proposta da SMA un’ulteriore evoluzione chiamata “team” – che garantisce un’efficienza di conversione mediamente più alta perché consente al sistema, attraverso il meccanismo delle inclusioni ed esclusioni degli inverter, di lavorare per un tempo maggiore al massimo della curva di rendimento. Box 1.3 Le smart-grid e gli inverter Le smart-grid – o reti “intelligenti” per la distribuzione di energia elettrica – sono reti bidirezionali (ovvero in grado di gestire indifferentemente e su scala locale l’immissione ed il prelievo di energia elettrica dalla rete) e modulari, dove gli eventuali surplus di energia di alcune zone vengono “riallocati”, in modo dinamico ed in tempo reale, in altre aree. Queste reti sono regolate da software di gestione. Sono ormai molte le opinioni di esperti che ritengono lo sviluppo della “rete intelligente” una possibile chiave di volta per un nuovo sistema energetico distribuito, in grado di ottimizzare il contributo della produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo scenario, l’inverter è considerato un compo- nente essenziale dal punto di vista della rete per la vasta gamma di funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, oltre a convertire la corrente continua in corrente alternata e fungere da interfaccia tra i sistemi di conversione di energia, i carichi locali e la rete, l’inverter avrebbe la funzione di gestire le variazioni di energia elettrica dovute ai diversi livelli di generazione prodotta dalle fonti rinnovabili, dei carichi variabili e delle tensioni variabili della rete. Gli inverter, infatti, potrebbero influenzare la frequenza e il livello di tensione della rete e sembrano quindi essere il principale mattone costruttivo delle future reti intelligenti su scala locale, ovvero per livelli di tensione medi e bassi. L’efficienza che viene misurata in laboratorio è in situazioni standard a una temperatura media di 25°C. L’effetto del mismatching deriva da cause esterne quali: ombreggiamento parziale del campo fotovoltaico, tolleranze intrinseche dei pannelli, diverse superfici di installazione. 13 E’ una configurazione che prevede che sia assegnata una priorità prestabilita ai diversi inverter, che entrano in funzione uno dopo l’altro al crescere della corrente generata dall’impianto fotovoltaico. 11 12 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 31 1. IL fotovoltaico L’analisi condotta ha permesso di rilevare che: (i) un incremento del livello di efficienza di 4,5 punti percentuali – che rappresenta il range tra efficienza media e efficienza massima per inverter con trasformatore (si veda figura 1.6) – aumenta dell’1,8% l’IRR di un “impianto tipo” da 200kW; (ii) variazioni positive di un punto percentuale di efficienza dell’inverter portano ad un incremento dell’IRR dello 0,5%. Il ruolo dell’inverter nel garantire la profittabilità complessiva del sistema appare essere quindi particolarmente critico e meritevole di un’attenta analisi nella scelta della soluzione tecnologica più adatta alle specifiche esigenze dell’impianto. 32 E’ interessante notare, da ultimo, come gli inverter di ultima generazione offrano funzionalità aggiuntive che vanno ben oltre la mera “trasformazione” di corrente continua in corrente alternata (si veda paragrafo 1.4.7). In particolare, quasi ogni inverter proposto sul mercato fornisce oggi funzioni di data-logging che vengono utilizzate soprattutto per il monitoraggio del funzionamento dell’inverter e del campo fotovoltaico. In genere i dati vengono registrati con una frequenza predefinita (5, 30 o 60 minuti) e successivamente trasferiti ad un sistema di monitoraggio per la valutazione di eventuali malfunzionamenti. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa E’ indubbio che uno dei temi su cui si è più dibattuto nel corso del 2009 sia stato il sistema di incentivazione per le installazioni fotovoltaiche in Italia. Tuttavia, se da un lato è innegabile, come insegna anche l’esperienza di altri Paesi in Europa – oltre ad essere uno degli argomenti più frequentemente usati dai detrattori del fotovoltaico – che lo sviluppo del settore sia ancora legato “a doppio filo” alla disponibilità di sussidi che rendano economicamente vantaggiosa la produzione di energia elettrica da fonte solare, dall’altro lato è altrettanto importante sottolineare come i fattori da tenere in considerazione per valutare correttamente la bontà o meno di un sistema di incentivazione siano diversi, eterogenei fra di loro e con interrelazioni spesso non così evidenti. L’obiettivo di questo capitolo è quello, per quanto possibile, di fare chiarezza analizzando il problema dei meccanismi di incentivazione del fotovoltaico attraverso: • il confronto con le soluzioni adottate dai diversi Paesi europei e con le esperienze più significative e/o innovative a livello internazionale; • la valutazione delle diverse “forme di incentivazione”, sia dirette (ad esempio attraverso contributi in conto capitale alle installazioni) sia indirette (ad esempio in termini di riduzione dei tempi di disbrigo delle pratiche autorizzative) che si affiancano al meccanismo delle tariffe feed-in e che, come si vedrà nel paragrafo 1.2.4, riescono a spiegare in parte le differenze – fra Regioni ed anche fra Province all’interno della medesima Regione – nella diffusione del fotovoltaico; • la stima delle entrate di natura fiscale – sia quelle direttamente connesse all’installazione dell’impianto, sia quelle legate al funzionamento durante la sua vita utile (ossia legate alla produzione di energia elettrica), sia infine quelle che attengono alla sua realizzazione (ossia corrisposte dalla “filiera” del fotovoltaico italiano) – che rappresenta un inevitabile termine di paragone 14 rispetto al quale considerare gli esborsi connessi all’erogazione degli incentivi; • la stima – su diversi scenari di potenza installata e di livello di incentivazione – delle risorse finanziarie che l’Amministrazione Pubblica deve assicurare per supportare il meccanismo delle tariffe feed-in in Italia. Il quadro che ne esce è decisamente molto più articolato di quanto forse un po’ troppo spesso viene presentato e spinge ad una serie di importanti riflessioni sulle ricadute “concrete” del fotovoltaico, che verranno poi riprese e ulteriormente affrontate nel capitolo 1.3. 1.2.1 Il nuovo panorama a livello europeo La tabella 1.1 mette a confronto le tariffe incentivanti per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici in vigore nel 2009 con quelle dell’anno precedente, in tre Paesi europei (Germania, Grecia e Spagna), oltre ovviamente all’Italia. La scelta non è ovviamente casuale e riflette anzi la volontà di investigare l’impatto che la normativa (ed il sistema di incentivazione in particolare) può avere, in positivo o in negativo, sullo sviluppo del fotovoltaico. I tre Paesi presi a riferimento sono infatti “rappresentativi” di altrettanti “stadi” di sviluppo del settore: • la Germania, leader indiscussa in Europa (e per ora, in attesa della “partenza” dell’Asia o degli USA, anche a livello mondiale) per potenza fotovoltaica complessivamente installata con i suoi 8,3 GW, che nel corso del 2009 ha continuato a registrare – nonostante i ritocchi alle tariffe – una crescita impressionante dell’installato (oltre 3 GW contro i poco più di 1,3 GW del 2008)14; • la Spagna, follower di lusso, che dopo aver drasticamente ridotto il distacco con la prima E’ probabile che il valore salga a circa 4 GW a causa delle imprecisioni di calcolo dell’autorità tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 33 1. IL fotovoltaico Tabella 1.1 Tariffe feed-in (€/kWh) nei principali Paesi europei Potenza (kW) 1-3 3-20 20-100 100-1.000 1.00010.000 Tipo di impianto Germania Grecia* Spagna Italia 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Integrato 0,4675 0,4301 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,49 0,4802 Non integrato 0,4675 0,4301 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,4 0,392 Integrato 0,4675 0,4301 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,46 0,4508 Non integrato 0,4675 0,4301 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,38 0,3724 Integrato 0,4562 0,4197 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,44 0,4312 Non integrato 0,4562 0,4197 0,49051 0,4778 0,4404 0,34 0,36 0,3528 Integrato 0,4399 0,3959 0,44051 0,4278 0,4175 0,34 0,44 0,4312 Non integrato 0,4399 0,3959 0,44051 0,4278 0,4175 0,34 0,36 0,3528 Integrato 0,4399 0,33 0,44051 0,4278 0,4175 0,32 0,44 0,4312 Non integrato 0,4399 0,33 0,44051 0,4278 0,4175 0,32 0,36 0,3528 * per il 2008 e il 2009 è stata calcolata la media delle tariffe feed-in in vigore sulle isole e sul continente d’Europa nel corso del 2008 – con i suoi quasi 4 GW complessivamente installati ed un balzo di oltre 3,5 GW rispetto al 2007 (quando ancora misurava in poche centinaia di MW il proprio “peso” nel fotovoltaico) – ha invece vissuto nel 2009 il suo annus horribilis installando poco più di 400 MW, registrando un calo di quasi il 90% rispetto all’anno precedente; • la Grecia, che solo nel 2009 ha realmente mosso i primi passi significativi nel fotovoltaico, portando il totale della potenza installata dai 18 MW di fine 2008 a oltre 52 MW. La scelta tedesca – non a caso frutto di un ampio confronto fra il Governo e le associazioni industriali del fotovoltaico – appare sicuramente la più interessante, anche in considerazione dei risultati ottenuti. I tagli più consistenti (nell’ordine del 25%) si sono concentrati sulle grandi installazioni, oltre il MW di potenza di picco, mentre impianti medi e piccoli hanno beneficiato di riduzioni delle tariffe più contenute, rispettivamente del 10% e dell’8%. Il percorso di evoluzione delle tariffe feed-in tracciato dal nuovo piano tedesco per il fotovoltaico prevede poi, nel 2010 e nel 2011, ulteriori riduzioni la cui entità complessiva dipenderà anche dalle effettive nuove installazioni realizzate nei due anni. Nel 2011, in ogni caso, si attendono riduzioni medie del 15% per le tariffe incentivanti. Una 34 ulteriore revisione delle tariffe è prevista a partire dal 2012. La stabilità del sistema di incentivazione, che – a parte il caso peraltro più “teorico” che reale degli impianti sopra il MW “a tetto” – prevede un taglio delle tariffe complessivamente inferiore al 30% spalmato su 3 anni, ha avuto un triplice effetto positivo: (i) spingere le imprese tedesche, già fra le più “mature” del settore, a muoversi ulteriormente verso l’efficientamento dei sistemi produttivi, della logistica e dell’attività di installazione e, di conseguenza, a ridurre i prezzi per il cliente finale mantenendo però fermi (crisi a parte) i livelli di marginalità; (ii) “tranquillizzare” gli investitori e chi stava valutando la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, fornendo loro un orizzonte di pianificazione con regole ben definite; (iii) ridurre il “peso” degli incentivi al fotovoltaico sul bilancio dello Stato, facendo un ulteriore passo in avanti verso l’auto-sostenimento del settore. Se la scelta tedesca appare essere pienamente coerente con la volontà di rafforzare la leadership a livello europeo, pur nella necessità di “salvaguardare” i conti pubblici, di tutt’altro tenore (e però anche, come si è visto prima, risultato) sono le modifiche al sistema di incentivazione decise dalla Spagna. Il calo delle tariffe è stato qui pari, in media, a circa il 22% con valori dell’incentivazione passati a 0,34 €/kWh per i piccoli impianti e a 0,32 €/kWh per le grandi centrali (segmento quest’ultimo sempre pri- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa vilegiato dal governo spagnolo e che nel 2008 è stato alla base della “esplosione” della potenza fotovoltaica installata). Un calo così brusco ha disorientato gli investitori e – in un anno già particolarmente negativo come il 2009 – bloccato gli investimenti in “parchi fotovoltaici”, fermando come visto a poche centinaia di MW le nuove installazioni. A dare però il vero “colpo di grazia” al fotovoltaico spagnolo è stata indubbiamente l’introduzione del meccanismo – che già aveva dato prova di scarso successo altrove – del maximum cap per le nuove installazioni, fissato a 500 MW nel 2009 e a 502 MW nel 2010. L’introduzione del limite sulle installazioni, infatti, ha un effetto per certi versi “perverso”: da un lato, introducendo grande aleatorietà nella concessione dell’incentivo (per la difficoltà a priori di sapere se, visto l’ordine di presentazione delle domande, si rientrerà o meno nel contingente incentivato), incrementa il rischio dell’investimento, dall’altro lato spinge a comportamenti speculativi sulle nuove installazioni. È estremamente importante far notare che da un punto di vista meramente tecnico le nuove tariffe spagnole sarebbero comunque in grado (si pensi al confronto con il caso tedesco, ma con la “correzione” della maggior insolazione15) di sostenere la profittabilità di un investimento in fotovoltaico. Tuttavia, l’aleatorietà cui si faceva riferimento e il tetto alla capacità massima installabile – che è stata interpretata come una “presa di posizione” avversa al fotovoltaico – sono state più che sufficienti a deviare altrove l’entusiasmo (che pure abbiamo visto è rimasto intatto) degli operatori. Il caso della Grecia, infine, è estremamente significativo perché permette di chiarire come le tariffe feed-in , che pure sono leggermente diminuite nel corso del 2009 (-4% per gli impianti di medie dimensioni e –15% per le centrali fotovoltaiche), rappresentino solo uno degli aspetti da prendere in considerazione per analizzare l’impatto della normativa sullo sviluppo del settore. La crescita del mercato greco (con l’installato totale cresciuto del 188% rispetto al 2008) può essere infatti spiegata guardando a tre aspetti: • un importante “snellimento” burocratico, introdotto a partire dal 15 gennaio 2009, che ha consentito di “sbloccare” l’iter autorizzativo per gli impianti fotovoltaici, praticamente fermo dal marzo 2008 per problemi connessi all’interpretazione delle norme ed allo smaltimento delle domande arretrate; • un piano di incentivi ad hoc per i piccoli impianti residenziali (fino a 10 kW “a tetto”) che garantisce per 25 anni, ovvero per ulteriori 5 anni rispetto al resto degli impianti, una tariffa agevolata straordinaria di 0,55 €/kWh nel caso in cui al fotovoltaico vengano abbinati “sistemi di produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile” (ossia impianti solari termici); • la disponibilità, da cumulare alle tariffe feedin, di finanziamenti agevolati a copertura governativa sino al 40% del valore totale dell’investimento per impianti con un costo totale superiore a 100.000 €, corrispondenti circa a 25 kW di potenza. Appare quindi possibile tracciare – dando per scontato come più volte ricordato l’imprescindibile presenza di un sistema di tariffe feed-in sufficientemente remunerativo – un percorso di sviluppo “virtuoso” della normativa che interessa il settore fotovoltaico: • condizione indispensabile per garantire la crescita delle installazioni è la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione e l’allaccio alla rete degli impianti e di accesso ai meccanismi di incentivazione. La predisposizione di procedure chiare, facilmente comprensibili da parte dell’utente finale (soprattutto per quanto riguarda il segmento di mercato delle installazioni residenziali) e soprattutto omogenee sul territorio nazionale hanno storicamente rappresentato (in Germania e Spagna prima e di recente, come visto, in Grecia) un punto di snodo fondamentale per “accelerare” il numero di installazioni. I vantaggi di un sistema autorizzativo “snello” sono infatti molteplici: (i) per gli utenti residenziali esso rappresenta un segno inequivocabile di “trasparenza” del processo e favorisce quindi il superamento dell’inevitabile inerzia all’adozione di “nuove” tecnologie; (ii) per i gruppi industriali e gli investitori che hanno invece l’obiettivo di realizzare impianti di grandi dimensioni, la riduzione dei tempi di autorizzazione (conseguenza diretta e naturale della semplificazione procedurale) si traduce in minori costi di “immobilizzazione” del capitale e quindi – a parità di altre condizioni – maggiori ritorni attesi 15 Una centrale da 1 MW in Spagna assicura una produzione media annuale di 1.350.000 kWh/kW, contro i 900.000 kWh/kW di un analogo impianto installato in Germania. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 35 1. IL fotovoltaico redditizie e soprattutto più “pesanti” in termini dall’investimento16; (iii) per gli operatori del settore conta soprattutto l’omogeneità delle procedi ricadute occupazionali e sul tessuto economidure a livello nazionale, che facilita lo sviluppo di co ed imprenditoriale (si veda capitolo 1.4) – è competenze specifiche e l’elaborazione delle offerte quello di adeguare “progressivamente” il meccommerciali; canismo di tariffe feed-in , da un lato spingen• il passo successivo consiste nell’introduzione do le imprese a massimizzare la loro efficienza e di meccanismi di supporto – a livello locale, ma dall’altro “scremando” le operazioni che hananche qui meglio sarebbe disporre no come obiettivo la produzione di “Uno dei maggiori colli di bottiglia di strumenti validi su tutto il terrienergia da fonte solare da quelle in Italia per il fotovoltaico? Senza torio nazionale – che permettano di indubbio cui prevale invece una componente l’iter autorizzativo e la ridurre l’investimento necessario speculativa. macchina burocratica in alcuni casi anche soprattutto per le medie e grandi che rallentano, pesantemente, la messa E’ indubbio come questo sia anche il installazioni17. Affiancandosi alle in funzione dell’impianto” tariffe feed-in, questo tipo di incenpasso più delicato visto che, come inAmministratore delegato tivi favorisce un più rapido sviluppo segna il caso della Spagna uno scarto di un’impresa di distribuzione del settore e, soprattutto, un magtroppo “brusco” – anche se in parte giore bilanciamento nella presengiustificabile con i timori per i conti za di impianti di piccole e grandi dimensioni. pubblici – rischia di vanificare quanto fatto in preLa scelta greca, ad esempio, se confrontata con cedenza e danneggiare l’intero settore industriale del quella spagnola (che invece ha privilegiato con fotovoltaico nazionale. Una pianificazione di lungo il proprio sistema di tariffe quasi esclusivamente termine, accompagnata dalla capacità di tenere i grandi impianti) mette in evidenza la volontà “salda la barra” anche nei periodi di crisi, è presupdel governo nazionale di evitare eccessi nell’uno posto indispensabile per poter cogliere le opportunio nell’altro verso; tà del fotovoltaico ben sapendo (si veda paragrafo • il terzo passo – da attuarsi solo una volta che si 1.3.4) che il traguardo dell’indipendenza del settore sia sviluppata una filiera nazionale, sia nelle fasi dai sussidi governativi è – seppure ancora lontano – a valle che in quelle a monte, per certi versi più ormai in vista. Box 1.4 Il piano francese nel 2010 per il fotovoltaico Le nuove tariffe pianificate in Francia, a cui EDF acquisterà nel 2010 l’elettricità fotovoltaica – 0,602 €/kWh per gli impianti integrati ad alta valenza estetica, 0,45 €/kWh per gli impianti integrati con almeno 3 kW di potenza installata, da 0,328 a 0,394 per gli impianti con potenza superiore ai 250 kW a seconda del valore dell’irraggiamento e infine 0,328 €/kWh per tutti gli altri edifici – sono meno generose di quanto annunciato nell’estate 2009 da parte del Ministro dell’Ambiente francese. In realtà, le nuove tariffe stanno provocando una certa confusione, poiché prediligono le soluzioni architettonicamente integrate e di maggior pregio estetico, evidentemente minoritarie rispetto al potenziale delle installazioni e non sono definite in base alla potenza, e questo potrebbe portare ad avvantaggiare enormemente il settore delle centrali che hanno costi di investimento inferiori. A fine settembre la potenza installata nella Francia europea era di circa 174 MW. Le nuove tariffe, come detto, potrebbero attirare investitori esteri per il settore delle centrali. In particolare a giugno di quest’anno erano già state presentate richieste per 1,9 GW, con il rischio che possano manifestarsi investimenti speculativi come nel caso della Spagna. Un ulteriore ostacolo allo sviluppo del mercato francese proviene anche dalla complessità delle procedure di allacciamento, con tempi estremamente dilatati, che possono arrivare anche a 5 mesi per i piccoli impianti e a 10 per quelli di medie dimensioni (200 kW). Inoltre è stata presa la decisione – per evitare eccessivi aggravi di spesa da parte del Governo – di ammettere alle più generose tariffe del 2009, fra le innumerevoli richieste che ovviamente si sono avute nei mesi finali dell’anno, solo gli impianti che all’11 gennaio 2010 avessero già presentato richiesta di allacciamento alla rete. Inutile sottolineare come le previsioni di crescita del fotovoltaico in Francia nel 2010 sono state riviste al ribasso. Su questo punto si veda paragrafo 1.2.5, ove viene esplicitamente considerato questo “costo” di immobilizzazione del capitale. Nel mercato residenziale, infatti, è assai diffuso il meccanismo del “chiavi in mano” con l’investimento iniziale coperto attraverso la contrazione di un mutuo bancario, che viene ripagato con parte dei flussi di ricavo generati dalla produzione di energia elettrica dell’impianto una volta entrato in funzione, mentre per gli impianti di medio-grandi dimensioni non è ancora entrato a regime un meccanismo di questo tipo. 16 17 36 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa Box 1.5 Il Piano India L’annuncio ufficiale del Governo indiano – contenuto nel “Jawaharlal Nehru National Solar Mission” di fine 2009 – punta ad arrivare al 2020 a ben 20 GW fotovoltaici installati, che diverrebbero addirittura 100 GW al 2030. L’India, d’altra parte, ha un notevole potenziale, dovuto a: (i) una insolazione ottima; (ii) un forte bisogno di elettricità, con un deficit del 10-15% di fabbisogno elettrico e poco meno del 40% della popolazione (pari a 450 mln di persone) ancora senza corrente. Gli strumenti che verranno messi in campo per raggiungere l’obiettivo sono: (i) una tariffa feed-in di circa 0,28 €/kWh della durata di 25 anni per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica; (ii) una serie di incentivi, non ancora definiti, per gli impianti fotovoltaici off-grid; (iii) un sistema paragonabile ai nostri certificati verdi, associato all’obbligo per le utilities di ottenere dal sole almeno lo 0,25% dell’elettricità prodotta e immessa in rete al 2013 e il 3% al 2022. Già ora i progetti per la costruzione di centrali fotovoltaiche ini- ziano ad essere numerosi e alcune grandi imprese hanno dichiarato il loro interesse a localizzare nel Paese le proprie attività di produzione di celle e moduli. Rimane però un ostacolo alla realizzazione di questo piano. Vi è ancora forte incertezza infatti in merito alle modalità per recuperare i fondi necessari alla sua attuazione, circa 19 mld $ rispetto ai 900 mln $ che sono stati al momento reperiti. Per le risorse mancanti l’India fa affidamento al fondo internazionale per i Paesi in via di sviluppo (UNFCCC), che rende piuttosto incerta la prospettiva del programma sul lungo termine. Anche il finanziamento dei vari progetti potrebbe non essere così semplice, a causa dell’inesperienza del settore bancario in questo tipo di investimenti e per l’enorme ostacolo che potrebbe provenire dalle procedure autorizzative. Resta il fatto che l’Asia è certamente destinata a giocare nel futuro un ruolo di primo piano nelle settore delle energie rinnovabili a livello mondiale. E l’Italia? Certamente si trova di fronte alla decisione più critica per lo sviluppo del fotovoltaico. Intrapresa con ancora più decisione (con un potenziamento delle fasi del processo gestibili on line sul sito del GSE) la strada della semplificazione normativa, resta da decidere se imboccare la strada virtuosa tracciata dalla Germania, oppure seguire l’esempio spagnolo e “farsi travolgere” dalla crisi. In un contesto dove il settore del fotovoltaico diventa sempre più globale e con nuovi attori, non soltanto gli USA ma anche ad esempio l’India (si veda box 1.5), pronti a contendere all’Europa il primato industriale a livello mondiale, sino ad ora uno dei pochi di cui ci si può effettivamente vantare. 1.2.2. Le tariffe feed-in in Italia: un’analisi di benchmark europeo Il meccanismo di incentivazione del fotovoltaico in Italia attraverso tariffe feed-in, le cui principali caratteristiche sono riportate nel box 1.7 e, come Box 1.6 La normativa nei Paesi dell’Est europeo In Slovenia, da luglio 2009, è entrata in vigore la legge che prevede una tariffa incentivante compresa tra 0,39 e 0,48 €/kWh per le piccole installazioni e i sistemi architettonicamente integrati, con una crescita rilevante rispetto alla tariffa precedentemente in vigore (0,37 €/kWh). Per gli impianti con una potenza superiore ad 1 MW, la tariffa varia tra 0,29 €/kWh (se costruiti su aree edificabili) e 0,32 €/kWh (nel caso di installazioni su tetti). La tariffa è però soggetta ad un decremento annuale ed ha una durata di 15 anni contro i 10 previsti dalla legge precedente. La potenza cumulata totale non supera i 5 MW. In Bulgaria le tariffe feed-in in vigore nel 2009 sono suddivise a seconda della dimensione dell’impianto. Per impianti di potenza inferiore ai 5 kW, gli incenti- vi sono pari a circa 0,42 €/kWh; per impianti di taglia maggiore, le tariffe sono di 0,385 €/kWh. La durata dell’incentivo è di 25 anni, e la decurtazione è pari al 5% annuo. La potenza cumulata in Bulgaria a fine 2009 è di circa 20 MW. Lo Stato prevede di raggiungere i 140 MW nel corso del 2010. In Turchia, nel corso del 2009, è entrato in vigore un sistema di tariffe incentivanti che prevede 0,28 €/kWh per i primi dieci anni e 0,22 €/kWh per i dieci successivi. Il 2009 è il primo anno in cui è stato definito un programma nazionale di politiche incentivanti per il settore fotovoltaico. Per questo motivo, sebbene la potenza cumulata nel 2009 si sia attestata sui 2 MW, ci si aspetta per il 2010 un notevole incremento del mercato. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 37 1. IL fotovoltaico Box 1.7 Il Nuovo Conto Energia Il Nuovo Conto Energia è in vigore dal 19 Febbraio 200718 e fissa a 1.200 MW il limite massimo di potenza finanziabile a cui si aggiunge un periodo di proroga di 14 mesi per gli impianti di proprietà privata e di 24 mesi nel caso di Amministrazioni Pubbliche per l’installazione degli impianti già autorizzati prima del raggiungimento dei 1.200 MW. La ridefinizione del Nuovo Conto Energia da parte del Governo porterà ad un nuovo Decreto Ministeriale, attualmente in discussione, i cui effetti entreranno in vigore da Gennaio 2011. Le tariffe applicate nel 2009 e 2010 sono riportate in tabella 1.2 e sono il risultato del taglio del 2% annuo delle tariffe in vigore nel 2008. Esse hanno valore costante e sono garantite per 20 anni. Il Nuovo Conto Energia distingue tra impianto integrato (quando sostituisce alcuni elementi architettonici e coperture), parzialmente integrato (quando è installato su tetti piani o terrazze di edifici, oppure nel caso in cui risulti complanare a tetti e coperture) e non integrato (in tutti gli altri casi). Tabella 1.2 Tariffe incentivanti (€/kWh) definite dal Nuovo Conto Energia Tipologia di impianto fotovoltaico Non integrato Potenza nominale impianto (kW) Parzialmente integrato Integrato 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1≤P≤3 0,392 0,384 0,431 0,422 0,480 0,470 3 < P ≤ 20 0,372 0,365 0,412 0,404 0,451 0,442 P > 20 0,353 0,346 0,392 0,384 0,431 0,422 già anticipato, oggetto di profonda revisione a partire dal 2011, merita di essere messo a confronto in modo approfondito con quanto accade negli altri Paesi europei già presi a riferimento nel paragrafo precedente. Il confronto “puro” tra tariffe feed-in , quale quello presentato nella precedente tabella 1.2, rende infatti solo in parte merito delle effettive differenze nei meccanismi di incentivazione. Il sistema italiano ha infatti due peculiarità che lo rendono unico nel panorama europeo considerato: • è l’unico sistema a prevedere, oltre all’incentivazione assicurata dal Conto Energia ed erogata attraverso il GSE, la possibilità di vendita dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. In altre parole, mentre ad esempio in Spagna o in Francia la tariffa incentivante riportata in tabella 1.1 è onnicomprensiva anche della vendita dell’energia, in Italia è possibile per il produttore “negoziare” la vendita dell’energia ad un altro operatore della rete elettrica (o all’Acquirente Unico) sia direttamente che passando attraverso la Borsa Elettrica19. Questo significa, da un lato, che vi è un’altra componente di ricavo di cui tener conto per il produttore italiano di energia da fotovoltaico ma, dall’altro lato, che ricade su quest’ultimo anche il rischio “imprenditoriale”20 della variazione negli anni del prezzo dell’energia; • è l’unico sistema a permettere, per impianti sino a 200 kW di potenza (e quindi anche per clienti industriali o commerciali di medie dimensioni) il meccanismo dello “scambio sul posto”, che consente lo scomputo dalla bolletta elettrica “tradizionale” dei kWh prodotti dal’impianto fotovoltaico. In questo caso, all’incentivo alla produzione erogato dal GSE, si affianca un “mancato costo” che è tanto più significativo quanto più “energivora” è l’attività industriale o commerciale e quanto più concentrato è il consumo nelle ore centrali del giorno (per intenderci, quelle che ricadono in Fascia 1 della bollettazione)21. DM del 19/02/2007. Cfr. Solar Energy Report 2008, pp 42-43. 20 Sebbene negli ultimi anni il prezzo dell’energia abbia mantenuto un trend di crescita abbastanza stabile e quindi relativamente prevedibile, su un orizzonte di pianificazione ventennale è possibile si verifichino anche fenomeni di discontinuità nell’andamento dei prezzi, sia in positivo (e quindi a vantaggio del produttore da fonte fotovoltaica) sia in negativo. 21 Per un impianto industriale di media potenza il costo del kWh può andare dagli 0,18 €/kWh della Fascia 1 (ovvero quella che va dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì) agli 0,11 della Fascia 3 (dalle 23 alle 7, dal lunedì al venerdì) 18 19 38 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa incentivazione più bassi – quegli imOltre a queste peculiarità del sistema di incentivazione italiano, nel con- “Il Nuovo Conto Energia è senza pianti in aree maggiormente soggette dubbio uno dei migliori meccanismi a radiazione solare22 . fronto con gli altri Paesi europei è di incentivazione partoriti dai Governi italiani” necessario tener conto della diversa L’analisi condotta ha preso in considurata degli incentivi, che in Spagna Amministratore delegato di un’impresa produttrice derazione tutte le differenze soprasono di 25 anni contro i 20 degli aldi celle e moduli citate e i suoi risultati sono riportati tri Paesi del campione, e soprattutto nelle figure 1.7, 1.8 e 1.9, rappresendella diversa produttività degli imtative dei tre principali segmenti di mercato (resipianti dovuta all’insolazione media delle diverse denziale, industriale e centrali) e dove il prodotto aree: a parità di potenza ed efficienza dell’impianto tra incentivo, insolazione media e durata dell’in(e quindi di investimento), essendo l’incentivo lecentivo è fissato ad 1 per il caso italiano, in modo gato alla produzione di energia, sono infatti più avda rappresentare il termine di raffronto per gli altri vantaggiati dal punto di vista dei ritorni – e quinPaesi. di economicamente sostenibili anche per livelli di Figura 1.7 Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 3 kW Germania Spagna Francia Grecia Italia 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Valore normalizzato Italia=1 Figura 1.8 Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 100 kW Germania Spagna Francia Grecia Italia 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Valore normalizzato Italia=1 In Italia la producibilità media è pari a 1.200 kWh/kW e tiene conto dell’energia effettivamente prodotta e immessa in rete al netto delle perdite del sistema, contro le 900 ore della Germania, le 1.350 ore della Spagna, le 1.050 ore della Francia e le 1.250 ore della Grecia (dati elaborati da Photovoltaic Geographical Information System – PVGIS). 22 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 39 1. IL fotovoltaico Figura 1.9 Confronto tra le tariffe di incentivazione nei principali Paesi europei per un impianto da 1 MW Germania Spagna Francia Grecia Italia 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Valore normalizzato Italia=1 È d’obbligo sottolineare almeno due aspetti: • l’Italia, quasi sempre tallonata dalla Grecia, è il Paese europeo con il livello di incentivazione complessivo più elevato per ciascuna taglia di impianto; • la Germania è invece sempre e di gran lunga la più lontana, con livelli di incentivazione che, tenendo conto anche della minor insolazione, sono talora pari a poco più di metà di quelli italiani. Varie possono essere le interpretazioni di questa analisi comparativa, che si vogliono lasciare però alla riflessione autonoma del lettore, senza mancare però di suggerirne una “virtuosa”: l’esempio tedesco insegna che gli spazi di manovra – di cui tener conto per la già citata pianificazione di lungo termine – sono enormi e che il fotovoltaico, laddove il tessuto industriale del settore è più solido e maturo, già è in grado di sostenersi. La strada per raggiungere la Germania è però ancora lunga e riduzioni “brusche” verso quel livello di incentivi paiono in Italia troppo pericolose. 1.2.3 L’impatto del Nuovo Conto Energia sulle finanze pubbliche Nei precedenti paragrafi si è discusso come la revisione del Nuovo Conto Energia potrebbe tradursi in uno “stallo” del mercato italiano a partire dal 2011 (anno in cui il nuovo sistema di incentivazione attraverso tariffe feed-in entrerà in vigore) se si verificasse un insieme di condizioni analoghe 40 a quelle ad esempio riscontrate in Spagna. Come già anticipato nel Solar Energy Report 2008, c’è una seria preoccupazione in merito all’impatto negativo che questa brusca frenata del mercato avrebbe sulla filiera industriale italiana e sulle nostre imprese, che hanno effettuato consistenti investimenti in tecnologia e capacità innovativa negli ultimi anni. Al fine di supportare la revisione del Nuovo Conto Energia, è tuttavia necessario approfondire l’analisi dell’impatto che il sistema di incentivazione attualmente in vigore ha avuto, e avrà negli anni futuri, sulle entrate e le uscite di denaro che interessano le finanze pubbliche dello Stato. Solo in questo modo si avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari a prendere in modo oculato una decisione di politica industriale tanto importante per la competitività del nostro Paese in un comparto strategico, ad alta tecnologia e tasso di innovazione, come quello delle energie rinnovabili. L’obiettivo del paragrafo è di presentare e discutere i risultati di questa analisi. In particolare, l’indagine cercherà di confrontare le uscite per lo Stato (in parte coperte attraverso la componente A3 del costo del kWh sostenuto dalle famiglie italiane) dovute alle tariffe feed-in previste dal Nuovo Conto Energia, con le entrate per la nostra Pubblica Amministrazione (sia centrale che nelle sue articolazioni territoriali) derivanti dall’imposizione fiscale sull’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, dall’IVA sul valore aggiunto realizzato dagli operatori industriali sul territorio italiano, dalle imposte dirette che questi sono chiamati a corrispondere e da altre forme di ricaduta positive. Solo in questo modo si potrà avere un quadro completo di quanto il Nuovo Conto Energia “costi” effetti- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa vamente alle finanze pubbliche e di quanto quindi la revisione al ribasso delle tariffe sia “sostenibile” negli anni a venire. Determinare l’ammontare delle uscite per le finanze della Pubblica Amministrazione è relativamente semplice, dato che esse dipendono dall’entità della tariffa incentivante (valore costante e, come noto, influenzato dalla potenza nominale e dalla tipologia di impianto fotovoltaico) che lo Stato si impegna a riconoscere per 20 anni e dalla quantità di energia prodotta dagli impianti che sono stati ammessi al Nuovo Conto Energia (facilmente stimabile conoscendo i livelli di producibilità medi degli impianti fotovoltaici localizzati a diverse latitudini). Ben più complesso è invece stimare l’ammontare delle entrate per lo Stato, dal momento che i fattori in gioco sono molteplici e le ipotesi semplificative che è necessario introdurre particolarmente delicate. Nella stima che è stata effettuata, si sono considerate le seguenti voci di entrate ed ipotesi semplificative e di lavoro: • imposte dirette (IRES e IRAP) corrisposte dalle imprese italiane (e da quelle straniere con sede produttiva o commerciale in Italia per quanto di competenza) operanti nelle diverse fasi della filiera (produzione di componenti e tecnologie, produzione di celle e moduli, distribuzione e installazione) in funzione del reddito d’esercizio realizzato sul mercato italiano. Questa stima è stata effettuata considerando la marginalità media delle aziende operanti nelle diverse aree di business della filiera, rilevata attraverso l’analisi del loro bilancio e le interviste con i principali player, l’entità del volume d’affari realizzato sul mercato italiano ed il peso dell’imposizione fiscale nel nostro Paese. La scelta di considerare questa specifica voce di entrata è giustificata dal fatto che il Nuovo Conto Energia è stato, e continuerà ad essere anche nei prossimi anni (considerata la distanza che ancora ci separa dalla grid parity in Italia), una condizione imprescindibile per la nascita e l’esistenza di imprese italiane e non che operano con unità produttive o commerciali nel nostro Paese. Senza il fondamentale contributo del Nuovo Conto Energia, non esisterebbe un mercato e non sarebbero nate di conseguenza imprese o siti produttivi che generano redditi e quindi entrate per le finanze pubbliche. • le imposte dirette (IRES e IRAP) pagate dalle imprese che detengono la titolarità di impianti fotovoltaici sul reddito generato dall’esercizio dell’impianto stesso. Nel determinare l’ammontare di tale reddito imponibile sono state condotte accurate simulazioni sulla redditività media degli impianti fotovoltaici di diversa taglia ed installati in diverse aree del nostro Paese (si tratta delle medesime simulazioni su cui si basano le analisi riportate nel paragrafo 1.2.5). Sono poi state consultate e considerate le norme che disciplinano come e in quali condizioni il risparmio di costo determinato dall’auto-consumo dell’energia elettrica prodotta e i ricavi dalla vendita di energia e dalla tariffa incentivante concorrono a determinare il reddito d’impresa.23 La stima dell’ammontare complessivo di queste imposte ha infine richiesto un’analisi del numero di impianti installati, per le diverse taglie di potenza e tipologie, nonché della loro distribuzione geografica. • oltre alle imposte dirette di cui all’ultimo punto, è stato stimato anche il flusso di denaro in ingresso alle casse dello Stato derivante dal pagamento dell’ICI da parte delle imprese che detengono la titolarità di impianti fotovoltaici a terra. L’assunzione di fondo è stata che la norma che disciplina l’applicazione dell’ICI agli impianti fotovoltaici realizzati a terra24, ad oggi applicata ancora in modo non uniforme sul territorio italiano ed oggetto di diverse interpretazioni giuridiche, sia chiarita ed entri effettivamente in vigore. Si è assunto un valore medio di imposizione fiscale pari al 4 per mille e si è proceduto alla stima della superficie coperta dagli impianti fotovoltaici a terra in funzione della loro potenza. • è stata anche considerata l’IVA (al 10%) che i titolari degli impianti fotovoltaici di taglia superiore a 20 kW sono chiamati a versare25 sull’energia venduta. Per realizzare questa stima è stato sufficiente calcolare l’energia prodotta e in media venduta dagli impianti in esercizio di taglia superiore ai 20 kW e valorizzarla al prezzo corrente di mercato. • il calcolo ha incluso anche l’IVA (anche in questo caso al 10%)26 sul valore aggiunto generato dalle imprese (italiane e straniere con realtà produttive in Italia) operanti nelle diverse fasi della filiera industriale nel servire il mercato italiano. Circolare n. 46/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2007. Risoluzione n. 3/2008 emanata dall’Agenzia del Territorio. Circolare n. 46/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2007. 26 Circolare n. 46/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2007. 23 24 25 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 41 1. IL fotovoltaico • infine, si è proceduto anche con il calcolo delle entrate per lo Stato o, meglio, delle mancate uscite, dovute alle tonnellate di CO₂ che gli impianti fotovoltaici in esercizio evitano che siano immesse in atmosfera. Il calcolo è stato effettuato considerando il valore medio dei titoli di emissione di CO2, pari a 15 €/tonnellata, che ogni Stato deve acquistare nel caso superi il limite nazionale stabilito di concerto con l’Unione Europea27. Ovviamente focalizzarsi esclusivamente su queste voci porta ad una stima per difetto delle entrate per lo Stato, dato che diverse altre esternalità positive vengono trascurate per l’impossibilità di stimare il loro impatto con un accettabile livello di confidenza. Oltre a ciò, esistono dei benefici che non è possibile quantificare e valorizzare tra le “entrate”, ma che hanno ugualmente una significativa importanza da un punto di vista sociale o di altra natura. Un esempio emblematico è rappresentato dall’occupazione, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo 1.4.9. La filiera industriale italiana del fotovoltaico dà lavoro ad un numero di persone, che si stima possa crescere in modo significativo negli anni a venire, ovviamente solo nel momento in cui non si verifichi il tanto temuto “stallo” del mercato fotovoltaico cui si è fatto cenno anche in questo paragrafo. Oltre a rappresentare un fenomeno con una significativa importanza sociale, la crescita dell’occupazione porta più denaro nelle “casse” dello Stato nella forma di maggiori imposte da lavoro dipendente. Un altro beneficio non quantificabile del Nuovo Conto Energia è legato alla sua capacità di favorire lo sviluppo di competenze in ambiti tecnologici all’avanguardia, di cui potrebbero beneficiare in futuro altri comparti industriali in Italia e la competitività del Paese nel suo complesso sulla scena internazionale. Venendo alle stime oggetto di questo paragrafo, una prima interessante analisi considera le uscite per lo Stato (anche se formalmente in capo al GSE) derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico. In tabella 1.3 sono riportati i risultati della valutazione per impianti di diversa taglia e tipologia costruttiva, che si ipotizza installati nel corso del 2009 in diverse zone del Paese (Nord, Centro e Sud), ciascuna delle quali ha un caratteristico livello medio di irraggiamento. Si nota come il valore attualizzato degli incentivi che lo Stato si impegna a riconoscere al titolare dell’impianto per 20 anni passi da circa 16.000 € per un impianto residenziale parzialmente integrato da 3 kW, fino ad arrivare a più di 4 mln € per una centrale fotovoltaica da 1 MW realizzata a terra (nel caso di installazione nel Centro Italia). L’impegno economico che, per effetto del Nuovo Conto Energia, lo Stato si assume in occasione dell’installazione di un nuovo impianto non è irrilevante, specie se confrontato con l’investimento medio richiesto all’investitore, che per un impianto residenziale da 3 kW è di circa 15.000 €, mentre per un grande impianto da 1 MW può arrivare anche a superare i 2,5 mln €. Questo dato suggerisce, unitamente alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, come esistano degli spazi di snellimento dell’attuale sistema di incentivazione senza che esso si traduca necessariamente in una drastica riduzione delle installazioni. Una valutazione compiuta del bilancio per le “casse” della Pubblica Amministrazione del Nuovo Conto Energia, come accennato in precedenza, non può tuttavia prescindere dallo stimare le entrate che l’installazione di nuovi impianti assicura allo Stato. Considerando il caso della centrale fotovoltaica da 1 MW (per cui è possibile effettuare delle stime maggiormente affidabili), è possibile calcolare un valore attualizzato complessivo delle entrate pari a circa 1,5 mln €28. Questo suggerisce che l’impatto “netto” sulle “casse” dello Stato non supera i 2,5 mln €, impatto che nella realtà potrebbe essere ancora inferiore se si considerassero anche le numerose ricadute positive di difficile quantificazione di cui si è parlato in precedenza (in termini, ad esempio, occupazionali). Questo indica che, a parità di impatto netto sulle risorse pubbliche della versione rivista del Nuovo Conto Energia che il Governo sarà disposto a tollerare per favorire un’ulteriore crescita del mercato e della filiera fotovoltaica in Italia, è possibile innalzare in modo anche sensibile le tariffe feed-in (rispetto al valore che si potrebbe calcolare considerando solo l’impatto “in uscita” del sistema di incentivazione), potendo contare su un consistente flusso di risorse finanziarie in entrata. È possibile approfondire questa analisi ampliandone la prospettiva per confrontare l’ammontare complessivo delle entrate e uscite per le “casse” Borsa Europea di Diritti di Emissione di Diossido di Carbonio (SENDECO2). Rispetto alle voci di entrata discusse in precedenza, in questo calcolo non sono state considerate le imposte dirette corrisposte dalle imprese della filiera in quanto, adottando il singolo impianto come unità d’analisi, questo tipo di valutazione perde di significato. 27 28 42 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa Tabella 1.3 Uscite per lo Stato relative al pagamento delle tariffe feed-in per alcuni impianti “tipo” installati nel 2009 3 kW 200 kW 1 MW Livello di integrazione Parzialmente Integrato Parzialmente Integrato Non Integrato Tariffa incentivante [€/kWh] 0,4312 0,392 0,3528 Area geografica Nord Centro Nord Nord Centro Sud Nord Centro Sud Produzione annua [kWh] 3.000 3.600 4.200 200.000 240.000 280.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Costo annuo per lo Stato [€] 1.294 1.552 1.811 70.560 84.672 98.784 352.800 423.360 493.920 Costo totale attualizzato per lo Stato [€] 13.704 16.445 19.186 745.514 897.016 1.046.519 3.737.568 4.485.082 5.232.596 trate per lo Stato, il “costo netto” reale è però andello Stato “di competenza” dell’anno 2009 (si concora inferiore. Questo senza contare le esternalità siderano quindi anche, nel calcolo delle imposte di natura sociale ed intangibile di cui si è detto in corrisposte dalle imprese che gestiscono impianti precedenza. È fondamentale però notare che la refotovoltaici, gli impianti installati prima del 2009 visione al ribasso delle tariffe incentivanti è oltre e, tra le uscite, gli incentivi corrisposti agli impianche inevitabile anche assolutamente necessaria. ti entrati in esercizio prima del 2009). A fronte di Il minore “peso” sulle finanze pubbliche dovuto uscite complessive “di competenza” stimabili all’applicazione di tariffe incentivanti più basse, nell’ordine di 450 mln €, le entrate calcolate in sarà tuttavia bilanciato dalle minori entrate dovubase alle assunzioni descritte in precedenza amte al fatto che il livello di installazioni raggiunto montano a poco più di 300 mln €. Questo signirisulterà inevitabilmente inferiore a quanto ipofica che il “costo netto” del Nuovo Conto Energia tizzato nello scenario utilizzato come riferimento con riferimento all’anno 2009, che nei fatti ricade nell’analisi. sulla collettività, si attesta intorno ai 150 mln €. Ipotizzando invece un trend di sviluppo del merAttraverso le analisi sviluppate in questo paragrafo cato italiano che porti l’installato, da qui al 2015, a si è inteso fornire un quadro di riferimento per supsalire ad un livello di potenza pari a 8 GW (l’orizportare il dibattito in merito alla revisione del Nuovo zonte di riferimento e il tetto di potenza installata Conto Energia attualmente in atto presso i Ministeri sono mutuati dalla proposta di revisione del Nuovo competenti. Le riflessioni riportate Conto Energia fatta dalle associazioni suggeriscono la necessità, nel valutare di categoria e riportata nel paragrafo “La differenza tra entrate la convenienza di un prolungamento, successivo), e considerando invariato ed uscite per lo Stato il livello di tariffe incentivanti previste non è così elevata come spesso ancorché con tariffe ridotte, dell’attuasi è portati a ritenere” le schema di incentivazione, di adotdall’attuale Nuovo Conto Energia, il Marketing Manager tare un approccio omnicomprensivo valore attualizzato complessivo delle di un importante EPC contractor che consideri anche le ricadute positiuscite per lo Stato nel periodo 2010ve in termini di maggiori entrate per 2015 è stimabile nell’ordine di 4 mld la finanza pubblica che esso consente di realizzare. €, a fronte di un ammontare complessivo di entraDetto altrimenti, anche tralasciando le ricadute pote attualizzato pari a circa 3 mld €. Questo signifisitive in termini di contributo al raggiungimento dei ca che, anche se il Governo decidesse di prolungare livelli di produzione di energia da fonte rinnovabili nella sua versione attuale il Nuovo Conto Energia stabiliti a livello europeo e di miglioramento della e si raggiungesse una potenza installata pari al licompetitività del nostro Paese in un settore critico vello sopracitato, il valore attuale del costo per lo per lo sviluppo economico degli anni a venire, esiStato sarebbe di circa 1 mld €. Considerando che stono dei benefici immediatamente quantificabili la nostra analisi sottostima l’ammontare delle en- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 43 1. IL fotovoltaico ed innegabili associati al prolungamento del Nuovo Conto Energia, che rendono l’impatto di quest’ultimo sulle finanze pubbliche e, di conseguenza, sulla collettività intera, maggiormente sostenibile. 1.2.4 Un quadro sugli incentivi e la normativa a livello regionale Come è stato discusso precedentemente in questo capitolo, il sistema di incentivi attraverso tariffe feed-in previsto dal Nuovo Conto Energia ha avuto e tuttora ha un ruolo fondamentale nello stimolare la crescita delle installazioni fotovoltaiche in Italia e nel contribuire alla nascita di imprese italiane che riescono ad essere competitive sul mercato interno e non solo. Nel Solar Energy Report 2008 si sottolineava tuttavia l’importanza, per il sistema Paese, che il framework di supporto al fotovoltaico comprendesse anche degli incentivi, nella forma ad esempio di sgravi fiscali, contributi in conto capitale o in conto interessi, destinati a: • gli attori “a monte” della filiera del fotovoltaico, ossia i produttori di silicio, celle e moduli, e componenti, per favorire le loro attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo delle nuove tecnologie fotovoltaiche; • gli investitori, sia famiglie che imprese private o Pubbliche Amministrazioni, per contribuire a superare la barriera rappresentata dall’elevato livello di investimento iniziale necessario per installare un impianto fotovoltaico. A questo si aggiungeva la convinzione, anch’essa chiaramente espressa nel Solar Energy Report 2008, dell’importanza di una maggiore uniformità territoriale, in termini di procedure autorizzative e di allacciamento alla rete, affinché si realizzi uno sviluppo “sano” del mercato, scevro da comportamenti di natura speculativa da parte degli operatori. Alla luce di queste considerazioni, nel presente paragrafo si approfondisce il ruolo che l’Amministrazione Pubblica centrale e le sue emanazioni locali (con particolare riferimento alle Regioni) hanno rivestito e stanno tuttora rivestendo in Italia nell’affiancare alle tariffe feed-in del Nuovo Conto Energia strumenti efficaci che vadano incontro alle esigenze espresse sopra. È stata innanzitutto condotta una ricerca sui fondi (nella forma di finanziamenti totali o parziali in conto capitale o in conto interessi e di finanziamenti di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) stanziati dai principali ministeri competenti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico), dalle Regioni, dalle Province, dai principali Comuni (in particolare i Capoluoghi di Provincia) e dalle Camere di Commercio per favorire l’investimento in nuove tecnologie da parte delle imprese “a monte” della filiera e per agevolare l’investimento in impianti fotovoltaici da parte di privati cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. La ricerca si è focalizzata sui bandi di finanziamento emanati nel periodo 2007-2009 e con uno stanziamento complessivo superiore a 100.000 €. L’analisi ha evidenziato l’esistenza di più di 50 bandi di finanziamento focalizzati sul fotovoltaico, per uno stanziamento complessivo superiore ai 320 mln €. A questi si aggiungono tuttavia oltre 60 bandi (per un valore Figura 1.10 Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione dei soggetti istituzionali promotori 1,8% Ministro dell’ambiente 8,8% Regioni 53,8% 35,6% Province Comuni 44 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa degli stanziamenti a favore di cittadini privati complessivo degli stanziamenti vicino ai 390 mln (che ammontano a quasi 135 mln €), seguiti dai €) che, avendo come focus le tecnologie energetiche finanziamenti per le imprese (che ammontano a alternative e rinnovabili, hanno contribuito a fipoco meno di 125 mln €, di cui quasi metà relativi nanziare anche le imprese e gli investitori del coma stanziamenti per ricerca industriale e sviluppo di parto fotovoltaico. Questo lascia intendere come nuove tecnologie) e quindi da quelli alle Pubbliche la Pubblica Amministrazione abbia, negli ultimi 2 Amministrazioni (per quasi 70 mln €). Da questa anni, seriamente considerato l’importanza di supanalisi emerge come questi incentivi addizionali portare la crescita dell’installato e della filiera fotorispetto al Nuovo Conto Energia siano comunque voltaica attraverso stanziamenti complementari al fortemente sbilanciati a favorire l’installazione di Nuovo Conto Energia. nuova potenza fotovoltaica, rispetto alla ricerca Approfondendo l’analisi e concentrandosi esclue messa a punto di nuove tecnologie sivamente sui bandi focalizzati sulla tecnologia fotovoltaica, dall’anali- “Le Regioni e le Province hanno che possano aiutare le nostre imprese si della figura 1.10 (che mostra il dedicato una parte consistente a ritagliarsi una posizione di leaderdelle loro risorse, nel corso del ship sulle tecnologie di futura generapeso relativo dei principali soggetti 2008 e del 2009, a sostenere il comparto del fotovoltaico” zione. Va detto tuttavia che le aziende finanziatori misurato rispetto allo del fotovoltaico possono beneficiare, a stanziamento complessivo di risorse Marketing Manager di un’impresa che opera nella distribuzione supporto dei loro investimenti in rifinanziarie), emerge come le Regioni cerca industriale, di stanziamenti dee, in seconda battuta, le Province, stinati in modo più ampio alle energie alternative e abbiano avuto un ruolo critico nel promuovere rinnovabili, nonché di fondi che provengono dalla questo tipo di interventi, essendo responsabili Unione Europea. complessivamente di quasi il 90% dei fondi messi a disposizione. È stato quindi approfondito il ruolo delle diverse Regioni nel panorama di questi stanziamenti comLa figura 1.11 riporta invece una ripartizione plementari al Nuovo Conto Energia, considerato delle risorse finanziarie stanziate in funzione dei il loro peso rilevante cui si è accennato in precesoggetti destinatari di queste misure, distinguendo denza. La figura 1.12 riporta la ripartizione deltra privati cittadini (interessati a finanziamenti a le risorse finanziarie indirizzate al fotovoltaico in supporto dell’investimento nell’impianto), imprebase alla Regione che le ha stanziate. È interessanse private (interessate sia a finanziamenti per l’inte notare una forte disuniformità in questi dati, vestimento in impianti che per attività di ricerca con realtà quali la Sardegna, il Lazio, la Sicilia, industriale e sviluppo sperimentale) e Pubbliche il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Amministrazioni (alle quali i bandi hanno messo a che hanno messo a disposizione un ammontare disposizione risorse per la realizzazione di impiandi risorse fortemente superiore rispetto ad altre ti fotovoltaici, ad esempio, in ospedali o complessi Regioni quali la Toscana, il Veneto o le Marche. scolastici). Dai dati emerge una preponderanza Figura 1.11 Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione dei soggetti destinatari 21% Privati cittadini 41% 38% Imprese private Enti Pubblici www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 45 1. IL fotovoltaico Figura 1.12 Ripartizione degli stanziamenti destinati al settore fotovoltaico in funzione della Regione promotrice 1,5% 2,2% 9,9% 1,1% 20,0% Sicilia Lombardia Calabria Emilia Sardegna Piemonte Liguria Trentino Altre 10,5% 10,1% 14,1% 12,4% 16,8% Lazio 1,4% Più che rispecchiare una diversa distribuzione della ricchezza e del PIL pro-capite, queste difformità si spiegano con una diversa attenzione e sensibilità da parte degli amministratori locali al tema dell’ambiente ed alle potenzialità della tecnologia fotovoltaica in funzione delle peculiarità territoriali. Le Regioni del Sud Italia e in particolar modo le isole si sono rese responsabili di oltre il 45% degli stanziamenti complessivi, mentre quelle del Nord e del Centro di circa il 27-28%. Un secondo aspetto che è stato approfondito riguarda le diversità esistenti in termini di procedure a livello locale per l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Come descritto nel Solar Energy Report 2008, l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto fotovoltaico è regolata innanzitutto dal Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03. Esso prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad un’autorizzazione unica che deve essere rilasciata dalla Regione o dalla Provincia, se delegata dalla prima, entro 180 giorni dalla richiesta. Le linee guida per lo svolgimento di questa autorizzazione unica avrebbero dovuto essere fissate attraverso un apposito Decreto cha ancora non è stato emanato. Al momento, perciò, esistono ancora delle forti disuniformità a livello Regionale. La Legge Finanziaria 2008 ha sancito la possibilità di realizzare impianti fino a 20 kW di potenza di picco attraverso la sola Denuncia di Inizio Attività (DIA), se non situati in aree o siti protetti da vincoli ambientali o paesaggistici, nel qual caso sono richiesti i necessari permessi integrativi a livello territoriale. Questo vale tuttavia salvo diversa indicazione prevista dalle leggi re- 46 Puglia gionali, che spesso introducono delle difformità non irrilevanti. Esistono ad esempio delle Regioni che hanno delegato le Province a definire le linee guida per l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto. È il caso ad esempio del Friuli Venezia-Giulia, della Toscana e della Lombardia. Sebbene nella maggioranza dei casi le Province delle Regioni in questione si adeguino alla normativa esistente a livello nazionale, per cui sono esclusi da screening VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) gli impianti di potenza inferiore a 20 kW, esistono tuttavia delle difformità che complicano notevolmente l’attività di sviluppo cui sono costretti gli investitori che intendono operare in queste aree del nostro Paese. Alcune Regioni hanno invece esteso il limite di potenza entro cui è sufficiente la sola DIA a specifiche tipologie di impianti. Ad esempio, in Calabria la DIA è sufficiente per impianti fino a 500 kW purché integrati nei tetti degli edifici (industriali, agricoli, commerciali e destinati ai servizi), mentre in Lazio per impianti fino a 200 kW installati sulle coperture di edifici agricoli e industriali. In Sicilia la DIA è sufficiente per impianti fino a 200 kW purché operino in regime di scambio sul posto e per impianti di potenza inferiore ad 1 MW, ma totalmente o parzialmente integrati in edifici pubblici. La semplice DIA in Sardegna e in Veneto si applica anche a tutti gli impianti di taglia superiore ai 20 kW che sono totalmente o parzialmente integrati. In altri casi la VIA è richiesta solamente per impianti di taglia sensibilmente superiore, tipicamente 1 MW, come accade ad esempio in Basilicata. In Puglia questo limite è stato addirittura innalzato a 10 MW attraverso la Legge Regionale 20/2009. In altri casi www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa ancora la procedura varia in funzione dell’estensione dell’impianto. Ad esempio nelle Marche lo screening VIA è obbligatorio esclusivamente per gli impianti fotovoltaici con un estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, mentre nella già citata Basilicata sono esclusi dalla VIA anche gli impianti di taglia superiore ad 1 MW, purché totalmente e parzialmente integrati e di superficie inferiore ai 2.000 metri quadrati. Per quanto riguarda le altre Regioni non citate in questo paragrafo, non esistono delle disposizioni specifiche che modifichino la procedura definita a livello nazionale, per cui l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto prevede lo screening VIA per tutti gli impianti di taglia superiore a 20 kW. Queste sostanziali difformità nelle procedure di autorizzazione hanno necessariamente un impatto sullo sviluppo del fotovoltaico a livello regionale, come si avrà modo di discutere anche nel paragrafo 1.3.2, e suggeriscono come ci sia ancora molto da fare affinché questo importante vincolo ad una crescita più “sana” ed uniforme del fotovoltaico nel nostro Paese possa essere rimosso. 1.3.3), è verosimile che il limite di 1.200 MW sia raggiunto prima del 31/12/2010 (una recente stima del GSE ritiene che ciò potrà accadere già dal luglio di quest’anno). Considerando il periodo di proroga di cui si è fatto cenno in precedenza, le tariffe incentivanti riviste entreranno nella pratica in vigore a partire dalla seconda metà del 2011. Il dibattito in merito alla revisione del Nuovo Conto Energia presso i Ministeri competenti è entrato nel vivo nell’estate del 2009, e sta proseguendo nei mesi in cui il presente rapporto viene redatto. Inizialmente, il Decreto che definisce il nuovo schema di incentivazione era previsto entro la fine del 2009. Gli operatori del mercato e le loro associazioni sperano che esso venga promulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico in tempi brevi, in modo da limitare l’incertezza che attualmente circonda gli investimenti nella realizzazione di nuovi impianti, ma, soprattutto, in capacità produttiva. La revisione delle tariffe verrà realizzata, come previsto dal Nuovo Conto Energia, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici. Le tariffe subiranno quindi un ribasso, che è giusti1.2.5 La revisione del Nuovo Conto ficato sostanzialmente dal progresso tecnologico Energia e dalle economie di scala che negli anni hanno portato ad una riduzione consistente del prezzo Come previsto dal Comma 3 dell’Articolo 6 del dei componenti chiave di un impianto fotovoltaiDecreto Ministeriale del 19/02/2007, noto come co. Questo taglio si aggiunge alla riduzione delle Nuovo Conto Energia, a partire dal 2009 il Ministero tariffe già prevista dal Nuovo Conto Energia, che dello Sviluppo Economico è chiamato ad emanare aveva istituito un abbassamento del 2% annuo dei decreti con cui si ridefiniscono le tariffe indell’ammontare dell’incentivo per gli impiancentivanti l’energia prodotta da impianti fotovolti che sarebbero entrati in esercizio a partire dal taici che entreranno in esercizio negli anni suc2009. Questo adeguamento delle tariffe feed-in cessivi al 2010. L’attuale sistema di incentivazione al ribasso, che riflette quanto accaduto in altri rimarrà in vigore quindi fino al termine del 2010, Paesi europei quali Germania, Spagna e Francia, a meno che non si raggiunga prima il limite di poè assolutamente necessario per limitare comportenza massima incentivabile attravertamenti fortemente speculativi ed so il Nuovo Conto Energia fissato a evitare che gli operatori di mercato “E’ corretto diminuire le tariffe 1.200 MW. Il Comma 2 dell’Articolo previste dal Nuovo Conto Energia, realizzino delle marginalità superioma non ci dimentichiamo cosa 13 del suddetto Decreto Ministeriale, ri alla media potendo far leva su un successo in Spagna. Abbiamo tuttavia, prevede che in aggiunta agli èfiducia sistema incentivante eccessivamente nel lavoro del Governo e impianti che concorrono al raggiun- pensiamo che ci possa essere un generoso. Tuttavia, come già rilevato gimento del limite di potenza di 1.200 ampio margine di discussione e nel Solar Energy Report 2008, l’enconfronto” MW, hanno diritto alle tariffe incentitità del taglio avrà una ripercussiodi un fondo di investimento vanti tutti gli impianti che entreranno Managerattivo ne molto importante non solo, come nel fotovoltaico in esercizio entro 14 mesi dalla data ovvio, sul livello e sulla tipologia di nella quale verrà raggiunto il limite di installazioni che si realizzeranno in potenza. Questo termine è elevato a 24 mesi per gli futuro nel nostro Paese, ma anche sul nascente impianti i cui soggetti responsabili sono pubblici. sistema industriale italiano e sulla filiera intera. Considerando il livello di potenza incentivata al Considerato che la grid parity in Italia è ancora termine del 2009 e le previsioni di crescita delle indi là da venire, a meno di alcune realtà geografistallazioni nei prossimi mesi (si veda paragrafo che specifiche (quali ad esempio la Sicilia, di cui www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 47 1. IL fotovoltaico (impianto residenziale da 3 kW architettonicamenspesso si parla come ormai prossima alla parità), te integrato, impianto ad uso industriale da 200 una riduzione eccessiva delle tariffe feed-in rikW non integrato, e centrale fotovoltaica da 1 MW schierebbe di non rendere più economicamente non integrata) e si è proceduto a calcolare il Tasso conveniente l’installazione di nuovi impianti, Interno di Rendimento (TIR o IRR) dell’investiinterrompendo di fatto la crescita del mercato. mento in ciascuno di questi impianti nel 2011. I Oltre ad avere un impatto negativo sulla capacidati e le ipotesi di lavoro necessari per procedere tà dell’Italia di raggiungere gli obiettivi che si è con il calcolo dell’IRR dei tre impianti sono stati prefissata in termini di produzione di energia da raccolti attraverso la consultazione di numerosi fonte rinnovabile rispetto al consumo totale, ciò operatori del settore (system integrator, EPC conrischierebbe di mettere fuori mercato molti degli tractor, istituti di credito) e sono state validate atoperatori italiani (produttori di celle e moduli, traverso la partecipazione a diversi tavoli di lavoro system integrator, EPC contractor, distributori) indetti dalle principali associazioni di categoria che negli ultimi anni hanno investito consistenti che patrocinano il presente studio. La tabella 1.4 risorse nell’ampliare la propria capacità produtriporta le principali ipotesi di lavoro adottate per tiva, le proprie competenze e la propria presenza ciascun impianto “tipo”. sul territorio. Queste imprese, salvo alcune eccezioni, non hanno ancora la capacità di competere Adottando le ipotesi riportate in tabella 1.4, la con successo sui mercati europei ed internazionatabella 1.5 fornisce un’indicazione della reddili: un crollo del mercato interno le metterebbe tività assicurata dalle diverse tipologie di impianti in seria difficoltà, con conseguenze altrettanto installati nel corso del 2009. negative anche sull’occupazione potenziale che esse sarebbero in grado di assicurare negli anni Si è proceduto quindi con il calcolo dell’IRR e con a venire. Un brusco crollo del mercato, analogo a la stima del valore che esso assumerebbe nel 2011 quello delineato in questo paragrafo, si è verificacon diversi livelli di tariffe incentivanti. I risultati to in Spagna nel corso del 2008, quando a fronte di questa simulazione sono sinteticamente riportadi una diminuzione significativa del livello di inti nelle figure 1.13, 1.14 e 1.15. centivi (pari in media al 22% delle tariffe) e ad un tetto massimo della potenza incentivabile fissato Innanzitutto si nota come, nel caso a 500 MW, si è assistito ad un vero e venisse mantenuto inalterato il livello proprio blocco del mercato. Nel caso “Non ci possiamo certamente di incentivazione previsto dal Nuovo della Spagna, il tessuto industriale lamentare dei rendimenti Conto Energia (considerando quindi del fotovoltaico, come risultato di e dei tempi di ritorno dell’investimento che si sono un mercato da alcuni anni in forte registrati nel 2009 nel settore la riduzione annua del 2% delle tariffe feed-in a partire dal 2009), la redditiespansione, comprendeva imprese residenziale” vità dell’investimento in un impiancon una elevata esperienza nel settoMarketing Manager di un’impresa to fotovoltaico nel 2011, specialmente re. Questo ha permesso agli operatori che opera come system integrator in quei casi in cui il titolare dell’imlocali più forti di espandere notevolpianto auto-consuma una parte conmente il proprio raggio di attività nel sistente dell’energia elettrica prodotta (cosa che 2009 ad altri Paesi europei, tra cui anche l’Italia, accade tipicamente negli impianti residenziali e in in cui le installazioni registravano ancora tassi quelli ad uso industriale), sarebbe del 26% per un di crescita consistenti. Per i motivi sopra esposti, impianto da 3 kW e di circa il 19% per un impianto questo difficilmente potrà accadere per le imprese da 200 kW. Principalmente questo si spiega da un italiane (eccetto alcuni casi). lato con il progresso tecnico che negli ultimi anni Alla luce di queste considerazioni, l’obiettivo ha significativamente ridotto il costo dei principali dell’analisi è quello di esaminare l’impatto che dicomponenti dell’impianto (il costo totale tecnico di versi livelli di riduzione delle tariffe incentivanti un impianto da 200 kW nel 2008 era mediamente potrebbero avere nel 2011 sulla redditività assopari a 4.500 €/kW, mentre oggi si possono trovare ciata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. offerte anche a livelli decisamente inferiori a 3.800 L’assunzione di fondo è che una riduzione eccessiva €/kW). Oltre a ciò, un ruolo rilevante è rivestito delle tariffe renderebbe non più conveniente l’indall’andamento del prezzo di acquisto dell’enervestimento in nuovi impianti fotovoltaici, detergia elettrica, tanto per l’utenza domestica quanto minando nei fatti l’interruzione della crescita della per quella industriale, che negli ultimi anni (come potenza installata. Da un punto di vista metodoillustrato anche nel Solar Energy Report 2008) logico, sono stati selezionati degli impianti “tipo” 48 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa Tabella 1.4 Ipotesi di lavoro adottate per ciascun impianto “tipo” relative all’anno 2009 3 kW 200 kW 1 MW Costo totale dell’impianto 5.500 €/kW 3.800 €/kW 3.200 €/kW Utilizzo dell’energia prodotta Autoconsumo Autoconsumo/Vendita Vendita Leva finanziaria 100% 75% 75% Costi di connessione alla rete elettrica 305 € 40.000 € 75.250 € Altri costi accessori (manutenzione, assicurazione, …) 448 €/anno 15.200 €/anno 48.000 €/anno Costi opportunità - Costi opportunità del capitale e da mancata produzione per la durata media del processo di allacciamento alla rete elettrica Costi opportunità del capitale e da mancata produzione per la durata media del processo di allacciamento alla rete elettrica Prezzo di acquisto dell’energia elettrica 0,168 €/kWh 0,143 €/kWh - Prezzo medio di vendita dell’energia elettrica - 0,1011 €/kWh 0,08 €/kWh Tipo di imposizione fiscale Persona fisica esente da imposizione fiscale Soggetto a imposizione fiscale per la parte relativa alla tariffa incentivante e alla vendita di energia Soggetto a imposizione fiscale per la parte relativa alla tariffa incentivante e alla vendita di energia Producibilità annua29 1.200 kWh/kW Tasso annuo d’inflazione ed incremento del prezzo dell’energia 2% Diminuzione annua del costo totale dell’impianto 5% Decadimento medio annuo delle prestazioni dei moduli 0,8% Tabella 1.5 IRR assicurato da ciascun impianto “tipo” installato nel 2009 3 kW Livello di integrazione IRR 31 200 kW30 Integrato Parzialmente Integrato 16% 8% ha è stato quasi indifferente al prezzo del greggio e che influenza la convenienza per l’investitore di produrre ed auto-consumare energia. Il livello di redditività che si conseguirebbe mantenendo inalterato il Nuovo Conto Energia suggerisce quindi che una riduzione delle tariffe, oltre che necessaria per aspetti di equità sociale, sarebbe anche sostenibile da parte degli investitori, che potrebbero comun- 1 MW Integrato Parzialmente Integrato Non integrato Non Integrato 16,5% 14,5% 12,4% 12% que ritenere conveniente l’investimento in nuovi impianti fotovoltaici, anche in presenza di un livello di incentivi più basso. Ipotizzando un livello minimo di redditività accettabile da un investitore “tipo” quale quello indicato nelle figure 1.13, 1.14 e 1.15 (pari al 5% per gli impianti residenziali e 10% per gli impianti industriali e per le centrali), è possibile stimare, seppur con tutte le cautele del caso, che ridu- 29 La producibilità media annua espressa in kWh/kW tiene conto dell’energia effettivamente prodotta e immessa in rete al netto delle perdite del sistema 30 I valori dell’IRR sono calcolati come valore medio tra il caso di impianti che autoconsumano il 100% dell’energia prodotta (regime di scambio sul posto) e impianti che vendono tutta l’energia prodotta. 31 IRR del capitale proprio investito nel progetto, o IRR equity. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 49 1. IL fotovoltaico zioni delle tariffe incentivanti al 2011 fino al 20% per gli impianti residenziali, al 15% per quelli industriali (fino al 30% gli industriali che autoconsumano tutta l’energia prodotta) e al 15% per le centrali, non avrebbero delle ripercussioni estremamente negative sul mercato. Sicuramente diminuirebbe il tasso di crescita delle installazioni rispetto a quanto registrato nel nostro Paese negli ultimi anni, dato che l’investimento nell’impianto risulterebbe molto meno conveniente rispetto a quanto accade anche oggi. Esisterebbero tuttavia degli investitori che potrebbero essere propensi a valutare positivamente l’investimento in questo tipo di tecnologie, in quanto in grado di assicurare una redditività coerente con i livelli conseguibili sul mercato, ma con il vantaggio di una maggiore sicurezza, derivante dalla certezza della tariffa assicurata dallo Stato Italiano per un periodo di anni consistente e sufficiente a raggiungere il pay-back del progetto. L’elemento importante che emerge dall’analisi è che un taglio degli incentivi in sede di revisione del Nuovo Conto Energia che porti Figura 1.13 Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 3 kW installato nel 2011 0,6 0,5 IRR (%) 0,4 0,3 26% 0,2 0,1 IRR 5% 0 0,46 - 0,1 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,345 0,6 Incentivo (€/kWh) Figura 1.14 Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 200 kW installata nel 2011 0,6 0,5 IRR 18,9% IRR (%) 0,4 Autoconsumo dell’energia prodotta IRR 16% 0,3 0,2 0,1 Vendita del 50% dell’energia prodotta 18,9% IRR 10% 0 0,34 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 Incentivo (€/kWh) 0,205 50 0,9 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.2 La normativa Figura 1.15 Andamento del valore dell’IRR in funzione del livello di incentivo per un impianto da 1 MW installata nel 2011 0,6 0,5 IRR (%) 0,4 IRR 11,6% Se si considera l’applicazione dell’ICI 0,3 0,2 0,1 0 13,3% IRR 10% 0,34 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,28 0,8 0,9 1 Incentivo (€/kWh) successivi al 2011. Va detto tuttavia che, se l’invele tariffe feed-in a livelli inferiori rispetto a quelstimento in un impianto è conveniente nell’anno di li indicati nelle figure 1.13, 1.14 e 1.15 porterebbe introduzione del nuovo sistema di incentivazione verisimilmente ad uno”stallo” del mercato, con le con un determinato livello di tariffa, per i motivi conseguenze cui si è fatto cenno in precedenza. Un sopraesposti lo sarà a maggior ragione negli anni altro aspetto critico riguarda il fatto che un taglio a venire. Di conseguenza, osservare quello che acdelle tariffe uniforme, che prescinda dalla tipologia cade nel 2011 è fondamentale per prevedere la pose in particolare dalla taglia dell’impianto, avrebbe sibilità di un totale stallo del mercato un impatto differente sulla tipologia fotovoltaico italiano. Ovviamente di installazioni che si realizzerebbe“Le centrali viaggiano questo tipo di stima sarebbe invece ro nel futuro in Italia, considerato il su rendimenti a due cifre già da un bel po’ di mesi. Speriamo necessaria nel momento in cui la relivello di redditività eterogeneo che questa condizione possa visione del Nuovo Conto Energia precontraddistingue i tre impianti “tipo”. perdurare” vedesse, oltre ad un taglio delle tariffe Mentre un taglio del 20% della tariffa Amministratore delegato una tantum a partire dal 2011, anche per le centrali fotovoltaiche di grossa di un EPC contractor una consistente riduzione annua deltaglia potrebbe rendere non più conle stesse a partire dal 2012. veniente la loro realizzazione, almeno Chiaramente l’entità della tariffa incentivante è l’elenel Nord e nel Centro Italia, dove la producibilità mento principale su cui verte il dibattito in merito annua dell’impianto non è particolarmente alta, la alla revisione del Nuovo Conto Energia. Tuttavia, medesima riduzione continuerebbe ad assicurare esistono molteplici altri fattori che definiscono il una redditività soddisfacente per gli impianti utisistema di incentivazione nel suo complesso e che lizzati per scopi industriali e di processo, in cui una potranno avere un impatto importante sulla posparte consistente dell’energia prodotta viene autosibile evoluzione delle installazioni fotovoltaiche in consumata. Di conseguenza, differenziando il liItalia. Tra questi, alcuni aspetti particolarmente rivello di riduzione delle tariffe in funzione della levanti sono: la durata dello schema di incentivaziotaglia dell’impianto, il legislatore potrà influenne, il limite massimo di potenza incentivabile, gli zare radicalmente il modello di sviluppo futuro scaglioni di potenza degli impianti cui corrispondel sistema fotovoltaico italiano, privilegiando ad dono diversi livelli tariffari, le tipologie installative esempio un paradigma fortemente decentralizzato (nel Nuovo Conto Energia attualmente in vigore, si di generazione fotovoltaica, piuttosto che una magdistingue tra impianto integrato, parzialmente ingiore diffusione delle centrali di grande potenza. tegrato e non integrato), l’esistenza di un transitorio Per motivi di sintesi, non si riporta qui la stima in cui si realizza un adeguamento progressivo della della redditività degli impianti “tipo” negli anni www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 51 1. IL fotovoltaico Energy Report 2008 e dall’esperienza, si inserisce tariffa feed-in al nuovo livello, gli incentivi e i bonus la proposta comune diffusa il 12 novembre 2009 per certe tipologie di impianti, l’applicazione di ICI da parte di ANIE-GIFI, APER e ASSOSOLARE, ed altre imposte agli impianti in esercizio, le proi cui elementi cardine sono sintetizzacedure di autorizzazione ed allacciabile nei seguenti punti: mento dell’impianto. In merito a que“I segmenti su cui puntare sto aspetto, la nostra analisi rileva un per un sano sviluppo del impatto particolarmente consisten- fotovoltaico dovrebbero essere • durata del futuro meccanismo di il residenziale e l’industriale, incentivazione pari a 5 anni (2011te, sulla redditività dell’investimen- in cui si utilizza l’energia prodotta 2015); to, delle procedure di allacciamento per l’autoconsumo” • limite massimo di potenza incentie autorizzazione dell’impianto, che Marketing Manager di un’impresa produttrice di moduli vabile nel periodo 2011-2015 non infedeterminano per l’imprenditore degli riore a 8 GW; ingenti costi vivi e costi opportunità • introduzione di nuovi scaglioni di potenza, osdel capitale immobilizzato causati dalla lunghezza sia: 1-6 kW, 6-20 kW, 20-200 kW, 200-1000 kW, spesso eccessiva di queste fasi istruttorie del proces>1000 kW; so. Per una centrale fotovoltaica da 1 MW, ad esem• semplificazione delle tipologie installative: vista pio, la nostra analisi rivela che l’accorciamento dei la difficoltà pratica riscontrata dagli operatori tempi dell’attività di connessione alla rete elettrinel qualificare un impianto come “parzialmenca del 40% porta ad un miglioramento dell’IRR te integrato”, si suggerisce la sua eliminazione, di circa 1 punto percentuale. Questo esempio sugmantenendo così solo due tipologie: impianti su gerisce che un investitore razionale potrebbe essere edificio e impianti a terra; disposto ad accettare una tariffa incentivante infe• livello delle nuove tariffe per il 2011 (dopo il tranriore nel momento in cui le procedure di autorizzasitorio di cui si fa cenno più avanti) pari ai valori zione e allacciamento divenissero meno complesse riportati in tabella 1.6 e di durata più facilmente prevedibile. Per il legisla• bonus per integrazione architettonica (incluse tore, ciò suggerisce l’enorme importanza di agire serre agricole, pensiline, tettoie) pari al 15% in più sulla riduzione della burocratizzazione di queste rispetto alla tariffa per gli impianti su edificio; attività accessorie (oltre che su altre variabili del • bonus per impianti realizzati in aree comprosistema di incentivazione nel suo complesso) per messe pari al 10% in più rispetto alla tariffa ricopoter ridurre l’impatto negativo che un abbassanosciuta per gli impianti a terra; mento della tariffa incentivante (e conseguente• bonus per la sostituzione di coperture in eternit o mente delle uscite per lo Stato) avrà sulla crescita amianto pari al 10% in più rispetto alla tariffa per futura delle installazioni. Oltre a ciò, il caso della gli impianti su edificio. Spagna discusso nel paragrafo 1.2.1 suggerisce • introduzione di un transitorio di 6 mesi nel 2011, come il tetto di potenza incentivabile possa avere all’interno del quale si realizzi un decremento un impatto altrettanto importante nell’influenzare costante bimestrale della tariffa fino al raggiunil comportamento degli investitori. gimento della riduzione stabilita per l’anno 2011; Nell’ottica di una revisione completa del comples• introduzione di un decremento annuale del 4% sivo sistema di incentivazione, fatta salva la bontà delle tariffe incentivanti a partire dal primo ludei principi su cui si fonda il Nuovo Conto Energia glio 2012. che è stata largamente documentata anche nel Solar Tabella 1.6 Livello delle nuove tariffe (€/kWh) proposto da ANIE, GIFI, ASSOSOLARE e APER Classe di potenza (kW) 1-6 6-20 20-200 200-1000 >1000 52 Impianto a terra 0,365 0,339 0,313 0,304 0,297 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Impianto su edificio 0,401 0,375 0,330 0,323 0,315 1.3 Il mercato L’obiettivo di questo capitolo è quello di illustramogeneità nei percorsi di crescita degli Stati che re le dinamiche che hanno caratterizzato lo svila compongono, con alcune realtà che si conferluppo del mercato fotovoltaico in Europa ed in mano eccellenti mercati per il fotovoltaico, alItalia nel corso del 2009 e di interpretarne l’imtre che “segnano il passo” ed altre ancora che patto sulla sua evoluzione futura. Nella seconda sembrano avere le carte in regola per giocare parte del capitolo, si propone inoltre una valutaun ruolo di rilievo nel prossimo futuro. Si tratta zione del potenziale di sviluppo del rispettivamente: fotovoltaico nel nostro Paese e una “Il cambiamento del sistema stima della distanza che ci separa dal di incentivi in Spagna e soprattutto • della Germania, che ha installato l’introduzione di un tetto alle conseguimento della grid parity per installazioni così basso ha del tutto oltre 3 GW32 di nuova potenza fotodifferenti tipologie e taglie di impian- arrestato lo sviluppo del mercato, voltaica nel corso del 2009, dimocon pesanti ripercussioni, in termini to. Infine, vengono approfonditi due di occupazione e competitività, sulle strandosi in grado – nonostante la imprese della filiera” crisi economica – di sostenere inveimportanti ambiti di applicazione stimenti per circa 13,5 mld €. Il fatto della tecnologia fotovoltaica nel noBusiness Developer di un’impresa produttrice di moduli che negli ultimi tre anni le installastro Paese, ossia il Building Integrated zioni fotovoltaiche si siano mantenute Photovoltaics (BIPV) e le cosiddette sopra la soglia del GW è un ulteriore conferma serre fotovoltaiche. della solidità della crescita del mercato tedesco; • della Spagna, di cui nel Solar Energy Report 1.3.1 Il fotovoltaico in Europa 2008 si commentava il percorso di avvicinamene nel mondo to alla leadership tedesca, che invece è ritornata nel 2009 – in conseguenza di una improvvida Nel corso del 2009, nonostante la crisi economodifica al quadro normativo (si veda paramica non abbia certo favorito in generale i nuovi grafo 1.2.1) – ai livelli di installazione di due investimenti, la potenza fotovoltaica installata in anni prima, con un crollo di quasi l’80% riEuropa è stata pari a oltre 5 GW (per un volume spetto al 2008; d’affari complessivo di quasi 21 mld €), in cresci• dell’Italia e, anche se in misura minore della ta di quasi il 9% rispetto al 2008, quando le nuove Francia, che invece – pur se su valori assoluti installazioni avevano toccato i 4,6 GW. ancora decisamente inferiori – hanno intrapreso un percorso di crescita che le ha Se si guarda al totale installato, “La Cina rappresenta un mercato portate in tre anni a moltiplicare l’Europa ha raggiunto alla fine del potenzialmente vastissimo, se gli rispettivamente per oltre 7 e 9 volte incentivi annunciati dal Governo 2009 circa 14 GW di potenza (pari cinese il livello di potenza fotovoltaica invenissero confermati nella al 65% del totale a livello mondiale) stallata annualmente. pratica, si aprirebbero enormi opportunità per i produttori – pari a quasi sette volte l’installato di moduli, anche e soprattutto in Giappone e dieci volte quello degli La crescita delle installazioni in per quelli occidentali” USA – confermandosi di gran lunga Italia, cui si dedicherà ampio spazio Business Developer di un’impresa l’area geografica leader nelle installanel paragrafo 1.3.2, appare ancor produttrice di moduli zioni fotovoltaiche. più interessante se la si confronta con quella del Giappone (484 MW nel 2009, poco La tabella 1.7 mostra, tuttavia, come questa lepiù del doppio di due anni prima) e soprattutto adership dell’Europa sia il risultato di forti disodegli USA (450 MW nel 2009, il 22% in meno 32 Secondo alcune fonti, è probabile che il valore salga a circa 4 GW a causa di alcune imprecisioni di calcolo dell’autorità tedesca delle telecomunicazioni. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 53 1. IL fotovoltaico Tabella 1.7 Potenza installata nei principali Paesi del mondo (MW) Potenza cumulata installata al 31/12/2009 Potenza installata nel corso del 2009 Potenza installata nel corso del 2008 Potenza installata nel corso del 2007 Germania 8.351 3.139 1.350 1.103 Spagna 3.904 420 2.671 591 Giappone 2.703 484 300 210 USA 1.681 450 400 207 Italia 1.041 581 338 70 Francia 425 250 44 3 Europa 14.000 5.100 4.613 1.826 Mondo 21.400 6.500 5.500 2.400 1.3.2 Il fotovoltaico in Italia come alla fine del 2009 in Italia fossero installati impianti per una potenza complessiva di circa 1.041 MW, di cui circa 1.000 incentivati attraverso il meccanismo del Conto Energia (sia nella sua prima versione che in quella rivista nel febbraio 2007). Per quanto riguarda l’Italia, il 2009 ha segnato un primo passo verso la maturità del mercato fotovoltaico che, dopo il boom delle installazioni registrate nel 2007 e specialmente nel 2008, si è assestato su tassi di crescita sicuramente consistenti, soprattutto in un periodo di forte contrazione dell’economia, anche se meno dirompenti rispetto agli anni precedenti. La figura 1.16 illustra la crescita della potenza fotovoltaica cumulata installata in Italia a partire dal 2005. Si nota La figura 1.17 illustra invece l’andamento della potenza installata annualmente in Italia negli ultimi tre anni, da cui si evince come nel 2009 siano stati installati impianti fotovoltaici per circa 580 MW di potenza. Si nota come, a fronte di una crescita delle installazioni superiore al 380% tra il 2007 e il 2008, l’ultimo anno abbia fatto registrare una crescita della potenza installata di circa il 72%. Come accennato in precedenza, si tratta di un incremento dell’installato (e del relati- dell’Italia), nonostante sia ancora significativa la distanza rispetto a questi Paesi in termini di installato totale. Box 1.8 La Cina e la rincorsa alla leadership mondiale La Cina vive indubbiamente un paradosso: domina il mercato mondiale della produzione di celle e moduli fotovoltaici, ma ha un mercato interno del tutto marginale, nonostante le indubbie potenzialità. Questa situazione sembra tuttavia rapidamente destinata a cambiare, tenuto conto che – con il “pragmatismo” che contraddistingue l’azione legislativa cinese – è stato introdotto nel corso del 2009 un meccanismo di incentivazione straordinario, che riconosce un contributo una tantum di circa 2.200 € (pari a quasi il 50% dell’investimento totale necessario) per ogni kW fotovoltaico installato sugli edifici residenziali. Nelle ultime settimane del 2009 sono stati poi resi pubblici i progetti di alcune grandi aziende cinesi relativi alla costruzione di 54 centrali fotovoltaiche per oltre 200 MW da realizzarsi in alcune aree desertiche del Paese. Gli analisti, anche se non tutti sono concordi visto che non sono ancora chiare le modalità attraverso cui il sistema di incentivazione verrà messo in pratica, ritengono che si possa installare nel corso del 2010 più di 1 GW di potenza fotovoltaica in Cina. D’altra parte la Cina ha già dimostrato la rapidità con cui è in grado di recuperare posizioni sulla scena internazionale: come fece nei primi anni ’90 divenendo il primo Paese al mondo per le installazioni di impianti solari termici, o nella seconda metà degli anni ’00 nel settore eolico, con una crescita rapidissima che l’ha portata a quasi 13 GW di potenza installata totale. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.16 Andamento annuale cumulato della potenza installata in Italia dal 2005 a oggi 1200 1040,5 MW 1000 800 600 459 999,5 Potenza installata totale 400 Potenza incentivata con il conto energia 418 200 120,6 9 200 8 200 6 200 7 5 200 200 79,6 0 giore interesse l’investimento nel fovo giro d’affari annuo, che per il 2009 “Considerato il credit crunch tovoltaico, rispetto ad altri impieghi è stimabile, come si illustrerà nel pae la congiuntura economica ragrafo 1.4.1, nell’ordine di 2,3 mld negativa, il mercato fotovoltaico a maggior rischio. Come si approfonin Italia ha fatto registrare dirà più avanti in questo rapporto, è €) molto consistente se si considera il nel 2009 sviluppi molto positivi” molto probabile che la crescita della difficile contesto economico generale Responsabile commerciale potenza installata sarà tuttavia più in cui ha avuto luogo e che ha avuto di un’impresa che si occupa di progettazione e installazione consistente nel 2010 rispetto all’anno profondi contraccolpi in molti settodi impianti fotovoltaici appena conclusosi, per effetto della ri dell’economia del nostro Paese. La “corsa alle installazioni” cui si ascrescita del mercato fotovoltaico in sisterà nei prossimi mesi, prima che entri in viItalia è stata assicurata primariamente dalle tagore, verosimilmente nel gennaio 2011, la nuova riffe incentivanti particolarmente generose pretariffa incentivante stabilita dall’attesa revisione viste dal Nuovo Conto Energia. Come si vedrà del Nuovo Conto Energia. più avanti parlando di grid parity (si veda paragrafo 1.3.4), il costo di produzione da fotovoltai1.3.2.1 La segmentazione del mercato co è infatti oggi ancora molto superiore rispetto a fotovoltaico quello di generazione da fonti tradizionali, nonCome già illustrato nel Solar Energy Report 2008, ché al costo di prelievo dell’energia dalla rete, il il mercato fotovoltaico è fortemente eterogeneo in che rende la presenza di un meccanismo incentermini di dimensione e taglia media dell’impianto, tivante una condizione indispensabile per l’esidi utilizzo che viene fatto dell’energia stenza stessa di un mercato del foelettrica prodotta e per quanto riguartovoltaico. C’è tuttavia una seconda “Nella seconda metà del 2010 aspettiamo una vera e propria da i soggetti coinvolti nel processo di interessante dinamica che la nostra cicorsa all’installazione di nuovi acquisto e installazione della centrale. analisi ha messo in luce. In un perioimpianti, prima dell’entrata in vigore della revisione Rispetto alla segmentazione introdo di crisi economica, specialmente del Nuovo Conto Energia” dotta nel Solar Energy Report 200833, per impianti di grandi dimensioni, Direttore tecnico di un’impresa per cogliere al meglio l’evoluzione e la “sicurezza” del ritorno assicurata responsabile di progetti per impianti le peculiarità del mercato fotovoltaidal meccanismo del Nuovo Conto di grande taglia co italiano nel corso del 2009, è stato Energia ha spinto parecchi investinecessario prevedere una segmentazione in parte tori (perlomeno quel ristretto gruppo con risorse differente, che è illustrata in figura 1.18. finanziarie disponibili) a considerare con mag33 Cfr. Solar Energy Report 2008, p. 52. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 55 1. IL fotovoltaico Figura 1.17 Andamento della potenza installata annualmente in Italia 700 600 581,5 MW 500 400 338,4 300 200 100 70,1 0 2007 2008 2009 Figura 1.18 Segmentazione del mercato italiano del fotovoltaico MERCATO INDUSTRIALE GRANDI IMPIANTI MERCATO CENTRALI Non Integrato MERCATO RESIDENZIALE FONDI D’INVESTIMENTO Totalmente Parzialmente Integrato Integrato UTILITIES PRIVATI e PICCOLE IMPRESE 1 kW IMPRESE INDUSTRIALI e COMMERCIALI 20 kW 200 kW 1 MW Dimensione degli impianti La segmentazione distingue tra: • il segmento residenziale, dove l’impianto fotovoltaico viene utilizzato per soddisfare parte del fabbisogno energetico di una o più unità abitative o di piccole realtà commerciali; • il segmento industriale, in cui l’energia elettrica prodotta viene utilizzata da imprese medio-piccole e da Pubbliche Amministrazioni per soddi- 56 sfare il fabbisogno energetico dei propri edifici o dei propri processi produttivi. Nel caso di sistemi con taglia superiore ai 150 kW, una parte dell’energia prodotta dall’impianto viene normalmente anche venduta sul mercato elettrico o attraverso contratti bilaterali; • il segmento dei grandi impianti, che comprende sistemi fotovoltaici realizzati prevalentemente da imprese di medio-grandi dimensioni, le quali www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato derante, nel range di potenza tra 20 e 200 kW (riutilizzano parte dell’energia prodotta per autospetto al segmento 20 – 100 kW). Questo in quanconsumo e vendono in rete il surplus, che in alcuto, per effetto della delibera 1/09 dell’Autorità per ni casi può essere molto consistente. Un esempio l’Energia Elettrica e il Gas, il limite di potenza è quello dello storico marchio automobilistico fino a cui è possibile accedere al meccanismo delLamborghini, che ha inaugurato un nuovo imlo scambio sul posto è stato innalzato a 200 kW, pianto fotovoltaico da 1,4 MW (corrispondenti rispetto alla soglia dei 20 kW in vigore per tutto ad oltre 1,5 GWh l’anno di produzione elettrica) il 2008. Questo ha fatto aumentare significativaper una superficie di 17.000 metri quadrati presmente il numero di impianti utilizzati per finalità so la propria sede di Sant’Agata Bolognese. Non di auto-consumo con taglia compresa tra 100 e 200 è infrequente poi che fondi di investimento o kW. Il limite di potenza inferiore del segmento delEPC contractor realizzino impianti, tipicamente le centrali fotovoltaiche è stato inoltre innalzato ad “a terra”, di dimensioni inferiori ad 1 MW, con 1 MW. Questa modifica è stata suggel’obiettivo di vendere l’intero quanrita dal fatto che, nel corso del 2009, titativo di energia prodotta, come “Finalmente anche in Italia sono stati installati e sono entrati in accade tipicamente nel segmento le grandi centrali fotovoltaiche funzione diversi impianti di taglia delle centrali; a terra sono diventate una realtà” superiore ad 1 MW, facendo diven• il segmento delle centrali, dove tare le grandi centrali a terra una utilities e società energetiche quaDirettore tecnico di un’impresa di progetti per impianti realtà importante anche nel nostro li Sorgenia, Enel (con Enel Green responsabile di grande taglia Paese. Questo ha suggerito la necessiPower), Eni ed Edison, fondi di invetà di introdurre un ulteriore segmento stimento italiani e soprattutto stradi mercato con caratteristiche “ibride”, quello degli nieri, ed infine EPC contractor di grandi dimenimpianti con potenza compresa tra 200 e 1.000 kW, sioni, investono nella realizzazione di impianti di parte dei quali sono realizzati da grandi imprese grande taglia (tipicamente sopra ad 1 MW) con che li impiegano per soddisfare una porzione confinalità di produrre energia destinata alla vendita sistente del loro fabbisogno elettrico, parte invece sul mercato. sono il risultato di scelte di investimento da parte di fondi o EPC contractor di medie dimensioni. Rispetto alla segmentazione introdotta nel Solar Energy Report 2008, è stato necessario innanziLa figura 1.19 riporta la segmentazione della tutto ri-collocare il segmento industriale, in cui la potenza cumulata installata in Italia negli ultimi componente di energia auto-consumata è prepon- Figura 1.19 Segmentazione della potenza cumulata installata in Italia 100% 80% 4,1% 33,7% 31,4% 16,0% <=20 (kW) 34,0% 28,5% 60% 20-200= (kW) 24,1% 27,9% 40% 23,6% 200-1000= (kW) 66,3% 44,5% 20% >1000 (kW) 34,0% 31,9% 8 9 200 200 7 200 200 6 0 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 57 1. IL fotovoltaico Figura 1.20 Ripartizione della potenza annua installata per segmento di mercato 200,0 180,0 6 160,0 5 140,0 120,0 MW 4 100,0 3 80,0 60,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 2006 (MW) 2007 (MW) 2008 (MW) 2009 (MW) <=20 (kW) 6,3 31,2 115,2 185,6 20-200= (kW) 3,2 16,9 94,5 137,3 22,0 114,9 165,5 13,8 93,1 200-1000= (kW) >1000 (kW) quattro anni per classe di impianto, mentre la figura 1.20 illustra la ripartizione della potenza annua installata per segmento di mercato. L’analisi delle figure rivela che nel 2007 le installazioni di potenza inferiore ai 20 kW erano le più diffuse in Italia (circa il 45%), ma anche che non esistevano impianti in funzione di taglia superiore ad 1 MW. Le centrali di grande taglia sono state per la prima volta realizzate in Italia nel 2008, anno in cui anche gli impianti di dimensioni “medie” (ossia tra 20 e 200 kW e tra 200 e 1.000 kW) hanno registrato un lieve aumento del loro peso relativo, a scapito delle installazioni residenziali. Questo si spiega in larga misura con il fatto che, per buona parte del 2008, il prezzo dei moduli e degli impianti fotovoltaici si è mantenuto su livelli particolarmente elevati a causa di un eccesso di domanda. La redditività, in ottica relativa, degli impianti di grande dimensioni è quindi aumentata visto che maggiori erano le possibilità di realizzare apprezzabili economie di scala. La situazione nel corso del 2009 ha visto un’ulteriore riduzione del peso relativo degli impianti residenziali, sebbene la potenza installata, per questo segmento, sia aumentata del 61% tra il 2008 e il 2009 grazie alla diminuzione vertiginosa del prezzo dei moduli fotovoltaici che, a partire dalla fine del 2008, ha determi- 58 nato un ritorno sull’investimento in questi impianti di livelli estremamente soddisfacenti (si veda paragrafo 1.2.5). Parallelamente, gli impianti di taglia media e medio-grande, realizzati prevalentemente da imprese commerciali o industriali, hanno visto ridurre il loro peso sull’installato complessivo, principalmente per effetto del fenomeno del credit crunch che, anche e soprattutto nel corso del 2009, ha fatto sentire i suoi effetti sulle capacità di investimento di moltissime imprese italiane, specialmente quelle di medio-piccole dimensioni. Tuttavia, anche questo tipo di impianti (20-200 e 200-1000 kW) ha registrato una crecita dell’installato tra il 2008 e il 2009 di circa il 45%. Viceversa, le centrali con taglia superiore ad 1 MW hanno visto il proprio peso percentuale aumentare esponenzialmente rispetto al 2008 (+575%). La nostra analisi suggerisce che ciò è dovuto, come in parte già registrato nel corso del 2008, al fatto che molti fondi di investimento privati, italiani e stranieri, trovandosi di fronte alla mancanza, per effetto della crisi generalizzata cui si è già fatto cenno, di alternative di investimento con un profilo rischio-rendimento particolarmente favorevole, hanno indirizzato una crescente fetta delle loro risorse verso le centrali a terra, che presentano, con il sistema di incentivazione in vigore in Italia, un’opportunità di investimento ad alto ritorno sul capitale www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Tabella 1.8 Taglia media degli impianti fotovoltaici installati in Italia (kW) Ripartizione impianti per taglia <=20 4,7 5,3 5,2 5,3 2006 2007 2008 2009 20-200 44,4 44,3 56,1 65,1 investito (si veda paragrafo 1.2.5) a fronte di un profilo di rischio comunque contenuto. In particolare, il mercato delle centrali è diventato a tutti gli effetti un segmento trainante in Italia, contando ben 34 impianti a terra di taglia superiore ad 1 MW installati nel 2009. Tra il 2007 e il 2008, la crescita del numero di impianti installati è stata superiore al 280%, mentre tra il 2008 e il 2009 la crescita si è attestata intorno al 55%, fino a raggiungere, alla fine del 2009, un totale di poco più di 69.100 impianti installati. La tabella 1.8 mostra l’andamento nel tempo della taglia media degli impianti fotovoltaici per i diversi segmenti di mercato. Dall’analisi dei dati in essa riportati si evince che la taglia media complessiva è variata meno dal 2008 al 2009 rispetto agli 200-1000 610 532 615,4 >1000 2.299 2.738,4 Taglia media 6,8 11,1 14,0 15,6 anni passati, pur essendo aumentato sensibilmente il numero delle centrali. In particolare, risulta interessante notare come per il settore industriale (20200 kW) e per quello dei grandi impianti (200-1000 kW) la taglia media sia cresciuta di circa il 16% e per il settore centrali l’incremento è stato addirittura dell’ordine del 20%. 1.3.2.2 La distribuzione geografica degli impianti In questo secondo paragrafo si intende approfondire l’analisi del mercato italiano del fotovoltaico34 considerando la distribuzione geografica degli impianti alla luce delle specificità delle diverse Regioni e ambiti territoriali. La figura 1.22 fornisce innanzitutto un quadro della potenza installata al 31/12/2009 nelle diverse Regioni Italiane. Figura 1.21 Potenza installata al 31/12/2009 nelle diverse Regioni italiane 160 140 120 MW 100 80 60 40 20 Lom Pug lia b ard Emi ia lia R oma gna Laz io Piem onte Ven Tre ntin eto o Al to A dige Mar che Tos can a Sici lia Sar deg na Um bria Cala bria Bas ilica ta Cam pan ia Friu li Abr uzzo Mol ise Ligu ria Vall e D’ Aos ta 0 34 I dati si riferiscono alla potenza installata attraverso il Primo ed il Nuovo Conto Energia. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 59 1. IL fotovoltaico Figura 1.22 Segmentazione per taglie di impianto della potenza installata nelle diverse Regioni italiane nel corso del 2009 100 90 80 70 60 <=20 (kW) MW 50 20-200= (kW) 40 30 200-1000= (kW) 20 10 >1000 (kW) In generale si registrano alcuni cambiamenti nella “classifica” delle Regioni più “virtuose” nel fotovoltaico italiano rispetto al 200835. In particolare, c’è da rilevare il “sorpasso” della Puglia, al 31/12/2009 prima Regione Italiana per potenza installata, a scapito della Lombardia, che si colloca ora al secondo posto di questa particolare classifica. Guadagnano terreno il Lazio e la Basilicata, che hanno sperimentato una notevole crescita nel corso del 2009, mentre perde terreno, per un fenomeno di naturale “saturazione” del mercato, il Trentino Alto Adige. Di seguito si approfondisce l’analisi per illustrare le ragioni alla base di queste dinamiche evolutive. La figura 1.22 fornisce innanzitutto una rappresentazione della potenza fotovoltaica installata nelle diverse Regioni italiane nel corso del 2009 per classi di impianto, mentre la figura 1.23 confronta la potenza installata nel corso del 2009 con il 2008. Una prima considerazione importante riguarda la crescita particolarmente consistente della potenza annua installata che si è registrata nelle Regioni del Sud Italia e nelle Isole rispetto al 2008, Friu li Cala bria Mol ise Ligu ria Vall e D’ Aos ta Lom Pug lia bar dia Laz Emi io lia R oma gna Piem onte Ven eto Tre Mar ntin c he o Al to A dige Sici lia Sar deg na Tos can a Bas ilica ta Um bria Cam pan ia Abr uzzo 0 con tassi di incremento in media superiori al 98%, e con picchi del 110% e del 465% rispettivamente in Puglia e in Basilicata. La potenza installata nelle Regioni del Nord Italia è cresciuta nel corso del 2009 in media del 55%, mentre nelle Regioni centrali il mercato si è espanso ad un ritmo leggermente più veloce, anche se inferiore ai picchi registrati al Sud, assestandosi su una crescita nell’ordine del 68%36. Questa dinamica testimonia innanzitutto come il mercato italiano del fotovoltaico si stia muovendo verso un maggiore livello di maturità, con gli impianti fotovoltaici che hanno cominciato a diffondersi a ritmi sostenuti anche in quelle aree del nostro Paese caratterizzate da una minore ricchezza e da un reddito pro-capite inferiore. Come illustrato nel Solar Energy Report 2008, le Regioni del Sud Italia, con l’eccezione della Puglia, si erano mostrate poco propense all’adozione della tecnologia fotovoltaica nel primo anno che è seguito all’approvazione del Nuovo Conto Energia, soprattutto se confrontate con il Nord del Paese, ma questo divario nel corso del 2009 ha cominciato ad essere colmato. Va anche detto che le Regioni del Sud Italia, e in particolar modo le Isole, come discusso nel paragrafo 1.2.4, si sono dimostrate più propense, rispetto a quelle settentionali e cen- Cfr. Solar Energy Report 2008, p. 55. Ai fini dell’analisi, l’Italia è stata suddivisa nelle seguenti tre macroaree: Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli, Liguria, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta); Centro (Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e Sud e Isole (Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata). 35 36 60 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.23 Confronto tra la potenza installata nel 2009 e nel 2008 nelle diverse Regioni italiane 100 90 94,9 80 70 67,7 59,5 60 50 MW Potenza installata nel 2008 50,3 43,2 41,7 40 32,3 26,224,0 22,1 22,121,3 14,713,9 ,9 12 12,7 11,1 7,1 30 20 10 3,5 0,6 Friu li Cala bria Mol ise Ligu ria Vall e D’ Aos ta Lom Pug lia bar dia Laz Emi io lia R oma gna Piem onte Ven eto Tre Mar ntin c he o Al to A dige Sici lia Sar deg na Tos can a Bas ilica ta Um bria Cam pan ia Abr uzzo 0 Potenza installata nel 2009 impianti tra 900 e 1.000 kW. Questo è l’effetto della trali, a stanziare finanziamenti complementari al Deliberazione della Giunta Regionale 35/2007, in Nuovo Conto Energia per favorire l’installazione base a cui era sufficiente una Denuncia di Inizio di impianti da parte di privati cittadini, imprese e Attività (o DIA) ai fini del rilascio dell’autorizzaPubbliche Amministrazioni, il che ha avuto sicuzione a costruire impianti fotovolramente un ruolo importante nelle ditaici fino ad 1 MW, diversamente da namiche di mercato discusse in que“Le regioni del Sud Italia quanto previsto in molte altre Regioni sto paragrafo. Bisogna infine rilevare sembrano essere uscite che i tassi di crescita particolarmente dal letargo che ha contraddistinto italiane, in cui al di sopra dei 20 lo sviluppo del loro mercato kW è necessario ottenere la ben più consistenti sperimentati dalle Regioni fotovoltaico negli scorsi anni” complessa e costosa Valutazione di del Sud nel 2009 e illustrati in figura commerciale di un’azienda Impatto Ambientale (o VIA) per pro1.23, in alcuni casi, sono dovuti anche Direttore di distribuzione fotovoltaica cedere con la realizzazione dell’imal limitato livello di installazioni regipianto. Il 7 ottobre 2009 la Puglia ha strato nel 2008. In termini assoluti, le approvato inoltre la Legge Regionale 20/2009, che prime Regioni per potenza fotovoltaica installata ha addirittura escluso da VIA gli impianti fino a nel corso del 2009 rimangono, ad eccezione della 10 MW. Nonostante ciò, probabilmente in Puglia Puglia, quelle localizzate nel Nord e nel Centro non si assisterà ad un “boom” delle centrali a del Paese (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, terra di dimensioni superiori ad 1 MW, poiché la Piemonte e Veneto). Questo lascia intendere come Regione, con l’approvazione della successiva Legge esistano ancora consistenti potenzialità di sviluppo Regionale 147/2009 del 20 ottobre 2009, ha deciso del mercato fotovoltaico italiano (come d’altronde di puntare su un modello di sviluppo del fotovolillustrato nel paragrafo 1.3.3 del presente rapportaico più compatibile con il territorio e le esigenze to) proprio in quelle aree in cui l’irraggiamento è paesaggistiche, vietando l’installazione di impianti maggiore e quindi la redditività dell’investimento fotovoltaici in zone agricole e privilegiando invece più elevata. l’integrazione dei nuovi impianti sulle coperture e sulle facciate degli edifici e la loro collocazione in La Puglia nel 2009 ha replicato l’incredibile aree in disuso come le cave. sviluppo già sperimentato nel corso del 2008: nell’anno appena terminato ha messo in esercizio Anche la Basilicata, come accennato in precedencirca il 44% della potenza complessiva installata za, ha registrato una crescita della potenza instalin Italia nel 2009 in impianti compresi tra i 200 e lata annua nel corso del 2009 senza precedenti, 1.000 kW, installando il 40% della potenza totale in www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 61 1. IL fotovoltaico essendo responsabile di circa l’11% della potenza complessiva installata in Italia nel 2009 in impianti compresi tra i 20 e i 200 kW. Anche in questo caso, lo sviluppo del mercato in Basilicata si spiega con un contesto normativo particolarmente favorevole (si veda paragrafo 1.2.4), ed in particolare con la decisione, presa dalla Regione nel 2008, di esentare dall’obbligo di VIA tutti quegli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati aventi un’estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati. A questo si aggiunge una decisa politica energetica della Basilicata sancita nel PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale)37 del 2009, che ha stabilito la necessità di procedere con l’installazione di circa 300 MW di potenza fotovoltaica entro il 2020. Nell’ambito di questo piano di indirizzo, la Regione si è impegnata anche a destinare più di un terzo dei fondi provenienti dal POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, stanziati per metà dall’Unione Europea e per metà dallo Stato Italiano), corrispondente a circa 56 mln €, per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Nonostante non siano stati recentemente promossi dalla Regione Basilicata degli stanziamenti di taglia consistente focalizzati sulla tecnologia fotovoltaica (si veda paragrafo 1.2.4), a detta degli operatori una quota rilevante dei fondi provenienti dal POR FESR ha contribuito allo sviluppo del mercato fotovoltaico locale. Puglia e Basilicata hanno visto crescere significativamente la potenza installata nel corso del 2009 specialmente grazie all’installazione di impianti di medio-grandi dimensioni (la taglia media degli impianti installati è stata di 36,1 kW e di 33 kW rispettivamente in Puglia e Basilicata, contro una media a livello nazionale di 15,6 kW). Un diverso modello di sviluppo ha contraddistinto invece la Sardegna, che ha incrementato la potenza installata nel 2009 di più dell’85% rispetto al 2008, con una taglia media degli impianti entrati in esercizio di 7,8 kW, significativamente minore rispetto alla media nazionale, testimoniando una significativa focalizzazione sul segmento residenziale e piccolo commerciale. Questo si spiega da un lato con la disponibilità di un consistente ammontare di stanziamenti pubblici destinati a favorire l’installazione di impianti di piccola taglia (si veda paragrafo 1.2.4), dall’altro con l’approvazione della Legge Regionale 30/2008, 37 che ha introdotto delle serie limitazioni all’installazione di impianti di medio-grande taglia su terreni agricoli e destinati alla produzione di energia precipuamente con scopo di vendita. In conclusione, la nostra analisi mostra, come è d’altronde evidente anche da questi brevi esempi, che le Amministazioni Pubbliche locali nel Sud Italia e nelle Isole hanno seriamente affrontato, a partire dal 2008, il tema dello sviluppo della fonte fotovoltaica in ambito territoriale, con una particolare attenzione a prevenire comportamenti puramente speculativi da parte degli investitori, a promuovere una crescita compatibile con le peculiarità territoriali e riconoscendo l’importanza di stimolare, attraverso stanziamenti ulteriori rispetto alle tariffe incentivanti previste dal Nuovo Conto Energia, l’installazione di impianti fotovoltaici. La crescita del mercato fotovoltaico nel Nord Italia nel corso del 2009 è stata decisamente minore (+55%) rispetto a quanto registrato tra il 2007 e il 2008 (+368%). Anche nel 2009 emerge una netta prevalenza degli impianti residenziali, di piccola taglia, che sono compatibili con il tessuto urbano che caratterizza le aree densamente popolate delle Regioni settentrionali del nostro Paese. In questo quadro, la Lombardia è la Regione del Nord in cui è stata installata la maggiore potenza fotovoltaica nel corso del 2009 e si è resa da sola responsabile dell’installazione di oltre il 14% della potenza complessiva entrata in esercizio in Italia nella forma di impianti residenziali. È interessante rilevare come, nel corso del 2009, le Regioni del Nord abbiano visto aumentare in modo non irrilevante il numero di centrali fotovoltaiche, ossia gli impianti a terra di taglia superiore ad 1 MW (la Lombardia è stata responsabile dell’11% della potenza installata a livello nazionale in questo tipo di impianti, mentre il Piemonte di circa il 7%). Questo si spiega principalmente con la diminuzione consistente del prezzo dei moduli a partire dalla seconda metà del 2008, che ha reso sempre più conveniente l’investimento in centrali fotovoltaiche anche in aree con livelli di irraggiamento non particolarmente elevati. Anche se le Regioni settentrionali del nostro Paese sono contraddistinte da un irraggiamento annuo medio che varia tra i 950 e i 1.200 kWh/kW, esistono alcune “sacche solari” (ad esempio il Cuneese e il Pavese), ossia aree circoscritte in cui, per le condizioni metereologiche particolari e favorevoli alla produzione Decreto n. 720 del 22 aprile 2009, attraverso il quale la Giunta Regionale ha adottato il PIEAR. 62 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.24 Potenza installata per mille abitanti nelle diverse Regioni italiane al 31/12/2008 e al 31/12/2009 60,0 50,0 40,0 kW/1000 abitanti al 31/12/2008 30,0 20,0 kW/1000 abitanti al 31/12/2009 10,0 Friu li Cala bria Mol ise Ligu ria Vall e D’ Aos ta Lom Pug lia bar dia Laz Emi io lia R oma gna Piem onte Ven eto Tre M a ntin rche o Al to A dige Sici lia Sar deg na Tos can a Bas ilica ta Um bria Cam pan ia Abr uzzo 0,0 particolare attenzione è il Lazio che ha sperimentafotovoltaica, l’irraggiamento medio arriva a cirto una crescita di circa il 210% dovuta principalca 1.350 kWh/kW: esse risultano particolarmente mente all’esplosione del segmento delle centrali, adatte all’installazione di grandi centrali, ed è qui con ben 6 impianti installati per una potenza che che si concentrano le attenzioni degli investitori. rappresenta il 43% della potenza complessiva enLa figura 1.24 riporta i livelli di potenza installata trata in esercizio nel 2009 in impianti superiori ad nelle varie Regioni al 31/12/2008 e al 31/12/2009 pro 1 MW in Italia (grazie anche alla messa in funzione milia capita. Dall’analisi della figura si desume che a dicembre 2009 del più grande impianto fotovoltaiil Trentino Alto Adige ha una potenza installata co d’Italia a Montalto di Castro, che ha una potenper abitante (pari a 54,5 kW/mille abitanti) pari a za di 24 MW e che si aggiunge al secondo impianto più del doppio della media Italiana (di circa 21,4 d’Italia per potenza nominale, che è localizzato nelkW/mille abitanti). Considerando che in Trentino la stessa Montalto di Castro ed ha una potenza di 6 le installazioni fotovoltaiche, per la naturale conMW). Va inoltre sottolineato il caso formazione del territorio e per il livello del Molise, in cui la potenza installata di irraggiamento che sconsiglia invele regioni in cui il fotovoltaico annua è cresciuta del 600%, per effetto stimenti in grandi centrali per la pro- “Tra non ha espresso ancora le sue duzione e vendita di energia elettrica, potenzialità ci sono sicuramente tuttavia dell’entrata in esercizio di un la Toscana e la Calabria” numero molto limitato di centrali di prendono prevalentemente la forma di impianti residenziali o comunque Direttore commerciale di un’azienda grande taglia (una in particolare di 2,8 di piccola taglia, si comprende come il installatrice di impianti di grande taglia MW) e di un installato nel 2008 molto contenuto, di poco superiore ad 1 livello di saturazione di questo mercaMW. Quelle Regioni del Centro Italia to sia notevolmente superiore rispetto in cui è stata registrata una crescita dell’installato in ad altre Regioni che hanno analoghe caratteristiche linea con la media (ad esempio l’Emilia Romagna – territoriali ed abitative, ma una penetrazione per abicresciuta di oltre il 55%) devono ciò anche ad una tante del fotovoltaico decisamente più bassa (si pensi buona dotazione di finanziamenti in conto capitaad esempio alla Lombardia – con 11,9 kW/mille abile ed in conto interessi messi a disposizione dalle tanti - o al Piemonte – con 17 kW/mille abitanti). Amministrazioni Locali, come illustrato nel paragrafo 1.2.4. L’unica Regione che tra il 2008 e A metà strada tra il Sud ed il Nord si è collocato il 2009 ha sperimentato una diminuzione nella il mercato del fotovoltaico del Centro Italia nel crescita della potenza installata è stata la Toscana, corso del 2009, che è cresciuto, rispetto al 2008, che ha registrato nel 2009 una contrazione di circa di circa il 68%. Tra queste, una Regione che merita www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 63 1. IL fotovoltaico Box 1.9 Le centrali di Montalto di Castro Ad agosto 2009 è stata completata a Montalto di Castro, che gode di condizioni metereologiche e di insolazione particolarmente favorevoli, una centrale fotovoltaica dalla potenza di 6 MW. L’impianto ha un’estensione di circa 9,5 ettari ed è in grado di produrre oltre 7 milioni di kWh all’anno, pari al fabbisogno di 2.700 famiglie, che consentono di evitare l’immissione in atmosfera di 4.500 tonnellate di CO2. L’impianto è stato progettato e realizzato da Enel.si, società controllata di Enel Green Power, con l’utilizzo di pannelli fabbricati dalla giapponese Sharp. A dicembre 2009 è stato inoltre inaugurato, sempre a Montalto di Castro, un ulteriore impianto da 24 MW (si veda figura), che sarà ulteriormente ampliato entro la fine del 2010, fino a raggiungere una potenza di 100 MW. Esso sarà in grado di coprire il fabbisogno di 13.000 abitazioni, rendendo di fatto autonomo il Comune ed evitando l’emissione di 22 mila tonnellate di CO₂ all’anno. La centrale si estende su una superficie di 80 ettari e sfrutta inseguitori solari di ultima generazione, che consentono un incremento del 25% della produttività rispetto ai sistemi fissi. L’impianto è stato progettato e costruito da SunRay Renewable Energy e la sua realizzazione ha richiesto 8 mesi di lavoro e ha coinvolto 250 operai e 10 aziende locali. il 4% dell’installato a causa anche delle disomogeneità conseguenti alla delega delle responsabilità autorizzative che la Regione ha demandato ai Comuni e alle Province. funzione della loro estensione territoriale. Dal confronto di questi dati con quelli riportati in figura 1.24 emerge chiaramente come esistano diverse realtà, tra cui la Liguria, la Valle D’Aosta, la Calabria e la Toscana, che non hanno ancora sperimentato un consistente sviluppo del fotovoltaico, come invece è accaduto in altre Regioni italiane, molte delle quali maggiormente penalizzate dal punto di vista La figura 1.25 riporta invece la potenza installata al 31/12/2009 (confrontata con il valore corrispondente alla fine del 2008) nelle diverse Regioni espressa in Figura 1.25 Potenza installata nelle diverse Regioni italiane al 31/12/2008 e al 31/12/2009 espressa in funzione della loro estensione territoriale 8,0 7,0 6,0 5,0 kW/Km2 al 31/12/2008 4,0 3,0 kW/Km2 al 31/12/2009 2,0 1,0 64 Friu li Cala bria Mol ise Ligu ria Vall e D’ Aos ta Pug lia Lom bar dia Laz Emi io lia R oma gna Piem onte Ven eto Tre M a ntin rche o Al to A dige Sici lia Sar deg na Tos can a Bas ilica ta Um bria Cam pan ia Abr uzzo 0,0 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Box 1.10 Il caso Lombardia38 In tabella 1.9 si riporta innanzitutto la potenza e il numero di impianti installati nelle diverse Province lombarde al 31/12/2009. L’esame dei dati riportati in tabella mostra come la Provincia più “virtuosa” sia quella di Brescia, sia per quanto riguarda il numero di impianti, sia considerando la potenza complessiva. Al 31/12/2009 in Provincia di Brescia risulta installato oltre il 25% di tutti gli impianti esistenti in Lombardia. Segue poi la Provincia di Bergamo (con oltre il 15% degli impianti lombardi) e quella di Milano (con circa il 13%). In termini assoluti il fotovoltaico ha sperimentato invece una diffusione molto più limitata nelle Province di Lodi, Sondrio e Lecco. Interessanti considerazioni emergono se si considera la taglia media degli impianti. Nelle Province di Lecco, Como e Sondrio sono preponderanti impianti di dimensioni relativamente piccole, a suggerire una prevalenza di sistemi residenziali o utilizzati in piccole imprese commerciali. La taglia media dell’impianto aumenta invece nelle Province di Pavia e Lodi, in cui significativa è la diffusione di impianti realizzati a terra o sulla copertura di serre o edifici di società agricole. La Provincia di Pavia, in particolare, ha una dimensione media degli impianti installati molto maggiore rispetto alla media italiana (che si attesta sui 15,6 kW), con una crescita consistente rispetto alla fine del 2008. Questo si spiega con l’attenzione che gli investitori hanno recentemente riservato al territorio pavese (dove, come accennato in precedenza, esiste una “sacca” solare in cui si raggiungono livelli di irraggiamento particolarmente elevati) come localizzazione ideale per l’installazione di impianti fotovoltaici di grande taglia. La tabella 1.10 riporta invece i dati relativi al numero di impianti e alla potenza installata rapportati al numero di abitanti ed all’estensione territoriale delle diverse Province lombarde. L’analisi della tabella mostra che: • le Province di Milano e la neonata Provincia di Monza e Brianza sono le prime per diffusione del fotovoltaico in termini relativi rispetto all’estensione territoriale. Diversamente, il valore per abitante le colloca all’ultimo posto di questa particolare classifica. Questo è il risultato della forte densità abitativa di queste Province, in cui predominano unità abitative a più piani e multifamiliari; • le Province di Brescia e Bergamo confermano il loro ruolo di primo piano nella diffusione del fotovoltaico anche in termini relativi (soprattutto se si tiene conto Tabella 1.9 Potenza e impianti installati al 31/12/2009 nelle diverse Province lombarde Numero impianti 38 Percentuale rispetto al numero di impianti installati in Italia Percentuale rispetto al numero di impianti installati in Lombardia Potenza cumulata al 2009 (kW) Potenza installata nel 2009 (kW) Percentuale rispetto alla potenza cumulata al 2009 in Italia Percentuale rispetto alla potenza cumulata al 2009 in Lombardia Percentuale rispetto alla potenza installata nel 2009 in Lombardia Dimensione media impianti (kW) Bergamo 1583 2,3% 15,1% 14843 9901 1,7% 14,6% 16,2% 9,4 Brescia 2666 3,9% 25,4% 24454 16312 2,9% 24,1% 22,5% 9,2 Como 518 0,7% 4,9% 3465 2311 0,4% 3,4% 3,1% 6,7 Cremona 740 1,1% 7,0% 6163 4111 0,7% 6,1% 4,4% 8,3 Lecco 419 0,6% 4,0% 2330 1554 0,3% 2,3% 1,8% 5,6 Lodi 270 0,4% 2,6% 3662 2443 0,4% 3,6% 2,0% 13,6 Mantova 575 0,8% 5,5% 5204 3471 0,6% 5,1% 4,4% 9,0 Milano 1416 2,1% 13,5% 16239 10832 1,9% 16,0% 19,0% 11,5 Monza e Brianza 596 0,9% 5,7% 6182 4124 0,7% 6,1% 5,9% 10,4 Pavia 474 0,7% 4,5% 9573 6385 1,1% 9,4% 11,2% 20,2 Sondrio 383 0,6% 3,5% 2668 1780 0,3% 2,7% 2,4% 7,0 Varese 868 1,3% 8,3% 6704 4472 0,8% 6,6% 7,1% 7,7 TOTALE 10508 15,4% 100,0% 101487 67696 11,8% 100,0% 100,0% 9,8 I dati discussi in questo Box sono stati raccolti nell’ambito del progetto REN LAB – Renewable Energy Lab della CCIAA di Milano. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 65 1. IL fotovoltaico di Lodi, Como, Sondrio e Lecco, anche in termini di diffusione relativa del fotovoltaico. Questo le rende tuttavia un promettente ambito in cui la tecnologia fotovoltaica potrà diffondersi nel prossimo futuro. del fatto che una parte consistente del loro territorio ha carattere montano e quindi nei fatti è difficilmente utilizzabile per l’installazione di impianti fotovoltaici); • si confermano lontane dal pieno sviluppo le Province Tabella 1.10 Potenza e impianti installati al 31/12/2009 nelle diverse Province lombarde per abitante e per estensione territoriale Numero impianti per 100.000 abitanti Potenza per abitante (W) Numero impianti per 100 km² Potenza per km² (kW) Bergamo 145,9 13,7 58,1 5,5 Brescia 214,9 19,7 55,7 5,1 Como 87,9 5,9 40,2 2,7 Cremona 204,6 17,0 41,8 3,5 Lecco 124,1 6,9 51,3 2,9 Lodi 119,9 16,3 34,5 4,7 Mantova 139,6 12,6 24,6 2,2 Milano 45,4 5,2 89,7 10,3 Monza e Brianza 71,0 7,4 147,2 15,3 Pavia 87,3 17,6 16,0 3,2 Sondrio 209,6 14,6 11,9 0,8 Varese 99,2 7,7 72,4 5,6 dell’irraggiamento medio e della configurazione del proprio territorio. Solamente un maggiore sforzo da parte delle Amministrazioni Pubbliche locali, che si concretizzi nello stanziamento di ulteriori fondi da impiegare per il finanziamento dell’installazione di potenza fotovoltaica e soprattutto nello snellimento delle procedure di autorizzazione e di allacciamento dell’impianto, potrà contribuire a fare uscire queste Regioni dallo stadio ancora embrionale in cui il loro mercato fotovoltaico a tuttoggi versa. Nonostante esistano chiaramente diverse “velocità” con cui il mercato fotovoltaico si è affermato nelle Regioni italiane, bisogna ricordare come sussistano anche delle marcate disuniformità all’interno del territorio delle stesse Regioni. Il box 1.10 approfondisce lo studio del caso della Lombardia, illustrando le differenze esistenti tra le Province lombarde. 1.3.3 Gli sviluppi futuri del fotovoltaico in Italia Dopo aver approfondito le dinamiche che hanno caratterizzato il mercato del fotovoltaico in Italia, l’obiettivo di questo paragrafo è illustrare le prospettive di sviluppo future del fotovoltaico nel nostro Paese. Si presenteranno innanzitutto le 66 stime sull’evoluzione attesa delle installazioni nei prossimi anni, mentre nella seconda parte del paragrafo si presenterà un’analisi del potenziale “teorico” di crescita del fotovoltaico in Italia. 1.3.3.1 L’evoluzione attesa Per stimare l’evoluzione attesa del fotovoltaico in Italia, sono stati costruiti due scenari, uno ottimistico ed uno pessimistico, cui corrispondono diversi tassi di crescita della potenza installata. Entrambi gli scenari assumono, dato che si tratta di un’eventualità assolutamente certa, che nel corso del 2010 si realizzi la revisione del Nuovo Conto Energia di cui si è discusso nel paragrafo 1.2.5, in occasione della quale le tariffe feed-in verranno profondamente riviste al ribasso. Lo scenario ottimistico è caratterizzato da: • una revisione del Nuovo Conto Energia in linea con la proposta definita congiuntamente da Aper, Assosolare e GiFi, di cui si è parlato nel paragrafo 1.2.5. Si tratta di un’assunzione che consideriamo comunque ottimistica in quanto il Governo, come emerge dal confronto con gli operatori del settore, sembra essere propenso ad una modifica del sistema incentivante più penalizzante per le installazioni fotovoltaiche, per quanto www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato riguarda l’entità delle tariffe feed-in e soprattutto per quanto concerne il limite massimo di potenza incentivabile (pari, nella proposta definita congiuntamente da Aper, Assosolare e GiFi, a 8 GW per il periodo 2011-2015); • una riduzione del prezzo dell’impianto fotovoltaico nell’ordine dell’8% annuo, il che si traduce in una consistente diminuzione nel tempo del costo medio di produzione dell’energia elettrica da fotovoltaico; • un’accelerazione del processo di semplificazione delle procedure autorizzative e di allacciamento dell’impianto fotovoltaico (che il GSE ha già avviato all’inizio del 2010 e di cui si è parlato nel paragrafo 1.2.2) e che diversi operatori stimano si possa estendere anche al frammentato processo di connessione alla rete dell’impianto; • una conferma dell’attenzione dimostrata particolarmente nell’ultimo anno dalle Amministrazioni Pubbliche locali nel supportare, attraverso investimenti in conto interesse e conto capitale, l’installazione di nuovi impianti nei territori di competenza. riffe feed-in (nell’ordine in media del 25% ) e un tetto molto più basso per la potenza incentivabile (pari a 3 GW di nuova potenza installata tra il 2011 e il 2015); • una riduzione del prezzo dell’impianto fotovoltaico nell’ordine del 5% annuo, valore inferiore rispetto a quanto registrato negli ultimi anni a causa di un fenomeno di saturazione dell’efficientamento ottenibile sulla tecnologia cristallina, che ancora nei prossimi anni avrà un ruolo preponderante nelle nuove installazioni; • nessuna sostanziale modifica e semplificazione al processo di autorizzazione e di connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico; • una profonda revisione nelle politiche di incentivazione e supporto messe in atto dalle Amministrazioni Pubbliche, che si traduca in un taglio delle risorse disponibili per sostenere l’investimento iniziale. Lo scenario pessimistico si contraddistingue invece per: In entrambi gli scenari, nel corso del 2010 è verosimile si realizzi ancora un significativo aumento della potenza installata, rispetto ai livelli raggiunti nel 2009, per effetto della “corsa alle installazioni” cui si cimenteranno gli operatori prima del • una revisione dell’attuale sistema di incentivazione che prevede tagli più significativi alle ta- La figura 1.26 descrive l’evoluzione della potenza fotovoltaica installata in Italia in ciascuno dei due scenari precedentemente illustrati. Figura 1.26 Evoluzione della potenza fotovoltaica installata in Italia per scenario 8000 7000 MW 6000 5000 Scenario Pessimistico 4000 Scenario Ottimistico 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2015 67 1. IL fotovoltaico raggiungimento del limite di 1.200 MW previsto dall’attuale Nuovo Conto Energia. Con ogni probabilità, questo limite verrà superato già nella prima metà del 2010, ma considerato il periodo di proroga (di 14 mesi per gli impianti di proprietà privata e di 24 mesi nel caso di Amministrazioni Pubbliche) concesso dal legislatore per installare gli impianti già autorizzati prima del raggiungimento dei 1.200 MW, anche nella seconda metà del 2010 il tasso di crescita del mercato si manterrà consistente. Con l’entrata in vigore delle nuove tariffe, a partire dal 2011 il mercato subirà però un’inevitabile contrazione, che sarà ovviamente maggiore nel caso si realizzi lo scenario pessimistico. In caso di riduzione delle tariffe prevista dallo scenario pessimistico, tuttavia, considerati i risultati dell’analisi della redditività degli impianti di cui si è parlato nel paragrafo 1.2.5, è possibile che in alcuni segmenti di mercato – segnatamente quello delle centrali e quello degli impianti industriali (soprattutto a bassa componente di autoconsumo) – si assista a una “frenata” estremamente significativa. È in ogni caso verosimile che a partire dalla fine del 2014 ci si avvicini al limite dei 3 GW di nuova potenza incentivabile, il che porterà necessariamente ad un rallentamento del mercato. Questo anche a causa del comportamento degli investitori (ad esempio fondi investimento e utilities), che tenderebbero a privilegiare maggiormente mercati con un forte potenziale di crescita futura. Nello scenario ottimistico, invece, dopo un iniziale rallentamento delle installazioni che seguirà all’entrata delle nuove tariffe, a partire dal 2012 il mercato ricomincerà a crescere a tassi consistenti, considerata l’elevata redditività che gli investitori potranno comunque conseguire (si veda paragrafo 1.2.5). Le simulazioni condotte ed il confronto con le esperienze di altri Paesi europei portano comunque a ritenere che, entro il 2015, il limite di 8 GW di installato attraverso il nuovo sistema di incentivazione (assunto come ipotesi nello scenario ottimistico) non verrà comunque raggiunto. Fintanto che la riduzione delle tariffe si manterrà nell’ordine dei valori ipotizzati nei due scenari, sembra che l’evoluzione del mercato da qui al 2015 sarà influenzata più dall’entità del tetto di potenza massima incentivabile che dall’entità del taglio delle tariffe, come insegna tra l’altro l’esperienza della Spagna (si veda paragrafo 1.2.1). Questo rappresenta un importante messaggio per il legislatore, in quanto il tetto massimo di potenza incentivabile (e quindi installabile) influenza direttamente il contributo che la fonte solare potrà assicurare al raggiungimento degli impegni presi dall’Italia in sede europea39, ma ha anche delle ripercussioni sulle dinamiche evolutive del mercato. Per completezza di analisi, sono state condotte delle simulazioni sullo sviluppo del mercato fotovoltaico in Italia nel caso in cui non si realizzasse quella profonda discontinuità nel sistema di incentivazione che il Governo Italiano si presta invece a varare. Ipotizzando una riduzione delle tariffe graduale e nell’ordine di quanto realizzato in Germania a partire dal 200640, non sarebbe irragionevole attendersi che il mercato italiano del fotovoltaico raggiunga i 5 GW di potenza installata già nel 2013, per avvicinare quota 10 GW nel 2015. In questo caso, il contributo della tecnologia fotovoltaica ad una maggiore indipendenza energetica del nostro Paese ed al raggiungimento dei sopracitati obiettivi sarebbe tutt’altro che marginale. Questo a fronte di un costo per lo Stato, e quindi per tutta la collettività, sicuramente consistente, ma che riteniamo dovrebbe essere oggetto di una valutazione completa e onnicomprensiva, come è stato proposto nel paragrafo 1.2.3 del presente rapporto. 1.3.3.2 Il potenziale “teorico” di sviluppo del fotovoltaico in Italia Obiettivo di questo paragrafo è di fornire una stima del potenziale di crescita “teorico” del fotovoltaico in Italia al 2020. Non è infrequente che nel dibattito pubblico si sollevino delle voci secondo cui non esistono in Italia le condizioni di irraggiamento e di configurazione del territorio che possono permettere alla fonte fotovoltaica di diffondersi in modo consistente e di contribuire così all’indipendenza energetica e ad incrementare sensibilmente il peso delle fonti rinnovabili sui consumi di energia. La nostra analisi dimostra invece come esistano molteplici ambiti di applicazione che potrebbero potenzialmente assicurare una diffusione su larga scala della fonte fotovoltaica, che è importante conoscere per realizzare una valutazione compiuta del ruolo che il fotovoltaico potrà assumere nel nostro mix energetico futuro e per pianificare di conseguenza le politiche più opportune. 39 In particolare, il “Pacchetto-Clima-Energia” (noto anche come “Pacchetto 20-20-20”) approvato nel 2008 dalla Commissione Europea obbliga l’Italia a raggiungere una percentuale del 17% di energia da fonti rinnovabili sul totale di quella consumata entro il 2020. 40 Il decremento medio delle tariffe feed-in in Germania è stato dell’ordine del 5,5% tra il 2006 e il 2007 e del 7% tra il 2007 e il 2008 a fronte di una crescita media del mercato del 42% tra il 2004 e il 2008. In seguito, la tariffa incentivante ha subito un decremento percentuale superiore (si veda il paragrafo 1.2.1) 68 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato e associando a ciascuna nuova unità abitativa 1 kW di installazione fotovoltaica, è possibile stimare in 5,2 GW la potenza fotovoltaica teoricamente installabile da oggi al 2020. La stima non • le nuove edificazioni residenziali, che rapprevaria sostanzialmente se si ipotizzasse che solo una sentano un ambito di applicazione degli impianti porzione delle nuove edificazioni ospitino un imdi piccola taglia, ad uso prevalente di auto-conpianto da 1 kW (ad esempio a causa del fatto che sumo. Si tratta di un segmento che potrebbe divemolte delle nuove unità abitative fanno parte di nire in futuro molto promettente nel caso in cui condomini in cui non è possibile installare 1 kW nel mercato immobiliare si affermasse una ancor di potenza fotovoltaica per ogni unità per motivi di maggiore sensibilità alle prestazioni ambientali spazio), ma considerare (come è d’altronde verosidegli edifici o venissero approvate e rese operatimile) che un numero consistente di impianti resive le normative già peraltro approvate (anche se denziali verrà installata su costruzioni esistenti. se ne attende l’entrata in vigore) che impongono Per quanto riguarda le coperture della GDO in l’uso delle rinnovabili nelle nuove edificazioni41; • le coperture delle superfici commerciali della Italia, esse hanno un estensione, a fine 2009, pari Grande Distribuzione Organizzata, che costia circa 5,3 milioni di metri quadrati42. A questi vanno aggiunti circa 2,6 milioni di metri quadrati tuiscono un interessante comparto per l’instalrelativi alle coperture delle piccole sulazione di impianti fotovoltaici di perfici commerciali. Supponendo che taglia medio-grande dato che il loro “Il potenziale inespresso del nel periodo 2010 – 2020 la totalità di fabbisogno energetico è per lo più fotovoltaico in Italia è enorme, concentrato in quelle ore del giorno si tratta solo di capire quanto lo queste superfici vengano utilizzate per e in quei periodi dell’anno (princi- Stato voglia puntare su questa l’installazione di impianti fotovoltaici fonte per rispettare gli impegni è possibile stimare un potenziale di palmente per esigenze di climatizzapresi a livello europeo” crescita di circa 680 MW43. Una prozione) in cui il prezzo dell’elettricità Amministratore Delegato di un’impresa è maggiore e in cui l’impianto foto- italiana produttrice di celle e moduli spettiva di analisi più “ottimistica”, che consideri la crescita delle superfivoltaico produce più energia; ci a disposizione e l’impiego degli im• le coperture delle serre ortofruttipianti fotovoltaici anche per la copertura parziale cole, estremamente diffuse nel nostro Paese, che delle superfici destinate a parcheggio (nella parte rappresentano, per motivi di natura tecnica, un già attualmente “coperta”) porta questa stima a interessante ambito di diffusione della tecnologia oltre 1,3 GW al 2020. fotovoltaica (si veda paragrafo 1.3.6); La superficie delle serre per coltivazioni agrarie • le superficie coperte delle aree portuali, anch’esa fine 2008 in Italia è pari a circa 300 milioni di se destinate ad accogliere impianti di mediometri quadrati44. Se, nel periodo 2010 – 2020, anche grande taglia e particolarmente diffuse nel nosolo una percentuale limitata di questa superficie stro Paese; disponibile (ad esempio il 20%) venisse destinata • i terreni incolti o a scarso rendimento agricolo, all’installazione di impianti fotovoltaici, la poche potrebbero essere destinati invece all’instaltenza totale installata ammonterebbe a circa 5,8 lazione di centrali fotovoltaiche di grande taglia. GW. Anche in questo caso, si avrebbe una stima analoga se si ipotizzasse di destinare una percenPer quanto riguarda il primo ambito di applicaziotuale ancora più limitata delle coperture di serre ne, le nuove unità abitative realizzate in Italia nel esistenti all’installazione di impianti fotovoltaici, periodo 1995-2006 sono state pari nel complesso a ma si considerassero le nuove serre che verranno oltre 5 milioni di unità, ciascuna con un’estensione costruite da qui al 2020. media di 80 m2. Ipotizzando un simile trend di crescita dell’edificato anche per il periodo 2010 – 2020 Per quanto concerne le aree portuali in Italia, è Nell’ambito dell’analisi, sono stati considerati i seguenti campi di diffusione del fotovoltaico: 41 La legge 25/2010 di conversione del Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto decreto legge “Milleproroghe”), ha posticipato al 1° gennaio 2011 la scadenza prevista per il 1° gennaio 2010, che definisce il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. L’obbligo è peraltro da considerarsi già vigente nei comuni che nel frattempo hanno adeguato i propri regolamenti edilizi. 42 Elaborazione da fonti CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) sulle superfici commerciali sopra i 5.000 m2. Il dato è calcolato a partire dalla GLA tenendo conto del numero medio di piani delle strutture commerciali nelle differenti Regioni. 43 Si avrebbe una stima analoga se si ipotizzasse di destinare all’installazione di impianti fotovoltaici una percentuale inferiore delle coperture esistenti, ma si considerassero i progetti in essere per la realizzazione di nuovi centri commerciali. 44 Elaborazione da fonti ISTAT sulle serre per coltivazioni agrarie. Non considerando le serre per floricoltura, per le quali mancano dati, si tratta di una stima decisamente per difetto. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 69 1. IL fotovoltaico Tabella 1.11 Potenziale “teorico” di crescita delle installazioni al 2020 in Italia per campi di applicazione Applicazioni Edificazioni residenziali Superfici della GDO Serre ortofrutticole Aree portuali Terreni incolti Totale possibile stimare una superficie complessiva coperta nell’ordine di 3 milioni di metri quadrati. Se questa superficie venisse destinata all’installazione di impianti fotovoltaici, si realizzerebbe una crescita della potenza nell’ordine di 250 MW. Chiaramente questa stima non considera i numerosi progetti di ampliamento o di nuove costruzioni in essere e che verranno realizzati negli anni a venire. Infine, le foraggere permanenti (prati e pascoli, di cui il 32% classificato come “pascoli poveri”) e le foraggere non permanenti (erbai e prati avvicendati) hanno in Italia, al termine del 2008, un’estensione di 35,3 e 19,5 miliardi di metri quadrati. Se si destinasse, da qui al 2020, solamente l’1% di questi terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”, si registrerebbe una crescita della potenza di circa 27,4 GW. Considerando tutte queste possibili applicazioni della tecnologia fotovoltaica, è possibile stimare un potenziale di crescita “teorico” del fotovoltaico in Italia da qui al 2020 nell’ordine di 39 GW (si veda tabella 1.11). Questo senza considerare che ovviamente esistono molteplici altri promettenti campi di applicazione che non sono stati considerati in questa analisi, quali ad esempio le coperture di stazioni ferroviarie, aeroporti o di centri logistici e di smistamento merci. Si tratta ovviamente di una crescita della potenza fotovoltaica nei fatti irrealizzabile in Italia, dal momento che sussistono dei vincoli di natura tecnica (legati all’impatto che un tale incremento di potenza distribuita avrebbe sull’infrastruttura di distribuzione) e di mercato (relativi sia alla domanda che, quand’anche rimanesse in vigore l’attuale sistema di incentivi, non sarebbe in grado di “trainare” una crescita quale quella dipinta in questo paragrafo, sia all’offerta, dato cha la filiera e il sistema industriale esistente non sembrano capaci di “reggere” questi tassi di sviluppo). Questo senza contare che il sistema di incentivazione, da qui al 70 Potenza (GW) 5,2 0,68 5,8 0,25 27,4 39,3 2020, avrà ancora un peso fondamentale (si veda paragrafo 1.2.5) nel determinare lo sviluppo del mercato, e l’incipiente revisione del Nuovo Conto Energia non potrà che avere un effetto frenante. Se è indiscutibile che in Italia non si potrà realizzare la crescita cui si fa riferimento in questo paragrafo, è altrettanto vero che esistono altri Paesi, uno su tutti la Germania, che hanno espresso e ancora esprimeranno in futuro un potenziale analogo a quello delineato in queste pagine. Alcune stime accreditate tra gli operatori di mercato ritengono che nel 2020 la Germania, nonostante abbia delle caratteristiche meno favorevoli rispetto al nostro Paese allo sfruttamento della fonte solare, avrà oltre 45 GW di potenza fotovoltaica installata, che corrisponderanno a circa 519 kW per mille abitanti. Se l’Italia dovesse colmare il gap, in termini di penetrazione per fotovoltaico, che la divide da questo Paese leader a livello mondiale, dovrebbe installare da qui al 2020 oltre 31 GW (la penetrazione attuale del fotovoltaico è in media di 21,4 kW pro milia capita in Italia), il che porta ad una stima in linea con quanto emerso dallo studio che è stato descritto in precedenza. Si tratta quindi di una potenzialità “teorica”, ma che almeno in Germania si è dimostrata molto “concreta”. 1.3.4 La grid parity nel fotovoltaico Il raggiungimento della grid parity è indubbiamente l’obiettivo ultimo di chi sviluppa tecnologie di produzione energetica da fonte rinnovabile. Il concetto nella sua formulazione verbale appare semplicissimo, giacché fa riferimento alla “parità” fra il costo di produzione dell’energia da fonte rinnovabile e il costo di acquisto dell’energia dalla rete (“grid” appunto), che invece si basa per la quasi totalità sulla produzione elettrica da fonti fossili “tradizionali”. Al raggiungimento della grid parity si ha – almeno teoricamente – l’indifferenza perfet- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato • la definizione della vita utile – convenzionalmente fissata in 25 anni, ma che rappresenta una stima per difetto dell’effettiva potenzialità degli impianti “moderni” – e degli oneri di gestione e manutenzione è altro parametro che si modifica significativamente a seconda della potenza 1.3.4.1 La definizione di grid parity e alcune dell’impianto e, per quanto riguarda gli oneri, ipotesi di base del “potere contrattuale” dei contraenti; La “traduzione” del concetto di grid parity in • il calcolo della produttività dell’impianto è ovforma analitica, ovvero il provare concretamente viamente influenzato dalla specifica localizzaa calcolare il punto di parità fra il costo dell’enerzione, che ne determina l’insolazione media dugia prodotta dagli impianti fotovoltaici e l’energia rante l’anno, oltre che dall’efficienza dei moduli, acquistata dalla rete, porta con sé una serie di proma anche dalle scelte relative agli inverter e ai blemi, alcuni dei quali di non facile soluzione. sistemi di controllo, e ancora dal grado di efficacia dell’attività di manutenzione; La prima obiezione, forse la più sostanziale, è ad• infine, anche il calcolo del termine di confrondirittura sul principio stesso di indifferenza ecoto, ossia del costo di acquisto dell’energia dalla nomica. Se è vero, infatti, che questo si può applicare “rete”, è estremamente complesso giacché ditranquillamente al caso di una impresa (ad esempio pende, per le utenze residenziali, commerciali e una grande utility) che dispone di cenindustriali, dal profilo di consumo e trali di produzione elettrica e che quindal tipo di tariffa elettrica adottato, e “Esistono decine di definizioni di usa gestire e mantenere impianti per ancora dalla scelta o meno di vendere differenti di grid parity, è la generazione di energia, non è altret- necessario fare chiarezza in questo l’energia piuttosto che di “scambiarla campo per valutare correttamente tanto vero che per il privato cittadino sul posto”46 , mentre per le “centrali” la convenienza nell’incentivare ulteriormente la tecnologia fotovoltaiche il paragone deve essere (o anche la piccola e media impresa fotovoltaica” fatto tenendo conto esplicitamente industriale o commerciale) si possa Marketing Manager di un’impresa dei costi di dispacciamento, ossia dei considerare indifferente – anche a produttrice di celle e moduli costi che devono essere sostenuti per parità di costo – l’acquistare energia far arrivare l’energia prodotta, attradalla rete o disporre in proprio di un verso la rete elettrica nazionale, agli utenti finali. impianto di produzione di energia. Nel secondo caso, solo per citare qualche esempio, il rischio leDi fronte ad un numero di possibili combinaziogato al funzionamento dell’impianto, la complesni praticamente infinito ed al problema di fondo sità di gestirne la manutenzione e l’irreversibilità circa la correttezza della misura dal punto di vista dell’investimento45 vanno a “pesare” (anche se non economicamente) sul proprietario dell’impianconcettuale, la scelta fatta per l’analisi condotta to, mentre sono assolutamente irrilevanti quando è quella di assumere una prospettiva “originale” l’energia viene “prelevata” direttamente dalla rete. e misurare la grid parity non tanto guardando all’uguaglianza del costo di produzione dell’enerLa seconda questione riguarda l’estrema variabigia con il costo di acquisto della stessa dalla rete, lità dei fattori chiave per la determinazione dei bensì di verificare la sostenibilità per se dell’invevalori utilizzati per il calcolo della grid parity: stimento in un impianto fotovoltaico. ta, dal punto di vista economico, fra le diverse fonti di energia. Nel caso del fotovoltaico ciò si tradurrebbe nel rendere economicamente conveniente la produzione di energia da fonte solare anche nella totale assenza di sistemi di incentivazione. • innanzitutto, l’investimento necessario a parità di potenza ed efficienza dell’impianto fotovoltaico può variare significativamente a seconda della localizzazione geografica, per effetto della maggiore o minore complessità dell’iter autorizzativo e/o del grado di competizione fra system integrator e installatori; Il cambio di prospettiva, che è certamente radicale, è però secondo l’analisi condotta estremamente utile perché risolve molti (anche se non tutti) dei problemi sopra evidenziati. Assumendo la prospettiva dell’investimento si considera esplicitamente il rischio per il proprietario dell’impianto e si risolve quindi la prima e più importante obie- Si pensi ad esempio all’impossibilità di recuperare l’investimento fatto qualora si decida di vendere casa o di dismettere l’attività produttiva prima di aver raggiunto il tempo di pay back dell’impianto. Come già osservato nel paragrafo 1.2.5, nel caso di scambio sul posto il paragone va fatto con il costo di acquisto dell’energia, mentre nel caso di cessione dell’energia alla rete come riferimento bisogna assumere il prezzo medio d’acquisto (PUN) da parte dell’Acquirente Unico. 45 46 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 71 1. IL fotovoltaico zione di natura concettuale sulla correttezza della misura di “indifferenza economica”. Assumendo la prospettiva dell’investimento possono essere presi in considerazione tutti gli oneri di natura fiscale (certo non irrilevanti) e connessi all’impiego del capitale (si pensi al “costo” di immobilizzare il capitale per la realizzazione di una centrale da qualche MW) che altrimenti vengono trascurati, ma che sono indispensabili per valutare la concreta fattibilità dell’impianto. Assumendo la prospettiva dell’investimento, il termine di paragone è più semplicemente identificabile nel tasso di rendimento alternativo che rende indifferente per l’investitore la scelta di realizzare l’impianto fotovoltaico. In altre parole, la grid parity si raggiungerà quando l’investimento in un impianto fotovoltaico sarà economicamente conveniente, in termini di rendimento dell’investimento stesso, anche in assenza di incentivi. Ovviamente rimangono i problemi visti sopra di valutazione delle componenti di costo e di definizione della produttività, per i quali si è qui fatto volutamente riferimento ai valori medi rilevati durante l’analisi condotta e le interviste con gli operatori. La tabella 1.12 riporta le assunzioni di base fatte per eseguire i calcoli per tre impianti “tipo” rappresentativi dei tre segmenti di mercato individuati, ossia il segmento residenziale, industriale e delle centrali. Tenendo conto del basso grado di rischio connesso all’investimento la parità è fissata per ritorni del 5% nel caso degli impianti residenziali e del 10% nel caso degli impianti industriali e delle centrali. 1.3.4.2 Il fotovoltaico in Italia: a quando l’indipendenza dagli incentivi? Vengono presentati in questo paragrafo i risultati dell’analisi condotta per i diversi segmenti di mercato in Italia che tiene conto, da un lato, dei parametri riportati nella tabella 1.12 e, dall’altro lato, di una ragionevole stima dell’evoluzione del costo di investimento associato alla realizzazione degli impianti stessi che (si veda paragrafo 1.2.5) può essere assunto in riduzione di circa il 5% all’anno per almeno i prossimi 6-8 anni. La figura 1.27 riporta, in assenza di incentivi, la curva degli IRR (ossia dei rendimenti dell’in- Tabella 1.12 Principali voci di costo per tre impianti “tipo” (residenziale, industriale, centrale) Principali voci di costo (2009) Costo di realizzazione dell’impianto (€/kW) Costo di connessione alla rete elettrica (€) Costo annuo di gestione (manutenzione, assicurazione) (€/anno) Leva finanziaria Produzione annua media (kWh/kW)47 Regime di trattamento fiscale Regime di produzione elettrica 3 kW 200 kW 1 MW 5.500 3.800 3.200 305 40.000 75.250 448 15.200 48.000 100% 75% 75% 1.000 per le Regioni del Nord, 1.200 per il Centro e 1.400 per il Sud Italia. Soggetto a Soggetto a imposizione fiscale imposizione fiscale Persona fisica per la parte per la parte esente da relativa alla tariffa relativa alla tariffa imposizione fiscale incentivante e alla incentivante e alla vendita di energia vendita di energia Scambio sul Scambio sul posto o Vendita dell’energia posto (valore vendita dell’energia prodotta al prezzo medio dell’energia alla rete al prezzo medio di acquisto (PUN) previsto risparmiata in medio di acquisto dall’Acquirente bolletta pari a circa (PUN) previsto Unico 750 €/anno) dall’Acquirente Unico I valori medi utilizzati sono cautelativi e fanno riferimento all’energia prodotta e messa in rete al netto delle perdite di sistema (come evidenziato nel paragrafo 1.2.5). 47 72 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.27 Grid parity per un impianto da 3 kW 10 IRR (%) 5 0 Sud -5 Media nazionale -10 -15 -20 2012 2015 vestimento) per un impianto da 3 kW messo in funzione nei diversi anni riportati sull’asse delle ascisse. Per gli impianti da 3 kW la grid parity appare ancora relativamente lontana, ed è raggiunta nel giro di 10 anni, ossia nel 2020, nelle aree a maggior insolazione (si veda la linea blu che rappresenta gli impianti con una producibilità media annua di 1.400 kWh/kW), mentre bisogna attendere ulteriori 3 anni per raggiungere lo stesso risultato se si prende in considerazione l’insolazione media in Italia. Ovviamente questo dipende dal fatto che il costo al kW degli impianti residenziali è il più alto presente nel settore, a causa dell’assenza di “effetti di scala” nell’acquisto e della parcellizzazione dell’attività di installazione. Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti da sottolineare: • se è vero che l’indipendenza completa dagli incentivi per questo tipo di impianti è ancora di là da venire, è altrettanto vero che – secondo le nostre stime – già nel 2015 (ossia fra 5 anni) la grid parity potrebbe essere raggiunta in tutta Italia con un livello di incentivi pari a 20 c€/kWh (quasi il 60% in meno degli incentivi attuali) e nel 2018 allo stesso scopo sarebbero sufficienti 10 c€/kWh; • la diffusione degli impianti fotovoltaici residenziali contribuisce in maniera significativa a “ridurre” i consumi elettrici delle abitazioni, soddisfacendo potenzialmente l’intero fabbiso- 2018 2021 gno diurno di energia di una famiglia italiana media48. In questa prospettiva, il mantenimento di un livello minimo di incentivazione, quale quello indicato al punto precedente, dovrebbe essere correttamente considerato come un investimento verso l’efficientamento energetico del Paese. Le prospettive appaiono in ogni caso più rosee per gli impianti industriali con una taglia media da 200 kW. Se si considera, infatti (come assunto nella figura 1.28) la possibilità di “scambio sul posto”, che è qui particolarmente redditizia visto che gli impianti fotovoltaici producono di più proprio nelle ore del giorno ove è più alto il costo del prelievo di energia dalla rete, già nel 2016 nelle Regioni del Sud e nel 2018 se si considera il dato medio italiano l’investimento in questo tipo di impianti è economicamente conveniente anche in assenza di incentivi. E’ ancor più interessante sottolineare come già dal 2012 l’investimento abbia in realtà un rendimento percentualmente positivo, anche se probabilmente non sufficiente a convincere un eventuale investitore. La grid parity si sposta in avanti – nel 2020 per il Sud Italia – se si prende in esame il caso in cui l’energia venga venduta invece che auto-consumata. È chiaro come, a differenza del caso residenziale, la “scala” dell’impianto e la possibili- 48 Una famiglia in un anno consuma circa 3.300-3.500 kWh. Un impianto fotovoltaico da 3kW con una producibilità media annua di 1200 kWh/kW produce 3.600 kwh all’anno. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 73 1. IL fotovoltaico Figura 1.28 Grid parity per un impianto da 200 kW (con scambio sul posto) 20 18 16 IRR (%) 14 12 Sud 10 8 Media nazionale 6 4 2 0 2012 2015 2018 2021 Figura 1.29 Grid parity per un impianto da 200 kW (senza scambio sul posto) 12 10 8 IRR (%) 6 4 Sud 2 0 Media nazionale -2 -4 -6 -8 2012 2015 2018 tà per l’impresa che se ne fa carico di negoziare direttamente con i produttori di moduli e altri componenti, oppure di rivolgersi a grandi system integrator, abbassi significativamente i costi (e conseguentemente incrementa il rendimento economico dell’investimento). Le centrali fotovoltaiche, ovvero gli impianti con una taglia di potenza in media pari a 1 MW, raccontano una storia ancora differente per almeno due ragioni: (i) perché in questo caso si devono sopportare, per arrivare alla grid parity, anche i costi di dispacciamento (peraltro simili a quelli delle tradizionali centrali a fonti fossili) dell’energia elettrica prodotta; (ii) perché sono qui signifi- 2021 cativi i costi di “immobilizzo” del capitale, anche per i lunghi tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni e successivamente la connessione alla rete49. La grid parity (si veda figura 1.30) si raggiunge così nel 2023 (fra 13 anni) nelle Regioni del Sud e 3 anni più tardi in tutta Italia. In particolare, già nel 2018, a fronte di un incentivo di circa 12 c€/ kWh, la grid parity potrebbe essere raggiunta nel Sud Italia. Nel 2021 la grid parity potrebbe essere raggiunta nel Sud Italia e nel resto d’Italia con un incentivo rispettivamente pari a 5 €/kWh e a 9 €/kWh. In realtà, è necessario “correggere” i dati precedenti per tener conto che, nel caso delle centrali fotovol- 49 Nel caso di una centrale da 1 MW, i costi del solo immobilizzo del capitale sono pari a circa 75.000 € (pari al 2,4% dell’investimento tecnico complessivo), per tempi di autorizzazione e connessione che nel complesso si attestano intorno a 6 mesi. 74 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.30 Grid parity per un impianto da 1 MW 8 6 IRR (%) 4 2 0 Sud -2 Media nazionale -4 -6 -8 2012 2015 2018 2021 Figura 1.31 Renewable grid parity per un impianto da 1 MW 16 14 IRR (%) 12 10 8 Sud 6 Media nazionale 4 2 0 -2 2012 2015 2018 taiche, ove l’obiettivo dell’investimento è la produzione di energia elettrica da immettere in rete, non ci si può dimenticare che esiste un obbligo50 di immissione di energia elettrica “pulita”. Per spingere al rispetto di quest’obbligo esiste un meccanismo, quello dei Certificati Verdi, che nulla ha a che vedere con le tariffe feed-in, ma che ugualmente potrebbe remunerare i produttori di energia fotovoltaica. Se si tiene conto del valore medio che i Certificati Verdi hanno avuto tra il 2003 e il 2010 (ossia circa 97 €/ MWh) e lo si proietta sull’orizzonte di riferimento dell’indagine condotta, si ottengono le curve riportate in figura 1.31. Il punto di equilibrio, simbolicamente ribattezzato renewable grid parity, è 2021 molto più vicino e nel 2018 sarà possibile avere le prime centrali fotovoltaiche realizzate senza bisogno di incentivi nel Sud Italia, raggiungendo la grid parity nel 2021 nel resto d’Italia. Lo scenario cui ci si trova di fronte merita grande attenzione e, come più volte detto, lascia presupporre che il destino del fotovoltaico sia quello di rappresentare una delle fonti di energia rinnovabile più importanti e ad alta crescita dei prossimi 10-15 anni. Perché queste previsioni si avverino, tuttavia, è bene non dimenticare come sia necessario evitare “scossoni” troppo bruschi nel breve periodo: l’ipo- Il Decreto “Bersani” 79/99 richiede che i produttori di energia elettrica immettano ogni anno sul mercato energia “pulita” (ovvero da fonte rinnovabile) per una percentuale non inferiore al 2% del totale dell’energia da loro immessa nell’anno precedente. L’obbligo può essere anche soddisfatto acquistando Certificati Verdi per un quantitativo corrispondente. 50 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 75 1. IL fotovoltaico tesi di diminuzione del costo degli impianti sottende una serie di investimenti da parte degli operatori del settore in efficientamento produttivo ed in innovazione di prodotto e di processo che avrà luogo solo se – nel frattempo – i governi nazionali avranno la forza e la volontà di assicurare, anche se “artificialmente”, adeguati livelli di profittabilità. 1.3.5 Il Building Integrated Photovoltaics Nel corso dell’ultimo anno gli operatori e gli analisti di mercato hanno prestato sempre maggiore attenzione ad un’applicazione molto promettente della tecnologia fotovoltaica, che va sotto il nome di Building Integrated Photovoltaics (BIPV), ossia fotovoltaico integrato in architettura. Un’applicazione BIPV prevede l’installazione di un sistema fotovoltaico in sostituzione di un convenzionale materiale da costruzione. Questo significa che il sistema fotovoltaico, oltre a produrre elettricità, deve essere in grado di assicurare le medesime prestazioni funzionali del materiale da costruzione che sostituisce, quali l’isolamento termico, la resistenza al vento ed alla pioggia, la rigidità strutturale. Il concetto di BIPV non va tuttavia confuso con quello di Building Applied Photovoltaics (o BAPV), con il quale ci si riferisce alla più tradizionale applicazione del sistema fotovoltaico su materiali da costruzione, frequentemente in modo complanare ad essi. La figura 1.32 illustra le differenze esistenti tra BAPV e BIPV. Figura 1.32 Confronto strutturale tra BAPV e BIPV BIPV- Building Integrated Photovoltaics Sistema fotovoltaico BAPV- Building Applied Photovoltaics Sistema fotovoltaico In commercio esistono diversi prodotti attraverso cui è possibile realizzare delle applicazioni di BIPV. Alcuni produttori hanno messo a punto delle tegole o coppi fotovoltaici, modificando gli elementi tradizionali in modo che possano fungere da supporto sul quale inserire moduli fotovoltaici. Tegola Canadese Spa, tra gli altri, ha ormai da tempo dato vita ad una joint venture con Uni-Solar, azienda statunitense leader nella produzione di laminati fotovoltaici flessibili in silicio amorfo specificamente sviluppati per integrazione su materiali da costruzione, per la commercializzazione in Europa delle tegole Tegosolar. Altro prodotto BIPV che sembra particolarmente promettente è rappresentato dai cosiddetti solar roofs, ossia guaine isolanti polimeriche che incorporano celle fotovoltaiche e che vengono utilizzate per l’impermeabilizzazione di tetti. Un esempio di interesse in questo campo è rappresentato da Sika Italia Spa. La divisione italiana del Gruppo Sika, nato in Svizzera più di cent’anni fa e leader nella chimica applicata all’edilizia, a valle dell’integrazione con Sarnafil, azienda italiana attiva nel campo dell’impermeabilizzazione di coperture industriali, ha dato vita ad una collaborazione con Solar Integrated per sviluppare una nuova linea di membrane solari che sta riscontrando una certa diffusione sul mercato. Il prodotto più promettente e che sta attirando gli investimenti più consistenti è rappresentato però dalle vetrate fotovoltaiche, ossia sistemi BIPV che utilizzano come substrato il vetro. Secondo alcune stime, questo prodotto è stato responsabile di più del 50% delle installazioni di BIPV a livello mondiale nel 2009. Le vetrate fotovoltaiche possono essere utilizzate in diverse tipologie di applicazioni, ma l’uso più comune è rappresentato dalla realizzazione di finestre e facciate di edifici di nuova costruzione. Un esempio molto noto di questo tipo di applicazione delle vetrate fotovoltaiche è l’Altra Sede della Regione Lombardia a Milano, in zona Porta Garibaldi (si veda figura 1.33), che ospita un impianto da 170 kW realizzato dall’italiana EnergyGlass utilizzando tecnologia monocristallina SunPower. Le vetrate fotovoltaiche possono essere impiegate anche come lucernari, come è accaduto in una porzione del nuovo edificio dell’Ospedale Meyer di Firenze, in cui sono state installate 181 vetrate fotovoltaiche con tecnologia Solon, per una potenza complessiva pari a 32 kW. Altro ambito di applicazione è rappresentato dalla realizzazione di pensiline e sistemi di ombreggiamento. Dal punto di vista tecnologico, i prodotti BIPV possono essere realizzati utilizzando diverse soluzioni. 76 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato fo (a-Si) assicura maggiori livelli di trasparenza rispetto, ad esempio, al film sottile in diseleniuro di L’altra Sede della Regione Lombardia indio, gallio e rame (CIGS) e, ovviamente, al silicio cristallino tradizionale. È tuttavia possibile, anche nell’applicazione di queste tecnologie, realizzare dei moduli con celle distanziate che permettono il passaggio ancorché parziale della luce, anche se questo va a scapito dell’efficienza del sistema. Per quanto concerne la diffusione sul mercato delle soluzioni BIPV, alcune fonti stimano un volume d’affari per il 2009 superiore a 1,3 mld € a livello mondiale, che ci si aspetta possa crescere consistentemente fino a superare i 6 mld € nel 2015, per una potenza installata maggiore di 10 GW. Considerando che le vetrate fotovoltaiche pesano e verosimilmente continueranno a pesare per più del 50% delle installazioni di sistemi BIPV, non è irragionevole pensare che il mercato mondiale per queste soluzioni nel 2015 possa arrivare a generare un volume d’affari superiore ai 3 mld €. Questo Ad oggi il silicio cristallino di prima generazione a fronte di un potenziale di mercato immenso, al rappresenta la tecnologia maggiormente diffusa: si punto che alcuni stimano che nei principali 14 può stimare che tra l’80% e il 90% delle installazioPaesi sviluppati esistono più di 23 miliardi di metri ni di BIPV a livello europeo impiegano tecnologia quadrati di tetti e facciate adatte alle applicazioni cristallina. Nonostante ciò, la tecnologia del film 51 52 e CIGS ) presenta BIPV, cui corrisponderebbe una potenza nominale sottile (in particolare a-Si, CIS molteplici vantaggi rispetto a quella cristallina installabile, con le attuali tecnologie commercialdi prima generazione (si veda paragrafo 1.1.2), mente disponibili, superiore a 1.000 GW. È estreal punto che molti analisti ritengono che essa conmamente complesso fornire una stima delle inquisterà sempre più spazio nel mercato del BIPV. stallazioni di BIPV in Italia. Quello che è certo Analogo interesse sembra esserci per è che gli impianti fotovoltaici archiapplicazioni BIPV che incorporano tettonicamente integrati sono in cocelle di terza generazione. Ne è testistante crescita, rispetto a quelli par“Sarebbe auspicabile che nella revisione del Nuovo Conto Energia monianza il caso di Permasteelisa, zialmente integrati e non integrati venissero riservati degli incentivi impresa italiana attiva nel campo del- specifici per il BIPV: si tratta di una (si veda figura 1.34), come effetto le costruzioni e in particolare delle tecnologia in cui diverse imprese del Nuovo Conto Energia che premia italiane potrebbero dire la loro” facciate continue, che ha promosso e maggiormente (fino a oltre il 20%) gli Manager di un’impresa distributrice preso parte, insieme ad ERG Renew e impianti integrati nelle superfici degli di moduli e materiale fotovoltaico ad altri partner accademici ed induedifici. striali, ad un progetto co-finanziato nell’ambito del programma “Industria Concentrandosi sulle vetrate foto2015” del Ministero dello Sviluppo Economico, che voltaiche, che rappresentano il prodotto di magha l’obiettivo di sviluppare pannelli con tecnologia giore interesse nel mercato del BIPV, la loro diffuDSSC (Dye Sensitized Solar Cells). Bisogna infine sione nel nostro Paese è estremamente limitata ricordare che le diverse tecnologie sopracitate si ad oggi. Si possono contare poco più di una dedifferenziano, nel momento in cui sono utilizzate cina di impianti che utilizzano vetrate fotovoltaiper la realizzazione di vetrate fotovoltaiche, anche e hanno una potenza nominale significativa. che per il livello di trasparenza che permettono di Corrispondono a realizzazioni “pilota” (alcune raggiungere. Chiaramente questo rappresenta un della quali già citate in precedenza), in edifici di fattore molto importante che influenza il livello di grande valore e pregio, commissionate da costrutintegrabilità architettonica conseguibile nell’applitori e investitori particolarmente attenti al tema cazione della vetrata. Il film sottile in silicio amordella sostenibilità ambientale o all’immagine di Figura 1.33 51 52 Celle al Diselenurio di Indio e Rame (CIS). Celle al Diselenurio di Indio e Rame arricchito con Gallio (CGIS). www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 77 1. IL fotovoltaico Figura 1.34 Percentuale di impianti architettonicamente integrati rispetto al totale di impianti installati in Italia 30% 20% 22,5% 10% 18% 12% 0 2007 2008 innovatività che l’utilizzo di queste tecnologie può conferire. Si può stimare una potenza complessivamente installata inferiore ad 1 MW ed un’estensione complessiva non superiore agli 8.000 metri quadrati. La nostra analisi suggerisce che esistono ad oggi molti ostacoli e barriere ad una consistente diffusione, quantomeno nel breve-medio termine, delle vetrate fotovoltaiche in Italia. Innanzitutto si rileva una scarsa conoscenza da parte degli operatori del mercato immobiliare ed edilizio in merito alle prestazioni tecniche e funzionali delle vetrate fotovoltaiche. Nella valutazione della convenienza economica della scelta di utilizzare le vetrate fotovoltaiche, si tende poi a considerare esclusivamente l’entità dell’investimento e a trascurare altri elementi critici come l’efficienza della tecnologia impiegata ed i ritorni economici derivanti dal risparmio dell’energia elettrica e dalla tariffa incentivante assicurata dal Nuovo Conto Energia. Nel momento in cui ci si concentra esclusivamente sull’entità dell’investimento, una vetrata fotovoltaica risulta decisamente più costosa rispetto sia alla maggior parte dei materiali di costruzione che sostituisce (ad esempio il vetro laminato o isolante), sia ad un impianto fotovoltaico tradizionale, con il quale entra spesso in competizione in fase decisionale (si veda figura 1.35). La scelta di utilizzare vetrate fotovoltaiche introduce inoltre un elemento di rischio ed incertezza aggiuntiva per l’investitore, il quale non ha un track record consistente di performance per impianti di questo tipo che possa ulteriormente corroborare la sua decisione. A questo problema si aggiunge lo stadio embriona- 78 2009 le in cui si trova il mercato del green building in Italia, specialmente se confrontato con la realtà della maggior parte dei Paesi anglosassoni. Il mercato immobiliare nel nostro Paese non si dimostra ancora in grado di riconoscere un prezzo superiore ad edifici che abbiano dei requisiti energetici particolarmente elevati, il che scoraggia spesso gli investitori dal dotare di questi impianti le loro costruzioni. Chiaramente la crescente e diffusa sensibilità ambientale potrebbe però giocare un ruolo importante nello stimolare una maggiore diffusione delle vetrate fotovoltaiche, ma va detto che ad oggi questo aspetto ha un qualche peso solo nel caso di grandi investitori, di aziende che realizzano nuove sedi produttive o commerciali, e di edifici realizzati per iniziativa delle pubbliche amministrazioni. Per gli altri investitori privati, tipicamente coinvolti nella costruzione di edifici di piccole-medie dimensioni, l’attenzione all’ambiente non sembra sufficiente per stimolare un’accettazione di questa tecnologia su ampia scala. Va infine rilevato come nel nostro Paese esista in questo ambito un quadro normativo che, nonostante potenzialmente possa rappresentare un fattore non irrilevante nel fare uscire il mercato delle vetrate fotovoltaiche dallo stadio fortemente embrionale in cui si trova, è estremamente eterogeneo ed incerto. Un esempio è il Testo Unico dell’Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001), di cui si è già parlato nel paragrafo 1.3.3. Questa norma prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si dovesse procedere in via obbligatoria all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabi- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Figura 1.35 Costi dei diversi materiali per la realizzazione di facciate in edilizia Vetro laminato Vetro isolante Vetro serigrafato Moduli fotovoltaici tradizionali Vetrate fotovoltaiche Marmo 100 200 300 400 500 li, in modo da garantire una potenza installata non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 m2, la potenza minima è di 5 kW. La legge 25/2010 di conversione del Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto decreto legge “Milleproroghe”), ha posticipato al 1° gennaio 2011 la scadenza inizialmente già posticipata al 1° gennaio 2010. Un provvedimento di questo tipo sarebbe potenzialmente in grado di stimolare una diffusione significativa del BIPV ed, in particolare, delle vetrate fotovoltaiche, essendo il fotovoltaico l’unica tecnologia ad oggi 600 700 �/m2 capace di assicurare l’ottemperamento dell’obbligo a costi economici e nel breve periodo. Tuttavia gli operatori hanno forti perplessità in merito al fatto che questa norma non sia ulteriormente rimandata e specialmente che, anche in caso di entrata in vigore della stessa, vengano contestualmente varati dei decreti attuativi capaci di renderla efficace nei fatti. Un altro aspetto è legato ai regolamenti comunali in merito ai rapporti aero-illuminanti. che devono essere soddisfatti nella progettazione e realizzazione di nuovi edifici. Nonostante in linea di principio una vetrata fotovoltaica semi-trasparente Box 1.11 EnergyGlass EnergyGlass nasce nel 2007 a Como dall’iniziativa di imprenditori già attivi nei settori del vetro e del fotovoltaico con l’obiettivo di progettare, produrre e commercializzare sistemi fotovoltaici a totale integrazione architettonica, che sostituiscono naturalmente gli elementi di costruzione in vetro. Le competenze distintive di EnergyGlass fanno leva su una profonda conoscenza del settore del vetro per architettura di interni ed esterni e l’esperienza nella progettazione architettonica degli edifici. EnergyGlass è la prima azienda italiana, con impianti produttivi in provincia di Como, che dal 2008 realizza vetri fotovoltaici in stratificati di sicurezza che si adattano alle esigenze di integrazione architettonica in cui è previsto il vetro come elemento di costruzione. Per la stratificazione dei moduli fotovoltaici, l’azienda utilizza un tipo speciale di PVB (PolyVinyl Butyral) studiato ap- positamente per il solare. I moduli fotovoltaici in vetro sono disponibili sia con celle in silicio mono- o policristallino, sia in film sottile. EnergyGlass dispone di strutture e capacità produttiva per realizzare 50.000 metri quadrati di vetri fotovoltaici all’anno. A oggi, EnergyGlass si avvale della collaborazione di 15 dipendenti e ha fatto registrare nel 2009 un fatturato di 2,7 mln E, quadruplicando così il risultato dell’anno precedente. Nel corso del 2009 EnergyGlass ha realizzato oltre 20 progetti e installazioni di vetri fotovoltaici tra cui i principali sono: Altra Sede Regione Lombardia (vetri fotovoltaici facciate sud delle 2 torri), Politecnico di Torino (copertura edificio ex Fucine), Serre Bioclimatiche a Milano, Vela Fotovoltaica scuola a San Lorenzo al Mare Imperia, Diamante Enel, Campanile Fotovoltaico a Selvatelle Pisa. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 79 1. IL fotovoltaico possa concorrere alla determinazione dei suddetti rapporti proporzionalmente al suo grado di trasparenza, in molti casi e specialmente nei comuni di medie dimensioni i progettisti non sono autorizzati ad includerla nel calcolo. Questa incertezza e disuniformità delle procedure di autorizzazione rappresenta un ulteriore freno alla diffusione delle vetrate fotovoltaiche, soprattutto nel segmento degli investitori privati impegnati nella realizzazione di edifici di piccole-medie dimensioni. Nel complesso, quindi, nonostante i sistemi BIPV e le vetrate fotovoltaiche siano in grado di abilitare la diffusione del fotovoltaico anche in aree urbane densamente popolate e presentino un potenziale di diffusione estremamente rilevante, nel nostro Paese è ragionevole attendersi un’accettazione sul mercato di queste soluzioni più lenta e meno pervasiva rispetto a quanto si possa immaginare per altri Paesi europei e non. Sicuramente il segmento dello costruzioni di grande valore e pregio, oltre a quello degli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, è quello che registrerà una maggiore diffusione del BIPV e delle vetrate fotovoltaiche negli anni a venire. Complessivamente, è ragionevole attendersi uno scenario in cui il volume d’affari annuo generato dalle vetrate fotovoltaiche in Italia si attesti intorno ai 100-150 mln € entro il 2015, cui corrisponderà una potenza installata annua nell’ordine di 30-40 MW. Anche come risultato della minore penetrazione che le vetrate fotovoltaiche hanno sperimentato nel nostro Paese negli ultimi anni, i produttori italiani sono in numero molto limitato e si tratta prevalentemente di imprese che, lavorando nella produzione di vetro o delle facciate continue, hanno cercato di differenziare la propria offerta includendo prodotti a maggiore marginalità come le vetrate fotovoltaiche, sfruttando tuttavia tecnologie già esistenti e sviluppate da grandi player stranieri come ad esempio SunPower o Wurth Solar. Normalmente l’inserimento dei moduli fotovoltaici avviene in fase di costruzione della serra. Va detto tuttavia che esistono sul mercato delle soluzioni attraverso cui è possibile incorporare il sistema fotovoltaico in serre pre-esistenti, in alcuni casi anche in film plastico, nonostante esistano serie perplessità sulla qualità e sulla durata nel tempo di queste realizzazioni. La taglia dell’impianto integrato in una serra fotovoltaica è molto variabile: si passa da sistemi con qualche kW di potenza di picco, fino ad arrivare anche ai 10 MW, in funzione della dimensione della serra e del tipo di coltivazione che vi si intende realizzare, il che impatta sul grado di luce (e quindi sulla densità dei moduli fotovoltaici installabili per metro quadrato di superficie) che è necessario attraversi la copertura. Esistono due tipologie di serre che si prestano ad essere realizzate con integrazione di moduli fotovoltaici: le serre monofalda e quelle bifalda (si veda figura 1.36). La serra bifalda può essere di tipo “wide span”, con falde molto ampie, oppure di tipo “venlo”, con falde di dimensioni minori. In questo caso nella falda orientata a Sud vengono inseriti i moduli fotovoltaici (realizzando una copertura tipicamente del 100%), mentre la falda a Nord è costruita con pannelli in vetro normale o temprato. La serra di tipo “venlo” ha un costo normalmente più alto rispetto alle “wide span”, ma presenta alcuni vantaggi sia dal punto di vista agronomico sia per quanto riguarda la produzione fotovoltaica: 1.3.6 Le serre fotovoltaiche • è contraddistinta da una maggiore pendenza delle falde, che massimizza la radiazione incidente e nello stesso tempo riduce la formazione di condensa; • ha un’altezza al colmo più contenuta, il che determina un alleggerimento alla spinta del vento; • ospita tipicamente delle aperture di ventilazione più numerose ed efficienti, garantendo una migliore areazione della serra, con impatti positivi sia per le colture che per la produzione fotovoltaica, dato che i moduli in questo caso risultano meno soggetti a surriscaldamento. Un secondo ambito di applicazione particolarmente promettente della tecnologia fotovoltaica nel nostro Paese è rappresentato dalle cosiddette serre fotovoltaiche, ossia serre agricole sulla cui copertura sono installati dei moduli fotovoltaici. Le serre che si rivelano essere più adatte per questo tipo di applicazione sono quelle in ferro-vetro, realizzate con elementi metallici prefabbricati e in cui, sulla falda orientata a Sud, i pannelli di vetro vengono sostituiti con i moduli fotovoltaici. Nel caso di serra monofalda, l’unica falda esistente ospita i moduli fotovoltaici con un livello di copertura variabile. Con una copertura del 100% si ha un completo ombreggiamento, il che rende di fatto impraticabile coltivare la stragrande maggioranza delle specie vegetali. Normalmente si raggiungono livelli di copertura compresi tra il 60 e il 90%, alternando i moduli fotovoltaici alle lastre di vetro. Rispetto alla soluzione bifalda, questa tipologia massimizza la produzione fotovoltaica della serra. 80 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato il terreno su cui essa sorgerà, che richiede una DIA o un Permesso a Costruire. Esistono tuttavia delle forti disuniformità da Regione a Regione: in alcuni casi l’autorizzazione è infatti subordinata al rilascio del parere di altri enti competenti, quali l’Ispettorato all’Agricoltura o il Genio Civile. Nella maggioranza dei casi, per concedere l’autorizzazione alla costruzione della serra, il Comune competente richiede un atto d’obbligo con il quale il soggetto promotore dell’iniziativa si impegna a mantenere inalterata la destinazione d’uso del terreno su cui la serra sorgerà per i successivi 20-25 anni. Per quanto concerne l’impianto fotovoltaico, in molte Regioni (ad esempio la Calabria, la Campania e il Lazio), esso è autorizzato contestualmente alla serra quale elemento costruttivo della stessa. In altri casi, quali ad esempio la Puglia o la Sicilia, è necessario seguire un iter autorizzativo parallelo. In alcune Regioni (ad esempio Calabria, Campania, Lazio e Puglia), gli impianti in serre fotovoltaiche sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità a VIA, mentre in altri casi questa si rende necessaria per impianti di dimensioni oltre un certo limite (ad esempio, in Basilicata sono escluse dalla VIA le serre fotovoltaiche con superficie inferiore a 20.000 metri quadrati, mentre in Dal punto di vista tecnico, qualsiasi modulo fotovoltaico potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di una serra fotovoltaica. A detta degli operatori è tuttavia preferibile propendere per moduli realizzati con tecnologie (quali il silicio poli-cristallino e il film sottile, rispetto invece al silicio monocristallino) che risentono meno, in termini di perdita di efficienza, delle elevate temperature che si raggiungono nella serra (in alcuni casi, specie se non esiste un sistema di arieggiamento ottimale, si può arrivare a temperature anche di 70°C). Ad oggi gli operatori sembrano propendere per i moduli in silicio poli-cristallino, che hanno il vantaggio di essere realizzabili senza extracosti eccessivi con fondo in tedlar trasparente. L’impianto fotovoltaico ospitato da una serra fotovoltaica ha accesso al livello massimo di incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, configurandosi come un impianto architettonicamente integrato. L’iter autorizzativo che è necessario ottemperare per procedere alla costruzione di una serra fotovoltaica si compone di due momenti distinti, ossia l’autorizzazione alla realizzazione della serra e quindi dell’impianto fotovoltaico. L’ente competente per l’autorizzazione alla realizzazione della serra è tipicamente il Comune in cui si trova Figura 1.36 Caratteristiche costruttive delle serre fotovoltaiche Moduli FV 4-5m 3-5m Moduli FV 9 - 13 m 8 - 12 m 2-3m 6-7m Moduli FV 7-8m www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 81 1. IL fotovoltaico fo 1.2.5, un tasso di crescita superiore rispetto a Sicilia sono esclusi impianti con potenza nominale quello medio di mercato. inferiore a 1 MW). Nonostante l’iter procedurale Bisogna evidenziare tuttavia che, nel valutare sia più snello rispetto a quanto accada per gli iml’eventualità di realizzare una serra fotovoltaica, pianti fotovoltaici a terra, non è infrequente che gli aspetti agronomici non devono essere sacrifiil processo autorizzativo richieda anche 7-8 mesi cati a quelli puramente speculativi. Alcuni operadi tempo per essere completato, giocando in quetori di mercato hanno dimostrato la loro preoccusto un peso non irrilevante la fase di autorizzapazione in merito all’eventualità che gli investitori zione alla connessione in rete. Questa complessità realizzino serre trascurando la coltivazione che in burocratica rimane un aspetto critico anche per lo esse viene realizzata, per usufruire esclusivamente sviluppo futuro di questo tipo di applicazione della dei vantaggi di cui si è parlato in precedenza. Se tecnologia fotovoltaica in Italia. è vero che l’autorizzazione alla costruzione della Dal punto di vista della fiscalità, le serre fotovolserra rilasciata dal Comune dovrebbe decadere nel taiche sono accatastabili come edifici agricoli, il momento in cui essa non venisse coltivata, è alche le rende, da un anno circa a questa parte, totrettanto vero che questo è un aspetto talmente esenti da qualsiasi imposta comunale sugli immobili, compresa “Per alcune colture, l’integrazione di difficile verifica e monitoraggio nel l’ICI che invece, anche se su questo del fotovoltaico nella copertura tempo. Uno dei maggiori vantaggi di aumenta addirittura una serra fotovoltaica è che, grazie ad aspetto non c’è chiarezza da parte della laserra produttività media” essa, è possibile realizzare impianti dell’Agenzia delle Entrate, grava sugli Business Developer di un’impresa distribuiti di generazione dell’enerimpianti a terra. Inoltre, nel caso in installatrice di impianti fotovoltaici gia elettrica senza sottrarre terreno cui il promotore dell’iniziativa sia all’agricoltura, soddisfacendo al conuna società o un imprenditore agritempo il significativo fabbisogno energetico delle colo (condizione comunque in molti casi necessacoltivazioni in serra. È fondamentale che le autoria affinché il Comune competente rilasci l’autorità competenti vigilino affinché questo vantaggio rizzazione alla costruzione della serra), l’Agenzia dell’integrazione della tecnologia fotovoltaica neldelle Entrate ha confermato, con la Circolare nule serre agricole non vada perduto. mero 32/E del 6 luglio 2009, il diritto ad accedere Esistono poi delle preoccupazioni espresse da alad una fiscalità agevolata, che prevede il calcolo cuni osservatori in merito all’eventualità che la delle imposte dirette sulla base del reddito agrario. copertura delle falde della serra con moduli fotoA questo si aggiunge la possibilità, da parte della voltaici, che ostacolano il passaggio della luce, pegsocietà o imprenditore agricolo, di accedere alle giori le condizioni in cui la coltivazione ha luogo. agevolazioni e ai contributi che sono frequenteIn realtà, la nostra analisi e la letteratura speciamente stanziati dalle Regioni per l’irrobustimenlistica mostrano come questa preoccupazione sia to e il sostegno delle filiere agricola e zootecnica. in larga parte ingiustificata, dato che un adeguato Anche grazie alle agevolazioni fiscali cui si fatto ombreggiamento può addirittura migliorare la cenno, l’investimento in una serra fotovoltaica produttività di alcune colture. Esistono infatpuò risultare particolarmente vantaggioso, con ti alcune colture (quali fiori recisi e piante ornalivelli di redditività (misurati attraverso l’IRR) mentali, alberi da frutta o verdure bianche quali che possono raggiungere anche il 15% in condicavolfiore e cipolla) che crescono ottimamente in zioni di irraggiamento medio intorno a 1.400 condizioni di notevole ombreggiamento, mentre kWh/kW e con un grado di copertura della falda altre specie vegetali (tra cui molti ortaggi, quali Sud pari all’80-90%. Questo spiega, insieme agli carote, pomodori, carciofi) possono essere coltivaaltri vantaggi che sono stati discussi in questo pate solo in presenza di un ombreggiamento molto ragrafo, l’enorme potenziale di sviluppo di questo più limitato. comparto di applicazione del fotovoltaico in Italia, Dal punto di vista industriale, negli ultimi anni si e si aggiunge alle considerazioni svolte nel parasta diffondendo la soluzione che vede l’EPC congrafo 1.3.3 in merito alla grandissima estensione tractor come unico soggetto con cui l’investitodelle serre per coltivazioni ortofrutticole nel nore si interfaccia e che è responsabile del progetto stro Paese. Nonostante sia impossibile effettuare complessivo, comprensivo di serra e impianto fodelle stime con un adeguato livello di confidenza, tovoltaico integrato. Tipicamente si tratta di sociela nostra analisi suggerisce che questo specifico tà che hanno esperienza nel mercato fotovoltaico segmento sperimenterà negli anni a venire, fatte (gli EPC contractor più attivi nel segmento delle salve le riflessioni relative all’imminente revisione serre fotovoltaiche sono Enerqos, Juwi, Isofoton, del Nuovo Conto Energia presentate al paragra- 82 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.3 Il mercato Ray Energy ed MXGroup) e che subappaltano la realizzazione della serra ad operatori specializzati (quali, ad esempio, Gome Agri ed Artigianfer). È possibile poi identificare due modelli in base a cui l’investimento e la successiva gestione della serra fotovoltaica possono avere luogo: • quello in cui l’agricoltore è l’unico soggetto coinvolto, in quanto proprietario sia della serra e dell’impianto fotovoltaico in essa integrato che del terreno su cui essa sorge; • quello in cui sia la serra che il terreno sono di proprietà di un soggetto diverso dalla società o imprenditore agricolo, a cui esso affitta la serra stessa. Il secondo modello, oltre alle complessità insite nella gestione delle relazioni tra i soggetti coinvolti, espone al rischio che gli aspetti agronomici, per mancanza di competenze specifiche, vengano trascurati in fase di progettazione della serra, con le conseguenze negative di cui si è parlato in precedenza. Il primo modello, anche se frequentemente porta alla realizzazione di impianti di dimensioni inferiori rispetto al secondo (con una potenza massima tipicamente di 1 MW), è quello che ha avuto, e che alla luce della nostra analisi verosimilmente avrà anche in futuro, una maggiore diffusione in Italia, consentendo peraltro una crescita più virtuosa di questo promettente comparto del mercato fotovoltaico. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 83 1.4 La filiera Tre aspetti hanno profondamente caratterizzato la filiera del fotovoltaico in Italia nell’anno 2009: (i) la piena presa di coscienza – grazie ad una crescita dell’installato che a fine 2008 ha fatto segnare un +380% rispetto all’anno precedente – che il fotovoltaico non fosse più un “fenomeno” da relegarsi nel novero dei mercati “di nicchia”, bensì un settore industriale con elevate potenzialità di generazione di valore e con ricadute importanti nel rivitalizzare il tessuto industriale del nostro Paese; (ii) la modifica dello scenario dell’industria solare a livello globale, con il crollo dei prezzi del silicio (si veda capitolo 1.1) e la repentina uscita di scena di una serie di operatori asiatici e, a livello europeo, con l’accentuarsi del vantaggio di investire in Italia a seguito degli interventi legislativi di “taglio” degli incentivi in Spagna ed il conseguente incremento negli “ingressi” di operatori stranieri nel nostro Paese; (iii) l’acuirsi della crisi finanziaria, i cui prodromi si erano già avvertiti al termine del 2008, che ha ulteriormente ridotto le risorse a disposizione per gli investimenti e la crescita delle imprese, rendendo più evidenti le differenze fra quelle più “mature” ed efficienti e quelle nate sulla scorta dell’entusiasmo, un po’ come era accaduto ai tempi della Internet bubble. L’obiettivo di questa sezione è quello di evidenziare i principali cambiamenti che questi tre fattori hanno indotto nell’articolazione della filiera, nella distribuzione della marginalità e nei modelli di business delle imprese che operano in Italia. 1.4.1 Il volume d’affari del fotovoltaico in Italia Il fatturato generato dalla vendita di impianti fotovoltaici in Italia nel corso del 2009 è stato pari a circa 2,34 mld € in crescita del 28% rispetto all’anno precedente53. Il dato sui cui riflettere in prima battuta è la differenza fra la crescita in valore del fatturato, il 28% appunto, e la crescita della potenza installata che è invece stata pari al +72%, passando dai quasi 340 MW installati nel 2008 agli oltre 580 MW installati nel corso del 2009 (si veda capitolo 1.3). Le cause alla base di questa differenza sono sostanzialmente due: • il differente mix di installazioni con una crescita delle installazioni di grandi dimensioni (circa il 16% della potenza totale installata è costituita da centrali con taglie superiori a 1 MW contro una situazione 2008 che vedeva questo tipo di impianti attestarsi a meno del 4%) ove grazie all’effetto “scala” i prezzi al kW di installazione sono decisamente più contenuti (poco più di 3.000 € contro i circa 5.500 € necessari per installare impianti con potenze totali intorno a 3 kW); • il calo significativo, che in media si è attestato nell’ordine del 30% (ma con picchi di oltre il 35% per le grandi installazioni), del prezzo di vendita dei moduli per l’effetto congiunto – già citato in premessa a questa sezione – del crollo del prezzo del silicio e dell’incremento della competizione sul mercato italiano. La distribuzione del fatturato nei diversi mercati, nonché nelle diverse fasi che costituiscono la filiera54 è riportata in figura 1.37. Il mercato residenziale ha generato nel 2009 un volume d’affari di 925 mln €, in crescita del 38% rispetto all’anno precedente anche grazie allo sviluppo di offerte commerciali “chiavi in mano” che hanno ulteriormente rafforzato l’interesse dei consumatori. Il segmento industriale (20-200 kW) ha fatto registrare vendite per 561 mln € così come quello dei grandi impianti (200-1000 kW) che insieme contano per più di un miliardo di €. Inoltre, cresce esponenzialmente – anche a seguito della citata maggior diffusione di impianti di taglia supe- Il fatturato 2008, calcolato tenendo conto anche degli impianti autorizzati nel dicembre 2008 ed entrati effettivamente in esercizio nei primi mesi del 2009, è stato pari a 1,69 mld €. Cfr. Solar Energy Report 2008, pp 73-79. 53 54 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 85 1. IL fotovoltaico Figura 1.37 Principali aree di business nella filiera fotovoltaica e volume d’affari nel 2009 Componenti & Tecnologie Silicio & Wafer Celle & Moduli 1.509 mln � Distribuzione & Installazione Residenziale 925 mln � Industriale 561 mln � Produzione & Trading Grandi Impianti 562 mln � 1.020 mln � 1.418 mln � 2.345 mln � Centrali 297 mln � 65 mln � Finanziamento & Assicurazione 1.820 mln �* 6 mln � riore al MW – il segmento delle centrali con 297 mln € (+ 440% rispetto all’anno precedente). Appare interessante analizzare la distribuzione del volume d’affari nelle diverse fasi che precedono l’attività di installazione. I produttori di celle e moduli hanno segnato, infatti, nel corso dell’anno 2009 in Italia un fatturato pari a oltre 1,4 mld €, mentre l’attività di produzione della materia prima per eccellenza degli impianti fotovoltaici, ovvero il silicio, ha fruttato per il solo mercato italiano circa un miliardo di €, facendo segnare tuttavia una crescita più contenuta rispetto alle altre fasi soprattutto a causa del già più volte citato calo del prezzo del silicio. Se si estende l’analisi anche all’indotto, i “numeri” del settore divengono ancora più significativi. Nel corso del 2009, l’attività di fornitura di impianti e tecnologie (soprattutto per le linee di produzione delle celle e per l’assemblaggio dei moduli) nonché della componentistica accessoria degli impianti fotovoltaici (ove la lion’s share spetta agli inverter, come meglio discusso nel paragrafo 1.4.7) ha fatto registrare un volume d’affari di circa 1,5 mld €. Anche se di un ordine di grandezza inferiore, va tenuto in considerazione anche il totale dei premi che le società di assicurazione hanno incassato nel corso del 2009 per “garantire” gli impianti fotovoltaici – in particolar modo dai furti se si prendono in esame le centrali, e dagli eventi atmosferici in tutti i casi – che è stato di poco inferiore ai 6 mln €. Al “peso” complessivo del settore fotovoltaico in Italia, considerando anche l’indotto vanno aggiunte due ulteriori componenti: (i) il valore della produzione di energia elettrica che è stata pari a circa 65 mln €, anche se in parte configurabile (negli impianti ove vige il regime di scambio sul posto) come “mancato costo”; (ii) il valore degli impieghi degli istituti di credito per finanziare la realizzazione degli impianti fotovoltaici, che è stato pari a 1.820 mln €55, ed è un indicatore significativo (in un periodo di crisi quale quello attuale) dell’interesse che gli investitori hanno per il settore. 1.4.2 Le marginalità Il risultato della analisi sulla marginalità, misurata come il rapporto fra i ricavi e l’EBITDA presenti nel bilancio 2008 delle imprese che operano in Italia, è riportato in figura 1.38. Il valore degli impieghi degli istituti di credito è calcolato come prodotto tra la leva media utilizzata nei finanziamenti per le diverse taglie di impianto (75% centrali, 80% industriale e 90% residenziale) e il volume di affari generato dai diversi segmenti di mercato. 55 86 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera Figura 1.38 EBITDA margin medio delle imprese operanti nelle diverse fasi della filiera fotovoltaica 70% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 14% 16% 10% Produzione Silicio e Wafer Produzione Celle EDITDA margin medio 2007 Produzione Moduli Distribuzione EDITDA margin medio 2008 Innanzitutto, per confronto rispetto alla situazione dell’anno precedente56, è necessario evidenziare un calo significativo (in media superiore al 25%) della marginalità, in apparente contrasto con la crescita del volume d’affari sperimentata nel corso del 2008. Le ragioni di un simile andamento sono tuttavia “facilmente” spiegabili se si considera che – come ricordato in premessa di questa sezione – sino al 2007 il fotovoltaico ha goduto di quello che si può definire, con una analogia forse un po’ ardita, un “regime di competizione agevolato”. Il fatto che venisse considerato un mercato quasi per appassionati (o per convinti ambientalisti) aveva trovato riflesso in una distribuzione di marginalità – da oltre il 50% dei produttori di materia prima, al 15% dei produttori di moduli e al 17% degli installatori – tipica di quei settori di “nicchia” ove esiste un rapporto privilegiato fra cliente e fornitore e dove il primo è più favorevolmente disposto a riconoscere un premium price per vedere soddisfatte le proprie esigenze. A partire dal 2008, e con ancor maggior vigore nel 2009, il grado di competizione nel mercato italiano si è fortemente incrementato per effetto della crescita del numero di imprese coinvolte, in parte italiane nate per cogliere una opportunità che – si è capito – andava ben oltre la 56 5% 9% 0% Progettazione e Installazione Deviazione rilevata “nicchia” iniziale, ed in parte straniere provenienti da mercati (quali quello spagnolo e tedesco) ormai maturi ed abituate a confrontarsi aspramente per conquistare nuovi clienti. Il calo dei prezzi delle materie prime e la crisi finanziaria di fine anno – fenomeni peraltro entrambe ulteriormente acuitesi nel corso del 2009 – hanno indubbiamente anch’essi giocato un ruolo: nel “limare” i margini dei produttori di silicio il primo, nell’appesantire i costi dei magazzini di modulisti e distributori (in conseguenza dello stop o del rallentamento di una serie di investimenti che a fine estate parevano essere ai “nastri di partenza”) il secondo. L’EBITDA margin dei produttori di silicio e wafer che operano sul mercato italiano, infatti, si è attestato attorno al 40% nel 2008. Un valore ancora di tutto rispetto e che tuttavia, se si tiene conto che questa è anche la fase produttiva più capital intensive (e quindi ove il peso degli ammortamenti è più significativo), ha colpito profondamente gli operatori, soprattutto quelli asiatici, trovatisi impreparati di fronte ad un calo di prezzo che li ha costretti a puntare sull’efficienza dei processi produttivi. Anche i produttori di celle hanno subito un calo di marginalità importante passando dal 2007 al 2008, Cfr. Solar Energy Report 2008, p. 76. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 87 1. IL fotovoltaico con il dato dell’ultimo anno fermo al 16%. In questo caso, a pagare maggiormente il prezzo dell’incremento della competizione sono state le italiane – con una marginalità media di poco inferiore al 10% contro il quasi 23% delle straniere che raggiungono il mercato del nostro Paese – penalizzate dal fatto di operare con “scale” produttive di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto ai grandi player internazionali (si veda paragrafo 1.4.5). Ancor meno rosea la situazione per i produttori di moduli che nel corso del 2008 hanno visto i loro margini scendere di poco al di sotto del 9% (dal 15% circa del 2007), schiacciati da un lato dal potere contrattuale dei produttori di celle e dall’altro lato da un mercato finale più competitivo. Una nota positiva sta però nel minor divario fra imprese italiane e straniere (con margini medi rispettivamente del 7% e dell’11%), anche come effetto di una lungimirante politica di investimenti in automazione ed efficientamento dell’attività produttiva iniziato già nel 2008 (e proseguito anche nel 2009 nonostante le difficoltà economiche) intrapreso dai principali modulisti italiani. Anche i distributori, con una marginalità media del 5%, lasciano sul campo della maggior competizione dovuta all’ingresso di operatori stranieri due punti percentuali rispetto all’anno precedente. L’attività di progettazione e installazione è forse quella che – nonostante il cliente finale, soprattutto per le grandi installazioni, abbia incrementato la sua consapevolezza in merito al “giusto” prezzo degli impianti fotovoltaici ed abbia beneficiato dell’incrementata possibilità di scelta fra gli operatori – ha “perso” meno, passando dal 17% circa del 2007 al 14 % del 2008. In realtà rispetto all’anno 2007 si è allargato significativamente il divario fra i system integrator, solitamente coinvolti nelle installazioni di taglia inferiore e che hanno fatto registrare margini medi del 7,5%, e gli EPC contractor, cui compete la progettazione e la realizzazione degli impianti di grande taglia e che invece hanno fatto registrare marginalità medie del 18,5% (estremamente lusinghiere se si considera che questo tipo di attività richiede bassi investimenti in immobilizzazioni e quindi generalmente non vi è forte differenza fra EBITDA e EBIT). Anche quest’ultimo fenomeno è conseguenza tipica della “maturazione” del settore cui si associa una maggior ricerca da parte del cliente del valore aggiunto apportato dall’installatore e che evidentemente premia i più sofisticati EPC contractor. Anche se non sono ancora disponibili al momento della stesura del presente rapporto i dati di mar- 88 ginalità relativi al 2009 è possibile inferire dalle interviste svolte qualche ipotesi. Gli operatori sono tutti concordi sul fatto che una ulteriore riduzione dei margini è inevitabile, sia perché nel 2009 è proseguito l’ingresso di agguerriti operatori stranieri, sia perché la fase negoziale con il cliente finale è divenuta sempre più “difficile” ed ha ulteriormente eroso una quota di valore. L’effetto più interessante che ci si attende, tuttavia, è l’ulteriore aumento della varianza dei valori, ovvero della differenza che è possibile osservare in ciascuna fase fra i margini delle imprese più “virtuose” rispetto e quelli delle imprese più inefficienti. L’auspicio è che l’anno 2009 segni l’avvio di un processo darwiniano di “selezione” delle imprese italiane del fotovoltaico destinato (come spesso succede nei periodi di crisi) a far sopravvivere solo le imprese più efficienti e profittevoli, ovvero le più pronte a cogliere e sfruttare al meglio le opportunità di crescita che la ripartenza dell’economia inevitabilmente moltiplicherà. 1.4.3 I player della filiera fotovoltaica italiana L’analisi condotta permette di stimare in più di 700 il numero di imprese che operano nelle aree di business del mercato fotovoltaico italiano, a cui si aggiungono alcune migliaia di operatori locali, coinvolti principalmente nella fase di installazione dell’impianto e 430 banche e istituti di credito che operano nelle attività di finanziamento e investimento. Il numero degli operatori attivi sul mercato italiano è aumentato di circa il 12% rispetto al 2008. Questo incremento della competizione è dovuto sia all’ingresso di nuovi player italiani - start up ma anche imprese già attive in altri settori industriali, che sono state attratte dal tasso di crescita fatto registrare dal fotovoltaico italiano nonostante il periodo di crisi economica - sia all’accresciuta presenza di operatori stranieri che a seguito del ridimensionamento del mercato spagnolo hanno cercato in Italia opportunità di crescita alternative. Questa duplice dinamica, particolarmente evidente nell’area di business “Celle e Moduli” (in cui il numero di operatori è aumentato di oltre il 23% rispetto al 2008), ha di fatto lasciato inalterato il peso relativo delle imprese italiane rispetto a quelle straniere in tutte le aree di business della filiera, come illustrato in figura 1.39. Nel corso dell’ultimo anno, quindi, le imprese italiane non sembrano essere state in grado di www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera Figura 1.39 Le imprese nella filiera fotovoltaica italiana 26% Componenti & Tecnologie 46% 125 imprese se e 28% Silicio & Wafer Celle & Moduli Distribuzione & Installazione 51 imprese 73 imprese 345 imprese + piccoli installatori 10% 16% 39% 90% Impresa estera 45% Impresa estera con filiale italiana Residenziale 925 mln � Industriale 561 mln � Produzione & Trading Grandi Impianti 562 mln � 25% 75% Centrali 297 mln � Impresa Italiana Finanziamento to ne e & Assicurazione e 430 banche appropriarsi di porzioni più consistenti del valore del mercato italiano del fotovoltaico rispetto a quanto non accadesse nel 2008 (quando si era stimato che le imprese italiane generassero circa il 28% del margine operativo lordo della filiera italiana), specialmente in quelle aree in cui i livelli di marginalità sono particolarmente consistenti. Tre erano le strade identificate nel Solar Energy Report 2008 come necessarie per rafforzare il ruolo del made in Italy nel fotovoltaico: • la prima, che interessa le istituzioni, riguarda l’introduzione a fianco del Nuovo Conto Energia di meccanismi di politica industriale che incentivino la ricerca e gli investimenti produttivi nelle fasi più a monte della filiera; • la seconda, che interessa direttamente le imprese italiane, richiede invece significativi investimenti nell’incrementare la capacità produttiva così da cogliere le opportunità di crescita del mercato italiano ed europeo; • l’ultima suggerisce invece alle imprese italiane attive nella produzione di celle e moduli di puntare sulle tecnologie fotovoltaiche di seconda generazione per costruirsi una posizione di rilievo nel mercato del fotovoltaico del futuro. Chiaramente, in un contesto caratterizzato dal perdurare della crisi economica e dalle incertezze, 8% 7% 85% che dovrebbero essere cancellate con la revisione del Nuovo Conto Energia, sul futuro del fotovoltaico in Italia, percorrere con forza queste strade nel 2009 sarebbe stato estremamente rischioso per le imprese italiane. In questo senso, l’anno appena trascorso ha rappresentato un periodo di transizione per gli operatori italiani, nella speranza che essi si dimostrino pronti a compiere un salto verso la maturità, nel caso in cui il futuro del fotovoltaico in Italia si riveli roseo. 1.4.4 Area di Business Silicio e Wafer È possibile stimare in circa 80 il numero di imprese operanti a livello mondiale in questa area di business nel 2009, a fronte dei circa 50 operatori censiti nel 2008. I principali player sono riportati in tabella 1.13. Le principali dinamiche che hanno interessato le imprese che competono in questa area di business possono essere così riassunte: • nel corso dell’ultimo anno, i produttori di polysilicon e wafer si sono dovuti confrontare con una crescita della domanda mondiale di celle e moduli decisamente inferiore rispetto a quella registrata nel 2008, a causa della congiuntura www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 89 1. IL fotovoltaico Tabella 1.13 I principali produttori di silicio a livello mondiale Capacità installata 2008 (MW) Obiettivi futuri di crescita della capacità installata (MW) Ricavi 2009 area polysilicon (mln €) Produzione di wafer Impresa Nazione Capacità installata 2009 (MW) Hemlock Semiconductor Corporation USA 19.000 19.000 35.000 (al 2010) 3.670 No OCI Company (ex DC Chemical) Corea 17.000 6.500 27.000 (al 2010) n.d. No Wacker Chemie Germania 14.500 14.500 25.000 (al 2010) 2.660 No MEMC USA 10.500 8.000 15.000 (al 2010) 834 Si REC Norvegia 10.000 6.500 28.000 (al 2010) 1.050 Si Tokuyama Speciality Products Giappone 6.500 5.200 11.200 (al 2012) 756 No Nitol Russia 3.800 - n.d. n.d. Si Mitsubishi Materials Giappone 3.300 3.000 4.300 (al 2010) 522 No M.Setek Giappone 3.000 2.000 32.000 (al 2012) n.d. Si Osaka Technologies Giappone 1.400 1.400 3.600 (al 2011) 125 No anticipato nel Solar Energy 2008. Tra le più imeconomica negativa generalizzata e della decisa portanti si possono citare la russa Nitol e la giapcontrazione di alcuni importanti mercati, quale ponese Tokuyama. La maggior parte di queste quello spagnolo, per effetto della revisione dei imprese operava da anni nel settore chimico e sistemi incentivanti. Ciò si è immediatamente ha messo a frutto competenze tecnologiche contradotto in una crescita della domanda di posolidate per adattare i propri processi produttivi lysilicon e wafer ampiamente al di sotto delle alla fabbricazione di silicio fotovoltaico; aspettative, il che, insieme agli ingenti investi• oltre agli ingressi da parte di imprese operanti menti in nuova capacità produttiva realizzati in settori affini ed alla nascita di nuodagli operatori nel 2008 e nel 2009 ve iniziative imprenditoriali (come ed al contemporaneo rallentamen“I produttori di silicio a livello to della domanda di polysilicon per mondiale continuano a dormire ad esempio la cinese Yaan Yongwang sonni tranquilli” Silicon Industry che ha avviato la proapplicazioni elettroniche, ha ridotduzione di 300 tonnellate di silicio a to sensibilmente le loro marginalità Business Developer di un’impresa produttrice di moduli fine marzo 2009 ed ha avviato la coe ha causato il fallimento di molti di struzione di un impianto da 3.000 essi, specialmente di quelle imprese tonnellate con lo scopo di arrivare ad una capacinate di recente nel Far East. Basti pensare a quetà produttiva di 10.000), a partire dalla fine del sto proposito che nel 2009 l’offerta complessiva 2008 e nel corso del 2009 diversi dei principadi polysilicon a livello mondiale è cresciuta del li player del silicio hanno significativamente doppio rispetto all’anno precedente, mentre aumentato la loro capacità installata (si veda la domanda è aumentata solo nell’ordine del tabella 1.13). La MEMC e la REC hanno incre30%; mentato la loro capacità produttiva tra il 2008 e • tra il 2008 e il 2009 molte nuove imprese hanno il 2009 rispettivamente del 31% e del 53%. I profatto il loro ingresso nel mercato del polysilicon getti di investimento intrapresi dalla Hemlock e dei wafer provenendo da settori “affini”, come 90 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera polysilicon nel 2010 di circa il 25% rispetto al porteranno a disporre nel 2010 di una capacità valore registrato nel 2009; produttiva di 35.000 tonnellate all’anno (con un • l’analisi ha inoltre messo in luce una tendenza, aumento dell’84% rispetto al 2008). La Wacker da parte delle imprese di medio-grandi dimenstima invece di raggiungere nel 2010 una capasioni attive da anni in questa area di business, cità annua di 25.000 tonnellate (con una crescita all’acquisizione o alla fusione con operatori più del 72% rispetto al 2008), mentre la giapponese piccoli, di recente entrati nel mercato. Luoyang M.Setek prevede di disporre, nell’arco di 2 anni, è ad esempio una joint venture tra l’americana di una capacità installata di 32.000 tonnellate MEMC e la cinese Sijia, nata nel 2008 per la proall’anno, con una crescita rispetto al livello atduzione di silicio poli-cristallino e silicio orgatuale di oltre il 900%; nico e con una capacità produttiva annua di 500 • l’aumento vertiginoso dell’offerta rispetto alla tonnellate, che dovrebbe salire a 2.000 tonnellate domanda ha avuto come ovvia ripercussione un nei prossimi due anni. Si rilevano inoltre procesabbassamento significativo dei prezzi del polysisi di fusione e acquisizione che hanno interessato licon. La produzione effettiva di polysilicon nel imprese attive nella produzione di polysilicon e 2008 è stata pari a 5,7 GW e a 8,2 GW al 2009. aziende operanti nelle fasi più a valle della filiera. Nel 2008 i prezzi medi del silicio di grado solaOCI Company ha ad esempio assunto una posire sul mercato spot si attestavano sui 320-380 $/ zione rilevante nel capitale di EverGreen Solar, kg, mentre il prezzo per contratti di fornitura di impresa americana attiva nella produzione di lungo termine era nell’ordine dei 90 $/kg. Nella wafer, celle e moduli. Queste dinamiche sono seconda metà del 2009 il prezzo spot del polysid’altronde frequenti in quei comparti industriali licon per applicazioni solari è sceso a 120-140 $/ caratterizzati da marginalità in contrazione e aukg e la maggior parte dei contrati di fornitura mento della competizione; di lunga durata sono stati rinegoziati su valori • dal punto di vista tecnologico, si conferma la nell’ordine di 60-70 $/kg; tendenza già registrata nel corso del 2008, per • il mercato mondiale del polysilicon e dei wafer cui le imprese produttrici di wafer risulta ancora fortemente concene di celle stanno investendo ingenti trato, anche se si rilevano delle inGli investimenti in polysilicon sono risorse in attività di ricerca e sviteressanti evoluzioni rispetto agli “troppo consistenti per la mentalità anni passati. Nel 2007 i primi 7 del nostro Paese e anche la buona luppo sperimentale finalizzate alla produttori di polysilicon e wafer a volontà si scontra con un costo riduzione degli spessori dei wafer dell’energia troppo alto. Un caso stessi e nella ricerca di una maggiore livello globale realizzavano circa il a parte sono le imprese cinesi 90% della produzione mondiale, e che pur sperimentando un costo efficienza di trasformazione, così da dell’energia piuttosto alto ricevono ancora nel 2008 la produzione dei una serie di incentivi o facilitazioni diminuire sensibilmente il fabbisoprimi 7 player ammontava all’85% dallo Stato. Abbiamo incontrato un gno di silicio. cinese di polysilicon che del totale. Nel 2009 questo valore è produttore ha ricevuto dal governo i soldi per sceso al 75%, segno di una riduzio- triplicare la sua produzione e 500 Per quanto riguarda il contesto italiainvestire in parchi solari in no, le principali iniziative imprendine non irrilevante della concentra- mln $ dagiro per il mondo” toriali nella produzione di silicio dezione del settore. Questa dinamica Business Developer di un’impresa scritte nel Solar Energy Report 2008 si spiega con una crescita della capaproduttrice di moduli (Silfab, Italsylicon ed Estelux) hanno cità installata da parte di nuovi ensubito una battuta d’arresto. Di fattranti proporzionalmente superiore to nessuna di esse ha attivato la propria attività, né a quella messa in atto dagli incumbent. Basti pentantomeno ha completato l’installazione della casare in questo senso alla coreana OCI Company, pacità produttiva prevista: che è entrata nel 2007 nell’area di business del silicio ed ha già raggiunto la seconda posizione a • i progetti in questione hanno un carattere fortelivello mondiale per capacità installata, la russa mente capital intensive (per realizzare un impianNitol, che già vanta una capacità produttiva di to di produzione di polysilicon da circa 5.000 ton3.800 tonnellate all’anno, o la giapponese Japan nellate/anno sono necessari dai 350 ai 400 mln Solar Silicon, anch’essa protagonista di una rapi€). La stretta creditizia seguita alla crisi econoda crescita della sua capacità. L’effetto della promica generalizzata, i cui effetti si palesavano già gressiva entrata in produzione di questi nuovi nel 2008 ma che si sono accentuati e prolungati stabilimenti produttivi nel corso del 2009 sta in nel 2009, ha impedito ad alcune delle iniziative questi mesi mostrando i suoi effetti, con una ulimprenditoriali sopracitate di accedere ai capiteriore diminuzione media del prezzo spot del www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 91 1. IL fotovoltaico tali necessari a portare avanti i loro progetti di crescita; • i processi per l’autorizzazione alla realizzazione di questi impianti si sono rivelati, in alcuni casi, estremamente complessi e di notevole durata. A causa del fatto che questi stabilimenti produttivi fanno uso di sostanze inquinanti e pericolose (tra cui il cloro), si rende necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’ottenimento di autorizzazioni aggiuntive che spesso variano da Regione a Regione. Silfab ha ad esempio impiegato più di 9 mesi per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per avviare l’impianto di produzione a Borgofranco d’Ivrea in Provincia di Torino, mentre in altri casi (come quello di Italsylicon) le complicazioni burocratiche sono state persino maggiori; • infine, la significativa riduzione del prezzo del polysilicon descritta nel paragrafo precedente e il conseguente contrarsi delle marginalità industriali degli operatori attivi in questa area di business, hanno ridotto l’attrattività dell’iniziativa agli occhi degli imprenditori e, soprattutto, dei potenziali finanziatori. è quello della Lux, impresa di Bozzolo Formigaro (AL) che intende operare nel campo della produzione di wafer di silicio (si veda box 1.12). Altro esempio è quello della Depasol Silycon, con sede in Provincia di Foggia, che dovrebbe avviare la produzione di lingotti e wafer in silicio mono-cristallino ad alta efficienza attraverso un impianto di 3.000 metri quadrati di superficie coperta, con una capacità produttiva annua che supererà, a regime, i 15 MW. 1.4.5 Area di Business Celle e Moduli L’area di business che comprende i produttori di celle e moduli fotovoltaici è stata caratterizzata nel 2009, a livello internazionale, da alcuni profondi cambiamenti che possono essere sintetizzati come segue: • a partire dai primi mesi del 2009, come illustrato nel paragrafo 1.1.1, si è assistito ad una significativa riduzione del prezzo dei moduli fotovoltaici, dovuta ad una crescita del mercato mondiale inferiore rispetto alle attese e ad un Il nostro Paese rimane quindi ancora completacontemporaneo e vertiginoso aumento della camente dipendente dalla produzione estera di sipacità produttiva installata, per effetto licio di grado solare. Le uniche unità produttive ad oggi in funzione sono “Noi siamo passati da un prezzo degli investimenti pianificati nel 2008. quelle dell’americana MEMC, che è medio dei moduli di circa 3 € nel Nonostante le continue riduzioni dei 2008 a 2,15 € nel 2009 e si costi di produzione di celle e moduli presente in Italia con gli stabilimenti prevede un’ulteriore diminuzione di Merano, in cui è attiva una produ- per il 2010. Questa è la situazione fotovoltaici conseguite attraverso miattuale…” glioramenti tecnologici dei processi zione di polysislicon e lingotti con una capacità produttiva di circa 1.500 ton- Amminsitratore delegato di un’impresa produttivi, questa dinamica al ribasso produttrice di celle e moduli dei prezzi ha messo in crisi i margini nellate/anno, e di Novara, che ospita industriali delle imprese produttrici. anche una produzione di wafer. Questo fenomeno avrebbe potuto essere estremaNonostante il quadro competitivo non particolarmente problematico per quelle imprese che si mente favorevole, non è infrequente imbattersi in erano vincolate, nel corso del 2007 e del 2008, a nuove iniziative promosse da imprenditori italiacontratti pluriennali di fornitura del silicio (in alni in questa area di business. Un caso interessante Box 1.12 Lux Lux è una nuova iniziativa imprenditoriale italiana attiva nella produzione di wafer realizzati utilizzando esclusivamente silicio poli-cristallino vergine, di grado 9N o superiore. Fondata nel 2007, la società ha sede a Pozzolo Formigaro, in Provincia di Alessandria. Dopo un primo periodo dedicato allo studio del mercato e della tecnologia, nel corso del 2009 la Lux ha raggiunto un accordo con la tedesca ALD Vacuum Technologies per la fornitura della prima fornace a solidificazione direzionale utilizzata per la fusione del silicio, che può garantire una capacità 92 produttiva annua di circa 8 MW. Ciò ha reso possibile la realizzazione del primo lingotto nel dicembre del 2009. Con una produzione potenziale di 200.000 pezzi al mese, Lux intende affermarsi sul mercato europeo della produzione di wafer. Nel corso del 2010 la società piemontese ha dichiarato l’intenzione di raddoppiare la propria capacità produttiva. Lux ha anche reso noto che sta siglando accordi per inserirsi nel business della produzione di celle fotovoltaiche, in modo da aggredire il mercato italiano come fornitore integrato verticalmente lungo la filiera. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera hanno visto la luce in Cina (alcuni esempi sono cuni casi anche decennali) i quali prevedevano un Nantong Qiangsheng Photovoltaic Technology, prezzo al chilogrammo che rapidamente, nel giro Shangai Solar Energy Science & Technology) con di pochi mesi, si è trovato ad essere quasi doppio capacità produttive iniziali comprese tra i 30 e rispetto a quello spot del 2009. La nostra anali150 MW. Queste realtà, non potendo contare su si mostra come i principali produttori di celle e un mercato interno con una domanda robusta, moduli, internazionali e non, siano in realtà stati si sono rivolte sin da subito ai mercati europei, in grado di rinegoziare i contratti di fornitura incrementandone il livello di comcon i produttori di polysilicon, otpetizione, come è accaduto anche in tenendo una diminuzione di prezzo “Negli Stati Uniti lo sviluppo della nell’ordine del 40-50% ed evitando tecnologia a film sottile sta facendo Italia; così di finire fuori mercato. Insieme passi da gigante, principalmente • la capacità produttiva di film sotgrazie ai contributi in conto tile a livello globale è aumentata nel ad un ulteriore efficientamento dei capitale che vengono assicurati processi produttivi, ciò ha permesso al titolare dell’impianto. È chiaro 2009, salendo dai 2,5 GW del 2008 di limitare l’impatto delle dinami- che, in questa situazione, conviene ad oltre 7 GW. Basti pensare a questo costruire un impianto che costi il che di mercato sopra descritte sulle meno possibile, il che mette il film proposito che, nell’arco di un anno, la marginalità industriali dei produt- sottile in una posizione di vantaggio capacità installata di First Solar, una rispetto al silicio tradizionale. Le tori di celle e moduli riportati in fi- tariffe feed-in, invece, focalizzano delle imprese leader nella produziol’attenzione sull’efficienza ne di film sottile in CdTe, è salita da gura 1.38; dell’impianto” 735 a 1.200 MW, per un investimento • la competizione nell’area di business Amministratore delegato complessivo stimabile in 200 mln $ e si è ulteriormente accentuata. È indi un system integrator la Best Solar High-Tech, costituita dicativo in questo senso che la quota dal fondatore della LDK Solar, che di mercato dei primi 10 produttori ha iniziato le attività nel febbraio 2008 ed ha di celle e moduli fotovoltaici è passata dal 65% nel all’attivo una capacità produttiva di moduli in 2007 al 45% nel 2008, fino ad arrivare ad un vasilicio amorfo di circa 1 GW con piani di espanlore che è possibile stimare nell’intorno del 35% sione piuttosto consistenti (si veda tabella nel 2009. Tra la seconda metà del 2008 e i pri1.14). Oltre a ciò, nel 2009 si registra l’ingresso mi mesi del 2009, si stima siano nate circa 300 nell’attività di produzione di film sottile di diversi nuove imprese a livello mondiale, che hanno nuovi player (a Taiwan per esempio tra fine 2008 cominciato a competere con i produttori di cele il 2009 sono nate rispettivamente BeyondPV e le e moduli consolidati. Molte di queste aziende Tabella 1.14 I principali produttori di moduli a film sottile a livello mondiale Impresa Nazione Capacità installata 2009 (MW) Obiettivi al 2010 di capacità installata (MW) Tecnologia utilizzata First Solar U.S.A 1200 1272 Tellururo di Cadmio Best Solar Hi-tech Cina 1000 1500 Silicio amorfo Sunwell Solar Taiwan 180 n.d. Silicio amorfo UNI Solar - United Solar Ovonic U.S.A 180 420 Silicio amorfo Sharp Giappone 160 1000 Silicio amorfo Sunfilm-Sontor Germania 145 205 Silicio amorfo Solibro Germania 135 n.d. CIS/CIGS Schott Solar Germania 130 450 Silicio amorfo Mitsubishi Heavy Industries Giappone 128 600 Silicio amorfo Solyndra U.S.A 100 610 CIS/CIGS Calyxo Germania 85 n.d. Tellururo di Cadmio www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 93 1. IL fotovoltaico Box 1.13 First Solar Fondata nel 1999 a Tempe (Arizona), First Solar è uno dei leader mondiali nella produzione di moduli fotovoltaici, attiva in particolare nel segmento delle centrali di grandi dimensioni. La società statunitense è il principale produttore al mondo di pannelli fotovoltaici a pellicola sottile in Tellururo di Cadmio (CdTe). Grazie a questa tecnologia, First Solar è stato il primo operatore nel settore fotovoltaico capace di ridurre i costi di produzione a meno di 1 dollaro al Watt: nel terzo trimestre del 2009, il costo dichiarato si attestava sugli 85 centesimi di dollaro. Nel giugno dello stesso anno la società ha annunciato un piano per abbattere ulteriormente i costi di produzione, ponendosi come obiettivo al 2014 un valore compreso tra i 52 e i 63 centesimi di dollaro. First Solar ha stabilimenti produttivi in Malesia, Germania e negli Stati Uniti e a fine 2009 ha raggiunto e superato 1 GW di capacità produttiva. La società può contare su un organico di oltre 4.000 dipendenti a livello globale e ha fatto registrare nel 2009 un fatturato di poco superiore ai 2 mld $, quasi raddoppiando il valore raggiunto nell’anno precedente. Chi Mei Energy) e la conclusione di processi di aggregazione che hanno portato all’affermazione di nuovi grandi operatori. Tra questi ultimi, da ricordare sono le fusioni tra Sunfilm e Sontor, una controllata di Q-Cells, che ha dato vita ad In Italia First Solar non ha uffici commerciali, che a livello europeo sono localizzati in Germania e in Spagna, ma ha stipulato diversi contratti di collaborazione con sviluppatori di impianti, il più importante dei quali è stato siglato a fine 2008 con Sorgenia Solar per la fornitura a lungo termine di moduli fotovoltaici. Tra le sue più importanti iniziative a livello globale, nel settembre 2009 First Solar ha siglato una dichiarazione di intenti con il governo cinese per creare a Ordos City in Mongolia una centrale solare da 2 GW di capacità installata; l’inizio dei lavori è previsto per il giugno del 2010. First Solar è stata la prima società del settore a lanciare un programma pre-finanziato di ritiro e recupero dei propri pannelli. Chiunque acquisti un pannello dell’impresa, ne può chiedere il ritiro al termine del ciclo di vita, con First Solar che sosterrà i costi di ritiro e riciclaggio. Secondo la società statunitense, il 95% dei materiali semiconduttori può essere rigenerato con uno specifico processo di recupero chiuso per poi essere utilizzato nella costruzione di nuovi pannelli fotovoltaici. una delle più grandi imprese, a livello internazionale, produttrice di moduli a film sottile a silicio amorfo, e tra Sanyo e Nippon, che ha dato alla luce Sanyo-Eneos Solar Company, che inizierà la produzione e la vendita di 80 MW di moduli Figura 1.40 Andamento della capacità produttiva installata (MW) di moduli in silicio cristallino e in film sottile a livello mondiale 70000 60000 50000 40000 30000 Silicio cristallino 20000 Film sottile 10000 0 2008 94 2009 2010 E www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2012 E 1.4 La filiera Figura 1.41 Capacità installata di moduli in film sottile nei principali Paesi mondiali 3000 2500 CIS 2000 1500 CdTe 1000 silicio amorfo 500 2009 Res to Cina an Taiw USA e opa pon Giap Eur Res to Cina an Taiw USA one Giap p Eur opa 0 2010 E nel corso del 2010, aumentando gradualmente la capacità produttiva con l’obiettivo di arrivare a 1 GW di produzione entro il 2015. Da un’analisi dei progetti di espansione delle principali imprese attive nella produzione di film sottile, è possibile stimare si possa raggiungere una capacità installata a fine 2010 di oltre 10 GW. Questo si spiega con la crescente attenzione che gli investitori stanno indirizzando alle tecnologie fotovoltaiche di seconda generazione e con le prospettive sempre più rosee in merito alla quota di mercato che esse saranno in grado di conquistare nei prossimi anni (si veda paragrafo 1.1.2). La figura 1.40 riporta l’andamento atteso della capacità produttiva a livello mondiale di moduli realizzati con le due principali tecnologie, il silicio mono- e poli-cristallino ed il film sottile. Interessante è anche analizzare la distribuzione della capacità installata per le tecnologie a film sottile nei principali Paesi mondiali. Dalla figura 1.41 si evince che le imprese cinesi e giapponesi hanno fatto dei considerevoli passi avanti in termini di capacità installata nel 2009 e, almeno in ottica prospettica, nel 2010, puntando esclusivamente sulla tecnologia che si basa sul silicio amorfo. È in Europa e negli Stati Uniti, oltre che in altri Paesi quali India, Malesia e Sud Corea, che si registra la maggiore capacità installata di moduli di film sottile, il che pone questi Paesi in una posizione di sicuro vantaggio nel momento in cui le tecnologie di seconda generazione dovessero conquistare, nel medio periodo, significative quote di mercato a scapito del silicio tradizionale. L’attrattività dell’area di business si è ridotta nel 2009 anche per effetto dell’entrata in produzione di quei nuovi stabilimenti i cui progetti sono stati approvati nel corso degli anni passati, che hanno portato ad un aumento della capacità installata di celle e moduli decisamente superiore rispetto alla crescita della domanda (come d’altronde si è già rilevato nel caso del polysilicon). Si stima che la capacità produttiva a livello globale sia salita a 23 GW nel 2009, dai 15 GW di fine 2008 (con previsioni di crescita per il 2010 a 35 GW). La produzione totale nel 2009 a livello mondiale è stata pari a circa 10 GW, a fronte di una domanda complessiva di circa 7 GW. Si è quindi passati da una situazione di shortage di celle e moduli nel corso del 2008, almeno in molti dei principali mercati europei, ad un contesto di oversupply, con un livello di invenduto. Ciò ha innanzitutto “spinto” fuori mercato molte imprese, specialmente quelle di minore dimensione e di recente nascita (alcuni stimano che quasi il 50% delle 300 nuove start up di cui si è parlato in precedenza siano fallite entro la fine del 2009). Queste imprese non sono state in grado infatti, anche per effetto dell’acuirsi del credit crunch, di recuperare nuove risorse per finanziare il loro crescente capitale circolante. In www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 95 1. IL fotovoltaico Tabella 1.15 I principali produttori di celle a livello mondiale Nazione Capacità produttiva celle 2009 (MW) Capacità produttiva celle 2008 (MW) Ricavi 2009 (mln €) Ricavi 2008 (mln €) Impresa estera U.S.A 1.100 735 1.600 880 Q-Cells Impresa estera Germania 800 760 85058 1.230 Kyocera Impresa estera con filiale italiana Giappone 650 300 n.d. n.d. JA Solar Impresa estera Cina 600 500 405 585 Motech Industries Impresa estera Taiwan 580 450 27359 450 Impresa Presenza sul mercato italiano First Solar secondo luogo, l’oversupply ha stimolato un rilevante processo di fusioni ed acquisizioni, per effetto del quale le imprese più in difficoltà sono divenute preda dei grandi player del settore (nel giro di poco più di 2 anni, Suntech ha ad esempio acquisito Nitol, MSK, Shunda e Asia Silicon). Per quanto riguarda gli operatori attivi sul mercato italiano, il censimento ha permesso di identificare 73 imprese in questa area di business, con un incremento di oltre il 20% rispetto alla nume- rosità degli operatori registrata nel 2008. Le tabelle 1.15, 1.16 e 1.17 forniscono alcune informazioni sui principali produttori a livello mondiale di celle e moduli, suddivisi in base al modello di business adottato (ossia produttori di celle, produttori integrati e modulisti57) e ordinati in base alla capacità produttiva del 2009. Per quanto riguarda i produttori di celle, si nota una tendenza all’espansione della capacità produttiva nel corso del 2009, nonostante una cresci- Box 1.14 SunPower SunPower è una società statunitense fondata nel 1985 e con sede a San Josè, in California. L’azienda è attiva nella produzione di celle e moduli fotovoltaici a elevata efficienza. A seguito dell’acquisizione di Power Light nel corso del 2007, l’attività di SunPower si è estesa alle fasi a valle della produzione, il che le ha permesso di proporsi sul mercato anche in qualità di system integrator ed EPC contractor. Nel 2008 SunPower ha fatto il proprio ingresso nel mercato italiano con l’acquisizione di Solar Solutions, società che distribuiva e installava sistemi solari fotovoltaici con sede a Faenza. È stata quindi costituita una nuova entità giuridica denominata SunPower Italia, che ha una forza lavoro superiore ai 40 addetti. SunPower Italia si rivolge sia al mercato residenziale, dei distributori locali, come fornitore di moduli, sia al mercato industriale, dove opera come EPC contractor. Nel 2009 ha fatto registrare vendite per un fatturato superiore ai 200 mln €. La società ha concluso diversi importanti accordi nel corso del 2009. È possibile 57 58 59 citare la collaborazione con Sunshire, controllata di Api Nova Energia, per la progettazione e la costruzione di un impianto fotovoltaico da 7,2 MW a Tolentino nelle Marche di cui 5 MW già connessi, e il contratto per la progettazione, costruzione e gestione del parco più grande d’Italia da 24 MW a Montalto di Castro, in Provincia di Viterbo, siglato con SunRay Renewable Energy. Inoltre, SunPower ha recentemente annunciato un accordo con SunRay che verrà perfezionato entro Giungo 2010. SunRay è un EPC contractor che opera anche come produttore indipendente di energia, con sedi in Europa e Medio Oriente e con una delle principali sedi operative a Roma. Nel 2009 la capacità produttiva di moduli di SunPower, che non ha però alcuna unità produttiva in Italia, è stata pari a circa 500 MW. È tuttavia in corso di realizzazione un nuovo impianto produttivo a Kuala Lumpur (Malesia), che porterà la produzione a regime ad un valore stimato di circa 1.5 GW. Cfr. Solar Energy Report 2008, pp 82-91 Stima fatta prendendo come riferimento il dato di settembre 2009 Stima fatta prendendo come riferimento il dato di settembre 2009 96 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera Tabella 1.16 I principali produttori integrati a livello mondiale Nazione Capacità produttiva celle 2009 (MW) Capacità produttiva moduli 2009 (MW) Capacità produttiva celle 2008 (MW) Capacita produttiva moduli 2008 (MW) Ricavi 2009 (mld €) Ricavi 2008 (mld €) Impresa estera con filiale italiana Cina 1000 1000 1000 1000 1,1 1,4 Sharp Electronics Impresa estera con filiale italiana Giappone 855 800 710 710 n.d. n.d. Yingli Green Energy Impresa estera con filiale italiana Cina 600 600 400 400 0,78 0,81 SunPower Impresa estera con filiale italiana USA 500 500 400 400 1,160 1,05 Sanyo Impresa estera Giappone 500 145 340 145 n.d. n.d. Impresa Presenza sul mercato italiano Suntech Power Tabella 1.17 I principali modulisti a livello mondiale Imprese Capacità produttiva 2008 (MW) Capacità produttiva 2009 (MW) Ricavi 2009 (mln €) Ricavi 2008 (mln €) Solon 500 500 30061 815,1 62 180 250 295 360,5 Centrosolar 150 150 309 333 Aleo Solar ta del mercato che è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Questi dati confermano quindi quanto già anticipato in questo paragrafo. Si rileva in particolare la crescita della capacità della giapponese Kyocera, che è più che raddoppiata in meno di un anno. Tuttavia, si regista in media una contrazione del fatturato rispetto al 2008, dovuta alle dinamiche di mercato illustrate in precedenza in questo rapporto, con la sola eccezione di First Solar63, produttore di moduli in CdTe. Anche per quanto riguarda i produttori integrati, si nota innanzitutto una contrazione generale, con l’unica eccezione di SunPower, dei ricavi 2009 rispetto a quelli registrati nel 2008, cui corrisponde un aumento della capacità produttiva installata. È da rilevare il passo in avanti rispetto al 2008 di Sanyo, che ha incrementato la propria capacità di celle del 47% nel corso del 2009 e il significativo aumento di capacità produttiva di celle e moduli (+50%) rispetto al 2008 sperimentato dalla cinese Yingli Green Energy. Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte per i produttori integrati e i produttori di celle valgono infine anche per i modulisti. Le tabelle 1.18 e 1.19 forniscono invece un elenco delle principali imprese italiane che operano come produttori integrati e modulisti - anche nel 2009 non si registrano infatti aziende italiane produttri- Stima fatta prendendo come riferimento il dato di settembre 2009 Stima fatta prendendo come riferimento il dato di settembre 2009 Nel corso del 2009, l’impresa è stata acquisita con una quota di maggioranza (75%) da Bosch. 63 First Solar non compariva tra i principali produttori di celle a livello mondiale nel Solar Energy Report 2008 in quanto nel precedente rapporto l’analisi era focalizzata sui produttori di celle a base di silicio cristallino. 60 61 62 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 97 1. IL fotovoltaico Tabella 1.18 I principali produttori integrati italiani Imprese Capacità produttiva celle 2009 (MW) Capacità produttiva moduli 2009 (MW) Produzione celle 2009 (MW) Produzione moduli 2009 (MW) Obiettivi capacità produttiva 2010 (MW) Ricavi 2009 (mln €) Ricavi 2008 (mln €) XGroup 90 30 22 19 Celle 90 Moduli 100 40 27 Helios Technology 60 55 35 1264 Celle 60 Moduli 58 75 92 Solsonica 30 60 n.d. 19 Celle 35 Moduli 80 n.d. 19 EniPower 10 20 1,7 14 Celle 30 Moduli 30 7,8 11,2 Box 1.15 XGroup XGroup nasce nei pressi di Padova nel 2006 come produttore di celle fotovoltaiche multicristalline. XGroup si è fin da subito dimostrata un’azienda molto dinamica, caratterizzata da una strategia di forte crescita ed espansione: nel 2008 ha esteso la propria attività a valle, entrando nel settore della produzione di moduli, grazie all’acquisizione di Cemi, formalizzata poi nel maggio del 2009. Ciò ha portato l’organico complessivo a circa 150 addetti, con una capacità produttiva di celle al 2009 pari a 90 MW, oltre a 30 MW di capacità produttiva di moduli. Oltre a sfruttare il canale di vendita tradizionale rappresentato dai distributori, XGroup si è recentemente aperta al mercato dei contratti EPC, avviando alcune relazioni con importanti operatori italiani, quale Terni Energia, e stranieri. Grazie alla sola commercializzazione di celle e moduli, la società ha raggiunto nel 2009 un fatturato di 40 mln €. Da novembre ci di sole celle con l’eccezione di Omniasolar (con una capacità produttiva di celle a fine 2009 di circa 10 MW e una produzione di 5 MW) - ordinate per capacità produttiva 2009. Dall’analisi condotta sui produttori integrati italiani emerge che: • la produzione effettiva di celle da parte delle imprese italiane nel 2009 è stata di circa 75 MW, a fronte di una capacità produttiva di circa 200 MW (con una saturazione media di circa il 37%). La previsione degli operatori era tuttavia quella di riuscire a saturare almeno il 65% della capacità, arrivando a produrre circa 130 MW di celle; • la capacità produttiva prevista per fine 2010, 64 2009 XGroup è membro di PV Cycle, un’associazione che organizza il ritiro volontario dei moduli prodotti dai suoi membri. Grazie a questa iniziativa, i clienti non devono sostenere costi di smontaggio, trasporto e riciclo dei moduli non più funzionanti. L’impresa prevede per il 2010 di mantenere inalterata la capacità produttiva delle celle (90 MW) e di effettuare un investimento, già deliberato, di espansione della capacità relativa ai moduli, per raggiungere un valore di 100 MW. Le previsioni di produzione effettiva per il 2010 sono pari a 70 MW, sia per le celle che per i moduli. È ancora in fase di definizione un possibile progetto di integrazione a monte, per il quale è stata attivata una collaborazione con una società di ingegneria romana per la realizzazione di prototipi di lingotti di silicio. È invece in fase di avvio un progetto di ricerca sul film sottile, che sperabilmente vedrà i primi risultati nel 2015. a fronte dei piani di investimento in essere, è di circa 390 MW. Nel corso del 2009 è stato ultimato l’impianto produttivo di celle di Solarcell a Vimercate (MI), impresa controllata da MXGroup, che tuttavia non è ancora entrato in regime di produzione. Nel corso del 2009, XGroup ha significativamente incrementato la propria capacità produttiva di celle, affermandosi così come la principale impresa italiana per capacità produttiva in questa specifica attività. Nello stesso anno l’impresa ha formalizzato ufficialmente l’acquisizione di CEMI, modulista già incorporata nel 2008, grazie alla quale XGroup ha rafforzato la propria presenza anche sul mercato dei moduli. Helios ha prodotto altri 24 MW di moduli all’estero. 98 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera esempio l’interessante progetto di investimenLe principali considerazioni che emergono dall’anato di STMicroelectronics, Sharp ed Enel Green lisi in merito ai produttori di moduli italiani possoPower in un nuovo impianto di fabbricazione di no essere così riassunte: moduli in film sottile da realizzarsi a Catania. • nel 2009 sono stati prodotti da imprese italia65 In questo senso è anche da rilevare la costitune circa 200 MW di moduli a fronte di una capacità produttiva installata di circa 500 MW zione, nel corso del 2009, della Moncada Solar (il grado di saturazione è perciò di circa il 40%). Equipment, parte di Moncada Energy Group La capacità a fine 2010 dovrebbe cree partecipata dal Monte dei Paschi scere ulteriormente per attestarsi su di Siena, che si propone l’ambizioso dei fattori critici di successo valori prossimi a 700 MW. A questa “Uno obiettivo di diventare rapidamente la per le imprese produttrici di celle crescita contribuiranno in modo si- e moduli, in questo e nel prossimo più grande impresa italiana di proanno, è il sapersi proporre sul gnificativo, considerando i piani di duzione di moduli in silicio amorfo. mercato con soluzioni integrate, espansione approvati, le imprese di anche in partnership con imprese L’impianto avrà una capacità promedio-piccole dimensioni, il che ri- che operano a valle della filiera” duttiva di 15 MW al 2010, e dovrebdurrà verisimilmente la concentrabe arrivare a 40 MW di produzione a Amministratore delegato di un’impresa produttrice di celle zione di questo specifico segmento regime. L’investimento complessivo e moduli dell’area di business; è stato di circa 90 mln €. Il gruppo • diversi modulisti italiani sono nati Marcegaglia sta ultimando la realiza cavallo fra il 2008 ed il 2009, tra cui Ferrania zazione di un impianto di produzione di moSolis, che avvierà la sua produzione nel 2010, e duli al Tellururo di Cadmio da circa 15 MW Invent srl, società veneta di San Donato di Piave per un investimento complessivo che si aggira (VE) che avvierà la propria linea di produzione sui 30 mln €, finanziati in parte dalla Regione nel 2010 con una capacità installata di 12 MW. Lombardia; Anche in Italia si registrano i primi proget• le imprese moduliste di più piccole dimensioti di investimento in capacità produttiva di ni (quali Vipiemme Solar, Brandoni Solare, moduli a film sottile. Il box 1.16 descrive ad SpSitem, D.G. Energy e V-Energy) hanno si- Tabella 1.19 I principali modulisti italiani Imprese Capacità produttiva moduli 2009 (MW) Produzione moduli 2009 (MW) Previsioni (2010) (MW) Ricavi 2009 (mln €) Ricavi 2008 (mln €) Solarday 60 30 60 61 57 MX Group 60 n.d. 60 40 14,8 Renergies 30 12 35 29 13 Istar Solar 15 10 30 n.d 11,1 Sorgenia Solar 10 10 15 40 30 Vipiemme Solar 8 8 20 30 5,5 Box 1.16 L’accordo tra Enel Green Power, Sharp e STMicroelectronics Enel Green Power, Sharp e STMicroelectronics hanno firmato a inizio 2010 l’accordo finalizzato alla realizzazione della più grande fabbrica di moduli fotovoltaici in Italia. L’impianto sarà costruito a Catania e produrrà pannelli a film sottile a tripla giunzione. L’accordo prevede la collaborazione tra le tre società: Enel Green Power, nello sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili a livello internazionale e nel project management; 65 Sharp, nella tecnologia del film sottile a tripla giunzione; STMicroelectronics nelle capacità manifatturiera, con personale specializzato in settori all’avanguardia tecnologica come la microelettronica. L’impianto, che prevede un investimento iniziale di 320 mln € e vedrà l’avvio della produzione nel 2011, avrà inizialmente una capacità produttiva annuale di moduli fotovoltaici pari a 160 MW, che diventerà a regime 480 MW. Il dato non considera i 40 MW prodotti da Solon (azienda tedesca) in Italia. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 99 1. IL fotovoltaico turazione di alcuni dei principali modulisti itagnificativamente incrementato la loro capacità liani, è naturale che essi comincino a guardare produttiva nel 2009, che è arrivata a circa 75 con crescente attenzione a quei mercati in cui il MW complessivi, ma presentano ancora valofotovoltaico sembra pronto a partire ri di produzione piuttosto bassi, con una saturazione che nel 2009 “Abbiamo la capacità di realizzare (quali Turchia, Grecia o Repubblica Ceca) e quelli in cui esso continua a qualsiasi disegno particolare o si è attestata su valori prossimi al di proporre qualsiasi soluzione registrare dei tassi di crescita signi45-50%. Altri produttori di modi integrazione architettonica. ficativi (quale la Germania). Questo duli hanno invece avviato dei Disponiamo di diversi brevetti internazionali depositati” soprattutto in un momento in cui il programmi di espansione della loro capacità produttiva all’este- Amministratore delegato di una piccola futuro prossimo del mercato italiano impresa produttrice di moduli è ancora molto incerto, e con l’esigenro. Istar Solar produrrà 5 MW nel za, da parte di molte imprese italiane, 2010 nel suo impianto di Bangkok, di trovare uno sbocco di mercato al loro invenmentre si prevede che FVG Energy fabbricherà, duto o di saturare maggiormente la loro capacinel proprio stabilimento di Shangai, 25 MW di tà produttiva. L’internazionalizzazione dell’attimoduli nel 2010. vità è stata realizzata sia attraverso la semplice esportazione dei propri prodotti (come è avveNel complesso, l’area di business “celle e moduli” nuto con Helios in Turchia, XGroup, che ha fatin Italia è stata contraddistinta dalle seguenti dito registrare il 5% delle proprie vendite all’estero namiche competitive: e sta valutando una probabile espansione verso i mercati della Germania, Francia e dei Paesi • nel corso del 2008, lo shortage di celle e moduli dell’Est e con Solarday in Grecia e Turchia), sia aveva permesso ai principali produttori italiani attraverso l’apertura di nuovi filiali di lavorare a pieno regime, con la in Paesi esteri (MXGroup ha aperto certezza di trovare uno sbocco di “Quest’anno è stato un anno mercato per i propri prodotti. Nel particolare. Per come è strutturata una filiale in Germania nel 2009 e si la nostra azienda dal punto di sta affacciando, con la costituzione di 2009, specialmente nei primi mesi vista commerciale, il nostro target nuove unità, sul mercato israeliano e dell’anno, queste condizioni non si di riferimento è rappresentato dal segmento residenziale e turco); sono più verificate. L’incremento dal commerciale medio-piccolo. • le imprese straniere di maggiori della capacità produttiva realizQuest’anno, per cause di forza zato dagli operatori di questa area maggiore, siamo stati costretti dimensioni operanti in Italia hana guardare anche al segmento no fatto leva prevalentemente sul di business e il contemporaneo centrali che, almeno nei primi mesi rallentamento del mercato hanno dell’anno 2010, offriva opportunità canale dei grandi distributori, andi business molto attrattive” che “generalisti”, per veicolare i loro messo molti player in una condizione difficile, con gradi di saturazio- Amministratore delegato di una grande prodotti sul mercato. Solo alcune imne dei propri impianti decisamente impresa produttrice di celle e moduli prese europee (quali ad esempio BP Solar e SunPower) hanno iniziato ad bassi. Le previsioni di produzione instaurare partnership con installatori e system per oltre 275 MW di moduli fotovoltaici nel 2009 integrator, a seguito dell’apertura di filiali comsono state largamente disattese; merciali nel nostro Paese. Le imprese italiane, • si registra un significativo aumento delle sia i modulisti che i produttori integrati, sono esportazioni da parte di alcuni produttori itastate chiamate invece a costruire un rapporto liani, tra cui Helios Technology, MXGroup e diretto con gli installatori e i clienti finali, salSolarday (per quest’ultima, il fatturato del 2009 tando in molti casi la fase di distribuzione, per è stato realizzato per il 35% in Italia e per il 65% evitare l’abbassamento dei margini e per fare all’estero, rispetto ad un rapporto del 53% in leva sulla vicinanza al cliente e offrire un livello Italia e 47% all’estero nel 2008). Ciò si spiega da di servizio e garanzie dirette differenzianti riun lato con l’aumento della competizione, dospetto ai competitor europei. In questo senso, vuta all’ingresso sul mercato italiano di produtalcune imprese italiane di maggiori dimensioni tori cinesi e taiwanesi – molti dei quali sono nati hanno anche iniziato a mettere in atto nel 2009 recentemente e non trovano nel mercato interno strategie di integrazione a valle della filiera, uno sbocco sufficiente per la propria offerta – e operando in qualità di system integrator (e di quelli con una forte presenza in Spagna – alla appoggiandosi a installatori di fiducia) tipicaricerca di un nuovo “Eldorado” del fotovoltaico mente per impianti di taglia superiore a 50-100 dopo la battuta d’arresto registrata dal mercato kW. Altre imprese hanno stretto collaborazioni iberico. Dall’altro, con il rafforzamento e la ma- 100 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera versa taglia, la soluzione non ha preso piede per strategiche con partner a valle della filiera (EPC l’elevata resistenza dimostrata dall’utilizzatore contractor o system integrator), così da aumenta“tipo”, ossia il privato cittadino, a valutare le care la loro presenza commerciale. Esempi in queratteristiche tecniche del prodotto e a confronsto sono la collaborazione di XGroup con Terni tare diverse soluzioni disponibili sul mercato. Energia e l’integrazione a valle di Solsonica con A questo si aggiunge anche la complessità delle Kopernico e Solsonica Energia; procedure di autorizzazione e accesso agli in• si è osservata una crescente specializzazione centivi, che rappresentano un ulteriore elemendelle imprese attive in questa area di business to di incertezza per la famiglia intenzionata ad in Italia su uno specifico segmento di mercato. acquistare un impianto; I modulisti italiani di piccole dimensioni si sono • la crescita della produzione di celle e moduli rivolti in modo più deciso e focalizzato rispetto nel 2009 rispetto al 2008 da parte delle impreal passato al settore residenziale, costruendo se italiane è stata consistente, nonostante le strette collaborazioni con installatori e system aspettative fossero più ottimistiche. integrator che permettono loro di Si è passati infatti da una produzione fidelizzare il cliente “tipo” (in que“Nei primi mesi del 2009, per poter stare sul mercato era di celle di 30 MW a oltre 75 MW (+ sto caso il privato cittadino). Le imnecessario abbassare i prezzi 150%) e da una produzione di moprese straniere e le aziende integratremendamente. Le aziende in te italiane di maggiori dimensioni, maggiore difficoltà, con i magazzini duli di 150 MW a circa 200 MW (+ cercavano di vendere i moduli 33%). Nonostante ciò, le imprese itache fino al 2008 avevano servito pieni, sul mercato a prezzi ancora più anche il mercato degli impianti di bassi. Di tutto ciò hanno beneficiato liane continuano ad avere una posisenza dubbio i clienti finali” zione del tutto marginale rispetto al minore taglia, ad uso residenziale e piccolo industriale, si sono decisa- Amministratore delegato di un’impresa panorama europeo, se si pensa che, mente orientate al segmento delle distributrice di materiale fotovoltaico ad esempio, la Germania ha fatto registrare già nel 2008 una produzione centrali e degli impianti di grande di moduli pari a oltre 1.200 MW. Oltre a ciò, potenza (spesso superiore ai 500 kW), che ha rela capacità installata delle imprese del nostro gistrato nel 2009 un “boom” di installazioni; Paese, specialmente di quelle focalizzate sul• diversamente da quanto alcuni operatori si atla produzione di celle, rimane di un ordine di tendevano, il 2009 non ha visto una diffusiograndezza inferiore rispetto ai principali player ne della soluzione del kit fotovoltaico su larga europei, nei confronti dei quali esse scontano scala. Nonostante molte imprese si siano orgaun inevitabile svantaggio di costo dovuto alle nizzate per allestire e fornire alla distribuzione differenti economie di scala in gioco. generalista e specializzata kit fotovoltaici di di- Tabella 1.20 I principali player nella distribuzione ed installazione Impresa Modello di business MW realizzati nel 2008 MW realizzati nel 2009 MW del portafoglio ordini 2010 Ricavi 2009 (mln E) Enel.si System integrator 29 45 n.d. n.d. Terni Energia* EPC contractor 10 27 40 45 Enerpoint* Distributore con attività di EPC 17 24 45 80 Enerray* EPC contractor 4 14 37 53 Sunerg Solar* System integrator 10 12 25 33 Enerqos* EPC contractor 7 12 35 60 Tecno Spot* Distributore 12,5 11,2 n.d. 39 Ecoware* EPC contractor 6 8 67 n.d. Enereco* System integrator 4 8 5 16 * I dati sono stati forniti dalle imprese www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 101 1. IL fotovoltaico 1.4.6 Area di Business Distribuzione e Installazione • il segmento di mercato servito principalmente dai distributori solari rimane quello residenziale, per il quale Come già rilevato nelle altre aree di essi realizzano oltre il 50% del probusiness, anche nella fase di distribuprio fatturato. È aumentato rispetto zione e installazione di impianti fotoal 2008 (in misura pari al 10-20%) voltaici si è assistito durante il 2009 il numero di installatori locali che ad un incremento del numero di opeacquistano moduli e altro materiale ratori attivi sul nostro mercato, che dai distributori solari. In aumento è sono stimabili nell’ordine di 350 66 , anche la quota del loro fatturato reail 75% dei quali è rappresentato da Amministratore delegato di un’impresa lizzato con grossisti di materiale eletimprese italiane. La tabella 1.20 distributrice di materiale fotovoltaico trico e termosanitario. Tutto questo a riporta le principali imprese attive in fronte di una domanda che nel merquest’area di business nel 2009, suddivise in base cato residenziale, è cresciuta meno rispetto alle al modello di business che esse adottano67 e ordiprevisioni di molti operatori; nate per il valore di potenza fotovoltaica degli im• la competizione sul mercato italiano è aumenpianti che hanno installato nel 2009. Dall’analisi tata per effetto dell’ingresso di player stranieri, della tabella si desume che le posizioni di forza in “ritirata” da alcuni mercati in deciso rallentarelative tra i principali player non sono variate mento quali la Spagna; sostanzialmente rispetto al 2008 (ad eccezione di • per fronteggiare la riduzione della marginalità Enerray e Terni Energia che hanno incrementato dovuta all’abbassamento del prezzo dei moduli notevolmente i MW realizzati nel 2009 rispeted al maggior grado di competizione sul mercato to all’anno precedente). Ad esclusione del caso interno, molti distributori solari hanno signifidi Tecno Spot, poi, tutti gli operatori riportati in cativamente incrementato la componente di tabella 1.20 hanno incrementato in modo siservizio associata alla loro offerta, investendo gnificativo la potenza installata rispetto al 2008. consistenti risorse in formazione e assistenza alla Interessante è il caso di Enerpoint, che ha fatturaprogettazione per gli installatori locali e i system to nel 2009 ben 80 mln € (con un aumento di circa integrator, oltre ad attività di promozione e maril 35% rispetto al 2008). keting per rafforzare la propria presenza commerciale. Questo spiega in parte la crescita media Si descrivono di seguito le principali evoluzioni degli addetti registrata nei distributori solari nel che hanno interessato le imprese con diversi mocorso del 2009, che si attesta su valori prossimi al delli di business attive in questa fase della filiera 30%; fotovoltaica. • con lo stesso obiettivo, alcuni distributori solari di maggiori dimensioni hanno cercato di metPer quanto riguarda i distributori solari, imprese tere a frutto le proprie competenze tecniche incon 15-20 dipendenti e un fatturato dell’ordine tegrandosi in una fase della filiera a maggior dei 25 mln €, le principali tendenze messe in luce valore aggiunto e marginalità come quella dall’analisi possono essere così riassunte: dell’EPC contracting, assumendo in alcuni casi “Ricordo che tre anni fa eravamo noi a cercare le banche per i nostri clienti e a spiegare loro cosa fosse un impianto fotovoltaico. Oggi il cliente arriva da noi accompagnato dalla banca, dal promotore finanziario che gli ha consigliato di realizzare l’impianto. Anche se poi alla fine la banca o l’ente che eroga il finanziamento guarda con maggiore attenzione alla solvibilità del cliente che alla producibilità dell’impianto” Box 1.17 Tecno Spot Tecno Spot nasce nel 1998 a Brunico (Bolzano) per iniziativa di Gert Gremes. L’azienda si sviluppa rapidamente, fino a diventare oggi uno dei più importanti distributori italiani nel mercato del fotovoltaico. L’attività di distribuzione ha per oggetto principalmente moduli fotovoltaici, inverter e sistemi di montaggio. L’organico dell’azienda è passato da 15 addetti nel 2008 a 21 addetti nel 2009, anche se la vendita di moduli ha subito un lieve calo, passando dai 12,5 MW del 2008 agli 11,2 MW del 2009. Uno dei principali accordi conclusi nel 2009 ha riguardato la fornitura di 9 MW di moduli fotovoltaici alla società greca HelioSphera, con consegna distribuita nel corso del biennio 2009-2010. 66 A queste si aggiungono i singoli operatori o le micro-imprese, stimabili in un numero pari a circa 5.000, che avendo maturato esperienze in settori “affini” quali l’idrotermosanitario, l’elettrico e l’edile, sono oggi in grado di installare un impianto ad uso residenziale. 67 Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 92-96. 102 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera la proprietà degli impianti e gestendo la vendita dell’energia, come è il caso di Enerpoint che ha generato in questo segmento circa il 35% del suo fatturato 2009; • come rilevato per altri operatori della filiera fotovoltaica italiana, i distributori solari di maggiori dimensioni si sono affacciati sui mercati stranieri nel corso del 2009, aprendo filiali in Paesi europei ed extraeuropei (come è accaduto ad Enerpoint che ha venduto oltre 3 MW tramite la sua filiale in Germania). Questo sempre nell’ottica di far fronte alla maggiore competizione sul mercato interno ed alla riduzione della domanda rispetto alle aspettative; • la redditività realizzata dai distributori solari nel corso del 2009 è stata influenzata negativamente anche dalle dinamiche verificatesi nei primi mesi dell’anno quando, a causa della brusca riduzione del prezzo dei moduli e del rallentamento del mercato dovuto al credit crunch, si sono trovati con un livello di giacenze e di invenduto particolarmente consistenti, cui sono seguite necessarie svalutazioni. Per quanto riguarda i system integrator (tra cui Enel.si, Enereco, Sunerg Solar, Ecoenergia, Solar Energy Italia, Eco Solare), anche nel 2009 essi si sono focalizzati principalmente sul segmento degli impianti industriali e commerciali, e hanno realizzato circa l’85% del loro fatturato tra segmento residenziale e industriale. Le principali dinamiche che hanno interessato questi operatori sono sintetizzabili come segue: • nonostante i volumi d’affari siano in media leggermente cresciuti rispetto al 2008, come rilevato nel paragrafo 1.4.2, i system integrator hanno subito un calo della marginalità industriale (anche nell’ordine del 10%), dovuto pre- valentemente alla maggiore consapevolezza del cliente finale del reale valore aggiunto apportato dall’installatore; • in risposta a questa contrazione generalizzata delle marginalità, diversi operatori hanno cercato di specializzarsi su nicchie di mercato in cui esistono maggiori opportunità per creare valore aggiunto per il cliente. Un esempio è Heliolux, che ha progressivamente focalizzato la sua offerta sugli impianti destinati all’uso in aziende agricole. Sempre in quest’ottica si interpreta il tentativo, da parte di alcuni tra i system integrator di maggiori dimensioni, come ad esempio PV Energy, di aggredire il segmento delle centrali, contraddistinto dall’opportunità di realizzare margini superiori. Per quanto riguarda gli EPC contractor, nel paragrafo 1.4.2. si è già osservato come siano le imprese che hanno subito in modo molto meno evidente rispetto ai player con altri modelli di business il calo generalizzato delle marginalità industriali. Questo nonostante il livello di competizione tra EPC contractor sia sensibilmente aumentato, così come il potere contrattuale messo in campo dai clienti cui essi si rivolgono. Si riassumono di seguito le principali dinamiche che hanno interessato questi operatori: • l’aumento della competizione interna in questa area di attività è aumentata nel corso del 2009 a causa dell’ingresso di molti system integrator di grandi dimensioni ed EPC contractor provenienti principalmente dalla Spagna (è questo il caso di Siliken e del Gruppo OPDE) e da altri Paesi europei (il gruppo Phoenix Solar, che ha acquisito una prima quota di Red 2002 nel 2006 e poi la restante nel 2008, diventando Phoenix Solar Italia, che ha obiettivi ambiziosi in Italia Box 1.18 Gli EPC contractor stranieri Il consorzio iberico di imprese OPDE (Promociòn de Plantas Solares) ha in progetto di realizzare in Piemonte ben 17 centrali fotovoltaiche dalla potenza complessiva di circa 70 MW. La prima fase, prevista per l’inizio del 2010, dovrebbe portare alla costruzione di 7 impianti con una potenza totale di circa 30 MW, per un investimento complessivo di circa 150 mln €. Da fine 2010, dovrebbe essere avviata la costruzione di altri 45 MW, per un investimento di 200 mln €. I moduli saranno forniti da REC e Trina Solar, e verranno in parte mon- tati in modo fisso, in parte su inseguitori prodotti da Mecasolar SL, impresa spagnola aderente al medesimo consorzio. Gli inverter saranno invece forniti da SMA Solar Technology. La società tedesca Trend Capital AG sta invece terminando la progettazione del parco solare da 8 MW, i cui lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2010. I moduli installati saranno forniti dalla cinese Shangai Chaori Solar Energy Science and Technology, con inverter di SMA Solar Technologies. Il costo complessivo dell’impianto si è attestato sui 4.500 €/ kW. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 103 1. IL fotovoltaico Box 1.19 Terni Energia Terni Energia, costituita nel settembre del 2005 e parte del gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed è particolarmente attiva nel fotovoltaico. La società è quotata sulla Borsa Italiana. Terni Energia opera come system integrator ed EPC contractor, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di potenza tipicamente superiore a 20 kW, destinati al segmento industriale e delle centrali. L’azienda lavora frequentemente con enti ed amministrazioni locali, come nel caso del parco fotovoltaico da 6 MW realizzato a Montalto di Castro. Terni Energia realizza anche impianti in joint venture con EDF Energies Nouvelles Italia (società del gruppo EDF, responsabile dello sviluppo e della gestione di impianti da energie rinnovabili), con la quale sono state costituite con una pipeline di progetti per oltre 50 MW, la maggior parte dei quali localizzati in Sicilia). Diversi di questi player stranieri, per sfruttare i generosi incentivi ancora in essere nel nostro Paese, hanno cominciato ad operare anche in qualità di Produttori Indipendenti di Energia (IPP), assumendo la proprietà e la gestione dei parchi fotovoltaici da essi stessi realizzati; • nel corso del 2009, una parte rilevante dei clienti degli EPC contractor attivi in Italia sono stati fondi di investimento stranieri, principalmente di origine anglosassone (si veda paragrafo 1.4.8). È cresciuto infatti il numero di EPC contractor che hanno stipulato contratti di finanziamento con i suddetti fondi che, di concerto con le banche, si impegnano a investire nella realizzazione di campi solari. Accordi di questa natura prevedono l’uscita da parte degli investitori dal progetto in un tempo medio dell’ordine dei 6 anni, in questo modo gli EPC contractor variano il loro modello di business diventando dei veri e propri Produttori Indipendenti di Energia (IPP), in alcuni casi creando anche delle società ad hoc, mantenendo all’interno del loro portafoglio anche le attività di gestione degli impianti e della vendita stessa di energia. Sono stati stipulati, ad esempio, da Enerqos con Foresight Group per la realizzazione di 4 impianti da 1 MW in Puglia, e da Terni Energia con Next Energy Capital per lo sviluppo di impianti per 15 MW entro il 2010; • nel corso del biennio 2008-2009, si è assistito ad un processo di fusioni ed aggregazioni industriali che ha visto come protagonisti gli EPC contractor attivi nel nostro Paese. In alcuni casi questi 104 in collaborazione le seguenti joint venture: SolarEnergy, EnergiaAlternativa, Energie e Fotosolare Settima. Al 31 dicembre 2009, la società ha costruito impianti per poco più di 40 MW di capacità installata complessiva, di cui 10 MW sono stati realizzati nel 2008 e 27 nel corso del 2009. Nel 2009 le vendite, pari a circa 45 mln €, sono state ripartite equamente tra contratti per conto terzi e contratti per conto delle joint venture a cui Terni Energia prende parte. Questa proporzione verrà mantenuta anche nel corso del 2010. Terni Energia ha dichiarato recentemente di essersi posta un duplice target per il periodo 2010 – 2012: da un lato, di installare 80 MW di capacità per conto delle joint venture, dall’altro, di consolidare la vendita di contratti EPC “chiavi in mano”, per un ammontare di 74 MW. player sono stati acquisiti da gruppi di dimensioni maggiori e quotati come nel caso dell’ingresso di Ecoware nel Gruppo Kerself (composto da altre 4 imprese – DEA, Helios Technology, Nuova Thermosolar e Saem – che occupano tutte le fasi della filiera fotovoltaica e solare termica italiana). In altri casi hanno promosso la costituzione di joint venture (come quella tra Terni Energia ed EDF Energies Nouvelles Italia) o sono nati per il volere di grandi gruppi industriali (Enerray che è nata in seguito ad una strategia di differenziazione che include anche la produzione di biomasse e biogas del gruppo industriale Maccaferri). Queste scelte strategiche si spiegano con l’esigenza, da parte degli EPC contractor, di recuperare maggiori capitali per finanziare i propri investimenti, aumentare la scala delle proprie attività e incrementare le competenze detenute in house, così da attirare clienti privati più numerosi e con progetti di espansione più ambiziosi. In modo analogo, si registrano acquisizioni di imprese di dimensioni minori da parte di EPC contractor con l’obiettivo di assicurare una maggiore presenza locale sul territorio (come accaduto nel caso dell’acquisizione da parte di Enerqos della piccola società toscana Eq-solar specializzata nelle attività di installazione) o il presidio di competenze complementari alla progettazione e realizzazione dell’impianto, quali quelle relative allo sviluppo di sistemi per l’automazione, controllo e supervisione degli impianti (è il caso questo dell’acquisizione da parte della stessa Enerqos di Samares, società attiva nella attività di automazione e controllo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e ESP, specializzata nello sviluppo di tecnologie www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera 2008 e il 2009. Recentemente, si registra una magausiliarie per il fotovoltaico, quali strutture per il giore attenzione rivolta ai Paesi del Medio Oriente, montaggio dei moduli e inseguitori biassiali); che rappresentano un interessante bacino per la re• se nel corso del 2008 gli EPC contractor attivi in alizzazione di centrali di grandi dimensioni; Italia servivano, con proporzioni pressoché ana• esiste anche qualche caso di impresa che ha avviato loghe, i segmenti di mercato dei grandi impianti la propria attività come EPC contractor ed è intenta ad uso industriale e delle centrali fotovoltaiche, a risalire la filiera verso monte nella produzione nel 2009 queste ultime sono arrivate a pesare di celle e moduli. Uno fra tutti è Energie Future per circa l’80% del fatturato di questi operatori. che ha aperto uno stabilimento di produzione di Questo si spiega con la ricerca di opportunità di moduli (Italia Solare Industrie) in Provincia di business in grado di assicurare redditività supeFirenze riconvertendo un vecchio stabilimento delriori, con lo sbilanciamento del portafoglio clienti la Electrolux. Inoltre, la stessa Energie Future ha in degli EPC contractor verso i grandi fondi di private cantiere la creazione di un’impresa che dal 2011 sarà equity stranieri, che sono ovviamente interessati a attiva nella produzione di wafer e celle in Provincia queste tipologie di impianti come opportunità di di Caserta; investimento dei propri capitali, e con la crescita • nel complesso, il volume di attività e il fatturato delle dimensioni di questo segmento di mercato in degli EPC contractor attivi in Italia, Italia nel corso del 2009, che ha visto per effetto delle scelte strategiche ilcosì incrementare decisamente la sua “Ci sono ancora immensi spazi che possono essere utilizzati lustrate in precedenza, è aumentato attrattività; per l’installazione di impianti anche in modo piuttosto sensibile • si conferma nel 2009 la tendenza, anfotovoltaici, sia all’estero (penso ad esempio all’Algeria), rispetto al 2008 (in media del 45%). ticipata nel Solar Energy Report 2008, In Sicilia, ad esempio, Conseguentemente, anche il numero verso una maggiore presenza degli cheviinè Italia. sicuramente un grande di dipendenti degli EPC contractor è EPC contractor italiani sulla scena potenziale inespresso” cresciuto in modo non irrilevante (in internazionale, mossi in questo dalle Amministratore delegato EPC contractor di un media del 50%), con Enerqos che ha prospettive ancora incerte sullo sceampliato il proprio organico da 50 a 104 nario normativo futuro nel nostro dipendenti nell’arco di un anno. Paese e dall’aumento della competizione sul mercato interno. Francia Grecia, USA e Paesi dell’Est sono le principali aree in cui gli operatori italiani 1.4.7 Area di Business Componenti hanno investito, aprendo proprie filiali. Saem, ape Tecnologie partenente al gruppo Kerself, a fine 2009 ha annunciato l’apertura di una filiale in Bulgaria (il cui nome Il 2009 è stato un anno particolarmente “ricco” per sarà Kersaem Ltd.), mentre Enerqos ha aperto due le imprese che si occupano dello sviluppo e installasocietà una a Parigi e l’altra ad Atene a cavallo tra il Box 1.20 Ecoware Ecoware, parte del gruppo emiliano Kerself, è un EPC contractor che si occupa in modo integrato delle attività di progettazione, realizzazione e installazione di parchi fotovoltaici bancabili con tecnologia fissa o a inseguimento biassiale. Fondata nel 2003 a Padova, Ecoware ha inaugurato il suo primo parco ad alto rendimento dopo un anno di attività operativa, attraendo investitori nazionali e internazionali. Acquisita nel 2008 da Kerself, la società padovana ha dato vita a Ecoscout S.r.l., azienda finalizzata allo scouting ed allo sviluppo di terreni adatti alla creazione di parchi solari in Italia. Ecoware si è specializzata nella realizzazione di grandi impianti solari, un business molto attrattivo per grandi investitori privati e fondi di investimento, in particolare stranieri (inglesi, australiani, israeliani, tedeschi, belgi, cinesi), a cui offre soluzioni standard da 1 MW di capacità installata, che vengono realizzati spesso nel Sud Italia. Le installazioni sono passate da 5 MW a 8 MW nel corso del 2009, con ulteriori accordi siglati per 67 MW da realizzare a breve. In particolare, la società ha stipulato un contratto da 130 mln € con il fondo di investimento cipriota Origis, che prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico chiavi in mano da 25 MW, a cui faranno seguito altri due impianti, rispettivamente da 25 MW e da 50 MW, da realizzare entro il 2011 nel Sud Italia. Il 2009 ha visto anche la firma in dicembre di un accordo tra Ecoware e Amplio Solar per la costruzione di 3 impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno nel comune di Foggia, in Puglia. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 105 1. IL fotovoltaico Box 1.21 Baccini Fondata nel 1967 in Provincia di Treviso per iniziativa di Gisulfo Baccini, l’omonima società è attualmente una delle imprese italiane più note nel campo della microelettronica e produce macchine e linee per lavorazioni di processo. Già dagli anni ’80 Baccini è entrata nel mercato del solare fotovoltaico, affermandosi nel tempo come leader nella produzione di sistemi automatizzati di serigrafia/metallizzazione e collaudo per la produzione di celle fotovoltaiche in silicio cristallino. Attualmente l’azienda controlla l’85% di questo mercato a livello mondiale con un fatturato che nel 2008 ha toccato i 230 mln €, raddoppiando il valore raggiunto nell’anno precedente. La società ha sedi commerciali in Italia, Germania e Stati Uniti ed esporta i propri prodotti negli Stati Uniti, Europa, Giappone, Cina e Corea. A partire dal 31 gennaio 2008, Baccini è diventata una controllata del colosso statunitense Applied Materials, in seguito all’accordo raggiunto tra le due parti per una contropartita di 225 mln €. Applied Materials è il leader mondiale nelle soluzioni di Nanomanufacturing Technology, con servizi e software per la fabbricazione di chip semiconduttori, display a schermo piatto, celle solari fotovoltaiche, elettronica flessibile. In seguito a questa acquisizione, la società trevigiana opera quindi come una filiale di Applied Materials Italia. zione di impianti, sistemi e tecnologie di processo per le fasi “a monte” della filiera: la produzione di silicio e di wafer e la realizzazione di celle e moduli. L’affermazione, che può sembrare paradossale se si pensa alla particolare situazione di crisi in cui ha versato l’economia mondiale e almeno parzialmente anche il fotovoltaico, è giustificata dalle particolarità di questa area di business che – considerata la sua distanza dal mercato finale – ne subisce con ritardo l’effetto delle variazioni, per quanto repentine esse siano. La crescita repentina del mercato del fotovoltaico nel corso del 2008 ha spinto, come sottolineato nei paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, le imprese dedite alla preparazione della “materia prima” (silicio e wafer) ed i produttori di celle e moduli ad incrementare nel corso del 2008 e durante tutto il 2009 la propria capacità produttiva. Conseguenza immediata è stato un crescente numero di ordinativi per i nuovi impianti che ha interessato in primis i grandi player internazionali, come la tedesca Centrotherm Photovolatics, leader mondiale degli impianti “chiavi in mano” per la produzione di celle, che ha visto il proprio fatturato crescere di circa il 58% nel corso del 2009 arrivando a quota 500 mln € 68; oppure il gruppo canadese ATS Automation, che ha incrementato il fatturato derivante dalla vendita di impianti per la produzione di celle e moduli del 37% per un ammontare di circa 200 mln € 69. Le imprese italiane (si veda tabella 1.21) hanno cercato di cogliere l’opportunità che si è presentata loro: • da un lato, nello sfruttare i fenomeni di crescita del mercato interno, avendo anche il coraggio di effettuare significativi investimenti in Ricerca e Sviluppo. E’ il caso, ad esempio, della Baccini – impresa trevigiana che opera sin dal 1967 nella microelettronica e che nel 2007 è entrata a far parte del gruppo americano Applied Materials – che nel 2009 ha investito in ricerca circa 210 mln €, in crescita di oltre il 50% rispetto al 2008, “scommettendo” larga parte del suo fatturato sulla costruzione di potenzialità di business future; • dall’altro lato, nell’allargare i propri orizzonti cercando di aggredire i mercati emergenti, dove è ancora possibile – almeno teoricamente – costruirsi posizioni “di peso” in questa area di business. E’ il caso ad esempio della Ecoprogetti, che ha conquistato nel corso del 2009 ordini per la costruzione di 4 linee produttive di moduli e pannelli chiavi in mano in India con la possibilità di allargare la fornitura ad ulteriori 4 linee produttive, in corso di trattativa, oppure ancora della 2BG, entrata in questo settore nel 2002, e costituitasi un portafoglio di ordini da più di 6 mln € in pochi mesi nel corso di quest’anno, per circa l’80% provenienti dall’estero; • oppure ancora, come peraltro evidenziato nel Solar Energy Report 2008, andando alla ricerca di opportunità da sfruttare nelle “nuove” tecnologie (si vedaparagrafo 1.1.2). La Kenosistec, grazie allo sviluppo di una tecnologia che sfrutta il vuoto per produrre celle a film sottile, ha fatturato 10 mln € nel corso del 2009, aumentando in modo significativo il risultato dell’anno precedente (1,8 mln €). 68 69 Stima fatta prendendo come riferimento il dato di settembre 2009. Il dato fa riferimento al bilancio 2009 che si è chiuso il 31 Marzo. 106 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera sperimentato condizioni di mercato meno favorevoli di quelle attese, a causa del più volte citato Il 2009 è stato un anno positivo per le imprese aprallentamento nella crescita (pur sempre positiva partenenti a questa area di business e nonostante a onor del vero) delle installazioni finali e sono (almeno stando alle opinioni degli intervistati) state quindi costrette ad una riduzione dei prezper il 2010 si assisterà ad una contrazione degli zi dell’ordine del 5% per gli impianti di piccola ordinativi di nuovi impianti soprattutto per il taglia e del 10% per i grandi impianti, dall’altro mercato europeo, alcune imprese appartenenti lato è altrettanto vero che il 2009 ha segnato un a quest’area di business potrebbero focalizzarsi deciso “cambio di passo” strategico da parte dei sullo sviluppo di nuovi impianti volti ad increprincipali operatori. mentare l’efficienza delle celle. Inoltre, le preocLe principali tendenze in atto per i cupazioni delle imprese italiane in produttori di inverter possono essere questa fase della filiera sono almeno “L’aumento della capacità in parte mitigate dalle aspettative di produttiva di celle e moduli, tanto in così sintetizzate: crescita dei mercati asiatici e degli Italia quanto all’estero, rallenterà con ogni probabilità durante il USA, rispetto ai quali tuttavia è ne- prossimo anno. Stiamo guardando • a fronte di una “saturazione” facessario incrementare gli sforzi per alle nuove imprese che nascono in ticosamente raggiunta dell’efficienza India e soprattutto in Cina come un di trasformazione (come visto nel garantirsi efficaci canali di accesso e importante mercato di sbocco per i paragrafo 1.1.4, nel corso del 2009 costruire network di relazioni con gli nostri prodotti” attori locali (evidentemente destina- Amministratore delegato di un’impresa i valori medi di riferimento sono produttrice di impianti per la passati dal 95% al 97% con punte di ti ad avere un peso significativo nella fabbricazione di celle e moduli eccellenza che arrivano a superare il “domanda” di nuovi impianti). 98%) è cambiata la “base” della competizione, che si è spostata dalla performance Discorso assai differente è quello che invece ripura alla valutazione dell’offerta in senso lato guarda – sempre nell’ambito dell’area di business dei produttori. Questa trasformazione, che è “Componenti e Tecnologie” – i produttori di intipica delle tecnologie che raggiungono un cerverter, ovvero del componente del sistema fotovolto grado di maturità, ha reso sempre più riletaico che consente la trasformazione della corrente vanti caratteristiche quali: (i) l’affidabilità del continua generata dai moduli fotovoltaici in corprodotto, che si caratterizza non solo per un rente alternata che può essere immessa nella rete numero sempre crescente di operatori disposto elettrica e collegata alle utenze. ad offrire una garanzia per un periodo da 2 a 5 Se è vero, da un lato, che nel corso del 2009 ananni a copertura degli eventuali danni derivanche le imprese produttrici di inverter hanno Tabella 1.21 Le principali imprese italiane attive nell’area di business Componenti e Tecnologie Impresa Anno Costituzione Ricavi 2008 (mln €) Attivita' Sede Baccini 1967 n.d. Opera nella microelettronica e produce macchine e tecnologia per prodotti solari a film sottile e in silicio Treviso P.Energy 2005 17,7 Progetta e realizza impianti di produzione di pannelli solari Fontaniva (PD) 2BG 2002 8,5 Progetta e realizza macchine per la produzione di pannelli fotovoltaici San Martino di Lupari (PD) Eco.Progetti 1998 7,9 Progetta e realizza impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Padova 2,9 Commercia all’ingrosso macchinari e attrezzature per la fabbricazione di celle fotovoltaiche Monza (MB) Tecnofimes 1997 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 107 1. IL fotovoltaico prodotti con la creazione di nuove ti da problemi di funzionamento “Ricordiamoci sempre che una del sistema (con una penale media centrale solare ha una vita media serie e nuovi modelli ogni anno (le da versare al titolare dell’impianto di 25 anni. Quindi sto scegliendo aziende leader mondiali riescono a oggi un partner che dovrà produrre anche 4 nuovi modelli per di 1,2 €/kW per ogni giornata di garantirmi un determinato IRR Paese all’anno); mancata produzione), ma anche per 25 anni” • il supporto al cliente ha assunto dal bagaglio di esperienza che le Marketing Manager di un’impresa produttrice di inverter e – secondo gli intervistati – è destiimprese più mature appartenenti a nato ad assumere nel futuro un ruoquest’area di business hanno sperilo sempre più rilevante. I principali produttori mentato sul campo e da una base di installato hanno aperto nel corso del 2009 diversi centri tale da costruire un background storico di prodi assistenza sul territorio italiano offrendo supblematiche e casistiche che permettano di risolporto agli stessi system integrator o agli studi di vere i problemi emersi e di trovare nuove soluingegneria attivi nel settore nella fase di progetzioni; e (ii) la compatibilità plug & play con il tazione e configurazione dell’impianto fotovolmaggior numero possibile di moduli diversi, taico. Alcune imprese quali SMA, PowerOne ed per massimizzare la flessibilità progettuale di Elettronica Santerno si sono spinte oltre con la chi realizza l’impianto; costituzione di veri e propri “centri • viene posta una attenzione magdi formazione” per i tecnici, i progetgiore alla ricerca e sviluppo per “Il servizio al cliente risulta tisti e gli installatori, con l’obiettivo cercare fonti di differenziazione fondamentale in quanto le grandi di diffondere la cultura progettuale competitiva che derivino dalla centrali vanno manutenute. È inoltre fondamentale poter offrire cura estrema della componenti- consulenza gratuita agli installatori e sensibilizzarli all’adozione di componenti sempre più tecnologicamente stica e dell’architettura del sisteche si trovano sul plant e che ma – come è il caso del progetto possono trovare delle difficoltà di avanzati. tipo tecnico. In questo modo essi portato avanti dai ricercatori del risparmierebbero molto tempo e si Fraunhofer Institute di Friburgo permetterebbe al cliente di iniziare Nonostante le modifiche significatia produrre energia molto più ve al modello di business dei produtper la messa a punto di una archirapidamente” tori di inverter, le posizioni relative tettura circuitale che riduca le perMarketing Manager di un’impresa dei principali produttori a livello dite di energia dovute alla generaproduttrice di inverter mondiale (e italiano) non hanno suzione di correnti interne – oppure bito variazioni di rilievo rispetto a ancora da modifiche ancor più siquanto rilevato nel Solar Energy Report 2008. gnificative al “modo d’uso” del sistema, come La tabella 1.22 riporta l’elenco ed i principaavverrebbe in conseguenza dell’adozione di li dati dei produttori di inverter che operano sul soluzioni tipo il “microinverter” (si veda mercato italiano. box 1.22) e dallo sviluppo continuo di nuovi Box 1.22 I microinverter Il primo microinverter è del 1994 e si deve all’ingegno di Henk Oldenkamp che progettò un dispositivo da aggiungere a ciascun modulo fotovoltaico per renderlo in grado di erogare “direttamente” corrente alternata. Il microinverter semplificava il montaggio degli impianti poiché l’installatore poteva collegare l’uscita in corrente alternata dei moduli direttamente alla rete elettrica domestica. Le vendite di questo tipo di prodotti ebbero un certo sviluppo a metà degli anni 90, raggiungendo circa 50.000 unità, e alcune imprese europee (principalmente tedesche) si cimentarono nello sviluppo di questi dispositivi, incontrando però notevoli difficoltà tecniche legate all’affidabilità del prodotto. In realtà, la crescita costante delle dimensioni e degli impianti richiesti dal mercato non fu controbilanciata dalla domanda parallela di microinverter e a uscirne vincenti furono così gli inverter di stringa, più 108 flessibili e relativamente più convenienti, almeno in rapporto alla potenza. Il concept di base dei microinverter si è tuttavia mantenuto ed una decina di imprese (fra le quali l’inglese Enecsys Ltd, le americane Solarbridge Technologies Inc e Petra Solar Inc) sono state fondate negli ultimi cinque anni con l’obiettivo di portare sul mercato una nuova generazione di microinverter. L’americana Enphase Energy ha sviluppato nel corso degli ultimi quattro anni un microinverter, che commercializza da settembre 2009, adatto a moduli da 190 watt di potenza in uscita, con un’efficienza del 95% e una garanzia di 15 anni. Anche la tedesca SMA, maggior produttore mondiale di inverter, a settembre 2009 ha acquisito dallo stesso Oldenkamp un nuovo schema costruttivo con l’obiettivo di mettere a punto un modello di microinverter adatto al mercato europeo. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera Tabella 1.22 I produttori di inverter attivi sul mercato italiano Impresa Nazione Numero prodotti nella gamma Settore di Provenienza ABB Italia Svizzera 11 Tecnologie per la generazione di energia Aros Italia 30 Elettrotecnica industriale Bonfiglioli Italia 11 Automazione industriale Conergy Italia Germania 13 Celle e moduli fotovoltaici Danfoss Solar Inverter Danimarca 7 Elettrotecnica e automazione industriale Elettronica Santerno Italia 42 Automazione industriale Fronius Austria 22 Elettrotecnica industriale Ingeteam Spagna 31 Fornitura di impianti elettrici e sistemi di controllo Italcoel Italia 6 Elettrotecnica e automazione industriale Mitsubishi Electric Giappone 4 Automazione industriale e fotovoltaico PowerOne Stati Uniti 17 Elettrotecnica e automazione industriale Riello UPS Italia 13 Elettrotecnica industriale SIAC Italia 19 Elettrotecnica industriale Siemens Germania 20 Elettrotecnica e automazione industriale SMA Solar Technology Italia Germania 60 Focalizzata nel fotovoltaico Leader a livello mondiale è la tedesca SMA, che controlla da sola circa il 38% della quota di mercato globale con una capacità produttiva di 4 GW di potenza all’anno, inseguita da altri operatori specializzati nella produzione di inverter come l’austriaca Fronius, l’americana PowerOne, la spagnola Ingeteam e il colosso dell’impiantistica tedesca Siemens. Le filiali italiane di molte di queste imprese hanno visto crescere significativamente la loro quota di mercato in Italia anche grazie agli investimenti sostenuti nel corso del 2009, che ad esempio hanno portato ad un aumento del numero di addetti impiegati mediamente pari al 60% nel corso dell’ultimo anno. Anche il fatturato delle imprese estere con filiale in Italia è cresciuto a ritmi del 40%, con alcune realtà che hanno sperimentato crescite vertiginose, come SMA che dai circa 2 mln € del 2008 è passata ad un fatturato dell’ordine dei 35 mln € nel 2009. Accanto a questi operatori, che operano a livello globale, sono in crescita anche le imprese italiane – soprattutto per gli impianti di piccola taglia dove assume un ruolo chiave la presenza sul territorio e dove è quindi possibile creare posizioni di forza a livello locale – che controllano circa il 50% del mercato italiano. In genere gli inverter di piccola taglia, utilizzati per le installazioni nei settori residenziale e commerciale, sono infatti venduti o utilizzando il canale “tradizionale” dei distributori di materiale elettrico oppure attraverso la vendita diretta tramite agenzie proprie. Negli inverter di grande taglia, destinati ad impianti industriali e centrali fotovoltaiche, si instaura invece un rapporto diretto fra il produttore di inverter e l’EPC contractor che realizza l’impianto. In questo segmento, si distingue in particolare Elettronica Santerno, pioniera del settore in Italia, che, nonostante la competizione sempre più agguerrita, ha comunque mantenuto una posizione di primo piano sfruttando un network di relazioni ormai consolidate con gli operatori italiani. Sembra tuttavia di poter dire che la classifica dei principali produttori di inverter sia destinata a cambiare nel corso del 2010 visto che hanno fatto il loro ingresso nell’arena competitiva nuovi operatori di grandi dimensioni provenienti dal settore elettrico – quali ad esempio ABB, Schneider www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 109 1. IL fotovoltaico Box 1.23 Elettronica Santerno Fondata oltre 40 anni fa, Elettronica Santerno è dal 2006 parte del Gruppo Carraro (uno dei principali operatori a livello mondiale nella trasmissione di potenza meccanica) quotato alla borsa di Milano. La società ha la propria sede principale presso Imola (Bologna), mentre la sede amministrativa si trova a Padova ed uffici commerciali a Milano e Roma. Elettronica Santerno ha inoltre filiali all’estero, più precisamente in Brasile e in Russia da 10 anni e, in tempi recenti, in Spagna e negli USA. Ha inoltre uffici commerciali a Monaco di Baviera, a Pune in India e a Qingdao in Cina. L’azienda progetta e realizza prodotti impiegati nei diversi settori dell’elettronica di potenza, della conversione statica delle energie rinnovabili (fotovoltaico ed eolico), dei sistemi di supervisione, produzione e risparmio energetico. Per quanto riguarda il fotovoltaico, Elettronica Santerno ha istallato i propri inverter solari nel 1994 nella centrale fotovoltaica di Serre (che è stata la più grande al mondo sino al 1998) e da allora è la principale impresa italiana nel campo delle tecnologie inverter per la conversione dell’energia. La società progetta interamente inverter solari ad alto contenuto tecnologico per impiego su impianti di piccola, media e grossa potenza, mentre la produzione è in gran parte esternalizzata ad aziende italiane. (che ha acquisito la Xantes) e Control Tecnic Emerson – e che anche Siemens e Mitsubishi, già attivi da qualche anno nella produzione di inverter, si stanno preparando a rafforzare ulteriormente la loro presenza nel settore. una riduzione del rapporto di leva (che è passato da un valore medio nel 2008 del 90%, a circa il 75% nel 2009) e con una crescita degli spread da 120130 punti base ad un minimo di 250 punti base, portando il tasso di interesse effettivo ad un valore compreso tra il 6 e il 6,5% annuo nel caso di tasso fisso e a 3,5-4% nel caso di tasso variabile. Più che a causa di un minore livello di redditività complessivo degli investimenti in impianti fotovoltaici o di un maggior rischio percepito dal soggetto finanziatore, questo peggioramento delle condizioni per la concessione del debito si spiega con una minore disponibilità complessiva di capitali da parte delle banche e con il peggioramento dei fondamentali di bilancio delle imprese investitrici, dovuto alla crisi economica generalizzata. Se durante i primi mesi del 2009 anche per gli impianti residenziali ed industriali di taglia medio-piccola si è assistito ad un peggioramento delle condizioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda la percentuale di capitale di debito concesso rispetto all’investimento totale, a partire dalla metà del 2009 è aumentato il numero di system integrator che hanno stipulato accordi con istituti di credito per concedere finanziamenti anche nell’ordine del 100% del capitale investito. Nel complesso, l’offerta di prodotti per il finanziamento di impianti fotovoltaici continua ad essere molto ampia, ed è aumentato anche il numero di istituti di credito che hanno siglato l’accordo quadro con il GSE per poter usufruire del meccanismo della cessione del credito (all’inizio del 2010, il numero di banche iscritte è salito di 80 unità rispetto all’inizio del 2009, arrivando a 427). Oltre al numero di istituti di credito che hanno siglato l’accordo, sono incrementate le risorse interne (in termini di addetti o vere e proprie divisioni) focalizzate sulle energie 1.4.8 Area di Business Finanziamento e Assicurazione Come già rilevato nel Solar Energy Report 2008, la possibilità di finanziare l’investimento in un impianto fotovoltaico offerta dagli istituti di credito è stata una condizione fondamentale per assicurare lo sviluppo del mercato italiano negli anni 20072008. A partire dalla fine del 2008, e per la prima metà del 2009, i finanziamenti concessi dalle banche alla realizzazione di impianti fotovoltaici si sono tuttavia ridotti sensibilmente, per effetto del credit crunch che ha d’altronde colpito duramente i più diversi settori industriali. Ciò si è tradotto nel forte rallentamento delle installazioni osservato durante i primi mesi dell’anno 2009, e ha interessato prevalentemente gli impianti di grossa taglia ad uso industriale, di potenza superiore ai 100 kW, e le centrali fotovoltaiche. Da un lato le banche hanno richiesto, per questi impianti, garanzie sempre più consistenti a tutela del debito, ammettendo al finanziamento solo impianti per cui esistessero contratti “chiusi” sul terreno (compravendita o cessione del diritto di superficie), che fossero autorizzati in VIA e con garanzia di completamento dei lavori entro la fine del 2010, per evitare il rischio di entrata in vigore delle tariffe ridotte che saranno definite contestualmente alla revisione del Nuovo Conto Energia. Allo stesso tempo, le condizioni di finanziamento sono andate peggiorando, con 110 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera contractor di grandi dimensioni che dispongono di rinnovabili ed in particolare sul settore fotovoltaiuna presenza già radicata sul territorio. Caso embleco (si stima un aumento di risorse umane dedicato matico in questo senso è quello di Foresight Group, del 15%) anche e soprattutto nelle banche di minouna delle principali società di gestione di fondi di ri dimensioni. L’analisi ha mostrato che nel 2009 investimento inglese, specializzata in energie rinnola durata media del finanziamento è andata da un vabili, che ha firmato un accordo con Enerqos per minimo di 5 anni ad un massimo di 15-20 anni, la realizzazione di 4 campi fotovoltaici in funzione della tipologia di soggetto “Chi fornisce i capitali per di potenza complessiva pari a 4 MW investitore, così come l’importo comrealizzare l’impianto ha oggi plessivo, che per il privato cittadino è molto potere, dato che la finanza situati in Puglia. Anche NextEnergy in questo momento è un bene Capital, merchant bank londinese spearrivato ad un massimo di 75.000 €, lo sviluppo del mercato cializzata in energie rinnovabili, ha redi 500.000 € per le imprese di picco- critico per fotovoltaico” centemente chiuso un accordo strategile dimensioni e 5 – 6 mln € nel caso Amministratore delegato di un’impresa co con Terni Energia per lo sviluppo di di aziende medio-grandi (concessi produttrice di celle e moduli 15 MW di potenza fotovoltaica entro il perlopiù dalle banche di maggiori di2010. Kerself, gruppo italiano attivo in mensioni che operano a livello naziodiversi stadi della filiera fotovoltaica, ha siglato un nale). L’indagine mostra anche come il leasing, noaccordo con un fondo di diritto lussemburghese parnostante comporti delle difficoltà dovute alla stima tecipato da due importanti investitori istituzionali del valore futuro dell’impianto come rilevato nel svizzeri, che ha portato alla costituzione di Fortesa, Solar Energy Report 200870, sia stato utilizzato in misura crescente nel corso del 2009. Esistono ansocietà il cui obiettivo è di sviluppare, installare e cora tuttavia degli elementi di incertezza, che sono gestire circa 100 MW di potenza fotovoltaica entro attualmente al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, in la fine del 2010. Il capitale di Fortesa è di proprietà merito all’iscrizione a bilancio degli impianti ogdel fondo estero per l’85%, mentre il restante 15% getto di leasing (attualmente, è invalso l’uso di iscrisarà controllato da Kerself in qualità di azionista di verli come “beni strumentali” nel caso minoranza. Il fondo metterà a dispoin cui la componente di autoconsumo “Io faccio questa divisione un po’ sizione l’equity necessario per la reasia prevalente, e nella voce “immobi- categorica fra il fondo speculativo e lizzazione degli impianti fotovoltaici, il gestore del patrimonio. Il secondo li, impianti a macchinari” nel caso di ha dei soldi che gli vengono dati attraverso un aumento di capitale per impianti per la vendita dell’energia in da persone che conosce e quindi un controvalore pari a circa 70 mln €. punta a gestirli al meglio. Il fondo rete). Dal canto suo, Kerself si occuperà delle speculativo ha un atteggiamento più da “Madoff del fotovoltaico”, attività di EPC contracting per i procompra centrali a destra e a È inoltre da rilevare come nel corso getti che saranno sviluppati. Inoltre, sinistra per un totale di decine degli ultimi due anni sia aumentato non mancano casi di fondi di investidi MW, con l’unico interesse di massimizzare il ritorno” in modo sensibile il numero di invemento esteri che preparano il terreno stitori privati con interessi e presenza per lo sviluppo di impianti di enormi Marketing Manager di un EPC contractor sul mercato italiano. In questo senso, dimensioni (per la tecnologia fotovolè possibile distinguere tra soggetti che taica) nel Centro-Sud Italia. Un eseminvestono nello sviluppo di progetti per impianti e pio è dato dal fondo tedesco Copex, specializzato in centrali fotovoltaiche (ad esempio società di gestione investimenti nelle fonti di energia rinnovabili, che di fondi di investimento, che apportano capitale di in prima battuta ha inviato una delegazione per la rischio anche attraverso la forma del project finanvalutazione del territorio di Ascoli Piceno con l’incing) ed operatori (principalmente fondi di private tenzione di realizzare quello che potrebbe diventare equity e venture capital) che investono nel capitale uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Europa, di rischio di imprese attive nella filiera fotovoltaica con un investimento da 620 mln € per la realizza(principalmente produttori di tecnologia ed EPC zione di un complesso fotovoltaico da 50 MW e una contractor). La prima categoria di player comprende serie di impianti eolici. società per la maggior parte straniere, che hanno una È interessante rilevare che, tra i fondi di private equiprospettiva di breve-medio termine e un orizzonte ty e venture capital che hanno realizzato importanti di investimento compreso tra i 5 e i 7 anni. Molto investimenti negli ultimi anni, si sono ritagliati un spesso la strategia che essi adottano per entrare nel ruolo anche alcuni operatori italiani. Un esempio mercato italiano consiste nel siglare accordi con EPC emblematico in questo senso è rappresentato da 70 Cfr. Solar Energy Report 2008, p. 103. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 111 1. IL fotovoltaico Tabella 1.23 Misure di sicurezza per impianti fotovoltaici installati ad altezza inferiore a 5 metri Misure di sicurezza per impianti fotovoltaici • Sistemi di protezione antifurto o Recinzione perimetrale o Sistemi di antintrusione perimetrale • Sicurezze fisiche dell’impianto fotovoltaico oBulloni per l’ancoraggio dei pannelli ai sostegni saldati o a testa spaccata o Incollaggio dei pannelli ai sostegni o Chip per riconoscimento del pannello dall’inverter o Sistema antifurto di localizzazione GPS • Sorveglianza o Ronde o Sistema di videosorveglianza • Antifurto o Impianto di allarme antifurto o Collegamento con istituti di sorveglianza (polizia, istituti privati) Atmos (fondo di Fondamenta Sgr gestita da State Street Global Investment), che è stato uno dei primi veicoli d’investimento italiani di private equity, con circa 60 mln € di raccolta e interamente dedicato agli investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica. Tra le società italiane in cui il fondo ha investito in questi ultimi anni ci sono l’EPC contractor Solar Energy Italia, Omniasolar Italia, produttore di celle in silicio cristallino ed Energia & Servizi, che opera attraverso diverse società nella produzione elettrica da fonti rinnovabili con un focus particolare nel settore eolico e solo una piccola parte di potenza fotovoltaica installata. Da citare è il fondo italiano di private equity Atlantis Capital Special Situations che a fine 2008 ha rilevato, per una contropartita di 10,5 mln €, Ecostream Italy, società attiva nella realizzazione di impianti fotovoltaici (oltre i 500 kW), poi ribattezzata Me-Making Energy. Altro investitore italiano è il Fondo PPP Italia, fondo infrastrutturale gestito da Fondaco sgr che si avvale della consulenza di Equiter (appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo), che ha effettuato, nel corso del 2009 investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Sud Italia per una potenza complessiva pari a 5 MW. Il costo complessivo degli impianti si aggira sui 22 mln €. Non si osservano infine particolari evoluzioni per quanto concerne l’assicurazione degli impianti fotovoltaici rispetto al 2008. Il business rimane ancora di limitate dimensioni, con un giro d’affari annuo, in termini di premi assicurativi complessivi nell’ordine di 6 mln €. Le principali compagnie che dispongono di un prodotto assicurativo mirato per impianti fotovoltaici sono Zurich (con la polizza Solar Power All Risks), Navale Assicurazioni (con la 112 polizza Protezione Fotovoltaici), Toro Assicurazioni (con Toro Sistema Solare), Assicurazioni Generali e Royal Ace. Nel 2009 i premi assicurativi medi sono stati pari a 12.000 €/MW per le centrali di taglia superiore ad 1 MW, valore che aumenta fino al 50% per impianti di potenza inferiore ai 200 kW. In funzione della tipologia di impianto e del contesto in cui esso viene installato, variano sensibilmente le condizioni relative a franchigie e limiti. Il furto dei moduli si conferma un problema estremamente rilevante, che rappresenta la percentuale di gran lunga più significativa dei sinistri registrati. Mentre qualche anno fa i furti riguardavano solo impianti di grandi dimensioni dai quali era possibile trarre un ricavo proficuo, dal 2008 e per tutto il 2009 si sono allargati anche verso impianti di minori dimensioni (a partire anche da 1520 kW). Nonostante sia molto complesso valutare l’entità dei furti che interessano gli impianti fotovoltaici, alcune stime parlano di 50 mln € di moduli oggetto di furto in Italia nel 2008 (a fronte di un valore di 35 mln € nel 2007). Una valutazione condotta dall’ENEA colloca il valore dei furti di moduli fotovoltaici a livello mondiale nell’intorno del 5-7% del venduto. Anche in risposta all’aggravarsi di questo fenomeno, la tendenza generale rilevata tra gli istituti assicurativi oggetto dell’indagine è quella di richiedere all’investitore, come requisito per l’assicurabilità dell’impianto, il rispetto di misure di sicurezza sempre più stringenti. Gli operatori lamentano tuttavia la mancanza di requisiti di sicurezza standard, accettati in tutto il settore, il che si traduce in condizioni estremamente eterogenee richieste dalle diverse agenzie assicurative. Un esempio delle misure di sicurezza che in alcuni casi vengono considerate quali requisiti per www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera l’assicurabilità dell’impianto (nel caso di sistema realizzato su edifici di altezza inferiori ai 5 metri), è riportato in tabella 1.23. Un ultimo aspetto da rilevare riguarda le polizze weather risk, ossia quei prodotti che permettono al titolare dell’impianto di tutelarsi dal rischio derivante dalla variabilità delle condizioni atmosferiche. Nel corso del 2009 l’interesse verso queste polizze, che alcuni operatori pensavano potessero incontrare una favorevole risposta del mercato, è stato molto basso. Alcune compagnie stanno addirittura ritirandole dal mercato, nonostante fossero state recentemente progettate e proposte ai potenziali clienti. Ciò si spiega con una producibilità media annua degli impianti localizzati nel nostro Paese costante e più che soddisfacente agli occhi del potenziale investitore. 1.4.9 Dinamiche occupazionali nella filiera del fotovoltaico in Italia Come anticipato nel paragrafo 1.2.5 del presente rapporto, in fase di revisione del Nuovo Conto Energia è auspicabile venga adottata una prospettiva il più ampia possibile, che consideri non solamente i costi per lo Stato associati ad un certo livello di tariffe feed-in, ma anche le ricadute in termini di entrate (o di mancate uscite) derivanti dalle imposte dirette e dall’IVA corrisposte dalle imprese italiane operanti nelle diverse fasi della filiera e da quelle che detengono la titolarità degli impianti, dal pagamento dell’ICI per gli impian- ti a terra e dalle emissioni di CO2 risparmiate. A questo bilancio, è necessario tuttavia aggiungere un’attenta valutazione delle ricadute occupazionali del fotovoltaico in Italia. È innanzitutto possibile stimare, con un certo livello di confidenza, in circa 2.000 il numero di dipendenti che lavorano oggi nelle imprese italiane (o nelle sedi commerciali e produttive delle imprese straniere presenti sul nostro territorio) attive nelle fasi di fabbricazione di silicio e wafer o di celle e moduli. Passando alle aree di business relative alla produzione di tecnologie e componenti ed alla distribuzione e installazione, è più complesso effettuare delle stime a causa del fatto che frequentemente questi operatori (si pensi ai produttori di inverter, ai distributori generalisti, ai system integrator o ai semplici installatori) sono attivi contemporaneamente in altre aree d’affari diverse dal fotovoltaico (ad esempio, l’idrotermosanitario o l’elettrico). Una stima ragionevole valuta in oltre 5.000 i dipendenti che operano in queste imprese e che sono direttamente coinvolti nel business del fotovoltaico, portando il numero di dipendenti diretti della filiera fotovoltaica italiana a oltre 7.000. Considerando l’occupazione totale, che comprende anche i dipendenti solo indirettamente coinvolti nel business del fotovoltaico, questa stima potrebbe salire a oltre 20.000 unità. Nonostante si tratti di una valutazione molto approssimativa, è possibile stimare il numero di addetti, sia direttamente che indirettamente impiegati nel business fotovoltaico, in rapporto alla potenza installata. Considerando gli scenari di sviluppo del mercato Box 1.24 Zurich Fondato nel 1872, Zurich Financial Services Group ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera. Il Gruppo fornisce servizi finanziari assicurativi e dispone di una rete di sedi e filiali dislocate in tutto il mondo. In Italia, Zurich opera dal 1902, avvalendosi a oggi di 1.400 collaboratori e 600 agenzie, che riescono a raggiungere oltre 2 milioni di clienti. Negli ultimi anni Zurich ha esteso il proprio campo di attività al settore energetico, proponendo soluzioni di copertura assicurativa per i diversi impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo è leader in Italia nei prodotti assicurativi rivolti al segmento del fotovoltaico, che costituiscono il 10% dei premi assicurativi del comparto delle rinnovabili. Zurich ha messo a punto diverse soluzioni in base alla clientela cui si rivolge. Per i clienti residenziali, è possibile acquistare la garanzia direttamente nella polizza incendio per la propria abitazione. Per la clientela aziendale, Zurich ha invece predisposto una copertura specifica, denominata “SolarPower All Risks”, che indennizza in caso di: guasto macchine e/o fenomeno elettrico; danni dovuti agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale e alle sovratensioni elettriche; atti di terzi, come il furto; atti vandalici e dolosi; atti di terrorismo e sabotaggio; danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell’impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi o impossibilità di vendere l’energia al gestore). www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 113 1. IL fotovoltaico fotovoltaico italiano illustrati nel paragrafo 1.3.3 e tenendo conto dei naturali fenomeni di apprendimento e delle economie di scala di cui potranno beneficiare i player della filiera, si può stimare che, nello scenario ottimistico, si possa arrivare ad avere oltre 50.000 dipendenti complessivi nel 2013, di cui oltre 20.000 diretti71. Nello scenario pessimistico, il valore dei dipendenti totali potrebbe essere nell’ordine dei 18.000 addetti. Nonostante non si tratti di numeri in termini assoluti enormi, e per giunta decisamente inferiori rispetto alle stime proposte da alcune ricerche recentemente condotte, non si possono negare i benefici occupazionali che lo sviluppo del mercato italiano del fotovoltaico sembra essere in grado di assicurare, soprattutto in un contesto economico sfavorevole ed in un momento molto negativo per il mercato del lavoro nel suo complesso. In questo senso, un’altra interessante valutazione che è stata condotta riguarda la crescita occupazionale che hanno fatto registrare le imprese attive nella filiera italiana del fotovoltaico negli ultimi anni. Per quanto riguarda i produttori di celle e moduli, tra il 2007 e il 2008 la crescita media degli addetti nelle filiali italiane delle imprese straniere è stata di oltre il 100%. Anche le imprese italiane di medie dimensioni hanno registrato incrementi della forza lavoro nell’ordine del 90%, con eccezioni positive quali Solarday, che ha incrementato il numero di addetti addirittura del 350%, ed MXGroup, che ha fatto registrare una crescita del 300%. I modulisti di dimensioni minori si sono attestati su una crescita della forza lavoro, tra il 2007 e il 2008, di circa il 45%. Nel periodo 20082009, per effetto dell’acuirsi della crisi economica le imprese italiane di medie dimensioni hanno incrementato il numero di propri dipendenti di circa il 50% (con delle eccezioni, quali MXGroup, che è cresciuta ancora ad un ritmo del 180%), mentre i più piccoli modulisti hanno registrato una crescita media del 42%. Si tratta di aumenti di assoluta rilevanza, specialmente se confrontati con la crescita dell’occupazione in Italia nel corso del 2009, che si è attestata su valori prossimi allo 0,4%. Analoghe considerazioni valgono se si analizzano le principali imprese distributrici, i system integrator e gli EPC contractor attivi in Italia, che hanno in media visto crescere la propria forza lavoro del 67% tra il 2007 ed il 2008, e di oltre il 28% nel corso del 2009. Alcuni system integrator di grandi dimensioni ed EPC contractor hanno addirittura raddoppiato il numero dei propri dipendenti, come è accaduto ad Enerqos. Infine, l’indagine ha permesso di identificare alcuni profili professionali che sono stati tra i più richiesti nella filiera del fotovoltaico in Italia negli anni 2008 e 2009, e che lo saranno verosimilmente ancora nei prossimi anni. Con il peso rilevante che ha assunto il mercato delle centrali fotovoltaiche e degli impianti industriali di grandi dimensioni, si è registrata una crescente richiesta da parte di EPC contractor, con una presenza radicata sul territorio nazionale e con filiali anche in altri Paesi, di figure professionali capaci di integrare competenze tecniche - relative alla progettazione di impianti complessi – con attitudine ed esperienza nel project management. Tra di esse, il business developer (o origination manager) ha il compito di individuare i siti su cui sviluppare i parchi fotovoltaici e di predisporre le procedure autorizzative necessarie alla costruzione degli stessi. Si parla inoltre di site manager per indicare quella figura che riporta al project manager (ossia al responsabile ultimo del progetto di realizzazione dell’impianto) e che garantisce che la centrale fotovoltaica venga realizzata così come progettato, oltre a mantenere i rapporti con i fornitori di componenti e con i proprietari del parco fotovoltaico. Si occupa quindi delle attività di costruzione, della logistica di materiali e componenti e della gestione delle risorse umane che vengono impiegate nel progetto. Senza dubbio, le figure più richieste per ricoprire queste posizioni sono l’ingegnere elettrico (per quanto riguarda l’attività di project manager) e l’ingegnere industriale (per quanto concerne il ruolo di site manager). Per il ruolo di business developer, le figure più ricercate sono quelle degli ingegneri civili o elettrici con una certa esperienza lavorativa. I system integrator e gli EPC contractor di minori dimensioni lamentano inoltre una forte difficoltà nel reperire figure professionali (tipicamente ingegneri o periti elettrici con un’esperienza professionale di 4-5 anni) in grado di svolgere il compito di tecnico installatore, ossia di occuparsi della progettazione di impianti complessi e del coordinamento delle attività di installazione. I modulisti e i produttori integrati di celle e moduli, i system integrator e i produtto- 71 Nell’impostare il calcolo, si è tenuto conto del numero medio di occupati per MW di potenza calcolato considerando il mercato italiano e confrontandolo con un campione rappresentativo composto da alcuni Paesi europei. 114 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 1.4 La filiera ri di inverter per applicazioni fotovoltaiche, sono inoltre alla ricerca di tecnici commerciali, ossia di figure con una base di competenze tecniche, che si occupino però di proporre i prodotti dell’azienda o gli impianti chiavi in mano ai potenziali clienti, fornendo allo stesso tempo un servizio di consulenza ed assistenza. Si tratta normalmente di ingegneri elettrici con esperienze professionali pregresse in ambito commerciale, piuttosto che agenti e rappresentanti che vengono sottoposti ad una formazione specifica, focalizzata sulle nozioni tecniche di base, che può durare dai 3 ai 6 mesi. A detta degli intervistati, reperire questo tipo di risorse è particolarmente complesso nel mercato del lavoro odierno. È da rilevare infine come si stiano affermando anche in Italia, in modo analogo a quanto registrato in Germania, delle iniziative imprenditoriali specializzate sulle attività di service e manutenzione lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto fotovoltaico, specialmente delle centrali di maggiori dimensioni. Nel momento in cui questo modello si diffondesse maggiormen- te, figure quali elettricisti, cablatori e manutentori con competenze specifiche in campo fotovoltaico saranno sempre più richieste. In risposta a questo crescente fabbisogno di figure professionali specializzate nel settore del fotovoltaico, così come in altri comparti delle rinnovabili, diverse tra le principali società di head hunting e di ricerca di personale qualificato, italiane e straniere, hanno dato vita ad un processo di specializzazione nel settore dell’energia, e in particolare delle fonti alternative. Emblematico in questo senso è il caso di Adecco, che nel 2009 ha creato la divisione Adecco Green Energies con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese del comparto una conoscenza specifica nel campo delle energie rinnovabili e rapporti consolidati con le principali associazioni industriali. Analogamente, alcuni head-hunter hanno modificato profondamente il loro posizionamento sul mercato, incrementando significativamente nel corso del 2009 il numero di clienti attivi nel business dell’energia, con un’attenzione particolare al comparto delle rinnovabili. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 115 IL SOLARE TERMICO 2.1 La tecnologia Nel corso del 2009 il solare termico in Italia non ha registrato evoluzioni particolarmente significative, sia per quanto riguarda gli sviluppi di natura tecnologica e di mercato, sia per quanto concerne il quadro normativo e le posizioni di forza relative degli operatori industriali attivi nel nostro Paese. Le considerazioni svolte nel Solar Energy Report 2008, cui si rimanda per approfondimenti e ulteriori informazioni di contesto, rimangono perciò in larga parte valide anche per l’anno che si è appena concluso. Obiettivo della presente sezione del rapporto è quindi quello di fornire un aggiornamento dei principali dati di mercato e delle previsioni di sviluppo di questo importante comparto delle energie rinnovabili in Italia, oltre a mettere in evidenza i maggiori cambiamenti che si sono registrati rispetto al quadro delineato nell’edizione precedente del Solar Energy Report. Dal punto di vista tecnologico, nell’arco del 2009 non si sono osservate discontinuità degne di nota che hanno messo a disposizione degli utilizzatori finali e degli operatori della filiera componenti o soluzioni impiantistiche particolarmente innovative. Per quanto concerne le tre principali tipologie di collettori (scoperti, piani vetrati e sottovuoto), l’analisi non rileva sostanziali evoluzioni nel loro peso relativo sulle installazioni totali rispetto al 2008, con i collettori piani vetrati che sono responsabili della parte largamente più consistente della potenza installata (si veda figura 2.1) anche alla fine di dicembre 2009. Questo dato si spiega principalmente, come già rilevato nel Solar Energy Report 2008, con l’assoluto predominio degli impieghi residenziali a bassa temperatura, in cui i collettori piani vetrati sono ampiamente preferibili rispetto a quelli sottovuoto, dato il loro costo decisamente inferiore. Per quanto riguarda invece la tipologia di circolazione (si veda figura 2.2), si rileva rispetto al 2008 una leggera crescita, confermata dalle opinioni degli intervistati, delle soluzioni a circolazione naturale (che pesano al termine del 2009 per circa il 35% della potenza complessiva installata, a fronte del 30% della potenza installata sotto forma di piccoli impianti nel dicembre 2008). Con l’attesa maturazione del mercato italiano del solare termico, ci si sarebbe potuti attendere piuttosto una crescita dei sistemi a circolazione forzata, Figura 2.1 Diffusione delle diverse tipologie di collettori nel mercato italiano per tipologia di circolazione Circolazione naturale Circolazione forzata 3% 5% 17% 95% 80% Collettori piani vetrati Collettori sottovuoto Collettori non vetrati www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 119 2. IL SOLARE TERMICO Figura 2.2 Diffusione delle diverse tecnologie di circolazione nel mercato italiano per classi di impianto Piccoli impianti Grandi impianti 5% 35% 65% 95% Circolazione naturale contraddistinti da una maggiore integrabilità architettonica rispetto alle soluzioni a circolazione naturale, controbilanciata da un maggiore costo iniziale (che ci si aspettava però in diminuzione per effetto del progresso tecnologico e delle crescenti economie di scala realizzate). Nei fatti, la contrazione delle disponibilità finanziarie delle famiglie italiane, per effetto del perdurare della crisi economica, ha probabilmente aumentato la propensione dell’investitore verso l’installazione dei più economici sistemi a circolazione naturale. Per quanto riguarda la ricerca industriale nel campo delle tecnologie del solare termico, durante l’ultimo anno si è mossa lungo due principali direttrici, confermando così una tendenza già registrata negli anni passati: • verso la riduzione del costo complessivo dell’impianto, che arriva oggi per l’utilizzatore finale ad un valore medio di 5.200 E per un impianto di 3kWth per acqua calda sanitaria, con una diminuzione rispetto al dato relativo al 2008 di circa il 5%. Questa riduzione si spiega principalmente con l’abbassamento del costo di produzione dei collettori e dei componenti accessori dell’impianto, che continua a pesare per oltre il 70% dell’investimento che grava sull’utilizzatore finale. I pesi percentuali delle attività di installazione, dello sviluppo del progetto e del collegamento all’impianto esistente rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto registrato nel corso del 20081; 1 Circolazione forzata • verso la riduzione delle dimensioni dei collettori e degli altri componenti dell’impianto, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrabilità architettonica degli stessi. Alcuni interessanti progetti sono stati portati avanti in quest’ottica sui sistemi a concentrazione piana, come descritto nel box 2.1. Le principali traiettorie di sviluppo tecnologico tracciate nel Solar Energy Report 2008 (e in particolare la messa a punto di sistemi ibridi termicofotovoltaici, di collettori polimerici e di sistemi di raffrescamento solare, noti anche con il nome di solar cooling) rappresentano ancora oggi, a detta degli operatori intervistati nell’ambito dell’indagine, le più importanti frontiere verso cui si indirizzano gli sforzi di ricerca e sviluppo e l’attenzione da parte degli operatori della filiera. Ciononostante, nel corso del 2009 non si rilevano in Italia applicazioni su scala commerciale di queste tecnologie, che rimangono ancora ampiamente confinate al ruolo di applicazioni di nicchia o di progetti sperimentali. Un approfondimento lo merita tuttavia la tecnologia del solar cooling (anche nota come solar air-conditioning) attraverso cui l’energia termica proveniente dalla fonte solare attiva un ciclo termodinamico per la produzione di acqua refrigerata o per il trattamento dell’aria destinata al condizionamento degli ambienti o ai processi di refrigerazione. Nella maggioranza dei Paesi industrializzati si realizzerà verisimilmente un deciso incremento della domanda di sistemi di raffrescamento e di condizionamento dell’aria, che è destinata addirittura a quadruplicare Cfr. Solar Energy Report 2008, p.111. 120 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.1 La tecnologia di piccola taglia, che rappresentano tuttavia, a detsecondo alcune stime da qui al 2020. Questo aumenta degli operatori, i più promettenti in ottica comterà in modo sensibile il fabbisogno di energia eletmerciale in quanto adatti ad affermarsi nel mercato trica necessaria agli edifici residenziali e industriali, numericamente più vasto rappresentato dagli edicon le conseguenze negative in termini di impatto fici residenziali. I sistemi ad oggi in funzione sono ambientale che un uso più intenso dell’energia prosostanzialmente realizzati “su commessa”, con un dotta da fonte fossile comporterebbe. Nel momento carattere quasi “sperimentale”, e hanno costi comin cui i sistemi di solar cooling si affermassero sul presi tra 3.000 e 8.000 E per ogni kW di capacità di mercato nei prossimi anni, essi permetterebbero di raffrescamento. Questi costi, a detta degli operatori, far fronte a questo consistente incremento del fabbisono tuttavia destinati ad essere significativamente sogno di energia attraverso una fonte “pulita” e rinabbattuti con l’aumento della scala produttiva ed novabile come il sole. A ciò si aggiungono molteplici il progresso tecnologico, al punto da altri vantaggi di questi sistemi, tra cui rendere i sistemi di solar cooling comun significativo risparmio energetico “Queste soluzioni innovative petitivi con i tradizionali impianti di rispetto ai sistemi di climatizzazione hanno la potenzialità condizionamento nel giro di alcuni tradizionali, una notevole silenziosità di assicurare una notevole riduzione dei consumi, motivo anni. L’Italia, come si vedrà anche più e durata, ridotti costi di manutenzioper cui il tema del solar avanti in questa sezione del rapporto, ne, una elevata modularità nell’instalcooling diventa di giorno in giorno sempre più ha un potenziale molto elevato per la lazione ed un ingombro limitato. Dal interessante ed attuale.” diffusione dei sistemi solar cooling, punto di vista commerciale, i sistemi Marketing Manager dei uno dei più considerando che si tratta del secondo di solar cooling sono tuttavia ancoimportanti produttori di collettori solari mercato europeo per i climatizzatori e ra ad uno stadio di diffusione molto gli altri sistemi di raffrescamento (con embrionale. Come emerge anche dalle circa il 25% di tutta la superficie climatizzata a livelanalisi condotte nell’ambito di un recente progetto lo europeo), ed alla luce delle caratteristiche del suo di ricerca promosso dall’Unione Europea (progetto territorio in termini di irraggiamento medio. Anche SOLAIR), che ha visto coinvolti 13 partner dai prinnel nostro Paese, tuttavia, la tecnologia del solar coocipali Paesi europei tra cui l’Italia, in tutta Europa ling si trova ad uno stadio di sviluppo assolutamenesistono approssimativamente 500 installaziote embrionale, con all’attivo un numero limitato di ni di sistemi solar cooling. Tra questi, l’assoluta installazioni, di cui nessuna nel settore residenziale. maggioranza è rappresentata da macchine di taglia Un caso interessante di applicazione della tecnolomedio-grande (con potenza superiore ai 50 kW frigia del solar cooling in Italia è descritto nel box 2.2. goriferi). Una porzione molto più limitata (si stima La messa a punto di sistemi di raffrescamento solanell’ordine di poche decine) è costituita da sistemi Box 2.1 I collettori solari a concentrazione piana ad alto rendimento Nell’ambito del progetto DOCUP 2000-2006, finanziato dalla Regione Abruzzo, e grazie alla collaborazione tra Radionica (impresa abruzzese attiva nelle energie rinnovabili) e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara, è stato sviluppato un particolare collettore solare a concentrazione piana ad alto rendimento. L’obiettivo del progetto è stato quello di risolvere uno dei problemi dei collettori solari piani, ossia il notevole ingombro dovuto al basso rendimento dei collettori “standard” che richiedono elevate superfici di esposizione per coprire l’intero fabbisogno termico. Il collettore sviluppato nell’ambito del progetto è caratterizzato da una struttura scatolare rigida, con coperchi laterali dotati delle connessioni di collegamento agli elementi di completamento del sistema. La struttura scatolare assicura resistenza agli agenti atmosferici, durata nel tempo e leggerezza. Il sistema è studiato per far sì che l’esposizione degli elementi assorbitori alla radiazione solare risulti doppia rispetto a quella che avrebbe normalmente. Ciò è possibile grazie alle superfici piane speculari poste al di sopra e al di sotto dei tubi evacuati, che riflettono la luce e la convogliano verso il collettore. Le inclinazioni delle superfici riflettenti sono state determinate in modo tale da massimizzare l’afflusso di radiazione riflessa sui tubi evacuati, mantenendo costante l’inclinazione del pannello. Inoltre, grazie alla particolare geometria della struttura scatolare, è possibile posizionare il collettore senza l’ausilio di sottostrutture di supporto. I test effettuati durante le fasi di studio e sviluppo dei prototipi hanno registrato un rendimento del pannello pari a circa l’80%, riferito alla superficie lorda, contro un rendimento che è pari a circa il 50-65% per i pannelli tradizionali. Le prove per le certificazioni di prodotto, secondo quanto previsto dalle norme EN 12975, sono state effettuate presso il Centro Ricerche ENEA di Trisaia. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 121 2. IL SOLARE TERMICO Box 2.2 L’impianto solar cooling dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca Lo scorso anno è stato presentato l’impianto di solar cooling installato presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca in integrazione al sistema di climatizzazione già esistente. Sul tetto di uno dei padiglioni sono stati installati 72 pannelli solari sottovuoto realizzati da Paradigma, suddivisi in 18 file composte ognuna da 4 pannelli, per una superficie totale d’apertura di 324 m2. L’acqua calda prodotta dall’impianto solare viene utilizzata come fonte di energia, per il funzionamento di un chiller ad assorbimento per la produzione del freddo. Inoltre il circuito frigorifero dell’assorbitore riduce notevolmente i consumi elettrici, rispetto ai tradizionali sistemi a com- pressione di gas frigorigeno, grazie ad una miscela di acqua e bromuro di litio che, una volta riscaldata, innesca il processo di assorbimento per la produzione del freddo. L’acqua esce così dall’assorbitore alla temperatura di 7°C e viene stoccata in un accumulatore da 9.000 litri che si trova all’esterno dell’edificio. In seguito, attraverso apposite pompe di circolazione, essa viene distribuita alle utenze climatizzando gli ambienti tramite venti convettori. All’esterno, vicino al sistema ad accumulo per acqua fredda, è presente un ulteriore sistema ad accumulo inerziale da 9.000 litri, con il compito di immagazzinare l’energia termica solare. re sempre più efficienti e meno costosi rappresenta probabilmente un fattore decisivo per determinare il tipo di diffusione che la tecnologia solare termica potrà sperimentare negli anni a venire in Italia ed in molti altri Paesi europei. Se i sistemi di solar cooling costituiscono un campo di applicazione della tecnologia solare termica molto promettente in ambito residenziale, esistono progetti di ricerca industriale e applicazioni sperimentali che consentono lo sfruttamento della tecnologia solare termica su larga scala, quali i sistemi solari di teleriscaldamento. Si tratta di sistemi di teleriscaldamento assistiti da generazione termica solare che sono pensati per essere utilizzati in aree e distretti ad alta densità abitativa, con l’obiet- tivo di assicurare la copertura di una buona porzione del fabbisogno termico complessivo attraverso l’energia generata dal sole. Da un punto di vista tecnico i sistemi sono molto complessi soprattutto per quanto concerne il dimensionamento e la simulazione del funzionamento dell’impianto, che spesso è integrato con altre fonti, quali ad esempio le biomasse. A questo si aggiunge la necessità di prevedere dei sistemi di accumulo stagionale per immagazzinare il calore resosi disponibile durante la stagione estiva e bilanciare così la produzione tra estate ed inverno (si veda figura 2.3). Questi sistemi di accumulo possono essere realizzati attraverso tecnologie differenti, tra cui le strutture in calcestruzzo rivestite in acciaio e i pozzi trivellati e Figura 2.3 Schema di un impianto solare termico con sistema di accumulo Co t ll e to ri Co ll e tt or i Centrale termica Scambiatori di calore Scambiatori di calore Caldaia Rete per accumulo calore da collettori Rete di distribuzione di riscaldamento Impianto di accumulo 122 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.1 La tecnologia di cui si è parlato in precedenza, che richiederà anperforati sembrano essere quelle più promettenti. cora molte sperimentazioni e che è contraddistinta Esistono diverse installazioni sperimentali e dida una economicità e redditività ancora da valutare mostrative di questa tecnologia in Europa, speattentamente (in alcuni impianti pilota si stima che cialmente nei Paesi del Nord. In Germania, ad si possa scendere sotto i 0,20 E per kWh termico esempio, sono stati realizzati recentemente più di prodotto per conversione da fonte sodieci progetti di questo tipo, con imlare). Tuttavia, si ritiene che la ricerca e pianti che ospitano collettori con una superficie media che supera i 5.000 “La domanda di impianti di grandi la messa a punto di nuove applicazioni dimensioni sta sensibilmente come quelle descritte in queste pagine metri quadrati, equivalenti a oltre 3,7 crescendo. Anche in risposta MWth. È un’applicazione che pare a questi stimoli, abbiamo ampliato possa rappresentare un’importante la nostra gamma di prodotti leva capace di indirizzare l’attenmolto adatta al contesto italiano, ai sistemi centralizzati e abbiamo considerate la presenza di distretti organizzato anche eventi specifici, zione di imprenditori ed investitori insieme ad importanti studi verso una tecnologia come quella del densamente abitati e concentrati dal di architettura, destinati solare termico che rischia altrimenti, punto di vista geografico, le favoa progettisti e studi come d’altronde alcuni osservatori del revoli condizioni di irraggiamento, di ingegneria.” nonché l’interesse che il modello del Marketing Manager di uno dei principali mondo delle energie rinnovabili e alteleriscaldamento (ad esempio da produttori di componenti per impianti ternative tendono a ritenere, di essere solari termici considerata ormai matura e destinata cippati e altre biomasse di origine a contribuire solo marginalmente al agro-forestale) sta riscontrando nesoddisfacimento del fabbisogno di energia primaria gli ultimi anni nelle Pubbliche Amministrazioni nel nostro Paese. Le analisi riportate nei paragrafi locali e tra gli investitori privati. Infine, va detto successivi mostrano come in realtà le potenzialità che si tratta chiaramente di un tipo di utilizzo deldel solare termico siano particolarmente prometla tecnologia solare termica ad uno stadio ancora tenti anche e soprattutto in Italia. più embrionale rispetto ai sistemi di solar cooling www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 123 2.2 La normativa Anche sotto il profilo normativo, nel corso del 2009 non si registrano evoluzioni particolari che hanno avuto, o potrebbero avere nell’immediato futuro, un impatto sostanziale sullo sviluppo del mercato solare termico in Italia. un requisito imprescindibile per evitare un consistente rallentamento del mercato del solare termico italiano e sfruttarne interamente il potenziale, di cui si parlerà nel capitolo 2.3. Nonostante in termini assoluti le domande di detrazione fiscale per interventi di installazione di pannelli solari Un primo aspetto da rilevare riguarda il fatto che termici siano estremamente numerose, gli operale norme2 che sancivano l’obbligo, sia per gli editori del settore intervistati nell’ambito dell’indafici pubblici che privati, tanto nel caso di nuova gine lamentano un difetto di informazione sulla costruzione quanto di ristrutturazione di impianti possibilità di accedere a questi sgravi e sui passi termici, di soddisfare almeno il 50% del fabbisoda seguire per ottenerli, con molti progettisti e ingno annuo di energia termica attraverso impianti stallatori che si dimostrano impreparati in merito solari termici, si confermano inefficaci nella praai dettagli di queste agevolazioni ed alle procedure tica anche nel 2009. Questo a causa di una forte che il cliente deve adempiere per poterne beneficiadisomogeneità a livello regionale nella loro applire. A questo si aggiunge una notevole complessicazione e per la mancanza di decreti tà del procedimento per l’accesso alla attuativi e sanzioni opportune. detrazione, quantomeno a detta degli operatori intervistati, con il risultato “Se quest’obbligo imposto per legge dovesse venire applicato Per quanto riguarda i meccanismi di che per una percentuale non trascunella pratica, si tratterebbe di un incentivazione, rimangono in vigore rabile di interventi di riqualificazione notevole incentivo per il nostro settore. Va detto però che c’è (fino alla fine del 2011, come previsto energetica essa non viene nemmeno molta ignoranza sul tema: molti dalla Finanziaria 2009) sia la riduzio- sperano di sfruttare la tecnologia richiesta (circa il 35% nelle Regioni del solare termica per soddisfare ne al 10% dell’aliquota IVA sull’acSud Italia e il 20% nel Nord, nel 2009). il 100% del proprio fabbisogno quisto dei pannelli solari termici, sia … solo se vivessimo in Tunisia l’efficace detrazione fiscale dall’imInfine, un aspetto che merita di essere potrebbe essere ragionevole!” posta lorda (pari al 55%) delle spese Amministratore delegato di una grande approfondito riguarda il collegamento di riqualificazione energetica, tra impresa di progettazione e installazione che esiste tra il tema della certificaziocui l’installazione di impianti solari ne energetica degli edifici e il solare per la produzione di acqua calda satermico. In Italia, dal 1 gennaio 2007 nitaria. Gli operatori del settore auspicavano che l’ottenimento dell’Attestato di Certificazione nel corso del 2009 si facesse chiarezza sul destino Energetica è una condizione indispensabile per di questo meccanismo di detrazione fiscale oltre il accedere alle agevolazioni fiscali, (ossia alla detra2011. In realtà, permane un alone di incertezza su zione del 55% concessa per gli interveti di efficienza questo tema confermato dalla bocciatura al Senato energetica di edifici esistenti), mentre dal 1 luglio di un emendamento alla Finanziaria 2010 che pre2009 esso diviene obbligatorio anche per procevedeva la proroga dell’agevolazione al 31 dicembre dere alla compravendita della singola unità abi2012. Nonostante l’investimento in sistemi solari tativa. Lo Stato ha quindi demandato alle singole termici sia particolarmente conveniente anche in Regioni il compito di definire, attraverso l’emanaassenza di questi sistemi di detrazione fiscale (con zione di opportuni decreti, gli aspetti operativi e un tempo di pay back, nel caso di impianto “tipo” procedurali (valori di riferimento, procedimenti di per una famiglia media, pari a meno di 5 anni), un calcolo, modalità di formazione e accreditamento loro prolungamento per i prossimi 3-5 anni sembra dei certificatori) necessari all’entrata in funzione 2 Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192 e Decreto Legislativo 29/12/2006, n. 311. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 125 2. IL SOLARE TERMICO dell’Attestato di Certificazione Energetica. Alcune Regioni - tra cui la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia - hanno già legiferato in materia, in altre invece l’attestato di Certificazione Energetica non è ancora entrato in funzione. Il quadro risulta quindi molto eterogeneo a livello italiano, con profonde differenze tra Regione e Regione. Nonostante, come già discusso nel paragrafo 1.3.5, il mercato immobiliare in Italia non si sia ancora sviluppato al punto da riconoscere un valore significativamente superiore agli edifici con forte compatibilità ambientale, l’attenzione al tema della certificazione energetica ha tuttavia portato gli operatori del settore ad interessarsi maggiormente alle tecnologie che possono essere impiegate per raggiungere determinate classi energetiche degli edifici. In questo contesto, l’analisi effettuata mostra come la scelta delle soluzioni per ottenere una determinata classe energetica sia influenzata sostanzialmente da considerazioni di costo e dall’entità dell’investimento iniziale. Per raggiungere la classe energetica richiesta dal committente della costruzione, gli 126 architetti e i progettisti tendono in prima battuta a sfruttare le modalità di risparmio energetico passivo, e solo in un secondo momento cercano di utilizzare le fonti alternative per la generazione di energia elettrica e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. Tra queste, al solare termico viene tipicamente data priorità rispetto ad altre energie rinnovabili (ad esempio il fotovoltaico), sostanzialmente per il minore investimento addizionale che esso richiede all’investitore. La filiera delle costruzioni immobiliari sembra quindi maggiormente interessata al costo delle tecnologie rinnovabili piuttosto che al loro rendimento o alla loro efficienza. In questo senso, l’affermarsi di un mercato immobiliare “green”, l’omogeneizzazione normativa a livello nazionale e l’entrata in vigore nei fatti delle procedure di certificazione energetica degli edifici potrebbero rappresentare un importante volano per la crescita del mercato del solare termico in Italia, nonostante non stimolerebbero, almeno per i primi anni, la ricerca di soluzioni sempre più efficienti e tecnologicamente all’avanguardia. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.3 Il mercato Come già evidenziato nel Solar Energy Report calo tuttavia rispetto al 2008, in cui da sola era sta2008, il mercato europeo del solare termico ha regita responsabile di oltre il 50% del mercato europeo. strato negli ultimi anni una forte crescita. Nel solo Questo è il risultato di un rallentamento del mer2008 in Europa sono stati installati più di 4 milioni cato nel corso del 2009, e specialmente nei mesi di metri quadrati di collettori, che corrispondono a estivi, quando le vendite di impianti solari termici oltre 3 GWth di potenza. Nonostante si tratti di una sono calate di oltre il 40% rispetto al medesimo tecnologia che recentemente ha suscitato un minoperiodo dell’anno precedente. Questa dinamica è re interesse tra gli operatori del settore rispetto ad evidente anche in figura 2.5, che mostra i livelli altre forme di sfruttamento dell’energia rinnovabidi potenza solare termica pro-capite installati nei li quale il fotovoltaico, anche nel 2009 principali Paesi europei, ed è dovui tassi di crescita del mercato europeo ta principalmente ad un repentino del solare termico sono estremamente e profondo re-indirizzamento degli “La Germania è 2 o 3 anni avanti a noi, ma l’Italia rilevanti, a dispetto del rallentameninvestimenti delle famiglie tedesche, è costretta ad inseguire to dovuto alla crisi economica. Nel che hanno investito i loro risparmi in anche rispetto ad altre nazioni come l’Austria 2009 si stima siano stati installati altri beni (ad esempio l’automobile) il o la Gran Bretagna” in Europa poco meno di 5 milioni di cui acquisto è stato fortemente sosteMarketing Manager metri quadrati di collettori, il che ha nuto dal governo tedesco. Nel corso di una grande impresa portato la potenza totale cumulata dei prossimi anni, tuttavia, il merdi progettazione e installazione a oltre 22 GWth, che corrispondono cato tedesco del solare termico spera a più di 31 milioni di metri quadrati di trarre beneficio dal nuovo decreto di collettori. Il giro d’affari annuo è stimabile in sulle fonti d’energia rinnovabile (noto come EEG oltre 3 mld E. Wärme) varato dal governo federale a fine 2008 e in vigore dal 1 gennaio 2009. Questa norma stabiLa figura 2.4 riporta il peso dei diversi Paesi eurolisce che la quota di energia termica per riscaldapei nel mercato del solare termico nel 2009. Come mento da fonte rinnovabile raddoppi, dal 7 al 14% si può notare, la Germania conferma la sua leaderrispetto al consumo complessivo, da qui al 2020. A ship indiscussa, con un peso superiore al 40%, in questo fine essa rende obbligatorio l’uso di energie Figura 2.4 Peso dei diversi Paesi europei nel mercato del solare termico 2% 2% 2% 2% 2% 8% 40% 7% 7% 8% 10% 10% Germania Polonia Spagna Belgio Italia Portogallo Francia Svizzera Austria Regno Unito Grecia Altri www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 127 2. IL SOLARE TERMICO Figura 2.5 Capacità installata (per 1.000 abitanti) nei principali Paesi europei 35 30 kWth 25 20 15 10 5 IT 128 DE GR 9 6 200 200 5 200 È interessante soffermarsi su quelle che potrebbero essere le prospettive per il solare termico in Europa nei prossimi anni. In questo senso, bisogna ricordare che, nonostante gli osservatori e gli analisti tendano spesso a sottostimarlo, il potenziale che questa tecnologia ha di concorrere in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 8 4 200 rinnovabili per il riscaldamento degli edifici nuovi (o ristrutturati), lasciando tuttavia gli investitori liberi di scegliere quale specifica fonte di energia utilizzare. Occupano la seconda posizione di questa particolare classifica la Spagna e l’Italia, che sono responsabili di circa il 10% del mercato complessivo nel 2009. In Spagna in realtà il mercato ha subito un marcato rallentamento del tasso di crescita (nell’ordine del 30%) rispetto a quello registrato nel corso del 2008. Secondo gli operatori, si tratta principalmente del risultato del crollo del mercato immobiliare che si è registrato negli ultimi mesi dell’anno e che ha di fatto arrestato anche la crescita delle installazioni di impianti solari termici. Si conferma il peso marginale di Austria e Grecia, il che sembra stridere col fatto che si tratta dei due Paesi europei che per primi hanno pesantemente scommesso sul solare termico. In realtà sono proprio ovvi motivi di saturazione a spiegare questa dinamica, come già rilevato nel Solar Energy Report 2008 e come è chiaro consultando la figura 2.5. EU27+CH 200 3 200 ES 7 2 200 FR 200 1 200 0 200 199 9 0 AT a livello europeo in tema di contributo delle rinnovabili al consumo finale di energia è particolarmente consistente. Basti pensare che il fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento degli ambienti in Europa pesa per quasi il 50% del fabbisogno totale di energia. Un recente studio dell’AEE (Istituto per le Tecnologie Sostenibili dell’Università di Vienna) ha delineato tre scenari di sviluppo della tecnologia solare termica in Europa, uno pessimistico, uno intermedio e uno ottimistico, in funzione del grado di supporto (attraverso sgravi fiscali e altre forme di agevolazioni) che le Amministrazioni Pubbliche centrali e locali assicureranno all’utilizzatore che voglia investire in un impianto ed alle imprese che si occupano dello sviluppo e messa a punto di queste tecnologie (si veda figura 2.6). Nello scenario ottimistico, ipotizzando una riduzione del 9% entro il 2020 (rispetto al valore del 2006) della domanda totale di energia finale grazie alle misure di efficienza energetica, il contributo del solare termico al raggiungimento dell’obiettivo del 20% di energie rinnovabili nell’Unione Europea sarebbe del 6,3%, mentre nello scenario intermedio si arriverebbe al 2,4%. Per raggiungere gli obiettivi al 2020 descritti dallo scenario ottimistico, sarebbe necessario che il mercato europeo del solare termico sperimentasse un tasso di crescita medio annuo di circa il 26% (contro il 15% www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.3 Il mercato Figura 2.6 Scenari di previsione della capacità cumulata delle installazioni solari termiche in Europa 7000 6000 GWth 5000 4000 3000 2000 1000 Scenario ottimistico 5 0 5 0 5 0 202 203 203 204 204 205 0 5 201 202 0 201 200 5 0 Scenario intermedio del caso intermedio e il 7% di quello pessimistico). Conseguentemente, la superficie totale di collettori installati da qui al 2020 si aggirerebbe tra i 97 milioni di metri quadrati (nello scenario pessimistico) e i 388 milioni di metri quadrati (in quello ottimistico), che corrispondono rispettivamente a 67,9 GWth e 271,6 GWth di potenza installata. Per raggiungere i livelli di installato previsti dallo scenario ottimistico servirebbero investimenti privati per oltre 200 mld E. Proseguendo nella direzione delineata dallo scenario più favorevole, al 2050 si arriverebbe ad un installato pari a 5 TWth di potenza, cui corrisponderebbero circa 8 metri quadrati di collettori per abitante, in grado di soddisfare circa il 47% della domanda di calore a bassa temperatura a livello UE. Chiaramente, per realizzare questo potenziale di crescita, sarebbe necessario sfruttare, molto di più di quanto non accada oggi, tutte le applicazioni potenziali della tecnologia solare termica, tra cui in particolare l’uso della stessa a supporto degli impieghi industriali, sia in bassa che in media e alta temperatura. Questo non significa tuttavia che il comparto residenziale, in cui il solare termico viene impiegato per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, non avrà in Europa un peso rilevante. Si stima infatti che circa la metà dei consumi finali di energia in Europa riguardi l’energia termica e, di questa, il 60% circa è relativa all’uso nel comparto residenziale. Scenario pessimistico Per quanto concerne più da vicino l’Italia, va detto che a fine 2009 la potenza solare termica installata era pari a 1,4 GWth, corrispondenti a circa 2 milioni di metri quadrati di collettori solari. Questo a fronte di una potenza installata a fine 2008 di poco superiore a 1 GWth, pari a 1,5 milioni di metri quadrati di collettori (si veda figura 2.7). La potenza installata nel corso del 2009, pari ad oltre 350 MWth, è stata superiore di circa il 26% rispetto al 2008, cui corrisponde un volume d’affari annuo complessivo stimabile in circa 500 mln E. Il mercato solare termico è quindi cresciuto a ritmi decisamente consistenti, soprattutto se si considera l’impatto della congiuntura economica negativa, principalmente per effetto dell’efficace sistema di detrazione fiscale di cui si è parlato in precedenza in questa sezione. Come anticipato nel Solar Energy Report 2008, il mercato non si è tuttavia espanso al medesimo ritmo registrato nel 2008, vero anno di esplosione del solare termico in Italia, per effetto da un lato dei problemi di sottodimensionamento della capacità cui si è fatto cenno nello studio condotto lo scorso anno, dall’altro dell’inevitabile peggioramento della situazione economica complessiva. Considerando la penetrazione relativa del solare termico nel nostro Paese, si rileva (si veda figura 2.5) una potenza installata di 6 kWth per mille abitanti alla fine del 2009, ancora inferiore www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 129 2. IL SOLARE TERMICO Figura 2.7 Capacità cumulata delle installazioni solari termiche in Italia 1500 1400 1200 MW 1000 800 600 400 200 • si suppone che nel periodo 2010 – 2020 il numero di nuove unità abitative realizzate in Italia segua il trend registrato nel periodo 1995 – 2006; • si assume che l’impianto solare termico venga utilizzato per coprire in media il 35% del fabbisogno termico di una singola unità abitative; • si stima che un’unità abitativa di dimensioni medie (con superificie pari ad 80 metri quadrati), composta da 3 persone nel Nord Italia e da 5 persone nel Sud del Paese, necessiti, per soddisfare il 35% del suo fabbisogno di acqua calda, di circa 1,55 metri quadrati di collettori (nel caso di collettori piani); • si ipotizza che il 50% di tutte le nuove unità abi- 3 8 9 200 7 200 tative realizzate nel periodo 2010 – 2020 installino un impianto solare termico con le caratteristiche riportate in precedenza. Sotto queste ipotesi, sarebbe necessario installare circa 4 milioni di metri quadrati di collettori (corrispondenti a circa 2.800 MWth) da qui al 2020. Questo significa che non sarebbe impensabile triplicare la potenza installata a fine 2009 da qui al 2020 considerando il solo campo di applicazione della produzione di acqua calda ad uso sanitario. Un notevole potenziale hanno anche le applicazioni di solar cooling in Italia, tenuto conto del fatto che il nostro Paese è la nazione con il più importante mercato a livello europeo per i sistemi di climatizzazione e raffrescamento (ha sperimentato in particolare una crescita esponenziale a partire dal 2000, con una vendita media di 1,3 milioni di unità all’anno). Si consideri che il numero di immobili ad uso residenziale presenti in Italia a fine 2008 era pari a circa 23 milioni di unità. Se solo il 2% venisse dotato, da qui al 2020, di un impianto di solar cooling (si è ipotizzata una percentuale limitata in quanto una larga parte del parco immobili esistente in Italia è dotato di sistemi autonomi di riscaldamento su cui non è possibile applicare macchine per il raffrescemanto solare), ciascuno con una potenza media di circa 30 kW frigoriferi, verrebbero installati circa 34 milioni di metri cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 121-123. 130 200 6 200 5 200 3 200 Per quanto riguarda la sopracitata stima del potenziale del solare termico in Italia, è stata condotta una prima valutazione del mercato degli impianti ad uso residenziale. Sono state adottate le seguenti ipotesi: 4 2 200 rispetto alla media dell’Europa a 27. Questo lascia intendere, come confermano in Italia alcune analisi che si riportano di seguito, che ci sia ancora un potenziale inespresso molto consistente che attende di essere realizzato. Considerato il quadro decisamente stabile che è stato dipinto in queste pagine, le prospettive future per il mercato solare termico italiano non si discostano da quelle presentate nel Solar Energy Report 20083. 200 1 200 0 200 9 199 199 8 0 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.3 Il mercato temperature più basse, nell’ordine di 70-80 °C), ai quadrati di collettori per solar cooling, per una sistemi più avanzati con doppia copertura, sia piapotenza frigorifera complessiva di 13.000 MW. ni che sottovuoto (quando si lavora su temperature Una stima può anche essere elaborata sul trend fino a 120 °C). Esistono soluzioni per temperature di realizzazione delle nuove costruzioni, come è anche superiori, fino a 250 °C, che utilizano però stato fatto in precedenza per gli impianti solari collettori parabolici a concentrazione in alluminio, termici tradizionali. Ipotizzando di dotare di un analoghi alle soluzioni impiegate nelle applicazioimpianto di solar cooling solo il 5% delle nuove ni di solare termodinamico. I settori costruzioni che verranno verisimilindustriali in cui maggiore è la probamente realizzate da qui al 2020, si “E’ fondamentale che bilità che il solare termico sperimeninstallerebbero circa 3,3 milioni di si sviluppi il mercato delle ti, negli anni futuri, una significativa metri quadrati di collettori, per una applicazioni industriali e del solar cooling. diffusione sono riportati in figura corrispondente potenza frigorifera Si tratta, di fatto, di tecnologie 2.8. Il settore che esprime un potendi 1.300 MW. concrete e non di applicazioni futuribili” ziale maggiore è quello alimentare, in cui il calore può essere sfruttato nei Per poter sfruttare appieno il potenAmministratore delegato ziale del solare termico in Italia, è ne- di un’impresa produttrice di collettori processi di sterilizzazione dei contenitori, di fermentazione dell’alcol o di cessario che si affermino anche le apcottura dei cibi. Segue poi il settore plicazioni a media-alta temperatura a tessile, in particolare per quanto concerne i prointegrazione dei processi industriali. Già nel Solar cessi di lavaggio dei tessuti in cui si fa ampio uso di Energy Report 2008 si indicava questo come uno acqua a medio-bassa temperatura. Gli altri settotra i più promettenti campi di impiego della tecri importanti per una diffusione futura del solare nologia solare termica: tuttavia gli operatori sono termico sono il chimico e il cartiero. concordi nel ritenere che nel corso del 2009 non si siano fatti passi in avanti decisivi verso una magMutuando le stime proposte dall’Enea4 sul congiore diffusione di queste soluzioni. Il solare tertesto europeo, è possibile ipotizzare che il solare mico può essere integrato a diversi livelli del protermico possa arrivare a soddisfare fino al 3-4% cesso industriale. Tipicamente viene impiegato per del fabbisogno di calore dell’industria italiana, riscaldare direttamente il fluido di lavoro o per la entro il 2020, il che corrisponderebbe all’instalproduzione di vapore ad alta temperatura. Ad ogni lazione di 4,84 milioni di metri quadrati di colmodo, esso trova utilizzo dove non si ha necessilettori e ad una potenza di oltre 3,4 GWth. tà di temperature superiori ai 250 °C. Dal punto di vista tecnico, i collettori più idonei per queste Chiaramente i livelli di potenza solare termica applicazioni vanno dai sistemi più convenzionali, installata che emergono da queste simulazioni ossia i collettori piani, vetrati e sottovuoto (per le Figura 2.8 Probabilità con cui il solare termico troverà applicazione nei principali settori industriali Alimentare Tessile 19% 40% 4% 5% 7% Bevande Chimica 7% Carta 18% Desanilizzazione Altro 4 Dossier Enea “Usi termici delle fonti rinnovabili” – novembre 2009 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 131 2. IL SOLARE TERMICO non verranno mai raggiunti nella pratica, come d’altronde accennato in precedenza parlando delle prospettive future per questa fonte di energia rinnovabile in Italia. Tuttavia esse sono utili per mostrare, da una punto di vista “teorico”, che la tecnologia solare termica potrebbe contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi in termini di produzione di energia 132 da fonte rinnovabile su cui il nostro Paese si è impegnato da qui al 2020. In questo modo, si ritiene anche che esse possano scoraggiare quelle posizioni fortemente “scettiche” in merito al valore instrinseco di questa tecnologia ed alla convenienza da parte del Governo e delle altre istituzioni di continuare a stimolarne con opportuni meccanismi la diffusione. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.4 La filiera venduti dai principali operatori tradizionali attivi in Italia nel 2009 sono destinati ad impieghi residenziali, in particolare impianti con collettori di superficie compresa tra i 15 e i 30 metri quadrati (per Vaillant questa percentuale si attesta sul 95%, per Riello sul 90% mentre per Velux arriva al 100%). Questo in quanto gli operatori tradizionali cercano di sfruttare, anche nel mercato del solare termico, Gli operatori tradizionali (si veda tabella 2.1), il loro marchio ampiamente riconosciuto e la capilossia quelle imprese che operano da diversi anni lare rete di distribuzione che hanno sviluppato da nel settore idrotermosanitario e che tempo nella filiera idrotermosanitaria, hanno ampliato la loro offerta agli in cui il cliente tipo è un privato citta“Nel 95% dei casi le aziende impianti solari termici, continuano dino o una famiglia. Questi operatori interessate ad installare a controllare poco più della metà credono fortemente e cercano di afun sistema solare termico di grande taglia vogliono (nello specifico il 55% nel 2009) del fermare sul mercato la soluzione del comunque pacchetti completi. mercato italiano di questi prodotti. kit per impianto solare termico (ossia Per questo noi offriamo sistemi che partono Il solare termico continua tuttavia un bundle dei componenti necessari dall’accoppiata bollitore ad avere un peso marginale rispetall’installazione dell’impianto, oppore pannello solare” to al loro complessivo portafoglio di tunamente dimensionati per determibusiness in Italia, rappresentando in Manager di un operatore tradizionale nate tipologie di impieghi) e puntano media il 9% del fatturato complessivo principalmente sul prezzo e sulla fiderealizzato nel 2009, almeno per quanlizzazione della rete di installatori per to riguarda gli operatori principali riportati in taguadagnare un vantaggio competitivo difendibile. bella 2.1. Più del 90% dei sistemi solari termici Essi continuano anche ad essere i player della fiAnche per quanto concerne gli operatori della filiera, le relative posizioni di forza e le determinanti del loro vantaggio competitivo, nel corso del 2009 non si rilevano delle sostanziali evoluzioni rispetto al quadro delineato nel Solar Energy Report 2008, al quale si rimanda quindi per approfondimenti e ulteriori dettagli. Tabella 2.1 I principali operatori tradizionali Impresa* Ricavi 2008 (mln e) Ricavi 2007 (mln e) Paese Ariston Thermo** Ferroli Riello Baxi Immergas Vaillant Schüco Viessmann Velux Buderus 1.189,6 615,6 574,0 277,3 195,3 149,6 124,3 101,7 89,3 48,9 1.200,8 630,0 549,4 280,1 214,7 148,3 96,0 83,9 93,5 45,3 Italia Italia Italia Inghilterra Italia Germania Germania Germania Danimarca Germania *I dati di fatturato e dei dipendenti sono riferiti alle attività in Italia **Ariston Thermo è il nuovo nome di Merloni TermoSanitari www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 133 2. IL SOLARE TERMICO sua attività, ha scommesso sul solare termico con l’effetto di aumentare il livello di occupazione in questa area di business di circa il 30% tra il 2008 e il 2009 ed innalzarne i ricavi da 24 a 28 mln E. Gli investimenti di cui si è parlato in questo paragrafo testimoniano come gli operatori tradizionali percepiscano il mercato del solare termico Diversi di questi produttori hanno ampliato la come un’attrattiva opportunità per differenziare propria capacità produttiva di sistemi e compoil proprio business negli anni futuri. Questo è in nenti per impianti solari termici nel corso del special modo vero per gli operatori stranieri (in 2009, ma nessuno degli operatori stranieri ha inparticolare tedeschi) che operano in via prioritaria vestito in nuovi impianti nel nostro Paese. Vaillant su mercati geografici in cui il solare termico è afferha inaugurato da circa un anno un nuovo impianto mato da anni ed ha prospettive di crescita particodi produzione di pannelli piani forzati e a svuotalarmente promettenti. Si rileva infine una leggera mento in Germania e, da qualche mese, un secondo riduzione della marginalità industriastabilimento in Francia dedicato allo le degli operatori tradizionali nel corstesso tipo di prodotto. Viessmann “Il prezzo è la principale so dell’ultimo anno, dovuta tuttavia ha aperto un nuovo stabilimento in variabile su cui si compete, dato che il nostro cliente agli effetti della crisi economica che li Cina nel corso del 2009, in cui circa è l’installatore. Non è l’utente ha costretti in molti casi ad abbassare 300 dipendenti sono impegnati nelfinale che sceglie l’impianto, la produzione di tubi sottovuoto. Per ma l’immobiliare che costruisce i prezzi di vendita per sostenere volul’abitazione e che, se potesse, mi e quote di mercato. il 2010 è prevista una produzione di l’impianto lo farebbe dipinto sul muro!” circa 650.000 tubi, che salirà nel 2012 Come illustrato nel Solar Energy a oltre un milione di pezzi, rendendo Amministratore delegato con ogni probabilità lo stabilimento di una grande impresa di progettazione Report 2008, si definiscono distribue installazione tori evoluti quegli operatori speciaViessmann di Dachang l’impianto lizzati nella distribuzione di compodi produzione di tubi sottovuoto per nenti per impianti solari termici, che sono presenti collettori solari più grande al mondo. Questi invein questo specifico mercato in Italia mediamente da stimenti avrebbero potuto essere perfino più conun numero maggiore di anni in confronto agli opesistenti se la crisi non avesse colpito duramente il ratori tradizionali (in alcuni casi da oltre 10 anni) mercato idrotermosanitario da cui queste imprese e che hanno una dimensione decisamente inferiore ricavano la parte più consistente dei propri ricavi, rispetto ad essi (si veda tabella 2.2). costringendo diversi player (tra cui Velux, Vaillant e Ferroli) a ridimensionare le proprie attività con Come già rilevato per il 2008, questi operatori conripercussioni non trascurabili anche sul proprio tinuano ad avere una quota del mercato italiano del organico attivo in Italia. Una dinamica particosolare termico prossima al 40%. I distributori solarmente interessante ha caratterizzato Riello, che lari puntano molto sullo sviluppo e sulla messa a proprio per far fronte alle ripercussioni negative punto di nuovi sistemi e componenti innovativi, che la crisi ha avuto sul settore principale della liera che detengono una posizione dominante nel campo delle installazioni di taglia maggiore, con in particolare Vaillant, Buderus e Viessmann che nel 2009 si sono mossi proattivamente per rafforzarsi su questo specifico segmento di mercato. Tabella 2.2 I principali distributori “evoluti” Impresa* Ricavi 2008 (mln e) Ricavi 2007 (mln e) Sonnenkraft Paradigma Solar Energy Italia Accomandita Kloben Idrosistemi Suntek 26,1 25,6 15,4 10,1 6,9 6,6 4,1 22,4 21,2 10,1 14,2 5,2 7,2 4,3 *I dati di fatturato e dei dipendenti sono riferiti alle attività in Italia 134 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 2.4 La filiera Box 2.3 Paradigma Paradigma è stata fondata in Germania nel 1988 con la missione di inaugurare un nuovo modo di fare energia, basato sul rispetto dell’ambiente assicurato attraverso la messa a punto e l’uso delle più sofisticate tecnologie. Attualmente Paradigma è una delle principali aziende tedesche nei settori delle caldaie a pellet di legno e, soprattutto, del solare termico, con una forte presenza anche in Italia, dove opera secondo il modello di business del distributore evoluto. Paradigma è anche leader di mercato nel segmento dei collettori solari sottovuoto e pioniere negli impianti termici con caldaie a condensazione. La sede principale in Italia si trova a Darzo, in Provincia di Trento, ed è attiva dal 1998. Sono inoltre operative una filiale a San Germano Chisone, in Provincia di Torino, una a Calcinato in Provincia di Brescia, una a Marcon in Provincia di Venezia e due uffici commerciali a Milano e Macerata. Dal 2009 l’im- presa, oltre alla commercializzazione di impianti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, è attiva in Italia anche nelle applicazioni di solar cooling, per le quali un primo embrionale mercato sembra profilarsi. Nel 2008, circa il 50% dei ricavi totali di Paradigma in Italia sono stati associati alle sue attività nel campo del solare termico, mentre nel 2009 la percentuale si è leggermente ridotta, attestandosi sul 43%. Nel corso del 2009 Paradigma in Europa ha venduto oltre 138.000 metri quadrati di pannelli solari termici. Il mercato di Paradigma non si limita tuttavia alla sola Europa. Nel 2001 l’impresa tedesca ha infatti dato vita ad una joint venture con un’azienda cinese per la produzione di pannelli solari sottovuoto ed è oggi presente in Cina con 800 negozi in franchising, che hanno complessivamente venduto 1.500.000 metri quadrati di pannelli, con una media di circa 2.000 impianti al giorno. sfruttando le loro competenze interne di progettazione e di sviluppo industriale. Diversi di questi operatori sono anche integrati a monte e producono internamente questi componenti innovativi, sia in Italia (come accade per alcune realtà di piccole dimensioni, tra cui Kloben e Costruzioni Solari) che all’estero (come è il caso dei distributori evoluti stranieri, quali Paradigma o Sonnenkraft, che operano nel nostro Paese solamente attraverso filiali commerciali). In particolare Kloben, nella seconda parte del 2008, ha ampliato il suo stabilimento produttivo di Verona e, a partire dal 2009, ha iniziato a produrre in house i suoi boiler ad alte prestazioni, divenendo così uno dei pochi distributori evoluti in grado di fornire un prodotto completamente realizzato internamente. È interessante rilevare come, a detta degli operatori intervistati, i distributori evoluti abbiano guardato con crescente interesse il segmento degli impianti solari di grandi dimensioni e per applicazioni industriali, dove hanno cominciato a mettere a frutto le loro elevate capacità tecniche e progettuali fornendo al cliente un servizio integrato di progettazione e di assistenza tecnica. Ciononostante, questo segmento di mercato rimane molto circoscritto in Italia in termini di volumi complessivi (si registra un numero limitato di impianti realizzati in centri sportivi, alberghi, case di riposo, ospedali, con infrequenti applicazioni ai processi produttivi) e gli operatori tradizionali vi detengono ancora le quote più consistenti. Questo maggiore interesse alle applicazioni industriali del solare termico da parte dei distributori evoluti era stato anticipato anche nel Solar Energy Report 2008. È inoltre interessante rilevare come, a detta degli intervistati, il 2009 rappresenti il primo anno in cui il mercato italiano ha dimostrato interesse per i sistemi di solar cooling, almeno in termini di richieste di preventivi pervenuti agli operatori di mercato. Chiaramente si tratta di un segmento di applicazione della tecnologia solare termica ancora in uno stadio molto embrionale del suo sviluppo, come accennato prima in questa sezione, in cui però i distributori evoluti sembrano essersi mossi in anticipo e con più decisione rispetto agli operatori tradizionali. Kloben ha ad esempio installato circa 10 impianti di questo tipo (di cui oltre il 70% nel corso del 2009) per una potenza che supera gli 800 kWth. Anche Paradigma (si veda box 2.3) è attiva in questo comparto e ha partecipato alla progettazione ed installazione dell’impianto realizzato presso l’Università di Milano-Bicocca, di cui si è parlato nel box 2.2. Bisogna tuttavia sottolineare che ad oggi le applicazioni di solar cooling presenti in Italia sono relative ad impianti di taglia medio-grande, in cui le forti competenze tecniche e di progettazione dei distributori evoluti possono fare la differenza. In futuro, nel momento in cui queste macchine si dovessero diffondere in modo consistente sul mercato residenziale, come d’altronde è auspicabile che avvenga per i vantaggi ambientali e di risparmio energetico che assicurano, il posizionamento dei distributori evoluti potrebbe essere messo in crisi dalla capillarità della rete di distribuzione e dalla riconoscibilità del marchio degli operatori tradizio- www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 135 2. IL SOLARE TERMICO nali, oltre che dagli operatori della filiera elettrica (produttori e installatori di climatizzatori). Mentre non emergono considerazioni rilevanti in merito a quegli operatori che nel Solar Energy Report 2008 erano stati identificati come installatori evoluti, alcuni aspetti relativi alla dimensione internazionale del mercato solare termico, che non erano stati affrontati nel precedente rapporto di ricerca, meritano di essere approfonditi. Si rileva in particolare che la domanda italiana di collettori solari è stata coperta, nel corso del 2009, per circa il 65% attraverso prodotti realizzati in Paesi europei ed extraeuropei, e solo per il 35% da produzione nazionale. A questo si aggiunge un altro dato interessante, che riguarda la percentuale (pari a circa il 18%) di prodotti e componenti fabbricati in Italia che nel 2009 sono stati esportati. Ciò è il risultato di decisioni strategiche messe in atto anche da alcune piccole e medie imprese italiane, che hanno cominciato ad aggredire con i loro prodotti i mercati sia europei che extraeuropei (Costruzioni Solari sta attualmente lavorando ad una partnership con un importante operatore per entrare in diversi mercati europei, ma commercializza già i suoi prodotti in Centro America e Medio Oriente. Kloben realizza una quota non marginale del suo fatturato all’estero, soprattutto nell’Est Europa). Anche Riello, in modo analogo ad altri operatori tradizionali, ha cominciato a vendere i propri collettori piani in Francia e Spagna e sta valutando le opzioni percorribili per fare lo stesso con l’Inghilterra e l’Est Europa. Questi dati sull’import-export suggeriscono che gli operatori italiani incontrano serie difficoltà a conquistarsi significative fette del mercato interno e che la competizione degli operatori stranieri è particolarmente sentita, con ripercussioni negative sulla profittabilità degli operatori. 136 In conclusione, è ragionevole attendersi che il mercato italiano del solare termico, in termini di volumi di mercato, posizioni di forza relative dei principali operatori e tecnologie in gioco, non subirà nei prossimi 3-5 anni delle profonde evoluzioni. Questo fino a quando quelle applicazioni più promettenti di cui si è parlato in queste pagine, quali gli impieghi a medio-alta temperatura nei processi industriali e il solar cooling, non prenderanno piede nel nostro Paese. Quando ciò accadrà, si assisterà probabilmente a dei rilevanti cambiamenti, oltre che nei volumi di vendita di collettori solari, anche nelle posizioni di forza e nel ruolo dei distributori evoluti e degli operatori tradizionali, con l’eventualità che ciascuno di essi si focalizzi maggiormente sul segmento di mercato più affine alle proprie competenze e perciò a maggiore attrattività. Affinché questo scenario si realizzi, è tuttavia necessario che le istituzioni rinnovino le agevolazioni già esistenti per gli impianti solari termici e intervengano direttamente a favore delle applicazioni di cui si è parlato, introducendo ad esempio specifiche sovvenzioni per l’installazione di impianti di solar cooling, adeguando la normativa tecnica vigente alle specificità dei grandi impianti solari termici, stimolando la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale su queste tecnologie. Quanto convenga destinare risorse pubbliche a questo tipo di interventi dipende da considerazioni di natura prettamente politica e da quanto le istituzioni ritengono il solare termico una tecnologia in grado di contribuire in modo tangibile al soddisfacimento degli impegni presi dall’Italia in sede europea. Le analisi presentate in questa sezione offrono sperabilmente degli spunti per impostare queste valutazioni in modo critico e fondato sui dati e i pareri degli operatori. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano IL solare termodinamico 3.1 La tecnologia 3.1.1 Un anno di crescita degli investimenti in sviluppo tecnologico… nonostante la crisi Il 2009 è stato indubbiamente un anno di svolta per il solare termodinamico, per una serie di ragioni: Come conseguenza, lo sviluppo tecnologico del settore ha mosso un deciso passo in avanti, riservando in realtà non poche sorprese. Il comparto del solare termodinamico, infatti, è ancora in una fase quasi “embrionale” di sviluppo e, in assenza di standard tecnologici consolidati quali ad esempio quelli che caratterizzano l’impiantistica elettrica di potenza per le fonti “tradizionali”, ogni nuovo progetto viene gestito in ottica di commessa e diviene occasione di sperimentazione di nuove soluzione tecnologiche e ingegneristicoimpiantistiche. Tecnologie apparentemente relegate a ruoli marginali possono quindi prendere nuovo vigore qualora si presenti la disponibilità concreta di un sito di applicazione. Gli impianti solari termodinamici possono essere classificati a seconda della modalità di captazione della luce solare in quattro tipologie1: • innanzitutto per la più decisa ripresa – dopo i timidi segnali del 2008 – della installazioni di nuovi impianti, con 150 MW di nuova potenza elettrica entrata in esercizio nel corso dell’anno, cui si sommano un numero significativo di “annunci” (quali ad esempio quello relativo ad una serie di impianti in India, nella Regione del Gujarat, per un totale di oltre 3 GW di potenza, o quello che fa riferimento ai 2 GW in progetto a Penglai City in Cina). Ripresa che è tanto più significativa se si tiene • gli impianti a concentratore parabolico lineaconto che il 2009, con il degenerare della sire (parabolic trough), che rappresentano ancora tuazione economica globale, è stato un annus oggi la grande maggioranza degli impianti in horribilis soprattutto per i settori industriali esercizio e che sono caratterizzati da lunghe file capital intensive; di specchi parabolici che ruotano attorno ad un • per i sommovimenti che si sono registrati tra asse e che concentrano la luce solare i grandi impiantisti e che hanno su un tubo ricevitore nel quale scorportato ad esempio Siemens – dopo “Le torri solari sono una tecnologia re un fluido cosiddetto termovettouna accesa battaglia “al rialzo” in Germania negli anni ’80. re. Il fluido ha il compito appunto di con altrettanti colossi del calibro nataSarà importante capire di Areva e Alstom – ad acquisire come la utilizzeranno le imprese “condurre” il calore generato verso nel novembre del 2009, per circa americane nel corso del 2010” scambiatori di calore ove si produ310 mln €, l’israeliana Solel Solar Marketing Manager di un importante ce vapore surriscaldato, successivaEPC mente espanso in turbine a vapore System specializzata nella produ“tradizionali” per la produzione di zione di tubi ricevitori per impianti energia elettrica; solari termodinamici; • gli impianti a ricevitore centrale (solar tower) • per il peso “politico” che il piano energetico che si configurano come una distesa di specchi di Barack Obama, neo-eletto presidente USA, piani concentratori (detti eliostati) che puntano ha voluto attribuire al settore e che – come si ad un “fuoco” posto sulla sommità di una torre vedrà meglio più avanti nel capitolo 3.3 – ha di altezza variabile fra 60 e 100 metri. Anche in fortemente incrementato il numero di imprese questo caso il calore convogliato viene “scamdisposte a “scommettere” sugli sviluppi del sobiato” per la produzione di vapore surriscaldato lare termodinamico. 1 Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 135 -142. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 139 3. IL SOLARE TERModinamICO da inviare in turbina. A differenza del caso precedente, tali sistemi sono in grado di raggiungere temperature più elevate (fino a 1000 °C, contro i 500° C dei parabolic trough) e quindi – almeno potenzialmente – efficienze di conversione superiori; • gli impianti a concentratore a disco parabolico (parabolic dish) caratterizzati da uno specchio parabolico che concentra i raggi solari su un ricevitore posto nel fuoco, ove avviene direttamente – mediante un piccolo motore alternativo a ciclo Stirling – la generazione di energia elettrica. Il vantaggio principale di questi sistemi è la ridotta dimensione relativa, con la possibilità di avere unità indipendenti con taglie dell’ordine di qualche decina di kW (contro le decine di MW degli impianti a torre o parabolici lineari), cui tuttavia fanno da contraltare costi di installazione superiori a 10.000 €/kW (quasi il doppio di quanto registrato ad esempio per i parabolic trough); • gli impianti a concentratore lineare di Fresnel, dal nome della particolare conformazione ottica degli specchi utilizzati per la concentrazione dei raggi solari, che hanno il vantaggio – per ora solo verificato su siti sperimentali – di un minor costo di investimento a parità di potenza e di rendimento atteso. In riferimento alle diverse tipologie di impianti, l’indagine presentata nel Solar Energy Report 2008 suggeriva come la tecnologia dei parabolic trough avesse conquistato, e fosse destinata a conservare, un’indiscussa leadership nel settore, con i solar tower relegati ad un ruolo marginale così come i parabolic dish (legati semmai ad un poco probabile diffondersi del termodinamico come soluzione per la “generazione distribuita” di energia). Particolarmente promettente apparivano essere di contro gli impianti a concentratore lineare di Fresnel, sullo sviluppo dei quali si scommetteva per il raggiungimento di livelli di efficienza maggiori. Nel corso dell’anno 2009 si è stati costretti a rivedere queste previsioni (come si evince dalla figura 3.1 che fornisce un confronto tra il 2008 e il 2009): • confermando, anche se su valori meno elevati, il predominio dei parabolic trough, sui quali tuttavia (si veda paragrafo 3.1.2) molto si è investito per ridurre i costi del campo solare ed incrementarne l’efficienza; • rivalutando significativamente il ruolo degli impianti solar tower, destinati secondo le nuove previsioni a contare per circa un quarto del mercato nei prossimi 5-10 anni. A giocare qui un ruolo chiave è stata la ripartenza del mercato americano, ove la grande disponibilità di territori aridi e pianeggianti (condizione necessaria per una efficace disposizione degli eliostati) mette in ulteriore risalto, in pratica rendendolo economicamente vantaggioso, il divario nell’efficienza di produzione elettrica che differenzia questo tipo di impianti dai parabolic trough; • riducendo (e non di poco) le aspettative sugli impianti Fresnel, come effetto combinato di un maggior ritardo nello sviluppo di questa tecnologia e del “balzo” che gli impianti di cui ai Figura 3.1 Ripartizione per tecnologia degli impianti solari termodinamici realizzati e in progetto Dati al 31/12/2008 Dati al 31/12/2009 1% 7% 14% 32% 58% 78% 8% Fresnel reflector 140 Parabolic dish Parabolic trough www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Solar tower 2% 3.1 La tecnologia Figura 3.2 Ripartizione dei costi del campo solare per un impianto solare termodinamico con tecnologia parabolic trough da 50 MW 28% 22% Struttura di sostegno 30% Specchi Tubo collettore 20% Attuatori, piping e sistemi di controllo punti precedenti hanno invece registrato a seguito del rinnovato interesse dei grandi operatori del settore. In altre parole, a fronte dei concreti miglioramenti registrati nei parabolic trough e nei solar tower, viene sempre più messa in discussione l’effettiva possibilità – al di là del “fascino” tecnologico della soluzione Fresnel – di raggiungere livelli di costo e profittabilità attesa che li rendano effettivamente competitivi sul mercato; • sospendendo (anche per l’anno 2009) il giudizio sui parabolic dish, per i quali non si è ancora in grado di valutare quanto concreta sia la possibilità che si affermi una modalità di impiego distribuita della tecnologia solare termodinamica per taglie di impianto che, però, andrebbero in diretta competizione con il fotovoltaico. costi, sia di investimento che di gestione e manutenzione, di questo tipo di impianti. Il campo solare, ovvero l’insieme degli specchi parabolici lineari e del sistema di tubi ricevitori entro i quali scorre il fluido termodinamico che serve a trasferire in turbina il calore generato dal sole, costituisce da solo circa il 54% del costo complessivo dell’impianto. Per un impianto da 50 MW, il campo solare richiede investimenti dell’ordine di 105 mln € (corrispondenti a poco più di 2 mln € al MW). Se si analizzano poi i pesi relativi delle diverse componenti del campo solare è possibile ricostruire la situazione riportata in figura 3.2, ove si nota che gli specchi veri e propri pesano per circa il 20% del totale, così come al 22% si arresta il contributo al costo di investimento del tubo ricevitore. I costi “accessori”, ovvero quelli legati alle strutture di soste3.1.2 La struttura dei costi gno degli specchi solari – particolarmente comdi un impianto parabolic trough plesse giacché non soltanto devono sopportarne il peso, ma devono anche limitare al Come evidenziato nel paragrafo preminimo le deformazioni del materiacedente, gli impianti solari termodi- “E’ prioritario per noi intervenire le riflettente e contrastare l’effetto del sui materiali e sui processi namici che impiegano la tecnologia vento per mantenere una efficienza produttivi delle strutture di sostegno degli specchi, parabolic trough rappresentano olottica di concentrazione adeguata 2 che hanno un impatto significativo tre il 64% della potenza installata ed sui costi complessivi del campo - e al sistema di posizionamento e collegamento al resto dell’impianin progetto. Inoltre, anche i tre imsolare e su cui esiste un ampio margine di miglioramento” to, contribuiscono invece per oltre pianti realizzati nel corso del 2009, di cui si daranno maggiori dettagli nel Amministratore delegato di un’impresa il 58% del totale. componenti per impianti capitolo 3.3, hanno adottato questa produttrice ditermodinamici Se poi si prende in esame l’impianto soluzione costruttiva. E’ interessante solare termodinamico nel suo comquindi, anche in considerazione della plesso, ai costi del campo solare è necessario agmaggiore disponibilità di dati recenti, approfongiungere ulteriori voci di costo relative: dire il tema di come è articolata la struttura dei 2 Basti pensare che in un impianto da 50 MW collocato in un’area ove l’irraggiamento solare diretto è del’ordine dei 1.800 Kwh/m2 al’anno, una perdita di un punto percentuale di efficienza porta ad una riduzione del valore dell’energia (valorizzata a 0,36 €/kWh tenendo conto del sistema di incentivazione) complessivamente prodotta durante la vita dell’impianto pari a oltre 6,5 mln €, ovvero pari a oltre il 6% dell’investimento necessario per la realizzazione del campo solare. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 141 3. IL SOLARE TERModinamICO • al sistema di accumulo termico, in pratica il “serbatoio” per il fluido termodinamico, che “conserva” parte dell’energia generata sotto forma di calore con il duplice obiettivo di assicurare la stabilità del funzionamento dell’impianto anche a fronte di brusche variazioni delle condizioni meteorologiche (ad esempio per il passaggio di corpi nuvolosi) e la continuità di funzionamento per un numero di ore (tipicamente 6 o 8) maggiore rispetto al periodo di effettiva insolazione. L’accumulo termico ha in media un impatto che varia dal 10% al 20% del costo totale, in funzione del dimensionamento, del tipo di soluzione utilizzata (a singolo oppure a doppio serbatoio) e del fluido termodinamico impiegato; • al fluido termodinamico, che può essere costituito da sali fusi o oli diatermici, che contribuisce per un ulteriore 4% circa ai costi totali d’impianto; • alle turbine a vapore che, insieme agli impianti tecnici annessi, costituiscono il cosiddetto power block, ovvero il “nucleo” di trasformazione del calore in energia elettrica, e che incidono per circa l’8% del costo totale; • alle opere civili di predisposizione del sito e alle attività di EPC (Engineering Procurement and Construction), che impattano per un ulteriore 15% circa del totale. Nel complesso, la messa in esercizio di un impianto solare termodinamico con parabolic trough da 50 MW richiede in media un investimento pari a 200 mln € (equivalente a 5 mln € al MW), cui vanno aggiunti circa 2 mln € all’anno per la manutenzione e la gestione, e garantisce in un’area a insolazione medio-alta, per almeno 30 anni, una produzione di oltre 110.000 MWh/anno di energia elettrica. Il costo di produzione dell’energia elettrica attraverso questo tipo di impianto (tenendo conto degli effetti di “ammortamento” dell’investimento iniziale attraverso il calcolo del LEC – Levelized Energy Cost) risulta pari a poco più di 20 c€/ kWh, valore ancora lontano dai 6,5 c€/kWh che rappresentano il benchmark per il costo di produzione di energia elettrica da fonti fossili, ma allo stesso tempo decisamente inferiore ai 27 c€/kWh assicurati ad esempio dalle attuali tariffe incentivanti in vigore in Spagna. 3.1.3 Le potenzialità degli impianti parabolic trough: verso la grid parity? Nel paragrafo precedente si è presentata la situazione attuale degli investimenti necessari per realizzare un impianto solare termodinamico con la tecnologia parabolic trough. I progressi dell’ultimo anno, tuttavia, spinti anche dal già citato rinnovato interesse da parte dei grandi operatori del mondo dell’impiantistica di potenza, permettono di tracciare un quadro di sviluppo futuro estremamente interessante. Innanzitutto, esiste un consenso abbastanza ampio fra gli operatori del settore in merito alla possibilità di ridurre significativamente i costi del campo solare. Se è infatti vero che sui sistemi di accumulo e soprattutto sul power block gli spazi di manovra sembrano essere molto limitati, trattandosi di tecnologie relativamente mature, buona parte dei componenti del campo solare sono ancora realizzati “su commessa” ed hanno un grado di standardizzazione tecnologica piuttosto limitato. Inoltre, la taglia degli impianti realizzati più di recente (50 MW) sembra essere ancora lontana dalla dimensione ottimale dal punto Figura 3.3 Ripartizione dei costi del campo solare per un impianto solare termodinamico con tecnologia parabolic trough da 400 MW Struttura di sostegno e fondazioni 22% 22% 34% Specchi Tubo collettore 22% Attuatori, piping e sistemi di controllo 142 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.1 La tecnologia attuali), ma soprattutto gli operatori si stanno di vista tecnologico, che è invece nell’ordine dei concentrando sul migliorare il contributo di 400 MW, ovvero almeno 8 volte superiore. questi sistemi all’incremento dell’efficienza deAnche se impianti così grandi (un impianto da 400 gli impianti solari termodinamici MW richiede un campo solare di circa nella produzione di energia elet2,2 chilometri quadrati, contro i circa “La grid-parity nel 2020? trica. Se è vero, infatti, che strutture 200.000 metri quadrati necessari per E’ un obiettivo a cui dobbiamo più leggere e meno costose hanno un un impianto da 50 MW) sono evidentutti puntare, e che può temente destinati ad incontrare forti essere raggiungibile sfruttando impatto positivo sugli investimenti le notevoli economie di scala necessari per realizzare le fondazioni problemi di localizzazione, l’analisi e di esperienza che si condotta ha messo in evidenza come manifesteranno nei prossimi anni” dell’impianto e sulla potenza richiesta dai sistemi di posizionamento, è il risparmio che si potrebbe otteneMarketing Manager di un’impresa meccanica attiva nel settore altrettanto vero che potrebbe essere re per effetto “scala” è pari in media termodinamico più auspicabile assicurare minori al 26% dell’investimento iniziale. perdite di efficienza dovute a deforIl costo del campo solare passerebbe mazioni o errati posizionamenti (soprattutto in così dagli attuali 5 mln € al MW a poco più di 3,7 siti ad elevato irraggiamento), attraverso l’utilizzo mln € al MW, con una ridistribuzione dei pesi di sistemi di supporto e posizionamento migliori4 . delle diverse componenti quale quella rappresenSe si tiene conto anche di questo effetto, non è irtata in figura 3.3. ragionevole ipotizzare livelli di LEC per gli impianti parabolic trough che, nel corso dei prosAppare evidente la riduzione del peso relativo di simi 10-12 anni, si avvicinino ai 4-6 c€/kWh, quei componenti, quali ad esempio gli attuatori valori del tutto confrontabili con la produzione e la parte idraulica di connessione, per i quali i di energia elettrica da fonti tradizionali. benefici di costo rispetto alla situazione attuale sono stimati nell’ordine del 40%. Il passaggio Il solare termodinamico sembra quindi destinato poi da una produzione “su commessa” ad una a rappresentare una delle fonti energetiche che produzione “in serie”, conseguenza diretta della nel medio periodo si affiancheranno, ovviamencrescita del settore (di cui sarà dato miglior conte in quei Paesi la cui latitudine e conformazione to nel capitolo 3.3), dovrebbe portare secondo territoriale lo consentiranno, con l’analisi condotta ad una riduzione sempre maggior forza alle fonti di circa il 20% anche per i costi di fossili per la produzione di energia realizzazione degli specchi e della “Il progetto Desertec elettrica a costi competitivi. relativa struttura di supporto. è una sfida da cogliere non solo per i Paesi in via L’effetto congiunto di queste riduziodi sviluppo e per le grandi Per il raggiungimento degli obiettivi ni – che anche con il conforto di almultinazionali, ma anche per le imprese italiane di costo sopra identificati, tuttavia, tri analisti del settore3 sembra essere che stanno cercando un posto possibile entro i prossimi 5-8 anni, appare imprescindibile uno sforzo al sole in questo settore” ovvero al raggiungimento di una “reale” in ricerca e sviluppo e nell’auMarketing Manager di un’impresa nuova potenza installata complesmento della capacità installata che italiana produttrice di componenti siva superiore a 1 GW – porterebbe funga da “banco di prova” delle ipoil costo dell’energia prodotta da imtesi fatte sulle potenzialità di sviluppo pianti parabolic trough a circa 15 c€/kWh. tecnologico. In questo contesto – pur se non scevri da innumerevoli problemi sia di natura geo-politica In realtà, all’effetto “scala” appena discusso va che di natura tecnico-economica (ad esempio legaassociato un altro elemento almeno altrettanti all’enorme costo infrastrutturale per il trasporto to importante, relativo all’attività di ricerca e dell’energia) – vanno considerati con interesse tutti sviluppo soprattutto sul fronte delle strutture quei progetti, quali ad esempio il Desertec (si veda di supporto e dei sistemi di posizionamento. I box 3.1), che vanno nella direzione di aumentare la margini di miglioramento sono anche qui estreconsapevolezza tra gli operatori e i policy maker in mamente elevati (nell’ordine del 20-30% dei costi merito alle potenzialità del solare termodinamico. Presentazione “Trends In CSP Technology”, Convegno “SolarPACES 2009”, 18 settembre 2009, Berlino. In un impianto da 400 MW, un punto in più di efficienza nella trasformazione dell’energia solare in energia elettrica comporta una produzione maggiore di quasi 9.000 MWh all’anno. 3 4 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 143 3. IL SOLARE TERModinamICO Box 3.1 Il Progetto Desertec Il progetto Desertec, nato sotto gli auspici del Club di Roma e della Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC), ha l’obiettivo di sfruttare le più recenti tecnologie solari e termodinamiche e le peculiari condizioni ambientali delle aree desertiche dell’Africa Settentrionale e del Medio Oriente per soddisfare il 15% della domanda di energia elettrica in Europa al 2050 e, in aggiunta, coprire una parte sostanziale dei fabbisogni energetici dei Paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). L’energia prodotta raggiungerà l’Europa mediante cavi a corrente continua ad alta tensione (HVDC - High Voltage Direct Current) con perdite complessive limitate al 10-15%, la cui posa rappresenta indubbiamente uno degli aspetti più critici dell’intero progetto. 144 La Desertec Foundation, che coordina il progetto e conta sulla collaborazione tra i Paesi della aree interessate, prevede un investimento complessivo stimato nell’ordine dei 400 mld €. Nel mese di novembre 2009 è stato siglato l’accordo che sancisce l’avvio ufficiale dell’iniziativa, che si avvale della collaborazione di 12 società riunitesi sotto il nome di Desertec Industrial Initiative: ABB, Abengoa Solar, Cevital, Deutsche Bank, E.ON, HSH Nordbank, Munich Re, M+W Zander, RWE, Schott Solar, Siemens e Solar Millennium. Recentemente, altre 5 imprese, provenienti dalla Francia, dall’Italia, dal Marocco, dalla Spagna e dalla Tunisia, i cui nomi saranno ufficializzati nei prossimi mesi, hanno dichiarato la propria intenzione a partecipare al progetto. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.2 La normativa Rispetto a quanto riportato nel Solar Energy Report 2008, non si segnalano modifiche di rilievo per quanto riguarda la normativa che in Italia regola il settore del solare termodinamico. Il dispositivo legislativo attualmente in vigore è contenuto, infatti, nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici” dell’11 aprile 2008 che definisce: • la tariffa incentivante da riconoscere per un periodo di 25 anni per gli impianti in esercizio (si veda tabella 3.1) sulla base dell’energia elettrica prodotta e dell’effettivo contributo - trattandosi solitamente di impianti ibridi5 - della componente solare termodinamica; • le caratteristiche degli impianti che possono accedere a questa forma di incentivazione. In particolare, vengono fissati dei criteri relativi: al dimensionamento minimo dell’impianto (2.500 metri quadrati di superficie captante, equivalenti a circa 4 MW di potenza, che salgono a 25.000 metri quadrati nel caso di impianti ibridi); al dimensionamento minimo del sistema di accumulo termico (1,5 kWth per ogni metro quadrato di superficie captante); al tipo di fluidi termovettori utilizzati (con ad esempio il divieto dell’impiego di oli dielettrici); e alle modalità di allaccio alla rete elettrica, che deve avvenire con un unico punto di connessione; • gli obiettivi nazionali di potenza solare ter- modinamica da installare entro il 2016, pari a circa 2 mln di metri quadrati di superficie captante (equivalente circa a 270 MW), di cui però solo 1,5 mln potranno avere accesso alle tariffe incentivanti. Non ci si può però esimere dal far notare che – nonostante l’impianto legislativo sia particolarmente articolato ed entri con estremo dettaglio nella definizione delle specifiche degli impianti di cui si auspica l’installazione in Italia – la legge è al momento completamente inapplicata visto che, come si vedrà meglio nel capitolo 3.3, non vi sono impianti solari termodinamici in funzione sul nostro territorio. Il raggiungimento poi di 270 MW di potenza installata entro il 2016 appare una sfida quanto mai ambiziosa (per usare un eufemismo), se si considera che l’unico impianto attualmente in costruzione, e che ha preso le mosse nell’ormai lontano 2001, è “Archimede”. Nonostante questo, ed almeno per il momento6 , il Governo sembra voler tener fede agli impegni presi, mantenendo impegnate le risorse per il finanziamento del solare termodinamico. La situazione appena descritta, ove alla presenza di meccanismi di incentivazione anche interessanti sul piano economico non corrisponde un adeguato sviluppo delle installazioni, non è però una eccezione italiana, ma pare essere anzi una “regola” in Europa. Tabella 3.1 Tariffa incentivante per il solare termodinamico Tipologia impianto Incentivo (€/kWh) Impianto in cui la frazione solare sia superiore all’85% Impianto in cui la frazione solare sia compresa tra il 50% e l’85% Impianto in cui la frazione solare sia inferiore al 50% 0,28 + vendita energia 0,25 + vendita energia 0,22 + vendita energia Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 135 -142. In particolare il 14 luglio 2009 è stato approvato in Senato un emendamento (poi corretto ed eliminato) ad una proposta di legge sulle rinnovabili che prevedeva l’esclusione del solare termodinamico dalle fonti che hanno diritto a ricevere incentivi per l’energia prodotta. 5 6 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 145 3. IL SOLARE TERModinamICO Box 3.2 Il Piano Obama e gli incentivi per gli impianti solari termodinamici negli USA Il presidente Obama ha introdotto nel luglio 2009, come parte delle misure per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, il Renewable Portfolio Standard (RPS), ovvero un livello minimo di produzione di energia elettrica – con l’obiettivo fissato a livello federale di raggiungere il 25% al 2025 – da fonti rinnovabili cui sono obbligate tutte le utilities americane. L’RPS, secondo gli esperti, crea condizioni particolarmente favorevoli per la diffusione su larga scala della produzione di energia elettrica da solare termodinamico, che – tenuto conto della conforma- zione territoriale degli USA – è di gran lunga la tecnologia che permette di installare impianti di produzione di energia elettrica “rinnovabile” con i maggiori livelli di potenza. A supportare le nuove installazioni – entro la fine del 2010 si prevede l’avvio di progetti per 40 impianti in 7 Stati, per un totale di 10,6 GW di potenza – vi è anche la possibilità di accedere, sino a tutto il 2013, ad una detrazione fiscale del 30% sulle attività collegate allo sviluppo di impianti di produzione di energia che utilizzano tecnologie rinnovabili. In Germania, ove gli incentivi messi a disposizione per remunerare l’energia elettrica prodotta dagli impianti solari termodinamici sono i più alti d’Europa con oltre 30 c€/kWh (che diventano circa 29 nel 2010), la potenza effettivamente installata è attorno a 1,5 MW in un impianto di testing a Jülich, nella zona nord ovest della Germania. Anche in Grecia, che pure ha tariffe incentivanti nell’ordine di 25 c€/kWh, il solare termodinamico non ha ancora applicazioni concrete. Interessante è anche il caso della Francia, che ha deciso di puntare sul sostegno ad impianti medio-piccoli (con taglie inferiori ai 12 MW, per i quali sono previsti incentivi di 30 c€/kWh), ma dove la potenza installata non supera complessivamente i 14 MW. Le ragioni di una simile situazione vanno ricercate nelle peculiarità degli impianti solare termodinamici, che richiedono caratteristiche del sito di installazione particolari, sia dal punto di vista dell’insolazione (che non soltanto deve essere significativa ma anche sufficientemente continuativa nel tempo, il che sfavorisce decisamente la Germania e, almeno in parte, la Francia), sia soprattutto dal punto di vista della morfologia del territorio (che dovrebbe essere pianeggiante e con una scarsa densità di insediamenti, condizione ad esempio assai difficile da incontrare in Grecia). Il Paese europeo ove si concentrano (si veda in merito anche il capitolo 3.3) le maggiori aspettative in termini di installazioni solari termodinamiche è senza dubbio la Spagna, che ha invece a disposizione diversi siti con caratteristiche adatte agli impianti solari termodinamici. Qui è la normativa, invece, a giocare il ruolo di “freno” allo sviluppo del settore, in seguito all’introduzione di un tetto alla potenza massima incentivabile pari a 500 MW, già ampiamente superata se si considerano gli impianti in esercizio (231 MW) e quelli in via di completamento (1.417 MW). 146 Le aspettative di crescita del solare termodinamico nel bacino del Mediterraneo sono tuttavia rinvigorite dall’affacciarsi di Paesi quali la Turchia – candidata ad entrare nell’Unione Europea nel 2015 – e l’Algeria, che hanno allo studio, con previsione di entrata in vigore entro il 2011, sistemi di incentivazione per gli impianti solari termodinamici estremamente redditizi (tenendo anche conto delle condizioni di insolazione): rispettivamente, tariffe feed-in di 24 c€/kWh per i primi 10 anni di esercizio e 20 c€/kWh per i successivi sino al ventesimo anno, e una maggiorazione di almeno il 160% del prezzo di vendita dell’energia al kWh rispetto al valore fissato per le fonti tradizionali. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.3 Il mercato Il Solar Energy Report 2008 dava conto dei timidi tre il confronto delle installazioni anno su anno segnali di ripresa delle installazioni di impianti sovede un +115% rispetto all’anno precedente. Il lari termodinamici dopo il lungo “sonno” seguito solare termodinamico conta quindi ad oggi una all’entusiasmo del progetto SEGS, con le nove inpotenza installata totale a livello globale di 655 stallazioni che dal 1984 al 1990 hanno interessato MW – contro i 500 MW della fine del 2008 ed i la California7. Soprattutto si sottolineava l’apparire 430 MW del 2007 – e garantisce una produzione sulla scena mondiale della Spagna come attore di di energia elettrica annua intorno a 1.400 GWh. riferimento per questo settore, non soltanto perché Se si considera poi che nel corso del 2009, anno di lì si erano realizzati tre dei quattro impianti che profonda crisi finanziaria, i soli nuovi impianti avevano visto la luce a partire dall’anno 20018 , ma solari termodinamici entrati in esercizio hanno anche perché spagnole sono le principali imprese richiesto investimenti per circa 600 mln €, ci si che operano ormai su scala mondiale nell’ambito rende conto della “portata” del fenomeno di credel solare termodinamico (Abengoa, Iberdrola e scita che ha interessato il settore. Acciona, solo per citare alcuni nomi). Nel corso del 2009 la posizione della Ancora più interessanti appaiono le “Per quanto gli Spagnoli Spagna si è ulteriormente rafforzata previsioni di crescita per i prossimi a rimanere leader con la messa in funzione di tre nuo- continueranno 10 anni. La nuova potenza installata indiscussi nel termodinamico? vi impianti (si vedano box 3.3, 3.4 e si stima possa raggiungere i 18,6 GW Io credo ancora per poco” 3.5), con tecnologica parabolic trough, al 2020 (si veda figura 3.4), con gli Marketing Manager dei uno dei più importanti produttori ciascuno con una potenza da 50 MW: USA a dominare il mercato con oltre il di collettori solari 55% del totale – come risultato del già • l’Andasol 2, “gemello” dell’Andasol analizzato nuovo corso della politica 1 (entrato in funzione nel 2008), che ha fatto deldi Obama – ed il “balzo” dei Paesi asiatici (India e la provincia di Granada una delle principali aree Cina in testa) che con 5 GW di installazioni attese di sviluppo del solare termodinamico in Europa, si piazzano al secondo posto, doppiando l’Europa con 100 MW totali di potenza installata; “ferma” – ma qui conta soprattutto la conforma• l’Energia Solar de Puertollano, nella comuzione geografica ed il grado di urbanizzazione dei nità autonoma di Castiglia-La Mancia a sud territori – a 2,5 GW (13% del totale). di Madrid, entrato in esercizio nel maggio del 2009; Il raggiungimento di un simile obiettivo com• l’Alvarado 1, a Badajoz al confine meridionale porta un investimento complessivo, anche tecon il Portogallo. nendo conto dei possibili risparmi legato allo sviluppo tecnologico (si veda paragrafo 3.1.3), I tre impianti sopra citati – che rappresentano vicino ai 70 mld €, ma contribuirebbe ad una 9 gli unici entrati in funzione nel corso del 2009 produzione di energia elettrica superiore ai – hanno portato ad un incremento del 23% della 40.000 GWh annui (ovvero pari a circa il 13% del potenza installata totale rispetto al 2008, menfabbisogno annuo di energia elettrica di un Paese Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 150 -152. Si tratta degli impianti PS10 (solar tower) da 11 MW a Sanlucar La Maior, entrato in esercizio nel 2001, PS20 (solar tower) da 20 MW sempre a Sanlucar La Maior, entrato in esercizio nell’aprile 2008, e Andasol 1 (parabolic trough) da 50 MW nella provincia di Granada, entrato in esercizio nel giugno 2009. L’unico impianto non realizzato in Spagna negli ultimi 10 anni è il Nevada Solar One (parabolic trough) da 64 MW nell’omonimo Stato americano del Nevada, entrato in esercizio nel 2006, ma dietro commessa della società energetica spagnola Acciona. 9 In USA nell’agosto 2009 è stata completata la costruzione del Sierra Sun Tower, impianto da 5 MW costruito da eSolar, il primo con tecnologia solar tower operante nel Nord America. 7 8 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 147 3. IL SOLARE TERModinamICO Box 3.3 Andasol 1 e 2 Andasol 1 è uno dei tre impianti “gemelli” che costituiscono uno dei più grandi parchi solari al mondo che utilizzano la tecnologia parabolic trough. Il complesso si trova nella piana di Gaudix, nella provincia spagnola di Granada. Ciascun impianto, denominato con la stessa dicitura seguita da un numero progressivo in base all’ordine temporale di costruzione, ha una potenza di 50 MW ed è installato su un terreno di 2 chilometri quadrati. Andasol 1 è entrato in funzione a dicembre 2008, Andasol 2 è stato ultimato, dopo due anni di lavori, a fine 2009 e ad oggi si trova in fase di testing. I lavori per la realizzazione di Andasol 3 sono iniziati nella primavera del 2009 e l’avvio dell’attività è previsto per il 2011. Andasol 2, la cui realizzazione è costata 310 mln €, è caratterizzato da una superficie del campo solare pari a circa 510.000 metri quadrati, equipaggiata con 624 col- lettori parabolici con più di 200.000 specchi, in grado di generare annualmente 180 GWh lordi di energia elettrica. La particolarità dell’impianto, comune agli altri due “gemelli”, è la presenza di un sistema di accumulo del calore in grado di mantenere stabile la generazione elettrica per 7,5 ore in caso di fluttuazione della radiazione solare o durante le ore notturne. L’accumulo di energia termica è garantito da due serbatoi cilindrici di 14 metri d’altezza e 36 metri di diametro, contenenti 28.500 tonnellate di sali fusi. L’intero complesso è stato ideato e sviluppato dal gruppo tedesco Solar Millenium. Per quanto concerne l’impianto Andasol 2, la progettazione e ingegnerizzazione ha visto la collaborazione tra Flagsol, una controllata al 100% di Solar Millenium, responsabile della progettazione del campo solare e della realizzazione dei collettori parabolici, e Sener Ingenierìa y Sistemas, società d’ingegneria spagnola che ha preso in carico la progettazione di quelle che sono le sezioni convenzionali dell’impianto di generazione dell’energia, ossia turbine, generatori e apparati accessori. L’impianto è stato realizzato da un consorzio di cui hanno fatto parte all’80% ACS/Cobra Group, società di costruzioni spagnola, e al 20% Sener Ingenierìa y Sistemas, mentre la proprietà dell’impianto è suddivisa tra lo stesso ACS/Cobra Group (75%) e Solar Millenium (25%). come l’Italia) per un controvalore di oltre 230 mln €. Soltanto un anno fa, lo scenario a 10 anni giudicato più plausibile10 si attestava a 12 GW di potenza installata complessiva, ovvero a circa due terzi delle attuali stime. E’ indubbio che molte cose (una su tutte il cambio al vertice della politica americana) sono mutate da un anno a questa parte e che vi è negli operatori, anche in conseguenza dei risultati ottenuti grazie alla ricerca tecnologica, una maggior consapevolezza delle potenzialità del solare termodinamico. Tuttavia, appare necessario distinguere, nel medesimo orizzonte di analisi, tra: Il quadro che risulta da questo supplemento di indagine appare estremamente interessante ed è rappresentato nella figura 3.5, che riporta la distribuzione geografica degli impianti in fase di realizzazione per un totale di 1,6 GW, e nella figura 3.6, che invece colloca geograficamente gli impianti ancora in fase di progetto (che sono responsabili dei restanti 17 GW). • gli impianti già in fase di realizzazione, ovvero per i quali si sia raggiunto l’accordo dal punto di vista autorizzativo e/o siano già stati avviati i lavori di costruzione; • gli impianti ancora in fase di progetto, per i quali si è a conoscenza dei dettagli di massima relativi alla localizzazione ed alla taglia, ma dove l’iter di autorizzazione è ancora in corso. 10 Se si prendono in esame gli impianti in fase di realizzazione, appare evidente come la scelta spagnola di investire decisamente nel solare termodinamico, nonché i progetti terminati con successo nel corso del 2008 e del 2009, facciano da volano per lo sviluppo a breve termine del settore, sia perché hanno attratto capitali interessati ai ritorni associati all’investimento, sia perché possono contare su un tessuto industriale che si è via via rafforzato ed ha sviluppato competenze ad hoc, non soltanto nella fase progettuale, ma anche in quella realizzativa. La tabella 3.2 riporta l’elenco dei principali impianti in fase di “Assessment of the World Bank/GEF strategy for market development of concentrating solar thermal power”, luglio 2008. 148 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.3 Il mercato Box 3.4 Energia Solar De Puertollano L’impianto Energia Solar de Puertollano, che sfrutta la tecnologia solare termodinamica parabolic trough, è stato progettato e realizzato dalla società Iberdrola Renovables (la più grande società al mondo nello sviluppo di parchi eolici), parte della spagnola Iberdrola Group. L’impianto si trova a Puertollano, in provincia di Ciudad Real, nella Regione spagnola di La Mancia, ed è entrato in funzione nel maggio del 2009, dopo due anni di lavori. Costato circa 200 mln €, l’Energia Solar de Peurtollano ha una potenza installata di 50 MW, copre una superficie al suolo di 1,5 chilometri quadrati e ospita 352 collettori parabolici con 120.000 specchi, grazie ai quali può produrre una quantità annua di energia elettrica pari a 100 GWh. L’impianto è di proprietà di Iberdrola Renovables (90%) e dell’Istituto Spagnolo per la Diversificazione e il Risparmio Energetici (IDAE). Box 3.5 Alvarado 1 Nel mese di luglio 2009, la società spagnola Acciona ha aperto il primo impianto a tecnologia solare termodinamica nel Comune di Alvarado (Badajoz), nella Regione spagnola dell’Extremadura. Per la realizzazione dell’impianto, denominato “Alvarado 1” e dotato di una potenza di 50 MW, Acciona ha sostenuto un investimento di 236 mln €. Realizzato su una superficie di 1,35 chilometri quadrati, Alvarado 1 si compone di 768 collettori parabolici con circa 185.000 specchi che indirizzano le radiazioni solari verso i tubi ricevitori, al cui interno il fluido termovettore raggiunge temperature di 400°C. L’impianto, costruito in 18 mesi, genera annualmente 105,2 GWh di energia elettrica. La società spagnola ha in programma la realizzazione di un’ulteriore centrale analoga, accanto a quella già realizzata ad Alvarado, che avrà una potenza installata di 50 MW e verrà denominata “Alvarado 2”. Figura 3.4 Localizzazione geografica degli impianti in costruzione ed in progetto 4,3% 13,4% 26,9% Europa USA 55,4% Asia Resto del mondo www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 149 3. IL SOLARE TERModinamICO Figura 3.5 Localizzazione geografica degli impianti in fase di realizzazione 5% 7% Europa USA 88% Resto del mondo Figura 3.6 Localizzazione geografica degli impianti in fase di progetto 4% 29% Europa 6% 61% USA Asia Resto del mondo ca) ben si sposa con la conformazione del territorio realizzazione nel mondo, indicando sia la localize con il tipico approccio “su larga scala” che conzazione che la potenza e la tecnologia impiegata. traddistingue gli investimenti infrastrutturali dei A questo proposito è interessante notare il caso Paesi asiatici. L’esplosione del mercato americano, di Gemasolar, unico impianto che adotta la teccon 10,3 GW di nuovi impianti in progetto nei nologia solar tower, ma che, vista anche la taglia prossimi 10 anni, è però indubbiamente il fenomeridotta (17 MW), pare configurarsi più come un no cui guardare con più attenzione, per almeno tre campo sperimentale, da affiancare al già esistente motivi: PS10 – 11 MW realizzati nel 2001 dalla Abengoa – piuttosto che come un possibile ca• perché già in passato, come il caso postipite di una futura generazione di impianti di questo tipo sul suolo “Rimane da vedere quanti degli del Nevada Solar One insegna, gli impianti in fase di progetto USA sono stati “territorio di caccia” europeo. riusciranno in pratica ad essere per le imprese europee (o meglio per completati come previsto.” ora solo spagnole) che operano nel La situazione cambia decisamenResponsabile di divisione solare termodinamico e quindi può te se si prendono in considerazione di un importante centro di ricerche italiano rappresentare un mercato di sbocco gli impianti in fase di progetto, ove estremamente interessante; ad un ruolo marginale dell’Europa – • perché, accanto ai parabolic trough, sono preanche per il naturale esaurirsi delle localizzazioni viste installazioni importanti anche di imin cui gli investimenti in impianti solari termodipianti solar tower (oltre 3,1 GW) e parabolic namici sono economicamente convenienti – fa da dish (1,6 GW) e quindi vi sono ulteriori spazi contraltare la crescita di India e Cina, la cui “fame” di manovra per le imprese di tecnologie che di energia (e soprattutto di indipendenza energeti- 150 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.3 Il mercato vogliano investire, o abbiano già investito, in questo campo; • perché il mercato americano, soprattutto nei settori ad alta tecnologia, può rappresentare un “modello di riferimento” a livello globale (e certamente lo è per i Paesi occidentali) che funga da ulteriore volano per la crescita di lungo termine del solare termodinamico. Tabella 3.2 Elenco e principali caratteristiche degli impianti solari termodinamici attualmente in fase di realizzazione nel mondo Impianto Localizzazione Tecnologia Potenza (MW) Anno previsto di entrata in funzione Extresol 1,2,3 Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), Spagna Parabolic trough 150 n.d. Aste 1A,1B Alcàzar de San Juan (Ciudad Real), Spagna Parabolic trough 100 2011 Helioenergy 1,2 Ecija, Spagna Parabolic trough 100 2011 Palma del Rio 1,2 Cordoba, Spagna Parabolic trough 100 2010 Solaben 1,2 Logrosan, Spagna Parabolic trough 100 n.d. Termosol 1,2 Navalvillar de Pela (Badajoz), Spagna Parabolic trough 100 n.d. Valle Solar Power Station Cadiz, Spagna Parabolic trough 100 2011 Martin Next Generation Solar Energy System Florida, USA Parabolic trough 75 2010 Andasol 3 Granada, Spagna Parabolic trough 50 2011 Arenales PS Moron de la Frontera (Seviglia), Spagna Parabolic trough 50 n.d. Astexol 2 Badajoz, Spagna Parabolic trough 50 2011 El Reboso 2 El Puebla del Rio (Seviglia), Spagna Parabolic trough 50 n.d. Helios 1 Ciudad Real, Spagna Parabolic trough 50 n.d. Helios 2 Ciudad Real, Spagna Parabolic trough 50 n.d. La Dehesa La Garrovilla (Badajoz), Spagna Parabolic trough 50 2010 La Florida Alvarado (Badajoz), Spagna Parabolic trough 50 2010 Lebrija 1 Lebrija, Spagna Parabolic trough 50 2010 Majadas de Tiétar Caceres, Spagna Parabolic trough 50 2010 Manchasol 1 Ciudad Real, Spagna Parabolic trough 50 2010 Serrezuela Solar 2 Talarrubias (Spagna) Parabolic trough 50 n.d. Solnova 3 Sanlùcar la Mayor, Spagna Parabolic trough 50 2010 Kuraymat Plant Kuraymat, Egitto Parabolic trough 40 2010 ISCC Algeria Hassi R'mel, Algeria Parabolic trough 35 2010 ISCC Morocco Beni Mathar, Marocco Parabolic trough 35 2010 Agua Prieta 2 Messico Parabolic trough 25 2010 Gemasolar Fuentes de Andalucia (Seviglia), Spagna Solar tower 17 2010 Archimede Priolo Gargallo (SR), Italia Parabolic trough 5 2010 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 151 3.4 La filiera Nel capitolo precedente si è dato conto di un “mercato” del solare termodinamico che, nonostante il periodo di crisi economica, ha dato chiari segnali di crescita e per il quale sono previsti piani di sviluppo futuro che interessano ormai tutte le grandi aree industrializzate a livello mondiale, oltre all’Europa e agli USA, anche l’India e la Cina. Ai movimenti del mercato sono chiaramente corrisposte delle modifiche, talora anche importanti, a livello di filiera industriale, con diversi operatori “tradizionali” che hanno consolidato le proprie posizioni ed altri – forse i più interessanti da investigare – che attraverso processi di diversificazione hanno fatto il loro ingresso nel settore. In questo capitolo si analizzano dapprima le strategie dei principali gruppi a livello internazionale che operano nel solare termodinamico, vista la già citata dimensione “globale” di questo business, e successivamente si approfondisce il caso italiano, dove pare finalmente cogliersi qualche concreto segnale di sviluppo. 3.4.1 Il quadro internazionale: l’affermarsi delle Società di Ingegneria Solare Nel Solar Energy Report 200811 si sono identificate due “configurazioni” tipiche di filiera attraverso cui vengono realizzati gli impianti solari termodinamici (si veda figura 3.7): • una configurazione denominata Energy Pull, che vede nelle società produttrici di energia elettrica da fonti “tradizionali” il motore della realizzazione del nuovo impianto. Attorno a queste società – che, oltre a mantenere la proprietà dell’impianto, si occupano poi della gestione operativa e del trading dell’energia prodotta – si costituiscono dei consorzi di attori (società di ingegneria e impiantistica, centri di ricerca e produttori di componentistica) cui spetta il compito di costruire e mettere in esercizio l’impianto solare termodinamico; • una configurazione Technology Push, ove sono le cosiddette Società di Ingegneria Solare – società di ingegneria con una forte specializzazione e delle competenze scientifico-tecnologiche molto avanzate nel solare termodinamico – a “spingere” la realizzazione dell’impianto. Queste società, come si vedrà meglio in seguito, dispongono, oltre che di competenze progettuali, anche di capacità di ingegnerizzazione12 e di produzione di taluni tipi di componenti. Esse sono quindi in grado di offrire impianti “chiavi in mano” (compresa l’attività di gestione operativa e manutenzione) alle società energetiche tradizionali o, più in generale, agli investitori che – solitamente attraverso il meccanismo dello Special Purpose Vehicle13 – ne diventano proprietari. Alla seconda configurazione già nella scorsa edizione del Solar Energy Report veniva attribuita la larga parte (80%) della potenza solare termodinamica in esercizio e si prevedeva che tale percentuale fosse destinata a salire in futuro. Nel corso 2009 sono emersi con maggior chiarezza almeno tre trend che “convergono” nel confermare questa previsione: • il rafforzamento lungo la filiera delle Società di Ingegneria Solare, impegnate “a monte” nell’ac- Cfr. Solar Energy Report 2008, pp. 153 -157. Vale la pena ricordare che nel solare termodinamico, visto il numero ancora ridotto di impianti in esercizio e costruzione, le soluzioni tecnologiche e la componentistica necessaria per la realizzazione degli impianti sono in larga parte sviluppate ad hoc per la specifica “commessa”. La fase di progettazione e ingegnerizzazione del processo produttivo – in assenza di soluzioni “a catalogo” – giocano ancora un ruolo chiave nel determinare i costi dell’impianto e quindi nel garantirne un adeguato livello di profittabilità. 13 Lo Special Purpose Vehicle (SPV) è, come dice il nome stesso, una società giuridicamente indipendente che funge da “veicolo” per l’investimento e ha fra i propri soci la società energetica tradizionale coinvolta nell’iniziativa, altri investitori istituzionali (branch equity di grandi banche o fondi di investimento) e solitamente – anche se in posizione minoritaria – la società di ingegneria solare che ha partecipato alla realizzazione. L’SPV è titolare degli incentivi eventualmente previsti per la produzione di energia da fonte solare termodinamica e solitamente negozia – su un orizzonte di tempo decennale e nella forma dei Power Purchasing Agreement (PPA) – la cessione dell’elettricità prodotta dall’impianto in via esclusiva alla società energetica tradizionale che fa parte della compagine societaria. 11 12 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 153 3. IL SOLARE TERModinamICO Figura 3.7 Le configurazioni tipiche per la realizzazione e gestione degli impianti solari termodinamici Sviluppo progettuale Produzione componenti Progettazione ed integrazione tecnologica Ingegneria e costruzione Gestione Proprietà operativa e ma- dell’impianto nutenzione Trading energia TECHNOLOGY PUSH ENERGY PULL CONSORZIO Produttori di componentistica Produttori di componentistica Centri di ricerca Società di ingegneria e costruzione Società di Ingegneria Solare Società energetica Special Purpose Vehicle Società Energetica più di 30 mln € nel 2008 ad oltre 200 mln € nel crescere la propria capacità di produzione di 2009, facendo segnare una crescita superiore al componentistica ad alto valore aggiunto (soprat500% (in larga parte dovuta alla conclusione dei latutto specchi e ricevitori) e, “a valle”, nell’increvori dell’Andasol 2, si veda box 3.3). L’impresa, che mentare le proprie quote di proprietà negli SPV si contraddistingue per la specializzazione nella per gli impianti di nuova costruzione e le attività tecnologia parabolic trough, ha già nella propria di gestione operativa e manutenzione; pipeline progetti di sviluppo di impianti sola• l’ingresso sempre più frequente nel settore – ri termodinamici per oltre 700 MW da avviarsi secondo il modello delle Società di Ingegneria nel corso dei prossimi 5 anni. Nel frattempo, larga Solare – di imprese operanti nell’impiantistica parte degli utili realizzati dalla Solar Millenium “tradizionale” ed il crescente interesse mostrato sono stati reinvestiti nelle fasi “a valle”, con un dai grandi operatori dell’energia e dai finanziaulteriore incremento delle disponibilità della tori per le imprese che operano secondo questo branch finanziaria dell’impresa. modello di business; Un percorso di crescita molto simile, • la crescente specializzazione dei “Le imprese internazionali produttori di componentistica per di ingegneria solare acquisiscono con il fatturato che è più che triplicato sempre maggiore forza. negli ultimi 2 anni, è quello di Abengoa il solare termodinamico, che semE’ molto difficile entrare pre più “si allontanano” dalla visio- in quest’area di business da soli.” Solar – “figlia minore” (contando ancora per poco meno del 3% dell’intene del progetto nel suo insieme per R&D Manager di un importante ro gruppo) del colosso dell’ingegneria massimizzare l’efficacia (in termini EPC spagnola Abengoa – che ha ampliato di rispetto delle specifiche funzionel corso del 2009 il suo portafoglio nali e di performance) e l’efficienza progetti e le sue competenze impiantistiche e di (in termini di costi del processo) delle specifiche componentistica includendo anche la tecnologia componenti che propongono. parabolic trough, il cui potenziale futuro è, come visto nel capitolo 3.3, comunque superiore ai solar Con riferimento al primo punto, di particolare intower con cui l’impresa ha mosso i suoi primi passi teresse è scorrere la tabella 3.3, che riporta l’elennel solare termodinamico, con gli impianti PS10 e co delle principali Società di Ingegneria Solare attiPS20. ve a livello globale. Nel campo dei parabolic dish, ovvero la terza concreta alternativa tecnologica a disposizione per la Leader per potenza installata (300 MW complesrealizzazione di impianti solari termodinamici (si sivamente) è la tedesca Solar Millenium, fondata veda paragrafo 3.1.1), si distingue fra le Società nel 1998 e che ha legato il proprio nome ai progetti di Ingegneria Solare la Stirling Energy System Andasol (3 impianti da 50 MW, due dei quali già che, facendo leva sulle competenze di componenentrati in esercizio). Il fatturato è passato da poco 154 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.4 La filiera Tabella 3.3 Le principali Società di Ingegneria Solare Nome Paese Breve Descrizione Israele È una delle pioniere del termodinamico. È nata da una costola dall’israeliana Luz, coinvolta nella costruzione dei SEGS. Oltre a realizzare impianti “chiavi in mano”, è anche fornitrice di tubi ricevitori, condividendo la leadership di mercato in questo campo con Schott Solar Solar Millenium Germania Fondata nel 1998, è un punto di riferimento nel campo della tecnologia CSP. L’impresa si è specializzata nelle attività di sviluppo e commercializzazione di impianti che incorporano la tecnologia parabolic trough, utilizzata nella costruzione di Andasol Abengoa Solar Spagna Abengoa Solar è una business unit di Abengoa, società pubblica di ingegneria. Costruisce impianti PV e CSP, occupandosi di tutte le fasi della catena del valore, a partire dalle attività di ricerca e sviluppo. USA / Inghilterra SES è un fornitore di tecnologie dish stirling per impianti solari termodinamici. Tessera Solar si occupa di sviluppare progetti per le utilities lungo tutte la fasi della realizzazione di un impianto termodinamico: progettazione, installazione e gestione Israele Bright Source Energy è una società originata da Luz II, impresa a sua volta nata dalla Luz I, con l’obiettivo di sviluppare su scala commerciale la tecnologia solar tower, dopo aver completato la realizzazione dei nove impianti SEGS USA eSolar è un produttore statunitense di centrali elettriche basate su tecnologia solare termodinamica, che impiega una particolare tecnologia di tipo solar tower. Ha già siglato una partnership con Ferrostal e accordi con Southern California Edison e NRG Energy per la realizzazione di impianti in Cina (fino a 2 GW) con tecnologia solar tower Solel* Stirling Energy System (Ses) - Tessera Solar Bright Source Energy eSolar * Impresa controllata da Siemens tistica relative agli omonimi motori per la generazione di energia elettrica, ha creato nell’aprile del 2009 una società ad hoc (Tessera Solar) con l’obiettivo di gestire i progetti di realizzazione di impianti solar dish di dimensioni comparabili (utility scale) con quelli attualmente realizzati con le altre tecnologie. Tessera Solar prevede di realizzare oltre 1,5 GW nei prossimi anni, ovvero di coprire la quasi totalità del mercato atteso per questa tecnologia (si veda capitolo 3.3). A chiudere il quadro delle principali Società di Ingegneria Solare due imprese israeliane, ma con una fortissima presenza negli USA, “gemmate” dalla Luz, vera e propria pioniera del solare termodinamico cui si deve la realizzazione negli anni ’80 degli impianti SEGS: la Bright Source Energy, che si sta specializzando nella tecnologia solar tower (in linea con l’obiettivo di conquistare una fetta del mercato americano), con oltre 400 MW di progetti in previsione nel corso dei prossimi 5 anni; e la Solel, che si contraddistingue per le forti competenze “a monte” sui tubi ricevitori, e che è stata nell’ottobre del 2009 acquisita dalla Siemens nell’ambito di un deal da 310 mln €. La vicenda di Solel è in realtà un primo esempio del secondo dei trend identificati come caratterizzanti il settore nel corso del 2009, ovvero l’interesse verso il modello di business delle Società di Ingegneria Solare da parte degli “impiantisti”, in questo caso ben rappresentati da Siemens14 . Gli esempi qui sono innumerevoli: la tedesca MAN Ferrostaal15, con un fatturato di gruppo di 1,6 mld € ed oltre 4.400 addetti, che ha dato vita con Solar Millenium Sulle mosse di Siemens nel solare termodinamico si veda anche il paragrafo 3.4.2 relativo all’esperienza italiana del progetto Archimede In realtà la quota di maggioranza (70%) della MAN Ferrostaal è detenuta da una società di investimenti, l’International Petroleum Investment Company di Abu Dhabi, anche se è la tedesca MAN (con il restante 30%) a detenerne il controllo operativo. 14 15 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 155 3. IL SOLARE TERModinamICO ad una joint venture (Solar Trust of America) per sfruttare il previsto boom sul mercato americano; la spagnola Sener, strettamente collegata al gruppo Cobra (3,2 mld € di fatturato nel 2008), che ha dato vita alla Torresol Energy, impresa specializzata nella realizzazione di “torri solari”; ed infine la tedesca Schlaich Bergermann und Partner, società di ingegneria attiva nelle costruzioni civili, che sta investendo significativamente in competenze per lo sviluppo di impianti solari termodinamici, cercando di specializzarsi nei solar dish. L’interesse per il modello di business delle Società di Ingegneria Solare – che mediamente hanno realizzato nel corso dell’ultimo anno margini operativi lordi superiori al 30% per le attività di progettazione e al 10% per l’ingegneria impiantistica in senso stresso – è testimoniato anche dall’attenzione che ad esso rivolgono le grandi utilities (Iberdrola ha progettato e terminato di costruire a maggio 2009 l’impianto Energia Solar de Puertollano, a tecnologia parabolic trough, uno dei tre nuovi impianti spagnoli costruiti nel 2009) e le banche di investimento, come ad esempio Goldman Sachs che, prima nel 2008 con Cogentrix (produttore indipendente di energia con all’attivo installazioni di impianti termodinamici per 43 MW), e poi nel corso del 2009 con Sunray Energy, ha investito in imprese che operano nel settore, evidentemente scommettendo almeno sul mantenimento dei livelli di profittabilità visti sopra. Nella configurazione Technology Push un ruolo di rilievo, soprattutto per quanto riguarda la spinta all’innovazione, è giocato dai componentisti che, da un lato, sono chiamati dalla Società di Ingegneria Solare a massimizzare le performance (e minimizzare i costi) dei loro prodotti e, dall’altro lato, hanno nella specializzazione spinta il loro vero punto di forza. L’analisi condotta ha permesso di evidenziare come la marginalità operativa lorda media di queste imprese si sia attestata intorno al 15%, con punte del 20% per i componenti più critici, come ad esempio i tubi ricevitori. I principali produttori mondiali di componenti per il solare termodinamico sono riportati nella tabella 3.4. Fra i casi di maggior interesse è possibile sottolineare quello di Flabeg, azienda attiva nella fabbricazione di vetro sottile (con ben 11 impianti all’attivo) e leader nella produzione di specchi per la tecnologia parabolic trough, che lo scorso ottobre ha aperto un nuovo impianto a Pittsburgh per la produzione di specchi parabolici con una capacità produttiva di 450 MW. Un’ultima nota merita il caso di Ausra (si veda box 3.6), impresa americana legata allo sviluppo della tecnologia degli specchi di Fresnel e che, visto il drastico ridursi delle aspettative di mercato (si vedaparagrafo 3.1.1), ha deciso nel corso del 2009 di riposizionarsi, facendo leva sulle competenze sviluppate nella componentistica, nel campo dei generatori di vapore per impianti termodinamici, attraverso cui si ha l’ultimo passaggio del calore prodotto prima dell’ingresso in turbina. Tabella 3.4 I principali produttori mondiali di componentistica per impianti termodinamici Impresa Albiasa Solar Flagsol Novatec Biosol Solar Power Group Solargenix Energy Solel Schott Alanod Almeco-Tinox Flabeg Saint-Gobain Rioglass Ausra 156 Paese Spagna Germania Germania Germania USA Israele Germania Germania Germania Germania Francia Spagna USA Impianti Parabolic Trough Parabolic Trough Fresnel Linear Fresnel Linear Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough Parabolic Trough www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Componenti Collettori Collettori Collettori Collettori Collettori Collettori Tubi Ricevitori Strutture di Supporto Strutture di Supporto Specchi Specchi Specchi Boiler 3.4 La filiera Box 3.6 Ausra Il colosso del nucleare francese Areva ha annunciato, nel mese di febbraio 2010, l’acquisizione del 100% della compagnia statunitense Ausra, società attiva nella produzione degli specchi di Fresnel per il solare termodinamico. L’operazione dovrebbe concludersi in pochi mesi e quindi non sono ancora stati ufficializzati i dettagli dell’accordo. Tuttavia alcuni analisti di 3.4.2 Il solare termodinamico in Italia Il 2009 ha rappresentato per l’industria del solare termodinamico in Italia un anno importante: mercato stimano il valore del deal in più di 200 mln $. L’acquisizione di Ausra è un’ulteriore manifestazione della tendenza, da parte delle società operanti nel comparto delle energie “convenzionali” ma sempre più “attratte” dalle potenzialità del settore delle rinnovabili, ad acquisire competitori diretti o indiretti attivi in questo mercato. nità. Di certo il 2010 sarà un anno importante per il solare termodinamico, per capire se la crescita del 2009 ha rappresentato o meno un concreto e decisivo passo verso l’asupicata maturazione del settore. • innanzitutto perché si è ulteriormente rafforzata All’interno del Consorzio Solare XXI (si veda tala “cordata” di operatori (denominata Consorzio bella 3.5) vanno registrati, infatti, i primi signiSolare XXI) che sta portando avanti un proprio ficativi investimenti in capacità produttiva. Reflex progetto sperimentale; darà avvio nel 2010 ad un impian• perché Enel ed Enea stanno ultimando to completamente robotizzato per “La strategia che devono il progetto dimostrativo Archimede, la produzione di specchi ad elevata necessariamente adottare le imprese italiane che si stanno un impianto solare termodinamico a riflettività (sino ad un massimo del affacciando al termodinamico sali fusi da 5 MW a Priolo Gargallo in 98%) e con una tempra chimica, che consiste nella creazione di Provincia di Siracusa16; ne aumenta ulteriormente la resistenpartnership e collaborazioni con imprese nazionali ed estere. • perché, grazie a 12,5 mln € di finanza. Archimede Solar Energy – che nel Diversamente, sarà molto ziamenti del Ministero dello Sviluppo marzo del 2009 ha visto l’importante dura fronteggiare le big del termodinamico” Economico nell’ambito del proingresso di Siemens nel capitale sociagramma Industria 2015 (Efficienza Amministratore Delegato di un’impresa le con una quota del 28% – ha investito italiana produttrice di componenti Energetica), si è attivata una uloltre 30 mln € con l’obiettivo di avviare teriore “cordata” per il progetto nel 2011 la produzione di 75.000 tubi riFREeSUN, che ha l’obiettivo di mettere a punto un cevitori all’anno. Gli obiettivi dell’impresa sono animpianto sperimentale da 1 MW con la tecnologia cora più ambiziosi, con la capacità produttiva annua degli specchi Fresnel; in ulteriore aumento fino a 140.000 tubi ricevitori • infine perché, indipendentemente dalle due “cor(equivalenti ad oltre 280 MW di potenza installata in date” appena citate, sono nati o comunque hanno impianti solari parabolic trough) a partire dalla fine fatto il loro ingresso nel settore del solare termodel 2012 e con piani di espansione che hanno come dinamico nuovi operatori con il ruolo di compotarget il mercato spagnolo. nentisti specializzati, dimostrando la vitalità anche in questo campo del tessuto industriale italiano. Una nota particolare la merita il progetto FREeSUN sistema industriale saper cogliere questa opportu(si veda tabella 3.6) che ha preso avvio nel 2009. Tabella 3.5 Il Consorzio Solare XXI Impresa Techint Archimede Solar Energy Reflex Duplomatic 16 Ruolo-Attività Design delle strutture di supporto e integrazione dei componenti Produzione del tubo ricevitore su licenza ENEA. Realizzazione dei pannelli riflettenti. Sviluppo del sistema di movimentazione e delle logiche di inseguimento. Cfr. Solar Energy Report 2008, p. 152. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 157 3. IL SOLARE TERModinamICO Box 3.7 Archimede Solar Energy Archimede Solar Energy è l’azienda del Gruppo Angelantoni che opera nel settore delle energie rinnovabili, con sede a Massa Martana (Perugia) e attiva sul mercato dal 2008. Il Gruppo Angelantoni ha oggi 8 unità produttive, tra Italia ed estero, con 750 dipendenti e un fatturato di 140 mln €. Nel 2009 il colosso tedesco Siemens ha ufficializzato l’ingresso nel capitale di Archimede Solar Energy con una partecipazione al 28%. Archimede Solar Energy produce, dietro licenza concessa dall’Enea, tubi ricevitori ad alta efficienza per centrali solari termodinamiche, capaci di produrre energia elettrica e acqua dissalata. I tubi lavorano ad alte temperature (fino a 550°C) e utilizzano i sali fusi come fluido termovettore, particolarità che rende questa azienda unica al mondo. Grazie a un rivestimento spettralmente selettivo (CERMET) e ad un involucro che viene posto sottovuoto, i tubi Archimede sono in grado di assicu- rare la massima efficienza nel trasferimento di calore al fluido termovettore (massimo assorbimento e minima emissione). La società umbra, tra i promotori del Consorzio Solare XXI insieme a Techint, Reflex e Duplomatic, ha realizzato 2,9 mln € di fatturato nel 2008 e sta perseguendo una strategia di forte crescita dimensionale, supportata dalla costruzione di un nuovo stabilimento a Massa Martana. Al di là della partecipazione al progetto di costruzione dell’impianto a Priolo Gargallo, Archimede Solar Energy mira ad affermarsi in questo nuovo segmento di mercato come società leader in Italia e in Europa, avviando progetti più ampi a livello italiano ed estendendo la propria attività nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in particolare Spagna, Libia, Tunisia ed Egitto, ma con attenzione anche all’affermarsi di nuovi mercati in altri continenti. Se è vero, infatti, come discusso nel paragrafo 3.1.1, che la tecnologia degli specchi di Fresnel pare destinata a giocare un ruolo marginale nel prossimo futuro, è altrettanto vero che in un contesto come quello italiano ove il settore è ancora nelle prime fasi di sviluppo, la possibilità di confrontarsi su un tema di frontiera dal punto di vista scientifico e tecnologico (e con una pressione competitiva relativamente limitata da parte dei grandi player internazionali) può rappresentare un’ottima “palestra” ove testare le potenzialità delle imprese nazionali, anche al di fuori della specifica tecnologia Fresnel. I gruppi industriali coinvolti peraltro sono di assoluto rilievo: Almeco, con i suoi quasi 90 mln € di fatturato, opera da anni nel settore dell’illuminotecnica e, Tabella 3.6 Il Progetto FREeSUN Impresa FERA Almeco CNR Itae DNA Engineering IMAT (Gruppo Marcegaglia) Politecnico di Milano Sdi Automazione Turbocoating Xeliox Università di Catania Università di Genova Ruolo-Attività Capofila del progetto Ricerca e sviluppo e produzione delle superfici riflettenti (ad alta riflettività) per gli specch Studio sistema di stoccaggio e composizione coating Sviluppo della struttura portante Sviluppo del tubo assorbitore Sviluppo dei modelli matematici di simulazione dell’impianto Sviluppo del tracking system Sviluppo dei sistemi di coating dei tubi assorbitori Sviluppo della struttura portante per gli specchi Studio termo fluidodinamico Valutazione tecnico-economica dell’impianto 17 Vega è un alluminio ad alta riflessione ottenuto con tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition) che la Almeco ha messo in produzione nel 2006 a Bernburg in Germania. Il processo produttivo prevede la deposizione di film sottili metallici e ceramici con processo di sputtering. Il processo in vuoto rende la superficie metallica particolarmente performante e, rispetto all’alluminio anodizzato ad alta riflessione, il trattamento garantisce proprietà antigraffio, anti usura, antistatiche e di resistenza alla corrosione, alle impronte ed all’umidità. 158 www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 3.4 La filiera ne geografica e per la morfologia del territorio in all’interno del progetto FREeSUN, si occupa dello Italia sia assai difficile ipotizzare una diffusione sviluppo delle superfici in alluminio per applisu “larga scala” di impianti solari termodinamicazioni ad alta riflettività basata sulla tecnologia ci, è altrettanto vero, come dimostrano i già citati VEGA17 ; IMAT, del gruppo Marcegaglia, con una lunga tradizione nella componentistica per l’incasi delle israeliane Bright Source Energy e Solel, dustria della refrigerazione, si è presa in carico che competenze tecnico-scientifiche di frontienell’ambito del progetto lo sviluppo del sistema ra in questo settore danno “rapido” accesso al ricevitore. Accanto ad esse, ed ai cenmercato globale e potrebbero quindi tri di ricerca coinvolti che sono fra i permettere anche alle imprese itanecessari per competere principali in Italia negli ambiti tecno- “Gli skill liane di entrare in aree geografiche nel settore li possediamo. logici di interesse per il progetto, van(come ad esempio gli USA o l’Asia) Dobbiamo però ancora capire quale strategia di ingresso no citate almeno altre due imprese di in forte espansione per quanto riè più conveniente per noi … particolare importanza. Fera, promo- non dimentichiamoci che siamo guarda la potenza installata. in un periodo non facile trice del progetto, che da anni opera per il mondo dell’impresa.” Due sembrano le strade, entrambe nel settore delle rinnovabili in Italia, ma che per la prima volta abbandona R&D Manager di un’impresa italiana da percorrere, per l’industria del produttrice di componenti meccanici solare termodinamico in Italia: il tradizionale business della installazione di impianti eolici per dedicarsi • le grandi società di ingegneria e impiantistica al solare; Xeliox, start up con meno di 10 addetti – quali ad esempio Techint, ma anche le divifondata nel 2008 da Donati Group, che ha l’obietsioni dei grandi gruppi dell’energia come Enel o tivo, nell’ambito del progetto, di sviluppare il supancora Eni, che hanno avviato attività operatiporto strutturale in alluminio per la superficie ve la prima e di ricerca la seconda – dovrebbero riflettente. abbracciare con ancor più “coraggio” il modello di business delle Società di Ingegneria L’interesse per il solare termodinamico in Italia Solare, se vogliono cogliere le opportunità di va anche oltre le due “cordate” di cui si è appena crescita del solare termodinamico, che semdetto. Alcuni gruppi industriali di rilievo hanno brano essere ormai certe a livello mondiale; infatti intrapreso nel corso dell’ultimo anno un • le società di componentistica devono rafforzapercorso di “avvicinamento” al settore. re le proprie competenze e la propria speciaFra questi è possibile citarne almeno due: Flenco, lizzazione nel settore, andando a identificare fondata alla fine degli anni ’80 da Piaggio e speciaquelle aree di miglioramento ove è nella pratica lizzata in fluidodinamica, che ha aperto una diviancora possibile imporsi su scala globale; sione Biosolar per sviluppare sistemi termodinami• le opportunità anche qui sembrano essere molci a sali fusi ad alta temperatura con una tecnologia te. L’analisi condotta, in particolare, ha idenproprietaria (in attesa di copertura brevettuale) tificato due aree di eccellenza: (i) quella degli denominata SIP Solar; e Turboden, gruppo stospecchi, ove le imprese italiane (Reflex, Flenco, rico nella costruzione di generatori basati su cicli Fenzi, Xeliox e Almeco per citare qualche nome) ORC18 , che ha reso noti piani di sviluppo di medio termine che comprendono anche applicazioni nel hanno competenze distintive nella lavorazione di solare termodinamico. spessori sottili di vetro, nello sviluppo di vernici per aumentare la riflettività dei materiali e nelGli operatori italiani del settore hanno anche la lavorazione dell’alluminio, ovvero proprio in dato vita, alla fine del 2009, ad una associazioquei campi ove si sta concentrando l’attività di ne (Anest – Associazione Italiana per il Solare ricerca anche a livello internazionale; (ii) quella Termodinamico) al fine di promuovere, anche e delle applicazioni meccaniche (Meccanotecnica soprattutto nei confronti delle istituzioni, la coUmbra, Gabbioneta, ecc.), soprattutto per quannoscenza delle tecnologie e delle opportunità leto riguarda i giunti ad alta tenuta, necessari per gate allo sviluppo del comparto. collegare fra di loro i diversi collettori nelle “linee” dell’impianto, e le pompe fluidodinamiche Se è indubbio, infatti, che per la sua conformazioadatte all’impiego dei sali fusi. 18 Il ciclo Rankine a fluido organico (ORC) è simile a quello utilizzato da una tradizionale turbina a vapore, eccetto per il fluido di lavoro che, in questo caso, è un fluido organico con elevata massa molecolare. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 159 3. IL SOLARE TERModinamICO In altre parole, l’Italia ha le carte in regola per giocare la partita del termodinamico secondo la configurazione Technology Push, ma spetta al sistema industriale saper cogliere questa opportunità. Di certo il 2010 sarà un anno importante per il solare termodinamico, per capire se la crescita del 2009 ha rappresentato o meno un concreto e decisivo passo verso l’auspicata maturazione del settore. Box 3.8 Reflex Reflex è stata fondata nel 1989 da Luciano Lucatello. L’azienda ha sede a Biancade di Roncade (Treviso) e opera nel settore dell’arredamento per interni in legno e vetro. Ha fatto registrare nel 2009 un fatturato di circa 20 mln € e si avvale della collaborazione di 70 dipendenti. Nel 2008 la società ha avviato dei progetti di diversificazione nel settore del solare termodinamico, con l’obiettivo di sfruttare il proprio know-how nel campo della lavorazione del vetro. Reflex intende proporsi come fornitore di vetri per la tecnologia del termodina- 160 mico parabolic trough. L’azienda prevede di avviare la produzione industriale nel 2010, con l’impiego di circa 30 addetti. La strategia di Reflex si basa principalmente su una forte attività di ricerca e sviluppo a livello di materiali e geometrie di supporto e sull’avvio di collaborazioni con altre società della filiera del termodinamico (Consorzio Solare XXI), che le hanno permesso di mettere a punto particolari processi di lavorazione del vetro (molatura, tempratura e argentatura) particolarmente adatti agli impieghi nel settore termodinamico. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Gruppo di lavoro Vittorio Chiesa - Direttore Energy & Strategy Group Davide Chiaroni - Responsabile della Ricerca Federico Frattini - Responsabile della Ricerca Lorenzo Boscherini - Project Manager Paolo Silva Riccardo Terruzzi Marco Alberti Mattia Bianchi Alberto Cavaliere Francesca Michetti Elena Comunian Rosaria Intenza Silvia Lasala Simone Lena Francesca Mapelli Veronica Pellegatta Anna Realini Jonathan Roncolato www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 161 Metodologia La ricerca i cui risultati sono raccolti nel Solar Energy Report 2009 è stata condotta utilizzando approcci metodologici diversi, ancorché complementari e tra loro interrelati. Ciò si è reso necessario data l’ampiezza ed eterogeneità delle tematiche che il Rapporto, per ciascuna forma di sfruttamento dell’energia solare (fotovoltaica, solare termica e termodinamica), ha affrontato: le potenzialità e gli sviluppi delle tecnologie, il quadro normativo in essere, i volumi d’affari e le caratteristiche del mercato, e infine l’articolazione della filiera industriale. La tecnologia I capitoli del Rapporto che approfondiscono le tematiche di natura tecnologica si basano principalmente su: • l’analisi estensiva della letteratura scientifica sul tema e delle ricerche promosse dai principali centri ed istituti di ricerca a livello mondiale; • i risultati dei progetti di ricerca che il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano ha portato avanti negli anni sulle tecnologie del solare; • una serie di interviste dirette con ricercatori e professori universitari afferenti ad istituzioni diverse dal Politecnico di Milano. La normativa I capitoli del Rapporto che esaminano il quadro normativo in essere ed interpretano i suoi impatti sul business dell’energia solare si basano invece su: • l’analisi estensiva della normativa relativa all’incentivazione della produzione di energia solare ed alle procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti in vigore in Italia e, in ottica comparativa, nei principali Paesi europei e mondiali; • il confronto con le associazioni di categoria che hanno patrocinato la ricerca, ossia Aper, Assosolare, CTI e GiFi. Il mercato La stima dei volumi d’affari dei mercati del fotovoltaico, solare termico e termodinamico e l’analisi delle loro caratteristiche distintive sono state condotte attraverso: • interviste dirette ad oltre 90 operatori del settore (imprese produttrici di celle e moduli, imprese di progettazione e installazione, istituti di credito, esperti di settore, associazioni di categoria, rappresentanti di organismi di regolazione); • l’analisi comparativa e l’interpolazione delle previsioni contenute in rapporti di ricerca o studi di settore, messi a punto da associazioni ed enti di ricerca italiani ed internazionali; • lo sviluppo e l’applicazione di modelli di simulazione costruiti a partire da un’analisi del tasso di crescita della potenza installata sperimentato in altri Paesi, e validati attraverso un confronto con esperti di settore. La filiera I capitoli del rapporto che approfondiscono l’articolazione della filiera industriale nei mercati dell’energia solare si basano su: • il censimento e la raccolta di informazioni anagrafiche ed economiche (attraverso l’esame di siti web istituzionali, la consultazione del database AIDA, l’analisi di annual report e altra documentazione pubblica) di oltre 900 imprese operanti nei diversi stadi delle filiere industriali del fotovoltaico, solare termico e termodinamico; • la realizzazione di oltre 100 casi di studio, condotti attraverso interviste dirette e raccolta di documentazione da fonti secondarie, su un campione di imprese selezionate tra quelle incluse nel censimento; • il panel study con i manager delle imprese partner della ricerca, ossia BP Solar, Edison, Enel Green Power, Enipower, Intesa Sanpaolo, Mitsubishi Electric, Siemens, SMA, Solarday, Sorgenia, Techint. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 163 Bibliografia Si riportano di seguito le principali fonti di natura bibliografica che sono state consultate nell’ambito della ricerca: • APER (2008), Report Fotovoltaico 2007 -2008 • APER (2009), Report Fotovoltaico 2008 -2009 • ASSOLTERM (2008), Position Paper • CNES (2008), Rapporto preliminare sullo stato attuale del solare fotovoltaico nazionale • CNES (2008), Rapporto preliminare sullo stato attuale del solare termico nazionale • Deutsche Bank (2009), The CSP industry • Deutsche Bank (2009), Solar Photovoltaic Industry • Deutsche Bank (2009), Infrastructure Investments in Renewable Energy • Deutsche Bank (2009), Creating jobs and growth • DLR (2009), Role and Potential of Renewable Energy and Energy Efficiency for Global Energy Supply • ECOSTAR (2003), European Concentrated Solar Thermal Road-Mapping • Emerging Energy (2008), Solar PV Development Strategies in Europe, 2008-2020 • Emerging Energy (2009), Global concentrated solar power markets & strategies: 2009-2020 • Enea (2009), Usi termici delle fonti rinnovabili • EPIA (2008), Global Market Outlook for Photovoltaics unit 2012 – Facing a Sunny Future • EPIA (2009), Global Market Outlook for Photovoltaics until 2013 • EPIA e Greenpeace (2008), Solar Generation V • ESTIF (2008), Solar Thermal Markets in Europe – Trends and Market Statistics 2007 • ESTIF (2009), Solar Thermal Markets in Europe – Trends and Market Statistics 2008 • ESTELA-GREENPEACE (2009), Global Concentrating Solar Power • EurObserv’ER (2008), Photovoltaic Barometer • EurObserv’ER (2008), Solar Thermal Barometer • EurObserv’ER (2009), Photovoltaic Barometer • EurObserv’ER (2009), Solar Thermal Barometer • European Commission, JRC e IES (2009), PV Status Report – 2009 • GSE (2009), Incentivazione degli impianti fotovoltaici • IEA (2009), Technology Roadmaps - PV: Targets • IEA (2009), Renewable Energy Essentials: Concentrating Solar Thermal Power • IEA (2009), Renewable Energy Essentials: Solar Heating and Cooling • IEA (2009), Trends in Photovoltaic Application. Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2008 • Lawrence Berkeley National Laboratory (2009), Tracking the Sun II - The Installed Cost of Photovoltaics in the U.S. from 1998-2008 • Morgan Stanley (2008), Solar Device Growth at Lower Margin • MRS Bulletin (2008), Solar Energy Conversion Toward 1 Terawatt • NREL (2003), Assessment of Parabolic Trough and Power Tower Solar Technology Cost and Performance Forecasts • NREL (2009), 2008 Renewable Energy Data Book • REN LAB (2009), Il sistema industriale lombardo nel business dell’energia fotovoltaica • SOLAIR (2009), Market report for small and medium-sized solar air-conditioning appliances • SOLAIR (2009), Survey of available technical solutions and successful running systems www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 165 Elenco delle organizzazioni intervistate Si ringrazia infine, per la disponibilità e le informazioni forniteci, le imprese e le organizzazioni intervistate nel corso della ricerca: • ADECCO • AL ENGINEERING • ALEO SOLAR • ALERION • ALTAIR IFM (GRUPPO MANUTENCOOP) • ALUK • ANTONIO CITTERIO AND PARTNERS • AROS • ARUP • ATMOS • BP SOLAR • CASSA RURALE BCC DI TREVIGLIO • CHAPMAN TAYLOR • COENERGIA • COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI • COSTRUZIONI SOLARI • DEA • ECOS ENERGIA • ECOWARE • EDISON • ELETTROSANNIO • ELETTRONICA SANTERNO • ENEA • ENEL GREEN POWER • ENERGENIA • ENERGES GESTION MEDIOAMBIENTAL • ENERGIE FUTURE • ENERGY GLASS • ENERPOINT • ENERQOS • ENERRAY • ENIPOWER • EU ENERGY • FOTIR • FRONIUS • GDM COSTRUZIONI • GREEN UTILITY • GRUPPO TOSONI • HELIOS TECHNOLOGY • HINERGY • INTESA SANPAOLO • ISOFOTÓN • KPMG • MANENS • MARCORA COSTRUZIONI • MARIO CUCINELLA ARCHITECTS • MECCANOTECNICA UMBRA • MITSUBISHI ELECTRIC • MPS CAPITAL SERVICES • MXGROUP • PARADIGMA ITALIA • PM SERVICE • POWER-ONE • PROMELEC INTERNATIONAL • PV ENERGY • REFLEX • RENERGIES • RICHARD ELLIS INVESTORS SGR • RIELLO • SAFEM • SCHOTT SOLAR • SCHÜCO INTERNATIONAL ITALIA • SIEL • SILFAB • SMA SOLAR TECHNOLOGY • SOLARDAY • SOLAREX www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano • SOLON • SOLSONICA • SONNENKRAFT • SORGENIA SOLAR • SPS ISTEM • STUDIO ARCHITETTURA PIAGGI • STUDIO ARIATTA • SUNERG SOLAR • SUNPOWER • SUNTECH • TECHINT • TECNO SPOT • TECNOTIN • TELEYA • TERNIENERGIA • UNICREDIT • VAILLANT • VELUX • XGROUP • XELIOX • ZURICH 167 La School of Management e l’Energy & Strategy Group School of Management Energy & Strategy Group La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell’economia e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, i Corsi Undergraduate e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Milano che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master. La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori, lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate. La School of Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi. L’Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano è composto da docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e si avvale delle competenze tecnico-scientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in particolare il Dipartimento di Energia. L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo di istituire un Osservatorio permanente sui mercati e sulle filiere industriali delle energie rinnovabili in Italia, con l’intento di censirne gli operatori, analizzarne strategie di business, scelte tecnologiche e dinamiche competitive, e di studiare il ruolo del sistema normativo e di incentivazione. L’Energy & Strategy Group intende presentare i risultati dei propri studi attraverso: • rapporti di ricerca “verticali”, che si occupano di una specifica fonte di energia rinnovabile (solare, biomasse, eolico, geotermia, ecc.); • rapporti di ricerca “trasversali”, che affrontano il tema da una prospettiva integrata (efficienza energetica dell’edificio, sostenibilità dei processi industriali, ecc.). www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 169 Le imprese partner BP Solar Edison Enel Green Power Enipower Intesa Sanpaolo Mitsubishi Electric Siemens SMA Solarday Sorgenia Techint www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 171 Imprese partner BP Solar fa parte di BP Alternative Energy, la divisione dedicata alle energie alternative che affianca il core business del gruppo BP legato al gas e al petrolio. Con più di 2.000 dipendenti nel mondo e oltre 1,5 mld $ di fatturato, BP Solar è uno dei principali player del mercato del fotovoltaico a livello mondiale. L’azienda vanta impianti produttivi di panneli fotovoltaici in Polonia, Messico, USA, India e Cina, oltre ad uffici commerciali in più di 160 Paesi nel mondo. BP Solar è impegnata anche nei Paesi del terzo mondo, dove ha fornito corrente elettrica ad interi villaggi, alimentato sistemi di pompaggio per l’irrigazione, nonchè realizzato impianti fotovoltaici per sistemi di comunicazione. I moduli BP Solar installati nel mondo, per una potenza complessiva di oltre 1 GW, consentono oggi di evitare l’immissione in atmosfera di circa 14 milioni di tonnellate di CO2, che equivale a piantare più di 5 milioni di acri di alberi. BP Solar in Italia propone soluzioni innovative per impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, garantendone la qualità e la producibilità agli investitori ed alle banche finanziatrici. La sua mission consiste nel raggiungere nel più breve tempo possibile la grid parity e proporre al mercato un’offerta con “il più alto valore aggiunto ed il minor costo in termini di centesimi per kWh, lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto”. BP Solar opera da oltre 30 anni nel mercato italiano, che è ritenuto dal Gruppo come uno dei più attrattivi a livello mondiale. BP Solar ha realizzato grandi impianti per 8 MW nel 2009 e ha una pipeline di progetti per oltre 100 MW da realizzarsi nel 2010. BP Solar si avvale inoltre di partner selezionati e qualificati per realizzare impianti di piccole e medie dimensioni, ossia residenziali e commerciali, consentendo all’azienza di essere presente su tutto il territorio ed in tutti i segmenti di mercato. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 173 Imprese partner Edison è uno dei principali operatori in Italia nel settore dell’energia, attivo dall’approvvigionamento e produzione alla vendita di energia elettrica e di gas. Edison dispone di una capacità di generazione di oltre 12.000 MW e gestisce circa 2.100 MW di capacità produttiva da fonte rinnovabile, di cui circa 1.690 MW di idroelettrico di grande taglia, 50 MW di mini-idro, 354 MW di eolico, 3,3 MW di fotovoltaico e 6 MW di biomasse solide. L’obiettivo di Edison è crescere e consolidare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, settore in cui è storicamente attiva. Le linee di crescita di Edison si articolano lungo cinque principali direzioni: • eolico: nel triennio 2010-12 Edison darà un forte impulso allo sviluppo di nuovi impianti eolici in Italia con l’obiettivo di arrivare a circa 440-450 MW di potenza installata. Già nel 2009 è entrato in esercizio l’impianto di Melissa/Strongoli in Calabria da 50 MW. Nei primi mesi del 2010 verrà inaugurato l’impianto eolico di Mistretta in Provincia di Messina (30 MW) e verranno avviati i lavori per altri due campi eolici in Campania a San Giorgio La Molara (BN) e a Faiano di Val Fortore (BN) - con una potenza rispettivamente di 54 MW e 18 MW. L’entrata in esercizio dei due impianti è prevista nel corso del 2011. Sempre nel 2009 è stato firmato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% del Parco Eolico San Francesco da Gamesa, che sta ultimando la costruzione di un impianto da 26 MW nel Comune di Melissa (Crotone). Edison intende crescere anche all’estero, in particolare nel Sud Est europeo (Romania e Grecia), dove punta sullo sviluppo di impianti eolici green field; • idroelettrico: nel settore idroelettrico proseguono le attività di ripotenziamento e riammodernamento delle centrali del gruppo. Edison intende cogliere le eventuali opportunità di incremento della capacità installata che si manifesteranno nel tempo attraverso lo sviluppo del mini-idroelettrico; 174 • fotovoltaico: Edison ha debuttato nel fotovoltaico con il completamento dell’impianto di 3,3 MW ad Altomonte (CS), situato accanto alla centrale a ciclo combinato a gas naturale di proprietà. La crescita ulteriore nel fotovoltaico farà leva sulla pipeline esistente, alla luce delle nuove tariffe incentivanti del Conto Energia; • biomasse: in questo campo, si registra l’entrata in esercizio della centrale a biomassa solida di Castellavazzo (BL), a valle del progetto di rifacimento effettuato attraverso Sistemi di Energia, società controllata da Edison attiva anche nel campo degli impianti mini-idro (con circa 19 MW di potenza installata); • efficienza energetica e sostenibilità: Edison è entrata con decisione nel mercato dell’Efficienza Energetica e Sostenibilità creando un’area di business dedicata. Il modello che Edison intende promuovere è semplice ma innovativo: mettendo a disposizione la sua esperienza di operatore energetico, Edison analizza la struttura dei consumi del cliente, impegnandosi sul conseguimento del risultato attraverso interventi di ottimizzazione e di autoproduzione. Edison è disponibile ad intervenire con proprie risorse finanziarie per sostenere l’investimento, a vantaggio non solo del cliente ma anche della collettività, con evidenti ricadute positive in termini di contenimento delle emissioni. Edison dedica inoltre particolare attenzione all’attività di innovazione nel settore delle energie rinnovabili ed in particolare alle tecnologie del fotovoltaico di terza generazione e del solare termodinamico. In questo senso, è stata allestita una area test, vicino all’impianto fotovoltaico di Altomonte (CS), per la sperimentazione ed il confronto di sistemi fotovoltaici tradizionali, innovativi ed a concentrazione. Sono stati anche attivati progetti di ricerca su tecnologie sviluppabili nel medio termine, quali l’eolico innovativo offshore. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Imprese partner Enel è la più grande azienda elettrica in Italia, che produce, distribuisce e vende energia elettrica e gas in Europa, Nord America e America Latina. Nel dicembre 2008 l’azienda ha creato Enel Green Power, la società del gruppo dedicata allo sviluppo della capacità installata da fonti rinnovabili in tutto il mondo. Enel Green Power detiene il 100% del capitale sociale di Enel.si, impresa nata nel 2000 con l’obiettivo di operare nei settori del fotovoltaico, del solare termico, dei prodotti ad alta efficienza (climatizzatori e caldaie) e delle fonti rinnovabili in genere. Le attività di Enel Green Power nel settore del fotovoltaico sono in continuo sviluppo, sia attraverso Enel.si nel mercato retail, sia attraverso una continua ricerca delle migliori opportunità di investimento diretto o in partnership, come ad esempio quella che è attualmente in essere con Sharp e che ha l’obiettivo di sviluppare, entro il 2016, campi fotovoltaici nella regione mediterranea per una capacità installata totale di circa 500 MW. A ciò si affianca una strategia di integrazione a monte della filiera: a tal fine è stato siglato un accordo con Sharp e con STMicroelectronics per la realizzazione della più grande fabbrica italiana di pannelli fotovoltaici a film sottile a tripla giunzione, a Catania. E’ previsto che la produzione dei pannelli parta nel primo semestre del 2011. Nel mercato fotovoltaico Enel.si si occupa della progettazione, installazione e manutenzione di impianti “chiavi in mano” di diversi livelli di potenza. Quest’attività è svolta da Enel.si attraverso i suoi circa 100 dipendenti ed una rete di oltre 500 installatori presenti su tutto il territorio nazionale, legati ad Enel.si da un contratto di franchising. Nel 2009 sono stati realizzati impianti per una potenza pari a circa 50 MW. Enel.si ha inoltre realizzato e messo in esercizio per Enel un impianto da 6 MW a Montalto di Castro. L’impresa è in grado di fornire ai propri clienti, tramite la propria rete di concessionari, finanziamenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici. Questo è possibile grazie alle convenzioni stipulate, tra gli altri, con il Gruppo Deutsche Bank per l’ambito retail e con il Gruppo Montepaschi, la Banca Popolare di Sondrio, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano per gli impianti di dimensioni più consistenti. Enel.si offre, sempre attraverso la rete di affiliati, impianti solari termici, prevalentemente per il mercato domestico. Enel Green Power nel 2009 ha inoltre sottoscritto diversi importanti accordi nel settore del fotovoltaico: • con il Centro Ingrosso Sviluppo Campania (CIS) e Interporto Campano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 25 MW, il più grande progetto integrato su tetti con tecnologia innovativa in Italia, e tra i più grandi a livello mondiale. L’impianto, di proprietà di Enel Green Power, sorgerà nel Comune di Nola, in Provincia di Napoli, e sarà realizzato sulle coperture di immobili commerciali e logistici, in totale integrazione architettonica. Dotato di innovativi moduli fotovoltaici flessibili a film sottile, in silicio amorfo, entrerà in esercizio nel 2010; • con il Gruppo Marcegaglia per la realizzazione a Taranto, sulle coperture degli stabilimenti industriali del gruppo Marcegaglia, di un impianto fotovoltaico da 4 MW in totale integrazione architettonica, per la maggior parte con la tecnologia innovativa del film sottile flessibile, in silicio amorfo. Il Gruppo Enel è attivo anche nel campo del solare termodinamico con il progetto Archimede - di cui si è parlato ampiamente nel rapporto di ricerca - e nella ricerca sul fotovoltaico a concentrazione, con alcuni prototipi che si stanno testando presso i laboratori di Catania. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 175 Imprese partner Enipower è la società di Eni per le attività di generazione di energia elettrica, di vapore e per la produzione e commercializzazione di impianti fotovoltaici. La tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza delle proprie risorse umane, oltre ai rapporti con il territorio e con gli stakeholder, sono obiettivi primari nelle logiche gestionali dell’azienda. Enipower e le sue società controllate dispongono di 8 centrali di generazione elettrica, vapore tecnologico e acqua surriscaldata, con una potenza elettrica installata di oltre 5,3 GW, insediate nei siti industriali di Ravenna, Ferrara, Mantova, Ferrera Erbognone, Livorno, Brindisi, Taranto e Bolgiano. La società sta completando un piano di investimenti che comporta la graduale sostituzione degli impianti tradizionali, acquisiti alla sua costituzione, con moderni impianti a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, che garantiscono standard elevati per la sicurezza e la salute delle risorse umane impiegate e per la salvaguardia dell’ambiente. Nel comparto fotovoltaico, Enipower dispone dal giugno 2006 di un sito produttivo, localizzato a Nettuno, nei pressi di Roma, dove si realizzano celle e moduli mono- e multi-cristallini. La linea di produzione di questo impianto ha raggiunto nel 2008 una capacità di 10 MW e la società sta terminando un programma di investimenti per un suo significativo incremento. Lo stabilimento si estende su una superficie di circa 34.000 metri quadrati, di cui 8.000 coperti, divisi in aree produttive, uffici e laboratori, aree di servizio tecnico 176 e magazzini. L’impianto è in grado di produrre celle solari ad alta efficienza a base di silicio multi-cristallino e di assemblare moduli fotovoltaici mono- e multi-cristallini, mediante utilizzo di moderne tecnologie. Le linee di produzione dello stabilimento sono costituite da una serie di apparecchiature automatiche che sottopongono la materia prima acquistata sul mercato (“fette” di silicio o wafer dello spessore di circa 200 micron) a un trattamento chimico-fisico per la trasformazione in cella fotovoltaica, con una serie di processi consecutivi. Enipower fornisce impianti, con il marchio Eurosolare®, principalmente alle piccole-medie imprese. Essa si serve del supporto di società esterne solamente per la fase di installazione. Per la fornitura dei diversi componenti dei moduli (EVA, vetri e cornici in alluminio) e dell’impianto (inverter e componentistica elettrica), l’impresa indice delle gare d’appalto cui partecipano fornitori pre-selezionati che hanno la possibilità di ottenere contratti di fornitura di lungo periodo. Oltre alla realizzazione di una serie di impianti fotovoltaici su pensiline di stazioni di distribuzione carburanti Eni, su pensiline dei parcheggi presso la sede di SnamProgetti di Fano e diversi impianti realizzati su tetti e terreni, al momento Enipower annovera nel suo portafoglio una centrale a produzione fotovoltaica in Italia, a Nettuno. In Algeria, Enipower ha realizzato, nell’ambito di un accordo di cooperazione e sviluppo delle energie rinnovabili nei paesi del Nord Africa firmato dal Governo Italiano ed Algerino, il primo impianto del Paese connesso alla rete. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Imprese partner Il Gruppo Intesa Sanpaolo è tra i gruppi bancari leader in Italia nei settori retail, corporate e wealth management. Intesa Sanpaolo guarda con particolare attenzione, sin dall’introduzione del Primo Conto Energia, al settore delle fonti rinnovabili, in particolare al comparto del fotovoltaico. Il ventaglio di offerte in questo campo è piuttosto ampio e si suddivide tra prodotti per installazioni residenziali, per imprese o per il finanziamento diretto di grandi impianti. Grazie all’accordo quadro siglato con il GSE, tutti questi finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia rappresentata dalla cessione dei crediti nei confronti dello stesso ente riferiti al Conto Energia. Nel campo dei prodotti retail, il “Prestito ecologico” è lo strumento destinato a soggetti privati e utilizzato, tra l’altro, per finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari termici. Tale prestito può avere una durata massima di dodici anni ed un importo finanziabile massimo di 75.000 €. Il “Finanziamento energia business” è lo strumento pensato per piccole imprese e liberi professionisti che intendono realizzare un impianto fotovoltaico. Esso prevede un finanziamento fino al 100% dell’ammontare complessivo, IVA esclusa. Il prestito può avere un importo variabile tra 20.000 € e 500.000 €, con una durata compresa tra due e quindici anni. Uno strumento di finanziamento per le imprese che abbiano intenzione di installare un impianto fotovoltaico è il “Finanziamento fotovoltaico imprese”, che può avere una durata fino a quindici anni ed un importo finanziabile variabile tra 75.000 € e 6 mln €. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’investimento, IVA esclusa. “Leasenergy” è il leasing nato per professionisti, artigiani e imprese di qualunque dimensione che intendono utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di energia, quindi anche impianti fotovoltaici. Lo strumento ha una durata di 180 mesi, con canoni prevalentemente mensili. Per sostenere gli imprenditori che investono nel settore delle energie rinnovabili, Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nello sviluppo delle piccole e medie imprese, ha cre- ato il Desk Energy. Si tratta di una struttura specialistica dedicata al settore delle energie rinnovabili, con la finalità di fornire supporto e risposte concrete a tutte le esigenze, non solo finanziarie, delle aziende interessate a sviluppare tale business. Nel campo del fotovoltaico opera anche la divisione di Project & Industry Specialized Lending, che ha come clienti potenziali grandi imprese e fondi infrastrutturali o di private equity. In entrambi i casi Intesa Sanpaolo si occupa degli aspetti finanziari del progetto, ma senza per questo prescindere dalle tematiche strettamente industriali degli impianti. La strutturazione in project finance di un parco fotovoltaico risulta essere interessante al raggiungimento di una certa massa critica. Nel project financing Intesa Sanpaolo ricopre sia il ruolo di advisor finanziario nella fase di strutturazione dell’operazione sia il ruolo di lender nella fase di arranging. Tra i principali requisiti di bancabilità di un EPC contract fotovoltaico, oltre alla solidità finanziaria dell’azienda, vi è la presenza delle seguenti garanzie: l’advance payment bond, che viene rilasciato dall’EPC contractor all’owner dell’impianto, dietro corresponsione anticipata di circa il 20% - 30% del costo del contratto, il performance bond, che garantisce la buona esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto fino al suo collaudo, ed infine il warranty bond, che garantisce l’impianto da difetti dei materiali e dei componenti per circa i due anni successivi al collaudo. Altro approccio al business del fotovoltaico da parte di Intesa Sanpaolo consiste nella possibilità di intervento diretto nell’equity delle aziende più interessanti del settore. Un esempio in questo senso è rappresentato da Equiter, investment company del Gruppo dedicata al settore delle infrastrutture, che detiene il 20% del capitale di Enerpoint con la quale è stata costituita Enerpoint Energy, una joint venture paritetica che sta sviluppando un portafoglio in proprietà di impianti di generazione di energia da fonte fotovoltaica. Sempre Equiter è advisor per la selezione degli investimenti del Fondo chiuso PPP Italia, che sta dedicando una parte del proprio portafoglio agli impianti fotovoltaici. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 177 Imprese partner Mitsubishi Electric è nata nel 1921 in Giappone ed è oggi leader mondiale nella produzione, nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Presente in 34 Paesi, ha iniziato la sua attività in Europa nel 1969 e dal 1985 ha creato una filiale in Italia che opera in cinque divisioni commerciali, tra cui quella fotovoltaica – inverter fotovoltaici e pannelli fotovoltaici. L’ingresso di Mitsubishi Electric nel mercato dei sistemi fotovoltaici per applicazioni residenziali risale al 1996. Nel 1998 è stato inaugurato lo stabilimento produttivo di Iida, destinato alla produzione di celle e moduli, mentre il sito produttivo di Kyoto ha iniziato la sua attività nel 2003. Nel 2007 lo stabilimento di Iida è stato interamente destinato alla produzione di celle, mentre l’assemblaggio di moduli è stato concentrato a Kyoto. Nel settembre 2008 il presidente di Mitsubishi Electric ha annunciato l’imminente costruzione di un ulteriore impianto produttivo di celle fotovoltaiche localizzato a Iida, che è stato recentemente inaugurato. Con un aumento di 50 MW entro marzo 2011 l’azienda raggiungerà i 270 MW di capacità produttiva annua di moduli fotovoltaici e prevede inoltre di raggiungere una capacità annua di 600 MW nel 2012. Oltre alla gamma esistente di moduli fotovoltaici in silicio policristallino, Mitsubishi Electric intende installare nella fabbrica di Iida nuove apparecchiature in grado di produrre celle fotovoltaiche in silicio monocristallino e di avviarne la regolare produzione entro Marzo 2010. Allo stesso tempo 178 l’azienda installerà nuove linee di produzione per la realizzazione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino presso la fabbrica di Kyoto. Per quanto riguarda l’articolazione del modello di business, Mitsubishi Electric acquista lingotti di silicio e produce internamente celle (destinate interamente all’autoconsumo) e moduli in silicio policristallino, realizzati con tecnologia multilayer ad elevata qualità. Dal settembre 2006 Mitsubishi Electric ha inoltre completato la sua offerta per il mercato fotovoltaico europeo attraverso la fabbricazione e distribuzione di inverter monofase per uso residenziale. La produzione è totalmente centralizzata in Giappone e la filiale italiana, che impiega 10 addetti, si occupa esclusivamente della vendita di moduli e inverter, principalmente a grandi installatori e system integrator, e dell’assistenza tecnica. In Italia il target dell’azienda è equamente suddiviso tra mercato industriale e mercato residenziale: nel 2008 sono stati venduti moduli per circa 24 MW e nel 2009 per 28 MW. Per quanto riguarda gli inverter, l’azienda è presente sul mercato con prodotti di piccola taglia e destinati ad usi prevalentemente residenziali. La gamma di inverter si caratterizza per il grado di efficienza tra i più elevati del mercato. Mitsubishi ha venduto in Italia, nel 2008, circa 4 MW di inverter, mentre nel 2009 5 MW. L’azienda sta inoltre mettendo a punto un kit fotovoltaico costituito da modulo più inverter, che potrebbe arrivare a breve sul mercato. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Imprese partner Solarday S.p.A. è una società italiana specializzata nella produzione di moduli fotovoltaici in silicio policristallino. Solarday realizza prodotti di alta qualità e massima affidabilità attraverso processi produttivi all’avanguardia, un sistema di apparecchiature industriali di ultima generazione e la collaborazione di personale tecnico altamente specializzato, dedito alla ricerca ed allo sviluppo tecnico sia a livello di prodotto che di processo. Solarday ha realizzato nel 2009 un fatturato di circa 61 mln €. L’azienda, fondata nel 2004 da un gruppo di tecnici del settore e da alcuni imprenditori, si colloca tra i primi progetti industriali italiani del settore fotovoltaico. Lo stabilimento per la produzione di moduli, nato nel 2006, si trova a Mezzago, nel cuore della Brianza; oltre 100 sono gli addetti tra operai, impiegati e responsabili che hanno contribuito e contribuisco al successo di Solarday. Nel corso del triennio 2006-2009 l’azienda ha portato a regime le proprie linee di produzione e triplicato la propria capacità produttiva, raggiungendo in breve tempo una capacità nominale di 60 MW/ anno. Solarday rappresenta un punto di riferimento per impiantisti, progettisti e installatori che intendono utilizzare prodotti e soluzioni di eccellente qualità e affidabilità e usufruire della professionalità e del supporto qualificato di un team di esperti nelle differenti fasi del progetto. Oltre ai processi produttivi per i quali Solarday ha ottenuto la certificazione da parte dell’ente tedesco TÜV Rheinland secondo gli standard IEC 61215 Ed.2 e SCII, l’azienda è certificata per i processi di gestione (ISO 9001-2008) e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001-2008). Solarday focalizza la sua offerta nella produzione di moduli fotovoltaici policristallini, che maggiormente si adattano alle esigenze di installatori e impiantisti e, più in generale, a quelle del mercato nazionale ed internazionale. Il modello di punta è rappresentato dal modulo standard denominato Solarday PX60, disponibile nelle versioni Classic, Trend e Glamour in base alla potenza (da 210 a 240 Wp). I moduli della serie PX60, in silicio multicristallino, assicurano un elevato rendimento energetico anche in situazioni di bassa insolazione e grazie alle dimensioni, al peso contenuto ed alla potenza di fascia alta, riscontrano il gradimento degli installatori, che vengono facilitati durante le fasi di montaggio da minori movimentazioni e dalla conseguente riduzione dei costi di gestione e messa in opera. Solarday dispone, inoltre, di una vasta gamma di prodotti custom con classi di potenza e dimensioni differenti, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di impiantisti e installatori. Punta di diamante della linea custom è il modulo fotovoltaico vetro/vetro. Sviluppati per rispondere alla sempre crescente richiesta di integrazione architettonica, i moduli fotovoltaici BIPV sono prodotti su richiesta, coerentemente con le specifiche tecniche dettate dai clienti. Si tratta di pannelli fotovoltaici con potenza, dimensioni e caratteristiche personalizzabili in base allo specifico contesto applicativo, come accade appunto anche per i moduli vetro/vetro, realizzabili anche in vetrocamera e con potenza fino a 1000 Wp, che rispondono alle norme IEC 61215 (Ed.2), IEC EN 61730 1-2 e EN 12543 (vetro di sicurezza). Inoltre, grazie alla collaborazione con aziende specializzate nella realizzazione di serramenti e sistemi di fissaggio, Solarday offre soluzioni complete per qualsiasi esigenza di integrazione architettonica. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 179 Imprese partner Il Gruppo Siemens, con un’organizzazione articolata in tre Settori - Energia, Industria e Sanità - è presente a livello mondiale con circa 405.000 collaboratori ed un fatturato 2008/09 di 76,7 mld €. Siemens S.p.A., attiva in Italia dal 1899, rappresenta una delle più importanti realtà industriali del Paese, con oltre 5.500 dipendenti e un fatturato pari a 2,6 mld € nell’anno fiscale 2008/09. In un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici, crescita della popolazione mondiale e aumento dell’urbanizzazione, oltre che dall’esigenza di rispettare i vincoli di emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto, non si può prescindere dall’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili. Siemens, unico fornitore in grado di coprire tutte le esigenze del sistema energetico elettrico – dalla generazione alla trasmissione e distribuzione fino alla gestione dei consumi industriali e civili, è leader nelle attività di innovazione tecnologica e player di riferimento per la generazione da fonte rinnovabile nei settori eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, idrico, biomasse e geotermico. Nel fotovoltaico, Siemens si propone sia come partner per la progettazione esecutiva, dimensionamento, realizzazione e ottimizzazione in esercizio di centrali “chiavi in mano”, sia come fornitore delle componenti tecnologiche fondamentali per la gestione efficiente dell’impianto: inverter, quadri e trasformatori elettrici, sistemi scada (supervisory control and data acquisition) di monitoraggio elettronico e sistemi di videosorveglianza. La modularità e l’integrazione dell’offerta Siemens rappresentano i principali fattori del suo successo. 180 Per sfruttare le potenzialità del mercato fotovoltaico, Siemens adotta tre principali approcci a questo business: • approccio “Chiavi in Mano”: consiste nella progettazione esecutiva, dimensionamento e realizzazione di impianti “chiavi in mano” di potenza superiore a 500 kW, comprensivi dei moduli fotovoltaici. Questo modello è adottato principalmente per clienti industriali e produttori di energia; • approccio “EPC elettrico”: consiste nell’ingegnerizzazione, fornitura e commissioning di sistemi elettrici e di automazione per l’efficienza, la flessibilità e la continuità degli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 500 kW; • approccio “Fornitura prodotti”: consiste nella fornitura della tecnologia Siemens attraverso la tradizionale rete commerciale dei distributori per installatori e system integrator locali, che progettano e sviluppano impianti di taglia mediopiccola, senza la diretta supervisione di Siemens. Siemens sta investendo molto anche nel Concentrated Solar Power (o solare termodinamico). Oltre ad essere leader mondiale per la fornitura di turbine a vapore per applicazioni solari termodinamiche, Siemens ha ampliato ulteriormente il proprio ambito di attività in questo comparto. Grazie alle recenti acquisizioni di una quota del capitale di Archimede Solar Energy, che produce ricettori solari a sali fusi per impianti CSP, e dell’israeliana Solel, che permette a Siemens di offrire anche la parte di potenza per impianti a specchio parabolico, l’impresa è in grado di ottimizzare il rendimento degli impianti ed aumentare l’efficienza del sistema nel suo complesso. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Imprese partner SMA Italia è la filiale di SMA Solar Technology AG. Con una potenza installata di oltre 6,5 GW, SMA è il primo produttore a livello mondiale di inverter fotovoltaici ed è in grado di offrire la più ampia gamma di inverter per tutte le classi di potenza e compatibili con ogni tipo di modulo. Il Gruppo, fondato nel 1981, ha la sede principale a Kassel, in Germania, ed è presente in tutti i mercati chiave del mondo con oltre 4.000 dipendenti e 13 filiali commerciali e di assistenza tecnica. Nel 2009 ha registrato un fatturato di circa 934 mln €. Dal 27 giugno 2008 SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della Borsa di Francoforte e dal 22 settembre dello stesso anno le sue azioni sono inserite nel TecDax. SMA ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Best Place to Work Europe come miglior datore di lavoro. SMA Solar Technology AG ha una capacità produttiva annua di 4 GW, generata nello stabilimento “CO2 Carbon Neutral” di Kassel, Germania: 18.000 metri quadrati, il più grande stabilimento produttivo di inverter fotovoltaici al mondo alimentato totalmente da energie alternative a impatto zero per l’ambiente. Il Gruppo sta inoltre realizzando un secondo stabilimento di produzione negli Stati Uniti. L’inverter è il cuore intelligente di ogni impianto fotovoltaico. E’ il componente strategico, in quanto trasforma la corrente continua prodotta dalle celle fotovoltaiche in corrente alternata conforme alla rete del distributore. Gli inverter SMA si distinguono per un grado di rendimento particolarmente elevato, che raggiunge e supera in alcuni dispositivi il 98%, consentendo una maggiore produzione di corrente ed un rapido ritorno d’investimento. La mission di SMA è di riconoscere le esigenze del mercato in anticipo e di stabilire le tendenze grazie alla continua innovazione tecnologica che consente di aumentare i benefici riducendo il prezzo specifico per Watt. Le innovazioni immesse da SMA nel campo della tecnologia inverter sono in- numerevoli e rivoluzionarie: la tecnologia String, il sistema Multi-String, la topologia H5, il sezionatore di carico ESS integrato, il sistema di raffreddamento Opticool e molte altre innovazioni sono gli highlights che hanno consentito agli inverter SMA di essere dichiarati più volte vincitori dei rispettivi test merceologici. La gamma di inverter SMA è la più ampia attualmente disponibile sul mercato ed offre le soluzioni per ogni tipo di esigenza. Diverse sono le famiglie di prodotti SMA. Per gli impianti residenziali di piccola taglia gli inverter Sunny Boy, con un eccezionale grado di rendimento, garantiscono un’elevata disponibilità operativa dell’impianto ed un’alta produzione energetica. La famiglia Sunny Boy è oggi arricchita dalla presenza degli inverter di nuova generazione senza trasformatore e dalla linea con trasformatore High Frequency. Per impianti di media-grande potenza, SMA offre gli inverter della famiglia Sunny Mini Central che, grazie alle loro possibilità di combinazioni illimitate, consentono di realizzare tutti i tipi di impianti e di ottenere il massimo rendimento. Per le grandi installazioni, SMA offre la gamma dei Sunny Central, dai 100 kW fino ai grandi inverter da 1 MW, che abbinati possono dare vita alle grandi centrali fotovoltaiche da diversi MW. Per la produzione di energia in zone isolate o non connesse alla rete, SMA propone inoltre i Sunny Island. SMA ha un ventaglio completo di soluzioni anche per il controllo e il monitoraggio degli impianti. Gli strumenti di comunicazione SMA consentono di ricevere tutte le informazioni sulla produttività del proprio impianto da qualsiasi luogo. Inoltre, tutti gli inverter di ultima generazione sono predisposti alla trasmissione dati via Bluetooth. SMA è trend-setter anche dal punto di vista della formazione, del Customer Care e del Marketing, come dimostrato dall’ampia offerta di corsi di formazione Solar Academy e dal Sunny PRO Club, il primo Club di Marketing dedicato ai professionisti del fotovoltaico. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 181 Imprese partner Il Gruppo Sorgenia è il primo operatore privato del mercato italiano dell’energia ed uno dei principali protagonisti del mercato libero italiano del gas. L’azienda opera nelle fasi di approvvigionamento e vendita diretta, sia nel comparto elettrico sia in quello del gas naturale. Nel 2007 il Gruppo ha registrato un fatturato di 1,8 mln €. L’azienda è molto sensibile al tema della produzione di energia da fonti rinnovabili e al momento opera nei comparti dell’idroelettrico, eolico e fotovoltaico. Dell’attività fotovoltaica di Sorgenia si occupa la società Sorgenia Solar, che comprende circa 45 addetti. L’azienda, leader del mercato fotovoltaico italiano per impianti installati di proprietà, si rivolge al mercato degli impianti fotovoltaici “chiavi in mano” composto da grandi investitori quali banche e fondi di investimento che hanno progetti per grandi centrali solari, imprese e gruppi industriali italiani che intendono installare impianti nelle proprie aree produttive e, infine, al mercato domestico. Sfruttando la propria produzione di moduli fotovoltaici, Sorgenia fornisce il suo prodotto al mercato degli installatori e dei distributori. Sorgenia collabora con istituti di credito come il Gruppo Sella e società di leasing come Unicredit leasing per quanto concerne gli aspetti finanziari e assicurativi associati alla fornitura dell’impianto. Negli anni Sorgenia ha affiancato a questo modello di business la vendita di materiali e tecnologie a business partner monomarca, che integrano tali componenti in impianti “chiavi in mano”, di po- 182 tenza tipicamente inferiore a 50 kW e destinati al mercato business/residenziale, comportandosi di fatto come distributori per i prodotti Sorgenia. In questo caso l’azienda rifornisce i propri partner di: • pannelli mono- e poli-cristallini prodotti internamente o acquistati principalmente sul mercato europeo; • quadri elettrici prodotti internamente; • celle, inverter, cavi e altre strutture di cui Sorgenia si approvvigiona da fornitori esterni. Sorgenia costruisce quindi anche impianti solari che integra nel proprio parco centrali e che contribuiscono a raggiungere la quota del 2% di energia da fonti rinnovabili che è chiamata ad immettere in rete. Attualmente Sorgenia dispone di 14 centrali con una taglia di 1 MW e situate nel Sud Italia. Attualmente ha in fase di costruzione o autorizzativa altri impianti di dimensione minima di 1 MW. La realizzazione di queste centrali solari è stata effettuata sulla base di un modello cherry picking. L’azienda dimostra anche un forte interesse per la tecnologia dei moduli a film sottile, come dimostra un contratto pluriennale sottoscritto con il fornitore First Solar. Tali moduli saranno utilizzati sui propri impianti e rappresenteranno una nuova area di business per Sorgenia già a partire dal 2009. L’impresa partecipa al fondo di investimento Noventi, con sede in California, che finanzia l’attività di ricerca in nuove tecnologie, tra cui il fotovoltaico, di società statunitensi, cinesi, taiwanesi e indiane. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano Imprese partner Il Gruppo Techint è una realtà multinazionale che comprende oltre 100 società, in cui lavorano circa 49 mila persone e con un fatturato di oltre 22 miliardi di dollari. In quasi 70 anni di attività le società del Gruppo, presenti nei cinque continenti, hanno raggiunto livelli di eccellenza in diverse aree di business: siderurgia (Tenaris & Ternium), impianti industriali (Tenova), Engineering & Construction (Techint), Oil & Gas (Tecpetrol) e sanità (Humanitas). Techint Engineering & Construction ha completato più di 3.500 progetti in tutto il mondo. L’attività spazia dalla costruzione di grandi infrastrutture alla realizzazione in tutte le fasi, dagli studi di fattibilità fino alla fornitura chiavi in mano, di impianti industriali, siderurgici, chimici e petrolchimici, e centrali elettriche. Techint infatti è specializzata nella progettazione e costruzione su base EPC di impianti che richiedono comprovata capacità di gestione di progetti complessi e conoscenza approfondita del territorio. Grazie alla sua storica presenza in Europa, America Latina, Medio Oriente ed Africa, Techint ha raggiunto una solida e radicata posizione nei paesi in cui opera. L’approccio “multilocal” consente a Techint di lavorare in queste aree in maniera più efficace avendo come vantaggio competitivo la conoscenza delle pratiche di business e degli standard locali. Utilizzando le soluzioni progettuali e le tecnologie più all’avanguardia, Techint è in grado di progettare e costruire impianti industriali che garantiscono la completa soddisfazione delle esigenze dei propri Clienti nel massimo rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, ambiente e qualità. Techint si è recentemente adoperata per associare la sua solida conoscenza nel settore dell’energia con l’innovazione e la ricerca, affrontando le sfide delle risorse energetiche e dell’ambiente per andare incontro alla domanda di mercato, investendo nelle energie rinnovabili e in particolare nella tecnologia del Solare a Concentrazione (CSP). Tale tecnologia ha già dato prova di fattibilità ed ha dimostrato un elevato potenziale nell’efficienza produttiva, affidabilità e flessibilità. Questo può essere realizzato attraverso l’impiego dello “stato dell’arte“ della tecnologia per collettori solari parabolici lineari, un concetto di stoccaggio dell’energia innovativo e un processo che può essere disegnato e ottimizzato con impianti stand-alone, integrati con i tradizionali cicli termodinamici o con impianti di desalinizzazione. Techint ha dato vita al Consorzio Solare XXI, all’interno del quale ha il compito di integrare i diversi componenti tecnologici, per formare un prodotto omogeneo e affidabile, e ottimizzare le strutture dei collettori. Accanto al collettore solare, un’ulteriore ottimizzazione dell’impianto può venire dal valore aggiunto di Techint nel design dell’accumulo termico, nella selezione della power island, nel disegno dei sistemi di raffreddamento o nella valutazione delle opzioni di desalinizzazione. Grazie al proprio track record nel settore degli impianti termoelettrici e la lunga esperienza nella costruzione e nella gestione dei progetti, Techint è garanzia di progetti realizzati con successo accompagnati da una sensibile riduzione dei costi, per il massimo rendimento dell’investimento del cliente. www.energystrategy.it solar energy report • Copyright © dig – Politecnico di Milano 183 Note Note Note Note Note Note Note Note Copyright 2010 © Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale Collana Quaderni AIP Registrazione n. 433 del 29 giugno 1996 – Tribunale di Milano Direttore Responsabile: Umberto Bertelè Progetto grafico e impaginazione: ADM Studio Stampa: Litogì ISBN: 978-88-904839-0-5 Main Partner Partner Con il patrocinio di www.energystrategy.it isbn 978-88-904839-0-5
Scarica