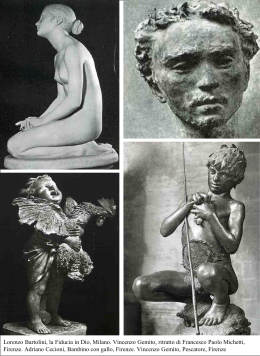Regione Veneto Comunità Montana dell’Alpago Maria Pia Pedani CAOTÈS La valle incantata Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione Veneto © Comunità Montana dell’Alpago Piazza Papa Luciani – 32015 Puos d’Alpago (Belluno) Tel./ 0437-454358 Ai prati e ai boschi dell’Alpago di cui ho imparato a conoscere la segreta magia PARTE PRIMA VALDENOGHÈR, 1544-45 1. Vincenzo Il ragazzino dal viso affilato, chiuso nel suo mantello grigio, spiccò la corsa su per il sentiero e raggiunse il capo della comitiva che teneva per la cavezza un asino carico di bagagli. «Manca ancora molto, mastro Fioravante?» gli chiese. «No, non molto, ancora un’ora di cammino.» rispose l’uomo. Era un vecchio magro e bruno, come la gente di quelle parti, calmo e solido come solo i contadini, abituati al lento avvicendarsi delle stagioni, sanno essere. «L’aria è fredda e il sole è già basso.» insistette il ragazzo. «Saremo a casa di suo nonno prima del calar della notte, se è questo che vuol sapere, signor Vincenzo.» Il signor Vincenzo, abbassò lo sguardo, vide un sasso, lo raccolse e poi lo scagliò con forza verso il bosco. Era la prima volta che si trovava così solo, lontano da casa. La solitudine… da più di un mese era ormai la sua unica compagna, da quando i suoi genitori erano morti all’improvviso, a poche settimane l’uno dall’altro. «Com’è nonno Alessandro? Lei lo conosce?» chiese ancora alla sua guida. «Un gran signore, che è stato in terre lontane e ne ha riportato grande scienza.» disse mastro Fioravante, con la voce di uno che sa molto ma preferisce parlare poco. La conversazione procedeva a rilento, eppure Vincenzo avrebbe voluto saperne di più di quel parente di cui, un mese prima, non conosceva neppure l’esistenza. Era stato il caso che aveva fatto incontrare a chi si era preso cura di lui un vecchio signore di passaggio per Venezia. Questi aveva raccontato di aver conosciuto in gioventù proprio suo nonno, Alessandro degli Alessandri, un gran filosofo e medico, il quale, dopo aver litigato con tutti, compreso il suo unico figlio, si era ritirato tra i monti, per poter studiare in solitudine. Una lettera gli era stata subito inviata e il ragazzo si era ben presto ritrovato in viaggio per raggiungerlo. In quel momento uno degli asini della fila fece uno scarto e si impuntò. Un uomo che si era mosso di corsa per raggiungerlo cadde pesantemente, scivolando su una sottile lastra di ghiaccio: a causa del gelo un rivo che attraversava il sentiero si era ghiacciato. Questo fatto creò un po’ di confusione e Vincenzo si accorse improvvisamente di quanto faceva freddo. «Manca molto che arrivi la neve?» chiese ancora. «Quando il gelo si farà meno pungente, allora scenderà tanta neve e non sarà più possibile salire così facilmente a Valdenoghèr.» rispose Fioravante. «È questo il nome del paese dove vive il nonno?» «Questo è il paese dove vive il signor Alessandro.» «Si vede già? Manca molto?» insistette Vincenzo. «Ancora un paio di curve e poi cominceranno a vedersi le prime case.» Dunque il gran momento si avvicinava e il ragazzo cominciò a provare un po’ di timore. Chissà come lo avrebbe accolto il vecchio che, informato dell’esistenza di un nipote, aveva risposto con una lettera molto ampollosa in cui si diceva disposto ad accogliere l’orfano, ma solo per carità cristiana e non perché dovesse qualcosa al figlio che aveva disconosciuto tanto tempo prima. «E com’è la casa dove vive il nonno? Suvvia, mastro Fioravante, mi dica qualcosa di più.» «È una grande casa, da signori, tutta di pietra; non come quelle che costruiscono da queste parti; solo a vederla si capisce che è diversa dalle altre.» Vincenzo rinunciò a tentare di avere nuove informazioni. Ormai dovevano essere quasi arrivati e tanto valeva aspettare. Pensò a quando aveva lasciato Venezia, dove era nato e aveva vissuto fino ad allora. Chissà come sarebbe stata la vita qui. D’inverno, tra la neve, ad aspettare la primavera, solo con il nonno. Ben diversa certo dalla confusione della città che aveva lasciato, dove le strade erano in gran parte selciate e si trovavano merci e persone provenienti da ogni parte del mondo. In quel momento, appena dietro una curva, vide ergersi contro il cielo terso i rami di un grandissimo albero. Era un noce gigantesco, che sembrava anch’esso contorto e intirizzito per il gelo. Senza sapere il perché lo salutò con un cenno della mano. Sentiva che da quel momento in poi gli alberi e le piante sarebbero stati i suoi compagni di gioco, piuttosto che gli altri ragazzi della sua età. «Buon giorno, signor noce.» avrebbe voluto dirgli. Il ragazzo immaginò una voce profonda che gli rispondeva: «Buon giorno.» Si voltò intorno ma non vide nessuno a cui poter attribuire quel saluto e pensò di averlo solo sognato. «Eccola, siamo arrivati! Quella è la casa di suo nonno!» il richiamo di mastro Fioravante lo scosse improvvisamente dai suoi pensieri. Un edificio alto, di pietra, apparve alla vista. Era davvero un palazzo da città, con tre grandi archi e sopra i balconi, e faceva una strana impressione tra le poche casupole basse e lo sfondo dei monti. Il sole al tramonto colorava tutto di rosa. Erano arrivati prima che facesse notte, come aveva promesso mastro Fioravante. Il chiasso della piccola comitiva venne a rompere la pace incantata di quel roseo imbrunire. «Ehi, di casa? C’è nessuno?» 6 «Fate piano! - rispose una voce di donna - Lo sapete che al padrone non piace la confusione. Sta studiando e finché c’è luce non lascia le sue stanze, neppure per una visita importante.» «Maria, Maria, quando smetterai di brontolare.» disse uno della comitiva. «Abbiamo camminato tanto e abbiamo bisogno di un buon bicchiere di vino.» Una donnetta svelta e magra si affacciò sotto il porticato. Portava lo scialle nero delle contadine e un fazzoletto del medesimo colore le serrava i capelli. Due occhi incredibilmente azzurri e vivaci brillavano come pietre preziose incastonate nell’ovale della faccia. «Allora venite dentro. Potete sistemare gli asini nella stalla. Date qui i bagagli. Questi bisogna portarli subito nelle stanze del signor Alessandro. Che nessuno li tocchi.» In quella confusione Vincenzo si sentiva come uno dei pacchi che quegli uomini avevano portato fin lassù. Chissà cosa contenevano! Ce n’erano di grandi e di piccoli e alcuni dovevano evidentemente essere trattati con maggior delicatezza degli altri. Quando finalmente le bestie furono sistemate nella stalla e fu tolto loro il basto, Maria sembrò accorgersi di quel ragazzo, avvolto in un mantello grigio, che si confondeva con il grigio dei muri. «E questo chi è?» chiese incuriosita. «Ma come, il padrone non gliene ha parlato? È il signor Vincenzo, suo nipote!» «Suo nipote? E da quando in qua il mio padrone ha un nipote?» disse Maria squadrando quel poco che si riusciva a scorgere di Vincenzo alla luce del crepuscolo. Mastro Fioravante si fece avanti, con fare importante: «Ma se ha scritto lui, al suo agente a Venezia, di mandarglielo pure, assieme ai vetri di Murano che aveva ordinato e a tutte quelle altre cose. È il figlio di suo figlio Jacopo, con cui ha litigato tanto tempo fa.» «Il figlio del signor Jacopo?» disse Maria che evidentemente, dalla sorpresa, non sapeva far altro che ripetere le parole che le erano dette. «Non ha più nessun parente a Venezia e quindi lo abbiamo portato qui.» Vincenzo si sentiva sempre più come uno di quei pacchi che erano stati portati dagli asini, e forse neppure il più prezioso. Quanto avrebbe voluto che quella conversazione finisse assieme alla viva curiosità con cui Maria lo fissava. «Un ragazzo, qui? È davvero impensabile. Ma dove aveva la testa il padrone quando ha scritto di mandarlo? Di sicuro tra i suoi libri, non certo sulla terra.» continuò la donna che evidentemente lavorava in quella casa da così tanto tempo da potersi prendere certe libertà di parola. «Bisognerà pensare a un letto… ma poi… per quanto si fermerà?» «Buonasera, buonasera a tutti.» disse una voce calda e profonda. Tutti si voltarono per salutare il padrone, che entrava in quel momento dalla porta. Alessandro degli Alessandri era un vecchio alto, con il volto incorniciato dalla barba e dai capelli bianchi. Il suo solo apparire faceva sentire che era una persona 7 importante, di quelle che non passano mai inosservate ed egli godeva della deferenza che gli altri mostravano per la sua età, la sua ricchezza e la sua scienza. «Avete portato tutto ciò che ho ordinato? E i libri? Devono averli trovati. Sono troppo importanti per le mie ricerche.» Il padrone di casa aveva evidentemente molto a cuore i suoi studi. «Signor Alessandro - disse Maria - ci sono i libri e i vetri ma a quanto pare c’è anche dell’altro.» «Dell’altro? Avete portato ancora zolfo e mercurio?» «Nossignore. - rispose mastro Fioravante - C’è qui il signor Vincenzo, suo nipote.» A sentirsi nominare così, all’improvviso, Vincenzo ebbe un sussulto. Non sapeva come comportarsi; nessuno gli aveva detto come doveva salutare, se con un inchino o con quali parole, quindi preferì stare zitto e, d’altra parte, il nonno sembrò appena accorgersi di lui. «Maria, occupatevene voi. Lo sapete che i bambini mi annoiano.» disse rivolto alla serva. «E cosa devo farne, padrone?» «Non ne ho idea, ma qualcosa si caverà pure da lui. Per adesso abiterà con noi e con calma ci penseremo. La casa è grande. Sistemalo di sopra. Ma fatemi vedere i vetri. Voglio controllare che valgano davvero quello che mi sono costati.» e con la felicità di un bambino alle prese con un giocattolo nuovo si mise ad aprire i pacchi e le casse che gli erano stati portati. Vincenzo non sapeva neppure dove guardare. Per fortuna Maria, che se ne accorse, lo strappò bruscamente dai suoi grigi pensieri. La serva provava una sorta di materna compassione per il piccolo orfano impaurito capitato così all’improvviso in quella grande casa. «Dai, ragazzo, vieni con me, qui non sei altro che d’impiccio.» gli disse obbedendo a un impulso improvviso e Vincenzo la seguì in silenzio nella stanza vicino. Allora la contadina cominciò a trattarlo con fare più deferente: «Allora cosa ha portato di suo? Quel baule? Non si preoccupi, lo farò portare di sopra. La sistemerò nella stanza della signora. Non è più stata usata da…, beh da tanto tempo.» Maria sembrava davvero una persona solida e pratica, che non si lasciava scomporre dalle bizzarrie del padrone, a cui doveva ormai essere abituata. «Quello è mio nonno?» chiese Vincenzo, tanto per dire qualcosa. «Credo proprio di sì. È da lui far arrivare qui un nipote, proprio all’inizio dell’inverno, senza avvertire nessuno di casa. Per fortuna le provviste bastano e avanzano anche per una bocca in più e qui, di spazio, ce n’è per tutti. Anni fa, quando la stagione era ormai avanzata, invitò cinque suoi amici che, naturalmente, con tutta la neve che scende, non riuscirono a tornare a casa loro prima di tre mesi…» 8 Maria parlava e parlava, mentre Vincenzo continuava a chiedersi come sarebbe stato quell’inverno. «Il signor Alessandro non è cattivo, non si spaventi - riprese Maria che dall’espressione di Vincenzo doveva aver intuito le sue preoccupazioni - solo un po’ troppo preso dai suoi libri e dalle sue idee, ma ci sono ragazzi qui nel vicinato con cui potrà fare amicizia. Non abbia paura.» «Ma ha litigato con mio padre? Ne sapete qualcosa?» le chiese Vincenzo mentre salivano le scale per raggiungere il piano superiore. «È successo tanto tempo fa e le cose si dimenticano. Suo padre voleva viaggiare, conoscere posti lontani, vivere la sua vita, mentre il signor Alessandro ormai aveva dimenticato le imprese della gioventù e voleva solo ritirarsi qui, tranquillo e in pace, e sperava che suo figlio lo aiutasse nei suoi studi. È stato un gran viaggiatore, sa, il signor Alessandro, ai suoi tempi! È stato nel paese del sultano dei turchi e poi tra i mori e ne ha riportato grandi conoscenze e anche dell’altro…» Entrarono intanto in una stanza che odorava di chiuso. Maria si diresse a una finestra e l’aprì e l’aria fredda di quella sera venne a scuotere la polvere che si era accumulata sui teli che ricoprivano i mobili. Un profondo divano troneggiava d’un canto, vicino a un tavolino basso. Due dischi di bronzo pendevano da una parete, legati con una corda intrecciata. Un quadro attirò subito l’attenzione del ragazzo: raffigurava una donna con un grande copricapo, come quello che portavano alle volte certi mercanti a Venezia; l’abito che indossava aveva una foggia strana, con ampie braghe e fitti ricami dorati. Sembrava sorridergli dalla parete. La serva intanto cominciò a togliere i cenci e a sbattere i cuscini mentre la luce si faceva sempre più fioca. «Ormai è ora di andar giù a prendere un lume. Per questa notte dovrà accontentarsi di dormire qui, anche se non è proprio tutto in ordine e c’è odore di chiuso. Simone arriverà subito per attizzare il fuoco nel camino e domani vedremo di sistemare un po’ meglio la sua stanza. Venga, scendiamo. È ben ora di andare a cenare.» Maria si avviò trotterellando verso le scale seguita dal ragazzo ancora quasi incapace di dire una parola. 2. Valdenoghèr La notte passò come in un attimo per Vincenzo che si svegliò, la mattina dopo, quando un raggio di luce già illuminava la stanza. Si chiese per un momento dove si trovava, ma poi gli tornò tutto in mente: il viaggio, suo nonno, la casa e quella strana immagine di donna che gli sorrideva dal grande quadro. Si vestì in fretta e corse da basso: tutto un mondo aspettava di essere scoperto. La prima persona che incontrò fu Maria: «Già in piedi? Bene, entri lì a fare colazione con gli altri; c’è del latte appena munto.» La serva lo osservò un momento, 9 con curiosità, ma poi ricominciò ad affaccendarsi: aveva altro a cui pensare e il piccolo orfano avrebbe dovuto imparare a cavarsela da solo. Vincenzo entrò nella piccola stanza, che odorava di buono, dove gli uomini che lo avevano accompagnato il giorno precedente stavano mangiando. Mastro Fioravante lo salutò, ma quella fu l’unica attenzione che ricevette. Guardandosi intorno cominciò a chiedersi se il suo destino in quel luogo fosse solo di annoiare gli altri. Stava finendo la sua ciotola di latte, quando giunse un ragazzino più o meno della sua età: era più basso e magro di lui, i suoi capelli erano biondi e aveva uno sguardo vivace. «Salve, io mi chiamo Celeste, e lei è certo il nipote del signor Alessandro… - gli disse tutto d’un fiato - Maria mi ha detto che devo mostrarle il paese. Vogliamo andare?» Finalmente qualcuno con cui parlare. Ringraziò in cuor suo la serva e seguì Celeste fuori dalla cucina. L’aria fresca e frizzante lo colpì, facendogli venir voglia di correre e giocare. La neve promessa non era ancora scesa e si preannunciava invece una giornata di sole. La visita al paese durò poco: vi era la casa di Modesta e Tranquilla, due anziane contadine che vivevano sole, con una quantità incredibile di animali e che, per festeggiare il ragazzo venuto da tanto lontano, diedero a tutti e due un bell’uovo fresco, appena raccolto nel pollaio. La chiesetta invece era chiusa. Il prete che la officiava, don Floriano, stava a Pieve e solo nelle feste importanti saliva fin lassù; ci sarebbe stata un’altra occasione per incontralo. Vi era poi qualche altra casa tra cui quella di Celeste e quella di Olmo, il padre di tre bambine, Rosa, Margherita e Iris. Celeste non sapeva bene cosa dire e come comportarsi. La presenza di quel ragazzo venuto da così tanto lontano e certo abituato a ben altri ambienti e altra compagnia lo metteva in imbarazzo. Lui, invece, non aveva mai abbandonato quei monti e Venezia gli appariva come una città mitica, piena di meraviglie e di personaggi strani. «Cosa ne dice? - fece a un certo punto, per interrompere un silenzio che cominciava a divenire pesante - Non è certo come stare in una grande città come Venezia, ma vedrà che ci sono tante cose belle da scoprire. Adesso è tutto addormentato, perché siamo all’inizio della cattiva stagione, ma a primavera ogni angolo si riempirà di fiori e si potranno trovare tanti animali, dai falchi ai caprioli.» «È proprio vero; l’inverno tinge tutto di grigio e marrone; a Venezia, invece, l’acqua diventa verde, da azzurra che è in estate, e il rosso delle case si fa più cupo; alle volte, tutto viene avvolto dalla nebbia; allora sembra di vivere dentro una nuvola.» rispose Vincenzo, colpito soprattutto dalla differenza di colori; la sua città era fatta di pietra e d’acqua e il cielo era solo la continuazione della laguna; Valdenoghèr invece era un luogo solido, fatto di terra e di piante. «Venga, andiamo a trovare Jacopo. - riprese il suo compagno - è un po’ distante ma poi, più in là, c’è la casa del Matt. Vedrà che ci divertiremo.» 10 Si mise a correre e Vincenzo stentava a tenergli dietro. Ogni tanto Celeste si fermava per vedere se il signorino di città riusciva a seguirlo. Sembrava lo facesse apposta di ripartire proprio quando l’altro lo raggiungeva. Quando finalmente arrivarono a una casa isolata Vincenzo era quasi senza fiato mentre l’aria gelata gli trapassava i polmoni. «Jacopo, esci! Ti voglio presentare un signore di città.» Un ragazzo robusto si fece sulla porta della stalla, era più alto di Vincenzo di un buon palmo e aveva la solidità dei monti che circondavano la sua casa. Seguirono i saluti; quelli di Vincenzo furono un po’ freddi e ansimanti. Il ragazzo aveva appena finito di rigovernare le vacche e suo padre lo lasciò libero di andare via per un po’ con gli amici. Così decisero di proseguire la corsa per un sentiero di cui non si riusciva a scorgere la fine. «Così arriveremo sino alla casa del Matt.» disse Celeste. Passarono un gruppo di case, chiamato da tempo immemorabile All’Ò e poi il paesello di Broz, dove si aprivano ben tre strade. Una di queste portava dritta dritta alla casa dove erano diretti. «Chi è il Matt?» riuscì a chiedere Vincenzo in uno dei rari momenti di sosta. «Il Matt è il Matt, cioè è un tipo strano, che vive da solo sulle Coste de Mai. Alla gente del paese non piace arrivare fin lì. Ci vanno solo i bambini e i ragazzi, quando portano le bestie al pascolo e lui racconta storie fantastiche. Vale la pena di conoscerlo.» disse Jacopo. «Andiamo avanti.» continuò Celeste che ricominciò a correre e saltare. Arrivarono infine a una casupola isolata; un uomo alto e bruno stava rompendo dei ceppi di legna con l’accetta. I suoi vestiti erano vecchi e scoloriti e aveva tutta l’aria del contadino, come ce n’erano tanti da quelle parti, eppure quando si volse verso i nuovi arrivati i suoi occhi chiari brillarono mentre li apostrofava con una voce profonda: «Guarda chi si vede. Jacopo e Celeste! Cosa fate qua? e a quest’ora?» «Ti abbiamo portato una visita. Questo è Vincenzo, il nipote del signor Alessandro. Viene da Venezia.» riprese Celeste tutto contento di poter presentare una persona così importante e che aveva viaggiato. «Il nipote di Mavì Hatùn! Questa è davvero una bella sorpresa!» disse il Matt inchinandosi davanti a Vincenzo, che sbottò incuriosito: «Il nipote di chi?» «Di Mavì Hatùn; non mi dirai che non conosci il nome di tua nonna?» e scoppiò in una sonora risata che fece sentire il ragazzino ancora più a disagio: non solo non riusciva a tenere il passo degli altri due ma addirittura aveva dimostrato di non conoscere i suoi propri parenti, e poi quel contadino osava trattarlo come un suo pari... la giornata che era cominciata così bene gli sembrava ora molto meno felice. «Forse ti va meglio il nome di Maria Turchese? Era così che la chiamava suo marito, oppure «la turca», come dicevano tutti in paese.» 11 «Sai qualche storia interessante sulla nonna?» chiese Vincenzo che non voleva mostrare che era la prima volta in vita sua che sentiva quei nomi. Dopo tutto, aveva saputo dell’esistenza di suo nonno da meno di un mese. «Se volessi potrei raccontarti molto. Quando lei venne qui io ero poco più piccolo di te, ma mi ha insegnato tante cose. Chissà, un giorno forse…» «Dai, racconta - insisté Celeste - non ci hai mai parlato della signora.» «Perché ai ragazzi piacciono altre storie. Dunque, vediamo… Lo sapete che ieri sono andato fino alla Fontana del Manteo e ho parlato con un falco pellegrino? Mi ha detto che quest’anno la neve si farà attendere, anche se gli uomini dicono il contrario.» «E che altro ti ha detto?» «Beh, che fra poco sarà Ognissanti e poi ci sarà San Martino.» «Questo lo sappiamo anche noi.» sbottò Celeste. «Sì, ma ciò che non sapete è che questi dieci giorni sono particolari. Tutta la natura è in subbuglio perché deve prepararsi al lungo sonno dell’inverno. È il momento in cui le Pleiadi sorgono alla fine del crepuscolo.» «Le cosa?» disse Jacopo che non conosceva quella parola. Vincenzo se ne stava zitto. Non voleva far sapere che anche lui non ne sapeva il significato. «Sono delle stelle che con il loro apparire e tramontare segnano la fine l’inizio della bella stagione. - continuò il Matt - A parte questo, il falco mi ha detto di stare attento perché «loro» saranno tutti in giro, come ogni anno, durante questi giorni, finché non giungerà il santo, a mandarli via. Una volta un frate mi ha raccontato che a Ognissanti le anime dell’inferno si scatenano, ma poi viene san Martino a cacciarle; in quei dieci giorni, però, è bene, anche per voialtri ragazzini, non oltrepassare le Coste de Mai da questa parte e la Valturcana dall’altra.» Jacopo e Celeste sembravano veramente preoccupati. Vincenzo lo era molto meno. Ricordava qualche discussione, ascoltata di nascosto, tra gli amici di suo padre. Alcuni dicevano cose molto strane: per esempio che a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, c’era il corpo di sant’Atanasio, una persona saggia e importante che aveva, però, tre teste, venerate in altrettanti santuari, situati in posti molto lontani. Poiché di solito un uomo ha solo una testa, due delle tre reliquie dovevano essere un po’ meno venerabili di quanto la gente pensasse. Da quando aveva sentito questa storia il piccolo degli Alessandri aveva cominciato ad essere un po’ scettico riguardo a tutte le pie leggende che gli raccontavano su santi e patroni. Facendosi dunque avanti, fiero di essere più coraggioso di quei ragazzi di paese, domandò: «E che cosa può succedere?» «Potresti scomparire per sempre, inghiottito dalla foresta - disse serio serio Celeste - come tanti anni fa capitò a Gildo, il fratello di Modesta e Tranquilla. Era andato lontano, a pascolare le vacche; dicono fosse arrivato fino alle Fratte, ai confini dell’altra parte, verso Chiès. Infatti le sue sorelle trovarono le bestie che brucavano sole proprio in quel luogo e le riportarono a casa, ma di lui non si seppe più nulla e 12 gli uomini non poterono certo andare a cercarlo. Non possono entrare e poi, se «loro» li trovassero…» «E chi sono «loro»?» «Erano uomini, una volta - disse il Matt con un tono cupo - adesso sono solo «loro». Secondo la Signora Maria Turchese sono dei morti ai quali è stata rapita l’anima. Per questo è facile ingannarli. Sono involucri di carne che restano legati alla terra. Non possono diventare polvere, come capita a tutti, ma sono condannati a un’esistenza maledetta, sospesi in un eterno presente. Solo bevendo il sangue possono calmare la loro pena e assaporare nuovamente una parvenza di vita. Qualche volta si vedono, ma è meglio non incontrali, anche per chi li conosce bene come me. Non si sa mai cosa possono fare. Vedete quella pietra laggiù? - riprese indicando un grande sasso che si ergeva, largo e solitario come un altare, ai margini del bosco che stava dietro la casupola - quello è il loro limite. Non possono passare oltre. Per questo io qui sto tranquillo, a casa mia. Alle volte, di notte, arrivano e si mettono a urlare, eppure finché sto qui non mi possono fare niente.» «E chi altro abita in quei boschi?» chiese Jacopo. «Non vi sono solo esseri malvagi. Alle volte si vedono delle ragazze passeggiare, soprattutto a primavera o in estate, quando il sole riscalda la terra e l’aria si fa immobile. Cantano canzoni meravigliose, ma non è facile sentirle.» «Perché? - chiese ancora Jacopo - Non parlano come noi?» «La natura non ha voce, ma chi sa ascoltarla capisce ciò che dice.» «Vuoi dire che la senti nella tua testa?» chiese Vincenzo, che improvvisamente si ricordò del suo arrivo a Valdenoghèr e di quello strano saluto con cui era stato accolto. «Se vuoi puoi dire così. - continuò il Matt - Tutta la natura parla così: il falco pellegrino e la fonte, il fiore appena sbocciato e anche quel sasso solitario. Ognuno ha una storia da raccontare oppure ti vuole dare un avvertimento o farti una richiesta…» guardò con interesse Vincenzo «Forse assomigli a tua nonna. - disse - Mi sbaglio?» Vincenzo non sapeva cosa dire così preferì cambiare discorso: «Ma tu l’hai mai visto, san Martino? Ne parli come uno che sa tante cose di lui.» «Certo che l’ho visto, anche se una volta sola. - disse il Matt - Faceva veramente freddo quell’anno, ma avevo finito la legna e soltanto su, oltre la costa, se ne poteva trovare. Così entrai nella terra proibita agli uomini e a un certo punto il freddo si fece ancora più intenso e venne notte, anche se fino a poco prima c’era un pallido sole in cielo. Così lo vidi; era vestito di nero e aveva un mantello nero; un’oca lo stava seguendo e mi sembrò che gli stesse parlando. Facevano uno strano contrasto, lui avvolto dall’oscurità e lei una macchia bianca. Rimasi nascosto dietro un albero, tremando per il terrore e il gelo. Non ho mai provata tanta paura come quella volta, neppure davanti a «loro». Poco dopo, per fortuna, se ne andarono e tornò il sole e sentii un po’ meno freddo. Ho sempre pensato che il gelo che tormenta queste valli e 13 il fatto che vi siano tanti abeti, dipenda proprio dal fatto che san Martino ama passeggiare per questi luoghi; si vede che le cime delle nostre colline non gli piacciono e infatti sono piene di betulle, contrariamente a quello che accade altrove, dove gli abeti stanno abbarbicati sui monti e gli altri alberi più in basso. Sia come sia, è stato don Antonio a dirmi che era san Martino, perché vestiva di nero ed era seguito dall’oca. Ma ero giovane a quell’epoca… - terminò come parlando a se stesso. - Guardate che il sole comincia a declinare; vi conviene tornare a casa, adesso; e poi io ho da fare. Per oggi basta storie. Devo lavorare.» I ragazzi salutarono e ripresero la via per tornare a casa. Strada facendo parlarono un po’ e Vincenzo scoprì che il Matt era chiamato così perché affermava di vedere santi e morti. Gli adulti lo evitavano e lui non faceva nulla per farsi accettare; solo i ragazzi lo frequentavano per sentire le sue storie. Abitava da solo e viveva di un piccolo orto e di quello che il bosco gli procurava: anche lui, come i ragazzi, si recava ogni tanto nei pascoli che si estendevano a nord, dove i grandi non andavano mai. Nei giorni seguenti Vincenzo cominciò a conoscere meglio Valdenoghèr e la gente che vi abitava. Conobbe la moglie di Olmo, Aurora, che era grande amica di Maria; nonostante fosse molto giovane aveva già tre bambine che portavano il nome di fiori; accolse il signore di città con parole gentili, senza imbarazzo, e Vincenzo paragonò il suo sorriso a quello di sua madre, che non avrebbe mai più rivisto. Poi c’era Catina, la servetta di casa Alessandri, a cui venivano dati i lavori più pesanti. Aveva la pelle bianca bianca ma le gote le si colorivano facilmente di rosso, soprattutto quando si affaticava; il suo sguardo era serio, come se fosse cresciuta troppo in fretta, anche se doveva avere poco più dell’età di Vincenzo. Un vecchio, Simone, alle volte l’aiutava. Era del Friuli e a tutta prima non era facile capirlo perché usava spesso strane parole. Vicino alla chiesetta c’era invece la casa di Inigo, che doveva avere più o meno l’età del Matt, ma era molto più magro e basso. Quando in paese c’era qualcosa di difficile da fare chiamavano sempre lui. Alle volte era d’aiuto anche al signor Alessandro, se c’era bisogno di un’erba speciale o di un attrezzo particolare. Era giunto qualche anno prima, affamato e con una spalla ferita. Era stato curato e una giovane del paese, Lina, che era già vedova dopo essere stata sposata per meno di un anno, aveva deciso di accettarlo come marito. Così Inigo si era sistemato lì, ma senza mai parlare del paese da cui veniva: qualcuno diceva che era spagnolo, che era uno di quei soldati di ventura che avevano combattuto in Italia. Infatti non era riuscito proprio un bravo contadino, ma sapeva arrangiarsi se era necessario, e a poco a poco era stato accettato, anche in una società chiusa come quella. Chiacchierando con la gente del paese Vincenzo fece anche una grande scoperta. Nessuno voleva parlare delle terre che stavano oltre le case del Matt e di Jacopo. Alcuni dicevano che c’erano solo rocce impervie da quelle parti, altri che non sapevano o che non c’erano mai stati. A una domanda diretta Maria rispose che non 14 era bene voler conoscere ciò che non si lasciava conoscere. Vincenzo cominciò a fantasticare su quello strano paese dove era capitato. Era una terra divisa a metà: da una parte stava la solida realtà di tutti giorni, dall’altra un mondo fantastico dove vivevano mostri spaventosi e passeggiavano i santi. Naturalmente era quest’ultimo che lo attirava, nonostante la paura. Si vedeva già su un cavallo, con la lancia in resta ad attaccare un essere diabolico; era lui il prode paladino che avrebbe trionfato su ogni pericolo. Avrebbe trovato il Graal e lo avrebbe portato al suo re per farlo guarire. Tante avventure erano lì ad attenderlo, a un passo da casa sua. Celeste lo venne ancora a cercare. Aveva ricevuto l’ordine di far compagnia al ragazzo di città, almeno finché il signor Alessandro non avesse deciso qualcosa a proposito di quel nipote comparso così all’improvviso a turbare la quiete incantata in cui viveva. Comunque, a quanto pareva, la fretta non era una delle qualità di Alessandro degli Alessandri. Così, per Vincenzo, le giornate passavano tra le chiacchiere di Maria e i complici silenzi di Celeste e Jacopo. I tre ragazzi avevano ben presto cominciato a frequentarsi con una familiarità che sarebbe stata impensabile in un altro ambiente: infatti Vincenzo era pur sempre il nipote di una persona importante mentre gli altri due erano figli di contadini, ma la solitudine di quei monti rendeva più stretti i legami. Comunque quella conoscenza non si era mai trasformata in una vera amicizia. Jacopo e Celeste erano cresciuti assieme mentre lui era l’intruso venuto da lontano che, di nascosto, si poteva prendere in giro per il suo accento diverso e per la sua incredibile ignoranza riguardo alle piante e agli animali. Qualche volta Margherita e Rosa, le figlie più grandi di Olmo e Aurora, li raggiungevano per giocare, ma anche loro lo trattavano spesso con un tono di superiorità e condiscendenza, soprattutto quando non sapeva riconoscere il velenoso aconito o pensava che l’erba di san Giovanni non avesse fiori. Margherita era la più grande e faceva spesso la saputella, dicendo alla sorella cosa doveva o non doveva fare. Rosa la lasciava parlare, scuoteva i suoi riccioli biondi, e si metteva d’impegno a fare l’opposto di quello che le era stato detto, proprio per farla arrabbiare. Intanto la neve non si decideva a scendere quell’anno, come aveva annunciato il falco pellegrino, e Vincenzo cominciò a fare qualche passeggiata, da solo, per i viottoli di Valdenoghèr. Ormai tutti lo conoscevano e lui conosceva i sentieri che si allontanavano dal paese. Avrebbe voluto tornare dal Matt per parlare con lui, ma la sua casa era lontana e non era ancora sicuro di saperla ritrovare. Alcune volte era arrivato fino al grande noce che si vedeva dalla strada che portava a Farra. Era davvero un albero imponente, che metteva paura, ma Vincenzo si sentiva bene quando gli arrivava vicino. Lo considerava come un vecchio amico, o meglio come un vecchio nonno pronto ad ascoltare con comprensione i problemi di un giovane nipote. Si sedeva allora sui suoi rami più bassi che sembrava si piegassero come per consentirgli di scalarlo più facilmente. Il noce era ormai quasi spoglio in quei giorni di freddo, ma si sentiva in lui la presenza di una grande forza, ora quasi addormentata ma pronta a riesplodere in tutta la sua vitalità quando fosse venuto il momento. 15 Vincenzo gli narrava le sue paure e i suoi sogni e l’incertezza di un presente per lui ora sempre uguale, ma foriero di improvvisi e drastici cambiamenti. Quei rami erano divenuti il suo rifugio. Un giorno Celeste e Jacopo lo presero in giro più del solito, mentre Margherita e Rosa si dimostrarono assolutamente insopportabili. Per una volta tanto, invece di litigare tra loro, avevano fatto comunella schierandosi con i due compagni contro il signorino di città. La disputa verteva sulle regole di un gioco che, secondo Vincenzo, gli amici non avevano rispettato. Dalle parole si passò ben presto ai fatti ed egli si trovò ad accapigliarsi con i due ragazzi. Per quanto coraggio avesse non poteva competere con due persone, per cui, a un certo punto, ritenne che l’unica via di salvezza fosse la fuga. Forse sarebbe riuscito a separarli e ad affrontarli uno alla volta; in un libro di suo padre aveva letto che un soldato romano aveva fatto così per vincere ben tre nemici che si accanivano contro di lui. Approfittò di un momento di calma improvvisa, seguito all’urlo di Rosa che si era spaventata per quanto stava succedendo, e spiccò la corsa. Senza pensare si diresse proprio verso il grande albero, mentre Jacopo e Celeste gli correvano dietro. Come al solito trovò agevole salirvi: era come se il vecchio noce lo aiutasse nella sua scalata alzando verso il cielo i rami su cui Vincenzo si era aggrappato e sostenendolo per impedirgli di cadere. In poco tempo arrivò fino alla parte più alta, dove mai aveva avuto il coraggio di salire. Si fermò per tirare il fiato e guardarsi intorno. «Vieni giù, se hai coraggio! Non credere di fuggire in questo modo!» Le voci di Jacopo e Celeste erano lontane. I due ragazzi saltavano e si affannavano ai piedi dell’albero, ma non riuscivano ad afferrare i rami più bassi. A quanto pareva lo stratagemma scelto da Vincenzo aveva funzionato solo in parte: era riuscito a sfuggire ai suoi nemici ma non a separarli e ora era assediato nella sua fortezza. Ritenne più prudente rimanere dove si trovava: «Venite voi a prendermi, se avete coraggio. Abitate in mezzo agli alberi e non sapete neppure scalarne uno! Deve essere uno di città a insegnarvi come farlo?» Allora Jacopo e Celeste cominciarono ad accanirsi con calci e pugni contro il tronco con l’unico risultato di farsi male. Dopo altre urla e scambi di insulti alla fine se ne andarono, certi che Vincenzo non avrebbe lasciato subito il suo nido. «Che si trasformi pure in uccello, se vuole, ma con noi non giocherà più.» furono le ultime parole dette da Celeste prima di allontanarsi. Vincenzo ebbe un tuffo al cuore. Si chiese cosa avrebbe fatto e con chi avrebbe parlato per tutto il periodo che doveva stare con il nonno in quel posto isolato. Fu preso dal panico e improvvisamente si rese conto di essere appollaiato sul ramo più alto del noce. Sopra di lui vi era solo il cielo e, sotto, il colore scuro della terra e dell’albero. «Coraggio! Non aver paura!» Come il giorno del suo arrivo un pensiero compiuto, che non era il suo, echeggiò intorno a lui. «Coraggio! Io ti proteggerò sempre, perché tu sai capire le piante, gli animali e l’Azzurro Cielo!» Vincenzo si 16 sentiva avvolto come in una nuvola. I rami sotto di lui cominciavano a scomparire e vi era solo il cielo che lo abbracciava. Gli sembrava che, se si fosse lasciato andare, sarebbe stato risucchiato verso l’alto, anzi sarebbe come caduto verso l’alto perché, in quella ovattata nullità, il sopra e il sotto si confondevano. Di fronte a quell’esperienza così diversa dal solito fu preso nuovamente dal panico. Con uno sforzo di volontà cercò di riprendere in mano la situazione. «Sono su un albero, sul ramo più alto di un albero!» cominciò a ripetersi lentamente e un poco alla volta la terra tornò al suo posto. «Probabilmente stavo per svenire. - disse a se stesso - Ora il problema è scendere. Calma, calma. Ti sei spaventato abbastanza.» Ramo dopo ramo riuscì infine ad arrivare a terra. Intorno non c’era nessuno. Ancora con il cuore che gli martellava nel petto si diresse verso casa. 3. Ca’ degli Alessandri Nei giorni seguenti Vincenzo evitò di raggiungere la radura del noce e si rinchiuse nella sua stanza. Fino a quel momento vi era stato il meno possibile, ma dopo la lite con i compagni e la scalata all’albero non era poi male ritrovare un po’ di solitudine in un ambiente familiare. Il tempo poi gli diede una mano, perché cominciò ad annuvolarsi. La signora del quadro continuava a sorridergli e i suoi vestiti strani e sontuosi colpivano l’immaginazione di Vincenzo. Cominciò a pensare che fosse una fata, come quelle dei racconti che aveva ascoltato quando era piccolo, a Venezia. Un giorno Maria, che era salita a mettere in ordine, lo trovò così, tutto solo, che fissava il ritratto. «Era bella sua nonna, vero?» gli chiese Maria. «È la nonna? Non lo sapevo. E com’era? E come si chiamava? Dai, raccontami qualcosa.» Bastava poco per spingere la donna a parlare. Tanto il signor Alessandro era taciturno, altrettanto Maria era loquace. «Era una gran signora e anche lei veniva da lontano. Si chiamava Maria, proprio come me, anzi, Maria Turchese, come la chiamava il padrone. Sorrideva sempre, come se vivesse in un gioioso segreto che non poteva rivelare agli altri. L’unica cosa che la faceva soffrire era la lontananza da suo figlio Jacopo, suo padre. Quando riceveva sue notizie era veramente felice; però mi diceva sempre che a un certo punto i figli devono lasciare i loro genitori; devono andarsene per crescere, come i cuccioli degli animali; ciò che le importava era sapere che stava bene e che anche lui si era fatto una famiglia.» «Qualcuno la chiamava Mavì Hatùn.» disse Vincenzo. «Conosce quel nome? Qui non veniva mai pronunciato. Anch’io, che pure sono anni che vivo in questa casa, l’ho sentito solo un paio di volte e per caso, come se non dovesse essere mai detto, ma non so perché.» 17 «Da dove veniva la nonna? Non era di Venezia, anche se ho visto cappelli come quello nella mia città. Ma li portavano di solito solo mercanti che erano stati in Oriente e che volevano dimostrare in quel modo la qualità delle loro merci.» «Non so bene di dove fosse. Forse me l’hanno detto, ma io con i luoghi che non conosco non mi trovo a mio agio. So solo che il signor Alessandro la sposò durante uno dei suoi viaggi in Levante. Tornò a casa con quella moglie così diversa da noi. Forse fu anche per questo che si ritirò quassù. Qui era per tutti “la signora” e il suo accento e i suoi abiti diversi erano visti come naturali, come quelli di gente di città.» A Vincenzo piaceva ascoltare notizie su quei suoi familiari di cui, fino a poco tempo prima, neppure immaginava l’esistenza. Chiese ancora notizie del nonno che era stato un medico di fama, proprio come suo padre, chiamato un tempo a curare persone del gran mondo. I contadini erano contenti che avesse scelto di abitare a Valdenoghèr perché, nonostante le sue stranezze e il rispetto che incuteva, era sempre gentile e disponibile, nel caso si trattasse di visitare un malato per aiutarlo a guarire quando le erbe e le cure tradizionali non sortivano ormai più alcun effetto. Comunque ciò che incuriosiva di più Vincenzo in quel momento era la casa in cui si trovava. A prima vista sembrava come tutte le altre. Con gli archi a piano terra, le stanze e la solita grande sala al piano superiore, dove si aprivano le porte delle varie stanze, come tanti edifici della città lontana in cui aveva abitato fino a poco tempo prima. Certo, aveva le stalle, che a Venezia non c’erano, e aveva anche una stanza che il nonno chiamava, “la mia officina”, oppure “il mio studio”, in cui Vincenzo non era mai stato invitato a entrare. Ciò che lo interessava però non erano né gli affreschi un po’ pretenziosi che adornavano le camere di sopra e neppure le sculture rosse della facciata ma la mancanza di canne fumarie. Sin dal primo giorno un odore acre lo aveva colpito. Il fumo dei camini che servivano a cucinare e a scaldare non usciva all’esterno attraverso i comignoli, come in tutte le case che aveva conosciuto, bensì si riversava nel vano delle scale e procedeva su su, fino al tetto, attraverso cui trovava la sua strada verso il cielo. A vederla da lontano, sembrava che la casa stessa fumasse perché il vapore caliginoso usciva da tutte le fessure che stavano tra le assi e le pietre che ricoprivano il tetto. Era davvero una casa speciale. Quasi intuendo i suoi pensieri Maria riprese: «Lo sa che quando vennero qui, questa casa non esisteva? Fu suo nonno a farla costruire.» «Davvero? È una bella casa. Colorata e di pietra come quelle di Venezia.» «Certo. È una casa da signori. Fu sua nonna a dare gli ordini su come doveva essere fatta. Voleva che assomigliasse alle abitazioni del suo paese. Fu lei che volle che le scale facessero da camino; le ricordava la tenda dove era nata, con il focolare nel mezzo dell’unica stanza e un buco al centro del soffitto per far uscire il fumo ed entrare gli spiriti che proteggevano la famiglia. E così volle che le pareti fossero tutte foderate di rami di nocciolo. Era un modo per proteggere chi vi abitava, soleva dire. Così le potenze maligne non potevano entrare, a meno che non fossero state invitate. 18 La signora riuscì anche a far rappresentare sulla facciata in marmo il castone simbolo di una città, dove era vissuta a lungo: un diamante posto tra due zaffiri e due smeraldi. Per il resto, però, è stata fatta secondo gli ordini del padrone che chiamò anche un mastro scultore per fare le immagini che l’adornano. Poveretto. Dovette lavorare a lungo. Fare e disfare. Al signor Alessandro non va mai bene niente. Alle volte mi chiedo come non sono impazzita a stare qui al suo servizio. E invecchiando diviene sempre peggio.» Maria parlava e parlava, come al suo solito, e Vincenzo ne approfittò per avere qualche altra informazione. Quei due oggetti di metallo che erano appesi alla parete erano appartenuti alla nonna. Maria non sapeva a cosa servissero, ma ogni tanto la signora li prendeva e cominciava a fissarli. Se erano degli specchi, disse la serva, erano ben poca cosa rispetto al grande specchio di Murano che il signor Alessandro aveva fatto venire da Venezia. Quello sì che permetteva di rimirarsi davvero. Di oggetti appartenuti a Maria Turchese ne erano restati ben pochi. Il padrone li aveva fatti buttare quasi tutti, come per allontanare un ricordo che era divenuto doloroso. Era rimasto solo qualche abito e ciò che si trovava in quella stanza. Anche un piccolo tamburo con cui, quando le ore si facevano lunghe, la signora soleva suonare strane e ritmiche melodie era stato gettato via. Era stata la stessa Maria Turchese che, poco prima di morire, aveva chiesto alla serva di tagliarlo con un coltello, in modo che nessun altro potesse mai più suonarlo. Un giorno, mentre Vincenzo se ne stava tra i campi, a guardare un paio di contadini che conducevano dei muli, sentì una voce che lo chiamava: «Vincenzo! Vincenzo! Eccoti finalmente. Il nonno vuole parlarti.» Margherita era quasi senza fiato. Era stata mandata a cercare Vincenzo, ché tornasse a casa immediatamente. Quelle parole fecero accelerare i battiti del cuore al ragazzo che scese di corsa e si precipitò giù dal pendio. Finalmente suo nonno si era accorto che lui esisteva! Chissà cosa doveva dirgli di così urgente. Entrò sotto il porticato ansando. Alessandro degli Alessandri lo stava aspettando. «Finalmente sei arrivato. Vieni, ho bisogno di te.» Per la prima volta Vincenzo fu ammesso nell’officina del nonno. Una specie di pentola stava su un fuoco sottile sottile sottile, posto al centro della stanza. «Tieni questa bottiglia e versa lentamente, goccia a goccia, mentre io mescolo. Non voglio che gli altri vedano quello che sto facendo.» Vincenzo obbedì, senza proferire parola. Tutto si sarebbe aspettato tranne che essere chiamato ad aiutare il nonno in un lavoro. E chissà che tipo di lavoro era. La stanza era poco illuminata, piena di recipienti delle forme più varie. Un odore acre riempiva l’aria e si combinava con quello della legna che bruciava, quasi a togliere il respiro. Continuarono a versare e rimestare per una decina di minuti e a un certo punto Vincenzo si accorse, dall’espressione contrariata del nonno, che non tutto andava nel verso sperato. «Un altro fallimento. Questa volta la luna non si è combinata bene con mercurio. Dovrò riprovare un’altra volta. Tu puoi andare ora.» concluse rivolgendosi 19 al nipote il quale, una volta ammesso in quella fucina misteriosa, non aveva nessuna intenzione di lasciarsi cacciar via così facilmente: «Cosa state facendo, nonno? È tutto così bello qui.» «Sì, sì, è bello e molto interessante. Quando sarai più grande ti spiegherò.» «Cosa volevate dire parlando di mercurio e della luna?» riprese il ragazzo, che dopo tanto tempo di solitudine vedeva finalmente l’occasione di parlare. «Si tratta di elementi che si combinano e si lasciano; un giorno troverò il modo giusto per metterli assieme e allora…» Il vecchio cominciò a tossire; l’odore si faceva sempre più acre e penetrava nei polmoni togliendo il respiro. Entrambi si avviarono in fretta verso l’uscita. Quando furono fuori dovettero aspettare qualche minuto prima di riuscire a parlare di nuovo. L’incanto era rotto e il nonno ne approfittò per cambiare discorso. «Ormai è novembre. Siamo a Ognissanti e Maria ha preparato le fave dei morti. Mi piacciono tanto e piaceranno anche a te. Non dirmi che non sai cosa sono.» Vincenzo sapeva che erano dei dolci che si mangiavano in quel periodo e lo disse con un certo orgoglio. «Ma sai anche perché si chiamano così? - gli chiese il nonno - Vedi, le fave sono il cibo dei morti e mangiandole si rende omaggio alle forze della natura, che tutto crea e distrugge, ma per noi alchimisti la fava ha anche un altro significato. Rappresenta il sole, imprigionato nella materia, che saprà dare a chi è capace di domarlo il triplice privilegio della salute, della fortuna e della ricchezza. Per questo le fave dei morti mi piacciono tanto. È come nutrire il corpo con ciò che lo spirito desidera.» Concluse Alessandro degli Alessandri, lasciando il nipote senza fiato. Non si trattava tanto di ciò che aveva detto riguardo alle fave, quanto piuttosto una parola, «alchimista», che rimbombava nelle orecchie del ragazzo. L’aveva già sentita tante volte a Venezia, detta ora con ammirazione, ora con disprezzo, ora addirittura con paura. Dunque suo nonno era un alchimista. La mente di Vincenzo ragionava rapidamente. Era una di quelle persone che dedicavano tutta la loro vita a cercare di trasformare il metallo in oro, oppure si affannavano per trovare l’oro potabile, la misteriosa bevanda che avrebbe consentito loro di vivere eternamente. Salute, fortuna e ricchezza dunque, come aveva detto Alessandro degli Alessandri. Suo nonno era davvero speciale, pensò Vincenzo. Anche a Venezia suo padre, Jacopo degli Alessandri, aveva fama di essere diverso dagli altri. Era un medico famoso, che aveva studiato a lungo in Oriente e sapeva guarire molte malattie ritenute da molti suoi colleghi mortali. Aveva tanti amici che passavano a trovarlo. Vincenzo ricordava le lunghe chiacchierate che facevano, le sere d’inverno accanto al caminetto e d’estate su nell’altana, sopra i tetti. Lui non era invitato a tali riunioni, anzi di solito aspettavano che avesse dato a tutti la buonanotte per cominciare le discussioni più interessanti. Allora il ragazzo fingeva di andare a letto e invece si accoccolava o sulle scale che portavano all’altana oppure dietro la porta del tinello, per ascoltare di nascosto. Parlavano di tante cose, di argomenti che lui non capiva o 20 che riusciva ad afferrare solo in parte. Comunque alle volte poteva ascoltare storie meravigliose, raccontate sotto il sigillo del silenzio. Ciò lo faceva sentire importante, come se anche lui condividesse con quegli uomini dotti segreti che non potevano essere rivelati a chiunque, e adesso Vincenzo era a conoscenza anche del segreto del nonno. «L’alchimia non è una vana scienza che cerca solo ricchezza ed eternità continuò Alessandro come indovinando i pensieri di Vincenzo - La natura è piena di simboli e la realtà non è altro che il velo che copre un’altra verità celata ai molti e conoscibile solo da pochi eletti. L’alchimia è la scienza della Natura, che permette di collegare tra loro i diversi piani e, proprio attraverso i simboli, comprendere la misteriosa armonia dell’universo. Essa trasmette a chi la pratica un sottile piacere intellettuale. Vedi, la solitudine di queste montagne è il luogo più adatto all’alchimista, che vive nel silenzio e di esso si nutre.» Alessandro degli Alessandri tacque, come se avesse fatto uno sforzo enorme a dire quelle parole. Quindi si volse e rientrò in casa, come il sasso lanciato da un bambino che, dopo aver vibrato nell’aria, si inabissa nelle acque calme di uno stagno. 4. Le pietre rosse di Inigo Vincenzo rimase a ciondolare sulla soglia, senza voglia di rientrare in casa. Di lontano passò Olmo, il padre di Margherita e Rosa, che lo salutò con il cenno della mano. Era in compagnia di Inigo e del vecchio Simone, che a un certo punto si diressero verso il portico dove stava il ragazzo. «Come va, signor Vincenzo? È tornata Maria? - disse Simone - Mi ha detto di venire qui ad aspettarla perché ha bisogno di me per la legna.» La serva non era ancora tornata e allora Simone si sedette sulla panca che stava appoggiata al muro della casa. Inigo lo imitò senza dire una parola ma scrutando con i suoi occhi neri il ragazzo. «Come sarebbe bello essere dalle mie parti ora.» cominciò Simone tanto per interrompere quel silenzio. «Vengo dal Friuli, al di là dei monti, e a Ognissanti si faceva una gran festa nel mio paese quando ero piccolo.» Vincenzo fece un viso di circostanza; non aveva voglia di parlare dopo quello che aveva scoperto e così lasciò che l’altro continuasse. «Mia mamma mi raccontava che a novembre i morti riescono a mettersi in comunicazione con i vivi. Il confine tra gli uni e gli altri cade… » «Lascia stare questi discorsi - disse il suo compagno - non vedi che al signorino qui non piacciono queste fantasticherie. Forse preferisce parlare delle Coste de Mai. Ho saputo che va in giro a chiedere a tutti cosa c’è oltre il paese, da quella parte.» concluse con un cenno della mano. 21 «Lascia perdere tu, Inigo. Non c’è nulla, là. Solo rocce e sassi che impediscono il passaggio.» disse Simone che si alzò all’improvviso. «Se Maria non torna, allora vado io a cercarla. Non posso passare tutto il giorno qui, seduto su una panca.» E si allontanò con passo svelto, desideroso solo di sfuggire a quello straniero, secondo lui troppo curioso e furbo per poter essere accolto come un amico. Inigo cominciò a dondolare avanti e indietro uno dei suoi lunghi piedi. «Io non sono come lui, sa, e neppure come quasi tutti qui. Io ci credo invece a certe cose. Cosa le hanno detto?» «Proprio nulla, che non c’è nulla da sapere.» «E i ragazzi… Jacopo, Celeste… le avranno pure raccontato qualcosa…» «Mi hanno solo detto che ci sono degli esseri cattivi che girano oltre la casa del Matt, e che non è bene andare da quelle parti.» rispose Vincenzo. «Allora non le hanno detto tutta la verità. - fece Inigo, con uno sguardo furbo Sa, alle volte si vogliono tenere nascoste le cose più preziose. Per esempio io so che al di là della casa del Matt, nella parte dove non entra mai nessuno, non ci sono affatto dei mostri bensì un gran tesoro. Si tratta di un prato di rubini, smeraldi e zaffiri. Basta allungare la mano e si raccolgono pietre preziose, come se fossero manciate di sassi. Guardi, le voglio mostrare una cosa segreta, che non ho fatto vedere a nessuno qui, perché i contadini non possono capire.» Inigo tirò fuori una mano che teneva in tasca. L’aprì e sul palmo brillarono tre piccole pietre rosse. «Vede che le sto dicendo la verità. Queste me le diede il fratello piccolo di Olmo qualche anno fa. Ormai anche lui è cresciuto e si è dimenticato tutto, ma mi ha raccontato di un prato di pietre preziose e di un cavaliere, vestito di verde, che lo custodiva. Questi si era fermato a chiacchierare con lui e, dal momento che lo trovava simpatico, gli aveva permesso di portar via tutto ciò che riusciva a mettersi in tasca. Ecco perché Celeste e gli altri suoi amici parlano solo di mostri. Per nascondere questo tesoro.» Vincenzo rimase interdetto. Fino a quel momento aveva creduto ciecamente a quello che avevano raccontato il Matt, Celeste e Jacopo. Ora invece cominciava ad avere dei dubbi. E se quello che avevano detto non era la verità? Se davvero c’era un tesoro che volevano tenere nascosto? Dopo tutto lo avevano trattato così male, quel giorno che si era rifugiato sul noce. E dopo non erano più stati tanto assidui a chiamarlo per andare a giocare. «Vede che anche lei pensa che ho ragione - continuò Inigo - Lei che ancora può, perché non prova ad entrare lì, nella terra proibita? Mi hanno detto che basta andare sempre dritti e alla fine si trova subito il campo con il tesoro. Ci deve essere anche una fonte, da quelle parti. Magari può portarmi anche un po’ di quell’acqua. Tanto per provare se ha lo stesso sapore di quella che scorre qui. Potrebbe essere quella che suo nonno cerca alle volte la mattina, quando si reca nei boschi, per utilizzarla poi nei suoi esperimenti. Può andarci presto presto, quando si preannuncia una giornata di sole, così è sicuro di saper ritrovare la strada per tornare indietro. Vuole?» 22 Vincenzo era dibattuto tra la rabbia per essere stato ingannato dai suoi amici e la voglia di non mostrare i suoi sentimenti. Inoltre a quanto sembrava Inigo doveva sapere qualcosa più degli altri dell’attività di suo nonno. Era una persona che sembrava conoscere molti dei segreti che stanno nascosti alla maggior parte della gente. «Non so, forse, un giorno.» rispose e aggiunse «Ma se anche lei non mi dice la verità? Come posso essere sicuro delle sue parole?» «Io non la inganno - continuò l’altro, - e glielo posso dimostrare. Domani è il due novembre. Venga con me, la mattina presto. Le mostrerò una schiera di bianchi guerrieri: sono i compagni del Cavaliere Verde che sta a guardia del prato con le pietre preziose.» Vincenzo era molto incerto, ma anche desideroso di andare con Inigo. Si trattava finalmente di una vera avventura. Dopo quasi un mese di noia tra i monti, qualsiasi novità gli pareva desiderabile. «Non deve aver paura - riprese l’altro, per rassicurarlo - starà con me e dopo tutto non andremo lontano; solo poco oltre la casa di Jacopo; non faremo un passo di più, stia tranquillo. Domani mattina poco prima dell’alba sarò qui ad attenderla. Può scegliere se venire o no. Io comunque la aspetterò con la lanterna in mano.» Inigo si alzò e si diresse, senza aggiungere altro, verso la sua casa. Sperava vivamente che Vincenzo credesse alle sue parole e facesse quanto gli aveva chiesto. Era ormai un uomo e sapeva che non avrebbe mai potuto percorrere i boschi incantati. Anni prima, appena arrivato in quel paesino fuori dal mondo, aveva pensato che Valdenogher fosse davvero il luogo ideale per nascondersi e ricominciare una nuova vita. Poi, a poco a poco, aveva conosciuto quella magica terra e ne aveva subito il fascino arcano. Avrebbe voluto carpirne i tesori segreti e soffriva di non poterlo fare. Si sentiva respinto e provava un’invidia sorda, che stava trasformandosi a poco a poco in odio, per tutti coloro che, diversi da lui, vi potevano penetrare. Vincenzo passò una notte inquieta. Non sapeva se credere a quello straniero dalla pelle scura e dagli occhi neri e mobilissimi. Quella notte gli sembrò di dormire solo qualche secondo. Ogni tanto si affacciava alla finestra a guardare la luna e si domandava come mai procedesse così lentamente la sua corsa nel cielo. Finalmente scorse un lume dondolante all’altra estremità dello spiazzo, davanti alla sua casa. Era Inigo di certo. Quasi senza pensarci si vestì rapidamente e scese le scale, cercando di non fare rumore. Ogni scricchiolio gli rimbombava nel cuore. Finalmente fu fuori. Era tutto sudato, come se avesse fatto dieci volta di corsa un pendio. «Eccola, signor Vincenzo. Andiamo.» disse Inigo. Il ragazzo si sentì improvvisamente grande. «Andiamo.» rispose con tono serio. Percorsero la strada in silenzio, come due complici che temono orecchie indiscrete. La lanterna illuminava fiocamente il sentiero, al resto ci avrebbe pensato il crepuscolo che stava avanzando. Arrivarono alla casa di Jacopo mentre il cielo si 23 faceva bianco. Avanzarono ancora ed ecco aprirsi davanti a loro un ampio spiazzo erboso, dove una grande pietra solitaria segnava il limitare della radura. Albeggiava. Improvvisamente una bruma bianca salì dalla terra. A poco a poco si videro apparire candide figure di uomini a cavallo. Era un esercito quello che si stava radunando, sorgendo dalle profondità del suolo. Vi erano guerrieri con casacche e calzoni di pelle armati di lunghe lance. Si sentiva nell’aria un rumore di armi e nitriti di cavalli. A Vincenzo sembrò che quella visione durasse secoli, eppure, quando il disco del sole apparve splendente all’orizzonte il rumore cessò e una lunga fila di uomini, alti a cavallo, si mosse nel silenzio del mattino, tutti bianchi come la bruma da cui erano apparsi sul fare dell’alba. Un guerriero li guidava, più imponente e più triste degli altri, con il viso adorno di una lunga barba. «Ecco. È la schiera di cui le parlavo - disse Inigo - perché questa è l’alba maledetta, in cui i morti possono parlare con i vivi.» concluse, come parlando a se stesso. Con la mano spinse avanti Vincenzo che si trovò così quasi a ridosso del cavaliere. «Ehi tu - disse questi - perché fermi il mio cavallo? Chi sei? Cosa vuoi da me?» «Non volevo... - balbettò Vincenzo - sono solo un ragazzo. Mi chiamo Vincenzo e cercavo un Cavaliere Verde su un prato di pietre preziose, lo ha mai visto?» concluse tutto d’un fiato, quasi per paura di non trovare poi il coraggio per chiedere ciò che gli stava a cuore. «Non qui e non ora. Dovrai aspettare per vedere il verde Signore della pioggia e dell’erba. Dove cammina la natura si perfeziona e tu puoi in effetti vedere pietre multicolori apparire sotto i suoi piedi mentre l’acqua della vita scorre via per vivificare piante e animali. Ma questo ormai non mi interessa più....- continuò il vecchio dall’alto della sua cavalcatura quasi con un tono di rimpianto - Il mio compito è ora quello di proteggere i miei discendenti e guidare le loro schiere alla vittoria. Il mio nome è Aldoino, la mia stirpe è longobarda, e questo è il mio esercito.» I cavalli dietro di lui scalpitavano, a stento trattenuti dai loro cavalieri. Sembrava che, da un momento all’altro, quelle pallide anime si dovessero gettare in un galoppo sfrenato. «É davvero una grande schiera quella che guidi, mio signore - gli rispose Vincenzo ormai rinfrancatosi - gloriosa e senza fine, come le stelle del cielo.». Il ragazzo ringraziò mentalmente i libri di storia che suo padre lo aveva costretto a leggere. Grazie ad essi sapeva almeno qualcosa sul popolo di cui Aldoino era stato un capo. I Longobardi erano arrivati in Italia tanti secoli prima, nel Medioevo, ed erano passati anche per il Veneto. Il vicino paese di Farra portava infatti un nome che indicava proprio che una famiglia della loro stirpe si era stabilita in quei luoghi. «Eppure, quando i miei occhi hanno visto la vittoria, non ho potuto assaporarla fino in fondo... ed è stato inutile innalzare quella grande pietra per imprigionare chi 24 mi doveva appartenere.» continuò tristemente il bianco cavaliere, indicando il masso che troneggiava al limitare del bosco. Anche Inigo si sentiva rinfrancato. Da tempo sapeva che alla vigilia del giorno dei morti comparivano degli spettri in quella radura, ma non aveva mai avuto il coraggio di avvicinarli, anche se qualcuno aveva detto di aver parlato con loro. Così, per vedere cosa succedeva, aveva spinto Vincenzo verso lo spettro. Non era accaduto nulla e quella bianca visione non sembrava ostile, per cui, pieno di curiosità, intervenne dicendo: «O grande signore, raccontaci per piacere che cosa è successo.» «L’anima del mio nemico, Qutlù, mi è stata sottratta. La pietra che avevo eretto per imprigionarla è rimasta vuota ed egli non farà mai da cuscino al mio letto funebre. - disse allora lo spettro - Qutlù... colui che sovrastava di un braccio gli altri uomini: un guerriero grande e orgoglioso, ma anche avventato, altrimenti non si sarebbe lasciato prendere nel tranello che gli ho teso. Ma tutto ciò non ha portato a nulla: la valle, i cui pascoli tanto agognavo, è stata sigillata per sempre. Nessun guerriero vi è più potuto entrare. Ora è sospesa in un eterno presente, sottratta al fluire del tempo, abitata dalle pallide ombre di quanti non esistono più.» «Ed è possibile riaprirla?» chiese ancora Inigo. Da una parte egli non voleva che quel bianco spettro cominciasse a raccontare a Vincenzo dei mostri infernali che infestavano quelle zone, di cui anche lui aveva sentito parlare, ma dall’altra era sempre più curioso di saperne di più di quello strano paese che ormai era divenuto anche il suo. «Solo chi l’ha sigillata, può togliere il sigillo.» «Eppure i bambini vi possono entrare...» «Vi entrano i bambini, i pazzi, e tutti coloro che sanno leggere nel Cielo Azzurro, assumere un aspetto che non avevano e parlare con la natura. Per loro non valgono le leggi cui sono sottoposti tutti gli altri e solo per loro la valle è sempre aperta. - poi il bianco vecchio continuò - Ormai il sole è sorto completamente e noi dobbiamo andare. Addio.» e sciolse il suo cavallo al galoppo, assieme alla bianca e luminosa turba che lo seguiva. Nei giorni seguenti Vincenzo continuò a pensare ai racconti di Inigo e all’incontro con lo spettro del cavaliere longobardo. Quando era tornato a casa si era infatti ricordato delle parole di Simone a proposito del mese di novembre e delle ombre che, in quel periodo dell’anno, potevano parlare con i viventi. Inigo dunque gli aveva detto il vero. I bianchi spettri che gli aveva promesso erano apparsi veramente e anche il Cavaliere Verde esisteva. Il ragazzo cominciò a pensare che davvero quella terra nascondeva un tesoro immenso e che il Matt e gli altri volevano solo tenerlo tutto per loro. Era ancora un po’ perplesso riguardo alle ombre di cui aveva parlato Aldoino, e si confidò con Inigo che però gli spiegò che si trattava di spettri, come quelli che avevano visto, che non si erano certo dimostrati ostili nei loro confronti e anzi li avevano aiutati. Il Matt doveva aver esagerato nel descriverli, 25 trasformandoli in esseri mostruosi per far paura a Vincenzo e tenerlo distante dal suo tesoro. La neve intanto non arrivava e quindi la via verso la terra proibita era ancora aperta. La tentazione di entrarvi era davvero grande e Inigo, con qualche ammiccamento e qualche parola gettata lì come per caso ogni volta che lo incontrava, contribuiva a tenerla viva. Finalmente Vincenzo si sentì pronto ad affrontare la grande avventura. Jacopo e Celeste non si facevano vivi da tempo e lui era troppo orgoglioso per andare a chiamarli, anche se ormai era stanco di ciondolare senza scopo tra le casette di legno del villaggio. Anche il nonno non lo aveva più cercato, dopo quel giorno in cui gli aveva rivelato di essere un alchimista, preferendo dimenticare il nipote e sprofondarsi nei suoi vecchi codici polverosi e nei suoi esperimenti. Maria era indaffarata, come al solito, e nessuno si curava di lui: lo consideravano ormai come uno di casa, o peggio ancora come uno dei tanti oggetti che si trovavano in quella strana dimora, che bisognava solo spolverare di tanto in tanto, ma che non avevano bisogno di cure particolari. Una mattina, dunque, sgattaiolò via senza che nessuno facesse caso a lui. Conosceva ormai il sentiero che portava fuori del paese. Lo aveva percorso tante volte dopo la gita con Celeste, il primo giorno che aveva passato a Valdenoghèr. Senza pensare che il sole era alto e la strada lunga si avviò tra i campi. Passò oltre la casa di Jacopo, attraversò il campo dove aveva visto gli spiriti pronti alla battaglia e continuò dritto, come aveva detto Inigo. Avanti, sempre più avanti, nella terra che non apparteneva a nessuno, dove il tempo si faceva immobile e anche il vento aveva timore di respirare. Avanti. Mentre camminava qualche nuvola cominciò a oscurare il cielo e quasi senza accorgersi si trovò a camminare nella foschia. Un’atmosfera umida e lattiginosa lo circondava ma i suoi passi continuarono sicuri. Fu molto tempo dopo che si accorse improvvisamente di essersi completamente perduto. Doveva aver sbagliato a un certo punto perché il sentiero, all’inizio così ben segnato, non si vedeva più. Vincenzo procedeva tra il muschio e i sassi, senza aver la minima idea di dove stesse andando. Intanto il cielo si era fatto sempre più grigio e scuro. Il sole stava tramontando. Si fermò a pensare mentre avanzava il crepuscolo. Sulla sinistra si stendevano dei prati contornati da alberi mentre a destra la montagna saliva sempre più in alto. Pensò che forse, scendendo, avrebbe trovato una malga o una casa dove chiedere aiuto. Camminava già da parecchio, senza aver trovato ciò che cercava, quando sentì uno strano fruscio e un ansito poco lontano. Si fermò con il fiato sospeso mentre un silenzio assoluto lo circondava. Riprese ad avanzare e lo strano rumore riprese. Vincenzo aveva il cuore in gola. Proprio quella sera aveva scelto per perdersi. Ripensò a quanto aveva detto il Matt del periodo che va da Ognissanti alla festa di san Martino. Nonostante il freddo cominciò a sudare. Gli sembrò di vedere delle ombre scure che si nascondevano dietro i tronchi degli alberi e sentì un cattivo odore, come di carne morta. Forse era solo la sua immaginazione, o forse no. Cercò di non farsi prendere dal panico: fuggire urlando 26 sarebbe stata la cosa peggiore da fare. Suo padre gli aveva sempre detto che doveva ragionare, osservare e solo allora decidere cosa era meglio. Continuò ad avanzare piano verso il limitare della radura dove si trovava. Se si trattava di un lupo o di qualche altra bestia feroce i rami di un albero sarebbero stati un rifugio sicuro. Ripensò con nostalgia al grande noce che lo aveva protetto dai pugni di Celeste e Jacopo, e che gli aveva infuso calma e tranquillità. Forse la cosa migliore da farsi era proprio salire su un albero. Intanto era giunto al limite del bosco, ma sibili e ansiti lo seguivano. Vide un grosso pino, a terra, schiantato da un fulmine, che recava però anche i segni di un’accetta. Questo fatto gli fece coraggio: non era dunque nella parte più pericolosa di quei monti, dove gli uomini non andavano mai, come aveva detto Celeste. Salì sul tronco caduto, poi sulla radice che si ergeva come una grande mano nera protesa verso il cielo e quindi sui rami più bassi di una betulla che stava lì vicino, la quale ondeggiò pericolosamente. Cadendo, il grande albero aveva spostato dei massi e dissestato il terreno scosceso. Vincenzo si afferrò in alto, con le braccia, mentre un’ombra scivolava sotto il tronco. Una zaffata di odore nauseabondo lo colpì, due occhi rossi lo guardarono da terra, due mani bianche si alzarono per afferrarlo, ma il ragazzo riuscì, scalciando, a sollevarsi più in alto. «Vieni qui che ti prendo. Non scappare, ché ti ho preso.» Era un essere nudo, pallido come un cadavere, quello che gli stava dinanzi, e lo fissava famelico, digrignando i denti come se già assaporasse il suo sangue. «Vai via. Non mi hai ancora preso. Aiuto. Aiuto.» urlò Vincenzo. Una risata fu la risposta a quel grido. «Non vado via. Non puoi darmi ordini. Neppure Qutlù, che dice di essere un capo, può ordinare veramente qualcosa.» Vincenzo si ricordò di quel nome e dello spettro del cavaliere longobardo che lo aveva pronunciato per la prima volta. Quindi continuò, con un barlume di speranza, cercando di immaginare cosa poteva far paura al suo nemico. «Un capo? Credevo fosse un servo. C’è un bianco signore che lo cerca per tutto il bosco con una schiera di uomini armati. Il suo nome è Aldoino. E se non vai via lo chiamo qui subito.» «Aldoino può cercare chi vuole, ma non riuscirà mai ad avere uno schiavo per fare da cuscino al suo letto funebre. - rispose il mostro con una grassa risata - Il Qutlù che cerca è stato portato via, tanto tempo fa, assieme alle anime di tutti noi, dal Signore della Sorte che passava per questi boschi. Ha preso tutti i morti, senza riguardo per chi aveva combattuto con i longobardi o con gli unni bianchi. Tanti sono rimasti insepolti ... e ciò che resta è solo un involucro di carne a cui non importa distinguere tra chi un tempo era amico o nemico.... ormai siamo tutti uguali, ma non per questo siamo meno pericolosi.» Un’altra risata fece seguito a queste parole. 27 «Non è vero. Qutlù è un servo. - riprese Vincenzo con la forza della disperazione e urlò - Aldoino vieni ad aiutarmi!» Non poteva sperare che il bianco cavaliere rispondesse alla sua richiesta di aiuto ma solo che la sua voce fosse sufficiente a richiamare qualcuno. «Anche senza la coppa del potere Qutlù non è il servo di nessuno ma quando l’avrà trovata ti dimostrerà tutta la sua forza, piccolo essere di sangue. Vieni qui ché ho bisogno di te per assaporare la vita.» Improvvisamente il bianco vampiro si afferrò alla betulla, nel tentativo di raggiungere la sua preda. Questa volta Vincenzo non ebbe tempo di avere paura. L’albero su cui si trovava, sbilanciato dal peso, crollò in avanti, seppellendo con i suoi rami spogli quel mostro e proiettando in avanti il ragazzo, che con un capitombolo, si trovò di nuovo nella radura. Senza guardarsi indietro prese a correre dalla parte da cui era venuto. L’aria che respirava era molto fredda e i polmoni cominciarono ben presto a fargli male, tanto che dovette fermarsi per un momento. L’oscurità lo avvolse e il gelo lo circondò improvvisamente. In lontananza vide un’ombra scura che passava. La paura si impossessò di lui e cominciò a tremare. Era una sensazione di immobilità e disperazione, che non aveva mai provato, come se ogni possibile felicità se ne fosse andata dal mondo. Per fortuna, l’apparizione svanì lentamente, così come era venuta, e l’aria riprese colore, così come le gote di Vincenzo, che ricominciò a correre. Dopo una decina di minuti, si fermò ansimante, per riprendere fiato. In quel momento un forte fischio ruppe il silenzio. «Ehi, chi c’è lì? C’è bisogno di aiuto?» Era il Matt che parlava e niente sembrò più bello di quella voce. «Sono qui. Sono qui. Ho perso la strada.» «Guarda chi si vede. Un ragazzino di città disperso tra i boschi. - fece il contadino con aria canzonatoria, depositando per terra una fascina di legna che portava sulle spalle - Buonasera. Non avevo detto che era pericoloso passeggiare da queste parti in questi giorni di novembre?» «Me ne sono accorto. Ho provato una grande paura - disse Vicenzo ancora rabbrividendo - c’era un essere tutto bianco che mi correva dietro…» «Ah, ne hai visto uno? Penso che questo ti avrà fatto passare la voglia di venire qui. Era uno di «loro». Hanno lunghi denti e sono pronti a succhiare il sangue di chiunque capiti loro a tiro. - disse il Matt, divertito dal terrore che vedeva negli occhi del ragazzo - Deve essere un mezzo per sopravvivere. Don Floriano direbbe che sono delle anime dannate, uscite dall’inferno per catturare gli uomini e portarli negli abissi del male.» Di fronte alla paura che si leggeva chiaramente sul volto del suo interlocutore, continuò, come per infondergli un po’ di coraggio: «Per fortuna non sono molto intelligenti; sono lenti e goffi e, con un po’ di abilità, è facile fuggire, soprattutto se non ci si lascia prendere dal panico.» 28 Il Matt si fece poi spiegare cosa era successo e come era riuscito a scappare e poi scoppiò a ridere, appoggiandosi al lungo bastone che teneva in mano. «Te lo avevo detto che sono stupidi. Comunque sei stato bravo a non lasciarti vincere dalla paura.» «Sono stati gli alberi. Mi hanno aiutato.» «Gli alberi? - disse il Matt - Chissà… forse sei davvero come tua nonna. Anche lei sapeva parlare con tutte le creature, e anche come me, no?» rise ancora, cominciando a scostare con il bastone le foglie cadute. «Ma di che coppa parlava?» gli chiese Vincenzo. «So solo quanto mi ha detto la Signora Mavì Hatùn. Chi vuole essere un capo deve possedere la coppa del potere, ma questa è andata perduta tanto tempo fa. Per questo Qutlù la cerca disperatamente. Quando sarà nelle sue mani potrà finalmente comandare ai mostri che stanno con lui.» anche il Matt sembrò rabbrividire per un momento, poi riprese: «Vieni torniamo indietro. Ti riaccompagno verso Valdenoghèr. Qui siamo ancora nella zona proibita. Forse non ti ha fatto una gran bella impressione questa valletta oggi, ma dovresti vederla a primavera, quando si riempie di fiori e il sole scaccia quei mostri. Devi sapere che la luce li annienta; se quel tronco riesce a trattenere quell’essere fino all’alba e se domani è una bella giornata di sole, di lui resterà solo un po’ di erba bruciacchiata.» Raccolse la fascina e cominciò a camminare, appoggiandosi al bastone. «Ho proprio sbagliato strada, allora - disse pensoso Vincenzo, mettendosi al suo fianco - siamo oltre le Coste di Mai.» «Proprio no, siamo dall’altra parte. Ai limiti della Valturcana.» «È un nome strano ma suona bene, ha un che di incantato.» «È stata tua nonna a chiamarla così e ora anche i contadini la conoscono con quel nome. Ci si arriva da Cornei, e anche da Valdenogher facendo un lungo giro. Poi però la strada si interrompe e solo i bambini e i pazzi arrivano fin qui. A tua nonna piaceva venire da queste parti. Le ricordavano le montagne del paese dove era nata, tanto, tanto lontano.» il Matt rimase zitto e Vincenzo non ebbe coraggio di interrompere quel silenzio. Poco dopo, in lontananza, videro stagliarsi contro il cielo ormai scuro le sagome nere delle case di Valdenoghèr. 5. San Martino Novembre scorreva monotono. Dopo quel giorno famoso il nonno non aveva più chiesto l’aiuto di Vincenzo per preparare chissà quali strane pozioni; si era chiuso invece nella sua stanza al primo piano, piena di libri e fasci di carte a studiare e scrivere. Nessuno poteva disturbarlo e solo Maria riusciva a entrare per portargli un po’ di cibo. Inigo invece andò più volte a chiedere di Vincenzo. Alla fine riuscì a 29 parlargli a quattr’occhi e ne approfittò per chiedergli se era stato nella terra incantata e se aveva trovato le pietre. Il ragazzo lo trattò male. Lo accusò di avergli nascosto i pericoli che si annidavano oltre le Coste de Mai. L’uomo non disse nulla. Si limitò a fissare il ragazzo con i suoi occhi scuri e se ne andò borbottando qualcosa tra sé e sé. Da quel momento però una sorda ostilità nacque tra i due: Vincenzo cercava di evitare quell’uomo di cui non si fidava più e di cui sospettava ormai le oscure trame. Visto che la neve non era ancora caduta, nonostante tutte le previsioni contrarie, arrivò finalmente don Floriano, che andò a stare come sempre da Tranquilla e Modesta. Le due contadine erano contente di ospitarlo, anche per l’importanza che, di riflesso, assumevano agli occhi dei compaesani. Inoltre portava fresche notizie dalla città, sempre ricercate con avidità dalle due sorelle, che vivevano ormai più di quello che gli altri facevano e dicevano che non di una loro vera vita. Don Floriano era un giovane prete, che sapeva fare delle belle prediche. Il suo comportamento era molto edificante, sempre con gli occhi bassi e pronto a dire una buona parola a tutti coloro che si comportavano bene. I contadini, abituati con il prete vecchio, don Antonio, molto più alla mano, lo trovavano un po’ troppo rigido. Non che facesse qualcosa che non andava o che predicasse delle cose sbagliate, ma, come dicevano gli uomini del paese, una cosa era fare il prete e un’altra era dover lottare tutti i giorni contro la fame, le malattie e soprattutto contro i capricci della donne. Non tutto poteva andare per il verso giusto, mentre don Floriano cercava sempre la perfezione in sé e negli altri e così, alle volte, scambiava la stanchezza o la debolezza per i peccati più gravi. Una volta Alessandro degli Alessandri disse che era davvero il modello del prete perfetto, come allora voleva la Chiesa. In paese si discusse a lungo su tale affermazione e non tutti pensarono che si trattasse, in fondo in fondo, di un complimento. La vigilia di San Martino Vincenzo pensò di organizzare, assieme a Margherita e Rosa, una di quelle feste di bambini che si usavano a Venezia e, alla fine, si unirono a loro anche Celeste, il suo fratellino più piccolo, Olindo, e gli altri bimbi del paese. Andarono di casa in casa, facendo un gran chiasso, percuotendo pentole e sbattendo coperchi, cantando una filastrocca in onore del santo e minacciando di continuare all’infinito davanti alle porte di quelli che rifiutavano loro un frutto secco o un piccolo dono. Modesta e Tranquilla, sempre felici quando qualche bambino le andava a trovare, invitarono dentro casa tutta la comitiva, mentre don Floriano faceva un’aria seccata di fronte a quella confusione. Dopo un po’, comunque, anche lui si lasciò prendere dall’allegria e pensò di divertire, a suo modo, la compagnia raccontando la storia del santo di cui si festeggiava in quel modo la ricorrenza. Parlò dunque di quel giovane soldato romano che era vissuto in Pannonia, ai margini dell’impero; era conosciuto per aver diviso il suo mantello con un povero ma poi era diventato un monaco famoso, un taumaturgo di fama e un grande evangelizzatore: la sua lotta si era rivolta soprattutto contro gli dei pagani degli antichi celti. Don Floriano raccontò anche ai bimbi, che ormai pendevano dalle sue labbra, una antica 30 leggenda: un giorno, alcuni contadini per vendicare il sacrilegio che, secondo loro, il santo aveva commesso abbattendo un pino che consideravano sacro, lo legarono a un tronco che poi segarono. Erano convinti così di punirlo in modo orribile. San Martino però non rimase ucciso; l’albero non cadde travolgendolo, come pensavano i suoi persecutori, bensì si rovesciò miracolosamente esattamente dalla parte opposta, schiacciando i barbari che per i loro riti malvagi erano meritevoli di una tale punizione. Quando cominciava don Floriano era un oratore appassionato. Anche lui, come Maria, parlava e parlava – si disse Vincenzo - ma sapeva anche usare paroloni difficili. La storia di san Martino aveva confuso un po’ le idee al ragazzo. Pensava a quanto gli era successo, ai limiti della Valturcana, al mostro seppellito dall’albero, e poi metteva in relazione quella leggenda con quanto aveva detto il Matt a proposito del santo e di come gli aveva raccontato di averlo visto, vestito di nero, in mezzo al gelo. Poi gli apparve davanti l’immagine di quell’ombra oscura, che lui stesso aveva scorto. Procedendo logicamente si arrivava alla conclusione che gli alberi fossero nemici dei cattivi e degli spiriti immondi. Forse anche il noce che lo aveva attirato, su su, verso la sua cima, voleva solo fargli conoscere qualcosa di bello e non spaventarlo, come invece era successo. Con i pochi elementi che aveva a disposizione il ragazzo cercava di penetrare il segreto di quello strano paese di cui ormai faceva parte. La successiva storia raccontata da don Floriano fu quella di Lucia, vergine e martire di Siracusa. La sua festa sarebbe caduta tra poco più di un mese ed era bene che i bambini conoscessero anche la vicenda edificante di quella santa cui erano stati strappati gli occhi e per questo era divenuta la protettrice di tutti coloro che soffrivano alla vista. In molti paesi della Repubblica Veneta, fino nel bergamasco, santa Lucia avrebbe portato doni ai bambini buoni e bacchette e bastoncini per punire i cattivi. Inoltre quella notte aveva un incanto particolare. Era la più lunga di tutto l’anno, mentre le ore del giorno erano corte, corte. Poi le giornate avrebbero ricominciato a crescere per divenire lunghissime alla festa di San Giovanni. Don Floriano parlava, parlava. Iris, la sorellina piccola di Rosa e Margherita, si era silenziosamente addormentata tra le braccia di Tranquilla e anche Vincenzo sentiva le palpebre che gli calavano sugli occhi. Poco dopo la compagnia si sciolse e tutti tornarono in fretta alle loro case a dormire i sonni profondi dei bambini. Il periodo di bel tempo di metà novembre, chiamato da tutti «l’estate di san Martino» quell’anno passò in un attimo. Quella notte cadde finalmente la neve, ricoprendo tutto il mondo di bianco. Quella stessa notte Iris prese freddo e il giorno dopo cominciò a tossire. Don Floriano, che aveva pensato di tornare subito a Pieve, fu costretto a fermarsi e per passare il tempo andò a visitare tutti gli abitanti del paese, con l’intento di fornire loro il suo sostegno morale e il cibo delle sue parole. Dopo aver esaurito le case dei dintorni capitò anche da Alessandro degli Alessandri, l’unica persona a Valdenoghèr che gli metteva un po’ di soggezione e per questo 31 aveva lasciata per ultima. Il padrone di casa lo ascoltò per un certo tempo tutto compunto, poi fece chiamare Vincenzo, sia per presentarlo ufficialmente al rappresentante dell’autorità ecclesiastica, sia per interrompere con un diversivo quel fiume di parole. Lo spirito didascalico del prete cominciò allora ad accanirsi sul ragazzo. Il suo scopo era forse quello di dimostrarsi superiore ai maestri che il nipote di una persona tanto importante aveva di certo avuto a Venezia. Cominciò chiedendogli che materie aveva studiato: se sapesse la grammatica, la retorica o la storia; quando però sentì che Vincenzo aveva cominciato anche a studiare aritmetica, poiché suo padre riteneva che saper far di conto fosse molto importante per chiunque fosse nato in una città mercantile e pensasse un giorno di viaggiare, incominciò a decantare il valore simbolico e cristiano dei vari numeri. «Il tre rappresenta la Trinità, il quattro invece è il numero del maligno ma unito al precedente forma il sette, come le virtù, teologali e cardinali, oppure i peccati capitali, nove sono i cori angelici e dodici invece gli apostoli…» «Ha mai notato la mia casa? - lo interruppe a questo punto Alessandro degli Alessandri con un’espressione compiaciuta - Il mio intento nel costruirla è stato quello di innalzare un inno al Creatore. Vi ho voluto rappresentare tutta la creazione, l’uomo, il demonio e gli angeli del cielo.» Il viso di don Floriano si fece interessato e per qualche tempo non aprì bocca lasciando al suo ospite la soddisfazione di esporre il significato simbolico dell’edificio in cui si trovavano. La facciata era stata fatta in bianco e rosso, non solo perché questi erano i più antichi colori usati per rappresentare gli elementi opposti, prima che si imponessero il bianco e il nero, ma anche perché erano la miglior contrapposizione tra l’Inferno e il Paradiso: per la medesima ragione nei pavimenti delle chiese di Venezia il bianco della pietra di Carrara si contrapponeva al rosso di Verona. Il tre, simbolo della Trinità, era rappresentato dai tre archi al piano terra, che si univano alle tre finestre del piano superiore; quella al centro era però una bifora e quindi il numero dei fori in quel piano doveva essere aumentato a quattro. Tre più quattro davano sette e, contando le cinque finestre all’ultimo piano, si arrivava a dodici, proprio uno dei numeri importanti secondo don Floriano. La chiave di volta dell’arcone centrale rappresentava invece un cherubino; sopra la sua testa vi era una conchiglia come quella che il padrone di casa aveva riportato dal viaggio che aveva fatto in gioventù a San Giacomo di Campostela. Sotto vi aveva fatto scolpire la sommità del suo bastone da pellegrino. A destra e sinistra invece due caducei rinviavano alla sua professione di medico. La facciata aveva poi delle decorazioni rosse che rappresentavano dei vasi con dei tralci di vite, a ricordo delle parole del Salvatore: «Io sono la vite e voi i tralci»; e infatti sulla sinistra una testa quasi divorata da un serpente, rammentava che non tutti i tralci davano buoni frutti. Sotto la gronda, dei serpenti e dei visi angelici richiamavano ancora la contrapposizione tra l’inferno e il paradiso. 32 Don Floriano plaudì con riverenza alla dottrina di Alessandro degli Alessandri e alla sua sapienza e pietà cristiana. Non aveva mai pensato che anche un edificio profano potesse essere trasformato in una Bibbia dei poveri. Si era meravigliato quando aveva visto per la prima volta le strane sculture che ornavano la casa, ma aveva pensato a un intento puramente decorativo. Poche persone, davvero, erano così dotte e pie come il suo ospite. Alla fine se ne andò, dopo mille complimenti e moine, con viva contentezza da parte di nonno e nipote che si scambiarono di nascosto uno sguardo complice, come se solo allora, per la prima volta, avessero intuito l’uno i pensieri dell’altro. 6. La Signora della febbre Lentamente scivolò via un novembre coperto di neve e silenzio. Per Vincenzo le giornate seguivano il ritmo del sole: si andava a letto presto e ci si alzava tardi, la mattina, quando la luce faceva finalmente la sua comparsa. Molte notti l’unico lume acceso in tutto il paese era la candela che ardeva nella stanza del signor Alessandro, intento a leggere qualche grosso codice. Vincenzo, che come al solito si annoiava, aveva ottenuto dal nonno qualche libro per studiare ma procedere da solo, senza un maestro, era faticoso, nonostante la migliore buona volontà. Qualche volta Celeste lo veniva a cercare, ma non si era mai istaurata una vera amicizia con i ragazzi del paese che continuavano tra loro a burlarsi di chi era così diverso; Vincenzo lo sentiva e preferiva rimanere in disparte. Dopo l’avventura ai limiti della Valturcana aveva ricominciato a considerare positivamente gli alberi e aveva fatto ancora visita al vecchio noce, pur soffermandosi a guardarlo dal limitare della radura in cui sorgeva, evitando di salire ancora una volta sui suoi lunghi rami spogli. D’altro canto, anche l’albero sembrava sonnecchiare in quelle giornate di neve e cielo grigio e a disinteressarsi di ciò che lo circondava. Iris aveva continuato a tossire per molti giorni dopo San Martino e alla fine non era più uscita di casa. Margherita, molto preoccupata, aveva riferito ai compagni che stava sempre più male e la mamma l’aveva relegata al caldo, nella sua stanza. La vigilia di Santa Lucia la bambina raggiunse la grande casa dove viveva Vincenzo con un visino lungo lungo. Sua sorella stava peggio del solito e tutti erano in ansia, tanto da vincere ogni timore e mandarla a chiamare il signor Alessandro, che era un gran medico, per visitare la malata. Vincenzo, senza essere interpellato, si accodò al piccolo corteo che scortò suo nonno fino alla casa di Olmo. Le donne che erano sulla porta quasi non lo notarono, nella confusione del momento, mentre Margherita, piena di paura per quello che stava accadendo, andò a rifugiarsi in cucina. Vincenzo salì in silenzio le scale che conducevano al piano superiore. Era molto dispiaciuto per Iris e voleva saperne di più. Rimase fuori della camera, affollata di 33 donne. Dopo un po’ arrivò anche Olmo e infine tutti scesero, compreso suo nonno che aveva una faccia scura scura. Allora Vincenzo entrò. L’atmosfera era soffocante e Iris era distesa sul pagliericcio, coperto da una trapunta rossa mentre del fuoco ardeva in un braciere. Teneva gli occhi chiusi e ogni tanto cercava di tossire, mentre respirava a fatica. Non si accorse della presenza di Vincenzo che rimase muto, a guardarla, cercando di distinguerne i tratti nella fioca luce di quel pomeriggio di dicembre. Gli sembrò che il rosso della coperta permeasse tutta la stanza, si riflettesse sul viso di Iris, si mescolasse con le braci per fondersi poi in una fiammeggiante oscurità. Riverberando sul muro vicino al letto il colore del fuoco sembrava danzare e, con grande sorpresa, Vincenzo si accorse di due fiammelle, sfuggite chissà come dal braciere. Si stropicciò gli occhi per vedere meglio ma quelle non se ne andarono, anzi gli sembrò che si fossero fermate e avessero cominciato a fissarlo con interesse. A poco a poco distinse un volto grinzoso che lo guardava. Il ragazzo pensò che assomigliasse ai demoni che stavano nella grande immagine del giudizio universale nella cattedrale di Torcello, un’isola della laguna che un giorno ormai lontano aveva visitato con suo padre. «Chi sei? Cosa vuoi? Vattene, vattene. Non puoi star qui. Non puoi star qui.» si sentì dire, mentre il caldo aumentava. Vincenzo si rese conto che chi gli stava di fronte non era veramente una persona, ma solo un’ombra attraverso cui si potevano ancora scorgere i contorni scuri dei mobili e della stanza. Era un alone di fuoco nelle cui orbite stavano le due fiammelle danzanti. Ebbe paura ma, come l’altra volta, nel bosco, cercò di reagire. Le stesse parole che gli erano state dette lo spinsero a restare: non c’era in loro minaccia ma quasi un timore per la sua presenza e Iris aveva bisogno di aiuto. Vincenzo intuì che era quel fuoco ad arderle dentro e a consumarla, ed era quell’essere che si doveva cacciare. «Dimmi tu, chi sei e cosa fai qui?» chiese a sua volta. Una risata portò la risposta: «Non mi riconosci? Eppure ci siamo già incontrati, tanto, tanto tempo fa un essere della tua stirpe cercò di avere il mio aiuto.» «Un mio parente? Non io, dunque, che non ti conosco. Però non mi piaci.» «Che io piaccia o non piaccia non fa differenza. Io sono Ek, la padrona della febbre, che ruba i neonati alle madri e le madri ai figli. Il mio potere è immenso e non sarà certo un ragazzo a cacciarmi. Vattene. Vattene.» «Non me ne andrò finché non avrai lasciato Iris. - rispose Vincenzo con tutto il coraggio che riuscì a trovare - Sei tu che devi andartene. Vattene. Vattene.» Alle sue parole i due occhi di fiamma ebbero un guizzo: «Non puoi cacciarmi, sei troppo piccolo e non ne hai la forza.» «Sono solo un ragazzo - riprese Vincenzo, incerto tra il timore e la speranza che quelle parole avevano generato in lui - ma presto sarò un uomo e la forza di cui parli è già tutta dentro di me. Vattene. Vattene. Vattene.» L’immagine cominciò lentamente a svanire: «Non finisce qui. Sei un piccolo lupo, ma le tue zanne non sono sufficienti per vincermi. Ora me ne vado, ma 34 tornerò. Non dubitare. Aspettami. Tornerò quando avrò radunato tutti i miei poteri. Allora sarà il mio momento e allora dovrai essere veramente forte per fermarmi.» Come l’ultima fiamma scompare ondeggiando in un camino, così quella rossa visione svanì in un guizzo verso l’alto. Vincenzo si sentì improvvisamente sollevato, come se tutta la tensione fosse sparita dalla stanza. Il caldo era ora meno intenso e anche le guance di Iris erano divenute più chiare e il suo respiro meno affannoso. Si sentiva stanco, come chi ha combattuto una grande battaglia, ma anche felice, perché sapeva di aver vinto. Chi fosse stato il suo avversario non riusciva a immaginarlo, ma sapeva di essere più forte di lui e per questo di essere stato da lui temuto e obbedito. Improvvisamente capì che la diversità non era necessariamente un male. Uscì dalla stanza e scese lentamente le scale. Incrociò la mamma di Iris che saliva affannata, con il volto sconvolto. Il giorno dopo portò, assieme a qualche dono di santa Lucia per i bambini, anche una notizia incredibile, che si sparse in un batter d’occhio per Valdenoghèr: Iris era guarita. Scomparsa la tosse, sparita la febbre, la bambina aveva addirittura chiesto di alzarsi e mangiare, smentendo tutte le cattive previsione formulate il giorno prima. Si disse che solo la presenza di un gran medico, come il signor Alessandro, era servita ad allontanare la malattia, nonostante che Aurora, la mamma di Iris, sostenesse che anche lui aveva temuto il peggio. Don Floriano, da parte sua, accolse con sufficienza quelle dicerie, affermando che solo l’intercessione dei santi poteva compiere miracoli e che le preghiere di molti avevano sortito il loro effetto: lui stesso aveva pregato per ore santa Lucia, la santa degli occhi, affinché guarisse la piccola con il suo sguardo misericordioso nel giorno della sua festa. Mentre il prete diceva questo a un gruppo di devoti contadini, Vincenzo, che era presente, pensava a quelle orbite piene di fiamma che aveva veduto nella camera di Iris e si chiedeva se c’era una qualche relazione tra quell’essere demoniaco e la santa, ma, nelle sue poche nozioni di agiografia non riuscì a trovare alcun nesso che li accomunasse. Intanto, però, don Floriano aveva cominciato a fare domande, a chiedere cosa aveva fatto il signor Alessandro, se avesse dato a Iris qualche strana pozione o se avesse fatto dei gesti insoliti o detto qualche parola che non avrebbe dovuto dire. Rimase a casa di Inigo a lungo, a parlare con lui. Vincenzo se ne accorse per un caso fortuito. La giara dell’olio, fatto arrivare da tanto lontano per uso personale del nonno, era stata fatta cadere a terra da Catina; si era rotta in mille pezzi e Maria aveva cominciato a disperarsi e a chiedere aiuto: spargere l’olio per terra era un cattivo presagio e il signor Alessandro si sarebbe di certo arrabbiato. Tutto il pavimento della cucina era unto e scivoloso e, nonostante il freddo, bisognava darsi da fare e pulire. Vincenzo si era offerto di correre dalla vicina a chiedere aiuto. Si era dunque recato dalla moglie di Inigo. La signora Lina, come era ormai chiamata da tutti, era una ragazzotta di campagna, robusta e piena di salute, che, da quando aveva sposato uno straniero, si sentiva diversa dalle altre donne del paese e molto più importante di loro. Cominciò dunque a chiamare a gran voce la ragazza che aiutava in casa e, visto 35 che questa non arrivava, uscì un momento a cercarla. Vincenzo quindi, per quanto malvolentieri, si ritrovò ad aspettare nella stanza dove stavano Inigo e don Floriano, intenti a parlare fitto fitto vicino al focolare. Le occhiate che gli lanciarono i due, quando lo videro fermo vicino alla porta, non furono delle più gentili. Il ragazzo lesse foschi pensieri negli occhi che lo fissavano. Mentre aspettava Lina, una parola alchimista - risuonò nelle sue orecchie e anche il tono con cui venne pronunciata gli fece impressione. Non vi era nulla di buono nell’aria e tutta la compunzione che don Floriano aveva dimostrato qualche tempo prima per suo nonno, quando avevano parlato del significato della casa, sembrava svanita come per incanto. Nei giorni seguenti Vincenzo divenne sempre più irrequieto. Avvertiva una vaga tensione nell’aria, ma non sapeva neppure lui quale esattamente ne fosse la causa. Una conversazione con il nonno inoltre lo pose di fronte a un nuovo tema di riflessione. Una sera, dopo una lauta cena, Alessandro degli Alessandri cominciò a parlare di politica e di come, secondo lui, stava andando il mondo. Il vecchio, che si era volontariamente isolato dalla società in cui era vissuto per molti anni, non aveva però mai smesso di essere curioso su quanto avveniva altrove. Ogni tanto, durante la bella stagione, si recava a Farra o a Pieve, per avere notizie e informazioni. A Valdenoghèr però non aveva ascoltatori adatti ai suoi ragionamenti, per cui spesso scriveva lunghe lettere ad amici lontani con cui si manteneva in contatto. Ora però vi era quel nipote capitato così inopinatamente tra i monti che sembrava la persona adatta a cui spiegare quanto il vecchio sapeva o intuiva di fatti che avvenivano a Venezia e in altre grandi città. «Devi capire, Vincenzo, - cominciò dunque a dirgli - che il mondo è sempre più diviso. Solo tre anni fa a Ratisbona è fallito un tentativo di mediare tra le posizioni di Roma e le idee che si sono ormai diffuse nelle terre tedesche. Non so cosa succederà in futuro, ma niente di buono certamente. Gli animi sono troppo esasperati, ormai, sia da una parte che dall’altra.» Suo nipote ascoltava abbastanza annoiato. Non capiva perché fossero così importanti cose che succedevano tanto lontano da casa sua. «Vedi - continuò Alessandro degli Alessandri, senza accorgersi dello sbadiglio che aleggiava sul volto di Vincenzo - ci sarà certo una guerra e chi pensa con la sua testa verrà sicuramente sconfitto. Dovrà ritirarsi, così come ho fatto io, in qualche luogo solitario per poter continuare a studiare. Pensa... un amico di Roma mi ha scritto che da un paio d’anni opera ormai di nuovo la Santa Inquisizione: l’hanno chiamata Congregazione del Santo Uffizio. Si tratta di un tribunale dotato di poteri illimitati il cui compito è quello di scovare e reprimere ogni eresia. Chiunque non la penserà come loro verrà indagato, processato e condannato. Dovremo stare attenti a quello che diciamo, d’ora in poi, anche in un paese come questo. Non si sa mai che cosa può dire anche una vecchia contadina nel segreto della confessione e un prete come don Floriano potrebbe causare tanto male a tante persone.» 36 Il nome conosciuto fece fare un sobbalzo a Vincenzo, che di quel discorso vagamente capì solo come decisioni prese in una città lontana come Roma avrebbero potuto turbare anche la quiete di quel piccolo ricovero e causare delle noie a suo nonno. Si rammaricò di non aver ascoltato fin da principio le parole del vecchio e si ripromise di ascoltarlo con più attenzione. Alessandro degli Alessandri però non aveva più voglia di parlare: con una faccia scura e pensierosa si ritirò nella sua stanza lasciando Vincenzo nell’ombra, solo con i suoi pensieri. 7. La casa alchemica Venne finalmente il Natale mentre il nuovo sole, passato il solstizio invernale, cominciava a risalire impercettibilmente sull’orizzonte. Non faceva più così freddo e la gente si godeva quel pallido calore, consapevole che i momenti peggiori sarebbero giunti a febbraio, all’inizio della quaresima. La festa fu celebrata con la debita devozione. La predica impressionò tutti. Era la prima volta che sentivano il giovane prete in un’occasione così importante e sperarono tutti di non doverlo ascoltare più. Invece di parlare di bontà e misericordia, don Floriano cominciò a nominare le seduzioni del maligno. Esseri cattivi si aggiravano tra i buoni per portarli lontano dalla retta via. La sua descrizione del Male fu così efficace che Vincenzo cominciò a pensare che anche il prete fosse stato in Valturcana e avesse incontrato Qutlù e la sua schiera di dannati, o che almeno qualcuno ci fosse stato e glielo avesse poi riferito. Timidi accenni alla terra vicina, ove nessuno osava mettere piede, convinsero Vincenzo della sua ipotesi. Il demonio si annidava in quelle zone e protendeva i suoi artigli verso la pacifica gente di Valdenoghèr. Era il Male e bisognava distruggerlo, così come tutto ciò che non si capiva e che era solo un inganno del maligno. Mentre don Floriano parlava il ragazzo si vedeva già come il salvatore del paese, colui che, armato solo della sua fede, riusciva a dissolvere l’incanto e a riportare quella terra alla realtà di tutti i giorni. Non ci sarebbero state più valli proibite, popolate da mostri e anime dannate; al contrario i pastori avrebbero portato tranquillamente al pascolo le loro bestie e i contadini avrebbero seminato quei campi e tutto sarebbe stato ricolmo del profumo dei fiori. Celebrato il Natale, don Floriano decise di approfittare del clima più mite per scendere finalmente a Pieve: sarebbe tornato alla festa di sant’Antonio, per prendersi nuovamente cura di quel piccolo gregge solitario. Alessandro degli Alessandri, che stava alla finestra a vederlo partire, trasse un sospiro di sollievo quando l’asino che portava il fagotto nero del prete scomparve dietro la curva della discesa. Il vecchio divenne infatti improvvisamente loquace e cominciò a chiamare a gran voce Maria per ordinarle di tirare il collo a una gallina, perché bisognava festeggiare. «Ma Natale è stato due giorni fa, cosa c’è ora da festeggiare?» chiese sbalordita la serva. 37 «Lo so io, lo so io.» le rispose il vecchio; poi, rivolgendosi a Vincenzo, che si ciondolava saltellando sui gradini della scala interna, gli disse allegramente: «Tu. Smettila di giocare. Andiamo, con quest’aria frizzante bisogna fare una passeggiata, per ritemprare il corpo e lo spirito.» e prendendo per la collottola il nipote lo trascinò giù dalla scala. Quella fu proprio una bella passeggiata. Per la prima volta Vincenzo sentì di valere qualcosa per suo nonno, anche se questi cominciò a fargli dei discorsi molto difficili: «Vedi - cominciò a dirgli - gli antichi adoravano il Sole come un Dio, perché rende fertile la terra e assicura l’alternarsi delle stagioni. Noi invece viviamo nel mondo sub-lunare, cui è stata concessa, come sommo bene, la vita. Questa è fatta di cose buone e cose cattive, perché tutto si compenetra e tutto è simbolo di un’altra realtà.» Per quanto confusamente, Vincenzo cominciava a intuire che Alessandro degli Alessandri non era completamente d’accordo con quanto diceva don Floriano. A un certo punto il suo discorso si fece più interessante, scivolando da quanto credevano gli antichi romani all’alchimia. «Vedi, la scienza alchemica è la vera e unica scienza della natura, che prende un minerale, un oggetto vile e disprezzato, e lo trasforma in un’entità perfetta, come l’oro. Colui che la pratica va alla ricerca della pietra filosofale, che trasforma ogni cosa con cui viene in contatto, e dell’elisir, la bevanda che rende eterna la vita dell’uomo, non per fini di lucro o volontà di vivere eternamente bensì per conoscere le più segrete leggi della natura. La casa che ho costruito non rispecchia solo dei simboli cristiani, come ho mostrato a don Floriano, essa conserva, nascoste ai non iniziati, anche le immagini di un’altra realtà.» Se ce ne fosse stato bisogno quelle parole avrebbero ridestato completamente l’attenzione del ragazzo, che improvvisamente disse: «Allora i numeri e quegli angeli e demoni hanno un altro significato?» «Certamente - disse Alessandro degli Alessandri - vedo che sei un ragazzo intelligente e degno nipote di tuo nonno.» concluse con un certo autocompiacimento. «Dunque, il numero tre indica le fasi dell’opera alchemica, caratterizzate dai colori bianco e rosso, proprio come quelli della facciata, cui si unisce il nero degli archi del piano terra. Quattro sono invece le qualità e precisamente l’umido, il secco, il freddo e il caldo e quattro sono gli elementi, cioè la terra, che è fredda e secca, l’acqua, che invece è umida e fredda, l’aria, che è umida e calda, e infine il fuoco, che è caldo e secco. Combinandoli nella perfetta proporzione, e questa è la parte più difficile e il compito ultimo della scienza alchemica, si riuscirà ad arrivare a un perfetto equilibrio delle forze opposte e complementari della natura. Si riuscirà così a catturare l’energia vitale che ogni cosa, anche la più vile e disprezzata, contiene in potenza, e a creare un farmaco e un elemento perfetto.» «E le figure cosa significano?» insistette Vincenzo. 38 «Il volto in alto al centro, con i capelli ondulati al vento, è Elia Lelia, cioè l’arte alchemica, nella chiave di volta dell’arco centrale vi è il simbolo dell’ariete, periodo in cui comincia l’anno solare, mentre nei due archi laterali vi sono la foglia e i due serpenti, a rappresentare le forze, opposte e complementari, della natura. I vasi con la vite sono invece a ricordo della materia prima, mentre quella testa a sinistra, tra le fauci del lupo, rappresenta lo spirito vitale che passa dalla terra al cielo, e viceversa, attraverso l’azione dell’alchimista che si avvale di agenti, come il trisolfuro di antimonio, sempre rappresentato con il potente simbolo del lupo grigio.» «Ma don Floriano, che pure ha letto tanti libri, non immagina tutto ciò?» fece Vincenzo. «Taci e ascolta – continuò suo nonno, seccato di essere interrotto – non tutti coloro che hanno studiato possono capire la scienza segreta della natura. Solo pochi eletti hanno le capacità sufficienti. Dunque, gli occhi della bifora hanno invece la forma dei vasi della natura e dell’arte, da cui può sorgere l’albero della vita, come si vede nella finestra centrale dell’ultimo piano. Sotto le gronde i draghi sono stati messi a ricordo della materia fluida, serpentina e vitale, cioè l’argento vivo, mentre un minuscolo volto sullo stipite in alto a sinistra rinvia al piccolissimo seme dell’oro; infine le chiome ondulate delle due teste laterali sono una rappresentazione del vento, cioè delle onde delle acque superiori, grazie alle quali l’opera diventa alchemica.» Alessandro degli Alessandri terminò il suo discorso tutto di un fiato, come se avesse paura che orecchie indiscrete si appressassero. A Vincenzo sembrava ora di vedere finalmente il significato vero della casa. Era un inno all’arte alchemica praticata da suo nonno. Come mai non c’era arrivato subito? Certo non sapeva molto, ma a Venezia qualcosa aveva ben appreso. Avrebbe dovuto riconoscere almeno le corna dell’ariete, invece di lasciarsi trarre in inganno e ritenerlo un bastone da pellegrino. Inoltre come potevano i serpenti rappresentare il demonio, quando erano invece sempre stati legati all’idea dell’acqua e della vita. Felice che suo nonno si fosse finalmente confidato con lui e lo avesse ritenuto degno di condividere i suoi segreti, il ragazzo pensò che fosse giusto dimostrargli la medesima fiducia. Nella sua mente tornava spesso il ricordo delle strane esperienze che aveva vissuto da quando era salito lassù tra i monti. Era giunto il momento di chiedere consiglio a una persona grande. «Nonno - chiese in uno slancio di sincerità - vorrei chiedervi una cosa. Da quando sono arrivato mi sono successe delle cose strane. Forse voi potete darmene una spiegazione.» «Dimmi, dimmi. - rispose il vecchio, che per una volta tanto si sentiva come uscito dalla corazza entro cui si era rinchiuso tanti anni prima - Ho sempre considerato Valdenoghèr come un posto particolare, un po’ fuori dal mondo, e per questo l’ho scelto come ritiro per la mia vecchiaia. Inoltre la gente di quassù racconta fantastiche leggende, che a tua nonna piacevano moltissimo. Non so perché ma qui 39 Maria Turchese si sentiva bene, quasi non avesse lasciato la sua terra che tanto amava.» concluse con una nota di rimpianto nella voce. «Ecco, per esempio - riprese Vincenzo che in verità non sapeva bene da che parte cominciare - tempo fa sono salito sul grande noce, quello che sta all’inizio di Valdenoghèr, dalla parte di Farra, ed è stato come trovarsi tra le nuvole, mentre in testa mi nascevano vaghe parole.» «Probabilmente salendo sull’albero sei quasi svenuto. È una cosa che accade alle volte e nel tuo caso non c’è nulla di preoccupante. Hai avuto paura dell’altezza e tutto ha cominciato a girarti intorno e a diventare tutto bianco. Non è stato così?» disse il vecchio medico con aria professionale. «Proprio così.» rispose mesto Vincenzo, un po’ deluso che la sua grande esperienza si fosse trasformata in un caso fin troppo comune. «Poi, però, un giorno sono arrivato sino ai limiti della Valturcana e ho visto un essere tutto bianco che ha cercato di prendermi e mi ha fatto molta paura.» «Una creatura albina?» fece il nonno. «Un che?» gli fece eco il ragazzo. «Una persona con i capelli bianchi e con gli occhi rossi. Ci sono due fratelli così a Farra. Devi sapere che gli uomini non hanno tutti riccioli neri e occhi scuri come i tuoi. Avrai certo incontrato a Venezia qualche mercante del Nord, con gli occhi azzurri e la barba bionda oppure rossa, come le chiome di quelle belle donne che un pittore delle nostre montagne usa dipingere.» «Sì - rispose Vincenzo - ho anche visto gente con la pelle nera, come il carbone, ma non ho mai visto nessuno con la pelle così bianca e con quegli occhi rossi.» «Eppure se ne vedono, anche se molto raramente. Sono esseri imperfetti con cui la natura si è divertita creando una forma particolare, come capita per i nani, che sono molto più comuni. Lusus naturae, dicono i dotti, cioè uno scherzo della natura.» «Allora degli occhi che fiammeggiano come il fuoco non sono solo quelli del demonio?» riprese Vincenzo pensando al suo incontro nella camera di Iris. «Gli occhi rossi si possono vedere. - disse il vecchio - Io stesso, una volta, ad Alessandria d’Egitto incontrai un moro che li aveva, assieme a una pelle bianca come il latte. Per altro, egli era una persona assai dotta che conosceva a fondo i misteri degli antichi. Ero giovane allora – continuò Alessandro degli Alessandri, perso ormai nei suoi ricordi - ed egli mi insegnò molte cose. Per esempio fu lui a spiegarmi che, come tre sono le fasi dell’opera alchemica, così tre sono anche le parti in cui si suddivide l’essere umano: l’uomo è formato da corpo, anima e spirito. Il primo è la parte materiale dell’individuo, la seconda ne è il fuoco ardente, che muove ed agita la prima, la terza infine è l’energia vitale, che mette in comunicazione le altre due e permette all’una di agire sull’altra. Non a caso essa è rappresentata da Mercurio, l’antico messaggero celeste che faceva da tramite tra gli dei e gli uomini, così come lo spirito è il mezzo che mette in contatto l’anima con il corpo.» 40 «Ma io una volta ho visto due fiamme rosse che ballavano nel profondo di due orbite vuote. E non erano occhi veri e propri.» insistette Vincenzo. «Non vorrai diventare come don Floriano, spero.» disse Alessandro degli Alessandri, cui non piaceva molto essere contraddetto, soprattutto quando parlava dei suoi studi preferiti. «Ma anche il Matt mi ha detto di aver visto…» «Il Matt, il Matt. Non mi piace quel ragazzo. - lo interruppe il vecchio, indicando con queste parole quello che per Vincenzo era invece un uomo fatto - Gira sempre qua intorno e non sa fare nulla, solo raccontare storie. Andiamo a casa.» Qualcosa si era spezzato nella confidenza che aveva unito per un momento nonno e nipote. Vincenzo si morse le labbra, dispiaciuto di aver nominato, nel suo desiderio di trovare dei testimoni, una persona che evidentemente al vecchio signore non piaceva. Tornarono in silenzio verso la grande casa e nessuno dei due gustò quella sera la povera gallina a cui Maria aveva, obbedientemente, tirato il collo. 8. Gli animali di sant’Antonio Giorno dopo giorno ci si avviò verso l’Epifania. In quel periodo Vincenzo, che cercava di evitare suo nonno, rimase spesso fuori, nei campi, e così prese freddo. Niente di preoccupante, solo un po’ di tosse che però lo costrinse a rimanere rintanato nel locale più caldo della casa, cioè in cucina. La vigilia della festa vi fu un gran via vai di gente. Tutto doveva essere perfetto per il giorno dopo, anche se il signor Alessandro era solo con il nipote e non vi erano vecchi amici giunti di lontano per chiacchierare con lui di scienza e di filosofia come un tempo era capitato spesso. C’era Catina, la ragazzina che di solito aiutava Maria nelle faccende domestiche, e c’era anche Simone, incaricato come al solito di lavori pesanti come rigovernare le bestie o tagliare la legna per il focolare. «Dai Simone - disse a un tratto Catina, mentre mescolava la zuppa - racconta qualche cose delle tue parti. Come si festeggia la venuta dei re magi di là dai monti?» «Si festeggia, si festeggia, anche da noi - disse l’uomo interrompendo per un momento di spostare dei pezzi di legno. - Quando ero piccolo, a Tarcento, facevamo delle grandi cataste di tronchi e arbusti, i pignarul. Poi, quando veniva la sera un uomo poneva una fiaccola sulla cima di una lunga pertica e la portava lungo le pendici del colle di Coia, seguito da un corteo di persone, tutte con una fiaccola in mano. Giunti al castello dei Frangipane il signore del maniero aveva l’onore di accendere il pignarul grant e questo era il segnale per i contadini dei casali dei dintorni di accendere i falò. Allora cominciava la festa che continuava finché ardevano le cataste di legna. Era come se la notte stellata si fosse per una volta tanto capovolta e per gli uomini fosse possibile camminare sulla volta celeste, in mezzo al 41 firmamento. Era davvero una notte magica, quella dell’Epifania.» concluse con un tono di saggio rimpianto. Il ragazzo rimase profondamente colpito da quel racconto. Sonnecchiando vicino al focolare cominciò a pensare di vedere anche lui un uomo che rubava al cielo la fiamma di una stella, quindi la processione luminosa che andava ad accendere il pignarul grant; a quel segnale mille fuochi esplodevano ardenti nella campagna. Lungo la via tracciata dalle lingue di fuoco che sfumavano verso il cielo era possibile salire sempre più su e anche lui, Vincenzo, assunta la consistenza del vapore, si faceva trasportare sulle ali del fumo; usciva così dalla cucina del nonno, passava per le scale e quindi si disperdeva attraverso il tetto. La terra non era più sotto di lui ma su, in alto, sopra la sua testa. Eppure ciò che calpestavano i suoi piedi non era una nuvola impalpabile, bensì una solida pietra di montagna. Su di essa scorrevano ad onde quelle «acque superiori», di cui aveva parlato il nonno. Con la loro armonia riuscivano a trasformare e perfezionare l’esperimento alchemico mentre lo spirito fatto di fuoco passava dalla terra al cielo… e una gran pace si diffondeva nel cuore. «Signor Vincenzo, si svegli, vuole assaggiare un po’ di questi dolci?» La voce di Maria lo riportò improvvisamente lontano dal cielo del suo sogno, giù per la via percorsa dal fumo del focolare, fino a quella buia cucina dove l’odore del pane appena cotto si univa a quello della caligine. «Salve Maria, mi ero appisolato un momento.» L’idea di assaggiare un dolcetto gli apparve subito molto più allettante di una qualsiasi passeggiata celeste. L’indomani poi la Befana, scendendo dal camino come una strega, avrebbe portato altri dolci ai bambini buoni e carbone a quelli che erano stati cattivi. Vincenzo si trovò a pensare come avrebbe fatto quella vecchietta a scendere in una casa che come camino aveva la tromba delle scale, coperta da un solido tetto, come quella in cui si trovava. Forse avevano costruito quell’edificio particolare proprio per consentirle di non sporcarsi troppo e rendere la sua discesa più agevole. Era un pensiero divertente e lo disse a Maria che, chissà perché, lo guardò di traverso, come se quell’idea non fosse poi così strana. «Rida pure, signorino - disse Maria con voce alterata - ma la Befana è una figura antica, e ha un compito importante da svolgere su questa terra: è come la natura che porta semi di vita futura ai buoni. Non rida delle tradizioni della gente comune, come me. Noi sappiamo cose che voi, signori che avete studiato, neppure potete immaginare e siamo noi che, anno dopo anno, difendiamo i raccolti e, in definitiva, vi permettiamo di mangiare. Anche il signor Alessandro, se sapesse…» disse guardando Simone di sottecchi. In quella cucina scura, che assomigliava tanto all’antro dell’alchimista, Maria aveva ormai dimenticato la parte della brava serva. «Anche il signor Alessandro - continuò - se sapesse che tutti i suoi esperimenti e i suoi studi non lo porteranno mai a nulla perché la natura non si rivela a chi sa tante cose ma solo a chi la sente dentro di sé.» 42 «Maria, taci. Hai detto troppo - la interruppe Simone - e poi il signore qui ha una gran voglia di assaggiare i tuoi dolci e non vuole sentire delle chiacchiere senza senso.» Vincenzo ne ebbe infatti una doppia razione assieme a un gran bicchiere di sciroppo contro le infreddature. Dopo aver gustato il bruno liquore si appisolò nuovamente e quando si svegliò era ormai sera e si chiese se per caso non fosse stato tutto un sogno. Pochi giorni dopo riapparve, sulla via che conduceva al paese, don Floriano, che aveva sperato fino all’ultimo in una tempesta che gli impedisse di raggiungere la sua meta, ma il Signore non era stato clemente con lui e il bel tempo lo aveva costretto a obbedire agli ordini del pievano e a dirigersi verso Valdenoghèr. Quella località, per quanto isolata e distante dagli altri centri abitati, rientrava nella sua giurisdizione e nella sua cura d’anime. Poco più in su, invece, cominciava una terra che era preda del maligno, dove il sacro suono delle campane non riusciva neppure a penetrare. Don Floriano rabbrividì, nonostante tutta la sua dottrina, al pensiero delle leggende di demoni ed esseri strani che popolavano quelle valli. Era molto più riposante pensare a Sant’Antonio, il «santo del pursel», come dicevano da quelle parti. Il giorno dopo avrebbe dato la solenne benedizione agli animali e ne avrebbe ricevuto in cambio qualche dono. Accanto a lui avanzava con passo affaticato una figura avvolta in un mantello nero da cui spuntava un abito bianco; teneva la testa china, come per guardare attentamente dove metteva i piedi. Passando, i due uomini si fermarono un attimo per prendere fiato e salutarono con un cenno Vincenzo che, seduto sulla soglia della grande casa con un libro in mano, si era alzato in piedi in segno di rispetto. Il ragazzo si chiese con meraviglia chi fosse quel frate che accompagnava don Floriano. Poi riprese a leggere il volumetto manoscritto che aveva scovato in un angolo remoto della soffitta. Era una raccolta di storie edificanti e, tra le altre, vi era proprio anche quella di sant’Antonio il cui maialino era riuscito un giorno a sgusciare oltre la porta dell’Inferno e aveva cominciato a scorrazzare nelle distese infuocate; alla fine i diavoli, disperati, non avevano potuto far altro che pregare il suo padrone di andare a riprenderselo; riacchiappato il fuggitivo, il santo aveva cominciato il viaggio di risalita, appoggiandosi sul suo bastone a forma di tau cui a un certo punto aveva fatto prendere fuoco per riscaldare con questo tutta l’umanità. A Vincenzo parve un racconto molto bello e poco dopo, raggiunta la cucina, cominciò a raccontarlo a Catina, che stava attizzando il fuoco. «È una bella storia - disse la servetta - ma la verità è un’altra. Il maiale accompagna il santo perché, nella notte della sua festa, tutti gli animali possono parlare. Provi a andare in una stalla questa sera, signorino, e vedrà» concluse con fare divertito. Vincenzo pensò che l’idea non fosse cattiva. Una spedizione notturna, tra le sicure mura della casa, gli pareva un’avventura che avrebbe allontanato per un po’ la 43 monotonia di quell’inverno. Inoltre si era da poco rappacificato con i ragazzi del villaggio e avrebbe potuto coinvolgerli. Si ripromise dunque di chiamare Celeste, per metterlo a parte della progettata spedizione. Intanto chiese a Maria, che stava preparando la cena, se conosceva quel religioso che era giunto con don Floriano. «Un altro uomo di chiesa da queste parti? - chiese con voce incerta la serva - La cosa è ben strana. Non viene mai nessuno quassù, soprattutto in questa stagione.» «Forse il nonno ne è al corrente.» disse Vincenzo che, senza sapere perché, voleva come rassicurarla. «Il padrone è troppo preso dalle sue carte per sapere qualcosa di quello che succede nel mondo. Comunque sarà meglio informarlo.» Concluse Maria che, dopo un attimo di smarrimento, aveva ripreso il suo fare abituale. La conversazione morì lì e Vincenzo andò a casa di Celeste per accordarsi con lui per quella notte. «Non mi sembra una cosa molto giusta… - cominciò Celeste, per nulla divertito - andare di notte, in una stalla… Ci si può andare con tutta tranquillità anche di giorno.» Non poteva dire cosa veramente pensava di quella strana idea perché Vincenzo, per quanto della sua stessa età, era, pur sempre, il nipote del signor Alessandro. «Sì, ma Catina ha detto che questa notte gli animali parlano.» rispose Vincenzo. «Non parlano. Non ne ho mai sentito uno.» «Ma anche il Matt ha detto una volta di aver parlato con un falco pellegrino.» «E allora? Il Matt è appunto il Matt; non ha mica proprio la testa a posto quello, come dice mio padre. E poi uscire di notte, con il freddo… quando non ce n’è bisogno e si potrebbe stare ancora a letto. Mi basta dovermi alzare quando è ancora buio per mungere le vacche.» Celeste era infastidito per quella strana proposta. Si poteva anche immaginare di vivere avventure meravigliose quando era il momento di giocare, ma la realtà era un’altra cosa e sapeva che in una stalla, di notte, avrebbero trovato solo degli animali addormentati. Se avesse accettato, e magari poi Jacopo o Margherita lo avessero saputo, sarebbe diventato lo zimbello del paese. «Va bene. Lasciamo perdere.» concluse Vincenzo a malincuore. Sembrava che tutto andasse per il verso sbagliato quella sera. Prima quella figura vestita di bianco e di nero che faceva paura, poi Catina che lo prendeva in giro, e infine Celeste che non voleva andare con lui. Pazienza. Sarebbe andato da solo. Dopo desinare corse subito a rifugiarsi nella sua stanza, per aspettare che tutti si addormentassero. Era intenzionato a restare ben sveglio per vedere quando suo nonno avrebbe spento la candela. Si cacciò a letto tutto vestito. Il sonno però lo vinse: si stava così bene al caldo, sotto le coperte. Si svegliò di soprassalto nel mezzo della notte, ricordandosi della progettata spedizione. La candela che aveva lasciato accesa era consumata ormai a tre quarti. Senza esitare allontanò la trapunta, prese il lume e si diresse verso la porta. Piano piano scese le scale. Il legno scricchiolava terribilmente, comunque, a parte questo, non si udiva altro suono. Arrivato giù, si 44 avvicinò alla stalla: gli sembrò per un momento di udire delle voci, ma forse era solo la sua immaginazione. Entrò e cominciò a guardarsi attorno. C’erano i due asini, immobili e addormentati, e poco più lontano la vacca. Fu una macchia bianca, scorta alla tremula luce del suo lume, che lo fece fermare. Una grassa oca lo stava fissando con il collo piegato. Vincenzo si ricordò di quella che, secondo il Matt, accompagnava San Martino. «Ehi, oca, ochetta… cosa fai qui?» «Non mi pare che questi siano affari tuoi.» fu l’inattesa risposta. «Dunque, le oche non parlano.» disse a se stesso Vincenzo cercando di mantenersi calmo, ma senza riuscire a scacciare del tutto la sua eccitazione. «Certo che parlano, certo che parlano, ma solo a coloro da cui vogliono farsi sentire.» «E tu vuoi farti sentire da me?» «Visto che sei qui. Visto che sei qui. E poi mi sembri abbastanza gentile, non come quei ragazzacci dei tuoi amici.» concluse l’oca. «Chi è questo qui?» un’altra voce penetrò l’oscurità. «E tu chi sei?» chiese il ragazzo che non stava più in sé, incerto tra la meraviglia e il timore. «Io sono Lug - riprese l’altro con tono profondo - e sono lo spirito di tutti i cinghiali.» «Piacere Lug» disse Vincenzo che voleva mostrarsi gentile. «Vedi che ho ragione, vedi che ho ragione - interloquì l’oca. - Io ho ragione.» «Taci. Devo pensare.» riprese il cinghiale. «Dobbiamo dirglielo. Dobbiamo dirglielo, come ti avevo detto.» continuò il bianco animale. «Dire che?» chiese Vincenzo. «Cose gravi. Ma devi dimostrare di essere degno di condividere questo segreto.» «Cosa devo fare?» chiese Vincenzo, ormai mosso solo dalla curiosità. «Ecco - riprese il cinghiale - vai di sopra e prendi uno specchio e portalo fuori. Prova a guardarci dentro. Se sei veramente chi quest’oca dice che tu sia, succederà qualcosa, ma spetta poi a te decidere cosa fare.» «Uno specchio?» chiese Vincenzo. «Tonto di un ragazzo - continuò Lug - uno di quei dischi che riflettono le immagini degli uomini.» «Le donne vi si rimirano, come nelle pozze d’acqua.» fece l’oca. «Ho capito. Non mi sembra una gran prova. Comunque vado e torno.» disse Vincenzo che, alzato nuovamente il lume si diresse verso la porta. Corse di sopra. Lo specchio di Murano che stava appeso nella stanza al primo piano era troppo grande e fragile per essere spostato. Se lo avesse rotto non avrebbe certo evitato un bel castigo. Allora si ricordò di quei due dischi di metallo che stavano attaccati alla parete della sua camera, in cui sua nonna soleva guardarsi, come 45 aveva detto Maria. Non gli fu difficile staccarli dal chiodo, però non riuscì a dividerli, tanto erano intrecciati i cordoni che li legavano, per cui li portò fuori entrambi. Ridiscese le scale scricchiolanti e uscì di casa. Fuori, la luna piena, alta nel cielo, illuminava i contorni degli edifici e degli alberi. Appoggiò gli specchi per terra, al centro della strada, davanti alla grande casa. Il silenzio intorno era tangibile. Sulla superficie lucida del primo si stagliava solo la sagoma scura della sua testa. Allora si spostò e il bagliore della luna vi si rifletté in tutto il suo splendore. L’altro specchio rimaneva opaco nell’oscurità. Piano piano mentre Vincenzo fissava il riflesso dell’argenteo disco lunare, l’immagine si intorbidò e comparvero degli uomini che parlavano concitatamente. Uno era suo nonno, ma aveva la faccia scura e preoccupata. Un altro era don Floriano e c’era anche il frate vestito di bianco con le ali del mantello che gli ondeggiavano intorno, come quelle di un uccello notturno. Stavano entrando in casa e Alessandro degli Alessandri li seguiva. Erano sul punto di aprire la porta dell’officina del nonno ed scoprire il fumoso antro da alchimista. «Vedrà padre: è colpevole, colpevole, colpevole…» diceva compiaciuto don Floriano. «Allora merita la massima punizione per aver praticato arti magiche - continuava l’altro - dovrà essere portato davanti al tribunale del Santo Uffizio per essere giudicato…» Così come era venuta l’immagine svanì e Vincenzo si ritrovò a fissare il disco lunare. Si stropicciò gli occhi, ma non riuscì a vedere altro. Allora di corsa tornò nella stalla, ma vi erano solo gli asini e la vacca che dormivano. Ritornò fuori a a prendere la candela che aveva dimenticato, ma anche quel lume non gli consentì di vedere altro. Lug, il cinghiale, e l’oca bianca se ne erano andati. Vincenzo passò il resto della notte senza chiudere occhio, a domandarsi che cosa avrebbe potuto fare. Un’angoscia terribile lo attanagliava. Ripensava a quella mattina, alle due ombre che salivano a Valdenoghèr e alla faccia scura e preoccupata di Maria. Quando stava per sorgere il sole era già in piedi; scese subito ma trovò solo Catina, intenta a preparare la colazione. Poco dopo arrivò la serva che gli chiese stupita cosa faceva alzato a quell’ora. «Maria, ti devo parlare. - disse Vincenzo - è una cosa importante.» Poi a pezzi, un po’ tremando, titubante per la paura di non essere creduto, cominciò a raccontarle quello che aveva visto quella notte. Stranamente, Maria non mutò espressione. Era solo attenta a non perdere una parola di quello che il ragazzo diceva. Viveva in quel paese da sempre e aveva conosciuto cose che alla maggioranza della gente restano nascoste. Alla fine disse: «Dobbiamo cercare Simone. Tre teste sono meglio di due, quando bisogna ragionare.» Poco dopo anche il vecchio friulano venne messo al corrente del segreto. «Sarebbe bello che aprissero quella porta e vi trovassero solo un deposito di cose vecchie.» sbottò alla fine Simone. 46 «Già, un deposito, una cantina. Ecco cosa deve diventare la fucina del nonno.» disse Vincenzo. «Ma non possiamo spostare tutto. Il padrone si arrabbierà. - disse Maria dobbiamo avvertirlo.» Vincenzo ebbe un sussulto. Sicuramente suo nonno avrebbe trovato assurdo il suo racconto e si sarebbe rifiutato di smantellare la sua officina solo per riguardo a un sogno. «Dobbiamo farlo e subito. - disse - Non c’è tempo di avvertire nessuno. Se il nonno si arrabbia... troveremo una giustificazione, in qualche modo. Direte che è stato un mio ordine e non ve la siete sentita di disobbedire.» Alla fine si decisero. Chiamarono Catina e tutti e quattro cominciarono a vuotare la stanza dell’alchimista. I vetri furono portati delicatamente nel fienile e riposti sotto strati e strati di paglia. I libri, compresi quelli che stavano di sopra, finirono in una cassa, in soffitta. Vincenzo abbandonò su uno scaffale solo l’erbario di Dioscoride, il Leggendario dei santi e un paio di poemi che gli sembrarono innocui. Poi portarono nella stanza a piano terra un vecchio aratro, degli attrezzi da contadino e molti oggetti inutili. Catina era sbalordita di tutti quei cambiamenti. «Ma cosa dirà il padrone? - non faceva che ripetere - se la prenderà con noi e ci caccerà via.» In capo a un’ora la stanza era completamente trasformata. Ora aveva l’aria di un deposito di cose vecchie e solo la mancanza di strati di polvere poteva dar da pensare a un osservatore attento. Quando finalmente si fermarono per riposarsi Vincenzo si rese improvvisamente conto che né Maria né Simone avevano messo in dubbio la veridicità della sua visione. Passarono così dieci minuti, quando un bussare alla porta fece voltare tutti. «Chi può essere? a quest’ora.» disse Maria andando ad aprire. Era don Floriano, accompagnato dall’altro prete, che chiedeva se il signor Alessandro era già in piedi. «Andate a chiamarlo subito - fece con tono perentorio - devo parlargli di una cosa molto, molto importante.» Maria lo fece accomodare, poi andò su, a svegliare il padrone. Vincenzo che era sull’uscio della cucina si tirò indietro, per non farsi vedere. Poco dopo il signor Alessandro comparve, un po’ preoccupato; non riusciva a capire bene cosa significasse quella visita inaspettata. Allora i tre uomini cominciarono a discute animatamente, il primo a difendersi e gli altri due ad accusarlo di essere un mago e uno stregone. «Andiamo dentro - disse a un certo punto un compiaciuto don Floriano al suo compagno - qui troveremo le prove della sua colpa. Vedrà padre: è colpevole, colpevole, colpevole…» «Allora merita la massima punizione per aver praticato arti magiche - gli rispose l’altro - dovrà essere portato davanti al tribunale del Santo Uffizio per essere giudicato…» 47 Con fare sicuro don Floriano si diresse verso la stanza dell’alchimista, ma la sua espressione soddisfatta sparì non appena ebbe aperto la porta. «Cosa c’è qui? - chiese l’altro - Vedo solo cose vecchie.» Alessandro degli Alessandri era estremamente sorpreso, ma non disse una parola: assunse invece quell’aria indecifrabile che teneva davanti ai suoi pazienti più gravi, quando non voleva che alcuno scorgesse sulla sua fronte l’avvicinarsi della morte. Poco dopo i due uomini di chiesa se ne andarono, balbettando qualche scusa. Vincenzo ripensò alla visione notturna e ringraziò in cuor suo il cinghiale Lug, gli specchi di sua nonna e anche quell’oca bianca e pettegola. 9. La terra incantata Nessuno parlò di quanto era successo quella mattina eppure, occhiate e ammiccamenti, convinsero Vincenzo che la notizia aveva fatto rapidamente il giro del villaggio. Inigo si era chiuso in casa ma sua moglie, la signora Lina, era andata a trovare quel giorno stesso le due vecchie che davano ospitalità a don Floriano e al suo compagno e si era fermata un pezzo a chiacchierare con loro. Ciò convinse Vincenzo che la notizia era passata di là. Inigo certo era a parte del complotto e sarebbe stato strano che sua moglie non sapesse nulla. Come strano sarebbe stato se Tranquilla, che era sempre al corrente di tutto ciò che accadeva ai suoi vicini, non avesse trovato il modo di essere informata e di far fare poi alla notizia il giro del villaggio. Nonostante la delusione e il disappunto, don Floriano non si dette per vinto. Era fermamente convinto che il diavolo abitasse a poca distanza da Valdenoghèr, alla fine della Valturcana e su, oltre le Coste de Mai, in quelle lande desolate dove nessun uomo riusciva a entrare. Così convinse padre Domenico, il frate che era venuto con lui, che era necessario almeno benedire il villaggio e i boschi intorno. Era questi un giovane, suo coetaneo e amico d’infanzia. Le loro strade si erano però divise quando Giovanni, così un tempo si chiamava quel giovane, aveva deciso di farsi frate e aveva preso il nome di Domenico, mentre don Floriano era rimasto legato al paesello d’origine. I suoi superiori, notata la sua viva intelligenza, lo avevano mandato a studiare a Roma, dove si era appassionato alle nuove idee che scuotevano allora le istituzioni ecclesiastiche: bisognava darsi da fare in prima persona per dare una risposta alle minacce e al dilagare del protestantesimo e ritornare a una vita più vicina agli ideali antichi. Bisognava dunque cercare e condannare quanti si lasciavano sedurre dal maligno, ma al tempo stesso anche educare, istruire e assistere i poveri. Dopo lunghe discussioni i due preti decisero che l’unica iniziativa che potevano prendere era, per il momento, quella di organizzare per la domenica successiva una grande processione per benedire i boschi. La giornata si preannunciò stupenda fin dal mattino presto. Una luce rosata penetrava l’aria gelata e avvolgeva le 48 case. La gente, vestita a festa, cominciava a incolonnarsi. Prima venivano i bambini, poi le donne, seguivano i due preti contornati dagli uomini. Vincenzo, come al suo solito, arrivò in ritardo e si ebbe un’occhiataccia da almeno una dozzina dei presenti. Non erano poi in molti, pensò il ragazzo, che volgendosi intorno scorse appena una quarantina di persone. Eppure c’erano tutti. Maria stava nascosta in mezzo alle donne mentre Simone si mise vicino a Olmo. C’era anche il Matt, pure lui vestito a festa. Alessandro degli Alessandri si sistemò tra gli ultimi, come se partecipare fosse per lui uno spiacevole dovere. Inigo invece era in prima fila, portando una gran croce, mentre sua moglie Lina, avvolta in un abito «da città», guidava le donne. Don Floriano intonò un canto e tutti si mossero. L’idea della processione era stata accolta con gioia. Si trattava di una novità nella vita monotona di quei mesi invernali e poi, ormai, si era in carnevale e tanto valeva cominciare a far festa. Un poco alla volta, sia per scaldarsi che per farsi notare, anche chi non aveva voce si mise a cantare a squarciagola e quello che doveva essere un canto latino si trasformò in un insieme indistinto di suoni, che della lingua di Cicerone avevano ormai ben poco. Cammina cammina arrivarono fino alla casa di Jacopo, isolata in mezzo a campi scoscesi. I preti benedissero quei luoghi e poi la processione riprese verso nord. Quando giunsero ad All’Ò, ormai molti parlavano, anche se a bassa voce. Vincenzo udì la madre di Iris, Rosa e Margherita che stava dicendo a un’altra donna: «Ecco, fu proprio qui che le vidi, tanti anni fa a primavera. Erano bellissime e danzavano in cerchio. Non toccavano quasi terra e la più bella di tutte, vestita di azzurro come l’acqua e il cielo, conduceva la danza. Non potrò mai dimenticare quel momento.» «Anche mia mamma mi raccontava di averle incontrate - le rispose l’altra contadina - era un mezzogiorno d’agosto e tutto era immobile, tranne un canto che non si era mai sentito da queste parti. Quando ero bambina mia madre me lo ripeteva come una ninnananna. Ecco, faceva così…» e si mise a canticchiare sottovoce una strana melodia. Vincenzo non riuscì a trattenere la curiosità: «Ma chi erano?» chiese. «Non so, non saprei - disse Aurora, parlando sottovoce - erano delle ragazze che non avevo mai visto.» «Erano come le fate di quei racconti che si fanno di sera, vicino al camino riprese l’altra - e quando spariscono cresce un anello di funghi, là dove hanno ballato.» «Oppure le messi si piegano seguendo i passi della loro danza. Ma è meglio non parlarne. Don Floriano non vuole.» concluse Aurora chinandosi a prendere in braccio la piccola Iris che aveva cominciato a tirarle la gonna per dimostrare tutta la sua stanchezza. L’idea dei preti era quella di procedere oltre All’Ò e Broz fin dove era possibile, visto che di neve, quell’anno, non ce n’era molta. Vincenzo si accorse che il sentiero 49 era quello che lo aveva portato a perdersi dritto dritto nella Valturcana qualche mese prima. Dopo un po’ di cammino però non ne era più tanto sicuro. La strada che aveva seguito quella volta si dirigeva verso i boschi mentre ora il sentiero che stavano percorrendo piegava mollemente tra i campi. Il sole, ormai a perpendicolo sulle loro teste, non era un buon riferimento. Don Floriano, forse rendendosi conto anche lui che stavano tornando indietro, si fermò per dire a voce alta che bisognava andare verso il bosco, quando all’improvviso apparve una nuvola, spuntata chissà da dove. Ci fu appena il tempo di fare un centinaio di metri che il cielo si fece scuro scuro. Un chiarore giallo, foriero di tempesta, avvolgeva l’aria. Le prime furono le donne, preoccupate che i bambini prendessero freddo, a dire che bisognava tornare indietro. Tutti si fermarono. I preti cercarono di riorganizzare le fila, ma ormai il gruppo era spezzato. Cominciò qualche goccia e ci fu appena il tempo di una veloce benedizione al bosco, che si stagliava scuro e vicino contro il cielo, prima che cominciasse a cadere una pioggia fitta fitta. A quanto pareva i demoni dell’inferno si erano scatenati e invece di essere cacciati via stavano mettendo in rotta i loro avversari che non si presero neppure la briga di combattere. Ci fu un fuggi fuggi generale e tutti tornarono a casa bagnati fin nelle ossa. Il luogo venne poi ricordato a lungo come l’ultimo a esser stato benedetto prima che quella strana processione, fatta a Carnevale, si sciogliesse. Don Floriano e padre Domenico rimasero poi una mezza giornata chiusi in casa a confabulare, o meglio a dirsi che i boschi oltre la Viaz, erano preda di un incantesimo. «Anche abbastanza lontano da qui, dalle parti di Lavina, c’è un posto che si chiama Sabbadalt, - diceva l’uno - e solo il nome mi fa rabbrividire. Hanno fatto bene i contadini di quel villaggio a chiamare "al Sant" l’ultima terra prima della zona indemoniata e a costruirci un capitello.» «Anche dall’altra parte, dal paese di Chiès, non si riesce a salire oltre il Pian dei Tac e a superare la casera in rovina.» diceva don Floriano. «Ed è abitata da quelle due vecchie, che tutti considerano delle maghe. continuava padre Domenico - Eppure il passaggio con Chiès dovrebbe essere possibile.» «Era proprio quello che Gildo, mio fratello, voleva fare, quando scomparve.» fece allora Modesta, che stava arrivando con due ciotole di zuppa calda. «Lasciaci soli. Non sono cose che riguardano le donne.» disse don Floriano. «Eppure io mi ricordo di quei posti. Almeno qualcosa - continuò la contadina senza mostrare di aver sentito - i bambini si tramandavano anche dei nomi. Oltre la Valturcana, dove la signora passeggiava sempre, mi ricordo di luoghi chiamati il Bus, il Spin, il Fossalet, vicino ai massi che formavano il recinto detto da tutti Tambre. E poi ce n’erano altri di cui ho solo sentito parlare, come la valle Busa Tonda, il Pian delle Lastre e un posto che faceva proprio paura: lo chiamavamo Pian delle Mosche, e nessuno voleva andarci.» Terminò d’un fiato. 50 Modesta era una donna bassa, grassoccia, buona massaia, ben diversa da sua sorella Tranquilla, magra e allampanata e all’apparenza tanto fragile, cui piaceva parlare e sparlare di tutti. Modesta, che si atteggiava da sempre a padrona di casa, era un cuore d’oro che si lasciava facilmente sedurre da un sorriso di bambino o dalle lacrime della sorella ma che, allo stesso tempo, sapeva far la voce grossa e tener testa anche al più burbero dei boscaioli. Intanto i due preti erano rimasti senza parole per lo stupore. Non immaginavano certo che la vecchia cui non avevano mai dato molta importanza sapesse tutte quelle cose, e così cominciarono a interrogarla, e a confrontare ciò che diceva con quello che sapevano e che avevano detto loro alcuni abitanti di Chiès. Quella grande zona sconosciuta cominciava a prendere forma. Padre Domenico prese anche un pezzo di carta e una matita per tentare di disegnarla. Le parti più frequentate da presenze inquietanti sembravano Pian delle Mosche, dove si aggiravano di certo dei demoni, e Caotès, dove dovevano stare le sorgenti del fiume Tesa; nessuno le aveva mai viste perché gli alberi erano troppo fitti e i rovi troppo intricati per penetrarvi. Dalla parte di Chiès non si poteva procedere molto oltre la casera abitata dalle due streghe. Dal terzo lato la gente poteva arrivare poco oltre Lavina e anche i viottoli che partivano da Malolt e Cornei si interrompevano a un certo punto; si arrivava così sin dentro la Valturcana ma nessuno era mai riuscito poi a percorrerla tutta. Infine chiesero chi era quella signora a cui Modesta aveva accennato. «Era la moglie del signor Alessandro.» disse la donna. «Ah! - fece don Floriano - la signora Maria Turchese.» «Perché non andiamo a sentirla, allora?» chiese padre Domenico. «Non è proprio possibile. Ormai è morta da anni. - gli rispose don Floriano - Ma ne raccontano strane storie, qui a Valdenoghèr. Lo dicevo io, che c’è qualcosa che non va in quella famiglia!» concluse con soddisfazione. Nei giorni seguenti cominciarono a interrogare tutto il paese. Purtroppo pochi avevano dei vividi ricordi come quelli di Modesta. Maria raccontò che lei faceva la serva e non si occupava di simili fantasticherie. Simone li guardò con gli occhi spalancati, come a far vedere di capire meno della metà di quello che gli chiedevano. I bambini dissero che loro andavano su con le mandrie, ma di solito arrivavano fino ai limiti della Valturcana, che era un bel posto, tranquillo, dove le bestie stavano bene e c’era ombra. Alla fine ammisero che, però solo qualche volta, si spingevano fino a Tambre, perché vi era un recinto di pietre fatto apposta per chiudere le mandrie, costruito chissà quando e chissà da chi. Poco oltre c’era anche una grande vasca di pietra dove si raccoglieva l’acqua di un piccolo rivo: tutti la chiamavano «la fontana», ma senza sapere il perché. Nessuno confessò di essersi spinto più in là e anche molti dei nomi citati da Modesta non vennero ripetuti. I due religiosi andarono anche a trovare il Matt, che però non era in casa. Dopo averlo aspettato a lungo, ormai sul calar della sera, don Floriano e padre Domenico se ne andarono. Il giorno dopo 51 ricominciò a piovere e alla fine, dopo vari tentativi, dovettero rinunciare a interrogarlo. Si videro spesso con Inigo e con Lina; invece a casa Alessandri neppure si presentarono, sicuri di non essere bene accolti, e Vincenzo, che li aveva seguiti per quanto possibile, curioso di saperne di più, non lo presero neppure in considerazione, perché era appena arrivato e non poteva certo aver nulla a che fare con quella storia. Con il loro sacco di conoscenza infine se ne ripartirono per Farra, tra la soddisfazione generale. Il più contento di tutti fu però Alessandro degli Alessandri. La prima visita dei due aveva risvegliato sopiti ricordi di momenti che si sforzava di dimenticare. Si era ritirato lassù, tra i monti, proprio per sfuggire a quanti parlavano di maghi e stregoni. Lui voleva solo continuare in pace i suoi studi di quella che era la vera scienza della natura. Lui non aveva nulla a che fare con le arti magiche, ma non sempre era facile far capire questo a menti limitate. Finché i due religiosi erano stati in circolazione aveva lasciato i libri nella cassa in soffitta e i vetri nel fienile. Dopo la loro partenza però aveva fatto mettere via con cura storte e alambicchi, pensando che forse era meglio non continuare con i suoi esperimenti per qualche tempo. Prese poi l’abitudine di chiudersi nella stanza al primo piano, che prese a chiamare «biblioteca»; e cominciò a dire a tutti che doveva scrivere un poema che trattava degli amori di Giove con una ninfa dei boschi. Vincenzo aveva sperato che suo nonno trovasse finalmente un po’ di tempo anche per lui ma si era sbagliato: Alessandro degli Alessandri non era il tipo a cui piaceva stare con i bambini. Riuscì solo a ringraziare il nipote per il sogno profetico che aveva fatto, circa l’arrivo di quell’inquisitore, e ricordò, con parole dotte, che tali sogni vengono sempre con il chiarore dell’alba. Vincenzo cercò di spiegargli che, secondo lui, gli animali che aveva visto erano reali. Non ci fu verso di convincere il vecchio che continuò a parlare di Morfeo e della dolce Eoo, l’Aurora, che, quando si incontravano, portavano tali visioni meravigliose. 10. La notte di Caotès Quello fu un febbraio davvero strano, come era stato tutto quell’inverno. Dopo la pioggia, venne finalmente il gelo che tutti aspettavano, ma non la neve. Le giornate erano terse e limpide e si vedevano chiare le linee dei monti. Forse faceva davvero troppo freddo perché scendesse la bianca coltre che tutto nasconde. Così passò anche il Carnevale, con i fuochi e i canti, e venne la quaresima, con l’astinenza e il digiuno. A fine mese finalmente il freddo si fece meno pungente e Vincenzo si accorse di un profumo nuovo nell’aria. Era il 24 febbraio quando si rese conto di quanto intensamente desiderasse la primavera. Andò a cercare i suoi amici ma quella mattina avevano tutti un gran da fare. Allora si recò fino ai piedi del grande noce. Si sentiva un po’ in colpa con l’albero che, dopo tutto, lo aveva pur salvato quando 52 Celeste e Jacopo volevano prenderlo a pugni. I suoi rami si stagliavano stecchiti verso il cielo e sembrava dormire profondamente, insensibile a quanto gli accadeva intorno. Un po’ deluso tornò sui suoi passi. Quando arrivò a casa Maria aveva già preparato da mangiare. «Oggi ho tanto da fare - gli disse - si sbrighi signorino, si sbrighi.» Vincenzo si mise in bocca un cucchiaio di minestra ma subito la sputò tanto era calda. In quel mentre entrò Aurora: «Allora Maria, vieni?» le fece. «Sono proprio in ritardo, questa volta - le rispose la serva - Fioravante è arrivato ieri sera all’improvviso e devo sistemare tutto quello che ha portato. Comunque, devo farcela, altrimenti lascerò Catina a finire il lavoro. Tu va’ avanti.» «D’accordo. Ci vediamo alla fontana.» concluse l’altra, sottovoce. Maria le diede un’occhiata di rimprovero e accennò con la testa a Vincenzo. «Non ha ancora finito, signor Vincenzo! Vada fuori che il tempo è bello e lasci lavorare chi deve lavorare.» Il ragazzo ingoiò quello che restava della sua minestra e uscì. Il sole era ancora alto in cielo e pensò di aver tempo per recarsi da Jacopo, che non vedeva da tanto. Rimasero a chiacchierare assieme per un po’. Poi però l’amico fu chiamato a casa e Vincenzo si avviò per tornare anche lui sui suoi passi. Aveva appena lasciato la casa quando vide di lontano una figura che veniva su per il sentiero. Si nascose tra i cespugli: se era qualcuno che conosceva ci si poteva divertire a fargli paura. Era infatti Maria, che camminava rapida, tutta avvolta nel suo grande scialle nero. Aveva il viso serio e Vincenzo si dimenticò improvvisamente dello scherzo che aveva appena progettato. La serva puntava dritta verso la terra proibita e il ragazzo rimase senza parole dalla meraviglia. Gli adulti non potevano entrare in quei posti. I cespugli si sarebbero dovuti chiudere, oppure i rami degli alberi piegarsi, o ancora sarebbe dovuta cadere una fitta pioggia, come era successo durante la processione. Invece non accadde niente di tutto questo. Il sole continuava a splendere e il cielo era terso. La donna passò davanti a Vincenzo senza vederlo e procedette oltre. Dopo un po’ il ragazzo si mosse silenziosamente, deciso a seguirla. Fu una lunga camminata. La serva evidentemente conosceva bene la strada in quella terra incantata, anche se non aveva mai ammesso di esservi entrata. A un certo punto il viottolo piegava leggermente a sinistra e Vincenzo riconobbe la via che lo aveva condotto allo spiazzo erboso dove aveva incontrato «la creatura albina», come suo nonno aveva definito quel mostro. Maria invece continuò a salire dritta, senza incertezze, tra gli arbusti e i sassi. Cammina cammina, penetrarono in una zona dove il ragazzo non era mai stato. Salirono ancora. Era come se gli alberi si aprissero al loro passaggio indicando la via. A sinistra si vedevano monti lontani, mentre a destra saliva la montagna. Superarono anche un ruscello che scendeva verso il basso. A questo punto si cominciò a udire un brusio di voci. Allora Vincenzo si fermò, pur 53 senza perdere di vista la sua guida, timoroso che qualcuno lo vedesse. Il sole era ormai al tramonto e rivestiva tutto con il suo manto rosato. «Alla buonora, Maria. Come stai?» alcune voci di donna diedero il benvenuto alla nuova arrivata. Erano una decina, tutte raggruppate attorno a una vasca di pietra, come quelle che si usano per far bere gli animali. Tra loro Vincenzo riconobbe anche Aurora, la madre delle sue compagne di giochi. «Sono riuscita a far tutto appena in tempo. Non volevo che al padrone venissero strane idee in testa, vedendomi uscire questa sera - disse Maria ansimando - come successe quella volta con la signora Maria Turchese. Ci chiuse in casa per un mese, allora, e non voleva più lasciarci uscire e voleva sempre sapere che cosa stavamo facendo. Un buon uomo, ma davvero anche un grande ficcanaso.» «Sono qui…sono qui… sono arrivata…sono arrivata…» una grassa contadina che stava a Broz corse giù per il pendio, passando poco discosto da Vincenzo, rannicchiato tra i cespugli. «Ci siete tutte? Ci siete tutte? - chiese - Chi viene con me? Chi vuol venire con me?» Maria la interruppe volgendosi a una vecchina curva, che stava vicino a lei: «Guidaci tu, Isela, che sei la più anziana.» «Sorelle è ora! La signora ci chiama. Siete pronte?» disse questa, mentre un sorriso di compiacimento attraversava il suo viso rugoso. Un coro voci le rispose: «Siamo pronte. Andiamo.» Poi tutte cominciarono a cantare, prima piano piano, poi sempre più forte, mentre una donna con una specie di piccolo tamburo batteva il tempo di quella canzone. Si incamminarono in fretta ed era come se non toccassero terra, sparendo ben presto allo sguardo. Vincenzo rimase lì, come inebetito a guardare quella strana processione che si allontanava per le vie dell’aria, mentre il sole scompariva dietro l’orizzonte. Il ragazzo non ebbe il tempo di preoccuparsi per essere rimasto solo in quel posto inaccessibile agli uomini che qualcosa di peloso gli si strofinò sui calzoni. «Signorino, che si fa? Si spia? Eh?» Due occhi curiosi lo stavano osservando da sotto in su. Un muso setoloso, con due grosse zanne, lo guardava divertito. «Mi sbaglio, oppure tu sei Lug?» chiese il ragazzo fissando lo spirito di tutti i cinghiali. «Sono proprio io. Ma tu, cosa fai qui? Se ti trovavano sai che cosa ti facevano? Magari, ti prendevano al loro servizio, come un servo? Ti sarebbe piaciuto, vero, obbedire agli ordini dalla vecchia Isela?» L’idea non era molto gradevole e Vincenzo rispose: «Per fortuna, allora, non mi hanno visto. Mi sarebbe piaciuto seguirle, ma senza dover obbedire a nessuno. Ma dove sono andate?» «Sono andate nel posto più sacro. Se vuoi venire ti porto io, ma non bisogna farsi vedere perché ci vanno solo le femmine e noi non siamo ben visti, sai.» Fece Lug piegandosi in avanti come per invitare il ragazzo a salirgli in groppa. Vincenzo 54 non si fece pregare. Il cinghiale gli era rimasto simpatico sin dalla notte in cui lo aveva conosciuto, al contrario di quell’oca pettegola e chiacchierona che, sicuramente per parlare di più, non faceva altro che ripetere due volte tutto ciò che diceva. Lug si mise a canticchiare a mezza voce la nenia che prima aveva intonato tutto il corteo. La luna illuminava ormai il cielo, nel pieno del suo splendore. Superarono degli alti alberi, quindi un gran pianoro erboso, piegarono a sinistra per finire poi di nuovo in mezzo alla foresta. A un certo punto il cinghiale si fermò. «Qui bisogna fare attenzione a non farsi vedere. Sono cose da femmine. Vieni. Possiamo trovare un posticino adatto per goderci lo spettacolo.» Le donne erano già arrivate. Il loro canto era terminato. «Cos’è questo rumore?» chiese Vincenzo che sentiva un gorgoglio vicino. «È la sorgente - gli rispose Lug - borbotta e chiacchiera come tutte le altre. Non riesce a star zitta un momento, anche lei. Non vedi il posto da cui sgorga?» Vincenzo scorse allora tra lo scuro degli alberi e del cielo una gran pozza d’acqua che si trasformava in ruscello. A poco a poco il gorgoglio divenne un dolce canto e il ragazzo vide salire su dall’acqua una fanciulla che brillava di una luce azzurrina. «Quella è Tesa, la fonte. - proseguì Lug - Siamo nella sua terra qui. Questo è il Caotès, come dicono i contadini, cioè il capo della Tesa; è qui che l’acqua comincia la sua strada.» terminò con un tono di rispetto. Le donne le si fecero attorno e presero a cantare una diversa canzone. Quando ebbero terminato la fanciulla disse: «Siete venute tutte? Avete rispettato l’accordo?» «Lo abbiamo rispettato.» dissero quelle. «Siamo qui a parlare a nome di tutti gli abitanti della valle. Queste sono alcune delle ossa degli animali che abbiamo mangiato. Come promesso non sono spezzate. Le altre le abbiamo seppellite come era nostro dovere.» disse Isela avanzando verso la fanciulla e deponendo al limite dell’acqua un involto scuro. «Se avete rispettato il vostro patto allora anche gli animali rispetteranno il loro. C’è qualcuno che si oppone?» «Siamo tutte d’accordo. Siamo tutte d’accordo.» Ripeté la contadina grassa con la sua voce petulante. La fanciulla spruzzò dell’acqua. Era come se tante scintille di vita si diffondessero a cascata sull’involto e da esso uscirono galline, maiali, conigli, lepri, cinghiali… ogni sorta di animali che i contadini di quelle parti usavano mangiare. «Vedi - disse Lug a Vincenzo - in questo modo tutti quelli che sono stati sacrificati nell’anno passato, per dar da mangiare ad altre creature, tornano in vita, perché niente muore e tutto rinasce.» Vincenzo era stupefatto e quasi perse l’equilibrio quando un grosso maiale, nella foga di scappar via gli passò vicino. «Volete siglare un nuovo patto per la prossima stagione?» chiese ancora la fanciulla. 55 «Lo vogliamo.» dissero in coro le donne. «Diffondi la tua acqua, dolce Tesa, e riporta in vita tutto ciò che dorme.» L’alone di luce grigio azzurra e l’acquerugiola impalpabile che circondava la fanciulla cominciò ad assumere un colore violetto che ben presto divenne rosa, poi cominciò ad allargarsi, a diffondersi intorno e a posarsi sulle piante e sulle cose. Vincenzo sentì nuovamente un profumo di primavera, anche se si era alla fine di febbraio, mentre l’aria bagnata lo investiva e passava oltre. I rami addormentati cominciarono a fremere e delle tenere gemme comparvero. Tra l’erba, brulla e secca, crebbero nuovi germogli verdi che si spiegarono in fiori colorati. Qualche frutto maturò all’improvviso. Bastava volgere lo sguardo per scoprire che in quel luogo ormai l’inverno era terminato ed era giunta prima la primavera e, pochi istanti dopo, già la piena estate. L’aria era calda e profumava come di erba appena tagliata e delle grandi rose rosse e bianche sbocciarono meravigliose. «Ora potete andare. Raccogliete ciò che volete, ma badate a rispettare quanto avete promesso.» disse Tesa rivolgendo un’ultima raccomandazione. Poi svanì lentamente nella sua polla d’acqua. Le donne allora si precipitarono intorno a prendere chi un fiore e chi un frutto. Anche il luogo dove stava Vincenzo, pur a qualche distanza dalla sorgente, aveva subito la medesima trasformazione: un bel melo allungava i suoi rami proprio sopra la testa del ragazzo e primule, viole, genziane si contendevano il tappeto erboso. «Il patto è stato ripetuto, come ogni anno. - disse Lug - La natura è stata risvegliata e se le potenze maligne non riusciranno a prevalere i fiori e i frutti che vedi intorno a te riempiranno Valdenoghèr, Spert, Farra, Chiès e tutta la campagna intorno. Se vuoi puoi prendere qualcosa anche tu.» Allora Vincenzo allungò una mano e raccolse un grosso frutto rosso e appetitoso che gli sfiorava la testa. Faceva proprio gola. Si ripromise di mangiarlo una volta solo nella sua stanza. «È davvero bello qui.» disse a Lug. «Bellissimo, ma anche un po’ pericoloso. - rispose il cinghiale, ridendo tra sé e sé - Guarda, se ne vanno. Dobbiamo ripartire anche noi. Qui non si può restare più a lungo. Tesa non vuole che nessuno arrivi qui, se non in certi momenti dell’anno. È molto gelosa della sua casa, sai. Negli altri periodi, solo a pochi consente di avvicinarsi.» Vincenzo, obbedendo anche se un po’ a malincuore, salì di nuovo sulla sua strana cavalcatura che ricominciò a canticchiare allegramente. Le donne erano già partite e si vedevano delle sagome scure sullo sfondo del cielo stellato. «Ti lascio qui, vicino a casa. Va bene? - disse infine Lug fermandosi proprio dietro la casa di Vincenzo a Valdenoghèr - così Maria non si accorge della nostra scappatella.» A quanto pareva il cinghiale era proprio di buonumore. Infatti appena fatto scendere il ragazzo riprese, con voce baritonale, la sua canzone e ben presto sparì nell’oscurità della notte. 56 La mattina dopo Vincenzo si svegliò con la testa pesante, scosso da brividi di freddo. Stava veramente male e non aveva proprio voglia di alzarsi. Maria venne su a vedere perché il signorino non era ancora sceso. «Ma lei hai un febbrone da cavallo. - gli disse tastandogli la fronte - Ha preso freddo, di certo. Si sente un po’ di aria di primavera e subito, voi ragazzi, cominciate a correre e saltare come se fosse già estate.» concluse scuotendo la testa. «Sto male. Mi gira tutto.» «Allora resti a letto. Le porto un po’ di minestra di ieri, che le farà anche meglio del latte, con due dita di vino, per cacciare via la febbre.» Quelle parole fecero scendere un altro brivido lungo la schiena di Vincenzo. Ricordò quella rossa apparizione nella stanza di Iris e cominciò ad avere paura. Poco dopo Maria ricomparve con una ciotola e un bicchiere senza che, nel frattempo, fosse successo niente di particolare. Vincenzo mandò giù la minestra, che sapeva di buono e non scottava come il giorno prima, per fortuna. Bevve il vino come si fa con una medicina. Non gli era mai piaciuto, ma quando si sta male bisogna pur fare qualche sacrificio per guarire. Infine si lasciò andare sui cuscini in un piacevole torpore, mentre Maria portava via la ciotola. Un pensiero teso e disperante cominciò a farsi strada piano piano nella testa di Vincenzo il quale, socchiudendo gli occhi, vide che i dischi di metallo appesi alla parete baluginavano di una luce incandescente. Due braci rosse lo stavano fissando. «Salve, piccolo lupo. Come stai?» disse una voce che aveva già sentito. «Cosa vuoi? cosa mi hai fatto?» si agitò Vincenzo. «Io? Assolutamente nulla. - rise la rossa signora che, uscita da uno degli specchi, gli stava ora dinanzi - Sei stato tu a portarmi qui. Non sai che non posso entrare in questa casa, a meno che non sia invitata? I rami di nocciolo di cui è foderata la proteggono dagli esseri come me.» «Non ti ho chiamato. Come avrei potuto?» «Eppure lo hai fatto. Guarda che bel frutto hai raccolto, questa notte. sogghignò Ek - La grande mela rossa che porta la febbre.» Vincenzo non lo sapeva e rimase senza fiato. Guardò la mela che aveva posto sul tavolino accanto al letto. Ora era tutta avvizzita e rugosa come quelle dell’anno precedente. Ripensò a Lug e alla sua allegria, tanto simile a quella di un bambino che ha commesso una marachella divertente. Si era preso gioco di lui e della sua ignoranza e non lo aveva avvertito del pericolo. «Vuoi che resti? Vuoi venire via con me? Vuoi che facciamo un patto?» gli sussurrava nell’orecchio quella inquietante presenza. «Sto male e voglio restare solo.» «Allora vado, perché non è ancora giunto il momento che mi è stato assegnato. Ma ci rivedremo, quando avrò radunato le mie forze. - disse Ek con una risata - Non ti preoccupare.» Poi cominciò a dissolversi, cantando una nenia che parlava di mele 57 rosse, che portano la febbre, di rose bianche che danno il raffreddore e di rose rosse che provocano la tosse. Ci vollero quattro giorni perché Vincenzo avesse il permesso di uscire, finalmente, dal caldo della sua stanza. Nel frattempo anche Catina e Simone si erano ammalati. Niente di grave, ripeteva Maria, però era una cosa davvero seccante che si sarebbe potuta evitare se solo il signorino fosse stato più attento. Il primo giorno, in camera del ragazzo, il suo sguardo era corso alla mela rugosa; se anche aveva sospettato qualcosa non aveva detto nulla e Vincenzo gliene fu grato. Quando finalmente poté uscire si accorse che la natura si era davvero risvegliata. Allora si recò ai piedi del grande noce, poi appendendosi ai rami salì verso l’alto. Ritrovò quel ramo solitario dove in autunno soleva appollaiarsi e si sistemò con la schiena appoggiata al tronco. «Buongiorno. Come va? Chi si rivede dopo tanto tempo?» La voce profonda era quella che lo aveva salutato al momento del suo primo arrivo a Valdenoghèr. «Buongiorno grande noce. Ti sei svegliato, finalmente.» fece Vincenzo, senza provare stupore. Aveva ormai capito che la natura parlava davvero a chi la sapeva ascoltare, come gli aveva spiegato il Matt tanto tempo prima. «Non ancora del tutto, però sto cominciando. Mi piace fare le cose lentamente, soprattutto dopo il riposo invernale. Sei cresciuto in questi mesi, a quanto pare. Non finirete mai di stupirmi, voi, creature che vi muovete.» rispose il noce. «Già, non stiamo mai fermi.» Chiacchierarono così, del più e del meno. A Vincenzo pareva di aver ritrovato un amico anche se, a un certo punto, ne aveva avuto paura. Così gli chiese qualche spiegazione su quello che era successo qualche giorno prima in Caotès. «È compito dell’elemento femminile risvegliare la natura e farla fruttificare mentre gli uomini hanno il compito di proteggere ciò che è nato.» «Proteggere da che?» chiese il ragazzo. «Da ciò che è malvagio e vuole solo distruggere e non rigenerare. Vedrai, quando verrà il momento giusto ti apparirà tutto chiaro.» «E perché quella mela che ho preso era così pericolosa?» «Non tutto ciò che esiste è buono. Vi sono cose che sembrano meravigliose eppure nascondono in sé il male. Quel frutto, così simile eppure così diverso da quelli che ti piacciono tanto, è una di queste cose. Vi sono delle mele che i ragazzi non dovrebbero toccare, neppure quando vengono loro offerte.» disse il noce. «E che altro non devo toccare?» «In una notte come quella non si devono prendere per esempio le rose bianche, perché portano il raffreddore, o quelle rosse, che danno la tosse.» Vincenzo pensò a quei due bellissimi cespugli che per sua fortuna non aveva toccato e alla canzone cantata dallo spirito della febbre quando aveva lasciato la sua camera. 58 « Ma vi è sempre qualche sprovveduto che non sa resistere alla loro bellezza ed ecco che arrivano queste malattie ed Ek si diverte come una pazza, a dar fastidio a tutti. » concluse il noce. «Me ne sono accorto. L’ho incontrata.» rispose Vincenzo. «Stai lontano da lei, se puoi. - riprese il grande albero con voce profonda - Non ci si può fidare di lei e dei suoi simili. Sono esseri malvagi che godono a veder soffrire ogni tipo di creatura. Non stringere mai un accordo con simili potenze. Non saresti più in grado di guardare il grande Cielo Azzurro e a poco a poco il tuo unico piacere sarebbe il male. Io ti ho avvertito.» Il sole stava allora tramontando e di lontano si sentivano le campane della chiesetta di Farra che suonavano. Vincenzo discese lentamente, un po’ preoccupato forse più dal tono di quel discorso che non dalle parole che aveva udito e che non aveva ben compreso. 11. Il Cavaliere Verde Ormai era primavera inoltrata. I ragazzi del paese avevano cominciato a recarsi nella terra incantata per far pascolare le bestie. Qualche mamma si preoccupava, ma l’erba di quei prati era davvero buona e le mucche che vi erano state producevano latte migliore e più abbondante delle altre. Anche il vello delle pecore che l’avevano brucata cresceva più compatto e forte e per questo era tradizione mandare i figli piccoli in quei pascoli. Inoltre, dopo la scomparsa di Gildo, nessuno si era più perso. Quel triste avvenimento era capitato tanto tempo prima che solo le sue due sorelle ne portavano ancora un vivido ricordo. Comunque fu fatto promettere a tutti che non si sarebbero mai spinti oltre Tambre o, al massimo, Pianon. Vincenzo aveva preso ad accompagnare i ragazzi del paese nella terra incantata. Quando il tempo si faceva uggioso, però, passava ore e ore seduto sui rami bassi del noce, a leggere e fantasticare, fino a che la pioggia non lo costringeva a un rapido rientro tra le solide mura di casa. Spesso si chiedeva chi fosse stata in realtà sua nonna, Maria Turchese, e che parte aveva avuto in quel paese così uguale eppure così diverso dagli altri. Gli sarebbe piaciuto averla conosciuta e aver appreso da lei quanto c’era da sapere sugli strani riti che si svolgevano nelle profondità di Caotès e sugli esseri mostruosi che vivevano con il sangue e la vita altrui. Con il nonno era impossibile parlare: avrebbe trasformato un’avventura meravigliosa in una piatta realtà quotidiana. Maria sapeva certo qualcosa, ma la serva era abbastanza abile da eludere le risposte e Vincenzo non se la sentiva di farle delle domande dirette. Un giorno di pioggia, non sapendo cosa fare, tirò giù dal muro della sua stanza i due piatti di bronzo. Aveva sempre pensato che fossero uguali, ma adesso si accorse che non lo erano. Entrambi avevano una superficie liscia, ma uno era leggermente più grande; sul retro poi, i disegni che li adornavano erano diversi. Sul maggiore vi 59 era graffita una ruota, come quella di un carro, sull’altro una spirale, formata da tanti cerchietti che si rincorrevano all’infinito. Pensò alla notte di Sant’Antonio e si chiese quale specchio gli aveva mostrato il futuro. Li fissò entrambi e vide riflessa sulla superficie di quello più grande quella stessa stanza. I mobili, però, erano disposti in modo diverso e vi erano delle tende a fiori alle finestre. Con la mente in tumulto continuò a guardare e vide una signora vestita con un abito strano: era la nonna. Vincenzo si voltò verso il quadro ma l’immagine dipinta gli sorrideva immobile come sempre, mentre la donna dentro lo specchio si muoveva allegra. Ed ecco comparire Maria, molto più giovane di come era adesso: «Svelta Maria, preparami, devo recarmi alle Fratte questa mattina, lo sai, non posso mancare. Il Signore della Pioggia mi aspetta.» disse con una voce trillante. La visione lentamente svanì. Era il passato quello che aveva visto, mentre l’altro specchio gli aveva dunque mostrato quanto doveva ancora accadere. I due dischi erano come le due valve di un’unica conchiglia, che racchiudevano il fato degli uomini. Passò anche la Settimana Santa. Don Floriano fece una fugace apparizione. Non amava quei luoghi e ci veniva solo per dovere. A poco a poco Vincenzo, che aveva trovato una libertà che gli era mancata durante l’inverno, cominciò a percorrere la campagna anche da solo. Ormai conosceva abbastanza la via che portava nella terra incanta e vi andava spesso. Non era distante e il posto era davvero bello a primavera. Pieno di fiori colorati e di profumi. Un giorno andò fino alla casa del Matt. Aveva bisogno di parlare con qualcuno. Lo trovò al lavoro nell’orto. Non si dimostrò molto socievole, comunque parlarono del tempo e delle giornate che ancora non si allungavano. Il contadino era allo stesso tempo compiaciuto e infastidito per la visita del ragazzo. I suoi modi bruschi nascondevano in realtà il disagio che provava nel trattare con la gente. Molti non lo capivano ed egli non si sforzava di capire gli altri. Da molto tempo ormai la solitudine era la sua sola compagna. A un certo punto Vincenzo gli chiese se aveva mai sentito parlare di un Signore della Pioggia. «Una volta, tanto tempo fa. - rispose il Matt - a primavera lo si incontra, in qualche giorno speciale, ma bisogna arrivare fino al colle delle Fratte.» «Dove si trova? - chiese il ragazzo - Conosco Tambre, e poi il luogo che chiamano «alla fontana» e so che c’è una valle fatta di pietre scoscese.» «Pian delle Lastre, allora, e conosci anche Pian delle Mosche, dove sono soliti ritrovarsi i tuoi amici con i capelli bianchi e le unghie acuminate? Sembrano uomini, eppure non lo sono. È molto strano, non trovi? - continuò il Matt - Tua nonna diceva che l’uomo ha molte anime. Quando muori la tua intelligenza vola via e diventa un uccellino che si perde nel Cielo Azzurro. Il tuo sangue poi va a fecondare la terra. Invece, se si dimenticano di seppellirti, allora il tuo corpo resta sospeso in un eterno presente e divieni uno di quei mostri che hanno bisogno proprio del sangue 60 altrui per assaporare ancora la vita. Ti piacerebbe andare a vivere a Pian delle Mosche?» «Non sono mai stato in un posto simile.» rispose Vincenzo con un certo tremore nella voce. «Lo riconosci facilmente quando ci capiti per via dell’odore. Comunque vedo che hai girato molto. Ti ho visto ad All’Ò, dove le fate danzano in circolo e lasciano scie di fiori e di funghi al loro passaggio. Sei forse arrivato fino in Caotès?» chiese all’improvviso. La faccia di Vincenzo era un libro aperto e infatti il Matt riprese: «Ma certo che ci sei stato e hai visto Tesa, vero? È bellissima. La più bella ragazza che abbia mai incontrato, più bella anche di tua nonna, con tutto rispetto. Ecco, - fece riprendendo il discorso - il Cavaliere Verde, come lo chiamo io, o il Signore delle Acque o della Pioggia, come dici tu, si trova alle volte vicino al Caotès. A destra, oltre il bosco delle Fratte.» Vincenzo improvvisamente si rese conto che il Signore della Pioggia e il Cavaliere Verde, di cui gli aveva parlato una volta Inigo, erano la stessa persona. «Com’è?» chiese curioso. «Mi hanno detto che nasconde un tesoro. È vero?» «Forse qualcuno lo crede, ma Mavì Hatùn diceva che il suo bene più prezioso è l’acqua che scorre nel luogo dove si trova. Ho sentito dire che anche Tesa va a raccoglierla e poi la nasconde nella sua fonte per tutta l’estate. Lo riconosci perché dove posa il piede, lì nasce subito dell’erba. A me è sembrato un vecchio, quando lo vidi la prima volta, ma ero giovane allora, più piccolo di te, e forse ora direi che è solo un uomo.» Altro non volle dire o forse non sapeva. Il 23 aprile cadeva la festa di San Giorgio e il cielo appariva terso e limpido come non era mai stato. Vincenzo pensò che quella era la giornata adatta per arrivare fino al bosco delle Fratte. Si era informato su dove fosse precisamente e, con stupore, aveva scoperto che Modesta ricordava qualche nome e qualche luogo, anche se erano anni e anni che non riusciva più a entrare nella zona proibita. Così si mise in marcia di buon mattino assieme ai ragazzi che andavano a pascolare le bestie. Camminando chiese se non avevano paura di fare qualche cattivo incontro. «Non è mai successo niente.» disse Margherita che camminava vicino a loro. «Si è sempre fatto così.» «Eppure - riprese Vincenzo ammiccando ai suoi compagni - potrebbe esserci qualche animale cattivo che sente odore di sangue.» «Allora - rispose Jacopo - bisogna prendere un bastone e piantarlo per terra. Se lo fai quando sei qui si crea come un cerchio magico tutt’intorno, e nessuno da fuori può penetrarvi.» Celeste propose di fare una prova. Si fermarono e, raccolto un grosso ramo, lo pulirono bene. Jacopo chiamò tutti intorno a lui e poi, con aria seria, lo piantò per terra. Una luce azzurrina cominciò a uscire dalla punta del ramo e ricadde attorno ai bambini come fanno i rami dei salici piangenti. Vincenzo si era ormai abituato alle 61 stranezze che succedevano in quei posti incantati. Allungò una mano per toccare quelle gocce di luce e sentì come un pizzicore. «Fa il solletico, vero?» disse Margherita. «È tanto divertente. Peccato che accada solo qui e non a casa.» Jacopo alzò il bastone e il cerchio svanì. Rosa avanzò cantando e scuotendo i suoi riccioli biondi. Era davvero primavera. Una bambina che era con loro, di nome Anna, la superò correndo, subito imitata da Corinna, i cui capelli avevano il colore delle foglie d’autunno. Ben presto tutti arrivarono a Tambre. Sostarono un po’, poi decisero di andare ancora avanti, alla fontana dove si sarebbero fermati per mangiare un po’ di pane e formaggio. Vincenzo disse che voleva esplorare la zona e continuò da solo, seguendo la via sinuosa, che scendeva e poi risaliva, prima tra i prati e poi tra gli alberi. Ancora un po’ e un grande pianoro gli si presentò davanti: era quello che Modesta aveva definito Pianon. Procedette ancora avanti ed ecco che l’erba lasciava spazio a una scarpata di sassi, come una ferita nel cuore della montagna. Era arrivato alle Fratte. Un cavallo e un cavaliere di colore verde erano fermi sull’ultima erba. Vincenzo pensò a una statua coperta di muschio, tanto stavano immobili. Si avvicinò cauto per superarla. «Chi sei e cosa fai qui?» chiese il cavaliere scuotendosi dal suo torpore. Vincenzo fece un salto, comunque rispose con voce ferma. Aveva visto troppe cose strane in quei mesi per spaventarsi proprio ora, alla luce del sole. «Mi chiamo Vincenzo, e voi signore?» «Non ti chiami così - rispose il cavaliere - il tuo nome è un altro e se ti metti d’impegno un giorno forse lo scoprirai. Anch’io ho tanti nomi. Alcuni mi chiamano Elia, oppure Cavaliere Verde: altri mi venerano come Signore della Pioggia o come san Giorgio. In autunno poi divento per molti san Demetrio e mi ricopro del colore delle foglie cadute. Ma non ha importanza. Ciò che conta è che si ricordino di me. Posso fare molto per gli uomini perché i quattro elementi mi obbediscono. E tu, cosa vuoi che faccia?» «Non ho mai pensato di chiederti un favore - rispose - sono soltanto un ragazzo curioso che cerca di capire il mondo che mi sta attorno.» «Questo è un buon principio. Puoi seguirmi, se vuoi.» Scese da cavallo e cominciò a camminare tenendo il suo destriero alla cavezza. Vincenzo si accorse con meraviglia che dove posava i piedi nasceva dell’erba. A poco a poco i sassi si coprirono tutti di verde e allora il cavaliere si fermò, guardò la sua opera e cominciò a soffiarci sopra. Comparve un rivolo d’acqua che si tuffò tra i fili d’erba; comparvero allora dei fiori multicolori, e qua e là cominciò a brillare qualcosa. L’alito caldo del Signore delle Acque non aveva solo risvegliato la natura ma anche fatto apparire ciottoli d’oro e pietre preziose. Vincenzo era incantato dallo spettacolo. Era quello dunque il tesoro che Inigo tanto desiderava. «Posso raccogliere una pietra?» chiese timoroso di offendere il suo compagno. 62 «Prendi pure, fiori o pietre, tutto fa parte della natura.» questi gli rispose. «Se mio nonno ti avesse visto. - non seppe trattenersi dal dire Vincenzo mentre prendeva una manciata di rubini e zaffiri e se la metteva in tasca - È tutta la vita che cerca di trasformare in oro il vile metallo e tu ci riesci solo soffiando.» «L’oro è il metallo perfetto, incorruttibile e immutabile ed è bello vederlo brillare tra i fiori.» «E questa è l’acqua incantata, di cui tanti parlano?» chiese Vincenzo, pensando sia ad Inigo che a suo nonno e agli altri alchimisti, sempre alla ricerca del magico liquore che rende immortali. «È un’acqua prodigiosa che fa germogliare e fiorire. - rispose il cavaliere - Alcuni la possono chiamare elisir. Mi chiamano Signore della Pioggia proprio perché distribuisco il mio liquore che tutto muta e trasforma, che per alcuni è un farmaco e per altri un veleno.» «Come sarebbe? Allora non è l’elisir di lunga vita?» «È proprio quello. Ma la vita non è immobilità bensì una continua trasformazione. Sbagliano quegli uomini che pensano che sia per loro possibile raggiungere l’eternità. Solo cambiando si è vivi e solo morendo si può generare altra vita. Se per il regno minerale la perfezione è l’immobilità dell’oro, per gli animali, le piante e anche per l’uomo la perfezione si raggiunge nel cambiamento.» A quelle parole il ragazzo rimase in silenzio. Si era accorto improvvisamente della vanità della grande scienza del nonno e di alcuni amici di suo padre. Non sarebbero mai riusciti a trovare ciò che cercavano. «Stai indietro ora - fece il cavaliere - sento che sta arrivando.» «Chi sta arrivando?» «Il mio eterno nemico. Il grande drago bianco. Ogni anno a primavera ci battiamo e io lo allontano dalle pianure, dai colli, su su fino sui monti. Alla fine si rifugia in qualche anfratto ghiacciato dove rimane in agguato per riapparire poi quando la lunghezza della notte supera quella del giorno. Allora torna e sono io che devo fuggire. Stai indietro, che ci sarà battaglia.» Così dicendo risalì in sella, mentre da una fenditura di una roccia appariva, enorme, la testa della creatura. Vincenzo si fece piccolo piccolo e si tirò in disparte mentre il cavaliere partiva lancia in resta contro il drago che ormai si ergeva fuori dalla grotta in tutta la sua mole. Il combattimento non durò a lungo. Il drago sbuffava e dove arrivava il suo soffio i fiori e l’erba si coprivano di gelo bianco; era un mantello di candide pietre che sfavillavano al sole. Poi si alzò in volo e il cavallo e il cavaliere si slanciarono sulle vie dell’aria al suo inseguimento. Rimasto solo il ragazzo stette a fissare il magico rivolo d’acqua che si faceva sempre più sottile. Avrebbe voluto raccogliere quel dolce liquore e portarlo al nonno, ma non aveva nulla per conservarlo. Lo osservò mentre scompariva del tutto, inghiottito tra l’erba e le pietre. Allora si volse e tornò sui suoi passi per raggiungere i 63 compagni. Era ormai tardi. Arrivarono ad All’Ò poco dopo il crepuscolo, quando anche le pleiadi stavano tramontando. 12. Calendimaggio Ormai la natura si era risvegliata completamente. Anche il grande noce non era più sonnacchioso come poco tempo prima e si era coperto di un bel manto di foglie verdi. Il rito compiuto in Caotès aveva dato i suoi frutti, pensava Vincenzo, e il Cavaliere Verde era riuscito a cacciare lontano quel drago che gelava i fiori ed amava il ghiaccio. Ormai si era certo nascosto in qualche caverna di gelo sulle montagne più alte, dove la neve non si scioglieva mai e sarebbe tornato solo dopo molti mesi. Una sera, mentre stava chiacchierando in cucina con Maria, la conversazione cadde ancora una volta sulla nonna. «Lo sa che le assomiglia molto, signor Vincenzo? - disse la serva - Credo proprio che anche lei, quando diventerà grande, potrà continuare ad entrare nella zona proibita.» «So che la nonna arrivava in Valturcana, ma poi?» chiese Vincenzo. «Ho visto una bella mela sul suo comodino mesi fa, che poi è diventata rugosa e vecchia, non è vero?» Il ragazzo abbassò lo sguardo e non disse niente. «Non è ancora grande e quindi non importa, anche se ha visto più di quello che avrebbe dovuto.» Continuò la serva, che aveva intuito ormai da tempo che Vincenzo era diverso dagli altri ragazzi. La sua riconoscenza verso Maria Turchese, che la aveva sempre trattata da pari a pari e le aveva insegnato a capire la natura, la spingeva ora a cercare di trasmettere al nipote quanto di quell’antica sapienza aveva appreso. «Noi non siamo gelose… ma… non era con noi che doveva venire… e non a fine febbraio…» «E con chi allora? - chiese Vincenzo - E quando?» «Fra poco, all’inizio di maggio. Dopo tutto, perché no? - continuò quasi parlando a se stessa - Perché non potrebbe andare con gli altri?» «Gli altri?» «Sì, con Simone e gli altri uomini. In tal modo anche lei entrerebbe nella loro società. Se vuole, gli parlo, ma non ne faccia parola ad alcuno e soprattutto a suo nonno.» «Lo so, non capirebbe.» concluse Vincenzo, che così, il giorno dopo, si ritrovò nel primo pomeriggio a camminare nuovamente su su, oltre Broz, in compagnia di Simone. Aveva preso con sé un bastone, pensando che forse poteva tornargli utile. Si era infatti ripromesso di portarne sempre uno quando fosse penetrato ancora nella terra incantata. 64 «Mi raccomando – disse a un certo punto Simone con aria seria – non dovrà mai dire a nessuno ciò che vedrà oggi. Sarà un nostro segreto.» Vincenzo cominciò a preoccuparsi: «Non capiterà per caso qualcosa di brutto?» chiese. «Accadrà ciò che deve succedere, come ogni anno.» gli rispose il compagno. «Vuoi dire che vi incontrate sempre, a Calendimaggio?» «Certo, è sempre stato così. Anche mio padre faceva parte della società e suo padre prima di lui.» «E saremo in tanti?» «Pochi, purtroppo. Solo quelli che possono entrare in questa terra. Vedi – continuò Simone – noi siamo diversi dagli altri e abbiamo qualcosa da fare qui: dobbiamo proteggere i raccolti, anno dopo anno, così che tutti abbiano da mangiare e gli esseri malvagi non trionfino.» «Chi sono questi esseri? Sono degli uomini cattivi oppure dei demoni, come quelli di cui parla sempre don Floriano? » chiese incuriosito Vincenzo. «Se vuole può chiamarli anche così.– gli rispose il vecchio – Io sono solo un povero contadino e l’unica cosa che so è che sono creature malvagie e che devo combattere contro di loro. Ecco, fra poco saremo a Col Indes, che è il luogo dove si ritrovano tutti quelli che vengono dall’Alpago. Lì la accoglieremo tra noi.» «Cioè, cosa vuoi dire?» fece Vincenzo. «Dovrà solo rispondere ad alcune domande.» gli disse Simone. «E poi?» «E poi dovrà fare come gli altri e non spaventarsi di nulla, altrimenti sarà perduto.» concluse il contadino. Il ragazzo non sapeva se aveva fatto davvero bene a mettersi in quell’avventura. Cominciava ad avere paura, e per di più tutto quel cammino significava che prima del mattino dopo non sarebbero ritornati a casa e, anche se Maria avrebbe nascosto la cosa al nonno, l’idea di passare un’altra notte da quelle parti non gli piaceva molto. Comunque ormai aveva accettato e doveva andare avanti. Salirono a lungo per un sentiero tortuoso che si inoltrava in un bosco. Poi gli alberi cominciarono a farsi più radi e dolci colline si aprirono allo sguardo. Erano arrivati a Col Indes. Una betulla si ergeva solitaria in mezzo al prato. Sotto i suoi rami stavano una decina di uomini che li salutarono contenti. Uno di loro era il Matt; gli altri erano tutti di quelle montagne e Vincenzo ne conosceva qualcuno di vista; tre erano di Farra ed erano saliti un paio di volte a Valdenoghèr quell’inverno; gli altri, che non aveva mai incontrato, venivano da Chiès. Alcuni avevano dei bastoni in mano, uno portava invece un grosso martello. Comunque, gli fecero un’accoglienza festosa. «Era ora che arrivasse qualcuno di nuovo. Stiamo invecchiando e abbiamo bisogno di braccia giovani.» fece il più vecchio del gruppo, un omone con i capelli e la barba ancora neri. 65 «Viene dalla città, ma saprà aiutarci. Ti stupirai di lui, Giovanni.» gli rispose Simone. Gli occhi del vecchio friulano brillavano. Era diverso dal contadino taciturno che Vincenzo aveva imparato a conoscere. Tra gli alberi e le piante della terra incantata era finalmente a suo agio, come se anche lui facesse parte di quel mondo segreto. «Ora dobbiamo accoglierlo solennemente. Preparatevi.» ordinò ai suoi compagni che gli si fecero attorno. Fu una breve cerimonia. A Vincenzo venne chiesto se intendeva entrare nella società e se giurava di mantenere il segreto su tutto quello che avrebbe visto e avrebbe fatto. Naturalmente lui disse di sì. Gli venne chiesto ancora se intendeva combattere le potenze malvagie che bruciano i campi, distruggono i raccolti e affamano la gente. Anche a queste domande rispose affermativamente. Allora un contadino con i capelli arruffati porse al capo della compagnia una cintura di pelle. «Prendi questo segno - fece con solennità Giovanni - ed entra nella nostra società. Lega la tua vita e così sarai legato a noi e alla nostra missione.» Vincenzo si legò la cintura mentre le ombre del pomeriggio inoltrato si allungavano. Ripresero dunque la marcia. Attraversarono tutta quella che Simone chiamava la Val de Piera e poi si inoltrarono nel bosco. Strada facendo anche chi non aveva un portato un bastone si procurò qualche grosso ramo nodoso. Vincenzo camminava in silenzio. Aveva provato a chiedere cosa sarebbe successo, ma sia Simone che il Matt non avevano voluto rispondergli. Il contadino gli aveva detto solo: «Vedrai, vedrai… Fra poco saremo alla piana della Palantina e allora... fai come gli altri.» mentre il Matt lo aveva guardato con aria di sufficienza e si era voltato a parlare con il suo vicino. Camminarono fino a sera. Era ormai buio quando arrivarono in un’ampia conca, ma la luna piena illuminava il paesaggio con il suo splendore argenteo. Dall’altra parte del pianoro stavano arrivando in gruppo altri uomini. L’incontro fu caloroso, anche se Vincenzo non capì molto di quello che dicevano. Tutti quelli che erano saliti dall’Alpago faticavano a capirli. Solo Simone parlava il loro dialetto e così faceva da interprete. Il ragazzo si ricordò che il contadino gli aveva un giorno detto di essere nato in Friuli, la regione che stava proprio di là di quel monte, oltre la forcella. «Eccoli, stanno arrivando. Arrivano gli stregoni.» disse improvvisamente il Matt. In lontananza si udiva il rullare ritmico di un tamburo. E arrivarono davvero, come uccelli neri portati dal vento. Erano una ventina di uomini, o così sembravano, a cavalcioni di alberi sradicati, orci di terracotta, scuri, ruote di carro, pale da forno. Uno era in piedi, ritto al centro di una piccola barca. Agitavano grossi rami e picche su cui erano piantate teste di orso, cavallo, toro. Uno portava, legati alla sommità del suo bastone, un gruppo di serpenti che si agitavano. Cominciò allora la battaglia. Lo stregone che stava sulla barca si avventò con foga contro Giovanni che con un colpo ben assestato riuscì a farlo cadere per terra. Il Matt invece aveva preso a rotolarsi per 66 terra, avvinghiato al suo nemico che era giunto sulle ali di un grosso ramo di abete. Simone si stava battendo a colpi di bastone con vecchio vestito di pelli. Il tamburo continuava con il suo rullio di guerra, solo, a mezz’aria, senza che, apparentemente, nessuno lo suonasse. Nella foga della battaglia Vincenzo si trovò di fronte a quello che stava a cavalcioni sulla ruota di carro. Cercando di difendersi dall’assalitore che gli roteava attorno il ragazzo si trovò con il bastone incastrato tra i raggi; con uno sforzò cercò di liberarlo e così facendo proiettò lontano la cavalcatura del suo nemico. La lotta continuò e a un certo punto il ragazzo, che si sentiva inferiore a quell’uomo che gli stava dinnanzi, si arrampicò di corsa su per il pendio cercando di scappare. «Prendilo! Non lasciartelo sfuggire!» una voce nota stava incitando lo stregone e due occhi rossi brillarono nell’oscurità. «Che fai qui, Ek?» chiese il ragazzo, ancora intento a difendersi. «Non sono sola, oggi. Questa non è la mia sera - rispose l’inquietante presenza ma quella del mio compagno.» Con uno sforzo incredibile Vincenzo riuscì a colpire le gambe del suo aggressore che precipitò a rotoloni giù per il pendio. Si fermò un attimo per guardarsi intorno. Giù nella piana la battaglia continuava tra grida, rantoli e cozzar di bastoni. Un bagliore di un fuoco verdastro risplendeva nell’aria sempre più vicino, mentre il tamburo continuava a suonare incessante. «Eccolo, arriva.» sibilò Ek. «Salve, piccolo lupo.» disse una voce lugubre e lamentosa. «Chi sei? Tu mi conosci, ma io non conosco te.» «Sono il signore della fame e della carestia e come vedi questa è la mia notte. rispose la voce - Quando i miei guerrieri vinceranno, i raccolti andranno persi e porterò via una gran messe di anime.» «Vedi contro chi combatti? - riprese Ek - Con coloro che muovono le alluvioni e deviano i corsi dei fiumi, bruciano i raccolti con un sole troppo ardente oppure portano insetti che distruggono le piante. I tuoi amici non hanno speranza di vittoria, perché troppo forti sono coloro che volano nell’aria. Non sarebbe più semplice accordarti con noi? Se tu vuoi ce ne andiamo e non entreremo nel tuo territorio quest’estate.» «Non voglio accordarmi con voi. - rispose Vincenzo, ricordandosi improvvisamente degli avvertimenti del vecchio noce. - Le estati si succedono e ve ne sono di belle e di brutte, di rigogliose e di secche. Non sempre la vittoria spetta ai vostri guerrieri.» Il bagliore verdastro che gli stava davanti si incupì e si agitò, come per afferrarlo. Vincenzo si tirò indietro. Da una parte stava la rossa Ek, dall’altra quello spirito corrucciato e il guerriero che aveva mandato a ruzzolare stava risalendo il pendio. Tre nemici erano troppi in una volta. Ricordandosi ancora una volta delle sue letture e della storia romana, Vincenzo pensò che alle volte la fuga poteva essere un modo 67 per salvarsi e affrontare poi un nemico alla volta. Si volse dunque indietro e si mise a correre a caso nel bosco che gli si apriva davanti. I suoi nemici non lo inseguirono. Da tempo immemorabile il luogo prescelto per la battaglia era la piana della Palantina e lì si sarebbe stabilito il destino di quell’estate. Così, dopo un po’, Vincenzo si ritrovò ansante e solo. Il bosco che stava attraversando si ergeva dritto su una costa scoscesa. Gli alberi a poco a poco si fecero più radi e un colpo di vento gli scompigliò i capelli. Era arrivato in un valico, non tanto alto perché altri monti si ergevano vicini, alla sua destra, ma sufficiente per incanalare l’aria di forcella. Una grossa pietra stava solitaria, come a difendere quel passaggio. Vincenzo, con il fiato grosso, si sedette ai suoi piedi per riposare e trovare un riparo dal vento. «Chi ansima, qui vicino?» chiese una voce che pareva venire dalle profondità della terra. Vincenzo fece un salto e si ritrovò in piedi. «Sono Vincenzo. - disse - E tu?» «Sono il grande signore Karakartàl.» «E dove sei? non ti vedo!» Anche se la luce piena della luna illuminava la notte non scorgeva nessuno. «Sono qui, davanti a te. Questo sasso è la mia dimora. Da qui osservo il mondo che sta ai miei piedi e do consigli a chi arriva fino a me.» «Davvero dai consigli? - chiese interessato Vincenzo - E secondo te cosa dovrei fare, ora?» Non sapeva infatti se tornare sui suoi passi a combattere ancora contro quelle forze malvagie oppure riposarsi e aspettare che la battaglia volgesse alla fine. La risposta di Karakartàl fu però completamente diversa da quella che poteva immaginare. «Hai in te una grande forza, che non sentivo da molti anni: in te si trova una scintilla che appartenne ad un altro, tanto tempo fa. Ormai i miei discendenti si sono allontanati da questi luoghi e nessuno viene più qui a chiedermi di proteggere le sue schiere per vincere i nemici della mia stirpe. Potresti spezzare il legame che mi tiene racchiuso in questa prigione di pietra.» disse la voce che proveniva dal grande sasso. «Che vuoi dire? Cosa dovrei fare?» «Chiedi che ti sia resa la parola che fu data tanto tempo fa. Spezza il sigillo che ci lega tutti. Sono tanto stanco. Tu puoi liberarmi, e liberare assieme a me tanti altri che sono incatenati in questa terra incantata.» «Come posso riuscirci?» chiese Vincenzo. «Trova il Nero Signore e parla con lui.» rispose la pietra. Vincenzo non fu molto soddisfatto della risposta. Era ancora affannato e impaurito per la battaglia cui aveva partecipato e incontrare un Nero Signore non sembrava la cosa più piacevole. Durante la predica di Natale aveva immaginato se stesso come il cavaliere della fede che combatteva contro il maligno e liberava 68 dall’incanto quella terra. Ora anche chi vi abitava gli chiedeva di incontrare un tale essere. Don Floriano aveva dunque ragione? La luna era ormai bassa e il crepuscolo si stava avvicinando. Si allontanò in silenzio di qualche passo. Il suo piede scivolò sulle foglie viscide e si ritrovò disteso per terra. Una pietra sfavillava tra l’erba. Cercò di prenderla, ma era attaccata a un oggetto. Scavando con il bastone e le mani riuscì a dissotterrarlo. Lo sollevò e vide che era una specie di coppa, tutta incrostata, con un paio di fori da una parte. Tra la terra secca che la ricopriva si vedevano, seminascosti, degli sprazzi colorati e brillanti. Pulendola con la manica apparvero oro e pietre preziose. Vincenzo legò la coppa con la sua cintura, facendola scorrere tra i due fori; quindi, con il bastone in mano, tornò indietro. La battaglia non era ancora terminata. Si sentivano delle grida e il tamburo non aveva ancora smesso di suonare. Vincenzo scese di corsa il pendio, desideroso di mostrare che non era fuggito per vigliaccheria. Ritrovò il suo antico avversario e riprese a combattere, ma non si vedevano più le fiamme degli spiriti con cui aveva parlato. Avevano già abbandonato quel campo di battaglia. Poco dopo il cielo cominciò a imbiancarsi e gli esseri malvagi sparirono, dissolvendosi nell’aria. I contadini si radunarono. Nonostante parecchi lividi e ammaccature, nessuno si era fatto veramente male, ma sul terreno giacevano le carcasse delle strane cavalcature che avevano solcato l’aria. Anche il tamburo stava d’un canto, immobile. Vincenzo lo raccolse e si chiese in che modo un oggetto così piccolo fosse riuscito a provocare tutto quel baccano. «Abbiamo vinto. Se ne sono andati.» urlò qualcuno e gli altri risposero. Poi i contadini si divisero in due gruppi e ognuno prese la via del ritorno. I friulani si diressero su, verso la forcella, mentre gli uomini dell’Alpago tornarono indietro fino a Col Indes e poi ancora giù mentre il sole accarezzava i boschi. 13. Il fiore di San Giovanni Vincenzo tornò a casa con i suoi trofei. Nascose nella sua camera la cintura, segno della sua appartenenza alla società, assieme al tamburo, che aveva preso in Palantina. La coppa invece la lasciò in un canto deciso a lavarla bene, non appena fosse rimasto solo per un po’. Una mattina riuscì a riempire un secchio d’acqua, a prendere una delle spazzole che Maria teneva così gelosamente e si mise, di lena, a pulirla. Bagliori colorati apparvero da sotto lo spesso strato di terriccio, ma apparve anche dell’altro. Con gran raccapriccio Vincenzo si accorse che si trattava di un teschio, riccamente legato con oro e gemme, ma non per questo meno macabro. Comunque lo lavò per bene, lo asciugò e poi lo nascose avvolgendolo in uno straccio. Si chiese a cosa potesse servire quella strana tazza. Ripensò a tutto quello che gli era successo in quei mesi e soprattutto al mostro bianco che gli aveva detto che il suo signore aveva perso una coppa. Forse era proprio quella. Pensò che fosse bene nasconderla. Camera sua 69 sarebbe stato il posto più logico, ma Maria andava così spesso a pulirla che poteva anche capitarle tra le mani. Aveva riposto le pietre che gli aveva donato il Cavaliere Verde dentro la sopraccoperta di un libro, sicuro che la serva non lo avrebbe aperto, ma una coppa era un’altra cosa. Forse era meglio metterla in soffitta, dove ancora stavano i vetri del nonno. Decise anche di chiedere al grande noce, che era sempre stato così gentile con lui, se ne sapeva di più su quello che gli aveva chiesto di fare la grande pietra. «Ho visto grandi eserciti, arrivare, combattere e scomparire - gli rispose l’albero ho visto viandanti, animali e uccelli; i contadini si sono spesso seduti ai miei piedi a parlare, ma nessuno mi ha mai detto perché su questa terra è stato gettato l’incanto. È successo prima che io nascessi, quando un altro grande noce stava qui, al mio posto.» Vincenzo rimase scosso nell’apprendere che neppure quell’essere maestoso e saggio sapeva perché quei boschi e quelle piante vivevano sotto quella coltre di magia. Prese allora un po’ di coraggio e, una sera, si rivolse a Maria che certo doveva saperne parecchio della vita lassù. «È sempre stato così - rispose la donna - da tempi di mia nonna e di sua nonna prima di lei. Secondo me ci sono, al mondo, altri posti come questo, dove il tempo si stanca di scorrere e il mondo di girare. Sono luoghi incantati, abitati dalle fate, come Tesa, e qui anche i poveri contadini come noi possono fare qualcosa di importante. Se chiedi a Simone, o al Matt, anche loro ti diranno lo stesso. Nessuno sa il perché. È così e basta e bisogna accettarlo e cercare di fare del nostro meglio.» concluse la serva con la saggezza dei contadini. Alla fine, disperando di riuscire a capire qualcosa, Vincenzo decise di rivolgersi anche a suo nonno. Lo raggiunse di sopra, nella biblioteca, con la scusa di trovare qualcosa da leggere sulle proprietà delle piante e dei fiori che ormai sbocciavano numerosi. «Non c’è alcun incanto - disse il vecchio - è solo che la gente adulta non ha tempo di andare a passeggiare, come fate voi ragazzi. Abbiamo cose più importanti da fare. Senti un po’ il mio poema, se ti piace.» e cominciò a recitare: Giove, concedi a chi t’invoca pio il tuo sommo favor e regi doni, ch’io possa narrar col libro mio per la ninfa gentil le tue passioni… Forse non era brutta poesia, pensò Vincenzo, ma era altro quello che voleva sentire. Così cercò di riportare il nonno al discorso interrotto. «Secondo te, nonno, tu che sai tanto di alchimia, cosa si deve fare con una coppa e cosa vuol dire spezzare un sigillo?» «Non capisco bene cosa intendi, dove hai trovato una frase simile?» 70 «La diceva sempre un amico di papà.» mentì Vincenzo per cercare di togliersi d’impaccio. «Anche lui si dedicava alla nobile arte? Allora, l’elemento che esiste acerbo in natura viene trasformato dall’alchimista in farmaco, togliendogli il veleno, ma sono le onde delle acque superiori che permettono all’opera di divenire alchemica. Si crea così il liquore perfetto. L’elisir che tutti ricerchiamo. Se fossi in te andrei a cercare la rugiada una di queste mattine. È un elemento puro e il momento adatto per raccoglierla è proprio il solstizio. La gente da poco direbbe che la notte più adatta è quella di San Giovanni, cioè il 24 giugno, ma io ho studiato le stelle e mi sono accorto che la notte giusta cade undici giorni prima, il 13 giugno, e questo è il motivo per cui tanti miei dotti colleghi non riescono ad affinare la materia e a trovare ciò che è perfetto. Se vuoi possiamo andare assieme, a raccogliere la rugiada e ne approfitteremo per raccogliere molte erbe medicamentose che nascono in quella magica notte.» Vincenzo fu molto contento. Suo nonno aveva superato in qualche modo la paura che avevano suscitato in lui don Floriano e il frate con le loro accuse. Così la vigilia del 13 giugno si misero in marcia. Il posto prescelto era vicino a Broz, dove il nonno diceva crescessero le benefiche piante. Portarono un lume, perché in cielo brillava solo una falce di luna, e passarono parecchie ore a raccogliere le erbe di San Giovanni, che hanno anche la funzione di scacciare demoni e streghe e proteggere dal malocchio. Vincenzo scoprì così l’artemisia, dedicata alla lunare Diana, sorella del solare Apollo, la verbena, che sopisce le dispute e porta il benessere, il ribes, che protegge da malefici e sortilegi e che è anche buono da mangiare. Presero anche dell’iperico dai piccoli fiori gialli traforati, che serve per fare un olio buono contro le ustioni. «Vedi che questa è la notte giusta? - disse a un certo punto il nonno, sfregandosi dei fiori di iperico tra le mani che si tinsero di rosso. - ecco il colore del sangue di san Giovanni. Solo nella notte del solstizio questi piccoli fiori gialli lo rilasciano, a ricordo del sacrificio del santo.» «Prendiamo anche dell’aglio – continuò il vecchio - protegge dai vukodlak.» «Da chi?» chiese Vincenzo che era la prima volta che sentiva quella parola. «Sono degli uomini che non sono più uomini e devono bere il sangue dei vivi o di quanti sono appena morti. Li chiamano così in Dalmazia, dove sono stato quando ero giovane. Quando tua nonna sentì per la prima volta questa parola, anche lei mi chiese chi erano, proprio come hai fatto tu. - disse il vecchio ricordando la sposa che non c’era più. - Me la ricordi proprio, sai. Aveva i tuoi stessi capelli. Solo che lei non mi guardò fisso, come fai tu ora. Al contrario scoppiò in un’allegra risata e disse che allora erano vügutlïk, poveri involucri vuoti di una vita che non esisteva più.» «E come sono fatti?» chiese Vincenzo. «Se ti devo confessare la verità non ne ho mai visto uno. Però ho letto molto su di loro. Personaggi simili sono descritti da Guglielmo di Newburg nella sua Historia 71 rerum anglicarum. Anche Burcardo di Worms nel decimo dei suoi Decretorum libri, dice che i cattivi cristiani trafiggono con un piolo i cadaveri delle donne morte di parto e dei bambini nati morti per prevenire un loro ritorno malefico, mentre nel quinto libro delle Gesta Danorum il Saxo Gramaticus racconta come Asmund abbia dovuto tagliare la testa e poi piantare una picca nel cuore del cadavere del suo amico Aswid per evitare che continuasse a divorare i viventi. » Tali storie fecero correre un brivido lungo la schiena di Vincenzo che ripensò al bianco mostro che un giorno aveva incontrato. Per fortuna erano ben fuori dai boschi incantati. Stava così rimuginando tra sé e sé quando, tra i rami bassi di un abete vide splendere, vicino a una felce, una tenera luce d’argento. «Nonno, guarda, cos’è?» «Siamo davvero fortunati questa notte. Vieni, dobbiamo fare in fretta.» rispose il vecchio che si affrettò verso il lume e con il coltello usato per raccogliere le erbe tracciò rapidamente sulla terra un cerchio attorno alla magica pianta e un altro attorno a sé e al nipote. «Ecco, adesso fissa il fiore e non ti lasciare distrarre dalle voci che sentirai. Continua a guardarlo e forse riusciremo a prenderlo.» Un vento bizzoso spense il lume che erano riusciti a tenere acceso fino ad allora in quella tiepida notte. Si sentirono come delle voci lontane ma nessuno dei due si voltò, mentre il fiore diveniva sempre più luminoso e inargentava le tenebre. Dopo tornò il silenzio e anche il vento tacque. Alessandro degli Alessandri recise con il suo coltello l’alto stelo azzurrino che continuava a splendere, anche se con minore intensità. «Questo è il fiore chiamato di san Giovanni - disse il nonno con aria soddisfatta - e questo dimostra che il 13 giugno è la notte del solstizio. Serve a cacciare gli spiriti immondi, consente di resistere agli incantesimi e rende invisibile chi lo possiede, ma soprattutto consente di realizzare il proprio sogno. Non che io creda a tutte queste virtù, concluse, ma così dicono i contadini e qualche volta è bello fidarsi anche della loro antica sapienza. E adesso aspettiamo l’alba, per raccogliere la rugiada.» Quella fu una delle più belle notti mai trascorse da Vincenzo, tra gli alberi, con il nonno e con quel fiore meraviglioso. Quando il cielo divenne roseo cominciarono a raccogliere anche quell’acqua «che è benedetta perché le acque di san Giovanni sono omologhe al segno del Cancro, che ha il suo domicilio nella Luna, al cui inizio cade il solstizio.» concluse dottamente Alessandro degli Alessandri. Pochi giorni dopo, un sera, rientrando a casa dopo un pomeriggio passato a veder pascolare le bestie Vincenzo si accorse che qualcuno era stato nella sua stanza. Tutto era sottosopra. Il letto disfatto. Il catino rovesciato per terra e la brocca vuotata. Lo sguardo gli corse al paio di libri che stavano di solito sopra l’armadio. Anch’essi non erano al loro posto; stavano sul tavolo e quello in cui aveva nascosto le pietre aveva la coperta stracciata. Corse giù da Maria a chiedere se era salito qualcuno ma la serva non aveva visto anima viva. Era stato un giorno caldo e 72 assolato, di quelli in cui si prende sonno facilmente nel primo pomeriggio e nessuno aveva visto o sentito nulla. Vincenzo corse su in soffitta. Per fortuna l’altro suo tesoro era ancora intatto. Nessuno aveva trovato la coppa misteriosa, fatta di oro, zaffiri, smeraldi, rubini e di morte. La settimana dopo Inigo andò giù a Pieve, per affari importanti, disse. Tornò dopo tre giorni con un vestito nuovo per sua moglie, tutto ricami e velluto, come quello delle donne di città. Lina non stava in sé dalla gioia. Si pavoneggiò per tutto il paese. Anche chi tanto tempo prima l’aveva presa in giro per aver sposato uno da fuori ora diceva che, forse, aveva fatto bene. Vincenzo non ci mise molto a collegare quell’abito alle pietre che gli aveva donato il cavaliere. Era stato il marito, di certo, a prenderle. La sua antipatia per lui si accentuò. Quando lo incontrava faceva finta di non vederlo ma, purtroppo, ciò accadeva anche troppo spesso. Era come se Inigo si fosse trasformato nella sua ombra. Vincenzo si sentiva spiato. Non poteva fare un passo senza essere seguito e gli venne il dubbio che la sua stanza fosse stata frugata ancora da mani indiscrete. Cominciò a temere per la coppa. Non doveva essere rubata. Un giorno finalmente Inigo si recò ancora a Farra e Vincenzo pensò che fosse meglio approfittare dell’occasione e riportare quel macabro trofeo ai piedi del grande sasso dove lo aveva trovato. Lo avvolse in un cencio e si diresse verso la valle incantata. Passò la casa di Jacopo e si diresse verso il prato dove aveva incontrato la cavalcata di spettri. Al bivio avrebbe preso sulla destra lasciandosi a sinistra la via per Tambre. Voleva arrivare a Col Indes e da lì proseguire per la Palantina, dove c’era stato lo scontro con gli stregoni malvagi. Non riuscì però ad andare lontano. Aveva la sensazione che qualcuno lo seguisse, nascondendosi dietro gli alberi. Per questo piegò a sinistra, incerto se tornare indietro. Il cielo era terso e il sole alto nel cielo. Il respiro caldo della natura avvolgeva ogni cosa. A un certo punto qualcosa di scuro cominciò ad oscurare il sole. «Che strano! una nuvola!» si disse il ragazzo. Sembrava quasi che il tempo si fosse fermato, immobile ad aspettare. Anche Vincenzo si fermò. Era tutto così simile, eppure così diverso. I rami bassi di un albero che si ergeva davanti a lui vennero scostati. Una donna vestita di azzurro lo stava fissando. Il cuore del ragazzo ebbe come un sobbalzo. Non aveva mai visto nessuno così. Vincenzo non si era mai interessato delle ragazzine con cui giocava e quella che gli stava dinanzi era evidentemente troppo grande, quasi vecchia avrebbe detto in un altro momento. Eppure aveva un viso diverso dai soliti, un viso luminoso, in cui risplendevano due occhi scuri. E gli sorrideva. «Salve - disse - mi sono persa. Puoi aiutarmi a ritrovare la via per Valdenoghèr?» Se era una fata, non era certo di quelle parti, si trovò a pensare il ragazzo. Avrebbe voluto uscire con una frase ampollosa, di quelle che sapeva usare il nonno, ma riuscì solo a mormorare: «Sì, certo, è da quella parte.» indicando con la mano la via da dove era venuto. 73 «Sei molto gentile. Grazie.» cinguettò quella azzurra visione, che si diresse decisa giù per il sentiero. Vincenzo rimase fermo, ancora senza fiato, incerto sulla via da seguire. Passarono così alcuni minuti, quando un urlo lacerò l’aria. Era la fata che gridava. Il ragazzo tornò indietro di corsa. Vide il Matt che stava per raggiungere la fanciulla, che scappava urlando. Era dunque lui che lo aveva seguito fino a lì. Vincenzo non riusciva a capire. Sapeva solo che stava succedendo qualcosa di brutto. Si slanciò in avanti, senza pensare, in mezzo al bosco. «Lasciala stare. Cosa vuoi da lei?» «È una fata, finalmente… -disse il Matt fuori di sé - … finalmente ne ho trovata una e puoi star certo che questa non me la lascio scappare.» Aveva preso la ragazza per un braccio. Vincenzo non ci vide più. Neppure lui sapeva perché provava un tale dolore a vedere quella donna sconosciuta in pericolo. Nella corsa inciampò e cadde, rotolando tra l’erba alta. Il fagotto che teneva in mano gli sfuggì lontano. Alzò le braccia e tese tutti i nervi, pieno di una rabbia incontenibile, che non aveva mai provato. Sentì dentro di sé una grande forza, come quella degli animali da preda. Digrignò i denti come solo i cani e i lupi sanno fare. Pochi istanti dopo era diventato davvero un lupo. Procedette a balzi, di zolla in zolla, sino a raggiungere il luogo dove stavano i due e con un ringhio di battaglia si gettò contro il Matt e lo azzannò. Rotolarono per terra, poi l’uomo riuscì ad afferrare un pezzo di legno e a colpire l’animale. Vincenzo mollò la presa per il dolore mentre l’altro si allontanava di corsa. La donna vestita d’azzurro era ferma ai piedi di un albero. Incerto sul da farsi, sbalordito dalla sua stessa trasformazione, Vincenzo si fermò titubante in mezzo al bosco. Allungò le zampe anteriori come per sentire meglio il terreno, poi alzò il muso per fiutare l’aria. Fu un odore sottile che lo fece volgere. C’era qualcuno, laggiù. Animali. Altri animali simili a lui. Seguì senza incertezze la traccia su per il pendio, oltre il grande pianoro. C’erano degli altri alberi abbarbicati sul fianco della montagna e lì accanto un grande lupo nero. Si avvicinarono e si annusarono a vicenda. Vincenzo si sentiva davvero uguale al lupo che aveva di fronte. I suoi sensi si erano affinati. Le vie dell’aria gli portavano mille diversi odori quando prima riusciva a distinguere solo il profumo della primavera dall’olezzo più intenso. Il bosco, che era sempre stato così silenzioso, si era riempito improvvisamente di mille diversi fruscii e sussurri e anche i colori del mondo erano cambiati. Si sentiva ora estremamente forte rispetto al ragazzo di prima. Sapeva di poter affrontare e vincere anche un uomo, anche se il Matt era riuscito a sfuggire alla sua presa, ma era stato lo stupore di quella trasformazione ad averlo fermato, non il bastone del suo nemico. Consapevole di tutto ciò guardò con interesse l’animale che aveva di fronte. «Salve, Kurt, uomo-lupo - si sentì dire - era molto tempo che non passavi da queste parti.» «Non mi chiamo Kurt, sono Vincenzo.» rispose. 74 «Eppure il tuo manto è grigio-azzurro, proprio come il suo. Non sei un uomolupo, dici?» «Sono un uomo, anche se ora sono un animale. Non capisco bene cosa sia successo.» concluse. «Ciò che era nascosto è venuto alla luce. La tua duplice natura si è manifestata ed ora io posso accoglierti tra miei simili.» «Perché proprio tu? E come?» «Io sono lo spirito di tutti i lupi, il loro progenitore ed essi sono tutti figli miei. Anche tu, che sei rivestito ormai della nostra pelliccia entri da questo momento a far parte della mia stirpe. Avvicinati.» Molti altri lupi uscirono dal bosco e li circondarono annusando il nuovo arrivato. «Se ci tratterai con rispetto e amore la nostra alleanza durerà per sempre concluse il grande animale nero - la nostra forza sarà la tua forza e il nostro potere ti apparterrà e ti aiuterà a realizzare il tuo sogno.» Poi il branco si allontanò e Vincenzo rimase solo. Ritornò indietro senza vedere nessuno. Il Matt era certo ormai lontano e anche la donna dall’abito azzurro era andata via. Lo spiazzo erboso era vuoto di ogni presenza umana e anche la coppa d’oro era svanita. Un altro se stesso, però, giaceva immobile e come addormentato, mezzo nascosto tra l’erba. Ululò e una voce gli rispose: «Potresti anche fare a meno di rompermi i timpani in questo modo, sei un ragazzaccio maleducato.» Era Lug che lo stava osservando con la sua aria divertita. «Allora, come va? piccolo uomo-lupo.» «Un po’ frastornato, ma va bene. Cosa è successo? Perché sto dormendo e allo stesso tempo sono un lupo? Come posso tornare dentro di me?» «Calma. Calma. Una risposta alla volta. Tutto bisogna insegnarti. Basta che lo desideri intensamente e tornerai come prima. Non te lo hanno già detto?» «Smettila di trattarmi così. Abbiamo un conto in sospeso, noi due - gli rispose Vincenzo - proprio tu, all’arrivo della primavera, ti sei ben guardato dal dirmi che le mele portavano la febbre. E ora chissà cosa mi nascondi.» «Proprio nulla, stai tranquillo. Ormai sei stato accettato tra le persone adulte, sia tra gli uomini che tra gli animali, sebbene io avessi dei dubbi sulla tua idoneità. Comunque ciò che è fatto è fatto. Andiamo, riprendi il tuo aspetto e ti accompagno per un po’, verso casa.» Vincenzo cercò di desiderare di tornare uomo, ma non fu così semplice. Fece vari tentativi, tra le risate di Lug, che lo prendeva in giro. Alla fine ci riuscì e si ritrovò nuovamente sveglio, in mezzo al bosco. Poi si avviò con il suo ingombrante e zannuto amico che lo seguiva come un cagnolino. Il sole stava calando. A un certo punto Lug si fermò per salutarlo. Aveva uno sguardo triste. 75 «Ci rivediamo domani.» disse Vincenzo che assaporava per il giorno dopo già un’altra avventura, questa volta nei panni di un lupo grigio-azzurro. «Ci rivedremo, chissà… Addio.» gli rispose Lug, lo spirito di tutti i cinghiali. Vincenzo si allontanò saltando, senza voltarsi. A casa, a Valdenoghèr, Maria stava entrando in biblioteca, per portare la cena al padrone, questi si era addormentato per sempre, con in mano la penna con cui stava concludendo il suo poema: O Giove sommo, o Muse, o Numi buoni accogliete il poema di mia vita, e non negate i vostri incliti doni per terminare alfin l’opra infinita. Il fiore di San Giovanni, solitario in un vaso di vetro, stava bianco e secco sulla mensola del focolare: Alessandro degli Alessandri non avrebbe più dovuto cercare l’elisir e affaticarsi per compiere l’opera alchemica. Per suo nipote stava per cominciare, ancora una volta, una nuova vita. 76 PARTE SECONDA IL RITORNO, 1577 1. La vecchia casa La comitiva procedeva tranquilla per il sentiero tortuoso che si snodava tra gli alberi. I muli, con i loro basti pesanti, sembravano quasi non sentire la fatica in quella giornata limpida e fresca e anche Vincenzo degli Alessandri respirava con avidità l’aria delle montagne. Andava con il pensiero a un altro viaggio e a un altro arrivo, quando era appena ragazzo e per la prima volta aveva incontrato suo nonno e la grande casa a Valdenoghèr. Erano passati più di trent’anni e una vita d’uomo da allora. Dopo la morte improvvisa di Alessandro degli Alessandri non era più stato in quei luoghi. Gli amici di suo padre, che già si erano presi cura di lui, lo avevano fatto tornare a Venezia e poi lo avevano inviato a studiare a Costantinopoli, presso la cancelleria del bailo veneziano: il piccolo orfano aveva così cominciato, prima come interprete, e poi come segretario, a lavorare nell’ambiente burocratico, dove aveva trovato soddisfazioni, denaro e amicizie. Eppure non era mai riuscito a dimenticare quell’inverno passato in Alpago, neppure durante i suoi lunghi e avventurosi viaggi in Oriente. Aveva sempre mantenuto la proprietà della vecchia casa di pietra, unico legame che ancora gli restava con la sua famiglia. «Ormai non manca molto - disse più a se stesso che agli uomini che lo accompagnavano - siamo quasi arrivati. Un paio di curve e si cominceranno a vedere le prime case.» Si preparò a salutare il vecchio noce, su cui soleva rifugiarsi un tempo, ma, dietro gli ultimi abeti, apparve solo un tronco annerito, come un ragno nero che si protendeva inutilmente verso il cielo. Un fulmine doveva averlo schiantato e Vincenzo pensò che non avrebbe più sentito il vecchio amico rispondere sommesso al suo saluto. Solo la presenza di una giovane pianta, nata poco distante dall’altra, attutì un po’ il dispiacere per la perdita del suo antico compagno. Ancora un pezzo di sentiero ed ecco la casa del nonno. L’orgoglioso edificio di un tempo appariva ora cupo e triste. Il bianco e il rosso della facciata non contrastavano più come una volta, eppure le finestre erano aperte e, sulla soglia, alcune persone chiacchieravano aspettando il suo arrivo. C’erano Celeste, il compagno di tanti giochi, e sua moglie Corinna, che si era data da fare per preparare la casa per il ritorno del padrone. Si sentiva odore di pulito nelle vecchie stanze e Vincenzo fu contento di essere tornato. «Come va a Venezia?» gli chiese Celeste quando si fu sistemato. Il contadino era contento di ritrovare il padrone, eppure intimidito dalla presenza di una persona che ormai non conosceva più. «Con la bella stagione la peste riprende - rispose Vincenzo - è stato prudente venir via. Non so davvero cosa succederà quest’estate.» L’anno precedente il morbo, pur a lungo negato dalle autorità, aveva mietuto centinaia di vittime. Per le calli e i campi di Venezia si sentivano solo campane a morto e si vedevano solo i carri dei becchini che portavano a seppellire i morti. Chi poteva restava chiuso in casa per evitare il contagio, ma la nera signora visitava indistintamente i palazzi dei ricchi e le stamberghe dei poveri. Anche sua moglie e suo figlio erano morti. Andò con il pensiero a quei momenti dolorosi e alla sua casa in Campo San Moisé, ormai desolatamente vuota. Si disse che aveva fatto bene a lasciare Venezia per venire lassù. «E i suoi amici quando arriveranno?» chiese Corinna, curiosa di tutte quelle novità che venivano a rompere la monotonia di una vita sempre uguale. Aveva la carnagione bianca e rossa e una massa di capelli del colore delle foglie d’autunno le incorniciava il volto. «Fra pochi giorni saranno qui. Sono solo due e ci sono stanze a sufficienza per tutti.» «È già tutto pronto. Stefano, il marito di Rosa, ci ha aiutato; abbiamo rimesso tutto a posto e abbiamo anche pitturato le pareti con la calce.» «Ma le scale sono sempre caliginose, come una volta.» rispose Vincenzo. «Quelle non le abbiamo toccate. - disse Celeste - Con tutto il fumo che si incanala per di là, invece che per i camini, come sarebbe giusto, sarebbe stato un lavoro inutile.» Vincenzo sorrise e ripensò alla nonna. Cinque anni prima le aveva viste finalmente, le tende come quella dove Maria Turchese era nata e che era stata il modello per costruire la casa di Valdenoghèr. Era stato durante il viaggio in Persia che aveva compiuto come inviato della Repubblica di Venezia. Allora c’era la guerra con il Turco e aveva dovuto attraversare luoghi pieni di pericoli, inseguito dagli emissari del sultano, per raggiungere lo scià e trattare un’impossibile alleanza. Per lui si era trattato non solo di una missione diplomatica, ma anche di un viaggio alla scoperta delle proprie origini. «E degli altri, cosa sai dirmi? Jacopo, Margherita, Rosa…» chiese a Celeste. «Stanno tutti bene e tutti hanno una nidiata di marmocchi. Jacopo ha sposato Iris e le altre due hanno scelto due giovani di Farra, che sono venuti a stare qui da noi. Sono i vecchi che ormai non ci sono più. Modesta, Tranquilla, Simone e anche Maria, di cui le abbiamo inviato notizie.» Celeste provava un certo timore davanti a quel signore di città e aveva dimenticato il tono confidenziale con cui lo aveva trattato tanti anni prima. 6 «Solo don Floriano resiste - continuò sua moglie - avrà più di sessant’anni ormai, ma continua a venire tutti gli anni alle feste comandate.» «Già - le fece eco il marito - ed è sempre alla ricerca del demonio e delle sue apparizioni. Da una decina d’anni poi, da quando i preti hanno cominciato a farsi sempre più rigidi, è tutto contento e non fa altro che fare domande e imporre penitenze a tutti.» «Ha organizzato altre processioni su, oltre Broz, come quella di tanti anni fa, quando c’ero anch’io?» «No, dopo quella volta che finì con l’acquazzone, non ci ha più provato. Nessuno va volentieri da quelle parti, lo sa bene anche lei e, ormai, non vi mandiamo più neanche i bambini a pascolare le bestie. Non vogliamo avere guai con le autorità ecclesiastiche e don Floriano, quando è qui, non fa altro che spiarci, come se fossimo un branco di anime dannate.» «Non gli è mai piaciuto questo paese - concluse Vincenzo - e visto che non può prendersela con i suoi superiori, che non lo hanno mandato altrove, se la prende con i poveri contadini. Eppure, se avesse visto quello che abbiamo visto noi la penserebbe diversamente, non è vero Celeste?» «Visto che cosa?» chiese l’altro. «Beh, una cascata di luce scendere dalla sommità di un bastone piantato in terra e poi, quei mostri bianchi e stupidi che succhiano il sangue agli uomini, di cui parlava sempre il Matt.» Celeste fece una faccia strana, come se faticasse a ricordare. «Non so - disse - fantasticherie di bambini, certo.» Vincenzo preferì non insistere, ma si chiese perplesso se ciò che ricordava fosse solo un sogno. Quella sera nella sua vecchia camera, che era stata anche della nonna Maria Turchese, ripensò agli anni trascorsi prima a Costantinopoli, a imparare il turco e il persiano, poi a Venezia, dove aveva ricoperto gli importanti uffici di segretario del Senato e del Consiglio di Dieci, e infine nella lontana Persia, a Erevan, Tabriz, Qazvin. Guardò gli specchi che erano appartenuti alla nonna, ancora appesi a un chiodo sulla parete bianca. Ora riusciva forse a capire un po’ meglio cosa doveva aver desiderato e sognato la giovane Mavì Hatùn in quelle montagne così diverse e al tempo stesso così simili a quelle del suo paese. Ripensò a tutto quello che lui stesso aveva vissuto tanto tempo prima in quel posto incantato e gli tornarono alla mente luoghi a lungo dimenticati: la Valturcana, Tambre, la fontana solitaria, la Palantina e il misterioso Caotès. Durante i suoi viaggi aveva visto posti meravigliosi e fatti strani, inimmaginabili per chi, come Celeste, non aveva mai abbandonato la sua terra natia: uomini dagli occhi stretti come fessure, distese di erba verde ampie come l’oceano, montagne invalicabili coperte di nevi perenni, animali feroci eppure maestosi e belli, e anche del fuoco che neppure l’acqua era in grado di spegnere. Per quanto fantastici, quelli non erano stati sogni bensì realtà e li ricordava con la stessa intensità con cui 7 rivedeva ora episodi vissuti in un inverno di tanti anni prima, trascorso nella casa del nonno a Valdenoghèr. Possibile che fossero solo fantasticherie di bambini, come aveva detto il suo vecchio compagno di giochi? Dopo parecchio tempo, non riuscendo a dormire, prese un lume e uscì nella notte. Si era ricordato che era la vigilia del 13 giugno e che, tanto tempo prima, in una notte come quella, aveva fatto una passeggiata notturna con suo nonno. Voleva rivivere quei momenti, riprovare quel senso di felicità senza nubi, ritrovare l’iperico, che al solstizio tinge le mani di rosso, cogliere il fiore misterioso, che fiorisce solo quella notte, e infine raccogliere la rugiada del mattino. Si diresse su, verso i boschi, ma non proseguì di molto. Poco dopo la casa di Jacopo, nascosto tra le felci e i rami più bassi, vide uno splendore azzurrino. Risentì il vento passargli tra i capelli, le voci lontane e l’aria mite dell’estate che avanzava. Tracciò con il coltello un solco sul terreno e raccolse il fiore luminoso, che realizzava i desideri più nascosti di chi lo sapeva cogliere. Poi tornò a casa. Si addormentò ripromettendosi di andare l’indomani a salutare i boschi e i prati in cui tanti anni prima aveva immaginato di vivere avventure meravigliose. Quella stessa notte un allegro cinghiale, di nome Lug, comparve inaspettato nei suoi sogni. La mattina seguente portò invece una visita imprevista. Il signor Inigo, come lo chiamavano ora, si presentò nella grande casa di pietra, assieme a sua moglie, la signora Lina, per presentare a Vincenzo i suoi omaggi. Il padrone di casa Alessandri era considerato dagli abitanti di Valdenoghèr una persona importante, che era stata inviata dalle più alte autorità della Serenissima Repubblica a trattare con re e regine, ma quei due erano diventati comunque l’autorità riconosciuta di tutto il paese e per questo si presentarono subito alla sua porta. Vennero inviati ad entrare. La conversazione procedette molto formalmente. Inigo ripeté quanto aveva raccontato a tutti, e cioè di aver ricevuto da un suo zio di Spagna una grande eredità. Non era più un soldato venuto a curare le proprie ferite. Il trascorrere degli anni non aveva lasciato solchi profondi su di lui, sempre magro e dritto come un tempo; solo i capelli, ora un po’ brizzolati, lasciavano intravvedere la sua età. Lina invece aveva assunto un aspetto matronale che ben si addiceva alla sua nuova condizione. Non aveva avuto figli, ma questo non sembrava un cruccio per lei che aveva sempre considerato i bambini una gran seccatura. Era più importante atteggiarsi a gran dama e infatti la donna indossava un abito di velluto nero, troppo ricco e troppo elegante per quelle montagne. Naturalmente, come ripeté anche a Vincenzo, lei si sarebbe trasferita volentieri da tempo a Belluno, oppure a Pieve, dove aveva una casa, per partecipare alla vita della società di cui ormai faceva parte, ma il marito era caparbiamente attaccato a Valdenoghèr da cui non voleva muoversi. «I miei omaggi, signor Vincenzo - disse Inigo sul punto di accomiatarsi - sono davvero felice di averla rivista qui, dopo tanti anni.» Il raggio di sole che illuminava il portico faceva apparire il suo volto scarno sorprendentemente simile a quello di più 8 di trent’anni prima. Anche se il tono era serio e compassato, gli occhi, mobilissimi, dimostrarono che, ora come un tempo, non era bene fidarsi di lui. «Grazie per la visita.» rispose Vincenzo con quell’aria indecifrabile che aveva imparato ad usare quando trattava con i potenti. «Pensate a quanto vi ho detto, nel caso vogliate finalmente vendere la casa. disse Inigo - Sarei disposto a comprarla, sapete? È molto rovinata ormai, ma investendoci del denaro si potrebbe rimetterla un po’ a posto.» «Non ho intenzione di vendere, almeno per il momento - rispose Vincenzo - Mi fermerò qui per l’estate, per gustare il fresco dei monti. Come vi ho detto, l’anno scorso c’è stata una gran mortalità a Venezia. Aria cattiva, malsana, hanno detto i medici e così ho pensato di trasferirmi qui per un po’.» Lina fece un’espressione delusa. Se doveva rimanere a Valdenoghèr, avrebbe almeno voluto abitare nella più bella casa del paese, ma per ora questo restava per lei solo un sogno. Non fu tuttavia il suo volto dispiaciuto che attirò l’attenzione di Vincenzo, bensì i bagliori di una collana rossa che adornava il suo collo e risplendeva ora al sole. Era una cascata di pietre, legate da sottili catenelle d’oro. Un gioiello magnifico che mai ci si sarebbe aspettato di vedere indossato da una contadina. Vincenzo ripensò a un prato sfavillante dei colori dei fiori che aveva visto tanti anni prima e alle tre pietre che un giorno Inigo gli aveva mostrato sul palmo della sua mano. Possibile che avesse solo sognato tutto ciò? La storia dello zio morto in Spagna divenne per lui improvvisamente assurda e si chiese in che modo quell’uomo fosse riuscito a carpire i tesori che quella terra nascondeva. Passarono alcuni giorni, pieni di incombenze da sbrigare, e Vincenzo non ebbe tempo di recarsi al limite dei boschi. Per quanto l’edificio fosse stato riassettato ben bene, occorreva sistemare quanto aveva portato da Venezia, controllare la dispensa, la legnaia e il fienile. Corinna, da brava massaia, si dava da fare a mettere tutto in ordine, felice che la grande casa avesse ritrovato il suo padrone, e le stanze risuonavano finalmente, dopo tanti anni, delle risa e del vociare delle donne che erano andate ad aiutarla. Al piano superiore, su una mensola sopra un caminetto stava, dimenticato in una vaso di vetro, un magico fiore azzurrino. Vincenzo voleva che tutto fosse in ordine quando sarebbero giunti i suoi amici. Erano più giovani di lui ma il fatto di essere ormai solo lo aveva portato in quegli ultimi mesi ad accostarsi a quanti erano liberi e non si erano ancora creati una famiglia. Comunque era sempre gente di quell’alta borghesia veneziana a cui lui stesso apparteneva. Era un mondo che viveva a contatto con i nobili più illustri della Serenissima; chi vi faceva parte doveva essere pronto anche a trattare in nome dello stato con ambasciatori e monarchi stranieri, come era capitato a lui stesso che era stato inviato dal doge di Venezia a portare la sua parola allo scià di Persia. Oltre alla politica però bisognava conoscere anche le lettere; in tal modo ci si poteva far apprezzare, se non per la nobiltà dei natali, almeno per una vasta cultura. A tale ambiente dunque appartenevano gli amici che aveva invitato ed essi avevano 9 accettato con piacere. La peste aveva mietuto molte vittime l’anno precedente; chi poteva cercava rifugio in campagna, lontano dalle vie affollate della città, e Valdenoghèr era un posto davvero isolato e dove l’aria era buona. 2. I giovani di città Pochi giorni dopo arrivarono finalmente. Mentre era nel cortile, sul retro, Vincenzo fu raggiunto dalle voci degli amici veneziani che lo chiamavano. Avviandosi verso l’entrata Vincenzo sentì un frusciare di vesti femminili e delle risate argentine. Rimase contrariato e interdetto. Aveva pensato a una piacevole e cameratesca brigata e invece arrivavano anche altri, non invitati. Il ricordo della moglie che aveva perduto era ancora troppo fresco per permettergli di accogliere delle donne nella propria dimora senza provare sofferenza e rimpianto. All’ombra dell’ampio portico che immetteva in casa scorse cinque persone. Almorò era un giovanotto biondo, di poco più di vent’anni, alto e ben piantato, proprio il tipo che sapeva come incantare un uditorio femminile. L’altro, di nome Vittore, invece era magro e alto, quasi allampanato; aveva l’aria dello studioso, ma Vincenzo si era sempre chiesto se la sua fosse vera cultura o semplice erudizione. Comunque era un abile oratore, che sapeva usare parole difficili, anche se questo, alle volte, rendeva faticoso seguire i suoi ragionamenti. Con loro c’erano però tre ragazze. «La peste ha allentato di molto le formalità - disse subito Almorò - e così non te l’avrai a male se abbiamo deciso di portare con noi delle nostre parenti. Volevamo evitare anche a loro il caldo dell’estate e i rischi del contagio. Questa è mia sorella Flaminia.» e presentò così la fanciulla più alta, bionda e dal portamento aristocratico, come il fratello, del resto. «Questa invece è mia cugina Fosca.» gli fece eco Vittore, mentre una biondina minuta faceva un inchino compito. «Io invece sono Clelia - disse la terza ragazza presentandosi da sé - e sono solo un’amica.» Nell’oscurità del portico non si distinguevano bene i volti, soprattutto per occhi ancora abbagliati dal sole, ma qualcosa nella voce di Clelia fece sobbalzare Vincenzo. «Una cara amica - intervenne Flaminia - e per questo le abbiamo detto di venire. I suoi genitori sono morti lo scorso anno, durante la peste, ed è rimasta sola. Ora vive con noi e così le ho chiesto di accompagnarci.» Vincenzo balbettò qualche parola di circostanza. Non vi era alcun problema. Capiva la situazione. Per fortuna la vecchia casa aveva stanze a sufficienza e a Valdenoghèr nessuno si sarebbe scandalizzato per quella forzata convivenza. «Sono usi di città», avrebbero pensato i contadini per i quali recarsi a Pieve rappresentava già un viaggio ai limiti del mondo conosciuto. Fissò il bel volto di Clelia, incorniciato di capelli ricci e scuri. Era come se un pensiero appena abbozzato cercasse di farsi 10 largo nella sua mente, ma senza riuscirci. Rinunciò a capire quello che provava. Bisognava accogliere gli ospiti. La sistemazione delle camere fu estremamente laboriosa. Flaminia faceva la difficile e solo dopo una lunga discussione si riuscì a sistemarla da sola, al secondo piano. Clelia invece trovava tutto buffo e decise, di buon grado, di dividere la propria stanza con Fosca, la più giovane e la più timida delle tre. Al primo piano invece alloggiarono i due giovani, vicino al loro ospite. Sullo stesso piano stava anche quella che tutti chiamavano da sempre la Biblioteca. Il locale vicino era stato trasformato da Vincenzo in un salottino «alla turca», cioè addobbato con tappeti, cuscini, piccoli tavolini bassi e un imponente divano. Il ritratto della nonna in vesti orientali troneggiava su una parete. Sarebbe stato quello il luogo di conversazione e ritrovo, nel caso la pioggia o il freddo li avesse costretti a trascorrere lunghe ore al coperto. Fu lì che quella sera, dopo cena, si sistemarono tutti, a chiacchierare, mentre fuori faceva ormai buio e un paio di candele inondavano la stanza di una tremula luce. «Dai Vincenzo, raccontaci dei tuoi viaggi.» cominciò Almorò, sempre interessato a tutto ciò che era al di fuori dell’ordinaria normalità. Suo padre era un affermato notaio e vedeva in lui il suo successore, ma il giovane non sognava il polveroso banco di uno studio bensì sperava di diventare il cancelliere di qualche rettore o ambasciatore, in modo da viaggiare e vedere il mondo, proprio come aveva fatto Vincenzo. «Di cosa volete che parli. Delle città della Persia o delle donne di quel paese? Sono brutte le une e altre.» Risero tutti, in coro. «Le donne hanno bei lineamenti e nobile aspetto ma sono troppo austere per me, mentre le città sono in luoghi magnifici, ma gli edifici sono per lo più costruiti con il fango. Niente a confronto con le case colorate di Venezia.» Conversarono così, piacevolmente, di siti ameni e di bellezza femminile. «Qual è stata la donna più bella che hai visto - chiese a un certo punto Flaminia una delle mogli dello scià o una ballerina?» «Le donne dei personaggi importanti stanno chiuse nei loro palazzi e non è facile vederle, almeno in Persia. È più semplice tra i turcomanni che abitano in tende e si spostano spesso, da un pascolo a un altro. In quelle tribù le donne hanno veramente un posto importante e sono visibili. Assomigliano a quella.» fece indicando il quadro appeso nella sala. Gli amici gli chiesero chi rappresentava e ammirarono dunque la nonna di Vincenzo, che, chissà per quale ghiribizzo, si era fatta una volta ritrarre in vesti orientali. «Ma voi volete sapere chi è la più bella che abbia mai conosciuto, escluse le presenti naturalmente.» continuò subito, prima che qualcuno gli chiedesse qualche altra informazione sulla donna che li osservava dalla parete. «Ecco, era una fanciulla che incontrai una volta proprio tra queste montagne.» 11 I suoi amici volevano sapere chi era quel miracolo di bellezza ma il loro ospite non poté accontentarli. Non conosceva il suo nome e la ricordava appena, anche se gli aveva fatto una profonda impressione. Rivedeva solo un abito azzurro che ne nascondeva la figura come una nuvola. «Doveva trattarsi di una fata, come se ne vedono tra queste montagne incantate.» concluse Vincenzo, quasi mordendosi le labbra e chiedendosi perché mai quel ricordo gli era improvvisamente capitato davanti, senza che niente lo avesse fatto affiorare. Si accorse, però, ben presto di aver forse commesso un errore. Non avrebbe mai dovuto nominare le fate e le leggende che aleggiavano su Valdenoghèr. Non aveva calcolato bene la curiosità dei suoi amici e soprattutto la fantasia femminile che ama i racconti. Dalle contrade e dai palazzi dell’Oriente, fantastici eppure per lui reali, si passò quindi a discutere di incanti e miti, di racconti cavallereschi e di dei dell’Olimpo. Comunque l’atmosfera era cordiale e serena e Vincenzo si lasciò andare a raccontare quelle che già considerava solo leggende. Si era infatti ormai convinto di aver scambiato per realtà le favole e i sogni di un tempo: dopo l’incontro con Inigo, nient’altro gli aveva fatto dubitare che poco lontano vivessero orridi mostri, ninfe e cavalieri erranti. Favoleggiò dunque delle fate che intrecciavano danze ad All’Ò e di un luogo chiamato Caotès, dove abitava una bellissima ninfa; ella custodiva gelosamente la sua polla d’acqua da cui sgorgava il torrente Tesa. I contadini usavano parlarne sottovoce, al riparo da orecchie indiscrete, ma dicevano che era un luogo magico, dove vigeva una legge diversa da quella del mondo degli uomini. Anche l’acqua di quella fonte era speciale: poteva curare qualsiasi malattia e far germogliare fiori ed erba. A Valdenoghèr le nonne raccontavano la sera, accanto al focolare, che una volta, tanti e tanti anni prima, una bambina aveva annaffiato con quel liquore un vecchio melo, che non dava frutti da anni e che si pensava di abbattere: il giorno dopo l’albero era talmente carico che i suoi rami si piegavano a toccare la terra. Il racconto fu tanto apprezzato che Clelia decise di organizzare una gita, oltre Broz e le Coste de Mai. L’indomani però pioveva, di una pioggerellina fine e incessante che non prometteva nulla di buono, neppure per i giorni seguenti. Non restava altro da fare che tornare nella stanza turca a chiacchierare e avvolgersi in pesanti soprabiti per non ammalarsi di freddo e umidità, nonostante si fosse ormai alla fine di giugno. Passarono così alcuni giorni, umidi e noiosi. Fu solo il 20 di giugno che il sole fece una timida comparsa, scaldando l’aria e cominciando ad asciugare l’erba. Due giorni dopo un tramonto trionfante tinse di rosa tutto il cielo facendo dimenticare la pioggia e preannunciando finalmente la completa vittoria del bel tempo. Nell’aria si diffondeva il rumore dei contadini intenti ad affilare le falci e i coltelli. Lo sfregare leggero di una pietra contro una lama si era alzato da un campo lontano e a decine gli avevano risposto; ben presto tutta la valle risuonava di quel ritmico sussurro mentre il sole calava rosso all’orizzonte. 12 «Questa sera si vedranno tutte le stelle.» disse Flaminia. «Potremmo uscire, e fare una passeggiata al lume della luna - propose Almorò L’aria si è fatta calda, come deve essere in questa stagione.» L’idea venne accolta con frasi di approvazione e risa di gioia. Finalmente la possibilità di fare qualcosa di diverso. Solo Vittore ebbe qualcosa da obiettare: «Non credo che questa sia la sera più adatta. - disse - Siamo alla vigilia della festa di San Giovanni, e questa è una notte maledetta, quando le streghe si riuniscono per compiere i loro riti immondi.» Un coro di proteste si levò attorno a lui. Non si poteva certo sprecare una serata così bella per stare ancora rintanati in casa. Inoltre erano in tanti e le streghe stavano soprattutto nei racconti e nelle commedie, non in un paese tranquillo come quello. Vincenzo fece un viso dubbioso ma per fortuna nessuno se ne accorse e lui preferì tacere. Si decise dunque di passare la serata in un grande prato che stava poco lontano dal paese, a mangiare pane, formaggio e bere un po’ di buon vino che era stato portato con i bagagli. Si mossero da casa in processione. Vittore apriva il corteo con una lanterna, poi venivano Flaminia e Fosca; chiudeva il corteo Almorò con il gran cesto delle provviste mentre Clelia e Vincenzo cercavano di illuminare la strada con due lumi più piccoli. La colazione notturna si rivelò un vero successo. L’aria era davvero calda e anche il vento spirò tanto leggermente da non disturbare i convitati; il solo danno che fece fu di piegare le due luci tremolanti delle candele, non protette dalla lanterna, e spegnerle un paio di volte. Il dolce frinire di grilli riempiva la notte. Anche Vittore, che aveva cominciato la serata tutto cupo, si lasciò andare a qualche complimento, cosa davvero inusitata per lui. Disse a Flaminia che sembrava Diana, incorniciata da uno spicchio di luna, e a Fosca che una ninfa dei boschi non poteva essere più bella di lei. Solo Clelia non ricevette uno dei suoi complimenti, ma la fanciulla non sembrò soffrirne, quasi sollevata di non essere al centro delle attenzioni di quel cavaliere. Era ormai profonda la notte quando tornarono nella vecchia casa di Valdenoghèr. Vincenzo era contento e tranquillo come non era stato da tempo. Era come se la giovinezza dei suoi amici avesse cominciato a scorrere di nuovo anche nelle sue vene. Sogni e desideri da lungo tempo dimenticati cominciavano a riaffiorare nella sua mente. Non sarebbe certo riuscito a prendere sonno in una notte come quella. Lasciò che gli altri si ritirassero nelle loro stanze e poi uscì di nuovo, per assaporare da solo l’aria tiepida e profumata di quella notte. Improvvisamente un lontano rullio di tamburo attraversò l’aria e sembrò anch’esso piegare da un lato la fiammella che si sprigionava dalle candela di cera che teneva in mano. Il rumore divenne a poco a poco più chiaro. Era ritmico e ossessivo, e non cessava. Vincenzo si sentì trasportato di colpo nell’atmosfera fatata di tanti anni prima. Un pallido quarto di luna illuminava i prati e le case. L’aria sapeva troppo di erba tagliata e profumo di fiori per far nascere pensieri paurosi. Il rullio, poi, veniva dalla parte di Farra e non dai boschi che si stagliavano 13 oscuri e silenziosi alle sue spalle, in lontananza. Vincenzo procedette sotto le stelle che punteggiavano d’argento il cielo. Le sagome scure delle case gli torreggiavano intorno ma nessuna luce brillava, mentre il rullio continuava ritmico e incessante. Attraversò un paese che sembrava addormentato e andò avanti per scoprire l’origine di quel suono misterioso. In lontananza il vecchio noce si ergeva ancora, scheletrico verso il cielo, ma furono le sagome scure che si muovevano ai suoi piedi che lo spinsero a nascondersi tra le ultime betulle, in modo da poter guardare e sentire senza essere visto. Molte persone stavano immobili attorno al grande albero. Dopo un po’ il tamburo si fermò e ci fu silenzio. Una voce di donna cominciò a parlare: «Questa sera la nostra società si riunisce per celebrare un momento importante. Questa sera non vi insegnerò, come le altre volte, le virtù delle piante o come guarire i malati. Questa sera dimentichiamo l’interpretazione dei segni del cielo. Dobbiamo riunire le nostre forze per difendere i raccolti e tener lontano chi ci vuole male. Sorelle e fratelli è giunta l’ora. Siete pronti?» «Siamo pronti.» «Siete venuti tutti? Avete rispettato l’accordo?» «Lo abbiamo rispettato.» dissero le ombre che stavano attorno all’albero. «Se avete rispettato il vostro patto allora anche la natura rispetterà il suo. C’è qualcuno che si oppone?» Tutti tacquero. «Volete siglare un nuovo patto per la prossima stagione?» chiese ancora la voce. «Lo vogliamo.» rispose il coro. «Ecco dunque il dono che anche quest’anno vi viene concesso. - fece la voce prendete questa verga di nocciolo, essa vi consentirà di farvi riconoscere dalle forze più segrete della natura e farle agire a vostro vantaggio.» Un nera processione cominciò ad avvicinarsi alla donna che stava ai piedi dell’albero. Ciascuno riceveva dalle sue mani un oggetto e quindi tornava a prendere il suo posto nel cerchio. Quando tutto fu finito si alzò dalla radura un canto strano, che ricordò per un momento a Vincenzo un’altra canzone che aveva udito tanto tempo prima, presso una polla d’acqua, in un magico boschetto. Il tamburo riprese a suonare la sua marcia e le figure nere di uomini e donne si mossero in circolo attorno al noce seguendo con i passi il ritmo della musica che si faceva sempre più ossessivo. Vincenzo, al riparo degli ultimi arbusti sul limitare della radura, era senza fiato e senza parole; osservava sconvolto quello strano rito che gli si presentava come una copia sbiadita e perversa di un’altra notte, ben altrimenti fatata. Fu proprio il contrasto tra ciò che ora vedeva e quanto ricordava del passato a fargli pensare che il rito cui aveva un giorno assistito in Caotès forse non era stato un sogno. Allora gli animali erano risorti per volere della fanciulla delle acque e la natura era improvvisamente rifiorita al tocco della luce iridata che da lei proveniva. Eppure ciò era avvenuto in un’altra stagione, a fine febbraio, mentre ora si era la fine di 14 giugno. Come aveva detto Vittore era la vigilia di San Giovanni ed era una notte magica. Dopo qualche tempo qualcuno si accasciò a terra, esausto, ma il tamburo continuò a battere. Poco dopo quanti erano attorno al noce si riunirono ancora a formare come una processione. La donna che aveva parlato guidava quella schiera di ombre. Fecero un ampio giro, attorno alla radura. Vincenzo rimase immobile, al riparo tra gli alberi e gli arbusti per non essere visto. Alcune di quelle sagome scure mostrarono finalmente il loro volto e li riconobbe. In testa vi era Catina che tanti anni prima, appena fanciulla, aveva fatto da serva in casa del signor Alessandro. C’erano poi Stefano, Anna e Rosa, dai riccioli biondi, e altri volti noti, ma non c’erano né Maria né Simone, morti ormai da tanti anni, e neppure la dolce Aurora, che un giorno aveva visto le fate danzare ad All’Ò. Finalmente quella cupa compagnia si sciolse e tutti ripresero la via del ritorno. Alcuni si diressero verso Farra, altri verso le case di Valdenoghèr. Il cielo stava ormai schiarendosi nella pallida luce del crepuscolo e anche Vincenzo rientrò, preoccupato, nella vecchia casa di pietra dell’Alchimista. 3. Gita in Valturcana Nei giorni seguenti Vincenzo continuò a pensare con apprensione a quanto era successo. Continuava a chiedersi se ciò che ricordava di aver vissuto con l’ingenua fiducia dell’infanzia fosse stato realtà o sogno. Cominciò allora a porre qualche domanda, timidamente e come per caso, alla gente del villaggio; le risposte lo convinsero quasi del tutto che esisteva davvero una terra incantata, dove solo i bambini e i pazzi potevano penetrare. Intanto Fosca, che aveva preso freddo, stette male e Clelia andava avanti e indietro, dividendosi tra la malata e gli amici. Flaminia, come al solito, si annoiava e bisognò accompagnarla a vedere i campi e i boschi, almeno quelli più vicini, visto che non si poteva stare via tutta la giornata. Vittore cominciò a rovistare tra i libri del nonno, che Celeste aveva accuratamente spolverato e disposto in ordine negli scaffali, e dopo un po’ sentì la necessità di discutere con i suoi due compagni di botanica, medicina e di varie altre materie. Alcuni di quei tomi non gli erano piaciuti affatto, racchiudevano un sapere che non era in linea con le direttive della Chiesa e per sostenere tale tesi cercava l’appoggio di Vincenzo e di Almorò. Ebbe da ridire anche sul fiore azzurrino che stava in un angolo della biblioteca: non ne aveva mai visto uno simile, né lo aveva trovato descritto nei trattati che aveva consultato quindi, necessariamente, non esisteva ed era fatto di carta. Vincenzo preferì non dire niente ma gli venne in mente come anche suo nonno avesse sempre cercato, a suo modo, una spiegazione razionale in tutto: eppure, in un giorno ormai lontano, aveva colto un fiore come quello d’impulso, fidandosi di leggende e sogni che non appartenevano al suo mondo. 15 L’atmosfera cominciava a divenire pesante. Fu Clelia che a un certo punto decise di intervenire, rispolverando il progetto che aveva fatto appena arrivata, quello di una gita nella valle vicina. «Vincenzo, come hai detto che si chiamava quella valletta piena di fiori? Aveva un nome particolare, che sa di paesi lontani.» «Valturcana, intendi?» le rispose il suo ospite. «Proprio quella. Domani faremo una camminata fin lì. Fosca ormai sta bene e il tempo si è rimesso del tutto. Servirà ad allontanare le ombre che vedo sui vostri volti.» Vincenzo pensò che tanto valeva assecondarla. Era sicuro che il giorno dopo ci sarebbe stata tempesta come era già successo. Contrariamente a ogni più nera previsione invece splendeva ancora il sole. Non c’era una nuvola in cielo e gli amici partirono finalmente per la gita così a lungo progettata. Presero un paio di cesti, dove misero pane e formaggio, salame e vino. Poi si allontanaro assieme andando verso la casa di Jacopo. Il tragitto non avrebbe dovuto richiedere più di una mezz’ora. Dopo una decina di minuti però Fosca si ricordò di aver dimenticato a casa il velo per coprirsi la testa che in una giornata limpida come quella era assolutamente necessario per evitare un colpo di sole, corse quindi giù a riprenderlo e bisognò aspettarla un bel pezzo. Poco dopo una vespa cominciò a ronzare attorno ai capelli biondi e profumati di Flaminia; quell’odore doveva avere per la creatura alata un fascino speciale se l’attirava in quel modo e solo dopo vari strilli, urla, e imprese guerresche dei giovanotti si riuscì ad avere la meglio su un siffatto mostruoso avversario che alla fine giacque al suolo, sconfitto e schiacciato. Ripresero a camminare di lena quando Clelia mise la sua scarpetta leggera su un po’ di fango che bagnava il sentiero: la caduta che fece fu epica, la sua gonna azzurra si macchiò di verde mentre i tre cavalieri si precipitavano in suo soccorso, sollevandola di peso e ponendola a sedere su masso vicino. La ragazza era incerta tra le lacrime, per il male della caduta, e il riso, per il comportamento buffo dei suoi salvatori, che decisero infine di portarla in braccio per un po’, almeno finché fosse scemato il dolore per quel volo imprevisto. Vincenzo e Almorò intrecciarono allora le loro mani per creare una specie di trono per l’infortunata fanciulla. Poi fu la volta di Vittore, che scorse in una radura vicino al sentiero un bel esemplare di digitale, una pianta mai vista in Veneto. Un suo amico era riuscito ad averne dei fiori secchi che venivano dal nord della Francia. Precisò che se ne faceva una droga purgante, emetica, emmenagoga, che serviva anche per curare le ferite ed era estremamente importante averla. Lasciò quindi il gruppo per raccogliere quella pianta che aveva una cascata di petali di un bel color cremisi, con tanti puntini di porpora. Ritornò trionfante con il suo trofeo in mano i cui fiori, simili a ditali, contrastavano in modo ridicolo con il rosso carota dei suoi capelli. A poco a poco sembrò quasi che lo spazio si dilatasse mentre il tempo scorreva veloce. Una passeggiata di mezz’ora si trasformò in più di tre ore di cammino e 16 quando arrivarono nei pressi della casa di Jacopo il sole era alto nel cielo e le gole riarse. Bisognò fermarsi per avere un po’ di refrigerio all’ombra dei primi abeti. Vincenzo si mise a chiacchierare con il padrone di casa, ricordando i tempi lontani. Jacopo era ora un contadino solido e taciturno, che sembrava far fatica a parlare, soprattutto con un gran signore, come gli appariva ora il suo antico compagno di giochi. «Non ho più visto Aurora, la madre di tua moglie.» disse a un certo punto. «È morta anni fa, improvvisamente. Era ancora giovane. L’abbiamo pianta tutti.» «E il Matt? Non l’ho visto né ho sentito alcuno che lo nominasse.» «Quello è sparito da tanti anni. Ormai nessuno ne parla più e tutti evitano anche di recarsi presso la casa, ormai in rovina, dove un tempo abitava. Un giorno, pressappoco all’epoca in cui anche lei andò via - continuò Jacopo - lo si vide arrivare a casa mia tutto scarmigliato e urlante. Era fuori di senno. Diceva di aver incontrato un grosso lupo grigio che voleva azzannarlo. Continuò così a delirare per giorni e giorni. Alla fine si riprese un po’ e allora si fece accompagnare da mio padre fino alla sua capanna, raccolse quelle poche cose che aveva e andò via, dicendo che questi luoghi sono maledetti e che don Floriano aveva ragione. Non è più tornato in paese.» A Vincenzo tornò in mente uno degli ultimi giorni che aveva trascorso lì da bambino, quando lui stesso aveva preso le sembianze di un lupo per difendere una ragazza. Ogni giorno che passava quell’azzurra visione assumeva sempre più, nella sua mente, le fattezze di Clelia. Scherzi dei ricordi, pensava. Comunque all’idea che il Matt fosse fuggito a quel modo dal paese provò un senso di colpa. Pensò che forse era stato lui a farlo impazzire. «Qualcuno mi ha detto che si è fatto cappuccino. - intervenne Iris, la moglie di Jacopo, che stava in disparte ad ascoltare - Pensate un po’, proprio il Matt, che vedeva spiriti ovunque… farsi frate…» Iris era ormai una donna fatta, una contadina che lavorava da mattina a sera, dividendosi tra la casa, i figli e i campi, eppure nel suo sguardo vi era ancora traccia della bimbetta ritrosa che Vincenzo aveva conosciuto in tempi lontani, sempre attaccata alle gonne di sua madre o delle sue due sorelle maggiori. «Beh, abbiamo visto anche noi tante cose strane, vero Jacopo?» disse Vincenzo al suo vecchio compagno il quale lo guardò come se anche lui fosse uscito di senno. «Noi? - fece - Io non ho mai visto uno spirito in tutta la mia vita e ringrazio il cielo per questo.» Vincenzo pensò che anche lui come Celeste non ricordava più nulla di quanto era accaduto tanto tempo prima. Sospirò: «Volevo dire che anche noi abbiamo fantasticato su spettri e mostri, tanto tempo fa. Comunque speriamo che anche il Matt abbia trovato il suo posto nel mondo.» 17 «Già e speriamo che abbia trovato almeno un po’ di pace - concluse Jacopo - in questi luoghi non avrebbe fatto altro che dannarsi l’anima, davvero.» Vincenzo pensò che il suo vecchio amico aveva ragione. Gli comparve davanti agli occhi l’immagine del Matt come quando percorreva solitario la Valturcana, incerto tra due mondi e due realtà diverse. Doveva essere stato difficile vivere in quella zona di confine, respinto da una parte e dall’altra, incapace di comprendere quanto avveniva dinanzi ai suoi occhi. Forse Vittore aveva ragione: bisognava trovare il significato di tutti gli strani episodi che lui stesso aveva vissuto con l’incosciente innocenza di un bambino. Ripensò ai libri che aveva letto ma in nessuno di essi si trovava una spiegazione logica: vi erano dotti trattati che descrivevano strani animali oppure uomini con la testa di cane o piante misteriose ma solo nelle poesie si trovavano valli incantate e fiorite di mille colori, dove abitavano fate delle acque e cavalieri verdi che combattevano contro grandi draghi alati. Vincenzo si ritrovò a pensare a ciò che gli aveva detto un giorno la grande pietra: lo aveva pregato di spezzare il sigillo che li legava tutti. Rinfrancata dalla breve sosta la compagnia proseguì per una radura poco distante. Due sentieri conducevano lì e Vincenzo e Almorò fecero a gara a chi vi arrivava per primo. Vinse Vincenzo che aveva preso il sentiero che piegava leggermente a destra; l’altra via, che pure a vederla sembrava più rapida, faceva una lunga curva ed era evidentemente la più lunga. Ci si sedette all’ombra di un gran masso che, chissà come, era rotolato sin lì, e si diede finalmente mano alle vivande. Dopo mangiato, un lieve e dolce torpore invase l’aria. Come per reagire Almorò si alzò per esplorare la radura. Aveva appena fatto qualche passo che un oggetto che spuntava tra i sassi attirò la sua attenzione. Si mise a scavare con un bastone che aveva trovato lì vicino. Con un po’ di fatica uscì dalla terra una corta spada, quasi un coltello. Non fu però l’unica scoperta che fecero quel giorno, con grande stupore di Vincenzo che pure era passato e ripassato tante volte da quelle parti senza tuttavia mai notare nulla. Un po’ alla volta dalla terra uscirono elmi, lance, pezzi di fibula, delle rozze staffe e degli archi stranamente ricurvi, come dei gigli a cui mancasse solo la freccia al centro per trasformarsi in un fiore completo. Vittore, con la sua aria sapiente, cominciò a discettare su quei luoghi e sulla loro storia. Il nome del paese poco lontano era Farra e ciò stava a significare un antico insediamento longobardo. Una fara era infatti ciascun gruppo familiare gentilizio in cui quel popolo era suddiviso e anche l’insediamento dove tale famiglia abitava. Nulla di strano quindi che alcuni di quegli antichi barbari si fossero arrampicati fin lassù dove magari avevano incontrato un altro popolo con cui erano venuti a contesa, altri longobardi o chissà quali genti. Tra i pezzi di ferro saltò fuori anche qualche osso umano e gli amici si resero conto in quei luoghi, secoli e secoli prima, si doveva essere svolta una grande battaglia e, forse, erano stati sepolti alcuni degli uomini che l’avevano combattuta. 18 Le ragazze stavano svogliate al margine della radura. Non avevano voglia di sporcarsi le mani per raccogliere vecchi pezzi di metallo. Fosca sonnecchiava quando una farfalla si posò sul suo abito giallo. Era una di quelle bianche, che si vedono spesso nei campi, ma subito dopo ne arrivò un’altra di un bel colore rubino e con delle striature nere. Altre stavano poco distante e la fanciulla si alzò per prenderle. Quelle si mossero solo di poco ed ella fece ancora dei passi. Senza accorgersi si allontanò dirigendosi sempre più avanti, tra l’erba e i fiori. Era passato qualche minuto, o forse un’ora, chissà, quando Clelia si guardò in giro e non vide più l’amica. «Fosca, dove sei?» cominciò a chiamare ma le sue parole servirono solo a ridestare Flaminia e a far volgere verso di lei i suoi amici. Si misero dunque tutti a cercarla, mentre Vincenzo assumeva un’aria scura e preoccupata. Non avrebbe dovuto permettere che quella gita neppure cominciasse. Si diressero dunque chi a destra, chi a sinistra, per esplorare i prati; Clelia sarebbe rimasta nella radura, visto che non si era rimessa del tutto dalla caduta e il piede ancora le doleva. Dopo un po’ Vincenzo tornò indietro, assieme a Vittore ed Almorò, ma Flaminia non riapparve. Ormai tutti erano veramente preoccupati anche se il sole era ancora alto nel cielo. Almorò decise di raggiungere la casa di Jacopo, per chiedere se avessero visto le due fanciulle. Vittore rimase con Clelia mentre Vincenzo si avviò con passo deciso verso la parte più nascosta del bosco che si apriva davanti a loro. 4. La casa dello spaccalegna «Fosca, Fosca… dove sei? Rispondimi per favore.» aveva cominciato a gridare Flaminia all’inizio della ricerca. Ma nessuno le rispondeva. Il bosco le faceva paura e pensò che anche la sua amica mai si sarebbe avventurata da sola da quella parte. I rovi le avrebbero certo stracciato il delicato vestito giallo che indossava quel giorno e il prezioso velo che le copriva i capelli. Così avanzò tra l’erba che si faceva sempre più alta cercando di immaginare dove mai fosse andata e perché non rispondeva. Il cielo intanto si era fatto un po’ più scuro. A un certo punto il terreno incolto lasciò il posto a un prato falciato. Di lontano si vedeva una casa colorata e Flaminia vi si diresse per chiedere notizie della sua compagna. Una bimbetta di pochi anni stava seduta sull’aia. «Mamma, mamma, c’è qualcuno.» si mise a gridare la piccola quando vide quella signora che arrivava. Una donna vestita di stracci apparve sulla soglia tenendo in braccio un lattante. «Buongiorno, signora - disse - desiderate qualcosa?» «Avete visto la mia amica, dovrebbe essere venuta da questa parte.» «Qui non capita mai nessuno, ma può chiedere a mio marito, dovrebbe essere qui a momenti. È andato nel bosco a tagliare la legna e forse lui l’ha vista.» 19 Flaminia decise di aspettare. Intanto chiese alcune informazioni. Era poco tempo che abitavano in quella casa. L’avevano costruita con le loro mani qualche anno addietro, simile a quelle che facevano dalle loro parti. Non erano infatti originari di quei luoghi. Erano poveri taglialegna che avevano accettato di trasferirsi lì, spinti dalla fame e dalla promessa di un buon lavoro nei boschi della Serenissima. L’attesa intanto sembrava farsi davvero lunga quando finalmente arrivò il marito, con una gerla carica. Neppure lui aveva vista una fanciulla dal vestito giallo e dal velo bianco aggirarsi da quelle parti. Comunque, per non mostrarsi scortese, chiamò la moglie e le disse: «Hai offerto qualcosa alla signora?» «Abbiamo della polenta.» gli rispose la moglie. «Va a prenderla allora.» Flaminia cercò di scusarsi. Non le piaceva l’idea di dover mangiare della polenta stantia in cui magari le formiche avevano fatto il loro nido. In un modo o nell’altro riuscì a rifiutare e non volle accettare neppure una mela rossa che la bambina le offriva, o un po’ d’acqua da una brocca sbeccata. Disse che non stava bene, che doveva tornare subito indietro e che si era intrattenuta in quei luoghi fin troppo. «Avete ragione - le disse l’uomo guardandola e poi volgendo lo sguardo al cielo che si stava come schiarendo - dovete andare altrimenti si fa tardi e non potrete più tornare indietro.» «Mi dispiace - gli fece eco la donna - sarebbe stato bello trattenervi qui con noi per sempre.» Senza sapere perché Flaminia rabbrividì. Salutò in fretta i suoi ospiti e corse via dalla parte da cui era venuta. Ripassò in mezzo alle erbe alte e ritrovò la radura dove si erano seduti. Non c’era nessuno e il sole stava ormai calando. Con il cuore in gola si precipitò giù per il pendio fino alla casa di Jacopo. Iris stava cullando il suo ultimo nato quando vide arrivare la signora di città, senza fiato e tutta rossa in faccia. «Dove sono i miei amici?» le chiese Flaminia. «Sono scesi giù, a Valdenoghèr, ormai da parecchio.» Tale risposta rassicurante la tranquillizzò. Si sedette un attimo su una vecchia sedia che stava sotto il portico. «Ho incontrato della gente, poco sopra, uno spaccalegna e sua moglie, li conoscete?» chiese. «Non abita nessuno da quella parte - rispose Iris - ci sono solo prati e poi la costa scende giù dritta.» Flaminia non rispose ma rimase senza fiato. Disse che non conosceva bene la strada che conduceva a casa e, quando Jacopo ritornò, si fece accompagnare fino a Valdenoghèr. 20 5. Gli spiriti inquieti Clelia e Vittore rimasero dunque soli ad aspettare, estremamente preoccupati per quello che poteva essere accaduto a Fosca e Flaminia. Era improbabile che avessero incontrato qualche persona male intenzionata. La via che arrivava sin lì era una sola e non sarebbe stato possibile nascondersi. Era forse più facile che qualche grosso animale le avesse spaventate. «Non certo quell’oca. - disse Clelia che aveva scorto una macchia bianca che si muoveva in fondo alla radura. - Ehi, ehi, ehi, vieni qui, vieni qui.» L’oca si accostò alla ragazza e cominciò a beccare qualcosa tra le pieghe della sua gonna. «Sei davvero simpatica, sai? - continuò Clelia facendo scorrere la mano sulle penne dell’animale - proprio una brava oca, bella e fiera.» Quelle parole dovevano certo aver fatto piacere al volatile che si strusciò con la testa sul vestito di lei. «Vai via, cosa cerchi qui? - disse Vittore - non c’è nulla da mangiare.» L’oca lo guardò un momento da sotto in su e poi, come affascinata dai colori della pianta di digitale che Vittore aveva appoggiato con cura vicino a sé, cominciò a beccarla. Il giovane lanciò un grido e cercò di salvare il suo preziosissimo tesoro da quella gola famelica. Tra urla e schiamazzi inseguì l’animale sino al limitare del bosco poi si voltò per tornare indietro. In cielo il sole cominciò a scurirsi come quando la luna gli passa davanti. Ormai non ne restava che una piccola falce. Ben presto sarebbe stato completamente nascosto nell’ombra e sarebbe calato il buio. Vittore si guardò intorno cercando di indovinare i contorni delle piante. Dalla terra saliva verso l’alto una nebbia biancastra, impalpabile e brillante che ben presto prese la forma di uomini. Non erano i cavalieri delle leggende arturiane che avevano rievocato qualche giorno prima. Erano barbari vestiti di pelle e portavano spade come quelle che avevano appena dissotterrato proprio in quella stessa radura. Altri, vestiti più miseramente, lavoravano per seppellire i morti di una recente battaglia. «Quid vis, bone homo?» gli disse uno di questi. Parlavano in latino! Lo stupore di Vittore si fece ancora più grande. «Chi siete? e cosa fate?» chiese loro nella medesima lingua. «Siamo dei poveri schiavi. Ora il nostro compito è seppellire questi morti, prima del calar del sole, e piantare qui quella pietra. Così vuole il capo, Aldoino.» «È stata davvero una bella battaglia - gli fece eco un compagno - degna di essere tramandata ai posteri. I longobardi hanno vinto e gli unni bianchi sono stati tutti distrutti. Ma per noi che vincessero gli uni o gli altri non era importante. Anche se possiamo dire di essere cittadini romani, ormai siamo solo degli schiavi.» «Lavora e taci. - brontolò un altro - Altrimenti se la prendono anche con noi.» Tutti ripresero con lena il lavoro, senza più curarsi di Vittore. Una decina di loro, a 21 forza di braccia e con notevole sforzo, riuscirono a innalzare una grande pietra che era stata fatta rotolare fino a lì. Alcuni cavalieri in armi passarono vicino, al galoppo. Per evitare di essere calpestato dai cavalli Vittore fece qualche rapido passo indietro. Lentamente quella visione inquietante cominciò a sfocarsi, come risucchiata dalla terra, lasciandolo pallido e titubante. «Cosa fai lì? Vittore, muoviti, sembri una statua.» la voce di Clelia lo chiamava dall’altro lato della radura. «Hai visto l’eclissi? Guarda! fa ancora buio.» le chiese. «Visto che? Quella nuvola davanti al sole?» «No, il sole che scompariva e tutti quegli spiriti che si muovevano nella radura.» «Non ho visto proprio niente. - lo rassicurò la ragazza - Sei sicuro di non aver preso troppo sole oggi? Te ne è restato il colore nei capelli.» «Non ho preso sole e poi succedono troppe cose strane qui. - continuò Vittore Forse è meglio tornare indietro, almeno sino alla casa di Jacopo.» «Ma non è il caso. Abbiamo detto che avremmo aspettato gli altri.» «Gli altri sapranno cavarsela e poi Almorò e già andato giù. Vieni, ti aiuto.» Clelia non era molto convinta ma Vittore si mostrò irremovibile. Se lei non voleva il suo braccio, pazienza, sarebbe sceso, lasciandola lì ad aspettare Vincenzo. La ragazza rifiutò sdegnosamente la compagnia di uno che prima si metteva a combattere con un’oca e poi vedeva spiriti e fantasmi dove invece c’erano solo piante ed erba. Vittore prese ciò che restava della sua preziosissima pianta e cominciò a scendere. Era già avanti quando Clelia si decise finalmente a seguirlo. 6. Un lupo nel bosco Clelia era rimasta indietro mentre il suo compagno dai capelli rossi camminava veloce e indignato verso la casa di Jacopo. Al bivio piegò verso destra ma la ragazza che lo seguiva da distante decise di prendere l’altra via. Quello era il sentiero percorso da Vincenzo all’andata. Sarebbe arrivata prima di Vittore alla casa di Jacopo, nonostante la caviglia le facesse ancora male. Si inoltrò tra l’erba ma dopo qualche tempo si rese conto che forse aveva sbagliato strada. Tornò indietro a fatica, tra le felci che sembravano farsi sempre più grandi mentre del sentiero non vi era più alcuna traccia. Il suo vestito azzurro si impigliò a un ramo e dovette fermarsi per liberarlo. Non riusciva a capire come aveva fatto a perdersi così facilmente e si diede mentalmente della stupida. Il respiro caldo della natura avvolgeva ogni cosa. A un certo punto il cielo si fece ancora più scuro. «Che strano! un’altra nuvola!» si disse Clelia. 22 Sembrava quasi che il tempo si fosse fermato, immobile ad aspettare. Tutto era silenzio. Anche i grilli tacevano. Clelia si guardò intorno. Era tutto così simile, eppure così diverso da dieci minuti prima. Scostò i rami bassi di un albero che si ergeva davanti a lei. Un ragazzino era in piedi, fermo a pochi passi di distanza. Colpito dal rumore si volse a guardare dalla sua parte. Aveva un’aria stupita, come se non si aspettasse di vedere qualcuno in quel luogo. Doveva essere uno dei giovani del paese, che magari andava a prendere le bestie che stavano al pascolo. Clelia gli sorrise. Trovare qualcuno l’aveva tranquillizzata. «Salve - disse - mi sono persa. Puoi aiutarmi a ritrovare la via per Valdenoghèr?» «Sì, certo, è da quella parte.» balbettò il ragazzo indicando con la mano la via da dove era venuto. Con l’altra teneva un fagotto fatto di stracci. «Sei molto gentile. Grazie.» disse Clelia, stupita che quelle parole non fossero state dette nel dialetto del paese ma in veneziano. Forse era un parente di Vincenzo, infatti un poco gli assomigliava. Si volse dunque e proseguì decisa, quasi dimentica del dolore al piede. Il sentiero indicatole procedeva tra l’erba e i sassi, incorniciato da alti abeti e betulle argentee. Poco dopo si accorse di un uomo, fermo non troppo lontano, che la stava fissando. Decise di far finta di non vederlo, per non essere importunata, ma quando gli passò vicino quello si fece avanti. «Finalmente ti ho trovata.» disse in un sussurro, prendendola per un braccio. Il cuore di Clelia sembrò fermarsi un istante e improvvisamente la prese una grande paura. Lanciò un grido e cominciò a scappare, ma l’altro la raggiunse facilmente. «Lasciala stare. Cosa vuoi da lei?» era la voce di un salvatore. Il ragazzino di poco prima stava arrivando di corsa. «È una fata, finalmente… - disse il suo aggressore fuori di sé - … finalmente ne ho trovata una e puoi star certo che questa non me la lascio scappare.» Afferrò per un braccio Clelia che cercò di divincolarsi con tutte le sue forze, anche se l’impresa era impari. Improvvisamente un lupo grigio uscì dal folto del bosco e con un ringhio di battaglia si gettò contro l’uomo e lo azzannò. Rotolarono per terra, poi questi riuscì ad afferrare un pezzo di legno e a colpire l’animale, che mollò la presa con un latrato di dolore. L’uomo approfittò di quel momento per allontanarsi di corsa. Clelia si appoggiò con la schiena ad un albero per non cadere. Il lupo si fermò in mezzo al bosco. Allungò le zampe anteriori come per sentire meglio il terreno, poi alzò il muso a fiutare l’aria. Qualcosa doveva aver attirato la sua attenzione. Non degnò di uno sguardo la ragazza, che pure tremava come una foglia, quasi incapace di respirare. Si volse verso il monte e cominciò a correre, spinto da un invisibile richiamo. Clelia riprese fiato. Si volse sperando di scorgere il suo giovane salvatore ma tutto era immobilità e silenzio intorno a lei. L’aria era ancora calda e sapeva di foglie cadute, resina e muschio. Per terra, abbandonato tra i sassi, giaceva il fagotto che poco prima il ragazzo aveva tenuto in mano. Si chinò e lo raccolse. Una macchia 23 bianca, che si muoveva poco lontano, attirò la sua attenzione. Era la candida oca con cui aveva fatto amicizia alla radura, poco prima. L’animale si avvicinò, beccò qualcosa ai piedi della fanciulla, e quindi, starnazzando, proseguì per il pendio. Clelia decise di seguirla. Apparteneva certo a qualche contadino dei dintorni e come ogni brava oca doveva conoscere la strada di casa. Il sole intanto illuminava di nuovo trionfante i monti intorno. Poco dopo riconobbe il bivio che stava nei pressi della casa di Jacopo. Vittore stava arrivando proprio allora dall’altra parte. 7. La comparsa di un vecchio amico Vincenzo intanto si era diretto verso il folto del bosco. Non sapeva neppure lui dove cercare Fosca e Flaminia. Erano persone adulte e se quei posti erano davvero preda della magia, come ormai sospettava, non sarebbero dovute neppure poter passare di lì, ma poi pensò a Maria, Aurora e anche a sua nonna. Forse anche loro erano state ammesse, per qualche arcana ragione, in quei luoghi incantati. Il suo compito era cercarle ovunque si fossero dirette. Si domandò se anche lui avesse ereditato quella ignota qualità che aveva consentito a Mavì Hatùn di recarsi in quei boschi. Improvvisamente il sentiero che conduceva in Valturcana gli si aprì davanti come per invitarlo a entrare. Le betulle luccicavano argentee al sole. La giornata era davvero limpida e quei luoghi conservavano intatto il fascino di un tempo. Ripensò alla nonna che, ormai più di mezzo secolo prima, soleva passeggiarvi. Ripensò alle verdi foreste del Caspio in cui era stato e alle tribù che aveva incontrato. Tra tutti gli stranieri che aveva conosciuto gliene tornò allora in mente uno solo. Era un vecchio, scavato dal sole e dal vento, che lo aveva accolto una sera nella sua misera tenda, quando sfinito cercava di fuggire agli emissari del sultano turco che volevano la sua vita. Senza una parola lo aveva preso per mano e gli aveva offerto del cibo. «Vedo intorno a te un alone luminoso - gli aveva detto il vecchio - era tanto tempo che ti aspettavo.» Poi avevano parlato. Era stata una strana conversazione la loro, fatta più di silenzi che non di parole dette o sussurrate. Quel vecchio era uno sciamano, un uomo di religione tra quei nomadi, e aveva cercato di spiegargli la pace che si prova quando si viene a contatto con il Cielo Azzurro, la disperazione senza ritorno causata dall’alleanza con le potenze malvagie che percorrono il mondo degli uomini e infine ciò che non si può raccontare: una volta superato il limite, l’unione profonda con l’essenza stessa del creato che rende inesistente lo spazio e vano il tempo e fornisce una comprensione più profonda delle leggi che regolano l’universo. «Per superare il limite, però, - gli aveva anche detto - bisogna trovare un animale che ti guidi e ti aiuti nella tua ricerca. Dovrai carpire la sua forza e la sua essenza. Solo così potrai compiere ciò che veramente vuoi e realizzare il tuo sogno.» 24 Vincenzo allora non aveva dato peso alle parole del vecchio; era troppo intento a nascondersi per sfuggire ai suoi nemici e salvare così la vita e la missione di cui era stato incaricato da parte del Consiglio di Dieci. Ora gli tornavano in mente. Aveva bisogno di una guida per ritrovare Flaminia e Fosca e, forse, anche per compiere ciò che qualcuno si aspettava da lui. Pensò all’animale in cui, fanciullo, si era trasformato e al lupo nero con cui aveva stretto un patto. Era quello il suo animale guida? L’altra faccia della sua duplice natura? Due vividi occhi lo stavano, infatti, fissando da dentro una macchia di erbe e rovi. Si avvicinò cauto, con il cuore che batteva forte. L’incanto esisteva davvero e quindi quello che stava vivendo - pensò – non era sogno bensì realtà. Due zanne ricurve si fecero largo tra i pruni e l’allegra voce di Lug, il cinghiale, risuonò di nuovo nel bosco. «Ohilà, guarda chi si rivede? Vincenzo! Come stai? Ancora da queste parti, eh?» Il muso dell’animale era buffo e simpatico e tutta la tensione provata fino a quel momento si dissolse. Vincenzo aveva ritrovato un vecchio amico, un po’ impertinente forse, ma certo a conoscenza di molte cose. Lug era ben diverso dal lupo nero cui si poteva forse ricorrere quando c’era bisogno di forza e violenza, ma che comunque faceva sempre un po’ paura. «Allora, cosa ti spinge in questi luoghi ameni?» gli chiese il cinghiale. «Ho perso due fanciulle, si chiamano Fosca e Flaminia; le hai per caso viste?» «Ti hanno lasciato solo? È davvero un bel guaio. - disse Lug con il tono con cui un padre si rivolge a figliolo un po’ sbadato. - Comunque può capitare in momenti come questo. Non vedi che il sole si sta oscurando?» Effettivamente il cielo non appariva più dell’azzurro luminoso di prima e un’ombra scura stava coprendo il sole. «Cosa vuol dire? Che cosa accade?» chiese Vincenzo, di nuovo preoccupato. «Ecco, in certi momenti molte cose possono succedere e ti può capitare di andare dove non vorresti. Quando il sole diventa nero in pieno giorno, il tempo non corre più come dovrebbe, soprattutto sul limitare di posti come questo. Qui esiste solo il tempo eterno della natura, dove il ciclo delle stagioni si ripete all’infinito sempre uguale a se stesso. Poco più in là, invece, c’è il tempo degli uomini, che procede a balzi, ed è molto, mooolto più disordinato, come voi tutti, del resto!» concluse il cinghiale, scuotendo il suo muso setoloso. «E le ragazze dove possono essere ora? - riprese Vincenzo - sono sparite e visto che questi luoghi sono un po’ strani…» «Non c’è niente di strano, qui - disse l’altro - sei tu ad essere strano. Prova a metterti dal mio punto di vista.» Vincenzo non seppe che cosa rispondere. «Non ti preoccupare, via! Stanno già tornando a casa e tu sei rimasto indietro.» «Devo crederti?» «Certo che devi credermi. Ti ho mai mentito?» Vincenzo pensò ad una bella mela rossa che gli aveva regalato la febbre. 25 «Mentito proprio no, ma forse, ecco, sei stato zitto quando invece potevi darmi qualche avvertimento.» «Ai giovani non piace essere avvertiti. Vogliono provare tutto in prima persona. - disse Lug - Se ti avessi avvertito mi avresti detto di pensare ai fatti miei e il risultato sarebbe stato lo stesso.» Vincenzo chinò la testa, proprio come avrebbe fatto davanti a suo padre, anche se ormai tra i suoi capelli vi era qualche filo bianco. «Se vuoi puoi darmi avvertimenti, ora. Ti prometto che li terrò nella debita considerazione.» «Bene, bene - fece Lug - vedo che cominci a ragionare. Sei sulla buona strada e poi, devo dire, che, dopo tutto, mi sei simpatico. Vedremo cosa si può fare con te. Per ora, se mi sali in groppa, ti riporto a Valdenoghèr, come abbiamo fatto una volta.» «E gli altri?» chiese dubbioso. «Sei un testone. Ti ho appena detto che ormai saranno già tutti a casa. Chi è che aveva promesso di seguire i miei consigli?» Vincenzo preferì non replicare e montò in groppa al cinghiale che prese a correre veloce, come se non sentisse il suo peso, mentre il sole del tramonto, di nuovo luminoso, tingeva tutto di rosa. 8. Corvi, colombe e farfalle Quando si separarono Almorò percorse in fretta il breve sentiero che portava alla casa di Jacopo. Chissà che Flaminia e Fosca non si fossero dirette da quella parte e stessero ora sedute comodamente sotto il portico assieme a Iris. Il pensiero era confortante ma non ci sperava molto, comunque. Quando arrivò, infatti, non c’era nessuno. Il sole era alto nel cielo e probabilmente erano ancora tutti nei campi. Si fermò quindi incerto sul da farsi. Un corvo intanto lo stava osservando dal tetto del fienile. Raccolse un sasso e glielo tirò, così senza sapere il perché. Intanto una bianca colomba volava attorno la casa. Dopo pochi minuti sentì le voci di Jacopo e di un paio dei suoi figli che tornavano a casa. Seguirono domande e dinieghi. Nessuno aveva visto le due ragazze. Almorò stava pensando di tornare indietro quando videro salire tranquilla, dalla parte di Valdenoghèr, la smarrita Fosca. «Ehi, dove sei stata? Ci hai fatto penare davvero?» le disse il giovanotto quando se la vide dinnanzi. «Come? sono io che vi faccio penare? Siete voi che siete tutti spariti all’improvviso. Vi ho cercato dappertutto e sono persino arrivata fino a casa, a Valdenoghèr, ma nessuno vi aveva visto.» Almorò rimase interdetto. Era stata Fosca ad andarsene e non viceversa. Cominciarono quasi a litigare e il viso della ragazza si atteggiò al pianto. 26 «È vero - ammise alla fine - mi sono assentata un momento, ma solo per seguire una bellissima farfalla rossa e quando sono tornata non c’era più nessuno.» In quel mentre videro arrivare giù dal sentiero Vittore, che camminava impettito e rigido con una malridotta pianta di digitale in mano. Il suo viso era rosso quasi quanto i suoi capelli. Clelia lo seguiva sfinita, saltellando su un piede solo. Almorò si precipitò ad aiutarla e lei si lasciò andare tra le sue braccia, evidentemente stanca per tutta la strada che aveva percorso a quel modo. Il viso di Fosca si fece serio serio a quella scena e delle lacrime vere le scesero lungo le gote. Vincenzo e Flaminia mancavano però ancora all’appello. «Perché non torni indietro alla radura?» fece Almorò a Vittore. «Non credo sia una buona idea.» fu la risposta secca secca. «Dì pure che non vuoi.» disse Clelia. «Allora andrò io - concluse Almorò - e Vittore porterà la nostra malata in braccio fino a casa.» Fosca osservava ansiosa la scena. «Non desidero essere presa in braccio da un tale cavaliere, piuttosto continuo a saltellare.» strillò l’altra. Alla fine fu deciso che Jacopo avrebbe raggiunto la radura, per vedere se Flaminia e Vincenzo erano tornati, mentre loro quattro si sarebbero diretti subito verso Valdenoghèr. Con estremo buon senso Iris mandò allora il suo primogenito nella stalla, a prendere l’ asino: sarebbe stato un viaggio più agevole per tutti se Clelia vi fosse salita in groppa. Si avviarono dunque verso casa, ancora preoccupati per la sorte dei due compagni, anche se il ritorno di Fosca aveva risollevato di molto il morale agli altri tre. Vittore era ancora rosso in viso e procedeva impettito, come prima. Almorò invece portava per la cavezza l’asino su cui si trovava Clelia, che appariva pensierosa e preoccupata. Teneva con una mano un cesto di vimini dove aveva deposto il fagotto di stracci che aveva portato con sé. Dall’altra parte dell’animale si mise Fosca che, per la prima volta nella sua vita, desiderava tanto parlare e dire cose interessanti ma riusciva solo a balbettare qualche insulso sì o no. Più tardi, quella sera, ritornarono anche i due amici che mancavano all’appello. Prima arrivò Flaminia, accompagnata da Jacopo, e infine ricomparve anche Vincenzo. Quella gita, cominciata sotto un sole splendente, era finita in un modo molto diverso da come ciascuno di loro aveva immaginato. 9. La stanza turca Fu solo il giorno dopo che ci furono le prime spiegazioni. Sin dal mattino la giornata non prometteva niente di buono. Nubi minacciose correvano il cielo e un vento freddo spazzava le montagne. Si era ormai ai primi di agosto ma il clima era ben diverso da quello afoso che ci doveva essere allora a Venezia. Così si riunirono tutti 27 ancora una volta nella stanza turca per scambiarsi qualche idea su quello che era avvenuto il giorno prima. La prima conclusione a cui si giunse era che quel luogo era davvero strano. Era vero dunque che non tutti potevano penetrare nella valle, come qualcuno aveva detto. L’incanto esisteva. In secondo luogo cercarono di mettere a confronto quanto ciascuno di loro aveva vissuto il giorno prima. I tempi però non coincidevano. Mentre Fosca si era persa dietro le farfalle, era poi tornata alla radura, era scesa a Valdenoghèr e era infine risalita fino alla casa di Jacopo, Almorò aveva percorso solo un sentiero da dieci minuti e tirato un sasso a un corvo. Clelia si era persa nei boschi, come disse, vergognandosi di raccontare l’aggressione subita. Vittore aveva visto un’eclissi che, per tutti gli altri, non c’era mai stata e Flaminia aveva impiegato il pomeriggio per arrivare alla capanna di uno spaccalegna, di cui mai nessuno aveva udito parlare, e tornare indietro. «Per fortuna non hai mangiato quello che ti offrivano.» disse improvvisamente Almorò. «Certo che non potevo mangiarlo, sarei stata male per giorni. La brocca che mi avevano offerto era sporca e sbeccata. Perché hai detto ’per fortuna’?» «Stavo pensando a una leggenda che ho sentito tanto tempo fa da un vecchio marinaio, che tornava dal un viaggio con la muda di Ponente. I contadini d’Irlanda dicono che non si mangia il cibo del mondo fatato; chi lo fa non torna più indietro.» Flaminia rabbrividì. «Allora, è stata la tua fortuna essere così schizzinosa.» disse Fosca. «Taci tu che ti perdi dietro alle farfalle.» le rispose l’altra. «Non lo sai che questo alato insetto rappresenta l’anima degli uomini?» - le chiese Almorò, meritandosi uno sguardo riconoscente. «Giusto - intervenne finalmente anche Vittore - come dice Dante: non v’accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l’angelica farfalla, che vola alla giustiza senza schermi?» «Io intendevo però qualcosa di ancora più sublime - riprese Almorò fissando intensamente Fosca - essa rappresenta l’amor divinus che congiunge il celeste al mortale.» «E invece il corvo che hai visto? - gli chiese Vincenzo sorridendo - che razza di simbolo è?» «Ho pensato molto - disse Almorò, facendo finta di essere serio - e sono arrivato alla conclusione che quanto mi è successo è solo una chiara rappresentazione delle fasi dell’opera alchemica, come dicono i libri che il nostro padrone di casa tiene nella sua biblioteca. Il corvo rappresenta la fase iniziale della nigredo, o combustione della materia, che, con il fuoco, passa poi all’albedo, cioè alla calcinazione; insomma si trasforma da nero corvo in bianca colomba.» 28 «La cosa mi sembra estremamente complicata e di poca importanza, comunque ti crediamo sulla parola. - concluse Clelia tra le risate di tutti - E come possiamo interpretare l’esperienza del nostro Vittore?» «Dai, raccontaci.» fecero eco gli altri. Prima riluttante ma poi sempre più infervorato Vittore cominciò a descrivere quello che aveva visto: il sole che si oscurava, il sorgere dei morti, il suo discorso in latino con due importanti personaggi e infine il loro sparire come risucchiati dalla terra mentre la luce riprendeva a splendere. Il giovanotto ci mise in effetti un po’ del suo, per rendere più accattivante l’avventura che aveva vissuto. Aver parlato con degli schiavi non gli sembrava poi una cosa di cui vantarsi. «Non so cosa dire. - fece Almorò - Certo in questi luoghi deve esserci stata una grande battaglia.» «Ho visto degli archi simili a quelli che abbiamo trovato - disse pensoso Vincenzo - Fu qualche anno fa ed erano dei mongoli che li portavano.» «Dei mongoli a Valdenoghèr? e come ci sono arrivati? con Marco Polo?» fece Flaminia. «Forse non proprio mongoli, ma tra i vari barbari che vennero in Italia ve ne furono alcuni che avevano gli occhi a mandorla e il naso camuso proprio come loro.» continuò Almorò. «Già. Ho letto una descrizione degli unni in un libro scritto da Ammiano Marcellino: avevano per naso un’escrescenza informe e piatta, gli occhi infossati nell’orbita come in caverne, e lanciavano intorno sguardi penetranti che abbracciavano gli spazi più lontani. Insomma erano dei mostri infernali.» disse Vittore. Clelia, che stava accoccolata sul divano con il suo piede malato poggiato delicatamente sui cuscini, lo interruppe dicendo: «Tu vedi demoni dappertutto. Sono certa che anche Attila era considerato bello da sua mamma. Tutto dipende dal punto di vista.» concluse con il suo solito buon senso. Vittore le lanciò un’occhiata corrucciata. A questo punto intervenne Flaminia: «Udite, udite. Manca ancora Vincenzo. Non ci ha raccontato nulla di ciò che ha fatto ieri.» Il padrone di casa si fece pregare. Non desiderava rivelare il suo incontro con Lug su, nei boschi incantati, per cui rispose con un’altra domanda. «E tu, Clelia? Non hai raccontato cosa ti è successo, quando sei rimasta sola.» «Ho visto un lupo che annusava l’aria - rispose la ragazza, pensierosa - e un’oca molto simpatica. Con me ha fatto amicizia e ha trovato molto appetitosa la digitale di Vittore.» Il giovane appena citato divenne rosso al ricordo di quanto era successo. 29 «E quel fagotto di stracci con cui sei tornata indietro? - disse, tanto per distogliere l’attenzione dalla propria persona - cosa c’era dentro? Quando ti ho lasciato su alla piana non l’avevi.» Il volto di Clelia si fece scuro: «È un oggetto strano, che ho raccolto nel bosco. L’aveva con sé un ragazzo che ho scorto solo per un attimo; è fuggito via subito, probabilmente spaventato dal lupo, e ha lasciato cadere l’involto. L’ho preso, perché pensavo di rivederlo e restituirglielo.» disse quasi vergognosa. Tutti si dimostrarono molto curiosi, e Fosca si incaricò di andare di sopra, nella loro stanza, per prendere il cesto in cui ancora si trovava. Scese poco dopo e tutti si sedettero in circolo per guardare. Clelia, come se fosse una gran sacerdotessa, aprì il fagotto. Una coppa d’oro e pietre preziose sfavillò alla luce del fuoco che ardeva nel caminetto. Non era un oggetto qualsiasi. Era un cranio d’uomo incastonato a formare un calice. Flaminia e Fosca fecero un gesto di raccapriccio, ma Vincenzo si sentì gelare a vedere quell’oggetto che lui stesso aveva smarrito nel bosco tanti anni prima. Guardò con occhi diversi Clelia e si accorse dell’abito celeste che la fanciulla ancora portava. «Succedono cose strane in questo paese - disse Vittore, fissando il macabro trofeo - e l’autorità ecclesiastica dovrebbe intervenire e porvi rimedio.» «Per quanto strana è solo una vecchia coppa, fatta dai barbari chissà quanti secoli fa. - disse Almorò - Probabilmente il ragazzo l’aveva trovata sotterrata da qualche parte, come noi abbiamo scoperto archi e lance, e poi l’ha persa, scappando impaurito alla vista del lupo.» Sembrava la soluzione più probabile. Era ormai tardi. Tutti si ritirarono e Vincenzo rimase solo. Dal ritratto sulla parete sua nonna lo stava fissando. Allora prese la coppa, che nessuno aveva più voluto toccare, e andò in soffitta, per nasconderla ancora, come aveva fatto tanti anni prima. Tornò poi nella sua stanza. Molti ricordi gli si affollavano ora alla mente. Tornare a Valdenoghèr, rivedere i luoghi della sua infanzia, tenere ancora tra le mani quella coppa misteriosa, avevano risvegliato in lui tante memorie che erano rimaste sopite, ma mai realmente dimenticate. Prese dalla parete gli specchi che erano stati di Maria Turchese e cominciò a guardarli. A poco a poco, in quello più piccolo, che gli aveva un tempo mostrato il futuro, si formò un’immagine. Era Flaminia che stava parlando con una donna vestita di stracci, la quale teneva in braccio un bambino. «Buongiorno, signora - disse la contadina - desiderate qualcosa?» «Avete visto la mia amica, dovrebbe essere venuta da questa parte.» «Qui non capita mai nessuno, ma può chiedere a mio marito, dovrebbe essere qui a momenti. È andato nel bosco a tagliare la legna e forse lui l’ha vista.» Vincenzo si chiese come era possibile vedere quello che lui vedeva. Quello specchio gli avrebbe dovuto mostrare ciò che doveva ancora accadere e non ciò che era già stato. Pensò che il passato e il presente si intrecciavano davvero, alle volte, in 30 modo inesplicabile e che esistevano luoghi o momenti, perduti in una eterna immobilità, dove era possibile superare le barriere che dividevano il tempo e lo spazio. Fissò l’altro specchio e anche lì cominciò a comparire l’immagine di una donna che aveva già visto. Era sua nonna che con passo svelto si dirigeva verso il noce che si ergeva, ancora imponente, al limitare del paese. Salì con facilità verso la cima, aiutata dai rami che la sostenevano, come avevano fatto una volta con lo stesso Vincenzo. Lei però non si fermò, andò avanti e quando arrivò in cima si trasformò in un piccolo uccello che spiccò il volo verso il cielo azzurro. Così come era venuta la visione scomparve. 10. Il Signore di Pian delle Mosche La notizia dell’esistenza di una coppa splendente, fatta d’oro e di pietre preziose, si sparse velocemente. Fosca ne parlò con Corinna, che svolgeva le funzioni di governante nella casa degli Alessandri, e che fu felice di avere qualcosa di importante da raccontare. La notizia passò così ben presto ad Anna, la sua grande amica. In men che non si dica tutti in paese ne parlavano, con gran disappunto di Vincenzo, che avrebbe preferito tenere la cosa segreta. Lina venne due volte a trovare le amiche di città, come disse. Probabilmente voleva saperne di più, pensò Vincenzo, e spiare dove era tenuto quello strano oggetto. Suo marito si era sempre dimostrato troppo interessato alle cose preziose che racchiudeva la terra incantata. Negli anni che erano trascorsi da quando si erano conosciuti Inigo era infatti riuscito a carpire molti dei segreti che quella strana terra racchiudeva. La curiosità aveva però ben presto fatto spazio all’odio per quel piccolo paese da cui non riusciva più a staccarsi. Valdenoghèr lo teneva incatenato ma i suoi boschi incantati e ricchi di tesori rimanevano chiusi per lui che solo attraverso gli occhi e le mani di altri poteva vederli e toccarli. Un giorno, Vincenzo, tornando da una passeggiata, si accorse che qualcuno era entrato nella sua stanza. Tutto preoccupato corse in soffitta. Il suo tesoro era ancora lì, per fortuna. Non era prudente lasciarlo dove si trovava. La cosa più saggia sarebbe stata riportarlo su, ai piedi del grosso sasso dove un tempo lo aveva trovato e dove era rimasto nascosto per secoli. Così un giorno decise che doveva assolutamente recarsi a Farra, per incontrare un nobile veneziano che sarebbe passato per il paese. La notizia non era sicura, comunque Vincenzo la colse come la sospirata scusa che gli consentiva finalmente di andare dove voleva, senza renderne conto agli amici. Montò uno dei cavalli che stavano oziosi nella stalla e si diresse verso Farra. La sua meta però non era quella. Dopo un lungo giro risalì dall’altra parte, dove si trovavano i paesetti di Borsoi e Lavina. Si era informato e aveva scoperto che anche lì il sentiero si inoltrava misteriosamente in un bosco dove nessuno riusciva a penetrare. 31 Mentre cavalcava pensava. E se fosse stata tutta un’illusione del maligno? Se Vittore avesse avuto ragione nel dire che bisognava informare l’autorità ecclesiastica di quanto succedeva a Valdenoghèr? Rivide l’allegro sguardo di Lug e cacciò lontano, con dispetto, l’idea che il suo amico di un tempo fosse un demonio. In vita sua aveva conosciuto persone di fedi diverse; aveva visto uomini adorare il fuoco e altri credere nell’azzurro Cielo, eterno e immutabile. Chi dunque, tra tutti, sbagliava? Chi era nell’errore? In verità non era molto sicuro che fosse saggio ciò che aveva in mente. Lui stesso non era più un ragazzo ma un uomo di più di quarant’anni che aveva viaggiato e conosceva il mondo. Non era un povero pazzo come il Matt e neppure un’ingenua contadina, come Maria o Aurora, che credeva all’esistenza delle fate. Quasi vergognandosi dunque di ciò che stava facendo, con la coppa nascosta in un fagotto, cavalcò rapido oltre Borsoi e oltre Lavina arrivando al luogo che i contadini chiamavano Al Sant, per un capitello eretto a difesa di quel confine contro il maligno. Era il punto estremo ove cominciava la terra di nessuno. Spinse avanti la sua cavalcatura. Si sentiva un po’ come quando era sbarcato dalla nave a Trebisonda e aveva preso a inoltrarsi nel paese dello scià. Un mondo diverso gli si apriva dinnanzi e quel sentiero non si chiuse per lui. Il cavallo trovò facilmente la via tra sterpi e rami. Dopo poco riconobbe la fontana. Prese a destra, senza esitazione, come se avesse sempre abitato in quei luoghi. Dopo aver cavalcato per un buon tratto riconobbe infine la piana della Palantina, dove aveva un tempo combattuto la battaglia contro gli stregoni che causavano i cattivi raccolti. Allora lasciò il cavallo e proseguì a piedi. Eccola infine, la grande pietra che si ergeva solitaria al vento della forcella. «Salve, o grande khan - si sentì in dovere di dire, pur vergognandosi di se stesso - sono tornato. Sono stato in paesi lontani - continuò, quasi per scusarsi - ma ti ho riportato la coppa che avevo preso qui tanto tempo fa. Sono sicuro che questo è il luogo migliore per conservarla. Tu puoi proteggerla.» La pietra non disse nulla. Vincenzo si chinò, scavò con il suo coltello una buca, vi depose la coppa e poi la ricoprì di terra. Quindi si preparò ad andarsene. «Addio.» disse, ma nessuno rispose. Il sole cominciava a declinare quando si voltò per tornare indietro. Imboccò il sentiero da cui era venuto. Eppure ben presto gli sembrò di inoltrarsi in posti mai visti. Cercò di ritrovare la via ma non vi riuscì. Dopo un po’ si trovò su un alto pianoro, fatto di lastre di pietra, come se un gran terremoto avesse fatto scivolare grossi massi l’uno sull’altro. Svoltò a sinistra e, alla luce della luna, vide un’altra zona pianeggiante ed erbosa. «Guardate che cosa ho trovato - disse alle sue spalle una voce che lo fece sobbalzare - sangue buono, sangue fresco.» Delle urla risposero a quella voce: «A me, a me, no, a me…» 32 Molte creature bianche, con gli occhi rossi, i capelli sciolti e le unghie lunghe, si raggrupparono intorno a lui. Il loro odore era pestilenziale e richiamava, nonostante l’oscurità della notte, nugoli di mosche. Sembravano davvero una schiera di anime dannate. «Per me. No, per me.» I suoi assalitori cominciavano già a litigare per il bottino. Vincenzo li riconobbe. Erano i compagni di quel mostro che lo aveva assalito tanti anni prima in Valturcana. Rabbrividì. Se solo fosse stato possibile fuggire, ma erano in troppi e troppo vicini. «Fermi tutti, sono io che devo decidere.» disse un essere enorme che avanzava verso di loro. «Una preda prelibata, a quanto vedo.» Una risata fece ghiacciare il sangue a Vincenzo. Quella giornata si stava concludendo nel peggiore dei modi. Il pensiero corse a Gildo, al fratello di Modesta e Tranquilla, che era sparito tanto tempo prima, una notte, nella terra incantata. Bisognava trarsi d’impaccio. Ma come? Vincenzo aveva la testa che gli doleva per lo sforzo di pensare, eppure non era mai stata così lucida. «O grande signore - disse - cosa vuoi fartene di me?» «Non lo immagini? ho bisogno del tuo sangue per sentire ancora la vita scorrere nelle mie vene.» rise il gigante. «Dai, Qutlù, dividiamoci il suo sangue. Abbiamo bisogno di lui per aver forza anche noi e non trascinarci come ombre in questo bosco.» disse uno di quegli esseri. A quel nome Vincenzo ebbe un sussulto. Ripensò all’altro momento di terrore che aveva vissuto in quella terra incantata e all’altro mostro da cui era sfuggito. «Ho incontrato una volta un grande cavaliere. - riprese Vincenzo, sperando in un diversivo - Il suo nome è Aldoino e ha un esercito con sé.» La risposta fu una sonora risata: «Ormai Aldoino non può fare niente, né a me né a nessuno. Alcuni dei suoi sono qui tra noi. Siamo tutti legati al medesimo destino e non distinguiamo più tra amici e nemici.» E tutti cominciarono a ridere come se quell’affermazione li divertisse a dismisura. «Bada, che lo chiamo.» disse Vincenzo. «Chiamalo, e vediamo cosa succede. - fu la risposta. - Aldoino non può fare nulla. Solo vagare alla ricerca dei suoi discendenti che ormai non esistono più. Lo spirito che avrebbe voluto trasformare in cuscino per il suo letto funebre mi ha lasciato tanto tempo fa, rapito dal Signore della Sorte nelle gelide profondità del suo regno, il giorno in cui buttai stoltamente la coppa che racchiudeva il mio potere. E molti degli uomini del mio nemico hanno seguito la mia medesima sorte.» proseguì il gigante come con un tono di rimpianto, subito scacciato da una grassa risata: «Aldoino non può nulla e continuerà inutilmente a vagare.» concluse. 33 Vincenzo cercava disperatamente di trovare un modo per allontanare quell’immane pericolo. Ripensò alla descrizione che il Matt aveva fatto di loro tanto tempo prima, quando lui era solo un ragazzo. Erano esseri stupidi, facili da ingannare e il sole dell’alba li avrebbe bruciati con i suoi raggi. Bisognava cercare di confonderli. Di imbrogliarli. Di trattenerli a chiacchierare fino al mattino. Ma come? «Una coppa? - disse - Ho visto una bella coppa, tanto tempo fa.» «Dove? Dimmelo. Era la mia?» chiese Qutlù. «Non so se fosse la tua.» «Era fatta con teschio e legata in oro?» disse il mostro. «Proprio così. Era molto bella.» riprese Vincenzo cercando di non dire troppo. «Era lei, l’hai vista. Dov’è? Dimmelo.» «Un attimo, devo pensare. È stato tanto tempo fa.» «Sapresti ritrovarla?» «Ci posso provare.» concluse speranzoso Vincenzo. Così cominciò la ricerca. La coppa era distante, e non era ben sicuro del luogo dove si trovava. Bisognava attraversare il bosco e poi andare a sinistra e quindi a destra e così via. Dopo un bel po’ di urla e schiamazzi, dovuti al contendere tra chi voleva bere subito il suo sangue e chi invece voleva seguire Qutlù, si decise di partire alla ricerca. Era una strana compagnia quella che lasciò il pianoro: Vincenzo stava in testa, armato di un bastone che aveva raccolto, sperando di riuscire a piantarlo nella terra per creare quel magico cerchio di luce che lo avrebbe protetto dai suoi nemici. Lo seguivano il gigante bianco e le altre creature pestilenziali. Qualcuno di quando in quando inciampava, e gli altri al vederlo sghignazzavano e si rotolavano per terra, intralciando chi stava dietro. Ridevano tanto che Vincenzo, a un certo punto, diede una spinta all’essere che gli stava più vicino e si diede alla fuga, nella confusione generale. «Prendetelo.» urlava Qutlù, ma nessuno lo ascoltava. Uno solo si buttò avanti e afferrò Vincenzo per le gambe. Improvvisamente qualcuno urlò: «Il crepuscolo, arriva il sole!» Le risa si fermarono e tutti cominciarono a fuggire. Dovevano trovare rifugio in una caverna o in una di quelle profonde fenditure nel terreno di cui l’Alpago era pieno e che gli abitanti di Valdenoghèr chiamavano «bus». Solo il vampiro che stava a terra avvinghiato a Vincenzo sembrò non sentire. Assaporava già il sangue fresco che era così vicino e che gli avrebbe donato vigore. L’uomo stringeva ancora il bastone in mano e con quello riuscì a colpire quel mostro proprio in pieno petto. La creatura rimase inchiodata sul terreno: una scheggia l’aveva trapassata e si era fissata nella terra. In quel momento sorse il sole. Con i suoi raggi inondò di rosa i prati e i boschi. Quando la luce arrivò a colpire quell’essere, egli si mosse ancora una volta, come in agonia, ed improvvisamente avvampò. Di lui non rimase altro che un piccolo mucchio di cenere bianca. 34 Alla luce del sole Vincenzo ritrovò finalmente la via. Vide in alto il vecchio masso, ai cui piedi aveva sotterrato la coppa. Si volse a destra e poco dopo era già in Palantina dove trovò il cavallo intento a brucare l’erba verde. I mostri bianchi non si erano curati di lui, desiderosi solo del sangue, ben più prelibato, di un uomo. Montò di nuovo in sella e si diresse verso Tambre, l’attraversò e ben presto fu sulla strada che aveva fatto per arrivare al Sant. Alle sue spalle stava, silenziosa, la terra incantata con i suoi misteri e i suoi orrori. Chi erano, dunque, quegli esseri bianchi? – si chiese mentre cavalcava lontano da quei luoghi – Da bambino aveva accettato la loro esistenza così come si crede al sole o alla pioggia. Ma ora? Erano davvero esseri umani a cui era stata rapita l’anima, come aveva detto una volta il Matt? Pensò ai libri di alchimia, che lui pure aveva letto. Chi ci credeva affermava che tre sono le parti che compongono l’individuo: il corpo, l’anima, e l’essenza che li unisce, cioè lo spirito. Forse, per qualche strano caso, quegli esseri erano fatti di corpo e animati dallo spirito, mentre la loro parte più nobile era stata portata via, come essi stessi avevano detto, da un essere demoniaco nelle viscere dell’inferno. Aveva sempre considerato l’alchimia come un passatempo ma ora si chiedeva se quella antica scienza non contenesse, dopo tutto, qualche scintilla di verità. Vincenzo decise di aspettare ancora un giorno prima di tornare a Valdenoghèr. Si fermò nel primo villaggio che trovò. Lì c’era una cappella e il sacrestano gli diede volentieri alloggio. Non erano molti gli stranieri che passavano da quelle parti. Verso sera arrivò anche un prete, che ogni tanto giungeva sin lì. Quando entrò in cucina Vincenzo riconobbe il viso sempre arcigno, anche se invecchiato, di don Floriano. Doveva avere ormai più di sessant’anni, come aveva detto Corinna, ma era sempre austero e dritto come un vecchio tronco su cui il passare degli anni lascia solo qualche traccia. Vincenzo preferì presentarsi come un veneziano, capitato per caso da quelle parti, senza ricordare Alessandro degli Alessandri e i mesi trascorsi in Alpago. Poco dopo, davanti alla zuppa scaldata, cominciarono a parlare della peste che mieteva tante vittime a Venezia. «Sono i peccati degli uomini che causano una simile calamità - disse il prete viviamo in un posto preda degli spiriti più immondi. Sapete che cosa è successo a Pieve, pochi giorni fa? Era appena morto un bambino di una decina d’anni, e quando sono andato per accordarmi sul funerale non siamo più riusciti a trovarne il cadavere.» «Ma non si lascia da solo un morto. - fece Vincenzo - qualcuno deve pregare per lui.» «Sono d’accordo. - riprese il prete - Ma quella povera donna di sua madre si disperava tanto che erano tutti intorno a lei, e hanno lasciato solo il bambino per qualche ora, e quando sono tornati per dire le preghiere, non c’era più. E nessuno è più riuscito a trovarlo.» terminò quasi d’un fiato. «È una storia davvero strana.» fece Vincenzo ma l’altro lo interruppe subito. 35 «E non è la prima volta che accade. Anche a Farra, qualche anno fa, è successo un fatto simile. E poi ci sono state delle strane sparizioni. Ragazze giovani e belle... fuggite con qualcuno di fuori, ha detto la gente. Ma io non ci credo. Sono sicuro che hanno fatto una brutta fine. Succedono cose davvero terribili in questi luoghi. Sono già due anni che proprio al di là di queste montagne, nella terra del Friuli, gli inquisitori hanno scoperto che si compivano riti innominabili.» «Davvero? - fece Vincenzo dimostrando finalmente un certo interesse raccontate padre. In città si sa poco di queste cose.» «Ebbene ci sono persone che hanno confessato che in qualche notte speciale dell’anno si recavano in un posto segreto e si incontravano con demoni e stregoni.» Un brivido di paura scosse Vincenzo che ricordò una notte in Palantina, trent’anni prima, a cui aveva partecipato anche gente che veniva dal Friuli. «Ma li prenderemo tutti, non dubitate - continuò don Floriano senza accorgersi del turbamento del suo interlocutore - non possiamo permettere che si perpetui un siffatto abominio.» Era dunque quella la causa per cui ormai anche i bambini non venivano più inviati a pascolare le bestie a Tambre. C’era paura del potere di persone come don Floriano che, a loro volta, temevano quei riti a loro ignoti. Oltre il confine, sia guardandolo da una parte che dall’altra, vi era comunque un mondo sconosciuto e minaccioso. «In una città come Venezia cose simili non possono accadere? Non è vero?» «No, non capitano però ci sono persone che vengono da paesi lontani e che seguono religioni diverse.» rispose Vincenzo. «False religioni e cattivi uomini quelli che le seguono.» continuò l’altro. «Eppure durante i miei viaggi ho conosciuto anche uomini buoni, che mi hanno aiutato. Mi ricordo di un mercante che rischiò la vita per me, per avvertirmi che gli uomini del Turco mi stavano cercando e volevano la mia testa.» «Sarà stato un caso, oppure aveva un secondo fine. Forse voleva convertirla al suo falso credo. Alle volte anche chi appare innocente in realtà non lo è. Prendete per esempio gli abitanti di Valdenoghèr.» A quanto pareva i soggetti di conversazione preferiti da don Floriano non erano molti. «Anche loro sembrano tutti tanto buoni, eppure qualcuno mi disse una volta che durante una notte speciale si recavano attorno al vecchio noce per compiere strani riti. Per questo l’ho fatto bruciare e ne vado fiero.» Vincenzo provò un sordo dolore. Il suo amico di un tempo non era stato quindi schiantato da un fulmine, mentre si ergeva imponente contro la tempesta, bensì era stato ucciso dalla mano dell’uomo che non aveva compreso la sua importanza e la sua saggezza. Non aveva più voglia di parlare. Disse che era stanco e si avvolse nel suo mantello stendendosi su un cumulo di fieno che stava in un angolo della stanza. Dormì male quella notte e il vecchio lupo nero che con cui aveva stretto un’alleanza tanto tempo prima venne a trovarlo in sogno. 36 11. Una gita a Chiès La cavalcata di Vincenzo fece nascere nei suoi amici il desiderio di muoversi un po’ dal paese, la cui atmosfera stava diventanto davvero troppo soffocante. Decisero così di scendere anche loro a Pieve e poi, eventualmente, trovare qualche mezzo per visitare i dintorni. Il piede di Clelia era quasi guarito e la fanciulla non aveva più bisogno di Almorò come robusto cavalier servente, con grande soddisfazione di Fosca. Appena saputo della progettata gita la signora Lina si offerse di accompagnare la comitiva. Avrebbe ospitato volentieri tutti nella sua «casa di città», come diceva lei. Suo marito si profuse in gentilezze ma disse che avrebbe raggiunto la compagnia dopo qualche giorno, perché doveva ancora controllare lo sfalcio dell’erba. Vincenzo non ebbe nulla da ridire: la magica coppa era ormai lontana, al sicuro, protetta dallo spirito del suo antico padrone. Inigo avrebbe potuto cercarla finché voleva e controllare tutta la grande casa di pietra, ma non avrebbe potuto trovare nulla. Un mattino di agosto, dunque, lasciarono tutti Valdenoghèr per scendere a valle. Lina aveva mandato avanti un servo per avvertire del loro arrivo e quindi trovarono la casa già pronta. Quel giorno passò piacevolmente tra la curiosità degli abitanti di Pieve. Quando andarono a visitare la chiesa trovarono don Floriano, che venne presentato agli ospiti. Egli riconobbe in Vincenzo sia il ragazzo di un tempo, sia il signore veneziano incontrato qualche giorno prima, ma preferì non ricordare suo nonno, l’alchimista Alessandro degli Alessandri. Vittore fece subito amicizia con il vecchio prete. «Succedono cose strane, su, a Valdenoghèr.» disse a un certo punto il giovane. Non occorreva altro per dar la stura a una serie di affermazioni relative alla presenza del maligno in quei luoghi. Il piccolo paese era, nella mente di don Floriano, il ricettacolo di ogni diavoleria. Bisognava estirpare il male finché si era ancora in tempo. Vittore si dimostrò un attento discepolo. Anche lui la pensava così. Clelia cercò di intervenire per mitigare con il suo buon senso quel fiume di drastici giudizi, ma venne fatta tacere con qualche frase relativa alla leggerezza femminile e al fatto che le donne non possono capire tante cose. Arrabbiatissima la ragazza si allontanò andando a raggiungere Vincenzo che camminava una buona decina di passi avanti, deciso a mettere la maggiore distanza possibile tra sé e don Floriano. Almorò e Fosca parlavano fitto fitto, senza curarsi del mondo che li circondava. Flaminia e Lina, invece, avevano fatto amicizia e discutevano delle nuove mode di abiti, portate dalla Francia. In definitiva fu un bel pomeriggio, allietato da un sole splendente e da un venticello fresco fresco. «È stata davvero una buona idea, scendere fin qui.» disse Clelia cercando un argomento di conversazione con il suo compagno che procedeva in silenzio. 37 «Dopo tanti giorni passati tutti assieme, ci voleva un po’ di novità.» rispose Vincenzo. «Cosa pensi di Valdenoghèr? È davvero un villaggio particolare. Come chiamano quei luoghi? La «terra incantata», se non sbaglio?» fece la ragazza. «Sì, proprio così - disse il suo compagno - è un vasto territorio che va dalle Coste de Mai, alla Palantina, al Sant, e dall’altra parte sino quasi a Chiès. Comunque non credo a quello che pensa don Floriano, se vuoi saperlo. Ho visto altri paesi e uomini che avevano una fede diversa dalla nostra, eppure anche loro sapevano essere buoni e compassionevoli. Non bisogna considerare mostri tutti quelli che non non hanno condiviso le nostre esperienze. Il bene e il male sono ovunque e non è detto che anche quello che noi pensiamo sia male, visto da un altro punto di vista, non possa essere considerato il suo opposto. Come dicevi tu, l’altro giorno: la mamma di Attila avrà certo considerato bellissimo suo figlio.» Clelia si dimostrò compiaciuta: «Allora non è vero che le donne sono tutte delle sciocche, come dice don Floriano?» Vincenzo sorrise e continuò: «Secondo me nella «terra incantata» vige un’altra legge, diversa dalla nostra, ecco tutto. Altri esseri vi abitano con cui solo a pochi è permesso avere dei contatti.» «E chi sono questi esseri?» chiese ancora la fanciulla. Vincenzo per la prima volta dopo tanto tempo si sentiva tranquillo, sicuro di potersi fidare. Dopo tutto era ormai convinto che Clelia fosse quella fata vestita d’azzurro che da ragazzo aveva salvato nel bosco. Forse non era proprio una fata, capace di compiere magie, come Tesa, la fanciulla delle acque, comunque era quanto di più incantevole avesse visto da molto tempo. Le parlò ancora delle leggende che le vecchie contadine raccontavano la sera, accanto al focolare: dei mostri dai capelli bianchi e dagli occhi di fuoco, di un luogo chiamato Caotès e della sua ninfa, e anche di un prato di pietre lucenti dove si poteva incontrare un cavaliere verde che aveva il compito di combattere contro un enorme drago bianco. Quella sera Clelia propose a tutta la comitiva una gita a Chiès. Ella sperava di poter finalmente penetrare da quella parte nella terra incantata. La sua mente razionale le impediva, in realtà, di credere che esitesse davvero un posto come quello descritto dal suo compagno. Aveva bisogno di prove e conferme per credere. Venne dunque organizzata la nuova scampagnata. Lina non voleva parteciparvi, ma alla fine si disse convinta: non poteva pensare che le dame che venivano da Venezia facessero qualche cosa di sbagliato. Se andavano loro, allora doveva andare anche lei. Chiès era davvero carino. Poche case abbarbicate sul pendio e tanti prati. Quasi senza parere Clelia trascinò la compagnia per un sentiero che portava verso la terra incantata. Non sapeva neppure lei cosa cercava. Era solo curiosa e sperava di trovare qualcosa di diverso. A un certo punto lasciarono il servo di Lina con i cavalli e procedettero a piedi, dicendo che sarebbero tornati dopo qualche ora e che li aspettasse pure al paese. Il viottolo che percorsero non si inoltrava di molto e 38 terminava, dopo circa mezz’ora di cammino, presso una casera quasi diroccata. Due vecchie erano sedute sulla soglia. Quando videro arrivare tutta quella gente si alzarono e si fecero loro incontro. Si chiamavano Artemisia e Caterina e vivevano lì da sempre. Dissero di non aver mai sentito parlare di nessun incanto, ma se i signori volevano, tanto per divertirli, potevano tentare di leggere per loro la sorte. Avevano visto un’altra vecchia farlo, tanti anni prima, e poteva essere divertente. Un soldino sarebbe stato sufficiente a pagarle. Fosca rise felice. Certamente voleva conoscere il suo futuro. Chiese cosa doveva fare. «Basta che mi mostri il palmo sinistro, bella signora. - le disse Artemisia - Ecco leggo felicità e amore in questa mano, basta avere pazienza e tutti i tuoi desideri verranno esauditi.» Fosca volse lo sguardo verso Almorò e rise ancora, vergognosa di far vedere che credeva a quanto le era stato appena predetto. Artemisia la fissava dritta negli occhi, come volesse catturarle l’anima. «Vieni da me, bella signora - le sussurrò - quando hai bisogno di un consiglio.» Vittore intanto aveva un’aria scura: «Stupidaggini.» disse, allontanandosi di una decina di passi e mostrando di studiare con estremo interesse le piante che stavano nell’orto. «Ora tocca a me.» fece Lina, desiderosa come sempre di imitare le compagne anche se aveva almeno trent’anni più di loro. Artemisia si volse verso di lei: «Vedo… vedo tante cose in questa mano… un dolore, ma non troppo grande, e comunque sempre tante ricchezze che ti permetteranno di fare ciò che desideri.» Lina parve soddisfatta della risposta. Denaro e realizzazione dei suoi desideri era quello che voleva. A questo punto la vecchia si rivolse verso Clelia, che rifiutò decisamente di farsi leggere la mano. Flaminia invece accettò, ma non fu contenta di quelle che le venne predetto. «Un gravissimo pericolo ti sovrasta - fece la vecchia - ma non dipende da te evitarlo. Se uno dei tuoi amici saprà essere forte, allora anche tu ti salverai, altrimenti la sventura sarà su di te.» La ragazza volse intorno lo sguardo impressionata. Vittore era tutto intento a studiare una foglia; suo fratello Almorò si era allontanato con Fosca e Vincenzo stava parlando con Clelia. Non poteva sperare molto da quei baldi cavalieri. «Via, via - fece allora Caterina, vedendo il volto scuro della giovane - non bisogna credere a tutto quello che dice mia sorella. Alle volte parla troppo e a sproposito.» Artemisia si era intanto allontanata, girando dietro la casa, ma nessuno notò la sua assenza. «Si può proseguire per questo sentiero?» chiese Lina, tanto per cambiare discorso. 39 «No, finisce qui, dove comincia il bosco. È troppo fitto per entrarvi.» disse la vecchia. «Allora dovremo tornare indietro.» disse Clelia, un poco dispiaciuta. Si fermarono ancora, per aspettare Almorò e Fosca. Alla fine, visto che non arrivavano, si decisero a partire, sicuri che fossero andati avanti, verso Chiès. Erano giunti quasi a metà strada quando sentirono la voce di Almorò che chiamava la sua compagna. Poco dopo il giovanotto li raggiunse, aveva un viso preoccupato ed era senza fiato. «Avete visto Fosca? Non riesco a trovarla.» «Ma non era con te?» «Sì, eravamo assieme ma poi si è allontanata un momento. Sarebbe tornata subito, ha detto. Invece è più di mezz’ora che la cerco.» «Forse ha visto di nuovo la farfalla rossa.» fece Flaminia, quasi contenta che suo fratello fosse solo. «Questa volta non dobbiamo disperderci - disse Clelia - la cercheremo tutti assieme, altrimenti chissà cosa può capitare.» «No - disse Vincenzo - la cercherò io, che conosco questi luoghi. Voi tornate da quelle due contadine e chiedete che cosa può essere successo.» Voleva provare a inoltrarsi da solo nel bosco incantato. Forse anche Fosca era come lui e poteva entrare dove agli altri non era permesso. Forse qualche essere fatato la stava chiamando, ma lui doveva riportarla dai suoi amici. Era ormai pomeriggio inoltrato. La comitiva cominciò a ripercorrere il sentiero che portava alla casera. Vincenzo si inoltrò solo nel bosco. Vagò a lungo tra i sassi e le felci. Il luogo non gli era ostile. Non aveva neppure bisogno di usare il bastone che aveva raccolto per farsi largo tra il verde. Di Fosca tuttavia non riuscì a trovare traccia. Avrebbe voluto avere l’odorato di un lupo per poterne seguire le tracce e la velocità di un animale da preda per poterla raggiungere subito. Rivide luoghi in cui era già stato. Arrivò fino al grande pianoro dove aveva incontrato un tempo un lupo nero. Desiderò ancora una volta di essere come lui, di possedere la sua forza e il suo aspetto. Tutto fu inutile. Era un uomo ormai e ciò che voleva fare andava oltre la razionalità di un adulto, oltre quello che era abituato ormai a considerare normale. Non sapeva più comportarsi come un bambino, lasciando liberi e senza freni i suoi sentimenti più profondi. «O grande lupo nero - si trovò a pensare - vieni in mio aiuto.» Un muso peloso apparve tra gli arbusti. La grande anima di tutti i lupi era giunta in suo soccorso. L’animale capì ciò che lui voleva dirgli e lo condusse indietro, fino al sentiero che avevano percorso, annusando l’aria e la terra. Fosca doveva essere passata di lì, ma poi? Invece di dirigersi di nuovo verso il bosco il lupo procedette sicuro verso la casera, seguito da Vincenzo. Sopra di loro la luna splendeva come un globo luminoso sospeso nel cielo. I suoi amici dovevano essere dentro, assieme alle due vecchie. Il suo compagno lo condusse dietro l’edificio, dove stava il fienile e poi 40 ancora oltre, ad un piccolo capanno abbandonato. Vincenzo intuì che la ragazza doveva essere lì dentro. Perché fosse in quel luogo non lo sapeva, ma sentiva che c’era. Con un salto il lupo riuscì a far cadere un bastone che stava appoggiato alla porta. Il battente cigolò sui cardini. Vincenzo scorse nell’oscurità una forma di donna accasciata per terra, addormentata. Si avvicinò per prenderla in braccio. In quel mentre si udì la voce di Almorò che diceva: «Fosca, sei tu? Chi è?» L’animale nero ululò alla luna e allora Almorò si accorse della sua presenza e si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo! Aiuto.» Altre persone uscirono dalla casera. Un sasso venne scagliato contro la bestia che cominciò a ringhiare di rabbia. Vittore prese un bastone, mentre Vincenzo si fece avanti, per fermare i suoi amici. Le due vecchie si misero a gridare mentre Clelia e Flaminia starnazzavano come due galline. Il vecchio lupo si volse e riparò nel folto del bosco. «Ma chi è? - disse Almorò - Fosca? hai trovato Fosca.» Tutti si fecero attorno alla ragazza che venne portata dentro, in cucina. Anche dopo molti sforzi però la bella addormentata non dimostrava alcuna voglia di svegliarsi. Anche i sali odorosi, che Clelia aveva con sé, non servirono a nulla. «Non mi pare ferita.» disse Vincenzo dubbioso. «Forse è svenuta per lo spavento di aver visto un lupo.» gli fece eco Almorò. «Come ogni donnetta che si spaventa per un nonnulla - fece allora Vittore secondo me la cura migliore sarebbe un sonoro ceffone, così smetterebbe di prenderci in giro.» «Va a prendere dell’acqua invece - disse Clelia per allontanarlo - e aiutaci a farla rinvenire.» Vittore uscì imbronciato e tornò poco dopo con un secchio. Non si capì mai se lo avesse fatto apposta oppure no, comunque inciampò a pochi passi dal gruppo e l’acqua gelata investì la fanciulla e bagnò quanti le erano attorno. Con un urlo Fosca si riprese. Era ancora intontita e non ricordava cosa le fosse successo, comunque era finalmente sveglia. Vittore fu biasimato per quanto aveva fatto, ma Flaminia benedì quella sbadataggine che aveva risolto la situazione. Se fosse stato giorno i suoi amici si sarebbero accorti che le guance del giovanotto erano diventate tutte rosse. L’aurora ormai rivestiva di rosa i monti e permetteva di distinguere i volti e le cose. Vincenzo si guardò intorno. La cucina dove stavano era piena di oggetti che ai suoi occhi assumevano ora significati inquietanti. Dei grossi calderoni, inutili per due vecchie senza altra famiglia, pendevano dal soffitto. Un gatto nero, cieco d’un occhio, stava immobile in un angolo. Una grande tavola di noce stava al centro della stanza e molte sedie erano disseminate qui e là. Un corvo nero, impagliato, li fissava da sopra una madia. 41 «Andiamo - disse - ormai è inutile annoiare ancora le nostre ospiti. Andiamo.» «Questo è per il disturbo.» disse Almorò lasciando cadere qualche moneta sul tavolo, sollevato che Fosca fosse ormai fuori pericolo. Caterina afferrò rapidamente il denaro. La fanciulla appariva ancora intontita ma cominciava a guardarsi intorno. Vincenzo la prese in braccio, impedendole di fissare ancora Artemisia. «È troppo soffocante qui - disse all’indirizzo delle due vecchie - e succedono cose che non dovrebbero succedere. Bisognerebbe avvertire don Floriano.» e uscì con il suo fardello all’aria fresca del mattino. Gli altri lo seguirono. Artemisia e Caterina rimasero, zitte, in cucina. Si misero in marcia. Poco dopo Almorò volle dare il cambio a Vincenzo nel portare Fosca che ormai era quasi del tutto sveglia e che fu ben contenta di essere accolta tra le braccia del suo innamorato. Strada facendo cercarono di capire quello che era accaduto. «Si trattava di un lupo mannaro, certo.» disse a un certo punto Lina. «Un che?» chiese Vincenzo. «Si tratta di un uomo che si trasforma in animale, quando la luna è al massimo del suo splendore, come ieri sera. Basta essere stati morsi una volta da un lupo; in tal modo si entra a far parte della sua specie, e una volta al mese avviene la terribile trasformazione. A quanto pare molti abitanti di Chiès hanno siglato un simile patto maledetto con i lupi. Le due vecchie mi hanno raccontato che, per questo, hanno deciso di abitare lontano dal paese.» Vincenzo non disse nulla. Per lui diventare un lupo era un modo per acquisirne i poteri, pur rimanendo comunque, nel suo intimo, sempre un uomo. La leggenda che gli era stata appena raccontata era solo un allucinante riproposizione di una realtà da lui veramente vissuta, così come la cerimonia guidata da Catina attorno al noce era solo il pallido e stravolto ricordo di un rito ben diverso. Arrivati in paese ritrovarono le cavalcature che avevano lasciato il giorno precedente assieme al servitore della signora Lina, estremamente preoccupato per quello che poteva essere successo. A Chiès si raccontavano strane storie sulle due vecchiette che abitavano nella casera isolata nel bosco. Si diceva che erano due maghe, che avevano oltre cent’anni e che più di una ragazza, andata da quelle parti, era rimasta incantata dal potere dei loro occhi e non aveva poi più fatto ritorno a casa. 12. La peste Qualche giorno dopo erano tutti di nuovo a Valdenoghèr. Nonostante il cielo della mattina fosse stato minaccioso, quel pomeriggio tornò il bel tempo e con esso il caldo. Si stava proprio bene all’aria aperta e, la sera, l’allegra compagnia si trasferì con 42 cuscini e tappeti in mezzo a un prato vicino, dove tante piccole lucciole illuminavano qua e là l’erba, come dei lumini. Altre volavano emettendo una luce intermittente. In cielo le stelle brillavano fisse nella volta celeste. Un dolce frinire riempiva l’aria. I giovani passarono delle ore piacevoli, chiacchierando e scherzando. In quel luogo lontano dal mondo le notizie arrivavano rade e anche la peste non faceva paura. Si sapeva che ancora alcuni morivano a Venezia ma era come un fatto lontano, solo raccontato e non appartenente al mondo reale in cui si viveva. La discussione facilmente scivolò sulle strane avventure che avevano vissuto in quei giorni. Vittore ripeté quanto aveva già detto: «Sono terre del diavolo. Quando tornerò a Venezia informerò le autorità ecclesiastiche di ciò che avviene qui. Bisogna finirla con questa storia di una terra incantata, dove gli uomini non possono entrare.» Fosca, nonostante la brutta avventura che aveva vissuto alcuni giorni prima, era affascinata da quei luoghi: «È davvero un mondo fatato. Se chiudo gli occhi mi è facile immaginare delle fate che passeggiano tra l’erba, come mi ha raccontato una serva pochi giorni fa. Sono sicura che da qualche parte c’è un drago che nasconde un grosso tesoro e c’è un bel cavaliere che sta cercando di portarglielo via.» «Forse si tratta del cavaliere verde - fece Clelia ammiccando - credo che nelle leggende di re Artù ve ne sia uno di quel colore. Non è vero, Vincenzo?» chiese, ma il suo interlocutore si mise ostentatamente a fissare le stelle. «Ma la coppa che Clelia ha trovato non assomiglia per nulla al Graal.» disse Flaminia. «Allora dovremo accontentarci di una spiegazione più razionale. - fece Almorò la natura ci parla per simboli. Sta a noi comprenderli e capire quindi il loro più recondito significato. È questa la vera scienza. Nulla è buono o cattivo, ma solo più o meno perfetto.» «E la perfezione è la bevanda che rende immortali, l’elisir di lunga vita, oppure la pietra filosofale, il cui tocco trasforma ogni cosa in oro. Ho ragione?» terminò Vincenzo. «Sembra che tu non creda molto, né a me né a Vittore.» fece Almorò. «Non so neppure io cosa credere. - disse Vincenzo - non capisco. Ecco tutto. Forse bisogna ricorrere al buon senso, di cui la nostra Clelia è così ben dotata, e accettare la realtà così com’è.» La discussione si fermò qui. Era ormai tardi quando una stella attraversò brillante il cielo. «Questa è la notte delle stelle cadenti - disse Vittore - e ce ne eravamo dimenticati!» Vincenzo alzò lo sguardo alla volta celeste. Era di un blu cupo, quasi nero, ma le stelle che la punteggiavano sembrarono muoversi. Alcune cominciarono ad attraversare, come frecce luminose, quel buio. Intorno a lui le lucciole sembravano 43 alzarsi dal prato e procede in larghi giri verso l’alto. Anche lui si sentì trasportato in aria, come gli era successo tanto tempo prima, verso un luogo di pace e felicità, senza ombre e senza pensiero. Su, sempre più su, tra quelle luci celesti che stavano immote. Ancora una volta però non riuscì ad assaporare fino in fondo ciò che stava provando. Non era pronto per perdersi in quell’oblio senza tempo. Dentro di lui le sensazioni e i sentimenti erano ancora vivi. Si trovò a pensare ai luoghi incantati che aveva visto. Voleva conoscere il loro mistero e spezzarne il sigillo, come gli aveva chiesto, in un giorno ormai lontano, la grande pietra. Si trovò a pensare al sorriso di Clelia, una fata vestita di azzurro. Si guardò intorno. Era disteso tra i cuscini e i tappeti, in mezzo a un prato che sapeva di fiori e di erba tagliata mentre le lucciole dal lume lampeggiante gli volavano attorno. Il giorno dopo non vi fu nessun allegro conversare. Flaminia stava male. In un primo tempo gli altri non diedero molto peso a quanto diceva, poi però le salì la febbre e cominciarono a preoccuparsi. Da Pieve giunse anche l’inaspettata e terribile notizia che vi era stato un caso di peste in paese. Almorò cominciò a essere in ansia per Fosca, mentre Vittore cominciò a tremare per se stesso. Come al solito fu Clelia che prese in mano la situazione. Invitò tutti a recarsi per qualche giorno in una casetta che si trovava tra Broz e Spert, in un luogo incantevole. Corinna le aveva detto che apparteneva a Stefano, il marito di Rosa, e che era vuota. Avrebbero dovuto arrangiarsi ma almeno non avrebbero contagiato né sarebbero stati contagiati da nessuno. Lei invece si sarebbe fermata lì, a curare la malata, sperando che si trattasse solo di un’infreddatura. Non dissero nulla dei loro timori ai vicini. La scusa per tutti fu quella di una nuova scampagnata, a cercare funghi questa volta e, come si sa, per trovare i più belli bisogna alzarsi presto la mattina. Tanto valeva dunque essere già sul posto. Non era il caso di far nascere il panico in paese, quando si trattava solo di un malessere passeggero. Si accordarono dunque con Stefano e partirono in quattro con un mulo carico con coperte e provviste. Fosca era incerta sul da farsi. Non voleva trovarsi sola con tre uomini, ma Almorò la convinse che era il comportamento più sensato, data la situazione. Clelia li guardò andar via di sotto l’arco della porta, con le lacrime agli occhi, chiedendosi se sarebbe stata ancora viva quando gli amici fossero tornati. Aveva tanta paura ma non voleva dimostrarlo e cercò di nascondere la sua agitazione con un sorriso. Vincenzo si voltò per salutarla e le disse di non temere, che avrebbe sistemato tutto e poi sarebbe tornato. Il breve viaggio fu fatto in silenzio. Ciascuno pensava a Flaminia e alla peste che avevano cercato di fuggire. La casetta nel bosco non era poi nel disordine che avevano temuto. Cominciarono a disfare i bagagli per sistemarsi alla meglio con l’aiuto di Stefano, che stava a Broz e la usava spesso durante l’estate. Il sole era ormai calato quando ebbero finito. Allora, Vincenzo lasciò gli amici per tornare indietro; voleva mantenere la promessa che aveva fatto a Clelia. Arrivando in paese vide di lontano una finestra illuminata: era quella della malata. Sicuramente Clelia le vegliava accanto, cercando di darle conforto, come solo 44 lei sapeva fare. Le altre case attorno erano buie. I contadini erano già andati a letto. D’estate le giornate sono lunghe e le ore della notte corte e quindi, appena tramonta il sole, è già l’ora di riposarsi dopo il duro lavoro nei campi. Vincenzo si avvicinò all’edificio bianco e rosso e fece per entrarvi ma un vento caldo lo spinse indietro. Cercò ancora, ma non riuscì ad avvicinarsi alla porta. Si guardò intorno e vide due occhi brucianti che brillavano nell’oscurità. Questa volta non provò paura, bensì rabbia. Conosceva già il suo nemico. «Lasciami passare e va’ via. Va’ via!» ripeté con il tono di uno che sa di dover essere obbedito, ma un riso maligno fu la risposta. «Questa volta sei tu a non poter entrare, - rise la rossa signore della febbre - il campo è mio e tu non puoi fare nulla.» «Come sei arrivata nella mia casa. Io non ti ho chiamato questa volta.» le rispose Vincenzo che cercava di capire come riuscire a sconfiggere il suo avversario. «Mi ha portato la ragazza e la tua bella dimora incantata non è servita a nulla. È stato per me un vero piacere andare a trovarla una notte che avete passato a Pieve.» gli rispose Ek, mentre i suoi occhi brillavano nel buio, come per schernirlo. «Ciò non toglie che sono sempre più forte di te. Sono riuscito a sconfiggerti quando ero bambino e quindi ci riuscirò anche adesso.» continuò Vincenzo con la forza della disperazione. «Quella volta ero debole, pochi pensavano a me. Ora invece è arrivato il mio momento e bisogna che tu sia davvero bravo per mandarmi via.» disse la rossa signora. «Va’ via!» urlò Vincenzo. «Vedi come sei debole e fiacco. Dove sono le tue zanne?» rise ancora quello spirito malvagio. Vincenzo pensava intensamente come sempre quando affrontava un pericolo. Anche durante i suoi lunghi viaggi, lontano da Venezia, gli era sempre accaduto lo stesso. Se si fermava a pensare aveva anche lui paura, oppure poteva scoraggiarsi o anche rinunciare, ma quando si trovava di fronte a un nemico diveniva freddo e calcolatore, come se la sua intelligenza non gli appartenesse più e fosse un altro a guidarla. Rifletté sulle parole di Ek. Gli tornò in mente come lo aveva chiamato tanto tempo prima: “Piccolo lupo.” E ora gli chiedeva dove erano le sue zanne. Pensò al lupo in cui si era trasformato una volta, ma troppo tempo era passato: un’intera vita di uomo. Ormai non sapeva più comportarsi come aveva fatto allora, lasciando liberi e senza freni i suoi sentimenti più profondi. Doveva riuscire a tornare bambino per sentire e agire in piena armonia con la natura. Dopo molti vani sforzi si arrese. Il vento caldo che sembrava uscire dalla casa non gli dava tregua. Stanco e sfinito alla fine si allontanò. Doveva andare nei boschi incantati in cerca di aiuto. Per quella volta, si disse disperando, Ek aveva vinto. Tornò indietro chiuso nel suo sconforto. Avrebbe raggiunto All’Ò e poi, invece di proseguire per la casa di Stefano, avrebbe tirato dritto per andare a Tambre ed 45 eventualmente in Caotès, a cercare Lug, il cinghiale, per chiedere consiglio, o meglio ancora il lupo nero, della cui forza e del cui coraggio aveva ora disperatamente bisogno. Stava per voltare quando si vide venire incontro, quasi senza fiato, Vittore. «Eccoti, per fortuna ti trovo! Vieni. Fosca sta male. Tuo nonno e tuo padre erano medici e forse tu puoi fare qualcosa.» Gli disse ansimando il giovane. Vincenzo lo seguì. Fin a quel punto era dunque arrivata la rossa Ek, a sfidarlo entrando nella sua casa e poi giocare con la vita di quelli che gli erano più vicini. Camminarono cupi e silenziosi. Una volta in casa egli scorse, sul grande letto di legno che era stato portato in cucina, la povera Fosca, scossa dai brividi. Almorò era al suo capezzale con gli occhi lucidi. Ormai non importava più a nessuno il contagio della peste. Era là, era dentro la casa, forse già correva anche nelle loro vene. Fra due, tre giorni al massimo, pensava Vincenzo, sarebbero stati tutti morti e la rossa signora avrebbe gioito del suo trionfo. Anche con tutta l’arte di suo nonno e di suo padre non sarebbe riuscito a sconfiggerla. Lo leggeva sulle labbra rosse e sul viso teso di Fosca. Flaminia doveva stare anche peggio, giù a Valdenoghèr e quella sera Clelia lo avrebbe atteso invano. «Lo dicevo io - incominciò disperato Vittore - questo è il regno del demonio. Tutti quelli che hai visto, che abbiamo visto, non sono altro che spiriti demoniaci che vogliono la nostra rovina. Perfino quell’albero maledetto che è stato giustamente bruciato e anche gli animali. Sono tutti diavoli usciti dall’inferno e in questa valle si trova la porta per entrare nel loro regno maledetto.» Almorò ascoltava in silenzio, quasi senza capire ciò che diceva l’amico. «Taci, non è così - disse Vincenzo - ci sono forze buone e potenze malvagie che operano attorno a noi; non tutto quello che non comprendiamo è malvagio.» «Non è vero - continuò Vittore con disperazione - sono demoni che vogliono irretire e trascinare alla perdizione uomini e donne. Non vedi cosa è successo a Fosca, a Flaminia e cosa succederà tra poco a tutti noi? Diverremo come gli spiriti che ho visto, condannati a ripetere sempre gli stessi gesti, ogni volta che l’oscurità avanza, oppure a vagare eternamente, senza mai trovare la pace. E quelle due vecchie che abbiamo incontrato a Chiès? Non sono streghe che compiono riti terribili alle soglie degli inferi?» Vincenzo cercò di calmarlo e di farlo sedere, ma non fu facile. Vittore era atterrito dalla paura di divenire anche lui, molto presto, una delle vittime della peste. Cominciò a pregare tutti i santi del paradiso. «Allontanate da me questo pericolo - disse - non fatemi diventare come lui - e indicò Vincenzo - che il diavolo ha già preso con sé. Cacciate via il pericolo che mi sovrasta.» Cominciò a singhiozzare e si mise in ginocchio, mentre Vincenzo provava pietà per lui. Di fronte a un nemico come Ek, che colpiva in tal modo, da parte dei suoi amici non vi era possibilità di difesa. Quanto a lui, cosa mai avrebbe potuto fare? E se Vittore avesse avuto alla fine ragione? Se si fosse trattato davvero solo di demoni 46 malvagi? Un dubbio cominciò a tormentarlo. Non aveva mai creduto alle fiabe di fate e cavalieri erranti; erano solo un esercizio di letteratura. Anche l’alchimia, tutta simboli e scienza segreta, lo aveva sempre lasciato perplesso. Non pensava che potesse portare a qualche scoperta esaltante. Secondo lui anche quello era, in definitiva, un modo per giocare e far volare l’immaginazione. Ma in molti, ricchi e poveri, ignoranti e sapienti, credevano a ciò che Vittore aveva affermato e con quale coraggio poteva lui, da solo, opporsi a queste affermazioni e cercarne di diverse? E se avesse avuto ragione? Se in quella terra si fossero davvero aggirate solo anime dannate? Possibile che Lug, il cinghiale, fosse solo un demone pronto a irretirlo e a dannargli l’anima? Almorò sedeva sempre serio tenendo la mano di Fosca. Alzò lo sguardo verso l’amico, come in una muta preghiera ma non disse niente. Fuori albeggiava. La giornata pareva perdersi nella bruma lattiginosa del mattino. Fosca stava sempre più male e Vincenzo consigliò di bagnare la fronte della malata con acqua di fonte. Altro non poteva fare. Eppure qualcosa doveva fare. Non poteva stare lì immobile a guardare mentre le potenze delle tenebre portavano via, uno ad uno, i suoi amici. Aveva bisogno di un aiuto, di una guida. Come il giorno che si erano persi gli tornarono chiare alla mente le parole dello sciamano, scavato dal sole e dal vento. Anche la nonna di Vincenzo, Mavì Hatùn, era nata da quella stessa gente e aveva certo avuto la stessa fede. Forse le terre d’Oriente dove ella era nata erano simili a quelle dell’Alpago, e forse in entrambe vigeva una legge diversa, condannata e aborrita da alcuni, conosciuta e compresa da altri. Incerto tra due mondi diversi e contrapposti, Vincenzo decise alla fine di affidarsi a quanto gli aveva detto il vecchio sciamano. Era l’unico mezzo che aveva per tentare di salvare i suoi amici: doveva recarsi di nuovo a Tambre e cercare una guida. Uscì senza una parola; infatti niente si poteva dire. Fosca non capiva ormai più nulla, presa dalla febbre, e Almorò si era assopito al suo capezzale. Vittore era andato nell’altra stanza, a pregare. Uscì nell’aria fresca del mattino e si diresse deciso verso Tambre. Quella parte della zona proibita gli era sempre parsa più rassicurante che non il Pian delle Mosche e persino la Palantina. Vagò a lungo, cercando Lug. Lo chiamò a gran voce, ma questa volta il cinghiale non si fece vedere. Camminò e camminò e alla fine giunse in Caotès. La polla d’acqua era quasi secca come se anche Tesa se ne fosse andata. Tornò allora indietro. Anche una piccola fonte che stava al limitare del bosco non gettava più acqua. La disperazione sembrava avvolgere tutto con il suo velo grigio, come la tela di un ragno, oppure come il mantello di un lupo. Si rivide fanciullo, ardere di rabbia per come il Matt stava trattando la fata dall’abito azzurro. Ripensò a quel giorno cercando di provare la stessa violenza. Tutto fu inutile. Era un uomo ormai e non un ragazzo. Il sole stava già tramontando. Aveva perso una giornata intera in quei suoi inutili tentativi. Pensò a Flaminia e Fosca, che 47 forse erano già morte, e agli altri che forse proprio allora erano scossi dai primi brividi di febbre. Le foglie degli alberi cominciavano appena ad arrossarsi quando tra i rami più bassi vide due occhi argentei che lo fissavano. Era il vecchio lupo nero con cui aveva scambiato una volta un giuramento. «Aiutami, ti prego - gli disse - fammi da guida, dammi la tua forza e il tuo coraggio.» «Allora guardami negli occhi - gli disse il lupo - e pensa quello che penso io. Ricerca la mia forza e il mio ardore. Aspira l’aria libera dei monti. Senti i mille odori che impregnano l’aria e che parlano di cose lontane. Pensa alla preda che devi cacciare, ad essere più veloce e più forte del tuo nemico. Solo vivendo e sentendo da lupo potrai veramente diventarlo.» Vincenzo fissò l’animale negli occhi e cercò di essere lui. Allungò il collo come per azzannare l’aria e i colori del mondo cambiarono. I profumi dell’erba e dei fiori si fecero più intensi. Stirò tutti i muscoli e i nervi del suo nuovo corpo e fece alcuni passi. «Ora va - gli disse lo spirito di tutti i lupi - io proteggerò il tuo corpo dormiente sino al tuo ritorno.» Il lupo grigio-azzurro fece un paio di giri attorno a quello nero, poi si volse verso Tambre e si mise a correre. Doveva far presto se voleva salvare gli amici. Sapeva che, come era riuscito a divenire animale, così sarebbe anche riuscito a cacciare la rossa signora della febbre. Arrivò alla fontana in attimo. La terra correva sotto le sue zampe di lupo. Passò Tambre e andò avanti, senza fermarsi. Era ormai salita la notte. Uscì dai boschi incantati, passò la radura dove durante la gita si erano fermati a mangiare, superò la casa di Jacopo e andò ancora avanti. Finalmente gli apparve la grande casa di Valdenoghèr. La finestra in alto, al secondo piano, era ancora debolmente illuminata. Forse Flaminia era ancora viva. Avanzò verso la soglia ringhiando al suo nemico di cui, pur senza vederlo, sentiva la presenza. Il caldo vento che la sera precedente gli aveva impedito di passare scompigliò appena il suo pelo argenteo e la porta d’ingresso si spalancò davanti a lui. Vincenzo salì le scale senza fare alcun rumore, ed entrò nella camera dove giaceva la fanciulla malata. Una candela posta vicino alla finestra la illuminava con la sua luce fioca. Clelia era appisolata su dei cuscini, per terra, ma due occhi rossi brillavano vicino al viso di Flaminia che aveva il colore livido della morte. «Eccomi, Ek, rossa signora, sono arrivato - disse senza proferir parola - e questa volta ho denti e pelo di lupo.» «Non puoi entrare, sei tu che devi andartene.» dissero gli occhi sollevandosi un poco. Flaminia emise un lamento. «Vattene, vattene, vattene! - ripeté Vincenzo - oppure vuoi che ti affronti? Dove sono i tuoi malvagi servitori che combattono per te, come quella volta in Palantina?» 48 Saltò in avanti, passando d’un balzo oltre il letto, e azzannò nella luce fioca qualcosa che si muoveva. Clelia si svegliò di soprassalto per il rumore e fissò senza una parola l’animale che era entrato nella stanza, tanto simile a quello che l’aveva salvata nel bosco. Tenendo stretta tra i denti la sua preda, che cercava di liberarsi, il lupo grigio-azzurro uscì e scese a precipizio le scale, poi si mise correre per portare la malattia lontano da quella casa. Vincenzo corse come non aveva aveva mai corso. Sentiva l’aria che gli passava tra il pelo e gli fischiava nelle orecchie. Vide un fuoco che ardeva davanti a lui. Una casa doveva essersi incendiata a Broz. Superò dei contadini che correvano da quella parte con i badili in mano. Si sentirono delle urla al suo comparire. Arrivato al paese si fermò un attimo, incerto sul da farsi. Lunghe lingue rosse e brillanti nell’oscurità della notte gli sbarravano il passaggio verso la terra incantata. Dall’altra parte alcune persone cercavano inutilmente di spegnere le fiamme che da una casa si erano appiccate agli alberi intorno. «Lasciami, lasciami andare. - diceva intanto la sua preda. - Accordati con me e diventerai potente. Gli uomini ti invidieranno e si inchineranno al tuo passaggio. Potrei darti il potere di curare tutti quelli che vorrai.» Il lupo grigio-azzurro non l’ascoltava. Vide vicino ai suoi gli occhi di fuoco di quell’essere malvagio, che ardevano più delle fiamme, e poco distante la profonda vasca della fontana dove i contadini stavano attingendo l’acqua per spegnere l’incendio. Con un balzo la raggiunse e vi si precipitò dentro. La rossa signora si agitò un momento mentre ancora la stringeva con i denti. L’acqua spense le sue orbite fiammeggianti ed Ek fuggì, dissolvendosi nell’aria come una nuvola rossa. Vincenzo uscì dalla vasca e scosse via l’acqua. Sentì delle urla attorno a sé e dei sassi lo colpirono. Pensò a Fosca e ai suoi due amici, che aveva abbandonato senza una parola. Corse alla loro capanna. Entrò piano annusando l’aria ma non sentì l’odore di Ek. Almorò dormiva come la sera prima, tenendo la mano di Fosca, ma la fanciulla aveva ora la fronte imperlata di goccioline di sudore, come le persone che hanno superato una crisi e stanno guarendo. Nella stanza accanto Vittore borbottava delle preghiere. Non aveva più nulla da fare lì. Ek se ne era andata. Era stata sconfitta, si disse con sollievo. Il suo pensiero andò al lupo nero e lo ringraziò in cuor suo. Ora poteva tornare indietro, al luogo dove aveva abbandonato il suo corpo addormentato. Fece un ampio giro per evitare la casa che bruciava e i contadini affaccendati. Le fiamme erano state quasi domate. Corse su per il sentiero, godendo della propria velocità e di quel corpo di lupo che ora gli apparteneva. Passò Tambre e salì verso Pianon. Dopo la curva si inoltrò tra gli alberi. La notte era scura, illuminata solo da un piccolo spicchio di luna nuova. 49 13. La notte di San Michele Il giorno dopo i buoni abitanti di Valdenoghèr ebbero molto da raccontare; la casa di Stefano a Broz era stata incendiata e c’era voluta tutta la notte per spegnere le fiamme che rischiavano di propagarsi al bosco vicino; un lupo era stato visto scorrazzare per il paese, aveva tentato di azzannare più di un contadino ed era stato infine cacciato via dal coraggioso comportamento di molti; infine, caso ancora più strano, una delle dame che erano giunte dalla città per la villeggiatura era scomparsa. Clelia infatti non si trovava più. Flaminia si era svegliata la mattina, debole e risanata, ma l’amica non era più al suo capezzale. Poco dopo era giunto Vincenzo che si era subito disperato. Tutti erano stati avvertiti e avevano cominciato a cercare la ragazza che però non riapparve. Dove fosse finita era un mistero. Nel frattempo giunse il carrettiere da Farra, a dire che la notizia della peste era stato un falso allarme: vi erano stati un paio di casi nella lontana Venezia, ma in paese solo delle infreddature che i villici, timorosi, avevano subito indicato come una ripresa del flagello dell’anno precedente; era stata certo l’aria buona di quell’estate che aveva allontanato la pestilenza e nessuno aveva ormai più paura, né nella capitale né, tantomeno, tra le montagne. Vincenzo, però, era davvero preoccupato. Non riusciva a capire cosa fosse successo. La rossa signore della febbre si era allontanata da quei luoghi e quindi la sparizione di Clelia non poteva essere opera sua. Si chiese chi altro poteva avere qualche interesse a lei, o poteva odiarlo a tal punto da voler portare la disperazione nella sua casa. Vide alcune contadine che stavano nella piccola piazza di fronte alla sua casa, a parlare fitto fitto tra loro. Si avvicinò. Pensava che le comari sanno sempre molto più degli uomini di quello che succede in un paese. Sovrastava le altre la grossa figura di Catina. «Non riesco a immaginare cosa possa esserle capitato - rispose quella a una domanda di Vincenzo - mi chiedo invece chi sia stato ad appiccare il fuoco alla casa di Stefano. Sua moglie ha visto fuggire un’ombra, poco prima che divampassero le fiamme.» L’incendio scoppiato proprio quella notte faceva dunque parte di un piano prestabilito, pensato da un uomo e non da un essere malvagio che avrebbe avuto a disposizione ben altri poteri. Così pensava tra sé e sé Vincenzo, che chiese ancora: «E chi avrebbe potuto voler distruggere la casa di Stefano?» «La cosa non ha proprio senso. - riprese Catina -. Nessuno che vive qui correrebbe il rischio di dar fuoco al bosco per fare un dispetto a qualcuno.» A Vincenzo venne in mente Inigo. Non era certo del paese, lui. E chissà quanto gli importavano gli alberi e i boschi. Sua moglie Lina poi, da donna furba qual era, poteva aver intuito quali erano i suoi sentimenti per Clelia e averne parlato al marito. Era certo che quello straniero avesse provato per lui del rancore e forse anche del vero e proprio odio, sin da quando, bambino, aveva rifiutato di aiutarlo a rubare i 50 tesori di quella terra. Catina intanto continuava a parlare, quasi rincorrendo i suoi pensieri. «Non ho visto Inigo, questa mattina. Chissà dov’è andato! È davvero un tipo strano. E chissà come ha fatto tutti quei soldi!» «E il parente di Spagna?» chiese Vincenzo. La donna fece un sorriso furbo. «Ci sono molti modi per procurarsi i soldi e una mia amica, che conosce la cugina della moglie di un gioielliere che sta a Pieve mi ha detto che il signor Inigo arriva sempre con tante pietre luccicanti da vendere. Ma dove le tenga, proprio non so. Sono stata tante volte nella sua casa qui in paese, a pulire. E a primavera e autunno la signora Lina mi fa scendere con lei a Pieve, per fare le pulizie stagionali, perché non c’è una serva che sia più brava di me, nel riordinare e nel lustrare.» terminò con una certa fierezza nella voce. Un sudore freddo cominciò a formarsi sulla fronte di Vincenzo. Era sicuro che Inigo non fosse mai riuscito a penetrare nella terra incantata. Era già un uomo quando gli aveva chiesto di rubare per lui le pietre preziose, perché da solo non poteva. Dunque doveva aver trovato un altro mezzo per prenderle, forse un altro fanciullo da inviare al suo posto. Vincenzo continuava a chiedersi come avesse fatto a procurarsi quei tesori. Eppure c’era riuscito, in qualche modo... Intanto le ombre dei mostri che popolavano quei luoghi si facevano largo nei suoi pensieri. Risentì la risata del bianco vampiro che tanto tempo prima aveva incontrato ai limiti della Valturcana. Era stato proprio Inigo a spingerlo in quell’avventura che gli era quasi costata la vita. Aveva corso il rischio di morire dissanguato, preda della voracità famelica di quell’essere e dei suoi simili. Ecco, Qutlù era il nome del capo di quella terribile schiera, che vagava senza sosta, nelle notti di quella magica terra. E se Inigo avesse trovato il modo per accordarsi con un essere malvagio ma stupido come quello? un essere che amava bere il sangue umano... e che, in cambio, avrebbe potuto portargli mucchi di pietre preziose, che non valevano nulla per lui, a confronto del rosso liquido dove era racchiusa la vita degli uomini. Vincenzo cominciò a tremare, pensando alla sua dolce amica... se era caduta in potere di quello straniero... se mai... Improvvisamente si rese conto di dover agire subito: se Clelia non aveva già incontrato il suo fato quella notte aveva ancora poche ore per trovarla. Corse alla casa di Inigo per chiedere a Lina se sapeva dove fosse suo marito, ma lei disse che era uscito il giorno prima per andare a Farra e che sarebbe tornato solo dopo aver sbrigato tutti i suoi affari. Chiese in paese se qualcuno sapeva quali erano i luoghi dove Inigo soleva recarsi. Fu ancora Catina ad aiutarlo indicandogli la vecchia casa in rovina che un tempo era appartenuta al Matt e che tutti evitavano perché dicevano che era abitata dagli spiriti. Vincenzo vi si recò subito. Il prato, un tempo così pulito, era ricoperto di sterpi e rovi. Quasi non si vedeva la grande pietra piatta che stava al limite del bosco. Vincenzo si fece largo tra l’erba alta per raggiungerla. Un odore di carne marcia stagnava nell’aria e lo fece sobbalzare. L’aveva già sentito quel fetore, poco tempo prima, a Pian delle Mosche. Dei resti giacevano tra l’erba e 51 sopra la pietra. Erano poveri pezzi di carne a brandelli di un piccolo corpo, ormai senza sangue, abbandonato da molti giorni in quel luogo. Rabbrividì pensando al morticino di Pieve. Quello era il limite oltre cui i mostri non potevano procedere e oltre quella pietra gli uomini non potevano avanzare. Quello era il luogo dell’incontro. L’altare su cui sacrificare agli esseri bianchi e riceverne in cambio il tesoro agognato. Ormai era sera. Vincenzo si nascose dentro la casa in rovina, desiderando e temendo di vedere giungere Inigo. Ed egli arrivò, infatti, portando un fardello che mai Vincenzo avrebbe voluto vedere in quel posto. Clelia, legata, intontita da qualche droga, venne posta sulla pietra, come una vittima sacrificale. Delle ombre bianche si mossero tra i rami del bosco. Una portava nella coppa formata dalle mani un tesoro di pietre multicolori. Questa volta la trasformazione fu rapida, improvvisa. Non fu Vincenzo ma il lupo grigio-azzurro quello che si scagliò contro gli esseri bianchi, che si ritirarono impauriti nel folto del bosco. Poi si volse verso l’altro suo nemico. Inigo si era fatto avanti, chiamando quegli esseri a raccolta, ma il lupo gli si precipitò addosso azzannandolo alla gola e facendolo cadere, nella foga dell’attacco, proprio sulla pietra di confine. Le ombre bianche, attirate dal sangue dell’uomo avanzarono, mentre Vincenzo, lasciata la sua preda, si preoccupò di trascinare la ragazza lontano di qualche metro, oltre il limite che separava i due mondi, al riparo da quei mostri. In quel momento sentì delle voci poco distante. Vittore, Catina e alcuni contadini stavano arrivando. Quella che un tempo era stata la servetta di casa Alessandri e che ora era un florido donnone con le gote rosse aveva intuito qualcosa di quello che sarebbe potuto succedere e aveva chiesto aiuto agli uomini del paese. La luce delle loro fiaccole allontanò le tenebre e disperse gli esseri bianchi che odiavano la luce. Alla vista degli uomini il lupo grigio-azzurro lasciò la presa e cercò rifugio nel bosco. Ormai Clelia era salva, tanto valeva allontanarsi senza essere visto. Qutlù e gli altri erano dietro di lui. Vincenzo sapeva che non avevano alcun potere sulla sua pelliccia di lupo ma preferì correre su per il sentiero e lasciarsi quelle orrende creature alle spalle. Il suo corpo giaceva, al sicuro, oltre il confine, dentro la casa diroccata. Il lupo grigio-azzurro corse sulle ali del vento della notte, senza pensare, come fa l’animale della foresta che vuole porre la maggior distanza possibile tra sé e il suo nemico. Intono a lui gli abeti cominciarono a fare spazio alle betulle e poi a una vegetazione più rada. Quasi senza rendersene conto percorse un buon tratto e si ritrovò presso il grande masso, al vento della forcella. Allora gli sembrò che la notte divenisse ancora più buia, come se un’ombra scura avesse nascosto la luna e le stelle. Nonostante la folta pelliccia, sentì il gelo penetrargli nel cuore e in tutte le fibre del suo essere. In vita sua aveva provato una volta un freddo terribile. Era stato quando aveva attraversato le montagne del Caucaso, a piedi, tra la neve, il ghiaccio e le rocce aguzze che ferivano le mani. Eppure anche quello che aveva provato allora sembrava tepore al confronto del gelo 52 che lo attanagliava in quel momento. Una paura senza nome cominciò a impossessarsi di lui. Un’ombra oscura lo sovrastava. «Chi sei? Cosa vuoi?» pensò con la forza della disperazione. «Cerco le anime abbandonate. - fu la cupa risposta. - Non mi interessano gli animali ma gli uomini. Sono i loro pensieri e la loro intelligenza che ghermisco quando vagano incerti, dopo aver abbandonato le spoglie mortali.» Poi volse i suoi occhi ciechi verso il luogo dove Vincenzo si trovava: «Eppure io ti ho già incontrato anche se non riesco a distinguerti. Riconosco la tua scintilla di vita. - disse - Sei dunque finalmente tornato a prendere ciò che ti appartiene?» Incredulo a quelle parole, Vincenzo non sapeva cosa rispondere. Quella presenza oscura e paurosa non sembrava essergli ostile, ma non riusciva a immaginare cosa sarebbe successo. «Kurt, uomo-lupo, la messe che mi hai offerto era copiosa e io ho rispettato quanto avevo promesso. Ogni anno, da allora, quando le notti si fanno sempre più lunghe, sono tornato in questi luoghi per incontrarti, ma tu non ti sei mai presentato. Ho chiesto agli animali che incontravo, ma né l’aquila che vola alta nell’aria, né il falco, né la volpe e neppure l’oca dalle bianche piume hanno saputo dirmi qualcosa di te.» Vincenzo si ricordò improvvisamente del grande masso, ai cui piedi aveva sotterrato la coppa. Lo spirito che vi abitava gli aveva chiesto un giorno di trovare un Nero Signore e di parlare con lui. Era forse quell’essere che gli stava davanti? E cos’altro gli aveva detto la pietra? di spezzare un sigillo e di farsi restituire la parola data. «Sono qui.– disse rabbrividendo di freddo e di paura, desideroso solo di porre fine al senso di disperazione che lo attanagliava – Sono tornato per spezzare il sigillo che incatena questa terra.» «Allora possiamo sciogliere il giuramento e continuare ciascuno per la propria strada. – gli rispose ansimando l’inquietante presenza - Addio, lupo grigio-azzurro delle grandi pianure, il cieco Signore della cieca Sorte ti saluta.» L’oscurità della notte svanì come per incanto e apparve improvvisamente la luce. Il giorno era già sorto e il cielo era tutto rosso per i raggi del nuovo sole che si stava alzando già al di sopra dell’orizzonte. Chi era quell’ombra oscura che aveva incontrato? Continuava a chiedersi Vincenzo. Quel sigillo che doveva essere spezzato, di cui aveva parlato la pietra, era forse un patto stretto, chissà quanto tempo prima, tra quell’essere di gelo e di buio e un uomo-lupo? Un venticello d’autunno corse leggero sulla sua pelliccia e gli sussurrò delle parole: «Grazie, amico, e addio. Ci hai liberati tutti, finalmente. Hai spezzato il sigillo che ci legava e io, il grande khan Karakartàl, non sono più incatenato in questa 53 roccia. La mia stirpe è scomparsa da tempo e la mia missione è terminata. Ormai posso perdermi in pace nel grande Cielo Azzurro che tutto ricopre. Addio.» Si sentì un rumore lontano. Era il rullio di un tamburo, anzi di molti tamburi; ben presto si avvertì uno scalpitio di zoccoli e un nitrire di cavalli. Apparve una lunga cavalcata di candidi spettri. Li guidava il grande Aldoino. Passarono gloriosi, senza fermarsi, salendo veloci per le vie dell’aria. Vincenzo rimase a guardare a lungo quello spicchio di azzurro dove si erano involati e si chiese se un giorno anche lui sarebbe andato lassù. Soltanto il frinire dei grilli attraversava ormai l’aria. «Non hai dimenticato qualcosa?» - gli fece una voce baritonale che proveniva dal basso. «Lug! - disse Vincenzo - sei tornato?» «Sono sempre stato qui, sciocco di un ragazzo, ad aspettarti. Te lo avevo detto che mi eri simpatico ed è tanto tempo che ho deciso che dovevo essere io il tuo animale guida e non quel noioso di cui hai vestito fino ad ora la pelliccia, sei contento? - due occhi piccoli e ridenti lo fissarono. - Ormai hai realizzato il sogno che hai espresso tanto tempo fa, quando eri bambino. Sei riuscito a spezzare il sigillo che legava questa terra e questo grazie al grande lupo nero.» Vincenzo cominciava a capire mentre il suo amico parlava. «La nera notte avvolge ogni cosa quando il Nero Signore vaga alla ricerca delle sue prede, ma oggi si è trattenuto a parlare con te. Ha tolto l’incanto che aveva gettato su questi luoghi tanto tempo fa.» «Come gli era stato chiesto da un altro lupo grigio-azzurro?» chiese Vincenzo. Lug sembrò quasi sorridere, ma non rispose e continuò il suo discorso: «Quando se ne è andato il sole era già alto e trionfante nel cielo. Vedi cosa succede a chiacchierare troppo? Gli esseri bianchi non hanno potuto nascondersi ai suoi raggi infuocati e di loro resta solo della candida cenere. Ma ora hai certo un altro sogno da realizzare e questa volta ci sarò io a darti una mano. Cosa ne dici di un bel paio di zanne e di qualche setola in più? Dopo tutto sono bravissimo a giocare e a far divertire i bambini, sai? e quella ragazza con i capelli neri è davvero simpatica.» «Vedi cosa succede a chiacchierare troppo? – continuò allegro Lug - Gli esseri bianchi non hanno potuto nascondersi ai suoi raggi infuocati e di loro resta solo della candida cenere. Ma ora hai certo un altro sogno da realizzare e questa volta ci sarò io a darti una mano. Cosa ne dici di un bel paio di zanne e di qualche setola in più? Dopo tutto sono bravissimo a giocare e a far divertire i bambini, sai? e quella ragazza con i capelli neri è davvero simpatica.» Allora si rese conto che c’era a casa qualcuno che forse lo stava aspettando e che quello era il suo nuovo sogno. Desiderò essere un cinghiale, come il suo vecchio amico. Se ne andarono assieme, grufolando, verso la stamberga diroccata che un tempo era appartenuta al Matt, dove giaceva il corpo addormentato di Vincenzo, e ben presto svanirono alla luce del mattino. Intanto a casa, a Valdenoghèr, lo 54 splendore azzurrino di un magico fiore si faceva sempre più tenue; alla fine rimase solo uno lungo stelo con qualche foglia di un bianco polveroso e una grande corolla secca. I contadini di Valdenoghèr, Broz e Spert ricordarono a lungo la notte di San Michele di quell’anno di grazia 1577. Si era aggirato per il paese un lupo rabbioso che aveva azzannato a morte Inigo, il marito di Lina, mentre la dama della città che era sparita era stata ritrovata. Quando arrivò in paese Vincenzo venne informato da Corinna, con dovizia di particolari, di tutto quello che era successo. Vittore era l’eroe del momento poiché era tornato in paese portando la ragazza tra le braccia, come un trofeo. Flaminia stava molto meglio e quello che era sembrato qualche giorno prima l’inizio di un bubbone pestilenziale era sparito completamente. Vincenzo era molto provato; erano tre notti che il suo spirito non trovava riposo e solo l’agitazione nervosa per quello che era successo lo teneva ancora sveglio. Probabilmente a un certo punto sarebbe crollato e avrebbe dormito per un paio di giorni. Poco dopo vide anche Clelia, che aveva gli occhi rossi e che lo fissò intensamente senza dire nulla, ma era uno sguardo che valeva per mille parole. Rassicurato sulla sua salute andò fino a Broz, dove un odore di bruciato portava nell’aria la notizia dell’incendio. Arrivò fino alla casetta nel bosco. Fosca si era già rimessa. La sua febbre era durata poco più un giorno ed era già in piedi. Vi era anche Stefano. Visto che la sua casa era andata a fuoco doveva per forza andare ad abitare lì. Almorò e Vittore avevano già fatto preparare i bagagli per tornate a Valdenoghèr. I sei amici si ritrovarono così di nuovo insieme nella grande casa dalla facciata bianca, ornata di rosse sculture e risero di tutta la paura che avevano provato. Delle lettere, appena giunte da Venezia, avevano confermato che la peste era davvero finita. «Avete sentito del lupo - fece a un certo punto Flaminia - Clelia dice che è arrivato anche nella mia camera, mentre io deliravo, e ha cercato di azzannarmi, ma poi se ne è andato.» «Tu deliri sempre. - disse Fosca con un nuovo coraggio - Forse ti ha visto quando stavi male e ha preso paura.» Non era più la ragazzina timida e paurosa dei primi giorni. Sapeva di essere amata e questo le infondeva una sicurezza fino ad allora ignorata. «Non mi pare abbia fatto del male - disse Clelia - forse cercava qualcosa. È saltato sopra il letto di Flaminia e poi è andato via. Ma aveva gli occhi buoni.» concluse pensando a un altro lupo che l’aveva salvata. Stava guardando Vincenzo quando le tornò alla mente il viso del ragazzo a cui quel giorno aveva chiesto la strada. Erano stranamente simili. Vincenzo la stava fissando con riconoscenza ma, di fronte al suo sguardo, abbassò gli occhi. Avrebbe voluto dirle tante cose, ma c’era tempo. Sarebbero tornati tutti insieme a Venezia. Vivere per sempre con lei era il suo nuovo sogno e l’avrebbe certo realizzato. 55 «Era tanto buono che ha azzannato a morte Inigo. - disse Vittore - E avrebbe certo ucciso anche te. Per fortuna c’ero io che sono arrivato a salvarti.» concluse compiaciuto. La vicenda del lupo fece presto il giro dei villaggi della zona e dopo qualche giorno comparve don Floriano, accompagnato da un giovane prete che lo aiutava. Radunò i villici e fece loro un solenne discorso. Bisognava finirla, una buona volta, con quelle presenze inquietanti. Bisognava esorcizzare tutto, le persone, le case, gli animali e i boschi e in primo luogo quelli dove mai nessuno osava recarsi. Tutto veniva da lì, da quella terra maledetta. Una volta risanati quei luoghi tutto l’Alpago ne avrebbe tratto giovamento. Ormai era settembre inoltrato. I campi si erano riempiti di colchici viola e le foglie degli alberi cominciavano a cadere. Lina aveva abbandonato il paese per trasferirsi definitivamente a Pieve, e anche per gli altri era giunto il momento di partire. Da molto tempo ormai non vi erano più casi di peste a Venezia e tutti coloro che, per prudenza, avevano passato quell’estate lontano, stavano tornando. Facendo i bagagli Vincenzo pensò di portare con sé anche il magico fiore che stava sulla mensola del caminetto, ma quando lo toccò esso si dissolse in una polvere bianca e impalpabile, come se fosse diventato cenere. Mancava un giorno alla partenza della comitiva, quando don Floriano decise che quello era il momento giusto per esorcizzare i boschi e i campi e salvare così dalla perdizione le anime che abitavano in quei luoghi. Radunò tutti nella piazza di Valdenoghèr e poi si mosse alla testa di un lungo corteo. Aveva fatto appena un centinaio di passi che arrivò un uomo trafelato raccontando una novità incredibile. Un contadino di Spert, rincorrendo il suo asino che si era imbizzarrito, era entrato in Valturcana e anche oltre. Tutto il paese fu presto in subbuglio. Don Floriano disse che certo quello era uno scherzo del demonio per perderli tutti e decise di sospendere per il momento la processione. Catina disse che se il prete aveva paura, lei non ne aveva e voleva andare a vedere cosa stava succedendo. Alla fine anche chi era dubbioso cedette alla curiosità. Dopo tutto cosa mai poteva accadere? Ci sarebbe stato al massimo un altro temporale, come trent’anni prima. Partirono dunque tutti da Valdenoghèr: Catina era in testa, seguita da Rosa e Margherita, e via via da tutti gli abitanti del paese. Partì anche don Floriano, appoggiandosi stretto al braccio dell’altro prete: non poteva certo mostrarsi debole davanti alle sue pecorelle. Anche i signori veneziani decisero di seguire gli altri. Avevano tanto parlato di quei boschi incantati e se ora c’era la possibilità di penetrarvi tanto valeva prenderla al volo, prima della partenza. Tra le chiacchiere delle comari e gli sguardi dubbiosi di molti si arrivò sino alla casa di Jacopo, si tirò dritto fino alla radura dove stava la grande pietra e poi si proseguì. Il sentiero era sgombro e il sole splendeva nel cielo azzurro. Avanti, avanti, senza fermarsi. Ed ecco i profumi che dalla Valturcana venivano a corteggiare chi passava. Avanti e ancora avanti. Luoghi a lungo dimenticati si riaffacciavano alla 56 memoria di chi li aveva visti da bambino. Avanti. Ecco Tambre, nascosta tra il verde. Sempre più avanti. Comparve l’allegra fontana, e poco dopo tutti si addentrarono tra gli alberi per uscire nei prati di Pianon e scendere poi, passato un altro bosco, fino alla polla d’acqua dove nasceva il ruscello chiamato Tesa. Nel loro cammino incontrarono altra gente che veniva da Chiès, ed altri ancora da Borsoi e da Lavina. Altri casi come quello del contadino di Spert si erano verificati e tutti volevano vedere e toccare con mano quei luoghi che, anche se non erano più proibiti agli uomini, tuttavia conservavano ancora intatto il loro misterioso incanto. 57 PARTE TERZA LO SCIAMANO 1. Il lupo Kurt, il lupo, allungò le zampe anteriori come per sentire meglio il terreno, poi alzò il muso per fiutare l’aria. Cercò con lo sguardo una presenza umana, ma attorno a lui si vedevano solo prati e boschetti. Fu invece un odore sottile che lo fece volgere verso la valle. C’era qualcuno, laggiù. Uomini. Erano quelli gli uomini che cercava, di cui sentiva indistintamente la presenza. Fece un passo sull’erba morbida, poi un altro, quindi scese di corsa, in silenzio, appena sfiorando il suolo. Il sole era al tramonto e il colore grigio-azzurro della sua pelliccia si perdeva nell’oscurità che avanzava. Uomini. Longobardi. Eccoli finalmente, ben nascosti alla vista di un uomo, ma non all’odorato di un lupo. Avanzò cauto tra gli alberi che lo proteggevano. Si accucciò tra l’erba per sfuggire ai loro sguardi e rimase in attesa. Trattenne il suo istinto da animale che lo spingeva ad attaccare, ad affondare i suoi denti nella loro carne. Non era questo ciò che doveva fare, ciò che lo interessava. L’uomo-lupo voleva ascoltare i loro discorsi, carpire i loro segreti, sapere se avrebbero attaccato battaglia all’arrivo del nuovo sole. «Qutlù non è lontano - disse con voce sommessa Aldoino - e non ci aspetta.» «Ci aspetta, forse, ma sicuramente pensa a un gruppetto di poche persone. Donne e vecchi lasciati indietro… una facile preda.» disse, soffocando una risata uno dei suoi compagni. «E da cacciatore sarà lui a trasformarsi in selvaggina… un boccone degno di un capo.» «E la sua anima sarà il cuscino su cui poggerò il capo quando sarò morto continuò Aldoino - e mi servirà per sempre.» Un altro guerriero longobardo si avvicinò dicendo: «Grande Aldoino, un’altra pietra verrà a segnare la tua tomba di guerriero e un altro schiavo ti servirà.» «E con lui, centinaia dei suoi unni bianchi. I nostri sono pronti?» «Gran parte di loro già dorme per rinfrancare l’animo prima della battaglia. Solo le sentinelle vegliano.» «Allora avvolgiamoci anche noi nei nostri mantelli - disse il capo longobardo L’ordine è di alzarsi prima dell’alba. Sarà una sorpresa. Qutlù non immagina certo che siamo così vicini e che sappiamo dove è accampato. Questa valle non sarà mai calpestata dagli zoccoli del suo cavallo. Solo gli armenti della mia fara vi potranno pascolare. Ma ora dormiamo. In cielo già splende la falce di padre-luna e il suo cammino è breve in questa stagione e madre-sole farà presto la sua comparsa.» Kurt, il lupo, indietreggiò acquattato tra il fogliame. Sopra di lui si ergevano i rami di un grande noce, venerato come albero sacro dai longobardi. Aveva saputo ciò che voleva sapere. Il suo istinto gli diceva che decine e decine di guerrieri erano nascosti tra l’erba e gli alberi. Non voleva farsi scoprire anche se difficilmente gli uomini di Aldoino gli avrebbero dato la caccia in una notte come quella. Era più probabile che si sarebbero limitati a spingerlo lontano, senza fare troppo rumore. Un lupo non poteva far paura a tanti uomini armati e per incominciare una caccia anche contro un solo animale, così come per attaccare una battaglia, si dovevano compiere i dovuti riti perché si mettevano in moto forze misteriose e potenti che occorreva placare. Inoltre, era importante anche per loro mantenere il silenzio in una notte come quella. Fece a ritroso il cammino sulla terra molle e umida del sottobosco. Corse tra i sassi e l’erba fin dove cominciavano le grandi pietre piatte che contrassegnavano la valle vicina, così diversa da quella verde e piena di alberi che aveva appena lasciato. Salì su un sasso maestoso e ululò alla luna. Aldoino doveva sentirlo e doveva riconoscere in quell’ululato un grido di guerra. Poi, lentamente, allungò le zampe, come per allontanare la stanchezza. Kurt, lo sciamano, aprì le dita di quelle che tornavano ad essere mani e tese tutti i nervi del suo corpo. Si alzò da terra; due specchi di bronzo pendevano dalle sue spalle, una cintura di pelle cingeva i suoi abiti, accarezzò il piccolo tamburo che, quando era uomo, portava sempre con sé; infine sollevò il bastone e, tenendolo alzato, si diresse di corsa verso l’accampamento di Qutlù Khaghàn. 2. Qutlù Khaghàn «Qutlù, mio khaghàn, ti porto importanti notizie.» Lo sciamano si avvicinò con atteggiamento umile al grande signore degli unni bianchi. Anche se il ruolo che ricopriva era diverso e di maggior importanza di quello di tutti gli uomini che lo circondavano, Kurt provava sempre un certo timore quando si avvicinava al suo capo che portava un titolo riverito e temuto, quello di khaghàn, il signore dei signori che governavano le famiglie della sua gente. La sua collera sapeva essere terribile e, quando si scatenava, non aveva rispetto per nessuno. Non si sarebbe fermata neppure davanti al tamburo e alla pelliccia di lupo che lo sciamano portava sulle spalle. Forte, ma anche avventato, come molto spesso i giovani, il khaghàn non temeva né i nemici né il Grande Cielo Azzurro in cui Kurt riusciva a perdersi, durante le sue estasi. 60 «Qutlù, mio grande khan, ti porto gravi notizie. Nella valle vicina, dove l’erba è verde e tenera, sono accampati Aldoino e i suoi longobardi. Il loro numero è pari alle stelle del cielo, le loro spade brillano nella notte come gli occhi della tigre in cerca di preda, il loro passo è silenzioso come quello del lupo. All’alba saranno qui.» «Non raccontare storie, vecchio!» fu l’improvvisa risposta. «Nessuno li ha visti e nessuno li ha sentiti, se non tu, e i tuoi occhi non sono più quelli di un tempo. Vai a curare le donne e i bambini. Ormai è quello il tuo posto e lascia che a fare la guerra siano i guerrieri.» «Ti ripeto, o eccelso khan, innalzato sulla coperta di feltro al di sopra di tutti gli altri uomini, che Aldoino è vicino; è nella valle, oltre le grandi pietre piatte, e i faggi del bosco gli forniscono riparo.» insistette lo sciamano con un velo di pianto nella voce. Qutlù era famoso per la sua statura considerevole, per sua forza e il suo coraggio, e anche per le sue decisioni improvvise. Altre volte il suo carattere lo aveva portato alla vittoria e anche a imporsi come signore degli unni bianchi, ma ora, in questo frangente, poteva condurlo alla rovina. Non aveva mai stimato Kurt, troppo vecchio e perdente, dal suo punto di vista, e questa sembrava un’occasione insperata per distruggere sia lo sciamano sia il potere che quella pelliccia di lupo rappresentava per il suo popolo. «Forse si potrebbe mandare qualcuno a controllare, quattro occhi vedono meglio di due.» disse un uomo che sedeva accanto al khaghàn, con una voce profonda. Simùrgh, era uno dei migliori guerrieri, e anche uno dei più saggi. A lui sarebbe dovuto toccare il comando, pensò Kurt. Lui sarebbe dovuto diventare il khan di tutti i khan di quella stirpe ma il Cielo aveva voluto altrimenti. «E cosa troverebbe? - rispose Qutlù con una sonora risata - Qualche carro con grandi ruote condotto da donne e carico di masserizie. Già ieri gli esploratori hanno riferito che c’è solo una piccola retroguardia ancora accampata e che il grosso della fara ha lasciato la valle. I longobardi hanno troppa paura e il luogo è troppo pericoloso per loro. Siamo proprio sotto la chiusa che porta al di là dei monti. Entro pochi giorni non ne resterà più neppure uno e i pascoli saranno per noi e per i nostri cavalli. Ormai ci siamo sistemati qui e nessuno potrà prendere il nostro posto. Anche le pietre lo dicono. Non vedi il recinto per il bestiame che abbiamo già costruito, spostando sassi su sassi? e l’abbeveratoio che i miei uomini hanno fatto incidendo un macigno proprio sotto il ruscello? Basta! Il mio ordine è dato! Mangiamo e stiamo allegri, ché nessun pericolo è in agguato.» «O grande khan - insistette ancora con la forza della disperazione lo sciamano a te spetta il comando, ma tuo è anche il grido di battaglia. Schiera le insegne, prima che spunti l’alba. L’antica testa di tigre proteggerà i tuoi uomini se la isserai su una picca. Me lo ha detto il vento che conosce i segreti degli uomini, degli alberi e delle pietre.» 61 Qutlù non ascoltava. Era sicuro di quanto gli avevano riferito gli uomini che aveva mandato in esplorazione durante il giorno e non lo sfiorava il dubbio che potevano essersi sbagliati o, peggio, che potevano mentire. «Basta! Taci, vecchio! Smettila di sibilare menzogne come fa la vipera che i longobardi appendono al loro noce sacro, attorno al quale corrono a cavallo. Non ho bisogno dei tuoi consigli. Vattene! Da questo momento sei bandito da questo popolo e puoi ritenerti fortunato che la mia collera non ti colpisca in modo ben più orribile.» Qutlù si alzò in piedi e lanciò con rabbia contro il vecchio l’oggetto che teneva in mano: una coppa d’oro fatta con il cranio di un prode guerriero ucciso dal suo predecessore, il khaghàn Karakartàl. Kurt abbassò la testa, non per vergogna o umiltà, bensì per nascondere il lampo di fuoco che gli brillava nello sguardo. Era stato un fedele alleato del sovrano precedente, zio di Qutlù, che lo aveva sempre stimato e trattato con rispetto. Lo sciamano rimpiangeva il vecchio signore degli unni bianchi, portato via poco tempo prima da una caduta da cavallo durante una battuta di caccia. Tutto si era compiuto quando erano appena giunti in quella terra, verde di erba e bianca di rocce. Karakartàl era morto ed era stato sepolto sotto un cumulo di pietre. Infine, dall’alto della montagna un enorme masso era stato fatto rotolare sulla sua tomba. Ormai la sua anima di capo si era insediata in quella roccia e da lì poteva osservare e proteggere le imprese gloriose dei suoi discendenti e del suo popolo. Ora invece… Sin da quanto aveva ottenuto il comando supremo, imponendosi tra i maschi della sua stirpe, Qutlù si era comportato in modo avventato e aveva trattato il vecchio sciamano con diffidenza, deridendo i suoi riti e ignorando i suoi consigli. E ora lo bandiva solo perché aveva voluto aiutarlo e impedire che i suoi guerrieri venissero uccisi. Kurt si voltò lentamente e si chinò a raccogliere la coppa, simbolo dell’autorità sovrana. Mentre si drizzava i suoi occhi incontrarono lo sguardo preoccupato di Simùrgh. Fu un attimo, ma sufficiente per capire che l’uomo non condivideva la decisione del suo capo. Lo sciamano si sistemò la pelle di lupo sulle spalle, appoggiò la punta del bastone per terra e poi cominciò a camminare dritto davanti a sé, senza voltarsi indietro. 3. Il grande albero L’oscurità accolse lo sciamano che si dirigeva verso la piana, in fondo alla valle. Al centro, isolato, si ergeva nero contro il blu stellato della notte un grande faggio. La sua posizione e la sua imponenza dimostravano che si trattava di un essere sacro, che poteva mettere in comunicazione chi sapeva parlargli con il Cielo Azzurro. Kurt cominciò a percuotere lento lento il piccolo tamburo che portava legato alla vita e a camminare attorno al tronco. Poco alla volta il rullio si fece sempre più incalzante e il 62 suo passo più rapido, fino a trasformarsi in un ritmo danzato. A quel suono, ripetitivo eppure sempre diverso, la sua mente cominciò a sgombrarsi, a dimenticare il pensiero per vivere solo di sensazioni. Lo aveva fatto tante volte e il ritmo e la danza gli avevano sempre permesso di diventare lui stesso il profumo dell’erba e il colore del cielo. Quella volta però non riuscì a penetrare completamente sotto il velo della natura, a identificarsi con essa. Un dolore sordo che proveniva dal suo petto gli esplodeva a tratti nella mente, impedendogli di identificarsi con il tutto. Il ricordo di quanto era appena accaduto non lo abbandonava e gli bruciava dentro come una fiamma invisibile. Qutlù doveva pagare per averlo bandito, per quell’offesa che gli aveva appena inflitto e per le molte altre umiliazioni che gli aveva fatto soffrire da quando aveva raggiunto il potere supremo. Lo sciamano cercava di allontanare da sé il peso che lo opprimeva, che gli impediva di sollevarsi e di comunicare ancora una volta, attraverso il grande albero, con l’Eterno e Azzurro Cielo. «Aiutami, grande albero. Accogli il mio spirito, ora, così come accoglierai un giorno le mie ossa. Chiedi al Cielo, Immobile ed Eterno, che i tuoi rami sorreggono, cosa devo fare. Suggeriscimi come devo comportarmi con Qutlù e con Aldoino.» Un vento leggero scosse le fronde ma nessun pensiero penetrò nella mente dell’uomo. «Ti prego, aiutami!» disse ancora lo sciamano. Le foglie si mossero appena, come controvoglia: «L’Azzurro Cielo non si cura degli esseri umani - sussurrarono le fronde - e chi pensa come un uomo, viva dunque come un uomo!» Il rullio del tamburo andò perdendosi e le dita che lo percuotevano si mossero sempre più lente sino a fermarsi del tutto. Kurt arrestò la sua danza e rimase immobile. Era vero. Il Dio Cielo, Immobile ed Eterno, non si era mai occupato di quello che provavano gli uomini. Alle volte permetteva a qualche essere privilegiato, come era capitato a Kurt stesso, di librarsi sino a lui, ma chiedeva in cambio la rinuncia a ogni passione e il riuscire a dilatare il proprio cuore sino a comprendervi tutta la natura e tutte le cose. In quel momento invece lo sciamano provava un senso di disperazione e un profondo desiderio di vendetta. 4. Lo spirito d’acqua Agitato da tali sentimenti Kurt vagò a lungo sotto il cielo stellato senza meta, fino a quando raggiunse un ampio spazio dove crescevano le piante dalle grandi foglie che protendono le loro radici nelle acque. Un tenero gorgoglio veniva da una pozza che si disperdeva in un rivolo argenteo. Era giunto nel luogo sacro dove nasceva un fiume. Lo sentiva nel cuore e nella mente. Oh, se quel fiume avesse potuto sommergere Qutlù, Aldoino e tutti gli altri, unni bianchi e longobardi… 63 «Anima della sorgente, dove sei?» Una risata argentina fu la risposta. «Fatti vedere, dolce spirito d’acqua.» disse ancora lo sciamano. «Eccomi, cosa vuoi da me?» L’immagine di una fanciulla aleggiò nell’aria, argentea come la luna. La fonte amava apparire sotto spoglie umane quando parlava con gli uomini. «Sei tranquilla e dolce in questa notte di primavera, eppure so che puoi essere diversa, se lo vuoi. Quando il disgelo ingrossa le tue acque, niente e nessuno ti può resistere. Allora sei bella e terribile e tutti ti portano venerazione e rispetto.» «E allora? In quest’aria calma godo del profumo dei fiori e dell’erba e non ho voglia di scuotermi dal mio letto tra le grandi foglie.» «Eppure potresti aiutarmi, se solo tu lo volessi. Ti ho sempre venerato, non ho mai intorbidato la tua purezza, né sporcato le tue acque.» «Aiutarti, perché? Tutti devono comportarsi così. Hai fatto solo quanto era giusto!» «Domani, quando il sole sarà alto nel cielo - continuò lo sciamano - potrei sospingere verso questa radura un prode khaghàn con i suoi guerrieri. Facile preda sarebbero per le tue acque che si mescolano alla sabbia, diventando una trappola inesorabile. Potresti sommergere tutti con la tua potenza.» «Nessun khaghàn mi ha offeso. Nessun guerriero mi ha intorbidato. Nessun sovrano ha tradito i patti che sono stati giurati dove sorgono dalla terra le mie acque. Nessun uomo ha violato le tombe dei potenti che si nascondono nel mio sacro letto. Verso chi dovrei dunque dimostrare la mia collera?» «Hai ragione. Nessuno ti ha offeso - disse Kurt - ma io ti chiedo solo di aiutarmi a sopraffare i miei nemici.» «I nemici di un uomo svaniscono nel breve volgere di una stagione, come la neve al sole. - rispose la sorgente - Non è saggio lasciarsi guidare dai sentimenti. Uno sciamano dovrebbe saperlo.» «Essere agitati dalle passioni è umano e anch’io sono un uomo, anche se sciamano. - replicò Kurt - Tu non capisci.» «Siete molto buffi.» trillò la voce argentina della fanciulla d’argento. «Non ridere. Non vi è nulla di divertente in tutto questo. - si arrabbiò Kurt Devi rispettarci, se vuoi che ti rispettiamo, o sorgente.» «Siete solo esseri senza senso.» ribatté allegra la fonte. Scuro in volto, Kurt non rispose. Si volse indietro, avanzando tra gli alberi e lasciandosi alle spalle quell’immagine impalpabile di fanciulla che andava sparendo in una nebbia sottile e in una risata argentina. 5. Il guerriero Simùrgh 64 Kurt era solo nella foresta e pensava. Pensava a quanti guerrieri avrebbero incontrato il loro fato il giorno dopo, e a tutte le loro anime che si sarebbero disperse, molte di più del numero dei morti. Infatti, secondo quanto sapeva lo sciamano, ogni essere ne possiede molte, a seconda delle sue qualità. Con l’esaurirsi del soffio vitale, di solito l’anima-intelligenza si trasformava in uccello e volava via. Nel caso di grandi khan o di uomini prodi l’alito del loro coraggio poteva volontariamente restare insediandosi in una grande pietra o in un simulacro per proteggere la propria stirpe. Le animeintelligenza di pur forti guerrieri, ma sconfitti in battaglia, sarebbero state preda dei vincitori; questi le avrebbero condannate a eterna schiavitù, imprigionandole in alti sassi infissi nel terreno. L’anima-sangue si sarebbe dispersa nella terra e avrebbe contribuito a ravvivare tutta la natura, a meno che un nemico, raccogliendo in una coppa quel rosso liquido di vita, non se ne fosse cibato appropriandosi così della forza di chi aveva sconfitto. L’anima della specie sarebbe tornata, invece, al primo progenitore, scintilla tra molte scintille, che senza posa si trasferisce da un essere all’altro. L’anima più vile e bassa, infine, quella che agisce senza il pensiero, veniva di solito risucchiata dalla terra attraverso il corpo sepolto, ma se i raggi del nuovo sole la scoprivano, allora avrebbe continuato a vagare nel mondo per anni e anni, senza trovare pace, rifuggendo la luce e cibandosi di sangue, alla disperata ricerca di una parvenza di vita. Mentre Kurt era assorto in simili pensieri, una voce profonda lo chiamò: «Sciamano, sei qui? Finalmente ti ho trovato. È tanto che seguo le tue tracce!» «Sono qui. Cosa vuoi, Simùrgh? Non è stato sufficiente quanto ha ordinato Qutlù? Cosa cerchi?» rispose Kurt che aveva riconosciuto nella notte il guerriero unno in cui un tempo aveva riposto tante speranze. «Non vengo a cercarti da parte del khaghàn. - riprese Simùrgh - Le parole che ti porto sono le mie. Non condivido quanto ha detto Qutlù. La volpe sta sempre guardinga nel bosco e l’orso non si lascia attaccare alle spalle e così devono fare i guerrieri.» «Apprezzo quanto dici, Simùrgh, ma chi detiene il potere ha deciso e neppure uno sciamano può opporsi al suo volere.» «Sono venuto a chiederti cosa devo fare. - disse l’unno bianco - Non posso contrastare gli ordini del khaghàn e solo i membri della mia famiglia mi obbediscono. Con dieci uomini, una quindicina di donne e molti bambini non ci si può certo opporre all’esercito di Aldoino.» «Allora prendi i tuoi e allontanati da questi luoghi maledetti. Domani ci sarà battaglia e nessuno si salverà perché i longobardi sono numerosi e ben armati e colpiranno come il falco che giunge inaspettato dal cielo. Qualche centinaio di unni bianchi, sorpresi nel sonno, non potranno certo opporre una grande resistenza.» «Ma si tratterebbe di una fuga… - disse dubbioso Simùrgh - non si possono abbandonare i compagni nell’ora del pericolo.» 65 «Anche il lupo si ritira quando vede che il suo nemico gli è superiore. E poi l’ordine del khaghàn è stato di mangiare, bere e stare allegri, e non di prepararsi alla battaglia. Vai dunque, raduna i tuoi e dirigiti verso la chiusa da cui siamo scesi lo scorso anno. Queste valli non daranno mai più da mangiare alle loro bestie.» Simùrgh appariva dubbioso, incerto tra il desiderio di non abbandonare i compagni e quello di seguire i saggi avvertimenti dello sciamano. «Vai dunque! - riprese Kurt - Agisci come agiscono gli animali della foresta. E quando il sole sarà alto volgiti indietro, contempla con lo sguardo questi prati e vedrai che avevo ragione. Se mi sarà possibile allora ti raggiungerò e proseguiremo assieme verso il nero-azzurro nord-est, perché la grande anima degli unni bianchi non deve essere distrutta e in te e nei tuoi figli continuerà a vivere.» Simùrgh non disse nulla. Accennò solo con il capo, poi si volse e tornò sui suoi passi lasciando Kurt immerso nell’ombra e nei suoi pensieri. 6. Le grandi anime degli animali «Agisci come gli animali della foresta.» Il consiglio che lui stesso aveva dato riecheggiò con forza nella mente dello sciamano. «Sii prudente e infido come la volpe, aggressivo come l’orso, terribile come la tigre delle bianche pianure. - disse Kurt a se stesso - Gli animali sono come gli uomini, possono amare e odiare. Capiranno ciò che provo e mi aiuteranno nella mia vendetta.» Alzò allora le braccia e tese tutti i nervi. Pensò intensamente al lupo dal mantello nero con cui, tanti anni prima, aveva stretto un patto. In pochi minuti era tornato ad essere l’uomo lupo. Procedette a balzi, di zolla in zolla, di pietra in pietra, sino a raggiungere il limitare del bosco. Qui si fermò, si sedette sulle zampe posteriori e ululò alla luna. Non era questo un grido di battaglia, bensì un accorato richiamo: «Venite a me, animali della foresta e della pianura. Rapida volpe, maestoso orso, falco dallo sguardo penetrante, civetta che voli nella notte. Venite a me, perché ho bisogno del vostro consiglio.» Passarono alcuni minuti e poi si sentì un battito d’ali, seguito dal fruscio di erbe smosse. Le grandi anime degli animali si stavano radunando attorno a lui. Ognuno di quegli spiriti rappresentava tutta la sua specie e parlava in nome di essa. Era il grande antenato che tutti i discendenti veneravano e a cui si rivolgevano in cerca di conforto e aiuto nelle avversità. Alcuni erano anche i protettori di tribù che avevano scelto di imitare il comportamento di un animale; bevendo in una cerimonia sacra il sangue di un orso, un’aquila o un cavallo e innalzando su una picca il suo simulacro impagliato, alcuni uomini si erano legati con giuramento a una delle grandi anime, scegliendola come proprio capostipite e propria insegna di battaglia. Così la sua stirpe aveva, in un giorno e in un luogo ormai lontani, stretto un patto con la tigre delle fredde pianure. Gli unni avevano scelto il falco che vola alto nel cielo. I sassoni innalzavano la testa 66 di uno stallone bianco, i longobardi una vipera. Tra le varie tribù turche vi era chi diceva di discendere da un lupo e chi da un toro di due anni. Infine, nel lontano azzurro est, vi era anche chi si era legato con un sacro giuramento al drago mostruoso, da cui aveva tratto la forza per soggiogare i propri nemici. «Cosa possiamo fare per te, uomo-lupo? Perché ci hai convocati?» ruggì l’orso. «Aiutatemi a vendicarmi sul mio nemico. - rispose Kurt - Voi conoscete i sentimenti degli uomini. Domani Qutlù khaghàn incontrerà la morte, ma la sconfitta che gli verrà inflitta non toglierà nulla alla sua gloria perché ad ucciderlo sarà il prode guerriero Aldoino. Anche se egli servirà da cuscino al letto funebre del principe longobardo, anche se una pietra ospiterà la sua anima e narrerà a tutti della sua sconfitta, tuttavia ciò non è abbastanza. Il suo nome sarà ricordato dalle generazioni future come quello di un grande guerriero, quando invece deve essere dimenticato. Solo quando sarà cancellato anche nel ricordo degli uomini, solo allora cesserà veramente di esistere. Aiutatemi a raggiungere questo scopo.» «Aldoino mi venera - sibilò la vipera - e io sto dalla sua parte. Procedo, innalzata, alla testa delle sue schiere. Qui si tratta di una questione di uomini e non di animali. Cosa ha fatto Qutlù contro di noi, perché ci sia bisogno del nostro intervento?» «O grandi anime - disse lo sciamano - anche voi siete soliti punire chi vi reca offesa e quindi potete capire il mio dolore. Amico - continuò quindi rivolgendosi a un lupo nero che gli stava accanto - proprio per la fratellanza che unisce l’uomolupo, quale io sono, alla tua specie, ti chiedo di mandare un tuo discendente ad azzannare Qutlù questa notte così la sua morte non sarà quella di un guerriero o di un cacciatore, bensì di un uomo comune. In tal modo il suo nome sarà dimenticato ed egli pagherà il suo debito nei miei confronti.» «Il khaghàn non ha recato alcuna offesa alla nostra specie - disse la grande anima dei lupi - ma solo a te, come suo simile. Ci ha forse cacciato senza avvertirci con i dovuti riti? Ha forse spezzato le nostre ossa mentre le mangiava? Le ha forse bruciate dopo essersi cibato di noi? o non le ha invece sepolte sotto uno strato di soffice terra, come era suo dovere? Nessuno dei miei discendenti rinascerà storpio per causa sua e non ho visto perire tra le fiamme alcuna scintilla del mio essere.» «È vero! - ribadì l’orso - Grave offesa è spezzare le ossa della preda catturata, perché il suo soffio vitale non potrà reincarnarsi in un altro animale perfetto, ma chi nascerà dopo di lui sarà storpio e monco. Ancor più grave è poi il bruciare i resti di coloro che ti sono serviti da cibo, perché si trattano così solo i nemici di cui si vuole eliminare per sempre la specie. Nessun individuo potrà mai sostituire quello perduto e anche le grandi anime vedono così scemare la loro fiamma vitale.» «Qutlù, però, non ha commesso tali crimini e non merita la nostra vendetta.» proseguì Lug, il luminoso, lo spirito di tutti i cinghiali. «Non possiamo aiutarti. - concluse l’aquila - Se lo facessimo saremmo noi a spezzare la legge che regola la natura.» e detto questo aprì le grandi ali e con un rapido movimento si librò nell’aria profumata della notte. Per due volte girò attorno 67 agli esseri radunati attorno all’uomo-lupo, oscurando al suo passaggio le stelle, poi si volse verso il cupo nord e sparì alla vista. Una dopo l’altra, in silenzio, le grandi anime degli animali abbandonarono la radura. Kurt, l’uomo-lupo, rimase solo nell’oscurità della notte. 7. Ek, lo spirito della febbre Lo sciamano rimase immobile, avvolto dall’oscurità così come dai suoi cupi pensieri. La natura, con cui era vissuto per tanti anni a così intimo contatto, per una volta lo aveva respinto. Si drizzò pian piano, sotto il grande faggio. Gli specchi di bronzo, il piccolo tamburo, e la pelle di lupo pendevano dalle sue spalle. La coppa di Karakartàl e la lunga picca stavano nelle sue mani. Il Cielo lo aveva allontanato da sé, l’acqua non lo aveva capito e gli animali gli avevano rifiutato il loro aiuto. Le forze che lo avevano sempre sostenuto per una volta si erano dimostrate ostili. Quali altre potenze avrebbero potuto aiutarlo? Come una risposta al suo pensiero due occhi rossi e luminosi apparvero nella notte. Erano come due carboni ardenti che bruciavano se stessi e consumavano ugualmente tutto ciò su cui si posavano. «Kurt, uomo-lupo, volgi lo sguardo verso di me. Anche altre forze agiscono nel mondo.» Disse una voce stridula, più sibilante di quella della vipera. «Ek, Ek, rossa signora delle febbri, - disse Kurt - riconosco il tuo respiro di fuoco. Cosa sei venuta a fare quaggiù? Quale bambino vuoi portare via con te questa notte?» «Tante sono state le battaglie che ci hanno visto nemici, non è vero, sciamano? Questa notte, però, sono venuta a proporti una tregua. Io e le altre potenze oscure non ti serbiamo rancore anche se hai sempre tentato di allontanarci.» «Un patto? Un accordo? - disse Kurt - Il mantello di lupo che porto è grigioazzurro, come il Cielo Eterno, e non voglio mutarlo con l’oscuro colore del sangue rappreso.» Un altro bagliore di un fuoco verdastro splendette tra gli alberi poco distante dagli occhi incandescenti di Ek e un’altra voce, questa lugubre e lamentosa, disse: «Eppure alcuni tuoi simili si sono accordati con noi. Ci hanno accolto, e noi siamo stati generosi nei loro confronti. - Chi parlava era il signore della fame e della carestia - Il potere che ti offriamo non ha limiti, lo sai…» «E porta solo alla distruzione.» concluse Kurt. «È il destino di ogni cosa e se ti accordi con noi avrai la tua vendetta. - dissero assieme le due voci - Guarda quanto grande è la nostra benevolenza! Tale è il nostro potere, di cui tu puoi avere parte, che si apre come un mantello a coprire la specie umana e, soprattutto attraverso gli uomini, può colpire anche le forze stesse della natura.» 68 Lo sciamano rabbrividì. Eppure ebbe la forza di rispondere: «Ogni cosa che muore poi rinasce anche se sotto altra forma. La tigre delle grandi pianure sarà sempre viva finché avrà discendenti e finché altre tigri prenderanno il suo posto. Ek, Ek, tu e le altre potenze simili a te, invece, cercate solo di rendere nulla gli uomini, gli animali e financo le cose.» «O grande sciamano - disse Ek - se ci accordiamo questa notte io andrò a trovare Qutlù e mi impossesserò della sua vita. Domani la rovina dei suoi uomini sarà inevitabile e Aldoino stesso non potrà gioire del suo trionfo perché io gli avrò sottratto la sua preda più ricca: lo schiavo che spera di destinare al suo servizio nel regno dei morti gli sfuggirà di mano e tu potrai godere di una duplice vendetta.» Un sapore sottile di amara vittoria cominciò a penetrare nel cuore di Kurt. Una sua parola e non vi sarebbe stato altro vincitore che lui. Eppure la controparte di tutto questo era un accordo con quelle stesse potenze del male contro cui aveva combattuto per tutta una vita. Ricordava ancora le parole del suo maestro, Karatày; il vecchio sciamano lo aveva messo in guardia contro la rossa Ek, che rapisce i bambini alle madri e le mamme ai neonati, contro il signore della fame e della carestia, che secca le fonti e disperde i frutti, e contro tanti altri esseri malvagi che anche quando scendono a patti con gli uomini lo fanno, non per dare loro il potere, bensì per accrescere il proprio. «Non ti accordare mai con Ek e con i suoi simili. - lo aveva messo un giorno in guardia Karatày - Il patto è senza ritorno. Non si potrà sciogliere mai più e tu sarai costretto a usare i tuoi poteri per compiacere le infuocate potenze del male. Il profumo dei fiori non ti apparterrà e non potrai più gioire del canto dell’allodola. Solo la fiamma rosso-cupo, che tutto consuma, ti brucerà nel petto per sempre. Guai allo sciamano che rinuncia al Cielo Azzurro per avere in cambio gli occhi roventi di Ek.» Questo gli aveva detto il suo vecchio maestro, dopo che Kurt aveva sentito per la prima volta il cuore e la mente innalzarsi sino a toccare il Cielo, e quelle parole ritornarono ora; le sentiva come se Karatày fosse stato ancora lì, presente e vivo, accanto a lui. No, non avrebbe potuto rinunciare a tutto ciò solo per ottenere vendetta. Qutlù doveva pagare per la sua avventatezza e per il suo disprezzo, ma lui, Kurt, lo sciamano bianco, non doveva soffrire ancor più del khaghàn per questo. «Andatevene! Non scendo a patti con voi e con i vostri simili!» disse con voce ferma. Quattro occhi di fiamma brillarono nel buio ma solo una voce rispose: «Te ne pentirai. Un giorno verrò a prenderti… e allora…» «Fintanto che non ho stretto il patto che mi proponete sono libero e appartengo al Cielo. Andatevene!» I bagliori di fuoco diedero un guizzo e sparirono nella notte. 69 8. Il Signore della Sorte Kurt era di nuovo solo, sotto l’immenso faggio che con i suoi rami sosteneva la volta celeste. Era un albero così diverso, eppure così simile, al grande noce che stava nella valle accanto. Su una cosa Ek aveva avuto ragione, e cioè che sarebbe stato bello poter contrastare anche i progetti del longobardo Aldoino, rendendo vani i suoi sforzi per conquistare potenza e gloria. Lo sciamano, però, non possedeva un esercito, non aveva seguaci che combattessero per lui e la stoltezza di Qutlù aveva ormai votato il popolo degli unni bianchi alla morte. Domani, quello stesso luogo avrebbe visto decine e decine di cadaveri che nessuno avrebbe mai seppellito. A chi poteva interessare la vita di tanti uomini e donne? Un brivido scosse le membra dello sciamano. Un pensiero che metteva paura attraversò la sua mente come un lampo in un cielo d’estate. Esisteva una forza, un essere, che sarebbe stato contento di sapere in anticipo l’ora e il luogo di una grande battaglia. Imre Khan, il cieco Signore della cieca Sorte, che usava vagare per il mondo alla ricerca delle anime-intelligenza di chi era appena defunto. Le portava con sé, nei suoi domini sotterranei, e nessuno gli si poteva opporre quando arrivava. Se passava per un campo di battaglia, nessun vincitore poteva reclamare nuovi schiavi a far da guanciale a un letto funebre; se invece si avvicinava a un uomo morente di febbre, Ek stessa fuggiva spaventata, lasciando la sua preda nelle mani del suo nuovo signore. Imre Khan era indifferente al male così come al bene. Non cercava di annientare, ma neppure di perpetuare la vita. Era la sorte, il caso, che colpiva ciecamente, senza essere né buono né cattivo, anche se il suo solo nome faceva tremare anche i più coraggiosi. «Ecco una forza con cui si può scendere a patti, senza rinunciare all’Immenso Cielo.» Pensò Kurt, mentre un tremito involontario gli percorreva le membra. «Conosco qualcosa che lui desidera e posso chiedergli in cambio un favore.» Lo sciamano prese la picca che, come un fedele destriero, sempre lo accompagnava e la piantò dritta nel terreno, creando così un cerchio sacro. Poi cominciò ancora una volta a suonare il suo tamburo. «Imre Khan, Imre Khan.» ripeteva incessantemente «Vieni, devo parlarti.» Il ritmo si fece sempre più rapido e quando raggiunse l’apice un’ombra enorme oscurò le stelle. Il cuore di Kurt diede un balzo mentre le sue membra provavano un gelo che mai aveva sentito, neppure nelle grandi pianure bianche del nord, dove il sole e la luna combattevano le loro più aspre battaglie. «Chi mi ha invocato?» chiese Imre Khan. «Io ti ho invocato, o grande spirito. Io, Kurt, lo sciamano bianco. Voglio proporti un patto.» «Che genere di patto?» fu la risposta. «So che ciò che brami di più sono le anime degli uomini - disse Kurt - ma so anche che molte sfuggono alla tua presa e raggiungono come uccelli l’Immenso 70 Azzurro Cielo. Io te ne posso offrire centinaia domani, ma in cambio voglio un favore.» «La tua proposta è allettante - ansimò la voce cupa che lo sovrastava - ma dimmi, qual è il prezzo?» Lo sciamano rabbrividì ancora di freddo e di paura; un terrore cieco e senza nome, irrazionale, gli attanagliava i visceri e gli gonfiava il collo, causato dalla sola presenza del Signore della Sorte, ben diversa da quella bruciante e disperante di Ek e dei suoi simili. «Domani devo lasciare queste terre dove l’erba è così soffice e dolce per le mie bestie. Non voglio che gli armenti di altri la bruchino e lascino solo qualche filo di paglia. Veglia per me su questi prati e sui boschi che li circondano fino al mio ritorno. Impedisci a ogni uomo di penetrarvi e distruggerli. Trattieni gli esseri che vi abitano cosicché non possano raccontare ad alcuno delle loro bellezze.» «Ciò che chiedi non costa fatica - rispose Imre Khan - il mio potere è grande e posso fare quanto richiedi, ma anche se gli uomini si inchinano davanti a me, tu sai che non posso toccare i bambini e gli sciamani. Tu ben lo sai perché sei uno di loro, altrimenti non avresti avuto il coraggio di evocarmi.» Kurt rispose: «Hai ragione, o potente khan che segni con il tuo sigillo gli uomini e le cose, ma pochi bambini che giocano tra l’erba non daranno fastidio alle mie bestie.» Poi, facendosi coraggio, riprese: «Ti piace dunque l’accordo?» «Mi piace. - rispose Imre Khan - La tua picca crea un cerchio sacro che io dilaterò fino al limitare dei boschi e questa terra sarà sottratta al fluire del tempo degli uomini. Chi sarà dentro vi rimarrà imprigionato e quelli di fuori non vi potranno entrare. Così resterà fino al tuo ritorno, ma devi dirmi dove potrò trovare domani centinaia di anime.» «In questi stessi luoghi ci sarà battaglia al sorgere del sole. Molti guerrieri moriranno e con loro le loro spose e i loro figli, che sempre li accompagnano in guerra. Sono tutti tuoi. Nessuno potrà sfuggirti.» «Ma dimmi, chi sei? - chiese ancora Imre Khan, senza dimostrare né gioia, né altro sentimento. - Percepisco la tua scintilla di vita e sento che sei uno sciamano, ma non conosco il tuo nome e il viso degli uomini mi sfugge.» «Mi chiamano Kurt, l’uomo-lupo, perché so cambiare la mia pelle con il vello grigio-azzurro del lupo delle grandi pianure che, quando le foglie si fanno rosse, vaga alla ricerca di nuove prede.» «Il patto è concluso e il giuramento consumato - disse il cieco Signore della cieca Sorte - se domani coglierò il mio frutto questa terra rimarrà sigillata fino al tuo ritorno.» L’ombra oscura che nascondeva il cielo stellato svanì e con essa anche il gelo che attanagliava la mente e le membra. L’aria tornò tiepida, improvvisamente, e carica del profumo dell’erba e dei fiori. Kurt ne fu sollevato. La presenza di Imre Khan era terribile anche per chi, come lui, sapeva di essere intoccabile dal suo potere. 71 Aveva stretto un patto, pagato il dovuto e nulla più gli sarebbe stato chiesto. In cambio avrebbe avuto la sua vendetta nei confronti di Qutlù, la cui anima sarebbe stata rapita dal Signore della Sorte e il cui nome di guerriero sarebbe stato dimenticato per sempre. Aldoino, il grande condottiero dei longobardi, non avrebbe potuto godere il frutto della vittoria: quei pascoli sarebbero stati per sempre chiusi ai suoi armenti e il suo spirito di capo non avrebbe avuto il servo che tanto agognava. Imre Khan avrebbe fatto buona guardia e Kurt, lo sciamano, non sarebbe mai più tornato indietro a reclamare quella terra. Un ultimo pensiero di pietà e rammarico fu per tutti coloro che, innocenti, sarebbero rimasti insepolti. Ma il loro destino era già scritto nella decisione presa da Qutlù e, comunque, la loro vita e la loro morte non dipendevano da lui. La loro anima-intelligenza sarebbe stata portata dal Signore della Sorte nelle viscere della terra, ma la loro anima più vile e bassa, risvegliata dai raggi del nuovo sole, avrebbe continuato a vagare chiusa in quella valle per sempre, fuggendo la luce, destinata a lottare vanamente per non essere annullata nel respiro eterno della natura. Kurt aveva messo in moto forze tali che avrebbero spaventato anche il più coraggioso degli uomini. Era meglio allontanarsi da quei luoghi. La luce opaca del crepuscolo cominciava appena a scorgersi all’orizzonte e Kurt si diresse in fretta verso le grandi pietre piatte che chiudevano la valle. Poi salì sempre più su. Fece un ampio giro per passare davanti alla tomba di Karakartàl. Sua era la coppa che Qutlù gli aveva gettato contro e che ora teneva in mano, suo era stato il nemico cui apparteneva quel cranio e a lui doveva tornare assieme alla potenza e alla maestà che vi erano racchiuse. «Addio, grande khan.» disse quando fu davanti alla pietra infissa nella terra. «Addio, Kurt. - rispose l’anima insediatasi nella roccia - che la mia stirpe possa durare per sempre. Io starò qui, a proteggere gli unni bianchi, e solo quando i figli dei figli mi avranno dimenticato, allora potrò volare negli spazi eterni dell’azzurro cielo.» «Ecco la coppa di maestà. Te la restituisco.» disse Kurt, che, scavata una piccola buca ai piedi del sasso vi depose quel teschio per poi ricoprirlo di terra. Tanti anni prima Karakartàl aveva usato quel macabro trofeo per bere il fresco sangue del nemico che aveva appena ucciso, assumendone così il potere e la forza e assicurandosi il trono. «Veglia per me su questi luoghi, anche se i figli dei figli dei figli ti avranno dimenticato.» Kurt si avviò di corsa tra gli alberi, scese un colle, attraversò un grande spiazzo erboso e poi andò su, sempre più su, verso il passo. Di lontano vide Simùrgh e i suoi che erano già lì, in attesa. Si trattava di un piccolo drappello, ma quegli uomini e quelle donne erano la speranza degli unni bianchi. La stirpe non sarebbe stata distrutta e la testa della tigre delle bianche pianure sarebbe stata ancora issata davanti alle schiere disposte alla battaglia. Il sole apparve infine a est in tutto il suo splendore e un grido di guerra risuonò nella valle. I longobardi erano arrivati. Lo sciamano si voltò e si diresse con passo fermo verso la chiusa dove Simùrgh lo stava aspettando. 72
Scarica