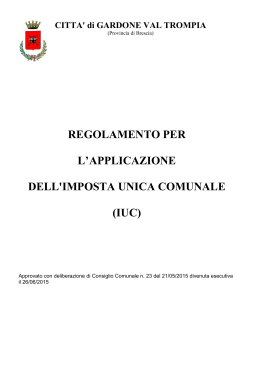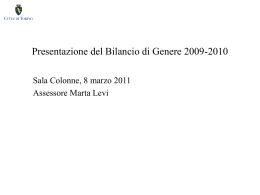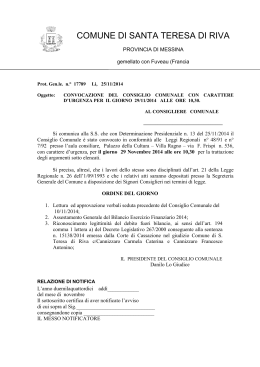REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI VARESE
COMUNE DI GOLASECCA
committente :
COMUNE DI GOLASECCA
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
(P.U.G.S.S.)
titolo documento:
RAPPORTO TERRITORIALE
PER IL P.U.G.S.S.
scala elaborato:
codice elaborato
___ __ _ ____ __ __ ___
revisioni
PUA
SIGLA ELAB.
0 0 16/12/2013 Emissione
progettazione:
dott. arch. Roberto Ripamonti (capogruppo)
dott. arch. Alfredo Castiglioni
dott. arch. Gianni Francisco
dott. arch. Luca Francisco
dott. arch. Anna Maria Vailati
dott. arch. Aldo Vecchi
collaboratori:
dott. Martha Maulini
dott. arch. Paola Vecchi
geom. Paolo Zanetta
INDICE DEL TESTO
1 – INTRODUZIONE
1.1 - PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
1.2 - R IFERIMENTI NORMATIVI
1.2.1 – DALLA DIRETTIVA NAZIONALE ALLA LEGGE REGIONALE N° 12/2005.
1.2.2 - IL REGOLAMENTO REGIONALE N° 6 DEL 15 FEBBRAIO 2010
1.2.3 – OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE
1.3 - QUADRO DI RIFERIMENTO (PTCP VARESE e PGT)
1.3.1 – P IANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
1.3.2 – P IANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
1.4 - METODOLOGIA DI LAVORO
2 – RAPPORTO TERRITORIALE
2.1 - IL SISTEMA GEO-TERRITORIALE
estratti dalla
“definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano
di governo del territorio”
studio tecnico associato di geologia dei dott. Zaro e Carimati – Gazzada Schianno (Va)
2.1.1 - GENERALITA’
2.1.2 - ANALISI GEOLOGICA
2.1.3 - ANALISI GEOMORFOLOGICA
2.1.4 - ANALISI IDROLOGICA, IDROGRAFICA E IDROGEOLOGICA
2.1.5 - ANALISI GEOLOGICO – TECNICA
2.1.6 - PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
2.1.7 - CARTA DI SINTESI
2.2 IL SISTEMA URBANISTICO
2.2.1 - S ISTEMA INSEDIATIVO
2.2.2 - TESSUTO URBANO E TIPOLOGIE EDILIZIE
2.2.3 - S ISTEMA INFRASTRUTTURALE
2.3 - S ISTEMA DEI VINCOLI
2.3.1 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
2.3.2 - V INCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L.
183/89
2.3.3 - V INCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
2.3.4 - FATTIBILITÀ GEOLOGICA
2.3.5 - ALTRI VINCOLI
pag. 1
Ver. 16/12/2013
2.4 - S ISTEMA DEI SERVIZI A RETE: RICOGNIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE
INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO
2.4.1 - RETE ACQUEDOTTISTICA
2.4.2 - RETE FOGNARIA
2.4.3 - RETE GAS
2.4.4 - RETE ELETTRICA
2.4.5 - RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2.4.6 - RETE DI TELECOMUNICAZIONI
2.4.7 - SOLUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE
2.5- LE SCELTE STRATEGICHE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
3 - ANALISI DELLE CRITICITA’
3.1 - LA SENSIBILITÀ DELLA RETE STRADALE
3.2 - VULNERABILITÀ’ DELLE STRADE PER ESONDAZIONE E FRANE
4 - PIANO DEGLI INTERVENTI
4.1 - CRITERI D I INTERVENTO: CAUTELE GEO-TECNICHE
4.2 SCENARIO DI INFRASTRUTTURAZIONE
4.2.1 - INTRODUZIONE
4.2.2 - METODO DI POSA TRADIZIONALE
4.2.3 - METODO DI POSA CON TUNNEL (CUNICOLI TECNOLOGICI E GALLERIE
PLURISERVIZI)
4.3 - MODALITÀ PER LA CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
4.4 - VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO
5 - REGOLAMENTO ATTUATIVO
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ
ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - PIANIFICAZIONE
ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
ART. 6 - CARTOGRAFIA E COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE
ART. 7 - MONITORAGGIO
ART. 8 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE
ART. 9 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI CUNICOLI TECNOLOGICI E GALLERIE
PLURISERVIZI
ART. 10 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI POLIFORE
ART. 11 - INFRASTRUTTURE AUSILIARIE
ART. 12 - REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI PAVIMENTAZIONE SUPERFICIALE
ART. 13 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
ART. 14 - INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO
pag. 2
1-
INTRODUZIONE
1.1 - PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
In concomitanza con la formazione del Piano di Governo del Territorio, il Comune di
Golasecca, in ottemperanza ai disposti della normativa vigente, come illustrata al
successivo paragrafo, si dota del Piano Urbano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo
(PUGSS), quale integrazione del Piano dei Servizi.
Gli obiettivi generali del PUGSS:
-
la conoscenza delle infrastrutture sotterranee e delle reti di servizi connesse, in
rapporto allo studio idrogeologico ed ai vincoli sovraordinati;
-
la individuazione delle problematiche relative alla gestione e manutenzione di tali
infrastrutture ed alla progettazione degli ulteriori sviluppi dei servizi nel sottosuolo,
in relazione ai nodi della trasformazione urbana, come prospettati dal PGT e del
Piano Generale del Traffico Urbano, nel rispetto dei piani sovracomunali;
-
la individuazione delle direttive per la pianificazione dei nuovi interventi, alla luce
dei programmi settoriali dei singoli enti gestori;
-
la organizzazione dell’“Ufficio per gli interventi nel sottosuolo”
regolamentazione delle conseguenti procedure di autorizzazione.
e
la
1.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI (direttiva 3/3/1999, LR 26/2003, LR 12/2005, RR
6/2010)
1.2.1 – DALLA DIRETTIVA NAZIONALE ALLA LEGGE REGIONALE N° 12/2005
La programmazione razionale dei servizi sotterranei è stata postulata a livello normativo
inizialmente con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 03/03/1999
"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"; tale provvedimento di
indirizzi, ricco di indicazioni metodologiche e tecnologiche, ma scarso di prescrizioni
cogenti, riservava l’obbligo di formazione di un nuovo strumento specifico, il Piano Urbano
per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo, ai Comuni capoluogo di Provincia ed a quelli
superiori ai 30.000 abitanti (salvo decisioni estensive delle regioni).
La Regione Lombardia, con progressive approssimazioni, ha recepito e sviluppato
autonomamente tale direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferendo alla
disciplina del settore dignità legislativa, dapprima con il Titolo IV della Legge Regionale n°
26 del 12-12-2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che
contemplava per tutti i Comuni la redazione del Piano Urbano per la Gestione dei Servizi
nel Sottosuolo quale specificazione del Piano dei Servizi (allora però facoltativo), e poi
recependola all’interno della più generale normativa per il Governo del Territorio (art. 9,
comma 8, della L.R. n° 12/2005 e successive modifiche e integrazioni), rendendo così
cogente per i Comuni l’obbligo del P.U.G.S.S. contestualmente alla formazione del Piano di
Governo del Territorio e connesso Piano dei Servizi.
pag. 3
Ver. 16/12/2013
L’art. 38 della L.R. 26/2003, al comma 2, specifica che “Il PUGSS, anche sulla base
degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua
le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo
non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e
sulla base di valutazioni tecnico-economiche.”
Con il Regolamento Regionale 28-02-05 n°3, poi sostituito dal R.R. n° 6 del 15 febbraio
2010, “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo
(PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi
della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma
18)” e relativi allegati tecnici, la Regione, sulla scorta della suddetta L.R. 26/2003, ha
definito dettagliatamente i contenuti dei PUGSS.
1.2.2 - IL REGOLAMENTO REGIONALE N° 6 DEL 15 FEBBRAIO 2010
Si ritiene opportuno esporre di seguito un riassunto puntuale del R.R. n° 6/2010
A RT . 1 - OGGETTO DEL R EGOLAMENTO
A ) – CRITERI PER LA REDAZ IONE DEL PUGSS;
1 – RUOLO DEI C OMUNI ( PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO ,
CONTROLLO ),
2 – REQUISITI TECNICI DELLE INFRASTRUTTURE PER L ’ ALLOGGIAMENTO DELLA RETE
DEI SERVIZI,
3 – MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI;
B ) - MODALITÀ PER LE MAPPATURE GEOREFERENZIATE DELLE INFRASTRUTTURE E
RACCORDO CON IL S ISTEMA INFORMATIVO T ERRITORIALE REGIONALE .
A RT . 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
S OTTOSERVIZI PER
A ) - ACQUEDOTTI ;
B ) - FOGNE BIANCHE E NERE ;
C ) – ELETTRODOTTI ( A M EDIA E B ASSA T ENSIONE ) PER ENERGIA E PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ;
D ) – TELECOMUNICAZIONI E CABLAGGI ;
E ) – TELERISCALDAMENTO ;
F ) – GASDOTTI;
G ) - ALTRE RETI SOTTERRANEE ,
NONCHÉ
H ) - CORRELATE OPERE AUSILIARIE IN SUPERF ICIE .
A RTT . 3 - P IANIFICAZIONE COMUNALE: VEDI ART. 38.2 LR 26/03, SOPRA CITATO ,
NONCHÉ CONNESSIONE CON PGT, P IANO DEI SERV IZI E P ROGRAMMI T RIENNALI DELLE
O PERE P UBBLICHE
A RT . 4 – C RITERI PER LA REDAZIONE DEI PUGSS
1 (criteri generali)
A ) – USO RAZIONALE DEL SOTTOSUOLO ; CONDIVISIONE E RI - USO INFRASTRUTTURE ,
PROGETTAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE ;
B ) – COERENZA CON TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA , AMBIENTE , PATRIMONIO
STORICO - ARTISTICO , NONCHÉ EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI;
C ) – CRITERI PROGETTUALI PER MANUFATTI :
pag. 4
- CON COSTI SOCIALI RIDOTTI,
- FACILE ACCESSO PER MANUTENZIONI,
- POSSIBILITÀ DI CONTROLLI AUTOMATICI;
2 – SOSTENIBILITÀ ECONOM ICA , CON ESPLICITAZIONE RISORSE DEI VARI SOGGETTI;
3 – CRONO - PROGRAMMA ANNUALE PER COORDINAMENTO INTERVENTI DEI SINGOLI
GESTORI .
A RT . 5 – C ONTENUTI DEI PUGSS ( DETTAGLIATI NELL ’ALLEGATO 1)
A ) - R APPORTO TERRITORIALE ( CARATTERISTICHE AREA URBANA E RICOGNIZIONE
CONSISTENZA RETI );
B ) - A NALISI DELLE CRITICITÀ ( SISTEMA URBANO E COMMERCIALE , SISTEMA VIARIO ,
SISTEMA INFRASTRUTTURALE );
C ) - P IANO DEGLI INTERVENTI :
1 – SCENARIO DI INFRASTRUTTURAZIONE ,
2 – CRITERI DI INTERVENTI ( VEDI ART . 6),
3 – SOLUZIONI, ANCHE PER COMPLETAMENTO RICOGNIZIONI, SE NECESSARIO ( VEDI
ART. 9),
4 – MODI E STRUMENTI DI CORNO - PROGRAMMAZIONE,
5) - SOSTENIBILITÀ ECONOM ICA ,
6) - PROCEDURE DI MONITORAGGIO .
A RT . 6 – C RITERI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
1-2 – DIMENSIONAMENTO SECONDO PIANI COMUNALI E DEI GESTORI, NL RISPETTO
DI NORME UNI-CEI, ED IN COERENZA AL PUGSS STESSO ;
3 – P ER AREE DI URBANIZZAZ IONE NUOVA O RINNOVATA, CONTESTUALITÀ CON
OPERE DI SUPERFICIE ED UTILIZZO AREE A STANDARD NECESSARIE ANCHE PER
SOTTOSERVIZI ;
4 – P ER PIANI ATTUATIVI, REALIZZAZIONE A CURA DELL ’ OPERATORE, CON
COMPENSAZIONI SE IL DIMENSIONAMENTO È DOVUTO A RAGIONI EXTRA - LOCALI;
5 – IMPIEGO DI INFRASTRUTTURE PIÙ COMPLESSE SOPRATTUTTO PER I LUOGHI DI
INTERSEZIONE E LE AREE CON DENSITÀ DI RETI , NUOVE O DA RISTRUTTURARE ;
6 – C AUTELE PER AREE GIÀ EDIFICATE E PER BENI STORICO - ARCHITETTONICI;
7 – I N CASO DI RIUTILIZZABILITÀ DI INFRASTRUTTURE, DIV IETO DI NUOVE
INFRASTRUTTURE PARALLELE FINO AD ESAURIM ENTO CAPACITÀ DELLE RETI ESISTENTI ;
8 – P RIORITÀ A SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE , OVE POSSIBILE.
A RT . 7 – U FFICI PER GLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO
1 – C OMUNALI OPPURE INTERCOMUNALI, SPECIFICI OPPURE ACCORPATI A SERVIZI
ESISTENTI (nota: senza escludere l’utilizzo di risorse esterne)
2 – C OMPITI:
A ) REDAZIONE PUGSS,
B ) RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE ,
C ) RICOGNIZIONE RETI SOTTOSERVIZI,
D ) CRONO - PROGRAMMAZIONE ,
E ) MONITORAGGIO ATTUAZ IONE PUGSS,
F ) CONTROLLO SU INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO ,
G ) RILASCIO AUTORIZZAZIONI, OVE OCCORRA TRAMITE C ONFERENZE ,
H ) COORDINAMENTO INTERVENTI “ CONGIUNTI”,
I ) GESTIONE S ISTEMA I NFORMATIVO ,
L ) COLLEGAMENTO CON O SSERVATORIO REGIONALE .
A RT . 8 – AUTORIZZAZIONI
pag. 5
Ver. 16/12/2013
1) – (premessa) LE OPERE NEL SOTTOSUOLO ( REALIZZATE DA SOGGETTI DIVERSI
DA C OMUNE E P ROVINCIA ), NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE SPECIFICA , CHE PUÒ
ESSERE INCLUSA IN ALTRO “ TITOLO ABILITATIVO EDIL IZ IO ”;
2) – I COMUNI DISCIPLINANO ( NEL R EGOLAMENTO C OMUNALE ):
A ) – MODALITÀ PER LA COM PILAZIONE DELLE DOMANDE ,
B ) – TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO ,
C ) – ONERI E GARANZIE ,
D ) – CASI DI S ILENZIO A SSENSO ,
E ) - MODALITÀ DI GESTIONE ;
3) – A UTORIZZAZIONI: CONFORMI A PUGSS, PTCP, PGT;
4) - D INIEGO IN CASO DI SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI SPAZIO IN INFRASTRUTTURE
ESISTENTI;
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: NON DISCRIMINATORIO , EQUO ,
ECONOMICO , CELERE E TRASPARENTE .
5) - P OSSIBILI TEMPI RIDOTTI PER SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ;
6) – A UTORIZZAZIONE DEVE CONTENERE:
A ) TEMPI E MODI ESECUZ IONE ,
B ) MODI RIPRISTINO ,
C ) EVENTUALI SANZIONI;
AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DELLA P ROVINCIA , TRAMITE C ONFERENZA DEI
S ERVIZI, IN CASO DI INTERVENTO INTERCOMUNALE
A RT .9 – CARTOGRAFIA E GESTIONE DEI DATI
1) – CRITERI: VALIDI PER MAPPATURA INIZIALE E PER SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI;
2-3) - I SOGGETTI TITOLARI E GESTORI DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI RETI SONO
TENUTI A FORNIRE I DATI COME DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATO DA ALLEGATO 2 E
D.G.R. 21-11-2007 N ° 5900; (3) - CON SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO ANNUALE;
4) – MAPPATURA: F INALIZZATA A COORDINAMENTO , PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE ;
5) – I COMUNI DEVONO DISPORRE BASE CARTOGRAFICA EX D.G.R. 20-02-2008 N °
8/6650 E INTEGRARE MAPPATURA DI INFRASTRUTTURE E RETI AL SIT ( ART. 3 L.R.
12/2005);
6) R EGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PUGSS: PUÒ VIETARE AUTORIZZAZIONI A
SOGGETTI CHE NON ADEMPIONO COMMA 2 ( FORNITURA DATI ), ESCLUSI INTERVENTI PER
CONTINUITÀ DEL SERVIZ IO ;
7) – T RASMISSIONE DATI DA C OMUNI A R EGIONE ENTRO 2 MESI DA RACCOLTA (nota:
o comunque inizialmente con il PUGSS) ; LA R EGIONE ALTRIMENTI PUÒ CHIEDERLI AI
SOGGETTI GESTORI .
A RT . 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1 - PUGSS GIÀ APPROVATI RESTANO VALIDI;
2 – PER ALTRI COMUNI OBBLIGO DI PUGSS CONTESTUALE AL PGT;
3 – ABROGAZIONE R.R. 28-02-2005 N ° 3.
1.2.3 - OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE
Con le disposizioni sopra illustrate e con i dettagliati ALLEGATI 1 e 2 del R.R. 6/2010,
la Regione Lombardia si è posta all’avanguardia a livello nazionale in materia di
programmazione delle reti tecnologiche sotterranee, e stimola correttamente gli enti locali
ed i soggetti proprietari e gestori di infrastrutture e servizi a sviluppare iniziative nella
direzione
- di una maggior conoscenza,
pag. 6
-
di un miglior coordinamento
della formazione di un processo organico di pianificazione-progettazioneprogrammazione.
Tuttavia occorre considerare che le risorse informative, tecnologiche ed operative
effettivamente disponibili presso gran parte degli enti locali e dei soggetti gestori non sono
mediamente adeguate alle necessità imposte dalla normativa in esame, e che i recenti e
crescenti tagli all’autonomia finanziaria degli enti locali stessi non aiuta a prospettare a
breve termine un futuro migliore, anche per l’incertezza sul necessario riassetto della
struttura e delle competenze di Comuni e Provincie.
Opportunamente l’ALLEGATO 1 del R.R. 6/2010 specifica quanto segue:
4.c3 Soluzioni per il completamento della ricognizione
Laddove in occasione della stesura del PUGSS non sia stato possibile dotarsi di una
completa mappatura georeferenziata del sottosuolo, il Piano Operativo dovrà illustrare e
prevedere le più opportune iniziative per raggiungere tale obiettivo, tenuto conto delle
previsioni di cui all'arto 9 del Regolamento, indicando le tecnologie che si intendono
utilizzare, avendo peraltro cura di verificarne la sostenibilità economica.
Dovranno altresì essere indicate le prescrizioni, eventualmente da tradursi nel
regolamento attuativo, per regolamentare gli obblighi di comunicazione dei dati da parte
degli operatori.
e pertanto configura, ove risulti impossibile una piena disponibilità dei dati, il primo
PUGSS come “quadro tendenziale” per successive implementazioni.
Analoga flessibilità diviene necessaria per individuare nella situazione concreta l’assetto
ottimale dello “Ufficio per gli interventi nel sottosuolo”, avvalendosi dei suggerimenti
contenuti nel punto 5 del suddetto ALLEGATO 1, e tenendo conto del carico di lavoro già
oggi gravante sui settori tecnici comunali.
1.3 - QUADRO DI RIFERIMENTO (PTCP VARESE e PGT)
1.3.1 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese, approvato nel 2007, si
occupa solo marginalmente delle tematica delle reti tecnologiche sotterranee, che nelle fasi
di formazione del PTCP stesso era ancora embrionale, soprattutto riguardo alla
disponibilità dei dati e alla conoscenza dei programmi dei soggetti gestori.
Il paragrafo 3.4 “Corridoi tecnologici” della Relazione Generale del PTCP, richiamando
la L.R. 26/2003, si limita a formulare alcuni principi preliminari, individuando, per le reti di
interesse sovracomunale, “le aree già interessate da infrastrutture lineari (tecnologiche o di
mobilità)” quale “riferimento privilegiato per la collocazione dei corridoi in argomento”,
nell’impossibilità di individuare percorsi specifici “in assenza di trasmissione alla Provincia
di Piani o Programmi da parte dei soggetti gestori”.
Successivamente, richiamando la necessità di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, il
paragrafo in esame si occupa diffusamente degli elettrodotti, facendo propri i criteri “ERA
(Esclusione, Repulsione e Attrazione) definiti dal Gestore Rete Trasmissione Nazionale
dell’energia elettrica,
--- in quanto criteri generali, applicabili alle reti tecnologiche in
genere”.
L’art. 30 delle Norme di Attuazione del PTCP ribadisce tali principi.
Con riferimento a quanto sopra riepilogato ed all’insieme delle previsioni e prescrizioni,
anche cartografiche, del PTCP, per il territorio di Golasecca emergono le seguenti
attenzioni prioritarie:
pag. 7
Ver. 16/12/2013
-
-
Tutela dei corridoi ecologici, di cui alla tavola PAE2 del P.T.C.P., che riguardano
1. in direzione in direzione Nord-Sud, la Valle del Ticino – sul lato ovest
dell’abitato - e le aree agro-forestali ad Est dell’abitato
2. in direzione Est-Ovest i collegamenti tra i due corridoi verticali suddetti;
Protezione delle risorse acquifere in sottosuolo, essendo la parte sud-est del
territorio di Golasecca classificata nel PTUA (Piano regionale di Tutela ed Uso
delle Acque), e nello stesso PTCP, come “Area di ricarica degli acquiferi profondi”,
con i territori limitrofi di Somma Lombardo e Vergiate (la parte del territorio
comunale vincolata è delineata da una diagonale congiungente idealmente
Coarezza con il centro di V ergiate, ed include le propaggini sud-est dell’abitato zona produttiva e commerciale).
1.3.2 – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Le connessioni tra il presente PUGSS ed il PGT (ed in particolare con il Piano dei
Servizi) sono strette e molteplici: in questo paragrafo introduttivo si ritiene opportuno
limitarsi a riepilogare, quale quadro di riferimento, gli obiettivi generali del PGT (come
riassunti nel Documento di Piano), evidenziando con la sottolineatura i temi che più
direttamente interferiscono con il PUGSS:
Ø 1) risparmio di suolo a fronte della pressione insediativa espressa dal sistema
socio - economico e manifestata dalle richieste di cittadini e di imprese; tale
obbiettivo si concretizza nella limitazione delle espansioni esterne al perimetro
dell’aggregato urbano e nella priorità alla trasformazione di ambiti già compromessi
oppure sottoutilizzati ed interclusi nell’abitato.
Le necessità del risparmio del suolo si pone non solo in ottemperanza alle
direttive di tutti i piani sovra - ordinati ed alla preoccupazione sugli equilibri
ambientali per le future generazioni, ma anche come riflessione sulla concreta
situazione territoriale di Golasecca, anche se la percentuale di suolo urbanizzato
risulta nettamente inferiore alla media provinciale.
Il nucleo abitato infatti è circondato da boschi, estesi su oltre 2/3 del suo
territorio (in gran parte sottoposti a vincoli superiori), che lo separano dalle
conurbazioni, lungo l’asse del Sempione, e deve contemperare le esigenze di
sviluppo urbano e dei settori extra - agricoli con la vitalità residua del settore
agricolo (e le connesse potenzialità turistiche), costretto in limitate estensioni
coltivabili;
Ø 2) valorizzazione di ambiente e paesaggio come risorsa peculiare per la
qualificazione dell’identità locale sia sul versante abitativo sia su quello dello
sviluppo delle attività economiche; l’obbiettivo si traduce in una accentuazione
degli aspetti paesaggistici nell’analisi e nella progettazione di tutti gli strumenti del
P.G.T., con formulazione di indirizzi su cui la comunità potrà rafforzare gli elementi
caratteristici del patrimonio naturale e storico;
Ø 3) riorganizzazione della città pubblica attraverso un nuovo assetto della
mobilità.
Partendo dalla constatazione di una sostanziale sufficienza quantitativa delle
dotazioni urbane, si ritiene che il loro adeguamento qualitativo deve essere
affiancato da una riforma delle modalità di accesso, concentrata soprattutto sulle
criticità presenti nel centro abitato antico, che trasferisca la priorità alla mobilità
debole, mediante una nuova offerta di percorsi specifici riorganizzando il traffico
veicolare e la sosta.
pag. 8
1.4 - METODOLOGIA DI LAVORO
In vista degli obiettivi generali esposti al precedente paragrafo 1.1, tenendo conto del
quadro di riferimento normativo e pianificatorio sopra riepilogato e della concreta
disponibilità dei dati sulle infrastrutture ed i servizi nel sottosuolo di Golasecca, il
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti incaricato per la redazione del presente
PUGSS ha ritenuto di procedere con le seguenti modalità metodologiche:
- progettazione di uno schema generale del Piano e sua ripartizione tra gli studi
afferenti al RTP sulla base delle diverse specializzazioni e propensioni
-
organizzazione della comunicazione interna al RTP mediante costituzione di un
data base informatico condiviso tramite il server remoto CORE/FTP e mediante
comunicazioni telematiche
-
affiancamento all’ufficio tecnico comunale per il reperimento e l’organizzazione dei
dati relativi al sottosuolo e alla viabilità
-
raffronto con il PGT, redatto dal medesimo raggruppamento di progettisti;
-
recepimento dello studio geologico finalizzato al PGT (il testo è stato riportato in
abbondanti estratti nel presente Rapporto, per l’importanza anche pratica che gli
aspetti geologici hanno per gli operatori nel sottosuolo, onde ridurre la necessità di
risalire puntualmente alla consultazione dello studio geologico complessivo)
-
individuazione delle problematiche emergenti e delle alternative progettuali
(tecniche, programmatorie e procedurali) da sottoporre alle scelte
dell’Amministrazione comunale
-
redazione di un prima bozza del Piano
-
verifica della bozza da parte dell’Amministrazione Comunale
-
redazione finale del P.U.G.S.S.
Deposito preliminare e avvio della procedura di adozione ed approvazione,
unitamente con il P.G.T.
pag. 9
Ver. 16/12/2013
2 – RAPPORTO TERRITORIALE
2.1 - IL SISTEMA GEO-TERRITORIALE
ESTRATTI DALLA
“DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
DOTT. ZARO E CARIMATI – Gazzada Schianno (VA)
2.1.1
- GENERALITA’
Il Comune di Golasecca è situato nella porzione sud orientale della Provincia di Varese,
a circa 19 Km dal capoluogo, adiacente alla sponda orografica sinistra del Fiume Ticino; la
superficie del territorio comunale è di circa 750 ha; il punto altimetricamente più elevato
sfiora i 320 m s.l.m. (a cavallo con il comune di Vergiate), mentre la quota più bassa è di
circa 190 m s.l.m. per una escursione altimetrica complessivamente pari a circa 30 m.
I limiti amministrativi del territorio comunale sono, a partire da nord e in senso orario,
con i comuni di Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo (in Provincia di Varese) e
Castelletto sopra Ticino (in Provincia di Novara).
In via del tutto generale nell’ambito del territorio comunale è possibile isolare due ambiti
morfologicamente distinti.
Il settore centro-settentrionale, quello arealmente più esteso e su cui si è sviluppato il
nucleo urbano, è caratterizzato da una morfologia ondulata con allineamenti di modesti
rilievi collinari (cordoni morenici) dell’Anfiteatro morenico del Verbano, relitti delle fasi
cicliche di espansione-ritiro delle lingue glaciali, la cui continuità laterale risulta spesso
interrotta da piane intermoreniche edificate dagli scaricatori durante le fasi temperate di
ritiro dei ghiacciai
La porzione occidentale è invece caratterizzata dall’incisione valliva del Fiume Ticino e
dalla scarpata morfologica ad esso adiacente, mentre in quella sud orientale si succedono
piane terrazzate stabili di origine fluvioglaciale delimitate da scarpate erosive evidenti, a
morfologia pianeggiante o debolmente ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio
(paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall'idromorfia, in posizione intermedia fra il
Ticino attuale e il Livello Fondamentale della Pianura.
2.1.2
- ANALISI GEOLOGICA
Il territorio in esame si colloca nel settore dell’alta Pianura Padana compreso fra il
Fiume Ticino e il Torrente Strona, a sud della zona dei laghi prealpini del Varesotto.
Geologicamente l’area è caratterizzata dalla presenza esclusiva di depositi sciolti
continentali quaternari giustapposti ed organizzati in vari ordini di terrazzi con direzioni
grosso modo coincidenti con il corso degli attuali e il cui spessore complessivo, almeno per
la zona di studio, può essere stimato superiore agli 80 metri.
pag. 10
La storia geologica del territorio nel Quaternario inizia con la definitiva ritirata del mare
che occupava la Pianura Padana.
Tale regressione, avvenuta in modo lento e progressivo a partire da ovest verso est, ha
provocato l’instaurarsi di un ambiente di tipo lagunare (depositi argilloso torbosi con lenti
sabbioso – ghiaiose del “Villafranchiano”) e quindi più decisamente continentale.
Per quanto riguarda la suddivisione del Quaternario va ricordato che essa è oggetto di
molteplici controversie: quella classica, scandita sulle Alpi da quattro fasi principali (Gunz,
Mindel, Riss e Wurm) e da altrettante fasi interglaciali, si è dimostrata parzialmente
insufficiente per interpretare tutte le variazioni litostratigrafiche esistenti e la complessità
dei rapporti su scala regionale.
Coloro che si occupano del rilevamento dei depositi quaternari sul versante meridionale
delle Alpi, di recente hanno abbandonato il “modello classico” delle glaciazioni.
Così per giungere ad una più adeguata classificazione dei corpi geologici e ad una più
precisa ricostruzione della cronologia degli eventi e dell’evoluzione e paleogeografia dei
depositi, tali ricercatori hanno deciso di usare le “Unità Allostratigrafiche” (Autin, 1992;
Bini, 1994).
In particolare, nel rilevamento di dettaglio dell’Anfiteatro del Verbano (cui l’area in
esame appartiene) si possono riconoscere corpi geologici affioranti estesamente che
formano l’anfiteatro stesso, con cerchie concentriche di morene e piane fluvioglaciali
adagiate sui corpi geologici sepolti costituenti il loro substrato.
Lo studio delle caratteristiche sedimentologiche, paleopedologiche, geometriche e dei
rapporti stratigrafici di queste unità, associato alle datazioni geocronometriche, alla
palinologia e al paleomagnetismo consente una ricostruzione paleoambientale e
paleogeografica sufficientemente dettagliata e tale da permettere il riconoscimento di
almeno 13 diverse glaciazioni separate da corrispondenti interglaciali.
In linea generale si può affermare che a partire dal Pleistocene medio in poi, si assiste
ad un succedersi di periodi caratterizzati da climi sensibilmente differenti, da freddo a
temperato caldo; questi cambiamenti sono scanditi da momenti di avanzata e di ritiro dei
ghiacciai alpini, con la creazione di diversi terrazzi climatici che nella nostra era sono di
tipo fluvio – glaciale e , più recentemente, fluviale.
In particolare, per quanto concerne l’Anfiteatro del Verbano, i 13 corpi di till risultano
separati da evidenze sedimentologiche e pedologiche di clima caldo e le glaciazioni si
sarebbero verificate a partire dal Pliocene superiore.
Per comprendere la genesi di questi terrazzi, a forma di ripiani dovuti ad un’alternanza
di episodi di erosione e di sedimentazione, è necessaria una breve trattazione di questi
fenomeni.
Di solito, lungo un corso d’acqua, è possibile separare schematicamente un tratto ove
prevalgono i processi erosivi e uno in cui prevalgono quelli di sedimentazione: il punto di
passaggio fra questi due settori è detto punto neutro o punto critico).
Risulta evidente che il punto critico di un corso d’acqua migra verso monte in occasione
del periodo di piena e verso valle in quello di magra.
Questo semplice schema consente di comprendere i cambiamenti del sistema
morfoclimatico delle regioni prealpine e dell’alta Pianura Padana.
In sostanza il passaggio da un periodo interglaciale ad un periodo glaciale ha avuto
come risultato l’alluvionamento del fondovalle; il passaggio opposto ha favorito una
incisione di queste alluvioni sotto forma di terrazzi.
Si veniva così a formare un terrazzo alluvionale climatico; le condizioni subtropicali
caratteristiche delle fasi interglaciali determinarono la genesi di suoli che ora delimitano la
sommità dei terrazzi.
I corpi deposizionali più recenti (alluvioni oloceniche) sono a loro volta incisi dai corsi
d’acqua attuali (nella fattispecie il Ticino) a testimoniare che nella fase odierna
predominano i processi erosivi rispetto a quelli deposizionali.
pag. 11
Ver. 16/12/2013
Le unità sono state organizzate in legenda dalla più recente alla più antica e distinte
graficamente in modo univoco attraverso l’attribuzione di un colore, diverso da unità a
unità, e da una sigla (di comodo); per ogni formazione cartografata vengono inoltre riportati
in modo sintetico i caratteri litologici, le facies tipiche e diagnostiche e l’età.
DESCRIZIONE DELLE UNITA’ CARTOGRAFATE
Unità postglaciale (UPg) (Olocene-attuale): con tale terminologia vengono raggruppati i
corpi sedimentari deposti dopo la fusione del ghiaccio dell'ultimo grande evento glaciale
Pleistocenico con l'instaurarsi di processi erosivi/sedimentari slegati da quelli glaciali propri
dell'area in esame; trattasi di un’unità marcatamente diacrona che non ha un sottinteso
cronologico ma genetico.
Nell’ambito dell’area di indagine all’unità sono riferibili i depositi alluvionali attuali e
recenti del Fiume Ticino, caratterizzati da prevalenti sabbie e ghiaie pulite con ciottoli e/o
blocchi con matrice scarsa e generalmente confinata in letti sottili e/o lenti.
I clasti sono poligenici, generalmente subarrotondati, non o debolmente alterati
(alterazione in genere limitata ai termini scistosi o foliati).
All’unità post glaciale sono attribuibili anche depositi di versante al piede della scarpata
morfologica del Ticino costituiti dai materiali colluviati dell'Unità di Daverio o delle coltri
loessiche, costituenti plaghe e/o falde di continuità areale e spessore variabile (da 0 a
pochi metri).
Alloformazione di Cantù (Ca) (Bini, 1987) (Pleistocene superiore, Wurm auct) sinonimo
di. Alloformazione di Bodio: prevalenti ghiaie a supporto di matrice sabbiosa medio
grossolana con ciottoli sparsi; localmente depositi più marcatamente sabbiosi.
In pratica l’unità comprende i depositi che formano i terrazzi più bassi del Ticino,
originati dal Ghiacciaio Verbano, e conservati a quote variabili mediamente fra 200-220 mt
s.l.m, sospesi di circa 15 m rispetto al Ticino attuale.
Allogruppo di Besnate (Riss pro parte e Wurm pro parte auct., Pleistocene mediosuperiore) Costituisce l’unità con maggior diffusione areale nell’ambito dell’Anfiteatro
morenico del Verbano; comprende al suo interno varie unità informali che, pur espressione
di vari episodi sedimentari, non sono state elevate al rango di alloformazioni per carenza di
adeguate informazioni in quanto hanno caratteri peculiari solo per alcuni dei parametri
necessari per istituire un’alloformazione.
La distinzione fra le diverse unità si basa in questo caso sul riconoscimento di parametri
quali presenza di discontinuità morfologico/stratigrafiche e caratteri dell’alterazione
(spessore del profilo di alterazione, colore della matrice …).
Unità di Daverio (BDa) (Da Rold, 1990): sabbie e ghiaie di origine fluvioglaciale passanti
localmente a ghiaie grossolane o ghiaie sabbiose grossolane con rari ciottoli non alterati in
cui abbondano scisti e gneiss, mentre più rari sono i termini granitoidi e anfiboliti; il limite
superiore dell’unità presenta un profilo di alterazione di colore giallo pallido moderatamente
evoluto (spessore fino a 2.5 m).
L’unità, pur in mancanza di evidenze litologiche e morfologiche nette, è stata
cartografata in una fascia che si sviluppa con buona continuità in corrispondenza della
scarpata morfologica del fiume Ticino.
Verso SW costituisce i terrazzi di Coarezza, Maddalena e Castelnovate.
Unità di Mornago (BMo) (Da Rold, 1990): l’unità comprende ghiaie e sabbie
fluvioglaciali, generalmente stratificate, alternate a sabbie a laminazione pianoparallalela o
incrociata, o livelli di ghiaie a supporto clastico; i clasti delle facies ghiaiose sono
rappresentati in prevalenza da gneiss, scisti, granitoidi e rocce intrusive, mentre sono
assenti quelli di natura carbonatica.
L’unità si appoggia con limite di natura erosionale sulle sottostanti unità (Albusciago e
Sumirago) il che suggerisce un deposizione come riempimento di piane vallive con canali a
treccia; la litologia e le strutture sedimentarie indicherebbero in particolare, durante la
massima fase di espansione glaciale, l’attività di un corso d’acqua braided che
pag. 12
successivamente, come conseguenza del ritiro del ghiacciaio e la formazione dei laghi
intermorenici, si evolve in un fiume a meandri (paleoalveo nella piana di C.na San
Giuseppe).
La letteratura riporta in proposito spessori massimi del profilo di alterazione dell’ordine
di 2,5 - 2,6 mt, di colore giallastro-marrone; diffusa la copertura loessica.
Appartengono alla sopra citata unità i terreni che si estendono nella fascia meridionale
del territorio (Pelizzolo, Brughiera di Guaglio e Brughiera del Vigano fino alla cava di ghiaia
di Cascina Vigano) e sono l’espressione di una delle direzioni principali di scarico del
ghiacciaio.
In particolare i suddetti depositi sono organizzati e fra loro giustapposti a originare una
serie di terrazzi espressione di avanzate successive della lingua glaciale, il più alto dei
quali (e quindi più antico) si estende mediamente fra qt. 255 ÷ 260 m s.l.m. (corrispondente
alla piana di Pelizzolo e alla fascia che decorre con andamento SW – NE da C.na Jelmini
verso la Brughiera di Garzonera) e poi in successione il secondo fra qt. 255 ÷ 250 (piana
delle baite di Rolo e C.na Fresca e, verso E, la spianata di Cassera e C.na Torrani), il terzo
fra qt. 247 ÷ 250; il quarto a qt. 246 circa; il quinto fra qt. 240 ÷ 245 e l’ultimo a qt. 238.
I due ultimi terrazzi corrispondono al paleoalveo di un fiume a meandri: in particolare la
direzione della pendenza della piana escluderebbe una sua provenienza dal Ticino ma, in
base alle quote, risulta correlabile alla piana in cui è stata aperta la cava di C.na Vigano.
La spianata di C.na San Giuseppe corrisponde alla point bar riconoscibile per la
successione arcuata di rughe e di depressioni in cui sono riconoscibili anche tratti di canale
abbandonato.
Unità di Sumirago (BSu) (Da Rold, 1990): comprende depositi che testimoniano una
fase di avanzata glaciale (Fase Sumirago) durante la quale il ghiacciaio, pur ricoprendo i
dossi gonfolitici a nord dell’area in esame (dosso di Vergiate) ne risente l’influenza
suddividendosi in tre lingue principali (Lobo di Comabbio, Gallarate e Castronno).
L’unità è costituita sia da depositi morenici a forte componente sabbiosa sia da depositi
di origine fluvioglaciale a prevalenti ghiaie, generalmente stratificate, alternate a sabbie
grossolane.
I primi si rinvengono a formare le cerchie ad andamento NE – SW del M.te Bertone –
M.te Valli Rosse presso Gruppetti fra Sesona e Golasecca, i secondi a costituire le piane
fluvioglaciali a SW di Sesona.
Il limite superiore, di tipo erosionale, presenta un profilo di alterazione di spessore fino
a 4 m con matrice di colore giallastro-marrone.
Alloformazione di Golasecca (Go) (Riss pro parte, W•rm pro parte auct. ,Pleistocene
medio): costituita essenzialmente da diamicton massivi (till di origine glaciale) a supporto
di matrice caratterizzati da una forte componente sabbiosa con ciottoli sparsi di dimensioni
medie da decimetriche a doppio decimetriche.
La matrice è limosa e/o sabbioso-limosa, localmente debolmente argillosa, di un colore
tendenzialmente giallastro; i ciottoli (più raramente blocchi) sono irregolarmente sparsi
mentre nettamente subordinata la ghiaia, presente in sporadiche e irregolari intercalazioni
sotto forma di livelli e/o lenti.
Fra i clasti diffusi nei depositi, di natura esclusivamente granitoide e scistosogneissica,
la percentuale di quelli alterati è prossima al 50 % e il grado di alterazione generalmente
scarso.
Dalla letteratura si ricava che il profilo di alterazione risulta in genere abbastanza
evoluto (spessore fino a 5 - 6 mt) con presenza diffusa di una coltre di loess di colore da
rossiccio (70 cm) o bruno scuro (100 – 150 cm).
Appartengono alla suddetta unità le cerchie con andamento NW – SE del M.te Tabor, di
C.na Vignaccia, C.na delle Motte e M.te Motta, nonchè quelle che segnano il limite
amministrativo del comune di Golasecca a SW di Sesona.
L’orientazione dei cordoni morenici, presenti come modesti dossi semisepolti dal
fluvioglaciale dell’Unità di Sumirago, è prevalentemente NW-SE; questi definiscono il limite
pag. 13
Ver. 16/12/2013
occidentale del Lobo glaciale di Somma Lombardo, correlabili a quelli del Monte AmenoMonte della Guardia fra Somma Lombardo e Arsago Seprio, ad allineamento NE-SW, che
ne costituiscono il fianco orientale.
UNITA’ SEPOLTE
Alloformazione di Pombia (Pliocene Superiore?): l’unità corrisponde al Villafranchiano
degli Autori ed è rappresentata da prevalenti ghiaie a supporto clastico con ciottoli, in
genere arrotondati e ben selezionati, di dimensioni massime prossime al decimetro,
completamente alterati, costituiti per oltre il 90% da granitoidi e scisti.
La matrice, talora abbondante in quanto prodotto della disgregazione dei clasti, è
costituita da sabbia da media a fine, molto ossidata.
Facies correlabili al Villafranchiano sono state segnalate nel territorio comunale di
Somma Lombardo (circa 500 ma sud delle opere di presa del Canale Villoresi e in uno
scavo edile lungo la “via del Ticino” a sud del Candeggio Visconti); l’unità non affiora
nell’ambito del territorio comunale di Golasecca; ad essa è stato attribuito il livello di
“argilla sabbiosa con ciottoloni” incontrato fra 63 e 78 m p.c. nel pozzo comunale.
Argille Plioceniche: depositi prevalentemente argillosi, talora fossiliferi, con irregolari e
discontinue intercalazioni di orizzonti sabbiosi di spessore ridotto; trattasi di depositi di
ambiente litorale.
Come per l’unità precedente non affiorano entro l’area di studio ma sono state raggiunte
da varie perforazioni di pozzi per acqua da quella del pozzo comunale di Golasecca (a
partire da circa 80 m p.c.) ad alcuni pozzi nel vicino territorio comunale di Somma
Lombardo.
I rapporti fra le unità descritte vengono esemplificati nella sezione geologica
interpretativa riportata in allegato 1/a.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Dall’esame della carta geologica e sulla base delle considerazioni esposte nel corso del
capitolo si possono estrapolare i seguenti elementi di sintesi:
- nell’ambito del territorio comunale affiorano unicamente depositi sciolti continentali
quaternari di origine glaciale e fluvio-glaciale;
- nella porzione meridionale del territorio prevalgono depositi fluvioglaciali sabbiosoghiaiosi-ciottolosi organizzati in vari ordini di terrazzi sub pianeggianti separati fra loro da
scarpate morfologiche, geneticamente collegati all’attività del Fiume Ticino o di antichi
scaricatori, cioè corsi d’acqua attivi durante i periodi glaciali, responsabili della costruzione
della piana fluvioglaciale, riattivata dai maggiori emissari dei bacini lacustri interglaciali;
- la distinzione fra i terreni appartenenti ai diversi ordini di terrazzi risulta problematica
basandosi su criteri puramente litologici e bisogna quindi valutare anche la loro posizione
morfologica unitamente al diverso grado di alterazione dei materiali che li costituiscono.
- nella porzione centro settentrionale del territorio comunale si estendono prevalenti
depositi morenici caratterizzati da una forte componente sabbiosa; sono ancora
riconoscibili le tracce delle massime espansioni glaciali (episodio Golasecca e Sumirago)
rappresentati dai relitti delle morene frontali che all’oggi si presentano sotto forma di dossi
dalle forme blande e arrotondate, semisepolti dai depositi fluvioglaciali che hanno edificato
modeste piane intermoreniche;
- le unità profonde indicano il passaggio a depositi ghiaioso sabbiosi profondamente
alterati (Villafranchiano Auct.) e poi prevalentemente argillosi, talora fossiliferi e con
irregolare distribuzione di orizzonti sabbiosi (Argille Plioceniche) che, data la loro bassa
permeabilità, costituiscono dove presenti il livello di base su cui poggia l’acquifero.
pag. 14
2.1.3 - ANALISI GEOMORFOLOGICA
GENERALITA’
Lo studio geomorfologico ha inteso riconoscere oltre alle forme proprie del paesaggio in
esame, nei tratti originari e in quelli propri delle trasformazioni storiche cui è stato oggetto,
anche i processi, attivi e inattivi, attraverso i quali i medesimi tipi morfologici si sono
originati.
La situazione geomorfologica dell’area è, come logico, intrinsecam ente collegata alla
sua storia geologica (e strutturale); in particolare, come già avuto modo di anticipare nei
capitoli precedenti, nell’ambito del territorio comunale di Golasecca è possibile distinguere
due distinti sistemi di paesaggio: il sistema dei rilievi morenici e il sistema dei terrazzi della
pianura fluvioglaciale.
Il primo ambito, che si estende a coprire la porzione centro-settentrionale del territorio
(indicativamente dal cimitero verso nord fino al confine con Vergiate-Sesto Calende),
presenta una morfologia ondulata, con pendenze variabili ma moderate (20 - 40% ), ed è
caratterizzato da una successione di rilievi collinari poco pronunciati e dalle forme
arrotondate orientati preferenzialmente NW-SE, edificati durante l’espansione del lobo
glaciale di Somma Lombrado e successivamente semisepolti dai materiali rimaneggiati
durante le fasi di ritiro dei ghiacciai, che hanno edificato le piane intermoreniche.
Nella parte meridionale si succedono invece diversi ordini di piane terrazzate stabili di
origine fluvioglaciale delimitate da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o
debolmente ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente
ribassate ed affrancate dall'idromorfia, in posizione intermedia fra il Ticino attuale e il
Livello Fondamentale della Pianura.
Di fatto non sono stati evidenziati sul territorio gravi processi geomorfici in atto o
importanti sintomatologie di evoluzioni negative.
Ai fini del presente studio si ricorda che sono definiti “attivi” i processi ad evoluzione
continua e progressiva nelle normali condizioni climatico–fisiche, sono stati invece definiti
quiescenti i processi che si presume possano essere riattivati sotto condizioni climaticoidrologiche a carattere eccezionale, o da un mutato carico antropico.
Le fenomenologie osservate sono state quindi suddivise geneticamente secondo gli
agenti morfologici principali che modellano o hanno modellato le forme del paesaggio.
Nel prosieguo del capitolo verranno riprese puntualmente le problematiche relative ai
vari elementi geomorfologici incontrati sul territorio.
ELEMENTI DI LITOLOGIA
Sulla base dei dati ricavati dalla letteratura a tema, confrontati ed opportunamente
integrati con osservazioni dirette sul terreno, si è proceduto all’individuazione di superfici
omogenee relativamente ai tipi litologici prevalenti.
E’ stato così possibile definire varie classi litologiche, differenziate graficamente
attraverso l’attribuzione di un retino colorato, i cui caratteri sono di seguito riportati
Unità 1
Sabbie e ghiaie fluvioglaciali da medie a grossolane con ciottoli poligenici e isolati
blocchi sparsi; occorrenza di sabbie fini e limi di origine eolica (coltri loessiche);
consociazione di suoli da sottili a moderatamente profondi, limitati da substrato
sabbioso molto pietroso a drenaggio buono; spessore massimo del profilo di alterazione
indicato fino a 2.5 m in relazione all'età dei depositi.
Costituisce le aree terrazzate della porzione meridionale del territorio comunale
(Pellizzolo, Brughiera di Guaglio, Brughiera di Garzonera).
Unità 2
Sabbie fini con abbondante componente micacea e limi in letti discontinui di spessore
generalmente limitato a pochi metri su sabbie e ghiaie ciottolose riferibili alla precedente
pag. 15
Ver. 16/12/2013
unità; suoli moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso molto pietroso a
drenaggio buono Individuabile limitatamente all’area pianeggiante di “La Valle” (territorio di
Somma Lombardo) o ai tratti di canale abbandonato in corrispondenza del paleoalveo nei
pressi di C.na San Giuseppe.
Unità 3
Sabbie limose con ghiaia passanti a sabbie e ghiaie talora ciottolose; localmente coltri
di loess colluviati; suoli da molto sottili a sottili, a drenaggio da buono a rapido.Detta unità
risulta in pratica costituita dalle alluvioni recenti e attuali del Fiume Ticino, con una
distribuzione indicativa fino a 200-210 m s.l.m.
Unità 4
Diamicton massivi a supporto di matrice caratterizzati da una forte componente
sabbiosa e sabbioso-limosa (depositi di morena frontale e di fondo) con rari ciottoli e/o
blocchi sparsi e sporadici orizzonti o lenti di ghiaia.E’ l’unità litologica arealmente più
estesa a costituire la porzione centro settentrionale del territorio comunale dove si è
sviluppata l’area urbanizzata di Golasecca.
.
I tipi e i processi geomorfologici sono stati censiti e cartografati in base al fattore
predisponente in:
• Forme e processi gravitativi di versante
Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana; coronamento in arretramento
Trattasi di una tipologia di processo diffusa soprattutto in corrispondenza del ciglio della
scarpata morfologica di raccordo al Fiume Ticino, favorita dalla presenza di materiale fine
limoso-sabbioso facilmente erodibile e dalla condizione di locale non equilibrio del ciglio
della scarpata stessa per via dell’elevata acclività. I dissesti appartenenti a questa
categoria hanno dimensioni estremamente variabili con lunghezze del ciglio da 2–4 mt a
oltre 100 mt ed altezze della scarpata da <1 mt a 8–10 mt e si evolvono come progressivo
arretramento dell’orlo della scarpata da cui si generano franamenti localizzati di materiale
incoerente e crollo di alberi.
Dissesti principali
Fra le aree in dissesto individuate sono state poste in particolare evidenza quelle che
per dimensione o prossimità a strutture antropiche risultano meritevoli di maggiore
attenzione e per le quali è stata predisposta apposita scheda.
Fra quelli censiti durante la campagna di rilevamento sono almeno tre quelli meritevoli
di attenzione tutti localizzati a ridosso dell’orlo di terrazzo parallelo al corso del Ticino.
Il primo, e più pericoloso, interessa una proprietà privata ad ovest del cimitero; il
secondo risulta ubicato appena prima dell’edificio adiacente lo sbarramento sul Ticino e
l’ultimo, il più grande come dimensioni, coinvolge un centinaio di metri dell’orlo del terrazzo
morfologico nella porzione sud occidentale del territorio comunale segnalato per la
vicinanza al metanodotto.
In corrispondenza di tale dissesto si segnala un reticolo di solchi di origine antropica,
profondi fino a 1,5 mt e di pari larghezza, con andamento subparallelo al ciglio di frana
(trincee ?).
Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana; coronamento in arretramento
Processi legati al progressivo arretramento lungo il versante della nicchia di frana
favorito localmente da locali condizioni di elevata acclività o di scarpate prossime alla
verticale.
Fenomeno franoso a carattere puntuale (non fedelmente cartografabile)
In questa voce sono compresi i dissesti di varia tipologia (scivolamenti indotti da
scalzamento al piede per erosione torrentizia di sponda, smottamenti, piccole colate etc.)
di dimensioni tali da essere considerati alla stregua di elementi puntuali i cui contorni,
proprio per via delle esigue dimensioni, non risultano cartografabili con precisione.
pag. 16
Sono concentrati prevalentemente lungo le principali incisioni vallive che incidono la
scarpata del Fiume Ticino.
• Forme dei processi glaciali
Cordone morenico
Morfologia limitata al settore settentrionale e centro occidentale del territorio comunale
e nelle aree immediatamente esterne allo stesso (zona a ovest di Sesona).
I rilievi morenici si configurano all’oggi come dossi dalle forme piuttosto arrotondate,
risultato del modellamento dell’erosione con assi fra loro sub paralleli orientati secondo
due direzioni preferenziali NW–SE e NE–SW corrispondenti a due distinte fasi di
espansione del Ghiacciaio Verbano (episodio Golasecca ed episodio Sumirago
rispettivamente).
In particolare ogni cresta morenica corrisponde ad un’avanzata glaciale: esse cioè
vengono generate dal ghiacciaio in avanzata e rilasciate al ritiro.
Le dimensioni dei suddetti corpi e la loro distribuzione sul terreno dipendono perciò
strettamente dalle condizioni di alimentazione del ghiacciaio e dalla forma del substrato: in
condizioni di sovralimentazione (massima espansione) il ghiacciaio possiede uno spessore
maggiore risentendo solo della presenza dei dossi più accentuati del substrato e quindi può
espandersi maggiormente.
Le morene hanno andamento semicircolare, piuttosto grandi e ben distanziate e tendono
a rappresentare una singola fase di avanzata invece di essere formate per accrezione di
più morene.
Durante le avanzate successive, che avvengono durante il ritiro generale del ghiacciaio,
in condizioni di alimentazione minore, il fronte dello stesso è più irregolare, lo spessore più
ridotto così che il ghiacciaio risente più marcatamente della presenza di dossi del
substrato. Ne derivano morene con andamento molto articolato, generalmente piccole e
ravvicinate, poiché il ghiacciaio in questa fase evolutiva subisce frequenti pulsazioni di
modesta entità.
• Forme e processi per acque correnti superficiali
Conoide detritico torrentizio
Forme di accumulo sedimentario localizzate preferenzialmente allo sbocco delle
principali incisioni vallive afferenti al Fiume Ticino o alla base delle scarpate di raccordo fra
terrazzi morfologici e legate in parte a passati regimi idrologici.
Fra le conoidi cartografate quelle attive sono generate ad opera di torrenti temporanei: il
corso d’acqua in condizioni pluviometriche eccezionali erode i materiali in alveo per deporli
subito a valle, allo sbocco nel Ticino.
Le stesse forme possono risultare completamente obliterate in occasione delle piene di
quest’ultimo.
Tratto di alveo con tendenza all'approfondimento e/o solco di erosione concentrata
Sotto questa definizione vengono identificate quelle porzioni di territorio in cui risulta
dominante l’azione erosiva delle acque di ruscellamento incanalate.
Nel primo caso trattasi di fenomeni che interessano linee di deflusso naturali già
esistenti e ben definite con progressiva e continua incisione dell’alveo che assume un
caratteristico profilo a “V” mentre il secondo tipo è proprio di acque di ruscellamento che,
seguendo direzioni preferenziali in genere non corrispondenti a impluvi veri e propri,
tendono a creare solchi più o meno incisi nella copertura.
Tale tipologia si esplica in modo particolarmente manifesto soprattutto alla testata degli
impluvi che si originano dal ciglio del terrazzo morfologico (zona cimitero, rudere di San
Michele, etc.) risultando favorita dalla forte pendenza sia, spesso, dalla presenza di
scarichi civili.
Si vuole sottolineare una situazione, particolare per le sue dimensioni, osservata a
ovest dell’impianto di depurazione (presso il Fiume Ticino) laddove il solco che si è
generato raggiunge larghezze massime sui 3–4 mt e profondità anche superiori (si veda in
proposito la documentazione fotografica allegata).
pag. 17
Ver. 16/12/2013
Trattandosi di una tipologia di fenomeno particolarmente diffusa, per ragioni di scala
grafica si sono volute cartografare solo le zone in cui esso risulta molto evidente o laddove,
direttamente o indirettamente, può interagire con strutture antropiche.
Tratto di alveo sovralluvionato
Questa tipologia di fenomeno risulta particolarmente evidente in corrispondenza della
prima grande incisione a sud del rudere di San Michele.
L’alveo risulta ampiamente sovralluvionato con depositi costituiti da ghiaia, ciottoli e
blocchi in matrice sabbiosa scarsa o assente.
Diversi sono i tratti, più frequenti nella porzione mediana dell’inciso, dove lo stesso
risulta non o difficilmente percorribile per la presenza di alberi franati che ne ostruiscono la
regolare sezione di deflusso.
Si segnala da ultimo lo stato di generale ammaloramento dell’opera di regimazione
(soglia in cls) presso la quale si sono registrati fenomeni di scalzamento in corrispondenza
delle spalle ad opera delle acque correnti non efficacemente drenate a causa
dell’abbondante sovralluvionamento.
Area allagata/allagabile per esondazione fuori dagli argini
Aree soggette ad alluvionamento in occasione di portate di piena conseguenti ad eventi
meteorici a carattere eccezionale.
In particolare, sulla base delle segnalazioni del Settore Ambientale e Ufficio GIS del
Parco Lombardo del Ticino, è stata identificata la porzione di sponda adiacente la S.P. 27
dal Campig Turist “Il Gabbiano” fino allo sbarramento allagata in occasione della piena del
16 ottobre 2000.
Paleoalveo di scaricatore, direzioni principali delle alimentazioni fluvioglaciali
Traccia relitta dai maggiori corsi d’acqua attivi durante i periodi glaciali, responsabili
della costruzione della piana fluvioglaciale, riattivata dai maggiori emissari dei bacini
lacustri interglaciali (laghi di Varese, Monate, Comabbio)
Le direzioni principali delle alimentazioni fluvioglaciali indicano le provenienze
prevalenti degli apporti sedimentari responsabili della costruzione della pianura
fluvioglaciale.
Nel territorio comunale si segnala la traccia del paleoalveo nelle adiacenze di C.na San
Giuseppe che, per l’ottimo stato di conservazione, costituisce una zona di una certa
rilevanza ambientale meritevole di tutela quale ambito di interesse geomorfologico; nel
tratto di meandro il canale presenta una larghezza di circa 200 m e l’area su cui sorge la
Cascina San Giuseppe rappresenta i depositi della point bar, caratterizzata da una
successione di rughe e depressioni e tratti di canale abbandonato.
Terrazzo morfologico, orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia
Le morfologie attive sono potenzialmente oggetto di scalzamento al piede da parte dei
corsi d’acqua temporanei, in condizioni idrologiche particolari; le morfologie inattive sono
relitte da decorsi fluviali antecedenti quelli attuali, su di queste il profilo del versante è
modificato dai soli processi su versante (dove efficaci).
Aree acclivi con depositi fini interessate da erosione concentrata e diffusa
Morfologia limitata al quadrante nord occidentale del territorio comunale dove si
evidenzia una ramificazione di numerosi impluvi e solchi di erosione concentrata a
carattere temporaneo delimitati da scarpate acclivi e cigli spesso instabili favoriti dalla
circolazione e dal dilavamento operato dalle acque di ruscellamento su depositi fini
incoerenti (morene sabbiose e coltri loessiche).
Tratto di corso d’acqua privo di recapito definito con tendenza allo spagliamento
Processi legati tipicamente alle aste idriche a carattere stagionale o temporaneo che
incidono la scarpata del Ticino dove le acque circolanti, generalmente a seguito di eventi
meteorici intensi o rovesci a carattere temporalesco, mancando un recapito finale vero e
proprio, tendono a disperdersi alla base del versante o in corrispondenza di significative
variazioni di pendenza della superficie topografica ove depositano anche l’eventuale carico
pag. 18
solido (lapideo e/o vegetale) (torrenti identificati con n. 5, 8, 9 e 10 nello studio di
definizione del reticolo idrico minore).
Situazioni analoghe si evidenziano in corrispondenza del tratto terminale dei principali
impluvi del quadrante nord occidentale per i quali il tratto terminale sfuma
progressivamente fino a coincidere con il tracciato di vecchie strade consorziali (torrenti
identificati con n. 1, 2, e 3).
Impluvi praticamente non più attivi caratterizzati da assenza di recapito finale sono
quelli che incidono il versante a sud-est del cimitero e che si interrompono all’arrivo sulla
piana di C.na San Giuseppe consorziali (torrenti identificati con n. 11, 12, e 13).
Erosione torrentizia di sponda
La morfologia è caratterizzata dall’azione delle acque correnti laddove la linea di
maggior velocità, e quindi di maggior capacità erosiva, si sposta verso il margine convesso
dell’alveo in corrispondenza delle anse fluviali.
Frequentemente negli impluvi giovanili tributari del Ticino lo scalzamento indotto
dall’erosione torrentizia induce fenomeni di scivolamento/smottamento nella porzione di
versante immediatamente adiacente l’alveo.
Per ragioni di opportunità, trattandosi di un fenomeno abbastanza circoscritto e
difficilmente cartografabile alla scala degli elaborati cartografici, non è stato contemplato
nella carta di inquadramento geomorfologico.
• Forme dei processi antropici
Oltre ai processi “naturali” si è ritenuto opportuno cartografare anche le “forme” indotte
dalla pressione antropica in modo da rendere immediato il riconoscimento delle opere, dei
manufatti e degli interventi in generale che nel corso degli anni hanno modificato e spesso
obliterato l’assetto morfologico originario del territorio in esame.
A tale scopo si sono messi in evidenza i seguenti elementi:
Terrazzamento antropico, ciglio di scarpata artificiale
La prima categoria individua e comprende interventi di sagomatura dei versanti collinari
mediante realizzazione di vari ordini di gradoni artificiali realizzati allo scopo di ottenere
una migliore stabilizzazione dei terreni associata spesso ad un eventuale loro utilizzo a
scopo agricolo (vigneti, frutteti etc.).
Per quanto concerne i cigli di scarpate artificiali individuano sia gli orli di scarpate
generate a seguito di sbancamenti o scavi, sia conseguenti ad interventi di rimodellamento
del territorio mediante realizzazione di rilevati.
Muri a secco di contenimento
Strutture di contenimento/consolidamento dei versanti, attualmente risultano spesso
parzialmente ammalorati per mancanza di periodica manutenzione.
Superficie di rimaneggiamento antropico
Area nella quale gli interventi antropici hanno obliterato le originarie caratteristiche del
paesaggio.
In questa definizione, volutamente generica, rientrano ad esempio le superfici di
spianamento, le aree interessate da riporti di terra e/o materiali inerti (opere in terra
realizzate dall’uomo utilizzando materiali di risulta quali terre di sbancamento o inerti di
cava, e quindi aventi caratteristiche variabili in relazione alla tipologia dell’intervento
eseguito, come ad esempio i rilevati stradali) o gli scavi (attivi e/o abbandonati).
“Forme” di questo tipo sono state riconosciute presso l’incrocio fra la S.P. 27 e la Strada
Alzata Fiume Ticino, in adiacenza alla Strada Comunale della Mercantera a nord di località
Cassera o, in vari tratti lungo Viale Europa (rilevati).
Deviazioni, correzioni, stabilizzazioni di sponda, canali artificiali
Individuano gli interventi di stabilizzazione delle sponde/alveo operati lungo alcuni
impluvi.
L’opera principale riconosciuta sul territorio comunale riguarda l’inciso a valle
dell’impianto di depurazione in località Persuado (torrente n. 4 dello studio di definizione
del reticolo idrico minore) che si immette poi nel Fiume Ticino.
pag. 19
Ver. 16/12/2013
Le sponde sono state stabilizzate con posizionamento di massi ciclopici ed il fondo, a
salti, rivestito in cemento.
Sul versante a monte della conca di navigazione presso lo sbarramento della Miorina, a
seguito dei recenti interventi di consolidamento del versante, il corso dell’incisione che
originariamente recapitava nel Ticino è stato deviato mediante creazione di un canale
artificiale realizzato in tronchi con briglie in legname e pietrame.
A tergo del contenimento in massi ciclopici in fregio all’alzaia del Ticino è stata quindi
realizzata una canalizzazione per l’intercettazione delle acque provenienti dal versante le
quali vengono recapitate nel torrente n. 4.
Sbarramento, opere di regimazione trasversali su corso d’acqua
Trattasi di strutture realizzate normalmente rispetto alla direzione di flusso della
corrente. Lungo il Fiume Ticino è stata individuata la traversa della Miorina, per mezzo
della quale viene regolato il lago Maggiore.
Lungo gli altri corsi d’acqua (a parte i salti di fondo e le briglie in legname e pietrame
lungo il corso del torrente n. 4 a valle del depuratore) è stata cartografata la briglia a monte
dell’Alzaia del Ticino realizzata lungo l’alveo a valle del rudere del San Michele.
Strutture antropiche ammalorate
In questa categoria sono stati identificati i tratti con deformazioni del manto stradale
verosimilmente indotti da attività morfologica.
Si rinvengono essenzialmente lungo la strada che costeggia il Fiume Ticino (lesioni e
cedimenti riconducibili ad erosione fluviale) e lungo Viale Europa nel tratto che scende al
Ticino (deformazioni di tipo gravitativo).
Porzione di versante consolidata con interventi di ingegneria naturalistica
Individua una ampia porzione di versante a monte della traversa della Miorina
(superficie piana di poco superiore a 1 ha) recentemente interessata da interventi di
riconformazione morfologica e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica.
Manufatti di contenimento a piede versante (massi ciclopici, palificate)
Sono stati cartografati il muro di contenimento in massi ciclopici realizzato al piede del
versante consolidato di cui alla voce precedente (lunghezza circa 160 m) e la palizzata
(circa 20 m) alla base di una scarpatella in dissesto in fregio alla via Alzaia del Ticino (a
circa 40 m di stanza dal muro).
Aree ad acclività da media a elevata con predisposizione a processi di tipo gravitativo
e/o erosione concentrata/diffusa
Sono state individuate le porzioni di versante ad acclività variabile (30-60 % ) che per
loro natura (presenza di depositi fini e/o ruscellamento di acque non incanalate) risultano
maggiormente sensibili quindi più predisposte all’innesco di fenomeni franosi in condizioni
meteorologiche particolarmente sfavorevoli.
Aree ad acclività da media a elevata con depositi fini interessate da processi di
erosione diffusa
Sono localizzate in corrispondenza del quadrante nord occidentale del territorio
comunale dove si individuano processi attivi di erosione diffusa superficiale favorita dalla
presenza di depositi morenici sabbiosi che hanno portato alla formazione di un reticolo
ramificato di incisioni vallive che non ha riscontro in altre porzioni del territorio.
Il rilevamento ha posto in evidenza i caratteri morfologici/paesistici primari del territorio
in esame, che possono essere così riassunti:
- il settore centro-settentrionale del territorio comunale presenta ancora ben riconoscibili
i caratteri della morfogenesi glaciale, solo parzialmente obliterati dalla crescente pressione
antropica (rilievi del M. Motta, C.na delle Motte, etc.) in forma di dossi arrotondati spesso
separati, gli uni dagli altri, da ampie superfici subpianeggianti o debolmente inclinate.
- Il settore meridionale deve i suoi caratteri morfologici principali all'azione di deposito
delle acque glaciali e interglaciali, secondo le direzioni di apporto che sono state
individuate. Le variazioni ritmiche delle oscillazioni climatiche e pluviometriche intercorse
pag. 20
nei tempi geologicamente più recenti (olocenici) hanno lasciato sovrapposti i segni di
differenti equilibri idrologici nei corsi d'acqua che hanno modellato il rilievo, ora con
prevalente sedimentazione (costruzione dei diversi ordini di terrazzi o ripiani alluvionali),
ora con prevalente erosione (incisione degli orli di terrazzo). A questo proposito risulta
particolarmente didattica l’ampia superficie subpianeggiante di C.na San Giuseppe dove
risulta ancora ben conservato il sistema deposizionale del corso a meandri che occupava
detta area (point bar, tratti di canale abbandonato, etc.).
- Per quanto concerne i caratteri dell’idrografia superficiale si possono identificare
indicativamente due situazioni ben distinte che trovano diretto riscontro sulla morfologia.
La scarpata morfologica di raccordo fra il pianoro su cui si è sviluppato il centro abitato e il
Fiume Ticino è solcata da aste ad andamento lineare fra loro subparallele con andamento
medio EW o SW-NE, con prevalenza di impluvi piuttosto ampi con assenza di tributari in cui
le evidenze di attività erosiva da parte delle acque superficiali sono spesso limitate alla
testata dell’inciso dove maggiore è la pendenza del terreno, mentre nella porzione
terminale, dove l’inclinazione si riduce drasticamente, spesso non si può identificare un
vero e proprio alveo. Si discosta da questa situazione la porzione nord occidentale di
territorio comunale, grosso modo compresa fra il Fiume Ticino, località Persualdo-Brusada
e M.te Gagliasco dove si riconosce un reticolato a carattere marcatamente ramificato
verosimilmente legato anche a variazioni litologiche del substrato con prevalenza di
depositi fini incoerenti e come tali più facilmente erodibili.
- come già avuto modo di anticipare, non sono state evidenziate sul territorio comunale
particolari sintomatologie ad evoluzione negativa. Si sottolinea comunque una situazione
abbastanza delicata lungo tutta la scarpata morfologica di raccordo al Fiume Ticino in
relazione soprattutto alla generale (anche se variabile) elevata pendenza del versante e al
deflusso delle acque di scorrimento superficiali. Per quanto riguarda la gestione dell’area
suddetta è indispensabile che qualsiasi eventuale intervento venga attentamente valutato
soprattutto in relazione al rischio di erosione anche in conseguenza della scarsa profondità
dei suoli. Per gli stessi motivi si ritiene sconsigliabile un ulteriore incremento della
pressione antropica nelle fasce immediatamente adiacenti le testate degli impluvi che
incidono la scarpata in quanto aree a sensibilità particolarmente elevata sotto il profilo
idrogeologico.
- Sul territorio comunale sono state riconosciute aree di particolare valenza ambientale
(brughiera a conifere) caratterizzate da particolari associazioni vegetazionali probabilmente
superstiti di paleoclimi ad affinità più boreale. Queste aree, date le peculiarità floristiche e
lo stato di conservazione, rappresentano le unità paesaggistiche più rilevanti del territorio
in esame ed aree che non hanno subito alcuna modificazione ad opera dell’uomo: come tali
andrebbero quindi valorizzate e sottoposti a provvedimenti di salvaguardia. Fra le aree per
cui si consigliano provvedimenti di tutela ambientale si cita inoltre la spianata adiacente a
Cascina San Giuseppe dove si riconosce, ben conservata, la traccia di un paleoalveo di
scaricatore fluvioglaciale. L’analisi del territorio comunale in relazione alle modificazioni
indotte dall’attività antropica ha permesso di evidenziare un significativo incremento
dell’urbanizzazione a partire dai primi anni del ‘900, facilmente riscontrabile attraverso una
semplice comparazione fra le attuali carte topografiche e quelle compilate ad inizio secolo.
L’espansione urbana, con una prevalente vocazione allo sviluppo di attività produttive,
sembra comunque aver inciso in misura relativamente ridotta sull’originaria destinazione
agricolo-forestale dei terreni anche se molteplici sono i casi in cui, terreni un tempo
utilizzati per la produzione agricola intensiva, oggi sono quindi in quasi totale stato di
abbandono venendo progressivamente interessati da vegetazione arborea ed arbustiva
spontanea.
pag. 21
Ver. 16/12/2013
2.1.4 - ANALISI IDROLOGICA, IDROGRAFICA E IDROGEOLOGICA
INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO
In linea del tutto generale per l’area di studio si può parlare di un clima di tipo
continentale, con inverni rigidi ed estati calde, elevata umidità specie nelle zone con più
ricca idrografia, nebbie frequenti specie in inverno, piogge piuttosto limitate (600-1100
mm/anno) e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la ventosità è ridotta e
frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi.
Regime termico
Per la definizione delle caratteristiche termiche dell’area di indagine sono state prese in
considerazione le serie storiche delle temperature registrate alla stazione di Porto della
Torre in Comune di Somma Lombardo (periodo 1978-1998)
Dall’esame dei dati numerici riportati si può notare come la temperatura media annuale
(relativamente alla serie storica analizzata) sia di poco superiore a 10° C; luglio e agosto
sono i mesi più caldi mentre quello più freddo gennaio.
Le temperature medie stagionali risultano essere 0,87 °C per l’inverno, 9,58 °C per la
primavera, 20,18 °C per l’estate e 11,08 °C per l’autunno.
L’escursione termica è prossima ai 20° C.
L’escursione annuale risulta contenuta al di sotto dei 2 °C.
Regime pluviometrico
Per la caratterizzazione generale del regime pluviometrico sono stati presi in
considerazione i dati relativi alle precipitazioni registrate presso la stazione di Porto della
Torre in Comune di Somma Lombardo (periodo 1978-1998), che evidenziano una
distribuzione delle precipitazioni con due massimi corrispondenti alla stagione primaverile e
autunnale, mentre i minimi cadono a luglio e lungo l’intera stagione invernale.
Sempre sulla base dei dati di temperatura e precipitazione raccolti si è potuto calcolare
la possibile perdita di acqua meteorica ad opera dei fenomeni di evaporazione e
traspirazione del manto vegetale (evapotraspirazione), mediante la formula di L. Turc
(1954):
I valori ricavati sono apparsi essere per lo più compresi tra i 485 e i 540 mm di pioggia
equivalenti annui, corrispondenti a percentuali fra il 32 e 56% delle precipitazioni avute.
Per quanto riguarda la residua quota di acque meteoriche, in relazione alla elevata
permeabilità dei terreni superficiali ed alla generale blanda topografia del territorio
comunale, si ritiene che esse siano soggette ad una immediata infiltrazione con
conseguente alimentazione diretta della falda (fatta eccezione per le zone acclivi come le
scarpate dei terrazzi morfologici dove, evidentemente, prevalgono fenomeni di
ruscellamento).
CENNI DI IDROGRAFIA
Il territorio comunale di Golasecca presenta una rete idrica superficiale relativamente
semplice, in cui l’elemento primario è rappresentato dal Fiume Ticino che scorre lungo il
limite occidentale del territorio comunale segnando il confine fra la Regione Lombardia e la
Regione Piemonte (e le province di Varese e di Novara).
Nel tratto sublacuale (indicativamente fino a Vizzola) il Ticino presenta un alveo molto
inciso, con sponde ripide e vegetate, incassato entro i depositi glaciali quaternari del lago
Maggiore, con alveo a struttura monocursale a sezione media di larghezza pari a 50-80 m
ed una discreta velocità di corrente.
In questo tratto il fiume non presenta fenomeni erosivi rilevanti; quelli esistenti sono
comunque limitati a livello locale con possibilità di innesco, per le portate elevate, di piccoli
fenomeni gravitativi.
Il deflusso risente della regolazione del lago effettuata dalla traversa della Miorina; i
livelli hanno mediamente escursioni poco rilevanti e permettono una stabilizzazione delle
sponde e dell’interfaccia sponda-alveo.
pag. 22
Sul resto sul territorio comunale non si individuano corsi d’acqua di rilievo ed a
carattere perenne, piuttosto si riconoscono solo aste a carattere temporaneo attive o
riattivabili a seguito di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate o, in parte,
dagli scarichi delle reti fognarie.
In linea del rutto indicativa nell’ambito del territorio comunale di Golasecca si possono
distinguere tre settori distinti con caratteri idrografici peculiari.
Scarpata del Fiume Ticino: è solcata da numerose incisioni, alcune piuttosto profonde,
subparallele con direzione media SSE-NNW o E-W, a carattere stagionale e regime di
portata fortemente variabile in relazione all’entità e durata delle precipitazioni; i materiali in
alveo sono prevalentemente grossolani (ciottoli, ghiaie e blocchi) e le pendenze in genere
da medie a, localmente, elevate.
La porzione centro meridionale del territorio comunale è caratterizzata da una
successione di terrazzi morfologici subpianeggianti con depositi altamente permeabili che
favoriscono i processi di infiltrazione rispetto a quelli di ruscellamento superficiale; ne
deriva in pratica l’assenza pressochè totale di aste idriche.
Infine il quadrante nord occidentale del territorio, a cavallo con il confine con Sesto
Calende, presenta un discreto numero di incisioni, più o meno profondamente scavate
entro le morene sabbiose, anch’esse a carattere temporaneo e comunque spesso prive di
un vero e proprio recapito finale dato che in molti casi il tratto terminale di tali aste coincide
con sentieri o piste a fondo naturale.
Reticolo Idrico Principale
Relativamente al territorio comunale di Golasecca ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R.
7/13950 del 1 agosto 2003 l’unico elemento classificato come Reticolo Idrico Principale è il
tratto del Fiume Ticino (2/M EL. AAPP.) a valle della diga della Miorina.
Per via della funzione di regolazione delle portate esercitata dalla traversa la porzione
di Fiume Ticino a monte dello sbarramento fino al Lago Maggiore viene pertanto
considerata come lago.
Reticolo Idrico Minore
Il Comune di Golasecca ha avviato lo studio per la determinazione del Reticolo Idrico
Minore in ottemperanza alla D.G.R. del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 “Determinazione del
reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica
concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000
– Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e le successive modifiche apportate dalla
D.G.R. del 1 Agosto 2003, n. 7/13950.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle caratteristiche principali dei corsi
d’acqua computati quali elementi del Reticolo Idrico Minore.
Torrente n. 1
Trattasi di un sistema ramificato di valli più o meno incise entro le morene sabbiose,
prive di deflusso idrico se non a seguito di precipitazioni a carattere eccezionale o
particolarmente intense e/o prolungate.
Tutto il tratto a valle del tracciato autostradale è attualmente una pista a fondo naturale
(alveo tombato ?) con tratti incisi a denotare un ruscellamento occasionale non controllato.
Nel tratto terminale la pista è fiancheggiata da canaletta in cls a sezione trapezoidale
che raccoglie le acque provenienti dal rilievo della zona archeologica le quali vengono
convogliate in una vasca in cls a pianta rettangolare 260x370 cm profonda 250 cm dalla
quale escono due tubi cls Ø 100 cm.
Il tratto terminale tombato sbocca a fiume entro l'area di proprietà del camping " Il
Gabbiano".
In fregio alla strada sterrata decorre poi la canaletta in cls che raccoglie le acque
provenienti dalla zona archeologica presso l'imbocco della galleria autostradale
Torrente n. 2
pag. 23
Ver. 16/12/2013
Sistema ramificato di impluvi che incidono più o meno profondamente il versante ad
ovest del Monte Gagliasco, prive di deflusso idrico se non a seguito di precipitazioni a
carattere eccezionale o particolarmente intense e/o prolungate.
Dette incisioni non presentano un recapito finale definito dal momento che sboccano su
piste a fondo naturale o sentieri i quali non presentano di fatto evidenze particolari di
ruscellamento; la pista principale termina poi a sua volta in corrispondenza di un piazzale
sterrato usato per la sosta dei veicoli con quota di p.c. inferiore rispetto a quella della S.P.
27 per cui è verosimile che in caso di eventi sfavorevoli le acque e l'eventuale carico solido
delle aste idriche vadano a spagliare sul piazzale stesso.
Torrente n. 3
Impluvio che incide il versante a nord del Lazzaretto, privo di deflusso idrico se non a
seguito di precipitazioni a carattere eccezionale o particolarmente intense e/o prolungate.
L'alveo non presenta un recapito finale definito anche se causa la fitta vegetazione
infestante a ridosso della S.P. 27 non consente di verificarne lo sviluppo.
Il tratto terminale coincide con una pista a fondo naturale ed in caso di eventi a
carattere eccezionale le acque e l'eventuale trasporto in sospensione spagliano sul
piazzale nei pressi della cabina elettrica presso il pozzo comunale; l'impluvio riceve le
acque chiare provenienti dalla S.P. 27.
Torrente n. 4
Asta idrica che trae origine presso il depuratore, a monte del quale è visibile un tubo in
cls e che verosimilmente prosegue verso monte fino al tornante della S.P. 27 (tratto non
percorribile a causa della fitta vegetazione infestante); dopo aver percorso circa una
ventina di metri coperto, ritorna a cielo aperto come canale con fondo e sponde in pietrame
con vari salti di fondo; all'incrocio con la via Alzaia del Ticino è stata realizzata una grossa
e profonda camera in cls con funzione di laminazione e dissipazione dell'energia prima
dello scarico a fiume.
Circa a metà del percorso riceve in sponda destra il canale realizzato a seguito degli
interventi di consolidamento del versante (canale in tronchi con briglie in legname e
pietrame).
Torrenti n. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10
Aste idriche che solcano la scarpata del Ticino con direzione media variabile da E-W a
SE-NW; trattasi di impluvi a carattere temporaneo, attivi o riattivabili a seguito di
precipitazioni a carattere eccezionale o particolarmente intenso e/o prolungato; l'elevata
acclività della scarpata e la presenza di materiali incoerenti possono localmente innescare
fenomeni di approfondimento e episodi di trasporto solido di fondo e in sospensione.
Ad eccezione del numero 6 e del numero 7 non presentano un recapito finale definito
tendendo piuttosto a spagliare a monte della strada consorziale o in aree boscate o in
corrispondenza di rotture di pendenza della scarpata.
Torrenti n. 11 – 12 - 13
Trattasi di incisioni vallive piuttosto evidenti limitatamente alla testata e al tratto
mediano ma che tendono a perdere progressivamente identità verso la parte terminale; non
presentano un recapito finale definito ma le eventuali acque (circolanti solo a seguito di
eventi a carattere eccezionale o particolarmente intensi e prolungati) spagliano in
corrispondenza di aree boscate all’incrocio con la piana di C.na San Giuseppe.
Note sul Fiume Ticino
Per completezza in questo paragrafo si riportano alcune brevi note sul Fiume Ticino
tratte dai lavori: “POZZI R. (1976) – Per una politica del territorio: la valle del Ticino” e
“PARCO DEL TICINO AA.VV. (1994) – Il Ticino – studi e proposte per l’assetto
idrogeologico e sull’uso del territorio della valle fluviale”.
Le portate liquide lungo il corso del Ticino sublacuale dipendono principalmente dal
deflusso del Lago Maggiore; il rilascio del lago è regolato dallo sbarramento della Miorina,
operativo dal 1942.
pag. 24
In base ai dati disponibili all’idrometro della Miorina le portate (espresse in mc/s)
caratteristiche del Ticino sono le seguenti:
portata minima: 35 (16 – 01 – 1922);
portata media: 279 (1943 – 1992);
portata massima: 5000 (2 – 10 – 1868).
Le portate minime si registrano nelle stagioni invernali (febbraio) ed estive (agosto,
minimi assoluti), le massime nelle stagioni intermedie (da aprile a giugno e, in assoluto, fra
settembre e ottobre).
Le derivazioni d’acqua per uso agricolo e industriale utilizzano un totale di 220 – 240
mc/s.
La piena del Ticino del 1993 è stata la più grande di questo secolo e la più grande dal
1868: si può perciò definire un tempo di ritorno dell’ordine dei 125 anni.
Il periodo di piena con portate superiori alla piena ordinaria (900 mc/s) è stato dal 24 –
09 al 26 – 10; con portate massime superiori ai 2000 mc/s nel periodo 09 – 17 ottobre
(massimo assoluto: 2500 mc/s nel giorno 15 – 10 – 1993).
Lo studio delle caratteristiche idrogeologiche locali finalizzato alla ricostruzione della
geometria delle unità sepolte si è basato essenzialmente sull’esame e la comparazione
delle stratigrafie dei pozzi per acqua perforati nel territorio comunale ed in quello dei
comuni limitrofi.
Dalla consultazione di materiale vario in parte reperito anche presso l’Amministrazione
comunale risultano censiti complessivamente sul territorio comunale di Golasecca 3 pozzi,
di cui uno perforato in località Cascina Melissa (profondità 8 m, privo di stratigrafia) e due
ad uso idropotabile in località Presualdo.
Del pozzo “Presualdo I^” perforato nel 1962 dalla I.P.T.A. nel 1962 (profondo 43.5 m)
non esiste stratigrafia né dati di ubicazione. ttualmente l’acquedotto comunale è servito dal
pozzo “Presualdo II^” (perforato nel 1982 dalla ditta Negretti) profondo 80 m.
La ricostruzione dell’assetto idrogeologico dell’area si è basata essenzialmente
sull’analisi delle stratigrafie dei pozzi per acqua e sulla distribuzione delle litologie
affioranti.
In via del tutto schematica è possibile individuare due distinti complessi idrogeologici
Complesso ghiaioso-sabbioso
Vi si riconosce, a partire dalla superficie, una successione di alluvioni di spessore
variabile fra 20-40 m a prevalenza di ghiaie e ghiaie grossolane poligeniche con ciottoli, a
matrice sabbiosa da media a molto grossolana, con subordinati intervalli di sabbia da
media a molto grossolana, spesso ciottolosa (fluvioglaciale Wurm), espressione dei
sedimenti depositatisi in ambienti fluviali di alta energia attivi durante le fasi interglaciali
del Quaternario (Pleistocene superiore e medio).
Secondo le recente interpretazione della geologia del sottosuolo a livello regionale
(Regione Lombardia, “Geologia degli acquiferi Padani della Regione Lombardia” - 2002)
tale materasso alluvionale coincide con l’unità idrostratigrafica denominata Gruppo
Acquifero A.
Più in profondità si passa a sabbie da fini a grossolane con intercalazioni subordinate di
argilla siltosa e silt (40-50 m) (Riss-Mindel Auct.) o a conglomerati e arenarie (Gruppo
Acquifero B).
Al di sotto di tali unità (oltre 80-100 m) si incontrano facies continentali e di transizione
(unità sabbioso-argillosa riferibile al Villafranchiano o Gruppo Acquifero C del Pleistocene
medio-inferiore con acquifero multifalda) e alle argille marine del Pliocene che
costituiscono la base impermeabile degli acquiferi sovrastanti.
Il primo acquifero è sede di falda di tipo freatico profonda (L.S. indicativamente oltre 35
m p.c.) debolmente protetto.
La permeabilità subsuperficiale è stimabile da media ad alta (depositi fluvioglaciali
sabbioso-ghiaiosi-ciottolosi localmente ricoperti da sabbie fini e/o limi corrispondenti a
pag. 25
Ver. 16/12/2013
depositi eolici o di alveo abbandonato con matrice fine in proporzioni variabili) e variabile
indicativamente fra 0.1-0.001 cm/sec.
Con riferimento alla vulnerabilità della falda è possibile distinguere due situazioni
profondamente differenti.
Mentre infatti per tutto il settore centro meridionale si può stimare una vulnerabilità
media (spessore dell’insaturo oltre 30 m) limitatamente alle alluvioni recenti in fregio al
Ticino (dove è perforato il pozzo dell’acquedotto) si hanno condizioni di bassa soggiacenza
della falda (5-8 m p.c.) che determinano una vulnerabilità da alta a elevata.
Complesso limoso-sabbioso
La struttura idrogeologica del complesso vede una successione di prevalenti limi e
sabbie limose o argillose inglobanti ciottoli e/o isolati blocchi di diverse decine di metri di
spessore (di spessore localmente fino a 100-150 m), passanti a facies continentali e di
transizione (unità sabbioso-argillosa riferibile al Villafranchiano con acquifero multifalda) e
alle argille marine del Pliocene che costituiscono la base impermeabile degli acquiferi
sovrastanti.
Il primo acquifero è sede di falda di tipo freatico profonda (L.S. indicativamente oltre 50
m p.c.) moderatamente protetto; la prevalenza di depositi fini implica una permeabilità
subsuperficiale da media a localmente scarsa (variabile indicativamente fra 0.01-0.0001
cm/sec).
Lo spessore del profilo di alterazione può toccare valori fino a 5-6 m con diffusa
copertura di loess, di spessore anche metrico; i suoli sono profondi a tessitura media a
drenaggio buono.
La vulnerabilità della falda si stima quindi variabile da media a bassa.
Metodologia per il calcolo della permeabilità
Dato il carattere generale della presente trattazione e la disponibilità di dati che non è
evidentemente organica e uniforme, i valori di permeabilità sono stati stimati su grande
scala utilizzando range di ragionevole ampiezza.
In mancanza di prove di permeabilità e di portata, che per costi e caratteristiche non
sono compatibili con gli scopi del lavoro, ci si è basati su un approccio empirico, fondato
sui concetti teorici utilizzati negli studi idrogeologici generali, integrando il tutto con i
risultati degli studi condotti in aree limitrofe (si veda a tal proposito la bibliografia).
Per una prima valutazione della permeabilità in terreni sciolti si è proceduto mediante il
confronto fra i dati riportati in letteratura come tipici per le varie unità ed il confronto con
semplici formule empiriche, di vasto utilizzo (anche se molto approssimative) quali la
formula di Hazen, che si basa sulle dimensioni dei grani, valutata mediante apposita
granulometria.
I risultati ottenuti con questa formula sono stati confrontati con metodi grafici, validi per
terreni omogenei, quali i grafici di Prough.
Valutazione del grado di vulnerabilità
La valutazione della vulnerabilità dell’acquifero costituisce un valido strumento di
pianificazione territoriale in quanto mette in evidenza le zone in cui maggiore è la facilità di
contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte inquinante.
Diversi sono i fattori principali che regolano la vulnerabilità di un acquifero; essi
(Civita,1994) da una parte sono legati alla velocità di passaggio dalla superficie alla falda
dell’eventuale inquinante, dall’altra alle caratteristiche del deflusso sotterraneo e dai
fenomeni di possibile attenuazione dell’impatto intrinsechi all’ambiente.
Il tempo di transito dell’inquinante è legato a diversi fattori:
- la soggiacenza della falda, e cioè dallo spessore dell’aerato;
- le caratteristiche litostratigrafiche dell’aerato;
- le caratteristiche di permeabilità dell’aerato;
- le caratteristiche della copertura del suolo e la sua capacità di ritenzione
specifica;
- la densità, viscosità e solubilità dell’inquinante;
pag. 26
- la ricarica attiva media globale della falda.
Il deflusso sotterraneo è funzione:
- delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero;
- della sua struttura, geometria e gradiente idraulico;
e quindi, la capacità di attenuazione dell’impatto degli inquinanti è regolata da:
- temperatura dell’acqua e delle rocce acquifere;
- caratteristiche dell’inquinante;
- spessore, tessitura, composizione mineralogica, ..., del suolo e
dell’aerato, come visto nelle voci precedenti.
In primissima approssimazione gli elementi più importanti che concorrono a questa
valutazione sono legati a due fattori:
- lo spessore, la litologia e la permeabilità della copertura superficiale
(strato non saturo);
- la profondità e le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero.
Gli elementi principali da considerare, soprattutto nella valutazione della vulnerabilità
verticale sono quindi la velocità di infiltrazione (Vi), la soggiacenza della falda (S) e, di
riflesso, il tempo di arrivo (Ta) del potenziale inquinamento in falda; questi fattori sono
legati da un rapporto del tipo:
Ta = S / Vi
Analoghi concetti determinano la valutazione della vulnerabilità orizzontale (che tiene
conto della diffusione dell’inquinante nell’acquifero) e della vulnerabilità complessiva (data
dal rapporto fra vulnerabilità verticale ed orizzontale); la stima di questi fattori richiede però
la conoscenza di parametri che nel nostro caso non sono disponibili e andranno ricercati
puntualmente una volta nota l’area direttamente interessata dall’intervento di progetto.
Pertanto si è stimata una vulnerabilità verticale, con i dati in nostro possesso.
PIEZOMETRIA
Per la ricostruzione della superficie piezometrica relativa alla prima falda (freatica) ci si
è basati essenzialmente su studi esistenti a carattere provinciale e regionale integrati con
misure piezometriche relativamente recenti (1999-2002) sui pozzi idropotabili del Comune
di Somma L.do e Golasecca (rif. carta di inquadramento idrogeologico proposta in allegato
3 alla scala 1:5.000 su base topografica CTR).
La distribuzione delle curve evidenzia una direzione media di deflusso da NE verso SW
con un gradiente di poco inferiore al 2% ; in prossimità del Fiume Ticino le isopiezometriche
subiscono una evidente distorsione con scostamento della direzione media verso W ed un
gradiente prossimo al 4‰ .
L’andamento della superficie piezometrica risulta infatti da un lato condizionato
dall’alimentazione dei bacini a monte (Monate-Comabbio) e dal drenaggio esercitato dal
Fiume Ticino che, scorrendo molto incassato nella pianura, ad una profondità di circa 50-60
m, richiama le acqua della prima falda anche a notevoli distanze (fino a 15 Km).
La valutazione dell’andamento della superficie piezometrica è comunque complicata da
alcuni fattori, quali la variabilità dell’emungimento della prima falda nel corso del tempo e
la sua irregolarità, la presenza di attività agricole che modificano anche profondamente
l’aspetto della superficie piezometrica nelle varie stagioni dell’anno, i rapporti con i corsi
d’acqua superficiali, etc.
Pertanto la superficie piezometrica adottata ha soltanto una funzione esempificativa del
trend locale della falda.
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Caratteristiche degli acquiferi e vulnerabilità verticale della falda
Si è cercato di procedere ad una zonazione del territorio attraverso l’individuazione di
aree omogenee quanto a caratteri idrogeologici e di vulnerabilità.
pag. 27
Ver. 16/12/2013
Per ogni poligono individuato, univocamente differenziato con l’attribuzione di un retino
colorato, vengono descritte sinteticamente le principali caratteristiche quali:
- il tipo di acquifero (libero, confinato, semiconfinato, …) indicando altresì un valore
indicativo della soggiacenza della prima falda rispetto al p.c.;
- il tempo indicativo (stimato in base al range dei valori della conducibilità idraulica
rappresentativi della locale litologia e al valore della soggiacenza) che occorre ad un
generico inquinante idroveicolato, versato in superficie o nel primo sottosuolo, per
raggiungere e contaminare la prima falda;
- il valore della conducibilità idraulica in relazione alla litologia prevalente;
- lo spessore indicativo della zona di aerazione;
- le caratteristiche del suolo e/o dello strato di alterazione eventualmente
presente.
Accanto al valore di permeabilità dei materiali stimato sulla base dei metodi empirici
descritti in precedenza è stato indicato un altro valore di permeabilità definita
subsuperficiale.
Lo schema sintetizza le porzioni dei depositi che devono essere attraversate dalle
acque meteoriche e/o dai fluidi provenienti dal piano campagna per raggiungere la falda
acquifera. Il tempo di deflusso dei fluidi dal p. c. alla zona satura (acquifero) è funzione
in senso lato del grado di permeabilità e dello spessore dei materiali attraversati.
In sintesi i sedimenti in questione sono rappresentati da:
- SUOLO, porzione di sedimenti pedogenizzati, caratterizzati da un grado di
permeabilità definita superficiale.
- SEDIMENTI COMPRESI NELLA ZONA DI AERAZIONE (senso lato), caratterizzati da
un grado di permeabilità definita subsuperficiale.
Geometria e idrodinamica dei corpi idrici sotterranei
Linee isopiezometriche (luogo dei punti del tetto della falda di ugual quota
piezometrica espressa in m s. l. m.): sono state costruite interpolando i dati piezometrici
dei pozzi per acqua presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, allo
scopo di visualizzare in modo facilmente comprensibile l’andamento spaziale della tavola
d’acqua.
L’equidistanza fra le linee isopiezometriche è di cinque metri.
Per ogni linea piezometrica è stata specificata la quota assoluta in m s. l. m. onde
permettere una immediata valutazione dell’intervallo esistente rispetto alla quota
topografica.
Direzioni di deflusso delle acque sotterranee: indicano il verso di scorrimento medio
delle acque sotterranee così come dedotto dall’andamento generale delle locali curve
isopiezometriche.
Elementi antropici
Sono stati suddivisi in:
• PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO DEI CORPI
IDRICI SOTTERRANEI
Sono stati identificati e distinti, con appositi colori e simboli grafici i seguenti elementi
(presenti sul territorio comunale o in aree ad esso adiacenti)
• stazioni di rifornimento: ne è stato individuato uno solo, ubicato lungo Viale Europa,
con annessa officina per autoriparazioni;
• punti di recapito di acque reflue trattate: due sono quelli riconosciuti in
corrispondenza dei due impianti di depurazione: uno con scarico direttamente nel Fiume
Ticino e l’altro come dispersione in area a utilizzo misto agricolo/prativo;
• rete fognaria: è stato trasposto su base CTR il tracciato della rete fognaria messa a
disposizione degli scriventi dai Tecnici dell’Amm.ne Com.le di Golasecca.
pag. 28
Alla sopra citata cartografia si rimanda per qualsiasi difformità riscontrabile con quanto
riportato sull’elaborato cartografico (allegato 3) a corredo della presente relazione tecnica.
• cimitero: situato in posizione periurbana in via Matteotti
• strade di grande traffico e autostrade: autostrada A26, Viale Europa e strada
comunale di Coarezza-Somma;
• industrie zootecniche o assimilabili: trattasi di allevamenti di bovini; la pericolosità è
rappresentata dalle deiezioni animali specie se in condizioni di stabulazione libera;
• rete metanodotto (tracciato indicativo);
• pozzi ad uso non idropotabile.
• PREVENTORI E/O RIDUTTORI DELL’INQUINAMENTO
• impianti di depurazione;
• piattaforma ecologica: viene indicata come preventore dell’inquinamento in quanto
parte del sistema di smaltimento dei rifiuti verso siti più adeguati
• zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile:
• PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO
• pozzo di captazione ad uso idropotabile
IDROGRAFIA
E’ stato riportato il reticolo idrografico superficiale operando una distinzione fra
• corsi d’acqua perenni (Fiume Ticino);
• corsi d’acqua temporanei: praticamente tutti i corsi d’acqua censiti sul territorio
comunale ad eccezione del Ticino;
• corsi d’acqua drenanti la falda: nella fattispecie il Fiume Ticino si comporta come
asse drenante lungo tutto il suo corso (entro il territorio in esame).
Per completezza sono stati considerati anche i seguenti elementi:
• aree ad acclività da media a elevata: identificano le scarpate di raccordo fra i
terrazzi fluvioglaciali o i fianchi dei maggiori rilievi morenici dove i processi di
ruscellamento superficiale sono tendenzialmente prevalenti su quelli di infiltrazione nel
sottosuolo;
• rete acquedottistica.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Da una osservazione puntuale si possono ricavare le seguenti considerazioni:
- la superficie piezometrica, nell’area di studio, è mediamente compresa fra 190 e 230 m
s. l. m., con una direzione di flusso media da nord-est a sud-ovest nella porzione nordorientale del territorio.
Tale deflusso devia più marcatamente in direzione ovest laddove scorre il Fiume Ticino
il quale si comporta come elemento drenante. Il gradiente idraulico è nettamente maggiore
nella parte settentrionale del territorio comunale e diminuisce sensibilmente in quella
meridionale;
- la struttura idrogeologica è quella tipica di un acquifero multistrato, con primo
acquifero di tipo freatico generalmente a buona produttività; la base dell’acquifero
tradizionale è costituita dalle argille marine del Pliocene;
- la superficie della prima falda è prossima alla superficie topografica lungo le sponde
del Ticino (zona acquedotto); la profondità massima è invece stimata sull’ordine dei 60–70
metri spostandosi verso nord-est.;
- la vulnerabilità dell’acquifero vede una compensazione fra elementi favorevoli (falda
profonda e/o terreni a bassa permeabilità) ed elementi negativi (terreni molto permeabili).
La possibilità di infiltrazione e, quindi, di alimentazione della falda, risulta parzialmente
ridotta nella porzione centro settentrionale ed orientale sia per la presenza del nucleo
urbanizzato e per l’occorrenza di terreni morenici sabbiosi a permeabilità media o mediobassa sia per l’elevata soggiacenza del primo acquifero; le aree meridionali risultano
invece meno protette in relazione soprattutto alla presenza di depositi a granulometria più
pag. 29
Ver. 16/12/2013
grossolana (sabbie ghiaiose o ciottolose di origine fluvioglaciale) anche se la soggiacenza
si mantiene comunque elevata; una situazione di vulnerabilità elevata appare riscontrabile
in tutta la fascia di terreni adiacenti il Ticino (indicativamente dall’area del “Camping Turist
il Gabbiano” fino allo sbarramento) comprendente quindi anche il complesso
dell’acquedotto comunale.
In questa zona si ha infatti una convergenza di elementi sfavorevoli rappresentata sia
dalla bassa soggiacenza della falda (pochi metri dal piano campagna) sia dalla presenza di
depositi ghiaioso-sabbiosi a permeabilità elevata quindi con scarsa possibilità di
autodepurazione delle acque di infiltrazione e assolutamente insufficienti a garantire una
adeguata protezione dell’acquifero in caso di inquinamento.
Nel complesso il territorio comunale appare interessato da una potenziale e diffusa
situazione di alimentazione della falda superficiale per infiltrazione dalla superficie, più
evidente nelle porzioni meridionale e occidentale dell’area studiata.
La capacità di infiltrazione risulta essere invece parzialmente ridotta nella parte centrale
e centro-occidentale per la presenza del nucleo urbanizzato e di terreni a forte pendenza
della scarpata morfologica del Ticino dove prevalgono invece processi di scorrimento delle
acque superficiali.
Questo quadro, pur rivestendo una limitata importanza dal punto di vista quantitativo,
appare essere molto importante da uno prettamente qualitativo, in quanto la presenza
verso nord di terreni a minore permeabilità appare maggiormente garantire la possibilità di
preservazione e di autodepurazione delle acque di infiltrazione che alimentano la locale
falda superficiale, favorendone una maggior preservazione rispetto alle porzioni meridionali
ed occidentali, relativamente meno protette.
In questo contesto particolare attenzione dovrà essere rivolta all’interno delle aree
urbanizzate onde evitare la dispersione nel sottosuolo, di acque di superficie degradate o
di prodotti di scarico;
- per quanto riguarda l’approvvigionamento di acque potabili dalle aree caratterizzate da
condizioni di vulnerabilità elevata o estremamente elevata, se ne ritiene sconsigliabile
l’effettuazione in quanto non sussistono condizioni tali da permettere una duratura
protezione nel tempo;
- in relazione alla possibilità di individuare altre fonti di approvvigionamento alternativo
e maggiormente tutelato rispetto a quello attualmente utilizzato, sebbene i dati a
disposizione siano ancora parziali e limitati solo ad alcune aree del territorio comunale, si
ritiene positivamente perseguibile l’idea di individuare la futura ricerca verso gli orizzonti
profondi più protetti. In particolare tale possibilità appare perseguibile nella porzione nordorientale del territorio comunale, esternamente all’area urbanizzata, dove la prevalenza di
depositi fini risulta garante di una maggiore protezione nei confronti dell’acquifero
sottostante;
- in fase di realizzazione di pozzi di emungimento di acqua dagli orizzonti più profondi,
si consiglia di evitare la messa in comunicazione dagli orizzonti acquiferi più superficiali
con quelli più profondi onde impedire il futuro degrado di questi in presenza di situazioni di
inquinamento delle acque più superficiali;
- per quanto riguarda l’emungimento di acque sotterranee per scopi diversi da quello
idropotabile, qualora si verificasse la necessità di realizzare utilizzi distinti, si consiglia di
effettuare la captazione unicamente dai livelli più superficiali onde limitare al minimo
l’utilizzo delle falde “profonde” e la loro potenziale messa in comunicazione con i livelli più
superficiali.
DELIMITAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO SECONDO IL CRITERIO TEMPORALE
A completamento di quanto precedentemente esposto si è proceduto alla definizione
della fascia di rispetto, secondo i parametri temporali descritti dalla DGR n.6/15137 del
27.06.1996.
pag. 30
In relazione alla necessità di poter disporre di idonei parametri di calcolo, in data
22.05.2002 è stata eseguita una prova di pompaggio sul pozzo comunale
In relazione ai risultati conseguiti ed in considerazione degli spessori utili di acquifero
sopra individuati, i relativi valori caratteristici dell’acquifero captato così risultati:
Trasmissività (T) = 3,96 10-2 m2/sec
Permeabilità (K) = 1,07 10-3 m/sec
Come prescritto dalla delibera citata (DGR n. 6/15137 del 27.06.1996), la zona di
rispetto è stata individuata quale inviluppo dei punti isocroni circostanti il pozzo in
condizioni di emungimento secondo il regime massimo di esercizio prevedibile (eq. 0,031
mc/sec), con un valore di tempo d’arrivo pari a 60 giorni.
Sulla base dei risultati conseguiti, si è pertanto ottenuta una isocrona di 60 giorni
con estensione massima, a monte del pozzo, rispetto alla direzione delle linee di flusso
idrico sotterraneo, pari a 174 metri mentre l’estensione a valle è pari a 25 metri.
La fascia di rispetto nell’area di massima larghezza assume dimensione laterale di 60
metri.
Per quanto riguarda le attività da vietarsi o regolamentarsi entro il perimetro così
individuato, si rimanda a quanto specificato all’art. 94 comma 4 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2.1.5 - ANALISI GEOLOGICO – TECNICA
La caratterizzazione geologico–tecnica proposta nel presente studio deve venire intesa
come una definizione preliminare ed indicativa delle proprietà geotecniche dei terreni in
relazione ad interventi di modificazione dell’area ai fini costruttivi.
CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE: DESCRIZIONE DELLE UNITÀ LITOLOGICO
TECNICHE
Secondo quanto anticipato all’inizio del capitolo i raggruppamenti effettuati nell’ambito
del presente studio sono da considerarsi come indicativi di comportamenti generalizzati
che andranno di volta in volta verificati in funzione delle problematiche incontrate in sede di
indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 14.09.2005 “Norme Tecniche delle Costruzioni” e
succ. mod..
Utilizzando i criteri descritti al paragrafo precedente è stato possibile suddividere il
territorio di Golasecca nelle seguenti unità a caratteristiche geologico–tecniche
sostanzialmente omogenee:
Unità geotecnica 1: sabbie e ghiaie ciottolose
Litologia prevalente: sabbie e ghiaie fluvioglaciali da medie a grossolane con matrice
giallastra chiara-ocracea generalmente scarsa con ciottoli poligenici, da sub arrotondati ad
arrotondati non alterati, e subordinati blocchi sparsi (500-700 mm); possibile occorrenza in
superficie di sabbie fini e limi di origine eolica (coltri loessiche)
Pedologia: consociazione di suoli da sottili a moderatamente profondi, limitati da
substrato sabbioso molto pietroso, a tessitura franco-sabbiosa da media a moderatamente
grossolana in superficie e grossolana in profondità a drenaggio buono
Formazione geologica: Unità di Daverio, Mornago e Sumirago (Allogruppo di Besnate)
Morfologia: piane terrazzate stabili di origine fluvioglaciale delimitate da scarpate
erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o debolmente ondulata, comprendenti antiche
linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall'idromorfia, in
posizione intermedia fra il Ticino attuale e il Livello Fondamentale della Pianura; piane
intermoreniche corrispondenti a scaricatori fluvioglaciali secondari
Classificazione U.S.C.S.: GW, GP, SW, SP .
Caratteristiche tecniche generali: materiali a comportamento granulare con stato di
addensamento discreto in aumento con la profondità e l’età relativa dei depositi; capacità
portante da discreta a buona
pag. 31
Ver. 16/12/2013
Permeabilità subsuperficiale: da media a elevata..
Problematiche: terreni con caratteristiche tecniche da discrete a buone; si raccomanda
comunque l’asportazione dello scotico vegetale e la valutazione della stabilità dei fronti di
scavo; da verificare l’eventuale occorrenza e spessore di depositi fini eolici (loess)
Unità geotecnica 2: sabbie e ghiaie ciottolose con limo
Litologia prevalente: sabbie con abbondante componente micacea e limi in letti
discontinui di spessore generalmente limitato a pochi metri su sabbie e ghiaie
ciottoloseriferibili alla precedente unità 1
Pedologia: suoli moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso molto pietroso,
a tessitura da media a moderatamente grossolana in superficie e grossolana in profondità a
drenaggio buono
Formazione geologica: Unità di Mornago (Allogruppo di Besnate); Unità Post glaciale
Morfologia: come riempimento di paleoalvei e di canale abbandonato (aree pianeggianti
o subpianeggianti debolmente depresse); come piccole conoidi alluvionali inattive nelle
principali incisioni allo sbocco sul piano alluvionale
Classificazione U.S.C.S.: SW-SP, SW-SM
Caratteristiche tecniche generali: materiali da sciolti a debolmente addensati a capacità
portante generalmente scarsa; possibili cedimenti differenziali
Permeabilità subsuperficiale: da media a bassa
Problematiche: lo spessore limitato ne rende in genere poco significativa l’influenza; in
previsione di scavi fondazionali gli stessi dovranno essere spinti a profondità tale da
superare l’unità raggiungendo la sottostante unità 1; da valutare la stabilità dei fronti di
scavo ed eventuali locali situazioni di drenaggio difficoltoso connesso all’occorrenza di
plaghe di materiale fine limoso corrispondenti ad aree di canale abbandonato
Unità geotecnica 3: sabbie con ghiaia
Litologia prevalente: sabbie limose con ghiaia passanti a sabbie e ghiaie talora
ciottolose
Pedologia: lungo le scarpate suoli da molto sottili a sottili, a tessitura da francosabbiosa a sabbiosa e scheletro abbondante a drenaggio da buono a rapido; nelle porzioni
meno acclivi o di raccordo alla piana alluvionale suoli profondi a tessitura sabbiosa
Formazione geologica: Unità di Daverio (Allogruppo di Besnate); Alloformazione di
Cantù, Unità Postglaciale
Morfologia: versanti ad acclività variabile da media a elevata fino a scarpate subverticali
interessati da processi geomorfologici attivi (erosione superficiale diffusa); alluvioni
terrazzate attuali e recenti del Fiume Ticino ad acclività bassa o nulla
Classificazione U.S.C.S.: GW-GM, GP-GM, SP-SM.
Caratteristiche tecniche generali: materiali a comportamento granulare; capacità
portante da discreta a bassa in corrispondenza delle coltri eluvio-colluviali
Permeabilità subsuperficiale: da media a buona; in corrispondenza delle aree acclivi
processi di ruscellamento superficiale prevalenti su quelli di infiltrazione
Problematiche: sulle aree di versante presenza diffusa di coltri detritico colluviali di
spessore variabile e caratteristiche tecniche scadenti; acclività elevata con processi attivi
legati al ruscellamento superficiale di acque incanalate e non, e predisposizione all’innesco
di scivolamenti superficiali; da valutare la stabilità dei fronti di scavo e la possibile
occorrenza di venute d’acqua al contatto fra litologie a differente grado di conducibilità
idraulica; presso le aree in fregio al Ticino possibili allagamenti in occasione di eventi di
piena
Unità geotecnica 4: limi e sabbie con ciottoli sparsi
Litologia prevalente: ciottoli poligenici da decimetrici a pluridecimetrici sparsi in
abbondante matrice limosa più raramente sabbiosa medio-grossolana; diffuse le coltri di
loess rossiccio e bruno scuro (70-150 cm); subordinate ghiaie più o meno sabbiose;
possibile occorrenza di coltri eluvio-colluviali alla base dei versanti maggiormente acclivi
pag. 32
Pedologia: consociazione di suoli profondi, a tessitura da franco-limosa a francosabbiosa in superficie, sabbiosa grossolana in profondità, con scheletro da scarso a
comune a drenaggio da buono a rapido
Formazione geologica: facies glaciali s.l. dell’Alloformazione di G olasecca e dell’ Unità
di Sumirago (Allogruppo di Besnate)
Morfologia: aree a morfologia da subpianeggiante a ondulata con pendenza da blanda a
media (2-40% ): piane intermoreniche degli scaricatori glaciali e cordoni morenici principali
e secondari (depositi di morena frontale)
Classificazione U.S.C.S.: SC-SM (CL-ML, ML-MH); SP-SM (ML-MH), GCGM
Caratteristiche tecniche generali: materiali a comportamento granulare da sciolti a
moderatamente addensati (raramente sovraconsolidati); capacità portante variabile spesso
in modo significativo sia lateralmente che con la profondità (in genere in aumento con la
profondità)
Permeabilità subsuperficiale: variabile, generalmente mediocre
Problematiche: presenza diffusa di materiale fine di origine eolica (loess) e/o
occorrenza di plaghe eluvio-colluviali a caratteristiche tecniche scadenti e con spessore
variabile anche se generalmente ridotto (0-2 m); possibilità di cedimenti differenziali in
relazione all’eterogeneità dei materiali che possono richiedere miglioramenti delle
caratteristiche del piano di posa fondazionale ad esempio mediante interventi di bonifica
statica; possibilità di incontrare isolati blocchi e/o trovanti in fase di scavo; possibile
occorrenza di falde sospese a carattere locale; aree ad acclività variabile con processi di
ruscellamento/erosione superficiale concentrata; da valutare la stabilità dei fronti di scavo;
possibile occorrenza di aree debolmente depresse con tendenza alla concentrazione delle
acque e potenziale drenaggio difficoltoso; possibile occorrenza di rimaneggiamenti
antropici
Unità geotecnica 5: aree interessate da rimaneggiamento antropico
Litologia prevalente: variabile.
Formazione geologica: -Morfologia: aree interessate da rimaneggiamento antropico (scavi e rilevati)
Classificazione U.S.C.S.: --.
Caratteristiche tecniche generali: possibile presenza di materiali eterogenei non o
debolmente addensati, comunque con stato di addensamento variabile
Permeabilità subsuperficiale: variabile.
Problematiche: aree di profondo rimaneggiamento antropico con caratteristiche
geotecniche variabili, potenzialmente scadenti in relazione all'eterogeneità dei materiali, al
grado di addensamento e agli spessori variabili del materiale di riporto o colmatazione;
possibili bassi valori di capacità portante e cedimenti differenziali
In quanto significativo ai fini della stabilità dei materiali si è ritenuto significativo
individuare sulla cartografia le aree mediamente o fortemente acclivi.
Corrispondono alle aree di versante a litologia variabile caratterizzate da acclività da
media a, localmente, elevata (40-80% ) interessate da processi geomorfologici attivi legati
alla circolazione delle acque superficiali incanalate e non (ruscellamento concentrato e
diffuso, erosione superficiale) e da processi di tipo gravitativo (arretramento dei cigli di
scarpata, scivolamenti corticali).
In aggiunta alle limitazioni legate alle caratteristiche proprie dei materiali bisogna
considerare in aggiunta la presenza diffusa di coltri detritico-colluviali di spessore variabile
e caratteristiche tecniche scadenti alla base delle porzioni di versante a maggiore
pendenza; acclività elevata con processi attivi di dilavamento e legati al ruscellamento
superficiale di acque incanalate e non e predisposizione all’innesco di scivolamenti
superficiali; possibile occorrenza di venute d’acqua al contatto fra litologie a differente
grado di conducibilità idraulica; problemi di stabilità dei fronti di scavo.
pag. 33
Ver. 16/12/2013
CONSIDERAZIONI GENERALI CONCLUSIVE
Dal punto di vista geotecnico la zonazione di massima effettuata ha permesso di
verificare come i terreni di gran parte del territorio comunale, non presentino particolari
problematiche connesse con l’utilizzo degli stessi ai fini edificatori o per la realizzazione di
opere di interesse pubblico.
Uniche eccezioni a questo panorama sono rappresentate dalle porzioni di territorio
corrispondenti alla scarpata morfologica del fiume Ticino e dei principali rilievi collinari
dove le più consistenti limitazioni sono, non tanto di natura esclusivamente geologicotecnica (stabilità dei fronti di scavo), quanto piuttosto legate alla dinamica geomorfologica
(elevata acclività e problemi connessi al ruscellamento delle acque superficiali)
In queste situazioni eventuali opere che dovessero essere eseguite su tali terreni,
dovranno essere precedute da accurate campagne di analisi e prove conoscitive del reale
stato di addensamento dei terreni e delle possibili interazioni con eventuali falde sospese,
onde poter fornire ai progettisti i necessari parametri di valutazioni preliminari delle
possibili problematiche riscontrabili in fase d’opera e successivamente alla realizzazione
della stessa.
Per quanto riguarda le restanti parti del territorio, la possibilità di locali variazioni delle
caratteristiche geotecniche superficiali, più probabili nei terreni settentrionali di natura
morenica, rende comunque consigliabile l’esecuzione di indagini geognostiche di
approfondimento, onde permettere di accertare l’assenza di particolari problematiche e
comunque consentire un corretto dimensionamento ed un’appropriata scelta delle tipologie
fondazionali.
2.1.6 - PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E METODI DI APPROFONDIMENTO
Il Comune di Golasecca secondo la riclassificazione sismica del territorio nazionale
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8
maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72, adottata con d.g. Regione Lombardia n. 14964
del 7 novembre 2003) ricade in zona sismica 4 (quella a minor grado di sismicità ovvero a
“bassa sismicità”).
Tale classificazione costituisce la pericolosità sismica di base che deve essere
verificata ed approfondita, in base ai criteri dettati dalla L.R. 12/2005, in fase di
pianificazione territoriale e geologica.
La metodologia per l’approfondimento e la valutazione dell’amplificazione sismica
locale, riportata nell’allegato 5 dei Criteri attuativi della L.R. 12/05 – Componente
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. “Analisi e valutazione degli effetti sismici di
sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in
adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le
costruzioni” e succ. mod., dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, e della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o. n. 19904 del
21 novembre 2003, prevede 3 livelli di analisi da applicarsi in funzione della zona sismica
di appartenenza.
L’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale è il prodotto del
completamento del I° dei tre livelli di approfondimento previsti, obbligatorio per tutti i
comuni della Lombardia, ed esteso a tutto il territorio comunale (PSL); tale carta
costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nell’analisi della Fattibilità Geologica per
le azioni di Piano, la base fondamentale per gli indirizzi di pianificazione urbanistica
identificando per ciascuna zona gli studi richiesti per valutare in dettaglio la risposta delle
strutture alle sollecitazioni dinamiche di tipo sismico.
pag. 34
In questo senso ricadendo il Comune di Golasecca in Zona 4 ed in base all’allegato 5
dei Criteri attuativi della L.R. 12/05, in fase progettuale gli approfondimenti di II° e III°
livello sono obbligatori unicamente per gli edifici strategici e rilevanti di cui all’elenco in
Allegato A al D.D.U.O. 21 novembre 2003 - n. 19904; è comunque a discrezione
dell’amministrazione richiedere l’approfondimento in fase d’istruttoria nei casi che si
ritengono opportuni non rientranti nell’elenco.
Per effettuare una zonazione preliminare del territorio comunale si è proceduto ad
un’analisi di primo livello: tale analisi consiste in un approccio di tipo qualitativo e
costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo
empirico che trova le basi nella continua e sistematica osservazione diretta degli effetti
prodotti dai terremoti.
Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione
sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e
sulla raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali la cartografia topografica
di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti e i risultati di indagini geognostiche,
geofisiche e geotecniche già svolte.
La base tecnica e cartografia è costituita dalle analisi di tipo geologico s.s.,
geomorfologico, idrogeologico e geotecnico e dai relativi Allegati, descritti ai capitoli
precedenti.
REDAZIONE DELLA CARTA DI ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE
Come anticipato in questa fase di studio è stata completata l’analisi di I° livello che ha
portato all’elaborazione della carta “Zonazione sismica preliminare del territorio comunale –
Primo livello” .Sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell’analisi geologica,
geomorfologica, idrogeologica e geologico-tecnica nell’ambito del territorio comunale di
Golasecca è stato possibile identificare alcune situazioni tipo corrispondenti a diversi
scenari di pericolosità sismica ed effetti di amplificazione prevedibili.
DESCRIZIONE DEGLI SCENARI
Scenario Z1c - zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Sono state inserite in questo scenario le aree di versante caratterizzate da acclività da
media a elevata interessate da processi attivi connessi alla circolazione non regimata delle
acque meteoriche e di corrivazione; trattasi di aree in cui non sono riconoscibili gravi
situazioni di dissesto ma a pericolosità potenziale per effetto di
fattori sfavorevoli quali l’acclività elevata, la presenza di coltri discontinue di depositi
eluvio-colluviali e/o locali condizioni di equilibrio limite specialmente con presenza di
depositi fini e con suoli molto sottili.
In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di instabilità dei versanti con
riattivazione di dissesti quiescenti o stabilizzati e neoformazione di fenomeni franosi; la
classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; il livello di approfondimento richiesto in
fase progettuale per tali aree è il III° solo per edifici strategici e rilevanti di nuova
realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali strutture se già esistenti) di cui
all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, qualora non sussistano già prescrizioni
di inedificabilità relativi alla Classe IV di fattibilità geologica.
Scenario Z2 - zone con terreni di fondazione scadenti
In questa categoria sono state comprese le aree con probabile scarsa capacità portante
e basso grado di addensamento dei terreni corrispondenti a due distinte tipologie:
- aree interessate da rimaneggiamento antropico: trattasi di una superficie allungata ad
est dell’azienda faunistica caratterizzate dalla presenza di scavi e da un rilevato; le
potenziali caratteristiche scadenti sono legate alla possibile natura eterogenea dei
materiali, allo spessore e grado di addensamento variabili in senso lateroverticale;
- aree con presenza di depositi fini: tali aree (individuabili in corrispondenza del
paleoalveo di C.na San Giuseppe) sono contraddistinte da generiche caratteristiche
pag. 35
Ver. 16/12/2013
geotecniche scadenti per effetto delle loro peculiarità litologiche, legate alla prevalenza,
almeno nei primi metri di profondità (0-2 m) di prevalenti sabbie fini e limi in proporzioni
variabili; trattasi inoltre di porzioni di territorio a morfologia pianeggiante o talora
debolmente depressa con potenziali episodi di drenaggio ritardato.
In caso di evento sismico l’effetto di amplificazione prevedibile è quello di insorgenza di
cedimenti e/o liquefazioni e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2.
Sarà obbligatorio in fase progettuale l’approfondimento di III° livello per edifici strategici
e rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali strutture se già
esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03.
Scenario Z3a - zona di ciglio con altezza H > 10 m
Allo stato attuale per definire questo scenario e le relative aree di influenza del fattore
di amplificazione a partire da elementi lineari quali i cigli delle scarpate torrentizie e i cigli
dei terrazzi morfologici di origine fluvioglaciale sarebbe stato necessario avere il supporto
di un approfondimento di II° livello, basato sulle proposte metodologiche sintetiche della
Regione Lombardia, esulando dagli scopi di pianificazione territoriale a grande scala del
presente studio.
Pertanto in questa fase sono stati individuati come elementi lineari i cigli delle principali
scarpate morfologiche (indipendente dal processo morfogenetico che le ha prodotte)
suscettibili di amplificazioni topografiche in caso di evento sismico.
In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni topografiche e la
classe di pericolosità sismica corrispondente è H2.
Nelle zone Z3 è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici strategici e
rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali strutture se già
esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 e l’approfondimento di
III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa
calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale.
Scenario Z4a - zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari
Le porzioni di territorio comunale attribuite a questo scenario corrispondono alla
successione dei terrazzi fluvioglaciali affrancati dall’idromorfia che caratterizzano la
porzione meridionale del territorio comunale.
In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente
litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2.
Scenario Z4b - zona di piede scarpata con presenza di falde eluvio-colluviali
econoidi detritico torrentizie
Corrisponde alla porzione basale della scarpata morfologica del Ticino e a piccoli edifici
di conoide alluvionale non più attivi edificati da corsi d’acqua che hanno inciso depositi fini
a dominante sabbiosa.
In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente
litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2.
Per quanto concerne la scarpata del Ticino si è deciso di privilegiare lo scenario Z1c in
quanto più restrittivo.
Scenario Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(compresi le coltri loessiche)
Corrisponde alla zona di pertinenza dei depositi morenici della glaciazione Wurm-Riss e
delle relative morfologie (rilievi collinari) con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(diamicton massivi a supporto di matrice limosa e/o limoso/sabbiosa molto abbondante) e
di coltri loessiche di spessore ed estensione areale variabili.
Vi è stato compresabuona parte del territorio comunale.
In caso di evento sismico è prevedibile l’instaurarsi di amplificazioni litologiche e
morfologiche; la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2.
Nelle zone Z4 è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici strategici e
rilevanti di nuova realizzazione di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o
pag. 36
anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l’approfondimento di III°
livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato
risultasse superiore del valore soglia comunale.
2.1.7 - CARTA DI SINTESI
Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: comprendono le
porzioni di territorio in cui le situazioni di instabilità hanno già originato fenomeni di
dissesto e quelle in cui tali situazioni potrebbero svilupparsi a seguito della concomitanza
di eventi sfavorevoli (precipitazioni a carattere eccezionale, evento sismico, etc,).
Sono state identificate:
- aree con prevalenza di depositi fini interessate da processi di erosione concentrata e
diffusa: è stato delimitato l’insieme di incisioni vallive a nord di Persualdo dove la
conformazione della rete di drenaggio, abbastanza anomala rispetto al resto del territorio,
evidenzia una particolare attività dei processi di erosione laminare legata al ruscellamento
delle acque superficiali su scarpate acclivi con substrato sabbioso.
L’intensità del fenomeno risulta incrementata sia dalla generale elevata acclività dei
versanti che dalla presenza di litotipi poco coerenti.
- aree ad acclività da media a elevata a pericolosità potenziale per predisposizione a
fenomeni di dissesto e/o ruscellamento concentrato/diffuso (valutate in base all'acclività, al
tipo di materiale e al tipo di processi morfologici in atto): sono state attribuite a questa
categoria le aree maggiormente acclivi sensibili dal punto di vista idrogeologico interessate
da potenziali fenomeni di instabilità a seguito di eventi sfavorevoli.
- aree a franosità superficiale attiva diffusa e/o puntuale: comprendono la aree in cui si
sono manifestati fenomeni franosi di varia natura quali scivolamenti, orli di scarpata di
degradazione, etc.
- dissesti principali: distinti in base al loro stato di attività:
- dissesti a carattere puntuale;
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
- aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile: la
vulnerabilità elevata è legata da una parte la relativa minor soggiacenza del primo aquifero
e dall’altra alla presenza di terreni a permeabilità più elevata con scarsa o nulla protezione
nel caso di sversamento di un generico inquinante sul terreno o nel primo sottosuolo;
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico
- aree allagate per esondazione del Fiume Ticino: è stata identificata la fascia adiacente
il Fiume Ticino sulla base delle segnalazioni del Settore Ambientale e Ufficio GIS del Parco
Lombardo del Ticino;
- aree al piede di alvei sovralluvionati potenzialmente interessate da colate di detrito:
trattasi di aree potenzialmente interessate da colate di detrito in caso di rimobilizzazione
dei materiali incoerenti in alveo.
Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche
- riempimenti di paleoalveo con presenza di prevalenti depositi fini (0-2 m) associate a
locali condizioni potenziali di drenaggio difficoltoso; piccole conoidi inattive: lo spessore
limitato dei depositi ne rende comunque poco significativa la presenza
- aree interessate da rimaneggiamento antropico (scavi, rilevati e/o riporti) con
potenziale occorrenza di materiali eterogenei a stato di addensamento variabile.
Sono stati riportati anche i principali ambiti di interesse geomorfologico (paleoalveo di
C.na San Giueseppe) e i principali elementi antropici fra cui:
- l’ubicazione del pozzo ad uso idropotabile;
- le opere di contenimento a piede versante;
- le aree di versante consolidate con interventi di ingegneria naturalistica.
pag. 37
Ver. 16/12/2013
2.2 - IL SISTEMA URBANISTICO
Al fine di fornire una visione completa degli elementi conoscitivi del soprasuolo e del
sottosuolo, vengono di seguito riportate le analisi legate alla componente urbanistica, in
termini di: Sistema insediativo - Tessuto urbano e tipologie edilizie - Sistema
infrastrutturale.
2.2.1
- SISTEMA INSEDIATIVO
E’ costituito da:
- un aggregato principale, addensato nel nucleo di antica formazione, e più rado e
sfrangiato lungo le direttrici verso i centri limitrofi, ed occupa gran parte del pianoro
principale, con propaggini a nord/ovest verso il margine della valle del Ticino e a sud e a
nord/est verso i rilievi del Monte Tabor e della Motta; tale aggregato include tipologie a
corte e tradizionali nel nucleo antico e nei cascinali inglobati in area urbana, un solo
condominio a torre, e per le parti più esterne in prevalenza tipologie a villa e villino oppure
a palazzina isolati in lotti contigui
- zona turistica della Melissa, con campeggio, ristorante, spiaggia e parcheggi
- pochi insediamenti rurali e residenziali sparsi
- insediamento Vestor a nord del nucleo antico
- area produttiva e commerciale presso l’asse della Sp 27 verso sud/est
- altri capannoni frammisti al tessuto urbano, soprattutto verso nord/est (via battisti, sai
al di qua che al di là della Sp 27
Il sistema dei servizi esistenti, analizzato quantitativamente e qualitativamente dal
Piano dei Servizi, si articola come segue:
nel nucleo antico ed in prossimità: Municipio, Chiesa ed oratorio, Cappelle e rudere
di S.Michele, Scuole,
Cimitero a sud/ovest
centro sportivo a sud/est
spiaggia e area archeologica a nord.
L’offerta di servizi è integrata dalla facile accessibilità al verde agro-forestale, in parte
già fruibile per usi ludici-ricreativi.
IL PUGSS è particolarmente intrecciato, oltre che alla dislocazione dei servizi
tecnologici cui fanno capo le reti dei di alcuni servizi in sottosuolo, anche al progetto di
migliore connessione e accessibilità all’insieme dei servizi, attraverso la razionalizzazione
della rete stradale auto-veicolare e la formazione della rete ciclopedonale, mediante la
integrazione dei tracciati già oggi utilizzabili.
2.2.2
- TESSUTO URBANO E TIPOLOGIE EDILIZIE
L’analisi delle tipologie edilizie è stata effettuata per il tessuto urbano a prevalente
destinazione residenziale, allo scopo di stimare la densità abitativa, che influisce sul
bisogno ed uso delle reti sotterranee, e le peculiarità dei criteri di allacciamento ai
sottoservizi, che risultano differenziate in relazione alle tipologie stesse.
Salvo poche eccezioni, le principali tipologie individuate all’interno del tessuto urbano di
Golasecca sono: “corti lombarde” e altri edifici tradizionali; Ville singole e villini; Edifici a
schiera e pluriplano.
Corti lombarde e altri edifici tradizionali
Si tratta principalmente di edifici in linea, costruiti lungo il margine delle strade, con
altezza media di due o al massimo tre piani. Sul retro di questi edifici si aprono cortili
sterrati, che evidenziano l’origine rurale di questa tipologia edilizia. Nelle corti vi è quasi
pag. 38
sempre la presenza di edifici minori o accessori, spesso adibiti ad autorimessa. Sul lato
strada, nelle aree più centrali, sono stati aperti spazi al pian terreno che in parte ospitano
piccole attività commerciali, artigianali, o agenzie di servizi.
Gli allacciamenti alle reti dei sottoservizi sono spesso complesse, perché originati da
una successione di interventi diluiti nello spazio e nel tempo, con una scarsa conoscenza
delle tubazioni preesistenti ed in funzione di assetti proprietari spesso frammentati e non
lineari.
Ville singole e villini
Le Ville singole e i villini rappresentano la tipologia edilizia più diffusa in tutto l’ambito
comunale, in parte risalenti a fine ‘800/inizio ‘900, ma in maggioranza al secondo ‘900 .
Tali strutture mono o plurifamiliari sorgono su lotti singoli, isolati o più spesso adiacenti.
Spesso tali edifici sono affiancati da locali adibiti ad uso autorimessa. Mediamente l’altezza
riscontrata per questa tipologia non supera i due piani.
Gli allacciamenti sono per lo più razionali e di facile controllo e manutenzione, ma le
reti, pubbliche e private, risultano di elevata estensione in rapporto al carico insediativo, in
unzione inversa alla bassa densità edilizia.
pag. 39
Ver. 16/12/2013
Palazzine
Mediamente questi edifici, risalenti agli ultimi decenni, si elevano per due o tre piani di
altezza e sono affiancati o da edifici minori ad uso autorimessa, o da spazi interrati adibiti
al medesimo scopo.
Gli allacciamenti centralizzati, e per lo più gestiti da una figura unica di proprietario od
amministratore, facilitano la gestione delle reti pubbliche di sottoservizi e ne riducono lo
sviluppo lineare.
Tale razionalità è maggiore per l’edilizia pubblica residenziale e per gli insediamenti
sorti tramite Piano di Lottizzazione.
pag. 40
Capannoni
Si tratta di fabbricati per lo più risalenti al secondo ‘900, con destinazione produttiva o
commerciale.
Salvo alcuni casi di frazionamenti con la compresenza di diverse imprese, gli
allacciamenti centralizzati, e gestiti da una figura unica di proprietario od amministratore,
facilitano la gestione delle reti pubbliche di sottoservizi e ne riducono lo sviluppo lineare.
Tale razionalità è maggiore per le grandi aziende e per gli insediamenti sorti tramite
Piano di Lottizzazione.
2.2.3
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Morfologia.
L’analisi effettuata descrive lo stato di fatto della rete stradale locale e sovracomunale, i
flussi di traffico ed il sistema del trasporto pubblico, con l’obiettivo di far emergere le
eventuali criticità della rete stradale..
La maglia viaria di Golasecca (escliudendo l’Autostrada A26, che influisce sul
paesaggio e sugli afflussi indiretti, ma non innerva la rete comunale) è costituita da tre
livelli gerarchici di infrastrutture:
1 - Strada Provinciale 27 e via C. Colombo:
La Sp 27 collega Golasecca a Nord con Sesto Calende e l’auotostrada A8/A26 ed a
sud/est con Somma Lombardo e la SS 336 delal Malpensa: è costituita da un tratto a nord
pianeggiante in prossimità del campeggio e della spiaggia della Melissa, da una salita
sinuosa con muraglioni e scarpate, ed infine da un lungo rettilineo che taglia il pianoro
principale, separando la frazione della Motta dal centro e proseguendo verso sud/est
delimita l’espansione urbana verso nord/est
La S.P. 27 (che nel territorio comunale di Golasecca è denominata: viale Europa), pur
essendo stata tracciata progressivamente come la corda di un arco passante dal centro
storico di Golasecca, ne costituisce di fatto una sorta di circonvallazione, escludendo dal
pag. 41
Ver. 16/12/2013
centro il traffico di transito (che invece interferisce con la viabilità locale nel quartiere della
Motta, in direzione Sesona - Vergiate, lungo la stretta e contorta via C. Battisti).
La Via Colombo è un lungo rettilineo che collega la frazione Coarezza al capoluogo di
Somma Lombardo, intersecando in parte l’estremo Sud del territorio comunale, ove sono
pochi insediamenti isolati (Cascina S.Giuseppe e poche altre costruzioni rurali e villette),
tagliando i terrazzamenti del Guaglio e del Vigano, in area agro-forestale.
2- Viabilità storica principale:
Include le principali vie di collegamento dal nucleo antico ai centri limitrofi di Sesto
Calende a nord (via Roma), Sesona/Vergiate a est (via Battisti), Somma Lombardo
capoluogo a sud7est (via Vittorio Veneto), Coarezza a sud/ovest (via Matteotti), nonché la
via Soma Selva, dal margine sud-est dell’abitato verso la via C. Colombo.
3 – Viabilità locale: traverse e parallele, alla viabilità storica, nel tessuto urbano, con
piazze e parcheggi nonché cortili passanti, diramazioni per accesso alle cascine, maneggi
e case sparse,
planimetria in riferimento tav. PU 2
La rete stradale nell’insieme è composta da molteplici assi stradali. Di queste
alcune sono classificati come strade vicinali e altre come strade consorziali.
Le intersezioni con la viabilità principale (SP 27 e Via C. Colombo) sono 7,di cui
solamente 1 regolata con rotatoria.
Golasecca non è dotata di una rete ciclabile comunale strutturata, tranne un
breve tratto alla spiaggia Melissa (dove si innesterà la rete provinciale di
collegamento al Lago di Comabbio ed al Lago di Varese); il margine ovest del
territorio è caratterizzato dalla Strada Alzaia, lungo il corso del fiume Ticino, ed è
attraversato in direzione nord-sud dal Sentiero internazionale E1, in parte
coincidente con il tracciato storico dell’Ippovia, ad est dell’abitato.
Utenza
L’asse maggiormente trafficato, anche dai mezzi pesanti, è la SP 27, di cui il
Documento di Piano stima i seguenti flussi:
Traffico effettivo attuale rilevato dal PGTU di Sesto Calende al confine comunale:
3.000 veicoli/giorno nei due sensi, di cui 1500 veicoli in direzione nord-sud
Stima ripartizione del flusso in direzione Nord-Sud al confine con Sesto Calende
-
da Sesto a Golasecca
600
-
da parte di Sesto verso parte di Somma
150
-
da oltre Sesto a Golasecca
300
-
da Sesto ad oltre Somma e verso Varallo Pombia
400
-
da oltre Sesto ad oltre Somma
50
Totale
1500
Traffico stimato attuale al confine comunale con Somma Lombardo:
3.800 veicoli/giorno nei due sensi, di cui 1900 veicoli in direzione nord-sud
Stima ripartizione del flusso in direzione Nord-Sud al confine con Somma Lombardo
-
1000
da Golasecca a Somma
pag. 42
-
da parte di Sesto verso parte di Somma
150
-
da Golasecca a oltre Somma
300
-
da Sesto ad oltre Somma e verso Varallo Pombia
400
-
da oltre Sesto ad oltre Somma
50
Totale
1900
In coerenza a tali stime, i flussi di traffico rilevabili sulla via Colombo e sulla viabilità di
secondo livello sono dell’ordine di grandezza massimo di 1000 veicoli/giorno.
La SP 27, la via Colombo e la viabilità di secondo livello costituiscono anche l’insieme
dei tracciati praticati dal traffico pesante, per lo più passante sulle prime 2, ed invece
generato od attratto dagli insediamenti produttivi e commerciali locali (Vastor, area PIP,
via Battisti est e ovest, florovivaisti, rete del commercio al minuto nel nucleo antico) sulla
restante rete.
Trasporto pubblico
Il comune di Golasecca non possiede di un servizio di trasporto pubblico urbano, ma
usufruisce di alcune linee extraurbane che transitano nell’abitato connettendolo ai comuni
limitrofi.
All’interno del territorio comunale transitano le seguenti linee:
- Golasecca-Somma Lombardo-Gallarate, con attestazione al deposito autobus
“Beltramini&Gianola di via XXV Aprile e transito per via XXV Aprile, via Battisti,
corso EuropaCorsa per studenti verso Sesto Calende, tramite Sesona con transito
per via XXV Aprile e via C. Battisti
I tracciati percorsi dal trasporto pubblico richiedono peculiari attenzioni progettuali per il
PUGSS con la finalità di contenere la vulnerabilità dei relativi sedimi stradali soprattutto
quando non risultino possibili alternative di percorso.
pag. 43
Ver. 16/12/2013
2.3
- SISTEMA DEI VINCOLI
Di seguito vengono riportati, suddivisi per tipologia, i vincoli che interessano il Comune
di Golasecca.
2.3.1
- AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
Nelle aree di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi che ricadono o ricadranno sul
territorio comunale valgono le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, art. 94.
L’area di tutela assoluta (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è costituita
dall'area immediatamente circostante la captazione: essa deve avere una estensione di
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta
(recinzioni; sistemi di allontanamento delle acque meteoriche; impermeabilizzazione del
terreno superficiale; difesa da esondazioni di corpi idrici superficiali) e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
L’area di rispetto è rappresentata dalla porzione di territorio circostante la zona di
tutela assoluta; nel caso dei pozzi del Comune di Golasecca la delimitazione è stata
realizzata con il criterio temporale (isocrona a 60 giorni)
Quest’area deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata (art. 94 comma 4 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.).
Per gli insediamenti o le attività potenzialmente pericolose preesistenti, ove possibile e
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro
allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
All'interno delle zone di rispetto la realizzazione di fognature, di interventi di edilizia
residenziale (e relative opere di urbanizzazione), di opere viarie, ferroviarie ed in genere
infrastrutture di servizio e le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 5 sono disciplinate dalla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693:
“Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6,
del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni”.
In particolare i nuovi tratti di fognatura (i collettori di acque bianche, di acque nere e di
acque miste, nonchè le opere d’arte connesse, sia pubbliche sia private) da situare nelle
zone di rispetto devono:
• costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e
viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima;
• essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano
costituire elemento di discontinuità , quali i sifoni e opere di sollevamento.
Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in
cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno
della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere
analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni
e con idonea capacità di trattenimento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con
l’impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori
condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido
all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte.
Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
• non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo
di liquami e impianti di depurazione;
pag. 44
• è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti
da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona
di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.
I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni
evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate e` subordinata all’esito
favorevole del collaudo.
In merito alla realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa
urbanizzazione nelle zone di rispetto non è consentita:
• la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi
non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo
(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera i) del
d.lgs. 152/99);
• l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
2.3.2
- VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L.
183/89
Sul territorio comunale di Golasecca sono presenti vincoli derivanti dal Piano di Assetto
Idrogeologico del bacino del Fiume Po, costituiti dalle Fasce Fluviali .
Le Fasce Fluviali riguardano il Fiume Ticino m, e risultano alquanto compresse nella
loro estensione, data la profonda incisione valliva in cui scorre l’alveo fluviale:
Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
La Fascia A si trova lungo il Fiume Ticino. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di
garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il
mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi
favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento
in quota dei livelli idrici di magra.
Le attività vietate nella Fascia A sono definite nell’art. 29 comma 2 delle NdA del PAI,
mentre quelle consentite sono descritte nell’art. 29 comma 3. Con particolare riferimento
alle infrastrutture a rete si specifica che è vietata (art. 29 comma 2 ) la realizzazione di
nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti
esistenti di trattamento delle acque reflue; è consentito (art. 29 comma 3) l’adeguamento
degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a
mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
Fascia di esondazione (Fascia B)
La Fascia B è presente lungo il Fiume Ticino. Nella Fascia B (art. 30 NdA PAI) il Piano
persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini
principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
Le attività vietate nella Fascia B sono riportate al comma 2 dell’art. 30, mentre quelle
consentite, oltre agli interventi ammessi nella Fascia A, sono indicate nel comma 3. In
particolare sono consentiti gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata
l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e
messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso
anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
pag. 45
Ver. 16/12/2013
Nei territorio di fascia A e B valgono inoltre le seguenti disposizioni:
art. 38 - interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico: è
consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici
naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che
possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e
non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad
incrementare il carico insediativo. Le nuove opere di attraversamento, stradale o
ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei
criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva
emanata dall'Autorità di bacino.
art. 38bis -impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di
approvvigionamento idropotabile: L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le
prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli
impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B. I
proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce
fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti
impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e
soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano
gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
art. 38ter - Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi
art. 39 - Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
art. 41 - Compatibilità delle attività estrattive.
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
La Fascia C delimita le aree di esondazione per piena catastrofica lungo il Fiume Ticino.
Nella fascia C (art. 31 NdA PAI) il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di
sicurezza delle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti
competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle
Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio
derivanti dalle indicazioni del Piano.
2.3.3
- VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
Lungo i corsi d’acqua comunali, individuati da apposito studio in conformità ai criteri
della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i., è perimetrata una fascia di rispetto,
individuata con criterio geometrico, avente estensione minima di m 10 dal ciglio spondale.
Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle
possibili aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio
e della risorsa idrica, il regolamento di polizia idraulica comunale, cui si rimanda per
maggiori dettagli, definisce le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione
comunale.
Con riferimento particolare alle reti sotterranee si sottolinea che costituiscono attività
vietate:
− Il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione.
pag. 46
−
Il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione
di pendenza del corso d’acqua mediante la formazione di soglie di fondo.
− Lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di
pertinenza.
− Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di
difesa esistenti.
Sono invece Interventi ammessi, previa valutazione di compatibilità e successiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale (art. 97 e 98 del R.D. n° 523 del
25.07.1904):
− La realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e
infrastrutture a rete in genere):
• con luce superiore a 6 m: dovranno essere realizzati secondo la direttiva
dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica
delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e
B”, paragrafi 3 e 4. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da
apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il dimensionamento
delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un
franco minimo di 1 m.
• con luce inferiore a 6 m: il progetto di tali interventi deve essere accompagnato
da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il
dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno anche
inferiore a 100 anni, in base alle specifiche esigenze tecniche, adeguatamente
motivate. Le opere non devono comunque comportare un significativo
aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti in
caso di piene con tempi di ritorno superiori a quelli di progetto.
In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione
mediante spalle e rilevati di accesso, avere l’intradosso a quota inferiore al piano
campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo
di soglie di fondo.
− La realizzazione di attraversamenti in sub-alveo posti a profondità inferiori a quelle
raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dotati di
adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso
d’acqua.
− Lo scarico nei corsi d’acqua, realizzato nel rispetto della vigente normativa ovvero
nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/13950 del
01/08/2003. Dovrà essere verificata preliminarmente la capacità del corpo idrico
ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di
deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale. I limiti di
accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di
Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiati:
−
20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree
di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
−
40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree
già dotate di pubbliche fognature.
Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo
ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione
dell’energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.
- La realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse (strade, percorsi
pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnoclogigi a rete in genere, etc.) se
non altrimenti localizzabili; il progetto deve essere accompagnato da apposita
relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi la compatibilità idraulica
pag. 47
Ver. 16/12/2013
dell’intervento. Le opere non devono comunque comportare un aggravamento
delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti.
2.3.4
- FATTIBILITÀ GEOLOGICA
Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ha
suddiviso il territorio comunale in quattro classi di fattibilità geologica in base a valutazioni
incrociate dei fattori di maggior incidenza sulle modificazioni del territorio e dell’ambiente.
Per ciascuna classe di fattibilità, lo studio fornisce indicazioni generali in riferimento alle
cautele e alle indagini necessarie, da effettuarsi preventivamente all’intervento previsto.
Fattibilità senza particolari limitazioni (classe di fattibilità 1) - comprende quelle
aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla
modifica della destinazione d’uso.
Fattibilità con modeste limitazioni (classe 2) - comprende le zone nelle quali sono
state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. Sono
tuttavia indicate le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali
approfondimenti per la mitigazione del rischio.
Fattibilità con consistenti limitazioni (classe 3) – comprende le zone nelle quali
sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei
terreni per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. L’utilizzo di queste aree
sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la
compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali e individuare di
conseguenza le prescrizioni di dettaglio per procedere o meno all’edificazione.
Fattibilità con gravi limitazioni (classe 4) - l’alta pericolosità/vulnerabilità riscontrata
in queste aree comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso. Dovrà
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica e geomorfologica per la messa in sicurezza dei siti; dovrà
essere valutata puntualmente (tramite indagini e rilievi di dettaglio) la realizzazione di
infrastrutture d’interesse pubblico non altrimenti localizzabili.
2.3.5
- ALTRI VINCOLI
Nel seguente elenco dei restanti “vincoli” operanti sul territorio comunale, perché
recepiti oppure introdotti dal PGT, si evidenziano con sottolineatura e brevi commenti
sottolineati quelli inerenti alle problematiche del PUGSS:
- perimetro del centro abitato;
- perimetro del Nucleo di Antica Formazione: segnala la necessità generale di
particolari cautele, sia riguardo alla frequente complessità delle reti e degli
allacciamenti più vetusti preesistenti nel sottosuolo stradale, sia riguardo alle
tecniche di intervento da adottare, in particolare qualora siano posate od in
progetto pavimentazioni lapidee;
- interesse archeologico, relativamente all’area del Monsorino;
- vincoli monumentali ex DLGS 42/2004 e s.m.i., e seguenti immobili tutelati dal
Piano delle Regole: (cautele analoghe a quelle segnalate per il N.A.F.)
o Edifici rurali di notevole interesse architettonico ed ambientale (art. 15.5 Norme
del Piano delle Regole);
o Edifici ed aree soggetti a vincolo di tutela archeologica, storica ed architettonica ed altri
siti di interesse archeologico (art. 15.6 Norme del Piano delle Regole);
pag. 48
Edifici soggetti a vincolo di tutela architettonica ed ambientale (art. 17.1 Norme del Piano
delle Regole);
o Ville con parco di fine ottocento ed inizio novecento (art. 17.2 e 17.3 Norme del Piano
delle Regole);
aree agro-forestali di rilevanza paesaggistica e ambientale (Rete Natura 2000: S IC
e ZPS; rete ecologica regionale e locale) : qualche attenzione specifica deve
essere posta nelle sole fasce indicate quali “corridoi ecologici”, perché una
eccessiva rigidità dei manufatti sotterranei, eventualmente presenti in tali aree, può
limitare talune forme di permeabilità ecologica per specie appartenenti alla microfauna (può essere opportuno prevedere tunnel di attraversamento delle arterie
stradali);
aree boscate soggette alla L.R. n° 31/2008;
interesse paesaggistico, che si estende – a decorrere dal DLGS 63/2008 sull’intero territorio comunale, in quanto incluso nel Parco Regionale del Ticino.
classi di sensibilità paesaggistica, che articolano i contenuti del suddetto vincolo:
con riferimento al piano comunale per il Paesaggio, particolare attenzione, anche
per le reti nel sottosuolo, va posta per i tracciati della viabilità storica
(Mercantera/Ippovia, reti stradali nel nucleo antico)
fasce di rispetto stradale;
tracciati della viabilità di progetto: richiedono una progettazione integrata dei
servizi di sottosuolo, e modalità precauzionali in caso di interventi per i sottoservizi eventualmente precedenti alla realizzazione delle nuove opere stradali
fasce di salvaguardia degli elettrodotti;
fasce di salvaguardia dai metanodotti: comportano il rispetto di specifche
prescrizioni, al fine di prevenire il formarsi di sacche di gas pericolose;
fasce di rispetto dei depuratori;
fasce di rispetto cimiteriale;
o
-
-
-
2.4 - SISTEMA DEI SERVIZI A RETE: RICOGNIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE
INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO
È stato esaminato il sistema delle reti dei sistemi tecnologici esistenti sul suolo e nel
sottosuolo urbano.
-
I sistemi considerati, in quanto portatori di servizi sono stati:
rete acquedottistica;
rete fognaria;
rete di trasporto e distribuzione per i servizi di illuminazione pubblica;
rete di distribuzione del gas;
rete di trasporto e distribuzione elettrica;
rete di telecomunicazioni.
Sono state acquisite le informazioni in possesso degli uffici dell’Amministrazione
comunale, chiedendo aggiornamento e/o integrazione mediante richieste dirette alle
Aziende che erogano i servizi 1.
1 Art. 3 comma 6 del Regolamento regionale del 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la
redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e
la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37,
comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)
pag. 49
Ver. 16/12/2013
Nel quadro conoscitivo sono stati valutati gli interventi rilevanti in corso per avere una
visione il più possibile aggiornata della dotazione infrastrutturale, e quelli previsti, anche a
lunga scadenza, onde valutarne, per tempo, la compatibilità con lo sviluppo urbanistico,
secondo i criteri stabiliti nel presente documento, ed attivare quanto prima un efficace
coordinamento tra le Aziende stesse.
L’analisi conoscitiva e gli elementi progettuali rappresentano anche la base tecnica che
permette di stabilire le esigenze di adeguamento delle singole reti a seconda che esse
siano mancanti, siano insufficienti o siano obsolete.
L’analisi consente di evidenziare eventuali inefficienze o possibilità di miglioramento
progettuale e gestionale.
Il quadro iniziale ottenuto risulta in parte carente, mancando informazioni precise circa il
tracciato esatto delle reti, la qualità dei servizi, il rischio e le esigenze di adeguamento.
Permane quindi quale finalità del PUGSS migliorare progressivamente lo stato
conoscitivo dei sistemi, attività complessa che richiederà necessariamente del tempo 2;
inoltre ciò permetterà di sistematizzare i dati, secondo i metodi che si stanno diffondendo e
che gli Enti sovraordinati hanno contribuito a mettere a punto, dati che man mano dovranno
confluire nel Sistema Informativo Territoriale.
A questa finalità provvederà l’Ufficio del Sottosuolo, previsto dall’art. 7 del Regolamento regionale del 15
febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e
criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art.
37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18). Vedi anche art.11 del Regolamento attuativo, in allegato.
2
pag. 50
2.4.1
- RETE ACQUEDOTTISTICA
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.1
Rete Comunale con by-pass intercomunale
AMSC con capitale a prevalenza pubblica
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Stazioni di sollevamento
- Pozzi
- Serbatoi
- Idranti
- Saracinesche
- Nodi modelli matematici
- Nodi con pressione < 2 bar secondo modellazione Q.
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da tubazioni come da reticolo cartografico alla Tav.
PU4.1.
TIPOLOGIA TUBAZIONE
- Acciaio
- PEAD
- Ghisa
CRITICITA’
Disegni della rete non corrispondenti al sistema di coordinate geografiche (UTM – WGS84).
Alcune tubazioni in acciaio di età superiore ai 30 anni.
Presenza di arsenico nelle falde dei pozzi esistenti, mitigata da appositi trattamenti.
PREVISIONI
Essenziali di integrazione: nuova condotta tra Nuovo pozzo e Nuovo serbatoio Monte Motta (PS3),
nonché tra il bacino sopra citato ed il bacino esistente Monte Tabor.
SERVIZIO FORNITO
Sufficiente e occorre integrazione fabbisogno idrico, migliorando la qualità dell’acqua (esente dalla
presenza di arsenico in falda).
pag. 51
Ver. 16/12/2013
2.4.2
- RETE FOGNARIA
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.2
Rete Comunale
AMSC con capitale a prevalenza pubblica
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Depuratori
- Camerette di ispezione
- Stazione di sollevamento
- Manufatti speciali di derivazione delle acque nere e di sfioro delle acque di supero meteorico
- Colletori
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da tubazioni come da reticolo cartografico alla Tav.
PU4.2.
TIPOLOGIA TUBAZIONE
- Cls
- PVC
- Gres porcellanato
CRITICITA’
Reti miste e vetuste che non garantiscono regolarità nei deflussi.
Depuratore Nord e Sud da adeguare e/o ampliare.
PREVISIONI
Ampliamento delle reti per servire aree urbanizzate attualmente sprovviste: nucleo abitativo lungo via
Colombo e estremo Sud-Est Via Europa/Via Cavour.; separazione delle condotte miste in acque
bianche e acque nere.
SERVIZIO FORNITO
Integrazione fabbisogno pregresso.
pag. 52
2.4.3
- RETE GAS
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.3
Rete Comunale
Società concessionarie
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Giunti dielettrici
- Punti di misura P.C.
- Valvole gas metano
- Cabine di salto.
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da tubazioni come da reticolo cartografico alla Tav.
PU4.3.
TIPOLOGIA TUBAZIONE
- Acciaio
CRITICITA’
Non emergono indicazioni relative a debolezze e criticità.
PREVISIONI
Integrazione rete per alimentare le aree di trasformazione previste da PGT.
SERVIZIO FORNITO
Buono per alimentazione singole utenze.
pag. 53
Ver. 16/12/2013
2.4.4
- RETE ELETTRICA
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.4
Rete Comunale B.T. e M.T.
ENEL
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Stazioni
- Sottostazioni
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da linee come da reticolo cartografico alla Tav. PU4.4.
TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA
- Per rete interrata cavidotto in corrugato plastico e/o PVC
- Reti aeree
CRITICITA’
Adeguamenti ove necessario per meglio rispondere ai requisiti di qualità urbana e paesaggistica, in
particolar modo nei luoghi di interesse paesaggistico.
PREVISIONI
Integrazione rete B.T. e M.T. in aree di trasformazione previste da PGT e tendenzialmente nelle altre
aree.
SERVIZIO FORNITO
Sufficiente con alimentazione singole utenze.
pag. 54
2.4.5
- RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.5
Rete Comunale
ENEL SOLE + Comune
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Punti luce
- Cabine
- Cassette
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da linee come da reticolo cartografico alla Tav. PU4.5.
TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE
- Aerea
- Cavidotto interrato in corrugato plastico e/o PVC
CRITICITA’
Incertezze su soggetto gestore e modalità contrattuali.
Necessità di adeguamento alle norme su inquinamento luminoso e su risparmio energetico, nonché
requisiti di qualità urbana e paesaggistica lungo i percorsi di notevole interesse.
PREVISIONI
Integrazione di punti luce in via Colombo per carenza pregressa.
SERVIZIO FORNITO
Sufficiente.
pag. 55
Ver. 16/12/2013
2.4.6
- RETE DI TELECOMUNICAZIONI
SERVIZIO IMPIANTO
GESTIONE IMPIANTO
Vedi tavola: Stato attuale rete acquedotto PU 4.6
Rete Telecom e rete wireless (antenne)
Telecom e Comune
I dati territoriali della rete si articolano in:
Elementi puntuali:
- Cabine e armadi di derivazione
- Antenne per telefonia mobile
Tracciato di distribuzione della rete, costituito da linee come da reticolo cartografico alla Tav. PU 4.6.
TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE
- Cavidotto in corrugato plastico
- Cavi aerei.
CRITICITA’
Attivazione rete wireless comunale.
Impatto paesaggistico delle antenne esistenti e delle reti aeree di distribuzione.
PREVISIONI
Integrazioni reti per alimentare le aree di trasformazione previste da PGT e completamento di
interramento reti.
SERVIZIO FORNITO
Sufficiente per alimentazione singole utenze.
pag. 56
2.4.7
- SOLUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE
I dati riguardanti le reti tecnologiche sono stati richiesti dal Comune a ciascun gestore
sia per gli aspetti sistemici che di mappatura delle reti.
I gestori hanno fornito la documentazione della mappatura delle reti in formato
elettronico, spesso non adeguata e non in linea con le specifiche tecniche che la Regione
Lombardia ha definito per la mappatura delle reti dei sottoservizi nell’allegato n 2 del
Regolamento Regionale n. 06/10.
Inoltre i gestori non hanno fornito la documentazione tecnica sulle modalità di gestione
e di manutenzione delle reti, degli allacci agli immobili e dei consumi suddivisi per tipologia
e per il loro andamento degli anni precedenti.
Queste informazioni dovranno essere fornite al Comune in quanto previste dalla
normativa vigente e necessarie per rendere attuale ed operativo il Piano.
L’esigenza di approfondire l’attuale conoscenza delle reti potrà comportare la necessità
di predisporre campagne di rilievi mirate, con l’obiettivo di attualizzare gli elementi
conoscitivi di ogni sistema a rete secondo le disposizioni regionali.
Pertanto, dopo l’istituzione dell’Ufficio del Sottosuolo 3, potranno essere programmate
specifiche campagne di rilievo per la mappatura delle reti di sottoservizi con le modalità
prescritte nell’Allegato 2 del Regolamento Regionale 06/10.
L’Ufficio dovrà disporre l’avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio
quali - quantitativo delle reti di sottoservizi e delle infrastrutture locali esistenti fruite e non.
Il m onitoraggio dovrà interessare i manufatti, i punti di accesso, lo stato delle opere
murarie, i servizi presenti ed il loro stato d’uso, in collaborazione con le Aziende erogatrici.
I risultati dell’indagine, al termine della ricognizione, dovranno essere inviati
all’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia.
Ogni ente ha fornito le informazioni relative alla propria rete secondo la forma in cui
possedeva il dato: raster e/o vettoriale (pdf o dwg ). In tutti i casi il disegno della rete dei
sottoservizi non è stato consegnato nel sistema di coordinate geografiche adottato dalla
Regione Lombardia (UTM-WGS84).
L’informazione vettoriale è stata trasformata dal formato dwg originale in shapefile.
Successivamente, i dati shapefile saranno georeferenziati su base cartografica DBT
regionale.
Infine, i dati territoriali shapefile - puntuali, lineari o poligonali - sono stati depurati delle
informazioni che ricadevano al di fuori del confine comunale, e ripuliti delle informazioni
strettamente legate all’utilizzo dei tecnici dei singoli enti.
I dati digitalizzati sono da verificare con i gestori per gli opportuni aggiornamenti sia a
livello grafico e di elementi tecnico - costruttivi che di posa nel sottosuolo.
I dati dovranno essere integrati dalla documentazione riferita agli aspetti impiantistici
che non sono stati forniti da ogni gestore.
Tali informazioni dovranno essere ampliate nel tempo richiedendo ai gestori i dati
mancanti per completare la documentazione tecnico-conoscitiva. Inoltre, in occasione di
aperture di cantieri per interventi sui disservizi, è importante che siano consegnati gli
elementi del come costruito (metodo as built).
Le Aziende erogatrici sono tenute, secondo le disposizione di legge, a mantenere
costantemente aggiornati i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti, a renderli
disponibili al Comune senza oneri economici.
3
Cfr. art 11 del seguente Regolamento attuativo.
pag. 57
Ver. 16/12/2013
2.5 - LE SCELTE STRATEGICHE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Si riproducono di seguito alcuni estratti dal “Documento di Piano – Quadro
Programmatico” che riassumono le scelte del PGT riguardo alle aree di trasformazione:
Le scelte progettuali del Documento di Piano rispondono alle seguenti valutazioni
sulla morfologia urbana di Golasecca e sul rapporto tra abitato e contesto agro forestale:
• contrapposizione ai fenomeni di frammentazione casuale e sfrangiata del confine
tra abitato e campagna, con la promozione di una moderata compattazione del
tessuto edificato, che contiene diffuse presenze di verde privato e pause
significative di verde pubblico e di interesse paesaggistico;
• freno alla tendenza ad allineamenti edificatori ad alta densità edilizia lungo l’asse
viario della S.P. 27 (viale Europa) ed incentivo ad una contenuta densificazione
degli spazi a nord del nucleo antico per ampliare l’area caratterizzata da funzioni
urbane rilevanti.
Con riferimento ai criteri espressi in vari paragrafi del capitolo C, gli Ambiti di
Trasformazione sono individuati in prevalenza all’interno del perimetro complessivo
dell’abitato, su aree già utilizzate oppure intercluse o di perimetro.
Si evidenzia quanto segue:
• aspetti qualitativi: raggruppati per destinazione d’uso di progetto, sono analizzati in
rapporto alla situazione di fatto e di diritto nel previgente P.R.G., con evidenziazione
delle modalità di intervento e delle finalità pubbliche connesse;
• aspetti quantitativi: si indicano la superficie territoriale e gli indici di edificabilità
assegnati, con i risultati singoli e complessivi al netto ed al lordo di trasferimenti ed
incentivi;
• dotazioni urbane: sono espressi gli standard minimi da applicare in generale per le
diverse destinazioni d’uso nonché i vincoli progettuali del Documento di Piano per la
dotazione minima rispondente alle finalità pubbliche.
La definizione degli indici urbanistico – edilizi assunti per i diversi gruppi di Ambiti di
Trasformazione, rispondono ai seguenti criteri:
- TA Terziario: alberghiero o sociale privato e TR Turistico e ricreativo: Riutilizzo e
riqualificazione dei contenitori esistenti
- P Produttivo extra – agricolo: Altezza e superficie coperta massima congruente
con gli indici applicati nel previgente P.R.G., con incrementi marginali per
incentivazione ecologica PC Produttivo extra – agricolo e commerciale ed
energetica
R Residenziale: Indici minimo e massimo compatibili con il contesto del paesaggio
urbano ed extra – urbano; differenziale tra minimo e massimo idoneo per attivare i
trasferimenti volontari di diritti volumetrici e i meccanismi di incentivazione
RT Residenziale e terziario: Indici minimo e massimo sostenibili in prossimità del
Nucleo di Antica Formazione, sufficienti per sorreggere i processi di rilocalizzazione
aziendale e di riconversione delle aree già edificate, differenziale tra minimo e
massimo idoneo per attivare i trasferimenti volontari di diritti volumetrici e i
meccanismi di incentivazione
V Verde pubblico e agricolo: Indice di edificabilità territoriale da trasformare in diritti
volumetrici trasferibili negli Ambiti R e RT, sufficiente a compensare l’acquisizione
pubblica dei terreni, considerato lo stato di fatto di estesa zona agricola tutelata dal
P.T.C.P., scarsamente urbanizzata e frammentata in particelle con dimensioni non
adeguate ad una utilizzazione edilizia razionale ed estesa
pag. 58
Aree per nuova viabilità: Indice di edificabilità territoriale da trasformare in diritti
volumetrici trasferibili negli Ambiti R e RT, sufficiente a compensare l’acquisizione
pubblica dei terreni, considerato lo stato di fatto differenziato nel territorio peri –
urbano e nel territorio extra – urbano
L’articolazione degli indici di edificabilità per gli Ambiti di tipo R, RT e V risponde
anche a un principio di cautela – espresso dall’Amministrazione - nella
sperimentazione dei nuovi istituti della perequazione e compensazione con
trasferimento dei diritti volumetrici.
Le previsioni relative al consolidamento dei tessuti urbani e dei relativi servizi
comportano limitati carichi addizionali sulle reti dei sottoservizi e non ne alterano gli assetti
(tranne lo specifico progetto per la nuova strada parallela a via C. Battisti).
pag. 59
Ver. 16/12/2013
3 - ANALISI DELLE CRITICITA’
3.1 - LA SENSIBILITÀ DELLA RETE STRADALE
L’analisi della sensibilità/vulnerabilità della rete stradale è stata compiuta adattando specificamente
il set di indicatori regionali alle specifiche condizioni di Golasecca, e trascurando i parametri assenti o
poco incidenti nella realtà locale (ad esempio il calibro stradlae, essendo comunque sempre assai
limitato, oppure la presenza di banchine e/o marciapiedi, che sono sporadici oppure ricavati dalla
carreggiata originaria, oppre ancora la incidenza dei mezzi pesanti sui flussi veicolari, che è
quantitativamente trascurabile, ad eccezioen delal SP 27, ma comunque qualitativamente rilevante,
ovunque siano attive aziende, siano esse agricole, produttive o commerciali).
Gli indicatori utilizzati pertanto sono i seguenti:
INDICATORE
CRITICITA’
STRUTTURALI *
VALORE
PUNTEGGIO
AFFOLLAMENTO
VALORE
SOTTOSUOLO PUNTEGGIO
TRASPORTO
PUBBLICO
ALTA CRITICITA'
MEDIA CRITICITA'
BASSA CRITICITA'
ALTA CRITICITA'
MEDIA CRITICITA'
BASSA CRITICITA'
3
2
1
> 6 reti
3
5 < reti <6
1
< 5 reti
0
VALORE DEPOSITO/STAZIONE PERCORSI ABITUALI
PUNTEGGIO
3
2
NO
0
PUNTEGGIO
>3000 V/g
(SP 27)
3
ALTRA VIABILITA’
PRINCIPALE
1
VALORE
PUNTEGGIO
ALTA
3
MEDIA
1
BASSA
0
COMMERCIO DI
VALORE
VICINATO
PUNTEGGIO
ALTA
3
MEDIA
1
BASSA
0
TRADIZIONALE
3
VILLE SINGOLE
1
ALTRO **
0
FLUSSI
VEICOLARI
PRESENZA
AZIENDE
TIPOLOGIA
INSEDIATIVA
VALORE
VALORE
PUNTEGGIO
VIABILITA’ LOCALE
0
* STRADE SENZA USCITA E/O SENSI UNICI E/O SENZA ALTERNATIVE E/O MOLTO
STRETTE
** PALAZZINE, CAPANNONI, TESSUTI MISTI OPPURE RADI
pag. 60
viale
Europa
b
c
via
Garibaldi
vicolo
via
piazza
via
via
piazza
Guazzoni
I Maggio
IX Maggio
Lazzaretto
Leopardi
Libertà
Madonna degli
Angeli
Marconi
Mascagni
via
via
via
a
b
da via Roma verso Sesto
C.
da via Roma a via
Berlinguer
da via Berlinguer verso
Somma L.
NAF
fuori
pag. 61
TIPOLOGIA INSEDIATIVA
a
COMMERCIO DI VICINATO
Belvedere
Berlinguer
Buonarroti
Cavour
Colombo
da Vinci
delle Cascine
della Volta
delle Corti
alle Scuole
delle Vignazze
del Torchio
Diaz
Edison
PRESENZA AZIENDE
via
via
via
via
via
via
via
via
vicolo
via
via
vicolo
via
via
a da centro a Sp 27
b da Sp 27 a Alighieri
c oltre Alighieri
FLUSSI VEICOLARI
Battisti
TRASPOSRTO PUBBLICO
via
AFFOLLAMENTO
SOTTOSUOLO
via
Alighieri
strada Alzaia del Ticino
vicolo Aspesi
CRITICITA' STRUTTURALI
tratti
TOPONOMASTICA
Sulla base degli indicatori scelti si è quindi proceduto alla valutazione della rete stradale secondo le
modalità contenute nella seguente tabella riepilogativa.
2
3
3
2
3
3
2
1
3
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
3
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
0
3
0
0
1
1
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
3
0
1
2
1
0
3
1
0
0
1
1
2
3
1
0
0
2
3
2
3
3
3
1
1
3
1
1
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
0
3
1
3
3
3
1
0
3
1
3
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
Monte Grappa
via
via
via
via
via
via
Monte Rosa
Monte Tabor
Pascoli
Petrarca
Pianetta
Piave
via
Porto della
Torre
via
Puccini
via
Roma
vicolo
via
via
via
vicolo
via
via
Salvetta
San Michele
San Rocco
Sanzio
Ticino
Ungaretti
Verdi
via
Vittorio Veneto
via
via
via
vicolo
Volta
XXV Aprile
Lodi Bianca
Oriaggio
a NAF
b fuori
a NAF
b
c campagna
1 NAF
2 fino Mad Angeli
3 da Mad Angeli a SP 27
a NAF
b
TIPOLOGIA INSEDIATIVA
via
COMMERCIO DI VICINATO
Mazzini
Montale
PRESENZA AZIENDE
via
via
FLUSSI VEICOLARI
Matteotti
TRASPOSRTO PUBBLICO
via
NAF (fino casa
a
Bandinelli)
b fino a via S. Rocco
c oltre via S. Rocco
AFFOLLAMENTO
SOTTOSUOLO
Mattè
CRITICITA' STRUTTURALI
vicolo
tratti
TOPONOMASTICA
Ver. 16/12/2013
3
0
0
0
0
0
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
1
3
3
1
2
3
2
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
1
0
3
1
3
1
3
0
0
0
3
3
3
1
0
0
3
1
0
3
3
0
1
3
1
1
3
0
1
1
0
0
Dalla analisi della rete stradale emerge una criticità medio-bassa. Le strade a più alta criticità scontano il fatto
di trovarsi in pieno centro o di essere le principali arterie di traffico cittadino.
Le maggiori criticità si hanno in Via Cesare Battisti e Via Matteotti.
pag. 62
3.2 - VULNERABILITÀ DELLE STRADE PER ESONDAZIONE E FRANE
Nel presente paragrafo sono state analizzate le possibili interferenze tra la viabilità, ed i
sottoservizi a rete a questa connessi, ed i fenomeni di dissesto idrogeologico (esondazioni
e frane) che gravano su alcune porzioni del territorio comunale.
Esondazione
La regolazione artificiale del deflusso delle acque dal lago Maggiore e la forte incisione
valliva dell’alveo del Ticino limitano l’area di esondazione potenziale del Fiume (fasce A-BC del Piano di Assetto Idrogeologico per il Bacino del Po), interessando solo per brevi tratti
il percorso della Sp 27 verso Sesto Calende e la Strada Alzaia costiera dello stesso Ticino.
I fenomeni alluvionali connessi al reticolo idrico minore – paragrafo 2.1.4 -riguardano
potenzialmente solo il medesimo tracciato Alzaia/tratto nord della Sp 27, lungo il quale
sorgono solo limitati insediamenti (turistici, residenziali e tecnologici), di cui il P.G.T.
prevede la riqualificazione e non ulteriori espansioni.
La progettazione delle infrastrutture nel sottosuolo lungo tale tracciato costiero deve
raffrontarsi con tali specifiche problematiche, sia riguardo la prevenzione di eventi turbativi,
sia anche semplicemente riguardo l’innalzamento delle acque di falda, connesso ai
processi pluviometrici, alluvionali ed esondativi.
Frane
Come esposto nel paragrafo 2.1.3, i processi gravitativi di versante risultano presenti
lungo l’orlo del terrazzo parallelo al Fiume Ticino, nella forma diffusa di coronamento in
arretramento e nella forma concentrata di n° 3 aree con specifico dissesto, ad ovest del
cimitero, a monte della Miorina ed a sud-ovest (metanodotto).
Tali fenomeni non interferiscono specificamente con l’attuale rete stradale e con i
connessi servizi nel sottosuolo.
Tuttavia si raccomanda specifica cautela per le eventuali opere di nuova progettazione
con tracciati interferenti con il ciglio del terrazzamento verso la valle del Ticino e per le
infrastrutture connesse alla Sp 27, nel tratto in cui attraversa la scarpata stessa.
pag. 63
Ver. 16/12/2013
4 - PIANO DEGLI INTERVENTI
4.1 - CRITERI DI INTERVENTO: CAUTELE GEO-TECNICHE
Sulla base delle caratteristiche litologiche dei terreni (unità di prima caratterizzazione
geologico tecnica) e delle condizioni di pericolosità / vulnerabilità in relazione ai possibili
fenomeni di dissesto, riportata nel paragrafo 2.1.5, si evidenziano di seguito le principali
indicazioni in merito all’esecuzione delle opere di scavo e posa delle reti tecnologiche.
Unità geotecnica 1: sabbie e ghiaie ciottolose
Problematiche: terreni con caratteristiche tecniche da discrete a buone; si raccomanda
comunque l’asportazione dello scotico vegetale e la valutazione della stabilità dei fronti di
scavo; da verificare l’eventuale occorrenza e spessore di depositi fini eolici (loess)
Unità geotecnica 2: sabbie e ghiaie ciottolose con limo
Problematiche: lo spessore limitato ne rende in genere poco significativa l’influenza; in
previsione di scavi fondazionali gli stessi dovranno essere spinti a profondità tale da
superare l’unità raggiungendo la sottostante unità 1; da valutare la stabilità dei fronti di
scavo ed eventuali locali situazioni di drenaggio difficoltoso connesso all’occorrenza di
plaghe di materiale fine limoso corrispondenti ad aree di canale abbandonato
Unità geotecnica 3: sabbie con ghiaia
Problematiche: sulle aree di versante presenza diffusa di coltri detritico colluviali di
spessore variabile e caratteristiche tecniche scadenti; acclività elevata con processi attivi
legati al ruscellamento superficiale di acque incanalate e non, e predisposizione all’innesco
di scivolamenti superficiali; da valutare la stabilità dei fronti di scavo e la possibile
occorrenza di venute d’acqua al contatto fra litologie a differente grado di conducibilità
idraulica; presso le aree in fregio al Ticino possibili allagamenti in occasione di eventi di
piena
Unità geotecnica 4: limi e sabbie con ciottoli sparsi
Problematiche: presenza diffusa di materiale fine di origine eolica (loess) e/o
occorrenza di plaghe eluvio-colluviali a caratteristiche tecniche scadenti e con spessore
variabile anche se generalmente ridotto (0-2 m); possibilità di cedimenti differenziali in
relazione all’eterogeneità dei materiali che possono richiedere miglioramenti delle
caratteristiche del piano di posa fondazionale ad esempio mediante interventi di bonifica
statica; possibilità di incontrare isolati blocchi e/o trovanti in fase di scavo; possibile
occorrenza di falde sospese a carattere locale; aree ad acclività variabile con processi di
ruscellamento/erosione superficiale concentrata; da valutare la stabilità dei fronti di scavo;
possibile occorrenza di aree debolmente depresse con tendenza alla concentrazione delle
acque e potenziale drenaggio difficoltoso; possibile occorrenza di rimaneggiamenti
antropici
Unità geotecnica 5: aree interessate da rimaneggiamento antropico
Problematiche: aree di profondo rimaneggiamento antropico con caratteristiche
geotecniche variabili, potenzialmente scadenti in relazione all'eterogeneità dei materiali, al
grado di addensamento e agli spessori variabili del materiale di riporto o colmatazione;
possibili bassi valori di capacità portante e cedimenti differenziali
pag. 64
4.2 SCENARIO DI INFRASTRUTTURAZIONE
4.2.1
INTRODUZIONE
Finalità generale del PUGSS è perseguire la razionalizzazione delle reti nel sottosuolo,
nella consapevolezza che l’efficienza dei sottoservizi risulta di notevole importanza per lo
sviluppo urbano, perché contribuisce alla competitività generale dell’economia mediante la
continuità nell’erogazione dei servizi e la rapidità negli interventi di manutenzione ed
integrazione, evitando sprechi di risorse e contenendo le perdite e i costi sociali che sono
collegati a questi temi.
La legge regionale 26/03 all’art. 34 definisce l’infrastruttura polifunzionale come il
manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche UNI-CEI, atto a raccogliere, al proprio
interno, tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il
tempestivo libero accesso per gli interventi legati alla continuità del servizio.
Le nuove infrastrutture interrate che verranno posate nel territorio ricadono nelle
seguenti tipologie (in ordine crescente di complessità, ed anche di efficienza):
a) in trincea: realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o in
tubazioni, successivo rinterro e ripristino della pavimentazione;
b) in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o
termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete;
c) in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni
e passerelle portacavi, dotati di chiusura mobile carrabile disposta sul piano di calpestio,
facilmente ispezionabile ma non percorribile dagli operatori;
d) in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni
e passerelle portacavi, percorribile da uomini ed eventualmente da mezzi per un
alloggiamento multiplo di servizi che risponda ai criteri di affidabilità e di resistenza rispetto
a problemi di assestamento dei suoli e a fenomeni sismici.
Le infrastrutture dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte
temporale non inferiore a dieci anni;
b) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento
dell’effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze (tecnologie No Dig);
c) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli
allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI – CEI;
d) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con
le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
e) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di
plotte scoperchiabili, abbinate a polifore;
f) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri
improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare.
Per le scelte progettuali specifiche, a partire dalla profondità rispetto al piano stradale
(e quindi alla gamma delle possibili altezze interne) occorre valutare:
a) condizioni morfologiche dei terreni,
b) caratteristiche dei fabbricati al contorno e relative fondazioni,
c) vincoli altimetrici delle singole reti, e soprattutto delle fognature,
d) condizioni del traffico in relazione ai tempi di esecuzione.
pag. 65
Ver. 16/12/2013
Obiettivo specifico del PUGSS di Golasecca, considerando le scarse conoscenze
analitiche sullo stato di conservazione delle reti idrauliche, comunque in parte fatiscenti, e
l’assenza di reti interrate per la pubblica illuminazione, è di procedere al rinnovo delle reti
idrauliche, e ad integrare nel sottosuolo le altre reti, a partire dalla pubblica illuminazione,
mediante l’introduzione graduale di moderne strutture polifunzionali, in grado di contenere
contestualmente più servizi, facilmente ispezionabili Questi elementi sono previsti
prioritariamente all’interno degli Ambiti di Trasformazione (qualora di dimensione superiore
ad una soglia determinata dal PGT), nonché nella sostituzione delle reti esistenti, a partire
dalle aree di maggiore vulnerabilità o criticità, come ad esempio il Nucleo di Antica
Formazione.
La limitata disponibilità di risorse per tali investimenti, non consentirà comunque una
rapida sostituzione delle reti esistenti, èer cui per un tempo medio-lungo si dovrà ricorrere
in gran parte del territorio urbanizzato alle modalità tradizionali di posa e manutenzioni dei
sottoservizi.
4.2.2
METODO DI POSA TRADIZIONALE
La procedura tradizionale per la posa dei sottoservizi è costituita dallo scavo e dal
successivo interramento, con due casistiche principali: in presenza o in completa assenza
di condotte. In entrambi i casi ogni singolo intervento comporta uno scavo con la
conseguente interruzione della viabilità, salvo disporre di spazi laterali di marciapiedi o
banchine particolarmente estesi.
Le difficoltà e i tempi di realizzazione variano in funzione del tipo di pavimentazione, ma
soprattutto in funzione delle attività e delle utenze presenti che inevitabilmente risultano
danneggiate.
Un’ulteriore problematica nella gestione dei sottoservizi, impiegando il metodo
d’intervento tradizionale, è la difficoltà di valutare la reale consistenza e posizionamento
delle condotte esistenti. La difficoltà di conoscere il reale stato di consistenza delle
condotte (principalmente acquedotti e fognature) non consente una coerente e costante
programmazione degli interventi. Le perdite (affioramenti o infiltrazioni) si manifestano solo
dopo un certo lasso di tempo e spesso in luoghi distanti dal reale punto di rottura.
Le perdite principali degli acquedotti e delle fognature interrati sono diffuse e di difficile
localizzazione; soprattutto in presenza di terreni molto permeabili i liquidi filtrano in
profondità senza manifestarsi. Nell’analisi economica di questo metodo, occorre
considerare queste dispersioni come valore negativo, che sul medio-lungo periodo possono
determinare perdite e danni anche considerevoli, sia sotto il profilo economico sia sotto il
profilo ambientale. Gli interventi di ripristino, oltre a creare notevoli disagi alla viabilità,
pedonale e veicolare, sono difficoltosi per gli operatori. Economicamente, inoltre, si devono
quantificare non solo la spesa di intervento, ma anche i danni economici, diretti ed indiretti,
alle attività produttive, commerciali e turistiche.
Nei centri abitati i lavori sulla rete dei sottoservizi esistente possono riguardare la
sostituzione di interi tratti di tubature danneggiate e/o obsolete ed interventi puntuali di
riparazione in caso di rottura.
L’esecuzione dei lavori implica l’installazione del cantiere, l’asportazione della
pavimentazione, che sarà più o meno difficoltosa in funzione della tipologia esistente.
Lo scavo, eseguito a sezione ristretta, deve essere effettuato con cautela, spesso a
mano, per non danneggiare la pavimentazione da asportare, e i sottoservizi esistenti.
pag. 66
In caso di interventi su strade pavimentate in pietra, i tempi e gli oneri di lavorazione
dovranno considerare anche la cura necessaria per il riposizionamento delle pietre, che
dovranno essere riadattate perfettamente, al fine di evitare la formazione di discontinuità
con l’esistente esteticamente disprezzabile, soprattutto in centro storico.
In presenza di pavimentazioni in asfalto, i lavori di scavo richiedono lo sbancamento e
l’allontanamento dal cantiere del materiale di risulta. I problemi maggiori sorgono in fase di
asfaltatura della sezione di scavo che con il tempo manifesta sempre cedimenti e quindi
avvallamenti rispetto all’intera sezione stradale già consolidata.
Per evitare disagi alla viabilità l’asfaltatura dovrebbe interessare l’intera carreggiata.
In generale lo scavo, da eseguirsi a sezione ristretta, richiede cura per la presenza di
altri sottoservizi (cavi elettrici e linee telefoniche, fibra ottica ecc ).
Non sono rare le rotture anche dei cavi di fibre ottiche, non ben segnalate, che possono
procurare alla ditta esecutrice ed all’Ente Committente delle spese aggiuntive sostanziose.
Durante l’esecuzione dei lavori spesso dovrà essere interrotta la fornitura dei servizi
nelle vie in cui sono in corso gli allacciamenti. L’interruzione può interessare un tratto più o
meno esteso a seconda della tipologia degli interventi e della diffusione delle valvole di
intercettazione.
Le condotte dovranno essere posate su un piano di sabbia e rinfiancate a mano con uno
spessore adeguato sempre in materiale fine, a protezione delle stesse per evitare lesioni e
rotture.
Il reinterro della sezione di scavo prevede il riempimento con materiale ghiaioso per
ridurre i cedimenti della pavimentazione stradale.
Con le tubature dovranno essere posizionate anche le camerette d’ispezione, una per
ogni condotta, al fine di poter intervenire in caso di guasto e per effettuare le periodiche
manutenzioni.
L’esecuzione dei lavori di posa dei sottoservizi in zone non urbanizzate, consente la
razionalizzazione e la collocazione delle condotte.
Anche in assenza di sottoservizi si dovranno espletare le stesse fasi lavorative del caso
di sottoservizi esistenti. Si procederà quindi all’installazione del cantiere, allo sbancamento
e scavo, alla posa delle condotte e delle camerette d’ispezione, al successivo reinterro e
alla realizzazione della nuova pavimentazione.
4.2.3
- METODO DI POSA CON TUNNEL (CUNICOLI TECNOLOGICI E GALLERIE
PLURISERVIZI)
La posa dei sottoservizi mediante tunnel (cunicoli tecnologici oppure gallerie
percorribili) è una procedura finora poco utilizzata in Italia.
I tunnel permettono la posa dell’insieme dei sottoservizi in una struttura facilmente
accessibile, ampliabile con nuovi sistemi e facilmente controllabile con videoispezioni.
Tali sistemi offrono la possibilità di rinnovare le reti, di espanderle, di assicurare una
manutenzione agile ed un pronto intervento tempestivo, e quindi di facilitare la
programmazione degli interventi di implementazione e di manutenzione..
I cunicoli tecnologici e le gallerie pluriservizi possono essere realizzati con differenti
tipologie di infrastrutture e differenti dimensioni.
Caratteristiche comuni alle due tipologie sono:
- la realizzazione degli interventi di manutenzione senza manomissione del corpo stradale
o intralcio alla circolazione,
- la collocazione di più servizi in un unico attraversamento,
pag. 67
Ver. 16/12/2013
- l’accesso mediante pozzetti, localizzati possibilmente fuori della carreggiata.
I tunnel possono avere tre diverse modalità costruttive:
a) gettato in opera: consiste nella realizzazione del manufatto tramite casserature,
armature e getti di cls. in loco;
b) prefabbricato in conci di cemento armato;
c) a tecnica mista, realizzato con parti gettate in opera (fondazioni), parti semiprefabbricate (pareti) e parti prefabbricate (solette).
Il modo a) permette delle economie se realizzato su tratti molto lunghi, per contro
presenta lo svantaggio di avere tempi realizzativi maggiori per i tempi di attesa delle
scasserature del getto in opera.
Il modo b) è utilizzabile solo in strade di larga dimensione per il peso e la
movimentazione dei conci. È molto costoso, i grossi conci sono difficilmente posabili e
appaiabili, presentano delle grosse discontinuità, servono degli autocarri con delle gru
molto pesanti, nelle strade non larghe e non rettilinee offre risultati scadenti perché le
giunzioni sono evidenti e permettono infiltrazioni d’acqua se non ben sigillati.
Il modo c) è di gran lunga il più indicato per le realtà urbane.
Offre il vantaggio della velocità di posa, permette l’impiego di mezzi di piccola
dimensione e si adatta anche alle strade strette e con curvature. Le pareti possono
combaciare perfettamente e il getto di riempimento crea la continuità tra le parti. Inoltre
questo metodo consente una notevole velocità di posa e il fronte di scavo aperto è ridotto a
circa 10 -12 metri.
I vantaggi legati al modo “c” (particolarmente adatto nella situazione di Golasecca,
applicandolo più ai cunicoli che non a gallerie a maggior altezza) possono essere così
riassunti:
• facilità di posa;
• agevole ispezionabilità;
• maggiore tutela degli impianti, non più sottoposti alle sollecitazioni e ai cedimenti che
spesso si producono con la posa sottoterra;
• maggiore sicurezza durante gli interventi: gli addetti delle aziende gestori hanno una
visione immediata della posizione di tutti i servizi presenti;
• minimo impatto sul traffico: per qualsiasi intervento di posa, controllo o manutenzione
non sarà più necessario chiudere o restringere tratti di strada e marciapiedi;
• possibilità di migliore finitura delle urbanizzazioni superficiali: strade e marciapiedi
potranno essere finiti con materiali di migliore qualità dal momento che non sono più
sottoposti a frequenti manomissioni;
• gestione del tunnel attraverso l’affitto degli spazi che rimangono inutilizzati ai fornitori di
servizi (come nel caso delle connessioni a banda larga su cavi in fibra ottica).
La disponibilità dei tunnel tecnologici facilita il controllo e la manutenzione sia della
stessa struttura polifunzionale, sia delle singole reti, consentendo ai singoli gestori la
possibilità di provvedere alla sostituzione programmata di elementi obsolescenti, sulla
scorta dei piani di ammortamento ed ammodernamento delle rispettive reti.
I tunnel vengono illuminati con impianto a norma 46/90 e 626/94, mediante luci al neon;
gli interuttori verranno posti negli ingressi principali e vicino ad ogni botola di accesso.
Gli accessi principali avvengono mediante delle botole di accesso realizzate con
appositi chiusini in ghisa sferoidale classe 400, mentre è previsto all’inizio della galleria un
pag. 68
portellone principale di accesso di dimensioni di mt 1× 2 al fine di consentire l’introduzione
di eventuali tubi di ricambio di grossa lunghezza.
In tutti gli accessi viene prevista la posa di una scala fissa in alluminio completa di
corrimano, per agevolare l’accesso e per garantire l’evacuazione in caso di emergenza.
pag. 69
Ver. 16/12/2013
4.3 - MODALITÀ PER LA CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
La realizzazione delle infrastrutture e delle tecniche di scavo deve essere progettata in
base alle caratteristiche delle aree che vengono interessate.
La loro realizzazione deve rientrare nella predisposizione e negli obiettivi del Piano dei
Servizi e in relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
La scelta delle possibili infrastrutture e le tecniche di scavo dovranno essere effettuate
in base alle caratteristiche delle aree stesse, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi
di rete da alloggiare secondo le esigenze di carico urbanistico descritte per ogni area in
trasformazione.
In fase di programmazione annuale e pluriennale degli interventi sarà necessario che gli
uffici comunali convochino tutti gli Enti Pubblici portatori di interesse e i gestori delle reti in
Conferenza dei Servizi.
Sarà utile pertanto attivare un tavolo per coordinare gli interventi e le loro modalità
operative e temporali. Questo processo di pianificazione dovrà permettere di sviluppare
un’azione coordinata in grado di cogliere le possibili sinergie esistenti tra le parti
interessate, ottimizzando i lavori di infrastrutturazione e diminuendo i costi economici ed i
tempi di esecuzione.
Il cronoprogramma degli interventi nel sottosuolo comunale dovrà seguire interventi per
fasi nell’ambito della definizione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, reso attuabile
con interventi annuali.
La procedura di cronoprogramma potrà essere organizzata secondo le seguenti fasi:
a) Richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi annuale
(con esclusione di quelli di allaccio di utenze), da concordare con il programma comunale.
Tale lavoro dovrà essere coordinato dagli uffici in collaborazione delle Aziende
erogatrici.
L’Ufficio del Sottosuolo comunicherà periodicamente alle Aziende erogatrici l’elenco
degli interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, avviando un’azione di
coordinamento finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione
ottimale della rete stradale e del sottosuolo, per valutare i programmi degli interventi
previsti dal Comune, dagli Enti, dai privati e dalle Aziende erogatrici, e fissare il
programma delle opere da effettuare.
I gestori delle reti sono tenuti a trasmettere ogni anno il proprio Programma Operativo
Annuale per l’anno successivo, costituito da: una relazione generale, un programma dei
lavori, un’opportuna cartografia (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle riportanti
l’indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.
b) Convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel
sottosuolo, al fine di coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti nella fase
precedente, nonché di coordinarli con gli interventi previsti nel Programma Triennale delle
OOPP o con eventuali altri interventi previsti dal Comune.
L’Ufficio del Sottosuolo convocherà una riunione di coordinamento con i gestori per
definire il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’anno dislocati
nel territorio comunale. Tale programmazione è volta ad attuare una gestione complessiva
degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, per migliorare
l’uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi efficienti, riducendo i
disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i costi sociali e vanno coordinati
con gli interventi programmati dal Comune ed inseriti nel programma triennale degli
interventi e nel relativo aggiornamento annuale.
pag. 70
c) Predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno
annuale, il più possibile condiviso cui gli operatori dovranno attenersi nelle successive
richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.
Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione
e coordinamento tra i gestori delle reti ed il Comune) dovrà essere riferito a tutti gli
interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione delle reti
programmati e prevedibili per l’anno successivo.
Contestualmente le aziende erogatrici sono tenute a trasmettere ogni anno la
cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati
dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà
utilizzata dall’Ufficio per effettuare il coordinamento scavi.
La tempistica di inizio e di fine lavori degli interventi e le modalità di organizzazione dei
cantieri fanno parte dell’azione di pianificazione dell’Ufficio.
4.4 - VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO
In linea di massima il costo di realizzazione della galleria pluriservizi è di circa € 1000
al metro lineare, mentre per i cunicoli tecnologici si può stimare in € 2.500.
Una volta realizzati i tunnels, la spesa annua sarà quella dovuta ad eventuali
manutenzioni, ma trattandosi di condotte fissate alle pareti di un manufatto, protette, si può
ipotizzare una spesa di € 300,00 anno/km, a fronte di una spesa di € 500 anno/km per la
gestione di reti tradizionali.
Inoltre nella progettazione delle gallerie pluriservizi e dei cunicoli tecnologici, la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere trasformata dai Comuni in canone
a carico dei soggetti gestori di reti; la tassa sarà calcolata sulla base della superficie
lineare occupata.
Si può inoltre ipotizzare che, con l’evolvere dei servizi, l’Amministrazione conceda in
uso ad altri gestori di servizi il passaggio nel sottosuolo: il teleriscaldamento, la rete dei
servizi di società telefoniche o telecomunicazione.
Per l’utilizzo dell’infrastruttura l’Amministrazione può applicare, a prezzi ragionevoli, un
affitto annuo stimabile in complessivi € 2.500 km/anno.
Pertanto, sommando i risparmi nella manutenzione e le prevedibili entrate, la differenza
annuale di gestione tra i due metodi realizzativi potrà essere colmata dopo una decina di
anni per i cunicoli tecnologici ed in circa quindici anni per le gallerie pluriservizi.
.
Si consideri inoltre che, mediamente, dopo 30 anni le tubazioni realizzate con il metodo
tradizionale dovranno essere sostituite, con investimento complessivo, comprendente scavi
e reinterri. Nel caso dei tunnel tecnologici, invece, tale onere inciderebbe solo per la
fornitura e posa delle condotte.
I costi unitari per la realizzazione di trincee o polifore è inferiore a quella per i tunnels,
ma non in misura così significativa da suggerirne l’applicazione su vasta scala, perché non
consentirebbero comunque una rapida razionalizzazione dell’intero sistema, e producono
nel tempo minori economie gestionali: saranno quindi da utilizzare su singoli tronchi,
quando se ne ravvisi una specifica convenienze, od a fronte alla impossibilità operativa
nella progettazione della posa di tunnels.
pag. 71
Ver. 16/12/2013
La scelta di investire nella infrastrutturazione del sottosuolo per conseguire non solo
vantaggi funzionale ma anche risparmi economici negli anni e decenni seguenti dovrà
essere definita dall’Amministrazione con I Piani Triennali delle Opere Pubbliche.
Complessivamente, considerando che il bilancio del Piano dei Servizi cui il presente
PUGSS è allegato, individua un potenziale “attivo di bilancio per €1.900.000” nel decenio
(da Relazione del PdS), sarebbe possibile mettere in cantiere fino a circa 1 chilometro di
tunnel tecnologici o gallerie pluriservizi, oltre ad un primo campione lungo circa 1.100 metri
che dovrà essere comunque realizzato negli Ambiti di Trasformazione, a carico dei soggetti
attuatori, e che costituirà utile sperimentazione per estenderne la pratica.
pag. 72
5 - REGOLAMENTO ATTUATIVO
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE
1. Per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere rispettate tutte le norme
tecniche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme tecniche dettate dalla
scienza delle costruzioni, dalle Leggi, decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati
e vigenti alla data di esecuzione dei lavori.
2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti e
prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI di settore
e quanto previsto dal Codice della Strada (art. 66 del D.P.R. n. 495/92).
3. Di seguito vengono riportate le normative di settore maggiormente significative
attualmente in vigore:
• D.L. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada.
• Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” modificato dal Decreto
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
• DPCM 3 marzo 1999: Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti
tecnologici.
• DM 24 Novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8.
• DM 16 Novembre 1999 – Modificazione al decreto ministeriale 24 Novembre 1984
recante: “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”.
• D.M. 12 Dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni - Circolare 20
Marzo 1986 – D.M.
• 12.12.85 – Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.
• UNI 10576 – 30 Aprile 1996 – Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel
sottosuolo.
• D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni –
Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
• D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 – Attuazione della Direttiva CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili.
• D.Lgs 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
14 Agosto 1996, n. 494 recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili.
4. Per quanto non normato nel presente regolamento si fa riferimento e qui si rimanda
alle norme contenute nel Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per
la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la
mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003,
n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ
1. Il Comune disciplina l'utilizzo del sottosuolo stradale e coordina le azioni sul sistema
delle reti stradali e delle reti ed infrastrutture del sottosuolo stradale in fase di
pag. 73
Ver. 16/12/2013
pianificazione, di gestione e di intervento, inoltre applica i relativi oneri economici e fissa le
convenzioni.
- 2. Il presente regolamento, in attuazione della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999
("Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici") e della normativa
regionale sopra richiamata, persegue le seguenti finalità:
- offerta di servizi efficienti, efficaci ed economici, riducendo i disservizi delle reti e
limitando gli scavi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento e di congestione urbana.
- utilizzazione razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
- miglioramento e massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le
forme di condivisione;
- riduzione al minimo dello smantellamento delle sedi stradali, delle operazioni di scavo
(con il conseguente smaltimento del materiale di risulta), del conferimento in discarica e
del successivo ripristino della sede stradale;
- promozione di scelte progettuali e modalità di posa innovative e tali da salvaguardare
la fluidità del traffico;
- coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale;
- mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti e monitoraggio dei dati in
collaborazione con i gestori e con l’Osservatorio risorse e servizi regionale;
- realizzazione di infrastrutture sotterranee come definite dall’art. 34 comma 3 della L.R.
n. 26/03 per l’alloggiamento dei servizi a rete;
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:
- alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ed ai relativi allacciamenti;
- ai rifacimenti e/o integrazione di quelle già esistenti;
- alla realizzazione di opere significative di riqualificazione urbana (quali sotto-passi,
parcheggi sotterranei, sistemazioni stradali, ecc.).
4. Il presente regolamento ha per contenuto le disposizioni relative alla posa, nelle sedi
stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici
e dei gestori dei servizi, degli impianti sotterranei sotto elencati (nonché di eventuali reti
che nel futuro le tecnologie e la domanda sociale rendessero possibili):
- acquedotti;
- reti elettriche di distribuzione, comprese quelle destinate alla alimentazione dei servizi
stradali;
- reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi
particolari;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condutture per la distribuzione del gas;
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane.
5. Le disposizioni si applicano anche alle correlate opere superficiali di connessione.
6. Si considera suolo pubblico il sedime stradale e relativo sottosuolo appartenente al
demanio comunale ed al demanio stradale di altri Enti, il patrimonio indisponibile del
Comune ed il suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
7. Il presente regolamento non riguarda le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti
idriche, le grandi infrastrutture quali collettori primari di fognature, le condotte primarie per
il trasporto di gas e fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi
particolari di rilevanti concentrazioni di servizi in strutture appartenenti ad un'unica azienda
(centrali telefoniche, cabine elettriche ecc.).
8. Il presente regolamento non norma l’allacciamento alle utenze mediante linee aeree.
Il Comune può concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell’ambito del
proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni.
pag. 74
ART. 3 - DEFINIZIONI
Manufatto interrato (o impianto):
struttura costituita da gallerie polifunzionali o polifore (cavidotti), da installarsi, ove
possibile, sotto i marciapiedi della sede stradale, destinata a contenere le reti dei servizi
sotterranei.
Galleria pluriservizi:
passaggio percorribile destinato a contenere servizi a rete.
Cunicolo tecnologicoi:
manufatto continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e passerelle portacavi,
non praticabile all’interno, ma accessibile dall’esterno mediante la rimozione di coperture
amovibili a livello stradale.
Polifora (o cavidotto):
manufatto costituito da più tubi interrati (detti anche tubazioni o canalizzazioni) destinati
a contenere i servizi.
-
Reti dei servizi sotterranei contenute negli impianti:
reti di distribuzione dell’acqua (escluse adduttrici, alimentatrici primarie e tubazioni
aventi diametro > 200 mm);
reti di distribuzione del gas (escluse linee primarie, condotte di media pressione e
tubazioni aventi diametro > 200 mm);
reti di distribuzione dell’energia elettrica (escluse linee elettriche ad alta tensione 15
kV);
reti di telecomunicazioni;
reti elettriche per impianti semaforici e di telesorveglianza;
reti elettriche di pubblica illuminazione;
reti di teleriscaldamento (escluse adduttrici, alimentatrici primarie e tubazioni aventi
diametro del rivestimento esterno > 200 mm).
Trincea:
scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o
pertinenze di queste ultime.
Aziende Erogatrici:
soggetti che operano, sulla base di specifiche convenzioni, per la pianificazione, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in armonia con
gli indirizzi del Comune e degli interventi sulla reti stradali. Tali aziende sono le Società e
gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servizi a rete di cui al capitolo 2 punto
4.
Aziende Operatrici:
soggetti che realizzano le nuove reti e le infrastrutture nel territorio comunale dopo
regolare autorizzazione.
ART. 4 - PIANIFICAZIONE
1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e
pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento
degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi e il contenimento dei
disagi per la popolazione e per la mobilita urbana.
pag. 75
Ver. 16/12/2013
2. Non appena terminata l’esecuzione di un manufatto interrato, gli operatori autorizzati,
nuovi o già esistenti nel tratto stradale interessato, devono collocare le loro reti nella nuova
struttura realizzata.
3. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre in ogni tempo, qualora necessario
e per motivi di pubblico interesse, modifiche o nuove condizioni, ivi compreso lo
spostamento degli impianti esistenti regolarmente autorizzati.
ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
1. L’azione di programmazione è svolta dall’Ufficio per il sottosuolo, eventualmente
supportato da specialisti interni ed esterni, in collaborazione con le Aziende Erogatrici e
degli altri uffici comunali.
2. La procedura di cronoprogrammazione è organizzata secondo le seguenti fasi:
a) richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (con
esclusione di quelli di mero allaccio di utenze e comunque non prevedibili o non
programmabili), quanto meno annuale, che tenga conto di quanto comunicato dal
Comune;
b) convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel
sottosuolo, al fine di coordinare i programmi esposti dai diversi operatori ed enti
nella fase precedente, nonché di coordinarli con gli interventi previsti nel
programma triennale delle opere pubbliche o con eventuali altri interventi previsti
dal Comune;
c) predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno
annuale, il più possibile condiviso cui gli operatori dovranno attenersi nelle
successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.
3. Gli interventi programmati devono essere inseriti nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale. Il programma sarà approvato dagli
Organi Amministrativi Comunali.
4. L’Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale
dell’area stradale, del sottosuolo e delle relative infrastrutture, collabora con gli uffici
pubblici interessati e con le Aziende, e comunica tempestivamente alle Aziende gli
interventi urbanistici previsti dal P.G.T. e dai Piani Attuativi.
5. L’Ufficio, dopo l’esame diretto e congiunto dei programmi presentati dalle Aziende, si
riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Erogatrici ed
Operatrici per conseguire un’azione organica negli interventi e nella fase di cantiere.
6. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione viene concordata tra il Comune e le
Aziende, in sede di programmazione, in relazione alle aree interessate, alle dimensioni e
alla potenzialità degli impianti ed al numero dei servizi offerti.
7. Qualora, in sede di programmazione, si dovesse verificare il caso di sovrapposizione,
nello stesso tratto di strada, di interventi da parte di più Aziende, le stesse Aziende
dovranno accordarsi per eseguire idoneo manufatto multiservizi.
ART. 6 - CARTOGRAFIA E COMPLETAMENTO DELLA RICOGNIZIONE
1. L’Ufficio per il sottosuolo del Comune, eventualmente supportato da specialisti interni
e/o esterni, ha il compito di predisporre la mappatura georeferenziata degli strati informativi
relativi al sistema stradale, ai servizi a rete e alle infrastrutture sotterranee secondo le
procedure di gestione del SIT in atto nel Comune e sulla base delle cartografie fornite dalle
Aziende Erogatrici, nonché di garantire costantemente l'integrazione e l'aggiornamento dei
dati. A tale scopo le Aziende Erogatrici devono mantenere costantemente aggiornati i dati
cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dall’Ufficio per
il sottosuolo del Comune e devono renderli sempre disponibili al suddetto Ufficio senza
alcun onere per lo stesso.
pag. 76
2. I dati cartografici di cui sopra devono comprendere anche le infrastrutture non
normate dal presente regolamento (ad esempio le linee aeree ad alta tensione, qualora
venissero interrate).
3. La cartografia relativa ai sistemi esistenti e previsti, in conformità alla L.R. 12/05
nonché al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", deve
rispondere agli standard regionali sulla creazione delle banche dati informatizzate
(Sviluppo del SIT integrato. Criteri attuativi dell'art. 3 della L.R. 12/2005).
4. Il sistema informativo, in conformità a quanto stabilito nella D.G.R. 21.11.2007, n.
5900 e applicando le direttive contenute ne “Linee guida per la costruzione del Sistema
Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)1, deve fornire i seguenti servizi:
- la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture
sotterranee con annesse caratteristiche, secondo il disposto dell’art. 15 comma 5
(direttiva 3/3/99) e art. 35 comma 1 punto c) della L.R. n. 26/03 e l’art. 11 comma 1 del
Regolamento regionale n. 6 (15.02.2010); 1 pubblicato nel BURL n. 5, edizione speciale
del 31.1.2008
- una mappa dei "lavori in corso", completa del tipo di lavoro, le caratteristiche tecniche
dello stesso, i responsabili, la durata delle attività e gli eventuali ritardi;
- un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.
5. L'Ufficio, in accordo con le Aziende Erogatrici, deve dare avvio ad un programma di
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali esistenti nel
sottosuolo. Il programma di monitoraggio si riferisce a tutte quelle attività di controllo,
operative e amministrative, che vengono condotte dall’Ufficio del Sottosuolo, sia sul ciclo di
vita del singolo intervento, sia sulla corretta applicazione del Piano. L’attività di
monitoraggio di un intervento si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la restituzione dei
dati relativi all'intervento svolto.
6. Il programma di monitoraggio deve comprendere le strutture, gli accessi, lo stato
delle opere murarie, i servizi esistenti e il loro stato d'uso. I risultati delle indagini vanno
inviati all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia.
7. Alla conclusione di un intervento, le Aziende Erogatrici, nello scambio delle
informazioni sull’occupazione del suolo, devono precisare per ciascun tipo di impianto,
l’ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di
riferimento degli edifici o altri punti singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le
seguenti caratteristiche principali:
- gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale,
dimensione;
- elettricità: tensione nominale, materiale, protezioni;
- telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del
materiale e dimensione.
8. Inoltre dovranno indicare le future modalità di gestione dell'impianto realizzato.
ART. 7 - MONITORAGGIO
1. Monitoraggio preventivo (per i soli interventi relativi alle fognature):
I nuovi allacciamenti alle fognature possono avvenire solo nei pozzetti esistenti , oppure
in pozzetti appositamente inseriti nella rete. E’ onere dei soggetti interessati (enti gestori
oppure privati richiedenti) un accurato monitoraggio tramite video-camere mobili per i tratti
di rete fognaria presistenti a monte ed a valle dell’intervento, fino a 50 metri in pogni
direzione. Per le aree di trasformazione e gli interventi soggetti a piani Atrtuativi tale onere
riguarderà le condotte fognaire interne o prospicienti all’area di intervento, nonché i tratti a
monte ed a valle, per una estensione di 100 metri in ogni direzione.
2. Monitoraggio in corso d’opera:
pag. 77
Ver. 16/12/2013
Gli Enti gestori devono programmare ogni intervento con un crono-programma che
evidenzi le fasi di lavorazione ed i tempi previsti. Ogni qualvolta un intervento entra in una
nuova fase, questa deve essere evidenziata da chi esegue l’intervento all’interno della
scheda informativa che descrive l’intervento, secondo il modelo predisposto dall’Ufficio del
Sottosuolo. Durante la fase esecutiva dovranno essere allegati alla scheda tutti i documenti
necessari a descrivere l’avanzamento dei lavori. In tal modo l’ufficio del Sottosuolo avrà
sempre evidenza di quale sia la situazione e potrà attuare le opportune azioni di verifica e
di controllo.
3. Monitoraggio a consuntivo dei singoli interventi:
Alla conclusione di un intervento, l’esecutore sarà tenuto a fornire l’aggiornamento dei
dati relativi alle reti coinvolte nell’intervento, nonché tutti i dati a consuntivo dell’intervento
stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la disposizione finale
delle linee interrate. Più precisamente, ogni ente, a conclusione di un proprio intervento,
dovrà garantire:
l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e
condiviso previsto nel Regolamento Regionale 06 all. n. 2;
le specifiche tecniche degli impianti realizzati;
le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro
eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione delle
tubazioni interrate);
le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle
infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la loro posizione
orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali);
le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una planimetria con
indicazione dei coni di ripresa;
tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento
eseguito; tutta la documentazione necessaria a future modalità di gestione.
ART. 8 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE
1. Tutte le opere devono essere realizzate con le modalità progettuali/costruttive
contenute nel “Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano”
edito dalla Regione Lombardia 4 nel 2007 e degli articoli seguenti.
2. Per scavi di profondità superiore ai m 2 nel caso di realizzazione di nuove opere
infrastrutturali di una certa importanza (gallerie pluriservizi, cunicoli tecnologici, etc.)
specie in prossimità di aree urbanizzare, si prescrive la realizzazione di apposite indagini
geognostiche propedeutiche (pozzetti esplorativi, sondaggi geognostici, prove
penetrometriche, etc.) con lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geologico tecnico i
terreni oggetto di scavo (natura litologica, caratteristiche di addensamento, presenza di
acqua, etc.) per la progettazione delle opere di sbancamento (scelta delle metodologie e
delle tecniche più adeguate) e degli eventuali manufatti di sostegno.
3. In presenza di vincoli urbanistici od idrogeologici occorre inoltre rispettare le
specifiche prescrizioni e precauzioni, come indicate al capitolo 2.3 del Rapporto Territoriale
del presente PUGSS.
4
Il manuale, redatto in collaborazione con “Laboratorio sottosuolo” e ORS Osservatorio Regionale
Risorse e Servizi, è un supporto concreto per espletare il complesso compito di governare localmente
manutenzione, modernizzazione e innovazione dei sistemi a rete che rappresentano un elemento
fondamentale del tessuto connettivo del territorio. Esso ordina e raccoglie le informazioni e buone
prassi, nate da sperimentazioni sul campo, per gli interventi da realizzare nel sottosuolo secondo le
migliori procedure e le migliori tecnologie innovative disponibili.
pag. 78
ART. 9 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI CUNICOLI TECNOLOGICI E GALLERIE
PLURISERVIZI
1. I cunicoli tecnologicie e le gallerie polifunzionali devono possedere i requisiti previsti
dal R.R. n. 6 15.02.2010 e devono essere realizzati secondo i criteri definiti dal R.R. n. 6
15.02.2010 e dall’art. 39 della L.R. n. 26/03.
2. Le suddette infrastrutture sono considerate opera di pubblica utilità ed e assimilate,
ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.
3. La gestione delle infrastrutture e regolata da una convenzione che il Comune stipula
con le Aziende Erogatrici, sulla base delle disposizioni dell’art. 40 della L.R. 26/03.
4. Il Comune ha facoltà di trasferire a proprie spese i servizi a rete delle varie Aziende
Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune può imporre alle Aziende
Erogatrici, oltre alla tariffa per l’utilizzo dell’infrastruttura, un contributo “una tantum” nelle
spese di costruzione dei cunicoli e delle gallerie, che non può superare nell’insieme il 50%
delle spese medesime.
L’onere sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la realizzazione delle infrastrutture,
nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo sostenuto nell’interesse
generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell’Autorità per i servizi di
pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481 del 14/11/1985 art. 2 comma 12
lettera e), in misura correlata alle opere progettate e autorizzate.
ART. 10 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI POLIFORE
Per la realizzazione delle polifore è prescritto l’utilizzo di più tubazioni interrate
(cavidotto a più tubi), con apertura di trincea o in alternativa con tecniche senza scavo a
cielo aperto (microtunnelling).
I cavidotti sono posati, ove possibile, sotto il marciapiede, o comunque nelle fasce di
pertinenza stradale (banchine), in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione
stradale e permettere una più agevole distribuzione del servizio all’utenza.
Nel caso in cui, per la ridotta sezione del marciapiede o per l’alta densità delle reti
esistenti di servizi o per mancanza del marciapiede, non siano possibili altre soluzioni, i
cavidotti possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata.
I cavidotti non devono mai essere posati, nel loro andamento longitudinale, al di sopra
di altri servizi interrati.
Qualora debba essere adottata la posa sotto la carreggiata, i cavidotti devono essere
disposti per quanto possibile in prossimità del bordo della carreggiata stessa, o, nel caso di
presenza del marciapiede, in prossimità del cordolo delimitante lo stesso.
Gli attraversamenti stradali di vie con alta densità di traffico e la posa di impianti in zone
con pavimentazioni di particolare pregio (piazze, vie nei borghi storici, ecc.) sono di norma
da eseguire con la tecnica di microtunnelling.
ART. 11 - INFRASTRUTTURE AUSILIARIE
1. Pozzetti e camerette
L’impiego di pozzetti deve essere limitato al numero indispensabile. I pozzetti, cosi
come già detto per il cavidotto, sono di norma collocati su marciapiede, sono di tipo
normalizzato in calcestruzzo vibro compresso armato ad elementi modulari o monolitici.
Le dimensioni interne e le distanze tra pozzetti (passi) devono essere tali da consentire
agevolmente l’infilaggio, la giunzione, il cambio di direzione e la derivazione dei servizi a
rete. Tutti i manufatti in C.A.V. rispondono a quanto previsto dalle vigenti norme italiane, in
particolare dal D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. In casi particolari, dovuti alle ridotte
pag. 79
Ver. 16/12/2013
dimensioni
all’impiego
gettato in
all’impiego
del marciapiede od alla presenza di altri servizi interrati, in alternativa
di pozzetti di tipo normalizzato e ammessa la costruzione di camerette in c.a.
opera. Pozzetti prefabbricati, camerette e relative solette sono calcolati
in condizioni di carico stradale di 1^ categoria.
2. Chiusini
I dispositivi di chiusura dei pozzetti e delle camerette devono essere conformi alla
classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >400 kN, dotati di
semicoperchi incernierati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata. Per
l’impiego su marciapiede, per pozzetti di derivazione d’utenza (cm 40x40), sono ammessi
chiusini conformi alla classe C250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura
>250 kN.
In caso di posa in corrispondenza di sedi stradali con pavimentazioni speciali in pietra
naturale e/o prefabbricata, i chiusini devono essere del tipo “a riempimento”.
3. Sfiati
In conformità al DM 24.11.84, i manufatti interrati predisposti per contenere le reti di
distribuzione del gas sono sezionati da opportuni diaframmi e dotati di dispositivi di sfiato
verso l’esterno, posti alla distanza massima di 150 m l’uno dall’altro e protetti contro
l’intasamento.
ART. 12 - REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI PAVIMENTAZIONE SUPERFICIALE
1. Salvo le più precise indicazioni che l’Ufficio impartirà in fase di rilascio della
concessione di manomissione del suolo pubblico, per la realizzazione dello strato di
pavimentazione superficiale si procederà in via indicativa, ma non limitativa, nel seguente
modo:
- gli scavi saranno riempiti con idoneo materiale arido stabilizzato, curando di
ripristinare al meglio le caratteristiche del sottofondo, soprattutto con riferimento al
suo grado di costipamento e della sovrastruttura stradale;
- le pavimentazioni stradali e le opere complementari manomesse dagli scavi o anche
solo danneggiate dai lavori dovranno essere ricostruite a nuovo secondo le modalità e
con i materiali prescritti;
- le pavimentazioni bituminose saranno di norma costituite da due strati di conglomerato
bituminoso: toutvenant bitumato spessore cm 10-15 per la carreggiata e 8-10 per i
marciapiedi; tappeto d’usura tipo bitulite spessore cm 3 per la carreggiata e cm 2 per i
marciapiedi.
- i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, cosi come i manufatti di
arredo urbano e la segnaletica stradale eventualmente rimossi saranno ricollocati nella
loro posizione. In caso di danneggiamento saranno sostituiti a nuovo.
2. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà estendersi, oltre che alla zona
propria dello scavo, anche alle zone laterali, nella misura che il Settore Tecnico giudicherà
necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stessa, e comunque mai inferiore a
metà della carreggiata.
3. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione l’Ufficio potrà
richiedere appositi depositi cauzionali.
ART. 13 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di
garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone
con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere, anche provvisionali, dovranno
osservare tendenzialmente gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del
pag. 80
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, predisponendo adeguate transennature
e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.
ART. 14 - INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO
1. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 19 DPCM 3/3/99, entro i termini di
approvazione del PUGSS, costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici,
una struttura, denominata Ufficio per il sottosuolo, cui demandare le funzioni legate alla
pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi e
l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi secondo i modelli al punto 5
dell’allegato 1 del R.R. 06/2010.
2. Il C omune organizza il funzionamento dell'ufficio in termini di personale e di strutture
tecnico- amministrative anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici comunali e
l'apparato dei Gestori dei servizi a rete, oppure nell’ambito della razionalizzazione sovra
comunale dei servizi, già in atto, od anche mediante specifiche convenzioni tra enti
pubblici.
3. Fino alla costituzione dell’Ufficio per il Sottosuolo, le relative funzioni sono comunque
svolte dall’Ufficio Tecnico Comunale.
pag. 81
Scarica