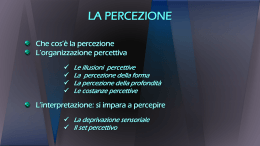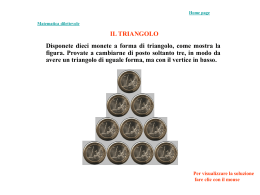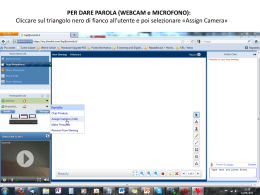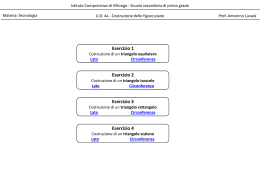leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it MEDICINA OGGI Collana diretta da Vito Cagli Luca Genoni L’UNICITÀ DEL PAZIENTE L’ettagono di Ippocrate ARMANDO EDITORE GENONI, Luca L’unicità del paziente. L’ettagono di Ippocrate ; Pres. di Ugo Fornari ; Postfaz. di André-Marie Jerumanis ; Roma : Armando, © 2014 400 p. ; 20 cm. (Medicina oggi) ISBN: 978-88-6677-722-9 1. Approccio al paziente 2. L’ettagono di Ippocrate 3. Medicina e bioetica CDD 610 © 2014 Armando Armando s.r.l. Viale Trastevere, 236 - 00153 Roma Direzione - Ufficio Stampa 06/5894525 Direzione editoriale e Redazione 06/5817245 Amministrazione - Ufficio Abbonamenti 06/5806420 Fax 06/5818564 Internet: http://www.armando.it E-Mail: [email protected] ; [email protected] 21-06-043 I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), in lingua italiana, sono riservati per tutti i Paesi. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02 809506, e-mail [email protected] Sommario Presentazione di UGO FORNARI 9 Introduzione 15 1. Il primo triangolo: un concetto dell’essere umano 1.1. Il perché di un concetto dell’essere umano 1.2. La storia già avviata 1.3. L’individuo 1.4. Il triangolo di base dell’essere umano come tale 1.4.1. Il primo lato del triangolo: l’essere umano quale soggetto 1.4.2. Il secondo lato del triangolo: l’essere umano quale essere biologico-analizzabile 1.4.3. Il terzo lato del triangolo: l’essere umano quale essere relazionale 1.4.4. I tre lati insieme: il triangolo di base come unità armonica 1.4.5. La storicità del triangolo di base 33 33 35 38 42 2. Il secondo triangolo: il tempo 2.1. Considerazioni generali 2.2. Il tempo quale contesto dell’essere umano: il tempo esterno all’uomo 2.2.1. Presente, passato e futuro e i tre aspetti dell’essere umano 2.2.2. Identità: la sincronizzazione fra i movimenti delle diverse storie 65 65 46 49 54 58 61 66 66 71 2.3. L’essere umano quale contesto del tempo: il tempo interno all’uomo 2.4. Il tempo misurabile 2.5. Promuovere l’armonia dei tempi: un atto profondamente terapeutico 73 80 84 3. Il terzo triangolo: il pensiero e l’operato del medico 3.1. Il medico che si meraviglia e accoglie 3.2. Il sapere e il fare del medico 3.3. L’immaginare e il progettare del medico 3.3.1. La definizione del problema 3.3.2. Il punto di partenza e la sua modificabilità 3.3.3. Il punto d’arrivo: il traguardo 3.4. Il sentirsi grati e il congedarsi 101 125 131 136 136 138 143 179 4. Il quarto triangolo: la libertà 4.1. La libertà dell’essere umano quale soggetto 4.2. La libertà dell’essere umano quale essere biologico-analizzabile 4.2.1. Conflitti 4.3. La libertà dell’essere umano quale essere relazionale 4.4. Promuovere l’armonia delle libertà: un atto profondamente terapeutico 185 185 5. Il quinto triangolo: la salute 5.1. La salute dell’essere umano quale soggetto 5.2. La salute dell’essere umano quale essere biologico-analizzabile 5.3. La salute dell’essere umano quale essere relazionale 5.4. Mantenere tutti i tre tipi di salute dell’essere umano: un atto medico fondamentale 211 211 6. Il sesto triangolo: i tre valori fondamentali 6.1. Il valore del bello 6.1.1. Il bello come sobrietà 6.1.2. Il bello sociale 6.1.3. Il bello spirituale 6.1.4. Riassunto 188 191 201 205 214 217 222 227 229 239 245 257 278 6.2. Il valore del vero 6.3. Il valore del bene 6.4. Armonia di bello, vero e bene 279 300 316 7. Il settimo triangolo: TU, LUI/LEI, IO – NOI 7.1. L’essere umano quale TU 7.2. L’essere umano quale LUI/LEI 7.3. L’essere umano quale IO 7.3.1. Aspetti generali 7.3.2. Il medico quale IO 7.3.3. Il paziente quale IO 7.3.4. I limiti dell’IO 325 328 337 352 353 356 374 380 Conclusione: l’ettagono 385 Postfazione di ANDRÉ-MARIE JERUMANIS 393 “Ringraziamo il dott. Genoni di aver permesso alla Clinica Luganese di sostenere questa opera che favorisce una profonda riflessione sul tema della malattia e della presa a carico della persona ammalata e sofferente”. Si ringraziano Carla e Piergiorgio Baroni per la revisione dei testi. Elaborazione grafica e layout delle illustrazioni e della copertina: www.micheldesign.ch. Presentazione UGO FORNARI1 Nella sua interessante e complessa monografia Luca Genoni cerca di ampliare la concezione dell’essere umano andando al di là di quella meramente (o prevalentemente) bio-antropologica o propria di altri modelli riduttivi e di altre visioni limitate che “tendono nel lavoro concreto a ridurre il paziente a un puro punto di applicazione”, per rispondere alla domanda: “Cosa è un essere umano?”. La domanda non è nuova, ma nuova e originale è l’impostazione che viene data allo svolgimento del tema e alla metodologia proposta. Nel suo procedere Luca Genoni prende le mosse da tre ineludibili dati. Il primo è che ogni essere umano è sempre un soggetto incondizionato. Il secondo riguarda il fatto che ogni essere umano ha un corpo; l’uomo è di conseguenza obbligatoriamente un essere biologico-analizzabile, perciò condizionato. In fine ogni essere umano nasce quale ospite di un mondo che lo accoglie e con il quale inevitabilmente interagisce fino alla sua morte; egli è perciò necessariamente un essere relazionale. Questi tre aspetti sono collegati fra loro e formano un tutt’uno che possiede un’identità vivente. L’identità richiede che domani resti qualcosa di quello che oggi c’è del singolo individuo, e la vita che qualcosa cambi. A suo avviso, “il triangolo è la figura che meglio riesce a rappresentare queste caratteristiche”, dato che può cambiare la sua forma senza modificare la misura della sua superficie e giacché “il triangolo è la forma geometrica stabile per eccellenza”. Su questa base, egli propone una sua personale concezione dell’essere umano, “formato da sette triangoli”, esaminati e discussi in sette specifici capitoli del libro. 1 Neuropsichiatra e medico legale, già professore ordinario di Psicopatologia Forense presso l’Università degli Studi di Torino. 9 Il primo triangolo funziona da triangolo di base. Il suo primo lato “rappresenta l’essere umano quale essere soggettivo che tramite il suo unico e proprio modo di percepire, sentire, interpretare, selezionare – ricordando e dimenticando – agire e fare manifesta l’identità della propria esistenza. Questa identità personale – inconfondibile rispetto al passato, unica nel presente e irripetibile nel futuro – conferisce senso al singolo”. Il secondo lato fa riferimento all’essere umano quale oggetto biologicoanalizzabile. Il terzo lato del triangolo descrive l’essere umano quale essere relazionale. “Dico essere relazionale e non semplicemente essere sociale, dato che l’essere umano oltre a interagire con le persone che lo circondano, si relaziona sempre anche con tutto l’ambiente artificiale e naturale che lo attornia”. L’essere umano si colloca poi in un contesto temporale (il secondo triangolo: il tempo) che, a sua volta, si costituisce come “fatto di un passato il cui inizio assoluto nessuno conosce, di un presente infinitamente piccolo e di un futuro la cui fine non è immaginabile. Al passato appartiene l’anamnesi del paziente, al presente la sua attuale sofferenza e la terapia in corso, al futuro il progetto terapeutico, la prognosi. Passato, presente e futuro si escludono a vicenda. Contemporaneamente sono necessariamente congiunti fra loro come collegati sono i tre aspetti dell’essere umano”. Nel collocare il paziente al centro della conoscenza e dell’intervento, l’Autore riprende il concetto di relazione paziente-medico come il punto fondamentale da cui prendere le mosse per svolgere ogni successivo ragionamento che si fondi su bilateralità, alterità, comunicazione, dialogo, comprensione e rispetto dell’Altro come persona indipendente, autonoma, responsabile. Nel rapporto tra sanitario e paziente è fondamentale il riconoscimento delle rispettive individualità, la capacità di reciproca donazione e gratificazione, la condivisione e tolleranza delle frustrazioni, delle sofferenze e dei distacchi (terzo triangolo). In ogni persona sono presenti (il quarto triangolo) tre forme di libertà di cui nessuno può fare a meno (l’essere umano come soggetto dotato di libero arbitrio, come essere biologico-analizzabile che occupando il suo posto si scontra e come essere relazionale portato agli incontri). Da parte del sanitario, promuovere l’armonia di queste tre libertà è un atto profondamente terapeutico: “Nell’attività professionale quotidiana il medico deve essere consapevole che una grande libertà biologica non è 10 sufficiente. Deve tenere sempre presente che un minimo delle altre due deve essere conservato sia dal paziente sia da lui stesso. Deve badare che le tre libertà devono essere le più ampie possibili”. Luca Genoni illumina nel quinto triangolo ciò che è l’assenza di patologia: la salute. E nel sesto i valori fondamentali del bello, del vero e del bene, soffermandosi sul piano etico sulla regola d’oro nelle due accezioni; quella negativa che dice di non fare all’altro quello che non vuoi venga fatto a te e quella positiva che postula di fare all’altro quello che desideri venga fatto a te. *** Giunti a questo punto, sospendo per un attimo la mia analisi del testo e provo a svolgere il tema affrontato da Luca Genoni sotto un punto di vista che prevede un altro tipo di lettura teorica e pratica che prende le mosse da referenti teorici diversi e utilizza un altro linguaggio, ma che giunge alle stesse conclusioni. Inizio con il rilevare come tutti i comportamenti umani si costituiscano in un contesto sociale e non solo privato2. In altre parole il comportamento umano è il risultato di un equilibrio dinamico, funzionale e transattivo fra tre modelli concettuali e operativi mutevoli nel tempo e nello spazio che si intersecano e che sono il modello di cultura, quello di personalità e quello di società. Dall’interazione tra le caratteristiche innate, il sistema di cultura e l’ambiente, attraverso processi di apprendimento e di modellamento, si sviluppa quella singola persona, in un tempo e in uno spazio dati. Ogni persona, pertanto, non è la somma delle sue parti, ma è un’identità nuova e unica, organizzata secondo leggi biologiche, psicologiche e socio-culturali irripetibili e caratteristiche del suo modo di essere nel mondo in cui è stato gettato in un dato periodo della (sua) storia. In particolare, le caratteristiche individuali (substrato neurobiologico, apprendimento emotivo-relazionale) modellano nella normalità e nella patologia le risposte della singola persona: risposte che devono essere non solo spiegate, ma soprattutto comprese secondo il modello 2 Le pagine che seguono sono tratte da Fornari U., Trattato di psichiatria forense, Utet, Torino, 2013, V edizione. 11 delle scienze umane (le scienze dello spirito = il comprendere) per le quali la persona umana non è solo un sistema biologico, ma anche un’organizzazione psicologica, sociale e culturale. Ne consegue che l’attività del clinico formato in ambito psicopatologico (e fenomenologico) si discosta nettamente dal modello delle scienze naturali (le scienze della natura = lo spiegare). In una visione integrata dell’attività sanitaria, un modello non esclude l’altro, ma riconosce e ammette la sussidiarietà e la parzialità del secondo rispetto al primo, quando, come specificato nel settimo triangolo del volume di Luca Genoni (Tu, Lui/Lei, Io-Noi), al binomio “Io-Lui/ Lei” (le scienze naturali) subentra il binomio “Io-Tu”, nella costruzione del “Noi” (la relazione). In particolare, neuroscienze, neuropsicologia e genetica molecolare, come ogni compromissione del bios devono essere valutate nell’ambito di un discorso clinico integrato che prenda in considerazione l’intera persona, nella sua storia di vita irripetibile e non riproducibile in laboratorio. Un approccio di questo tipo pone in primo piano lo studio del funzionamento globale della personalità del paziente, di volta in volta collocato nelle quattro possibili dimensioni cliniche del funzionamento mentale (normale, abnorme nevrotica o psicopatica, borderline e psicotica). Non sottovaluta, però, da un lato l’incidenza di eventuali componenti patofisiologiche specifiche funzionalmente correlate ad altre (aspetti biologici); dall’altro non sottace l’importanza delle caratteristiche culturali, sociali, ambientali, economiche, storiche e situazionali che sempre fanno da sfondo ai nostri comportamenti (cultura e società). Ecco allora che contro le discipline mediche che tendono sempre più a costituirsi come i luoghi dell’oggettivizzazione e della reificazione, ad appartenere alle scienze naturali che spiegano, misurano, oggettivano, psichiatria e psicologia diventano i luoghi della soggettivizzazione e dell’alterità, e la psicopatologia rappresenta la loro essenziale categoria conoscitiva. Essa da un lato individua e descrive i segni psicopatologici presenti, allo scopo di costruire il contenuto della diagnosi psichiatrica (psicopatologia descrittiva); dall’altro esplora cosa c’è di là del sintomo (nevrotico o psicotico); come il soggetto lo vive; quali significati gli conferisce (psicopatologia fenomenologica). Sulla comunicazione, sul dialogo e sul colloquio si fondano lo statuto epistemologico della psico12 patologia e la comprensione della sofferenza umana quale si manifesta nella relazione Io-Tu3. In questo senso, “noi siamo un colloquio”4 anche quando la comunicazione si frammenta, si disperde e si dissolve in espressioni e in manifestazioni che danno comunque sempre senso e significato alle nostre esperienze nevrotiche e psicotiche. *** Con linguaggio mutato, ma di uguale pregnanza semantica e portata terapeutica, Luca Genoni scrive che “non esiste l’IO come tale… IO e TU possono esistere unicamente quale coppia di parole. Detto diversamente, se un essere umano pronuncia la parola TU implicitamente dice anche la parola IO… Non può fare diversamente. La coppia di parole IO-TU viene enunciata con l’essere e non può essere espressa che con tutto l’essere. Nella relazione IO-TU il contatto è onnicomprensivo; non può essere parziale. L’IO vede o il TU con il proprio occhio interno… oppure il LUI/LEI… con l’occhio esterno. L’IO dell’essere umano è perciò sempre doppio, o IO-TU oppure IO-LUI/LEI… Ogni coppia IOTU o IO-LUI/LEI è sempre anche una coppia TU-IO, rispettivamente LUI/LEI-IO. Non può esistere una relazione fra due persone che in una direzione è un contatto di tipo IO-TU e nell’altra è un legame LUI/LEIIO… Ritengo che una medicina che non tenga conto dei contatti IO-TU sia una medicina esclusivamente riparativa che si muove al massimo ai livelli di una regola d’oro nella sua accezione negativa. Una medicina che fa il salto dalla formulazione negativa a quella positiva della regola d’oro deve includere per necessità incontri di tipo IO-TU. In questo contesto nella relazione IO-TU il medico riesce a trovare in uno slancio di auto-motivazione la ragione per continuare a lavorare quando non sono più visibili traguardi di risultato significativi e raggiungibili, quando non può più fare del bene”. Al di là delle figure retoriche, o, meglio, suggestive (i sette triangoli in una forma isoscele che confluiscono in un ettagono) utilizzate per esporre la propria complessa e affascinante teoria e le sue ricadute pra3 Si veda, al proposito, Di Petta G. (a cura di), Io e Tu: fenomenologia dell’incontro, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2008. 4 Borgna E., Noi siamo un colloquio, Feltrinelli, Milano 1999. 13 tiche, è presente nella monografia dell’Autore, tra l’altro ricchissima di dotte citazioni, un forte richiamo alla realtà, alla deontologia medica e all’etica. Nel riflettere sulla sua formazione di base e specialistica e nel raccontare con linguaggio innovativo e ricco di cultura filosofica e antropologica del formarsi e dello svilupparsi del suo sapere, del suo saper fare e del suo saper essere, l’Autore descrive e propone al lettore il (suo) ruolo di medico come quello di un operatore della salute (fisica e mentale) che si muove all’esterno di facili estremismi (l’esasperato naturalismo e il radicale psicologismo) e che riporta costantemente tutta la sua azione a un basilare principio che qui di seguito sintetizzo. Il paziente è, al contempo, oggetto e soggetto della conoscenza e dell’intervento sanitario: oggetto, quando lo si approccia in maniera impersonale e si retribuiscono sintomi e comportamenti attraverso interventi sostanzialmente psicofarmacologici o contenitivi; soggetto, quando lo si avvicina come persona e ci si prefigge il compito di promuovere la salute all’interno di una relazione fatta non solo di parole, ma soprattutto di empatia, di ascolto, di silenzi e di speranze. 14 Introduzione Scrivo queste pagine principalmente per una necessità interiore. Scrivere mi costa poca fatica; anzi è grande gioia. L’inerzia che devo superare è di scarsa consistenza, la spinta notevole nel voler riassumere le mie esperienze accumulate in oltre 40 anni di vita professionale trascorsi nel mondo della medicina, tempo degli studi inclusi. Si tratta di esperienze in un’attività professionale che ho sempre svolto con profonda coscienza e grande passione. Quest’ultima la auguro a chiunque svolga una qualsiasi attività; personalmente la vivo come una grande fortuna, più precisamente come una grazia ricevuta: più passano gli anni più la consapevolezza di questa grazia e la riconoscenza per essa diventano indelebili. Ho pensieri, concetti e sentimenti semplici e limpidi in merito a quanto voglio mettere su carta. Sento che ciò che sto scrivendo ha un solido fondamento fatto di esperienza quotidiana, lettura e vive discussioni e che mira a traguardi sia significativi che raggiungibili. Penso infatti che il presente libro possa delimitare un contesto di critico e fertile dialogo per medici, terapeuti, educatori, operatori sociali e tutte le altre persone in stretto e frequente contatto con esseri umani, che nelle loro attività professionali sono spinti dalla motivazione e attirati dal desiderio di favorire la fioritura di singoli individui o di comunità, ossia di promuovere processi di sintesi. Nel medesimo tempo non pretendo e nemmeno voglio, anzi proprio non desidero, che il contenuto dei capitoli che seguono abbia sapore di scientificità per dare inizio a un dibattito tipo “questa è l’unica verità e chi la pensa diversamente è nell’errore”. 15 Ogni libro che ho letto mi ha permesso di imparare qualcosa. Non ce n’è stato uno di cui conoscessi già tutto il contenuto. Alla fine di ogni libro il mio sapere si era perciò incrementato. Quasi sempre era aumentata in maggior modo la mia consapevolezza di quanto non conoscevo ancora, poiché nelle rispettive bibliografie scoprivo due o tre libri per me nuovi e non ancora letti. Scrivo queste pagine convinto che qualcosa so; questo mio sapere è come un grattare alla superficie di un blocco di granito con uno spessore che supera il metro. Sono convinto che, grazie al lavoro di scrivere, qualcosa imparerò. E sono altrettanto certo che alla fine del percorso la mia consapevolezza del “non sapere” sarà cresciuta ancora più. Dopo l’ottenimento a Zurigo del diploma di maturità iniziai a studiare elettrotecnica al Politecnico di questa città. Già in quei tempi rimasi sempre sconcertato e soffrii nell’osservare il degrado ambientale. Il professore Slovik, mio docente di biologia al ginnasio e al liceo, durante un’uscita portò la classe a visitare impianti di depurazione delle acque luride sommerse da metri di schiuma provocata dai fosfati, e spiagge sul lago di Zugo coperte di pesci morti in seguito all’inquinamento; contemporaneamente andammo a “catturare” del plancton in una idilliaca riserva naturale – usando da una barchetta a remi una retina – per osservarlo poi al microscopio: un microecosistema meraviglioso. Il professore Slovik mi aveva risvegliato allora un profondo rispetto, un vero e proprio amore per il nostro ambiente. Da tredicenne e novello allievo del ginnasio, ossia all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, cominciai a usare detersivi con parsimonia, a riciclare la carta e a rinunciare, quando c’era un’alternativa, a salire sull’autovettura privata. I miei genitori mi lasciarono fare e nel medesimo tempo mi fecero capire con un sorriso, fra l’umoristico e l’ironico, che il mio atteggiamento era un po’ esagerato. Comunque qualche anno più tardi mio padre ristrutturò nel nostro paese d’origine della Valle di Blenio una stalla situata a 1600 metri per fare vivere e comprendere a noi, sei figli, come si svolgeva una volta la vita: la baita venne resa abitabile senz’acqua corrente e senz’elettricità. Andavamo a prendere l’acqua direttamente da una vicina sorgente. Nella cascina riscaldavamo e cucinavamo con il fuoco alimentato da legna tagliata a mano senza motosega e la sera giocavamo a carte al lume di candele o vecchie lampade a petrolio. La prima parte della mia adole16 scenza si svolse in questo contesto scolastico-familiare. Il mio obiettivo professionale, da grande, divenne quasi obbligatoriamente fare qualcosa contro l’inquinamento della natura e che la lasciasse fiorire nella sua bellezza; concretamente, volli inventare l’automobile elettrica. L’anno di ingegneria al Politecnico di Zurigo mi fece conoscere la bellezza della matematica; per le altre materie invece proprio non riuscii a entusiasmarmi. Decisi allora di studiare medicina con l’intenzione di voler fare del bene alla gente. Quest’aspirazione mi era stata trasmessa dall’ambiente familiare in cui ero cresciuto, dove aiutare chi avesse bisogno e giustizia sociale erano parte integrante della vita quotidiana. Ricordo che mio padre, ingegnere civile e direttore di una fabbrica con una settantina di operai, aveva rifiutato la possibilità di aderire a una cassa di previdenza sociale perché l’offerta era stata limitata alla direzione. Unicamente se anche i “suoi” – non nel senso di possesso, bensì di essere delle persone a lui care – operai avessero potuto usufruire dell’uguale diritto avrebbe accettato. In occasione delle Feste Natalizie del 1971, pochi mesi dopo l’inizio dei miei studi di medicina all’Università di Zurigo, ricevetti dai miei genitori un libro sulla storia della medicina1 con la dedica “… I bambini del Bengala a Luca nel Natale 1971…”. Mia madre si era rivolta a suo fratello medico, Alberto Pedrazzini, chiedendogli cosa avrebbe potuto regalare a uno studente principiante di medicina. Mio zio, che sette anni più tardi divenne il mio primo primario, le suggerì questo volume, la cui prima edizione risale al 1920 e la quinta al 1965. Il manuale di oltre 300 pagine mi seguì in tutti gli innumerevoli traslochi fatti da studente, giovane medico-assistente e medico con formazione specialistica terminata come un soprammobile facente parte del mio inventario personale. Tante volte lo guardai con attenzione, in diverse occasioni lo presi in mano sfogliandolo con l’intenzione di iniziare a leggerlo. Mai lo lessi. Qualcosa non si stancò di ripetermi che era ancora troppo presto. Quando all’inizio del 2010 germogliò in me l’idea di scrivere il presente lavoro sentii che prima avrei dovuto leggere la storia della medicina. Durante 1 Meyer-Steineg T., Sudhoff K., Illustrierte Geschichte der Medizin, Gustav Fischer, Stuttgart, 1965. 17 la lettura capii finalmente una frase che mio zio mi disse il 1 ottobre 1978, il primo giorno di lavoro quale medico assistente: “Luca, fatti le tue esperienze; stasera sei di picchetto”. Era vero che avendo superato l’esame finale di medicina con la miglior nota in 17 su 18 materie ero ben preparato; era altrettanto vero che sull’esperienza pratica risultavo quasi vergine. Possedevo ottime nozioni della scienza allo stato teorico di allora; non avevo avuto che marginalmente l’opportunità di fare conoscenza del paziente, quale essere umano con la sua storia personale, i suoi principi, le sue speranze e perciò i suoi modi unici di percepire, interpretare e tentare di modificare la realtà e con ciò che lo circondava: il suo contesto sociale e culturale e il suo ambiente naturale. Tanto meno avevo avuto la possibilità di incontrare pazienti nella loro dimensione di essere essi stessi fiducia, amore e speranza. Infatti lo studio di medicina fu principalmente un insegnamento fortemente scientifico e ben poco umanistico. Divenne per me, principalmente, un assimilare passivamente il più possibile di ciò che veniva trasmesso a noi studenti. Più che una mente pensante in modo autonomo e innovativo, mi ci volle una grande capacità di rimanere seduto alla scrivania per imparare a memoria un’enormità di nozioni. Non nego che con il passare del tempo insorse anche un certo piacere per la capacità di collegare singoli dettagli appresi in diverse materie fra di loro: una specie di giocare con la scienza, capacità che andava indubbiamente anche a favore dei malati. Questo ludico muoversi nel “sapere quasi tutto” che ricorda la massima di Goethe: “Arbeite nur, die Freude kommt von selbst”, tradotto in italiano: “Lavora, e il piacere arriva da solo”, non attingeva le sue energie da quel tipo di spirito che mi aveva spinto a voler inventare l’automobile elettrica, rispettivamente a fare del bene alla gente. Fu piuttosto espressione di un atteggiamento difensivo di sapere il più possibile, per fare il meno possibile errori. Fu un amore astratto per la scienza medica come tale, nato da tantissime ore di ininterrotto studio. Il voler fare il bene della gente divenne quasi un traguardo secondario rispetto a quello di non commettere sbagli e di esibire ludicamente il mio sapere accumulato. La paura dominava sull’amore, l’arroganza sull’umiltà, la malattia sulla persona sofferente. Una delle poche eccezioni nell’istruzione quasi esclusivamente biologica-scientifica dello studio di medicina fu un corso incentrato sul 18 tema del colloquio medico. Il docente raccomandò a noi studenti di leggere il libro Haben und Sein, in italiano Avere e Essere di Balthasar Staehelin2. Fu il mio primo libro di psichiatria letto al di fuori di quelli necessari per passare gli esami. Lo rilessi trentacinque anni più tardi trovando fra le mie annotazione scritte a mano la seguente, datata 7 ottobre 1975, perciò situata nel tempo all’inizio della seconda metà degli studi di medicina: “Mi accorgo come questo studio universitario mi ha allontanato progressivamente dalla motivazione iniziale di studiare medicina, ossia di fare del bene alla gente e alla società in generale. Spero che un giorno le cose cambieranno”. Lo psichiatra e psicanalista Balthasar Staehelin scrive della necessità, nella medicina, di affiancare all’indelebile realtà del condizionato, ossia di quanto in qualche modo è misurabile, quella altrettanto reale dell’incondizionato, che nei colloqui medici emerge nel fatto che ogni paziente è sempre anche fiducia, amore e speranza, malgrado che particolari condizioni della vita passata e presente possano camuffare queste sue peculiarità. Esse le possono anche per lungo tempo nascondere, non le possono mai distruggere. L’inizio della mia prima attività di medico da mio zio era stato preceduto da due episodi per me importanti vissuti durante lo stage obbligatorio che occupava, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quasi interamente il penultimo anno dello studio di medicina delle università svizzere. La prima parte dello stage la feci in un ospedale della Svizzera Tedesca. Parte dell’ospedale era situata in un vecchio convento dotato di un bellissimo cortile interno. La ristrutturazione del patio con una solida pavimentazione in pietra naturale e un pozzo d’acqua centrale si trovava in quel periodo nelle sue ultime fasi. Da una finestra del terzo piano che dava su questo armonioso spazio interno osservai insieme al medico del reparto gli artigiani che completavano le ultime rifiniture. Quasi contemporaneamente ci passò per la testa un pensiero con un fondo un po’ sconsolante, che ci confidammo reciprocamente: “Quello che loro fanno rimane, quello che facciamo noi in poco tempo non si vede più”. Aggiunsi: “Il loro rimane un po’ di più”. 2 Staehelin B., Haben und Sein, Editio Academica, Zurigo, 1969. 19 Allora iniziai una lunga ricerca su ciò che durante la mia attività professionale potesse sottrarsi al proprio sgretolamento; sento che dopo circa 35 anni l’ho trovato. Esso è reperibile nel contenuto di questo libro. La seconda parte la trascorsi in un ospedale a Ifakara, allora una piccola città della Tanzania situata a circa 400 km dalla capitale Dar es Salaam, lungo la linea ferroviaria che collega la capitale della Tanzania a Lusaka, il capoluogo dello Zambia. Durante uno dei primi giorni visitai nell’ambulatorio una donna sulla trentina sofferente di polmonite; mi ricordo che fu una polmonite del lobo superiore sinistro. Dall’anamnesi risultarono sei gravidanze portate a termine senza complicazioni con la nascita di sei bimbi, tutti sani. Alle mie domande sull’attuale stato di salute e sulla situazione dei sei figli mi rispose che tre erano morti. Non abituato e impreparato a tali situazioni e rimasto in qualche modo personalmente sconvolto mostrai alla donna il mio dispiacere, sotto forma di esternazione delle condoglianze. Immediata la reazione della paziente: “Ti rendi conto che stupidità stai dicendo?” Il mio comportamento fu vissuto da lei come totalmente inadeguato. Con il passare delle settimane capii il perché; allora in quella regione più o meno la metà dei bambini morivano prima di raggiungere i cinque anni. Per una donna perdere la metà dei bambini era indubbiamente un dolore, non invece un evento eccezionale, come per me. Mi resi conto che non esistono problemi di una grandezza che per tutti è identica, ossia di una dimensione omologabile e standardizzabile secondo una scala “scientifica”. Una specifica situazione può rappresentare per un individuo un dispiacere o una gioia grande, per un altro essere invece di scarsa rilevanza. Malgrado queste due esperienze molto umane e poco scientifiche, il mio bagaglio per affrontare il “battesimo” del mio primo giorno quale medico assistente, a mo’ di immersione totale, avvenne, viste le mie note brillanti, in una rassicurante consapevolezza di sapere molto, “quasi tutto”. Fui dominato dalla mentalità dello studio universitario con ampia componente difensiva, dettata da un’ansia di fondo e priva della speranza di costruire l’auto elettrica e di voler fare del bene alla gente e alla società. L’obiettivo principale di tale mentalità, quello di ridurre a un minimo gli errori, fu importantissimo e indispensabile. Nel medesimo tempo fu insufficiente per lasciare tracce indelebili del mio operato e soprattutto per dialogare con l’unicità di ogni singolo paziente sulle proprie questioni esistenziali. L’importanza di non commettere sbagli 20 l’avevo comunque toccata direttamente nel lavoro della mia tesi per l’ottenimento del dottorato, nel cui ambito avevo esaminato 44 casi di intossicazioni iatrogene letali che erano stati accertati all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Zurigo. I risultati terapeutici organici e perciò riparativi durante il periodo passato da mio zio furono buoni, in certi casi anche eccellenti. Ricordo in modo particolare la rianimazione e le susseguenti cure di una donna rimasta oltre venti minuti sott’acqua, che portarono a una guarigione praticamente totale. Il “caso” venne presentato a un convegno annuale di medicina intensiva e pubblicato3. In precedenza avevo scritto con l’aiuto di mio zio altri 2-3 articoli. Malgrado questi aspetti positivi non riuscii a trovare quello slancio propositivo che mi aveva spinto a studiare prima elettrotecnica e poi medicina. Rimasi in bilico fra quanto scrisse Blaise Pascal, ossia che “Quando saremo afflitti, la scienza della realtà fuori di noi non ci consolerà dell’ignoranza morale, ma la scienza morale ci consolerà sempre dell’ignoranza delle scienze oggettive”4 e i dati delle “scienze oggettive” della medicina che indicano che in Germania ancora nel 1892 la difterite aveva ucciso 50.000 bambini e che i decessi erano drasticamente calati in pochi anni dopo l’introduzione della vaccinazione5. Mio zio fu un medico abituato a frequentare e curare anche persone di alto livello sociale. Verso la fine del tempo passato nel suo reparto mi fece una confidenza ricca di un prezioso consiglio: “Le cose più interessanti della vita le ho sentite e imparate dai pazienti dei reparti comuni”. Dopo circa due anni di attività quale medico assistente in reparti di medicina interna venni chiamato a prestare servizio militare per quattro mesi quale medico di una scuola reclute in una caserma militare. I problemi di natura fisica, vista l’età dei futuri soldati di 20 anni, furono di minima entità. Diverso il discorso per le reazioni psicologiche dei 3 Genoni L., Domenighetti G., Beinahe-Ertrinken beim Erwachsenen: günstiger Verlauf nach 20minütiger Submersionszeit, Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 1982. 4 Pascal B., Pensieri, Garzanti, Milano, 2007, p. 9. 5 Meyer-Steineg T., Sudhoff K., Illustrierte Geschichte der Medizin, Gustav Fischer, Stuttgart, 1965, p. 339. 21 giovani all’impatto con una situazione per tutti nuova e nel medesimo tempo identica. Gli uni furono contenti e curiosi di vivere un’esperienza al di fuori della routine giornaliera e di fare nuove conoscenze, gli altri reagirono con disturbi psichici, contrassegnati da una grande varietà di problemi e sintomi, in parte presenti singolarmente, in parte in variabile combinazione fra di loro. La sofferenza poteva essere di leggera entità con possibilità di superamento, oppure assumere una portata che non lasciò altra scelta che fare ritornare i giovani a domicilio da dove quasi tutti erano partiti in un buono stato di salute psicologica. Essa si manifestava con: malinconia da casa; preoccupazioni di perdere l’amica a causa della lontananza, il posto di lavoro per la prolungata assenza o il proprio stato di preparazione fisica-sportiva per l’impossibilità di allenarsi, con conseguenti prestazioni competitive insufficienti; timore che la propria omosessualità non ancora apertamente dichiarata potesse essere scoperta; paura di farsi male durante le esercitazioni militari e di subire un danno che potesse compromettere future attività professionali, sportive, artistiche o di altro tipo; sofferenza ansiosa, incluse le varie forme di fobie, insonnia, disturbi alimentari, scompensi depressivi, comportamenti di fuga o di tipo aggressivo, eccessivo consumo di bevande alcoliche, ecc. Al decimo giorno l’impossibile divenne possibile, capitò l’impensabile: l’atto suicidale purtroppo riuscito di un giovane compiuto in presenza di una mezza dozzina di compagni. L’arco della gravità “oggettiva” dei disturbi manifestati dai giovani militi era simile a quello osservato al pronto soccorso e nelle corsie del reparto di medicina interna dell’ospedale: dalla transitoria insonnia paragonabile a un intercorrente infetto alla drammaticità del suicidio equiparabile alla morte per overdose del consumatore di eroina o per emorragia cerebrale della giovane apprendista. La differenza consisteva nel vissuto privato di un’identica situazione e nella varietà di possibilità e di modi concreti di reagire. Questa molteplicità era sicuramente presente anche nei pazienti curati in medicina interna, nel vissuto e nella reazione del singolo alla notizia di doversi sottoporre a un intervento chirurgico oppure di essere affetto da un “brutto male”. L’operato del medico nell’ospedale era però dominato dalla notizia oggettiva data al paziente e dai susseguenti passi consigliatigli per affrontare il problema fisico; la malattia aveva priorità 22 sul paziente, l’omologabile sul privato. Quasi diametralmente opposta la situazione con le reclute sofferenti: era il giovane milite ad avere la precedenza sul disturbo ansioso, depressivo o di altro tipo diagnosticato. Mi ritornò in mente la donna africana che aveva perso tre dei suoi sei figli. In una situazione di massima standardizzazione, come quella rappresentata da una scuola militare, affiorava in modo prepotente l’aspetto privato del singolo. Le mie conoscenze medico-scientifiche, che per la mia posizione di medico assistente allora erano assai buone, mi permisero d’una parte di contenere l’ansia di fare errori e dall’altra di ricevere lodi e complimenti: un sentirmi sicuro, sicuro nella fortezza del sapere scientifico. L’esperienza con i giovani militi mi costrinse nel vero senso della parola a dare seguito al consiglio di mio zio, quello di “farmi le mie esperienze”; contemporaneamente riaccese una mia dinamica e speranzosa vena inventiva, un desiderio simile a quello di voler costruire l’auto elettrica e ridimensionò la statica sicurezza datami dalla conoscenza del contenuto dei libri di medicina. Alla fine dei quattro mesi passati quale medico militare decisi di cambiare i miei progetti disdicendo un posto di medico assistente in una clinica reumatologica universitaria francese e di cominciare una formazione in psichiatria. La avviai in un reparto per pazienti lungodegenti di una clinica psichiatrica. L’impronta terapeutica in questo ambiente fu principalmente di tipo organico-farmacologico e socioergoterapeutico. Vi rimasi per oltre due anni. Quattro furono gli episodi che ricordo con particolare lucidità: – Un consiglio datomi dal capo-clinica nei primi giorni: “Ascolta quello che ti dicono gli infermieri che conoscono questi pazienti da anni”. Capii l’importanza di conoscere la storia dei pazienti e le abitudini al di fuori dell’attuale stato di salute e dei semplici dati anamnestici concernenti le malattie sofferte nel passato. – Al ritorno da un intervento di recupero tramite elicottero di un paziente allontanatosi senza consenso medico dal nosocomio e rifugiatosi in una stalla in alta montagna, dove era rimasto bloc23 cato da impreviste abbondanti nevicate il primario mi disse le seguenti parole: “Bravo Luca, ottimo intervento; ricordati comunque che la psichiatria è anche pericolosa”. Capii solo più tardi cosa intendesse l’anziano e saggio primario. L’intervento stesso fu contrassegnato da una circostanza importante: il paziente non fece nessuna resistenza al nostro arrivo, né partecipò attivamente al suo trasporto dalla stalla all’elicottero. Assolutamente muto, dovette essere spostato come un peso morto. Comunque il nostro atteggiamento, ossia quello dell’agente di Polizia, dell’aiutante di volo e il mio, fu di assoluto rispetto. Al momento che il paziente fu accomodato su un sedile del velivolo l’agente di Polizia mi guardò con un’espressione come se volesse chiedermi: “Cosa faccio ora”? Intesi che si trattava di ammanettare o meno il paziente. A malincuore ma senza dubbio dissi di sì, comunicando la mia decisione al paziente stesso. Presi questa decisione fortemente invasiva, malgrado che il paziente non mi paresse per nulla violento; fui preoccupato dalla sua scarsa prevedibilità. Un suo improvviso stato di agitazione avrebbe messo in pericolo tutti quanti. Una volta atterrati gli feci subito togliere le manette. In quel momento il paziente mi sussurrò in un orecchio: “Grazie”; ricevetti l’assoluzione che il mio duro intervento (di ammanettare una persona che non aveva avuto un minimo di manifestazione aggressiva) fu comunque, nella specifica situazione, proporzionato. – Un giorno venni chiamato dagli infermieri per ordinare una somministrazione intramuscolare di una terapia che il paziente per bocca non voleva prendere. In sé il paziente non fu particolarmente agitato e sicuramente – almeno con il senno di poi – si sarebbe potuto e dovuto aspettare. Infatti ebbi un’intuizione; non la ascoltai e diedi retta agli infermieri. Ne scaturì una scena al limite della violenza terminata con l’iniezione intramuscolare. Mesi più tardi mi fermai a parlare del più e del meno con due infermieri in una piccola cucina situata accanto all’infermeria di reparto. Il paziente entrò calmo nel locale e chiacchierò con noi tre, camminando tranquillamente avanti e indietro, senza mai sedersi. Passando dietro la mia sedia improvvisamente mi prese per il collo e mi fece cadere supino per terra. Rimase un attimo sopra di me per poi mollarmi. Capii al volo che era un regolamento di conti e gli 24 dissi: “Ora siamo pari”. Non ebbi più nessun dubbio che il mio atteggiamento, in occasione della somministrazione intramuscolare, pur tenendo conto dell’insistente richiesta degli infermieri (che avrei potuto rifiutare) era stato veramente sproporzionato. Ricevetti la giusta punizione. – Dopo circa un anno e mezzo di attività all’ospedale psichiatrico organizzai, con il consenso del primario e la collaborazione di due infermieri, un’uscita di tre giorni con dodici pazienti che da decenni non avevano più dormito al di fuori del nosocomio. Grazie alla mia precedente attività di medico militare riuscii a ottenere per le due notti l’infermeria della caserma, dove due anni prima avevo lavorato per quattro mesi quale medico di una scuola reclute. Consumavamo la prima colazione e la cena all’interno della struttura militare. Il resto della giornata era dedicato a passeggiate nelle località turistiche del Lago Maggiore, Locarno, Ascona e dintorni. Il comportamento dei pazienti fu adeguato e non ci fu nessun problema, a parte un paziente che entrò nel locale dove si svolgeva una riunione dello Stato Maggiore Generale per chiedere al relatore una sigaretta… Al ritorno in ospedale, due pazienti, appena scesi dagli autoveicoli, urinarono sul parcheggio del nosocomio. L’attività medica nell’ospedale psichiatrico fu inizialmente interessante e affascinante: un vero e proprio tuffo in un mare pieno di fortissime emozioni. Imparai presto a usare con più che discreto successo gli psicofarmaci, riuscii a partecipare con una certa facilità alle diverse attività socioergoterapeutiche e acquistai conoscenze nel gestire i contatti con i vari enti assicurativi e assistenziali. Passata l’euforia del nuovo riemerse la mancanza di un esplicito concetto professionale operativo, di un approccio teorico che mi avrebbe permesso di “costruire l’automobile elettrica in medicina, in modo particolare in psichiatria”, insomma un orientamento che avrei potuto “sposare”. L’approccio biologico-medicamentoso da solo fu di nuovo troppo tecnico-scientifico e perciò difensivo; stesso discorso sia per quello comportamentale di tipo biofeedback che per quello socioergoterapeutico; mi sembrarono tutti delle singole cornici ermeticamente chiuse verso l’esterno e dove la comunicazione poteva avvenire unicamente 25 all’interno della singola cornice. Ebbi l’impressione di essere caduto dalla padella nella brace: avevo perso in buona parte la sicurezza che la medicina scientifico-teorica mi aveva garantito e contemporaneamente mi trovai di nuovo incatenato da concetti vissuti da me come statici, riduttivi e simili a ciò che ha il nome scientifico con la differenza di una assai minore precisione. Grazie alla psicoterapia sistemica ebbi nuove speranza di poter lavorare nel campo della psichiatria in un modo professionale offensivo, ossia rivolto al compimento, alla fioritura di chi mi affidava la propria salute e non esclusivamente difensivo-riparativo nel senso di un puro contenimento dei singoli disturbi e sintomi. Feci una formazione dallo psichiatra Gottlieb Guntern. Per la prima volta in circa dieci anni di studio e di lavoro passati nel mondo della medicina sentii parlare di comunicazione, di aspetti che trascendono il singolo paziente come individuo e del fatto che è il sistema superiore a dare il senso a quello inferiore, tipo: il fegato dà senso alla singola cellula epatica, il sistema digestivo nella sua totalità al fegato e l’organismo nel suo insieme al sistema digestivo. Si discusse di estetica, di etica, di relazioni la cui somma è zero, di equilibri dinamici, ossia di situazioni mobili che passano senza interruzioni o comunque senza grossi scossoni da un equilibrio a un altro, di ecosistema e via dicendo. Furono descritti due metodi di arrivare alla conoscenza delle cose6. Il primo fa capo al pensiero “analitico - dualistico”, che descrive il mondo scomponendolo in più parti; spiega il mondo riducendo, perciò pensiero analitico - dualistico - riduttivo, tutto a un unico elemento. Questo metodo cerca la causa prima della malattia, analizzando un dettaglio, dividendolo in due per scartare ciò che è di scarso interesse e proseguendo questo meccanismo di “dividi e scarti” all’infinito per arrivare all’elemento più piccolo possibile, una specie di atomo o di archè con il quale si pretende poi di spiegare e curare la malattia. La terapia parte dal basso e sale verso l’alto. Opposto al pensiero analitico - dualistico - riduttivo venne teorizzato quello olistico, che descrive il mondo delineando un quadro globale: enfatizza la conoscenza degli insiemi, in modo partico6 71. 26 Guntern G., Therapodos ovvero la via del terapeuta, Hoepli, Milano, 1993, p. lare di quelli ai quali il paziente appartiene; la modulazione da parte del terapeuta di un rispettivo gruppo porta alla guarigione del paziente, che ha perso l’etichetta di paziente come tale, diventando il paziente “designato”, quello che porta i sintomi di un gruppo malato, per esempio la famiglia, sui cui appunto bisogna agire. La terapia della visione olistica parte dall’alto e scende verso il basso. Il pensiero sistemico combina le due modalità. Il mio entusiasmo iniziale venne parzialmente ridimensionato, quando mi accorsi che sia il metodo che tende alla conoscenza “dell’atomo” – in greco l’indivisibile – sia quello olistico – in greco del tutto – perciò in qualche modo dell’universo, sia la combinazione dei due nel pensiero sistemico tengono solo parzialmente conto del malato come persona inconfondibile, unica e irripetibile: tutte le tre forme scotomizzavano l’unicità della donna africana, rispettivamente dei giovani militi. Di conseguenza il pensiero sistemico, una combinazione dei due pensieri, non portò per me qualcosa di fondamentalmente diverso dalla somma dei due concetti. La relazione del terapeuta rimase sempre principalmente quella con “oggetti”, indipendentemente se si trattasse della malattia, del gruppo con le sue relazioni o di ambedue insieme. Il soggetto, quello che non è l’IO e nemmeno il LUI o la LEI, bensì il TU, quello di cui Martin Buber tramite la frase “Io dico io dicendo tu” afferma che dà identità al singolo io7 non fu che marginalmente presente, rispettivamente preso in considerazione. (Nel presente libro i pronomi personali soggetto al singolare vengono scritti quando non riferiti a una determinata persona con caratteri maiuscoli in vista di quanto verrà discusso nell’ultimo capitolo). Questo fu in grandi linee il mio bagaglio con il quale nel 1985 ottenni il titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia, bagaglio arricchito da un lavoro su me stesso svolto sull’arco di quattro anni da una collega e da esperienze nel campo peritale. Quest’ultima attività mi dimostrò indirettamente l’ineluttabilità della parte soggettiva del peritando – perciò di ogni paziente e in senso lato di ogni essere umano. Compresi che una o più diagnosi psichiatriche non furono mai in grado di descrivere una persona nella sua totalità. Di conseguenza mi fu chiaro che il margine di 7 Buber M., Ich und Du, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2009, p. 3. 27 valutazione non omologabile da parte del perito nel rispondere a quesiti di tipo abilità lavorativa, idoneità alla guida di autovetture, capacità di intendere e volere, pericolosità, ecc. ebbe una dimensione non indifferente. Le rispettive opinioni furono difficilmente estranee alle convinzioni e alle caratteristiche individuali del perito e alla sua relazione specifica con il periziando, malgrado sinceri sforzi di neutralità; essa non fu mai raggiungibile in modo assoluto. Di seguito riassumo una tale situazione, che sta al posto di tante. Donna 54enne primogenita di quattro fratelli; sin dall’età di otto anni dovette accudire i suoi fratellini. Padre di professione manovale, madre affetta da malattia psichiatrica caratterizzata da comportamenti violenti, risorse finanziarie molto esigue. Prima di andare a scuola preparava la colazione per i fratellini, dopo la scuola doveva sbrigare le faccende domestiche, la sera e il fine settimana non usciva mai con le amiche. Riporto con il permesso della paziente parti di una relazione scritta dalla direzione della scuola che la paziente aveva frequentato all’attenzione dell’ispettorato scolastico: “L’alunna BA ha conseguito nello scorso anno scolastico la licenza elementare e non si è potuta iscrivere alla scuola media proprio perché deve aver cura della mamma ammalata e della famiglia. La mamma è quasi sempre degente in ospedale, così che la cura dei tre fratellini più piccoli e anche del padre resta affidata quasi esclusivamente a lei. Quello che importa rilevare è però la cura e l’amore con cui disimpegna questi difficili compiti. I suoi fratellini sono sempre puliti e vanno a scuola sempre in ordine; la sua casa è sempre ordinata ed ella non si risparmia neanche la fatica di passare ogni giorno lo straccio sul ruvido pavimento di mattoni della sua casa. I vicini di casa quando ella andava a scuola la vedevano già in piedi alle cinque del mattino e mentre i suoi dormivano lavava spesso la biancheria in una tinozza. Fa pena agli stessi vicini questa ragazza piccola, mingherlina e gracile che ha rinunziato senza rimpianti alle gioie e ai giochi della sua età per accollarsi il grave peso della famiglia che la tiene impegnata tutto il giorno. […] Ella si distingueva sempre per la cura e l’impegno che metteva nel lavoro scolastico, così che ha conseguito la licenza elementare con otto in tutte le materie e con la lode della commissione esaminatrice”. 28 Inizia a lavorare a 14 anni, si sposa a 20 anni e ha presto due figli. Con il suo stipendio paga gli studi universitari a un fratello. Per decenni fa da madre, moglie, casalinga e donna delle pulizie. Passati i cinquant’anni inizia a sentirsi stanca, ha un po’ ovunque dolori ai muscoli e alle articolazioni, dorme male e soffre di cefalea. A 54 anni non riesce più a seguire un’attività lavorativa lucrativa. Tutti gli esami organici sono nel limite della norma, a parte un certo sovrappeso. Sul piano biologico è perciò sicuramente abile al lavoro. Anche sul piano umano dopo 46 anni di lavoro? Il perito può avere un atteggiamento distaccato e prendere in considerazione principalmente gli esami somatici oppure può mettersi almeno parzialmente nei panni della donna e sentire l’esaurimento delle risorse. La fortuna di poter far parte per dodici anni di una commissione di “psichiatria di guerra e di catastrofe” mi permise di formarmi, lavorare e poi insegnare nel campo della psicotraumatologia. Essa mi confermò di nuovo dopo l’esperienza militare e quanto vissuto anni prima in Tanzania, che non esistono situazioni problematiche o gioiose come tali bensì unicamente situazioni vissute da un singolo individuo come problematiche o meno: un identico evento traumatogeno, ossia potenzialmente traumatico, può sia sfiorare solo marginalmente gli uni sia colpire in maniera profonda gli altri. Feci anche esperienza di quanto importante sia conoscere nel singolo traumatizzato – e di conseguenza per il lavoro terapeutico nel singolo paziente – sia la storia delle malattie sia quella delle risorse individuali per superare eventi difficili come un evento traumatico. Una vera e propria scoperta personale fu l’importanza del rito come soglia per ridare continuità alla vita quando un evento traumatico ha fatto sì che “l’impossibile è diventato possibile”. Di grande importanza fu la proposta fattami nella seconda metà degli anni Novanta dal mio amico Andrea, infermiere psichiatrico che conosco sin dai primi giorni della mia attività quale medico assistente in psichiatria, di frequentare insieme dei corsi di filosofia alla Facoltà di Teologia di Lugano, fondata pochi anni prima. Seguii per tre anni dei corsi, dando anche gli esami e ottenendo circa la metà dei crediti per un Bachelor. Lasciai gli studi per la nascita della terza figlia. Da una parte gli studi furono un ampliamento del modo di pensare: fino ad allora non avevo mai discusso su concetti come sostanza e forma, su cosa 29 possano essere il tempo, la salute, la libertà, la responsabilità, il lavoro ecc.. Il pensiero che mi affascinò, che mi incuriosì più di tutti fu quello in merito a ciò che è l’armonia. Dall’altra gli studi portarono a una collaborazione e amicizia con Paolo Pagani, ora professore associato alla Università Cà Foscari di Venezia. Insieme fondammo una piccola società, attribuendole il nome della mia terza figlia: Anastasia, la risorta. La società ha offerto sull’arco di una decina d’anni consulenza e coaching a impronta filosofica e medica a professionisti. Di grande insegnamento fu l’esperienza fatta nella collaborazione con sportivi professionisti di alto livello: un mondo fortemente orientato all’ottenimento di risultati immediati e quantificabili si dimostrò sensibile, molto sensibile a concetti estetici, etici e di giusti equilibri. In questo mio percorso formativo voglio aggiungere gli innumerevoli preziosi insegnamenti ricevuti liberamente dai pazienti che, nell’affidarmi la loro salute, furono e sono tuttora sempre anche miei maestri, aprendomi la porta alla loro parte privata, sempre unica, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla formazione scolastica o professionale, dal grado d’integrazione nella società, dallo stato di salute, dalla provenienza, dalle proprie convinzioni politiche, religiose o di altro tipo; fu ed è così, come mi aveva anticipato mio zio Alberto Pedrazzini, in merito ai pazienti del reparto comune. Cito quattro frasi ricevute come regalo dai pazienti in giorni qualsiasi della mia attività professionale: “Sa dottore, io so divertirmi anche con un filo d’erba”; “Dottore, questa depressione proprio ci voleva; mi – o meglio in famiglia ci – ha fatto bene”; “Dottore la cura è troppa buona; è tempo che sto bene. Ho bisogno di dare fuori di testa. Le preannuncio che sospendo le pastiglie e che mi farò ricoverare in clinica psichiatrica”; “Sa dottore, non voglio sprofondare troppo nella realtà”. L’insieme degli insegnamenti ricevuti e delle esperienze fatte – fra di loro a volte “con quasi impossibile congiunzione congiunte”, comunque mai completamente scollegate e in nessuna circostanza completamente contraddittorie fra di loro come sono gli opposti manichei – fece sbocciare e fiorire in me in questi quaranta anni un’immagine di un loro necessario denominatore comune. Tale rappresentazione voleva dare una risposta a una fondamentale domanda, che in qualche modo ogni 30 medico si pone: “Per poter svolgere nel miglior modo possibile la mia professione come posso descrivere l’essere umano che in veste di paziente ho davanti a me, rispettivamente quali sono i punti di vista che lo caratterizzano e che devo prendere in considerazione?” L’immagine volle pure delineare quei criteri, valori e aspetti che sono ineluttabilmente e necessariamente legati all’operato medico, anche se non peculiari di esso. Essa tende a dare una risposta alla domanda il più possibile completa nella consapevolezza di mai raggiungere la completezza. La figura base di quest’immagine divenne il triangolo, il loro numero sette. Insieme formano un ettagono. Ai due numeri – il 3 e il 7 – sono arrivato magari per caso, forse per inevitabile necessità. Nel sette volte tre espongo pochi, essenzialmente tre, fondamentali concetti diverse volte, in certe occasioni con un volto nuovo e in altre ripetendomi, facendo i rispettivi riferimenti alle pagine precedenti. 31 1. Il primo triangolo: un concetto dell’essere umano 1.1. Il perché di un concetto dell’essere umano Tutti hanno quotidianamente a che fare con esseri umani, in modo particolare chi lavora nel campo terapeutico; di esso fanno parte oltre alla professione medica anche quella infermieristica, di assistente di cura, di laboratorista, di tecnico di radiologia, di soccorritore, di coordinatore e altre. Pure a stretto contatto con individui sono gli educatori e gli operatori sociali. Gli approcci teorici e le loro applicazioni tecniche-pratiche sono in questi contesti professionali innumerevoli. Sovente manca però un concetto dell’essere umano. Infatti se si domanda: “Cosa è un essere umano?” la prima risposta è nella mia esperienza: “Uno come me”. Sotto questo uno come me, ossia come io mi vedo, si cela comunque una propria convinzione, che si svela parzialmente al momento che ci presentiamo: abitualmente dapprima diciamo il nostro nome, ossia qualche cosa di (quasi) unico, poi la professione, cioè cosa facciamo e infine la parentela (a dipendenza se si hanno importanti legami familiari o meno), il luogo dove si abita o la nazionalità: “Mio cugino è il …”; “Abito a Lugano”; “Sono svizzero”. Magari c’è chi confida una particolarità personale di tipo “Sono tifoso di …” o “Nel tempo libero mi piace fare…” oppure aggiunge la propria credenza religiosa, dando così espressione all’inerente personale convinzione, che l’essere umano ha un aspetto trascendente. Quale medico ho partecipato a decine di congressi, che evidentemente hanno avuto come tema principale l’essere umano. Molto raramente la discussione si è basata su un concetto dell’essere umano esplicitamente discusso. Chi parlava doveva però per forza avere un proprio concetto. 33 Non se ne è mai parlato – come a un congresso all’inizio di una presentazione si usa e si deve rendere pubblici i propri contatti professionali legati a interessi commerciali proiettando l’immagine con la rispettiva lista – forse per una relativa debole consapevolezza. Magari il concetto era limpidamente tracciato nella mente dell’oratore e lui lo riteneva tacitamente valido per tutti. Con un po’ di umoristica enfatizzazione si può affermare che a un congresso a impronta psicofarmacologica l’essere umano viene vissuto come una specie di prosciutto che per guarirlo è sufficiente condirlo adeguatamente con psicofarmaci; dopo dieci anni di terapia lo psicoanalista rimane irremovibilmente dell’opinione che il paziente non ancora guarito non ha finora risolto i suoi più profondi e perciò essenziali problemi relazionali a livello emotivo con le principali persone di riferimento avute nei primi anni di vita. Il clown-dottore è convinto che il paziente si è ammalato perché non ha riso sufficientemente, rispettivamente non guarisce perché non è abbastanza gioioso e così dicendo si mette in sintonia con il fondamentalista religioso che sostiene che le cause stanno nel fatto che il paziente non crede e non ha pregato quanto basterebbe. Il terapeuta orientato a un concetto sistemico vede le principali cause della malattia nella disarmonia dell’ambiente familiare e/o lavorativo e ritiene prioritario riportare equilibrio nei rispettivi sistemi. Sono tutte frasi da me udite più di una volta durante i quattro decenni di studio e lavoro. Esse esprimono un sottostante concetto dell’essere umano, non sempre dichiarato in modo così risolutivo, sovente invece difeso in maniera radicale, soprattutto quando il proprio concetto arriva a raggiungere i suoi limiti. Non di raro ne consegue una guerra da trincea con altri concetti per inconciliabili posizioni. Infatti, sempre con un po’ di humor rivolto anche alle mie convinzioni, sembra che gli specialisti nel campo della psichiatria e psicologia diventino essi stessi vittime del ritorno dell’archetipo o degli “antecedenti senza antecedente” che con la propria visione unilaterale hanno rimosso. L’arcaico desiderio di una univoca e onnicomprensiva mono-concezione porta in prima linea e inevitabilmente a una staticità non conciliabile con la contemporanea necessità della vita sia di stabilità sia di flessibilità. Infatti l’essere umano esiste unicamente se muta e nel medesimo tempo è lui stesso a esistere solamente se resta immutabile. Da qui la mia proposta di un concetto dell’essere umano che sia in grado di accordare queste due ine34 luttabili esigenze della vita, raffigurabili nell’immagine del funambolo che rinunciando a opporre l’indispensabile stabilità al flessibile movimento riesce a conciliare e addirittura a fare reciprocamente esaltare i due aspetti della vita. 1.2. La storia già avviata Inizio con “la storia già avviata”, ossia quella preesistente al singolo essere umano, rispettivamente a tutta l’umanità. Essa mi serve per sviluppare il mio concetto dell’essere umano. Fra le varie possibilità che raccontano “la storia già avviata” ho scelto quella proposta dalla Bibbia, perché in qualche modo a me nota in seguito alla mia educazione. Avrei indubbiamente potuto far riferimento ad altre convinzioni o miti, in modo particolare alla mitologia greca, della quale ho ricevuto una certa infarinatura. Inizio con il primo versetto del primo capitolo del primo libro del Vecchio Testamento, ossia la Genesi. “In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto, le tenebre coprivano gli abissi”1. Finisco qui la citazione e riassumo i seguenti versetti: il primo giorno creò la luce. Il secondo giorno Dio separò le acque: una parte rimase sopra, ossia le nuvole, una parte rimase in basso, i mari. Il terzo giorno creò l’asciutto e divise terra e mare. Sulla terra fece crescere erba, grano, alberi e fiori. Il quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle e con loro giorno e notte. Il quinto giorno creò i pesci e gli uccelli. 1 Parola del Signore: La Bibbia: traduzione interconfessionale in lingua corrente, Elle di ci, Leumann, Torino, 1985. 35 Il sesto giorno creò gli animali domestici, quelli selvatici e quelli che strisciano. Sempre al sesto giorno creò infine l’uomo; diede vita a due che creò singolarmente prima uno e dopo l’altro e non Adamo ed Eva contemporaneamente. Il settimo giorno riposò. Nell’ultimo versetto, il ventinovesimo, sempre del primo capitolo si legge: “Dio disse: ‘Vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme. Così avrete il vostro cibo’”. Nel quindicesimo versetto del secondo capitolo infine sta scritto: “Dio, il Signore, prese l’uomo e lo mise nel giardino dell’Eden per coltivare la terra e custodirla”. Malgrado nell’Eden per la sua costituzione paradisiaca regnasse ininterrottamente la felicità, Adamo ed Eva dovettero operare con un obiettivo, ossia coltivare la terra – un atteggiamento offensivo verso la fioritura – e custodirla – un comportamento difensivo che conserva. Un’istruzione d’uso non viene data e nemmeno viene prescritto il come. L’uomo sembra perciò essere libero di come svolgere questi due inevitabili compiti fondamentali e perciò responsabile delle sue scelte. In questi due capitoli della Genesi cinque sono i messaggi di fondamentale importanza per la nostra tematica: 1. Innanzitutto il fatto che l’uomo non ha potuto decidere se venire al mondo o meno, rispettivamente che non si è creato da solo, ma che è stato creato. I primi due esseri umani, Adamo ed Eva, sono stati creati da Dio. In seguito qualsiasi essere umano è stato generato da chi lo ha preceduto. Anche nelle tecniche più sofisticate della riproduzione artificiale ci sono sempre almeno due persone che fanno una qualsiasi cosa per generare un essere umano. Il suo essere se stesso nella propria inconfondibilità, unicità e irripetibilità si sviluppa su un originale appartenere biologicamente a chi lo ha generato. In altre parole, come scrive Salvatore Natoli, nessuno è un puro inizio; nessuno viene da solo al mondo, ma tutti 36 2. 3. 4. 5. noi siamo, almeno parzialmente sempre anche messi al mondo2. Ciò corrisponde a quanto Aristotele scrive nella fisica: “Nulla viene mosso se non in presenza di un altro motore”3. Ogni uomo viene creato o generato singolarmente. Egli è perciò un individuo (vedi paragrafo 1.3.). Dio ha creato i primi due esseri umani singolarmente uno dopo l’altro; non ne ha fabbricati un’infinità in un botto solo. Il terzo messaggio è quello che alla nostra nascita entriamo in un mondo già esistente. Terra, mare, vegetazione, giorno e notte e animali erano sulla terra prima di noi. Del resto anche nella teoria evoluzionistica l’uomo è arrivato come ultimo su questa terra; la differenza fra quest’ultima e la genesi e altre convinzioni religiose o miti è che per la prima tutto è avvenuto “tirando i dadi”, rispettivamente è conseguenza della selezione naturale che premia il più forte, per la seconda invece tutto è il risultato di un disegno divino. In ogni caso alla nostra nascita siamo ospiti di un ecosistema che ci precede e ci accoglie. Uso intenzionalmente la parola “eco”; essa proviene dal Greco oìkos, che significa dimora nativa. Tutti entrano alla propria nascita in un discorso già avviato. So che anche nella religione egizia e nella mitologia greca l’uomo non è la prima cosa o il primo essere. Personalmente non conosco nessuna mitologia, religione o filosofia che ritiene consapevolmente l’uomo l’inizio di tutto. Il quarto messaggio dice che l’uomo si ciberà delle piante con il proprio seme e degli alberi da frutta con il proprio seme. L’uomo ha perciò a tutti gli effetti un corpo. In più, da una parte la vegetazione è a disposizione dell’uomo, dall’altra l’uomo dipende da essa. Senza di essa muore di fame. Il suo appartenersi nella propria diversità è costretto a svilupparsi su un originario appartenere al mondo esterno, su una primordiale dipendenza biologica, che perdura durante tutta la sua vita. L’ultimo messaggio sottolinea che l’essere umano è necessariamente un homo faber. È costretto a fare e questo persino nell’Eden, dove per definizione regna la felicità, e non esclusivamente 2 Natoli S., La felicità di questa vita, Mondadori, Milano, 2011, p. 9. Reale G., Antiseri D., Il pensiero occidentale dalle origini a oggi, vol. 1, La Scuola, Brescia, 1995, p. 137. 3 37 dopo essere stato cacciato dal paradiso. Non può scegliere di fare; può e deve invece scegliere come fare. Detto diversamente, nessuno ha potuto liberamente scegliere di venire al mondo e tutti sono costretti a decidere cosa fare e come stare a questo mondo. Nessuno è responsabile di essere nato e tanti sono responsabili di molte scelte che fanno durante la vita. Riassumo: l’essere umano non è un puro inizio. È creato, rispettivamente è generato singolarmente con una propria inconfondibilità e unicità. Non è unico al mondo; è addirittura ospite di questo mondo. Non gode di un’assoluta autonomia ed è costretto a decidere e a fare. Non può decidere di non decidere: già al risveglio deve decidere se rimanere sdraiato o se alzarsi e ogni decisione oltre a essere una scelta è sempre anche una rinuncia. Può e deve invece responsabilmente decidere cosa fare e in che modo agire. 1.3. L’individuo La parola individuo significa unità indivisibile, inseparabile. Un individuo è in senso lato un organismo vivente considerato distintamente da ogni altro della specie o del genere a cui appartiene4. L’individuo in senso stretto è un organismo umano, considerato distintamente da qualsiasi altro essere umano. Inizio la discussione con la descrizione da un punto di vista medicopsichiatrico di un individuo qualsiasi che sta in questo momento davanti a noi e di cui noi non sappiamo nulla, né età, né sesso, né provenienza, né altro. Gottlieb Guntern5 lo delinea dall’esterno nel suo essere e nel suo operare, nel suo stato operativo attuale, ossia nel suo funzionare momentaneo in generale, in modo assai completo tramite i seguenti cinque aspetti: 4 5 38 Il grande dizionario Garzanti, Garzanti, Milano, 1987, p. 933. Guntern G., Mit den Schwingen des Adlers, Orell Füssli, Zürich, 2003, p. 68. I cinque aspetti possono essere simboleggiati da una stella a cinque punte, il pentacolo. Le cinque punte rappresentano i cinque singoli aspetti; il fatto che la stella possa essere disegnata con un unico ininterrotto movimento sottolinea che le punte appartengono ad un’unica inseparabile unità, appunto l’individuo all’interno della quale interagiscono. I cinque aspetti si trovano così in un delicato equilibrio fra ciò che li accomuna e ciò che li distingue. Le punte di una singola stella non devono avere come nel disegno l’identica grandezza. Il numero di forme possibile di questa stella è perciò infinito. Magari solo per pura coincidenza il pentacolo è il simbolo di Venere, la dea della bellezza femminile. Le principali correnti terapeutiche si occupano di una singola punta della stella con l’obiettivo o la speranza di poter così modificare tutta la stella. Con una buona dose di humor e una componente molto riduttiva descrivo le singole correnti nel seguente modo: 39
Scarica