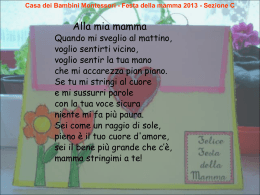PRESENTAZIONE Attenzione! Se sei alle medie o stai per andarci, questo diario è la tua unica possibilità di uscirne vivo…. LEGGILO! Dopo il primo anno di scuola media pensavi che il peggio fosse passato? Niente di più sbagliato! Ma per fortuna c’è l’Operazione “Fatti una vita”… «Rafe, il protagonista perfetto di questo libro perfetto per il suo pubblico.» D di Repubblica «Un romanzo perfettamente azzeccato.» Times James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei giorni nostri. Famoso tra gli adulti come autore di thriller (pubblicati in Italia da Longanesi), è conosciutissimo tra i ragazzi per le sue serie Witch & Wizard e Maximum Ride (Editrice Nord). Nel 2010 è stato incoronato dai giovani lettori americani come miglior autore dell’anno. I suoi libri hanno venduto 270 milioni di copie nel mondo. Da qualche anno Patterson è molto impegnato nelle scuole per la promozione della lettura. Troverai i suoi consigli sul sito www.salani.it Chris Tebbets è autore di fantasy e libri d’avventura per ragazzi. Laura Park, fumettista e illustratrice, vive a Chicago con il suo piccione domestico. Per essere informato sulle novità del Gruppo editoriale Mauri Spagnol visita: www.illibraio.it www.infinitestorie.it Titolo dell’originale inglese MIDDLE SCHOOL. MIDDLE SCHOOL GET ME OUT OF HERE ISBN 978-88-6715-719-8 T raduzione di Paolo Antonio Livorati Lettering italiano di Studio Plancton Design di copertina: Alison Impey Illustrazioni: Laura Park foto (c) Ragnar Shmuck/Getty Images Copertina (c) Hachette Book Group, Inc. Copyright © 2013 Adriano Salani Editore S.p.A. Gruppo editoriale Mauri Spagnol Milano www.salani.it Prima edizione digitale 2013 Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. Be’, chi l’avrebbe mai detto che in una sola estate sarebbero cambiate tante cose? Non io, di sicuro. E neanche il mio migliore amico, Leonardo il Taciturno. E probabilmente nemmeno quelli della Scuola d’arte Airbrook. Era lì che avrei dovuto iniziare la seconda, in autunno. Avrei dovuto. È chiaro perché il mio libro precedente si intitolava Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, no? La prima media è stata solo l’inizio. Ho un sacco di altra roba da raccontarvi. Prima però dovrei presentarmi. Ma tanto avrei dovuto immaginarlo. Ogni volta che la mia vita comincia ad andare per il verso giusto, arriva sempre qualcosa a cambiare tutto. Come una tegola, o peggio, in testa. E infatti tutto è cambiato il giorno in cui Swifty’s è andato in cenere. Vi racconto com’è andata. Nella cucina del ristorante c’è una cosa che si chiama filtro del grasso, sulla griglia dove Swifty (alias Fred) cuoce tipo millecinquecento hamburger al giorno. Se non viene pulito ogni tanto, questo filtro diventa una bomba incendiaria che aspetta solo il momento giusto per esplodere. E secondo voi cos’è successo? Io non ho visto granché. Ero nel magazzino sul retro, aspettando la fine del turno di mamma per il pranzo. E poi di colpo ho sentito un ‘VUUUM!’ gigantesco. Qualcuno si è messo a gridare, l’allarme antincendio ha cominciato a suonare e io ho sentito subito odore di fumo. Un attimo dopo è entrata mamma. «Dai, Rafe! Dobbiamo uscire, subito!» ha detto e mi ha spinto fuori dalla porta di servizio. Nessuno si è fatto male, ma il fuoco aveva raggiunto le finestre e il tetto ancora prima che arrivasse l’autobotte. Quando i vigili del fuoco sono finalmente riusciti a spegnere l’incendio, il ristorante di Swifty era ormai diventato ‘il mucchio di braci di Swifty’, un edificio tutto nero e fumante. Swifty’s non esisteva più. E non finisce qui. Niente più Swifty’s, niente più lavoro per mamma. Niente più lavoro, niente più soldi per l’affitto. Niente più casa, uguale fare i bagagli e trasferirci. Capite adesso cosa intendevo con ‘tutto è cambiato’? L’unico posto dove potevamo andare era a casa di nonna Dotty. Ci aveva assicurato che potevamo stare da lei per tutto il tempo che ci serviva. Molto gentile da parte sua, ma il problema era che lei abita in città, più o meno a centotrenta chilometri da noi. In altre parole, troppo lontano per poter iniziare a frequentare la Airbrook. Avrei dovuto fare la seconda media in qualche mega-scuola in città, di quelle dove i ragazzini come me vengono ridotti tutti i giorni in polpette. Visto? Non è nemmeno ancora finito il primo capitolo che già devo ricominciare daccapo. Provateci voi a battermi, se ci riuscite. Insomma, questo è solo l’inizio, la parte in cui dico... «Ciao ciao, Hills Village!» «Ciao ciao, periodo fortunato!» E anche: «Eccomi qui, seconda media!» Il giorno in cui abbiamo lasciato Hills Village ci hanno salutato così. Niente male, eh? Seh, magari. Se mi conoscete già, sapete che ho quella che mamma chiama ‘una fantasia molto spiccata’ e che alcuni miei insegnanti invece chiamano ‘tendenza a dire bugie’. Mi piace pensare che sia solo un modo per dare una mia versione personale di quello che mi capita. Ma non preoccupatevi, rimedierò sempre con la verità. Per esempio, quando siamo partiti in realtà è andata così: Quelle che ci stanno salutando sono la signora Donatello e Jeanne Galletta, praticamente le uniche due persone che siano mai state gentili con me alla Scuola Media di Hills Village. La signora Donatello era la mia insegnante di inglese. Io la chiamavo Lady Dragon, ma alla fine si era rivelata incredibilmente umana. Era stata lei a farmi iscrivere alla Airbrook, prima che i miei piani grandiosi finissero nel tritarifiuti. Quanto a Jeanne, è sempre stata buona con tutti, quindi non so quanto contasse il fatto che lo fosse con me. Quando le dissi che volevo che ci tenessimo in contatto, lei rispose che sì, potevo inviarle dei messaggi sulla sua pagina personale nel sito della scuola. Buon segno? Non lo so, ditemelo voi. Non è che io abbia chissà quale esperienza di amici e di ragazze. Soprattutto di ragazze. Eppure, se c’era una persona che mi sarebbe mancata, quella era lei. E quindi, se non l’avete ancora intuito, non mi lasciavo certo dietro una reputazione immacolata a Hills Village (probabilmente questo è l’eufemismo dell’anno). Se volete capirlo meglio, ve lo spiego nel prossimo capitolo. La classifica dei dieci sei più grandi risultati ottenuti da Rafe Khatchadorian in prima media: «Ci divertiremo, fidatevi» continuava a dire mamma andando verso la città. «Non vedo l’ora di portarvi un po’ in giro. C’è un sacco di roba da fare qui, e il parco vi piacerà tantissimo». Dopo un po’ non le diedi più retta. E anche mia sorella Georgia, credo. Tutti e due ci limitammo entrambi a guardare fuori dal finestrino, mentre cercavamo di immaginare come avremmo fatto a vivere lì. Pensate alla città che volete: New York, Chicago, Boston, giù giù fino a South Bend, Boise, Omaha, dove vi pare. Immaginatevi tanti grattacieli scintillanti, marciapiedi perfettamente puliti e milioni di abitanti felici che acchiappano i soldi che piovono dal cielo. E adesso provate a immaginare l’esatto opposto. Fatto? Allora benvenuti nel quartiere di nonna Dotty, cioè anche il nostro. «E tu sei cresciuta qui?» disse Georgia, ma non con un tono ammirato. «Una volta era... diverso» disse mamma, ma si capiva che intendeva ‘migliore’. Fu lì che capii perché era sempre nonna a venirci a trovare a Hills Village e mai il contrario. Tutte le case dell’isolato erano ammassate l’una contro l’altra. Non avevano giardini né davanti né sul retro, solo marciapiedi. Dappertutto bidoni della spazzatura e graffiti. «Qui non riuscirò mai a farmi degli amici!» piagnucolò Georgia. «Su, tesoro. Ambientarsi non sarà facilissimo, lo so, ma bisogna essere ottimisti e convinti» le rispose mamma. «Okay, allora io sono convinta che qui non farò mai amicizia con nessuno». Mamma sospirò, sconsolata. «E tu invece, Rafe? Non vuoi provare a vedere com’è la vita di città?» «Ma certo» dissi. «Perché no?» In realtà mi sentivo né più né meno come Georgia. Non volevo vivere lì e di sicuro non volevo andarci a scuola. Però, al contrario di mia sorella che non capisce mai quando deve chiudere il becco, io sapevo che mamma stava già facendo del suo meglio per renderci un po’ più facili le cose. «Be’, siamo arrivati» disse. Subito dopo si fermò davanti alla quintultima casa dell’isolato. «È il 625 di Killarney Avenue». Georgia fece un verso come un gatto strozzato da una palla di pelo. «È quella messa peggio in tutta la via!» disse. «Ha solo bisogno di essere ravvivata un po’» disse mamma. «Vedrete. Basta un pizzico di fantasia. Vero, Rafe?» «Certamente» dissi. «Solo un pizzico di fantasia. Nient’altro». Mamma ha sempre detto che nonna Dotty era come un topolino accumulatore. Non mi ero mai chiesto davvero cosa volesse dire. Me la immaginavo così: Non appena entrammo, però, capii subito come stavano le cose. I due aggettivi perfetti per descrivere casa di nonna erano ‘piccola’ e ‘stipata’. «Venite, venite, accomodatevi!» ci disse, abbracciandoci tutti come una pazza. «Avete altri bagagli da scaricare dalla macchina?» chiese poi a mamma. «Non tantissimi» rispose lei. Il grosso infatti era rimasto in un box a Hills Village. «Ah, bene, perché al momento non ho molto spazio negli armadi» disse subito nonna. A me invece sembrava che non ci fosse spazio per Rafe, Georgia e mamma, altro che vestiti. «Perché quei musi lunghi, bambini?» ci chiese poi. «Sembra che vi sia appena morto il gatto!» «Sono solo stanchi» disse mamma. «È stata una giornata lunga». «Questa piccolina non si regge in piedi. E tu, Ralph... scommetto che dalla fame che hai ti mangeresti un cavallo e mezzo!» «Be’...» risposi io, ma dentro di me pensavo: E di colpo trovarmi lì mi sembrò ancora più assurdo. «Rafe, mamma, non Ralph». «Ah, certo, certo. Scusami, Rafe. Un piccolo lapsus. Ma adesso venite, forza. Allora, chi ha fame?» Guardai mamma perplesso, ma lei mi fece un sorriso per dirmi di stare tranquillo. E in verità il profumo che arrivava dalla cucina era fantastico, proprio come quello delle lasagne che mamma preparava nella vecchia casa. Poi entrando in cucina vidi subito qualcos’altro che non mi era nuovo. «Ma non è uno dei tuoi?» chiesi a mamma. «Sì». L’ultima volta che avevo visto dei suoi quadri appesi era stato da Swifty’s, ma erano andati tutti in fumo con il locale. «In questa casa vostra madre è un’artista famosa» disse nonna. Poi si voltò verso mamma e le fece un inchino esagerato. Lei scoppiò a ridere. E anche Georgia rise, per la prima volta più o meno da una settimana. «Ah, così si fa!» disse nonna. «Molto meglio». Allungò una mano e solleticò mia sorella sotto il mento. Due secondi dopo stavamo ridendo tutti. «Questi sono i Khatchadorian che ricordo!» Mi abbracciò di nuovo. «Ci divertiremo un sacco insieme, vero, Ralph?» Le due del mattino, ma ero sveglissimo. Mamma mi aveva detto di scegliere tra il divano al piano di sotto e la camera degli ospiti da dividere con Georgia. Inutile dire che non ci fu gara. Se non altro al pianterreno avrei avuto un minimo di riservatezza. Eppure non riuscivo a dormire, troppo occupato a pensare come arrivare vivo alla fine dell’anno scolastico. Non era ancora iniziato e già mi vedevo davanti nient’altro che grane. A un certo punto finalmente mi assopii, ma Leonardo il Taciturno non ci mise molto a intrufolarsi nei miei sogni. «Cosa fai?» mi chiese. «Cerco di dormire». «No, tu cerchi di immusonirti. Dai, c’è tutta una metropoli che ci aspetta. Abbiamo di meglio da fare». E aveva ragione, lo so. Saltai giù dal letto (dal divano?) e insieme modellammo un finto Rafe sotto le coperte, con tanto di maschera ultrarealistica con le mie fattezze, nel caso mamma o nonna fossero scese durante la notte. Poi indossammo le cose meno vistose che avevamo e uscimmo. Un attimo dopo eravamo per strada. «Da dove vuoi iniziare?» mi chiese Leo. «Da qualcosa di alto. Ci serve una panoramica di quello che ci aspetta». «Ottima idea». Indicò l’edificio più alto. «Meno male che ho portato l’attrezzatura da arrampicata». Ci muovemmo come due ombre, passando per vicoletti e passaggi segreti. Con tutte le scorciatoie che conosceva Leo ci ritrovammo in un batter d’occhio ai piedi delle Megamega Towers. «Allora è così che è fatto un palazzo di trecento piani» dissi. «E aspetta di vederlo dall’alto!» Dopo esserci imbragati, ci infilammo gli scarponi a ventosa e partimmo verso il cielo. «Non guardare in basso finché non saremo arrivati» mi disse Leo. «Varrà la pena aspettare, fidati». Aveva ragione anche su questo. Quando arrivammo sul tetto si vedeva in ogni direzione per chilometri e chilometri. «Questo a Hills Village non c’è mica» mi disse. Le macchine di sotto sembravano tante formichine dalle antenne luminose, e l’intera città mi si spianava davanti come il gioco da tavolo più grande del mondo. A quel punto non dovevo fare altro che decidere la mia mossa seguente. «Forse quest’anno non andrà poi tanto male come pensavo». «Be’, se ti è piaciuto salire» disse Leo, «con la discesa impazzirai». Ci lanciammo con il nostro deltaplano pieghevole proprio mentre il sole cominciava a spuntare all’orizzonte. La nostra prima nottata in città era già volata via. Mamma si sarebbe svegliata fra poco e quindi dovevo tornare. Nel frattempo, però... che vista! Okay, facciamo una pausa di un secondo. Se avete letto il libro precedente sapete già tutto di Leo. Cioè, specialmente il fatto che lui non esiste davvero. Se invece la cosa vi giunge nuova, allora forse c’è qualcos’altro che dovreste sapere. È roba un po’ pesante, ma togliamocela subito il pensiero. Il vero Leonardo era il mio fratello gemello. Si è ammalato ed è morto quando avevamo tre anni. È una storia tristissima, certo, ma è successa tanto tempo fa. Io me lo ricordo appena. Il fatto è che mi sono sempre chiesto come sarebbe Leo se ci fosse ancora. Penso che in effetti abbia sempre parlato con lui… quasi un’idea di Leo, che io chiamo Leonardo il Taciturno. Quindi se adesso pensate che io sia suonato... vi garantisco che non è così. Sono soltanto... be’, non so cosa di preciso. Fantasioso, forse. Un solitario, di sicuro. Ma suonato no. Mamma dice che Leo è la mia musa. Una musa è qualcuno che aiuta un artista a farsi venire delle idee e a pensare meglio, anche quando non esiste fisicamente. E Leo non sarà reale, ma chissà come mi aiuta ad affrontare cose che invece sono reali eccome. Per questo è anche è il mio migliore amico. Ehi, sentite, non vi ho mai detto che non era una storia complicata. Vi ho solo detto che non sono suonato. La mattina dopo, a colazione, mamma ci preparò degli ottimi french toast. I preferiti di Georgia, quelli con la banana e lo sciroppo d’acero, e per me doppia razione di cannella. «Rafe, quando hai finito vorrei che ti mettessi la camicia che ti ho lasciato sul divano» disse a un certo punto mamma. «E dei pantaloni puliti, per favore». Mi bloccai con la bocca piena. Non promette niente di buono quando uno si deve mettere dei vestiti che gli ha scelto sua madre. «Cos’hai in mente?» chiesi. Lei si limitò a sorridere e a passarmi una seconda razione. «È una sorpresa». «Dove deve andare Rafe?» si intromise Georgia. «Cosa fate? Posso venire anch’io?» «Ci andiamo tutti» disse mamma, ma non aggiunse altro. Poco dopo eravamo già seduti in macchina e stavamo uscendo da Killarney Avenue. Mamma sapeva ancora orientarsi benissimo. Ci indicò il museo della scienza, l’IMAX, lo stadio di baseball e un sacco di altra roba. Si capiva che stava cercando di farci piacere l’idea di abitare lì. Quello che non capivo, invece, era perché dovessi portare la camicia infilata nei pantaloni. Alla fine cedetti: «E dai, mamma, per favore. Dicci dove stiamo andando». «Okay, okay. Tanto siamo quasi arrivati. Ora non ti agitare, eh...» «In che senso?» risposi. «Perché dovrei agitarmi?» «Vedi, lo so che per te non poter andare alla Airbrook è stata una grossa delusione. Ma stamattina potremmo rimediare. Ti ho fissato un colloquio, Rafe. Alla scuola d’arte Cathedral». Non so che cosa mi aspettassi che mi dicesse, ma di sicuro non una cosa simile. La Airbrook mi era sembrata una di quelle opportunità che non tornano più. «Vuoi dire che esistono altri posti del genere?» «La Cathedral è persino meglio. È pubblica, quindi è gratis. Però bisogna farsi ammettere. È per questo che facciamo il colloquio». Fu lì che compresi perché mi aveva detto di non agitarmi. Non avevo nemmeno ancora visto questa Cathedral e già sapevo di volerci andare. Se era come me la immaginavo, poteva essere davvero la scuola più grandiosa del mondo. «Però non capisco... come ci sei riuscita?» «Ah, non sono stata io a farti avere il colloquio» disse mamma. Mi voltai verso nonna. «Uh, non guardare me, Ralph» disse lei. «Sono confusa quanto te». «È stata la signorina Donatello» disse mamma e io mi voltai di nuovo verso di lei, di scatto, come se stessi guardando una partita di tennis. «Eeeh?» «Neanche a farlo apposta...» Mamma indicò l’altro lato della strada rispetto a dove avevamo appena parcheggiato. «Eccola lì». Scendemmo dalla macchina. La signora Donatello ci aspettava sul marciapiede: aveva un sorriso enorme in faccia e una cartella di cuoio ancora più grande sotto il braccio. «Scommetto che non ti aspettavi di rivedermi così presto, eh?» Io non mi aspettavo di rivederla e basta, ma non glielo dissi. «Tieni». Mi diede la cartella. «Ho messo insieme un portfolio dei tuoi disegni dello scorso anno. Adesso andiamo, però, altrimenti faremo tardi!» La seguimmo oltre l’ingresso e fino all’ufficio più grande, dove si sarebbe svolto il colloquio. Da fuori la Cathedral era un edificio come tanti altri, ma dentro era fichissimo, con un sacco di finestroni e di scale che sembravano portare dappertutto. La signora Donatello ci spiegò che fino a un centinaio di anni prima la scuola era stata una fabbrica di mattoni. Mamma continuava a dire cose tipo: «Uuuh!» o «Ma che bello!» Io chiudevo la fila e nel frattempo stavo cominciando a sclerare, senza che nessuno ci facesse caso. Ero sempre più convinto di essermi imbarcato in una missione suicida. C’erano dipinti e disegni appesi ovunque alle pareti, e mi sembrava che qualunque alunno di quella scuola fosse un artista molto più bravo di me. «Forse non saremmo dovuti venire» dissi. Mi fissarono tutti, perfino Georgia. «Andrà tutto benissimo, Rafe!» fece subito la signora Donatello. «Cosa faranno, lì dentro?» chiesi indicando la porta dell’ufficio. «Prima daranno un’occhiata al tuo portfolio...» «... e poi ti faranno qualche domanda sui tuoi disegni». «Dopodiché ti chiederanno di uscire e la commissione valuterà la tua richiesta d’iscrizione». E poi, senza accorgermene, passai il punto di non ritorno. La porta si stava già aprendo. Toccava a me. «C’è altro che dovrei sapere prima di entrare?» le chiesi. Solo che la signora Donatello non era più la signora Donatello. Gli occhi le si erano trasformati in due fessure gialle e dalle fauci le usciva del fumo. Diede una zampata alla cartella che tenevo tra le mani. «Tutto quello che ti serve è qui dentro». Guardai e notai che aveva nascosto nel portfolio la mia vecchia spada. Incredibile! La mia vecchia nemica Lady Dragon ora era un’alleata. Ma ormai mi aveva accompagnato fin dove poteva. Qualunque cosa mi aspettasse oltre questa porta, avrei dovuto affrontarla da solo. L’unica domanda adesso era se ne sarei uscito vivo... ... o no. Nella stanza degli interrogatori fa freddo. Vedo il mio fiato che si condensa, ma nessuno dei tre estranei seduti davanti a me sembra farci caso. Sembrano umani, ma io non ci casco. Il loro è un travestimento molto astuto: vogliono che mi senta al sicuro per poi farmi abbassare la guardia. «Khatchadorian, giusto?» dice quello alto, al centro. Sorride e mi fa segno di avvicinarmi. «Sì» rispondo. «Rafe». «La signora Donatello ci ha detto che ti chiami così in onore del grande Raffaello Sanzio. Conosci bene le sue opere?» Io sto al gioco. Dico: «Certo», ma intanto il mio sguardo vaga per tutta la stanza. In qualsiasi punto potrebbero esserci delle trappole pronte a scattare. «Vediamo che cosa ci hai portato» dice un’altra. Mentre allunga la mano intravedo le verruche sotto la sua finta pelle umana. Ci siamo. Se c’è un motivo per agire, è questo. Frugo nella cartella... e un attimo dopo tiro fuori la spada. Le sedie si rovesciano. Le finte pelli si staccano. Gli artigli si sguainano. In meno di due secondi mi ritrovo davanti i tre gemelli più brutti che possiate immaginare. Si allungano nei loro nuovi corpi e scoprono le zanne. Uno di loro emette un ruggito lungo e rabbioso. No, non è rabbia, è fame. Quello era uno stomaco che brontolava. Poi attaccano, tutti insieme. Io abbasso la testa e seguo l’istinto. Colpisco! Schivo! Finto! Una botola mi si apre sotto i piedi. Salto via appena in tempo. Tiro un pugno! Un altro! E un altro ancora! Fin qui me la sto cavando, ma non so quanto resisterò. Loro continuano ad attaccarmi, prima uno per volta e poi tutti insieme, gridandosi qualcosa nella loro lingua segreta. Perdo un po’ di terreno e mi riprendo. Perdo un altro po’ di terreno e mi riprendo. Però poi, senza accorgermene, mi ritrovo bloccato in un angolo. Proprio dove non dovrei essere. Mi hanno circondato. Tengo alta la spada, aspettandomi un attacco. Invece loro stanno fermi e non mi ci vuole molto per capire perché. Il muro dietro di me si sgretola. Sento il soffitto che si crepa. È una trappola, anche questa! Alzo lo sguardo, ma è troppo tardi. Vedo solo una pioggia di mattoni e calcinacci che mi cade addosso. La stanza sta crollando. È tutto. Avevo una possibilità e me la sono giocata. Il colloquio è finito. «Sono certa che non è stato tremendo come pensavi, eh?» mi disse mamma dopo. «No, è stato anche peggio. Neanch’io mi ammetterei in questa scuola». Ricordavo a stento i dettagli del colloquio. Avevo mostrato il portfolio e dato delle risposte sceme alle loro domande, ma non avrei saputo ripetervi niente di quello che avevo detto. Eravamo di nuovo in corridoio e stavamo aspettando che uscissero a darci la brutta notizia. «Stai tranquillo, tesoro. Peggio per loro, se non ti vogliono» disse nonna. «Perché non aspettiamo la risposta prima di commentare?» disse invece la signora Donatello. «Devo andare in bagno» disse Georgia. Non avevo più voglia di parlare, così feci come Leonardo il Taciturno e tenni la bocca chiusa. Alla fine la porta dell’ufficio si aprì e il preside, il signor Crawley, uscì per venirci a parlare. Io cercai di non dare l’impressione di essere quello che voleva sparire, o autodistruggersi, o tutte e due le cose insieme. «Prima di tutto, Rafe» iniziò, «devi sapere che in un candidato noi cerchiamo tre cose. Una è l’esperienza. Molti dei nostri alunni hanno cominciato a studiare arte ancora prima di imparare a leggere». «Certo» dissi. «Capisco. Non c’è problema». Ma il signor Crawley non aveva ancora finito. «Le altre due sono il talento e la perseveranza. Il tuo portfolio non è solo pieno di promesse artistiche, ma è anche letteralmente pieno. Quando lo guardo, vedo un ragazzo che probabilmente continuerebbe a disegnare anche se nessuno ci facesse caso». Guardai mamma per cercare di intuire la sua reazione, perché io non avevo ancora capito se quella fosse una bella o una brutta notizia. «Tutto questo per dire...» Mi porse la mano perché gliela stringessi. Di colpo tutto andò al rallentatore. «... che abbiamo accettato la tua domanda». Non riuscivo a crederci. Era uno scherzo? Si erano confusi con un altro Rafe? «Dice davvero? Sta dicendo sul serio?» «Serio quanto il periodo blu di Picasso» fece il signor Crawley. Mamma e la signora Donatello scoppiarono a ridere, mentre io gli stringevo la mano. «Benvenuto alla Cathedral!» E anche se non mi sembrava ancora vero, vi assicuro che quelle furono le tre parole più belle che avessi sentito da un gran bel po’ di tempo a quella parte. Tornati a casa di nonna trovai il coraggio per fare qualcosa di iper-terrificante: scrivere a una ragazza. A: [email protected] DA: [email protected] OGGETTO: Roba da non credere Ciao, Jeanne! Come va nella buona vecchia Hills Village? Manco già a qualcuno? Oppure nessuno si è accorto che me ne sono andato? ;) Qui sono successe cose assurde. Su una scala da uno a dieci direi quattordici, perché indovina chi è stato ammesso alla scuola d’arte Cathedral? Ti do un aiuto: inizia per R e finisce per AFE. Ci sei ancora? O sei svenuta per lo shock? Anch’io sono rimasto sorpreso non poco, ma se tu prometti di non avvertirli che si sono sbagliati me ne starò zitto anch’io. Ah ah. La scuola inizia lunedì, quindi fammi un ‘in bocca al lupo’ perché mi servirà eccome. E scrivimi, se vuoi (non c’è fretta, tranquilla). Rafe A: [email protected] DA: [email protected] OGGETTO: Re: Roba da non credere Ciao, Rafe. È fantastico. Congratulazioni! Jeanne Galletta Quel fine settimana mamma mi comprò un abbonamento dell’autobus per poter andare alla Cathedral e tornare. Lei invece avrebbe portato Georgia a scuola in macchina, in un’altra zona della città. Il lunedì mattina, però, disse che voleva accompagnarci tutti e due, solo per il primo giorno di scuola. Credo che fosse più eccitata di me per la Cathedral. «Hai preso l’album?» mi chiese. «Eccolo». «E la penna buona?» «Anche quella». «Vuoi che entri con te?» disse quando ci fermammo davanti alla scuola. «Nah, sono tranquillo». C’era tipo un milione di altri ragazzi sul marciapiede e col cavolo che mi sarei fatto vedere accompagnato da mia madre il primo giorno di seconda media. «Ah, okay. Be’...» Mamma mi stava guardando come fa quando sta per commuoversi. E poi, infatti... «Sai, frequentare la scuola d’arte è sempre stato un mio grande sogno» disse. «Ma anche se non sono mai riuscita ad andarci, oggi... ecco, mi sembra che quel sogno si sia avverato». Temevo che si mettesse a piangere. Se c’è una cosa che proprio mi mette a disagio è quando mamma piange, anche se sono lacrime di gioia. Però in quell’attimo (una volta tanto!) la boccaccia di mia sorella si rese utile. «Dai, dai, MUOVETEVI! Faremo TARDI!» gridò dal sedile dietro, come se nei primi dieci minuti di quinta elementare dessero delle informazioni vitali che non poteva perdersi. «E va bene» disse mamma. «Allora... in bocca al lupo, tesoro!» «ANDIAMOOO!» fece Georgia. «E scendi, Rafe!» Nessun problema. Prima che mamma riuscisse a darmi un bacetto davanti a tutta la scuola, aprii la portiera e mi diedi alla fuga. Poi entrai dritto a scuola per il mio primo giorno da studente d’arte vero e certificato. Qualunque cosa significasse. La prima cosa che vidi appena entrato fu un enorme striscione con la scritta: ‘Benvenuti sul pianeta Cathedral!’ E non per modo di dire. Tutto l’atrio era addobbato con lucine che lampeggiavano come stelle e un mucchio di pianeti e asteroidi di cartapesta appesi al soffitto. Alcuni alunni stavano suonando con dei sintetizzatori della musica tipo quella dei film di fantascienza. Gli insegnanti che erano lì per guidare i nuovi arrivati indossavano costumi fatti di stagnola, come robot alieni. Evidentemente per loro il primo giorno di scuola era una festa. Fu in quel momento che capii di essermi lasciato la scuola media di Hills Village alle spalle di circa ottanta milioni di anni luce. Per iniziare partecipai a una cosa chiamata ‘Orientamento’. Praticamente spiegarono a me e a un altro centinaio di alunni di seconda tutto quello che c’era da sapere sull’anno che avremmo passato alla Cathedral. Dopo che il signor Crawley ebbe finito di dirci quanto dovevamo essere contenti di trovarci lì (e io lo ero eccome!), ci divisero secondo le varie specializzazioni: teatro, musica e arti visive. Il mio gruppo seguì la signora Ling, la direttrice del programma di arte, che ci condusse in una visita guidata della nostra parte della scuola. Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere tutto quello che la signora Ling ci mostrò, sarebbe... una figata totale, ancora di più di quello che mi aspettavo!> Sì, lo so, non è una parola sola, ma fa lo stesso. Non vedevo l’ora di provare a usare quello che avevo intorno. E più cose avevo intorno, più avevo voglia di usarle. Certo, avrei dovuto comunque alzarmi presto cinque giorni alla settimana. Quello era inevitabile. Però la seconda media prometteva bene, bene, BENISSIMO! Solo che naturalmente non fu tutto così facile (e quando lo è?). Dopo la visita guidata, la signora Ling ci fece sedere in un’aula e si lanciò in una tirata. Iniziò con la solita roba sulle regole, sulle lezioni e qualcos’altro che non ricordo perché non stavo proprio seguendo. Ero ancora troppo esaltato dal resto. Poi però, verso la fine, buttò lì la fregatura. «... e quindi, ragazzi e ragazze, sono convinta che ognuno di voi potrà ottenere grandi risultati» disse. «Tuttavia... non tutti gli studenti vengono riammessi alla Cathedral l’anno successivo». La mia attenzione si risvegliò in un attimo. E c’era dell’altro. «Come alcuni di voi già sanno, tutti i nostri alunni specializzandi in arti visive hanno l’obbligo di rinnovare la domanda di ammissione dopo la Mostra di primavera, a marzo. E se nel frattempo non sarete riusciti a tenervi al passo con le lezioni e con i compiti e in più a dimostrare che siete motivati a rimanere qui, per l’autunno successivo vi dovrete trovare un’altra scuola». In altre parole, se non fossi riuscito a trovare un modo per fare questo: ... alla fine dell’anno mi sarebbe successo questo: Se devo essere sincero, fin lì avevo pensato che farmi ammettere alla Cathedral fosse stata una grande impresa da parte mia. Ma ora avevo capito che quella era stata la parte più facile. Entrarci era una cosa. Rimanerci era tutto un altro paio di maniche. Dopo l’orientamento, le prime tre ore della giornata furono matematica, scienze sociali e... Vabbè, ci siamo capiti. Roba noiosa alla scuola d’arte come in qualsiasi altra scuola. Però poi tutti noi di seconda media avremmo avuto due ore d’arte, la quarta e la quinta, tutti i giorni. Cioè dieci ore alla settimana che avrei affrontato molto volentieri, praticamente dieci in più di quelle che avevo a Hills Village. Niente male. La mia prima vera ora d’arte fu quella di disegno, con il signor Beekman. Ve lo descrivo un pochettino. Se mai ci fosse un concorso per l’insegnante più vecchio del mondo, iscriverei proprio il signor Beekman, e magari vincerebbe pure. Parlava con un accento molto raffinato e usava spessissimo termini come «signore e signori». La primissima cosa che ci disse fu questa: La mia prima lezione d’arte era iniziata da meno di mezzo minuto e io ero già confuso. Stavo ancora cercando di capire la frase, quando il signor Beekman accese il proiettore e ci mostrò il disegno di un cavallo bello in carne. O almeno immaginai fosse un cavallo: in quel momento non ero sicuro di nulla. «Ventitremila anni fa, qualcuno disegnò quest’immagine sulla parete di una grotta» disse. «Secondo voi come si chiamava l’artista?» «Era lei?» bisbigliò qualcuno, troppo piano perché il signor Beekman riuscisse a sentirlo. «La risposta, ovviamente, è che ci è impossibile saperlo. Anche così, però, queste immagini primitive sono in grado di dirci parecchio sulle persone che le avevano dipinte, sugli animali che cacciavano, sulle storie che si raccontavano, sugli elementi del loro mondo e sui loro oggetti quotidiani. Non vi sembra?» A me per niente. Poi il signor Beekman si voltò e scrisse alla lavagna: arte = vita = arte. «Nel mio corso vi insegnerò quali sono i materiali giusti da usare, come dare qualità al vostro tratto, la composizione... tutte le tecniche che vi serviranno come artisti. Il resto però dipende da ciò che riuscirete a tirare fuori». Ormai si era fatto prendere e passeggiava per tutta l’aula. Improvvisamente non sembrava nemmeno più così vecchio. «Che cos’è che vi affascina? Quali esperienze di vita avete avuto finora? Che cosa vi rende quelli che siete? Perché è questa, signore e signori, la vera essenza dell’arte!» «Io fra un attimo vomito la vera essenza della colazione» disse lo stesso tizio di prima. Mi voltai. Era seduto nelle ultime file, come me, e si stava disegnando un tatuaggio finto sul braccio. Dovrei dire anche che era vestito in modo strano, ma quello era il pianeta Cathedral e lì ‘strano’ voleva dire ‘normale’. Intanto Beekman andava avanti. «Detto questo, il vostro primo compito dell’anno sarà un autoritratto» disse. Poi scrisse ancora alla lavagna: chi siete? «Voglio che rispondiate con le vostre opere. Poi domani, in classe, faremo la nostra prima ‘sessione krit’. Ricordatevi, signore e signori... mettete vita nella vostra arte e la vostra arte prenderà vita». Non avevo capito nemmeno la metà di quello che aveva detto, ma tutti gli altri facevano sì con la testa belli convinti. Per esempio, cosa cavolo significava ‘krit’? Fu allora che capii che forse mi ero perso più di un semplice anno scolastico, in quel posto. Avevo perso tempo, e dovevo recuperare. Quella sera restai alzato fino a tardi per fare tutti i compiti. No, non siete finiti chissà come in un altro libro. Sono sempre io, Rafe K. È solo che avevo pensato che il primo giorno di scuola fosse un tantino presto per cominciare a rimanere indietro. Anche così, però, quando riuscii finalmente a spegnere la luce per cercare di dormire, non riuscii a smettere di pensare a tutto quanto. Non immaginavo che la scuola d’arte potesse essere così complicata. Pensavo fosse... una scuola d’arte e basta, ecco. E invece mi ritrovavo a dovermi preoccupare di un sacco di altra roba. Tipo come non farmi buttare fuori, per esempio. E nel frattempo come farmi una vita. «Ah, questa è una missione per me» disse subito Leo. «Quando vuoi cominciare?» Il problema di Leo è proprio questo: non esiste un pulsante per spegnerlo. Per lui qualsiasi momento è buono per darsi da fare. E poi ha un debole per le missioni. L’ultima si chiamava Operazione R.A.F.E., cioè ‘ Regole Assurde Finirete Eliminate’, e mi aveva fruttato una bella estate di corsi di recupero. «Calma» gli dissi. «Non posso ricacciarmi subito nei guai. L’ho promesso a mamma». «No, a te stesso» mi ricordò. «E poi chi ha parlato di guai? Io intendevo qualcosa di meglio. Di più grande!» «Tipo?» «Tipo la vita vera! Tipo la storia della ‘essenza dell’arte’ di cui parlava Beekman! Magari essere un artista è qualcosina di più che frequentare la Cathedral tutti i giorni e dormire su ’sto divano tutte le sere, no?» Sì, su quello non potevo discutere. Però... «E allora? Dovrei ‘farmi una vita’... così, in generale?» «Sei messo già meglio di quanto credi. Puoi fare tutto quello che vuoi. Viaggiare in metro facendo la verticale, mangiarti tarantole ricoperte di cioccolato, vederti dodici film di fila... se è una cosa che non hai mai fatto prima, finisce automaticamente sulla lista». «Ehi, ehi, un attimo... c’è una lista?» «Possiamo chiamarla Operazione ‘Fatti una vita’. Che ne pensi?» Un’altra cosa di Leo è che è sempre un passo e mezzo avanti rispetto a me. «Penso che tanto non sei tu quello che poi deve metterla in pratica. Hai fatto caso a tutti questi compiti? Be’, non posso iniziare adesso una nuova operazione». «O forse» disse Leo «non te lo puoi permettere. Ti ricordi cos’ha detto la signora Ling? ‘Non tutti gli studenti vengono riammessi’. Certo, a meno che tu non stia cercando di stabilire un record di espulsioni dalla scuola media...» Non sapevo cosa dire. Mi girai a pancia in giù e infilai la testa sotto il cuscino. Non pensavo che Leo avesse torto. Era solo che dopo una giornata così mi sentivo il cervello come un fungo ripieno. Non c’era spazio per nient’altro. «Be’, adesso io dormo» dissi. «Guarda, ne dubito». E, naturalmente, aveva di nuovo ragione. Il giorno dopo scoprii il significato di ‘krit’. È un gergo delle scuole d’arte, sta per ‘critica’ (ovviamente) e consiste nell’esporre il tuo lavoro davanti a tutta la classe, che poi lo discute. Più o meno come finire davanti al plotone d’esecuzione. No, senza il ‘più o meno’. Pensai che se mi fossi seduto in ultima fila, se avessi tentato di mimetizzarmi rimanendo immobile, magari il signor Beekman non mi avrebbe chiamato. Ma verso la fine della quinta ora la fortuna mi fece ciao-ciao. «Mmm... Rafe Khatchadorian» disse, guardando il registro. «Il nostro nuovo alunno. Vediamo cosa ci ha portato, eh?» Venne verso di me, prese il mio autoritratto e andò ad attaccarlo su una delle bacheche, davanti a tutti. «Bene, signore e signori, voglio i vostri commenti. Che cosa vi dice questo ritratto del suo artista?» Subito Zeke McDonald alzò la mano. Non lo conoscete ancora, quindi ve lo dico io: lo odio, Zeke McDonald. Lui e tutti i suoi amici. Avete presente il genere, no? Quelli che vanno in giro per la scuola come se avessero sulla testa una corona invisibile? Ecco, sono loro. Zeke era bravo praticamente in tutto, e lo sapeva. E passava la maggior parte del suo tempo ad assicurarsi che anche gli altri lo sapessero. Certo, ero appena arrivato alla Cathedral ed era troppo presto perché qualcuno mi stesse antipatico, ma ero sulla strada buona. «Signor Beekman...» attaccò. «Rafe non era dei nostri l’anno scorso… dovremmo tenerne conto in questa sessione d i krit? Per esempio, il fatto che la sua tecnica sia così... insomma... rudimentale?» «La critica è sull’opera in sé» disse Beekman. Non ero sicuro di cosa intendesse con quella frase, ma evidentemente c’entrava col farmi a pezzettini, perché subito anche la mano di Kenny Patel scattò in alto come una fetta di pane dal tostapane (Kenny era seduto in prima fila accanto a Zeke, e non serve aggiungere altro). «Sinceramente non credo che il ritratto ci dica molto di Rafe, se non che aspetto ha» disse. Poi si voltò e mi guardò come se avessi i capelli pieni di cacchette di cane. «Be’, forse neanche quello» aggiunse. Molti scoppiarono a ridere. «Signore e signori, vi ricordo che le vostre critiche devono essere rispettose» disse Beekman con circa cinque secondi di ritardo. «Se non avete niente di costruttivo da aggiungere, tenetevi per voi i vostri commenti. C’è qualche altra osservazione positiva? Che cosa vi piace nel disegno di Rafe?» E nessuno… disse… una parola. Mi sembrò di sentire uno spillo cadere. E forse anche qualche grillo. E anche il rumore della mia faccia che diventava rossa come un segnale di stop. Se in quel momento avessi scoreggiato forte, la cosa mi avrebbe imbarazzato meno di quel silenzio. Alla fine, per fortuna, Beekman parlò di nuovo. «Penso sia un buon inizio, signor Khatchadorian. Ha una mano sicura e si vede. Però credo che lei si stia trattenendo. La prossima volta vorrei vedere un po’ più di Rafe, mi capisce?» «Certo» risposi, ma sinceramente gli avrei persino detto che portavo delle mutandine da ragazza, se fosse servito a far finire più in fretta quella krit. E poi, proprio quando Beekman si voltò per andare finalmente a staccare il disegno dalla bacheca, il buon vecchio Zeke McDonald alzò il suo album e lo fece vedere a tutti. Mi aveva fatto lui un ritratto, ma state certi che non mi piacque per niente. Ho sentito dire che ogni tanto nel terreno si aprono improvvisamente delle voragini che inghiottiscono quelli che passano. Non so quanto spesso succeda, ma in quel momento avrei voluto che succedesse subito. O almeno prima di dover affrontare un’altra krit. Se vi dicessi che dopo la lezione andai dritto al mio armadietto, presi il mio pranzo, me lo portai in bagno, gettai l’autoritratto nel water, tirai l’acqua e poi mangiai il panino seduto sulla tavoletta mi dareste dello sfigato? Eh, lo immaginavo. Per me i bagni della scuola sono come un rifugio antiaereo. Non ci puoi stare sempre, ma ogni tanto sono utili. «E adesso che si fa?» disse Leo. «Quello che vedi». Forse facevo ancora in tempo a trasferirmi in una scuola media più accogliente, magari in un quartiere con un nome tranquillo e carino tipo ‘Tritatutto’. «Sul serio? Ti arrendi? Lo sai cosa direbbe Jeanne Galletta, vero?» Lo sapevo, sì. Avrebbe detto: «Non fartela addosso, datti una mossa». È la sua espressione preferita. Facile a dirsi. Per lei l’idea di una giornata storta è prendersi una A–, oppure arrivare in mensa quando il latte al cioccolato è già finito. Però devo ammettere che la sa lunga. E anche Leo, se è per questo. Sapevo benissimo che cosa stava pensando: che l’Operazione ‘Fatti una vita’ diventava più probabile, ma anche più necessaria, ogni secondo che passava. «Okay, ci penserò su». «E vai!» «Per ora ci penserò e basta. Non voglio prendere impe...» La porta dei bagni si aprì ed entrò qualcuno. Smisi subito di parlare e alzai i piedi. Non volevo far sapere a nessuno che stavo facendo la pausa pranzo chiuso lì a tenere il broncio. Anzi, non volevo far pensare che stessi facendo la pausa pranzo chiuso lì, punto. Subito dopo sentii scorrere l’acqua in un lavabo. Il tizio, che non vedevo, la lasciò aperta per un sacco di tempo. Stavo già cominciando a pensare che sarei rimasto bloccato lì fino alla sesta ora quando finalmente chiuse il rubinetto. Feci un mezzo sospiro di sollievo, ma mi fermai quando il tizio si avvicinò ed entrò nel cubicolo accanto. Un attimo dopo sentii una voce. Non accanto a me, ma sopra di me. «Ehi». Alzai lo sguardo, ed era il ragazzo del corso di disegno, quello col tatuaggio finto. Era in piedi sul water, immagino, e si sporgeva da sopra il divisorio. «Cosa fai?» gli dissi. «Tornatene dalla tua parte!» «Esiste un termine per quello che ti hanno fatto, sai?» «Eh? Un nome per cosa?» «Durante la krit. Ti hanno ‘smorzato’. Niente di personale, eh. In questa scuola è quasi uno sport. E Zeke McDonald è il capitano della squadra». Smorzato, krit... era come se sul pianeta Cathedral parlassero davvero un’altra lingua. «Capito» dissi. «Ehm... grazie». Non sapevo proprio cosa aggiungere. Il ragazzo se ne stava lì fermo a guardarmi. «Nient’altro?» «Be’, sì». Mi fece vedere una cosa che mi sembrò un palloncino. In realtà era un guanto di lattice preso da una delle aule d’arte, riempito d’acqua e annodato. Ero certo che me l’avrebbe tirato in faccia. E invece lui mi fece un sorriso diabolico e disse: «Cosa ne dici di una piccola vendetta?» C’erano tantissimi motivi per non farlo. Non potevo permettermi di finire nei guai. Mamma mi avrebbe ucciso se fosse venuta a saperlo. Non sapevo neanche se mi potessi fidare di questo ragazzo. Però una parola mi era piaciuta: vendetta. Lui neanche aspettò una risposta. Uscì dal cubicolo e poi dalla porta dei bagni, senza fermarsi, mentre io rimasi lì come un fesso a decidere che cosa fare. Così decisi di seguirlo, dato che seguire qualcuno fuori dai bagni non era contro le regole. Lui mi stava aspettando in fondo al corridoio, vicino a una porta che dava su una rampa di scale. «Dove stai andando?» chiesi. La scuola era come un labirinto e io non mi ci orientavo ancora. «Di sopra». In cima trovammo altre due porte. Una era collegata all’allarme antincendio, ma l’altra si apriva senza problemi. Entrammo in un grande sgabuzzino per i bidelli, con una finestra che dava sul tetto. C’era una grata di ferro con la serratura, che era già stata rotta. E io avevo una mezza idea di chi fosse stato a romperla. Il ragazzo aprì la grata, tirò su la finestra e scavalcò. «Ehm... credo che sia vietato salire sul tetto...» «Ehm... io non vedo nessun cartello. Allora, vieni?» Sapete cosa vi dico? Se al posto mio foste riusciti a voltarvi e a tornare giù dalle scale, allora siete molto migliori di me. Strisciammo quatti quatti fino alla parte opposta del tetto e ci fermammo al riparo del muretto, proprio sull’orlo. Era come essere in battaglia... o almeno in una tiratissima partita di paintball. Lui alzò due dita e mi fece segno di guardare oltre il muretto. E guarda caso sotto c’erano Zeke e Kenny, seduti in cima agli spalti come sul loro personalissimo trono. Il mio cuore nel frattempo si era messo a suonare un assolo di batteria, ma mostrai lo stesso tutti e due i pollici al ragazzo. Lui aprì lo zaino e mi passò due di quei guanti-gavettone. Poi ne prese altri due per sé. Vidi che ci aveva disegnato sopra degli occhi iniettati di sangue, con dei pennarelli indelebili rossi e neri. Si era anche firmato con quelle che immaginai fossero le sue iniziali: MIF. Ciò che non sapevo ancora era che il ragazzo aveva un soprannome fantastico, come pochi al mondo. Alla Cathedral tutti lo chiamavano Matty il Freak. Piacere di conoscerla, signor Freak. Poi prese un pezzettino di filo di ferro e fece un foro minuscolo in ognuno. «Per essere sicuri che si rompano, invece di rimbalzare» disse. Quello fu praticamente il punto di non ritorno, come accendere una miccia. Un attimo dopo Matty il Freak stava già lanciando i gavettoni oltre il muretto. E l’attimo dopo ancora li stavo lanciando anch’io. Non vidi cosa succedeva di sotto, ma lo sentii eccome: quattro forti ‘splash!’ e un bel po’ di urla. Noi intanto stavamo già tornando indietro di corsa. Scavalcammo di nuovo la finestra e ci sedemmo sulle scale per poter sghignazzare un po’ in privato. «Grandissimo!» esclamai. «Be’, è l’essenza dell’arte, no?» Non immaginava neanche quanto avesse ragione. L’Operazione ‘Fatti una vita’ era ufficialmente iniziata. Anche quella sera restai sveglio fino a tardi, ma non per fare i compiti. Visto che l’Operazione ‘Fatti una vita’ sarebbe partita davvero, Leo e io dovevamo studiare che forma darle. L’idea di base era semplicissima. Decidemmo che per la missione avrebbero contato solo le cose che non avevo mai fatto prima. Tutto lì. Al contrario dell’altra volta, niente punti, niente bonus, niente vite da perdere. Se fossi riuscito a farmi riammettere alla Cathedral per l’anno successivo, missione compiuta. Altrimenti... be’, tanto valeva fare il passaporto per Sfigaland. Come seconda cosa diedi un’occhiata al calendario. Mancavano centonovantacinque giorni alla Mostra di primavera a scuola, il 23 marzo. Subito dopo avrei dovuto ripetere la domanda di ammissione per conoscere il mio destino. Così decisi di fare centonovantacinque cose mai fatte prima, almeno una al giorno. Centonovantacinque occasioni per farmi una vita. «E faccio tornare valida la Regola Non Far Male A Nessuno» dissi. «Come l’anno scorso. Nessuno si deve far male per colpa mia. Se succede, è game over». «Va bene, ma i gavettoni di oggi valgono lo stesso» chiarì Leo. «Quando li hai tirati in testa a Zeke e Kenny, la regola non era ancora tornata in vigore». Mi andava bene, tutto sommato. Però avevo qualche altra condizione da far valere. «Stavolta metto anche me stesso nella regola. Se mi becco una settimana di reclusione a scuola, è una settimana di pausa. Se mi sospendono, game over anche qui. E soprattutto, se mamma scopre qualcosa...» «Seh, seh, capito. Game over» disse Leo. «Non ne posso già più». Su quello però non avevo intenzione di cedere. L’ultima cosa di cui mamma aveva bisogno era dover ricominciare a preoccuparsi per me. E l’ultima cosa di cui avevo bisogno io era farle sospettare che avessi ricominciato a mettermi nei guai. Anche se non era vero. Tecnicamente questa missione era l’esatto opposto di quella dell’anno prima. L’idea allora era stata di infrangere più regole scolastiche possibile. Stavolta invece si trattava di non farmi cacciare dalla scuola, ma temevo che mamma non l’avrebbe vista in questo modo. Dopo quello che era successo in prima media, ero più che sicuro che mi avrebbe abbandonato in un orfanotrofio se avesse di nuovo sentito la parole ‘missione’ e ‘Rafe’ nella stessa frase. «E allora dovremo fare in modo che non lo scopra» disse Leo. «E neanche Georgia, perché ha una boccaccia grande come questa città». Anche quello mi andava bene. Nessuno si sarebbe fatto male, nessuno l’avrebbe saputo, nessun problema. E quindi... azione! Il secondo giorno dell’Operazione ‘Fatti una vita’ iniziò alla grande. Appena prima di continuare male e di finire ancora peggio. Ma iniziamo dalla parte buona: per andare a scuola, mamma mi lasciò prendere l’autobus da solo per la prima volta. E non parlo dello scatolone giallo che ci scarrozzava in prima media, ma di un vero autobus urbano. Era una sensazione strana (in senso positivo) attraversare così la città, da solo. Continuavo a guardare le mille persone attorno a me e pensavo: ‘Sono uno di loro!’ Rafe Khatchadorian, un ragazzo di città: chi l’avrebbe mai detto, anche solo qualche mese prima? Così quando arrivai a scuola avevo già fatto almeno una Cosa Nuova Quotidiana ancora prima di iniziare la giornata. Se fosse andata avanti così, avrei completato la missione a occhi chiusi. Poi però arrivai all’armadietto (e qui iniziò a mettersi male). Da fuori sembrava a posto, ma quando feci scattare il lucchetto e aprii lo sportello vidi che durante la notte una qualche creatura aliena ci si era intrufolata, aveva ingoiato una bomba a mano e si era fatta esplodere. Okay, era solo vernice verde, ma... il mio libro di scienze sociali era diventato verde, i miei album verdi, la mia roba da ginnastica verde. E tutto grondava, tutto era appiccicoso, tutto faceva davvero schifo. Qualcuno aveva trovato il modo per pompare dalle fessure dello sportello almeno quattro litri di vernice. Con ‘qualcuno’ intendo Zeke McDonald e Kenny Patel, chiappa destra e chiappa sinistra della scuola d’arte Cathedral. Mi guardai intorno ed erano proprio lì, ai piedi delle scale. Zeke aveva il cellulare puntato verso di me e tutti e due scoppiarono a ridere quando si accorsero che li avevo visti. Poi se ne andarono. ‘La vendetta funziona a doppio senso, d’altronde’ pensai. Forse quei gavettoni non erano stati una grande idea. E non era finita. Ero ancora lì che pensavo a come avrei fatto a sverniciare l’interno dell’armadietto quando dagli altoparlanti si diffuse un messaggio, e la parte della mia mattinata che era andata male fece spazio a quella ancora peggiore. Cinque minuti dopo entro a tentoni nella tana del Ragno Crawley, nelle viscere del pianeta Cathedral. È buio, troppo buio per riuscire a vedere dove metto i piedi. Da qualche parte sgocciola dell’acqua e nell’aria c’è un cattivo odore, come di un panino col formaggio andato a male... e di morte. Tasto coi piedi mentre avanzo. «Ehi...» dico. «C’è nessuno?» «Buongiorno» risponde una voce dall’ombra. «Accomodati». Faccio un altro passo, ma è un passo di troppo. Il terreno mi scompare sotto i piedi e un attimo dopo precipito nel vuoto. Atterro su qualcosa di morbido, ma appiccicoso. Lunghi fili, come corde ricoperte di supercolla, mi si attaccano a gambe e braccia e non mi lasciano andare. Mi dimeno, ma è peggio. Prima ancora di poter reagire, sono già intrappolato nella tela del Ragno Crawley. Qui sotto non si prende nemmeno la briga di assumere sembianze umane. Perché dovrebbe? Ora sono nel suo territorio... e in suo potere. Un solo colpo di quelle chele affilate come rasoi e potrebbe bermi il sangue come una spremuta d’arancia. «Come stai, Rafe?» mi chiede, serafico come un angioletto con otto zampe al posto delle ali. «Abbastanza bene». È importante che rimanga calmo anch’io. Si dice che il Ragno Crawley riesca a fiutare la paura anche a un chilometro di distanza. Si dice anche che gli piaccia giocare con le sue prede, prima di mangiarle. «Vorrei parlarti di un piccolo incidente che si è verificato ieri» dice. «C’erano di mezzo dei gavettoni». ‘Non gavettoni, ma guanti di lattice’ penso. Ma non sono certo stupido. Meno dico, qui, meglio è. «Ne sai qualcosa?» continua. «Ne ho sentito parlare». «Tutto qui? E quindi non sai chi potrebbe essere il responsabile?» «No». C’è una sola arma che posso usare in questa situazione e si chiama ‘negare tutto’. Finché il Ragno Crawley non ha le prove, ho ancora una minima possibilità di uscire vivo da qui. Comincia a girarmi intorno. Io ho la testa praticamente mummificata e non posso voltarmi, così lo perdo di vista per un minuto. Quando lo rivedo ha qualcosa in mano. «Sai che cos’è questo, Rafe?» All’inizio mi sembra una cartellina qualsiasi. Poi però ci leggo sopra il mio nome e le parole ‘Scuola media di Hills Village’. «A quanto pare hai avuto un anno movimentato, in prima. Ti sei messo un po’ nei guai sul tuo pianeta natale, vero?» Cerco di farmi venire in mente in fretta qualcosa da dire. «È stato tutto un equivoco. Da allora sono cambiato. Ho voltato pagina. Non sono più quello che...» Sto parlando troppo. Si capisce che non ci casca. Vorrei guardarlo negli occhi, ma è difficile, perché ne ha sei. «Te lo chiedo ancora una volta, Rafe... sei sicuro di non saperne niente?» «Sicurissimo! Giuro!» Sulla tana cala il silenzio. Lui mi squadra a lungo. L’unico rumore udibile è il ticchettio delle sue chele, pronte a farmi a pezzettini da un momento all’altro. Poi però il Ragno Crawley alza una zampa e trancia i fili della sua ragnatela. Un attimo dopo crollo a terra. «Puoi andare» dice. Io sono già in piedi e sto correndo verso la luce più veloce che posso. «Ma ti tengo d’occhio, Rafe!» mi grida dietro. «Non voglio pensare a cosa potrebbe succedere se finirai di nuovo qui dentro!» ‘Siamo in due’ penso. Quando uscii dall’ufficio del signor Crawley, tutto era cambiato. Non ero più il nuovo alunno arrivato da fuori. Ero diventato il nuovo casinista, almeno per lui. Non capivo perché andasse sempre a finire così. Non sono mai stato bravo a fare il bravo, se mi passate la battuta, ma a volte mi sento come se tutti i guai del mondo fossero di ferro e io fossi una grossa calamita ambulante. Potrei anche cambiare scuola ogni due settimane e non farebbe nessuna differenza. Tanto varrebbe tatuarmi le note disciplinari sulla fronte. E poi, proprio quando mi ero convinto che la mia mattinata non potesse diventare ancora più bizzarra, lo diventò. Ero in corridoio e stavo andando verso l’aula della prima ora quando mi sentii afferrare da dietro. Un attimo dopo mi tirarono in una specie di sgabuzzino, la porta si chiuse e mi ritrovai al buio. Non aspettai che parlassero e cominciai a tirare pugni alla cieca. Se erano Zeke e Kenny, tanto valeva fare più danno possibile prima che riuscissero a prendermi. Poi però sentii: «Ahi! AHIA! E piantala! Sono io, Matty!» «Eh?» Mi fermai col pugno a mezz’aria. «Ma cosa fai?» «Volevo sapere perché ti avevano mandato dal preside» disse, come se fosse normalissimo fare un discorso del genere in uno stanzino buio. D’altronde, per quanto potevo saperne, forse per Matty era normale. «Secondo te? In pratica Crawley sa che ho tirato io quei gavettoni dal tetto». «Erano guanti di lattice». «Vabbè, è lo stesso». «E tu cosa gli hai detto?» «Niente. Non aveva nessuna prova, perciò ho tenuto la bocca chiusa e basta». Sarà assurdo, ma giuro che in quel momento sentii Matty sorridere nel buio. «Grandissimo!» «Per te, magari. Intanto però Zeke e Kenny mi hanno distrutto l’armadietto». Lì non mi fu difficile sentirlo ridere, invece. «Non farci caso, a loro. Per quella piccola guerra abbiamo ancora un sacco di tempo». «Io non voglio guerre, né piccole né grandi. Voglio solo arrivare in aula per la prima ora. Da adesso in avanti Crawley non mi toglierà più gli occhi di dosso, peggio di un canale craccato della pay tv!» «Va bene, va bene». Matty aprì un poco la porta e controllò il corridoio. «Comunque sono in debito con te. Se mai cambiassi idea, ti copro io». Solo mentre me ne stavo andando capii che forse da quella faccenda sarebbe potuto anche uscire qualcosa di buono. A meno di non essermi sbagliato di grosso, avevo fatto amicizia con un essere umano in carne e ossa per la prima volta dall’inizio delle medie (no, Jeanne Galletta non conta: primo, era la mia tutor di matematica; secondo, anche se era una cosa amichevole, non eravamo amici, soprattutto secondo lei). Matty aveva detto ‘ti copro io’. Doveva per forza significare qualcosa, no? Salto in avanti! Se mettessi per iscritto tutto quello che è successo in quel primo trimestre alla Cathedral, per portarvi dietro questo libro avreste bisogno di una carriola. Quindi ora salterò qualcosina. Per farla breve: mi ci è voluto un sacco di tempo soltanto ad abituarmi alla nuova scuola, alla nuova casa e alla nuova città. Però ho imparato molto, quasi sempre andando a sbattere contro i muri. Di seguito vi do qualche consiglio, nel caso vi capitasse di trovarvi nella stessa situazione. UNO Se siete l’unico maschio in una casa piccola con una nonna, una madre e una sorella, ho un solo consiglio da darvi: imparate a essere pazienti. E a muovervi molto in anticipo, ovvio. DUE L’arte non è uno scherzo! È piena di regole, proprio come qualsiasi altra materia. Se non mi credete, provate a tenere il pennello nel modo sbagliato durante una lezione della signora Grundewald e poi mi direte. TRE La scuola d’arte è fatta per gli intelligentoni. Secondo me quasi tutti gli alunni di questa scuola sono nati con un libro di matematica in una mano e un cervello extra nell’altra. Perciò se siete una zucca vuota come me non aspettatevi di amalgamarvi. (E nel caso ve lo chiedeste, sì, è vero, tutti i grandi artisti del passato andavano bene in matematica. Almeno è quello che mi ha detto il signor Frum quando gliel’ho chiesto io.) QUATTRO Volete vivere in una grande città? Allora dovete essere tosti. Qui vi camminano sopra, se li lasciate fare... e quindi non lasciateglielo fare! CINQUE Ma perché mi date retta? Se finora siete stati attenti, ormai sapete che la cosa migliore è osservarmi per bene e poi fare l’esatto opposto di quello che faccio io, perché la mia strada porta a un sacco di grane. Non dite che non vi avevo avvertito. Capito? Bene. Prego, eh? Quando uno si ritrova in una nuova casa e una nuova scuola in una nuova città, scopre che non è poi così difficile fare nuove esperienze. A me capitavano anche senza che me le andassi a cercare, e per la mia missione andava benissimo. Nel frattempo eccovi alcuni degli alti, dei bassi e dei medi dell’Operazione ‘Fatti una vita’. Non dico che cinque C e un B– facessero di me un genio, ma erano i voti migliori che avessi mai preso. Essendo sempre a casa, mamma poteva aiutarmi con i compiti e controllare che finissi tutti gli esercizi, anche quando non ne avevo voglia. E l’Operazione ‘Fatti una vita’ andava sempre meglio. All’uscita delle pagelle avevo già accumulato cinquantotto cose fatte e me ne mancavano centotrentasette. Qualcosa di buono, evidentemente, lo stavo facendo. Leo però non era d’accordo. «Devi darci dentro, con questa missione» mi disse. «È ora di pensare più in grande». «Ma come? Ho già una lista lunghissima!» «Si chiama Operazione ‘Fatti una vita’, non Operazione ‘Finisci una lista’. E tanto sono tutte lezioni a cui saresti dovuto andare comunque, oppure passeggiate che fai in città con tua madre. Che ti tiene al guinzaglio, fra l’altro. Non ti stai neanche sforzando di rendere interessante il gioco». «Oh, cavolo. Ci risiamo». Leo fa così. Lui lo chiama ‘rendere interessante il gioco’, io lo chiamo una rottura di scatole. «Nuova regola» disse. «Da oggi in poi ogni dieci cose normali devi fare almeno una cosa grandiosa. Altrimenti niente credito per le cose normali». «Un attimo... in che senso ‘cosa grandiosa’?» Figurarsi se non aveva una risposta pronta, come sempre. «Tanto per cominciare, dev’essere una cosa che ricorderai finché vivi». «Ah, tutto qui?» «Be’, no. Non può essere roba che fai a scuola e non ci dev’essere nessun adulto che sbircia mentre la fai». Oltretutto dovevo tenere conto anche della Regola Non Far Male A Nessuno. E le cose da fare avrebbero dovuto essere gratis, perché non avevo soldi. Eppure Leo aveva ragione. Perché ne valesse la pena, questa operazione andava condotta bene. Era arrivato il momento di salire di livello. Solo che non avevo ancora idea di dove avrebbe potuto portarmi tutto questo. E poi, solo qualche giorno dopo, la signora Ling ci assegnò il lavoro con i materiali di scarto. «Guardate questa» disse la signora Ling, e ci mostrò la foto di un bidone della spazzatura. «E adesso questa». «E questa. E questa». «Molto spesso il compito di un artista è quello di mostrare al mondo qualcosa di conosciuto, ma in un modo completamente nuovo. Come compito per la settimana voglio che prendiate un oggetto che per chiunque altro sarebbe spazzatura e lo facciate rivivere come opera d’arte». Lì compresi che ormai mi ero ambientato alla Cathedral, perché avevo finalmente capito quello che la signora Ling aveva detto. L’idea di prendere qualcosa e dargli una nuova vita mi piacque subito. Era un po’ quello che stavo facendo con me stesso. Come al solito ero seduto in fondo, con Matty. Lui stava già buttando giù idee a mille, ma poi scrisse qualcosa in un angolo della pagina, lo strappò e me lo passò. Dopo la lezione mi disse che conosceva un sacco di posti dove la gente di solito buttava roba decente. «E possiamo prenderla tranquillamente? Sei sicuro?» «Rilassati. Cerchiamo spazzatura, non stiamo rapinando una banca» disse. «Tu ti preoccupi troppo, sai?» Lo trovai buffo, perché quasi tutti invece pensano che io non mi preoccupi abbastanza. Mi lasciò usare il suo cellulare per chiamare mamma. Le dissi che dopo la scuola sarei stato impegnato su un compito e lei la prese benissimo. Mi chiese soltanto se volevo che venisse a prendermi più tardi. «No, torno in autobus» risposi. Tecnicamente non avevo detto una bugia. Solo non avevo detto dove sarei andato, un po’ perché pensavo che mamma non avrebbe apprezzato e un po’ perché nemmeno io lo sapevo. Non ero neanche sicuro di come si facesse di preciso un tuffo nei bidoni, però dava l’idea di essere divertente. E dava anche l’idea di essere una delle cose di cui la mia lista aveva bisogno, secondo Leo. E infatti fu così. Quando la sera tornai a casa, la prima cosa che pensai fu: ‘OH, CAVOLO, CI SONO STATI I LADRI!’ L’armadio nell’ingresso era aperto, il pavimento era tutto ricoperto di roba e la casa di nonna era nel caos più totale. Be’, più del solito. «Rafe? Sei tu?» gridò mamma. «Siamo di qua!» Seguii la roba sparsa sul pavimento come le briciole di Hänsel e Gretel e arrivai in cucina. Erano là tutte e tre. Mamma stava cacciando delle pile di giornali in un sacco della spazzatura, Georgia girava a fatica in un paio di scarpe col tacco alto, nonna era seduta al tavolo e guardava delle vecchie foto prese da una scatola da scarpe. «Ma cosa fate?» «Le pulizie di primavera!» rispose nonna. Eravamo a novembre. «Era ora di svuotare questi armadi e fare un po’ di spazio per voi tre». Belle notizie, volendo, perché io stavo usando la valigia come cassettiera e il grosso della nostra roba era in un box a Hills Village. Ma in realtà non erano poi così belle. Mamma aveva intenzione di trovare un lavoro in modo che potessimo trasferirci tutti e quattro in un appartamento più grande. Il lavoro però non era ancora arrivato e con quelle pulizie era evidente che non saremmo andati da nessuna parte. Mamma stava pensando la stessa cosa, glielo leggevo in faccia. «Vi ho mai fatto vedere le mie vecchie foto, ragazzi?» disse nonna. «Su, venite qui. Facciamo partire la macchina del tempo! Guardate com’era carina vostra madre da piccola!» Georgia si avvicinò, ma io continuai a osservare mamma. Dal modo in cui ci ficcava dentro la roba, mi aspettavo che il sacco si sfondasse da un momento all’altro. «Anche questa è una bella foto» disse nonna. «Guarda, Jules. Siete tu e Ralph di fronte al Salone Capello». Quello mi fece drizzare le orecchie. Avevo sempre pensato che nonna si riferisse a me quando diceva ‘Ralph’, ma poi vidi la foto. «E quello chi è?» chiese Georgia. «È papà» le risposi io. «Solo che pensavo si chiamasse Luca». «Sì, infatti» disse mamma. Stava ancora riordinando e non aveva nemmeno alzato gli occhi per guardare la foto. «Ralph è il suo secondo nome». «Ah. Non lo sapevo». Però questo spiegava diverse cose, tipo perché nonna continuava a chiamarmi così. Significava che era solo un po’ matta e non completamente fuori. Nella foto mio padre stava abbracciando mamma e tutti e due erano molto giovani, forse ancora alle superiori. Non l’avevo mai vista prima. In realtà non avevo mai visto molte foto di mio padre. Credo che mamma le avesse buttate via tutte quando lui se n’era andato. Ormai non lo nominavamo quasi più. Era un argomento delicato e ogni volta che facevo qualche domanda al riguardo, mamma rispondeva sempre allo stesso modo: «La storia è breve e la sai». Dopo un po’ avevo imparato la lezione e avevo smesso. E più o meno la storia breve era questa: mio padre se n’era andato quando io avevo quattro anni e Georgia due, più o meno un anno dopo che Leo era morto. Da allora non avevamo più saputo niente di lui. Chiuso. Fino a quel giorno, almeno. «Sai se Capello è ancora aperto?» le chiese nonna. «Era su Calumet Avenue, no?» Per un attimo sembrò che mamma volesse dire qualcosa. Poi invece posò il sacco per terra, fece un respiro profondo e uscì dalla cucina. Qualche attimo dopo sentii la porta del bagno chiudersi, al piano di sopra. «Ma cos’è successo?» chiese Georgia. «È arrabbiata?» Nonna prese in braccio mia sorella. «Credo che per mamma sia una giornata un po’ storta» le disse. «Tutto qui». Ma non era tutto lì. Non per me. Avevo appena capito quale sarebbe stata la mia prossima sfida grandiosa. E Capello mi sembrava il posto migliore da dove partire. Magari vi sembrerà strano, ma prima di quel giorno non è che avessi passato poi tanto tempo a pensare a mio padre. Per gran parte della mia vita, semplicemente, non era esistito. Dopo aver visto quella foto, però, non riuscivo a smettere di pensare a lui. Com’era adesso fisicamente? Viveva ancora in città? Era ricco? Era povero? Si ricordava di noi, ogni tanto? Quella sera restai sveglio fino a tardi, a disegnare sul mio album e a parlare con Leo. «Secondo te cosa succederebbe se lo trovassi?» «Non lo so, ma la missione ti darebbe una tonnellata di crediti». A volte Leo ragiona a senso unico. «E se lo cerco ma alla fine non lo trovo?» «E se la smettessi di fare domande e cominciassi a mettere giù un piano?» E così non appena sentii nonna spegnere la tv, di sopra, scesi dal letto e andai al computer. Il Salone Capello non aveva un sito web, ma trovai comunque l’indirizzo: 3921 Calumet Avenue. Lo evidenziai su una mappa e tossii forte mentre la stampavo, giusto nel caso mamma fosse stata ancora sveglia. Poi piegai il foglio, lo misi in fondo allo zaino e cercai di dormire un po’. Nemmeno quello fu facile. Oltretutto mi misi a pensare anche alla domanda che il signor Beekman aveva scritto sulla lavagna il primo giorno di scuola: ‘Chi siete?’ Se avessi potuto saperne di più su mio padre, forse avrei potuto saperne di più anche su di me. E se quello non era un modo per farsi una vita, non sapevo cos’altro avrebbe potuto esserlo. Il giorno dopo, quando gli chiesi come fare per arrivare all’angolo tra Calumet Avenue e la 33 a, Matty si offrì subito di accompagnarmi. Appena finita la scuola partimmo. Mi insegnò come prendere il 23 e poi il 9 per arrivare al punto che avevo segnato sulla mappa. Non gli avevo detto il perché del viaggio, ma non sembrò importargli. Per Matty il Freak ogni avventura era buona. Scendemmo dall’autobus, e trovammo subito Capello all’angolo. Era ancora più o meno come nella foto, ma solo vedendolo di persona mi accorsi che era il salone di un barbiere. «Be’, ‘Salone Capello’... c’era da aspettarselo» disse Matty. «Aspettami qui fuori. Torno subito». Lui diventò subito curioso. «Perché? Cosa devi fare?» «Non so, pensavo di rapinare una banca. Aspettami qui, okay?» La scelta era tra fare così o dirgli che stavo cercando una persona basandomi su una foto scattata all’incirca vent’anni prima. Tutto normale, no? Dentro la bottega c’erano tre poltrone in fila davanti a uno specchio, ma un solo barbiere. Però capii subito che doveva essere lui Capello, perché... be’, perché aveva un sacco di capelli. E di peli. Ed era enorme. Sembrava un Bigfoot tatuato. «Accomodati un attimo» mi disse. «Ho quasi finito». «Ah... va bene». Mi sedetti su una delle seggiole da attesa, quella più vicina alla vetrina. Presi una delle riviste sul tavolino. Parlava di caccia e pesca e mi sembrò strano, perché da quando ci eravamo trasferiti in città non avevo mai visto né uno stagno né un boschetto. Prima ancora che potessi sfogliarla, però, Matty entrò come se niente fosse. «C’è la fila» gli disse Capello. «Se vuoi aspettare, ce la caviamo in fretta». «Per me va bene» disse Matty. Poi si piazzò a qualche seggiola di distanza da me, come se non ci conoscessimo neanche. Io lo guardai male per tutto il tempo, ma le occhiatacce non gli facevano né caldo né freddo. Si prese una rivista, la aprì sottosopra, e aspettò di vedere cosa avrei fatto. ‘E chi se ne frega’ pensai. Ormai ero lì e indietro non sarei tornato. L’altro cliente stava già pagando il suo taglio. E subito dopo Capello mi chiamò, con un cenno delle enormi forbici che teneva in mano. «Avanti il prossimo!» «Ah, veramente volevo solo chiederle una cosa...» Immediatamente gli venne una faccia minacciosa e le sue sopracciglia spessissime si unirono in una specie di grosso cespuglio. «Mica è una biblioteca, questa» disse. «Se ti fai tagliare i capelli e paghi, parliamo quanto vuoi. Sennò ho altri clienti che aspettano». Ero sicurissimo che un taglio sarebbe costato più dei trentacinque centesimi che avevo in tasca. Nel frattempo la gola mi si stava trasformando in una tubatura intasata. «Eh... no... cioè... volevo solo chiederle se conosceva...» «Sei sordo?» disse, o più che altro ruggì. «Non farmi perdere tempo, ragazzino! Ho i conti da pagare, io!» Non sapevo cosa rispondere, ma ci pensò Matty. «Ehi, senta...» gli disse. «Giusto per curiosità. Cosa si prova a essere l’imbecille più alto del mondo?» La conversazione praticamente finì lì. Capello si mise a correrci dietro, con la faccia di uno pronto a uccidere (ah, e vi ho già accennato alle forbici enormi, no?). Non per vantarmi, ma io corro veloce. Mi ritrovai sul marciapiede in mezzo secondo netto e non mi fermai per una decina di chilometri. O forse solo tre isolati, non so. Quando Matty mi raggiunse stava ancora ridendo. «Ma hai visto che faccia aveva?» disse. «Il barbiere più scorbutico di sempre, non c’è storia». Forse avrei dovuto prendermela con lui perché aveva mandato tutto all’aria, ma in realtà ero contento che Matty fosse lì con me. D’altronde era improbabile che Bigfoot mi avrebbe fatto mettere comodo e portato il latte con i biscotti, no? «Però non capisco perché ti sei comportato così» aggiunse. «Pensavo che foste parenti». «Parenti?» Pensai mi stesse prendendo in giro, ma era serissimo. «Come sarebbe a dire?» «Sullo specchio c’era il nome, proprio di fianco alla foto. Non l’hai visto?» «Ma quale nome?» «Harold Khatchadorian. Com’è che non mi avevi mai detto di avere i geni di un gigante?» Allora gli raccontai tutto. Be’, non proprio tutto. Non gli dissi di Leo. Non sono tante le persone di cui mi fido, a parte mamma (e Leo, ovviamente), ma anche se ci fossero, dubito che inizierei a confidarmi parlando del mio amico immaginario. Comunque gli dissi di mio padre, del perché fossimo andati da Capello e perfino dell’Operazione ‘Fatti una vita’. Temevo che alla fine si sarebbe messo a ridere o qualcosa del genere. Invece rimase serissimo. «E lo stai facendo solo per poter rimanere alla Scuola di artistoidi Cacchidral? Come mai?» «Perché, a te non piace?» «Rispetto a cosa? Certo, è meglio di una scuola normale, ma è sempre una scuola, no?» Mi sembrò una risposta validissima. Più lo conoscevo, più quel tizio mi piaceva. «Sai una cosa?» disse. «Lascia perdere Capello e tutto il resto. Vuoi una botta di vita? Vieni». Nel dirlo, stava già tornando alla fermata. E poi si mise a correre, di nuovo. Toccò a me cercare di tenergli dietro. «Dove andiamo?» Lui non si voltò neanche. «Dappertutto!» rispose continuando a correre. Quel giorno imparai diverse cose su Matty il Freak. Per esempio: – il suo vero nome, completo, era Matthew Isidore Fleckman; – si era inventato lui stesso il soprannome ‘Matty il Freak’, in modo che la sigla rimanesse uguale; – abitava con tre fratelli più piccoli, la madre, il padre e un beagle. Tanto per fare gli spiritosi, il cane lo avevano chiamato Bagel; – ma soprattutto scoprii che nel fare cose senza pagare Matty Fleckman aveva più talento di chiunque altro avessi mai conosciuto. Dopo aver preso l’autobus, la prima fermata fu il più grosso negozio di elettronica che possiate immaginarvi. Una roba che praticamente aveva un codice di avviamento postale tutto suo. Il terzo piano era solo videogiochi e quasi tutti erano esposti in modo da poterli provare sulle console a disposizione del pubblico. «Devi solo spostarti continuamente» mi disse. «Così i commessi non capiscono da quanto sei lì e tu puoi continuare a giocare anche tutto il giorno, se vuoi. Dopodiché attaccammo il mega-multisala nella stessa via. Era il tipo di cinema con poltrone superlusso, dove uno potrebbe spendere anche cento dollari in snack senza saziarsi e dove i biglietti costano quindici dollari. A meno di non essere Matty il Freak, ovviamente. Ignorammo l’entrata principale e girammo l’angolo. Sul lato l’edificio aveva un sacco di uscite di sicurezza, di quelle con le porte senza maniglia all’esterno. Nessun problema, però. Il cinema aveva tipo trentotto sale e non ci volle molto prima che uno dei film finisse e la gente uscisse. «Fai finta di niente e seguimi» disse. Poi camminò dritto in senso contrario alla folla, come se risalissimo un fiume. «Mamma?» si mise a dire. «Mamma? Scusi, ha visto una signora alta con un cappello rosso?» Io già consideravo Leo il Taciturno un genio, ma quella di Matty fu la mossa più spettacolare di sempre. Un paio di minuti dopo eravamo spaparanzati in due poltrone ultracomode a vedere il mio primo film vietato ai minori di diciassette anni. Si intitolava Zombomania e, credetemi, dentro c’era diversa roba che per legge non avrei potuto vedere, tipo una tizia che non solo era una zombie, ma è pure rimasta senza vestiti dall’inizio alla fine! E il mio unico commento è stato: !!!!!!!!!!!!!! Sarebbe già stato fantastico così, ma quando dopo il film ci venne fame Matty disse di conoscere un posto dove avremmo potuto mangiare... gratis, naturalmente. «Io ci sto. Dove?» «Allora, sta venendo bene la scultura di rifiuti?» mi chiese mamma a cena, mentre io facevo finta di avere fame. «Ultimamente hai lavorato sodo». Le dissi che stava andando bene, il che era vero, ma nel frattempo stavo anche cercando di cancellarmi dal cervello le cinque ore precedenti. Non so la vostra, ma mia madre è telepatica. È più sicuro se non penso le cose che non voglio farle sapere. E non era facile, perché c’erano ancora più o meno cento domande che avrei voluto farle. Alla fine, dopo cena, decisi di tentare la fortuna. Non con mamma, però: con nonna. Aspettai che mamma e Georgia andassero di sopra a vedersi un film e poi la cercai in soggiorno, dove, come tutte le sere, mi stava preparando il divano per la notte. «Nonna?» La chiamai piano, non si sa mai. «Sì, tesoro?» «Sai quella foto di mamma con mio padre? Quella davanti al Salone Capello?» «Certo. Mi piace tanto, quella foto». «Be’, ho una curiosità... tu lo sai chi è ‘Capello’? Non che ci perda il sonno, eh, ma...» «Ah, è lo zio di tuo padre» rispose, come se niente fosse. «Non è un tipo simpatico, però». Poi tornò a rimboccare le coperte sotto i cuscini del divano. Per me fu come un pugno nello stomaco. Quell’omone cattivo e peloso era il mio prozio? Mi sembrava quasi impossibile, anche se non era per niente impossibile. «Nonna?» «Sì?» «Sai come si chiama davvero?» «Chi, tesoro?» A volte comunicare con nonna è come parlare a un telefono che funziona male. «Capello, il barbiere, quello nella vecchia foto». Fece un sorrisone. «A proposito, ti ho mai fatto vedere le mie vecchie foto? Un giorno o l’altro dovremmo prenderle e andare a farci due passi sulla strada dei Bei Ricordi». Che cosa potevo rispondere? In ogni caso non ero tornato al punto di partenza, perché sapevo qualcosa in più rispetto a prima. «Certo, buona idea». Lei mollò due cuscini sul divano e poi mi strinse in uno di quei suoi abbracci che sono sempre più forti di come te li aspetti. «Ti voglio bene, Ralph. Sei un bravo ragazzo». «Anch’io ti voglio bene, nonna». Ed era la verità. Decisi di lasciar perdere per un po’ la faccenda e di dare a Capello il tempo di calmarsi. Fino alla prossima era glaciale, magari. Non che avessi intenzione di arrendermi, però. Quella sera, dopo che nonna si fu messa a letto, tornai al computer. Su Google digitai ‘Luca Khatchadorian’, per vedere cosa sarebbe saltato fuori. Non molto. La maggior parte dei risultati riguardava un ragazzino che abitava in una fattoria con un allevamento di capre in Lettonia. Così provai soltanto con ‘Khatchadorian’, ma il problema era opposto: vennero fuori più o meno due milioni di link. Alla fine cercai ‘Ralph Khatchadorian’, così, tanto per fare. Il risultato fu zero, ma il messaggio sullo schermo diceva anche: ‘Forse cercavi «Rafe Khatchadorian?’». E io pensai: ‘Non so... forse cercavo Rafe?’ Decisi che cliccare non avrebbe fatto male a nessuno. Il primo risultato della lista riportava il mio nome e qualcosa riguardo alla Cathedral. Quando lo cliccai si aprì la mia pagina personale sul sito della scuola, con un mucchio di foto, disegni e roba simile. Il problema era che io non avevo una pagina personale sul sito della scuola. Cioè, sapevo che potevamo metterne su una, ma lo facevano solo quelli che avevano tipo diciottomila amici di cui vantarsi. E chiunque avesse messo su la mia non era certo un amico. Più la guardavo, più dimenticavo il motivo per cui mi ero seduto al computer. Non pensavo più a Luca Khatchadorian, ma a Zeke McDonald e a Kenny Patel. E a vendicarmi. Di nuovo. «Senti, Leo...» dissi. «Cosa?» «Devo sospendere per un po’ l’Operazione ‘Fatti una vita’». «EH?» «Solo per qualche giorno». «Perché?» «Per via della Regola Non Far Male A Nessuno. Mi sa che sto per infrangerla e non voglio che succeda mentre stiamo giocando». Il giorno dopo, in pausa pranzo, portai Matty nel laboratorio di informatica e gli feci vedere la pagina finta creata da Zeke e Kenny. Prima di poter anche solo dire «Facciamogliela pagare!», lui aveva già un’idea. Tirò fuori l’album e cominciò a disegnare, velocissimo, come fa sempre. «Ci vendicheremo con il loro stesso sistema» disse. «Cioè con un’altra pagina web?» «No, meglio. E quando succederà sapranno benissimo chi è stato, ma non avranno mai le prove per dimostrarlo». Capito? È per questo che è sempre un bene avere dalla propria parte un pazzoide professionista. Non sapevo ancora nemmeno quale fosse, ma l’idea di Matty già mi piaceva. Nel frattempo lui continuava a scribacchiare e disegnare, disegnare e scribacchiare. «La krit per le sculture con i rifiuti è questo venerdì, no?» disse a un certo punto. «Vuol dire che alla quinta ora di giovedì tutti avranno finito i lavori e li avranno messi nel retro dell’aula della signora Ling». «Be’, sì. E allora?» «A che ora finisce la lezione?» «A mezzogiorno meno un quarto». Andai sul sicuro perché so sempre quando inizia la pausa pranzo. Matty scrisse ‘Ling’ e ‘11.45’ su due parti diverse del foglio. Fu in quel momento che capii cosa stava disegnando. Era una pianta della scuola. Però continuavo a non capire perché. «Secondo me ci servono più o meno cinque minuti prima che la signora Ling scenda». Scrisse anche quello. «Poi circa altri tre minuti fino...» «No, rallenta, rallenta» dissi. «Devi darmi il tempo di capire bene. Cosa dovrebbe succedere giovedì a mezzogiorno meno un quarto?» Matty allora posò finalmente la penna e mi guardò con l’espressione di uno che si stava tenendo per sé il segreto più entusiasmante del mondo. Il che in un certo senso era vero. «Ah, niente. Solo il primo caso professionale di artepimento nella storia della scuola d’arte Cathedral. Tutto qui». Se ancora non l’avete notato, Matty il Freak non lascia mai niente a metà. È una delle cose che mi piacciono di lui. Entro la quinta ora di quel giovedì sapevamo già tutto il piano a memoria, nei minimi dettagli. Non che ci saremmo tenuti le sculture di Zeke e Kenny. Le avremmo solo nascoste sul tetto finché loro non avessero rimosso quella stupida pagina web. Dopo avrebbero trovato nell’armadietto un altro messaggio con su scritto dove cercarle. Se quei due avessero avuto un minimo di buonsenso, tutto si sarebbe risolto prima della krit di venerdì. E Matty aveva ragione: non importava che sapessero o meno che dietro c’ero io. Anzi, io volevo che lo sapessero. Dopotutto quella era una guerra, il tipo di guerra in cui devi sapere di preciso chi è il tuo nemico. E io lo sapevo, poco ma sicuro. Per tutta la quinta ora, quel giorno, riuscii a malapena a concentrarmi per finire la mia scultura. Avevo ricavato un divanetto da alcuni scarti di legno. Poi con il filo di ferro avevo fatto un omino stilizzato, con addosso un foglio di stagnola modellato come una coperta. Non era esattamente un autoritratto, ma stavo comunque cercando di metter vita nella mia arte, come ci consigliava sempre il signor Beekman. L’avevo intitolata Ragazzo che dorme sul divano (anche perché non mi era venuto in mente niente di meglio). Finalmente suonò la campanella per la pausa pranzo. L’Operazione ‘Artepimento’ era iniziata! Per prima cosa Matty e io portammo le nostre sculture sul tavolo in fondo e andammo al piano di sotto come tutti gli altri. Poi però, mentre nessuno guardava, tagliammo per l’aula magna e uscimmo sul lato opposto della scuola. Da quel punto potevamo tenere d’occhio la signora Ling nel corridoio. Non appena girò l’angolo e andò in sala professori, con in mano il suo vassoio, noi tornammo di sopra. Mezzo minuto dopo eravamo di nuovo nella sua aula, deserta. Fin lì tutto bene. Matty afferrò la scultura di Kenny e io presi quella di Zeke. Con un tubo di plastica e un ombrello rotto, Kenny aveva fatto una palma, tutta ricoperta di ritagli di scatole di cereali che aveva colorato di marrone e verde. Non era male. Quanto alla scultura di Zeke... be’, avreste dovuto torturarmi e in più darmi mille dollari per farmi dire qualcosa di buono su Zeke McDonald, ma non c’era dubbio che con quella si sarebbe preso una A, come sempre. Per prima cosa aveva costruito un cubo con delle asticelle e le aveva fissate con della colla speciale. Poi, usando una lenza da pesca, aveva appeso all’interno della struttura più o meno un milione di viti, ingranaggi e molle, tutti arrugginiti. In pratica aveva creato una gabbia con all’interno una scultura mobile che produceva un bel tintinnio quando ci soffiavi sopra. E devo dire... okay, che era... non so... forse giusto un tantino... fighissima. Anche così, comunque, pensavo soltanto a come Zeke e Kenny sarebbero andati fuori di testa quando avessero scoperto che le loro opere erano state rapite. Gettai la felpa sul cubo perché non facesse troppo rumore e andammo dritti verso la porta. E lì trovammo il primo intoppo. Mentre controllavo il corridoio vidi uno dei bidelli, il signor McQuade. Aveva parcheggiato il suo bidone a rotelle fuori dal bagno dei ragazzi, che guarda caso era di fronte alla rampa di scale verso il tetto. Lo indicai a Matty. «Cosa facciamo?» Proprio in quel momento il signor McQuade aprì la porta dei bagni ed entrò. «Vai!» disse Matty. «Veloce!» Prima che potessi reagire, lui mi passò davanti e uscì. Allora lo seguii in corridoio. Ci servivano al massimo venti, trenta secondi per superare la porta. E lì beccammo il secondo intoppo. Matty raggiunse le scale e si bloccò di colpo. Io quasi gli andai a sbattere contro e la scultura di Zeke si mise a fare rumore sotto la felpa. E anche il mio cuore. ‘COSA C’È?’ mimai con la bocca. Matty indicò il fondo delle scale e mi segnalò: ‘ARRIVA QUALCUNO’. Subito dopo sentii una voce provenire dalle scale: «Se volete seguirmi, ora vi mostro l’ala dedicata alle arti visive...» Era il signor Crawley. Organizzava continuamente visite guidate della scuola, a cui non avevo mai nemmeno fatto caso. Mai prima di allora, ovvio. E stava venendo proprio verso di noi. Eravamo troppo lontani per tentare di rientrare nell’aula della signora Ling. Anche i bagni erano da scartare, per via del signor McQuade. Cercare di salire ormai era troppo rischioso. Guardai Matty. Matty guardò me. ‘NASCONDIAMOCI’ mimò. Scattammo subito. Io feci la prima cosa che mi venne in mente: mi tuffai nel grosso bidone che il signor McQuade aveva lasciato nel corridoio. Non fu facile con la scultura sottobraccio, per non parlare del fatto che il bidone aveva le ruote. Mentre mi abbassavo il coperchio sopra la testa vidi la porta del bagno delle ragazze che si chiudeva dietro a Matty e pensai: ‘Quella sì che è un’idea furba’. Ma era troppo tardi per rimediare. Potevo solo starmene lì dentro al buio e pregare che il signor Crawley passasse oltre prima che il bidello uscisse dal bagno. Se pensate che stessi chiedendo un po’ troppo, be’... avete ragione. Ovviamente da dov’ero non riuscivo a vedere niente, ma non ci vuole un genio per immaginare cosa successe dopo. Mentre mi ci infilavo dentro, il bidone doveva essere arrivato proprio davanti alla porta del bagno e probabilmente il signor McQuade uscì da lì un attimo dopo, perché io sentii una bella botta sul lato del bidone... ... il bidone schizzò lungo il corridoio... ... e poi... Non so se vi è mai capitato di trovarvi in un bidone di plastica mentre rotola giù per una rampa di scale, ma fidatevi, non è divertente come sembra (anche se non lo sembra per niente, pensandoci bene). Quando mi schiantai sul pianerottolo, non fummo solo io e un mucchio di asciugamani di carta usati a rovesciarci fuori. Uscì anche la scultura di Zeke, che dopo tutti quei rimbalzi, colpi, schiacciamenti e rotolamenti si era ritrasformata nel milione di singoli pezzi con cui era stata creata. E quello, signore e signori, ragazze e ragazzi, fu un ottimo esempio di quello che si chiama toppare alla grande. Perché ormai non era più un caso di artepimento, no. Era diventato articidio. Mi tennero nell’ufficio del preside per tutta la sesta e la settima ora, mentre aspettavamo che mamma arrivasse per la mia esecuzione. Voglio dire, per un colloquio con il signor Crawley. Tutte e due le cose, in realtà. Quando mamma arrivò ci furono occhiatacce e scuotimenti di capo, poi mi dissero di aspettare fuori. Alla fine la punizione che decisero di darmi fu un po’ come la scultura di Zeke, nel senso che era fatta di tante parti. Per prima cosa non avrei più potuto frequentare il corso della signora Ling per il resto dell’anno. Disegno, pittura e tutto il resto sì, ma il mezzo anno di scultura avrebbe dovuto essere recuperato in terza. Sempre se ci fossi arrivato, ovvio. Secondo, dovetti chiedere scusa di persona a Zeke McDonald. Lo mandarono a chiamare durante l’ottava ora per costringermi a farlo lì nell’ufficio, davanti a mamma e al signor Crawley. Io cercai di sbrigarmela il più in fretta possibile prima che mi venisse da vomitare. Giusto per chiarire: sapevo di aver fatto una brutta cosa. Se qualcuno avesse demolito la mia scultura, anche senza farlo apposta, avrei preteso ben più di un semplice ‘scusa’. Allo stesso tempo, però, questo non cancellava di certo quello che Zeke aveva fatto a me, e lo sapevamo tutti e due. Forse meritava le mie scuse per la scultura, ma non significa che non meritasse anche di essere buttato nella gabbia dei leoni allo zoo con due braciole di maiale graffettate sulle chiappe. Nel frattempo, comunque, dovetti subire l’umiliazione mentre mamma e il signor Crawley continuavano a farmi pagare le conseguenze del mio misfatto. La terza parte della punizione fu una sospensione dalla scuola di tre giorni, uno per aver rubato la scultura e due per averla distrutta. Non sapevo se fosse troppo o troppo poco, ma non mi importava. L’anno prima ero stato sospeso per un solo giorno ed ero praticamente morto di noia. Le possibilità di sopravvivere a tre mi sembravano parecchio scarse. E nel caso vi stiate chiedendo che cosa era successo a Matty... be’, lui aveva fatto la cosa più furba. Aveva aspettato nei bagni delle ragazze finché le acque non si erano calmate, poi era tornato di nascosto nell’aula della signora Ling e aveva rimesso a posto la palma di Kenny prima che qualcuno si accorgesse che era sparita. Ovviamente io non spifferai niente su di lui e neanche su Kenny, tanto non ce n’era motivo. Certo avrei dovuto essere anch’io abbastanza furbo da cavarmela da solo. O abbastanza fortunato. O abbastanza qualcosa. Però qui stiamo parlando di me, mai furbo, mai fortunato, mai niente. E non era finita lì. In un certo senso, il peggio doveva ancora arrivare. Per tutta la strada dalla Cathedral fino a Killarney Avenue mamma non mi disse una parola. Neanche una. Forse avrei dovuto parlare io per primo, ma non mi veniva in mente niente di sensato. Un semplice ‘scusa’ non basta quando ti sei messo nelle grane per la terza, quarta, quinta volta... o per la centoventisettesima, come me. Così rimasi seduto e zitto mentre cercavo di non farmi congelare dal freddo che c’era fra noi due. Mamma trovò parcheggio vicino a casa e spense il motore. A quel punto non ne potevo più. «Ti chiedo scusa, mamma. Sono pentito, davvero». Sentito? Frasi da sfigato totale, ma dovevo pur dire qualcosa. «Pentito di esserti fatto beccare? O pentito piuttosto di aver rubato quella scultura?» «Entrambe le cose» dissi, prima di capire che la risposta giusta sarebbe stata: «Pentito piuttosto di aver rubato quella scultura». Uuups. «No, volevo dire...» «Non sono solo arrabbiata, Rafe, sono anche molto delusa. Dopo tutto quello che è successo l’anno scorso, speravo che alla Cathedral riuscissi a ricominciare da capo. Ma non ha funzionato, vero?» «No». Mi sentivo più a disagio ogni secondo che passava. «Forse la Cathedral non è il mio posto. È quello che pensano tutti». «Tutti chi?» «Be’, tutti quelli più bravi in arte, almeno. Tipo Zeke McDonald e i suoi amici». Mamma fece un respiro profondo, poi disse: «Rafe, guardami... ti è mai passato per la mente che gli studenti possano sentirsi minacciati da te?» Mi venne da ridere. «Minacciati? Da me?» «Fidati, non sei l’unico alunno della Cathedral ad avere dubbi sul proprio talento. Quello dell’arte è un mondo competitivo, già alle medie. Però se è questo il modo in cui hai scelto di confrontarti con altri artisti forse hai ragione, forse non dovresti stare alla Cathedral». «No! Io voglio rimanere alla scuola d’arte!» Lei sorrise, giusto un pochino. «Lo immaginavo» disse, e per circa un decimo di secondo mi sembrò che non fosse più arrabbiata. Mi sbagliavo. «Le regole sono queste» disse. «Sei in punizione fino a nuovo ordine. Dopo scuola tornerai subito a casa, farai i compiti e non uscirai. Anche dalla settimana prossima, durante le vacanze di Natale, resterai a casa. Non andrai da nessuna parte, se non con me». «Fino a nuovo ordine?» «Esatto». In altre parole, non aveva ancora deciso quanto essere arrabbiata. Il periodo di punizione poteva andare da un paio di giorni a... be’, all’eternità. Perché quel giorno non avevo rotto soltanto la scultura di Zeke. Avevo rotto anche il rapporto di fiducia tra me e mamma, forse per l’ultima volta. Dopo una cosa del genere non si sarebbe mai più fidata di me, lo sapevo. Perché, voi sì? Ecco, appunto. Se vi dicessi che all’inizio delle vacanze di Natale ero già pronto a rituffarmi nell’Operazione ‘Fatti una vita’ mi prendereste per pazzo? O per uno scemo? O per uno con ben poca memoria? Adesso vi spiego. Per come la vedevo io, potevo sfruttare un dettaglio tecnico. Perché tecnicamente la missione era in pausa quando mi ero preso la sospensione e quindi tecnicamente non ero obbligato a dichiarare game over. Anzi, più ci pensavo e più mi sembrava evidente. Le cose erano andate meglio (non alla perfezione, ma meglio) proprio fino a quando avevo messo in pausa la missione. Era stato lì che tutto aveva cominciato ad andare a rotoli. Dovevo ricominciare a farmi una vita. E naturalmente non dovetti ripeterlo due volte a Leo. La nostra conversazione andò più o meno così: Restava solo il piccolo problema dalla mia punizione a tempo indeterminato. Avremmo dovuto trovare un modo per fare qualcosa di nuovo senza uscire da Killarney Avenue. Ma ero abbastanza sicuro che tra me e Leo avremmo escogitato qualcosa. Mamma dice sempre che basta un pizzico di fantasia. E se c’è una cosa che io e Leo abbiamo in abbondanza è proprio quella. E così possiamo intitolare la parte che inizia ora... Non dico che tutto quello che Leo e io ci inventammo durante le vacanze mi avrebbe regalato un posto nella storia della grandiosità (o neanche mezzo posto), ma ce la cavammo piuttosto bene. Giudicate voi. Per Natale, dato che non ero esattamente pieno di soldi, regalai a mamma, nonna e Georgia dei buoni che valevano un disegno a scelta. Tutte e tre scelsero dei ritratti e io passai buona parte della giornata a disegnarle, come un vero artista. Lasciai che scegliessero pure l’ambientazione. Era anche la prima occasione in cui dei miei disegni diventavano dei veri regali. Forse perché era Natale, Leo disse che potevo contarli come tre cose fatte per la lista, invece di una sola. Accettai subito. Buon Natale anche a me! Per la fine delle vacanze di Natale la mia lista era arrivata a centoquattordici cose fatte, il che significava che ne rimanevano ottantuno ancora da fare nei settantasette giorni che ci separavano dalla Mostra di primavera alla Cathedral. Ero un po’ indietro sul programma, ma avrebbe potuto andarmi peggio, visto che ero rimasto incatenato in casa di nonna per le ultime due settimane. E dovevo essermi comportato piuttosto bene, perché mamma disse che avrei potuto essere in punizione limitata una volta ricominciata la scuola. Le chiesi più volte che cosa volesse dire ‘limitata’, ma lei si limitò a rispondere: «Vedremo» oppure: «Non tirare troppo la corda». Così non le chiesi più niente. Sapevo benissimo come avrei usato quel briciolo di libertà in più. Durante le vacanze avevo combinato un bel po’ di roba piccola, ma era di nuovo tempo di pensare in grande. Grande davvero. Grande come Capello, il Bigfoot. Ormai era passato un po’ di tempo e forse, se ero fortunato, Capello aveva frequentato un corso per il controllo della rabbia o qualcosa del genere. E comunque ero deciso almeno a provare a farmi raccontare di mio padre da lui. Non ci sarei andato senza rinforzi, però. Mi serviva qualcuno che fosse già al corrente della storia di papà e che non si spaventasse facilmente. E anche che fosse una persona vera (senza offesa, Leo!). Quindi non appena tornai a scuola andai a cercare proprio il tizio a cui state pensando. Lo trovai davanti al suo armadietto, mentre disegnava sopra la porta un paio di occhi per sostituire quelli che il signor McQuade aveva cancellato durante le vacanze. «Khatchy!» esclamò quando mi vide (non mi aveva mai chiamato in quel modo prima, ma Matty il Freak è fatto così). «Cosa mi hai regalato per Natale?» «La metà del cervello che ti manca. E tu cos’hai regalato a me?» Lui fece spallucce, aprì lo zaino e tirò fuori una bellissima penna d’acciaio, ancora chiusa nella scatola. «Non sono bravo a fare pacchetti» disse e me la lanciò. Mi sentii un cretino, perché non mi era neanche passato per la testa di prendergli un regalo. E la penna era davvero bella, una di quelle che avrebbe potuto usare un artista vero. Sembrava pure piuttosto costosa, fra l’altro. «Ehm... come hai fatto a comprarla?» chiesi, perché con Matty non si sa mai. «Ah, non preoccuparti. Quest’anno ho avuto un po’ di soldi a sorpresa da mia zia». Non sapevo se mi stesse dicendo la verità, ma non mi sarei messo di certo a dargli del bugiardo subito dopo che mi aveva fatto un regalo. E appena prima di chiedergli un favore. «Be’, senti...» gli dissi. «Ti ricordi Capello il Bigfoot, vero?» «Mi ricordo di essere scappato per salvarmi la pelle, sì». «Che ne diresti di tornarci insieme per tenerlo un po’ sotto sorveglianza?» Ormai conoscevo il Freak abbastanza bene da sapere che parole usare per suscitare il suo interesse. E infatti il modo in cui sorrise alla domanda avrebbe fatto pensare che fossi stato io ad aver dato a lui un regalo e non viceversa. Praticamente un affarone per tutti e due. Mamma disse che quella settimana avrei potuto scegliere un pomeriggio per andare in giro con Matty, a patto che fossi tornato a casa per le sei (forse era quello che intendeva per ‘punizione limitata’). In altre parole, dovevamo approfittarne. Una cosa era certa: se volevo parlare con Capello, non doveva accadere nel suo negozio, dove c’era una sola uscita. Senza contare tutte quelle forbici. Così ci piazzammo nell’edificio di fronte, come due veri detective in appostamento. Va bene, non andò proprio così. In realtà Matty aveva telefonato al negozio e, camuffando la voce, aveva chiesto a che ora chiudevano. Poi ci eravamo seduti alla fermata dell’autobus su Calumet Avenue ad aspettare di vedere cosa sarebbe successo. Alle cinque meno dieci Capello iniziò a spazzare il pavimento prima della chiusura. Fu lì che cominciai a diventare un tantino nervoso, e con ‘tantino’ intendo che ero lieto che fuori si gelasse, perché almeno avevo una scusa per rabbrividire. Quando Capello uscì, con indosso un giubbotto di pelle nero da motociclista, tremavo dalla testa ai piedi, letteralmente. Però non era il momento di mollare, specialmente davanti a Matty. «Andiamo!» disse lui, poi saltò in piedi. «Aspetta!» Non credo che Matty fosse abituato a seguire i piani di altri, ma riuscii a farlo restare seduto e fermo finché Capello non ebbe percorso circa metà dell’isolato. Non era difficile da tenere d’occhio, perché era alto il doppio di chiunque altro per la strada. «Okay, adesso possiamo andare» dissi, e gli andammo dietro. All’inizio fu un pedinamento a singhiozzo. Avanzavamo un po’ e poi ci nascondevamo dietro un’edicola. Avanzavamo un altro po’ e ci fermavamo nell’ingresso leggermente rientrato di un negozio di scarpe. «Cos’è che vorresti dirgli, alla fine?» mi chiese Matty. «Non lo so. Ci penserò al momento, se capita». «‘Se capita’? Come sarebbe a dire, ‘se’?» «Ssst!» Capello si era fermato in mezzo al marciapiede, senza un motivo apparente. Io mi voltai di scatto e mi calai il berretto sul viso, mentre cercavo di non farmi venire un esaurimento nervoso istantaneo. «Cosa sta facendo?» chiesi a Matty. «Aspetta! Non guardarlo!» «Tranquillo. Si sta solo allacciando una scarpa». Aspettammo che ripartisse e tornammo a seguirlo. Però aveva accelerato, e restargli alle calcagna diventava sempre più difficile. Quando svoltò l’angolo, Matty e io ormai stavamo correndo. Speravamo di poterlo vedere prima che svoltasse di nuovo. Ma c’era qualcosa che non avevo considerato. Capello il Bigfoot era più furbo di quanto non sembrasse. Appena facemmo capolino oltre l’angolo, lo trovammo lì ad aspettarci. Era un’imboscata! Afferrò Matty per la schiena con una delle sue zampe gigantesche, e con l’altra prese me per il braccio. «SCAPPA!» gridò Matty, come se ne avessimo ancora la possibilità. Perché Capello non solo ci aveva sgamato: ci aveva anche catturato. E io ero abbastanza sicuro di avere appena commesso l’ultimo errore della mia vita. Avete presente quando dicono che prima di morire ti scorre tutta la vita davanti agli occhi? Be’, non è vero. Quello che mi ritrovai io davanti agli occhi fu una massa di capelli, peli, muscoli e tatuaggi alta quindici metri. «Perché cavolo mi state seguendo, cretini?» disse. Per la verità non disse né ‘cavolo’ né ‘cretini’, ma questo non è un libro per un pubblico adulto. «Non la stavamo seguendo!» gli gridò Matty. «NON DIRMI BUGIE!» urlò Capello a sua volta e strinse ancora di più la presa. Mi torceva il braccio come fanno gli animatori con i palloncini per creare degli animaletti. Matty era praticamente sospeso per aria. Quello che dissi allora mi uscì senza pensarci. Non avevo un piano, se non sopravvivere. «Lei è lo zio di mio padre!» gridai (va bene, forse più che altro lo strillai, ma in modo molto mascolino). «‘Capello’ Khatchadorian, giusto?» Fu stranissimo. Si bloccò e non mosse un muscolo. Nei suoi occhi, però, c’era circa il settantacinque per cento in meno di istinto omicida. E poi disse: «Tu sei Rafe?» Credetemi, proprio non me lo sarei aspettato. «Come fa a saperlo?» «Incredibile. Ti ho tenuto in braccio quando avevi tre anni. Che cavolo, ti ho tenuto in braccio quando eri appena nato. Ti ho perfino cambiato il pannolino, qualche volta». A quel punto Matty si mise a ridere e mi fece arrabbiare un po’. Però avevo altre cose più importanti per la testa e non volevo rischiare che il tizio si incavolasse di nuovo. Così continuai. «Sa dov’è mio padre?» Lui ci lasciò andare e si infilò le mani in tasca, guardandomi in modo bizzarro. Per un secondo credetti che stesse per rispondermi. E invece no. «Senti, Rafe...» disse. «C’è qualcosa di cui dovresti parlare con tua madre. Anzi, a proposito, dov’è lei?» «A casa». Capello mi sembrò confuso. «Abitiamo qui in città, adesso». «Ah, sì? Ma lei ha sempre odiato la città». «Davvero?» Per me era una novità. «E dai, su» si intromise Matty. «Rafe vuole solo sapere di suo padre. Non può dir...?» Capello tornò il mostro di prima. «Tu bada ai fatti tuoi, ragazzino» disse, ma con un tono del tipo: «Se volessi ti potrei ammazzare con un pugno solo, ragazzino». Non avevo mai visto nessuno far abbassare lo sguardo tanto velocemente a Matty il Freak (né a chiunque altro, in effetti). «Vai a casa, Rafe» disse poi. «Parlane prima con tua madre. Poi, se vuoi, torna pure a trovarmi. Ho tante storie da raccontarti su tuo padre». Non sapevo come rispondere. Non sapevo nemmeno cosa pensare. Restai lì come una statua con la bocca aperta. Capello mi diede una pacca sulla spalla e si incamminò. Mi dimenticai perfino che Matty fosse lì con me, finché non parlò di nuovo. «Ehi, guarda lì!» C’era un biglietto da dieci dollari che mi spuntava dalla tasca del giubbotto. «Ma come ha fatto?» chiese. «E che ne so?» dissi io. La testa mi vorticava, come il cestello di una lavatrice. C’erano ancora tante cose che non sapevo, evidentemente. Tornai a casa che mancavano solo due minuti alle sei. Entrai in cucina. Nonna stava preparando la cena, mamma stava dipingendo sul cavalletto accanto alla porta del retro e la mia testa era ancora in centrifuga. Non riuscivo a smettere di pensare all’ultima cosa che mi aveva detto Capello. Aveva delle storie da raccontarmi? Su mio padre? Che tipo di storie? E quante? «Ma guarda un po’ chi c’è» disse Dotty. «Il mio nipote maschio preferito!» «Ciao, Rafesauro!» fece mamma. «Grazie di essere tornato puntuale». Mi avvicinai e lei mi diede un abbraccio e un bacio di benvenuto, come le piace fare sempre anche quando lavora. «Cosa stai dipingendo?» «Un paesaggio urbano. O l’idea di un paesaggio urbano, almeno». Non riesco mai a capire subito i soggetti astratti di mamma, ma quando poi mi dà qualche indizio intuisco quasi sempre ciò che vuole dire. In quello c’erano tante linee rette che andavano in tutte le direzioni, tipo le vie di una città. Lei era tutta esaltata dal quadro, e si vedeva. Non ne aveva ancora venduto uno da quando ci eravamo trasferiti in città, ma si stava impegnando molto. «Che ne pensi, studente d’arte? Sto andando nella direzione giusta?» «Decisamente». Mamma mi sorrise e tornò a dipingere. E anche se il mio cervello stava ancora faticando per contenere tutto ciò che mi era capitato nel pomeriggio, decisi che per il momento non avrei detto nulla. Non ancora, almeno. D’altronde la faccenda era appena venuta a galla e mamma era contenta come non la vedevo da tempo. E poi Dotty stava preparando le frittelle, e io adoro quando a cena si mangia il cibo della colazione. Perché rovinare tutto? E così, invece di imbarcarci in una lunga e spiacevole discussione, parlammo di pittura, di disegno, di scuola e della famiglia di piccioni che viveva sotto il tetto di fronte. Non avevo idea di quale potesse essere il momento giusto per cominciare a fare domande su mio padre. Però sapevo che non era quello. Quindi per un po’ me le sarei tenute per me e per il mio album (e per Leo, naturalmente). Qualche settimana dopo la ripresa delle lezioni, la signora Ling passò in tutte le classi d’arte per fare un annuncio. «Ragazze, ragazzi, il momento è arrivato. Dovete cominciare a pensare ai vostri progetti per la Mostra di primavera». Ma io stavo già pensando al mio, da mesi. Non avevo mai partecipato a una vera mostra e quella sarebbe stata la centonovantacinquesima e ultima cosa sulla mia lista, il grosso traguardo per l’Operazione ‘Fatti una vita’. Il mio progetto sarebbe stato spettacolare! Quando avrei deciso quale. La signora Ling disse: «Ricordatevi che questa è l’occasione migliore che avete per farci vedere non solo chi siete davvero come artisti, ma anche il tipo di artista che potreste diventare se continuerete a frequentare la Cathedral». E lì stava una grossa parte del mio problema. Primo, come potevo far vedere chi ero ‘come artista’ se non ne avevo ancora idea? E secondo... più pressione no? La Mostra di primavera era l’ultima occasione per dimostrare che la scuola d’arte era il posto adatto a me. E non sapevo neanche se sarei riuscito a farmi ammettere in terza! A essere sincero, mi sembrava che i miei problemi aumentassero man mano che la signora Ling parlava. «È un compito aperto» ci disse. «Significa che potete lavorare con qualsiasi materiale vi piaccia, per creare qualsiasi cosa vi venga in mente». Questo poteva non sembrare un male, eppure lo era. Perché un conto è quando ti dicono di fare un autoritratto o una scultura di rifiuti o roba simile, ma quando si può fare qualsiasi cosa è come ricevere un test a risposta multipla dove hai una domanda sola, ma trentadue trilioni di risposte possibili. Prova ad azzeccare quella giusta: in bocca al lupo. E che tutti gli altri alunni dessero l’idea di sapere già che cosa fare non mi aiutava affatto, no. «Nel frattempo» aggiunse la signora Ling, «per venirvi incontro faremo presto una bella gita al museo dell’Art Institute. Spero che sfrutterete l’opportunità di ammirare alcune delle opere meravigliose che sono esposte in questa città e di ispirarvi a raggiungere nuove vette voi stessi, con le vostre creazioni». Nuove vette? E chi aveva mai parlato di nuove vette? Io mi stavo ancora sforzando di raggiungere quelle vecchie. O qualunque tipo di vette. All’improvviso quel grosso traguardo a cui pensavo dall’inizio dell’anno aveva cominciato ad avvicinarsi... ma troppo velocemente! Nei giorni precedenti alla gita ebbi un sacco di tempo per pensare al mio progetto per la Mostra di primavera. E dopo una lunga, seria e attenta analisi, alla fine riuscii a farmi venire in mente... zero buone idee. Però forse la signora Ling aveva ragione. Forse la gita mi avrebbe ispirato a fare qualcosa a cui non avevo mai pensato prima. Forse proprio lì mi sarebbe venuta l’idea migliore della mia vita. E sennò... be’, almeno ci avrebbe risparmiato una mattinata di lezioni. Quando arrivammo al museo, ci lasciarono liberi di andarcene in giro per le gallerie a disegnare sui nostri album quello che ci colpiva. Matty sembrava molto sicuro di sé, così lasciai che fosse lui a fare strada. All’inizio mi aspettavo di vedergli fare qualcosa nel suo stile, tipo raccogliere le monetine dalla fontana all’ingresso o cercare di salire sul tetto, o come minimo toccare quello che in un museo non si dovrebbe toccare. E invece, per quanto vedevo, era interessato seriamente alle opere d’arte. Girammo per un po’, facemmo gli schizzi di alcuni quadri e poi girammo un altro po’. Era un lato di Matty che non avevo mai visto. Mi sembrava normalissimo. Il che, trattandosi di Matty, era bizzarrissimo. Quando alla fine la signora Ling venne a dirci che mancava un quarto d’ora alla fine della visita, Matty chiuse l’album, mise via la sua roba e disse: «Dai, altrimenti ci perdiamo la parte migliore». Io lo seguii fino all’atrio e poi nel bookshop accanto all’entrata. «Sarebbe questa la parte migliore?» «Fidati. Da’ un’occhiata in giro». Mi guardai attorno. E che cosa imparai? Imparai che i bookshop dei musei sono fatti per i ricchi. Tutto quello che vendono costa dieci volte il prezzo che ti aspetteresti. Perfino le cartoline costavano cinque dollari l’una. Dopo poco Matty mi si avvicinò. «Tienimi questo» disse, poi mi diede il suo zaino. «Devo andare in bagno. Ma tu aspettami qui, eh?» Non ci pensai neanche su. Presi lo zaino e continuai a sfogliare un libro da cento dollari su un certo Mondrian che era diventato famoso per aver disegnato un mucchio di quadrati rossi, gialli e blu, continuamente, in qualunque combinazione. Forse allora anch’io potevo sperare che qualcuno un giorno scrivesse un libro sulle mie opere! Subito dopo, però, vidi la signora Ling farmi cenno di incamminarmi verso l’autobus. Era ora di tornare. Matty era ancora in bagno, così decisi che gli avrei ridato lo zaino fuori dal museo. Ma non appena feci per uscire... L’allarme antifurto del negozio scattò, come se qualcuno fosse uscito con della roba non pagata. E dato che io non sono esattamente molto sveglio, mi guardai intorno per cercare di capire chi potesse essere il ladro. Mi ci volle qualche secondo per accorgermi che l’unica persona sulla porta ero io. «Metti giù lo zaino e allontanati!» urla in un megafono il capo dei negoziatori. Anche così, è quasi impossibile da sentire, con gli elicotteri che volano bassi e la polizia a sirene spiegate. Qui è successo qualcosa di davvero brutto, ma tutto quello che so è che non sono stato io. «C’è un errore!» grido. «Allontanati dallo avvertimento!» zaino! È l’ultimo Sento rumore di passi. Tutto intorno c’è gente che corre. E che sbraita. Sento gracchiare forte le radio della polizia. E tutto questo per me? Non voglio rischiare. Tengo le mani dove tutti possono vederle. Poi mi chino lentamente e appoggio lo zaino per terra. Un attimo dopo, una decina almeno di cavi scende dal cielo. Una squadra intera di agenti SWAT, in corda doppia, tocca terra nello stesso istante. Prima che riesca a muovere anche solo un dito mi hanno già circondato, con in mano così tanta ferraglia da... be’, da poter aprire subito un negozio di ferramenta, e pure grande. «Non muovere neanche un muscolo!» grida uno di loro. «Scusa, giovanotto... puoi rientrare negozio, per cortesia?» dice un altro. nel Abbassa pure le mani» mi disse la guardia. «Puoi rientrare nel negozio, per favore?» Nel frattempo era arrivata anche la signora Ling. E vedevo anche Matty: era con il resto della classe e mi guardava. Non si avvicinava, però. «Rafe?» disse la signora Ling. «Ma cosa succede?» «Non lo so, ma non sono stato io». La guardia le chiese il permesso di controllare lo zaino. Lei guardò me, come se avessi potuto rifiutarmi. Io non dissi niente e glielo diedi. Lui lo aprì sul bancone e un attimo dopo stava già tirando fuori una di quelle penne d’acciaio, ancora nella scatola. Era identica a quella che Matty mi aveva regalato a Natale, solo che la mia era al sicuro a casa. «Come la spieghi, Rafe?» disse la signora Ling. Io continuavo a guardare verso Matty, ma lui non faceva altro che scuotere piano la testa. ‘No, no, non dirglielo’ sembrava dirmi. Mi sentivo in trappola, con la testa già sul ceppo. Poi però mi misi a pensarci su e... Avete presente quando vi arriva una camionata di pensieri tutti insieme? Ecco, a me successe proprio quello. Mi ricordai di tutte le volte in cui ero finito nelle grane durante l’anno... mentre Matty l’aveva sempre fatta franca. Non voglio dire che la colpa fosse sua. Anzi, il più delle volte era stata quasi tutta colpa mia. O tutta, senza ‘quasi’. Lì però io non avevo fatto niente di male e non potevo permettermi di fingere il contrario. «Lo zaino non è mio» dissi. «Non ho preso io quella penna». «E di chi è, allora?» chiese la guardia. «Non voglio dirlo». «Se è così dovrai venire con me». «Rispondi alla guardia, Rafe» disse la signora Ling. «Di chi è quello zaino?» Il cuore mi rimbalzava nel petto come la pallina di un flipper. Ancora non sapevo bene che cosa fare. Non prima di aver dato un’altra occhiata verso l’atrio, almeno. Fu lì che vidi il signor Crawley guidare il resto della seconda verso l’uscita. E non immaginereste mai chi c’era nel bel mezzo del gruppo, cercando di uscire come se niente fosse e senza nemmeno guardarmi. Anzi, probabilmente lo immaginate benissimo. «È di Matty Fleckman» dissi. Non so che cosa successe a Matty dopo. Vidi soltanto che né lui né il signor Crawley erano sull’autobus che ci riportava a scuola. Evidentemente però aveva ammesso di avere preso lui la penna (o magari una telecamera di sorveglianza l’aveva beccato), perché io non ero più nei guai. Quella sera cercai di rintracciarlo con qualsiasi metodo, meno i segugi. Lo chiamai diverse volte, ma lui non rispose. Gli inviai due e-mail, ma da lui non mi arrivò niente. Gli scrissi perfino un sms dal cellulare di mamma dicendo che si trattava dei compiti, perché lei avrebbe potuto leggerlo e non è che potessi scrivere che riguardava ‘la penna che hai rubato e che forse hai cercato di farmi portare fuori dal negozio’, no? E il problema era quello. Non sapevo se al museo Matty avesse cercato di sfruttarmi o se avesse davvero intenzione di tornare, riprendere lo zaino e portare fuori lui la penna rubata. Quindi non ero nemmeno sicuro se dovessi essere io arrabbiato con lui o viceversa... o tutte le due cose insieme... o nessuna delle due... o che altro. Stavo diventando scemo. Alla fine, verso le nove, il telefono squillò. Corsi in cucina per rispondere, ma nonna fu più veloce. «PRONTO, E COSA C’È DI TANTO IMPORTANTE DA DOVER CHIAMARE CASA MIA IN PIENA NOTTE?» disse. Sorpresa sorpresa, dall’altra parte riattaccarono. «Mmm» disse nonna. «Devo averli spaventati». Appena uscì, portai il telefono fuori, sulle scale del retro, e chiusi la porta. Poi composi il numero di Matty. Non mi aspettavo che rispondesse, e invece... «Seh?» «Mi hai chiamato un minuto fa?» «Ah, sei tu. Aspetta un secondo. Non muoverti». Lo sentii appoggiare la cornetta, poi silenzio. E il silenzio durò tantissimo. Anzi, passarono forse tre minuti buoni prima che capissi, finalmente, quello che stava succedendo. Se non altro non c’erano più dubbi: era Matty ad avercela con me. Ora che lo sapevo, il problema diventava un altro, molto più preoccupante. Mettiamola così: se dovessi elencare i cinque motivi principali per cui conviene avere Matty il Freak come amico, la lista sarebbe più o meno come quella della prossima pagina: Ricordate quando vi avevo detto che Matty non fa mai le cose a metà? Era di questo che avevo paura. Non dico che fossi paranoico quando andai a scuola il giorno dopo, ma mi sentivo un po’ come se mi stessero dando la caccia. Non impiegai molto a scoprire che cosa sarebbe successo. Più mi avvicinavo al mio armadietto, più vedevo gente in corridoio che mi fissava e bisbigliava nell’orecchio di chi aveva accanto. E parlavano di questo: Il lato positivo era che almeno stavolta la vernice era tutta all’esterno. In qualsiasi altra occasione avrei sospettato di Zeke e Kenny. Ma quel ‘fatti una vita’ era come un segnale in codice. Matty era l’unico in tutta la Cathedral a sapere dell’operazione. E a quanto potevo vedere, era anche l’unica persona che in quel momento non era lì intorno a ridermi dietro. Così andai a cercarlo. Non mi ci volle molto. Tutte le mattine, prima che iniziassero le lezioni, lui se ne stava sulle scale sul retro. Quando arrivai, non alzò nemmeno lo sguardo, e la cosa mi fece solo imbestialire di più. «Qual è il problema?» gli chiesi. «Che non si fa la spia quando c’è un amico di mezzo». «Ah, sì? Be’, allora non si fa in modo che un amico venga beccato con della roba che hai rubato tu». «Stavo tornando a riprendermi lo zaino». «E come facevo a saperlo?» «Perché te l’avevo detto». Mi guardò dritto negli occhi. Forse stava dicendo la verità, forse no. Avevo già visto com’era bravo a mentire. «E va bene, ti sei divertito un po’. Ora smettila». Lui chiuse l’album e si alzò. Poi si avvicinò fino a tipo due centimetri dalla mia faccia e mi fece quel sorriso che ormai conoscevo bene. Mi era sempre sembrato malvagio e allegro allo stesso tempo. Quella volta invece mi sembrò malvagio e basta. «Non ho paura di fare a botte con te, Matty» gli dissi. «No, ma hai talmente paura di metterti nei guai che non farai niente. O sbaglio?» Non risposi, più che altro perché sapevo che aveva ragione. Quella fu la parte peggiore. Matty mi conosceva meglio di chiunque altro a scuola e io gli avevo raccontato più di quanto avrei dovuto. Era troppo tardi per rimediare. «E a proposito...» disse. «Quando avrò smesso di divertirmi te lo farò sapere». E poi se ne andò. Restai lì come un fesso a guardarlo. Da non credere. Solo il giorno prima eravamo amici, o almeno così sembrava. E poi era bastato che una volta tanto finisse lui nei guai invece di me, e non lo eravamo più? Per quanto mi riguardava, in tutta questa faccenda si stava comportando da bambino. Un bambino grande e grosso... ... imprevedibile... ... e molto pericoloso. Passai il resto della mattina a chiedermi quale sarebbe stata la sua mossa seguente. Alla quinta ora ormai ero così stanco di guardarmi alle spalle che avrei fatto volentieri un pisolino. Faccio per dire, ovviamente. Tanto per cominciare, non volevo certo dargli l’occasione per tatuarmi la faccia o farmi rotolare fuori dalla finestra. E in più, dato che la mia giornata non era già abbastanza complicata, alla quinta ora avevamo un’altra sessione krit. Faceva parte di un modulo sull’arte digitale tenuto dal signor Crawley. Il compito era scattarci una foto, caricarla sul computer, scomporla e ricreare una nuova immagine dai vari pezzi. Devo dire che quello che avevo fatto mi piaceva. Avevo chiesto a Matty di scattarmi una foto (prima che litigassimo, ovvio). Poi avevo inserito delle parti di me in un’altra foto, di un muro di mattoni, in modo da far sembrare che qualcuno me l’avesse costruito intorno, con braccia, faccia e gambe che spuntavano qua e là. Sempre con il computer avevo creato dei graffiti e li avevo messi sul muro. Naturalmente non mi aspettavo che piacesse a qualcuno. La regola di Zeke e Kenny era praticamente quella di detestare tutto ciò che facevo. In più adesso dovevo anche preoccuparmi di che cosa avrebbe detto Matty. Chissà, magari non avrebbe detto niente, perché era troppo impegnato a escogitare un modo per spingermi sotto l’autobus all’uscita da scuola. Insomma, la prospettiva della krit non mi entusiasmava affatto. La krit delle opere digitali funzionava un po’ diversamente dalle altre. Finito il compito, si usava la propria password per caricarlo sul server della scuola. Così il signor Crawley poteva recuperarlo e proiettarlo sul grande schermo dell’aula per farlo vedere a tutti. Ve lo dico perché quella era forse l’unica cosa che non avevo previsto. Quando Matty e io stavamo ancora cercando di rimuovere la finta pagina RAFE K che Zeke e Kenny avevano pubblicato, io gli avevo detto la mia password. All’epoca non mi era sembrato potesse portare a niente di male. Se c’era una persona di cui mi potevo fidare, in tutta la scuola, era lui. E quello potrebbe essere stato il mio più grande errore di tutto l’anno scolastico. «Bene, Rafe, vediamo che cosa ci hai preparato» disse il signor Crawley quando toccò a me. «Come si intitola la tua opera?» «‘Ragazzo sul muro’». Che vi posso dire? I titoli non sono il mio forte. Il signor Crawley premette un paio di tasti sul suo portatile e aprì il mio file. Ma invece di ‘Ragazzo sul muro’, ecco cosa apparve sullo schermo: Sul laboratorio calò il silenzio. Nessuno rise, nessuno parlò, nemmeno sottovoce. Nessuno respirò, credo. Almeno per i primi dieci, venti secondi. Dopodiché non saprei dirvi, perché io ero già uscito dall’aula. Ciò che accadde dopo fu quello che avevo pensato di fare più o meno un milione di volte in prima media senza mai averne il coraggio. Uscii dal portone principale della scuola, in pieno giorno, e non mi fermai. Non mi importava di finire nei guai. Non mi importava di farmi sbattere fuori dalla Cathedral. Non mi importava più di niente. Volevo solo una cosa. ANDARMENE. «Dove siamo diretti?» mi chiese Leo. «A casa». «Ma se arrivi troppo presto sospetteranno qualcosa». «E vabbè». Tanto non intendevo Killarney Avenue. Oltrepassai la fermata del 23 e continuai. Ne passai un’altra, poi un’altra e un’altra ancora. Nessuno fece caso a me, nonostante in teoria dovessi essere a scuola. È uno dei lati positivi dell’abitare in una grande città, immagino. Anche soltanto camminare mi faceva bene. Mi dava il tempo per pensare e per ideare un piano. Quando finalmente arrivai a casa di nonna, era più o meno l’ora in cui tornavo di solito. Bene. Non volevo attirare troppa attenzione, nel caso avessi dovuto restare ancora un po’. Perché personalmente mi consideravo soltanto di passaggio. «Ciao, bello» disse nonna quando entrai. «Com’è andata a scuola?» «Be’... è stato incredibile». «Sono contenta«. «Mamma c’è?» Non avevo visto la sua macchina parcheggiata fuori. «Aveva un altro colloquio di lavoro. Ma tornerà presto». Mamma era stata a così tanti colloqui che non facevano più differenza, ormai. Non era mai tornata a casa con un lavoro. Però la cosa avrebbe reso più facile la mia mossa successiva. Non appena nonna andò in cucina, salii di corsa le scale verso la camera di mamma e Georgia. Quando entrai, Georgia era sul letto, al telefono. «Esci» le dissi. «Ma esci tu! È la mia st...» Probabilmente si sarebbe fiondata di sotto a piangere con nonna perché l’avevo trattata male. O magari prima si sarebbe fermata a rovinare un po’ della mia roba, per ripicca. Ma non mi importava. L’importante per me era continuare a muovermi. Quando Georgia uscì, io aprii il cassetto più in alto nel mobile di mamma e presi la scatolina ricoperta di conchiglie dove teneva i soldi per le emergenze (‘giusto nel caso’ diceva lei). Dentro c’erano tre biglietti da venti piegati e fermati con una grossa clip. Ne presi due e rimisi a posto l’altro, con una nota. L’unica altra cosa che presi fu la chiave del grande box a Hills Village in cui avevamo ancora molta della nostra roba, tipo il mio sacco a pelo e altri vestiti. Dopodiché scesi piano fino a metà delle scale e cercai di capire se Georgia si stesse lamentando in cucina. Non sentii niente, ma la via sembrava libera e allora scesi. Poi, quando stavo già girando la maniglia della porta... «Cosa fai?» Mi voltai. Georgia mi stava osservando da dietro lo schienale della grande poltrona-sdraio di nonna. Davvero, dovrebbe lavorare come agente segreto per la CIA. In Mongolia, magari. «Niente. Però di’ a mamma che la chiamo più tardi». «Rafe, ma...?» Georgia aveva l’espressione di chi aveva capito che c’era sotto qualcosa e non voleva che me ne andassi. «Scusa se prima ti ho sgridato» le dissi. Poi aprii la porta e uscii prima che lei potesse ribattere. Arrivato al marciapiede mi misi a camminare veloce, lungo Killarney Avenue, nella direzione da cui ero arrivato solo pochi minuti prima. «Sei sicuro che sia una buona idea?» mi chiese Leo. «No, ma ci vado lo stesso. Tu vieni?» «Secondo te?» «Non stai bene, tesoro?» mi chiese la signora seduta sul sedile accanto. «Sembra che tu abbia la testa da tutt’altra parte». «No, no, grazie, va tutto bene». Eravamo più o meno a metà strada per Hills Village. Sulla corriera faceva troppo caldo e io ero mezzo addormentato. «Come ti chiami, tesoro?» «Ehm... Leo». «È un bel nome. Dove stai andando?» «Vado a trovare il mio amico Matty. È in ospedale, con una bruttissima malattia che gli sta consumando la pelle». Lei mi fissò senza sapere bene se credermi o no. «Mi deve ancora cinque dollari» aggiunsi. «Quindi mi tocca arrivare da lui... be’, sì, prima che sia troppo tardi». A quel punto di sicuro stava già valutando se cambiare posto. «No, scherzo» dissi. «Senti, Leo... non sei un po’ troppo giovane per viaggiare da solo?» Si mise a frugare nella borsetta. «Devo chiamarti qualcuno?» «No, grazie. Sul serio, sono andato in città a trovare mia nonna. Mia madre viene a prendermi all’autostazione». Per la prima volta la guardai negli occhi mentre le parlavo. Non troppo a lungo, solo quanto bastava. Se la bevette, credo. Non mi fece altre domande e il resto del viaggio verso Hills Village filò tranquillo. Matty il Freak qualcosa evidentemente. Tipo come mentire bene. me l’aveva insegnata, Fu PROOOPRIO strano scendere dalla corriera nel bel mezzo di Hills Village. C’era il Duper Market dove mamma faceva la spesa quando abitavamo qui. C’era il parchimetro su cui mi ero rotto un dente a dieci anni. C’era anche un ragazzino che conoscevo ma di cui non mi ricordavo il nome. Mi sentivo come Scrooge nel Canto di Natale, quando torna dove aveva vissuto, si guarda intorno e nessuno si accorge di lui. «Ehi, ricordati che quello invisibile sono io» disse Leo. «Comunque se fossi in te non mi fermerei troppo in centro». Aveva ragione. Hills Village non è molto grande ed era solo questione di minuti prima che incontrassi qualcuno che non avrei voluto vedere. Avevo speso ventinove dollari per il biglietto della corriera, quindi me ne rimanevano undici in tasca. Ne spesi qualcuno per comprarmi un sacchetto di patatine gusto barbecue piccante e una lattina di Zoom, al chioschetto dell’autostazione. Poi mi rimisi a camminare. La casa di Jeanne Galletta era solo a un chilometro e mezzo di distanza, più o meno, ma quando vi arrivai era già quasi buio. Sì, avete capito bene, la casa di Jeanne Galletta. Non ho mai detto che fosse un buon piano, okay? Era un piano e basta. Per un attimo mi chiesi se non fosse meglio aspettare l’indomani. Poi però ripensai a tutto quello che avevo fatto per arrivare lì. Non potevo fermarmi solo perché era quasi notte. Così feci tutto il vialetto e suonai il campanello. Ancora prima che qualcuno arrivasse alla porta, una tenda della finestra sul davanti si mosse, ed ecco Jeanne. Sembrava non credere ai suoi occhi. Poi la porta si aprì e mi ritrovai davanti il signor Galletta. «Sì?» disse. «Salve. C’è Jeanne?» «Sai che ora è, giovanotto?» Confesso che avrei potuto essere agitato. Anzi, avrei dovuto essere agitato. Ma avete presente quei giocatori di poker che si vedono in tv, quando spingono in mezzo al tavolo tutte le fiches che hanno? Ero io in quel momento. Niente mezze misure. «Rafe?» disse Jeanne, che era spuntata all’improvviso dietro al padre. «C’è qualcosa che non va?» «Ciao, Jeanne». «Cos’è ’sta storia?» chiese il padre. «Non lo so» disse lei. «Che c’è, Rafe?» «Ah, niente di grave. Volevo solo passare per... per ringraziarti perché sei stata gentile con me l’anno scorso». Tutti e due mi guardarono come mi aveva guardato la signora sulla corriera: come se fossi pazzo davvero, e magari pericoloso. Non mi importava. Avevo fatto quello per cui ero venuto fin lì. Se non altro potevo dire di avere concluso almeno qualcosa nell’anno. «Tutto qui. Ci vediamo, Jeanne». Uscii dal portico. Il signor Galletta guardò su e giù per la via. «Sei da solo?» chiese. «Sì. Cioè, per adesso. Mia madre si è fermata al Duper Market per comprare del latte. La raggiungo all’angolo fra un minuto». Si vedeva benissimo che Jeanne non era convinta, ma prima che potesse dire qualcosa suo padre fece per chiudere la porta. «Va bene, allora. Buonanotte, Rafe. E la prossima volta non così tardi, eh?» «Certo» dissi e mi incamminai. Aspettai di sentire la porta chiudersi prima di voltarmi. Jeanne era di nuovo alla finestra e mi osservava. Non so bene perché, ma la cosa mi fece piacere. La salutai con la mano e poi guardai da un’altra parte, prima che lo facesse lei. Non andai molto lontano. Ero ancora sulla sua via quando sentii di nuovo il signor Galletta chiamarmi. «Ehi, Rafe!» Mi voltai e lo vidi venire verso di me. Per un attimo fui tentato di scappare. «Perché non ti fermi un momento da noi?» Non era una vera domanda, però. E poi non avevo più voglia di scappare. Una volta in casa, i Galletta mi fecero telefonare a mamma per dirle di non preoccuparsi. Lei era parecchio agitata, ma non mi sgridò. Be’, non subito. Poi si fece passare la signora Galletta, che disse più volte che le sembrava che stessi bene e che per loro non era un disturbo se avessi dormito lì. Mamma disse che sarebbe venuta subito a prendermi l’indomani mattina. Credetemi: di tutte le cose che non mi sarei mai e poi mai aspettato che mi succedessero nella vita, direi che dormire a casa di Jeanne Galletta era quasi in cima alla lista. Passare la notte nella loro camera degli ospiti fu praticamente la conclusione più assurda in assoluta per una giornata che era stata assurda dall’inizio alla fine. Non dormii molto, comunque. Più che altro rimasi lì disteso a pensare a mamma e a quanto ero stato stupido a comportarmi così. E anche a quant’ero contento per non aver dovuto passare la notte in un sacco a pelo in un box freddo e buio (sul serio, ma cosa m’ero messo in testa?). Quando mamma disse che sarebbe venuta subito a prendermi non scherzava. Alle sei la signora Galletta venne a svegliarmi e poi la sentii chiedere a mamma se volessimo fare colazione prima di ripartire. «No, grazie. Prenderemo qualcosa fuori» rispose lei. «Abbiamo bisogno di parlare un po’». Ero abbastanza sicuro che intendesse uccidermi lontano da occhi indiscreti, ma non potevo dirlo ad alta voce. Mi limitai a ringraziare la signora Galletta (Jeanne dormiva ancora) e salii in macchina. Appena mamma chiuse la portiera, iniziai a parlare. «Senti...» Non riuscii ad andare oltre. Mamma si sporse dal suo sedile e mi abbracciò forte, un abbraccione come quelli di nonna. E mi strinse a lungo, pure. «Scusami, mamma» riprovai. Non si capì molto, perché avevo la faccia schiacciata contro il suo giaccone, ma credo che capì. «Sono io che devo chiederti scusa, Rafe. Il signor Crawley mi ha detto cos’è successo a scuola ieri. E mi spiace tanto, davvero». «Ma non sei arrabbiata perché ho preso i soldi? E la corriera?» Lei mollò l’abbraccio e si sistemò di nuovo sul sedile. «Certo che sono arrabbiata. Però a questo punto c’è una cosa che devo dirti, Rafe. Avrei dovuto dirtela già da tempo. Quello che è successo ieri in classe me l’ha confermato». «Non ti capisco, mamma». C’era roba super-seria di mezzo, altrimenti ormai sarei già stato in guai seri. Perché non mi stava facendo una scenata? «Sto parlando di tuo padre, tesoro. Andiamo, devo mostrarti una cosa». Avevate già capito che saremmo finiti in un cimitero, eh? E infatti fu proprio lì che mi portò mamma. E non posso dire che sia stata una sorpresa al cento per cento nemmeno per me. Solo non avevo intuito quanto lo sospettassi già. Fino al momento in cui arrivammo ai cancelli non mi resi conto di dove eravamo. Mamma mi prese la mano. Più che stringerla, la copriva con la sua. «Tuo padre era un soldato» disse. «Si era arruolato nell’esercito quando tu avevi sette anni e Georgia cinque. E poi è andato in guerra». Mi guardò e aveva gli occhi lucidi. Credo che lo fossero anche i miei. Prese una scatola dal sedile posteriore e mi fece vedere una foto di papà in divisa e una medaglia che probabilmente si era guadagnato mentre era in missione. «Perché non mi hai mai detto niente?» le chiesi. Non capivo ancora. «Ti chiedo scusa, Rafe, ma per me è difficile. Tuo padre alla fine è stato un eroe per il suo paese, ma non è sempre stato un eroe per la sua famiglia, la nostra famiglia. Non quando ci ha abbandonato. Trovare il modo giusto per parlartene non era facile, certo, ma avrei dovuto farlo prima». Guardai a lungo la foto e la medaglia. Poi alzai gli occhi fuori dal finestrino, verso l’ingresso del cimitero. «Dov’è?» Mamma indicò alcuni alberi. «È laggiù. Vuoi andare a trovarlo?» Feci un respiro profondo. «Sì». Così scendemmo. Mamma mi diede la mano e insieme andammo a trovare mio padre. Okay, facciamo un’altra pausa. Non so che dire di questa faccenda. Non posso dare la colpa a mamma per non avermelo detto prima. Era stata lei a rimanermi accanto per tutta la mia vita, non lui. Fu triste e mi fece un effetto davvero strano scoprire che mio padre era morto da soldato, ma allo stesso tempo non cambiò di molto le cose. Come ho detto prima, ormai ero abituato alla situazione. In un certo senso l’unica cosa che cambiò fu la mia opinione su papà. Fino a quel momento avevo considerato solo uno che era fuggito e non era mai più tornato. A quel punto però era diventato anche un eroe. Non dico che non fossi giù, e anche un tantino confuso. Adesso comunque sto bene. Capito? Tutto qui, in pratica. E nel caso stiate pensando che questo libro avrà il finale più triste del mondo, ora vi racconterò che cosa successe dopo. Una figata, ripensandoci. Quando uscimmo dal cimitero, mamma mi chiese se preferissi mangiare qualcosa o andare subito a casa. Lo so che nei film e nei romanzi la gente perde sempre l’appetito nei momenti tristi, ma se vi devo dire la verità io non ci vedevo più dalla fame. «Andiamo a mangiare» dissi. Tornando verso il centro passammo dove una volta c’era Swifty’s... e nel frattempo era successa una cosa stupenda. Swifty’s era tornato! Quindi ovviamente fu lì che ci fermammo a fare colazione. Io ordinai una pila alta così di frittelle con bacon e anche con salsiccia. Mamma invece prese una fetta di torta di mele, un caffè e del succo d’arancia. Quando Swifty ci vide ci venne subito incontro dalla cucina. Lui e mamma si abbracciarono. Non li avevo mai visti abbracciarsi. «Ma guarda un po’ chi c’è!» disse. «Credevo che vi foste trasferiti». Mamma mi guardò e sorrise. «Siamo qui solo per una gitarella». «Ah, peccato» disse Swifty. «Peccato?» «Avrei proprio bisogno di qualcuno che mi desse una mano, qui. Guarda, sono perfino riuscito a salvare dall’incendio uno dei tuoi quadri». E infatti era proprio lì, appeso alla parete dietro il bancone. «Comunque, se per caso decidete di tornare ad abitare qui fammelo sapere, eh, Jules?» Quando Swifty tornò in cucina, mamma si sedette di nuovo al tavolo con me. Restammo lì a guardarci, entrambi con un’espressione strana. «Pensi anche tu quello che penso io?» mi disse. «Non saprei, ma credo di sì». Non ci fu neppure bisogno di dirlo. Stava per cambiare tutto, di nuovo. Perché è così che va sempre a finire, no? E come sono cambiate, le cose! Sono di nuovo a scuola e sto finendo la seconda alla Airbrook, dove avrei dovuto iniziare l’anno. La signora Donatello si è fatta in quattro per me (di nuovo!) e la direzione ha detto che potevo frequentare lì il trimestre finale e anche la terza, con un po’ di corsi estivi di recupero. Eh, sì, passerò un’altra estate a scuola, come l’anno scorso. Solo che stavolta è perché lo voglio io. Pazzesco, eh? Ovviamente siamo tornati a vivere a Hills Village: io, Georgia, mamma e nonna Dotty. Come abbiamo scoperto, anche una casa piccola e malmessa vale qualcosa, se è in città. Dopo aver venduto quella di nonna, ci siamo ritrovati con i soldi sufficienti per pagare l’affitto del nostro nuovo appartamento per anni. Sì, siamo in un appartamento e non più in una casetta, ma ci stiamo tutti e quattro comodi lo stesso. Non devo nemmeno più dormire sul divano! Se c’è un lato negativo in tutta questa storia, riguarda Matty il Freak. Ho cercato di chiamarlo prima di partire, ma non ha mai risposto. E sapete che vi dico? Mi va bene così. Mi sono divertito molto con Matty, ma credo che in realtà non sia mai stato un vero amico. D’altra parte forse nessuna delle cose buone che sono successe sarebbe mai arrivata se lui non si fosse comportato così. E quindi non posso neanche arrabbiarmi del tutto. È pure finito due volte sulla mia lista per l’Operazione ‘Fatti una vita’! Non solo come primo amico in tutta la scuola media, ma anche come primo amico perso (ehi, quando cerchi di farti una vita capitano cose belle e brutte, no?). Sì, ho ancora la mia lista. Sono arrivato a duecentosettantanove e non ho intenzione di fermarmi. Mi sono chiesto: perché smettere a centonovantacinque? Perché smettere, punto e basta? A volte mamma dice che vivere è come i lavori in corso, e io sono d’accordo. Sto ancora cercando di farmi una vita e FORSE, magari, diventare un artista. Chi lo sa? Il che mi porta all’ultima cosa buona che è capitata, finora. Swifty mi ha dato l’opportunità di aggiungere una voce alla lista: la mia prima vera mostra. Forse è stato perché avvertivo meno la pressione, non lo so, ma non mi ci è voluto molto per capire cosa volessi fare. Anzi, mi è quasi sembrato ovvio, adesso che ci ripenso. Voltate pagina e guardate. All’inaugurazione sono venuti tutti e hanno mangiato una tonnellata di torta. Jeanne ha portato i suoi genitori, la signora Donatello suo marito, Capello il Bigfoot dei sigari di cioccolato. Hanno fatto un salto anche due o tre insegnanti della Airbrook. Da una parte è stato un po’ imbarazzante, ma dall’altra è stata la serata migliore della mia vita. Finora, naturalmente. INDICE Presentazione Frontespizio Pagina di Copyright 1 VUUUM! 2 TRASLOCO 3 PIÙ O MENO 4 LA MIA TOP TEN (CON SOLE SEI VOCI, VERAMENTE) 5 BENVENUTI NELLA METROPOLI! 6 PICCOLA... E STIPATA 7 UNA SERATA IN CITTÀ 8 PAUSA 9 MAMMA E IL SUO TIRO MANCINO 10 IL RITORNO DI LADY DRAGON 11 IL COLLOQUIO 12 DENTRO 13 SALUTI DALLA METROPOLI! 14 VENTIDUE ORE E QUARANTANOVE MINUTI DOPO (NON CHE STESSI TENENDO IL CONTO, O COSA) 15 IL PRIMO GIORNO DEL RESTO DELLA MIA VITA 16 IL PRIMO GIORNO SUL PIANETA CATHEDRAL 17 LA FREGATURA 18 L’ESSENZA DELL’ARTE 19 E LA GRANDE IDEA? 20 IN CONDIZIONI KRIT–ICHE! 21 NASCOSTO IN BAGNO 22 E LA VENDETTA È DOLCE (E BAGNATA) 23 OPERAZIONE: FATTI UNA VITA 24 BENE, MALE, PEGGIO 25 IL RAGNO CRAWLEY 26 OPERAZIONI SEGRETE 27 CONSIGLI PER LA SOPRAVVIVENZA 28 LA MIA NUOVA VITA, FASE 1 29 LEO ALZA IL LIVELLO 30 UN ALTRO PUNTO DI VISTA 31 QUESTO È IL TUFFO NEI BIDONI 32 VECCHIE FOTO 33 TANTE DOMANDE 34 SALONE CAPELLO 35 VUOTO IL SACCO (PIÙ O MENO) 36 CHE GIORNATA! 37 LA RISPOSTA DI DOTTY 38 CI RISIAMO 39 GUERRA! 40 RI-VENDETTA 41 UN PIANO COI FIOCCHI 42 OPERAZIONE ‘ARTEPIMENTO’ 43 QUANTO MI MERITAVO, E PURE DI PIÙ 44 RAFE KHATCHADORIAN: IL PEGGIOR FIGLIO AL MONDO 45 COME RAFE È SOPRAVVISSUTO ALLA SOSPENSIONE A SCUOLA 46 L’ARTE DI ARRANGIARSI 47 SEREN(ISSIM)O NATAL 48 ALLA GRANDE OPPURE NIENTE 49 L’APPOSTAMENTO 50 BECCATI! 51 NON ADESSO 52 TRENTADUE TRILIONI E PASSA 53 CARTOLINE A CINQUE DOLLARI, UN CERTO MONDRIAN E QUALCHE ALTRA COSETTA CHE MI È SFUGGITA 54 L’ASSEDIO! 55 NON È GIUSTO 56 MATTY IL FURIOSO 57 LA PRIMA PARTE DELLA PARTE PEGGIORE 58 IL RESTO DELLA PARTE PEGGIORE 59 ME NE VADO 60 SOLO DI PASSAGGIO 61 DI NUOVO IN VIAGGIO 62 BE’, SE AVESTE DOVUTO VIAGGIARE CORRIERA CALDA E PUZZOLENTE VI INVENTATI UNA STORIA PURE VOI 63 RIECCOMIII! 64 UNA NOTTE FUORI CASA 65 LA VERITÀ SU UNA SARESTE 66 PAUSA 67 UNA PILA ALTA 68 IL MIO LIETO (PIÙ O MENO) FINE
Scarica





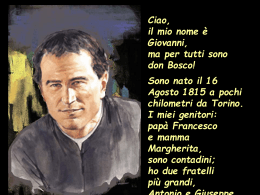
![Felaco_elaborato7[1]..](http://s2.diazilla.com/store/data/000084584_1-c0d32aa64ea920109a8a507124e0b22f-260x520.png)