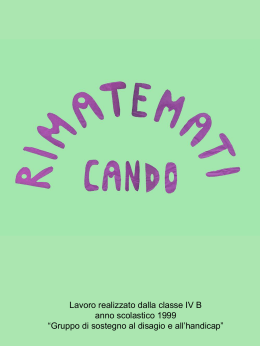L’Associazione Culturale Acquaticità & Medicina Naturale “AcquaMeNa” presenta Le AcquaCoccole Tutte le Magie dell’Acqua, in … Coccole www. massimopietrangeli.net WATER SHIATSU Training pre-parto in piscina Massaggio Neonatale Psicomotricità Naturopatia Rilassamento profondo Percorso Nascita Naturale Acquaticità 0-4 anni Terapie naturali Anti-Stress Diagnosi-cura Intolleranze Somatopsicoterapia Dr. Massimo Pietrangeli - Pediatria O.C. di Pescara Info: 348.8621980 Corso alle ASSISTENTI SPECIALIZZATE PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI Dott. Massimo Pietrangeli Neonatologo - Pediatra Perfezionato in Scienze Motorie Istruttore Pediatric Basic Life Support IL BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE L’ ETA’ EVOLUTIVA non è un concetto puramente cronologico, ma un periodo della vita umana dominato e regolato da leggi specifiche, e la cui principale caratteristica ( che non deve essere mai tradita ) è rappresentata dalla NECESSITA’ per il bambino DI APPRENDERE in maniera creativa, al fine di costruire una realtà personale inseribile armonicamente in una dimensione sociale più ampia e totalizzante. DISABILITA’ e SOCIETA’ Qualsiasi programma che interessa l’età evolutiva deve obbligatoriamente considerare queste due esigenze : Il rispetto più rigoroso delle esigenze evolutive e La disponibilità dialettica della società a proporsi al B. in termini di comprensibilità, accettabilità, coerenza REQUISITI FONDAMENTALI Verificare la Propria disponibilità e la Propria capacità di mettersi al servizio del B diversamente abile, sempre sgombrando il più possibile il campo da pregiudizi, preconcetti, luoghi comuni, impostazioni culturali rigide che limitino eccessivamente o del tutto il lato istintivo dell’approccio al mondo dell’handicap REQUISITI FONDAMENTALI Preparazione specifica per poter meglio affrontare i diversi tipi di handicap Verifica periodica - in equipe - della bontà dei metodi e delle metodiche adottate, in maniera critica, analitica, e con la massima disponibilità a cambiare tiro, a rimettere continuamente in discussione ed eventualmente modificare l’approccio PREREQUISITI FONDAMENTALI CAPACITA’ / ABILITA’ personale innata, istintiva Grande ELASTICITA’ MENTALE Grande AMORE verso il prossimo, specie quando questo ci si mostra sotto le spoglie del diversamente abile o dell’inabile totale HANDICAP e SOCIALIZZAZIONE INFANTILE • • Anni fa si parlava di INSERIMENTO ( “mettere dentro” un B cosiddetto “con dei problemi” assieme a BB cosiddetti “BB normali” ) Oggi si parla di SOCIALIZZAZIONE Ma come socializziamo? Il problema di fondo è che il gruppo in genere tende a rapportarsi al B come persona handicappata, dunque al suo handicap e non all’individuo in quanto persona QUALE SOCIALIZZAZIONE Il modo diverso di rapportarsi del gruppo nei confronti del B, e viceversa, conduce a un modo diverso di socializzazione. “Abbiamo un epilettico”, “Abbiamo un mongoloide”, “Abbiamo un cieco”: sono frasi che testimoniano inequivocabilmente come il B in quanto persona passi in secondo piano rispetto alla sua malattia o al suo disturbo COME RAPPORTARCI Chiediamoci allora tutti COME ci rapportiamo col B con handicap nonostante il suo H, a prescindere dal suo H, e Proviamo ad accostarci a quel B come persona che, fra tutte le sue varie caratteristiche, ha anche quella dell’ H di cui è portatore ; proviamo ad accostarci a quel B come facciamo col gruppo di BB “normali” QUANTO E’ IMPORTANTE SENTIRSI ACCETTATI Il B diversamente abile riuscirà a socializzare in misura direttamente proporzionale al modo in cui verrà accettato come PERSONA GLOBALE, e questo discorso sarà fondamentale, importantissimo per la possibilità di realizzare degli specifici programmi di lavoro BISOGNI ESSENZIALI DEL D.A. NELLA SOCIALIZZAZIONE Essere riconosciuto come PERSONA Poter esprimere e condividere le sue angosce inerenti al suo handicap Realizzare, conoscere meglio, le specifiche difficoltà che ruotano intorno al suo handicap CONOSCERE IL BAMBINO Il primissimo “step” è quello di stabilire un rapporto con la famiglia, per una conoscenza che offra la possibilità di farsi un’idea il più possibile esatta sulla STORIA del B, per poi impostare in maniera conseguente un programma di lavoro che sia concordante con ciò che viene implicitamente realizzato in ambito familiare STRATEGIE per CONOSCERE il BAMBINO OSSERVARE REGISTRARE RIFLETTERE ENTRARE IN COMUNIONE Da tutto ciò, dallo studio della sua storia pregressa, della sua storia familiare, dei suoi problemi oggettivi, dalla riflessione su ciò che il B con difficoltà vuole esprimere, e dall’ analisi dei bisogni per i quali egli chiede delle risposte, potrà scaturire un corretto programma di lavoro PROGRAMMA DI LAVORO Solo con l’approccio che dicevamo, e con un lavoro svolto collegialmente da parte della famiglia, del personale medico, dello psicologo, del fisioterapista, dell’insegnante di sostegno e degli assistenti, sarà possibile svolgere un programma di lavoro che diventa un discorso INDIVIDUALE, costruito e realizzato su misura partendo dalle CARATTERISTICHE e dai BISOGNI del Bambino diversamente abile LA SCUOLA E’ DI TUTTI E DI CIASCUNO Socializzazione, secondo Sergio Neri, significa rottura degli schemi prestabiliti, per cui FAR SOCIALIZZARE UN B NON SIGNIFICA ADATTARE UN B ALLA SITUAZIONE SCOLASTICA, MA ADATTARE LA SITUAZIONE SCOLASTICA AI BISOGNI DEI BB, rendendo il problema del B un problema del gruppo, e qui realizzare il significato ultimo della socializzazione, intesa come una modificazione che investe tutta la persona ma anche tutto il gruppo in cui essa viene ad inserirsi FORMAZIONE-SOCIALIZZAZIONE E’ dunque un “modello circolare”, in cui il bisogno del singolo viene recepito dal gruppo, il quale lo elabora e dà una risposta che nello stesso tempo fa maturare il gruppo medesimo Dunque non si seguono più, come una volta, le due linee della socializzazione e della formazione, in quanto la formazione fa parte integrante della socializzazione La socializzazione, con questo scambio bidirezionale, acquista dunque un significato di COMUNICAZIONE, e comunicazione in questo caso significa CONOSCERE dall’una e dall’altra parte, vale a dire mettere assieme le cose che si hanno: i BISOGNI del D.A. e la capacità di risposta da parte del gruppo di cui il D.A. viene a far parte Dal momento che il comunicare del D.A. si realizza nei modi più svariati, la scuola proporrà delle attività che permettano lo sviluppo della sua personalità infantile IL D.A. NELLA SCUOLA CONSIDERAZIONI GENERALI 1. La socializzazione dipende fortemente dalla capacità che gli operatori hanno di modificare il contesto in cui il ragazzo viene ad inserirsi, affinchè in quel contesto il ragazzo possa esprimersi al meglio 2. Ogni B, H o non H, dovrebbe avere un proprio piano di lavoro 3. Spesso un genitore vive la propria relazione con i figli con handicap con un senso di colpa o di vergogna che deve essere aiutato a superare non certo colpevolizzando ulteriormente la famiglia, ma cercando di coinvolgerla al meglio, direttamente, in un programma di recupero e/o potenziamento delle capacità e delle potenzialità del B 4. Per q.r. la valorizzazione delle potenzialità e delle capacità del B, va ricordato che nel momento in cui noi parliamo di “BAMBINO portatore di H” ci accostiamo implicitamente ai suoi aspetti positivi e quindi alla possibilità di sviluppare le sue potenzialità, esattamente al contrario di quando – adottando etichette tipo “l’epilettico”, “il mongoloide” – concentriamo la nostra attenzione sulla malattia, sugli E’ SOLAMENTE RINFORZANDO GLI ASPETTI POSITIVI ANCORA DISPONIBILI CHE ESSI POSSONO ESSERE SVILUPPATI E POTENZIATI, CON MIGLIORAMENTI SPESSO MOLTO ECLATANTI O ADDIRITTURA SORPRENDENTI IL CERVELLO NON FUNZIONA “PER COMPARTIMENTI STAGNI”, PER CUI, AD ESEMPIO, UN MIGLIORAMENTO NELL’AREA VISIVA SI RIFLETTERA’ POSITIVAMENTE SULL’AREA MOTORIA, E VICEVERSA… SOCIALIZZARE IL PROBLEMA DEL DIVERSAMENTE ABILE Il problema dell’educazione va “socializzato” alla famiglia Deve esservi continuità anche nelle attività specifiche della riabilitazione, le quali è bene non siano asettiche, separate dal contesto della vita familiare del bambino D.A. Socializzare il problema del D.A. significa renderne partecipi tutte le persone che col B hanno delle relazioni Socializzarlo vuol dire quindi partire da ciò che di positivo è avvenuto all’interno del gruppo e all’interno della comunicazione ( non del solo D.A. ) Non ci può né ci deve essere un intervento su due binari diversi, uno della socializzazione e l’altro della riabilitazione o del recupero, ma le due cose devono essere integrate Le dinamiche del D.A. e del gruppo varieranno continuamente e vanno conseguentemente aggiornati obiettivi, strategie e metodi
Scarica