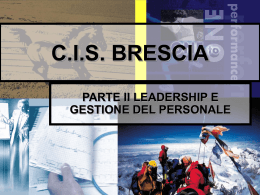Quaderni di Ricerca quaderni di ricerca Apprendimento e flessibilità del lavoro: la logica delle carriere organizzative nel post-fordismo Massimo Follis Copertina e grafica: 24Hoursdesign Stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Sociali fondi locali (ex quota 60%) anno 2003 progetto di ricerca dal titolo: "Le carriere dei lavoratori tradizionali e dei lavoratori atipici come meccanismi sociali. Una prospettiva comparata" Quaderni di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino, n° 3, maggio 2004 Apprendimento e flessibilità del lavoro: la logica delle carriere organizzative nel post-fordismo. di Massimo Follis Edizioni Libreria Stampatori Via S. Ottavio, 15 10124 Torino tel.011 836778 - fax 011 836232 e-mail: [email protected] ISBN 88-88057-49-8 INDICE Abstract 1. Il vantaggio retributivo delle carriere organizzative e le promozioni "senza mobilità" 1.1. Introduzione 1.2. Il vantaggio comparato delle carriere organizzative e della mobilità esterna 1.3. La logica delle promozioni senza mobilità 1.4. Conclusioni 2. Apprendimento continuo e carriere orizzontali 2.1. Introduzione 2.2. La riproduzione delle competenze professionali il mercato interno del lavoro fordista 2.3. Le coordinate della problematica della formazione in contesti di lavoro knowledge centered" 2.4. La carriera orizzontale come leva dell'apprendimen to continuo 2.5. Conclusioni Riferimenti bibliografici pag. 1 pag. 1 pag. 5 pag. 19 pag. 34 pag. 39 pag. 39 pag. 42 pag. 46 pag. 53 pag. 61 pag. 65 ABSTRACT Il quaderno abbina due lavori che affrontano da punti di vista complementari l’evoluzione delle carriere organizzative nel passaggio dal fordismo al post-fordismo. Il primo concentra l’attenzione sul vantaggio retributivo delle promozioni rispetto ai cambiamenti volontari d’impresa. Il problema è stato paradossalmente trascurato dalla letteratura economica e sociologica, ma tre recenti ricerche consentono finalmente di delinearne le coordinate. Le promozioni nelle gerarchie delle posizioni organizzative sono sempre associate ad aumenti retributivi superiori a quelli conseguibili via cambiamenti d’impresa, ma la loro minore frequenza le rende relativamente meno vantaggiose nel medio periodo; se però si considerano anche le promozioni indipendenti da cambiamenti di posizione organizzativa, il vantaggio si rovescia. La seconda parte del lavoro s’interroga sulla logica di questa fattispecie di promozioni e, dopo averne identificato le caratteristiche organizzative, suggerisce, sulla base delle evidenze fornite dalle stesse ricerche menzionate e della teoria degli incentivi retributivi, che esse servano essenzialmente a motivare i lavoratori ad incrementare le proprie competenze. Nel secondo contributo quest’ipotesi viene sviluppata in una prospettiva analitico deduttiva, sulla base delle nuove determinazioni che assume l’apprendimento sul lavoro in contesti produttivi caratterizzati dalla rapida innovazione dei prodotti e dei processi e in cui l’assetto regolativo del lavoro si sposta dall’azione alla conoscenza. Se apprendere diventa una condizione dell’evoluzione dei ruoli lavorativi a tutti i livelli dell’organizzazione, il tradizionale mercato interno del lavoro perde un suo scopo essenziale. Se, inoltre, diventa inseparabile dallo stesso svolgimento dei compiti lavorativi e dalle relative interazioni organizzative, occorre rivedere le stesse categorie dell’investimento in formazione sul lavoro ed ammettere che un suo adeguato sviluppo presuppone la risoluzione di due distinti, ma correlati, problemi di coordinamento: tra impresa e lavoratori (circa il loro effettivo impegno ad apprendere), tra imprese diverse (circa la disponibilità a rendere facilmente osservabili le competenze acquisite dai loro dipendenti). La seconda parte del lavoro si concentra sul primo dei due problemi ed argomenta, anche in riferimento ad evidenze empiriche, i vantaggi della soluzione d’incentivare l’acquisizione di competenze con aumenti stabili di retribuzione (ovvero con promozioni in una gerarchia di merito), tra cui la possibilità di raccordare le promozioni interne alla mobilità esterna, così da lasciare alle imprese una sufficiente flessibilità allocativa e ai lavoratori la possibilità di progettare, in parte, la propria carriera. Nelle conclusioni vengono brevemente discussi i termini e le implicazioni essenziali del secondo problema di coordinamento, alla luce della teoria classica dell’azione collettiva. 1. Il vantaggio retributivo delle carriere organizzative e le promozioni “senza mobilità” 1.1. Introduzione La tesi che con l’avvento dei modelli produttivi “post-fordisti” sia iniziato un irreversibile smaltellamento dei mercati interni del lavoro è diventata un quasi luogo comune nella letteratura sociologica e in quella collegata alle business schools. A parte l’insuperabile difficoltà ad osservare direttamente il fenomeno invocato (cioè la contrazione dell’allocazione interna del lavoro rispetto a quella via mercato esterno)1, la tesi è viziata dal fatto di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione “quantitativa” del fenomeno. Le inferenze ricordate riguardano, infatti, la riduzione del numero d’imprese che adottano modalità di gestione delle relazioni d’impiego tipiche del mercato interno, e della platea dei lavoratori ai quali si offrono opportunità di carriera interna (Cappelli et al., 1997; Grimshaw et al., 2001). E’, invece, trascurata la dimensione “qualitativa” del fenomeno, relativa ai vantaggi retributivi associati alle carriere inter1 Gli specifici dati longitudinali sono praticamente irreperibili, se non limitatamente a singoli casi aziendali. Pertanto, il fenomeno viene, di norma, inferito da una serie di processi di cambiamento, tra cui soprattutto: la costante riduzione della dimensione delle imprese, la riduzione dei livelli delle gerarchie aziendali (delayering), l' “esternalizzazione” delle relazioni d’impiego mediante un uso massiccio di contratti di lavoro a tempo definito, la loro generalizzata “precarizzazione”. 1 ne. Fatta eccezione per la riduzione dei livelli delle gerarchie aziendali, che implica un’automatica riduzione delle opportunità d’avanzamento ad essi associate, non vi sono dati né argomenti che consentano d’inferire che i vantaggi retributivi conseguenti dalle progressioni di carriera interna siano diminuiti. Si tratta di una carenza sostanziale, anche se molto presumibilmente inavvertita dai fautori della tesi in questione. In realtà il problema del vantaggio retributivo delle carriere organizzative costituisce una carenza ab origine della problematica dei mercati interni del lavoro. Fino alla metà degli anni ’90, l’approccio empirico a questo tema ha interessato quasi unicamente gli epigoni dell’approccio istituzionalista e i sociologi. I primi hanno concentrato l’attenzione sulle differenze tra diversi sistemi di mercati interni del lavoro, trascurandone gli aspetti retributivi (Osterman, 1987). I secondi, animati dall’esclusivo obiettivo di dare un più preciso fondamento strutturale alla spiegazione delle diseguaglianze tra i redditi (Baron e Bielby, 1980; Althauser e Kalleberg, 1981), si sono concentrati sull’analisi dei meccanismi che condizionano le opportunità d’ascesa delle gerarchie aziendali, trascurando parimenti le conseguenze retributive delle promozioni2. Del resto il vantaggio fornito dalle carriere interne poteva essere dato per scontato, alla luce delle sistematiche evidenze che i sistemi retributivi aziendali prevedono, per lo più, elevati e crescenti differenziali, in funzione della classificazione gerarchica delle posizioni organizzative (Baron e Bielby, 1980). Gli economisti del lavoro per parte loro si sono preoccupati abbastanza precocemente di verificare l’effetto positivo dell’anzianità di servizio sugli aumenti di retribuzione, confermando che i differenziali di retribuzione tra posizioni situate a livelli gerarchici contigui sono più alti di quelli relativi ai lavoratori in ognuna delle medesime posizioni (Medoff e Abraham, 1980; Murphy, 1985). Tuttavia – al di là della produzione di modelli teorici sui sistemi d’allocazione interna del lavoro e sulla funzione incentivante delle promozioni (Gibbons e Waldman, 1998; Valsecchi, 2000) – il loro effettivo interesse per il funzionamento dei mercati interni del lavoro è molto più recente. Uno stimolo importante a questo fine è derivato dal contributo di Lazear (1992), che ha ispirato in particolare due lavori, basati sugli archivi di altrettante grandi imprese di servizi, i cui risultati, tra altro, hanno 2 Rassegne di queste ricerche sono fornite da Follis (1991) e Rosenfeld (1992). 2 permesso di completare la conoscenza degli effetti retributivi delle promozioni (Baker, Gibbs e Homstrom, 1994a; 1994b; Baker e Holmstrom, 1995; Treble et al., 2001) 3. Anche queste ricerche, però, hanno lasciato inesplorato il problema del vantaggio relativo delle carriere interne. Il problema comprende, in realtà, due aspetti distinti: da un lato gli incrementi di retribuzione conseguenti dagli avanzamenti nelle gerarchie aziendali; dall’altro lato la probabilità di ottenere tali avanzamenti, tenuto conto che le promozioni sono per definizione eventi decisi dalle direzioni aziendali, rispetto ai quali i lavoratori hanno al massimo un potere d’influenza. Economisti e sociologi si sono, per così dire, spontaneamente divisi il lavoro, dedicandosi rispettivamente al primo e al secondo di questi aspetti del problema, senza, però, preoccuparsi di metterli insieme. Di conseguenza, per quanto la cosa risulti paradossale, la ricerca empirica e l’analisi teorica sui mercati interni del lavoro e sulle carriere organizzative si sono sviluppate per circa venticinque anni, ignorando un aspetto essenziale del proprio oggetto di studio. Questa carenza assume un rilievo particolare alla luce della tesi dello smaltellamento dei mercati interni del lavoro e del suo corollario, che le opportunità di carriera sono tendenzialmente esperibili solo sul mercato esterno del lavoro (Arthur e Rousseau, 1996). Per falsificare queste ipotesi occorrerebbe, infatti, sapere proprio qual è il vantaggio relativo delle carriere interne rispetto a quello della mobilità sul mercato esterno del lavoro. Se restare in un’impresa, in vista di migliorare la propria posizione al suo interno, risultasse mediamente meno vantaggioso che spostarsi in un’altra impresa, le tesi in discussione sarebbero molto rafforzate. Se, invece, le convenienze relative fossero di segno opposto, la dimensione “quantitativa” della crisi dei mercati interni (cioè la riduzione della platea dei lavoratori cui si offrono opportunità di 3 Si tratta in sostanza della triplice evidenza che: i) i guadagni associati ai passaggi di livello gerarchico devono scontare le progressioni retributive nell’ambito delle medesime posizioni, ii) le direzioni aziendali tendono a promuovere soggetti che hanno raggiunto i livelli retributivi massimi nelle posizioni ricoperte; iii) costoro, accedendo ad una posizione situata al livello gerarchico successivo, percepiscono di norma la retribuzione minima ad esso associata. Di conseguenza, rilevando le discontinuità retributive conseguenti da promozioni, si ottengono valori significativamente inferiori a quelli previsti dalle classificazioni delle posizioni, le quali si riferiscono ovviamente alle retribuzioni medie nelle posizioni di partenza e di arrivo. 3 carriera interna) acquisterebbe un’importanza dirimente, e si aprirebbe lo spazio per più scenari di segmentazione del mercato del lavoro. Negli ultimi anni sono stati pubblicati tre lavori empirici (McCue, 1996; Pergamit e Veum, 1999; le Grand e Tåhlin, 2002) basati su altrettante indagini longitudinali di fonte istituzionale 4, che, per quanto non espressamente interessati all’argomento, consentono di cominciare a colmare questo vuoto, e, quantomeno, di delineare i termini fondamentali del confronto tra i vantaggi associati alle promozioni e quelli conseguenti dai cambiamenti volontari d’impresa, tenuto conto della probabilità di ottenere ognuno di questi vantaggi. Una di queste ricerche (Pergamit e Veum, 1999) evidenzia, inoltre, che l’opportunità di progredire nelle gerarchie aziendali è relativa a che cosa s’intende per promozione: se unicamente cambiamenti di posizione organizzativa rispetto alle gerarchie manageriali e professionali delle imprese, oppure anche passaggi di livello professionale e retributivo, indipendenti da 4 McCue (1996) e Pergamit e Veum (1999) si basano su rilevazioni panel. La prima ricerca utilizza un sottocampione del Michigan Panel Study of Income Dynamics (PSID) di 6.440 lavoratori dipendenti nell’industria e nei servizi in possesso di specifici requisiti quanto a istruzione e continuità lavorativa, in vista di analizzarne le vicende lavorative nel periodo 1976-1988. La seconda si serve dei dati della National Longitudinal Survey of Youth (NLSY), che a partire dal 1980 ha intervistato con cadenza regolare un campione di circa 10.000 giovani, che nel 1979 si trovavano nella fascia d’età 14-22. Di questa base dati Pergamit e Veum (1999) hanno preso in esame le vicende professionali esterne e interne dei lavoratori dipendenti a tempo pieno (esclusi i dipendenti pubblici, che anche negli USA sono passibili di promozioni “automatiche”), riscontrate nel 1989, quanto la coorte studiata era nella fascia d’età 24-32 anni, nonché gli incrementi di retribuzione rilevati tra il 1989 e il 1990 e il 1989 e il 1996 - l’ultimo anno del panel NLSY utilizzabile. La terza ricerca (le Grand e Tåhlin, 2002) si basa, invece, su dati retrospettivi raccolti dalla Swedish Level of Living Survey (SLLS), relativi alle storie di vita di un campione rappresentativo di 3.466 cittadini svedesi, di cui gli autori hanno utilizzato le informazioni relative ai soggetti maschi, nati tra il 1925 e il 1955, che in coincidenza dei 26 e dei 35 anni d’età erano risultati occupati come lavoratori dipendenti. La loro ricerca, quindi, riguarda il segmento iniziale della vita professionale (i dieci anni a cavallo dei 30 anni d’età) delle venti successive coorti di lavoratori compresi nella base dati SLLS – a partire da quelli che avevano compiuto 26 anni nel 1951, fino a quelli che, avendo 26 anni nel 1981, avevano raggiunto i 35 anni nel 1990 (l’anno terminale della SLLS). 4 qualsiasi cambiamento di posizione. Qui di seguito ci proponiamo appunto di analizzare i risultati di queste ricerche e le conseguenze che ne derivano. 1.2. Il vantaggio comparato delle carriere organizzative e della mobilità esterna I lavori di le Grand e Tåhlin (2002), McCue (1996), Pergamit e Veum (1999) forniscono due importanti vantaggi al fine del nostro problema di ricerca. Per un verso, in ragione della stesse dimensioni dei campioni su cui si basano, danno la garanzia di rappresentare l’intero spettro della popolazione occupata, e in particolare la situazione dei dipendenti delle piccole imprese. Questi ultimi, pur costituendo la maggioranza relativa degli occupati, costituiscono da sempre una “scatola nera”, per ciò che riguarda mobilità interna e promozioni. Le equazioni stimate in queste ricerche non considerano la dimensione delle imprese e pertanto non colmano la lacuna, ma almeno danno la certezza che le loro stime dei vantaggi delle promozioni rispetto a quelli conseguibili via mobilità esterna comprendono le presumibili differenze d’opportunità, che caratterizzano la carriera interna secondo la dimensione delle imprese. Per un altro verso, questi lavori si concentrano sulla fase iniziale della vita di lavoro – due in modo esclusivo, McCue (1996) fornendo opportune disaggregazioni per fasce d’età. L’interesse per la fase iniziale della vita lavorativa si giustifica per svariate ragioni, ma ai nostri fini, per tre motivi essenziali: i) il ruolo cruciale che hanno le decisioni che si prendono in questa fase per il proprio futuro lavorativo; ii) La maggiore propensione alla mobilità esterna, che caratterizza i giovani lavoratori, testimoniata dal rapidissimo declino dei tassi di mobilità oltre i 35 anni; iii) la maggiore propensione delle imprese a concentrare gli investimenti (in formazione e in valutazione del potenziale) sui giovani5. 5 Le due ricerche americane considerano anche come il genere condizioni sia la probabilità di essere promossi, sia i rendimenti degli eventi in questione. Ne risultano evidenze di grande interesse, che confermano e integrano quelle prodotte dalla vasta letteratura sociologica ed economica all’insegna del “tetto di vetro” – l’efficace metafora che connota le minori opportunità delle donne nella progressione delle gerarchie manageriali e professionali. Tuttavia, la loro considerazione im- 5 Peraltro il modo in cui queste ricerche misurano l’evento promozione – aspetto evidentemente cruciale ai nostri fini – pone problemi di trasparenza, confrontabilità e completezza. Da un lato esse godono del vantaggio di basarsi su indagini (panel o retrospettive), in cui gli episodi di mobilità esterna e interna (promozioni) sono rilevati mediante domande dirette agli intervistati, che evitano di doverli inferire da altre informazioni (la diversa denominazione delle posizioni, la loro durata, ecc., come avviene inevitabilmente nelle base dati di fonte istituzionale), e forniscono maggiori garanzie circa la loro effettiva natura e la loro incidenza temporale. Dall’altro lato, però, si servono di definizioni operative dell’evento promozione seriamente inadeguate, soprattutto quando l’identificano con “cambiamenti di posizione organizzativa”, ma anche quando riconoscono, come Pergamit e Veum (1999), che la fattispecie del cambiamento di posizione non esaurisce il fenomeno. Nel primo caso, infatti, occorre tenere conto che i cambiamenti di posizione organizzativa sono del tutto relativi ai sistemi di classificazione delle posizioni stesse, i quali variano sensibilmente da un’impresa all’altra, sino all’estremo dettaglio di quelli adottati dalle grandi imprese, spesso articolati in diverse centinaia di posizioni (Lazear, 1992). Pertanto, secondo i criteri adottati in fase di rilevazione e/o di codifica (sostanzialmente secondo il livello di disaggregazione al quale si considerano i sistemi di classificazione), l’entità del fenomeno rilevato può variare sensibilmente. Ma né McCue (1996) né le Grand e Tåhlin (2002) forniscono indicazioni in proposito. La rilevazione del 1990 del NLSY aveva, invece, utilizzato una diversa definizione di promozione, articolata in otto categorie, di cui cinque volte a specificare diverse modalità di cambiamento di posizione, e due relative a cambiamenti di status organizzativo non associati al passaggio ad altra posizione, né ad alcuna modificazione di quella ricoperta6. Purtroppo, anche Pergamit e Veum (1999) non forniplicherebbe dilatare eccessivamente lo scopo e la lunghezza di quest’articolo. Farò un’eccezione per alcuni risultati di McCue (1996), rispetto ai quali la distinzione di genere è importante per comprendere il vantaggio relativo delle promozioni rispetto alla mobilità esterna. 6 Le otto categorie, non si sa se predefinite o ricavate in occasione della codifica di domande aperte, sono: 1) “promosso al posto di un precedente supervisore”; 2) “promosso a una posizione di livello superiore in un diverso reparto/ufficio”; 3) 6 scono sufficienti chiarimenti circa queste due ultime categorie ed in particolare circa la seconda di esse, nonostante la loro inclusione nello schema di rilevazione avesse prodotto conseguenze clamorose circa l’entità del fenomeno promozione, tanto da giustificare l’interrogativo del titolo del saggio in questione. 1.2.1. Le opportunità di essere promossi e di cambiare impresa Considerando i dati PSID relativi ai soli lavoratori bianchi maschi con 10 anni d’esperienza lavorativa (McCue, 1996: 182), per consentire il confronto con i dati SLLS, il tasso annuale di cambiamenti d’impresa risulta pari a 18.0 e quello delle promozioni sub specie di cambiamenti di posizione organizzativa a 6.7. Le Grand e Tåhlin (2002) producono evidenze analoghe. Poco più della metà dei lavoratori del loro campione (50.7%) aveva cambiato impresa almeno una volta nel decennio di riferimento e 21% due o più volte, mentre 24% erano stati promossi almeno una volta in una posizione organizzativa di livello superiore e il 6.7% più di due volte. Il diverso riferimento temporale dei dati non consente un confronto puntuale, ma una prima conclusione plausibile è che i cambiamenti di lavoro (d’impresa e di posizione organizzativa, sub specie di promozione) sono più frequenti negli USA che in Svezia. Nella misura in cui il mercato del lavoro svedese e i sistemi di regolazione delle relazioni d’impiego vigenti in quel paese possono essere considerati rappresentativi di quelli europei, si potrebbe dire, più frequenti negli USA che in Europa. Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra mobilità esterna e promozioni, gli USA sembrerebbero presentare un rapporto più svantaggioso della Svezia/Europa: 6.7 a 18 contro 24 a 50. Tuttavia, occorre considerare che secondo McCue (l996: 179) i dati PSID impediscono d’identificare correttamente i cambiamenti di posizione classifi“scelto per occupare una nuova posizione”; 4) “promosso in seguito a una riorganizzazione”; 5) “spostato a una posizione di analogo livello in un diverso reparto/ufficio”; 6) “la posizione ricoperta è stata classificata a un livello superiore (upgraded)”; 7) “promosso continuando a svolgere all’incirca gli stessi compiti”; 8) “altro. Le modalità 1-5 identificano cambiamenti di posizione; la 6 e la 7, promozioni “nella posizione”, secondo l’efficace espressione degli autori. 7 cabili come promozioni, causando una sottorappresentazione del fenomeno, anche se d’entità imprecisata. Comunque, la differenza tra i tassi di promozione risultanti dalle due rilevazioni è certamente inferiore. Il che consentirebbe di concludere prudentemente che sia in Svezia/Europa, sia negli USA la frequenza dei cambiamenti d’impresa è all’incirca doppia di quella degli avanzamenti nelle gerarchie organizzative. La conclusione è coerente con le scarse, ma uniformi evidenze che si hanno sulle dinamiche delle carriere organizzative. Le ricerche di Lazear (1992), Baker, Gibbs, Holmstrom (1994a) su due grandi imprese americane e di Treble et alii (2001) su una banca inglese, mostrano che il reclutamento dal mercato esterno non concerne esclusivamente e nemmeno prevalentemente le posizioni situate alla base delle linee di carriera aziendali – come avevano suggerito Doeringer e Piore (1971) – bensì riguarda quasi tutti i livelli delle gerarchie aziendali. Ne conseguono contemporaneamente un vincolo alle opportunità degli insiders di salire di livello in tali gerarchie, e uno stimolo alla mobilità esterna, per cui è del tutto plausibile che a livello aggregato i cambiamenti di posizione gerarchica risultino meno frequenti di quelli di cambiamento d’impresa. Tuttavia le evidenze prodotte da Pergamit e Veum (1999) impediscono di concludere che le opportunità effettive di carriera interna, rispetto a quelle (presunte) di carriera esterna stanno in un rapporto di 1 a 2. Ciò è vero, appunto, solo se s’identificano le promozioni con “cambiamenti di posizione organizzativa”; ma, se si estende il concetto ad eventi indipendenti da qualsiasi cambiamento, il quadro delle opportunità cambia completamente. Nel 1989, anno di riferimento dell’analisi di Pergamit e Veum (1999), quando la leva considerata aveva 24-35 anni, 23 intervistati (maschi e femmine) su 100 avevano lasciato la loro impresa, di cui 18 di propria iniziativa e il restante 5 in seguito a licenziamento. Nello stesso anno 10.4 avevano assunto una nuova posizione lavorativa all’interno della propria impresa. Escludendo i casi classificati come “spostamento laterale in un altro reparto” e “altro”, questi cambiamenti di posizione erano stati identificati in gran maggioranza (9.3%) come promozioni (Pergamit e Veum, 1999: pag. 585 con mie rielaborazioni). Si noti che queste evidenze sono identiche o simili a quelle prodotte dal PSID e che ne risulta un rappor- 8 to promozioni/mobilità esterna pari a 9.3 a 18 – presumibilmente quasi uguale a quello che avrebbe ottenuto McCue (1996), se avesse potuto rilevare correttamente i passaggi a posizioni di livello superiore. Ma dall’indagine NLSY risulta anche che un altro 13.72% degli intervistati avevano ricevuto una promozione restando nella medesima posizione” (6.4% via upgrading della posizione stessa; 7.3% continuando a svolgere gli stessi compiti) 7. Ne consegue uno scenario delle opportunità di carriera sostanzialmente diverso da quello delineato più sopra. Da un lato il rapporto tra tasso (complessivo) di promozioni e tasso di mobilità passa da negativo a positivo: 23 contro 18. Dall’altro lato, facendo uguali a 100 i 2583 intervistati che nell’anno di riferimento non avevano cambiato impresa, e supponendo costanti i valori riscontrati, risulta una probabilità annuale di ricevere una promozione pari a 0.314, di cui 0.118 via cambiamenti di posizione e 0.180 senza alcun cambiamento. A ciò si può aggiungere che 8.7 volte su 10 coloro che erano risultati promossi nel 1989 avevano asserito di “considerare possibile un’altra promozione nella posizione attualmente ricoperta”. 1.2.2. Gli incrementi di retribuzione associati alle promozioni e ai cambiamenti d’impresa I vantaggi retributivi conseguenti dalla mobilità esterna e dalle promozioni sono stati categorizzati dalle due ricerche americane in riferimento alla retribuzione oraria – anche se l’opzione obbliga ad assumere che le componenti variabili della retribuzione e in particolare i premi di produzione non varino significativamente in seguito a cambiamenti di posizione (McCue, 1996: pag. 179). La SLLS, su cui si basa il lavoro di le Grand e Tåhlin (2002), ha ricavato, invece, l’informazione sulle retribuzioni 7 A conferma del carattere non puramente simbolico delle promozioni senza mobilità sta l’evidenza che 9 volte su 10 coloro che si erano dichiarati promossi, quindi compresi i recettori di questo tipo di promozioni, avevano anche dichiarato che la promozione ricevuta “aveva comportato un aumento di retribuzione” (Pergamit e Veum, 1999: 586). 9 pregresse dalle dichiarazioni dei Redditi degli intervistati, rese accessibili dalla rilevazione del loro codice fiscale8. McCue (1996: 183) presenta alcune statistiche descrittive relative agli aumenti annuali medi di retribuzione, distinti per fasce d’anzianità lavorativa e per sesso e razza. Questi dati mostrano con chiarezza che la mobilità “paga” rispetto alla decisione di mantenere un impiego senza percepire promozioni. Nella fase iniziale della vita lavorativa determina un incremento annuale di retribuzione quasi doppio rispetto a quello associato alla stagnazione della situazione lavorativa, e nelle fasi successive una differenza via via più marcata. Però, i medesimi dati ci dicono anche che, nel breve periodo le promozioni “pagano” di più della mobilità esterna. Chi, restando nella propria impresa, viene promosso ad una posizione di livello superiore, nell’anno successivo guadagna dal 30 al 500% di più di chi aveva deciso di cambiare datore di lavoro. L’anzianità lavorativa e il genere svolgono in questo processo un ruolo complesso. Per un verso i lavoratori più giovani non risultano affatto penalizzati dalla scelta di non cambiare impresa; per un altro la stessa scelta risulta addirittura avvantaggiare le donne e i neri, coerentemente con l’assunto che la protezione dalla competizione “sul prezzo” è la funzione principale dei mercati interni del lavoro (Thurow, 1975). Il quadro è precisato da Pergamit e Veum (1999: 591-593), che stimano una serie di modelli di regressione, in cui il vantaggio degli eventi in esame è espresso nei termini degli aumenti percentuale di retribuzione, che ne sono conseguiti in media nell’arco di un anno – tecnicamente, dalla differenza tra i logaritmi delle retribuzioni orarie percepite nei due anni. Per facilitare il confronto che le altre due ricerche, si considerano qui di seguito solo le promozioni conseguenti da cambiamenti di posizione, prima a livello aggregato, poi distinte secondo le quattro modalità individuate: 8 Per la fascia d’età considerata queste dichiarazioni riguardano 9.3 volte su 10 unicamente redditi da lavoro. In tal modo è riuscita ad aggirare brillantemente l’ostacolo della fallacia della memoria, che impedisce alle indagini retrospettive di rilevare mediante interviste l’ammontare delle retribuzioni percepite nel passato. In tutte le ricerche si è, ovviamente, provveduto a deflazionare le dinamiche retributive rilevate, in modo da considerare incrementi reali. 10 Tab. 1 – Effetti dei cambiamenti volontari e involontari d’impresa e delle promozioni sugli incrementi di retribuzione nel breve periodo (19881989) (Fonte: Pergamit e Veum, 1999) Mobilità involontaria: Mobilità volontaria: Tutte le fattispecie di promozione: Promozioni dovute a: passaggi al ruolo di supervisore: passaggi ad un nuovo reparto: passaggi ad una nuova posizione: riorganizzazioni aziendali: - 8.01** 2.80 ** 6.61** 9.69** 8.27** 4.72 11.82** Livelli di significatività (test a due code) * 10% ** 5% Le evidenze sono coerenti con quanto ci si poteva aspettare. Chi viene licenziato, perde vantaggi di anzianità aziendale o è costretto ad accettare lavori meno remunerativi. Viene anche confermato che la carriera interna è più remunerativa della mobilità sul mercato esterno del lavoro9. La scarsa redditività delle dimissioni volontarie nel breve periodo è un fenomeno ben noto nella letteratura. Le ricerche classiche sulla mobilità lavorativa negli USA ci dicono che negli anni ’30 e ’40 i lavoratori che decidevano di cambiare impresa dovevano addirittura scontare una diminuzione di retribuzione in percentuali comprese tra l’11 e il 52, secondo i contesti locali (Parnes, 1954). In base ai dati della National Longitudinal Survey, elaborati da Akerlof, Rose e Yellen (1988: 552-557), negli anni ’60 e fino agli inizi dei ’70 le conseguenze retributive di breve periodo della mobilità volontaria (misurate in un intervallo di due anni) risultano in media 9 McCue (1996: 185) richiama anche l’attenzione sulla forma della distribuzione degli aumenti di retribuzione, da cui risulta che la varianza dei guadagni conseguenti da cambiamenti d’impresa è molto più alta di quella dei guadagni associati a promozioni. Queste ultime, per male che vada, lasciano immutate le retribuzioni reali, mentre nei casi migliori (al 75esimo percentile della distribuzione) determinano un aumento del 18%. Per le separazioni dall’impresa, invece, si registra in coincidenza del 25esimo percentile una riduzione della retribuzione del 10%, e al 75esimo, un aumento del 23%. Come facilmente intuibile, la carriera esterna è più rischiosa di quella interna. 11 sempre positive, ma con incrementi che non superano mai lo 0.3%. Una parte delle spiegazioni del fenomeno fa riferimento alle motivazioni che inducono a cambiare datore di lavoro. Le rilevazioni disponibili ci dicono, infatti, che la maggioranza delle separazioni volontarie sono motivate prioritariamente dall’insoddisfazione per l’ambiente di lavoro (inteso nel senso più ampio), e solo una minoranza, dall’aspirazione a una retribuzione più elevata. Le percentuali riscontrate nel campione NLS sono rispettivamente 57 e 25% (Akerlof, Rose e Yellen, 1988: 553). Tuttavia l’evidenza prodotta dalla medesima ricerca, secondo cui i soggetti che avevano cambiato lavoro, spinti dal guadagno, erano riusciti in due anni a conseguire un incremento della retribuzione oraria estremamente modesto (tra 0.27 e 0.56%), suggerisce che l’argomento motivazionale non è comunque sufficiente e che occorre andare a ricercare una spiegazione nei vincoli informativi che caratterizzano il processo di cambiamento di datore di lavoro. Non è questa la sede per approfondire l’argomento, ma l’intuitiva ragionevolezza dell’ipotesi suggerisce che, per valutare l’effettivo vantaggio relativo della carriera interna e della mobilità volontaria, è indispensabile considerare gli effetti retributivi nel medio periodo delle due prospettive. L’opportunità di quest’opzione ai fini del nostro interrogativo è rafforzata e qualificata dall’evidenza prodotta da le Grand e Tåhlin (2002: 388), secondo cui la mobilità esterna e la carriera interna si caratterizzano, già nella fase iniziale della vita lavorativa, come due modalità alternative di sviluppo delle carriere. L’indice di correlazione tra il numero di rapporti d’impiego instaurati dai lavoratori svedesi nei primi 10-15 anni della vita lavorativa (26-35 anni) e il numero dei cambiamenti di posizione organizzativa è – 0.51. La matrice mostra, inoltre, che coloro che avevano cambiato più di due imprese, non avevano ottenuto nessuna promozione. Tutte e tre le ricerche considerate forniscono evidenze circa gli incrementi retributivi nel medio periodo. Pergamit e Veum (1999: 591) hanno stimato un’equazione di retribuzione che assume come variabile dipendente la differenza tra i logaritmi delle retribuzioni orarie percepite nel 1989 e nel 1996 (limitatamente ai 2829 casi risultati occupati in quell’anno), e quindi rappresenta le conseguenze retributive dei cambiamenti avvenuti nel 1989 a distanza di sette anni, quando la coorte esaminata si trovava tra i 31 e i 42 anni. 12 Tab. 2 – Effetti dei cambiamenti volontari e involontari d’impresa e delle diverse fattispecie di promozione sugli incrementi di retribuzione nel medio periodo (1989-1996) (Fonte: Pergamit e Veum, 1999) Mobilità involontaria: Mobilità volontaria: Tutte le fattispecie di promozione (#) Promozioni dovute a: passaggi al ruolo di supervisore: passaggi ad un nuovo reparto: passaggi ad una nuova posizione: riorganizzazioni aziendali: 0.23 6.21** 6.44 11.85** 16.64** 20.92** Livelli di significatività (test a due code) * 10% ** 5% (#) ll coefficiente relativo all’insieme delle promozioni non è pubblicato Si tratta nuovamente di risultati plausibili, anche se per nulla scontati. Gli effetti avversi dei licenziamenti si riducono nel tempo, così come più che raddoppiano i guadagni conseguenti dalla decisione di lasciare volontariamente l’impresa. Ma questi restano comunque in media meno della metà di quelli conseguenti dalle passate promozioni10. I motivi del protrarsi dell’effetto positivo di questi eventi sono difficili da determinare. Tuttavia, la medesima ricerca fornisce due indicazioni precise e convergenti in proposito. Da un lato, la grande maggioranza di coloro che avevano ricevuto una promozione nel 1989, avevano anche dichiarato di avere ulteriori opportunità di promozione (Pergamit e Veum, 1999: 586). Dall’altro lato, la medesima ricerca evidenzia una forte correlazione positiva tra quest’evento e le promozioni percepite negli anni passati: coloro negli anni precedenti erano stati già promossi almeno una volta (s’intende nella medesima impresa) avevano avuto il 18% in più di probabilità di esse10 In tema di rendimenti di medio periodo delle promozioni è anche molto istruttivo il risultato di Baker, Gibbs, Holstrom (1994b) sulle conseguenze retributive della mobilità di carriera in una grande impresa: i dipendenti che in un arco di 5 anni erano stati promossi almeno una volta, avevano avuto un aumento di retribuzione del 28%, (rispetto a quella iniziale), a fronte di uno del 7%, conseguito da coloro che non erano stati mai promossi. 13 re nuovamente promossi nel 1989, rispetto a coloro che non lo erano ancora mai stati (Pergamit e Veum, 1999: 587-588). Nell’insieme questi dati confermano l’esistenza di una correlazione seriale tra le promozioni, che Rosenbaum (1984) ha qualificato con l’efficace immagine della “profezia che si auto adempie”. Si tratta di un risultato riscontrato in quasi tutte le ricerche quantitative sulle carriere organizzative sia all’interno d’imprese private che di enti pubblici, e che, pertanto, deve essere ormai considerato come un “fatto stilizzato” (Stewman e Konda, 1983; Rosenbaum, 1984; Brüdel, Diekman e Preisendörfer, 1991; Baker Gibbs e Holmstrom, 1994°; Spilerman e Petersen, 1999; Treble, van Gameren, Bridges e Barmby, 2001). Il lavoro di McCue (1996: 184-188) integra questi risultati sotto due aspetti importanti: da un lato, ponderando gli incrementi di retribuzione associati a mobilità esterna e interna per la probabilità del verificarsi di ognuno degli eventi; dall’altro depurando questi incrementi da quelli dovuti allo sviluppo economico, di cui, quindi, godono anche i lavoratori che non sperimentano né promozioni né cambiamenti d’impresa. In tal modo riesce ad esprimere il vantaggio retributivo di medio periodo, dovuto ad ognuno degli eventi considerati, nei termini del suo peso percentuale sull’incremento di retribuzione rilevato. Così, agli inizi della vita lavorativa (1-10 anni di lavoro), il conseguimento di una promozione da parte di un bianco contribuisce per il 9.47% all’incremento di retribuzione di cui ha usufruito, mentre, se avesse deciso di cambiare impresa, l’evento avrebbe contribuito per il 24.21%. Tab. 3 – Incrementi percentuali di retribuzione nel periodo 1976-1988, imputabili esclusivamente a mobilità esterna o a promozioni, secondo il genere e l’anzianità di lavoro (Fonte: McCue, 1996) Anni di lavoro 1-10 11-20 21-30 31-40 Mobilità esterna .2421 .2109 .1833 .1713 Uomini Promozioni .0947 .1062 .1057 .1166 14 Mobilità esterna .1210 .0036 .0067 -.0408 Donne Promozioni .1175 .1369 .1396 .1857 I risultati d’esercizi econometrici di questo tipo devono essere apprezzati soprattutto per la loro struttura, piuttosto che in relazione alla grandezza dei valori ricavati. Per esempio, secondo Topel e Ward (1992), la cui procedura statistica è stata riutilizzata da McCue (1996), il contributo della mobilità esterna alla crescita retributiva in un periodo di dieci anni è ben superiore a quello rilevato da questa ricercatrice. Correttamente letti in una prospettiva strutturale, questi dati dicono diverse cose interessanti. I maggiori vantaggi retributivi di breve periodo associati alle promozioni devono scontare la minore frequenza media delle promozioni stesse, cioè della probabilità di conseguirli, mentre i minori vantaggi conseguenti dai cambiamenti d’impresa vengono, almeno in parte, compensati dalla loro relativa maggiore frequenza. Tuttavia, il netto vantaggio relativo dei cambiamenti d’impresa per gli uomini non dipende solo dalla loro frequenza, ma evidentemente anche dalla qualità dei loro esiti, per cui queste decisioni, al di là delle motivazioni dichiarate, riflettono comunque valutazioni di convenienza economica. La qualità dei job match realizzati dagli uomini dipende plausibilmente dalle risorse sociali disponibili a questo fine e, specularmene, i bassi rendimenti delle decisioni di mobilità esterna delle donne, riflettono motivazioni personali, incentrate sull’esigenza di conciliare la “doppia presenza”, e/o le minori risorse sociali a loro disposizione per trovare lavoro. Le Grand e Tåhlin (2002) adottano una diversa procedura per depurare gli incrementi di retribuzione dagli effetti dello sviluppo economico, che consente stimare i vantaggi dovuti agli eventi in esame come “incrementi aggiuntivi di retribuzione”, rispetto a quelli dovuti alla crescita economica. La loro analisi degli incrementi di retribuzione, intervenuti nell’intervallo d’età considerato (26-35 anni), si basa su un’equazione di regressione in cui la frequenza dei cambiamenti di posizione organizzativa e d’impresa è misurata mediante due variabili dummy per ogni modalità di cambiamento; le consuete variabili di controllo (istruzione, anni d’esperienza lavorativa, anzianità nella posizione), sono categorizzate come incrementi intervenuti nel periodo di riferimento, e infine, ad esse viene aggiunta una misura della crescita economica, espressa dalla media degli incrementi nazionali di retribuzione per i periodi considerati. Il risultato saliente del modello è che, al netto degli effetti dovuti ai controlli 15 indicati, i cambiamenti d’impresa e quelli di posizione organizzativa hanno un effetto opposto, secondo la loro frequenza. Tab. 4 – Effetti del numero di cambiamenti di posizione (mobilità interna) e d’impresa (mobilità esterna) sugli incrementi aggiuntivi di retribuzione conseguiti tra i 26 e i 35 anni (Fonte: le Grand e Tåhlin, 2002) Mobilità interna Un solo cambiamento Due o più cambiamenti Mobilità volontaria esterna 2.39 19.39** 6.69** 5.04* Livelli di significatività (test a due code) * 10% ** 5% Questi risultati forniscono indicazioni preziose circa i vantaggi relativi delle carriere interne rispetto alla mobilità esterna. Sul versante della mobilità esterna, ci dicono che i vantaggi (aggiuntivi) conseguenti dalla decisione di cambiare impresa tendono a ridursi, a misura che la decisione si ripete. L’evidenza rinvia intuitivamente alla logica dei meccanismi che governano la mobilità esterna e aiuta ad interpretare i risultati di McCue, nel senso di ridurre il peso della capacità di muoversi sul mercato esterno come tale, rispetto a quello della qualità degli incontri che si realizzano 11. Sul versante delle carriere interne, evidenziano che la scelta di rimanere 11 Questa considerazione si può ricollegare all’ulteriore analisi svolta da le Grand e Tåhlin (2002) circa la qualità o lo “status” delle posizioni lavorative ricoperte, o più esattamente, l’incremento di status associato ai cambiamenti in esame. La variabile utilizzata a questo fine dai due ricercatori è una misura originale dello status professionale, costruita in riferimento alle 281 “professioni” risultanti dalla matrice di correlazione tra la classificazione ISCO a tre digit e cinque categorie di “classe sociale” (tre livelli di qualificazione per le professioni white collar e due per quelle blue collar), che esprime il valore potenziale di reddito associato ad ognuna di queste “professioni” (il reddito da lavoro atteso), al netto di una serie di fattori di variazione (istruzione, sesso, ecc.). L’inserimento di questa variabile nell’equazione dei differenziali retributivi – contrariamente a quello che ci si poteva aspettare – non determina una riduzione generalizzata dei guadagni derivanti da cambiamenti sul mercato esterno e interno, bensì provoca il dimezzamento di quelli associati ai cambiamenti d’impresa reiterati. Il che sta ad indicare che la principale motivazione che spinge a cambiare ripetutamente datore di lavoro è, almeno nella fase iniziale della vita lavorativa, l’aspirazione a migliorare lo status professionale dell’impiego. 16 nell’impresa rispetto a quella di cercare una migliore sistemazione altrove, “paga” (nel medio periodo), solo se si traduce in una successione di promozioni. Si tratta di un’ipotesi che trova conferme in due aspetti del funzionamento dei mercati interni del lavoro: l’aumento dei differenziali di retribuzione tra livelli gerarchici al crescere degli stessi (Gibbs, 1995; Hedstrom, 1988; Lambert, Larker e Weigelt, 1993; Murphy, 1998) la correlazione seriale tra i tassi di promozione, di cui si è già detto. Questo secondo aspetto trova una buona spiegazione nel vincolo delle imprese ad individuare le persone adatte a ricoprire posizioni che richiedono il possesso di qualità difficili da osservare (come per definizione quelle situati ai livelli non iniziali delle gerarchie aziendali), e quindi nel vantaggio fornito dalla possibilità di apprendere il potenziale dei propri dipendenti, osservandone le prestazioni, da cui deriva l’incentivo a sfruttare le informazioni così acquisite, promuovendoli ripetutamente12. E’ tuttavia indispensabile ricordare ancora una volta che il vantaggio retributivo delle promozioni ripetute deve scontare il vincolo della scarsità di opportunità, come conferma il fatto stesso che nel campione analizzato da le Grand e Tåhlin (2002) solo il 6.7% degli intervistati avevano ottenuto più di una promozione in dieci anni. 1.2.3. Conclusioni L’insieme delle evidenze empiriche sin qui considerate consente di formulare una duplice conclusione. La prima è che il vantaggio di breve periodo delle promozioni (rispetto alla mobilità esterna) si consolida e incrementa nel medio periodo, se queste non restano un fatto isolato: generalizzando, che il vantaggio relativo delle promozioni dipende dalla loro frequenza. Quest’affermazione trova un preciso riscontro nell’effetto d’interazione tra mobilità esterna e opportunità di carriera interna, evidenziato da molte ricerche sociologiche ed economiche, per cui le decisioni di cambiare datore di lavoro risultano sistematicamente associate (anche se in modo più o meno forte a seconda delle ricerche) alla percezione e/o all’effettiva disponibilità di opportunità di carriera nell’ambito 12 Per una rassegna di questi modelli si veda Valsecchi (2000). 17 dell’impresa in cui si trova13. Ciò rafforza il carattere strutturale del meccanismo sociale identificato da questa conclusione, rispetto al quale sono, quindi, irrilevanti sia la relativa “anzianità” delle evidenze empiriche, da cui deriva (si ricordi che si tratta della fine degli anni ’80); sia le caratteristiche istituzionali e dei sistemi di relazioni industriali, cui esse fanno riferimento. Tuttavia, come abbiamo già detto, la frequenza delle promozioni associate a cambiamenti di posizione organizzativa è subordinata alla disponibilità di posti vacanti, e quindi alla distribuzione per età dei dipendenti nei vari livelli, ai tassi di crescita delle imprese e soprattutto alla frequenza con cui le loro direzioni si rivolgono al mercato esterno, per allocare i posti situati ai livelli intermedi e superiori delle gerarchie. Per questi vari motivi risulta relativamente scarsa. Ma questa non è l’unica fattispecie di promozioni. La rilevazione NLSY ci dice che occorre tenere conto anche dell’esistenza di promozioni “nella posizione”, la cui frequenza è più del 50% superiore alle prime (Pergamit e Veum, 1999: 585). Questa realtà può cambiare radicalmente il quadro delle convenienze relative. Se, infatti, le promozioni “nella posizione” risultassero determinare incrementi di retribuzione analoghi a quelli conseguenti da promozioni associate a cambiamenti di posizione, la loro elevata frequenza ci obbligherebbe ad ammettere che l’effettivo vantaggio relativo delle carriere interne è molto più alto di quello rappresentato dai dati fin qui esaminati. I seguenti risultati dei modelli di Pergamit e Veum (1999: 593), già considerati più sopra a proposito degli effetti retributivi delle promozioni dovute a cambiamenti di posizione, sciolgono il quesito in modo netto. 13 Halaby (1986) ha trovato una forte correlazione positiva tra l’intenzione dichiarata o la decisione di cercare un nuovo impiego e la valutazione di avere scarse probabilità di ricevere una promozione nella posizione ricoperta. Meitzen (1986) ha stimato che la probabilità di lasciare un’impresa dipende significativamente dalle opportunità di crescita retributiva associate alle diverse posizioni lavorative, al netto dell’anzianità aziendale e di quella nella posizione. Petersen e Spilerman (1989), e in modo più approfondito Petersen, Spilerman e Dahl (1989) hanno considerato l’influenza delle opportunità di promozione sui tassi di dimissioni volontarie, fornendo consistenze evidenze che nelle aree organizzative in cui i tassi di promozione sono relativamente elevati, quelli di dimissione sono relativamente bassi e viceversa. 18 Tab. 5 – Effetti delle due modalità di “promozione nella posizione” sugli incrementi di retribuzione nel breve e nel medio periodo (Fonte: Pergamit e Veum, 1999) ǻ1990-1989 ǻ1996-1989 La posizione ricoperta è stata classificata ad un livello superiore 10.10** 8.93** Promosso continuando a svolgere all’incirca gli stessi compiti 7.09** 13.08** Livelli di significatività (test a due code) * 10% ** 5% Nel breve periodo le “promozioni nella posizione” rendono in media un po’ di più di quelle associate a cambiamenti di posto, e nel medio periodo un po’ di meno, ma comunque, più dell’incremento del 6.21, conseguibile via mobilità volontaria. Purtroppo, i dati a disposizione di Pergamit e Veum (1999) non consentono di stimare in modo adeguato il vantaggio retributivo di medio periodo della carriera interna “estesa” (promozioni con cambiamento di posizione e nella posizione) rispetto alla mobilità esterna. Ma è intuitivo che, se anche i lavori di McCue e di le Grand e Tåhlin (2002) avessero potuto tenere conto della seconda fattispecie di promozioni, i risultati delle loro stime del vantaggio relativo delle carriere interne e della mobilità esterna si sarebbero modificati alquanto, a favore della prima. Da qui la seconda conclusione, che, in ultima istanza, l’effettivo vantaggio relativo della carriera interna dipende dalla diffusione delle promozioni “nella posizione” come sistema di gestione delle relazioni d’impiego. 1.3. La logica delle promozioni senza mobilità La precedente conclusione pone un problema di verifica empirica, per il quale mancano al momento strumenti adeguati – oltre al lavoro citato. Nello stesso tempo, obbliga ad interrogarsi sulle ragioni per cui le imprese promuovono i propri dipendenti, senza far loro assumere una diversa posizione organizzativa, e, prima ancora, sul significato delle due tipologie di promozione identificate dalla NLSY, nonché su ciò che le differenzia sia dalle promozioni “normali” sia dagli altri sistemi di gestione delle relazioni d’impiego. Il punto interrogativo, che qualifica il titolo del 19 lavoro di Pergamit e Veum (1999), anticipa la sua incapacità a fornire una riposta a questi interrogativi, e le cose non vanno molto meglio, se ci si rivolge alla letteratura economica e sociologica14. Pertanto, non resta che procedere per tentativi, e cercare d’individuare in via deduttiva le proprietà organizzative delle promozioni senza cambiamenti di posizione, per poi discutere quali funzioni svolgono, sulla scorta di alcune, ulteriori evidenze prodotte da Pergamit e Veum (1999). 1.3.1. Gerarchie di posti e gerarchie di merito Due condizioni concorrono a dare un significato tecnico al concetto di promozione. La prima è che le retribuzioni normali (cioè al netto d’incentivi lineari e bonus) siano differenziate secondo una scala predeterminata, scandita in livelli discreti, di modo che il vantaggio che si consegue da una promozione è dato dal differenziale tra il livello retributivo di partenza e quello che si consegue per la restante durata del rapporto con l’impresa. La seconda è che l’entità approssimata dei differenziali tra i vari livelli della scala retributiva sia nota a tutti in anticipo. A queste condizioni occorre aggiungere due ulteriori elementi definitori, di stoffa empirica invece che concettuale, ma che hanno una grande rilevanza pratica. Il primo riguarda il criterio adottato per stabilire la successione delle promozioni rispetto alla scala retributiva, quindi il nesso tra l’evento promozione e il fenomeno carriera. La regola seguita normalmente dalle im14 Paradossalmente, gli economisti del lavoro hanno scoperto agli inizi degli anni ’90 la funzione allocativa delle carriere organizzative, e nell’arco di pochi anni due colleghi econometrici hanno evidenziato che questa aveva un ruolo, se non secondario, certamente non più esclusivo, ponendo un interrogativo al quale non hanno dato ancora risposta. In campo sociologico si è verificato un movimento opposto. Dopo aver dedicato quasi vent’anni di sforzi ad analizzare e misurare come i vincoli strutturali posti dalla disponibilità di posti vacanti (Stewman, 1986) e l’esistenza di definite sequenze tra le posizioni organizzative (linee di carriera) condizionino e differenzino le opportunità di salire le gerarchie aziendali (Althauser e Kalleberg, 1990), hanno scoperto agli inizi degli anni ’90 che molte promozioni non implicano alcun cambiamento di posizione (Spilerman, 1986; Petersen, Spilerman e Dahl, 1990; Stewman e Yeh, 1991). Non casualmente, di fronte all’evidente inutilità degli strumenti a loro disposizione rispetto a questa nuova dimensione delle carriere organizzativa, la letteratura sociologica sul tema si è alquanto rarefatta, per quantità e qualità, nel corso degli anni ’90. 20 prese è che ogni promozione comporti il passaggio da un livello (di partenza) a quello immediatamente successivo, ovvero che la scala di riferimento possa essere ascesa un gradino alla volta e quindi che ogni passaggio di livello (al di sotto di quello massimo) sia condizione necessaria per accedere a quello successivo. Il secondo elemento riguarda il carattere pubblico dell’evento promozione, nel senso che l’identità di chi viene promosso è nota a tutti i membri dell’organizzazione o della comunità. Ciò vale per definizione nel caso delle carriere relative a posti, ma non necessariamente in quello delle promozioni relative ad una gerarchia di merito (v.infra), e costituisce un elemento di differenziazione importante tra di esse. Delle due condizioni sopra richiamate (predeterminazione dei differenziali e loro notorietà), la prima è decisiva per comprendere le diverse modalità di promozione. Infatti, la definizione dei differenziali tra i livelli retributivi può riflettere due logiche, reciprocamente esclusive, dalle quali discendono due sistemi archetipici di carriera, che nel loro principio hanno proprietà e conseguenze molto diverse tra loro. Da un lato, i differenziali possono essere riferiti alle posizioni ricoperte, facendo quindi coincidere la gerarchia delle retribuzioni con quella delle posizioni aziendali, in funzione della loro complessità, della responsabilità decisionale richiesta, ecc. Dall’altro lato, possono essere riferiti al merito, alle prestazioni, o alle competenze dei lavoratori – quindi separando la metrica dei ranghi da quella delle posizioni organizzative e facendo coincidere la gerarchia delle retribuzioni con una gerarchia del merito degli individui – ove il merito riguarda, ovviamente, la logica degli avanzamenti di carriera oltre che il criterio di valutazione utilizzato. Le implicazioni di questa distinzione sono già state evidenziate nelle analisi svolte nel paragrafo precedente. Le promozioni relative ad una gerarchia di posti sono associate al passaggio ad una posizione di livello superiore: quindi, hanno come condizione l’esistenza di un posto vacante a questo livello. Ne consegue che il numero delle possibili promozioni è predeterminato, ovvero che i ranghi di una gerarchia di posti della gerarchia sono per definizione chiusi. Le promozioni relative ad una gerarchia di merito vengono, invece, acquisite senza che il lavoratore cambi la posizione ricoperta, o addirittura senza che alcun elemento rilevante del ruolo svolto venga modificato. Il loro numero non è soggetto ad alcun vincolo. In termini concettuali, i ranghi di una ge- 21 rarchia di merito sono, in linea di principio, aperti. Se si trascura il prestigio associato alla progressione dei ranghi della gerarchia, di cui si dirà più avanti, le promozioni “nella posizione” sono, quindi, contrassegnate unicamente dal passaggio ad un livello retributivo superiore. Il carattere permanente di questo vantaggio retributivo è ciò che le distingue in modo sostanziale dalle varie forme di premio o bonus, che, invece, sono, per definizione, contingenti. In assonanza con Aoki (1988) propongo di definire le prime come relative ad una carriera “verticale” e le seconde ad una “orizzontale”. La conseguenza essenziale dell’apertura dei ranghi della gerarchia è il trasferimento del vincolo organizzativo sulle opportunità di promozione dalla struttura demografica dell’organizzazione e dalla disponibilità di posti vacanti, alla scadenza delle valutazioni. Le opportunità offerte da una gerarchia di posti dipendono dal numero di posti vacanti disponibili ad ogni livello/rango, e quindi, dallo spostamento di coloro che li occupano, oppure dall’aggiunta di nuovi posti. Poiché normalmente i cambiamenti di lavoro sono volontari, la prima condizione è subordinata a sua volta alle opportunità (di miglioramento) offerte a coloro che occupano i posti; la seconda, in ultima istanza, alla crescita dell’organizzazione – quindi è determinata esogenamente (Sørensen, 1983). La probabilità di progredire in una gerarchia di ranghi dipende, invece, unicamente dalla frequenza secondo cui i candidati vengono valutati ai fini della promozione. Pertanto nell’ambito di questo sistema di carriera la scadenza delle promozioni diventa per un verso un parametro esplicito e negoziabile – e, di fatto, spesso uno dei principali oggetto di discussione tra le parti sociali – per un altro verso il principale criterio di differenziazione delle persone. Data una certa cadenza delle valutazioni, l’eccellenza delle persone è resa visibile dalla rapidità dei loro avanzamenti. Nello stesso tempo però, chi non ce la fa alla prima scadenza, può provare a quella successiva, e in tal senso il sistema protegge dalla frustrazione, ed evita il rischio di spreco, insito nella carriera verticale, conseguente ai “falsi negativi”. Una seconda e altrettanto decisiva conseguenza riguarda i criteri in base ai quali gli individui vengono promossi. Stante la normale forma piramidale delle gerarchie organizzative, in un sistema di carriera verticale il numero dei candidati ad una promozione supera di regola quello dei posti disponibili. In tutti questi casi pertanto le possibilità d’avanzamento di 22 carriera dipendono da una valutazione comparativa dei candidati, cioè le promozioni avvengono per merito relativo. Nel caso invece di gerarchie di merito le promozioni si basano su una valutazione per merito assoluto15. La differenza tra valutazione comparativa (per merito relativo) e per merito assoluto ha a sua volta svariate e importanti implicazioni. Una cruciale tra queste è il diverso meccanismo incentivante implicato dai due sistemi di carriera. Nei sistemi di carriera verticale la leva dell’incentivo è la competizione che la probabilità di conseguire una promozione scatena tra i candidati (posto appunto che il loro numero superi quello dei posti disponibili), e che li induce ad erogare migliori prestazioni nell’esercizio dei compiti loro affidati. Questa competizione è di natura “avversativa”, poiché qualsiasi gesto cooperativo con i propri competitori avrebbe la conseguenza di ridurre il proprio impegno lavorativo e di migliorare le prestazioni dei competitori, quindi di peggiorare le proprie opportunità a vantaggio dei competitori. Invece, la leva incentivante dei sistemi di carriera orizzontale è solo la probabilità di conseguire la promozione, ovvero di raggiungere le mete prestazionali associate a quest’evento, probabilità che dipende unicamente dall’impegno personale – posto che la valutazione delle prestazioni non sia distorta. Un elemento di complicazione rispetto a questa distinzione è che le gerarchie di merito possono comprendere, in tutto o in parte, ranghi chiusi, qualora il numero delle opportunità d’avanzamento che essi offrono venga determinato in anticipo. Tale è per esempio la situazione che si verifica nell’Università italiana nel passaggio da professione associato ad ordinario, e in molti altri sistemi di carriera di tipo professionale. Una gerarchia di merito a ranghi chiusi impone vincoli e criteri d’avanzamento identici a quelli associati ad una gerarchia di posti. Quindi da’ luogo ad un sistema di carriera “verticale”, anche se lo sviluppo di tale carriera non implica un cambiamento significativo del ruolo svolto. A ben guardare si tratta, però, di un sistema di carriera a sé sante, perché in questo caso la chiusura dei ranghi è conseguenza di una decisione. Pertanto il numero 15 L’assunto è confermato dal dato raccolto dalla NLSY circa il tipo di valutazione da cui era scaturita la promozione ricevuta (se “altre persone erano state considerate per la promozione”), da cui è possibile inferire che le promozioni “senza mobilità” non dipendono quasi mai da una valutazione comparativa (Pergamit e Veum, 1999: 586). 23 delle opportunità associate ad ogni rango può essere variato a piacere. In tal senso le gerarchie di merito a ranghi chiusi consentono di conservare i vantaggi associati alle gerarchie di posti, senza perdere quelli conseguenti alle gerarchie di merito. Da un lato, infatti, possono essere manipolate in modo da assicurare sempre un rapporto negativo tra numero delle opportunità e dei candidati, così da assimilare le relative promozioni a una selezione per merito relativo, con gli effetti d’incentivazione che ne derivano. Dall’altro lato consentono di far variare il numero delle opportunità in funzione sia delle esigenze dell’organizzazione – così da evitare di frustrare le attese di candidati meritevoli – sia, sul versante opposto, in funzione delle compatibilità di bilancio – così da evitare gli eccessi di spesa, potenzialmente conseguenti dalla mancanza di vincoli sugli avanzamenti in una gerarchia a ranghi completamente aperti. Riassumendo: l’analisi precedente, per quanto schematica, rende evidente che le carriere orizzontali risolvono in linea di principi diversi dei problemi che, invece, limitano l’efficienza di quelle verticali: i) La probabilità di conseguire le promozioni non dipende dalla disponibilità di posti vacanti ad ogni livello della gerarchia, né dal rapporto tra candidati e posti disponibili; ii) la cadenza delle promozioni non è vincolata dalla distribuzione dei posti; iii) l’incentivo fornito non dipende da fattori al di fuori del controllo del candidato, come avviene, invece, nel caso delle promozioni per merito relativo, dove la probabilità di essere promossi dipende dal numero e dalla qualità degli altri candidati16; iv) per lo stesso motivo, non implica una competizione “avversativa” tra i candidati, che può gravemente pregiudicare l’efficienza complessiva. 16 La ricerca empirica ha evidenziato che, a pari condizioni, l’incentivo di carriera, per essere efficace, richiede una probabilità assoluta di promozione relativamente alta, perché un basso tasso di promozione stabilizza la composizione dei gruppi di lavoro, di modo che tra i loro membri si sviluppano legami personali affettivi, che scoraggiano la disponibilità ad impegnarsi per essere promossi; inoltre fa apparire le rare promozioni come frutto del caso e comunque non correlate al merito dalle prestazioni erogate (Kanter, 1977; Sørensen, 1994). Per quanto riguarda la probabilità relativa, l’equità delle scelte operate dalle direzioni aziendali risulta essere sistematicamente contestata dai membri delle imprese, soprattutto da chi è rimasto indietro rispetto ai colleghi (Follis, 1996). 24 1.3.2. La carriera senza mobilità come leva della crescita professionale dei dipendenti delle imprese Quale funzione organizzativa svolgono le promozioni “nella posizione”? La rilevazione NLSY identifica questa fattispecie con l’ ‘“upgrading della posizione ricoperta” e con “promozioni senza variazione dei compiti svolti”. In assenza d’indicazioni sulle intenzioni dei ricercatori, sulle istruzioni trasmesse agli intervistatori e i criteri di codifica, queste denotazioni non aiutano molto a trovare una risposta. Tuttavia, non resta che provare a ragionare sul loro significato letterale. In quest’ottica, si può dire con certezza che l’upgrading di una posizione presuppone l’esistenza di un criterio di classificazione ordinale, su cui si basa appunto l’operazione. Pergamit e Veum (1999: 587) citano in proposito l’esempio del dipartimento dei servizi informatici della Monsanto, i cui i tecnici sono classificati come “Technologist”, “Senior technologist”, “Distinguished technologist”. Il passaggio ad ognuno dei livelli successivi di questa classificazione può essere definito correttamente come upgrading di un medesimo ruolo. Pertanto, questa fattispecie di promozioni “nella posizione” dovrebbe servire essenzialmente a collocare (o meglio ri posizionare) i lavoratori in un sistema di divisione del lavoro, che fa riferimento ad una gerarchia prestabilita di competenze, responsabilità decisionali, attività informali d’addestramento e consulenza dei colleghi meno esperti, ecc., relative ad un medesimo ruolo. Si tratterebbe, quindi, di una funzione allocativa atipica, relativa a tappe dell’evoluzione di un medesimo ruolo – così come un apprendista diventa progressivamente artigiano e poi maestro artigiano17. Più incerto è il significato organizzativo delle promozioni che non implicano un accrescimento delle responsabilità affidate al lavoratore. Non pare sbagliato presumere che quest’altra fattispecie faccia generica17 A parte questo riferimento storico, il modello delle carriere “orizzontali” risale al sistema di opportunità “parallele” di carriera (dual ladder) – manageriali e professionali – istituito già negli anni ’50 nelle organizzazione di ricerca o comunque nei settori aziendali ad elevata intensità di lavoratori “professionali”, al fine di aggirare il vincolo della forma piramidale delle gerarchie di autorità e/o di offrire opportunità di riconoscimento materiale e simbolico a soggetti vocazionalmente restii ad assumere funzioni manageriali (Goldner e Ritti, 1967). 25 mente riferimento al raggiungimento di un qualche livello predeterminato di prestazione o di capacità professionale. In questo caso le promozioni avrebbero puramente la funzione d’incentivare il raggiungimento di certi obiettivi, ed è pertanto logico ipotizzare che esse si riferiscano a una gerarchia di merito con ranghi tendenzialmente aperti. Un esempio significativo, proprio perché controintuitivo, è quello della gerarchia di merito dei lavoratori giapponesi addetti a processi di produzione, che è parametrata sulle capacità professionali dimostrate dai lavoratori e non sui compiti loro affidati. In questo caso, infatti, l’“immobilità” o l’identità del ruolo corrisponde ad una continua variazione delle allocazioni o una continua mobilità tra posizioni e compiti (è noto che nelle imprese giapponesi i confini tra le mansioni di produzione sono mobili), per cui, anche l’ascesa della gerarchia presuppone un costante incremento (per estensione e profondità) delle competenze esercitate, che non può essere registrato come cambiamento di posizione organizzativa (Koike, 1994; Itoh, 1991). Trascurando le differenze appena richiamate, l’elemento che unifica e contraddistingue le due fattispecie di “promozione nella posizione” – anche se forse senza esaurire il loro significato organizzativo18 – sembra essere il riferimento a processi di crescita professionale, nel senso dell’acquisizione progressiva della capacità di affrontare problemi diversi e più complessi e/o di conseguire risultati qualitativamente migliori relativamente ad una data funzione o processo organizzativo. Pergamit e Veum (1999: 588-595) forniscono due evidenze che danno consistenza e specificano quest’assunto. 18 Queste potrebbero anche riflettere la scelta dell’impresa di onorare la clausola del contratto implicito stipulato con i propri dipendenti, in presenza di difficoltà/impossibilità a promuovere quelli meritevoli a posizioni di livello superiore per mancanza di posti vacanti. Secondo un responsabile del personale intervistato da Baker e Holmstrom (1995, p. 257), questa sarebbe appunto una delle risorse cui fanno ricorso le imprese, per aggirare i vincoli che il sistema formale impone alle opportunità di promozione. La logica di queste promozioni “senza mobilità” sarebbe, pertanto, coerente con un sistema di carriera riferito ad una gerarchia di posti, anziché di merito. Tuttavia, in mancanza d’informazioni specifiche e alla luce delle evidenze prodotte da Pergamit e Veum (1999) circa il nesso tra promozioni “senza mobilità” e formazione aziendale (v. infra), quest’ipotesi sarà trascurata nella trattazione che segue. 26 La prima riguarda il forte effetto positivo della formazione aziendale ricevuta nell’anno precedente sulla probabilità di essere stati promossi nel 1989, al netto del contributo dei consueti controlli (istruzione, quoziente d’intelligenza, sesso, etnia, anzianità lavorativa, ecc.). Si tratta di un risultato non sorprendente, ma significativo (il coefficiente riscontrato è 10.88**), che conferma che le promozioni sono spesso anticipate da investimenti formativi. Purtroppo il modello presentato non distingue la variabile dipendente per modalità di promozione, di modo che non si può sapere se questi investimenti fossero rivolti ad adeguare anticipatamente le competenze in vista di un prossimo cambiamento di posizione organizzativa, oppure anche ad altri scopi. La seconda evidenza, speculare alla prima, è, invece, del tutto inedita e riguarda le esperienze formative successive alle promozioni ricevute nel 1989 – più esattamente, l’effetto di queste promozioni (ora debitamente distinte secondo le modalità previste dalla NLSY) sulla probabilità di avere fruito d’iniziative di formazione aziendale nell’anno successivo. Tab. 6 – Effetto delle diverse fattispecie di promozione (verificatesi nel 1989) sulla probabilità di avere fruito di un’azione di formazione nell’anno successivo e, in parentesi, sugli incrementi di retribuzione percepiti nel medesimo anno (Fonte: Pergamit e Veum, 1999) Promozioni dovute a cambiamenti di posizione: Supervisore Nuovo reparto Nuova posizione Riorganizzazione Promozioni senza mobilità: Riclassificazione della posizione Senza variazione dei compiti 12.12** 6.87 0.61 5.85 (9.69**) (8.27**) (4.72) (11.82**) 5.72** (10.10**) 5.14* (7.09**) Livelli di significatività (test a due code) * 10% ** 5% Questi risultati, ai quali ho accostato i coefficienti degli incrementi di retribuzione percepiti nel medesimo anno (già considerati nel paragrafo precedente), permettono di qualificare la logica di carriera professionale delle “promozioni nella posizione”. Come ci si poteva aspettare, le pro- 27 mozioni al ruolo di supervisore, che implicano plausibilmente compiti del tutto nuovi, e quindi, necessitano di una massiccia integrazione delle competenze possedute, determinano, una maggiore probabilità d’ulteriori attività di formazione – anche al netto dell’eventuale formazione già ricevuta in vista del cambiamento19. Ma, sorprendentemente, anche dalle “promozioni senza mobilità”, cioè situazioni in cui apparentemente (o dichiaratamente) quest’evento non implica alcuna discontinuità nei compiti e nelle responsabilità assegnate, derivano probabilità relativamente elevate (e comunque statisticamente significative) di fruire di formazione aziendale. Se, come probabile (stante il peso relativo delle “promozioni nella posizione”), la sequenza causale inversa (formazione ĺ promozione) valesse anche per questo tipo di promozioni, una parte importante delle iniziative di formazione aziendale verrebbe a caratterizzarsi nello stesso tempo come veicolo e conseguenza delle “promozioni nella posizione” – e viceversa, queste risulterebbero la leva, per così dire, di una correlazione seriale delle azioni formative20. Pertanto, pare logico concludere che almeno una parte consistente di questo tipo di promozioni coincida con percorsi o con segmenti di carriera di tipo “professionale”, cioè finalizzati ad assicurare il progressivo sviluppo di competenze professionali, rispetto al quale la formazione aziendale si qualifica come un’attività ricorrente, e al limite continua, invece che come un mezzo per adeguare le competenze a fattori esogeni di discontinuità, e pertanto essa stessa discontinua. Alla luce di queste considerazioni le “promozioni nella posizione” paiono coerenti con la visione convenzionale dei mercati interni del lavo19 Questa conseguenza non, invece, è verificata per le promozioni associate alle altre modalità di cambiamento di posizione, che pure dovrebbero parimenti condurre a compiti, responsabilità, ambienti di lavoro, almeno in parte, nuovi. Per alcuni di questi risultati si potrebbero trovare spiegazioni ex post. In particolare, il coefficiente negativo relativo alle promozioni conseguenti a riorganizzazioni aziendali potrebbe essere plausibilmente imputato al processo di selezione da cui derivano queste promozioni, che avrebbe portato a scegliere soggetti già in possesso delle competenze adeguate ai nuovi compiti. L’elevato coefficiente relativo ai guadagni conseguenti a questa modalità di promozione potrebbe qualificarsi proprio come un riconoscimento del possesso di competenze non comuni. 20 A ciò si può aggiungere che, poiché le “promozioni nella posizione” determinano in media significativi vantaggi retributivi, resta poco spazio per l’ipotesi di un trade off tra formazione ulteriore e incrementi retributivi. 28 ro, proposta da Gary Becker (Mori, 1991) e da Doeringer e Piore (1971), e non smentita dalle più recenti teorie, incentrate piuttosto sul rischio di selezione avversa nell’allocazione delle posizioni di livello superiore e sul fallimento degli incentivi lineari. Secondo tale visione i mercati interni servono a favorire la produzione e la diffusione delle conoscenze e abilità necessarie all’impresa, in ragione sia della loro specificità (rispetto all’impresa stessa), sia delle prevalenti modalità informali mediante cui vengono acquisite sul lavoro (Watcher e Wright, 1990; Gibbons, 1998). Tuttavia occorre considerare che questa specifica tipologia di promozioni fornisce una leva per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti delle imprese, sostanzialmente diversa da quella prevista dal mercato interno convenzionale21. Per un verso, offrono molti più margini di libertà all’apprendimento e sono compatibili con un’elevata indeterminatezza dei confini tra le posizioni organizzative, e con l’apertura dei ruoli. Per un altro, permettono d’emancipare l’opportunità di ricevere addestramento e formazione, dal duplice vincolo della disponibilità di posti vacanti e della funzione di selezione, inevitabilmente associata alle promozioni in una gerarchia di posti. In tal modo rendono effettivamente praticabile l’assunto della teoria del capitale umano, secondo cui gli investimenti in formazione nei luoghi di lavoro derivano da decisioni congiunte d’imprese e lavoratori. Infine, avvicinano la logica dei percorsi di carriera interna a quella dei percorsi che si realizzano via mobilità esterna. In entrambi i casi, infatti, la carriera non viene a coincidere con l’ascesa di una gerarchia di posizioni, bensì con l’avvicinamento al centro del sapere relativo ad un dato “mestiere” o professione, da cui dipende la riproduzione e l’aggior21 Il mercato interno del lavoro, infatti, si basa sulla scomposizione delle attività aziendali in posizioni strutturate secondo una logica di divisione verticale del lavoro, che da un lato corrisponde a quella delle scatole cinesi (per cui ogni posizione successiva richiede solo un delta di conoscenze in più) e dall’altro, integra capacità professionali e autorità gestionale, di modo che il comando e il controllo si giustifichino per il possesso di maggiori competenze rispetto ai subordinati – il noto principio dell’organizzazione burocratica evidenziato da Weber. I processi d’apprendimento consentiti da un siffatto sistema di divisione del lavoro dipendono, pertanto, dalla riallocazione dei lavoratori nelle posizioni, e dal quantum di conoscenze aggiuntive necessarie per passare dall’una all’altra di esse – in sostanza sono subordinati alla preventiva definizione dello stock di conoscenze e abilità di cui l’impresa abbisogna. 29 namento le competenze che lo qualificano. Analogamente alle professioni tradizionali, le tappe di questa progressione sono contrassegnate (all’interno di un’impresa, di un territorio o di una comunità professionale) dalla varietà e dalla complessità dei problemi affrontati, che riflette appunto il volume delle competenze possedute, e dall’incremento della propria “reputazione” – invece che dallo status della posizione ricoperta (Kanter, 1989a; 1989b). 1.3.3. La funzione incentivante delle “promozioni nella posizione” Le promozioni “nella posizione” sono quindi associate a contesti organizzativi che assegnano un’alta priorità allo sviluppo delle competenze professionali (intese come quell’insieme di conoscenze, abilità, disposizioni soggettive che si traducono in prestazioni eccellenti), e che quindi si preoccupano di svincolare questo sviluppo dai processi d’allocazione interna del lavoro. In questi contesti la loro funzione specifica è incentivare l’acquisizione di competenze professionali. Evitando d’entrare nell’ormai estremamente complessa e articolata problematica degli incentivi, ci si può limitare a tre essenziali considerazioni in proposito. La prima riguarda lo stesso accostamento, sostanzialmente irrituale, della problematica dell’apprendimento a quella degli incentivi. Nella prospettiva della teoria del capitale umano, infatti, il vincolo motivazionale sull’apprendimento sul lavoro è soddisfatto dall’assunzione da parte delle imprese dei costi (diretti e indiretti) delle attività d’addestramento e formazione. A parte il rischio che una volta formati possano lasciare l’impresa, i lavoratori dedicano all’apprendimento il tempo di lavoro, per cui sono normalmente retribuiti, senza bisogno d’incentivi. Ma questa prospettiva è del tutto insufficiente nei moderni contesti tecnologici e organizzativi, in cui la stessa attività lavorativa consiste nella risoluzione di problemi – ovvero richiede di trovare, selezionare, elaborare l’informazione necessaria per fornire soluzioni efficaci – e i lavoratori sono chiamati ad adattare ruoli e routines a cambiamenti imprevisti, e quindi a mobilitare la loro capacità di apprendere dall’esperienza. Nella misura in cui l’apprendimento (esplicito e implicito) non è nettamente 30 distinguibile dall’attività lavorativa, ma ne costituisce un ingrediente essenziale, è del tutto ragionevole farne un problema d’incentivazione. La seconda riguarda l’efficacia delle promozioni come incentivo. La letteratura economica ha elaborato l’argomento solo in riferimento alle promozioni relative a gerarchie di posti o comunque a ranghi chiusi, sulla scorta della metafora del “torneo”22. Tuttavia permette d’identificare con buon’approssimazione i vincoli cui è soggetta la soluzione del problema di stimolare l’apprendimento sul lavoro e con ciò, d’individuare lo spazio delle promozioni “nella posizione” come sistema d’incentivo. Si tratta de: i) l’assoluta inadeguatezza degli incentivi collettivi, poiché ciò che è in questione – la motivazione ad apprendere – dipende da disposizioni soggettive che rinviano al sé profondo dell’individuo; ii) la limitata possibilità di utilizzare incentivi negativi, e parimenti iii) di ricorrere a contratti impliciti, dal momento che con il venire meno della garanzia di stabilità della relazione d’impiego si è più che proporzionalmente ridotto lo spazio per contratti o clausole contrattuali impliciti (scambi parziali di doni); iv) la conseguente necessità di ricollegare in modo relativamente lineare l’apprendimento sul lavoro a ricompense, ovvero di definire con precisione l’orizzonte temporale del dispositivo incentivante, in modo da consentire alle parti di valutare le proprie convenienze. Alla luce di queste argomentazioni la soluzione del problema si riduce a poche alternative tra i sistemi d’incentivazione fin ora sperimentati, e in particolare a due: i sistemi definiti pay for performance e quelli pay for skills o for knowledge, appunto basati su carriere orizzontali. Nella misura in cui negli attuali contesti di lavoro l’apprendimento può essere considerato come un aspetto intrinseco alle prestazioni attese, 22 La prospettiva di conseguire premi di grandezza predeterminata (pari al differenziale di retribuzione tra due livelli della gerarchia) induce una competizione tra i dipendenti che si ritengono adatti a conseguirli (quindi che non differiscono visibilmente in capacità e abilità), e, pertanto, li motiva ad impegnarsi nei compiti loro affidati. Erogando un solo premio l’impresa incentiva le prestazioni di più dipendenti. Inoltre, questo premio può essere assegnato sulla base di valutazione comparativa delle prestazioni stesse (del loro merito relativo), riducendo la necessità d’investimenti di “forma” (Thevenot, 1984) per misurare il merito secondo una scala assoluta, e neutralizzando i fattori esterni al controllo degli agenti, ma che ne condizionano le prestazioni (Lanfranchi, 1996). 31 rendere variabile una parte della retribuzione in funzione delle prestazioni osservate serve certamente ad incentivare l’apprendimento continuo. Questa è appunto la logica di alcuni sistemi di retribuzione variabile, introdotti in seguito ad innovazioni organizzative che comportano l’allargamento dei compiti degli operativi in direzione di funzioni di manutenzione, controllo della qualità, programmazione della produzione, ma in realtà parametrati sulla valutazione delle prestazioni fornite (Gomez-Mejia e Balkin, 1992). Tuttavia, solo in alcuni ruoli lavorativi prestazioni e apprendimento si fondono in modo tanto inestricabile. Inoltre e soprattutto la teoria economica degli incentivi (Milgrom e Roberts, 1992, cap. 12; Gibbons, 1996; 1998; Prendergast, 1996; 1999) nonché l’analisi psicologica (Lawler, 1990) hanno efficacemente messo in luce che i sistemi di incentivazione delle prestazioni incontrano grossi ostacoli negli attuali contesti di lavoro, sia quando riferiti ai risultati conseguiti (l’output) – a causa della difficoltà di parametrarli in modo adeguato e di separare l’effetto dei contributi individuali – sia, e ancor più, quando riferiti direttamente ai contributi (gli inputs) forniti dai lavoratori al processo produttivo, la cui valutazione necessariamente soggettiva va’ incontro a svariati problemi. Invece, se s’incentiva direttamente l’apprendimento, il problema risulta alquanto semplificato, per il fatto stesso che qualsiasi apprendimento si oggettiva in competenze, il cui possesso è evidenziato dalla stessa (estensione dell’) attività operativa del soggetto – ciò che sa fare in modo adeguato – per definizione osservabile da terzi. La terza considerazione riguarda la valenza simbolica e morale, oltre che monetaria, dell’incentivo fornito dalle promozioni, soprattutto quando relative a progressioni in una gerarchia di merito. Si tratta di un tema, cui ha dedicato una particolare attenzione la riflessione sociologica sulle carriere. Fin dalla scuola di Chicago i sociologi hanno privilegiato della nozione di carriera l’idea di una sequenza di transizioni tra stati, relativamente predeterminata e socialmente riconosciuta, e tale da qualificare questi cambiamenti come un’evoluzione sia verso “l’alto” (secondo l’accezione comune di carriera), sia verso il “basso” (la carriera del drogato, della prostituta, ecc.), ma comunque associata ad una crescente tipizzazione dei tratti che rendono esclusiva la sequenza stessa, e quindi all’impiego di “risorse” aggiuntive per poterla percorrere. Nel caso delle carriere lavorative (così come quelle relative a molti altri ambiti d’attività, 32 ed in particolare quelle sportive) queste “risorse” sono appunto l’esperienza e/o crescenti capacità e competenze, riconosciute in un dato ambito professionale. L’idea di sviluppo verso l’alto, implicito nella nozione di carriera, non fa altro che riflettere un’evoluzione coerente del nesso tra lavoro e competenze personali, che giustifica il progressivo aumento delle ricompense e delle attese delle persone, con cui s’interagisce (ovvero del prestigio di cui si gode). Per i sociologi, quindi, la carriera costituisce un artefatto sociale, nel duplice senso che la sequenza di stati che l’identifica è facilmente riconoscibile (dai membri dell’organizzazione o della comunità professionale) come progressione nel senso anzidetto, e che questo carattere di progressione o sviluppo entra a strutturare in modo definito e percepibile aspettative, giudizi, e valori individuali. In tal senso la carriera costituisce un punto di raccordo particolarmente sensibile tra il sociale e l’individuale, e un terreno privilegiato per comprendere come la valutazione degli altri condizioni quella di sé stessi. Stinchcombe (1974) e Sørensen (1994) hanno elaborato questa problematica in una prospettiva d’analisi strutturale, richiamando l’attenzione sul carattere (normalmente) pubblico degli avanzamenti di carriera, e sulle conseguenze che ne derivano sul piano simbolico. Nella misura in cui modificano lo status relativo di coloro che li ottengono nell’organizzazione in cui sono inseriti (impresa o comunità professionale), e quindi nella stratificazione sociale, essi costituiscono una delle più importanti leve di cui dispone il nostro sistema sociale per rafforzare l’autostima dei suoi membri. Una significativa verifica di queste argomentazioni è fornita da alcuni studi sperimentali, particolarmente sofisticati sul piano metodologico (Loewenstein e Sicherman, 1991; Frank e Hutchens, 1993), da cui risulta che decisori razionali (studenti di economia, frequentatori di musei scientifici, ecc.), chiamati a scegliere tra diversi ipotetici rapporti di lavoro di uguale durata (3, 6, 40 anni) e associati ad una medesima retribuzione complessiva, ma distribuita in modo diverso negli anni (in modo decrescente, uniforme, moderatamente, abbastanza, molto crescente), preferiscono nella grandissima maggioranza dei casi (con percentuali che si aggirano intorno all’80%) le ipotesi occupazionali associate a redditi (anche fortemente) crescenti nel tempo – scontando quindi redditi iniziali proporzionalmente inferiori. Il dato può essere ricondotto alle preferenze per il consumo, e pertanto il sacrificio della capacità immediata di consumare 33 in vista di consumi crescenti futuri può essere riferito all’evoluzione delle esigenze proprie e familiari, e/o ad un’estrema avversione al rischio. Tuttavia questi esperimenti prevedevano, anche nell’ipotesi di una distribuzione uniforme del reddito, un ammontare annuale tale da consentire in genere risparmi per investimenti (per es. in titoli azionari), per cui le preferenze dichiarate appaiono comunque irrazionali dal punto di vista economico. Nello stesso tempo colpisce la coincidenza di questi risultati con la logica delle carriere lavorative, che presuppongono appunto una relazione (più o meno stretta) tra avanzamenti e aumenti di retribuzione (diversamente da gran parte delle carriere relative a hobbies e attività sportive). Frank e Hutchens (1993) hanno addirittura ipotizzato che le carriere esistano in ultima istanza proprio per soddisfare questa preferenza per la distribuzione del reddito, piuttosto che per incentivare l’accumulazione di competenze, come vorrebbe la saggezza comune. Il caso delle carriere retributive dei piloti d’aereo e di mezzi pubblici è un esempio pertinente. La ricerca di Loewenstein e Sicherman (1991) approfondisce l’argomento, sulla base della distinzione tra redditi da lavoro e proventi di rendite (l’affitto di uno stabile). La preferenza per una distribuzione crescente nel tempo viene confermata per entrambe le fonti di reddito, ma con uno scarto molto significativo: 83% nel caso dei redditi da lavoro, contro 56% per le rendite. Questa differenza qualifica, per così dire, l’irrazionalità della preferenza per occupazioni che offrono retribuzioni crescenti nel tempo, mostrando che il riferimento alla capacità di consumare ne fornirebbe in ogni caso solo una spiegazione parziale, e che essa rinvia ad esigenze che la razionalità calcolistica non è apparentemente in grado di soddisfare, connesse all’immagine di sé e ad aspettative di riconoscimento sociale. 1.4. Conclusioni Le analisi proposte nei paragrafi precedenti mostrano quanta strada si possa fare, indagando le proprietà strutturali dei processi sociali, prima di chiamare in causa il cambiamento. Per un verso, è stato probabilmente sempre vero che, a causa dei vincoli sulla probabilità di scalare le gerarchie aziendali, i guadagni che ci si può attendere nel medio periodo dalla prospettiva di restare in un’impresa, sono meno attraenti di quelli associati alla prospettiva di cambiare datore di lavoro. In ogni caso ciò è sempre 34 più vero, nella misura in cui i datori di lavoro, o i loro dirigenti, si rivolgono al mercato esterno per allocare posizioni che si rendono vacanti ai livelli intermedi e superiori delle gerarchie aziendali. Similmente, la correlazione seriale tra le promozioni costituisce una dimensione strutturale delle carriere organizzative – anche se resta ancora da spiegare fino in fondo la logica del fenomeno. Per cui, da un lato, l’accumulo di promozioni si traduce in un netto vantaggio relativo di medio periodo; dall’altro, quanto più precoce è la prima promozione, tanto più aumenta, a pari condizioni, la probabilità di riceverne altre, sicché le convenienze relative cambiano in funzione dell’anzianità aziendale, alla quale si percepisce la prima promozione. Infine, i vantaggi conseguibili dalla permanenza in un’impresa dipendono dalla sua disponibilità ad usare il sistema delle promozioni come puro meccanismo d’incentivazione, quindi svincolandolo dai processi di allocazione interna – disponibilità che plausibilmente dipende dal rilievo che essa attribuisce alla crescita professionale dei propri dipendenti, ovvero dall’esigenza di accumulare capitale umano (specifico?), al fine di assicurare la propria competitività. La valenza strutturale dei tre risultati appena richiamati, sta appunto nel fatto che la loro plausibilità è relativamente indifferente rispetto ai cambiamenti che si possono ipotizzare. Il che significa che la relativa “anzianità” delle evidenze empiriche, su cui si basano, è del tutto irrilevante. Tuttavia, l’ultimo di questi rinvia ad un problema empirico (quante imprese adottano e adotteranno nel prossimo futuro, sistemi di gestione delle relazioni d’impiego, basati su carriere “orizzontali”?), sul quale voglio aggiungere poche considerazioni conclusive. A questo fine, mi avvarrò anch’io di un procedimento inferenziale, ma limitandone l’indeterminatezza attraverso la distinzione tra promozioni “attive” e “nella posizione”, ovvero carriere “verticali” e “orizzontali”. E’ molto probabile che lo spazio delle carriere “verticali” si sia sensibilmente ridotto nel corso degli anni ’90, e a questo proposito si deve dare ascolto a molte delle analisi richiamate nell’introduzione. E’ evidente che la costante riduzione della dimensione delle imprese e delle unità produttive, l’appiattimento delle gerarchie aziendali, l’esternalizzazione di molte funzioni amministrative e di staff, unitamente alla crescente diffusione delle imprese di piccole e piccolissime dimensioni, concorrono a fare venire meno le condizioni per una gestione delle relazioni d’impiego 35 basata sulla riallocazione dei dipendenti in una gerarchia “di posti”. L’esistenza di una forte relazione positiva tra opportunità di promozione (osservate dal ricercatore) e dimensione delle imprese o delle unità produttive è stata variamente documentata (Baron, Davis-Blake e Bielby, 1986; Villemez e Bridges, 1988; Hedström, 1988; Hachen, 1992; Kalleberg e Van Buren, 1996). Vi sono anche svariate evidenze circa gli effetti negativi, prodotti dalla riduzione dei posti ai livelli intermedi e superiori delle gerarchie aziendali, in seguito a processi di ristrutturazione, fusioni, ecc.: eventi ormai quasi comuni nella vita delle imprese (Stewman, 1986; Preisendörfer e Burgess, 1988; Haveman e Cohen, 1994). Analoghi effetti derivano dall’orientamento ad allocare via il mercato esterno anche le posizioni medio alte delle gerarchie, di cui si è già detto, e che probabilmente si è andato accentuando. Per un alto verso, si può argomentare che, anche indipendentemente da questi fattori di turbolenza, un sistema di carriera basato sulla mobilità tra posizioni organizzative è esposto, come tale, alla distribuzione per età dei dipendenti nei livelli organizzativi, che spesso determina la creazione di colli bottiglia ai livelli intermedi delle gerarchie aziendali (Stewman, 1986). L’unico modo per assicurare l’efficacia di un simile sistema è, quindi, (poter) aggiungere posti all’organizzazione – considerazione che rinvia all’osservazione, secondo cui la crescita dell’impresa costituirebbe una condizione dello stesso funzionamento dei mercati interni del lavoro, che non casualmente si sono affermati in un epoca caratterizzata da una crescita costante delle imprese (Kanter, 1989b). Per quanto riguarda il possibile spazio delle promozioni “nella posizione”, mi limiterò a una considerazione di buon senso, che può essere presentata sotto forma d’interrogativo. Questo tipo di promozioni sono sempre state così frequenti, come evidenziato da Pergamit e Veum (1999), oppure identificano una modalità di gestione delle relazioni d’impiego relativamente nuova – come suggerisce implicitamente il punto interrogativo del titolo del lavoro citato? Se fosse vera la prima alternativa ci si troverebbe di fronte a una clamorosa lacuna della ricerca empirica – quasi casualmente colmata dalla NLSY – che solleverebbe in particolare seri dubbi sulle capacità professionali dei sociologi che negli anni ’80 hanno pubblicato ricerche su serie di dati, che si estendevano fino alla seconda metà degli anni ’70. Pare, invece, più probabile che il ricorso a si- 36 stematico da parte delle imprese a promozioni “nella posizione” risalga agli anni ’80, come starebbe a confermare il fatto stesso che i ricercatori sociali si sono accorti di questa fattispecie di promozioni solo dagli inizi degli anni ’90 (cfr. nota 14). In ogni caso, se vale l’ipotesi che le diffusione delle promozioni “nella posizione” coincide con l’adozione di nuove modalità di gestione delle relazioni d’impiego, stimolate dalle innovazioni tecnologiche dall’inasprimento della competizione e intervenuti negli anni ’80 e potenzialmente ispirate dal modello giapponese, non si vedono validi motivi per cui queste stesse modalità dovrebbero avere successivamente esaurito il loro potenziale. Pare, anzi, ragionevole ipotizzare una loro ulteriore diffusione. Questa tesi può essere opportunamente qualificata alla luce della specifica funzione d’incentivo all’accumulazione di competenze, certamente svolta dalle promozioni “nella posizione”, o da una parte importante di esse. Le evidenze fornite da Pergamit e Veum (1999) a questo proposito sono impressionanti. In questa prospettiva la fortuna dei sistemi di gestione delle risorse umane basati su carriere “orizzontali”, è strettamente legata, da un lato, alla crescente importanza che va assumendo la dimensione intellettuale del lavoro e all’esigenza sempre più estesa che l’apprendimento dei lavoratori si prolunghi nel corso della vita lavorativa (Butera, 1991; Butera, Donati, Cesaria, 1997); dall’altro lato, ai vincoli molto stretti entro cui le imprese possono disegnare i sistemi per incentivare tale apprendimento. Mettendo insieme i due ordini di considerazione, viene spontaneo ipotizzare che le dinamiche del post-fordismo determinino, piuttosto che uno smaltellamento dei mercati interni del lavoro, una loro modificazione o ristrutturazione, di cui le evidenze presentate indicano probabilmente una direttrice di fondo. Di queste nuove modalità di governo delle relazioni d’impiego sappiamo comunque ancora poco. La ricerca sociale condotta sulla base a rigorose procedure scientifiche richiede molto tempo, per cui un prezzo, probabilmente inevitabile, che si deve pagare alla possibilità di ottenere solidi risultati, è uno scarto tra il momento del cambiamento e quello in cui se ne conoscono gli effetti. 37 38 2. Apprendimento continuo e carriere orizzontali 2.1. Introduzione Nella letteratura sociologica internazionale circola da alcuni anni la tesi che, in seguito al cambiamento dei vincoli di competitività delle imprese, i sistemi di gestione delle relazioni d’impiego riconducibili alla logica del mercato interno del lavoro (d’ora in avanti MIL) – cioè basati su relazioni d’impiego stabili e sulla (prevalente) allocazione interna del lavoro mediante promozioni – sono entrati in una crisi irrimediabile. Ne fornirebbero una conferma particolarmente significativa la generalizzata “esternalizzazione” e precarizzazione delle relazioni d’impiego (lavori a termine, lavori parasubordinati, ecc.), oltre che la costante riduzione del numero degli occupati nelle grandi imprese, che caratterizzano il nostro paese. Tuttavia, parallelamente a questa letteratura se n’è venuta sviluppando un’altra, più eterogenea sul piano disciplinare e spesso di taglio prescrittivo piuttosto che analitico, che enfatizza l’importanza strategica che sono venute assumendo le competenze professionali e i processi d’apprendimento continuo a tutti i livelli delle gerarchie aziendali, per poter sfruttare le innovazioni tecnologiche e organizzative, da cui dipenderebbe oggi la capacità competitiva delle imprese. Si starebbe così delineando una contraddizione paradossale tra la crescente precarietà delle relazioni d’impiego e la crescente mobilità interaziendale, da un lato, e l’esigenza delle imprese di disporre di dipendenti disposti ad apprendere, oltre che a trasmettere le proprie conoscenze, dall’altro. Se pure i termini reali di questa contraddizione richiedono molti chiarimenti (vi è in particolare chi invita alla cautela circa la crisi dei MIL: vedi E. G. Levine et alii, 2002), 39 essa costituisce certamente il sintomo del divario che si è venuto a creare nel corso dell’ultimo decennio tra innovazione organizzativa e gestione delle risorse umane, di cui si lamentano diversi commentatori, e che ad avviso di chi scrive rappresenta un nodo critico dell’attuale evoluzione del lavoro dipendente. Questo contributo muove, appunto, dall’assunto che in contesti in cui il contenuto del lavoro si sposta da un assetto regolativo ed operativo “action oriented” ad uno “knowledge centered”, il problema dell’incentivazione dei processi d’apprendimento acquista per le imprese un’importanza prioritaria. Pertanto, s’interroga sui sistemi di gestione delle risorse umane capaci di risolverlo efficacemente, e suggerisce come soluzione l’adozione di meccanismi d’incentivazione ispirati alla logica delle carriere professionali. Non si tratta di una proposta particolarmente originale. Già i più attenti analisti dei sistemi di gestione del personale nelle grandi imprese giapponesi (Itho, 1991; Koike, 1994), e studiosi che a tali sistemi s’ispirano in senso lato (Brunello e Camuffo, 1996), hanno sottolineato le virtù incentivanti delle promozioni relative ad una gerarchia di merito. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, questa proposta è stata declinata sul terreno strettamente tecnico della praticabilità e dell’efficacia, senza una sufficiente consapevolezza del nesso costitutivo tra apprendimento e sistemi di carriera, e quindi dei vantaggi forniti dalle carriere “orizzontali” a questo fine; ma, soprattutto, senza collegarla in modo adeguato alla problematica dell’apprendimento sul lavoro e ai problemi di coordinamento che ne derivano (tra impresa e lavoratori e tra imprese diverse). L’ambizione di questo contributo è, appunto, di rimediare a queste carenze, almeno da una prospettiva teorica. Esso si qualifica, quindi, come un esercizio analitico inteso ad argomentare l’adeguatezza d’alcuni sistemi di regolazione delle relazioni d’impiego, rispetto a processi di cambiamento, che vengono, invece, trattati in modo alquanto schematico. Pertanto, non è in grado di precisare con quale margine di probabilità la diagnosi che propone è realistica e se la cura che suggerisce è generalizzabile. Il perseguimento di quest’obiettivo si colloca in una zona di confine tra alcuni filoni della ricerca economica e sociologica, rimasti per lo più separati, e che l’articolo si propone di fare interagire. Un primo versante riguarda l’analisi dei vincoli attuali sulla formazione continua. Come suggerisce la problematica dell’apprendimento organizzativo, in contesti tecnologicamente e organizzati- 40 vamente evoluti l’apprendimento è sempre più funzione della soluzione di problemi. Di conseguenza, diventa difficile separarlo dall’attività lavorativa, ma nello stesso tempo diventa anche impossibile continuare a considerarlo come un prodotto “congiunto” di quest’ultima, come l’apprendimento implicito convenzionale, per definizione privo d’intenzionalità e di costi. L’impegno intellettuale e psicologico richiesto oggi per apprendere sul lavoro obbliga, quindi, a porre al centro della problematica della formazione continua il vincolo della motivazione dei lavoratori – che è, invece, del tutto estraneo alla visione economica tradizionale. Da qui l’opportunità d’affrontarne l’analisi sulla base del paradigma della relazione d’agenzia, e di ricercarne una soluzione sul terreno della teoria degli incentivi. Un secondo versante riguarda la problematica delle carriere organizzative. Le riflessioni e i risultati empirici accumulati dalla ricerca sociologica in tema di sistemi di carriera permettono d’argomentare che le carriere “verticali”, tipiche dei MIL fordisti, anche se nate per risolvere il problema della produzione di competenze specifiche, non sono in grado di rispondere all’esigenza di un potenziamento generalizzato dell’apprendimento sul lavoro. Nello stesso tempo, suggeriscono che il modello della carriera “orizzontale” si presta bene allo scopo, non solo in ragione della sua efficacia incentivante, ma anche perché capace di raccordare in modo abbastanza lineare progressioni interne e mobilità esterna, così da rispettare il vincolo della flessibilità sulla competitività delle imprese. Un terzo versante, che costituisce il logico sbocco di quest’analisi, riguarda i vincoli sulla trasferibilità delle competenze tra imprese diverse. La teoria del capitale umano assume correttamente che la trasferibilità delle competenze è una condizione essenziale della mobilità sul mercato del lavoro, ma circoscrive il problema all’opposizione tra competenze specifiche (rispetto ad un dato contesto aziendale) e generali (quindi trasferibili), assumendo implicitamente che le seconde siano perfettamente osservabili. Le attuali determinazioni dell’apprendimento sul lavoro, invece, impediscono di dare per scontata questa condizione e suggeriscono anzi che la valutazione delle competenze offerte sul mercato del lavoro incontra un grosso problema d’asim-metria informativa, che può essere risolto solo attraverso policies, capaci di rendere trasparente ciò che ogni singola impresa ha interesse a mantenere opaco, e d’assicurare con ciò lo statuto di bene pubblico delle competenze professionali*. * Ringrazio sentitamente Filippo Barbera, Giancarlo Cerruti e Franceso Consoli per i preziosi suggerimenti che mi hanno fornito. 41 2.2 La riproduzione delle competenze professionali e il mercato interno del lavoro fordista. Anche le più recenti analisi dei MIL prodotte nell’ambito dell’economia dell’informazione e dell’economics of personnel (Baker, Gibbs, Holmstrom, 1993; Lazear, 1995) condividono in linea generale la tesi, proposta implicitamente già da Gary Becker (Mori, 1991) e poi esplicitamente da Doeringer e Piore (1971), secondo cui questo sistema di gestione delle relazioni di impiego serve essenzialmente a favorire la produzione e la diffusione delle conoscenze e abilità necessarie all’impresa, in relazione sia alla loro specificità rispetto all’impresa stessa, sia alla prevalente modalità d’apprendimento mediante addestramento sul lavoro. Questa tesi è stata sostanzialmente accettata dai sociologi in ragione della sua apparente plausibilità (Althauser, 1989). Nella misura in cui i percorsi di carriera interna riflettono un sistema di divisione verticale del lavoro per posti ben definiti, che dal punto di vista del contenuto professionale obbedisce alla logica delle scatole cinesi, per cui ogni posizione successiva richiede solo un delta di conoscenze in più, e che integra capacità professionali e autorità gestionale, di modo che il comando e il controllo si giustifichino per il possesso di maggiori competenze rispetto ai subordinati (il noto principio dell’organizzazione burocratica evidenziato da Weber), la mobilità interna consente all’impresa d’ottenere le conoscenze e le abilità di cui abbisogna in ogni specifica posizione, e che si apprenda solo ciò che si usa, allocando in modo selettivo le più rare azioni di formazione off the job. Nello stesso tempo fornisce ai lavoratori un potente incentivo ad impegnarsi in attività di formazione, sia ovviamente quando queste coincidono con l’addestramento iniziale in una posizione di livello superiore, sia quanto costituiscono la condizione per esser promossi, e quindi si svolgono nell’ambito della mansione attuale23. Il MIL sembra esprimere pertanto un sistema particolarmente efficiente per gestire l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche, proprio perché consente d’attribuire le relative 23 I modelli di promozione “up or stay” forniscono una solida spiegazione del razionale di un sistema in cui retribuzioni crescenti in funzione della complessità dei posti incoraggia i lavoratori abili nelle posizioni più facili ad investire nell’acquisizione di abilità specifiche all’impresa (Prendergast, 1993; Gibbons, 1998). 42 decisioni congiuntamente alle imprese e ai lavoratori, annullando le differenze rispetto alle rispettive convenienze, e di utilizzare al meglio la risorsa dell’apprendimento sul lavoro. Questa tesi presenta in realtà molti aspetti problematici. a) Innanzitutto, fa riferimento ad una versione particolare del problema di accumulazione di capitale umano, nel senso che la pretesa dell’impresa di definire preventivamente lo stock di conoscenze e abilità di cui abbisogna utilizzando come unità di riferimento i posti di lavoro, è del tutto relativa ad un sistema tayloristico di organizzazione dei processi aziendali. Ne consegue che il contesto tecnologico e organizzativo in cui opera l’impresa deve essere sostanzialmente stabile, cioè tale da non richiedere variazioni nel breve periodo dello stock di conoscenze di cui abbisogna per essere competitiva. Poiché infatti in un sistema taylorista conoscenze e abilità sono per definizione relative a posti, solo a condizione di una notevole stabilità delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro l’impresa può essere certa che: i) il suo sistema di divisione del lavoro (ovvero la distinzione tra varie posizioni organizzative e la definizione dei loro contenuti) esprima effettivamente il suo fabbisogno di conoscenze e abilità; ii) il legame che essa istituisce tra retribuzione e compiti relativi ad ogni posizione organizzativa riflette l’effettivo contributo produttivo del capitale umano posseduto dai vari lavoratori24. b) Inoltre, nella misura in cui questo sistema di riproduzione del capitale umano specifico riguarda processi di apprendimento nelle mansioni attuali, la leva incentivante di tali processi, cioè l’attesa di essere promossi a posizioni di livello superiore, è subordinata alla condizione che vi 24 Un’importante implicazione di quest’analisi è che i MIL, proprio se funzionano bene, non permettono la creazione di uno slack di capitale umano. E’ tentante istituire una relazione tra questa ideale leaness a livello di risorse umane, tipica del modello organizzativo fordista e taylorista e lo slack di risorse materiali (assets fisici e finanziari) che caratterizza il sistema fordista di produzione. Il riferimento a criteri organizzativi di stampo taylorista serve anche a rendere conto del fatto che nei MIL le opportunità d’apprendimento, e quindi di carriera interna sono spesso molto diversificate secondo le categorie di lavoratori. In generale la struttura per definiti sentieri d’evoluzione professionale in una certa area funzionale (job ladders) ha interessato i lavori impiegatizi e tecnici, lo strato degli operai qualificati, e in parte quelli nei reparti di fabbricazione su macchine. 43 siano posti vacanti a tale livello. Pertanto il sistema funziona a condizione che vi sia un tasso costante ed abbastanza elevato di posti vacanti a tutti i livelli dell’organizzazione. Questa condizione impatta con la distribuzione per età dei dipendenti nei livelli organizzativi, che molto spesso determina la creazione di colli bottiglia ai livelli intermedi delle gerarchie aziendali (Stewman, 1986), per cui il modo più pratico di soddisfarla è aggiungere posti all’organizzazione. Secondo alcuni analisti (Kanter, 1989b) la crescita dell’impresa costituisce addirittura una condizione dello stesso funzionamento di un MIL, e non a caso sottolineano che questo sistema di gestione del personale si è affermato in epoca fordista, caratterizzata appunto da una crescita costante delle imprese25. c) Infine, un sistema di riproduzione delle conoscenze e delle abilità professionali che sia condizionato allo spostamento dei dipendenti verso nuove posizioni, comporta alcune conseguenze, che entrano in parte in contraddizione con i suoi stessi presupposti. Data la normale forma piramidale delle gerarchie organizzative, le decisioni di investire in formazione – indipendentemente da chi le prende – richiedono un qualche criterio di priorità e quindi di selezione. Poiché in questo sistema la conseguenza della formazione è il passaggio ad un posto di livello superiore, l’impresa si trova di fronte ad un problema di scelta allocativa, che tenderà a risolvere selezionando le persone più adatte, anche in relazione a loro caratteristiche innate o frutto della socializzazione secondaria (comunque difficilmente acquisibili)26. Ne consegue che nell’ambito del MIL tradizionale 25 Stando ad un responsabile del personale intervistato da Baker e Holmstrom (1995, p.257), le imprese, invece, avrebbero comunque sufficienti risorse per aggirare i vincoli che il sistema formale impone alle opportunità di promozione, riclassificando le posizioni, inventandosi nuove etichette, ecc. Tuttavia, nella misura in cui queste pratiche generano disfunzioni organizzative, implicano, di fatto, un trade off tra diversi ambiti d’inefficienza. Inoltre, il nostro argomento limitativo vale in ogni caso per quanto riguarda la dimensione dell’impresa. E’ ovvio, infatti, che un sistema di gestione del personale via mobilità interna non può che essere implementato in un’impresa medio grande, in cui i livelli intermedi e superiori della gerarchia comprendono più posizioni. Per cui, la soluzione d’incentivare l’acquisizione d’abilità specifiche via carriere di tipo verticale, non è in ogni caso applicabile alle piccole imprese. 26 Inoltre, poiché la formazione che serve è prevalentemente on the job, coloro chiamati a trasmettere le proprie conoscenze, che per la logica del sistema stanno 44 si può venire a creare una netta sfasatura tra convenienze individuali e dell’impresa. L’impresa sceglierà chi formare secondo criteri d’efficienza allocativa, che escludono inevitabilmente qualcuno per motivi indipendenti dalla sua volontà e disponibilità. I lavoratori pertanto si vedono di fatto costretti a delegare all’impresa le scelte circa la propria formazione, e l’unica cosa che possono fare è cercare di influire sulle decisioni dei selezionatori, peraltro con conseguenze spesso inefficienti per l’impresa (Milgrom e Roberts, 1992). Com’è stato sottolineato ancora recentemente (Arthur e Rousseau, 1996), il MIL è un sistema di gestione delle relazioni d’impiego basato sulla carriera, ma i cui avanzamenti sono regolati unilateralmente dall’impresa. Nell’insieme queste considerazioni suggeriscono che il MIL tradizionale fornisce una soluzione parziale e poco efficiente del problema di produrre capitale umano. Ciò è tanto più vero in contesti tecnologici e organizzativi, in cui diventa vieppiù irrealistica la pretesa di stabilire una relazione biunivoca tra conoscenze e posizioni organizzative e di risolvere le esigenze di capitale umano delle imprese attraverso la specificazione dei compiti associati ad ogni posizione organizzativa. A tutti i livelli dell’organizzazione i ruoli lavorativi sono diventati molto più aperti ed esposti a frequenti adattamenti e i loro confini, più incerti27. ad un livello superiore, devono essere garantiti che coloro al quale insegnano non faranno loro concorrenza (Thurow, 1975), per cui ai livelli intermedi e alti delle gerarchie le promozioni devono necessariamente tenere conto dell’anzianità. 27 L’elevata flessibilità allocativa richiesta dall’adozione (ormai generalizzata) del modello del “lean manufacturing” costituisce un esempio emblematico. Agli addetti alla produzione ora si chiede di essere capaci di: i) svolgere tendenzialmente tutti i compiti direttamente produttivi inerenti un dato segmento produttivo, ovvero ricoprire le posizioni lavorative in quell’ambito; ii) svolgere compiti (a progressivi livelli di complessità) relativi ad altri processi (controllo della qualità, manutenzione degli impianti, diagnostica dei guasti e interventi di primo livello, programmazione della produzione, gestione dei materiali in entrata, ecc.); iii) gestire una crescente variabilità dei prodotti, l’eterogeneità del loro mix; iv) suggerire e adattarsi a frequenti evoluzioni delle procedure. 45 2.3 Le coordinate della problematica della formazione in contesti di lavoro “knowledge centered” La formazione successiva all’ingresso nella professione e al conseguente addestramento iniziale, risponde a due essenziali esigenze funzionali: i) consentire a un lavoratore di spostarsi da un impiego a un altro (se nel mercato esterno del lavoro) o tra posti di lavoro (se in quello interno), che implichino una significativa discontinuità nelle competenze possedute; ii) metterlo in grado di fronteggiare cambiamenti del proprio ruolo lavorativo (che implichino una significativa discontinuità nelle competenze possedute) in conseguenza di un’innovazione [del prodotto, dei materiali, del processo, dell’organizzazione (rapporto tra ruoli e procedure), istituzionale (cambiamenti di disposizioni normative, ecc.)]28. Rispetto a questa distinzione, l’evoluzione delle condizioni di competitività delle imprese comporta uno straordinario aumento dell’importanza della seconda delle due esigenze funzionali a scapito della prima. Tanto che si può senz’altro affermare che l’attuale problematica della formazione riguarda prevalentemente l’adattamento al cambiamento/evoluzione dei ruoli lavorativi (Stankiewcz, 1998). Tuttavia – al di là del riconoscimento degli effetti “quantitativi” di questo spostamento di baricentro (cioè, della maggiore frequenza delle azioni di formazione e della loro estensione a tutti i livelli dell’organizzazione) – si è ancora lontani dall’avere compreso le conseguenze di fondo che una formazione finalizzata all’evoluzione dei ruoli e all’innovazione ha sui processi d’apprendimento, sulle aspettative delle parti, e quindi sulla gestione delle relazioni d’impiego. Qui di seguito verranno fornite alcune prime indicazioni circa le coordinate di questa problematica, traendo spunto dalla letteratura d’ispirazione neoistitu28 Le due esigenze funzionali richiamano intuitivamente la distinzione tra flessibilità numerica e funzionale (Reyneri, 2002, cap. 8), ma non vi si sovrappongono. L’adattamento all’evoluzione dei ruoli rientra certamente nella fattispecie della flessibilità funzionale, ma, per un verso, l’emergere di forme di mercati interni professionali, cui conduce l’evoluzione delle condizioni di competitività, fa sì che quest’apprendimento possa essere funzionale anche alla mobilità esterna. Per un altro verso le nuove forme d’organizzazione del lavoro implicano frequenti spostamenti tra le posizioni lavorative, la cui logica non risponde all’esigenza di ottimizzare il rapporto tra stock di lavoro e produzione, bensì di permettere ai lavoratori d’acquisire una conoscenza complessiva dei processi aziendali (Koike, 1994). 46 zionalista, ma anche neoclassica, che ha recentemente cercato d’integrare o modificare i presupposti della teoria del capitale umano, per superare alcuni suoi evidenti fallimenti29. Una prima, essenziale conseguenza della formazione finalizzata all’innovazione riguarda il venir meno della stessa distinzione tra formazione (tempo dedicato ad apprendere) e lavoro (tempo dedicato a produrre risultati utili). Se lavorare significa sempre più spesso adattare routines operative a cambiamenti imprevisti e se il problem solving caratterizza le prestazioni attese a tutti i livelli dell’organizzazione (da cui l’esigenza di reperire, selezionare, elaborare l’informazione necessaria), l’apprendimento si qualifica anche come una dimensione della stessa prestazione lavorativa. In realtà, le azioni formative in senso proprio (off e on the job) identificano una parte sempre più piccola del processo complessivo d’apprendimento, e riguardano sempre di più l’acquisizione di competenze trasversali, come supporto di un’attività di auto formazione continua. Ne derivano diverse conseguenze: a) Le opportunità d’apprendere (per il lavoratore) e le esigenze d’apprendimento (per l’impresa) vengono a dipendere meno dalla posizione ricoperta (come avveniva in passato), che dalla strategia competitiva dell’impresa. Anche se permangono ovvie differenze tra aree e posizioni organizzative, la complessità e la varietà dei problemi da risolvere nell’esercizio dei vari ruoli e, quindi, lo spazio dei processi d’apprendimento, sono determinati in ultima istanza dal segmento della filiera produttiva in cui si colloca l’impresa e, soprattutto, dal livello d’innovazione che persegue in questo ambito. In questo senso, le opportunità d’apprendere offerte dalle imprese sono meno soggette ad asimmetrie informative rispetto al passato (e quindi i lavoratori meno esposti al rischio di selezione avversa), perché la stessa posizione dell’impresa sul mercato ne fornisce un segnale sufficientemente preciso. 29 Si tratta fondamentalmente dell’impossibilità di spiegare attraverso la teoria Beckeriana il coinvolgimento attivo e il sostegno finanziario delle imprese alla formazione di tipo generale, di cui sono state fornite ampie evidenze (v. e.g. OECD, 1999, cap. 3), e nello stesso tempo la loro resistenza nei confronti d’azioni finalizzate a migliorare la trasferibilità delle competenze, da cui l’ipotesi di una produzione sub ottimale di competenze generali (Johansen, 2002). 47 b) La formazione via esperienza sul lavoro non ha costi opportunità e i costi diretti identificabili comprendono solo la fatica mentale e psicologica necessaria per apprendere. Peraltro, la formazione connessa alla soluzione di problemi richiede spesso la mobilitazione delle energie intellettuali e psicologiche (reggere lo stress) degli agenti e può, quindi, risultare particolarmente onerosa. Si tratta di un’implicazione cruciale, normalmente trascurata dalla letteratura sulla formazione sul lavoro (ma v. Acemoglu, Pischke, 2000), che ha tre importanti conseguenze: x l’efficacia della formazione diventa più aleatoria. Diversamente da quanto assunto dalla teoria standard, l’efficacia della formazione aziendale non dipende soltanto dal livello della spesa, ma anche dalla partecipazione attiva e dall’impegno dei suoi destinatari: quanto più questo sforzo mentale e psicologico implica una disutilità, tanto meno interesse hanno i lavoratori ad impegnarsi ad apprendere (Acemoglu, Pischke, 2000). x Per partecipare all’investimento in formazione, l’impresa dovrebbe farsi carico della disutilità conseguente allo sforzo mentale e psicologico, che è impossibile parametrare, e che costituisce piuttosto un correlato della prestazione. L’investimento dell’impresa, quindi, assume tendenzialmente la forma dell’incentivo. x Secondo la teoria standard, la disponibilità di un lavoratore ad investire in formazione è funzione inversa del tasso al quale egli sconta i benefici attesi, e del tempo di cui dispone per godere di questi benefici – quindi della sua età/anzianità lavorativa. Ma, se l’investimento non comporta costi opportunità, la stessa teoria predirà che, a pari condizioni, questa disponibilità si prolunga rispetto al corso della vita lavorativa. Per altro verso, nella misura in cui si può ragionevolmente assumere che il costo psicologico dell’apprendimento diminuisce con l’esperienza (con l’abitudine ad apprendere), la teoria predirà che la disponibilità ad investire è funzione della continuità dell’apprendimento: ovvero che, nelle attuali, nuove condizioni, la formazione sul lavoro diventa per i lavoratori un processo che s’autoalimenta. Un secondo ordine di conseguenze dell’apprendimento finalizzato a sostenere l’innovazione riguarda la distinzione tra capitale umano generale (ma spesso specifico rispetto ad un settore merceologico) e capitale 48 umano specifico rispetto alla singola impresa, su cui poggia la spiegazione Beckeriana della formazione sul lavoro. Per la maggioranza dei ricercatori il nuovo assetto regolativo del lavoro fa aumentare l’importanza delle competenze di tipo specialistico e trasversali (quindi trasferibili almeno tra le imprese di un medesimo settore produttivo), rispetto a quelle specifiche. Di conseguenza riduce la necessità di un legame di dipendenza biunivoca tra impresa e lavoratore. Senza entrare nel merito di una questione empirica che resta difficile da dirimere, occorre tenere conto almeno dei seguenti aspetti di complessificazione del problema, che evidenziano come l’opposizione generale/specifico diventi più indeterminata e analiticamente meno rilevante: c) La trasferibilità delle competenze (al di fuori delle imprese in cui vengono acquisite) dipende indistintamente dal loro valore d’uso e dalla visibilità di tale valore d’uso. In assenza di specifiche documentazioni e certificazioni, si genera un’asimmetria informativa tra l’impresa in cui le competenze sono state acquisite e le altre, circa l’effettiva attitudine di tali competenze a creare valore (la loro efficacia generale), che limita le opportunità di mobilità esterna dei lavoratori (Chang, Wang, 1996). Il ruolo che assume l’apprendimento organizzativo negli attuali contesti di lavoro (v. infra) aumenta, a pari condizioni, quest’asimmetria. d) La flessibilità funzionale che caratterizza gli attuali contesti di lavoro, può costituire un distinto ostacolo alla trasferibilità, in quanto l’aggregato di competenze che deriva dall’esperienza lavorativa in una data impresa può essere altamente specifico, anche se i suoi ingredienti (le singole unità di competenza che lo costituiscono) sono largamente esportabili30. e) Infine, la distinzione tra competenze generali e specifiche viene spiazzata dalle nuove determinazioni che assume quella tra conoscenze “esplicite” e “tacite” (Nonaka, Takeuchi, 1995). La problematica dei “tacit skills” e dell’ “apprendimento organizzativo” è, come noto, successiva a quella della trasferibilità del capitale umano. Tuttavia in passato è 30 Bishop (1996) ha argomentato che l’esperienza in un’impresa porta normalmente ad acquisire competenze d’ordine generale, la cui combinazione da un luogo ad un insieme specifico. E’ tuttavia intuitivo che la flessibilità funzionale rafforza la verosimiglianza dell’argomento. 49 stato stabilito un raccordo implicito tra le due, sulla base del duplice assunto che i) l’apprendimento fornito dall’esperienza pratica del lavoro è una causa principale della specificità (rispetto al contesto di lavoro) delle competenze che ne risultano (Doeringer, Piore, 1971) e che ii) il carattere “tacito” delle competenze è un correlato necessario dell’apprendimento attraverso l’esperienza (Nordhaug, 1993). Da cui l’idea che le competenze tacite sono anche specifiche. Ma l’argomento non regge nel caso in cui l’apprendimento via esperienza lavorativa riguardi la soluzione di problemi, cioè coincida con la scoperta di soluzioni che si rivelano adeguate o superiori. Questo tipo d’apprendimento non è specifico rispetto ai contesti di lavoro, ma rispetto ai tipi di problema da risolvere, esattamente come avviene per l’apprendimento sul lavoro degli artigiani, che oltre certe soglie di varietà giunge a produrre regole di validità generale (Piore, 1975). Pertanto le competenze che ne derivano sono insieme tacite e trasferibili tra contesti di lavoro diversi. In conclusione, si deve ammettere che, soprattutto negli attuali contesti d’apprendimento, la trasferibilità delle competenze è solo in parte determinata esogenamente dalle tecnologie di processo e di prodotto, come vorrebbe la teoria Beckeriana, e che per il resto (e quindi per lo più) è, invece, endogena rispetto alle scelte d’organizzazione del lavoro e soprattutto all’informazione disponibile circa le loro caratteristiche. Nell’insieme questi elementi d’analisi suggeriscono che l’apprendimento continuo, finalizzato all’innovazione, complica alquanto la dialettica delle convenienze delle imprese e dei lavoratori. Dal lato dei lavoratori, l’impegno mentale e psicologico richiesto dall’apprendimento connesso alla soluzione di problemi, unitamente ai vincoli sulla trasferibilità delle competenze, giustificano l’ipotesi che essi non siano normalmente disposti ad erogare un impegno ottimale nell’apprendimento. Nello stesso tempo è evidente che le loro opportunità d’impiego e di carriera dipendono dalla reputazione professionale che riescono a costruirsi, la quale a sua volta dipende dalla qualità delle esperienze d’apprendimento sul lavoro. Le imprese si trovano, invece, esposte al rischio di perdere pezzi del proprio sapere organizzativo in seguito all’uscita di chi detiene queste competenze, fino a quando non sono state convertite in conoscenze trasmissibili. Nello stesso tempo si offre loro l’opportunità d’arricchire tale sapere (cioè innovare), attirando soggetti che, in virtù del proprio percorso pro- 50 fessionale, hanno esplorato possibilità del mestiere di riferimento a loro sconosciute. L’assunto di una generalizzata tendenza alla contrazione delle competenze specifiche rispetto alle imprese risulta, quindi, compatibile con una dinamica di ritenzione e di sostituzione dei dipendenti (dal lato delle imprese) e di mobilità volontaria e carriera interna (dal lato dei lavoratori), che ha poco a che vedere con l’imputazione dei costi della formazione tra le parti, e molto più con il moral hazard delle controparti. I lavoratori, infatti, possono fare solo finta d’impegnarsi ad apprendere, se non adeguatamente motivati. Inoltre, fino a quando le competenze tacite di cui sono in possesso non vengono oggettivate in procedure, essi godono di un potere d’interdizione: l’impresa non ha convenienza a licenziarli, e comunque i risultati del processo di conversione delle conoscenze dipendono dalla loro collaborazione. Le imprese, per parte loro, trovano nelle attuali modalità dell’apprendimento ulteriori opportunità per fare aumentare il costo opportunità delle dimissioni volontarie dei propri dipendenti, adottando criteri idiosincratici di valutazione delle competenze, che impediscano alle altre imprese di poterle apprezzare pienamente. Quest’analisi conduce alla conclusione, in parte originale anche rispetto alle più recenti prospettive dell’economia della formazione, che, per ottenere un livello ottimale d’apprendimento finalizzato all’innovazione, occorre risolvere almeno uno di due problemi di coordinamento: uno relativo al rapporto tra impresa e lavoratore, l’altro, alle imprese afferenti ad un determinato bacino di reclutamento. I termini del primo problema di coordinamento integrano bene la fattispecie del rapporto d’agenzia. L’impresa che sceglie una strategia competitiva basata sull’innovazione, ha bisogno che i suoi dipendenti s’impegnino nell’apprendimento continuo e siano disposti a collaborare a che le loro competenze tacite siano convertite in procedure esplicite. Ciò costa loro una disutilità, proporzionale all’impegno mentale e psicologico richiesto e alla quasi rendita, cui devono rinunciare. I comportamenti in questione non sono osservabili dall’impresa, quindi l’arma del controllo è inservibile. I risultati, invece, lo sono, anche se è difficile valutarli sulla base di una scala assoluta. Il secondo problema di coordinamento riguarda la trasferibilità delle competenze dei lavoratori. Questo vincolo è stato discusso dalla letteratura in riferimento alla formazione aziendale di base, il cui prototipo è il si- 51 stema tedesco della formazione in alternanza (Johanson, 2002). Nel caso della formazione continua riguarda più semplicemente i criteri e le modalità della “certificazione” delle competenze31, ma presenta analoghe implicazioni. Ogni impresa che utilizza criteri idiosincratici di “certificazione”, impedisce alle altre d’apprezzare pienamente il capitale umano accumulato dai suoi dipendenti. Nella misura in cui questa è la regola32, tutte le imprese si trovano in difficoltà ad individuare sul mercato esterno del lavoro competenze diverse e/o più sviluppate di quelle in loro possesso, e i lavoratori vedono aumentare il costo opportunità delle dimissioni volontarie e la difficoltà di re impiegarsi in caso di licenziamento. Ne consegue una fondamentale distorsione delle regole del “gioco dell’investimento in formazione”, che deprime i relativi investimenti a un livello sub-ottimale. In un simile contesto, infatti, i lavoratori non possono mettere in competizione l’offerta retributiva dell’impresa in cui hanno accumulato competenze con quelle di altre e, pertanto, non possono fare di quest’accumulazione un’opportunità d’investimento. Ciò significa che il costo della formazione (la compensazione dello sforzo richiesto per ap31 Le virgolette servono ad indicare che con “certificazione” si vogliono qui denotare, non solo i sistemi specificamente finalizzati a garantire erga omnes la corrispondenza delle conoscenze e abilità possedute a standard prefissati, ma anche varie forme di documentazione dell’esperienza individuale di lavoro (il curriculum professionale), validate da una qualche autorità. Nel contesto della presente analisi la “certificazione” delle competenze, infatti, serve solo a ridurre l’asimmetria informativa e il rischio di selezione avversa, cui sono esposte le imprese nel momento in cui vogliono valutare il bagaglio professionale di un candidato all’assun-zione. Quindi, è necessario dare alla nozione di certificazione la flessibilità necessaria a comprendere le varie determinazioni che quest’asimmetria informativa può assumere. 32 Infatti, ogni impresa che s’impegna a finanziare l’apprendimento continuo dei propri dipendenti (che si traduca in competenze trasferibili) deve mantenere elevato il costo opportunità delle loro dimissioni volontarie, fino a quando non ha la garanzia che le altre imprese non potranno godere di “poaching externalities” (Stevens, 1996). Il fallimento del mercato nel produrre questo bene informativo riguarda anche il settore della consulenza organizzativa. Le imprese di consulenza, offrendo ai propri clienti la (spesso inutile) personalizzazione dei servizi forniti, rendono più opaco e quindi più profittevole questo mercato. Ma se cercassero d’omogeneizzare i criteri di classificazione e valutazione delle competenze proposti – operazione per cui hanno certamente competenze adeguate – ridurrebbero il valore di tali servizi. 52 prendere) deve essere sostenuto interamente dalle imprese – il che porta, appunto, a trasformare un problema d’investimento in uno d’incentivazione. L’asimmetria informativa circa le caratteristiche delle competenze possedute dai lavoratori può essere superata mediante l’istituzione di sistema di “certificazione” condiviso dalle imprese. Quali che siano gli interessi prevalenti (v. par. 4), questo esito non potrà mai derivare dalla dinamica del mercato, ma richiede di risolvere un problema d’azione collettiva (Olson, 1971). Questo contributo si concentra sul primo dei due problemi, sia per vincoli di spazio, sia perché è stato trascurato dalla letteratura, mentre il secondo è al centro del nuovo corso dell’economia della formazione. Tuttavia, nelle conclusioni del paragrafo successivo verranno svolte anche alcune considerazioni circa la problematica della “certificazione” delle competenze. 2.4. La carriera orizzontale come leva dell’apprendimento continuo Come per qualsiasi rapporto d’agenzia, la soluzione del problema di stimolare un lavoratore ad impegnarsi attivamente nell’apprendimento sta nell’adottare un sistema d’incentivazione, capace di allineare i suoi interessi con quelli dell’impresa. Nel caso specifico, però, quest’obiettivo restringe le alternative praticabili a pochi sistemi d’incentivazione tra quelli fin ora sperimentati, e in particolare a due: i sistemi definiti pay for performance e quelli pay for skills o for knowledge33. Nella misura in cui ne33 Si deve, infatti, dare per scontata l’inadeguatezza degli incentivi collettivi, dal momento che i membri di un gruppo di lavoro possono controllare reciprocamente i contributi individuali al risultato collettivo solo in relazione agli aspetti estrinseci delle prestazioni, ma non all’apprendimento. Ma risulta anche poco praticabile la prospettiva degli incentivi negativi: indurre i lavoratori ad allinearsi alle aspettative dei datori, per evitare di perdere una quasi rendita. Il duplice vincolo posto da questi sistemi d’incentivazione – i) l’osservabilità dei comportamenti attesi, ii) la loro valutazione in termini di una pura soglia d’accettabilità (Milgrom e Roberts, 1992) – li rende inadeguati al problema in questione. Volendo forzare questi limiti, l’incentivo negativo finisce per incoraggiare comportamenti opportunistici. Per ciò, la leva della precarizzazione delle relazioni d’impiego si rivela uno strumento inadatto ad incentivare l’apprendimento continuo. Nello stesso tempo, il venire meno 53 gli attuali contesti di lavoro l’apprendimento può essere considerato come un aspetto intrinseco alle prestazioni attese, l’impegno dei lavoratori nel raggiungimento dei compiti assegnati viene a coincidere con la mobilitazione del loro capitale umano. Di conseguenza rendere variabile una parte della retribuzione in funzione delle prestazioni osservate serve certamente ad incentivare l’apprendimento continuo. Questa è appunto la logica d’alcuni sistemi di retribuzione variabile, introdotti in seguito ad innovazioni organizzative che comportano l’allargamento dei compiti degli operativi in direzione di funzioni di manutenzione, controllo della qualità, programmazione della produzione, ma in realtà parametrati sulla valutazione delle prestazioni fornite (Gomez-Mejia e Balkin, 1992; Bergström, 1994). Tuttavia, la teoria economica degli incentivi (Milgrom e Roberts, 1992; Gibbons, 1998), nonché l’analisi psicologica (Lawler, 1990) hanno efficacemente argomentato che i sistemi di incentivazione delle prestazioni incontrano grossi ostacoli, soprattutto negli attuali contesti di lavoro, quando riferiti ai risultati conseguiti (l’output) – a causa della difficoltà di parametrarli in modo adeguato e di separare l’effetto dei contributi individuali – e ancor più, quando riferiti direttamente ai contributi (gli inputs) forniti dai lavoratori al processo produttivo, la cui valutazione necessariamente soggettiva va’ incontro a svariati problemi. I sistemi d’incentivazione riferiti direttamente alle conoscenze e abilità acquisite incontrano meno difficoltà34. La loro logica è simile a quella dei sistemi di “carriera professionale”, teorizzati da Kanter (1989b), secondo cui l’aspettativa di conseguire successivi incrementi stabili della retribuzione induce il lavoratore ad aumentare progressivamente il proprio bagaglio di competenze, e queste, in funzione della loro visibilità, accrescono la sua reputazione professionale. Pertanto, possono essere riferiti al della garanzia della stabilità dell’impiego riduce lo spazio per clausole contrattuali implicite, legate all’aumento della retribuzione in funzione dell’anzianità aziendale. Non resta, quindi, che la prospettiva di ricollegare in modo relativamente lineare l’apprendimento sul lavoro a ricompense individuali, ovvero definire con precisione l’orizzonte temporale del dispositivo incentivante, in modo da consentire alle parti la valutazione delle proprie convenienze. 34 S’intendono difficoltà gestionali. Questi sistemi, invece danno luogo in genere a un’accentuata dinamica delle retribuzioni, che può risultare onerosa per le imprese e in tal senso aiuta a spiegare la loro relativamente scarsa diffusione. 54 modello della carriera “orizzontale” (d’ora in poi CO) ed essere opportunamente analizzati alla luce delle sue proprietà strutturali. Una carriera “orizzontale” si differenzia da quella “verticale”, tipica del MIL fordista, per tre aspetti fondamentali35: a) il riferimento delle promozioni a una gerarchia di merito, invece che di posti; b) l’apertura dei ranghi della gerarchia (il numero delle opportunità di promozione ad ogni livello superiore non è predeterminato); c) l’assegnazione delle promozioni in seguito ad valutazione del merito assoluto delle prestazioni, invece che del merito relativo, per cui “vince il migliore”. Si tratta intuitivamente d’ingredienti che si richiamano l’uno con l’altro: la logica di una gerarchia di merito implica che i suoi ranghi siano aperti (anche se il principio può essere violato), e ciò implica a sua volta una selezione dei candidati alle promozioni basata sul merito assoluto delle loro prestazioni. Tuttavia, è opportuno considerarli distintamente. Il riferimento ad una gerarchia di merito qualifica il nesso tra la valenza professionale della prestazione lavorativa e l’idea di sviluppo, incorporata nella nozione di carriera. Infatti, per un verso il progressivo incremento di competenze si traduce in incrementi stabili di retribuzione, indipendentemente dall’uso effettivo delle competenze stesse, per un altro l’incremento di competenze riflette la varietà e la crescente complessità dei problemi affrontati. In questo senso i percorsi interni di carriera possono essere accomunati a quelli via mobilità esterna. In entrambi i casi la carriera viene a coincidere, non con l’ascesa di una gerarchia di posizioni, ma con l’avvicinamento al centro del sapere relativo ad un dato “mestie35 Lo spazio delle carriere organizzative (verticali e orizzontali) deriva dalla determinazione dei differenziali di retribuzione (nel senso ampio del termine) in base ad una gerarchia prestabilita, così da scindere l’ammontare della retribuzione dalla prestazione. La carriera consiste quindi in una sequenza di premi, rappresentati da incrementi permanenti di retribuzione d’entità predeterminata e nota a tutti in anticipo, la cui acquisizione è condizionata ad eventi chiamati promozioni. Nella carriera “verticale” i differenziali retributivi tra i livelli sono agganciati alle posizioni ricoperte (la gerarchia delle retribuzioni coincide con quella delle posizioni); in quella “orizzontale”, al merito o alle competenze dei lavoratori (la gerarchia delle retribuzioni coincide con quella del merito dei lavoratori). La distinzione in parola fornisce un razionale strutturale a quella proposta dalla Kanter (1989b) in termini di tipi ideali, tra carriera: “professionale” e “burocratica”. Per una trattazione più approfondita di questa problematica si rinvia a Follis, 1996; 2002. 55 re” o professione, da cui dipende la riproduzione e l’aggiornamento delle competenze che lo qualificano. Analogamente alle professioni tradizionali, le tappe di questa progressione sono contrassegnate (sia all’interno di un’impresa che di un territorio o comunità professionale) dall’incremento della “reputazione” del soggetto invece che dello status della reputazione ricoperta. Questa proprietà formale delle CO mette quindi in luce che la loro leva incentivante è la competizione con sé stessi, che, come avviene in atletica o nelle aule scolastiche, ha nella tensione a conseguire certi risultati la sua molla. L’apertura dei ranghi mette invece evidenza l’efficacia incentivante della CO dal punto di vista delle opportunità d’avanzamento offerte, e l’avvicina sotto quest’aspetto ai sistemi d’incentivazione lineare delle prestazioni. Infatti, la conseguenza essenziale dell’apertura dei ranghi della gerarchia è il trasferimento del vincolo organizzativo sulle opportunità di promozione dalla struttura demografica dell’organizzazione e dalla disponibilità di posti vacanti, alla scadenza delle valutazioni. La probabilità di progredire nella gerarchia viene, cioè, a dipendere, non dal rapporto tra posti e candidati, ma dalla frequenza secondo cui i candidati vengono valutati ai fini della promozione. Pertanto nell’ambito di questo sistema di carriera la scadenza delle promozioni diventa per un verso un parametro esplicito e negoziabile, e di fatto spesso uno dei principali oggetto di discussione tra le parti sociali, per un altro verso il principale criterio di differenziazione delle persone. Infatti, dato un certo ritmo di scadenze, l’eccellenza delle persone è resa visibile dalla rapidità dei loro avanzamenti. Nello stesso tempo però, chi non ce la fa alla prima scadenza, può recuperare a quella successiva. In tal senso il sistema evita il rischio di spreco, insito nella carriera verticale, conseguente ai “falsi negativi”, cioè coloro che avendo “perso” per motivi casuali alla prima tornata, non vengono più considerati di “prima categoria”. In una gerarchia a ranghi aperti le promozioni dipendono dal raggiungimento di determinati standards o obiettivi prefissati, invece che dal merito relativo dei candidati. Ciò identifica uno specifico vantaggio di questo sistema d’incentivazione, in quanto sottrae la valutazione dal confronto diretto con gli altri (ogni percorso di carriera orizzontale è, al limite, un caso a sé), e quindi protegge maggiormente dalla frustrazione La letteratura economica (v. Milgrom, Roberts, 1992, cap. 12) ha, tuttavia, 56 speso pagine molto acute per argomentare le gravi difficoltà cui va incontro ogni valutazione del merito assoluto, tanto da creare un grave pregiudizio negativo nei confronti d’ogni sistema che pretenda di misurare il valore di un lavoratore sulla base del contributo lavorativo che fornisce al processo produttivo, invece che ai risultati della sua prestazione. Questo è certamente l’aspetto più delicato della CO, ma non irrisolvibile. Se i livelli della gerarchia sono riferiti all’acquisizione di competenze (numero e/o livello delle competenze possedute) e se si accetta un’accezione “moderata” di competenza, come insieme di conoscenze e abilità, rispetto al quale le attitudini personali costituiscono una risorsa che differenzia livello e tempi dell’acquisizione, e non uno specifico ingrediente (Nordhaug, 1993), il problema può trovare una soluzione, che rispetti il duplice vincolo i) della parametrazione dell’incentivo in base a una scala assoluta e ii) del carattere soggettivo della valutazione. Le soluzioni concrete, rilevate da chi scrive, vanno dalla valutazione di un responsabile, che ha valore solo se sottoscritta dal candidato, alla valutazione dei membri del collettivo/gruppo di lavoro, all’autovalutazione degli stessi interessati, in funzione del peso della componente soggettiva della valutazione circa il livello delle competenze acquisite. I criteri sono, comunque, sempre pubblici e di norma sono previste procedure di “appello” con l’intervento di terze parti, in caso di controversie. Il grado d’apertura dei ranghi (in funzione dei vincoli di spesa), i criteri di valutazione, la frequenza delle valutazioni, la pubblicità delle promozioni (che è ovviamente cosa diversa dalla pubblicità dei criteri) sono gli ingredienti formali che differenziano i sistemi di CO interna, e in particolare il modello prevalente nelle imprese Giapponesi da quello che sta emergendo negli USA (Pfeffer, 1994) e in diversi paesi europei: Svezia, Francia, Italia36. Nel modello giapponese non è assolutamente chiaro, probabilmente perché varia da un’impresa all’altra, se il numero delle opportunità di promozione annuali è predeterminato (in funzione di vincoli 36 Chi scrive ha avuto modo di svolgere in questi paesi alcuni studi di caso nel contesto di due progetti, finanziati dai programmi comunitari Force e Leonardo, su modelli innovativi di gestione del personale operativo in imprese di medie e grandi dimensioni. L’analisi comparativa dei sistemi di CO abbozzata nei capoversi che seguono si basa prevalentemente sulle evidenze prodotte da questi pochi studi, e va quindi recepita con le cautele del caso. 57 finanziari o altro), oppure i ranghi sono aperti. Invece, in tutte le esperienze europee note a chi scrive i ranghi sono completamente aperti. Tale apertura ha in genere come contropartita per l’impresa la possibilità di orientare le attività d’apprendimento e di formazione (le competenze da acquisire) in funzione delle sue esigenze. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, non si hanno informazioni circa il modello giapponese. Si tratta evidentemente di una differenza di peso, poiché è dall’apertura dei ranghi che dipendono le opportunità d’avanzamento, ma che è spiegabile, alla luce della considerazione che le imprese giapponesi sono tuttora in grado di assicurare la continuità dell’impiego alla maggioranza dei loro dipendenti (Miyamoto, 1999), diversamente da quelle europee. Il modello europeo fa riferimento solo alle competenze acquisite e in tal senso riduce di molto le difficoltà di una valutazione per merito assoluto, oltre che essere compatibile con una combinazione molto ampia di modalità di valutazione e validazione, in linea di principio tutte egualmente efficienti. Il modello giapponese si è recentemente rinnovato nel senso di ridurre il peso dell’anzianità sulle promozioni nella gerarchia di merito a favore delle prestazioni rilevate, anche se non è chiaro che cosa venga inteso per prestazione. L’opinione di chi scrive è che comunque anche su questo punto il modello europeo si differenzi da quello giapponese, che pare fondarsi in modo più marcato su clausole contrattuali implicite. Il modello europeo si differenzia al proprio interno per quanto riguarda i criteri utilizzati per tradurre in incrementi di retribuzione le competenze acquisite. In diverse imprese svedesi è stata adottata una parametrazione per punti, secondo la quale le competenze da acquisire sono rapportate ad scala a punti, ove ad ogni punto è associata una (medesima) somma di denaro, che entra a far parte stabilmente della retribuzione. Nelle imprese francesi esaminate e in una Italiana il criterio usato fa, invece, riferimento al sistema di inquadramento contrattuale e ai differenziali retribuivi associati a questa gerarchia. Gli incrementi di competenze vengono cioè tradotti in punti che, raggiunta una certa soglia, danno luogo al passaggio al livello di inquadramento superiore. In alcune versioni si richiede come ulteriore condizione che l’apprendimento riguardi diversi tipi di competenze, per cui i passaggi di categoria sono subordinati al raggiungimento di un dato punteggio medio rispetto a diverse scale. Questi criteri danno luogo a promozioni scadenzate più raramente e dotate di 58 maggiore valore simbolico, mentre il sistema svedese è molto simile ai sistemi di pay for knowledge. Un punto sensibile è la pubblicità degli aumenti retributivi associati ad una gerarchia di merito. Poiché gli avanzamenti in una gerarchia di merito non sono automaticamente eventi pubblici (diversamente da quelli in una gerarchia di posti), le diverse possibili soluzioni dipendono in larga misura dal sistema di valutazione dei processi di apprendimento utilizzato, ma costituiscono a loro volta un argomento per la scelta tra di essi. Una miriade di studi psicologici, infatti, stanno a provare che i membri di un gruppo, se si percepiscono troppo diversi tra loro, tendono ad entrano in conflitto, ma qualora le differenze che li separano vengano occultate, il conflitto non si accende. Peraltro mantenere segreta una retribuzione al merito, equivale ad indebolirne la leva incentivante. La tendenza prevalente in Europa, del resto coerente con la logica di carriera professionale di questi sistemi di incentivazione, sembra essere di assicurare la visibilità delle progressioni delle CO mediante diversi accorgimenti organizzativi (si veda l’esempio dei tabelloni, in cui viene comunicata e continuamente aggiornata la polivalenza dei membri di un’unità organizzativa rispetto alle posizioni lavorative previste). Il problema della pubblicità delle promozioni confina con quello della trasferibilità delle competenze. Il bagaglio di competenze professionali accumulato nel corso di un rapporto d’impiego può restare un fatto privato, cioè noto solo alle parti, oppure può essere conosciuto da terzi. La seconda opzione apre alla prospettiva di estendere il modello della CO oltre l’ambito delle singole imprese, e di realizzare così una soluzione di rango superiore. Se, infatti, le progressioni nella gerarchia di merito di una data impresa si potessero raccordare con quelle conseguenti al passaggio in un’altra, (cioè la mobilità esterna si potesse raccordare con le carriere interne) e quindi, i processi d’apprendimento e i percorsi di crescita professionale che si svolgono nell’ambito d’imprese diverse si potessero integrare tra loro, si avrebbe i) un aumento della produzione di competenze, proporzionale alla disponibilità dei lavoratori a sostenerne l’onere psicologico (quindi relativamente indifferente all’anzianità di lavoro), ii) una significativa facilitazione della mobilità esterna dei lavoratori, e iii) per le imprese una maggiore flessibilità allocativa, da cui la diffusione delle competenze nel sistema produttivo. Le condizioni di questa dinamica virtuosa sono: i) che i sistemi aziendali di gestione delle risorse umane spe- 59 cifichino bene il nesso tra apprendimento e avanzamenti di carriera (o vantaggi retributivi immediati), così da consentire alle parti una valutazione delle convenienze nel breve periodo; e soprattutto ii) che, cambiando impresa, i lavoratori vedano riconosciute le competenze trasferibili, che hanno acquisito in quella precedente37. Come si è argomentato, ciò è possibile, se tale trasferibilità non è soggetta a vincoli d’asimmetria informativa, ovvero se viene istituito un sistema di “certificazione”delle competenze, condiviso e accettato dalle imprese. Questo problema d’azione collettiva è, a prima vista, meno complesso di quelli su cui si focalizza la letteratura sulla formazione professionale: cioè come realizzare efficaci sistemi di formazione iniziale in azienda, e come distribuire i relativi oneri finanziari tra le imprese. Per conseguire questi obiettivi, infatti, non basta indurre le imprese ad accordarsi su obiettivi e procedure, ma occorre anche impedire che i sottoscrittori dell’accordo possano defezionare successivamente – per esempio che un’impresa riduca la sua quota di posti per apprendisti e/o che cominci a reclutare massicciamente giovani formati da altre imprese. Secondo la teoria dell’azione collettiva, si tratta di un problema di gran lunga più difficile da risolvere del primo (Olson, 1971; Johansen, 2002). Nel caso della realizzazione di un sistema di “certificazione” delle competenze, si può, invece, ammettere che, una volta che il sistema sia stato accettato dalle associazioni dei datori di lavoro e abbia ottenuto il consenso di quelle sindacali, il problema del suo mantenimento trovi una soluzione “naturale” e particolarmente efficace nell’interesse dei lavoratori alla trasferibilità delle proprie competenze. I lavoratori stessi provvederanno a controllare i free riders, sia denunciandoli all’autorità sovraordinata, che gestisce gli incentivi selettivi (positivi o negativi), sia sanzionandoli con l’arma delle dimissioni. Tuttavia, la stessa efficacia autoapplicativa di questi sistemi suggerisce che la loro istituzione è destinata ad incontrare gravi ostacoli. Da un lato, perché le due leve dell’azione collettiva – la “dimensione del gruppo” e gli incentivi selettivi forniti da un’autorità sovraordinata (Olson, 1971) – sono fortemente condizionate dall’eterogeneità e dalla composizione della 37 Nel caso di mobilità esterna la specificità incorporata nelle competenze acquisite diventa un investimento irrecuperabile. 60 popolazione di riferimento38. Dall’altro lato, perché l’implementazione di tali sistemi esporrebbe le imprese che perseguono una strategia competitiva basata sui costi, e che quindi non hanno interesse a sviluppare l’apprendimento continuo dei propri dipendenti, al triplice rischio di i) retribuire di più i lavoratori qualificati, ii) subire un più elevato tasso di dimissioni dei propri dipendenti (una volta che essi abbiano verificato la mancanza d’opportunità di crescita professionale), iii) essere evitate dai lavoratori più ambiziosi e capaci. Se si considera che la strategia in questione prevale tra le imprese minori, e che esse sono anche strutturalmente esposte ad un turn over più elevato, si comprende la tenacia della loro avversione39. Nel caso del nostro paese questi argomenti trovano conferma nella straordinaria lentezza con cui proseguono le iniziative promosse dagli Organismi Bilaterali per la Formazione. 2.5. Conclusioni Le analisi precedenti delineano una prospettiva sulle tendenze di cambiamento del lavoro, che non condivide la visione pessimistica di chi sostiene che i processi di deregolamentazione del mercato del lavoro e la crisi dei MIL fordisti porteranno inevitabilmente alla fine dei career jobs. A ben vedere, infatti, un simile esito non dipenderebbe dalla deregolamentazione in quanto tale, ma dal prevalere di una strategia competitiva 38 Per “dimensione del gruppo” s’intende il peso relativo di coloro che possono trarre i maggiori vantaggi dall’azione collettiva: in questo caso, la proporzione degli addetti alle imprese interessate alla formazione continua rispetto al totale degli occupati. L’autorità sovraordinata, in grado di stimolare l’impegno nell’azione collettiva mediante incentivi selettivi, coincide, nel caso in questione, con le associazioni di rappresentanza degli interessi dei datori di datori di lavoro o con organizzazioni da esse partecipate, ma possibilmente anche con i governi locali e quello centrale. In questo caso il peso relativo dei due gruppi d’imprese si traduce nella capacità d’influenzare le decisioni dell’autorità sovraordinata. 39 E’ anche facile predire che – stante l’impossibilità di negare la razionalità dell’obiettivo di favorire la trasferibilità delle competenze, e quindi la mobilità dei lavoratori, da parte d’imprenditori che considerano la flessibilità come una risorsa competitiva strategica – quest’avversione non sarà esplicita, ma si manifesterà attraverso tattiche di dilazionamento (“migliorare le soluzione proposte, per non farne nulla”), di svuotamento, ecc. 61 delle imprese basata sulla riduzione dei costi di produzione (e segnatamente del lavoro), per la quale la deregolamentazione costituisce una condizione essenziale. La prospettiva delineata non condivide nemmeno la posizione di chi, mettendo l’accento sui molti fattori di frizione che incontrano le forze del cambiamento, prevede il sostanziale prolungamento degli attuali assetti, anche se nel contesto di una struttura più fortemente segmentata del mercato del lavoro. Ad avviso di chi scrive i MIL, così come li abbiamo conosciuti (i MIL fordisti), sono entrati in una crisi senza ritorno, perché non forniscono una soluzione adeguata né alle strategie competitive basate sull’innovazione, né, ovviamente, a quelle basate sulla riduzione dei costi di produzione. La contrapposizione tra i due tipi di strategia competitiva è certamente schematica, ma adeguata a fare da presupposto alle argomentazioni proposte, che fanno perno sulla funzione prevalente che assumerebbe la formazione continua nei contesti aziendali orientati all’innovazione: assicurare l’adeguamento delle competenze professionali all’evoluzione dei ruoli a tutti i livelli dell’organizzazione. Da questo assunto deriva una catena di conseguenze, che l’articolo ha cercato di dipanare in via analitica: i) per adeguare le competenze ad una rapida evoluzione dei ruoli, non bastano iniziative formali di formazione, ma occorre soprattutto che i lavoratori mobilitino le loro risorse intellettuali, per apprendere dall’esperienza di lavoro; ii) questa modalità d’apprendimento evidenzia l’inadeguatezza della versione Beckeriana della teoria del capitale umano, e fornisce specifici incentivi alle parti per agire opportunisticamente; iii) ne consegue che, per conseguire un adeguato sviluppo dell’apprendimento continuo, occorre risolvere due distinti, ma correlati, problemi di coordinamento: come indurre i lavoratori ad impegnarsi effettivamente nell’apprendere sul lavoro, come indurre le imprese a non trattenere/deformare l’informazione circa le competenze acquisite dai propri dipendenti. Su questa base, circa un terzo dell’articolo è stato dedicato ad argomentare come i sistemi d’incentivazione riferibili alla logica della CO possano fornire una buona soluzione del primo dei due problemi. Alcune evidenze empiriche hanno confermato la praticabilità di questa prospettiva. Essa s’ispira in modo evidente ad uno scenario in cui i “lavoratori della conoscenza” (Butera, Donati, Cesaria, 1997) abbiano un ruolo preponderante, anche in termini numerici. In tal senso può essere opportunamente colle- 62 gata al crescente livello d’istruzione delle leve che stanno entrando nel mercato del lavoro. In diversi paesi industrializzati sta arrivando all’età della pensione la grossa coorte di lavoratori entrati nel mercato del lavoro negli anni ’60, sull’onda del boom industriale e che le imprese già stanno rimpiazzando con nuovi assunti, in media assai più istruiti. Quest’ondata di nuove assunzioni è destinata tra breve a modificare sensibilmente la composizione delle forze di lavoro, caratterizzandole nel complesso per profili d’aspettative più elevate, dal momento che, com’è noto, vi è una netta relazione positiva tra livello d’istruzione e aspettative sul lavoro (retribuzione, qualità intrinseca, possibilità di crescita professionale). Un importante risvolto di questi sistemi di gestione delle relazioni d’impiego è la loro possibilità di stimolare l’innovazione a livello d’organizzazione del lavoro e dei processi. La prospettiva ereditata da una lunga tradizione di studi organizzativi è che l’innovazione della gestione delle risorse umane costituisce piuttosto una conseguenza del cambiamento dell’organizzazione dei processi e del lavoro, al fine di adeguare i sistemi di classificazione, di valutazione e di ricompensa a nuove modalità d’impiego delle risorse umane. Questa è stata anche la prospettiva d’analisi seguita in quest’articolo. E’ tuttavia possibile, in linea di principio, rovesciare questa sequenza causale, ed immaginare che l’innovazione della gestione delle relazioni d’impiego, modificando i vincoli delle scelte d’organizzazione del lavoro, offra inedite opportunità d’innovazione a questo livello, qualificandosi come una leva autonoma del cambiamento organizzativo. Non mancano analisi storiche in questo senso (Edwards, 1979). Questa nuova prospettiva è, appunto, particolarmente coerente con i sistemi di gestione delle relazioni d’impiego basati sulla CO. Essi, infatti, sganciando l’incentivo ad apprendere dalle prestazioni, determinano un aumento dello stock di competenze disponibili, proporzionale all’intensità dell’incentivo erogato, che non solo si traduce in risorse per il cambiamento organizzativo, ma può anche imporlo, al fine di utilizzare appieno risorse che vengono comunque remunerate40. 40 Un esempio pertinente è fornito dal caso di un’impresa svedese di medie dimensioni, specializzata nella produzione di parti in plastica per autoveicoli, che chi scrive ha avuto modo di studiare recentemente. Qualche anno dopo l’introduzione di un sistema di pay for knowledge l’impresa concepì la riorganizzazione della sua 63 E’ peraltro evidente che un sistema di CO, limitato a singole imprese, fornisce una soluzione di secondo rango del problema dell’apprendimento continuo. Il suo pieno sviluppo in un contesto dinamico e che non può rinunciare alla flessibilità allocativa, richiede di raccordare processi d’apprendimento in successivi rapporti d’impiego, quindi carriere interne e mobilità esterna. L’analisi ha messo in luce che l’istituzione di sistemi condivisi di “certificazione” delle competenze incontra difficoltà molto serie, che riguardano essenzialmente il decollo dell’iniziativa, dal momento che il suo successivo mantenimento godrebbe del vantaggio delle particolari proprietà autoapplicative di questi sistemi. Tali difficoltà sono peraltro proporzionali al peso prevalente che hanno nei sistemi produttivi (compresi i servizi alle imprese) le imprese che appoggiano la propria strategia competitiva sul contenimento del costo dei fattori. Se quest’analisi è corretta, ne consegue una precisa indicazione di policy, secondo cui le istanze del governo (centrale e locali) dovrebbero assumere un ruolo cruciale nella promozione e nell’implementazione di sistemi di “certificazione”, facendo leva sull’interesse collettivo all’affermarsi di strategie competitive basate sull’innovazione. Potendo evitare il coinvolgimento nel processo di mantenimento di tali sistemi, comunque più soggetto al rischio della perdita di consenso, questo ruolo potrebbe essere declinato nella prospettiva squisitamente politica dello stimolo alle forze economiche ad imboccare percorsi virtuosi, ma che richiedono d’abbandonare vecchie mentalità, routines consolidate e, in ultima istanza, strategie perdenti nel medio lungo periodo. principale linea di produzione (paraurti verniciati) secondo la logica del “canale”, cioè mettendo in sequenza tutte le lavorazioni necessarie per realizzare il prodotto finito, che in precedenza erano svolte in tre reparti distinti. La premessa era che ogni addetto diventasse via via in grado di svolgere ogni lavorazione, nonché le operazioni d’attrezzaggio e prima manutenzione delle macchine, di modo che la conoscenza generalizzata dell’intero processo consentisse d’evitare (o intercettare per tempo) gli spinosissimi problemi di qualità estetica associati alla verniciatura di superfici in plastica (che derivano dall’interazione di fattori relativi sia alle operazioni di stampaggio sia a quelle di verniciatura), e di realizzare ingenti risparmi, poiché lo scarto di un prodotto verniciato non solo impedisce il riuso del materiale, ma implica costi aggiuntivi di smaltimento. I risultati conseguiti solo un anno dopo l’avvio della riorganizzazione confermano la bontà dell’iniziativa. 64 Riferimenti bibliografici Acemoglu D. e J. Pischke (2000), “Certification of Training and Training Outcomes”, European Economic Review¸44: 917-927. Akerlof, G., A. Rose, e J. Yellen (1988), “Job Switching and Job Satisfaction in the U.S. Labor Market”, Brookings Papers on Economic Activity, 2: 495-595. Althauser R. P. (1989), “Internal Labor Markets”, Annual Review of Sociology, 15: 143-161. Althauser, R. e A. Kalleberg (1981), “Firms occupations, and the Structure of Labor Markets”, in I. Berg (a cura di), Sociological Perspectives on Labor Markets, pp. 119-149, Academic Press, New York. Althauser, R. e A. Kalleberg (1990), “Identifying Career Lines and Internal Labor Markets Within Firms: A Study in the Interrelationships of Theory and Method”, in R. Breiger (a cura di), Social Mobility and Social Structure, pp. 308-356, Cambridge University Press, New York. Aoki, M. (1988), Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy, Cambridge University Press, New York (trad. It. La microstruttura dell’economia giapponese, Angeli, Milano, 1991). Arthur, M. e D. Rousseau (a cura di) (1996), The Boundayless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York. Baker, G., M. Gibbs e B. Holmstrom (1993), “Hierarchies and Compensation: A Case Study”, European Economic Review, 37: 366-378. Baker, G., M. Gibbs e B. Holmstrom (1994a), “The Internal Economics of the Firm: Evidence from Personnel Data”, Quarterly Journal of Economics, 59, 4: 881-919. Baker, G., M. Gibbs e B. Holmstrom (1994b), “The Wage Policy of a Firm”, Quarterly Journal of Economics, 59, 4: 921-955. 65 Baker, G. e B. Holmstrom (1995), “Internal Labor Markets: Too Many Theories, Too Few Facts”, American Economic Review, 85, 2: 255-259 Baker, G., M. Jensen e K. Murphy (1988), “Compensation and Incentives: Practice vs. Theory”, Journal of Finance, 43, 3: 593-616. Baron, J. e W. Bielby (1980), “Bringing the Firm back in: Stratification, Segmentation, and the Organization of Work”, American Sociological Review, 45: 737-65. Baron, J.N., A. Davis-Blake e W.T. Bielby (1986), “The Structure of Opportunity: How Promotion Ladders Vary within and among Organizations”, Administrative Science Quarterly, XXXI, 2, pp. 248-273. Bergström P-O. (1994), Svanholm, Wages and Reality, ciclostilato, Swedish Metalworkers’Union, Stockholm. Bridges, W.P., W.J. Villemez (1994), The Employment Relationship: Causes and Consequences of Modern Personnel Administration, Plenum, New York. Brüdel, J, P. Preisendörfer e R. Ziegler (1993), “Upward Mobility in Organizations: The Effects of Hierarchy and Opportunity Structure”, European Sociological Review, 9, 2, pp.173-188. Brunello G., e A. Camuffo (1996), “Velo o vincolo? Note sui sistemi d’inquadramento contrattuale in Italia”, Lavoro e Relazioni Industriali, 1, 1: 7-41. Butera, F. (1991), “Professionisti nelle organizzazioni”, Studi Organizzativi, 3-4: 3-53. Butera, F., E. Donati e R. Cesaria (1997), I lavoratori della conoscenza, Angeli, Milano. Cappelli, P., L. Bassi, H. Katz, D. Knoke, P. Osterman e M. Useem (a cura di) (1997), Change at Work, Oxford University Press, New York. Chang, C, Wang, Y. (1996), “Human Capital Investment under Asymmetric Information: The Pigovian Conjecture Revisited”, Journal of Labor Economics, 14, 3: 505-519. Diekman, A. e P. Preisendörfer (1988), “Turnover and Employment Stability in a Large West Germany Company”, European Sociological Review, 4, 3, pp. 233-258. DiPrete, T. (1989), The Bureaucratic Labor Market: The Case of the Federal Civil Service, Plenum, New York. 66 DiPrete, T. e W. Soule (1986), “The Organization of Career Lines”, American Sociological Review, 51: 295-309. Doeringer, P. e M. Piore (1971), Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Heath, Boston. Edwards R. (1979), Contested Terrain: The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century, New York, Basic Books. Follis, M. (1991), “Traiettorie e scalate: l’approccio sociologico alla mobilità di carriera”, Politiche del lavoro, 15-16: 27-68. Follis, M. (1996), “La carriera come sistema di gestione delle relazioni d’impiego: funzioni e proprietà strutturali delle carriere interne alle imprese”, Rassegna italiana di sociologia, 36, 3: 433-476. Follis M. (2002), “Quanto convengono le promozioni? Un’analisi secondaria”, Studi organizzativi, 3: 5-38. Frank, R. e R. Hutchens (1993), “Wage, Seniority, and the Demand for Rising Consumption Profiles”, Journal of Economic Behavior and Organization, 21: 251-276. Gibbons, R. (1998), “Incentives in Organizations”, in Journal of Economic Perspectives”, 12, 4:115-132. Gibbons, R. (1996), “Incentives and Careers in Organizations”, NBER Working Paper N° 5705, National Bureau of Economic Research, Cambridge. Gibbons, R e M. Waldman (1998), “Careers in Organizations: Theory and Evidence”, in O. Ashenfelter e D. Card (a cura di), Handbook of Labor Economics, vol. IV, North Holland, New York. Gibbs, M. (1995), “Executive Compensation in a Corporate Hierarchy”, Journal of Accounting and Economics, 19: 247-277. Goldner, F. e R. Ritti (1967), “Professionalization as Career Immobility”, American Journal of Sociology, 32, 5: 489-502. Gomez-Mejia, L. e D. Balkin (1992), Compensation, Organizational Strategy and Firm Performance, South-West Publ. , Cincinnati. Grimshaw, D, K. Ward, J. Rubery e H. Beynon (2001), “Organisations and the Transformation of the Internal Labour Market”, Work, Employment & Society, 15, 1: 25-54. Groshen E. e D. Levine (1998), “The Rise and Decline (?) of U.S. Internal Labor Markets”, NBER Working Paper, National Bureau of Economic Research, Cambridge. 67 Hachen, D. (1992), “Industrial Characteristics and Job Mobility Rates”, American Sociological Review, 57: 39-55. Halaby, C. (1978), “Bureaucratic Promotion Criteria”, Administrative Science Quarterly, 23: 466-483. Haveman, H. e L. Cohen (1994), “The Ecological Dynamics of Careers: The Impact of Organizational Founding, Dissolution, and Merger on Job Mobility”, American Journal of Sociology, 100, 1. 104-152. Hedström, P. (1988), The Structure of Inequality: A Study of Stratification within Work Organizations, Almquist and Wiksell International, Stoccolma. Itoh H, (1991), “Japanese Human Resources Management from the Viewpoint of Incentive Theory”, Ricerche Economiche, 45, 2-3:345-376. Johansen L-H. (2002), “Transferable Training as a Collective Good”, European Sociological Review, 18, 3: 301-314. Kalleberg, A., D. Knoke, P. Marsden e J. Spaeth (1996), Organizations in America: Analyzing Their Structures and Human Resources Practices, Sage, Thousand Oaks. Kalleberg, A. e M. van Buren (1996), “Is Bigger Better? Explaining the Relationship Between Organization Size and Job Rewards”, American Sociological Review, 61: 47-66. Kanter, R. (1977), Men and Women of the Corporation, Basic Books, New York (trad. It. Maschile e femminile in azienda, Olivares, Milano, 1988). Kanter, R. (1989a), When Giants Learn to Dance, Simon and Schuster, New York (trad. it., Quando i giganti imparano a danzare, Prima Donna-Edizioni Olivares, Milano, 1990). Kanter, R. (1989b), “Careers and the Wealth of Nations: A Macroperspective on the Structure and Implications of Career Forms”, in M.B. Arthur, D.T. Hall e B.S. Lawrence (eds.), Handbook of Career Theory, pp. 506-522, Cambridge University Press, New York. Koike, K. (1994), “Learning and Incentive Systems in Japanese Industry”, in M. Aoki e R. Dore (eds.), The Japanese Firm: The Sources of Competitive Strength, Oxford University Press, Oxford. Lambert, R., D. Larker e K. Weigelt (1993), “The Structure of Organizational Incentives”, Administrative Science Quarterly, 38: 438-461. 68 Lanfranchi, J. (1996), «Les contracts incitatifs: les modèles des tournois», in G. Ballot (a cura di), Les marchès internes du travail : de la microéconomie à la macroéconomie, 51-120, PUF, Paris. Lawler, E. III (1990), Strategic Pay, Jossey-Bass, San Francisco. Lazear, E. (1992), “The Job as a Concept”, in W. Burns Jr. (a cura di), Performance, Measurement, Evaluation and Incentives, pp. 183-215, Harvard Business School Press, Boston Lazear E. P. (1995), “A Jobs-Based Analysis of Labor Markets”, American Economic Review, 85, 2: 260-265 Lawler E. E. III (1990), Strategic Pay, San Francisco, Jossey-Bass. Le Grand, C. e M. Tåhlin (2002), “Job Mobility and Earning Growth”, European Sociological Review, 18, 4: 381-400. Levine D., D. Belman, G. Charness, E. Groshen e K. O’Shaughnessy (2002), How New is the “New Employment Contract”?, New York, Upjohn Institute. Loewenstein, G. e N. Sicherman (1991), “Do Workers Prefer Increasing Wage Profiles?”, Journal of Labor Economics, 9, 1: 67-84. McCue, K. (1996), “Promotions and Wage Growth”, Journal of Labor Economics, 14, 2: 175-209. Medoff, J. e K. Abraham (1980), “Experience, Performance and Earnings”, Quarterly Journal of Economics, 95: 703-736. Meitzen, M. (1986), “Differences in Male and Female Job-Quitting Behavior”, Journal of Labor Economics, 4, 2: 151-167. Miyamoto, M. (1999), “Challenges facing the Japanese Employment System: An Examination from the Structure-Function Theory Perspective”, paper presentato alla XI Conferenza SASE, Madison. Milgrom, P. e J. Roberts (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall, Hampstead (trad. it. Economia, organizzazione e management, Prentice Hall Int.-Il Mulino, Bologna, 1994). Mori, P. (1991), “Addestramento sul lavoro, incentivi e dinamiche salariali: Problemi e modelli economici”, Politiche del lavoro, 15-16: 69-90. Murphy, K. (1985), “Corporate Performance and Managerial Remuneration: An Empirical Analysis, Journal of Accounting and Economics, 7: 11-42 Murphy, K. (1998), “Pay, Performance and Executive Compensation”, in O. Ashenfelter e D. Card (eds.), Handbook of Labor Economics, vol. IV, North Holland, New York. 69 Nonaka I. e H. Takeuchi (1995), The Knowledge-Creating Company, New York, Oxford University Press. Nordhaug O. (1993), Human Capital in Organizations: Competence, Training, and Learning, Oslo, Scandinavia University Press. OECD (1999), Employment Outlook, Paris. Olson M. (1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge (Mass.), Harvard University Press. Osterman, P. (1987), “Choice of Employment Systems in Internal Labor Markets”, Industrial Relations, 26, 1: 46-67. Parnes, H. (1954), Research on Labor Mobility: An Appraisal of Research Findings in the United States, Social Science Research Council, Washington. Peiperl, M., M. Arthur, R. Goffee e T. Morris (a cura di) (2000), Career Frontiers: New Conceptions of Working Lives, Oxford University Press, New York. Pergamit, M. e J. Veum (1999), “What is a promotion?”, Industrial and Labor Relations Review, 52, 4: 581-601. Petersen, T., S. Spilerman e S. Dahl (1990), “The Structure of Employment Terminations Among Clerical Employees in a Large Bureaucracy”, Acta Sociologica, 32: 319-338. Pfeffer, J. (1994), Competitive Advantage Through People: Unleashing the Power of Work Force, Harvard Business School Press, Boston. Pfeffer, J. e Y. Cohen (1984), “Determinants of Internal Labor Market in Organizations”, Administrative Science Quarterly, 29: 550-572. Piore M (1975), “Notes for a Theory of Labor Market Stratification”, in M. Reich, D.M. Gordon, R. Edwards (a cura di), Labor Market Segmentation, pp. 125-150, Lexington (Mass.), Heath. Preisendörfer, P e Y. Burgess (1988), “Organizational Dynamics and Career Patterns: Effects of Organizational Expansion and Contraction on Promotion Chances in a Large Western Germany Company”, European Sociological Review, 4, 1: 32-45. Prendergast C. (1993), “The Role of Promotion in Inducing Specif Human Capital Acquisition”, Quarterly Journal of Economics, 108: 523534. Prendergast, C. (1996), “What Happens Within Firms?”, NBER Working Paper N° 5802, National Bureau of Economic Research, Cambridge. 70 Prendergast, C. (1999), “The Provision of Incentives in Firms”, Journal of Economic Literature, 37: 7-63. Reyneri E. (2002), Sociologia del mercato del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2° ed. Robinson S. L., Rousseau D. (1994), “Violating the Psychological Contract: Not the Exception but the Norm”, Journal of Organizational Behavour, 15: 245-259. Rosenbaum, J. (1984), Career Mobility in a Corporate Hierarchy, Academic Press, New York. Rosenfeld, R. (1992), “Job Mobility and Career Processes”, Annual Review of Sociology, 18: 39-61. Sørensen, A. (1983), “Process of Allocation to Open and Closed Positions in Social Structure”, Zeitschrift für Soziologie, 12, 3: 303-324. Sørensen, A (1994), “Firms, Wages and Incentives”, in N. Smelser e R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology, pp. 504-528, Princeton University Press, Princeton. Spilerman, S. (1986), “Organizational Rules and Features of Work Careers”, Research in Social Stratification and Mobility, 8: 41-102. Spilerman, S. e T. Petersen (1999), “Organizational Structure, Determinants of Promotion, and gender Differences in Attainment”, Social Science Research, 28: 203-227. Stankiewcz F. (a cura di) (1998), Travail, compétences et adaptabilité, Paris, L’Harmattan. Stevens M. (1996), « Transferable Training and Poaching Externalities », in A.L. Booth e D.J. Snower (a cura di), Acquiring Skills:Market Failures, Their Symptoms, and Policy Responses, pp. 19-40, Cambridge, Cambridge University Press. Stewman, S. (1986), “Demografic Models of Internal Labor Markets”, Administrative Science Quarterly, 31, 2: 121-147. Stewman, S., e S. Konda (1983), “Careers and Organizational Labor Markets: Demographic Models of Organizational Behavior”, American Journal of Sociology, 88, 4: 637-685. Stewman, S. e K. Yeh (1991), “Structural Pathways and Switching Mechanisms for Individual Careers”, Research in Social Stratification and Mobility, 10: 133-168. 71 Stinchcombe, A. (1974), Creating Efficient Industrial Administrations, Academic Press, New York. Thevenot, L. (1984), “Rules and Implements: Investments in Form”, Social Science Information, 23, 1: 1-45. Thurow L. C. (1974), Generating Inequality: Mechanism of Distribution in the U.S. Economy, New York, Basic Books (trad. it. All’origine dell’ineguaglianza. I meccanismi della distribuzione del reddito nell’economia statunitense, Milano, Vita e Pensiero, 1982). Topel, R. e M. Ward (1992), “Job Mobility and the Careers of Young Men”, Quarterly Journal of Economics, 107, 2: 439-479. Treble, J., E. van Gameren, S, Bridges, e T. Barnaby (2001), “The Internal Economics of the Firm: Further Evidence from Personnel Data”, Labour Economics, 8: 531-552. Valsecchi, I. (2000), “Job Assignment and Promotion”, Journal of Economic Surveys, 14, 1: 31-51. Villemez, W. e W. Bridges (1988), “When Bigger is Better: Differences in the Individual-Level Effect of Firm and Establishment Size”, American Sociological Review, 53: 237-255. Watcher, M. e R. Wright (1990), “The Economics of Internal Labor Markets”, in J. Mitchell e M. Zaidi (a cura di), The Economics of Human Resources Management, pp. 86-108, Blackwell, Oxford. 72 Finito di stampare nel maggio 2004 dalla Viva s.r.l - via Forlì, 56 - Torino
Scarica