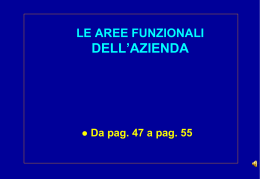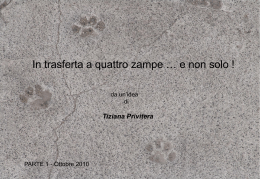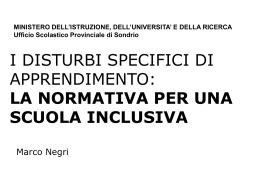RASSEGNA STAMPA giovedì 9 luglio 2015 L’ARCI SUI MEDIA ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA WELFARE E SOCIETA’ INFORMAZIONE SCUOLA, INFANZIA E GIOVANI CULTURA E SPETTACOLO ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO AVVENIRE IL FATTO PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA del 09/07/15, pag. 6 La provocazione del Coisp: «Via la targa che lo ricorda» Carlo Giuliani. Il sindacato vuole manifestare a piazza Alimonda in occasione del 14esimo anniversario del G8 Nonostante lo neghi, quella che il Coisp si prepara a fare il prossimo 20 luglio, 14esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, è l’ennesima provocazione di un sindacato di polizia capace solo di accendere polemiche. Tra una settimana sarà l’anniversario del G8 2001 e il Coisp vuole manifestare in pazza Alimonda, dove Carlo Giuliani morì colpito dal proiettile sparato da un carabiniere al quale si stava avvicinando con un estintore in mano. Obiettivo del sindacato è quello di promuovere una raccolta di firme per rimuovere la targa che ricorda il giovane ucciso. «Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa diventare un’arma da usare contro le forze dell’ordine» ha affermato in una nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. «Vogliamo un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per l’ennesima volta solo un pretesto per attaccare le forze di polizia». Il Coisp non è nuove a iniziative di questo genere. Si tratta dello stesso sindacato che in passato ha promosso a Ferrara un sit in sotto le finestre dell’ufficio in cui lavora Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, per difendere i quattro agenti condannati per la morte del giovane. Adesso quest’ennesima iniziativa che il Coisp nega si tratti di una provocazione della quale fa parte anche un dibattito: «Questo sarà il nostro 20 luglio dal titolo ‘L’estintore quale strumento di pace: un’evoluzione lunga 14 anni! Dalla devastazione ed il saccheggio al reato di tortura, dal divieto di manifestare con il volto travisato al numero identificativo per le Forze dell’Ordine’», ha proseguito il Coisp. Solo due giorni fa, in una conferenza stampa al Senato, proprio Patrizia Moretti ha annunciato l’intenzione di ritirare la querela al segretario del Coisp Franco Maccari, l’organizzatore del sit in sotto il suo ufficio che accusò la famiglia Aldrovandi di usare il dolore per spargere veleno contro la polizia. Saputo della manifestazione, Giuliano Giuliani ha preferito evitare ogni polemica: «Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo», ha detto i padre di Carlo. «Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo — ha concluso -. C’è la nostra manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia». Altri, invece, hanno condannato senza mezzi termini l’iniziativa. Per il deputato di Sel Nicola Fratoianni si tratta di una «provocazione inaccettabile», mentre l’Arci chiede «che chi ne ha l’autorità impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città e del paese si compia. Come ogni anno – prosegue l’associazione — quelle drammatiche giornate vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001». 2 Del 9/07/2015, pag. 23 Piazza vietata ai poliziotti anti Giuliani Il sindacato Coisp nell’anniversario del G8:faremo rimuovere la targa in memoria del ragazzo ucciso A Genova scoppia la polemica.Il padre:cercano solo pubblicità.La questura dice no alla manifestazione ALBERTO PUPPO GENOVA. Da alcuni anni il copione si ripete, identico: il sindacato di polizia Coisp (lo stesso che organizzò il sit in a Ferrara, sotto le finestre della madre di Federico Aldrovandi) annuncia, pochi giorni prima della ricorrenza, una manifestazione in piazza Alimonda. Un luogo simbolo di Genova. Qui, il 20 luglio di 14 anni fa, un colpo di pistola al volto uccise Carlo Giuliani. E qui, ogni anno, il comitato che porta il nome del giovane colpito durante gli scontri del G8, ne organizza il ricordo. L’ipotesi, dal sapore della provocazione, non si è mai concretizzata. Ma, questa volta, il segretario del Coisp ligure, Matteo Bianchi, sembrava avere nuove carte da giocare. E così ha tempestivamente annunciato che, dopo anni di dinieghi, il presidio, con tanto di raccolta di firme per rimuovere il cippo che ricorda il ragazzo, era stato finalmente autorizzato da non meglio precisate “autorità preposte”. Giusto il tempo di scatenare polemiche ed incassare reazioni. Ma non oltre, perché nel pomeriggio la questura genovese ha notificato il decreto con cui la manifestazione viene formalmente vietata per ragioni di ordine pubblico. La richiesta, peraltro, era stata presentata nel giugno 2013 e poi reiterata. Il faccia a faccia, così, non ci sarà. Rimane quello virtuale, negli stessi giorni in cui la madre di Aldrovandi ha scelto di ritirare la querela contro il segretario Coisp, Franco Maccari. Il sindacato, nel motivare l’idea della contromanifestazione, aveva spiegato che la manifestazione non avrebbe voluto essere «assolutamente etichettata come una boutade o peggio ancora una provocazione, ma essere un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà evitando che diventi per l’ennesima volta solamente un pretesto per attaccare nuovamente l’operato delle forze dell’ordine». I toni non sembravano particolarmente concilianti: «Fin dalle prime luci dell’alba raccoglieremo firme per togliere la targa posta ufficialmente nel 2013 per ricordare il ragazzo». Una lapide che per il Coisp è una forma di cattiva educazione per le giovani generazioni: «Per chi non lo ricordasse, Carlo Giuliani cercò di uccidere un carabiniere servendosi di un estintore». Era bastato l’annuncio perché si scatenassero reazioni a catena. Con il segretario di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero a definire l’idea come «indecente provocazione», l’Arci a chiamare all’appello tutte «le forze democratiche contro un’offesa alla memoria della città e del Paese». E ancora Sel, con i suoi referenti nazionali e locali impegnati a chiedere al prefetto di Genova di bloccare la manifestazione. In campo, inevitabilmente Giuliano Giuliani, padre di Carlo, tra i promotori dell’ormai tradizionale happening, con reading e musica in piazza Alimonda. Con pacatezza e la convinzione che, il Coisp, il 20 luglio, sarebbe rimasto a casa. «È sempre la stessa storia. Quel sindacato cerca solo pubblicità. Ma ancora una volta, in strada, ci saremo soltanto noi». Poco dopo la conferma che la speranza fosse ben riposta. 3 Da Repubblica.it del 08/07/15 (Genova) G8, bufera sul Coisp: "Vuole rimuovere la targa di Carlo Giuliani" L'Arci: "Provocazione inaccettabile" Una raccolta di firme per far rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo delle giornate di Genova per "per ricordare tutta la verità sul G8": sono le iniziative messe in campo per il prossimo 20 luglio, quattordicesimo anniversario della morte di Carlo, dal sindacato di polizia Coisp, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre dell'ufficio della madre di Federico Aldrovandi. "Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di Piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa diventare un'arma da usare contro le forze dell'ordine" afferma in una nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. Immediate e sdegnate le reazioni da più parti del monbdo politico e sociale La manifestazione del Coisp in piazza Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono una "pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare". Lo sottolinea l'Arci chiedendo che "chi ha l'autorità impedisca per tempo che questa offesa alla memoria della città e del paese si compia". "Sembra una notizia incredibile ma purtroppo è vera - continua l'Arci - Come ogni anno, quelle drammatiche giornate, vanno invece ricordate non nel nome dell'odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001". A 14 anni di fatti di Genova, conclude l'Arci, "in piazza Alimonda si ritroveranno come ogni anno da allora le forze democratiche". "Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo". Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di Carlo. "Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C'è la 'nostra' manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia". http://genova.repubblica.it/cronaca/2015/07/08/news/g8_bufera_sul_coisp_vuole_rimuover e_la_targa_di_carlo_giuliani_-118660578/ Da il SecoloXIX del 08/07/15 Il Coisp: «Raccolta firme per rimuovere la targa in ricordo di Carlo Giuliani» Genova - Una raccolta di firme per far rimuovere da piazza Alimonda la targa che ricorda Carlo Giuliani e una manifestazione in quel luogo simbolo delle giornate di Genova per «per ricordare tutta la verità sul G8»: sono le iniziative messe in campo per il prossimo 20 luglio, quattordicesimo anniversario della morte di Carlo, dal sindacato di polizia Coisp, lo stesso che organizzò un sit in sotto le finestre dell’ufficio della madre di Federico Aldrovandi. «Finalmente dopo 14 anni saremo in piazza Alimonda per ricordare gli scontri di Piazza, le scene di devastazione e saccheggio con il pensiero che un estintore possa 4 diventare un’arma da usare contro le forze dell’ordine» afferma in una nota il segretario del Coisp Liguria Matteo Bianchi. L’iniziativa solleverà nuove polemiche ma, secondo il sindacato, non si tratta di una «provocazione: vogliamo un momento costruttivo dal quale però far emergere il G8 genovese in tutta la sua cruda e difficile realtà, evitando che diventi per l’ennesima volta solo un pretesto per accattare le forze di polizia». Il Coisp sostiene di esser riuscito ad ottenere il via libera a svolgere la manifestazione in piazza Alimonda, dopo diversi tentativi falliti, grazie ad una richiesta formale inviata 2 anni fa, «dopo l’ennesimo divieto». La giornata del Coisp prevede anche una raccolta firme «per far rimuovere dalla piazza il monumento posato per ricordare la memoria di Carlo Giuliani che, per chi non lo ricordasse, cercò di uccidere, servendosi di un estintore, un carabiniere». Il sindacato sostiene che la raccolta firme «non vuole essere affatto un attacco alla famiglia Giuliani ma una vera e propria azione per il senso civico della città di Genova che a tutt’oggi, per bocca dei propri rappresentanti politici locali e di chi ha autorizzato materialmente la posa in opera di detto monumento, non ha ancora ricevuto una spiegazione su quale esempio possa essere per le generazioni future la memoria di Carlo Giuliani». L’intervento di Giuliano Giuliani: «Una cosa che non esiste» «Non commento una cosa come questa, una cosa che non esiste. Non voglio fare ulteriore pubblicità a questa gente, vogliono solo questo». Lo ha detto Giuliano Giuliani, padre di Carlo. «Il 20 luglio saremo in piazza Alimonda per ricordare Carlo - ha concluso -. C’è la `nostra´ manifestazione nel ricordo di una cosa ingiusta nei confronti della quale non è mai stata fatta giustizia». L’Arci: «Provocazione inaccettabile» La manifestazione del Coisp in piazza Alimonda e la raccolta firme per far rimuovere la targa dedicata a Carlo Giuliani sono una «pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare». Lo sottolinea l’Arci chiedendo che «chi ha l’autorità impedisca per tempo che questa offesa alla memoria della città e del paese si compia». «Sembra una notizia incredibile ma purtroppo è vera - continua l’Arci - Come ogni anno, quelle drammatiche giornate, vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001». A 14 anni di fatti di Genova, conclude l’Arci, «in piazza Alimonda si ritroveranno come ogni anno da allora le forze democratiche». Ferrero (Rc): «Provocazione indecente, intervenga il Viminale» «La manifestazione che il Coisp vorrebbe fare a Piazza Alimonda il 20 luglio, ovvero nello stesso luogo e nello stesso giorno in cui fu ammazzato Carlo Giuliani 14 anni fa, è una indecente provocazione. Il Ministero dell’Interno intervenga». È quanto dice Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. «Servono dei corsi di formazione - aggiunge - basati sulla Costituzione per questi rappresentanti delle forze dell’ordine che evidentemente non conoscono la Carta. Alla famiglia di Carlo Giuliani la nostra solidarietà, ancora una volta, davanti a queste ennesime, vergognose ingiurie. Noi saremo in piazza Alimonda il 20 luglio, come ogni anno - conclude Ferrero - per ricordare Carlo e continuare a chiedere verità e giustizia per la sua uccisione e per la mattanza dei giorni del G8 di Genova». 5 Da Redattore Sociale del 08/07/15 Via la lapide in memoria di Carlo Giuliani? Arci: "Respingiamo la provocazione" L’associazione nettamente contraria alla raccolta firme del sindacato di polizia Coisp. “Chi ne ha l’autorità impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città e del paese si compia” ROMA – “Sembra incredibile, ma purtroppo è vera, la notizia secondo cui il sindacato di polizia Coisp intende manifestare il 20 luglio in piazza Alimonda a Genova, a 14 anni dall’uccisione di Carlo Giuliani, e raccogliere le firme per rimuoverne la lapide in sua memoria. Si tratta di una pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare”. Ad affermarlo è l’Arci, che in una nota chiede che “chi ne ha l’autorità impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città e del paese si compia”. “Come ogni anno quelle drammatiche giornate vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto – conclude l’Arci -, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001”. Da Genova24 del 08/07/15 G8 di Genova, Arci: “Iniziativa Coisp incredibile, pura provocazione” Genova. “Sembra incredibile, ma purtroppo è vera, la notizia secondo cui il sindacato di polizia Coisp intende manifestare il 20 luglio in piazza Alimonda a Genova, a 14 anni dall’uccisione di Carlo Giuliani, e raccogliere le firme per rimuoverne la lapide in sua memoria”. Così l’Arci commenta l’iniziativa annunciata dal sindacato di polizia. “Si tratta di una pura provocazione che nessuna organizzazione democratica può accettare. Chiediamo fin d’ora che chi ne ha l’autorità impedisca per tempo che quest’offesa alla memoria della città e del paese si compia”. “Come ogni anno quelle drammatiche giornate vanno invece ricordate non nel nome dell’odio ma in quello della speranza per un mondo più giusto, non segnato da diseguaglianze e da guerre, che erano gli ideali che animavano le centinaia di migliaia di manifestanti in quel luglio del 2001″. http://www.genova24.it/2015/07/g8-di-genova-arci-iniziativa-coisp-incredibile-puraprovocazione-91443/ Da L’Espresso.it del 09/07/15 Radicali: cosa fare per includere i Rom Supere i campi e azzerare gli affari per le “mafie capitali” è possibile. Basterebbe ispirarsi al modello spagnolo. A Roma si raccolgono le firme per due delibere di iniziativa popolare di Alessandro Capriccioli* Iniziare dalle persone rom, dai singoli individui e cittadini, deponendo i provvedimenti adottati per categoria e disarticolando un'idea di rappresentanza che si è ormai dimostrata inutile; partire dalle specifiche necessità, competenze e aspirazioni per elaborare percorsi 6 di inclusione diversi da persona a persona. Questo è il cuore della proposta per il superamento dei campi rom contenuta nelle delibere di iniziativa popolare "Accogliamoci": un cambio di prospettiva radicale rispetto a decenni di politiche inefficaci perché destinate a un gruppo indistinto, come se "i rom" fossero un corpo monolitico e non un insieme di individui, ciascuno con la propria singolarità. Del resto è proprio su questa semplicistica idea di categoria, sia pure declinata in una direzione diversa, che hanno fatto leva i peggiori pregiudizi, quelli che tuttora attraversano dolorosamente il paese: i rom che rubano, che non vogliono lavorare, che non vogliono integrarsi, che sono culturalmente diversi dagli altri. È possibile rispondere a quei pregiudizi, è ragionevole pensare di affrontarli e disinnescarli utilizzando la loro stessa prospettiva? È ipotizzabile venirne a capo continuando a riferirsi genericamente ai rom, anziché spostare lo sguardo sulle singole persone? Evidentemente no. Il fallimento delle politiche degli ultimi decenni sta tutto qua: nel voler fronteggiare una questione che riguarda qualche migliaio di individui muovendosi tra le due deformazioni del pregiudizio verso un gruppo etnico e dell'illusione di poterlo rappresentare nella sua totalità, azzerando le differenze, spesso assai rilevanti, che lo attraversano. Il risultato, per ora, nella sola città di Roma, è di 25 milioni di euro l'anno di spesa, con gli effetti che tutti conosciamo. Quello che allora serve è un cambio di prospettiva difficile da accettare e forse perfino da comprendere, per chi fino ad oggi ha vissuto e ha ragionato, in un modo o nell'altro, nell'ottica del gruppo: eppure è indispensabile, se si ha davvero l'ambizione di restituire ai rom, alle singole persone rom, la qualifica di individui e cittadini che dovrebbe spettare loro come spetta a chiunque altro; se ai rom, finalmente, si vuole dare voce davvero, al di là della necessità di salvaguardare un patrimonio culturale che può restare intatto anche nella valorizzazione dell'individualità, e che anzi proprio grazie a quella valorizzazione potrebbe finalmente mettersi al riparo dal degrado e dalla marginalità, sopravvivendo invece di scomparire: inclusione senza tentativi di assimilazione. Superare i campi rom superando la segregazione, da chiunque essa venga promossa e malgrado le sue intenzioni, attraverso un'indagine conoscitiva sulla situazione di ogni singolo nucleo familiare e l'implementazione di un piano di inclusione sociale, abitativa e scolastica con tempi stabiliti e monitorati, utilizzando i finanziamenti europei per finanziare i progetti abitativi non soltanto dei rom, ma anche degli altri cittadini. Ecco come si può fare. Un cambio di prospettiva e un modello che in altri Paesi, come ad esempio la Spagna, hanno funzionato. A Madrid, nel 2007, vivevano circa 70.000 persone rom, di cui 12.000 nei campi: a partire dal 2011 il Comune ha deciso di chiudere i campi e di investire in educazione e formazione, diventando in pochi anni un modello in tutta Europa. Finora sono stati chiusi 110 insediamenti e 9.000 persone hanno avuto accesso ad alloggi e a percorsi di integrazione. L'obiettivo è chiudere definitivamente tutti i campi entro il 2017. Tutti i progetti sono stati finanziati con fondi europei destinati all’integrazione dei cittadini rom: ma il nostro paese non ha mai fatto richiesta di quei fondi, preferendo sperperare milioni di euro per la politica di segregazione nei campi. Sarebbe il caso di cambiare prospettiva, anche qua. * Alessandro Capriccioli, segretario di Radicali Roma è membro comitato promotore di Accogliamoci”, un'iniziativa promossa da Radicali Roma, Associazione 21 luglio, A buon diritto, Arci Roma, Cild, Possibile,Un ponte per, Zalab, Asgi. http://espresso.repubblica.it/palazzo/2015/07/08/news/radicali-cosa-fare-per-includere-irom-1.220518 7 ESTERI del 09/07/15, pag. 1/2 L’orgoglio di Tsipras di Dimitri Deliolanes Con applausi, abbracci e grandi sorrisi Alexis Tsipras ha fatto ieri il suo primo ingresso al Parlamento Europeo. Non era una passeggiata. Nel suo discorso introduttivo, il premier greco si è concentrato a rispondere, usando il buon senso e la ragionevolezza, a tutte le critiche, spesso del tutto infondate, che sono state mosse in tutti questi mesi contro di lui e la Grecia. Provocando spesso reazioni tempestose, attacchi, persino invettive, da parte di alcuni deputati europei. Innanzitutto Tsipras ha voluto sancire, anche in questa sede, il fallimento del programma di austerità: «I soldi che ci avete prestato non sono andati a favore del popolo greco né a favore dell’economia reale. Sono andati alle banche, greche e straniere. La mia patria è stata trasformata in un laboratorio sperimentale che ha portato il popolo greco a esaurire la sua capacità di resistenza facendo fallire l’esperimento. Oggi, qualsiasi sia l’ orientamento di ognuno, tutto il popolo greco sente che non ha altra scelta che lottare per la sua liberazione». La Grecia, ha continuato, ha fatto uno «sforzo senza precedenti di adeguamento» alle richieste dell’eurozona. «Nessun altro paese sotto programma di salvataggio e con riforme in corso ha fatto uno sforzo simile alla Grecia», ha detto il premier greco. Ma tutto invano. Poi Tsipras ha risposto a chi lo ha accusato di non aver portato proposte martedì alla riunione dell’eurogruppo: «Abbiamo inviato un testo di 47 pagine che non comprende le nostre posizioni ma il risultato del difficile negoziato. In queste proposte è compreso il nostro forte impegno a raggiungere gli obiettivi di bilancio che abbiamo fissato. Manteniamo però il nostro diritto, come governo sovrano, di aggiungere o togliere imposte. È un nostro diritto tassare le imprese in utile e non tagliare le pensioni. Se non abbiamo il diritto a trovare da soli i settori in cui risparmiare, allora saremmo condotti in una logica estrema e antipopolare. Si direbbe allora che nei paesi sotto programma di salvataggio non si debbano tenere elezioni, solo nominare dei tecnocrati e che solo loro possano decidere». Il riferimento è alle ripetute interferenze dello stesso presidente del Parlamento europeo Martin Schulz sulla composizione del governo greco. Ma anche un colpo preventivo verso i piani, accarezzati da una parte della destra tedesca, di puntare a risolvere il caso Atene attraverso il rovesciamento del governo. Tsipras ha negato decisamente ogni progetto, segreto o palese, di ritorno alla dracma: «La settimana scorsa la maggior parte delle dichiarazioni consistevano nel dire che il vero quesito del referendum era la scelta tra euro e dracma e che la vittoria del no significava l’uscita del paese dall’eurozona. I greci hanno votato No. Se avessi voluto far uscire il mio paese dall’euro non avrei fatto le dichiarazioni che ho fatto domenica sera». Il referendum rappresenta un «forte messaggio» del popolo greco: «Il forte no di domenica ci ha dato l’incarico di rafforzare i nostri sforzi verso una soluzione sostenibile al problema greco, senza ripetere gli errori del passato e senza l’eterna e inutile austerità». Rispondendo all’attacco di un deputato conservatore tedesco, il premier greco ha sollevato il problema del debito: «Voglio ricordarle che il momento più intenso di solidarietà europea c’è stato nel 1953, quando il suo paese usciva pieno di debiti da due guerre mondiali. L’Europa e i popoli europei hanno mostrato la massima solidarietà nel momento in cui 8 hanno deciso di tagliare il 60% del debito della Germania e hanno posto, per la restituzione di quello che rimaneva, la condizione che la stessa Germania fosse in fase di sviluppo. Per questo anche noi oggi chiediamo un programma sostenibile che ci porti a essere in grado di restituire i nostri debiti. Quando chiediamo il taglio del debito, lo chiediamo proprio per poterlo restituire». Alle accuse verso il governo di aver mostrato scarso dinamismo riformatore, Tsipras ha risposto elencando orgogliosamente quello che è riuscito a fare nei cinque mesi di governo: «Abbiamo finalmente cominciato a indagare sulla famosa lista Lagarde, che il governo precedente aveva nascosto nel cassetto. Abbiamo cercato e in parte riuscito a portare davanti alla giustizia molti grandi evasori fiscali. Abbiamo firmato un accordo con la Svizzera per poter tassare i greci che hanno conti in quel paese. Abbiamo tassato le transazioni triangolari. Abbiamo chiesto agli editori televisivi di pagare finalmente le tasse arretrate». Un’azione riformatrice fortemente in contrasto con le azioni dei governi precedenti di Atene: «Mi assumo la piena responsabilità per tutto quanto è successo in questi ultimi cinque mesi. Dobbiamo però con sincerità tutti riconoscere che la grande responsabilità per lo stallo sul negoziato non pesa tanto sugli ultimi cinque mesi ma sugli ultimi cinque anni». Tsipras ha voluto chiudere il suo discorso con una citazione dall’Antigone di Sofocle: «Sofocle ci ha insegnato che la legge superiore a quella degli uomini è la giustizia. Credo che siamo in un momento in cui vige questo principio». Del 9/07/2015, pag. 1-4 L’ultima sfida di Alexis “Noi cavie dell’austerità soldi finiti alle banche” e alla fine cita Sofocle IL PERSONAGGIO ANDREA BONANNI STRASBURGO. Per conquistare il Parlamento europeo Alexis Tsipras ha scelto di indossare i nobili panni di Antigone. «Io rispetto le leggi europee. Ma ci sono momenti in cui il diritto degli uomini prevale sulla legge. Questo è uno di quei momenti», ha detto citando l’eroina di Sofocle. Una metafora per spiegare come le sofferenze del popolo greco valgano più dei parametri di Bruxelles. Ma, poiché l’indole delle persone può essere nobilitata solo fino ad un certo punto prima di tradirsi, il premier greco ha cominciato la sua giornata a Strasburgo con un passo falso: arrivando in ritardo nell’emiciclo gremito dove compagni dell’estrema sinistra e camerati dell’estrema destra lo aspettavano come fosse una superstar. Il film di questa seduta di autocoscienza europea sulla crisi greca comincia subito dopo le 8,30 di mattina. Nell’aula affollata gli eurodeputati sentono il brivido delle grandi occasioni. Sull’estrema destra e sull’estrema sinistra dell’emiciclo, i banchi sono fioriti di cartelli bianchi con le scritte rosse: “NO” e “OXI”. Sotto uno di questi, il leader dell’estrema destra britannica Nigel Farage ride, forse divertito di trovarsi per una volta in sintonia con i dirimpettai del Gue, la “sinistra unitaria”, che di solito gli riservano solo pernacchie. Si aspetta Tsipras, che non arriva. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e il suo vice Frans Timmermans sono già seduti ai loro banchi e fumano di rabbia. Arrivano il 9 presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, accompagnato dal premier del Lussemburgo, che ha la presidenza di turno dell’Ue. Non se li fila nessuno. Un capannello di tifosi del leader greco, tra cui spiccano alcune “groupies” per la verità un po’ attempate, rompe il protocollo restando ad attendere il beniamino all’ingresso dell’aula. Quando finalmente Tsipras arriva, accompagnato come vuole il protocollo dal presidente del Parlamento Martin Schulz tutto rosso per l’imbarazzo del ritardo, i fan esplodono in un applauso liberatorio. Baci (dalle signore), abbracci, pacche sulle spalle. Un po’ di «buuu» che risuonano dai banchi dei popolari tedeschi, per i quali il ritardo è una colpa poco inferiore al debito. Ma l’entusiamo dei supporter è travolgente. La festa continua anche dopo che il premier, abito blu, camicia bianca senza cravatta, cronometro svizzero al polso, è andato a sedersi subito dietro Tusk, al banco numero 23. Il ritardo si accumula. Se gli sguardi potessero uccidere, quelli che Schulz, Juncker, Timmermans e Tusk dirigono verso il banco 23 avrebbero già risolto la crisi greca alla radice. Schulz rompe gli indugi e comincia a parlare mentre ancora c’è gente che sta baciando il premier greco. Il discorso di Tsipras è insieme appassionato ed equilibrato. Evoca i disastri provocati dall’austerità: «Siamo stati la cavia di un esperimento che non ha funzionato». Riconosce che i mali del suo Paese non sono colpa degli europei ma dei precedenti governi greci». Spiega che i soldi del prestito hanno beneficiato le banche e non la gente. Denuncia i negoziati «a porte chiuse». Chiede comprensione. Chiede aiuto. Promette sia un presagio. il tedesco Weber: «Lei ha distrutto la fiducia dell’Europa e ora i debiti che non vuol rimborsare saranno pagati dalle infermiere slovacche e dagli impiegati finlandesi ». Solidale il capo dei socialisti europei Gianni Pittella: «Per noi un’Europa senza la Grecia non esiste. I socialisti non accetteranno mai un’uscita della Grecia dalla moneta unica». Sferzante il rappresentante dei liberali, Verhofstadt: «Promettete riforme ma ancora non abbiamo visto nulla: dovete tagliare i privilegi agli armatori, ai generali, alla Chiesa e ai partiti». L’estrema destra, da Le Pen, a Farage a Salvini lo elogia ma lo invita ad andare fino in fondo e a lasciare l’euro. Anche Juncker è duro nella sua risposta: «Un accordo era a portata di mano e avete rotto le trattative». E accusa Tsipras di approfittare proprio dei negoziati a porte chiuse per mentire sulle vere proposte della Commissione. L’operazione di seduzione del premier greco è riuscita, ma solo fino ad un certo punto. Nella replica, forse anche per difendersi dalle molte accuse, Tsipras cita l’Antigone e la prevalenza dei diritti naturali sulle leggi degli uomini. Poi lascia l’aula. Forse dimentico che, nella tragedia di Sofocle, l’eroina muore suicida poco prima che il tiranno si decida a liberarla. Speriamo che non un programma dettagliato di riforme. Ma rivendica il diritto sovrano di decidere come raggiungere gli obiettivi di bilancio. Esclude di avere un piano per uscire dall’euro. Però insiste sulla necessità di discutere una ristrutturazione del debito greco, «proprio perché vogliamo essere in grado di pagarlo ». Molti applausi, dalle estreme dell’emiciclo, interrompono la sua arringa, che si chiude su un’ovazione finale. Le repliche dei gruppi politici sono altrettanto accalorate. Durissimo il leader dei popolari, il tedesco Weber: «Lei ha distrutto la fiducia dell’Europa e ora i debiti che non vuol rimborsare saranno pagati dalle infermiere slovacche e dagli impiegati finlandesi ». Solidale il capo dei socialisti europei Gianni Pittella: «Per noi un’Europa senza la Grecia non esiste. I socialisti non accetteranno mai un’uscita della Grecia dalla moneta unica». Sferzante il rappresentante dei liberali, Verhofstadt: «Promettete riforme ma ancora non abbiamo visto nulla: dovete tagliare i privilegi agli armatori, ai generali, alla Chiesa e ai partiti». L’estrema destra, da Le Pen, a Farage a Salvini lo elogia ma lo invita ad andare fino in fondo e a lasciare l’euro. Anche Juncker è duro nella sua risposta: «Un accordo era a portata di mano e avete rotto le trattative». E accusa Tsipras di approfittare proprio dei negoziati a porte chiuse per mentire sulle vere proposte della Commissione. 10 L’operazione di seduzione del premier greco è riuscita, ma solo fino ad un certo punto. Nella replica, forse anche per difendersi dalle molte accuse, Tsipras cita l’Antigone e la prevalenza dei diritti naturali sulle leggi degli uomini. Poi lascia l’aula. Forse dimentico che, nella tragedia di Sofocle, l’eroina muore suicida poco prima che il tiranno si decida a liberarla. Speriamo che non un programma dettagliato di riforme. Del 9/07/2015, pag. 10 “Volevano umiliarci” ecco la crisi vista dal governo di Atene Un alto funzionario racconta il dietro le quinte della lunga trattativa fra la Grecia e Bruxelles CHRISTIAN SALMON Qualche giorno prima del referendum, un importante funzionario del governo greco ha ricevuto alcuni giornalisti francesi, tra i quali Christian Salmon di Mediapart, per raccontare loro quello che era successo negli ultimi mesi di trattative fra il governo di Syriza e Bruxelles: le discussioni con le istituzioni europee, la situazione catastrofica della Grecia, le strategie di soffocamento messe in atto dall’Eurogruppo e l’asfissia finanziaria che ha distrutto l’economia greca. Quello che segue è un estratto del racconto che il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha fatto ai giornalisti. “FIN dall’inizio non ero d’accordo sul modo in cui abbiamo negoziato con gli europei. Il governo greco ha avuto delle discussioni, degli accomodamenti sulla politica di bilancio, sulle condizioni, ma siamo sempre stati noi a fare concessioni, ad avvicinarci alla Troika, senza che loro facessero il minimo movimento nella nostra direzione. Non hanno mai discusso del debito: la ristrutturazione del debito, la sua sostenibilità. Non hanno mai discusso dei finanziamenti: la Bce avrebbe tolto o no le restrizioni? Con quali limiti le banche avrebbero potuto prendere in prestito, e lo Stato prendere in prestito dalle banche? Perché noi non possiamo prendere in prestito niente. Potevamo farlo fino a febbraio. Potevamo ancora emettere commercial paper : si tratta di titoli a breve scadenza, obbligazioni a tasso fisso a tre mesi, nella maggior parte dei casi a un anno. Ma questo governo non è mai stato autorizzato a usare questi strumenti. Appena arrivato, la Bce ha detto: «Niente più commercial paper ». IL REBUS DELLE BANCHE Così, da marzo in poi, abbiamo cominciato a economizzare tutto quello che potevamo nelle spese dello Stato. Abbiamo accorpato tutte le riserve di denaro delle varie ramificazioni dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali, per pagare il Fmi. Questo ha portato a una riduzione interna della liquidità in contanti. Le banche, le imprese esportatrici, le imprese manifatturiere non potevano più prendere soldi in prestito. Le persone non potevano più pagare i loro debiti. Il sistema del credito ha cominciato a disintegrarsi. Normalmente la liquidità sul mercato, (il denaro in circolazione), si colloca intorno ai 10 miliardi di euro. Ora, con quello che è successo, la gente tiene i soldi sotto il materasso e la liquidità si aggira intorno ai 50 miliardi di euro. Le persone che hanno sul loro conto venti, trenta o quarantamila euro possono ritirare appena 60 euro al giorno. Chi ha più conti, può ritirarne di più. Ma che succede per le persone che non hanno risparmi, che vivono del loro stipendio? Alla fine di ogni mese sono al verde finché non arriva l’assegno. E improvvisamente si ritrovano a poter ritirare solo 60 euro. Le riserve che avevano stanno per esaurirsi. Se tutti ritirano 60 euro, arriverà 11 il momento in cui le banche non avranno più soldi del tutto. Ed è qui che comincia il problema. In questo caso, se non avremo accesso ai fondi di emergenza della Bce, non avremo altra scelta che emettere una sorta di moneta parallela. Sarebbe la fine dell’economia. C’è già la paura. C’è il panico all’idea che anche se le banche riapriranno dovranno essere ricapitalizzate. Finora erano solventi. UN WATERBOARDING FINANZIARIO Tutti i prestiti che abbiamo ricevuto — 240-250 miliardi — sono andati a pagare gli interessi sul debito, e dunque sono tornati ai creditori. Il primo piano di salvataggio è stato un salvataggio delle banche e un trasferimento in favore dello Stato. Non potevamo prendere nessuna misura per migliorare la liquidità dell’economia: la Bce ha imposto restrizioni, una dopo l’altra. Fin dall’inizio questo l’ho chiamato strangolamento attraverso il credito. A metà marzo qualcuno a Bruxelles ha detto: «Sì, le istituzioni (Bce, Fmi, Commissione europea) usano il creditoper costringere il Governo a sottomettersi e accettare le riforme. Fatele in fretta». Per quanto mi riguarda, equivaleva ad ammettere che usavano il peggiore degli strumenti di ricatto economico contro il Paese. La peggiore delle sanzioni economiche. Non si può sopravvivere troppo a lungo a un trattamento del genere. Il ministro dell’Economia Yanis Varoufakis ha parlato di waterboarding finanziario, io gli ho detto: «Dobbiamo far sapere che stanno commettendo un reato equivalente a un crimine contro l’umanità. Tutta l’economia del Paese è distrutta. Ci sono poveri e senzatetto, bambini compresi. Questi fatti sono stati portati avanti in modo intensivo per arrivare a una forma di ricatto che è un crimine rispetto alle leggi internazionali, ai trattati europei. Non possiamo continuare così, perché equivarrebbe a legittimare questo crimine». IL RUOLO DELLA GERMANIA Schäuble e Berlino sono intelligenti. Hanno alimentato artificialmente la crisi: «I greci non collaborano. Non hanno capito che cosa bisogna fare. Non forniscono nessuna cifra». Avevo detto che Tsipras doveva andare di fronte al Parlamento europeo e rivelare pubblicamente il modo in cui siamo stati trattati e perché rifiutava di mettere in atto le misure di austerità che ci venivano chieste, perché preferiva perdere le elezioni che applicare quelle misure. Ogni volta che abbiamo provato a portare avanti delle trattative politiche, ci hanno mandati a quel Paese. Quante riunioni dell’Eurogruppo si sono concluse con «Tornate dai gruppi di lavoro tecnici, tornate dalla Trojka »? C’è stato un Eurogruppo, un altro Eurogruppo, delle riunioni di lavoro e ancora e sempre altri Eurogruppi… Gli europei hanno creato una ridda di pseudotrattative: tempo perso, che dal loro punto di vista è stato tempo guadagnato. E intanto hanno condotto una campagna incessante contro Varoufakis, l’hanno assassinato mediaticamente. E lui continuava a negoziare. Che cosa sperava? Abbiamo perso ogni leva economica per trovare i termini di un nuovo accordo, e perso ogni credibilità per costringerli a negoziare con noi. Il governo Tsipras dice che quando ci hanno presentato l’ultimatum c’erano delle misure peggiori di quelle che avevano preteso dal precedente governo. Un nuovo accordo è necessario. La prima cosa da fare è andare a elemosinare dei fondi di emergenza dalla Bce. Ma gli europei dicono che hanno bisogno di tornare davanti ai loro Parlamenti e così via. Eppure è indispensabile una ricapitalizzazione (delle banche) per far funzionare di nuovo l’economia. È la prima condizione per stabilire un nuovo programma. CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ L’uscita della Grecia dall’euro, come tutte le altre misure che i greci hanno subito, è illegale rispetto alla legge internazionale, alle leggi sul lavoro, ai trattati europei, alla dichiarazione europea del diritti dell’uomo, alla dichiarazione europea del lavoro. All’inizio del 2014 il Parlamento europeo aveva cominciato ad attaccare la Trojka, rimproverandole di imporre misure che facevano a pezzi i diritti umani, i diritti del lavoro. Ma noi avevamo 12 un governo che non voleva sentir parlare di questo. Preferiva attaccare l’opposizione piuttosto che i creditori. Non si è reso conto che era l’arma più potente che avevamo. Oggi è troppo tardi. È una questione di egemonia politica e ideologica. All’inizio Varoufakis da solo ha cercato di far cambiare verso all’opinione pubblica in Europa e perfino in Germania. I responsabili dell’Eurogruppo hanno risposto a modo loro. All’inizio di febbraio Dijsselbloem ha detto a Varoufakis: «O firmate il memorandum o la vostra economia colerà a picco. Come? Faremo crollare le vostre banche». C’era una volontà di umiliazione. Varoufakis ha chiesto: «Chi lo ha deciso?». Dijsselbloem gli ha risposto: «Io l’ho deciso». Non avrebbe dovuto esserci un voto? Quella decisione non avrebbe dovuto essere presa all’unanimità? In un funzionamento normale, sicuramente. Ma all’eurogruppo non è necessario, perché non c’è nessun rendiconto scritto. E dunque, non c’è niente di formale. Varoufakis ha detto di aver registrato le riunioni, perché doveva riferire al primo ministro e agli altri membri del governo quello che diceva. Gli altri hanno gridato allo scandalo. Ha descritto degli episodi che provano che l’Eurozona è totalmente antidemocratica, quasi neofascista. Solo Varoufakis ha parlato apertamente. Schaeuble ha detto: «Quanto volete per lasciare l’euro? ». Non vuole la Grecia nell’euro. È stato il primo a parlare di uscita della Grecia, nel 2011. Abbiamo sottovalutato il loro potere. È un potere che si iscrive in una vera e propria fabbrica della società, del modo di pensare delle persone. Si fonda sul controllo e il ricatto. L’edificio europeo è kafkiano”. (Traduzione di Fabio Galimberti) Del 9/07/2015, pag. 4 La liquidità. La Bce ha deciso ancora una volta di non elevare, ma neppure di diminuire, il tetto ai prestiti di emergenza per gli istituti di credito greci Banche ancora chiuse e consumi giù del 70% appello degli industriali “Subito il salvataggio” ETTORE LIVINI MATTEO PUCCIARELLI ATENE . Il soldi non ci sono. La Bce non riaprirà i rubinetti fino a lunedì compreso. E Atene, obtorto collo, è stata costretta a prolungare la chiusura delle banche fino a venerdì. Il governo non aveva scelta. I bancomat continuano miracolosamente a sfornare i 60 euro di prelievo giornaliero a testa, ma le riserve di banconote sono ridotte al lumicino. La speranza è che un accordo con i creditori in zona Cesarini consenta di sbloccare i finanziamenti e di riaprire le saracinesche del credito (inevitabilmente con gradualità) dall’inizio della prossima settimana. La crisi di liquidità ha paralizzato l’economia nazionale. I consumi sono crollati del 70%, certificano le camere di commercio. Cinque associazioni industriali (tra cui quella del turismo) hanno scritto al premier Alexis Tsipras scongiurandolo di firmare un’intesa che tenga il paese nell’euro in tempi strettissimi. Le prenotazioni di vacanze dalla Germania sono crollate del 39% dal cinque luglio. Il tam tam di queste ore sotto il Partenone parlava di una delle quattro grandi banche nazionali in forte difficoltà che rischia di saltare senza una schiarita nel fine settimana. 13 Un accordo in tempi brevi è necessario anche per pagare stipendi e pensioni di questo mese. Kathimerini, uno dei più autorevoli quotidiani ellenici, ha scritto ieri che gli uffici contabili dell’esecutivo avrebbero allo studio l’ipotesi di saldarli non in contanti ma con una valuta parallela, i cosiddetti “I owe you” (Iou, “Pagherò”) destinati in quel caso ad affiancarsi alla moneta unica — previa ovvia svalutazione — come valuta in circolazione in Grecia. Il ministero delle Finanze ha seccamente smentito questa ipotesi. Non ci vorrà molto per capire chi ha ragione: il governo dovrà pagare lunedì prossimo buste paga per 400 milioni di euro ai dipendenti pubblici. Una seconda tranche da 400 milioni dovrà essere sborsata il 27 luglio. Entro fine mese vanno trovati altri 800 milioni per gli assegni previdenziali. Una corsa ad ostacoli da brividi visto che il calendario delle uscite mensili ricorda che Atene per evitare il default dovrà restituire alla Bce 3,5 miliardi il 20 luglio ed — entro il 31 — altri 1,6 miliardi all’Fmi. Impegni impossibili da onorare se in un modo o nell’altro non si scongelerà il piano di aiuti finanziari dell’ex troika. Il Tesoro è riuscito ieri a collocare sul mercato 1,6 miliardi di bond a sei mesi al 2,97 per cento di tasso per rinnovare un pari importo in scadenza. A comprarli tutti sono state le banche domestiche che hanno interesse a evitare incidenti di percorso che possano portare al crac fino a quando sarà vivo un lumicino di speranza per un accordo con i creditori. Altre strade per finanziarsi — Bce a parte — non ce ne sono. Il premier intanto incontrerà oggi i partiti d’opposizione per concordare le prossime mosse in questa ultima delicatissima fase di trattative. Il vero nodo però è quello degli equilibri nel suo partito. Perché è sicuramente vero che il voto di domenica scorsa ha rafforzato Tsipras e la sua maggioranza interna, ma tutti sanno che il possibile accordo con l’Europa sarà assai doloroso. Ci sono due dinamiche da valutare, quindi. Cioè se e come il compromesso tra Grecia e Ue passerà da Syriza. Il comitato centrale di un mese e mezzo fa aveva votato un ordine del giorno in cui si diceva che ogni decisione doveva passare dallo stesso parlamentino interno. Ma i tempi sono ristrettissimi e convocare l’assemblea composta da 201 membri può far perdere tempo prezioso, oltre ovvia- mente a rappresentare un pericolo per la tenuta della “Coalizione della sinistra radicale”. La segreteria si dovrebbe riunire domani, quando i 13 membri decideranno quale sarà il passaggio da fare. Chi potrebbe sfilarsi, alla fine, è l’ala trozkista del partito, la Dea. Storicamente la più critica e riottosa rispetto alla svolta governista impressa negli anni scorsi da Tsipras. L’amaro calice, loro, potrebbero decidere di non berlo. Il resto della minoranza riunita nella “Piattaforma di sinistra”, capeggiata dal ministro dell’Ambiente Panagiotis Lafazanis, seppur a malincuore, potrebbe cedere, visto appunto il successo del referendum. Anche se non manca il nervosismo: lo steso Lafazanis due giorni fa ha abbandonato un dibattito televisivo, in polemica con la conduzione considerata troppo faziosa. «Resta il fatto che su due punti non possiamo cedere — spiega un membro del comitato centrale vicino alla maggioranza — e sono almeno la promessa di una rinegoziazione del debito e allo stesso tempo la predisposizione di un piano per lo sviluppo. Altrimenti la nostra sarà una morte solo rimandata». Del 9/07/2015, pag. 33 L’ERESIA DI SYRIZA PUÒ SALVARE L’EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ EGUALITARIA 14 SLAVOJ ZIZEK LA VITTORIA del “no” al referendum greco, netta oltre ogni aspettativa, è un voto storico, espresso in una situazione disperata. In passato ho spesso citato la barzelletta che circolava negli ultimi dieci anni di vita dell’Unione Sovietica e che aveva come protagonista Rabinovitch, un ebreo intenzionato a emigrare. Il funzionario dell’ufficio emigrazione gliene chiede il motivo e Rabinovitch risponde: «I motivi sono due. Il primo è che ho paura che in Unione Sovietica i comunisti perdano il potere e che il nuovo governo incolpi noi ebrei di tutti i crimini dei comunisti — che si torni ai pogrom antisemiti…». «Ma è assurdo», lo interrompe il funzionario, «in Unione Sovietica non può cambiare nulla, il potere dei comunisti durerà in eterno!». «Beh» risponde calmo Rabinovitch, «quello è il secondo motivo ». Mi hanno detto che ora ad Atene circola una nuova versione della storiella: un giovane greco va al consolato australiano di Atene per chiedere il visto di lavoro. «Perché vuole lasciare la Grecia?» gli chiede il funzionario. «Per due motivi», risponde il giovane. «Il primo è che ho paura che la Grecia esca dall’Ue, della nuova povertà e del caos che ne verranno…». «Ma è assurdo », lo interrompe il funzionario, «la Grecia rimarrà nella Ue e si assoggetterà alla disciplina finanziaria!». «“Beh», risponde calmo il greco, «quello è il secondo motivo… ». Vuol forse dire che, parafrasando Stalin, entrambe le scelte sono le peggiori? È ora di andare oltre i dibattiti sterili sui possibili errori di comportamento e valutazione da parte del governo greco. Le poste in gioco ormai sono troppo alte. Il fatto che negli attuali negoziati tra la Grecia e gli amministratori Ue si arrivi sempre a un passo da un accordo senza raggiungerlo è in sè profondamente sintomatico, poiché in realtà non si tratta di vere e proprie questioni finanziarie — a questo livello, la differenza è minima. La Ue di solito accusa i greci di esprimersi solo in termini generali, facendo promesse vaghe senza entrare nello specifico, mentre la Grecia accusa la Ue di voler controllare anche i minimi dettagli e di imporre al nuovo governo greco condizioni più dure rispetto al passato. Ma dietro queste recriminazioni aleggia un altro conflitto, più profondo. Tsipras ha dichiarato recentemente che se avesse avuto occasione di andare a cena da solo con Angela Merkel avrebbero trovato una soluzione in due ore. La sua tesi è che lui e la Merkel, due politici, avrebbero affrontato il dissidio come contrasto politico, a differenza degli amministratori tecnocrati, come il capo dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. Se c’è un cattivo per eccellenza in tutta questa storia è Dijsselbloem: «Se pongo le questioni sul piano ideologico non risolvo nulla» è il suo motto. Questo ci porta al nodo della questione: Tsipras si esprime come se i problemi fossero parte di un processo politico aperto, in cui si devono prendere decisioni in fin dei conti “ideologiche” (basate su preferenze normative) mentre i tecnocrati della Ue si esprimono come se tutto si riducesse a specifici regolamenti e nel momento in cui i greci rifiutano questo approccio e sollevano questioni più prettamente politiche, li si accusa di mentire, di evitare soluzioni concrete e così via. Non c’è dubbio che la verità qui sta dalla parte greca: rifiutare il “piano ideologico” come fa Dijsselbloem equivale alla più pura ideologia, significa spacciare per regolamenti elaborati da esperti decisioni che sono in realtà fondate su scelte politico-ideologiche. La lotta in atto è la lotta per la Leitkultur economica e politica in Europa. Le potenze della Ue appoggiano lo status quo tecnocratico che da decenni mantiene l’Europa in uno stato d’inerzia. Nel suo Notes Towards a Definition of Culture (Note sulla definizione di cultura) il grande conservatore T.S.Eliot osserva che in alcuni momenti l’unica possibile scelta è tra l’eresia e il non credere, per tener viva una religione bisogna cioè creare nel suo corpo principale una frattura settaria. È questa la nostra posizione oggi riguardo all’Europa: solo una nuova “eresia” (rappresentata in questo momento da Syriza) può salvare quello che vale la pena di salvare dei valori europei: la democrazia, la fiducia nelle persone, la solidarietà egualitaria… L’Europa che vincerà se Syriza verrà messa fuori gioco sarà un’”Europa dai valori asiatici” (che ovviamente nulla 15 ha a che fare con l’Asia, ma molto con la tendenza netta e attuale del capitalismo contemporaneo a sospendere la democrazia). Non è solo che il destino della Grecia è in mano all’Europa. Noi dell’Europa occidentale amiamo guardare alla Grecia da osservatori distaccati, che seguono con compassione e simpatia il dramma della nazione impoverita. Questa posizione di comodo poggia su una pericolosa illusione — ciò che accade in Grecia in questi ultimi giorni ci riguarda tutti, è in gioco il futuro dell’Europa. Il problema è che la politica dei tecnocrati si basa su una finzione, quella di estendere i termini di restituzione del debito dando a intendere che verrà ripagato in toto. Perché ci si ostina in questa finzione? Non è che renda l’estensione del debito più accettabile agli elettori tedeschi; e non è neppure che la cancellazione del debito greco possa innescare pretese analoghe da parte di Portogallo, Irlanda, Spagna… È che ai vertici in realtà non si vuole che il debito venga del tutto ripagato. I finanziatori accusano i paesi indebitati di non mostrare sufficiente senso di colpa, li accusano di sentirsi innocenti. Le loro pressioni corrispondono perfettamente a quello che gli psicoanalisti definiscono come superio: il paradosso del superio sta nel fatto che, Freud ci insegna, più obbediamo alle sue richieste più ci sentiamo in colpa. Immaginate un perfido insegnante che assegna ai suoi alunni compiti impossibili e ghigna con sadismo vedendoli in ansia e in preda al panico. Il vero obiettivo di prestare denaro ai debitori non è ottenere il rimborso del debito lucrando, ma perpetuare il debito a tempo indefinito, tenendo il debitore in perenne dipendenza e subordinazione… questo per la maggior parte dei debitori, perché ne esistono varie tipologie. Non solo la Grecia, ma anche gli Usa non saranno in grado neppure in teoria di ripagare il loro debito, come ormai è di pubblico dominio. Esistono quindi debitori (le grandi banche) in grado di ricattare i creditori perché non possono permettersi di farle fallire, debitori che possono controllare le condizioni di pagamento del loro debito (il governo Usa) e, infine, debitori che possono essere maltrattati e umiliati (Grecia). I finanziatori fondamentalmente accusano il governo Syriza di non mostrare sufficiente senso di colpa, lo accusano di sentirsi innocente. È questo che disturba l’establishment Ue: il governo Syriza riconosce il debito, ma senza colpa. Si sbarazza della pressione del superio. Ma ripetere all’infinito che la politica di Syriza rientra nei modesti confini della vecchia buona socialdemocrazia per convincere gli eurocrati che non è pericolosa e spingerli a concedere gli aiuti, in qualche misura non riesce nell’intento. Syriza è in realtà pericolosa, pone effettivamente una minaccia all’attuale orientamento della Ue — il capitalismo globale odierno non può permettersi un ritorno al vecchio stato sociale. Quindi c’è dell’ipocrisia nelle rassicurazioni circa la sobrietà delle istanze di Syriza: in realtà il suo obiettivo è impossibile da realizzarsi entro le coordinate del sistema globale esistente. Servirà una seria scelta strategica: e se fosse giunto il momento di gettare la maschera della sobrietà e di chiedere invece apertamente il cambiamento ben più radicale necessario per ottenere un progresso, seppur modesto? Forse il referendum sarà il primo passo in questa direzione. del 09/07/15, pag. 3 Pressing dell’America: tagliatele il debito Il segretario del Tesoro all’Europa: «Niente rischio fallimento». Lagarde: «Sì alla ristrutturazione» DAL NOSTRO INVIATO NEW YORK Il ministro del Tesoro americano, Jack Lew, usa parole che non possono essere più chiare: «Il debito della Grecia è insostenibile. L’Europa deve ristrutturarlo». Lew, figura chiave nell’amministrazione di Washington, ieri è 16 intervenuto in un convegno della «Brookings Institution» nella capitale Usa. Il suo discorso porta in superficie tutta l’impazienza e l’irritazione americana per come si è sviluppata la crisi tra Bruxelles e Atene. «La minaccia di fallimento della Grecia è un rischio che non vale la pena prendere», è la conclusione di Jack Lew. Già a febbraio il presidente Barack Obama aveva richiamato l’Europa a «non spremere un Paese già in recessione». Un richiamo caduto nel vuoto, si osserva oggi alla Casa Bianca. Ma adesso che il momento finale sembra arrivato, «o dentro o fuori», il governo statunitense prova a mettere sul piatto tutto il suo peso politico. Il messaggio è rivolto ormai solo in modo laterale al Fondo monetario internazionale. Lew riconosce al Fmi di aver insistito per concedere al governo di Tsipras il taglio del debito. Una proposta ripetuta anche ieri da Christine Lagarde, numero uno del Fondo. Un passo indispensabile, per Washington. Tuttavia, la stessa Lagarde, in passato, ha complicato la trattativa, pretendendo, come contropartita, misure di austerity considerate da Obama inapplicabili nel contesto greco. L’amministrazione americana sente salire il nervosismo dei mercati finanziari. Osserva la nuvola nera in arrivo dalla Cina. Vede una ripresa economica non ancora consolidata, con ampie zone di fragilità, per esempio nella distribuzione del reddito o nelle difficoltà delle esportazioni. In questi giorni è in corso una grande discussione sui tassi di interesse e sul dollaro forte. Su quello che dovrà fare o non fare la Federal Reserve. Ma l’economia americana chiede soprattutto stabilità e un clima di fiducia. Il ministro dell’Economia ha tradotto questo insieme di interessi e di stati d’animo e lo ha trasformato in un doppio messaggio. Un appello rivolto ai leader europei, soprattutto alla cancelliera Angela Merkel. E, nello stesso tempo, una sponda preziosa per Tsipras. Come dire: se hai bisogno di aiuto, noi americani siamo qui. Non c’è bisogno di andare fino a Mosca . Giuseppe Sarcina del 09/07/15, pag. 3 Il pilota automatico della Ue La mutazione genetica della socialdemocrazia. Probabilmente la paura degli Stati uniti non è legata alla crisi greca, che nei fatti ha solo accelerato un problema di governo dell’economia europea, piuttosto nella perseveranza di politiche recessive e nei rischi geopolitici insiti nella crisi dell’eurozona Paolo Pini, Roberto Romano L’Unione Europea e chi la governa, socialisti e popolari, hanno una idea di Europa e, probabilmente, la porteranno fino i fondo. Qualche rumors avanza; alcuni dubbi si affacciano, ma nella sostanza preferiscono una unione monetaria omogenea nei fondamenti. C’è l’illusione che senza la zavorra greca l’Europa si possa vivere molto meglio. Le parole del ministro Padoan sono rappresentative dello stato dell’arte: «i fondamentali dell’Italia si sono rafforzati… ci sarà un po’ di volatilità… ma non c’è nessun rischio per l’Italia che sta facendo le riforme, che sono la via maestra anche dal punto di vista finanziari». Relativamente alla crisi greca il Ministro ri-afferma che «ci vogliono riforme strutturali per rimettere l’economia greca su un sentiero di crescita sostenibile. Questa è anche la condizione per rendere il debito sostenibile» (il sole 24 ore, 7 luglio). Per quanto possa 17 apparire impossibile, sono proprio i socialisti a irrigidirsi. Le posizioni del vice cancelliere tedesco Gabriel e del presidente del Parlamento europeo Schulz sono coerenti con una certa idea di socialismo. Il primo ha sostenuto che «un compromesso ormai è quasi impossibile e i paesi europei alla Grecia al massimo possono fornire aiuti umanitari», il secondo si è apertamente schierato con il sì al referendum. Qualcuno parla a ragione di mutazione genetica della socialdemocrazia europea. Come dargli torto appare difficile. Probabilmente sono posizioni condivise da tutti o quasi i socialisti europei, mentre i popolari continuano nella deriva istituzionalista. Per la Germania, inoltre, è opportuno sottolineare la matrice culturale che caratterizza da sempre questo paese, fino a domandarsi se abbiano mai fatto i conti con la propria storia. L’idea stessa di un piano umanitario per la popolazione greca è la declinazione di una idea di società, l’economia sociale di mercato di natura ordoliberale. Se non adotti il nostro modello e le nostre regole non partecipi alla comunità, ma posso in condizioni estreme considerare un intervento umanitario che, per assurdo, umilia ancor di più le persone. Giornali, riviste e istituzioni di ricerca, formulano ipotesi per superare l’attuale fase di stallo. Noi stessi ci siamo impegnati a suggerire alcune soluzioni, ma la sensazione è quella di una discussione utile per riempire i giornali, non certo quella di concorrere alla soluzione dei problemi. Dopo alcuni anni tutti gli economisti concordano sulla profonda inadeguatezza del Patto di Stabilità e Sviluppo, al netto dei soliti eroi (la coppia AlesinaGiavazzi è un campione insuperabile nel panorama economico), ma le istituzioni europee sono sorde. Se nemmeno una delle tante proposte formulate dai think tank tedeschi sulla possibilità di istituire un Fondo unico che raccolga gli eccessi nazionali di debito pubblico, rispetto al tetto del 60% del Pil, riesce a fare breccia, vuol dire che l’Europa ha inserito un pilota automatico. Probabilmente la paura degli Stati uniti non è legata alla crisi greca, che nei fatti ha solo accelerato un problema di governo dell’economia europea, piuttosto nella perseveranza di politiche recessive e nei rischi geopolitici insiti nella crisi dell’eurozona. Crisi dopo crisi la politica economica europea è rimasta sempre la stessa ed è diventata sempre più autoregolatrice. È un treno su un binario. Al massimo può rallentare o accelerare (i famosi margini di flessibilità di cui tanto si discetta). Nulla di più e nulla di meno. L’aspetto sorprendente è come tutto questo sia stato istituzionalizzato a tutti gli effetti. La posizione delle istituzioni europee, lasceremmo da parte il Fmi per la sua posizione che ha recentemente formalizzato, benché il suo presidente sia palesemente vittima della sua brama di potere – rielezione alla guida del Fmi -, è granitica perché pensano proprio quello che dicono. L’Europa deve avere bilanci pubblici in avanzo, una crescita della offerta di moneta coerente ad un target di inflazione stabile, un mercato del lavoro flessibile, un mercato dei beni interamente guidato dalla concorrenza, debiti pubblici sotto controllo e, preferibilmente, anche quelli privati visto che sono stati introdotti vincoli insormontabili alle banche e alle imprese per accedere al credito per nuovi investimenti (Basilea I, II, III e IV), crescita economica guidata dalle esportazioni e tassi di interesse allineati tra paesi. Questa è la posizione europea e delle sue istituzioni. Sono un pilota automatico che i funzionari seguono pedissequamente. Non a caso sono proprio i funzionari delle istituzioni a guidare la crisi greca, mentre i paesi dominanti, al massimo, concedono ai paesi vassalli di piazzare qualche funzionario qua e la. Abbiamo già dimenticato le formazione della Commissione Europea? Sarebbe anche possibile immaginare uno scenario europeo diverso. Le proposte non mancano, ma i funzionari non hanno il potere di cambiare le politiche. La politica? Forse è diventata un funzionario anch’essa. Renzi è forse la versione peggiore, ma Monti non era diverso. Il dibattito non è più se uscire o meno dall’euro. Il problema è l’Europa. Dopo il 20 luglio, quando la Grecia non pagherà i 3,5 mld alla BCE, vediamo cosa succede. Dispiace 18 dirlo, ma il tema che oggi la sinistra deve affrontare è lo stesso affrontato da Spinelli e da altri grandi europeisti. del 09/07/15, pag. 8 Putin ospita il vertice degli emergenti e sogna un nuovo ordine monetario I Brics in Russia per far decollare la loro Banca e sfidare l’Occidente Anna Zafesova Più di 10 mila ospiti stranieri, tra cui leader di prima grandezza come il cinese Xi Jinping e l’indiano Narendra Modi, tre vertici contemporanei - quello dei Brics, dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai e dell’Unione euro-asiatica post-sovietica - e una raffica di iniziative. Vladimir Putin sposta per due giorni il centro della sua diplomazia a Est, a Ufa nel Bashkortostan, per dimostrare a tutto il mondo che ha altre priorità e alleanze rispetto all’Occidente. I dossier sul tavolo sono a 360 gradi: dalle nuove architetture finanziarie mondiali (da discutere con Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si sentono emarginati dal Fondo monetario internazionale), all’Isis (che interessa al gruppo di Shanghai, nato come più strategico che economico). E si parla anche di soldi, della Nuova banca dello sviluppo dei Brics con 50 miliardi di dollari, e di un fondo di riserva di 100 miliardi per aiutarsi a vicenda in caso di crisi. Lo Zar cerimoniere Uno sfoggio di potenza impressionante in termini di miliardi di abitanti e di dollari, anche se Xi arriva a Ufa proprio mentre Bloomberg dichiara la borsa di Shanghai più rischiosa di quella di Mosca dopo la crisi della Crimea, e Putin chiede al collega cinese «aiuto nel superare le attuali difficoltà» generate dalla crisi economica e dalle sanzioni occidentali. Per il Presidente russo è senz’altro un momento di compensazione e - approfittando anche della coincidenza della presidenza di turno russa sia nei Brics sia nel gruppo di Shanghai - è il maestro di cerimonie di un evento senza precedenti, dove stringe mani, discute accordi, snocciola miliardi e costruisce strategie ad architettura variabile cercando di porsi al centro dei vari, e spesso contraddittori, interessi dei suoi interlocutori. Mosca a caccia di soldi Ma è anche il primo a dover smentire i piani di un «anti-G7» da far nascere a Oriente, e dice che i Brics «non hanno alcun progetto di un’alleanza politica e militare», ma sono uniti dall’«interesse strategico» di cambiare un ordine monetario internazionale troppo imperniato sul dollaro. Dai corridoi del summit giungono voci che Mosca avrebbe spinto per dare ai Brics una struttura più formale, lanciando decine di iniziative complementari tra commissioni, comitati, forum e segreterie nei campi più disparati, ma ha incontrato l’opposizione soprattutto dell’India, e Putin si accontenta di promettere che «a lungo termine avremo una segreteria virtuale». Le economie e le diplomazie dei cinque Paesi sono troppo differenti, e Brasile e Sudafrica avrebbero respinto i tentativi russi di creare un’alleanza anti-occidentale, mentre i cinesi giocano su più tavoli, e accanto alla banca dei Brics mandano avanti il loro progetto della Banca asiatica di investimenti infrastrutturali, al quale Mosca ha aderito solo all’ultimo momento. Alleanze variabili Il Cremlino per il momento appare il più interessato alle nuove strutture dei Brics, con il ministro del Tesoro Anton Siluanov che già spera di ottenere fondi per le società russe tagliate fuori dalla finanza occidentale (ma qualche voce russa aveva ipotizzato anche aiuti 19 per Atene in caso di Grexit). Il mondo «multi-polare», tanto auspicato dal Cremlino, è però molto più asimmetrico e pragmatico, come lo stesso Putin ha appena dimostrato, spingendo con una mano per il deal con Teheran e con l’altra firmando accordi miliardari con i sauditi. E così Xi invita Putin a Pechino, ma nello stesso tempo le banche russe si lamentano che i colleghi cinesi ormai gli chiudono gli sportelli in faccia, mentre molti esperti sospettano che i mega-progetti russo-cinesi si stiano impantanando. Resta lo yoga, che il Presidente russo ha promesso al premier indiano di imparare. del 09/07/15, pag. 5 Una nuova Banca di sviluppo anti Fmi Brics. In corso in Russia il VII Vertice dei cinque grandi emergenti Geraldina Colotti Si conclude domani a Ufa, in Russia, il VII Vertice dei Brics, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica: il 40% della popolazione mondiale e oltre il 30% del Pil globale. A Mosca tocca la presidenza di turno, dopo il precedente incarico del Brasile, che ha ospitato il summit dell’anno scorso. E il ministro dello Sviluppo economico russo, Anton Siluanov è il governatore della nuova Banca dello sviluppo, grande invenzione dei Brics. L’altro ieri, le banche centrali dei cinque grandi emergenti hanno firmato un accordo operativo che regola il funzionamento del fondo di riserve monetarie comune, pari a 100.000 milioni di dollari. La Cina metterà 41 miliardi di dollari, Russia, India e Brasile 18 miliardi ciascuno e il Sudafrica 5 miliardi. La sede sarà a Shanghai, ma un altro centro regionale si troverà in Sudafrica. La Banca è dotata di un consiglio di amministrazione, il cui primo presidente è Siluanov, di un direttivo a conduzione brasiliana e da una presidenza, a cui è stato nominato l’indiano Kundapur Vaman Kamath, affiancato da 4 vicepresidenti degli altri 4 paesi. La nuova Banca di sviluppo comincerà ad essere operativa entro la fine di aprile del 2016. Obiettivo del fondo comune sarà quello di concedere prestiti ai paesi partecipanti in caso di problemi con la liquidità in dollari. La decisione di dotarsi di una banca è stata presa dai Brics l’anno scorso, durante il vertice di Fortaleza, in Brasile. Se ne discute però dal 2009, con il primo vertice dell’organismo. Ora, l’intenzione dei cinque paesi è quella di farne un organismo finanziario globale «specializzato in progetti di infrastruttura»: il disegno di una nuova architettura finanziaria, alternativo al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale (che ha un patrimonio di 490 miliardi di dollari), egemonizzati dagli Usa. I Brics hanno dichiarato la loro disponibilità ad incorporare altri stati fondatori, ma le modalità sono ancora da definire. L’indirizzo è però dichiarato: una logica di prestiti senza il cappio al collo degli aggiustamenti strutturali richiesti dall’Fmi, presso cui i Brics hanno solo il 10,3% del diritto di voto. Un atteggiamento importante dato il dislivello esistente all’interno dei paesi membri, ove l’economia cinese è 28 volte quella del Sudafrica, e date le differenti modalità di governo adottate dai singoli paesi. Verso la fine dell’egemonia del dollaro? Intanto, i Brics ragionano sull’istituzione di una moneta comune. Intanto, costituiscono una sponda per la Russia colpita dalle sanzioni. E potrebbero lanciare un salvagente anche all’economia greca, nell’ottica di una politica di Atene a più dimensioni, in cui i Brics giocherebbero un ruolo principale. A fine maggio, la Grecia ha manifestato interesse per la nuova Banca di sviluppo. E anche se Atene non potrà certo apportare contributi iniziali, potrebbe ricevere un credito non condizionato e un appoggio finanziario significativo. Di recente, il presidente russo Vladimir Putin ha detto 20 che la crisi greca è fuori dall’agenda della Banca di sviluppo, ma non da quella del vertice, e che se ne dovrebbe discutere in una colazione di lavoro, insieme ad altri temi di interesse internazionale come l’Ucraina o la minaccia del Califfato. L’anno scorso, l’Argentina ricattata dai fondi avvoltoio, posizionati a Washington, è stata presente a Fortaleza e la presidente Cristina Kirchner ha posto decisamente l’esigenza dei paesi del sud di impostare un sistema finanziario alternativo. Presenti anche i presidenti dei paesi socialisti latinoamericani, che — Venezuela in testa — hanno inaugurato una logica solidale alternativa negli scambi sud-sud. Domani, sempre a Ufa, si svolge anche un altro importante vertice finanziario, quello dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Ocs), che attualmente include Russia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, e prevede l’entrata di India e Pakistan per configurarsi come un nuovo G8. del 09/07/15, pag. 17 Veto della Russia su Srebrenica «Non si trattò di genocidio» Non c’è pace per la memoria di quella che per molti è la più grave carneficina in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale. Mosca ha esercitato ieri il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla risoluzione di condanna del massacro avvenuto 20 anni fa durante la guerra in Bosnia. L’11 luglio 1995, nella cittadina bosniaca di Srebrenica, le truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic deportarono la popolazione e trucidarono oltre ottomila uomini e ragazzi bosniaci musulmani. A ormai vent’anni di distanza da quel massacro, la comunità internazionale non riesce ancora a trovarsi d’accordo nel definire quell’evento come «genocidio». Il documento, messo a punto dalla Gran Bretagna, ha infatti ricevuto solo dieci voti a favore, su 15. Oltre al veto russo, quattro Paesi - Cina, Venezuela, Angola e Nigeria - si sono astenuti. Del 9/07/2015, pag. 20 Emergenza Siria, oltre quattro milioni in fuga LA CRISI. L’APPELLO DELLE NAZIONI UNITE: “SERVONO 5,5 MILIARDI DI DOLLARI” GIAMPAOLO CADALANU È un esodo epocale. Appena dieci mesi dopo l’arrivo del profugo numero tre milioni, la marea di fuggiaschi dalla guerra in Siria ha superato il livello di quattro milioni. Il conto dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati arriva a 4 milioni e tredicimila, le previsioni dicono che entro fine anno si arriverà a 4,27. E il quadro del disastro umanitario in arrivo si completa solo aggiungendo gli sfollati che sono rimasti all’interno della Siria, ma sono stati costretti a lasciare le loro case: secondo l’Unhcr sono almeno 7,6 milioni. Il totale sfiora dunque i dodici milioni: un popolo in fuga, per il quale i numeri danno solo un’idea generale, senza restituire il senso della tragedia individuale. Milioni di storie 21 oscillanti fra l’angoscia e la speranza, vite legate alla generosità degli altri, alla disponibilità degli organismi internazionali, alle esili o persino inconsistenti prospettive di pace. «Per questa generazione è la più massiccia popolazione di rifugiati di una sola guerra», dice Antonio Guterres, alto commissario dell’Onu. Secondo Guterres, «il deteriorarsi della situazione spinge molti a cercare di raggiungere l’Europa o di andare oltre, ma la grandissima maggioranza resta nella regione». La Turchia ospita oltre 1.805mila profughi, circa 250mila sono in Iraq, 630mila in Giordania, 1.172mila in Libano, 132mila in Egitto, altri 24mila sparsi nel nord Africa. Almeno 270mila sono i richiedenti asilo in Europa. Ma il superamento di quota quattro milioni corrisponde all’allarme per le risorse: l’Unhcr stima che servano almeno 5,5 miliardi di dollari in aiuti umanitari, prima che i paesi ospiti siano spinti verso l’instabilità. Anche perché i rifugiati che vivono nei campi di raccolta del Medio oriente sono ormai alla disperazione: in Giordania l’86 per cento vive sotto i livelli di povertà, con meno di 3,2 dollari al giorno, in Libano più della metà è costretta a vivere in strutture improvvisate. E lo sconforto stimola evoluzioni inaccettabili: fra i profughi si diffondono il lavoro minorile, l’accattonaggio, i matrimoni di minori, mentre cresce la competizione per le risorse, dall’acqua all’energia. del 09/07/15, pag. 17 Un muro anti-jihadisti tra la Tunisia e la Libia Sarà costruito dall’esercito tunisino e verrà completato entro il 2015. La decisione di sigillare con un muro il «fianco» libico della Repubblica tunisina arriva a poche settimane dall’attacco jihadista di Sousse, che ha provocato 38 morti e colpito al cuore l’industria del turismo, Così Habib Essid, primo ministro tunisino, è andato in tv e ha annunciato la costruzione del muro. «I gruppi terroristici e criminali hanno in programma altri attentati con il fine di paralizzare l’economia del Paese», ha ribadito ieri Essid al parlamento, riunitosi in un’udienza straordinaria dopo la proclamazione dello stato di emergenza da parte del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi il 4 luglio scorso. Il premier ha spiegato che la Tunisia vive una situazione eccezionale, come dimostrano i pericoli e le minacce. Il «vallo di Essid avrà delle stazioni di controllo poste a intervalli regolari». del 09/07/15, pag. 8 Gaza 2014, “Direttiva Annibale” Gaza. Un anno fa Israele lanciava l'offensiva "Margine protettivo". Tra le pagine più insanguinate della scorsa estate c'è quella del 1 agosto a Rafah, quando i comandi dello Stato ebraico diedero il via libera al codice di condotta previsto quando un soldato viene catturato dal nemico: bombardamenti continui su tutta la zona. Fu strage nella città palestinese Michele Giorgio RAFAH (STRISCIA DI GAZA) 22 Una lacrima scende lentamente sul bel viso di Fatma Abu Musa. Si ferma all’altezza del labbro superiore. Una mano corre veloce ad asciugarla, per farla sparire subito. È un dolore composto quello della giovane donna, tenuto dentro, manifestato solo a tratti dalla voce rotta dall’emozione. «Karam era la mia migliore amica, ci volevamo bene. L’avevo aiutata io a indossare l’abito da sposa e quattro mesi dopo sono stata io a lavare il suo corpo prima della sepoltura. Delle volte mi dico…è stato solo un brutto sogno e presto ti sveglierai… ma non è così. Karam non c’è più», racconta Fatma, tecnico di laboratorio dell’ospedale “Kuwaiti” di Rafah. La sua amica Karam Dheir, 26 anni, è rimasta uccisa il 1 agosto del 2014 durante quello che rimarrà scolpito nella memoria collettiva della popolazione di Rafah come il “Venerdì Nero”. E’ delle pagine più insanguinate dell’offensiva militare israeliana “Margine Protettivo” cominciata l’8 luglio dello scorso anno e andata avanti fino al 26 agosto. Cinquanta giorni di bombardamenti aerei, tiri di mezzi corazzati e di artiglieria, cannonate dal mare, di incursioni e combattimenti che hanno ucciso circa 2.200 palestinesi, tra i quali molte centinaia di civili indifesi, oltre 500 bambini e ragazzi. Tante famiglie sono state decimate, colpite da bombe mentre erano riunite in casa. Undicimila i feriti, centinaia di migliaia di persone sfollate per settimane, decine di migliaia di case ed edifici distrutti o danneggiati gravemente, anche ospedali, in particolare nella fascia orientale di Gaza. Beit Hanoun, Shujayea, Khuzaa, Zayton, Zannah e, appunto Rafah, sono i nomi di alcuni dei centri abitati ridotti a una distesa di rovine. Migliaia sono i razzi e i colpi di mortaio che il movimento islamico Hamas e altre organizzazioni palestinesi hanno sparato verso il territorio israeliano, facendo sette morti civili (tra i quali un bambino di 4 anni) e centinaia di feriti. 66 sono i soldati israeliani rimasti uccisi un anno fa, quasi tutti, negli scontri a fuoco con i combattenti di Hamas e di altri gruppi. Uno di questi militari morti era il sottotenente Hadar Goldin, di una unità di ricognizione della Brigata Givati, caduto quel 1 agosto. La sua vicenda genera ancora emozione nell’opinione pubblica israeliana. Il suo corpo, e quello del sergente Oron Shaul, sempre della Givati, sarebbero nelle mani di Hamas. Per i palestinesi il nome di Goldin invece è sinonimo di strage, di civili fatti a pezzi dalle cannonate. Il 1 agosto 2014 gli abitanti di Rafah hanno appreso sulla loro pelle dell’esistenza della “Direttiva Annibale”. «Era stata annunciata una tregua di diverse ore a Rafah – ricorda Fatma Abu Musa –, perciò andai al lavoro più rilassata rispetto agli altri giorni. Le strade erano affollate, alcuni andavano ai forni per comprare il pane, altri si procuravano un po’ di frutta e ortaggi. Tanti ancora ne approfittavano per tornare per qualche ora alle case che avevamo dovuto abbandonare perchè troppo esposte alle cannonate». Poco dopo, aggiunge Fatma, si sarebbe scatenato l’inferno: «All’improvviso cominciarono a cadere bombe sulla parte est di Rafah, le esplosioni erano continue, tanti scappavano urlando e in preda al panico. I colleghi dell’ospedale ‘Abu Yusef al Najjar’ (il principale di Rafah, ndr) ci dissero di tenerci pronti perchè loro erano in pieno codice rosso per l’arrivo di decine di feriti in condizioni gravissime e che presto ci sarebbe stato bisogno del nostro intervento». Saleh Mohsen, quel giorno era in Sharaa Bildesi, una delle strade più colpite. «Chiedevo a Dio di farmi ritrovare in vita la mia famiglia — dice Mohsen — non mi importava di morire, pensavo solo alla salvezza dei miei figli. I colpi cadevano ogni 10 secondi, in modo indiscriminato». Alle ore 12 i morti erano già decine, centinaia i feriti. Fu colpito – da due missili, secondo testimoni palestinesi — anche l’ospedale “Abu Yousef al Najjar” e i medici furono costretti ad evacuare i feriti e gli ammalati. «Cominciarono a portarli da noi, nonostante si trattasse di un ospedale specializzato in ostetricia e ginecologia– spiega Fatma Abu Musa –, nelle nostre piccole sale operatorie i medici facevano quattro inteventi chirurgici alla volta. Era talmente continuo l’afflusso dei feriti che chiedemmo ai proprietari delle case vicine di ospitare quelli meno gravi». Andò avanti così per tre giorni. Ad un certo punto, aggiunge Fatma, «con l’obitorio pieno, svuotammo i frigoriferi dei gelati nelle sale di attesa e li 23 usammo per conservare i cadaveri dei bambini e i corpi smembrati che i medici non avevano potuto ricomporre». Fatma in quei giorni si sarebbe trovata davanti agli occhi anche il corpo senza vita della sua amica Karam, uccisa dall’esplosione di missile sganciato da un drone, nessuno sa contro chi e contro cosa. Quel “Venerdì nero” 1 agosto scattò la “Direttiva Annibale”, in risposta all’uccisione di due soldati israeliani e alla cattura – ma forse era già morto — del sottotenente Hadar Goldin da parte di uomini di Hamas. Si tratta di un codice di condotta delle forze armate israeliane — deciso nel 1986 e revocato nel 2003 ma tornato in vigore dopo il caso del caporale Ghilad Shalit, fatto prigioniero da un commando palestinese nel 2006 e tornato a casa solo nel 2011 in cambio della liberazione di un migliaio di detenuti politici — che impone di “non lasciare indietro nessuno” a costo di ucciderlo: meglio un soldato morto che prigioniero del nemico. La direttiva prevede un bombardamento violento e intenso, per ore, dell’area dove potrebbe trovarsi il militare catturato. Rafah però non è un deserto o una enorme campagna vuota e disabitata. E’ la terza città della Striscia di Gaza per numero di abitanti. Sparare a tappeto sulla zona est della città e i suoi sobborghi significa provocare una strage di civili. Quella mattina del 1 agosto tutto comincia a cavallo dell’inizio della tregua. Le versioni di Israele e di Hamas sono opposte. I soldati, afferma Tel Aviv, erano in perlustrazione, alla ricerca di tunnel sotterranei e Hamas avrebbe approfittato della cessazione delle ostilità per tendere un agguato alla pattuglia, fare prigioniero un militare e trascinarlo dentro Gaza attraverso un tunnel. Il movimento islamico nega e afferma che sarebbe stato proprio l’esercito israeliano a violare la tregua mandando in esplorazione i suoi soldati a ridosso delle linee palestinesi in segno di sfida e per provocare la ripresa dello scontro. Neppure la Commissione d’inchiesta del Consiglio dell’Onu per i Diritti umani, che ha ascoltato 22 testimoni, visionato filmati e immagini satellitari sui fatti del 1 agosto, è stata in grado di determinare se lo scontro a fuoco e la cattura di Goldin siano avvenuti prima o dopo l’inizio della tregua. Ha accertato però che Rafah finì sotto un bombardamento spaventoso, con i civili in trappola. Una pioggia di oltre 1000 proiettili solo nelle prime tre ore, caduta su strade e case. Un grandine di fuoco che ha devastato Mashru Amer, Tannur, Hay al Jneina, Via Uruba, Al Shawka, Zallata, la zona dell’aeroporto e la superstrada Salahuddin. Il 95 per cento delle vittime della “Direttiva Annibale” viveva in queste zone. Un caso riferito alla Commissione dell’Onu è quello di un’ambulanza colpita mentre trasportava civili feriti a Msabbeh. Il veicolo prese fuoco uccidendo le otto persone a bordo. Secondo i dati delle Nazioni Unite a Rafah si sono avuti 100 morti solo il 1 agosto, tra cui 75 civili (24 bambini e 18 donne). I media palestinesi hanno parlato di circa 200 morti a Rafah dopo la cattura di Hadar Goldin. Il bagno di sangue è andato avanti anche nei giorni successivi, segnati dalla strage (10 morti), il 3 agosto, in una scuola dell’Unrwa (Onu) che, come molte altre di Gaza in quei giorni, ospitava sfollati. I comandi israeliani dissero di aver ordinato di sparare contro miliziani armati e non verso la scuola. In Israele della “Direttiva Annibale” si discute ancora, e sui fatti del 1 agosto ha indagato la Procura militare. Ma solo in riferimento al sottotenente Goldin e a una possibile negligenza che potrebbe avere segnato la sorte della pattuglia finita sotto attacco. Non certo per le conseguenze devastanti che la sua applicazione ha avuto sulla popolazione di Rafah. Il tenente colonnello Eli Gino, comandante durante “Margine Protettivo” delle unità di ricognizione della Brigata Givati, ha dichiarato che il fuoco delle forze armate israeliane è stato «proporzionato» e sottolineato che quando «viene rapito un soldato, tutti i mezzi sono leciti» anche se esigono un prezzo elevato. Il 26 settembre 2014, il quotidiano Yediot Ahronot ha ricostruito l’accaduto in un lungo articolo, “Impedire un altro incidente Ghilad Shalit”, in cui si ribadisce che la linea seguita era quella di impedire, ad ogni costo, che Goldin rimanesse vivo nelle mani di Hamas. E nonostante Israele sostenga, contro gli esiti 24 delle indagini dell’Onu, di non aver commesso alcun crimine la scorsa estate, l’esercito si è premurato di nascondere l’identità di un capitano e di un maggiore che, si comprende dallo stesso articolo di Yediot Ahnorot, sono coinvolti nella attuazione della direttiva e rischiano di finire davanti alla Corte penale internazionale. La “Direttiva Annibale è l’inizio del fascismo in Israele”, scrisse l’opinionista Uri Arad il 12 agosto del 2014. Inizio del fascismo non per la strage di civili innocenti a Rafah in quel “Venerdì nero” ma perchè il premier Netanyahu riteneva e forse ancora ritiene sacrificabile la vita di un soldato israeliano. del 09/07/15, pag. 8 Traumi psicologici infiniti per i bambini Gaza. Circa il 98.3% dei bambini che vivono nella Striscia presenta sintomi riconducibili ad una diagnosi di PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). I piccoli di Gaza si trovano chiusi in una spirale di traumi dalla quale non è possibile uscire perchè le uniche vie di fuga, le relazioni familiari e sociali, sono a loro volta compromesse e “traumatizzate”. Eleonora Pochi GAZA “La guerra più devastante per la Striscia di Gaza”, come viene definita dai palestinesi, ha provocato un tragico deterioramento del benessere psicofisico di adulti e minori. Circa il 98.3% dei bambini presenta sintomi riconducibili ad una diagnosi di PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Tuttavia resta sempre molto difficile parlare di disturbi da stress “post” traumatico poichè nella Striscia i traumi continuano a ripetersi e a mantenere livelli di stress ricorrenti. I sintomi più diffusi — secondo specialisti locali — sono tra quelli della “ipervigilanza”: aggressività, flashback ed incubi e nella valutazione psicologica del bambino, sono da considerare non solo i comportamenti manifesti ma anche il percorso di sviluppo, il funzionamento del sistema familiare, le caratteristiche individuali dei genitori e della loro relazione di coppia. La presa in carico del bambino comporta spesso un supporto anche alla coppia genitoriale. Molto spesso i genitori soffrono di depressione a causa del senso di impotenza dovuto al non riuscire a proteggere i loro figli come vorrebbero. Da una situazione ambientale altamente ostile e mortificante — come ad esempio l’esposizione cronica all’umiliazione intenzionale — scaturisce la repressione di pulsioni che porta talvolta all’abuso sessuale di minori da parte di membri di sesso maschile all’interno del nucleo familiare. Inoltre, il bambino che vive eventi traumatici tipici di contesti di conflitto armato percepisce i genitori come incapaci di proteggerlo. La morte violenta di una figura d’attaccamento genera nel minore uno stress grave e delle reazioni depressive. Sono sempre le madri che si rivolgono agli specialisti e quelle che segnalano eventuali abusi corrono il rischio di ripercussioni, poiché a livello sociale e culturale è una pratica inaccettabile. Per quanto riguarda i bambini rimasti orfani dalla guerra, sono presi in carico da cugini o parenti, grazie ad un forte senso di solidarietà. Alcune delle esperienze traumatiche causate dall’operazione militare “Protective Edge” sono state: la fuga da un bombardamento in corso, l’irruzione di soldati in casa durante la notte, essere utilizzati come scudi umani dall’esercito israeliano, avere la percezione di non essere mai in un posto sicuro, vedere distrutta la propria casa e perdere qualsiasi cosa, sopravvivere con una o più disabilità croniche. Delle 138.406 case danneggiate o 25 distrutte durante l’ultima guerra, nessuna è stata ricostruita. Attualmente migliaia di bambini non hanno accesso all’istruzione e molti di quelli che riescono a raggiungere scuole o strutture adibite dall’UNRWA hanno scarsa capacità di concentrazione che riescono a riacquistare pian piano con il supporto di operatori e specialisti, poiché anche gli insegnanti molto spesso trovano difficoltà a gestire livelli così alti di stress. Solo nella parte della costa, quasi 300 edifici scolastici sono stati danneggiati da “Protective Edge”. In un contesto simile, il lavoro minorile diviene uno strumento di sopravvivenza. Durante una visita al Gaza Community Mental Healt Program, Yasser Jamei, direttore generale, ha spiegato:“Durante l’ultima guerra noi del GCMHP siamo stati costretti a restare in casa, nonostante l’istinto ci spingesse inesorabilmente in strada per dare supporto ed aiuto alle persone. Noi specialisti della salute mentale dobbiamo cercare di preservarci, per quanto possibile, dai traumi perchè altrimenti come potremmo curare i bambini e la gente…E’ un compito estremamente difficile. Molti operatori di ONG, anche internazionali, sono scesi nelle strade, negli ospedali, durante i bombardamenti per dare il loro aiuto, si sono fatti guidare dall’istinto. Ma il risultato è stato che dopo poche settimane erano distrutti, traumatizzati, stressati, non in grado di operare. Ed è proprio quando finiscono di fumare le macerie che noi entriamo in azione. Perchè da lì il crollo è invisibile, ma egualmente devastante”. L’incubo più ricorrente per i bambini di Gaza è il serpente, rappresentazione di un male incontrollabile, ostile ed insidioso. “Ascoltano la radio, guardano la TV, vedono cadaveri, sentono le bombe, il rumore assordante dei vetri che scoppiano, ascoltano storie di guerra. Sono terrorizzati”. Le parole del fondatore del Gaza Community Mental Healt Program, Eyad Serraj, anche se riferite all’attacco armato del 2012, sono tristemente attuali. Lo scenario che si disegna è preoccupante; rappresenta un quadro in cui il bambino si trova chiuso in una spirale di traumi dalle quale non gli è possibile uscire perchè le uniche vie di fuga, le relazioni familiari e sociali, sono a loro volta compromesse e “traumatizzate”. Uno scenario caratterizzato da un’eterna, angosciante attesa del prossimo bombardamento. Eleonora Pochi è una giornalista pubblicista e una esperta di servizi sociali. Di recente ha visitato Gaza del 09/07/15, pag. 9 Nella Striscia 2200 morti e 12620 case distrutte La Striscia mostra ancora, e lo farà per diversi anni, le conseguenze della devastante operazione militare israeliana scattata un anno fa Michele Giorgio Si sono svolte con giudizi e finalità opposte, le commemorazioni di palestinesi e israeliani per il primo anniversario dell’inizio dell’offensiva “Margine Protettivo” contro Gaza. 50 giorni di bombardamenti israeliani e di lanci di razzi palestinesi costati la vita a oltre 2.200 abitanti di Gaza (solo una parte erano miliziani armati) e a 72 israeliani, 66 dei quali soldati. Un’offensiva devastante condannata dagli organismi internazionali, con il Consiglio dell’Onu per i Diritti Umani che il mese scorso, con un rapporto della sua commissione d’inchiesta, ha denunciato che Israele e anche il movimento islamico Hamas hanno commesso crimini di guerra. Tel Aviv ha respinto ogni accusa. Il premier Netanyahu ha difeso l’operazione a Gaza e ammonito i “nemici di Israele” dal lanciare attacchi, altrimenti, 26 ha aggiunto, saranno puniti severamente. In casa palestinese le commemorazioni hanno puntato sulla solidarietà con le famiglie delle vittime e le decine di migliaia di persone che hanno perduto la casa. In un anno si è fatto davvero poco per riparare e ricostruire le case e le infrastrutture distrutte dall’attacco israeliano. Un rapporto pubblicato lunedì da Ocha, l’Ufficio dell’Onu per il coordinamento degli affari umanitari, riferisce che 12.620 abitazioni sono state completamente distrutte, altre 6.455 danneggiate seriamente. 17.670 famiglie (circa 100mila persone) sono state costrette a sfollare. Ma nei giorni più duri di “Margine Protettivo” furono quasi mezzo milione i palestinesi che abbandonarono le loro case, 300 mila dei quali vennero accolti in scuole e strutture dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che assiste i profughi palestinesi. Sino ad oggi non una singola abitazione tra quelle distrutte completamente è stata ricostruita, denuncia Ocha. Altre 150.000 abitazioni sono state danneggiate e i proprietari da soli cercano di ripararle. Se tiene conto anche delle altre due operazioni militari (Piombo fuso e Colonna di difesa) subite da Gaza tra il 2008–9 e il 2014, si stima che sia arrivato nella Striscia soltanto l’1% del cemento e dei materiali necessari per la ricostruzione. Inoltre solo una parte delle famiglie senza casa ha ricevuto la donazione di 200–250 dollari al mese (per un semestre) stabilito dalle agenzie internazionali per aiutare chi ha perduto tutto e oggi vive in case prefabbricate, tende, rifugi di lamiera e tra ciò che resta delle loro case. Persone che hanno un accesso limitato ai servizi igienici, all’acqua potabile e all’energia elettrica. Senza dimenticare i rischi causati dalla presenza di ordigni inesplosi tra le rovine e l’impossibilità, almeno sino ad oggi, di effettuare uno screening per accertare la presenza di radiottività nelle macerie (i proiettili di artiglieria e i missili spesso contengono uranio impoverito). Del 9/07/2015, pag. 12 Il crac di Shanghai brucia 2.500 miliardi La Cina rallenta e spaventa il mondo La febbre degli acquisti ha creato una super-bolla E ora la frenata asiatica fa tremare tutte le Borse FEDERICO RAMPINI UN tracollo del 32% in tre settimane, 2.500 miliardi di euro di ricchezza distrutta. Il crac della Borsa cinese è un avvertimento serio. Trema paurosamente il mercato finanziario dell’economia che — a seconda delle misurazioni — è la prima o la seconda del mondo. Gli europei occupati dalla loro ossessione monomaniacale sulla Grecia, devono convincersi di non essere l’ombelico del mondo. Può succedere — forse sta iniziando a succedere — qualcosa di ben più grave della Grexit. La ricchezza distrutta in Cina in queste tre settimane, secondo i calcoli dei trader di Hong Kong, vale 11 volte il Pil della Grecia e 6 volte il suo debito pubblico. E in prima linea tra le possibili vittime c’è la più forte economia europea: la Germania, prima esportatrice verso la Cina, e unico paese avanzato a godere di una bilancia commerciale attiva con Pechino, è la più esposta ad una crisi di quel mercato. Se si ammalasse davvero la Cina le conseguenze sarebbero di un ordine di grandezza multiplo rispetto al default greco e le beghe Merkel-Tsipras passerebbero rapidamente in secondo piano. La giornata di panico che ha vissuto ieri il mercato di Shanghai, con il 40% dei titoli sospesi dalle contrattazioni, è giunta al termine di un anno folle. Nei dodici mesi precedenti al 12 giugno quella stessa Borsa aveva più che raddoppiato la sua capitalizzazione. 27 C’erano tutte le caratteristiche di una super-bolla speculativa, con valutazioni folli, irrealistiche soprattutto per le società medio-piccole. Un’aggravante della febbre speculativa cinese: è stata un fenomeno di massa, che ha visto come protagonisti centinaia di milioni di piccoli risparmiatori. Molti dei quali non hanno esitato a speculare a debito, facendosi prestare soldi dalle banche alle quali offrivano come garanzia gli stessi titoli acquistati. Una spirale viziosa, un meccanismo infernale che è antico quanto la storia delle Borse: lo ha descritto tra i primi nel romanzo “Il denaro” lo scrittore francese Emile Zola nel 1891. Tanto più pericolosa, questa speculazione fondata sui debiti, lo diventa se viene adottata con l’entusiasmo dei neofiti nel paese più popoloso del mondo, con 1,3 miliardi di abitanti, un motore trainante della globalizzazione nel XXI secolo. Nel momento in cui la bolla si sgonfia, come sta accadendo nelle ultime tre settimane, le ricadute si possono ramificare in più direzioni, con effetti micidiali. C’è un effetto-ricchezza — al contrario — perché di colpo una quota della popolazione cinese si sente depauperata nei risparmi, e quindi può essere costretta a tagliare i propri consumi. Ci possono essere tensioni sociali e politiche, con risposte imprevedibili da parte di un regime autoritario e di un leader come Xi Jinping che ha accentrato su di sé un potere senza precedenti dai tempi di Deng Xiaoping. Tutto questo può ripercuotersi in ondate di sfiducia nel resto del mondo. Le prime risposte venute dal governo di Pechino non ispirano ottimismo. Proprio per paura del malcontento popolare, il regime sta facendo di tutto per rinviare, rallentare e attutire lo scoppio della bolla. Pessimo atteggiamento perché interferisce con la necessaria operazione di verità e pulizia su un mercato impazzito, lo droga con iniezioni di aiuti pubblici, ne ritarda il risanamento. Pechino ha manovrato tutto l’armamentario dei possibili interventi statali a sostegno della Borsa — come se fosse compito di un governo manipolare i prezzi delle azioni. Ha tagliato in fretta e furia il costo del denaro. Ha spinto i maggiori broker di Shanghai a unirsi e a creare un fondo per l’acquisto di azioni (20 miliardi). Ha finanziato con le riserve della banca centrale questi acquisti. Ha criminalizzato i ribassisti e chi diffonde voci negative. Queste madornali e goffe interferenze creano a loro volta due perversioni. Una si chiama “moral hazard”: se gli speculatori si convincono che il governo li protegge, saranno ancora più scriteriati. L’altro danno è la protratta opacità del sistema finanziario cinese, costruito su bilanci, regole e controlli tutt’altro che affidabili. La finanza ombra è da anni uno dei punti deboli del boom cinese. Ora i nodi vengono al pettine, anche perché si è accumulato un eccesso di investimenti “politici”: cattedrali nel deserto, grandi opere, volute dai potentati locali della nomenclatura comunista, per ragioni di prestigio e di potere, ma spesso fonti di debiti irrecuperabili per il sistema bancario. Il sisma che colpisce la Borsa di Shanghai coincide con un periodo già problematico per la superpotenza dell’Estremo Oriente. La crescita rallenta, quest’anno sarà “solo” del 7% del Pil. Un ritmo fantastico se giudicato con gli occhi degli occidentali, ma un rallentamento netto per un paese che si era abituato a crescere del 10%. La frenata cinese ha già messo in crisi tutto il sistema dei Brics e molti altri paesi emergenti: dall’America latina all’Africa, dal sudest asiatico all’Australia, vaste aree del pianeta si erano agganciate alla Cina vendendole materie prime, minerali, derrate agricole. In Europa l’alta tecnologia tedesca e il lusso made in Italy erano fra i settori beneficiati dal boom cinese. Ora tutti devono rivedere al ribasso gli scenari, almeno per quanto riguarda il traino della domanda che veniva da Oriente. Questo è anche il primo test serio per la leadership di Xi Jinping, un presidente che gli occidentali hanno studiato poco. Un personaggio ben più autoritario dei suoi predecessori. Carismatico, nazionalista, populista. Circondato dall’ammirazione di tanti suoi concittadini, per avere lanciato una vasta campagna anti- corruzione. Ma ora il ceto medio parsimonioso che ha creduto alle favole della ricchezza facile in Borsa, si rivolge verso Xi aspettando il miracolo. 28 del 09/07/15, pag. 12 Marijuana libera anche in Cile Il Sudamerica guida la svolta Filippo Fiorini Il Cile ha fama di essere un Paese conservatore, fino alla settimana scorsa le sale bingo erano considerate attività illegali e dal 2014 è proibito fumare sigarette sotto i portici o mentre si guida. Tuttavia, martedì la Camera ha approvato una legge che permette la coltivazione e il consumo di marijuana per scopi medicinali, ricreativi e addirittura «spirituali». La legge sta facendo molto discutere, ma segna anche una tendenza comune in tutto il Sudamerica: concedere nuove libertà personali e togliere mercato ai narcotrafficanti. Con 68 voti a favore, 39 contrari e 5 astenuti, la norma consente di coltivare fino a sei piante di cannabis, di portarne 10 grammi in tasca e di averne mezzo chilo in casa. Non sarà possibile accendersi uno spinello in pubblico, ma è permesso il consumo ai minorenni, previa ricetta medica e consenso dei genitori. Dopo l’accorato intervento in aula della deputata comunista ed ex leader degli studenti Camila Vallejo, che ha accusato i critici di «ignorare la realtà della strada, dove il consumo alimenta lo spaccio», il fascicolo passerà ora al Senato e la vittoria del «sì» è data per favorita. Il Cile si mette così in scia all’Uruguay, protagonista a fine 2013 della legalizzazione in toto di produzione, vendita e consumo di cannabis, anche se gli intoppi burocratici non hanno ancora visto l’attivazione del sistema. Sulla stessa lunghezza d’onda, c’è anche la Bolivia, dove il presidente ed ex sindacalista della coca, Evo Morales, ha sfidato la comunità internazionale e ha legalizzato il mercato della pianta da cui si ricava la polvere bianca da sniffare detta «cloridrato», ma che qui viene masticata in foglie secche, con gli effetti di una qualsiasi tazza di caffè. Ancor più rilevante, è il caso della Colombia: seconda solo al Perù nella classifica globale dei produttori di coca, la nazione che ha reso celebre la parola «narcos» nel mondo è stata lo storico banco di prova della «Guerra alla Droga», tuttora patrocinata dagli Stati Uniti. Senza risultati soddisfacenti e dopo anni di operazioni militari, il presidente Santos si è detto favorevole all’adozione di politiche più libertarie, che vedono un progetto di legge per legalizzare la cannabis, l’ipotesi di farlo anche con la cocaina e un negoziato con i guerriglieri delle Farc perché distruggano le piantagioni. La tragedia del Messico Se è ancora presto per tirare le somme sull’efficacia delle liberalizzazioni, non si può ignorare la tragedia del Messico, dove è ancora in vigore la strategia di attacco frontale ai banditi della droga: a Sud del Rio Bravo, il traffico d’erba, coca e anfetamine ha portato a uno scenario da guerra civile, in cui sono morte quasi 200 mila persone in 10 anni, cioè più che in Afghanistan. 29 INTERNI Del 9/07/2015, pag. 2 Compravendita senatori Berlusconi condannato: tre anni più l’interdizione Accolta la tesi dei pm:il Cavaliere corruppe De Gregorio Stessa pena per Lavitola,dovranno risarcire Palazzo Madama DARIO DEL PORTO NAPOLI. Silvio Berlusconi comprò un senatore per indebolire il governo Prodi fino a provocarne la caduta. Dopo diciassette mesi di processo e oltre sei ore di camera di consiglio, il tribunale di Napoli ha condannato l’ex Cavaliere a tre anni di reclusione e 5 di interdizione per corruzione. Stessa pena per l’ex direttore ed editore dell’ Avanti! Valter Lavitola. I giudici della prima sezione penale, collegio presieduto da Serena Corleto, hanno dunque accolto la tesi del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e dei pm Henry John Woodcock, Fabrizio Vanorio e Alessandro Milita: i magistrati avevano indagato con il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza sui tre milioni di euro, due dei quali in nero, versati tra il 2006 e il 2008 da Berlusconi, attraverso Lavitola, all’ex senatore Sergio De Gregorio, eletto con Italia dei Valori, poi passato con il centrodestra, con l’obiettivo di condurre «una guerriglia urbana» contro l’esecutivo di centrosinistra che si reggeva su una maggioranza risicatissima. Gli imputati e Forza Italia dovranno anche risarcire il Senato, che si era costituito parte civile in giudizio su impulso del presidente Piero Grasso. «È una sentenza che non ha precedenti - commenta il procuratore Giovanni Colangelo - aspettiamo le motivazioni, ma si stabilisce che non si può fare mercimonio della promessa di voto di un parlamentare. Ringrazio i colleghi per la serenità e la qualità professionale con cui hanno portato avanti il processo ». Di tutt’altro tenore il commento dell’avvocato Niccolò Ghedini, che assiste Berlusconi con l’avvocato Michele Cerabona: «È un verdetto che riteniamo clamorosamente ingiusto e ingiustificato. Anche se il processo si prescriverà il 6 novembre, faremo certamente ricorso in appello. Valuteremo se rinunciare alla prescrizione». «In un paese dove centinaia di parlamentari hanno cambiato casacca, l’unica condanna arriva per Berlusconi. Surreale», twitta Giovanni Toti. Il procuratore aggiunto Piscitelli, nella sua requisitoria, aveva definito l’Operazione libertà «un colossale investimento economico di Berlusconi, ossessionato dal pensiero di mandare a casa il governo Prodi». Nella replica di ieri mattina, l’avvocato Franco Coppi, legale di Forza Italia, con l’avvocato Bruno La Rosa, aveva evidenziato: «La libertà di disporre del mandato come meglio si crede è prevista nell’interesse del parlamentare. Stiamo parlando di atti sottratti al sindacato del giudice penale. La Costituzione garantisce l’immunità a tutte le condotte che si risolvono nel voto». Il pm Woodcock, invece, aveva definito quello tra Berlusconi e De Gregorio (che ha confessato e patteggiato 20 mesi di reclusione) «un contratto illecito basato sulla vile pecunia, un baratto tra i soldi e tutto ciò che rientra nella funzione parlamentare. I motivi politici restano sullo sfondo. Ci sono episodi della storia come il delitto Matteotti e atti rivoluzionari. Chi può negare che vi siano motivi politici? E ciò elide la rilevanza penale? Io dico di no». Alla lettura del dispositivo gli imputati non erano presenti: Lavitola, difeso dall’avvocato Marianna Febbraio e tuttora detenuto, ha rinunciato dopo essere stato colto da un lieve malore, dovuto al grande caldo. Alla notizia, esplode l’ira di Berlusconi: «Processo politico, sentenza assurda». 30 Del 9/07/2015, pag. 14 La scure di Gabrielli sul capo dei burocrati “Ostia, consiglio a casa” Il prefetto chiede la rimozione del direttore generale Iudicello,che lavorò anche con Renzi a Firenze CARLO BONINI ROMA . La Giunta Marino è salva, ma il prezzo che pagheranno la macchina amministrativa del Campidoglio e alcuni dei Municipi della città sarà alto e aprirà una nuova partita tutt’altro che “neutra”, perché politicamente cruenta. Le oltre ottocento pagine della relazione del prefetto Franco Gabrielli consegnate ieri pomeriggio al ministro dell’Interno Angelino Alfano, nell’escludere che ricorrano i presupposti dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e nel fotografare la metastasi di illegalità che si è mangiata la pubblica amministrazione della capitale del Paese, raccomandano infatti nelle loro conclusioni l’immediata rimozione dell’attuale Segretario e Direttore generale del Comune, Liborio Iudicello, il più alto burocrate della città. L’uomo che era stato segretario generale della Provincia di Firenze quando ne era Presidente l’attuale premier Matteo Renzi. Che del presidente del Consiglio e della sua “amicizia” ha spesso fatto vanto, e da allora, quantomeno negli ultimi sette anni, è buono per tutte le stagioni. Quella di Alemanno, che lo aveva voluto come segretario e direttore generale della sua amministrazione. E quindi quella di Marino, in cui era transitato senza alcuno scossone conservando le stesse cariche e dunque il ruolo cruciale di cinghia di trasmissione tra la Giunta e i dipartimenti, gli uffici, le municipalizzate e le società controllate in cui lavorano i 50 mila dipendenti pubblici che conta la città. E di cui la Politica è da sempre ora ostaggio, ora consapevole complice. Né è il solo a pagare, Iudicello. Gabrielli raccomanda che con lui vengano immediatamente sospesi dall’incarico e perseguiti disciplinarmente circa venti tra dirigenti e funzionari attualmente impiegati nei dipartimenti travolti dall’inchiesta “Mafia Capitale” (tra loro, per dire, quel Walter Politano indagato dalla Procura e che Marino aveva nominato responsabile dell’anticorruzione): il Dipartimento Tutela e Ambiente, quello delle Politiche sociali e Migranti e quello per le Politiche abitative. E ancora: il prefetto sollecita l’immediato annullamento di numerosi affidamenti che vedono protagoniste municipalizzate e società controllate dal Comune: Ama, Ente Eur, Multiservizi, Marco Polo. Oltre alla sospensione di alcuni dei loro dirigenti e funzionari. Gabrielli sollecita infine lo scioglimento del Municipio di Ostia, già commissariato dal Comune con l’assessore alla legalità Alfonso Sabella dopo le dimissioni imposte dal Pd nel marzo scorso del suo presidente Andrea Tassone (poi arrestato), e quello di almeno altri due Municipi in cui si sono già manifestate o dovessero manifestarsi situazioni patologiche, con l’insediamento di viceprefetti quali commissari. Nel ricevere la relazione, Alfano ha annunciato che non consumerà i tre mesi, che pure la legge gli concede, per decidere se aderire o meno, ovvero in tutto o in parte, alle conclusioni del prefetto di Roma. Entro la fine del mese, insomma, la pratica dovrebbe arrivare alla discussione in Consiglio dei Ministri e, solo a quel punto, Alfano firmerà i decreti di immediata rimozione dei dirigenti e funzionari pubblici individuati da Gabrielli (e dalla relazione della Commissione prefettizia di accesso agli atti insediata dal precedente prefetto Pecoraro) come ostacolo al ritorno ad una fisiologica e trasparente attività amministrativa. E con loro disporrà lo scioglimento dei Muncipi inquinati. Le norme 31 richiamata dal prefetto nella sua relazione al Ministro dell’interno sono infatti «l’articolo 143 comma quinto del Testo Unico di Legge sugli Enti Locali» e l’articolo 146 (norma finale del testo di legge) che estende i poteri di rimozione e scioglimento del Ministro dell’Interno dai singoli funzionari e dirigenti dell’amministrazione pubblica a interi consigli Municipali e alle «aziende speciali degli enti locali ». Nell’articolo 143 si legge infatti che «Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di inquinamento o condizionamento mafioso con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente ». È evidente che non tutte le teste che rotoleranno faranno lo stesso rumore. Ma il “sacrificio” di Iudiciello non sembra impensierire più di tanto il Pd e Palazzo Chigi. Perché – si lascia intendere – l’uomo era già finito “da tempo” dietro la lavagna del commissario del partito a Roma Matteo Orfini, convinto che fosse uno dei «problemi da risolvere » in Campidoglio. Al punto che, nel marzo scorso, se ne era tentato inutilmente lo spostamento a commissario straordinario del debito capitolino e che, da alcune settimane il sindaco Marino aveva annunciato un bando per la ricerca di un city manager che di Iudicello assumesse le deleghe di segretario generale. Bisognerà capire ora come la prenderà l’interessato. Che resta pur sempre il custode dei segreti di sette anni di amministrazione. Del 9/07/2015, pag. 16 Il personaggio L’atto d’accusa dei pm: con lui al potere i Ds milanesi subiscono una metamorfosi Da assessore comunale a ras delle dazioni così Penati ha costruito il “sistema Sesto” SANDRO DE RICCARDIS MILANO. Non è soltanto una storia di presunte tangenti e appalti truccati. L’inchiesta sul “Sistema Sesto”, arrivata alla requisitoria del pm che ha chiesto la condanna a quattro anni per Filippo Penati, racconta anche la metamorfosi di un sistema politico. Che passa come ha detto il pm di Monza Franca Macchia- da un «finanziamento di matrice personalistica a un finanziamento di sistema». A tenere insieme «le buste di soldi » che la segretaria del grande accusatore, Piero Di Caterina, ha raccontato di preparare già negli anni ‘90, con i più raffinati sistemi di pagamento di fine anni 2000, come i soldi alla fondazione “Fare metropoli” o nelle società off-shore dell’architetto Sarno, è la stessa storia di Filippo Penati, per come è ricostruita nell’indagine. Dopo anni da assessore al comune di Sesto San Giovanni, la ex Stalingrado d’Italia, nel 1994 Penati diventa sindaco e nel 2001 segretario metropolitano dei Ds. Nel 2004 sconfigge Ombretta Colli alle elezioni alla provincia di Milano e diventa l’unico rappresentante del centrosinistra in un territorio dominato dal berlusconismo. All’ascesa nelle istituzioni corrisponde quella nel partito, negli organi nazionali di Ds, Ulivo, Pd. E in questa scalata, sostengono ora i magistrati, si distingue per una capacità già allora 32 fondamentale in politica: intercettare finanziamenti. «Penati è lanciato nel partito, spicca la sua qualità di uomo di finanza - dice in aula il pm - . Gli viene dato l’incarico di risanatore finanziario. Il partito aveva bisogno di lui». In un’indagine lunga quasi cinque anni, di cosa si sono convinti gli inquirenti? «La storia di Penati dimostra che la sua capacità di finanziamento è crescente: passa da Di Caterina, dai quei finanziamenti di natura personalistica, e la consolida nelle altre campagne, quando da politico più importante allarga il suo finanziamento illecito. Finché non troviamo tra i finanziatori di “Fare metropoli” anche le banche. Il suo è diventato un “finanziamento di sistema” ». I SOLDI NELLE BUSTE In origine c’è dunque Di Caterina, l’imprenditore del trasporto locale di Sesto che con le sue accuse dà il via all’indagine, seguito poi dal costruttore Giuseppe Pasini. Dice di aver finanziato Penati con 3,5 milioni di euro. Ed è la sua più stretta collaboratrice, Giulia Limonta, a confermare in udienza i pagamenti. «Di Caterina mi dava i contanti e mi diceva di preparare le buste coi soldi - ha svelato la donna - . Erano a volte da duemila euro, a volte da cinque o diecimila. Una volta, da cinquantamila. Sulle buste erano indicati i nomi di battesimo del destinatario. Le ho preparate tantissime volte. E per tre, quattro o cinque volte le ho portate nella sala riunioni della nostra azienda, quando Di Caterina era con Penati». Negli stessi anni, Pasini è alle prese con la riqualificazione delle aree Falck, le industrie siderurgiche di Sesto. Racconta di aver pagato, nel 2000, tre miliardi di lire all’estero perché «quando ho chiesto a Penati se, nel caso avessi comprato le Falck, era possibile arrivare a una licenza, mi disse che avrei dovuto dare qualcosa al partito». E i pm, trovano le tracce del denaro in Lussemburgo, dove Pasini si autobonifica il denaro sul conto “Pinocchio”. Soldi poi rientrati, anche in contanti, in Italia. «Ci è stato impedito ogni accertamento sulle vicende Falck – ha sempre ricordato il pm – l’imputato si è avvalso della prescrizione ». “PATTO CORRUTTIVO GAVIO-PENATI” Quando Di Caterina è ormai spremuto e minaccia di parlare, Penati chiede l’intervento di Bruno Binasco, gruppo Gavio, per far arrivare all’imprenditore due milioni attraverso la caparra di una finta compravendita. Ma perche Binasco si presta a pagare, attraverso Codelfa, quei soldi? la procura parla di un «patto corruttivo » e ricollegano la dazione agli extracosti garantiti poco prima da Serravalle, società della Provincia, a Gavio nell’appalto della terza corsia A7: 14 milioni in più (di cui hanno chiesto confisca) al privato, rispetto ai 4,4 indicati da Anas. SARNO SOSTITUISCE DI CATERINA Ma, dice la procura, il sistema di finanziamento si perfeziona quando, al posto di Di Caterina, compare l’architetto Renato Sarno, considerato il «collettore delle tangenti» per Penati. I pm scoprono nel suo pc il file coi versamenti alla fondazione culturale di Penati “Fare metropoli”. Un «mero schermo per occultare la destinazione di illeciti finanziamenti elettorali a Penati», candidato alle Provinciali 2009 e alle Regionali 2010. La lista dei finanziatori rivela la nuova rete di relazioni: Lega delle cooperative, società che lavorano per Serravalle, come Tubosider e Gavio; banche come la Popolare di Milano di Massimo Ponzellini e la Banca di Legnano; gli imprenditori Enrico Intini e Roberto De Santis, vicini al Pd pugliese e a Massimo D’Alema. Per i pm Sarno gestisce «la contabilità occulta di tangenti e finanziamenti illeciti per circa 5,3 milioni tra Svizzera, Londra e strutture off shore». Di questi, solo la metà rientrano sui conti dell’architetto. «Se Penati - accusa il pm - ha soldi all’estero o li ha dati tutti ai Ds, noi non lo sappiamo. Ma sappiamo che Sarno è l’uomo dell’ operatività finanziaria di Penati e solo l’architetto avrebbe potuto dirci dove sono andati quei soldi. Ma non l’ha fatto». 33 LEGALITA’DEMOCRATICA del 09/07/15, pag. 12 “Se scrivi ti ammazzo” Le mafie odiano i cronisti Oltre 2.300 intimidazioni dal 2006, almeno 30 giornalisti vivono sotto scorta di Tommaso Rodano L’ultimo giornalista minacciato dalla criminalità organizzata si chiama Nello Trocchia. Il cronista campano lavora per il Fatto Quotidiano, l’Espresso e La Gabbia di La 7. Trocchia è un giornalista giovane e versatile: si occupa di politica, cronaca e inchieste; in televisione, in Rete e sulla carta stampata. Ha scritto e scrive anche di camorra: il suo primo libro – Federalismo Criminale (che ha dedicato al collega Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra) – racconta le storie dei Comuni sciolti per mafia e spiega la capacità del crimine organizzato di infiltrarsi e divorare le istituzioni. Qualche vigliacco ha giurato di fargliela pagare: il nome di Trocchia è citato in una conversazione intercettata tra due malavitosi, in cui un boss condannato per camorra dice di volergli “spaccare il cranio”. Una minaccia esplicita, a cui non ha ancora fatto seguito l’emissione di un dispositivo di sicurezza per tutelare il giornalista: l’intercettazione è stata registrata il 10 giugno e trasmessa alla Procura antimafia di Napoli, ma in un mese non è stata presa nessuna misura di protezione. Il nome di Trocchia si aggiunge a una lista che continua a crescere. Nell’elenco ci sono giornalisti di fama nazionale. Il caso più noto è quello di Roberto Saviano, “condannato a morte” dai Casalesi dopo lo straordinario successo editoriale di Gomorra. Lo scrittore napoletano vive sotto protezione da nove anni. Il numero esatto di giornalisti scortati non è noto: secondo le stime sarebbero non meno di 30 e non più di 50. Tra di loro c’è anche Sandro Ruotolo, lo storico collaboratore di Michele Santoro. Anche in questo caso la minaccia arriva dai Casalesi, che dimostrano di essere terrorizzati dagli uomini liberi. Il boss Michele Zagaria, intercettato in carcere, ha detto di Ruotolo ‘O vogl’ squartat’ viv’, “lo voglio squartato vivo”. Il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, ha ordinato la scorta per il giornalista. Come lui anche Federica Angeli, la cronista di Repubblica che ha subito le minacce della mafia di Ostia, di cui ha raccontato gli affari senza reticenze. O Lirio Abbate, storica firma della cronaca giudiziaria de l’Espresso, che vive sotto protezione da ben otto anni. Ma i giornalisti costretti alla scorta non lavorano solo nei quotidiani e nelle riviste nazionali. Giovanni Tizian, da cronista giovane e precario, ha raccontato le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia Romagna sulle colonne della Gazzetta di Modena. Nicola Femia, uno degli imprenditori accusati di collusioni con la criminalità organizzata, è stato intercettato mentre si lamentava del lavoro del giornalista assieme a un suo sodale: “O la smette o gli sparo in bocca e finita lì”. Scrive su un giornale locale anche Michele Albanese, cronista del Quotidiano del Sud. È l’uomo che ha fatto lo scoop, tra gli altri, sull’inchino della statua della Madonna delle Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti a Oppido Mamertina. I suoi articoli gli sono costati una tutela di terzo livello: Albanese è sotto scorta dall’estate del 2014. 34 L’elenco è molto più lungo: non tutti i giornalisti che subiscono soprusi e intimidazioni, peraltro, godono del “privilegio” della protezione. Molti di loro lavorano nell’ombra, tantissimi sono precari. Non ci sono soltanto le minacce fisiche: lo strumento preferito di chi vuole impedire che una notizia sia raccontata è la querela, specie nei confronti di chi non ha la possibilità di garantirsi una tutela legale all’altezza. L’associazione “Ossigeno per l’informazione” da anni tiene la “contabilità” delle violenze, fisiche e verbali, e degli abusi giudiziari a cui è sottoposta la professione che avrebbe il compito di informare l’opinione pubblica. I numeri sono impressionanti: dal 2006 al giugno 2015 i giornalisti minacciati in Italia, sotto varie forme, sono 2351. L’annus horribilis è stato il 2014, con addirittura 506 intimidazioni, ma anche il 2015 si difende bene. Nei primi sei mesi dell’anno in corso le violenze sono già arrivate a quota 206. La parte del leone la fanno le denunce e le azioni legali: 102. Quindici i danneggiamenti, 54 gli avvertimenti, 28 le aggressioni. del 09/07/15, pag. 12 Chi ama il suo lavoro non ha paura di nulla di Nello Trocchia | Quando ho saputo delle minacce, ho avuto una sola idea: continuare a fare il mio mestiere, con lo stesso impegno. Nulla più. Penso ai cronisti che lavorano nei territori divorati dalle mafie, non solo al Mezzogiorno, spesso sottopagati e precari. Non subiscono solamente intimidazioni, ma querele temerarie e richieste di risarcimenti. Il combinato delle minacce e delle querele rappresenta una nuova mordacchia, un macigno sulla libertà d’informazione. Tutto ciò che possiamo fare – ripeto – è lavorare con passione. Le borghesie mafiose e le organizzazioni criminali in genere sono una zavorra insopportabile per il sud e per l’intero Paese. Un’emergenza che dura da troppi anni. Per combattere le mafie e la zona grigia del potere serve il contributo di tutti. I giornalisti hanno una responsabilità fondamentale: ce ne sono tanti che raccontano i fatti di mafia, i processi dove sfilano i politici conniventi e gli imprenditori contigui al potere criminale; che denunciano l’affarismo che porta a investire fuori dalle Regioni a tradizionale presenza mafiosa attraverso teste di legno e prestanome. Ma anche la politica può e deve fare molto. La solidarietà fa piacere, ma senza un impegno concreto diventa stucchevole. Troppo spesso nella composizione delle liste elettorali non si sceglie la strada dell’etica pubblica, ma si seleziona la classe dirigente sulla base dei pacchetti di voti, ignorando contiguità e vicinanze. Da cittadino campano per me è ancora più importante continuare a denunciare gli affari del potere criminale anche nel grande business delle bonifiche che si muove attorno ad alcune aree martoriate della mia Regione, dove negli anni sono state smaltite tonnellate di rifiuti tossici. Continuerò a fare il mio lavoro come prima, ma serve davvero la partecipazione di tutti. Non sono accettate deleghe: si vincono le mafie solo con il contributo di ognuno di noi, attraverso il proprio lavoro quotidiano. 35 WELFARE E SOCIETA’ del 09/07/15, pag. 6 I poveri di Renzi e Boeri Pensionati. Secondo il rapporto Inps sul 2014, la metà degli over 65 vive con meno di 700 euro al mese. E sotto i 500 euro ci sono soprattutto donne. La crisi per gli anziani non è mai finita e per loro non arriva mai la stagione degli aumenti. Ispezioni sul lavoro: ben l’81% delle aziende è irregolare Un’italia che non riesce a liberarsi dalla crisi, e che anzi vede numeri sulla povertà sempre più preoccupanti: il rapporto Inps sul 2014, presentato ieri dal presidente Tito Boeri, è una sfilza di cifre raggelanti. Ben 1,9 milioni di pensionati percepiscono assegni medi mensili sotto i 300 euro, per l’esattezza 286,9 euro, mentre ammontano a 4,7 milioni quelli la cui pensione media non supera i 700 euro mensili. Complessivamente un’esercito di 6,6 milioni di persone, il 42,5% del totale, dunque, non arriva a 700 euro. L’Inps accende un faro più generale sulla povertà, visto che eroga anche istituti come la cassa integrazione, e non a caso ieri Boeri ha ribadito l’idea di pensare a un ammortizzatore speciale dedicato agli over 55 che hanno perso il lavoro, ancora troppo lontani dal pernsionamento. La crisi che dal 2008 ha falcidiato il Paese ha infatti lasciato dietro di sé una lunga scia di povertà aggravando e peggiorando le condizioni dei più deboli, perciò servirebbero interventi speciali, mirati sulle vittime della crisi. In cinque anni la quota totale di persone povere, spiegano all’Inps, è aumentata del 7% fino a raggiungere il 25% della popolazione, ovvero 15 milioni di persone. Non solo. Il 10% più povero della popolazione ha sperimentato, tra il 2008 e il 2013, una contrazione reale del proprio reddito vicino al 30% mentre, nello stesso periodo, la diseguaglianza dei redditi è cresciuta a tassi sostenuti, con un incremento dell’indice relativo pari al 39% tra il 2008 e il 2013 (da 0,21 nel 2008 a 0,32 nel 2013). Un trend, questo, che si intreccia con l’andamento dell’occupazione — la crisi ha lasciato sul terreno dal 2008 al 2014 circa 800 mila posti di lavoro — ma soprattutto con il «forte, prolungato aumento della disoccupazione». È tra i disoccupati che il rischio di povertà è aumentato: in particolare tra gli over 50, il cui numero dei senza lavoro è triplicato nell’arco di 6 anni. E se la povertà aumenta, i dati sono purtroppo molto più pesanti per le donne: le pensionate sono ben lontane dalla parità di genere, visto che la discontinuità della loro vita lavorativa assegna una concentrazione maggiore nelle classi di importo più basso e una progressiva riduzione del loro peso al crescere dell’assegno. Tra le pensioni sotto sotto i 500 euro, ben il 62,6%, sono femminili contro il 37,4% degli uomini; e oltre i 3 mila euro, soltanto 1 pensionato su 4 è donna. E se parliamo di pensioni alte non possiamo non citare quelle dei magistrati: tra i lavoratori pubblici sono infatti questi ultimi a percepire l’assegno previdenziale più alto, pari a 9.573 euro lordi medi mensili. Segue l’Università con 3.565 euro medi mensili e le Forze armate con oltre 3 mila euro. Ma l’Inps è anche uno degli istituti che compie le ispezioni sui luoghi di lavoro: nel 2014 ne ha fatte oltre 58 mila, registrando irregolarità nell’81% delle aziende (oltre 47 mila). Si è ridotto il numero delle ispezioni rispetto al 2013 (-19,2%) ma i controlli, secondo l’Inps, sono stati più mirati, portando a un accertamento lordo (comprese le prestazioni indebite 36 annullate) per 1,3 miliardi (+5,8% sul 2013). Nel complesso sono stati scoperti oltre 77 mila lavoratori in posizione irregolare (erano 86.499 nel 2013). Infine Boeri ha commentato in dati sul bilancio (in rosso) dell’Inps: nel 2014 l’istituto ha avuto un risultato economico di esercizio negativo per 12,7 miliardi e un disavanzo finanziario di competenza di 7,8 miliardi La sostenibilità del sistema però, sempre secondo l’Inps, «non è a rischio». Il patrimonio netto è salito da 9,028 a 17,952 miliardi grazie al ripianamento dei debiti verso lo Stato dell’ex Inpdap di 21,7 miliardi. In passivo per 6 miliardi il comparto ex Inpdap, per 5–6 la gestione degli artigiani e per 1 quella dei commercianti. Contro le proposte di Boeri si è scatenato un vespaio di polemiche, provenienti anche dalla maggioranza. Secondo Renato Brunetta (Fi) «deve smetterla di fare il ministro ombra». Per Cesare Damiano (Pd) «il ruolo legislativo spetta all’esecutivo e alle Camere: e va ricordato che il governo Prodi aveva istituito la quattordicesima per i pensionati sotto i 700 euro». L’M5S è contrario a dare un «reddito di cittadinanza» solo agli over 55. 37 INFORMAZIONE del 09/07/15, pag. 15 Il governo tratta. Così cambia la riforma Rai Maggiori poteri a Vigilanza e consiglio di amministrazione. Giacomelli: cogliamo i frutti del dialogo ROMA La riforma della Rai voluta da Matteo Renzi procede ma cambia rispetto al testo originario del disegno di legge presentato dal governo all’inizio di aprile. Oggi la commissione Lavori pubblici del Senato dovrebbe licenziare il testo destinato ad approdare in aula a Palazzo Madama dopo il 15 luglio per il dibattito e il voto. Per la Camera, a meno che Matteo Renzi non decida per un corridoio preferenziale, si slitterà a settembre con una proroga estiva del consiglio scaduto, con Anna Maria Tarantola presidente e Luigi Gubitosi direttore generale (ma c’è sempre chi non esclude un rinnovo urgente con l’attuale legge Gasparri). «Come annunciato, il governo sulla riforma della Rai sta percorrendo fino in fondo il percorso parlamentare ascoltando i suggerimenti di tutta l’opposizione per migliorare il testo: ora stiamo raccogliendo i frutti di questa scelta», dice il sottosegretario Angelo Giacomelli commentando i voti nella commissione Lavori pubblici del Senato. Per il governo i tre piloni della riforma (ampi poteri all’amministratore delegato, nomina del consiglio di amministrazione sottratta alla Vigilanza e quindi ai patteggiamenti, Rai considerata una «normale» società per azioni) sono salvaguardati e il confronto con le opposizioni non ha modificato la struttura fondamentale del disegno. Ma c’è molta soddisfazione anche da Forza Italia per i risultati ottenuti nel voto agli emendamenti presentati. Per un tipico contrappasso politico italiano, è stato proprio Maurizio Gasparri (titolare di quella legge che il disegno di legge del governo vuole modificare) a presentare con Augusto Minzolini (ex direttore del Tg1) l’emendamento, poi approvato, che prevede una novità per il presidente nominato dal consiglio di amministrazione: dovrà essere sottoposto al voto della commissione di Vigilanza e solo il sì dei due terzi renderà efficace la sua nomina. Nel testo originario il passaggio non era previsto. Commenta proprio Gasparri: «Si ribadiscono due principi contenuti nella legge vigente, cioè la funzione di controllo del Parlamento e della Vigilanza più volte ribadita dalla Corte costituzionale, e la funzione di garanzia del presidente della Rai che non potrà essere espressione di una semplice maggioranza parlamentare. L’impianto della legge Gasparri resta in vigore». Sempre un subemendamento di Gasparri all’emendamento dei relatori prevede che l’amministratore delegato, quando procederà alle nomine (reti in chiaro, canali digitali, tg) dovrà acquisire il parere «obbligatorio» del consiglio di amministrazione che diventa «vincolante» se sarà espresso a maggioranza dei due terzi. In due parole: se due terzi del consiglio di amministrazione dovesse bocciare una nomina, l’amministratore delegato dovrà ritirarla. Un ulteriore emendamento Gasparri-Minzolini prevede che le linee editoriali e le direttive di programmazione vengano non solo «adottate» ma anche «formulate» dal consiglio di amministrazione. Oggi riunione definitiva in commissione Lavori pubblici. Ottimista il correlatore Enrico Buemi del Psi (con Raffaele Ranucci, Pd): «Dovremmo riuscire a chiudere nel pomeriggio». Molto critico il Pd Michele Anzaldi: «Se dirigenti e direttori sono ancora scelti dal consiglio di amministrazione, nominato a maggioranza da Parlamento, i partiti continuano a lottizzare la tv pubblica». Il disegno di legge prevede sette consiglieri: due 38 votati dalla Camera, due dal Senato, due dal governo (tra loro l’amministratore delegato) e uno dai dipendenti Rai. Paolo Conti del 09/07/15, pag. 6 La riforma Rai si tinge sempre più di azzurro Servizio pubblico. Torna il 'presidente di garanzia', stempera i poter dell’amministratore delegato, meno poteri al «capo azienda» voluto da Renzi, rafforzato il consiglio d’amministrazione. Accolti gli emendamenti forzisti, in vista di un aiuto sulle riforme costituzionali Micaela Bongi Chi si rivede, il «presidente di garanzia». La commissione lavori pubblici del senato, dove è in discussione la riforma Rai, approva l’emendamento firmato da Maurizio Gasparri in base al quale la nomina del presidente della tv pubblica dovrà essere ratificata dai due terzi della commissione parlamentare di vigilanza. Come avviene nella attuale legge, che porta la firma proprio di Gasparri. Altro subemendamento approvato ieri, sempre firmato Gasparri, stempera i poter dell’amministratore delegato, il «capo azienda» voluto da Renzi, rafforzando quelli del consiglio d’amministrazione, sulle nomine dei direttori. In base a un emendamento dei relatori, sulla scelta dei dirigenti apicali — direttori di canale, rete e testata — l’ad dovrà acquisire il parere obbligatorio del cda. Con la modifica di Fi si stabilisce che il parere, se è espresso dai due terzi del cda, diventa vincolante. E un altro emendamento ancora di Gasparri e Minzolini, approvato, dice che le linee editoriali e le direttive sulla programmazione sono non solo adottate, ma anche formulate dal cda. «Come annunciato, il governo sta seguendo il percorso parlamentare ascoltando i suggerimenti di tutta l’opposizione: ora stiamo raccogliendo i frutti di questa scelta», sottolinea il sottosegretario alle comunicazioni Antonio Giacomelli. E in effetti che Forza Italia avrebbe dato una mano sulla «riforma» (non per generosità: in cambio della nomina di una presidente gradita a Silvio Berlusconi, Luisa Todini) lo aveva scritto nei giorni scorsi il Corriere della sera. A ciò va aggiunto che Renzi ha bisogno di aiuto anche sulla riforme istituzionali, vecchia storia, dunque. Non è detto, comunque, che tutto filerà liscio fino alla nomina dei vertici Rai con la «nuova» legge. Il sottosegretario prevede un paio di settimane per il via libera del senato. Poi toccherà alla camera ma servirebbe una corsia preferenziale per andare spediti e evitare il rinvio a settembre e una lunga proroga del cda scaduto. Insomma, si torna a ipotizzare il rinnovo del consiglio con la Gasparri. Del resto, la «riforma Renzi» già somigliava molto alla legge attuale. E ancora di più grazie ai «suggerimenti» forzisti accolti ieri, con altri in arrivo nei prossimi giorni. (mi.b.) del 09/07/15, pag. 6 Radio città futura in sciopero Che ne sarà di Radio città futura? E’ questa la domanda che si pongono i lavoratori dell’emittente romana nata negli anni ’70. 39 La radio sta vivendo una delle più gravi crisi della sua storia: da cinque mesi tutti i lavoratori sono senza stipendio. Eppure finora non hanno mai fatto mancare l’impegno garantendo la messa in onda delle trasmissioni e il normale funzionamento della Radio. Di fronte al prolungarsi di questa situazione i giornalisti di Radio città futura hanno deciso di indire per il 9 luglio una giornata di sciopero, per denunciare una situazione che sta diventando insostenibile sia per la progressiva riduzione del fondo editoria, sia per la mancanza di risposte da parte dell’azienda, che continua a ribadire di non voler far ricorso a nessun tipo di ammortizzatore sociale. I 97.7 in FM di Radio città futura rischiano insomma di spegnersi. Per evitare che una testata storica sia costretta alla chiusura, i giornalisti hanno deciso lo sciopero. Per alzare la voce, per evitare un silenzio che rischia di diventare assordante. 40 SCUOLA, INFANZIA E GIOVANI del 09/07/15, pag. 6 Scuola, oggi voto finale alla Camera, ma la legge finirà in tribunale No Ddl Scuola. L'ipotesi di ricorso alla Consulta per l'incostituzionalità, i ricorsi per i precari. E Civati lancia un referendum abrogrativo della Roberto Ciccarelli ROMA Sono almeno tre le strade che l’opposizione alla riforma della scuola prenderà dopo che il Ddl sarà votato oggi in maniera definitiva dalla Camera. In maniera unitaria, tutti i sindacati della scuola ricorreranno alla Corte costituzionale contro i profili di incostituzionalità contenuti nella chiamata diretta dei docenti da parte dei «presidi manager» imposti da Renzi, Giannini e il partito Democratico. La via giudiziaria non si ferma qui perché, da settembre il Miur sarà travolto da migliaia di ricorsi volti a garantire in tribunale i diritti dei docenti precari aventi diritti ma esclusi dalla maxi stabilizzazione di oltre 102 mila persone. Sarà una strada lunga, ma le sigle intendono così affrontare la situazione dei docenti di seconda fascia nelle graduatorie di istituto e dei diplomati magistrali che non sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. La terza strada è quella del referendum abrogativo. Questa opzione presenta numerose difficoltà e insidie e i sindacati della scuola ne sono perfettamente al corrente. Innanzitutto il quesito da sottoporre agli elettori. Poi le firme da raccogliere, mentre la legge sarà entrata in vigore. Infine il quorum da raggiungere in una consultazione che potrebbe essere chiamata quando saranno passati mesi o addirittura anni dall’approvazione della legge. Il referendum abrogativo è un’ipotesi che ricorre tra le numerose componenti del movimento della scuola (Il manifesto, 30 giugno). Ieri Pippo Civati ne ha lanciato uno dal suo blog «Ciwati». La complicata materia referendaria sarà affrontata con un solo quesito sulla «chiamata diretta». In realtà di punti incostituzionali ce ne sarebbe almeno altri sei o sette, a partire dagli albi territoriali, come qualcuno dei commentatori dello stesso blog ha fatto notare. Civati ha scelto la «chiamata diretta» perché è la «norma-bandiera» della contro-riforma Renzi-Giannini. Si vedrà in autunno dove in molti stanno meditando di presentare una gragnuola di referendum abrogativi contro le principali leggi approvate dal governo Renzi: dal Jobs Act allo Sblocca Italia. In questo pacchetto la scuola rischia di scomparire, come del resto anche le altre istanze.Quanto ai sindacati, sarà necessario perlomeno contare sulla loro partecipazione, anche per eliminare una crescente sensazione di confusione tra istanze e proposte che rischiano di sovrapporsi. L’opposizione dei docenti — nelle piazze, sui social network — resta fortissima anche in piena estate. Ieri, la loro indignazione è esplosa in rete quando la ministra dell’Istruzione Stefania Giannini ha ritenuto opportuno caricare sul suoscarno profilo facebook il video del discorso tenuto alla Camera sulla riforma. Il profilo, che è stato aperto con l’auspicio di un confronto tardivo e infelice con il «mondo della scuola», è stato travolto nelle prime otto ore da circa 400 commenti. In pochi minuti la bacheca si è trasformata in un rodeo di insulti, invettive, accuse al partito democratico. Un altro caso disastroso di comunicazione del governo Renzi. Su tutti questo commento: «Esigua ministra nel caso avesse l’impressione che con oggi 7 luglio possa considerarsi chiusa la questione perché si 41 sbaglia di grosso; gli insegnanti non dimenticheranno mai la violenza perpetrata da questo governicchio di non eletti sulla scuola». Giannini non ha ancora risposto a nessuno ma in compenso ha detto: «Non facciamo riforme per placare le proteste». Una frase inopportuna presa alla lettera dai docenti. Dalle 10 di oggi il presidio dei sindacati a Montecitorio. 42 CULTURA E SPETTACOLO Del 9/07/2015, pag. XI RM “Meno soldi ma più pubblico” Federculture, rapporto sulla crisi SARA GRATTOGGI DA un lato la ripresa dei musei civici, che dopo il brusco calo del 12% nel biennio 20122013, lo scorso anno hanno registrato il 5% di visitatori in più (così come gli statali). Dall’altro, invece, la continua diminuzione della spesa per la cultura del Comune, passata dal 4,5% del bilancio nel 2010 al 2,4% del 2014. Sono i dati che emergono dal rapporto 2015 di Federculture, presentato ieri dal presidente, Roberto Grossi, alla presenza del ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, e del direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi. Il confronto con le altre città italiane vede Roma in coda alla classifica per gli investimenti in cultura (sotto c’è solo Napoli) con 55,7 euro per cittadino. Mentre, ad esempio, il comune di Firenze destina al settore il 9% del bilancio (182,9 euro per abitante) e quello di Milano il 2,9% (139,2 euro per cittadino). Nonostante gli scarsi investimenti, il sistema museale civico è riuscito a totalizzare nel 2014 1,5 milioni di ingressi, +116% rispetto al 2000. La crescita ha riguardato tutti i musei: dal Macro (che nel 2013 aveva visto i visitatori dimezzarsi, ma ora ha recuperato con un +49%) ai Capitolini. Una tendenza registrata anche nei musei e monumenti statali del Lazio ( ad eccezione di Palazzo Barberini), che complessivamente nel 2014 hanno avuto 18,5 milioni di visitatori (di cui 15,7 solo a Roma) e 58 milioni di introiti (+ 6%), di cui oltre 54 nella capitale. In linea con la ripresa dei consumi culturali registrata anche a livello nazionale. Eppure, allargando l’orizzonte, si rileva “una distanza ampia fra Roma e le altre capitali internazionali, i cui tre musei principali ogni anno attraggono oltre 10 milioni di visitatori, mentre quelli romani ( aree archeologiche escluse) si fermano a circa 2 milioni”. E non va meglio per le mostre temporanee: le 10 principali realizzate nella capitale nel 2014 hanno avuto 714.480 visitatori, contro gli oltre 3 milioni di quelle di Londra e Parigi e i quasi 5 di quelle di New York. Buoni, invece, i dati sul turismo: nel 2014 a Roma gli arrivi (oltre 13 milioni) e le presenze (quasi 33 milioni) sono aumentati del 6 e del 5%. Anche se, conclude il rapporto, la Città Eterna “risulta comunque meno attrattiva e competitiva” rispetto ad altre capitali europee. A livello generale, Grossi ha sottolineato l’esigenza di “investire nella ricerca e nella produzione culturale” e ha lanciato diverse proposte: dalla creazione di una piattaforma di crowdfunding unica per la cultura (visti gli scarsi risultati ottenuti, ad esempio, per la Domus Aurea) all’introduzione di standard di qualità. del 09/07/15, pag. 1 (Roma) Roma investe troppo poco nella Cultura, ma i musei civici raddoppiano gli ingressi Federculture: più 5% negli statali, con 18,5 milioni di presenze 43 Fondi per la cultura: Roma si posiziona dopo Firenze, Bologna, Milano e Torino. Tra le città d’arte è quella che investe meno in cultura, la spesa procapite dell’amministrazione comunale è di 55, 50 euro, contro i 182,90 di Firenze, i 139,20 di Milano, gli 84,20 di Bologna, i 61,30 di Torino. Peggio fanno Genova con 47,60 e Napoli con 16,70. Nel 2014 la spesa per la cultura è stata il 2,4% del bilancio comunale. Questi dati arrivano dal rapporto annuale di Federculture, presentato ieri nel conservatorio di Santa Cecilia dal presidente Roberto Grossi, con il ministro dei beni Culturali e Turismo, Dario Franceschini. Il volume dal titolo «Cultura, identità, innovazione la sfida del futuro» ha la prefazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma se a Roma si investe poco sulla cultura, l’interesse della gente va nel segno assolutamente opposto: i musei civici romani hanno raddoppiato gli ingressi, per tutte le strutture museali romani lo scorso è stato un anno particolarmente felice, soprattutto se raffrontato con quello precedente. Volendo dare dei numeri: nel 2000 avevano visitato i musei comunali 700.308 persone, lo scorso anno sono state 1.513,466, con un aumento del 116%, in questo modo si è recuperato il brusco calo del bienno precedente che si era attestato intorno al 12% in meno. Per esempio i musei Capitolini che nel 2013 perdevano il 9% di visitatori, lo scorso anno hanno visto un incremento del 7%; ancora meglio ha fatto il Macro, i cui visitatori nel 2013 erano più che dimezzati con meno 52%, nel 2014 hanno recuperato ampliamente con una crescita degli ingressi del 49%. In generale a Roma e nel Lazio sono cresciuti i visitatori, sia nei musei statali sia nei civici. Per quanto riguarda le strutture statali i visitatori lo scorso anno sono stati oltre 18,5 milioni, il 5% in più dell’anno precedente. E con l’aumento degli ingressi sono aumentati anche gli introiti: con oltre 58 milioni di euro, in crescita del 6,3%. Buone notizie almeno sul piano nazionale, anche se lo stesso rapporto segnala che la Capitale è meno attrattiva e meno competitiva rispetto alle principali capitali europee. Il ministro Franceschini coglie l’occasione per replicare alle polemiche sulla «Medea», in scena al Colosseo. «È un caso in cui tutela e valorizzazione coincidono, perché il monumento sarà protetto durante la rappresentazione aperta al numero giusto di persone. Ma la Rai mostrerà a tutto il mondo uno spettacolo unico». Maria Rosaria Spadaccino del 09/07/15, pag. 17 INTERVISTA RICCARDO TOZZI PRESIDENTE ANICA «Il cinema italiano è in declino» Più presenze in sala, ma la quota made in Italy è in caduta libera milano «Il cinema italiano non sta andando bene. Bisogna partire con serietà da questa consapevolezza, altrimenti le analisi saranno sempre approssimative». L’inizio della conversazione con Riccardo Tozzi, 68 anni, presidente dell’Anica, l’associazione che rappresenta l’industria del cinema in Italia, è in qualche modo spiazzante. Solo una settimana fa sono stati resi noti i dati di presenze e incassi nel primo semestre 2015. Numeri che hanno fatto dire ad Anica, Anec e Anem (le due associazioni di esercenti) che «il mercato cinematografico del 2015 è partito bene». Da gennaio a giugno 2015 sono andati al cinema più di 51 milioni di spettatori (il 5% in più dei quasi 49 milioni di un anno prima) con relativo incasso per oltre 330 milioni di euro (+9,4% rispetto ai 302 milioni di 44 euro dell’anno precedente). «Sì, ma il problema vero è quanto di prodotto italiano ci sia in questa crescita. La verità è che la quota di mercato del prodotto italiano è del 22 per cento. Siamo lontanissimi dal 35% del 2012», precisa il numero uno dell’Anica il cui mandato andrà in scadenza nel 2017, ma che conta di «lasciare prima. Magari nel 2016». Bene, allora analizziamolo questo mercato. Anche perché sembrava si dovesse parlare di un 2015 esaltante per i film in arrivo, primi fra tutti quelli portati a Cannes da Nanni Moretti, Paolo Sorrentino e Matteo Garrone. E poi è in arrivo il nuovo film di Checco Zalone. Per carità. I prodotti di livello ci sono stati e ci saranno. Ma parliamo di numeri che non possono spostare una situazione che vede invece il cinema italiano sempre più in difficoltà nel confronto con il prodotto americano. Ma è un segnale di difficoltà del sistema. Per tutta una serie di motivi. Quali? Guardiamo per esempio alle sale. C’è un circuito di sale molto forte nelle periferie e nelle zone interurbane che, in genere, è preferito dai pubblici che prediligono il prodotto americano. Dall’altra parte non si è sviluppato un circuito nuovo e adeguato nei centri urbani, in cui il pubblico è soprattutto quello che preferisce il prodotto europeo e italiano. E di chi è la colpa? Vincoli, costi, burocrazia. Esistono problemi di licenze che nei centri storici rendono molto difficile sia il mantenimento, sia l’apertura delle sale. I Comuni non sembrano interessati a occuparsene. Per chiarire, faccio un esempio che ritengo clamoroso. A Roma abbiamo un sontuoso festival del Cinema. Ma non ci sono sale dove svolgerlo. Si va all’Auditorium. Non sarà però solo un problema di sale. Sul versante produttivo, che vi vede più direttamente interessati, ci saranno altri problemi... Ovvio che sì. Solo fra 2012 e 2014 siamo passati da 166 a 201 film italiani prodotti. Se andassimo più indietro di qualche anno ci accorgeremmo che il numero è praticamente raddoppiato. Ma con le stesse risorse. Quindi bisogna fare meno film o servono più risorse? Evidentemente tutte e due le cose. Altrimenti diventa un problema di qualità. E il responso del pubblico è quello sancito dai numeri. In Francia si fanno gli stessi film. Ma le risorse sono più del doppio rispetto ai circa 250 milioni di euro che ha a disposizione il cinema italiano. E ci sono 6mila schermi, contro i nostri 3.500. In Italia c’è anche storicamente un problema di forte stagionalità che quest’anno, almeno stando ai programmi, avete cercato di affrontare con l’uscita di qualche film in più in estate. Come sta andando? Su quel versante le cose stanno andando un po’ meglio. C’è ancora da lavorare, ma avere la consapevolezza della necessità di andare oltre la stagionalità è un punto di partenza irrinunciabile. Siete preoccupati per l’arrivo di Netflix? In fondo il cinema potrebbe risentirne. Direi di no. I mezzi sono tutti opportunità. Occorre saperle cogliere e anche non pensare che ogni nuovo mezzo sostituisca quello precedente. Peraltro ci sono ricerche, come “Sala e Salotto”, che attestano come gli affezionati al cinema continueranno a esserlo. Oltre a essere presidente di Anica lei è però anche presidente della casa di produzione Cattleya. Sono state rivelate trattative in corso fra voi e Netflix per la produzione di serie tv. A questo punto, non c’è contraddizione o conflitto fra i suoi due ruoli? Le ripeto: non c’è incompatibilità fra i due mezzi. Piuttosto occorre fare tesoro di alcuni cambiamenti in atto, soprattutto nel linguaggio. Il pubblico che va al cinema è anche quello che apprezza la nuova serialità televisiva. Piuttosto che opporsi, il cinema dovrebbe tenere conto dei cambiamenti nei modelli e nei linguaggi. Andrea Biondi 45 ECONOMIA E LAVORO del 09/07/15, pag. 4 Ttip, ok alla nascita della «super corte» Trattati. Gli emendamenti della società civile sono stati sacrificati sull’altare della «grosse koalition» che mai come oggi teme il rialzo d’orgoglio greco Monica Di Sisto* L’Europarlamento ha approvato le regole per il Ttip con 436 sì (Ppe, S&D, Alde), 241 no (Gue, Verdi, destre) e 34 astenuti. In pratica sono state approvati le «raccomandazioni» che includono un sistema alternativo alle controverse corti arbitrali private per le dispute investitori-stati (il cosiddetto Isds). Le regole in Europa — a quanto pare — valgono per il debito greco, ma per la maggioranza del Parlamento europeo, come da paradigma orwellianio, valgono meno. Soprattutto se alla mattina le tribune dell’emiciclo a Strasburgo hanno traboccato come mai in almeno vent’anni per Alexis Tsipras e al pomeriggio si deve votare la Risoluzione con cui il Parlamento europeo esprime la sua valutazione sul Trattato transatlantico di liberalizzazione di scambi e investimenti tra Usa e Ue. Valgono meno perché se una buona parte delle commissioni parlamentari ha espresso preoccupazioni per come la Commissione europea sta conducendo il negoziato — con scarsa trasparenza e considerando servizi, agricoltura e regole come merce di scambio per l’accesso al mercato finanziario, energetico e degli appalti Usa — fuori dal Parlamento gli hanno fatto eco oltre 2 milioni di cittadini che hanno firmato una petizione che chiede lo Stop alle trattative. E ciò fa problema alla cabina di regia dell’istituzione Ue. Il convitato di pietra si chiama «franco tiratore»: da ormai da mesi le email, i profili Facebook e Twitter degli europarlamentari vengono inondati da migliaia di messaggi di cittadini che gli chiedono di trattare con cura la fragile democrazia europea e di dar voce, nella risoluzione sul Ttip, alle preoccupazioni diffuse sul contenuto di un trattato che mira a costruire un mercato comune transatlantico che, valendo il 42% del Pil globale, aspira a fare legge per il resto del pianeta. Per questo, con una forzatura procedurale inedita, il presidente dell’Europarlamento il socialdemocratico Martin Schulz fa saltare l’emendamento 40 al testo, che avrebbe permesso di far esprimere l’aula sull’arbitrato internazionale per proteggere gli investitori dalle decisioni degli Stati, il famigerato Isds, su cui proprio il gruppo socialdemocratico si era spaccato. Lo fa esercitando le prerogative del presidente su un argomento controverso e lo fa una seconda volta, scegliendo di porre in votazione un emendamento di compromesso, elaborato dal suo stesso gruppo, in cui l’Isds si salva nella sostanza ma non viene più chiamato tale, e anzi si prefigura l’introduzione di una «super corte» di giustizia imprecisata nel medio periodo, che è una toppa quasi più brutta del buco alla giustizia ordinaria creato con l’Isds. Saltano, così, uno dopoTutti gli emendamenti della società civile vengono sacrificati all’altare della «grosse koalition» popolare — socialdemocratica che mai come oggi teme l’Europa infiammata dal rialzo d’orgoglio greco. l’altro gli oltre cento emendamenti presentati in meno di due ore, soprattutto quelli di buon senso sostenuti dalle campagne Stop Ttip. Salta l’emendamento sulla Human Rights Clause, che avrebbe anteposto la tutela vincolante dei diritti umani rispetto alle dinamiche di mercato. Resta un capitolo sullo 46 sviluppo sostenibile solamente consultivo senza nessuno strumento impositivo. Viene bocciata la lista positiva per i servizi pubblici, che avrebbe permesso di scrivere nero su bianco i servizi che si vogliono mettere sul mercato, salvaguardando quelli non elencati. Viene bocciata la possibilità di inserire il riferimento a settori sensibili da escludere dal negoziato, come dovrebbe avvenire per alcune produzioni agricole, fortemente a rischio di estinzione. La Commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom, furbescamente, ringrazia via Twitter il Parlamento per il sostegno ricevuto, ma sottolinea anche che l’Isds è morto, cui contrappone la sua proposta, quella che, per dirla con la campagna «Stop Ttip» europea, mette il rossetto al maiale pretendendo che diventi qualcos’altro. Ma i conti non tornano per la coalizione di maggioranza, che tanto grossa non è più. 241 sono stati i voti contrari alla Risoluzione, molti di più di quelli algebrici tra maggioranza e opposizione. Si attende la lista del voto palese per capire chi c’è stato e chi no a far finta, per l’ennesima volta, di voler la democrazia impedendone l’esercizio. E se l’Isds s’ha da cambiare, come ammette anche la Commissaria, vanno riaperti anche gli accordi commerciali con Canada e Singapore, che contengono l’Isds ed espongono già a rischio di cause i nostri governi. Da lunedì 13 Usa e Ue si rivedranno a Bruxelles per un nuovo ciclo di negoziati transatlantici, e ritroveranno ad accoglierli le stesse proteste e gli stessi dubbi di ieri. Il Parlamento ha perso l’occasione di farsene interprete, di diventare parte del cambiamento e non del problema democratico europeo che verrà affrontato dalla grande mobilitazione Stop Ttip di ottobre, che sembra necessaria oggi ancor più di ieri. *Portavoce della Campagna stop TTIP Italia www.stop-ttip-italia.net 47
Scarica