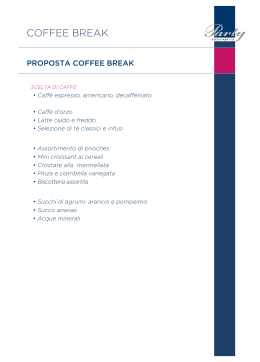Domenica La di DOMENICA 10 APRILE 2005 Repubblica l’inchiesta “Le camerette della nostra vita doppia” MARIA STELLA CONTE il viaggio Alla scoperta del popolo Miao FEDERICO RAMPINI Gli ultimi Re Il matrimonio di Carlo e Camilla in Inghilterra e la morte del principe Ranieri hanno acceso i riflettori sulle monarchie. Siamo andati a vedere come vivono e quanto contano oggi i sovrani d’Europa LEONARDO COEN «O MONTECARLO H, my God! Trovo tutto ciò profondamente noioso», avrebbe esclamato giorni fa la regina Elisabetta ad uno dei suoi numerosi collaboratori. Costui cercava vanamente di coinvolgerla nei preparativi del matrimonio civile di Carlo e Camilla che si è celebrato ieri nella modestissima saletta del municipio di Windsorloue e che è costato 720.000 euro. La confidenza, secondo una prassi ormai consolidata, è approdata in tempo quasi reale sulle pagine dei tabloid londinesi che subito l’hanno sbattuta in prima pagina. La vita da monarca è un sogno per i mercanti di sogni, ma non per chi è re o regina. La legittimità delle monarchie riposa sul consenso ereditato dalla Storia, ma oggi quel consenso è barattato giorno dopo giorno. Onori e privilegi sono sempre più discussi, gli appannaggi sono contrattati dai governi. Per non parlare della privacy. Devastata. Gli spessi muri dei castelli dovrebbero tenere i sovrani ben al riparo dalla plebea curiosità dei sudditi. Macché. Avviene il contrario. Ne sa qualcosa proprio Elisabetta: maggiordomi, camerieri, autisti, segretari, guardaspalle, persino gli scudieri fidatissimi fanno a gara per “rivelare” i segreti della sua vasta e avventurosa famiglia. C’è persino chi s’introduce furtivamente a Buckingham Palace, pur di rubare attimi di intimità regali. D’altra parte, i re oggi diventano popolari se si parla tanto dei loro affanni, se si condividono con essi problemi, apprensioni, drammi e tragedie. Transfert collettivi di emozioni. Solo che ispirare simpatia non basta, devono saper comunicare rispetto. E questo è sempre più difficile: la vita da re comporta sacrifici, s’intende, sacrifici dorati, doratissimi, ma pur sempre incombenze regali che non possono essere eluse. Di recente, Elisabetta si è recata come ogni anno alla gran festa del Commonwealth di cui lei è istituzionalmente alla testa. Anzi, di più. Di 15 dei 54 Stati membri di questa alleanza, lei è ancora il capo di Stato: la sua effigie compare sulle monete, sulle banconote, nei francobolli. Sfoggiando il suo più bel soprabito rosa e un coraggioso cappello a cloche rosa e viola, abbinato con l’abito, si è recata in Rolls Royce all’abbazia di Westminster per celebrare il Regno Unito e le sue molteplici culture. L’accenno alla vettura non è casuale. segue nella pagina successiva servizi di PAOLO FILO DELLA TORRE e LAURA LAURENZI cultura L’eterna guerra per l’Arca perduta ELENA DUSI e GUIDO RAMPOLDI spettacoli Se Hollywood conquista Broadway ANTONIO MONDA l’incontro Paolo Rossi: ricomincio da capo RODOLFO DI GIAMMARCO 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 la copertina Sono ricchi, in alcuni casi come la regina Elisabetta d’Inghilterra ricchissimi. Tranne rare eccezioni, come Juan Carlos di Spagna, contano ormai pochissimo. Oggi stare sul trono è diventato sempre più un mestiere normale. Ma è indispensabile una specializzazione nelle pubbliche relazioni Corone d’Europa Quando essere Re è un lavoro LEONARDO COEN (segue dalla copertina) er ragioni di sicurezza, innanzitutto. Incombe, poi, un’altra regola scolpita nel marmo di ogni statuto monarchico: l’auto del re deve essere un modello particolare. Limousine corazzate, alte ed agevoli. Capaci di rendere l’entrata e l’uscita dall’abitacolo un gesto semplice e disinvolto. Nel garage della regina Elisabetta sono parcheggiate otto vetture: tre Rolls Royce, tre Daimler e due Bentley. È la “flotta” automobilistica ufficiale della corona inglese. Lord Donoughue, simpatizzante del Labour Party di Tony Blair, sostiene che costano troppo all’erario e ogni volta che può lo denuncia in Parlamento: 1,2 milioni di sterline l’anno, compreso il salario di tre autisti. Due milioni di euro. La regina, tuttavia, in privato preferisce guidare una grossa Jaguar Estate (targata Y694 COU), oppure una Vauxhall, mentre Carlo, più spericolato, ama l’Aston Martin. Eh, sì. I sovrani costano. Auto, yacht, aerei. Residenze. Personale di servizio rigorosamente selezionato. Sorveglianza. Le monarchie costituzionali sono un lusso. Persino il lillipuziano Principato di Monaco concede un lauto appannaggio ai P Grimaldi, Ranieri (fino alla sua recente morte), Alberto e Stephanie (non Caroline) ricevono — in quote diverse — alcuni milioni di euro l’anno. I soldi sono un capitolo a parte, nella saga delle dinastie. In tutto il mondo, ne sono rimaste 29 a regnare: il 15 per cento dei Paesi membri dell’Onu. Nel club delle trenta economie nazionali più ricche, l’Ocse, le monarchie sono il 40 per cento. Solo dunque i Paesi con tanto denaro possono mantenere adeguatamente una famiglia reale? Sembra di sì. In Europa sul trono ci stanno ancora quattro re, tre regine, due principi e un granduca. Sette di questi regni fanno parte dell’Unione Europea. Due dei tre che ne stanno fuori, sono considerati paradisi fiscali: Monaco e Liechtenstein. I re incassano, ma lavorano sodo, almeno a sentir loro: cominciano da piccoli. Spediti nei college più riservati e severi, se non addirittura nelle accademie militari. Elisabetta II, per esempio, assomma nella sua persona un cumulo di cariche e di funzioni impressionanti: capo di stato del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda, capo dell’esecutivo, capo della magistratura, comandante in capo delle forze armate e governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, senza dimenticare il Commonwealth. In pratica, il Regno Ci sono quattro re, tre regine, due principi e un granduca. Sette regni fanno parte dell’Unione Europea, due, Monaco e Liechtenstein, sono paradisi fiscali. E fra i paesi più ricchi del mondo quattro su dieci sono tuttora retti da monarchi Unito è governato dal governo di Sua Maestà nel nome della Regina (le maiuscole in questo caso sono un obbligo), la quale agisce su consiglio del governo. La Regina partecipa ancora ad alcuni atti importanti del governo. Fra questi, la convocazione e lo scioglimento del Parlamento, l’assenso reale alle leggi, le nomine del premier e dei ministri, di giudici, vertici delle forze armate, governatori, diplomatici, vescovi della Chiesa d’Inghilterra. Per lo svolgimento di questi impegni ufficiali riceve un appannaggio dal governo di 7,9 milioni di sterline all’anno. Briciole, rispetto al patrimonio personale. Le spese milionarie Tanto per avere un’idea, ogni anno Elisabetta II paga 103 milioni di sterline solo come imposte dirette. È considerata una delle donne più ricche del mondo, se non la più ricca: può permettersi di spendere miliardi (delle vecchie lire) per acquistare splendidi cavalli o per implementare la sua preziosa raccolta filatelica, la più importante del mondo. Quand’era più giovane, assieme al consorte principe di Edimburgo, partiva per lunghe crociere sul suo Britannia, uno yacht grande come una nave. Il mare è la passione sfrenata di tanti monarchi. Più di tutti, del sessantaset- tenne don Juan Carlos, re di Spagna dal 1975, velista provetto e regatante di vaglia. A differenza della regina Elisabetta, Juan Carlos ha un modesto patrimonio. Per mantenere la Casa Real, lo Stato spagnolo gli assegna 6,74 milioni di euro l’anno, di cui può disporre liberamente. Non ci sono appannaggi né per la regina né per i principi ereditari. In compenso, Juan Carlos ha giocato un ruolo decisivo nella restaurazione della democrazia, da lui difesa quando, nel 1981, fu tentato un putsch militare: il suo drammatico e coraggioso discorso alla nazione, trasmesso in diretta tv, sbarrò la strada ai nostalgici del regime fascista di Franco. Gli spagnoli, anche i più irriducibili repubblicani, ebbero per lui il più grande rispetto: aveva saputo cristallizzare attorno alla sua figura «sopra le parti» l’identità e l’orgoglio del Paese. Le sue non sono competenze puramente formali, in quanto capo dello Stato e capo supremo delle forze armate. Ha la facoltà di promulgare le leggi, convocare o sciogliere il parlamento e convocare elezioni e referendum, proporre e nominare il capo di governo (anche dimetterlo), i membri del governo (su proposta del premier), ha il compito di manifestare il consenso per i trattati internazionali e quello di dichiarare la guerra (o la pace). 3 1 Repubblica Nazionale 30 10/04/2005 2 ome e quanto stiano cambiando le monarchie europee lo si deduce soprattutto dai matrimoni. E che matrimoni. Impensabili fino a non molti anni fa, oggi ormai la norma. Incredibile: ci si sposa per amore. E al diavolo la ragion di Stato, al diavolo i matrimoni di convenienza, gli intrecci fra casati, le alleanze dinastiche, le nozze inter pares. È un vento liberatorio che spazza tutte o quasi le corti del continente. I matrimoni programmati a tavolino appartengono ormai soltanto ai libri di storia, morti e sepolti sotto pagine incartapecorite. Gli eredi al trono si sono imborghesiti. Anzi: spesso i borghesi si rivelano più attenti e più calcolatori dei principi del sangue, nell’acquisire e moltiplicare tramite nozze oculate patrimoni considerevoli. I futuri re, onore al merito, si dimostrano per niente arrampicatori, sposando semplicemente le donne di cui si sono innamorati: amandole — come in un fotoromanzo o in una soap opera — per quello che sono. Fanciulle senza blasone, dal curriculum non sempre specchiato. Non si tratta di fisiologici impulsi giovanili. E a dimostrarlo urbi etorbiè l’erede al trono più prestigioso (o per lo meno così era) del pianeta, cioè Carlo d’Inghilterra. Ormai prossimo alla sessantina, è riuscito ieri a coronare il suo sogno d’amore che dura da oltre tre decadi con una coetanea di scarsissima avvenenza. Ha impalmato la sua amante storica contro tutto e contro tutti persino a rischio abdicazione. Per un semplice motivo: la ama. Certo: agli sposi manca le phisique du rõle, ma si tratta di una storia estremamente romantica. Lui le ha offerto un dono di gran classe e di principesca eleganza, rifiutando di farle firmare un contratto pre-matrimoniale e disobbedendo così ad avvocati e consiglieri. Il nostro è un matrimonio basato sulla fiducia, ha fatto sapere l’erede alla corte di San Giacomo, e dunque honi soit qui mal y pense, come si legge nello stemma dell’Ordine della Giarrettiera. E al diavolo ogni patto pre-nuziale, meschineria da piccolo-borghesi attenti al soldo. Guardando al passato, non fu invece un matrimonio d’amore, per lo me- Nozze d’amore C le monarchie cambiano così LAURA LAURENZI no all’inizio, quanto una strategica operazione promozionale, quello fra Ranieri e Grace Kelly, che i sudditi monegaschi nei primi tempi ribattezzarono «Glace» per la sua non calorosità. Fu il socio-amico poi nemico Onassis a suggerire al sovrano Grimaldi di portare all’altare un’attrice, meglio, una diva, che avrebbe calamitato doviziosa pubblicità internazionale e selezionati flussi turistici. Resasi innocua — vuole la leggenda — Marilyn Monroe — la seconda scelta cadde su Grace Kelly, assai racée per essere un’attrice, la quale accettò di buon grado quel matrimonio combinato, interpretando così bene la parte di principessa da finire per crederci. Tornando alla generazione dei principi sposo-chi-mi-pare, quello che ha compiuto il gesto più clamoroso è stato senz’altro Haakon Magnus di Norvegia. Nell’agosto del 2001 è riuscito a portare all’altare la ragazza che aveva forse meno requisiti nell’intero regno per diventare un giorno regina. Mette-Marit Tjessem Hoiby non soltanto non è aristocratica, non soltanto è un’ex frequentatrice di droga party per i quali fece pubblica ammenda in tv alla vigilia delle nozze, non soltanto ha un padre semi-alcolizzato e uno zio condannato per spaccio di cocaina, ma è anche una ragazza madre. Ha portato in dote un figlio, Marius, di quattro anni, avuto da un pregiudicato, anche lui con precedenti penali nel ramo stupefacenti. Il re Harald e la regina Sonja (anche lei una borghese, detta «la camiciaia») hanno fatto l’impossibile perché il loro figlio maschio abbandonasse una ragazza così imbarazzante, ma hanno dovuto capitolare. Haakon era disposto anche a rinunciare al trono pur di sposare la donna che ama. Tanto impeto merita il lieto fine: a fare compagnia a Marius è nata una bambina, Ingrid Alexandra, che un giorno cingerà la corona di Norvegia. È stato certamente un matrimonio d’amore anche quello, celebrato nel maggio dell’anno scorso, fra Felipe di Spagna e la rampantissima Letizia Ortiz, la plebeya col nonno tassista e la mamma infermiera-sindacalista che il DOMENICA 10 APRILE 2005 Pacifista convinta è la sessantacinquenne Margrethe II regina di Danimarca dal 1972. Divenne erede al trono ufficialmente nel 1953, grazie ad un emendamento costituzionale che permetteva anche alle donne l’accesso alla corona. È quindi la prima regina di Danimarca, regno le cui radici affondano nel X secolo. La responsabilità regale non la distrae dalla sua attività preferita: quella di dipingere. È infatti una pittrice di talento, conosciuta sotto lo pseudonimo di Ingahild Grathmer: ha illustrato un’edizione danese del Signore degli Anelli. Laureata a Copenaghen in Scienze politiche, ha seguito dei corsi di archeologia a Cambridge, ha frequentato la Sorbona e la London School of Economics. Forse sognava una cattedra all’università. Sopporta il (fortunato?) destino di sovrana intellettuale, col portafoglio gonfio. Ha infatti due castelli, uno chalet in Norvegia e un discreto patrimonio, che amministra oculatamente. È ricca, ma non tanto quanto Elisabetta o la regina Beatrice d’Olanda, figlia di Giuliana. Nonostante il ruolo assolutamente simbolico, le passano un sostanzioso appannaggio, 5 milioni di euro. Anche Carlo d’Inghilterra dipinge: languidi paesaggi, in stile neoromantico. In genere, però, i sovrani amano LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 comprarli i quadri, commissionarli, possederli. Ranieri di Monaco l’ha fatto: l’arte vista come collezione (e magari fruttuoso investimento). Nessuno, però, può vantare la competenza di Hans-Adam II, principe del Liechtenstein, unica monarchia a non erogare alcun appannaggio. Grandissimo esperto del Rinascimento, Hans-Adam possiede una favolosa raccolta di dipinti del valore di 500 milioni di euro (Raffaello, Mantegna, Cranach, Van Dyck), la LGT Bank, terreni in Austria per 20mila ettari, palazzi a Vienna. L’impegno ecologico Hans-Adam è il Paperone dei re d’Europa. Lo scorso agosto ha abdicato a favore del figlio Alois che ha frequentato l’accademia militare di Sandhurst (Gran Bretagna), ed ha in seguito servito nella guardia britannica a Hong Kong e a Londra, per concludere a Vienna gli studi di diritto. Anche il granduca Henri di Lussemburgo è passato per l’accademia di Sandhurst. Come Alberto di Monaco, è un ardente difensore della natura. Con un pallino fisso: salvaguardare l’ecosistema delle Galapagos. Per contribuire a questo scopo, attinge alle sue cospicue proprietà. C’è modo e modo di rendere immor- tale e rispettato il proprio nome. Carlo XVI Gustavo, re di Svezia dal 1973, ha operato per l’Agenzia internazionale svedese di sviluppo e di cooperazione con l’Africa. E in seguito, durante i Giochi di Monaco del ’72, conobbe un’interprete della delegazione tedesca e la sposò quattro anni dopo. Coronò, nel vero senso della parola, una storia d’amore. Alla gente piacciono i principi e i re romantici che sfidano le convenzioni dinastiche e si comportano secondo i canoni hollywoodiani, compiendo gesti che gli permettono di superare qualunque ostacolo. Piace chi, come Alberto del Belgio un mese fa, fa quello che non hanno avuto il coraggio di fare i suoi ministri, va cioè a bussare per la seconda volta alla porta di Rik Van Nieuwenhuysen, direttore dell’impresa di cibi precotti Remmery, a Ledegem. Il signor Rik, ex poliziotto, ha dato lavoro a un’operaia musulmana. Un gruppo xenofobo estremista lo ha minacciato più volte di morte. Alberto gli ha detto che il Belgio civile, antirazzista e democratico sta dalla parte sua e dell’operaia musulmana. Come sono remoti i tempi di re Leopoldo I che conquistava il Congo e lo considerava impero privato, o dell’altro re Leopoldo III, arresosi senza condizioni alle truppe naziste che invadevano il Belgio. NOZZE DI FELIPE * LE Foto di gruppo delle teste coronate d’Europa Parla lo storico Peter Furtado invitate al matrimonio del principe Felipe di Borbone “Ma un sovrano deve avere stile” 1 Il re e la regina Alberto e Paola del Belgio 2 Il re Carlo Gustavo e la regina Silvia di Svezia principe Felipe delle 3 IlAsturie e la moglie Letizia PAOLO FILO DELLA TORRE Ortiz. A sinistra della sposa re Juan Carlos di Borbone di Spagna e, a destra del principe, la regina Sofia «S principe d’Olanda 4 IlGuglielmo d’Orange Nassau regina Margrethe II 5 La di Danimarca con il principe consorte Henrik re Harald e la regina 6 IlSonja di Norvegia 7 Il principe Carlo d’Inghilterra 8 La principessa Caroline di Monaco e, a sinistra, Ernst di Hannover * 8 4 7 5 FOTO OLYCOM Repubblica Nazionale 31 10/04/2005 6 principe delle Asturie ha imposto a re Juan Carlos, formidabile incassatore, e alla sconfortata regina Sofia. I cattolicissimi re di Spagna hanno dovuto accettare, facendo buon viso a cattivo gioco, una nuora divorziata. E pensare che Sofia la pretendeva addirittura di sangue reale: non si sarebbe accontentata di un’aristocratica qualunque. Figurarsi una giornalista televisiva, per di più già sposata. E munita di vari scheletri nell’armadio, giudicati più o meno disdicevoli. Per esempio la copertina di un Cd messicano in cui la bella Letizia appare a seno nudo. Per esempio certe foto che la ritraggono nelle vesti di distributrice ambulante di sigarette a un congresso a Guadalajara. Anni spensierati in cui nulla lasciava presagire un destino dinastico tanto impegnativo. Che sembra generarle stress e angoscia, per lo meno secondo i royal watchers, i quali non mancano di sottolineare la sua magrezza crescente (è ormai una taglia 36), le rughe premature, l’espressione tirata dietro il volto dell’ufficialità. Che soffra di anoressia? Dalla Zarzuela, circostanza senza precedenti, si sono affrettati — e abbassati — a smentire. Fin troppo facile liquidare la sua apparente infelicità non tanto con l’insofferenza al cerimoniale di corte, quanto con la disperazione per la mancata gravidanza. Letizia come Soraya, si sono precipitati a scrivere i rotocalchi. Un po’ presto: Felipe & Sofia sono sposati da nemmeno undici mesi. Chi dal sangue borghese sembra avere attinto nuova linfa, entusiasmo, energia, oltre a una doppia discendenza (aspettano il secondo bambino) è Guglielmo d’Orange Nassau, il futuro re d’Olanda. Anche lui ha dovuto sudare sette camicie per imporre la donna prescelta: una che sulla carta sembrava una vera catastrofe. Maxima Zorreguita, di Buenos Aires, era la fidanzata venuta dal golpe. Non soltanto straniera, non soltanto drasticamente priva di sangue blu, non soltanto cattolica, ma anche figlia di un ministro della giunta golpista di Videla. Gli scontri politici furono accesissimi, ad Amsterdam si arrivò persino a sfiorare la crisi di governo. Il parlamento alla fine po- se come condizione che il padre della sposa si tenesse alla larga dalle nozze e dal Paese. Lanci di vernice bianca, il colore delle madri della Plaza de Mayo, bersagliarono il corteo nuziale il 2 febbraio del 2002. A tre anni di distanza Maxima si è rivelata un’ottima scelta, è amatissima dai sudditi per la sua personalità, la sua comunicativa e il suo temperamento latino. È osannata dalle folle anche Mary Donaldson, la bruna «Venere della Tasmania» che il principe Frederick di Danimarca, lineamenti infantili ma una robusta fama da playboy, ha sposato lo scorso maggio, commuovendosi fino alle lacrime in mondovisione. Una commoner anche lei, naturalmente, agente immobiliare e consulente finanziaria in carriera conosciuta alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Sposerà probabilmente il suo personal trainer Vittoria di Svezia, che un giorno sarà regina, «figlia d’arte» in quanto il padre convolò a nozze con una hostess congressuale. «La sola cosa che conti è che io sia innamorata e felice», ha dichiarato la principessa, non più sofferente di anoressia, al fianco dell’intraprendente Daniel Westling, proprietario di una palestra a Stoccolma. È corredato di fidanzata platealmente borghese anche William d’Inghilterra, primogenito di Carlo e Diana, che ormai da due anni fa coppia fissa con una compagna di facoltà della St Andrew’s University, in Scozia. Lei si chiama Kate Middleton, e non appare poi così marginale se la regina Elisabetta ha richiesto il piacere della sua compagnia al ricevimento di nozze tra Carlo e Camilla. Un bel segnale. In fin dei conti a fare eccezione è Filippo del Belgio, l’unico o quasi fra gli eredi al trono che abbia sposato un’aristocratica. Mathilde d’Udekem d’Acoz, definita dal ministro degli esteri belga «un dono del cielo», è impeccabile: bella, bionda, di rango, dal passato integerrimo, con indefesse doti di generosità nel volontariato, ha già dato alla corona due figli. Forse troppo perfetta per essere vera: difatti appare paradossalmente come un personaggio scialbo. Di scarsissimo interesse. embra un paradosso ma proprio per il suo declino come centro di potere, la monarchia britannica può cavarsela persino dinanzi alla prospettiva di Camilla regina». Peter Furtado, direttore di History Today è un accademico di origine portoghese esperto di questioni costituzionali britanniche. Dice: «Io sarei per un cambiamento delle istituzioni. Servirebbe a modernizzare il paese. A renderlo meno schiavo delle tradizioni. Tuttavia mi rendo conto che è impossibile intravedere una Repubblica britannica. Le dinastie sono cambiate ma le radici istituzionali sono profonde. Se ne rendono conto i laburisti. Anche Tony Blair che non perde occasione per mostrare in pubblico la sua devozione alla regina Elisabetta». Eppure negli anni Cinquanta Re Faruk d’Egitto, dopo aver perso la corona disse che nel 2000 di re sarebbero rimasti solo quelli di cuori, di quadri, di picche, di fiori e quello di Inghilterra. «Aveva torto perché a quell’epoca non si poteva prevedere che a Madrid sarebbe stata restaurata una monarchia molto più solida di quella precedente al regime franchista, spodestata dai repubblicani». Se i tedeschi avessero vinto la guerra ci sarebbe oggi una Repubblica britannica? «Penso che Hitler avrebbe invece imposto il ritorno sul trono di Edoardo VIII, l’uomo che aveva abdicato per sposare Wally Simpson. Lo avevano sacrificato perché a quell’epoca sposare una divorziata significava non essere in sintonia con la classe dominante, cioè con il Parlamento, il governo e la Chiesa d’Inghilterra. Io penso che in ogni caso un uomo imposto dai nazisti come capo di Stato inglese non sarebbe durato molto tempo. Alla prima opportunità sarebbe stato sostituito magari appunto con un presidente della Repubblica». Lei crede che i re debbano mantenere un loro stile? Per esempio voi definite con disprezzo “monarchie in bicicletta” quelle di Olanda, Belgio e dei paesi scandinavi. «Personalmente adoro la mia bicicletta quindi non ho niente contro chi adopera la sua. Tuttavia se un paese deve avere come capo di Stato un monarca, questo deve apparire almeno nei suoi costumi diverso dagli altri suoi sudditi. Non vedrei favorevolmente una monarchia in bicicletta in Gran Bretagna». Crede che nel prossimo futuro altri paesi cambieranno la loro forma istituzionale? «Credo proprio di no perché non prevedo nuove guerre in Europa né terribili tensioni sociali o crisi economiche disastrose. Certamente ci saranno alti e bassi e persino tensioni sociali. Ma per le nostre generazioni non si intravede la possibilità di eventi tali da portare ad una rivoluzione. E poi c’è un grande paradosso». Quale? «Sono le grandi potenze repubblicane, a cominciare dagli Stati Uniti fino a Germania e Francia, a garantire il mantenimento delle corone che non sono cadute né durante le guerre del secolo scorso né nei dopoguerra». Lei crede che dopo Elisabetta l’Inghilterra dovrà affrontare forti tensioni se sul trono andrà Carlo con la sua regina Camilla? «Non c’è dubbio che è molto difficile per qualsiasi regnante trovarsi in contrasto con l’opinione pubblica del suo paese, specialmente quella che conta. Tutto dipenderà dai tempi della successione a Elisabetta che per fortuna della monarchia sembra poter ereditare la longevità della madre. Elisabetta è salita al trono a 25 anni ed è il capo di Stato che vi è rimasto più a lungo». Qual è la sua forza? «Ha sempre avuto l’abilità di mantenere una eccezionale prudenza mettendosi al di sopra delle parti, di mostrare di non voler interferire. In Spagna il re si è invece rafforzato quando è intervenuto per contrastare un push militare. Sono certo due stili che appaiono diversi. Ma probabilmente perché in Inghilterra un colpo di Stato è del tutto impensabile». 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 l’inchiesta Si chiamano Vittoria, Marco e Davide: sono figli di genitori separati che si specchiano nelle loro stanze, quella nella casa della mamma e quella nella casa del papà, per raccontare la loro esperienza. Con un gioco di prestigio: trasformare uno svantaggio in un vantaggio apparente Dopo il divorzio “Le due camerette della nostra vita doppia” MARIA STELLA CONTE uella certa ombra sul muro. I muri della propria infanzia. Eserciti di soldatini in marcia. Orchi. Draghi. Onde. Mongolfiere che diventavano lupi e... E il sonno giù, come una saracinesca. Da bambini, la vostra stanza com’era? Io di stanze ne ho due... Cosa vi era proibito e cos’altro permesso? Ennò... qui no, mamma non vuole che porti sul letto né Gildailconiglio, né Alfioilgatto, né Tiukeilcane; da papà invece, posso dormire con Luky il mio cocher e lasciare tutto in disordine. Cos’era per voi quella cameretta? Quanto ne eravate gelosi? Quanto vi mancava se dormivate altrove? Q Vittoria Mio papà vive a La Spezia, io a Firenze con la mamma. A La Spezia ci stanno anche i nonni, la moglie di papà e una sorellina appena nata. Mi viene a prendere lui i fine settimana, con la macchina. La stanza che ho lì, beh sì è piccina, ma quando sono qui, un po’ mi manca l’odore del mare... Vittoria gioca le sue carte di figlia di separati come una che a dieci anni ha già capito il trucco della doppia opzione: data una certa situazione, è possibile trasformare lo svantaggio evidente, in vantaggio apparente. A volte riesce. Capita magari che per difendermi mi vanti con le mie compagne: mi vanto di avere due stanze e di essere più viziata e coccolata, di avere più regali, più vacanze, il doppio di tutto. Diciamo che è un argomento che uso se mi prendono in giro, però dentro di me no, non mi sento più fortunata degli altri. Due case. Due famiglie. Due stanze. Quella del lunedì e quella della domenica. Quella di tutti i giorni e quella del sabato sera. Mondi paralleli, ma non lo stesso mondo anche se ad abitarvi è lo stesso bambino. Perché Vittoria è Vittoria. Ma mamma non è papà. E a Firenze la stanza è grande, con le pareti incollate di ricordi: è come entrare in un caleidoscopio. Ovunque disegni, da quelli di quando aveva tre anni in poi; foto a non finire dell’intera famiglia: genitori, nonni, zii, cugini; cinque quadretti acquerello che sembrano fogli strappati dai libri delle fiabe; il pc con il quale si collega per parlare con il papà; videocassette di cartoni animati; pupazzi di pezza, di pannolenci, plastica, peluche sparsi dappertutto, persino attaccati alle ante dell’armadio; il letto sopraelevato con la scaletta e sotto la scrivania; il mappamondo che si illumina; i libri di scuola; i quaderni. Anche se non l’avessero descritta loro, si immagina perfettamente la scenetta della madre che tenta l’estenuante impresa di insegnare alla figlia come dare un ordine al caos della vita quotidiana. Non come a La Spezia. Dove la stanza è talmente piccola: casa di bambola. Il letto. L’armadio. I muri che sfumano su miti alberelli ocra e verdi, dipinti a mano tempo fa, con la zia. Il canguro di pezza come bagaglio a mano. Quanto basta. Visto che avere una stanza qui e una là, non è solo questione di duplicazione dello spazio, ma la possibilità di esprimere comunque il proprio doppio, l’altra parte di sé: ordine e disordine; la regola e l’eccezione; i sì e i no; noi, per come gli altri — i genitori — ci consentono di essere. Figli di coppie separate. Le loro camerette, in fondo, sono il racconto di un privilegio. Perché sono in pochi a potersi permettere, una volta usciti di casa, una sistemazione con la stanza del figlio. Padri, nell’85 per cento dei casi. Pionieri di un’era prossima ventura se passerà la legge sull’affidamento condiviso dei figli; se passerà il principio che si può essere una ex coppia, ma non più, mai più ex genitori. E allora: se hai un figlio, devi fargli posto non solo nel tuo cuore, ma anche nella tua casa. Parole. Ma poi nei fatti — legge o non legge, soldi o non soldi — la vita scivola via tra le ortiche. Angelica Somigli, madre di Vittoria, anni 35: «La verità è che devo fare grossi sforzi per mantenere buoni rapporti con Dario, la sua compagna, la loro figlioletta; non è facile ma bisogna farlo. Così, per farle un esempio, dopo la na- Parla la psicologa Tilde Giani Gallino: “Fondamentale un progetto educativo comune dei genitori” “Se c’è armonia è una risorsa preziosa” T ilde Giani Gallino, parliamo di figli di coppie separate e della possibilità per alcuni di loro di avere due stanze: una nella casa materna, l’altra in quella paterna. Cosa può significare questo per il loro sviluppo? Un arricchimento o una frantumazione del proprio mondo? «Poiché la cosa migliore sarebbe che i figli di coppie separate passassero metà tempo con la madre e metà con il padre, ritengo che — in questo caso — sarebbe importante per i bambini avere due camerette. Se i genitori se lo possono permettere, naturalmente. Cosa possono diventare questi spazi, dipende da come i genitori faranno vivere la separazione al figlio: la doppia stanza può tradursi in una opportunità per l’espansione di sé; o rappresentare il luogo della mancanza dell’altro genitore. È fondamentale quindi che madre e padre continuino a vedersi per fissare criteri che consentano alle due stanze di non differenziarsi troppo l’una dall’altra». Dovrebbero essere camere gemelle? «Assolutamente no. Però bisogna fare molta attenzione: avere un doppio spazio è un arricchimento nel senso che ho tanto più posto — e non solo fisico — per me stesso. Ma se non c’è accordo tra i genitori la stanza può diventare uno strumento di ricatto. Se quando sono da papà posso rientrare a qualsiasi ora mentre da mamma no; se lì posso tenere la musica a tutto volume, saltare con le scarpe sul letto, o mangiare davanti alla tv e nell’altra casa no, il rischio non è solo di creare uno stato confusionale, ma di innescare un meccanismo di rivalsa: da papà posso fare questo e quello, da te no... In questo senso, avere una strategia educativa comune aiuterebbe genitori e figli a non fare dello spazio un terreno di scontro». Quando, invece, l’altra stanza può diventare il luogo dell’assenza? «Quando i conflitti dei genitori si riverberano sui figli: allora quel bambino, anche nella stanza più bella del mondo, sarà un bambino molto triste. scita della bambina li ho invitati tutti qui a Firenze: ci sono equilibri indispensabili per la serenità dei figli e costano un’immensa fatica». Dario Hayun, padre di Vittoria, anni 39: «Soprattutto importa che il genitore meno presente abbia l’umiltà di ascoltare l’altro e mettersi eventualmente di fianco accogliendo il suo punto di vista per il bene del bambino. Come dire: ecco vedi? Ti do retta perché lo so, a parità di voti, il tuo vale un po’ più del mio». Marco Si riparte. Trecentottanta chilometri a nord di Firenze. Questa è Colico, sul lago di Como, che fuori stagione stringe un po’ il cuore. Questa è la casa del papà di Marco che si chiama Enzo Maffioli e ha un’agenzia immobiliare, 44 anni e una nuova compagna. Quella dalla quale siamo appena usciti, invece, è la casa della mamma di Marco, Laura Sivilotti, che ha un’agenzia di viaggi, 40 anni e un nuovo compagno. Si sono separati che il figlio era piccino. Ora è un adolescente con i capelli al gel e una sana voglia di non lasciarsi frugare dentro. Lui è il centro dell’universo per loro. Ma l’universo di Marco a un certo punto si è frammentato quando ha cominciato ad avere due letti diversi in due stanze diverse in due case diverse con due famiglie diverse. Due. Di tutto. Anche di se stesso. C’è Marco nella solare camera della villetta materna, tra pile di libri di scuola, cd, la bandiera dell’Inter, un disegno sul muro, i trofei dei tornei di calcetto, la tv, una maglia sul letto, la bottiglia di coca cola sulla scrivania. C’è Marco anche qui. Nella camera della villa paterna, tutta così ordinata, così tranquillizzante, con ogni cosa così razionalmente allineata al Separandosi, è normale che una coppia possa tornare a due progetti di vita diversi, ma dovrebbe continuare ad avere un solo progetto educativo per i figli». E chi non è in grado di offrire ai figli questa doppia stanza? «Se non si può, non si può. E del resto sono ancora una minoranza quelli che se la possono permettere. Se lo spazio è poco, basteranno alcuni semplici accorgimenti: in particolare il genitore con il quale il figlio trascorre meno tempo, dovrebbe creare un angolino che il bambino riconosca come suo e che non gli dia la sensazione di essere di passaggio. Anche intorno ad un divano letto si può: basta un armadietto con la chiave; un cesto con i suoi giochi; un cassetto con il nome; un ripiano di libreria tutto per lui. Ma soprattutto, attenzione: qualora ci fosse un nuovo compagno o compagna, sarebbe giusto di notte garantire al figlio un luogo separato da quello della coppia per non essere costretto ad assistere anche alle più semplici affettuosità. Ovviamente, ci sarebbero molte variabili da considerare: età e sesso, la presenza di fratelli e sorelle...». Situazioni comunque difficili e fuori dell’ordinario «Sono situazioni anomale sì, ma rispetto ai nostri stereotipi. In realtà non esiste la famiglia normale. Esiste una condizione ottimale, che è quella di crescere con due genitori che si amano e ci amano. Per il resto, la famiglia normale dell’Ottocento era diversa da quella normale del Novecento che è diversa da quella normale del Duemila. Ad ogni mutamento, ci si stracciavano le vesti dicendo: sarà una catastrofe! Ma catastrofe non è stata. L’unica cosa che può fare una coppia, dunque, è di far vivere al figlio la separazione nel miglior modo possibile, facendogli sentire che ha non solo due stanze, ma due genitori: due sponsor che tiferanno per lui tutta la vita. Insieme». (m. s. c.) posto giusto. Qui dove sua madre mette piede dopo anni per la prima volta «perché ho sempre avuto la sensazione che a Marco non avrebbe fatto piacere; e infatti, quando lui sta col padre sta col padre: io non faccio domande né lui mi parla mai di quel che fa o avviene di là; poi, quando è qui è qui: sono due vite completamente diverse e credo che il suo tenerle separate sia un modo per non soffrire, una strategia di difesa». È come vedere materializzarsi le parole del neuropsichiatra infantile Francesco Montecchi, una vita da primario al Bambino Gesù di Roma: «La stanza, anzi in questi casi le doppia stanza, rappresenta la dimensione creativa di un sano sviluppo che non può avvenire al di fuori dello spazio: esse sono o dovrebbero essere il luogo rassicurante nel quale il bambino definisce via via la propria identità. Ciò è possibile, tutta- via, solo se il figlio ha la garanzia di avere un buon rapporto con entrambi i genitori. Viceversa, se non esistono garanzie affettive, le due stanze diventano lo spazio dell’angoscia e della scissione. Attenzione però: scissione non significa tenere separate le due realtà attraverso il silenzio, che è invece una importante modalità protettiva dei propri spazi interiori e di quelli dei genitori; provi solo a immaginare l’emotività che si scatenerebbe nel bambino nel raccontare, o peggio ancora nel sentirsi internamente obbligato a raccontare quel che avviene nell’altra casa. Scissione è il non riuscire a integrare le parti diverse e in opposizione che ciascuno ha dentro di sé, parti che rischiano di rimanere scisse per sempre, cosa piuttosto frequente proprio nei figli di separati». Una cosa in comune le due stanze di DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 FOTO LORENZO PESCE/CONTRASTO MARCO. Qui sopra Marco Maffioli, 16 anni, nella cameretta a casa della madre. A destra, il ragazzo nell’appartamento del padre Repubblica Nazionale 33 10/04/2005 VITTORIA. Sopra, Vittoria Hayun, 10 anni, nella cameretta a casa del padre. A destra, la bambina nell’appartamento della madre Marco ce l’hanno, e non sono solo le coppe vinte nei tornei di calcio. Hanno in comune un’aria che è la sua: a tratti a colori, a tratti in bianco e nero. Come adesso che non sembra più quello di prima e dice: «A volte tra amici, soprattutto con quelli che hanno i genitori che stanno in crisi, se ne parla. Mi chiedono. Com’è dopo? Come si sta? Che accade? Ed io che devo dire: certo sarebbe meglio che non accadesse, anche se poi penso che essere figli di separati ti da una marcia in più, ti fa capire prima come gira la vita. E un po’ è vero, ha ragione papà, ti adagi, perché ti senti più protetto, più sostenuto da entrambi. Comunque il momento difficile arriva dopo, quando loro incontrano un nuovo amore. Allora bisogna fare uno sforzo per accettare la situazione, perché è difficile avere una famiglia tanto grande». Con il suo scooter, Marco va LA NUOVA LEGGE Sta per riprendere alla Camera la discussione del progetto di legge sull’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione e divorzio. Il principio della nuova legge è che i figli — salvo eccezioni — saranno affidati dopo la separazione ad entrambi i genitori. Madre e padre stileranno un progetto educativo da sottoporre al giudice per poi condividerlo. Entrambi provvederanno al mantenimento del figlio DAVIDE Nella foto qui a sinistra, Davide Ferrucci, 7 anni, a casa della madre. A fianco, il bimbo nella sua cameretta nell’appartamento del padre e viene dalle case dei suoi in cinque minuti. Entra ed esce. Si ferma o se ne va. Fa come vuole. Come dovrebbe essere a 17 anni per qualsiasi figlio «senza barriere, senza ritmi scanditi da un calendario dettato dalla mano di ferro di un giudice secondo una partitura che fa del continuo salutarsi un eterno addio», riassume il professor Marino Maglietta, presidente di Crescere insieme: per quel che lo riguarda la doppia stanza a nulla serve se poi quella cameretta resta quasi sempre vuota «a testimoniare più un’assenza che una presenza». Ma qui non è così, qui Marco c’è. Ciao Marco. Davide Si va in macchina, da Pontedera a Montecastello. Spicchio di Toscana atipico, eventualmente inadeguato per uno spot sulle bellezze regionali. Si va a ca- sa di Davide, 7 anni, che vive con la mamma, Danielle Miliano, 38 anni, ragioniera, e il nuovo marito di lei. Venti minuti più giù, a Fornacette, c’è la casa del padre, Antonio Ferrucci, 41 anni, socio in un’azienda per macchine da ufficio, attualmente senza fidanzata. Fra loro deve essere stata dura subito prima e subito dopo la separazione, tre anni fa; ce ne è voluto per arrivare ad oggi. A parlarsi sorridendo. Lei: «Bisogna fare attenzione a non usare i figli per i propri rancori: quando ci si lascia di rabbia dentro ce n’è sempre tanta e non sono gli avvocati, non è una legge che te la fa passare»; lui: «Eppure una buona legge sarebbe d’aiuto a non far sentire un genitore proprietario dei figli, e l’altro completamente escluso»; lei: «Noi all’affidamento congiunto ci siamo arrivati alla fine. Davide di solito dorme qui, ma la sua vita si svolge ogni giorno con tutti e due nel senso che io conto su suo padre e suo padre conta su di me. È più complicato a dirsi che a farsi»; lui: «Sì, si deve avere la forza di mettere i figli al primo posto cercando a tutti i costi un accordo e una nuova normalità». Davide intanto corre a destra e a sinistra. Apre armadi, cassettiere, cesti di vimini, tutti stracolmi di giocattoli; ti trascina felice per la manica spalancando le porte dei suoi tesori, esclamando continuamente... e non è finita!... E non smette fin quando non coglie la giusta dose di stupore nel tuo sguardo. Da grande voleva fare il pagliaccio. Ora gioca a fare Pollicino. «Solo io so dove si nasconde Pollicino e se tu ci vuoi parlare devi chiedere a me...». Le sue due camere sono molto simili tra loro. Piene di qualsiasi cosa un bambino possa desiderare. Di musica in cassette. Di album da disegno. Di gru basse alte medie. Di allegria da paese dei balocchi. E lui ci si muove dentro come se l’una e l’altra fossero una stanza sola. «Ora Pollicino sta dormendo, non so se lo posso svegliare... cosa vuoi chiedergli?». Davide sveglia Pollicino. E non ride più. Chiude la porta della stanza perché nessun altro entri, e resta così, con le manine attaccate alla maniglia, di spalle, mentre ricorda, mentre racconta. La sua voce è un sussurro che per ascoltarla devi smettere di respirare. È così serio adesso: il bambino più serio del mondo, il più bello, il più solo. Bussa il papà. Davide torna a far volare bianchi aeroplanini di carta a quadretti, ridendo. Chissà dove è adesso Pollicino. E in quale stanza dormirà stanotte. E se davvero Davide lo sa. 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il racconto Oltre la guerra DOMENICA 10 APRILE 2005 Il primo presidente del dopo-Saddam è il curdo Talabani. Nella terra da cui viene, nell’ultimo anno gli stipendi si sono triplicati e il denaro ha cominciato a girare. Così un popolo fino a ieri perseguitato ha capito di poter vivere nel benessere. E ora la parola indipendenza non è più tabù Repubblica Nazionale 34 10/04/2005 S ERBIL (Iraq del Nord) herwan indossa un abito di perfetto taglio italiano, sopra la camicia rosa e una cravatta in tinta. Con un gesto elegante alza la mano e la protende a magnificare la spaziosa e illuminata hall del nuovo Sheraton che da pochi mesi ha sostituito il vecchio, glorioso ma buio hotel Chwar Chra (Quattro fuochi), come punto di incontro nella capitale del Kurdistan iracheno, Erbil. «Gli affari vanno non solo bene, ma benissimo — ammette con franchezza il businessman curdo, 35enne aitante non ancora accasato, mentre mastica con gusto il filetto di pesce proveniente ogni mattina dal Golfo persico — nel giro di poco tempo il traffico dei miei camion è decuplicato, trasportiamo di tutto. Questa è la parte tranquilla dell’Iraq, e non ci vorrà molto tempo prima che la regione diventi indipendente». Bauer ha invece la solita aria sorniona e leggermente trasandata. Pochi mesi fa ha venduto la jeep Chevrolet con cui scorrazzava da Tikrit a Suleymania e comprato terreni attorno alla zona dell’aeroporto. «Sai — dice — tra un paio di settimane sarà finalmente pronto. È il primo scalo internazionale curdo, e tutta l’area è destinata a rivalutarsi. Con i soldi realizzati dopo l’acquisto costruirò delle abitazioni». Figlio di un maggiorente del partito di Massud Barzani, il leader locale, ha lasciato il lavoro di traduttore e si è messo alle dipendenze di una società di consulenza con sede a Washington. Nello spazio di nemmeno dodici mesi è stato promosso tre volte, e agisce come vice presidente della filiale d’area. Bauer è svelto e capace. «Sono gli americani che sanno apprezzare il lavoro ben fatto — ammette con malcelato orgoglio — tra poco potrò permettermi un’auto ben superiore a quella che avevo prima». Goran ha compiuto da poco 28 anni. Lo scorso anno dirigeva un avviato Internet cafè in centro, proprio di fianco al cinema Diamante che proietta film un po’ osé. Il fiuto per gli affari non gli manca, e nello spazio di una stagione ha costruito nel quartiere di Shorsh, dall’altra parte della città, Sky, un centro a tre piani dove ora sciama tutta la gioventù che gravita su Erbil. Design italiano, arredamento dalla Turchia, tecnologia da Giappone e Stati Uniti. Il mix è stordente in un’atmosfera antica come quella che si respira nella capitale curda. Eppure funziona. Caffetteria al primo piano, ristorante al secondo, videogiochi all’ultimo. Assieme a Feisal, 26 anni, inseparabile amico d’infanzia, e ai ragazzi del vecchio Internet cafè, Goran prepara nuovi progetti. «Voglio costruire un centro di comunicazione senza fili. E poi, tra qualche giorno, andremo a Dubai, negli Emirati arabi, per studiare come hanno tirato su i grandi complessi commerciali. È venuto il momento di provarci anche qui, e noi siamo pronti a farlo. Ho tante idee in testa, cerco di realizzarle una per volta. Ma quest’anno l’investimento principale riguarda me stesso: vorrei andare un anno ad Harvard e specializzarmi in amministrazione pubblica. Dopo, si vedrà». Goran non porta più i maglioni da giovane studente universitario. Ha lasciato nell’armadio il vecchio guardaroba e ora indossa solo gessati. Come Feisal. E tutti i ragazzi del gruppo. Una divisa. Forse il giovane imprenditore pensa a una futura carriera in politica. «Mio padre lo scorso anno è rimasto ucciso nella doppia strage fatta a Erbil da Ansar al Islam: morirono duecento persone. Io gli arabi li odio. Questa zona non ha più nulla a che fare con il resto del paese. Qui c’è il Kurdistan». Il miracolo economico Tre storie diverse, ma simili, e potrebbero essere mille. Benvenuti nell’altro Iraq. Formalmente, una regione ancora attaccata ai confini nazionali. Nei fatti, e nella testa della sua gente, non più. Il Kurdistan, ormai, vive di vita propria. Una realtà diversa. Che se ancora da un punto di vista politico e istituzionale resta unita a Bagdad, sotto altri profili, quello economico prima di tutto, è adesso del tutto slegata. Insieme con la società civile irachena emersa dalle elezioni del 30 gennaio, c’è a nord uno Stato nascente. Di cui la rapida trasformazione subita dalle città curde è solo uno degli aspetti. Ancora un anno fa il flusso delle vetture era più simile a quello di un centro di campagna. Oggi lo sviluppo crescente ha portato il traffico di Erbil ad aggrumarsi come quello di una metropoli europea. E, fiutato il vento, note fabbriche d’automobili tedesche si sono catapultate in zona aprendo concessionarie e filiali. Vendono i prodotti a cifre irrisorie, ma i guadagni ripagano le aziende ampiamente. Il risultato è che adesso ogni famiglia curda possiede due, tre, a volte quattro vetture nuove di zecca. E l’indotto seguirà. Una buona parte delle strade è asfaltata, ma altre vie di comunicazione vanno migliorate, e tra un po’ di tempo un’autostrada collegherà l’aeroporto di Erbil verso ovest con la frontiera turca, e verso est con l’altra grande città locale, la moderna Suleymania. Nei centri urbani il traffico, aumentato vertiginosamente, però è ancora regolato da sparuti vigili. C’è bisogno di semafori e segnaletica stradale. Il primo imprenditore che farà scalo a Erbil, Suleymania, Dohuk, Dokan, Zakho, Halabja, per costruire strade, palazzi, alberghi, stadi, complessi commerciali e residenziali, non c’è dubbio, farà fortuna. Per molti aspetti, il Kurdistan sembra oggi il Far West americano. Un territorio nuovo, inesplorato che, pur tra rischi e possibilità di agguati (la situazione è pericolosa e ancora altamente instabile soprattutto attorno alle due città di Mosul e Kirkuk, immerse nel petrolio ma divise fra etnie contrapposte), si apre alla conquista. Frotte di avventurieri ed esploratori stranieri, turchi, tedeschi, americani, si stanno lanciando alla volta del nord Iraq, spesso concludendo affari colossali. «C’è bisogno di tutto — spiega Sherwan, che dal traffico di camion sta ampliando il suo raggio di azione verso nuovi fronti commerciali — dai semafori agli alberghi, dalle scuole ai negozi, fino ai cellulari che sostituiscano i costosi telefoni satellitari. E noi qui possiamo offrire molto. Questa è una terra ricca, non solo di petrolio, ma di minerali pregiati e di marmi belli come quelli italiani, di acque termali e montagne innevate dove poter costruire impianti sciistici». Un’azienda vinicola italiana ha appena concluso un contratto per sfruttare i vigneti coltivati a nord di Erbil e produrre così un buon vino da pasto, bevanda non disdegnata dalla popolazione locale, di religione musulmana sunnita ma di ferme tradizioni laiche. Un governatore locale sta seriamente pensando a promuovere il turismo, idea che da lontano, osservando le immagini sull’Iraq sconvolto dal terrorismo, potrebbe apparire quanto meno balzana. «La gente trova difficile credere che da queste parti esista una zona sicura — spiega il ministro per le municipalità curde Barzan Dezayee — ma dobbiamo convincerla che non tutto l’Iraq è come Falluja, che il Kurdistan è tranquillo». Molti segnali rivelano la svolta. Centri polifunzionali crescono ovunque, e dentro sembra di essere in una qualunque città americana o nord europea. La vita di tutti i cittadini poi, è migliorata. I curdi oggi fanno spesso più di un lavoro, indossano capi d’abbigliamento più pregiati, e nello spazio di un solo anno gli stipendi, trainati dal volume d’affari circolante e dagli impressionanti introiti derivanti dal petrolio ancora sotto il loro controllo, si sono triplicati. Il denaro gira, e in grande quantità. Qui nessuno si lamenta. Sono tutti ottimisti. Di più, felici. La guerra, fortemente voluta dai leader Barzani e Talabani, poi combattuta a fianco degli ame- SCENE DI VITA QUOTIDIANA Una veduta aerea di Erbil. Sotto, un’anziana donna che trasporta un sacco per i rifornimenti, in basso ancora donne in un supermarket di Dohuk. Nella foto grande la Khanzad Home: centro di ascolto e di protezione per le donne. Nell’altra pagina in basso una mamma con bambino in una strada di Halebja FOTO NEWSHA TAVAKOLIAN/POLARIS/GRAZIA NERI MARCO ANSALDO FOTO AGOSTINO PACCIANI/ANZENBERGER Kurdistan, l’altro Iraq che ha scoperto la felicità “Gli affari non vanno bene, vanno benissimo”, dice un giovane businessman. “Questa è una terra ricca e non solo di petrolio. Il futuro? Possiamo puntare persino sul turismo” LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 FOTO NEWSHA TAVAKOLIAN/POLARIS/GRAZIA NERI FOTO AGOSTINO PACCIANI/ANZENBERGER DOMENICA 10 APRILE 2005 ricani, e infine vinta contro il comune nemico Saddam, ha sovvertito la situazione di frustrazione precedente. L’ora del riscatto Sì, i curdi sono felici. Un fenomeno di questi tempi difficilmente riscontrabile altrove. E mostrano una grinta in molte latitudini dimenticata. Sono sempre stati gli sconfitti della Storia, i battuti da cento trattati internazionali che hanno spesso giocato a loro sfavore, un popolo alla perenne ricerca di un proprio Stato o almeno di una stabilità politica. E adesso l’onda degli eventi internazionali sembra premiarli, fino a farli apparire come i vincitori. È ancora presto per dire l’ultima parola. Ma i curdi stanno provando a emergere dall’imbuto storico in cui erano finiti, usando tutta la capacità e l’intelligenza forgiate da secoli di batoste. Ci provano intanto da un punto di vista politico. Con abilità e prudenza, alle recenti elezioni i leader si sono presentati alle urne parlando di «unità dell’Iraq, all’interno in un sistema federale che assicuri ampia autonomia alle regioni». Si sono così assicurati il 25,4 per cento dei consensi nazionali: sono decisivi in Parlamento e soprattutto nel governo di Bagdad (dove detengono per ora ben sei ministeri in posizioni chiave, di cui due assegnati a donne) e cercano di amalgamare la realtà locale guidando una solida amministrazione pubblica nella zona sotto il loro controllo. Jalal Talabani è stato nominato questa settimana nuovo capo dello Stato iracheno. Eppure la questione quasi tenuta nascosta durante il voto, resa tuttavia palese dal proliferare di tendoni piazzati a fianco dei seggi ufficiali, è quella dell’indipendenza. Negli scrutini effettuati in via informale e del tutto consultiva, ma dall’esito indicativo, la percentuale di voti favorevoli a un referendum per un Kurdistan indipendente è stata del 98,7 per cento. Un plebiscito. Due milioni di voti su nemmeno cinque di popolazione totale. Pare che alle urne si siano presentati in qualche caso anche i bambini e non pochi elettori con una doppia scheda. Ma i brogli manifesti hanno rafforzato ancor di più la determinazione di un obiettivo preciso. Cautela vuole che i curdi procedano comunque nella direzione desiderata — il sognodiunKurdistanindipendente—per gradi. La cosiddetta no fly zone, l’area di non volo per dodici anni garantita da Usa e Gran Bretagna con gli aerei decollati dalla base turca di Incirlik, iniziativa nata per proteggere la popolazione da nuovi massacri dopo i gas chimici lanciati dal regime di Saddam su Halabja, ha regalato all’intera regione un periodo di pace e prosperità considerata oggi come “l’età dell’oro”. Garantendofinoal2003,alloscoppiodelconflitto, il raggiungimento di un’autonomia di fatto. Adesso questa autonomia viene reclamata con forza dai curdi, che la pretendono scritta nella Costituzione. E si diconoprontiabloccarelanuovaCarta(possono tecnicamente farlo, avendo ben tre regioni a disposizione) qualora le loro richieste non vengano accolte. Il progetto sperato è ancora lontano. Autonomia non significa per ora indipendenza. Ma le basi, economiche e istituzionali, ci sono tutte. I curdi battono moneta (il dinaro curdo), hanno un esercito (i peshmerga, guerrieri come dice il nome “che guardano la morte in faccia”), un’amministrazione con proprio governo e parlamento, rilasciano regolari visti di ingresso in modo del tutto libero da Bagdad. Sulle strade sventola il loro tricolore con un sole splendente in mezzo, e nemmeno per sbaglio si incrocia il vessillo nazionale iracheno. I curdi guardano con fastidio ai vicini arabi, persiani e turchi, ben sapendo che proprio da loro, Siria, Iran e Turchia giungeranno i veti volti a fermare il sogno di costruire una patria. Ma sono sempre pronti a battersi. Seppellendo le tradizionali rivalità tribali che li hanno costantemente divisi, costringendoli a improbabili alleanze (con Saddam persino) e a sconfitte memorabili (diplomatiche e militari). «Questo non è l’Iraq, è il Kurdistan. E io sono curdo. I am kurdish people». Forse in modo un po’ sgrammaticato, ma ogni persona incontrata per strada esprime chiaramente il suo pensiero. E non c’è bisogno di ulteriori dichiarazioni di appartenenza, che ogni interlocutore fa di sua spontanea volontà battendosi più volte il pugno sul cuore. A poco a poco, dietro la spinta della gente anche il linguaggio dei politici sta cambiando. Fino a ieri i leader curdi si sono pronunciati per un Iraq unito e federale, come vuole la dottrina insegnata dagli alleati americani. Ma le prime crepe si intravedono, persino nella coalizione con gli Usa, invitati ora almeno a considerare di poter lasciare il paese. «Avere un nostro Stato — dice oggi Massud Barzani, a cui la nomina di Talabani a presidente ha per ora lasciato campo libero come leader unico nel nord — è un nostro diritto naturale. Non è ancora giunto il momento. Ma spero, nella mia vita, di vedere il Kurdistan indipendente». Sherwan, Bauer e Goran sarebbero d’accordo. Ma il futuro politico è ancora incerto RENZO GUOLO trana sensazione quella che si vive nel Kurdistan iracheno. Si festeggia la storica nomina a presidente dell’Iraq di Jalal Talabani; ma questo evento, impensabile sino a qualche anno fa, salutato con feste e danze nella regione, non dirada la preoccupazione per il futuro. E ora, che accadrà? È la domanda che si fanno tutti. Sin qui la linea seguita della leadership curda ha pagato. L’alleanza tra Unione patriottica del Kurdistan di Talabani e il Partito democratico del Kurdistan di Barzani, ha ottenuto un ottimo risultato alle elezioni del 30 gennaio: il 25,4 per cento dei voti e 75 seggi. E ha trionfato nelle tre province di Sulemaniyah, Arbil e Dohuk. Soprattutto, ha vinto nelle province miste di Tamim e Niniveh, che comprendono le città di Kirkuk e Mosul. Eppure la nascita del nuovo Iraq sembra aver segnato la fine della nuova “età dell’oro” curda. Negli ultimi quindici anni, complice un Saddam lanciatosi nella suicida avventura kuwaitiana, i curdi hanno vissuto una sorta di indipendenza di fatto. Hanno formato un esercito, coniato moneta, beneficiato delle royalties petrolifere dei pozzi sotto il loro controllo, praticato una politica doganale servita da volano alla rinata economia locale. Ora tutto potrebbe essere messo in discussione. Un nuovo potere, legittimato dalle elezioni, e sponsorizzato dagli Stati Uniti, si instaura a Bagdad. Un governo a guida araba: questa volta sciita. Al quale, per la prima volta dopo lungo tempo, occorre rendere conto. Come dimostrano i non facili rapporti con l’Aui, la lista sciita benedetta da Sistani che ha conquistato la maggioranza assoluta nella Costituente, sin dai primi giorni dell’insediamento della nuova assemblea. Certo, l’obbligato accordo istituzionale con i seguaci dell’ayatollah di Najaf, ai quali è andata la guida del governo con Jaafari, ha retto. Ma è questa nuova, forzata, sovranità condivisa che i curdi non amano troppo. Dopo il grande tributo di sangue pagato per sottrarsi all’arabità, prodotto storico della divisione forzata della nazione, il timore è che quel fantasma ricompaia nella veste della shi’a. E voglia, oltre che uno stato islamico, mettere in discussione conquiste ottenute con grande sacrifico. Per evitare una nemesi che trasformi la caduta di Saddam in pietra tombale delle loro aspirazioni, i curdi reclamano un federalismo etnico che assomiglia a una sorta di “cantonalizzazione alla bosniaca”. Un federalismo in cui il potere centrale sia, più che altro un’istituzione di facciata. Ottenere questo “federalismo debole” non sarà facile: sulla richiesta curda si decide l’intero assetto geopolitico dell’Iraq. E già gli sciiti lasciano balenare, a loro volta, l’i- S potesi di costituire una regione autonoma se non vi sarà un accordo in materia ritenuto soddisfacente. Per parare i contraccolpi della difficile transizione i partiti curdi, Pdk e Upk, hanno messo da parte le storiche rivalità e dato vita all’unità nazionale. I curdi intendono gettare sul tavolo anche il peso del referendum, non ufficiale, svoltosi nelle loro province nello stesso giorno delle elezioni. Referendum che ha visto trionfare, plebiscitariamente, il “si” all’indipendenza. Anche se la loro “arma di riserva” resta la clausola delle “tre province”. La nuova carta fondamentale sarà, infatti, sottoposta a referendum confermativo e dovrà ottenere l’avallo di almeno quindici delle diciotto province irachene. Il voto di quelle curde, a cui potrebbe aggiungersi quello delle province sunnite decise anch’esse a contrastare un forte potere sciita, permette di bloccare ipotesi sgradite. Anche se un simile scenario implica inevitabilmente l’inasprimento del conflitto etnoconfessionale. I curdi chiedono anche che Kirkuk sia capitale della loro regione. La città contesa è stata arabizzata da Saddam. L’ex-rais, in una sorta di pulizia etnica, ha costretto all’emigrazione migliaia di curdi. Lasciando campo libero ad arabi e turcomanni, che a loro volta rifiutano ora di andarsene. Il “no” che più conta viene, però, dall’ingombrante vicino turco. Ankara considera i turcomanni, gruppo etnico non arabo che rappresenta circa il 12% della popolazione irachena, autentici turchi; e la sua politica estera prevede la tutela delle “minoranze turche” fuori confine. Tanto più quando quella tutela incrocia la strada dei curdi. Ma anche Iran e Siria, legate su più fronti a un comune destino, guardano con preoccupazione a quanto avviene nel Nord dell’Iraq. Anche perché temono una presenza di Israele nell’area. Nel Nord sono in corso acquisizioni, da parte di ebrei curdi, di terre che gli arabi lasciano per timore di un futuro in ambiente ostile. Un fatto che manda in fibrillazione siriani e iraniani, turbati dall’incubo di un potenziale yishuv ebraico nel cuore del Medioriente. Preoccupazione chesi interseca con la questione del petrolio. Quell’oro nero che i curdi non vorrebbero dividere con gli sciiti, e che un giorno un Kurdistan autonomo potrebbe pompare in una pipeline che parte da Kirkuk e finisce a Haifa. Una prospettiva, quella di una nuova rotta del petrolio curda-israeliana, assai temibile per i paesi islamici dell’area. Anche se abituati agli angusti spazi delle gole di montagna, è davvero una via stretta e impervia quella da cui devono ancora passare i curdi. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 le storie/1 Venti anni fa la dottoressa Awa Marie Coll-Seck visitò un dispensario nel Senegal. E lì lasciò il cuore. Decise così di dedicare la vita alla malattia che in Africa uccide un milione di persone l’anno. Siamo andati a trovarla in un piccolo villaggio nella savana, dove l’infezione portata dalle zanzare rischia di diventare più devastante dell’Aids Donne coraggio FOTO PIERRE RENE-WORMS “La mia lotta contro la malaria” O GUEREW (Senegal) ttanta chilometri di pista di terra rossa e da Dakar arrivi a Guerew, un villaggio della Petite Côte non affacciato sul mare. Poco più di mille anime. Case in mattoni di fango e tetti di lamiera. Non tutte così, quasi. Una parte resta in fango e paglia, sorda al programma briques et tôles (mattoni e lamiera) strombazzato da anni in molti paesi africani. Ma stamane Guerew ha la sua dignità. E la sua fortuna. Da una “4x4” impolverata è sceso nientedimeno che Youssou N’Dour, gloria nazionale senegalese, più rispettato, più seguito, più blandito di El Hadji Diouf, Leone della Teranga (la squadra di calcio del Senegal). La popolazione lo aspettava da ore sotto il sole in una situazione istituzionale: una tribuna costruita per l’occasione e, all’ombra, alcune poltrone in velluto nel pomposo stile del mobilio africano, prese in prestito da qualche salotto buono. Militari, notabili. Un microfono. Discorsi ufficiali, molto diversi da quelli che la sera prima Youssou N’Dour aveva fatto da un palcoscenico durante l’ultima delle due serate del festival Live Africanello stadio Iba Mar Diop di Dakar. Ma con lo stesso argomento: la malaria. Sotto l’occhio delle cineprese (da luglio, grazie a un documentario, inizierà una campagna mondiale di sensibilizzazione contro la malaria), il cantante consegna ad alcune donne altrettante zanzariere impregnate di insetticida. Il resto, ancora chiuso nei cartoni nella “4x4”, verrà distribuito da volontari per le case del villaggio. Awa Marie Coll-Seck si infila nel dedalo delle stradine, lontano dall’eccitazione per l’arrivo della star. Oggi vive a Ginevra ed è segretaria generale di Roll Back Malaria, associazione creata nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della sanità, dal Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, dall’Unicef e dalla Banca mondiale. Ma nel 2001 è stata ministro senegalese della Sanità. E una ventina di anni fa ha lasciato il cuore in un dispensario nella brousse, la savana. È in una zona rurale vicino a Saint Louis — seconda città del Senegal — che la professoressa Coll-Seck ha fatto il suo tirocinio di giovane medico. «Mio padre era dottore, mia madre insegnante. Sin da piccola sapevo che avrei studiato medicina. Il mio sogno era la cardiologia. Mi sembrava che attraverso il cuore si potesse curare l’umanità intera. Dopo l’università mi hanno mandato nella broussea fare esperienza. E lì mi sono accorta che il grande problema del mio paese, e di tutta l’Africa, era la malaria. In città si vedeva meno, non mi rendevo conto. Tornata a Dakar dopo un anno, mi sono messa a studiare malattie infettive. Ed eccomi qui». Quando era ancora ministro, nel 2003, Awa Marie Coll-Seck aveva organizzato un “Telethon” senegalese contro la malaria e aveva raccolto circa un milione di dollari. La stessa cifra che, nel gennaio scorso, per la stessa causa, Sharon Stone ha assemblato in pochi minuti al Forum economico mondiale di Davos. «È stata una buona idea», commenta la signora Coll-Seck. «Abbiamo molto bisogno dell’Occidente». Abiti laceri Nel piccolo dispensario di Guerew non vedi morire bambini, almeno non oggi. Capisci però perché bisogna fare presto. Questa casa un poco più grande delle altre, appena fuori dal centro abitato, potrebbe essere in ogni villaggio africano. Anche l’umanità in visita è la stessa. Le donne hanno i fianchi stretti nei pagne, i tessuti colorati; gli uomini indossano gli abiti laceri con i quali si avviano al campo; solo i bambini hanno (spesso) il vestito della festa. C’è la febbre negli occhi di tutti. Le coeur chauffe, il cuore riscalda, dice un adolescente. È la parola d’ordine. Significa malaria. L’infermiere scrive sul carnet de santé, la metà di un quaderno a quadretti tagliato in senso orizzontale. L’infer- 3.000 I bambini sotto i 5 anni che in Africa muoiono ogni giorno di malaria 40% La percentuale della popolazione mondiale minacciata dalla malaria miere si chiama Lavenir, senza apostrofo. Suo padre l’ha chiamato così perché nutriva grandi speranze per il futuro. Ma Lavenir crede che al maiale del suo vicino abbiano tirato il malocchio, e così il futuro resta, ancora e sempre, il passato. «Arrivano nei dispensari quando non ce la fanno più, quando si rassegnano al fatto che la medicina tradizionale non possa curarli. Ma spesso è troppo tardi. La malaria va presa in tempo, nelle prime ventiquattro ore, se no sono guai», dice la signora Coll-Seck. Nel dispensario è entrata una donna. Ha occhi liquidi di febbre, trascina le ciabatte senza staccarle dal suolo. Sulla guancia destra ha una piaga aperta perfettamente circolare, un’ustione grande come il fondo una bottiglia. Lavenir le alza la maglia. Il ventre della donna è coperto da minuscole cicatrici. Tagli di lametta. «Fanno così per fare uscire l’aria, perché il corpo respiri», dice la Coll-Seck. «Noi non siamo contro i rimedi all’indigène, cerchiamo anzi di collaborare con la medicina tradizionale. Per esempio, da qualche tempo in Benin i medici tradizionali rifiutano di curare i bambini, li mandano direttamente nei dispensari». Proprio perché la malaria è ormai soltanto una malattia dei paesi in via di sviluppo; proprio perché in Africa colpisce tra i FOTO AP LAURA PUTTI SHARON STONE In alto, giovani donne del villaggio di Guerew. Qui sopra, Sharon Stone a Davos Il diplomatico Ferdinando Salleo: “Da piccolo mi ammalai in Sicilia” Quando la febbre colpiva in Italia ono in pochi a ricordare di quando la malaria colpiva anche l’Italia, di quando i bambini morivano anche da noi, di quando il chinino, unico rimedio conosciuto, era monopolio di Stato e si comprava dal tabaccaio. Ferdinando Salleo lo ricorda bene. Perché molto prima di diventare un importante diplomatico italiano, prima di vivere a Parigi, New York, Praga, Bonn, Mosca, Washington, Salleo viveva in Sicilia ed era un bambino con la malaria. La zanzara, l’anòfele ha sconvolto la sua infanzia. «La malaria era molto diffusa in Sicilia» dice l’ambasciatore. «Io la presi a sei anni, nel ’42, alla fine della guerra. Eravamo rifugiati in un paese in provincia di Messina. Ricordo benissimo il freddo improvviso, la febbre altissima del terzo giorno. Gli attacchi sono andati avanti per circa quattro anni, ad ogni mezza stagione. Nel ’43, quando sbarcarono in Sicilia, gli alleati portarono il Ddt in quantità enormi, e una medicina della quale S ancora ricordo il nome: Atebrin. A me andò bene, ma la sorella di mia madre morì. Aveva preso la malaria perniciosa, la più terribile». Si moriva nel Lazio (prima della bonifica Pontina), si moriva in Maremma, non solo in Sicilia. «Quando nell’81 diventai direttore generale della Cooperazione italiana per lo sviluppo, scelsi Guido Bertolaso come capo dei servizi sanitari». L’attuale direttore generale della Protezione Civile è un infettivologo con esperienze in Thailandia e in Cambogia. Salleo e Bertolaso si concentrarono sull’Africa. «Iniziammo una campagna ispirata dal grande malariologo Mario Coluzzi. Ci unimmo alla Sclavo nella ricerca di un vaccino. C’eravamo quasi. Bertolaso andò in Cina, nello Yunnan, dove cresce l’artemisia che oggi sembra essere l’unico rimedio contro il parassita. Con i cinesi facemmo un protocollo d’intesa per poterla utilizzare. Ma ci mancarono i fondi e il sogno del vaccino svanì». (l.p.) 300 e i 500 milioni di persone ogni anno e ne uccide più di un milione; proprio perché è la prima causa di mortalità dei bambini africani sotto i cinque anni, qui si sta sviluppando una rete di ong locali. «Roll Back Malariaha “antenne” in ogni paese africano e nel consiglio di amministrazione ha rappresentanti di ong specializzate nella lotta alla zanzara. Le nostre “antenne” ci informano costantemente. Sono operatori della salute, vivono soprattutto nelle zone rurali, che sono l’80 per cento del continente. Grazie a loro sappiamo che, se non si troveranno nuovi farmaci, la malaria diventerà sempre più mortale, diventerà come l’Aids». Il nuovo parassita Il nemico si chiama adesso Plasmodium Falciparum ed è un parassita (sempre trasmesso dalla zanzara) resistente ai rimedi classici come la clorochina o l’amodiachina. «Il sud est asiatico ne è invaso, e così l’Africa dell’est e quella del sud. Il Falciparum si sta estendendo al centro e presto arriverà all’ovest, dunque in Senegal, in Mali, in Camerun. Con le medicine classiche ancora riusciamo a contenere il Plasmodium Vivax; l’altro si combatte oramai soltanto con l’artemisina, derivato dall’artemisia, pianta che cresce soltanto nella Cina del sud». Sono cose che neanche Lavenir potrebbe immaginare. Del prodotto cinese ha sentito dire, ma dove sia la Cina, questo non lo sa. La compagnia svizzera Novartis ha messo in vendita il Coartem, a base di artemisina, già in uso con successo in Sudafrica. Ma siamo alle solite: l’artemisia è una pianta a crescita lenta e la sua coltura è appena uscita dalla Cina per essere sperimentata in Tanzania e in Kenya. Quindi una scatola di Coartem costa due dollari e mezzo. Troppo cara per una signora febbricitante e tagliuzzata in un dispensario nella savana. E allora, signora Coll-Seck? «E allora non resta che la prevenzione», dice mentre da fuori giunge un gran vociare di donne e bambini. Sono arrivati i volontari con gli scatoloni e iniziano a distribuire la speranza. Che qui ha l’aspetto di un tulle bianco che odora di insetticida. «Sono le nuove zanzariere Olyset, impregnate di insetticida a lunga durata, fabbricate in Tanzania», dice la signora Coll-Seck. «Durano quattro anni invece di sei mesi. Contiamo di fabbricarne e distribuirne più di un milione all’anno». Se è vero che l’anofele (la zanzara che trasmette la malaria) colpisce dal tramonto all’alba — quando nella brousse di solito si dorme — posare una zanzariera su quattro bastoni agli angoli del letto sembrerebbe la scoperta dell’acqua calda. «A noi di città, certo. A voi occidentali, pure. Ma nei villaggi africani, prima di tutto, bisognerebbe averlo, un letto». DOMENICA 10 APRILE 2005 le storie/2 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Momenti di gloria CORRADO SANNUCCI Repubblica Nazionale 37 10/04/2005 Q uesta è la storia delle meta più bella del rugby italiano. Forse ce ne sono state di più belle ma questa è stata anche la più importante perché è quella che ha strappato il rugby italiano dalle parrocchie per consegnarlo alla Bbc. La meta segnata dopo che il pallone era passato per tutte le mani dei giocatori che avevano un sogno: portare l’Italia nel Cinque Nazioni e farlo diventare Sei. Il sogno impossibile di generazioni di giocatori e di spettatori, i quali poi nella storia d’Italia praticamente erano la stessa gente, padri, figli, nipoti, di Rovigo, Padova, Treviso. «Eravamo un gruppo di ragazzi che veniva dal nulla, che aveva il senso delle proprie origini e un obiettivo davanti» racconta Massimo Giovanelli, il capitano di quella squadra, il numero 8. A chi somiglia uno così? A uno Spartaco, un Gattuso o un Braveheart, o un Rivera o Giulio Cesare, tutti insieme, uno di loro a seconda delle battaglie del campo. Ma è il leader e il trascinatore. È il 22 marzo 1997. Tutto inizia proprio con Giovanelli che si ritrova in mano un pallone da una touche sbagliata. È il 16’ della ripresa, la partita è Francia-Italia, lo stadio è quello di Grenoble, finale di Coppa Europa. Lo stadio è pieno di italiani, c’è il sole e una lunga fila di pioppi sullo sfondo. La Francia ha appena vinto il Cinque Nazioni facendo anche il Grande Slam. Schiera i suoi maestri, Sadourny, Saint-André, Merle, Pelous, ma certo i festeggiamenti avranno pesato. Andiamo a vedere se hanno ancora le bollicine dello champagne nel sangue, si erano detti gli azzurri. L’Italia non ha mai battuto la Francia. L’Irlanda sì, ma la Francia non ancora. Le grandi del Cinque Nazioni la guardano ancora dall’alto in basso. Ma Giovanelli prima del match ha fatto un discorso da far arrampicare sui muri per l’elettricità. «Ricordatevi delle fatiche degli emigranti. La loro fatica a farsi rispettare. Voi rappresentate questa gente. Avete la responsabilità di questa maglia». Alla vigilia la squadra era stata nei bar di Grenoble, lì aveva incontrato gli emigranti. In campo si presentarono quindici pazzi scatenati. Giovanelli è sorpreso per il pallone conquistato, i compagni ancora di più e non gli danno supporto, la palla viene strappata dai francesi e ricacciata con un calcio profondo verso l’area dei 22 azzurra. La partita finora è in perfetta parità, 20-20, l’aggressività azzurra ha messo in seria difficoltà i francesi e le loro bollicine. È una partita che attende la sua svolta. «Si sentiva nell’aria che qualcosa sarebbe successo», dice Giovanelli. La vigilia è stata piena di tensione e combattività. Dalla Panda alla Jaguar Il primo giorno del ritiro, vicino al confine francese, Franco Properzi era arrivato in ritardo inscatolato nella sua Panda. Era uno sgarro alle regole, Giovanelli, nel suo ruolo di capitano, lo aveva affrontato, erano volate parole grosse, Franco era incavolato perché si era perso, ci voleva del fegato a mettere a posto quel gigantesco pilone. Poi, dopo avere recitato ognuno la propria parte, si erano calmati e avevano chiarito. Non lo sapevano ma stava per finire l’era delle Panda e cominciava quella delle Jaguar, stavano per lasciare le osterie venete dove si parlava di rugby davanti a un’ombra, il bicchiere di vino bianco, per mettersi il frac ed essere invitati ai party degli anglosassoni. Finiva il dilettantismo, cominciava il professionismo, finiva la passione che non chiede niente, cominciava il lavoro che chiede Grenoble, 22 marzo ’97: l’Italia affronta la Francia. Loro hanno vinto tutto, noi niente. La partita è perfettamente in bilico quando su una palla persa gli azzurri danno il via all’azione più bella, intensa e decisiva della storia della Nazionale. Che quel giorno chiude l’era del dilettantismo, conquista il grande pubblico e trasforma uno sport minore in un fenomeno di massa La meta che portò il rugby in Paradiso un salario. La palla adesso è nelle mani di Vaccari, nel fondo della difesa italiana. S’impappina, gli cade, rischia di perderla, tre francesi gli sono addosso, li evita sfiorando la linea laterale. È il segno della magia in arrivo. Dalla destra il pallone scorre via verso sinistra e lì c’è la seconda scintilla, quando finisce tra le mani di Javier Pertile, l’estremo italo-argentino. Lo chiamano il Gatto, ha il passo che sembra leggero ma un tempo d’entrata devastante. Crea un buco, fa una finta, poi viene stoppato, libera la palla. Adesso ce l’ha Troncon che la allarga a Diego Dominguez che la allarga ancora a Vaccari. Diego è di Cordoba, porterà per mano l’Italia nel decennio con i suoi calci e la sua saggezza tattica, ringraziando l’Italia per la fiducia in lui che non avevano avuto i suoi connazionali. L’Italia del Duemila, in compenso, quella della pancia piena e dei soldi dei diritti tv, gli userà anche qualche sgarbo, fino a escluderlo di fatto dalla nazionale. Sugli spalti sventolano le bandiere italiane. È uno strano innesto questo del rugby nel carattere italiano: perché è sport di combattimento, che non ammette sotterfugi, che obbliga alla lealtà, dove non c’è spazio per alibi o bugie. È uno sport dove non puoi sottrarti ai tuoi impegni, perché la mollezza porterebbe a ferite maggiori. Bisogna lottare anche solo per non essere distrutti. È una setta che ha lavorato per cinquant’anni per crescerlo, farlo conoscere, coltivarselo come una religione segreta, e adesso sta venendo il momento della rivelazione. Adesso la palla è a metà campo, di nuovo nelle mani di Vaccari. «In quei IL LIBRO Le foto in pagina sono tratte da “Fratelli per forza”, di Daniele Resini (Mondadori). Sopra, gli azzurri prima della sfida col Galles nel 2003. Sotto, bimbi rugbysti e la squadra delle isole Tonga tempi poteva fare quello che voleva contro ogni nazionale al mondo. Duttile, capace di partire a testa bassa come un pilone, o di fare la terza linea al momento del bisogno», ricorda il vecchio capitano. Vaccari vede un corridoio, ci si infila, lo allarga, prende venti metri, e improvvisamente i francesi sono aperti, senza più difesa, in uno stato di allarme rosso. Lo vanno a placcare ma ormai la linea è frantumata e lui fa in tempo a dare a Marcello Cuttitta, l’ala, che la tocca solo un istante per poi consegnarla a Troncon che adesso può puntare verso la meta, in una Francia ormai dissolta. In questa squadra che aveva una costola nata dalla provincia, Vaccari da Calvisano, Giovanelli da Noceto, Francescato dalla Tarvisium, i fratelli Cuttitta, Marcello e il pilone Massimo, ci hanno messo la loro infanzia sudafricana, un innesto di rugby d’élite, con una cultura di lavoro profonda. E gli stranieri erano solo tre, Diego, Pertile e Gardner, autore di una meta di forza nel primo tempo. Divertente pensare che la concione sugli emigranti abbia per primo eccitato un italo-australiano. Già, questa è la meta più bella della storia del rugby italiano e non la segnerà Ivan Francescato, un altro dei geni di questa squadra. «Lo chiamavamo il Giullare per la sua totale mancanza di rispetto nelle situazioni di gioco: oppure l’Animale per la sua capacità di sentire, odorare, quando l’avversario lo sottovalutava». Francescato era in campo all’inizio e aveva dato il via all’impresa azzurra segnando dopo pochi minuti una meta delle sue, una partenza imprevedibile e una corsa a coltello nella difesa avversaria. Si fa male toccando in meta senza tuffarsi, torna verso metà campo indicando di avere subito un contraccolpo alla coscia sinistra. Uscirà dal campo piangendo intorno alla metà del primo tempo, ed è il ricordo più struggente di quella partita, perché Francescato sarebbe morto per un arresto cardiaco appena un anno e mezzo dopo, a gennaio ‘99. Ma, al di là di questo, allora nessuno se ne rese conto, usciva dal campo anche il rugby delle stirpi dei giocatori. Non ci saranno più in nazionale quattro Francescato, come Bruno, Nello, Ivan e Rino, né loro né nessun’altra famiglia. Gli ultimi venti metri Adesso c’è da finire la meraviglia, Troncon è in fuga in quel pomeriggio di otto anni fa, i pali sono a una ventina di metri davanti a lui. Ma pensa di non farcela e allora si guarda intorno. Incredibilmente c’è ancora un compagno pronto a dargli sostegno, e forse il più inatteso, Giambattista Croci, il lungo numero 4, che avanza con il suo passo da cammello. Chissà quale ispirazione ha seguito per venire a questo appuntamento, finora aveva dominato nella touche, con la sua aria tranquilla, la sua benda bianca intorno alla fronte e le tre magliette che si è messo come glielo avesse raccomandato la mamma in una giornata fredda. È passata una vita da quando l’azione è partita, laggiù nella propria difesa, e la vita sarà diversa adesso che si fa meta. Croci prende il pallone e corre a schiacciarlo a terra, e il suo è quasi un timbrare il modulo d’ammissione al Sei Nazioni. È stata una meta dalla «fine del mondo» come si dice di quelle partite dal fondo della propria difesa, e l’Italia è capace di queste meraviglie. Croci torna lentamente verso la metà campo, senza esultare, i rugbisti non festeggiano sguaiatamente. «Ma io ero un po’ stanco», racconterà dopo. L’Italia vincerà 40-32, e al fischio finale c’è un’invasione di campo, il ct Coste piangerà come un bambino, un francese che ha battuto la Francia, un francese che ha portato l’Italia tra i grandi del rugby. La partita perfetta è stata giocata, la meta più bella di sempre segnata. Sono passati solo otto anni e quel mondo è così lontano. Tre anni dopo, nel 2000, l’Italia faceva l’esordio nel Sei Nazioni a Roma contro la Scozia. In realtà è già cambiato tutto dal giorno di Grenoble, il ct è un ex pilone sudafricano, c’è lo stupore di tutti per i nuovi riti, gli sponsor, la nuova dimensione dello show planetario alla quale è ammessa l’Italia. Giovanelli non è più il capitano ma viene invitato a tenere il discorso prima della gara. «C’è gente che ha pianto per vedere l’ingresso dell’Italia nel Sei Nazioni e noi non abbiamo il diritto di buttare via la partita». I compagni assentono. «E poi ricordatevi di Ivan Francescato». I compagni sussultano. L’Italia vinse, con le energie e la passione che erano di tre anni prima. Massimo Giovanelli giocò la sua ultima partita, in uno scontro di gioco si procurò un distacco della retina, le partite più felici dell’Italia sono state marcate dai segnali di qualcosa che si chiudeva. Il rugby intanto cresce, muta, in maniera rapidissima. Lo stadio canta l’inno di Mameli, c’è un modo di vivere la partita che ha fatto scuola. Le birrerie intorno al Flaminio si arricchiscono con i tifosi anglosassoni e francesi, a modo suo il Sei Nazioni è una festa europea, di guerrieri solidali. Sono arrivati tanti soldi, forse troppi. I giocatori di Grenoble vincendo la partita hanno ucciso il proprio mondo. «Mettimi dove ti pare ma mettimi la maglia azzurra addosso, questa era la mia filosofia», dice Giovanelli. Giambattista Croci è fuori dal rugby e lavora in banca. 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il viaggio Genti antiche DOMENICA 10 APRILE 2005 Sono stati i primi abitanti della Cina e per questo li chiamano anche “aborigeni”. Dominavano le grandi pianure, poi di sconfitta in sconfitta sono stati cacciati sulle montagne del sud-ovest. I superstiti ora vivono in povertà in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo Il mistero del popolo Miao FEDERICO RAMPINI L KAILI (Guizhou) Repubblica Nazionale 38 10/04/2005 a strada dondola piacevolmente in mezzo alle colline carsiche dai profili bizzarri. I prati di colza in fiore sono una gioia per gli occhi, ogni tanto la testa di una donna affiora in mezzo a una distesa di alti fiori gialli. Sui pendii secoli di fatica hanno scolpito il paesaggio elegante delle risaie a terrazza con le loro forme sinuose. Nessuna macchina agricola è arrivata fin quassù, nei campi ci sono solo contadini curvi nell’acqua delle risaie inondate, come ai tempi dei nonni dei loro nonni l’unico aiuto è il bufalo che arranca con la pancia nel fango. Per strada si incrociano gruppi che scendono a valle con grandi ceste vuote sulle spalle. Camminano fino a Kaili dove sosteranno sui marciapiedi in attesa che qualcuno li affitti. Vendono la nuda forza delle loro schiene, se sono fortunati si guadagneranno la giornata trasportando pesi immensi. In città li usano al posto dei camion, su e giù con quelle ceste sgombrano montagne di detriti dei cantieri edili. È lontana Pechino, con i suoi problemi da capitale imperiale, le sue manovre strategiche verso Taiwan o il Giappone. Sono lontane Shanghai e Canton, le loro preoccupazioni di inflazione immobiliare, le bolle speculative, il “denaro caldo” che arriva a miliardi dall’estero. Kaili, capoluogo di contea, appartiene a quella Cina immensa dove non è ancora arrivato un McDonald’s, un Kentucky Fried Chicken, un caffè Starbucks, né gli ingorghi di Audi e Bmw. In auto da Kaili dopo due ore si arriva in vista dei villaggi di Shiqiao e Qingman, poche casette di pietra e legno scuro che da lontano sembrano chalet, con i tetti appuntiti di tegole nere. È su questi monti l’ultimo rifugio del popolo Miao. Li chiamano gli aborigeni, perché furono i primi ad abitare la Cina. Loro preferiscono considerarsi una nazione. Se quattromila anni fa la storia avesse avuto un corso diverso avrebbero potuto dominare la Cina, ora la loro cultura sta scomparendo in silenzio. La storia di questa etnìa è piena di misteri perché hanno solo linguaggi orali, quelli in cui si tramandano 15.000 versi di canzoni. Praticavano culti totemici, nelle loro leggende compaiono creature metà uomini e metà bufali, nella notte dei tempi furono probabilmente i veri inventori della tecnica dei batik, le stoffe immerse nei colori vegetali e disegnate con la cera calda. Formavano una società agricola egualitaria in cui gli antropologi hanno intravisto una sorta di comunismo primordiale. Ai tempi del leggendario capo Chiyou erano i padroni delle grandi pianure tra il Fiume Giallo e lo Yangtze, la pancia fertile della Cina. Poi arrivarono le invasioni degli Han — i cinesi attuali — e di sconfitta in sconfitta ripiegarono sulle montagne; siccome la storia la scrivono i vincitori, furono battezzati Miao che voleva dire “barbari”. Ne rimangono otto milioni, la maggior parte qui attorno a Guiyang e Kaili nella provincia del Guizhou (sud-ovest della Cina). Altri a furia di fuggire finirono in Indocina dove li chiamano Hmong. Spesso perseguitati in Vietnam e Laos, Per arrivare nei loro villaggi sperduti non ci sono strade. L’isolamento ha mantenuto tradizioni magnifiche: i costumi delle contadine sono tra i più belli, le feste rituali sono uno spettacolo. Ma dalle risaie ricavano a stento di che vivere alla fine della guerra negli anni Settanta furono i primi boat-people: duecentomila rifugiati vivono in America. La più enigmatica delle loro tradizioni è un lungo “canto della creazione” in lingua Miao — composto a quanto pare prima di ogni contatto con l’Occidente — che contiene un’allegoria della separazione originaria tra loro e i cinesi, ma ha anche strane analogie con la Genesi biblica, perché descrive una sorta di diluvio universale e una torre di Babele. Nei versi iniziali recita: “In quel giorno Dio creò i cieli e la terra. In quel giorno aprì i cancelli della luce. Sulla terra fece montagne di pietra. In cielo fece le stelle, il sole e la luna. In terra creò il falco e l’aquilone. In acqua il pesce e l’aragosta. Nei boschi mise la tigre e l’orso, fece le piante per coprire le montagne, le foreste invasero l’orizzonte, fece la canna verde e leggera fece il bambù robusto. Sulla terra creò l’uomo dal fango. Dall’uomo formò la donna. Quindi il Patriarca Fango fece una bilancia di pietre. Misurò il peso di tutta la terra. Misurò la grandezza delle stelle. La terra si riempì di tribù e di famiglie. La creazione fu condivisa dai clan e dai popoli. Si combatterono tra loro sfidando la volontà del creatore. Allora la terra fu scossa fino alla profondità di tre strati”. Per salire fino al villaggio Shiqiao bisogna lasciare l’automobile e proseguire a piedi su un sentiero. Presto arri- verà fin qui una vera strada, finanziata dallo Stato. La stanno costruendo con le loro braccia, vanghe e picconi, una ventina di donne Miao. Yuan Qizhi, 31 anni, sorride felice nel dirmi quanto la pagano. Venti yuan cioè due euro al giorno. Una fortuna per queste contadine, finché dura. Dall’alba al tramonto a picconare: «Non è un lavoro pesante in confronto a quello che facciamo di solito nelle risaie, e qui guadagniamo molto di più», assicura Yuan. Scava e parla con le sue amiche, scherzano divertite dal raro passaggio di un bianco. Lavorano ridendo e sembra davvero che la fatica sia lieve per queste donne, visto che invitano la mia interprete a raggiungerle la sera al villaggio per ballare insieme. Più avanti lungo il sentiero ci sono i loro uomini che per dodici ore al giorno spaccano pietre. Poi come fantasmi un gruppo di minatori dalle facce nere emergono dal cratere di una piccola cava di carbone a cielo aperto, a poche centinaia di metri dal villaggio. A Shiqiao ci accoglie Long Rongcheng, il più ricco fra i contadini. Ha 47 anni, guadagna seimila yuan (seicento euro) all’anno, la metà li spende per mandare due figli a scuola in città. Long ci invita in casa sua. Al piano terra la stanza più spaziosa è quella dove vivono i maiali. Ha a fianco la cucina e l’unico forno-stufa, che deve bastare per cuocere e per riscaldare tutta la casa. Al piano di sopra sono ammucchiati riso, pannocchie di mais essiccate, pezzi di lardo, strutto e carne di maiale cruda che attirano le mosche. I Miao non sanno cosa sia un frigo ma sul tetto Long esibisce un’antenna satellitare, l’unico modo per captare la tv da queste parti. LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 FOTO GAMMA FOTO CORBIS DOMENICA 10 APRILE 2005 LA VITA NEL VILLAGGIO Qui sopra, immagini della vita dei Miao nei loro villaggi: il lavoro nelle risaie, le feste tradizionali e la tessitura dei loro antichi vestiti. Sotto, due contadini in cammino sulle montagne nel sud-ovest della Cina Repubblica Nazionale 39 10/04/2005 In un angolo vicino alle scorte alimentari c’è un largo giaciglio ingombro di coperte spiegazzate, è il letto di tutta la famiglia, nonni inclusi. I vestiti sono appesi a un fil di ferro che traversa il soffitto da un angolo all’altro. «Chi sta bene qui ha appena di che mangiare e vestirsi. I più poveri non guadagnano duemila yuan all’anno, non possono permettersi neppure il sale per cucinare». Long Rongcheng brontola solo per la tassa che il governo gli impone ogni volta che lui macella un maiale: 50 o 60 yuan a seconda del peso. Non protesta invece per i 1.500 yuan che ogni figlio gli costa di retta scolastica. È il prezzo perché possano fuggire da questo mondo. Il suo vicino Pan Qingyue, 70 anni, vive in una casa di una sola stanza, con i vestiti gettati per terra in un angolo vicino a un mucchietto di patate dolci. Per proteggersi dal vento gelido che soffia la sera dalle montagne, al soffitto ha incollato pezzi di polistirolo, avanzi di imballaggi raccolti nelle discariche in città. A una parete c’è un calendario dove fra tanti ideogrammi si stacca la figura di una croce. Il vecchio Pan sa poche frasi di mandarino, con fatica spiega che un secolo addietro da queste parti passarono un missionario inglese e un francese, da allora un terzo dei Miao sono protestanti. Ci accompagna fino alla minuscola chiesetta, ricostruita vent’anni fa sulle macerie di quella rasa al suolo durante la Rivoluzione culturale. Si lascia fotografare davanti al simbolo della croce, ma di fronte alla curiosità sul passato il suo sguardo si perde nel vuoto e la risposta è laconica: «Abbiamo avuto le nostre punizioni». Nella povertà i Miao hanno mante- nuto tradizioni magnifiche. I costumi antichi delle contadine sono tra i più belli della Cina: giacche e gonne di seta decorate con sofisticati motivi geometrici, grembiuli dai ricami colorati, con i bordi di maglia disegnati all’uncinetto, sfavillanti cinture di cotone. In testa portano turbanti neri o si fasciano i capelli in tessuti a strisce bianche e celesti avvolti a foggia di colbacco. I copricapi più maestosi li tirano fuori per le feste: ogni donna ha la sua corona argentata, un capolavoro di stelle e fiori lavorati nel metallo, con contorno di orecchini, collari, anelli e pendagli che ciondolano tintinnando come miriadi di campanelli. Alla “festa del bufalo”, che è il Capodanno dei Miao, ballano al suono dei lusheng, i grossi flauti verticali di bambù. Alla “festa del riso delle sorelle” si organizzano i futuri accoppiamenti: le ragazze in età di matrimonio invitano i giovani maschi, offrono acquavite e paste di glutine di riso. Alla fine delle danze e delle libagioni i giovanotti ricevono in regalo la pasta di riso da portare a casa. Se in mezzo al cibo trovano nascosta una spina, è una proposta di matrimonio; se ci sono pistilli rossi la ragazza ha fretta di convolare a nozze; il peperoncino o l’aglio sono un rifiuto. Un opuscolo raccolto negli uffici governativi di Kaili vanta tutto il bene che la Cina ha fatto ai Miao: «Prima del 1949 (l’anno della rivoluzione comunista, ndr) il 95% della popolazione era affetta da malaria, da allora è stata sradica- INVENTORI DEL BATIK Vivono in casette di pietra e legno di pino, allevano polli, tacchini e maiali, che uccidono per festeggiare l’anno nuovo, o lavorano nei campi di riso coltivati a terrazze. Ma i Miao sono famosi soprattutto per i tessuti ricamati dalle loro donne. Probabilmente furono loro, nella notte dei tempi, a inventare la tecnica del batik. Quarta minoranza etnica di tutta la Cina, hanno fama di essere un popolo indipendente e ribelle che partecipò alla sommossa contro il potere centrale dei Qing dal 1840 al 1870. Originari del nord, si spostarono dalla riviera del Fiume Giallo sempre più verso sud e, dopo le invasioni degli Han, si stabilirono sulle montagne. Furono battezzati Miao, che vuol dire “barbari”. Otto milioni in tutto, restano un popolo senza scrittura, che venera draghi e serpenti e che parla tre dialetti ta. 23.000 insegnanti hanno portato l’istruzione nei villaggi di montagna dove regnava l’analfabetismo». Nel piccolo mondo medievale di Shiqiao l’improvviso apparire di manifesti di una campagna contro l’Aids tradisce un’altra faccia della modernizzazione: facendo leva sulla miseria di questa gente, società private senza scrupoli sono venute anni fa a comprar sangue. Usavano vecchie siringhe già infettate, interi villaggi sono stati contaminati. Lo Stato centrale esibisce con orgoglio i privilegi demografici che ha concesso alle minoranze etniche come i Miao. A differenza dei cinesi Han, per il popolo di queste montagne non vale la legge sul figlio unico. Ai Miao è permesso avere famiglie numerose, per impedire che scompaiano. Otto milioni contro un miliardo e trecento: la partita è persa comunque. Nelle scuole si insegna il mandarino, lingua nazionale. «I nonni parlano solo dialetti Miao — dice Long Rongcheng — con i nipoti non si capiscono più». Anche le migliori intenzioni nascondono insidie. Per strapparli alla miseria il governo incita i Miao a scoprire il bu- siness del turismo. Sono arrivati fin qui i primi pulmini di viaggiatori, per ora soprattutto cinesi incuriositi dalla storia delle loro minoranze etniche. Si avvicina il giorno in cui la cultura e le tradizioni affascinanti dei Miao si snatureranno in “folclore”, i meravigliosi vestiti e le feste danzanti del villaggio a poco a poco subiranno una metamorfosi, diventeranno una recita per le videocamere digitali dei turisti. E poi l’antenna satellitare di Long ha già portato fin qui le immagini dell’altra Cina, le sue luccicanti promesse di benessere. I cortei dei Miao che ogni mattina all’alba scendono a valle con le ceste vuote sulle spalle, al ritorno hanno gli occhi che brillano come le vetrine illuminate dei supermercati in città. A Shiqiao le mamme che puzzano di sudore e di bufalo alla sera si sono messe lo splendido costume delle antenate e le corone d’argento, mi hanno offerto la grappa di riso e hanno ballato sulla piazza del paese. Ma in un angolo le loro figlie adolescenti immusonite indossavano jeans e finte Nike, e sognavano una discoteca. 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 Da sempre illustri studiosi e spregiudicati avventurieri cercano le tracce della cassa che custodisce le Tavole della Legge. La Bibbia la descrive e secondo la tradizione sarebbe sepolta sotto il Monte del Tempio, il luogo dove sorgono il Muro del Pianto, sacro agli ebrei, e la moschea di al-Aqsa, sacra ai musulmani. Un saggio ricostruisce le vicende tra archeologia, religione e politica sugli scavi degli “infedeli”: i negoziati di pace dovranno occuparsi anche della disputa su ciò che sta sottoterra Alla ricerca Arca dell’ Le lotte segrete nel sottosuolo di Gerusalemme perficie. A ben vedere non potrebbe essere altrimenti, tanto le sante pietre di Gerusalemme sono sovraccariIL CAIRO che di simboli. La loro terribile uniscritto nel Libro dell’Esodo cità risiede in questo: sono le pietre che Mosè, ricevute da dio le dove dio divenne storia. Non la stesTavole della Legge, le fece sa storia né lo stesso dio: ma le stesse custodire nell’Aron herit, pietre, purtroppo. l’Arca, una cassa in legno d’acacia. La Generazioni di pellegrini le hanno Bibbia ne offre una descrizione mismussate strofinandovi le mani o calnuziosa, e in un passo di grande inpestandole con i calzari; ma a levitensità racconta come re Davide e le garle ha concorso anche il passo dei tribù d’Israele portassero l’Arca in guerrieri che se le disputavano, per corteo, gridando e saltando, suonanfede, per ambizione, per avidità. do e cantando, fino al luogo dove esGrondano santità ma anche sangue. sa era venerata. Chi legge tutto queNon sbaglierebbe chi le considerasse sto come una metafora può ricavarne gli altari sacrificali del dio degli eserche secondo la citi, sempre alaBibbia la Legge cre in Medio morale deriva da Oriente. Più esatdio, i suoi precettamente sono il ti sono assoluti, pretesto cui queldunque “Non ucla divinità spesso cidere” non è una ricorre quando ha norma abrogabisete. Così i primi le da una società o gravi scontri in da un parlamento Palestina, nel a seconda delle 1929, cominciacontingenze. Ma rono quando il chi invece prenda Gran Muftì di Geil testo nel suo rusalemme accusenso letterale, sò gli ebrei di vodeve concludere ler distruggere la che l’Arca fu reale Cupola della Roce dovunque oggi cia, da cui Maosia, contenga una metto avrebbe traccia di divino. spiccato il volo Infatti la Bibbia per il paradiso. riferisce all’Arca Dalle consideravari prodigi, così zioni del Gran originando la traMuftì, di fatto indizione israelita citamenti al massecondo cui essa sacro, risultò la irradia una certa morte di duecenpresenza d’Onnitocinquanta perpotente. E in quel sone. Sospettoso caso trovarla come quel dio equivarrebbe a musulmano semDal libro trovare un’imbra il dio di quei dell’ESODO, 25,10 pronta di dio, credi cristiani cosenza dubbio la stretti alla coabipiù sensazionale tazione forzata scoperta della storia. Ma al di là delle nel tempio del Santo Sepolcro, sparsuggestioni riservate a chi crede, antito secondo confini tuttora conteche chi non crede non può restare instati: i suoi sacerdoti da decenni litidifferente alla storia antichissima gano, e talvolta si pestano, per il posscolpita nelle Tavole della Legge. E sesso di qualche scalino, di qualche questo spiega perché da tempo nel centimetro quadrato di pietra. Né sottosuolo di Gerusalemme sia avvemancano esempi analoghi sul vernuto qualcosa che Hollywood titolesante israelita. rebbe: la ricerca dell’Arca perduta. Negli ultimi decenni l’ingresso in A guidarci in questa vicenda favocampo degli archeologi avrebbe polosa è un saggio di Paolo Pieraccini tuto sedare queste risse tra idolatri (Politica, religione e archeologia in delle pietre e in futuro, chissà, riporPalestina/Israele dal 1967 al 2000), tare tutti al dio unico sepolto sotto i pubblicato da Letture Urbinati, la risassi. Invece col tempo ha preso pievista dell’Università di Urbino. Viagde un’archeologia d’ispirazione religiando tra l’archeologia e la politica giosa o politica che sembra badare Pieraccini scopre sorprendenti relasoprattutto a fondare il diritto storizioni tra lo scontro sotterraneo, letteco degli uni o degli altri: col risultato ralmente, che oppose archeologi e di complicare ulteriormente la conreligiosi, e le dinamiche politiche che tesa. Così adesso per arrivare a una si sviluppavano, per così dire, in supace tra israeliani e palestinesi la GUIDO RAMPOLDI È Repubblica Nazionale 40 10/04/2005 ‘‘ Legno e oro Faranno dunque un’arca di legno d’acacia [...]. La rivestirai d’oro puro: dentro e fuori la rivestirai [...]. Farai il coperchio d’oro puro [...]. Farai due cherubini d’oro [...]. Nell’arca collocherai la Testimonianza che io ti darò questione da risolvere non è soltanto la sovranità sulle pietre visibili, ma anche su quelle invisibili e probabili, le pietre che sono, o potrebbero essere, sottoterra. Basti pensare a cosa avvenne nell’ultimo negoziato di pace, fallito, tra governo laburista e Arafat, quando si affrontò il contenzioso sul complesso noto come il Monte del Tempio, che include Muro del Pianto, sacro agli israeliti, e la moschea al-Aqsa, sacra ai musulmani. Clinton propose di scindere la sovranità sulla superficie dalla sovranità sul sottosuolo: ai palestinesi la superficie, agli israeliani il sottosuolo. È un po’ come se stabilissimo che venti metri sotto i piedi degli italiani comincia la Francia. Inusitata e paradossale, l’opzione Clinton offriva però una possibile soluzione al conflitto che oppone, ormai da quarant’anni, due avversari acerrimi. Da una parte le autorità islamiche che amministrano i luoghi sacri ai musulmani considerano “terra araba” anche quanto sta sotto, e non gradiscono scavi archeologici “infedeli”. Dall’altra quei settori religiosi israeliani per i quali il Monte del Tempio è senza alcun dubbio proprietà della nazione ebraica, in quanto così afferma la Bibbia (in Samuele XXIV, 24, è scritto che re Davide l’acquistò dai Gebusei per 50 sicli: peraltro l’esistenza storica di Davide secondo alcuni studiosi non sarebbe provata). Il Monte del Tempio è appunto il luogo dove sarebbe sepolta l’Arca, secondo la tesi non inverosimile di alcuni gruppi religiosi. Il Tempio sorgeva sulla sommità della collina, lì dove prima c’era un altare del dio fenicio Baal e oggi la moschea di al-Aqsa. L’Arca era custodita nella stanza più segreta, cui avevano accesso solo i più alti sacerdoti in occasioni particolari. Sparì nel 587 avanti Cristo, in seguito DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 MITO E REALTÀ FOTO CORBIS/CONTRASTO Nella foto qui sotto, una antica illustrazione che rappresenta Mosé nel tabernacolo dell’Arca dell’alleanza. Nella foto in basso, uno scatto d’epoca del Monte del Tempio, il punto di Gerusalemme sacro sia agli ebrei sia ai musulmani in cui l’Arca - secondo la leggenda e gli studi di alcuni archeologipotrebbe essere sepolta: nell’immagine si distingue con precisione la Cupola della Roccia Parla lo storico Michele Piccirillo Le stalle di Salomone trasformate in moschea ELENA DUSI alla distruzione del Tempio da parte dei babilonesi. È possibile che i sacerdoti l’abbiano messa in salvo solo quando fu chiaro che la cittadella stava per capitolare; e in quel caso po- FOTO ALINARI Repubblica Nazionale 41 10/04/2005 FOTO CORBIS/CONTRASTO D IL DIPINTO Sopra, l’Arca in un dipinto murale di Luigi Ademollo a Palazzo Pitti trebbero averla nascosta proprio sotto il Tempio, dove correvano canali e forse passaggi segreti. Dovunque sia finita, ignoriamo cosa ne sia stato in seguito. Nel 63 avanti Cristo, quando Pompeo arrivò a Gerusalemme per ispezionare l’ultima conquista di Roma, visitò il Tempio, nel frattempo ricostruito, e non vi trovò «una singola immagine di dio», come scrive Tacito. I Romani ne furono sorpresi e forse si convinsero che quel santuario vuoto rappresentava un’oscura minaccia all’Impero e alle sue divinità colorate. Lo distrussero due secoli dopo, nel 70 dopo Cristo. Ci sono anche le suggestioni di questa storia millenaria dietro il forte interesse dell’archeologia israeliana per il Monte del Tempio. Ambivalente invece l’atteggiamento dei religiosi: alcuni arrivarono ad azzuffarsi con gli archeologi che intendevano scavare l’area a sud del Muro del Pianto, ritenendoli profanatori; altri sterrarono di propria iniziativa un antico canale che passava sotto le case del quartiere arabo, anche con l’idea di affermare la sovranità israeliana su quell’area. Per ottenere che il governo israeliano fermasse gli scavi sgraditi l’autorità religiosa islamica, il Waqf, argomentò che lo sterro in realtà aveva lo scopo di far crollare la moschea di al-Aqsa erodendone le fondamenta, un’antica paura araba agitata sia dal Gran Muftì negli anni Venti sia da Arafat settant’anni dopo. Da questo conflitto tra religiosi armati di badile nacque l’epica batta- glia del 1981, combattuta nelle viscere del Monte del Tempio. Da una parte alcuni rabbini e i loro studenti, che scavarono un tunnel lungo il muro occidentale fino a raggiungere una cisterna d’epoca crociata sotto la spianata. Dall’altra il personale del Waqf, che aveva preso a scavare un altro tunnel per rintuzzare l’invasione. Respinti gli avversari, in seguito anche il Waqf si diede da fare per attestarsi nel sottosuolo. A quindici metri di profondità c’erano le cosiddette Stalle di Salomone, un enorme sotterraneo di 500 metri quadrati, con 88 pilastri su dodici file, fatto costruire da re Erode e successivamente ristrutturato durante il periodo ommayade, quando divenne un sito musulmano. Dopo scontri interminabili con gli israeliani nel 1996 il Waqf riuscì a trasformare le Stalle in una moschea; e sullo slancio di quella vittoria, cominciò a scavare due antichi tunnel, anch’essi in origine ebraici, senza curarsi di eventuali reperti. Per lo scandalo dell’archeologia israeliana lo scavo venne condotto con bulldozer. Quando si scoprì che il materiale di risulta conteneva pezzetti di ceramica risalenti al Primo e al Secondo Tempio, prestigiosi intellettuali israeliani chiesero al Waqf di fermare quell’“atto irreparabile di vandalismo”. Lo scontro è ancora aperto. Probabilmente non si placherà fin quando una pace tra israeliani e palestinesi non indurrà religiosi e archeologi a fare la cosa più ovvia: scavare insieme. IL CAIRO a Mussolini erede degli imperatori romani a Saddam Hussein che imprimeva il proprio nome sui mattoni usati per ricostruire Babilonia, alla maniera di re Nabucodonosor. Salire sulle spalle dei grandi del passato e guardare il mondo dall’alto della storia: quale modo migliore per legittimare il proprio potere? E quale strumento più efficace, per ottenerlo, del piegare eventualmente l’archeologia a scopi politici o religiosi? Padre Michele Piccirillo, autore di numerosi scavi fra Israele, Palestina e Giordania e docente di Storia e geografia biblica allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha vissuto quarant’anni di diatribe archeologiche in Terrasanta. Diatribe che, nel cuore spirituale dei tre monoteismi, hanno visto ebrei laici, ebrei religiosi, musulmani, cristiani cattolici e protestanti l’un contro l’altro armati, pronti ad alzare le pale contro i colleghi-nemici. Quando iniziano i problemi in Terrasanta? «Con gli esordi dell’archeologia biblica nell’800. I primi archeologi cristiani hanno iniziato a lavorare con il preciso intento di documentare i fatti narrati nella Bibbia. Poi, con il tempo, abbiamo iniziato a scavare più serenamente, ma il problema si è riproposto con la nascita del sionismo. A quel punto archeologia e attualità, religione e politica hanno iniziato a intrecciarsi fra loro. La ricerca delle vestigia del passato da un lato e l’interpretazione dei testi sacri dall’altro sono diventati un fatto nazionale, legato alle vicende dei giorni nostri più che a criteri di scientificità. Per esempio, l’uso di alcuni termini come «periodo israelitico» in alternativa a «età del ferro» è un elemento fuorviante. In Terrasanta troviamo infatti reperti del periodo israelitico, ma appartenenti a popolazioni ben diverse dagli israeliti, come aramei, idumei, fenici o altri. Analogamente, bisogna mettersi d’accordo sulla definizione dell’antica regione della Palestina: i suoi confini si estendevano a nord solo fino al monte Carmelo, poi si entrava in territorio fenicio. Sarebbe scorretto fare paragoni con la Palestina attuale». Com’è la situazione oggi sulla spianata del Tempio, e soprattutto nel sottosuolo? «C’è una relativa calma, dopo anni terribili. Ricordo quando gli israeliani scavavano per aprire la seconda porta del tunnel che corre lungo il Muro occidentale. Il mio convento è a pochi metri di distanza, e di notte sentivo i martelli pneumatici trapanare la terra. Oggi il tunnel è tranquillamente visitato dai turisti, ma l’apertura della seconda uscita nel 1996, sotto il governo di Netanyahu, scatenò violenze terribili fra israeliani e palestinesi. Anche la moschea di Marwan è frequentata quotidianamente. Si trova nel sottosuolo, esattamente sotto la al-Aqsa, ed è diventata un luogo di preghiera riservato alle donne. Questo ambiente immenso storicamente ospitava le cosiddette Stalle di Salomone. Certo, vederlo trasformato in un locale tutto marmi e luci al neon può non corrispondere al nostro gusto estetico, ma non credo che lì sotto sia stato commesso alcuno scempio archeologico». La guerra dell’archeologia rimane confinata solo a ebrei e musulmani o coinvolge anche i cristiani? «Alcuni episodi spiacevoli coinvolgono anche noi, ma difficilmente fuoriescono dall’ambito religioso per toccare quello politico. Penso all’invenzione di alcuni siti di pellegrinaggio o all’esagerazione dell’importanza di alcuni reperti. Così una barca del primo secolo ritrovata accanto al lago di Tiberiade è diventata la barca di Gesù. I presunti siti della “Nuova Emmaus” ormai si sprecano. Una cisterna recentemente pubblicizzata come luogo di preghiera di Giovanni il Battista sembra non avere nulla a che fare con il personaggio. Mentre gli scopritori di un ossario con un’iscrizione relativa a Giacomo, fratello di Gesù, ora si trovano davanti ai giudici». LE OPERE DI SAUL BELLOW NEGLI OSCAR MONDADORI JAMES ATLAS VITA DI SAUL BELLOW www.librimondadori.it La sparizione Il circolo Bellarosa Quello col piede in bocca e altri racconti I conti tornano Il re della pioggia Herzog Ne muoiono più di crepacuore L'uomo in bilico Le avventure di Augie March La resa dei conti Il dicembre del professor Corde Ravelstein 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 Il musical dei Monthy Python sulla leggenda di re Artù continua a fare il tutto esaurito. E sui più prestigiosi palcoscenici di New York si alternano interpreti del calibro di Denzel Washington, Jessica Lange, Kathleen Turner, Billy Crystal, Jude Law, Ralph Fiennes, Liam Neeson. Perché un attore di fama può garantire il successo al botteghino, ma soprattutto perché per molte star la prosa può essere una occasione di rilancio, una sfida da vincere o una passione che torna FOTO CORBIS/CONTRASTO Repubblica Nazionale 42 10/04/2005 NEW YORK a decisione di una star hollywoodiana di calcare i palcoscenici di Broadway crea un evento mediatico che allarga inevitabilmente, ed esponenzialmente, il pubblico che frequenta i teatri intorno a Times Square. È lunghissima la lista di spettacoli il cui successo è legato alla presenza di un divo del cinema, o che sono stati salvati dal disastro commerciale dalla sostituzione del protagonista con una star scritturata frettolosamente e a suon di milioni. Tuttavia la scelta degli attori di privilegiare il teatro sul cinema suscita tra gli addetti ai lavori giudizi spesso velenosi: si va dall’accusa di tentare di nobilitarsi e darsi un’aura intellettuale a quella di adattarsi per forza maggiore durante un mesto periodo di declino. A queste valutazioni, basate principalmente su un dato economico e mediatico (i cachet e la visibilità che offre Broadway non sono paragonabili a quelli di Hollywood) va aggiunto in alcuni casi un dato crudelmente anagrafico: il teatro non contempla i primi piani, e il palcoscenico minimizza i segni del tempo sul volto di una star che invecchia. Certo, non mancano casi di grandi divi del cinema nati sulla ribalta e sinceramente appassionati di teatro al punto da ritornarci a costo di pesanti sacrifici economici (basti pensare allo Shakespeare in the Parkal quale hanno prestato il loro talento attori del calibro di Al Pacino e Meryl Streep); e sono sempre più frequenti i casi di attori che individuano nel palcoscenico un momento di riflessione rispetto al vuoto hollywoodiano. La recente storia di Broadway, caratterizzata in primo luogo dalla cosiddetta “British Invasion” (il boom delle megaproduzioni inglesi, cominciato con Cats), e quindi dalla “Disney Invasion” (iniziata con Beauty and the Beast), ha visto la riduzione sensibile degli spazi dedicati alla prosa ed una parallela diminuzione degli allestimenti dei classici del musical, sostituiti da adattamenti di film di successo (Grease), pellicole di culto (Hairspray), collage di canzoni dichiaratamente “camp” (Mamma Mia, basato sui grandi successi degli Abba) o addirittura di spet- L’obiettivo di tutti è ripetere il trionfo di Producers, il film di Mel Brooks la cui messa in scena con Matthew Broderick ha ottenuto dodici premi Tony e ora farà ritorno al cinema FOTO AFP ANTONIO MONDA FOTO PHILIP RINALDI/AP Le stelle di Hollywood si divertono a teatro L tacoli comici televisivi. L’esempio più eclatante é rappresentato da Spamalot, un esilarante musical basato sui personaggi creati dai Monty Python che fa il verso sin dal titolo al mondo epico di Camelot. Ne sono protagonisti attori cinematografici come Tim Curry ed Hank Azaria, e non é certamente un caso che sia diretto da Mike Nichols, un regista nato nel teatro, ma diventato celebre in tutto il mondo grazie alla settima arte. Lo spettacolo, che rielabora in puro spirito Python le leggende di re Artù, discende direttamente dal film Monthy Python and the Holy Grail. AncheSpamalotproponeunapproccio “camp” caratterizzato da riferimenti alla cultura popolare, sfacciati anacronismi e volgarità ripetute al punto da diventare inoffensive. I più attenti riconosceranno che la voce del Padreterno é quella di John Cleese,mal’interaplateasirendecontosin dall’entrata in scena che Hank Azaria ottiene con questo spettacolo la consacrazione che ancora non ha avuto ad Hollywood. Si ride molto, ma affiora ripetutamente la sensazione di una commistione di generi che ha ben poco a che fare con il teatro, ed è sintomatico che le critiche siano state caratterizzate soprattutto da un interrogativo puramente economico: riuscirà a diventare il nuovo Producers? Il riferimento al fortunatissimo spettacolodiMelBrookshasigillatounnuovocapitolo nell’ambivalenza tra Broadway e il cinema. The Producers é infatti un film di Mel Brooks che il regista ha adattato in uno spettacolo vincitore di dodici premi Tony e che sta per diventare nuovamente un film, prodotto dallo stesso Brooks con l’identico cast che ha trionfato a Broadway. Con la lungimiranza di chi è nel mestiere da quasi cinquant’anni, Brooks scritturò per la messa in scena teatrale un divo indiscusso di Broadway (Nathan Lane) ed un attore cinematografico di successo (Matthew Broderick). I due sono stati richiamati sul palcoscenico ogni volta che la sostituzione con attori meno noti generava una flessione nella vendita dei biglietti. Negli stessi giorni del debutto di Spamalot, Denzel Washington ha portato a Broadway un allestimento di Giulio Cesare nel quale si cimenta nel ruolo di Bruto. L’indubbio “star power” dell’attore ha generatovenditerecord,maancherecensioni al vetriolo: sul New Yorker Hilton Als ha DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 LA STORIA GLI ESORDI IL PULITZER WEST SIDE STORY CATS DISNEY INVASION La grande stagione di Broadway inizia nel gennaio del 1893 quando viene aperto l’Empire (nella foto), il primo teatro Nel 1931 per la prima volta uno spettacolo di Broadway vince il premio Pulitzer: è il musical “Of thee I sing” di Gershwin (nella foto) Il debutto del musical West Side Story, nel 1957 al Rivoli Theatre (nella foto), è considerato uno dei momenti salienti della storia di Broadway Con la prima di Cats (nella foto), il 7 ottobre 1982, inizia a Broadway la “British invasion”: il pubblico premia gli show arrivati dal Regno Unito L’ultima ondata riguarda spettacoli teatrali nati dalle storie della Disney; tra essi “Lion King” (nella foto), “Beauty and the Beast” e “Aida” Debutti e flop dei divi sul palco Quando Burton recitò ubriaco C Repubblica Nazionale 43 10/04/2005 stigmatizzato i manierismi cinematografici della sua recitazione, ed ha scritto che «non è riuscito a diventare Bruto, ma lo ha trasformato in una versione di se stesso». Come racconta Eva contro Eva, il più grande film hollywoodiano mai dedicato a Broadway, non esiste forma di spettacolo in cui la critica abbia un potere maggiore, e sono numerosi i casi in cui una stroncatura sul New York Times abbia causato la chiusura di uno spettacolo prima dell’apertura ufficiale al pubblico. Se Ben Stiller ha preferito optare per il prestigioso Off Broadway del “Public Theatre” per il testo teatrale di un regista cinematografico come Neil Labute, Jessica Lange e Christian Slater duettano malinconicamente a Broadway in Zoo di Vetro di Tennessee Williams. Lo spettacolo è decisamente modesto, ma le critiche hanno riconosciuto il carisma della diva, garantendo il tutto esaurito almeno per le prime settimane di programmazione. Basta addentrarsi nella quarantacin- quesima strada per assistere al ritorno a teatro di Jeff Goldblum in The Pillowman e di Kathleen Turner in Chi ha paura di Virginia Wolf, mentre al confine della zona delimitata da Times Square, John Turturro sta per debuttare con la versione americana di Questi Fantasmi. Diverso ma egualmente sintomatico il caso di Billy Crystal, che con 700 Sundays propone a Broadway un one man-show simile a quelli che lo hanno imposto all’inizio della sua carriera, ma che deve in primo luogo alla sua popolarità cinematografica il trionfo attuale. Negli ultimi anni Broadway ha rappresentato anche l’occasione per arricchire il curriculum di un divo non americano da lanciare sullo schermo: per non rimanere cristallizzato nell’immagine del Wolferine degli X-Menl’australiano Hugh Jackman ha debuttato con esiti disastrosi in una commedia musicale prettamente americana come The Man from Oz, mentre i britannici Jude Law, Ralph Fiennes e Liam Neeson hanno compreso che il modo migliore per conquistare la difficile platea newyorkese è quello di affidarsi a testi ambiziosi come Indiscretions o a classici come Amleto e Il Crogiuolo. Di tutt’altro genere la scelta dell’americano Alec Baldwin, il quale nell’illusione di ripercorrere le tracce di Marlon Brando dopo Caccia a Ottobre Rossodecise di non interpretare più il personaggio di Jack Ryan pur di recitare in un allestimento di Un tram che si chiama desiderio. Per lo sconcerto dei produttori, e soprattutto del suo agente, l’attore rifiutò persino un rilancio miliardario per il film successivo nel quale compariva il personaggio creato da Tom Clancy, e offrì la propria versione di Stanley Kowalsky accanto a una Blanche interpretata da Jessica Lange. Lo spettacolo si rivelò un clamoroso fiasco, ed il ruolo di Jack Ryan venne affidato ad Harrison Ford, che ne fece un eroe cinematografico ed un personaggio di successo secondo solo ad Indiana Jones. IL FENOMENO Qui sopra, una scena di “Spamalot”, il musical dei Monthy Python che sta riscuotendo un successo enorme in queste settimane. Nella pagina accanto, dall’alto, Jessica Lange e Christian Slater in “The Glass Managerie”, Nicole Kidman e Iain Glen in “The Blue Room” e infine Denzel Washington che interpreta il ruolo di Bruto nel “Giulio Cesare” ome ha raccontato in maniera immortale Eva contro Eva, la più nota pellicola dedicata a Broadway, la storia della «grande strada bianca» che taglia Manhattan in verticale si nutre della leggenda quotidiana di fiaschi e successi, rivalità violentissime e complimenti al vetriolo. Accanto ai pochi trionfi che si registrano nel corso di un anno, ci sono una infinità di spettacoli che arrivano al debutto, come si dice in gergo, «d.o.a.»: «dead on arrival» ovvero «morti all’arrivo». La causa può essere, di volta in volta, una idea sbagliata in partenza, una debolezza di regia o di recitazione, oppure un fuoco di fila di feroci stroncature. Perfino Katharine Hepburn ebbe la sua razione di critiche al limite dell’insulto, e decise di abbandonare lo spettacolo e rinunciare al compenso quando Dorothy Parker scrisLA STRONCATURA Nella foto, se che le «sue emoKatharine zioni non andavaHepburn: dopo no oltre il passagle feroci critiche gio dalla A alla B». a una sua Tra le stroncature interpretazione che più vengono ria Broadway, cordate e citate c’è abbandonò la quella che subì Riparte e rinunciò chard Burton, il al compenso quale pensò bene di concedersi qualche bicchiere di troppo durante gli intervalli dell’anteprima di un Amleto, e lesse il giorno successivo: «L’effetto dell’alcool sulla recitazione ha trasformato negli ultimi due atti il principe in un omosessuale». Tra i debutti che meno hanno lasciato il segno, c’è invece quello di Marlon Brando in I remember Mama (la critica stroncò compatta e scrisse quasi all’unanimità di un cast da dimenticare), mentre il più sorprendente è probabilmente quello di James Cagney, che in Every Sailor interpretò il ruolo di una ballerina di fila, con tanto di parrucca e tutù. La consapevolezza dell’importanza fondamentale della “opening night” ha scatenato reazioni paradossali nei talenti più istrionici. L’esempio più clamoroso viene da John Barrymore. Disturbato dai continui colpi di tosse della gente in sala durante un’anteprima per la stampa di un suo spettacolo, il celebre attore si affacciò alla ribalta all’inizio del secondo atto con del pesce in mano e lo lanciò in platea, gridando: «Divertitevi con questi, maledetti trichechi!». (a.m.) DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 spettacoli CAPOLAVORI Francis Ford Coppola è nato a Detroit il 7 aprile 1939. Alcuni suoi film fanno parte della storia del cinema: dalla trilogia de “Il Padrino” ad “Apocalypse Now” e “Cotton Club” Grandi registi ENRICO BONERANDI A BUSTO ARSIZIO Repubblica Nazionale 45 10/04/2005 pocalypse now a Busto Arsizio. Hanno fatto arrivare Francis Ford Coppola in elicottero con musica wagneriana d’accoglienza, mentre tre ragazzotti di Gallarate maniaci di giochi di guerra simulata, vestiti in tuta verde da Settimo Cavalleria, gli facevano il saluto militare. Il regista, che compie in questi giorni 66 anni, da secoli non gira un film — l’ultimo è stato L’uomo della pioggia— e fa il pensionato in camicia hawaiana coi palmizi, si è accomodato nella sceneggiatura imbastita dal BA Film Festival, che ieri l’ha invitato nel Varesotto, ed è stato al gioco. Diabolico, Coppola ha poi sabotato l’evento — targato centrodestra — da esperto guastatore. Dichiarando col sorriso più aperto che non conosceva il festival e non aveva la minima idea del perché lo avessero voluto lì (pagandogli il viaggio): «La verità? Nessuno mi ha spiegato un bel niente, però adesso m’informo». Subito dopo ha rinnegato supposte iniziative culturali che gli avevano attribuite, annunciando come unico suo progetto concreto l’intenzione di aprire un albergo a Bernalda, paese natale della sua famiglia, nel cuore della Basilicata, visto che finalmente ha ottenuto il passaporto italiano e può così avviare iniziative commerciali nel nostro Paese senza troppi problemi. Ma se l’elicottero sembrava uscito da Apocalypse now, l’arrivo nella sede del festival è stata una scena de Il Padrino. Accanto a Coppola c’era un personaggio molto abbronzato, giacca coi bottoni d’oro, foulard infilato nel collo aperto della camicia e sigarone in mano. Si chiama Nunzio Alfredo D’Angeri ed è l’ambasciatore del Belize: Francis — che in California pure lui rappresenta lo Stato centroamericano, dove possiede un esclusivo resort — venerdì notte ha dormito nella villa di Parabiago di D’Angeri. Alla sinistra di Coppola, invece, c’era Zucchero Fornaciari. Vi conoscete? «No». Scavando, viene fuori soltanto che Zucchero stima molto Coppola, ha fatto uno dei suoi pri- Coppola. Mi offrono soltanto film stupidi mi concerti in Basilicata e ha registrato un disco a Napa Valley, vicino alle vigne dove Coppola produce milioni di bottiglie di un vino che ha chiamato «Rubicone». Entrambi — ecco svelato il mistero — sono amici dell’ambasciatore. Parla un po’ di italiano, Coppola, e dichiara amore per la nuova patria, soprattutto per la Basilicata, «poco famosa nel mondo perché non c’è mafia o camorra». Alle prossime elezioni potrebbe pure votare. Per chi, sempre che abbia nozioni della nostra politica? «Non vedo perché dovrei dirlo». Lui non è un anti-Bush come tanti altri dello show-business nordamericano, e come si poteva arguire da vecchie interviste. Lo si scopre per caso, parlando del documentario di Jonathan Nossiter Mondovino, appena uscito sugli schermi italiani. Coppola spiega che non ha voluto partecipare al film, al contrario di tanti altri personaggi famosi amanti dell’enologia, perché non aveva il controllo delle immagini: «Quando ti piazza- ‘‘ Famoso a trent’anni Non giro nulla da quasi nove anni: un artista che comincia molto giovane e diventa famoso a trent’anni che fa dopo? no davanti a una telecamera, non sai mai come va a finire». Per illustrare meglio il concetto, cita come esempio di film-patacca che distorce la realtà proprio quel 9/11 di Michael Moore che è una delle bandiere della resistenza contro il presidente repubblicano. Chiamando Moore — apposta, probabilmente — Roger, come l’interprete di James Bond. Di sé, Francis Ford Coppola racconta la maturità tranquilla e benestante, l’orgoglio di essere padre di artisti come la figlia Sofia («bellissime le scene del suo nuovo film Marie Antoinette. Ma io non ci ho messo il naso»), l’impegno saltuario come produttore («spesso l’unica cosa che fa il produttore è piazzare il suo nome nei titoli»). Gli ricordano rispettosamente che da sette anni non fa un film, e lui: «Veramente mi avvicino ai nove. Un artista che comincia molto giovane e diventa famoso con le pellicole girate sui trent’anni, che fa dopo? Sceglie di ripetersi o di tornare all’inizio, come fosse uno studente. Piuttosto dei film stupidi che mi proponevano di girare, ho deciso così. Sono pochi quelli che fanno belle cose anche da vecchi. Penso a Shakespeare — ride di gusto — o al vostro Verdi, che ha composto l’Otello che aveva una bella età». Niente stress o nostalgie, assicura: «Col cinema non devo mantenere la famiglia». Gli bastano il vino e gli alberghi. «Beh? Ho un’azienda di prestigio che mi dà il privilegio di poter aspettare l’idea giusta. E poi, i film di oggi sono tutti uguali». Una storia sulla guerra in Iraq le potrebbe interessare? «No». Perché? Coppola si spazientisce, probabilmente da anni lo torturano con questa domanda. Risponde alla Jannacci: «Perché no». Poi si addolcisce in un «preferisco il futuro degli uomini alla guerra». Il vecchio progetto Megalopolis, un film su una città dell’utopia, per ora è accantonato: «Ho scritto e riscritto la sceneggiatura, ci ho lavorato tantissimo, ma forse era una cosa troppo ambiziosa e l’ho messa da parte. Se vivo a sufficienza, magari la riprenderò in mano». Gli organizzatori del festival bustese provano a fargli dichiarare qualcosina sull’importanza di sostenere il cinema italiano, ma Coppola non ci pensa neanche a pronunciare una frase gradita ai suoi ospiti: «Negli anni ‘50 e ‘60, con gli stessi problemi, avete avuto almeno trenta grandi registi che hanno creato opere indimenticabili. Ora succede in Iran. Il cinema gira, tornerà il vostro momento». Un ragazzo cerca di consegnare a Coppola un suo copione, ma il regista ritrae le mani come se i fogli bruciassero: «Non voglio». Questione di diritti d’autore: in futuro il simpatico giovane potrebbe accusarlo di avergli rubato un’idea. Che consiglio darebbe a un regista principiante? «Sposati presto». Per la morte del papa, in Italia, il mondo dello spettacolo si è fermato per giorni e le tv sono state monotematiche: che ne pensa? Coppola allarga le braccia e risponde soavemente: «È il primo papa che muore nell’epoca dei grandi media e della Cnn. Le tv ci hanno costruito il loro business, che volete farci, anche se l’evento non era poi così importante». 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 i sapori L’espresso - macchiato, corretto o allungato accompagna le nostre giornate e scandisce i nostri break purché sia fatto come “regola comanda”. L’ultima occasione per celebrarlo mercoledì a Milano dove saranno premiati artisti e designer che hanno raccontato i luoghi d’incontro davanti alla tazzina Gusto in tazza itinerari Il napoletano Antonio Tubelli è uno dei più appassionati conoscitori della cultura alimentare campana. Nel suo locale-culto Timpàni e Tèmpura propone solo piatti della tradizione più antica Trieste Roma Napoli Porto franco dall’inizio del 1700, qui sbarcavano le navi in arrivo dalle piantagioni per rifornire i bellissimi caffè dell’impero asburgico, tradizione rimasta intatta in città. L’Associazione Caffè Trieste, nata nel 1891, è ancora operante. La tradizione della tazzina fumante ha il suo tempio in piazza Santo Eustachio, con due bar che si contendono meriti e clienti. Molto diffusa in città, la variante del “caffè al vetro”, servito in un bicchierino riscaldato e riempito per un terzo La tazzulella ‘e cafè è così radicata nella cultura e nella tradizione cittadina, che la vera scommessa dei bar è fidelizzare i clienti: se la tazzina non è caldissima, la miscela profumata, l’abbandono è certo DOVE DORMIRE L'ALBERO NASCOSTO Via Felice Venezian 18 Tel. 040-300188 Camera doppia da 80 euro, colazione inclusa DOVE DORMIRE LE SUITE DI VIA OTTAVIANO Via dei Gracchi 6 Tel. 06-39745602 Camera doppia da 75 euro, colazione inclusa DOVE DORMIRE B&B ATRI3 Via Atri 3 Tel. 081-292834 Camera doppia da 60 euro, colazione inclusa LA MIGLIORE TAZZINA CAFFE’ SAN MARCO Via Cesare Battisti 18 Tel. 040-363538 LA MIGLIORE TAZZINA TAZZA D’ORO ORIGINAL COFFEE Via degli Orfani 84 (Pantheon) Tel. 06-6789792 LA MIGLIORE TAZZINA DON GENNARO 0’ CAFETTIERE Via Sant’Anna dei Lombardi 4 Tel. 081-5512837 DOVE COMPRARE CREMCAFFE’ Piazza Goldoni 10 Tel. 040-820747 DOVE COMPRARE TORREFAZIONE G. DE SANCTIS Via Tagliamento 88 Tel. 06-8552287 DOVE COMPRARE CAFFE’ DELIZIA Via Cuma 131 (Bacoli) Tel. 081-8543043 Caffè Più che un piacere un rito antico icono che i baristi siano persone piuttosto pazienti. Non si spiegherebbe altrimenti come resistere dalle sette di mattina a un’ora imprecisata della sera, davanti a orde di clienti che ti chiedono la stessa bevanda — il caffè — in almeno una dozzina di modalità differenti. Contare per credere: corto, lungo, doppio in tazza piccola o grande, freddo o shakerato, con latte freddo o caldo a parte, macchiato (anche in questo caso freddo o caldo), allungato con acqua, corretto con i liquori più diversi (dalla Sambuca al Fernet, passando per Grappa, Brandy, Anice). Più che un’abitudine, un rito. Più che una bevanda, un premio, piccolo e inderogabile, che ci regaliamo da appena svegli a prima di coricarci (tutti noi abbiamo almeno un amico che sorseggia beato il caffè dopo cena, «tanto dormo lo stesso»). E siccome davanti al piacere della tazzulellanon c’è anatema del ministro Sirchia che tenga, negli ultimi anni l’interesse per il caffè — come simbolo, pretesto, luogo d’incontro — è montato come la crema di un espresso fatto come regola comanda. Così, mercoledì, in contemporanea con il Salone del Mobile, a Milano verranno premiati i vincitori del concorso internazionale di idee «Espresso — spazio/tempo del caffè», indetto da Do- Repubblica Nazionale 46 10/04/2005 D a contatto con la bevanda calda sprigionamus e IllyCaffè. Gli oltre 700 concorrenti, no odori poco aromatici, il caffè espresso designer e artisti under 35 da tutto il monè un parente lontano di quello che beviado, hanno avuto un anno di tempo per mo nel nostro bar preferito. Ma non è queraccontare — progettandolo — il loro sto il punto. concetto di caffè coIn realtà, il caffè, me luogo di consucon tutte le sue immo, ma anche di inprobabili varianti contro, conoscen(dal Frappuccino al za, scambio. Mocaccino) è il preBen lo sanno testo per entrare in quelli di Starbucks, un luogo accoglieninventori di uno dei te — spazioso, calfenomeni più imdo, con i bagni puliportanti nel mondo ti e le sedie comode del fuori-casa ali— dove con un paio mentare, appena di dollari puoi trasbarcati in Italia. A scorrere dieci miloro, il merito di nuti o un intero poaver aperto un primeriggio leggendo, mo locale, a metà chiacchierando, latra il bar per studenvorando al computi e una sala d’attesa ter (grazie alla conferroviaria, aperto nessione wireless) — non a caso — in senza che nessuno quel di Seattle, rapivenga a chiedertene damente assurto a conto. E in più, gli luogo-culto di gioDa QUESTI FANTASMI approvvigionavani (e meno giovamenti delle materie ni) di tutta America. Certo, da Starprime, caffè cacao e bucks il caffè è sicuramente migliore di altro, sono fatti in base a scelte socialquello offerto negli altri bar (per il livello mente responsabili, tra il commercio statunitense). Comunque, la tazzina di ceequo e solidale e le associazioni no-profit. Quella dell’irreprensibilità etica sta diramica non esiste, i bicchieri di polistirolo MOKA Inventata da Alfonso Bialetti nel 1933 e ispirata da un prototipo di lavatrice con bollitore e cestello per la raccolta dell’acqua. La moka si basa sul passaggio dell’acqua dal basso in alto, ovvero dalla piccola caldaia, attraverso il cestello-filtro con dentro il caffè, (grazie alla pressione del vapore), alla parte superiore ‘‘ Eduardo De Filippo A noialtri napoletani, toglierci questo poco di sfogo fuori al balcone... Io...a tutto rinuncierei tranne a questa tazzina di caffè, presa tranquillamente qua, fuori al balcone ... NAPOLETANA E’ composta di due parti, con in mezzo un filtro a cestello, che viene colmato, senza pressare, con caffè. L’acqua riempie la parte inferiore, alla quale si avvita, a testa in giù, quella superiore, col beccuccio. Al primo bollore e a fuoco spento, si capovolge la caffettiera, lasciando che l’acqua filtri lentamente attraverso il caffè FOTO ZEFA LICIA GRANELLO ventando una moda che coinvolge grandi aziende e artigiani di nicchia. Si va dal progetto “Terra!” di Lavazza alle strategie di supporto allo sviluppo locale dei paesi produttori lanciata da Illy, giù giù fino ai “Bambini del caffè” di Caffè del Doge, il marchio che ha fatto conoscere in Italia il caffè “Caracolito” cubano. Perché pagare il giusto chi produce è sacrosanto, comprare gli scuolabus per i bambini delle comunità andine meritorio. Ma la qualità? Il chicco-perla del caffè cubano che rilascia sentori di cacao o il profumo di zenzero che rinfresca la bocca gustando un caffè etiope, sono meravigliose eccezioni. È sulle miscele, ovvero la grande maggioranza del caffè in commercio, che le speculazioni dilagano. In pochissimi specificano percentuali e provenienze. E in pochissimi conservano l’arte del cafetiere, il barista specializzato che con il suo braccio allenato è pronto a pressare, accompagnare, staccare dalla macchina— espresso, secondo necessità e intuito. Raccontano che a Napoli, prima dell’avvento dei bar, al mattino presto le donne dei “bassi” vendessero sull’uscio di casa il caffè alla napoletana, fatto al momento per i passanti. Se qualcuna è ancora in attività, prego, si faccia riconoscere. A INFUSIONE Usata nel nord Europa, la caffettiera funziona con uno stantuffo che preme una cialda in carta piena di macinato all'interno di un vaso di vetro termico colmo d'acqua bollente. Fa un caffè adatto agli appassionati della tazza grande e della bevanda leggera. Particolarmente diffusa in Svezia 600 Il numero di tazzine procapite che gli italiani gustano ogni anno al bar e in casa 712mln A tanto ammonta,in euro, il giro d’affari del mercato del caffè in Italia 1570 È l’anno in cui viene inaugurato a Venezia il primo caffè pubblico DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 I PAESI PRODUTTORI BRASILE COLOMBIA PERU’ COSTARICA E’ il Paese numero uno per quantità. Con la sua produzione, infatti, copre quasi un terzo dell’intero fabbisogno mondiale. La coltivazione è cominciata nel 1729.Tra le due guerre il periodo peggiore a causa dei ripetuti eccessi di raccolto Considerato il principale prodotto agricolo e d’esportazione del Paese, il caffè viene coltivato sulle prime alture andine, intorno ai 1200 metri di altezza. La qualità del “tinto”, tazzina di caffè nero, varia a seconda delle zone di produzione E’ una terra consacrata alla coltivazione del caffè, anche grazie ai terreni fortemente minerali e al clima particolarmente piovoso. Chanchamayo, che si trova nel dipartimento di Junin, è considerata la zona-culto per la raccolta dei chicchi più pregiati di caffe’ Altro Paese benedetto per la coltivazione dell’arabica: suolo vulcanico e clima temperato, insieme alla presenza di porti affacciati sui due oceani, lo collocano ai primissimi posti per quantità e qualità di produzione ARABICA La più pregiata delle specie del caffè coltivate nel mondo Tra le varietà: Moka, Bourbon e Tipica. Necessitano di colture in terreni minerali, meglio se di origine vulcanica, oltre i seicento metri di altezza. Il clima ideale si attesta intorno ai venti gradi ROBUSTA Ha caratteristici grani piccoli, più ricchi di caffeina rispetto all’Arabica. Il nome specifica un’attitudine, quella di crescere anche in terreni poco vocati e di resistere alle malattie. I costi di coltivazione, quindi, sono inferiori, aromi e gusto risultano però molto meno eleganti Una bevanda simbolo del dinamismo borghese E la caffeina battezzò la civiltà del business MARINO NIOLA FOTO STOCKFOOD Repubblica Nazionale 47 10/04/2005 I l caffè è utile soprattutto a coloro che intendono risparmiare il tempo piuttosto che la salute. Lo diceva Linneo, padre delle scienze naturali, a proposito della bevanda nera appena giunta in Europa dall’Oriente. Nel mondo arabo fin dall’antichità il caffè era una sostanza sacra proprio perché rende lucidi, dinamici e favorisce il controllo razionale. Il grande scienziato svedese è dunque il primo intellettuale europeo a intuire la ragione della successiva, travolgente fortuna della mitica tazzulella. Linneo coglie, infatti, una perfetta corrispondenza tra il ritmo sempre più veloce della modernità nascente e le proprietà eccitanti della bevanda. Nel Seicento si verifica una crescita esponenziale della produzione, anche grazie alla tratta degli schiavi africani deportati in America Latina per lavorare nelle piantagioni. E il caffè si diffonde massicciamente in Europa. Il rapporto tra caffeina e lavoro è una costante nella storia dell’Arabica. Come dirà a fine Settecento Benjamin Franklin, il caffè tenendo svegli i lavoratori, permette l’allungamento del tempo operativo e, poiché il tempo è denaro, diventa automaticamente un fattore produttivo. Non a caso nei posti di lavoro americani il caffè è da sempre a disposizione del personale. Dopo la seconda metà del Seicento, quando il nero infuso comincia a imporsi come consumo di massa, resta strettissimo l’intreccio tra il suo gusto amaro e forte e le lucide emozioni del business. I primi Caffè nati in Europa sono locali dove ci si riunisce per gustare profumate miscele e insieme per concludere affari. Il più celebre è il Lloyd’s Coffee House di Londra. Apre nel 1687 e diviene ben presto il punto d’incontro di tutte le persone che hanno a che fare con il commercio marittimo. Capitani, armatori, mercanti, frequentano il Caffè per ricevere notizie sul loro settore, sulle condizioni del mare, sul buon esito delle loro spedizioni poiché Mr. Lloyd pubblica un notiziario costantemente aggiornato: il Lloyd’s News. Le cose vanno talmente bene che dal Caffè nascono i Lloyd’s, ovvero la più grande Compagnia di assicurazioni del mondo. Il caffè si afferma come il simbolo stesso del dinamismo richiesto dall’economia borghese nascente. E, soprattutto, diventa luogo della democrazia, della mobilità sociale, indispensabili alla modernizzazione di una società che per svilupparsi ha bisogno di diventare sempre più leggera. Nello spirito ma anche nel corpo. A differenza del cioccolato e del vino che appesantiscono, ingrassano e rallentano, la bevanda arabica diventa sinonimo di magrezza perché rende attivi ma non nutre, non ha calorie. Con l’Illuminismo e la definitiva affermazione della borghesia imprenditrice, il caffè diventa l’emblema di un nuovo modo di vivere, di una nuova classe e di una nuova concezione dell’uomo e del suo corpo. Un corpo leggero, scattante, nervoso: insomma un corpo moderno. L’autore insegna antropologia culturale all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa a Napoli 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Abitare oggi DOMENICA 10 APRILE 2005 Arredi ridotti, multifunzione, pieghevoli, reversibili: il mercato continua a proporre soluzioni per risolvere i problemi del vivere in appartamenti sempre più piccoli Ecco le novità, in rassegna da mercoledì, al Salone del Mobile di Milano IL PIU’ ECLETTICO AMANTE DELLE COMODITA’ Cu, piccolo monumento all'eclettismo. Può far da tavolino, bordo divano, sgabello. Di Kristalia Due le posizioni che può assumere il comodo Lover di Ligne Roset Trasfor Mobili Così la casa diventa nomade AURELIO MAGISTÀ a metamorfosi è di casa. Versatile, eclettico, adattabile: sono gli aggettivi del nostro tempo, chiave di un mondo che rinuncia a un’identità univoca e si apre all’ibridazione e all’incrocio, scegliendo nella stratificazione di codici quello giusto in ogni circostanza. E per quanto riguarda la casa, argomento nell’agenda dell’attualità dacché mercoledì comincia il Salone del Mobile di Milano, questo è particolarmente vero. Nell’idea di riferimento di non avere punti di riferimento, ovvero di averne molti, da scegliere in relazione ai contesti, confluiscono due importanti fenomeni, più significativi nelle grandi città, dove finiscono per ipotecare i comportamenti e le scelte di vita. Il primo è che si vive in case sempre più piccole e sempre più aperte. L’Istat registra che ogni italiano ha uno spazio abitativo di 36,8 metri quadrati, un dato con profonde differenze, se si pensa che si va dai 110 metri del Veneto ai 29,7 della Campania e si tiene conto del fatto che soprattutto nelle grandi città le famiglie hanno imparato a stringersi per sopravvivere all’impennata del costo degli immobili e addirittura le persone che vivono in roulotte, camper, container e baracche è aumentato dal 1991 al 2001 del 10 per cento. Quindi si rinuncia per esempio alla cucina non solo perché è di tendenza il living, ma perché diventa inevitabile, come ha recentemente rilevato una ricerca Corepla-Makno che individuava la centralità del soggiorno nelle case degli italiani, dato confermato anche dal buon momento di mercato per divani, poltrone, chaise longue e dintorni. Il secondo fenomeno è il nomadismo. Vite precarie legate alla crisi economica e al nuovo mercato del lavoro, inquietudine professionale di un terziario di manager, spesso single o single di ritorno. Bisogni e ambizioni che si misurano con la ricorrente necessità di trasferirsi e cambiar casa, anche con spostamenti all’interno dello stesso centro urbano o poco oltre. In questo scenario le persone, costrette a sacrifici con gli immobili, cercano di risolvere i loro problemi con i mobili. Oggetti adattabili, polifunzionali, modificabili nella forma, robusti, eclettici, capaci di accordarsi con occasionali compagni di arredo. E sotto questo ampio tetto di aggettivi c’è spazio per gli umili ma utilissimi sgabelli che si chiudono e le poltrone gonfiabili, come per la piccola geniale cucina a scomparsa, esemplare per contenuti di qualità e servizio, o il pouff-tavolino del grande designer. Un curioso melting pot che senza snobismi fuori tempo e soprattutto fuori luogo, compone in amichevole contiguità l’alto e il basso, il costoso e l’economico. Una globalizzazione dell’arredo che sembra proprio la nuova democrazia del bello. Repubblica Nazionale 48 10/04/2005 L ‘‘ UNA SEDUTA A BOLLE BLU Si chiama Bubbles, ed è una suggestiva poltrona gonfiabile salvaspazio. Prodotta da Maiuguali Alessandro Mendini Oggi la diffusione del design ha creato una maggiore qualità...le creazioni sono tutte meno belle ma di qualità ragionevole olumi vuoti e assenze. La sottrazione contro l’accumulo. Oggetti che si ripetono e ripetono fino all’indistinto in un movimento che riconsegna al reale un po’ di semplicità. Il numero gli importa, il seriale. Pezzo unico e stile offendono “l’etica” progettuale di Vico Magistretti. Architetto, ambienti sempre più mescolati, case provvisorie, oggetti dall’identità incerta, trasformabili. Il designer come entra in queste case? «Togliendo. Abitiamo sempre più spaesati e nomadi. Per questo in casa abbiamo necessità di trovare un luogo. Anche transitorio, ma che c’è. Dal punto di vista architettonico questo esserci della casa si traduce in volumi, spazi aperti e campo sgombro di inutilità. Cose che servono e fanno bene, semplici semplici. La decorazione in una casa è l’esatto contrario del mio modo di lavorare». Ce lo racconti. «È quando uno va in un negozio e di- V SOFA’ PER DUE Divani che diventano letti ce ne sono moltissimi. Questo ha qualcosa in più: si trasforma in un letto a castello. Di Clei PROFILO INCONFONDIBILE Dal profilo inconfondibile, si conferma poltroncina che si chiude (o sgabello) Comoda e dal design di grande efficacia Ravello è firmata Poltrona Frau DOMENICA 10 APRILE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 LA SCOMPARSA DELLA CUCINA PICCOLO MA GENEROSO Sembra un armadio ma Tivalì, dietro i battenti, rivela la sua efficientissima anima di piccola cucina. Perfetta per single o per piccole abitazioni, genialmente serve anche da parete divisoria. Prodotta da Dada Panciuto, ma non inutilmente, il pouff battezzato con ironia Fat fat da B&B Italia: sotto il coperchio, che fa anche da tavolino, rivela un ventre accogliente in cui occultare anche piccoli disordini domestici LO SPAZIO E’ SALVO A sinistra, Maitresse di Campeggi, totem luminoso che diventa paravento e lettino SPIRITO LIBERO Modifica i connotati degli spazi in un attimo, aggiunge un’improvvisa nota di colore tra il neutro di wengé e il rovere sbiancato. Il tappetino di Missoni Home si compiace del suo spirito nomade Notte a San Siro Repubblica Nazionale 49 10/04/2005 Il 14 aprile la Scala del calcio si apre alla creatività: dalle 6 di sera alle 6 del mattino spettacoli, concerti e mostre. Spiega il direttore della rivista Domus, Stefano Boeri: «Per una notte la grande astronave del calcio si aprirà alla varietà e l’indeterminatezza della città» IL DIVANO CHE NASCONDE Perfetto per case con bimbi: i giochi scompaiono nel cassettone all'interno del divano Discovery. Di Feg L’ARTE DI ADATTARSI Piccole cose spiritose, con grande capacità di adattarsi e di ritirarsi in piccoli spazi, sono le tazze da colazione in tinte pastello di Maiuguali e gli sgabellini richiudibili di Viceversa L’architetto-designer Vico Magistretti teorizza “la sottrazione contro l’accumulo” “Cose semplici, cose per tutti volevo inventare l’ombrello” ALESSANDRA RETICO EFFETTO POP ART Sarebbe piaciuto ad Andy Warhol, Cubik, Di Diliddo & Perego ce questa lampada o questa sedia mi servono e sono giusti per me. E dice anche ma tu guarda com’è semplice perché non ci ho pensato prima io. Ecco: è questo che voglio, che la gente dica che faccio cose scontate, umane, popolari fino al banale. Quelle cose che non devi spiegare perché si spiegano da sé, hanno un concetto dentro, un’intenzione. E il concetto sta nel contenere una tecnologia e un fine di riproducibilità su larga scala. Il concept design è il design che mi piace». C’è un particolare oggetto suo o di altri al quale è legato e che racchiude questa intenzione? «Miei sì, ce ne sono. Ma vorrei parlare dell’ombrello. Del fatto che l’ombrello è straordinario e che avrei voluto disegnarlo io. Mi piace per la sua semplicità, per il suo essere niente e per il suo essere la risposta a una necessità. Pure la sedia Thonet mi piace. Perché è nata nel 1859 e perché è così moderna, dentro ci ha tutta una lungimiranza tecnologica e pratica: il legno curvo era una sfida che è stata vinta. L’altra novità di quella sedia è di aver creato una nuova idea di produzione, industriale e “sporca” rispetto a un’ideologia di design per pochi». Quando lei ha cominciato nei ‘60 il rapporto con l’industria non aveva una connotazione “sporca” però. «Infatti. Già nel dopoguerra grazie all’istinto di alcuni degli industriali, alle informazioni e suggestioni che arrivavano attraverso la Triennale, all’eredità del razionalismo, il design italiano conosce un periodo di fioriture e vibrazioni. Era un modo di intendere il design come etica, come politica, come qualcosa che aveva a che fare con la quotidianità, con i problemi veri della gente, con lo svegliarsi andare in ufficio e il fare. Quello che mi interessava era portare in quante più famiglie possibili cose che avessero un senso. L’industria e la produzione in serie sono stati i mezzi per farlo. E anche il mio fuoco creativo e la mia disciplina: io posso pensare a un oggetto che mi piace ma sarei un folle se non seguissi il consiglio di un tecnico, se rinunciassi a usare meno stampi possibili per ottenere un prodotto più economico. E non solo in un senso monetario, ma concettuale, di educazione all’essenzialità e all’intenzione. L’industria per il mio lavoro è stata ed è una questione di civiltà. Nel senso che la produzione in grandi numeri ti mette in relazione con la vita delle persone, ti fa stare dalla parte di chi vive e non di chi insegna, ti dà la possibilità di scambiare cultura e vita. E anche di espropriarti, che è un bel lasciare per un “creativo”: la mia sedia Selene la producono negli Stati Uniti con materiali in plastica e la puoi vedere nei bar o nei salotti. L’industria e la gente ti salvano perché se tu hai ingenuamente disegnato un destino per qualcosa, loro lo cambiano. È quando il tradimento diventa una possibilità che tu non avevi visto». 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 10 APRILE 2005 l’incontro Dopo trent’anni di successi, il comico più eversivo e censurato ha ripreso i libri di teatro. E si è rimesso a studiare, con un obiettivo: ricominciare tutto da capo. Il ragazzo terribile è diventato un uomo maturo. E adesso ci confessa i sentimenti più intimi, i legami familiari, la ricerca di Dio ma anche i piani per il futuro, di cui dice: la satira politica non basta più, devo imparare a prendere in giro anche me stesso. Come facevano Jannacci e Gaber Nuova vita Paolo Rossi o devo ancora cominciare. La sfida grossa non l’ho ancora affrontata. Lo so. E mi sono rimesso a studiare. Da un anno e mezzo. Libri di teoria, testi teatrali, i dvd di Eduardo, i monologhi di Walter Chiari, e commedie come L’ispettore generale di Gogol, e manuali di drammaturgia con regole che sono quasi una matematica. Sono tornato all’esercizio, alla formazione. Forse perché a suo tempo non ho mai avuto un buon rapporto con le scuole. Meglio così: a 23 anni fu maggiore la spinta a buttarmi come praticante nel mondo del teatro. Ma adesso ricomincio. Da capo». Il neo-praticante delle regole è quello che passa per essere uno degli attori italiani più eversivi, anfetaminici e censurabili: è il 51enne Paolo Rossi, taglia da kid intrepido e da story-teller peso Piuma, jeans e guardaroba da snowboarder, andatura felpata, occhi buoni che se la ridono, e un qualcosa (a dispetto della nomea) di non-polemico e non-irruento nei toni. Come a dire che dignità e impegno non corrispondono a tatuaggi da kamikaze. Anzi. Quest’attore scomodo e di culto per maree di giovani manifesta oggi una sindrome da palazzeschiano “Fatemi divertire” che ha a che fare anche col privato della vita: lo spauracchio della Rai è mosso da pensieri per la madre, per i figli, per le compagne, per la famiglia naturale che è la sua troupe e con cui replica per l’Italia (finora all’Ambra Jovinelli di Roma) Il signor Rossi contro l’impero del Male. «Intanto l’età. Questo mestiere ti privilegia, e non ti rendi conto degli anni che accumuli. Io posso fare cose che molte volte un “umano” coetaneo non fa più: viaggiare, avere mattinate libere, uscire la sera con gli amici. A Ferrara, dove ho vissuto dai 5 ai 18 anni, vicino al Teatro Comunale mi sono sentito chiamare “Paolo! Paolo!”, mi sono chiesto chi fossero i due vecchi che si rivolgevano a me, e ho scoperto che erano miei compagni del 3-2 finale. In casa mia si faceva il tifo per Mazzola padre, quello che morì nella tragedia del grande Torino, e la passione s’è poi riversata su Mazzola figlio, quello dell’Inter. A mia volta io ho obbligato i miei figli a essere interisti». Mettendo insieme le prime tessere delle esperienze di Rossi risalta un misto di bracciantato artigianale e manovalanza eclettica. «Io ho fatto teatro entrando dalla porta di servizio. Il lavoro dell’attore — me lo insegnò Checco Rissone a Como — prima che un’arte è un mestiere. Ti ci devi guadagnare da vivere. E il problema mi si pose, dopo una parentesi al Teatro Girolamo di Milano diretto da Umberto Simonetta, col Teatro Stabile di Trieste, dove fui scritturato con Vittorio Caprioli per Vita di Carl Valentin con regia di Pressburger. Mi fecero una promessa, non mantenuta. E così finii sottopagato. Cominciai a saltare un pasto al giorno, Caprioli se ne accorse, si indignò e mi portò sempre a pranzo con lui, pagando. Io gli rubai una cosa preziosa: la cattiveria nei camerini. Una volta mi disse “Dai, stasera improvvisiamo”. Una sfida. M’andò bene, strappai un applauso. Mi chiamò nell’intervallo: “Bravo, m’è piaciuto, da domani però questo lo faccio io”. E questa perfidia del dietro-le-quinte io l’ho ap- Amo le donne da sempre, amo il loro mistero, la loro diversità. E a chi mi rimprovera di non conoscerle abbastanza rispondo sempre: io non le voglio conoscere FOTO OLYCOM «I ROMA di scuola. Il vantaggio che avevo su di loro era dato dal dispendio di energie cui di solito mi sottopongo nel rapporto col pubblico, un contatto che però me ne restituisce di più, di energia». Lavora da trent’anni, Paolo Rossi: «Ma non capitalizzo. Slitto per indole dall’emozione alla riflessione, dalla comicità all’incazzatura, senza alternare coscientemente. Tutto è dipeso dagli inizi. Avevo qualcosa nel sangue. Mio nonno, di Corleone, era stato in una compagnia di Rosso di San Secondo, e dopo vari sperperi era finito nella Solvay di Monfalcone creando una filodrammatica pirandelliana. Mia zia calcava la scena, vinse un concorso italiano con uno sketch basato su vari dialetti collezionati in treno, le offrirono un contratto, ma la famiglia intimò: “O ti sposi o reciti”, lei s’intimorì, fece la casalinga. Anch’io, con papà che stava alla Solvay come mio nonno, ero destinato a fare il perito chimico. Ma mi piaceva di più il mondo dello spettacolo. Visto dal basso. Ho cominciato facendo il tuttofare nella compagnia di Gianni e Cosetta Colla. Come manovratore di marionette, addetto alle scene, ai rumori di fondo, e anche come attore. La sera, per 2.500 lire, m’impegnavo in un teatro sperimentale, il Cth di Milano (la sigla stava per Centro teatrale dell’hinterland), una cantina di 70 posti in un condominio di Via Valassina dove regnava l’off e il politico, con pubblico che c’era e non c’era». Il Paolo Rossi principiante era occupato in storie di Barbablù a base di omicidi e ladrocini, o faceva le luci in piccoli spettacoli a tema. Era il cosiddetto teatro di base o teatro delle case occupate degli anni ‘70. Guadagnava la mattina con le marionette, il pomeriggio come favolista per bambini, la sera con l’avanguardia. «Con un amico psicologo mettemmo in cantiere anche psicodrammi, reclutando Gigio Alberti che era stato mio collega in un corso di recitazione d’un attore del Living Theatre, e una biondona presa con un annuncio sui giornali. Volevamo proporre agli alunni delle scuole un lavoro, e un manager con forte nevrosi ci organizzò la vendita di biglietti in alcuni istituti (dal Manzoni al Carducci) per un collage di Prévert intitolato Il prevertimento. Dopo tre repliche chiudemmo. Ma non mi davo per vinto. Frequentai la scuola del Piccolo Teatro, i corsi mimo di Marise Flach. Lì venne a vedermi Dario Fo e mi prese nel cast dell’Histoire du soldat. Condusse un laboratorio per noi che eravamo una trentina di ragazzi. Ebbi più parti a rotazione. Con me c’erano Marco Columbro, Lucia Vasini». Che è stata una compagna di vita da subito dopo, da quando furono assieme allo Stabile di Como, per fare commedia dell’arte. «Con Lucia c’è stata una storia che, comprese le interruzioni, è durata 12 anni e da cui è nato un figlio, Davide, che adesso ha 17 anni. Pochi mesi fa ho regalato a Davide un cellulare che per suoneria ha il chiasso scatenato dal terzo gol dell’Inter alla Sampdoria lo scorso 9 gennaio, quello segnato da Recoba, quello plicata spesso: distraendo in tutti i modi Bisio in Comedians di Griffiths, facendo incespicare Hendel in un reading...». Poi, come si sa, il marchio teatrale vero viene impresso sulla pelle di Paolo dal Teatro dell’Elfo e dal Derby, quasi contemporaneamente. «All’Elfo una coincidenza di talenti straordinari introdusse uno stile nuovo. Al Derby c’era lo stimolo dato dal sovrapporsi di persona e personaggio. All’Elfo, nel 1983, per Nemico di classe di Williams, violentissimo testo di rottura in un’aula scolastica, Elio De Capitani volle liberarsi in una sola anteprima di colleghi e amici, che massacrarono lo spettacolo, mentre i critici fecero un osanna. Ma contò molto il passaparola e un clamore sollevato dalla polizia a Pordenone, con un fermo fino alle sette del mattino. Da allora sfondammo come i Six Pistols». E c’è però l’altra faccia dello sfacciato Rossi. Al di là d’un successo sconfinato, all’epoca, con le donne («Stipendio da camionista ma problemi da Mick Jagger»), cova in lui un senso atavico della famiglia. «I ricordi corrono alle estati a Monfalcone. Tavolate coi vecchi, coi nipoti, coi fidanzati. Idee politiche divergenti all’interno dello stesso ceppo. Sensazioni, leggerezze, fragranze. E poi ci sono le “mie” famiglie. Dopo il lungo legame con Lucia Vasini c’è stato quello con la madre non teatrante di Georgia, che adesso ha 12 anni, e poi c’è stato per la prima volta il matrimonio, quello attuale con Nadia, eritrea (un destino, perché l’altro mio nonno ha vissuto per un certo periodo in Eritrea, e decantava la bellezza delle donne di lì), danzatrice, con cui ho avuto il terzo figlio, Shoan, di due anni e quattro mesi». Parla di questo accumulo di affetti con l’aria di un mohicano che a metà della vita ha attraversato epoche intere, ha consapevolezza del dare e dell’avere, ha pudori e orgogli. E oltre ai vincoli paterni che sono la sua creatività più indicibile, viene fuori che la figura della donna ha sempre svolto un ruolo essenziale anche nella sua sfera di uomo pubblico, di scena. «Sono cresciuto tra donne. Nonne, zie e mamma. Sono creature diverse da noi uomini, e io ci tengo a sottolineare le differenze. Loro devono avere qualcosa di sconosciuto, di un altro pianeta, un mistero. Quando mi dicono tu-non-conosci-le-donne rispondo che è vero. Io “non” voglio conoscerle». E di questo passo arriviamo alla corda più nascosta, quella della madre, scomparsa da poco tempo. «Dopo una perdita del genere, uno s’avvicina alla morte in modo diverso. Ti accorgi che non c’è più quella che ti ha portato in grembo. Adesso sei solo. Capisci la labilità delle cose, pensi in modo meno materiale, meno furente. La fantasia viaggia a un’altra velocità, e in un’altra direzione. Mia madre era malata da due anni e io andavo spesso in ospedale da lei. A Reggio Emilia, dieci minuti prima dello spettacolo, m’hanno avvisato che era entrata in coma. Avevo davanti a me ottomila persone del festival dell’Unità, il produttore m’ha proposto di sospendere, ma io conosco le regole dello spettacolo, ho capito che non sarei stato utile a lei, e sono salito sul palco: un’esperienza metafisica col cervello squartato in due. Poi per mia madre l’agonia s’è protratta. Quando l’ho raggiunta, un vecchio medico m’ha fatto sentire la poesia della morte, e m’ha tolto la paura». Che Dio c’è per un attore? ci si chiede. «Io ho sempre pensato che Arlecchino fosse un tramite fra i morti e i vivi. Se guardo una nuvola penso a mio nonno. Nei piatti lascio sempre qualcosa da mangiare: si fa per gli antenati. Più che parlare con Dio, prego e parlo con me, perché secondo me c’è Dio in ogni cosa, nel caffè, e anche in me per come sono stato concepito». Il passato che torna in auge sotto forma di numeri e comicità ne Il signor Rossi contro l’impero del Male ha a che fare col rispetto dell’arte dei padri, del triestino Angelo Cecchelin (già idolo della madre di Paolo), di Totò, Petrolini, Govi. «I maestri più vicini a me sono Strehler, Cecchi, Fo, Gaber, Jannacci. E io a mio volta riverso qualcosa nei miei figli. Sono cresciuti dietro le quinte, dove c’è sempre educazione, disciplina. Io li aiuto con discrezione a trovare la loro strada, un lavoro dove non ti capiti di guardare l’orologio perché non vedi l’ora di tornare a casa». Poi ci sarebbe l’argomento soldi. «Col teatro popolare, con una compagnia numerosa come quella attuale, non puoi rischiare. Avrei potuto essere più ricco come comico solista, ma mi va meglio così. Rammento l’imbarazzo quando portai a casa l’incasso della mia serata di cabaret: era lo stipendio di un mese di mio padre. Mi piace spenderlo, il denaro. Ho l’anima del giocatore». Una novità: alla lunga (senza mutare idee e ideali) la politica, la satira potrebbero costituire per lui un circolo chiuso. «Io faccio teatro anche per quelli che non sempre vengono a teatro, e devi essere diretto, devi sapere che in sala c’è pure, magari in minoranza, chi è di destra, e devi saperti prendere in giro. Come ho appreso da Jannacci e Gaber». ‘‘ RODOLFO DI GIAMMARCO
Scarica