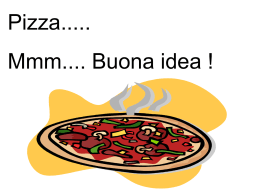Domenica La di DOMENICA 13 MARZO 2005 Repubblica il personaggio Maskhadov, ucciso nel villaggio di Tolstoj ADRIANO SOFRI e GIAMPAOLO VISETTI il racconto Bicicletta, le due ruote che fecero la storia MARIO FOSSATI e ENRICO FRANCESCHINI Vivere edamorire agente segreto FOTO CORBIS Ecco chi sono e come si muovono gli uomini e le donne che, come Nicola Calipari, sono impegnati sul nuovo fronte dell’intelligence da Roma a Bagdad CARLO BONINI U ROMA no squillo…Due squilli…Tre squilli. «Urbana 7 buongiorno, desidera?». Il centralinista del Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare ha l’ordine di non pronunciare neppure l’acronimo — Sismi — degli uffici del nostro controspionaggio. È una vecchia tradizione, sopravvissuta al tempo. Se qualcuno compone quel numero, sa chi sta chiamando. Se lo ignora, è meglio pensi di aver sbagliato. Anche perché quel numero non esiste. Non esiste in elenco, non esiste sul Web. Come del resto quello del Servizio Informazioni per la Sicurezza Democratica (Sisde), la nostra intelligence civile («Buongiorno, dica…»), e quello del Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (Cesis), il vertice della piramide, il punto di raccordo tra spionaggio domestico e controspionaggio estero («Pronto?…»). Va così. Nel Paese dove in decine di migliaia sfilano commos- si di fronte alla bara di un agente «eroe gentile», dove il generale (Nicolò Pollari) che dirige le mosse del Sismi decide di mostrare le proprie lacrime prendendo la parola dal pulpito di un’orazione funebre, il segreto mantiene forme antiche. Anche soltanto un numero di telefono è merce per addetti. *** T. — chiamiamolo così — abbozza un sorriso. «Tempo fa, il figlio di un amico mi ha chiesto: mi spieghi come si fa a diventare una spia? A chi devo mandare il mio curriculum? Ho pensato che non avevo una risposta. Ho abbozzato la verità: “Qualcuno ti deve chiamare” e devi già lavorare per lo Stato. Diciamo che se fai il poliziotto, il carabiniere, il finanziere o sei magari nell’esercito, è tutto più facile». Forte Braschi (la sede del Sismi) non è Langley. Il tetro palazzone di via Lanza (gli uffici del Sisde) non è l’Edgar Hoover building. La Cia e l’Fbi reclutano con bandi di concorso nelle migliori università del Paese: Stanford, Harvard, Yale. In Italia, si diventa agenti segreti per cooptazione. (segue nella pagina successiva) servizio di FILIPPO CECCARELLI le storie Nel bordello quotato in Borsa GIANNI CLERICI cultura L’album segreto di Eva Braun JOACHIM FEST e LAURA LAURENZI spettacoli L’uomo che catturò la magia del jazz GINO CASTALDO e ANTONIO MONDA 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Guerra segreta DOMENICA 13 MARZO 2005 Sono quasi cinquemila, guadagnano tra i 2000 e i 4000 euro al mese, sono ben addestrati, scelti per lo più tra carabinieri, finanza, polizia ed esercito. Ecco chi sono e come si muovono i colleghi di Nicola Calipari, gli uomini e le donne dei servizi italiani, che dall’11 settembre sono impegnati sul fronte del terrorismo. Da Roma a Bagdad Operazione “reclutatore” identikit dei nuovi 007 tenere una risposta, ma anche come riuscire a rispondere a una domanda senza mai offrire una risposta. Si insegna anche a leg(segue dalla copertina) gere in modo diverso. A darsi un metodo nell’analisi delle cosiddette “fonti aperte”: libri, giornali, siti web. A trovare in materian giorno saluti quelli con cui hai lavorato per anni le di libero accesso quei nessi capaci di trasformare isolati branin un ministero o negli stanzoni di una caserma o delli di informazione in una notizia con una testa e una coda. di una questura, infili la tua roba in un cartone e ti Ma, soprattutto, si insegna la “gestione delle fonti”, il rapporpresenti al tuo capoufficio con un decreto di “dito con l’informatore. Nel gergo degli addetti una formazione prostacco fuori ruolo presso la Presidenza del Consifessionale pensata per l’humint, la human intelligence. È ancora glio dei Ministri”». P. lavora con T., lo ha ascoltato S. che parla: «Non abbiamo risorse tecnologiche tali da poter inin silenzio e ora completa il racconto senza nessun imbarazzo: vestire sullo spionaggio o controspionaggio elettronico. Aspet«Forse è meglio dirlo senza tanti giri di parole. Non c’è dubbio che tiamo da anni una riforma che ci metta nelle condizioni di fare un tempo il nostro era un mestiere da raccomeglio il nostro mestiere. Dunque, investiamo mandati e poco raccomandabile. Non è più sull’uomo, sull’intelligence che si costruisce nel LE STRUTTURE così. E lunedì mattina, guardando i funerali di rapporto individuale, nella capacità di analisi. Il Nicola Calipari, ho sentito che forse è caduto modo più antico e “povero” di fare la spia». il diaframma. Credo, o forse spero, che la gen*** te non ci consideri più un corpo separato delDall’autunno del 2001, il lavoro dell’intellilo Stato». gence militare, prima in Afghanistan e quindi in In Italia, gli agenti segreti non arrivano a Iraq è stato proprio questo: “gestire le fonti”, “alcinquemila. Duemila lavorano per il Sisde, inlargarne il numero”. A chi ha dismesso il captorno ai duemila e cinquecento per il Sismi. potto corto e la cravatta per infilarsi in qualche Per avere un’idea statistica, cinque spie per abito cencioso e salire su un aereo per Kabul o ogni 250 tra poliziotti e carabinieri. GuadaBagdad (e parliamo di non più di qualche degnano meglio, con stipendi medi di 2.500 eucina di uomini) è stato chiesto di andare a faro, circa il doppio di un agente di pubblica sire un mestiere che gli americani chiamacurezza o di un appuntato. Che superano i no “case officer”. In italiano, “il reclutatoIL CESIS 4.000 se si arriva al vertice di una divisione. E È l’organo di coordinamento. re”. Venerdì scorso, in un’aula del se hanno un vezzo da tribù, è un’eleganza moCampidoglio, il direttore del Sismi Lo presiede il premier daiola un po’ tetra nei colori, con cappotto Nicolò Pollari lo ha raccontato con mentre la responsabilità corto e cravatte dal nodo sempre troppo lardue battute: «Sono sicuro — ha operativa è del segretario go. P. non se la prende, anzi ci ride su: «Il guaio detto il generale — che Nicola generale, attualmente il è che ci portiamo dietro il look da “sbirro eleCalipari avrebbe voluto che io prefetto Emilio del Mese gante”… ». facessi questa domanda: coNella tarda estate del 2002, ne rideva anche me opera un agente segreNicola Calipari. Era appena arrivato in quella to? Ebbene, l’agente setribù che non conosceva e la raccontava con greto tratta con persone un misto di divertita curiosità e sincera sorin ambiti pericolosi e lo presa: «Figurati, ho trovato gente che è invecfa spesso disarmato. chiata nel servizio, che può raccontarti la stoCerte volte, presenria di questo Paese senza che tu riesca a dire tarsi anche soltanto una sola volta “questo lo so”, al punto che ti con un giubbotto chiedi dove sei stato fino ad oggi e che diavoantiproiettile è conlo ha fatto chi te lo sta raccontando. Ma ho insiderato offensivo». contrato e scoperto anche molti giovani, se Nicola Calipari IL SISMI per giovani intendiamo dei quarantenni. È tendeva «reti inforSi occupa delle operazioni di come se l’11 settembre avesse imposto a tutti mative» e come lui intelligence all’estero e noi un’accelerazione improvvisa, un richiacontinua a farlo oggi contrasta le minacce esterne mo necessario di nuove forze». Lo dicono alchi lavora in Afghaniallo Stato. Il responsabile cuni numeri. Tra il 2002 e il 2004, con l’arrivo politico è il ministro della Difesa, stan e in Iraq. I nodi di di Mario Mori alla direzione del Sisde e di Niquelle reti sono i più diquello operativo Nicolò Pollari colò Pollari a quella del Sismi, accade che Diversi. Uomini d’affari, gos, Ros, Gico della Guardia di Finanza — inex militari di un esercito somma i nuclei di eccellenza investigativa che non c’è più, leader tridelle nostre tre polizie — vengano svuotati di bali o religiosi, spicciafacalmeno tre buone dozzine di giovani ufficiali cende dai mestieri itineranti. A e funzionari che si trasferiscono nelle divisioCalipari capitava di raccontarlo ni operative di Sismi e Sisde. Che questi uotornando dalle sue trasferte iramini vengano collocati al vertice delle divisiochene: «Quando rimetto piede a Roni operative dei due servizi, per una “riforma” ma penso spesso a chi mi sono lasciato che si vuole parta dalla testa e si immagina dietro. A chi ho convinto a lavorare per possa servire a destare il corpaccione di strutnoi. Alle ragioni per cui lo fanno. Qualcuno ture abituate a non rispondere ad altri che a se per soldi, certo. Ma non tutti». (Le fonti venIL SISDE stesse. Anche per questo, un venerdì di margono retribuite con fondi riservati la cui entità È deputato a contrastare zo, scopri in Iraq un maggiore dei carabinieri è coperta dal segreto). Accade anche che la rete gli attacchi all’integrità che hai lasciato sul marciapiede di un’operasi strappi. Che l’informatore salutato l’ultima dello Stato democratico e zione antidroga. O riconosci nella faccia cotvolta non risponda più. Perché nessuno, a Bagl’eversione. Dipende dal ta dal sole di Kabul, il volto familiare che, per dad o a Kabul, fa caso a chi muore sul ciglio di ministero dell’Interno ed è anni, hai incrociato nei corridoi della Digos. una strada per una rapina che forse è una rapidiretto da Mario Mori Ieri si occupava di sit-in non autorizzati, oggi na o forse no. O sotto una macchina in un incitiene il filo con un paio di tribù Pashtun. dente stradale che forse un incidente non è. Al Sismi, lo chiamano «controspionaggio of*** S. racconta: «Quando ho cominciato, pensavo che, in fondo, fensivo». Ti spiegano che significa spostare la linea della difesa avrei continuato a fare il mestiere della mia prima vita. Immagidel Paese sulla frontiera della minaccia potenziale, anticipandonavo che non doveva esserci poi così tanta differenza. Data una ne gli sviluppi. Ti raccontano che è un lavoro cominciato quandomanda, trovare una risposta. Dato un problema, venirne a cado l’Iraq era ancora di Saddam Hussein. E battezzato nella prima po. Sempre usando le armi dell’investigazione. Mi sbagliavo. È settimana di conflitto, nel marzo del 2003, quando il controspiotutto più difficile. Lavori a partire da informazioni scadenti, innaggio militare italiano lavorò alla «illuminazione» di obiettivi controllabili, incontrollate e il tuo approdo devono essere altre militari strategici per le colonne corazzate anglo-americane che informazioni. Questa volta, solide. Il problema non è pedinare tiavanzavano dal Kuwait. Aggiungono che è l’unico modo per sotzio. Osservare se si incontra con Caio. Sapere se mette le corna altrarsi alle pratiche dell’intelligence in “outsourcing”, l’intelligenla moglie. Per quello ci sono le agenzie di investigazione private. ce in appalto ad un servizio informativo alleato. Non è quasi mai un lavoro muscolare. È sempre un lavoro sciIl problema è trovare e reclutare un signore che devi imparare a voloso. Racconta ancora P. «Contano la tua testa e il tuo equiliconoscere, di cui devi valutare l’affidabilità. Perché occhi e orecbrio. Quando dico che non siamo più un corpo separato dello chie di quel signore diventano i tuoi occhi e le tue orecchie. Lui Stato significa che, oggi, avvertiamo più forte il legame diretto sarà dove tu non puoi arrivare o non puoi essere. Lui è la tua “foncon l’autorità politica, le sue priorità. E allora, conta la tua cate” e la “fonte” è la tua sola ricchezza». pacità di non rimanere schiacciato tra quello che ti dicono il terPer insegnargli il mestiere e prima di inquadrarle nelle divisioreno e le tue fonti, la tua deontologia professionale, e quello che ni in cui saranno operative, mandano le reclute alla “Scuola di adsai o, peggio, immagini che l’autorità politica si aspetta da te. destramento e formazione”. Ci restano un tempo variabile, non Anche perché una cosa impari in fretta. Questo è un mestiere uguale per tutte. Tre settimane o tre mesi. Nessuno impara tutto in cui il successo non ha mai il tuo nome, ma la sconfitta sì». perché nessuno deve saper fare tutto. La scuola insegna tecniche di difesa individuale (gli agenti sanno usare tutte le armi, ma di *** Non è più neppure un mestiere per soli uomini. Un venti per solito portano la Beretta 7.65 in dotazione alla polizia), di infilcento degli agenti della nostra intelligence sono donne. Al Sitrazione, di contraffazione documentale, di intercettazione ovsde, come al Sismi, come al Cesis. Dicono non siano interdette vero di protezione elettronica e informatica, di decrittazione e a nessuno degli incarichi. Anche quelli operativi. L’8 marzo di decodificazione. Le reclute vengono addestrate alla “compartiun anno fa, al nostro Mario Pirani accadde di ricevere un invimentazione”, la routine che impone, in ogni servizio, di custodito inconsueto per la Festa della Donna: tenere una relazione ad re il segreto anche con chi lavora accanto a te. All’assemblaggio una trentina di analiste del Cesis. Ricorda oggi Pirani: «Mi misi di una “squadra tipo” per operazioni clandestine, dove un “cora ragionare sulla figura della donna-spia dalla Bibbia a Mata riere” deve avere capacità diverse da un esperto in effrazioni o in Hari e dopo poco mi trovai nel mezzo di una discussione che ripedinamento. Chi impara a pedinare, deve anche sapere come cordo molto stimolante per la qualità di chi avevo di fronte. non farsi pedinare. E chi dovrà provare a rubare informazioni deDonne sui trenta, quarant’anni che erano evidentemente figlie ve sapere come custodirle. Nelle sessioni dedicate alle tecniche di un’altra cultura». di interrogatorio si insegna come fare una domanda capace di ot- CARLO BONINI U NEL MIRINO “La prima cosa che impari in questo mestiere - dice un agente dei servizi - è che il successo non porta mai il tuo nome, ma la sconfitta sì”. Gli agenti del Sismi e del Sisde ricevono un addestramento che varia dalle tre settimane ai tre mesi LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 FOTO VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE FOTO MARCO LONGARI/AFP DOMENICA 13 MARZO 2005 I Servizi della vergogna poi il Sismi di Calipari FILIPPO CECCARELLI FOTO ANSA IL CASO SIFAR I servizi di De Lorenzo (foto) fanno schedare, fra il ’55 e il ’62, 157mila italiani. Da qui nasce il Piano Solo del ’64, che doveva portare all’arresto di 731 politici e sindacalisti FOTO A3 O PIAZZA FONTANA Gli agenti del Sid Maletti, Giannettini (foto) e Labruna finiscono sotto inchiesta, negli anni Settanta, per i depistaggi delle indagini sulla strage FOTO A3 gni tanto ne arrestavano uno. C’erano infatti «disfunzioni» e «deviazioni»: continue le prime, più gravi le seconde, anche se in realtà non si è mai capito bene cosa diavolo dovessero fare, i servizi segreti, per meritarsi la qualifica di «deviati». E comunque di tanto in tanto qualche generale prendeva la porta della galera. Oppure quella di Montecitorio. Il generale De Lorenzo, protagonista dell’affare Sifar, eletto con i monarchici; il capo del Sid generale Miceli, che pure conobbe l’umiliazione degli arresti, trovò sicuro ricovero nelle liste del Msi. Non era un bel mondo, quello degli spioni; e dirigerli era considerato da sempre mestiere a rischio. Così nel bel mezzo dell’ennesimo cambio di sigla, da Sid a Sismi pare di ricordare, un provvisorio responsabile, l’ammiraglio Casardi, espresse quella sua condizione con una specie di sospiro. E disse dunque, l’ammiraglio, che era romano: «So’ rogne». Per lui. Ma per l’Italia furono anche piaghe, e per gli stessi servizi, militari o civili che fossero, un fardello di vergogna che solo il sangue di un funzionario coraggioso poteva alleggerire, o forse riscattare. Ecco. A queste piaghe purulente si torna oggi per meglio comprendere il sacrificio di Nicola Calipari. A un lungo passato di arresti, condanne, rapporti con l’eversione, depistaggi, ricatti, diffamazioni, approssimazioni, ruberie, sprechi, servilismi. Per scoprire che il mondo dei servizi segreti non solo è cambiato, ma finalmente in meglio. E se pure ci sono ancora colonnelli e maggiori in carcere per la strage di Bologna, e generali che vivono in Sudafrica, beh, gli agenti di oggi non sono più gli indegni spioni di un tempo; né più, a menzionare Sismi e Sisde, si evoca polvere da sparo, puzza di bruciato, veleni, fango e quell’altra cosa che le «barbe finte» si dilettavano a mettere nel ventilatore. E insomma sembra chiusa — fino a prova contraria — una stagione di servizi troppo segreti e al tempo stesso troppo servizievoli con il potere politico. Gli aerei del Cai per portare a zonzo i potenti, le ristrutturazioni delle case dei ministri fatte passare come «allestimento di misure di difesa passiva», i fondi riservati che finivano nei conventi di suore, le mangiate di aragoste a Capo Marrargiu, le veline «da lupanare», come le definì il capo della segreteria di Craxi, Acquaviva. Era questa di frugare nella pattumiera, un’autentica fissazione dei responsabili della sicurezza nazionale, neanche fossero stati alla guida della Buoncostume. Cominciò il Sifar negli anni cinquanta a schedare le amicizie, le amanti, i figli illegittimi, l’omosessualità, i debiti, l’alcolismo dei politici, anche di governo; e si arrivò all’inizio del decennio scorso a scoprire che il controspionaggio militare aveva allestito una «barca-garconniere», l’indimenticabile “Islamorada”, mentre il servizio per la Sicurezza democratica GLI SCANDALI LA ROSA DEI VENTI Vito Miceli (foto), capo del Sid, è arrestato nel ‘74 per il caso della Rosa dei Venti, un gruppo segreto di cui fanno parte uomini dei servizi coinvolti in attentati LA LOGGIA P2 All’organizzazione massonica di Licio Gelli aderiscono sia il generale Miceli sia il primo direttore del Sismi Santovito: con loro molti membri dei servizi FOTO A3/CONTRASTO IL RICORDO Sopra, una copia del “manifesto” alzata al cielo durante i funerali di Nicola Calipari. A destra, i ritratti di Giuliana Sgrena e del funzionario del Sismi davanti al palazzo della Provincia a Roma nel giorno delle esequie I FONDI NERI DEL SISDE Nel ’94 si scopre che le casse del Sisde vengono svuotate per rimpinguare i conti di alcuni dirigenti, fra cui il direttore amministrativo Maurizio Broccoletti (foto) disponeva di un accogliente resort alle porte di Roma, il “Borgo Parahelios”, dove pure si riuniva la corrente del Golfo. Questo succede quando si lavora sulle umane debolezze, e tanto più dentro lo spietato serraglio del potere. E ci sarà pure stato qualche Calipari, oltre ai Labruna, ai Giannettini, agli ufficiali che foraggiavano i latitanti neofascisti o al direttore dell’ufficio “Affari Riservati” del Viminale, quel Federico Umberto D’Amato cui Dario Fo s’ispirò nel suo Pum pum chi è? La polizia. Ma certo i servizi facevano ridere e insieme facevano paura, doppiezza che si rese evidente durante il caso Moro. Vero è che erano votati a combattere il comunismo — salvo preoccuparsi che i dollari distribuiti dai sovietici al Pci non fossero falsi. Ma certo, ancora alla fine degli anni ottanta il livello di professionalità lasciava disperatamente a desiderare: e lo provano le informative sequestrate dai giudici nell’archivio di un generale capocentro che tutti, pare, a Forte Braschi (dove pure c’era un misterioso zoo con cerbiatti e gazzelle) chiamavano graziosamente «Capemuorto». Bene, come documenta Gianni Cipriani in Lo spionaggio politico in Italia (Editori riuniti, 1998), in quelle carte il presidente americano era sistematicamente scritto «Busch», ma si parlava anche di Olaf «Palmer» e del generale «Jerucheski». Non solo: proprio in quei giorni stava cadendo il muro di Berlino, e l’informatore di «Capemuorto» si dedicava ai «trucchi» del festival di Sanremo: «Se non si opererà in maniera di neutralizzarne le conseguenze — avvertiva — queste ultime ricadranno sicuramente sugli ambienti che fanno parte dei circoli demitiani». E già la prosa suonava a suo modo fantastica. Ma intanto correvano soldi e si consumavano residui di dignità. Era l’Italia della «cartuccella», del ricattuccio, del dossierino falso, dello scaricabarile, del segreto di Pulcinella. Era la sagra permanente dell’informatore inattendibile e/o sospetto: nel 1993 ne spuntò fuori uno, a nome Allocca — «Gennarino o’ spione», naturalmente — che segnalò una valigia d’esplosivo su un treno, solo che ce l’aveva messa lui. Il punto più basso di questa epopea sempre più drammatica e pagliaccesca si toccò in sintomatica coincidenza con la caduta della Prima Repubblica. Da un lato la vicenda di Donatella Di Rosa, «Lady Golpe», poi rapidamente convinta a fare lo spogliarello in tv; dall’altro l’allegra brigata ortofrutticola del Sisde con Broccoletti, Finocchi e una certa «Zarina» che a spese del servizio volava a Buenos Aires per conoscere il protagonista della sua telenovela preferita. E come si dice sempre: non poteva andare avanti così. E forse infatti ci voleva davvero la caduta del comunismo, la fine della Guerra Fredda, la rottura di ogni equilibrio geopolitico. Anche se per accorgersene, purtroppo, basta la tragica dignità silenziosa di Nicola Calipari. 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 il protagonista Cecenia in fiamme La tragica parabola di Aslan Maskhadov, l’ex colonnello dell’Armata Rossa diventato comandante delle forze cecene e poi leader della Repubblica di Ichkeria, nella testimonianza di chi lo ha conosciuto e frequentato. E che oggi lo ricorda: nel male e nel bene Il presidente ucciso nel villaggio di Tolstoj S IL LEADER Qui sopra, Maskhadov. A sinistra, il cadavere dopo l’omicidio. A destra, un soldato russo in Cecenia FOTO ANSA apete che Aslan Maskhadov, già presidente della Repubblica cecena di Ichkeria, designato nel 1996 in elezioni controllate dall’Ocse, è morto ammazzato e tradito nella cantina di un villaggio che si chiama, figuratevi, Tolstoj-yurt. Alcuni telegiornali l’hanno distrattamente definito come mandante o complice dell’orrore di Beslan: non lo era, e non meritava quella calunnia, la più infamante. Alcuni giornali hanno scritto che con la sua uccisione scompare l’ultimo interlocutore possibile di una soluzione negoziata della tragedia russo-cecena. Non è vero: quel negoziato era da tempo impossibile, e Maskhadov era un morto che cammina. Era impossibile perché Putin e i suoi generali l’avevano cancellato dal loro orizzonte, per odio prima ancora che per calcolo politico, consegnando così Maskhadov all’impotenza e alla frustrazione di fronte all’oltranzismo cinico di Shamil Basaev e dei terroristi suicidi. Dunque commemoro la morte di Maskhadov non come un colpo fatale alla speranza di un negoziato, o come un regalo fatto all’estremismo islamista: tutto ciò era consumato, e l’avevo scritto qui da tempo. Commemoro la morte solitaria di un uomo, e il suo tragico destino. Lo faccio anche, come dirò, per un fatto personale. Aslan Maskhadov era un militare di professione addestrato nelle file dell’Armata Rossa, colonnello messo ancora alla prova nella repressione dell’indipendentismo baltico, come il suo eroe imminente, il generale dell’aeronautica sovietica Dzokhar Dudaev. Militari di carriera, e prodi, Dudaev in modo impetuoso, e Maskhadov più metodicamente e discretamente. Stiamo parlando della Russia, 145 milioni di abitanti, e della Cecenia, neanche un milione. Nella prima guerra russo-cecena — la prima di due guerre nel giro di dieci anni! — Maskhadov era stato il comandante in capo delle forze cecene, valoroso nella resistenza regolare come Basaev e altri giovani guerrieri erano valorosi nelle sfide spavalde e sfrenate. Maskhadov era personalmente serio e schivo. Lo vidi pressoché ogni giorno per un mese, quando era il sicuro presidente in pectore di una repubblica riconosciuta, e aveva sempre un atteggiamento misurato, che di fronte alla telecamera o al registratore si mutava in una vera timidezza. Nell’intervallo fra le due guerre — un’unica guerra spietata con una illusoria pausa di pace — c’era un solo posto telefonico nel centro di Grozny, e ogni sera i capi del Paese ci venivano, con le loro scorte di ragazzi armati e chiassosi. Uno dei figli di Maskhadov passava il suo tempo in una roulotte sgangherata parcheggiata di fronte, in cui un pugno di giovani intraprendenti, reduci alcuni dagli studi in Europa o in America, avevano installato un computer e si cimentavano con le meraviglie di Internet. Il figlio di Maskhadov fu ammazzato presto alla ripresa della guerra, e altri della sua famiglia ebbero la stessa sorte. I superstiti sono stati alla fine sequestrati dai russi e dai loro scherani locali, le bande dei Khadirov, e tenuti in ostaggio, secondo l’usanza, per fiaccare la sua tenacia. Conoscete il repertorio di quella sedicente guerra: sequestri di famiglie, sparizione di persone seguita benignamente dalla restituzione dei cadaveri in cambio di denaro e gioielli, stupri, torture. Maskhadov aveva concluso col generale Lebed la fine della guerra. Dudaev era già morto in un attentato russo. Lebed sarebbe morto in un incidente russo. Nelle elezioni presidenziali del 1996, Maskhadov aveva dei concorrenti, e fra loro Zelimkhan Yandarbiev FOTO AFP ADRIANO SOFRI e il giovane Basaev. L’islamista Yandarbiev è morto nel Golfo in un attentato di sicari russi. Basaev è ancora vivo, ha solo perso una gamba su una mina, e in quella circostanza tenne a farsela amputare in pubblico, e senza anestesia, perché così fa un combattente ceceno. La sua leggendaria prodezza si piegò dopo quell’effimera tregua agli azzardi più loscamente provocatori e alle gesta più infami, fino a Beslan. In lui la virile audacia personale ha mostrato oltre ogni misura la vicinanza, e poi lo sconfinamento, nella brutalità più ripugnante. Beslan, appunto, e prima il plagio o la violenza su donne mandate a uccidere e uccidersi. Nessuna nefandezza è ormai fuori dalla portata di Basaev e dei suoi. Dapprincipio né Basaev né Maskhadov erano così fervidi islamisti. Basaev lo diventò, in uno dei suoi “Nel gennaio ’97, reduce dalla Cecenia, entrai in prigione. Fu allora che mi arrivò il suo messaggio” travestimenti da avventuriero. Maskhadov non lo diventò mai, ma vi cedette con una incresciosa riluttanza, quando si rassegnò all’introduzione della sharia, e poi quando la resistenza armata diventò sempre più tributaria del sostegno arabo. La campagna presidenziale alla fine del 1996, forse perché potetti assistervi e per così dire parteciparne, perché correvo dietro quotidianamente a tutti i capi ceceni che collaborassero alla restituzione degli italiani rapiti, mi sembra ancora l’incubatrice fatale della tragedia a venire. Basaev era l’idolo della sua gente, aveva trent’anni, si illuse che la devozione popolare per il figlio eroe si traducesse nel voto. Ma i popoli, anche il ceceno, sono romantici e saggi insieme. Abbracciano Basaev con le lacrime agli occhi, e votano per il gri- gio e responsabile Maskhadov. Discussi animatamente con Basaev della sua candidatura. Aveva tanto tempo. Ma lui era troppo giovane, dunque aveva fretta. Nelle elezioni non arrivò nemmeno al ballottaggio. L’affidabile Maskhadov sconfisse nettamente Yandarbiev, che doveva la sua poca reputazione alla successione provvisoria a Dudaev assassinato. Dopo, per un breve tempo, la Cecenia di fatto indipendente dovette misurarsi con se stessa, mentre i generali umiliati di Mosca covavano la vendetta, e si preparava l’ora di Putin. Con quella specie di pace la leggendaria unità dei ceceni di fronte al secolare nemico russo andava in pezzi, nel feudalesimo dei signori della guerra e la sfrenatezza criminale delle bande armate. Basaev oscillò per qualche tempo fra l’affarismo privato e la corresponsabilità col nuovo Stato, e arrivò fino a diventarne il primo ministro. Fu lui, e il vanesio emiro Khattab, a scatenare la demenziale impresa daghestana, fallita e ridicolizzata, ma bastante a dare al Cremlino l’occasione che aspettava. Poi Maskhadov restò il più autorevole leader del suo popolo, ma il suo prestigio era ormai ferito dalla prova mancata della presidenza e dalla debolezza nei confronti dell’avventurismo islamista. Non cessò mai di chiedere una soluzione negoziata, ai russi e a Putin personalmente, e all’Onu, all’Europa, agli Stati Uniti. Se avesse trovato una sponda appena salda, la sua leadership avrebbe ripreso vigore, e la sua condanna dell’estremismo si sarebbe sbarazzata dei compromessi. Nei suoi appelli sempre più frustrati, Maskhadov arrivò a sottoscrivere dichiarazioni non-violente, incredibili ad ascoltarsi in quel Caucaso e in quelle circostanze. Si nascondeva da sei anni nella sua terra bruciata, e intanto i capi russi lo presentavano al mondo come il più pericoloso dei terroristi, gli mettevano addosso una taglia di decine di miliardi, lo additavano come un accolito di Basaev. Ogni tanto fra gli “esperti” e fra gli appassionati al destino ceceno (e dunque russo, dell’altra Russia), gruzzolo di persone sempre più sfiduciate e amare, rinasceva la voce che stessero per aprirsi trattative fra Putin e Maskhadov, anzi che si fossero già segretamente incontrati, che da un momento all’altro sarebbe arrivata la svolta. Io avevo smesso da tanto tempo di crederci. Per questo ho guardato a quel torso nudo esibito in un cortile come a uno che è morto solo, un bandito Giuliano ormai senza fili. Non mi aspettavo più niente da Maskhadov, quanto alla Storia, alla Guerra e alla Pace. Per questo, dalla posizione un po’ grottesca in cui mi trovo, commemoro alla buona quell’uomo ammazzato in una cantina di un villaggio. Però la grandezza, che si ride della Storia, ma spesso infila uno zampino malizioso nelle nostre giornate, si è insinuata nel nome del villaggio estremo di Maskhadov: Tolstoj-yurt, dal grande scrittore che fu di guarnigione in Cecenia, e rese immortale la fierezza di quel popolo. La Russia e l’altra Russia si sono date appuntamento in quell’irrisorio villaggio. E il fatto personale? Nel gennaio del 1997 entrai in galera. Ero reduce da un secondo viaggio in Cecenia — ci ero stato la prima volta durante la guerra — in cui riuscimmo a tirar fuori vivi tre medici volontari italiani sequestrati. Stetti giorno e notte con quelle persone, anche Aslan Maskhadov, anche Shamil Basaev, anche quel detestabile Khattab. Non me ne preoccupai affatto, c’era la pace, avevo una cosa da fare, e poi avevo letto La figlia del capitano, e sapevo che può capitare di fare un viaggio nella neve con Pugaciov. Insomma entrai in galera, e dopo un po’ ricevetti la copia di un messaggio solenne che il presidente eletto della Repubblica cecena di Ichkeria, Aslan Maskhadov, e il capo di quel governo, Shamil Basaev, avevano indirizzato al Quirinale, per parlare di me e auspicare la mia liberazione. Com’è la vita. LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 FOTO REUTERS DOMENICA 13 MARZO 2005 Parla la Melnikova, oppositrice di Putin “Colpito per fermare la pace” GIAMPAOLO VISETTI «I MOSCA l Cremlino aveva capito che la necessità di un negoziato di pace in Cecenia stava ormai diventando patrimonio condiviso del mondo. Onu, Usa e Ue erano pronti a risoluzioni critiche contro la Russia, ponendo a Putin il problema del mancato rispetto dei diritti umani. Per questo Aslan Maskhadov è stato ucciso ora. Mosca ha voluto eliminare l’unico interlocutore politico, riconosciuto dentro e fuori la Cecenia. Ha preferito consegnare il Caucaso al terrorismo islamico. Nessuno potrà così chiedere a Putin di sedersi al tavolo delle trattative con Shamil Basaev: e la guerra necessaria al nuovo zar continuerà indisturbata». Valentina Melnikova si batte da anni contro il massacro ceceno. Presidente del Comitato delle madri dei soldati russi, ha iniziato a lottare chiedendo di sospendere l’invio di ragazzi inesperti nell’inferno di Grozny. Presto, come racconta a Repubblica, ha aperto gli occhi sulle altre vittime, sui ceceni. Quali conseguenze avrà la morte di Maskhadov? «La guerra cecena si estenderà in tutto il Caucaso. Da lotta per l’indipendenza, diverrà battaglia di religione. Maskhadov era un prodotto della mentalità sovietica, ma rappresentava l’anima profonda della Cecenia. Conciliava ortodossia e islamismo, conosceva centralismo e autonomia: per questo si era giunti alla pace di Khassavjurt con Eltsin. Eliminato lui, a Grozny restano solo le cinture esplosive, a Mosca i carri armati: presto scorrerà molto sangue, inutile e innocente». Il 24 febbraio lei ha incontrato a Londra Akhmed Zakaiev, portavoce di Maskhadov: è vero che era pronto un piano di pace sostenuto dalla comunità internazionale? «Quel tentativo, senza precedenti, ha sancito la condanna di Maskhadov. In febbraio era riuscito ad imporre alla guerriglia un cessate il fuoco unilaterale di un mese, era tornato un punto di riferimento affidabile. Con Zakaiev era stato steso il piano che in mezz’ora poteva porre fine alla guerra: ritiro dei soldati russi in cambio di stop al terrorismo dei ribelli. Di autonomia e indipendenza si sarebbe discusso più avanti. Putin ha capito che rischiava di perdere la sua guerra ed è intervenuto». In cosa sarebbe consistita l’annunciata dichiarazione congiunta? «Diceva che la guerra è ormai un onere insostenibile sia per la Russia che per la Cecenia, che nessuno potrà mai prevalere, che sofferenze e vittime pesano su Mosca e su Grozny, ma pure sulle cancellerie di tutto il mondo. L’Occidente era pronto a sottoscriverla: dalla Russia invece ormai è impossibile ottenere qualcosa». Perché il Cremlino non vorrebbe la pace? «Oltre alle considerazioni politiche, ci sono quelle pratiche. La Cecenia è uno scannatoio, ma pure una mangiatoia d’oro. In troppi, dalle due parti, fanno troppi soldi. Petrolio, armi, fondi per esercito e ricostruzione, traffico di persone. Coloro che dovrebbero dialogare non hanno alcun bisogno della pace. Generali russi e ribelli ceceni si arricchiscono con le stragi: la guerra è il solo patrimonio che possiedono e lo reinvestono ogni giorno». Come giudica il rifiuto di restituire alla famiglia il cadavere di Maskhadov? «La Russia sa che non saprebbe gestire il funerale. Secondo la tradizione caucasica, parteciperebbero migliaia di persone: il rito durerebbe giorni, consentendo ai terroristi di confondersi nella ressa. La sua tomba diventerebbe luogo di culto islamico e motore di unità per la guerriglia indipendentista. Maskhadov per i ceceni è morto da eroe: Putin lo ha fatto uccidere dai servizi segreti proprio perché, da prigioniero sotto processo, ne avrebbe perso il controllo. Ora teme anche il suo cadavere, al punto che ha dovuto nasconderlo a Mosca. Non restituirlo ai suoi cari è una chiara violazione dei diritti umani». Chi raccoglierà l’eredità reale di Maskhadov? «Nel breve periodo deciderà tutto Basaev. I ceceni non sanno nemmeno chi sia lo sceicco Abdul Khalim Saidullaev. In qualità di giudice del tribunale islamico servirà solo a fornire una base giuridica e un’assoluzione religiosa alle prossime stragi. Presto emergeranno però nuovi leader. Da una parte potrebbe esserci il figlio di Maskhadov, Anzor; dall’altra il figlio di Kadyrov, Ramzan. I loro padri si sono reciprocamente eliminati. Putin sfrutterà la loro sete di vendetta per farli scannare tra loro». Perché la morte di Maskhadov non potrebbe invece contribuire alla resa dei secessionisti? «Nessuno di loro, come la maggioranza dei ceceni, accetterebbe mai di perdere l’onore. È discutibile, ma resta un fatto: da secoli lottano per l’indipendenza, non accetteranno di prendere ordini da chi li ha deportati e decimati. Mosca finge di ignorare la realtà, di credere che i ribelli combattessero per Maskhadov, o che lotteranno fino a quando ci sarà Basaev. Se Putin pensa di uccidere tutti i ceceni, uno ad uno, lo dica francamente. L’alternativa al genocidio è un tavolo della pace. Il problema è che il Cremlino ha invece bisogno di un conflitto: e proprio nel Caucaso». Cosa intende dire? «In gioco non ci sono solo petrolio, armi, basi militari, il passaggio tra Caspio e mar Nero. Guerra in Cecenia significa pressione sulla Georgia: ossia merce di scambio per l’indipendentismo di Abkhazia e Ossezia del Sud, ma pure esempio per ciò che potrebbero diventare la Transnistria, o altre regioni della Russia. Putin si sta giocando lo spazio post sovietico, scosso da forze centrifughe sostenute dalla Nato. E la cosiddetta lotta al terrorismo gli consente di non regalare agli Usa il Medio Oriente». 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 il racconto Rivoluzione a pedali Tutto cominciò nel 1696, con un progetto che rimase sulla carta. Ma la prima vera bicicletta fu progettata nel 1867. Da allora quel “cavallo meccanico” semplice e geniale ha segnato l’infanzia di intere generazioni. E ora un libro ne ripercorre l’incredibile viaggio Le due ruote che fecero la storia ENRICO FRANCESCHINI essuno di noi può ricordare l’attimo in cui è nato, e nella memoria di un adulto rimane ben poco dell’intera infanzia: delle prime parole, dei primi passi, dei primissimi giochi. Eppure quasi tutti conserviamo qualche precisa reminiscenza della prima pedalata, la sensazione del giorno in cui, inforcata una bicicletta, abbiamo finalmente spiccato il volo: la mano del genitore che sorregge il sellino da dietro aiutandoci a mantenere un precario equilibrio su due ruote, e poi d’un tratto si stacca, e all’improvviso ci accorgiamo di correre senza più alcun sostegno, soli, sulle nostre gambe. Tramandata di padre in figlio, quella magica esperienza costituisce spesso il primo ricordo autentico, quasi il momento in cui abbiamo acquisito la consapevolezza di vivere. Di generazione in generazione, molto è cambiato nel mezzo di trasporto protagonista di questa indicibile emozione: la forma, il materiale, l’equipaggiamento che lo completa e lo arricchisce. In fondo è cambiato perfino il nome: i quarantenni o cinquantenni odierni non dimenticheranno mai la “bici” della loro giovinezza, mentre i ragazzi d’oggi parlano soltanto di mountain bike. Ciononostante, molto resta anche immutato, nella bicicletta. Milioni di persone in cinque continenti continuano a usarla come efficace ed economico sistema di locomozione. Legioni di ciclisti dilettanti continuano a montarci sopra nel weekend, per fare esercizio o andare a spasso. Ogni anno, il Tour de France e altre classiche competizioni continuano ad attirare spettatori e a suscitare grandi passioni. In un mondo che si evolve e si trasforma a velocità prodigiosa, il boom della bicicletta sembra un’inesauribile costante. Non ci sarebbe dunque da meravigliarsi se i nostri antenati la considerarono una delle maggiori conquiste del progresso, alla stregua della nave a vapore, del treno, del telegrafo e del telefono. Potrebbe stupire, piuttosto, che di un tale meraviglioso marchingegno nessuno avesse ancora raccontato la storia come si deve. A colmare la lacuna provvede ora un libro illustrato di cinquecento pagine, altrettanto meraviglioso, uscito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna: Bicycle, the history, a cui l’autore, David Herlihy, storico di Harvard, ha dedicato ben quindici anni di studi e di ricerche. L’invenzione di un veicolo in grado di sostituire il cavallo, bisogna dire, prese molto più tempo. Nel 1696, un francese visionario, Jacques Ozanam, progettò un mezzo “auto-movente” azionato dall’uomo: ma la sua idea non andò troppo lontano dalla carta su cui era tratteggiata. Da allora dovette trascorrere oltre un secolo affinché un eccentrico tedesco, il barone Karl von Drais, producesse nel 1816 il prototipo del primo velocipede (dal latino “velox pedis”, dal piede veloce): una sorta di “cavallo meccanico”, con due ruote ma senza pedali e, particolare da tenere presente, pure senza freni. In pratica funzionava secondo il concetto del monopattino: uno ci saliva sopra e dava una spinta con i piedi. Comportava rischi non indifferenti: se per caso prendevi velocità su una discesa, potevi romperti il naso; altrimenti consumavi la suola delle scarpe e non facevi molta strada. Bastò tuttavia a suscitare entusiasmi in mezza Europa. «Il più grande trionfo della tecnica», scrisse liricamente un giornalista inglese nel 1819. «Sarà la creazione di una macchina o di un carro per viaggiare, senza cavalli o altri animali che lo tirino». I tempi, evidentemente, erano maturi, ma ci volle un altro mezzo secolo perché a qualcuno venisse in mente di metterci i pedali. N IL MITO Qui a destra, poliziotti in bicicletta a Stamford, Connecticut, nel 1910. Sopra, una illustrazione del 1873: quattro membri del Middlesex Bicycle Club in viaggio da Londra alla Scozia del nord. Nelle altre immagini, manifesti pubblicitari di biciclette d’epoca e dei primi pneumatici Michelin La svolta venne nel 1867, quando un fabbro francese di nome Michaux aggiunse non solo i pedali, ma anche i freni. Il suo primo modello, costruito in acciaio massiccio, pesava però più di trenta chili e aveva le ruote di legno: pilotarlo in equilibrio non era un’impresa facile. In più costava un patrimonio: all’inizio poteva permetterselo soltanto l’aristocrazia. Ciò malgrado, era nata la bicyclette, la definizione francese destinata a diventare universale (da “bicycle”, che a sua volta deriva dal latino “bi” e dal greco “kyklos”: a due ruote). La curiosità fu immediata: il primo, primitivo esemplare lanciò una frenesia di sperimentazioni sulle due sponde dell’Atlantico, catturando rapidamente l’attenzione del Si calcola che nel mondo ne circolino più di un miliardo. Lo storico: “Le bici continueranno a esistere finché uomini e donne avranno le gambe” mondo. «Mai prima d’ora nella storia manifatturiera americana è sorta una simile domanda di massa», declamò il New York Times nel 1869. Esagerata retorica, ma l’eccitazione era comprensibile. Per la prima volta nella storia dell’umanità, la gente poteva effettivamente immaginare un’esistenza in cui il cavallo — amata ma esigente e talvolta bizzosa creatura — non rappresentava più il principale mezzo di trasporto quotidiano. All’orizzonte si approssimava una nuova era di viaggi su strada, che avrebbe consentito a chiunque di ricoprire grandi distanze in un tempo relativamente breve, partendo in qualsiasi momento. Quelle due ruote a pedali, insomma, promettevano una rivoluzione. Certo, l’euforia degli inizi si rivelò prematura. Sebbene le vendite aumentassero a ritmo prodigioso, e sorgessero quasi subito i primi circuiti per corse agonistiche, si dovette attendere un’altra generazione prima che la bicicletta assumesse una forma più pratica e invitante. Con il 1870 arrivarono le bici dall’enorme ruotona anteriore, che col senno di poi ci appaiono buffi apparecchi da equilibristi del circo ma che per un breve periodo sembrarono ispirate dal miglior buon senso. In ogni caso è a quel punto che furono introdotte due importanti innovazioni: la catena di trasmissione e il tubolare pneumatico. Il passaggio al tipo di bicicletta che conosciamo oggi avvenne verso la fine del decen- L’EVOLUZIONE DELLA BICI L’ELEGANTE HOBBYHORSE IL VELOCIPEDE A QUATTRO RUOTE UN “CANGURO” DA PASSEGGIO REGINA DELLA PARIGI-AVIGNONE La hobbyhorse creata da Johnson per il duca George Spencer (1766-1840) Fu Willard Sawyer di Dover a introdurre nel 1840 il velocipede a quattro ruote Si chiamava Canguro il veicolo inventato nel 1884 e prodotto in 100mila esemplari Prototipo in legno della bicicletta dei fratelli Olivier creata per la Parigi-Avignone (1865) DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 IL PRIMO BOOM Le prime biciclette fecero il giro del mondo. Nella foto grande, un modello Phantom del 1871 fabbricato a Londra ma già esportato in Nuova Zelanda Quella Sanremo del marzo ’46 MARIO FOSSATI o seguito il ciclismo degli ultimi anni alla maniera dei vecchi, a tratti e a bocconi, rimpiangendo il tempo che passa. Il mio ciclismo è legato ai tre grandi: Coppi, Bartali, Magni; alle due K elvetiche: Koblet e Kubler; a Rik Van Steenbergen; a Merckx, figlio di Coppi; a Bobet, a Girardengo al pari di Binda (grandissimo). Il mio ciclismo comprende Gimondi, Hinault, Saronni e Nencini. Ho veduto sbarcare questo ciclismo in America, nel Colorado, e due ragazzi italiani (Argentin primo, Saronni terzo), stravincere davanti agli stralunati cadetti di una celebre accademia militare statunitense. Poi il ciclismo ha moltiplicato le sue classifiche e le sue corse. L’ultimo corridore che ho digitato, nella sua casa in mezzo alla Toscana, Franco Bitossi detto “cuore matto” ha buttato sulla brace della sua fumosa cucina una enorme costata che assomigliava alla planimetria del Tour de France, ha stappato una bottiglia di un vino asprigno. «Che vuoi che ti dica della vita: non la capisco più. L’altro giorno, qua vicino, è venuto un cantautore: è stata la fine del mondo». La Sanremo bussa alle porte, mi chiedono di personificare il suo percorso attraverso il libro d’oro. Parlerò di una sola Sanremo: del 19 marzo 1946, che ha iniziato la nuova era. La sera di quel lontano San Giuseppe, Armando Cougnet, il vecchionissimo che ha inventato il Giro d’Italia, era pensoso: il ciclismo comunque non assomigliava più a se stesso. Frequentavamo io e Negri a Sestri Ponente, la casa dei Ciampolini, dove Coppi aveva sposato la figlia Bruna, fresca e allegra, che gli aveva detto di aspettare un figlio. La Sanremo era smozzicata dai passaggi a livello, non era appianata dai tunnel, girava attorno ad ogni promontorio. Coppi aveva combinato con Tragella, il direttore tecnico della Bianchi, di cui vestiva i colori bianco-celesti, di non lasciare partire nessuno prima del Turchino. E così era avvenuto. I francesi avevano portato in corsa Teissere, Molineris, Lazarides. Il gruppo si sbriciolò. Alla prima agitazione, sul Turchino, Coppi si liberò di Teissere. Per chi sa di pista dirò che la classicissima era diventata una australiana gigante. Fausto non sente la catena. Capisce di essere in grado di puntare da solo a Sanremo. Traffica con il cambio. Nella valle dell’Orba, che è maledettamente umida, accusa un temporeggiamento. Tira via in solitudine Coppi. Le gambe lunghissime, con quella muscolatura fine, la testa leggermente incassata nelle spalle. Sfiora la folla ai margini. In azione quest’uomo, che appiedato pare goffo, è bellissimo. I poliziotti vestiti di cuoio scortano l’ammiraglia rosso sangue di Giuseppe Ambrosini, direttore di corsa, che attraverso l’altoparlante urla alla folla, la cui visione ingroppa la gola. Quanti i cappotti rivoltati, i vestiti sdruciti. E Coppi arriva! Fate tre cerchi: la ruota anteriore, la ruota posteriore, il busto allupato. In una posizione aerodinamica perfetta. Un robot convenientemente ispirato o un magnifico giocattolo meccanico, che risponde ad ogni richiamo. Coppi taglia le curve, una linea quasi retta. Lui la lepre, dietro tutta la muta, che si disperde, perde terreno. Sappiamo che ha avuto la febbre e un dolore allo stomaco. Cavanna ci ha però tranquillizzato. Il ciclismo da corsa non fa H nio successivo, quando dagli stabilimenti della ditta Rover di Coventry, in Inghilterra, uscì un modello con sellino basso, ruote delle medesime dimensioni, catena, freni, pedali, e un costo più accessibile. Il successo fu immediato. Nel 1890, mezzo milione di biciclette circolavano già sulle strade del Regno Unito. Poi, nel 1891, arrivò l’ennesimo, fondamentale passo avanti, compiuto di nuovo al di là della Manica: a Clermont-Ferrand, in Francia, Edouard Michelin di fatto reinventò la ruota, realizzandone una distaccabile dall’intelaiatura, a cui era affissa con viti e bulloni. Fino a quel momento, le ruote venivano incollate al telaio: oltre a essere più pratico, il nuovo sistema permette- va al ciclista, in caso di foratura, di cambiare la ruota e riprendere il viaggio. A patto, naturalmente, di averne con sé una di scorta. Il resto è noto. La storia della bicicletta è anche la storia della sua accettazione sociale come mezzo di locomozione, e dell’impatto che ebbe sullo sviluppo di una rete stradale, sul costume, perfino sull’eguaglianza tra i sessi. «Che le donne abbiano le gambe, e che anch’esse possano usarle, segna l’avvento di una nuova epoca», annotò un cronista (uomo) alla fine del diciannovesimo secolo. La bici conteneva inoltre il seme di altre future, strabilianti invenzioni: non a caso Henry Ford e i fratelli Wright iniziarono le loro carriere come meccanici di biciclette. E soprattutto, osserva l’Economist, essa simboleggiava un nuovo gusto di muoversi e un desiderio d’indipendenza. Il ventesimo secolo ha portato nuovi materiali, prezzi più bassi, produzione di massa. Oggi, all’alba del ventunesimo, si calcola che sulle strade del pianeta ne circolino più di un miliardo. La previsione è che non smetterà di evolversi, cambiare, modernizzarsi: ma è altamente probabile che resti l’unico mezzo capace di portarci così lontano per così poco. Una cosa è certa, scrive David Herlihy a conclusione del suo enciclopedico volume: «Finché uomini e donne continueranno ad avere le gambe, continueranno a esistere le biciclette». bene alla salute, ha sentenziato: i dolori sono il frutto di una preparazione ossessiva. I chilometri sono stati molti, moltissimi. Settemila. Coppi arriva, scende di sella. Finisce nelle braccia di Pellizza, il massaggiatore del Genoa, a cui Cavanna ha passato la stecca. La folla ribolle. Coppi ha staccato il secondo arrivato di 24 minuti. “i’ Gino” chiede immediatamente il nome del vincitore. Chi può essere, rispondono: Coppi. Quando finalmente può allungare le gambe dice: i polmoni sono infiammati all’apice. L’indomani l’Italia si divide fatalmente in coppiani e bartaliani. Girardengo contro Binda, Binda contro Guerra, Bartali contro Coppi. È una tradizione, un rito. Le grandi rivalità non si spengono un metro dopo il traguardo. Coppi e Bartali divennero, Gino per Fausto e Fausto per Gino, un incubo a cui si erano affezionati. Poi... E poi, la storia è risaputa. Ci sono congiunture nella vita che paiono dettate dal destino. Coppi, a quarant’anni si innamora di una bella donna... Il figlio che nasce in una clinica del Sudamerica. L’Italia che gli ritira il passaporto, facendo ridere mezzo mondo. Giulia, l’amata, in carcere. La Sanremo, la corsa al sole, continua a srotolarsi. Un anno Gino, il vecchio campione che credevamo finito, in via Roma batte allo sprint Rik Van Steenbergen, «l’imperatore di Herenthal». Mouton, l’impresario, gira con il carnet degli assegni, di quotazioni astronomiche. Li intesta a Coppi. La sfortuna, la vecchia con i denti verdi, sta sempre lì. Noi inviati facciamo una vita esaltante: giriamo con Coppi. La Francia tutta in cima ai colli, ad ammirare Coppì e Bartalì. Fiorenzo Magni, il terzo uomo, cui hanno rubato un Tour de France, paradossalmente si chiede come mai Bartali non dovrebbe cedergli la sua parte di tifo. Che cosa farà il vostro campione? chiedevano di Coppi. La gente ingrata, domandava quando Coppi aveva vinto l’ultima corsa; e la data della sua più recente caduta. Mi chiedeva Gianni Brera: cosa fa il vostro campione? Io gli rispondevo: fa il gentleman e l’amministratore di notte. E di giorno si prepara alle kermesse quasi fossero delle classiche. Il suo ha corso una Roubaix: è giunto 43esimo. Atleta di giorno, gentleman di notte: ditegli, mi ammonì Brera, di smettere, è pericoloso. A noi ci sembrava che Coppi non dovesse finire mai. Ci fu un invito di Geminiani per una battuta di caccia nell’Alto Volta. Un circuito, per ringraziare gli ospiti. E Coppi partì. Tornò la vigilia di Natale. Aveva la febbre. Cavanna aveva chiesto notizie al fido Milano. Il medico di casa aveva dichiarato: febbre di natura banale. Si erano scordati di riferirgli che Coppi tornava dall’Alto Volta. Cavanna, allarmato, ribatteva: io non ho studiato ma so che, se la febbre non scende, influenza non è. Da Clemont Ferrand, tramite Geminiani, fanno sapere che si tratta di “plasmodium falciparum”, pericolosissimo, perché innesca la malaria. Risposta dei medici italiani: loro facciano come credono, noi faremo quanto pensiamo. Coppi è morto. Un errore bestiale dei medici. Ricordo quel funerale. Il pomeriggio era luminoso. Sulla campagna c’era un grande silenzio. Lo sguardo s’alzava verso le colline di San Biagio ed errava lontano sulle valli della Bormida e del Po e verso le colline del Novese, sulle quali il sole estendeva spazi vaporosi. C’era un’enorme malinconia. Quel funerale portava via tanta storia ciclistica, forse tutta. LA HUMBER SAFETY POPOLARISSIMA WHIPPET LA MOUNTAIN BIKE TIDALFORCE M-750 Messa in commercio nel 1884 la Humber fu una delle prime bici con forcella moderna In Gran Bretagna la Whippet nel 1890 perfezionò la prima bici con ammortizzatori E’ il 1979 quando Fisher-Kelly e Ritchie producono la prima mountain bike Disegnata per usi militari la bicicletta con motore promette altissime performance 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 le storie/1 appartiene infatti all’azienda di Beate Uhse, una catena di sexy shop che è stata quotata pubblicamente alla Borsa di Francoforte nel 1999. È nel Nevada invece “il bordello dell’anno”: si chiama Chicken Ranch e si vanta di essere la casa chiusa più famosa del mondo. È in attività da ben 158 anni e fa parte delle 33 case chiuse nel deserto del Nevada fornite di licenza statale FOTO CORBIS Finanza creativa SESSO E AZIONI Il Daily Planet di Melbourne, posseduto dalla Planet Platinum, è il primo bordello al mondo quotato in Borsa: uno dei più esclusivi hotel a ore che, oltre ai tradizionali servizi ai clienti, offre anche azioni agli investitori. La quotazione è stata presentata come unica nel suo genere, ma non è l’unica volta che il sesso fa il suo ingresso in Borsa. La prima “azione erotica” in Europa Nel bordello quotato in Borsa I MELBOURNE n Australia, e più precisamente a Melbourne, ho un amico che si chiama Tom. Tom è un agente di borsa, e insieme un tennista. Difficile dire quale componente prevalga in lui, ma come tutti noi tennisti Tom si sente iniziato ad una piccola religione, i cui riti si svolgono non solo sui court, ma si estendono poi alla vita, e quindi anche al business. Ogni anno, a gennaio, in occasione dell’Open, Tom e io giochiamo una partitella di singolo sull’erba del Kooyong, il più vecchio club di Melbourne. Alla fine, l’amico mi invita nel ristorante del Club, e, terminato il dessert, insiste per offrirmi qualche dritta sui mercati orientali. Ad ascoltare lui, in Europa e negli Usa, ormai c’è solo da rimetterci, con l’azionario. Percorrevamo quindi insieme il listino quando, sarà stata curiosità o sesto senso, l’occhio mi è caduto sopra un titolo, il Planet Platinum. «Metalli preziosi? » ho indagato, e per tutta risposta mi è giunta una risata omerica: «Lo conosci benissimo, dirty old man», ha infine esclamato. «È la nuova denominazione del Daily Planet, dove sarai certo andato». Dopo qualche istante, la mia sorpresa è parsa sollecitarne in Tom una maggiore. «Ma allora non lo conosci. Insomma, dove vivi?». Il grande business E Tom ha preso a spiegarmi che il Planet Platinum era una società, quotata in borsa dal primo maggio del 2003, che salita agli inizi quattro volte il prezzo di emissione, era poi discesa «perché gli investitori istituzionali, spesso, non si sentivano di proporla causa l’attività societaria. Tuttavia — credette di aggiungere — Planet Platinum era stata in grado di distribuire un dividendo del 6 per cento». A questa informazione, la mia ascendenza mercantile si attivò vivamente. «C’è rischio?», mi informai. «Nessuno. L’oggetto sociale si rivolge ad un’attività umana non meno necessaria del cibo». «E si tratta di?»: Tom sorrise, e infine rise, scuotendo la testa. «Vai tu stesso a controllare. Meglio la sera», aggiunse. «Hai l’inidirizzo?». «Qualsiasi taxista sarà in grado di portarti». La guida che mi toccò in sorte era indiano come quasi tutti i tassinari di Melbourne. Come pronunciai il nome di Planet Platinum iniziò a ridacchiare, per poi spingersi addirittura a una strizzatina d’occhi, seguita da una considerazione inattesa: «Complimenti signo- re. Alla sua età». Una decina di minuti più tardi, il taxi si fermava di fronte a un edificio a tre piani, una costruzione decisamente impersonale che alberava una grande scritta argentea: il Planet Platinum, appunto. Scesi, mi inoltrai oltre un ingresso che si era magicamente spalancato. Da alcuni dettagli — la biglietteria, il guardaroba — ero ormai quasi certo di trovarmi in un night. Domandai, allora, di essere accompagnato, e venni raggiunto da una giovane donna, sorridente e elegante, che si presentò come Marika, la manager. Mi accompagnò, lungo un corridoio, sul quale si aprivano le porte delle camere che si affrettò a mostrarmi. «Quelle per soste brevi sono più o meno simili», illustrò, mostrandomi una stanzetta confortevole, dotata di letto matrimoniale e servizi. «Ma se pensa di trattenersi più a lungo, magari di passare l’intera notte, possiamo offrire di meglio. Le stanze pompeiane». L’idea che devono avere in Australia dell’antica Pompei era rappresentata da una sorta di saloncino, sul quale si apriva una piccola piscina. «Acqua profumata, eventuale Jacuzzi, e assistenza imbattibile» sorrise, mentre io mi trattenevo dal chiedere chi fossero le bagnine, perché finalmente avevo capito. Con l’abituale cortese ma distaccata eleganza, Marika mi invitò al bar, e prese ad informarsi sulle mie predilezioni. Mi informò di non far parte delle accompagnatrici disponibili, e mi concesse alcuni dettagli. C’erano, pronte ad accudirmi, non meno di centocinquanta professioniste. Disse proprio così, professioniste, un termine più che giustificato se quella mano d’opera qualificata era soggetto fiscale, e insieme oggetto di una assistenza medica da far invidia alla più qualificata delle nostre ASL. Mi guardavo intorno. Nel salone adiacente alcuni visitatori giocavano a biliardo, insieme a una delle signorine. Altri conversavano amabilmente, con ragazze dall’aria educata, se non proprio riservata. Coperte di abitini eleganti, sufficientemente succinti da mostrare le loro virtù. Molte tra loro reggevano bicchieri gentilmente offerti dagli ospiti, ma, come mi spinsi a proporre a Marika un A Melbourne c’è un palazzo di tre piani su cui brilla una grande scritta grigia: Planet Platinum. È la sede di una società per azioni un po’ particolare. Che il nostro cronista è andato a scoprire bicchiere di champagne, la vidi sorpresa: le bevande del locale erano rigorosamente analcoliche. Come la mia guida fu chiamata al telefono, venne, a sostituirla il manager, Steven. Ottimo conoscitore dell’Europa, per aver lavorato — sempre nel settore vendite — alcuni anni in Svezia. Non solo prostituzione Privo delle riserve che mi avevano trattenuto con una giovane signora quale Marika, passai ad informarmi su alcuni dettagli tecnici dell’offerta. E, ottenuti che li ebbi, mi spinsi a domandare come mai, tra le prestatrici d’opera, non ce ne fosse qualcuna che ricordasse non dico una diva, ma nemmeno una semplice velina. «Non offriamo una bellezza dirompente — informò Steven — perché ci siamo resi conto che il cliente standard preferisce simpatia, calore umano, accessibilità. La maggior parte dei visitatori ama non solo il contatto fisico, ma ambisce alla conversazione. Un analista, nostro assiduo frequentatore, mi ha minacciato di farci causa per concorrenza sleale. Secondo lui, la prima ragione dell’affluenza maschile è il desiderio di confidarsi». Ritornò Marika dai suoi impegni, conversammo ancora, ma ad un certo punto colsi, tra lei e Steven, un’occhiata perplessa. Di fronte a noi era sfilato, peraltro con discrezione, tutto il campionario offerto dal Planet. Avevo ammirato ragazze alte e basse, rotondette e slanciate, bianche, nere, gialle e caffelatte, bionde o more. Possibile, sembravano domandarsi i miei due ospiti, che non ce ne fosse nessuna che sollecitasse il mio interesse. Con un sorriso, fu infine Steven a decidersi. «Vede, caro amico. Il nostro locale accoglie esclusivamente clienti etero». Sorrisi, e mi decisi a confessare che quel che mi interessava, più dell’indiana o della mulatta, era una pensionante italiana. «Per facilitare il dialogo», mi giustificai. Di lì a qualche minuto, avevo di fronte Carla, una morettina piemontese. Fu lei, e non io, a raccontare brandelli di una storia probabilmente vera. «Sono capitata in questo paese con un marito italiano, che aveva ottenuto un permesso di lavoro. Ho avuto un figlio, FOTO AFP GIANNI CLERICI IL CLUB Sopra, la tessera del Daily Planet di Melbourne e l’interno del club. In alto, prostitute in un bordello francese del secolo scorso che ormai va a scuola, in prima elementare, e che mi costa un occhio, in baby sitter. Il matrimonio si è rivelato un fallimento, forse eravamo troppo soli, lontano da casa, e tutto si focalizzava tra di noi, senza nessun contesto nè di persone, nè di luoghi. Abitavamo anche in un casone impersonale, parlavamo male quella specie di dialetto inglese che usano qui. Io ero troppo a disagio, spesso scontenta, lui ha cominciato a tradirmi, le donne australiane sono molto libere, molto facili. Dopo il divorzio ho pensato di ritornare in Italia, ma c’erano complicazioni per le visite di lui al bambino, e anche con i miei. Mi sono trovata un paio di lavori umili, commessa, cameriera, qui lavorare è facile. Poi nel mio ristorante è capitata una cliente. Pian piano abbiamo fatto amicizia. E, con l’amicizia, ci siamo confidate. Mi ha spiegato dove lavorava. Quanto guadagnava. Com’era salvaguardata dalle legge. Mi sono sottoposta ad un test per essere ammessa al Platinum, molto rigoroso. Mi hanno presa in prova. Probabilmente ho avuto fortuna con i primi clienti, l’inizio è la cosa più difficile, perché non si tratta tanto di fare l’amore, quanto di venderlo. Via via mi sono abituata, ho iniziato a considerare i clienti come fossero carte di credito umane. Non lavoro sul numero, quanto sulla qualità. Ho anche quello che chiamo il mio club, gente che conosco da più di un paio d’anni. Un tipo molto ricco, proprietario di un elicottero, figurarsi, mi ha proposto di prendermi in carico, come amante. Ho rifiutato. Ho rifiutato anche una proposta di matrimonio. Un vedovo, anziano, poveretto. Ho molte conoscenze. Ci sono negozi in cui non solo ottengo sconti incredibili, ma a volte mi si offre gratuitamente la merce. Ristoranti in cui non ho nessun bisogno di pagare. Vivo benissimo, il mio bambino cresce bene. I miei sono venuti due volte dal Piemonte, credono e crederanno sempre che io lavori in una grande ditta. Quando il bambino avrà dieci anni probabilmente la smetterò, con questa attività. Avrò accantonato abbastanza per vivere di rendita. Uno dei miei clienti più affezionati è un bravissimo broker». Certo in seguito ad una curiosa coincidenza, si chiamava Tom. In quella, un ospite del Planet rivolse a Carla un sorriso d’intesa. «Il lavoro mi chiama», sorrise lei, e prima di abbandonarmi, mi posò un bacino su una guancia. «Mi saluti l’Italia», suggerì. Fu Steve ad accompagnarmi molto cortesemente all’uscita «Ero nella tribuna d’onore allo Australian Open — sorrise — e credo di averla vista, nel box della stampa. Ma perché non mi ha detto che era un giornalista?». DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 le storie/2 Trappole telematiche C’ ROMA è ancora qualche italiano che comprerebbe il Colosseo, il Foro romano o la fontana di Trevi da uno sconosciuto incontrato per strada? Naturalmente no. Eppure c’è chi è convinto che nel mondo ci sia qualcuno pronto a regalargli — così, senza un motivo — 80 milioni di dollari. Questa è la storia di una stangata dei nostri tempi. La storia di due ragazzi del Sud che per inseguire il sogno ingenuo di una fortuna miracolosa hanno perso tutti i loro risparmi: 30 mila euro. Due persone come tante: lui, 28 anni, è impiegato in una piccola azienda di Caserta. Lei, 24 anni, sta per laurearsi. Tutto comincia una sera d’autunno, in una pizzeria del centro. Mario e Giovanna — li chiameremo così per tutelare la loro privacy — incontrano un amico che ha appena ricevuto un’e-mail con una proposta allettante: due cassieri infedeli di una società petrolifera vogliono portare in Italia i capitali sottratti alla cassa, e gli offrono un quinto del bottino se è disposto ad ospitare sul suo conto la transazione bancaria. L’amico, scrupoloso, tentenna: «Non voglio fare nulla di illegale». Loro due invece non ci avrebbero pensato su neanche un minuto: devono comprarsi la casa e hanno solo 20 mila euro. Uscendo, mormorano un vecchio proverbio: «Chi ha pane non ha i denti e chi ha i denti non ha pane...». Salvare i beni di famiglia Eppure il pane — o qualcosa che gli somiglia molto — arriva anche per i loro denti. Due sere dopo, Mario riceve un’e-mail in inglese da un mittente sconosciuto. Non è un virus e non è una pubblicità: cosa ci sarà scritto? Quando ha finito di tradurla, non crede ai suoi occhi. La lettera è firmata da una donna, Miriam Abacha, che si presenta come la vedova dell’ultimo dittatore della Nigeria, il generale Sani Abacha. «Il nuovo governo democratico — scrive la vedova — vuole sequestrare tutte le proprietà di mio marito. Mio figlio Mohammed è sotto interrogatorio e io sto cercando disperatamente di salvare i beni della nostra famiglia: opere d’arte, oro, diamanti. E denaro: sono in possesso di 80 milioni di dollari americani». Perché ha scritto a Mario? Perché ha bisogno di lui. «Vi imploro di aiutarmi a portare questo denaro al sicuro, prima che venga scoperto e confiscato. Indicatemi il vostro conto bancario, in modo che io vi possa far accreditare subito l’intera somma». E qui viene il bello: «La vostra preziosa collaborazione sarà compensata con il 20 per cento dell’importo accreditato. Vi supplico: aiutate una vedova nel bisogno! Che Allah vi benedica». Naturalmente, né Mario né Giovanna hanno mai sentito parlare del generale Abacha. Ma da una veloce ricerca su Internet scoprono che il feroce dittatore della Nigeria, ucciso da un infarto provocato dal Viagra, si chiamava proprio Abacha. La storia sembra vera. Non si chiedono, i due, come mai la scaltra vedova di uno spietato tiranno africano si rivolga a uno sconosciuto impiegato di Caserta. Pensano, semplicemente, che alla lotteria della fortuna è finalmente arrivato il loro turno. La sera stessa Mario si mette a disposizione: «Eccole le coordinate del mio conto». Poi, mentre aspetta la risposta, fa i conti: il 20 per cento di 80 milioni sono 16 milioni. Di dollari. In lire, sarebbero 24 miliardi. Il giorno dopo scrive, a nome della vedova, il suo «procuratore speciale», Galadima Hassan. «Stiamo provvedendo al trasferimento della valuta, ma c’è un piccolo problema pratico: il vostro Internet, la stangata del tesoro nigeriano terflora. C’è un biglietto firmato dalla vedova: «Grazie per tutto quello che state facendo». Un gesto commovente, pensa Giovanna: «Con quello che sta passando il figlio, ha trovato il tempo di pensare a noi». Il messaggio successivo invece è drammatico, e arriva dal solito Hassan: «La situazione sta precipitando. Dobbiamo portare subito fuori dal paese le opere d’arte della famiglia. Le nasconderemo nei galleggianti di un elicottero. Vi terremo aggiornati». Poi, dopo 24 ore, la seconda parte: «Stiamo organizzando il trasferimento dei lingotti d’oro. Sono tanti, e servirà un furgone blindato con una scorta di 20 guardie». Mario e Giovanna sentono di essere entrati nel clan, e quasi si vergognano di starsene al sicuro mentre i loro amici nigeriani passano tanti guai. Il terzo giorno vengono però a sapere che, ancora una volta, possono rendersi utili: «Dobbiamo pagare l’elicottero, il furgone blindato, le guardie e tutto il resto. La signora Abacha è ancora in Svizzera e bisogna pagare in anticipo: potete mandarci subito altri 15 mila euro?». Altri 15 mila euro non ce li hanno, i due fidanzati. Così li chiedono prima agli amici e poi ai parenti. La sera stessa fanno un altro bonifico alla Western Union. Per farsi prestare i soldi, però, hanno dovuto rivelare il loro segreto. E un cugino diffidente vuol vedere con i suoi occhi questo fantasmagorico conto alle isole Cayman. Mario accende il computer, va sul sito, digita il numero di conto e dà l’ok. Gli 82 milioni di dollari sono sempre lì. Ma il cugino — che di Internet si intende — nota all’istante che qualcosa non va. «Non hai inserito la password, e l’estratto conto è apparso lo stesso. Rifallo». FOTO WEBPHOTO SEBASTIANO MESSINA Mario e Giovanna ricevono una e-mail: la vedova del dittatore Sani Abacha gli offre 16 milioni di dollari, a condizione che la aiutino a far espatriare i capitali del marito. Accettano la proposta e in pochi giorni bruciano 30mila euro. Ecco come un messaggio di posta elettronica può trasformarsi in una truffa planetaria IL FILM Nella foto, la locandina de “La stangata”, pellicola del ‘73 con Robert Redford e Paul Newman +245% L’aumento delle truffe via web in Italia nel 2003 secondo l’Istat 300.363 I casi di truffa telematica registrati dal Viminale nel triennio 2001-2004 conto deve essere in dollari, altrimenti l’operazione non può essere effettuata». Panico. «Purtroppo non ho un conto in dollari, posso chiedere come si fa ad aprirne uno», risponde subito Mario. «Non ce n’è bisogno, glielo apriamo noi» replica Hassan. E infatti dopo tre giorni arriva la comunicazione: a nome di Mario è stato aperto un conto presso la filiale della West Pacific Bank alle Isole Cayman, «così non avremo problemi col fisco». C’è un numero di conto, una password e un indirizzo web. I due fidanzati si precipitano su quel sito. E scoprono che il conto esiste. Che la password funziona. E che a nome di Mario risulta un credito di 82 milioni di dollari Usa. Mentre Mario e Giovanna sono incantati da quella magica pagina del web che certifica la loro inaspettata ricchezza, a Lagos comincia la fase due dell’operazione. Il «procuratore speciale» li informa che ci sono cattive notizie. Il figlio del dittatore, Mohammed, è in fin di vita ed è stato 1,2mld 200mila I dollari sottratti agli americani dai truffatori telematici nel 2003 GLI SCERIFFI DELLA RETE I loro colleghi americani hanno imparato a rispettarli, da quando, nel 2002, hanno scoperto e identificato i sei hacker italiani che erano riusciti a violare i computer supersicuri del Pentagono e della Nasa. Sono gli uomini del Nucleo speciale anticrimine tecnologico- Gat, una unità speciale della Guardia di Finanza: 40 militari ad altissima specializzazione, guidati da due capitani e comandati un colonnello, Umberto Rapetto (nella foto), che si è guadagnato sul campo il soprannome di “sceriffo del web”. Le pistole le usano poco. Le loro vere armi sono i 150 computer con i quali tengono sotto controllo la rete, riuscendo a risalire in pochi minuti all’identità di qualunque navigatore. Le denunce in Italia per i “dialer” i programmi che gonfiano le bollette ricoverato d’urgenza in una clinica svizzera. La madre è partita con lui. «Pregheremo per il povero Mohammed — risponde l’ingenuo impiegato — e se possiamo essere utili fatecelo sapere». In effetti qualcosa potete farla, scrive Hassan, qualcosa di molto urgente. «Poiché la signora Abacha è all’estero e io non ho il potere di firma sui suoi conti, potete anticiparci il denaro per pagare le spese del viaggio in Svizzera? L’ambulanza, l’aereo speciale, il medico personale, l’albergo, la clinica: fanno 15 mila euro. Naturalmente, poi li tratterrete dal conto in dollari, quando tireremo le somme». Si possono rifiutare 15 mila euro a chi ti ha appena dato, senza conoscerti, 82 milioni di euro? Naturalmente no. «Vi facciamo subito un bonifico». «No, mandateceli con Western Union, così arrivano oggi stesso». Mario e Giovanna corrono in banca a ritirare 15 mila euro, quasi tutti i loro risparmi, e li portano all’agenzia Western Union prima che chiuda. Il giorno dopo bussa il fioraio: c’è un mazzo di rose arrivato tramite In- Un sito fasullo Nel giro di trenta secondi il sogno miliardario viene inghiottito da una paura raggelante. Il sito è fasullo. È composto da due sole immagini, la homepage e l’estratto conto di Mario. Non appartiene alla West Pacific Bank ma a un tal Abdullah Baziz, residente in Costa d’Avorio. «Non è possibile» mormora Mario, pietrificato. Afferra il telefonino e chiama subito il «procuratore speciale» Hassan. Risponde una segreteria telefonica che rinvia ad un altro numero. Al quale c’è un’altra segreteria telefonica che rinvia a un altro numero. Al quinto numero della catena risponde qualcuno: è il portiere di un albergo di Lagos, che naturalmente non sa nulla né della vedova Abacha né conosce alcun mister Hassan. «Però stanno chiamando molte persone che chiedono di loro» rivela. Solo a questo punto i due candidi fidanzati di Caserta chiedono aiuto ai finanzieri del Gruppo anticrimine tecnologico. Purtroppo è tardi. I loro 30 mila euro sono stati incassati entro mezz’ora, ovviamente con documenti falsi. In compenso, scoprono di non essere stati gli unici, ad abboccare all’amo dei truffatori nigeriani: ci sono cascati in migliaia, dalla Germania agli Stati Uniti. Più tardi sapranno che la banda era guidata da due autentici insospettabili: Maurice Ibekwe, deputato alla Camera dei Rappresentanti di Lagos, e Fred Ajudua, avvocato e leader — incredibile ma vero — del movimento consumatori del suo paese. Mario e Giovanna sono stati catturati da una catena di montaggio del raggiro, che ha drenato in tutto il mondo 450 milioni di dollari con il miraggio dei miliardi virtuali. Solo nei conti di Ibekwe la polizia troverà 300 mila dollari e 75 mila marchi, le briciole di quella che è stata battezzata «la truffa del 419», dal prefisso telefonico della Nigeria. Soldi che il furbo deputato non potrà mai spendere, perché sei mesi dopo l’arresto è morto in un ospedale di Lagos. I due fidanzati di Caserta non hanno rivisto un solo euro. Però non rispondono più alle e-mail degli sconosciuti. i luoghi Isole nascoste DOMENICA 13 MARZO 2005 Dopo la Toscana, gli inglesi si sono spinti a Sud e hanno scoperto l’altra Sicilia dove il Barocco gioca con le cave e i grandi palazzi nobiliari, dove la letteratura si mescola con la buona cucina. Sono arrivati sin qui e ora stanno comprando case e ville in tutta la provincia, favoriti anche dai prezzi d’occasione Ragusa, la nuova Inghilterra ATTILIO BOLZONI È RAGUSA lontana. Per raggiungerla bisogna attraversare un’isola grande, scavalcare montagne, scendere giù, scendere sempre più giù fino a quando si scivola così in basso che sei sotto la punta dell’Africa. Guardi la carta geografica e scopri che Tunisi è a nord. Guardi la campagna e tra i muretti di pietra si inseguono ulivi e carrubi. Fanno ombra alle masserie, ai casali, alle ville patrizie. Non c’è neanche un metro di autostrada in questo paesaggio antico, tanto distante dalle superbie di Palermo capitale, natura estrema per i colori, per la sua luce. Da una parte sale il profumo del mare, dall’altra ci sono città ricostruite magnifiche dopo un terremoto di tre secoli fa. Dietro una curva, all’improvviso, appare la vecchia Ibla con il suo barocco. È lontana l’altra Sicilia. Quella che gli inglesi stanno per invadere. È il momento del Ragusashire. Lasciata sola là in fondo, quasi staccata, ignorata per la sua diversità, in quest’altra isola dove non c’è mai stato il feudo e i contadini erano ricchi già trent’anni fa con i loro pomodori e le loro melanzane coltivate in serra, Londra va alla ricerca di un nuovo paradiso. E di investimenti. Dalle rive del Tamigi chiedono ruderi da restaurare in mezzo alle cave, cercano tre stanze e un balcone con vista su duomi settecenteschi, sono a caccia di sontuose tenute o anche solo di piccole costruzioni nascoste tra i borghi marinari. E già comprano, gli inglesi. A Ragusa. A Scicli. A Modica e a Sampieri. Qualche mese fa il Daily Telegraph ha dedicato la copertina del suo inserto Property proprio alla provincia ragusana e alle opportunità del suo mercato immobiliare, da quel giorno le agenzie locali ricevono una tempesta di richieste. I prezzi per ora sono ancora molto bassi, bassissimi al confronto del Chianti o di altri “luoghi” della bella Italia. Da 350 euro al metro quadro a 900 per un appartamento da ristrutturare in un centro storico, da 1100 fino a 1400 per un fattoria da risistemare. Si superano i 2000 euro al metro quadro per le dimore nobiliari. È la “scoperta” di Ragusa, è la febbre britannica per il mattone firmato barocco. Il boom delle agenzie Fino a qualche anno fa erano una ventina a vendere case, oggi sono più di cinquanta. Ci sono tre agenzie solo intorno a quella di Giovanni Gulino, che è anche il presidente degli immobiliaristi della provincia e il vicepresidente della categoria per il Meridione. Racconta lui, che sta trattando proprio in questi giorni l’acquisto di un casale rincorso da un illustre professore universitario londinese: «Gli inglesi vengono, si innamorano e poi tornano per acquistare, perlustrano il territorio, sono attentissimi, è un’élite che sceglie con cura». Molti scendono direttamente dall’Inghilterra, altri risalgono da Malta con il catamarano che in meno di un paio d’ore li scarica al molo di Pozzallo. Tutti trovano quello che cercano. Cattedrali bianche incastrate nelle piazze, palazzi monumentali, scalinate, vicoli, ‘‘ Gesualdo Bufalino Fui giovane e felice un’estate, nel ’51. Né prima né dopo: quell’estate. E forse fu grazia del luogo dove abitavo, un paese in figura di melagrana spaccata; vicino al mare ma campagnolo, metà ristretto su uno sprone di roccia, metà sparpagliato ai suoi piedi con tante scale fra le due metà a far da pacieri, e nuvole in cielo da un campanile all’altro Da ARGO IL CIECO prima pubblicazione 1984 chiostri, sculture, un tripudio di capitelli, un’architettura che stordisce e poi quella campagna dolce, quel mare color pastello. Ricorda ancora il presidente degli agenti immobiliari: «È stata la tivù con gli sceneggiati del commissario Montalbano di Camilleri, ambientati qui nell’immaginaria Vigata, che ci ha fatto conoscere all’Italia e all’Europa. Poi l’Unesco ha inserito Ragusa e Modica e Scicli tra i siti patrimonio dell’umanità. E poi ancora c’è un altro segreto....». Dell’altro segreto parlò per la prima volta e tanto tempo fa Leonardo Sciascia, che da queste parti veniva a trovare il suo amico Gesualdo Bufalino. A Comiso, che è appena a una ventina di chilometri dal trionfo del barocco. Sciascia scriveva di Ragusa e delle sue contrade come della provincia “babba”, che in siciliano vuol dire non maliziosa, non cattiva, la Sicilia senza mafia. È sempre stata così, lontana anche dal veleno che sprigiona l’isola che sta a occidente, estranea a quella cultura, a quella violenza. Un’altra storia. È diventata opulenta. Forzieri pieni e tante case. In alcuni paesi sono più quelle che gli abitanti. In molti, di proprietà ne hanno tre: una in città, una in campagna, un’altra al mare. «Siamo pronti per vendere o per affittare, abbiamo un parco alloggi notevole e soprattutto di grande pregio», promettono Carolina Carnemolla e Salvatore Di Maria, architetti, agenti immobiliari anche loro e alla guida di una cooperativa turistica che aspetta la nuova ondata da Londra. La calata degli inglesi è cominciata nell’autunno scorso. Dopo la fase magica della Toscana, altri pionieri del turismo di qualità hanno cambiato rotta. E sono arrivati qui, un po’ per l’incanto della Sicilia più sconosciuta e un po’ per quei prezzi così invitanti. Il Ragusano è un approdo che piace. A uomini d’affari, avvocati, editori, attori, giornalisti. Una siciliana di Vittoria trapiantata a Londra restaura e poi propone case per tutte le voglie, ha una mappa completa degli immobili di valore architettonico e offre assistenza per il soggiorno: trasporti, lavori domestici, itinerari guidati. Si chiama Raffaella D’Andrea e la sua Sunway srl è stata la prima agenzia a svelare Ragusa oltre la Manica. «Nel Chiantishire oramai ci sono solo inglesi, escono e si vedono tra di loro, il mercato è saturo. In Spagna c’è una fascia media che compra per vivere al caldo, ma le classi alte adesso hanno scelto noi», spiega Duccio Gennaro, vicepreside che insegna proprio inglese in un liceo intitolato a Tommaso Campailla, medico e letterato modicano del ‘700 che il filosofo George Berkeley volle incontrare per i suoi studi cartesiani, il primo innesto di un processo virtuoso tra l’Inghilterra e questa Sicilia. Rifatta come un palcoscenico Rasa al suolo dallo spaventoso terremoto del 1693 e rifatta dai potenti del tempo come un palcoscenico, Ragusa si è goduta sempre la sua separazione dall’isola. Gelosa delle sue intimità e toccata anche dalla buona sorte. Prima i semi di carrubo li davano in pasto ai muli e ai cavalli, oggi quella distesa di alberi che crescono sulla schiena delle colline più impervie si è trasformata in un altro piccolo tesoro. La fa- FOTO MAGNUM (1,2) e CORBIS (3) 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 FOTO GRAZIA NERI FOTO LAPRESSE DOMENICA 13 MARZO 2005 PROFONDO SUD Qui sopra a sinistra, il Duomo di Ragusa. A destra, un particolare del balcone barocco di palazzo Cosentino. A sinistra, Ragusa Ibla vista dalla chiesa di Santa Maria delle Scale. Nella pagina accanto, da destra, una scalinata del centro cittadino e due dettagli del Castello di Donnafugata. Sotto, la panoramica della città ragusano: «Mi hanno più volte offerto di trasferirmi altrove, al massimo posso spostarmi 50 metri da qui». Il sale se lo fa portare da Trapani, il maialino è quello nero dei Nebrodi, il pistacchio di Bronte, l’olio di Chiaramonte Gulfi, il formaggio è il dop che viene dai pascoli intorno. Nel Ragusashire il vino è buono. Raffinatissima la pasticceria. Dal barocco di Ibla a quello di Modica, antica la rivalità tra le due città, entrambe sotto amministrazione di Siracusa fino a quando il Duce — nel 1927 — elesse Ragusa a provincia. Qualcuno sostiene che riferirono a Mussolini di Modica come di «un covo di socialisti», altri preferiscono ricordare le sue smanie e la provocante moglie brasiliana del deputato fascista Filippo Pennevaria, lo sponsor di Ragusa capoluogo. Comunque sia andata, i risentimenti sono rimasti. E in Il cioccolato degli aztechi Gli inglesi sono anche qui. Cercano e comprano nel quartiere Cartellone, l’ex ghetto ebraico dove qualche giorno prima che Colombo scoprisse l’America ci fu un massacro, uomini e donne e bambini, quattrocento ne uccisero il 22 settembre del 1492. Rione abbandonato per anni, dove le scalinate si arrampicano verso il cielo. Poi Franco Ruta prese casa lì e tutti lo seguirono. Franco Ruta è un uomo speciale. Suo nonno materno era Francesco Bonajuto e faceva un cioccolato come lo facevano gli aztechi. E anche lui fa quello stesso cioccolato. Ricetta tramandata nell’antica contea di Mo- dica dalle famiglie dominanti spagnole, i conquistadores che tornavano dal Messico. Pasta di cacao lavorata a freddo, in bocca si distinguono prima i granelli dolci dello zucchero e poi l’amaro. La sua bottega è un santuario dove italiani e stranieri fanno pellegrinaggio. Dopo Franco, tutti a Modica hanno prodotto il suo cioccolato. Ne vendono ogni anno più un milione di pezzi. Alla cannella. Alla vaniglia. Al peperoncino. È un altro grande affare, un’altra ricchezza per questi siciliani che non sembrano neanche siciliani. Un cliente di Franco Ruta era Leonardo Sciascia. «Quando lo provò per la prima volta mi confidò che aveva trovato qualcosa di simile in un piccolo pueblo spagnolo vicino ad Alicante», ricorda Franco. In Sicilia, quel cioccolato «puro» è tradizione solo entro i confini di Modica. Ora Ruta lo vende però anche a Londra. È Juan Isgrò che glielo piazza. Confessa Juan, un ragazzo mezzo catanese e mezzo argentino: «In Inghilterra commercializzo prodotti regionali, ma a farmi conoscere il cioccolato di Modica paradossalmente è stato un inglese. L’ho incontrato in un mercato londinese e mi ha detto che nella nostra isola aveva assaporato il segreto amaro degli aztechi». L’ultimo barocco del Ragusashire è a Scicli. Tra gli ulivi e le lunghe spiagge vive il pittore delle linee della terra e del mare, quello che per Tahar Ben Jalloun «ha il talento di saperci comunicare le sue prime emozioni che sono mediterranee». Un altro grande della provincia siciliana più lontana, il maestro Piero Guccione. FOTO CORBIS rina dei semi è il collante naturale di molti alimenti, dei gelati, degli yogurt, dei rossetti, del latte in polvere. Capolavori di pietra e terra generosa. E grandi interpreti in cucina. Come Ciccio Sultano, patron e chef del Duomo, per il Gambero rosso «il miglior cuoco emergente d’Italia», citato su tutte le guide grand gourmet. Serve i suoi piatti proprio alle spalle della cattedrale. Anche lui orgoglioso di essere questa Sicilia dove si parla un dialetto molto particolare, dove le “h” non esistono e chiave si dice ciave e chiodo si dice ciovo, per le strade si sente spesso ancora ripetere la battuta: «A Ragusa provincia e a Modica sta’ mincia». Una spacconata ragusana che forse nasconde un ancestrale senso di inferiorità, Modica era uno stato nello stato, era «regnum in regno» con quella sua contea che dalla fine del 1200 arrivava «alle porte di Palermo». È a Modica che è nato anche Salvatore Quasimodo, in fondo a un vicolo tra i palazzi più eleganti, facciate di pietra bianca e pavimenti di pietra nera dell’Etna. E a Modica ha insegnato Gesualdo Bufalino, esperienza richiamata alla memoria nell’incipit di Argo e il cieco, uno dei suoi libri più belli: «Fui giovane e felice un’estate, nel ‘51. Né prima né dopo: quell’estate. E forse fu grazia del luogo dove abitavo, un paese in figura di melagrana spaccata». Era Modica. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 Ecco le immagini rarissime della Braun: mentre scia, pattina sul ghiaccio, fa la verticale, gioca con gli amici. Il materiale è stato trovato in un archivio tedesco; un’antologia di filmati amatoriali a colori, girati tra il’38 e il’43 che raccontano la storia di una fanciulla piccolo-borghese che fu per sedici anni l’amante del Führer e che diventò la signora Hitler solo il 30 aprile del 1945, nella stessa notte in cui si suicidò insieme a lui nel bunker della Cancelleria di Berlino La donna Hitler di Fräulein Eva l’album segreto va in costume da bagno, che prende il sole su un lettino di vimini di nascosto da Hitler. Eva snodatissima che fa ginnastica, anche il ponte. Si arrampica su un albero, fa la verticale, la spaccata, la sbarra, pattina sul ghiaccio, scia, rema, va in bicicletta, si tuffa di testa. E sorride, sorride sempre. Nuda o quasi, mentre si nasconde vezzosa dietro un ombrellino, o si allaccia uscendo da una tenda il reggiseno. Eva Braun privata, a capo della sua minuscola corte, mentre fuma disobbedendo al Führer (dopo, ogni volta, correrà a fare i gargarismi, rivela un cameriere italiano). Mentre abbraccia cani, conigli, bambini ariani nel luttuoso eremo montano detto il nido dell’aquila sulle Alpi bavaresi. Mentre decora l’albero di Natale o mentre fa la caccia agli ovetti nella serra. Mentre lavora a maglia, circondata da madre, sorelle, amiche fra le quali risulta sempre la più bionda. Eva poco vestita che fa giochi goliardici, Eva molto vestita, in tailleur gessato, con uno scoiattolo che le si arrampica fin sopra la gonna e la giacca come in un cartone animato. Eva Braun come non l’abbiamo quasi mai vista, nello speciale TG1 in onda stasera intitolato Il matrimonio di Frau Hitler nel quale Roberto Olla ha selezionato le immagini più intime, vivide e rare tratte da quasi venti ore di filmati. Filmati amatoriali, a colori, girati fra il ‘38 e il ‘43 E dalle sorelle di Eva o da Eva stessa, a raccontare che cosa succedeva nel rifugio di Berchtesgaden sia quando c’era Hitler — e lo si vede persino accennare a un passo di fox-trot — sia in sua assenza. La vacuità dei passatempi puerili, l’adulazione dei cortigiani, i giochi, le feste, la noia, il tè, l’isolamento. E anche i viaggi: a Firenze, a Rapallo, a Capri, sulle falde del Vesuvio, o in crociera nel Mare del Nord. Materiale in buona parte scovato in un archivio privato tedesco: un’antologia di fotogrammi che testimoniano la «banalità del male» intesa come il succedersi dei giorni all’interno di una «corte spensierata e futile dove un’atmosfera di disinvolto erotismo nascondeva la pratica dei ricatti sessuali», secondo le parole che echeggiarono in aula durante il processo di Norimberga. E’ la corte di Eva Braun (possibile che non sapesse?), delle sue cedevoli amiche, delle due sorelle Gretl e Ilse, dei suoi genitori e in particolare della madre Franziska, definita la capoclan. Una corte che si era prefissata uno scopo sopra tutti gli altri: fare di Eva, geisha sottomessa e adorante, la signora Hitler. Il che avverrà soltanto la stessa notte in cui i due amanti, neosposi, si toglieranno la vita nei sotterranei del bunker, il 30 aprile del ‘45. La mia sposa è la Germania, aveva ripetuto Hitler tante e tante volte. E anche: un uomo di intelligenza superiore dovrebbe prendersi una donna primitiva e stupida. Eva Braun, la donna senza qualità, bella appena quanto basta, non appariscente, rientra perfettamente nell’identikit. Quando si conoscono lei ha 17 anni e fa la commessa dal fotografo personale del Führer. Le basta poco per diventare la favorita di un’incestuosa e labirintica alcova che somiglia più a un obitorio, punteggiata di suicidi e morti FOTO A3 LAURA LAURENZI Era atletica come imponeva il modello ariano. Era appassionata di scarpe italiane e aveva letto un solo libro: “Via col vento” violente. Che cos’ha più delle altre? Non certo l’intelligenza, anzi, è contraddistinta da una certa opacità. Non l’avvenenza: alta, morbida e atletica insieme, ha belle gambe ma anche il cruccio di un seno insignificante. Convenzionale, con aspirazioni (allora) modeste, unico libro letto Via col vento, ama i film di Hollywood e le scarpe di Ferragamo, come quelle che indosserà nel bunker per farsi infilare la fede nuziale al dito e inghiottire la sua fiala di cianuro. Vivrà quasi sempre segregata, ignorata dal resto del mondo, almeno fino a quando due diversi tentativi di suicidio (il primo con uno sparo alla carotide, il secondo per barbiturici) convinceranno Hitler a darle una qualche visibilità. Ecco che la nomina «segretaria», le elargisce una Mercedes con autista, una villetta tutta sua fuori Monaco perché non abiti più con i genitori, una pelliccia. E un cane. Anche un cane, il primo di una serie di Scottish terrier, prima Burli, poi Negus e Stasi. E soprattutto fa di lei la first lady del nido dell’aquila, lì e solo lì, a mille metri, dove sfileranno ospiti illustri come Mussolini e dove costruiranno ossequiosi le loro ville di gerarchi Goering e Bormann. A Eva non è richiesto molto. Di essere solo, e moderatamente, decorativa. Pratica quasi tutti gli sport, è la personificazione dell’ideale femminile nazionalsocialista. Dice sempre di sì, sorride, è riposante e disponibile, i suoi orizzonti non sono impegnativi, non chiede, non è curiosa, non intercede per nessuno, nemmeno per la sorella Gretl, incinta, cui Hitler farà uccidere il marito. Ma nel suo diario prevale la disperazione. «Mi usa solo per i suoi scopi igienici». Peraltro rari: «L’amore è stato cancellato dai suoi orari». Si lamenta di essere trattata come una prostituta. «Perché devo vivere così, nell’ombra?». Sedici anni accanto a Hitler, ma come se lei non esistesse: «Desidero ammalarmi gravemente. Perché il diavolo non mi porta via?». Ma il diavolo è già lì. Negli ultimissimi mesi Hitler ripete sempre più spesso: «Ormai posso contare solo su Blondie e su Eva», come racconterà Erich Kempka, l’autista capo della Cancelleria. Blondie è il suo amatissimo pastore alsaziano, una femmina. Su Blondie e su Eva: prima la cagna e poi la donna, forse è quella la vera gerarchia degli affetti. Anche Blondie, con Eva, avrà diritto nel bunker alla sua dose di cianuro. Oggi il nido dell’aquila, ristrutturato, ampliato, riedificato, è un modernissimo hotel a cinque stelle. Lo hanno appena inaugurato: si chiama Prima Stazione di Montagna Tedesca, conta 138 camere doppie e dodici suite. La più lussuosa costa 1300 euro a notte. DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 STASERA LO SPECIALE TG1 Nella foto grande, Eva Braun con Adolf Hitler. Accanto, nell’immagine piccola in basso, la ragazza a 17 anni. Nella sequenza qui sotto, Eva fa ginnastica in riva al lago vicino allo chalet; ancora, tre uomini della “corte” del Fürher, scherzano con la Braun e la gettano in acqua; Hitler mentre stringe la mano di Gretl Braun, sorella di Eva; una istantanea del viaggio in Italia del ’40 (Firenze); infine la Braun con un cappotto da sfilata: per un po’ di tempo la donna fece infatti la modella. Le foto pubblicate in questa pagina sono state gentilmente concesse dallo speciale Tg1 in onda stasera alle 22,45, intitolato “Il matrimonio di Frau Hitler” a cura di Roberto Olla Stregata da un uomo che non la amò mai JOACHIM FEST soprattutto come un non-personaggio, o come un personaggio piccolo piccolo, privo di fascino e di appeal, che Eva Braun è rimasta nella Storia. Nella Storia dei libri, nelle ricerche di noi storici e degli archivisti, non nella memoria collettiva. I tedeschi di oggi — lo constato ogni volta che parlo con gli studenti — non la ricordano, non la conoscono, non provano interesse né curiosità verso di lei. Così fu il destino di una semplice fanciulla piccolo-borghese. Ricordiamolo. Eva crebbe come figlia di un professore. Cominciò a guadagnarsi qualche soldo lavorando come segretaria e modella da un fotografo berlinese. E fu lì, nello studio del fotografo, che per caso incontrò per la prima volta Adolf Hitler. Hitler la volle subito sedurre, la portò con sé nel suo rifugio in montagna, la fece innamorare. Lui prese l’iniziativa dell’approccio, eppure non la amò mai. Dall’inizio alla fine, la loro love story fu il dramma di un amore non ricambiato. L’amore, anzi l’innamoramento profondo e forte di Eva per il Führer, cui lui rispose appena con segni di rispetto soltanto alla fine. Nel Bunker, negli ultimi giorni del Reich, a Berlino già in mano ai russi. Quando lei rifiutò ogni offerta di lasciarlo e trovare la salvezza, e scelse di morire accanto a lui. Ripensare oggi a Eva Braun vuol dire anche, per voi amici italiani, accostare il ricordo di lei a quello di Claretta Petacci, l’amante del Duce. E anche dal raffronto tra le vicende delle due amanti, il Führer esce male. Il dittatore Mussolini fu un uomo normale. Tradiva sua moglie con un’amante, come molti già allora. Ma a quanto mi risulta seppe amare Claretta: il suo coinvolgimento sentimentale, la sua passione virile e umana per lei, è rimasta nella Storia. E il fascismo seppe convivere con chiacchiere e pettegolezzi su un affaire di dominio pubblico. Hitler no. Hitler non seppe mai regalare a Eva un coinvolgimento da innamorato. Non le seppe neanche dare la dignità trasgressiva di amante di fatto nota in società. Di Eva ufficialmente, nei tredici anni del Terzo Reich, non sapeva nulla nessuno. Eva era insieme un’amante per forza, perché ai vertici del regime ognuno doveva avere un’amante (o un amante omosessuale) in nome del bon ton nazista della sessualità per forza, e un segreto di Stato. Nessuno al di fuori della cerchia più ristretta dei gerarchi del regime ufficialmente sapeva di Eva. Nessuno doveva parlarne. Nel mio ultimo libro riferisco delle confessioni che nel dopoguerra raccolsi da Albert Speer, l’architetto del Reich. Speer mi disse che in tutti i suoi anni di vicinanza a Hitler non colse mai in lui sentimenti d’amore verso Eva. Mi disse che il Führer cominciò a parlare di lei con rispetto solo dal marzo 1945. Quando la guerra era perduta agli occhi di tutti, e l’umile, semplice ragazza piccolo borghese venne alla Cancelleria con pochi bagagli, dicendo di voler morire al fianco del Führer che amava. E Dal 16 marzo 2005 Dorotheum apre a Milano Esposizione di una selezione di dipinti antichi e oggetti d’arte delle aste primaverili a Vienna 16 – 18 marzo, ore 10 – 19 Giornate di valutazioni 16 – 17 marzo, ore 10 – 18 Dipinti antichi, vetri e porcellane, mobili e arti decorative, 16 marzo Jugendstil e arte applicata del ‘900, 17 marzo Argenti, oggetti di Case Imperiali e decorazioni, gioielli, 17 marzo Dorotheum Milano, Palazzo Amman, Via Boito, 8, I-20121 Milano Informazioni ed appuntamenti: Angelica Cicogna Mozzoni tel. +39 02 303 52 41, fax +39 02 304 101 20, [email protected] www.dorotheum.com Palais Dorotheum, A-1010 Vienna, Dorotheergasse 17 Paolo Pagani (1661 ca. – 1716), Il ratto di Elena (particolare), olio su tela, 225 x 135 cm, uno di una coppia, venduta a Vienna, asta 29 settembre 2004, prezzo realizzato € 480.000 La breve vita di Eva fu dominata e schiacciata da questo amore infelice. Lei lo narrò nel suo diario: confessò due tentati suicidi cui la spinse la disperazione dell’amore non corrisposto da Adolf. Hitler non era capace di amare. Era travolto dalla sua egomanìa, fanaticamente convinto di dover cambiare la Storia del mondo. Non aveva spazio per l’amore nel suo animo. Non aveva neanche la capacità di lasciarsi andare. Rileggo oggi, pensando a Eva Braun, gli appunti di Speer e dell’addetto stampa internazionale del Führer, Ernst “Putzi” Hanstengel. Appunti secondo cui Hitler si vergognava persino di spogliarsi davanti al suo medico personale. Hitler non era capace di condividere intimità e animo con una persona amata. Meno che mai con una donna forte: per questo alla fine lo rifiutò la forte, orgogliosa Winifried Wagner che egli frequentò prima di Eva. Lui sopportò Eva perché al confronto di una Winifried Wagner gli appariva piccola e debole, controllabile, ma non seppe amarla né desiderarla. L’amore tra i due fu passionale e carnale da parte di Eva, ma non corrisposto. Speer mi disse quanto Ernst “Putzi” Hanstengel, addetto stampa internazionale di Hitler, gli aveva confessato. Cioè che probabilmente l’amore tra Eva e Adolf non fu mai consumato a letto, nonostante l’insistenza vogliosa e innamorata di lei. Lei voleva, lui no. Lei poteva tenergli compagnia, ma era tenuta rigorosamente lontana da ogni vertice ufficiale. Speer cercò di integrarla nella cerchia più ristretta del regime. E di darle da amico una sensazione di normalità. La portava a nuotare, la accompagnava in passeggiate. Cercò insieme ad altri di convincerla a lasciare il Bunker della cancelleria. Invano. Eva rifiutò. La sua devozione cieca ed estrema la rese grande. Ma in un certo senso rivelò anche i limiti del suo piccolo animo. Eva fino all’ultimo non volle mai ascoltare la minima critica contro il suo Adolf: lui ai suoi occhi innamorati era un grande uomo, non tutti i comuni mortali potevano capirlo. Accecata dall’innamoramento e dal suo piccolo animo, non seppe vedere i crimini mostruosi e la natura demoniaca del regime. Vi sembra paradossale? Lasciatemi dire, da uomo anziano, che non capisco Eva Braun così come in generale mi sembra difficile per un uomo capire razionalmente le donne. Come accade da sempre alle donne, fu vittima del fascino del potere. Un uomo potente può essere piccolo, grassoccio, vecchio e brutto ma ha più chances di successo di un bel giovane privo di rango sociale. Senza il suo amato Adolf, Eva non voleva più vivere. In un certo senso lei fu il prototipo del piccolo borghese ingenuo e incosciente, convinto di dover seguire il Führer fino all’ultimo. Quella di Eva fu la tragedia d’un animo limitato, incapace di capire cosa davvero ti accade attorno. Molti, troppi tedeschi allora furono travolti da questi sentimenti ingenui di devozione al Führer, e finirono trascinati come lei nel baratro della Storia. L’autore è uno dei massimi studiosi della vita di Adolf Hitler 23º anno - XVI Edizione ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON IL PATROCINIO DELLA RAPPRESENTANZA A MILANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA LUNEDÌ 14 MARZO 2005 - ORE 20,30 TEATRO VENTAGLIO NAZIONALE PIAZZA PIEMONTE 12 - MILANO Consegna dei Premi Librex Montale e Librex Montale International a Franco Loi e Michael Longley Consegna del Premio "Poetry for Music" a Ivano Fossati Massimo de Vita legge una selezione di poesie di Eugenio Montale Concerto del Maestro Giuseppe Nova dedicato ad Astor Piazzolla INGRESSO LIBERO www.librexmontale.com SI RINGRAZIA DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 il racconto LA MUMMIA DEL LAMA Qui a fianco una sequenza di tre immagini della mummia del lama Khambo Itighelov a Ulan-Ude in Buriazia. In basso una foto del lama agli inizi del ’900 Buddisti in preghiera GIAMPAOLO VISETTI L MOSCA a testa, rasata, suda. Le mani, morbide, sono calde. Il cervello trasmette impulsi elettrici. Le unghie crescono. Il corpo perde e riacquista peso. La pelle, tesa, è elastica. Gomiti e ginocchia si muovono. Naso ed orecchi sono dove ognuno li ha. Gli occhi, intatti, stanno chiusi: qualcuno, raramente, nota le palpebre sollevarsi. Il cuore sembra pronto a riprendere il battito. Vene e arterie sono piene di sangue, di gelatinosa consistenza. Il lama Khambo Itighelov è tornato. Prima di morire, nel 1927, lo aveva promesso. Ora i buddisti russi lo venerano come «il dio rinato». Sette volte all’anno, nelle feste solenni, la sua cella nel monastero di Ivolghinskij, affacciato sul lago Baikal, si apre ai fedeli. A migliaia lasciano i villaggi dell’estremo Oriente e della Mongolia per accorrere a Ulan-Ude, in Buriazia. Non c’è posto per tutti. Attorno alla cassa di cedro protetta da una campana di cristallo, dove il corpo disteso 78 anni fa è riemerso seduto nella posizione del loto, possono sfilare 15 mila persone al giorno. Per quest’anno gli accessi, aumentati a 130 mila, sono esauriti. Medici e scienziati di tutto il mondo non sanno spiegare il fenomeno. Nei laboratori si esaminano campioni di tessuti, capelli, cartilagini. Le radiografie confermano solo il mistero: gli organi di quella che fu la guida spirituale dei buddisti russi sono perfettamente conservati. Dove si ferma la ragione, accorre la fede. I monaci del “dazan” sono sicuri. Il lama Khambo, dopo aver raggiunto lo stato della “perfetta vuotezza”, è vivo. In lui si è reincarnato il primo capo della chiesa buddista, Pandito Khambo, lama Zajaev. Era nato nel 1702. Morì a 75 anni, promettendo agli allievi di tornare dopo altrettanti. Alla data stabilita, 1852, venne alla luce Khambo Itighelov. Visse altri tre quarti di secolo, confermando a sua volta il ritorno dopo un tempo corrispondente. Alla scadenza, tre anni fa, ha rispettato Il lama reincarnato che stupisce la Russia l’appuntamento. Da allora la vita, identificata con la «trasmigrazione dell’anima», riprende a scuotere il suo corpo: mummificato pur senza aver subìto alcun trattamento. Aveva lasciato il mondo in modo sorprendente. Nel 1917, mentre l’impero degli zar Romanov crollava sotto i colpi dei bolscevichi di Lenin, aveva rinunciato a governare la chiesa buddista. Per dieci anni Khambo Itighelov si era ritirato in un monastero. Sedeva immobile, solo nella cella: «Devo perfezionare — spiegava — il mio spirito». Il 15 giugno del 1927 convocò i suoi discepoli. Chiese che recitassero per lui la preghiera dei defunti: «Auguri di bene per chi se ne va». Gli allievi erano incerti. «Perché maestro — chiesero — dobbiamo recitare questi versi per lei che è sano e forte?». Il lama sorrideva. Li pregò di tornare a guardare il suo corpo dopo 30 anni. Volle che venisse scritto che dopo 75 anni il suo spirito sarebbe stato nuovamente tra loro. Poi, dopo aver pronunciato da sé l’orazione funebre, smise semplicemente di respirare. Lo stupore, dominato dalla paura, ha impedito che venisse cremato. Fu messo nella terra, avvolto in un lenzuolo e cosparso di sale. «Nel 1957 — racconta oggi la direttrice dell’istituto religioso a lui dedicato, Yanzhima Dabaevna — il lama Itighelov è stato esumato. Era intatto, non si è potuto bruciare come prescrive la legge buddista. Nel 2002 la conferma del miracolo. Pesava 37 chili, oggi oscilla sui 42». Nessuno ha diffuso la notizia della mummia reincarnata. Si temeva che attorno al Maestro fiorisse un’ingiustificata idolatria. Poi, misteriosamente, decine e quindi centinaia di fedeli hanno iniziato a battere al portone del convento. «Chiedevano di Khambo — spiega la sua discendente — abbiamo dovuto prendere atto della verità». Il fenomeno è stato contenuto fino a gennaio. Il centro di medicina legale del ministero della salute, assieme all’università di Mosca, esitavano a pronunciarsi. Quindi il verdetto choc: «Gli esami di laboratorio — scrive il professor Viktor Zvjagin — non hanno rilevato nei tessuti organici del corpo qualcosa che li distingue da quelli di una persona vivente». Dieci giorni fa, su richiesta dei monaci, gli esami sono stati sospesi. Il «lama rinato» smette di essere un fenomeno scientifico e si consegna all’insondabilità della credenza. I buddisti dell’estremo Oriente russo, ma anche quelli sparsi lungo il confine cinese, giovedì hanno festeggiato, pregato e ringraziato. Al monastero sono stati fissati i giorni in cui, entro un anno, si potrà onorare il Maestro: 24 aprile, 23 maggio, 10 luglio, 27 settembre, 24 ottobre, 26 novembre, 29 gennaio 2006. «I dubbi sono fugati — dice l’attuale capo dei buddisti, Khambo lama Ajuscejev — gli esperimenti non servono più. Il lama Itighelov è come noi, solo in un stato di assenza. La reincarnazione è compiuta». I monaci della Buriazia ricordano così l’origine dell’enigma. La «mummia vivente», appena onorata anche dall’attore Richard Gere, avrebbe raggiunto il livello di astrazione dal corpo descritto nel 1400 dal famoso lama Bogdo Zonkhavy. «È uno stato paranormale straordinario. Si ottiene attraverso lo svuotamento: un percorso spirituale ignoto, che consente di abbandonare e riacquisire il proprio corpo». A provarlo, un vecchio verbale della locale guarnigione della polizia russa. «Il lama — si legge — nel pomeriggio correva a cavallo sulla superficie del lago Beloje, come fosse sul selciato». Altri raccontano che fosse in grado di spostarsi fulmineamente: si riduceva ad un punto, riapparendo in un istante ad un chilometro di distanza. Yanzhima Dabaevna ha scoperto che i magici poteri si sono rivelati al ritorno del Maestro dopo vent’anni di studi alchimistici in Tibet. Il monastero, oggi cinese, è stato distrutto. Khambo Itighelov rimane l’ultimo custode del proprio segreto. 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 Ci sono Miles Davis, Charlie Parker, Louis Armstrong. E poi le “lady”: Billie Holiday, Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald. Ci sono il “Duca” Ellington e il “Conte” Basie. Ci sono tutti i più grandi jazzisti: piangono, ridono, suonano, rivivono dentro le oltre centomila foto che Frank Driggs ha raccolto in più di cinquant’anni. Una collezione da un milione e mezzo di dollari, che ora lui sta pensando di vendere. Scatenando la caccia degli appassionati di tutto il mondo Jazz L’uomo che catturò la leggenda ANTONIO MONDA I 1,5mln NEW YORK n occasione del suo settantaquattresimo compleanno Frank Driggs ha deciso di regalarsi una serata solitaria di ricordi, ed ha cominciato a scavare nella sua sconfinata collezione fotografica, incantandosi di fronte ai volti, ai gesti e agli atteggiamenti di un’epoca che ha amato profondamente e della quale rappresenta il più accurato, imprescindibile ed anomalo testimone oculare. Il freddo dell’inverno newyorkese, suggellato da una delle tante nevicate di questa ultima stagione, impallidiva i colori all’esterno del suo appartamento, e Driggs si è commosso a scoprire che non c’era nulla che evocasse le atmosfere, i suoni, e soprattutto i colori di quel mondo come quelle migliaia di immagini in bianco e nero che ha raccolto per oltre cinquanta anni. Tra le sue mani sfilavano le fotografie della più importante collezione di jazz del pianeta, che Driggs ha cominciato a raccogliere quasi per caso, e per molto tempo con una spesa irrisoria. Louis Armstrong è tra i personaggi che compare più frequentemente, ma hanno un posto d’onore Lester Young, Sidney Bechet e «la sublime Billie Holiday». Da quando si è trasferito in un appartamento nella zona West di Soho, ed ha appreso che la sua collezione è valutata un milione e mezzo di dollari, Driggs ha deciso di conservare le oltre centomila immagini in un deposito segreto, tenendo con sé soltanto le copie. Per gli originali farebbero follie molti appassionati, che in questi giorni hanno letto dell’intenzione di Driggs di vendere il tesoro. In realtà lui spiega che cederà le foto solo in blocco, «per non disperderle», e che non ha ancora sciolto tutti i dubbi. Sono passati molti anni da quando Driggs è andato via dalla cittadina di Bennington, nel Vermont, per seguire le ombre del padre jazzista e rinunciare alle concrete possibilità di lavoro offerte da una laurea in scienze politiche a Princeton. Cercò sin da piccolo di imparare a suonare la tromba, ma si accorse subito di non avere il talento dei musicisti che andava ad ascoltare con devozione religiosa, conquistandone l’amicizia per la sin- 100mila La collezione di Frank Driggs è stata valutata un milione e mezzo di dollari cerità con cui discuteva dei momenti di felicità pura che offre l’ascolto, e, soprattutto l’esecuzione della grande musica. Oggi acquista un sapore agrodolce il ricordo del periodo in cui lui, bianco e con gli occhi azzurri, rimaneva fino a tarda notte in locali frequentato solo da neri come a chiacchierare con Count Basie e Bucker Pitman. Gli è tuttora difficile capire se l’incanto delle serate al Basin Street e al Café Bohemia, che gli davano l’illusione che al mondo non esistessero i conflitti razziali, fosse IL COLLEZIONISTA Qui sopra, Frank Driggs, proprietario della grande raccolta di foto 1.083 Le immagini della collezione di Driggs sono oltre centomila dovuto alla grandezza umana, prim’ancora che artistica di quei musicisti, ma è certo che cominciò a capire che l’atmosfera stava cambiando all’inizio degli anni Sessanta, quando sentì sulla propria pelle cosa dovessero provare nella quotidianità i suoi amici di colore. «Tra musicisti non ricordo episodi odiosi di razzismo» racconta mentre mi ripropone il rituale del viaggio nelle immagini. «Quello che succedeva nelle serate di musica, o quando dividevamo l’eccitazione e la stanchezza delle tournée rappresentava la celebrazione di un mondo incantato e privilegiato, nel quale il fine ultimo era la purezza espressiva dell’arte. Appena uscivamo da quell’incanto, si aveva immediatamente la percezione che il mondo ci riconoscesse invece per i nostri diversi colori, per il modo differente in cui vestivamo, parlavamo e mangiavamo. Ma quel mondo incantato, che ha prodotto alcuni dei momenti più alti dell’arte del novecento aveva anche un dramma interno, che ne ha caratterizzato perennemente l’esistenza: la droga». È un aspetto di cui Driggs non parla mai volentieri, e tra i grandi musicisti preferisce ricordare gli esempi positivi come Clifford Brown, rievocato con commozione per la straordinaria generosità e l’assoluta integrità morale. Nelle immagini della collezione, che è diventata il suo lavoro da quando ha smesso di produrre riedizioni di classici dimenticati, il volto di Brown si alterna ripetutamente con quel- Le foto che ritraggono Louis Armstrong sono complessivamente 1.083 ‘‘ Charlie Parker Le cose che ascoltate vengono dallo strumento di un uomo, sono esperienze: il beltempo, la vista di una montagna, un bel respiro di aria fresca. La musica è questo: la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi non verrà fuori lo di Charlie Parker, che invece rappresenta il lato tormentato dell’epopea jazz, ma la potenza evocativa delle foto, sembra negare gli spasmi quotidiani di Bird, che alla droga immolò la propria vita. Lo stesso si può dire per le immagini notturne in cui è immortalato Miles Davis, o per gli infiniti musicisti dimenticati dal pubblico ma ricordati ad uno ad uno da Driggs, che ne celebra i talenti artistici ed invita alla comprensione sulle debolezze umane. Le foto consentono una lettura parallela della società americana del secolo scorso: un bianco e nero estremamente contrastato mostra Duke Ellington che esegue un classico come Take the A Train in una foto che comunica una straordinaria energia. Chi conosce New York sa che si tratta della metropolitana che porta nel cuore di Harlem, ed il trascinante brano di Ellington assume immediatamente il significato dell’invito a celebrare una cultura di cui il musicista è il primo ad essere orgoglioso. In un’altra delle 1545 fotografie che immortalano Ellington, il jazzista imbraccia il clarinetto accanto a Joe Louis: sono gli anni dei match leggendari tra il brown bombere l’ulano neroMax Schmeling, e lo scambio di sorrisi tra il campione afro-americano ed il grande musicista sembra tranquillizzare il mondo intero su chi prevarrà alla fine in un conflitto che assunse connotati razziali, politici e sociali. Driggs ricorda ancora con turbamento DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 Un secolo di musica in bianco e nero GINO CASTALDO rrivò il jazz e fu subito luce. Ma questa luce fu definitivamente fissata in bianco e nero, una volta per tutte: centinaia, migliaia di foto che hanno quasi sempre preferito non lasciar entrare il colore, come fosse il tradimento di un precetto estetico, come un disturbo che poteva fuorviare dall’anima, dall’essenza di quella musica. Per molti, ancora oggi, il fascino del jazz è racchiuso nelle immagini in bianco e nero. Il jazz potremmo aggiungere, almeno attraverso le sue foto, è musica in bianco e nero. Un contrasto che servì all’inizio a raccontare lo smagliante, bianchissimo sorriso di Louis Armstrong sul suo nerissimo volto, che poi indagò le ballroom affollate di svolazzanti vestiti di fronte alle orchestre dello swing, le pieghe rugose del volto di Ellington, una sobrietà inevitabile quando bisognava spiare i capricci notturni dei boppers e le loro pose anticonformiste, indispensabile quando i fotografi cominciarono a voler restituire la magìa unica e irripetibile di un concerto jazz. Notte, fumo, facce africane tra le mura della metropoli, il soffio graffiante dei sax, la droga, l’ebbrezza, la poetica marginalità, l’imprevedibilità dell’improvvisazione, tutto questo esigeva, pretendeva il bianco e nero. E così è stato. Ci sono foto che hanno definito un approccio che, lungi dall’essere una limitazione, è diventato un vero e proprio sottogenere dell’universo fotografico. Tra le più famose, quella di Herman Leonard del 1948, che ritrae un giovane Dexter Gordon preso di taglio col sassofono poggiato sul ginocchio e una lunga voluta di fumo che va a incrociarsi con la luce di un faro, quelle di William Gottlieb a Billie Holiday, Louis Armstrong e Charlie Parker, e quella di Art Kane, forse la più famosa di tutte, che ha meritato addirittura un titolo, A great day in Harlem, come fosse un film o un racconto. Era l’estate del 1958 e la rivista Esquire chiese ad Art Kane che allora non era neanche un fotografo di riuscire a fotografare insieme almeno quattro giganti del jazz. Tra questi volevano assolutamente Charlie Parker. Kane obiettò che Parker era morto da tre anni, ma rilanciò dicendo: perché non riunirli tutti? La cosa incredibile è che ci riuscì davvero, alle dieci di mattina di un giorno di agosto, circostanza che, conoscendo le abitudini notturne dei jazzisti, ha del miracoloso. All’appello si presentarono ben 57 jazzisti, tra cui Coleman Hawkins, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Charlie Mingus, Art Blakey, Lester Young, Dizzy Gillespie, Count Basie. Praticamente tutti i grandi protagonisti, per una foto di gruppo, sulle scale di una palazzina di Harlem, che da allora è l’emblema della scena jazzistica. Vale, per il jazz, quanto valgono le straordinarie foto di gruppo che Annie Liebowitz ha realizzato nel mondo del rock. Fotografare il jazz è diventato una passione per molti, un culto, l’ambizione di catturare in immagini l’istante unico, la riproduzione congelata del momento in cui la grazia scendeva sui musicisti in trance creativa, e anche la voglia di narrare l’inesplicabile grandezza umana e artistica di musicisti che hanno suonato alcune tra le più alte pagine della musica del Novecento (per gli appassionati sono rintracciabili la classica fotostoria del jazz di Joachim-Ernst Berendt e i raffinatissimi Photographie Le Jazz di Guy Le Querrec e The Sound I Saw di Roy DeCarava). Tra i tanti c’è stato anche un italiano, Giuseppe Pino, le cui foto hanno fatto il giro del mondo e qualche volta sono finite nelle copertine di celebri dischi, com’è successo per Miles Davis. Quella del jazz, del resto, è stata definita «dialettica in bianco e nero» ed è come se le foto, in un tacito ma deciso passaparola, avessero rispettato l’assioma principale, ovvero la creatività travolgente degli afroamericani, immersi in un mondo dominato dai bianchi, qualche volta anch’essi grandi jazzmen, sebbene più di rado, basti citare Bix Beiderbecke, Bill Evans e Gerry Mulligan, più spesso veri emulatori assurti a rango di “re” per l’ansia tutta americana di cercare affannosamente bianchi che potessero ricoprire quei ruoli da primato invece di consacrare, come sarebbe stato logico, i neri. A rendere giustizia ci hanno pensato le foto, sempre o quasi in bianco e nero, con sfondi fumosi e scuri dove i volti dei jazzisti sembravano ombre stagliate nella notte. Buio, notte, oscurità, sono associazioni obbligate, come se si facesse fatica a immaginare il jazz in pieno sole, di mattina. Come se il bianco e nero rispettasse meglio l’indagine profonda, le stimolazioni dell’anima, la spudorata capacità di arrivare dove spesso la musica “scritta” non arriva. Alla fine, una dopo l’altra, se potessimo un giorno scorrerle tutte in sequenza, quelle foto compongono una loro sinfonia, una meravigliosa improvvisazione lunga più o meno un secolo. GENTILE CONCESSIONE ART KANE ARCHIVES A MANZI LE STELLE il pianto disperato di Billie Holiday al funerale di Lester Young, e l’angoscia che colpì tutti gli appassionati quando pochi mesi dopo anche “la signora del Blues” passò a miglior vita. L’addio alla Holiday, nella chiesa all’angolo tra la 59° strada e la nona avenue fu molto più affollato di quello di Young, ma Driggs è il primo ad evitare delle semplici deduzioni relative alla rispettiva qualità: la folla che volle salutarla per l’ultima volta si identificava anche con il suo dolore, struggente come l’anelito che risuonava nella sua voce. Negli ultimi anni, né Young né la Holiday avevano dato il meglio del proprio straordinario talento, ma per tutti gli amanti del jazz la loro morte segnava la fine di un’epoca irripetibile. Le foto ed i ricordi di Driggs consentono di rievocare anche rivalità segrete, come quelle tra Count Basie e Duke Ellington. Nel saloni del Savoy sembrano ancora risuonare le note della serata indimenticabile in cui il “duca” ed il “conte” si trovarono ad esibirsi l’uno dopo l’altro: nel giro di pochi brani l’incontro si trasformò in una sfida, nella quale i musicisti cercarono di trascinare il pubblico dalla propria parte suonando i propri cavalli di battaglia. Ancora oggi gli appassionati si dividono su chi abbia prevalso, e lo stesso Driggs, che accompagnò Basie in una lunga tournée diventandone intimo amico, e del quale possiede 585 rarissime fotografie, preferisce non assegnare la palma del vincitore. Diverso il caso di Roy Eldridge, che nel 1933 cercò di sfruttare l’assenza dalle scene di Louis Armostrong procurata da alcune piaghe sulle labbra, per affermarsi come l’indiscusso re del jazz utilizzandone lo stesso repertorio. Satchmo, che aveva il carattere solare che si leggeva sul suo sorriso, non si preoccupò mai troppo di quanto facesse il rivale, ed anzi lo elogiò ripetutamente in pubblico, ma fu il manager Joe Glaser, che amministrava entrambi, a far capire ad Eldridge che non c’era bisogno di un atteggiamento così aggressivo per conquistare il successo meritato dal suo talento. Fu molto meno aspra la rivalità tra Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald, mentre le foto di Dinah Washington ne esaltano immediatamente il carattere imperioso e imprevedibile. Driggs ricorda una notte al Birdland in cui cominciò ad insultare senza motivo tutti gli astanti, citando come esempio di mascolinità solo alcuni dei suoi primi otto mariti. Il connotato razziale riemerge di fronte alle immagini di Benny Goodman: «Ci sono stati dei grandissimi musicisti bianchi, come ad esempio Bix Beiderbecke, ma il jazz è naturalmente, direi intimamente nero», mi spiega mentre si incanta di fronte ad una foto di John Coltrane, «prova a mettere a confronto Don’t be that way suonata da Benny Goodman e da Chick Webb: nel primo caso ci troviamo di fronte ad una meravigliosa interpretazione, nel secondo alla realtà più intima del pezzo. So che può sembrare un luogo comune, ma nel caso dei grandi musicisti neri si avverte una naturalezza ed un senso di relax ir- raggiungibile». Alcune immagini risalgono ad un periodo che Driggs è dispiaciuto di non aver vissuto: il suo archivio è arricchito dalla unica foto della Buddy Bolden Band (datata 1895) e uno degli scatti più pregiati mostra Louis Armostrong con l’orchestra di Fletcher Henderson in una foto autografata da Satchmo nel 1924 a Fate Marable. In una delle 1083 foto di Armstrong, lo vediamo ritratto nei primi anni venti insieme a King Oliver: l’eccessiva eleganza della coppia fa una certa tenerezza, specie per il cappello Oliver, esibito come la conquista di stato sociale. Sono gli anni in cui a New Orleans Freddy Kapperd dominava la scena, ed anche lui, che cercava a sua volta di scalzare Satchmo, esibisce un vestito dalla sontuosità eccessiva. Una gigantografia celebra la grandezza dell’orchestra di Jelly Roll Morton, ma Driggs spiega che il segreto nella foto è nelle tre ragazze bianche che accompagnavano la band, e nel sorriso di George Mitchell, grandissimo musicista gobbo, che nelle foto di gruppo era sempre pregato di accomodarsi sullo sfondo. «Nessun film è riuscito a catturare l’essenza di quegli anni» mi spiega mentre afferra la cartella con Benny Goodman (692 foto): anche nei casi migliori come Bird di Clint Eastwood e Sweet and Lowdown di Woody Allen si ha la sensazione di una messa in scena: «Il jazz è prima di ogni cosa l’emozione di un momento irripetibile». Alcune delle immagini che conserva gelosamente sembrano confermare lo scetticismo del suo giudizio: alla lettera “T” emerge la foto di Snakeship Tucker un ballerino di Harlem detto il serpente per l’incredibile elasticità delle sue vertebre. Mentre mostra Snakeship che riesce a fare una “S” con il suo corpo mette un vecchio long playing di Jelly Roll Morton, ed attende gli scrocchi sulla antiquata testina prima di dirmi: «Ecco, forse così può averne una idea. Ma non illuderti che sia la stessa cosa». Le immagini in questa pagina appartengono alla collezione di Frank Driggs. Nella foto grande, Sarah Vaughan. Dall’alto, in senso orario, Duke Ellington e la sua band nel 1936, Bessie Smith negli anni Venti, Billie Holiday con la Willie Bryant Band nel 1935, i grandi del jazz fotografati nel 1958 ad Harlem da Art Kane, Louis Armstrong e sua moglie Lil fotografati nel 1930 a Los Angeles 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 i sapori Comincia domani a Salsomaggiore l’edizione numero quattordici del campionato mondiale dei pizzaioli. Una prova del successo planetario della ricetta più amata, cucinata e consumata. Ma anche insidiata nella sua purezza. Tanto che la Ue approverà un disciplinare che fissa regole e ingredienti per difendere questa “specialità tradizionale” Mangiare glocal itinerari Vico Equense Sorrento Napoli Uno dei luoghi di delizie gastronomiche della costiera, raggiungibile anche in traghetto e famoso per la storica, golosa “Università della Pizza”(Tel. 081 8798309), dove si gusta la pizza “a metro”, modalità di consumo che coinvolge l’intera tavolata Costruito a strapiombo sul mare, è uno dei luoghi-culto del turismo mondiale. Fuori dal paese, un trionfo di bellissimi aranceti, limoneti, ulivi, e la generosa campagna di Punta Campanella, che divide il golfo di Napoli da quello di Salerno La capitale dell’enogastronomia mediterranea celebra la pizza a metà settembre, in coincidenza con la festa di San Gennaro, nei dieci giorni del Pizzafest. I golosi di timballi e sformati possono degustarli da Timpani &Tempura (Tel. 081 5512280) DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE EDEN BLU Via Murrano 9, camera doppia da 100 euro, colazione inclusa Tel. 081 8028550 ANTICHE MURA Via Fuori Mura 7. Tel. 081 8073523 Camera doppia da 140 euro, colazione inclusa MORELLI 49 Via Morelli 49. Tel. 081 2452291 Camera doppia da 85 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE TAVERNA DEL CAPITANO (con camere) piazza delle Sirene 10/11, Marina del Cantone Tel. 081 8081028. Chiuso lunedì, martedì a pranzo. Menù da 48 euro DON ALFONSO 1890 (con camere) corso Sant'Agata 11 Sant’ Agata sui Due Golfi Tel. 081 8780026. Chiuso lunedì, martedì a pranzo. Menù da 80 euro L’OLIVO Via Capodimonte 2 Anacapri (Capri). Tel. 081 9780111 Aperto da marzo a ottobre. Menù da 70 euro LA PIZZA LA PIZZA LA PIZZA O’ SARACINO Via Torretta 14 Tel. 081 8798559 chiuso lunedì, pizza al metro a 18 euro DA FRANCO Corso Italia 265 Tel. 081 8772066. Senza chiusura, pizza al metro 18 euro FRATELLI CAFASSO Via Giulio Cesare 156 Tel. 081 2395281 Chiuso la domenica, pizza da 3.50 euro Il napoletano Gennaro Esposito, uno degli chef più rappresentativi della nuova cucina mediterranea, è un cultore della pizza, che prova nei localiculto della regione quando non è ai fornelli della “Torre del Saracino” sulla spiaggia di Vico Equense Pizza Così nostra, così di tutti buona da perdere la testa LICIA GRANELLO enza confronto. Non esiste sull’intero pianeta una della parola — non è più italiano (egiziani in primis). Lo stericetta più diffusa, amata, consumata, interpretareotipo del pizzaiolo napoletano è ormai un’icona riservata ta, cucinata. Così malleabile da sopportare il curry a una manciata di pizzerie-culto in Italia e a quelle da cartoe le uova fritte, le cozze e l’ananas (sì, perfino l’alina in giro per il mondo, da New York in giù. nanas). Senza barriere. La trovi in Laos e a StocGli appassionati sono inquieti. Come difendere la cultura colma, strepitosa a Brooklin e pessima (spesso) a del cornicione alto, del pomodoro fresco, del fiordilatte (sulMilano, offerta in locali pochissimo raccomandabili e ristola mozzarella di bufala i pareri sono discordi)? Qualche anno ranti sontuosi, accessibile a tutte le fafa, ci provò lo Slow Food, forte della sce di spesa e di età. Senza padroni. pratica dei Presìdi: l’idea era quella di Tanto che due anni fa al Pizzafest di Nacodificare la vera pizza napoletana e poli il più bravo di tutti fu un giovane proteggerla. Non se ne fece nulla. Anpizzaiolo giapponese (pur se allievo di tonio Tubelli, cuoco colto e storico delun grande maestro napoletano). Tanto l’alimentazione campana, spiegò che quest’anno, alla quattordicesima amaro: «I nuovi pizzaioli vogliono laedizione del campionato del mondo in vorare poco e guadagnare assai. E alloLa pizza Margherita deve programma da domani a mercoledì al ra comprano le farine prelievitate, le il suo nome alla moglie di Re Palazzetto dello sport di Salsomaggiolatte di pelati da quattro soldi, certe Umberto I, che nel 1899, re (ingresso libero) sono attesi centimattonelle di formaggio fuso da far naia di tostissimi concorrenti da tutti i pietà, l’olio di semi. Va a finire che la durante una visita alla reggia continenti. pasta non è più morbida dentro e crocdi Capodimonte, venne Con un solo obbiettivo: fare la pizza cante fuori, il pomodoro è acido, e la più buona del mondo. omaggiata di una pizza pizza è una vera schifezza». Da quando più di un secolo fa la regiPer fortuna, miglior sorte hanno con i colori della bandiera na Margherita si lasciò conquistare avuto i Pizzaiuoli napoletani e l’Assoitaliana, cioè con pomodoro, dalla croccante, morbida, calda, suaciazione verace pizza napoletana, che dente, meravigliosa miscellanea di pahanno prima sollecitato l’Università di mozzarella e basilico, creata sta del pane, pomodoro e mozzarella, Napoli a formulare il disciplinare di per l’occasione dal più famoso non c’è stato forno dalla Patagonia al produzione della specialità tradiziopizzaiolo di Napoli, Raffaele Polo Nord che sia stato immune all’enale e poi ne hanno chiesto il riconosperienza gloriosa di Marinara e affini. scimento dall’Unione Europea (atteso Esposito. La sovrana apprezzò Impossibile criticarla. Ben lo sanno i per le prossime settimane), con tanto e la ricetta fece il giro di tutte nutrizionisti, che l’hanno inserita a fudi certificazione dell’ente Det Norske ror di popolo nell’elenco degli alimenle pizzerie della zona, Veritas. ti sani, se non proprio dieteticamente Carlo Mangoni, docente di fisioloe divenne simbolo del piatto irreprensibili. E gli scienzati, che le gia della nutrizione e benemerito auhanno attribuito perfino delle inusitatore del disciplinare, è perentorio: te virtù anticancro, per via degli ingre«Chi vorrà fregiare il suo prodotto del dienti — olio e pomodoro — ricchi di marchio “verace pizza napoletana”, antiossidanti. dovrà accettare le regole stabilite. E Il guaio, come per tutti i cibi “glocal” — con una matrice cioè tirare la sfoglia a mano e usare tutti prodotti a norma: ben definita e una diffusione senza confini — è il progressiolio extra vergine, pomodoro San Marzano — ‘o piennolo vo smarrimento dell’identità originaria. Succede per il gelad’ò Vesuvio, che si lascia seccare e può essere usato d’inverto e per la pasta: come potrebbe sfuggire alla minaccia la più no — mozzarella di bufala campana doc o, in subordine, facilmente ripetibile delle ricette made in Italy? A cominciafiordilatte». re dagli addetti ai lavori. Esattamente come per il pane, la larSe poi leggere non vi basta e l’acquolina in bocca vi induga maggioranza di chi ha le mani in pasta — nel vero senso ce in tentazione, andate sul sito S la Margherita Pomodoro Pasta Il San Marzano è quello ideale – pochi semi, polpa soda, ridotta quantità d’acqua – sia in versione estiva che invernale (quello a grappolo lasciato asciugare all’aperto). Molto usati anche i “ciliegini” e la polpa passata, purchè di qualità La farina classica è di grano tenero tipo “00”, con l’eventuale aggiunta di farina tipo “0”, da impastare con sale marino, lievito di birra e acqua naturale potabile (e l’acqua è uno dei segreti della vera pizza di Napoli, proprio come per il caffè) DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 30mila Le pizzerie sono una delle tipologie più diffuse di ristoranti italiani: ce ne sono in totale 30mila 24 Ciascun italiano consuma, in media, ogni anno 24 pizze, vale a dire due pizze al mese 63 2,2mld Gli americani sono grandi consumatori di pizza: la media annua pro capite è di 63 pizze Ogni anno il giro d’affari complessivo delle pizzerie italiane tocca i 2,2 miliardi di euro Salerno Caserta Affacciata sul golfo, vanta una delle province più ampie, fertili e variegate d’Italia, adagiata tra Valle di Diano e Cilento. Imperdibili la treccia di latte vaccino e la colatura di alici, prezioso condimento tramandato dalle famiglie dei pescatori di Cetara Tutta da vedere, dalla cittadella medievale alla Reggia, da gustare, grazie al prosperare delle produzioni tipiche, dalla celebre mozzarella di bufala dop (ma senza trascurare le paste filate e la ricotta), ai vini, a partire dal Falerno del Massico DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE LA VECCHIA QUERCIA Via Montevetrano 4 Campigliano (Sa). Tel. 089 88 25 28 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa BED & BREAKFAST CASERTA Via San Michele 3 Caserta Vecchia. Tel. 0823 329455 Camera doppia a 120 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE IL FARO DI CAPO D’ORSO Via D.Taiani 48, Maiori Tel. 089 877022. Chiuso martedì. Menù da 65 euro LA PIZZA DELLA FERMATA Via Vinciprova Leonino 44 Tel. 089 2750565 Chiuso lunedì, pizza da 4 euro DOVE MANGIARE LE COLONNE via Nazionale Appia 7 Tel. 0823 467494 Chiuso martedì. Menù da 30 euro LA PIZZA LUNA ROSSA Via Vinciguerra 106 Tel. 0823 966858 Bellona (Ce) Chiuso lunedì, pizza da 4 euro La storia della pizza, cibo da poveri e da gourmet Enea, il primo morso per non morir di fame MARINO NIOLA a cibo a simbolo. In queste due parole sta tutta la storia della pizza, la bandiera planetaria dell’Italia da mangiare. É nel Settecento che questo capolavoro della gastronomia popolare ha iniziato la sua irresistibile ascesa dai vicoli napoletani ai quattro angoli del globo, fino a diventare un emblema del Belpaese, e in particolare di quel doppio concentrato d’italianità che è Napoli. In realtà, più che una storia quella della pizza è una mitologia. Qualcuno la fa derivare dalle mense, le schiacciate di grano cotte al forno che gli antichi popoli mediterranei usavano per poggiarvi sopra i cibi. Importatore inconsapevole della prima pizza sarebbe stato addirittura Enea. Racconta Virgilio in un celebre episodio dell’Eneide che l’eroe per non morire di fame è costretto a mangiarsi la propria mensa. Parenti strette del nan indiano, della pita araba, della tortilla ispanica, la margherita e la marinara apparterrebbero dunque a quell’antica famiglia di contenitori che il bisogno trasforma in cibo. Ma la pizza partenopea ha stracciato tutte le concorrenti. É già famosa quando Alessandro Dumas visita Napoli nel 1835 e ne rimane entusiasta. Da raffinato gourmet, il creatore di d’Artagnan coglie che dietro l’apparente semplicità questo cibo nasconde una estrema complessità. Croccante fuori e morbidissima dentro, elastica e resistente, né troppo alta né troppo bassa, né umida né secca, né cruda né cotta. Una sorta di quadratura del cerchio culinario, una leccornia strutturalista degna di Lévi-Strauss, una coincidenza degli opposti che racchiude in pochi centimetri un intero capitolo della fisiologia del gusto. Eppure, allora nessuno avrebbe scommesso sul successo planetario della pizza. Matilde Serao la considerava inesportabile, buona solo per i palati partenopei. E commentando il clamoroso fallimento della prima pizzeria napoletana aperta a Roma a fine Ottocento l’autrice de Il ventre di Napolisentenziò che tolta al suo ambiente napoletano la pizza «pareva una stonatura e rappresentava una indigestione». Evidentemente, anche i grandi prendono delle cantonate. In realtà, questo tradizionale street-food ha letteralmente colonizzato il gusto del nostro tempo al punto da dare il nome a un sapore autonomo che non ha più nulla a che fare con l’originario disco di acqua e farina. É il cosiddetto «gusto pizza», che ormai aromatizza di tutto, dalle patatine al pop corn, e che rappresenta la risposta mediterranea al nordicissimo «gusto barbecue». Certo, più si allontana dal Vesuvio, più la pizza diventa un’approssimazione che spesso dell’originale conserva solo la parola. Ma al di là di tutte le nefandezze perpetrate in suo nome, restano costanti le ragioni della sua fortuna globale. Da Caracas a Kiev, da Abu Dhabi a Houston la pizza conserva la sua natura di cibo democratico, economico, easy. In fondo, negli spicchi “millegusti” di Pizza Hut rivive lo spirito, anche se non il sapore, di quelle pizze con l’origano, o con la mozzarella, che gli ambulanti vendevano al popolo per le strade di Napoli. Al prezzo di un soldo a settore. L’autore insegna antropologia culturale all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli D Mozzarella Olio Basilico I vecchi pizzaioli sono fedeli al fiordilatte, meglio se lasciato un paio di giorni a maturare (per perdere l’acqua in eccesso). Per lo stesso motivo (troppa umidità), disdegnano la “bufala”, che però regala un sapore più deciso e particolare É tuttora diffuso l’uso di quello di semi. Il disciplinare prevede che si adoperi esclusivamente l’extravergine, lasciando al singolo pizzaiolo la scelta della tipologia (più o meno intenso, fruttato, profumato) per caratterizzare la farcitura Usato inizialmente per il suo colore, regala finezza e profumo. Il più pregiato è coltivato nella zona di Genova-Prà (con tanto di riconoscimento dop). Spesso quello che si trova comunemente ai mercati “vira” verso il sapore della menta DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 le tendenze Giocare dovunque: gli esperti non hanno dubbi, le console del momento sono quelle “mobili”. Venerdì è uscita la nuovissima Nintendo Ds, presto arriverà la Sony Psp. E allora i due colossi si daranno battaglia, con Nokia, per conquistare un pubblico sempre più adulto ed esigente Divertimenti hi-tech IN ARRIVO IL PIÙ VENDUTO La Psp segna l’ingresso della Sony nel mercato dei videogiochi portatili. È stata già lanciata in Giappone e Stati Uniti a 249 dollari. Sbarcherà in Europa tra maggio e giugno Il Game Boy Advance Sp, è l’ultima versione dello storico Game Boy Nintendo, la corazzata delle console portatili: in tutto il mondo ne sono stati venduti 60 milioni. Costa 99 euro LA NOVITÀ IL VIDEOGIOCO-CELLULARE La Nintendo Ds è stata lanciata ufficialmente in Europa, dopo il debutto in Giappone e Usa, due giorni fa. Il prezzo suggerito è di 160 euro Il Nokia N-Gage è l’unico cellulare-console sul mercato e l’unica risposta europea allo strapotere nipponico. È arrivato alla seconda versione. Il prezzo è di 199 euro Videogame, la carica dei portatili DARIO OLIVERO iocare sempre, giocare ovunque, giocare con chiunque. Detto con un’unica espressione: gaming on the move. Questo insegue il mercato dei videogiochi. Questo dicono le costosissime analisi delle società che studiano il settore. A partire da quest’anno, e con un’accelerazione più forte nel 2006, i giocatori cambieranno pelle e chiederanno un tipo di intrattenimento completamente diverso, basato su tre parole d’ordine: mobilità, connettività, convergenza. La trasformazione sta già avvenendo. Secondo un rapporto Npd, uno dei maggiori analisti del settore, per la prima volta negli Stati Uniti il fatturato dei giochi per console portatili ha superato il miliardo di dollari, con una crescita rispetto all’anno prima del 13 per cento accompagnato dal 9 per cento di crescita delle vendite delle console portatili (quasi 100 milioni di dollari in più rispetto al 2003). Alcuni osservatori dicono che nel 2007 ci si confronterà con un mercato globale delle portatili di 11,1 miliardi di dollari. Tradu- G cendo: giochi e console portatili crescono più di quelli tradizionali. E se i giocatori vogliono giocare muovendosi non resta che inseguirli. Con quali macchine si corre? Per ora fondamentalmente con due. La prima, appena uscita anche in Italia, è il nuovo Nintendo-Ds. In questo momento nel mondo ci sono quasi 60 milioni di possessori di Game Boy Advance, la penultima delle creature del colosso di Kyoto che fino a oggi ha sempre guardato la concorrenza dalla siderale distanza delle vette. Ma questa volta le cose si complicano perché si è mossa Sony, leader nelle console tradizionali con la sua Playstation2. Al Ds si contrappone la Psp, già lanciata in Giappone e negli Usa e che in Italia dovrebbe arrivare tra aprile e giugno. È la prima volta che Nintendo sente un brivido. Perché Sony fa paura? Perché la Psp sembra rispondere meglio di Nintendo alle tre tendenze indicate dagli analisti. È portatile, si può connettere tramite una porta Wi-fi a Internet e ha un sistema chiamato Umd che consente di vedere film in quel formato. Ed ecco Le piattaforme classiche puntano su gaming online e multimedialità, permettendo di ascoltare musica e vedere film. Si riaccende la rivalità tra X-Box e Playstation2 quindi anche la convergenza: Sony potrebbe addirittura utilizzare il suo sterminato catalogo di musica e film e farlo leggere alla Psp trasformandola in una console multimediale mai vista prima. Nintendo ha dalla sua parte la grande qualità dei giochi ai quali lavorano tutte le software housedel mondo, la possibilità di giocare in multiplayer grazie alla porta wireless e il vantaggio del doppio schermo, uno dei quali funziona come il touch screen dei palmari. Inoltre sul Ds girano anche i titoli per Game Boy. Riguardo alla connettività, anche il Ds è predisposto, ma per il momento non sono previste le stesse opportunità legate all’online che offre la concorrenza. Inoltre a Kyoto sperano che il formato proprietario che Sony sta utilizzando sia un limite per la diffusione della Psp. Certo, sono in molti a dire che Nintendo e Sony pescano in due mercati diversi: la prima in quello dei giocatori duri e puri, la seconda in quello dei new user. Ma le cose non sono così semplici se si analizza l’identikit del giocatore-tipo tracciato dai guru di Dfc Intelligence. Se in una famiglia c’è una console, dice Dfc, quasi sempre ci sono più giocatori. Con il figlio che com- FRESCA DI RESTYLING SVAGO AL CUBO La nuove Playstation2 è diventata più piccola e maneggevole e resta leader. Continua a essere l’unico prodotto che legge cd e dvd senza dover aggiungere periferiche. Costa 149 euro La tradizione è quella di Nintendo: Pokemon, Super Mario e gli altri big tra i titoli a disposizione dei giocatori. Ma il Game Cube non ha mai raggiunto la diffusione capillare del fratellino portatile. Costa 99 euro pra gli ultimi titoli c’è il padre cresciuto con il vecchio Atari, estremamente attratto dalle evoluzioni dei nuovi giochi. Quindi esiste una categoria di giocatori che non sono né incalliti né sprovveduti. E soprattutto che hanno un’età e una disponibilità economica ideali per il mercato. Mancano all’appello almeno due protagonisti. Nokia ha sofferto molto le performance non esaltanti del suo N-Gage QD, al momento l’unico cellulare-console sul mercato. Gli utenti continuano a scaricare suonerie ma non giochi. Però il colosso finlandese ha dalla sua la rete di connettività più diffusa, quella dei telefonini. E poi c’è Microsoft che sembra più concentrata, con la nuova X-Box, a potenziare il suo mercato di console tradizionali, insidiate da un ritorno dei videogiochi in versione per personal computer. Resta un’ultima domanda. A che giochi giocheremo? Oggi per finire un titolo medio ci vogliono 40 ore. Impensabile trasferire tempi così lunghi su una console portatile. Saranno giochi più corti, di durata dalle 5 alle dieci ore. Chi vuole giocare muovendosi non ha tempo da perdere. Ha sempre qualcos’altro da fare: connettersi, scaricare, vivere on the move. IL RITORNO IL GIOIELLO DI GATES I giochi per Pc dati per morti sono risorti grazie all’online. I Massive Multiplayer Online Gaming sono una delle grandi risorse del mercato. Soprattutto perché si è scoperto che in Cina li adorano X-Box è l’unica console di Microsoft (costa 150 euro) per il momento visto che si attende il lancio della nuova versione che dovrebbe essere pronta per il prossimo Natale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze DOMENICA 13 MARZO 2005 Degustare con stile Gli italiani bevono sempre meno ma sempre meglio. Così si moltiplica una generazione di oggetti raffinati che trasformano degustazioni e pranzi in cerimonie da iniziati: cavatappi, decanter, tagliacapsule, termometri, bicchieri salva-profumo dove la fantasia dell’industria si è sfrenata. E che ora sono in mostra al “Vindesign” di Pavia PRENDERE ARIA FUORI CANTINA Il decanter, strumento essenziale per far ossigenare il vino, può essere completato dall’imbuto, per versarlo correttamente. Entrambi di Blomus ACCIAIO, ROSSO E NERO Il cavatappi in acciaio di Maiuguali gioca con contrapposizioni di sapore stendhaliano: il rosso e il nero Bere Design FEBBRE LIQUIDA Il termometro Wine Fever, disegnato da Claudio Palmi Caramel, è in acciaio lucidato a mano con finitura in oro. Di Morellato Il nuovo vino mette il vestito della festa AURELIO MAGISTÀ U ROMA n tempo baastava chiedere il vino giusto e la relativa annata, magari uno Chateau Mouton-Rotschild del 1989 o un Sorì Tildin del 1979, oppure intrattenersi a discutere sulle particolarità della methode champenoise rispetto alla fermentazione in autoclave. Sapere di vino significava soprattutto sapere di etichette, annate, vitigni, tecniche di vinificazione, terreni. La competenza si concentrava sulla bottiglia e sul suo contenuto. Ma le cose cambiano. Mentre i consumi negli ultimi anni registravano la costante tendenza a bere meno ma meglio, il vino è diventato un segno di elezione sociale e la degustazione si è arricchita di modi e strumenti, fino a divenire un rituale in cui la forma enfatizza i contenuti. Intanto sono usciti film come SideWays, un viaggio di degustazione che si trasforma in pellegrinaggio dove le cantine sono metaforiche chiese per attingere una diversa conoscenza di sé e del mondo. Così oggi bere vino è una cerimonia in cui l’intenditore diventa officiante e rivela la sua competenza nel destreggiarsi in mezzo a una nuova e complessa generazione di oggetti. Il banco di prova passa per la scelta del bicchiere giusto, da indovinare in gruppo superiore a venti (ammirevoli per esempio quelli di Riedel), il cavatappi tecnico provvisto ovviamente di tagliacapsula, il termometro per controllate la temperatura, il portabottiglie capace di sorprendere e incuriosire con la sua forma. Perché, se gli strumenti specifici e professionali dedicati al vino sono sempre esistiti, ora si sono moltiplicati, esprimendo ambizioni di design sempre più elevate. Ovvero, la funzione di questi oggetti viene esaltata e sublimata nella forma fino a diventare esibizione. Quindi vino e design, due bandiere del Made in Italy, fanno coppia e, segnando un nuovo percorso del lifestyle, potranno trarne reciproco vantaggio. La strana ma promettente coppia viene celebrata a Pavia, dove dall’11 al 20 marzo si tiene l’esposizione internazionale Vindesign (0382/393408, www.vindesign.it), quasi un esperimento, per ora, che si propone di esplorare questa nuova dimensione della cultura enologica con un pugno di espositori da tutto il mondo (per l’Italia, per esempio, Alessi) e di designer particolarmente avvertiti che si confronteranno sull’innovazione degli strumenti del vino. Le ragioni di questa nuova sensibilità sono molte, come nota il marchese Piero Antinori, incarnazione del marchio italiano più noto all’estero, che di recente ha presentato il progetto per le nuove cantine di famiglia, una sintesi di design architettonico e di rispetto per le colline del Chianti dove sorgeranno: «Negli ultimi anni il vino è andato gradualmente perdendo i suoi connotati di alimento per assumere quelli di godimento, riferendosi così alla sfera dell’edonismo e della cultura. In questo contesto gli aspetti legati alla forma e al design contribuiscono a confermare la qualità ed il valore aggiunto di un prodotto particolare come il vino». FAMIGLIE DA COLLEZIONE Intere generazioni di cavatappi, quelle realizzate da Alessandro Mendini per Alessi anno dopo anno, veri pezzi da collezione in edizione limitata. Antropomorfi al maschile o al femminile, citano anche opere storiche del designer: quello grande a destra e il secondo qui in alto, per esempio, riprendono il motivo decorativo della celebre poltrona Proust. Il primo, il terzo e il quarto si chiamano Deft, Zebra e Pois DOMENICA 13 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 GLACETTE A SPIRALE PORTABOTTIGLIA EQUILIBRISTA La glacette di Mesa ha nome didascalico: So Cold. E’ un tubo ricurvo in lega antiossidante che contiene un liquido refrigerante. Va tenuta in freezer fino al momento di servire il vino in tavola Luna di Ugenio, perfetto per sorprendere gli amici A CIASCUNO IL SUO Sopra, sontuosi i bicchieri Premium di Bormioli Rocco. A ciascun vino il suo HAPPY HOUR IN FANTASIA PRONTI DA BERE SULLA STELLA Sotto, i bicchieri colorati, inadatti al vino, sono per allegri happy hour. Li ha fatti Guzzini Per i vini di pronta beva da tenere in cucina, il portabottiglie a stella di Viceversa Come esaltare gusto e profumo Tappi-cassaforte e anelli di Saturno DONATO LANATI e si accende la tv, sempre più spesso appare qualcuno che rimesta nella pentola o assapora un vino. Se si apre un giornale, una rivista, ogni pagina, ogni immagine, è caratterizzata dallo stile. Viviamo nell’epoca della cucina e del design: né possiamo lamentarcene, visto che come italiani siamo protagonisti sia nell’uno sia nell’altro campo. E il mondo del vino? Dando per scontato il suo abbinamento a quello del cibo, il rapporto con il design è innegabile, che si parli di etichette, packaging o accessori. Prendete il cavatappi: dal tradizionale a vite si è passati a quello supertecnologico, che giocando su tre leve e una ghiera ha ridotto al minimo lo sforzo. Ma all’avveniristico design dello Screwpull, i veri conoscitori preferiscono ancora l’arcaica forma del francese Laguiole: un cavatappi realizzato con corno di bue o con legno di rosa, e con una forma che accompagna delicatamente il palmo della mano. Da un accessorio all’altro: fino a ieri, per evitare di macchiare la tovaglia, si ricorreva all’anello salva-gocce… Superato: i designers hanno inventato il drop-stop, un dischetto in sottile lamina d’acciaio da arrotolare a cilindro e infilare nel collo della bottiglia. Lo riconosco: è efficacissimo. Proseguiamo? Per chiudere le bottiglie più preziose, è stato inventato uno stravagante tappo con la combinazione, mentre ben più utile è la pompetta aspirante che serve a togliere una parte dell’aria nella bottiglia aperta. In questo modo, si evita che il vino rimasto perda profumi e si mantiene integra la sua qualità almeno per qualche giorno. Anche il decanter è ricorrente oggetto di restyling. Il problema è che il design quasi mai rispetta le esigenze funzionali (come e in che misura ossigenare i grandi vini invecchiati), ma piuttosto insegue il desiderio di impreziosire ulteriormente tavole già importanti. Il vero accessorio-principe del vino, però, ormai trasformato in oggetto di culto, è senza dubbio il bicchiere. Intorno ai requisiti fondamentali — la forma a calice, la CALICE MERAVIGLIA Nella foto, il Calice trasparenza incolore — le dimenMeraviglia: un nuovo sioni si sono diversificate e amtipo di bicchiere che, pliate. Sono d’accordo con questa grazie all’anello tendenza, perché annusando si interno, promette portano via molecole di profumo, di non disperdere e se la quantità di liquido conteil profumo del vino nuta nel bicchiere è scarsa, dopo qualche “usmata” i sentori importanti tendono a scomparire. A proposito di profumi: qualche tempo fa, ho deciso di misurare il flusso dei profumi con uno strumento molto sofisticato, il gascromatografo. Risultato: dalla superficie del vino escono per prime le molecole più piccole, che hanno profumo di caramella, fiori, ananas, subito inseguite dal profumo di rosa e di scorza d’arancia. Per ultimi, escono i norisoprenoidi, cioè le molecole che caratterizzano il profumo delle varietà importanti (soprattutto violetta e frutta secca). Il flusso diventa una spirale di molecole profumate che si raggomitola su se stessa: una parte rientra nel liquido, ma il resto, scorrendo lungo la parete del bicchiere, scappa fuori, rovinando una parte dell’emozione. Ho provato allora a inserire un “anello di Saturno” (una specie di semicerchio concavo) a metà del bicchiere, e ho riscontrato che il rincorrersi di queste centinaia di molecole si concentra nel mezzo dello spazio interno al bicchiere, permettendo di annusarle con maggior facilità. Da questo gioco-studio è nato il mio Calice Meraviglia. L’autore è enologo e creatore di bicchieri da degustazione S ORIGINALE AL QUADRATO La scelta più ovvia, quella dei bicchieri in vetro, senza stelo, (sopra) diventa non banale in questo caso: quadrangolari invece che rotondi, small oppure large CON DOLCEZZA, UN COCKTAIL IN OTTO COLORI A destra, i bicchieri di D-Cube per cocktail possono essere impreziositi da una scelta particolare: lo zucchero intorno al bordo in versione a colori, invece che banalmente bianco. Le buste monoporzione sono in otto tinte diverse DOPPIA LEVA COME PER L’ORO NERO PERFETTAMENTE VERTICALE FASCINO DELLA MATURITÀ Wine & Bar di Pedrini è un cavatappi professionale a spirale con doppia leva. Corpo in argento e metallo cromato La struttura rigidamente verticale di questo cavatappi cromato di Blomus rievoca le colonne di estrazione petrolifera Il cavatappi Brucart consente l’estrazione verticale del tappo anche se la forza si applica lateralmente. Di Pulltex Brevettato oltre 25 anni fa, Leverpull di Screwpull, marchio cult di cavatappi e accessori per il vino, conserva un fascino intatto 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 13 MARZO 2005 l’incontro Ai confini della giustizia Da giovane sosteneva l’accusa nei processi americani che siamo abituati a vedere nei film. Oggi è un celebre avvocato penalista di Chicago e l’autore di “legal thriller” di successo mondiale. In tutti questi ruoli si è trovato faccia a faccia con la teoriae la pratica della pena di morte, ha conosciuto la voglia di vendetta e il morso del dubbio, ha cambiato più volte idea per approdare a una convinzione: mandare al patibolo un uomo è un terribile errore Scott Turow tore della pena di morte. Ryan, colpito dai troppi errori giudiziari scoperti troppo tardi grazie al Dna, istituì una commissione di esperti e scioccò l’America “perdonando” 164 detenuti del braccio della morte l’ultimo giorno prima di abbandonare l’incarico (uno dei “perdonati” era un serial killer di bambini). «Sono stati due anni di lavoro straordinari, con uomini straordinari sia favorevoli che contrari alle pena di morte. Ho capito che mi ero sempre posto la domanda sbagliata. Di fronte alla pena di morte io mi chiedevo: è questo un caso in cui riconosco il bisogno morale ed emotivo per una esecuzione? E la risposta talvolta era sì. La domanda giusta da farsi era invece un’altra. Visto che questi casi ci sono, siamo in grado noi di mettere in piedi un sistema legale che arrivi a punire i colpevoli, e solo loro, con assoluta certezza? E la risposta è no». Scott Turow beve un altro sorso d’acqua, torna sulle differenze tra Stati Uniti ed Europa — «sono convinto che da voi intellettuali e politici sulla pena di morte sono più avanti della grande mas- La prima cosa che è difficile far capire a voi italiani è che la nostra società è molto più violenta della vostra: qui gli omicidi sono quattro volte più numerosi FOTO CORBIS «S CHICAGO e sono contro la pena di morte? Posso dire di sì, ma è una risposta troppo facile. Nel corso della mia vita sono stato a favore e contro, ne capisco le ragioni e ne combatto gli errori e gli orrori, credo che ci siano casi in cui qualcuno la morte la meriti ma ritengo il nostro sistema sbagliato». Anche per un “liberal’agnostico” come Scott Turow — «no, non sono religioso» — se si affronta un tema delicato come quello della pena di morte occorre fare attenzione a non cadere nei luoghi comuni cari all’intellighenzia europea. Il famoso scrittore (i suoi romanzi sono best-sellers venduti in tutto il mondo) che ha inventato un nuovo genere di giallo, portando nel mondo della fiction la sua esperienza personale dove i codici della legge si incrociano e si scontrano con la realtà più dura, mi riceve con un sorriso aperto e una stretta di mano calorosa al settantasettesimo piano della Sears Tower, l’edificio più alto d’America che domina Chicago. «La prima cosa che è difficile far capire a voi europei è che noi siamo una società molto più violenta della vostra. Negli Stati Uniti il numero degli omicidi è tre volte e mezzo quello dei paesi dell’Unione Europea e, se prendiamo a paragone il vostro paese, quattro volte quelli dell’Italia». Scott Turow si interrompe un attimo, si versa un bicchiere d’acqua, scherza sul nome della saletta in cui ci troviamo (San Francisco) «la città più tollerante del mondo» e ammette: «Non posso negare che in parte siamo noi stessi responsabili di questa violenza, perché la tolleriamo, perché permettiamo la libera vendita delle armi anche nei supermercati». «Cosa ci divide dall’Europa? Oltre al fatto di essere una società più violenta ci sono anche delle ragioni storiche. Il nostro rapporto con la democrazia è molto efficiente, la stabilità della democra- zia americana è veramente notevole. Le faccio solo un esempio. Negli ultimi sei anni abbiamo avuto l’impeachment di un presidente, il suo successore che è stato eletto praticamente dalla Corte Suprema e l’attentato terroristico più grande della storia con migliaia di morti civili a New York e nella capitale del paese. Con tutto questo lei non ha visto l’esercito per le strade neanche per un giorno. In Europa ci sono stati Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, si è combattuta la più sanguinosa guerra della storia, le democrazie sono state usate e ribaltate, voi avete provato sulla vostra pelle come un governo può decidere di prendersi la vita dei propri cittadini per motivi politici. Per l’Europa è più facile accettare la mediazione politica, ed è anche più comprensibile che dopo gli orrori della seconda guerra mondiale la pena di morte venga vista come una barbarie». Gli uffici di “Sonnenschein, Nath & Rosenthal” occupano tre interi piani della Sears Tower. Familiarmente abbreviati in “SN&R” sono una “law firm”, uno studio legale, che è una vera potenza, con agenzie e soci diffusi lungo le due coste degli Stati Uniti, con decine di avvocati di chiara fama, centinaia di paralegali, migliaia di impiegati. Un vero e proprio “esercito giuridico” che ogni giorno affronta, si confronta e si scontra con uno dei più complicati (nella sua semplicità) sistemi giudiziari esistenti. Nella sua vita reale, quella di “criminal lawyer” — la fama e il successo non hanno convinto Scott ad abbandonare la professione — lo scrittore si è trovato ad affrontare il problema “pena di morte” per più di dieci anni, e alla fine ha scritto un libro (non di fiction ma avvincente come un romanzo: Punizione suprema, pubblicato da Mondadori e tornato in libreria proprio in questi giorni) per raccontare la sua esperienza, da giovane procuratore a grande avvocato difensore, e per spiegare come il suo punto di vista sull’argomento si sia evoluto nel corso degli anni. «Guardi, sulla pena di morte io non critico la posizione di nessuno perchè le ho sostenute tutte e due. Ho iniziato, un po’ come un “figlio dei fiori degli anni Sessanta” dicendo che era una barbarie, poi sono andato alla “law school”, sono diventato un procuratore e ho potuto capire meglio la razionalità della pena di morte. Poi sono diventato un avvocato difensore. Ho visto il sistema da un altro punto di vista e ho capito che era sbagliato, ho visto persone innocenti condannate a morte, ho visto giustiziare gente che era sicuramente colpevole ma che non aveva commesso crimini così efferati da meritarla. Poi come membro della “commissione Ryan” ho avuto l’opportunità di studiarla a fondo, di vederne sistematicamente pregi e difetti». La “commissione Ryan” prende il nome dall’ex governatore repubblicano dell’Illinois, un tempo grande sosteni- sa» — ed esclude che l’abolizione dipenda da un problema religioso e dalla grande forza della Chiesa cattolica: «Il cattolicesimo non spiega l’abolizione della pena di morte nel Regno Unito, in Germania o nei paesi del nord-Europa. É ovvio che l’influenza cattolica gioca un ruolo in Italia, però la Francia è stato l’ultimo paese europeo ad abolirla. Potrei dire che la religione ha giocato un ruolo più importante in America, anche se di segno opposto. Non bisogna dimenticare che questo è un paese che è stato fondato da fondamentalisti religiosi e i nostri padri fondatori credevano nella legge “occhio per occhio”, “vita per vita”. La vendetta, la rappresaglia fanno parte della nostra storia e della nostra cultura, noi siamo un mondo che vede tutto bianco o nero». Uno dei punti che gli sta più a cuore è quello razziale. «Vede, il 55 per cento degli omicidi in America è commesso da afroamericani, che sono solo il 12 per cento della popolazione, per cui non possiamo affrontare la pena di morte se non capiamo che è inevitabilmente legato con un problema razziale. E non si tratta del fatto che sono condannati soprattutto i neri, perché anche la grande maggioranza delle vittime è nera. Il problema è che loro nascono e vivono in un ambiente più violento e noi, tutti, siamo portati a proteggere più i “buoni” che i “cattivi”. Le faccio un esempio banale. Mi sono imbattuto in passato in due casi identici, due donne trovate morte con la gola tagliata dopo essere state violentate. La prima era una prostituta, la seconda una madre di famiglia, con tre figli. Non ci vuole molta fantasia per capire in quale caso la giuria ha voluto la pena di morte. É normale che sia così. I poliziotti, i procuratori, i giudici ragionano tutti allo stesso modo dei giurati. Ho fatto un esempio in cui la razza non c’entra nulla, un caso in cui i giurati si sarebbero comportati nello stesso modo anche se la vittima fosse stata nera». Lavorando alla “commissione Ryan” lo scrittore e gli altri esperti sono «rimasti colpiti dall’imparare quanto arbitrario il processo possa essere». La logica è spesso ignorata e in molti casi il diritto dei familiari delle vittime supera il diritto degli imputati, «e ricordiamoci che l’imputato è spesso è il primo sospetto a capitare sotto mano». Un altro dei punti che divide l’Europa dagli Stati Uniti — «sulla pena di morte siamo divisi più che sull’Iraq», sorride Turow — è proprio il ruolo che hanno i familiari delle vittime. In molti casi il loro “point of view” conta per i giurati più delle prove portate in tribunale, e la possibilità di alleviare la pena dei familiari facendoli assistere all’esecuzione di chi ha ucciso un loro caro induce la giuria ad essere più dura. «Non c’è nessuno studio che provi che i familiari delle vittime stiano meglio dopo una esecuzione. Lo si suppone, ma non è provato. Ci sono anche un paio di libri che dicono il contrario, ma anche questi sono di parte perché chi li ha scritti si dichiara pubblicamente contro la pena di morte. Io credo che per qualche famiglia un senso di sollievo ci sia e non è solo vendetta, il volere che l’assassino soffra quanto ha sofferto il loro figlio. É che l’esecuzione pone fine a una cosa che li rende pazzi e cioè il fatto che la loro figlia è morta e il killer è ancora vivo. Questo fa parte di un principio giuridico che esiste anche in Europa, chi ha commesso un reato non deve stare meglio di chi lo ha subito. Se ci rubano 500 dollari la prima cosa che vogliano è che ce li restituiscano. Il fatto che l’assassino resti in vita è un problema reale». Quello dei familiari non è però un ruolo così decisivo: «Se fosse per loro dovremmo condannare tutti a morte, invece in America finisce nel braccio della morte un assassino ogni cinquanta. E poi quando la gente dice “quello merita la morte” in realtà vuole dire che la società vuole la sua vendetta». Il primo impatto giuridico con la pena di morte Scott Turow lo ha avuto quando era un giovane procuratore «e mi domandavo se sarei stato capace di chiedere a una giuria di condannare al patibolo l’essere umano che avevo lì davanti; per fortuna in otto anni non mi è mai capitato». Lo preoccupa il fatto che l’argomento resti un tabù per i politici anche se vede piccoli significativi passi in avanti: «In campagna elettorale Kerry lo ha evitato, ma lo stesso ha fatto Bush». Ma non fa mistero che in alcuni casi non avrebbe alcuna remora a pronunciare una sentenza di condanna: «Prendiamo Osama bin Laden. Non ho alcun problema all’idea di condannarlo a morte. Se venisse ucciso da un missile sparato dentro il bunker dove si nasconde, nessuno avrebbe da obiettare. Non dobbiamo essere ipocriti, lo si potrebbe condannare a morte anche in tribunale». Dopo un’ora e mezzo di intervista sarebbe ancora difficile collocare lo scrittore-avvocato tra i paladini dell’abolizione della pena di morte (e tantomeno tra i suoi sostenitori). In una sola parola, è contrario alla pena di morte? «Se ha capito il senso di tutto quello che le ho detto, allora potrei dire sì, diciamo di sì». ‘‘ ALBERTO FLORES D’ARCAIS
Scarica