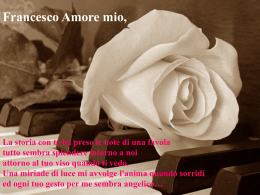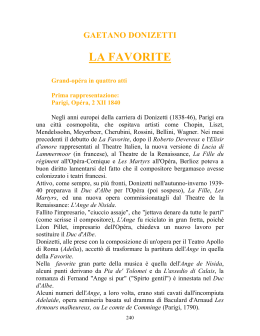Andrea Bertozzi CONDOMINIO MARRAKESH A Morena PRIMA PARTE Capitolo 1 Mercoledì 15 febbraio Ottanta scalini senza ascensore. Dal terrazzino la vista coglie un campo sul quale già hanno iniziato a tracciare le linee di demarcazione per nuovi edifici, poi una strada trafficata e più in là la ferrovia. Oltre, ancora case su case accatastate e allineate in ordine barbarico e sullo sfondo, quasi invisibile, il mare. «Le piace?» mi chiede distratta la portinaia. Se non rispondo non è per scortesia, è che sono impegnato a scovare tracce negli angoli nascosti, so infatti per esperienza che è lì che bisogna ficcanasare. E intendiamoci, non è che non abbia l’intenzione di affittare l’appartamento, no di certo, a queste condizioni non potrei trovare di meglio, ma si sa come sono gli amministratori di condominio: bravi venditori di fumo capaci di magnificare ogni più banale ovvietà, omettendo le cose veramente importanti. E poi, non tutto può essere detto. «Insomma, è interessato sì o no? Non posso mica stare qui tutto il giorno, ho altro da fare io!» protesta con aria indignata la portiera. «Beh, vede signora… signora?» «Signora Giovanna, per lei» risponde in tono di sfida. «Ecco sì, signora Giovanna, vorrei rimanere un po’ da solo, se non le spiace» dico con finta accondiscendenza. «Ah, per me…» risponde iniziando a ciabattare, strusciando esageratamente i piedi verso la porta d’ingresso. «Quando è pronto mi riporti le chiavi» aggiunge voltandosi, «tanto sono sempre in casa.» Le guardo le spalle lievemente curve, avvolte da una civettuola mantella azzurrina che mi avrebbe dovuto mettere in guardia. La sento scendere i gradini uno a uno con piccoli tonfi soffocati e sbattere con forza la porta. Poi silenzio. Vago 5 per le stanze vuote annusando un lontano sentore di muffa. Ecco vedi, mi dico. Infine mi abbandono su un letto, una specie di branda che il vecchio proprietario ha dimenticato nella camera di mezzo. Quella per gli ospiti, suppongo. Se mi lascio andare è certo che mi addormento, ma il desiderio di distendere i nervi è tanto e non resisto. D’altra parte, negli ultimi tempi, arrendermi al sonno è divenuto un esercizio complicato che mi costa una certa fatica, ma non in quella nuda bomboniera punteggiata dai segni di quadri rimossi. Non in quel letto che pende da un lato, non con lo sguardo rivolto al soffitto sul quale s’intrecciano le pennellate sbilenche di un’imbiancatura frettolosa. Il sonno viene leggero, in punta di piedi, donandomi preziosi attimi di sollievo, e così mi addormento. Mi è difficile dire se il sonno si impasta con la realtà o viceversa, e poi è troppo tempo che non rammento più i sogni per essere realmente capace di distinguerli e sezionarli a dovere. Mi sono risvegliato in preda alla mia cronica fame d’aria sbattendo la testa contro la parete vicina, mentre i polmoni raschiano sbuffando, cercando ossigeno, cercando di respirare. Seduto sul letto spalanco la bocca nel tentativo di ridurre il rantolo. Come sempre, dopo un po’ mi calmo e il cuore riprende il solito battere lento. La gola brucia, gli occhi lacrimano. Trascino la mano sudata sui capelli, che adesso porto corti. Dalla finestra distinguo un barbaglio di sole che si distilla sgocciolando sui fili della luce. «È ancora troppo presto» dico ad alta voce. Ci vuole tempo. Poi la musica inonda le stanze, sommergendole di note. Un pianoforte. Da un appartamento è difficile distinguere la provenienza dei suoni, così mi sposto da una stanza all’altra per cercarne l’origine. In cucina lascio scorrere l’acqua sul lavello smaltato, nel 6 bicchiere sono visibili minuscole particelle di calcare. Bevo tutto d’un fiato. Ed è da lì, dalla cucina, che il suono arriva più forte. Perplesso, penso alla bizzarria del caso. Gli appartamenti sono tre per piano, tutti uguali, tutti banalmente identici. Come è possibile che il musicista abbia piazzato il pianoforte tra pentole e acquaio? Sarebbe ben strano. Mi siedo sull’unica sedia impagliata con il bicchiere in mano e rimango in ascolto, cercando d’immaginarmi un volto appeso a un corpo che batte incessante sulle tastiere, ma l’immaginazione scarseggia e mi scopro indeciso tra uomo e donna, tra giovane e vecchio, tra ricco e povero, tra sano e malato. Inseguo le note cercando un indizio con il bicchiere oramai vuoto in una mano e l’altra che lascia segni indelebili come ombre nell’aria. Uomo, decido: quando i bassi si fanno prepotenti, assillanti. Donna, rettifico: quando gli acuti spiccano bucando come spilli il pavimento. Musica che s’interrompe improvvisamente sgranando, poi il tack del legno che rinchiude i tasti e il fievole movimento di passi che si allontanano. Resto lì, immobile, con la mano ancora sospesa nell’aria. È passato più tempo del previsto e devo andare. Quando mi chiudo la porta alle spalle, lo sguardo cade sulla targhetta dell’uscio accanto: sono gli ultimi due alloggi, poi il tetto. Mi avvicino incuriosito, dall’interno non percepisco alcun rumore. Sulla targhetta c’è un nome straniero, arabo direi. Mi accosto. Niente, o quasi niente, solo un soffiare smorzato come il verso di un’anatra muta, ma più impercettibile e graffiato. Mi volto e mi avvio, quasi di corsa, colto all’improvviso dal timore che qualcuno mi sorprenda in quella posa imbarazzante. Due a due gli scalini. 7 Al secondo piano rallento. Mi fermo. Ecco l’appartamento sul cui proprietario ho fantasticato. Accosto l’orecchio. I passi sono brevi, felpati; poi frettolosi. Rumore di stoviglie e d’acqua che cade a cascata. Si sta preparando un tè o forse un caffè, azzardo, e giurerei di sentire il crepitare del gas che da fiamma gialla si fa azzurra. I passi si allontanano lasciando una scia di vuoto opaco poi, improvvisamente, sono quasi un galoppo e si avvicinano. Mi pare di avere percepito un respiro al di là del legno, e naturalmente anche il mio ansimare non è passato inosservato. «Signor… signor non-so-come-si-chiama, cosa sta facendo?» All’improvviso la portiera è lì, che si sporge dal piano terra con gli occhi sgranati e indagatori. «Scusi» mormoro confuso, staccandomi malvolentieri dall’idea stravagante che mi evoca quel guscio chiuso. «Ecco le chiavi» bisbiglio con il fiato rotto, dopo essermi precipitato giù per gli ultimi scalini e realizzando solo allora che non mi sono presentato, così cerco di rimediare stendendo una mano. Mentre sto per pronunciare il mio nome quella mi evita allungando il collo oltre la balaustra. La fisso interdetto con ancora il braccio steso, come fosse un attaccapanni. La donna mi fissa dal basso della sua statura: «Non mi importa un fico secco del suo nome» dice godendo della gratuita sgradevolezza, e aggiunge con una punta di malignità: «Allora, l’appartamento lo vuole o no?» Se fossi capace di seguire l’istinto accantonando la ragione, avrei mille motivi per rifiutare l’offerta. Ma il prezzo è buono e l’edificio, situato a due passi dal centro, è ideale per i miei affari. Tentenno divagando con l’immaginazione, che s’invola tra il soffiare rauco dell’appartamento vicino e i passi smorzati di quello sottostante. 8 Invento misteri per confondere lo squallore quotidiano, mi vien da pensare. Un sorriso un po’ ebete mi si stampa sul viso. «Beh, che ha da ridere? Si prende forse gioco di me?» protesta indignata la portiera, che con uno scatto improvviso mi sottrae le chiavi di mano. «Comunque, visto che non è interessato, arrivederci!» Volta quel grosso deretano e s’infila con sorprendente agilità in un ingresso che profuma di lavanda. «Aspetti. Lo voglio!» esclamo senza più riflettere. «Ah sì?» risponde la donna regalandomi un sorriso che non le credevo possibile. «Sì» confermo con irragionevole convinzione. «Bene, in questo caso deve recarsi nell’ufficio dell’amministratore per firmare le carte e regolare i pagamenti. Quando avrà fatto, potrà tornare a prendere le chiavi e quindi possesso dell’appartamento.» «Domani stesso» replico soggiogato da un’irrazionale euforia. «Quando vuole, tanto io sono sempre qui» ribatte in tono zuccheroso la donna, scomparendo non prima però di avermi salutato con la mano. 9 Capitolo 2 Giovedì 16 febbraio Ho fatto tutto in ventiquattro ore. Mi consegneranno i mobili entro pochi giorni. Ho preferito affittarli, non si sa mai. Con il contratto in mano mi sono diretto verso la mia nuova casa ma lungo il tragitto ho rallentato, con l’intento di godermi il tempo che scorre prima di rinchiudermi tra le quattro mura. Mi sono fermato su una panchina del parco non troppo lontano dal giardino zoologico, dal quale provengono sbadigli che sembrano ruggiti. Ci sono rimasto a lungo, fin quasi a mezzogiorno, fissando senza alcun motivo i corpi dei passanti, intenti a inseguire inconsapevolmente il capriccio del destino. È ora di andare, mi sono detto infine, battendomi le palme delle mani sulle gambe e alzandomi deciso. La città a quell’ora cammina di sbieco, seguendo un tormentato percorso che sembra condurre tutti nella stessa voragine. I rumori si fanno assordanti, gonfi di inutili miasmi, i clacson rimbalzano graffiando penosi in un vortice di suoni fastidiosi e assillanti, il puzzo dei tubi di scappamento ammorba le narici. Non ho mai preso la patente e visto la natura dei miei affari ciò potrebbe apparire alquanto grottesco. In ogni caso, riesco a essere sempre puntuale ai miei appuntamenti. Forse sarà per quell’innato senso di responsabilità che mi è stato inculcato fin dall’infanzia; forse per la mia natura crepuscolare e solitaria, che tende a primeggiare senza fare sconti a nessuno. Negli ultimi tempi i miei soci mi chiamavano “il fantasma”, per questa mia capacità di comparire all’improvviso sbucando dal nulla. 10 L’ho vista uscire dal palazzo, così mi sono nascosto dietro un furgone parcheggiato sul lato della strada e l’ho seguita. Sono sempre in casa, aveva detto. Prima bugia. E poi quell’improvviso cambio di tono. Certo, avrà i suoi interessi quando fa da mediatrice in qualche transazione economica, eppure qualcosa mi sfugge, qualcosa mi manca. Cammino sul lato opposto della strada, così da vederla comparire e scomparire coperta dal traffico e dai mezzi parcheggiati. Ondeggia sui fianchi larghi in contrappeso coi grossi seni, che immagino simili a due enormi pere mature sorrette da un reggiseno extralarge di quelli rinforzati. Porta a tracolla una borsetta nera di finta pelle, tenuta ben stretta sul fianco come una fondina senza pistola, rivelando così un’anima sospettosa. Svolta a sinistra ticchettando sui tacchi che non la slanciano, anzi ne mettono in evidenza la bassa e tarchiata figura. S’infila in una tabaccheria e ne emerge subito dopo scartando il pacchetto di sigarette del quale getta, con colpevole noncuranza, la carta dorata per terra. Si accende una sigaretta aspirando con voluttà ampie boccate di fumo, ferma nel bel mezzo del marciapiede. Dalla mia postazione, incuneata tra due grossi fuoristrada, riesco a scorgere le labbra dipinte di un rosso vivace sporgersi vogliose e quasi voraci, nell’inghiottire il piccolo cilindro di carta. Sembra un’altra persona rispetto alla scialba portinaia conosciuta il giorno prima. Chissà quanti anni ha, mi chiedo, considerando che solo ieri gliene avrei dati almeno sessanta e oggi quarantacinque, forse cinquanta. Non saprei. Si rimette in marcia con l’aria di voler mostrare ai passanti il corto vestito nero e il collo avvolto da una pelliccetta ingrigita. Il mercato coperto spunta con il suo tetto spiovente tra gli ombrelloni dei venditori ambulanti. È alto, elegante, riverniciato di fresco. Adesso la seguo confondendomi tra gambe, braccia e corpi protesi a comprare o vendere. Ci immergiamo vicini, ma di11 stanti, in una babele di suoni, odori, colori. Qualcuno vende spezie che hanno l’aria impolverata di vecchi pigmenti per dipingere vasi in ceramica. Più in là un fruttivendolo ha allineato, formando piccole montagnole, ortaggi e frutta. Quasi accostati tra loro, un rosticciere fa ruotare la griglia su cui arrostiscono polli dorati e un pescivendolo infila le mani inguantate in vasche colme di cozze e vongole; poi, con maestria, sfiletta un nasello dalla pelle lucida per una signora con la borsetta di vernice rossa. Le voci ci sommergono intrecciandosi in cantilene antiche, in linguaggi sconosciuti che spillano da bocche i cui denti sanno d’avorio; da labbra che emergono su volti emaciati; da lingue che arrovellano e arrotondano parole mancanti al nostro sorpassato dialetto. La donna è scomparsa. L’ho perduta per colpa del mio più grande difetto: l’attenzione al più insignificante dettaglio, che sconfina in disattenzione per l’obiettivo. Non riesco proprio a imparare, maledizione. Torno sui miei passi. La sirena della grande fabbrica ha lanciato il suo lugubre richiamo. È l’una dopo pranzo e gli operai si accalcano con i cartellini in mano davanti all’orologio che scandisce il tempo da dedicare al padrone. È un tempo rubato al sole e alla pioggia, è un tempo rapinato alle gite sui prati, alle passeggiate coi figli o sottobraccio all’amata, ma gli operai sono uccelli a cui hanno strappato le ali e non sanno più volare o peggio, nemmeno più si ricordano l’ebbrezza del volo. Del resto che diritto ho io di giudicare, io che faccio quello che faccio, io che posso permettermi di oziare inseguendo fantasie. Mi infilo in una rosticceria e ordino un fritto di pesce con le patatine. Mi vengono servite dentro un cono di carta gialla, ci bevo sopra un vinello bianco frizzante, troppo friz12 zante. Gli anelli di totano sbucano bianchi tra l’impanatura bruciata insieme ai gamberi con le antenne spezzate. Seduto al tavolo di fronte al mio, un uomo con una folta barba bianca mi osserva con insistenza. Per un po’ fingo d’ignorarlo, fissando la tivù posizionata in alto, sopra le teste; le parole del giornalista fuggono via come acqua su pietre lisce, si dissolvono in pietose bugie tra il brusio dei commensali. L’uomo si alza e si avvicina al mio tavolo. Si ferma. «Buonasera» dice. «Buonasera» rispondo con forzata cortesia. «Scusi se la disturbo, ma per caso lei è il nuovo inquilino del Condominio Marrakesh?» «Come?» «Sì, il condominio qui vicino» insiste l’uomo mettendosi seduto al mio fianco. «Come ha chiamato il condominio?» «Marrakesh! Non lo sapeva?» «No.» «Beh, adesso lo sa. Ah, scusi, non mi sono nemmeno presentato. Il mio nome è Fernand De Pleussy e abito al primo piano del condominio, sul lato sinistro, proprio come lei.» Mi porge la mano sudata dopo aver arrotato ben bene l’unica erre che contiene il suo nome. Gliela stringo con artefatta cordialità, presentandomi a mia volta. «Posso offrire qualcosa?» chiede poi, piantandomi addosso due pupille ingrandite da spesse lenti racchiuse in un’oscena montatura violacea. «Un caffè, grazie» rispondo disinvolto, pensando che forse quest’uomo mi possa tornare utile. «Due caffè e una grappa, Carlo» ordina rivolto al bancone. Beviamo in silenzio facendo tintinnare le tazzine. «Come fa a sapere che sono il nuovo inquilino?» chiedo, mentre l’uomo si gusta il bicchiere di liquore. «La finestra» risponde disegnando un rettangolo in aria con l’indice. «Passo molto del mio tempo davanti alla finestra» 13 aggiunge in tono confidenziale. «Capisco» commento senza perdere di vista l’ossessiva motilità dei suoi occhi. «Bene» dice l’uomo alzandosi in piedi e divenendo all’improvviso frettoloso. «Naturalmente l’aspetto a casa mia quando vuole. Le voglio fare assaggiare un liquorino al mirtillo che… ma sentirà.» «Certo» rispondo in tono compiacente. «Ma senta un po’, la signora della portineria…» Si rimette immediatamente seduto, fissandomi attento. «Sì?» «È che mi pare un po’ strana. Oggi l’ho vista girare per la città e quasi stentavo a riconoscerla, truccata e vestita com’era.» L’uomo prima mi fissa incredulo, poi ride di gusto. «Chi? La Giove?» «Giove?» L’uomo è tornato serio e si avvicina conciliante. «Scusi per la risata, ma non è proprio possibile.» «Perché?» «Ma perché la Giove non esce mai, se ne sta rintanata nella sua casetta sorbendosi ogni poltiglia televisiva e bevendo tazze colme di cioccolata. In tanti anni non l’ho mai vista né truccata né vestita elegantemente.» «Guardi che sono sicuro e anzi, aggiungo che l’ho vista fumare.» De Pleussy spalanca ancora di più gli occhi e inizia a scuotere la testa: «No, mi creda, lei ha avuto un abbaglio scambiandola per qualcun’altra.» «Sarà» ammetto io. «Ma com’è che l’ha chiamata? Giove?» «Ah sì, è il suo soprannome, però non la chiami così finché lei non glielo permette. E questo avverrà, se avverrà, solo dopo che l’avrà invitata a casa sua a bere della cioccolata. In caso contrario eviti, se non vuole vederla andare su tutte le 14 furie: le assicuro che non è un bello spettacolo. Poi, vede, lei non è una vera portinaia.» «Ah no?» «No. Ha un accordo con l’amministratore, che le permette di abitare gratis nell’unico appartamento del pianoterra e di non pagare utenza in cambio di una sorta di portierato che, come di certo avrà intuito, svolge a modo suo. Nella sostanza, lei è un’inquilina come tutti noi.» «Capisco» ripeto per la seconda volta. «Allora… arrivederci» si congeda l’uomo. «Un’ultima domanda. Chi abita sotto il mio appartamento? Ho sentito una musica.» «Beh, non saprei, io devo… devo andare» dice improvvisamente l’uomo, irrigidendosi e facendosi serio. «Devo proprio andare» ripete avviandosi verso l’uscita, e dopo aver calcato in testa un cappello di stoffa che teneva nascosto nella tasca della giacca, apre la porta. Poi, come colto da un’idea improvvisa, si volta e dice qualcosa. Qualcosa che viene soffocato dal soffio di vapore della macchina del caffè. Alla fine scompare inghiottito da una folla di passanti frettolosi. Quel fritto maledetto mi balla sullo stomaco, perciò mi metto a camminare a passo veloce sperando di lenire il fastidioso gonfiore. In men che non si dica sono di nuovo davanti al palazzo e giuro, non ne avevo l’intenzione; pensavo di andarci più tardi, con calma. Invece eccomi qui, come una falena attratta dalla luce. Passeggio avanti e indietro senza convincermi a entrare. Un mendicante se ne sta seduto proprio all’angolo della strada. C’è un cane con lui, è di pelo rossiccio e guarda tutti con occhi imploranti, così mi vien fatto di pensare che i pochi spiccioli racimolati sono dovuti più alla pietà ispirata dal cane che a quella suscitata dall’uomo. Strani animali, gli esseri umani. 15 Entro. Ed eccola lì, ferma davanti alla prima rampa di scale: una Erinni pronta ad aggredirmi con urla disumane. «Buonasera» mi saluta invece con tono neutro, e lo sguardo di chi cerca di capire i pensieri che hai in testa. «‘Sera» rispondo confuso dalle mie stesse fantasie. Poi rimaniamo lì, in attesa che l’altro dica qualcosa. «Ho il contratto» spiego fingendo distacco. «Ah sì?» «Le chiavi…» Scompare nella fessura del suo appartamento, mentre io cerco inutilmente di rubare una qualche immagine della casa. «Eccole» mi informa sventolandomele sul naso. «Ma prima voglio vedere.» Indica il foglio che tengo piegato in una mano. Glielo porgo, lei lo afferra e attacca a leggere con attenzione finanche eccessiva. «Bene, tutto a posto» esclama dopo aver ripiegato il foglio. E mi allunga il mazzo. Prima che volti di nuovo le spalle e scompaia nella fessura, le chiedo a bruciapelo: «Mi offre una sigaretta?» «Cosa?» «Una sigaretta.» Mi guarda con aria disgustata. «Io non fumo.» «Credevo…» «Beh, credeva male. E adesso sloggi.» Strano, di solito non mi faccio mettere sotto da nessuno, ma stavolta non trovo le parole per ribattere e annaspo con la mano sulla ringhiera. «A proposito» aggiunge la donna frenando la mia fuga. «Hanno portato dei bagagli per lei dall’albergo. Perché lei abitava in un albergo, vero?» Non è una domanda, è un’accusa. Punto sul vivo riprendo coraggio e rispondo altezzoso: «Sì, certo. E allora?» «Allora se la porti via, la sua roba. E poi… così, solo per 16 curiosità: ma lei che lavora fa?» Non mi aspettavo una domanda del genere perciò rimango indeciso. «Io in realtà sarei un artista.» È la prima risposta che mi viene in mente. «Ah sì? E che genere di artista?» «Beh, così su due piedi è difficile da spiegare. Vede, raccolgo oggetti e informazioni e…» «Lasci stare. Per carità, conosco il tipo. Siete tutti dei perdigiorno senza il becco di un quattrino» replica in tono sprezzante. «Ma no, non dica così. Nel mio caso…» «Basta, non voglio sapere altro» conferma con un gesto della mano, e in un baleno scompare nel suo pertugio. Mi sono fatto gli ottanta scalini con i bagagli che man mano andavano aumentando di peso, e una rabbia sorda per quella donna che mi sbeffeggiava senza che riuscissi a trovare risposte adeguate. Ho volutamente ignorato l’appartamento del secondo piano e ansimando mi sono appoggiato allo stipite del mio alloggio. Sono entrato scorgendo con la coda dell’occhio una bambina di forse otto anni che mi fissava dall’appartamento vicino. «Ciao» mi dice dondolandosi. «Ciao» rispondo alzando una mano. Poi scompare ingoiata dal vuoto che di certo si cela dietro ogni porta di quel condominio. La casa ora mi appare ancora più vuota, ma non per la mancanza di mobili, è che la sento denudata da ogni parvenza di umanità, un’imbarazzante sequenza di muri sui quali non è rimasto appiccicato niente, nemmeno un ricordo, nemmeno una speranza. Il miscelatore del bagno sgocciola e lo specchio, bollato da innumerevoli macchie giallastre, mi rimanda un’immagine di me stesso che non riconosco, che non riconosco più; il 17 vecchio inquilino non si è disturbato a staccarlo dal muro e ha lasciato lunghe striature sulla vasca da bagno. Rimango a lungo seduto sulla tazza del cesso con le mani sul viso, inorridito come ogni volta dal trascorrere della notte. Dopo quel pranzo strappastomaco ho deciso di rimanere a digiuno per la cena. Ci fosse una bustina di tè, mi dico speranzoso rovistando nell’unico mobiletto, che funge anche da scolapiatti sopra il lavello. È sporco e vuoto, ma non del tutto. Sul fondo intravedo grumi di zucchero e forse pepe, un paio di biscotti. «Ottima cena» dico ad alta voce, intingendo una galletta impolverata in un bicchiere d’acqua calda, mentre me ne sto seduto sulla sedia sfondata, trafitto da una lama di luna che è riuscita a insinuarsi tra i buchi dell’avvolgibile. Ho passato così la prima metà della notte, assopendomi e risvegliandomi, indolenzito dalla rigidità dell’impagliatura e dalla durezza del legno. Poi, finalmente, mi sono deciso e ho devoluto l’altra metà della notte all’abbraccio del materasso sfiancato. Ho dormito. Senza sogni, senza apnee, senza rimorsi, avvolto dalla musica che mi si attorciglia addosso come un’onda insinuante. Finalmente ho dormito. 18 Capitolo 3 Venerdì 17 febbraio Venerdì è il giorno del mercato antiquario. Una pioggerellina densa e appiccicosa mi dà il benvenuto appena mi affaccio sulla strada. Non ho l’ombrello. Odio gli ombrelli. Un venditore ambulante cerca in tutti modi di appiopparmene uno e mi insegue insistente; i miei no svaniscono al contatto con i suoi occhi sorridenti e s’annullano tra i denti perfetti che spiccano sulla pelle levigata. Lui ora conta i soldi soddisfatto. Io mi allontano brandendo l’ombrello chiuso quasi fosse l’asta di una bandiera ripiegata poi, come un fioretto, lo infilo nel fodero di un portarifiuti e me ne vado. I banchi sono ancora semichiusi, avvolti nei verdi teli cerati. Si aprono gli ombrelloni. Non sarà questa misera pisciatina celeste a spaventare quei gatti di strada, quegli impavidi venditori di sogni e illusioni. Mi infilo in un bar-pasticceria, uno di quelli che ha le sedie ben foderate e le sfoggia al di là della vetrina e fuori, sotto i portici, ben protette dal vento. Ordino un cappuccino e una brioche. È ancora calda mentre la immergo nel liquido schiumoso fregandomene della buona creanza. Finalmente sazio mi immergo lungo le strade vocianti. Il cielo è divenuto una massa compatta e minacciosa di nuvole, ma almeno ha smesso di piovere. Il passato, rovistato e compresso, si vende sui tavolati malmessi. Non nascondo di emozionarmi quando sfioro oggetti toccati da altre dita, ne posso sentire le vibrazioni, immaginare stanze rischiarate da candelabri d’ottone dove piccole statue fissano, con occhi ciechi, mobili nei quali sono state 19 depositate innumerevoli vite. Non compro mai niente, assaporo soltanto. Nei molti alloggi dove ho vissuto l’essenziale ha sempre dominato. D’altra parte non potrei sostenere a lungo i bisbigli, le voci, i canti e le misere paure che esalano da quegli oggetti, che mi assillano le notti e mi perseguitano i giorni. No, è di natura professionale il mio interesse, penso poco convinto. Volti, facce, occhi, nasi e bocche sconosciuti m’incrociano, mi evitano, mi spingono, mi fissano. Qualche banco più in là un volto noto emerge dall’anonimato. Il signor de Pleussy sta discutendo animatamente con un venditore, quindi prende in mano un cannocchiale e se lo gira tra le dita. Sembra voglia trattare sul prezzo. Il commerciante scuote la testa e gli mostra un telescopio. Adesso è il de Pleussy che scuote la testa e nel farlo si volta verso di me che, lesto, fingo d’interessarmi a una ballerina di ceramica molto brutta, in tutta onestà. «Le faccio un buon prezzo» mi dice l’uomo avvolto in un eskimo che ha come bizzarra appendice una sciarpa vistosamente colorata. «Ah no, sto solo guardando» rispondo. «Vedo che anche lei si interessa di anticaglie» mi apostrofa Fernand de Pleussy, che nel frattempo si è avvicinato fingendo di non aver scorto il mio tentativo di passare inosservato. «Sì» rispondo sforzandomi di sembrare attratto dalla statuetta. «Allora gliela incarto?» insiste il venditore. «Un’altra volta» replico, cercando di sganciarmi dall’imbarazzo che mi tiene aggiogato al banco e al fianco del coinquilino. «Ma quanta fretta, aspetti che le voglio presentare un mio caro amico» dice de Pleussy afferrandomi per un braccio. Non riesco a controbattere. Resto a guardare l’inquilino del 20 primo piano che scompare tra la folla e per un attimo sono tentato di darmi alla fuga. Solo per un attimo. Poi eccolo di nuovo farsi largo tra cappotti abbottonati e giacche impermeabili. Si avvicina trascinandosi dietro un uomo alto, con le guance scavate e profondi occhi scuri. «Le presento il colonnello Gualtiero Altieri. Colonnello in pensione, si capisce. Abita al secondo piano sul lato destro.» Ci stringiamo la mano. La sua stretta è vigorosa, quasi violenta, così anch’io rispondo con altrettanta energia. Gli occhi dell’uomo hanno un guizzo, poi si spengono e mi fissano impauriti. «Purtroppo il colonnello è affetto dal morbo di Alzheimer. Perciò a volte c’è e altre volte invece è immerso in un mondo tutto suo» mi bisbiglia all’orecchio de Pleussy. L’uomo continua a fissarmi senza dire una parola e ora che ci penso non ho sentito uscire nemmeno una sillaba dalle sue labbra. Ma forse ha intuito qualcosa della mia vera natura, poiché solo i folli sono dotati di questa speciale capacità. Gli metto una mano sulla spalla e lui sobbalza fissandomi con vuoti occhi da ebete. «Sono venuto per comprare un cannocchiale» mi informa l’altro. «Ah sì?» «Certo, mi è necessario. È il mio occhio sul mondo e senza che il mondo mi veda» replica l’uomo con un sorriso che se non fosse punteggiato da una luce maliziosa, parrebbe disarmante. «E lei?» «Oh, io facevo solo un giro…» «E la statuetta?» «No, non credo…» Il commerciante, che già l’ha avvolta nella carta di giornale, la infila in una busta di plastica e me l’aggancia alle dita dicendo: «È sua.» Ho pagato bestemmiando in silenzio. Bestemmiandomi dentro nello scoprirmi così docile, così umanamente debole, 21 così scioccamente prevedibile. «Adesso dobbiamo andare, ma prima le comunico che è invitato ufficialmente a pranzo da me. Alle tredici, va bene?» dice de Pleussy. «Non saprei…» replico, di nuovo in preda a superstiziose reticenze. «Ma via, non si faccia pregare. Allora è deciso, alle tredici. Ci sarà anche Gualtiero. Ne avremo di cose da raccontarci…» «Va bene» cedo infine. «Perfetto! A più tardi allora» si congeda de Pleussy trascinandosi dietro il colonnello che, all’improvviso, si volta e mi guarda. Dai suoi grandi occhi scuri fugge via, per un breve istante, un lampo di comprensione. La statuetta ha avuto lo stesso destino dell’ombrello, imbucata nel primo cestino che ho incontrato. Mi immergevo nelle strette viuzze occupate dai tavolati e da gambe e braccia di manichini inconsapevoli. Il sole è riuscito a filtrare tra le nuvole. La campana dell’orologio comunale batte dodici rintocchi. Le anime lentamente si disperdono, sparpagliandosi come semi di grano che vanno cercando un luogo appartato per germogliare. Seduto sullo scomodo sgabello di un bar, sorseggio pensoso un insipido aperitivo e ingoio salatini. Una donna dai fianchi larghi e il seno prosperoso si affanna tra i tavoli, il corto grembiule le dona. Ogni volta che mi passa vicino per declamare gli ordini mi lancia uno sguardo, invitante direi. Con gli occhi perduti sull’orlo zuccherato del bicchiere, mi lascio scivolare in fantasie. Così la immagino seminuda, con i grossi seni sporgenti, appoggiata alle fredde mattonelle del bagno e la gonna nera rialzata sui glutei. Adesso la afferro e con forza, con rabbia, la penetro. La donna ansima, i seni ballano, gli occhi si appannano e riemergono mettendo a fuoco l’antipatica faccia del barista, che mi guarda con aria 22 perplessa. Faccio un gesto vago con la mano, pago e me ne vado; non prima però di aver gettato un’ultima occhiata alla cameriera, che saltella da un cliente all’altro senza lesinare sorrisi e distribuendo a tutti sguardi invitanti. Fantasie, fantasie, mi vado ripetendo, mentre chiudo anche l’ultimo bottone del cappotto. Ho continuato a vagare allontanandomi dal centro. La periferia mi scorre sotto i piedi. L’odore di cucina scivola attraverso le finestre socchiuse, cassonetti maleodoranti, marciapiedi inesistenti o sconnessi. Gatti che rincorrono topi che rincorrono i miseri resti delle pattumiere. Un olezzo incivile e vagabondo, proprio come me. «Ancora un po’ di tempo. Ho ancora bisogno di tempo» ripeto ad alta voce. E non sono fantasie queste, sono l’opprimente realtà. Il rintocco della campana batte dodici colpi pieni e uno stentato. Devo tornare, penso incamminandomi controvoglia. Ancora rimugino e farfuglio tra pensiero e parola. Forse mi possono servire, forse… Così ritorno sui miei passi ricordandomi che la notte ho dormito. Dopo tanto tempo ho dormito. Senza sentirmi morire. Senza avere paura. 23 Capitolo 4 Venerdì 17 febbraio. Pomeriggio. Il mercato è quasi svanito, lasciando in ricordo di sé solo cartacce che volteggiano al sole ritrovato e al vento lieve e sottile. Per le scale non c’è nessuno. Sopra il campanello c’è una targhetta di plastica con su scritto: “Rag. Fernand de Pleussy”. Suono, e dopo un attimo la porta si spalanca in un caldo e odoroso ritrovo per vecchi. «Buonasera signor de Pleussy, scusi se non ho portato niente ma avevo quasi dimenticato il suo invito e così…» dico con falsa aria da gesuita. «Niente signore, da ora in poi solo Fernand e… possiamo darci del tu?» «Ma certamente, è che io…» «È che tu non sai di essere appena entrato in una distilleria clandestina di alcolici, vero?» «Come?» «Vieni» decreta spingendomi in cucina. Su un tavolo appoggiato al muro c’è una lunga serpentina di vetro, terminante in un alambicco riscaldato a bagnomaria su un fornello da campo. Da un rubinetto cade qualche goccia all’interno di un contenitore. Sotto il tavolo ci sarà a occhio e croce una ventina di bottiglie. «Il mio tesoro» dice posandosi l’indice sul naso, e aggiunge ridacchiando: «Non è che per caso volevi portare altro alcool a questi due ubriaconi, eh?» Così dicendo indica se stesso e il colonnello. Gualtiero Altieri stringe un lungo mestolo di legno; in una pentola larga mescola quello che immagino essere, dato il profumo, un ragù. Poi si china spalancando il forno dal quale fuoriesce 24 un vapore denso e aromatico. Mangiamo in cucina. La pasta è buona, ricca. Fernand è ciarliero e mi racconta che da quando è andato in pensione ha pensato bene di integrare il magro reddito con quell’attività. «È per questo» racconta, «che controllo dalla finestra chi entra e chi esce.» E ride, ride versando generose quantità di vino che dobbiamo bere, tutti e tre, come buoni amici. «Cerchiamo un nuovo socio» dice a un tratto facendosi serio, nonostante il volto paonazzo riveli un eccesso di alcool in corpo. «E io ho pensato a te.» «A me? Perché proprio io? Mi conosci appena.» «Eh, amico mio! Tu non sai che io sono un grande conoscitore di uomini. Ho lavorato trenta anni per il fisco.» «E allora?» «Come allora, ma non capisci? Nella mia attività lavorativa ho avuto a che fare con migliaia di persone che grossomodo si suddividevano in tre grandi categorie: i furbi, i quasi furbi e gli onesti. Vedi, coi furbi c’è poco da fare. Sono calcolatori. Prevedono tutto e pianificano ogni loro azione. Scovarli è difficile, richiede tempo e pazienza. Poi ci sono i quasi furbi che di solito si scoprono da soli. Gli fai qualche domanda, gli fai notare le contraddizioni e in men che non si dica sono caduti nel tranello. Gli onesti, invece, sono una categoria a parte. Sono coloro che proprio non ce la fanno a barare e anche se tutte le condizioni gli sono propizie, hanno paura e rinunciano. Io non mi sbaglio mai sulle persone. Tu sei un onesto, per questo ti ho scelto.» «Bel sistema, cercate un uomo onesto per un’attività disonesta» commento. «Ma no, allora non hai capito, appartenere alla categoria degli onesti non è un pregio, anzi, potrebbe pure essere un difetto. Leale sì, se avessi usato questa parola ti darei ragione, ma non l’ho usata. E poi chi è più disonesto, io che vendo di contrabbando un liquore genuino fatto in casa o il 25 Governo che mi costringe a vivere con una pensione da fame?» Me ne resto in silenzio, poiché non so dargli torto su quest’ultima affermazione, ma in quanto alla mia onestà, se solo sapesse… Dall’altro lato del tavolo il colonnello alterna lunghi momenti in cui ha gli occhi affondati nel piatto ad altri, brevi, nei quali mi fissa senza battere ciglio. Non parla, ammicca soltanto. Fa gesti con le braccia quando Fernand chiede il suo parere. A volte sembra ridere con gli occhi, ma subito dopo la sua fatua allegria si trasforma in un ghigno dal quale potresti aspettarti qualsiasi cosa. «Allora? Che ne pensi della mia proposta? Attento, ho detto socio: tutto diviso in tre parti e a volte si riesce a guadagnare bene. Naturalmente dovrai sobbarcarti anche tu una parte delle spese, che non sono poi una gran cosa. Per te avrei pensato al ruolo di distributore, mentre io e Gualtiero produciamo. Hai la macchina?» Ho fatto fatica a non ridergli in faccia, e pur trattenendomi a stento ho trovato la forza per rispondere che no, la macchina non ce l’avevo, ma che il vero problema erano i troppi impegni. C’è rimasto male e senza fiatare mi ha indicato la finestra e poi i suoi occhi e poi me, come a dire che i miei spostamenti non gli erano sfuggiti. Il colonnello ha tagliato in fette triangolari una crostata di frutta e dopo avercela servita con piattini e cucchiaino ha fatto sentire per la prima volta la sua voce. «L’ho fatta io» ha detto con un timido sorriso. Gli avrei attribuito una voce tremolante, un timbro indeciso e invece le parole sono uscite con forza, vigorose come la stretta della sua mano. Fernand ha stappato il liquore al mirtillo che aveva promesso e ne ha versato una generosa porzione in tre bicchieri. «Sei forse preoccupato per Gualtiero?» mi ha domandato poi con aria distratta. 26 «No» ho risposto deciso, «è che davvero non posso. Ho un altro compito da assolvere» e per la prima volta ero stato del tutto sincero. «Capisco. Ma non devi decidere ora. Hai tutto il tempo per pensarci su, noi comunque il posto te lo teniamo ben caldo e quando vorrai, se vorrai, discuteremo dei dettagli, vero Gualtiero?» Il colonnello si è limitato a emettere un grugnito, alzandosi subito dopo per sparecchiare. «Vieni» mi ha detto Fernand accompagnandomi in salotto. Ci siamo seduti sul divano posizionato proprio di fronte alla finestra. «Voglio parlarti anche degli altri inquilini» spiega. «Ci sono le due vecchie sorelle. E poi la famiglia Hussein, che vive nell’appartamento accanto al tuo. Al momento le sorelle, Matilde e Carolina, sono fuori città. Immagino che le troverai eccentriche ma non prive di interesse. Per quanto riguarda gli Hussein, è necessario procedere con una certa cautela, vanno infatti molto fieri della loro visione del mondo, che è particolare e moderatamente austera. Ma non pensare male, sono ottime persone.» «È quella la finestra?» domando. «Sì.» «Posso guardare?» «Ma certo» risponde, facendo però trapelare una nota di inquietudine nella voce. Il vetro si affaccia sulla strada e con lo sguardo si può abbracciare tutto il quartiere. Il portone d’ingresso è chiuso. La luce del giorno si è fatta obliqua e taglia in due la strada, conferendole un’aura dorata che si esaurisce in un cono d’ombra. Fernand si muove a disagio sui cuscini lanciandomi occhiate lunghe e penetranti. Torno alla carica: «Chi ci abita al secondo piano?» «Ah… mmmh…» dice Fernand. «Beh?» insisto. «Ecco… vedi… no, meglio non parlarne, credimi.» «Forza!» protesto. 27 «Fernand.» Dalla cucina la voce tonante del colonnello spezza in due il nostro disarticolato dialogo. «Allora?» insisto. «Devo andare a preparare il caffè» dichiara lui alzandosi con un sorriso mesto. «È l’unica cosa che Gualtiero non sa fare.» Con la coda dell’occhio scorgo qualcosa di rosso che emerge dal portone. Guardo meglio. È lei. La portinaia si allontana indossando un abito attillato e succinto, ha la stessa borsetta di ieri e si muove ancheggiando sui tacchi a spillo. «Fernand, guarda!» dico voltandomi, ma nella saletta sono già solo. La donna si allontana con passo lesto, sembra avere fretta. «Fernand!» chiamo di nuovo alzando la voce. «Sì?» risponde l’uomo rientrando con un vassoio in mano. «La portinaia» dico indicando il vetro. «Ah sì?» «Sì, vieni a vedere.» Dopo aver posato il vassoio con le due tazzine colme di caffè fumante, mi si avvicina mordendosi il labbro inferiore, che a malapena si nota sotto la folta barba. Per un attimo lo immagino a piazzare timbri su un’enorme catasta di fogli, con il viso più giovane che sbuca da una barba nera. «Dov’è?» chiede. «Troppo tardi, se n’è andata.» «Certo» risponde l’uomo tradendo scetticismo. «Ti giuro che era lì fuori vestita di rosso. Un rosso sgargiante.» «Non dico di no, ma pazienza. Adesso perché non ci beviamo un buon caffè in santa pace. Vuoi?» «Ma sì…» Bevo con rabbia, in fretta e quasi mi ustiono il palato, poi mi avvio senza tante cerimonie verso l’uscita. Fernand mi segue. Il colonnello è scomparso quasi fosse stato ingoiato dall’acquaio. 28 «Adesso devo proprio andare. Grazie di tutto» dico stringendogli la mano. «Arrivederci, e non dimenticare la proposta. Riflettici bene, d’accordo?» «Sì, va bene.» Rimango qualche minuto fuori dalla porta, indeciso se uscire o rientrare. Dal pianterreno giungono voci che mi inducono istintivamente ad appiattirmi contro il muro. «Non so se è in casa.» La sgradevole voce della portinaia mi ferisce le orecchie. Non è possibile che sia già rientrata, mi dico perplesso. Lo sconosciuto che è con lei parla a bassa voce, così non riesco a distinguerne le parole. «Lasci pure a me. Mi occuperò personalmente di recapitare la missiva» aggiunge la donna. L’uomo ha un tono smorzato, basso. Colgo solo due parole che emergono sganciate dal contesto: “importante” e “pericoloso”. Infine il portone sbatte dopo aver ruotato sui cardini. La donna è rimasta ferma, forse si sta rigirando la lettera tra le mani. Credo d’intuirne il respiro confuso col jingle di una canzoncina pubblicitaria che sbuca dal televisore attraverso la porta aperta. Mi affaccio prudentemente dalla ringhiera, quando le ciabatte iniziano a strisciare monotone, giusto in tempo per vederla scomparire nel pertugio con l’immancabile scialle azzurrino che le copre le spalle. Risalgo. Al secondo piano rallento. Mi fermo. Una forza magnetica mi attrae verso la porta. Silenzio. Poi un movimento, simile a un pendolo che oscilla sul suo asse e che man mano aumenta il ritmo. L’aria stride al di là delle porta chiusa, freme e s’addensa. Il sibilo ora è acuto, penetrante, poi raschia e s’inceppa, come se qualcuno avesse messo una zeppa di legno a frenare una ruota dentata lanciata al massimo della velocità. Il sibilo è divenuto un rantolo che s’avvicina, s’avvicina. Adesso è un respiro ansimante, sgranato, che s’attenua, 29 s’attenua fino quasi a scomparire in un sussurro: «Ascolta!» Mi stacco dal legno. Frastornato e indeciso mi domando se davvero ho udito quella parola. Dall’interno il silenzio è profondo, appiccicoso come melassa. Incerto riprendo a salire le scale, ma a metà della rampa la musica mi assale all’improvviso. È una melodia poderosa, minacciosa, asciutta, che non si concede a intime promesse e m’insegue fino all’ultimo scalino, infine si spegne in un trillo. Si spegne e muore. Davanti alla porta degli Hussein c’è un bambino di forse cinque anni. Ha i capelli corti sul viso rotondo e mi osserva con un’espressione di simpatica curiosità. Poi ride, forse di se stesso, mettendo in mostra la bocca aperta. Gli mancano i due denti davanti. «Ciao» dico. «Hai sentito la musica?» Il bambino ride con gli occhi ma non dà l’impressione di aver compreso. «La musica» ripeto avvicinandomi. Errore. Il bambino mi guarda inorridito, come se mi fossi improvvisamente trasformato in un mostro. «No» dico, facendo un gesto rassicurante. Adesso piange a dirotto e davvero non so che fare, così mi allontano e cerco le chiavi tentando d’ignorare quella ingiustificata disperazione. Quando la porta gli si schiude dietro, dall’interno si ode una voce di donna che chiama: «Omar.» Il bambino si volta e in un attimo un braccio avvolto da una larga manica di tessuto colorato si sporge e lo afferra delicatamente, traendolo a sé. Faccio appena in tempo a scorgere nella penombra due occhi nocciola che sbucano da sotto un velo azzurro, che già la porta si richiude. «Signora» dico facendo un passo in avanti. 30 «Buonasera» è la risposta che intuisco sfuggire dall’ultimo spiraglio tra il legno e lo stipite. Poi il tonfo del battente e di nuovo un soffiare sgranato. Apro la porta e mi lascio il mondo alle spalle. 31 Capitolo 5 Venerdì 17 febbraio. Notte. Il tempo ora trascorre lentamente e a tratti sembra quasi fermarsi, distribuendo un’aura d’immobilità ammuffita che pesa come un macigno sulle mie spalle. Ho lasciato che il mio corpo ciondolasse per le stanze semivuote che risuonano del cupo rumore dei miei passi. Svuotato mi sono seduto, spalle al muro, sul pavimento. I pensieri sono scivolati sul filo dei ricordi e hanno assalito il futuro. So che i miei soci verranno presto, mi scoveranno, chiederanno conto dei miei atti. Sono scaltri e non privi di risorse, sono malattia e inganno, sono tradimento e paura; s’ingozzano come maiali di ogni ansia che riesce a trapelare dai corpi e dalle anime. Certo, lo so, io non sono migliore di loro. Anzi, sotto certi aspetti io sono il peggiore, ma almeno ho tentato una fuga. Ho tentato di ricominciare. La luna si è insinuata gettando una lama di luce attraverso un varco tra i muri e il cemento; si è intrufolata girovagando per le anonime stanze e infine si è seduta al mio fianco. Inutile, gelida compagna. Ho aperto la valigia e ripiegato con cura i pochi vestiti. Ho tolto la striscia di cuoio che divide in due reparti la borsa. Le banconote sono impacchettate con cura e la luna, tuffandosi, le ha illuminate. Soldi. Molti soldi. Troppi soldi. Sangue che cola. Ho affondato le mani all’interno e ho raccolto molti pacchetti ben serrati da un elastico. Li lascio frusciare tra le dita. Rumore e odore che non sanno di niente. Non hanno sentore di corpi sudati, né olezzo di carta ba32 gnata, non cantano, né risuonano, né balbettano: è solo un lieve fruscio. Mi ricopro con quelle pezze numerate. Gambe e addome. Torace e braccia e collo e viso. Rimango lì, immune al desiderio che emanano. Il gioco di silenzi e umani vizi si ripete ovunque vada, ovunque traslochi la mia anima inquieta. Ho solo bisogno di un po’ di tempo ancora e poi tutto tornerà al suo posto, mi ripeto in uno stato tra veglia e oblio. È così che mi incammino verso una pozza d’acqua dove possa abbeverarmi. La musica mi accompagna. Oltre ogni miseria, oltre ogni paura. Oltre. La fonte è chiara e sgorga da un buco profondo. Sbuca dal nulla, mi dico. Il cammino è accidentato, cosparso com’è da pietre e detriti. Intorno a me il costone roccioso si erge a baluardo di occhi indiscreti con la cima punteggiata da alberi e cespugli. Devo muovermi con attenzione altrimenti è certo che il salto nel vuoto mi sarà fatale. Un passo, un altro, poi finisco carponi l’ultimo giro. L’ultimo ballo. E rimango così, perduto dentro me stesso, insensibile al ribollire della corrente che schizza, che sfregia il granito corroso. Nel rumore assordante la melodia si è confusa, si è unita e si è dispersa rimbalzando in un’eco attutita. Quando li vedo arrivare sono in pace, anche se l’inferno è vicino. Parlano, urlano, minacciano, mi colpiscono. Una, due, tre, cento volte, finché ho il volto tumefatto e le ossa spezzate. Finché non hanno infranto anche il mio orgoglio. La caverna ribolle e s’infiamma. L’onda si gonfia. Schianta, spacca e infine ci travolge portandoci a valle come bambole di pezza. C’è gente sulla riva. Incuriositi, hanno abbandonato lo svogliato girovagare tra bancarelle e souvenir e adesso s’accalcano sugli argini e sul ponte, indicandoci. La morte non è poi così brutta se è capace di far riemergere 33 dall’inferno e donare il potere di vedere, per l’ultima volta, le nuvole fuggire alte nel cielo. Poi la marea sale lenta e silenziosa, sommergendo delicatamente le pietre e gli arbusti e i nostri corpi inerti, che gorgogliano nell’ultimo disperato tentativo di soddisfare la fame d’aria. Fame d’aria… Con un grido mi rovescio in avanti alzandomi di scatto e tentando inutilmente di riempire i polmoni di ossigeno prezioso. Rantolo, sputo, tossisco. Trovare il ritmo, mi ripeto con gli occhi fuori dalle orbite. Trovare il ritmo. Il denaro si è sparpagliato sul pavimento come inutile carta straccia. La gola mi brucia. Acqua, ho bisogno d’acqua. Ma non riesco a bere. Non riesco a deglutire nel contempo saliva, acqua, aria. Inciampo, cado per terra rovesciandomi sul dorso, alzo la testa e mi muovo carponi tentando un’inutile fuga. Di nuovo in piedi apro la finestra sulla notte, lasciando che la vibrante ossessione delle stelle mi riempia finalmente i polmoni. Finalmente! Distendo le ossa con le gambe allungate sul terrazzino, saziandomi dei rumori che sfuggono dalla notte. Con la gola in fiamme il mio ansimare si fa raschiato, ma il respiro migliora e placa così la follia provocata dal soffocamento. Le pillole non bastano più, mi dico rassegnato a una catena infinita di notti insonni, costellate da incubi. Ho paura di assopirmi nonostante l’aria fredda mi culli rassicurandomi. I volti, tutti i volti, scorrono davanti ai miei occhi come trasportati da un tapis roulant. Volti antichi, volti vecchi, volti nuovi. Quello benevolo ma malizioso di Fernand de Pleussy, o quello assente del colonnello. La bambina che si dondola, 34 il bambino che ride e subito dopo piange, e gli occhi nocciola che per un breve istante si sono sottratti alla prigionia di un velo, mi ruotano attorno come ombre cinesi illuminate dall’ultimo raggio di luna. Spossato, sto cedendo al sonno. Che io sia morto domani, a chi può importare qualcosa? Questo mi chiedo, consapevole che darei la vita per poter tornare a riposare ogni notte in pace. La brezza sussurra: «Ascolta!» Le note sono fresche, l’armonia mi avvolge stretto. Mi arrendo, mi distendo, mi annullo. La musica contiene un linguaggio che reca con sé un messaggio da decifrare. Ma non stanotte. Stanotte sia quel che sia. 35 Capitolo 6 Sabato 18 febbraio Il camion ha parcheggiato proprio di fronte al portone. Gli strepiti della Giove rimbalzano lungo la scalinata fino al tetto. Mi sono vestito di corsa: jeans, maglione e acqua fredda in faccia. Al primo piano ho incrociato due vecchie donne che salivano gli scalini con una certa, arzilla baldanza. La prima, occultata dietro una parrucca rossa e grandi occhiali scuri, mi si è parata davanti e dopo avermi fissato con la testa piegata di lato ha esordito dicendo: «Sei tu quello nuovo che ha fatto imbufalire la povera Giove?» Non mi sono alzato di buon umore, ho ancora addosso gli incubi della notte appena trascorsa e, maledizione, finché non faccio colazione non sono in grado di connettere, così ho scartato di lato cercando di proseguire senza curarmi di rispondere. Tutto inutile. Con un saltello la donna mi ha di nuovo ostacolato il passaggio. «Giovanotto, cominciamo male» mi affronta dall’alto del suo metro e mezzo per cinquanta chili. «Che fai, eviti di rispondermi?» «Mi scusi signora ma ho fretta» spiego impaziente. «Bene, così va già meglio» mi concede la donna. «Non sarò certamente io a impedirti di rimediare ai tuoi danni. Comunque io sono Matilde, e quella vecchia cariatide ansimante è mia sorella Carolina» conclude indicandola. Le stringo la mano promettendo di andarle a trovare quanto prima. «Tanto se non lo fai tu ti becco io per le scale» mi avvisa mentre infila la chiave nella porta. La sorella, anche lei minuta, mi regala un sorriso che le fa 36 risaltare la rete sottile di rughe su un volto da prugna secca, incorniciato da una cascata di capelli bianchi. Le vedo scomparire. Sulla loro porta spicca uno spioncino dietro al quale, ci potrei scommettere, staziona a lungo un occhio. «Spostate subito quel rottame dal mio portone» urla inferocita la portinaia. «Signora si calmi, scarichiamo i mobili e ce ne andiamo» cerca di farla ragionare uno dei due trasportatori, il più vecchio. Quello più giovane, invece, fuma tranquillamente con un piede e la schiena appoggiati alla facciata del palazzo. «E tu togli quella scarpa schifosa dal muro» lo investe con ferocia la donna. Il giovane si allontana sollevando con noncuranza le spalle, e dopo essersi appoggiato a una macchina in sosta continua a fumare e a fissarla con insolenza. «Ah eccoti qui, ti sei degnato di scendere» mi grida non appena sbuco per strada. La ignoro e rivolgendomi agli operai dico: «Vi do una mano, così facciamo prima.» Ci muoviamo in fretta scaricando i pacchi sul marciapiede. La donna, all’improvviso calma, se ne sta appoggiata al portone e ci guarda con aria di sfida. L’operaio più giovane va a parcheggiare il camion svuotato. «A che piano sta?» mi domanda l’altro. «Purtroppo al terzo e… senza ascensore.» L’uomo s’ingolla un porc… e lo risucchia tra i denti. Cominciamo. De Pleussy, richiamato dai passi pesanti e dallo sbuffare affannato, si affaccia alla porta. «La mia vecchia sciatalgia non mi permette di aiutarvi» dice indicandosi la gamba destra, «ma adesso vi chiamo il colonnello, lui è forte come una roccia.» Sul pianerottolo del secondo piano il militare ci aspetta, con mossa fulminea mi strappa un grosso involto dalle mani e si avvia arrancando per le scale. 37 Abbiamo appoggiato tutti i pacchi nel salone. Prendiamo fiato. «Non ho niente da offrirvi, solo acqua» dico. I due mi osservano senza fiatare, ma i loro occhi lanciano sguardi ostili. «Ci penso io» esclama entrando Fernand. Ha in mano due bottiglie: una è il famoso mirtillino, l’altra ci spiega essere una crema al caffè di sua originale ed esclusiva produzione, e mentre ne parla mi fissa. Ho solo bicchieri scompagnati che riempiamo perlopiù con il corroborante liquore al caffè. Me lo sento scivolare giù, forte come una bava bruciante, attraverso l’esofago e lo stomaco vuoto. Gli operai bevono senza fare una piega e subito dopo si mettono all’opera. «Sistemate i mobili come più vi piace, e quando avete finito chiudetevi dietro la porta» dico loro. Mentre scendo le scale fingendo una fretta improvvisa, il colonnello e Fernand mi corrono dietro e mi accompagnano in silenzio rinchiudendosi ciascuno dentro il proprio appartamento. De Pleussy mi lancia un ultimo, indecifrabile saluto che, a pensarci bene, sembra quasi una minaccia tanto che mi viene di rallentare e, per un attimo, mi infilo in una delle mie solite paranoiche fantasie. Lascio scivolare le suole delle scarpe sul malandato marciapiede e immagino di avere a che fare con una sorta di clan capace di mutevoli atteggiamenti a seconda delle circostanze. Come dire, o l’ultimo arrivato è complice oppure è nemico. Ma poi mi convinco che sono solo fantasie e che al massimo si può trattare di piccoli malfattori senza nerbo e senza vera capacità di nuocere. Del resto poi, a parte il misero commercio di liquori e le stravaganze della portinaia, non è che sappia molto degli altri inquilini e allora… E allora il mio sesto senso mi tiene in allerta, mi invita a non scartare nessuna possibilità. In fondo ciò che sto cer38 cando di fare è semplicemente scomparire. Rendermi invisibile. Cancellare le tracce. Vedremo, mi dico, e mi consiglio prudenza. La piazzetta minuscola e appartata è colma di sedie e tavolini rotondi. Mi siedo dando le spalle al bar. Il cameriere non ha fretta, svogliato si aggira tra i pochi clienti con l’aria di farci un favore. Ordino un caffè con qualcosa di salato, visto che tutto ciò che era dolce è misteriosamente finito. Sul banco una vistosa zuccheriera. Davanti al banco una donna con una fiammante parrucca viola, si volta e mi fissa. Ci fissiamo. Quindi la donna parla brevemente con il barista e dopo aver sborsato alcuni spiccioli si avvia verso l’uscita. In mano ha un pacchetto bianco con il nome del bar stampato in oro, avvolto da un nastro rosso. Come sempre fingo indifferenza, fissando il passaggio di un gatto che cerca tra i tavoli qualche resto di cibo. «Tu che ci fai qui?» mi interroga la donna dopo essersi seduta e aver appoggiato il pacchetto proprio davanti al mio naso. «Oh, signora Matilde» esclamo fingendo meraviglia. «Signorina, prego.» «Ah già, scusi.» «Allora? Cosa ci fai qui?» mi incalza. Quando sono infastidito non riesco a nasconderlo nemmeno un poco, perciò replico stizzito: «Scusi sa, ma sono fatti miei.» Sul volto della donna si allarga un sorriso così ampio che le fa crepare gli strati di cerone tra una ruga e l’altra. «Bravo, così mi piaci. Dritto al punto» dichiara dandomi un colpetto sulla spalla. Quindi scarta con cura il pacchetto dal quale spuntano invitanti pasticcini. «Prendine quanti ne vuoi, non fare complimenti.» Non so resistere e me ne ficco in bocca subito uno, con le scaglie di mandorla in bella vista. Dopo averlo masticato 39 con cura rivelo: «Il cameriere mi ha detto che erano terminati.» «Eh, ci sono clienti e clienti caro mio. E comunque, dato che ne hai l’occasione mangiane pure, tanto li avrei portati a quel fossile di mia sorella che oltretutto è pure diabetica.» «Ma allora…» mormoro. «Non importa. Se muore nessuno ne sentirà la mancanza, compresa io» dichiara convinta. Ha una bella parlantina, non c’è che dire, così tra un pasticcino e l’altro ho la sensazione che mi racconti tutta la sua vita, che non è breve ed è stata intensa; ma qua e là affiorano vuoti, volute dimenticanze, studiate omissioni. Dopo un po’ di tempo, e con il pacchetto oramai vuoto, si zittisce fissando a lungo davanti a sé. «La mia vita non è stata facile, d’altra parte per chi lo è» commenta infine piantandomi le grosse lenti in faccia. Poi mi esorta a parlarle di me. Non le vedo gli occhi e mi sento a disagio. Faccio scorrere la vista sulle labbra strette, anch’esse vistosamente colorate di viola e poi sui muscoli tesi che contengono ossa minute, ma robuste. «Non c’è molto da dire» comincio. «Sono figlio di una casalinga e di un operaio vissuti da sempre alla periferia di qualche città, e nelle periferie siamo rimasti. Ho fatto studi discontinui e lavori irregolari e mal pagati. Oggi ho raggiunto un po’ di benessere grazie all’arte.» «Arte?» mi chiede incredula. «Sì» confermo, distogliendo gli occhi per la consueta bugia. «Che genere di arte?» Ci risiamo, ogni volta che racconto questa storia sono preda di contraddizioni e impappinamenti. Me la cavo affermando: «Installazioni.» Era facile immaginarsi che bastasse questa parola per mandare in confusione una vecchia signora che, probabilmente, per nascondere la propria ignoranza avrebbe cambiato discorso. 40 È quello che spero ma non va così, non con Matilde. «Ah sì? E che genere fai? Ti costruisci un modulo e poi lo ripeti all’infinito o usi delle pareti con fori e fessure per vedere al loro interno? E dove preferisci esporre? Nelle piazze, nelle chiese sconsacrate o nelle gallerie, dove?» mi domanda con un’aria di disincantata curiosità. «Luce» mi viene da dire. «Assemblo pannelli con luci colorate.» «E perché mai un artista postmoderno è finito in una piccola città dove non succede mai niente?» «Cerco ispirazione in un ambiente tranquillo» è la mia banale risposta. Ride la donna, rovesciando indietro la testa con mossa così repentina che per poco non le cade la parrucca. «Davvero? E cosa ti fa credere che il condominio Marrakesh sia un posto tranquillo?» sbotta tornando improvvisamente seria. «Mah, non saprei. Diciamo che è più una sensazione che una certezza.» «Almeno lo sai perché si chiama così?» «No, francamente lo ignoro.» «Devi sapere allora che all’incirca una decina di anni fa gli appartamenti erano tutti occupati da immigrati. Occupati sì, non pagavano l’affitto. Le case erano disastrate, vetri rotti, porte scardinate, pavimenti divelti e nessun servizio; insomma quella roba lì. Il proprietario dopo aver ipotecato tutto era scappato chissà dove. Per un po’ di tempo tutti finsero di non vedere e così anche quei poveri cristi ebbero un tetto sulla testa, seppure malridotto. Finché un giorno qualcuno pensò che era un vero peccato lasciare andare in malora quell’edificio e se lo comprò. Naturalmente la prima cosa che fece fu intentare una causa di sgombero. Così vennero le forze dell’ordine e a pugni e a calci liberarono gli appartamenti. Dei migranti solo una famiglia ottenne il contratto d’affitto: sono gli Hussein, la famiglia accanto al tuo appartamento. 41 Quindi fu la volta degli operai: muratori, imbianchini, fabbri, elettricisti, idraulici. Cancellarono le scritte sui muri tra le quali la più ripetuta era proprio “Marrakesh”, forse perché da lì provenivano perlopiù i migranti, non lo so; fatto sta che nonostante il nuovo proprietario si sforzasse di ribattezzare il caseggiato con i nomi più aggraziati tutti, proprio tutti, continuarono a chiamarlo “Condominio Marrakesh”, e questo nome gli è rimasto. Per ripulire – usarono proprio questa espressione – l’immagine del fabbricato, si prodigarono affinché i nuovi inquilini fossero dotati di credenziali di buona e civile condotta – usarono proprio queste parole. Selezionarono, valutarono, deliberarono e alla fine assegnarono gli appartamenti a onesti cittadini, o così almeno ritennero.» Adesso assume un’aria distratta, come di chi abbia appena svuotato un posacenere e subito dopo spruzzi del profumo in una stanza fumosa. Estrae dalla borsetta un astuccio dal quale tira fuori uno specchietto e un batuffolo d’ovatta. Si tampona diligentemente il viso e dopo aver compiuto questa operazione s’infila una sigaretta in bocca e inizia a fumare. L’occasione è troppo ghiotta per non coglierla al volo perciò domando: «La signora Giovanna, che lei sappia, fuma?» Matilde mi osserva con aria divertita. «Certo che fuma, quella vecchia baldracca.» «Ah ecco.» «Beh, che c’è di strano?» «No, è che il signor de Pleussy lo negava con forza.» «Figuriamoci, quel vecchio intrigante» è la sua risposta stizzita. «La protegge sempre.» Le rivolgo la domanda successiva fissando gli occhi direttamente nelle lenti scure: «Sono certo che ha una doppia vita, non è vero?» La risposta è vaga: «Tutti abbiamo una doppia vita. Anche io e te.» «Sì, ma lei fa di tutto per nasconderla, come se si vergognasse.» 42 «Certo» mi ripete, «come tutti. Se poi vuoi soddisfare le tue pruriginose curiosità allora sì, ha un amante.» Spontaneo, un nome affiora sulle labbra: «Fernand?» «Ah no, lui no. Il caro vecchio Fernand è omosessuale e il colonnello è il suo… come dire? Amico. Tra quei tre vige una sorta di comune assistenza per i loro traffici, capisci?» Capisco che devo stare molto attento, che forse ho scelto un luogo non così sicuro come mi aspettavo. Idee mi ballano in testa, non ultima l’ipotesi di azzerare tutto, di scomparire di nuovo. La campana batte dodici rintocchi e uno stormo di piccioni s’invola sui tetti vicini. Matilde si toglie gli occhiali e mi fissa con incredibili occhi azzurri. Due piccole pozze blu. Per me un’antica ossessione. Poche volte ho subito il disagio di sentirmi scavare dal di dentro come in quell’istante. «Devo andare» dice inforcando di nuovo gli occhiali e sfiorandomi una mano. È un tocco gentile, delicato, complice. Ecco, complicità è ciò di cui avrei bisogno. «Chi abita nell’appartamento sotto al mio?» chiedo a bruciapelo. «È difficile da spiegare» dichiara, e il tono non è quello consueto. Pare reticente e non le si addice. «Perché nessuno mi vuole rispondere?» replico esasperato. «Mettiamola così» dice la donna alzandosi in piedi con l’aria di voler troncare la conversazione. «Là dentro ci sono tutte le nostre paure e tutti i nostri misteri ed è un bene che nessuno, nemmeno tu, cerchi di saperne di più.» «Ma…» «Niente ma, è così e basta» esclama e allontanandosi mi saluta con la mano. È uno di quei giorni in cui non ho voglia di fare niente e contemporaneamente sono assillato e confuso da ipotesi e previsioni. Metto sul tavolo i pochi spiccioli necessari a pagare la 43 consumazione e mi allontano con alle spalle lo sguardo malevolo del cameriere, a cui non ho lasciato la mancia. Le strade non hanno un buon odore, è sempre così ogni volta che mi allontano da un centro e, già che ci penso, mi viene da chiedermi che cosa mi spinga verso le periferie anonime e dimenticate. L’abitudine, l’obbligata frequentazione, mi rispondo. In fondo è come ritornare a casa. La città è circondata dalla campagna, che s’annulla e si ricompone in un mosaico eterogeneo di orti e pollai recintati da reti strappate, e baracche con le porte serrate da lucchetti e catene. Da tempo ho preso l’abitudine di vagabondare senza una meta precisa e non poche volte mi sono perso, dopo aver percorso un’infinità di chilometri con la mente occupata in pensieri contorti. La strada a un tratto compie una curva ripiegandosi su se stessa, evidenziando così, alla sua sinistra, un sentiero di terra battuta che sembra inerpicarsi verso le colline. Resto a lungo indeciso, poi le gambe autonomamente scelgono di salire. Il sentiero ora è il letto di un torrente scavato dalla pioggia che ha inciso la terra rossa, argillosa, compatta. Mi afferro a spuntoni di roccia, a radici e in mancanza di meglio a precari steli erbosi per aiutare le gambe rigide. Il respiro è affannoso, il cuore batte furiosamente e me lo sento in gola; in gola insieme al nodo che la stringe sempre più spesso. Mi siedo approfittando di una balza di terra che sporge erbosa e invitante come una terrazza appesa sul corpo di un gigante. A poco a poco il respiro si regolarizza e il cuore riprende a ticchettare leggero e invisibile. I pantaloni si sono macchiati di rugginose patacche e le scarpe di un’impalpabile polverina rossastra. Chiudo gli occhi, abbandonandomi agli sbuffi di un vento vetroso e allo stormire delle fronde. Poi, dall’angolo curvo dell’occhio, in quello spazio lasciato 44 incustodito nell’ombra, il mostro mi assale. Relegato in una zona angusta dove la notte si fa padrona e il sonno è necessario bisogno, reclama maggiore visibilità, presenza, possesso. Mi disegna una smorfia cattiva sul volto e mi pungola ordinando una sequenza costante di azioni che appartengono a un’altra parte della mia vita. Un luogo che fingo di non aver mai visitato, ripulendomi l’anima con l’oblio. Annaspo, apro gli occhi e guardo il cielo. Sarà il bagliore del sole ma, inorridendo, gli vedo distillare gocce amaranto che cadendo imporporano il tarassaco e la malva. «Sangue!» grido, e so che non mi appartiene. «Sangue, sangue, sangue!» ripeto salmodiando una litania profana, mentre mi vedo quasi strapparmi la pelle. Acqua calda e sapone, strofinare con forza; per terra i vestiti, irriducibili prove del crimine. Gratta, graffia, scortica, anche dentro le unghie, nelle pieghe delle dita: ma niente potrà strappare quelle urla dal mio ricordo. Il mostro non mi aveva mai assalito di giorno, aspettandomi invece al varco le notti. Così, forse, qualcosa sta cambiando. Io sto cambiando. Rabbrividisco. Scaccio con un gesto della mano sogni e paure e rimettendomi in piedi mi guardo le dita sporche solo di terra. Le guardo e sospirando sollevato mi dico: «È solo terra.» La campana batte due colpi distinti, seppur soffocati. Ho le mani gelate, ho bisogno di calore. La fame di nuovo mi assale e, lo so, è soltanto un modo per riempire il vuoto che si sta impadronendo di me. Più ci rifletto, più la sensazione di inconsistenza mi si appiccica addosso. Parvenza senza contenuto. Le strade sporche del sobborgo hanno lasciato campo libero ai viali e ai lampioni illuminati già dal primo pomeriggio. Senza un preciso perché sono tornato al bar del mercato. I 45 tavoli sono quasi tutti vuoti, fatta eccezione per uno piccolo proprio di fronte alla vetrata che dà sulla piazza. Un uomo sulla cinquantina sorseggia un tè, insieme a una donna coperta da un velo. Lei mi dà le spalle, lui mi fissa e, non so perché, ha l’aria di chi voglia catturare un tacchino per le feste natalizie. Mi siedo a qualche tavolo di distanza dalla coppia. Ordino un piatto unico, grande, verdure e formaggio, un uovo nel mezzo, compreso nel prezzo un bicchiere di vino. Al centro della piazza una statua torreggia mettendo in mostra un uomo con la spada sguainata in sella a un cavallo, sul pavè sottostante il vento strapazza foglie e cartacce che si rincorrono fendendo l’aria cristallizzata. Mastico lentamente tentando di ignorare le volute acide che s’innalzano dal centro dello stomaco. La coppia ha alzato il tono della voce e sembra sul punto di superare la soglia che conduce dalla discussione al litigio. Cerco la bella signora dal corto grembiule, ma riesco soltanto a incrociare l’espressione antipatica del barista. Mi fissa contrariato, forse intuendo i miei pensieri. Distolgo lo sguardo. L’uovo è un po’ duretto, ma il formaggio di capra è buono, con quel vago sentore di paglia intrisa di pioggia. Le voci della coppia sono divenute un bisbiglio e mentre ficco in bocca le ultime forchettate d’insalata sento i loro occhi forarmi la nuca. Mi stanno inequivocabilmente fissando. Chissà perché poi ho ordinato un piatto freddo, mi chiedo. E indeciso tra un caffè, un tè o una cioccolata, sorseggio gli ultimi residui di vino. Prima che la mia decisione si tramuti in scelta il cameriere mi sistema sotto il naso una tazza fumante di tè. «Glielo offrono quei signori» dice indicando la coppia. L’uomo mi rivolge uno sguardo benevolo e un cenno con la testa, la donna rimane con gli occhi appoggiati alla vetrata e nonostante l’apparente indifferenza sono in grado di percepire in lei un fremito inusuale e voluttuoso. 46 Adesso l’uomo si alza e si avvicina. Lei è ferma, immobile. «Posso sedermi?» domanda. «Ma certo, e grazie per il tè. Ci conosciamo?» gli chiedo, ma credo d’indovinare la risposta. L’uomo ha grandi occhi scuri che spiccano brillando sulla pelle ambrata, i denti emergono bianchi e un po’ sporgenti tra le labbra carnose. Mi dà la mano: «Il mio nome è Adrien Hussein, abitiamo sullo stesso piano. Sa, il condominio.» «Già» mormoro stringendo quella mano forte, grande, avvolgente. E così, tutto d’un tratto, un volto emerge tra le nebbie, appena intravisto. Solo una voce che dice “Omar” e poi “buonasera”. È lei la donna, ne sono certo; la stessa donna che continua a rivolgere il viso ostinatamente altrove. All’uomo non sfugge il mio sguardo: «Quella è mia moglie Fatima. Non ci faccia caso, sa. Noi siamo molto attenti ai rapporti tra uomo e donna, specialmente con gli estranei.» E calca la voce su “estranei”. «Va bene» dico io. L’uomo spiega che voleva conoscermi come si fa tra buoni vicini, ma che voleva farlo fuori dal caseggiato. «Ho i miei buoni motivi» aggiunge. No, non ha proprio l’aria di un cacciatore di tacchini, piuttosto quella di un astuto predatore che spinge la preda in un angolo. Attento, mi dico passandomi la mano sul collo. «Adrien?» chiedo assumendo una forzata aria di interesse. Ride l’uomo, sporgendo se possibile ancora di più i denti in fuori. «Sono franco-marocchino» mi spiega, «perciò i miei genitori hanno cercato di fondere in un nome entrambe le origini. E lei? Di cosa si occupa?» Ripeto per l’ennesima volta la storiella dell’artista, che l’uomo sembra bersi senza fiatare, ma è lei che compie uno scatto con la testa quel tanto che basta per poter di nuovo scorgere i suoi occhi nocciola. Così prendo a fantasticare, immagi47 nando il volto perfetto che certo si nasconde sotto al velo, mentre l’uomo mi invita a cenare con loro la domenica sera. «Mia moglie e mia cognata le prepareranno un cuscus di pesce che vedrà… da leccarsi le dita. Possiamo contare sulla sua presenza?» «Eh?» rispondo distratto e penso: sua cognata? Due donne, allora. E quale delle due? Ma lei, lei certamente. «Allora che fa, viene?» insiste l’uomo. «Ma sì, certo, con vero piacere» riesco finalmente a dire riemergendo dalle mie fantasie. «Bene» si compiace lui. «Sarà anche l’occasione per esporle un mio progetto.» «Che progetto?» «Domani sera alle otto» precisa alzandosi in piedi e ignorando la mia domanda. Si allontanano leggeri, lui salutandomi con la mano ben protesa in avanti, lei a capo chino e le spalle leggermente incurvate. Li vedo scomparire infilandosi nella strada che costeggia per un breve tratto la piazza, per poi tuffarsi nel dedalo intricato di viuzze. Sono l’ultimo cliente. Sono rimasto solo. Il cameriere mi presenta il conto: dodici euro. Ne ho solo dieci. I soldi sono finiti. Eppure dentro la tasca interna della giacca, un pacco di banconote da cinquanta è lì in attesa di essere speso. Sì, lo so, sono gli altri soldi, soldi sporchi, macchiati di sangue. Come se esistessero soldi puliti, mi dico. Dai, non fare l’ipocrita. È che non è solo una questione morale, cerco di spiegare a quella parte della mia coscienza che sembra non sentire ragioni. Questi sono soldi rintracciabili per via del numero di serie, possono arrivare a me, a noi, e non sono pochi a darci la caccia. E allora che vuoi fare? Credi che se non paghi rimarrai anonimo, eh? Quel cameriere metterà su un tale casino… non vedi come ti guarda? Non essere stupido, tu sei un uomo 48 ricco. Improvvisamente realizzo che sto parlando con me stesso e il dialogo è acceso, serrato, in perfetto stile schizoide. Così cerco di darmi un tono fingendo di bere l’ultimo sorso di tè. Il cameriere mi osserva di sottecchi e prima che la campana batta tre rintocchi l’orologio posizionato sulla parete mi informa dell’ora. Mi dà il resto senza fiatare e con i gomiti appoggiati sul banco mi osserva chiudere la porta. Un pensiero mi turba, mentre passeggio distratto da alcune vetrine che pubblicizzano sconti favolosi su altrettanto favolosi capi di abbigliamento: quale bizzarra coincidenza fa sì che incroci, ovunque vada, gli altri condomini? E potrei scommetterci sul fatto che di vera coincidenza si tratti? Non è che mi seguono, mi controllano, mi spiano? E se così fosse, per quale oscuro motivo? Sei un paranoico, mi dico cercando un po’ di tregua nella folla di pensieri. La panchina è tagliata in due da una lama di sole, mi siedo in modo da goderne almeno un po’; le mani tuffate nelle tasche cercano assiduamente un calore che non si propaga dal tessuto alla carne. Una donna anziana getta manciate di mais ai piccioni che svolazzano sulla piazza della chiesa. Il rumore della fontana che vomita acqua nelle vasche squadrate è uno sbuffo che sposta e cristallizza l’aria sempre più gelida. Ho il corpo pesante, inchiodato, anzi affondato sulle verghe smussate del legno, con i vestiti cuciti e ingolfati addosso. La donna si volta e mi sorride. Mi sorride sotto un cappello di lana che le attribuisce una vaga aria da folletto; le manca un dente proprio davanti, un incisivo: il buco le conferisce un’aria ferina e sciatta insieme. Una lunga sciarpa bianca le gira più volte intorno al collo per poi allungarsi in una falda modulata sul corpo. Le mani inguantate pescano dentro un sacchetto gli ultimi residui di granoturco; infine, dopo aver gettato la carta in un cestino, se le pulisce sul panno. 49 Credo di avere la mente assopita, cosa che mi capita sempre più spesso, forse a causa delle lunghe notti insonni. Credo di avere colto solo all’ultimo istante lo sguardo della donna, e accade quando si ferma proprio a negarmi l’effimero spicchio di sole. Fissandomi sussurra: «Lei è sempre solo?» La risposta è quella che ci si aspetta tra estranei, così sibilo attraverso le labbra bruciate dal freddo: «Ci conosciamo?» «Non mi riconosce?» chiede la donna togliendosi il cappello di lana. Sulle prime non la identifico, poi la somiglianza si fa più chiara e il pensiero diventa intuizione: «Lei è la sorella di Matilde» esclamo come se avessi appena risolto un quiz. «Carolina» conferma lei con il tono lievemente imbronciato di chi realizza di non aver lasciato un ricordo di sé. «Sì, certo. Carolina» dico io stendendo una mano con l’intento di sfoggiare una cordialità che non mi appartiene. «Viene spesso a dare da mangiare ai piccioni?» La donna sorride ignorando il mio gesto, e di nuovo esibisce il foro scuro tra i denti che, giuro, non avevo notato la prima volta. Poi mi dico che era stato un incontro fugace, sulle scale, in fretta. Eppure… eppure ci avrei scommesso che l’altra volta non c’era, quel foro. «Non troppo spesso» risponde lei alzandosi per andare via. «Mi hanno detto di seguirla per vedere che fa» aggiunge in seguito, e mi allunga una carezza sui capelli arruffati. Non sono ben sicuro di avere compreso e resto come inebetito. «Come? » chiedo dopo troppi secondi. La donna è già distante e non si volta. Mi rimetto in piedi incurante dei sinistri scricchiolii provenienti dalle ginocchia. La inseguo con le gambe che tremano un po’, come addormentate. Mi fermo un attimo e alzando la testa vedo la donna girare l’angolo. 50 Quando raggiungo l’incrocio la strada alberata è sgombra, con l’eccezione di un venditore ambulante. La campana batte quattro colpi nitidi che si propagano nell’aria gelata come una crepa sul ghiaccio. I lampioni a gas si vanno incendiando in una colorazione rossastra che fende le prime ondate di nebbia. La donna è svanita, come un’idea che pensavamo di aver afferrato e subito dopo non c’è più. Zoppicando mi maledico. Entro in un panificio e poco dopo esco stringendo un sacchetto contenente una baguette farcita e una bottiglia d’acqua minerale: la mia cena. «Bastardi» sibilo tra i denti mentre mi arrampico sui gradini del condominio. Fuori la sera si è distesa spedendo nelle loro case i bravi cittadini; altri si preparano ad affrontare la notte coperti da cartoni e dalla loro confortevole rassegnazione. La scalinata è vuota, silenziosa. Dall’appartamento della portiera mi giungono i suoni smorzati di una pubblicità televisiva. Al primo piano, attratto dallo spioncino, mi accosto alla porta. «Vattene.» L’ordine che giunge al di là della porta è perentorio. «Scusi, io…» tento di rimediare. «Vattene a letto, amico.» La voce roca di Matilde non accetta compromessi. Riprendo a salire mormorando uno stizzito fanculo, e per tutta risposta mi pare di udire un fottiti dall’appartamento di sotto. Mi fermo al secondo, il silenzio è ovattato, denso, appiccicoso. Mi rimetto in cammino lanciando uno sguardo distratto alla porta con la targhetta: “Colonnello Gualtiero Altieri”. Mentre cerco le chiavi sposto da una mano all’altra il sacchetto e infine, imprecando, me lo ficco tra le gambe. Uno scricchiolio mi induce a voltare la testa e resto lì, con le chiavi a mezz’aria, vedendo emergere dalla fessura che si va allargando una donna. Indossa uno stupendo vestito rosso 51 con ricami verde e oro. Gli occhi, unica parte visibile, scintillano su un volto interamente coperto da un velo sottile, attraverso il quale s’indovinano fattezze delicate. «Buonasera» mi dice. «Buonasera» rispondo, impacciato nel trovarmi in quella ridicola posizione e per tentare di venirne fuori, mi alzo di scatto lasciando cadere con un piccolo tonfo la cena. Per fortuna la bottiglia dell’acqua è di plastica. Ride la donna ed è un risata che trilla. Ride la donna e il sangue mi saltella nelle vene. Faccio un passo verso di lei senza sapere che altro aggiungere, ma già la porta si chiude dietro le sue parole. «Devo andare, arrivederci.» Tlack! Resto lì come un fesso, la mano protesa in avanti, le chiavi nell’altra, il sacchetto per terra. 52 continua. . . © 2014 I sognatori, Lecce ISBN 978-88-95068-31-2 Per contattare la casa editrice I sognatori, consultare il sito internet: www.casadeisognatori.com in copertina disegno di Francesca Santamaria (per gentile concessione dell’autrice) finito di stampare nel mese di febbraio 2014 presso Digital Print srl Segrate (MI)
Scaricare