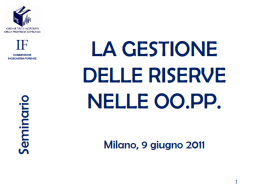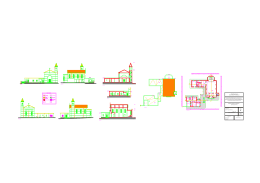Gli impianti per l’irrigazione
del vigneto
ing. Maines Fernando
Fondazione E.Mach – C.I.F.
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Premesse agronomiche;
Irrigazione per aspersione;
Microirrigazione;
Fertirrigazione;
Subirrigazione;
La progettazione di un impianto di irrigazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
2
Acqua e agricoltura
•
L’agricoltura è il settore che consuma
maggiormente la disponibilità idrica:
o
o
o
•
fino all’85% nelle zone aride;
anche in zone umide la siccità è un rischio
reale e può avere conseguenze disastrose;
l’agricoltore deve quindi adottare buone
pratiche agricole per risparmiare acqua:
•
0,3 % è il quantitativo di acqua disponibile;
l’irrigazione consente di aumentare e di
stabilizzare le rese e la qualità della
maggior parte delle colture:
o
70 % è la superficie utilizzabile:
•
26/10/2009
della superficie agricola totale nel mondo:
–
260 Mha sono attualmente irrigati:
–
3 Mha sono irrigati a goccia:
»
»
il 16% della superficie agricola mondiale
soddisfa il 40% della domanda alimentare.
pari allo 0’18% della superficie agricola
mondiale.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
3
Sviluppo sostenibile (1)
•
Un terzo dei coltivatori del mondo
sono impegnati nella lotta per la
sopravvivenza:
o
•
bisogna passare da un’agricoltura si
sussistenza ad un’agricoltura
sviluppata …
o
•
il 10% della popolazione vive con lo
0,5% del reddito mondiale.
… ma rispettosa dell’ambiente
(agricoltura di tipo conservativo).
sviluppo sostenibile necessita:
o
o
o
una gestione efficiente e razionale dei
fattori della produzione;
divulgazione delle nuove tecnologie.;
evoluzione dei sistemi produttivi e dei
canali commerciali:
•
•
orizzontale - graduale eliminazione delle
aziende di modeste dimensioni.
verticale - la grande distribuzione
controlla il settore primario.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
4
Sviluppo sostenibile (2)
• L’irrigazione ambientale è
una delle risposte:
o
anche in agricoltura si deve
aumentare la
consapevolezza ambientale,
per contrastare:
•
•
•
•
26/10/2009
eccessivo sfruttamento delle
risorse;
contaminazione delle sorgenti;
cattiva gestione
dell’irrigazione;
aumento della salinità delle
acque.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
5
Irrigazione ambientale
• Possibili strategie:
o
sostituire l’irrigazione per scorrimento
e a pioggia con la microirrigazione:
•
•
si irriga la pianta non il suolo;
consente una gestione precisa, economica
ed automatizzata dell’irrigazione:
–
o
o
erogatori autocompensanti per i terreni in
pendenza.
•
permette di adottare la fertirrigazione.
•
•
si evitano le perdite per evaporazione;
si favoriscela meccanizzazione delle
operazioni colturali.
subirrigazione:
utilizzo delle acque reflue:
•
mediante subirrigazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
6
Premesse agronomiche (1)
• La pratica dell’irrigazione viene svolta per diversi motivi:
o
apportare acqua al terreno (funzione umettante), per:
•
•
o
o
o
–
intervenire solo quando le colture non trovano nel terreno l’acqua sufficiente a
coprire il fabbisogno idrico necessario per sviluppare una produzione
economicamente soddisfacente.
scopo fertilizzante:
•
l’acqua diviene il veicolo per la distribuzione di nutrienti.
•
l’acqua veicola presidi sanitari per prevenire o combattere attacchi di insetti
o di funghi.
antiparassitaria:
antigelo:
•
o
mantenere nel terreno un contenuto ottimale di umidità;
migliorarne l’attitudine alla produzione vegetale
interventi sopra chioma a bassa intensità o sotto chioma mediante
microirrigazione a spruzzo.
climatizzante:
•
26/10/2009
in condizioni di temperature molto elevate si interviene con irrigazioni ad
elevata polverizzazione.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
7
Premesse agronomiche (2)
• In viticoltura l’irrigazione non è una pratica
consigliabile dal punto di vista della qualità delle uve
ottenute:
o
la vite è una pianta che:
•
•
si adatta bene ai terreni ciottolosi ed aridi;
si caratterizza per la capacità di ridurre il livello di
evapotraspirazione annuo:
–
in condizioni di aridità si riduce al 60 %.
o
non abbisogna di un regime idrico molto alto:
o
L’eccesso di acqua inoltre può favorire:
•
•
•
•
26/10/2009
da 200 ai 1000 m3/ha per anno (corrispondenti a 20 ÷ 100 mm di
pioggia.
fenomeni di spacco dei frutti;
marciumi;
aumento dell’incidenza di peronospora e di muffa grigia.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
8
Premesse agronomiche (3)
• In viticoltura l’irrigazione viene intesa come
intervento di soccorso:
•
per favorire l’attecchimento delle barbatelle e per supportare il loro
sviluppo uniforme nei 2 ÷ 3 anni successivi.
• situazioni particolari:
1.
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
26/10/2009
terreni aridi:
l’irrigazione è indispensabile;
ripetuta varie volte all’anno (come nel caso dei terreni salsi).
terreni con disseccamento è precoce:
l’irrigazione da effettuarsi nel periodo che precede l’invaiatura.
terreni con disseccamento diverse settimane dopo la
fioritura:
l’irrigazione non è necessaria,
terreni collinari:
interventi irrigui fino all’invaiatura.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
9
Premesse agronomiche (3)
• La scelta del metodo irriguo:
o
o
o
o
o
elementi fisico-pedologici e orografici;
forma di allevamento e sesti di impianto;
indice di meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta;
disponibilità di risorse idriche;
qualità della manodopera disponibile e la necessità di soddisfare
esigenze speciali (irrigazione polivalente, antibrina, ...).
• attenta valutazione:
o
•
•
economica;
agronomica.
•
risultati possono variare molto in funzione di:
verificare che i costi di impianto e di gestione non risultino
superiori al beneficio economico indotto dall’aumento produttivo
(in termini di quantità e/o di qualità):
26/10/2009
–
–
–
indirizzi produttivi (uve da tavola, uva per la produzione di vini pregiati, ...);
caratteristiche climatiche locali;
….
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
10
Analisi e progettazione
•
Per assicurare efficienza all’ impianto è necessario uno studio
preventivo molto accurato di diversi aspetti:
1.
2.
3.
4.
5.
•
6.
analisi delle fonti di approvvigionamento (cisterna o bacino, fiume o
consorzio, pozzo, ...);
determinazione della qualità dell’acqua;
scelta dei trattamenti a cui sottoporre l’acqua;
analisi delle caratteristiche del terreno e delle relazioni acqua–
terreno;
analisi dei fabbisogni idrici e dei fabbisogni di nutrienti;
analisi delle pratiche colturali ed agronomici;
studio delle caratteristiche di impianto;
1.
2.
3.
4.
26/10/2009
analisi delle caratteristiche ambientali locali;
studio dell’andamento plano-altimetrico e rappresentazione
topografica;
analisi della manodopera, degli aspetti energetici;
scelta dei materiali di impianto e delle metodologie di esecuzione.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
11
1. Fonti di approvvigionamento
• Fonti di approvvigionamento
o
o
o
o
acquedotto in grado di garantire la necessaria portata e pressione,;
prelievo in falda,
bacino o da corso superficiale;
impianto di trattamento di acque reflue:
•
valutare i rischi igienico-sanitari, i rischi ambientali ed i rischi tecnologici
connessi alla possibile presenza di elementi solidi (abrasione e corrosioni di
giranti delle pompe o delle condutture, occlusione degli erogatori, …)
• corrette modalità di approvvigionamento:
o
o
valori di pressione e portata necessari per soddisfare i fabbisogni
idrici;
variazione nel tempo (andamento stagionale) di portata e pressione
•
o
in caso di apporti di portata ridotta:
–
costi.
necessaria la predisposizione di opere per la raccolta e lo stoccaggio.
• acque di qualità marginale (come nel caso di reflui di
depurazione) si devono attentamente.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
12
2. Qualità dell’acqua (1)
•
Conoscenza della qualità dell’acqua.
o
o
•
assicurare la salvaguardia della fertilità fisico-chimica ed agronomica del suolo.;
l’analisi preventiva consente di valutare l’idoneità all’impiego in microirrigazione:
•
si valuta il rischio di occlusione degli erogatori.
analisi dei seguenti aspetti fisici e chimici:
o
o
temperatura:
•
non deve essere troppo alta, ma nemmeno più bassa di 4 °C di quella dell’aria;
solidi in sospensione:
•
•
particelle di suolo di dimensioni variabili;
organismi viventi in funzione della provenienza (pozzo, reflui, acque superficiali, acquedotto, …).
o
pH:
o
minerali disciolti:
o
contenuto in sostanza organica:
•
•
•
•
o
per acque normali assume un valore compreso fra 6,5 e 8,5;
concentrazione in sali;
composizione dei sali presenti.
–
–
COD (domanda chimica di ossigeno)
BOD5 (domanda biochimica di ossigeno).
quantità di ossigeno, misurato in mg, necessario per ossidare chimicamente o biologicamente (in 5
giorni) la sostanza organica presente in un litro di liquido;
residui di prodotti fitosanitari o di composti organici di sintesi.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
13
2. Qualità dell’acqua (2)
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
14
3. Trattamenti dell’acqua
• Trattamenti chimici:
o
mediante iniezione di cloro o di acidi:
•
•
eliminano materiali in soluzione, microrganismi;
effettuano la pulizia dell’impianto.
• trattamenti fisici:
o
o
sedimentazione in vasche;
filtrazione:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
15
4. Caratteristiche del terreno (1)
• Caratteristiche del terreno e relazione acqua –
terreno:
o
o
o
o
o
o
o
tessitura;
tipologia;
salinità;
ph;
movimenti laterali e verticali dell’acqua;
ritenzione idrica;
permeabilità.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
16
4. Caratteristiche del terreno (2)
• Comportamento dell’acqua nel terreno varia in
relazione alle caratteristiche fisiche del terreno.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
17
5. Fabbisogni idrici (1)
• Fabbisogni idrici:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
evapotraspirazione potenziale (ETP);
fattore colturale (Kc);
fabbisogni di protezione dal gelo;
resistenza alla siccità;
fabbisogni di lisciviazione (frequenza e volumi);
tolleranza alla salinità;
fabbisogni in fase di trapianto;
diametro e profondità dell’apparato radicale.
fabbisogno di nutrienti:
•
•
•
26/10/2009
tipo di fertilizzanti;
metodo di applicazione;
frequenza di applicazione.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
18
5. Fabbisogni idrici (2)
• Il calcolo si esegue mediante uno dei seguenti metodi:
o
o
o
determinazione del bilancio idrico del suolo;
combinazione del bilancio energetico e della diffusione del
vapore acqueo dalla superficie evaporante all’atmosfera
circostante;
correlazioni empiriche tra evaporazione ed uno o più fattori
climatici che possono influenzare l’evapotraspirazione.
• determinare il momento dell’intervento irriguo:
o
o
o
metodiche fisiologiche basate sulla misura dello stato idrico
della pianta;
tecniche di valutazione dell’acqua nel suolo (metodo
gravimetrico, tensiometrico, misura della resistività, ...);
indicatori meteorologici basati sul bilancio idrico e sulle
perdite per evapotraspirazione (calcolo di ETo con il metodo
evaporimetrico di classe A).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
19
5. Fabbisogni idrici (3)
• Bilancio idrico e calcolo di Eto con il metodo
evaporimetrico di classe A.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
20
5. Fabbisogni idrici (4)
• Coefficiente
colturale per le
principali colture
arboree
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
21
5. Fabbisogni idrici (5)
• Strumenti per la misurazione dell’umidità del terreno:
o
o
tensiometro;
TDR.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
22
6. Elementi colturali ed agronomici
• Pratiche colturali:
o
o
o
o
tipo di trapianto ed attrezzature utilizzate;
tipo di gestione dell’interfilare;
tipo di raccolta e attrezzature utilizzate;
pratiche colturali specifiche.
• caratteristiche di impianto:
o
o
o
o
o
vitigno e portaiinesto;
sesto d’impianto;
orientamento delle file;
lunghezza delle file;
….
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
23
Aspetti impiantistici (1)
• Caratteristiche ambientali locali:
o
o
o
o
o
elevazione (quote);
temperatura;
umidità relativa media nelle varie
stagioni;
piovosità e distribuzione delle
precipitazioni;
gelate e necessità di protezioni.
• andamento plano-altimetrico e
rappresentazione topografica:
o
o
o
o
o
o
scala;
curve di livello;
posizionamento della fonte idrica;
posizionamento della fonte di energia
disponibile;
strade esistenti, tubazioni esistenti, ecc;
ostacoli e servitù.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
24
Aspetti impiantistici (2)
•
Manodopera:
o
o
•
o
aspetti energetici:
o
o
o
•
o
disponibilità;
costo;
parametri di fornitura (voltaggio/potenza disponibili);
frequenza.
materiali di impianto:
o
o
o
•
disponibilità;
costo;
qualità.
o
tubi, raccordi, collanti, ecc;
disponibilità e costi;
fonti di ricambio disponibili;
fertilizzanti disponibili, ecc.
esecuzione:
o
o
o
tipo di scavi previsti e costi;
sovraintendente ai lavori disponibilità e costo;
andamento della temperatura durante la giornata.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
25
Metodi irrigui
• In viticoltura i metodi irrigui utilizzati sono
sostanzialmente due:
•
•
o
aspersione a pioggia:
microirrigazione.
entrambi del tipo “in pressione”:
•
•
26/10/2009
fronte di maggiori costi d’impianto e di spesa energetica
(richiedono infatti la presenza di macchinari e di attrezzature
specifiche):
assicurano una migliore efficienza ed uniformità.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
26
Aspersione: definizione
• L’irrigazione per aspersione prevede che l’acqua
giunga alle colture sottoforma di pioggia:
o
caratteri predominanti dell’impianto sono:
o
in viticoltura:
•
•
•
•
volumi medio-alti di acqua distribuita;
tempidi adacquamento contenuti;
lunghi intervalli tra una irrigazione e l’altra;
pressione dell’acqua medio-alta.
•
•
si utilizza l’aspersione sempre più raramente;
si utilizzano impianti fissi:
•
si hanno gli impianti mobili (tutti gli elementi dell’impianto devono
essere spostati):
26/10/2009
–
–
–
–
con comando manuale o automatico;
rete idraulica interrata;
comportano un elevato costo di impianto;
possono essere usati per la difesa antigelo e antibrina.
–
solo in caso di limitate superfici.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
27
Aspersione: funzioni
• L’acqua cade sul terreno e sulle
colture sotto forma di piccole
goccioline (irrigazione a pioggia):
o
svolge diverse funzioni:
•
umettante:
•
•
•
•
•
fertilizzante;
dilavante;
termica;
antiparassitaria;
sussidiaria.
26/10/2009
–
–
–
totalitaria (per tutto il ciclo di coltivazione);
ausiliaria (una tantum dopo trapianto);
di soccorso solo in caso di andamento
stagionale avverso.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
28
Aspersione: vantaggi e limiti
•
Vantaggi:
o
o
o
o
o
•
o
limiti:
o
o
o
o
o
26/10/2009
risparmio d’acqua rispetto ai sistemi di scorrimento;
possibilità di irrigare terreni non livellati o anche in
pendenza;
si evita la percolazione e il dilavamento dell’acqua e
delle sostanze fertilizzanti;
si limita l’erosione e il peggioramento della struttura
del suolo;
agevolmente automatizzabile;
possibilità di irrigare grandi superfici in poco tempo.
alti costi di impianto e di gestione (energetici);
alta sensibilità al vento;
elevato indice di manutenzione;
compattamento per effetto battente sul suolo;
bagnatura della parte epigea delle piante.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
29
Microirrigazione: introduzione
•
La microirrigazione:
o
o
o
somministrazione mirata dell’acqua alla pianta
attraverso una fitta rete di tubazioni provviste di
numerosi punti di erogazione:
•
sistema decisamente preferito in viticoltura.
•
mantenere nel terreno un livello ottimale di umidità:
•
ridurre i consumi idrici ed i consumi energetici:
•
•
massimizzare la possibilità di automazione;
elevata uniformità di distribuzione ed un’alta efficienza
irrigua.
consente di raggiungere quattro fondamentali
obiettivi:
–
–
–
–
piccoli volumi d’acqua;
lunghi tempi di adacquamento;
intervalli frequenti;
bassa pressione dell’acqua.
–
–
utilizza portate e pressioni ridotte;
risultano ridotte al minimi le perdite per evapotraspirazione
e per traspirazione delle piante infestanti.
elevati costi di impianto che possono variare da
2200 a 6500 €/ha (prezzi 2009).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
30
Microirrigazione: tipologie
• diverse tipologie di impianto:
o
o
a goccia: le portate sono generalmente comprese fra 2 e 16 L/h;
a spruzzo:
•
•
•
•
o
o
portate maggiori, generalmente 40 ÷ 80 litri/h;
pressione di esercizio di circa 2 bar;
minori tempi di adacquamento;
area bagnata risulta maggiore:
–
adatta ai terreni sciolti.
a manichette:
•
•
tubi in materiale plastico (PE o PP) forato o poroso;
normalmente floscio assume la sezione piena solo in fase di erogazione :
•
portate :10 ÷ 100 L/h per metro di manichetta.
•
l’acqua viene distribuita mediante tubazioni interrate ad una profondità di
30 ÷ 50 cm munite di fori, tagli, fessure o settori porosi.
–
acqua in pressione (0,4 ÷1,0 bar).
a subirrigazione capillare:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
31
Microirrigazione: vantaggi (1)
•
Risparmio di acqua (fino 50 %) e di energia:
o
o
o
•
•
•
o
tempi d’adacquamento prolungato;
turni frequenti (ogni 1 ÷ 3 giorni).
o
profondità di bagnatura costante e corretta.
uniformità di erogazione:
assenza di azione erosiva:
o
•
•
caratterizza l’irrigazione per scorrimento o per aspersione nel caso di
terreni in pendenza
assenza di rischio di asfissia radicali per appezzamenti in piano;
consentito l’entrata in campo delle macchine:
o
•
consente di sfruttare anche fonti di approvvigionamento minori.
contenuto d’umidità ottimale con continuità:
o
•
modeste portate (inferiori ai 10 L/h);
basse pressioni d’esercizio (tra 1 e 2 bar);
ridotta massa di terreno da inumidire;
durante e subito dopo l’irrigazione, in particolare nel caso di ali
interrate.
contenimento della crescita delle erbe infestanti;
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
32
Risparmio d’acqua
• Per ogni 100 m3 di fabbisogno irriguo netto di una
coltura:
o
o
con efficienza del 70% il volume lordo necessario e’ di
(100/0,7) = 142,9 m3;
con efficienza del 90% il volume lordo necessario e’ di
(100/0,9) = 111,1 m3;
•
il risparmio e’ di 142,9 - 111,1= 31,8 m3:
–
–
26/10/2009
pari al 22,25%;
con l’acqua risparmiata si può irrigare il 28,60% di superficie in
più.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
33
Uniformità di bagnatura
•Profondità di
•bagnatura
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
34
Microirrigazione: vantaggi (2)
•
•
•
•
Maggiori produzioni per ceppo ed un peso medio del grappolo,
associato ad una migliore concentrazione zuccherina;
possibilità di irrigare in presenza di vento:
o
possibilità di utilizzare acque fredde anche nelle ore più calde
della giornata;
possibilità di utilizzare acqua con salinità anche elevata :
o
•
•
•
•
senza subire perdite per evaporazione o disuniformità di erogazione;
si evita il contatto diretto con le foglie e viene mantenuta costantemente
una umidità elevata del terreno ed evitare così che i sali si concentrino
nella soluzione circolante;
possibilità di associare all’irrigazione la fertirrigazione;
applicabilità anche in appezzamenti a forte pendenza;
risparmio di manodopera grazie alla semplicità di automazione;
costi di impianto e di gestioni minori:
o
minori consumi energetici rispetto impianti ad aspersione per le minori
pressioni di esercizio necessarie.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
35
Microirrigazione: svantaggi
•
Rischio di occlusione degli erogatori:
o
o
o
o
•
•
•
•
annullare del tutto la portata degli erogatori;
progressivamente diminuisce l’uniformità di distribuzione;
•
•
•
•
solidi in sospensione (sabbia, limo, argille) ;
agenti biologici (semi, alghe, batteri;
depositi di ferro o zolfo a causa della presenza di ferrobatteri o solfobatteri;
precipitazione di bicarbonato di calcio e di magnesio;
•
•
•
sottoporre l’acqua ad analisi di laboratorio;
trattamento fisico di filtraggio;
trattamento chimico: aggiunta di cloro o di acido all’interno delle tubazioni.
causa:
dipende dai volumi erogati, dai turni e dalla durata dell’irrigazione;
gocciolatori ad orifizio più vulnerabili mentre i più protetti sono i gocciolatori a
labirinto con sezione di passaggio di almeno 1,4 mm (anche se interrati).
decisamente convenente operare per prevenire il fenomeno.:
danni prodotti da insetti (grillotalpa, coleotteri, ...);
non consente di:
o
o
distribuire antiparassitari sulla parte aerea delle colture;
ricorrere, nel caso degli irrigatori a goccia, all’irrigazione antigelo o
all’irrigazione climatizzante.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
36
Componenti di impianto (1)
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
37
Componenti di impianto (2)
•
•
•
•
Opera di presa: acquedotto in pressione, bacino di raccolta in quota, gruppo
pompante che preleva l’acqua da un pozzo, da un bacino di raccolta o da un corpo
idrico naturale;
condotta adduttrice: nel caso di impianti di grandi dimensioni collega l’opera di
presa con gli appezzamenti;
condotte principali: nel caso di impianti di grandi dimensioni collega fra loro i
diversi appezzamenti o i diversi settori;
testata di comando:
o
•
•
•
•
•
gruppo di filtraggio (solo per impianti di microirrigazione);
sistemi per la fertirrigazioni: dispositivi per il dosaggio, la distribuzione e la
miscelazione del fertilizzante (solo per impianti di microirrigazione);
condotta collettrice: distribuisce l’acqua alle diverse ali erogatrici;
valvole e filtri di settore;
ali distributrici per l’alimentazione degli erogatori:
o
•
con saracinesca generale, contatore, valvola di non ritorno e regolatore di pressione, sviati
dell’aria, flussometri, manometro, centraline elettroniche di controllo e comando, ...;
o
ali piovane, ali gocciolanti o ali disperdenti;
valvola per escludere la linea o per regolare la distribuzione di acqua;
erogatori.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
38
Pompe
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
39
Gruppo motore-pompa
•
Gruppo motore-pompa:
o
o
posto a monte dell’impianto, deve portare alla
pressione adatta l’acqua per irrigare;
costituito da:
•
•
•
motore a combustione interna (fisso o mobile) o
elettrico;
pompa.
la pompa e una macchina idraulica
operatrice:
o
serve per comunicare ad un fluido l’energia
meccanica trasmessale dal motore :
•
o
o
per sollevarlo, convogliarlo, metterlo in pressione,
per imprimergli una certa velocità, ecc.
può essere del tipo:
•
•
centrifugo: ad asse orizzontale o ad asse verticale;
a stantuffo.
•
•
in superficie;
sommersa.
in funzione della collocazione:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
40
Classificazione generale
• Le pompe sono classificate in funzione:
o
dell’impiego:
o
della pressione che forniscono;
del loro principio di funzionamento:
o
•
•
•
pompe di sollevamento;
pompe di spinta;
pompe di circolazione.
•
a stantuffo, centrifughe, ad ingranaggi, … .
• le pompe utilizzate in agricoltura per l’irrigazione
sono quelle centrifughe:
o
vantaggi:
•
•
•
•
26/10/2009
costi di impianto e di esercizio moderati;
poco peso e spazio;
possibilità di comando diretto da motori veloci, di strozzare
completamente la mandata;
trattare acque molto sporche.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
41
Classificazioni (2)
• in funzione della posizione
della pompa rispetto al pelo
libero:
–
pompe in aspirazione (aspirazione e
spinta):
» autoaddescanti, che aspirano
anche se sono vuote;
» non autoaddescanti, che aspirano
solo se sono piene;
–
pompe sottobattenti (solo operazione di
spinta).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
42
Potenza
• La potenza assorbita di una pompa è data dalla
seguente formula:
o
dove:
•
•
•
•
•
γ *Q * Ht
P=
1000 *η
P = potenza assorbita (kW);
g = peso specifico fluido (N/m3);
Q= portata (m3/h);
Ht= prevalenza (m);
h = rendimento (numero puro).
• nel caso di fluidi con massa volumica unitaria la
formula diventa:
Q*H
P=
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
t
102 *η
43
Potenza e rendimento
• La potenza assorbita è maggiore della potenza utile
(quest’ultima del tutto necessaria per operare):
o
definiscono il rendimento:
•
rapporto fra la potenza utile e quella assorbita”:
η =
•
p assorbita
valore sempre inferiore a 1:
–
–
o
p utile
in qualsiasi macchina si ha putile < passorbita;
presenza di attriti e perdite di potenza.
la potenza assorbita viene aumentata di circa il 30% per
assicurare una certa flessibilità di funzionamento.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
44
Prevalenza (1)
“è l’energia per unità di peso
che la pompa deve fornire
al fluido perché svolga il
compito previsto: superare
un dislivello, acquisizione
da parte del fluido di una
certa velocità e/o una certa
pressione”.
⎡ v2 P⎤
Ht = Hg + ⎢ + ⎥ + ∑Y
⎣ 2g γ ⎦
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
45
Prevalenza (2)
• Hg = prevalenza geodedica,
ovvero energia potenziale
necessaria per superare il
dislivello; si ha:
•
Ha = prevalenza geodedica di
aspirazione (solo per pompe in
aspirazione).
–
•
corrisponde alla distanza fra il pelo libero
del primo fluido al baricentro della pompa
(6 o 7 m massimi);
Hm = prevalenza geodedica di mandata:
–
26/10/2009
corrisponde alla distanza dal baricentro
della pompa fino al pelo libero finale.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
46
Prevalenza (3)
• Altre componenti della prevalenza necessarie per
contrastare tutto quello che impedisce od ostacola
il travaso. :
o
o
o
⎡ v2 ⎤
altezza cinetica, per fornire al fluido più velocità di ⎢ ⎥
efflusso;
⎣2g⎦
pressione di efflusso, quando si opera in
sovrappressione;
P
γ
perdite di carico avvenute durante il percorso.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
∑y
47
Perdite di carico distribuite
• Dette anche perdite continue:
•
•
•
sono attriti tubo-fluido e fluido-fluido; si
misurano in mm di colonna di fluido per m di
tubazione (o m/km) e rispecchia la seguente
equazione:
C * P * L *V 2
Y=
dove:
–
–
–
–
–
26/10/2009
S
C = coefficiente di scabrezza che tiene conto
del materiale e della rifinitura di esso
(considerando anche che le condizioni di
questo peggiorano col tempo;
P = diametro bagnato del tubo;
L = lunghezza della tubazione;
V = velocità del fluido trasferito (se v
raddoppia , le perdite quadruplicano);
S = sezione normale della corrente.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
48
Perdite di carico localizzate:
• Dette anche perdite concentrate:
•
26/10/2009
sono dovute a variazioni di sezione non graduali e raccordate
(bruschi restringimenti e/o allargamenti dovute a tubi e pezzi
speciali durante il percorso);
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
49
Perdite di carico localizzate
• Possono essere quantificate con la seguente
espressione:
V2
Y =k*
2g
•
dove k tiene conto dei cambi di sezione, direzione
ecc...
• in genere devono essere quantificate pezzo per pezzo:
•
•
o
valori calcolati sperimentalmente dai produttori
riportati su apposite tabelle e diagrammi, ed espressi in lunghezza
di tubazione equivalente (in m) per valutarne l’entità nelle perdite
distribuite.
per una valutazione in prima approssimazione si possono
quantificare pari al 10 % delle perdite distribuite.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
50
Grandezze caratteristiche (1)
• Le grandezze caratteristiche della pompa sono:
o
portata:
•
o
quantità di liquido che attraversa la pompa nell’unità di tempo;
prevalenza:
•
energia necessaria ad un kg di liquido per essere sollevato ad
una certa altezza considerando di dover vincere:
–
o
o
o
le resistenze, le perdite di carico e le perdite di potenza della pompa
stessa.
potenza idraulica;
rendimento;
NPSHR:
• carico all’aspirazione indicato dal costruttore.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
51
Grandezze caratteristiche (2)
• Portata, pressione e potenza
sono strettamente legate tra
loro:
•
•
o
la portata è proporzionale al numero
di giri compiuti, ovvero
raddoppiando i giri raddoppia la
portata.
la pressione raddoppiando il numero
di giri diventa quattro volte più
grande.
vengono rappresentate nelle
curve caratteristiche:
•
26/10/2009
in funzione del numero di giri.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
52
Curve caratteristiche
• “rappresentano, per una specifica categoria di pompe
l’andamento di prevalenza, potenza assorbita e
rendimento in funzione della portata”:
o
26/10/2009
consentono di scegliere, in base alla portata e alla prevalenza, i modelli
che assicurano il rendimento massimo.
Castellani Matteo
ing. Maines
e Gasperinatti
FernandoMattia
classe III^ S a.sc.
meccanica
2008/2009
viticola
53
Organi fondamentali
1.
2.
3.
4.
Girante;
distributore;
diffusore;
collettore.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
54
Elementi costitutivi (1)
• Girante: ruota munita di pale:
o
o
trasmettere al liquido l’energia fornita
dal motore accoppiato alla pompa;
può essere costituita in:
•
•
•
•
ghisa;
policarbonato;
resina termoplastica;
bronzo (per acque contenenti particelle
sabbiose).
• distributore:
o
è formato da elementi fissi … ;
•
•
… ricevono il liquido dal tubo di
aspirazione;
lo guidano con velocità e direzione
opportuna verso l’imboccatura della girante.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
55
Elementi costitutivi (2)
• Diffusore:
o
trasforma parte dell’energia cinetica
impartita al liquido dalla girante, in
energia di pressione.
• collettore:
o
ha il compito di raccogliere il liquido
all’uscita dalla girante o dal diffusore:
•
lo guida verso il tubo di mandata, di sezione
tale da diminuire ulteriormente la velocità del
liquido e quindi aumentarne la pressione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
56
Principio di funzionamento
• La girante ruota all’interno di una
camera chiusa (corpo o cassa):
o
o
determina per forza centrifuga una
depressione al centro dove è
collocata l’aspirazione.
l’acqua viene spinta verso la parte
periferica:
•
o
diffusore a sezione crescente converte
parte della velocità in pressione.
l’acqua raggiunge il collettore e il
tubo di mandata verso le condutture
di irrigazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
57
Classificazione pompe centrifughe
• In funzione al numero di giranti:
o
o
pompe monostadio (o unicellulari):
•
una sola girante;
•
più giranti sullo stesso albero.
multistadio (o pluristadio o multicellulari):
• in funzione all’architettura:
o
o
o
radiali;
assiali;
semiassiali;
• in funzione del motore di alimentazione
o
o
elettropompa;
motopompa.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
58
Pompe radiali ad asse orizzontale
• Pompa centrifuga ad asse orizzontale:
o
è una pompa ad una o più giranti:
•
•
•
o
o
o
motore è montato sull’asse;
aspirazione assiale;
mandata radiale verso l’alto.
non autoadescanti;
riescono ad operare con prevalenze negative che non devono
superare i 6 m;
il corpo della pompa è collegato tramite uno speciale raccordo al
motore creando un unico complesso monoblocco.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
59
Pompe radiali ad asse verticale (1)
•
Costituite da:
o
o
un robusto corpo pompa;
una colonna fissata alla piastra di staffaggio:
•
•
o
•
sopra è assicurata la lanterna che costituisce l'elemento di
fissaggio del motore elettrico;
sotto, supportato da un cuscinetto radiale, è fissata la girante
aperta.
il motore è montato in presa diretta tramite un giunto
elastico sull'albero della pompa.
la forma costruttiva consente lo smontaggio del
motore anche senza disinstallare la pompa stessa
dall'impianto.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
60
Pompe radiali ad asse verticale (2)
•
La girante:
o
o
•
•
solidale all'albero ed al motore elettrico,
montato in presa diretta;
messa in rotazione ad una velocità
prestabilita creando, per effetto centrifugo,
un'aspirazione sul condotto centrale e una
mandata sul condotto periferico.
devono essere esclusivamente installate
con l'asse disposto in verticale con la
pompa immersa in vasca;
necessari opportuni dispositivi per
disabilitare il funzionamento a secco e/o
la formazione di vortici ed eventuale
aspirazione di aria:
o
o
queste pompe devono funzionare
esclusivamente a pompa invasata;
il funzionamento a secco o in presenza di
bolle d'aria, può causare il danneggiamento
della boccola interna.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
61
Pompe assiali
• Mandata e aspirazione sono
poste sullo stesso asse.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
62
Pompe sommergibili
• Caratteristiche:
o
o
o
piccole pompe;
modeste portate;
prevalenze utilizzabili in piccoli
impianti per il prelievo di acque da
cisterna.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
63
Pompe sommerse (1)
• Costruita in un unico
blocco in asse verticale:
o
o
pompa a più giranti;
un motore elettrico ad
immersione posto nella
parte inferiore:
•
•
26/10/2009
griglia d’aspirazione nella
parte centrale;
valvola di sostegno nella
parte superiore.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
64
Pompe sommerse (2)
• Pompe indicata per il prelievo da
pozzi trivellati:
o
caratterizzati da:
•
•
o
sono sensibili alla sabbia, spesso
presente nei pozzi:
•
26/10/2009
una notevole profondità (oltre 6 m);
diametro limitato (10 cm).
può usurare le giranti che necessitano di
rapido ricambio.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
65
Pompe sommerse (2)
• Il moto è trasmesso
alla pompa da:
o
o
un motore elettrico
(elettropompe);
un motore endotermico
o dalla p.d.p del trattore
mediante un lungo asse
(moto pompe).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
66
Elettropompe
• Tipologia di macchine costituite da un lungo asse a
tenuta stagna:
o
trasmette il moto alla pompa che si trova immersa, anche a
profondità notevoli (250 m).
• sono costituite da:
o
o
o
corpo pompa;
linea d’assi;
gruppo di comando.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
67
Motopompe
• moto pompe.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
68
Sistemi di filtrazione
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
69
Premessa (1)
• L’efficienza del sistema di filtraggio è decisiva per
l’impianto microirriguo:
o
garantire l’assenza di ostruzioni causate da:
•
•
•
•
particelle inorganiche;
concrezioni calcaree;
composti ferrici e fosforici;
materiale organico: agenti biologici (batteri, mucillagini, alghe,
funghi, ...) o prodotti del loro metabolismo.
• le tipologie principali di filtri utilizzati sono:
o
o
o
filtri idrocicloni;
filtri a rete, a sabbia, a dischi lamellari
filtri a graniglia.
• la scelta dipende da:
o
o
o
il tipo di erogatore;
la portata da filtrare
fonte idrica di prelievo
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
70
Premessa (2)
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
71
Idrociclone: principio di
funzionamento
•
Acqua entra tangenzialmente:
o
azione della forza centrifuga generata dalla particolare conformazioni
delle pareti del filtro:
•
o
o
convoglia le impurità grossolane lungo le pareti stesse, le rallenta e le fa cadere
nel recipiente di raccolta.
l’acqua pulita viene sospinta in alto verso l’uscita.
il lavaggio del recipiente di raccolta viene eseguito aprendo la
saracinesca del contenitore.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
72
Idrociclone: struttura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
Entrata acqua;
movimento a vortice;
risalita dell’acqua;
risalita dell’acqua;
uscita dell’acqua;
recipiente di raccolta.
viene impiegato per rimuovere sabbia,
scorie e altre particelle più pesanti
dell’acqua;
• il filtro è in acciaio zincato, internamente
ricoperto con materiale epossidico (resina
antilogorante).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
73
Filtro a rete (1)
• È costituito da un contenitore in
acciaio zincato o in plastica, di
forma cilindrica chiuso da un
coperchio ermetico.
• sono presenti una rete con
maglia a fori larghi e una rete
con fori più piccoli:
o
o
funzionanti in contemporanea;
l’acqua entra attraverso la cartuccia
che porta le reti e trattiene le
impurità.
• può essere impiegato:
o
o
da solo, in presenza di acque non
provenienti da fonti a cielo aperto;
accoppiato a un filtro a graniglia o
idrociclone.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
74
Filtri a rete (2)
• Diverse tipologie:
o
filtri in linea:
•
•
•
•
•
o
dimensioni: dal 3/4” al 3”
cartuccia: in metallo, polyestere o dischi
portate: da 5 a 50 mc/h
pressione massima di funzionamento: 8
bar.
possono essere dotati di valvola di
scarico.
filtri a Tee:
•
•
•
•
diametri: da 2” a 3”
rete in inox o materiale plastico
mesh: da 20 a 450 (da 800 a 22 μm)
possono essere dotati di valvola di
scarico.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
75
Filtri a dischi (1)
•
•
È costituito da un corpo in plastica molto
resistente;
l’elemento filtrante è costituito da lamelle
circolari con superficie scabra:
o
o
•
•
per meglio trattenere le impurità dell’acqua.
le lamelle sono di diversi colori, e ad ogni colore
corrisponde un grado di filtrazione diverso.
utilizzato sia per separare sabbie sia per il
trattamento di acque superficiali, ricche di
alghe e sostanze colloidali.
per il lavaggio del filtro:
o
o
si svita il coperchio e si rimuove la molla o il
bullone che comprimono i dischi.
sistema di controlavaggio automatico:
•
26/10/2009
getti tangenziali generano una rotazione dei dischi che
unita alla forza centrifuga generata da un deflessero
elicoidale liberano la cartuccia dalle impurità.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
76
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
•STAZIONE DI FILTRAGGIO AUTOMATICA A DISCHI
77
Filtri a dischi (2)
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
78
Filtro a graniglia
•
Viene impiegato per l’acqua proveniente da dighe,
canali, fiumi, fossi:
o
oppone all’acqua sporca un ostacolo selettivo:
•
•
l’acqua penetra nel serbatoio contenente la graniglia
da un’apertura situata sulla sommità:
o
o
o
•
ghiaietto spaccato o elementi di quarzo, di pezzatura compresa
tra 1,5 e 5 mm.
si distribuisce in maniera omogenea sulla superficie della
graniglia;
attraversandone gli strati, viene purificata da alghe, terra
ed altre particelle grossolane;
le impurità si accumulano nello strato di graniglia e per
rimuoverle è necessario invertire il flusso dell’acqua.
il filtro ha forma cilindrica:
o
o
interamente in acciaio zincato;
internamente deve presentare un rivestimento
anticorrosivo, per contenere l’abrasione della graniglia
mossa dall’acqua.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
79
Filtro a graniglia: funzionamento
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
80
Filtro a sabbia
• Ha le stesse caratteristiche
costruttive del filtro a
graniglia:
o
o
o
l’elemento filtrante è costituito da
sabbia di più efficace potere
filtrante.
usato quando l’aspirazione
dell’acqua avviene da fonti a
cielo aperto.
ai filtri a sabbia vanno
necessariamente collegati dei
filtri a rete per impedire alla
sabbia di penetrare nell’impianto.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
81
Filtri autopulenti ed automatizzati
• L’automazione riguarda:
o
o
o
o
tempi di irrigazione;
chiusura e apertura valvole;
avviamento pompa;
lavaggio automatico filtro:
•
•
•
comporta un incremento dei costi di circa il 10-20% (in funzione del
grado di automazione di tutto l’impianto):
per i filtri che richiedono maggiore pulizia;
è presente un pressostato:
–
–
–
26/10/2009
rileva la differenza di pressione tra entrata ed uscita dell’acqua;
innesca la pulizia del filtro che avviene con degli ugelli che aspirano le
impurità e le scaricano all’esterno;
gli ugelli vengono messi in comunicazione con l’esterno del filtro:
»
differenza di pressione esistente tra esterno (pressione atmosferica) ed interno
(pressione dell’acqua nel filtro) costituisce il motore dell’aspirazione delle
impurità.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
82
•Problemi di origine
chimica
e biologica
Trattamento
chimico
dell
’acqua (1)
• Per contrastare lo sviluppo di alghe e di fanghiglia
batterica nella rete idrica e nell’impianto:
o
clorazione (ipoclorito di calcio, ipoclorito di sodio, gas di cloro):
•
•
•
o
trattamento continuo per impedire la crescita di alghe o batteri: 1 - 2
mg/litro;
trattamento intermittente per abbattere sviluppi eccessivi di alghe e batteri:
10 - 20 mg/litro;
superclorazione per disciogliere materiale organico che blocca gli
erogatori: 500 mg/litro per 24 ore.
solfato di rame (per i serbatoi):
•
da 0,05 a 2,0 mg/litro secondo le specie di alghe coinvolte e considerando i
primi 2 metri di profondità.
• sviluppo di precipitati solidi come carbonati e ferro:
o
o
o
ossigenazione e sedimentazione;
precipitazione con cloro;
controllo del pH.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
83
•Problemi di origine
chimica
e biologica
Trattamento
chimico
dell
’acqua (2)
• Iniezione di acido:
o
o
si effettuano per ridurre il ph e impedire la
precipitazione di solidi in soluzione come carbonati e
ferro;
composti consigliati:
•
•
•
•
o
acido ortofosforico;
acido idrocloridrico o muriatico;
acido solforico;
acido nitrico.
attenzione: aggiungere sempre l’acido all’acqua e non
aggiungere mai l’acqua all’acido.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
84
Le centraline di controllo e di
automazione
• L’automazione può riguardare:
o
o
o
o
o
l’avviamento e l’arresto delle stazioni pompanti;
la filtrazione, la regolazione della pressione,
il controllo delle portate;
l’intervento delle valvole di accesso ai diversi settori,
controllo ed interventi in caso di anomalie.
• Le centraline rendere più efficiente il controllo
dell’impianto grazie al collegamento con:
o
o
o
o
o
26/10/2009
regolatori di pressione ;
filtri e iniettori per la fertirrigazione;
manometri;
contatori volumetrici;
valvole a comando automatico.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
85
Le condotte
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
86
Condotte interrate
• Sono quelle sottoposte alle pressioni maggiori:
o
con pressioni nominali di esercizio fino a 16 atm ad una temperatura
media dell’acqua di 20 °C.
• si classificano in base alla funzione ed al diametro
(progressivamente decrescente):
o
o
o
condotta adduttrice con il compito di portare l’acqua dall’opera di
presa agli appezzamenti;
la condotta principale per collegare i vari appezzamenti;
le condotte collettrici (o secondarie o di testata);
• vasta gamma di diametri;
• percorsi da adottare per la stesura delle condotte:
o
o
o
andamento plano-altimetrico;
presenza di ostacoli;
caratteristiche meccaniche del terreno, … .
• in appezzamenti in forte pendenza è necessario installare:
o
o
valvole per lo svuotamento delle ali;
sfiati nelle parti più alte delle tubazioni per evitare depressioni.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
87
Materiali
•
•
•
•
Acciaio trattato (zincato o bituminato per protezione
contro l’aggressione di acqua e/o correnti vaganti);
alluminio;
polivinilcloruro (PVC): sempre meno usato;
polietilene alta densità (PEAD):
o
o
•
•
sempre più diffuso grazie a:
•
•
•
•
•
elevata resistenza agli aggressivi chimici, flessibilità;
costi ridotti e facilità di posa in opera, elevata durata;
leggerezza e conseguente facilità di trasporto;
il grado di rifinitura delle pareti interne;
l’elasticità del materiale permette di assorbire in parte i repentini
aumenti di pressione;
nella composizione vi è l’aggiunta di carbonblack
(nerofumo):
•
•
in percentuali non superiori al 2-3%;
migliora le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.
viene fornito in rotoli con lunghezze da 50 a 500 m;
nelle tubazioni ad alta densità è maggiore la
resistenza alla trazione, la durezza superficiale, la
resistenza ai solventi e l’impermeabilità a gas e
vapori.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
88
Condotte distributrici
•
Tubazioni che distribuiscono l’acqua agli
irrigatori:
o
o
ali piovane degli impianti ad aspersione;
ali gocciolanti negli impianti di
microirrigazione:
•
o
•
sospese lungo i filari ad uno dei fili di sostegno
della struttura portante ganci sagomati per
favorire la formazione delle gocce.
spruzzatori sottochioma si possono adottare
microtubi da ¼” in materiali plastici a ridotta
rigidità collegati ad una tubazione sospesa o
interrata.
generalmente in PE a bassa densità:
o
o
o
diametri da 16 a 315 mm;
pressioni nominali molto diverse (PN2,5 PN4 - PN6 - PN10 - PN16 - PN20 - PN25 PN32),
rotoli con lunghezze da 50 a 500 m.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
89
Tubazioni in PEad e PEbd
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
90
Tubazioni in lay flat
• Sono tubazioni flosce realizzate in PVC monostrato:
o
resistono a pressioni elevate (da 10 a 17 bar).
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
91
Danni provocati da insetti
•
•
•
•
Ferretti o elateridi;
piralide;
coleotteri;
...
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
92
Erogatori ed irrigatori
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
93
Irrigatori: definizione
• Sono gli organi distributori dell’acqua
sotto forma di pioggia artificiale e
determinano:
o
aspetti quantitativi:
•
o
•
altezza, intensità di precipitazione e portata (in
funzione della pressione)
caratteristiche qualitative:
•
•
dimensione delle gocce;
gittata.
•
rendendo minima l’azione battente delle gocce sul
terreno o sulle colture .
hanno il compito di spruzzare l’acqua in modo
uniforme:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
94
Irrigatori: classificazione (1)
• Esistono vari tipi di irrigatori:
o
in viticoltura si utilizzano irrigatori:
•
soprachioma:
–
–
a reazione esterna a braccio oscillante;
rotativi, con movimento discontinuo:
»
–
–
•
con un giro completo o a settore regolabile.
ad uno o due getti;
con rompigetto oscillante a bassa o media
pressione (getto intemittente).
sottochioma:
–
26/10/2009
fissi o dinamici.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
95
Irrigatori: classificazione (1)
•
Con riferimento all’intensità di
pioggia (rapporto tra portata
dell’irrigatore ( l/h) e area utile
bagnata (m^2):
o
o
o
•
o
o
o
o
•
•
•
•
•
lentissima (circa 3 mm/h);
lenta (5 mm/h);
media (5-10 mm/h);
alta (oltre 10 mm/h).
con riferimento alla pressione di
funzionamento (p):
o
• con riferimento alla gittata
(R):
o
a bassissima pressione:
•
p < 1,5 kg/cm2;
•
p da 1,5 a 2,5 kg/ cm2;
•
p da 2,5 a 5 kg/ cm2 ;
•
p > 5 kg/ cm2.
a bassa pressione:
d alta pressione:
26/10/2009
irrigatori a corta gittata
producono un adacquamento
più polverizzato rispetto a quelli
a lunga e lunghissima gittata;
•
a media pressione:
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
cortissima gittata R < 12 m;
corta gittata R da 12 a 20 m;
media gittata R da 20 a 35 m;
lunga gittata R da 35 a 50 m;
lunghissima gittata R > 50 m
("gettoni" o "cannoni") ;
il valore della pressione può
modificare questa caratteristica
qualitativa.
96
Disposizione degli irrigatori
• Esistono delle
disposizioni tipiche:
o
o
a quadrato, a rettangolo e a
triangolo.
in ogni caso si rende
necessario sovrapporre il
getto degli irrigatori:
•
o
per migiorare l’uniformità di
precipitazione.
le distanze tra irrigatori e ali
piovane devono risultare
multipli di sei metri:
•
26/10/2009
tubazioni piovane in
materiale metallico sono
costituite da singole tratte di
sei metri.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
97
Disposizione a quadrato
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
98
Disposizione a triangolo
• L’intensità di
pioggia è inferiore;
• l’orario di
adacquamento è
più lungo:
o
l’intensità oraria di
pioggia è inferiore.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
99
Irrigatori polivalenti
• Sono irrigatori:
o
o
soprachioma;
a “pioggia lenta”:
•
•
o
che possono essere usati
anche per:
•
•
•
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
intensità oraria inferiore
ai 5 mm/ora;
pressione superiore ai
2,5 bar.
la difesa antigelo e
antibrina;
distribuire fertilizzanti,
anticrittogamici ed
antiparassitari;
interventi climatizzanti.
100
Erogatori microirrigazione:
classificazione
• Gli erogatori degli impianti di microirrigazione:
o
dissipano la pressione interna alla tubazione;
scaricano all’esterno piccole portate orarie.
o
puntiforme (superficiale o sottosuperficiale):
o
• si classificano in base al metodo di erogazione:
o
•
lineare mediante gocciolatori posti ad una interdistanza
ravvicinata (inferiore ad 1 m) su apposite tubazioni costituite
da:
•
•
•
o
si utilizzano gocciolatori posti su ali distributrici ad interdistanze
costanti (generalmente maggiori di 1m);
tubi forati ad una camera;
tubi forati a camera doppia;
tubi porosi.
ad aspersione sotto chioma mediante spruzzatori che operano
la bagnatura di aree circolari (o di settori di cerchio) con una
ampiezza che varia da 1 a 10 m2.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
101
Gocciolatori (1)
• La tipologia più utilizzata è certamente
quella puntiforme con gocciolatori:
o
o
o
con portate da 2 a 20 L/h;
diametri del foro erogante di 0,4 ÷ 1,2 mm;
pressione di esercizio di 1 ÷ 3 bar.
• In base al meccanismo di dissipazione
del carico si distinguono in:
o
o
gocciolatori a lungo percorso tortuoso (a
spirale o a labirinto);
gocciolatori ad orifizio:
•
26/10/2009
l’acqua fuoriesce attraverso uno o più fori di
piccolissime dimensioni.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
102
Gocciolatori (2)
• Possono essere:
o
o
“on line” quando montati
in derivazione;
“in line” quando
costituiscono una continuità
della tubazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
103
On line
• Sono installati in derivazione
direttamente sulle tubazioni in
materiale plastico:
o
con diametri di 16 o 20 mm.
• si caratterizzano per:
o
o
o
o
o
o
economicità;
facilità di installazione;
affidabilità;
buone prestazioni:
•
con pressioni fra 0,5 e 8 bar.
•
si riduconoi rischi di sedimentazioni ed
occlusioni.
sono a flusso turbolento:
importante la presenza di regolatori di
pressione:
•
•
per mantenere la pressione costante,
evitare così danni o più semplicemente
indesiderate variazioni della portata.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
104
In line (1)
• Sono integrati all’interno della
tubazione a distanze prefissate
nell’ordine dei 20 ÷ 100 cm;
• si distinguono due tipologie:
o
o
quelli che occupano l’intera sezione del
tubo;
quelli che occupano una sola porzione
(ali gocciolanti integrali con erogatori
saldati all’interno dei tubi).
• coprono il 75 % del mercato:
o
con l’unica eccezione degli impianti
per frutteti a ritocchino dove, per
motivi pratici, si preferiscono ancora i
gocciolatori on line.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
105
In line (2)
• Le versioni compatte
presentano una lunghezza di
3,5 cm;
o
le bassissime perdite di carico
localizzate permettono, linee
più lunghe ed alte uniformità
di erogazione.
• versioni con sei fori per il
tandem:
o
diminuiscono le perdite per
percolazione profonda e
aumentano l’area bagnata
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
106
Ali gocciolanti (1)
•
Sono costituite da tubazioni in
polietilene nelle quali i gocciolatori
sono in line:
o
a seconda del materiale con cui sono
costruite possono essere:
•
•
•
–
–
–
manichette forate semplici;
le manichette a doppia camera;
ali munite di gocciolatori comuni posti al loro
interno.
gocciolatori sono inseriti nel tubo
durante la fase di estrusione dello
stesso:
o
gocciolatori coestrusi:
•
•
rigide
flosce:
a flusso turbolento con labirinto autopulente
e filtro incorporato.
gocciolatori a più fori per diminuire le
perdite per percolazione profonda e
aumentano l’area bagnata.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
107
Ali gocciolanti rigide (1)
• La famiglia delle ali rigide
comprende due categorie in
funzione delle modalità di
montaggio dei microerogatori:
o
o
ali gocciolanti “in line”, in cui i
microerogatori sono inseriti tra tratti
di tubo a distanze prefissate ed
occupano l’intera sezione del tubo;
ali gocciolanti “integrali”, in cui gli
erogatori sono saldati all’interno del
tubo, ed occupano una porzione della
sezione del tubo:
•
sono molto versatili:
–
–
26/10/2009
possibilità di poterle stendere sul suolo
lungo il filare;
è possibile adattare al meglio l’impianto
irriguo alle più diversificate forme di
allevamento e densità di piante.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
108
Ali gocciolanti rigide (2)
• Sospese all’ala
erogatrice con tanti
ganci quanto sono gli
erogatori:
o
gancio svolge il ruolo di
rompitratta:
•
26/10/2009
per evitare che le gocce
aderiscano alla condotta e
scivolino lungo la sua
superficie esterna basta.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
109
Gocciolatori autocompensanti (1)
• Assicurano la stessa portata al variare
della pressione:
o
grazie alla presenza di una membrana al
silicone incorporata nel gocciolatore:
•
mantiene costante il flusso (in un intervallo
di pressioni da 5 a 40 m.c.a.).
• da utilizzarsi quando si può verificare
una variazione significativa di
pressione di funzionamento tra il
primo e l’ultimo gocciolatore:
o
o
o
per impianti di grandi dimensioni;
su linee molto lunghe;
su terreni con una certa pendenza.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
110
Gocciolatori autocompensanti (2)
• Generalmente si tratta di
gocciolatore a flusso
turbolento con labirinto
autopulente e filtro
incorporato;
• tutti i gocciolatori
contemporaneamente:
o
o
cessano l’erogazione quando la
pressione nella tubazione è pari a
0,3;
torneranno in funzione quando la
pressione di esercizio sarà pari a
0,4 bar
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
111
Manichette forate
•
Condutture piatte (come dei nastri) stese e allacciate
all’alimentazione :
o
se alimentate si gonfiano facendo fuoriuscire l’acqua da
una serie di forellini :
•
o
con diametro da 0,4 a 4 mm ricavati a distanze prestabilite (da
10 a 50 cm).
diverse tipologie.
•
•
a parete singola, sulla quale la riduzione di pressione deve esser
garantita da fori di diametro molto contenuto;
a doppia parete (o a doppia camera).
–
–
o
o
o
o
o
a perdita di pressione si verifica nei fori fra la camera di erogazione e
quella di alimentazione;
fori di diametro superiore con minori problemi di intasamentio.
bassa pressione di funzionamento (0,3 ÷ 0,5 bar),
possibile presenza di un filtro interno e di un dispositivo
per la creazione di flusso turbolento.
alta qualità del labirinto, ottima resistenza all’occlusione;
alta uniformità anche in ali molto lunghe;
nessuna intrusione radicale.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
112
Microgetti a spruzzo (1)
•
•
•
Di solito vengono impiegati per la microirrigazione e
fertirrigazione di serre, orti e vivai, ma possono essere
utilizzati anche per frutteti e vigneti;
richiedono pressioni da 1 a 3 bar e accusano minori
problemi di intasamento:
o
fori compresi tra 0,5 e 4,5 mm e portate di 20 ÷ 100L/h.
Si dividono in statici:
o
o
sprayer a getto fisso);
dinamici (sprinklers a getto rotante):
•
•
ruotano mossi dalla deviazione del getto.
sono collegati all'ala piovana (esterna o interrata):
•
alcuni modelli sono concepiti per funzionare in posizione
capovolta.
–
26/10/2009
tramite tubicini di polietilene sui 6 mm di diametro, o con un'asticella
rigida cava, o direttamente sul tubo.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
113
Confronto goccia- spruzzo
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
114
Microgetti a spruzzo (2)
• Possono bagnare su settori circolari (di raggio
compreso fra 0,5 e 2,5 m) o su settori parziali (90°,
180°, 2x140°):
o
il raggio di bagnatura variada un minimo di 1 m e un
massimo di 5 m.
• danno origine a goccioline fini e hanno una buona
uniformità di copertura:
o
bassa intensità di pioggia con turni molto lunghi e bassa
probabilità di ruscellamento.
• le ali che alimentano gli spruzzatori possono essere:
o
fuori terra sospese ai fili della struttura portante:
•
o
in tal caso gli erogatori sono raccordati mediante tubicini di piccolo
diametro (8 ÷ 16 mm).
interrate.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
115
Prestazioni dei gocciolatori
• Si possono valutare mediante:
o
o
o
o
o
relazione portata-pressione;
variabilità costruttiva mediante il coefficiente di variazione
tecnologica (Cvt) espresso in %.
relazione portata-temperatura:
sensibilità all’occlusione:
•
•
•
molto sensibile per diametri minori di 0,7 mm;
mediamente sensibile per diametri compresi fra 0,7 e 1,5;
poco sensibile per diametri maggiori di 1,5.
•
sono maggiori nel caso di erogatori in linea al punto che le perdite
localizzate possono superare le perdite continue nella tubazione.
perdite di carico localizzate.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
116
Dimensionamento
• Per assicurare ad ogni pianta la giusta quantità d’acqua in
base all’effettivo fabbisogno idrico, si devono determinare:
o
o
o
numero e posizione dei punti di erogazione;
distanze fra gocciolatori in funzione.
dimensionamento viene fatto in funzione di:
•
•
•
al tipo di terreno (granulometria, …);
del clima e del terreno;
delle necessità specifiche della coltura.
• si possono utilizzare apposite tabelle ed abachi riportanti i
dati per il dimensionamento corretto.
o
ricavare la spaziatura ideale in funzione delle portate e delle
pressioni.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
117
Tabelle gocciolatori non
autocompensanti (1)
• Gocciolatori:
o
o
o
non autocompensanti;
ø 16 mm;
lunghezze consigliate
delle linee in metri:
•
in funzione
dell’uniformità di
emissione (E.U.%),
con una pressione di
esercizio di 1 bar.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
118
Tabelle gocciolatori non
autocompensanti (2)
• Tabella relativa alle
portate alle
differenti pressioni
di esercizio:
o
ottenute con la
seguente equazione
di flusso:
•
Q=KHX
–
dove:
»
»
»
26/10/2009
Q = Portata (l/h);
H = Pressione di
esercizio (mc.a.);
KeX=
constanti.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
119
Tabelle gocciolatori
autocompensanti (1)
• Gocciolatori:
o
o
o
o
autocompensanti;
ø 16 mm;
lunghezze consigliate
delle linee in metri:
in funzione
dell’uniformità di
emissione (E.U.%),
con una pressione di
esercizio di 1 bar
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
120
Tabelle gocciolatori
autocompensanti (2)
• Tabella relativa alle
diverse portate alle
differenti pressioni
di esercizio:
o
ottenute con la
seguente equazione
di flusso:
•
Q=KHX
–
dove:
»
»
»
26/10/2009
Q = Portata (l/h);
H = Pressione di
esercizio (mc.a.);
K e X = constanti.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
121
Pezzi speciali
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
122
Elementi generali
• Necessari per:
o
o
garantire la continuità delle linee di distribuzione e di erogazione;
per rendere efficiente il controllo (manuale o automatico) e la
manutenzione dell’intero sistema.
• sono generalmente in metallo o in materiali plastici ad
elevata resistenza meccanica e resistenza al deterioramento
atmosferico.
• principali tipologie:
o
raccordi filettati o a compressione:
•
•
o
o
o
o
o
per tubazioni di adduzione;
per ali gocciolanti.
giunti rapidi con ghiera di fissaggio;
prese a staffa;
valvole e saracinesche a comando manuale o elettrico , elettropneumatico, ...;
pozzetti di controllo;
... .
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
123
Tipologie (1)
• Giunti rapidi:
o
la ghiera di fissaggio garantisce ottime prestazioni di
funzionamento anche con tubazioni fuori norma.
• raccordi per ala gocciolante
o
tre differenti sistemi di connessione:
•
•
•
26/10/2009
con ghiera di fissaggio;
con anello di sicurezza;
barbati.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
124
Tipologie (2)
• Raccordi a compressione;
• giunti rapidi:
o
la ghiera di fissaggio garantisce
ottime prestazioni di funzionamento
anche con tubazioni fuori norma.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
125
Tipologie (3)
• Raccordi per tape;
• prese a staffa
o
o
o
o
adatte per PE e PVC;
dimensioni del foro per
assicurare le minime perdite
di carico;
anello di rinforzo in acciaio;
guarnizione NBR.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
126
Tipologie (4)
• Valvole a cilindro
o
o
o
due guarnizioni;
valvola bidirezionale;
massima pressione di
funzionamento: 6 bar;
• pozzetto di controllo valvole:
o
o
o
alta resistenza meccanica;
coperchio resistente ai raggi UV;
chiusura con bulloni;
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
127
La subirrigazione
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
128
Definizione
• Per subirrigazione si intende la pratica
microirrigua in cui l’acqua viene somministrata
alle colture mediante un impianto a goccia in
pressione posizionato ad una profondità variabile
dal piano campagna.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
129
Premesse agronomiche: vantaggi (1)
• I principali vantaggi sono:
1.
•
2.
3.
4.
5.
elevata efficienza dell’acqua irrigua e
conseguente risparmio di acqua:
il volume di terreno bagnato intorno al
punto di erogazione assume una forma
sferica con un aumento di circa il 45%, a
parità di acqua erogata, rispetto
all’irrigazione a goccia tradizionale;
minore probabilità di diffusione di
malattie fungine e minore crescita delle
erbe infestanti dato che la superficie
del terreno rimane asciutta;
minori perdite per evaporazione;
minori costi di manutenzione;
rischio quasi nullo di danneggiamento
causato dalle macchine o per atti di
vandalismo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
130
Premesse agronomiche: vantaggi (2)
6.
consente la completa meccanizzazione delle
operazioni colturali eliminando gli ostacoli
costituiti dalle tubazioni in superficie;
7. riduzione della richiesta di manodopera;
8. maggiore efficacia (in termini di precisione
e di tempestività) della fertirrigazione in
quanto la soluzione nutritiva viene
localizzata nella zona colonizzata dagli
apparati radicali;
9. minore competitività idrica da parte del
cotico erboso che può così essere
mantenuto al fine di contenere i fenomeni di
erosione;
10. transitabilità totale dell’appezzamento
durante le irrigazioni;
11. maggior durata dell’impianto;
12. possibile utilizzo di acque reflue.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
131
Premesse agronomiche: svantaggi
• I principali svantaggi sono:
o
o
costi di impianto elevati;
difficoltà recupero materiali:
•
il recupero delle ali è ancora un problema aperto
a molte ipotesi operative:
–
o
o
o
attenzione nelle lavorazioni del terreno;
filtraggi più spinti;
occlusioni dei fori di uscita dell’acqua da
parte degli apparati radicali:
•
diverse soluzioni:
–
–
o
bisogna sottolineare che il polietilene è un
materiale inquinante e quindi costituisce un
problema a livello normativo.
metodi meccanici (ad esempio l’adozione di fori
di uscita fessurati che si aprono per effetto della
pressione dell’acqua);
»
scarsi risultati.
metodi chimici: lenta cessione di erbicidi
nell’immediata vicinanza del foro.
terreno quasi perfettamente pianeggiante.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
132
Metodi chimici (1)
•
Miscelazione del Trifluralin in fase di
estrusione al polipropilene del
gocciolatore:
o
o
è poco tossico, con una bassa solubilità in
acqua, non è sistemico, non si accumula nel
terreno e non si muove nel terreno, si utilizza
in piccola quantità per ettaro;
cessione lenta, controllata e continua di
erbicida nel tempo in dosi uniformi:
•
•
•
26/10/2009
concentrazione sufficiente ad impedire la crescita
delle radici nel terreno circostante il gocciolatore;
il tempo di cessione varia con la temperatura:
–
–
a 80°C, il gocciolatore cede l’80% in peso di
principio attivo in 100 h;
a 23°C la stessa cessione avviene in 34 anni.
i residui nel terreno nei campioni delle sezioni di
terreno prelevate nei 10 cm immediatamente sopra
e sotto il livello di posa del gocciolatore, non hanno
mai raggiunto il livello minimo quantificabile (10
microgrammi/kg).
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
133
Metodi chimici (2)
• l’esperienza sul campo ha confermato i risultati
degli istituti di ricerca circa la totale assenza di
intrusioni di radici
• Gocciolatore protetto dopo 7 anni di irrigazione.
26/10/2009
•LA PROTEZIONE
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
134
Ali gocciolanti (1)
•
Sono in materiale plastico (PE):
o
o
o
atto ad operare a bassa pressione (minore di
1 bar);
prodotte appositamente per questo scopo;
vengono posate (ad ala singola o a doppia
fila per ciascun filare):
•
•
per ottenere un’ottimale uniformità è
indispensabile creare una rete sotterranea con
spaziature e portate dei gocciolatori adeguate;
ad una profondità di circa 15 ÷ 25 cm:
–
dipende dalle caratteristiche del terreno e dalle
caratteristiche del portainnesto:
»
–
o
l’acqua e gli eventuali fertilizzanti devono giungere
direttamente alle radici.
si tiene conto che l’apparato radicale della vite
raggiunge una profondità di circa 100 ÷ 200 cm,
con un massimo di capacità di estrazione fino alla
profondità di 80 cm.
sono da 16 o 20 mm con spessori di 1 ÷ 1,5
mm mentre le portate vanno da 1,5 a 15 L/h.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
135
Gocciolatori
• Si utilizzano gocciolatori:
o
coestrusi a flusso turbolento con labirinto
autopulente e filtro incorporato.:
•
o
la presenza di più fori diminuisce le perdite per
percolazione profonda e aumentano l’area
bagnata.
su appezzamenti in collina o con lunghezza
superiore ai 250 m è indispensabile
l’impiego di ali gocciolanti
autocompensanti:
•
assicurano una portata uniforme in un intervallo
di pressioni da 5 a 40 m.c.a..
• vengono utilizzate anche ali leggere:
o
o
con gocciolatore piatto coestruso a flusso
turbolento con labirinto autopulente e filtro
incorporato;
le dimensioni ridotte del gocciolatore
garantiscono basse perdite di carico.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
136
Aspetti progettuali
•
Per stabilire esattamente la profondità e l’interasse di posa dei sistemi
gocciolanti:
o
tali da soddisfare il fabbisogno idrico colturale tramite l’umettamento
dell’orizzonte di terreno esplorato dagli apparati radicali:
•
•
•
•
modelli di diffusione dell’acqua in un substrato di terreno asciutto;
analisi della capacità di estrazione della massima quantità di acqua da parte dell’apparato
radicale delle piante.
di solito questi sistemi gocciolanti, vengono interrati ad una profondità di
circa 10-15 cm.
la lunghezza degli appezzamenti ed il dislivello influiscono in maniera
diretta sulle scelte dei materiali da impiegare.
o
su appezzamenti in collina o con lunghezza superiore ai 250 m è indispensabile
l’impiego di ali gocciolanti autocompensanti.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
137
Capacità di estrazione
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
138
Diverse modalità di posa delle al
gocciolanti
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
139
Macchina posa tubi (1)
• Le attrezzature trainate (anche macchine
semoventi per controterzisti):
o
trattore appositamente equipaggiato con:
•
telaio, fissato ai tre punti del trattore che
sorregge il ripuntatore guida:
–
elemento che opera il taglio del terreno (apparato
discissore); e posa tubo
»
»
•
•
26/10/2009
i bordi di contatto tra il ripuntatore guida e il tubo
gocciolante devono essere privi di asperità per
agevolare sia l’entrata che lo scorrimento del tubo;
la posizione può essere regolata per l’ottenimento
di diverse profondità di posa e/o effettuare
l’interramento contemporaneo di più linee alla
volta.
porta bobina con speciale meccanismo che
consente lo srotolamento del tubo;
una frizione che assicura una certa tensione al
tubo stesso durante la posa.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
140
Macchina posa tubi (2)
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
141
Operatività (1)
• Immagazzinare l’ala erogatrice al riparo
dai raggi solari;
• assemblare e regolare l’interratore
secondo le esigenze;
• interramento delle ali gocciolanti dopo
verifica dei primi metri;
• preparazione degli scavi per
l’alloggiamento delle tubazioni;
• collegamento dei laterali alla testata e al
collettore di scarico;
• installazione dei gruppi di manovra, degli
sfiati d’aria e delle valvole di spurgo;
• lavaggio dell’impianto con scarichi aperti;
• messa in pressione del settore irriguo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
142
Operatività (2)
• Durante le operazioni è bene osservare
alcune accortezze:
o
o
o
o
o
lasciare 1 m di tubo fuori terra all’inizio per
poter effettuare i collegamenti alla linea di
alimentazione;
fermarlo alla estremità di partenza per evitare il
trascinamento;
controllare la giusta profondità di posa durante
l’avanzamento;
installare nei punti più a monte dei settori irrigui
degli sfiati d’aria per prevenire pericolose
aspirazioni di terreno dai fori dei gocciolatori
lasciare circa 1 m di tubo fuori terra nel punto
più a valle per potervi collegare le valvole di
spurgo;
•
lo stesso vale anche per i punti più a valle dei settori
costruiti ad anello.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
143
La fertirrigazione
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
144
Indice
•
•
•
•
•
Premesse agronomiche;
Struttura dell’impianto;
Centraline per l’irrigazione;
Centraline per la fertirrigazione;
Banchi di fertirrigazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
145
Definizione
• La fertirrigazione è una tecnica d’avanguardia mediante la
quale si incorporano i fertilizzanti nell'acqua
somministrandoli tramite l'impianto di irrigazione:
o
o
o
consente di gestire con accuratezza l’alimentazione idrico-minerale;
le coltivazioni esprimono al meglio le proprie potenzialità grazie ai
seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
localizzazione degli elementi nutritivi in prossimità dei peli radicali;
possibilità di intervenire in modo tempestivo e mirato;
miglioramento nel controllo di eventi parassitari;
utilizzo del sistema per distribuire alcuni fitofarmaci;
assenza di danni al sistema fogliare.
•
•
•
risparmio del consumo dei fertilizzanti;
raggiungimento della massima espressione della potenzialità produttiva;
riduzione generalizzata dei costi gestionali della coltura.
si raggiungono i seguenti obiettivi:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
146
Premesse agronomiche
•
•
•
•
E’ applicabile sia a pieno campo che per le
colture protette;
i migliori risultati si hanno in terreni
facilmente dilavabili, in cui per effetto della
stessa irrigazione viene alterata la naturale
fertilità;
questa tecnica è stata resa possibile dalla
diffusione della microirrigazione in risposta
alla sempre maggior scarsità idrica.
è possibile il raggiungimento di diversi
obiettivi:
o
•
o
risparmio economico e di manodopera;
maggiore efficienza agronomica.
la fertirrigazione eseguita con un sistema di
sub-irrigazione permette:
o
l’apporto degli elementi nutritivi poco mobili nel
terreno (per es., fosforo e potassio) proprio in
prossimità della parte assorbente dell’apparato
radicale.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
147
Premesse agronomiche
• La maggiore efficienza agronomica è data da:
o
o
efficienza di distribuzione:
•
•
•
–
i quantitativi di fertilizzante vengono controllati allo stesso modo di
come viene distribuita l’acqua tramite irrigazione a goccia.
efficienza nella nutrizione:
•
•
o
uniformità di distribuzione;
localizzazione precisa;
volume controllato:
soddisfazione degli effettivi fabbisogni della pianta in ciascuna fase
fenologica con concimazioni dinamiche.
miglioramento dell’assorbimento grazie alla somministrazione
intervallata.
rispetto dell’ambiente:
•
la localizzazione evita dispersione:
•
maggiore efficienza consente di ridurre le quantità di fertilizzante
ad ettaro.
26/10/2009
–
si riduce il rischio di contaminare falde e altre fonti idriche.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
148
Incompatibilità chimica
• E’ particolarmente importante verificare
l’eventuale incompatibilità fra diversi prodotti nel
caso si utilizzassero contemporaneamente più
fertilizzanti.
CONCIME
CO(NH2)2 NH4NO3
Urea
SI
Nitrato ammonico
SI
Solfato ammonico
SI
SI
Nitrato di calcio
SI
SI
Acido fosforico
SI
SI
Fosfato mono-ammonico - MAP
SI
SI
Fostato monopotassico
SI
SI
Nitrato di potassio
SI
SI
Nitrato di magnesio
SI
SI
Solfato di magnesio
SI
SI
Solfato di potassio
SI
SI
SI = MISCIBILE (COMPATIBILE)
26/10/2009
(NH 4)2SO4 Ca(NO3)2 H3PO4
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ML
SI
ML
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
ML
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
ML
SI
ML = MISCIBILITA' (COMPATIBILITA') LIMITATA
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
NH4H2PO4 KH2PO4 KNO3 Mg(NO3)2 MgSO4 K2SO4
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ML
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
ML
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
ML
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
ML
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO = NON MISCIBILE (COMPATIBILE)
149
Sistemi di distribuzione
• Un sistema per la fertirrigazione è costituito dai seguanti
elementi:
o
filtro primario:
•
o
o
o
riduttore e stabilizzatore di pressione per rallentare il flusso dell’acqua;
contenitori per le soluzioni dei fertilizzanti ed uno per la soluzione
dell’acido;
dispositivi di dosaggio (iniettore) delle soluzioni in linea o in vaso di
miscelazione:
•
o
o
o
o
si utilizzano principalmente filtri a quarzite ed a rete gestiti da una centralina
elettronica che aziona la loro pulizia automaticamente in quanto è necessario
assicurare un’elevata efficienza di filtrazione;
le apparecchiature si dividono in due gruppi:
–
–
attrezzature che sfruttano l’energia dell’acqua;
attrezzature che sfruttano fonti di energia esterna.
dispositivo di dosaggio dell’acido;
filtro per aiutare il mescolamento ed eliminare gli eventuali precipitati;
sonde per il monitoraggio del pH e della conducibilità elettrica (EC);
programmatore ed altri eventuali sistemi di automazione dell’intervento
irriguo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
150
Valvole (1)
• Valvola di non ritorno:
o
o
o
evitano il riflusso all’indietro dei fertilizzanti
nella sorgente d'acqua;
installate a monte del punto di iniezione;
sempre raccomandata, obbligatoria per taluni
regolamenti.
• valvola di rilascio del vuoto
(sull'iniezione):
o
impedisce la formazione di depressione nelle
tubature a impianto fermo per deflusso
dell’acqua dagli ugelli;
•
o
depressione potrebbe richiamare fertilizzante con
erogazione di una soluzione ad elevata
concentrazione alla successiva accensione
dell’impianto.
da installarsi più in alto del livello della
soluzione fertilizzante nel serbatoio.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
151
Valvole (2)
• Valvola di rilascio del vuoto e dell'aria
(sull’impianto di irrigazione):
o
la presenza dei volumi incontrollati di aria
all'interno dell'impianto di irrigazione può
avere serie ripercussioni sulle prestazioni del
sistema:
•
•
•
o
collasso delle pareti delle tubazioni;
corrosioni come conseguenza della cavitazione;
ridotta accuratezza delle portate di acqua per
diminuzione dei calibri.
installazione lungo l'impianto di irrigazione.
• altri dispositivi di controllo:
o
o
o
o
valvole di regolazione;
manometri;
contatori per il controllo dei volumi erogati;
centraline di comando per l’automazione
dell’impianto
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
152
Serbatoi
• Devono essere posizionati all’interno di una struttura
che sia in grado di proteggerli dai rischi di
rovesciamento;
• costruiti in polietilene, in vetroresina o in acciaio
inossidabile;
• la valvola di uscita deve essere installata a 4 - 8
centimetri dal fondo del serbatoio:
o
o
eventuali residui o materiali depositati non vengono
risucchiati nel flusso dell’irrigazione;
una valvola di scarico sul fondo sarà utile nel caso sia
necessario lo svuotamento completo del serbatoio.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
153
I sistemi d’iniezione e dosaggio
• Sono dispositivi più o meno complessi che:
o
o
aspirano e dosano la soluzione nutritiva concentrata da una
vasca;
operano una diluizione per iniettarla nel flusso dell’acqua
d’irrigazione che arriverà alle colture.
• l’immissione dei fertilizzanti in linea può avvenire:
o
o
con sistemi tradizionali di iniezione:
•
•
•
serbatoio fertirrigatore con by-pass;
dispositivi di aspirazione Venturi;
pompe ad iniezione con diversi gradi di automazione:
–
–
pompe idrauliche;
pompe elettriche.
sistemi tecnologicamente evoluti:
•
26/10/2009
sistemi completamente preassemblati (banchi di fertirrigazione):
–
permettono il controllo dell’impianto attraverso il monitoraggio dei
valori di portata, del pH e/o della conducibilità elettrica.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
154
Sistemi tradizionali per il dosaggio
• Si possono classificare in base:
o
all’energia utilizzata:
•
•
o
energia meccanica ricavata dalla pressione dell’acqua;
energia elettrica;
in base al modo di controllare il dosaggio:
•
•
26/10/2009
controllo volumetrico;
controllo proporzionale ad un valore di pH o di conducibilità
elettrica preimpostato.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
155
Serbatoio fertirrigatore con by-pass
• Adottati nelle prime applicazioni
di fertirrigazione erano:
o
o
contenitore di fertilizzante;
una valvola collegata alla linea di
irrigazione:
•
•
l’apertura della valvola permette
all’acqua di entrare e attraversare il
serbatoio, sciogliendo e trasportando il
fertilizzante con l’acqua di irrigazione.
valvola di uscita collegata ad una
seconda tubazione di ugual diametro di
quella d’entrata:
–
o
immette la soluzione nella linea
principale.
svantaggio fondamentale:
•
concentrazione della soluzione non
uniforme.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
156
Sistemi che sfruttano l’energia
dell’acqua (1)
• Il sistema più semplice è il
tubo di Venturi che sfruttano
il principio fisico del tubo di
venturi:
o
o
o
l’improvviso passaggio
dell’acqua da una sezione più
piccola ad una più grande
provoca una depressione che
viene sfruttata per aspirare una
soluzione esterna attraverso un
tubicino più sottile;
viene montato su un bypass della
linea principale;
al foro di aspirazione viene
attaccato un pescante con un
rubinetto che funge da regolatore
di flusso del fertilizzante.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
157
Sistemi che sfruttano l’energia
dell’acqua (2)
•
Sistema si caratterizza per:
o
o
o
o
il basso costo:
•
•
la semplicità di installazione e di
utilizzo;
la ridotta manutenzione e l’indipendenza
da qualunque fonte energetica;
il rapporto di diluizione non risulta
costante ma dipende dalla portata:
•
•
la costruzione del dispositivo è semplice;
non è necessaria energia elettrica ma
richiede energia idraulica.
con conseguente variazione di pH e di EC
della soluzione risultante.
è molto sensibile alle variazioni di
pressione:
o
deve essere impiegato solo nelle
situazioni in cui le condizioni di
funzionamento dell’impianto sono
conosciute e stabili.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
158
Pompe meccaniche
• Le pompe proporzionali:
o
o
si basano su di un sistema meccanicoidraulico che non necessita di energia
sistema è controllato da un PLC
(programmable logic controller):
• le pompe meccaniche a dosaggio
volumetrico:
o
di tipo a stantuffo che sfrutta la
pressione dell’acqua di passaggio:
•
•
•
aziona un sistema di aspirazione dal
serbatoio del fertilizzante operante in
modo proporzionale alla portata passante
per lo strumento.
possono essere montate in linea o in bypass,
hanno portate di esercizio che variano da
0,5 a 40 m3/h ed un rapporti di dosaggio
da 0,2 a 2 %.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
159
Pompe elettriche
•
Le pompe elettriche a dosaggio
volumetrico:
o
o
o
o
•
a membrana o a pistoni
controllate da un conta litri meccanico o
elettronico atto ad inviare un segnale
proporzionale al flusso idrico, da cui dipende
la velocità di pompaggio;
un sistema abbastanza economico, facilmente
automatizzabile;
non molto preciso (richiede un continuo
monitoraggio e continui aggiustamenti).
le pompe elettriche a dosaggio
proporzionale:
o
comandate da una scheda elettronica che
imposta la velocità:
•
in base alla differenza del valore di pH o più
comunemente di EC, fra il valore prefissato con la
centralina di controllo e il valore misurato dalla
sonda.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
160
Piaccametro e conduttivimetro
• Misurano pH (pHmetro) e la conducibilità
elettrica:
o
devono essere collocati abbastanza lontani dal punto di
iniezione per operare la misurazione su un flusso ormai
ben miscelato:
•
o
necessaria la presenza, prima delle sonde, di un filtro a dischi
che svolge anche il compito di diffusore.
la precisione delle misure viene aumentata ponendo le
sonde su di una deviazione di by-pass sulla linea
principale:
•
26/10/2009
la precisione è inversamente proporzionale alla pressione idrica.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
161
Centraline
• Sono dispositivi di gestione e
controllo computerizzati della
fertirrigazione:
o
o
o
consentono di gestire l’impianto con
maggior precisione:
•
soprattutto su impianti di microirrigazione.
•
aumenta l’efficienza e la capacità di
soddisfare diverse esigenze.
consentono molte opzioni:
operano in funzione di parametri
ambientali, e/o colturali:
•
l’umidità del substrato e la % del
drenaggio, fase fenologica delle piante, … .
• vi sono due tipi di centraline:
o
o
programmatori;
banchi di fertirrigazione.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
162
Centraline (2)
• Svolgono le seguenti attività:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ricevono ed organizzano gli input dei
sensori;
organizzano i turni irrigui (durata,
periodicità e ciclicità);
monitorizzano il sistema ed avvertono
con allarmi;
organizzano la fertirrigazione;
gestiscono la pulizia dei filtri;
effettuano l’iniezione percentuale da
uno a diversi fertilizzanti e di un acido;
controllano in tempo reale del pH e EC;
interagiscono con sensori esterni;
gestiscono il controlavaggio dei filtri.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
163
Centraline (3)
• Consentono di irrigare a settori:
o
o
o
dispongono fino a 100 uscite per
comandare in maniera autonoma le
diverse valvole;
la suddivisione in settori consente di
utilizzare pompe di dimensioni ridotte.
per ogni settore si può:
•
•
•
•
o
impostare svariati programmi;
escluderne alcuni;
aumentare la durata del turno
d’irrigazione nelle zone più sciolte o più
esposte;
farli partire in serie dal primo all’ultimo
ad orari preimpostati.
consentono di operare concimazioni
dinamiche, apportando quindi la
quantità di fertilizzante necessaria per
ciascuna fase fenologica.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
164
Centraline (4)
• Possibilità di memorizzare i cicli
irrigui effettuati e la quantità di
fertilizzanti usati;
• capacità di monitorare la portata
dell’acqua mediante contalitri ad
impulsi;
• possono comandare fino a sei pompe
dosatrici:
o
o
collegate ad un numero uguale di
serbatoicontenenti il fertilizzante
concentrato;
una o due serbatoi per il dosaggio
dell’acido:
•
usato per abbassare il ph dell’acqua di
irrigazione evitando cosi l’occlusione dei
gocciolatori dovuta alla formazione di sali
derivati dai fertilizzanti.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
165
Centraline (5)
• Sono dotate di sistemi per il
controllo del ph:
o
regolano l’eventuale immissione di
acido se questo si alza troppo;
• viene monitorata la
conducibilità elettrica:
o
valuta la concentrazione di
fertilizzante.
• prevede l’interruzione
dell’immissione di fertilizzante
prima di passare alla zona
successiva o al turno successivo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
166
Schema di un impianto completo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
167
Banchi di fertirrigazione
• Sul mercato sono presenti
stazioni di fertirrigazione
complete:
o
vanno solo inserite sulla linea
principale che collega la
fonte idrica ai vari settori.
• sono complete di:
o
o
o
o
o
centralina;
quadro elettrico.
serbatoio suddiviso per i
diversi fertilizzanti e l’acido;
elettrovalvole dosatrici;
elettropompa.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
168
Optional
• Le centraline sono dotate di vari optional
per migliorarne ulteriormente
l’efficienza:
o
o
il sensore di pioggia o di umidità che bloccano
o avviano i programmi automaticamente solo
quando si rende necessario.
il collegamento al pc o ad una stampante:
•
•
o
possibile impostare le variabili della centralina e i
turni di irrigazione e fertilizzazione utilizzando
software specifici e di facile utilizzo;
si possono stampare i dati memorizzati dalla
centralina per avere un resoconto sulle analisi e
sui turni effettuati.
sistema gsm:
•
avvisa tramite sms l’agricoltore nel caso vi siano
malfunzionamenti o necessità di manutenzione
come il riempimento del serbatoio.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
169
Manutenzione dell’impianto (1)
• Serbatoi:
o
o
risciacquo per eliminare i residui alla fine di ogni ciclo di
fertirrigazione e quando si cambia tipo di fertilizzante.
quando non vengono usati, di devono mantenere puliti ed asciutti:
•
o
le valvole: controllate e mantenute pulite:
•
• filtri:
o
o
o
o
se di metallo lasciati riempiti di acqua pulita, per evitare l'ossidazione ed
impedire la corrosione.
nel caso di perdite o di corrosione, bisogna intervenire tempestivamente.
si deve evitare l’eccessivo accumulo di sporco (può portare al
bloccaggio dell'impianto di irrigazione o influenzare negativamente
l'uniformità di distribuzione dell'acqua);
pulizia periodica mediante lavaggio con un flusso inverso di acqua
pulita;
dove esiste la valvola di deflusso manuale:
•
questa dovrebbe essere aperta periodicamente per vuotare lo sporco;
•
la pulizia del filtro dovrebbe essere controllata manualmente di tanto in tanto.
nel caso di lavaggio automatico:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
170
Manutenzione dell’impianto (2)
•
•
Lavaggio delle tubazioni:
o
lo sporco si accumula solitamente all'estremità delle linee di irrigazione:
o
almeno due lavaggi:
•
•
per sedimentazione dovuta alla diminuzione della velocità del flusso e la precipitazione dei
residui.
una volta durante stagione irrigua ed una volta alla fine;
seguendo il senso del flusso:
–
–
cominciando dalla testata ed filtri dell’impianto;
seguiti dalle estremità aperte della linea principale, le linee secondarie ,e infine, le prese
laterali (non più di 5 linee simultaneamente, per mantenere elevata la velocità del flusso).
Trattamento (iniezione) con acido:
o
o
o
•
•
per eliminare le incrostazioni saline al livello degli ugelli;
ad una concentrazione specifica e per un periodo di tempo specifico per ciascun
impianto;
efficace solo all'inizio del processo di incrostazione, quando gli ugelli sono
soltanto parzialmente bloccati (inutile se gli erogatori sono completamente o
quasi completamente bloccati.
verifica dei sistemi di misurazione della pressione, della portata.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
171
La progettazione di un
impianto di irrigazione
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
172
Analisi preliminari
• Necessario studio preliminare che richiede:
o
o
competenze di ambiti diversi: geologico, morfologico,
podologico, climatico, agronomico, tecnologico, ... ;
conoscenze specifiche a discipline quali l’agronomia, la
geologia o l’ingegneria.
• le principali fasi di progettazione sono:
o
o
o
o
o
o
raccolta dei dati;
progettazione preliminare;
scelta dello schema di impianto;
progettazione idraulica;
scelta e dimensionamento dell’eventuale impianto di
pompaggio;
preparazione degli schemi e delle istruzioni per la gestione
dell’impianto.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
173
Raccolta dati
•
Necessari per definire correttamente e completamente l’ambito
colturale in cui si dovrà operare e tutte le condizioni più
significative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
26/10/2009
ubicazione e clima;
analisi delle fonti di approvvigionamento;
qualità dell’acqua;
caratteristiche del terreno e relazioni acqua – terreno (elementi che
partecipano a definire il profilo umido del terreno);
caratteristiche dimensionali del vigneto;
pratiche colturali;
caratteristiche fisiologiche del vitigno e fabbisogni idrici;
fabbisogno di nutrienti;
caratteristiche aziendali;
aspetti energetici;
disponibilità in loco di imprese specializzate nella realizzazione e
nella manutenzione degli impianti di irrigazione e dei materiali per la
loro realizzazione.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
174
Dati significativi (1)
• Ubicazione e clima:
o
o
o
o
o
o
o
o
latitudine;
altitudine;
andamento delle temperature;
andamento dell’umidità relativa media nelle varie stagioni;
radiazione solare;
piovosità e distribuzione delle precipitazioni;
rischio di gelate e necessità di protezioni;
andamento plano-altimetrico espresso mediante una
rappresentazione cartografica in scala opportuna,
comprendente le curve di livello. E’ importante, inoltre, che
la rappresentazione evidenzi anche la viabilità esistente, le
tubazioni presenti, gli ostacoli e le eventuali servitù, il
posizionamento della fonte idrica e della fonte di energia
disponibile.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
175
Dati significativi (2)
• Analisi delle fonti di approvvigionamento:
o
o
o
o
o
o
tipologia (cisterna, pozzo, sorgente, laghetto collinare, fiume o
acquedotto consortile, impianto di depurazione, ...);
portata e pressione disponibili alla fonte;
limiti di portata, di volume (turni e orari di rifornimento) o di
tempo;
pressioni e livelli idrici stagionali;
livello dinamico del pozzo nelle varie stagioni;
costi.
• qualità dell’acqua:
o
o
o
o
o
materiali solidi in sospensione (ppm);
minerali disciolti (sono necessarie le relative analisi di laboratorio
per la determinazione di salinità, contenuto in Na, Ca, ...);
pH;
variazioni qualitative periodiche;
temperatura dell’acqua.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
176
Dati significativi (3)
• Caratteristiche del terreno e relazioni acqua – terreno
(elementi che partecipano a definire il profilo umido del
terreno):
o
o
o
o
o
o
o
tipologia;
tessitura;
salinità;
pH;
permeabilità (l’acqua si muove nel terreno per percolazione e per
capillarità);
movimenti laterali e verticali dell’acqua;
ritenzione idrica.
• caratteristiche dimensionali del vigneto:
o
o
o
superficie vitata;
forma di allevamento e sesto di impianto;
orientamento e lunghezza delle file.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
177
Dati significativi (4)
• Pratiche colturali:
o
o
o
o
tecnica di trapianto ed attrezzature utilizzate;
metodologia di gestione dell’interfilare;
pratiche colturali specifiche;
tipo di raccolta e attrezzature utilizzate.
• caratteristiche fisiologiche del vitigno e fabbisogni idrici:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
vitigno, portainnesto;
estensione e profondità dell’apparato radicale;
resistenza alla siccità;
tolleranza alla salinità;
evapotraspirazione potenziale (ETP);
fattori colturali (Kc);
piogge efficaci;
fabbisogni in fase di trapianto;
fabbisogni di lisciviazione (frequenza e volumi);
fabbisogni di protezione dal gelo.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
178
Dati significativi (5)
• Fabbisogno di nutrienti:
o
o
o
tipo di fertilizzanti;
metodo di somministrazione;
epoche e frequenza di applicazione.
• caratteristiche aziendali:
o
o
o
o
o
o
tipo di conduzione;
disponibilità della manodopera e relativi costi;
qualità della manodopera;
disponibilità finanziaria;
esperienza nella gestione delle tecniche di irrigazione;
capacità gestionali del responsabile e propensione all’innovazione.
• aspetti energetici:
o
o
o
disponibilità ed affidabilità;
costo;
parametri di fornitura (frequenza, voltaggio e potenza disponibile).
• disponibilità in loco di imprese specializzate.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
179
Pianificazione
• Per definire:
o
o
o
quando irrigare e quanta acqua somministrare;
determinare i fabbisogni;
definire i turni:
•
o
l’introduzione dei sistemi di automazione consente di adottare
turni molto brevi come previsto dai sistemi di irrigazione ad
altissima frequenza.
calcolare il volume di adacquamento da cui dipende la
durata di erogazione e la portata oraria di punta.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
180
Fabbisogno irriguo (1)
• Quantità di acqua da somministrare con l’irrigazione in una
determinata unità di tempo:
• dipende da diversi fattori fra i quali spicca
l’evapotraspirazione.:
o
o
misurata mediante attrezzature complesse e l’intervento di
personale specializzato;
stimata mediante :
•
•
•
•
il metodo del bilancio energetico,
i metodi microclimatici;
il bilancio dell’acqua nel suolo;
la stima attraverso dati climatici oppure mediante misure evaporimetriche.:
–
–
metodo viene preferito per la semplicità e la capacità di fornire buoni risultati
soprattutto come valor medio di periodi di almeno 10 giorni,
il valore ottenuto in campo (generalmente si utilizza l’evaporimetro di Classe A)
deve essere corretto mediante un coefficiente colturale KC che dipende dal tipo
di coltura, dalle caratteristiche climatiche (umidità e ventosità), dal grado di
copertura del terreno e dalla fase vegetativa:
»
26/10/2009
nel caso della vite da vino i valori da adottare sono 0,30 (fino ad un grado di
copertura del 10%), 0,70 (per una copertura dal 10 % fino alla piena copertura) e
0,45 dalla maturazione al raccolto.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
181
Fabbisogno irriguo (2)
• Individuato il valore corretto dell’evapotraspirazione, è
possibile stimare il fabbisogno irriguo in funzione di:
o
capacità di campo (quantità di acqua che un terreno ben drenato
trattiene in contrasto con la forza di gravità) da cui dipende:
•
•
o
•
l’acqua disponibile totale;
l’acqua facilmente disponibile (l’acqua che la pianta può assorbire senza
stress);
il coefficiente di stress.
•
•
•
•
•
•
l’evapotraspirazione colturale;
la pioggia totale;
la risalita capillare dalla falda superficiale;
il deflusso superficiale;
la percolazione profonda;
la variazione del contenuto idrico del suolo.
il metodo più utilizzato è quello del bilancio idrico del suolo, nella
cui equazione rientrano:
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
182
Volume di adacquamento
•
•
E’ la quantità di acqua che viene somministrata in un adacquamento
espressa in m3/ha o in mm di acqua (altezza di adacquamento) che
bisogna somministrare al terreno per portare l’umidità in condizioni
ottimali per un prefissato spessore di terreno, in modo da evitare stress
alle piante senza che il contenuto idrico del terreno superi la capacità
di campo (cosa che comporterebbe perdite per percolazione
profonda);
dipende da:
o
o
o
o
•
o
le caratteristiche climatiche del luogo;
le caratteristiche del terreno;
lo sviluppo vegetativo del vigneto;
l’andamento climatico stagionale; il sistema di irrigazione;
le condizioni di umidità prima dell’intervento.
il volume può essere somministrato frazionandolo in più parti secondo
il criterio dell’irrigazione ad alta frequenza:
o
si deve evitare il raggiungimento del punto di appassimento che rappresenta il
contenuto idrico del terreno quando l’assorbimento è uguale a zero.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
183
Il turno
•
•
Intervallo di tempo (in giorni o in ore) tra l’inizio di due adacquamento
consecutivi.
la programmazione degli interventi irrigui può seguire diverse modalità:
o
o
o
•
per una corretta determinazione del momento in cui irrigare è fondamentale.
o
o
o
•
turno e volume fisso: questo criterio, di facile strutturazione, si caratterizza per la bassa
efficienza fisiologica e idrologica;
turno fisso e volume variabile;
turno e volume variabile: la programmazione può basarsi sul livello idrico del suolo,
calcolato in funzione delle varie fasi del ciclo vegetativo utilizzando modelli ideologici
che possono essere integrati con tecnologie di elevato livello (GIS, GPSR; ...).
o
il continuo monitoraggio della pianta,
il controllo dell’umidità o della tensione dell’acqua nel terreno;
un continuo aggiornamento del bilancio idrologico.
una accurata conoscenza dei fabbisogni idrici del vigneto
in viticoltura è possibile contribuire a migliorare la qualità delle produzioni
adottando metodologie di irrigazione in condizione di stress controllato:
o
prevede la somministrazione di volumi irrigui corrispondenti al 50% circa del valore
ottenuto con la stima dell’evapotraspirazione colturale:
•
•
26/10/2009
è possibile ottenere l’equilibrio ottimale tra sviluppo vegetativo di chioma e radici;
una crescita dei frutti e differenziazione a fiore delle gemme.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
184
Efficienza
• Tutto il processo di analisi e di progettazione deve
basarsi su principi di:
o
efficienza idrologica espressa in percento sul volume o in
altezza di colonna d’acqua, in riferimento alle diverse
destinazioni che avrà l’acqua somministrata:
•
•
o
evaporazione, traspirazione, infiltrazione, percolazione profonda,
deflusso superficiale, …);
l’efficienza potenziale (per ricordare che tali valori in realtà
assumono valori minori a causa di elementi legati a problemi
gestionali) varia :
–
per gli impianti fissi a media-bassa intensità di pioggia:
–
per gli impianti di microirrigazione:
»
»
dal 60% per ambienti aridi e in presenza di vento, all’85% per climi freddi e
basse velocità di vento;
90% per gli impianti a goccia e l’85% per quelli a spruzzo.
uniformità di distribuzione:
•
26/10/2009
il rapporto tra l’altezza d’acqua infiltrata nella zona del campo che
ne riceve meno e quella media.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
185
Scelta del metodo irriguo
• La scelta del metodo irriguo e del tipo di impianto da
adottare può essere fatta in 5 fasi:
o
o
o
o
o
identificazione degli obiettivi, generalmente rappresentati dal
massimo rapporto benefici/costi;
individuazione di tutti i possibili vincoli economici,
ambientali ed amministrativi, in base alle caratteristiche del
sito di realizzazione analizzate nella precedente fase di
raccolta di dati;
preselezione di uno o più tipo di impianto con caratteristiche
idonee;
progettazione ed analisi economica degli impianti
individuati;
confronto dei risultati per la scelta della soluzione meglio
rispondente agli obiettivi.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
186
Progettazione preliminare (1)
• Determinazione delle principali variabili di
progetto:
o
o
altezza di adacquamento lorda;
portata di punta:
•
o
si richiede la scelta della durata giornaliera massima di
funzionamento dell’impianto, il turno in giorni e dipende dalla
superficie da irrigare e dall’altezza di adacquamento;
intensità di pioggia ideale (valore minimo si può
assumere, in condizioni climatiche favorevoli una
intensità di 2 ÷ 3 mm/h) dipende:
•
•
•
26/10/2009
dal tipo di terreno;
dalla pendenza;
dalle condizioni climatiche (temperatura, presenza di vento, ...).
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
187
Progettazione preliminare (2)
• Scelta del tipo di impianto e di irrigatore:
o
si deve assicurare l’intensità di pioggia ed il grado di uniformità
prefissati in base ai seguenti parametri:
•
diagramma del piovuto:
–
–
caratteristico per ciascun irrigatore;
da esso dipende l’uniformità di distribuzione:
–
dipende dalla pressione in quanto determina la dimensione delle gocce.
»
migliorabile con un certo grado di sovrapposizione.
•
portata di progetto determinata in funzione di.
•
gittata (da sovradimensionare di un 10 % per tener conto dell’eventuale
presenza di vento) dipende:
–
intensità di pioggia e della postazione (distanza sulle ali e distanza fra le ali).
–
dall’altezza dell’asta portairrigatore (la cui lunghezza minima si determina in base
alla portata);
dall’angolo di gittata:
–
•
»
nell’irrigazione sotto chioma deve essere basso (4° ÷ 7°) mentre negli impianti
soprachioma si adottano angoli di 25° fino ad un massimo di 32°.
uniformità ed efficienza di progetto espressa attraverso:
–
–
–
–
–
26/10/2009
caratteristiche dell’irrigatore;
dalla pressione di funzionamento;
dalla portata, dalla distanza fra gli irrigatori e fra le file;
dallo schema di avanzamento;
dalle caratteristiche ambientali (vento, ...) e dall’eventuale interferenza della chioma.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
188
Schema dell’impianto (1)
• Scelta dello schema di impianto e della sequenza di
alimentazione:
o
suddivisione in settori:
•
•
o
scelta risulta obbligatoria qualora la portata disponibile risulta
inferiore a quella prevista per un funzionamento generalizzato di
tutti gli erogatori;
scelta che consente di ridurre il diametro delle condotte.
dimensionamento ideale prevede settori di forma rettangolare
e di uguale superficie:
•
il loro numero, la dimensione e la forma reale dipendono da
moltissimi fattori:
–
–
–
–
–
–
–
–
26/10/2009
forma, dimensioni e giacitura degli apprezzamenti da irrigare;
presenza di manufatti o di ostacoli naturali;
forma di allevamento e sesto di impianto;
portata, orari di consegna e turnazione della dotazione idrica;
portata, gittata e diagramma del piovuto degli irrigatori;
tracciato delle tubazioni di adduzione;
tempestività di irrigazione richiesta;
grado di automazione.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
189
Schema dell’impianto (2)
•
Necessario assicurare a tutti i settori la stessa pressione iniziale:
o
•
o
accurata progettazione e installazione di idonei regolatori di pressione;
lo schema ottimale è quello di minor costo.
principale criterio di dimensionamento:
o
differenze massime di portata, tra gli erogatori funzionanti
contemporaneamente, del 10% circa della portata media:
•
•
a cui corrispondono differenze di carico del 20% del carico medio di
funzionamento degli irrigatori.
in relazione alle condizioni topografiche si deve individuare la
migliore combinazione di diametro, lunghezza e posizione delle
ali che garantisca il raggiungimento di tali obiettivi:
o
strategie consigliate:
•
•
nei terreni pianeggianti alimentare le ali dal centro;
nei terreni in pendenza disporre le ali lungo le curve di livello;
–
–
•
26/10/2009
se la pendenza non è eccessiva si possono disporre le ali in discesa alimentandole
dall’alto e disponendo regolatori di pressione dove serve;
le ali in salita possono essere adottate solo se i dislivelli sono inferiori alla massima
differenza di carico ammissibile.
nei terreni terrazzati le ali devono correre lungo le terrazze.
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
190
Schema dell’impianto (3)
• Posizionare (se possibile) la fonte di approvvigionamento
in modo da ridurre al minimo lo sviluppo della condotta
principale;
• le ali erogatrici, rispetto alle condotte di testata possono
essere:
o
o
o
o
“a pettine”:
“a doppio pettine”:
•
•
•
nei terreni pianeggianti: i due lati hanno la stessa lunghezza;
nei terreni declivi è più spostata verso monte;
consente di adottare diametri minori.
•
•
la posizione centrale per terreni pianeggianti;
da un estremo o da un punto intermedio spostato a monte per i terreni
declivi.
per la scelta del punto di alimentazione del settore si deve preferire:
il gruppo di comando può essere posizionato sulla condotta di
testata stessa o su una condotta secondaria.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
191
Progettazione idraulica (1)
• Determinazione delle perdite di carico;
o
perdite di carico localizzate:
•
dovute alla presenza di variazioni di velocità per brusche variazioni di
diametro della condotta o della direzione del flusso (innesti degli irrigatori
sulle condotte, gomiti, curve, saracinesche, valvole, filtri, ...):
–
–
o
perdite di carico continue:
•
dovute agli attriti lungo le pareti della tubazione ed agli attriti interni al
flusso d’acqua stesso:
–
–
o
negli impianti di aspersione le perdite di carico lungo le ali irrigue e nelle
condutture di testata sono trascurabili;
per la condotta principale si possono stimare pari ad una percentuale del 10 ÷
20% delle perdite di carico continue.
proporzionali alla lunghezza della condotta;
possono essere calcolate:
»
»
mediante formule sperimentali;
mediante apposite tabelle o abachi predisposti dai produttori delle condotte in
funzione del materiale utilizzato, del diametro e della velocità dell’acqua.
nel calcolo delle perdite di carico bisogna tener conto della
presenza lungo la condotta di eventuali sbocchi intermedi.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
192
Progettazione idraulica (2)
• Criteri di progettazione:
o
condotte distributrici:
•
o
nel caso di più ali (alimentate da una condotta di testata del settore)
sottoposte a carico iniziale non regolato (assenza di regolatori di pressione),
i diametri dell’ala e della condotta di testata devono essere scelti in modo
che le differenze di portata fra gli irrigatori siano minime e comunque
inferiori al 10% della portata media;
condotte adduttrici:
•
il dimensionamento segue un criterio economico:
–
–
alimentazione per gravità: il diametro da adottare è quello in grado di dissipare
interamente il carico disponibile.
con impianto di sollevamento: si deve adottare il diametro che presenta il costo
minore, dato dalla somma dei costi fissi di acquisto della condotta e della pompa
e dei costi di esercizio dell’impianto di sollevamento.
• si può passare a:
o
o
dimensionamento e verifica delle condotte di distribuzione
(settore);
dimensionamento e verifica della condotta principale.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
193
Progettazione idraulica (3)
• Dimensionamento e verifica delle condotte secondarie:
o
il diametro della condotta della condotta di testata deve essere tale che:
•
•
la differenza massima di carico nel settore non superi il 20 % del carico medio
di funzionamento degli irrigatori;
verifica con:
–
–
–
procedimenti semplificati che fanno uso di semplici equazioni per l’individuazione dei
soli irrigatori sottoposti alla pressione minima, media e massima rispetto alle quali
vengono scelti i diametri che rispondono al criterio del 20%:
»
nell’ipotesi che tutti gli irrigatori abbiano una portata costante e pari a quella media.
»
sono in grado di determinare la pressione di funzionamento e la portata di ciascun
irrigatore.
appositi modelli di simulazione del funzionamento idraulico attraverso procedimenti
iterativi:
(i risultati ottenuti con le due metodologie non si discostano in maniera significativa).
• N.B.: si considera un impianto irriguo per aspersione
idraulicamente equilibrato se le differenze tra l’irrigatore più
favorito e quello più svantaggiato è inferiore al 20 % del
valore della pressione di esercizio.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
194
Progettazione impianti di
microirrigazione (1)
•
Necessaria una diversa impostazione per la modalità di erogazione caratterizzata dalla
frequenza e dalla localizzazione della distribuzione:
o
•
o
sia nel caso di erogazione puntiforme che in quello di erogazione lineare;
l’uniformità di erogazione dipende esclusivamente dall’uniformità di portata degli erogatori.
determinazione delle variabili di progetto:
o
o
o
o
o
o
superficie bagnata: nei climi umidi e per terreni con tessitura da media a fine il valore minimo è del
20 ÷ 30% mentre per i climi semi-aridi si va da un minimo del 33% ad un massimo del 67%;
fabbisogno irriguo netto: nel calcolo di ETc si deve tener conto che le perdite per evaporazione dal
terreno non bagnato sono ridotte al minimo per effetto della localizzazione;
fabbisogno irriguo lordo;
altezza di adacquamento;
turno;
scelta dell’erogatore e numero di erogatori per pianta: dipende da molti fattori (fra loro
contrastanti):
•
•
•
•
•
o
•
la qualità dell’erogatore espressa mediante il coefficiente di variazione tecnologica;
le perdite di carico dovute all’innesto sull’ala;
la sensibilità all’occlusione;
il costo;
la durata e la stabilità delle caratteristiche funzionali nel tempo.
portata dell’impianto e suddivisione in settori: il risultato dipende dal valore della portata di punta
necessaria per il funzionamento contemporaneo di tutti gli erogatori, da confrontare con la portata
disponibile.
valutazione di campo delle prestazioni dell’impianto mediante prove di portata degli
erogatori da effettuarsi all’inizio ed alla metà della stagione irrigua, utilizzando 16
erogatori (scelti in modo appropriato) per ciascun settore.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
195
Progettazione impianti di
microirrigazione (2)
•
Criteri di progettazione idraulica:
o
per il dimensionamento e la verifica delle condotte principali e di quelle secondarie e per
la determinazione delle perdite di carico:
•
o
vedi impianti ad aspersione;
dimensionamento e verifica delle condotte di distribuzione:
•
determinazione delle variazioni di carico ammissibile nel settore sulla base di un prefissato valore di
uniformità oppure di una prefissata variazione massima di portata (generalmente si opera in base al
principio che sono accettabili variazioni di portata fino ad un massimo del 10% della portata media);
•
ripartizione della variazioni di carico ammissibile nel settore tra ala e condotta di testata;
•
determinazione della perdita di carico ammissibile nell’ala, noto l’andamento altimetrico;
•
determinazione del diametro interno teorico dell’ala;
•
scelta del diametro commerciale dell’ala;
•
determinazione delle perdite di carico complessive nell’ala di diametro uguale a quello commerciale
scelto;
•
determinazione della differenza di carico ammissibile nella condotta di testata;
•
determinazione della perdita di carico ammissibile nella condotta di testata, noto l’andamento
altimetrico;
•
determinazione del diametro interno teorico nella condotta di testata;
•
scelta del diametro commerciale nella condotta di testata;
•
determinazione delle perdite di carico complessive nella condotta di testata di diametro uguale a quello
commerciale scelto;
•
determinazione dei carichi iniziale e minimo del settore, ed eventualmente di quelli medio e massimo;
•
determinazione della portata dell’erogatore del settore funzionate sotto il carico minimo, ed
eventualmente medio e massimo;
•
verifica del coefficiente di uniformità di progetto;
•
se il valore di verifica è inferiore a quello prefissato, si ricomincia dalla scelta del diametro
commerciale dell’ala, adeguando opportunamente i diametri commerciali.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
196
meccanica viticola
Capitolato
• Le voci di capitolato per la realizzazione di un
impianto irriguo possono essere le seguenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
installazione e spianto cantiere per la realizzazione di pozzo a
percussione;
perforazione pozzo a percussione;
posa di tubazione di rivestimento in PVC con giunti filettati;
installazione di filtro in PVC con giunti filettati;
allestimento e smontaggio del sistema di spurgo e per
l’effettuazione delle prove di portata;
realizzazione di avampozzo interrato in CLS;
esecuzione scavi e reinterri per la rete di distribuzione
fornitura e posa di fili di ferro tripla zincatura per posa ala
gocciolante;
fornitura e posa di ala gocciolante;
fornitura e posa in opera di scarichi completi di pozzetti.
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
197
Schema
26/10/2009
ing. Maines Fernando
meccanica viticola
198
Scarica