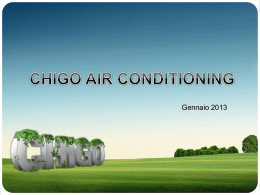Matteo Gaddi LOTTE OPERAIE NELLA CRISI Materiali di analisi e di inchiesta sociale Prefazione di Vittorio Rieser Edizioni Punto Rosso 1 Finito di stampare nel gennaio 2010 presso Digital Print, Segrate, Milano EDIZIONI PUNTO ROSSO Via G. Pepe 14 – 20159 Milano Telefoni e fax 02/874324 e 02/875045 [email protected]; www.puntorosso.it Redazione delle Edizioni Punto Rosso: Nunzia Augeri, Alessandra Balena, Eleonora Bonaccorsi, Laura Cantelmo, Loris Caruso, Serena Daniele, Cinzia Galimberti, Dilva Giannelli, Roberto Mapelli, Francesca Moretti, Stefano Nutini, Giorgio Riolo, Roberta Riolo, Nelly Rios Rios, Erica Rodari, Pietro Senigaglia, Domenico Scoglio, Franca Venesia. 2 INDICE Prefazione di Vittorio Rieser con un’intervista all’autore Traccia operativa per l’inchiesta sociale nei luoghi della crisi Alcuni elementi per un successivo approfondimento Inchiesta alla SPX di Sala Baganza (Pr) Inchiesta alla Fir di Casalmaggiore (Cr) Inchiesta alla ex Ineos-Vinyls di Marghera Inchiesta alla Montefibre di Marghera Sintesi dei principali dati del Rapporto Piastrelle di Ceramica Inchiesta alla TAT di Rotegia (Re) Inchiesta alla Marazzi Group di Iano (Re) Inchiesta alla Sadon Group di Vetto (Re) Appunti per un possibile iniziativa del Prc nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia Per un progetto di intervento sui principali distretti tessili–abbigliamento–calzaturiero del Nord I processi di delocalizzazione che hanno investito il sistema economico e occupazionale del Veneto Inchiesta alla Valentino Fashion Group di Valdagno (Vi) Inchiesta alla Raumer di Valli del Pasubio (Vi) Inchiesta alla Eaton di Monfalcone Inchiesta alla Carraro di Gorizia La crisi nel territorio di Ferrara Inchiesta alla LTE Ferrara Inchiesta alla Tenaris Dalmine (Bg) Inchiesta alla Frattini di Seriate (Bg) Inchiesta alla Rothe Erde Metallurgica Rossi di Visano (Bs) Inchiesta alla Ideal Standard di Brescia Inchiesta alla Azimut Benetti di Avigliana (To) La crisi nella Castellana Inchiesta alla Fervet di Castelfranco Veneto (Tv) Inchiesta alla AGC di Cuneo Una iniziativa politica concreta: la campagna per il lavoro nelle Regioni del Nord Appendice Tre proposte di legge presentate dal Prc nelle Regioni del Nord 3 5 24 29 35 46 56 69 79 83 89 99 107 113 120 130 138 146 157 166 170 180 201 214 227 241 253 259 272 282 288 Agli operai e alle operaie protagonisti delle lotte raccontate in questo libro, molti dei quali ancora presidiano le loro fabbriche. 4 Prefazione di Vittorio Rieser Una premessa Questo libro offre un materiale di inchiesta molto ricco e sostanzioso – e al tempo stesso “provvisorio”, perché fa parte di un work in progress. Un materiale raccolto in soli tre mesi di intenso lavoro, e che può essere letto in due modi. Una prima chiave di lettura riguarda gli elementi molto ricchi di conoscenza che può offrire una “inchiesta giornalistica seria”, in particolare su due aspetti: - una lettura della crisi che smonti alcune generalizzazioni superficiali assai diffuse; - una lettura che comprenda anche il punto di vista e le esperienze dei lavoratori. Una seconda chiave di lettura (che ci interessa particolarmente) riguarda invece il modo in cui costruire, nelle situazioni di crisi, un intervento di partito che non sia di pura propaganda calata dall’esterno (anche se “giusta”) e che offra quindi un qualche “valore aggiunto” alla lotta dei lavoratori. Da ambedue i punti di vista, il lavoro di Matteo Gaddi offre un materiale semi-lavorato molto più ricco, e fecondo di spunti, di quello contenuto in molte analisi apparentemente “compiute” o con pretese “scientifiche”. Le diverse facce della crisi nell’industria Proveremo qui a indicare – in modo non sistematico né completo – alcuni degli spunti che il lavoro di Gaddi offre per un’analisi articolata della crisi industriale. Un’analisi cioè che sfugga ai “luoghi comuni generalizzanti” a cui accennavamo prima: ad esempio, la visione di una crisi finanziaria che si abbatte “dall’esterno” e indiscriminatamente su tutta l’industria, o la visione di una generale arretratezza dell’industria italiana (dovuta in particolare alla prevalenza delle piccole dimensioni) che la rende particolarmente vulnerabile alla crisi. Ma, anche, un’analisi che comprenda il punto di vista dei lavoratori, visti cioè non come puro “oggetto” (o vittima) della crisi, ma come parte attiva delle possibili strategie per uscirne. Infatti, la crisi colpisce tutte le aziende industriali (il sintomo più immediato è che tutte registrano un calo del fatturato), ma per alcune di queste la 5 crisi mette in luce una profonda debolezza strutturale, mentre altre sono in grado di mettere in atto strategie di “riaggiustamento” e di possibile rilancio (si tratta ovviamente di vedere quali). In tutte le aziende, i padroni scaricano sui lavoratori molti dei costi della crisi: ma in forme e con strategie diverse, che implicano diverse prospettive future per il livello e la struttura dell’occupazione. Dovunque, i lavoratori vogliono difendere il loro lavoro (e il loro salario), ma anche in questo caso le prospettive e la strategie (talvolta “implicite”) da essi delineate non sono uniformi. Le aziende Va premesso che le inchieste contenute nel libro riguardano aziende medio-grandi. Non ci sono (almeno per ora) inchieste “di filiera” o di distretto che arrivino fino alle aziende piccole o piccolissime; anche quando sono stati toccati distretti industriali, essi sono caratterizzati da aziende medie e grandi (ceramica) o si è concentrata l’attenzione su aziende “capofila” (abbigliamento). Un lavoro di inchiesta che arrivi fino a questo tipo di aziende è importante e andrà fatto, ma comporta difficoltà notevoli e richiede uno sforzo organizzativo particolare. Le aziende esaminate si differenziano anzitutto per il tipo di proprietà. Abbiamo, anzitutto, aziende controllate da multinazionali estere: ma queste, a loro volta, si dividono in multinazionali finanziarie, in particolare fondi di investimento e fondi pensione (ad es. l’Ideal Standard o la Eaton) e multinazionali industriali (è il caso della Rothe Erde o della Berco, di proprietà del gruppo Thyssen Krupp). Ma le multinazionali possono anche essere italiane: è il caso del gruppo Techint (padrone della Tenaris) o della Carraro - ambedue multinazionali di prevalente vocazione industriale. Altre aziende sono il prodotto di imprese familiari molto cresciute, fino ad assumere dimensioni multinazionali (Marazzi, la stessa Carraro) o potenzialmente tali (Azimut), o ad articolarsi in più aziende in Italia, o comunque ad arrivare a dimensioni medio-grandi (es. Frattini, Sadon). Il tipo di proprietà incide sulle strategie messe in atto di fronte alla crisi. Ad es. le aziende controllate da finanziarie sono le più “volatili”, in quanto le finanziarie sono più pronte ad operazioni di dismissione. O ancora, aziende familiari reduci da una “crisi di transizione generazionale” sono più esposte ai rischi derivanti da un’acquisizione ad opera, ancora una volta, di finanziarie. Ma vediamo più da vicino alcuni aspetti delle diverse strategie. 6 Abbiamo strategie che puntano semplicemente a “liberarsi dell’azienda” (o dello stabilimento), magari cercando di intrecciare quest’operazione con una lucrosa speculazione immobiliare. Queste sono frequenti da parte delle finanziarie. Là dove invece il controllo proprietario è in mani industriali, le strategie di ristrutturazione hanno maggiori vincoli, in quanto non devono indebolire la capacità produttiva e competitiva del gruppo. Ciò si riflette anche nelle strategie di delocalizzazione e di esternalizzazione, già in atto prima della crisi ma che con la crisi si sono intensificate. Le delocalizzazioni possono avere diversi significati: possono semplicemente rispondere a una logica di riduzione del costo del lavoro, o possono corrispondere alla ricerca di una presenza produttiva diretta su nuovi mercati in espansione, o possono rispondere a una tendenza irreversibile di riduzione della domanda nazionale ed europea che spinge alla ricerca di mercati extra-europei... Analogamente, le esternalizzazioni possono rispondere a una pura logica di riduzione di costi, o invece possono dover rispondere a requisiti di qualità e di adeguata integrazione produttivaorganizzativa. Ciò non significa che le strategie guidate da una logica industriale siano di per sé “buone” e più favorevoli ai lavoratori. Esse, come le altre, si traducono anzitutto in esuberi, che tendono a colpire in primo luogo i lavoratori precari, e – tendenzialmente – in forme di riorganizzazione del lavoro che realizzino maggiore produttività e maggiore flessibilità sulla pelle dei lavoratori stessi. Tuttavia, ad es., il patrimonio professionale rappresentato, in certi casi, da una forza-lavoro particolarmente qualificata o con un’elevata esperienza legata alla specificità produttiva-organizzativa dell’azienda può rappresentare un “vincolo” per strategie dominate da una logica industriale. Infine, l’inchiesta mette in evidenza “fattori aggiuntivi specifici” che si aggiungono agli effetti generali della crisi rendendo particolarmente drammatiche certe situazioni aziendali: errori di strategia produttiva aziendale, o di strategia finanziaria (con conseguenti livelli non sostenibili di indebitamento), ma anche fattori dovuti ad “attori esterni” all’azienda, come il caso di un improvviso ridimensionamento di una commessa di Trenitalia che ha fatto esplodere la crisi di un’azienda di Castelfranco Veneto. Incidentalmente, si può notare come “l’interlocutore pubblico” non sia fattore di sicurezza e di affidabilità, in questo caso come nell’ambigua posizione dell’autorità portuale di Marghera sulla destinazione dell’area Montefibre all’ampliamento dell’attività logistica del porto. In particolare nei casi di aziende la cui crisi è legata anche ad errori e de7 bolezze della proprietà e del management (è il caso ad es. di aziende di origine familiare che “non hanno retto la transizione”), il tema all’ordine del giorno può essere la ricerca di un acquirente (si veda l’es. della Frattini): ma l’acquisizione può portare a uno “spezzatino” in cui l’acquirente si prende una parte particolarmente appetibile e lascia il resto alla sua sorte, o può legarsi a un’ipotesi globale sul futuro dell’intera azienda. Ovviamente, sul grado di “esposizione alla crisi” incide anche la collocazione settoriale dell’azienda: si veda il caso delle aziende appartenenti in vaio modo all’indotto dell’automotive. Le posizioni dei lavoratori Anche qui, va premessa un’avvertenza. Come si vedrà più in dettaglio dalla “intervista introduttiva” di Gaddi, i lavoratori con cui si è parlato sono, in genere, “avanguardie” in senso lato: RSU, o lavoratori iscritti al sindacato o comunque partecipanti a forme di lotta che richiedono un impegno permanente (i presidi). Non è quindi detto che il “senso comune” dei lavoratori sia allo stesso livello. Ma questo non riduce l’interesse delle cose che dicono. Anzitutto, l’analisi della situazione aziendale non è semplicistica, e utilizza in modo attento le informazioni di cui i lavoratori dispongono (anche quando – spesso per volontà dell’azienda – sono approssimative o incomplete). Nessuno vede la crisi aziendale come pura “manovra del padrone” e neanche come puro frutto di non ben precisati “errori del padrone”. Quando di questi errori si parla, li si individua con precisione: in tema di scelte di prodotto o di scelte di investimento (con le relative conseguenze di mercato, nel primo caso, o finanziarie, nel secondo). Quindi, anche gli obiettivi e le proposte non si limitano a una generica “difesa del posto di lavoro a tutti i costi”. Questa difesa si collega a ipotesi di correzioni strategiche aziendali o di scelte di politiche industriali (si veda ad es., alla Montefibre, il discorso sull’accordo relativo alla messa in produzione della fibra di carbonio). Tutto ciò si collega, spesso, alla difesa del “patrimonio professionale accumulato”, non solo individuale ma collettivo - che viene considerato, tra l’altro, un fattore importante di competitività. Anche in casi in cui si è pessimisti sulle sorti dello stabilimento, si chiede la messa in opera di corsi di riqualificazione che non siano puri ammortizzatori sociali mascherati. Per tutte queste ragioni, non ci si accontenta di una estensione e rafforzamento degli ammortizzatori sociali (che pure viene richiesto con forza). Un tema molto sentito, nelle aziende con più stabilimenti, è il coordina8 mento tra i lavoratori dei diversi stabilimenti, anche per contrastare il frequente tentativo padronale di “mettere uno stabilimento contro l’altro”. Spesso questo coordinamento si è riusciti a realizzarlo, ma altre volte no. L’esigenza è sentita anche rispetto agli stabilimenti di altri paesi (quando ci sono), ma risulta molto più difficile da realizzare. In questo quadro ci si riferisce talvolta ai CAE (comitati aziendali europei) – che però talvolta non funzionano del tutto (è il caso della Eaton), altre volte hanno avuto finora pesanti limiti ma si pensa di agire per utilizzarli meglio (Rothe Erde del gruppo Thyssen Krupp). Infine, anche nel caso di queste “avanguardie” si conferma, da un lato, il riferimento al sindacato come fondamentale strumento di difesa dei lavoratori, dall’altro una diffidenza verso “la politica” - che erano emerse anche da altre inchieste. Il sindacato può venire criticato (più spesso le critiche sono rivolte a Cisl e Uil, ma non poche anche alla Cgil), ma continua ad essere visto come uno strumento dei lavoratori. Verso “la politica”, invece, non si nutre alcuna fiducia; anche se, nel caso di questi lavoratori particolarmente “impegnati”, ciò non si traduce in una generica chiusura “qualunquista”: quando si parla di proposte politiche concrete (ad es. leggi regionali contro le delocalizzazioni) l’interesse e la disponibilità si ridestano. I sindacati Un dato fondamentale (che viene illustrato con efficacia nell’intervista di Gaddi) è la presenza costante della CGIL: “il sindacato” per questi lavoratori in lotta è, in sostanza, la CGIL. Ciò non significa che la sua presenza, in primo luogo, e la sua iniziativa sia sempre considerata adeguata: spesso, sotto questo aspetto, è diverso il giudizio sulle RSU (tutte interne alla lotta) e su certi sindacalisti “esterni”, anche CGIL, percepiti come distanti. E il riferimento al sindacato non impedisce di organizzare iniziative autonome, come quelle organizzate a Mestre dal coordinamento dei lavoratori Montefibre. Gli altri sindacati? In varie situazioni esiste, almeno formalmente, un’unità con Cisl e Uil – talvolta puramente formale, talvolta più effettiva. Ma esistono casi di accordi separati conclusi da Cisl e Uil a danno dei lavoratori: ad es. alla Montefibre di Porto Marghera (con un accordo che recepisce la chiusura dello stabilimento) o alla GCP Castelgarden di Castelfranco Veneto. In molte di queste aziende si sono già conclusi accordi, che in genere non chiudono la vicenda vertenziale, ma ne segnano per così dire una tappa. Ovviamente, il contenuto di tali accordi non dipende solo dalla 9 adeguatezza della politica sindacale e dal grado di unità tra i sindacati. I margini di contrattazione variano molto tra una situazione e l’altra, e dipendono da molteplici fattori, quali: la profondità della crisi aziendale, le strategie delle aziende e la loro disponibilità a trattare (ci sono multinazionali finanziarie che non si presentano neanche direttamente alla trattativa, e mandano un loro avvocato), la disponibilità delle istituzioni (locali o nazionali, a seconda dei casi) a intervenire, ecc. In questo quadro, buona parte degli accordi che si concludono sono “temporanei”, nel senso che puntano 1) a scongiurare la chiusura di stabilimenti; 2) a definire i meccanismi degli ammortizzatori sociali in modo da estenderli nel tempo e nel campo di applicazione (cioè agli “atipici”), se possibile definendo modalità come CIG a rotazione e aggiungendo clausole migliorative relative all’ammontare e ai tempi di erogazione; 3) su questa base, a garantire possibilità di controllo/contrattazione sulle future scelte aziendali in tema di politiche industriali e di occupazione. Fanno eccezione gli accordi separati già citati, che in un caso recepiscono la chiusura dello stabilimento (Montefibre), in un altro (GCP Castelgarden) accettano clausole peggiorative e discriminanti per gli “atipici”, salvo poi rivelarsi un accordo che la stessa azienda butta via per imporre clausole ancora peggiori, estese agli stessi tempi indeterminati. V’è anche un caso di accordo unitario “al ribasso” (Fracarro), dove si accetta la delocalizzazione della produzione in Tunisia. Ma il grosso degli accordi si colloca nella tipologia descritta prima: passando dai più “deboli”, dove in sostanza l’unica conquista è il prolungamento della CIG, ai più forti, dove ci sono garanzie di controllo/contrattazione sulle scelte industriali dell’azienda, abbiamo la Frattini, la Marazzi, l’Ideal Standard, la Rothe Erde, la Azimut. Vale la pena di notare che, a rafforzare i casi più “deboli”, abbiamo forme di lotta come i presidii, che - l’ultimo episodio è quello della Frattini di pochi giorni fa - servono anche ad impedire tentativi di smantellamento (anche graduale) dello stabilimento. Un metodo per il lavoro di partito Vari anni fa, l’allora segretario del PRC definì Rifondazione “il partito dell’inchiesta”. Una formula felice, che però si è ridotta a un vuoto slogan che copre una realtà ben diversa. In molti casi, quello che si gabella per “inchiesta” è in realtà un lavoro di propaganda generica, in cui si propongono ai lavoratori tre o quattro aspetti a tutti noti della loro condizione (reperibili anche da un’affrettata 10 lettura dei giornali) per mostrare quanto essa sia dura e ingiusta. E’ quello che un grande compagno della CGIL, Emilio Pugno, definiva “mettere il lievito nella merda” - cioè il ruolo dell’organizzazione sembra quello di riraccontare ai lavoratori (che lo sanno meglio di noi) quanto sia brutta la loro condizione - anziché vedere con loro come ci si può muovere per cambiarla. In alcuni casi, si sono fatte inchieste anche interessanti (pensiamo all’attività svolta durante tutti questi anni dal Dipartimento Inchiesta), ma il loro utilizzo è stato in sostanza “accademico/di immagine”, limitato all’organizzazione di convegni di presentazione (magari con la partecipazione di qualche prestigioso intellettuale) o a presentarli in riunioni nazionali di partito che non ne tenevano minimamente conto (come l’assemblea di organizzazione di Carrara qualche anno fa). Questa peraltro è purtroppo una parabola comune a tutte le organizzazioni del movimento operaio: si è passati da una situazione in cui “si faceva inchiesta” a tutti i livelli, magari “senza saperlo”, c’è senza chiamarla tale (pensiamo al lavoro capillare di inchiesta svolto dai delegati sindacali negli anni ’70!), a una situazione in cui di inchiesta se ne parla molto, e se ne fanno anche parecchie, ma queste vengono poi “mummificate” in un uso puramente di immagine, per il “dibattito culturale”. Il lavoro svolto da Gaddi (in collaborazione – non dimentichiamolo – con molti compagni delle strutture locali del partito) rimette l’inchiesta con i piedi per terra, in particolare per quanto riguarda una delle sue due funzioni fondamentali. Infatti l’inchiesta dovrebbe avere, per il partito, una duplice funzione: da un lato, essere strumento di quell’analisi di classe su cui dovrebbe fondarsi l’elaborazione della linea strategica; dall’altro, essere uno strumento quotidiano del “lavoro di massa” del partito. E’ chiaro che le inchieste qui raccolte, focalizzate anzitutto sui dati immediati di situazioni locali, rientrano in questa funzione dell’inchiesta; ma – in un “partito dell’inchiesta” che fosse veramente tale – esse sarebbero anche molte “tessere” di un mosaico più ampio, e contribuirebbero a un’analisi di classe ed a un’elaborazione strategica più complessiva. Proviamo a riassumere, in termini molto “terra terra” la logica e le “tappe” di questo tipo di lavoro: - ’inchiesta è anzitutto uno strumento preliminare di conoscenza delle situazioni di lotta di classe in cui si vuole intervenire: nel nostro caso, conoscenza della situazione produttiva e delle strategie aziendali, delle posizioni sindacali, delle idee che circolano tra i lavoratori; - questa è la base per la definizione di una nostra presenza che non sia 11 genericamente propagandistica, ma che sappia utilizzare le informazioni raccolte (che esistono tra gli stessi lavoratori, ma spesso in modo non organizzato) in un’analisi convincente, e – a partire da questa – formulare se possibile proposte, sia rivolte al lavoro del sindacato che riferite al ruolo più specifico del partito; - attorno a questo, si può costruire un nucleo di compagni, iscritti o meno al partito, interni ed esterni alla fabbrica, che sviluppi con continuità questo lavoro, utilizzando l’inchiesta come metodo permanente. Una delle ragioni di utilità di questo libro è che esso fornisce, in questo senso, una sorta di “guida pratica”, basata su esempi concreti ma integrata da esplicite indicazioni sul metodo di lavoro, per quei compagni o strutture di partito che vogliono concretamente “lavorare di inchiesta”. In che misura il nostro partito è disponibile ed “attrezzato” a lavorare in questo modo? Probabilmente non c’è una risposta univoca: esistono probabilmente strutture locali che “praticano l’inchiesta in incognito”, cioè che la usano concretamente nel loro lavoro, senza però “sistematizzarla” e comunicarla (anche perchè nessuno glie lo chiede); come, all’opposto, esistono esempi anche eclatanti di strutture totalmente estranee a questo metodo (in passato, rispetto a inchieste promosse centralmente dal partito, non solo la risposta di molte federazioni è stata debole e inconsistente, ma alcune grandi federazioni si sono esplicitamente rifiutate di collaborare). Nelle situazioni in cui ha lavorato Gaddi, le strutture locali di partito, se non sempre hanno avuto un ruolo propulsivo, hanno per lo meno dimostrato una disponibilità e una volontà di collaborazione. Ma esiste un’amplissima “zona grigia” del partito, in cui probabilmente questo metodo di lavoro di massa non ha neanche fatto capolino. Proprio perché queste sono le questioni cruciali che l’esperienza di inchiesta qui riportata solleva per il partito, abbiamo pensato che il modo più concreto per svilupparle (anziché il taglio forzatamente generico di una prefazione) fosse quello di porre a Gaddi una serie di domande precise – a cui egli ha risposto nell’intervista che segue. Intervista di Vittorio Rieser a Matteo Gaddi Come sono state scelte le situazioni: non solo i criteri, ma le “fonti” (in particolare, sollecitazioni di strutture locali - se ci sono state)? Non esiste un unico criterio di scelta. A volte le inchieste sono state sollecitate dalle federazioni locali che avevano iniziato un intervento politico in quel luogo di lavoro o che si accingevano a farlo, altre sono state indivi12 duate da me sulla base di notizie di stampa che segnalavano la vertenza in corso; in alcuni casi c’è stata una richiesta esplicita di lavoratori di incontrare il Partito affinché ci potessero “raccontare e spiegare” la loro situazione chiedendoci espressamente di assumere e sostenere la loro lotta. In un caso (aziende del petrolchimico di Marghera) si è trattato della prosecuzione di un lavoro già avviato e che, per l’impegno assunto dal partito e la risposta positiva dei lavoratori, rappresenta il caso più avanzato di cosa significhi “fare lavoro di massa” in una situazione di fabbrica. Sicuramente la situazione di Marghera aiuta un lavoro di questo tipo (si tratta di un’area industriale che, complessivamente, tra chimica, metalmeccanica e logistica occupa circa 15.000 dipendenti), ma fino a poco tempo fa la situazione era completamente diversa da quella di adesso. Ora gli operai , oltre a partecipare a tutte le nostre iniziative, ci telefonano per chiamarci ai loro presidi e blocchi dei cancelli. Da questo è partita una iniziativa molto più ampia che ha al centro il destino dell’area industriale di Porto Marghera e dei suoi livelli occupazionali con ragionamenti che ci portano a lavorare su strumenti come i Piani Industriali dei settori coinvolti o in una logica di Piano d’Area come strumenti di programmazione e intervento. Un discorso analogo vale per la situazione della Agc di Cuneo dove la federazione locale ha partecipato da subito al presidio e alle iniziative di lotta e, tanto per dare l’idea del livello di collaborazione raggiunta, per svolgere la nostra inchiesta siamo stati invitati sul tetto dai quattro operai che vi stazionavano. Un altro caso molto significativo è stato quello di Bergamo dove le inchieste svolte (Tenaris Dalmine e Frattini) si sono inserite nell’ambito di in un intervento del partito che ha seguito passo per passo le vertenze entrando nel merito delle stesse anche con proposte Indubbiamente in questa fase è mancata una programmazione del lavoro di inchiesta da fare: un po’ perché siamo stati travolti dalle situazioni di crisi che, pressoché quotidianamente, si manifestavano in maniera drammatica e che ci obbligavano alla rincorsa, un po’ perché il partito non era assolutamente abituato a questo metodo di lavoro. Io resto convinto del fatto che, chiusa questa prima fase di lavoro di “inchiesta-ampo”, che si è strettamente intrecciata con la campagna sul lavoro (con le proposte di legge regionali) avviata nelle Regioni del Nord, si debba fare un ragionamento su come proseguire. Mi spiego. Noi possiamo anche continuare ad inseguire le emergenze o ad intervenire a seconda delle segnalazioni o della sensibilità di chi scrive. Temo, però, che un metodo di lavoro di questo tipo si riveli particolarmente dispendioso sul piano delle energie e scarsamente produttivo sul piano politico. Molto meglio, invece, capire da questa prima tornata di inchieste se esistono alcuni filoni, due – 13 tre - quattro…, che meritano di essere sviluppati in funzione di un intervento politico del partito. Questo è l’aspetto centrale che non va dimenticato: le nostre inchieste non hanno nulla di accademico. Cioè, hanno tutta la serietà e tutto il rigore della documentazione necessaria, ma hanno una finalità prettamente politica: quella di evidenziare condizioni di lavoro o di crisi occupazionale sulle quali intervenire come partito. Io lo dico sempre: noi non siamo dei commentatori politici né un mero centro studi (che sarebbe già meglio di chi crede che far politica significhi commentare le notizie dei giornali o organizzare convegni sui “Principi del Leninismo”…). Noi siamo un partito che deve intervenire concretamente, che deve fare iniziativa politica sulle questioni di merito. Per fare questo, per preparare iniziative serie, non calate dall’alto, non estemporanee né superficiali, il lavoro di inchiesta è fondamentale. Per questo, per i prossimi mesi di lavoro, cerchiamo di capire cosa ci interessa e cosa riusciamo a fare, discutiamone e prepariamo un piano di lavoro che poi andremo a verificare. Cosa è stato fatto e cosa no, cosa resta da fare, se ci sono cose da correggere ecc. Sul terreno dell’inchiesta operaia e del lavoro di fabbrica (intendendo con questo termine ogni luogo di lavoro, fabbrica o ufficio che sia…) è impensabile che alle iniziative non faccia seguito un momento di verifica delle stesse. Anzi, se venisse a mancare il momento della verifica risulterebbe sostanzialmente svuotata di significato l’inchiesta stessa. Comunque, per tornare al ragionamento dei filoni di inchiesta, mi sembra che alcuni siano venuti fuori con una certa evidenza: le grandi aree industriali di alcune zone (Marghera in primis, ma anche la zona di Monfalcone e Trieste, in prospettiva Torino e Genova); le aree a forte industrializzazione diffusa dove grande e piccola fabbrica si mescolano e si integrano (Bergamo, Brescia); alcuni distretti industriali come il ceramico (Modena e Reggio Emilia) o il tessile (nelle zone venete, piemontesi e lombarde). Ovviamente questo approccio “territoriale” andrebbe strettamente intrecciato con un approccio più di tipo “settoriale”: cioè con i settori industriale della chimica, della grande cantieristica, siderurgia o delle telecomunicazioni…anche per cercare di cogliere le cosiddette filiere produttive, anche qui tanto di territorio quanto di settore, sulle quali organizzare un lavoro politico di quella che un po’ enfaticamente potremmo definire “ricomposizione di classe”. I “testimoni privilegiati” su cui è stata costruita ciascuna inchiesta: quali, come sono stati trovati? Trattandosi di “inchieste – lampo” non c’è stato modo di programmare 14 per bene i testimoni da intervistare. Diciamo che più o meno il modello seguito è stato questo: il primo contatto avveniva con qualche esponente della Rsu con cui si fissava il giorno dell’intervista. Questo garantiva la presenza delle Rsu e di qualche lavoratore disponibile a rispondere ad alcune domande o anche semplicemente a discutere. Il più delle volte, trattandosi di fabbriche presidiate, l’intervista si è svolta al presidio stesso dove, magari dopo una iniziale e comprensibile diffidenza, anche altri lavoratori si avvicinavano per dire la loro, per aggiungere o integrare le cose che venivano fuori. Il lavoro di intervista collettiva è risultato fortemente facilitato quando si era in presenza di alcune condizioni. Ad esempio la presenza di compagni del partito che sono stati dipendenti della fabbrica: la conoscenza che avevano dei lavoratori tutt’ora in servizio e la memoria storica che potevano mettere in campo hanno rappresentato una risorsa straordinaria che garantiva di godere immediatamente della fiducia e della disponibilità dei lavoratori intervistati e consentiva di collocare i ragionamenti in un quadro storico di evoluzione aziendale e di relazioni sindacali. Nel caso di presidi particolarmente “affollati” o, meglio ancora, nel caso di manifestazioni con corteo (Tenaris, Carraro, petrolchimico...) la grande concentrazione di lavoratori presenti e le modalità delle iniziative consentivano una ampia possibilità di relazione e di contatto con, tuttavia, maggiori difficoltà di comunicazione e di apertura da parte di chi veniva avvicinato (“ma cosa siete voi, giornalisti?!”; “No io con le televisioni non parlo!”). Altri invece si aprivano immediatamente, quasi con un senso di liberazione per poter finalmente “parlare”, “raccontare cosa sta succedendo” ecc. cioè, accanto a chi manifestava diffidenza, indifferenza, se non aperta ostilità, c’erano anche figure (in numero piuttosto consistente) che sembrava quasi che non aspettassero altro che poter parlare della loro condizione, dei loro timori, delle loro proposte quasi a manifestare un bisogno di parlare che nel tempo era andato perso o che addirittura non avevano mai conosciuto. Ci sono stati casi in cui chi parlava con noi lo faceva perché non aveva altro ambito a livello di organi di informazione – per quanto piccoli possano essere Liberazione Crisi TV (“I giornali non parlano mai di noi; non pubblicano niente di quello che mandiamo”) - o addirittura a livello delle assemblee nei rispettivi luoghi di lavoro (“nelle assemblee non possiamo dire niente…” o “tanto hanno già deciso tutto i funzionari sindacali che presentano il pacchetto immodificabile”.). Nel prosieguo del lavoro di inchiesta, ed in particolare per quei casi già oggetto di “inchiesta–lampo” che si intenderanno approfondire, la scelta dei testimoni da intervistare dovrà necessariamente essere oggetto di una at15 tenta valutazione: sicuramente andrà ampliata la platea di lavoratori senza incarichi sindacali e politici. Questa condizione non sarà difficile da rintracciare in alcune zone (penso ai distretti veneti, ad esempio); ma anche una condizione di contraddizione tra appartenenza sindacale e orientamento politico mi sembra che meriti di essere approfondita aldilà del banale e scontato cliché dell’“operaio Fiom che vota Lega”. Il salto di qualità che dobbiamo fare è quello di arrivare al corpo largo del mondo del lavoro. Mi spiego meglio. E’ facile prendere contatto con il funzionario sindacale di categoria o di camera del lavoro; ed è abbastanza facile arrivare anche ai delegati delle Rsu. Quello che è più difficile è intercettare i lavoratori privi di incarichi sindacali, quelli che prima ho definito il “corpo largo” del mondo del lavoro. Finché si parla con funzionari o delegati sindacali le cose filano, più o meno ci si intende, si parlano gli stessi linguaggi…il problema, quindi, è parlare con i lavoratori. Intercettare questi, discutere con loro, far venir fuori quello che pensano e quello che si aspettano da una forza politica. Quello che pensano dei partiti e per quale motivo ritengono che la politica per loro sia una cosa lontana, che non li riguarda e addirittura li schifa. Capire quali sono i loro bisogni e come ci si può mettere a disposizione per le loro lotte. Capire come possiamo diventare “strumento” delle lotte e non commentatori o osservatori/tifosi delle stesse. Il ruolo del partito locale e gli eventuali rapporti con altre forze? Il ruolo del partito locale è stato molto differenziato. All’interno di Rifondazione Comunista, nelle sue federazioni locali, convivono situazioni di grande internità alle lotte come di totale estraneità alle stesse. Tutti i discorsi critici sul partito leggero, sul partito d’opinione, hanno trovato una drammatica conferma nelle situazioni che vivono molti territori. La cosa ancora più drammatica, però, è che molti di quelli che lanciano strali contro il partito leggero sono i primi a deridere i metodi di inchiesta, sovente non escono mai dalle quattro mura delle sedi di partito, si impegnano unicamente in dibattiti dottrinali che interessano in tutta Italia a quattro o cinque persone. Chiusa la parentesi, ritengo che su questo vada avviato un serio ragionamento per una forza politica che ha raggiunto il punto più basso della propria consistenza organizzativa ed elettorale. Questi risultati non arrivano mai a caso: siamo completamente fuori dai grandi mezzi di informazione (e questo significa che nella percezione di molti non esistiamo più); se il partito non recupera una sua dimensione organizzata nei territori e nei luoghi di lavoro non vedo come se ne possa uscire. Però bisogna passare dai convegni al fare concreto. La situazione riscon16 trata in giro dipende sicuramente dalle difficoltà nello stimolare una militanza attiva, ma trovo assurdo che si spendano ore e ore in riunioni di corrente, di sottocorrente, di area, di sensibilità e chi più ne ha più ne metta e poi non ti accorgi nemmeno che a un km dalla tua sede qualche centinaio di operai viene licenziato. Nel dire queste cose ci tengo molto a precisare una cosa: per essere severi con gli altri bisogna prima di tutto essere rigorosissimi con sé stessi. Con tutta la modestia e la prudenza necessarie quando si discute di queste cose, credo che l’inchiesta sia un utile strumento per iniziare a riprendere contatti troppo a lungo interrotti con i luoghi di lavoro: è il primo passo per arrivare a dire cose sensate e fondate sulle condizioni dei lavoratori, sulle loro vertenze, sui loro bisogni. Questo da molte federazioni è stato capito ed è stata espressa la volontà di dare seguito alle “inchieste – lampo” con gruppi di inchiesta locali composti da due/tre compagni che si assumono questo impegno e programmano un minimo di attività rispetto all’intervento politico che si intende realizzare in un determinato territorio. Bertinotti più volte ha ripetuto che Rifondazione sarebbe stato il “partito dell’inchiesta”: per l’esperienza che ho avuto diverse federazioni hanno sentito per la prima volta, ma soprattutto hanno visto concretamente per la prima volta cosa significa fare inchiesta in occasione di questa tornata di “inchieste-lampo” nei luoghi della crisi. E purtroppo è ancora largamente diffusa l’attitudine a ragionare solo per parole d’ordine e slogan, magari con lo stesso volantino da Bolzano a Enna, con gli stessi temi indipendentemente che si tratti di un Centro di ricerca sulle nanotecnologie o di una acciaieria… Io stesso non è che avessi chissà quale esperienza di inchieste operaie e i limiti di questo sono largamente visibili, ma di fronte ad una crisi che ogni giorno faceva spuntare come funghi presidi e occupazioni e occupazioni di fabbriche ho deciso di buttarmi come un pesce…d’altronde se noi non nuotiamo in questo tipo di acqua… Per quanto riguarda le altre forze gli unici soggetti incontrati sono quelli sindacali. Un dato che viene fuori in maniera abbastanza omogenea è la tenuta sindacale e la presenza in tutti i luoghi di lavoro visitati da parte della Cgil. In alcuni ambiti la presenza della Cgil e delle sue categorie è assolutamente preponderante se non addirittura esclusiva (settore metalmeccanico); in altri la situazione con Cisl e Uil è più equilibrata; comunque va evidenziato il ruolo delle strutture sindacali ed in particolare dei delegati e dei funzionari del principale sindacato italiano. Nelle situazioni di crisi la Cgil c’è sempre e i suoi rappresentanti diventano 17 ben presto i referenti delle iniziative da assumere, sia nella fasi di lotta che di trattativa. Anche su questo dovrebbero ragionare tutti quelli che gridano ai cedimenti sindacali, alla burocratizzazione della Cgil, al moderatismo dei suoi quadri ecc. Non che molte di queste preoccupazioni non siano fondate (e in diversi segnali si trovano anche conferme), ma un conto è segnalare carenze sindacali stando dentro ai processi reali, altra cosa è farlo dalla cattedra senza alcun contatto o legame con i soggetti in carne e ossa che nei luoghi di lavoro ci sono. Insomma, per dirla brutalmente: quando arrivi ai cancelli di una fabbrica presidiata ci trovi il delegato Cgil e spesso anche il funzionario di categoria; e il più delle volte queste sono figure riconosciute dai lavoratori e da questi apertamente sostenute o quantomeno rispettate. Questo non significa che le posizioni espresse dai rappresentanti della Cgil siano sempre “di sinistra” né tanto meno coincidenti con le nostre. Però deve essere chiaro a tutti che, quando si progetta un intervento di fabbrica, la Cgil è un soggetto con quale ci si deve assolutamente rapportare; certamente su un piano di autonomia, ma pensare di scavalcare questo sindacato o, peggio ancora, di attaccarlo frontalmente, costituirebbe un gesto di assoluta cecità politica. Recentemente mi è stato chiesto da parte della segreteria nazionale del Partito un contributo scritto per ragionare sul ruolo dei nostri segretari di Federazione. Senza esitazioni ho risposto che per un intervento serio e concreto nel mondo del lavoro non si può prescindere da un rapporto con chi sindacalmente rappresenta i lavoratori e nei luoghi di lavoro ci sta davvero e quotidianamente. Per questo ho proposto che per aprire contatti con Rsu e Organizzazioni Sindacali andrebbero promossi incontri sulle specifiche situazioni dei vari luoghi di lavoro (che siano in crisi o meno poco importa. Non è che dove non ci sono presidi e occupazioni non esistono problemi per i lavoratori…), si ascolta il quadro della situazione, si entra nel merito concreto delle questioni, si manifesta la piena disponibilità a collaborare, si calendarizzano altri incontri e magari si comincia a promuovere anche qualche iniziativa pubblica sui problemi di questa o quella realtà lavorativa ecc.. Sono fermamente convinto che, comunque siano collocati, vadano mantenuti rapporti anche con i segretari delle categorie Cgil (ci si può dividere sulle questioni di merito, ma il rapporto va mantenuto, altrimenti li regaliamo tutti al Pd più per il vuoto pneumatico che esiste a sinistra che non per reali convinzioni). 18 A partire dall’inchiesta/analisi, se e quale tipo di proposte si è riusciti a formulare? Su questo punto preferisco rifarmi agli esempi concreti anche perché la diversità delle situazioni indagate, dei problemi che hanno originato la situazione di crisi, delle situazioni lavorative e industriali è stata tale da rendere arduo il tentativo di sistematizzare seriamente in un unico schema le proposte di lavoro che sono scaturite a seguito dei primi lavori di inchiesta. Parto dalla situazione che mi sembra più matura, sia sul paino politico che della presenza di partito: quella di Porto Marghera. Le inchieste condotte su alcune aziende del polo chimico, in realtà, si sono collocate dentro un percorso molto più ampio di iniziativa politica del partito sulle questioni dell’industria e del lavoro dell’area di Porto Marghera. Il rischio di uno smantellamento produttivo dell’area è suffragato da processi di deindustrializzazione che da tempo sono avviati e che hanno conosciuto una accelerazione molto forte in questi anni anche e soprattutto per le strategie dell’Eni. Sull’industria chimica è iniziato un lavoro che ha messo insieme, per la prima volta, i siti di Venezia, Mantova, Ferrara e Ravenna con un ragionamento complessivo di mantenimento delle produzioni industriali in funzione di difesa dei posti di lavoro, di salvaguardia di importanti attività produttive da riqualificare e ammodernare in senso ambientale con nuove tecnologie e investimenti adeguati. E, in particolare, su Porto Marghera, è stato attivato un intervento che mette insieme le varie realtà di fabbrica egualmente minacciate da processi di impoverimento o di vero e proprio smantellamento: non solo il Polo Chimico, quindi, ma anche Fincantieri, Alcoa, il Porto e le funzioni logistiche…nell’idea che si possa costruire uno strumento di programmazione (un Piano per Porto Marghera) in grado di difendere il lavoro e l’industria programmando gli interventi da realizzare e valorizzando le forme di partecipazione dei lavoratori a questo processo. Anche sul distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia tra gli obiettivi che hanno fatto seguito alle inchieste svolte è stato indicata la costruzione di un Piano Industriale d’area in grado di dare reale consistenza – industriale e occupazionale – alla dimensione del distretto. Sul distretto ceramico, oltre alla partecipazione alle vertenze operaie che ci sono state e all’obiettivo del Piano di Distretto, da parte delle strutture territoriali del Partito è stata avvertita l’esigenza di dare prosecuzione al lavoro di inchiesta in modo che questo diventi uno strumento ordinario di intervento politico da realizzare con un progetto di inchiesta centrato su argomenti quali: gli assetti proprietari e la concentrazione del capitale in po19 chi grandi gruppi; il ruolo delle banche negli assetti proprietari come sul piano dell’accesso al credito; l’accesso alle materie prime, volumi di merce prodotti e principali mercati di sbocco; le ristrutturazioni aziendali e nuove tecnologie, con relativo impatto sui processi produttivi e le possibili conseguenze occupazionali e sociali; i processi produttivi interni ed esterni al luogo di lavoro, la diversa condizione dei lavoratori e le reciproche relazioni, attuale composizione della classe lavoratrice; il ruolo del sindacato nei luoghi di lavoro; l’indotto; la qualità della vita nel distretto. Questa inchiesta, secondo gli intendimenti delle Federazioni locali del Prc, potrebbe essere un elemento fondamentale per elaborare una proposta politica in grado di incidere nella vita concreta di migliaia di lavoratrici e lavoratori. La traccia di un progetto di inchiesta come quello definito dalla Federazione di Modena, potrebbe servire, opportunamente adeguato in alcuni aspetti tecnici, per dare prosecuzione a approfondimento al lavoro avviato nei distretti del Veneto (ad esempio del settore tessile-abbigliamento) oltretutto colpiti da un pesantissimo fenomeno di delocalizzazione produttiva verso l’est europeo ma non solo. Se penso al caso del Veneto, dove certo non si può sperare di costruire una presenza politica contando su aspetti ideologici o tradizioni storiche, concentrare il lavoro sugli aspetti concreti della condizione lavorativa ed in particolare su quegli aspetti strutturali – come le delocalizzazioni produttive – che rischiano di cancellare il lavoro stesso, appare una condizione imprescindibile per un partito che non vuole limitarsi alla mera testimonianza ma ambisce ad intervenire nel concreto delle condizioni di vita dei lavoratori e delle dinamiche sociali ed economiche. Un investimento ancor più significativo va fatto nelle realtà di Bergamo e Brescia come già si è cominciato a discutere con le Federazioni locali. Si tratta di due province con uno dei tassi di industrializzazione più alti d’Italia, nelle quali accanto ad alcune grandi fabbriche esistono tantissime imprese di piccole dimensioni polverizzate su territori nei quali spesso non arriva nemmeno il sindacato. Territori nei quali, assieme ad alcune province del Nord Est, la Lega sembra essere riuscita a costruire, almeno a livello simbolico e di comportamento elettorale quel blocco sociale dei produttori che salda insieme padroncini e lavoratori dipendenti che espelle il conflitto sociale verso l’alto sostituendolo con quello orizzontale nei confronti delle figure più deboli. In questo caso l’impegno ad approfondire l’analisi degli altri elementi che contribuiscono alla formazione degli orientamenti politici e sociali dei lavoratori, rispetto a quelli direttamente dipendenti dalla loro condizione lavorativa, appare assolutamente decisivo. 20 Quali sono state le conseguenze operative (provvisorie, perché è un work in progress), cioè l’utilizzo pratico dell’inchiesta, quali gli eventuali ostacoli (interni, cioè di partito, esterni, cioè di rapporto con altre forze, “oggettivi” legati al tipo di situazione)? Preferisco partire dagli ostacoli, anche perché questi dipendono in larghissima misura dal nostro partito e dal suo modo di operare. I tempi del partito non coincidono con quelli dei processi reali. Cioè: se facciamo una “inchiesta-lampo” per raccogliere informazioni, dati e qualsiasi altro elemento conoscitivo utile per impostare un intervento politico nell’ambito di quella crisi, non è pensabile che le iniziative vengano assunte mesi dopo quando, magari, quella crisi si è già risolta in un modo o nell’altro. Se facciamo così arriviamo fuori tempo massimo. Continueremo a fare gli spettatori delle crisi aziendali, i commentatori dei dati sulla cassa integrazione e disoccupazione e, quando va bene, i tifosi di quei lavoratori che salgono sui tetti. All’inchiesta deve far seguito, subito, la discussione e la decisione sul tipo di intervento da assumere. Faccio un esempio, così rispondo anche alla domanda sulle utilizzazioni pratiche dell’inchiesta. A Bergamo, dopo aver incontrato le Rsu della Tenaris Dalmine, abbiamo subito prodotto un breve report dell’incontro con l’analisi della loro situazione di crisi, un documento politico con le prime proposte del Partito tanto sulle questioni occupazionali quanto sulle politiche industriali che si dovrebbero realizzare, e un volantino che stato prontamente distribuito. E’ stata messa in piedi una iniziativa pubblica a cui ha partecipato l’intera Rsu dello stabilimento e il Partito ha preso parte a tutte le iniziative di lotta (presidio, corteo ecc.) organizzate dai lavoratori. Con i livelli istituzionali di cui disponiamo (Consigliere Regionale in Lombardia e Consigliere Provinciale a Bergamo) sono state presentate interrogazioni urgenti per spingere gli Enti Pubblici ad intervenire e sono state attivate le Brigate di Solidarietà (Partito Sociale) per capire se si potevano assumere anche iniziative di tipo mutualistico. Questo è un esempio di inchiesta che si è strettamente intrecciata con la lotta in corso e con le iniziative che il Partito ha assunto. Per la realtà che conosco io, nel Nord solo la Federazione di Trieste con il suo gruppo di inchiesta locale ha assunto, ormai da tempo, un metodo di lavoro di questo tipo. Cioè: fanno una inchiesta al Porto, o in Fincantieri o in Alcatel? Bene, appena hanno i risultati pubblicano un volantone e lo distribuiscono ai lavoratori presso i quali è stata fatta l’inchiesta; organizzano una iniziativa di 21 discussione e approfondimento, attivano i livelli di partito competenti, si relazionano con il sindacato e l’Rsu per capire cosa altro fare di concreto…. Quello che non è possibile fare è operare con discontinuità. Per cui, magari, fai anche l’inchiesta ma poi da quei lavoratori non ci vai più, non assumi iniziative concrete, lasci che le cose seguano il loro corso senza un minimo di intervento concreto. Indubbiamente esistono difficoltà oggettive. Lo stato del Partito è quello che conosciamo e versa in gravi difficoltà di carattere organizzativo anche per la mancanza di risorse economiche. La maggior parte dei segretari di Federazione nella vita di tutti i giorni lavora e quindi non si può pretendere che abbia lo stesso tempo e le stesse energie di chi fa politica a tempo pieno. Il quadro militante è abbastanza sfibrato, frustrato dai continui insuccessi elettorali, indebolito – anche psicologicamente – dalle continue scissioni e risse a sinistra. Mancano risorse economiche che consentano di sostenere anche spese elementari come il mantenimento delle sedi, la stampa di materiali… A questo si aggiunga che la partecipazione politica in Italia ha forse raggiunto il suo punto più basso e il quadro è completo. Tuttavia questo non basta. Lo ripeto per l’ennesima volta anche a costo di essere noioso o di toccare qualche suscettibilità: così come lavoriamo noi non funziona. Di cosa discutiamo nei nostri organismi dirigenti locali? di due o tre cose: di politica nazionale o internazionale (più come commentatori che come organi in grado di decidere realmente qualcosa); di gruppi dirigenti e di candidature, di assetti interni al partito. Al nostro interno, inoltre, inutile nasconderlo, ci sono componenti o anche singole figure che trasformano ogni comitato politico o anche ogni riunione in una riedizione del congresso. E invece, quanto tempo dedichiamo alla discussione delle questioni concrete? quanti Comitati Politici dedichiamo alle crisi aziendali, ai piani sanitari locali, alle scelte locali e concrete su trasporti, energia, rifiuti? briciole del nostro tempo impiegato a discettare di grandi scenari politici, di equilibri tra correnti o dispute ideologiche. Io penso che il rapporto tra questi due ambiti vada esattamente rovesciato. Anche perché se si vuole attivare un minimo di militanza, bisogna individuare qualche obiettivo concreto e qualche progetto di lavoro per attivizzare i compagni. Faccio un esempio banale: proviamo a dire che ogni circolo territoriale del Prc “adotta” una fabbrica in crisi (tanto c’è solo l’im22 barazzo della scelta). Cioè: sceglie una fabbrica, va a fare una inchiesta tra i lavoratori, costruisce una analisi della crisi e delle ricadute occupazionali, comincia a prendere posizioni con volantini e assemblee pubbliche, segue passo per passo la vicenda, organizza qualche iniziativa di mutualismo (raccolte fondi per i cassaintegrati, Arancia Metalmeccanica, cucina ai cancelli presidiati…). Poi si fa un bilancio di quel che è stato fatto: si verifica quali risultati sono stati raggiunti, quali relazioni si sono costruite ecc. Mettendo insieme, a livello provinciale, dieci – quindici situazioni del genere, si potrebbero costruire delle assemblee provinciali sulla crisi e sul lavoro che non partono con una relazione sul fallimento di Bearn Stearns e della finanza mondiale per concludere con l’affermazione che il capitalismo va cambiato con il socialismo; ma diventerebbero occasioni di riflessione sulle situazioni concrete dei territori e, possibilmente, momenti di programmazione di lavoro politico concreto. 23 Traccia operativa di colloquio. Intervista per l’inchiesta sociale nei luoghi della crisi.1 Questa traccia deriva da un confronto con Vittorio Rieser che, oltre a partecipare alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della ricerca, ha manifestato la propria disponibilità a partecipare agli incontri territoriali di approfondimenti/formazione con i gruppi di inchiesta locali. Questo documento si integra con la scheda per la mappatura delle aziende in crisi. Mentre la mappatura è bene che avvenga nella maniera più ampia possibile in modo da censire il maggior numero possibile di aziende in crisi, l’approfondimento dell’inchiesta sociale non può che avvenire, a fronte della concreta situazione del Partito, soltanto in alcune situazioni specifiche. D’altronde, si tratta di due modalità di lavoro che, seppur strettamente intrecciate dal punto di vista degli obiettivi politici, risultano significativamente diverse sul piano degli strumenti e dell’impegno che presumono. La mappatura delle aziende in crisi può avvenire attraverso la compilazione della scheda già trasmessa e, in genere, avviene utilizzando dati più o meno già disponibili. Si tratta di raccoglierli e organizzarli attraverso le schede. Le fonti dalle quali attingere per compilare il maggior numero di schede sulle situazioni di crisi sono: notizia di stampa locale (che in genere, nelle cronache locali, riportano e dedicano ampio spazio alle crisi industriali del territorio); elenchi compilati dalle locali Camere del Lavoro (quindi si tratta di chiedere alla CGIL locale, o alle sue categorie, la messa a disposizione di questi elenchi); Rapporti prodotti dagli Enti Locali, in genere gli Assessorati alle Attività Produttive e al Lavoro delle Regioni e delle Province; Rapporti prodotti da Centri Studi di Camere di Commercio, Confindustria, Università ecc..; Verbali sulle vertenze prodotti dal Ministero dello Sviluppo Economico (sul sito: www.sviluppoeconomico.it alla voce “vertenze” ci sono i verbali delle principali situazioni di crisi con indicazioni interessanti sulle ragioni della crisi, sulle prospettive della stessa, sulle conseguenze per i lavoratori, sull’atteggiamento tenuto dal Sindacato, sulle soluzioni o non soluzioni che si prospettano ecc.). Poiché presumo che la situazione sia molto differenziata da territorio a 1 In collaborazione con Paolo Hlacia, Prc Trieste 24 territorio, sull’utilizzo delle fonti non viene fornita una indicazione valida per tutti, ma si suggerisce di reperire dati e informazioni attingendo dall’elenco di documenti sopra elencato. Come detto, il lavoro di inchiesta, invece, presume un impegno maggiore visto il maggior grado di approfondimento e in considerazione della diversa tipologia dello strumento adottato (intervista/colloquio e sua successiva trascrizione in un Report). Il primo passaggio è dato dalla scelta delle situazioni di crisi da sottoporre a inchiesta. Il criterio proposto, anche per rendere concretamente realizzabili l’inchiesta e politicamente utili i risultati, è quello, molto semplice, delle disponibilità di gruppi locali. Ossia, laddove i circoli dichiarano la disponibilità a fare l’inchiesta e, successivamente, ad utilizzarne politicamente le indicazioni per specifiche iniziative politiche. In questo senso, è bene precisare che si tratta di una inchiesta sociale nella crisi da cui si intendono trarre indicazioni per il lavoro politico, niente di accademico, quindi, ma anzi un lavoro politicamente utilizzabile. I risultati, quindi, non devono restare nel cassetto o sulle pagine di una pubblicazione, ma devono orientare l’operato politico delle strutture territoriali del Partito. Ogni Regionale, quindi, dovrebbe, in tempi strettissimi, chiedere alle Federazioni di indicare, in tempi altrettanto strettissimi, i circoli intenzionati e disponibili a questo tipo di lavoro. Una volta individuati questi, sarà cura del Dipartimento Nord e del rispettivo Regionale, con il supporto e la partecipazione di Vittorio Rieser, organizzare momenti operativi di formazione/approfondimento/chiarimento con i gruppi di inchiesta locali. Una volta fatta questa individuazione, i gruppi locali di inchiesta devono decidere quale situazione (o anche quali situazioni…meglio però darsi degli obiettivi realistici.) indagare. Il criterio di orientamento deve essere quello della rilevanza sociale e politica della situazione da indagare. Cioè deve trattarsi di una situazione significativa per: a) l’impatto che produce intermini sociali ed economici sulla realtà locale (es. l’elevato numero di lavoratori coinvolti; la perdita, per un territorio, di una importante realtà produttive ecc.); b) l’esperienza di conflitto attivato dai lavoratori (vedi l’esempio fin troppo noto della INSE di Milano, ma anche della LASME ecc..) o attivato sul versate del capitale (vedi esempio della Manuli di Ascoli che manda le guardie private contro gli operai). 25 Una volta individuata la situazione da indagare si procede con il lavoro di inchiesta. Poiché non si tratta di una inchiesta di tipo quantitativo, ma di tipo qualitativo, lo strumento utilizzato non è quello del questionario (non ci sono dati da raccogliere, statistiche da fare ecc.), ma quello del colloquio/intervista. Per ogni situazione si scelgono dei testimoni privilegiati con i quali condurre i colloqui/interviste sia in forme individuali che collettive (libera scelta dei gruppi d’inchiesta locali). I testimoni privilegiati sono costituiti da: 2/3 delegati sindacali del luogo di lavoro che si indaga; 4/5 lavoratori dello stesso (che non siano rappresentanti sindacali); altre figure che possono risultare utili (amministratori locali, segretari sindacali di categoria ecc.). Nel caso in cui, anziché una singola Azienda, venisse indagato un Distretto Industriale Territoriale, l’individuazione dei testimoni dovrebbe avvenire a questo livello territoriale: per cui si tratta di intervistare i delegati sindacali di più fabbriche facenti parte del distretto; lavoratori di più fabbriche ecc. La traccia da seguire per i colloqui/intervista, dovrebbe consentire di orientare la discussione attraverso questi punti: - come si è verificata la crisi dell’Azienda (sostanzialmente riprendendo le motivazioni della crisi indicate nella tabella: crisi di mercato, finanziaria, per delocalizzazione, per diverso uso delle aree ecc.). Chiaramente in questo caso le ragioni vanno indicate in modo discorsivo, così come vengono indicate dagli intervistati, facendosi spiegare come si è concretamente manifestata, quali sono state le avvisaglie, come sono stati messa a conoscenza…; - come l’Azienda (cioè il padrone) ha risposto alla crisi. Ad esempio: la crisi è stata un pretesto per realizzare altre operazioni? (dismissione produttiva e vendita terreni; utilizzo strumentale della Cassa Integrazione anche senza che ce ne fossero i presupposti; riduzione occupazionale; contrattacco sul versante delle condizioni di lavoro ecc.); l’azienda ha voluto gestire da sola la situazione di crisi con decisioni unilaterali oppure l’azienda ha accettato una gestione concertata della crisi con il coinvolgimento dei Sindacati e degli Enti Locali? quali prospettive ci sono per uscire dalla situazione di crisi? si tratta, sostanzialmente, di fare una fotografia della situazione confrontata con la situazione precedente alla crisi (questo aspetto è di particolare rilievo per capire come nelle diverse situazioni la crisi ha modificato o meno i comportamenti delle imprese); - come si sono comportati i sindacati, sia nelle loro rappresentanze nei 26 luoghi di lavoro sia a livello di categorie o di confederazioni. Anche in questo caso è importante rilevare i comportamenti sindacali prima e dopo la situazione di crisi (ad es. un sindacato troppo morbido e abituato alla concertazione può aver addormentato i lavoratori; al contrario un sindacato combattivo può aver anticipato i possibili motivi di crisi e può aver preparato i lavoratori alla lotta e all’iniziativa). Si tratta di parlare di quanto ha fatto il Sindacato non solo oggi nella situazione di crisi, ma anche prima che questa si verificasse. Su questo vanno sollecitati soprattutto i lavoratori (“E prima della crisi il sindacato cosa faceva?”, “qual era il seguito e la credibilità che aveva tra i lavoratori?”); - quale è stata la reazione dei lavoratori (lotta, rassegnazione, tentativo di recupero della concertazione, forme di lotta mediatiche), quale è stato l’atteggiamento dei lavoratori nei confronti dell’Azienda, dei sindacati, degli Enti Locali, delle forze politiche. Anche in questo caso va fatta la comparazione con la situazione precedente. Ad esempio è possibile che in luoghi di lavoro con una presenza di lavoratori non particolarmente vivace si sia abbattuta prima e con maggior forza la scure dei licenziamenti, della Cassa Integrazione ecc.; - infine, il rapporto con la politica, attraverso domande che riguardano il ruolo che hanno avuto i Partiti (soprattutto il nostro) nell’ambito della crisi e delle vertenze dei lavoratori; che riguardano il possibile ruolo che i Partiti possono avere (cosa chiedete ai Partiti? che cosa possiamo fare noi?). Un aspetto di particolare importanza riguarda il pacchetto di misure anti crisi che andremo a proporre nella campagna di autunno (legge delocalizzazioni, allargamento tutele sociali, vincoli delle aree, Made in Italy ecc.). Per intrecciare l’inchiesta sociale con le campagne politiche del Partito, è importante chiedere ai lavoratori cosa ne pensano delle nostre proposte, se sono disponibili a sostenerle e come.. Per non introdurre una separazione rigida tra azione sindacale politica e, soprattutto, per evitare la percezione tra gli intervistati di una pericolosa separazione NOI (che facciamo politica) e LORO (che lavorano in fabbrica) sarebbe bene impostate l’intervista con domande costruttive, del tipo : - Come vi siete organizzati per rispondere alla crisi? - (se la risposta è : siamo rassegnati) Quando e come pensate di agire per tutelare i vostri interessi? - Come vi siete organizzati o come pensate di farlo? - Vi appoggiate sul sindacato, sulle RSU, fate da soli (magari attraverso comitati di lavoratori)? Per quali ragioni? - Le istituzioni le vedete come avversari o come possibili alleati? Hanno 27 partecipato alla vertenza o sono rimaste indifferenti, se non ostili alle ragioni dei lavoratori? - Avete contattato i partiti? Perché? Pensate di farlo più avanti? - I partiti si sono attivati in qualche modo? Come? - Ci sono tra voi militanti di qualche partito o movimento che vi sono stati utili? In che modo vi sono stati utili? - Quali sono i vostri obiettivi? Chi pensate sia capace di stare assieme a voi in questa lotta? Solo altri lavoratori; altri lavoratori e qualche sindacato; qualche partito; vedremo nei fatti ecc...... 28 Alcuni elementi per un successivo approfondimento In questa scheda vengono elencati alcuni punti politici, presentati in maniera schematica, per avviare una discussione su essi e un approfondimento finalizzato alla definizione di un intervento politico. Alcuni di sistema (ammortizzatori flessibilità, altri più legati a organizzazione del lavoro) riguardano la condizione lavorativa di chi è stato intervistato e, mi permetto di sottolineare, la loro importanza deriva dal fatto che sono venuti fuori da inchieste concrete, non da speculazioni filosofiche o discussioni politiciste. Li elenco senza un ordine particolare, trattandosi, appunto di indicazioni di lavoro. Un elemento comune a diverse inchieste è l’avvio di iniziative di coordinamento spontaneo e autonomo dei lavoratori: cito come esempi il coordinamento Clac dei lavoratori della Azimut Benetti a livello di fabbrica, o il Coordinamento dei Lavoratori in Friuli che invece mette insieme lavoratori di fabbriche diverse, molte delle quali accomunate dal fatto di essere in crisi. In altri luoghi di lavoro, penso alla Spx di Parma, i lavoratori hanno avvertito l’esigenza di integrare la Rsu aziendale con rappresentanti dei lavoratori eletti a livello di reparto, una sorta di delegati di reparto. Si tratta di capire, quindi, se esistono (sicuramente sarà così) altre esperienze di questo tipo per esaminare i motivi che portano i lavoratori a costituire organismi di coordinamento tanto di fabbrica quanto di territorio. Cioè, in questo caso il nodo è costituito dalla rappresentanza sindacale classica: è sufficiente ed efficace a rappresentare istanze e bisogni dei lavoratori o no? e ancora: i problemi principali sono ravvisati nel rapporto con la Categoria, con la Rsu o con la Confederazione? Sarebbe interessante capire, quindi, in che rapporto entrano queste forme di organizzazione autonoma dei lavoratori con le strutture sindacali esistenti (di conflitto, di competizione, di cooperazione, di integrazione, di indifferenza reciproca…). E’ evidente che questo tipo di approfondimento ha senso se si esaminano solo forme di organizzazione autonoma che si danno i lavoratori “veri”, quelli in carne ed ossa. Non quei “fantomatici” comitati, coordinamenti, assemblee ecc. messi in piedi da qualche setta estremista senza rapporti con i lavoratori o con un numero estremamente esiguo di questi. Un ulteriore elemento che merita di essere sottolineato e che, in parte deriva da quanto sopra esposto è la forte richiesta di democrazia sindacale che si esprime tanto nella richiesta di valutare e votare gli accordi che riguarda29 no direttamente i lavoratori, quanto in forme di rappresentanza nei luoghi di lavoro. Trattandosi di momenti particolari in cui la crisi determina, o viene utilizzata dalle imprese, per realizzare pesanti interventi di ristrutturazione occupazionale, è ovvio che aumenta l’attenzione dei lavoratori nei confronti di tutti i passaggi che scandiscono la fase della vertenza: la decisone delle iniziative da assumere, la definizione degli obiettivi, il monitoraggio e la costante verifica di quanto si muove nella fila di incontri, discussioni, trattative ecc, e infine, la verifica di quanto è stato ottenuto o meno. In tutti questi passaggi è forte l’intenzione dei lavoratori di partecipare, per potersi esprimere, per capire fino in fondo cosa sta succedendo e decidere dei propri destini. In questo senso va prestata una grande attenzione al tema della rappresentanza sindacale, della democrazia, del diritto di partecipazione e di voto. Da questo punto di vista l’annunciata presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare da parte della Fiom merita grande attenzione. In occasione delle crisi occupazionali è piuttosto diffusa la tendenza delle aziende a ricorrere all’uso delle internalizzazione di funzioni precedentemente esternalizzate, forse per non colpire lavoratori diretti e scaricare tutto su figure professionali più deboli e meno tutelate sul piano sindacale. Ad esempio, diverse funzioni che vengono reinternalizzate sono quelle relative alla logistica, gestite da cooperative in cui i livelli di sindacalizzazione e di tutela sono bassissimi. La stessa cosa avviene per i lavoratori precari: in caso di crisi sono i primi a non vedersi rinnovato il contratto a termine. In questo modo, quindi, i primi a pagare il prezzo delle crisi sono i lavoratori più deboli: quelli delle ditte che operano in appalto e i precari. Resta da capire quali relazioni ci sono tra questi lavoratori e quelli direttamente impiegati nelle aziende; se il sindacato è in grado di intercettarli o meno; quali strumenti si possono studiare per creare forme di solidarietà tra i lavoratori e di organizzazione comune delle iniziative di difesa. E ancora: quali conseguenze comportano le esternalizzazioni in termini di diritti salariali e normativi per i lavoratori interni. ancora una cosa: le internalizzazioni servono ovviamente, in primo luogo, per garantire i lavoratori interni/stabili; ma possono essere anche un “sintomo autocritico” del fatto che la tendenza imperante alle esternalizzazioni ha spesso prodotto risultati di inefficienza e di costi non previsti. Riferimenti alle questioni poste sono presenti nelle inchieste Azimut, distretto ceramiche, Ideal Standard, Fervet. Sul tema delle delocalizzazioni l’ampio capitolo ad esse dedicato consente di schematizzare il ragionamento distinguendo tra 30 Delocalizzazioni verso: 1) paesi poveri, motivate dalla scelta di spostare le produzioni dove il costo del lavoro è molto più basso; in questo caso il processo di delocalizzazione comporta prevalentemente un impoverimento occupazionale del territorio; 2) Germania e Nord Europa ovviamente non motivate dalla ricerca del costo del lavoro più basso, ma probabilmente dalla concentrazione produttiva dove i livelli tecnologici e industriali appaiono più elevati (i punti alti dello sviluppo); in questo caso la delocalizzazione comporta, accanto all’impoverimento occupazionale, anche un impoverimento industriale e tecnologico. Nel capitolo sulle delocalizzazioni prima accennato, si trova anche un’ampia distinzione tra delocalizzazione produttiva finalizzata alla ricerca del lavoro a basso costo e quella, invece, finalizzata a presidiare nuovi mercati. Nelle inchiesta condotte alla Eaton, Fir, Lte, Agc e altre viene sottolineata la eparatezza tra manager e multinazionali, una separatezza che opera in due sensi: 1) i manager in genere sono senza autonomia decisionale: sono meri esecutori di scelte assunte nei paesi dove ha sede la multinazionale e ai tavoli di trattativa non possono decidere niente senza telefonare a New York, Tokio ecc.; 2) esiste una assoluta estraneità dei manager all’azienda e alle sue condizioni sociali e territoriali: vengono catapultati in situazioni che non conoscono dal punto di vista sociale, territoriale, culturale con la pretesa che assumano le medesime decisioni anche per contesti aziendali completamente diversi tra loro 3) esistendo questa separatezza tra proprietà della multinazionale e quadro manageriale, questi ultimi spesso sembrano quasi assumere un ruolo di mediazione nelle vertenze tra lavoratori e proprietà (vedi il manager della Lte che da Ostellato cerca di mediare verso Toyota durante le fasi di trattativa). Sulla figura dei manager e del rapporto di questi con le multinazionali presso le quali sono impiegati esiste un’ampia letteratura (penso, in particolare, ad alcuni lavori di Gallino), mi sembra che nella fase di crisi una certa attenzione debba essere psota anche su questa figura e le dinamiche che la coinvolgono. Ovviamente in tutte le inchieste in cui si aveva a che fare con una multinazionale si sottolineava il carattere di assoluta estraneità al territorio che questa manteneva con una sprezzante indifferenza alle conseguenze sociali di scelte come la chiusura di fabbriche o il loro ridimensionamento con le ovvie ricadute in termini occupazionali. Un approfondimento è doveroso anche sull’uso degli ammortizzatori sociali, senza dedicare troppo spazio al fatto, abbastanza ovvio e scontato, 31 che appena viene “annusata” una situazione di difficoltà le imprese scaricano sulla collettività i costi sociali di decisioni di riduzione, seppur temporanea, dei livelli occupazionali. Quello che preme rilevare è che con il ricorso ad ammortizzatori sociali in base alla giustificazione dell’“evento imponderabile”, questo esonera i management da ogni responsabilità. Non esiste nessun meccanismo di verifica delle responsabilità di gestione dell’impresa, si fa passare per imprevedibile, imponderabile l’evento di crisi e tutto bene “madama la marchesa”, tanto la cassa integrazione viene pagata con soldi pubblici versati dai lavoratori. A volte l’apertura della procedura per la richiesta di utilizzo degli ammortizzatori viene utilizzata dall’azienda come strumento di ricatto nei confronti delle organizzazioni sindacali: “noi chiediamo la Cassa Integrazione solo se voi firmate un accordo sindacale che accetta questo livello di esuberi ecc..) – vedi i casi della Tenaris e della LTE. Altre volte c’è un (possibile) uso sindacale degli ammortizzatori sociali per mantenere aperta la situazione in vista di una possibile contrattazione futura sulle scelte dell’azienda. Sarà importante vedere come, su esuberi e su CIG, è stato gestito nelle varie situazioni il rapporto tra stabili e precari: cioè se c’è stato un sforzo di tutela unitaria verso questi ultimi. Ma soprattutto sarà interessante vedere al termine degli ammortizzatori sociali come si presenteranno le diverse situazioni di fabbrica, se ci saranno spazi per una ulteriore iniziativa sindacale ecc. Nelle vertenze esaminate, la preoccupazione dei lavoratori è riferita anche alle scarsissime occasioni di reimpiego: chi perde il lavoro non ne trova un altro. La situazione viene descritta come completamente diversa rispetto a qualche anno fa, quando via da una fabbrica il giorno dopo si entrava i un’altra. Anzi, addirittura in alcuni territori del Nord est erano le fabbriche a litigarsi i lavoratori. Adesso la musica è completamente cambiata. Alla luce di questo andrebbe aperta una forte riflessione sul concetto di flessibilità, sulla presunta opportunità di ricercare lavoro e i vaniloqui della sinistra “moderna” sul presunto anacronismo del posto fisso. La crisi scatena anche Concorrenza tra stabilimenti in Italia, o peggio ancora, scatena forme di concorrenza tra i lavoratori dei vari stabilimenti di uno stesso gruppo industriale. Se un gruppo industriale decide di “razionalizzare” la propria presenza in Italia (cioè decide di tagliare il numero di stabilimenti per concentrare le produzioni solo in alcuni siti) non è difficile trovare situazioni opposte: in alcuni casi esempi di solidarietà e di unità nella lotta; in altri scatta l’atteg32 giamento tipico del “mors tua vita mea” (se chiude l’altro stabilimento ci salviamo noi). Anche in questo caso, dove si verificano queste dinamiche? come ci si approcciare a queste situazioni di crisi in maniera concreta, senza inutili pretese di essere avanguardie di lavoratori la cui unica preoccupazione, in realtà, è salvare sé stessi?, la stessa cosa vale per gruppi europei – a proposito dei quali merita di essere approfondito il ruolo dei CAE (Comitati Aziendali Europei) che sembrano essere tenuti in grande considerazione dai lavoratori per la funzione che possono svolgere in ambito europeo dove la singola vertenza o il singolo stabilimento risulterebbero, di fatto, isolati. Nello stesso argomento va approfondito il discorso del sindacato a livello europeo; in molti casi le relazioni tra lavoratori europei sono pressoché inesistenti (vedi inchiesta Eaton). Invece il coordinamento mondiale del Gruppo Tenaris rappresenta un esempio molto importante anche per il funzionamento di detto organismo che appare non limitarsi a funzioni pletoriche o superficiali ma entra nel merito di problemi di un gruppo mondiale come quello di proprietà della famiglia Rocca. Infine, la questione più spinosa che, pertanto, viene solo minimamente accennata: quella degli accordi sindacali che chiudono una vertenza (o una fase di una vertenza). Detto senza alcuna punta di estremismo: gli accordi chiudono quasi tutti con il risultato della riduzione occupazionale anche se non nella misura inizialmente prevista dall’azienda. La Tenaris punta a 1.024 esuberi si chiude con un numero superiore alle 700 unità, l’Agc intende chiudere un reparto determinando 67 esuberi, al termine della vertenza non vengono reintegrati 36 lavoratori per i quali parte il calvario della cassa, mobilità ecc. Analoga cosa per la ceramica Marazzi……Poiché l’argomento è molto delicato, è bene che non ci si abbandoni a considerazioni superficiali. Per adesso mi limito ad un dato di fatto: a prescindere dal fatto che i lavoratori in esubero vengano coperti o meno da percorsi di tutela (accompagnamento alla pensione, esodi incentivati ecc.) rimane un elemento indiscutibile: la riduzione dei posti di lavoro in un determinato territorio. La Fir di Casalmaggiore riduce di 25 unità il proprio organico? bene il cremonese perde 25 posti di lavoro, che al momento nessuno è in grado di ricreare. Questo è un problema molto serio, soprattutto se esaminato in un’ottica di prospettiva occupazionale futura. Per il resto gli approfondimenti sono doverosi: in sostanza, questa parte sarà utile da approfondire anche per mettere le cose coi piedi per terra, 33 contro tendenze estremistiche e settarie per cui qualsiasi “No” a un accordo va sempre bene, e qualsiasi accordo va sempre male. Non esistono posizioni assolute, valide per qualsiasi circostanza; e per questo non vale nemmeno il “simmetrico opposto”, per cui gli accordi vanno approvati a tutti i costi. Si tratta di distinguere tra accordi buoni e cattivi, ma sapendo che anche i primi - nell’attuale situazione di crisi - non possono corrispondere totalmente alle giuste esigenze dei lavoratori. Il problema è dunque se: 1) mantengono aperte possibilità successive di contrattazione e controllo; 2) se creano elementi di unità tra stabili e precari, o subiscono interamente la divisione; 3) infine, ovviamente, se strappano “qualcosa in più” sui livelli di occupazione rispetto ai piani iniziali dell’azienda. 34 Inchiesta realizzata sulla Tecnotest Divisione di SPX Italia Srl stabilimento di Sala Baganza (Pr)2 Tecnotest è una azienda che “… progetta, produce e offre una gamma completa di apparecchi e servizi per la manutenzione di autoveicoli, motocicli e veicoli pesanti. Strumenti per autodiagnosi multimarca, analizzatori gas di scarico per motori benzina e diesel, linee di controllo tecnico degli autoveicoli, stazioni plurioperative per la gestione coordinata della diagnosi in officina; stazioni per il trattamento degli impianti aria condizionata; apparecchi per la ricarica e la manutenzione delle batterie; centrafari; assetti ruote e simulatore di carico stradale sono solo alcuni dei prodotti che fanno di Tecnotest un partner globale nel comparto Aftermarket.” In questa situazione la scelta dei testimoni privilegiati con i quali è stato condotto il colloquio/intervista in forma collettive è avvenuta direttamente ai cancelli dell’azienda dove da giorni si svolge il presidio permanente dei lavoratori Spx che si trovano in una situazione di agitazione particolare attraverso la forma dello sciopero ad oltranza. I testimoni privilegiati, in questa inchiesta sono costituiti da 2 delegati sindacali RSU del luogo di lavoro e circa una decina di lavoratori dello stesso (che non sono rappresentanti sindacali). Qualche battuta è stata scambiata anche il segretario della categoria – Fiom Cgil. Il colloquio intervista si è svolto nella giornata di lunedì 21 settembre 2009 nel corso della quale, sempre nel presidio antistante la fabbrica Spx: - dalle 7,30 alle 9,00 si è tenuta l’assemblea dei lavoratori Spx per fare il punto della vertenza e decidere le iniziative da assumere nei prossimi giorni; - dalle ore 9,00 alle 11,30 circa si è svolto l’attivo dei delegati Fiom della provincia di Parma per discutere dei temi del rinnovo del contratto di categoria e dell’impatto della crisi economica; la scelta di tenere l’attivo dei delegati Fiom ai cancelli della Spx ha assunto un rilevante significato di vicinanza e solidarietà da parte delle rappresentanze dei lavoratori metalmeccanici del parmense; - dalle 16,00 alle 17,00 si è tenuta la Conferenza stampa per illustrare all’opinione pubblica gli sviluppi del caso Spx. L’intervista comincia i due rappresentanti sindaci Rsu – entrambi Fiom. Nel caso della Spx di Sala Baganza (PR) non si è verificata nessuna crisi, nè di mercato, né finanziaria ecc… Tra il 2007 e il 2008 si è verificato un leggere calo di fatturato, probabil2 In collaborazione con Andrea Davolo, Prc di Parma. 35 mente per strategie commerciali sbagliate (acquisizioni di aziende in Europa), ma comunque il 2007 ha chiuso con 1,5 milioni di € di utile operativo, il 2008 ha chiuso con circa 1 milione di € di utile operativo e il 2009, nonostante una riduzione del 20% di produzione, secondo le proiezioni, dovrebbe chiudere in pareggio. Quindi nessun problema di bilancio. I problemi cominciano a verificarsi già nel 2008 con le prime voci ufficiose secondo le quali l’Azienda avrebbe dato vita ad una riorganizzazione complessiva spostando il settore della produzione in un altro paese europeo che inizialmente sembrava essere la Francia. Spx, quindi, non avrebbe chiuso lo stabilimento di Sala Baganza, avrebbe mantenuto il settore dei servizi (progettazione, commerciale, amministrativo, IT software ecc.), ma avrebbe dismesso la parte produttiva per trasferirla in Francia. Per chiarire è bene fornire un minimo di numeri. Lo stabilimento Spx occupa 147 dipendenti di cui solo 47 addetti alla produzione. Quindi, i posti di lavoro a rischio per questa riorganizzazione sembrerebbero “solo” 47; forse anche questo tipo di considerazioni è possibile che abbiano guidato le scelte del management: in fondo, in uno stabilimento con scarsa conflittualità sindacale, dove si “salvavano” 100 posti di lavoro e se ne sacrificavano “solo” 47, tutto sommato non ci sarebbero stati molti problemi. Ma la risposta dei lavoratori è stata di segno ben diverso con un adesione allo sciopero praticamente del 100%. Questo è il primo è più importante elemento da rilevare. Nonostante il trasferimento della produzione all’estero interessi un reparto che impiega 47 persone, tutti i 147 dipendenti dell’Azienda entrano in sciopero. Ma questo lo vedremo meglio più avanti. Nell’aprile del 2009 l’Azienda convoca le Rsu per comunicare l’intenzione di chiedere il trattamento di Cassa Integrazione motivando tale richiesta con il calo produttivo che si sarebbe verificato tra gennaio e febbraio. Nei mesi di gennaio e febbraio si è realmente verificato un calo produttivo, ma dovuto in gran parte alla stagionalità del principale prodotto Spx. Questa azienda, infatti, produce attrezzature per Officine che svolgono manutenzione delle autovetture; in particolare il principale prodotto di Spx (che fa registrare circa il 40% del fatturato complessivo) sono le attrezzature per officine che consentono di intervenire sugli impianti di condizionamento della auto. Da qui deriva il carattere di forte stagionalità del prodotto che nei mesi di gennaio può anche conseguire una contrazione produttiva. Le Rsu hanno rigettato la richiesta di Cassa Integrazione sostenendo che 36 era immotivata e che di lì a qualche mese si sarebbe potuta verificare una ripresa produttiva tale da non rendere più necessario il ricorso alla Cassa stessa. Questo è quanto puntualmente si è verificato già in aprile (come del resto si è verificato anche negli anni precedenti che da aprile in poi hanno registrato significativi aumenti della produzione). Per cui si è verificata una situazione paradossale: l’Azienda, che solo due mesi prima voleva mettere i lavoratori in Cassa Integrazione, ha chiesto agli stessi la disponibilità ad orari di lavoro straordinari. Ovviamente questo atteggiamento ha provocato molta arrabbiatura tra i lavoratori: prima veniva chiesto loro di accettare la Cassa Integrazione per un presunto calo produttivo, un mese dopo veniva chiesta loro la disponibilità a fare straordinari per reggere all’aumento di produzione che la stagionalità del prodotto comporta. Questa prima vicenda (richiesta di Cassa Integrazione e immediatamente dopo richiesta di ore di straordinario) ha segnato il primo momento di tensione con i lavoratori. Viene ripetuto diverse volte che se l’Azienda avesse mantenuto un comportamento più serio e ragionevole (ad esempio, attenendo di verificare i volumi delle ripresa produttiva che comunque ci sarebbe stata da aprile in poi), non avrebbe provocato questa “incazzatura” tra i lavoratori. La richiesta di Cassa Integrazione sarebbe stata “contenuta” in 4/6 giorni al mese, segno evidente che non ci si trovava di fronte ad un processo di riorganizzazione né di calo produttivo di tale entità da giustificare tale richiesta. Alla fine, comunque, l’Azienda, sia per le proteste sindacali e dei lavoratori, sia per l’avvenuta ripresa produttiva, non ha nemmeno inoltrato all’Inps la richiesta di Cassa Integrazione. Finita la vicenda della Cassa Integrazione, sono riprese le voci di spostamento della produzione e ricominciano le preoccupazioni dei lavoratori, di tutti i lavoratori, non solo dei 45 coinvolti direttamente. La domanda che si pongono tutti i dipendenti è: se trasferiscono la produzione in un altro sito, qui cosa rimane? quale futuro avrà questo stabilimento? Queste voci, di trasferimento, si rivelano particolarmente insistenti a Bologna, in occasione della Fiera Promotec, a conferma del fatto che ormai l’intenzione del management è ampiamente conosciuta nel settore produttivo di riferimento. Ovviamente i lavoratori, sentendo queste voci anche in occasione della Fiera di Bologna maturano ulteriore amarezza nei confronti della loro Azienda. 37 Le Rsu decidono di chiedere ufficialmente un incontro per avere spiegazioni; l’incontro si tiene ma le spiegazioni sono vaghe: “stiamo ragionando di riorganizzazione a livello europeo”, “le valutazioni sono ancora in corso”…. Cominciano le richieste dei lavoratori di assumere subito iniziative forti, le RSU chiedono di capire meglio cosa sta succedendo in quanto non era stato presentato loro nessun progetto concreto. In particolare il Consiglio di Amministrazione di Spx non si era ancora riunito, quindi, non aveva ancora deciso né proposto niente. Dal punto di vista delle Rsu e dei lavoratori, però, non aveva alcun senso separare le funzioni di progettazione da quelle di produzione in quanto le due risultano strettamente integrate tanto da dar vita a modificazioni del prodotto in corso di produzione, “all’ultimo minuto il progettista può scendere per concordare con il capo – linea una modifica”. Questa stretta collaborazione con le linee di produzione viene descritta dalle Rsu come un importante elemento di qualità dovuto alla stretta sinergia tra i diversi settori dell’Azienda che consentono cambiamenti frequenti e conseguenti adattamenti del prodotto. Alla luce di questa profonda conoscenza del processo produttivo le Rsu hanno avanzato una contro – proposta al Piano Industriale dell’Azienda: quella di realizzare una seria analisi di processo che elimini eventuali inefficienze, ma, sottolineano, questa analisi di processo deve avvenire “con i lavoratori, non sulla loro testa”. L’Azienda ha deciso di trasferire la produzione in quanto considera questa attività come “no – core” in quanto non porterebbe valore aggiunto trattandosi, a detta dell’Azienda, di mero assemblaggio si materie prime e di semi – lavorati forniti da aziende dell’indotto locale. Questo passaggio è importante anche per ricostruire la rete di fornitori locali, cioè delle Aziende che, una volta trasferita la produzione all’estero, vedrebbero drasticamente ridotta la loro produzione con ulteriori conseguenti problemi occupazionali. In realtà, nonostante l’Azienda consideri attività di scarso valore quelle della produzione, le Rsu sottolineano come attività di assemblaggio e di collaudo necessitino di grande esperienza che non è certo acquisibile in un mese, ma necessita di anni. Le Rsu, a luglio 2009, chiedono che l’Azienda, prima di dare avvio alla procedura di mobilità, presenti un Piano Industriale da discutere; la risposta dell’Azienda è una convocazione nella quale vengono proiettate due slide con 4 calcoli economici che si limitano a quantificare il risparmio che deriverebbe dall’Azienda grazie alla riduzione dei 47 lavoratori addetti alla 38 produzione. La scelta dell’Azienda sul paese in cui trasferire la produzione cade sulla Germania dove esiste uno stabilimento di Spx. In Germania una parte del personale dello stabilimento Spx è fermo in quanto fornendo Bmw (in Germania si produce in prodotto diverso rispetto all’Italia, si tratta, appunto, di componenti per auto Bmw), il calo produttivo di Bmw stimato nel 30-40% in meno ha determinato, di conseguenza, una riduzione delle forniture di componenti e quindi una riduzione del personale impiegato in tale produzione. Quindi, secondo le Rsu, la decisione dell’Azienda sembra prefigurare questo: una riduzione occupazionale in Italia per trasferire la produzione in Germania ed impiegare in questa produzione i lavoratori tedeschi della componentistica per auto attualmente fermi per il calo produttivo di Bmw. Il problema che Spx non sembra essersi posta è cosa succederà se Bmw dovesse tornare ai livelli di produzione precedenti con la conseguente crescita di produzione di componenti e quindi la necessità di reimpiegare i lavoratori attualmente fermi che, nel frattempo, sarebbero stati messi a produrre quanto si produce adesso in Italia (attrezzature per auto – officine). Nella giornata di venerdì 11 settembre viene dichiarato dall’Assemblea dei lavoratori lo sciopero ad oltranza finalizzato al ritiro di questa decisione. Allo sciopero l’adesione è praticamente del 100%, con l’eccezione dei manager e di un lavoratore addetto alle IT con contratto a tempo determinato. Alla domanda se esistono altri tempi determinati, la risposta delle Rsu è positiva: ce ne sono circa dieci, sparsi nei vari reparti, tutti in sciopero (tranne uno, appunto). La cosa rilevante è che ad alcuni di questi era stata promessa la stabilizzazione. Cioè appare interessante rilevare che, nonostante ad alcuni giovani a tempo determinato, impiegati in settori non colpiti dal trasferimento, fosse stata promessa la conferma, questi abbiano comunque partecipato a tutte le iniziative di lotta dei lavoratori come lo sciopero ad oltranza. Ad esempio, alcuni di questi erano softwaristi, un settore non interessato dal trasferimento. Questa forte adesione di tutti i lavoratori alle iniziative di lotta desta stupore anche nelle Rsu. Spx non è certo una azienda con una forte storia e presenza sindacale, l’unico sciopero si è svolto nel 1996 in occasione del contratto aziendale, la partecipazione alle assemblee è molto bassa, non ci sono mai stati momenti di tensione. L’elemento che ha cominciato ad unire i lavoratori è stata la richiesta dell’Azienda dell’inizio 2009, come visto in precedenza, di mettere in Cassa 39 Integrazione. “Lì i lavoratori si sono proprio incazzati e hanno cominciato a parlare tra loro”. Secondo le Rsu, l’età abbastanza omogenea (il grosso è tra i 35 e 45 anni) ha aiutato il processo di unità dei lavoratori, che, a sua volta ha aumentato la consapevolezza degli stessi: “che senso ha una azienda senza il reparto produzione?!”; “quanto investiranno ancora?”; “per quanto tempo manterranno soltanto i settori non produttivi?”: sono le domande più frequenti che i lavoratori esprimono e che alimentano l’inquietudine e la preoccupazione. I lavoratori chiedono ai manager di “metterci la faccia” per spiegare l’operazione che intendono condurre. Questa avviene durante una “Communication Time”: una sorta di riunione del personale in cui l’Azienda comunica le proprie decisioni. Sul piano organizzativo l’Azienda intende dar vita ad una riorganizzazione verticale. Cioè l’assetto organizzativo non verte più sulle azienda singole (Italia, Francia, Germania ecc…), ma sulla organizzazione verticale per reparti, in cui cioè ogni reparto, a prescindere da dove è situato, risponde al responsabile centrale di gruppo. Secondo le Rsu questa scelta non regge: la progettazione, ad esempio non può essere standardizzata per tutti gli stabilimenti, ma deve mantenere delle differenze da Paese a Paese che spesso sono differenza anche di tipo normativo. I mercati di riferimento sono diverso, diverse le normative e, conseguentemente, non è possibile imporre un unico modello ma questo dovrebbe essere adeguato alle caratteristiche del mercato per il quale produce. Questa scelta è partita dagli Usa e calata in tutti i Paesi in cui ci sono stabilimenti Spx. Alla domanda se il sindacato è stato coinvolto in queste scelte la risposta è no; non ci sono stati contatti con organizzazioni sindacali degli altri paesi in cui ha sede Spx (“non sappiamo nemmeno se in Francia e Germania in fabbrica hanno il sindacato”). A fronte della decisione dell’Azienda di procedere con la propria decisione le Rsu si sono immediatamente attivare contattando la categoria. Alla Spx la Rsu è costituita da tre persone, due Fiom e una Uilm. Si tratta, quindi, di una Rsu di dimensioni molto contenute ma che ha assunto una importante decisione di allargamento della stesse come in seguito verrà spiegato. La Fiom, a fronte della sollecitazione della Rsu di Spx ha risposto immediatamente capendo che si trattava di una vertenza pesante. 40 Inizialmente è intervenuto il funzionario di zona, ma nei giorni successivi, con l’appesantimento della vertenza è intervenuto direttamente il segretario di categoria della Fiom (Sergio Bellavite). Tra Rsu e categoria ci si è organizzati in modo da avere sempre al presidio ai cancelli o un delegato o un funzionario Fiom, sia per la gestione del presidio sia per rispondere immediatamente ad eventuali convocazioni dell’azienda o delle istituzioni. La Rsu di Spx, con l’apertura della vertenza ha proposto l’allargamento della Rsu ad ulteriori tre lavoratori. Questa scelta è stata motivata da due ordini di motivi: 1) la pesantezza della vertenza che non può essere fatta gravare soltanto sulle spalle di tre persone, per ragioni di stress, di tensione, i impegni ecc..; 2) per coprire, in termini di rappresentanza tutti i reparti dell’Azienda: visto che ai tavoli si discuterà di recupero di inefficienze, per discuterne in maniera competente è necessaria la competenza di chi nei reparti lavora. Questa idea è stata espressa dalla Rsu alla Fiom, la quale ha accettato la proposta mentre agli altri sindacati (Cisl e Uil) non stava bene. La proposta è stata sottoposta all’assemblea che, autonomamente, ha indicato le tre persone che avrebbero costituito la Rsu allargata. Nemmeno Confindustria ha accettato questa formula, ma alla fine ha dovuto subirla. Questa scelta è stata molto apprezzata dai lavoratori. Così come viene riconosciuto e apprezzato il grande impegno della Rsu e della Fiom in questa fase, in particolare, viene sottolineato, anche da parte di chi “non ha mai amato il sindacato”. Le Rsu alla domanda sul rapporto con la politica rispondono che hanno sempre “tenuto fuori la politica intesa come “scaramucce””. Sono consapevoli che a Parma che una parte della Fiom è vicina a Rifondazione o comunque alla sinistra radicale, ma questo non ha mai creato problemi di nessun tipo. Della Fiom viene detto che si tratta dell’unico vero sindacato rimasto in Italia, anche se, magari, non si concorda con tutte le posizioni espresse dalla Fiom. In particolare un RSU che si definisce “abbastanza moderato” sottolinea che l’aspetto più importante del modo di fare sindacato della Fiom è l’aspetto democratico di coinvolgimento dei lavoratori: “io come Rsu vado a contrattare, ma poiché contratto su cose che verranno applicate a tutti i lavoratori, è giusto che siano questi ad esprimersi; hanno il diritto di esprimersi”. 41 Le Rsu precisano che solo 40 lavoratori su 147 risultano iscritti al sindacato (quasi tutti alla Fiom), questo pone loro un problema di rappresentatività (“rappresentiamo solo il 30% dei lavoratori”) che viene superato con il coinvolgimento e la decisione dei lavoratori sulle scelte più importanti (“sulle scelte fondamentali facciamo votare e questo ci da legittimazione”). La maggior parte degli iscritti lo sono alla Fiom perché, viene detto, è l’unica organizzazione sindacale che si è sempre presentata in azienda, “anche per fare assemblee con solo 3 persone”; “venivano sempre anche se non c’erano problemi, mentre gli altri mai”. I partiti che si sono presentati ai cancelli sono stati solo Rifondazione Comunista e il PD (con la sezione di Sala Baganza). La Lega non si è mai presentata. Ai partiti vengono chieste due cose. La prima di carattere contingente rispetto alla situazione di Spx: quella di mobilitare il più possibile le istituzioni. “Visto che parliamo con una multinazionale molto forte, i partiti possono avere la forza di mobilitare le istituzioni in modo da avere un peso maggiore nelle trattative”. Ovviamente la richiesta è quella di attivare tutte le istituzioni possibili, fino al Governo, in considerazione del peso che ha una multinazionale. La seconda, di carattere programmatico: a) proporre una legge che tuteli il know how italiano, la qualità del lavoro che viene svolto in Italia. (“assurdo che le multinazionali vengano qui, comprino e poi si portino via il patrimonio di competenze, esperienze e professionalità”); b) una legge sulle rappresentanze sindacali (“ma l’UGL chi rappresenta?! eppure lo chiamano a tutti i tavoli perché fa comodo che firmi tutto!”). Sul piano dell’organizzazione, oltre al presidio, alle iniziative di lotta (presidio davanti a Confindustria, conferenze stanmpa, ecc…) - è stato dato vita ad un blog http:// spxworkersinaction.blogspot; - è stato aperto un conto corrente per ricevere contributi per alimentare la cassa di resistenza visto che lo stipendio perso per le giornate di sciopero ad oltranza comincia a farsi sentire. All’intervista partecipano anche una decina di lavoratori. Con questi, vista l’esaustività della ricostruzione delle vicende aziendali fatta con le Rsu, il discorso viene focalizzato sul ruolo del sindacato e della politica. Il sindacato, viene detto, sta svolgendo un ruolo fondamentale in grado di “convogliare le energie con la loro esperienza”, “ci stanno guidando”. Spx, come detto non ha mai avuto esperienze di conflitto sindacale, per quasi tutti i lavoratori è la prima volta. In particolare del sindacato viene apprezzata la grande capacità organizza42 tiva (“si vede che c’è dietro una macchina organizzativa, a volta se serve qualcosa basta che facciano una telefonata”), la rete di relazioni che ha, la capacità di portare figure note (Cremaschi ed Epifani). Una lavoratrice, tra l’altro facente parte dei tre nomi votati dall’assemblea per l’allargamento della Rsu, dichiara di essersi iscritta alla Cisl senza un particolare motivo sindacale (“sul lavoro non avevo nessun problema, avevo bisogno di consulenza fiscale”), ma dichiara di essere rimasta delusa dalla Cisl (“il loro rappresentante è stato presente poche volte, mi ha solo chiesto di essere informato”). Questa lavoratrice, anche durante l’intervento fatto durante l’assemblea dei lavoratori dalle 7,30 alle 9,00, ha dichiarato di prendere atto che la presidio partecipa solo un sindacato (Fiom) se solo partiti di sinistra o di “estrema sinistra”. Un altro lavoratore si pone il problema di come comunicare il senso delle loro iniziative. Si dice preoccupato perché la sua vicina di casa, passando dal presidio gli ha testualmente chiesto “ma perché fate questi tafferugli ‘” (!). “Se questa signora ci chiede questo, usando il termine tafferugli, forse qualcosa ci sfugge”. Viene ribadito da altri il ruolo positivo svolto dalla Fiom soprattutto in una realtà che non ha mai fatto scioperi e non ha mai avuto una storia sindacale (“hanno attivato persone molto diverse”; “riescono a trascinare anche le persone indecise”). Ai partiti viene chiesta visibilità della loro vertenza. Visibilità: è la prima parola che pronunciano tutti gli intervista. Questo deriva anche dal sostanziale black out informativo della Gazzetta di Parma i cui articoli sull’economia parmense, ci viene detto, vengono selezionati da un funzionario di Confindustria. Da qui la richiesta di rendere visibili la loro situazione e le loro ragioni. Anche dai lavoratori viene chiesto ai partiti di attivarsi nei confronti delle istituzioni, sostanzialmente con le motivazioni già espresse dalle Rsu. Tuttavia, aldilà della situazione contingente, è forte la richiesta di allargare l’impegno dei partiti ad un “discordo generale sul mondo del lavoro”. In particolare, viene detto, manca una impostazione del rapporto da tenere con le multinazionali. Da parte di tutti: Istituzioni, Sindacati, Partiti, non hanno ancora elaborato strumenti che gli consentano di tenere testa alle multinazionali (“quando una multinazionale decide non si sa con chi parlare”). La richiesta è quella di costruire regole che consentano una maggiore tutela nei confronti delle multinazionali, ad esempio istituzionalizzando “tavoli di confronto a cui multinazionali devono partecipare”. Un’altra lavoratrice (attorno ai 30 anni) precisa che nel caso della loro ver43 tenza non ci sono elementi aprioristici: cioè non si tratta di un conflitto “a priori” tra classe operaia e padrone. Anzi, ritiene che non ci siano più i termini per una classica contrapposizione tra classe operaia e padrone (“noi ci battiamo perché questa è la NOSTRA azienda, difendiamo la nostra professionalità e il fatto che questa azienda è un elemento di benessere per il territorio”). “In questa azienda non siamo alla catena di montaggio, ci sono professionalità elevate”. Quindi, ad un partito come Rifondazione viene chiesto di impostare la propria iniziativa politica non come la classica contrapposizione classe operaia/padrone, ma con iniziative che tutelino la dignità e la professionalità del lavoro. Da parte di questa lavoratrice viene sottolineate la necessità che una forza politica come il Prc difenda l’etica e la dignità del lavoro. Questa lavoratrice, quindi, sembra rigettare una schematica identificazione di classe. Alla domanda “ma allora, secondo te, perché oggi sono venuti da voi delegati operai di altre fabbriche?”, risponde così: “perché hanno capito che qui non si tratta di una azienda in crisi, ma di logiche finanziarie e speculative. Colpiscono delle professionalità molto elevate. Qui ci sono margini maggiori per vincere e se si vince qui può essere un simbolo”. La richiesta forte di questa lavoratrice a Rifondazione è che imposti diversamente il suo approccio: nel caso della Spx si tratta di una lotta contro una multinazionale, non contro il classico padrone. Sempre questa lavoratrice ritiene che Rifondazione debba superare l’identificazione, ancora troppo forte a suo dire, con lo “spettro del comunismo” (e cita espressamente i nomi di Stalin e Tito), propone invece che Rifondazione debba essere identificata come il partito che difende l’etica e la dignità del lavoro; che costruisce vertenze dei lavoratori con una forte connotazione territoriale (difendere l’esistenza dell’azienda è difendere “un elemento di benessere per il territorio”). Anche altri lavoratori faticano a comprendere la categoria della classica lotta di classe contro il padronato; ora, viene detto, le multinazionali sono in mano a manager diversamente proprietari (ad esempio con il meccanismo delle stock options). Vengono espresse due frasi: “Magari ci fosse un padrone che investe capitale proprio”, “magari ci fosse un imprenditore, almeno sapremmo identificarlo”. Da queste due frasi emergono orientamenti molto critici nei confronti del sistema delle multinazionali, dei loro meccanismi decisionali, della loro 44 struttura proprietaria. Da una parte il senso di irresponsabilità che promana dalle multinazionali (un imprenditore, invece, investirebbe capitale proprio lasciando intendere una ben latra attenzione e sensibilità ai destini dell’azienda); dall’altra la multinazionale viene intesa come una entità lontana, sconosciuta, non identificabile e quindi è come se non esistesse controparte. Sotto accusa vengono messi i manager delle multinazionali, detentori delle azioni speciali, strapagati con il meccanismo dei bonus, naturalmente orientati a pensare soltanto all’andamento del titolo (essendo pagati per buona parte in azioni della loro stessa azienda) e quindi magari orientati a tagliare posti di lavoro se questa operazione consente un aumento del valore del titolo. La logica di questi manager è tutta di breve periodo, al massimo si spinge ad un anno, ma senza programmare investimenti, senza piani di lungo termine. Anche i lavoratori ricordano che i primi strumenti attivati (oltre alle mobilitazioni, presidio ecc.) sono stati il blog e la cassa di resistenza, a cui aggiungono anche una positiva relazione con il movimento studentesco che sostiene la loro lotta. I lavoratori riconoscono che Rifondazione Comunista è stato il primo partito ad attivarsi, sia con la sezione locale (Sala Baganza) che con la Federazione Provinciale. Alcuni ritengono che il Prc abbia tra i suoi compiti principali quello di tutelare e ricordare il fatto che la sovranità delle decisioni appartiene all’assemblea dei lavoratori. Sottolineano che non vogliono essere espropriati delle loro competenze nemmeno dal sindacato (su cui confermano un giudizio molto positivo per tutte le cose dette prima), ma ritengono che anche accordi suggeriti dal sindacato debbano comunque essere discussi e votati dai lavoratori con metodo democratico. Giudicano positivamente la decisione della Rsu di allargare la propria composizione e alcuni richiamano il fatto che questo meccanismo (Rsu allargata a rappresentanti di reparti) ricorda i vecchi Consigli di Fabbrica (questa cosa viene detta da una lavoratrice trentenne che certamente non ha conosciuto i Consigli di Fabbrica). Sempre a Rifondazione viene chiesto di mettere a disposizione mezzi di informazione per contrapporsi ai “poteri forti” tra i quali viene annoverata la Gazzetta di Parma che nasconde queste notizie. 45 Inchiesta relativa sulla fabbrica F.I.R. Elettromeccanica SRL di Casalmaggiore (Cr)3 Il Rapporto di Inchiesta che segue è stato realizzato a seguito di intervista /colloquio con Rsu e lavoratori Fir Elettromeccanica Srl in data 26 settembre 2009; in precedenza si era tenuto un primo incontro informativo, sempre con Rsu e lavoratori, in occasione della festa di Liberazione organizzata dal circolo Prc di Casalmaggiore. Fir Elettromeccanica è parte del Gruppo Fir, con sede negli Usa e di proprietà di un fondo di investimento. Dal loro sito internet: FIR Group designs and manufactures custom AC and brushless DC motors for industrial and niche applications. We hold market leading positions for combi-convection oven motors, self-locking motors and pump motor packages for dishwashing machines. FIR Group offers customers design and production capability optimized for their specific application. A leader in the production of induction electric motors since the 1960s, FIR produces hundreds of thousands of custom motors each year, including electro-pumps, brake-clutch motors, ventilation systems, self-braking motors, explosion proof motors, and permanent magnet brush-less motors. FIR Group also designs and manufactures electronic drives for brushless motors and inverters for special applications. FIR Group companies include FIR Elettromeccanica srl , TEA International and Selin Sistemi. TEA serves the global construction market with cable hoists and platform lift products. Selin supports the FIR Group by providing research & development for brushless motors and electronic systems. The FIR Group is part of Kinetek, a privately held global manufacturing enterprise that operates 28 facilities in North America, Europe and Asia. Kinetek companies hold market leading positions in elevator/escalator, commercial floor care, material handling/aerial lift, golf and utility vehicle, commercial food equipment, and medical market segments. Kinetek companies include Imperial Electric, Scott DC Power Products, Euclid Universal, Advanced Motors & Drives, Kinetek De Sheng (KDS), FIR Group, Kinetek Controls, Valmark Industries, Merkle-Korff Industries, Motion Control Engineering (MCE), Zhongxiu Kinetek (ZXK) and Kinetek Jinghe (KJH). Le Rsu illustrano l’origine della situazione di crisi occupazionale, quando nel novembre 2008 l’Azienda ricorre alla riduzione dell’orario di lavoro attraverso lo strumento della Cassa Integrazione a 40 ore/mese. Da gennaio 2009 le ore di Cassa Integrazione diventano 80 – per i mesi di gennaio e febbraio – poi 120 per arrivare alla richiesta della Direzione di arrivare alla Cassa Integrazione a zero ore. “Lì la situazione comincia a farsi pesante”; anche in considerazione del fatto che il Piano Industriale presentato dalla Direzione prevede la cancellazione delle lavorazioni meccaniche svolte 3 In collaborazione con il Circolo Prc di Casalmaggiore (Cr). 46 nell’officina di Via Vanoni (un reparto della medesima Azienda Fir, ma “distaccato” dalla sede centrale di Via Roma). Le lavorazioni meccaniche dell’officina di via Vanoni occupano 15 persone, praticamente tutte inquadrate nel 5° livello: quindi, operai con una buona professionalità e con i livelli retributivi più alti. Il manager che dirige l’Azienda è molto legato alla Cina (viene definito un “integralista cinese”, ma con stipendio “occidentale” viene subito precisato), Paese verso il quale l’Azienda sta spostando molte produzioni. L’Azienda, che produce motori elettrici, sta trasferendo la produzione di grossi lotti in Cina, ad esempio, un lotto di almeno 65.000 pompe. Il ricorso alla Cassa Integrazione viene giustificato con il calo degli ordini; e nello stesso periodo (aprile 2009), dalla sede degli Usa arriva alla Direzione Fir Elettromeccanica di Casalmaggiore il plauso per le modalità con cui lo stabilimento di Casalmaggiore ha retto nei primi tre mesi dell’anno superando quella che era considerata la fase più difficile. Quindi, il ricorso alla Cassa Integrazione del novembre 2008 (e mesi seguenti) è giustificato dal calo della produzione del 20-30%. Ma, viene precisato dai rappresentanti della RSU, il vero obiettivo è “sfoltire”; cioè ridurre i livelli occupazionali esternalizzando produzioni prima svolte all’interno. Attualmente è stata concessa la Cassa Integrazione a zero ore per 80 dipendenti con decorrenza dal 1 settembre 2009 (per 12 mesi). La Fir conta complessivamente 120 dipendenti di cui circa 70 operai e 50 impiegati. La produzione (motori elettrici) era organizzata prevedendo che i pezzi preparati dalle lavorazioni meccaniche dell’officina di via Vanoni, venissero poi trasferite sulle linee di via Roma, dove venivano assemblati e collaudato il prodotto finito. La Cassa Integrazione a zero ore del periodo 1 settembre 2009-31 agosto 2010 è stata ottenuta con la giustificazione della “riorganizzazione produttiva”. Tale riorganizzazione prevede semplicemente la soppressione delle lavorazioni meccaniche dell’officina di via Vanoni; lavorazioni che verrebbero esternalizzate completamente affidandone la realizzazione ad artigiani della zona a cui si aggiunge la decisione, già assunta, di dirottare i grossi lotti di produzione in Cina (come detto in precedenza) dove ormai si concentra il 30-40% della produzione di alcuni motori. Il cosiddetto “outsourcing” verso la Cina, infatti, riguarda la produzione di pompe, fusioni in alluminio e un elenco di tipologie di motori. Al momento della presentazione del progetto di riorganizzazione il mana47 ger (viene sempre chiamato così da Rsu e lavoratori) dichiara un esubero di 25/27 persone (ma il timore è che si possa arrivare a 37). Di queste, 15 sono le figure professionali di via Vanoni sulle quali si concentra in maniera massiccia l’utilizzo della Cassa Integrazione. La Cassa Integrazione, che dovrebbe essere a rotazione, in realtà colpisce in maniera particolare alcune figure: i lavoratori del reparto oggetto di dismissione e le figure più sindacalizzate e combattive. Insomma, l’utilizzo della Cassa Integrazione, che dovrebbe essere a rotazione, in realtà si presta ad un utilizzo discrezionale dell’Azienda. L’obiettivo del manager è ridurre, quindi, i livelli occupazionali aggiungendo al taglio degli operai addetti alle lavorazioni meccaniche almeno altre 10 figure, magari quelle più prossime al pensionamento. L’Accordo firmato, infatti, prevede per coloro che volontariamente intendessero presentare le dimissioni, un ‘offerta comprendente oltre alla garanzia del Tfr, anche una buona uscita di circa 12.000 euro. Questa posizione viene espressa dall’Azienda in occasione del tavolo di crisi convocato dal Comune di Casalmaggiore in occasione del quale l’atteggiamento dell’Azienda non è quello solito – aggressivo e autoritario – ma di apparente disponibilità a trovare una soluzione. In realtà, precisano Rsu e lavoratori, si tratta di un atteggiamento che il manager ha soltanto di fronte alle istituzioni, quando è con i lavoratori cambia completamente. Prova ne sia, come testimoniato da articoli della stampa locale (vedi la Cronaca di Cremona del 29 maggio 2009), il fatto che in maggio vennero proclamate quattro ore di sciopero per manifestare contro l’atteggiamento troppo rigido del Responsabile della Produzione (il “manager”) che in maniera massiccia era ricorso allo strumento del “richiamo scritto” (anticamera del provvedimento disciplinare) in caso di errori da parte dei lavoratori. Insomma, le Rsu lamentavano la preclusione di qualsiasi rapporto “verbale ed umano” a causa del continuo ricorso al richiamo scritto. Addirittura nell’incontro con il Comune il “manager” ha dichiarato che sono i lavoratori che non hanno capito bene la proposta dell’Azienda che “è solo di riorganizzazione” in quanto, a detto dello stesso Responsabile “noi l’azienda la vogliamo tenere”. Anche sulla stampa locale il Presidente di Fir (il “manager”) ha dichiarato che “non si è mai parlato di licenziamenti”, che “per gli esuberi ci sono cassa integrazione straordinaria e mobilità”. Si tratta di una evidente tentativo di maldestra difesa: chiunque sa che terminato il periodo cassa o si riprende a lavorare o si finisce in mobilità e quindi si perde il lavoro. 48 La posizione dell’Azienda è così giustificata: “l’azienda ha maturato da tempo una riorganizzazione, ormai in atto, per fare posto alle esigenze di oggi”. Sempre da dichiarazioni rese alla stampa locale, il Presidente sostiene che “le esigenze di oggi sono inevitabilmente legate alla crisi in atto che alla Fir si misura con una riduzione del 30–35% dei volumi del settore dei motori elettrici” Tre sono i fattori che caratterizzato il riassetto: “Riduzione dei costi del personale (in Cina un operaio costa 100 dollari al mese, in Italia 3.000 euro); non investire nelle macchine per la lavorazione meccanica non legate al nostro core-business; riqualificare il prodotto con professionalità più qualificate”. In Cina, infatti, il gruppo Fir ha acquistato quattro aziende dove sta spostando il grosso delle produzioni. In sintesi l’accordo prevede: - 25 esuberi (per la dismissione di tutte le lavorazioni meccaniche); - La messa in Cassa Integrazione di 80 lavoratori a rotazione (in realtà molto limitata come rotazione, quasi inesistente) - La possibilità di ricorrere alla mobilità per 6 lavoratori con gli incentivi economici prima descritti (purché questi rinuncino ad ogni forma di opposizione al licenziamento); - Il reimpiego di 7 lavoratori e la riqualificazione di altri 12 da reinserire in Azienda in altre mansioni. Il reintegro, previo riqualificazione, però, non sembra che sia in fase di realizzazione; anzi su questo le Rsu manifestano tutta la loro preoccupazione. Nel frattempo sono cominciate le esternalizzazioni di lavorazioni meccaniche a ditte artigiane del territorio che hanno assorbito soltanto 3 lavoratori provenienti dalla Fir. L’Azienda conta anche di arrivare a “smaltire” presto i lavoratori prossimi alla pensione. Un piano di dimagrimento del personale in piena regola, quindi, confermato anche dal fatto che negli ultimi anni la Fir non ha più assunto personale (“non ha assunto nessuno del territorio”), ma è ricorsa soltanto agli strumenti del lavoro interinale o delle collaborazioni esterne. L’obiettivo è ridurre al minimo il personale e le lavorazioni rimaste (“vogliono mantenere soltanto quei settori di produzione per i quali in Cina non ci sono competenze adeguate”) Ormai i lotti maggiori di produzione sono stati trasferiti in Cina, dove l’Azienda dichiara di poter disporre di un costo del lavoro molto più basso 49 (“ci hanno fatto capire che con un nostro stipendio in Cina pagano 7/8 operai”). Questa strategia di delocalizzazione produttiva, il cui “unico ragionamento è il costo del lavoro più basso” è fortemente contestata da Rsu e lavoratori: “prima c’era la Romania, adesso la Cina, e poi??”. Vengono citati con preoccupazione esempi simili: “succederà come a quelli della Indesit che un giorno si sono trovati i cancelli chiusi con la dichiarazione dell’Azienda di volersi spostare in Polonia”. Viene evidenziata l’assoluta lontananza dei centri decisionali e l’assenza di qualsiasi dialogo riconducibile ad un minimo di relazioni sindacali: “Se quelli decidono che l’Azienda non da il profitto che si aspettano, il giorno dopo trovi i cancelli chiusi”. La Fir, in precedenza di proprietà di un industriale di Parma (Bergamaschi) è passata attraverso diversi passaggi proprietari per finire in mano ad un fondo americano Kinetech operante in America, Europa e Asia (vedi scheda sopra). Dalla rassegna stampa si leggono le dichiarazioni di un operaio anziano che individua nel passaggio di proprietà il punto di svolta (“A condizionare le strategie ora sono gli investitori non più una singola proprietà. E gli investitori in quanto tali investono là dove si produce più profitto. Alla Fir il comparto meccanico della produzione dei motori non è più remunerativo. Ergo: va dismesso e affidato a chi è in grado di produrre a costi inferiori, vale a dire ai cinesi”): Le Rsu non nascondono la preoccupazione, anche a fronte di un atteggiamento così duro dell’Azienda che “picchia duro con le Rsu”. A questo, gli intervistati aggiungono anche uno scarso sostegno del Sindacato (“serviva una posizione più determinata, non potevano accettare decisioni così” è il commento di Rsu e lavoratori alla domanda circa l’intervento dei Sindacati Confederali). E la Fiom? “si è vista poco, bisogna considerare che a Casalmaggiore siamo lontani da Cremona, a differenza di altri territori qui siamo ai margini, non esiste un rappresentante di zona e dobbiamo sempre telefonare a Cremona”. Viene evidenziata questa scarsa presenza sindacale nel distretto casalasco che, pure, oltre alla Fir conta anche no stabilimento Marcegaglia di dimensioni rilevanti (400 dipendenti). Il giudizio sui dirigenti della Fiom è buono, ma viene lamentata la scarsa presenza su questo territorio: “Il sindacato doveva seguirci di più, appoggiare la nostra battaglia. Ad esempio, avevamo anche chiesto che mobilitassero le fabbriche vicine, come la Marcegaglia, ma non è stato fatto”. 50 Eppure nonostante queste difficoltà le Rsu sono riuscite ad organizzare uno sciopero di un giorno e mezzo con presidio ai cancelli, poi lo sciopero terminato anche per il timore dei dipendenti; la messa in Cassa Integrazione ha fatto il resto. Un tempo la fabbrica era molto sindacalizzata con una forte tradizione di lotta, adesso gli iscritti al sindacato sono 60 (40 Fiom e 20 Fim). Alle assemblee i lavoratori partecipano, ma intervengono pochissimo. Lo sciopero è terminato anche perché i lavoratori pensavano che a settembre la situazione potesse normalizzarsi, ma così non è stato e alcuni cominciano a pensare che il 31 agosto 2010 (termine della Cigs) non è poi così lontana. Questo sembra far riprendere un po’ la volontà di lottare (“se non lo facciamo adesso dopo sarà troppo tardi”). Le Rsu dichiarano che adesso l’obiettivo è quello di limitare il più possibile i danni salvando il mantenimento dell’Azienda (“vogliamo trovare il cancello aperto”). Eppure questa condizione non va giù ai lavoratori: “dobbiamo ricordare che la Fir prima delle cessioni di proprietà era a suo modo un colosso del settore, in grado di produrre fino a 2.000 motori al giorno tutti fatti mano con catene non automatizzate”. Questo aspetto viene sottolineato anche da un ex dipendente Fir, uscito da oltre 10 anni: “la Fir è una fabbrica storica del territorio, addirittura dopo gli Accordi del luglio ’93, in Azienda si riuscì ad ottenere un contratto integrativo migliorativo che consolidava il premio di risultato. Questo grazie ad una forte presenza sindacale.” Ora questo “manager” (viene ribadito: non è un datore di lavoro) ha fatto saltare anche il premio di risultato, non solo per ragioni economiche ma anche per perseguire un “obiettivo politico”. Il manager, infatti, appare piuttosto determinato a colpire i lavoratori più sindacalizzati, “non vuole ostacoli”. Questa crisi economica non può giustificare questi tagli al personale, l’obiettivo è quella di sfruttarla per esternalizzare le produzioni. Il “manager” si muove con delega piena da parte della proprietà. Il “manager”, in realtà è il Presidente di Fir e Responsabile della Produzione, non è Amministratore Delegato (ruolo assegnato ad un’altra figura). Ma è evidente che è questo il plenipotenziario. Quindi anche la scelta di togliere il premio di produzione si muove in questa logica, nonostante, fanno notare, la società abbia chiuso il bilancio 2008 con un utile di 3 milioni di euro. In realtà il premio di produzione non è stato soppresso ufficialmente, è 51 stato tolto ad alcuni e lasciato ad altri in maniera discrezionale. Cioè, il premio, pur essendo stato inserito negli Accordi Integrativi del 1995 e del 1998 come una voce consolidata (attualizzata in 1.000 euro all’anno) per tutti i lavoratori, nell’ultimo periodo è stato corrisposto in maniera parametrata alle ore di Cassa integrazione. Cioè è stato decurtato in maniera proporzionale alle ore in meno lavorate. In realtà anche questa riduzione parametrata è avvenuta in maniera discrezionale facendo saltare parametri oggettivi. La discrezionalità con cui si muove il “manager” è uno dei motivi di maggior contestazione da parte di Rsu e lavoratori Fir. Viene ribadito che anche la Cigs, che dovrebbe essere a rotazione, in realtà viene decisa discrezionalmente dal manager. Anche per il reintegro dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche da dismettere la prospettiva viene decisa in maniera unilaterale dal manager: dovrebbero essere reintegrate (almeno in parte) come da accordo, ma la pretesa è che questi accettino di ridurre il proprio livello di inquadramento e quindi lo stipendio. Sempre in tema di discrezionalità, viene detto dai lavoratori, la propensione dell’azienda è quella di definire i nuovi mansionari con la dizione generica di “operaio generico”: “così gli operai generici li può mettere dappertutto e gli può far fare di tutto”. Su questo le Rsu hanno chiesto sostegno, anche legale, alla Cgil e sono in attesa di avere una risposta. Aldilà della vicenda del premio di produzione, le Rsu sostengono la necessità di disporre di un avvocato del lavoro (“un esperto a livello nazionale”) che segua le vicende più importanti dei lavoratori Fir (“o almeno ch dica quello che si può fare e quello che non si può fare…”). La vicenda del premio brucia parecchio, anche in considerazione del fatto che è stato corrisposto, come stabilito negli Accordi del ‘95 e del ‘98, in cambio di un risultato importante per l’Azienda: l’aumento del 3% della produttività del lavoro. Anche su questo, ricorda l’ex dipendente, ci fu uno scontro molto forte perché l’Azienda voleva inserire parametri difficilmente misurabili (l’efficienza) , mentre la Rsu riuscì a tenere duro inserendo soltanto parametri in qualche modo misurabili e che, come tali, poteva controllare. Alla domanda sul perché, a loro avviso, in una fabbrica che fino a metà anni ’90 era così sindacalizzata siano potute succedere cose di questo tipo le risposte sono diversificate: - una operaia in linea sostiene che in fabbrica non si parla di problemi sindacali o del lavoro, alcuni giorni “l’argomento è il Gran52 de Fratello, allora mi metto la musica nelle orecchie altrimenti litigo”; - le Rsu ritengono che tra i lavoratori ci sia disillusione (“se vedono che sindacato e Rsu non riescono a ottenere niente, hanno paura che lui (il manager) riesca a ottenere tutto quello che vuole”); - tra i lavoratori emergono anche elementi di “menefreghismo” o di egoismo (“meglio che sia successo a lui che a me”) ; - infine non mancano forme di pressione sui lavoratori. Durante la discussione, da parte di un Rsu viene sottolineato che forse si è sbagliata strategia di lotta; cioè si doveva continuare con lo sciopero che “lo aveva messo con le spalle al muro. Aveva paura. Quello era il momento di tenere duro”. Lo sciopero, infatti, fu di un giorno e mezzo, il giovedì pomeriggio e tutto il venerdì, alla proposta di continuarlo anche il lunedì venne meno il sostegno del Sindacato (Cgil e Cisl). Rsu e lavoratori riconoscono che il Prc è stato l’unico partito che si è occupato della crisi Fir, partecipando da subito alle iniziative. Le Lega non si è mai vista e “nemmeno nessuno del PD”. Del Prc viene apprezzato anche l’intervento fatto a livello istituzionale dove l’Assessore Comunale del Prc è riuscito ad investire della vicenda il Sindaco portandolo ai cancelli a parlare con Rsu e lavoratori. Sempre il Sindaco del paese, ha poi convocato al tavolo le parti sociali per trovare soluzioni. Il Prc “si è dato da fare” e al Partito lavoratori e Rsu chiedono di: - aiutarli a mobilitare le persone, soprattutto quelle esterne alla fabbrica; - attivarsi a livello istituzionale per indurre le istituzioni a occuparsi del caso. Ritengono che le istituzioni debbano dare loro “un appoggio” perché da almeno tre anni con la Direzione “non c’è dialogo, si litiga solo”. Inoltre, ricordano, il manager, “se in Comune con il Sindaco parla in un certo modo, in fabbrica fa tutt’altro”. La richiesta più forte rivolta al Prc, che avevo già avuto modo di sentire in occasione dell’incontro alla Festa estiva di Liberazione, è quello di farsi promotore di una inziativa sul territorio che coinvolga tutte le fabbriche presenti a partire dalle maggiori (Fir, Marcegaglia, Cogeme) ma anche quelle minori. Viene molto sottolineato il carattere di territorialità che dovrebbe assumere questa iniziativa: “fate un incontro o una manifestazione, ma l’importante è che la facciate qui, sul territorio, non a Cremona”; “la fabbrica è qui e noi lottiamo qui!”). 53 Al termine della discussione un Rsu (quello della Fim) ritiene che ci siano ancora i margini per impostare una iniziativa di lotta forte, purché non si perda altro tempo. In particolare, si sottolinea, si dovrebbe sconfiggere la strategia di divisione dei lavoratori che trova la sua immagine più nitida nella distribuzione delle ore di Cassa Integrazione (“ci sono persone che fanno le ore piene; quelle fanno un po’ e un po’; quelle che sono sempre a casa”). Ovviamente questo di ripercuote anche sulle retribuzioni dei lavoratori e sigli altri aspetti contrattuali (es. ferie ecc.). La notizia dell’incontro con i lavoratori della Fir viene pubblicata con grande evidenza dalla stampa locale scatenando un putiferio. Alla lettura del resoconto giornalistico la Fim Cisl interviene in maniera pesantissima. Sulla Cronaca di Cremona vengono pertanto pubblicati ulteriori articoli di cui si ritiene importante riportare alcuni passaggi: “Una presenza non continuativa sul territorio del sindacato ed un’azione poco incisiva nella gestione della crisi F.I.R. (25 esuberi messi in cassa integrazione straordinaria per un anno) sono le criticità fatte emergere dalla Rsu aziendale in occasione dell’incontro con Matteo Gaddi, referente di Rifondazione Comunista per il nord Italia. Incontro nel corso del quale il caso della storica azienda di Casalmaggiore è stato affrontato ad ampio spettro con l’obiettivo di fornire a Gaddi, al quale i problemi della F.I.R. erano stati prospettati in occasione della festa di Rive Gauche, una panoramica esaustiva. Ebbene, quanto emerso riguardo al ruolo giocato dalle parti sociali non ha mancato di infastidire segretari provinciali di Cgil e Cisl e i funzionari di categoria di Fiom e Fim.” Mentre la riposta del segretario della Fiom è assolutamente pacata (“Ciò che a me preme non è aver fatto un’ora in più o un meno di sciopero ma aver portato a casa il risultato e ritengo che il risultato ottenuto sia buono”. “Ora occorre però stare attenti che l’azienda non intenda smantellare tutto”), quella della Cisl è a dir poco scomposta. “Non c’è bisogno che Rifondazione e Rive Gauche facciano il lavoro del sindacato. Rifondazione se ne stia a casa propria e si occupi delle cose che gli competono”. Ovviamente la nostra risposta non manca e il quotidiano locale la pubblica quasi integralmente: “È un dovere morale e politico, per un partito di sinistra, essere vicino ai lavoratori e andare nei luoghi della crisi per difendere il lavoro e i diritti sociali. Ormai quasi tutti i partiti sono scomparsi dai luoghi di lavoro, noi stiamo cercando, faticosamente, di ritornarci, forse questo dà fastidio a qualcuno, ma non saranno gli attacchi al limite della maleducazione da parte di qualcuno a farci desistere. 54 Per Rifondazione Comunista le conseguenze sociali della crisi, in termini di disoccupazione, cassa integrazione, caro vita, rappresentano l’impegno prioritario per i prossimi mesi. La nostra “casa” sono i cancelli delle fabbriche in crisi e le “cose che ci competono” sono proprio queste, (…) Siamo ben consapevoli della diversità di ruoli che distinguono il Partito dal Sindacato (…) Il problema, quindi, non è Rifondazione che fa sindacato, ma la Cisl che fa politica. E’ sotto gli occhi di tutti che la Cisl è diventata lo strumento di Berlusconi e Confindustria per far passare i peggiori attacchi al mondo del lavoro, a partire dall’accordo separato sulla riforma contrattuale.” Questo scambio avviene verso la fine di settembre. A fine dicembre si apprende che alla Fir è stata aperta una procedura per la mobilità di ulteriori otto lavoratori segnando un ulteriore punto verso il declino occupazionale e la dismissione produttiva della fabbrica. Ancora una volta è la Fim Cisl a rassicurarci che non ci si deve preoccupare in quanto si è trattato di mobilità volontaria. 55 Inchiesta realizzata sulla Ex Ineos - Vinyls Italia 4 Nel 2006, l’ennesima crisi industriale del Petrolchimico di Marghera, originata in questa caso dalla scelta repentina e unilaterale di Dow Chemical di chiudere l’impianto Tdi, viene risolta, o almeno così pareva, con l’altrettanto ennesimo Protocollo di Intesa. Si tratta del Protocollo di Intesa del 14 dicembre 2006 che, a proposito del Ciclo del Cloro, prevede a carico della società Ineos l’impegno a “rafforzare la sua presenza a Porto Marghera attraverso l’acquisizione dell’impianto Clorosoda-Dicloroetano di Syndial opportunamente modificato da Ineos che acquisterà l’impianto e che garantirà il passaggio dalla tecnologia con cella a mercurio alla tecnologia a membrana; bilanciare le produzione Cvm-Pvc al fine di renderle competitive; garantire che gli attuali livelli produttivi vengano mantenuti fino all’avvio del nuovo assetto industriale”. Sembrava che, complessivamente si trattasse di un buon Protocollo di Intesa, in grado di stabilire obiettivi e investimenti su tutti i principali cicli produttivi con l’indicazione dei risultati occupazionali da perseguire. Ma nel passaggio citato sopra, va segnalato uno degli elementi più negativi e maggiormente ricorrenti nella vicenda dei Petrolchimici italiani: gli impianti richiamati vengono ceduti da una società dell’Eni (Syndial) confermando il progressivo disimpegno del “cane a sei zampe” dall’industria chimica. L’acquirente è una società multinazionale (Ineos) che sembrerebbe fornire adeguate garanzie in termini industriali e finanziari: Ineos è un produttore globale di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi, comprende 17 imprese ciascuna e la sua rete di produzione si estende su 64 impianti produttivi in 14 paesi in tutto il mondo. Il ciclo del cloro è uno dei più delicati: dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dell’integrazione con le altre lavorazioni che nel Polo Chimico si svolgono. Per questo appare di fondamentale importanza la realizzazione degli investimenti previsti. La società non solo appare ben disposta, ma addirittura si lamenta delle lungaggini dell’amministrazione italiana a suo dire troppo lenta nel concedere le autorizzazioni necessarie. Tanto che, il 6 febbraio 2008, Ineos Italia dirama un comunicato stampa nel quale sottolinea il tempo trascorso dalla presentazione del progetto 4 In collaborazione con Sebastiano Bonzio, Renato Cardazzo e Piero Pettenò, Prc Venezia e Veneto. 56 senza che sia ancora stata ottenuta l’autorizzazione necessaria per attivare gli investimenti: “Si ricorda che il progetto è stato reso disponibile al pubblico dal 28.03.2003 presso la Regione Veneto, che in data 04.06.2003 la Società lo ha presentato al pubblico presso l’Auditorium Monteverdi di Marghera e che il 24.05.2004 si è svolta l’Inchiesta Pubblica prevista dalle leggi. E’ un dato di fatto certo e documentato che dal 2000 ad oggi Ineos ha investito per gli impianti di Porto Marghera 60 milioni di Euro, ottemperando agli impegni presi nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 1998, e questo a prescindere dall’ottenimento o meno delle autorizzazioni al progetto di bilanciamento previsto da quello stesso Accordo. Ineos Vinyls Italia chiede ora che si giunga alla conclusione degli iter autorizzativi, fino a quando non si otterranno queste autorizzazioni, non solo si impedirà all’Azienda di aumentare la sua capacità produttiva, necessaria per rimanere competitiva sul mercato, ma si impediranno anche ulteriori miglioramenti impiantistici in materia di impatto ambientale e di sicurezza. AGINA 2 di 4. Appare chiaro, quindi, che Ineos ha già realizzato, da parte sua, la maggior parte degli investimenti ambientali e di sicurezza previsti dal progetto ed è ora in attesa dell’autorizzazione per quegli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale e che comportano, oltre all’’aumento della capacità produttiva anche il completamento degli investimenti ambientali. In conclusione, Ineos Vinyls Italia ha già realizzato investimenti ambientali per 60 milioni di Euro e prevede per gli interventi mancanti ulteriori 35 milioni di Euro da realizzarsi nei 24 mesi successivi all’autorizzazione. Questi investimenti sono stati e saranno realizzati, nel pieno rispetto dell’Accordo di Programma sulla Chimica del 1998 e del 2006 con particolare attenzione al raggiungimento ampio ed indiscutibile dei limiti di emissione previsti in quegli accordi e applicando le Migliori Tecniche Disponibili.” Un po’ tutte le pressioni (dei lavoratori, dell’azienda, delle istituzioni locali, le preoccupazioni di carattere ambientale per l’obsolescenza degli impianti) inducono il Governo a forzare i tempi e a deliberare in Consiglio dei Ministri, il 18 marzo 2008, il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale positiva sul progetto di bilanciamento delle produzione Cvm – Pvc ricordando che la valutazione positiva sugli altri due aspetti impiantistici (trasformazione delle celle da mercurio a membrana e dicloroetano) era già stata espressa, rispettivamente, nel gennaio e luglio 2007. Quindi, tra il 2007 e l’inizio del 2008, Ineos trova risposta alle proprie lamentazioni: dispone delle autorizzazione necessarie agli investimenti, final57 mente si può partire; il comunicato sindacale unitario si esprime in termini positivi: “Dopo anni di dure lotte, manifestazioni, incontri a ogni livello, migliaia di ore di sciopero, grazie Ma appena ottenute le autorizzazioni per effettuare gli investimenti, Ineos si “accorge” di problemi di bilancio. In luglio il consiglio di amministrazione di Ineos Italia approva il bilancio 2007 in perdita assumendo contestualmente la decisione di abbandonare le produzioni chimiche italiane. “La crisi internazionale non perdona. E la chimica torna nell’occhio del ciclone. Alla crisi del mercato delle plastiche derivate dal petrolio, si aggiunge ora l’annuncio che la multinazionale Ineos Vinyls ha deciso di andarsene dal sito di Porto Marghera, dove l’impianto del Clorosoda di Syndial (Eni) lavora ormai al 50 % delle sue potenzialità e Ineos ha già ridotto la produzione di Pvc e bloccato i rifornimenti di dicloretano. La data chiave ora è quella dell’11 luglio quando l’Ineos deciderà ufficialmente se rimanere a Marghera, chiudere, liquidare o vendere. E i sindacati drizzano le orecchie: parlano di 1.300 posti di lavoro a rischio a Venezia, Ravenna e Assemini.” Nel mese di luglio 2008, in effetti, Ineos conferma le decisone di lasciare Marghera rinviando, tuttavia, di due mesi la chiusura degli impianti “al fine di identificare un futuro per le attività della Società in Italia con l’obiettivo di concretizzare entro il 3° trimestre 2008 una soluzione che possa dare continuità e stabilità alla filiera del cloro, elemento essenziale per lo sviluppo del comparto chimico italiano”: con questo comunicato stampa Ineos dà il benservito al nostro Paese. Ma il Sindacato legge nella notizia del rinvio un elemento positivo, enfatizzando un po’ i toni di una notizia che comunque conferma l’ennesimo disimpegno di chi ha acquistato impianti per poi “mollarli” senza aver fatto gli investimenti dovuti: la Filcem nazionale sostiene che “Per il Sindacato è una bella soddisfazione perché viene apertamente riconosciuto che il piano industriale da noi condiviso ha una sua validità. Forse la Filcem sperava in un ripensamento di Ineos che tuttavia rimane ferma sulle proprie posizioni tanto che in ottobre si cominciano a definire i contorni della cessione delle attività: “Il Consiglio di Amministrazione di Ineos Vinyls Italia riunitosi questo pomeriggio (4 ottobre 2008) a Milano ha deciso di non procedere alla liquidazione della società, ma di far entrare la società Safi Spa guidata dall’imprenditore Fiorenzo Sartor - nel capitale sociale, alleggerendo così l’impegno finanziario dell’azionista di riferimento, la multinazionale britannica Ineos. L’ingresso di Safi in Ineos Italia, inizialmente con una quota di minoranza, prelude all’acquisizione del 100% già prevista da una lettera d’intenti siglata nelle scorse setti58 mane. Da subito si palesano i problemi di carattere finanziario: chi acquista gli impianti ex Ineos deve saldare all’Eni forniture di materia prime non pagate; nel momento di subentro di Sartor il debito ammonterebbe a 14 milioni di euro per fatture già scadute a cui andrebbero aggiunti ulteriori 52 milioni per fatture in scadenza nei prossimi mesi. Le valutazioni più benevole del debito contratto nei confronti di Eni, stimavano in 40 milioni la cifra da saldare. A queste cifre vanno aggiunte le ingenti risorse economiche per realizzare l’intervento di ammodernamento che prevede la sostituzione delle celle a mercurio con quelle a membrana, più efficienti e meno inquinanti. Nonostante le difficoltà si manifestino da subito, da parte del Governo Berlusconi non viene espressa nessuna preoccupazione, anzi, dopo gli incontri a livello di Ministero dello Sviluppo Economico, esprime soddisfazione il Ministro Claudio Scajola: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con tutte le parti interessate: è stato individuato un acquirente per gli impianti Ineos. Ora la trattativa andrà avanti, ma sono fiducioso che riusciremo a trovare una soluzione positiva che garantirà il consolidamento e lo sviluppo di una filiera strategica per il sistema produttivo del Paese.” Di ben altro avviso sono i lavoratori Filcem del Petrolchimico di Marghera con concludono una assembela con il seguente comunicato: “I delegati e il Comitato degli Iscritti Filcem Cgil riunitisi in assemblea con la Segreteria esprimono grande preoccupazione per i comportamenti assunti dalle due maggiori aziende firmatarie del Protocollo d’Intesa per la Chimica sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo il 14 dicembre 2006, ovvero Eni e Ineos. La vicenda dei lavoratori Dow Chemical, che Eni si era impegnata a riassorbire, ne è l’esempio. Dopo due anni di continue richieste per la ricollocazione dei lavoratori Dow Chemical, per 19 di loro a cui è ormai scaduta la Cigs e si ritrovano ora senza un posto di lavoro. Eni continua a non dare soluzioni definitive confermando solo un impegno generico senza nessuna indicazione sui tempi di riassorbimento. Dopo la decisione di Ineos di lasciare l’Italia e Porto Marghera, Eni e Ineos devono favorire chi è interessato ad acquisire l’intero progetto industriale e occupazionale e realizzare tutti gli investimenti previsti. Per questi motivi chiediamo a tutte le Istituzioni Locali e al Governo di intervenire affinchè Eni ceda il ciclo del cloro a chi è veramente interessato all’intero progetto industriale, per realizzare tutti gli investimenti previsti garantendo così la continuità produttiva, economica ed occupazionale del Polo Industriale di Porto Marghera. Chiediamo a tutti coerenza perché non si può nella teoria sostenere ed essere tutti d’accordo sul fatto che è necessario rilanciare l’industria chimica e nella pratica chiudere le fabbriche volendo dare priorità alla logistica. Ci troviamo infatti di fronte ad un cambiamento di rotta di Ineos che sino a poche settimane fa assicurava di voler realizzare i progetti di investimento nel ciclo del cloro soda e derivati acquisendo poi l’impianto di proprietà di Eni non appena avesse otte59 nuto le autorizzazioni. Questa azienda ora dichiara apertamente di voler abbandonare gli impianti di Porto Marghera, Ravenna e della Sardegna, disattendendo gli impegni presi nel corso degli anni e provocando devastanti effetti economici e occupazionali su tutto il territorio veneziano e nazionale. Non è accettabile che Ineos, grande azienda inglese con partecipazioni in tutto il mondo e terzo gruppo mondiale della chimica, ed Eni, la maggiore azienda energetica e chimica italiana di cui il Governo è azionista di maggioranza relativa, si rendano responsabili dello smantellamento di questo settore industriale strategico per tutta l’economia del paese.” Nel comunicato, che molto bene sintetizza i principali problemi che hanno investito il Petrolchimico di Marghera e l’intera industria chimica italiana, si batte molto su un tasto ricorrente: quello del mancato rispetto di Accordi e Protocolli di Intesa: “Eni e Ineos hanno deciso di abbandonare la chimica ma devono rispettare gli impegni sottoscritti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e concludere le trattative per la cessione degli impianti. ENI deve favorire la realizzazione dell’intero progetto. Le OO.SS. sosterranno unitariamente solo chi realizzerà tutti gli investimenti dell’intero progetto industriale a partire dalla membranizzazione del ciclo del cloro, cuore del Petrolchimico di Porto Marghera. Dato che Governo, Istituzioni e Confindustria sostengono che l’industria chimica è strategica per l’intero Paese, devono impedire ad Eni e Ineos di scaricarsi a vicenda le responsabilità costringendoli invece a favorire la continuità produttiva e occupazionale. Il Governo deve fare da garante affinchè l’Accordo per la Chimica del 14 dicembre 2006 venga applicato integralmente in tutte le sue parti per le implicazioni di carattere industriale e occupazionale che la chimica ha sul territorio nazionale e veneziano. Nessuno si può permettere di smantellare uno dei più grandi poli industriali italiani ed europei, considerato anche il forte debito con l’estero di prodotti chimici. Nell’incontro tenutosi a Roma il 6 ottobre 2008, Eni ha espresso una serie di difficoltà sulla realizzazione degli accordi previsti sul sito della Raffineria di Venezia con troppa ambiguità confermando gli impegni dopo il 2011. Questa è l’Eni dei grandi annunci che dice di non preoccuparsi perché si farà lei stessa carico della continuità produttiva e occupazionale, salvo poi chiudere un pezzo alla volta il polo industriale di Porto Marghera e rifiutandosi di ricollocare i 20 lavoratori Dow Chemical. Infatti, la speranza che l’imprenditore veneto Sartor potesse risollevare le sorti di parte dell’industria chimica italiana durano lo spazio di qualche mese. Le difficoltà si confermano essere legate alla fragilità dell’imprenditore Sartor la cui principale impresa (Safi specializzata in ponteggi…) fattura circa 30 milioni di € all’anno a fronte di 80 milioni di crediti vantati da Eni per la fornitura di materia prime non pagati da Ineos; circa 200 milioni di investimenti necessari per l’adeguamento degli impianti; un costo rilevante 60 delle materia prime che ha scatenato l’accusa di Sartor, nei confronti dell’Eni, di “gonfiamento” dei loro costi (l’Eni, ovviamente, dal canto suo ha risposto che si tratta di costi di mercato). Alla portineria di Marghera riprendono i blocchi dei cancelli da parte dei lavoratori e nel capannone, nella primavera del 2009, si susseguono le assembelee. L’assemblea del 9 marzo 2009 si conclude con un comunicato sindacale nel quale si richiama l’ennesima responsabilità dell’Eni: “L’Eni ha comunicato a Fiorenzo Sartor, l’imprenditore trevigiano che si è reso disponibile all’acquisto di Ineos, che potrebbe non alimentare più materie prime agli impianti del ciclo del cloro se questi non verserà entro fine anno 30 milioni di € a parziale copertura dei debiti contratti da Ineos verso Eni negli ultimi anni. L’assemblea dei lavoratori del Petrolchimico (…) ritiene che l’atteggiamento di Eni sia inconcepibile e strumentale, finalizzato più a far fallire una operazione necessaria al sistema industriale di Marghera e del Paese, che alla reale e comprensibile necessità di rientro di un proprio debito. Il bilancio di Eni chiuderà il 2008 con 11 miliardi di € di utile. quanto pesa una dilazione dei tempi di pagamento per 15 milioni di € nelle strategie di questo gruppo? nulla, assolutamente nulla. La cosa che è ormai assolutamente indispensabile, è che il ministro Scajola, assuma non più un ruolo da notaio, ma sia garante dell’intesa del 14 dicembre 2006 e si renda arbitro determinato negli accordi che le parti datoriali dovranno applicare nei fatti. Il Sindacato esige l’applicazione integrale degli accordi stessi a partire proprio dal Protocollo d’Intesa per la Chimica sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 14 dicembre 2006 per la salvaguardia e lo sviluppo della chimica italiana. E’ sempre più importante, anche per le implicazioni che la crisi sta assumendo, che le garanzie sulla credibilità dei progetti industriali e sulla credibilità delle stesse aziende, siano date soprattutto dal Governo. (…) In conclusione l’assemblea ribadisce che se l’Eni agirà bloccando le forniture al ciclo cloro di Ineos, si chiuderanno immediatamente tutte le attività di Eni presenti nel territorio. E al tempo stesso, nel ribadire con forza l’emergenza e l’urgenza di una convocazione presso il Ministero per lo Sviluppo Economico del tavolo nazionale per la chimica di cui Marghera fa parte, l’assemblea condivide sulla necessità di ritornare a manifestare nella città la determinazione delle proprie richieste.”. Il 13 marzo si tiene uno sciopero dei lavoratori del Polo Chimico di Marghera (pienamente riuscito) mentre il 30 marzo, in occasione di uno dei tanti incontri convocati al Ministero, gli manifestano sotto le finestre del dicastero dello Sviluppo Economico. La preoccupazione si diffonde in tutta l’area della cosiddetta “chi61 mica padana”: i destini dei cicli del Cloro e della filiera Cvm-Pvc sono destinati a generare ricadute a cascata anche sui siti di Ferrara, Mantova e Ravenna con immediate conseguenze sull’intera area che produce il 40% del valore dell’intera chimica italiana (57 Miliardi di €). In aprile la situazione precipita. Vinyls Italia, dopo essere subentrata Ineos, dichiara il fallimento dando avvio all’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria con la nomina dei tre Commissari. Dopo dieci mesi di agonia si chiude anche il capitolo di Sartor facendo precipitare di nuovo nell’incertezza i lavoratori di Marghera e, di conseguenza, quelli di Mantova, Ferarra e Ravenna. Ennesima assemblea dei lavoratori – il 6 maggio 2009 – ed ennesimo documento approvato nel quale “Riconfermando la validità del progetto industriale del ciclo del cloro, (…), i lavoratori ribadiscono di non essere interessati minimamente ai nomi degli imprenditori ma esclusivamente agli investimenti che rendono possibile la continuità produttiva, investimenti previsti in tutti gli accordi sottoscritti negli ultimi dieci anni, ivi compreso il Protocollo d’Intesa per la Chimica del 14 dicembre 2006. I lavoratori esigono che ENI, dal momento che ha deciso di abbandonare la chimica, rispetti gli impegni assunti in sede ministeriale con i quali garantiva il suo contributo per favorire nuovi acquirenti interessati a realizzare gli investimenti necessari. Ritengono inaccettabile che ora ENI, principale azienda del sito, faccia di tutto per accelerare il processo di dismissioni del polo chimico di Marghera, dopo aver spezzettato le attività, intralciando eventuali imprenditori interessati a rilevare gli impianti, e favorendo di fatto coloro che intendono consegnare queste aree industriali a cordate speculative che con l’industria non hanno nulla a che vedere. Al Governo nazionale e al Ministro dello Sviluppo Economico Scajola i lavoratori chiedono di essere coerenti con gli impegni assunti e con le loro dichiarazioni sul ruolo strategico che l’industria chimica riveste per il nostro paese e pertanto di agire affinché non sia permesso ad ENI e alle altre imprese chimiche di Marghera, di smantellare un polo industriale chimico di questa importanza con la trasformazione d’uso delle aree industriali per altre attività. (…) I lavoratori ribadiscono la loro netta contrarietà alla chiusura degli impianti essendo il Petrolchimico un ciclo integrato, dove la trasformazione delle materie prime fino ai prodotti finiti avviene attraverso il completamento dei cicli ed è pertanto necessario operare per preservare il ciclo chiuso perché la sicurezza si garantisce solamente evitando il più possibile il trasporto di prodotti intermedi altamente pericolosi da uno stabilimento all’altro. L’assemblea generale dei lavoratori del Petrolchimico di Marghera e le Segreterie Terri62 toriali Filcem - Cgil, Femca - Cisl, Uilcem - Uil di Venezia, nel confermare lo stato di mobilitazione, la continuazione dello sciopero al minimo tecnico sugli impianti Eni di etilene, decidono di mettere in atto tutte le iniziative che si rendessero necessarie ed opportune, con il coinvolgimento anche della Raffineria, e chiedono inoltre alle Confederazioni Cgil – Cisl - Uil di Venezia di assumere iniziative di carattere generale a fronte dell’aggravarsi della crisi industriale e occupazionale.”. Oltre alle iniziative locali, il 24 giugno arriva anche lo sciopero nazionale dei lavoratori del comparto chimico – farmaceutico e dell’intero gruppo Eni con manifestazioni a Milano e Roma, sui destini generali dell’industria chimica che vede 20.000 posti di lavoro a rischio nel quadro del disimpegno Eni dalla produzioni industriali. In settembre Vinyls Italia dichiara lo stato di insolvenza e si apre la procedura di Amministrazione Straordinaria. Ai Commissari nominati dal Tribunale di Venezia vengono assegnati due anni (12 mesi prorogabili di altri 12) per attuare il piano di salvataggio nell’ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria prevista dalla “Prodi – bis”, la legge pensata per il salvataggio delle imprese di dimensioni medio – grandi. Le condizioni per il salvataggio ci sono tutte come evidenziato dal Tribunale di Venezia che ha riconosciuto l’esistenza di notevoli potenzialità aziendali sul piano operativo e strutturale; la società, infatti, costituisce un patrimonio unico in Italia sul piano delle competenze, degli impianti e delle professionalità. Per il Tribunale di Venezia “sussistono concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali da potersi realizzare attraverso la cessione complessi aziendali a soggetti interessati a realizzare il progetto di prosecuzione e di risanamento delineato nella relazione dei Commissari Giudiziali…”. Vinyls (e prima di essa, Ineos) costituisce l’unico produttore in Italia di Pvc il cui mercato viene considerato dagli analisti e dagli osservatori economici in buone condizioni. Il Piano di salvataggio prospettato dai Commissari prevede: - investimenti per realizzare l’ammodernamento degli impianti anche attraverso la definizione di Accordi di Programma; - la realizzazione di una maggior integrazione dei cicli produttivi del Cloro e del Pvc da perseguire anche attraverso un accordo con le due società dell’Eni (Polimeri Europa e Sindyal) responsabili della fornitura di materie prime (Cloro e acetilene) necessari alla produzione di Cvm e quindi di Pvc; - un accordo con l’Enel per il contenimento dei costi energetici. 63 Notizie di stampa del 3 settembre 2009 hanno indicato nel 15 settembre la data di conclusione delle operazioni di manutenzione che sarebbero già dovute essere terminate; il prolungamento dei tempi sarebbe stato dovuto alla necessità di recuperare pezzi necessari al completamento della manutenzione. Ma il problema principale sta nella mancata comunicazione, da parte di Commissari, della data della ripresa produttiva che rischia di aggravare ulteriormente la situazione e, soprattutto, di lasciare i lavoratori ex Ineos ora Vinyls senza stipendio a partire da settembre. Su Vinyls, come noto, grava l’insolvenza dei mancati pagamenti delle forniture Eni di etilene e dicloroetano. Il mancato riavvio degli impianti, e di conseguenza la mancata produzione, rischia di prosciugare le esigue risorse facendo venir meno le risorse per il pagamento degli stipendi. In questa situazione si tiene a Marghera, il 23 ottobre, il convengo organizzato da Rifondazione Comunista intitolato “In difesa della chimica padana” che mette insieme i lavoratori e i rappresentanti sindacali di Venezia, Mantova, Ferrara e Ravenna. Negli stessi giorni, dalle Federazioni dei quattro territori che ospitano i Petrolchimici “padani” viene diffuso un volantone del Partito con articoli scritti da lavoratori e sindacalisti degli stessi stabilimenti con al centro il tema della difesa dei posti di lavoro e del mantenimento delle produzioni industriali attraverso un piano di investimenti di ammodernamento degli impianti e di bonifiche ambientali. Riprendono le iniziative dei lavoratori (ore di sciopero, assemblee, cortei, blocco dei cancelli) che portano all’incontro del in data 26 ottobre 2009, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al termine di tale incontro il ministero ha diffuso un documento nel quale si afferma che: “sono state attivate dai Commissari le necessarie azioni tecniche e commerciali per consentire la riattivazione degli impianti. Oltre ai risultati già ottenuti per l’acquisizione delle materia prime necessarie, è ragionevole prevedere che i negoziati ancora in corso possano concludersi positivamente (…) e possano consentire l’avvio degli impianti entro il prossimo 10 novembre”; Questo passaggio riveste una importanza particolare in quanto: • indica una data precisa (“entro il prossimo 10 novembre”) quale momento per la riattivazione degli impianti; • segna il punto fermo dell’ottenimento delle prime 9.000 tonnellate di materie prime riconoscendo la necessità di ottenerne ulterio64 ri (altre 13.000) al fin di pervenire alla piena riattivazione degli impianti e delle produzioni; Infatti, l’ottenimento delle materie prime nelle quantità necessarie (22.000 tonnellate) è elemento imprescindibile per consentire la ripresa dell’attività produttiva e lavorativa. Il comunicato del Ministero arriva durante la fase di presidio della portineria nove in un clima di tensione anche per il possibile intervento delle forze dell’ordine a sgomberare i cancelli. Al convengo del 23 ottobre gli operai di Vinyls avevano espressamente richiesto la presenza di Rifondazione Comunista ai cancelli per sostenere le iniziative dei lavoratori concretamente. Fu in particolare un delegato Rsu, con un intervento interamente in dialetto a veneziano a dire che “di parole ce n’erano già state abbastanza e che gli operai si aspettavano i fatti”. La notizia di questo risultato porta le Categorie a chiedere agli operai di smobilitare il presidio; sembrerebbe che una richiesta in tal senso sia stata espressa dall’Eni per il proseguo delle trattative. La discussione tra i lavoratori non è facile: non tutti accettano di buon grado di lasciare i cancelli della portineria nove temendo un’altra “presa in giro”. Ma alla rassicurazione che la Filcem il giorno dopo sarebbe andata in fabbrica a spiegare le ragioni di tale richiesta, seppur con malumori diffusi, si decide di sciogliere il blocco. L’assicurazione delle forniture di materie prime, oltre al riavvio degli impianti e al pagamento degli stipendi, dovrebbe consentire anche ai Commissari di concentrarsi sulla valutazione delle offerte di possibili acquirenti (pare che sul tavolo ce ne siano sei: un gruppo arabo, Bertolini a cui si aggiungono due gruppi europei e altri due italiani). Tra gli industriali riprende il classico gioco delle parti: mentre il nuovo Presidente di Confindustria Venezia spinge per il rilancio dell’industria chimica a partire da Vinyls (“C’è il rischio che intere filiere produttive del Made in Italy, quelle che potranno contribuire a farci uscire dalla crisi, subiscano il ricatto sui prezzi delle materie prime”), Scaroni, Amministratore Delegato di Eni, gela ogni speranza spiegando che “L’obiettivo di Eni non è affatto quello di dare energia a basso prezzo all’Italia, ma quello di rendere l’azienda competitiva sui mercati internazionali per garantire i suoi trecentomila azionisti. Il mio predecessore Enrico Mattei stava seduto sulla poltrona di una azienda pubblica e aveva lo scopo sociale di dare energia alla giovane Repubblica italiana. Noi rispondiamo agli azionisti”. Il tanto agognato accordo per consentire il riavvio degli impianti Vinyls 65 viene raggiunto tra I Commissari e l’Eni e le sue aziende (Polimeri Europa e Syndial) il 12 novembre 2009 quando, presso il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrivono un documento in cui vengono garantite le forniture di materie prime (dicloroetano ed etilene, i cui prezzi vengono abbassati e allineati a quelli di mercato) e di utilities (energia elettrica, vapore e altre utilities generali). Anche in questo caso le reazioni all’accordo delle istituzioni, della politica e del mondo economico sono di grande sollievo: gli impianti possono ripartire per rendere la produzione appetibile per un soggetto industriale in grado di acquisirla e farla funzionare sul mercato. Ancora una volta l’auspicio espresso è che i Commissari possano concentrarsi sulla vendita ad operatori del settore tra i quali figurerebbero il solito gruppo arabo, Bertolini, una società belga, ma anche Solvay e Arkema. Anche questa volta la notizia dell’accordo porta i lavoratori a smobilitare il blocco ai cancelli del petrolchimico dove, ormai da ore in sciopero, avevano già cominciato ad accatastare legna da bruciare per le ore più fredde della notte e avevano allestito i primi gazebo. Anche in questo caso i lavoratori si erano preparati a tutto, compreso l’annunciato sgombero da parte delle forze dell’ordine. Anche stavolta il clima tra i lavoratori non è certo di entusiasmo e si sentono ripetere le preoccupazioni troppe volete espresse: “che non sia ancora una presa in giro…”; “anche se si riparte poi bisogna che ci sia qualcuno che compra davvero… altrimenti si va al fallimento, chiudono gli impianti e noi siamo a casa…”. In base all’accordo Vinyls avrebbe dovuto riaprire il 15 dicembre con forniture garantite fino al 28 febbraio. Subito dopo l’accordo ci pensa il Governatore del Veneto, Galan, a precisare bene come la pensa la destra, Lega compresa, sul mantenimento delle produzioni industriali: “Ci vorrebbe un po’ più di coraggio da parte di tutti (…) per ammettere che un futuro la cattiva chimica di Porto Marghera non ce l’ha. Tra l’altro il problema non è poi così complicato come si vorrebbe far credere, perché il valore di quell’area è straordinario, ha una potenzialità straordinaria, ma non per la chimica”. Nonostante l’accordo raggiunto in novembre non si muove niente e così, con l’approssimarsi di dicembre senza che ci siano prospettive concrete per il riavvio, la situazione peggiora ulteriormente con la trasmissione di 312 lettere di messa in cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Vinyls (su un totale di 470 dipendenti tra Marghera, Ravenna e Porto Torres). A questo punto è troppo e i lavoratori decidono per una forma di protesta eclatante: salgono sulle torri sia del Petrolchimico di Marghera 66 che di Porto Torres in Sardegna. Nel caso di Marghera si tratta delle torri dell’impianto che produce Cvm (il prodotto centrale del ciclo di produzione del Pvc); su di essa si alternano diverse squadre di lavoratori che a turno salgono manifestando su una posizione chiara: “Riavvio degli impianti subito e nessun ricorso alla cassa integrazione” che, nel caso dello stabilimento veneziano, interessa 176 lavoratori su 230. Al tempo stesso continuano a slittare i tempi della riattivazione delle produzioni con la decisione demandata al Tavolo Nazionale della Chimica convocato al Ministero per il primo dicembre. Il timore è forte che con la cassa integrazione si sia una procedura di pesante ristrutturazione dell’organico, in quanto, come sottolineato dal segretario veneziano della Filcem “come si fa a mettere in cassa integrazione i lavoratori nel momento in cui c’è più bisogno di forza lavoro ad esempio nel riavvio degli impianti? Data la delicatezza delle operazioni di riaccensione si mette anche in pericolo la sicurezza”. Il ricorso alla cassa integrazione appare ancor più assurdo perché per quasi un anno nessuno ne ha mai parlato anche se le produzioni erano di fatto ferme. Per questo tra i lavoratori è forte il timore che questa cassa integrazione sia funzionale soltanto alla riduzione drastica e stabile della forza lavoro; altrimenti non si spiegherebbe questa scelta che appare in contrasto con le più elementari norme della gestione industriale degli impianti e della sicurezza. Si tenga presente, infatti, che gli impianti di Vinyls dedicati alle produzioni di Cvm e Pvc sono classificati come impianti industriali a “rischio di incidente rilevanti” e la cui gestione deve essere improntata a rigidi e severi criteri di sicurezza. L’assemblea dei lavoratori approva un comunicato nel quale essi “esprimono una forte preoccupazione per i risvolti che la cassa integrazione proposta, nei termini dell’incontro del 19 novembre 2009, possa minare; sia la tenuta in sicurezza degli impianti a fronte della stagionalità, che della disponibilità delle risorse necessarie al riavvio degli stessi. Altresì si esprime un forte dissenso per la diseguaglianza di trattamento tra quadri/dirigenti ed operai nell’ambito della Cigs. Per sbloccare l’attuale vertenza e rientrare nella normale gestione della trattativa (abbandono dei presidi nelle torri) rimane per noi imprescindibile: 1. definizione dei tempi certi di riavvio impianti, prima dell’avvento dell’imminente stagione fredda, definendone le effettive e credibili risorse necessarie, sia al presidio impianti che all’assistenza delle procedure di riavvio. ricordiamo che nella normale gestione del riavvio degli impianti i turni vengono addirittura rinforzati con personale turnista!!!! 2. l’azienda deve rivedere la propria posizione affinché tutti paghino il sacrificio della 67 Cigs, anche in riferimento alle posizioni reddituali; non e’ concepibile che in una azienda commissariata siano ancora presenti, e pagati profumatamente, i dirigenti che hanno ripetutamente contribuito al fallimento della società. il bisogno espresso di fare cassa non tiene conto di questo aspetto. 3. definire con i commissari le modalità di erogazione degli elementi economici previsti ai lavoratori per i prossimi 4÷5 mesi, conoscendo in modo chiaro quale sia la liquidità aziendale in riferimento alle banche creditrici, per evitare di scoprire poi che i lavoratori dovranno aspettare mesi per vedersi erogare lo stipendio o la Cigs.”. Nonostante le lettere di cassa integrazione i lavoratori si presentano in fabbrica a sostegno di chi è rimasto sulle torri dello stabilimento. La frase che risuona continuamente, tanto nelle assemblee quanto ai presidi è sempre la stessa: “basta farci ingannare. Basta farci prendere in giro”. Ormai non c’è più fiducia: troppi Protocolli di Intesa ridotti a carta straccia, troppi accordi disattesi, troppi annunci a cui non hanno fatto seguito i fatti concreti. Orami i lavoratori del Petrolchimico sono all’esasperazione. Solo la Cisl appare favorevole alla cassa integrazione accusando la Filcem di essere “irresponsabile”. Il primo dicembre 2009 viene firmato il testo dell’intesa al Ministero del Lavoro con cui Vinyls attiva la procedura di Cassa integrazione per 312 unità lavorative. Nel frattempo parte una trattativa con un gruppo arabo intenzionato ad acquisire l’intero ciclo del cloro soda con una prospettiva, pertanto, anche per Vynils. 68 Inchiesta realizzata alla Montefibre di Porto Marghera5 Le situazioni di Montefibre, di Vinyls Italia e Sirma a Porto Marghera rappresentano i casi più urgenti ed immediati delle crisi più generale che sta vivendo l’industria chimica ormai da anni. Si tratta di crisi aziendali non possono essere considerate soltanto nello specifico delle due situazioni – seppur rilevanti – ma che, al contrario, devono essere inquadrate nel contesto molto più ampio e molto più preoccupante della situazione dell’industria chimica in Italia. Come ampiamente noto, infatti, i processi e le produzioni dell’industria chimica risultano strettamente interconnessi, tanto a livello di singolo stabilimento, quanto a livello di più stabilimenti anche territorialmente lontani. Valga su tutti l’esempio della cosiddetta “Chimica Padana” che comprende gli stabilimenti petrolchimici di Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna. La cessazione di una produzione in uno di questi stabilimenti, ed in particolare di Porto Marghera, rischia di generare il famigerato “effetto domino” con la conseguente chiusura, a cascata, di altre lavorazioni o addirittura di interi stabilimenti. Per questo ogni crisi industriale che interessa produzioni chimiche localizzate nell’ambito di stabilimenti petrolchimici deve essere guardata con un’ottica molto più ampia del singolo territorio; con un ottica di scala sovra regionale e, in alcuni casi, persino nazionale. Per Montefibre siamo ormai a quella che gli analisti finanziari hanno definito come “la fine dell’era del gruppo Orlandi alla Montefibre», la storica società della Montedison, passata in Enimont nel 1988 e approdata nel 1996 all’Enichem che due anni dopo l’ha venduta al gruppo Orlandi. Nel biennio 2006-2008 Montefibre ha effettuato grandi investimenti, entrando al 50% nel capitale della cinese Jilin Jimont Fiber, per poi cederne il 10,6% alla Simest. Le difficoltà produttive per Montefibre si palesano dal 2005 con un progressivo ridimensionamento della produzione che porta lo stabilimento di Marghera a tagliare drasticamente i quantitativi prodotti (da 140.000 tonnellate del 2004 a 36.000 tonnellate del 2008). Il Bilancio del 2008 chiude con un pesante passivo (- 94 milioni di €) e con un pesante indebitamento. Sempre il 2008 si chiude, a partire dal mese di dicembre, con la Cassa Integrazione Guadagni dei dipendenti e gli impian5 In collaborazione con Sebastiano Bonzio, Renato Cardazzo e Piero Pettenò, Prc di Venezia e Veneto 69 ti sostanzialmente fermi. La prospettiva per gli impianti di Porto Marghera e i 330 dipendenti di Montefibre (di cui 292 a Marghera, gli altri presso il centro direzionale di Milano) esiste: si tratta di dar corso all’Accordo di Programma del dicembre 2007 che prevede di realizzare un investimento molto significativo per l’avvio della produzione del precursore della fibra al carbonio da affiancare alle tradizionali fibre acriliche. Per consentire questo risultato (da realizzarsi attraverso una riorganizzazione della produzione, progettazione e realizzazione di nuovi e adeguati impianti), Montefibre ha richiesto e ottenuto dal Governo la concessione del trattamento di CIG per i propri dipendenti nel corso del 2008. La realizzazione del progetto di avvio della produzione del precursore della fibra al carbonio necessita di un investimento pari a 18 milioni di € di cui 12 investiti dalla società lussemburghese Rieauvillè Investitor legata ad investitori russi. Questo piano finanziario è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Montefibre nel settembre 2008. Sembrava fatta, ma già nel gennaio 2009 a fronte delle difficoltà di mercato e del continuo deterioramento della situazione debitoria, il CdA di Montefibre delibera un pesante ridimensionamento del Piano Industriale con la sostanziale rinuncia alla realizzazione dell’investimento relativo alla Fibra al Carbonio e all’avvio, anziché di attività industriali, di pesantissime cessioni immobiliari per fare cassa e rientrare dal debito. Così si è espresso, in data 20 aprile, il dott. Boriolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico in una riunione convocata per la vertenza Montefibre: “La crisi che ha colpito il settore delle fibre sintetiche ha radicalmente cambiato il quadro, costringendo l’azienda ad un pesante sforzo finanziario. La stessa decisione di voler diversificare introducendo la fibra di carbonio, si è scontrata con l’attuale situazione di crisi vanificando gli sforzi dell’azienda. Le dimensioni del sito produttivo non consentono infatti la possibilità di operare su piccoli volumi, quali quelli garantiti dalla fibra di carbonio; è necessario affiancare ad essi la produzione tradizionale. Per assicurare continuità al Gruppo il CdA di Montefibre ha deciso di avviare un piano di ristrutturazione del debito e di cessare la attività a Porto Marghera, già sospesa dal 22 dicembre 2008. Montefibre è, disponibile a cedere il proprio Know How ad un eventuale nuovo imprenditore che voglia proseguire nel progetto legato alla fibra di carbonio, un settore che ha pochi player a livello mondiale, le uniche aziende europee attive nel settore sono legate a multinazionali giapponesi. L’azienda non può proseguire in tale attività poiché non avrebbe più le risorse per gestire un simile progetto, neppure in compartecipazione con altri.” Ma Montefibre non cessa l’attività: chiude in Italia per mantenere le produzioni all’estero; in Spagna con Montefibre Hibernia e in Cina con la Joint venture Jilin Jimont Acrylic Fiber. 70 In Italia, invece, comincia la vendita delle proprietà immobiliari, a partire dai terreni di Porto Marghera sui quali ha manifestato interesse l’Autorità Portuale interessata all’ampliamento del Porto. La vendita di 35 dei 60 ettari - affacciati sul canale Ovest - all’Autorità Portuale che intende realizzare un mega-terminal per navi porta container consentirebbe di introitare circa 70 milioni di €, ma i 70 milioni che entrerebbero nelle casse di Montefibre servirebbero solo a risanare il debito (circa 70 milioni) e ricapitalizzare la società. La società, quindi, impone la propria soluzione alla crisi che prevede: - la rinuncia a realizzare il progetto della fibra al carbonio (cioè l’unico progetto industriale che avrebbe consentito di programmare un futuro allo stabilimento di Porto Marghera); - la chiusura dello stabilimento di Marghera e la cessione dei terreni; - la messa in CIG – a far data dal 6 aprile 2009 - dei dipendenti per i quali sono previsti i soliti generici impegni (riqualificazione professionale, ricollocamento ecc.); - la disponibilità a cedere gli impianti ad un nuovo soggetto imprenditoriale. Il giorno 10 settembre 2009, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto l’incontro tra le Parti programmato da tempo, ma l’unica cosa che è emersa da parte di Montefibre è stata l’intenzione di liberarsi del maggior numero di lavoratori; addirittura non è nemmeno stata posta all’attenzione del Ministero l’opportunità costituita dall’interesse manifestato da una multinazionale giapponese: questa la dice lunga sulla totale assenza di prospettiva industriale anche per i possibili sviluppi più innovativi ed interessanti come l’avvio del progetto della fibra al carbonio. Il Ministero dello Sviluppo Economico da una parte ha smentito la fattibilità di un progetto di ampliamento significativo delle aree portuali (e di conseguenza ha smentito la possibile rioccupazione di lavoratori in tali attività logistiche), e dall’altra ha confermato il proprio interesse per il progetto della fibra al carbonio definendolo innovativo e strategico. Per questo i lavoratori Montefibre, riuniti nel comitato iscritti Filcem Cgil, hanno sostenuto in un loro volantino del 15 settembre, la necessità che il Ministero competente verifichi, con tutte le parti interessate, “le reali intenzioni e l’interesse per il progetto della fibra al carbonio” e “il progetto sulla logistica dell’Autorità Portuale da realizzare nei 35 ettari liberi dalle attività industriali, i tempi di realizzo e quanti saranno i veri occupati”. Sempre nello stesso volantino il Comitato Iscritti Filcem Cgil di Montefibre ed i lavoratori impegnati nel presidio della Torre dell’Orologio in piaz71 za Ferretto a Mestre, hanno chiesto alle Organizzazioni Sindacali di organizzare una assemblea unitaria di tutti i lavoratori Montefibre per spiegare quanto emerso nell’incontro presso il Ministero e “decidere insieme quali iniziative unitarie da intraprendere verso chi ostacola i 2 progetti”. L’incontro avviene nella giornata di sabato 3 ottobre, mentre i lavoratori del presidio continuano nella loro iniziativa di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso una raccolta firme e la distribuzione di un nuovo volantino (datato 29 settembre) che aggiorna sulla situazione di Montefibre. Il volantino si apre con un ringraziamento a “tutta la cittadinanza per la solidarietà dimostrata anche firmando a migliaia la petizione per la riapertura della fabbrica e per la ripresa dell’attività produttiva di questa importante azienda del territorio veneziano. Il sostegno, la comprensione e la condivisione della forma di lotta da parte di migliaia di semplici cittadini sono un tangibile segno di quanto la cittadinanza veneziana si preoccupi del futuro del mondo del lavoro e dell’industria”. Su questo i lavoratori intervistati ci tengono a precisare che si tratta di una iniziativa autonoma assunta dai lavoratori di Montefibre che poi ha ricevuto il sostegno della Filcem Cgil. Le altre sigle sindacali, pur presenti in azienda, non sono presenti al presidio. Al presidio si sono presentati rappresentanti politici e istituzionali, ma i lavoratori ci tengono a precisare che non vogliono nessuna sovrapposizione con la politica, si tratta di una iniziativa dei lavoratori assunta e decisa autonomamente. Si tratta di una iniziativa che ha come obiettivo quello di costruire un rapporto con la città, con i cittadini per informarli e sensibilizzarli sulla situazione Montefibre. I lavoratori tengono a precisare che da parte dei cittadini è stato riconosciuto come positivo l’elemento della apoliticità della loro iniziativa e loro stessi ritengono che “più autonomi (dalla politica) riusciremo a stare e più la gente sosterrà la nostra proposta”. Le firme vengono raccolte in calce ad un documento di sostegno alla loro vertenza e vengono raccolte “per avvicinare le persone che finora sono rimaste all’oscuro della vicenda. Vogliamo aprirci alla città affinché questa non rimanga all’oscuro di cosa sta succedendo; vogliamo rendere consapevoli i cittadini delle ricadute sociali e ambientali che ci saranno se non vengono realizzati gli investimenti”. I lavoratori Montefibre sono in attesa che il Governo convochi, coma da impegni, un ulteriore incontro e non mancano di ribadirlo nel volantino 72 distribuito richiamando tutti i soggetti alle loro responsabilità: “…Confindustria cosa pensa di fare a sostegno dell’industria? cosa risponde ad Alessio Vianello & C. che hanno disegnato il futuro del nostro territorio senza fabbriche e fantomatici alberghi?” “A Montefibre ed Autorità Portuale i lavoratori chiedono che vengano esplicitati i loro obiettivi presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico superando questa situazione di incertezza e confusione che pregiudica che eventuali imprenditori seriamente motivati si propongano come soggetti motivati a rilevare l’azienda e a continuarne l’attività produttiva industriale.” “Al Ministero dello Sviluppo Economico, che continua a definire strategico per il Paese il nuovo progetto per la fibra al carbonio, i lavoratori Montefibre chiedono di essere conseguente con le sue dichiarazioni e di convocare le parti in tempi brevissimi perché vengano assunti precisi impegni a riguardo perché è inaccettabile che l’Azienda realizzi in Spagna o in altri paesi, anche extraeuropei, un progetto sviluppato dai ricercatori di Marghera, privando così i lavoratori Montefibre di questo sito del loro diritto al lavoro e a un reddito dignitoso”. Per i lavoratori il Governo deve mantenere fede agli impegni presi e trattare nell’ambito del Tavolo Nazionale della Chimica la vicenda Montefibre attivandosi per creare le condizioni affinché eventuali compratori rilevino l’azienda per realizzare il progetto di fibra al carbonio, una produzione di qualità, ad alto valore aggiunto, frutto della ricerca. Per i lavoratori uno dei principali pericoli consiste nel rischio di cadere nella logica di trasformare l’Italia in un paese di servizi cancellando o ridimensionando il settore industriale. Ma un paese di servizi senza industria è “a servizio di qualche altro paese che l’industria l’ha mantenuta; sei legato e subalterno a chi produce”. Smantellare l’industria significa anche rinunciare a valorizzare tutte quelle risorse rappresentate dai ricercatori, dalle Università, dai Centri di Ricerca che dovrebbero trovare una loro applicazione nei settori produttivi; “invece i nostri ricercatori sono costretti ad andare all’estero”. Le preoccupazioni sono per la tenuta del sistema manifatturiero e, di conseguenza, per i livelli occupazionali: “se non riqualifichi il tessuto industriale ne subisci le conseguenze; se non fai innovazione subisci le scelte fatte da altri“. Un punto su cui i lavoratori battono molto è la modalità di transizione da un sistema produttivo ad un altro sottolineando il rischio di salti nel buio: “In assenza del nuovo si rischia soltanto di perdere il vecchio. Se le industrie se ne vanno e non ci sono progetti alternativi concreti, allora non ri73 mane niente”. Su questo punto i lavoratori ritengono che le responsabilità siano a livello locale ma soprattutto a livello governativo che dovrebbe monitorare in maniera adeguata le trasformazioni: “bisogna capire cosa può comportare una deindustrializzazione per un territorio; quale impoverimento comporta”. Alla domanda sullo stato di attuazione dei tanti Accordi di Programma (che promettevano montagne di investimenti, tavoli di regia, riqualificazioni ecc…) che si sono succeduti la risposta è netta: “Per noi valgono quegli accordi e quegli impegni. Adesso vogliamo i fatti perché gli Accordi non li consideriamo falliti! vogliamo che vengano applicati e che si passi ai fatti.” A seguito del mancato rispetto degli Accordi di Programma viene fatta rilevare l’inerzia di Governo e Confindustria che avrebbero dovuto meglio garantire gli impegni sottoscritti: “Montefibre doveva investire, non lo ha fatto, a quel punto il Governo doveva intervenire immediatamente per indurre Montefibre a investire o per creare le condizioni per fare entrare un soggetto industriale interessato a fare gli investimenti. Non abbiamo preclusioni: tutti possono proporsi come compratori purché dicano chiaramente cosa intendono fare e il dovere di un Governo è quello di controllare questo.” Nei confronti del Comune l’aspettativa è che spinga sul Governo per verificare l’esistenza di progetti concreti. In particolare si chiede chiarezza nei confronti del Porto: “quando sono usciti i soci russi, il Porto ha dichiarato che voleva comprare tutto, ma non ci sono progetti concreti”. Questo viene ribadito anche nel volantino dove si sottolinea che “se esiste un progetto dell’Autorità Portuale su parte dell’area Montefibre non più utilizzata per la produzione di fibre, questo progetto deve essere esplicitato in sede di Ministero dello Sviluppo Economico indicando tempi, costi, soggetti che si accollano questi costi e i relativi risvolti occupazionali”. Ma, prosegue il volantino del 29 settembre, “Il Ministero delle Infrastrutture giudicando troppo oneroso il progetto, lo ha dichiarato “finanziabile solo in parte” perché non c’è la necessaria disponibilità economica”. A Montefibre “ha fatto gola” incassare i soldi dalla vendita delle aree” e si è disinteressata dagli investimenti. Così, tra Montefibre che non investe nelle produzioni industriali e l’Autorità Portuale che non ha progetti (e finanziamenti) concreti, per questi lavoratori l’unica cosa che conoscono è l’incertezza del loro futuro occupazionale. Alla domanda sul rapporto che hanno con la politica e i partiti e cosa si aspettano da questi, parte una riflessione che coinvolge diversi lavoratori. 74 La prima battuta la dice lunga su quanto la politica sia lontana dai luoghi di lavoro e dai bisogni dei lavoratori: “la politica non fa che correre in aiuto delle crisi; basta, bisogna anticipare i processi. E questo lo puoi fare se ci stai dentro”. “se un partito vuole rappresentare qualcuno deve stare dentro ai problemi con quei lavoratori, non valgono più le logiche precostituite, devi scendere al confronto concreto altrimenti non ti avvicini neanche”. “Se non entri nel merito dei problemi concreti i lavoratori credono che tu abbia già un discorso precostituito”. Sulla Lega viene fatto un passaggio significativo “la Lega presenta solo degli spot nei gazebo contro gli extracomunitari che ci rubano il lavoro, ma non sono loro che ci rubano il lavoro, siamo noi che stiamo perdendo tutto”. “Perdere le industrie vuol dire perdere il lavoro e tutte le tutele che ci sono legate; senza industrie non ci sono contratti nazionali di lavoro, relazioni sindacali, insomma tutte quelle garanzie che l’industria ti da”. Però, viene denunciato dai lavoratori, “negli ultimi anni da parte di tutti i partiti c’è stato l’immobilismo più assoluto. Noi chiediamo cosa si è fatto a livello politico indipendentemente dal colore politico di ciascuno?”. Rifondazione Comunista “è mancata, come tutti gli altri, è una critica che estendiamo a tutti i partiti. Nessuno è stato percepibile”. Adesso viene riconosciuto l’impegno di Rifondazione, soprattutto a livello delle istituzioni locali a partire dal comune, ma “quello che serve è un intervento sul Governo, il vero ruolo è quello può esercitare il Governo”. Da parte di un lavoratore viene sottolineata la difficoltà a creare una solidarietà vera tra lavoratori; “non la solidarietà spicciola, quella che non serve a niente. Oggi ci sono troppi interessi che dividono le persone, anche i lavoratori. Nemmeno più la miseria unisce le persone. Una volta era quella che ci univa”. “Nell’area industriale di Marghera ci sono 5.000 lavoratori e dall’altra parte cosa c’è?! c’è un progetto ecologico che viene avanti? bene, ma deve integrarsi con quello che già c’è, cioè i 5.000 lavoratori di Marghera”. E’ forte la preoccupazione, tra i lavoratori, che si continuino a sostenere futuribili progetti di riconversione industriale senza avere niente di concreto e senza integrare l’esistente (cioè le industrie e i lavoratori attualmente impiegati) con possibili progetti di riconversione. I lavoratori sostengono la necessità di far conoscere ai cittadini l’area industriale di Porto Marghera, “se la conoscessero non la vedrebbero come un mostro...Marghera si è trasformata, ha avuto un miglioramento, uno sviluppo sulla qualità elle produzioni industriali”. 75 I lavoratori si sono mobilitati, oltre che per difendere il proprio posto di lavoro anche per questo: per far conoscere il loro lavoro alla cittadinanza, farlo conoscere al territorio. Il gruppo di lavoratori che si attivato occupando la Torre della piazza ha ricevuto il sostegno della Filcem Cgil ma non di Cisl e Uil che, anzi, hanno firmato un accordo separato per la chiusura di Montefibre. L’iscrizione ad un sindacato viene valutata sulla base dei risultati che quel sindacato si propone di raggiungere e su quanto concretamente fa. “Se vuoi difendere il lavoro devi svincolarti da quegli elementi politici che ci sono anche nel sindacato, come la Cisl che fa più politica che sindacato”. “Noi crediamo molto nella democrazia sindacale: solo con il confronto puoi coinvolgere i lavoratori, li fai partecipare. Noi diciamo che si punta su un obiettivo, se poi non lo si raggiunge, magari non è colpa nostra e questo viene capito dai lavoratori perché partecipano continuamente e quindi capiscono”. La Cisl, invece, da quanto percepito sembra dividersi tra una impostazione “politica” e l’attività di intermediazione di manodopera con specifiche agenzie ad essa legate come la Humana. Cisl e Uil hanno firmato l’accordo per la cessazione di attività di Montefibre e “lo hanno fatto nonostante l’assemblea il giorno prima avesse deciso una cosa diversa. Hanno fatto un blitz al Ministero e hanno firmato”. “Hanno un atteggiamento solo politico perché coinvolgono le istituzioni a ridosso delle elezioni per strappare solo promesse elettorali. Qualche mese fa, quando si doveva votare per la Provincia dicevano che bisognava andare là; adesso che vota il Comune vanno a bussare a quella porta” Insomma, è come se la Cisl aspettasse le campagne elettorali dei vari Enti per sfruttare il momento, entrandovi e ottenendo promesse per la difesa dei posti di lavoro. Ancora su Rifondazione, viene detto che “da un Partito come Rifondazione voglio che difenda i posti di lavoro e che dichiari se è per il mantenimento delle industrie”. “Ci vuole coerenza fra idee e fatti”. I lavoratori tengono a precisare che “nessuno di noi ha sposato l’industria chimica. Però prima di dismettere queste produzioni deve esserci una alternativa concreta. Già in Italia c’è poca industria, ci sono solo PMI, se poi quel poco che c’è chiude…”. Come può, secondo voi, un Partito come Rifondazione rendersi utile in questa difesa? “Difendendo non l’industria chimica in generale, ma gli specifici piani in76 dustriali riferiti ai diversi settori. Parlare di industria chimica in generale vanifica le specificità dei vari settori e dei relativi Piani Industriali”. “A un partito chiediamo di dire chiaramente se approva o no un Piano Industriale e come si attiva per renderlo applicabile”. “Non bisogna essere ambigui o generici, parlare di industria è troppo generico, vogliamo posizioni chiare e precise”. Ad esempio sull’Accordo del 2007 che prevede l’attivazione presso Montefibre di Marghera della produzione della fibra al carbonio. L’Accordo del dicembre 2007 sulla fibra al carbonio, una volta attuato è in grado di garantire occupazione di qualità; di accompagnare diversificazione e riqualificazione dei processi industriali. “non siamo contro l’allargamento del Porto e il rafforzamento delle funzioni logistiche; ma bisogna continuare a produrre anche qui, altrimenti la logistica serve solo a trasportare merci prodotte da altri e quindi diventa subalterna. Deve servire a quello che si produce sul territorio”. Le soluzioni industriali consistono nell’attuazione dei Piani di sviluppo concordati in maniera specifica per ciascuna azienda, si tratta di piani specifici ciascuno dei quali prevede delle soluzioni precise, “Chiediamo che i partiti esprimano con chiarezza la loro posizione su ogni Piano Industriale”. L’ennesimo incontro a Roma si tiene al ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre e si conclude con un sostanziale nulla di fatto rinviando a nuovi incontri tra le parti. Si tratta dell’unico risultato positivo, cioè, il fatto che si sia stabilito un rinvio rispetto alla data del 31 dicembre 2009 indicata dal consiglio di amministrazione della società come il termine entro cui si sarebbe attuata la fermata definitiva, con la bonifica e lo smontaggio delle linee di produzione di fibre acriliche. La Dirigenza di Montefibre ha confermato l’impegno della società ad attuare il piano di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario. Nel piano di rientro dal debito è prevista anche la vendita all’Autorità Portuale veneziana dell’area di 67 ettari. Porto e Montefibre hanno raggiunto un accordo di massima sull’operazione, ma senza precisare se la vendita riguarderà tutta l’area o solo la parte non occupata dagli impianti industriali. I sindacati hanno ripetuto anche ieri che la vendita dei terreni al Porto, che ha in progetto di realizzare un terminal per navi-container, deve escludere i 7 ettari coperti dai capannoni e dalle linee produttive. Gli impianti, infatti, malgrado non producono nulla da mesi, non sono ancora stati spenti del tutto e questo - secondo i sindacati - è la premessa per permettere ad eventuali imprenditori, interessati a rilevarli ed avviare le nuove produzioni di precursori di fibre al carbonio, come prevedeva il piano di Montefibre, poi abbandonato. In gennaio spunta una ipotesi: si fa avanti un Consorzio locale costituito 77 appositamente per l’operazione di subentro a Montefibre che presenta al Ministero dello Sviluppo Economico un piano che viene giudicato positivamente per il prosieguo della trattativa. Il Consorzio Marghera Nuova, costituito da un pool di piccole aziende veneziane, un fondo di investimento e una impresa chimica italiana, sembra essere intenzionata a realizzare l’impianto per la produzione di fibre al carbonio con l’intenzione di renderlo operativo entro il 2013. Non mancano, tuttavia, i problemi: la produzione dell’impianto sarebbe di 10.000 tonnellate l’anno con una occupazione pari a 190 persone rispetto alle 292 attuali. 78 Sintesi dei principali dati del Rapporto Piastrelle di Ceramica - anno 2008 - a cura di Confindustria Ceramica Il principale distretto ceramico in Italia si trova a scavalco tra le province di Reggio Emilia e Modena. Il distretto ceramico nasce e si sviluppa a partire dagli anni ’50: in quel territorio si trova la materia prima (cave di argilla), manodopera in abbondanza e basso costo; le produzioni “tirano” grazie all’espansione edilizia che fa aumentare vertiginosamente la domanda di prodotti utilizzati nell’edilizia. La concentrazione di aziende in questo territorio avviene senza nessuna pianificazione territoriale con conseguenze, in termini di carenza di servizi, di infrastrutture e di inserimento nel territorio, che si pagano tuttora a caro prezzo. Dopo la crisi congiunturale del 1964/65 è la sostituzione della “bicottura” con la “monocottura” a costituire la prima e significativa innovazione tecnologica e produttiva che fa aumentare i margini di guadagno creando i presupposti per realizzare politiche commerciali di export molto marcate. Nella seconda metà degli anni ’70 prende avvio il processo di concentrazione che prosegue, poi, in tre fasi: la prima (a cavallo fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90) riduce il numero di imprese e di occupati; la seconda (tra il 1991 e il 1993) a cui partecipano (grazie ai cospicui guadagni derivanti dalla svalutazione del cambio), imprese e gruppi che non erano fino a quel momento in posizione dominante; la terza, di consolidamento, riduce il numero di acquisizione ma vede aumentarne l’entità. Adesso ci troviamo nella quarta fase di ristrutturazione del distretto con le imprese che, nell’ambito della crisi, sia per gli effetti di questa sia per la giustificazione che la stessa offre, stanno operando pesanti processi di riorganizzazione produttiva e, soprattutto, occupazionale. I contorni di questa fase stanno pian piano prendendo forma e già la Cgil stima che nel distretto circa 980 lavoratori di imprese ceramiche rischiano di restare senza lavoro. Come negli altri territori, quando finiranno gli ammortizzatori sociali, se le produzioni non riprenderanno o se non saranno stati creati nuovo posti di lavoro, il numero di disoccupati rischia di aumentare in maniera molto significativa creando una vera e propria emergenza sociale nella cosiddetta “Piastrella Valley”. Per dare una idea della concentrazione produttiva che il comparto ceramico ha conosciuto in questi territori da cui ha preso vita il vero e proprio 79 “Distretto Ceramica” è sufficiente rifarsi ai dati del Rapporto Piastrelle di Ceramica – anno 2008 – a cura di Confindustria Ceramica. In Italia le aziende produttrici di piastrelle risultano essere 195: di queste 68 sono a Modena, 29 a Reggio Emilia, 15 nel resto dell’Emilia Romagna e 83 nel resto d’Italia. Gli addetti diretti sono 26.364, in calo di 846 unità rispetto al 2007( il calo maggiore si registra tra gli operai). La perdita dei posti di lavoro è così ripartita a livello territoriale: 414 a Modena; 105 Reggio Emilia, 46 nel resto dell’Emilia Romagna e 281 nel resto d’Italia. I provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni riguardavano 7.300 addetti al 31 dicembre 2008; divenuti 8.300 al maggio 2009. I forni attivi in Italia sono 578 (- 63 rispetto al 2007; - 93 nel biennio): • 17 monocottura (ne restano 66); • 3 bicottura (ne restano 115); • 3 cotto (ne restano 51); • 8 altri prodotti (ne restano 46); • 32 gres porcellanato (ne restano 288: 195 per le produzioni in smaltato; 93 versione tecnica); • Stabili i forni per clinker (12). • Prosegue la contrazione di forni per la monocottura chiara (- 13; ne restano 42). Le ragioni della riduzione del numero dei forni sono da attribuire a due fattori: - in modo più significativo per la riduzione della capacità produttiva al fine di tener conto della flessione dei volumi; - per la ricerca di crescenti valori di produttività, razionalizzando l’esistente. Gli investimenti nel 2007 sono stati pari a € 302,5 milioni; nel 2008 hanno raggiunto i 303,8 milioni di euro e, in base alle dichiarazioni delle imprese, per il 2009 sono stati attivati 272,2 milioni di euro. L’incidenza degli investimenti sul fatturato, per l’anno 2008, è cresciuta al 5,51% per effetto della riduzione del fatturato è dovuta: - all’adozione di nuove soluzioni impiantistiche per la decorazione della ceramica; - agli investimenti per l’aumento della dimensione dei formati; - la prosecuzione dei fenomeni di internazionalizzazione di alcune fasi di lavorazione ausiliaria del prodotto; - classica manutenzione impiantistica. 80 La produzione in Italia si è attestata a 512,5 milioni di mq; con un calo di 46,6 Mmq rispetto al 2007, pari ad una riduzione dell’8,33%. Si tratta della settima flessione produttiva consecutiva; la più grave registrata nel decennio, con la seguente ripartizione per prodotto: - gres porcellanato – 7%; - monocotture: - 10,75%; - bicotture: - 10,26%. Il Rapporto evidenzia i seguenti risultati: Il gres porcellanato è il prodotto che conferma i maggiori volumi; la monocottura chiara registra una riduzione dell’8,74% e si attesta all’8,49% delle produzioni complessive; le monocotture, per mantenendo una componente significativa, ormai pesano per meno di un quinto nel portafoglio prodotti; nella bicottura si registra un forte calo della smalteria. Flessione anche per i prodotti di nicchia (-21 % clinker; -21% cotti; -33% altri prodotti). La produzione con marchio proprio si difende meglio mantenendo l’85,45% della produzione complessiva, a fronte del 14,55% della produzione conto terzi che cala maggiormente in termini percentuali (-12,39%, a fronte di un -7,6% del marchio proprio). La localizzazione produttiva è la seguente: - Modena e Reggio Emilia: 79,34% - Resto dell’Emilia Romagna: 11% - Resto d’Italia: 9,66%. Il supporto per terzi ha subito una forte contrazione (- 33%), l’attrattiva internazionale di questo semilavorato ceramico italiano appare destinata a scomparire. Attività diretta e commercializzazione: - le vendite relative all’attività diretta sono pari all’85%; - le vendite di materiale commercializzato (cioè le quantità che le aziende produttrici hanno fatto produrre con marchio proprio ad altre imprese) sono in calo del 23% assestandosi al 7,55% delle vendite totali; - gli intermediari si collocano al 7,35%. Le vendite registrano un calo del 6,4% nell’export e del 9,92% in Italia: il mercato italiano assorbe il 29,85% delle produzioni, quello estero il 70,15%. In Italia calano le vendite di attività diretta (- 7,38%) e la commercializzazione (- 38,4%) e aumenta la vendita di società commerciali con marchio proprio (+ 16,5%); all’estero, invece, aumentano solo le vendite di conto 81 terzi (+ 6,4%) e calano le vendite di attività diretta (- 6,3%); la commercializzazione (- 11%); e le vendite di società commerciali con marchio proprio (- 4,65%). Al 31 dicembre 2008 lo stock di magazzino è aumentato di 6,1 milioni di mq raggiungendo 252,2 M mq (pari a 6 mesi di produzione). Il fatturato 2008 è stato pari a 5,516,7 milioni di euro, in flessione del 4,63% : di questo 4043,9 M€ (73,3 % del totale vendite) sono esportazioni (- 3,34%), mentre il calo percentualmente più significativo è sul mercato domestico (- 8%) che si attesta al 26,7% del totale vendite. L’internazionalizzazione produttiva è descritta dai seguenti dati: - all’estero esistono 20 società di produzione di piastrelle controllate da 9 gruppi ceramici italiani; - esistono 34 stabilimenti con 85 forni attivi (+ 8 rispetto al 2007); - 6.976 dipendenti (+ 250). Queste imprese, con relativi stabilimenti, sono presenti in USA, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Svezia, Finlandia, Polonia, Ucraina e Russia. La produzione all’estero è aumentata a 126, 5 milioni di mq, in aumento di 10 milioni; la prima produzione è diventata quella del gres porcellanato smaltato. L’internazionalizzazione è un aspetto importante: nell’industria ceramica italiana, oltre ai notevoli volumi di prodotto esportato, molto significativi sono anche i fenomeni di internazionalizzazione delle imprese. Nel 2008 le aziende in Italia e nel mondo produttrici di piastrelle controllate da società italiane sono 215 (195 + 20) che operano in 324 stabilimenti con 663 forni. 82 Inchiesta condotta alla TAT di Roteglia (Re)6 Questa inchiesta è stato condotta prima dell’iniziativa di sabato 10 ottobre organizzata dal circolo delle Ceramiche sulla crisi del Distretto della Ceramica. Con colloquio intervista con alcuni lavoratori e con l’ausilio del testo di un volantino distribuito il 18 settembre dai lavoratori della TAT ceramiche di Roteglia è possibile ricostruire la situazione attuale di tale stabilimento e dei suoi lavoratori. TAT Ceramiche è una società che ha rilevato, mediante contratto d’affitto (quindi non di acquisto) la ex Nordica. Alla fine di giugno i titolari della TAT ceramiche (Sangermano, Zanichelli e Ruini) informano la Rsu aziendale della loro intenzione di dar corso ad un breve periodo di cassa integrazione ordinaria (cigo), con una probabile riapertura degli impianti intorno al 14 settembre, quindi con un mese di anticipo rispetto alla scadenza della cigo stessa. La TAT entra quindi in cassa integrazione il 5 di luglio anche se gran parte dei lavoratori prosegue l’attività fino all’ undici per esigenze produttive, entrando in cigo di fatto il 13 luglio, con la convinzione di tornare al lavoro a metà settembre. I piani dei titolari invece erano ben altri, infatti il consiglio d’amministrazione TAT pochi giorni dopo decide di mettere in liquidazione l’azienda e di affittare a terzi , per la precisione alla Casabella srl, il ramo d’azienda commerciale,infine il 17 luglio presentano una richiesta di concordato preventivo presso il tribunale di Reggio Emilia. Tutta questa operazione viene realizzata senza informare né la RSU, né le forze sindacali, né tanto meno le amministrazioni locali. La Rsu aziendale infatti apprende da terzi quale fosse la situazione aziendale il 21 luglio a fatti già avvenuti, e subito si mobilita per creare un presidio davanti all’azienda bloccando il transito dei camion che già venivano a caricare materiale a nome Casabella. Il presidio che si è protratto per settimane con un notevole riscontro mediatico ha portato all’apertura di un tavolo istituzionale in provincia che ha permesso di avviare una nuova procedura di cassa integrazione adeguata alla situazione in atto. Parte quindi il 5 agosto una cassa integrazione straordinaria (Cigs) per 12 mesi. Da li in poi però di fatto non accade più nulla se non l’avvenuta retribuzione della mensilità di luglio. In realtà quello che sta più a cuore dei 115 dipendenti TAT ceramiche, ad oggi di fatto senza lavoro, è la prosecuzione dell’attività produttiva, ma nonostante siano passati due mesi dal “fattaccio” non c’è 6 In collaborazione con Alessandro Antonini e Pierpaolo Prandi, Prc Reggio Emilia. 83 stato nessun passo avanti al riguardo. Nel volantino dei lavoratori TAT vengono invitate “tutte le forze in campo a partire dall’attuale proprietario del sito produttivo il Com. Frappi, a fare il massimo sforzo per dare una prospettiva ai lavoratori TAT. I soli ammortizzatori sociali seppur importanti non bastano, devono essere solo una soluzione momentanea in attesa di una ripresa produttiva, perché 750 euro di cigs bastano malapena a pagare affitto e poco altro. I lavoratori TAT vogliono solo lavorare! Ad oggi 115 persone hanno perso il loro posto di lavoro e non hanno prospettive per il futuro!” I lavoratori hanno sottolineato l’assoluta casualità con cui sono venuti a sapere delle reali intenzioni aziendali e solo a seguito di loro richiesta l’Azienda ha confermato l’intenzione di procedere con l’abbandono della produzione. Il Presidio dei lavoratori ha portato alla convocazione del tavolo tecnico che ha portato, come risultato concreto, alla trasformazione della Cassa integrazione da ordinaria in straordinaria; ma dal punto di vista dell’individuazione di eventuali compratori in grado di riattivare la produzione non è stato fatto nessun passo in avanti. La società TAT, di proprietà dei tre soci indicati nel testo del volantino, ha rilevato lo stabilimento di ceramiche dalla società Nordica nel 2005: TAT si è presentata con grandi promesse di investimenti, di miglioramenti produttivi ecc. Ma la realtà dei 4 anni di gestione TAT sono stati ben altro: i Piani Industriali così ambiziosi negli obiettivi sono stati solo annunciati ma mai presentati, quindi non è stato messo in campo nessun investimento concreto in termini di ricerca, di ammodernamento degli impianti di miglioramento dei processi produttivi. Insomma, TAT, ha rilevato con contratto d’affitto gli stabilimenti ex Nordica, li ha “spremuti come limoni”, poi quando non li ha più ritenuti sufficientemente redditizi ha deciso di chiudere. La strada scelta da TAT è stata quella del concordato preventivo: “per uscirne puliti” per poter pagare solo “liquidazioni ridicole” ecc. La Nordica era una impresa storica nel settore della ceramica che si era specializzata nella produzione di gres porcellanato prima di tutti gli altri assieme ad altre due aziende. Ora si tratta di una produzione diffusa, ma all’inizio degli anni ’90 erano poche le imprese che si dedicavano a questa produzione. Come a dire che la Nordica aveva conquistato un certo “vantaggio competitivo”, poi miseramente perso per strada per mancanza di investimenti ecc. 84 La vicenda Nordica/TAT la dice lunga su alcuni passaggi di impresa: TAT, come visto, non acquista ma semplicemente affitta. Una volta disdetto il contratto di affitto, produzione e lavoratori dovrebbero tornare in capo a Nordica che nel frattempo ha cessato questa attività di impresa. Risultato finale: 115 persone in Cigs e senza prospettive di lavoro una volta terminato il periodo di Cassa integrazione. TAT decide di terminare la produzione in quanto schiacciata da un debito pesantissimo: 35 milioni di euro di cui almeno 25 verso i fornitori. E’ evidente che si tratta di una cifra sproporzionata per una azienda di questo tipo che non ha mai avuto problemi di produzione e di vendita. I lavoratori parlano espressamente di “finanza creativa” per indicare il fatto che buona parte della ricchezza prodotta ha preso altre strade, non certo quelle della corretta gestione aziendale. “Se l’azienda continuava a lavorare, dove sono finiti gli utili?!” “Addirittura nel 2008 risulterebbe migliorata la produttività dell’anno precedente, quindi non c’erano particolari problemi legati all’attività produttiva. Il problema viene individuata nella natura del soggetto che ha rilevato la ex Nordica, la TAT, società controllata dalla società RU.SA.ZA. (iniziali dei tre proprietari: Ruini, Sangermano, Zanichelli), una società solo commerciale che al momento di rilevare non ha, come visto, acquistato, ma solo acquisito in affitto da Nordica l’attività produttiva. Una volta affittata l’attività di impresa, la TAT non ha realizzato nessun investimento. Insomma: un intervento a costo zero. Per quanto concerne le istituzioni: il comune territorialmente competente si è attivato, ma per le dimensioni dello stesso, poco si è potuto fare. La Provincia ha da subito istituito il Tavolo Tecnico, ma, viene sottolineato dai lavoratori “ha dato la disponibilità solo ad organizzare incontri, non c’è stata una gran spinta a trovare una soluzione concreta, non c’è stata nessuna spinta a coinvolgere imprenditori interessati ad intervenire”. E la Regione Emilia Romagna? “non pervenuta”. Proprio sulla Regione si appuntano le maggiori critiche: “sembra che per la Regione ci siano lavoratori di seria A e di serie B”; “se la Regione decide di muoversi lo deve fare per tutti, non solo per alcuni”. Il riferimento è alla crisi della IRIS che ha riscontrato ben altro impegno da parte della Regione. “Forse perché noi siamo una azienda più piccola con solo 115 dipendenti”. Il Distretto della ceramica sta vivendo una fase di forte crisi, molte aziende sono in Cassa Integrazione, “se continua così, il distretto avrà sempre 85 meno aziende, se non ci si muove è inevitabile”. I lavoratori riconoscono come oggettivo e inevitabile un “ridimensionamento” della produzione nel distretto della ceramica, ma, precisano, “per evitare che il ridimensionamento, che è nelle cose, si traduca nella perdita di posti di lavoro serve subito un ragionamento sulla riconversione produttiva di alcune aziende”. Questo il compito delle istituzione, che dovrebbero definire un piano di intervento, ma “finora è mancato qualsiasi collegamento tra le istituzioni”. “e allora cosa dobbiamo fare?! andare anche noi sul tetto?! ci fanno diventare tutti estremisti!” I lavoratori insistono molto sul futuro industriale del Distretto, ribadendo che il ridimensionamento è inevitabile: “in alcune fasce di mercato le nostre aziende non sono più competitive; sula bassa gamma il ridimensionamento è inevitabile, poi le aziende si lamentano molto dei costi dell’energia che sulla bassa qualità incidono molto nel rapporto costo/prezzo”. Quindi, la “riconversione è la strada giusta, anche per dare una prospettiva alle altre produzioni. Molta produzione metalmeccanica della zona è legata alla ceramica, se si ferma questa si fermano anche tutte le altre produzioni che da questa dipendono”. “Diversificare le produzione è quelle che aiuterebbe il Distretto ad uscire dalla crisi”, anche in considerazione della stretto vincolo occupazionale al settore ceramico: “ci sono intere famiglie che lavorano nello stesso settore, se questo salta significa che intere famiglie non avranno più niente”. Per quanto concerne l’obiettivo di una riconversione produttiva i lavoratori citano il caso di Scandicci dove una azienda che produceva frigoriferi (Elettrolux) ha lasciato il posto alla produzione di pannelli solari. “Rifondazione dovrebbe proporre progetti così anche da noi”. Dai discorsi dei lavoratori si avverte l’esigenza di un progetto complessivo sul Distretto della Ceramica. “Per le aziende della ceramica si tratta di investire per diversificare la produzione nei settori che non sono ancora saturi”; il distretto “non scompare ma rimarranno le imprese che hanno investito per produzioni di lata qualità; oppure gli altri che riusciranno a sopravvivere saranno i grandi gruppi” Al contrario, le aziende più in difficoltà sono quelle di minori dimensioni, concentrate su prodotti di più bassa gamma ed esposti alla concorrenza internazionale. Un lavoratore sottolinea che “adesso vanno di moda due cose: 1) cancellare i debiti accumulati attraverso la formula del concordato; 2) tagliare gli stabilimenti italiani per aprirli all’estero come il gruppo Marazzi di Sassuolo”. 86 Il Gruppo Marazzi, infatti, proprio in questi giorni ha annunciato l’intenzione di accorpare la produzione negli stabilimenti di Sassuolo, Fiorano e Finale Emilia provocando, come conseguenza, la chiusura dei due stabilimenti Ragno di Aldo Moro, a Sassuolo, e Iano a Scandiano; la produzione sarà unificata nei siti con maggiori prospettive di sviluppo. Nel frattempo Marazzi mantiene le unità produttive in Spagna, Francia Usa e Russia. “E’ inaccettabile che una azienda italiana si comporti in questo modo, dovrebbe mantenere la produzione qui e mantenere i posti di lavoro. A queste aziende è stato dato tutto! hanno chiesto le infrastrutture sono state fatte! a spese nostre e deturpando il territorio. E questo è il loro ringraziamento! Sempre questo lavoratore esprime un giudizio severo nei confronti del Sindacato: “oggi il giornale “Il Distretto” ha pubblicato un titolo giusto che dice “Il botto Marazzi: dov’è la sorpresa?”. questo giornale ha ragione, da tempo si sapeva di questo rischio, il Sindacato lo sapeva ma non si è mosso in tempo”. “Adesso è tardi, però se la Marazzi chiude quel terreno deve rimanere ai lavoratori”. Durante l’assemblea organizzata dal Circolo Prc della Zona Ceramiche, interviene anche un rappresentante della Filcem Cgil secondo il quale: 1) verso la fine del 2008 il primo effetto della crisi si è scaricato sui lavoratori precari delle aziende del distretto: per ridurre i costi di produzione le aziende sono ricorse al mancato rinnovo dei contratti dei precari. I precari nel distretto della ceramica sono presenti sia nel ciclo di produzione (diretti) sia nelle produzioni indirette. 2) La crisi è stata affrontata con la sospensione della produzione grazie ad un massiccio ricordo alla Cassa Integrazione. 3) Esistono situazioni strutturali di questo tipo: a) si verificano dismissioni di stabilimenti; b) molte aziende hanno seri problemi finanziari (problemi di sottocapitalizzazione, vedi la vicenda Italgraniti: si tratta di una fabbrica con 500 dipendenti, con una produzione di lata gamma, buoni impianti ecc…ma ha difficoltà finanziarie; c) la vicenda Marazzi sta facendo una politica di delocalizzazione. La chiusura degli stabilimenti è figlia di questa strategia aziendale. Inoltre, a fronte di situazioni di difficoltà, anziché intervenire per affrontare nel merito i problemi, si preferisce ricorrere alla liquidazione dell’Azienda (per non pagare i debiti); spesso da questi fallimenti nascono nuove so87 cietà che subentrano alle precedenti senza, tuttavia, i costi delle situazioni precedenti. Il Sindacato ha messo in campo alcune iniziative, innanzitutto per il mantenimento dei siti produttivi nell’ambito delle vicende Iris, ex Nordica (TAT), Pioppe, Marazzi. L’obiettivo del sindacato è mantenere le strutture industriali per ottenere risultati occupazionali. In questo distretto l’80% del lavoro è legato alla ceramica, compreso l’indiretto che lavora sempre per questo settore. Bisogna quindi fare attenzione: non siamo in una situazione che ci consente di sostituire subito un modello produttivo con un altro. Se adesso non c’è una adeguata difesa delle imprese ceramiche, non potremo nemmeno discutere di possibili alternative, non ci sarà più niente. 88 Inchiesta condotta alla Marazzi Group di Iano di Scandiano (Re)7 La crisi Marazzi piomba sulla testa dei lavoratori da un giorno all’altro. “Proprio il giorno prima eravamo impegnati a discutere con la Direzione il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria per far fronte ad un contenuto calo delle vendite”. La discussione aperta con la Direzione riguardava le modalità di ricorso alla Cassa integrazione ordinaria, della durata di un mese, per il personale impiegato nei siti produttivi di Iano, Sassuolo e Fiorano. Invece, il giorno dopo (6 ottobre 2009), nonostante l’avvio di questa discussione su come affrontare quella che sembrava una difficoltà tutto sommato contenuta, arriva il primo segnale che la situazione è ben più grava di quanto non apparisse i giorni precedenti. La posizione dell’azienda, infatti, è quella di ridurre il numero di magazzini da sei a quattro per centralizzare meglio la gestione logistica. L’azienda, infatti, ritiene non economico mantenere sei magazzini nel distretto. In realtà la proposta aziendale viene meglio precisata: non più un intervento limitato alla “sola” chiusura dei magazzini ma un intervento di riorganizzazione molto più pesante che riguarda anche la parte produttiva. Marazzi propone di chiudere gli stabilimenti produttivi di Iano e Sassuolo (Ragno di via Aldo Moro) concentrando la produzione nei cinque siti di Sassuolo, Fiorano e Finale Emilia. Secondo il giornale “Il Distretto” questa decisione risponde all’obiettivo, per la Marazzi, di unificare la produzione “nei siti con maggiori prospettive di sviluppo e porterà ad una riorganizzazione dell’assetto organizzativo del Gruppo”. Quindi per il sito di Iano si profila chiusura completa, tanto del magazzino quanto del settore produzione. Una volta presentato il piano di riorganizzazione e ristrutturazione da parte del gruppo Marazzi, (martedì 6 ottobre) relativo ai siti italiani, FemcaCisl, Filcem-Cgil, Uilcem-Uil di Modena e la Rsu della Marazzi hanno proclamato la mobilitazione di tutti i lavoratori. L’iniziativa sindacale ha previsto il blocco immediato di tutte le prestazioni straordinarie e uno sciopero di otto ore tenutosi 12 ottobre su tutti i turni di lavoro e con un presidio in via Regina Pacis a Sassuolo, sede centrale del gruppo. 7 In collaborazione con Alessandro Antonini, Annalisa Magri e Pierpaolo Prandi, Prc Reggio Emilia. 89 Nel comunicato sindacale si legge che «L’azienda ha giustificato il piano con la profonda crisi di mercato che attraversa il settore e che ha investito la stessa Marazzi. Il piano prevede un percorso di ristrutturazioni e accorpamenti produttivi che determinano gravi ripercussioni sugli stabilimenti modenesi e reggiani a causa dei ridimensionamenti produttivi e occupazionali. Gli stabilimenti di Ragno Sassuolo (a eccezione della parte logistica) e Ragno Iano cesseranno ogni attività produttiva, provocando un esubero di circa 295 lavoratori e lavoratrici; il terzo fuoco interno vedrà ridotta la produzione con un esubero di circa undici addetti. La riorganizzazione interesserà anche la parte impiegatizia, nella quale sono previsti circa 60 esuberi tra gli impiegati amministrativi, commerciali e tecnici degli uffici di Modena e Sassuolo». Quindi circa 360 esuberi così ripartiti: 60 tra gli impiegati del gruppo; 180 presso lo stabilimento di Iano; 120 presso lo stabilimento Ragno di Sassuolo. Per questi ultimi la prospettiva di ricollocazione avrebbe riguardato il loro impiego in sostituzione di 120 lavoratori a termine occupati presso cooperative che prestavano i propri servizi presso gli stabilimenti Marazzi. In definitiva, si sarebbero comunque persi 120 posti di lavoro, o direttamente sui dipendenti Marazzi o indirettamente sul personale di cooperative che lavorano per il Gruppo Marazzi. Per i dipendenti dello stabilimento di Iano, invece, nessuna prospettiva se non per un numero estremamente limitato pari a circa 35 unità da ricollocare nel Gruppo. Per tutti gli altri l’unica soluzione prospettata era la messa in Cassa Integrazione Straordinaria propedeutica alla mobilità e quindi alla perdita del posto di lavoro. Alla luce di questi dati, le organizzazioni sindacali e la Rsu della Marazzi, a proposito della proposta dell’azienda di avviare un percorso che prevede la parziale ricollocazione dei dipendenti in esubero sugli impianti in fase di installazione negli stabilimenti di Sassuolo e in sostituzione del personale di cooperative e di lavoratori somministrati, hanno giudicato inadeguata e insufficiente questa proposta a garantire la tenuta occupazionale e la capacità produttiva delle fabbriche italiane in quanto “Il saldo occupazionale rimane negativo per l’impossibilità di collocare tutto il personale in esubero. Inoltre vengono meno un importante sito produttivo come quello di Ragno Iano, recentemente oggetto di investimenti e riorganizzazione, e una realtà storica come la Ragno di Sassuolo. Emerge chiaramente la volontà dell’azienda di spostare la maggior parte delle produzioni negli stabilimenti extraeuropei”. 90 A fronte dell’intenzione della Marazzi di procedere con gli esuberi occupazionali anche dei lavoratori indiretti, sono da registrare due importanti prese di posizione sindacali riferiti ai lavoratori della logistica e ai lavoratori a termine. Le Organizzazioni Sindacali del settore Trasporti (competenti per le cooperative addette alla movimentazione merci e altre funzioni logistiche) con un comunicato del 9 ottobre hanno espresso profonda preoccupazione segnalando che presso la Marazzi, oltre ai dipendenti diretti, vi lavorano anche oltre 70 soci lavoratori delle cooperative Isolavoro e Colser che, in regime di appalto, svolgono le attività di movimentazione e logistica. I Sindacati dei Trasporti Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uil/Trasporti, nel comunicato di cui sopra, chiedono se la decisione unilaterale del Gruppo Marazzi, di rivedere gli assetti produttivi e ridurre i livelli occupazionali e le soluzioni a tutela della forza lavoro ad oggi occupata, terrà conto anche di questi lavoratori o se questi saranno i primi ad essere esclusi. “Questa decisione sarebbe doppiamente ingiusta, questi lavoratori, per anni impegnati nelle attività più disagiate, hanno garantito la flessibilità richiesta dal ciclo produttivo, spesso sottopagati e con meno tutele degli addetti, ora si troveranno a pagare per primi la ristrutturazione dell’impresa.” La richiesta, quindi, è stata quella di chiedere “un tavolo di confronto che metta sullo stesso piano la tutela del lavoratori dipendenti della Marazzi Group e quelli delle Cooperative, garantendo loro pari dignità.” La Nidil Cgil ha chiesto adeguate tutele anche per i lavoratori a termine. Con un comunicato in data 9 ottobre “Il Sindacato dei lavoratori atipici NIdiL/Cgil di Modena esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Marazzi SpA ed in particolare ai lavoratori somministrati (ex interinali) presso la stessa società, oltre 60, che in parte sono già stati espulsi dall’azienda per fine missione, impedendo loro, di fatto, di poter fruire degli ammortizzatori in deroga previsti dalla normativa vigente. Ancora una volta questi lavoratori pagano per primi la crisi senza, in alcuni casi, nessuna tutela sociale, a dimostrazione della totale mancanza e inefficienza degli strumenti messi in campo dal Governo per fronteggiare la crisi.” Quindi, appare possibile affermare che per quanto concerne le diverse categorie di lavoratori della Marazzi, le rispettiva categorie sindacali si sono mobiliate per la tutela di questi lavoratori. Non è dato a sapere, invece, se tra le diverse categorie (chimica, trasporti e precari) sia stata trovata e realizzata una forma di coordinamento delle iniziative. Di particolare rilevanza il fatto che quasi subito viene costituito il Coordinamento delle RSU del Gruppo Marazzi comprendente le Rsu di tutti gli 91 stabilimenti del Gruppo presenti nel distretto reggiano-modenese. Il comunicato del Coordinamento Rsu del Gruppo Marazzi comprende molti spunti di grande rilievo: “Il coordinamento sindacale del gruppo Marazzi, riunito ieri - martedì 13 ottobre - conferma il giudizio negativo già espresso da Femca-Cisl, Filcem-Cgil, Uilcem-Uil di Modena, Reggio ed Emilia-Romagna sulle linee di fondo del piano di riorganizzazione illustrato la settimana scorsa dalla Marazzi. Un piano di questo tipo, tutto centrato su tagli del personale e chiusure di stabilimenti, oltre a essere in contrasto con le linee guida del “Patto per attraversare la crisi” firmato in maggio da Regione e parti sociali, non garantisce sviluppo e prospettiva alla Marazzi, in particolare per quanto riguarda la sua presenza in Italia e nel nostro distretto. “Per queste ragioni diciamo no alla chiusura di due stabilimenti, no all’esclusione dalla trattativa dei lavoratori somministrati e delle cooperative, no alla revisione dei trattamenti contrattuali in essere per tagliare i costi, no al taglio di oltre 360 occupati. Chiediamo - continuano i sindacati - che il confronto riprenda sulla base di una profonda revisione delle scelte dell’azienda mettendo al centro il piano industriale, gli investimenti, le innovazioni di prodotto, le politiche commerciali e di presidio dei mercati (dalle aree geografiche ai nuovi settori di utilizzo del prodotto ceramico), le politiche di risparmio energetico, una logistica più efficiente e di sistema». Dal punto di vista dei metodi sindacali di intervento, appare importante sottolineare che “Il coordinamento sindacale ha stabilito che la vertenza deve svilupparsi a livello dell’intero gruppo e non per singolo territorio.” La richiesta di coordinamento sindacale investe anche il livello europeo della presenza del Gruppo Marazzi: “… Femca, Filcem e Uilcem chiederanno urgentemente la convocazione del Cae (Comitato aziendale europeo) per coordinare le iniziative sindacali a livello continentale.” Sul piano istituzionale il Coordinamento chiama in causa tutti i livelli a partire dal quello regionale: “Le organizzazioni sindacali e le Rsu, inoltre, chiederanno di aprire un confronto con tutti i soggetti interessati per definire politiche attive a sostegno del settore e del distretto e azioni atte a fornire i supporti e gli strumenti a fronte delle ristrutturazioni e delle innovazioni necessarie. A tal fine le istituzioni dovranno coordinarsi con un ruolo centrale della Regione Emilia-Romagna, che ha competenza per le politiche industriali, per le politiche attive del lavoro e per gli ammortizzatori sociali, come definito dal patto sottoscritto con le parti sociali nel mese di maggio 2009 con l’obiettivo di evitare i licenziamenti e salvaguardare le capacità produttive aziendali.” Sempre nello stesso comunicato viene ricordato il risultato dello sciopero 92 del 12 ottobre che ha visto una partecipazione unitaria di tutti i lavoratori, sia dei dipendenti Marazzi che di quelli delle cooperative: “La notevole partecipazione all’iniziativa di lotta, compresi i lavoratori somministrati e delle cooperative, è stata la risposta più chiara al tentativo dell’azienda di dividere i lavoratori tra stabilimenti, tra operai e impiegati, tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori precari e in appalto». In data 19 ottobre, si è tenuto l’incontro tra sindacati e Direzione aziendale Marazzi Group presso Confindustria Ceramica dopo la presentazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione del gruppo per la parte relativa ai siti produttivi italiani che prevede chiusure aziendali (Ragno Sassuolo e Iano) e tagli di personale (366 lavoratori). In base al comunicato sindacale: “In occasione di tale incontro, la delegazione sindacale ha chiesto che il confronto si sviluppasse in una logica di gruppo e mettesse al centro il piano industriale, gli investimenti, le innovazioni di prodotto, le politiche commerciali ed il presidio dei mercati, ecc. e dopo una prima fase di confronto ha espresso con chiarezza la necessità di proseguire la trattativa sul piano industriale senza soluzioni precostituite da parte dell’azienda e potendo, come sindacato, entrare nel merito delle scelte dell’impresa con proprie valutazioni e proposte sugli investimenti, sugli assetti produttivi e sulle ricadute organizzative. La direzione Marazzi ha inoltre confermato la disponibilità a proseguire il confronto sul piano industriale entrando nel merito dei singoli aspetti (investimenti, struttura produttiva, ecc.) e ha dichiarato che nessuna iniziativa unilaterale sarà assunta dall’impresa per quanto riguarda le eventuali ricadute occupazionali. Alla luce di ciò si è definito che: • il confronto prosegua a livello di gruppo • la discussione del piano industriale si svolga anche alla luce di nostre valutazioni e proposte; • siano esclusi interventi unilaterali dell’impresa sugli assetti occupazionali e che qualsiasi soluzione debba essere concordata.” La situazione dei due siti oggetto di chiusura è diversa: mentre a Sassuolo è stata bloccata la ristrutturazione di due forni, presso Iano sono stati realizzati importanti investimenti. Presso lo stabilimento di Iano: a) è in funzione un impianto atomizzatore per produrre la materia prima (parte della quale viene ceduta anche ad altri stabilimenti del distretto); detto per inciso, si tratta dello stesso tipo di impianto che pur essendo stato progettato per la Sadon di Vetto da questa non è mai stato realizzato con notevoli svantaggi in termini 93 economici e industriali; quindi, dal punto di vista della fornitura di materia prima lo stabilimento di Iano è assolutamente autosufficiente producendola in proprio grazie all’atomizzatore; b) è in funzione una turbina per la produzione di energia; l’energia prodotta non è solo è sufficiente ad alimentare le produzioni dello stabilimento, ma essendo anche in eccesso, la parte eccedente viene venduta all’Enel: quindi Iano può vantare la piena autosufficienza energetica ed essendo le industrie ceramiche molto energivore, questo rappresenta un vantaggio economico di non poco conto; c) esiste e funziona un impianto di trattamento delle acque reflue; quindi anche dal punto di vista ambientale lo stabilimento di Iano è pienamente attrezzato e autosufficiente. d) Sono stati realizzati importanti investimenti come la realizzazione di una nuova linea, il tinto metro, la sala compressori. Il Gruppo Marazzi non ha certo problemi di utili, nel 2008 ha realizzato 998 milioni di euro di fatturato con un utile che seppur in calo del 26% è comunque arrivato a circa 30 milioni di euro. Non ci sono nemmeno particolari problemi logistici in quanto la recente strada “Pedemontana” è stata realizzata proprio a servizio del distretto ceramico ed è in grado di collegare Sassuolo con l’area reggiana delle ceramiche. Da parte dei lavoratori Marazzi viene sottolineato molto l’aspetto relativo agli Accordi di Programma stipulati con i comuni per la realizzazione di infrastrutture e servizi a sostegno delle produzioni del distretto ceramico. Il clima nel quale si svolgono le trattative per la crisi Marazzi è pesantemente segnato dall’atteggiamento dell’azienda. Verso fine novembre, ad esempio, in maniera unilaterale, da parte dell’azienda viene avviata una procedura di attivazione di CIGS. Il comunicato sindacale dei lavoratori del Gruppo Marazzi così stigmatizza la decisione dell’azienda: “Grave iniziativa aziendale nella trattativa; avviata la procedura di CIGS per tutto il Gruppo nonostante l’impegno assunto dalla azienda, anche di fronte alle istituzioni, a non procedere con atti unilaterali. Chiediamo anche alla proprietà, che nell’incontro in Regione aveva garantito non ci sarebbero state forzature, ad intervenire per ripristinare la correttezza del confronto. L’azienda, a due giorni dall’incontro in cui il sindacato porterà le sue proposte unitarie alla “Bozza” di documento consegnato dall’azienda sul piano di ristrutturazione, ha già avviato unilateralmente le procedure di CIGS 94 per crisi aziendale. Per la delegazione sindacale l’incontro già fissato rimane confermato. Pertanto se l’azienda ritiene esaurito il confronto in sede sindacale, lo espliciti formalmente Il Coordinamento sindacale, nella riunione prevista per domani, continuerà l’analisi del documento fornito dall’azienda e valuterà unitariamente come proseguire il confronto e quali iniziative prendere anche alla luce della situazione verificatasi. Infatti ad un mese dall’avvio del confronto, nella lettera di procedura e nel comunicato affisso in bacheca l’azienda continua a parlare di chiusura di stabilimenti produttivi ed a proporre un taglio negli uffici, negli enti e nei servizi con esuberi tra gli impiegati ed il ricorso ad una Cigs per un platea di 400 lavoratori e lavoratrici.” Ritenendo non sufficientemente dura la posizione assunta, l’azienda decide anche di non presentarsi agli incontri convocati suscitando ulteriori proteste sindacali: “La Direzione Aziendale Marazzi Group in maniera immotivata, ha deciso di annullare l’incontro previsto per oggi pomeriggio in Confindustria Ceramica, nel corso del quale la stessa avrebbe dovuto rispondere nel merito al documento sindacale consegnato nell’incontro del 2 dicembre; inoltre ha rifiutato la proposta sindacale di usare il tempo che ci separa dall’incontro istituzionale previsto per il 10 dicembre, per continuare la trattativa in sede sindacale. In realtà, tale iniziativa aziendale deriva dal fatto che la loro posizione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto all’evolversi della trattativa, ed in particolare sui seguenti punti: - non c ‘è nessuna disponibilità a rivedere la loro decisione di dismettere lo stabilimento di Iano; - hanno riconfermato gli esuberi tra gli impiegati; - hanno ribadito la loro proposta di voler rivedere i trattamenti retributivi, le condizioni ed i diritti stabiliti negli accordi aziendali dei diversi stabilimenti, come parte integrante della loro bozza di piano industriale. Quando si è a corto di idee e di proposte, si rischia di perdere lucidità e di diventare sordi ed insensibili al dialogo ed alla ricerca di soluzioni condivise. In virtù di questa indisponibilità aziendale a prendere in considerazione le proposte unitariamente avanzate dal coordinamento sindacale Marazzi Group, la Filctem Cgil ha in preventivo iniziative di lotta e mobilitazione a sostegno della piattaforma sindacale unitaria, iniziative che si svolgeranno la prossima settimana con modalità da definire.” Anche le Organizzazioni Sindacali faticano a contenere la rabbia dei lavoratori che, a fronte delle continue fumate nere degli incontri con l’azienda, sono arrivati a contestare gli stessi rappresentanti sindacali e a minacciare l’occupazione dello stabilimento di Jano. 95 Il Coordinamento sindacale sulla vertenza Marazzi Group elabora, come posizione unitaria, un documento sindacale consegnato il 2 dicembre incentrato: ● Su un Piano Industriale e d’Investimenti capaci di dare futuro e rilanciare il gruppo; ● Sulle garanzie occupazionali e sugli organici a regime; ● Sul capitolo Impiegati, Logistica e Magazzini; ● Sulla continuità produttiva del sito di IANO. Tra i temi indicati, il Coordinamento Sindacale avanza proposte sui nuovi assetti della logistica e magazzini che prevedano il rientro e la gestione diretta da parte della Marazzi in modo stabile e definitivo delle attività; un piano straordinario e permanente di formazione per tutti i lavoratori; sulle attività impiegatizie e tecniche con la richiesta di discutere misure ed interventi atti a dare soluzioni alle disfunzioni ed agli errori nella progettazione ed implementazione del nuovo sistema di gestione integrato delle attività (Oracle) improntando il cambiamento organizzativo e l’organizzazione del lavoro ad un maggiore coinvolgimento dei tecnici, impiegati e lavoratori coinvolti nel nuovo processo, e fornendo loro i necessari strumenti formativi e decisionali. Alla accusa di “volere cogestire”, il Coordinamento Sindacale ha risposto che gli “basterebbe venisse riconosciuto il ruolo del lavoro e si abbandonasse un approccio subalterno alla “tecnica” ed alle aziende esterne” valorizzando le capacità, conoscenze ed esperienze presenti in Marazzi. In data 23 dicembre 2009 viene firmato l’accordo presso la Regione Emilia Romagna, gli enti locali di Modena e Reggio Emilia interessati dalla presenza di siti produttivi del gruppo Marazzi, l’azienda e le rappresentanze sindacali. Nelle premesse dell’accordo viene dato atto del calo del fatturato, tra il 2008 e il 2009, nell’ordine del 25% prevedendo che tale trend negativo sarà destinato a perdurare a causa della crisi determinando una grave riduzione degli ordinativi. La capacità produttiva degli impianti del Gruppo Marazzi è stata utilizzata, nel corso del 2009, per il 56% e si ritiene che il calo dei volumi produttivi abbia assunto una rilevanza non più temporanea ma strutturale. Sulla base di questi dati e di queste considerazioni viene riconosciuta la necessità, per l’azienda, di ricorrere alla Cigs per crisi aziendale (“crisi per evento improvviso e imprevisto”). Si tenga presente che nel corso del 2009 Marazzi aveva già realizzato operazioni di riduzione del personale attraverso la cessione dello stabilimento di Anagni (FR), la riduzione del 25% del personale dirigente e l’apertura della procedura di mobilità per 130 lavoratori. La CIGS a zero ore, riguarderà contemporaneamente circa 400 dipenden96 ti, con possibilità di estensione della stessa all’intero organico di 1.740 lavoratori. La tempistica della messa in Cigs, per ciascun sito, dipenderà dall’attuazione del Piano Industriale Marazzi; viene previsto il sistema della rotazione (ovviamente solo se compatibile con le esigenze tecnico – produttive dell’azienda) ma solo per quei dipendenti che accetteranno il piano di ricollocazione. Per 230 unità viene attivata la procedura di mobilità applicando i due autonomi criteri della volontà espressa in sede sindacale e della pensionabilità (cioè per coloro che hanno maturato o matureranno durante il periodo di mobilità il diritto alla pensione). Per comprendere e valutare, quindi, l’esatta portata dell’accordo, è necessario approfondire l’esame del Piano Industriale Marazzi e del piano di ricollocazione del personale. Il Piano Industriale parte dai dati della riduzione del 25% del fatturato e della saturazione impianti del 56%. Dopo aver elencato i principi generali a cui si ispira, in continuità con il Piano presentato dall’azienda nel marzo 2009 (forte innovazione di prodotto, modernizzazione degli impianti, ottimizzazione organizzativa). Dichiara ormai strutturale la riduzione dei volumi prodotti negli impianti italiani a fronte di un miglioramento delle quote di mercato dei prodotti degli stabilimenti USA (seppur con cali di volume di vendita) e del mantenimento delle posizioni di quelli russi. Al contrario, la crisi ha colpito duro negli stabilimenti dell’Europa Occidentale accusati di criticità negli assetti produttivi per mancanza di sinergie e armonizzazioni organizzative e produttive; si riconosce altresì che i grandi volumi prodotti nel 2008 hanno mascherato le inefficienze strutturali. Obiettivo del Piano è quello di mantenere il presidio della fascia di prodotto di prezzo medio – bassa, ma puntando ad assumere una significativa presenza anche nella fascia medio alta e cercando anche nuovi sbocchi geografici. Come detto, aldilà dei principi generali a cui si sarebbe ispirato il Piano Industriale, nel concreto le scelte assunte prevedono: a) la cessazione dell’attività produttiva dello stabilimento di via San Lorenzo a Sassuolo e la sua trasformazione in piattaforma logistica con conseguente ricollocamento dei 114 dipendenti negli altri stabilimenti di Sassuolo, Fiorano, Finale Emilia; b) l’area decorazioni dello stabilimento Terzo Fuoco viene ridotta ad un turno giornaliero e 11 lavoratori ricollocati nei tre stabilimenti sopra detti; c) l’incorporazione dello stabilimento Mix Ceramiche nel Gruppo Marazzi; d) una riorganizzazione del personale impiegatizio – amministrativo 97 demandata ad uno specifico gruppo tecnico; e) per lo stabilimento di Iano l’impegno dell’azienda è quello di mantenerne la continuità produttiva anche attraverso l’individuazione di un acquirente (in grado di garantire prospettiva industriale e salvaguardia occupazionale); questa eventuale soluzione sarà verificata in apposito tavolo sindacale e istituzionale. Per il prossimo semestre l’attività produttiva di Iano viene ridotta a un forno e verrà avviata la procedura di ricollocazione presso altri stabilimenti per 70 persone. Per realizzare questa riorganizzazione l’accordo prevede il ricorso alla CIGS per 12 mesi e l’attivazione di una procedura di mobilità per 230 lavoratori, dei quali 80 impiegati e intermedi. A queste due misure si aggiunge uno specifico impegno sulla riqualificazione e formazione professionale come parte integrante del Piano Industriale. Infine, sul piano delle scelte organizzative, sul piano della logistica viene stabilita l’internalizzazione (insourcing) delle attività del magazzino spedizioni. 98 Inchiesta condotta alla Sadon Group di Vetto (Re)8 La Sadon in provincia di Reggio Emilia è presente con un sito produttivo (a Vetto) e con una palazzina uffici a Casalgrande. Nello stabilimento di Vetto le produzioni sono quelle dei battiscopa e dei pavimenti. Le difficoltà iniziano dal mese di gennaio quando, a fronte di un calo di ordinativi dovuto alle condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica, i lavoratori vengono messi in Cassa Integrazione Ordinaria. La produzione in condizioni di normalità riprende in febbraio ma da aprile (periodo di Pasqua) fino a maggio, sempre con la stessa motivazione del calo degli ordinativi, l’azienda ricorre ad altre due settimane di Cassa Integrazione Ordinaria. Da giugno l’azienda comincia a dire ai lavoratori che “la situazione non è certo rosea” e come primo effetto di questo mutato clima si ricorre alla dilazione del pagamento degli stipendi: il 20 del mese viene erogato un acconto ed il 5 del mese successivo viene liquidato il saldo. In questo modo l’azienda impegna meno liquidità e ai lavoratori lo stipendio viene saldato il mese successivo a quello di lavoro. In seguito l’azienda ha comunicato il mancato pagamento dei contributi del fondo Fonchim e così i lavoratori hanno perso un anno di contributi. Segno evidente che l’azienda manifestava una pericolosa crisi di liquidità. A fine luglio i lavoratori vengono messi nuovamente in Cassa Integrazione Ordinaria; da settembre in poi l’azienda rimanda continuamente la riapertura (prima aveva detto il 7 settembre, poi è slittato…) e così il periodo di Cassa arriva fino al 5 ottobre. In ottobre per circa 20 giorni i lavoratori riprendono la produzione ma il 28 l’azienda decide di presentare i libri in Tribunale chiedendo l’ammissione al concordato preventivo per cessazione di attività. Questa decisione viene vissuta come un fulmine a ciel sereno dai lavoratori per almeno due motivi: 1) l’azienda, ed in particolare uno dei proprietari, ripeteva sempre che “andava tutto bene” e che “non c’era niente di cui preoccuparsi”; 2) viene sottolineato che gli ordini ci sono sempre stati; cioè l’azienda non ha mai avuto problemi di mercato: “Gli ordini ci sono sempre stati; il lavoro c’era sempre..”; 8 In collaborazione con Mariachiara Conti e Annalisa Magri, Prc di Reggio Emilia. 99 Inoltre, pesa la decisione dell’azienda di avviare la procedura di ammissione al concordato preventivo in maniera unilaterale, cioè senza nessuna informazione preventiva né alcuna forma di concertazione con i sindacati e i lavoratori. “Hanno avviato tutto di nascosto, e continuavano a dire che andava tutto bene!”. A quel punto inizia il presidio dei lavoratori e gli incontri con le istituzioni locali. Il problema principale della Sadon viene individuato da parte dei lavoratori nella gestione finanziaria: “Il bilancio era sempre in pareggio o in rosso… per questo avevano sempre bisogno delle banche…e quando queste hanno chiuso i rubinetti è finita…” Quindi la motivazione del ricorso al concordato è “l’indebitamento dell’azienda…non certo per mancanza di lavoro, quello non è mai mancato”. In precedenza erano state anche realizzate innovazioni e investimenti importanti: da 5 anni è stato realizzato il reparto che produce anche pavimenti arricchendo, quindi, la produzione che prima prevedeva solo il battiscopa. Parte della produzione che precedentemente era localizzata nello stabilimento di Albinea è stata trasferita proprio nel sito di Vetto (ad Albinea c’erano problemi di carattere urbanistico in quanto la destinazione d’suo produttiva della fabbrica non era più compatibile con il PRG e quindi lo stabilimento è stato dismesso e la produzione trasferita a Vetto). La chiusura di Albinea ha determinato qualche esubero tuttavia gestito senza traumi sociali con un po’ di ricollocamenti e di incentivi. Non è stato realizzato, invece, l’atomizzatore che nelle industrie ceramiche rappresenta un impianto di grande rilevanza per il ciclo produttivo in quanto è quello che produce la “miscela”, cioè la materia prima per le lavorazioni dello stabilimento. In assenza di atomizzatore la miscela viene comprata e stoccata in un silos. Il progetto di produrre direttamente la materia prima avrebbe consentito allo stabilimento di Vetto di diventare autonomo evitando di ricorrere a fornitori esterni per questo materiale. Il risparmio sarebbe stato notevole sia di carattere economico (la Sadon non avrebbe più acquistato sul mercato il prodotto) e ambientale (si sarebbe drasticamente ridotto il numero di camion attraverso i quali lo stabilimento veniva giornalmente rifornito di questo materiale. Inoltre questo investimento, oltre ad un importante consolidamento e rafforzamento dal punto di vista industriale – impiantistico, avrebbe comportato anche un certo numero di nuove assunzioni da impiegare nelle produ100 zioni dell’atomizzatore. Invece questo importante investimento, già progettato, è rimasto nel cassetto… I lavoratori insistono molto sulla cattiva gestione aziendale che ha determinato l’attuale situazione di crisi. Eppure, sottolineano “La Sadon ha pressoché il monopolio del prodotto “battiscopa”…inoltre è una azienda molto conosciuta, i suoi prodotti sono molto apprezzati e venduti…non ci sono mai stati problemi di vendite e di ordini..” Ma a cosa è dovuta questa situazione che ha portato l’azienda a portare i libri in Tribunale? “alla incapacità gestionale”. La Sadon Ceramiche è di proprietà di due famiglie che “non hanno mentalità imprenditoriale…non hanno saputo gestire…volevano solo sentirsi dire che tutto andava bene anche quando bisognava introdurre dei correttivi..” “un imprenditore dovrebbe essere lungimirante, non può sempre lavorare con le banche. La Sadon dipendeva sempre dai finanziamenti delle banche…” “un imprenditore dovrebbe essere previdente, non possono esserci sempre tempi di vacche grasse…dovrebbe prepararsi anche per i momenti di crisi…se fai tanti utili quando il mercato va bene, allora deve preparati anche per quando potrà andare peggio…se non risparmi poi in tempo di crisi non ti resta niente…” Cosa significa, in concreto, la mancanza di lungimiranza e di programmazione? “Significa che quando altre imprese del settore ceramico hanno un po’ ridimensionato la produzione, magari ricorrendo all’utilizzo di Contratti di Solidarietà, qui non si è utilizzata questa strada…con il ricorso ai Contratti di Solidarietà avrebbero alleggerito il peso economico del pagamento degli stipendi, avrebbero fruito di sgravi fiscali, insomma avrebbero ridotto le spese per un ceto periodo…” Oltre alla riduzione dei costi relativi al pagamento degli stipendi, un “raffreddamento dell’attività produttiva avrebbe consentito di ridurre anche altre forme di impegno economico “ad esempio si sarebbe ridotta la produzione e il magazzino, …cioè avrebbe ridotto i costi di gestione del magazzino..” Per i lavoratori il Contratto di Solidarietà avrebbe costituito la risposta più ragionevole ad una fase meno positiva rispetto agli anni scorsi: “I contratti di solidarietà ti mantengono comunque al lavoro; certo lavori meno e prendi uno stipendio più basso..ma non sei a casa..continui a lavo101 rare e anche la fabbrica continua a funzionare…non viene chiusa del tutto…” Questa proposta, cioè quella di “raffreddare” un po’ la produzione attraverso il ricorso allo strumento dei Contratti di Solidarietà è stata avanzata dalle RSU di stabilimento e dalla Filcem Cgil “che sono state molto più lungimiranti e realistiche della proprietà…”. Ma l’azienda non ha mai concretamente deciso cosa fare, “l’ha sempre tirata per le lunghe…non ha mai deciso se accettare o meno la proposta..” Della proprietà viene espressa una forte critica: “hanno una mentalità di 40 anni fa…vuole essere sempre il solito padre – padrone…” I lavoratori rivendicano, oltre alla loro professionalità, una capacità ed una competenza che vanno oltre le mere mansioni di produzione: “Qui la gente sapeva fare il proprio lavoro…e vedevano quello che non andava e bisognava cambiare…Tutto quello che non andava veniva detto ai padroni, ma questi non ascoltavano niente; volevano solo sentirsi dire che andava sempre tutto bene!”. L’azienda, circa tre anni fa, decise di assumere un consulente esterno che immediatamente segnalo alla proprietà quali erano le criticità dell’azienda, “era uno con le palle..che sapeva le cose e le diceva..e per questo è stato fatto fuori!”. “Il problema di questa azienda non erano gli operai che non lavoravano… quelli hanno sempre lavorato e bene! il problema era la cattiva gestione della proprietà”. Al contrario di altri casi, con i consulenti esterni calati in situazioni che non conoscono e che rimangono loro estranee portandoli ad introdurre modifiche avulse dalla realtà e spesso controproducenti, del consulente assunto dalla Sadon vengono espressi giudizi molto positivi: “Era sempre sulle linee di produzione, vedeva subito quando qualcosa non funzionava e lo segnalava subito…ad esempio capiva subito quando il materiale non andava bene…era sempre in mezzo ai lavoratori, parlava con noi e ci ascoltava.(…) Girava sempre tra gli operai e ci metteva nelle condizioni migliori per lavorare bene.” “Ma il proprietario non voleva sentirsi dire queste cose, non voleva che gli segnalassero gli aspetti critici, per lui doveva andare sempre tutto bene anche quando gli dicevano che qualcosa non andava bene e andava corretto…”. Insomma, per i lavoratori l’azienda “era sempre rimasta al solito livello familiare, e le cose dovevano sempre andare bene..”. Il consulente, grazie alle proprie competenze, era in grado di intervenire segnalando le maggiori criticità che si riscontravano a livello di organizza102 zione del ciclo produttivo intervenendo sulla organizzazione del lavoro: “era stato in grado di darci un metodo di lavoro” e sugli aspetti più tecnici come il funzionamento dei forni che, in una azienda ceramica, rappresentano un elemento importantissimo del ciclo produttivo: “con lui i forni funzionavano benissimo, mai un errore; da quando lo hanno mandato via sono cominciati i problemi nel funzionamento dei forni…”. Dal punto di vista delle Relazioni Sindacali il confronto periodico avveniva con il “capo fabbrica” e i consulenti dell’Associazione di Categoria dell’impresa. Nell’ultima fase avvenne con i consulenti dell’impresa che ormai ne stavano curando la procedura di concordato, cioè con quelli che i lavoratori chiamano “i becchini”. In questa fase la trattativa sta avvenendo con il liquidatore. La Sadon, infatti ha 144 dipendenti, si colloca sotto la soglia dei 200 dipendenti e pertanto ad essa non è applicabile la “legge Prodi bis” in materia di salvataggio di imprese. Su questo aspetto, quindi, sottoponiamo a verifica la fondatezza ed il reale possibile utilizzo di una nostra proposta di legge di estensione della “Prodi bis” anche alle imprese con meno di 200 dipendenti attribuendo alle Regioni le competenze in materia. Il livello di sindacalizzazione della fabbrica viene definito come “buono”: il 60% dei lavoratori sono iscritti alla Filcem Cgil e qualcuno alla Cisl. Della Filcem Cgil come categoria viene espresso un giudizio molto buono “sono loro che hanno seguito, da subito, la vertenza”, i funzionari della Filcem, infatti, seguono con continuità le vertenze della zona e dai lavoratori questo viene apprezzato anche per il livello di competenze che la categoria esprime nelle varie fasi della vertenza. Il livello di conflittualità viene definito come “buono”, nel senso che le iniziative assunte dalla Rsu e dal sindacato vengono seguite dai lavoratori che vi partecipano direttamente e in maniera compatta. L’obiettivo che i lavoratori si sono dati è quello di tenere viva l’attenzione “sperando che qualcuno acquisti l’azienda”. Per i lavoratori la natura del possibile e auspicabile acquirente non è indifferente rispetto alle sorti stesse della fabbrica e dei lavoratori: “Ad acquistare deve essere una azienda seria, non una s.r.l. che non fornisce adeguate garanzie.” “In questo senso non può andare bene la proposta di acquisto di una società finanziaria, come la Fenice, ci deve essere una proposta fondata su un Piano Industriale serio perché questa è una realtà produttiva e sociale da tutelare, sulla quale non si deve speculare”. Le istituzioni locali hanno assunto un atteggiamento diverso: mentre il Co103 mune di Vetto e la Comunità Montana hanno seguito da subito la vertenza manifestando pieno sostegno alle ragioni dei lavoratori; la Provincia ha organizzato un incontro attraverso un Tavolo di confronto che tuttavia non ha suscitato apprezzamento da parte dei lavoratori. Il Comune di Vetto e la Comunità Montana, tuttavia, al di là del sostegno espresso non dispongono di grosse risorse economiche e quindi risulta per loro difficile garantire un aiuto materiale ai lavoratori in cassa integrazione. In data 4 novembre viene firmato un accordo tra Azienda e Rappresentanze Sindacali nel quale si da atto che “In data 23/10/2009 a causa di un progressivo calo di ordinativi e di una situazione finanziaria sempre più critica per il forte indebitamento l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione della stessa …”. Nel testo dell’accordo “le parti ritengono sia verificata la sussistenza degli elementi richiesti in riferimento ai criteri per l’approvazione della Cigs per “crisi aziendale per cessazione attività” e che “sarà pertanto richiesto per un numero massimo di 141 dipendenti a cui vanno aggiunti 3 apprendisti (…) il trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore per cessazione di attività della durata di mesi 12”. Si ricorre alla Cassa per l’intero organico, ma “per una parte del personale, la decorrenza della Cigs sarà funzionale al completamento delle attività tecniche ed amministrative necessarie al miglior svolgimento della procedura, alle attività necessarie per ottemperare agli obblighi conseguenti al rispetto degli ordini di prodotto da evadere ed i successivi obblighi conseguenti allo spegnimento degli impianti produttivi e, comunque, successivamente al godimento delle ferie maturate.” Per i lavoratori si profila una situazione particolarmente difficile in quanto “l’Azienda, a causa dell’assoluta mancanza di liquidità e in considerazione della situazione di forte indebitamento citata in premessa, non sarà in grado di anticipare ai lavoratori alle normali scadenze di paga il trattamento di integrazione .’salariale, pertanto avanzerà richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale nella misura prevista a carico I.N.P.S.” L’accordo prevede che “le eccedenze di organico sopra evidenziate saranno affrontate con l’attivazione di un piano di gestione degli esuberi volto a supportare, mediante azioni ed interventi concreti, la ricerca di una nuova collocazione lavorativa per il personale in Cigs., con coinvolgimento delle Parti Sociali e dei soggetti pubblici e privati preposti o autorizzati alla ricerca, segnalazione e collocamento, nonché alla formazione all’aggiornamento ed alla riqualificazione professionale del personale. Il piano di gestione degli esuberi, di durata annuale, (…) farà leva sui seguenti principali strumenti ed interventi:. a. l’azienda si impegna a proseguire la ricerca di tutte le soluzioni imprenditoriali, nell’ambito del settore ceramico, che consentano la continuazione dell’attività (…); b. allo scopo di ridurre l’impatto sociale della cessata attività, le parti concordano che 104 (…) attraverso l’apertura di apposite procedure l’azienda potrà procedere alla collocazione in mobilità esclusivamente per i lavoratori che manifestassero interesse verso tale soluzione. c. l’Azienda si impegna. ad attivarsi nelle sedi e nelle forme più opportune, (…) per la segnalazione dei profili professionali di tutti i lavoratori collocati in Cigs. nei confronti delle aziende e dei clienti con le’ quali intrattiene rapporti; d. in riferimento a quanto sopra, le parti collaboreranno all’individuazione delle competenze professionali più richieste nel mercato del lavoro locale, al fine della progettazione e realizzazione di eventuali interventi formativi, (…) finalizzati all’accrescimento dell’occupabilità dei lavoratori attualmente in esubero (…); f. Confindustria Ceramica, sempre ad integrazione di quanto già convenuto fra le parti circa il piano aziendale di gestione degli esuberi, si impegna ad attivarsi, (…) per la segnalazione dei profili professionali di tutti lavoratori collocati in Cigs. o in mobilità, raccordandosi opportunamente con i Centri per l’impiego competenti; g. eventuali assunzioni presso aziende terze attraverso periodi ’di distacco dalla Cigs finalizzati alla ricollocazione presso le stesse aziende terze come previsto dalle normative vigenti.” Nella serata di giovedì 12 novembre il Consiglio Comunale di Vetto approva un documento che sottolinea che “lo stabilimento Sadon appartiene alla storia economica di Vetto d’Enza e del Distretto, avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del comprensorio, garantendo da sempre una buona offerta qualitativa e quantitativa in termini occupazionali (…) un sito produttivo di qualità per gli impianti, i prodotti lavorati, le maestranze e tutte le professionalità che sono impiegate”. Il consiglio comunale di Vetto, nell’esprimere la solidarietà di rito a tutti i lavoratori coinvolti e ai loro familiari, al tempo stesso chiede “alla proprietà della Ceramiche Sadon S.p.A di proseguire il confronto nei tavoli istituzionali preposti al fine di scongiurare la perdita di numerosi posti di lavoro, tenendo conto delle severe conseguenze economiche e sociali che tale decisione avrebbe su Vetto e sull’intero distretto.” Nel documento approvato dal Consiglio Comunale e, sostanzialmente, presentato e illustrato da Rifondazione Comunista, viene sostenuta “la necessità di predisporre un serio piano industriale – valutato dai lavoratori tramite referendum – in modo da riqualificare le produzioni, diversificale, migliorarle in modo da tutelare tutti i posti di lavoro per mantenere un tessuto manifatturiero nel territorio.”. Ma l’elemento più importante del documento deliberato dal Comune di Vetto è il passaggio in cui si sostiene “la necessità di un piano industriale per l’intero distretto della ceramica con al centro la qualità delle produzioni, la ricerca e l’innovazione, il tutto finalizzato alla difesa dell’occupazio105 ne.” La richiesta che si cominci a lavorare per predisporre un piano industriale d’area è una precisa posizione espressa da Rifondazione Comunista come elemento di programmazione pubblica delle produzioni industriali con specifiche finalità occupazionali. Importante appare anche il passaggio in cui il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta di Vetto a “vincolare ad uso esclusivamente produttivo/ industriale le aree attualmente occupate da dette attività.” Anche questo aspetto è parte della campagna sul lavoro di Rifondazione Comunista: il vincolo delle aree a destinazione d’uso esclusivamente produttiva/industriale è espressamente finalizzato ad evitare fenomeni speculativi: cioè ad evitare che la proprietà decide di dismettere gli impianti per poi ottenere, magari con qualche amministrazione compiacente, una variante urbanistica per rendere edificabile l’area destinandola a funzioni residenziali o commerciali. Alla politica, ed in particolare a Rifondazione Comunista, da parte dei lavoratori viene chiesto di “tenere viva l’attenzione, in modo che la crisi Sadon abbia adeguata visibilità”. Rifondazione è intervenuta da subito nella crisi partecipando al presidio, organizzando un banchetto di raccolta fondi, distribuendo un volantino e partecipando, con un documento al Consiglio Comunale di Vetto che poi ha sostanzialmente approvato il documento illustrato dal Prc. 106 Appunti per una possibile iniziativa del Partito della Rifondazione Comunista nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia L’aspetto sindacale La lettura della crisi che ha investito il settore ceramico da parte della Cgil può essere articolata in tre punti che corrispondono ad altrettante fasi temporali della crisi e delle sue conseguenze: 1. Le aziende del distretto ceramico di Reggio e Modena hanno conosciuto i primi effetti della crisi a partire dall’autunno del 2008. Il primo effetto della crisi si è tradotto nella decisione delle aziende di ridurre gli organici e si è scaricato sui lavoratori precari delle aziende del distretto: per ridurre i costi di produzione le aziende sono ricorse al mancato rinnovo dei contratti dei precari. I precari nel distretto della ceramica sono presenti sia nel ciclo di produzione (diretti) sia nelle produzioni indirette. La seconda categoria di lavoratori colpita immediatamente, assieme ai precari, è costituita dai lavoratori delle cooperative che gestiscono alcuni servizi connessi al ciclo produttivo, come la logistica. Quindi precari e lavoratori di cooperative di servizi, hanno perso il lavoro come conseguenza delle aziende di ridurre gli organici attribuendo le mansioni svolte precedentemente da queste figure lavorative ai propri dipendenti. 2. In una seconda fase, cioè dopo il ridimensionamento occupazionale derivante dalla riduzione di precari e indiretti, la crisi è stata affrontata con la sospensione della produzione grazie ad un massiccio ricordo alla Cassa integrazione. Il rallentamento produttivo e la gestione delle giacenze di magazzino (che hanno determinato scorte di prodotto di svariati mesi - 10/12 mesi) hanno indotto le aziende a richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali per far fronte alla fase che si era determinata. 3. Dopo l’estate del 2009 è iniziata una terza fase di gestione della crisi. Si tratta della fase più delicata perché le aziende hanno aperto un processo di pesante ristrutturazione per definire un loro possibile assetto post-crisi. Esistono situazioni strutturali di almeno due tipi: a) le aziende si propongono di realizzare dismissioni di stabilimenti (ad esempio per la Marazzi la chiusura di Jano e di via Moro a Sassuolo) per concentrare la produzione in un numero ridimensionato di siti produttivi; b) molte aziende hanno seri problemi finanziari (problemi di sottocapitalizzazione, vedi la vicenda 107 Italgraniti: si tratta di una fabbrica con 500 dipendenti, con una produzione di alta gamma, buoni impianti ecc…ma ha difficoltà finanziarie). Inoltre, sempre più spesso, a fronte di situazioni di difficoltà, anziché intervenire per affrontare nel merito i problemi, si preferisce ricorrere alla liquidazione dell’Azienda (per non pagare i debiti) o alla formula del concordato preventivo; spesso da questi fallimenti nascono nuove società che subentrano alle precedenti senza, tuttavia, i costi delle situazioni precedenti grazie alla ristrutturazione/riduzione del debito derivante dalla procedura di concordato. Mantenimento dei siti produttivi Il primo obiettivo da perseguire è innanzitutto quello del mantenimento di tutti i siti produttivi del distretto, cioè mantenere le strutture industriali, la continuità delle produzioni per ottenere risultati occupazionali. Si tratta, quindi, di mantenere la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti impendendo che alcuni siti vengano chiusi: su tutti valga l’esempio del Gruppo Marazzi che intende realizzare una pesante operazione di ristrutturazione industriale attraverso un forte ridimensionamento del numero dei propri stabilimenti sul territorio. E’ evidente, infatti, che la chiusura di uno stabilimento comporterebbe un forte indebolimento del “vincolo sociale” che lega una impresa ad un territorio. Il fatto di concentrare le produzioni in un numero inferiore di siti produttivi lascia presagire anche un progressivo disimpegno dagli investimenti, dalla qualificazione delle produzioni ecc. con la prospettiva di ulteriori ridimensionamenti produttivi e occupazionali. Inoltre, l’abbandono e la dismissione di stabilimenti produttivi, sui quali magari sono stati realizzati investimenti e sono state realizzati impianti di servizio e infrastrutture, rischia di determinare un impoverimento impiantistico e tecnologico del territorio; lasciando al proprio destino strutture ed impianti che invece sono pienamente nelle condizioni di poter funzionare non si persegue certo una politica di valorizzazione del patrimonio impiantistico/industriale e di valorizzazione delle produzioni e delle competenze del territorio. Dare concretezza alla dimensione distrettuale attraverso una programmazione e politiche industriali da realizzare a questo livello Il secondo obiettivo è quello di impostare il ragionamento in una logica complessiva di distretto. 108 In questo distretto l’80% del lavoro è legato alla ceramica, compreso l’indiretto che lavora sempre per questo settore, basti pensare a tutti i servizi logistici che vengono svolti. Ma anche altri settori industriali sono strettamente legati al ceramico: si pensi a molte produzioni meccaniche che realizzano macchinari che vengono utilizzati nei processi produttivi delle ceramiche. Ragionare in termini di distretto significa ricostruire tutta la filiera produttiva che, come visto, dalla ceramica si allarga fino a coinvolgere altre funzioni e settori produttivi e ricostruire un quadro delle produzioni specifiche del settore ceramico per cominciare a definire un ragionamento di politica industriale del settore ceramico stesso. Ragionare in una logica di distretto significa valorizzare gli elementi di programmazione anche in un’ottica di orientamento pubblico delle scelte e di cooperazione tra operatori economici. Si tratterebbe di fare il quadro delle produzioni insediate e dei volumi produttivi; delle prospettive future sia in termini di tipologia di prodotto che di possibili volumi produttivi e su questi impostare delle scelte. Per questo andrebbe immediatamente costituito un Tavolo di Distretto con la presenza delle Organizzazioni delle Imprese, delle Organizzazioni Sindacali e di forme di rappresentanza dei lavoratori (es. un coordinamento di Rsu), Enti Locali, Regione Emilia Romagna, Università e centri di ricerca. Ricerca, Innovazione, Investimento in alternativa alla logica del ridimensionamento produttivo e occupazionale Il terzo obiettivo è quello di fare in modo che l’approccio con cui si costruisce l’uscita dalla crisi non sia quello del ridimensionamento impiantistico e occupazionale; quello della mera riduzione dei costi (scaricato, soprattutto, sul fattore lavoro), ma, al contrario, sia quello della qualificazione dei processi produttivi in termini di qualità del prodotto e dei processi produttivi stessi. La vertenza Marazzi rischia di essere una vertenza “apripista”: cioè se si impone il modello Marazzi della chiusura dei siti produttivi, molte altre saranno le aziende che si inseriranno in questo processo determinando una chiusura a catena di stabilimenti con il conseguente impoverimento occupazionale e industriale del distretto. Al contrario, un progetto di distretto, incentrato sulla ricerca, sull’innovazione su investimenti di qualità può costituire un punto di riferimento per l’uscita dalla crisi alternativo a quello incentrato esclusivamente sulla logica del disimpegno. 109 Un esempio di politiche di innovazione, anche in quadro ambientale, può essere costituito dal “Protocollo per il Controllo e la Riduzione delle Emissioni Inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia” la cui implementazione potrebbe sviluppare interventi di ricerca, di applicazione della stessa e quindi di investimenti in termini di innovazione e miglioramento dei processi produttivi. Energia e Trasporti L’aspetto energetico è un elemento centrale nel settore dell’industria ceramica in considerazione delle elevate quantità di energia che tali processi industriali impiegano. Sul settore dell’energia e dei relativi costi, quindi, si possono programmare politiche energetiche finalizzate a garantire le necessarie forniture energetiche in una logica di distretto. Questo significa che: - gli impianti di produzione energetica esistenti, anziché produrre per il mercato dell’energia devono produrre prioritariamente per servire il fabbisogno energetico delle produzioni del distretto ceramico anche attraverso la costituzione di un consorzio di imprese che metta insieme tutti gli impianti di produzione di energia e attraverso un Accordo complessivo definisca le condizioni commerciali e industriali di fornitura; - tale consorzio si attrezzi immediatamente per la prossima probabile gara che l’Eni potrebbe bandire per la cessione di gas metano: in questo modo, acquisendo direttamente rilevanti quantitativi di gas, l’intera filiera energetica a servizio dell’industria ceramica sarebbe pressoché completata. In questo ambito non possono, tuttavia, essere fatte concessioni a progetti pesantissimi dal punto di vista ambientale come il progettato – contestatissimo dalle popolazione locali – del deposito di Gas a Rivara in provincia di Modena. Dal punto di vista della logistica si assume come prioritaria: - la realizzazione, il completamento e il rafforzamento degli Scali di Marzaglia e Dinazzano che vanno collegati alle infrastrutture esistenti garantendo priorità ai collegamenti ferroviari; - la realizzazione di “transit point” tra Sassuolo e Scandiano progettati e realizzati per ridurre i viaggi su gomma e ottenere benefici ambientali (riduzione emissioni), di viabilità e di costi economici per il distretto; piattaforme logistiche per ridurre le percorrenze e aumentare la saturazione dei TIR utilizzate non solo per lo smi110 - stamento dei materiali ma anche per l’immagazzinamento delle merci e l’approntamento delle spedizioni; il potenziamento, adeguata infrastrutturazione, del Porto di Ravenna quale piattaforma logistica per le spedizioni delle merci prodotte. Piano Industriale d’Area Distrettuale I ragionamenti – appena abbozzati e indicati pressoché solo per titoli – delle parti precedenti, non possono che trovare una adeguata sistemazione in un Piano Industriale d’Area nel quale si assumano come capisaldi: - dal punto di vista sociale e occupazionale: l’applicazione delle parti del “Patto per attraversare la crisi” finalizzate alla tutela del lavoro e ad evitare il ricorso ai licenziamenti attraverso tutti gli strumenti che la normativa mette a disposizione (“L’impegno ad operare per la salvaguardia dell’occupazione”); - il mantenimento e la qualificazione, attraverso opportuni investimenti, di tutti i siti produttivi del distretto; - la definizione di obiettivi e percorsi di realizzazione relativi ad aspetti ambientali, energetici, logistici come sopra indicati; - la definizione, a livello regionale, di strumenti di intervento di reindustrializzazione, riqualificazione, riconversione o diversificazione produttive delle aziende in crisi attraverso un intervento, da realizzarsi attraverso una società pubblica regionale, nella forma del venture capital finalizzata al risanamento finanziario e al rilancio industriale produttivo delle unità industriali in crisi con la prospettiva di una loro futura ricollocazione sul mercato. Proposta di “Inchiesta” sul distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia9 Soggetti da coinvolgere: Rsu (lavoratrici e lavoratori), funzionari sindacali e, se avremo la possibilità, qualche imprenditore o associazioni di categoria Modalità: attraverso colloqui su uno schema preordinato dal quale partire, per poi allargare la discussione e l’indagine a seconda anche della predisposizione e del livello di conoscenza degli intervistati Argomenti: • Assetti proprietari e concentrazione del capitale in pochi grandi gruppi (acquisizioni dentro e fuori il distretto, in Italia come all’estero); • Ruolo delle banche negli assetti proprietari come sul piano dell’accesso al credito (caso Marazzi, ad esempio) 9 Proposta elaborata da Marcello Graziosi, Prc di Modena 111 • • • • • • • • Accesso alle materie prime, volumi di merce prodotti e principali mercati di sbocco Ristrutturazioni aziendali e nuove tecnologie, con relativo impatto sui processi produttivi e le possibili conseguenze occupazionali e sociali Processi produttivi interni ed esterni al luogo di lavoro, diversa condizione dei lavoratori e reciproche relazioni, attuale composizione della classe lavoratrice Livelli salariali Quale ruolo del sindacato nei luoghi di lavoro, quale la sensazione rispetto alle politiche contrattuali (nazionali come aziendali) Indotto: peso, ruolo della piccola e media impresa, livelli occupazionali e composizione di classe Qualità della vita nel distretto: dove vivi, qualità dell’aria, livelli di inquinamento percepiti, traffico, quantità e qualità dei servizi sociali, qualità urbana ed edilizia Il rapporto con l’ambiente nel quale vivi Questa “Inchiesta” potrebbe essere un elemento fondamentale per elaborare una proposta politica in grado di incidere nella vita concreta di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Tutta la prima parte riguarda più che altro gli assetti del capitale economico come finanziario sul distretto, mentre la seconda parte ci consentirebbe di riflettere sulle modalità attraverso le quali il capitale tenta di uscire dall’attuale crisi, valutandone le conseguenze dal punto di vista del lavoro e della società. Parte non trascurabile è anche quella relativa ad ambiente e qualità della vita, passaggio fondamentale in una società complessa come la nostra e che nel distretto ceramico acquista ulteriori elementi di centralità. E’ evidente che questo progetto richiede impegno e tempo: difficilmente si potrà avere un quadro in tempi brevi, ma potremmo comunque tentare di impostare un lavoro a medio-lungo termine, dando volta per volta risultati anche parziali. 112 Per un progetto di intervento sui principali distretti tessili-abbigliamento-calzaturiero del Nord Per impostare un progetto di intervento politico sui principali distretti del tessile – abbigliamento – calzaturiero (t.a.c.) del Nord, appare necessario, innanzitutto inquadrare le zone geografiche in cui sono localizzati, le specializzazioni produttive e qualche dato di carattere industriale ed economico. Successivamente, vanno individuati alcuni strumenti di concertazione e indirizzo definiti tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria. Per quanto concerne il primo aspetto si riportano le descrizioni dei principali distretti T.a.c. del Nord offerte dal portale dei Distretti Italiani (www.distretti.org). Si tratta di un sito ricchissimo di documentazione e notizie che riceverà ulteriore impulso e qualificazione anche dalla imminente costituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Distretti. Per chi si occupa di distretti industriali e degli intrecci tra produzione, lavoro e territorio, si tratta di uno strumento informativo e di lavoro assolutamente imprescindibile. Ecco, quindi, come il portale dei distretti presenta quelli principali del settore t.a.c. Distretto Veneto. Il Distretto si estende da Valdagno (Provincia di Vicenza) a Treviso, nella cui provincia riguarda oltre trenta Comuni, ma comprende anche alcune realtà ed aziende delle province di Padova e Venezia. L’industria dell’abbigliamento veneta presenta una forte bipolarizzazione tra imprese piccolepiccolissime e medio-grandi. Treviso ospita infatti diverse importanti realtà produttive, come Benetton, Stefanel, Fashion Box, Lotto e Diadora; intorno a Vicenza è possibile individuare un territorio circoscritto ad elevata concentrazione di imprese operanti nel settore moda, tra cui spiccano Marzotto e Diesel. La propensione all’export è molto forte e la qualità di prodotto elevata: per quest’ultima ragione, il cliente estero gradisce un rapporto fiduciario diretto con il produttore veneto. Pur essendo le vendite concluse direttamente in Italia, a volte sono presenti anche appoggi a proprie forze di vendita all’estero ed in certi casi si costituiscono società con partner stranieri. L’attenzione al cliente e all’evoluzione dei suoi gusti ed esigenze sono molto marcati: questo orientamento e l’impegno alla salvaguardia del made in 113 Italy, fanno sì che la fase di design e concettuale venga assolutamente mantenuta nel territorio. Questo anche perché sono richieste grande versatilità in termini di skill e di organizzazione, largamente presenti ora sia nei lavoratori, sia nelle direzioni aziendali venete; c’è inoltre la consapevolezza che l’aumento della cultura tecnica e organizzativa sia indispensabile per contenere i costi di produzione; quest’ultima esigenza fa aprire comunque anche diverse unità all’estero, collegate alla casa madre con sistemi a rete, spesso appoggiati su moderni sistemi di telecomunicazione. Il settore tessile e dell’abbigliamento, pur costituendo un Distretto nella zona pedemontana veneta, è diffuso un po’ ovunque ed è quindi più presente di altri settori. Distretto Laniero di Biella: imprese 1.500; occupati 25.000. L’intera area di Biella, che si estende su di un territorio di 930 kmq comprende ottantadue Comuni della zona nord-orientale del Piemonte e costituisce, fin dagli inizi dell’Ottocento, uno dei maggiori centri mondiali dell’industria laniera, con una ulteriore specializzazione nel settore meccanotessile, cioè nella produzione di macchine per l’industria tessile. Il sistema produttivo biellese ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni settanta, passando da un’organizzazione della produzione di tipo verticale, cioè con tutto il ciclo produttivo svolto all’interno della stessa impresa, a una di tipo orizzontale, con la specializzazione delle singole aziende per fasi di produzione. Ciò ha comportato un forte rinnovamento tecnologico, in cui rivestono un ruolo strategico i fattori legati da un lato al design e dall’altro ai canali di commercializzazione. Attualmente il biellese è forse il polo laniero più qualificato del mondo, con tessuti e filati che dominano ogni mercato grazie a qualità e competitività dei prodotti. Tra le ragioni di questo successo, vi è la validità dell’imprenditoria locale, la qualità del prodotto e del patrimonio tecnologico e professionale. Nelle molte aziende della zona trovano applicazione i macchinari e le lavorazioni più sofisticate; al tempo stesso qui confluiscono le fibre più preziose, prodotte in loco e selezionate all’origine in molti Paesi del mondo. Le esportazioni di preziosi tessuti di lana (kashmir, alpaca, vigogna), di lini, cotoni e nuovissime stoffe ma anche di macchine per filatura, per tintoria e finissaggio, sono dirette verso i mercati di Germania, Francia, Giappone, Regno Unito, USA. Le produzioni principali riguardano i tessuti per abbigliamento maschile e femminile e i filati per tessitura e per maglieria; sono poi presenti altri comparti quali maglifici, biancheria per la casa, abbigliamento sportivo, i non-tessuti, oltre che tutte le lavorazioni ausiliarie della filiera tessile laniera (pettinature, tintorie, finissaggi ecc.). 114 Distretto tessile di Oleggio-Varallo pombia (No). Il settore tessile abbigliamento, pur essendo molto diversificato, costituisce una colonna portante per l’economia della provincia di Novara. I Comuni con il maggior numero di unità locali e di addetti sono Novara, Galliate Oleggio e Varallo Pombia. Con riferimento alla dimensione aziendale si può osservare la prevalenza di realtà imprenditoriali medio- piccole: nella fascia che include le imprese con un numero di addetti tra 1 e 9, si concentra il 93% delle imprese novaresi, mentre l’incidenza della classe con più di 100 addetti è limitata allo 0,33%. Questo vasto numero di piccole imprese si è formato attraverso il processo di esternalizzazione di alcune fasi di lavorazione, attuato dalle imprese di maggiori dimensioni, al fine di snellire il processo produttivo e rendere certi i costi di produzione. Le piccole e medie aziende conservano un ruolo di primo piano nella struttura produttiva locale grazie alla loro flessibilità e alla capacità di adattarsi alle trasformazioni ambientali. L’elevato numero di queste aziende e la forte concentrazione territoriale hanno contribuito all’individuazione di un distretto industriale del tessile abbigliamento nei Comuni attorno a Oleggio e Varallo Pombia. Si tratta di aziende contoterziste, per lo più artigiane, caratterizzate da una forte dipendenza da uno o pochi committenti, da un’attività lavorativa ormai solo stagionale, da un’automazione di processo molto limitata, e da un elevato impiego della manodopera. La situazione di crisi in cui si trovano le imprese di confezione di costumi da bagno è dovuta soprattutto al fenomeno della delocalizzazione produttiva, per il quale gran parte delle fasi della lavorazione vengono effettuate nei Paesi a basso costo di lavoro. Il 90% delle imprese artigiane del settore in questione operano in subfornitura; esse quindi rappresentano una parte significativa per il tessuto novarese e svolgono un ruolo essenziale come fonte di occupazione e di reddito. Distretto tessile della Val Seriana (Bg). La tradizione tessile della val Seriana è strettamente legata a quella della città di Bergamo e della lavorazione della seta che ha rappresentato, per secoli, la risorsa economica primaria della provincia bergamasca. Il tessile in val Seriana assume però una connotazione propriamente industriale a partire dagli anni sessanta. La superficie complessiva del Distretto è di 118 kmq; esso comprende dieci comuni, tutti localizzati in Provincia di Bergamo, il più importante dei quali è Albino. La maggior parte delle aziende che operano nel settore di specializzazione, il tessile, è concentrata nella tessitura di filati tipo-cotone, nel confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario e nel confezionamento di tappeti e moquet115 tes. Il Distretto della val Seriana è caratterizzato dalla presenza di una manodopera tipicamente molto specializzata e scarsamente scolarizzata e da forti differenze rispetto alle dimensioni delle aziende: le imprese piccole e piccolissime sono spesso specializzate in un’unica fase del processo produttivo, impegnano strutture e investimenti minimi, vendono i propri prodotti direttamente ai pochi committenti, non hanno contatto con il mercato e lavorano su margini bassissimi e spesso imposti; le medie imprese, che operano principalmente nella filatura e tessitura, producono soprattutto contoterzi e riescono a fornire qualità media e a manifestare una certa dinamicità e un gruppo di imprese leader, infine, che controlla la dinamica innovativa investendo in centri di ricerca, esprimendo attenzione verso i cambiamenti e implementando l’organizzazione del processo produttivo e le tecnologie. Negli ultimi cinque anni il Distretto ha perso 3.000-4.000 posti di lavoro, soprattutto nel comparto delle confezioni. La lavorazione dei prodotti di media qualità si è spostata all’estero, perlopiù in Romania e nel nord dell’Africa, provocando un generale ridimensionamento, in particolare nell’abbigliamento. Distretto della calzetteria di Castelgoffredo (Mn). Il Distretto di Castelgoffredo, capitale italiana della calza, copre quella porzione di territorio geograficamente collocabile nella fascia nord-ovest della Provincia di Mantova. Il Distretto ha il suo centro a Castelgoffredo e si estende tutt’intorno per un raggio di 20 km comprendendo diciotto Comuni, sedici in Provincia di Mantova e due in provincia di Brescia. La specializzazione economica dell’area consiste nella produzione di articoli di calzetteria (calze e collant da donna in particolare) e rappresenta in termini di produzione circa il 70-75% del totale prodotto in Italia e il 30% di quello europeo; dei 1.300 milioni di paia prodotti annualmente, la metà è destinata all’esportazione verso Germania, Polonia, Francia, Spagna, Regno Unito e Grecia. Il settore vede la presenza da un lato di alcuni marchi leader del settore come Golden Lady, Sanpellegrino, Filodoro, Levante, dall’altro di una fitta rete di piccole imprese e laboratori a gestione familiare dedicate ad alcune fasi del ciclo produttivo. L’industria italiana della calzetteria nasce timidamente negli anni trenta, in seguito all’introduzione del nylon, la prima fibra sintetica creata dal francese DuPont, che veniva definita «resistente come l’acciaio e delicata come una ragnatela» e che rendeva le calze, un tempo in seta e dunque particolarmente costose, un capo alla portata di un numero sempre maggiore di consumatrici. A Castelgoffredo comunque la produzione della calza ha avuto inizio già negli anni venti con la nascita dello storico Calzificio Noemi. Dopo un’interruzione in 116 concomitanza con la Seconda Guerra Mondiale, la produzione di calze ha un forte impulso negli anni cinquanta e sessanta, grazie all’avvento della minigonna. Questo capo richiedeva collant coprenti, la cui vestibilità veniva assicurata da una nuova fibra della Dupont: la lycra. Da ricordare inoltre la presenza all’interno del distretto del Centro servizi calze, che offre alle imprese servizi di assistenza tecnica, formativa e commerciale, e del Salone europeo della calzetteria Distretto tessile di Carpi (Mo). La vocazione tessile di Carpi ha radici molto lontane nel tempo e la sua origine viene fatta risalire addirittura al Cinquecento. Fin da allora nelle campagne della zona si sviluppò la lavorazione delle paglie ottenute dal legno del salice e del pioppo per produrre trecce e cappelli. Con il declino dell’uso del cappello, nel secondo dopoguerra, si verificò la crisi definitiva del settore, ma alcuni imprenditori della zona iniziarono a diversificare la produzione verso maglie e camicie portando così il distretto, negli anni cinquanta e sessanta, a un vero e proprio boom economico. Nel Distretto, che interessa cinque comuni situati nella zona nord- occidentale della Provincia di Modena (Carpi, Cavezzo, Concordia, Novi, San Possidonio), prevale la piccola dimensione di impresa. Il sistema produttivo di Carpi si basa sulla spinta divisione del lavoro fra imprese e sul decentramento della produzione sia all’interno che all’esterno del Distretto. Nel territorio sono prevalenti due tipologie di aziende: imprese finali che hanno un rapporto diretto con il mercato, generalmente di piccole dimensioni, con in media dodici addetti e imprese di subfornitura caratterizzate da piccolissima dimensione, molto flessibili, con meno di quattro addetti e nel 70% dei casi specializzate in una singola fase di lavorazione. La specializzazione produttiva del Distretto di Carpi riguarda la maglieria e l’abbigliamento femminile. Tra i marchi più noti della zona troviamo: Blumarine, Avirex, Liu-Jo, Robe di Kappa, Marchese Coccapani. I principali punti di forza del Distretto sono l’ampia capacità produttiva garantita da un elevato numero di piccole e piccolissime imprese, l’elevato grado di flessibilità e la capacità di risposta in tempi rapidi alle esigenze di mercato, la capacità di progettare prodotti propri e di offrire un’ampia gamma di modelli. Le imprese di Carpi sono sempre state orientate all’esportazione. L’Unione Europea costituisce il principale mercato di sbocco, con la Germania tradizionalmente al primo posto. Invece, dal punto di vista delle relazioni industriali e sindacali, come strumenti di concertazione sono stati esaminati il “Protocollo d’intesa sulla politica industriale – investimenti, occupazione, redditi” e il “Protocollo 117 d’intesa per un piano coordinato europeo di politiche a favore di investimenti, occupazione e redditi”. Di questi due documenti sono stati evidenziati i punti di maggiore interesse per un lavoro politico sulle condizioni di lavoro e di produzione di questo settore. Il 15 dicembre 2008 tra le Organizzazioni/Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa sulla politica industriale – investimenti, occupazione, redditi”. Del suddetto Protocollo si segnalano i seguenti aspetti: - la presa d’atto che i fenomeni di globalizzazione e di concorrenza dei mercati con il costo del lavoro più basso hanno determinato la chiusura di 250.000 aziende e la riduzione di 120.000 addetti; - nonostante queste conseguenze, la filiera produttiva italiana del tessile – abbigliamento – pelli – cuoio – calzature – occhiali esprime un fatturato di 70 miliardi di euro di cui 38 di esportazioni e livelli occupazionali che registrano ancora 757.000 unità; tale filiera, inoltre, rappresenta il primo committente dell’industria chimica e della gomma plastica; - la sottolineatura della caratteristica di questo settore costituito, accanto ai grandi marchi, da un elevatissimo numero di piccole e piccolissime imprese di fornitura e subfornitura specializzate per fase. Gli obiettivi principali del Protocollo vengono individuati: • nel sostegno ai consumi interni tramite: a) misure di sostegno selettivo; la riqualificazione della domanda pubblica in grado di valorizzare l’innovazione; c) misure di agevolazione fiscale per il rispetto di norma ambientali e sociali; • il sostegno alla capacità produttiva delle imprese della filiera tramite: a) garanzie creditizie; b) valorizzazione del lavoro femminile; c) norme nel campo dell’energia che riducano i costi; d) riduzione dei premi INAIL per le imprese che investono in sicurezza; e) valorizzazione dell’innovazione anche attraverso il Programma Industria 2015; f) sostegno alla promozione commerciale; g) sostegno alla certificazione dei prodotti; • nella valorizzazione della qualità delle produzioni italiane e la tutela della trasparenza del commercio internazionale (lotta alla contraffazione e all’abusivismo); • il potenziamento del Piano Formativo Nazionale; • il rafforzamento degli ammortizzatori sociali per la tutela dell’occupazione. 118 L’altro documento di rilievo è costituito dal “Protocollo d’intesa per un piano coordinato europeo di politiche a favore di investimenti, occupazione e redditi” sottoscritto dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali del sistema moda per la legislatura UE 2009 – 2014. In tale Protocollo si da atto che, dopo un periodo di crescita, il bilancio settoriale del 2008 è tornato negativo. Il Settore Moda condivide le seguenti priorità d’azione: - assicurare e rendere più fluido il credito per le imprese di ogni dimensione; - rafforzare la politica industriale europea nei confronti delle piccole imprese (Small Business Act); - potenziamento degli ammortizzatori sociali per conservare nelle imprese le professionalità indispensabili per il rilancio del serttore. Nello specifico, le principali misure richieste sono: - trasparenza e tracciabilità: Made In; - reciprocità e regole nel commercio internazionale: WTO e accesso al mercato; - Trade Defense Instruments; - Occupazione e Dialogo sociale; qualità e sicurezza dei prodotti: Reach; - Emission Tradinf System; Legalità e concorrenza. Si è ritenuto si riportare, in maniera sintetica e schematica, i punti oggetto dei documenti definiti e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni di Categorie perché molti dei temi richiamati vengono evidenziati nel corso delle inchieste condotte. 119 I processi di delocalizzazione che hanno investito il sistema economico e occupazionale del Veneto.10 Nella illustrazione dei processi di delocalizzazione utilizzerò due documenti redatti da Veneto Lavoro. il primo di questi si intitola: “Il Veneto nell’epoca della globalizzazione: analisi degli impatti e delle politiche”. si tratta di un contributo per il documento finale del progetto “deloc” ed è dell’ottobre 2007. Il secondo si intitola “Delocalizzazione e impatti sull’occupazione: il caso veneto” ed è dell’aprile 2007. Vista la completezza e il grado di approfondimento di questi documenti, si ritiene importante riportarne parti molto significative con alcune note di commento. Per chi si occupa di lavoro e industria in Veneto, ma anche in generale nel Nord Est, i rapporti redatti da Veneto Lavoro rappresentano una fonte di informazione di eccezionale valore essendo, oltretutto, costantemente aggiornati. I tratti caratteristici del sistema economico e occupazionale Veneto e le trasformazioni intervenute all’inizio degli anni ’90. Nel primo rapporto di Veneto Lavoro si delineano i tratti essenziali del sistema produttivo veneto per come si è andato costituendo tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni ’90: - una nutrita popolazione di piccoli imprenditori (spesso ex dipendenti, figli di contadini o di mezzadri), resa possibile dalla diffusa propensione a “mettersi in proprio”, ha attivato svariate iniziative economiche, sopperendo anche con il self employment ai progressi troppo lenti nella costruzione di posti di lavoro dipendenti, appoggiandosi in primis alle risorse familiari di lavoro, di risparmio e di tutela del rischio ma anche al credito locale; - nel territorio si sono diffuse a macchia d’olio piccole strutture produttive (unità locali di modeste dimensioni), con una frammentazione “fisica” anche superiore a quella dei soggetti economici; la frammentazione “fisica” della produzione si è spesso ricomposta in filiere integrate nel territoriodistretto; - all’interno della popolazione di piccole imprese, alcune hanno saputo emergere (Benetton, Luxottica, De Longhi) fino a diventare primari attori 10 Per la redazione di questa scheda si è fatto riferimento a “Il Veneto nell’epoca della globalizzazione: analisi degli impatti e delle politiche” e “Delocalizzazione e impatti sull’occupazione: il caso veneto”, entrambi redatti da Veneto Lavoro nel corso del 2007. 120 sulla scena mondiale, affiancate da un piccolo gruppo di medio-grandi imprese storiche, affermatesi da lungo tempo (Marzotto) o comunque grandi negli anni ’50 (Zanussi poi divenuta Electrolux); - la crescita dell’apparato manifatturiero ha poggiato su una grande capacità (e convenienza) di vendere all’estero: le imprese venete hanno trovato soprattutto nei vicini mercati europei (quello tedesco in particolare), contraddistinti da un’alta dinamica di beni di consumo finale per la persona e la casa, il loro preferenziale terreno di sbocco; - anche grazie all’apporto delle iniziative locali in tema di credito, la dinamica degli investimenti è stata in regione spesso superiore alla dinamica dei redditi; - le produzioni in cui il sistema produttivo regionale si è distinto sono riconducibili all’ampia varietà di beni di consumo tradizionali destinati alla persona e alla casa, accanto ai quali - e per costruire i quali - si è sviluppato un variegato e forte settore meccanico, talvolta giunto ad essere un punto di forza distintivo del Veneto più ancora della relativa produzione a valle. Nei primi anni ’90 si verificano almeno due eventi che segnano la conclusione di un’epoca e pongono le premesse per cambiamenti decisi del contesto socio-economico: 1. la fine dei regimi comunisti dell’Est, con l’apertura all’occidente di Paesi assai prossimi geograficamente al Veneto: a) desiderosi/bisognosi di molti prodotti di consumo (quindi con una forte domanda almeno potenziale), b) dotati di disponibilità abbondante di manodopera (e a costi molto più bassi di quelli esistenti in Europa Occidentale); c) con sistemi produttivi praticamente da ricostruire o da riconvertire, riqualificare, ammodernare ecc.. 2. si verifica l’ultima “grande svalutazione” (1993-1995) con il forte deprezzamento rispetto al marco che ha agevolato l’ultima fase di grande crescita delle esportazioni regionali; ma nel 1998 l’Italia è entrata nell’area euro: questo ha comportato il venir meno della possibilità di ricorrere a politiche di svalutazione della lira per sostenere la competitività delle aziende e i volumi di esportazione. In seguito a questi eventi, l’arrivo sulla scena internazionale dei grandi paesi asiatici (Cina, India) ha negli ultimi dieci anni ulteriormente rafforzato le pressioni per un ridisegno della divisione internazionale del lavoro. Data la specializzazione produttiva marcata in settori “tradizionali”, il Veneto non ha potuto eludere un serio confronto con i nuovi competitors, in modo particolare nel sistema moda. 121 Conseguenze della delocalizzazione (non dell’apertura dei mercati). Intanto una definizione di delocalizzazione: questo termine indica lo spostamento della produzione (totale o parziale) da imprese poste sul territorio nazionale ad altre localizzate in paesi stranieri. L’impresa delocalizzante mantiene il governo dell’attività che delocalizza (ne utilizza i prodotti come prodotti intermedi o li vende con marchio proprio). Se manca questo elemento di governo tra impresa delocalizzante e attività delocalizzate, non si può parlare di delocalizzazione ma di mero rapporto commerciale di importazione. Le principali conseguenze negative: 1) la fuga delle imprese e dei capitali attratti da aree a basso costo del lavoro, ad abbondante manodopera, con bassa – per non dire inesistente - intensità di regolazione in ambito sociale, del lavoro e dell’ambiente; 2) la concorrenza di nuovi territori e di nuove imprese sia nella conquista di mercati finali sia nella conquista delle commesse delle medio-grandi imprese con i connessi rischi di “spiazzamento” della subfornitura “indigena”; 3) la concorrenza in Veneto, rispetto ai lavoratori locali meno qualificati, dei nuovi immigrati mantenuti in una condizione di privazione dei propri diritti; 4) l’impossibile ricorso alla svalutazione e il contesto internazionale maggiormente concorrenziale hanno intensificato la selezione tra le imprese, costringendo fuori mercato quelle non più in grado di riposizionarsi. I punti 1) e 2) provocano conseguenze dirette in capo ai lavoratori delle imprese che hanno attivato i processi rilevanti e veloci di outsourcing con ricadute concentrate sul piano territoriale. Anche il punto 3), quando questo ha comportato la chiusura di imprese ha avuto riflessi occupazionali che, in caso di mancata di ricollocazione dei lavoratori dell’impresa che chiude, ha significato perdita del posto di lavoro. Il principale vantaggio ricercato dalle imprese che delocalizzano è indubbiamente di tipo economico. L’azienda punta ad un’immediata riduzione dei costi di produzione e lo fa attraverso la riduzione del costo del lavoro. Differenza tra processo di internazionalizzazione e delocalizzazione. Dal mio punto di vista non si può parlare di processo di internalizzazione delle imprese, ma di vera e propria delocalizzazione. L’internazionalizzazione può quindi essere definita come la crescita da parte delle imprese nei mercati esteri. Più in particolare, si ha processo di internazionalizzazione attiva quando una o più imprese sono in grado di orientare all’estero almeno la fase di122 stributiva dei propri prodotti/servizi; tra le forme di internazionalizzazione va richiamata anche l’espansione all’estero delle imprese multinazionali dal punto di vista della produzione. Ma quella che rileva, per definire un processo di internazionalizzazione, è l’obiettivo di allargare e rafforzare la propria presenza distributiva sui mercati esteri “presidiandoli” direttamente con le produzioni dei beni (o dei servizi) che in quei mercati si intendono distribuire. Ma, nel caso delle delocalizzazioni venete, la produzione fatta realizzare in Paesi a basso salario non viene venduta sul mercato locale, ma importata e successivamente esportata nei diversi centri del consumo mondiale, Italia compresa. Quindi non si tratta di una strategia di internazionalizzazione che punta a presidiare nuovi mercati e ad avvicinare la produzione ai luoghi del consumo di quanto prodotto. Si tratta soltanto di trasferire la produzione dove questa costa molto meno e poi di reimpostare le merci prodotte per venderle sui mercati tradizionali. Questa soluzione fa parte della strategia adottata dall’Italia e dal Veneto per far fronte alla pressione competitiva proveniente dagli altri paesi industriali i quali ormai da tempo hanno delocalizzato le loro produzioni nei paesi emergenti a basso costo del lavoro, attraverso la frammentazione internazionale della produzione. Questa strategia trova la sua ragione nelle differenze salariali, molto elevate, esistenti fra i paesi più sviluppati e i paesi in via di sviluppo. Il vantaggio è particolarmente forte per le produzioni labour intensive (quelle che necessitano della maggior intensità di manodopera, cioè della maggior quantità di lavoro umano per essere realizzate) in cui il costo del lavoro incide in misura notevole sul costo totale di produzione. L’idea, che sta alla base di queste delocalizzazioni è che inseguendo il costo del lavoro più basso si spuntino prezzi di prodotto più bassi e quindi maggiormente competitivi. Insomma: la competitività giocata tutta sul prezzo del prodotto da ridurre attraverso la compressione del costo del lavoro e quindi dei livelli salariali. Restano da discutere due letture del fenomeno delocalizzazione. La prima è quella che vede nella delocalizzazione non necessariamente un “male” ma un fenomeno legato al più generale processo di ridefinizione della divisione internazionale del lavoro. Cioè vedrebbe in essa un processo che può rafforzare il posizionamento internazionale della produzione locale, italiana e, in particolare, veneta, perché libera risorse di lavoro e capitale, che possono venire meglio impiegate, se adeguatamente riconvertite, in attività a maggiore qualificazione e più alta produttività e che, dunque, risentono meno della concorrenza in123 ternazionale sui costi, permettendo alfine di disporre di risorse per accedere a beni e servizi a più elevato contenuto di conoscenza. La delocalizzazione comporterebbe l’acquisizione di nuove attività e competenze produttive, rappresentando di fatto uno strumento per il riposizionamento nella divisione internazionale del lavoro, costituendo una spinta verso processi di innovazione e riaggiustamento industriale (Corò e Volpe, 2003). Dal mio punto di vista questa lettura sconta comunque tre aspetti critici: 1) comunque la si voglia guardare, la delocalizzazione comporta sempre un impoverimento del territorio e dei livelli occupazionali per il trasferimento di attività (e capitali e impianti) all’estero. e perdere attività manifatturiere non è certo un elemento positivo (vedi tutte le osservazioni fatte dagli economisti durante la crisi sull’importanza di avere un tessuto manifatturiero); 2) non è detto che la perdita di manodopera manifatturiera sia compensata dalla creazione di nuova occupazione nelle attività più “pregiate” come la ricerca, la progettazione, il marketing, i prototipi ecc.; 3) non è detto che anche queste attività, a lungo andare, non possano essere delocalizzate all’estero non appena anche nei paesi oggetto di delocalizzazione si comincino ad acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di tali attività professionali. La seconda è quella che vede nella delocalizzazione un processo volto a sostenere, rafforzare ed allargare la penetrazione commerciale delle imprese nazionali sui mercati internazionali. L’internazionalizzazione delle imprese italiane perseguirebbe la creazione di strutture produttive all’estero, tanto quanto le altre forme di espansione internazionale delle multinazionali italiane, per rispondere principalmente all’esigenza di potenziare la penetrazione commerciale su mercati terzi. Questo è vero se: 1) i prodotti realizzati dalle imprese che delocalizzano non vengono poi reimportati come semilavorati per produrre poi i prodotti finali o reimpostati per essere venduti sul mercato interno con il marchio della fabbrica delocalizzante; 2) se le imprese che delocalizzano realizzano beni e servizi realmente “compatibili” con le condizioni dei mercati dei paesi in cui trasferiscono attività (non credo in larga parte della Bulgaria o della Romania i capi firmati Valentino siano prodotti particolarmente diffusi…); 3) se l’installazione di produzioni all’estero non comporta la sostituzione di quelle esistenti sul territorio nazionale. 124 Nel documento di Veneto Lavoro vengono richiamate più ricerche condotte sul tema del rapporto tra delocalizzazione produttiva e occupazione. Tra queste, a mio parere, merita di essere segnalata quella condotta da Mariotti, Mutinelli e Piscitello (2000) che ha cercato di misurare l’effetto dell’internazionalizzazione delle imprese multinazionali italiane sull’occupazione domestica a livello settoriale nel periodo 1985-1995. I risultati ottenuti hanno evidenziato che un aumento dell’occupazione nelle affiliate estere, localizzate in paesi meno sviluppati e a basso costo del lavoro, riduce l’intensità di lavoro nella base domestica. Viceversa, l’impatto sull’intensità di lavoro domestica è positiva quando l’IDE è diretto verso paesi avanzati. Questi risultati confermano che gli investimenti guidati da strategie di tipo market seeking sono diretti verso i paesi più sviluppati, mentre gli investimenti verticali, che sfruttano i differenziali di costo, sono diretti verso i paesi meno sviluppati. In particolare, gli investimenti orizzontali inducono presso il paese di origine dell’impresa investitrice un maggiore impiego di lavoro, soprattutto qualificato, in conseguenza sia di attività addizionali di supervisione, coordinamento, R&S e marketing presso la casa madre, sia di una serie di esternalità positive generate da quest’ultima nell’ambiente economico locale. Gli investimenti verticali si confermano, viceversa, veicolo di riduzione dell’intensità di lavoro non qualificato e ciò determina una riduzione degli addetti low-skilled at home. Il processo di delocalizzazione delle imprese venete. Sempre la documentazione redatta da Veneto Lavoro ha evidenziato come in Veneto, come in tutta Italia, le imprese si internazionalizzano adattando i loro costi e i loro prodotti alle nuove condizioni del mercato, allacciando alleanze strategiche con partner esteri, modificando forma e ampiezza della filiera e investendo in conoscenza. Le medie imprese venete cercano, in genere, di adottare modalità simili, costruendo reti che poco hanno a che fare con quelle tipiche delle grandi multinazionali. In particolare, esse cercano di utilizzare dei partner locali all’estero con esperienza diretta del luogo di insediamento nonché di riprodurre, nei paesi esteri in cui si insediano, la rete locale di subfornitura. In altri termini, spesso le Pmi venete hanno cercato di organizzare la loro presenza all’estero non tanto con l’ampliamento dei propri confini proprietari ma tramite estensione delle catene di fornitura e del contesto di relazioni che le connota. E’ facile dedurne che in tal caso non sono le singole imprese ad espandersi all’estero, ma è l’organizzazione a rete a propagarsi, dando luogo a piccoli sistemi che lavorano in collegamento con la 125 rete di origine. Una caratteristica rilevante del processo di internazionalizzazione è perciò “l’esportazione” dei distretti.” Il distretto italiano/veneto più noto e popoloso, anche perché di più antica formazione, è quello di Timisoara, in Romania, dove operano molte consociate di imprese venete attive nei settori del Made in Italy, ma anche in quello della lavorazione del legno. Un altro tentativo nella medesima direzione è quello attivato dall’Associazione Industriali di Vicenza a Samorin, in Slovacchia. In questo distretto sono ospitate più di 60 aziende vicentine (in questo caso il settore è quello dell’elettromeccanica), in un’area di 500 mila metri quadrati. A conferma di quanto sopra detto, Assindustria di Vicenza prevede non solo la costituzione di filiali, ma anche una continua integrazione con il tessuto locale, al fine di “riprodurre” l’area-sistema della meccanica veneta. La scelta di Samorin, tra i paesi dell’Est è stata dettata, oltre che dalla disponibilità di manodopera a basso costo (20% di quella veneta), anche dalla collaborazione con le autorità locali (il governo assicura contributi a fondo perduto fino al 65% degli oneri destinati all’urbanizzazione delle aree industriali) e dalla vicinanza con il confine austriaco. In definitiva, data la struttura produttiva fondata sulle Pmi, il concetto di internazionalizzazione per il Veneto è da intendersi in senso ben più ampio del semplice riferimento agli IDE, in quanto spesso i limiti di risorse finanziarie, di management e organizzazione non permettono alle PMI di scegliere tale strategia. Lo studio di Veneto Lavoro sintetizza bene come la stessa delocalizzazione si concretizzi attraverso diverse modalità: • ricorso a subfornitori indipendenti per l’acquisto da essi di prodotti progettati dall’impresa committente. Questo metodo prende anche il nome di outsourcing o cooperazione e viene utilizzato in prevalenza da piccole e medie imprese con diverse varianti. Un caso particolare è il traffico di perfezionamento passivo (Tpp) con il quale le imprese esportano le materie prime o semilavorate nel paese a basso costo del lavoro dove esse vengono lavorate e successivamente reimportate come prodotto finito o semi-finito. • accordi di partnership con imprese estere di tipo contrattuale, senza la partecipazione al capitale di rischio (cessione di licenze, franchising ecc.); • joint venture e altri accordi con la partecipazione al capitale di rischio (partecipazioni di minoranza, ecc.); • investimenti diretti esteri (acquisizione o creazione ex novo di imprese): questa tipologia è utilizzata in prevalenza dalla grandi imprese o dalle multinazionali e porta alla realizzazione di co-interessi durevoli tra l’impresa 126 investitrice e la nuova realtà imprenditoriale estera. La delocalizzazione delle imprese venete avviene attraverso forme intermedie, come gli accordi di collaborazione commerciale e di subfornitura, in misura molto meno rilevante attraverso investimenti di capitale. La delocalizzazione del TAC (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero). Prendendo ad esempio la Romania, principale paese destinatario dei processi di delocalizzazione nel settore tac (tessile-abbigliamento-calazature), è interessante notare come la media del capitale veneto investito è di circa 20.000 euro per azienda, poco meno della metà dell’investimento medio delle aziende italiane e addirittura 40 volte inferiore a quello olandese. Questo valore così contenuto evidenza la natura medio-piccola dell’impresa italiana e, in particolare, di quella veneta e la scelta di delocalizzare in misura molto contenuta attraverso investimenti di capitale. Del resto le imprese venete del settore tessile-abbigliamento - settore in cui l’economia regionale vanta una forte tradizione - delocalizzano ricorrendo soprattutto alla subfornitura internazionale. Secondo il rapporto di Veneto Lavoro due sono i motivi di tale scelta. Il primo è che in conseguenza della spinta esercitata dalla concorrenza asiatica e da altre economie a basso costo del lavoro, negli ultimi quindici anni il settore ha subito in Europa una perdita consistente di posti di lavoro: fra il 1995 e il 2003 la riduzione dell’occupazione è stata di 655.000 addetti. Il problema, quindi, non è solo italiano/veneto, ma riguarda più in generale l’Europa. Il secondo motivo risiede nel fatto che il settore in esame è caratterizzato da un ciclo produttivo già profondamente segmentato in senso verticale, in cui singole fasi della produzione hanno un elevato grado di indipendenza. In particolare, la diffusione della tecnologia produttiva, delle competenze per utilizzarle e l’universalità del linguaggio che definisce le operazioni rendono possibile organizzare la produzione in luoghi diversi rispetto a quelli in cui si realizza la progettazione. Tutto ciò agevola la scomposizione produttiva e, per questa via, la delocalizzazione. Durante gli anni sessanta in tutti i paesi industrializzati il settore tessile -abbigliamento era dominato da imprese verticalmente integrate che svolgevano internamente tutte le fasi del processo produttivo. A partire dagli anni settanta si è assistito ad un intenso fenomeno di decentramento delle fasi manifatturiere da parte delle imprese finali in favore di più piccoli laboratori generalmente situati ancora all’interno dei confini regionali o nazionali. Fino agli anni novanta la frammentazione del settore si è concretizzata principalmente nella forma della subfornitura nazionale, ovvero 127 nella costituzione di reti di imprese terziste attorno alle imprese finali. Si veda il caso dei distretti tessili italiani con le loro reti di fornitura e subfornitura. La subfornitura ha giocato a lungo un ruolo importante in tutti i paesi dell’Europa Occidentale: per quanto riguarda l’Italia, ancora nel 1993 gli addetti alla subfornitura dell’abbigliamento erano più di 120.000, di cui 55.000 nel solo Veneto dove rappresentavano il 62% dell’occupazione totale del settore. Ciò è dovuto a molte ragioni tra le quali si ricorda la piccola dimensione media delle imprese, lo sviluppo soprattutto nelle regioni settentrionali dei distretti industriali, un sistema distributivo che ha a lungo limitato la penetrazione delle importazioni estere, la specializzazione del sistema in segmenti di mercato di fascia medio -alta e l’introduzione di alcune innovazioni di processo che hanno reso possibile ottenere altissimi livelli di produttività. Fino alla seconda metà degli anni ottanta la delocalizzazione ha riguardato una minima parte della produzione italiana di abbigliamento e calzature. Contrariamente alla crescente rilocalizzazione internazionale effettuata dai principali concorrenti europei, soprattutto tedeschi, le imprese italiane e venete hanno continuato a considerare come unica dimensione internazionale quella dell’esportazione di prodotti verso gli altri paesi industrializzati. Progressivamente, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, il settore abbigliamento è stato scosso da profondi cambiamenti strutturali nonché nelle forme e negli stili di consumo. Contemporaneamente, dal lato dell’offerta è iniziato un processo di riorganizzazione e concentrazione del settore portato avanti da alcune delle imprese maggiori. E nello stesso tempo alcuni Paesi a basso salario hanno cominciato a migliorare sensibilmente la qualità delle proprie produzioni attraverso processi di apprendimento continui, traducendo tutto ciò in pochi anni in una più forte concorrenza di prezzo che ha investito le imprese italiane e venete. Anche le imprese di abbigliamento medie e piccole sono state costrette a mutare rapidamente strategia: il sistema industriale è passato da un approccio ai mercati esteri basato su relazioni di tipo esclusivamente commerciale all’internazionalizzazione del ciclo produttivo, ovvero alla delocalizzazione. Già nei primi anni novanta la delocalizzazione è diventata un fenomeno significativo. La forma di gran lunga più diffusa è stata quella della subfornitura internazionale che la maggior parte delle volte si è tradotta in una sostituzione di subfornitori veneti con subfornitori esteri. In alcuni casi le relazioni produttive si sono basate esclusivamente su semplici accordi con produttori esteri locali, accordi che prevedevano l’acquisto da 128 parte dell’impresa veneta di un prodotto finale realizzato su materie prime comprate direttamente dall’impresa terzista sul luogo di produzione. Nella maggior parte dei casi però la subfornitura ha preso la forma dell’esportazione della materia prima e della successiva reimportazione del prodotto finito. I modelli di delocalizzazione del settore tessile -abbigliamento assumono diverse caratteristiche a seconda delle aree geografiche interessate. La delocalizzazione intesa come decentramento internazionale della produzione, che consente tuttavia un controllo logistico sulle funzioni di approvvigionamento e distribuzione, riguarda prevalentemente l’area dell’Est europeo e il bacino del Mediterraneo (Romania, Bulgaria, Ungheria, Croazia, Slovacchia, Tunisia, Marocco). Nei paesi dell’Europa Centro-Orientale il vantaggio localizzativo deriva, oltre che dal basso costo del lavoro, dalla presenza di un ampio numero di lavoratori qualificati nelle lavorazioni labour intensive e dalla relativa prossimità geografica con l’Italia. In questo modo, si possono de localizzare anche singole fasi di produzione, fornendo la materia prima al produttore estero in conto lavorazione e reimpostando in tempi relativamente brevi i prodotti finiti o semilavorati, i quali successivamente vengono venduti sul mercato nazionale e internazionale. Si de localizza l’industrializzato. Un altro modello di integrazione della produzione si manifesta nei confronti delle economie emergenti e in più rapida crescita del Sud-Est asiatico (Cina, India, Thailandia, Vietnam, Corea del Sud, Indonesia). In questi paesi, dove l’invio della materia prima risulterebbe troppo costoso a causa della distanza, si attuano prevalentemente subforniture finalizzate alla produzione del commercializzato: in tal caso sono gli stessi produttori esteri che provvedono all’approvvigionamento delle materie prime e degli accessori in loco. Si tratta, in altre parole, dell’importazione di prodotti finiti realizzati interamente in un altro paese, su progettazione però dell’impresa nazionale. 129 Inchiesta condotta alla Valentino Fashion Group di Valdagno (Vi)11 Nell’intervista con alcuni rappresentanti della Rsu della Valentino Fashion Group il punto di partenza è rappresentato dalla situazione di crisi che sta attraversando anche questo “gigante” dell’abbigliamento. E’ d’obbligo, quindi, partire dall’inquadramento di questa crisi e dalla ragioni che l’hanno originata. “Il grosso della nostra produzione va in export, in particolare negli Usa. E proprio negli Usa si è registrato un brusco calo delle vendite che poi si è esteso anche in Europa.” Quindi per una azienda fortemente orientata all’export, questo calo ha determinato una situazione di forte crisi con conseguenti ricadute occupazionali. La crisi riguarda tutti i marchi e le aree (il brand Valentino, ma anche Lebole, Principe, Marlboro Classic, Missono Donna, Hugo Boss). “Un anno fa è cominciato il calo delle vendite con una riduzione del 30% che nel tempo è arrivata fino al 70% in meno.” Una drastica riduzione delle vendite, con percentuali drammatiche di calo delle produzioni che portano l’azienda ad intervenire sugli organici, “Da qui è partita la prima fase di riorganizzazione che portato a sei settimane di cassa integrazione ordinaria.” Oggi lo stabilimento Valentino di Valdagno conta su 600 dipendenti di cui 400 impiegati e 200 addetti alla produzione. Di questi 200 dipendenti, 113 sono i lavoratori direttamente impiegati nella produzione, gli altri 87 sono gli indiretti, cioè addetti alla logistica, al magazzino ecc. Per comprendere le dimensioni della ristrutturazione produttiva e occupazionale a cui è andato incontro lo stabilimento di Valdagno (ex Marzotto) si tenga presente che: - alla fine degli anni ’80 la divisione moda produceva da 3.500 a 4.500 capi al giorno; - adesso, a regime, ne vengono prodotti 70 e a seguito della crisi e della messa in Cassa Integrazione Ordinaria soltanto 30; - i dipendenti erano 14.000 negli anni ’70, poi ridotti a 5.000 sul finire degli anni ‘80; - adesso ne sono rimasti 600 di cui solo 113 addetti alla produzione. Tutta la produzione è stata decentrata con un fortissimo processo di delocalizzazione all’estero (Egitto, Tunisia, Marocco), “e la cosa scandalosa è che poi sui capi viene appiccicata l’etichetta “Made in Italy”….” 11 In collaborazione con Giuliano Ezzelini Storti, Prc di Vicenza. 130 In questa intervista viene pienamente confermata, quindi, la tendenza delle aziende del settore tessile – abbigliamento a de localizzare nei Paesi caratterizzati da basso costo del lavoro per spuntare i margini maggiori di guadagno, alla luce del fatto che i prodotti realizzati da lavoratori pagati quattro o cinque volte meno di quelli italiani vengono comunque venduti nelle boutique a prezzi molto elevati. Ormai in Italia e segnatamente a Valdagno è rimasta una produzione minimale, con l’azienda che non fa nemmeno mistero di voler mantenere solo il cosiddetto Head Quartier (uffici, commerciale, un po’ di prototipi ecc.) esternalizzando tutta la produzione vera e propria. Nella fase attuale, “a volte, anche alcuni prototipi sono dati all’esterno, ad esempio ad un laboratorio presente nel napoletano.” Anche altre produzioni sono state esternalizzate in Veneto (a Padova, ad Asiago), ma alla domanda sulla consistenza del fenomeno la risposta è che “non si riesce a fare un quadro completo”. Questa risposta, fornita comunque da delegati sindacali preparati e attenti, la dice lunga sul processo di scomposizione di queste aziende e dei conseguenti processi di distribuzione ed esternalizzazione di fasi di produzione che non consentono nemmeno una conoscenza completa del fenomeno. Il livello di sindacalizzazione è molto basso ed è proprio la parte prevalente dei dipendenti, cioè gli impiegati, ad essere più lontana e disinteressata alla vicende sindacali. “Da noi il sindacato prevalente, storicamente, è la Cisl anche se ultimamente la Cgil ha guadagnato posizioni tanto in termini di iscritti che di delegati in Rsu.” Gli iscritti alla Cgil sono diventati 50 (quelli della Cisl circa 100 e 40 alla Uil) e i membri della Rsu 4 su 12 (in precedenza 1 su 15). Per la Cgil, quindi, si tratta di un risultato importante ottenuto in una fabbrica difficile inserita in un contesto territoriale e culturale particolarmente ostico. Ovviamente gli iscritti della Cgil sono tutti tra i lavoratori addetti alla produzione. Quello che i delegati Cgil continuano a chiamare il “Consiglio di Fabbrica” è stato profondamente rinnovato nel suo funzionamento, “prima era praticamente nullo, faceva tutto il funzionario territoriale”. La crescita della Cgil, sia in termini di iscritti che di voti per la elezione del “Consiglio di Fabbrica”, viene motivata con “il grande lavoro fatto su diversi temi: la gestione delle assemblee, la sicurezza nel luogo di lavoro, il rapporto con i lavoratori improntato alla trasparenza”. Il tema della trasparenza è strettamente legato a quello della democrazia sindacale: in assemblea, gestite direttamente dalle Rsu senza più la “tutela” 131 dei sindacalisti di categoria, “ai lavoratori vengono date tutte le informazioni, non viene nascosto niente. Cioè tutte le informazioni utili alla discussione, come gli andamenti delle vendite, gli ordini, ecc. vengono comunicati ai lavoratori in assemblea direttamente, non vengono più filtrate dal Consiglio di Fabbrica che prima decideva cosa dire e cosa no.”. E, soprattutto, i lavoratori vengono chiamati ad esprimersi su tutto attraverso il voto. Addirittura i lavoratori sono stati chiamati ad esprimersi sul contratto ed “è stata votata una mozione riferita all’aumento contrattuale che gli altri (Cisl e Uil) volevano limitare a 95 euro, invece noi abbiamo proposto 95 euro più gli altri istituti come i premi ecc.”. Queste votazioni, sul contratto e sulla definizione delle richieste di aumento salariale, “sono state fatte nonostante l’opposizione della Cisl che ha messo in campo addirittura il suo segretario nazionale di categoria, Spiller, per impedire che si precedesse”. La votazione sul contratto è di particolare rilievo in quanto il CCNL dei tessili non prevede assolutamente questa possibilità: una deroga democratica, quindi, che ha consentito ai lavoratori della Valentino di esprimersi su un tema che dovrebbe costituire il primo ed elementare aspetto di discussione e decisone democratica dei lavoratori stessi. Invece piattaforme, pre-accordo e accordo finale, tutti i passaggi sono stati democraticamente sottoposti al voto dei lavoratori. Tuttavia, fanno notare i due delegati della Cgil, la sensibilità complessiva, l’attenzione complessiva ai temi sindacali non è cambiata molto… Rimane ancora una forte distanza rispetto ai temi del lavoro, del sindacato, “della politica non ne parliamo nemmeno…”. Le ragioni di questa distanza vengono riferite al clima generale che si respira in questa parte di Veneto descritta come una zona nella quale tra i lavoratori prevale “una grossa ignoranza”, o meglio “una non cultura” che li rende del tutto indifferenti, se non addirittura ostili ai temi sindacali e politici. L’avversione alla politica sembra essere molto forte come ricorda un delegato: “quando parlo di temi strettamente sindacali, anche in termini radicali, ottengo un grosso consenso, ma appena percepiscono una sfumatura politica in quello che dico mi contestano apertamente…”. “Appena supero la linea che separa sindacato da politica non c’è più niente da fare e nonostante tutto quello che di buono ho appena detto sul piano sindacale, poi vengo contestato in quanto sconfino nella politica…”. Il 22 giugno viene raggiunta la pre-intesa tra azienda e organizzazioni sindacali. 132 Nel testo si legge che la Valentino Fashion Group intende avviare una procedura per la collocazione in mobilità di 125 lavoratori: le cause che hanno determinato questa decisione sono da individuare nella impossibilità di continuare l’attività produttiva con l’attuale organico a seguito della negativa e persistente congiuntura del settore abbigliamento in generale e della contrazione dei volumi e del fatturato dell’azienda in particolare con la necessità di ridurre a 14.500 capi equivalenti i volumi di produzione annui attraverso la concentrazione in un unico reparto delle sale lavorazione Uomo e Donna, nonché i costi strutturali e del personale. Decisone strutturale, non solo dovuta alla situazione particolare e contingente della crisi. L’accordo prevede la possibilità per l’azienda di aprire tra luglio e settembre 2009 due procedure per collocare in mobilità fino ad un massimo di 100 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Maglio di Sopra (Vi). I criteri di scelta per il collocamento in mobilità sono quelli classici prescritti dalla normativa e riferiti al perfezionamento dei requisiti per l’accesso all’età della pensione e la volontarietà. Tuttavia esiste un ampio margine discrezionale per l’azienda in quanto “La collocazione in mobilità del personale volontario dovrà essere compatibile con le esigenze tecnico-produttive e organizzative della società che si riserva pertanto facoltà decisionale”. Abbastanza generosi appaiono gli incentivi all’esodo per le figure in gradi di maturare i requisiti per il pensionamento durante il periodo di mobilità: da 4.800 euro a 16.800 sono le buone uscite previste a seconda dell’anzianità di servizio e quindi a seconda della maggiore o minore prossimità alla pensione. Invece ai lavoratori collocati in mobilità in base a scelta volontaria verranno corrisposte tre mensilità lorde. Agli incentivi all’esodo si aggiunge un fondo sociale di 50.000 euro da destinare al sostegno economico dei lavoratori in mobilità con criteri di assegnazione degli aiuti da definire a seguito di appositi incontri tecnici tra le parti. Nell’accordo è passato il concetto della “Ricollocazione”. Infatti, si legge nel testo che poiché l’applicazione dei criteri previsti dall’accordo non consente di ottenere nelle sale lavorazione l’adeguamento, cioè la riduzione dell’organico deciso dall’azienda, questa si impegna a ricollocare almeno 16 lavoratori in altre aree dello stabilimento di Maglio di Sopra. Viene inoltre previsto il ricorso ad un Contratto di Solidarietà Difensivo della durata di una anno che dovrà consentire di pervenire ad una defini133 zione dell’organico, al netto delle mobilità per pensionamenti e volontarietà, aderente alla scelta di riduzione dell’azienda. Il Contratto di Solidarietà prevederà una riduzione a sei ore giornaliere di lavoro su cinque turni, per complessive trenta ore settimanali. L’orario di lavoro del Contratto di Solidarietà viene flessibilizzato e reso funzionale alle esigenze produttive dell’impresa. Il grado elevato di flessibilità circa l’orario del Contratto di Solidarietà si rinviene nel passaggio in cui si stabilisce che: “Su richiesta dell’azienda, nei periodi di punta (campionario) l’orario dei lavoratori in solidarietà sarà temporaneamente aumentato. Nei periodi di minore attività, viceversa, si potrà ricorrere alla mobilità interna al fine di far fronte a picchi di attività in altre aree, aumentando temporaneamente l’orario di lavoro dei lavoratori in solidarietà”. Nonostante il pesante taglio di organico conseguente ad una altrettanto pesante ristrutturazione produttiva, le parti firmatarie dell’accordo riconoscono comunque la “importanza e centralità del sito di Maglio e sulla specializzazione dello stesso in particolare relativamente alle fasi di produzione del campionario e dei prototipi (…) Resta confermata la mission del sito di Maglio nell’ambito della Valentino Fashion Group, pertanto al termine degli interventi descritti, finalizzati ad adeguare l’assetto produttivo alla riduzione dei volumi, non sono previsti altri interventi di riorganizzazione delle attività e restano confermati i perimetri delle attività ausiliare a Valentino Fashion Group”. Su quest’ultimo passaggio sono possibili almeno due considerazioni caratterizzate da forte perplessità preoccupazione. La prima: è da trent’anni che questa azienda, nelle sue diverse proprietà ridimensiona fortemente organici e produzione. I dati esposti nella prima parte del rapporto di inchiesta sono ampiamente sufficienti a dimostrare in maniera lampante la coerenza del trend di dimagrimento occupazionale e riduzione produttiva seguito sino ad ora. La seconda: se ad un organico che nel corso degli anni è stato così fortemente ridotto, si aggiungono le 100 mobilità definite nell’accordo del 22 giugno, è evidente che la dichiarazione di riconoscere l’importanza e la mission del sito di Maglio suonano come dichiarazioni di principi vuote di contenuti. E’ evidente, infatti, che questo passaggio sulle mobilità, rappresenta l’ennesimo tassello del mosaico costruito dall’azienda per arrivare, pezzo per pezzo, alla trasformazione di Maglio da fabbrica a semplice Head Quartier (HQ, in linguaggio manageriale…) del Gruppo. » la stessa riflessione che ha maturato anche la componente Cgil della Rsu che ha firmato l’accordo, seppur con diverse sofferenze che hanno portato 134 anche alle dimissioni di un Rsu (il più politicizzato e dirigente di Rifondazione Comunista.). Per un rappresentante della Rsu, tuttavia non era possibile rifiutare l’accordo sulla mobilità anche per la pressione di alcune operaie prossime alla pensione che volevano la mobilità come scivolo per raggiungere l’età pensionabile. Il problema, riconosciuto dalla componente Cgil della Rsu è il drastico taglio della produzione: “Impossibile che questo stabilimento si riduca soltanto a trenta capi di produzione. Si tratta di un evidente tentativo di cavalcare la crisi per imporre quello che l’azienda aveva già deciso e scaricarne i costi sulla collettività”. Tra l’altro la composizione societaria della Valentino è fortemente cambiata con la famiglia Marzotto ridotta ad un misero 12% e, invece, il grosso delle quote detenute dal Fondo di private equità denominato Permira. Dell’acquisizione della Valentino da parte del Fondo di private equità ne dava notizia un portale specializzato in moda in questi termini: “Il Fondo Permira IV, con Canova Investimenti Srl e Canova Partecipazioni Srl, attraverso la società da loro controllata Red&Black Lux Srl, società lussemburghese, hanno prenotato il 60,2% delle azioni di Valentino Fashion Group. L’accordo prevede che il 18,9% già in mano a Canova Investimenti e Canova Partecipazioni passi di mano, rilevato da Permira per 491 milioni di euro. In dettaglio, quasi 14 milioni di titoli in mano a Canova Investimenti sono state vendute per quasi 487 milioni di euro, mentre 127 mila azioni di Canova Partecipazioni hanno raggiunto per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro. Il fondo è guidato da Gianluca Andena e Nicola Volpi. Le azioni del Valentino Fashion Group sono state acquistate al prezzo unitario di 35 euro l’una. La decisione di cedere le proprie partecipazioni è dovuto ai significativi cambiamenti in corso nell’assetto azionario di Valentino Fashion Group. Il forte apprezzamento per Red&Black Lux e alla sua intenzione di offrire a tutti gli azionisti del Gruppo Valentino Fashion la possibilità di vendere al medesimo prezzo di 35 euro per azione con offerta pubblica sull’intero capitale sociale ordinario, escluso il 29,6% già acquisito da Red&Black Lux lo scorso 16 maggio. Il marchio arriva al 60,2% grazie alla partecipazione dell’11,6% in possesso di G.D.D.R. e di PFC e Veninvest, due società guidate dalla famiglia di Paolo Marzotto e, ovviamente, grazie all’accordo con Canova.” Si tratta di un fondo di investimento che non ha nessuna specializzazione nel settore tessile – abbigliamento: L’attività dei fondi Permira ’investimento è supportato dal team del settore, con una profonda comprensione delle loro industrie. Since the firm was founded in 1985, the Permira funds have built up a record of sustained investment success in the following three broad sectors–Consumer, Industrials and Technology, Media & Telecoms 135 (TMT). Dal momento che l’azienda è stata fondata nel 1985, i fondi Permira hanno costruito un record di successo degli investimenti sostenuti nei tre seguenti settori ampio dei consumatori, Industriali e della Tecnologia, Media e Telecomunicazioni (TMT). More recently we have established two new international sector teams to focus on pursuing investment opportunities in the Financial Services and Healthcare industries. Più di recente abbiamo istituito due nuove squadre del settore internazionale di concentrarsi sul perseguimento di opportunità di investimento, servizi finanziari e le industrie Healthcare. We believe that our sector expertise contributes strongly to creating value in the funds’ portfolio companies. Noi crediamo che la nostra competenza settore contribuisce fortemente alla creazione di valore nelle imprese i fondi ’di portafoglio.” Il particolare approccio di questo Fondo conferma l’idea che in Italia i nuovi proprietari non intendano più mantenere la produzione, ma limitarsi soltanto alle funzioni tipiche di un Head Quartier: amministrazione, commerciale, marketing, logistica… Non si spiega altrimenti la scelta di arrivare ad una sola sala di lavorazione in cui concentrare sia Uomo che Donna, produzioni da sempre distinte. Parlando di tessile – abbigliamento non si può fare a meno di approfondire il discorso del Made in Italy, dell’etichettatura dei prodotti, soprattutto di quelli realizzati pressoché interamente all’estero e semplicemente etichettai in Italia. “E’ molto semplice: arrivavano i prodotti dalla Romania e il nostro lavoro era quello di mettergli l’etichetta Made in Italy. Così, prodotti realizzati all’estero venivano venduti sul mercato italiano con l’etichetta di garanzia. Le aziende ottengono così il massimo risultato: all’estero (Romania, Cina ecc.) pagano pochissimo i lavoratori, ma in Italia grazie all’etichetta del Made in Italy vendono i prodotti a carissimo prezzo”. “Servirebbe proprio una legge sul Made in Italy che vincoli l’etichettatura la fatto che un prodotto sia stato realizzato realmente in Italia.” “Tutti si sono impegnati a fare qualcosa ma nessuno ha fatto niente: abbiamo incontrato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Stradiotto; abbiamo incontrato i Comuni, la Regione Veneto…ma nessuno ha fatto niente di concreto, solo parole…”. Tra le proposte di Rifondazione Comunista a sostegno della campagna sul lavoro viene discussa anche una possibile proposta di legge sul Made in Italy definita in termini molto rigorosi che limiti la possibilità di tale etichettatura soltanto ai prodotti realizzati per almeno il 90% del loro valore in Italia, in modo da escludere che rimangano soltanto le funzioni della ideazione, progettazione, commercializzazione ecc., con lo spostamento all’estero delle attività manifatturiere. Una proposta di legge di questo tipo perseguirebbe almeno due obiettivi: 136 quello di evitare ulteriori delocalizzazioni all’estero con conseguente impoverimento occupazionale dei territori devastati da questo fenomeno; una tutela dei diritti dei consumatori che oggi acquistano prodotti etichettati come Made in Italy ma in realtà realizzati in Romania, India, Cina e in tutti quei paesi dove gli imprenditori italiani vanno in cerca di manodopera abbondante e a bassissimo costo. “Una proposta del genere troverebbe molto spazio tra i lavoratori…anzi la sosterrebbero concretamente…dà molto fastidio questo fatto del continuo trasferimento di lavoro all’estero…è ora che vi muoviate su questi temi, dovete proprio farla …e se la fate qualcuno da queste parti potrebbe restare sorpreso…” 137 Inchiesta condotta alla Raumer di Valli del Pasubio (Vi)12 La Raumer SpA da 30 anni produce filati per maglieria e una vasta gamma dei prodotti: dal classico (misto lana, pura lana, cotone) ai filati speciali (lana-lino, seta, seta-lino, seta-lana, viscosa, eccetera) ai filati moderni, cioè, gli elasticizzati in cui si sono raggiunti i migliori risultati a livello nazionale; La Raumer, situata a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, è composta da una piccola filatura-ritorcitura, da una tintoria ben strutturata e tecnologicamente avanzata, dagli uffici amministrativi e dal magazzino. Gli occupati totali sono 230 più 25 impiegati che fino al 30 settembre 2007 dipendono dalla sede di Alba di Ernesto Miroglio che ha affittato la rete commerciale con un contratto d’affitto di ramo d’azienda. L’occupazione è in maggioranza femminile e l’età media è attorno ai 40 anni. L’elevata componente femminile della manodopera e l’età media indicano da subito che in termini occupazionali i problemi sono assai seri: “si sa che le donne sono più svantaggiate nel mercato del lavoro; se poi di età non si è abbastanza anziani per essere vicini alla pensione, né abbastanza giovani per imparare un mestiere, allora i problemi raddoppiano…” Questa azienda nasce da un processo di espansione dell’originario proprietario che inizialmente – oltre 30 anni fa – aveva solo una piccola filatura, ma poi nel tempo acquistò altre lavorazioni, tra cui una tintoria, e quindi diede corpo al proprio progetto di allargamento. “Quelli erano gli anni del boom del filato, e lui ci ha preso in pieno. Ha investito nel settore giusto e ha cominciato a fare soldi, tanti soldi” Nella sua azienda non esistevano organizzazioni sindacali. “In fabbrica il sindacato non poteva entrare, e nessuno poteva iscriversi. Diceva sempre che la fabbrica doveva essere come una grande famiglia. Addirittura le assemblee del personale venivano fatto direttamente da lui, che ci convocava in una piccola stanza. Il timore reverenziale nei suoi confronti era massimo, addirittura chiamava tutti i dipendenti per nome, chiedeva a tutti se ciascuno aveva raggiunto gli obiettivi…”. Gli orari di lavoro erano massacranti: dal lunedì al venerdì si lavorava nove ore al giorno, il sabato otto e la domenica sei (bontà sua…). Sembra di ascoltare un racconto delle condizioni di lavoro dell’Inghilterra dell’ottocento, del boom della rivoluzione industriale, quando non esistevano limiti di orario, carico di lavoro alle stelle, nessun diritto di organizzazione dei lavoratori. Invece si tratta di un racconto che narra le condizioni di lavoro delle ope12 In collaborazione con Giuliano Ezzelini Storti, Prc di Vicenza. 138 raie della Raumer, negli anni settanta e ottanta del ‘900, in pieno nord est italiano. Nel 2001 comincia la fase di crisi per la Raumer: a seguito dell’acquisizione della azienda Montello, presso la quale il padrone intende trasferire tutte le lavorazioni che si svolgevano nello stabilimento di Valli del Pasubio. Montello viene acquistato da Raumer a seguito di fallimento. Ma si scontra subito con una difficoltà insormontabile: lo stabilimento di Montello non dispone della necessaria manodopera. “Quei lavoratori non sapevano fare le cose che si facevano da noi, non erano in grado di assorbire tutte le nostre produzioni. Ma Raumer insisteva…” A questo problema se ne aggiunge un altro: il grande aumento di costo delle materie prime che nella filiera tessile raggiungono un tremendo + 300%. “Questo fu una botta per tutti, ma soprattutto per chi lavorava il filato… quando lavori un prodotto povero, se ti aumenta così tanto il costo della materia prima diventa durissima reggere…”. Per far fronte a questa situazione di drammatico aumento del costo della materia prima venne avanti l’idea di costituire un consorzio tra le imprese tessili della zona specializzate nelle stesse produzioni (filati, elasticizzati…). L’idea che stava alla base della proposta era che consorziandosi le imprese avrebbe costituito una sorta di “centrale unica” di acquisto: questo avrebbe permesso, aumentando i quantitativi acquistati, di spuntare prezzi migliori. Ma a Raumer l’idea non consorzio non piacque, “non gli poteva piacere”. Per quale motivo? “Per un motivo di trasparenza. Se costituisci un consorzio, poi i conti vengono controllati, devi rendere leggibili e trasparenti i tuoi conti, le tue spese…ma non voleva”. Di Raumer viene contestata la gestione aziendale, soprattutto finanziaria che lo portava ad una scarsa distinzione tra spese aziendali e personali, anzi, “Sull’azienda caricava spese personali. Con il Consorzio non avrebbe più potuto farlo…” A questo punto Raumer decide per una ulteriore svolta: “Vuole diventare il Re del misto lana. Mentre le altre aziende del settore chiudevano, lui voleva diventare il Re…” Tuttavia, nonostante i proclami di Raumer le difficoltà si fanno sentire e cominciano le chiusure di stabilimenti: Recoaro, Isola Vicentina, porta queste lavorazioni a Valli del Pasubio ma, ovviamente, non c’è lavoro per tutti. La stessa cosa avviene a Frosinone dove Liritex era stata acquistata a prezzo di favore, con notevoli sgravi, in cambio del fatto che Raumer 139 mantenesse l’occupazione. Ma la notizia che la mobilità riguarderà anche i lavoratori dello stabilimento di Frosinone provoca la dura reazione delle organizzazioni sindacali che scrivono anche lettere di protesta alla stampa vicentina e ai sindaci della zona in cui Raumer ha i suoi stabilimenti. “Insomma, alla fine della storia, Raumer accetta di pagare liquidazioni stratosferiche per mettere buoni i lavoratori di Frosinone”. La stessa cosa avviene anche per Montello: “lì, addirittura venne aggredito il capo del personale, ci fu una trattativa molto dura che alla fine si risolse nello stesso modo: Raumer accetta di pagare delle buone uscite molto alte”. “Dopo averle provate tutte (Contratti di Solidarietà, Cassa integrazione ecc.) siamo finiti in Amministrazione Straordinaria.” Eppure le caratteristiche di questa azienda avrebbero portare ad un epilogo ben diverso. Le lavoratrici spiegano che, come riportare nelle interpellanze parlamentari presentate nel 2007 da deputati di Rifondazione Comunista “La Raumer è dotata di impianti adeguati a produrre sia grandi che piccole quantità, tutto nel massimo rispetto dell’ambiente e della salute dei lavoratori. In questo senso sono state fatte innovazioni e nuovi acquisti fino al 2000. In particolare, gli impianti di tintura sono dotati di cappe aspiranti e dispositivi di abbattimento dei fumi; i coloranti e i vari additivi vengono dosati tramite un moderno «color-service» in modo da evitare al massimo il contatto con sostanze pericolose e nocive.” La Raumer, quindi, disponeva di un mercato, aveva ordini, erano stati realizzati investimenti ed era conosciuta per le caratteristiche del suo prodotto: “la principale caratteristica distintiva della Raumer è la tintura in matassa che garantisce un’altissima qualità del prodotto finito, ma che le altre tintorie non eseguono più per l’alto valore aggiunto che richiede (ciclo di lavorazione più lungo e complesso e molta più manodopera) rispetto alla tintura in rocca” Le lavorazioni del prodotto di qualità si sono accompagnate ad investimenti anche sugli ambientali e sanitari delle produzioni e del luogo di lavoro: “… naturalmente è operante un depuratore biologico ben strutturato e all’avanguardia, l’ultimo ampliamento è stato fatto nel 1996 ed è stata ottenuta la certificazione ISO 14001, i controlli dell’Arpav hanno dato sempre ottimi risultati con punte di eccellenza. In questo ambito, finché l’azienda poteva ancora investire, si è fatto uno studio, in collaborazione con le Università di Genova e Venezia, sul riciclo dell’acqua di tinturatecniche di osmosi inversa, nanofiltrazione e recupero dei Sali”. Anche sul piano commerciale non esistevano problemi e il racconto e l’esperienza delle lavora140 trici hanno consentito ai deputati di Rifondazione di esprimere nelle interpellanze parlamentari considerazioni di sicuro fondamento in quanto derivanti dalla conoscenza diretta di chi nella fabbrica ci lavorava: “la Raumer ha sempre curato molto il rapporto con i clienti garantendo praticamente pronta consegna e servizio curatissimo eseguendo tutto al suo interno: dalle cosiddette «cartelle colore» da presentare alle fiere di settore alla campionatura dei colori. Infatti il laboratorio, tutto al femminile, è uno dei punti di forza della ditta, è ben attrezzato e si avvale di personale qualificato. Si lavora in tutto l’arco delle 24 ore riuscendo ad arrivare a fare anche 300 campioni al giorno, la gamma delle campionature infatti è praticamente illimitata: tutti i colori, tutte le fibre naturali e tutte quelle sintetiche. Se il laboratorio avesse in dotazione i macchinari appropriati sarebbe anche in grado di effettuare controlli di qualità su qualunque tipo di filato”. Ma i condizionamenti sono molto pesanti quando le difficoltà finanziarie e aziendali portano la Raumer ad essere “costretta a lavorare conto terzi per un unico cliente, Miroglio, ritrovandosi priva della rete commerciale e mancando completamente la liquidità per produrre filati per altri clienti.” Sempre grazie alle lavoratrici nelle interpellanze è stato possibile sottolineare che: “A quanto consta (…) il rapporto di collaborazione con Miroglio è molto più favorevole a quest’ultimo che alla Raumer che, pur rimanendo in produzione, «svende» giorno dopo giorno tutta la sua conoscenza, la sua tecnologia, la sua fetta di mercato e il marchio, a favore della filatura-tintoria che già da qualche anno Miroglio ha avviato in Bulgaria. Non esistono contratti scritti o accordi firmati, le relazioni fra le due aziende sono spesso tese e c’è un clima di diffidenza e di forte incertezza”. A causa di questa situazione il lavoro diminuisce notevolmente e nei primi giorni di giugno 2007 viene ventilato il rischio che si ricorra alla cassa integrazione. L’azienda, sempre nel 2007, annuncia inoltre che, se la Raumer funzionerà ancora, per la fine di settembre 2007 ci sarà un forte ridimensionamento del personale. Come detto in precedenza “affinché venissero mantenuti i livelli occupazionali si è fatto ricorso anche ai contratti di Solidarietà, si è tentato di trovare altri clienti e altre lavorazioni. Purtroppo l’entità dell’indebitamento è diventata insostenibile…”. All’inizio della crisi, che risale, come visto, alla fine del 2001, La Raumer era un gruppo con otto stabilimenti e con oltre 850 dipendenti. Nel 2007 “il suo debito è di 45 milioni di euro (in aumento), (…) e la nota veramente dolente è che il debito supera di gran lunga il capitale. Il tutto gravato da ipoteche, si sono vendute a Miroglio le macchine di tintura in rocca che, per ora, rimangono in fabbrica in comodato d’uso; quasi tutti i rimanenti 141 macchinari hanno affissa una targhetta recante la dicitura: «proprietà della Locafit BNL locazione macchine industriali»”. Da quanto scritto dai lavoratori e da quanto confermato da loro stessi nel corso dell’intervista i problemi si sommano in quanto la Raumer a fronte della situazione di crisi “ha stretto un legame di partenership con Miroglio di Alba, noto per la sua avversione a investire in Italia”. Ovviamente lavoratori e lavoratrici avevano visto giusto quando mettevano in guardia dal fatto che “Miroglio vuole la fetta di mercato in cui Raumer è leader, quindi acquista le quote di proprietà di Raumer in un’azienda bulgara e avvia una attività di filatura e tintoria usando i tecnici della nostra azienda, la nostra tecnologia e le nostre conoscenze del settore”. La Raumer si è privata della rete commerciale “che è stata affittata proprio da Miroglio” e così l’azienda Raumer si trova improvvisamente declassata “da leader che era nel settore diventa terzista…e per giunta lavora per un solo cliente: Miroglio, che fornisce le materie prime, paga la lavorazione e vende il prodotto tramite la rete commerciale in affitto”. Tuttavia la situazione non può durare a lungo: “Miroglio ha acquistato l’impianto di tintura in rocche che sarebbe rimasto in fabbrica in comodato d’uso fino a settembre (del 2007) e sempre a settembre sarebbe scaduto senza garanzie per il rinnovo”. Una incertezza acuita dal fatto che le ricerca di soluzioni da parte della proprietà finiscono in un nulla di fatto: finisce in niente la ricerca di un nuovo partner, “la creazione di una linea di prodotti con altro marchio per cui occorrono soldi che naturalmente non ci sono, la presentazione di un piano industriale in consorzio con altre aziende in difficoltà ad un grosso istituto di credito che però pone delle condizioni inaccettabili, si cercano anche altri tipi di lavorazione come il lavaggio di jeans (...) ma non si arriva da nessuna parte: il debito è troppo grande!”. La situazione è talmente deteriorata che i libri vengono portati in Tribunale. “In fabbrica arriva anche l’ufficiale giudiziario per portare via i macchinari che erano di proprietà della Locafit e che noi avevamo solo in leasing…c’erano pronti a camion per portare via la roba…sarebbe finito tutto: quindi abbiamo deciso di bloccare la fabbrica”. In precedenza uno dei creditori, la Banca Unicredit, aveva fatto istanza di fallimento. Nel giugno del 2007 viene dichiarato lo stato di insolvenza da parte del Tribunale di Vicenza e nominato il Commissario Giudiziale. In un successivo decreto del Tribunale, si prende atto che dalla relazione del Commissario Giudiziale si conferma che lo stato di insolvenza è da ricondurre in parte alla crisi del settore tessile esposto alla concorrenza degli 142 operatori asiatici, ma anche ad una cattiva gestione amministrativa, alla carenza di programmazione nell’affrontare la crisi e a “censurabili episodi di gestione che hanno privato la società di ingenti risorse”. Il Tribunale di Vicenza rigetta come tardiva e generica la proposta della proprietà di definire un piano industriale di rilancio, anche alla luce del pesante squilibrio finanziario determinatosi. L’unica possibilità viene individuata nell’estensione anche alle società partecipate dalla Raumer della procedura di Amministrazione Straordinaria puntando sulla cessione di rami d’azienda e dei cespiti ed in particolare del marchio Raumer. Con successive sentenze, nel corso del 2008, il Tribunale di Vicenza ha esteso la medesima procedura alle seguenti società del gruppo Raumer: Liritex S.p.a., Orchidea S.r.l., Montello S.p.a, Osmantus S.r.l., Filatura di Isola Vicentina S.r.l.. Con la decisione del Tribunale di ricorrere alla cessione dei beni della Raumer l’azienda stessa cessa di esistere. Tutti i beni vengono messi in vendita. Il ramo commerciale (comprendente il marchio Raumer) viene venduto a Miroglio così come il ramo tintoria. L’accordo sindacale prevede che dei lavoratori occupati presso lo stabilimento ex Raumer di Valli del Pasubio solo 61 vengano assorbiti da Miroglio; per gli altri 157 scatta la Cassa Integrazione. Nel frattempo si apre anche la partita giudiziaria con l’apertura di indagini, secondo notizie riportate dalla stampa locale, “per valutare l’eventuale danno che Miroglio avrebbe procurato a Raumer depauperandola dei beni. Si ricorderà che l’anno scorso la polizia tributaria di Vicenza sequestrò impianti di tintoria del valore di tre milioni di euro a Valli del Pasubio perché la Miroglio avrebbe voluto trasferirli nello stabilimento bulgaro di Sliven (…) sul registro degli indagati sono stati iscritti il fondatore del gruppo (…) Pino Raumer e i vertici del gruppo tessile Miroglio (…) perché sarebbe stato progettato lo svuotamento delle attività del gruppo di Valli del Pasubio. Questa manovra per gli inquirenti è avvenuta a partire dal gennaio 2005 quando Raumer affittò alla nuova società “Raumer Bulgaria Trade” il ramo commerciale e il marchio. La ditta poi si trasformò in E. Miroglio srl e quindi in E. Miroglio AD, società di diritto bulgaro. In questa maniera sarebeb stata perfezionata la svendita dei beni industriali che valevano molto di più dei 3,7 milioni di euro pagati”. In questa condizioni di lavoratori e di produzioni alla ex Raumer è rimasto ben poco. 157 sono in Cassa Integrazione e in azienda sono rimasti 34 impiegati e 26 unità in produzione, per un totale di 60 occupati. Durante il periodo di Amministrazione Straordinaria è stata chiusa la filatura “che Miroglio ha portato in Bulgaria”. Da parte delle lavoratrici intervistate viene sottolineato un aspetto importante, quello della qualità del prodotto a 143 seguito del trasferimento di parte delle attività in Bulgaria: “arriva del materiale difettoso e i clienti se ne accorgono…dicono che non vogliono quello che arriva dalla Bulgaria, altrimenti cambiano fornitore”. “In Bulgaria si sono trasferiti solo per pagare una miseria quei lavoratori, ma ne va della qualità. Oltretutto il fatto che arrivi materiale scadente dalla Bulgaria obbliga chi è rimasto a farsi il mazzo: bisogna correggere gli errori fatti dai bulgari e così è come se si lavorasse il doppio”. Eppure l’azienda continua a esercitare pressione sui lavoratori rimasti in stabilimento: “Ci vogliono creare pressioni…continuano a dirci che i lavoratori bulgari sono più bravi di noi…ma non è vero, noi vediamo come lavorano e vediamo la qualità del materiale… lo fanno solo per creare pressione…” “Non è facile per noi che siamo dentro”, sottolinea una lavoratrice, “a lavorare in reparto siamo in 27 ma sappiamo che fuori in Cassa ci sono 157 colleghi…ci pensiamo sempre a chi sta fuori..”. oltretutto sui lavoratori rimasti l’azienda carica ulteriori responsabilità: “ci dicono che se noi lavoriamo male l’azienda dovrà chiudere…ma la colpa non è nostra…dalla Bulgaria arriva del materiale schifoso…e l’azienda pretende la qualità! ma si fa fatica a lavorare è tutto materiale difettoso!” Rifondazione Comunista ha giocato un ruolo importante intervenendo nelle istituzioni locali inducendo alcuni Comuni a organizzare Consigli Comunali aperti sulla crisi Raumer e presentando le interpellanze parlamentari citate in precedenza. Inoltre, gli esponenti locali hanno avuto un ruolo importante a sostenere, e a volte anche a indirizzare, la lotta dei lavoratori. Questo ha creato una reazione da parte delle Categorie sindacali, in particolare di Cisl e Uil che hanno attaccato in maniera durissima alcune delegate sindacali accusandole di avere una “relazione diretta con Rifondazione”. Ma anche nei confronti della categoria dei tessili della Cgil il giudizio esprime qualche criticità: “ci aspettavamo un sostegno maggiore. Soprattutto nella fase finale, quando le trattative erano molto delicate e l’azienda arrivava con schiere di avvocati…ci saremmo aspettate anche un intervento del nazionale in questa vertenza…”. Su Cisl e Uil il giudizio è pessimo: “finchè ci scontriamo con il padrone, sappiamo chi abbiamo di fronte… ma quando siamo costrette a scontrarci con altri sindacati…questo ci sembra assurdo!”. “Con questa vertenza abbiamo dimostrato che la lotta paga…anche se abbiamo salvato solo 60 posti di lavoro…senza lotta non ci sarebbero nemmeno quelli….dimostrando che con la lotta si raggiungono risultati abbiamo fatto arrabbiare tantissimo Cisl e Uil…ce l’hanno a morte con noi…” Ma il risultato più importante, secondo le delegate sindacali, è proprio quello di essere riuscite ad organizzare i lavoratori: “Abbiamo creato una 144 solidarietà in azienda tra i lavoratori che in Veneto ce la sogniamo…”. “dopo aver avviato la sindacalizzazione di una fabbrica che per anni non aveva nemmeno un iscritto al sindacato, abbiamo anche fatto scioperare la gente…per la prima volta nella storia di questa azienda…”. Rimane un rammarico: “La Cgil avrebbe dovuto essere più combattiva…sostenerci di più…ci siamo rimaste male quando volevamo bloccare il Giro d’Italia e la Cgil non voleva venire….Forse questa fabbrica si poteva salvare, se la conflittualità fosse partita prima e se ci avessero sostenuto fino in fondo… non hanno voluto darci retta e ora sembrano solo preoccupati di gestire la crisi con gli ammortizzatori sociali”. 145 Inchiesta Eaton di Monfalcone13 “Lo stabilimento Eaton di Monfalcone produce valvole per motori endotermici (a scoppio), sia di scarico che d’aspirazione. La lavorazione si compone di una trentina di passaggi o traguardi di lavoro, ad alta cadenza temporale e precisione, per una produzione giornaliera, su tre turni, di 100.000 valvole teoriche, al netto dello scarto e della ripassatura che si mangia, più o meno, il 5% della produzione. I clienti di Eaton sono FIAT, Volkwagen, PSA (Renault, Peugeot, Citroen), in passato pure Honda, Ford e Toyota.La produzione annua dello stabilimento di Monfalcone (che conta 340 dipendenti) è di 22/23 milioni di valvole. Eaton, proprio come la Motorola, è una multinazionale (con sede negli USA, a Cleveland). I suoi maggiori azionisti sono dei fondi pensionistici.La Divisione europea della componentistica, fino al 2006, era composta da uno stabilimento a Montornès, in Catalogna, uno a Nordhausen, in Germania, e quattro in Italia: Bosconero, Rivarolo, Massa e Monfalcone. Tutti siti dimensionati sui 300/400 dipendenti.Poi, in successione, hanno chiuso lo stabilimento catalano, quello di Rivarolo e quello di Massa, l’unico che produceva punterie. Secondo il quotidiano La Nazione, a margine delle iniziative sindacali a Massa, Eaton avrebbe dichiarato l’intenzione “di smantellare tutte le aziende che attualmente si trovano sul territorio italiano: oltre alla Eaton apuana, anche gli stabilimenti di Monfalcone (provincia di Gorizia) e di Bosconero (provincia di Torino)”. L’azienda vorrebbe chiudere la sua produzione in Italia: probabilmente per seguire, da un lato, una strategia di delocalizzazione nell’Europa Orientale e, dall’altro, per concentrarsi di più sugli Stati Uniti. Secondo il quotidiano fiorentino tutto questo lo si può leggere pure all’interno del suo sito internet, in uno dei tanti documenti prodotti dall’azienda: “si parla di un preciso piano chiusura per gli stabilimenti italiani”. Non c’è miglior competenza operaia per descrivere uno stabilimento e per introdurre cos’è la Eaton è ampiamente sufficiente il passagio sopra riportata scritto da un Rsu di fabbrica. Questa inchiesta è stata condotta in due parti: la prima con l’ausilio di una video camera e impostata con 4/5 domande uguali per tutti gli intervistati; la seconda con il classico colloquio/intervista in forma collettiva per realizzare alcuni approfondimenti. La prima parte, appunto è stata condotta rivolgendo ai singoli lavoratori intervistati le seguenti domande: sei pessimista o ottimista rispetto alla vostra vertenza; quali obiettivi si pone la vostra lotta; quali metodi di lotta avete utilizzato ed infine una o due domande su una specifica iniziativa assunta da Rifondazione Comunista in merito alla presentazione di progetti 13 In collaborazione con Gaetano Dato, Prc di Trieste e Emiliano Zotti, Prc di Gorizia. 146 di legge su delocalizzazioni e obiettivi di reindustrializzazione. L’inchiesta è stata condotta l’otto ottobre 2009, in un momento nel quale i lavoratori Eaton di Monfalcone sono in Cassa integrazione straordinaria e stanno presidiando lo stabilimento per evitare che venga smantellato. La prima domanda, appunto, verte sull’atteggiamento che hanno maturato i lavoratori verso la crisi della loro azienda. Ovviamente prevale il pessimismo. “All’inizio ero così così, ora invece sono pessimista, siamo titubanti su questa crisi repentina. Non ci crediamo più, la Eaton ci tiene come ruota di scorta perché non sono sicuri che lo stabilimento in Polonia renda come previsto, quindi tengono qui un punto di riferimento. Anche se dicono che c’è la crisi, gli altri stabilimenti in Germania e Polonia fanno straordinari: più si chiude in Italia e più dagli altri aumenta il carico di lavoro, per questo siamo pessimisti sul futuro. Si entra subito nel merito del vero problema dello stabilimento di Monfalcone: la possibile chiusura dovuta alla strategia di delocalizzazione verso l’est europeo attuata dalla multinazionale Eaton: “Stiamo Pagando questo discorso di delocalizzazione verso est, hanno aperto in Polonia e abbiamo segnali dalla RSU che stanno cercando terreni in Cecoslovacchia: è evidente che l’azienda vuole delocalizzare in queste zone: è questo che ci penalizza di più.” Il fatto di avere a che fare con una multinazionale complica parecchio le cose, anche in termini di interlocuzione e di confronto: “Le vere decisioni non sono qua”. Come vedremo nel seguito del report, l’organizzazione piramidale della Eaton fa si che tutte le decisioni vengano assunte nel quartier generale degli USA e semplicemente attuate nei territori, senza possibilità di confronto e di ricerca di soluzioni diverse. Le decisioni USA vengono imposte a tutti i territori “Parlano tanto ma non c’è modo di sapere cosa vogliono fare di questa fabbrica. Siamo in una fase di fermo. La speranza è poca anche alla luce delle esperienze precedenti che hanno visto la Eaton chiudere senza troppi complimenti alcuni stabilimenti italiani.” “Da 30 anni lavoro qui , (…) ho già visto cosa hanno fatto a Massa, quando chiudono è difficile che riprendano; qui aspettano che se ne vada un po’ di gente; hanno aperto in Polonia e quindi sono pessimista” “esiste il 10% di possibilità che lo stabilimento riprenda, (…) al 90% viene chiuso per delocalizzare in Polonia che fa il doppio del nostro fatturato”. Alcuni chiamano in causa anche la specializzazione produttiva dello stabili147 mento di Monfalcone: “sono realisticamente pessimista, perché il settore auto motive è in crisi da decenni”. Tra i lavoratori non ci sono certezze. “Il problema di base è che la Eaton ci tiene a “bagno Maria”, da aprile 2009 siamo in CIG fino ad aprile 2010, ma abbiamo paura che ci sia ancora un anno di CIGS, questa voce comincia a girare nei palazzi della Regione, a fronte della crisi e del desiderio della Eaton di uscire dall’Italia per forza che sono pessimista”. Questo lavoratore introduce, accanto al tema della delocalizzazione, quello della concorrenza tra stabilimenti (e quindi tra lavoratori) “Adesso sono pessimista, anche se prima avevo qualche speranza, ora non vedo nessuna alternativa, siamo in Cassa integrazione ma da come va l’andazzo non so se ad aprile si apre, stanno tirando bene la Polonia che è nostro concorrente, gli Usa puntano sulla Polonia. “Chiudono in Italia, Massa, Rivarolo Canavese, Bosconero…. non va tanto bene, noi saremo il prossimo agnello da sacrificare.” A fronte di questa dichiarazione è stato chiesto se esistono contatti e forme di collaborazioni con i sindacati degli altri paesi europei dove la Eaton ha stabilimenti. “Non abbiamo rapporti con sindacati esteri, solo voci, sappiano che la Polonia lavora a pieno e noi siamo chiuso, ma non ci sono rapporti con i lavoratori.” La seconda domanda verte su quali obiettivi si sono posti i lavoratori con le loro iniziative. La prima risposta riguarda il rapporto con le altre realtà di crisi della zona: “Creare un insieme con altre realtà della zona che non mancano come la nostra, in modo di cercare in tutti i modi di far si che non portino via la produzione, che non spostino macchinari…” La Cassa integrazione non è vista come la soluzione, l’obiettivo è quello di “Tornare al lavoro come abbiamo sempre fatto” “La Situazione di Cassa inetgrazione noi ce l’abbiamo fino ad aprile e dopo si pensa già, con segnali della provincia, che verrà prolungata, loro cercheranno di prendere tempo, verrà prolungata, dobbiamo anche puntare al discorso di prendere un aumento di retribuzione della CIG, perché non basta per arrivare alla fine del mese”. Ovviamente la situazione è ancora più pesante per gli atipici, con contratti part time: “Io sto peggio di loro: ho 660 euro al mese e tre figli. Sono qua per non lasciare niente di intentato, se va tutto a rotoli almeno posso dire di avere fatto tutto quello che potevo”. Il discorso della delocalizzazione viene ampliato anche ad altre realtà del 148 territorio: “La Cassa integrazione è fino ad aprile, pensano al rinnovo ma non ci sono cose concrete, si sa che in Polonia hanno costruito stabilimento che se va a pieno regime fa 50 milioni di valvole e noi siamo tagliati fuori, hanno visto che è più conveniente e qui a Monfalcone ci sono già molte crisi come la nostra”. Tra i discorsi affiora anche l’aspetto della riqualificazione dei lavoratori dal punto di vista professionale. “…devo trovare un lavoro, devo pensare anche al mio caso, non ti prende nessuno, sappiamo lavorare macchine numeriche ma per certi lavori non ti prendono; devi essere esperto in certi campi (chimico, saldatore ecc…), vediamo se riesco a fare un corso, ho 52 anni, ho una famiglia con tre figli che studiano, non è facile riprendere a studiare, però la volontà c’è”. “Nel lungo periodo ci proponiamo la difesa lavoro, nel breve riuscire a far si che la Cassa integrazione se prolungata sia funzionale a corsi di formazione per essere reimpiegati in altri settori e non rimanere fermi per due anni attendendo le sorti, il lavoratore deve essere riqualificato e messo dentro nuovi cicli produttivi”. Per i metodi lotta viene spiegato che si è deciso per una “lotta che ha vari livelli: assemblee tutti mesi con le Rsu il giorno di paga, fare sempre il punto della situazione, a dicembre è stato allestito un gazebo di fronte al Municipio di Monfalcone per il Natale del Cassaintegrato, è stata fatta la festa in piazza, concerti per sensibilizzare l’opinione pubblica attorno alla Eaton. Mobilitazione e pressione verso giornali, le istituzioni e i partiti affinché il caso non si dimentichi visto che c’è anche tutto l’indotto, un pezzo di economia del territorio.” Secondo un membro del Direttivo provinciale Fiom di Gorizia “esista una sofferenza dei lavoratori nella parte economica perché la Cassa integrazione non consente di arrivare alla fine del mese. Alcuni prendono anche meno di 700 euro, se hai moglie a carico, i figli, il mutuo per la casa non ce la fai…, quindi prima cosa alzare i massimali della Cassa inetgrazione per arrivare ad un assegno decente, almeno l’80% reale dello stipendio, verso i mille euro. Poi servono corsi di riqualificazione: se lo stabilimento chiude bisogna essere pronti a ricollocare in latri settori, sperando che la crisi finisca in altri settori e quindi poter ricollocare i lavoratori che perdono il posto in altre aziende.” Per un membro della Rsu è importante “riqualificarsi, sono già state fatte riunioni con la Provincia che ha garantito veri corsi “ad personam” quindi con possibilità di riqualificarsi, siamo 330 persone è un allarme sociale per 149 la provincia, a fronte di una situazione come la nostra e la Carraro ; nel lungo periodo si spera che torni l’80% della retribuzione della Cassa integrazione, ma siamo solo noi Fiom a chiedere di tornare all’80% della retribuzione, mentre Cisl e Uil sono contrarie. La maggior parte dell’opinione pubblica non sa questo perché si dice che gli ammortizzatori sociali danno copertura, ma non sanno che è al massimo sono solo 800 euro”. “Da luglio la Provincia ha messo in campo una piano anti-crisi. Bisogna ricorrere a corsi di formazione per cercare di creare, per quanto difficile, competenze per inserire nel mondo del lavoro chi viene licenziato, vista anche la nostra età, siamo fuori dal mercato del lavoro”. Viene posta anche la questione della reindustrializzazione attraverso la riconversione delle produzioni: “Dobbiamo cercare di ottenere la salvaguardia dei posti di lavoro, altrimenti ricorrere alla riconversione degli stabili se esiste possibilità, come è successo da altre parti, come quello stabilimento che faceva catene, poi è stato riconvertito in altre operazioni meccaniche per salvaguardare i posti di lavoro. Ormai la situazione è questa in tutta la zona, ormai sta degenerando.” Torna il tema della concorrenza tra stabilimenti dello stesso gruppo industriale: “Si spera che nelle altre fabbriche aperte dalla Eaton in Polonia, Serbia ecc. facciano male un po’ di lavoro e che ci mandino qua qualche commessa altrimenti qui la fabbrica non avrà vita,” Accanto a questo il tema dell’etica (anche in considerazione del fatto che ormai è di moda tra le imprese predisporre e diffondere tra i dipendenti i Codici Etici): “ ci fanno la testa come un pallone parlando di etica, ma solo per noi operai, ma per i padroni è un’altra cosa, loro fanno quello che vogliono e noi siamo i burattini.” Non mancano i riferimenti al possibile ricorso ad altri strumenti di lotta: “Useremo anche metodi di lotta più efficaci: la dirigenza dovrebbe avere attenzione al fatto che non esiste solo guadagno…” “Da inizio estate abbiamo avviato il presidio dello stabilimento ogni mattina e cercheremo di portare avanti questo creando anche altre iniziative, presidi anche a livello provinciale e regionale “ Si prendono come riferimento anche esempi di lotte radicali condotte in altri paesi: “Comincio a guardare ai francesi, con loro i padroni hanno la vita più difficile”. I lavoratori si sono dati come strumento anche la creazione di un blog sul 150 quale raccontare l’evoluzione della vertenza e fornire tutte le informazioni utili al caso, il blog si chiama etonite. Il presidio al momento appare la forma di lotta più decisa e che ha consentito di ottenere anche obiettivi concreti come, ad esempio, evitare lo smantellamento dello stabilimento: “Vigiliamo che non portino via macchinari e altre cose” “Facciamo il presidio per controllare che le macchine siano dentro lo stabilimento e cercare il più possibile di coinvolgere sindacati e dirigenti sindacali, cercare qualche spiraglio, coinvolgere le autorità di tutti i settori, per qualsiasi cosa dove esiste qualche modo per arrampicarsi, vista la situazione buia…” Tra i metodi di lotta occupa un posto importante anche il tema dell’informazione, soprattutto riferita all’immagine che di sé cercano di costruirsi le multinazionali, torna quindi il tema dell’etica. “Facciamo informazione, cerchiamo di far casino per far vedere come si comportano, la ditta multinazionale americana ci faceva scrivere sul computer “cosa ne pensi della fabbrica”, ma a loro non frega niente, siamo dei numeri, non sanno che ci sono famiglie dietro2. “con la televisione facciamo casino per spiegare come si comportano le multinazionali”. Tra i lavoratori, viene spiegato, “la componente straniera rischia ancor di più, per questo dobbiamo far capire ai lavoratori italiani che il problema dei lavoratori stranieri è un problema anche per i lavoratori italiani”. Sempre in tema di fragilità sociali, si richiama il caso degli “atipici”: “c’è il problema precari fuori da qui che nemmeno conosciamo, noi abbiamo 750 euro di Cassa integrazione, ma questi soldi sono la loro paga, per questo vogliamo mettere insieme queste realtà diverse. Per questo abbiamo costituito il coordinamento regionale dei lavoratori contro la crisi per mettere insieme la varie vertenze e non lasciarle nella singola fabbrica”. “Il presidio è sempre aperto per avere come uno sportello sempre aperto per dare notizie e riprendere subito le trattative”. “Serve anche per essere visibili per l’opinione pubblica, se no si è dimenticati”. Torna il tema della professionalità, di come questa sia stata costruita in tanti anni di lavoro e sia un tema d’orgoglio operaio: “… dopo 20 anni che lavoro qua sono orgoglioso, non possono portarmi via tutte queste macchine in Polonia, gli faremo vedere che avranno di fronte gruppo di operai che ci tengono a questo lavoro, …dopo 20 anni che soino qua. Come hanno fatto altri andremo sui tetti, legarsi con le catene, qualcosa faremo, non 151 pensino che hanno tutte le porte aperte, non diremo “prego si accomodi”, gli diremo “non scherzate”. La domanda circa l’utilità di un progetto di legge contro le delocalizzaizoni riscuote grande interesse e disponibilità. “Si è molto utile, è una realtà che prende sempre più piede”. “Hanno portato in giro le fabbriche con tutti i soldi nostri, anche la Merkel ha dato soldi, ma la Eaton in Germania rimane là!, qui invece vanno in Polonia, anche ad esempio Obama negli Usa ha dato soldi alle fabbriche di auto perché restino in America”. “siamo interessatissimi, perché rischiamo la delocalizzazione, non solo in termini teorici, ma pratici, Eaton ha deciso per l’est europeo, quindi gli stabilimenti italiani progressivamente verranno dismessi. Non la sosteniamo solo in termini egoistici, ma anche di impostazione di politica economica, non si può pensare di delocalizzare dopo aver avuto contributi pubblici pagati dai contribuenti, tra cui i lavoratori dipendenti, è una questione di dignità. Forse la vostra proposta è arrivata un po’ in ritardo, e il sindacato non ha colto l’occasione per fare azioni di protesta contro le imprese che investono con contributi pubblici e pi decidono di andare altrove”. “Queste aziende non possono andare all’estero per aumentare il loro guadagno perché trovano un costo del lavoro molto minore con retribuzioni vergognose.” Parlando di strategie aziendali di delocalizzazione, il discorso coinvolge anche la politica: “La destra parla solo di aziende e non di lavoratori, ma ci dicano se per loro è un merito che la FIAT vada in Serbia e lascia Termini Imerese in Cassa integrazione, questo la dice lunga sulle loro intenzioni politiche.” Le aziende de localizzano per cercare il più basso costo del lavoro possibile, ma i prodotti che riportano in Italia (fatti, magari, in Romania, Cina o India) non hanno un prezzo proporzionalmente ridotto: “sulla vostra proposta di legge sono d’accordissimo, la delocalizzazione è il cancro da estirpare, è quello che ci mette in ginocchio tutti: soldi ad aziende che poi vanno all’estero e tornano con questi prodotti e ci mettono il marchio Made in Italy…”. Sareste disposti a sostenerla? “Magari, subito, grazie, da questo secondo, che dio vi benedica!” Alla domanda relativa alla proposta di legge sulle delocalizzazioni aggiungiamo anche quella relativa all’idea di assegnare alle società finanziarie regionali (in questo caso Friulia Spa) un ruolo di politica industriale, per realizzare reindustrializzazioni, riqualificazioni o riconversioni industriali delle 152 aziende in crisi. “E’ la via giusta per uscire da questa crisi, se questa idea può essere portata avanti il sindacato deve essere in prima linea per una cosa del genere.” “…Friulia ha preso taglio più legato alla finanza e meno alla produzione e sviluppo di aziende, questo è un punto nodale, noi rischiamo la marginalità, siamo una regione marginale anche per mancanza di trasporti e ferrovie, e se non c’è investimento con enti operativi di questa regione non rimane niente, c’è già stato l’errore delle giunte Illy per aver dato quel taglio a Friulia, devono essere preposti allo sviluppo.” “così come deve cambiare la normativa, se gli uffici del lavoro sono alle province, queste devono avere anche la formazione, è una contraddizione insostenibile: bisogna dare alle province la delega al lavoro assieme a quella della formazione professionale.” “Basta carozzoni, hanno mangiato troppo, queste finanziarie devono essere cambiate per fare qualcosa di concreto per le aziende” La crisi alla Eaton di Monfalcone giunge dopo diversi tentativi di minimizzazione da parte dell’azienda. Le prime avvisaglie si hanno nell’agosto 2008 e nel settembre dello stesso anno scatta il primo ricorso alla Cassa integrazione a rotazione. Da quel momento la riduzione del lavoro e del conseguente ricorso alla Cassa integrazione crescono sempre di più. Nell’aprile del 2009 parte la Cassa integrazione straordinaria per un anno, con prospettive di un prolungamento oltre la scadenza dell’aprile 2010. Tra le cause di questa crisi viene sicuramente richiamata la crisi generale del settore dell’automotive, direttamente legato al settore dell’auto che, a detta dei lavoratori, finora ha retto solo grazie alle generose politiche di incentivi e rottamazioni varie… Ma la vera causa del rischio chiusura per lo stabilimento di Monfalcone è da individuare nella decisione dell’azienda di de localizzare la produzione nell’est europeo, mentre in Italia si chiudono gli stabilimenti (Massa, Rivarolo Canavese, Bosconero in CIG, Monfalcone in CIG) in Polonia la Eaton apre un grande stabilimento che ha cominciato la produzione. La capacità produttiva dello stabilimento Eaton in Polonia è di 50 milioni di valvole, cioè è in grado di sostituire le produzioni di Monfalcone e Bosconero. Ma lo stabilimento in Germania non chiude, in quel paese la Eaton non riesce ad attuare le sue strategie di delocalizzazione. Perché? “Perché là lo Stato gli farebbe il mazzo”. Insomma, per la Eaton ci sono stabilimenti si seria A e di serie B: quindi quello di Nordhausen in Germania è stato oggetto di investimenti per la 153 messa in sicurezza e l’ammodernamento degli impianti, invece per quello di Monfalcone, nonostante siano stati richiesti investimenti non è stato fatto niente. Questo è dovuto anche la fatto che la dirigenza non è legata al territorio, “li mandano qui e basta”; “abbiamo avuto una lunga sequela di dirigenti durati pochissimo”. “A livello di stabilimento Eaton italiani, come Fiom abbiamo chiesto che si costituisse un coordinamento sul modello di Fincantieri, ma la proposta non è passata, anche per debolezza della stessa Fiom.” La stessa Eaton ha molto osteggiato questa proposta, non ha mai voluto rendere efficace qualsiasi forma di coordinamento e comunicazione, ha voluto tenere tutti gli stabilimenti ben separati tra loro. Su questo la Eaton è passata e ha vinto. “A livello europeo la Eaton ha accettato i CAE (Comitati Aziendali Europei), ma questi non sono mai stati sviluppati nello loro competenze, ci si limitava ad una forma di informazione una o due volte l’anno. Con i lavoratori dello stabilimento di Madrid (dove ci sono 80 persone licenziate) abbiamo comunicato per mail, grazie al blog, e ci siamo scambiati pareri e informazioni.” Purtroppo esiste questa concorrenza tra stabilimenti, è espressamente incentivata dalla Eaton tra l’altro con l’utilizzo di dati sulla produttività che non sono mai stati verificati nella loro reale fondatezza. “A Monfalcone la produttività nostra era la più elevata, da 216 valvole a persona siamo passati ad una produzione di 230 con un grosso sforzo, eravamo la punta della produttività ma non ce l’hanno mai detto; anzi venivano portando altri dati che parlavano di produttività più elevate in altri stabilimenti.” Con la chiusura dello stabilimento la crisi globale c’entra molto poco; la Eaton ha preso la palla la balzo per fare quello che aveva in mente da tempo: spostare tutto in Polonia. Anche lo stabilimento di Bosconero non aveva problemi di produzione: funzionava a pieno regime addirittura con ore di lavoro straordinarie. Adesso gli stabilimenti italiani vengono tenuti solo come “riserva” per tappare i buchi. La ragione dello spostamento delle produzioni in Polonia è semplice: “In Polonia un operaio lo pagano 800 euro contro i 1.300/1.400 euro di quanto vengono pagati in Italia.” L’atteggiamento delle istituzioni non è molto positivo, soprattutto tra loro non collaborano e se parlano lo fanno con diffidenza. Un esempio su tutti il mancato trasferimento alle province della competenza sulla formazione 154 professionale che risulta così separata dagli uffici del lavoro di competenza provinciale. I lavoratori alle istituzioni chiedono un piano organico sull’industria: un tavolo permanente che affronti le crisi. “Per fare questo bisogna che le istituzioni si parlino, che collaborino con le parti sociali, che si capisca il futuro di questo territorio. Quali imprese ci saranno e quale manodopera servirà.” I rapporti con l’impresa appaiono impossibili. “Sulla Eaton abbiamo tentato di intervenire ma ha una struttura piramidale molto gerarchica. Al vertice i dirigenti mondiali, poi quelli europei e infine quelli locali. Questo meccanismo non da risposte, anzi genera una grossa perdita di tempo, impone valanghe di telefonate e di riunioni rimandate. Si tratta di una struttura con un potere molto centralizzato, quando è il vertice della multinazionale che decide il livello territoriale si muove. Questo crea problemi non indifferenti a partire dal fatto che sui territori gli interlocutori dei lavoratori non sono i veri proprietari (“parliamo con dirigenti che non rappresentano l’azienda”), “attendono sempre gli input dagli USA” “A Massa addirittura agli incontri non si sono presentati con i dirigenti ma con l’Avvocato. Questo la dice tutta sulla rappresentatività dei dirigenti locali”. Quindi “anche le istituzioni, con chi parlano?” Alla strategia di delocalizzazione si accompagna un’altra strategia di prodotto: nell’ambito della Eaton cala la produzione di automotive e cresce l’investimento nell’elettronica. Anche questa è una indicazione della multinazionale: dismettere la parte pesante (auto) e tenere e sviluppare l’elettronica. “Al momento non vediamo prospettive sullo stabilimento; cerchiamo di difendere la nostra professionalità.” Sulla professionalità acquisita nel tempo, i lavoratori si soffermano a lungo indicandola come una grossa conquista raggiunta attraverso l’azione sindacale, mentre l’atteggiamento dell’azienda era tutto improntato al paternalismo. Una eventuale chiusura della Eaton produrrebbe reazioni a catena anche sulle aziende artigiane che lavorano in regime di fornitura per la Eaton stessa. Esiste un ampio indotto che dalla chiusura dello stabilimento subirebbe una mazzata pesantissima. Ogni volta che in un territorio si ragiona della chiusura di imprese così grosse si dovrebbe calcolare il numero di posti di lavoro non limitandosi a quelli direttamente persi, 155 Il rapporto con la politica e i partiti viene affrontato così: “ti faccio un esempio concreto: quando nel ’98 ci fu la prima crisi tra Prodi e Rifondazione tutti in stabilimento ne parlavano, dopo 10 anni nessuno parla più di politica. Viene vista come una cosa tutta verticistica”. “La sinistra deve fare proposte serie sulla questione sociale, deve essere percepita come utile e deve avere una presenza tra i lavoratori” Dopo la manifestazione del 2007 sulla precarietà non è cambiato nulla: questa è una delle cose che più hanno minato la credibilità della sinistra quando è stata al Governo. “Dopo il corteo bisognava dire ai lavoratori: ecco siamo arrivati a questo punto, adesso cosa facciamo? invece ai lavoratori non è stato detto niente e poi non si è fatto più nulla per ottenere quello per cui si manifestava. Quindi anche quella manifestazione, giusta nei contenuti, è stata vista come un momento di rottura tra sinistra e governo. Sicuramente c’erano delle ragioni, ma poi anche la caduta di Prodi è stata vista come colpa della sinistra.” “A sinistra serve una grossa discussione su cosa siamo e cosa vogliamo, serve meno elettoralismo e più centralità del lavoro”. La percezione dei lavoratori è che non esista più una sinistra politica, questa va riformata, va unita su pochi slogan: questo può dare più credibilità “I lavoratori non capiscono più tutte queste divisioni, non vedono un punto di riferimento. Se la sinistra è disunita allora prevale la logica del voto utile: votano PD in funzione anti-Berlusconi o ricorrono come voto critico a Di Pietro.” 156 Inchiesta condotta alla Carraro di Gorizia14 Questa inchiesta è stata condotta in due parti: la prima con l’ausilio di una video camere e impostata con 4/5 domande uguali per tutti gli intervistati; la seconda con il classico colloquio/intervista in forma collettiva per realizzare alcuni approfondimenti. La prima parte, appunto è stata condotta rivolgendo ai singoli lavoratori intervistati le seguenti domande: sei pessimista o ottimista rispetto alla vostra vertenza; quali obiettivi si pone la vostra lotta; quali metodi di lotta avete utilizzato ed infine una o due domande su una specifica iniziativa assunta da Rifondazione Comunista in merito alla presentazione di progetti di legge su delocalizzazioni e obiettivi di reindustrializzazione. L’inchiesta è stata condotta l’otto ottobre 2009, in un m omento nel quale i lavoratori Carraro di Gorizia stanno presidiando lo stabilimento per evitare che venga smantellato. La prima domanda, appunto, verte sull’atteggiamento che hanno maturato i lavoratori verso la crisi della loro azienda. Ovviamente prevale il pessimismo. “Io sono qui 13 anni e non ho mai visto una crisi così. (…) quindi da come si svolte cose in questi ultimi mesi mi fanno pensare al pessimismo. .. come lavoratori si, ci sono stati momenti di crisi, ma mai di questo genere, abbiamo sempre lavorato, fatto anche molti straordinari in un clima sempre pieno di lavoro, c’era tanto lavoro, fino a che è subentrata la cassa a settimane alterne tra febbraio e marzo.” Ma nessuno di noi pensava una cosa del genere. Personalmente l’ho saputo venendo a lavorare leggendo locandina dove vendono i giornali, abbiamo saputo lì degli esuberi, chi leggendo giornale che volevano mettere in mobilità, si vedeva che era calato lavoro, due linee erano state portate via (una in gennaio e una a fine anno), sapevamo che c’era esubero ma non che si evolvesse così. E’ stato un fulmine a ciel sereno, tra l’altro siamo in due io e mio figlio: è stata una botta che non ci si aspettava, abbiamo sempre lavorato, sempre con orgoglio di essere del gruppo Carraro con tanta volontà e grande disponibilità, disponibili sempre, Carraro, l’abbiamo sentito personalmente, diceva che ci tiene molto al nostro lavoro, sia lui che altri sempre elogi: siamo il fiore all’occhiello, produttivi, sempre contenti di Gorizia rispetto ad altri rami, sempre contenti di Gorizia. Adesso siamo quelli che hanno pagato di più.” Questa prima dichiarazione mette a fuoco almeno due temi centrali della 14 In collaborazione con Gaetano Dato, Prc di Trieste e Emiliano Zotti Prc di Gorizia. 157 questione Carraro: 1) la grande disponibilità dei lavoratori a corrispondere alle esigenze dell’impresa (soprattutto in termini di straordinari); 2) l’immagine della Carraro come quella di una azienda in cui il lavoro e la qualità dello stesso vengono riconosciute dalla proprietà come valori positivi. La Carraro ha deciso di precedere con la messa in mobilità di 80 lavoratori, ne rimarrebbero in produzione circa 40, ma nessuno si fa illusioni sul fatto che a questi 40 sia garantito il lavoro: “…è solo una questione di tempo, la proprietà aveva cercato già 4 anni fa di chiuderci dicendo che lo stabilimento non era così redditizio, ma lo stabilimento ha dimostrato sempre grosse capacità di lavoro e di flessibilità e quindi sono tornati sui propri passi aiutati dal fatto che il mercato aveva grossa ricezione oggi invece il mercato non ci aiuta in quanto vengono a mancare gli ordinativi, le 40 che rimarrebbero è solo per permettere alla azienda di riorganizzare e de localizzare le linee produttive che sono qua. Se gli 80 hanno due mesi di tempo, agli altri aggiungiamone 6.” Anche la Carraro, quindi, nonostante gli attestati di stima del padrone nei confronti dei lavoratori, della loro professionalità e disponibilità, non esita a de localizzare all’estero e questo problema viene avvertito come uno dei principali da parte dei lavoratori: “L’azienda ha stabilimento all’estero, in Polonia, Argentina, Cina e India…forse è questo il problema..”. Il pessimismo dei lavoratori deriva anche dalla situazione di grande indebitamento finanziario che ha maturato il Gruppo Carraro: “Sono pessimista: perché la Carraro ha grosso debito di 250 milioni di euro che non sanno come appianare. Sono veramente pessimista; anche gli altri stabilimenti sono nella nostra stessa situazione, anche loro hanno tagli importanti circa 50%, la vedo nera anche per loro. Loro hanno un fatturato nei primi 6 mesi di quest’anno che è la metà di quello che avevano previsto, per cui tutta la gente che hanno era previsto che lavorasse per doppio, quindi con metà fatturato taglieranno metà persone, alla fine previsto un taglio di 600 660 persone”. Anche per gli operai della Carraro gli ammortizzatori sociali in sé non sono un obiettivo, lo sono nella misura in cui consentono di tamponare la situazione attuale in attesa che si creino nuovamente le condizioni per tornare al lavoro vero: “Ce n’è voluto un po’ per rendersi conto, è stata una botta aver letto alla mattina che siamo fuori, ci sentiamo tagliati e buttai via da un giorno all’altro senza motivo, è una sensazione bruttissima, esser buttati fuori dal lavoro. L’obiettivo è lottare avere cassa straordinaria, questo è l’unico obiettivo, Carraro è stato deciso a dire che lo stabilimento di Gorizia mette in mobilità 80 operai quindi non si discute è irremovibile, …la nostra lotta è questa, se mi dicono vai a lavorare ci andrei subito ma 158 fuori non c’è lavoro, sono tutti in strada: chi in cassa, chi in mobilità, chi in disoccupazione…, il nostro obiettivo sopravvivere finché la situazione si sblocca, speriamo presto.” “L’obiettivo primario è quello di usufruire di contratti con ammortizza sociali, come i contratti di solidarietà, questo sarebbe l’ideale, anche perché questa azienda ha una età media di 30-40, siamo tutti giovani con impegni economici e con e famiglie alle spalle; un contratto di solidarietà ci sarebbe di grande aiuto, anche perché potrebbe essere rinnovato, invece oggi la mobilità non ci porta a nulla: in 12 messi dalla crisi non usciamo e non ci saranno alternative, per Gorizia ancora meno. Con un contatto di solidarietà hai comunque 24 mesi a cui aggiungere eventualmente la mobilità: tra 3 anni forse la crisi migliora. Vogliamo riprendere a lavorare anche perché Carraro non è qui da ieri, è qui da più di 20 anni”. “Gli obiettivi della lotta: vogliamo evitare che le 80 persone finiscano in mezzo a una strada e che non chiudano fabbrica”. “Il 15 ottobre ufficializzeremo il coordinamento di gruppo per cercare di andare fino al ministero per cercare di avere una uscita meno traumatica dei lavoratori e avere certezze maggiori anche a livello di paga, per agevolare il lavoratore se deve cambiare lavoro…la prospettiva di ripresa della produzione: dipende dalla crisi quanto sarà lunga.” I metodi di lotta adottati sono quelli del presidio permanente davanti allo stabilimento e l’organizzazione di volantinaggi per informare e sensibilizzare la popolazione: “il metodo è quello di restare uniti a fare il presidio, chi non lavora, …è una maniera silenziosa, con rispetto… Per il momento aspettiamo le risposte di Carraro, in silenzio ma facendoci sentire, abbiamo fatto un volantinaggio a Gorizia per fare conoscere la situazione sperando che Carraro conceda almeno la cassa integrazione, per non buttarci in strada.” Anche per descrivere la protesta, quindi, alcuni ricorrono all’utilizzo di termini come “in silenzio”, “con rispetto”, lasciando trapelare anche la mancanza di abitudine ad azioni di lotta nei confronti della Carraro. Tra i più giovani, tuttavia, non si esclude il ricorso anche a forme di lotta un po’ meno “silenziose” e “rispettose”….: “Come lavoratori al momento (…) stiamo continuando a picchettare dimostrando solidarietà tra noi, ma se cose non migliorano bisogna inasprire protesta, e..non so..occuperemo? andremo sui tetti anche noi? Bisogna estremizzare? estremizzeremo! Noi vogliamo continuare a lavorare, vogliamo essere ancora qui, Gorizia non offre altro. Se non otterremo nulla, la cosa più giusta sarebbe l’occupazione, impedire 159 che entrino o escano camion, che entri o esca e materiale. La proprietà deve capire che ha avuto a che fare con persone e non con dei numeri”. In altri è forte la preoccupazione di non superare un certo limite: “Stiamo usando il confronto, sollecitiamo le varie istituzioni…se le cose non cambieranno? ma..si.. forse cambieranno le modalità, ma abbiamo fatto scioperi, manifestazioni, sollecitato il confronto…. Più di così! Ma sempre nella legalità…bisogna stare nella legalità”. Il rappresentante della Rsu mette in guardia sulla capacità di tenuta e sull’efficacia delle azioni intraprese: “Abbiamo cominciato con uno sciopero appena abbiamo avuto l’incontro con l’azienda dove ci diceva che c’erano 80 esuberi, il giorno dopo subito abbiamo fatto lo sciopero con l’inizio del presidio, poi la settimana dopo abbiamo fatto 4 ore al giorno di sciopero, ma l’azienda si è subito adattata a questo sciopero. chiamando più gente del dovuto, hanno richiamato i cassaintegrati, hanno annullato il nostro sciopero, da questa settimana abbiamo levato lo sciopero e sono tornati come prima.. E’ un po’ difficile trovare una forma di lotta, non è così semplice, decidiamo giorno per giorno, decidiamo anche con gli esterni e vediamo… La lotta sarà lunga bisogna tenere sulla durata più che la forma…. Non è facile stare qui fuori per tanti mesi, la gente si stanca…. Altre forme di lotta sono state il volantinaggio alla festa sabato mattina. Domani andremo alla manifestazione a Milano (quella del 9 ottobre convocata dalla Fiom sulla questione del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, n.d.r.) … anche là porteremo striscione con le altre ditte del gruppo” Viene infine confermato il coordinamento sindacale tra gli stabilimenti del Gruppo Carraro: “Abbiamo questo Coordinamento con gli altri stabilimenti, su questo siamo partiti noi della FIOM…tutte le aziende si sono dette d’accordo e il 15 ottobre a Padova viene ufficializzato.” Il 15 si è tenuto il coordinamento sindacale degli stabilimenti Carraro con l’obiettivo di arrivare ad ottenere un Tavolo Nazionale. A Gorizia, su 117 dipendenti, 80 finirebbero i mobilità; questa riduzione occupazionale si aggiunge al fatto che negli anni molte macchine sono state smontate e portate in altri stabilimenti. Adesso rimarrebbero soltanto quattro centri di lavoro che, nell’ottica dell’azienda, rappresentano soltanto un costo. Alcune produzioni sono state spostate a Padova e Pordenone, nonostante fossero prodotti la cui progettazione era nata nello stabilimento di Gorizia. Esisteva un ufficio progettazione, addirittura il Gruppo Carraro aveva deciso di acquistare lo stabilimento di Gorizia proprio per la presenza di questo ufficio. 160 Poi per esigenze di gruppo sono cominciate le operazioni di accentrare il più possibile nello stabilimento padovano, a partire dai settori della progettazione e dei collaudi. Le decisioni aziendali, quindi, hanno fortemente indebolito lo stabilimento goriziano, progressivamente privati delle attività più qualificate ed ora ridotto a 4 centri di lavorazione ed al montaggio; molto poco rispetto alla situazione iniziale e alle potenzialità che esistevano. Anche in questo caso, da parte dell’azienda è prevalso un mero calcolo economico relativo al costo del lavoro: da qui la decisione di trasferire progressivamente quote di produzione in Polonia. Come detto in precedenza il 15 ottobre si sarebbe svolto a Padova il Coordinamento sindacale delle aziende del Gruppo Carraro: si tratta dei tre stabilimenti di Padova, Pordenone e Gorizia. Il coordinamento sindacale dei tre stabilimenti viene presentato come un buon risultato in termini di unità e solidarietà tra lavoratori: l’azienda, infatti, preferirebbe mantenere separati gli stabilimenti in modo da contrattare accordi separati; “per fortuna anche a Padova e Pordenone hanno capito che con gli accordi separati non si ottiene niente”. In questo caso il termine “accordi separati” non viene riferito alla separazione sindacale (tra Cgil da un parte e Cisl e Uil dall’altra) ma tra stabilimenti del medesimo gruppo industriale. In particolare l’unità tra stabilimenti del Gruppo Carraro viene individuata come un elemento imprescindibile sia per poter “fare un confronto e un accordo con il Governo” sulle strategie e i destini complessivi dell’azienda, sia per ottenere risultati contrattuali importanti per i lavoratori: “Con gli accordi singoli non ottieni niente. Nemmeno Padova, che è lo stabilimento più grande, da sola riesce ad ottenere risultati importanti”. L’obiettivo, quindi, è quello, a livello di Gruppo Carraro di tenere botta, di evitare lo smantellamento degli stabilimenti perché “magari tra 3 o 4 anni torna il lavoro”. Qual è il problema principale della Carraro? “Carraro ha un grosso debito finanziario. A causa degli investimenti che ha fatto in Cina e India ha un debito di 500 milioni di euro; a questo punto le Banche hanno cominciato a porre un ultimatum: o presenti un Piano Industriale oppure…”. In particolare sono i rappresentanti sindacali a battere il tasto degli errori della dirigenza, in termini di investimenti all’estero e, al contrario, della mancanza di innovazione ed investimenti nello stabilimento di Gorizia. “Nel Piano Industriale che ci hanno presentato non c’è nessun investimento ma soltanto lo spostamento delle produzioni dove il lavoro costa 161 meno”. Quindi nessun impegno nella ricerca, nell’innovazione, nel miglioramento dei processi produttivi e nel prodotto, ma solo l’obiettivo del “risparmio sul costo del lavoro”. Il mercato della Carraro è rappresentato per il 66% da paesi europei, per il 26% dall’America Latina e per il 7% dai nuovi mercati della Cina, dell’India e di altri paesi dell’est asiatico. In questa area il Gruppo Carraro sta concentrando i suoi investimenti in quanto intende acquisire maggiori quote di mercato. In realtà, come viene spiegato dai lavoratori, non si tratta di un processo di internazionalizzazione finalizzato alla conquista di nuovi mercati, ma di vera e propria delocalizzazione in quanto l’apertura di stabilimenti in Cina e India coincide con l’obiettivo di chiudere quelli italiani. Al momento non si intravvede una via d’uscita perché “con un debito così alto non ci sono risorse per fare investimenti e innovazione da noi”. Eppure la situazione produttiva era tutt’altro che negativo: “Il fatturato è sempre stato buono, addirittura in dicembre abbiamo fatto gli straordinari, abbiamo lavorato al sabato, hanno chiamato anche dei lavoratori interinali”. Questo è un aspetto centrale dell’inchiesta condotta in questa fabbrica come già rilevato n elle interviste precedenti: la grande disponibilità dei lavoratori a corrispondere alle richieste dell’azienda. Viene sottolineato da tutti: “Abbiamo sempre dato la massima disponibilità, anche a lavorare al sabato”. La Carraro di Gorizia viene descritta come una fabbrica in cui “c’è tutto a norma, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro mai nessun problema”. Anche dal punto di vista del rapporto azienda – lavoratori viene descritto in termini molto positivi: “Le relazioni sindacali sono sempre state buone; per noi lavoratori era proprio un bel lavorare; è molto difficile trovare un’altra azienda così…”. Per questo a diversi lavoratori risulta difficile capire come abbia “cambiato faccia” in maniera così repentina. Se le Rsu negli incontri con la Dirigenza avevano avuto qualche avvisaglia che le cose voltavano al peggio, i lavoratori hanno appreso della notizia della messa in mobilità per 80 di loro direttamente dai giornali ed in particolare dal titolone della locandina del giornale locale che annunciava la decisione dell’azienda. Come è stato detto, si è trattato di “uno choc”. La situazione viene vista negativamente perché, oltre alla crisi mondiale, il problema principale della Carraro viene individuato nel livello dell’indebitamento che, viene detto, potrebbe “portare addirittura al fallimento”. 162 L’unica possibile via d’uscita viene individuata nell’intervento del settore pubblico: “Se la Regione o lo Stato non intervengono la Carraro non ha alternative”. Per intervento pubblico diretto i lavoratori intendono il ricorso a “fondi agevolati, quelli europei, ma anche statali e regionali” in quanto ritenuti meno gravosi di “quelli delle banche” dal punto di vista del peso finanziario. Il ragionamento dei lavoratori verte sul futuro dell’attività produttiva e del loro lavoro chiarendo che preferirebbero un intervento in questa direzione anziché limitato ai soli ammortizzatori sociali: “La Regione ha detto che era disponibile a finanziare la Cassa, ma non per il resto…anche Friulia (la finanziaria regionale) non presta denaro in caso di debito così elevato, presta solo per spese di investimento…adesso non aiuta..”. Per i lavoratori il problema è quindi essenzialmente economico – finanziario: la richiesta è che qualche soggetto pubblico (Stato, Regione, Europa) intervenga con finanziamenti per salvare l’attività in base ad accordi precisi finalizzati alla tutela del lavoro “qui, in Italia”. E la richiesta di finanziamento è che “arrivi direttamente, non attraverso le Banche”. La chiusura della Carraro a Gorizia coinciderebbe con la chiusura pezzi di filiere produttive distribuite sul territorio con la conseguente perdita di ulteriori posti di lavoro (“almeno 100 posti nell’indotto”). I lavoratori parlano di alcuni fornitori, tra i quali la Meccanica Isontina, che negli anni avrebbero anche realizzato importanti investimenti con l’acquisto di macchinari e la predisposizione di specifici centri di lavorazione per far fronte alle commesse della Carraro. Ma adesso “lavorano solo per piccole quantità”. Dal punto di vista sindacale la Rsu è composta da tre membri di cui uno Fiom e due Fim; anche gli iscritti, seppur di poco sono a vantaggio della Cisl (40) rispetto alla Fiom (30). Complessivamente alla Carraro di Gorizia si è sempre registrata una bassa conflittualità sindacale; frutto delle buone relazioni sindacali e dell’ampia disponibilità dei lavoratori a corrispondere alle richieste dell’azienda (straordinari, sabati ecc…). Esisteva un alto livello di salario con un orario abbastanza favorevole: da contratto l’orario settimanale era di 35 ore, con un sistema di riduzione delle ferie (4 settimane) in modo complessivamente da garantire un orario figurativo di 38 ore e mezzo alla settimana, pagate 40. Al sabato la paga era piuttosto favorevole: un premio fisso di 20 € e una paga aumentata del 50%. 163 Il contratto integrativo prevedeva un sistema di premio di risultato centrato su tre obiettivi (qualità, redditività e produttività) che, anche se le Rsu riconoscono di non essere in grado di controllare appieno, di fatto sono sempre stati riconosciuti come raggiunti da parte dell’Azienda. Anche “a livello umano” l’azienda si è sempre dimostrata disponibile ad accogliere le esigenze dei lavoratori anche per eventuali problemi famigliari (“ad esempio se avevi il bambino che a scuola non stava bene potevi uscire per andarlo a prendere …”). Questa disponibilità aziendale, viene subito precisato, era ampiamente contraccambiata dalla disponibilità dei lavoratori. Anche i lavoratori interinali (che sono arrivati anche al numero di 33 unità) “erano trattai bene e molti venivano confermati”. Insomma: la sicurezza del luogo di lavoro (“tutto era a norma”), l’elevato livello salariale, le relazioni umane, le buone relazioni sindacali, unite ad una bassa conflittualità sindacale e ad un’ampia flessibilità e adattabilità dei lavoratori avevano creato un buon ambiente di lavoro che fa dire a molti: “Magari anche in altre aziende fosse esistito un ambiente così…” “sarebbe un peccato chiudere una azienda del genere” ecc. Dal punto di vista politico viene riconosciuto che i lavoratori discutono molto poco di politica. “Viene sentita come una cosa lontana”, o ancora “I partiti pensano solo alle elezioni e non si occupano di problemi dei lavoratori”. Per la RSU, in fabbrica “finché si parla di sindacato Ok; ma di politica non ne vogliono sentire, troppo sfiduciati”. A Rifondazione Comunista cosa chiedereste, per quali obiettivi si dovrebbe battere? La risposta è molto semplice: “Non permettere la chiusura dell’azienda, mantenere tutti i posti di lavoro”. Sull’inchiesta Carraro – contributo su quanto racconta il padrone: “il fiore all’occhiello” di Devi Sacchetto1 (tratto da Crisi tv) Un elemento centrale dell’inchiesta condotta è senza dubbio la solitudine, indipendentemente dalla presenza o meno del sindacato. Una solitudine che si coniuga con forme di lotta assolutamente inadeguate segno, credo, anche di modalità di conflitto perseguite nel corso degli ultimi trent’anni che tendono a essere concilianti e che mirano spesso a meri, seppur importanti, incrementi salariali. Come viene sottolineato anche in questo difficile momenti per una parte dei lavoratori la lotta deve essere condotta “in silenzio, con rispetto”, proprio mentre la direzione vuole chiudere la fabbrica mostrando come il legame con il territorio venga giudicato poco 164 importante. I giovani, come sempre, sono i più combattivi sebbene abbiano sicuramente qualche chance in più nel reperire un altro lavoro. Un altro punto che emerge con forza dall’inchiesta è la questione di questo adagiarsi, nei periodi di espansione economica, su quanto racconta il padrone: “il fiore all’occhiello”. Una frase che probabilmente il democratico Carraro ha usato anche per lo stabilimento indiano e cinese, quando si è trovato in quei paesi di fronte ai lavoratori indiani e cinesi. Lo schieramento a sinistra del padrone sembra abbia fatto abbassare la guardia oltremisura e nonostante l’estrema disponibilità dei lavoratori alle esigenze dell’azienda si arriva al punto di conoscere la crisi attraverso la locandina dei giornali. Colpisce come fino a un attimo prima questi lavoratori lavorassero anche il sabato con straordinari e così via e in pochi mesi si ritrovino sull’orlo della chiusura. Dopo averli ricattati negli ultimi quindici anni con la delocalizzazione e averli spremuti, ora grazie anche al nuovo riposizionamento dell’azienda con stabilimenti sparsi in varie parti del mondo parte la richiesta di cassa integrazione, mobilità. D’altra parte è importante sottolineare che, evidentemente, le capacità lavorative non sono considerate strategiche. Diversamente da quanto sostengono i lavoratori io penso che gli stabilimenti in giro per il mondo non siano stati pensati come delocalizzazione, ma costituissero la necessità dell’impresa ormai terzista di grandi multinazionali di seguire i propri committenti nello sviluppo di nuove imprese perché il just-in-time richiede la vicinanza logistica, almeno in questo caso. E’ il posizionamento come terzista che costringe l’azienda a questi spostamenti. Da questo punto di vista potrebbero essere vere le spiegazioni sostenute ancora prima della crisi da Tommaso Carraro: “clienti come John Deere e Bosch stanno investendo e ci chiedono di seguirli, in un area [la Russia, nda.] senza fornitori locali. (Federico Nicoletti, Gear World spinge sulle acquisizioni: Raddoppio in 4 anni, Il Corriere Veneto, 27 gennaio 2008). Allo stesso modo in India dove la Carraro ha uno stabilimento lo spostamento è dovuto anche al fatto che nell’area sono attivi tutti i nostri principali clienti, da Caterpillar a John Deere (Dichiarazione di Carlo Borsari, amministratore delegato della Carraro; si veda Pasqualetto C., Carraro, Più ricerca in India, Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2006). Resta da vedere se le lotte, finalmente, dei lavoratori riusciranno a modificare in modo consistente questa situazione e se imporranno al democratico Carraro le responsabilità sociali delle ricadute di mobilità e cassaintegrazione su un territorio che ha garantito in questi anni lauti profitti e una certa pace sociale. 165 La crisi nel territorio di Ferrara15 Per provare a comprendere la profonda crisi che ha colpito la Provincia di Ferrara nel 2009 è necessario partire da un dato sconcertante, quello delle ore di cassa integrazione cui le aziende hanno fatto ricorso. Il dato a fine anno si è attestato a 6 milioni e 700 mila ore, ripartite in 3 milioni e 600 mila per l’ordinaria e in 3 milioni e 100 mila per la straordinaria; interessate sono state 182 imprese. A questi dati devono poi aggiungersi quelli della cassa integrazione in deroga che ha coinvolto un centinaio di aziende, per un totale di più di 800 lavoratori. Presi in sé questi dati non sembrerebbero distinguersi più di tanto da quelli del resto del Paese; sicuramente potranno risultare più pesanti, ma pur sempre in linea con una depressione economica generale. Invece, se si prende in considerazione anche il 2008, è possibile accorgersi di come il territorio ferrarese abbia assistito quasi in anticipo al crollo del proprio tessuto produttivo industriale. Le settimane di cassa integrazione ordinaria concesse si assestavano già sulle diverse decine; tra tutte spiccano le 32 settimane della Berco di Copparo e le 20 settimane della VM Motori di Cento. Il settore su cui si è abbattuta maggiormente la contrazione dei mercati è stato sicuramente quello metalmeccanico, le cui principali imprese insistono in quattro aree del territorio provinciale così circoscrivibili: la zona di Ferrara, quella di San Giovanni di Ostellato, quella di Cento e quella di Copparo. Tra le aziende più a rischio spicca sicuramente la Berco di Copparo, del gruppo ThyssenKrupp, che produce componenti per macchine da movimento terra. L’azienda, con in suoi 2400 dipendenti circa, è sicuramente una delle più importanti della Provincia, nonché della Regione; inoltre rappresenta la fabbrica simbolo del comune di Copparo, sorgendo praticamente in centro e costituendo una risorsa fondamentale per tutta la comunità. Dopo la cassa integrazione ordinaria del 2008, nella primavera del 2009 è stata concessa la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per crisi aziendale, nonostante le richieste del sindacato fossero state di almeno 24 mesi; a lavorare a rotazione è più o meno il 40% dei dipendenti. Nei prossimi mesi verrà discussa la proroga della cassa, ma la dirigenza è già pronta a mettere sul tavolo la discussione sugli esuberi, che si assesterebbero sulle diverse centinaia. Inoltre le sorti di questa azienda sono strettamente collegate con quelle delle gemelle veneta e piemontese; l’impegno 15 Scheda a cura di Giovanni Verla, Prc di Ferrara. 166 dovrà essere perciò diretto su tre fronti, per scongiurare ogni esubero, ma soprattutto per impedire ogni ipotesi di chiusura di un qualche stabilimento. Considerando il territorio di San Giovanni di Ostellato le maggiori problematicità sono legate alla TRW, che produce componentistica per automobili con 360 dipendenti, e la Lte-Toyota, che produce carrelli elevatori e conta 175 dipendenti. E’ dei primi di gennaio la notizia che è stata siglata la cassa integrazione straordinaria per un anno per la Lte; con questa manovra dovrebbe essere scongiurata, almeno per il momento, la previsione da parte della dirigenza di una riduzione dell’organico, con un esubero di circa 30 lavoratori. Per quanto riguarda il territorio del comune di Ferrara, le situazioni più critiche riguardano Romagna Ruote, azienda leader nella produzione di cerchioni in lega (annoverava tra i propri clienti Jaguar e Bmw), e Nylco e P-Group, due aziende chimiche che insistono sul sito del petrolchimico. La condizione disperata di Romagna Ruote è il frutto di numerose crisi e di una mala gestione nella successione della proprietà. Dapprima gruppo Reynolds, passò successivamente alla Alcoa (da 400 operai si passa a 270) che nel 2005 ne annunciò la chiusura; venne rilevata nell’ottobre dello stesso dal gruppo Alessio, che le conferì l’attuale nome e assetto, con una riduzione di manodopera da 270 a 195 unità. Con la nuova gestione lo stabilimento precipitò in una crisi finanziaria e produttiva, gli investimenti concordati non vennero effettuati, si assistette al fallimento delle strategie commerciali, e alla perdita delle certificazioni di qualità. Nel dicembre del 2007, dopo essere stato dichiarato lo stato di insolvenza, i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione straordinaria e nell’aprile del 2008 è statp nominato il commissario straordinario. Nel settembre del 2009 scaduti i termini legali per la vendita dello stabilimento, è stata concessa un proroga che scadrà il 22 gennaio del 2010. Circa 90 lavoratori stanno presidiando lo stabilimento del 10 dicembre 2009, dividendosi su quattro turni per coprire tutto la giornata e tutta la notte. Una cordata di imprenditori ferraresi avrebbe avanzato una proposta di acquisto, ma solo 85 sarebbero i lavoratori interessati. Su questi presupposti lavoratori e oo.ss. non sono disposte a trattare e intanto il 22 gennaio è alle porte. Per quanto riguarda le due aziende del petrolchimico Nylco e P-Group, fallito il loro tentativo di fusione (Nylco è partecipata per il 60% da PGroup), sono state poste in liquidazione volontaria dai soci (rispettivamente il 6 novembre e il 23 dicembre), con l’obiettivo da un lato di ricercare un possibile compratore delle strutture produttive, e dall’altro di avviare una procedura concorsuale di abbattimento dell’esposizione finanzia167 ria. Ad oggi la società milanese Essebi sarebbe interessata e rilevare un ramo della Nylco, ma ad opporsi sarebbe Sef, società dell’Enipower, che fornisce energia elettrica e vapore; Sef non sembra disposta ad accettare il concordato preventivo e pretenderebbe l’anticipo sulle forniture, oltre al saldo dei pagamenti arretrati e non corrisposti. Venendo da ultimo a considerare il territorio di Cento, tutte le principali aziende sono in cassa integrazione: la VM Motori, con poco più di 1100 dipendenti, la Baltur, che produce bruciatori, caldaie e condizionatori con 196 dipendenti, la Lamborghini, che produce radiatori con 117 dipendenti, e la Oerlikon Graziano, che produce ingranaggi e alberi cilindrici con 226 dipendenti. La vertenza più complessa e più preoccupante è quella legata alla Oerlikon Graziano. La Graziano viene acquisita nel 2006 dalla svizzera Oerlikon Group, che controlla altri sette stabilimenti in Italia, oltre ad uno in India e ad uno negli Stati Uniti; uno stabilimento in Repubblica Ceca è già stato chiuso. La multinazionale nella primavera del 2009 ha annunciato 1370 esuberi in Italia su un totale di 2709 occupati tra i vari stabilimenti; nel frattempo è stata concessa la cassa integrazione straordinaria dal 26 ottobre 2009 al 25 ottobre 2010 per crisi aziendale. Nel dicembre 2009 è stata però annunciata la chiusura totale dello stabilimento di Cento entro il primo trimestre del 2010, nonostante vi siano commesse fino a giugno. Si segnala che negli anni non sono stati fatti investimenti in ricerca e tecnologia, ma grazie alla altissima professionalità degli operai la produzione è sempre stata d’eccellenza. Con riguardo alle cause della crisi aziendale, un problema sollevato dalla dirigenza sarebbe quello legato ai costi di affitto dell’area; questa, infatti, a differenza degli altri stabilimenti, non è di proprietà della Oerlikon, ma è data in affitto dalla New Holland, controllata di Fiat, che sostituisce di fatto anche l’unica committente, dopo il ritiro delle commesse da parte di Allison (General Motors). Risulta dunque necessario anche un intervento da parte di Fiat, volto a rivedere i canoni di affitto e a rinnovare le commesse, così da eliminare ogni ombra su una sua responsabilità, anche indiretta, nella scelta da parte dell’azienda svizzera di chiudere lo stabilimento. Un ulteriore problema è dato dalla possibile destinazione dell’area ad uso abitativo; l’amministrazione comunale dovrà necessariamente intervenire per vincolare l’area ad uso industriale, così da evitare ogni ipotesi di speculazione. La crisi sta interessando anche il settore tessile, ma questa affonda le proprie radici negli ultimi sette anni. La morfologia del settore in questione necessita di una riflessione iniziale; accanto alle poche imprese di mediograndi dimensioni si affiancavano decine di piccoli laboratori di artigiana168 to. Come previsto dalla l.164/75 ai lavoratori delle imprese artigiane, escluse quelle dell’indotto sottoposte all’influenza gestionale da parte del committente industriale, non è applicabile il trattamento di integrazione salariale. E’ così che uno dopo l’altro un centinaio di laboratori tessili si sono trovati costretti ad interrompere permanentemente l’attività. A salvare la poche aziende rimaste è stata la previsione legislativa nel 2005 della cassa integrazione in deroga. Si calcola, comunque, che da questa crisi si salveranno solo la maggiori aziende rimaste e che gli occupati passeranno da circa 800 a poco più di 400. 169 Inchiesta condotta alla LTE (Gruppo Toyota) di Ostellato (Fe)16 L’origine della attuale LTE nasce da un processo di fusione che finì sotto la lente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato epr verificarne la rispondenza alle normative anti trust per il processo di fusione per incoroporazione della Cesab su LTE. Cesab Carrelli Elevatori S.p.A. (di seguito Cesab) è una società attiva nella produzione, vendita e noleggio di carrelli elevatori e macchinari mobili e semoventi destinati al trasporto e al sollevamento di materiale. Cesab è indirettamente controllata dalla società svedese BT Industries AB, che opera prevalentemente nel settore della produzione e commercializzazione di carrelli elevatori ed, in generale, di prodotti per la movimentazione di merci, la quale è a sua volta controllata dal Gruppo TICO. Quest’ultimo fa parte del gruppo Toyota, al vertice del quale vi è la Toyota Motor Corporation, una società a responsabilità limitata di diritto giapponese. Lift Truck Equipment S.p.A. (di seguito LTE) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di montanti per carrelli elevatori e realizza anche attrezzature integrate per lo spostamento laterale dei carichi nonché posizionatori idraulici da impiegare per il funzionamento delle forche per carrelli elevatori. LTE al momento della fusione era controllata per il 78,90% da Siderval S.p.A., a sua volta controllata per l’88,61% da Calvi Holding S.r.l., la quale ultima risulta partecipata per il 51,36% da Calfin S.p.A. e per il 48,64% dalla famiglia Chini. LTE, a sua volta, controlla la società CME S.r.l. (di seguito CME) attraverso una partecipazione pari al 50% del capitale sociale (la rimanente parte del capitale è attualmente detenuta da due azionisti persone fisiche) e la società CELTI S.r.l. (di seguito CELTI) che realizza semilavorati relativi ai montanti per carrelli elevatori (il capitale sociale di CELTI è attualmente detenuto da LTE per una quota del 67% e da Cesab per la restante quota pari al 33%). L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Cesab del 100% delle azioni di LTE. In particolare, Cesab acquisterà una percentuale complessivamente pari all’80,4% del capitale sociale di LTE da Siderval (precedentemente al perfezionamento dell’operazione un’azionista persona fisica cederà a Siderval la propria partecipazione in LTE) e del 10% da alcune persone fisiche. Il rimanente 9,6% è posseduto da LTE a titolo di azioni proprie. 16 In collaborazione con Stefano Calderoni e Giovanni Verla, Prc di Ferrara. 170 LTE, quindi, viene acquistata tre anni fa da parte del Gruppo Toyota, che subentra nella proprietà alla precedente Siderval. Per la precisione, la catena di proprietà passa attraverso BT, società svedese che controlla Cesab (Bologna) che a sua volta controlla LTE. Al vertice della catena societaria la multinazionale Toyota. Per dare l’idea di come venne presentata l’acquisizione dell’azienda di Ostellato da parte del Gruppo Toyota basta leggere questa presentazione del 2006: “Il raddoppiare dei volumi di produzione in pochi anni e l’attenzione da sempre riposta alla qualità e alle esigenze dei mercati hanno permesso all’azienda di perseguire una costante ricerca e continui investimenti in ambito tecnologico, sia in relazione al prodotto che ai processi produttivi La recente acquisizione della società LTE, produttrice di montanti, e l’introduzione di una business unit completamente dedicata alla progettazione e produzione di “carrelli speciali” permettono di qualificare ulteriormente il caso di Cesab Carrelli Elevatori come un autentico fenomeno nel mondo della movimentazione, sulla scia di una continua evoluzione.” Da questa radicale trasformazione societaria, per i lavoratori LTE cominciano i problemi più seri che, tuttavia, in una prima fase, vengono gestiti con l’accordo sindacale sottoscritto nel settembre del 2008 improntato ad una flessibilità in negativo. L’obiettivo, cioè, è quello di non ricorrere all’utilizzo di ammortizzatori sociali – anche per intaccare la disponibilità di questi strumenti – ma attraverso il ricorso ad una leggera riduzione dell’orario di lavoro, seppur a parità di salario. “Nessun regalo da parte dell’azienda”, viene subito precisato, “la riduzione dell’orario a parità di salario avrebbe dato origine ad una compensazione futura attraverso la quale i lavoratori avrebbero “saldato” il conto con l’azienda”. La prima crisi, quindi, “è stata gestita in maniera molto soft e senza intaccare minimamente gli ammortizzatori sociali”; questa soluzione ha trovato un ampio consenso tra i lavoratori. Mentre i lavoratori accolsero con favore e pragmatismo un accordo sindacale che consentiva loro di superare una fase di difficoltà senza conseguenze sociali, da parte dell’azienda ci fu una gestione tutta politica della vicenda, con un fortissimo elemento di propaganda: “addirittura Bollini – l’amministratore delegato – fece una teleconferenza per dire quanto erano stati bravi ..per dire che aveva gestito la situazione senza nessun impatto occupazionale..” La multinazionale Toyota, però, comincia ben presto a pretendere di im171 porre anche in provincia di Ferrara il “modello Toyota” fatto di “qualità totale, processi snelli, drastica riduzione dei tempi ecc..” Alle dichiarazione sull’applicazione integrale del “modello Toyota” fanno seguito anche dei fatti importanti: nei Bilanci dell’azienda vengono previsti risorse economiche molto significative da investire per realizzare innovazioni di processo, di prodotto, per la formazione del personale …e tutto questo non rimane solo sulla carta ma viene fatto davvero”. L’azienda, quindi, ha voluto consolidare lo stabilimento di Ostellato e crescere dal punto di vista della qualità delle prestazioni, sui livelli produttivi e sul piano occupazionale. Insomma, “Lo stabilimento LTE di Ostellato veniva presentato e trattato effettivamente come la stella nascente del gruppo”. Due anni fa venne realizzata anche una operazione societaria di fusione per incorporazione con un’altra ditta, operazione che venne realizzata in maniera “molto garantita sul piano occupazionale e sindacale”. La fusione per incorporazione, infatti, sul piano occupazionale significò l’inglobamento delle lavorazioni svolte dalla ditta azienda inglobata con conseguente aumento dei livelli occupazionali. Cioè, anziché limitarsi ad acquistare o affittare il ramo d’azienda lasciando però le lavorazioni svolta all’esterno del proprio perimetro aziendale, LTE decise di internalizzare queste prestazioni con i lavoratori che erano occupati in esse. Ma con il tempo l’ingerenza di Toyota del suo tipico stile gestionale si fanno sempre più sentire; in particolare la multinazionale impone un modello di gestione aziendale – in tutti i suoi aspetti – da territoriale a sovranazionale. A partire dalle relazioni sindacali, che solitamente avevano un andamento abbastanza regolare e prevedibile e che diventano improvvisamente molto problematiche e conflittuali a seguito del manifestarsi dell’atteggiamento aggressivo di Toyota. La produzione dello stabilimento LTE è quella dei carrelli elevatori, un prodotto che, come moltissimi altri, subisce il contraccolpo della crisi economica e del raffreddamento dei mercati sui quali cala la domanda. Alla contrazione della domanda, fa seguito, automaticamente e abbastanza prevedibilmente, una riduzione della capacità produttiva. In particolare nel gruppo Toyota che, essendo ossessionato dai tempi e dalla piena rispondenza delle produzioni al mercato e alle condizioni produttive (basta solo richiamare la famosissima formula del just in time), non perde occasione per avviare una operazione di pesante ristrutturazione dei livelli produttivi e occupazionali. 172 Il calo di vendite comporta un conseguente calo dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali pressoché per tutti i gruppi industriali, figuriamoci per Toyota e per il “paradiso” del just in time, delle produzioni flessibili, del continuo adeguamento alle condizioni della domanda, della riduzione di scorte e magazzini ecc… A quel punto Toyota decide di imprimere una svolta molto forte a tutto il sistema di relazioni: la prima scelta è un cambio drastico e repentino di tutti i dirigenti di stabilimento. Viene imposto, in particolare, un nuovo Dirigente Generale che manifesta una impostazione esclusivamente tecnica, completamente avulsa dal contesto sociale e territoriale in cui si trova lo stabilimento LTE. “Dal punto di vista tecnico era molto capace, ma completamente estraneo al contesto”. Nonostante il 2009 inizi con una fase di crescita, in maggio la LTE torna a fare i conti con le conseguenze della recessione. A questa fase di difficoltà viene risposto con il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, una gestione della situazione attraverso una misura di basso impatto tanto che “nessuno si lamentava, quasi non ci si accorgeva della misura assunta”. La gestione della Cassa si rivelò indolore anche per la particolare modalità assunta che prevedeva la concentrazione delle chiusure consentendo una gestione delle riduzioni d’orario molto leggera. Improvvisamente si abbatte la decisione della corporation Toyota secondo la quale in Europa bisogna fare tutto il possibile per alzare la quotazione del titolo in Borsa. Per Toyota, quindi, anche gli stabilimenti europei dovranno adottare scelte di riorganizzazione, anche pesanti, pur di contribuire a spingere in alto il titolo. Lo strumento imposto da Toyota ai propri stabilimenti è quello classico che solitamente le multinazionali usano per dare un segnale forte ai mercati finanziari: la riduzione dei costi attraverso il dimagrimento degli organici. “La lezione che i fatti dimostrano è proprio questa: ogni volta che una azienda annuncia licenziamenti e riduzioni di personale il suo titolo in Borsa comincia a salire”, quindi “tutti i lavoratori hanno capito immediatamente che Toyota faceva un ragionamento esclusivamente finanziario; pur di alzare il valore del titolo non esitava a ricorrere al licenziamento dei lavoratori”. In prima battuta l’intervento di Toyota sembra limitarsi agli stabilimenti francesi e svedesi; “noi, come sindacato, veniamo avvertiti della cosa; im173 mediatamente ci preoccupiamo e interveniamo presso la Direzione LTE per capire se questo potrebbe succedere anche a Ferrara. Ma veniamo rassicurati del fatto che Ostellato non sarebbe interessato dai tagli di organici che invece stavano avvenendo dalle altre parti in Europa”. La posizione espressa inizialmente da Toyota, infatti, era che “lo stabilimento di Ostellato era considerato dalla Toyota come la parte della famiglia che non andava toccata”. Invece, dopo qualche tempo Bollini ha posto le organizzazioni sindacali di fronte: “ci ha detto che o accettavamo i licenziamenti che loro avevano quantificato, oppure gli impianti di LTE sarebbero stati commissariati”. Ovviamente da parte sindacale viene dichiarata l’indisponibilità a sottostare ad una simile forma di ricatto e a quel punto Bollini “apre una trattativa tutta sua al termine della quale dice di aver strappato un risultato a Toyota: cioè, a fronte di una disponibilità sindacale ad accettare l’ottica dei licenziamenti, Bollini avrebbe garantito ogni misura possibile contenere gli effetti sociali dei licenziamenti”. La trattativa si apre a Bologna presso il Gruppo Cesab (come visto, proprietario di LTE) con la posizione aziendale di una riduzione del personale che prevede un taglio di 120 lavoratori su Bologna e poco meno di 50 su Ostellato. L’azienda impone dei tempi molto stretti in quanto vuole realizzare tale riduzione dell’organico entro l’anno fiscale che, per il 2009, coincide con il primo trimestre 2010. “Bollini ci ha detto che avrebbe trattato con la “casa madre”; al termine della sua trattativa arriva con la proposta che, lui dice, è riuscito a strappare a Toyota: un taglio di 90 posti di lavoro a Bologna e 27 a Ferrara”. Questa proposta viene presentata dall’amministratore delegato in “termini non negoziabili”. A fronte della reazione sindacale, di ovvia contrarietà alla proposta, tuttavia, dichiara la disponibilità dell’Azienda ad attivare la procedura di richiesta di ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria. “Ma a noi interessava innanzitutto capire quale tipo di motivazione l’Azienda avrebbe addotto a sostegno della richiesta di Cassa Straordinaria, cioè quale tipo di situazione avrebbero dichiarato? Sospensione della produzione per riorganizzazione? Per situazione di crisi? Non si tratta, ovviamente, di una questione formale, ma sostanziale. Dal tipo di crisi che riconosci dipende direttamente la natura e la durata dell’ammortizzatore sociale e, soprattutto, la prospettiva futura per l’azienda e i livelli occupazionali.” L’azienda allora decide di aprire una procedura di attivazione di Cassa In174 tegrazione Straordinaria non per reggere una fase di riorganizzazione, di ristrutturazione e nemmeno per aprire una procedura concorsuale; ma con la motivazione del verificarsi di un evento imponderabile e imprevedibile. “In questo modo, ricorrendo alla motivazione del verificarsi di un evento imponderabile e imprevedibile, l’azienda può addossare tutte le responsabilità all’andamento dei mercati: la colpa è solo dei mercati internazionali, non del management che così non assume nessun tipo di responsabilità”. Il problema è che in caso di Cassa Straordinaria per evento imponderabile e imprevedibile, lo strumento di ammortizzazione sociale utilizzato non è prorogabile per un altro evento analogo; può essere prorogato solo in presenza dio una dichiarazione aziendale di ricorrere ad una riorganizzazione produttiva in grado di far scattare ulteriori 24 mesi di possibile Cassa Integrazione Straordinaria. “Anche questa richiesta viene immediatamente accolta da parte dell’Azienda; a questo punto sembra davvero che nell’accordo che si profila ci sia tutto quello che come FIOM abbiamo richiesto”. Ma immediatamente si pone subito la questione più spinosa: cioè la modalità di gestione degli esuberi, nel senso che “l’azienda pretende che il sindacato si assuma la responsabilità di accettare i 27 esuberi decisi dall’azienda”. Per la Fiom “non se ne parla nemmeno: accettare la logica dei 27 esuberi significa, di fatto, accettare 27 licenziamenti”. Per l’azienda non si tratterebbe di accettare 27 licenziamenti, ma di accogliere il principio della volontarietà alla mobilità. “E’ evidente che stanno forzando la mano: tutti i provvedimenti di Cassa Integrazione Straordinaria contengono la clausola di volontarietà alle mobilità, ma questa vale per i lavoratori vicini al pensionamento o al massimo per quelli che esercitano realmente una scelta volontaria”. Ma il problema principale alle LTE è costituito dal fatto che “si tratta di una azienda con una forza lavoro piuttosto giovane, sarebbero pochissimi coloro che potrebbero ricorrere alla mobilità in vista della pensione.” Se il ricorso alla mobilità avrebbe scarsa presa in vista del pensionamento per ragioni anagrafiche; la messa in mobilità in base alla scelta volontaria del lavoratore appare ancor meno praticabile: “Nel territorio non occasioni di reimpiego. Chi si licenzia dalla LTE rimane senza lavoro e chissà quando ne trova un altro. La fase è così; non è come in passato quando l’economia tirava e via da una fabbrica entravi in un’altra. Con la crisi è cambiato tutto.” A Bologna, invece, il sindacato, Fiom compresa, chiude l’accordo con Cesab sulla quantificazione di 90 esuberi. 175 Per la Fiom bolognese, infatti, il numero di 90 esuberi è sopportabile in quanto raggiungibile attraverso i lavoratori prossimi al pensionamento. Ma se per il territorio bolognese 90 esuberi sono sostenibili, per il ferrarese i 27 posti di lavoro che verrebbero tagliati alla LTE rappresentano un problema serio e non facilmente risolvibile. Anzi, come detto in precedenza, il numero di lavoratori LTE vicini alla pensione è molto basso e sul territorio non esistono occasioni di reimpiego vista la concomitante situazione di crisi di molte altre aziende del territorio: Romagna Ruote, Berco, VM, ecc. Questa diversità di esito (accordo sottoscritto alla Cesab di Bologna e vertenza aperta e sempre più conflittuale alla LTE di Ostellato) pone un problema di coordinamento sindacale: “abbiamo proposto una forma di coordinamento tra i due stabilimenti, ma stenta a prendere forma e a funzionare concretamente…” riconosce il rappresentante della Fiom di Ferrara. La perdita del posto di lavoro alla LTE suscita una particolare reazione da parte dei lavoratori, soprattutto di quelli più giovani, che prima di arrivare alla stabilizzazione, cioè al tanto agognato “posto fisso” hanno dovuto superare un vero e proprio “calvario, fatto da un lungo periodo scandito dal contratto interinale, poi dal contratto a tempo determinato, un altro contratto a tempo determinato e ancora…dopo parecchi “esami del sangue” finalmente vieni assunto a tempo indeterminato…”. Ma l’azienda ha individuato un obiettivo (il taglio di 27 posti di lavoro) e da questo non recede. Tanto che “persino quando eravamo vicini all’accordo finale, l’azienda ha mandato tutto all’aria. Ormai si era giunti all’accordo che l’azienda avrebbe chiesto al Ministero la Cassa Integrazione Straordinaria ma a quel punto l’azienda riapre il tutto”. “Ci dicono che il problema non è la Cassa Integrazione, quella sono già decisi a chiederla. Il problema, appunto, è un altro: l’azienda vuole avere la certezza che da parte sindacale viene accettato il principio dell’esistenza di 27 esuberi. Altrimenti, ci fanno capire, non si sentono appagati della trattativa”. La posizione aziendale viene illustrata in occasione dell’assemblea dei lavoratori la cui reazione è netta: “ si sono sentiti ingannati dall’azienda e nessuno ha accettato questo ricatto”. L’accordo proposto dall’azienda, infatti, costituisce una farsa: si fingerebbe di chiedere la Cassa Straordinaria sapendo già che il punto finale è rappresentato da 27 licenziamenti. “In sostanza pretendevano di fare un accordo (riservato, ma concretissimo), prima dell’accordo ufficiale (ma evidentemente depotenziato e svuo176 tato): avrebbe chiesto la Cassa Straordinaria per tutti, ma le parti sapevano che 27 lavoratori non sarebbero mai più rientrati al lavoro”. Per la Fiom questa proposta è inaccettabile: “lo è dal punto di vista del merito, ma anche delle modalità con le quali verrebbe presentata. Noi siamo per una linea di sincerità: cioè vogliamo dire in assemblea come stanno le cose e poi decidere con i lavoratori cosa fare”. La linea della Fiom e delle Rsu è quella di ottenere “l’applicazione di ammortizzatori sociali, come la Cassa Straordinaria, ma senza preconfigurare nessun tipo di esubero. Non vogliamo dare all’azienda questo potere di scegliere i contenuti e le forme degli accordi”. Al contrario, l’altro sindacato, presente in maniera marginale alla LTE, la Cisl, ha un atteggiamento molto più possibilista. La posizione della Cisl si attesta su un accordo di “monetizzazione”, cioè di quantificazione economica delle buone uscite per rendere possibile la riduzione occupazionale di 27 unità. Al contrario, la Fiom punta su un accordo di Cassa Straordinaria “pura”, senza cioè distorsioni dell’uso della stessa o pre – accordi che ne vanifichino le finalità sociali. Una volta ottenuto l’accordo sulla Cassa Straordinaria, per la Fiom è necessario un ulteriore accordo che rispetto agli esuberi definisca, non il numero, ma soltanto i criteri di gestione degli stessi. “Per la Fiom l’unico criterio di definizione degli esuberi e di gestione degli stessi è quello della volontarietà del lavoratore. Cioè se il lavoratore vuole, di sua spontanea volontà, bene; altrimenti non se ne fa niente”. Una ulteriore proposta dell’azienda vien egualmente respinta. “L’azienda ci ha proposto che noi facessimo l’assemblea per dare il via alla richiesta di Cassa Straordinaria, ma chiedendoci di quantificare già gli esuberi che rispondono ai requisiti del pensionamento. Anche a questo abbiamo risposto no perché anche questa pretesa aziendale risponde allo stesso principio di prima: darci il contentino della Cassa pur di pervenire all’unico obiettivo che l’azienda si è data. Cioè, quello di arrivare al taglio dei 27 posti di lavoro.” “Noi, invece, vogliamo un accordo pulito sulla Cassa Integrazione, che non nasconda altre operazioni. La Cassa va utilizzata per quello che prescrive la legge, non per operazioni di altra natura.” La Fiom è decisa a perseguire una linea di chiarezza: “Piuttosto di una Cassa Integrazione fasulla, meglio un sano conflitto sindacale”. Rimane da capire se la situazione della LTE giustifichi realmente, sul piano strettamente tecnico – produttivo il numero di esuberi. A questo punto le posizioni delle Rsu e del funzionario Fiom si dialettizza177 no. Per il funzionario della Fiom, rispetto alla situazione produttiva attuale esiste un problema reale. “Qualche mese fa con alcuni docenti universitari abbiamo condotto una analisi dei Bilanci delle principali aziende del territorio. Della LTE ci era stato detto che con la produzione esistente non avrebbero retto l’organico attuale. Testualmente ci dissero: se questi non aprono una procedura di mobilità potete accendere un bel cero!”. Ma la quantificazione del sindacato circa il numero di esuberi diverge da quella dell’azienda. Mentre l’azienda insiste su 27 esuberi, la Fiom ritiene che questi possano essere almeno dieci di meno. Riconoscere il calo produttivo e l’esistenza di una possibile questione di esuberi, però, per la Fiom non significa accettarli, anche perché “questa azienda ha sempre realizzato ottimi profitti e quindi, la nostra sfida è che non si proceda con nessun licenziamento. Al massimo, ripetiamo, che si applichi il principio della volontarietà del lavoratore, ma realmente!”. La messa in mobilità di lavoratori vicini al pensionamento (criterio che farebbe scattare la possibile volontarietà del lavoratore) potrebbe coinvolgere al massimo sei figure. Questo dato conferma la caratteristica della forza lavoro della LTE composta in larga prevalenza da lavoratori giovani e lontani del pensionamento. Per le Rsu invece non sembrano esserci problemi di volumi produttivi, anzi, “io da quando hanno dichiarato la situazione di crisi produco più di prima”. Il prodotto di LTE, dal punto di vista della qualità è ottimo, e in azienda i lavoratori esprimono una grande professionalità frutto anche di corsi di formazione e di qualificazione seguiti nel corso degli anni. In particolare un rappresentante delle Rsu segnala un fatto curioso. “Io sto monitorando la situazione produttiva del mio reparto. Nel senso che conto tutti i montanti che vengono prodotti. E oltre a contarli sto attento anche alla tipologia che ci dicono di produrre. La cosa strana è che stiamo producendo molti prototipi; sono effettivamente un po’ troppi… continuano a farci produrre molti modelli nuovi: mentre di solito per ogni settimana ne facevamo due, adesso tutte le settimane sono almeno dieci”. “E la cosa più strana, e preoccupante, è che mescoliamo la nostra produzione con i modelli dello stabilimento francese. Cioè, ci fanno produrre prototipi che sono quelli tipici delle produzioni dello stabilimento francese. E io ho l’impressione che la stessa cosa stiano facendo con i francesi: cioè che stiano facendo produrre a loro alcuni modelli nostri. In questo senso stanno mescolando le produzioni dei due stabilimenti”. 178 Una possibile ragione di questo? “Forse l’intenzione dell’azienda di mettere i due stabilimenti a produrre le stesse cose per vedere chi lo fa meglio”. Una sorta di messa in concorrenza degli stabilimenti, eventualmente per valutare, in un futuro prossimo, quale dei due mantenere e quale sacrificare. “A sentire l’azienda noi siamo leader di mercato dal punto di vista della qualità del prodotto; ma ci ripetono sempre che la concorrenza è molto alta e aumenta continuamente.” Si profila, quindi, una concorrenza tra stabilimenti di carattere europeo con il rischio di vedere gli stessi lavoratori in concorrenza tra loro; una preoccupazione aggravata anche dalla mancanza di un CAE (Comitato Aziendale Europeo) che, forse, avrebbe potuto facilitare azioni di coordinamento tra organizzazioni di lavoratori di diversi paesi. Tra i lavoratori italiani e quelli francesi, infatti, non c’è mai stata nessuna forma di rapporto. La questione di un coordinamento europeo tra lavoratori e sindacati sembra un obiettivo quasi irraggiungibile anche alla luce del fatto che un coordinamento reale e in grado di conseguire obiettivi concreti non è stato possibile realizzarlo nemmeno in un raggio di 30 km tra Ferrara e Bologna. Non è detto che il coordinamento con la Fiom bolognese non riesca mai; “ad esempio, con la vertenza Sirio ha funzionato, in questo caso no”. La risposta del territorio non è stata all’altezza della vertenza e della valenza sociale della stessa. “La Provincia ha assunto abbastanza bene la cosa, anche perché è competente per l’avvio della procedura di Cassa. Ma da parte dei sindaci della zona non c’è stato un intervento adeguato. Eppure tutti sono a conoscenza della cosa”. La vertenza è ancora aperta, le Rsu si augurano, ovviamente, di chiuderla alla svelta, anche perché “adesso abbiamo con noi tutti i lavoratori, ma qualcuno comincia a essere stanco e non sappiamo fino a quando riescono a tenere”. 179 Inchiesta alla Tenaris di Dalmine (Bg)17 Tenaris S.A. è il maggior produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. Nasce nel 2002 quando il gruppo Techint decise di raggruppare tutte le sue attività nella produzione di tubi in acciaio in un’unica società. Così Dalmine (Italia), Siderca (Argentina), Tamsa (Messico), NKKTubes (Giappone), AlgomaTubes (Canada), Tavsa (Venezuela), Confab (Brasile), Siat (Argentina), vennero riunite sotto il marchio Tenaris. Il nuovo marchio venne posto accanto ai marchi storici dando vita a TenarisDalmine, TenarisSiderca, TenarisTamsa... Si tratta, dunque, di una holding che raggruppa alcune società del gruppo Techint che nel 2004 acquista la società romena Silcotub e nel 2006 acquisisce la statunitense Maverick Tube Corp. Pur avendo la sede sociale in Lussemburgo gli impianti di produzione sono dislocati in Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Italia, Giappone, Messico, Romania, Stati Uniti e Venezuela. Tenaris SA è posseduta al 60.4% dalla finanziaria della famiglia Rocca la Rocca & Partners S.A.. Rocca & Partners SA ha sede nelle Isole Vergini Britanniche e controlla interamente la società con sede nelle Antille Olandesi San Faustin N.V. San Faustin N.V. a sua volta detiene il 60,4% delle azioni di Tenaris S.A., sia direttamente che tramite la società controllata interamente detenuta Industrial Investments Inc. Con oltre 21.500 dipendenti, Tenaris ha una capacità produttiva annua di 3.300.000 tonnellate di tubi senza saldatura e di 2.700.000 tonnellate di tubi saldati. Tenaris Dalmine è il primo produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura con oltre 3.000 dipendenti e una capacità produttiva di 950.000 tonnellate annue di prodotti finiti. Le attività produttive si svolgono in Italia presso cinque stabilimenti: Dalmine, Arcore, Costa Volpino, Piombino e Sabbio Bergamasco, che producono tubi senza saldatura, trafilati a freddo, saldati e bombole. Le esportazioni raggiungono quasi il 60% delle spedizioni totali. Le unità produttive in Italia sono le seguenti: - Dalmine: tubi meccanici, strutturali, OCTG Line pipe, Tubi per alte e basse temperature e impianti petrolchimici; 17 In collaborazione con Ezio Locatelli, Prc di Bergamo e Alessandro Favilli, Prc di Piombino. 180 - Costa Volpino: Tubi senza saldatura trafilati a freddo per circuiti e cilindri oleodinamici, auto motive e scambiatori di calore; - Arcore: Tubi meccanici e tubi per cuscinetti; - Sabbio Bergamasco: bombole, bomboloni, accumulatori; - Piombino: Tubi saldati e senza saldatura per impianti idrotermosanitari. Le prime avvisaglie di come la crisi avrebbe colpito anche le produzioni e i livelli occupazionali della Tenaris si leggono sulla pubblicazione delle Fiom di Tenaris Dalmine del dicembre 2008. “Lo scenario è improvvisamente cambiato anche per la Tenaris. Dopo quattro anni di forte crescita e di alti profitti, la crisi ha determinato effetti più pesanti del previsto, tanto da mettere seriamente in discussione il budget 2008/09 e i piani di investimento precedentemente decisi. Nell’incontro del 28 ottobre tra la Rsu e la direzione Dalmine è stato spiegato che, nonostante il calo dei consumi, dell’edilizia, dei beni durevoli, il settore energetico, il cui andamento è determinante per chi produce tubi oil & gas, sarà probabilmente quello meno colpito. La frenata per i tubi ad uso industriale è invece forte per Dalmine. Le riduzioni delle marce e le fermate dei vari impianti stanno diventando vistose: Arcore (tubi per meccanica ) sta’ già utilizzando la cassa integrazione, Costa Volpino (tubi per oleodinamica, cilindri e auto) ha in programma fermate significative, Piombino (tubi saldati) fermerà definitivamente il laminatoio a fine anno, Dalmine si è passati dai piani per 21 turni ad una realtà di 17 turni a Lam/Ftm con prospettive di ulteriore discesa e con ridimensionamenti in alcune aree a freddo (Agg/2) e all’EXP. Il Lam/Cn del Fapi sta già scendendo da 18 a 15 turni. L’Acciaieria sarà l’ultimo anello della catena a risentire del calo dei turni; per ora farà solo alcune giornate di fermata. Le nove settimane di fermo per l’investimento al forno rotativo Ftm previste nel periodo luglio-agosto 2009 slitteranno nel tempo, verso una fase di carico minimo degli impianti che potrebbe verificarsi nel secondo semestre dell’anno.” La Fiom di Dalmine mette subito in guardia contro le decisioni che potrebbero concentrarsi sui lavoratori più deboli: “Alla Dalmine entro la fine dell’anno sono in scadenza 150 contratti di lavoro somministrati. E’ inaccettabile che l’azienda proceda a tagli drastici; si deve salvaguardare almeno gli interinali addestrati nelle professionalità più importanti e una quota in sostituzione dei prossimi pensionamenti, rispettando gli accordi in essere. Inoltre in una situazione di calo produttivo, non è sostenibile l’effettuazione di straordinari mentre si licenziano dei giovani lavoratori precari.” 181 Purtroppo furono buoni profeti… Nella pubblicazione delle Rsu Fiom di Dalmine del giugno 2009, l’analisi viene approfondita e viene evidenziato che: “Se si guardano i dati di aprile della produzione, si vede che tutti i reparti sono in estrema sofferenza con un calo medio del 30%, rispetto a quanto previsto a budget, e la previsione per i prossimi mesi è anche peggiore. Gli ordini faticano ad entrare e non solo perché è crollata la domanda del mercato ma anche perché alcuni clienti non hanno le necessarie garanzie bancarie e potrebbero risultare insolventi inducendo così la Dalmine a rinunciare a priori ad acquisire i possibili ordini. A partire da ottobre il portafoglio ordini si è man mano assottigliato e le misure messe inizialmente in atto (CIGO per FAPI e ATB, programmazione di fermate collettive e/o riduzione dei turni per gli altri reparti, ferie forzate, corsi di formazione ecc.) non sono più sufficienti. L’Azienda ha, infatti, richiesto per i prossimi quattro mesi il ricorso alla CIGO per tutti i reparti e per tutti i lavoratori. Siamo in piena crisi, una crisi di proporzioni mai viste e di luce in fondo al tunnel non se ne vede ancora, almeno per quanto riguarda il nostro settore, nonostante l’ottimismo della Confindustria e del Governo.” La situazione dei vari reparti, in termini di riduzione dei carichi di lavoro, è la seguente: acciaieria – 19%; FTM – 25%; FAP – 30%; FAS – 5%. Invece, quella degli stabilimenti è la seguente: Arcore – 50%; Costa Volpino – 31%; Piombino – 25%; Sabbio – 16% La Fiom sottolinea come da subito, le prime conseguenze delle crisi siano state scaricate sui settori più deboli e meno garantiti della forza – lavoro (cioè, interinali, contratti a termine): “… il prezzo più alto lo hanno pagato tutti quei lavoratori interinali che, a causa della riduzione dei turni, non hanno avuto il rinnovo del contratto o, peggio, quelli che, pur avendo superato i dodici mesi presso lo stesso reparto, non sono diventati dipendenti Dalmine nonostante l’accordo aziendale. Da un giorno all’altro hanno perso il posto di lavoro e il salario.” Le decisioni assunte dall’azienda, anziché puntare sull’innovazione, riguardano esclusivamente la gestione delle eccedenze della forza – lavoro: “L’Azienda ha messo e sta mettendo in campo una precisa strategia per affrontare la crisi: 182 1 Azzeramento del personale precario (interinali). 2 Riduzione dei costi fissi (smaltimento delle ferie residue). 3 Utilizzo della CIGO e massima flessibilità di turni e orari. 4 Riduzione della forza nei reparti e negli uffici (saturazione). 5 Azioni opportunistiche per “approfittare e cavalcare” questa fase per uscire dalla crisi più forti, dal punto di vista dell’azienda, di come si è entrati (shopping industriale).” Ma anche questo non è bastato, e così si passa ai tagli strutturali del personale: “Oggi siamo alla fase 4: il ceo P. Rocca ha già preannunciato che i dipendenti Tenaris nel mondo dovranno subire un taglio del 20 % passando da 27.000 a 21.000. La dimensione del taglio per Dalmine e il destino degli stabilimenti del gruppo saranno chiariti nei prossimi mesi.”. Nella stessa pubblicazione, la Fiom ribadiva le preoccupazioni per gli stabilimenti “periferici” che in un ottica di ridimensionamento a livello internazionale del Gruppo Tenaris, sono i primi siti a rischiare la dismissione completa. Così si esprimeva la Fiom a proposito dello stabilimento di Costa Volpino: “la crisi ci coglie in un momento critico: dopo anni in cui una scelta aziendale da noi ampiamente criticata - quella di puntare solo su prodotti super-redditizi che, da una parte, ha assicurato utili eccezionali ma, dall’altra, ha via via assottigliato la varietà di prodotti che lavoravamo (o abbandonati o, più spesso, spostati in altri siti), finalmente si prospettava una fase nuova e nuove aspettative per il futuro, con l’investimento della nuova trafila e impianti correlati. Da parte nostra abbiamo sempre ritenuto che queste scelte (in primis quella di orientarsi progressivamente sul monoprodotto cilindri a scapito di scambiatori, componentistica ecc...) dovevano essere contrastate più efficacemente con azioni sindacali chiaramente unitarie ma più forti. Se oggi l’unica linea con una turnistica di 15 turni resta quella che lavora scambiatori (linea 5) significa che non avevamo tutti i torti. Ma in questo momento,lasciando alla coscienza di ognuno di noi queste considerazioni, abbiamo tutti il dovere-delegati, organizzazioni sindacali e lavoratori - di cercare di ragionare su come concretamente dobbiamo affrontare il presente , su come concretamente possiamo crearci un futuro. Nonostante tutto quello che è successo abbiamo ancora dei punti di forza. • Gli investimenti per Costa Volpino non sono cancellati ma solo sospesi (come molti altri anche a Dalmine). • Facciamo parte di un gruppo industriale solido che, anche grazie ai guadagni di questi anni , ha la possibilità di sfruttare la crisi per ammodernarsi per essere pronto alle nuove sfide di competitività. • Questo ammodernamento è necessario che non sia limitato ai soli impianti, perché dappertutto, ma in particolare a Costa Volpino, spesso è il fattore umano a fare la dif183 ferenza. Nel concreto, i primi problemi per la situazione produttiva e occupazionale per gli stabilimenti italiani vengono segnalati dal Coordinamento Fiom Cgil del Gruppo Tenaris Italia riunitosi il 25 giugno 2009 a Dalmine per valutare la situazione produttiva dei vari stabilimenti, l’andamento e i riflessi della Cassa Integrazione Guadagni, e le prospettive dopo la fermata estiva. Nel documento prodotto da tale coordinamento si legge che: “In riferimento ad una attenta analisi della situazione dei vari siti, con le rispettive Rsu, esprime forti preoccupazioni rispetto ai ridotti carichi di lavoro previsti e per l’incidenza della Cigo che riduce ormai pesantemente le retribuzioni dei lavoratori. Ancora più preoccupante è l’avvicinarsi della scadenza delle 52 settimane di utilizzo della Cigo, dato il rifiuto da parte del Governo del raddoppio della durata, come richiesto dal Sindacato. Sottolinea quindi, la necessità di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per salvaguardare le condizioni di lavoro e l’occupazione, anche in vista di una situazione che allo stato attuale non accenna a migliorare. Così come rimane del tutto necessario un intervento del Governo rispetto alla crisi e alle problematiche del settore siderurgico, che non vengono prese in considerazione. E’ fondamentale perciò una verifica puntuale con la Direzione del Gruppo, sui piani di sviluppo futuri per ogni stabilimento, a partire già dai prossimi incontri previsti dal 29 giugno a seguire. Il Coordinamento nazionale Fiom Cgil Tenaris respinge qualsiasi ipotesi che scarichi sui lavoratori gli effetti della crisi e ribadisce al Gruppo la necessità di confermare gli investimenti nei diversi siti produttivi, condizione necessaria per una loro prospettiva industriale futura.” Successivamente si tiene presso l’Unione Industriali di Bergamo l’incontro per il rinnovo dell’accordo sulla Cassa integrazione ordinaria. Nel documento sindacale prodotto a seguito di tale incontro si legge che: L’azienda ha confermato l’incertezza delle prospettive produttive per il prossimo periodo post feriale, le difficoltà nei volumi di carico degli impianti anche a settembre, l’impossibilità di fare previsioni attendibili dopo tale mese. Per valutare un possibile cambio di situazione sarà necessario attendere l’inizio del prossimo anno. Per questi motivi si è proceduto al rinnovo della Cigo per altre 13 settimane fino al 22 di novembre 2009. La Cigo continuerà ad essere gestita a rotazione, dove possibile e con l’anticipo delle spettanze da parte dell’azienda.” La situazione precipita in data 28 settembre quando, presso l’Unione Industriale di Bergamo la direzione aziendale presenta il piano industriale 2010- 2011, dove oltre a prevedere un piano di investimenti, vengono attuate una serie di scelte industriali e organizzative che, in un quadro di 184 mercato in flessione, prevedono una pesante ricadute occupazionale su tutti i siti produttivi. Il piano prevede in sintesi: • Chiusura dello stabilimento di Piombino; • Forte ridimensionamento delle attività produttive di Costa Volpino; • Graduale disimpegno delle attività dello stabilimento Fapi di Dalmine; • Pesante riorganizzazione sulle aree a Caldo e Freddo di FTM; • Razionalizzazione e riorganizzazione degli organici per tutti gli altri siti produttivi, servizi e strutture impiegatizie. Sui livelli occupazionali gli effetti di tale piano aziendale determinano allo stato attuale una riduzione complessiva di 1024 unità lavorative su 2814 attualmente in forza. In occasione dell’incontro con le Rsu della Tenaris Dalmine è stato fatto il punto della situazione approfondendo gli aspetti del Piano Industriale presentato, delle ricadute occupazionali e delle prospettive di intervento. Il Piano Industriale risulta strutturato a partire dalla premessa che nei prossimi anni la capacità produttiva di Tenaris verrà ridotta all’80%, con un margine di flessibilità del 20% a seconda dell’andamento degli ordinativi. In realtà dalle considerazioni svolte dalle Rsu la riduzione potrebbe arrivare fino al 50% della capacità produttiva. Tenaris considera non più raggiungibili i volumi produttivi del biennio 2007/2008 (quando si registrò un picco della produzione) e pertanto programma una pesante riduzione della propria capacità produttiva e quindi dell’occupazione. A giustificazione di questa posizione viene richiamata la situazione produttiva della Cina che, effettivamente sta producendo conseguenze non solo su Tenaris, ma su tutti i produttori mondiali. Attualmente nel mondo la capacità produttiva di tubi senza saldature è di 65 milioni di tonnellate; la richiesta mondiale è di 27 e la capacità produttiva della Cina è di 30. La Cina, quindi, è in grado di corrispondere da sola all’intera domanda mondiale di tubi senza saldature. Negli ultimi tempi, inoltre, le imprese cinesi, da sempre orientate prevalentemente al mercato interno, hanno cominciato ad esportare anche grazie ad uno strumento di sostegno fiscale a loro vantaggio attivato dal Governo cinese. Oltre al sostegno fiscale di cui godono, le imprese che operano in Cina possono contare su un costo del lavoro bassissimo: se in Italia un lavoratore costa mediamente 40 dollari al giorno; in Romania ne costa 11, in 185 Brasile 6 e in Cina 2. Con prezzi non esiste nessuna capacità di reggere la concorrenza cinese. Le norme antidumping nel settore della siderurgia e dell’acciaio, inoltre, non si applicano al prodotto della Tenaris (tubi espander di grosso diametro). Tenaris non può nemmeno più contare sull’esclusiva del prodotto del tubo espander in quanto anche altre aziende hanno cominciato a produrlo: la TPCO ha appena realizzato uno stabilimento nei paesi arabi per produrre espander, mentre altre iniziative di questo tipo esistono in Brasile. Tenaris sapeva che anche le imprese cinesi si stavano attrezzando per arrivare alle stesse produzioni di qualità, ma l’impressione era che ci sarebbe arrivata impiegando almeno 3/4 anni, non 1 solo anno. Questa situazione ha trovato conferma anche nell’incontro tra i Sindacati e Federacciai sulla situazione e le prospettive del settore siderurgico in Italia, Europa e a livello globale: Secondo Federacciai, che ha presentato i dati aggiornati ad agosto, la situazione non è brillante. La produzione mondiale di acciaio ha visto un massimo nel 2008, continuando la crescita dei 5 anni precedenti, per poi crollare dalla fine dell’anno scorso e nel primo semestre 2009. La parziale ripresa dei mesi successivi è stata dovuta sostanzialmente al perdurare della crescita produttiva della Cina, che ormai copre da sola quasi il 50% della produzione mondiale e spingerà sulle esportazioni, che necessariamente interesseranno anche l’Europa e il nostro paese, che continua ad essere un importatore netto di acciaio. Per quanto riguarda l’Italia si arrivati ad un – 43% della produzione, “forse si è toccato il fondo, ma la ripresa pare difficoltosa”, ha dichiarato Federracciai, infatti l’incremento degli ordini dei mesi scorsi non pare confermarsi a partire da settembre, lasciando intendere che si trattava soprattutto della necessità di ricostituire un po’ di scorte e non di una ripresa duratura. La strategia degli investimenti (114 milioni di euro) di Tenaris si colloca in questa cornice per rafforzare il proprio prodotto di punta: l’obiettivo è quello di aumentare la lunghezza del tubo prodotto lasciando inalterato lo spessore. L’obiettivo è di aumentare la lunghezza del tubo prodotto in modo da ridurre il più possibile il numero di saldature; ridurre le saldature per tubazioni che devo coprire km di lunghezza (nel settore petrolifero ad esempio) significa ridurre i costi di produzione. Per questo è stato ampliato e potenziato il forno FTM in modo da poter lavorare barre più grosse che consentono la realizzazione di tubi più lunghi e di maggior spessore. 186 Si tratta di tubi che uniscono alla lunghezza (riduzione delle saldature e quindi dei costi) anche una particolare resistenza (dovuta allo spessore) e quindi in grado di reggere in condizioni difficili dal punto di vista climatico, dai Mari del Nord all’Africa. A fronte di questo investimento, fanno da contraltare i 1.024 esuberi dichiarati dall’Azienda. Su questo punto le Rsu sono state nette: non ci sono distinzioni tra stabilimenti, la difesa dell’occupazione va fatta per l’intero gruppo. Non esiste, quindi, per le Rsu, distinzione tra i lavoratori bergamaschi e quelli degli altri stabilimenti: tutti devono essere difesi. Ma la Direzione ha assunto una posizione inflessibile: o si sottoscrive un accordo, oppure non si realizzano gli investimenti previsti. Nonostante questo evidente ricatto, la posizione dell’azienda è inaccettabile anche per le conseguenze occupazionali che produrrebbe sull’indotto e sui lavoratori indiretti che, a fronte del calo complessivo dei volumi di produzione, perderebbero il lavoro. Si tratta sia dell’indotto che lavoro attorno alle produzioni Tenaris, sia dei lavoratori indiretti e delle ditte in appalto che operano in particolare in alcuni settori come le pulizie, la logistica, le manutenzioni meccaniche ed edilizie. Le ditte che operano in appalto impiegano mediamente 400 dipendenti per tutto il corso dell’anno, ma durante la chiusura estiva dello stabilimento di Dalmine e quindi si concentrano le operazione di manutenzione, questa cifra sale a 1.500 lavoratori. Inoltre un disimpegno di Tenaris sullo stabilimento di Dalmine produrrebbe, a cascata, conseguenze anche sugli altri stabilimenti: con un basso numero di dipendenti (circa 80 persone) Costa Volpino e Arcore sarebbero i primi siti a pagare con la chiusura. La situazione si presenta particolarmente preoccupante per le significative differenze con il passato: non è la prima volta che lo stabilimento di Dalmine si trova a fare i conti con processi di ristrutturazione; ma mentre nel passato (es. negli anni ’80) si poteva ricorrere ai prepensionamenti e agli incentivi, oggi non esiste niente di tutto questo. La ristrutturazione si tradurrebbe in disoccupazione per oltre 1.000 lavoratori. Un taglio occupazionale così pesante non pare giustificato dall’andamento del mercato: sicuramente è calata la domanda globale e altrettanto sicuramente ci si trova di fronte alla Cina, ma se tra tre anni la domanda dovesse riprendere a tirare? Come farebbe a quel punto Tenaris a far fronte all’aumento dei volumi di 187 produzione? La risposta è chiara e altrettanto preoccupante: ricorrendo al lavoro interinale. Quindi non è azzardato dire che Tenaris sta realizzando una pesante ristrutturazione occupazionale che nel futuro potrebbe portare alla progressiva e sempre più massiccia sostituzione di lavoro ordinario con lavoro interinale. Presso lo stabilimento di Dalmine operavano 174 interinali, dei quali solo 60 sono stati stabilizzati negli ultimi anni, mentre i rimanenti sono rimasi senza lavoro. La riduzione dei volumi, pertanto, seppur reale, in termini quantitativi è stata enfatizzata in negativo per poter realizzare una operazione più ampia e pesante in termini occupazionali e di futura gestione della forza lavoro. La decisione dell’Azienda, quindi, sembra essere quella di concentrare l’investimento soltanto in un prodotto (quello, appunto, dei tubi più lunghi e con adeguato spessore) e sull’impiantistica del “filotto” forno – acciaieria – espander. Nonostante la politica “aggressiva” in termini di offerta commerciale attuata da Tenaris (in grado di fornire impianti “chiavi in mano” ad un prezzo inferiore del 30% a quello dei concorrenti) la Cina riesce a fare ancora di meglio “grazie” allo scandaloso costo del lavoro e alla politica di sostegno fiscale del Governo cinese. Questo chiama in causa le politiche industriali. Mentre il Governo italiano è unicamente impegnato a negare la crisi o a lanciare messaggi di improbabile ottimismo, il Governo cinese, a suo modo, fa politica industriale. In Italia nessuno oggi parla di politiche industriali. Una politica industriale sarebbe quanto mai necessaria nel settore dove opera Tenaris visto che il costo del lavoro incide solo per il 20%, mentre per l’80% dei costi complessivi sono i consumi energetici e l’approvvigionamento di materie prime a pesare. Intervenire su energia e materie prime significa fare politiche industriali a sostegno delle filiere produttive presenti in Italia. Anche la strategia di Tenaris appare fragile: concentrandosi e specializzandosi in un unico prodotto (tubi per gas e petrolio) si espone in maniera fortissima alla concorrenza cinese. Ed essendo concentrata su un unico prodotto, una eventuale soccombenza nell’ambito dei processi di concorrenza, sarebbe letale per l’impresa e i lavoratori. Per questo una politica industriale adeguata dovrebbe anche contribuire ad orientare l’impresa in una diversificazione dei prodotti: cilindristica, scambiatori di calore, tubo profilato per bombole. 188 Settori che non versano in una crisi particolare e che per alcuni prodotti (es. bombole per auto) potrebbero nei prossimi anni conoscere un certo sviluppo. Ma, a quanto pare, la famiglia Rocca preferisce trasferire le lavorazioni del settore meccanico in paesi come la Romania. Le misure antidumping sono ritenute dalle RSU importanti, ma è necessario che queste si accompagnino ad una gestione corretta. Rocca,a d esempio, ha ricevuto lo stabilimento di Dalmine dieci anni fa già ristrutturato e in buone condizioni di competitività, ma non ha investito né operato per mantenerlo tale. Come prima iniziativa il Prc definisce un documento nel quale precisa la propria posizione sulla crisi Tenaris che viene trasmesso alle Rsu e alle Organizzazioni Sindacali e viene presentato in conferenza stampa. Il testo del documento viene sintetizzato in un volantino distribuito ai lavoratori all’uscita dalla fabbrica. Il testo del documento è il seguente: 1) Il PRC ritiene inaccettabile il Piano proposto da Tenaris tutto giocato sulla riduzione occupazionale: per il PRC, al contrario, non si deve perdere un solo posto di lavoro; 2) la difesa dei livelli occupazionali è giustificata anche dal fatto che tra qualche anno la situazione della domanda mondiale potrebbe cambiare e di conseguenza potrebbero tornare ad aumentare anche i volumi produttivi di Tenaris: l’azienda questo lo sa bene, ma scientificamente ha deciso di disfarsi di una larga fetta di forza lavoro ordinaria per poi magari sostituirla nei prossimi anni con lavoratori interinali in caso di ripresa produttiva producendo una ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro; 3) già attualmente in Tenaris si registra una significativa frammentazione e differenziazione della forza lavoro attraverso il sistema delle ditte in appalto che operano all’interno dello stabilimento di Dalmine e che occupano da un minimo di 400 ad un massimo di 1.500 dipendenti nei momenti di massima manutenzione degli impianti: su questo aspetto di rende necessaria una maggior omogeneità di trattamento e di tutele tra lavoratori che operano nello stesso sito produttivo; 4) il costo del lavoro non costituisce la maggior voce di costo per Tenaris; anzi, questa copre la massimo il 20% dei costi complessivi. Il restante 80% è determinato dai costi energetici e di approvvigionamento di materie prime. Su questi aspetti il settore pubblico deve tornare ad esercitare una seria politica industriale; 5) dal punto di vista dei costi energetici non dovrebbero esserci particolari problemi in quanto la centrale è stata realizzata proprio per soddisfare il 189 fabbisogno energetico dello stabilimento. Da una pubblicazione dell’azienda si legge che: “La centrale, la cui potenza è di 120 megawatt elettrici, (…) sarà in grado di produrre annualmente circa 900 gigawatt/ora, il 70% dei quali verranno utilizzati per il fabbisogno energetico di Tenaris Dalmine ed il restante 30% venduto sul libero mercato dell’energia.”. Tenaris, quindi, di energia ne ha da vendere. Va ricordato che l’autorizzazione è avvenuta proprio per un impianto di autoriduzione, cioè destinato a soddisfare esigenze industriali e non di mercato: il Ministero dell’Ambiente, infatti, durante la procedura di autorizzazione, in data 22 gennaio 2004, ha emesso un decreto di “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione Centrale termoelettrica di Autoproduzione a Ciclo Combinato da 120 MWe da ubicarsi nello Stabilimento della Dalmine S.p.A. in comune di Dalmine (BG) , della Società Dalmine Tenaris Group S.p.A.,”; 6) dal punto di vista delle norma antidumping, la Commissione delle Comunità Europee ha istituito un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. Secondo tale norma: “» istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW)”. Il diametro dei tubi Tenaris (426 mm) non rientra nella protezione di detto Regolamento. Per questo motivo è necessario che il Governo intervenga in sede europea al fine di tutelare con misure antidumping anche i prodotti dell’industria italiana. 7) dal punto di vista delle forniture, poiché Tenaris opera nella realizzazione di prodotti per l’industria petrolifera, industria chimica e petrolchimica, produzione e trasporto di energia e calore, va rilevato che in questo settore operano società partecipate dal settore pubblico (ENI, ENEL, ex municipalizzate) impegnate in significativi investimenti nei prossimi anni che renderanno necessarie forniture di tubi e prodotti per questi settori industriali che il settore pubblico potrebbe orientare a favore dell’industria presente in Italia. Anche in novembre i tengono incontri, presso l’Unione Industriali di Bergamo tra la Direzione del Personale di Tenaris Dalmine e le Organizzazioni Sindacali e le Rsu di Dalmine. In novembre, infatti, viene espletata la procedura di rinnovo della Cassa 190 integrazione ordinaria la cui scadenza era prevista per il giorno 20 novembre; la Cassa viene rinnovata per 7 settimane dal 30 novembre al 17 gennaio 2010. La scelta dell’azienda di chiedere solo sette settimana, si legge nel comunicato delle Rsu, è stata giustificata con la necessità di parificare la scadenza per tutti gli stabilimenti e con la speranza di arrivare entro quella data ad un accordo che possa far partire la cassa integrazione speciali. In realtà, nonostante le speranze dell’azienda, il comunicato delle Rsu prosegue sottolineando come, al ribadimento delle posizioni sindacali (modifica del piano, no a chiusure impianti, privilegiare i contratti di solidarietà, no all’organizzazione del lavoro a isole), non si evidenziano significativi avvicinamenti da parte dell’azienda. Il giorno 3 dicembre Rifondazione Comunista organizza un incontro pubblico a Dalmine per discutere della crisi in corso. All’incontro partecipano le Rsu dello stabilimento e le categorie Fiom e Fim. La posizione espressa da sindacati e Rsu sottolinea il carattere di grande preoccupazione che la vertenza sta assumendo. “L’azienda si presenta dicendo sempre che è vero che il piano prevede una riduzione occupazionale, ma noi Tenaris siamo l’unica impresa che in Italia intende realizzare 114 milioni di investimenti; questo in Italia non lo fa nessuno, solo noi”. I sindacati sottolineano il carattere ricattatorio della posizione di Tenaris: “ci dicono: questo è il piano e questi sono 114 milioni di investimenti; ma questo piano lo realizziamo solo in presenza di un accordo sindacale che accetti gli esuberi che noi abbiamo individuato. Altrimenti, se non firmate l’accordo, noi non facciamo nessun investimento”. Dal punto di vista sindacale viene ribadita la posizione unitaria assunta dalle categorie e dalle Rsu: 1) la contrarietà alla chiusura dello stabilimento di Piombino: questo in un quadro di definizione dei costi delle bonifiche del sito inquinato e della definizione della vocazione industriale di quell’area; 2) lo stesso ragionamento vale per lo stabilimento di Costa Volpino rispetto al quale non sono previsti investimenti in ossequio al principio ispiratore del modo di fare impresa della famiglia Rocca: “Ci dicono sempre: dove non c’è business non si investe un euro, anzi si chiude”; 3) la contrarietà al trasferimento del settore FAPI in Romania: la strategia di Tenaris in questo settore /tubi piccoli) è diventata immediatamente chiara con l’acquisizione di una impresa rumena 191 (Silcotub), a quel punto era evidente che tale acquisto era ritenuto propedeutico al trasferimento in quel paese (ovviamente per sfruttare i notevolissimi differenziali salariali tra Europa Occidentale e Orientale) delle produzioni che potevano trovare realizzazione negli impianti di Silcotub; 4) fare chiarezza sul destino del laminatoio medio che nel Piano viene individuato come uno dei settori di punta su cui investire, ma la cui organizzazione della turistica suscita più di una preoccupazione. Anche sull’aspetto del ricorso agli ammortizzatori sociali permangono forti divergenze con l’azienda che, evidentemente, pensa di utilizzare anche gli ammortizzatori sociali come strumento di pressione sui sindacati: “noi continuiamo a chiedere il ricorso ai Contratti di Solidarietà, ma l’azienda non da risposte, è molto restia”. Non appare azzardato ritenere che anche gli ammortizzatori sociali vengano trattati nell’ambito di quell’atteggiamento di ricatto che ha visto Tenaris minacciare l’azzeramento degli investimenti in caso di mancato accordo sul numero di esuberi e sugli stabilimenti da dismettere. Ulteriori problemi secondo la Fiom sono da individuare: a) nel calo dei volumi produttivi. Da un anno nei quattro stabilimenti Tenaris si è ricorsi alla Cassa Integrazione, ma adesso non basta più perché il vero problema sarà rappresentato dal calo, significativo, dei volumi di produzione; b) dal punto di vista dell’unità dei lavoratori, un numero consistente di questi è vicino alla pensione e con alcuni anni di Cassa Integrazione e Mobilità arriverebbero all’età pensionabile: questo determina una scarsa combattività di questi indebolendo il fronte unitario; c) l’atteggiamento dei sindacati confederali non è particolarmente combattivo. Le Rsu di Tenaris e la stessa Fiom hanno più volte sollecitato la proclamazione di uno sciopero generale del territorio bergamasco, ma finora non si è fatto niente. Eppure sono moltissime le situazioni di crisi con aziende fortemente colpite da tagli occupazionali piuttosto pesanti: solo per restare nel solo settore metalmeccanico, vengono richiamate la Frattini, la Same, la ABB…”….a fronte di queste situazioni di crisi non è possibile che il massimo sforzo prodotto dalle confederazioni sia la marcia per il lavoro di sabato 12 dicembre, perché poi questi segnali vengono colti dai lavoratori…” d) a livello istituzionale si riscontra una grossa differenza con la si192 tuazione di Piombino: “…là lavorano tutti nella stessa direzione, si impegnano tutti a salvare lo stabilimento, ma qui non è così… ad esempio, il Consiglio Comunale di Dalmine ha approvato un documento in cui non si dice nemmeno che il Piano Industriale… e questo, invece, è il punto centrale: fare pressione sull’azienda affinchè cambi il Piano Industriale” “ …già si è visto l’atteggiamento di Calderoli…che non incontra nemmeno le Organizzazioni Sindacali, ma si limita a dire che lui conosce tanti imprenditori e grazie a queste conoscenze si darà da fare per ricollocare i lavoratori della Dalmine in esubero….” La Fim Cisl insiste molto sull’assenza i Italia di politiche industriale che sostengano i settori che altri Paesi europei considerano strategici e per questo sostengono con adeguati interventi. “In Italia non esiste da 30 anni una politica industriale e tra i partiti nessuno ne parla…nessuno individua gli obiettivi e come perseguirli dicendo in maniera chiara cosa si deve fare…”. In particolare un delegato Rsu della Fim Cisl insiste molto su questo punto: “Serve una Politica Industriale seria, che non sono gli eco – incentivi. Anche le misure antidumping, anche se necessarie, non risolvono il problema, perché valgono solo per l’Europa. Quindi l’antidumping lo puoi anche estendere al tubo da 711, ma resta il fatto che il 90% del mercato del tubo senza saldatura si svolge fuori dall’Europa, quindi non sarebbe efficace”. Sempre in dicembre la pubblicazione della Fiom di Dalmine torna a ribadire che “Si tratta di un Piano inaccettabile per vari motivi: 1) prevede la chiusura di Piombino e mette a rischio la sopravvivenza di Costa Volpino, che dovrebbe dimezzare la forza lavoro a fronte di esigui investimenti; 2) prevede la chiusura tra qualche anno del FAPI, considerato un impianto ormai strutturalmente ai margini del mercato. Tutto ciò in presenza di uno stabilimento Silcotub in Romania che produce a costi inferiori; 3) prospetta un forte ridimensionamento dei volumi produttivi di FTM, destinato a produrre i tubi tecnicamente più difficili e a più alto margine di profitto ma in un segmento di mercato che non garantisce la marcia piena mensile del laminatoio; 4) richiede una organizzazione del lavoro “a isole”, finalizzata al massimo risparmio possibile di manodopera per avere il massimo di produttività; 5) esige un taglio pesante negli organici dei servizi e dei settori impiegatizi. Non è molto credibile l’idea che l’impianto destinato a rimanere l’asse portante della 193 Dalmine, cioè FTM, abbia una prospettiva di marcia ridotta a 3 settimane mese.” Nella pubblicazione viene ribadito che la crisi, come in tanti altri casi, verrà utilizzata dall’azienda per poter pretendere “mano libera” nella gestione del personale e della sua organizzazione: È più facile pensare che, approfittando delle difficoltà derivanti dalla crisi, Tenaris voglia imporre un nuovo sistema di lavoro che permette la massima flessibilità ma che calpesta anche il diritto, sancito contrattualmente, di ogni lavoratore ad avere orari certi e turnazioni avvicendate regolarmente, per rispondere ad ogni esigenza produttiva. Il dato generale su cui la direzione Tenaris fonda il suo piano per Dalmine è che i costi del lavoro in Europa rendono difficile la competizione con i produttori di tubi cinesiI (e non solo quelli) e quindi è indispensabile prospettare per il nostro stabilimento un piano di pesanti sacrifici per l’ occupazione, con peggiori condizioni di lavoro. - non è accettabile che un’azienda con i bilanci degli ultimi 3/4 anni gonfi di profitti (l’anno 2008 è stato definito dagli imprenditori siderurgici “annus mirabilis”) oggi dica che, per salvare 1790 lavoratori degli stabilimenti Tenaris Italia bisogna buttarne via 1024. Le condizioni che abbiamo posto alla direzione sono chiare: 1) nessuna chiusura di impianti; 2) drastico ridimensionamento degli esuberi; 3) no al lavoro a isole in FTM; 4) no a licenziamenti, comunque mascherati, ma uscite volontarie incentivate per i lavoratori vicini alla pensione; 5) uso dei contratti di solidarietà finchè non ci sarà uscita dalla crisi. 6) sempre limitando al massimo l’impatto economico negativo degli ammortizzatori sociali. Il giorno 10 dicembre si tiene la manifestazione dei lavoratori della Tenarsi a Dalmine. Si verificano momenti di tensione allo sciopero degli operai Tenaris di Dalmine: quando il corteo tenta di raggiungere l’autostrada A4 un cordone di polizia in tenuta antisommossa si frappone tentando di contenerli. Ma la pressione è forte e il cordone cede nell’ambito di una breve colluttazione. Si arriva al casello autostradale, ma un nuovo cordone, questa volta irrobustito e più minaccioso di prima, li blocca nuovamente. Qualcuno passa, parte la trattativa ma in autostrada non ci si arriva anche se ormai sulla A4 in direzione Milano si sono formati diversi km di code. Quello che emerge dalla manifestazione è la solitudine nella quale istituzioni e territorio hanno lasciato l’azienda. Al corteo non era presente nessun rappresentante delle istituzioni: né il sindaco, né assessori o consiglieri comunali. Non c’erano cittadini o associazioni che testimoniassero la vicinanza di un 194 territorio che subirebbe le conseguenze sociali più pesanti dal ridimensionamento istituzionale della Tenaris. Con il perdurare della vertenza cominciano, lentamente, a cambiare anche alcune condizioni. Rispetto ai pesantissimi esuberi annunciati da Tenaris, dopo l’ultimo incontro del 11 dicembre dai 717 lavoratori a rischio nel sito di Dalmine si è scesi di 50, quindi gli esuberi potrebbero essere 667. Per quanto concerne lo stabilimento di Costa Volpino, nonostante l’incontro in Regione Lombardia la Fiom non esprime grande fiducia. Per Piombino viene raggiunta una prima, seppur parziale intesa: sarà firmato a gennaio un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, enti locali, Autorità portuale e TenarisDalmine con una serie di impegni tra le parti diretti a creare le condizioni per mantenere l’attività produttiva nello stabilimento Tenaris di Piombino. Anche sugli stabilimenti lombardi il confronto entra nel vivo con una maratone di trattative che si tiene negli ultimi giorni del 2009 Restano sul tavolo alcune divergenze, legate soprattutto alla riorganizzazione del lavoro a Dalmine, ma il primo risultato raggiunto è la scomparsa della parola “licenziamenti”dal piano aziendale con l’ulteriore impegno che per gli esuberi si procederà attraverso ammortizzatori come la Cassa straordinaria, mobilità incentivata, prepensionamenti e in alcuni casi contratti di solidarietà. L’ipotesi di accordo viene raggiunta e sottoscritta il 29 dicembre 2009 presso la sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo tra la Tenaris Dalmine S.p.A. per i siti produttivi di Dalmine/ATB Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino, e le organizzazioni e rappresentanze sindacali Il confronto fra le parti ha origine dal Piano strategico Tenaris Dalmine “Piano industriale per il riposizionamento di Tenaris Dalmine”, di cui le OO.SS. e le Rsu prendono atto, e che rappresenta il quadro complessivo delle strategie di mercato e di prodotto di Tenaris Dalmine. Il piano originale era stato, come ampiamente visto, rifiutato da Rsu e Organizzazioni sindacali di categoria. Su questo aspetto nell’accordo si sottolinea che “Nell’ambito di tale confronto con la RSU delle diverse sedi e le rispettive OO.SS. di categoria, rispetto all’iniziale ipotesi, sono state apportate alcune sostanziali modifiche, recepite nel Piano stesso, con riferimento a verifiche connesse agli investimenti e alle nuove organizzazioni del lavoro e riguardo le strategie di prodotto e sulle quantità di produzione attese al termine del biennio 2010-2011.” “Per lo stabilimento di Piombino, l’azienda conferma che è possibile mantenerlo in attività subordinatamente alla concretizzazione degli impegni assunti a livello 195 istituzionale per una soluzione positiva delle problematiche connesse alla riqualificazione ambientale ed allo sviluppo delle infrastrutture”: si tratta, in sostanza delle questioni relative alle bonifiche del sito e agli interventi sul Porto. Più problematico appare il versante degli esuberi, in quanto “le eccedenze strutturali complessive di personale al termine del Piano, di cui le OOSS e le Rsu prendono atto, sono confermate nel numero di 741”. Il piano di riorganizzazione viene presentato come ambizioso e centrato sulla valorizzazione del personale anche attraverso significativi investimenti di formazione e qualificazione professionale: “La realizzazione del Piano strategico si collega alla introduzione di nuovi progetti organizzativi per la ricerca di un equilibrato rapporto tra costi, organici e produzione, del miglioramento delle prestazioni in generale e della flessibilità del sistema con soluzioni idonee per rispondere agli adeguamenti della domanda richiesti dal mercato, della semplificazione dei processi e delle azioni di efficientizzazione del lavoro di ufficio con il supporto delle tecnologie informatiche, per questo è essenziale il necessario e costante aggiornamento del livello delle competenze tecniche e delle conoscenze. Questo piano è sostenuto per quanto riguarda il livello delle competenze professionali da un progetto di riqualificazione e aggiornamento, dove la formazione e lo sviluppo delle competenze costituiscono un elemento chiave per rispondere alla sempre maggiore sfida competitiva di uno scenario in costante cambiamento ed è indirizzato al personale di tutti gli ambiti interessati dagli effetti del citato piano, con diverse specificità ed articolazione e con riferimento ai vari ruoli professionali. Il Progetto ha la finalità di definire le competenze necessarie sia in termini di conoscenza che in termini di capacità operativa, di individuare le differenze e superarle attraverso specifici percorsi formativi ed è anche strumento che consente di contenere le ricadute di carattere occupazionale derivanti dal Piano medesimo e per la salvaguardia in futuro dei livelli occupazionali. L’impegno economico si stima in 3,5 milioni di euro ed il dimensionamento formativo complessivo prevede circa 359 mila ore di formazione.” Questo intervento formativo riguarda anche “i lavoratori percettori di trattamento Cigs (che) possono essere utilizzati in attività di formazione professionale e/o riqualificazione che nella loro realizzazione possono includere attività produttive connesse all’apprendimento.” Tenaris sembra voler insistere sul fatto intende puntare sulla qualità per reggere all’agguerrita concorrenza internazionale: “Il miglioramento della Qualità, inteso nella sua accezione più ampia, cioè affidabilità del prodotto, qualità percepita e prestazioni del servizio offerte, è un aspetto centrale del Piano. Esso deve costituire anche in futuro l’elemento distintivo di Tenaris Dalmine nei confronti della concorrenza, pertanto occorre rafforzare il sistema qualità, sia dal punto di vista del processo che delle soluzioni tecniche sul prodotto. Il coinvolgimento attivo del personale in tutte le sue dimensioni, inclusa la formazione, è di fondamentale importanza, per soste196 nere i progetti diricerca, sviluppo e industrializzazione di nuovi prodotti.” Per quanto concerne il programma degli investimenti previsti viene espressa “La volontà di Tenaris Dalmine è di consolidare la propria presenza industriale in Italia ed il ruolo degli insediamenti nell’ambito dei mercati di riferimento in un contesto caratterizzato da una sempre più accentuata competizione. Pur in un momento di profonda crisi economica, il risultato di questo ingente sforzo è quello di arrivare al momento della ripresa economica con maggior competitività e vantaggio sulle Imprese concorrenti, in particolare nei confronti di quelle appartenenti a Paesi che hanno costi dei fattori di produzione molto convenienti. Il programma degli Investimenti è stato sviluppato per il biennio 2010-2011 e costituisce elemento di continuità e di completamento di un costante impegno dell’azienda sul miglioramento continuo della: Produttività del lavoro; Efficienza nell’utilizzo degli impianti, della materia prima, delle energie e degli altri fattori di produzione; Incremento gamma dimensionale dei prodotti; Qualità dei prodotti e dei servizi forniti; Sicurezza e ambiente di lavoro; Ecologia. L’impegno economico complessivo degli investimenti previsto nel biennio 2010-2011 è superiore del 42,9 % in valore assoluto rispetto al valore di spesa sostenuto nel biennio precedente.” Dopo la filosofia si entra nel concreto. Ed entrare nel concreto in una vertenza come questa significa assumere decisioni sugli organici. Non lascia adito a dubbi l’incipit del paragrafo dedicato alla Cassa Integrazione: “… in considerazione della ridefinizione della struttura produttiva ed organizzativa secondo le linee illustrate e contenute nel citato Piano strategico, le parti concordano sulla necessità di avviare un adeguato programma di ristrutturazione e riorganizzazione per la gestione delle conseguenti ricadute occupazionali che si determineranno..(…) In relazione alle diverse fasi di implementazione e realizzazione dei progetti contenuti nel Piano si determineranno dei ridimensionamenti degli organici in generale ed a questo riguardo, il reale dimensionamento delle eccedenze potrà essere naturalmente influenzato positivamente da come l’Azienda riuscirà a collocarsi effettivamente nel mercato in termini di competitività e quindi del grado di realizzazione compiuta dei vari progetti oltre che dei volumi produttivi che sarà in grado di acquisire.” Nonostante quest’ultimo passaggio sembrerebbe lasciare indeterminati i livelli occupazionali colpiti da ristrutturazione, la determinazione dell’azienda viene esplicitata con numeri molto chiari: “La situazione determinerà per l’Azienda la necessità di procedere per un periodo di 24 mesi a partire dall’1.2.2010, alla sospensione di un numero medio mensile di dipendenti non superiore a 1062 unità (…) fino ad arrivare ad un massimo di 2727 unità in concomitanza delle iniziative e degli effetti connessi alla ristrutturazione su tutti i siti produttivi e aree organizzative aziendali. Per quanto sopra le parti considerano necessario accompagnare l’attuazione del Piano strategico con lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ri197 strutturazione e riorganizzazione (…) per la durata di 24 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2010.”; ma viene subito registrata la disponibilità delle parti, al termine del biennio a richiedere un ulteriore anno di proroga per il trattamento di Cassa Integrazione. “Da parte delle OO.SS e delle Rsu si prende atto della necessità di ricorrere alla Ciga ed esprimono parere favorevole all’accoglimento della richiesta stessa.” Per non farsi mancare niente, l’azienda pensa anche ai Contratti di Solidarietà: “E’ impegno delle parti, alla scadenza del biennio e dell’eventuale proroga, ricorrere anche ai Contratti di Solidarietà” Per la gestione delle inevitabili conseguenze sul piano sociale derivanti dal programma di ristrutturazione e riorganizzazione in attuazione del Piano, le parti hanno individuato come possibili strumenti idonei per la gestione delle eccedenze di personale: 1) Pensionamenti di anzianità e/o vecchiaia per coloro che conseguiranno il diritto all’effettivo pensionamento (…) 2) Esodi volontari incentivati per professionalità non funzionali alle nuove strutture organizzative/produttive che si configureranno (…) 3) La mobilità (…) come strumento di gestione degli esuberi attraverso l’attivazione concreta dei punti precedenti. Tenaris contemporaneamente ha dato avvio alla procedura relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per 741 dipendenti (576 operai 165 impiegati/quadri), attualmente occupati presso le sedi di Dalmine/ATB Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino. Nel verbale si da atto che “la società ha illustrato nel dettaglio le ragioni della riduzione dell’organico, motivandone la sussistenza e fornendo i dati e le informazioni richieste dalla legge con particolare indicazione delle cause che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale.” Per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, “avverrà unicamente sulla base dei criteri concordati dalle parti e di seguito specificati”: “Il primo criterio concordato è costituito dall’aver maturato i requisiti per l’accesso alla pensione (…). Il pensionamento è ritenuto dalle parti strumento idoneo e importante per gestire le ricadute occupazionali conseguenti la realizzazione del Piano.” “Il secondo criterio concordato, che riguarda coloro che non trovasi nelle condizioni per l’accesso alla pensione, prevede la “non opposizione” al licenziamento che potrà essere manifestata dai singoli lavoratori nell’ambito delle funzioni/aree rientranti non solo fra quelle indicate in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità.” Per la complessità della concreta applicazione delle decisioni sopra esposte, “le parti hanno esercitato la facoltà di proroga e di deroga dei termini (…) individuando nel superamento del termine di 120 giorni la condizione indispensabile per una valutazione oggettiva del piano di ristrutturazione. Le parti, in attuazione di quanto 198 precede, hanno pertanto concordato sulla possibilità di collocare in mobilità i lavoratori di cui alla lettera di apertura della procedura in un arco temporale compreso tra il 1.02.2010 ed il 31.01.2012 ed in diversi momenti in stretto collegamento con la realizzazione dei vari progetti di cui al Piano.” La riduzione del personale è un obiettivo talmente perseguito dall’azienda che la stessa “.. ove le condizioni tecnico-organizzative lo consentiranno e, soprattutto, in relazione a come andrà a configurarsi l’effettivo posizionamento della azienda rispetto alla situazione del mercato ed in connessione allo stato di realizzazione degli obiettivi del Piano, fatta salva la volontarietà del lavoratore, prevede la possibilità di ricorrere ad ulteriori strumenti previsti dalla disciplina vigente che consentano di agevolare l’uscita dei lavoratori e/o a favorire una nuova collocazione interna. In questo senso si andranno ad esaminare interventi quali: 1. trasformazione di contratti full time a part time; 2. conversione delle attività del lavoratore da attività indirette ad attività dirette, salvaguardando gli aspetti professionali e retributivi del lavoratore 3. mobilità interfunzionale all’interno dei siti e interaziendale fra i siti per compensare eventuali necessità degli uni con le eccedenze di altri. 4. interventi formativi e di addestramento finanziati finalizzati a favorire nuove opportunità occupazionali. 5. infine, la possibilità di assegnazione ad attività diverse (…)”. L’ultima parte di questo corposo e complicatissimo accordo è quella relativa alle verifiche che vengono stabilite con cadenza trimestrale e riguarderanno: “- nel mese di luglio 2011 le parti si incontreranno per un aggiornamento sugli investimenti successivi al piano industriale 2010-2011. - gli investimenti impiantistici ed i relativi riflessi sugli organici al momento della loro realizzazione. - la organizzazione ad isole ad FTM, come prevista nel piano, presuppone una marcia del laminatoio inferiore a 14 turni/settimanali, con la definizione sia in ingresso che in uscita di modalità applicative che tengano conto dei tempi minimi di preavviso e preparazione. La verifica periodica riguarderà inoltre l’avanzamento degli investimenti su tale linea, le produttività attese ed i volumi a quel momento acquisiti. Al riguardo è prevista che la Commissione ODL si riunisca con adeguato anticipo rispetto alla partenza dell’organizzazione ad isole con l’obiettivo di definire le modalità gestionali e applicative della stessa. - la integrazione della manutenzione e più in generale le organizzazioni delle manutenzioni di emergenza in relazione all’attuazione dei piani formativi/addestrativi. - gli investimenti informatici e le riorganizzazioni sulle strutture di coordinamento e di staff ed i riflessi conseguenti sul dimensionamento del fabbisogno di personale. 199 - l’attuazione del piano formativo sia per gli operai come pure per gli impiegati/quadri. Nel mese di ottobre 2011, in prossimità della scadenza del biennio 2010-2011, si effettuerà un incontro specifico al fine di verificare l’eventuale necessità di richiedere una proroga della Cassa Integrazione Straordinaria se occorrerà completare il Piano e dover gestire ancora le conseguenze occupazionali, ed in questo contesto anche l’utilizzo dei Contratti di Solidarietà; ovvero, se esaminando in quel momento i livelli di competitività e di efficienza raggiunta da Tenaris Dalmine, complessivamente e a livello di singolo sito, ciò anche con riferimento al contesto economico e alla effettiva acquisizione e consolidamento di crescenti quote di mercato, sia possibile considerare completato il Piano.”. Sicuramente rispetto a quella che si prospettava essere una vera propria “macelleria sociale”, gli effetti sono stati attenuati; rimane comunque il solito risultato di una riduzione complessiva e molto significativa del numero di posti di lavoro lasciando anche nell’incertezza la continuità produttiva, e quindi occupazionale, degli stabilimenti minori del gruppo come Arcore e Costa Volpino. 200 Inchiesta realizzata alla Frattini Spa di Seriate (Bg)18 La Frattini Spa è una azienda storica nel bergamasco, fondata dai fratelli Frattini nel 1920. Una data importante per la Frattini è il 1953, quando si decide la riconversione dell’attività passando dai macchinari per la lavorazione del legno alle costruzioni meccaniche. Si tratta, quindi, di una azienda con una forte connotazione famigliare e un forte radicamento nel territorio. L’altra caratteristica della Frattini è quella del modello di produzione adottato: non si producono singoli pezzi ma la macchina intera e collaudata. La struttura produttiva della Frattini è così organizzata secondo una produzione integrata che comprende: L’ufficio produzione che Studia i disegni e le distinte base dei clienti; Elabora i cicli di lavoro, le specifiche di acquisto e le procedure di controllo qualità; Programma e controlla l’avanzamento del lavoro; • L’ufficio tecnico di progettazione che progetta il macchinario per l’imballaggio metallico, ne sviluppa la tecnologia e collabora alla gestione assistenza clienti; progetta macchine o impianti in conformità alle esigenze specifiche dei clienti. • Il Controllo Qualità che controlla la qualità del prodotto in tutte le sue fasi di produzione secondo procedure e modalità stabilite dalle schede di lavorazione. • La Produzione Lo stabilimento è organizzato in modo da raccogliere le componenti del ciclo produttivo necessario alla fornitura di un prodotto “chiavi in mano”. La struttura produttiva è suddivisa in quattro aree: • Carpenteria • Lavorazioni meccaniche • Montaggio • Magazzini e spedizione Come detto, quindi, una organizzazione della produzione i grado di realizzare sempre prodotti finiti, dalla progettazione alle fasi di collaudo e spedizione. La Frattini produce sia su commesse di clienti, sia un prodotto proprio. I principali clienti della Frattini, negli ultimi anni erano rappresentai da: • Drent (azienda olandese che produce macchine per la stampa di 18 In collaborazione con Bruno Bonicchio, Prc Bergamo. 201 stampati commerciali, su imballaggi flessibili e rigidi; di sicurezza): per questa la Frattini produceva una “linea” costituita da più unità di stampa dette “torri”; • Hatebur (azienda Svizzera che produce macchine per lo stampaggio a caldo o a freddo di particolari in acciaio ed ottone): per questa la Frattini produceva macchine per stampaggio a caldo, gruppi di alimentazione delle macchine per stampaggio a freddo; • Negri Bossi (azienda di Milano che produce presse per lo stampaggio a caldo di particolari in plastica); • Adige Systems (azienda di Trento che produce macchine taglio laser per tubo e lamiera): per questa la Frattini produceva componenti meccaniche, montaggio e prove di funzionamento; • Sipa (azienda di Vittorio Veneto, del gruppo Zoppas che produce macchine per il soffiaggio e lo stampaggio di contenitori in PET e altri materiali plastici): per questa la Frattini produceva gruppi completi per la linea ECS – macchina integrata per la produzione di contenitori a partire dal granulo plastico); • Charmilles Technologies (azienda che fa parte del gruppo svizzero Agie Charmilles leader mondiale nel settore delle macchine per elettro - erosione a tuffo e a filo): per questa la Frattini effettuava le lavorazioni di pre – finitura sui componenti principali di alcune macchine. I prodotti propri della Frattini, invece, erano: - la conifica: pressa a stazioni multiple per deformare, attraverso operazioni successive, la parte superiore di un corpo cilindrico in alluminio; - la preconifica: nuova tecnologia applicata nel settore aereosol e bevande che consente di deformare anche la parte centrale del contenitore; - conifiche 2004: macchine riprogettate, rese modulari e utilizzabili per tutti gli usi possibili dall’estruso all’imbutito; - embossing – debossing: impronta definita localizzata in un’area specifica della zona laterale del barattolo realizzata usando due stampi contrapposti; - conature varie; - macchina pop can: produzione di lattine a strappo. Questa lunga e dettagliata elencazione delle produzioni della Frattini ha come scopo quello di evidenziare la grande ricchezza delle produzioni stesse, estremamente diversificate e di elevata complessità di progettazione 202 e realizzazione. Il tema della qualità delle produzioni Frattini, e del lavoro delle maestranze in essa impegnate, è un tema che verrà fuori con particolare rilevanza nel corso dell’inchiesta. Proprio la riduzione della diversificazione produttiva viene indicata dai lavoratori come una delle cause della crisi aziendale. La produzione per i clienti su commessa, quella che viene chiamata dagli operai la produzione per “conto terzi”, era la produzione i cui introiti consentivano di sostenere gli investimenti negli altri settori. Al contrario, l’azienda nell’ultimo periodo ha deciso, progressivamente, di relegare ad un ruolo marginale la produzione per i clienti e di puntare tutto sul prodotto “proprio”. Alla richiesta di ricostruire i fattori che hanno determinato la situazione di crisi, i lavoratori indicano una versione ufficiale (definita “buona”) e una ufficiosa (definita “cattiva”). Secondo la versione “buona” la crisi è dovuta essenzialmente a tre fattori: 1. la previsioni di vendita completamente sbagliate per l’anno 2008 che hanno portato la Frattini a realizzare 24 macchine senza disporre dei relativi ordini ma solo di promesse di acquisto; se si tiene conto che ciascuna di queste macchine ha un costo medio di 1 milione di euro è agevole ricostruire le fortissima esposizione finanziaria che questo intervento ha comportato; l’azienda anziché rallentare la produzione ha preferito costruire comunque anche se i lavoratori avevano segnalato il rischio di una decisione di questo tipo: “noi vedevamo che le linee erano ferme …che molti lavoratori erano sovrapposti …che non si lavorava bene…”; a fronte di questa constatazione per i lavoratori era meglio adottare una strategia più prudente e ragionevole “ad un certo punto era meglio rallentare un po’, magari fare un po’ di cassa integrazione per non portare l’azienda al fallimento…” ; “..era meglio fare 4 o 5 macchine e vedere se si vendevano, e poi decidere cosa fare…”; 2. è calata la produzione per “conto terzi”: in generale sono calate le commesse a causa della crisi economica, è crollato il settore metal container ed in particolare è stata perso un grosso cliente, la Drent, che tra l’altro aveva maturato un debito di 6 milioni di euro con la Frattini; 3. “è morto l’ing. Luciano che era l’anima della fabbrica, ci teneva tantissimo, lavorava anche 15 ore al giorno, era lui che dava la grinta giusta, che sperimentava ecc..”. Secondo la versione cattiva, invece, si è voluto portare l’azienda al fallimento magari per consentire alla Mall Harlen di comprare il ramo metal 203 container per quattro soldi, garantendosi l’acquisizione di un grosso patrimonio in termini di capitale. L’azienda, quindi, è finita in concordato preventivo, una modalità che, come ha recentemente rilevato IL Sole 24 Ore (…non Liberazione o il Manifesto) che sta sempre più evidenziando aspetti grigi e discutibili nella gestione delle situazioni di crisi. I lavoratori insistono molto sulle strategie sbagliate e sul fatto che le loro osservazioni, a differenza del passato, restassero inascoltate: “all’ing. Luciano dicevamo sempre dove si lavorava e dove no; …invece adesso hanno deciso di fare investimenti e dare premi solo sul prodotto proprio, sul conto terzi non hanno più messo investimenti e premi, ma solo penalizzazioni…” Il “conto terzi”, quindi, che poteva contare su numerosi clienti, su lavorazioni diversificate e di particolare qualità, è stato “del tutto trascurato, lo hanno voluto far saltare”. Accanto a questi macroscopici errori di gestione viene citata anche la “girandola di consulenti” di cui si circondava l’ultimo Frattini. Questi consulenti venivano, in genere, da grosse aziende che pretendevano di applicare “solo logiche aziendalistiche” ma in realtà “sbaglia cavano ogni organizzazione del lavoro, come sul carico di lavoro che assegnavano ai reparti”. Con la conseguenza che, in base alla loro programmazione, “…c’erano macchine e lavoratori fermi e si dava fuori il lavoro che poteva essere fatto dentro”: una assurdità: “certo, se sei pieno di lavoro puoi dare fuori qualcosa, ma con la gente ferma era assurdo dare fuori le commesse nostre”. Addirittura dentro lo stabilimento venivano portati dall’esterno degli artigiani per fare le lavorazioni del “conto terzi”, nonostante la contrarietà manifestata dalla Rsu l’azienda ha deciso di “fare spazio” nel reparto del collaudo a questi artigiani esterni affinché potessero lavorare nella Frattini. Questa situazione con il tempo si è consolidata “c’erano persone esterne che lavoravano dentro sul conto terzi, e i nostri lavoratori sono stati messi tutti sul prodotto proprio”. “la nostra proposta era diversa: non bisognava abbandonare il conto terzi e se c’erano dei picchi di lavoro o delle sostituzioni di lavoratori che andavano in pensione si potevano cominciare ad assumere i ragazzi che escono dai corsi di formazione professionale, affiancarli a noi, fargli imparare il mestiere e poi tenerli dentro…”. Invece, niente da fare, così si era deciso e così bisognava procedere. I consulenti procedevano per la loro strada producendo “montagne di riunioni, addirittura in ritiro in una agriturismo perché dicevano che bisogna204 va fare gruppo…”. Per creare gruppo i consulenti avevano diviso i lavoratori in tre fasce (fascia alta, impiegati e operai) alle quali dedicare attività e iniziative diverse. Gli operai, ad esempio, vennero portati al Circo…, gli impiegati, invece sul Lago di Garda…. In particolare uno di questi manager insisteva molto nell’applicazione del concetto di just in time in quanto era solito ripetere, a proposito del pezzo, “prima entra prima esce”. Questa rigida organizzazione della produzione e del lavoro non si addiceva alla Frattini i cui lavoratori continuavano a ripetere che i lavoratori potevano essere spostati sulle diverse produzioni, anche dal conto proprio al conto terzi e viceversa, pur di non spegnere le macchine, ma sempre inascoltati. La grande professionalità dei lavoratori Frattini è una caratteristica storica ampiamente conosciuta. La Frattini era una delle fabbriche più ambite, addirittura i capi – reparto di altre fabbriche “venivano alla Frattini per fare gli operai”, la Frattini è stata la seconda fabbrica di Bergamo ad ottenere la quattordicesima mensilità, e, a testimonianza dell’elevato livello di professionalità “molti operai che uscivano dalla Frattini diventavano imprenditori grazie alla professionalità che avevano acquisito qui dentro”. La crisi della Frattini porta la proprietà ad operare uno spezzatino e nell’ambito della procedura di concordato a decidere di vendere solo parte delle produzioni. La Mall Harlen, infatti, decide di acquistare soltanto la parte del metal container, ossia soltanto la parte che costruisce gli utensili, mentre la macchina generale viene realizzata all’esterno e acquistata. A questo punto si rende necessario ricostruire il quadro in cui si verificano queste operazioni societarie. Nel giugno del 2008 sono proprio due dirigenti della Frattini che costituiscono una società denominata Metal Container Srl, il cui nome, guarda caso, ricalca esattamente il nome del ramo di impresa in odore di acquisizione per 4,5 milioni di euro. I due dirigenti sono Ezio Foresti, direttore commerciale della Frattini, e Sergio Persico, fratello di Luciano (“l’ing. Luciano”), cognato di Roberto Frattini. Questa società è una scatole vuota, ma ben presto finisce nella pancia proprio della Mall Herlan, società svizzera di 1.800 dipendenti. Ma al ramo d’impresa “Metal Container” (costruzione di macchine per la produzione di barattoli meccanici per aerosol e bevande) si rivela interessata anche una azienda tedesca, la Hinterkopf, la quale lamenta un atteg205 giamento ostile da parte della Frattini nel fornire i dati e gli elementi conoscitivi necessari a formulare un’offerta di acquisto. Sempre la Hinterkopf, sulla stampa locale ha lamentato il fatto che la proposta di acquisto della Metal Container, da parte della Mall Herlan è stata “patrocinata anche dai principali manager di Frattini, i quali ricoprirebbero un ruolo di primo piano nella nuova Frattini, quella che nascerebbe dalla soluzione Mall Herlan.Riteniamo però che gli stessi manager che hanno partecipato alla gestione della Frattini fino al presente stato di crisi, non siano adatti a scegliere i loro successori e, ancora meno, a condurre la Frattini verso un futuro migliore.” Insomma, secondo l’azienda tedesca la Frattini ha mantenuto un comportamento che sembrava quasi voler scoraggiare altri possibili acquirenti diversi dalla Mall Harlen (che, appunto, aveva acquistato da tempo la società Metal Container Srl costituita proprio da due dirigenti Frattini). Sempre secondo la Hinterkopf, la Frattini avrebbe posto in essere tutta nua serie di operazioni assai discutibili: - il trasferimento, nell’imminenza del concordato, a un’latra società di alcuni brevetti della società stessa; così facendo avrebbe indebolito ulteriormente il valore di detti macchinari privati dei loro diritti di proprietà (i brevetti); - l’attivo della Frattini avrebbe subito una pesante svalutazione nel bilancio 2008, approvato qualche giorno prima della richiesta di ammissione al concordato preventivo; - sempre nel medesimo periodo, la Frattini avrebbe operato una pesante svalutazione del magazzino, a partire da una macchina conifica che, al contrario, costituisce una delle macchine più innovative e su cui la stessa Frattini aveva molto investito. L’offerta per l’acquisto del ramo d’azienda Metal Container viene formulata proprio dalla Metal Container Srl, acquistata e controllata dalla tedesca Mall Herlan. Tale Metal Container Srl è stata costituita proprio nel maggio 2009, cioè nel periodo in cui la Frattini preparava la procedura per la richiesta di ammissione al concordato preventivo, dai due dirigenti Frattini sopra richiamati e con sede sociale e oggetto sociale identici a quelli della Frattini e del ramo d’azienda metal container. In seguito, i soci della Metal Container Srl hanno deciso di vendere le loro quote a una società svizzera denominata Eta – Tech AG controllata interamente, anche questa, dalla Mall Herlan GmbH. Quindi alla Mall Herlan era già stata ceduta la società con cui la stessa avrebbe poi presentato l’offerta per l’acquisto del ramo di azienda della 206 Frattini medesima. Il 31 luglio 2009, il ramo d’azienda “Metal Container” della Frattini viene promesso in vendita alla Mall Harlen (tramite la Metal Container Srl) per un prezzo di acquisto pari a 4,5 milioni di euro, stipulando l’atto di cessione in data 15 settembre 2009. Ma l’offerta di acquisto della Mall Harlen suscita anche l’opposizione dei lavoratori. Dei 191 dipendenti della Frattini soltanto 37 sarebbero stati assorbiti dalla Mall Herlan. Per le Rsu, invece, in quel ramo d’azienda potevano trovare occupazione almeno 90 dipendenti e, oltretutto, con il problema che ne sarebbero rimasti altri 100 da rioccupare. Per questo la proposta di accordo viene bocciata dall’assemblea dei lavoratori con l’80% dei voti contrari, espressi anche da lavoratori del ramo metal container in quanto, stando ad una dichiarazione resa alla stampa da un lavoratore “nessuno del reparto si sente sicuro, anzi la convinzione è che vengano riassunti i soliti raccomandati di ferro”. Le Rsu e i sindacati hanno assunto la posizione di difendere tutti i posti di lavoro anche perché è forte il “rischio che alla fine chiuda anche questo reparto. Cioè, una volta venduto, potrebbero portare i brevetti in Germania e chiudere definitivamente a Bergamo”. “L’offerta della Mall Herlan non ci ha convinto anche se vedendo la nostra posizione si erano detti favorevoli a assumere fino a 71 persone, ma non c’era nessuna garanzia concreta. Non c’era chiarezza, l’unica cosa certa erano le 37 persone, per le altre si parlava di cassa e ammortizzatori sociali”. Quello che concretamente si prospetta è, appunto, una soluzione spezzatino anche dal punto di vista industriale la Frattini era specializzata nella produzione della macchina conifica (per la deformazione dell’alluminio), ed è solo su questo segmento che si è concentrata l’attenzione della Mall Harlen attraverso le sue controllate, prima Metal Container Srl, poi la svizzera Eta – Tech AG. La macchina conifica prodotta dalla Frattini è molto avanzata dal punto di vista tecnologico ed era un prodotto che la Frattini già vendeva alle due società (Mall Harlen e Hintekopf) che hanno manifestato interesse all’acquisto. E’ evidente, quindi, che con la vendita di questo segmento ad uno dei due concorrenti internazionali, dall’Italia se ne andrebbe un altro pezzo di industria e di tecnologia. Questo destino di perdita industriale viene segnalato dai lavoratori come un “processo che parte da lontano. Con i vecchi Frattini questo non sareb207 be mai successo. Ma le nuove generazioni non volevano governare più una azienda come era diventata la Frattini, se non all’ing. Luciano Persico..” “C’erano progetti che si potevano sviluppare e non è stato fatto. Frattini ha tenuto nel cassetto per 20 anni un progetto acquistato dal Tubettificio Ligure; c’è voluto Persico per recuperarlo”. L’obiettivo che indicano le RSU è quello di salvare l’azienda e i posti di lavoro. “Tutta l’azienda - precisano - perché con la soluzione Mall Harlen lavorerebbero in 37 e oltre 150 finirebbero per strada”. “Il nostro obiettivo è che qualcuno compri tutto e riassuma tutti”. Battersi per questo obiettivo significa battersi per l’unità, non solo dei lavoratori, ma anche dell’industria: in questo modo si terrebbero insieme i due grandi settori in cui era organizzata la Frattini, cioè il conto terzi e il prodotto proprio. Al contrario, la proposta Mall Herlan, con l’acquisto soltanto del metal container, prevede il salvataggio soltanto del prodotto proprio (macchina conifica) con il sacrificio di tutto il patrimonio industriale e professionale rappresentato dalle lavorazioni per i clienti del cosiddetto “conto terzi”. Per questo è partito un presidio davanti alla fabbrica, “per smuovere l’opinione pubblica e far arrivare qualche imprenditore che presenti un progetto serio per tutta la fabbrica”. “se arriva uno che compra, noi ci mettiamo la nostra professionalità e riparte tutto”. L’aspetto relativo all’elevata professionalità dei dipendenti Frattini è un elemento molto forte di orgoglio operaio: “qui c’è tutta gente di alto livello; tutta gente che sa fare tutto e infatti tutte le lavorazioni si facevano dentro l’azienda”. “Dentro questa azienda si può fare tutto: dalla A alla Z”. La Frattini storicamente è una fabbrica molto sindacalizzata, “dopo la Dalmine qui c’era il sindacato più forte”. Nei più anziani è forte il ricordo delle lotte degli anni ’70, quando alla Frattini ci furono importanti conquiste da parte del movimento dei lavoratori e quindi maggiore è il raffronto con la situazione attuale “dopo i sindacati hanno fatto troppo i pompieri, si sono abbandonate alcune lotte che prima si facevano”. In particolare vengono citati i vantaggiosi contratti aziendali che venivano strappati grazie alle lotte dei lavoratori e all’azione della Flm che in Frattini era molto forte. Addirittura le piattaforme di rivendicazione venivano definite proprio alla Frattini ed in seguito venivano estese anche alle altre fabbriche. 208 I successi sindacali conquistati dagli operai della Frattini erano talmente significativi che preoccupavano l’Associazione degli Industriali di Bergamo che “Richiamavano Frattini, si arrabbiavano perché qui si conquistavano “troppi” diritti; se fossero passati qui poi gli altri operai avrebbero lottato per estenderli anche ad altre fabbriche…” Di Daniele Frattini viene ricordato che aveva una concezione dell’imprenditore “come quella di Olivetti; voleva il medico in azienda, fece concessioni sulla mensa, passava tutti i giorni tra i reparti…certo aveva un atteggiamento un po’ paternalista, ma faceva vedere che ci teneva all’azienda… Il giudizio che viene espresso dai lavoratori a proposito del ruolo svolto dalle istituzioni nell’ambito della crisi Frattini non è positivo. “La Provincia ci ha convocato varie volte, per discutere delle modalità dell’anticipo della Cassa”; “LA Provincia ci ha convocato per discutere della crisi…si è discusso molto ma finora non ci sono risposte concrete”. Presso il Comune di Seriate è stato convocato un Consiglio Comunale aperto per discutere della crisi della Frattini, è stato apposto un vincolo urbanistico sulle aree approvato all’unanimità da parte del Consiglio Comunale, l’amministrazione comunale ha partecipato al presidio portando anche dei panini, la Sindaca (della Lega) ha partecipato alla manifestazione dei lavoratori. La Sindaca, che viene definita una “leghista partecipativa”, con “un buon livello culturale, ha preso parte a tutte le manifestazioni dei lavoratori, questo le viene riconosciuto ma viene anche chiamata alle proprie responsabilità: “aveva fatto delle promesse ben precise, che avrebbe cercato degli imprenditori disponibili ad acquistare…che aveva due o tre imprenditori disponibili, a valutare…” “In particolare diceva che “aveva” un imprenditore di Rimini disponibile a rilevare l’azienda, che prima della procedura di concordato preventivo aveva anche visitato la fabbrica, ma poi non si è più saputo niente…”. In Regione Lombardia invece si è svolta la procedura per la corresponsione della Cassa Integrazione Straordinaria che rappresenta un punto particolarmente critico: infatti nei mesi precedenti agli operai Frattini sono state corrisposte 400 euro mensili attingendo a quanto accantonato sul Tfr, mentre per questo mese non è stato corrisposto nemmeno un euro. Si è ancora in attesa, infatti, dell’approvazione dell’accordo relativo alla Cassa Integrazione necessario per procedere con le erogazioni mensili. Delle proposte di legge preparate da Rifondazione Comunista i lavoratori apprezzano quella relativa alla proposta di Iri Regionale con l’obiettivo di fare in modo che queste forme di intervento pubblico in economia consentano anche la tutela e la valorizzazione dei brevetti definiti in Lombar209 dia. “In Lombardia abbiamo dei brevetti di valore internazionale, la Regione Lombardia dovrebbe entrare a pieno titolo in questo ambito, per la tutela dei nostri brevetti. Se avviene che ci trasferiscono in Germania, qui perdiamo posti di lavoro, una fabbrica, delle produzioni di qualità e dei brevetti”. Il punto aperto, oltre ovviamente ai destini complessivi dell’azienda e dei lavoratori, è quello della concessione della Cassa Integrazione. Attorno a metà novembre la situazione si fa sempre più tesa per la condizione di stallo in cui versa la vicenda della concessione dei trattamenti di integrazione al reddito. Le Rsu, quindi, assumono una iniziativa decisa con una lettera indirizzata alle istituzioni locali e ai principali istituti di credito attraverso la quale “i lavoratori e le lavoratrici della Frattini SpA attualmente in cassa integrazione straordinaria sono a lamentare la situazione di grave disagio nella quale si trovano. Ci risulta che nell’incontro del 10 novembre 2009 avuto tra Provincia ed Organizzazioni sindacali non è emersa ancora una soluzione per anticipare a tutti il salario di cassa. Da diversi mesi siamo in questa situazione, senza stipendio, in quanto siamo ancora in attesa, come tutti sanno, che la cassa venga firmata. All’Istituzione, che dovrebbe garantire pari condizioni a tutti i cittadini, chiedevamo di individuare una Banca che come ponte garantisse l’anticipo a tutti i lavoratori: riteniamo che invece la sola applicazione dell’accordo del 24 dicembre 2008, se pur positiva, non rappresenti una soluzione uguale a tutti i lavoratori, in quanto le Banche definiscono situazioni eterogenee e non di unica tutela comune. Alle Banche, che ci leggono per conoscenza chiediamo di aiutarci con un’unica soluzione per tutti i lavoratori e le lavoratrici, tramite un unico istituto di credito che si accolli i bolli, applichi tasso zero e anticipi a tutti gli interessati indipendentemente da dove abbiamo il conto.” Grazie a questa iniziativa la situazione si sblocca. Con l’approvazione della Cassa Integrazione, dopo ben quattro mesi d’attesa. “L’approvazione è avvenuta solo grazie ai solleciti dei sindacati, dato che tutte le parti istituzionali e politiche, dopo i grandi proclami iniziali, ci sono sembrate latitanti da mesi” ha commentato Margherita Dozzi della Fiom-Cgil. “Addirittura Confindustria il 10 novembre si rassegnava ad ottenere un’approvazione ministeriale sulla base dei suoi contatti con il Ministero, solo per la fine del mese prossimo”. Emerge anche in questo caso, come già notato per la Tenaris di Dalmine, la sostanziale latitanza delle istituzioni locali, dove forte è la presenza di amministratori leghisti. Anche se nel caso dell’azienda di Seriate la Sindaca (leghista) sembra aver fatto qualcosa in più, questo impegno si è limitato alla sola partecipazione 210 a qualche presidio. Al contrario, di soluzioni concrete, quelle cioè che competono ad un livello istituzionale, non ne sono state assunte. Stessa cosa vale per la Provincia di Bergamo. I sindacati avevano chiesto alla Provincia di contribuire direttamente, pagando alle banche che accettassero di anticipare direttamente ai lavoratori la cassa integrazione gli interessi su quanto versato. Richiesta respinta dall’assessore al Lavoro secondo il quale la Provincia avrebbe dovuto limitarsi a fare da tramite per i lavoratori presso gli istituti bancari, ma senza farsi carico di spese o tassi aggiuntivi. Questo atteggiamento viene contestato dalla Fiom di Bergamo attraverso i propri dirigenti Margherita Dozzi e Mirco Rota: “La stessa cosa viene fatta da altre Province d’Italia. Si tratta di trovare una banca, sostenere dei costi e anticipare a tutti i lavoratori la cassa integrazione indipendentemente dall’istituto di credito presso cui il singolo dipendente ha il conto corrente. A questo dovrebbero servire le istituzioni, a rendere uguali i cittadini e a garantire loro i diritti”. “Abbiamo chiesto alla Provincia un impegno concreto a favore di lavoratori che hanno perso il posto, e che ora devono fare i conti anche con le lungaggini del nostro sistema burocratico. Abbiamo chiesto all’assessore di mettere in campo misure fattibili, e già attive in altre zone d’Italia, ma la risposta è stata negativa. I lavoratori della Frattini che hanno perso il posto di lavoro, oltre a essere in attesa da mesi della cassa integrazione, secondo quanto afferma l’assessore Zucchi dovrebbero anche pagare gli interessi sull’anticipo della cassa richiesta alle banche. Oggi abbiamo constato come da parte della Provincia di Bergamo ci sia tanta solidarietà a parole ma non nei fatti; a distanza di alcuni mesi infatti i lavoratori della Frattini non vedono nulla di concreto da parte di coloro che hanno diretto il tavolo istituzionale”. Nel frattempo si conferma che per le produzioni Frattini esiste un mercato, esistono ordini, insomma esiste il lavoro. L’ingegner Alexander Hinterkopf, alla guida dell’ o m o n i m o gruppo tedesco, dichiara pubblicamente che sarebbe disposto ad assumere da subito 70-80 lavoratori, contro i 37 riassorbiti dalla società svizzera Mall Herlan, in quanto avrebbe dodici milioni di euro di ordinativi in portafogli per la macchina «C 3000» della Frattini. Secondo Hinterkopf, il prototipo del macchinario di punta, la C 3000, sarebbe stato definito «ferraglia» dal commissario, quando lo stesso Hinterkopf avrebbe appunto una commessa per quattro macchine subito e altre sei nell’arco di due anni. Con queste dichiarazioni, quindi, la Hinterkopf riprende e conferma la battaglia legale in atto: “oggi, la Mall Herlan dispo211 ne di un capitale aziendale acquistato sottocosto e può quindi permettersi di vendere a prezzi di saldo…”. Hinterkopf ha parlato anche dei brevetti aziendali «non menzionati nel bando ma comparsi in maniera dettagliata nell’atto di vendita: una grave irregolarità che faremo valere in sede giudiziaria”. La speranza dei lavoratori licenziati, in presidio ai cancelli dal 12 ottobre, era di una seconda offerta per la parte di fabbrica rimasta invenduta, quella dove si effettuavano le lavorazioni in conto terzi: “Sarebbe da pazzi presentare un’offerta – ha detto l’imprenditore, gelando molte speranze – la Frattini era come un supermarket senza cassa, dove qualcuno ha preso tutte le merci e se n’è andato senza pagare». Durante le feste natalizie la Mall Herlan tenta il colpo di mano forzando la situazione per cominciare a smontare e spostare macchinari. Questo significherebbe una sola cosa: la fine di ogni ipotesi si salvare la situazione ei posti di lavoro Niente macchinari per la produzione, fine di ogni speranza di salvare il proprio posto di lavoro: per questo di fronte al tentativo di trasferire due torni dallo stabilimento Frattini a quello che ora ospita la Frattini Tech, cioè il ramo d’azienda che è stato rilevato da Mall Herlan, i lavoratori del presidio permanente hanno impedito l’operazione. Secondo la Fiom: “In modo del tutto improprio la Mall Herlan ha deciso in pieno periodo di feste natalizie, di spostare da un capannone all’altro le prime macchine, oggetto fra l’altro della denuncia penale sporta dalla Fiom Cgil qualche settimana fa” .“Immediata è stata la reazione dei lavoratori, sostenuti anche da molti delegati della Tenaris Dalmine: insieme hanno ostacolato il trasloco. Svuotare i capannoni significa togliere la speranza di tornare a lavorarci. Abbiamo avuto, come sindacati, un breve colloquio con i rappresentanti di Mall Herlan che si sono impegnati a non procedere ad alcun trasferimento di impianti prima della fine del periodo di ferie. Se la sospensione non verrà mantenuta la nostra azione sarà più incisiva nel presidiare i prodotti Frattini Tech in uscita”. Al blocco del trasferimento dei macchinari hanno partecipato anche i segretari provinciali dei sindacati confederali metalmeccanici e l’intera delegazione delle RSU Tenaris (compresi i delegati degli stabilimenti Tenaris di Arcore, Costa Volpino, Dalmine e Piombino). In questo momento si è realizzata una precisa solidarietà e cooperazione tra lavoratori di fabbriche diverse, ancorché dello stesso settore metalmeccanico, finalizzata al blocco del trasferimento dei macchinari e quindi alla piena realizzazione dello spezzettamento aziendale due rami: quelli da 212 mantenere per essere poi ulteriormente spolpato di macchinari e brevetti, e quello in cui concentrare gli esuberi occupazionali. Con questo presidio è stata bloccata l’attuazione concreta dello “spezzatino” societario che ha fatto seguito alla procedura di concordato preventivo con la separazione tra la vecchia Frattini (da dismettere e i cui lavoratori da lasciare al loro destino) e la nuova Frattini Tech acquisita dal gruppo Mall-Herlan e che occuperà soltanto 37 dipendenti. In tutta la vicenda Rifondazione Comunista ha giocato un ruolo decisivo, in più passaggi. Innanzitutto la presenza continua, 24 ore al giorno, domeniche e festività comprese, delle Brigate di Solidarietà Attiva al presidio dei lavoratori. Questa presenza, con la cucina e la messa a disposizione di strutture e attività volontaria, è stata decisamente apprezzata dai lavoratori che dopo un iniziale momento di smarrimento (“Ma chi sono queste brigate?! saranno mica le brigate rosse?!!”) hanno riconosciuto il lavoro svolto dai giovani e giovanissimi attivisti tanto da ringraziarli pubblicamente con una lettera sul principale quotidiano, l’Eco, di Bergamo. Rifondazione di Bergamo ha potuto contare, dal punto di vista delle relazioni con i lavoratori e le Rsu, sulla presenza di due ex operai della Frattini, attivisti di partito e molto riconosciuti in fabbrica per l’impegno sindacale e politico che avevano svolto. Questo ha consentito al Partito di avere una relazione continua e diretta con Rsu e operai, di avere informazioni e aggiornamenti quasi in tempo reale, di poter organizzare iniziative (assemblee, presidi a Seriate, raccolte fondi) da subito partecipate e pienamente sostenute dai lavoratori. 213 Inchiesta realizzata alla Rothe Erde Metallurgica Rossi di Visano (Bs)19 La Rothe Erde Metallurgica Rossi è una società del Gruppo Thyssen Krupp. Questa azienda opera nel settore della produzione e commercializzazione di cuscinetti volventi, con esclusiva mondiale per la produzione di cuscinetti inferiori a 680 mm destinati alle macchine movimento terra e macchine per l’edilizia. Lo stabilimento di Visano (in provincia di Brescia) è l’unico stabilimento del gruppo nel quale è installata la tecnologia automatizzata sulle linee per la produzione di cuscinetti. Quindi, una società che può produrre in condizioni di esclusiva, che può contare su una tecnologia automatizzata già installata e che in prospettiva dovrebbe avvantaggiarsi anche dei 15/16 milioni di euro di investimenti programmati dall’azienda. Ma l’abbassamento della produzione al 30% della capacità produttiva installata è all’origine della situazione di crisi che l’Azienda vorrebbe risolvere in maniera unilaterale imponendo un elevato numero di esuberi. L’inchiesta condotta sulla Rothe Erde parte con una intervista collettiva condotta ai cancelli di fabbrica al presidio permanente organizzato e gestito dagli operai con la partecipazione e il sostegno della Fiom. Lo “scenario” è quello abituale dei presidi di fabbrica: gazebo (debolmente) riscaldati con falò improvvisati, bandiere rosse della Fiom, striscioni di rivendicazione, volantini articoli di giornale sparsi sui tavolacci dove ci accomodiamo per discutere con gli operai in presidio.. “Allora, come comincia la storia: il nostro problema è nato con i primi di quest’anno a febbraio con la Cassa Integrazione: per la prima volta l’azienda, da quando lavoro qui, ha convocato lei l’assemblea per comunicarci i problemi e ci ha detto che eravamo in Cassa integrazione. Ha voluto subito rassicurarci… però state tranquilli, …ha detto che avrebbe salvaguardato i posti di lavoro,…perché noi siamo come una grande famiglia ecc.” “forse avevano speranza che la crisi si risolvesse. Poi, prima di Pasqua, 55 persone dicono che sono esuberi, da lì fino a metà ottobre partono tutti i vari incontri con il sindacato e da subito si vedono due posizioni: quella di Fim e Uilm che accettano prepensionamenti e mobilità; e la linea della Fiom, una linea chiara…che era solo per accettare i prepensionamenti”. 19 In collaborazione con la federazione provinciale Prc di Brescia e Gaetano Dato, Prc Trieste. 214 Si ripete un clichè ormai, purtroppo, noto, l’Azienda che tenta l’affondo occupazionale sfruttando il periodo di difficoltà produttiva; i sindacati compiacenti pronti a firmare qualsiasi tipo di accordo sulla pelle dei lavoratori; e la Fiom che da subito assume una posizione netta di difesa del lavoro e su questo incontra il favore della maggioranza degli operai. L’intenzione dell’azienda è proprio quella di arrivare ad un pesante dimagrimento occupazionale e da subito manifesta una forte decisione nel perseguire questo obiettivo: “..sotto l’accordo che loro volevano c’era una pregiudiziale dell’azienda…” cioè arrivare a definire il numero di esuberi da imporre al Sindacato per poi procedere concretamente con i licenziamenti: “L’azienda voleva un numero: 55, quello iniziale.” Questo non era accettabile per la Fiom perché avrebbe lasciato senza nessuna tutela almeno 25 lavoratori: “Cosa sarebbe successo? che i 30 (quelli che potevano maturare i requisiti per il pensionamento) magari andavano fuori con incentivo e con tutti i crismi di un accordo sindacale, ma 25 finivano fuori senza nessun diritto e senza nessuna tutela”. In fabbrica il sindacato maggioritario era la Uilm (ora, evidentemente, non più…), e la loro posizione era che “… dicevano che non avevano mandato per discutere, ma noi in assemblea il mandato lo abbiamo dato alle Rsu e da lì è iniziato il presidio (in ottobre) mentre l’azienda era chiusa per Cassa Integrazione. (dal 19 al 23). …Da allora è iniziato il presidio permanente chiedendo all’azienda ciò che la Fiom ha chiesto: cioè il reintegro dei licenziamenti. Nel frattempo, infatti, l’Azienda aveva avviato, in via del tutto unilaterale, la procedura di mobilità per 44 persone trasmettendo loro la lettera con cui si comunicava l’avvio della procedura. Dal punto di vista delle iniziative i lavoratori organizzano “…una assemblea pubblica il 23 ottobre alle sede delle Acli in paese, con inviatati tutti i sindaci della zona…” La risposta dei sindaci, tuttavia è molto fredda: si presentano solo il Sindaco di Isorella e il Vice – sindaco di Visano. Questa assemblea decide di continuare presidio anche se comincia a verificarsi quale “… problema con qualche lavoratore (impiegati) che vogliono rientrare in azienda, ma l’assemblea ha precisato 3 punti per riprendere trattativa : - Il reintegro tutti lavoratori; - Il prepensionamento solo per chi vuole; - usufruire di tutti gli ammortizzatori sociali previsti per legge”. Cominciano a registrarsi anche i primi momenti di tensione quando, ad esempio, “i dirigenti si sono presentati per entrare…c’è stata un po’ di ten215 sione, però stemperata grazie a funzionari della Fiom, e alla fine se ne sono andati. …Poi si sono ripresentati con l’assicurazione del sindacato che potevano entrare in condizioni di assoluta sicurezza e incolumità.” L’attacco dell’azienda, infatti, si concentra da subito sul presidio che, per la partecipazione che raccoglie e per la visibilità che garantisce alla vertenza, rappresenta un elemento di grande disturbo per le strategie di chi intende licenziare e riorganizzare il lavoro in condizioni di “mani libere”: “Dicono che è una cosa illegale…che non è giusto tenere fuori 170 persone, ma il nostro obiettivo è tutelare tutti i 218 lavoratori. Non solo 170: noi chiediamo il reintegro di tutti…semmai è l’azienda non ha rispettato criteri di legge licenziando in maniera unilaterale persone con famiglie a carico, ultra cinquantenni ecc.” Il fatto è che non si tratta di una “aziendina” di paese: la Rothe Erde fa parte della multinazionale Thyssen Krupp: “noi facciamo parte della Thyssen Krupp, …ed è la nostra fortuna…perché esiste un organismo, che è il CAE, che è a livello europeo…lì dentro abbiamo un nostro compagno di Copparo (dipendente della Berco di Copparo, Ferrara, azienda anch’essa facente parte del Gruppo Thyssen, n.d.r.) e abbiamo così notizie fresche dalla Germania (sede centrale della TK, n.d.r.) e possiamo intervenire a livello europeo.” Una forte aspettativa viene riposta nel ruolo del CAE con la capacità che ad esso viene attribuita di intervenire anche sulla “casa madre”: “…speriamo che in Germania capiscano la nostra situazione…che capiscano che questa azienda ha fatto dei grossi sbagli lasciando a casa delle persone…”. “La ragione che ha addotto l’azienda per riduzione la personale è quella della riduzione costi, ... noi oggi abbiamo una riduzione del 70% produzione, cioè lavoriamo al 30%”. Questa, però è una situazione comune al moltissime aziende: la crisi ha determinato la contrazione di molto mercati con la conseguente riduzione di ordini e quindi di produzione. “Infatti, la casa madre Thyssen Krupp, nelle nazioni dove è presente, ha dato l’input di usare tutti ammortizzatori sociali presenti nelle varie nazioni, noi con la Germania e Francia abbiamo gli ammortizzatori più alti, quindi bisogna utilizzare questi…” La posizione di utilizzo degli ammortizzatori sociali per evitare il ricorso ai licenziamenti durante i mesi della crisi, risponde ad un preciso orientamento espresso dal CAE: “C’è proprio un accordo a livello di CAE… quello di usare tutti gli istituti contrattuali previsti; cioè per evitare i licenziamenti vanno utilizzati tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle normative nazionali…”. 216 Un esempio dell’applicazione di questo accordo definito in sede di CAE esiste anche per l’Italia: “A Copparo la Berco (Gruppo TK, come visto – n.d.r.) ha evitato i licenziamenti ricorrendo alla Cassa Integrazione..”, “…a Copparo s’erano addirittura 800 esuberi, ma hanno firmato un accordo che prevede due anni Cassa Integrazione e quindi non hanno licenziato nessuno, …la stessa cosa hanno fatto a Terni, alle Officine (anch’esse facenti parte del Gruppo TK – n.d.r.): anche lì hanno usato solo mobilità volontarie e incentivate con alte buone-uscite; tutto questo è stato definito con un accordo sindacale…non in maniera unilaterale da parte dell’azienda come invece vogliono fare qui a tutti i costi…”. L’atteggiamento mantenuto a Visano, invece, è completamente diverso: “Qui invece per ridurre i costi “segano” 48 persone senza criteri, senza accordi,…” In questo territorio esiste un problema notevole: “..a livello istituzionale non ci aiutano, anzi il sindaco e il parroco ci sono contro….qui è tutto sotto l’ombrello dell’ex senatore Maninetti (che è anche il consulente azienda) ed amico del sindaco… il Sindaco addirittura ha convocato i lavoratori… dicendo di stare tranquilli, .. che rientreranno al lavoro… di stare attenti con questo presidio…” Sindaco e parroco vengono individuati come le due figure di riferimento del paese, da loro ci si aspetterebbe molto e invece la loro assenza, se non la loro malcelata ostilità alla lotta dei lavoratori, provoca reazioni molto decise tra i lavoratori: “…Ma vi sembra?! …. un sindaco e un parroco che non fanno il bene del paese…non si sono mai viste cose così!” I lavoratori temono anche operazioni di smantellamento di reparti aziendali: “Sotto ci può essere anche una operazione economica.” Potrebbe profilarsi, infatti, una completa esternalizzazione di lavorazioni che prima venivano svolte in azienda: si tratterebbe del reparto montaggio e spedizioni. “Un ex dipendente dell’azienda è uscito.. e ha messo su un capannone qui vicino… e ci risulta che ci sia un contratto firmato per esternalizzare tutto. Addirittura pare che il neo – imprenditore si sia già portato avanti: “ad alcuni di noi, tra quelli che l’azienda vuole licenziare viene proposta l’assunzione in questo capannone. Per questo abbiamo questo dubbio… che ci sia dietro questa operazione….”, Anche su questo aspetto torna il tema dell’informazione con il Gruppo Thyssen: “In Germania queste cose non le sanno… e noi cerchiamo di mandare loro più informazioni possibili.., anche per smentire quello che dicono i dirigenti… Ad esempio, quando il nostro Amministratore Delegato è andato in Germania ha detto che dalla mobilità non si può più tor217 nare indietro, ma noi lo abbiamo smentito mandando in Germania la legge sulla mobilità.” “Anche per questo noi puntiamo molto sul lavoro del CAE…”. L’atteggiamento dell’azienda è di scontro duro, senza esclusione di colpi. “Hanno fatto anche un ricatto: hanno detto non avendo accesso agli uffici non ci possono mandare lo stipendio…questo è falso…però la lettera con le turnazioni fino a fine anno sono riusciti a mandarcela…”. “Questo è solo un ricatto perché noi abbiamo dato la garanzia che il personale poteva entrare per fare le buste paga.” La durezza dell’atteggiamento si sposa appieno con la strategia dell’azienda di separare i lavoratori e di metterli in contrapposizione tra loro. Questo è l’aspetto centrale della vertenza Rothe Erde: il tentativo aziendale, parzialmente riuscito, di mettere in contrapposizione i lavoratori tra loro. In questa strategia hanno giocato un ruolo determinante alcune sigle sindacali compiacenti e ben disposte a mettersi a servizio dell’azienda per isolare attaccare la Fiom. “Hanno distribuito questo volantino in paese…è stato fatto dalla direzione dicendo che i lavoratori non aderiscono alla protesta…dice che i lavoratori dissentono dal picchetto….dicono che è stato fatto da lavoratori, ma in realtà è stato scritto dall’azienda e diffuso da loro in paese. Addirittura qui hanno scritto che l’azienda aiuta i colleghi in mobilità; ma questo è falso!!” Se la strategia di dividere i lavoratori della Rothe sembra sortire qualche, seppur parziale, risultato, c’è da registrare, invece, una forte solidarietà che è stata costruita con gli altri stabilimenti del Gruppo Thyssen Krupp. “... a Brescia si è tenuto il coordinamento nazionale Fiom della Thyssen Krupp Italia, ..questo coordinamento noi vogliamo aprirlo anche a tutti gli altri sindacati che vogliono aderire…”. “..è stata mandata una lettera alla FEM a Bruxelles per chiedere il rispetto degli accordi stabiliti nel CAE, la prossima settimana ci saranno assemblee in tutte le fabbriche Thyssen Krupp e due ore di sciopero, si farà anche colletta per sostenere questa lotta..”. Anche se l’azienda tenta di dividere i lavoratori, tra i partecipanti al picchetto viene sottolineata l’unità che si è creata tra gli operai in lotta: “Non era mai successa in questa azienda una unità così forte, prima era tutto in mano alla Uil, ma i lavoratori oggi sono uniti in un nucleo importante...” Nei giorni della vertenza la Uil sembra aver perso le posizioni di maggioranza che aveva in fabbrica, e anche la Cisl non sembra navigare in buonbe acque, anche alla luce del diverso atteggiamento che hanno negli altri 218 stabilimenti italiani del Gruppo TK: “Le assemblee e lo sciopero sono sostenuti anche da Cisl e Uil, solo qui la lotta non è sostenuta, ma nella altre fabbriche si…”. Perché solo qui? “Forse per dirigenza locale.” E si ritorna al tema dell’affondo aziendale sugli esuberi senza preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali: “Ma insomma, …possibile che solo qui, al primo momento di difficoltà anziché usare gli ammortizzatori sociali, come invece hanno fatto alla Berco…qui invece no! subito licenziamenti…ma qui fino al 2008 abbiamo fatto anche due turni di straordinari al sabato, si faceva la notte….” Cioè: quando la produzione tirava gli operai hanno dato la loro disponibilità a reggere l’aumento dei ritmi con turni di straordinari, disponibilità che non viene minimamente ripagata dall’azienda nel momento della difficoltà produttiva. Qualche segnale di difficoltà produttiva, tuttavia, i lavoratori lo avevano colto “ma loro niente… imperterriti hanno voluto andare avanti, per ricevere soldi dalla Germania hanno continuato su questo ritmo produttivo… Si è visto da luglio 2008 che qualcosa non andava, ma loro avanti, anzi, addirittura hanno assunto altre figure soprattutto impiegatizie…Da luglio fino alla fine del 2008 si vedeva che qualcosa non andava.. poi è scoppiata la bomba…” Anche le prima difficoltà produttive l’azienda pensa di risolverle a modo suo, con l’ennesima decisione unilaterale non concordata con il sindacato: “Prima di fare la Cassa integrazione, hanno deciso di usare 10 venerdì per obbligarci a metterci in ferie forzate… senza nessun accordo, è stata una scelta unilaterale dell’azienda.. da novembre a gennaio.” L’azienda non può dire che la Fiom abbia rifiutato ogni confronto: “Il piano presentato da noi sulla riduzione dei costi era chiaro: Mettiamo in mobilità volontaria solo i prepensionamenti; se ci sono altri esuberi si ricorre alla Cassa Integrazione Straordinaria che vuol dire mettere in sicurezza i posti di lavoro per due anni. Poi se il fatturato torna al 40% possiamo anche fare i contratti di solidarietà,…con una produzione dal 40% in poi la situazione si riesce a gestirla….” Anche il tema dell’isolamento e soprattutto dell’indifferenza con la quale le istituzioni hanno trattato la vicenda Rothe è un tema che torna spesso. “All’assemblea pubblica, venuti solo due sindaci (uno ha cercato di fare coordinamento un coordinamento tra sindaci della zona ma non c’è riuscito), …. sono rimasti molto freddi, non hanno preso posizione, tranne uno quello di Isorella che ha mandato una lettera in azienda dove chiedeva di applicare l’accordo definito in Confindustria che non prevede che in caso 219 di crisi si ricorra ai licenziamenti ma solo agli ammortizzatori sociali… lui è un imprenditorie, si è mosso quasi personalmente…” Nemmeno la Provincia si è mossa: “Noi non siamo nemmeno stati sentiti dalla Provincia, abbiamo chiesto un colloquio con Molgora (Il Presidente della Provincia n.d.r.), ma si vede che hanno altri problemi…Adesso hanno la testa sull’aeroporto…” Alle istituzioni, identificate dai lavoratori con “la politica” vien giustamente chiesto sostegno, ma senza nessuna delega alla soluzione dei problemi: “Se ci aiutano bene, … a livello politico se ci danno un aiuto bene, ma senza mettersi in prima fila,…che la politica ci aiuti ma non con un ruolo predominante, ma stando alle spalle del sindacato…senza mettersi in prima fila…non facendo un ruolo predominante dicendo “siamo noi che vi abbiamo salvato..” Alla domanda “cosa vi servirebbe da Rifondazione Comunista?” le risposte sono immediate e pressoché unanimi: “abbiamo bisogno di essere visibili il più possibile, con TV e giornali locali. Abbiamo anche telefonato a Rai 3…dateci una mano a essere visibili…”. Il ruolo di Rifondazione potrebbe anche essere quello di “pressare” i livelli istituzionali troppo disattenti alla vertenza in corso. Per questo motivo, il giorno dopo l’intervista partono due lettere, firmate dalla segreteria locale del Prc, indirizzate alla Provincia di Brescia e alla Regione Lombardia per indurre questi livelli istituzionali ad attivarsi e ad esercitare le competenze che gli sono proprie in materia di crisi aziendali e di sostegno all’occupazione. Ovviamente non arriva uno straccio di risposta, a conferma dell’autismo in cui versa la maggior parte dei livelli istituzionali completamente staccati dalla situazioni reali Per quanto concerne la solidarietà del territorio nei confronti degli oeprai in presidio, vengono segnalate le iniziative dello “Spi Cgil e della Coop… che ci hanno aiutati tantissimo, ci hanno dato un buono da 300 euro per fare le compere. Per comprare generi di prima necessità per il presidio, un po’ ci aufionanziamo, qualcuno ci lascia un po’ di vino, un salame…”. Una punta polemica viene manifestata nei confronti del segretario generale della Cisl di Brescia: “Strano che il segretario Cisl che abita due km dal presidio…. che sui giornali chiede sempre di non licenziare, di mettere in sicurezza i lavoratori…strano che non si sia mai fatto sentire, né vedere…”... Se al presidio è mancata la solidarietà del segretario della Cisl, non è venuta meno quella delle Rsu del Gruppo TK. “Sono venute qui le RSU di tutte le realtà della Thyssen Krupp Italia… ci 220 danno solidarietà perché hanno capito che questa situazione di licenziamenti può creare un precedente, anche loro attraversano una fase di difficoltà e temono che se passa questo precedente anche da loro l’azienda ricorra ai licenziamenti senza ammortizzatori sociali.” I lavoratori pensano che il’azienda intenda sperimentare la strada delle scelte unilaterali a Visano per poi allargarle anche alle altre aziende italiane del gruppo. Il 3 novembre si è riunito il coordinamento delle aziende del gruppo ThyssenKrupp che oltre ad esprimere solidarietà ai lavoratori della Rothe Erde ha proposto di lanciare una sottoscrizione volontaria di qualche ora di lavoro per il sostegno di questa lotta che riguarda non solo Brescia, ma tutti i lavoratori di Thyssen- Krupp. “Si sono riuniti a Brescia i delegati Fiom delle Rsu dei principali siti che fanno riferimento a ThyssenKrupp Italia, insieme alle strutture territoriali Fiom interessate e alla Fiom nazionale, per avviare il Coordinamento nazionale del Gruppo.” “Questo coordinamento è oggi necessario per intervenire sulla strategia di riorganizzazione del gruppo ThyssenKrupp a livello nazionale, europeo e mondiale. Tale strategia non può prevedere un restringimento della base produttiva; ciò vale, in particolare, in Italia, Paese che ha già pagato prezzi pesanti a partire dallo spostamento all’Estero della produzione di acciaio magnetico.” “Il rallentamento produttivo che, per effetto della crisi in atto, sta avvenendo nei diversi comparti, può essere gestito con i normali strumenti previsti dagli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione, contratti di solidarietà) senza attaccare l’occupazione e procedere a licenziamenti, ma salvaguardando invece le prospettive future con i necessari investimenti.” “Questa strada, contrattata con il sindacato, è quella che generalmente è stata seguita in tutti i siti ThyssenKrupp in Italia: a Terni, a Ferrara, a Castelfranco e altrove. Non così alla Rothe Erde di Visano (Brescia), dove l’Azienda, il 16 ottobre scorso, ha inviato le lettere di licenziamento a 45 lavoratori (40 operai e 5 impiegati) con effetto immediato.” La paura dei lavoratori è fondata, vista l’ostinazione dell’azienda a perseguire la strada del muro contro muro: “Temiamo quindi che l’Azienda voglia sperimentare un’altra strada, liberandosi unilateralmente di un gruppo di lavoratori; strada che, se passa a Brescia, potrebbe poi essere seguita anche per altri siti del Gruppo.” “Il Coordinamento Fiom di ThyssenKrupp Italia, nell’esprimere la propria solidarietà ai lavoratori della Rothe Erde che sono attualmente in sciopero e in assemblea permanente di fronte ai cancelli dello stabilimento, propone a tutte le Rsu del Gruppo, nell’ambito delle 4 ore di sciopero che la 221 Fiom ha proclamato contro il contratto separato del 15 ottobre, di convocare assemblee con tutti i lavoratori per discutere della situazione generale del Gruppo e dello strappo che l’Azienda ha prodotto a Brescia contro i lavoratori della Rothe Erde.” Nei giorni seguenti all’intervista si verificano momenti di tensione. Un primo momento di tensione avviene nella mattinata del 17 novembre quando al presidio si presentano alcuni impiegati e lavoratori, accompagnati dalle forze dell’ordine con il chiaro intento di forzare il presidio. Secondo il comunicato subito diffuso dalla Fiom, “La cosa grave era la presenza alla testa di questo corteo di lavoratori, di una quindicina di persone definite, non si sa bene a quale titolo, vigilantes e che avevano il chiaro obiettivo di intervenire fisicamente sui lavoratori che partecipavano al presidio. Grazie all’estrema serietà e alla ragionevolezza di tutti i lavoratori presenti al presidio, la Fiom e il rappresentante della questura hanno lavorato per trovare una mediazione che aprisse un tavolo di confronto con l’azienda. La mediazione trovata prevedeva la convocazione di un incontro nel tardo pomeriggio alla presenza della direzione aziendale, della questura e della Fiom, e l’impegno di tutte le parti ad evitare forzature fino allo svolgimento dell’ incontro.” Sembrava, quindi che l’accordo per il proseguo della trattativa fosse stato trovato ma “Nonostante gli impegni presi - prosegue il comunicato FIOM - , un gruppo è entrato da un cancelletto di una abitazione privata confinante con l’azienda, raggiungendo i reparti produttivi. Con questa azione pensiamo, che coloro che a parole si dichiarano solidali con i colleghi licenziati, e che da giorni tentano ripetutamente di forzare il presidio, hanno compiuto una azione estremamente vergognosa mettendo a repentaglio la possibilità di iniziare una trattativa sindacale.” I lavoratori in presidio “assediano” fino a notte i crumiri entrati che possono uscire solo a tarda ora scortati dalle forze dell’ordine. Ma i crumiri non demordono e qualche giorno dopo ritornano. Un importante giornale nazionale così descrive la vicenda: “Un cordone di poliziotti e carabinieri tiene a freno due ali di lavoratori in sciopero: nel mezzo passa un piccolo corteo di auto, perlopiù utilitarie e a quel punto dalla folla partono fischi, insulti, qualche testimone parla anche di sputi e colpi sulle fiancate. Ma dentro quelle vetture non ci sono dirigenti o business men, ci sono operai e impiegati identici a quelli che protestano. Alla Rothe Erde di Visano, fabbrica metalmeccanica del gruppo Thyssen, va in scena il conflitto sociale del nuovo millennio: lavoratori contro lavoratori, da una parte i «sommersi» che hanno già in tasca una lettera di licenziamento e dall’ altra i «salvati» da un processo di ristrutturazione che alla Rothe Erde prevede il taglio di 44 posti…” 222 Da che parte stia questo importantissimo quotidiano lo si capisce agevolmente dalle lettura delle prossime righe: “…..se fino a pochi giorni fa la base rimaneva alla finestra, scioperando in attesa di una soluzione concordata, ora circa 70 dipendenti hanno rotto gli indugi decidendo di presentarsi al lavoro. Dando luogo a uno scenario che pareva consegnato agli Anni 50, vale a dire lavoratori che entrano in fabbrica sotto la scorta della polizia, tra i fischi e gli insulti di altri lavoratori. Ieri mattina il corteo - circa 25 macchine - dei «disobbedienti» si è avviato verso l’ ingresso principale della Rothe Erde attorno a mezzogiorno, preceduto da 4 camionette della polizia. Davanti al cancello c’ era un presidio di 100-150 operai aderenti alla Fiom. Solo verso le 14 e non senza tensione, i 70 hanno potuto entrare in azienda. La loro permanenza è stata poco più che simbolica, prima delle 17 tutti sono tornati a casa, sempre inseguiti dalla rumorosa protesta dei loro colleghi.” Il quotidiano, così attento a descrivere la tipologia di auto e a notare le facce (non di business man) che su queste viaggiavano, non è stato altrettanto attento e acuto a porsi una domanda elementare: cosa sono entrati a fare questi “coraggiosi” se la loro presenza in azienda si è limitata a due o tre ore di presenza? Quale lavoro avranno avuto da svolgere se tutta la produzione risultava di fatto bloccata visto che la quasi totalità degli operai era in sciopero e presidiava i cancelli della fabbrica? Possibile che non ci si sia posti il problema che si trattava soltanto di un atto dimostrativo, finalizzato unicamente a dimostrare che l’atteggiamento della FIOM era caratterizzato da intransigenza e che così facendo divideva i lavoratori? Possibile che non ci si sia posto il problema che semmai era la direzione aziendale che giocava tutte le sue carte, comprese quella della connivenza di alcune sigle sindacali, pur di arrivare alla divisione tra lavoratori? E’evidente a tutti, ormai, che nel piccolo pese bresciano di Visano si gioca una partitta nazionale. Come ci hanno spiegato i lavoratori a Visano la Rothe, o forse la stessa Thyssen, stanno forzando in ogni modo per creare un precedente, per costruire un modello di intervento di riduzione del personale da esportare anche negli altri stabilimenti. La Fiom capisce l’antifona e così interviene con la propria segreteria nazionale: “La Segreteria nazionale della Fiom, in accordo con tutte le strutture interessate, ha deciso di proclamare per il 24 novembre 2 ore di sciopero in tutto il gruppo ThyssenKrupp Italia. Lo sciopero è stato deciso a sostegno della lotta dei lavoratori dello stabilimento ThyssenKrupp di Brescia, ove la multinazionale ha avviato la procedura di licenziamento per 55 lavoratori su 204. A Visano di Brescia i lavoratori sono in sciopero a oltranza dal 26 di ottobre e sono decisi a respingere questo attacco all’occupazione che oltre ad essere inaccettabile in sé può preannunciare un progressivo disimpegno della ThyssenKrupp dallo stabilimento. Il Coordinamento nazionale del Gruppo aveva già deciso una campagna di solidarietà a favore dello stabilimento bresciano che coinvolgesse tutti i 6mila dipendenti 223 italiani della ThyssenKrupp dislocati a Terni, Ferrara, Lombardia, Toscana e in altre regioni italiane. In questi giorni il conflitto si è aggravato e i lavoratori hanno dovuto respingere provocazioni da parte di piccoli gruppi di persone mobilitate dalla direzione aziendale. La lotta prosegue con l’assoluta adesione della stragrande maggioranza dei lavoratori e con la solidarietà della popolazione. Quanto è avvenuto, però, è indice del fatto che la Direzione del Gruppo non ha ancora accettato di aprire una reale trattativa che escluda i licenziamenti. Per queste ragioni la Segreteria nazionale della Fiom ha proclamato lo sciopero nazionale di tutto il Gruppo. La Fiom chiede alla ThyssenKrupp di rivedere le proprie decisioni anche perché gli stabilimenti italiani del Gruppo, da Torino a Terni, hanno già pagato prezzi altissimi e drammatici per le ristrutturazioni aziendali. Tutte le Istituzioni e il Governo debbono fare pressione sulla multinazionale tedesca perché ThyssenKrupp Italia abbandoni la linea dei licenziamenti e della chiusura degli stabilimenti. “ La Fiom nazionale, in questo modo, accoglie una delle preoccupazioni più forti da sempre espresse dai lavoratori del presidio della Rothe Erde: cioè che il Gruppo stesse “sperimentando” a Visano la strada delle scelte unilaterali, imposte al sindacato anche con più forzature, per poi allargarla anche ad altre aziende italiane del gruppo. Finalmente in dicembre, dopo una trattativa estenuante si arriva alla firma dell’accordo. L’accordo si compone di due parti. La prima è quella che riguarda il ricorso alla Cassa Integrazione. In premessa si da atto che l’azienda intende realizzare un “importante piano di investimento per circa 15,6 milioni di euro per una modernizzazione e una maggiore efficienza del processo produttivo che possa contribuire in maniera decisiva al consolidamento della posizione sul mercato dell’azienda”; a questi si aggiungono “ulteriori 5 milioni di euro con i quali è già stata acquistata l’area adiacente alla ferrovia di 4.500 mq dove è previsto l’allungamento dell’officina di 2.000 mq ed il relativo attrezzamento” A seguito di questi investimenti sarà attuata una riorganizzazione del lavoro: dalla produzione tradizionale di reparto si passerà a quella di linea, comprensiva delle attività di montaggio (quelle di cui si temeva la totale esternalizzazione). L’azienda giustifica la richiesta di ricorso alla Cassa integrazione “per effetto della pesante crisi di mercato” che ha fatto registrare “una costante riduzione dei volumi produttivi, che si è concretizzata, nel secondo semestre 2008 – 2009, rispetto al secondo semestre 2007 – 2008, in una riduzione del 75% della produzione e del fattu224 rato”. A questo l’azienda ha aggiunto la considerazione che “la riduzione delle commesse registrata negli ultimi mesi è tale da far ritenere che non vi sia, nel medio termine, la prospettiva di una ripresa dell’attività a livelli tali da garantire la piena utilizzazione degli impianti e della manodopera occupata”. Sulla base di queste premesse la società “presenterà istanza di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria della durata di complessivi 24 mesi per 195 addetti allo stabilimento di Visano BS)”. Si tratta, quindi, del ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per 195 dipendenti, con l’utilizzo della stessa secondo la modalità della rotazione: per questa “Durante il periodo di Cigs, la Società e le Rsu si incontreranno per verificare la rotazione del personale coinvolto mensilmente”. Sui 44 esuberi indicati dall’azienda si concentra la seconda parte dell’accordo. Rispetto a questi l’azienda aveva avviato, a tutti gli effetti, la procedura di mobilità con la trasmissione della lettera del 16 ottobre. Per 11 di questi, tuttavia, era stato firmato un accordo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia; così il numero si era ridotto a 33; per questi ultimi risultavano ancora pendenti le impugnazioni dei relativi licenziamenti. Nell’accordo si da atto che grazie all’intervento del Prefetto “la Società si è dichiarata disponibile a differire l’effetto dei citati 33 licenziamenti per i 24 mesi durante i quali la Società farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”. Per questi lavoratori, messi in cassa a zero ore e senza rotazione dal 14 dicembre 2009, tuttavia, si aprono interessanti opportunità che rappresentano il risultato più significativo strappato dai lavoratori e dalla Fiom. Il differimento al 13 dicembre 2011 degli effetti della risoluzione del loro rapporto di lavoro, infatti, viene giustificato così: “…gli auspicabili effetti del piano industriale e dell’evoluzione del mercato sono compatibili, in prospettiva, con il reinserimento dei lavoratori…”. Si apre quindi, una prospettiva di un loro reinserimento nell’azienda a seguito dei risultati conseguibili con l’applicazione del piano di investimenti previsto dall’azienda. Ma c’è di più. A questi lavoratori in CIGS, durante il periodo della stessa ed il successivo periodo di mobilità, “…verrà riconosciuto il diritto di precedenza, nel caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni…” Inoltre, viene stabilito che “Al termine del periodo di Cigs e di mobilità, (…) i lavoratori se privi di altra occupazione, saranno riassunti a tempo indeterminato dalla Rothe Erde Metallurgica Rossi di Visano (BS), senza patto di prova e con mantenimento delle condizioni economiche e norma225 tive pregresse…” Un accordo, quindi, che non solo tutela il maggior numero di posti di lavoro, ma che non lascia abbandonati a sé stessi i cassaintegrati prevedendo forti norme a loro tutela per un loro possibile reinserimento in azienda evitando che al termine del periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali si trovino senza lavoro. 226 Inchiesta realizzata alla Ideal Standard di Brescia20 I problemi per i lavoratori degli stabilimenti italiani di Ideal Standard cominciano a prendere forma nel dicembre 2007, in occasione di una riunione tra la Direzione Aziendale del Gruppo e i Sindacati per la firma dell’accordo quadro sulla riorganizzazione di una parte delle attività di Logistica (consegna prodotti) e sulla gestione delle conseguenze occupazionali. Nel corso dell’incontro la Direzione Aziendale ha illustrato i programmi produttivi previsti per il 2008, in cui si evidenziano livelli di produzione con quantità inferiori rispetto ai budget 2007; ciò introduce interrogativi sulle quote di mercato presidiate da Ideal Standard, in una fase in cui, anche sulla base dei nuovi assetti proprietari della Gruppo, sarebbero necessari programmi e iniziative più convincenti, volte a sviluppare la presenza sui mercati con prodotti di qualità e di efficienza organizzativa. La Delegazione Sindacale ha evidenziato le proprie perplessità, richiedendo al management una iniziativa in grado di dare respiro industriale e commerciale nel nostro Paese, con il mantenimento in essere di tutti i siti produttivi e con i loro specifici ruoli. Stesse preoccupazioni vengono manifestate 6 mesi dopo – giugno 2008 – quando da parte sindacale viene ribadita “l’urgenza e la necessità di andare oltre il 2008, di vedere un piano industriale vero, che consenta di capire qual è il futuro del Gruppo in Italia, quali le strategie, quali le iniziative con l’obiettivo di consolidare i siti italiani. Per queste ragioni la richiesta ribadita con forza dalla delegazione sindacale è quella di svolgere nel più breve tempo possibile un primo incontro con il nuovo Amministratore Delegato indicato da Bain Capital la cui operatività è prevista per il prossimo mese di luglio.” Le cose cominciano a mettersi male nel corso del 2009 quando “Il coordinamento sindacale di Ideal Standard (...) manifesta forte preoccupazione per la situazione che si sta determinando negli stabilimenti italiani, dove i lavoratori sono interessati da continui e pesanti ricorsi alla cassa integrazione, e al persistere di una assenza della proprietà, nella definizione di un piano industriale capace di rispondere all’aspetto contingente e orientato al consolidamento di prospettiva. Un superamento che dovrà avvenire sulla base di un forte e rinnovato impegno industriale del gruppo nel nostro paese, basato su scelte e programmi produttivi, di investimento, di innovazione e mirati processi di riorganizzazione.” La richiesta, rivolta a Bain Capital, è quella “di consolidare, in termini di pro20 In collaborazione con la Federazione Prc di Brescia e Gaetano Dato, Prc Trieste. 227 spettiva, la presenza produttiva e le quote di mercato oggi presenti e realizzate nei quattro stabilimenti italiani, attraverso una strategia che affronti la contingenza e qualora ve ne siano, gli ostacoli più strutturali. Va inoltre intrapresa una riflessione critica sulle scelte fin qui prese ed attuate dal Gruppo, che a nostro parere non hanno aiutato nell’attuale situazione congiunturale, ma viceversa rischiano ancor più di aggravare ed appesantirne gli effetti già a forte impatto industriale e sociale. Dentro questo scenario si colloca anche la necessità di una urgente illustrazione della nuova politica commerciale del gruppo.” Si manifestano da subito forti problemi di relazioni sindacali, anche si semplice comunicazione e informazione tanto da sollecitare che “la proprietà si presenti al tavolo ed al confronto con le Organizzazioni Sindacali, affinché si possano analizzare e individuare percorsi e strumenti che aiutino e accompagnino quanto converremo, compresa l’eventualità di un incontro al MISE, dove tra l’altro è già aperto un tavolo sul settore della ceramica.” Il tanto richiesto incontro si tiene il 27 marzo: questo incontro conferma la fondatezza delle preoccupazioni sindacali che confermano la critica ad alcune scelte aziendali, alla sottovalutazione dei problemi, al ritardo nel dotarsi di un serio piano industriale discusso con le Organizzazioni sindacali. L’azienda replica alle preoccupazioni sindacali ribadendo la propria volontà di reagire indirizzata alla predisposizione di un piano industriale, che risulterebbe già in fase di avanzata preparazione, adeguato alla congiuntura e soprattutto finalizzato ad intervenire sulle criticità strutturali dell’impresa, con l’obiettivo di consolidare e rilanciare la presenza di Ideal Standard nel nostro Paese. Da segnalare una nota della Segreteria Nazionale della Filcem – sempre del marzo 2009 – con la quale si intendono rassicurare i lavoratori del Gruppo Ideal Standard: “Poiché ci giungono - e sono mesi ormai - segnalazioni dai territori interessati al Gruppo Ideal Standard di voci e anticipazioni, spesso anche molto contraddittorie fra loro, circa il futuro degli stabilimenti italiani, cogliamo l’occasione per un commento di carattere generale. Ad oggi, che a noi risulti, in nessuna sede di confronto sindacale nazionale o territoriale, informale o ufficiale si è discusso di esuberi o di stabilimenti da ridimensionare o chiudere: se così non fosse sarebbe davvero inspiegabile e ingiustificabile che le organizzazioni sindacali a qualsiasi livello non avessero già proclamato iniziative di contrasto e di lotta. Le preoccupazioni sono comprensibili e legittime - innanzitutto fra i lavoratori - ma riteniamo sbagliato e controproducente assecondare, alimentare e fare da cassa di risonanza a voci incontrollate, magari messe lì ad arte o assegnate a qualcuno per essere veicolate in questo o in quello stabili228 mento.” Purtroppo, nel giro di due – tre mesi la situazione precipita concretizzando proprio quanto temuto dai lavoratori in termini di esuberi e chiusure di stabilimenti. All’inizio di luglio Ideal Standard comunica di voler ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per crisi, a decorrere dal 1 settembre 2009 e per 12 mesi. La procedura, avviata attraverso l’associazione di settore “Confindustria Ceramica”, interessa tutti gli stabilimenti italiani e la sede milanese del Gruppo. I numeri sono pesantissimi: i lavoratori complessivamente coinvolti sono 1740 dei quali 116 a Brescia, 30 a Gozzano (No), 474 a Orcenico (Pn), 624 a Trichiana (Bl), 302 a Roccasecca (Fr) e 3 nella sede centrale (Milano) del Gruppo. Sono coinvolti anche i 69 lavoratori della società commerciale, distribuiti tra le sedi di Milano, Orcenico e Trichiana, e i 122 addetti della “Ideal Standard Holding”, la società che fornisce i servizi indiretti di tipo amministrativo alle altre società del Gruppo. Inoltre, è intenzione della società arrivare alla chiusura degli stabilimenti di Brescia e Gozzano per cessazione di attività al termine della cassa integrazione straordinaria. Le motivazioni addotte dall’azienda per il ricorso alla cassa integrazione sono da ricondurre a una forte contrazione del fatturato (- 30% nel primo semestre 2009 sul periodo equivalente del 2008) e ad un aumento degli “insoluti” pari al 30% nello stesso periodo. La reazione dei Sindacati e dei lavoratori è immediata: viene proclamato per lunedì 13 luglio sciopero nazionale di otto ore in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo “Ideal Standard” e viene ottenuto per il 15 luglio, un incontro urgente a Roma al ministero dello Sviluppo Economico. La posizione sindacale è quella di respingere “senza mezzi termini sia la ventilata chiusura di alcuni stabilimenti che la decisione unilaterale sulla cassa integrazione straordinaria, considerata una vera e propria “anticamera del licenziamento”.” Un documento delle Rsu dello stabilimento di Brescia segnala la scorrettezza del comportamento dell’Amministratore Delegato che, scavalcando Sindacati ed Rsu decide di scrivere direttamente ai lavoratori per spiegare le ragioni della crisi e delle decisioni aziendali. Il documento si intitola “Il Lupo perde il pelo ma non il vizio” e sottolinea cosa si intenda per vizio, cioè “Quello di scaricare le proprie responsabilità e le proprie incapacità gestionali e di ordine industriale sui lavoratori.” “Questa piccola breve sintesi per rispondere a quella “insopportabile” lettera inviata nei giorni scorsi, con cura e dovizia di particolari, a tutti lavora229 tori dall’A.D. di Ideal Standard. Lettera che la dice lunga su come si pensa di nascondere da una parte, le proprie responsabilità e incapacità e dall’altra, di come si vuole superare la crisi. E’ il tempo delle domande? e allora ne facciamo anche noi 1 - come si pensava di rimanere sul mercato quando da anni non si fanno investimenti? 2 - come si pensava di rafforzare il proprio asset commerciale soltanto cambiando ed in brevissimo tempo numerosi responsabili commerciali? 3 - come si risponde all’assurda scelta di esternalizzare la logistica, certamente una delle cause dell’aggravamento della crisi del gruppo? 4 - come si pensa di traghettare il gruppo al dopo crisi? 5 - perché non si vuol parlare delle scelte sbagliate fatte dai diversi gruppi dirigenti che si sono susseguiti e dopo, solo dopo, del piano industriale? 6 - perché si continua a far pagare ai lavoratori le incapacità di altri? 7 - perché vi nascondete dietro “a un senso di responsabilità” e di pietismo addirittura ponendovi il pensiero di come faranno le famiglie a vivere? 8 - perché non si parla del superamento della crisi e di come, quanti e in che modo si posizionerà il futuro dei singoli stabilimenti e dell’intero gruppo? (…) Abbiamo letto con attenzione il Vostro comunicato stampa del sette luglio: la sospensione per 2 settimane della Cig Ordinaria concordata con i sindacati è un palese tentativo di confondere i Lavoratori. Non riuscirete a dividerci. Volete dare “un segno distensivo”... un vero segno distensivo? Allora rinunciate alla chiusura degli stabilimenti”. Il 15 luglio, in occasione dell’incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’azienda finalmente, in una sede ufficiale di confronto con istituzioni e sindacati, illustra il proprio Piano Industriale tutto giocato su tagli occupazionali e chiusure di stabilimenti. Si tratta di un elemento ricorrente in quasi tutte le situazioni: con il termine Piano Industriale vengono in realtà presentate operazioni occupazionali molto pesanti: si tratta, cioè, di meri interventi di riorganizzazione che hanno al centro la riduzione dei costi della componente lavoro senza uno straccio di investimenti industriali. Dal verbale redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico: “I Rappresentanti dell’Azienda (…) hanno illustrato approfonditamente i contenuti del Piano industriale, che ha l’obiettivo di creare, per il triennio 2009 – 2012, i presupposti per il rilancio dell’Azienda nel settore.(…). La strategia di rilancio prevede quindi uno sforzo finalizzato al rilancio dei prodotti, per recuperare una quota significativa di mercato. Nell’ambito commerciale lo sforzo dovrà essere finalizzato al recupero dei contatti commerciali persi con i principali influenza tori (architetti-idraulici –pro230 gettisti) ed in quello della distribuzione l’obiettivo è di rafforzare la cantieristica e la presenza nelle show-rooms, di recuperare visibilità sul mercato (a tal fine sono stati previsti nel piano commerciale 2009 – 2012, investimenti per circa 25 ml di euro). Il piano strategico a livello industriale prevede una serie di azioni per riequilibrare i costi in costante aumento con il decremento dei volumi di vendita. Il piano prevede la riorganizzazione delle attività aziendali in Italia, la chiusura dei siti di produzione di Brescia e Gozzano e la riduzione degli organici negli stabilimenti di Trichiana, Roccasecca, Orcenico e negli uffici di Milano. La strategia industriale per il riallineamento della capacità produttiva ed il recupero della competitività che dall’azienda è definito come il migliore possibile si basa su 4 leve: 1. specializzazione sulle linee produttive più efficienti; 2. recupero di produttività; 3. razionalizzazione dei prodotti; 4. recupero della competitività. Il piano industriale include un programma di investimenti 2009 -2012 che favorisce l’aumento e la maggiore sostenibilità della produttività. Per sostenere il Piano industriale sono stati previsti investimenti di 25 ml di euro. L’obiettivo illustrato dall’azienda è quindi quello di portare il Conto Economico in attivo attraverso investimenti complessivi (industriali e commerciali) di circa 50 ML di Euro. La riorganizzazione delle attività aziendali in Italia comporta la riduzione del numero totale della forza lavoro di 650 unità.” Da parte sindacale viene duramente stigmatizzata l’apertura unilaterale della procedura di Cassa integrazione straordinaria per crisi, vengono contestati molti degli argomenti sostenuti dalla Società con la richiesta esplicita della presentazione di un Piano diverso – un “Piano B”- capace di coniugare le esigenze di competitività In sintesi queste le richieste avanzate dalle OO.SS: 1. Aumento dei volumi di produzione italiana previsti dal Piano e mantenimento delle linee di produzione tradizionale a Trichiana e Orcenico. 2. Rientro completo della Logistica, con modi e tempi certi, presso lo stabilimento di Brescia. 3. Definizione degli investimenti per qualità, quantità e tempi secondo un programma trasparente e verificabile; ricorso anche a risorse pubbliche aggiuntive rispetto ai 50 milioni di euro annunciati (ricerca, innovazione,risparmio energetico ecc.). 4. Riduzione significativa delle eccedenze di personale previste dal Piano. 5. Ricorso ad ammortizzatori sociali nessuno escluso ( Cig ordinaria, Cig straordinaria, Contratti di Solidarietà, Formazione, Incentivazioni all’esodo ecc.) per una gestione sostenibile dal punto di vista sociale. Le posizioni, quindi, sono molto diverse e l’unico risultato che viene strap231 pato è quello di una intesa, ratificata al ministero dello Sviluppo Economico una prima intesa - convenuta il 29 luglio o – tra i sindacati, la società e Confindustria Ceramica che rinvia i termini della cassa integrazione straordinaria al prossimo 30 settembre. Questo significa guadagnare tempo, interrompere la procedura avviata in maniera unilaterale da parte dell’azienda e ottenere una discussione nel merito su prospettive industriali e occupazionali. Ma l’azienda tenta in tutti i modi di forzare la mano e così tenta l’affondo definitivo sullo stabilimento di Brescia attraverso lo spegnimento del forno. Questo intervento di spegnimento, se fosse andato a buon fine, avrebbe definitivamente segnato il destino dello stabilimento bresciano condanna dolo alla dismissione senza possibilità di appello. I lavoratori, questo rischio lo conoscono benissimo e passano dal presidio alla occupazione dello stabilimento. La Filcem sostiene immediatamente e senza riserve l’occupazione dei lavoratori: “Pieno sostegno alla decisione unitaria del sindacato e dei lavoratori di occupare lo stabilimento di “Ideal Standard” di Brescia a seguito della decisione aziendale di procedere allo spegnimento del forno”. “Come sindacati nazionali e territoriali abbiamo partecipato con convinzione e senso di responsabilità ad una trattativa che oggi si rivela – per esclusiva responsabilità dei vertici di “Ideal Standard” - del tutto inconcludente e inutile, piena solo di tatticismi, indifferente alle conseguenze sociali ed occupazionali, irrispettosa anche degli stessi interlocutori istituzionali, a cominciare dal ministero dello Sviluppo Economico”. “Infatti, dopo tre mesi di trattative (…) i vertici di “Ideal Standard” hanno azzerato le lancette dell’orologio, riportandolo ai primi giorni di luglio – evidentemente troppo ossequiosi nei confronti dell’azionista “Bain Capital” - al momento dell’annuncio dei 650 esuberi, della cassa integrazione straordinaria per 1740 lavoratori e della chiusura degli stabilimenti di Brescia e Gozzano, a Novara.” La situazione, quindi, si rivela particolarmente difficile proprio per l’atteggiamento del fondo di investimento Bain Capital deciso ad andare fino in fondo nella vertenza tanto da suscitare una reazione particolarmente dura da parte di un dirigente sindacale non certo accusabile di “massimalismo” come Alberto Morselli, segretario generale Filcem-Cgil: “Un piano industriale che non cambia una virgola, è un piano da rispedire al Mittente. A quel mittente, “Bain Capital” (il fondo americano proprietario del gruppo, n.d.r.) che persegue solo obiettivi finanziari e speculativi, a scapito della dimensione industriale, del lavoro e della occupazione”. 232 E’ in questo quadro – a inizio novembre 2009 - che si svolge l’intervista ai cancelli dello stabilimento Ideal Standard di Brescia presidiato da cinque mesi. “All’origine della nostra crisi, che per noi comincia il 2 luglio, c’è causa la solita che si ripete in Italia: noi eravamo American Standard e poi siamo stati acquistati da questa Bain Capital, che è una multinazionale americana… hanno acquistato 52 stabilimenti nel mondo e nei due anni e mezzo di loro proprietà hanno cominciato a vendere rami d’azienda. Il Primo passo è stato quello di vendere stabilimenti in America Latina, poi alcuni stabilimenti in Europa e infine l’ultimo atto la parte asiatica….la parte asiatica è uno dei bacini di produzione pezzi più ambito…il fatto che Bain Capital abbia venduto anche questa parte significa che non vuole più produrre in Italia…. Quindi il 2 luglio in maniera unilaterale ci hanno consegnato la carta e in maniera unilaterale hanno deciso di chiudere gli stabilimenti di Brescia e Gozzano”. L’atteggiamento che solitamente assumono le multinazionali in caso di vertenze occupazionali non fa eccezione nemmeno nel caso di Brescia: “Da subito da parte loro sono state fatte azioni unilaterali: all’inizio non volevano nemmeno venire al tavolo di trattativa, poi con l’aiuto della protesta dell’occupazione e del presidio siamo riusciti a portarli portati al tavolo ed è partita la discussione, ..ormai da 5 mesi .. e procede sempre più lentamente”. Questo conferma quanto ricostruito con la documentazione sindacale e i verbali del Ministero: cioè un continuo azzeramento dei risultati raggiunti anche con faticose mediazioni per far saltare continuamente la trattativa e riportare il tutto alle pretese aziendali in termini di licenziamenti e chiusure di siti produttivi. La discussione, nel merito delle scelte, conferma la contrapposizione tra azienda e sindacati: “Ci sono grosse difficoltà….Loro ribadiscono continuamente che il loro Piano Industriale vuole chiudere Brescia anche se Brescia è uno degli stabilimenti più produttivi e competitivi che c’è in Europa.” L’insistenza sulla chiusura dello stabilimento bresciano non è casuale vista l’appetibilità dell’area su cui sorge. Ci viene fatto notare che a fianco dell’Ideal Standard ha appena chiuso un’altra azienda (…..) e che se venisse dismesso anche questo stabilimento si libererebbe un’area di grandi dimensioni e soprattutto molto appetibile sul piano urbanistico essendo localizzata praticamente in città. Fare piazza pulita dello stabilimento per la nuova proprietà di Ideal Standard compor233 terebbe immediatamente due enormi vantaggi economici: dismettere uno stabilimento produttivo con conseguente azzeramento di costi; valorizzare un’area che sul mercato immobiliare si rivela molto ambita e quindi in grado di fruttare grandi guadagni senza muovere un dito… Anche in questo senso viene discussa la proposta di legge di Rifondazione Comunista di vincolare, nei Piani Regolatori dei Comuni, le aree occupate da stabilimenti ad uso esclusivamente produttivo per evitare operazioni di speculazione urbana. Questa preoccupazione sembra essere stata colta dal Comune di Brescia che, anche senza sapere con quale livello di convinzione e coerenza sembra intenzionato a vincolare l’area: “Da parte comunale l’intenzione del sindaco e della Giunta è quella di mantenere il sito produttivo perché Brescia sta già pagando tanto in termini di disoccupazione e…. da li sono partite dalla giunta comunale delle ricerche sul mercato …oltre al tavolo ministeriale è partito anche un tavolo locale per trovare un acquirente. Adesso ci sono diverse ipotesi in campo… uno sembra essere un gruppo di imprenditori Civita Castellana (fanno ceramiche), le altre due legate alle proposte del viceministro Saglia…cioè la proposta discussa al tavolo del Ministero: si tratta dell’ accordo di programma con Provincia e Regione; l’altra proposta di ordine produttivo riguarda una cordata imprenditori latini.” Si tratta di quanto esposto da Saglia proprio all’incontro ministeriale del 15 luglio: “L’On. Formisano, che ha riassunto il Piano su due livelli di intervento (uno basato sulla riorganizzazione della produzione, l’altro sulla riduzione del personale) ha chiesto al MSE di intervenire anche attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma. A questo proposito, il Sottosegretario Saglia, pur evidenziando la disponibilità del MSE a mettere in campo tutti gli strumenti possibili, ha però dichiarato che questo potrebbe essere fatto solamente in presenza di un Piano con non abbia effetti così pesanti sull’occupazione.” Come visto in precedenza, questa società dispone di molti altri stabilimenti sul territorio nazionale e pertanto si pone la necessità di un coordinamento: “Il 9 novembre terremo un coordinamento nazionale con gli altri stabilimenti del gruppo…anche perché la loro proposta avanzata nel piano è quella che in funzione di un abbassamento del numero di esuberi, vogliono abbassare il salario di 350 euro a testa. Il sindacato rispetto a questa proposta dell’azienda ha fatto barriera, cioè il sindacato non accetta di abbassare salari che sono già bassi rispetto al costo della vita.” Ricorre un altro tema sovente presente nelle vertenze: l’utilizzo di forme di ricatto che, in questo caso, prevedono lo scambio tra occupazione e riduzione del salario. Ovviamente senza nessuna garanzia circa il mantenimento dei livelli occupazionali e, soprattutto, scatenando una rischiosa 234 corsa al ribasso sul terreni dei diritti salariali (e magari anche normativi) pur di evitare che la scure dei licenziamenti si abbatta sul lavoro. In questo caso la costituzione immediata di un coordinamento sindacale si rivela quanto mai necessaria in quanto una proposta aziendale di questo tipo avrebbe potuto dividere, se non addirittura contrapporre, gli stabilimenti tra loro tra possibilisti e contrari. Dal punto di vista della trattativa sindacati e lavoratori bresciani hanno definito le coordinate entro le quali muoversi nell’ambito della trattativa: “Noi siamo disponibili a firmare un accordo fondato su due cose. Primo: diciamo no alla riduzione dei salari in cambio di un calo del numero di esuberi (anche se questo ci sembra l’input che il Ministro ha dato alla società…). Secondo: siamo disponibili che nasca su Brescia una proposta di piano industriale vera e dignitosa per il ricollocamento di 130 dipendenti; compresi gli interinali..visto che anche loro vogliamo tutelare”. La posizione espressa sul tema degli interinali è di particolare rilievo visto che in quasi tutte le crisi i primi posti di lavoro a saltare sono proprio quelli dei lavoratori precari. I metodi di lotta utilizzati sono quelli classici che ricorrono in pressoché tutte le situazioni di vertenza: “da subito abbiamo fatto il presidio che dura da ormai da 5 mesi, …ma abbiamo fatto anche un periodo di occupazione un mese e mezzo fa per impedire che spegnessero il forno. » l’unica salvezza per poter riaprire lo stabilimento Spegnere forno significa chiudere definitivamente lo stabilimento e per questo abbiamo fatto ricorso anche all’occupazione dello stabilimento…” “Ovviamente siamo pronti a rifare l’occupazione se il tavolo ministeriale non va nei canoni detti prima. (ricollocazione seguita da piano industriale)”. Il coordinamento tra lavoratori dei vari stabilimenti italiani si è resa necessaria perché “La situazione dei 3 stabilimenti è pesante: sono previsti complessivamente 650 tagli occupazionali distribuiti sui tre stabilimenti di Orcenico, Roccasecca e Trichiana. Questo significa una riduzione di circa 200 persone per ogni stabilimento, quindi una riduzione forte per ogni stabilimento. Anche in questo caso vogliono ancora ridurre i salari per evitare 70 esuberi. Loro ci dicono che sono disponibili ad abbassare 70 esuberi, però restituite la parte del salario flessibile”. Quindi, sia dal punto di vista dei tagli occupazionali che dal punto di vista dello scambio inaccettabile tra salario e lavoro, si è da subito costruita una forte collaborazione ed un forte coordinamento tra i siti produttivi del Gruppo. 235 Alla domanda su quale utilità potrebbe assumere Rifondazione Comunista la risposta va direttamente ai progetti di legge presentati: “Rifondazione dovrebbe portare avanti i punti salienti che avete illustrato prima : il blocco dei licenziamenti il blocco delle delocalizzazioni…sarebbe un sogno se si riuscisse a ottenerli…. Non c’è altro ..siamo tutti d’accordo come lavoratori su queste vostre proposte, però dovete portarli avanti davvero e magari con degli sbocchi positivi…” Sul tema delle delocalizzazioni industriali torna con fermezza anche il segretario FILCEM di Brescia: “Il problema più forte che stiamo affrontando è quello delle delocalizzazioni: c’è questa grande difficoltà…. nonostante siamo in Europa, il sindacato su questo problema è completamente assente e in Italia la politica è completamente assente. Le multi fanno e disfano tutto quello che credono, fanno come vogliono e nessuno può impedire queste cose…” “Per questo va fatta una riflessione sul piano legislativo ma anche sociale. Ad esempio, mi viene da ridere quando discutiamo, in alcune fabbriche della questione dei lavoratori extracomunitari che vanno e che vengono…..ci fanno discutere di questo problema ma quando se ne vanno le fabbriche nessuno dice niente! Lega compresa! Questa è zona della Lega e quando i lavoratori si rendono conto di chi hanno votato si rendono conto di quanto è stata strumentalizzata la loro posizione…. Su questo occorre fare chiarezza e fare iniziativa, cioè tentare in tutti i modi di impedire che le multinazionali abbiano mano libera, noi chiediamo che l’Ideal Standard non se ne può andare da Brescia, deve rimanere e fare investimenti.” Il ragionamento si allarga anche sulle politiche industriali, visto che i governi di destra si limitano solo all’aspetto riferito agli ammortizzatori sociali: “Non possiamo continuare a registrare la chiusura di aziende: fra 2 anni finiranno gli ammortizzatori sociali e a quel punto cosa proponiamo? Cioè, come si riparte? sarà sufficiente la green economy o no,servirà qualcos’altro? Il capitalismo dimostra che non c’è la volontà di ripartire in modo diverso, ma ripartendo alla stessa maniera torneremo ad avere gli stessi problemi con stessi errori del passato.” Nel bresciano sono molte le situazioni di crisi industriale e occupazionale che hanno originato tantissime vertenze nel territorio. Anche nel bresciano, però, si ripete il solito modello di lotte, anche durature e decise, ma isolate le une dalle altre. In ogni stabilimento si lotta duramente, ma l’iniziativa rimane confinata alla sola situazione aziendale senza una messa in rete delle tante vertenze che ci sono. Quindi, come legare, come mettere insieme le varie situazioni di crisi di lotta? “La Camera del lavoro di Brescia ci sta provando…ma la discussione è 236 complicata perché hai Cisl e Uil che fanno accordi separati… tentano continuamente di essere complici dei padroni… e quando Confindustria chiede la loro firma su un accordo separato la fanno subito…solo quando discutono anche dei loro licenziamenti sono unitari. C’è questa dicotomia che non aiuta…” Il ragionamento critico sul ruolo del Sindacato non lascia indenne nemmeno la Cgil: “Bisogna anche capire cosa vuol fare la Cgil nel suo congresso : se vuol essere carne o pesce, quale prospettiva costruisce per i lavoratori, chi li giuda e tenta di rappresentarli. La cosa vera e è come rappresentare i bisogni di questi lavoratori… o la Cgil ci prova o rischia di fare la fine di quelli che si siedono negli enti bilaterali, o di fare la fine di chi denuncia 730 da 360.000 euro all’anno come un dirigente Cisl: che rapporto di rappresentanza hai con i lavoratori quando sei messo così? nulla…” A molti lavoratori interessa il discorso della unificazione delle lotte di un determinato territorio, è un tema che suscita discussione e attenzione. “E’ stata avanzata in Camera del Lavoro l’idea di uno sciopero generale della zona per unificare le lotte dei lavoratori. Adesso è solo una ipotesi, però farlo sarebbe l’ideale…però per fare questo bisogna coinvolgere anche le fabbriche che lavorano e che adesso non hanno problemi… Una mobilitazione di questo tipo sarà un passo obbligato, non si può andare avanti in questa condizione.” Nel momento dell’intervista dentro lo stabilimento bresciano di Ideal Standard “lavorano due persone per turno per salvaguardia degli impianti: l’azienda ha cercato di ottenere lo spegnimento del forno che lavora da 60 anni, spegnerlo significa chiudere l’azienda, buttare via 60 anni di storia e di produzione…” Torna, quindi, anche la riflessione sul tema dell’occupazione e dell’autogestione degli impianti: “era un occupazione con autogestione: c’erano due figure per salvaguardare gli impianti e far si che il forno lavorasse normalmente… per la tutela dei lavoratori. Cioè non c’è produzione….il Forno gira a vuoto, la produzione è ferma.. ma il funzionamento del forno è quello che ci serve per mantenerlo in vita...” Anche tra i lavoratori che non hanno responsabilità sindacali gli obiettivi sono pienamente condivisi: “ i nostri obiettivi sono quelli di salvaguardare il posto lavoro per tutti, per un futuro per tutti noi e le nostre famiglie… questi signori non possono chiudere uno stabilimento che va bene e lascarci tutti a piedi.. Anche se sarà difficile qui a Brescia riprendere l’attività produttiva, forse 237 può esserci una soluzione logistica in alternativa alla attività produttiva. Si può discutere di fare qui a Brescia la piattaforma logistica…” Ovviamente questa possibile riconversione produttiva potrebbe porre problemi di organizzazione del lavoro: “Qui il livello del lavoro è su turni che coprono 24 ore al giorno…tra festivi e notturni c’è anche un aumento di quello che è lo stipendio mensile rispetto ad un lavoro normale,. Andranno trattate queste cose per impedire un peggioramento retributivo..vediamo quanto si riuscirà a recuperare…” Come potrebbe esservi utile il Prc? “… quelli che ci vogliono dare una mano sono tutti utili, Rifondazione come gli altri, tutte le iniziative sono bene accette, più la mobilitazione è alta e più per noi è importante…” “Da voi che servirebbe una politica diversa a livello di governo rispetto alle multinazionali…non siamo l’unica multinazionale che fa questa cose ..guarda caso sono tutte multinazionali quelle che si comportano così… serve un intervento diverso a livello di governo per dare più garanzie ai lavoratori”. La prospettata chiusura dello stabilimento di Brescia suscita reazioni dure anche dal punto di vista della qualità del lavoro e delle professionalità che andrebbero disperse: “Noi abbiamo i costi per pezzo più bassi…qui sono state installate tecnologie avanzate a livello europeo… però lo chiudono… ma in nome di cosa?!, se c’è una speculazione che lo dicano chiaramente… Il discorso della deindustrializza per una città come Brescia non può essere accettato…” “Non si può lasciare che multinazionali arraffino tutto…se c’è una speculazione in atto quelli ci guadagno… e parecchi soldi… e noi invece restiamo a casa!” “A livello di governo qualcuno deve intervenire, non si può guardare senza far niente…” Anche da parte di questi lavoratori le proposte di legge di Rifondazione Comunista sono apprezzate: “Nel vostro volantino ci sono molte proposte interessanti… quelle lì vanno bene..” Anche questa società ha messo in competizione tra loro gli stabilimenti in una corsa alla produttività che ha spinto sempre più in alto ritmi di lavoro, produzione e profitti: “ci hanno sempre fatto essere competitivi con gli altri stabilimenti interni,…. ma desso anche gli altri stabilimenti del gruppo hanno 600 esuberi, non ci sono solo i 130 di Brescia, sono tutti colpiti.” In questo caso, quindi, è il comune destino di pressoché tutti i siti produttivi Ideal Standard ha determinare unità tra i lavoratori e la ricerca di forma di coordinamento e collaborazione sindacale. Martedì 17 novembre viene siglata al ministero dello Sviluppo Economico 238 l’ipotesi di accordo da sottoporre all’approvazione dei lavoratori. L’ipotesi di accordo prevede una sostanziale modifica del piano industriale 2010-2012 presentato a luglio, con un aumento dei volumi, la permanenza di alcune produzioni e il recupero di investimenti industriali di 15-20 milioni di euro e di 25 milioni di euro per la parte commerciale, che scongiurerebbe la “fuga” della multinazionale dal nostro paese e dovrebbe gettare le basi per una ripresa della produzione con maggiori indici di competitività. Sul fronte occupazionale, la iniziale dichiarazione di eccedenza di 650 lavoratori è stata ridotta a 410, “ma una ulteriore riduzione degli esuberi potrà essere raggiunta attraverso accordi locali mirati ad operazioni di efficientamento e risparmio di costi”. Per i lavoratori degli stabilimenti di Trichiana (Belluno), Orcenico (Pordenone), Roccasecca (Frosinone) e per quelli degli stabilimenti di Brescia e Gozzano (Novara) che saranno ricollocati, “Ideal Standard” rinuncia al ricorso alla cassa integrazione straordinaria (quella annunciata unilateralmente il 2 luglio scorso) e concorda con i sindacati di ricorrere all’istituto del contratto di solidarietà (oltre 1000 i dipendenti interessati) per due anni, a partire dal 1 gennaio 2010. Per i lavoratori di Brescia e Gozzano che non saranno interessati da ricollocazioni e per i lavoratori di Milano verrà invece applicata la CIGS per cessazione e per crisi. Quanto ai lavoratori di Brescia, “Ideal Standard” si impegna a realizzare d’intesa con le amministrazioni locali, e attraverso un tavolo istituzionale locale - un polo logistico del gruppo nel comune di Brescia con l’eventuale intervento di un partner leader proprio nella logistica. Il 25 novembre vengono sottoscritti gli accordi relativi alla cassa integrazione straordinaria per crisi e cessazioni di attività, e all’attivazione di contratti di solidarietà, a supporto dell’intesa del 17 novembre scorso raggiunta al ministero dello Sviluppo Economico. Gli accordi al ministero del Welfare prevedono: 1) l’attivazione dei contratti di solidarietà per due anni negli stabilimenti di Orcenico (Pordenone), Trichiana (Belluno), Roccasecca (Frosinone) per circa 1.380 dipendenti, a partire dal 1 gennaio 2010; 2) la cassa integrazione straordinaria (per 1 anno, dal 1 gennaio 2010) per 116 lavoratori di Brescia, 28 di Gozzano (Novara), 8 per “Ideal Standard Holding” e 8 per “Ideal Standard Italia”, al lordo di eventuali trasferimenti e ricollocazioni. Infine, per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria è stata firmata una intesa tra le parti per l’integrazione al reddito. L’esito delle votazioni al termine delle assemblee è stato favorevole alla firma conclusiva dell’Accordo. Restano tuttavia dei punti non risolti che il 239 comunicato sindacale della Filcem così registra, riconoscendo “… la comprensibile amarezza dei lavoratori di Gozzano per la chiusura della rubinetteria che non è stato possibile scongiurare e la preoccupazione dei lavoratori dello stabilimento di Brescia per la puntuale realizzazione della riconversione nel Polo logistico nazionale del Gruppo: a questo proposito cogliamo l’occasione per riconfermare anche per il futuro l’impegno della Segreteria Nazionale Filcem a fianco delle strutture sindacali territoriali e di fabbrica, a supporto del tavolo istituzionale creato sul territorio bresciano e finalizzato alla definizione del percorso e degli impegni di ogni soggetto in causa per la concreta realizzazione della piattaforma logistica in quel comune.” 240 Inchiesta realizzata alla Azimut-Benetti di Avigliana (To)21 L’Azimut-Benetti SpA viene fondata nel 1969 dal Dr. Paolo Vielli, imprenditore piemontese con una forte passione per il mare. Inizialmente importatore, decide poi di commercializzare barche su proprio progetto, ma prodotte da terzi; negli anni 1975/80 introduce -primo in Italia- la produzione di imbarcazioni in vetroresina di grandi dimensioni e vara nel 1983 la prima barca oltre i 30 metri costruita in questo materiale. L’Azienda acquista nel 1985 i cantieri navali Fratelli Benetti di Viareggio, tra i più rinomati nel mondo per la produzione di megayachts in acciaio oltre i cinquanta metri, e nel 1988 inizia in proprio la produzione di barche in vetroresina tra i 10 e i 20 metri ad Avigliana presso Torino. Il Gruppo attualmente impiega oltre 1300 addetti ed offre lavoro ad un indotto di circa 2000 persone. Il Gruppo si posiziona come primo cantiere nautico europeo e primo cantiere al mondo per la produzione di yacht oltre i ventiquattro metri ed è sicuramente l’unico ad offrire una gamma così ampia, dai 9 ai 70 metri. La produzione è suddivisa in cinque linee ben distinte che permettono di soddisfare le richieste di una ampia fascia di mercato: - Sport cruisers open in vetroresina tra i 9 e i 16 metri (nel cantiere Gobbi di Sariano di Gropparello); - Motorcruisers in vetroresina tra i 12 e i 20 metri (nei cantieri di Avigliana presso Torino); - Motoryachts in vetroresina tra i 21 ed i 35 metri (nei cantieri di Viareggio-Lucca); - Motoryachts Open in vetroresina tra i 18 ed i 30 metri; - Megayachts in acciaio e alluminio dai 50 ai 70 metri e in vetroresina tra i 30 ed i 45 metri con il marchio Benetti (cantiere a Viareggio). Per dare un’idea di quanto la situazione di crisi della Azimut meriti un approfondimento oltre le affermazioni dell’azienda, basta riportare questo articolo di un anno e mezzo fa della Stampa di Torino: Azimut fa affari d’oro in Usa nonostante la crisi , mercoledì 20 febbraio 2008 Azimut Yachts conquista posizioni nel mercato Usa della nautica di lusso. In una situazione di contrazione del 3% nella fascia di riferimento, ovvero il segmento compreso tra i 40’ e gli 80’ (12-24m di lunghezza), l’azienda di Avigliana presenta una crescita del 10%. Il dato è stato fornito in occasione del Salone nautico di Miami. “Festeggiamo quest’anno 25 anni di presenza sul mercato statunitense - ha dichiarato Federico Martini, amministratore delegato di Azimut Yachts - e gli oltre 21 In collaborazione con Lucia Bisetti e Yuri Bossuto, Prc Torino. 241 500 yacht venduti negli ultimi 10 anni nell’area nordamericana confermano la nostra leadership di primo importatore sul mercato. Durante i soli 5 giorni di salone nautico abbiamo raccolto ordini per oltre 50 milioni di dollari di fatturato”. Al Salone nautico di Miami Azimut Yachts ha esposto 12 imbarcazioni, dalla più piccola Azimut 43plus, presentata qui in anteprima mondiale, all’ammiraglia del cantiere Azimut 116. “Vivere”, un megayacht di 35 metri realizzato nel cantiere di Viareggio è stato varato pochi mesi fa a Manhattan sotto la Statua della libertà. Durante i giorni di Salone è stato inoltre nominato in Canada il secondo dealer per la vendita esclusiva di yachts Azimut, estendendo così la copertura da est verso ovest nell’area di Vancouver e rafforzando la rete nordamericana. Azimut Yachts è ora presente in Nord America con 8 dealer. Il gruppo dispone di un centro di service a Fort Lauderdale che si avvale della collaborazione di 6 impiegati dedicati esclusivamente alla gestione di richieste di supporto tecnico nelle Americhe. (Lastampa.it) Appena sei mesi dopo queste dichiarazioni, l’azienda decide che è meglio entrare in crisi; e la prima cosa che viene rimarcata dai lavoratori Azimut in presidio è che si tratta di una crisi “molto strana”, che non ha niente a che fare con ragioni finanziarie o di bilancio. Il cantiere di Avigliana, in effetti, è anomalo rispetto agli altri cantieri che le ditta possiede in Italia, poiché è l’unico in cui la maggior parte della forza lavoro è direttamente dipendente del gruppo, mentre negli altri circa l’80% delle lavorazioni viene eseguita da esterni. L’ipotesi, quindi, è che Azimut voglia ridurre il più possibile la forza lavoro giocando dei numeri della crisi, per poi ricorrere a lavoro esterno qualora gli ordini riprendessero pieno ritmo. Proprio sui numeri si gioca un passaggio decisivo: diversamente dagli anni passati, l’azienda non dichiara quanto ha venduto ai saloni nautici, e questo alimenta il sospetto che Azimut voglia tenersi mano libera nei confronti del personale quantificando nella maniera più alta possibile il numero degli esuberi. Poi, qualora le vendite riprendessero, o qualora i numeri anche attuali di vendite non fossero negativi, l’azienda farebbe ricorso a lavoro esterno o costituirebbe società esterne alle quali commissionare il lavoro. Quindi nel caso di Azimut non si tratta di una crisi finanziaria, l’azienda non è indebitata e i dati economico-finanziari sono del tutto positivi. Negli ultimi dieci anni questa società ha avuto un tasso medio di crescita annuo superiore al 23%. Nel 1997/98 il valore della produzione del Gruppo era attorno a 110 milioni di euro, dieci anni dopo, nel 2007/08 Azimut raggiunge i 960 milioni. Il valore del patrimonio netto, sempre nei die anni considerati, passa da 14 milioni di euro a 293 milioni con una crescita media annua del 35%. Secondo le pubblicazioni specializzate nel settore, il Gruppo Azimut Benetti è da undici anni in consecutivi in testa alla gra242 duatoria degli ordini di nuovi yacht di lunghezza superiore a 80 m con una quota di mercato mondiale del 10,6%. Il Gruppo, infatti, può contare su 138 sedi distribuite in 67 paesi: la rete di vendita più completa nel panorama della nautica mondiale. Anche il livello degli investimenti è costantemente cresciuto nel corso del decennio considerato. La crisi si apre a partire dall’ottobre 2008 quando l’azienda dichiara, in maniera generica, che il Salone di Genova non è andato bene e per questo sarà costretta a ridurre la produzione di barche. I lavoratori vengono messi in ferie per 3 settimane nel periodo di Natale. A marzo 2009 parte la Cassa integrazione ordinaria. Tra ottobre e marzo vengono “tagliati” 320 lavoratori interinali ed entro il mese di luglio 2009 un nuovo dimagrimento occupazionale: viene ridotto di circa 200 unità il numero di lavoratori di ditte esterne. Inoltre viene chiuso un sito produttivo che l’azienda aveva in affitto (Mareschi) La Cassa integrazione ordinaria viene effettuata a rotazione, ma un primo elemento di contraddizione è dato dal fatto che nel periodo di Cassa integrazione viene richiesto, su una linea del reparto vetroresina, il terzo turno. Il periodo di Cassa integrazione ordinaria si aggancia alle ferie estive; al rientro l’azienda ottiene altri due mesi di Cassa integrazione per poter affrontare i Saloni nautici e capire cosa succederà in termini di ordini. E oltre a ciò ottiene anche di non pagare più interamente i ratei di ferie e permessi ai lavoratori, ma di farne maturare loro solo il 50%. Alla fine di ottobre si apre la trattativa e l’azienda dichiara un esubero di 420 unità e di voler delocalizzare alcune linee già lavorate presso lo stabilimento di Avigliana in Turchia. La Cassa integrazione ordinaria viene prorogata di altre 2 settimane per permettere il prosieguo della trattativa tra Azimut e i 4 sindacati presenti in fabbrica: Cgil, Cobas, Ugl e Cisl. Durante l’ultimo periodo di Cassa integrazione ordinaria alcuni lavoratori Azimut avevano cominciato a trovarsi il martedì mattina davanti alla fabbrica, e all’approssimarsi dell’inizio delle trattative hanno costituito il Coordinamento dei Lavoratori Azimut Cassaintegrati (Clac). Il suo primo impegno è stato quello di organizzare i lavoratori in un presidio diurno davanti alla fabbrica durato 4 settimane, discutendo e assumendo decisioni in modo democratico e condiviso anche votando in caso di diversità di pareri: ad esempio, per quanto concerne il rapporto con le istituzioni, l’ipotesi di richiedere un’audizione presso la Commissione Lavoro della Regione Piemonte, è stata discussa e approvata a maggioranza in occasione di una assemblea dei lavoratori del Coordinamento. A tutt’oggi il Coordinamento ha raccolto circa 150 adesioni. Discorrendo 243 con i lavoratori, la prima caratteristica che viene citata del Coordinamento è che “tiene fuori la politica”; la seconda che ad esso possono partecipare solo i lavoratori Azimut. E’ molto forte, infatti, il timore che organizzazioni o persone entrino nel Coordinamento per condizionarlo o per strumentalizzarlo verso finalità che non sono quelle della difesa del posto di lavoro. Anche se il fatto di tenere fuori la politica viene citato da quasi tutti i lavoratori, il concetto, tuttavia, è sfumato a seconda di chi parla. Alla domanda “cosa intendete per tenere fuori la politica”, un lavoratore risponde che “la paura è che la Cgil o i Cobas entrino nel coordinamento per condizionarlo, o per mettergli una etichetta politica”. All’obiezione che Cgil e Cobas non sono partiti politici la risposta taglia corto “per me sono politica anche questo!”. Un altro lavoratore, invece, sottolinea che il tenere fuori la politica risponde all’obiettivo di tenere uniti i lavoratori: “Nel coordinamento ci sono anche lavoratori di destra, non vogliamo che un’etichetta politica divida i lavoratori”. Alla richiesta del perché abbiano sentito il bisogno di darsi un Coordinamento nonostante l’ampia “offerta” sindacale presente in fabbrica le risposte sono nette e vertono sull’inefficacia e sulla scarsa credibilità di cui gode il sindacato, Rsu comprese: “Qualcosa non funziona nei sindacati; non solo tra sigle diverse ma anche all’interno delle stesse sigle” e: “Sindacati ed Rsu non hanno preso bene la nascita del Coordinamento” anche se non c’è opposizione di principio al sindacato, e tutti sostengono che il Coordinamento è nato “per sostenere l’azione sindacale, per affiancarla”. E’ evidente, tuttavia, lo scarso livello di rappresentatività delle Rsu e di comunicazione con i lavoratori: “Passano tra noi a testa bassa e non ci dicono niente, anche se gli diciamo che li abbiamo eletti noi e con noi devono parlare”. “Le Rsu devono tornare in mezzo a noi, in alcuni di loro forse si è anche aperta un riflessione sul loro ruolo e sul rapporto con i lavoratori, su cosa non ha funzionato….” “Nel coordinamento non vogliamo farci condizionare da nessuno, vogliamo organizzarci per difendere il posto di lavoro e basta…”. “Ci serve per capire le cose a fondo…per parlare, questo non succedeva mai nelle assemblee...nessuno parlava e le Rsu arrivavano sempre con la “pappa pronta” che facevano votare…” “Non c’era spazio per intervenire e anche se lo facevi era inutile, …ti toglievano anche la parola i delegati…ed erano loro i primi a dire che bisognava subito votare così com’era…”. Le ragioni dell’esistenza del Coordi244 namento sono citate in un comunicato stampa del 12 ottobre che ne annuncia la nascita “Ci costituiamo perché abbiamo sentito la necessità di rafforzare il ruolo dei nostri interlocutori sindacali che ad oggi, a nostro avviso, si sono formalizzati sulle strategie di confronto, dimenticandosi, purtroppo, di considerare e rimarcare la centralità di giudizio e di scelta dei lavoratori, centralità che deve passare obbligatoriamente da un processo di continuo confronto e di scelte condivise. Ci costituiamo per essere un luogo di confronto dei lavoratori che non sia solo un momento assembleare (l’ultima assemblea risale a luglio) a maggior ragione in questo momento di crisi e di cassa che impedisce il contatto diretto dei lavoratori fra loro e annulla le possibilità di dialogo e scambio (…) E’ nostra intenzione seguire la trattativa tra le Rsu e l’Azienda accompagnandola con una numerosa delegazione sotto l’Unione Industriale”. Successivamente la posizione del Clac viene espressa in un volantino che elenca in tre punti le rivendicazioni: Cassa Integrazione Guadagni per eventi eccezionali: “Con questo ammortizzatore sociale l’azienda non deve dichiarare il numero di esuberi (licenziamenti) che vuole effettuare.” Quello che il Clac intende evitare, in sostanza è “di passare subito a dichiarare un numero spropositato di esuberi, cercando di costringere il sindacato ad accettarlo; e poi, alla fine di un periodo che Azimut vuole sia il più breve possibile, buttare fuori chi vuole”. Il timore espresso dai lavoratori è che la situazione di crisi sia cavalcata ad arte dall’azienda per “ottenere mano libera nella gestione della cassa integrazione straordinaria decidendo lei chi sta dentro e fuori, ovvero non applicando la rotazione: prevista per legge ma derogabile per accordo. In questo caso raggiungerebbe comunque l’obiettivo di “accompagnare” i lavoratori verso l’uscita senza ritorno dalla fabbrica, abituandoli giorno dopo giorno a starne fuori. E’ anche questo che dobbiamo scongiurare.” Incentivo alla mobilità e trattamenti economici decenti: “Alla Pirelli (azienda del nostro stesso settore, gomma plastica) il sindacato ha concordato un incentivo pari a 50.000 euro lordi, che vuol dire tra i 35.000 e i 36.000 euro netti, oltre a un trattamento di integrazione al reddito durante il periodo di cassa integrazione di 200 euro al mese. Non c’è motivo che da un’azienda ricca e sfondata come Azimut il sindacato pretenda meno che dalla Pirelli. Casomai di più”; Riorganizzazione della struttura produttiva non penalizzante per nessun lavoratore: “L’azienda sta iniziando la sue solite manovre: spostamento su linee “sicure” dei prescelti a rimanere, demansionamento di team leader e capi vari 245 ad operaio ecc. Questo significa che Azimut vuol far pagare ancora una volta a noi il “salvataggio” dei suoi preferiti, poiché per ogni capo che ricomincia a fare l’operaio c’è un operaio che perde il lavoro al posto suo. Dobbiamo dire no a questa guerra fra di noi, e pretendere che ognuno resti al suo posto a fare quello che l’Azienda ha scelto che facesse; non è un problema nostro di cosa far fare a tutti i capini e capetti che l’azienda ha promosso in questi anni! Ma è interesse di tutti noi capire che il nostro posto di lavoro non è messo in forse dai colleghi ma da un’azienda sempre più rapace: mobilitiamoci per fare in modo che nessuno perda il posto”. L’ultimo punto del volantino è quello più significativo in quanto è il passaggio nel quale si esplicita chiaramente che il Clac non accetta gli esuberi prospettati da Azimut e intende battersi per la difesa di tutti i posti di lavoro. Si accenna alle frequenti e diffuse promozioni attuate dall’azienda negli ultimi 4/5 anni quando le strategie aziendali decidono di far passare lo stabilimento da cantiere artigianale ad industria vera e propria: è l’inizio di una “gerarchizzazione” dell’organizzazione aziendale che ha portato, oltre a un abbassamento della qualità del prodotto, alla creazione di una struttura di controllo assai articolata che adesso Azimut non sa più come impiegare. Il problema occupazionale e dell’organizzazione di quelle che in gergo manageriale si chiamano “risorse umane” è stato quindi creato proprio da scelte autonome e sbagliate dell’azienda. Il fatto che lo stabilimento di Avigliana a differenza degli altri del gruppo non presenti una quota elevata di lavoratori dipendenti da ditte esterne è invece l’esito di un esposto firmato da tutte le Rsu in cui veniva segnalato l’utilizzo scorretto di lavoratori esterni nella forma della intermediazione di manodopera oltre ai problemi relativi agli ambienti di lavoro dal punto di vista della sicurezza e delle nocività. Questo esposto, inviato alla Asl è stato poi da questa trasmesso alle altre Autorità tra le quali l’Ispettorato del Lavoro che è intervenuto per verificare la situazione dei lavoratori esterni impiegati presso lo stabilimento Azimut. Il numero di questi lavoratori esterni variava da 250 a 350 persone a seconda delle caratteristiche stagionali della produzione in Azimut distribuiti un po’ in tutti i reparti con punte estreme nel reparto carrozzeria, quasi completamente esternalizzato. La risposta dell’azienda, a seguito dell’intervento dell’Ispettorato del Lavoro è stata quella di stabilizzare solo parzialmente i lavoratori di alcuni settori e di esternalizzare del tutto i reparti in cui maggiore era la presenza di lavoratori esterni: in particolare il reparto carrozzeria, un settore in cui il 246 lavoro è particolarmente disagevole a causa della postura che deve mantenere il lavoratore, della presenza di molte polveri, della necessità di tenere sempre scafandri pesanti addosso ecc. insomma dal punto di vista delle condizioni di lavoro il reparto peggiore dello stabilimento. Ma con forti incentivi economici (dovuti al fatto che queste ditte esterne hanno fissato la sede legale in Sicilia e quindi i loro lavoratori figuravano come trasferisti) i lavoratori disponibili a svolgere questi lavori sono stati trovati. Quindi, stipendi più alti in cambio di lavoro pesante e in cattive condizioni ambientali. In falegnameria, invece, dove maggiore era l’equilibrio tra lavoratori interni ed esterni, la situazione è stata risolta da parte dell’Azienda attraverso una ripartizione del lavoro in squadre, parte delle quali – quelle per le quali si ricorreva al lavoro esterno – sono state completamente esternalizzate. Nel reparto vetroresina, invece, dove il numero di lavoratori esterni era contenuto, questi sono stati stabilizzati. In totale i lavoratori esterni stabilizzati sono stati 99. Per altri lavoratori esterni è andata peggio in quanto non sono stati oggetto né di esternalizzazione totale, né di stabilizzazione. Semplicemente con le loro ditte non sono stati rinnovati i contratti e quindi hanno perso il lavoro che svolgevano per Azimut. In definitiva, la questione dei lavoratori esterni è stata risolta in tre modi: - con la definitiva esternalizzazione del reparto o del segmento di lavoro che svolgevano (carrozzeria e falegnameria); - con la stabilizzazione (vetroresina); - con la perdita del lavoro dovuta al mancato rinnovo del contratto tra Azimut e le aziende esterne presso le quali questi lavoratori erano impiegati. Tra i lavoratori esterni e i lavoratori Azimut non c’era una collaborazione sindacale ma solo quella che alcuni chiamano “promiscuità” nei reparti. Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è la totale assenza di coordinamento sindacale tra i vari stabilimenti italiani del Gruppo Azimut. Questa assenza viene rimarcata dai lavoratori che hanno espressamente invitato le organizzazioni sindacali a costruire forme di coordinamento, collaborazione e comunicazione tra i vari stabilimenti del gruppo. La Cgil, presente in tutti gli stabilimenti, sostiene che la difficoltà viene dal fatto che non tutte le unità produttive appartengono allo stesso settore (Livorno e parte di Viareggio è Fiom, mentre Avigliana, Piacenza, Fano e il resto di Viareggio è Filcem). Ma comunque anche dove la categoria è identica non esiste collegamento, aspetto che Azimut cavalca per fare firmare accordi al ribasso in un sito e tentare poi di imporli altrove. Questa 247 assenza di collegamento tra stabilimenti di uno stesso gruppo industriale, nonostante esplicite richieste dei lavoratori in tal senso, ricorda molto il caso dei petrolchimici dell’area padana. Nella giornata di mercoledì 4 novembre i lavoratori hanno presidiato la sede dell’Unione Industriali di Torino mentre si stava svolgendo l’incontro decisivo per le sorti dello stabilimento. L’ipotesi di accordo firmata dopo una notte di trattative accoglie quasi interamente le richieste che erano state formulate dal Clac nel volantino citato, e in particolare il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per eventi eccezionali, imprescindibile per poter evitare il ricatto degli esuberi. Inoltre è stato ridotto il numero delle “eccedenze temporanee” da 420 a 171, è stata riportata la produzione del nuovo 43’ che doveva essere delocalizzata in Turchia, sono stati stanziati 24 milioni di euro in tre anni per il potenziamento del sito di Avigliana. Azimut è stata come al solito micragnosa con gli incentivi all’esodo e non si è portato a casa il pagamento dei ratei, ma l’azienda si è impegnata a garantire la rotazione del personale in Cassa integrazione straordinaria. Un accordo che pareva impossibile ottenere e che fa emergere ancora una volta come la mobilitazione e il protagonismo dei lavoratori riescano ad imporre le ragioni anche parziali della classe molto più dei tavoli di concertazione sindacali. Le assemblee non hanno potuto che approvare un accordo tutto sommato positivo. Il Clac ha già annunciato che proseguirà nella funzione che si è dato di affiancare e stimolare il sindacato nel controllare i molti aspetti di questo accordo (rotazione, demansionamenti, turnazioni ecc.) che necessitano di un monitoraggio attento e costante. Nel merito dell’accordo, appare importante sottolinearne alcuni passaggi. A proposito della situazione di crisi viene riconosciuto che “il tasso medio della crescita del fatturato nel quinquennio 2003–2008 era stato superiore al 15% e le previsioni pre–crisi confermavano il rafforzarsi delle posizioni di mercato in relazione allo sviluppo di nuovi mercati per la nautica italiana quali i Paesi Arabi, la Russia e la Cina. Ancora nel primo semestre 2008 tutti gli indicatori (tra cui gli ordinativi da parte dei concessionari) confermavano un trend di crescita del mercato superiore al 13%”. Infatti, la stessa Azimut riconosce che “la fase di profonda crisi della domanda (…) si contrappone in maniera drastica e inattesa a quelle che risultavano fino alla metà del 2008 la peculiarità di un settore in costante crescita di volumi e di fatturato”, “caratterizzato da una forte e costante crescita dei volumi prodotti e venduti in relazione alla sempre maggiore passione della clientela nazionale e internazionale per la nautica da diporto ed il rafforzamento anche del “made in Italy” anche in tale ambito”. A fronte di questa situazione, l’accordo individua nel secondo semestre del 2008 la fase di netto peggioramento dovuto alla scelta “da parte del248 la clientela finale di rinunciare agli investimenti legati all’acquisto di imbarcazioni da diporto, anche in ragione della stretta creditizia che ha di fatto limitato le possibilità e le disponibilità del sistema bancario…” A seguito di questo, la diminuzione dei volumi produttivi si sarebbe attestata “su un volume complessivo di imbarcazioni prodotte inferiori alle 200 unità a fronte di una iniziale previsione di budget superiore a 300 unità, in conseguenza della cancellazione di ordini e minore domanda…”. Questa premessa appare di fondamentale importanza per porre alcuni interrogativi. Il primo: è così vero che la riduzione degli ordini si è manifestata in maniera “drastica e improvvisa”? Non era forse prevedibile, anche se i dati del primo semestre 2008 sembravano indicare il contrario, che nel prosieguo probabilmente l’aggravarsi della crisi economica avrebbe potuto determinare conseguenze anche sul mercato della nautica da diporto? Il secondo interrogativo: e nel caso in cui la clientela dei prodotti Azimut– Benetti superasse le difficoltà contingenti e tornasse a garantire ordini analoghi a quelli del trend precedente la fase di crisi? viene sottolineato, infatti, che il calo degli ordini o la cancellazione degli stessi, è imputabile alla stretta creditizia che non ha consentito al sistema bancario di finanziare l’acquisto di mezzi di nautica da diporto, che per la loro peculiarità non possono che essere acquistati grazie ad operazioni di finanziamento di tali acquisiti. E qualora si superasse tale stretta creditizia e gli ordini tornassero ai livelli di un anno fa, come pensa Azimut di far fronte ad una nuova e possibile mutata condizione di mercato? questo è l’interrogativo che lascia aperte le preoccupazioni maggiori, soprattutto in termini occupazionali e, in misura maggiore, di organizzazione del lavoro e di tipologie contrattuali alle quali far ricorso. Cioè: una volta ridotto l’organico del sito di Avigliana e una volta riorganizzata la produzione, nel caso in cui gli ordini riprendessero con i trend pre-crisi, Azimut come farà fronte ai nuovi volumi di produzione dopo aver ridotto il personale e riorganizzato la struttura? Forse ricorrendo a prestazioni esterne, appaltando fasi di lavorazione o commesse intere all’esterno? Sicuramente positiva è l’affermazione secondo la quale il sito di Avigliana viene riconfermato come “quale sito principale e strategico dell’intero Gruppo Azimut-Benetti”. Coerenti con questa dichiarazione di intenti, sono le principali azioni del Piano Industriale organizzato –dal punto di vista industriale–produttivo– in due parti. Con la prima viene programmato l’obiettivo del “Rinnovo gamma prodot249 to”: in questa parte il Piano prevede la progettazione, la prototipia e la produzione di 9 nuovi modelli nel quadriennio 2009-2012. Nello specifico, il Piano prevede il “rafforzamento e consolidamento della missione industriale del sito di Avigliana, non solo confermando l’allocazione della gamma MC ivi allocata, ma anche il suo allargamento attraverso l’acquisizione di un prodotto della nuova gamma prodotto Magellano compatibile con le caratteristiche strutturali e dimensionali del sito di Avigliana”. Il rinnovo della gamma prodotto comporta un investimento complessivo pari a 24 milioni di euro a cui si aggiunge “l’impegno aziendale al completamento della parte di impiantistica strutturale rispetto alle opere edili/murarie concluse ad agosto 2009 relativamente alle nuova area denominata KPN per la quale viene confermata la sua destinazione ad uso produttivo”. Gli impegni assunti appaiono abbastanza certi in quanto viene stabilito che il Piano Industriale con relativi investimenti “avrà una distribuzione nel triennio 2010–2012 di circa 9 Ml di euro il primo anno, 8 Ml il secondo anno e 7 Ml il terzo, fermo restando le naturali considerazioni di carattere tecnico/gestionale che ne potranno variare la sola tempificazione…”. Più preoccupanti sono invece le decisioni assunte sugli organici e descritte nel Piano di riorganizzazione e nel Piano Sociale di gestione. Innanzitutto il verbale di accordo parte da una premessa: che “in riferimento al personale ad oggi in organico presso lo stabilimento di Avigliana della Azimut–Benetti S.p.a. l’azienda conferma l’esistenza allo stato attuale di una eccedenza di 30 operai diretti di produzione, 69 operai indiretti e 72 impiegati/quadri che le parti intendono definire temporanea e transitoria con il piano sociale di seguito convenuto”. Quindi, una dichiarazione di 171 esuberi complessivi. Il Piano di riorganizzazione viene definito come “teso al riequilibrio dei fattori produttivi, economici e commerciali rispetto al mutato scenario di mercato” e così le azioni di “risanamento ed efficientamento aziendale” riguardano: la revisione degli assetti organizzativi funzionali a rendere la struttura più snella semplificando la gerarchia (…era stata proprio l’azienda, come hanno spiegato i lavoratori, a istituire capetti su capetti…), interventi di unificazione e centralizzazione di svariate funzioni (amministrazione, finanza, logistica) standardizzazione di procedure e l’attuazione –parola magica di ogni management– di “sinergie”… Come si traducono questi indirizzi sull’organizzazione e sulla dotazione concreta del personale? Le misure più significative riguardano l’internalizzazione di parecchie attività: l’internalizzazione completa delle attività già oggetto di appalto con recupero a regime di 105 unità lavoro sulle mansioni di falegname, carrozziere e discatore; l’internalizzazione delle fasi ancora appaltate all’esterno di tappezzerie 250 (5+10 posizioni di lavoro tra il 2010 e il 2011); parti staccate delle nuove imbarcazioni (2+5 posizioni di lavoro tra il 2010 e il 2011) valutando anche una ulteriore internalizzazione di parti staccate VTR; fasi di pulizia (3 lavoratori) ma non degli uffici. L’Azimut, quindi, internalizza molte funzioni e segmenti di lavorazione precedentemente appaltati all’esterno recuperando così posizioni lavorative direttamente dipendente da essa, ma riducendo il numero complessivo dei lavoratori impiegati attraverso il taglio dei lavoratori esterni. Si conferma quindi una scelta strategica da parte dell’azienda: per non gravare in maniera troppo dura sul proprio organico (cioè sui propri dipendenti), Azimut decide di internalizzare funzioni prima esternalizzate occupando in esse i propri lavoratori precedentemente assegnati ad altre mansioni. In questo modo la scelta della riduzione occupazionale complessiva si scarica quasi interamente sui lavoratori delle ditte in appalto. L’internalizzazione, infatti, non si accompagna alla stabilizzazione dei lavoratori addetti alle funzioni appaltate che perdono il posto di lavoro in quanto per lo svolgimento di queste mansioni vengono sostituiti dai lavoratori “interni” alla Azimut. Piuttosto consistente è anche il ricorso agli ammortizzatori sociali ed in particolare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che coinvolge un numero medio mensile di 450 lavoratori con possibilità di raggiungere un picco massimo di 950. Il tutto a zero ore. Sull’individuazione dei lavoratori da mettere in CIGS, l’accordo prevede la definizione di criteri di sospensione e rotazione. I risultati positivi in merito al ricorso alla CIGS sono almeno due: 1) l’istituzione di un “tavolo operativo” con il compito di verificare l’applicazione della CIGS dal punto di vista della rotazione in modo da escludere che questa sia una decisione discrezionale dell’azienda magari finalizzata a colpire alcuni lavoratori (quelli più combattivi ecc.); 2) l’anticipo del trattamento di CIGS da parte dell’azienda in modo da non lasciare i lavoratori privi di reddito in attesa dell’erogazione INPS. Il piano di gestione delle eccedenze, cioè dei 171 esuberi indicati in premessa, viene gestito attraverso più strumenti: il blocco del turn over durante il periodo di CIGS; la riqualificazione professionale finalizzata al riassorbimento di una parte di lavoratori in sospensione (anche con assegnazione a mansioni diverse in deroga, pertanto, alla normativa vigente sull’assegnazione di mansioni); collocazioni in mobilità finalizzate al trattamento di quiescenza o alla ricollocazione esterna (incentivata dall’erogazione di una somma compresa tra 251 20.000 e 28.000 euro lordi); mobilità interna, anche in questo caso con la previsione dell’assegnazione anche a mansioni diverse; mobilità all’interno del Gruppo; trasformazione da tempo pieno a tempo parziale; ricollocazione esterna (il famigerato outplacement… sia collettivo che individuale); comando/distacco; incentivazione all’esodo. Tutti questi passaggi, così complessi e delicati necessitano dell’impegno già annunciato dal Clac di affiancare e stimolare il sindacato nel controllare i molti aspetti di questo accordo (rotazione, demansionamenti, turnazioni ecc.) che necessitano di un monitoraggio attento e costante. 252 Crisi nella Castellana22 La situazione dei lavoratori e delle famiglie della Castellana è drammatica. Secondo “Veneto Lavoro” la stima dei lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro ammonta a circa 4000 solo nell’area della Castellana (area di 7 comuni per un totale di circa 92000 abitanti), fra di essi lavoratori di medie imprese ma soprattutto lavoratori di piccole imprese privi di tutele sociali. Questo numero è stato calcolato evidenziando la differenza fra lavoratori assunti e lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro. Ammontano invece a circa 1500 i lavoratori in questo momento in cassaintegrazione, lavoratori cioè che, se si recano a lavoro lo fanno a giorni alterni a seconda delle esigenze aziendali. Questi lavoratori percepiscono uno stipendio ridotto, e per i più sfortunati di essi servono diversi mesi prima di percepire lo stipendio che arriva dall’Inps e che non sempre può essere anticipato dall’azienda (è il caso delle aziende indebitate e prive di liquidità come la Fervet). Nell’ultimo anno, 38 delle maggiori 40 aziende della Castellana hanno fatto richiesta al ministero del lavoro del sussidio della cassaintegrazione. Tuttora alcune di esse versano in crisi profonda, altre hanno solo attraversato un momento transitorio di crisi poi in parte rientrato. Di seguito descrivo alcune delle realtà più difficili. Fervet 204 dipendenti nella sede a Castelfranco in Borgo Padova, produce e fa manutenzione di carrozze per treni. Pochi anni fa, dopo gli scandali in Italia per le morti per asbestosi da amianto, la legge impedì le produzioni di vagoni con coperture in amianto e Fervet fu costretta a limitare fortemente la sua produzione tagliando molti posti di lavoro. Nel recente passato nascono i problemi più gravi: Fervet vince un appalto per la ristrutturazione di 901 carrozze intercity per Trenitalia. Le richieste di ulteriori manutenzioni rispetto a quelle stipulate inizialmente con Trenitalia porta il numero di ore di lavoro ad aumentare e, proporzionalmente, i costi. Trenitalia decide perciò di fermare la manutenzione a 450 carrozze anziché le 901 iniziali recedendo il contratto. L’azienda, che aveva già acquistato i materiali per ristrutturare tutte le 901 carrozze, si trova tra fine 2008 e inizio 2009 con i magazzini pieni, priva di liquidità e con elevati indebitamenti nei confronti dei fornitori (17,5 milioni di euro) e delle banche (12 milioni) a fronte di 23,5 milioni di crediti da Trenitalia e un patrimonio immobiliare stimato di 20 milioni di euro. In questa situazione Fervet avvia un’azio22 Questa scheda è stata realizzata da Enrico Baldin, Prc di Treviso. 253 ne legale contro le Ferrovie dello Stato per ottenere un risarcimento di 112 milioni di euro a causa della recessione anticipata del contratto. Da febbraio 2009 è partita la cassa integrazione ordinaria per 100 dipendenti per un mese, poi prolungata per altri 50 dipendenti, e quindi passata a un totale di 185 dipendenti ad usufruirne. In questa situazione le banche potrebbero dimostrare disponibilità a spalmare i debiti dell’azienda dilazionandoli, a patto vi sia il passaggio di proprietà: da diversi mesi infatti vi è un nuovo acquirente all’orizzonte per Fervet, ovvero il gruppo napoletano “Barletta” che però non ha ancora rilevato l’azienda ed è ancora in trattativa. Tutt’ora i lavoratori non conoscono i termini della trattativa. All’orizzonte inoltre c’è un nuovo possibile appalto di Trenitalia disposta ad investire 2 miliardi di euro sul trasporto locale per un totale di 600 carrozze a doppio piano, appalto che Fervet non può lasciarsi sfuggire e da cui dipenderà il futuro dei lavoratori a cui, ad aprile 2010, scadrà la cassintegrazione straordinaria al termine della quale potrebbero essercii licenziamenti se non ci saranno risvolti positivi. Da dire infine che la mancanza di liquidità e gli indebitamenti hanno fatto sì che l’azienda non abbia potuto anticipare, come succede abitualmente, gli stipendi ai lavoratori anticipando i tempi biblici dell’Inps. E’ accaduto perciò che i dipendenti percepissero uno stipendio ammontante a non più di 50-100 euro al mese per quasi 4 mesi consecutivi, dando origine a una situazione di allarme sociale tra i lavoratori. Berco Azienda storica della castellana che negli anni ’80 rilevò gli stabilimenti dell’industria bellica Simmel in Borgo Padova a Castelfranco. La Berco fa parte del gruppo Thyssen Krupp e ha sede principale a Copparo in provincia di Ferrara dove lavorano circa 2250 dei suoi quasi 3000 dipendenti. Castelfranco è il secondo stabilimento per numero di dipendenti (480), seguito da Busano Torinese (130) e Imola (50). Berco produce sottocarri, macchine utensili per movimento terra, cingoli; ha un export del 90% sul totale prodotto, il 37% è verso il mercato statunitense, primo a mostrare la crisi sul settore edile ed estrattivo trascinando Berco (azienda leader mondiale nel suo settore) a una crisi importante. Le previsioni di produzione per il 2009 e il 2010 di Berco, non sembrano avvicinarsi lontanamente alle 250000 tonnellate di acciaio prodotte nel 2007 che giustificavano un totale di quasi 3000 lavoratori. Le previsioni più rosee dicono, viste le prospettive di mercato, che il 2010 potrebbe vedere la produzione di circa 110000 tonnellate di acciaio. E’ragionevole pensare perciò che l’azienda praticherà una politica di tagli già dal prossimo anno (almeno diverse centinaia). Il 4 maggio 2010 infatti scadrà la cassintegrazione straordinaria cui fruiscono a 254 rotazione tutti i dipendenti Berco. L’accordo del maggio 2009 tra azienda e sindacati prevede, al termine dell’anno di cassaintegrazione, ulteriori due anni di cassaintegrazione in deroga a patto che l’azienda operi nuovi investimenti per almeno 13 milioni di euro (cosa che appare abbastanza improbabile visto che Thyssen sembra trattare Berco come palla al piede visto gli insuccessi recenti). L’accordo stipulato a maggio infine prevede che per tutti i dipendenti che non riescono a lavorare per più di 15 giorni al mese vi sia una integrazione di stipendio che elargirà l’azienda per 250 euro al mese a testa per far fronte alla mancata maturazione di ferie e permessi. All’oggi è impossibile stimare le intenzioni dell’azienda per maggio 2010: essa infatti non si è ancora pronunciata, come del resto sembra non lo abbia ancora fatto la casa madre Thyssen Krupp. Quello che si è evidenziato recentemente è che non è stato sostituito il manager che si occupava dello stabilimento di Busano Torinese, integrando sotto il lavoro del manager castellano anche quello stabilimento: questo fatto intuitivamente sembra indicare una mancanza di volontà di far riprendere la produzione allo stabilimento piemontese che potrebbe essere solo il primo a dover serrare i battenti. Fracarro Radioindustrie L’azienda produce apparecchi elettronici per TV-satellitari, citofoni, impianti di videosorveglianza ed antintrusione. Ha 255 dipendenti, ha sede a Castelfranco Veneto. A causa di importanti contrazioni delle vendite rispetto agli esercizi migliori, a inizio 2009 l’azienda annuncia il taglio di 130 dipendenti con il trasporto di buona parte della produzione in Tunisia in un nuovo stabilimento. A fine luglio 2009 le parti raggiungono un accordo: la maggior parte della produzione viene spostata in Tunisia come preannunciato, gli esuberi vengono limitati a 103 unità (30 impiegati e oltre 70 operai) tutti posti in cassintegrazione per 24 mesi con l’impegno per l’azienda di ricollocare entro i primi 12 mesi il 30% delle maestranze in esubero (a tal proposito è stato raggiunto un accordo con una cooperativa sociale locale che assumerà 35 dipendenti a pari retribuzione). Per la settantina di dipendenti rimanenti, dopo la scadenza dei 24 mesi di cassaintegrazione, vi sarà la mobilità. GGP Castelgarden Azienda che produce rasaerba, decespugliatori e apparecchi per il giardinaggio, ha stabilimenti in Svezia, Repubblica Slovacca, Cina, oltre che a Castelfranco Veneto. Visto il tipo di produzioni vi è un importante ricambio di manodopera stagionale, il picco di produzione si registra solitamen255 te nel mese di febbraio. Lo stabilimento di Castelfranco Veneto conta 550 dipendenti a tempo indeterminato oltre ai quali, nell’ultima stagionalità vi erano altri 450 dipendenti a tempo determinato quasi esclusivamente stranieri. Nella fabbrica castellana il 55% dei dipendenti è straniero. La crisi è evidente se si pensa che l’esercizio 2008/2009 è stato chiuso con quasi 200 milioni di euro di fatturato in meno rispetto all’esercizio 2007/2008. A marzo perciò, mentre si stava concludendo il picco di lavoro stagionale, l’azienda sotto la minaccia di delocalizzazione della produzione stipula un “accordo truffa” con Cisl e Uil ratificato da un referendum tra i lavoratori che l’hanno approvato col 68% dei voti favorevoli (contraria Fiom Cgil). Tale accordo prevede un aumento netto medio del salario di 0.41 euro all’ora, la promessa di investimenti nello stabilimento di Castelfranco per almeno 24 milioni di euro fino al 2012 (l’azienda minacciava che avrebbe delocalizzato la produzione) e una deroga nelle assunzioni dei terministi. Tale deroga prevede infatti che non vi sia l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con 36 mesi di precarietà compiuti (come è invece obbligatorio dalla legge del governo Prodi sulla precarietà), bensì prevede che vi sia un’assunzione a tempo indeterminato a part time verticale per 7 mesi di 35 dipendenti nel 2009, altri 35 nel 2010 e gli ultimi 30 nel 2011. I lavoratori invece a cui erano già scaduti i 36 mesi di lavoro con rinnovati contratti a tempo determinato ammontavano a 168. Con tale accordo invece l’azienda ne assume solo 95 spalmandoli in tre anni e chiude successivamente le assunzioni a tempo indeterminato anche qualora i terministi conseguissero 36 mesi di lavoro a tempo determinato. Tale accordo ha portato a molte polemiche e a una grande rilevanza mediatica: si trattava il tema dei lavoratori messi gli uni contro gli altri, italiani contro stranieri, stabili contro precari, Cgil contro Cisl e Uil. Al termine di questa vicenda Fiom Cgil ha annunciato un ricorso nelle sedi opportune tramite i suoi legali in quanto riteneva a ragione che l’accordo stipulato andasse contro le direttive europee sul lavoro a tempo determinato, contro il contratto nazionale di categoria dei metalmeccanici e contro il protocollo 23 luglio ratificato dal governo Prodi nel 2007. La beffa arriva pochi mesi dopo quando l’azienda decide di mandare in cassaintegrazione 530 dipendenti a tempo indeterminato per 5 settimane ad agosto (Fiom Cgil calcola che con queste 5 settimane tali dipendenti abbiano perso i benefici annuali dell’aumento contrattuale, in altre parole l’aumento salariale dell’accordo di marzo è stato annullato dagli stipendi ridotti della cassintegrazione). La situazione vista ad ottobre 2009 vede un nuovo amministratore delegato per Castelgarden, dei nuovi investimenti per 40 milioni di euro, un indebitamento ancora non noto ma che am256 monta a una cifra compresa tra 300 e 500 milioni di euro, lo spostamento di parte della produzione slovacca di decespugliatori in Cina, una previsione per giugno-luglio di di 3 o 4 settimane di cassintegrazione per ristrutturazione, la possibile ridiscussione dei debiti con le banche. Altre aziende Fra le altre situazioni di crisi si ricordano: - l’azienda Alessio di Riese Pio X con due stabilimenti di fonderia e cerchi in lega per un totale di oltre 70 dipendenti è recentemente fallita. Per i dipendenti si sta per chiudere il periodo di cassa integrazione concessa dal ministero oltre la quale ci sarà il licenziamento; - La Puleggia di Salvarosa di Castelfranco produce argani per ascensori e montacarichi. Da settembre 2009, 21 dei 50 dipendenti sono in cassintegrazione straordinaria a rotazione dopo un anno di cassintegrazione ordinaria; - Omp di Castello di Godego produce sedie e arredamento ha 99 dipendenti. Da ottobre 2009 42 dipendenti sono in cassintegrazione straordinaria a rotazione (20 dipendenti al giorno). Il settore dell’arredamento versa in particolare crisi; - Simec di Castello di Godego, produce macchine per lavorazione pietra. Dopo una contrazione di circa il 40% degli ordinativi nei mesi scorsi è partita la cassintegrazione straordinaria per 80 dei 120 dipendenti; - Breton di Castello di Godego, azienda leader nella lavorazione di pietra e ceramica non ha rinnovato il contratto di tutti i suoi terministi e ha ritirato il lavoro dato in appalto a altre piccole aziende locali. Ha fatto esaurire le ferie ai suoi dipendenti nel periodo di maggio 2009 e ha mandato in prepensionamento circa 30 dipendenti. Dopo essere stata definita in un nostro volantino come “in crisi” non condividendo ha minacciato di denunciare Rifondazione Comunista e Pdci; - Omart di Vedelago attiva sul settore della produzione di macchine di movimento terra e trasporto ha messo a maggio 2009 in cassintegrazione 61 dipendenti; - Campagnaro Elettrotecnica ha da inizio anno 100 dipendenti in cassintegrazione ordinaria. L’azienda ha contratto molti debiti e perciò paga gli stipendi in ritardo. Per questa azienda si vocifera di un possibile cambio di proprietà; - La Ferriera di Cittadella ha uno stabilimento a Vallà di Riese Pio 257 - X con 60 dipendenti in cassintegrazione da novembre 2008; Velo di Caselle di Altivole, leader nella produzione di botti, cisterne e materiale per l’enologia ha recentemente avviato una politica di tagli che negli ultimi mesi ha coinvolto 35 dei suoi oltre 200 dipendenti. Per essi la scadenza della cassintegrazione con il prossimo licenziamento sembrano imminenti. 258 Inchiesta realizzata alla Fervet di Castelfranco Veneto (Tv)23 La Fervet nasce a Bergamo nel 1907 come Fabbrica E Riparazione Vetture e Tramvays. Nel 1908 apre lo stabilimento di Castelfranco Veneto dove si trova oggi anche la sede legale. Dal sito internet della società si possono leggere alcune note per inquadrare la situazione industriale ed economica del sito. La valorizzazione dello stabilimento di Castelfranco Veneto si accentua nel corso degli anni ’80, tanto che viene considerato nel 1987 come “il più grosso della società sia come superficie, sia come numero di addetti, sia come importanza economica”, oltre che come “il più versatile ed il più eclettico”, lo stabilimento di Castelfranco si era negli ultimi decenni specializzato “in carrozze viaggiatori, elettromotrici e locomotori (con esclusione quindi dei carri merci), sia per grandi riparazioni sia per ristrutturazione”, sviluppando un’attività che potremmo considerare “di grosso artigianato, con assoluta prevalenza di mano d’opera ed altissimo valore aggiunto”. Dal 1 luglio 1997 esso ha raccolto l’eredità delle altre officine, realizzando in breve tempo quella inversione di tendenza, che ha consentito alla Società di superare la crisi del decennio precedente. L’obiettivo fu centrato non tanto attraverso una “riconversione completa” – giudicata sia “tecnicamente” che “economicamente” impraticabile – quanto invece adeguando il settore della riparazione, sviluppando quello “della costruzione” ed intervenendo “sul mercato estero”, previo un potenziamento delle “attività di ricerca in atto”.” Fervet ha individuato nella revisione e nella ristrutturazione di elettrotreni una nicchia di mercato promettente, perché a bassa concorrenza, per questo, a partire dal 2000 la Società si è progressivamente specializzata in questo settore, adeguando la propria organizzazione interna alle specifiche esigenze di un prodotto di crescente richiesta. E così ha acquisito via via commesse di elettrotreni da Trenitalia, Ferrovie Nord Milano, Ferrovia Alifana-Benevento-Napoli (ora MetroCampania NordEst), Ferrovia Adriatico Sangritana, Ferrovie del Gargano, ACTM di Modena, La Ferroviaria Italiana, Ferrovie Emilia Romagna, ecc. Fervet si è occupata anche della realizzazione di carrozze speciali quali la “Pizza Express”, carrozza dotate di tutto l’occorrente per produrre pizza da asporto; oppure quelle utilizzate da RFI per misurazioni sulla rete nascono così la “Oscillografica” e la “Frenografica”, della trasformazione di elettrotreni per la sperimentazione di apparati quali l’SCMT (Sistemi di Controllo Marcia Treno), quella dell’ETR Y 500 che serve a testare il sistema alta velocità. 23 In collaborazione con Enrico Baldin, Prc di Treviso e Alessandro Squizzato, Pdci di Treviso. 259 Ovviamente il core business della Fervet continua a rimanere quello della lavorazione delle carrozze, con interventi che vanno dalle manutenzioni cicliche, alle riparazioni e alle ristrutturazioni, del tipo di quella avvenuta per il Giubileo del 2000. In questo tradizione si inseriscono anche la ristrutturazione dei treni Eurostar (ETR 500) riproposti con la livrea del Brand AV. Nel 2002 la Fervet Spa ha costituito con la ditta Magliola Antonio & Figli Spa di Santhià (VC) il “Consorzio Corifer”, al quale hanno successivamente aderito anche le Officine Ferroviarie Veronesi Spa e la Rsi Italia Spa. Grazie alla creazione di questo consorzio è stato possibile, per la Fervet, acquisire commesse importanti, quali la ristrutturazione di 901 carrozze per treni Intercity, e puntare poi alla diversificazione della produzione, con la costruzione. del treno Vivalto. L’intervista con Rsu e lavoratori della Fervet avviene a Castelfranco Veneto, in un bar, anche testimonianza della drammatica carenza di spazi sociali (sedi di partito, circoli sociali ecc.) nel cuore del Veneto del “miracolo economico” del Nord Est. “La nostra crisi verificata con l’interruzione di una importante commessa in corso da novembre, era una commessa “Intercity”, si trattava della ristrutturazione di 901 carrozze… questa commessa avrebbe consentito di uscire dalla precedente crisi economica. Questa commessa è stata disdetta da Trenitalia a metà…cioè dopo aver ristrutturato 450 carrozze Trenitalia recede dal contratto e quindi la nostra azienda si è trovata con un mare di debiti... perché prima aveva chiesto alle banche dei prestiti per poter fare la commessa e quindi dopo che Trenitalia ha tagliato la commessa ci siamo trovati senza lavoro e l’azienda con sacco di debiti..”. “Poi la nostra crisi è continuata con la crisi internazionale aggravando ulteriormente la situazione… adesso siamo tutti in Cassa Integrazione tranne la parte amministrativa che sta cercando di salvare il salvabile, ma i debiti sono talmente alti e la situazione è così critica…viviamo nell’incertezza non sappiamo se usciremo da questa situazione…Eravamo poco più di 200 dipendenti, eravamo in 214.. .adesso qualcuno in meno perché alcuni sono andati in pensione e qualcuno si è licenziato..anche se questi sono pochissimi, solo uno o due…e così adesso stiamo aspettando che qualcosa si risolva…” I lavoratori Fervet, quindi, sono in una fase di attesa: “Nel frattempo siamo in Cassa Integrazione e speriamo che la situazione cambi… speravamo che Trenitalia desse nuove commesse che ci consentissero di lavorare,… qualcosa adesso si è mosso…ci sarà una gara d’appalto per circa 500 - 600 carrozze alla quale Fervet partecipa Ma il problema è: ce la faremo a resistere fino a quando avremo preso questo lavoro? 260 Intanto è una gara e bisogna vincerla… e non è facile perché partecipano anche altre ditte, molto forti come Ansaldo e altri mirano a acquisirla… anche loro sono in crisi e quindi vogliono questa commessa. Le 900 carrozze della commessa precedente non erano solo da noi, ma erano spalmate su tutto territorio nazionale…ma perché Trenitalia si è fermata a metà? Trenitalia si è fermata a 450 carrozze e queste non sono state fatte tutte da Fervet…” La commessa è stata acquisita, infatti da un Consorzio di aziende chiamato Corifer del quale fanno parte, oltre a Fervet anche Officine Ferroviarie Veronesi Spa di Verona, Magliola di Santhià, Real Service International (gruppo europeo). I lavoratori non riescono a capacitarsi della decisione di Trenitalia di sospendere le lavorazioni della commessa: “L’interrogativo che ci siamo posti: ma perché tagliate? …questo non è mai successo, mai successo che nella storia delle ferrovie che avessero tagliato una commessa…. e poi proprio adesso, in questo periodo di crisi. Questo era un lavoro utile all’Italia….tutti si lamentano perché si viaggia male, tutti i giorni c’è il problema dei pendolari, le carrozze sono brutte, i treni che arrivano in ritardo per guasti e problemi tecnici ecc..” Qualcuno azzarda una risposta: “Per favorire TAV tagliano ovunque e soprattutto il lavoro.” In effetti, la strategia di Trenitalia degli ultimi tempi sembra incentrata sul business dell’Alta Velocità a scapito dei servizi ferroviari utilizzati quotidianamente dai pendolari suscitando le clamorose proteste a cui periodicamente si assiste. I lavoratori Fervet chiamano direttamente in causa le responsabilità della politica e di cosa potrebbero significare politiche pubbliche nel loro settore. “Quello che ulteriormente non capiamo è che noi lavoriamo in un settore che è vicino alle necessità del governo, perché ci troviamo in crisi profonda come tutti gli altri, qui si potrebbe investire e non sprecare. Noi come lavoratori non vogliamo la Cassa Integrazione, vogliamo lavorare, chiediamo a governo e politici di spiegare come mai non ci fanno lavorare e ci danno i soldi della Cassa Integrazione, perché non spendono gli stessi soldi che ci danno per la Cassa per ristrutturare le carrozze… e questo sarebbe utile a tutto il sistema: noi lavoriamo, non si sprecano le risorse della Cassa, facciamo un lavoro utile per un servizio pubblico… Cioè, posso anche capire la crisi di chi compete sul mercato internazionale, magari i cinesi con la loro concorrenza hanno fatto chiudere alcune aziende tessili. Ma noi lavoriamo per produrre treni e fare servizi, abbiamo 261 anche del lavoro da finire in officina ma paradossalmente non possiamo finire perché non abbiamo i soldi per comperare i materiali e per finire il lavoro.” “L’azienda era molto indebitata prima di acquisire la commessa delle 901 carrozze, ma piano piano ne stava uscendo…la nostra nuova direzione aziendale stava lavorando per uscire dalla situazione di indebitamento che nasceva nei primi anni 20000…quando abbiamo cominciato a costruire il nuovo treno chiamato “Vivalto”..il treno a due piani,..ecco questo progetto ha causato grosso indebitamento..per noi è stato qualcosa di nuovo, una costruzione ex novo, mentre noi in precedenza facevamo solo riparazione e ristrutturazione… quindi si trattava di un nuovo progetto avrebbe fatto uscire Fervet da una situazione di immobilismo… ma in definitiva ha portato solo un grosso indebitamente… però con il cambio di direzione aziendale se ne stava uscendo… salvo poi essere fermati da Trenitalia che decide di tagliare la commessa a metà.” Una domanda sorge spontanea. Di questi servizi, di riparazione e ristrutturazione dei mezzi, Trenitalia ha sempre bisogno; quindi, anziché fare gare, che possono essere vinte da aziende straniere come Alstom o Bombard, per garantire che una azienda del territorio abbia commesse tali da garantire il lavoro, nessuno ha mai pensato che questo settore possa essere internalizzato in Trenitalia? “….Mah…Trenitalia ha le sue officine, che però non sono sufficienti a fare tutto il lavoro..quindi, si sarebbe auspicabile questo… sarebbe strategico”. Della proposta di internalizzazione in Trenitalia di questi servizi viene riconosciuta la fondatezza e anche l’importanza, sia dal punto di vista industriale che occupazionale, ma ovviamente i lavoratori si rivelano piuttosto scettici sulla reale riuscita di una operazione del genere. Eppure, la professionalità dei lavoratori Fervet rappresenterebbe un valore aggiunto anche per Trenitalia, in grado di qualificarne meglio le prestazioni di officina riparazione costruzione: “Da parte nostra abbiamo molta competenza, non abbiamo lavorato solo su un tipo di treno, ma su tutti i tipi di lavori ferroviari, abbiamo anche fatto corsi di aggiornamento per le officine Trenitalia”. “Fervet ha preso appalti anche in Germnaia con il gruppo delle Ferrovie Tedesche (Deutsche Ban). Può gareggiare in ambito europeo e lo ha fatto”. Fervet è una azienda antica per il territorio castellano: ha più di 100 anni e ancora durante la guerra la prima cellula comunista del territorio di Castelfranco Veneto si è costituita proprio in questa fabbrica. 262 Alla Fervet il livello di sindacalizzazione viene definito come “discreto , non direi buono ma discreto…buona parte dei lavoratori preferisce starne fuori e non essere iscritti..anche per questioni di ignoranza…ritengono di non esporsi….” Alla Fervet sono molti i lavoratori leghisti? “si ce ne sono parecchi…qualcuno è anche iscritto al sindacato, con noi della Fiom no..ma con altri sindacati si…” Il giudizio espresso nei confronti della categoria è molto positivo. “La Fiom fa tutto quello che è possibile fare, come delegato posso dirlo… ha fatto tutto il possibile, abbiamo fatto presentare anche una interpellanza parlamentare attraverso un deputato del PD; questa interpellanza è stata presentata dietro nostra pressione, ma su questo punto anche gli altri due sindacati ci hanno seguito”. Soprattutto in termini di presenza sindacale e di continuità nel seguire la vertenza Fervet, il giudizio dei lavoratori è molto buono: “Non ci siamo mai sentiti soli, il sindacato ci ha seguito e ci segue tuttora”. Tutti i passaggi di carattere sindacale sono stati esperiti: “Siamo stati al Ministero del Lavoro per un incontro, ci siamo incontrati con nostri dirigenti nazionali, con Rinaldini, perché si facessero carico della nostra situazione… cosa che puntualmente è stata fatta” Ben diverso è stato l’atteggiamento delle istituzioni. “Abbiamo chiesto l’intervento del Comune di Castelfranco, ad esempio per avere l’anticipo della Cassa Integrazione, ma purtroppo quanto si parla di soldi…quando si parla di soldi Comuni, Provincia e Regione non ha risposto nessuno…dicono che non ce n’è per nessuno. Ma nessuno si è defilato, a cominciare dal comune: il nostro sindaco è sempre stato attento alle nostre richieste, non è mai mancato agli appuntamenti che gli abbiamo chiesto… però di aiuti concreti ne abbiamo avuti pochi dalle istituzioni” La situazione dei lavoratori Fervet è quella tipica di lavoratori cassaintegrati, con i ritardi (ampiamente diffusi in tutte le situazioni di crisi, e per questo ancor di più inaccettabili) nei pagamenti della Cassa Integrazione: “abbiamo chiesto la Cassa Integrazione, prima ordinaria, poi quella straordinaria…adesso siamo in cassa straordinaria dal 14 aprile …e riceviamo i soldi dall’INPS mensilmente ma con ritardi: questo provoca una grossa lamentela da parte dei lavoratori. Ad esempio, oggi è il 3 novembre e stiamo ancora aspettando i soldi di settembre. Cioè lo stipendio che avremmo dovuto prendere il 15 settembre, deve ancora arrivare al 3 novembre..” “Saranno oberati di impegni negli uffici INPS, per pagare pagano… ma con questi ritardi.. questa cosa a tanti crea problemi”. “La cassa integrazione non è uguale per tutti, è diversa da individuo a indi263 viduo: alcuni la vivono in modi diversi..con molta ansia..anche perché tra noi c’è chi ha davvero bisogno di quei 800 euro, molte famiglie sono monoreddito, per questi lavoratori la Cassa Integrazione è pesantissima, hanno solo questa entrata al mese e ce lo dicono: hanno dato fondo ai propri risparmi per superare questa crisi”. La speranza viene riposta quasi esclusivamente nella gara per l’assegnazione di una ulteriore commessa: “Speriamo di vincere questa gara e di resistere fino all’assegnazione della gara..in modo che così l’anno prossimo..speriamo di ricominciare a lavorare” Tuttavia i lavoratori non rinunciano ad un ragionamento di politica industriale che, per il settore, non può che significare ragionare di intervento pubblico: “» chiaro che più il Governo investe risorse nella manutenzione treni e più si aprono prospettive. Questo per dire che essendo un settore di competenza del governo non dovrebbero esserci questi problemi…per questo diciamo che il Governo è disattento di fronte alle nostre esigenze, noi dipendiamo direttamente dalle loro decisioni e quindi ci chiediamo come mai siamo nelle stesse situazioni di altre aziende che invece con il governo non c’entrano niente…” “Perché non investono su di noi per cominciare a sanare una piccola parte dell’Italia. Fanno solo annunci in televisione, dicono che agiscono, ma noi non vediamo niente di concreto…” Il ragionamento di carattere generale su politiche industriali e interveto pubblico chiama in causa direttamente il settore dei trasporti ferroviari e il principale committente di Fervet: Trenitalia. “Trenitalia è stata sminuzzata in tante piccole aziende, non si capisce più nulla…così come sono state frammentate tutte le competenze. Ad esempio, in questa commessa Trenitalia decide di fare le carrozze, ma aspetta che sia la Regione, cioè i servizi ferroviari regionali del Veneto ad a investire in questo servizio, i quali magari aspettano i soldi dal governo…quindi il cittadino e il lavoratore a chi si rivolge? …A Trenitalia, alla Regione Veneto, … è difficile capire chi può sanare la mia situazione di lavoratore…e la stessa cosa vale per i cittadini utenti dei trasporti dei ferroviari: a chi si rivolgono? alla Regione? questa ti rimanda a Trenitalia, questa a sua volta ti rimanda al fatto che il Governo non fa investimenti…”. A questo punto è d’obbligo un approfondimento sul processo di regionalizzazione del servizio di trasporto pubblico, anche ferroviario, realizzato a partire da una legge approvata dal primo Governo Prodi: la domanda posta, quindi, è se i lavoratori del settore si sono accorti della regionalizzazione del servizio e se questa ha comportato maggiori attenzioni e maggiori risorse da investire nel settore. 264 “Assolutamente no, cioè si.. ce ne siamo accorti..ma in senso contrario… come in senso contrario sono andate le dichiarazioni di moretti di liberalizzare il mercato…ma come, tutti gli altri, a partire dai tedeschi e dai francesi, si tengono le loro aziende e i servizi di casa… e noi regaliamo tutto agli altri? soprattutto in questo settore che è così delicato, anche per il discorso della sicurezza…”. Il problema vero è quello di una continua delega di responsabilità. Il Governo delega Trenitalia, Trenitalia a sua volta delega il servizio ferroviario regionale, questo magari appalta anche ad esterni…insomma una continua delega di responsabilità e non ci si capisce più niente…” Quello che manca è una politica nazionale dei trasporti.” In questa situazione, segnata appunto dall’assenza di una politica nazionale in materia di trasporti, succede che la regionalizzazione si trasforma in una condizione caotica nella quale si scatena solo la concorrenza tra territori: “.. ciascuno tira per sé, ad esempio la Regione Veneto, o magari la Regione Emilia agiscono in un certo modo, magari nel nord ovest si muove altro gruppo, con un’altra logica…ma ciascuno cerca di tirare la coperta dalla sua parte… ma dov’è una politica di governo concreta che imponga a tutti le stesse regole?? qui si tratta di gestire risorse dei cittadini, per questo serve una quadro di regole chiare…invece succede che chi è più bravo porta a casa il lavoro e chi no rimane senza…”. Quindi la situazione attuale dei servizi ferroviari, e quindi di tutte le attività che ruotano attorno al servizio ferroviario come, in questo caso manutenzioni, riparazioni e costruzione di locomotori e carrozze, appare pesantemente segnata da alcune caratteristiche che più volte sono state segnalate nel corso dell’intervista. 1) la scelta di liberalizzazione del servizio ferroviario (dei trasporti pubblici in generale, ma orami di quasi tutti i servizi pubblici fondamentali – si pensi all’energia) attuata in maniera molto pesante in Italia senza che scelte analoghe siano state assunte da altri paesi europei. In gergo comunitario si direbbe: “senza condizioni di reciprocità”. E così i modernizzatori nostrani, per dimostrare di essere più realisti del re, hanno imposto liberalizzazioni e privatizzazioni anche laddove non sussisteva nessun obbligo normativo e, soprattutto, in situazioni che hanno visto gli altri partner dell’Unione Europea muoversi in maniera molto diversa tutelando maggiormente le aziende dei settori interessati (i cosiddetti “campioni nazionali”) e i lavoratori. 2) La scelta di regionalizzazione del servizio ferroviario non si è accompagnata ad un corrispondente trasferimento di risorse ai livelli 265 territoriali né questi hanno aumentato le risorse economiche da destinare al servizio di trasporto pubblico. L’unico risultato, quindi, è stato quello di creare un conflitto di competenze istituzionali con le Regioni contrapposte a Governo e Trenitalia nel momento di definire i contratti di servizio con l’indicazione dei servizi da realizzare e delle corrispondenti risorse economiche in grado di coprire i costi. Nessun avvicinamento della gestione del servizio e dei momenti decisionali al cittadino, ma solo un conflitto di competenze di difficile comprensione per le migliaia e migliaia di pendolari che ogni mattina utilizzano il treno. 3) La mancanza di una programmazione nazionale in grado di definire obiettivi, regole certe e livelli di servizio garantiti ha determinato una situazione di concorrenza territoriale con un ulteriore sfilacciamento del servizio e ulteriori confusioni sulle competenze decisionali e gestionali. Negli anni sono mancati programmi e investimenti che lasciano ancora aperti parecchi problemi: “un altro aspetto di cui non si parla quasi mai è quello dell’ambiente. Nessuno ne parla, ma qui si sbandiera tanto l’Alta Velocità…e poi succede che da Bassano a Trento la rete ferroviaria non è elettrificata e quindi si brucino tonnellate di cherosene… come da Montebelluna a Belluno ..anche lì succede la stessa cosa. Ma perché non vengono elettrificate queste linee e così si possono anche sviluppare i servizi regionali con treni più veloci? cioè, da Padova non è che parte il treno elettrificato e poi si cambia quando finisce la rete non elettrificata…no, da Padova parte la motrice a gasolio, per sviluppare corrente e portare il treno…quindi i viaggi dei treni a gasolio sono molto lunghi e quello lì è tutto inquinamento in più…e poi guardano solo le marmitte catalitiche, ma un treno a gasolio inquina in maniera spaventosa.” La discussione sullo sciopero dei lavoratori addetti alle pulizie delle carrozze per protestare contro la mancanza dei pagamenti degli stipendi da parte di Trenitalia (cioè, Trenitalia non ha pagato le cooperative addette alla pulizia delle carrozze e queste a loro volta non hanno pagato gli stipendi dei loro dipendenti) porta a ragionare sulle condizioni dei lavoratori di tutti i servizi connessi con il settore ferroviario. Immaginando una “filiera” del servizio ferroviario, viene da interrogarsi su quanti segmenti è stato frazionato l’intero servizio comprensivo di lavorazioni ausiliare e connesse, e, quindi, quali sono i problemi dei lavoratori di tutti questi passaggi: dal personale viaggiante, ai macchinisti, dai riparatori di carrozze ai tecnici degli impianti, dai bigliettai agli addetti alle pulizie di stazioni e carrozze. 266 Questo ragionamento va aperto per capire in quali forme siano ricomponibili quelle forme di solidarietà di classe (e quindi di iniziativa, di lotta, di rivendicazione, di organizzazione sindacale ecc.) che la frammentazione del servizio in più segmenti ha fatto saltare sbriciolandola in tante situazioni lavorative separate e non comunicanti. Gli stessi lavoratori della Fervet riconoscono questa mancanza di organizzazione: “Non abbiamo mai avuto nessuna forma di coordinamento con i lavoratori delle cooperative che fanno servizi, anzi… sembrano visti da noi come degli alieni… sono talmente lontani…oltretutto sono quasi tutti dei precari quindi c’è già li una differenza tra noi ancora a tempo indeterminato e loro che vivono una realtà ben peggiore della nostra”. Oltretutto in Fervet esiste una situazione di ulteriore frammentazione tra lavoratori: le cooperative, infatti, non si limitano ai soli servizi ausiliari (come possono essere quelli di pulizia) ma svolgono direttamente parte delle lavorazioni in capo all’azienda. Cioè in Fervet le cooperative svolgono anche parti del lavoro che dovrebbe essere svolto dai dipendenti diretti di Fervet stessa. “Le cooperative le abbiamo anche dentro la Fervet, ci hanno detto che far lavorare le cooperative era un vantaggio per noi perché i lavoratori delle cooperative erano esclusi dai premi aziendali e quindi l’azienda avrebbe speso complessivamente meno, ma un ci sarebbe stato un ritorno maggiore per noi: cioè il premio di produzione per noi dipendenti diretti sarebbe stato maggiore perché avrebbero risparmiato sul costo complessivo del lavoro attraverso l’utilizzo di queste cooperative.” L’inserimento delle cooperative nell’ambito delle lavorazioni della Fervet, quindi, è avvenuta anche con una promessa di maggiori risultati salariali per i dipendenti diretti in quanto i lavoratori delle cooperative non avrebbero partecipato alla ripartizione dei premi aziendali. Sarebbero stati esclusi da una torta, quindi, che l’azienda ha prospettato più grande per i dipendenti diretti grazie all’esclusione degli altri lavoratori delle ditte esterne. I delegati intervistati hanno avuto solo qualche contatto sporadico ed occasionale con i lavoratori delle cooperative, sufficiente, tuttavia, per rendersi conto delle condizioni nelle quali vengono costretti a lavorare: “come RSU mi è capitato di parlare con questi ragazzi e ho capito che lì dentro non tutti sono pagati nemmeno allo stesso modo, addirittura alcuni prendono 700 euro al mese…queste cooperative hanno assunto persone che hanno bisogno di assistenza sociale,…sono stati assunti solo perché vengono pagati pochissimo.” “Ne ho visti diversi lavorare…e alcuni fanno veramente pena da tanti pro267 blemi che hanno…sono persone con grossi problemi…io non li avrei fatti lavorare ma li avrei fatti curare…” Ma le considerazioni di carattere economico da parte dell’azienda, cioè il risparmio sul costo del lavoro che riescono a spuntare grazie all’utilizzo di questi lavoratori, prevalgono nettamente sulle preoccupazioni per la salute e lo stato di benessere di queste persone: “In poche parole: siccome costano poco li fanno lavorare in una cooperativa…ma tutto questo è un diastro…”. Oltre ad un trattamento salariale di gran lunga inferiore a quello dei dipendenti diretti di Fervet, i lavoratori delle cooperative sono privi dei più elementari diritti: “Non hanno nessun diritto. Lavorano anche 10 ore al giorno per prendere gli stessi soldi…. chiedevano a me il perché… magari sono persone che vengono dall’est o dall’India e hanno grande bisogno di lavorare… per questo sono sottoposti a uno sfruttamento totale, non hanno nessun diritto...”. Anche per quanto concerne i diritti più elementari, che oltretutto rappresenterebbero anche un costo assai contenuto per l’azienda, nei confronti di questi lavoratori vige l’esclusione più assoluta: “Non gli davano neanche la mensa.. che costa solo 1,5 euro…”. Nessuno di questi risulta iscritto al sindacato. Su questo andrebbe aperto un ragionamento sulla capacità del sindacato di intercettare e organizzare sindacalmente queste tipologie di lavoratori, ma indubbiamente queste difficoltà devono fare i conti con una situazione di debolezza estrema continuamente sottoposte ad un vero e proprio ricatto: “Questi lavoratori non sono nemmeno seguiti dal sindacato perché se si iscrivono li licenziano…” Questa grande differenziazione nelle condizioni di lavoro tra dipendenti diretti e lavoratori delle cooperative, che si esprimono in trattamenti salariali e normativi estremamente diversi, non trova nemmeno una giustificazione (sempre che ne esista una..) nella possibile diversità di mansioni svolte, anzi: “Fanno le stesse cose che facciamo noi, sono parti di lavorazione che sono state appaltate. “quando abbiamo iniziato a costruire i treni a due piani, dopo un po’ ci hanno spostato da un’altra parte, a fare un altro lavoro, e per continuare i treni a due piani hanno preso ditte esterne: hanno fatto ricorso agli appalti perché costano meno…”. Il timore che questo sistema dell’appalto al massimo ribasso, con le conseguenze sui lavoratori che sono state prima descritte, possa essere ripetuto anche per le prossime, auspicabili commesse, è molto forte: “se vinciamo questo appalto succederà anche in questo caso: lavoriamo due mesi e poi ci spostano da altre pareti… e per andare avanti nella commessa prendono 268 queste ditte esterne.” Si ripeterà, quindi, il sistema di sfruttamento di lavoratori senza diritti e senza tutele che fanno dire ai delegati sindacali che “…vediamo cose che offendono la dignità di chi lavora…”. Anche in questo caso una parte di responsabilità viene concentrata sulle modalità con le quali è stato realizzato il federalismo in Italia: “Buona parte di questo sfascio dipende da questo modo di interpretare l’idea di federalismo…così interpretata porta a questi danni, perché il federalismo è stato inteso come libertà di fare quello che si vuole in ogni dove, senza regola,e non abbiamo un governo capace di far rispettare regola da parte di tutti”. “Questo federalismo, fatto così, si trasforma in uno scaricabarile: chi deve investire? di chi è la responsabilità?..tutto senza risposte…”. La preoccupazione dei lavoratori Fervet si allarga anche alla vicenda del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici: “Ma in un momento come questo che motivo c’era di andare a fare un rinnovo contrattuale?! c’era già un contratto che scade nel gennaio 2012; ma adesso ne hanno fatto un altro, hanno stracciato quelle precedente e lo hanno rifatto al ribasso, prenderemo meno di quello precedente”. Viene sottolineata la strategia offensiva di Confindustria e destra di Governo: “qual era l’esigenza di fare questo nuovo contratto? lo hanno fatto approfittando di questo momento in cui la gente non riesce nemmeno ad aggregarsi perché tanti lavoratori sono a casa in Cassa Integrazione.” Anche nel trevigiano, ed in particolare nel territorio della castellana, si sono verificate tante crisi aziendali, ciascuna delle quali, però, è rimasta del tutto isolata dalle altre. Anche in provincia di Treviso, quindi, non si è creata una rete di vertenze ma tutte queste hanno proseguito il loro corso in maniera separata. Viene da chiedersi, quindi, se uno sciopero generale possa servire per mettere assieme tutti i lavoratori di Treviso: “Certo che servirebbe, ma la vedo molto difficile, qui hanno cambiato la mentalità del lavoratore. Ciascuno pensa a se stesso…le varie fabbriche lottano per resistere, ma ciascuno per proprio conto…”. Per valutare la fattibilità di una iniziativa simile non vengono taciute sia le difficoltà di carattere generale che caratterizzano il cuore del Veneto (“sapete che aria si respira qui!”) sia di carattere personale/soggettivo (“sarebbe buon periodo per farlo, ma ogni persona licenziata è come se fosse stata uccisa! con un licenziamento distruggi tutto, distruggi una famiglia…ti cambia la avita, quella dei tuoi figli…”. Anche la recente spaccatura intervenuta sulla vicenda del rinnovo contrattuale della categoria dei metalmeccanici costituisce un elemento di preoc269 cupazione per la buona riuscita di una iniziativa come quella dello sciopero generale del territorio: “Lo sciopero generale ci sembra difficile anche per la rottura sindacale che in questo momento è micidiale e segnerà il futuro. Resta da capire se la CGIL avrà la forza di reggere ed eventualmente di organizzare da sola uno sciopero del genere….» da vedere… la rottura c’è stata da poco tempo non ha ancora fatto vedere tutti gli effetti..per noi saranno molto pesanti…ovviamente noi come FIOM speriamo che la CGIL ce la faccia da sola ad andare avanti…”. Ai lavoratori Fervet vengono illustrate le proposte di legge della campagna sul lavoro presentate da Rifondazione Comunista e le campagne territoriali che invitano gli Enti Locali a sostenere i lavoratori licenziati e cassaintegrati con l’esenzione dal pagamento delle bollette e delle tariffe dei principali servizi pubblici. L’iniziativa viene accolta positivamente (“Tutto torna utile.”) ed in particolare la proposta, per la concretezza che assumere, di ridurre le spese che le famiglie sostengono per i servizi (“Ridurre queste spese andrebbe bene… io questo mese pago 115 euro solo di asilo, e poi l’acqua, il gas…”). Nei giorni precedenti l’intervista il circolo locale di Rifondazione Comunista, con il PDCI, ha organizzato un banchetto di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge e della richiesta, avanzata al Comune di Castelfranco Veneto, di istituire un fondo sociale attraverso il quale sostenere le famigli colpite dalla crisi in particolare attraverso l’esenzione dal pagamento dei servizi fondamentali. L’iniziativa ha riscosso un buon successo e anche l’attenzione del giornale locale sottolineando, in particolare, la proposta di abbassamento delle bollette e delle tariffe dei servizi locali per le famiglie colpite dalla crisi. Il timore che la crisi colpirà ancora più duro di quanto non stia già facendo è molto forte: “ in primavera inizia a scadere la Cassa Integrazione e allora si inizierà a “ballare”… tanti devono ancora entrare nell’ottica di questo…cosa succederà quando finirà il periodo di cassa per molti lavoratori?”. Cosa chiedereste a un Partito come il nostro? “Ai partiti chiedo di lavorare sulla questione sindacale, insistere perché i sindacati decidano da che parte stare, Cisl e Uil non sembrano più due sindacati, forse non lo sono mai stati,,, non sembrano dalla parte dei lavoratori sembrano d’accordo con datori di lavoro per una trasformazione di quello che è il sindacato, forse perché non riescono a reggere le strutture che hanno, talmente grosse che hanno bisogno di mezzi finanziari diversi e forse cercano la strada per avere questi mezzi…. Non vedo altro motivo, perché avrebbero dovuto, altrimenti, fare l’accor270 do con Federmeccanica e non con noi?” La rottura contrattuale avvenuta sulla vertenza dei metalmeccanici viene avvertita in maniera molto forte e preoccupata: “sul rinnovo del contratto abbiamo chiesto di aspettare, …di vedere una fase transitoria, per non stralciare il contratto nazionale adesso…e non lo hanno fatto e allo penso che ci stiano facendo fuori come Fiom…perché si sentono forti in quanto loro stanno attaccati al Governo e a Federmeccanica..stanno con i più forti in questo momento…”. “Anche la Fiom ha una grossa struttura e grosse spese…ma la Fiom non si è venduta, ha gli iscritti e mai dato un segnale per diventare un ente… o altro… mai detto niente di tutto ciò… Non ha mai prospettato di diventare un ente bilaterale… spero che questo lo capiscano i lavoratori, insomma: al sindacato ci partecipi o no, deve essere una decisone libera…., è una associazione di lavoratori alla quale io appartengo se lo voglio, pago la quota perché voglio essere affiliato e se non voglio basta…. non mi fa pagare per forza, non possono inventarsi cose per tenere il lavoratore dentro all’associazione per forza. Se c’è obbligo di iscrizione non è più sindacato… come nel fascismo...” 271 Inchiesta realizzata alla Agc Automotive di Cuneo24 “Siamo qui per fare una inchiesta. Vorremmo fare una intervista con voi…”. “Va bene, però noi siamo quassù…se ci volete intervistare salite…”. Dal tetto scende una scala, non sono pochi i metri da fare, ma ci sembra importante salire, se non altro per la curiosità di vedere cosa si prova lassù, tra bandiere, sacchi a pelo, generi di prima necessità. Ovviamente, essendo la scala non proprio corta e non particolarmente rassicurante, non riusciamo a portarci molte cose; dell’intervista riusciamo a registrare qualcosa, sufficiente però per capire la situazione che questi operai stanno vivendo, i loro obiettivi, le loro speranze e il perché di vertenze così dure. Nel primo pomeriggio dei primi giorni di ottobre, sul tetto della Agc di Cuneo con il sole si sta abbastanza bene, “ma aspetta di vedere quando va giù il sole…qui di notte non si resiste dal freddo…”. I problemi per i lavoratori della Agc cominciano a manifestarsi già sul finire del 2008. I problemi cominciano a manifestarsi lontano da Cuneo, presso lo stabilimento di Salerno che portano ad un incontro il 15 gennaio 2008, presso il Ministero dello Sviluppo Economico fra le organizzazioni sindacali, la Società Agc e i rappresentanti di Assovetro al fine di ottenere adeguate rassicurazioni circa il mantenimento dello stabilimento salernitano e la realizzazione dei necessari investimenti (realizzazione in tempi utili e certi un nuovo forno in sostituzione di quello attuale, ormai obsolteo). Ma la crisi sale ben presto anche al nord raggiungendo lo stabilimento di Cuneo. Un comunicato sindacale (Filcem) del gennaio 2009, così recita: “La Agc ( Asahi Glass Company) -colosso industriale giapponese e leader mondiale nella produzione di vetro per auto ed edilizia- è presente in Italia con due distinte società. Una, la Agc Automotive Italia srl, cui fanno capo le attività legate all’automotive, negli stabilimenti di Cuneo e Roccasecca (Fr) con 370 addetti occupati . L’altra - la Agc Flat Glass srl - cui fanno capo le attività legate all’edilizia, negli stabilimenti di Salerno e Cuneo, con circa 380 addetti occupati. E’ di ieri (20 gennaio, n.d.r.) l’incontro richiesto da Agc Automotive Italia con le organizzazioni sindacali presso il ministero del Lavoro, per esaminare la richiesta aziendale di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria 24 In collaborazione con Fabio Panero, Prc Cuneo e Salvatore de Luca, Prc Piemonte. 272 per crisi. Due le ragioni di fondo. Innanzitutto la crisi globale del settore auto che colpisce inevitabilmente anche l’ industria del vetro, che fornisce a quelle automobilistiche parabrezza, laterali e lunotti. Va inoltre aggiunta la crescente concorrenza dei paesi emergenti in grado di fornire prodotti tecnologicamente avanzati a un prezzo più basso.” “L’accordo sottoscritto in occasione dell’incontro del 20 gennaio 2009 prevede la collocazione in Cassa integrazione straordinaria di un numero massimo di 370 lavoratori a partire dal 1 febbraio 2009, per 12 mesi in concomitanza con momenti di particolare contrazione della domanda che comportino la chiusura collettiva degli impianti. Nella normale gestione della crisi saranno settimanalmente sospesi a rotazione 28 lavoratori a Cuneo e 40 a Roccasecca. Prima della collocazione in cigs dei lavoratori, l’azienda si è impegnata a raggiungere appositi accordi di gestione con le RSU di stabilimento, con l’obiettivo di minimizzarne il peso sui lavoratori e a garanzia di efficienza e sicurezza degli impianti. Prima dell’incontro al ministero del Lavoro, il Coordinamento sindacale nazionale del Gruppo si è incontrato con la Direzione aziendale. Nel condividere il giudizio sulla crisi e l’obiettivo - con il ricorso alla cigs - di mantenere competitivi gli stabilimenti senza tagli drammatici sugli organici, e senza dispersione di capacità professionali preziose, il Coordinamento sindacale ha sottolineato la necessità di guardare oltre la crisi per uscirne rafforzati. Per questo occorrono strategie, investimenti e innovazione. Su questi temi -che riguardano tanto l’automotive quanto l’edilizia e dunque anche il futuro dello stabilimento di Salerno - il Coordinamento ha chiesto di svolgere quanto prima ulteriori incontri.” Nel verbale di Accordo si legge che la Società rispetto alle prospettive produttive e alle previsioni di vendita inizialmente formulate per l’anno in corso ha evidenziato un trend marcatamente negativo a causa della crisi del mercato dell’automobile in cui la stessa opera. Il drastico ridimensionamento del mercato ed il conseguente grave calo degli ordini rappresentano una crisi senza precedenti nell’ultimo ventennio e di dimensioni ormai globalizzate che sta colpendo il mercato dell’auto sia esso di primo impianto o legato alla ricambistica”. La difficile situazione di mercato unita all’accresciuta concorrenza dei paesi emergenti in grado di fornire prodotti tecnologicamente avanzati ad un prezzo più basso complicando alla radice la concorrenzialità degli stabilimenti di Cuneo e Roccasecca evidenziando ancor più lo strato di crisi della Agc Automotive Italia.” 273 L’Agc per far fronte a questa situazione di difficoltà predispone un piano di intervento centrato sulla riduzione dei costi di quelli che definisce i “principali fattori di spesa” e cioè “materie prime, materiali di lavorazione, energia e risorse umane”. Nel corso di incontri con le Rsu negli stabilimenti interessati l’azienda prospetta il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale con la predisposizione di un piano di risanamento e rilancio definendo “gli strumenti per facilitare la gestione del personale in esubero”. Gli interventi previsti dal piano di risanamento da realizzare presso lo stabilimento di Cuneo sono incentrati sul principio della riduzione dei costi fissi e di struttura attraverso l’intervento in più aree: - quella della manutenzione attraverso l’ottimizzazione delle attività acquisite in outsourcing e la ridefinizione dei piani di manutenzione programmata al fine della riduzione dei costi; - quella della qualità con il ribilanciamento delle produzioni orientate al mercato della ricambistica piuttosto che del primo impianto con conseguente riduzione dei test di qualità da svolgere con riduzione dei relativi costi; - la riduzione dei costi energetici con interventi sui forni per il miglioramento degli scambi termici e investimenti in nuovi impianti per produzione di aria compressa, per liquidi refrigeranti ecc.; - la riduzione dei costi logistici attraverso una ottimizzazione dei depositi e dei trasporti. Il piano prevedeva anche la riduzione dei costi di produzione attraverso interventi di miglioramento tecnici ed organizzativi sulla linea di produzione dello stabilimento in maniera tale da poter conseguire valori della resa ai livelli dei miglior competitors. Nell’ambito di questo quadro di riorganizzazione, l’azienda AGC Automotive Italia, avrebbe presentato richiesta di attivazione della procedura di Cassa Integrazione Straordinaria per 370 dipendenti del Gruppo di cui 82 dello stabilimento di Cuneo (15 impiegati e 82 operai) per la durata di un anno a partire dal 1 febbraio 2009. I numeri indicati erano da riferirsi alle punte massime di contrazione del mercato e di conseguente chiusura, temporanea, delle produzioni (si sarebbe trattato, comunque, di situazione preventivate). Al contrario, in condizioni normali, il numero di lavoratori in cassa integrazione sarebbe risultato molto più basso: 68 unità complessive delle quali 28 a Cuneo. L’attuazione della cassa integrazione per Cuneo avrebbe significato la riduzione delle squadre di lavoro da quattro a tre, con una in Cassa. L’accordo prevedeva anche la gestione del personale in esubero – stimato 274 per Cuneo in 13 unità – da realizzare con gli strumenti della mobilità interna; delle possibili ricollocazioni presso altre strutture del Gruppo AGC; mobilità finalizzata alla ricollocazione, al raggiungimento dei requisiti pensionistici e ad iniziative di auto imprenditorialità; dimissioni incentivate; percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero sia in azienda che presso altre attività del territorio. Ma nel settembre 2009 la situazione precipita: l’azienda in via unilaterale, il giorno 22 settembre, annuncia alle organizzazioni sindacali e ai propri dipendenti la volontà di chiudere il reparto “laminato auto” presso lo stabilimento di Cuneo senza offrire nessuna alternativa o margini di trattativa e discussione. Per i 67 lavoratori del reparto si sarebbe trattato, quindi, degli ultimi tre mesi di lavoro: dal 1° gennaio sarebbero scattate, in ordine, cassa integrazione, mobilità e, assai probabilmente l’ingresso nella disoccupazione. La ragione addotta dall’azienda per un intervento così drastico e drammatico è unicamente di carattere economico: il reparto di Cuneo viene comparato con un reparto gemello localizzato in un paese dove il costo del lavoro è molto basso. E’ ovvio che il paragone non regge, e così il ragionamento di bilancio della multinazionale giapponese porta la Direzione a decidere di tagliare quello che costa di più e che per le casse della società rende meno. A quel punto scatta la reazione dei lavoratori che in assemblea il 29 settembre decidono all’unanimità di dare avvio alle iniziative di lotta con un presidio permanente ai cancelli della fabbrica. Ma oltre al presidio succede un’altra cosa: quattro lavoratori salgono sul tetto per aumentare la visibilità della protesta, al presidio si moltiplicano le iniziative: assemblee dei lavoratori, incontri con le istituzioni, visite di partiti, feste e concerti…E non potrebbe essere altrimenti visto che ai primi incontri l’azienda manifesta chiusura totale rispetto ad ogni ipotesi diversa rispetto al mero smantellamento del reparto. L’intenzione, quindi, è quella di non smobilitare il presidio né di scendere dal tetto fino a quando non sarà trovata una soluzione diversa. Al presidio da subito partecipa la Federazione locale del Prc, presente tutti i giorni a sostegno delle iniziative dei lavoratori. La presenza del Prc, con un comizio anche del segretario nazionale Ferrrero, è un aspetto molto apprezzato e riconosciuto dai lavoratori, alcuni dei quali, dicono chiaramente che, una volta “finito questo casino ci avvicineremo a Rifondazione…per collaborare…sono gli unici che sono qui tutti i giorni e ci danno una grossa mano”. La posizione espressa dai lavoratori è chiara: non accettano che una azien275 da di questo tipo e di queste dimensioni se la cavi con il semplice ricorso agli ammortizzatori sociali: “Troppo facile dire facciamo cassa integrazione, loro comunque hanno le possibilità…. non sono una piccola azienda…per questo noi siamo qui e non molliamo…perché loro possono fare molto di più, se solo volessero…”. Presidio e occupazione del tetto hanno un forte valore simbolico, rendono la protesta molto visibile agli occhi dei cittadini e ottiene grande spazio sui mezzi di informazione locali: “questa azienda ha un problema..che è l’immagine…se gli fai il presidio qui davanti gli tocchi l’immagine…hanno sempre voluto far vedere che qui era tutto bello, magari per avere delle agevolazioni, …qui va tutto bene, assumeremo ancora…così dicevano sempre!”. Anche in questo caso i lavoratori si sono fatti carico di situazioni in cui l’azienda chiedeva loro ulteriori sacrifici: “Qui i lavoratori hanno sempre dato grande disponibilità a lavorare e ..su quello che chiedeva l’azienda. Ad esempio, qui si facevano i 15 turni…ma poi ci hanno detto che per essere competitivi sul mercato bisognava aumentare la produzione: e così i turni sono diventati 21, anche sabati e domeniche al lavoro…”. Quello che è successo è stato per molti un fulmine a ciel sereno: “Sembra impossibile: nel penultimo anno non si poteva nemmeno andare in ferie… perché bisognava lavorare…e poi in quest’ultimo anno sono partiti con sei mesi di cassa integrazione e adesso vogliono i licenziamenti? Ci hanno munto per bene e adesso ci mollano…”. “eppure le cose le sapevano e le hanno tenute nascoste…ma loro lo sapevano…hanno tenuto nascosto per poi imporre la loro soluzione sperando che la gente si rassegnasse e dicesse eh, vedremo…qui invece i lavoratori si sono arrabbiati!”. “la gente non molla, anche giù al presidio non mollano, anche perché l’azienda è troppo vaga..agli incontri non fanno altro che dire vedremo, ci impegneremo, faremo in modo di salvare più gente possibile…ma non dicono mai niente di certo!”. “una azienda così non può dire solo cassa integrazione e mobilità, se vogliono possono fare molto di più…è su questo che noi picchiamo, vogliamo che facciano molto di più, e loro possono farlo!”. “Fino a quando non cambia questa cosa noi da qui non scendiamo…e qui si sta male, speriamo di scendere il prima possibile, ma vogliamo delle cose concrete…”. La reazione degli altri lavoratori, quelli occupati negli altri reparti, al momento non toccati dalla ristrutturazione aziendale e occupazionale avviata dall’azienda, è stata positiva: “Anche perché questa non è una grossa azien276 da…siamo 280 – 300 lavoratori…bene o male ci si conosce tutti… e tutti sono venuti al presidio…a darci sostegno”. » diffusa anche la sensazione che l’intervento dell’azienda sul reparto del “Laminato Auto” possa rappresentare un preludio ad un intervento molto più ampio, in grado di coinvolgere anche gli altri reparti: “Questo è possibile..è un rischio che ci può essere…quando hai che fare con queste multinazionali non sai mai cosa decidano di fare, non sai mai cosa hanno in testa…”. “Anche sul forno, per produrre il vetro, potrebbero esserci problemi… adesso ha già il magazzino pieno, dovrà essere revisionato tra qualche anno…e noi sappiamo che in Russia c’è già un forno pronto, deve solo essere acceso per funzionare e produce il doppio di questo…Anche in Algeria ci sono impianti e lì produrre il vetro costa la metà che da noi...”. Quindi il rischio che prima o poi la stessa succeda anche agli altri reparti dello stabilimento è forte e fondato. Dal punto di vista delle istituzioni locali, il consigliere comunale del Prc, Fabio Panera, sottolinea l’atteggiamento del Comune di Cuneo: “I Comuni non possono solo favorire queste multinazionali e non chiedere niente in cambio. Quando queste aziende chiedono varianti al piano regolatore, autorizzazioni…arriva sempre tutto…e poi in un minuto decidono di andarsene. I Comuni devono fissare degli impegni chiari: quando queste multinazionali chidono dei permessi devono assumersi degli impegni…” Un comunicato sindacale da notizia della sottoscrizione di un primo verbale: “A seguito della comunicazione fatta da AGC nel coordinamento nazionale del 22 settembre, relativa alla situazione del settore negli stabilimenti italiani e soprattutto nello stabilimento di AGC Automotive Italia di Cuneo, si è tenuto ieri l’incontro in Assovetro e si è realizzato un verbale di accordo tra le Parti, funzionale e propedeutico all’avvio del confronto in sede territoriale. Con questo verbale, costruito e condiviso con le nostre stesse strutture provinciali ed RSU di Cuneo, si è inteso definire un accordo quadro di riferimento, contenente criteri, modalità e priorità, affinché il confronto che si terrà sul territorio possa svolgersi all’interno di una impostazione non solo condivisa, ma soprattutto orientata alla migliore gestione dei problemi emersi e delle loro conseguenze. In particolare si è cercato di inserire tutti quegli elementi utili a ridurre al minimo l’impatto sull’occupazione e sulle ricadute sociali, guardando anche alle prospettive e a non lasciare intentata nessuna possibilità per consolidare il lavoro esistente e creare nuove opportunità. Naturalmente, come sopra detto, ora inizia il lavoro più difficile che è fatto di tempi, percorsi, garanzie, impegni e costruzione di un accordo complessivo che sappia rispondere alle nostre priorità, che riguardano il “lavoro” e i lavoratori. In allegato vi trasmet277 tiamo il citato verbale di accordo.” Nel verbale di accordo del 7 ottobre l’azienda giustifica i propri interventi con la fase congiunturale di crisi del mercato del vetro ed in particolare del vetro per l’auto e per l’edilizia. Le prospettive sul 2010 inducono l’azienda a prospettare un piano di intervento che per lo stabilimento di Cuneo prevede “Il completamento del piano di mobilità in corso pari a 11 unità volto alla riduzione delle strutture aziendali”; per la Linea Flat Gas l’attivazione della cassa integrazione ordinaria per compensare le insaturazioni produttive delle linee di trasformazione (coater, laminatoio per l’edilizia e mirror); per la Linea Automotive, invece, l’intervento si presenta più complicato. Nel corso degli ultimi due anni, infatti, l’organico della linea è stato ridotto da 92 a 67 unità attraverso il mancato rinnovo di contratti a termine e trasferimenti presso la società del gruppo Agc Flat Glass stabilimento di Cuneo. L’intenzione dell’azienda di fermare l’attività produttiva del reparto Laminato Auto viene giustificata dall’azienda facendo riferimento a tre cause: la crisi economica del settore Oem auto motive (vendita auto nuove): lo stabilimento di Cuneo produce il 25% di prodotti propri (parabrezza) destinandoli al mercato Oem (Original Equipment Manifacturing). Al riduzione della vendita di questo prodotto, e la conseguente mancata saturazione delle linee produttive, ha indotto la società ad avviare una ottimizzazione delle produzioni attraverso la concentrazione del prodotto destinato al mercato Oem negli stabilimenti europei che per struttura impiantistica e organizzazione sono specializzati e interamente votati alla produzione dell’Oem stesso. Al contrario, lo stabilimento di Cuneo è votato principalmente alla produzione di parabrezza destinati al mercato Arg (Automotive Replacement Glass). La seconda causa viene indicata nella crisi del mercato Arg nel quale, appunto, sono specializzate le produzioni di Cuneo. Il terzo fattore di crisi viene individuato in quella che viene definita come la “agguerrita competizione di produttori presenti in paesi, quali ad esempio la Cina o l’India. Una sempre maggiore quota di ordini di nostri clienti si sta spostando verso questi produttori che riescono a consegnare ai nostri clienti i loro prodotti a dei prezzi che per gli stabilimenti italiani risultano difficilmente praticabili”. Il risultato portato a casa dai sindacati in questo accordo è quello che stabilisce che “gli interventi complessivi che si renderanno necessari sulla linea produttiva vetri per auto di Cuneo dovranno essere assunti con l’obiettivo di ridurre al minimo ricadute sull’occupazione. In tal senso la Agc si adopererà, con il concorso delle OO.SS. per esaminare e attivare tutti gli strumenti ed interventi necessari comprese tutte le possibili integrazioni produttivo-organizzative con il settore Flat Glass al fine di ogni migliore opportunità per minimizzare i disagi. La Agc si attiverà per ricercare 278 ogni possibile incremento dei turni produttivi nel sito di Cuneo. La Agc si adopererà inoltre al fine di ricercare ogni possibile nuova attività e/o diversificazione produttiva compresi processi di insourcing compatibilmente alle esigenze tecnico – organizzative e valutare gli impegni contrattuali in essere”. I lavoratori continuano a tenere botta tanto ai cancelli quanto sul tetto, ma uno dei quattro operai in cima viene colto da un malore e viene recuperato dai Vigili del Fuoco per essere trasportato in ambulanza all’ospedale. Forse anche per la drammaticità questi passaggi la trattativa subisce una accelerazione: ormai si discute ad oltranza per arrivare ad un accordo. E finalmente nella notte questo viene sottoscritto. Il comunicato sindacale così presenta il risultato conseguito: “Preceduto da una intesa nazionale e da una forte mobilitazione sindacale è stato raggiunto lo scorso 20 ottobre un importante accordo sindacale per la gestione della crisi aziendale presso lo stabilimento di Cuneo della multinazionale giapponese del vetro AGC Automotive Italia srl. La chiusura dello stabilimento cuneese del Gruppo apriva per 67 lavoratori la prospettiva del licenziamento al termine della CIGS per crisi in scadenza il prossimo febbraio 2010. L’accordo consente, al contrario, di offrire all’insieme dei lavoratori una ben diversa prospettiva. Con il coinvolgimento nella gestione della crisi di altra società del Gruppo presente a Cuneo - la AGC Flat Glass Italia srl - sarà possibile ricollocare buona parte dei lavoratori. Per altri sarà possibile su base volontaria e incentivata l’accesso alla mobilità. Ove questi strumenti non fossero sufficienti le parti hanno concordato che il rimanente personale verrà comunque ricollocato presso AGC Flat Glass dove si potrà anche fare ricorso al contratto di solidarietà pur di evitarne il licenziamento. L’accordo è stato approvato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori interessati.” L’accordo nello specifico prevede i seguenti passaggi. La chiusura del reparto “Laminato Auto” entro il 31 dicembre 2009 viene confermata come “irrevocabile” da parte dell’azienda “per via dell’assenza delle condizioni minime di competitività industriale e dunque di mercato che permettano di ristrutturare (…) attività di lavorazione del vetro per la produzione di parabrezza”. A fronte di un esubero di 67 lavoratori, conseguente alla decisone di chiudere il “Laminato Auto” e dando atto della ferma contrarietà opposta a tale soluzione da parte delle organizzazioni sindacali, viene ribadita la posizione già espressa in occasione dell’accordo quadro precedente. 279 L’obiettivo generale, quindi, viene confermato quello di “esaminare e attivare tutti gli strumenti ed interventi necessari al fine di ricercare ogni migliore opportunità per minimizzare i disagi ai lavoratori in esubero. Inoltre l’Agc ha dichiarato la sua disponibilità a ricercare ogni possibile ogni possibile nuova attività e/o diversificazione produttiva compresi processi di insourcing compatibilmente alle esigenze tecnico – organizzative”. Adesso si tratta di verificare come nel concreto questo obiettivo generale si è tradotto in interventi specifici. L’azienda incrementerà le attività dell’unità produttiva “Laminato Piano” introducendo così un terzo turno, attività accessorie a completamento dell’orario di lavoro assorbendo 5 posizioni in esubero. L’azienda effettuerà un investimento di 1.500.000 euro per la creazione di una nuova attività produttiva presso l’Agc Flat Glass Italia assorbendo sette posizioni in esubero da Agc Automotive Italia. L’azienda rafforzerà il servizio di manutenzione presso Flatt Glass Italia assorbendo una posizione in esubero. L’azienda trasferirà presso l’organizzazione Flat Glass di Cuneo 14 esuberi da Agc Automotive a seguito delle previste uscite del personale della Flat Glass per pensionamenti immediati o nel corso del periodo di mobilità. L’azienda prevede complessivamente quattro collocamenti i mobilità finalizzati alla pensione. Si tratta quindi di 31 posizioni che trovano una soluzione con gli interventi descritti. Le parti, inoltre, si impegnano ad esperire due procedure di mobilità (una per Agc Flat Glass e l’altra per Agc Automotive) con l’impegno dell’azienda a collocare in mobilità in mobilità i lavoratori che riusciranno a ad accedere al trattamento pensionistico immediatamente o nel corso del periodo di mobilità. Le parti, inoltre, si impegnano ad attivare un programma di cassa integrazione straordinaria in deroga della durata massima di un anno a partire dal 1 febbraio 2010, valutando però tutti gli strumenti utili per prorogarla ulteriormente. Questi sono gli elementi essenziali dell’accordo, a cui si aggiungono l’anticipo del TFR a richiesta, la garanzia dell’anticipo della Cigs e diverse forme di incentivazione all’esodo. Merita di essere ripreso il passaggio in cui si precisa che “Qualora il suddetto piano non raggiunga completamente gli obiettivi di gestione per tutti i 67 lavoratori in forza Agc Automotive Srl, l’azienda si impegna al termine del periodo di C.i.g.s. autorizzato a non promuovere iniziative non concordate e traumatiche sul paino occupazionale nei confronti dei dipendenti eventualmente ancora in esubero, individuando tra le 280 parti strumenti industrialmente percorribili quali a titolo esemplificativo (…): ulteriore potenziamento dei turni e/o nuove attività produttive; recupero di attività a suo tempo esternalizzate; modifiche organizzative nell’ambito dell’area Flat Glass”. In definitiva un accordo che cerca di recuperare il più possibile per ridurre il numero di esuberi e che, tra cassa integrazione e mobilità finalizzate al pensionamento cerca di gestire che non rientra tra le 31 posizioni lavorative reintegrate. L’ultimo passaggio è quello che potrà riaprire momenti di conflittualità qualora la situazione, al termine del piano, presenti ancora elementi di esubero occupazionale. Resta, purtroppo, il dato di fatto, riscontrato in molte altre vertenze, della riduzione complessiva dei posti di lavoro del territorio che fa dire ai lavoratori protagonisti della lotta “la battaglia è finita, non possiamo parlare di vittoria perché in battaglie come questa si esce sempre sconfitti, da qualunque parti la guardi ti resta sempre un profondo senso di fallimento e sconfitta”. 281 Una iniziativa politica concreta: la campagna per il lavoro nelle Regioni del Nord Quando ha preso avvio la riflessione e la discussione su una campagna per il lavoro, siamo partiamo dai dati, impressionanti, delle ore complessive di Cassa Integrazione (ordinaria e straordinaria) registrate nel mese di settembre nelle principali Regioni del Nord. Piemonte: 14,4 milioni di ore; Lombardia quasi 40 milioni; Veneto: 9,2; Emilia Romagna: 8,2. In totale le quattro principali Regioni del Nord hanno oltrepassato la cifra di 70 milioni di ore di cassa integrazione su un totale nazionale di 104. Questo significa che il 70% della cassa integrazione si concentra in questa area geografica che, essendo quella maggiormente industrializzata e interessata dallo sviluppo della manifattura, oggi paga il prezzo più pesante alla crisi in corso. Finché è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali, la situazione sembra reggere, seppur con l’obbligo di stringere la cinghia; ma quando scadranno i termini per la fruizione della Cassa (12 o 24 mesi), allora saranno guai. Le 70 milioni di ore di cassa (magari destinate a crescere in questi mesi) potrebbero tradursi in vera e propria disoccupazione. E’ proprio nelle regioni del Nord, quindi, che la crisi sta picchiando in maniera durissima: con il ricorso alla cassa, la chiusura di imprese, l’incertezza circa la ripresa o meno del lavoro. Rifondazione Comunista intende sviluppare nei prossimi mesi, nella maniera più continuativa e capillare possibile, una forte iniziativa politica per contrastare gli effetti sociali della crisi sul mondo del lavoro a partire da queste Regioni, dove la crisi sta colpendo nei termini che sopra si richiamavano, e dove nessuna forza politica, a partire dalla Lega Nord, si sta occupando dei lavoratori e delle loro famiglie. Questa iniziativa prevede la presentazione di proposte di legge nei Consigli Regionali, sostenute da petizioni popolari. Si tratta, pertanto, di obiettivi concreti, la cui approvazione ed attuazione consentirebbero di intervenire in maniera efficace sugli aspetti più negativi, dal punto di vista sociale, della crisi in corso. Le proposte di Rifondazione riguardano sia gli aspetti più specificamente sociali, sia strumenti di possibili politiche industriali. Abbiamo cercato infatti, di tenere insieme due aspetti che oggettivamente sono inscindibili: la risposta immediata ad un bisogno sociale sempre più 282 urgente e pressante per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie; e la definizione di un possibile ruolo del settore pubblico in economia per orientare, in maniera efficace politiche economiche e industriali. Su quest’ultimo punto ci pare necessario un approfondimento in quanto riteniamo che proprio da questo – la ripresa di politiche industriali e di politiche economiche guidate e realizzate dal pubblico – passi il discrimine tra un approccio populista ed uno realmente di sinistra alla crisi in corso. Ci spieghiamo meglio: seppur in maniera insufficiente, con ampi margini di discrezionalità assegnati al Governo, neppure la destra nega l’esigenza di mettere a disposizione risorse per far fronte alla crisi in corso. E’ indubbio che lo stia facendo in maniera insufficiente (basti pensare alle misere cifre che da mesi percepiscono i cassaintegrati, o al fatto che i costi dei servizi fondamentali – servizi sociali, scuola, bollette ecc – non accennino a diminuire se non in maniera irrisoria); ma anche la destra sostiene la necessità degli ammortizzatori sociali ecc. Quello che la destra non può dire è che al pubblico va assegnato un ruolo preciso in economia, che non può essere solamente quello del “tampone sociale” a fronte dei fallimenti del capitalismo. Riteniamo, invece, che dotare il pubblico di strumenti per contrastare le delocalizzazioni industriali, per acquisire le imprese che chiudono e rilanciarle, per orientare reindustralizzazioni e riqualificazioni produttive, sia il vero obiettivo da perseguire per poter credibilmente perseguire risultati di carattere occupazionale, sociale, ambientale e industriale. Si tratta cioè, di non limitarsi al sostegno sociale – seppur doveroso e fondamentale come risposta immediata – di chi perde il lavoro, ma di intervenire per garantire il lavoro, per difendere quello che c’è o per crearne di nuovo. Da qui le proposte, presentate attraverso lo strumento delle leggi regionali sostenute attraverso le petizioni popolari. Che riguardano i seguenti ambiti. Il blocco dei licenziamenti. Si tratta di una misura richiesta anche dalla Fiom in occasione del confronto con Federmeccanica per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici. Il blocco dei licenziamenti opererebbe per la durata di 36 mesi consentendo, quindi, alle imprese di ricorrere esclusivamente ai Contratti di solidarietà e alla Cassa integrazione straordinaria. Il contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni produttive (e della conseguente riduzione dei livelli occupazionali). Il fenomeno dello spostamento geografico, totale o parziale, delle attività produttive verso altri Paesi, denominato “delocaliz283 zazione”, ormai da molti anni si estende in tutta Europa, causando, di fatto, una condizione di continua “ricattabilità” nei confronti degli Stati in cui le imprese a rischio di delocalizzazione sono collocate. In questo quadro le organizzazioni sindacali, e le istituzioni, il più delle volte non possono far altro che “gestire” i licenziamenti in massa di lavoratori che si trovano, loro malgrado, a dover competere sul piano economico, normativo e retributivo, con manodopera di altri Paesi (tendenzialmente in via di sviluppo), competizione impari che risulta essere sempre conveniente alle sole imprese. Per questo si rende necessaria e urgente una legge che renda il “pubblico” capace di dare risposte tramite interventi concreti: riconsegnare agli enti locali la possibilità di gestire questi processi. Il progetto di legge presentato dai compagni piemontesi e ripreso da Veneto e Friuli Venezia Giulia, prevede di contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni attraverso strumenti concreti quali: - l’obbligo di restituzione alla Regione di tutti i contributi pubblici ricevuti in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero, anche qualora la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o attività produttive o attraverso appaltati ad aziende terze, se a queste operazioni consegue riduzione del personale dell’azienda; - l’introduzione, per legge, del vincolo sulle aree occupate da attività produttive che le destini ad uso esclusivamente produttivo/industriale. Viene previsto che, in analogia con la legge sugli incendi boschivi dolosi, in caso di delocalizzazione, cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, e trasferimento dell’impresa, di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, il vincolo urbanistico viene mantenuto sulle suddette aree per almeno 15 anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso. Per evitare che le aree che ospitano attività produttive diventino oggetto di speculazioni urbanistiche (con la decisione di cessare le attività produttive per lucrare sulla vendita e sulla trasformazione d’uso di dette aree), si rende necessaria, quindi, una norma che, giustificata con il carattere dell’eccezionalità, consenta di vincolare ad uso esclusivamente produttivo/industriale le aree attualmente occupate da dette attività. Nel progetto di legge, una parte centrale è costituita dai contratti d’insediamento che consistono nella definizione di accordi “pubblico - privato”, finalizzati al riconoscere incentivi economici, a quelle realtà che, fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali, si impegnino a stabilizza284 re i rapporti di lavoro ed a non delocalizzare per almeno 25 anni, dal momento dell’erogazione dei contributi, l’azienda stessa, sanzionando la violazione del patto con la restituzione dei finanziamenti ricevuti. L’estensione della Prodi bis anche alle imprese di dimensioni inferiori in modo da definire uno strumento normativo in grado di salvare e rilanciare le Imprese in caso di crisi aziendale. Non è il caso di ripetere le ragioni che hanno portato nelle Regioni del Nord, con particolare accentuazione in alcune di esse, allo sviluppo di un tessuto di piccole e medie imprese spesso operanti in condizioni di contoterzismo nei confronti di quelle di dimensioni maggiori, anche multinazionali o estere. Si tratta delle imprese maggiormente esposte agli effetti della crisi anche per l’intrinseca debolezza del modello stesso. Pur non nutrendo nessun tipo di simpatia per il modello delle PMI, nell’ambito della crisi e dei suoi effetti sociali, si impone un intervento concreto in grado di dar risposte concrete alle crisi aziendali e occupazionali in atto. Per questo, uno dei compiti prioritari e strategici di una forza di sinistra è quello di fare in modo che il pubblico faccia sopravvivere quel tessuto di aziende, per nulla decotte, che possono avere un loro posizionamento nel mercato globale, ma che in questi mesi saranno a rischio. L’affidare al sistema bancario questo compito è altrettanto ridico che l’affidare ai prefetti il controllo del sistema bancario. E’ necessario, quindi, definire in quali forme e nel concreto può operare l’intervento pubblico . In sintesi si tratterebbe di una estensione e semplificazione della Legge 290 del 1970, comunemente chiamata “Prodi Bis”, che consentirebbe di nominare dei commissari pubblici anche per le aziende medie/piccole, e non solo, per le aziende con più di 200 dipendenti. Commissari che, portando le aziende in crisi di fatto in una sfera pubblica, abbiano il potere di congelare i debiti pregressi e di creare le condizioni strutturali per permettere la continuità produttiva e occupazionale. Una politica dunque che tuteli i lavoratori , anche indipendentemente dalle volontà delle banche. Così facendo l’attività produttiva non si fermerà completamente, creando i presupposti perché varie aziende non siano annullate definitivamente dalla crisi. E abbiano possibilità di rilancio nel medio periodo. In realtà già ora questo avviene per le grandi aziende, come è stato per la Parmalat, ma solitamente questi commissari, non avendo alcuna indicazione e sostegno pubblico, si riducono ad essere dei liquidatori delle aziende 285 in crisi. Per questo va accompagnata la proposta di una estensione della Prodi Bis, con la costituzione di un Fondo di Garanzia per il Lavoro regionale che abbia il compito di dare un adeguato sostegno ai commissari, nel loro ruolo pubblico di ristrutturazione aziendale ed un chiaro indirizzo politico di mantenimento delle attività produttive e dei livelli occupazionali. L’estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie di lavoratori che attualmente ne sono escluse. Da parecchi anni a questa parte le leggi Finanziarie prevedevano tutte il medesimo articolo: “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di XXX milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione (…) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 200XX, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il XXX ……”. Anche l’Accordo del 2009 tra Governo e Regioni appare viziato dal medesimo e forte limite: già all’articolo 1, infatti, le Parti riconoscono che “il sistema degli ammortizzatori in deroga non rappresenta una riforma degli ammortizzatori sociali né una devoluzione della funzione, ma costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità della attuale situazione economica.” In sintesi, quindi, in Italia manca una normativa organica in materia di ammortizzatori sociali il cui riconoscimento risulta fortemente differenziato ma seconda delle tipologie di impresa e di contratto di lavoro. Per questo motivo occorre una proposta normativa che ridefinisca in maniera organica e complessiva la materia degli ammortizzatori allargando la platea dei soggetti titolari degli stessi a tutti i lavoratori. La proposta avanzata è che le Regioni si facciano promotrici, con il potere di iniziativa legislativa che è a loro riconosciuto dalla Costituzione, di una riforma degli ammortizzatori sociali in grado di garantire che in caso di sospensione dell’attività lavorative, si applichi a tutti i lavoratori, eliminando la durata dell’applicazione degli strumenti di ammortizzazione sociale, considerandoli terminati solo al momento dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro. 286 Il riconoscimento del marchio “Made in Italy” soltanto ai prodotti realizzati per il 90% del loro valore in Italia. Tale provvedimento deve prevedere espressamente che solo tali prodotti possono fregiarsi del marchio “Made in Italy”. Questa normativa deve perseguire le finalità di: - salvaguardare la trasparenza della filiera produttiva; - introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti; - allargare anche ai produttori stranieri l’obbligo di indicare dove è stata prodotta la merce. L’obiettivo principale di questo intervento deve essere quello di perseguire: - il mantenimento in Italia delle produzioni tipiche del Made in Italy contribuendo ad evitare il fenomeno delle delocalizzazioni produttive; - conseguenza di cui sopra: tutelare i livelli occupazionali ed il mantenimento di attività produttive spesso caratterizzate da elevata professionalità, competenze, esperienza ecc.; - la tutela dei consumatori attraverso la precisa indicazione dei Paesi di produzione. Il Superamento della L. 30 e della precarietà per riunificare il mondo del lavoro, semplificando e unificando le tipologie contrattuali, stabilendo che la forma tipica del contratto di lavoro è quello a tempo indeterminato e, quindi, introducendo severi limiti all’utilizzo di contratti a tempo determinato, al sistema degli appalti, della cessione del ramo di impresa e della fittizia separazione tra imprese dello stesso gruppo. Anche in questo caso andrebbe attivato il potere di iniziativa legislativa riconosciuto in capo al livello regionale. Introdurre un reddito sociale per inoccupati, precari quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale, esentando totalmente i beneficiari dal pagamento del ticket sanitario riducendo del 50% dei servizi di trasporto e quelli sociali, educativi e formativi e con forme di sostegno al pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa. L’Introduzione di strumenti di Politica industriale attraverso la costituzione di una società pubblica regionale incaricata di realizzare interventi attivi di reindustrializzazione, riqualificazione e riconversione industriale con la finalità di realizzare politiche industriali finalizzate all’occupazione e alla qualificazione del tessuto produttivo. 287 Appendice Tre proposte di legge presentate dal Prc nelle Regioni del Nord Il blocco dei Licenziamenti Il Consiglio Regionale della… Considerato che: - - l’attuale crisi economica sta determinando pesantissime conseguenze sociali, rappresentate, in particolare, dall’aumento dei licenziamenti individuali e collettivi; il ricorso al licenziamento rappresenta una misura estremamente negativa dal punto di vista sociale anche per l’interruzione definitiva del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore; si rende necessario sospendere il ricorso ai licenziamenti al fine di consentire che adeguati interventi di politica industriale ed economica permettano di uscire rapidamente dalle condizioni di crisi lasciando inalterato il patrimonio occupazionale esistente; esistono strumenti, quali i Contratti di Solidarietà e la CIG, che consentono di gestire la fasi di difficoltà produttiva, di riorganizzazione, di riqualificazione e riconversione industriale/produttiva senza produrre conseguenze drammatiche come quelle rappresentate dal ricorso ai licenziamenti; tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Regionale della…..invita il Parlamento a discutere ed approvare in tempi brevi una proposta di legge del seguente tenore: Proposta di legge finalizzata ad evitare il ricorso ai licenziamenti nell’attuale fase di crisi economica Art. 1 Al fine di tutelare i livelli occupazionali e di evitare che le condizioni di difficoltà economico – finanziarie determinate dalla particolare situazione internazionale per le imprese si traducano nell’assunzione di provvedimenti di licenziamento, per la durata di mesi 36 dall’approvazione delle presente legge risulta sospesa l’applicazione degli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. 288 Nel caso in cui le condizioni di mercato, processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale, difficoltà di carattere finanziario con conseguenze sui livelli produttivi determinino eccedenze di personale, queste devono essere gestite, per la durata di 36 mesi dall’approvazione della presente legge, esclusivamente attraverso gli strumenti, indicati in ordine di utilizzo prioritario: ● dei Contratti di Solidarietà per le imprese in regime di C.I.G.S. di cui alla L.863/84 e per le imprese non rientranti nei regimi di C.I.G.S. di cui alla L. 263/93; ● della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di contrasto alla delocalizzazione delle imprese e alla dismissione delle attività produttive Art. 1 (Finalità) 1. Con la presente legge la Regione …….., nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio ……. e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. 2. La Regione …….. riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza. 3. Promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo d’incentivo o finanziamento. 4. Definisce criteri di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale. 289 5. La Regione ……., di concerto con province e comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici e ai lavoratori al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva. Art. 2 (Applicazione della norma) 1. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento a sostegno dell’occupazione o dell’imprenditorialità. Art. 3 (Revoca dei contributi pubblici) 1. Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all’occupazione, a qualunque titolo erogato dalla Regione ….. alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell’azienda in questione. 2. La restituzione delle somme di cui sopra, avviene anche in caso di: b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall’erogazione del contributo; c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 3. Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare alla Regione, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio. 4. Se l’erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste ai commi 1, 2 e 3. Art. 4 (Contratti di insediamento) 1. Gli incentivi alle imprese che si accingono a insediarsi sul territorio ……., sono accompagnati da obblighi contrattuali d’insediamento. 2. I contratti tra imprese e Regione ……. sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono: a) il piano industriale e di sviluppo dell’impresa; 290 b) l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento; c) l’assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime; d) l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro tre mesi dall’avvio dell’attività; e) il Piano di Sicurezza previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); f) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui alla lettera c), finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale. 3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi; gli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 4. In deroga ai criteri definiti al comma 2, lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e esclusivamente nell’ambito della provincia di appartenenza o nell’ambito di una distanza non superiore a 20 km rispetto all’ubicazione dello stabilimento, fermo restando il vincolo ineludibile all’aumento e/o al mantenimento dei livelli occupazionali. 5. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo. Art. 5 (Entità e criteri per l’accesso ai contributi) 1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell’entità dell’incentivo stesso, sulla base dell’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate 291 Art. 6 (Verifica in itinere) 1. Le imprese che sottoscrivono contratti d’insediamento con la Regione ……., sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo. 2. L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso. 3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari e agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Art. 7 (Base economica) 1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all’articolo 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge. Art. 8 (Modalità di restituzione dei contributi) 1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito: a) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione; b) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze; c) con la restituzione monetaria entro un anno delle erogazioni ricevute. Art. 9 (Vincoli alla destinazione d’uso delle aree produttive/industriali) Le aree destinate ad attività produttive ed industriali non possono avere una destinazione diversa da quella attuale per almeno quindici anni dall’approvazione della presente legge; i comuni sono pertanto obbligati ad apportare modifica automatica agli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio stabilendo quale vincolo gravante su dette aree la loro esclusiva destinazione d’uso a tali finalità. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell’impresa, 292 di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, il vincolo urbanistico di cui sopra è esteso a 20 anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone devono essere espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell’atto. Sono consentiti cambi di destinazione d’uso soltanto nel caso in cui l’impresa che decida il trasferimento apra una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di 20 km rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva già in essere, e che tale nuova apertura consenta l’impiego di tutte i dipendenti dell’unità produttiva trasferita. Art. 10 (acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali) In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all’articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili ad essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustralizzazione per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali. Art. 11 (Verifica di applicazione delle legge) 1. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge. Proposta di legge per la costituzione di una società regionale per la riqualificazione e la riconversione industriale Art. 1 (Istituzione dell’Istituto Regionale per la Riqualificazione e la Riconversione Industriale) 1. E’ costituito, mediante trasformazione di Finlombarda Spa, l’Istituto Regionale per la Riqualificazione e la Riconversione Industriale. 2. Accanto alle funzioni già esercitate da Finlombarda Spa, a tale Istituto compete l’acquisizione di imprese per le quali viene dichiarata la cessione, 293 la cessazione, anche parziale, di attività produttiva, il fallimento, la delocalizzazione e il trasferimento dell’impresa, la cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio. 3. Tale acquisizione deve essere seguita dalla predisposizione di un Piano Industriale, preventivamente discusso con le Parti Sociali, finalizzato al mantenimento, al riavvio e alla rideterminazione dell’attività di impresa con l’obiettivo prioritario di mantenere, valorizzare e possibilmente espandere i livelli occupazionali di ciascuna unità di impresa trattata. 4. L’acquisizione di aree, impianti, dotazioni patrimoniali afferenti alle unità di impresa di cui al comma precedente, avviene con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità. 5. Con successivo atto, da assumere entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Consiglio Regionale è chiamato ad approvare lo Statuto dell’Istituto Regionale per la Riqualificazione Industriale, il suo regolamento sul funzionamento e l’organizzazione ed il primo piano – programma di intervento. 294 NOVITÀ EDIZIONI PUNTO ROSSO 1969/2009 A QUARANT’ANNI DALL’AUTUNNO CALDO Dalle lotte dei lavoratori e degli studenti alla strategia della tensione Atti del convegno . Milano 6 novembre 2009, Palazzo Marino, Sala Alessi RELAZIONI DEL CONVEGNO Basilio Rizzo, Vladimiro Merlin, Franco Calamida, Lidia Menapace, Mario Capanna, Giorgio Cremaschi, Giorgio Galli, Federico Sinicato, Saverio Ferrari, Emilio Molinari APPENDICI Appendice storica Cronologia 1960-1980 di Fabrizio Billi Sindacati e lotte operaie di Carmelo Adagio Dal grande progetto rivoluzionario alla negazione intransigente. I movimenti studenteschi del ’68 e del ’77 di Marica Tolomelli “Donna è bello”. Il movimento femminista degli anni settanta di Pina Sardella Documenti dalle lotte operaie e studentesche Documento di Avanguardia Operaia sui Cub, Volantino di costtuzione del Cub Borletti, Volantino Cub Atm, Esperienze del Cub Pirelli, Volantino Cub Pirelli, Volantino Cub Recordati, Da “Voci dell’Atm” Documenti sulla Strategia della tensione Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri. Reparto Anti Eversione. Oggetto: verbale di sommarie informazioni rese dal Senatore a vita Paolo Emilio Taviani, nato a Genova il 6/11/1919, residente a Roma Via Asmara nr 34, 4° P, quale persona informata sui fatti. Roma, 7 settembre 2000. Stralcio Sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, dr. Guido Salvini. PARTE QUARTA. Gli attentati del 12 dicembre 1969 e l’attentato di Giancarlo Bertoli dinanzi alla Questura di Milano il 17 maggio 1973. Capitolo 41 Piazza Fontana, quella verità da non dimenticare. Intervista di Luciano Lanza a Guido Salvini Date, luoghi e vittime Appendice fotografica Collana Archivio Storico della Nuova Sinistra “Marco Pezzi”, pagg. 252, 12 Euro. 295 IL PARTITO SOCIALE Materiali di analisi e per il lavoro politico A cura di Roberto Mapelli e Vincenzo Vasciaveo Interventi di Nello Patta, Mimmo Porcaro, Francesco Piobbichi, Paolo Cacciari, Luigi Vinci, Matteo Gaddi, Paolo Favilli, Luciana Maroni, Marco Conti, Elio Limberti, Fabrizio Nizi, Giorgio Riolo, Andrea Di Stefano, Lorenzo Guadagnucci, Tonino Perna, Raffaele K. Salinari, Davide Biolghini, Lidia Menapace, Paolo Ferrero. “Il partito sociale, inteso come punto d’incrocio tra movimenti che si politicizzano e partiti che si socializzano”, sanciva uno dei passaggi fondamentali del Congresso di Rifondazione comunista del luglio 2008. Da allora si sono moltiplicate le pratiche che hanno dato vita a quell’enunciazione: dai gruppi d’acquisto popolari (Gap o Gasp) alle casse di resistenza a favore delle fabbriche in lotta, dai doposcuola popolari alle brigate di solidarietà attiva in Abruzzo e poi in altre realtà del territorio nazionale, fino ai mercatini dei libri, alle convenzioni con dentisti popolari e quant’altro di simile è stato ritenuto utile localmente, per giungere alla recente “arancia metalmeccanica”. Con l’ipotesi strategica del partito sociale, Rifondazione coglie che la strada per recuperare utilità sociale si snoda in quattro passaggi consequenziali: - denunciare pubblicamente gli effetti della crisi sugli strati popolari, dal carovita alle chiusure aziendali, ma anche entrare nelle contraddizioni della ricostruzione dopo disastrosi eventi naturali; - corredare questa denuncia con delle pratiche concrete di mutualismo capaci di risolvere almeno parzialmente questi effetti o esigenze; - far partire una vertenzialità diffusa nel territorio e nei luoghi di lavoro non più come esito di una sempre più inefficace propaganda, ma come conseguenza di una presa di coscienza diretta realizzata attraverso la mutualità, il dialogo e l’analisi comune; - ricostruire così un radicamento territoriale e di fabbrica che si è andato polverizzando dopo anni di egemonia culturale delle destre. A metà di quest’esperienza, nella scorsa primavera, vengono prodotti due importanti seminari; il primo a Bologna a carattere nazionale, il secondo a Cisliano, vicino a Milano, su iniziativa della Federazione milanese. Lo scopo è duplice: innanzitutto compiere una valutazione comune su quanto e come la pratica del partito sociale aveva saputo produrre fino ad allora, ma anche riprendere ed arricchire lo spessore teorico che aveva dato vita a questa scelta. Il lavoro che questo libro presenta è un assemblaggio ragionato dei contributi che sono stati portati a questi due eventi, sia dalla riflessione teorica sul partito sociale, sia dalle esperienze che ne hanno supportato l’attuazione pratica. Inoltre, a conforto ulteriore della fondatezza di quest’orientamento, si è pensato che fra i contenuti degli interventi non potessero mancare le radici storiche del mutualismo operaio, a partire dalla metà dell’ottocento. Collana Quaderni di Socialismo XXI, uno 2010, pagg. 200, 10 Euro. 296
Scarica