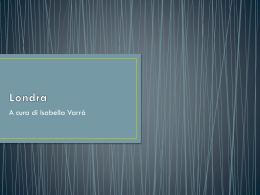Marta Gaggini My London Calling Vademecum minimo per sopravvivere a Londra Parte 4 EdiKiT MY LONDON CALLING - parte 4 - TANGO DI VERDURE La prima volta che ho attraversato quel ponte, il Millennium Bridge tanto famoso, accompagnata da cigolii sospetti che immediatamente mi hanno rimandato al destino incerto del futuristico ponte sul canale veneziano, lo skyline della città affacciata sul Tamigi non mi ha esattamente impressionato. La Tate dall’altra parte del fiume è sicuramente d’impatto, e voltandosi lo è anche la vista della cupola di Saint Paul incorniciata dalla struttura snella, forse un pelino troppo, del ponte che collega la City alla rinnovata zona di Southwark. Il fatto che pochi passi più avanti ci sia il Globe rende quest’area incredibilmente piena di attrattiva, ma sul momento, legata al ricordo di quella Firenze dai colori dorati inondata dal sole, dipinta sull’orizzonte del primo pomeriggio estivo sull’altra sponda del fiume, immagine del mio risveglio assonnato dopo il pisolino pomeridiano sulla panchina di quel piccolo giardino d’Oltrarno, la vista non mi sembrava poi questo granchè. C’ho messo un po’, a scoprire il suo fascino: palazzi neogotici e edifici trasparenti, antico e nuovo, la Londra che era accanto a quella che sarà. Stavolta non c’è il mondo a confronto, c’è lo scorrere inevitabile del tempo. E quello che attraversando questo ponte luminoso e dall’aspetto precario la prima volta mi aveva deluso, così diverso dall’estetica perfetta del panorama che avevo lasciato, tornando non solo mi ha colpito, mi ha completamente catturato. Perché Londra, sulle rive del Tamigi, diventa una città di mare. Incrociatori ancorati a riva, ricostruzioni di vascelli antichi, e più avanti barche e musei navali. Tutto questo mi era sfuggito. Non vedendo il mare l’avevo sottovalutato. E quel contrasto aspro che domina le rive del fiume è quello tra il suo passato concreto e il suo intangibile futuro, mattoni e vetri, pescatori e finanzieri. Al riparo di un ponte ferroviario, come tutti i migliori mercati di questa città, riposano gli ortaggi del Borough Market. Non che io non abbia mai visto banchi di verdure, ma qui, sotto le arcate neovittoriane di questo mercato alimentare, quella dell’ortolano è un’arte. Rispettano la scala colore che neanche noi, in negozio, coi cassetti di mutande. C’è un tappeto di pomodori di ogni forma e dimensione, in cui ‘pachini’ e ‘San Marzano’ cedono all’abbraccio del ‘cuore di bue’. Ci sono cascate di baccelli che sfumano in zucchine, asparagi e piselli. Ci sono ceste eleganti di cavolo e tuberi mai visti. Ci sono bozze di pane impilate come capolavori artistici. Ci sono banchi di dolci. E ci sono tavolini rosa all’ombra della cattedrale, che li ripara dal rumore della strada. Solo dopo aver attraversato i banchi di frutta e verdura del Borough Market, e aver riscoperto l’invadenza del Cetriolone, mi sono incamminata, risalendo il fiume, verso il Tower Bridge. Il mercatino dell’artigianato in cui mi sono imbattuta non mi ha insospettito, ma l’hanno fatto le note argentine che riempivano l’aria in quella sorta di anfiteatro scavato ai piedi del nuovo, tondeggiante municipio. Il Festival del Tamigi. Al loro fiume ci tengono così tanto che gli organizzano una festa ogni anno, con attività culturali che in alcuni casi non sembrano esattamente legate all’acqua corrente: ballare il tango, ad esempio, tanto per dire la prima che mi viene in mente. O riscoprire il fascino dell’agricoltura biologica, sul verde ponte di Southwark, che come nessun altro poteva essere altrettanto adatto. Zucche di Halloween a dare il benvenuto, balle di fieno come divertimento arcadico estremo, un mastro sfilettatore circondato da un pubblico numeroso di bambini impazienti di scoprire come privare una cernia delle lische, una banda di attori improvvisati che con lo sfondo del Tamigi rappresentavano scenette che vista la carenza di spettatori erano evidentemente meno interessanti di una lezione sulla disossatura del pesce, e cheers alla fantasia, con cappelli invasi dai rampicanti che tanto ricordavano quell’uomo patata dell’infanzia coi capelli fatti di insalata ed elaborati elmetti da guardia della regina fatti non di eleganti pennacchi neri ma di lucida barbabietola. Mary Poppins aveva cambiato panorama, e invece di volare sui tetti fra comignoli e spazzacamini, passeggiava a Southwark offrendo brindisi con un cappellino rosa dal motivo vegetale e un carretto da ambulante in cui esponeva, sui loro piedistalli come se fossero uccelli di verdure dell’Arcimboldo che la parola magica di quella magica bambinaia aveva incredibilmente portato alla vita, cappelli più simili ad orti pensili che a copricapo ornamentali, parenti stretti di lattuga e affini. C’era un’aria di festa, anche se festa non era, c’era un ritorno alle buone abitudini di un tempo passato, c’era l’aria pulita di un Ottocento ancora non industrializzato, con quel ponte verde che ancora non so dire se sia georgiano o vittoriano ma certo era anacronistico e in quel momento, a suo modo, sospeso. E c’era tempo. Non esisteva la fretta, o almeno, tra conchiglie e nastrini, si lasciava dimenticare. E Londra improvvisamente aveva un’altra dimensione, più umana, senza corse nei sotterranei della metro, senza il cambio di scarpe senza tacco all’uscita da lavoro, senza lancette troppo veloci e con spazi sconfinati solo lungo il corso del Tamigi. Senza frenesia. Così, fermandomi sul ponte di Southwark, in un tempo minuscolo e dilatato, ho creato il mio personale articolo di artigianato e con quello una nuova tradizione di questo strano, lungo viaggio: il ritorno frequente di un souvenir inaspettato. Dopo il cappello da cowgirl rosa acceso, che aveva dato la svolta al mio carnevale e mi aveva aiutato e costretto a calarmi nello spirito di quelle strade britanniche dal sapore caraibico, un’altra bella giornata avrebbe avuto il suo ricordo suggellato da un cappello. Memoria a tesa larga. Ma mentre allora ero passata un paio di volte davanti alla bancherella con aria titubante simulando indifferenza, allontanandomi esitante prima di tornare sui miei passi intenzionata a investire cinque pounds in quell’acquisto difficile da ammortizzare ma al momento a dir poco fondamentale, stavolta ci sono voluti molti più passaggi perché mi decidessi a trovare il coraggio di avvicinarmi a quella specie di merceria fluviale per chiedere la cosa fra tutte più importante: quanto mi sarebbe potuto costare. Per la verità me ne ero quasi andata, mi ero convinta che chiedere non sarebbe servito perché certo non poteva essere gratuito, e quindi avevo proseguito pensierosa per la mia strada perché le mie finanze non potevano sostentare un altro cospicuo tributo a un giorno speciale. A dirla tutta mi vergognavo. Mi vergognavo tremendamente. Come a Notting Hill mi sarebbe servito qualcuno con cui ballare la salsa sul marciapiede, così adesso serviva qualcuno che mi spingesse a oltrepassare i confini delle mie piccole paure. E se a Notting Hill il cappello era venuto in mio aiuto, qui fare il cappello era la sfida. Mentre mi allontanavo piano sentendo come un sentore nascosto di insoddisfazione, imbattermi in tutte quelle teste decorate mi ha convinto che anch’io lo dovevo fare, che dovevo concedermi almeno un tentativo, perché andarsene a mani vuote senza neanche aver rischiato mi avrebbe tormentato con un rimorso pungente sul vivo. Così mi sono avvicinata, e con un filo di voce ho lasciato cadere la domanda fatidica, convinta che quell’aspetto in apparenza liberale da qualche parte nascondesse una fregatura e che alla fine mi avrebbero presentato un conto tale da costringermi a dilapidare una fortuna. E non ci crederete, ma era gratis. Gratis. Quindi ho afferrato quel cappello di paglia dalla forma indefinita, mi sono scaraventata educatamente su un cesto di nastrini, ho fatto incetta di conchiglie di ogni dimensione, che ancora mi chiedo come facessero gli altri a impedirgli di cadere soltanto con un nastro adesivo di scarso potenziale, e cercando disperatamente ma senza disturbare colla, forbici e affini, in pieno blocco dell’ispirazione, ho cominciato timidamente a creare la mia opera, circondata da una riproduzione dello studio di Art Attack in versione caotica. Il risultato forse non era molto originale, ma a parer mio aveva un certo valore artistico, e comunque nascondeva un significato concettuale che lo rendeva almeno paragonabile alle misteriose installazioni della Tate. Sì, perché il mio cappello rappresentava la catena alimentare: penzolante sul retro al fondo di una serie di scampoli arancioni c’era il pesce piccolo, che astutamente si è dato alla fuga prima di arrivare a sera. Risalendo lungo quella chioma di tessuto fino all’assemblaggio di nodi multistrato da cui tutto era partito si raggiungeva il pesce grande, protagonista della parte posteriore di questo mio elaborato esperimento ornamentale, anch’esso rigorosamente di cartone. E infine, seguendo lungo le pendici la cornice di conchiglie, molto pericolante e a tratti decadente nel senso meno poetico che questo termine possa esprimere, ci si imbatteva nel vertice di questa piramide, l’uomo, rappresentato in modo astratto da due forchettine situate in mezzo alla fronte. A ben guardare, quel cappello era anche la mia rappresentazione, e non perché abbia un’empatia particolare per le prede o un sopito istinto da predatore, niente che abbia a che vedere con la storia dell’antilope e del leone, semplicemente perché, con quei residui di colla vinilica sparsi su tutta la superficie e quegli orpelli decorativi a rischio costante di caduta libera, era imperfetto e precario come me. Con questo nuovo bagaglio di esperienze sono tornata verso l’Argentina che avevo lasciato. Il tango era un disegno, uno schizzo in matita nera dal contorno definito, macchie sovrapposte di colori all’acquerello, una successione di istantanee del pieno Futurismo, come pagine di un libro animato, fatto di figure passeggere, di dettagli, di passi legati a formare non più una sequenza di immagini ma un dipinto ininterrotto in cui la tela non si è mai staccata dal pennello, fermi immagine che scorrono rapidi creando un meccanismo in cui ogni scatto è nitido e sinuosamente legato al successivo, frazioni immobili di un quadro in movimento. E la milonga, qui a Londra, ha altri colori, quelli di un cielo grigio e di un sole luminoso che prima di tramontare spara gli ultimi colpi inondando il Tower Bridge di luce, mentre un arcobaleno si intreccia ai cavi portanti blu acceso. Ha forse gli stessi suoni, ma stavolta corrono veloci lungo le acque del Tamigi. E ha ancora una volta protagonisti internazionali londinesi nell’essenza, perché non esiste altro modo di spiegare com’è che una coppia di giapponesi balla il tango al riparo di un ombrello se non dicendo che sono perfettamente acclimatati all’ambiente che Londra è in grado di offrire, da un punto di vista non solo strettamente meteorologico ma anche culturale. Tutti lì, sotto la pioggia, con l’ombrello, a ballare. Solo Londra. Perché immagino che a Buenos Aires abbiano una temperatura diversa. DANZA CON LE TUE PAURE Sempre per far la festa al fiume, qualche giorno dopo mi aspettavano i fuochi d’artificio. Da ingenua quale sono, prima di uscire per andare a lavoro, ho abbandonato il leaflet informativo sul tavolo e quindi, al momento di decidere la mia destinazione, ho aperto la cartina e fatto appello all’unico elemento che la mia memoria riusciva a ricordare: un ponte con una b come iniziale. Cercando di riportare alla mente qualche altra informazione fondamentale, come la collocazione del ponte lungo lo snodarsi di quel fiume che somigliava a un grosso serpentone, mi sono convinta di aver individuato il tratto del Tamigi immortalato su quelle pagine e con l’aiuto di un po’ di suggestione, ho creduto di capire dove sarei dovuta andare. Battersea. Mai sentito. Con un po’ d’affanno mi sono diretta senza indugio in questo angolo sconosciuto, uno dei tanti di questa città immensa che ancora non avevo incontrato. E nel momento stesso in cui ho imboccato quel ponte, su un autobus al secondo piano, mi sono arresa allo stupore di trovare, in quell’angolo sconosciuto, un posto inaspettato e speciale, con la luce obliqua del sole intento a tramontare che si rifletteva luminosa sull’acqua apparentemente immobile del fiume, la vecchia centrale elettrica a dominare quella che aveva tutto l’aspetto di essere un’area portuale, e l’incontro casuale con una vera città di mare. Battersea è la mia Londra, la Londra dove vorrei davvero vivere. Perché ho capito un paio di cose. La prima è che non mi piace solo il mare, ma tutto ciò che è navigabile, se anche il Tamigi esercita su di me lo stesso fascino irresistibile e impossibile da spiegare. La seconda è che sono una da altra sponda, da Rive Gauche parigina, o da San Frediano, se vogliamo dirla alla nostrana. Sono una da riva sinistra. E Battersea sarebbe perfetta: Battersea è dove vivrebbero i marinai, se a Londra i marinai ci fossero, e se ci fosse, davvero, il mare. Che poi, se invece del fiume ci scorresse un viale, è evidente che perderebbe tutto il suo valore. Mentre facevo tutte queste scoperte eccezionali, un’altra scoperta era saltata all’occhio, ossia che quel posto era bello, ma sarebbe rimasto senza fuochi d’artificio ancora molto a lungo. Qualcosa nel mio perfetto meccanismo di ricostruzione del percorso era andato storto. Sono tornata sui miei passi un po’ delusa, ma convinta che il destino fosse intervenuto per farmi imbattere in una Londra che altrimenti non avrei mai conosciuto, una Londra che il destino sapeva che avrei apprezzato. Tornata a casa ho subito controllato dov’è che avevo sbagliato. Il ponte di cui avevo bisogno era quello che per primo avevo scartato, fondamentalmente perché aveva un nome poco orecchiabile che mal si adattava all’attrazione che avrebbe animato quella serata, un altro carnevale. Mi sono affrettata e sono arrivata giusto in tempo per gli ultimi carri della sfilata, con formose ballerine di tutte le sfumature vestite solo di costumini succinti e variopinte piume, che si agitavano a ritmo di samba in un mare multicolore. Dalla salsa cubana del carnevale di New Orleans al carnevale di Rio con il suo vortice caleidoscopico e danzante di ritmi e di colori. E in entrambi un tratto comune, maschere mostruose che fluttuavano a mezz’aria portando un messaggio fondamentale: danza con le tue paure. Era un carnevale di luci, che ondeggiavano festose allontanandosi lungo le rive dell’Embankment, in un fiume brillante che scorreva ballando lungo un Tamigi scuro illuminato dalle tinte fluorescenti della ruota panoramica e poi dai fuochi d’artificio, che ancora una volta, dopo il San Giovanni prima della partenza, io mi trovavo a guardare da un Lungarno. E devo dire che a Londra ci sanno fare, anche se chissà, forse erano comunque meglio quell’altr’anno. E dopo un mese e mezzo di scoperte, nuovi mondi, inevitabili alti e bassi, ho cominciato a scoprire delle curiose costanti. Prima di tutto i dolci. Ardita torta di compleanno al cioccolato, dolce che dicono alle mele per presentarsi a una cena bengalese, cheesecake dal sesso incerto per un immeritevole duo barese, cupcake di un azzurro acceso per ridare colore alla giornata buia della mia vivace coinquilina spagnola, e un famigerato Cadburry viola rispedito su ordinazione in Italia. Non c’è modo più bello di dire alla mamma ‘ben arrivata’ di uno fatto di glassa zuccherata, e non c’è modo più sincero di augurare al mio amico Juri una buona avventura di quello a forma di fetta di cheesecake alla vaniglia. E stavolta, se c’è qualcosa da imparare, è qualcosa di piccolo, e saporito, e cioè che un dolce è sempre un regalo azzeccato. Poi arriva il momento in cui devi decidere se mangiare i muffin a colazione o togliere le maniglie dell’amore, se mangiare il cioccolato o combattere la cellulite, se mangiare solo carne secca e salmone pur di dimagrire. Ed è allora che sono costretta a prendere una posizione. Non credo ci sia bisogno di specificare quale. Soprattutto visto che gli errori di battitura che troverete dipendono dalle briciole del cheesecake che si sono incastrate fra i tasti del computer. Riguardo alle rughe, poi, che dire? L’unica soluzione sarebbe bandire la mimica facciale. Ma preferisco avere sulla fronte un pentagramma piuttosto che avere la pelle distesa e il sorriso al silicone e rinunciare però al gusto dell’espressione. Del resto, se sopra il naso ho un solco scavato da un aratro è perché sono una persona piena di domande, e la perplessità è la mia sensazione dominante. FRITTO SENZA CONFINE Non c’è niente di meglio, per scoprire una città, che assaggiarla. Perché non esiste altra manifestazione culturale più sincera di quella gastronomica. Musica e danza fanno certo parte della tradizione nazionale, ma rispetto alla cucina non esiste niente di più popolare. La cucina è cultura che si fa concreta e reale. E buona, salvo qualche eccezione che nel mio caso si fa piuttosto rara. Del resto un indiano, al di là del Bollywood più sfrenato, non sarebbe tale se nella sua dispensa non ci fosse il curry a farla da padrone, e ho avuto la prova che non il flamenco o le corride, ma la tortilla è il vero elemento distintivo delle spagnole. Per non parlare dell’italiano medio, che forse non saprà come si balla la taranta, ma certo non potrà vivere senza un buon piatto di pasta, batterà i supermercati alla ricerca di una passata che almeno somigli a quella vera e non si darà pace finché non avrà risolto, di solito direttamente alla fonte con l’acquisto di una macchinetta, il problema dell’espresso non servito in tazza piccola. Così io e la mamma, appena arrivata in visita, ci siamo dedicate, più o meno intenzionalmente, ad un’accurata ricerca gastronomica. Abbiamo cominciato trascorrendo la nostra prima sera fuori nel ristorante greco che conoscevo, nascosto in un vicoletto sotto un paio di gradini in calce bianca davanti a un club di tango argentino. La moussaka che avevo assaggiato la prima volta mi aveva deliziato, ma abbiamo scoperto con grande disappunto che a dispetto dell’atmosfera da perfetto locale della chora di Folegandros, la moussaka era probabilmente l’unico piatto che valesse davvero la pena di mangiare in quel posto. Così siamo tornate a casa un po’ deluse ma decise a testare, nell’ultima sera che avremmo trascorso insieme, il ristorante greco che mia madre diceva di ricordare. Anche perché con una allergica al peperoncino, non è che ci si possa sbizzarrire. Chissà il curry, che effetto le potrebbe fare. Appurato che anche questo ristorante greco era praticamente a due passi dal nostro portone, anche se in questo senso la memoria della mamma aveva mostrato delle iniziali lacune, abbiamo programmato questo spietato confronto diretto, che resterà memorabile per un galactoboureko d’avanzo. Ma prima ci aspettava tutta una serie di esperienze mangerecce intercontinentali, anche se, per proseguire alla grande, abbiamo deciso di iniziare con qualcosa di puramente britannico: la colazione all’inglese. Ovetto sbattuto, fagioli dolciastri, le classiche fette di bacon, e salsicce da grigliata domenicale, il tutto annaffiato da una buona tazza di the bollente. Non male. Anzi, come pranzo sarebbe stato eccellente. In mattinata, diciamo che un tantino appesantisce. Ed è per questo che, in attesa di lasciare Camden, ho stentato prima di accettare l’incursione nel fritto mondiale. Stentato, ma comunque senza rinunciare. Camden riserva sempre delle sorprese, ogni volta finisci per ritrovarti in un angolo sconosciuto di questo strano quartiere, come se fosse fatto di dimensioni parallele. Camden è la dimostrazione che il Matrix esiste: sembra sempre la stessa ma se la guardi attentamente ti accorgi che ha uno sfondo sempre differente. E stavolta era quello di una passeggiata lungo il canale, con romantici ponticelli, salici piangenti, Vespe affacciate su un bancone lungo la riva al posto degli sgabelli, e una strana atmosfera orientale, da sobborgo thailandese, come se dietro la successiva ansa di quello che a stento definirei fiume si potesse nascondere il fascino di un mercato galleggiante con venditori di spezie in sandali e cappelli di paglia a paralume. Stavolta lo sfondo era quello di una Bangkok occidentale. Proseguendo lungo il canale, seguendo un percorso che ovviamente Matrix mi impedisce di ricostruire e che con ogni probabilità la prossima volta sarà comunque diverso da quello che adesso credo di ricordare, si raggiunge una sorta di piazzetta dove in forma culinaria si manifesta ancora una volta l’internazionale: Dim Sum cinese, churros e cioccolata di indubbia origine spagnola, un banco che serviva esclusivamente cocchi ripieni di pina colada, e anche se la memoria mi trae in inganno, la convinzione che da qualche parte ci fosse anche un rivenditore autorizzato di noodle da asporto. Una concentrazione ad alto tasso di colesterolo di cibo da strada, taniche di olio da frittura in una densità molto più alta della media, un picco di grassi saturi nell’aria, le calorie che ti si attaccano addosso con cattiveria e con relativo incremento della massa corporea. E in tutto questo, incuranti del nostro obeso destino, e del probabile impiego in padella di lubrificanti meccanici di riciclo, noi abbiamo assaggiato una specie di panzerotto al formaggio che dicevano essere brasiliano. E non contente, così per mettere un fermino, visto che a colazione ci eravamo tenute leggere, ci siamo avventate avida- mente su una bomba glicemica di origine belga: palline di waffle servite con panna e cioccolata. Io e mia madre. Mia madre. Cosa strana, questa. Non che io abbia una progenitrice, ma che lei accetti di mangiare roba fritta e senza’altro poco salutare. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità. E in effetti, se c’è qualcosa che unisce davvero tutte le culture, è proprio questo: il fritto. Dalla tempura, ai samosa, al fish and chips. Una scoperta sensazionale che ha rivoluzionato la cucina mondiale, probabilmente in alcuni casi ha cambiato la consuetudine sociale, e certamente ha contribuito spesso a migliorare il nostro umore e ad allontanare l’utopia del peso ideale. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità. Un’umanità sempre più rotonda. E dalle similitudini, alle più pure contaminazioni. Un omaggio veloce a quell’abbinamento ardito fra tramezzini al salmone scozzese e assaggini di sushi, accompagnati da un succo di frutta al mango che ancora una volta non si è rivelato l’acquisto più azzeccato dell’anno. E poi Covent Garden, diventata sede di un nuovo esperimento gastronomico al limite dell’indigeribile: paella dal sapore intangibile servita in adorabile piattino di legno con forchettine a costante rischio scheggia nelle gengive e uno sgradevole retrogusto di larice, crepes francesi con falafel arabi, e per concludere alla grande, cupcakes. Con una glassa colorata e invitante, che si fingeva morbida nel modo più ingannevole e sembrava una di quelle decorazioni per torte a forma di fiore di dimensione gigante, una di quelle che a ben pensarci tutti vogliono nel piatto alle feste di compleanno ma che poi alla fine non mangia mai nessuno, perché sono sì esteticamente adorabili ma hanno il sapore di un pugnello di zucchero congelato e la consistenza granulosa di un bagno nel mare mosso su un fondale sabbioso. Coloranti e saccarosio. Ma la suggestione ci spingeva a credere che oltrepassando la soglia di quell’angolo rubato ad ‘Alice nel paese delle meraviglie’ avremmo vissuto un’indimenticabile esperienza extrasensoriale. E in effetti c’era qualcosa di reale. Perché nonostante la sensazione fosse davvero quella di masticare una porzione di spiaggia che un’improvvisa tramontana ci aveva fatto finire in bocca portandola fin lì dalla costa, stavolta il sapore accompagnava la glassa. Un sapore definito, incancellabile. E se per me avevo scelto il cupcake al cioccolato, certo poco originale, non molto brillante nel colore, ma dalle aspettative grandiose, che poi infatti sarebbero state amaramente disattese, per la mamma avevo preso qualcosa di più audace. In realtà, data la sua passione sfrenata per tutto ciò che è lilla, quella mi sembrava la scelta più ovvia: cupcake alla lavanda. Sfortunatamente il dolcetto non era solo stato imbevuto in una tintura viola e magari spruzzato di essenza, come uno si aspetta. Sapeva davvero di lavanda. Sembrava di mangiare un sacchettino lavabiancheria. Eravamo lì, io e la mamma, nel cuore pulsante di Londra, e stavamo divorando la Provenza. IN FUGA DAL TOFU Trascinata dal fascino della scoperta, anche una volta ripartita la mamma, ho portato avanti il nostro accurato programma, pianificando metodicamente le successive fasi di questa ricerca. Due erano le diramazioni del mio studio, due i percorsi che questa analisi dal sapore scientifico avrebbe seguito: la cucina dell’Estremo Oriente e i negozi di alimentari del quartiere che stavo per lasciare. Due strade che avevano un punto d’incontro nel minimarket orientale dove fino ad allora non avevo mai messo piede. Adesso, rompendo tutti gli indugi, avevo varcato la soglia di quell’estratto di cartone animato giapponese, e mi aggiravo rapita fra le corsie, letteralmente invase da salsine a me sconosciute scritte in dialetto cinese, noodle grossi come tubature, zuppe pronte sul cui contenuto preferisco non indagare, verdure mai viste, ogni varietà di spezie, e altri ingredienti di cui a tutt’oggi continuo ad ignorare impiego, origine e sapore. Me ne sono andata senza azzardi, giusto con un po’ di crackers che parevano essere filippini, approvati, e un pacchetto di crackers di riso all’apparenza innocui ma a parer mio assolutamente immangiabili. Di lì sono andata al negozietto russo senza indecisioni, e là mi sono dedicata all’acquisto di un altro articolo fondamentale, che poi, anche se magari non serve, comunque in casa non può mancare: biscotti. Una confezione graziosa, con una mucca valdostana disegnata sulla facciata, che faceva tanto Italia del dopoguerra, e che forse, visto il sapore stantio del contenuto, risaliva davvero a quell’epoca. Ma la spesa vera l’ho fatta in Moscow Road, la strada bizantina con la chiesa ortodossa, il bar con gli anziani che invece che a briscola giocavano a tavla, i vicoli che si snodavano su uno sfondo dall’aria britannica con un lastricato e un’atmosfera racchiusa che però ricordavano la quiete assolata di un villaggio su un’isola greca. E greca era infatti la grocery dove mi sono fermata, con quell’indecifrabile insegna che stavolta sapevo in che lingua era scritta solo perché era accompagnata da una bandiera inconfondibile e piuttosto nota. Ancora una volta, improvvisamente, Londra si trasformava in un’altra città, con colori più caldi e altre sonorità. Atene non era più così lontana. E non c’era più Tesco che tenesse, nessuna offerta tre per due che valesse l’esperienza di fare compere come facevano le nonne, indicando il formaggio puntando il dito oltre il vetro del bancone, in una mattinata luminosa, come luminosa sa essere solo questa città che è famosa al mondo per essere grigia. C’era un’aria familiare, un tempo immobile, fermo all’Italia del dopoguerra, o anzi a quella Grecia cicladica dove la vita scorre più lenta. Di nuovo scompariva la fretta, e scompariva Londra, presenza scomoda rimasta a fare da scenario a questo tassello importato di penisola Egea, che qui si era insediato senza rinunciare alla sua essenza più pura. Perché Londra è uno Stargate. La porta si spalanca e d’improvviso porzioni di mondo di ogni genere si ritrovano in un’altra dimensione, e continuano ad esistere per quello che sono, immutate nel tempo, o disposte col tempo a dare a questa nuova inaspettata patria la possibilità di farle cambiare. Sono convinta che se fossi andata in Moscow Road solo qualche giorno prima, forse non avrei trovato quell’angolo di Grecia camuffata. E sono ancora più convinta che qualcuno, ad Amorgos, portando il suo gregge di capre al pascolo, si stia chiedendo dove sia finito il villaggio sulla collina che vedeva ogni giorno, confuso al punto di credere che quel villaggio non sia mai esistito e che sia arrivato il momento di smettere di dissetarsi con l’ouzo. Quel villaggio sconosciuto sulla collina di Amorgos adesso è qui, in Moscow Road, sotto un tappeto di comignoli, perfettamente mimetizzato. E questa Grecia porta con sé anche un tempo passato, il ricordo vivo di una vita non molto lontana che spesso sembriamo aver dimenticato, l’Italia del dopoguerra con degli anziani che, senza fretta, invece di giocare a briscola giocano a tavla. In mezzo a tutta questa poesia è partito lo shopping sfrenato: un vero sacchetto di biscotti dall’aspetto molto greco, dei fagottini di pasta ripieni di formaggio che nelle intenzioni dovevano essere come quelli grondanti d’olio assaggiati a Milos, fichi, anche se non mi ricordo mai qual è il mio colore preferito, un altro Galactobureko da asporto e la feta più buona che abbia mai mangiato. Poi, tornando sui miei passi, è stata la volta dello yogurt e, affacciandomi nel negozietto dal carattere arabo della porta accanto, chiedendo se tutti i vegetali che vedevo erano mango, e allietando la giornata dell’ortolano in questo modo piuttosto ridicolo, è stato il momento per l’acquisto irrazionale di roba mai vista, cose tipo avocado, papaya e un ambiguo succo di frutta. Di lì a poco avrei scoperto che ancora una volta il Galactobureko era a dir poco sublime, e che evidentemente non sono un’amante della frutta tropicale. Per quanto riguarda il succo, che in effetti per esperienze pregresse era quello che più temevo, rimando il giudizio definitivo a quando avrò ricordato il nome di quelle palline bianche mollicce ricoperte di un friabile guscio rosa con cui era fatto, simili a cuccioli di tartarughe dinosauro. Detto questo, è stata la volta dell’esplorazione approfondita della cucina orientale più estrema. C’era solo un nome: Japan Centre. Nascosto tra gli altri grandi palazzi dei viali che si diramano da Piccadilly Circus, accanto a quello che ho scoperto essere l’Harrods personale dei cinesi, un negozio inaspettato dedicato solo alle delicatessen dei popoli ai confini dell’East mondiale: sushi in formati di tutte le dimensioni, un’intera corsia dedicata ai noodle precotti, questi finti spaghetti all’uovo che spaziano dalla misura dei capellini d’angelo a quella dei pali della metro, serviti in bicchieroni di carta colorati e che loro si ostinano a mangiare usando solo bacchettine di legno ed enormi cucchiai senza manico, come gli episodi migliori di Sailor Moon ci hanno insegnato. E poi ancora tutto un reparto dedicato interamente al miso, questo mistero strano che ancora non ho capito se sia una verdura asiatica, un asiatico frumento, o un prodotto mitologico derivato da un oscuro processo alchemico. Magari c’è chi ha inventato la polvere da sparo, e chi ha inventato il miso. E questo ci potrebbe dare da pensare riguardo al senso del gusto di questo popolo. O al fatto che potrebbero scambiare la polvere da sparo per cibo. Ma comunque, nonostante tutto, io un tentativo con il miso l’ho fatto. O meglio, l’ho comprato liofilizzato ma non credo che troverò mai il coraggio di assaggiarlo. Un po’ come con il tofu. Già nel mio Oriental Market c’ero passata davanti un paio di volte, fingendo di non riconoscerlo per non sentirmi costretta a comprarlo. Ma adesso non potevo negare, perché la scritta cubitale che campeggiava su quel panetto gigante immerso nell’acqua come una mozzarella rettangolare scaduta da settimane non lasciava molto spazio all’immaginazione. Il fatto è che questo momento di entusiasmo incontrollato mi spingeva a dare un sapore a cibi che certo avevo sentito nominare ma nessuna delle mie papille gustative aveva mai sentito il bisogno di assaggiare. E non sentivo questo bisogno neanche ora, era più per una questione intellettuale, l’obbligo morale di sapere. Ho svicolato con eleganza, fingendomi attratta dalla bakery giapponese e tornando con simulato interesse verso le creme da Geisha e le scatoline per il cibo copiate a Mila e Shiro. E a quel punto, a fianco della mia amica Elisa, che rispondeva “alga” ogni volta che chiedevo cosa fosse questa o quella cosa, convincendomi dapprima di essere molto preparata e alla fine facendomi dubitare che stesse approfittando della mia ignoranza colossale, mi sono diretta mascherando l’indugio al banco del cibo pronto. Ho ordinato una palla di roba fritta che solo dopo ho scoperto essere ripiena di noodle, immagine evocativa e un po’ angosciante, ve l’assicuro, e due fagottini ai gamberetti che se ho ben capito fanno parte di una serie di piatti leggeri, perlopiù cotti al vapore, il famigerato Dim Sum orientale, una sorta di tapas cinese. Ancora una volta, con la scusa poco credibile di non volermi appesantire, ho evitato l’incontro ravvicinato con il tofu, e ho compensato decidendo di pasteggiare a tè freddo verde. Tè verde freddo. Tè. Verde. Freddo. È un po’ come il soia vanilla latte, un altro gioco di parole di cui Elisa è l’esperta maggiore. Ecco, questo the era imbevibile. E lei lo sapeva. Ma io, incurante del pericolo, e fiduciosa che questa bevanda in bottiglia dovesse ricordare almeno vagamente l’Estathè e il suo sapore dolce, mi ero avventurata nell’acquisto senza chiedere il suo prezioso parere. Così, finito il Dim Sum e sconfitti i noodle, quel tè è venuto via con me, quasi integro, e tale sarebbe rimasto fin quando, dopo un paio di settimane, non mi sarei decisa a buttarlo. Non contenta, nel pomeriggio, dando una seconda chance a Brick Lane, la Banglatown londinese, come si ostinano a presentarla le guide, ho fatto uno spuntino leggero con un triangolino imbottito di verdure fortemente speziate. E da qui ho tratto un altro paio di conclusioni: mai fare merenda nei baracchini indiani. Per concludere questa saporita incursione, un ritorno più consapevole al mio minimarket orientale, non per comprare il tofu, che ancora non è salito in vetta alle classifiche, ma per un investimento inaspettato e irrazionale in quei fagottini ai gamberetti che avevo assaggiato cotti al vapore e che, come avrei scoperto tristemente, non hanno esattamente la stessa resa se invece li scaraventi nel microonde. Altri ritmi, non c’è niente da fare. Altri rituali. Speriamo che i biscottini della fortuna possano essere davvero rivelatori. • L’intermezzo sono le ortensie e i bottoni di Liberty, il caffè take away in Hyde Park sulla coperta a scacchi, la colazione regale di ‘Le pain quotidien’ prima di raggiungere Windsor, la mamma che continua a parlare durante gli autoscatti. RISATA GLOBALE E ora, prima di proseguire con tutta la Londra che viene, rincorrendo affannosamente gli arretrati da recuperare, una panoramica sulla Londra che è stata. Prima di tutto il Globe, che tra le sue pareti racchiude l’aria dell’Inghilterra del Cinquecento, intrappolata in uno spazio che ha una tenuta ermetica anche se di fatto è aperto, privo com’è del tetto. Con quel palco che si insinua malizioso tentando di non dare nell’occhio al centro di quella sorta di patio illuminato non dai riflettori ma dalla luce del giorno e con il cielo come sfondo. Un cerchio magico in grado di evocare il teatro elisabettiano, e una commedia di Shakespeare che ingenuamente pensavi non potesse essere divertente davvero. E invece ti sei trovata lì, in piedi in platea, sparata tra la folla urlante della Southwark di qualche secolo prima, a ridere -ridere- di una commedia in inglese arcaico scritta prima che inventassero la lampadina. Stupisce pensare che l’uomo ride da sempre, che negli angoli sconosciuti della storia che studiamo, negli intervalli tra le date importanti che tanto non ricorderemo, nelle pieghe dello storico quotidiano, l’uomo ha riso. Oltre l’epica, le grandi battaglie, le scoperte scientifiche, le esplorazioni geografiche, c’è l’essere umano. Un essere umano che ha sempre conosciuto il sorriso. Stupisce pensare che Shakespeare, quello dell’Amleto, quello del nostro rigoroso studio scolastico, quello che è tutto serio nel suo ritratto, proprio lui, potesse scrivere una commedia in grado di far ridere -ridere- gli spettatori di un teatro. Lo stesso teatro, centinaia d’anni dopo, con un pubblico che certo non può essere lo stesso ma in fondo non è cambiato e di quella commedia ride allo stesso modo, perché anche se sembra strano questo no, non è cambiato. L’umorismo è la scoperta più grande che l’umanità abbia mai effettuato. E tutti i grandi del nostro passato hanno vissuto una vita reale, fatta non solo di grandi momenti da immortalare, ma di momenti piccoli, comuni e speciali, che i libri di storia non si preoccupano di citare perché forse contribuiscono non a rafforzare l’immagine dell’eroe ma a costruire quella dell’uomo normale. Napoleone avrà fatto una risata, anche se magari trattenuta, alla battuta un po’ spinta di un suo commilitone, il re Sole se la spassava di sicuro alle feste sfrenate della corte francese. Leonardo era toscano, non poteva che essere allegrotto e probabilmente amante del buon vino, e Giulio Cesare e Antonio, prima di rovinare la loro bella amicizia per una donna ricca di fascino e di mistero, si saranno divertiti andando a bere insieme il sabato sera, magari svegliandosi sotto gli archi dell’acquedotto senza ricordare cosa fosse successo la sera prima. E Shakespeare, proprio lui, quello dell’Amleto, quello tutto serio nel suo ritratto, aveva forse l’aspetto composto e la risata sonora di un regista di cinema d’avanguardia, un Nanni Moretti del Cinquecento con un talento di altro livello. Così il Globe, affacciato sempre sullo stesso cielo, anche se il panorama lungo il fiume è un po’ diverso, diventa un compendio della storia umana, quella storia piccola che non si studia a scuola, dove gli uomini di oggi sono uguali agli uomini di ieri. Tutti qui, ancora una volta a ridere -ridere- di una commedia di Shakespeare dall’umorismo immortale, ieri e oggi uguale. Tutti qui, tra le mura di legno del Globe, a scrivere un altro capitolo di questa evoluzione immobile, fino a capire che guardando da vicino solo l’essere umano, la storia non esiste, passato e presente si confondono, fino a perdere di significato. E diciamocelo, Shakespeare questo ai suoi tempi l’aveva capito, Romeo e Giulietta potrebbero appartenere a qualsiasi epoca, le emozioni non hanno data. Dopo questa giornata luminosa, perché quando qui c’è il sole i colori brillano come difficilmente ho visto fare altrove, era il momento di scoprire altri contrasti di questa città che ogni giorno si arricchisce di particolari, in una mappa dai contorni sempre più definiti che ti scaraventa senza posa da un angolo all’altro dell’intero pianeta. “Immensa, la mappa del mondo, del mondo intero, da un capo all’altro, città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa.” Continua...
Scarica