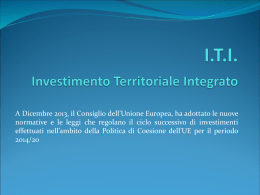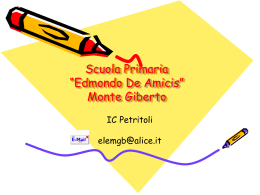ISI di Barga - ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F.lli Pieroni” Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli” Liceo Classico “L. Ariosto” Istituto Tecnico SETTORE ECONOMICO “A. Magri” Istituto Tecnico SETTORE TECNOLOGICO “E. Ferrari” Certificazione di Qualità Effective CAF User Sede legale: Via dell’Acquedotto, 18 – 55051 BARGA (LU) TEL.: 0583-723026 – FAX: 0583-723595 – Sito Web: www.isibarga.it – E-mail: [email protected] DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5 A indirizzo CHIMICO ITI FERRARI a.s. 2014/2015 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 1 INDICE 1 Presentazione della scuola 2 Composizione Consiglio di Classe 3 Composizione commissione esami di stato 3,1 Memorandum 4 Profilo professionale 4,1 Quadro Orario 5 Profilo classe 5,1 Continuità didattica nel triennio 5,2 Elenco allievi 6 Programmazione di classe 6,1 Situazione classe ingresso 6,2 Relazione sintetica 6,3 Obiettivi, educativi, cognitivi e professionali 6,4 Criteri e strumenti di valutazione 6,5 Attività integrative, di approfondimento ed extracurriculari 6,6 Numero e tipologia delle prove 6,7 Tipologia della terza prova e discipline coinvolte 6,8 Conoscenze, competenze e capacità in ambito disciplinare Allegato 1 Relazione finale di ogni docente e percorso formativo Allegato 2 Criteri di valutazione POF Allegato 3 Griglie di valutazione prove scritte Allegato 4 Simulazioni proposte documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 2 1. Presentazione della scuola L’I.T.I. “Enzo Ferrari” di Borgo a Mozzano è stato istituito nell’anno 1995 quale sede staccata del biennio I.T.I. “E. Fermi” di Lucca nella Valle del Serchio. Nell’anno scolastico ’98-’99 è diventato autonomo ed è stato aggregato all’Istituto Superiore di Istruzione di Barga. Il 19 aprile 2000 l’Istituto è stato intitolato all’Ing. Ferrari. L’istituto tecnico, con la specializzazione in chimica, risponde all’esigenza di formazione legata all’industria locale, soprattutto ai settori cartario, farmaceutico, metallurgico e ambientale, ampiamente radicati nel territorio lucchese. Quest’anno è il primo anno di una casse che ha seguito dalla prima i curricula della riforma. Presso questo istituto è presente l’indirizzo chimico autorizzato nell’anno scolastico 20002001; con la riforma è stato autorizzato l’indirizzo Meccanico Meccatronico ed Energetico, anche se ad oggi non sono presenti classi terminali. Il quadro orario prevede 32 ore settimanali, con un’alta percentuale di ore dedicate alle attività di laboratorio. A partire dal terzo anno, vengono svolte attività di stages presso le aziende locali pubbliche e private, per favorire l’alternanza scuola lavoro. Nella provincia di Lucca l’indirizzo chimico è presente solo all’I.T.I. di Borgo a Mozzano. Come attività esterne, l’Istituto ha partecipato quest’anno alle Fase Regionale dei giochi della Chimica . 2. Composizione del Consiglio di classe. MATERIE DOCENTI Lingua e letteratura italiana Mazzoni Laura Dina Storia Mazzoni Laura Dina Lingua straniera inglese Grassi Roberta Matematica Pieri Michela Chimica organica, biorganica e delle fermentazioni con laboratorio Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale Nannizzi Silvia Della Scala Jessica Barsocchi Chiara Palmieri Adelina Ciari Roberto Palmieri Adelina Educazione fisica Bulckaen Alessandra Analisi chimica ed elaborazione dati con laboratorio documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 3 Religione documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Rosi Don Emanuele Pagina 4 3. Composizione della Commissione dell'Esame di Stato. Commissario interno Barsocchi Chiara Materia Analisi chimica ed elaborazione dati con laboratorio Mazzoni Laura Dina Lingua e letteratura italiana e Storia Pieri Michela Matematica Materie assegnate ai commissari esterni Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale Chimica organica, biorganica e delle fermentazioni con laboratorio Lingua straniera inglese 3.1 Memorandum per i candidati Prima prova scritta: 17 giugno 2015 - ore 8.30 Seconda prova scritta: 18 giugno 2015 - ore 8.30 Terza prova: 22 giugno 2015: l’orario sarà comunicato dalla commissione. Durante le prove scritte sarà consentito: a. l'uso del dizionario della lingua italiana (non a carattere enciclopedico) b. l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile c. l'uso delle maschere UNICHIM Il giorno della Prima prova scritta ogni candidato potrà comunicare alla Commissione la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio specificando il titolo dell'argomento e/o l'esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale. 4. Profilo professionale Il perito chimico riceve una formazione a forte valenza culturale, basata sull’alternanza tra studio teorico e sperimentazione nei laboratori e stage presso aziende ed enti per stabilire un contatto tra scuola, mondo del lavoro e Università. Il perito chimico possiede aggiornate conoscenze delle discipline specifiche dell’indirizzo, integrate da un buon livello di cultura generale e da un’organica preparazione scientifica; è in grado di leggere e interpretare disegni e impianti chimici, così come usare tecnologie informatiche per partecipare alla gestione e al controllo dei processi industriali. possiede la preparazione di base necessaria all'accesso ai corsi postdiploma e al proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, in particolare in quelle tecnico-scientifiche; svolge la sua opera professionale nell’industria, dove: documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 5 gestisce dal punto di vista chimico e impiantistico problematiche ambientali e di igiene del lavoro; collabora alla progettazione di impianti chimici e tecnologici; gestisce la manutenzione degli impianti chimici; esercita mansioni di ricercatore e di analista nei laboratori chimici (tecnico di laboratorio di analisi nei settori: cartario, chimico, merceologico, alimentare, farmaceutico, chimico-fisico, ecologicoambientale); ha competenze per lo svolgimento della libera professione (collaudi, progettazioni, perizie, rilievi); sa rispondere ai bisogni del sistema industriale e delle realtà produttive locali, in particolare di quelle cartarie; è un tecnico capace di interagire con i cambiamenti del sistema economicosociale; può diventare insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria 4.1 Quadro orario dell'indirizzo chimico Discipline del piano di studi Classe III Classe IV Classe V Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Storia 2 2 2 Lingua straniera inglese 3 3 3 Matematica 3 3 3 Complementi di matematica 1 1 - Chimica organica, biorganica e delle fermentazioni con laboratorio 5 (2) 5 (2) 3 (2) Analisi chimica ed elaborazione dati con laboratorio 7 (6) 6 (5) 8 (6) Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale 4 (1) 5 (2) 6 (2) Educazione fisica 2 2 2 Religione 1 1 1 Le ore fra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio in compresenza con l'insegnante tecnico pratico. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 6 5. 5.1 Profilo della classe Continuità didattica nel triennio Disciplina Classe III a.s.2012-2013 Classe IV a.s.2013-2014 Classe V a.s.2014-2015 Lingua e letteratura italiana Mazzoni Laura Dina Mazzoni Laura Dina Mazzoni Laura Dina Storia Mazzoni Laura Dina Mazzoni Laura Dina Mazzoni Laura Dina Febi Raffaella Febi Raffaella Grassi Roberta Pieri Michela ( Vari supplenti) Pieri Michela Pieri Michela Cucciardi Giorgio Della Scala Jessica Nannizzi Silvia Della Scala Jessica Nannizzi Silvia Della Scala Jessica Cucciardi Giorgio Della Scala Jessica Barsocchi Chiara Palmieri Adelina Barsocchi Chiara Palmieri Adelina Amata Orazio Palmieri Adelina Ciari Roberto/ Neri Della Scala Jessica Ciari Roberto Palmeieri Adelina Educazione fisica Ricci Maria Letizia Iaccarino Aniello Bulckaen Alessandra Religione Rosi don Emanuele Rosi don Emanuele Rosi don Emanuele Lingua straniera inglese Matematica Chimica organica, biorganica e delle fermentazioni con laboratorio Analisi chimica ed elaborazione dati con laboratorio Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 7 4.2 Elenco allievi. Alunno ADORNI Luca BRAVI Beatrice Provenienza Classe IV Classe IV BRAVI Mattia Classe IV FORNARI Marco Classe IV GIUNTINI Giacomo Classe IV LORENZI Tiziano Classe IV MORGANTI Maria Giovanni MUGNAI Nicola Classe IV NOTINI Michele Classe IV PACINI Jacopo Classe IV PIERI Leonardo Classe IV PIERONI Stefano Classe IV PIOLI Alessandro Classe IV Classe IV 4.3 Esperienze di ricerca e progetto finalizzate al colloquio pluridisciplinare Tutti gli studenti hanno sviluppato, attraverso un lavoro di ricerca e rielaborazione personale, un argomento attinente all’ambito professionale da presentare al colloquio. ADORNI Luca BRAVI Beatrice BRAVI Mattia Piano di autocontrollo nell’industria alimentare FORNARI Marco I controlli nell’industria del latte. GIUNTINI Giacomo Analisi delle polveri in flussi gassosi convogliati LORENZI Tiziano Centrali Idroelettriche ed energie rinnovabili MORGANTI Giovanni Maria MUGNAI Nicola NOTINI Michele PACINI Jacopo Processo di Produzione della Carta Processo di compostaggio frazione organica Controllo qualità industria olearia Controllo qualità acque superficiali. Impianti trattamento acque a fanghi attivi. Indice biotico documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 8 PIERI Leonardo PIERONI Stefano PIOLI Alessandro Indagine per la ricerca dell’amianto negli ambienti abitativi Controllo qualità industria del vino Controllo qualità industria del miele. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 9 5. 5.1 Programmazione di classe Situazione della classe in ingresso Nell’anno scolastico in corso, la situazione in ingresso della classe dedotta dai risultati degli scrutini della classe IV risulta descritta come segue: Numero allievi Provenienza 13 Classe IV 5.2 Promossi Promossi con senza sospensione di sospensione di giudizio giudizio 7 6 Relazione sintetica della classe. La classe si compone di 13 alunni tutti regolarmente frequentanti. Durante il percorso scolastico per un ristretto gruppo di allievi sono emersi progressi curricolari positivi. Il limitato numero di ragazzi con buone capacità non è stato trainante per il resto della classe che, da questo punto di vista, ha evidenziato un comportamento attivo e interessato in modo abbastanza discontinuo con una acquisizione e rielaborazione personale degli argomenti non omogenea né approfondita. Negli ultimi mesi, alcuni alunni hanno dimostrato un maggior impegno almeno nel lavoro in classe, mantenendo tuttavia un modesto impegno nel lavoro a casa. Tutto questo ha comportato per un discreto numero di ragazzi un apprendimento più scolastico e mnemonico degli argomenti. La maggior parte degli allievi ha raggiunto le competenze delineate dal Consiglio di classe in modo sufficiente: il percorso si è realizzato talvolta con qualche difficoltà derivante dalla necessità di colmare alcune carenze, soprattutto nelle materie di indirizzo, e da un impegno e un metodo di lavoro non sempre costanti ed adeguati. Una buona acquisizione di contenuti e conoscenze non è stata possibile anche a causa di una mancata continuità didattica nelle discipline di indirizzo e all’avvicendamento di diversi insegnanti. In alcune discipline la situazione iniziale della classe non ha permesso di sviluppare in modo completo e approfondito la programmazione prevista. Lo sviluppa parziale della programmazione risulta abbastanza evidente in Tecnologie Chimiche Industriali, oggetto della seconda prova scritta, dove la classe è risultata particolarmente debole su alcuni assi portanti (tre insegnanti diversi per il triennio). Stesse considerazioni devono essere fatte per il programma di chimica organica, biorganica e delle fermentazioni, dove l’insegnante, per cause indipendenti dalla propria volontà, è risultata assente per lunghi periodi durante l’anno scolastico. Il quadro complessivo del profitto risulta pertanto quasi sufficiente, con alcuni elementi che evidenziano una preparazione complessiva abbastanza buona. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 10 5.3 Obiettivi educativi, cognitivi e professionali. Il Consiglio della classe 5A-indirizzo Chimico ha operato perseguendo i seguenti obiettivi: Obiettivi educativi - Favorire la formazione dell'identità personale dello studente - Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona - Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne - Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca comune di valori unificanti - Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale - Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro - Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà - Conoscere il proprio corpo e rispettarlo (Riconoscimento del diritto all'identità sessuale) - Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita - Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non - Saper valutare e autovalutarsi con senso critico Obiettivi Cognitivi per l'area linguistica Obiettivi generali 1. Sviluppo delle abilità espressive e comunicative sia nel linguaggio orale che scritto; sviluppo delle quattro abilità: parlare, scrivere, ascoltare, leggere. 2. Riflessione sulla lingua finalizzata alla graduale acquisizione della correttezza formale e ad una maggiore consapevolezza dei processi comunicativi e del funzionamento del sistema linguistico. 3. Educazione letteraria finalizzata alla promozione dell’esperienza estetica, al potenziamento delle capacità critiche e all’abitudine stabile alla lettura. Obiettivi specifici ASCOLTO individuare i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale del discorso altrui. Cogliere con chiarezza il punto di vista e le finalità dell’emittente. PARLATO a) Saper organizzare semplici testi orali, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, delle situazioni comunicative, delle diverse finalità del messaggio e del tempo a disposizione. b) Imparare a rispondere in modo pertinente alle domande, non ricorrendo ad uno studio mnemonico ma rielaborando quanto appreso in maniera personale. LETTURA Ricerca di dati e informazioni. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 11 Comprensione globale. Comprensione approfondita. Uso del testo per le attività di studio. Analisi e interpretazione di testi di diversi tipi. Capacità di una lettura ad alta voce, espressiva e corretta. SCRITTURA Consapevolezza della differenza tra la formulazione orale e scritta del pensiero. Uso efficace e corretto di forme di scrittura diversa in rapporto all’uso, alle funzioni ed alle situazioni comunicative. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. RIFLESSIONE SULLA LINGUA a) Graduale acquisizione della correttezza formale attraverso un rinnovato studio delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana. b) Acquisizione di un metodo scientifico nell’uso e nell’analisi della lingua che permetta di istituire confronti tra alcuni elementi fondamentali della lingua italiana e quelli di altri sistemi linguistici. c) Arricchimento del patrimonio lessicale. d) Capacità di istituire rapporti tra il linguaggio verbale ed i linguaggi non verbali. e) Consapevolezza della storicità della lingua e delle sue varietà nello spazio geografico. EDUCAZIONE LETTERARIA a) Promozione dell’interesse per la fruizione dei testi letterari. b) Capacità di comprendere i significati globali e parziali di un testo. c) Capacità di riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nelle sue principali realizzazioni (prosa, poesia, generi letterari). d) Capacità di porre in relazione le scelte strutturali e linguistiche dell’autore con i contenuti e i significati del testo. e) Individuazione in termini essenziali, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti di contenuto, del rapporto tra l’opera letteraria ed il suo contesto culturale e storico generale. Obiettivi per l'area tecnico-scientifica Obiettivi generali 1. Consolidamento di un comportamento responsabile e partecipe attraverso a) b) c) d) Rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni; Rispetto dell’ambiente scolastico; Rispetto delle scadenze; Partecipazione ordinata, pertinente e produttiva all’attività scolastica. 2. Rafforzamento del metodo di lavoro e sviluppo delle potenzialità individuali attraverso documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 12 a) Comprensione di un testo gradualmente sempre più complesso; b) Capacità di memorizzare e di esporre, in modo non puramente mnemonico, gli aspetti informativi più significativi degli argomenti trattati; c) Capacità di trasferire i contenuti appresi (dal contesto disciplinare ad altri contesti); d) Capacità di esprimersi in modo adeguato arrivando ad utilizzare il lessico specifico delle varie materie; e) Capacità di interpretare i problemi proposti; f) Capacità di applicare principi e formule; g) Capacità di collaborare nelle attività di gruppo; h) Capacità di lavorare in modo progressivamente sempre più autonomo; i) Utilizzo sistematico del libro di testo, di tavole numeriche e di manuali; j) Utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale; k) Uso corretto e consapevole della strumentazione di laboratorio e delle tecniche sperimentali; l) Capacità di progettare e di eseguire in maniera autonoma un’analisi di laboratorio adattandosi alle esigenze specifiche. Obiettivi minimi per il triennio Per le classi 3°, 4° e 5 si ritiene indispensabile che gli studenti raggiungano tutti gli obiettivi stabiliti per ogni singolo modulo. Il concetto di sufficienza è quindi relativo al livello di raggiungimento dell’obiettivo. Il livello minimo di accettabilità, relativamente ai contenuti culturali, riguarda la conoscenza dei temi, del lessico e delle strutture indispensabili per esporli. Le valutazioni superiori alla sufficienza sono state attribuite nei casi in cui l’alunno ha mostrato capacità di analisi e di sintesi, capacità critiche e capacità di rielaborazione personale in fase espositiva. 5.4 Criteri e strumenti di valutazione In base a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, deliberato dai Consiglio di Classe e parte integrante del POF, gli strumenti di verifica per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono i seguenti: Prove scritte tradizionali Prove scritte strutturate Prove scritte semi strutturate Prove orali Prove di ascolto Esercitazioni pratiche Osservazioni sistematiche Prove che si avvalgono di misure dispensative e compensative per alunni/e con certificazione DSA e per alunni/e indicati dai Consigli di Classe come studenti con BES Schede di autovalutazione I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei Docenti per l’Anno Scolastico 2014-2015, sono parte integrante del POF e sono riportati nell'allegato 2. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 13 Per la valutazione globale e per la promozione, il Consiglio di Classe ha tenuto conto del fatto che l'alunno/a abbia raggiunto conoscenze e competenze minimi nelle discipline portanti dell'area comune e dell'area d'indirizzo; dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, compresa la materia di Religione (se è stata scelta) o eventuali attività scolastiche alternative. del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; degli aspetti socio-affettivi; della partecipazione ai tirocini e agli stage; del fatto che l’alunno/a abbia riportato una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento. I crediti scolastici sono stati attribuiti secondo i seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente e dal punto precedente e tenendo conto che la media dei voti superiore o uguale al mezzo punto dà già adito all'ottenimento del punteggio massimo della relativa banda di oscillazione: frequenza delle lezioni, partecipazione e impegno di studio; partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica (ad es. organi collegiali); partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o ad essa richieste; partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola; valutazione del comportamento. 5.5 Attività integrative, di approfondimento ed extracurricolari Gruppi di studenti della classe si sono impegnati nel triennio in attività aggiuntive extracurricolari quali: Scuola aperta Orientamento formativo Giochi della Chimica Attività sportive Altre iniziative culturali legate al percorso didattico delle singole materie nel corso del triennio sono state le seguenti conferenze e visite tecniche: Stage presso Aziende, Studi Professionali e Università di Pisa Corso di formazione di 8 ore sulla sicurezza in azienda con certificazione Progetto “Formare per prevenire: sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro”, promosso da USR-ASL-VVFF-INAIL Seminario di educazione alla Legalità tenuto dal Comando dei Carabinieri di Borgo a Mozzano Pianeta Galileo: rappresentazioni teatrali annuali proposte nell'ambito delle iniziative regionali documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 14 5.6 Terza Prova: esercitazioni – simulazioni Il consiglio di classe ha programmato simulazioni per ciascuna prova scritta, che si sono svolte tra il mese di marzo e il mese di maggio. In particolare: I simulazione della terza prova 20 marzo II simulazione della terza prova 24 aprile III simulazione della terza prova 12 maggio simulazione della prima prova 14 aprile simulazione della seconda prova 30 aprile 5.7 Tipologia della terza prova e discipline coinvolte Tipologia B: quesiti a risposta singola Materie coinvolte (C. di C. 05/04/2011): Nella prima prova sono state somministrate agli studenti prove relative a quattro materie: Matematica, Chimica delle Fermentazioni/microbiologia, Chimica Analitica e Inglese; Nella seconda simulazione sono state scelte quattro materie: Storia, Chimica Analitica, Chimica delle Fermentazioni/microbiologia e Inglese Nella terza e ultima simulazione le seguenti materie: Matematica, Storia, Chimica delle Fermentazioni/microbiologia e Inglese; Le simulazioni della terza prova sono state progettate con 4 discipline scelte fra quelle suddette e somministrate con un tempo pari a 2 ore. Le prove proposte sono riportate in allegato 4. 5.8 Conoscenze, competenze e capacità in ambito disciplinare Si rinvia alla relazione finale di ciascun docente e al programma di ogni materia. (Allegato 1) Roberto Ciari Della Scala Jessica Pieri Michela Nannizzi Silvia Bulckaen Alessandra Barsocchi Chiara Grassi Roberta Mazzoni Laura Dina Palmieri Adelina Rosi don Emanuele Borgo a Mozzano, 15 maggio 2014 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 15 Allegato 1 PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 16 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE ITALIANO Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Prof.ssa Laura Dina Mazzoni Contenuti tempi livelli Mod. 1 GIACOMO LEOPARDI > Le idee: il pessimismo storico; la teoria del piacere; la poetica dell'indefinito; il pessimismo cosmico; il titanismo . Settembre > Lettura di brani da Lo Zibaldone: Sensazioni visive e uditive indefinite; Le parole poetiche. > I Canti: L'infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; Ottobre La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; La ginestra. > Le Operette morali : Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di Tristano e di un amico discreto Mod. 2 SCRITTURA > Testi espositivi/argomentativi con funzioni e destinazioni diverse (articoli di giornale, saggio breve) > Temi di opinione su argomento assegnato > Temi di argomento storico > Analisi del testo sufficiente Tutto l’anno Mod. 3 IL SECONDO OTTOCENTO in Italia sullo sfondo della cultura europea La delusione postunitaria Il pensiero: la scienza e l’evoluzionismo; il positivismo Ottobre Le poetiche e il dibattito letterario; Scapigliatura; Melodramma; letteratura Novembre didascalica; Naturalismo Lettura e analisi di Preludio di E. Praga. Il romanzo europeo. Dal Naturalismo al Verismo Mod. 4 GIOVANNI VERGA La vita ; la poetica: “l’ideale dell’ostrica”; il ciclo dei vinti; la fiumana del progresso con l’analisi della prefazione a I Malavoglia. Lettura e analisi di brani tratti da I Malavoglia e da Mastro don Gesualdo Lettura e analisi di Rosso Malpelo, La Lupa, Cavalleria Rusticana. Mod. 5 - IMMAGINI DEL POETA nella letteratura italiana sullo sfondo di quella europea Simbolismo; Dandismo; Parnassianesimo; Estetismo. Lettura e analisi di Corrispondenze e L’Albatros di C. Baudelaire G. Carducci, La vita, le idee e il ruolo del poeta. Lettura e analisi di Pianto antico, Nevicata > La nascita della lirica moderna G. Pascoli, La vita e le idee. La poetica e il tema del nido. Lettura e analisi di brani tratti da “Il fanciullino”;” La grande Proletaria si è mossa”; Italy. Da Myricae: Lavandare, Il temporale, X Agosto, L’assiuolo Da I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno, La mia sera G. D’Annunzio. La vita e le idee. “La vita come un’opera d’arte”, “Pochi uomini superiori” (brani tratti da Il piacere). Lettura e analisi de La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori Giuseppe Ungaretti. La vita e la poetica. Da L’ Allegria: Il Porto Sepolto, I fiumi, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. Eugenio Montale. La vita , la poetica. Da Ossi di seppia: I limoni, Non documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Dicembre sufficiente discreto Gennaio Febbraio Marzo discreto Aprile Maggio Pagina 17 chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Da Le occasioni : Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri. Da Xenia: Caro piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Umberto Saba. La vita, la poetica. Da “Il Canzoniere”: La capra, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Ulisse, Città vecchia. MOD. 6 IL NOVECENTO Il contesto storico culturale. Il Decadentismo. Il pensiero della crisi ; letteratura e società. Le Avanguardie. Il Futurismo . Filippo Marinetti: Il manifesto tecnico del Futurismo Crepuscolarismo. G. Gozzano : La signorina Felicita Cultura e società in Italia: > Luigi Pirandello. La poetica del relativismo e del grottesco : dal saggio sull’umorismo, Il sentimento del contrario; La vita e la forma. Dalle novelle : La carriola, La patente, La mosca. I Romanzi : Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila ( brani presenti sul testo in uso) Il teatro e il metateatro. > Italo Svevo. La vita e la poetica. Il vizio di scrivere. I romanzi. Lettura dei brani presenti sul testo in uso. Marzo Aprile discreto La classe ha partecipato in modo corretto alle lezioni, ma solo un piccolo gruppo di alunni ha ottenuto risultati eccellenti grazie ad un metodo di studio efficace, ad una partecipazione costante e ad un impegno adeguato che ha coronato un percorso di studi sempre ai massimi livelli. Altri hanno studiato in vista delle verifiche, che sono state frequenti, dato l’esiguo numero di alunni, ma la loro preparazione è rimasta abbastanza scolastica, anche se sufficiente, e non tutti sono stati capaci di intervenire attivamente nelle discussioni con l’esposizione delle proprie idee o opinioni, sia per mancanza di approfondimento delle tematiche affrontate sia per ragioni di carattere. In un caso o due la superficialità nell’affrontare il lavoro scolastico non è scomparsa neppure nel secondo quadrimestre e i risultati pertanto non sono adeguati. Metodi utilizzati Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione partecipata, con ampio spazio alle discussioni guidate, alla scoperta deduttiva, alla lettura dei testi e al confronto tra gli alunni. Il recupero è stato effettuato in itinere . Strumenti utilizzati Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: il libro di testo, testi di lettura C. Bologna, P. Rocchi – Rosa fresca aulentissima – Loescher Criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati sono stati: la valutazione sommativa (effettuata alla fine dei singoli moduli e alla fine del percorso formativo) e la valutazione formativa (valore diagnostico). Per la correzione degli elaborati scritti sono stati osservati i seguenti aspetti: la pertinenza; l’ordine logico; l’ampiezza dei contenuti; la correttezza ortografica e della punteggiatura; la struttura sintattica; la proprietà lessicale (vedi griglie allegate). Per la valutazione delle prove orali sono stati osservati i seguenti aspetti: l’acquisizione critica dei contenuti propri della disciplina; la capacità di operare collegamenti e di contestualizzare; la capacità di muoversi tra astrazione ed esemplificazione; la capacità di esporre con un linguaggio appropriato i contenuti appresi, seguendo un percorso logico e coerente. Strumenti di valutazione adottati Sono stati utilizzati: n. 6 prove scritte : Tipologia A, Tipologia B, tema storico, tema di ordine generale n. 6 interrogazioni tradizionali; domande brevi; discussioni documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 18 Obiettivi raggiunti Rispetto agli obiettivi indicati nel piano di lavoro gli obiettivi minimi sono stati raggiunti in misura nel complesso soddisfacente dalla classe sia sul piano delle competenze che su quello delle conoscenze e delle capacità così riassumibili: a. - conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina b. - esposizione dei contenuti acquisiti in un linguaggio appropriato seguendo un sufficiente ordine logico. Livelli raggiunti: Circa il 70% della classe ha raggiunto livelli che vanno dalla quasi sufficienza al discreto sia nella materia orale che in quella scritta; 3 alunni hanno conseguito una preparazione di livello ottimo sia allo scritto che all'orale evidenziando anche autonomia nella preparazione e buone capacità critiche e logiche; un restante piccolo gruppo presenta difficoltà più gravi. Visto per adesione i rappresentanti di classe _____________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Firma del docente _______________ Pagina 19 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE STORIA Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Prof.ssa Laura Dina Mazzoni Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Mod 1 : L'ETA' DEI MOTI LIBERALI a) Le correnti risorgimentali moderate e democratiche b) Il pensiero socialista e il Manifesto di K. Marx c) Il 1848: l'incendio rivoluzionario d) Il decennio di preparazione, le guerre d’indipendenza e il compimento dell’unità Mod 2 : IL TRIONFO DELLA BORGHESIA a) La definitiva affermazione della libera concorrenza b) I maggiori paesi europei tra il 1850 e il 1870. Gli Stati Uniti c) L’Italia postrisorgimentale, la Sinistra al potere e la crisi di fine secolo. Periodo Livelli Settembre Ottobre Novembre sufficiente Dicembre Gennaio discreto Febbraio Mod. 3 : L'ETA' DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E DELL'IMPERIALISMO c) Gli ultimi trenta anni dell'Ottocento fra depressione economica e rinnovamento del sistema produttivo d) La situazione europea: le rivalità tra Francia, Germania e Inghilterra e) La questione dei Balcani e il duello slavo-asburgico. f) Caratteri dell'imperialismo. Economia, politica, società. g) Verso la rottura degli equilibri internazionali. h) L'età giolittiana. i) La prima guerra mondiale: le cause, i fatti, le conseguenze; i numeri Mod. 4 : L'ETA DEI TOTALITARISMI Il tormentato primo dopoguerra La rivoluzione in Russia Il crollo delle istituzioni parlamentari in Italia e l'avvento del fascismo. La crisi del '29 Il nazismo in Germania I totalitarismi: franchismo, fascismo, nazismo, stalinismo. La seconda guerra mondiale La Resistenza e il dopoguerra in Italia Febbraio discreto Marzo Aprile sufficiente Maggio La classe nel corso dell'anno scolastico ha mostrato sufficiente interesse per gli argomenti svolti, partecipando alle conversazioni con atteggiamento positivo anche se il lavoro casalingo non sempre e non per tutti è stato costante e attivo. Nel primo periodo il rendimento, quindi, non è stato sempre adeguato, ma progressivamente buona parte degli alunni ha migliorato le modalità di studio e ha manifestato un maggiore interesse per le tematiche affrontate e ha profuso un impegno più attivo acquisendo conoscenze generalmente soddisfacenti e maturando migliori capacità di riflessione sui fatti e i fenomeni. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 20 Metodologie adottate Nell’ attività didattica è stata utilizzata la lezione frontale, ma largo spazio è stato lasciato alle discussioni guidate collegate agli interessi mostrati dagli alunni, in riferimento anche alla lettura del quotidiano (presente regolarmente nell’orario di lezione). Il recupero è stato effettuato in itinere. Strumenti utilizzati Gli strumenti utilizzati sono stati principalmente il libro di testo, la lettura di altri testi, l’elaborazione di sintesi e semplici “mappe” a schemi. Testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette: Passato Presente; ed. Scolastiche Bruno Mondadori Criteri di valutazione I criteri adottati per la valutazione formativa e sommativa sono riferiti a: acquisizione dei contenuti della disciplina, capacità di operare riferimenti e collegamenti, capacità di rielaborare autonomamente, capacità di porsi in modo critico e problematico di fronte ai fondamentali nodi storici, capacità di espressione con un linguaggio appropriato. Strumenti di valutazione Sono stati utilizzati conversazioni e discussioni guidate, interrogazioni tradizionali, domande brevi. Obiettivi raggiunti La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi in misura soddisfacente, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti propri della disciplina , sia per la capacità di esporli con linguaggio appropriato e di fare collegamenti diacronici e logici; alcuni alunni hanno raggiunto tali obiettivi in misura buona e anche ottima. Visto per adesione i rappresentanti di classe Firma del docente ______________________________ _______________________________ ______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 21 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE INGLESE Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Prof.ssa Grassi Roberta Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Module 1 (IN THE SCIENCE LAB) Unit 2: Laboratory equipment (p. 23-24) Lab techniques and experiments (p. 28-29) How to clean lab glassware (p. 30-31) What is a microbiology lab? (p. 36) Module 2 (THE STUFF THE WORLD IS MADE ON) Unit 1: Matter (p. 44-46) The building blocks of matter (p. 47-48) The periodic table (p. 49-50) Chemical reactions (p. 51-53) Unit 2: Branches of chemistry (p. 54-55) Analytical chemistry (p. 57) Analytical methods and instrumental analysis (p. 59-61) Module 3 (BIOCHEMISTRY: THE CHEMISTRY OF THE LIVING WORLD) Unit 2: Carbohydrates (p. 84-86) Proteins (p. 87-89) Lipids (p. 90-91) Nucleic acids (p. 92-93) Module 4 (MICROBES AND MICROBIAL BIOTECHNOLOGY) Unit 1: Microbes: the factory of everything (p. 106-107) Prokaryotes vs. eukaryotes (p. 108-109) Bacteria & Co. (p. 111-112) Unit 2: Microbial biotechnology (p. 116) The colours of biotechnology (p. 118-119) Genetic engineering debates (p. 130) Module 5 (TAKING CARE OF THE EARTH) Unit 1: Pollution (p. 136-138) Go green (p. 139-140) Green power: where our energy will come from (p. 142-144) Unit 2: Air pollution control technology (p. 146-148) Potable water supplies (p. 152-154) The types and causes of water pollution (p. 155-156) Module 6 (WHAT'S ON THE TABLE) Unit 1: Healthy eating (p. 182-183) How to read food labels (p. 186) Food preservation (p. 188) Food additives (p. 191) Unit 2 Foodborne illness (p. 196) HACCP: protection from foodborne diseases (p. 200) Periodo Livelli Settembre Ottobre Buono Novembre Buono Dicembre Gennaio Buono Febbraio Marzo Buono Aprile Discreto Maggio Giugno Sufficiente Testo: “New A Matter of Life” di Paola Briano, ed. Edisco. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 22 OBIETTIVI E LIVELLI RAGGIUNTI Per ciò che concerne gli obiettivi indicati nella programmazione di inizio anno, possono considerarsi raggiunti quelli principali, ovvero saper leggere, ascoltare, comprendere e riferire – sia oralmente che per scritto - i contenuti di testi che presentano termini, espressioni, strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche del linguaggio scientifico e tecnologico settoriale (in ambito chimico, biochimico, microbiologico, alimentare, ambientale e biotecnologico). Circa metà della classe si attesta su un livello di sufficienza; un piccolo gruppo di studenti ha mostrato impegno e partecipazione costanti, evidenziando risultati più che soddisfacenti, mentre vi sono alcuni alunni che presentano ancora difficoltà e lacune sul piano della competenza linguistica e comunicativa relativa alle tematiche svolte. METODI: - lezioni frontali; lezioni organizzate dagli studenti; analisi e traduzione dei testi; lavoro a coppie e in piccoli gruppi; discussioni, dibattiti; attività di ascolto. - libro di testo; fotocopie; Cds; Internet. MEZZI: CRITERI DI VALUTAZIONE Riguardo alla valutazione, sono stati considerati i seguenti criteri: - conoscenza globale e analitica degli argomenti affrontati; - capacità comunicativa, scritta e orale, corredata dall'uso di terminologia specifica; - correttezza e appropriatezza formale (grammatica, sintassi e lessico); - capacità di sintesi e rielaborazione personale; - impegno e costanza nel lavoro svolto. STRUMENTI DI VERIFICA: - n. 2 prove scritte per il primo periodo e 3 per il secondo periodo (di tipo strutturato – multiple choice, cloze – e semistrutturato – questionari a risposta aperta, riassunti); n. 1 interrogazioni per il primo periodo e numero 2 interrogazioni per il secondo periodo. Visto per adesione I rappresentanti di classe Firma del docente documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 23 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Contenuto disciplinare sviluppato N.unità didattiche Monodisciplina riPluridisciplinari Modulo 1: Le capacità motorie e la loro 3 misurazione, attraverso una serie di test d’ ingresso ,ripetuti nell’arco dell’anno scolastico per valutare miglioramenti. Modulo 2: Miglioramento delle capacità Tutto l’anno coordinative e condizionali anche attraverso attività di ginnastica aerobica con musica e combinazioni di movimento da memorizzare ed eseguire a tempo Modulo 3: Pratica dei principali sport di Tutto l’anno squadra ed individuali. Modulo 4: Conoscere i principali 1 paramorfismi dello scheletro e la giusta postura Modulo 5: Benessere e sicurezza, 1 alimentazione corretta e rischi legati ad una cattiva abitudine di vita (fumo, droghe ,sedentarietà). Modulo 6 : uscite di trekking, partite di 1 calcetto triennio fine anno e di pallavolo fra le classi Prof.ssa Alessandra Bulckaen Livello di approfondimento: (ottimo/buono/discreto/sufficiente) buono buono discreto buono ottimo buono METODOLOGIE DIDATTICHE Spuntare le celle di pertinenza con una x Le metodologie didattiche utilizzate sono state: x Lezione frontale con l’utilizzo degli strumenti didattici tradizionali (libro di testo, lavagna, etc.) Lezione attiva con osservazione di materiali, con l’ausilio di LIM, audiovisivi o con l’utilizzo di mappe concettuali Organizzazione di lavori di gruppo, con raccolta dati e informazioni su argomenti specifici e/o produzione di testi o documenti multimediali x Esercitazione pratiche, con risoluzione di problemi Discussioni in classe su articoli, filmati o materiali di laboratorio Lezioni sul campo Esperienze laboratoriali con produzione di relazioni scritte documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 24 Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica. Principio della gradualità. Approccio globale-analitico-globale. Lavoro individuale e di gruppo. Parti di lezione svolte dagli alunni in autonomia. x MEZZI DIDATTICI/STRUMENTI UTILIZZATI (In questa sezione si riportano le indicazioni del libro di testo ed eventuali sussidi di approfondimento, materiali multimediali, attrezzature e spazi didattici) Le lezioni sono state svolte per circa metà anno in attrezzature esterne campetto calcio con scarsissima disponibilità di attrezzatur,ho sfruttato i percorsi trekking presenti nella zona facendo passeggiate all’aperto di 2 ore circa e presso una palestra della zona con convenzione di entrata per sviluppare il programma di potenziamento muscolare ; da febbraio abbiamo utilizzato il palasport limitrofo alla scuola, ove è presente solo la rete per pallavolo,utilizzando i pochi piccoli e grandi attrezzi presenti nella struttura utilizzata e forniti dalla scuola. Socializzazione tramite incontri di giochi sportivi, pallavolo e calcio fra i ragazzi di questo istituto, Incontro formativo su una giusta alimentazione tra cui anche quella sportiva e sui danni che causano le cattive abitudini e comportamenti dannosi alla salute ed il benessere psico-fisico sono previsti per maggio .giugno. Libro di testo: Del Nista, Parker e Tasselli, In perfetto equilibrio/ pensiero e azione per un corpo intelligente. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI I criteri adottati sono quelli deliberati dal collegio dei docenti e presenti nel POF 2014-2015 dell’ISI di Barga. STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: sono stati utilizzati: Spuntare le celle di pertinenza con una x Il docente si è avvalso delle seguenti tipologie diverse di verifica: Prove scritte tradizionali x Prove scritte strutturate (domande a risposta chiusa, singola o multipla) Prove scritte semi strutturate (domande a risposta chiusa e a risposta aperta) Prove orali Prove di ascolto x Esercitazioni pratiche x Osservazioni sistematiche x Prove che si avvalgono di misure dispensative e compensative per alunni/e con certificazione DSA e per alunni/e indicati dal Consigli di Classe come studenti con BES Schede di autovalutazione documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 25 x Altro (specificare):TEST MOTORI OBIETTIVI RAGGIUNTI In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: Conoscenza del linguaggio specifico, delle possibilità di espressione del corpo Conoscenza delle metodiche inerenti la pratica motoria Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo adeguato nelle diverse situazioni operative Capacità di realizzare attività finalizzate Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni sport di squadra Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento di alcune discipline sportive Conoscenza della giusta postura e mantenimento della stessa nelle diverse situazioni per la tutela della salute Conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico Barga, _______________________________ Firma del docente _________________________ VISTO PER ADESIONE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE ____________________________________ ____________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 26 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Prof. Don Emanuele Rosi Periodo Livello Ambito 1: Storia della Chiesa Contempranea Ripresa di Alcuni Aspetti della Riforma Protestante Settembre/ La Controriforma Gennaio Il Concilio di Trento Il Vaticano I Il Concilio Vaticano II Le Figure di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Febbraio Benedetto XVI, Papa Francesco Buono Ambito 2: Prinicipi di etica religiosa Marzo/Aprile Maggio La convivenza I rapporti al di fuori del matrimonio L’omossessualità Il matrimonio La nullità del matrimonio Discreto Metodologie utilizzati Lezioni Frontali- Conversazioni – Discussioni Strumenti utilizzati Testi e Documenti forniti dall’insegnante. Lettura del quotidiano per la discussione degli argomenti di attualità e di cultura generale. Proiezione di Film. Criteri di valutazione adottati Verifiche orali – interventi e domande degli alunni sui vari argomenti. Obiettivi raggiunti Gli Alunni hanno partecipato alle lezioni curriculari collaborando ed interessandosi alle tematiche proposte, raggiungendo gli obiettivi fissati nella programmazione nel corso del triennio. A volte, non sempre tutti gli argomenti sono stati approfonditi a causa del tempo limitato, ad una sola ora di lezione settimanale, nonostante questo, gli alunni sono in possesso di un metodo di studio ed hanno acquisito alcuni contenuti essenziali delle unità svolte, in modo sufficiente ed in particolare sanno accostarsi in maniera corretta al fenomeno religioso in genere, nel rispetto delle tradizioni di altri popoli e culture. Alcuni alunni sanno prestare sufficiente attenzione e valorizzare i diversi “saperi” in un’ottica di interdisciplinarietà, mostrando come la dimensione religiosa e quella culturale siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza. Visto per adesione I rappresentanti di classe ______________________________ ______________________________ Firma del docente _______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 27 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Prof.Roberto Ciari Prof.ssa Adelina Palmieri Periodo Livello Scambio Termico Settembre/ Ottobre Buono a) Richiami sui concetti dello scambio termico b) Scambiatori di calore ed esercitazioni c) Evaporatori: Bilanci di materia e di energia per il dimensionamento delle macchine. d) Evaporatori a singolo e multiplo effetto in controcorrente e d equicorrente. e) Rappresentazione grafica e principali sistemi di controllo per gli evaporatori. Cinetica e Termodinamica chimica Richiami di termodinamica ed equilibrio chimico Calcolo del H di una reazione. Calcolo del H;S eG di una reazione. Calcolo ella costante di equilibrio Cinetica : equazioni del primo e del secondo ordine. Ordine di reazione. Molecolarità. Fattori da cui dipende la velocità di reazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi eterogenea e omogenea. Catalizzatori .Attività, selettività. Concetto di adsorbimento chimico. Reattoristica: processi continui e discontinui. Reattori CSTR e PFR. Cinetica applicata ai reattori. Calcolo del volume ottimale e tempo di riempimento. Controllo della temperatura. Principali tipi di catalizzatori industriali. Applicazioni numeriche. Novembre/Dice mbre Buono Processi industriali della grande chimica inorganica 1) Sintesi dell’ammoniaca dagli elementi: Termodinamica, Cinetica; Catalisi e reattoristica. Principali variabili operative. d. Produzione di Gas di sintesi. Reforming di idrocarburi, idrolisi acqua, gassificazione del carbone e. Produzione di acido nitrico: Processo, Termodinamica, cinetica e impianti di produzione. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Dicembre/ Gennaio Buono Pagina 28 Distillazione Caratteristiche delle miscele liquide e aeriformi. Legge di Raoult, dei diagrammi di stato a temperatura costante e a pressione costante. Legge di Clausius-Clapeyron e Antoine. Miscele azeotropiche. Diagrammi di equilibrio x-y. Scelta della pressione operativa. Gennaio / Marzo Studio della colonna di frazionamento. Bilancio di massa. Ipotesi semplificative di McCabe e Thiele. Rette di lavoro per il tronco di arricchimento e quello di esaurimento. Rapporto di riflusso minimo, massimo ed effettivo. Condizioni termiche dell’alimentazione. Definizione del parametro q. Linea q. Determinazione grafica dei piatti teorici della colonna. Piatti effettivi. Riflusso. Criteri di scelta del rapporto di riflusso effettivo. Applicazioni numeriche e grafiche. Distillazione flash; distillazione discontinua; distillazione estrattiva; distillazione azeotropica. Controlli e schemi di impianti di distillazione. Buono Assorbimento e stripping 1. Solubilità dei gas nei liquidi: concetti termodinamici. Equazioni aprile / maggio di trasferimento di materia, trasferimento attraverso l’interfase, coefficiente di trasferimento globale. 2. Apparecchiature utilizzate negli impianti di assorbimento e stripping. Colonne a stadi e a riempimento. Curve di equilibrio e rette di lavoro, condizioni di pinch. Determinazione del numero di piatti teorici di una colonna a stadi. Cenni sul dimensionamento di colonne a riempimento. 3. Esercitazioni numeriche e grafiche. Biotecnologie Discreto maggio Sufficiente maggio/giugno Sufficiente Produzione di bioetanolo: Concetti teorici ed impianti Produzione di Penicillina: Concetti teorici ed impianti Il petrolio Petrolio, processi di raffinazione e aspetti generali della lavorazione del petrolio. Topping, Cracking, Reforming, Alchilazione, produzione di MTBE e Metanolo. Produzione di olefine leggere, 1-3 butadiene, C4. Programma di Laboratorio svolto Lavoro Svolto Tavole di disegno Disegno di un Impianto di evaporazione in controcorrente Disegno di un impianto di rettifica continua esame di stato anno 2008 Disegno Esame stato anno 2011 Disegno Esame stato anno 2002 Disegno di un impianto di assorbimento prova 2010 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Periodo scolastico Ottobre Marzo Aprile Aprile Maggio Pagina 29 Metodologie utilizzate Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione frontale, con particolare attenzione alla risoluzione di esempi e problemi numerici guidati in classe. Per l’approfondimento e la rielaborazione degli argomenti trattati sono state organizzate lezioni dialogate ed esercitazioni singole. Strumenti utilizzati Lo strumento principale utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi è stato il libro di testo per quanto riguarda la parte teorica e testi di esame per quanto riguarda la parte applicativa. Tempi del percorso formativo Per quanto riguarda i tempi sono state utilizzate circa 200 ore di lezione sulle 230 previste per necessità di alcuni recuperi. Il programma non è stato svolto secondo la programmazione perchè il livello iniziale della classe risultato modesto. Non è stato possibile sviluppare in modo approfondito la parte relativa all’estrazione liquido-liquido e solido-liquido e la parte relativa alle biotecnologie e alla petrolchimica. Criteri di valutazione adottati I criteri di valutazione adottati sono stati: la valutazione periodica formativa (valore diagnostico) per tenere conto dell’acquisizione dei contenuti propri della disciplina, la valutazione complessiva (effettuata alla fine del percorso formativo), la capacità di operare collegamenti, la capacità di esporre con linguaggio appropriato i contenuti acquisiti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Strumenti di valutazione adottati Nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte, una prova orale e una di disegno pratico mentre nel secondo quadrimestre sono state utilizzate quattro prove scritte e due di disegno pratico, per valutare sia le conoscenze teoriche che le abilità applicative. Obiettivi raggiunti Gli obiettivi indicati nel piano di lavoro sono stati in media sufficientemente raggiunti sia sul piano delle competenze minime che su quello delle conoscenze e delle capacità basilari. Gli obiettivi raggiunti possono essere riassunti come segue: a) conoscenze dei contenuti essenziali della disciplina; b) esposizione dei contenuti acquisiti in un linguaggio non sempre appropriato soprattutto nella produzione orale; c) capacità di analisi, sintesi e rielaborazione solo per un limitato numero di alunni. Visto per adesione I rappresentanti di classe ______________________________ ______________________________ Firma dei docenti ______________________________ ______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 30 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CHIMICA ANALITICA, ELABORAZIONE DATI E LABORATORIO Classe 5 A Anno scolastico 2014/2015 Prof.ssa Chiara Barsocchi Prof.ssa Adelina Palmieri Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle Periodo Livello competenze Introduzione ai metodi ottici. Atomi e molecole: modello atomico quanto meccanico. Settembre Teorie del legame chimico: VB e teoria dell’orbitale molecolare. Ottobre Livelli energetici atomici e molecolari. Radiazioni elettromagnetiche e loro parametri caratteristici. Interazione tra radiazione e materia: spettroscopia di assorbimento. Legge di Lambert-Beer e limiti di applicabilità. Spettri: posizione, intensità e larghezza delle bande spettrali. Spettrofotometria UV-vis. Assorbimento nell’UV-VIS. Tipi di transizione promossi. EffettoNovembrebatocromico. Maggio Strumenti. Funzione di Sorgenti, Monocromatori, Celle, Rivelatori.(laboratorio) Strumenti monoraggio e doppio raggio. Analisi qualitativa e analisi quantitativa tramite retta di taratura e aggiunta multipla. Spettrofotometria di assorbimento atomico Strumenti: Sorgente (emissione a catodo cavo), cenni al processo di Febbraio atomizzazione (sistema di atomizzazione in fiamma). Lo strumento in dotazione alla scuola non è funzionante perciò l’argomento è stato trattato solo teoricamente e solo in funzione di un confronto con la spettroscopia Uv-vis, per distinguere spettroscopia atomica e molecolare. Spettrofotometria IR. Strumenti: solo cenni al confronto fra strumenti a dispersione e inMaggio trasformata di Fourier e con spettroscopia UV/Vis. Analisi qualitativa: interpretazione generale dello spettro di una molecola organica con riconoscimento dei gruppi funzionali a partire dalla formula molecolare per il calcolo del numero di insaturazioni. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Dicembre Gennaio Buono Ottimo Cenni Cenni Buono Pagina 31 Analisi Cromatografica Cromatografia Meccanismi chimico-fisici e principi generali di separazioneFebbraio cromatografica. Maggio Parametri caratteristici della separazione cromatografica, utilizzati per valutarne la qualità: - tempo di ritenzione assoluto e corretto - selettività - Buono efficienza: teoria dei piatti teorici (numero di piatti) e teoria delle velocità (altezza equivalente del piatto teorico) risoluzione Gascromatografia: elementi fondamentali Strumenti: iniettori split-splitless; colonne impaccate e capillari; rivelatori FID ed ECD. Discreto Analisi quantitativa: il metodo della normalizzazione interna, il metodo della retta di taratura, il metodo delle aggiunte multiple, il metodo della standardizzazione interna. Buono MaggioGiugno Ripasso Laboratorio Nella prima parte dell’anno la classe è stata divisa in gruppi per imparare ad utilizzare i tre spettrofotometri UV/Vis in dotazione alla scuola. Successivamente gli studenti hanno lavorato a coppie, operando con i kit Merck per analisi acque, per imparare ad utilizzare la spettroscopia UV/Vis per l’analisi quantitativa mediante retta di taratura. NELLA SECONDA PARTE DELL’ANNO GLI STUDENTI HANNO IMPARATO AD IMPACCARE UNA COLONNA CROMATOGRAFICA ED ELUIRE UNA MISCELA A DUE COMPONENTI; SUCCESSIVAMENTE È STATO CONDOTTO UN LAVORO UNICO DELLA CLASSE SULLA MESSA A PUNTO DEL GASCROMATOGRAFO PER ANALISI DI MISCELE DI SOLVENTI. PURTROPPO IL GASCROMATOGRAFO ERA COMPLETAMENTE DA GETTARE, PERTANTO IL LAVORO FATTO È STATO SOPRATTUTTO RELATIVO AL SOFTWARE CHE ALL’ANALISI CHIMICA DEI SOLVENTI. ALCUNI STUDENTI HANNO INOLTRE SVOLTO ANALISI CHIMICHE, NON SOLO STRUMENTALI, SU MATRICI REALI CHE HANNO SCELTO DI ANALIZZARE PER LE LORO TESINE; GLI ALTRI HANNO PARTECIPATO ALLE ANALISI SU TALI MATRICI COME SUPPORTO AI COMPAGNI. NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA ALCUNI STUDENTI, A COPPIE O SINGOLARMENTE, SI SONO OCCUPATI DI METTERE A PUNTO SVARIATE ANALISI SULLE ACQUE, UTILIZZANDO GLI APPOSITI KIT, PER REGISTRARE LE RETTE SPERIMENTALI SUGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE. Grazie a questa costante attività di laboratorio si è osservato quanto segue: • • inizialmente solo una parte degli studenti è stata pienamente partecipe; alla fine dell’anno però quasi la totalità degli studenti ha mostrato impegno e interesse nelle analisi da svolgere; lo studio personale a casa è risultato non sempre adeguato, ad eccezione di un gruppo ristretto di studenti, pertanto tutto il lavoro di laboratorio è stato svolto a scuola; documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 32 • sono state evidenziate caratteristiche degli studenti che difficilmente emergono nelle normali attività didattiche: capacità gestionali e organizzative, capacità relazionali, capacità di sintesi e approfondimento. • Purtroppo lo spettrofotometro AAS in fiamma non era funzionante ed è stato impossibile anche l’uso del polarografo per mancanza di parti di ricambio, pertanto solo alcuni metalli sono stati analizzati tramite spettrofotometro UV/vis. Nemmeno lo strumento FT-IR era funzionante, pertanto è stata studiata l’interpretazione degli spettri (solo gruppi funzionali) ma senza un’analisi preliminare strumentale. Ogni analisi ha previsto: ✓ Organizzare ed elaborare le informazioni. ✓ Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli teorici di riferimento. ✓ Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di software dedicati ✓ Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica ✓ Reperire informazioni sulla struttura atomica/molecolare mediante UV-Vis, IR ✓ Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici ✓ Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le attività di laboratorio ✓ Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi ✓ Definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto ✓ Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore ✓ Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza ✓ Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione di un’analisi ✓ Analizzare criticamente i risultati di una indagine allo scopo di migliorare la procedura d’analisi. Nella valutazione sono state considerate: - le relazioni scritte - le esposizioni alla classe un monitoraggio continuo e costante dell’autonomia raggiunta dagli studenti, del loro grado di conoscenza di quanto operato e della capacità di trasporre quanto appreso in analisi successive e più difficili da svolgere. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 33 Contenuto disciplinare sviluppato • • • • • • • • Tempi Spettrofotometria UV-Vis Introduzione allo spettrofotometro UV/Vis, principio di Ottobre funzionamento e osservazione dei suoi componenti Marzo Analisi qualitativa di una soluzione di KMnO4 Determinazione a gruppi di nitrati, ferro, tensioattivi anionici, solfati, fosfati in acque potabili mediante retta di taratura (utilizzando kit Merck). Analisi di acque potabili - a coppia o singolarmente, alcuni Maggiostudenti hanno determinato uno dei seguenti parametri, per i quali termine è stata registrata sullo strumento la retta di taratura da riutilizzare lezioni in anni successivi: nitrati, ammoniaca, nitriti, solfati, fosfati, cromo, ferro, zinco, nichel (utilizzando kit Merck). MarzoTecniche cromatografiche Separazione su colonna in bassa pressione di una miscela di termine permanganato-bicromato lezioni Settaggio del gascromatografo Registrazione del cromatogramma di alcuni solventi Analisi chimica su matrici reali Analisi di matrici reali scelte dagli studenti per le tesine: Marzo - miele acidità, pH, concentrazione acqua, zuccheri riducenti Maggio - latte pH, peso specifico, acidità, proteine, ceneri, estratto secco - vino pH, acidità, anidride solforosa, tannini - olio acidità, acidi grassi polinsaturi, punto di fumo, saponificazione Livello di approfondimento Buono Buono Sufficiente Buono Metodologie utilizzate L’attività didattica è stata affrontata tramite la lezione frontale, con l’ausilio di presentazioni multimediali fornite dall’insegnante, supportata da ampia attività laboratoriale. Purtroppo le analisi svolte sono state concentrate sull’utilizzo di poche strumentazioni funzionanti (UV/Vis e GC). Il recupero è stato effettuato in itinere. • • • Risorse Libro di testo: R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro, Elementi di analisi chimica strumentale, 2^edizione,, Zanichelli Laboratorio di informatica Laboratorio di chimica e di analisi chimica strumentale Tempi del percorso formativo I tempi previsti per la disciplina sono 8 ore settimanali, per un totale di 264 ore annuali, di cui circa 6 ore alla settimana sono state dedicate all’attività di laboratorio. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 34 Il programma è stato svolto nel complesso secondo la programmazione, ad eccezione dell’interpretazione degli spettri NMR e MS e delle analisi in GC, per l’errato settaggio dello strumento. Criteri di valutazione adottati I criteri di valutazione adottati sono stati: la valutazione sommativa scritta e orale; la capacità di operare collegamenti, di esporre con linguaggio appropriato i contenuti acquisiti; la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione. Per la correzione degli elaborati scritti sono stati osservati i seguenti aspetti: la pertinenza alla richiesta, la correttezza ortografica e l’uso del lessico specifico; l’ordine logico; la capacità di sintesi; l’uso di procedimenti specifici in ambito scientifico. Per la valutazione delle prove orali sono stati osservati i seguenti aspetti: l’acquisizione critica dei contenuti e la capacità di operare collegamenti; la capacità di esporre con linguaggio appropriato, seguendo un percorso logico e coerente. Per la valutazione delle attività di laboratorio sono stati osservati i seguenti aspetti: l’approfondimento personale; il rispetto delle scadenze; la produzione di elaborati scritti che riportino correttamente i dati sperimentali; l’autonomia; la capacità di eseguire analisi secondo un protocollo di legge (anche in lingua inglese). Strumenti di valutazione adottati Sono stati utilizzati: - verifiche orali; - n. 4 prove scritte; - n. 2 simulazioni di terza prova d’esame nel secondo quadrimestre - n. 1 esposizioni alla classe - n. 2 prove brevi - quaderno di laboratorio - autonomia in laboratorio Obiettivi raggiunti Gli obiettivi raggiunti possono essere riassunti come segue, in base alle competenze dimostrate: 1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 4. Elaborare progetti chimici semplici e gestire attività di laboratorio documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 35 5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali Visto per adesione I rappresentanti di classe ______________________________ ______________________________ Firma dei docenti ______________________________ ______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 36 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA Classe 5 A Anno scolastico 2014/2015 Prof.ssa Nannizzi Silvia Prof.ssa Jessica Della Scala Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Le biomolecole 1. Sintesi e riepilogo degli argomenti trattati in classe IV: amminoacidi, proteine, carboidrati semplici e complessi 2. Struttura, proprietà e nomenclatura degli acidi grassi 3. Struttura e proprietà dei lipidi 4. Struttura e proprietà delle membrane biologiche 5. Enzimi e catalisi enzimatica: nomenclatura, classificazione, meccanismo di azione, proprietà strutturali, fattori che influenzano l’attività enzimatica. 1. 2. 3. 4. 5. I microrganismi e la cellula Classificazione degli organismi viventi. Cellula eucariote e procariote Microrganismi di interesse industriale e sanitario. Breve trattazione storica delle principali tappe di rilievo in campo microbiologico Struttura della cellula batterica: - Membrana e meccanismi di trasporto attraverso la membrana - Parete cellulare: struttura, composizione, analogie e differenze tra Gram + e Gram -. Colorazione di Gram. - Strutture accessorie - DNA e plasmidi Periodo Livello Settembre Novembre Buono Aprile Discreto Dicembre Gennaio Buono febbraio Buono Marzo Buono Aprile Buono Maggio Discreto Marzo Aprile Sufficiente Metabolismo microbico 1. Aspetti introduttivi: definizioni e molecole coinvolte. 2. Tipi di trofie: microrganismi chemiorganotrofi, chemiolitotrofi, fototrofi; microrganismi aerobi, anaerobi e fermentanti. 3. Respirazione aerobica e anaerobica. Glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e accoppiamento chemiosmotico. Accettori terminali di elettroni. 4. Fototrofismo ossigenino e anossigenico: pigmenti utilizzati con analogie e differenze tra i diversi gruppi di microrganismi fotosintetici. Fase luminosa e fase oscura del processo. 5. Fermentazioni: alcolica, omolattica, etero lattica e acetica. Coltivazione e crescita dei microrganismi 1. Fattori che condizionano la crescita batterica: fattori nutritizi, di crescita, ambientali. Classificazione in base alla temperatura, richiesta di ossigeno e pH 2. Terreni di coltura: fonti di carbonio, di azoto, di ioni inorganici. Classificazione in base allo stato fisico, alla costituzione chimica e alla funzione documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 37 Biotecnologie 1. Microrganismi e produzioni industriali - Muffe: fermentazione citrica; produzioni di antibiotici - Lieviti: Produzione dell’etanolo - Batteri: fermentazione acetica e lattica - Produzione di amminoacidi e vitamina C Maggio Giugno discreto 2. Acidi nucleici e miglioramento genetico - Strutture e proprietà degli acidi nucleici - Mutazioni, trasferimenti genetici e ricombinazione - DNA ricombinante Programma di laboratorio svolto Contenuto disciplinare sviluppato - Microscopio ottico ed elettronico: struttura ed uso del microscopio ottico. - Allestimento di vetrini - Osservazione a fresco con e senza colorazione semplice - Colorazione Gram + / Gram - Preparazione di terreni di coltura - Semina, isolamento e trapianto di colture Livello Discreto Metodologie utilizzate L’attività didattica è stata affrontata tramite lezioni frontali supportate dall’utilizzo di strumenti multimediali e da attività di laboratorio, opportunamente selezionate. Non avendo la docente completato la formazione CLIL prevista dalla normativa non sono stati svolti argomenti in lingua inglese ma è stata inserita una parte di terminologia e schematizzazione degli argomenti in lingua alla fine della trattazione in italiano. Risorse In attesa della pubblicazione di un testo adeguato al tipo di percorso non era stato adottato alcun libro di testo per questa disciplina in questa classe. L’insegnante ha curato la stesura di dispense in formato elettronico condivise durante l’anno con gli studenti tramite dropbox. Tempi del percorso formativo Per quanto riguarda i tempi sono state utilizzate 83 ore di cui 20 h impiegate in attività di laboratorio. Il programma non è stato svolto completamente, soprattutto per quanto riguarda la parte di laboratorio a causa del ritardo nella sistemazione del laboratorio di microbiologia nella nuova struttura scolastica che ad oggi risulta non essere ancora stato ultimato nonostante i numerosi solleciti della Scuola. Per questo motivo non è stato possibile effettuare molte delle esperienze programmate all’inizio dell’anno, soprattutto quelle implicanti l’utilizzo della cappa aspirante (condizioni sterili) ancora non funzionante. Criteri di valutazione adottati I criteri di valutazione adottati sono stati: operare collegamenti esporre con linguaggio appropriato i contenuti trattati, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione Strumenti di valutazione adottati Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati Quesiti a risposta aperta come da terza prova d’esame documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 38 Produzione di elaborati multimediali di ricerca/approfondimento Colloqui Monitoraggio dell’attività sperimentale e della successiva rielaborazione Quaderno di laboratorio e relazioni tecniche sulle esperienze svolte Obiettivi raggiunti Gli obiettivi raggiunti possono essere riassunti come segue: 1. conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina; 2. esposizione dei contenuti acquisiti in un linguaggio sufficientemente appropriato; 3. capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale (solo per un numero ristretto di alunni). Visto per adesione I rappresentanti di classe ______________________________ ______________________________ Firma dei docenti ______________________________ ______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 39 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE MATEMATICA Classe 5° A Anno scolastico 2014/2015 Contenuti del programma che saranno utilizzati in funzione delle competenze Modulo n°0: RIPASSO Definizione di derivata e suo significato geometrico. Relazione tra derivabilità e continuità delle funzioni. Regole di derivazione (derivata delle funzioni elementari, derivata della somma , del prodotto, del quoziente). Derivata di una funzione composta. Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Modulo n°1: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE ALLO STUDIO DI FUNZIONI Definizione di punto stazionario e di massimo e minimo relativo. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti: condizione necessaria affinché un punto sia punto di massimo o minimo relativo per funzioni derivabili; condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo. Definizione di flesso: orizzontale, obliquo e a tangente verticale. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda. Studio di funzione : determinazione del dominio, ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui, intervalli di monotonia, ricerca di punti di massimo, di minimo e di flesso di funzioni algebriche e trascendenti (logaritmiche ed esponenziali) . Modulo n°2: CALCOLO INTEGRALE Integrale indefinito: concetto di funzione primitiva. Integrale indefinito come operatore lineare. Regole di integrazione immediate e metodo di scomposizione. Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di grado due). Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Prof.ssa Pieri Michela Periodo Livello Settembre Buono Ottobre Novembre Buono Novembre Dicembre Gennaio Discreto Pagina 40 Modulo n°3: APPLICAZIONE DEL CALCOLO INTEGRALE AL CALCOLO DELLE AREE Integrale definito: area del trapezoide. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media con interpretazione geometrica. Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Relazione tra la funzione integrale e l’integrale definito, formula fondamentale del calcolo integrale. Applicazione degli integrali definiti per il calcolo di aree delimitate dal grafico di funzioni. Modulo n°4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI Equazioni differenziali del 1° ordine: equazioni del tipo Febbraio Marzo Aprile Maggio Discreto Discreto y' f x; equazioni a variabili separabili; equazioni lineari. Equazioni differenziali del 2° ordine: equazioni del tipo y'' f x. Metodi utilizzati Nella trattazione degli argomenti è stata privilegiata la lezione frontale facendo ricorso anche alla lezione dialogata per coinvolgere in maniera attiva e partecipe la classe. Pur mantenendo un linguaggio rigoroso si è cercato di semplificare la trattazione degli argomenti, senza tuttavia tralasciare la giustificazione di certe conclusioni. Per sopperire alle difficoltà incontrate dagli alunni, ogni occasione è stata sfruttata per chiarire dubbi riguardanti anche conoscenze pregresse e darne ulteriore spiegazione. Per ogni modulo sono stati proposti esercizi standard partendo da quelli più semplici per arrivare a quelli più complessi. Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in itinere ma nel secondo quadrimestre si sono resi necessari alcuni incontri di recupero pomeridiani che i ragazzi hanno seguito in modo costante e costruttivo. Strumenti utilizzati 1. Lavagna tradizionale. 2. Lavagna interattiva multimediale. 3. Testi adottati (MATEMATICA E TECNICA TOMO A-B-D-E) M. Re Fraschini-G.Grazzi Ed. ATLAS. 4. Appunti fotocopiati o schede di esercizi per la preparazione delle verifiche. Tempi del percorso formativo Per quanto riguarda i tempi sono stati utilizzati quelli previsti dai programmi ministeriali in ragione di n. 3 ore settimanali per un totale di 99 ore annuali. In ogni caso va considerato che le ore effettivamente svolte sono state in numero minore a causa dell’adesione della classe a numerosi progetti ed attività extrascolastiche. La motivazione prevalente del mancato rispetto del piano formativo iniziale è comunque da attribuirsi alla necessità di completare il programma previsto per la classe 4° che ha costretto a documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 41 ridurre la trattazione delle equazione differenziali e ad eliminare lo studio delle funzioni di due variabili. Criteri di valutazione adottati Le prove assegnate sono state sia tradizionali che strutturate e con esse si è cercato di verificare la conoscenza dei contenuti e delle tecniche viste in classe. Per quanto riguarda la valutazione orale, nelle interrogazioni si è cercato di curare soprattutto gli aspetti teorici, come definizioni, teoremi e relative dimostrazioni. I criteri di valutazione sono quelli approvati nel POF. Strumenti di valutazione adottati Sono stati utilizzati: f) Primo periodo (settembre-dicembre) n° 1 prove orali n° 2 prove scritte g) Secondo periodo (gennaio-giugno) n°2 prove orali + 2 prove strutturate (simulazione 3° prova) n°3 prove scritte Obiettivi raggiunti Rispetto agli obiettivi indicati nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico in corso la classe, nel complesso, ha raggiunto un livello di conoscenza e competenza mediamente sufficienti anche se solo pochi alunni hanno ottenuto risultati tra il discreto e il molto buono ed evidenziato capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione dei contenuti appresi; comunque anche quelli che non sono riusciti a raggiungere un grado accettabile di conoscenza hanno generalmente mostrato impegno nel tentativo di superare le difficoltà incontrate. Inoltre è emersa una maggiore predisposizione per la produzione scritta rispetto a quella orale, nella quale la maggior parte degli alunni denota difficoltà nell’uso di un linguaggio specifico e rigoroso. Visto per adesione I rappresentanti di classe ______________________________ ______________________________ Firma del docente _______________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 42 Allegato 2 CRITERI VALUTAZIONE POF documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 43 I criteri di valutazione I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei Docenti per l’Anno Scolastico 2014-2015, sono i seguenti: Valutazione del Consiglio di Classe: uso della SCALA DECIMALE nelle valutazioni Voto 1-3 4 5 6 7 8 9 - 10 f) Livello di corrispondenza Insufficienza grave Insufficienza Mediocrità / Insufficienza lieve Accettabilità / Sufficienza Discreto Buono Ottimo Obiettivi Non raggiunti nella quasi totalità: la materia è stata abbandonata Nel complesso non raggiunti Raggiunti solo parzialmente Raggiunti in modo accettabile Raggiunti in modo soddisfacente Pienamente raggiunti Raggiunti ad un livello eccellente Esito finale Il Consiglio di Classe può ammettere l’alunno alla classe successiva motivando tale decisione. L’alunno è ammesso alla classe successiva Per la valutazione globale e per la promozione, il Consiglio di Classe tiene conto del fatto che l'alunno/a abbia raggiunto conoscenze e competenze minimi nelle discipline portanti dell'area comune e dell'area d'indirizzo; dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, compresa la materia di Religione (se è stata scelta) o eventuali attività scolastiche alternative. del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; degli aspetti socio-affettivi; della partecipazione ai tirocini e agli stage; del fatto che l’alunno/a abbia riportato una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento. g) L'attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avviene secondo i seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente e dal punto precedente e tenendo conto che la media dei voti superiore o uguale al mezzo punto dà già adito all'ottenimento del punteggio massimo della relativa banda di oscillazione: frequenza delle lezioni, partecipazione e impegno di studio; partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica (ad es. organi collegiali); partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o ad essa richieste; partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola; valutazione del comportamento. In sede di scrutinio per gli alunni con giudizio sospeso, il Consiglio di Classe deciderà, caso per caso, l’attribuzione del credito scolastico. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 44 Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) sono valutati se acquisiti in almeno uno degli ambiti sotto elencati – e regolarmente documentati – con l’attribuzione del massimo della banda di oscillazione del relativo credito: d) e) f) g) volontariato sociale; lavoro; formazione professionale; cultura; h) sport. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, comorbilità) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (DPR n. 122/2009; Legge n. 170/2010, Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e allegate Linee guida), gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Per la valutazione del limite delle assenze si fa riferimento al Regolamento applicativo del limite delle assenze Delibera del Collegio Docenti dell’8 settembre 2014 consultabile sul sito della Scuola. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 45 Valutazione del Consiglio di Classe: attribuzione del VOTO DI CONDOTTA i) A partire dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. j) La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. k) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunna o dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma1, del DPR n. 249/98 e successive modificazioni. INDICATORI FREQUENZA E PUNTUALITÀ IMPEGNO E COSTANZA NELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO RISPETTO DELLE NORME DISCIPLINARI BUONO SUFFICIENTE Costanti Discontinui Impegno costante, Rispetto puntuale nelle consegne Impegno discontinuo, non sempre puntuale nelle consegne Adeguato, pur in presenza di qualche sanzione disciplinare Costante INSUFFICIENTE Saltuaria, soprattutto in concomitanza con verifiche Mancanza di impegno e di puntualità nelle consegne Non adeguato, con presenza di ripetute sanzioni disciplinari l) GIUDIZIO SUGLI INDICATORI 3 giudizi buoni 2 giudizi buoni e 1 sufficiente 3 giudizi almeno sufficienti oppure 2 sufficienti con almeno 1 buono 1 giudizio almeno sufficiente Nessun giudizio sufficiente Alunni fatti oggetto di provvedimenti disciplinari di cui all’art. 4, comma 9 e 9bis del DPR 249/1998 e successive modifiche, qualora non vi siano indicazioni di ravvedimento e alunni che violino i doveri di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 5 del DPR 249/98 e successive modificazioni. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo VOTO DA ASSEGNARE 10 9 8 7 6 5 Pagina 46 Allegato 3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 47 Valutazione della prova scritta di ITALIANO Indicatori Analisi del testo Descrittori Comprensione Riassunto, parafrasi Competenze testuali p. 1 - 3 Competenze ideative p.1 - 4 punti Chiaro ed efficace 3 completo ma superficiale 2 incompleto o non chiaro 1 completa e approfondita completa, ma superficiale manca o è svolto in modo non efficace uno dei punti della traccia manca o sono svolti in modo non efficace due punti della traccia Analisi p. ass. 4 3 2 1 Interpretare e collegare con altri testi dello stesso autore e\o di altri autori Correttezza ortografica e morfosintattica lessico adeguato ampiezza del vocabolario registro linguistico coerente Capacità critiche p.1 - 3 Capacità espressive p.1 - 5 1 2 3 2,5 4 3 particolare originalità sufficiente capacità di contestualizzare e collegare carenze o difficoltà nel contestualizzare e collegare 3 2 1 elaborato corretto,esposizione chiara, lessico vario e appropriato alcuni errori esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico semplice molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, lessico non appropriato moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti vocaboli sbagliati e generici 5 4 3 2 1 5 3,5 6 4 7 4,5 8 5 9 5,5 10 6 11 6,5 12 7 13 8 14 9 15 10 punti 3 p. ass. Valutazione della prova scritta di ITALIANO : Tip. B – C – D ALUNNO... data punti …............ \15 voto …............ \10 Indicatori Rispetto delle consegne Competenza pertinenza alla traccia testuale registro stilistico p. 1 – 3 Capacità di organizzare il Competenza testo : organicità, ideativa coerenza, coesione ricchezza dei contenuti p. 1 – 4 Descrittori Completa attinenza alle consegne e uso di un registro stilistico adeguato sufficiente attinenza alle consegne e uso non costante del registro stilistico 2 scarsa attinenza alle consegne 1 Contenuti approfonditi e coerenza di argomentazione\esposizione 4 contenuti essenziali e buona coerenza\coesione 3 contenuti essenziali e sufficiente coerenza\coesione 2 contenuti superficiali e argomentazione disorganica 1 Sviluppo critico p. 1 – 2 analisi, riflessione critica, rielaborazione personale, collegamenti , originalità Trattazione personale con originali elementi di riflessione 2 spunti personali di riflessione critica 1 elaborato corretto, esposizione fluida, lessico vario e appropriato 6 alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 5 Capacità espressiva p. 1 -6 correttezza ortografica e morfosintattica lessico adeguato, ampiezza del vocabolario registro linguistico coerente diversi errori non gravi, esposizione abbastanza scorrevole, lessico semplice 4 molti e/o gravi errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico non appropriato 3 moltissimi errori, esposizione non scorrevole, lessico inadeguato 2 moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti vocaboli sbagliati e generici 1 1 2 3 2,5 4 3 5 3,5 6 4 7 4,5 8 5 9 5,5 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo 10 6 11 6,5 12 7 13 8 14 9 15 10 Pagina 48 ESERCIZIO 1. DISEGNO ESERCIZIO 2. CALCOLI DI PROCESSO GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA Indicatori Descrittori Punteggio Approfondita Discreta Elementi essenziali Sufficiente (Funzionalità di processo) Superficiale Scarsa Approfondita Simbologia UNICHIM e Discreta legenda Sufficiente (padronanza dei metodi Superficiale grafici) Scarsa Approfondita Discreta Sistemi di controllo Sufficiente Superficiale Scarsa PUNTEGGIO ESERCIZIO 1. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Descrittori Punteggio Utilizza gli strumenti di analisi e calcolo in modo corretto, sicuro e completo 5 Utilizza gli strumenti di analisi e calcolo in modo corretto sicuro ma con qualche errore di calcolo/unità misura Utilizza gli strumenti di analisi e calcolo in modo sufficiente ma incompleto diversi errori calcolo/unità misura Utilizza gli strumenti di analisi e calcolo in modo insufficiente errori di impostazione dei calcoli/errori nei calcoli. Capacità di analisi e calcolo limitate e approssimative 4 3 2 1 PUNTEGGIO ESERCIZIO 2. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 49 ESERCIZIO Descrittori Punteggio Contenuti approfonditi, correttezza formale, capacità di rielaborazione personale fluida e sicura, linguaggio specifico appropriato Contenuti abbastanza approfonditi e coprono tutti gli aspetti essenziali, linguaggio appropriato, coerenza con la traccia 3. RELAZIONE TECNICA 5 4 Contenuti limitati agli aspetti essenziali , linguaggio sufficientemente 3 Contenuti limitati e superficiali, linguaggio insufficiente, risposta incompleta 2 Conoscenze lacunose, linguaggio improprio , fuori traccia 1 PUNTEGGIO ESERCIZIO 3. SCALA DI CORRISPONDENZA QUINDICESIMI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DECIMI 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 Alunno:______________________________ Voto in 15:________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 50 CAPACITA’ COMPETENZE CONOSCENZE GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA - tipologia B ESERCIZI INDICATORI VALUTAZIONE 1 2 3 Acquisizione corretta dei contenuti/ Comprensione e conoscenza dei concetti e/o delle leggi scientifiche richieste dalla traccia Scarsa/inesistente 1 1 1 Lacunosa /con alcuni errori anche gravi 2 2 2 Parziale ma corretta 3 3 3 Corretta ma limitata agli elementi essenziali 4 4 4 Completa 5 5 5 Completa, approfondita, critica 6 6 6 Non coerente 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Appropriata e coerente 5 5 5 Precisa e articolata 6 6 6 Non sempre corretta e appropriata 1 1 1 Corretta e appropriata 2 2 2 Pertinente e efficace 3 3 3 Comprensibile con alcuni errori Semplice con alcune incongruenze Semplice ma corretta e coerente Esposizione, utilizzo del linguaggio specifico/interpretazione e utilizzo di formule e procedimenti nel campo scientifico Interpretazione rielaborazione e sintesi PUNTEGGIO ESERCIZI ALUNNO PUNTEGGIO MEDIO VALUTAZIONE DELLA PROVA SCALA DI CORRISPONDENZA QUINDICESIMI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DECIMI 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 51 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE INDICATORI VALUTAZIONE Disorientamento o grandi difficoltà nel comprendere il testo e quanto richiesto dalle domande Comprensione parziale con solo alcuni elementi e non sempre pertinente a quanto richiesto Comprensione del testo e pertinenza della risposta Comprensione dei punti essenziali o del senso generale, organizzati in modo abbastanza pertinente Comprensione discreta con la maggior parte degli elementi richiesti e pertinente Comprensione buona con tutti gli elementi richiesti in modo pertinente Gravi e numerosi errori grammaticali, lessicali e sintattici; espressione confusa e frammentaria Diversi errori di grammatica; lessico non sempre corretto, limitato e ripetitivo; discorso a volte Correttezza e incoerente appropriatezza formale (grammatica, sintassi e Pochi errori grammaticali e sintattici, lessico lessico) essenziale e una coerente organizzazione interna Qualche errore grammaticale, lessico adeguato e sintassi abbastanza articolata Errori irrilevanti; lessico e organizzazione sintattica coerenti e adeguati le risposte sono frammentarie, copiate dal testo e non rielaborate in maniera personale Capacità di sintesi e di le risposte sono parzialmente rielaborate, ma denotano rielaborazione personale una sufficiente capacità di sintesi Le risposte dimostrano una rielaborazione personale rispetto al testo con una buona capacità di sintesi PUNTEGGIO ESERCIZI ALUNNO PUNTEGGIO MEDIO VALUTAZIONE DELLA PROVA ESERCIZI 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Allegato 4 documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 52 SIMULAZIONE PROVE ESAME documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 53 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (LU) Classe V sez A 20 Marzo 2015 Esame di Stato 2015: Terza Prova ________________________________________________________________ Corso di Chimica e Materiali Tipologia della prova: b Materie: Analisi chimica strumentale Inglese Microbiologia Matematica Durata massima della Prova 2 ore: Dalle ore 9:10 alle ore 11:10 Ora di Consegna:_______________ Nome Candidato: _________________________ Firma Commissari:________________ Firma Candidato: _________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Numero Fogli consegnati compresa la presente copertina:________ Durante lo svolgimento della prova è consentito l’uso di : - Calcolatrici non programmabili Non è consentita la consultazione di libri di testo Non è consentito lasciare l’Istituto prima che sia trascorsa almeno 1 ora dalla consegna del testo documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 54 Non è consentito l'uso del cellulare per nessun motivo: il cellulare va consegnato spento prima della prova agli insegnanti di sorveglianza. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 55 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 20 Marzo 2015 ANALISI CHIMICA STRUMENTALE - Descrivi il meccanismo di esclusione, o permeazione su gel, nella separazione cromatografia e indica possibili campi di applicazione _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ - Descrivi lo strumento UV/Vis nei suoi componenti fondamentali, con particolare riferimento alle differenze fra spettrofotometri a doppio e singolo raggio. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 56 - La retta di taratura effettuata per la determinazione del rame in assorbimento atomico fatta per basse intensità del segnale A è (vedi tabella) : Sapendo che la deviazione standard dal valor medio per il bianco risulta, per un dato numero di prove, uguale a 0.002, calcola il limite di rilevabilità LdR e il limite di quantificazione LdQ. Calcola inoltre la concentrazione di una soluzione incognita che presenta, dopo diluizione 1+9, un’assorbanza di 0,3. Concentrazione Assorbanza (μg/L) A 16 0.10 64 0.42 160 0.81 Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 57 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 20 Marzo 2015 INGLESE Read the text and answer the questions below. Water pollution Water covers over 70% of the Earth's surface and is a very important resource for people and the environment. Water pollution affects drinking water, rivers, lakes and oceans worldwide. This consequently harms human health and the natural environment. Water can be polluted by nitrates from fertilizer runoff, lead compounds from lead pipes, or pesticides sprayed near water resources. Fertilizers are used to help plants to grow better, but they can enter waterways and cause problems. The nitrates in fertilizers can cause algae to grow at a fast rate. Eventually the algae die and bacteria begin to decompose them. The bacteria use up the oxygen in the water. Fish and other aquatic life cannot get enough oxygen and may die. This is called eutrophication. In the UK water is taken from areas that are well away from any sources of pollution, including lakes, rivers, aquifers and reservoirs. There is only a limited supply of fresh water, so it is crucial that we conserve water when we can. Source: http://www.water-pollution.org.uk What is eutrophication? How does it affect aquatic life? …............................................................................................ .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 58 What are some of the causes of water pollution? …............................................................................................ .............................................................................................. What does “fertilizer runoff” mean? …............................................................................................ .............................................................................................. Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 59 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 20 Marzo 2015 MICROBIOLOGIA 1. Confronta la parete cellulare nei batteri Gram + e Gram -, individua le principali differenze strutturali e spiega perché le due strutture si comportano diversamente rispetto alla colorazione di Gram. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Definisci il metabolismo e differenzia opportunamente tra anabolismo e catabolismo individuando quali relazioni esistono tra i due processi. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. Descrivi sinteticamente le principali strategie metaboliche adottate dai microrganismi per il rifornimento energetico. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 60 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 20 Marzo 2015 MATEMATICA 1. Trova a e b nella funzione grafico abbia un flesso nel punto con in modo che il suo e passi per . 2. Calcola i seguenti integrali: a. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo b. Pagina 61 3. Determina l’area della parte di piano delimitata dal grafico della funzione e dall’asse delle x nell’intervallo . Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 62 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (LU) Classe V sez A 24 Aprile 2015 Esame di Stato 2015: Terza Prova Corso di Chimica e Materiali Tipologia della prova: b Materie: Analisi chimica strumentale Inglese Microbiologia Storia Durata massima della Prova 2 ore: Dalle ore 10:15 alle ore 12:15 Ora di Consegna:________________ Firma Commissari: Nome Candidato: __________________ ________________ Firma Candidato: __________________ ________________ ________________ __________________ Numero Fogli consegnati compresa la presente copertina: _______________ Durante lo svolgimento della prova è consentito l’uso di : - Calcolatrici non programmabili Non è consentita la consultazione di libri di testo Non è consentito lasciare l’Istituto prima che sia trascorsa almeno 1 ora dalla consegna del testo Non è consentito l'uso del cellulare per nessun motivo: il cellulare va consegnato spento prima della prova agli insegnanti di sorveglianza. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 63 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 24 Aprile 2015 ANALISI CHIMICA STRUMENTALE 1. Descrivi sinteticamente le due caratteristiche fondamentali della separazione cromatografica Quantità aggiunte Area (mg) (cm2) 0,3955 4580 0,791 8923 1,300 16986 1,582 21903 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 2. Un campione di una bevanda alcolica fu analizzato per determinare il contenuto di metanolo. Previa una distillazione, un’aliquota del campione raccolta dal distillato fu sottoposta ad analisi gascromatografica ottenendo un’area pari a 1348cm2. Per la determinazione quantitativa si decise di procedere con il metodo delle aggiunte, pertanto furono aggiunte a 10mL del campione analizzato le quantità specificate in tabella, ottenendo le rispettive aree. Calcolare la quantità del campione analizzato. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 64 3. Lo spettro IR in figura è stato ottenuto da un composto di formula empirica C 9H8O. Indica i gruppi funzionali presenti e la possibile struttura molecolare Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 65 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 24 Aprile 2015 INGLESE Read the text and answer the questions below. Plastic bags are one of the greatest problems of the consumer society – or to be more precise – of the throwaway society. First introduced in the United States in 1957 and into the rest of the world by 1960s, they have been found so convenient that they have come to be used in massive numbers. In the world as a whole, the annual total manufactured now probably exceeds a trillion. According to a recent study, whereas plastic bags were rarely seen at sea in the late eighties and early nineties, they are now being found almost everywhere accross the planet, from Spitsbergen in the Arctic to the South Atlantic close to Antarctica. They are among the 12 items of rubbish most often found in coastal clean-ups. On land they are everywhere, too. Windblown plastic bags are so common in Africa that a small industry has appeared: harvesting bags and using them to make hats and other items, with one group of people collecting 30,000 per month. In some developing countries they are a major nuisance in blocking the drainage systems of towns and villages. What does the author of the text mean by “throwaway society”? .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 66 In your opinion, why have plastic bags been used so massively? .............................................................................................. .............................................................................................. How have plastic bags turned into resource materials in Africa? .............................................................................................. .............................................................................................. Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 67 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 24 Aprile 2015 MICROBIOLOGIA 1. Scrivi l’equazione chimica bilanciata dell’ossidazione completa del glucosio e descrivi sinteticamente le principali fasi con cui si realizza il processo. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Indica in quali fasi della respirazione aerobia si formano i singoli prodotti. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 68 3. Spiega come sono prodotte le 38 molecole di ATP nel catabolismo aerobio del glucosio. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 69 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 24 Aprile 2015 STORIA 1. Illustra le principali differenze fra Destra storica e Sinistra. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________ 2. Quali sono le relazioni fra imperialismo e scoppio della prima guerra mondiale? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 70 3. Illustra le caratteristiche del totalitarismo novecentesco. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 71 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (LU) Classe V sez A 12 maggio 2015 Esame di Stato 2015: Terza Prova ________________________________________________________________ Corso di Chimica e Materiali Tipologia della prova: b Materie: Storia Inglese Microbiologia Matematica Durata massima della Prova 2 ore: Dalle ore _____ alle ore ______ Ora di Consegna:________________ Firma Commissari: Nome Candidato: __________________ ________________ Firma Candidato: __________________ ________________ ________________ __________________ Numero Fogli consegnati compresa la presente copertina: _______________ Durante lo svolgimento della prova è consentito l’uso di : - Calcolatrici non programmabili Non è consentita la consultazione di libri di testo Non è consentito lasciare l’Istituto prima che sia trascorsa almeno 1 ora dalla consegna del testo Non è consentito l'uso del cellulare per nessun motivo: il cellulare va consegnato spento prima della prova agli insegnanti di sorveglianza. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 72 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 12 maggio 2015 STORIA 1. Illustra i principali problemi del neonato regno d’Italia. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________ 2. Quali sono le caratteristiche della seconda rivoluzione industriale? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 73 3. L’Europa e gli Stati Uniti nel periodo fra le due guerre mondiali. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________ Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 74 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 12 maggio 2015 INGLESE ALGAE BIOFUELS: THE WAVE OF THE FUTURE The necessity of developing alternative, renewable fuel sources to prevent a potential energy crisis and alleviate greenhouse gas production has long been recognised. Various sources have been tried – corn for ethanol and soybeans for biodiesel, for example. But to truly meet the world's fuel needs, researchers must come up with a way to produce as much biofuel as possible in the smallest amount of space using the least amount of resources. With fairly straightforward genetic modification, Nannochloropis gaditana – a marine alga – should be capable of producing biofuel on an industrial scale, which may be the wave of the future in the fuel research and production. Why are alternative sources of energy being developed? …........................................................................................... .............................................................................................. . How can Nannochloropis gaditana be the wave of the future in fuel production? …........................................................................................... .............................................................................................. . What is a biofuel? .............................................................................................. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 75 .............................................................................................. Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 76 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 12 maggio 2015 MICROBIOLOGIA 1. I microrganismi presentano una grande versatilità metabolica: possono utilizzare, infatti, diverse fonti di energia, di carbonio e potere riducente. Descrivi sinteticamente i principali gruppi metabolici a te noti. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. I processi metabolici sono regolati in modo altamente specifico da enzimi. Descrivi le proprietà e il meccanismo di azione di queste sostanze e spiega perché sono indispensabili al corretto funzionamento dei processi in cui sono coinvolti. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 77 3. Descrivi sinteticamente le caratteristiche comuni ai processi di fermentazione, spiega quali necessità metaboliche sono soddisfatte con questi processi e fai un esempio. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 78 ITT “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (Lu) Classe 5A 12 maggio 2015 MATEMATICA 1. Determina l’integrale particolare della seguente equazione differenziale verificante la condizione iniziale indicata: 2. Data la funzione determina l’altezza del rettangolo equivalente al trapezoide definito dal grafico nell’intervallo [0,2] (valor medio) documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 79 3. Data la funzione trova a e b in modo che presenti un punto di estremo relativo per x = 2 e che il suo asintoto obliquo passi per il punto di coordinate (3;8) Voto finale in 15:__________________; Voto finale in 10:_________________ documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 80 ITIS “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (LU) Classe V sez A 30 aprile 2015 Compito di Tecnologie Chimiche Industriali – Simulazione Seconda Prova Il candidato realizzi il disegno dello schema descritto nel primo esercizio e, a sua scelta, risponda a due degli altri tre quesiti proposti. 1) In un reattore cilindrico, contenente un catalizzatore solido allo stato granulare, vengono inviati in modo continuo due gas, a pressione superiore a quella atmosferica, che, portati a temperatura opportunamente elevata, reagiscono formando un composto facilmente condensabile a temperatura ambiente. La reazione, esotermica, viene mantenuta alla temperatura ottimale grazie ad un opportuno circuito di refrigerazione interno al reattore. La reazione, inoltre, è realizzata in condizioni di equilibrio tali che solo una parte dei gas sono convertiti nel prodotto desiderato. Dal reattore esce, pertanto, una miscela di aeriformi (gas non reagiti e composto formatosi) che viene inviata ad un condensatore alimentato da acqua industriale di raffreddamento, nel quale il condensato raggiunge una temperatura prossima a quella ambiente. Tale prodotto, raccolto in un primo serbatoio, contiene disciolti, in parte, i gas non reagiti. Attraverso una valvola riduttrice di pressione, il liquido passa quindi ad un secondo serbatoio nel quale viene a trovarsi ad una pressione di poco superiore a quella ambiente. In tale serbatoio si libera la quasi totalità dei gas disciolti nella fase liquida. Tali gas vengono recuperati e riciclati al reattore, dopo esser stati riportati a pressione elevata. Il prodotto liquido ottenuto prosegue quindi verso altre lavorazioni. Il candidato disegni lo schema del processo descritto, completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, serbatoi ecc.), dei recuperi di calore ritenuti opportuni e delle regolazioni automatiche principali, seguendo per quanto possibile, la normativa UNICHIM. ( Traccia esame 2002) 2) Una miscela bicomponente, la cui composizione è XF = 0,56, è sottoposta a rettifica continua. Si ottiene un distillato di composizione XD = 0,98 e un prodotto di fondo di composizione XW = 0,05. Le composizioni sono espresse come frazione molare del componente più volatile. La portata della miscela è F = 3,5 mol/s ed entra in colonna allo stato liquido e alla temperatura TF = 122 °C. Il distillato esce dall’accumulatore di riflusso alla temperatura TD = 88 °C e il prodotto di coda lascia il ribollitore alla temperatura TW = 144 °C. Si opera con un rapporto di riflusso effettivo R = 1,45 e nel condensatore di testa si sottrae solo calore latente. Per tutte le composizioni della miscela il calore V = 34 kJ/mol e il calore specifico è Cp = 0,165 kJ/(mol·°C). Ipotizzando che le perdite termiche siano trascurabili, con i dati a disposizione il candidato calcoli: 1. la portata del distillato e del prodotto di coda; 2. la portata del vapore di testa; 3. la potenza termica da sottrarre nel condensatore di testa; 4. la potenza termica da fornire nel ribollitore di coda. (Traccia esame 2012) documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 81 3) Il candidato illustri, a propria libera scelta un processo della chimica industriale nel quale la reazione principale sia realizzata facendo reagire due gas su di un catalizzatore allo stato solido, mettendone in evidenza gli aspetti cinetici, termodinamici ed impiantistici. ( Traccia esame 2001) 4) Nel processo di produzione dell’acido nitrico si ottiene una soluzione al 60 % circa. Oltre tale concentrazione si forma una miscela definita azeotropica. Quali problematiche si incontrano ad ottenere una soluzione più concentrata di acido nitrico? Esistono tecniche per ottenere soluzioni più concentrate? Descrivi il fenomeno delle miscele azeotropiche e le tecniche che conosci per poter distillare tali miscele. Durata massima della prova: 5 ore. Durante lo svolgimento della prova è consentito soltanto l’uso: − di manuali relativi alle simbologie UNICHIM; − di tabelle con dati numerici e diagrammi relativi a parametri chimico-fisici; − di mascherine da disegno e di calcolatrici non programmabili; Non è consentita la consultazione di libri di testo. Non è consentito consegnare prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 82 ITIS “E. Ferrari” Borgo a Mozzano (LU) Classe V sez A 14 aprile 2015 PROVA DI ITALIANO – Simulazione Prima Prova Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 1 Forse è un segno vero della vita: 11 non più mia, arsi, remoti simulacri. 2 intorno a me fanciulli con leggeri 12 E tu vento del sud forte di zàgare, 3 moti del capo danzano in un gioco 13 spingi la luna dove nudi dormono 4 di cadenze e di voci lungo il prato 14 fanciulli, forza il puledro sui campi 5 della chiesa. Pietà della sera, ombre 15 umidi d’orme di cavalle, apri 6 riaccese sopra l’erba così verde, 16 il mare, alza le nuvole dagli alberi: 7 bellissime nel fuoco della luna! 17 già l’airone s’avanza verso l’acqua 8 Memoria vi concede breve sonno; 18 e fiuta lento il fango tra le spine, 9 ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo 19 ride la gazza, nera sugli aranci. 10 per la prima marea. Questa è l’ora: Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la letteratura nel 1959. L’evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, dall’Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell’antichità sono spesso poesia originale (Lirici greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde (1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l’esigenza del poeta di volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell’infanzia e della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 1. Comprensione del testo Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 2. Analisi del testo 2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 2.2 Spiega l’espressione Pietà della sera (v. 5). 2.3 Qual è il significato dell’espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 2.5 Spiega l’espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 2.6 In quali scene si fa evidente l’atmosfera mitica e con quali espressioni? 2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell’insieme il testo dal punto di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l’interpretazione complessiva della poesia con opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 83 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO: Il dono. DOCUMENTI ORATORIO DI SAN SILVESTRO - Roma Donazione di Costantino, 1248 Jacques-Louis DAVID Antioco e Stratonice, 1774 PARMIGIANINO Adorazione dei Magi, 1529 circa «La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, secondo l’uso antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d’arancio, perché l’anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un’asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d’avorio: ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l’arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. […] Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov’era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse l’uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro primo fratellino – mormorò Lia. – Mio padre l’ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il “Gloria”. Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte.» Grazia DELEDDA, Il dono di Natale, 1930, in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell’identità de L’Unione Sarda, Cagliari 2012 «Gli uomini disapprendono l’arte del dono. C’è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la charity, la beneficenza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzato l’impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è necessariamente congiunta all’umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si adempie di mala voglia, con una scettica valutazione dell’altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l’altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: fondi di magazzino fin dal primo giorno.» Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it., Einaudi, Torino 1994 (ed. originale 1951) «La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o quasi). Possiamo percorrere strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire contatti e anche di dare vita a forme di aggregazione fondate sostanzialmente sul dono, ma che rimangono racchiuse in piccole nicchie, microcosmi con cui giocare o dove si può apprendere, nei quali ci si mostra, si costruiscono e si modificano identità, si condividono interessi, si elaborano linguaggi. Un dono costretto quindi dentro piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che riflettono e amplificano la documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 84 luce e i legami, ma che non sempre riescono a sopravvivere alle intemperie, agli improvvisi venti del mondo contemporaneo. E quando si spezzano, non si può fare altro che costruire qualcosa di simile, un po’ più in là. Una delle caratteristiche della Rete è quella di dare vita a comunità immaginate, che non sempre necessitano di relazioni tra gli individui.» Marco AIME e Anna COSSETTA, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 2010 «Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. […] Quando un dono s’inserisce in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente interpretare come un fenomeno puramente individualistico e interessato. Nel caso di una reciprocità diretta, invece, la tentazione è forte di assimilare lo scambio di doni a una variante dello scambio mercantile. […] È così che, in un mercoledì del mese di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la prima paziente nella storia a ricevere un rene all’interno di una catena di reciprocità generalizzata. Dopo che il primo donatore regala il suo rene a Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb, darà un suo rene ad Angela Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun altro ancora, e così via, in una catena continua che aiuterà altre sette persone. All’inizio di questa catena c’è un giovane uomo, Matt Jones, che accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi una persona cara, ma solo per la gioia di aiutare sconosciuti.» Mark ANSPACH, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità, in AA.VV., Cosa significa donare?, Guida, Napoli 2011 «Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c’è più posto per il dono ma solo per il mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove regna invece la legge del tornaconto. In un’epoca di abbondanza e di opulenza si può addirittura praticare l’atto del dono per comprare l’altro, per neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti umanitari» - per nascondere il male operante in una realtà che è la guerra. […] Ma c’è pure una forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto anche se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i mass media ci indicano come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle possibili perversioni del dono noi siamo avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell’indifferenza distratta; il dono può essere ricevuto senza destare gratitudine; il dono può essere sperperato: donare, infatti, è azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può anche essere pervertito, può diventare uno strumento di pressione che incide sul destinatario, può trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell’altro invece di suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia, abbia potuto e possa essere presentato come una cattura dell’uomo, un’azione di un Dio perverso, crudele, che incute paura e infonde sensi di colpa. Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un’arte che è sempre stata difficile: l’essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l’altro, ma resta vero che questo «donare se stessi» - perché di questo si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una convinzione profonda nei confronti dell’altro. Donare significa per definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere in cambio alcunché. Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c’è la vendita, lo scambio, il prestito. Nel donare c’è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all’altro, indipendentemente dalla risposta di questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto reciproco, ma può anche darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare appare dunque un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» Enzo BIANCHI, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 16/09/2012 – http://www.vita.it/nonprofit/volontariato 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO ARGOMENTO: Le nuove responsabilità. DOCUMENTI «Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall’atterraggio sulla Luna del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della natura e dell’ambiente ha acquistato un’importanza sempre maggiore, assumendo anzi documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 85 il carattere di una vera e propria industria. Le associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è più solo l’industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 2007) «Crescita demografica e scelta coercitiva. Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della popolazione mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato un’espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è un’altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed. originale 1999) «L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all’altro, a un mondo differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere e modificare questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un’infedeltà a noi stessi. […] Finché l’altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com’è, prima, il caso per l’altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché l’universale non sarà considerato essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori all’altro, anche mediante la sua morale e la sua religione.» Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008) «Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. Ciascuno deve sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese d’origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. […] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L’umanità ha in particolare il dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza accumulata.» Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011) documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 86 3. AMBITO STORICO - POLITICO ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento. DOCUMENTI «Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell’Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto una nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli atteggiamenti degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, un’accentuata indifferenza per la vita umana. Non erano soltanto la perdurante visibilità e lo status elevato dell’istituzione militare in paesi come la Germania a stimolare una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento mentale derivato dalla guerra, e dall’accettazione della guerra stessa. L’effetto del processo di brutalizzazione sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, di spingerli all’azione contro il nemico politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di fronte allo spettacolo della crudeltà umana e alla morte. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire completamente al processo di brutalizzazione; in buona parte dell’Europa, gli anni dell’immediato dopoguerra videro una crescita della criminalità e dell’attivismo politico. Da un capo all’altro dell’Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse prolungata nel periodo tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia politica, il desiderio di distruggere totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto sembrò continuare la prima guerra mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 1990 «Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa essere tanto temuta da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di manifestarsi secondo l’attuale ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella forma del diritto di sciopero garantito ai lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto agli Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla violenza. Contro questo modo di vedere si può certamente obiettare che l’omissione di azioni, un non-agire, come in fin dei conti è lo sciopero, non dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione ha certamente facilitato al potere statale la concessione del diritto di sciopero, quando ormai non si poteva più evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non vale illimitatamente.» Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010 «Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell’aggressività nel regno animale, la violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e segnatamente della sua creatività. Sorel, ispirato dall’élan vital di Bergson, mirava a una filosofia della creatività destinata ai «produttori» e polemicamente rivolta contro la società dei consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi parassitari. […] Nel bene e nel male – e credo che non manchino ragioni per essere preoccupati come per nutrire speranze – la classe veramente nuova e potenzialmente rivoluzionaria della società sarà composta di intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto grande, forse troppo grande per il bene dell’umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Comunque sia, in questo contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di Nietzsche nella loro versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa combinazione di violenza, vita e creatività sia presente nell’inquieta situazione mentale della generazione odierna. Non c’è dubbio che l’accento posto sulla pura fattualità del vivere, e quindi sul fare l’amore inteso come la più gloriosa manifestazione della vita, sia una reazione alla possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita sulla terra. Ma le categorie in cui i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la produttività della società nell’immagine della „creatività’ della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere nella violenza come forza vitale è cosa vecchia almeno quanto Bergson.» Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969) «Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza non è fatta solo per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è la legge della nostra specie, come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel bruto, ed egli documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 87 non conosce altra legge che quella della forza fisica. La dignità dell’uomo esige ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua condizione dinamica, non violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi con tutta l’anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio onore, la religione, l’anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della sua rigenerazione. E così non propugno che l’India pratichi la non violenza perché è debole. Voglio che pratichi la non violenza essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. […] La mia missione è di convertire ogni indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che “è possibile” e proseguirò per la mia strada.» Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975 «Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare all’America l’urgenza appassionata dell’adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si raffreddino o che si trangugi il tranquillante del gradualismo. Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento di levarsi dall’oscura e desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il momento di elevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dell’ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell’anima.» Martin Luther KING http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/ 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva. DOCUMENTI «Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e gli addetti ai lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l’eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell’invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di superamento dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della coscienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.» Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “l’Espresso” – 6 febbraio 2014 «Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po’ diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l’uomo – piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 88 idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali complessi». L’astronomo della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l’angoscia che prende molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c’è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all’interno dei grandi aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente.» Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 gennaio 2014 «Per molto tempo al centro dell’attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: «Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.» Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 gennaio 2014 «Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione dell’uomo, la storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell’oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell’ordine del proprio potenziamento. Null’altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.» Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO L’Europa del 1914 e l’Europa del 2014: quali le differenze? Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli Stati principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra gli Stati europei; rapporti fra l’Europa e il resto del mondo. TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE «Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro, non fotogeniche d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle città sono le periferie. […] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?» Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014 Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue considerazioni e convinzioni al riguardo. documento 15 maggio 2014_2015 rev 1 5A ITI Completo Pagina 89
Scarica