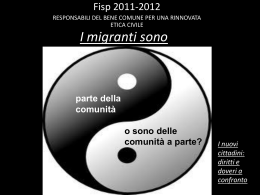RASSEGNA STAMPA Venerdì 26 giugno 2015 L’ARCI SUI MEDIA INTERESSE ASSOCIAZIONE ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO AVVENIRE IL FATTO PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE 2 L’ARCI SUI MEDIA Da Redattore sociale del 26/06/2015 Torna il Meeting antirazzista dell’Arci, dal 1 luglio a Cecina Organizzato insieme alla Regione Toscana, è il consueto appuntamento estivo per riflettere su temi dell’immigrazione e delle discriminazioni. Titolo di quest’anno: mare aperto FIRENZE – Torna il Meeting antirazzista di Cecina (Livorno) organizzato dall’Arci e dalla Regione Toscana, quest’anno in programma dal 1 al 5 luglio p.v. Titolo del meeting di quest’anno è mare aperto, il contrario, spiegano dall’Arci, “significa consegnare il Mediterraneo al significato di morte e all'immagine di immensa tomba”. Spiega ancora l’Arci: “Mare Aperto perché in mare aperto sono la società italiana e tutta la società europea, da decenni al centro di un processo sociale di trasformazione in cui si incrocia una molteplicità di culture. Mare Aperto perché così concepiamo un modello di accoglienza efficace. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata al tema dei conflitti, da cui molte persone sono appunto costrette a fuggire”. Nell’ambito del meeting, “proveremo quindi a conoscere e capire cosa succede in altre parti del mondo, con particolare attenzione all’area mediterranea e lo faremo insieme ai giornalisti ed esperti dell’Atlante delle guerre e dei conflitti”. Infine, oltre all’accoglienza, alle scuole di formazione, alle iniziative culturali, spazio alla complessa tematica delle identità. http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/486520/Torna-il-Meeting-antirazzista-dellArci-dal-1-luglio-a-Cecina 3 INTERESSE ASSOCIAZIONE Del 26/06/2015, pag. 24 La polemica. Da Piccolo uovo a Nessuno è perfetto: ecco i titoli espulsi dalle biblioteche scolastiche e messi all’indice dal movimento del Family day perché travierebbero i bambini Figli di due mamme e lotta ai pregiudizi cosa c’è davvero nei libri “gender ” MARIA NOVELLA DE LUCA ROMA . In fondo “Piccolo uovo “ cercava soltanto una famiglia. Etero, omo, adottiva, multirazziale: non importa, le famiglie sono tutte così belle, che per quello strano e goffo uovo era davvero difficile scegliere in quale approdare. Eppure, suo malgrado, quell’uovo, inventato da Francesca Pardi e magistralmente disegnato da Altan, è diventato il singolare bersaglio di una violenta crociata “anti gender”. Protagonista di una storia definita “pericolosa” e nelle cui pagine, tra gatti, conigli, pinguini in stile “Pimpa” si anniderebbe l’insidiosissimo fantasma del “gender”. Sfuggente teoria del tutto e del niente, sufficiente però a far finire “Piccolo uovo” tra i libri espulsi dalle biblioteche scolastiche italiane, in una lista sempre più folta di titoli messi all’indice perché, secondo l’agguerrito movimento del Family day, travierebbero la mente dei bambini. Ma cosa c’è davvero in questi libri (quasi tutti pubblicati dalla casa editrice “Lo stampatello”) che i comitati “Difendiamo i nostri figli” vorrebbero bruciare in un rogo virtuale? Né più né meno che il mondo reale. Attraverso storie di animali umanizzati, principesse, eroi furbi o eroi sognatori, personaggi in carne ed ossa, tra titoli come “Il Matrimonio dello zio”, o “Nessuno è perfetto”, “Il mio primo giorno in Italia”, o “Il grande libro delle famiglie”, ciò che si narra è una società dove si nasce da una mamma e da un papà, ma anche da due mamme, si è figli adottati o in affido, si è bimbi sani o disabili, si è italiani o migranti, si è maschi, femmine, ma in fondo si è come si vuole... Dunque in questa costellazione di avventure umane, spesso illustrate dai migliori disegnatori italiani, la famiglia “tradizionale” è solo una delle tante combinazioni della vita. Come accade nel mondo reale. Ma è proprio questo che i vari movimenti “Difendiamo i nostri figli” contestano: e cioè che nelle scuola si possa parlare di unioni gay, di doppi padri, di libertà di comportarsi al di là dei generi. L’ultimo caso è quello di Venezia, dove il neosindaco di centrodestra, Luigi Brugnaro, ha deciso che una serie di titoli presenti nelle biblioteche delle primarie e delle materne dovranno essere eliminati. Una battaglia analoga aveva sconvolto qualche mese fa il comune di Trieste, finito nella bufera per aver proposto l’introduzione, nelle classi dei più piccoli, del “Gioco del rispetto”. Ossia un percorso educativo basato sull’educazione di genere (non gender) cioè sul rispetto delle differenze, dei sessi, e sul superamento degli stereotipi. Le psicologhe, autrici del gioco, sono state accusate addirittura di aver favorito “palpeggiamenti” tra i bambini. «Quello che facevamo era chiedere ai piccoli di fare una corsa — spiegava una delle autrici — e alla fine facevamo mettere la mano di un bambino sul cuore di una bambina, per dimostrare che pur nella differenza i cuori battono allo stesso modo». Ma già lo scorso anno, una violenta campagna dei movimenti Pro-Life, aveva fermato la diffusione dei famosi libretti dell’Istituto Beck, opuscoli contro il bullismo decisi dall’ex ministro per le Pari Opportunità Elsa Fornero, e accusati di inoculare l’ideologia “Lgbt” tra i 4 ragazzi. Una feroce mistificazione, perché in quei testi, destinati agli insegnanti, si parlava di prevenzione al bullismo in tutte le sue versioni. Una stessa campagna di controinformazione sembra oggi colpire la nuova editoria dell’infanzia. Non solo lo “Stampatello”, minuscola casa editrice milanese, fondata da Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo, mamme gay di quattro bambini, che dopo aver cercato invano un editore per raccontare ai propri figli la particolarità della loro nascita, hanno deciso di fare da sè. Ma anche gli editori di “E con Tango siamo in tre”, avventure di pinguini papà gay, espulsi dalle scuole veneziane. «Raccontiamo che si nasce in tanti modi diversi, in una famiglia eterosessuale o con due madri, due padri, un single. Si può venire al mondo anche con la fecondazione assistita. È la realtà. Si può avere una pelle diversa — spiega Maria Silvia Fiengo — o una malattia, ma tutti sono degni di rispetto ». Ma la campagna è sempre più violenta. Con somma sorpresa delle case editrici straniere, che vedono i loro testi, accettati in patria, attaccati da noi. Ad esempio “Il grande, grosso libro delle famiglie” uscito senza polemiche in Inghilterra, messo all’indice in Italia. «Hanno scritto che insegniamo la masturbazione ai bambini: sfido chiunque a trovare riferimenti di questo tipo nelle nostre storie. Noi parliamo di valori, e siamo così tranquille che abbiamo mandato i nostri libri anche al Papa». Del 26/06/2015, pag. 1-24 QUELLE LETTERE PER DIRE NO A QUALCOSA CHE NON ESISTE MARIAPIA VELADIANO CAPITA che a scuola arrivi un modulo, un prestampato a cui i genitori aggiungono i loro nomi e il nome del figlio, con cui dichiarano di «essere informati circa l’esistenza della c.d. teoria “dei gender”, che alcuni programmi e/o insegnamenti scolastici veicolano i contenuti di detta teoria e pertanto con effetto immediato (grassetto in originale) dichiarano di dissentire totalmente con i contenuti di detta teoria che considerano dannosa per l’educazione dei propri figli e chiedono di non proporre detti contenuti sotto alcuna forma ai propri figli». Firma, data, protocollo. Se capita bisogna fermarsi e dalla posizione in cui ci si trova, nel caso insegnante, preside, felicemente credente e cattolica, bisogna chiedersi cosa sta succedendo. Di una teoria gender non si ha notizia certa. Un vorticoso giro fra i siti delle scuole della nostra lunga penisola non ci consegna una sola programmazione individuale in cui si parli di “teoria gender”. E ci si chiede allora perché genitori si organizzino con moduli, protocolli e un lessico blandamente giuridico e un poco minaccioso contro qualcosa che non c’è. Probabilmente succede che hanno paura perché, senza colpa alcuna, non capiscono. Il mondo affettivo e sessuale dei figli è misterioso, cambiato come è cambiato con pari sofferenza e scandalo negli anni Sessanta del secolo scorso e prima ancora negli anni Venti. Qualsiasi assemblea di istituto o festa di compleanno o happy hour ci consegnano una vita che di fatto rimescola i colori, i gesti, gli atteggiamenti di ragazze e ragazzi. Uno sconfinare i generi che somiglia a un’ultima trasgressione dopo che tutte le altre sono state agite e assorbite. La vita adulta vaglierà il vero o il falso che questo sconfinare porta dentro. Quel che la scuola davvero fa, e deve, è combattere gli stereotipi di genere. Ma essere contro questi stereotipi non significa dire che il genere non esiste. Significa educare a vedere dove sta la trappola di un sé condizionato da precomprensioni che autolimitano non solo le scelte ma il pensiero stesso, il desiderio. Per cui le bambine nemmeno sognano di diventare astronaute 5 (adesso forse un po’ di più, grazie a Samantha Cristoforetti) perché la loro educazione, implicita o esplicita, ha beneducato anche i desideri. La consapevolezza degli stereotipi di genere è una conquista lenta, lo stereotipo vive di un’inerzia sociale naturale ed è funzionale al vantaggio o al potere di qualcuno. E al potere il nemico serve. Ci sono poteri che si squagliano se vien meno il nemico. E anche alla paura il nemico serve. La saldatura fra potere e paura è micidiale. Il gender è una manna. Ogni giorno un po’ e lo sdegno è servito, il nemico è servito, il pensiero è congelato e si sente meno la paura per quel che non si capisce. Per fortuna c’è un nemico là fuori. Ad andare in piazza a dire il fantasma del gender non passa si rischia di schiacciare il pensiero in uno slogan a cui altri rispondono dalla sponda di uno slogan speculare e contrario. Ci vuole un pensiero paziente che non rinuncia a capire, senza per questo necessariamente approvare. E forse di tutto questo con i genitori proprio la scuola deve limpidamente parlare. Del 26/06/2015, pag. 9 Unioni civili, ma non sarà mai matrimonio Per avvicinare le posizioni di Pd e Ndc si pensa ad un nuovo istituto giuridico aperto anche ai gay Sarà possibile adottare il figlio biologico del partner e avere un cognome comune condiviso Ilario Lombardo L’eco della piazza del Family Day ha dato nuova linfa ai senatori di Ncd tornati alla carica sul testo delle unioni civili. Qualcosa sta cambiando. Piccole correzioni. Perché l’architettura portante del provvedimento dovrebbe restare intatta: equiparazione di tutti i diritti sociali ed economici (reversibilità della pensione e quant’altro) e stepchild adoption, l’adozione del figlio biologico del partner. L’obiettivo del Pd è portare in aula il disegno di legge Cirinnà entro fine luglio e licenziarlo da Palazzo Madama prima delle vacanze di agosto. Nessuna pausa di riflessione, dunque, come avevano chiesto i centristi. Ma disponibilità al confronto per avvicinare il più possibile le parti. E’ la linea di Palazzo Chigi: minimizzare i danni ed evitare contraccolpi nella maggioranza. La mediazione prosegue su un testo che non è più blindato. Il governo ha deciso di affidare al parlamento la totale competenza sulla materia. E se nel Pd c’è chi, come le deputate Chiara Gribaudo, Valentina Paris e Giuditta Pini, si rammarica per la libertà di coscienza lasciata su un tema «che non è etico, ma politico e sociale», secondo il grosso dei senatori Pd il venir meno dei vincoli di maggioranza permetterà di cercare alleanze alternative (vedi M5S e Sel) come avvenne su divorzio e aborto. Non è matrimonio Il primo blocco di emendamenti che andavano a intaccare il cuore del disegno di legge è stato stroncato dai pareri negativi della relatrice Monica Cirinnà. Ne sono stati accolti due. Assieme alla riformulazione di alcuni passaggi. Il più importante: l’unione civile è un nuovo istituto giuridico, differente dal matrimonio. La ratio deriva dalla Costituzione, anche se il richiamo diretto alla Carta, su cui si erano impuntati i popolari, è stato eliminato. Gli articoli di riferimento sono l’8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e il 2-3 della Costituzione, che normano le formazioni sociali, e non più il 29, relativo al matrimonio. Cambiando la radice, cambia la prospettiva. «Così Ncd la smette di dire che le unioni civili sono nozze mascherate» spiega Sergio Lo Giudice, del Pd. Il cognome 6 È stato definito meglio anche il passaggio sui cognomi. Nel matrimonio, non essendoci un rapporto di reciprocità, si impone di default il cognome del marito. Nel 2014 la Camera ha votato una proposta di legge che abolisce l’obbligo del cognome paterno. Ma la nuova disciplina è ancora in attesa dell’approvazione del Senato. Con il ddl Cirinnà, al momento di costituire un’unione civile, tra persone dello stesso sesso e non, i contraenti potranno scegliere un cognome comune, condiviso. Vietate ai minori I due emendamenti accolti. Dimentichiamo gli appositi registri che diversi Comuni avevano inaugurato per le unioni civili. Il nuovo istituto sarà censito nei registri dello stato civile accanto a nascite, morti, cittadinanza e matrimoni. Il secondo emendamento rimuove la possibilità, prevista in un primo tempo, di autorizzare le unioni civili anche tra minorenni. Il codice civile italiano, all’articolo 84, stabilisce che solo i maggiorenni possono contrarre il matrimonio. Lo stesso articolo, però, prevede una deroga, dai 16 anni in su, ma solo dietro autorizzazione del Tribunale dei minori. Una deroga che non ci sarà per le unioni civili. Del 26/06/2015, pag. 18 Tortura, Salvini-shock “La polizia deve lavorare chi si fa male affari suoi” Il leghista: “No al reato”.Ma gli agenti si dividono Attacco a Pansa: ha abbandonato le forze dell’ordine FABIO TONACCI ROMA. Con addosso la pettorina gialla del Sindacato autonomo di Polizia, Matteo Salvini fa quello che meglio gli riesce, ossia salire sul carro del malcontento. Dovunque esso si trovi. «La legge sul reato di tortura è sbagliata e pericolosa, espone i poliziotti e i carabinieri al ricatto», diceva ieri, manifestando con il Sap davanti a Palazzo Chigi. «Se poi un delinquente lo devo prendere per il collo e si sbuccia il ginocchio...cazzi suoi». Parole da cui due sindacati maggiori, Silp e Siulp, prendono le distanze. Definendola, né più né meno, una «strumentalizzazione». Roma, Piazza Colonna, le 16 di ieri. Il segretario della Lega sta partecipando alla protesta del Sap (in 100 punti strategici della capitale e di Milano) contro il ddl che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano, attualmente fermo al Senato dopo essere stato approvato, e annacquato, dalla Camera ad aprile. Con Salvini, che firma autografi e si fa i selfie con i delegati sindacali, c’è anche Roberto Maroni. «Governo e Parlamento tutelano di più chi commette i reati rispetto a chi difende i cittadini», dichiara il governatore della Lombardia. Poi Salvini se ne esce così: «La Corte di Strasburgo (che ha condannato il nostro paese perché non ha una legge sulla tortura, ndr) non deve rompere le scatole all’Italia. E Pansa non il è miglior Capo della polizia possibile: mai come oggi i poliziotti si sentono abbandonati dai loro dirigenti». Musica per le orecchie di Gianni Tonelli, segretario generale del Sap da sempre critico nei confronti della gestione di Pansa. «Il disegno di legge in discussione — sostiene Tonelli — nasconde la volontà di punire le donne e gli uomini in divisa». In realtà, per come è uscito da Montecitorio, l’articolo 613 bis che modifica il Codice penale e che recepisce la Convenzione di New York del 1984, si è parecchio ridimensionato. «Adesso è una norma mediocre», sostiene il senatore Pd Luigi Manconi. «Dubito che sarà approvato entro questa legislatura ». Il reato di tortura da proprio (cioè specifico per le forze dell’ordine) è diventato comune, con aggravanti se commesso da pubblici ufficiali. «E’ punito da tre a dodici anni chiunque, con violenza o 7 minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti», recita il testo, tornato in commissione al Senato. Ma nemmeno così il Sap è soddisfatto, ora si scaglia sul concetto di “forti sofferenze mentali”: «Chi potrà certificare dinanzi a un giudice una così intima angoscia? Qualunque poliziotto sarà esposto a denunce». Anche il Consap è dello stesso avviso: «l’esecutivo, con la complicità di Alfano, sta confezionando una polpetta avvelenata»). Opione opposta quella di Daniele Tissone, segretario del Silp Cgil: «Giusto introdurre il reato comune di tortura, va evitata però la previsione di norme penalmente rilevanti per comportamenti minimamente offensi- vi. Salvini che scende in piazza col Sap è una manovra politica di bassa lega, un tentativo strumentale e politico di accattivarsi le simpatie degli agenti». E Felice Romano, del Siulp, aggiunge: «Non capiamo le ragioni delle sue critiche a Pansa. Facile parlare di ruspe e di respingimenti dei profughi quando si è all’opposizione, ma gli unici che affrontano ogni giorno i problemi della sicurezza e dell’immigrazione sono come al solito i poliziotti e i volontari». Del 26/06/2015, pag. 7 Tortura, Renzi dica se sta con il Sap e Salvini Patrizio Gonnella Ieri il Sindacato autonomo di Polizia ha manifestato contro il reato di tortura, con il leader leghista Matteo Salvini e il governatore della Lombardia Roberto Maroni al seguito. Non lo sanno ma hanno manifestato anche contro il Papa e contro Ban Ki Moon. Era il 1997 quando le Nazioni Unite decisero che il 26 giugno fosse il giorno in cui ricordare su scala universale le vittime della tortura. Dieci anni prima, ovvero il 26 giugno del 1987, entrò in vigore la Convenzione Onu contro la tortura e ogni altra forma di punizione o trattamento inumano, crudele o degradante. Sono 158 gli Stati che in giro per il mondo hanno firmato e ratificato il Trattato. Possiamo però dire che la tortura, considerata dal diritto internazionale crimine contro l’umanità, sia oggi bandita dalla comunità degli Stati? Qui seguono due ordini di riflessioni. Il primo ordine di riflessioni riguarda quei Paesi che si sono adeguati, seppur parzialmente, ai contenuti del Trattato Onu che imponeva, tra l’altro, la previsione di un reato ad hoc nella legislazione interna a ciascuno degli Stati membri. Come sappiamo la codificazione del reato è condizione necessaria ma non sufficiente perché la tortura sia perseguita e perché non vi sia impunità per i torturatori. Non siamo così ingenui da credere che basti prevedere un reato perché la pratica di polizia si adegui e i giudici condannino. Di pochi giorni fa sono le osservazioni del Comitato Onu contro la tortura rispetto alla Spagna, Paese che dal 1995 ha introdotto il crimine nel suo codice. Il Comitato ha sostenuto che la definizione di tortura presente nella legislazione spagnola fosse del tutto inadeguata e ha invitato le autorità iberiche ad armonizzarla rispetto al testo Onu. All’articolo 1 della Convenzione si definisce la tortura. Devono ricorrere i seguenti requisiti: l’autore deve essere un pubblico ufficiale, deve esserci violenza o minaccia, deve essere prodotta sofferenza fisica o psichica, deve esservi l’intenzione di estorcere una confessione o di umiliare. Va altresì ricordato che lo Statuto della Corte Penale Internazionale abilitata a giudicare i gravi crimini contro l’umanità – tortura, genocidio, crimini di guerra – ha una definizione meno cogente. In ogni caso è questo il solco entro cui lo Stato deve muoversi. La Spagna non l’ha fatto. Il secondo ordine di riflessioni riguarda invece quei Paesi che non si sono adeguati per nulla ai contenuti del Trattato. L’Italia è in prima linea tra questi. La tortura da noi non è un reato, come ci ha ricordato la Corte Europea sui diritti umani lo scorso 7 aprile condan8 nando il nostro Paese nel caso Cestaro a causa delle brutalità commesse dalla Polizia nella scuola Diaz nel 2001. Pochi giorni fa il ministro Alfano in un convegno pubblico ha affermato: «Il reato non sia contro la Polizia». Il reato di tortura è essenziale per una Polizia moderna; aiuta a distinguere chi svolge il proprio compito correttamente da chi invece fa un uso brutale della forza. La contrarietà delle forze dell’ordine è ingiustificabile se non adducendo tesi oltranziste. Il ddl per l’introduzione del delitto nel codice pende in commissione Giustizia al Senato. È vittima di un ping pong parlamentare già troppe volte visto in passato. Tra il 16 e il 22 settembre il Sotto-Comitato Onu contro la tortura visiterà i luoghi di privazione della libertà in Italia. È la prima volta che gli ispettori Onu entreranno nelle nostre caserme, nei nostri Cie, nelle nostre prigioni. Subito dopo si recheranno in Turchia. L’Italia è tra i 78 Paesi che si è resa disponibile a farsi visitare. Per allora sarebbe essenziale che da un lato ci fosse il reato nel codice, dall’altro fosse nominato il Garante delle persone private della libertà. La legge c’è, il Garante non ancora. Per questo ci rivolgiamo direttamente a Matteo Renzi, il quale nei giorni successivi alla sentenza europea nel caso Diaz aveva detto che «la nostra risposta è il reato di tortura». La palla è nel suo campo. Vanno neutralizzate le obiezioni del partito di Giovanardi e Alfano. Il ministro della Giustizia Orlando, in occasione del dibattito alla Camera dello scorso aprile, aveva auspicato invece un voto ampio e condiviso. Una posizione importante che ora deve trovare conferma al Senato. Spetta al premier spingere in questa direzione, anziché in quella di retroguardia del ministro degli Interni, del Sap e di Salvini. *presidente Antigone Del 26/06/2015, pag. 45 Nelle associazioni possibile l’apporto solo delle società Per effetto del decreto legislativo 81/2015, il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non può essere più sottoscritto se l’associato è una persona fisica. Tuttavia questa forma di collaborazione resta ammissibile se l’associato è un soggetto societario. Con la circolare 13/2015 diffusa ieri, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha iniziato ad approfondire alcune delle novità introdotte dal “codice dei contratti” entrato in vigore ieri. Nel recente passato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è stato piuttosto utilizzato in alcuni settori, come nel commercio per i commessi. Utilizzo che spesso si è caratterizzato dal mancato rispetto delle disposizioni normative, tra cui, per esempio, la partecipazione degli associati agli utili o alle perdite economiche dell’attività, dato che veniva loro erogata una retribuzione fissa. A questo proposito la riforma del mercato del lavoro di tre anni fa (la legge 92/2012) aveva introdotto la conversione in rapporto di lavoro a tempo subordinato proprio se si fosse riscontrata la mancata partecipazione agli utili. Inoltre, sempre per limitare l’utilizzo di questo contratto, era anche stato posto il tetto massimo di tre associati con apporto di lavoro per ogni associante. Ora il Dlgs 81/2015 ha eliminato la possibilità di ricorrere all’associazione con apporto di lavoro in caso di persone fisiche. Restano salvi i contratti in corso che in alcuni casi hanno durata decennale, quindi, è probabile che questo tipo di inquadramento non scomparirà in tempi brevi dal panorama lavoristico. Inoltre, come accennato, l’associazione con apporto di lavoro sarà comunque possibile se l’associato è una società. 9 La circolare dei consulenti del lavoro illustra anche le novità riguardanti le collaborazioni, con il divieto di sottoscrivere, d’ora in poi, quelle a progetto. Restano possibili quelle coordinate e continuative, consapevoli che, a fronte della presenza di tre condizioni (carattere esclusivamente personale, continuità, eterorganizzazione anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro), si applicheranno le regole del rapporto subordinato. Tuttavia datore di lavoro e collaboratore hanno la possibilità di certificare, presso le commissioni indicate dall’articolo 76 del Dlgs 276/2003, l’assenza di tali condizioni. In questa procedura il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Una scelta, quest’ultima, sottolinea la circolare, che «conferma l’affidabilità della categoria dei consulenti del lavoro nel ruolo di terzietà», al pari dell’assistenza che i professionisti possono fornire, sempre in base al Dlgs 81/2015, quando azienda e dipendente concordano una modifica delle mansioni attribuite al lavoratore. Anche le collaborazioni a progetto già attive potranno essere mantenute fino a esaurimento. Però dal 2016 scatterà l’obbligo di rispettare i nuovi requisiti, in mancanza dei quali saranno ricondotte al lavoro subordinato, salvo alcune situazioni eccezionali. Tra queste il Dlgs individua le collaborazioni regolate da accordi collettivi nazionali con riferimento a trattamento economico e normativo. Una disposizione che, secondo la circolare dei consulenti del lavoro, vale anche per i contratti collettivi già in vigore che rispettano tali requisiti. 10 ESTERI Del 26/06/2015, pag. 10 Continua lo stillicidio domani ultima spiaggia per evitare il crac greco Altra fumata nera all’Eurogruppo. Palla a Tsipras Merkel: “Serve un accordo prima di lunedì” ANDREA BONANNI BRUXELLES. Un’altra fumata nera che avvicina la Grecia al baratro del default. La quarta riunione in una settimana dei ministri dell’eurogruppo per trovare un accordo che eviti la bancarotta di Atene si è chiusa dopo poche ore con l’ennesimo fallimento. La posizioni dei greci e dei loro creditori restano lontane su tutti i punti cruciali del negoziato: riforma del sistema pensionistico, modifica dell’Iva e tagli alla difesa. Rispetto all’incontro della sera prima, la delegazione guidata dal ministro Yannis Varoufakis ha anzi fatto qualche piccolo passo indietro riproponendo di mantenere le agevolazioni sull’Iva per le isole greche: un tema che sta particolarmente a cuore al partito di estrema destra alleato di Syriza al governo. Di fronte alla totale mancanza di progressi il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha congedato i ministri ed è andato a informare i capi di Stato e di governo della Ue, riuniti a pochi metri di distanza. Ma il vertice europeo ha rifiutato di farsi carico del negoziato: segno che i margini di flessibilità politica da parte dei creditori sono ormai ampiamente esauriti. E dunque si ricomincia da capo, con l’orologio del default che corre sempre più in fretta. I tecnici dell’euro working group che ha sostituito la troika si riuniranno ancora oggi, mentre nella notte sono previsti nuovi colloqui tra Tsipras e i vertici di Commissione, Bce e Fmi. Se emergerà una nuova disponibilità greca ad accettare le richieste dei creditori, i ministri dell’Eurogruppo si ritroveranno sabato per siglare l’accordo. Altrimenti, spiega una fonte vicina ai negoziati, l’incontro servirà a decidere come gestire il default greco. L’insolvenza di Atene, la «terra incognita» evocata da Mario Draghi, è ormai questione di ore. Se sabato ci fosse un’intesa domenica il Parlamento greco potrebbe ratificarla. E martedì la Grecia, ricevendo l’ultima tranche del prestito europeo da 7,5 miliardi, potrebbe rimborsare 1,6 miliardi che deve restituire al Fmi entro fine mese. «Ci deve essere un accordo prima che lunedì riaprano i mercati», ha spiegato Angela Merkel agli altri leader del Ppe riuniti prima del vertice. Nonostante la durezza dell’ultimatum dei creditori, rafforzato dal pochissimo tempo a disposizione, Tsipras si dimostra ottimista. In termini puramente contabili, la distanza tra le posizioni greche e quelle europee non è certo incolmabile. Ma la distanza politica da percorrere per superare le «linee rosse» che il governo greco si è auto-imposto è considerevole. Solo il premier può decidere se e come fare la marcia indietro che tutti gli chiedono. Sullo sfondo di questo braccio di ferro c’è la questione irrisolta di una ristrutturazione del debito greco. Tsipras vorrebbe un impegno esplicito da parte dei leader europei. Ma questi, pur avendogli dato assicurazioni lunedì, in occasione del vertice dell’eurozona, che la questione sarà esaminata una volta che Atene avrà accettato il piano di risanamento, non vogliono prendere adesso impegni vincolanti. «Non ci faremo ricattare dalla Grecia», ha detto la cancelliera ai suoi colleghi del Ppe. Il rifiuto, ieri, dei capi di governo europei di occuparsi ancora una volta delle richieste di Atene sembra confermare che su questo fronte Tsipras non potrà ottenere niente di più di quanto ha già avuto. L’ultima parola, adesso, tocca a lui. 11 Del 26/06/2015, pag. 30 LA LEZIONE DI ATENE PER L’ITALIA LUCIANO GALLINO POCHI giorni fa il Parlamento greco ha diffuso un rapporto del Comitato per la Verità sul Debito pubblico. Le conclusioni sono che per il modo in cui la Troika ha influito sul suo andamento, e per i disastrosi effetti che le politiche economiche e sociali da essa imposte hanno avuto sulla popolazione, il debito pubblico della Grecia è illegale, illegittimo e odioso. Pertanto il Paese avrebbe il diritto di non pagarlo. Il rapporto greco è fitto di riferimenti alle leggi e al diritto internazionali. E contiene, in modo abbastanza evidente, una lezione per l’Italia. Il rapporto distingue con cura tra illegalità, illegittimità e odiosità di un debito pubblico. Un debito è illegale se il prestito contravviene alle appropriate procedure previste dalle leggi esistenti. È illegittimo quando le condizioni sotto le quali viene concesso il prestito includono prescrizioni nei confronti del debitore che violano le leggi nazionali o i diritti umani tutelati da leggi internazionali. Infine è odioso quando il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che il prestito era stato concesso senza scrupoli, da cui sarebbe seguita la negazione alla popolazione interessata di fondamentali diritti civili, politici, sociali e culturali. Il Fmi è responsabile di tutt’e tre le infrazioni perché le condizioni imposte alla Grecia in relazione ai suoi prestiti hanno gravemente peggiorato le sue condizioni economiche e il suo sistema di protezione sociale. Da vari documenti interni del Fondo stesso, risalenti al periodo 2010-2012, appare evidente che perfino il suo staff, una parte consistente del consiglio direttivo formato da rappresentanti di vari paesi, e non pochi dirigenti sapevano benissimo quali sarebbero state le conseguenze negative a danno della popolazione greca. La Bce non è stata da meno, contribuendo ai programmi di aggiustamento macroeconomici della Troika e insistendo in special modo sulla deregolazione del mercato del lavoro — violando in tal modo anche gli articoli del Trattato Ue che stabiliscono la sua indipendenza dagli stati membri. Con le sue manovre relative al commercio dei titoli sul mercato secondario ha reso possibile alle banche private greche di scaricare dal bilancio gran parte dei titoli di stato, peggiorando le condizioni del bilancio pubblico. Quanto al fondo Efsf, sebbene gestisca fondi pubblici europei, è stato costituito come società privata cui non si applicano le leggi Ue, persegue unicamente obbiettivi finanziari, e sapeva bene di imporre con i suoi prestiti costi abusivi alla Grecia, senza che essi recassero alcun beneficio al paese. Pertanto molte azioni svolte da Bce e Efsf nei confronti della Grecia nel periodo 2010-2015 sono classificabili come illegali, illegittime e odiose. Il testo abbonda di rimandi ad altre violazioni operate dalla troika. Esse vanno dalla falsificazione delle statistiche economiche e sociali della Grecia alla violazione della sovranità fiscale dello stato greco. Si dirà: ma che c’entra l’Italia con le vicende del debito greco? C’entra eccome, poiché vi sono perentori memoranda e lettere di istruzione inviate al governo italiano dalle medesime istituzioni Ue, e nello stesso periodo, che nello spirito e nei contenuti sembrano delle fotocopie di quelle inviate al governo ellenico. Si veda ad esempio la lettera indirizzata al governo italiano dalla Bce nell’agosto 2011. Essa raccomandava varie misure pressanti, quali «la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali»; «privatizzazioni su larga scala»; una ulteriore riforma del «sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello di impresa»; l’adozione di «una accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti»; un ulteriore intervento nel sistema pensionistico; «una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego»; infine chiedeva che «tutte le azioni elencate… siano prese 12 il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare ». Questi e vari altri interventi peggiorativi delle condizioni di lavoro e di vita dei cittadini italiani sono stati prontamente adottati dai governi italiani, fino all’attuale con il suo scandaloso Jobs Act, non mancando di ripetere ad ogni momento la trita giustificazione «ce lo chiede l’Europa». In realtà non è l’Europa a chiederlo, ma singole istituzioni europee, molto spesso in violazione, come documenta il rapporto greco,degli stessi trattati Ue e di numerosi trattati internazionali. Al punto da far sorgere il dubbio che siano da considerare anch’essi, i dettati inviati all’Italia, illegali, illegittimi e odiosi. In attesa che qualcuno se ne accorga, avvii le procedure necessarie, e si impegni a chiedere alla Ue che rispetti almeno i medesimi trattati da essa sottoscritti. Tutto ciò non soltanto per il rispetto dovuto alle leggi ma perché il prossimo caso greco potremmo essere noi. Del 26/06/2015, pag. 2 Un «golpe strisciante» contro il governo di Tsipras Grexit. I media del mondo: no all’intransigenza della troika. Ma c’è l’opzione del «default» senza uscita dall’euro, con la Grecia che non ripagherà il debito pubblico detenuto per l’80% da fondi europei, paesi membri, Fmi e Bce, né pagherà gli interessi dovuti Il Fmi ha silurato l’ennesima proposta greca – in cui Syriza si era già spinta molto (troppo?) in là nelle concessioni alla troika, accettando nuovi aumenti delle imposte e obiettivi di bilancio per i prossimi anni difficilmente sostenibili – perché le misure proposte da Tsipras, tra cui l’aumento delle tasse sulle imprese e una tassa una tantum sugli utili d’impresa superiori ai 500,000 euro l’anno, in alternativa ai tagli alle pensioni chiesti dall’Fmi, avrebbero un «effetto recessivo». Se la situazione non fosse così drammatica, ci sarebbe da ridere. La stessa istituzione che in Grecia si è macchiata di uno dei più devastanti fallimenti predittivi ed economici della storia – nel 2010 il Fondo aveva previsto che il Pil greco si sarebbe contrato del 5%, mentre oggi siamo a –25% –, oggi vorrebbe dare a Tsipras, reo di aver cercato di redistribuire un po’ il peso fiscale dell’aggiustamento, lezioni di crescita. Quando peraltro gli stessi studi dell’Fmi sul famoso «moltiplicatore fiscale» dimostrano che gli aumenti di tasse hanno un impatto recessivo minore rispetto ai tagli alla spesa. D’altronde, non ci vuole molto a capire che in questo momento tagliare ulteriormente le pensioni, che rappresentano l’ultima linea contro la povertà per milioni di greci, avrebbe un impatto recessivo ben più grave degli inasprimenti fiscali proposti dal governo (che comunque, sia chiaro, sarebbe meglio evitare nel mezzo di una depressione economica). Difficile non condividere la reazione a caldo di Tsipras alla notizia dell’ennesimo niet dei creditori: «O non vogliono un accordo oppure vogliono servire gli interessi degli oligarchi greci». Paul Krugman sul suo blog è stato ancora più esplicito: «A questo punto dovremmo smetterla di parlare del rischio di un’“uscita accidentale” della Grecia dall’euro; se il Grexit ci sarà, sarà perché lo hanno voluto i creditori, e in particolare l’Fmi». D’altronde lo stesso Tsipras ha recentemente accusato la troika di voler imporre un «cambio di regime» nel paese ellenico. Un sospetto alimentato dalla presenza a Bruxelles negli ultimi giorni dei tre leader dell’opposizione: l’ex premier Antonis Samaras, il nuovo leader del Pasok Fofi Gennimata e Stavros Theodorakis, segretario di To Potami. Dando corpo all’ipotesi che l’obiettivo dei leader dell’Ue, a questo punto, non sia quello di un accordo ma piuttosto di 13 portare il paese sull’orlo del baratro, costringendo il governo a indire nuove elezioni, in cui l’opposizione si presenterebbe sotto un’unica bandiera pro-Europa. Se veramente siamo di fronte al tentativo dell’establishment europeo di imporre un golpe soft nel paese – e ormai è una possibilità che non si può escludere –, quali opzioni rimangono al governo? Insistere nel tentativo di giungere a un «compromesso onorevole» che ormai appare impossibile sarebbe controproducente. Anche perché, se uno degli obiettivi del tentativo di «appeasement» di Tsipras era quello di dimostrare la buona volontà della nuova dirigenza greca, sollevando così il governo da ogni responsabilità per un’eventuale «uscita forzata» del paese dall’euro — e annessi effetti collaterali –, quell’obiettivo può considerarsi raggiunto. Basta leggere i commenti della stampa internazionale, sempre più critici nei confronti dell’intransigenza della troika. È anche per salvaguardare questo «credito politico» — ma soprattutto per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione economica del paese, molto dipendente dalla importazioni di cibo, carburante e medicinali – che andrebbe evitata l’uscita unilaterale della Grecia dall’euro. Rimane una terza opzione: quella del default senza uscita dall’euro, con l’annuncio che la Grecia non ripagherà il debito pubblico detenuto per l’80% da fondi europei d’emergenza, paesi membri, Fmi e Bce, né pagherà gli interessi dovuti. A quel punto l’Europa sarebbe costretta a scoprire le sue carte. Non c’è nessun motivo, infatti, per cui un default dovrebbe comportare l’uscita del paese dall’euro; questo dipenderà unicamente dal comportamento della Bce: se questa accetta di ristrutturare e ricapitalizzare le banche greche – ponendo come condizione che queste non comprino più titoli di Stato ellenici, sostanzialmente recidendo il legame banche-governo, secondo la proposta avanzata da William Buiter sul Financial Times -, lo Stato greco, sollevato dal fardello del debito, potrebbe tornare sui mercati e l’economia potrebbe ripartire. Volendo, il governo potrebbe anche prendere in considerazione l’introduzione di una moneta complementare, sul modello dei «certificati di credito fiscale» di cui tanto si parla. Se, al contrario, la Bce decide di chiudere i rubinetti della liquidità, l’uscita del paese dalla moneta unica – o peggio – sarà quasi inevitabile. Ma almeno il mondo intero saprà che «sarà perché lo hanno voluto i creditori». Del 26/06/2015, pag. 3 La rabbia delle anime di Syriza Il bivio. Fra «inconciliabili» e «realisti» il programma di Salonicco alla prova dei numeri. Dura denuncia contro l’ex premier Antonis Samaras «servo dei creditori» a Bruxelles Più si dimostrano intransigenti i creditori nei confronti di Alexis Tsipras, più si rafforzano le voci almeno nella sinistra radicale greca che chiedono vie alternative, elezioni anticipate e l’uscita della Grecia dall’eurozona. Il contenuto dell’accordo, nel caso davvero ci fosse, non solo fa inasprire il dibattito in seno a Syriza, ma mette alla prova la compattezza del suo gruppo parlamentare. La sinistra radicale è sempre stata un’area politica che comprende tutti: dai socialisti irradiati dal Pasok e dal Kke, ex eurocomunisti fino a ecologisti-verdi, anti-global e «cani sciolti» con diverse strategie. Un vero arcobaleno politico, ma anche un campo di elaborazione ideologica in cui spesso si scontravano tendenze opposte, ma che ora deve governare in un ambiente europeo chiaramente ostile. Alexis Tsipras, mettendo in evidenza la necessità di un governo alternativo che potrebbe «combattere le politiche criminali dei creditori e dei governi della Nea Dimokratia e del Pasok responsabili per la crisi», ha lasciato in parte la retorica di denuncia. Fino all’ultima 14 campagna elettorale tendeva la mano ai comunisti del Kke, che considera Syriza un partito che «collabora con gli industriali, viene sostenuto dalle grandi imprese e ospita dei corrotti». Così il segretario Dimitris Koutsoubas. Il cosiddetto programma di Salonicco, grazie al quale il giovane leader ha vinto le elezioni del 25 gennaio, era in pratica un testo di compromesso tra varie correnti. Nonostante ciò, i battibecchi polemici tra le varie anime non si sono mai esauriti. Per i dirigenti, il dibattito è sempre costruttivo: rispecchia la ricchezza politica ed ideologica del Syriza, senza compromettere la sua unità. Per i media (e non soltanto per quelli che fanno il gioco degli oligarchi greci), il dialogo interno mette in evidenza le «divergenze profonde tra le correnti» e indebolisce il governo. Per una parte dell’elettorato, si tratta di «poliglottismo degli esponenti del Syriza». Nei cinque mesi di governo, il premier greco per evitare che il suo esecutivo fosse una «parentesi di sinistra», come vorrebbero falchi finanziari, conservatori e socialisti a Bruxelles ed ad Atene, ha preferito una svolta verso il realismo. L’alternativa sarebbe uno scontro frontale ancora più duro tra il governo e i creditori internazionali, la chiusura dei rubinetti dalla Bce, il default, l’uscita obbligata dalla zona euro. Durante questo periodo non erano pochi i momenti che componenti e deputati di rilievo del Syriza si sono schierati a favore di proposte opposte da quelle avanzate da Alexis Tsipras. L’eurodeputato di Syriza, Manolis Glezos, simbolo della resistenza contro i nazisti, il ministro delle Infrastrutture, Panajotis Lafazanis, ex dirigente del Kke e leader della Piattaforma di sinistra, la componente d’ opposizione interna più forte, la presidente del parlamento, Zoi Konstantopoulou, il vice-ministro della previdenza sociale, Dimitris Stratoulis ed ex socialisti, come il vice-presidente della camera, Alexis Mitropoulos, vorrebbero che il nuovo presidente della Repubblica provenisse dall’area della sinistra, e non di destra, com’è il conservatore Prokopis Pavlopoulos. Riferendosi all’accordo di Bruxelles del 20 febbraio, la Piattaforma di sinistra l’aveva caratterizzato «un indovinello». Glezos la aveva paragonato ad «una bomba alle fondameta del governo di Syriza-Anel». In un documento reso pubblico allora il professore di economia, Yannis Milios (giá responsabile della politica economica del Syriza), e altri due dirigenti avevano criticato aspramente l’operato del ministro delle finanze, Yanis Varoufakis. Lo scontro ideologico tra un dirigente apertamente marxista e un ministro di sinistra, ma di tendenza keynesiana, era piú che evidente. Noti esponenti, come il deputato Kostas Lapavitsas, professore all’Università di Londra, non perdono occasione per esprimersi a favore del ritorno alla dracma, mentre altri non vogliono sentir parlare di privatizzazioni o difendono i prepensionamenti. «Se la Grecia esce dall’ eurozona non sará la catastrofe» scrive nel sito web la Piattaforma di sinistra. Gli «inconciliabili» credono che una fuoriuscita della Grecia dall’Ue metterebbe i greci in salvo, ed è comunque meglio del perenne stato di impoverimento attuale, senza tener conto che la competitività resta bassissima. I «realisti» replicano che c’è spazio per un compromesso onorevole secondo il programma di Salonicco. L’opposizione interna non ha mai finora messo in dubbio apertamente né le scelte di Tsipras, né la sua tattica durante le trattattive. Anzi, ieri Syriza ha denunciato con toni duri l’ex premier Antonis Samaras, che dopo l’incontro a Bruxelles con i creditori e «nel momento in cui il governo dà una battaglia dura per difendere i diritti dei greci, chiede un governo nuovo con un premier servo degli interessi dei creditori». Ora per motivi di disciplina di partito o di convenienza, sembra che un numero piccolo rispetto alle reazioni interne di deputati Syriza (al massimo 10–15) voterebbero contro l’accordo. Ma, di fatto, guadagnano spazio le voci critiche alle scelte di Tsipras. Anche nel comitato centrale del Syriza. Giá 44 dei 149 parlamentari si erano espressi contro la nomina di Elena Panaritis all’incarico di rappresentante della Grecia nel Fondo monetario 15 internazionale. Se poi si tiene conto che il partner di governo e leader del partito di destra “Greci Indipendenti” (13 seggi), Panos Kammenos, è pronto a votare contro l’accordo nel caso preveda l’abolizione dell’Iva scontata sulle isole, e che Syriza ha 149 seggi, non è da escludere un nuovo ricorso alle urne o un referendum affinché Tsipras rinconfermi il mandato. Del 26/06/2015, pag. 20 Attacco a sorpresa l’Is rientra a Kobane L’accusa dei curdi “Aiuti dalla Turchia” Battaglia nella città simbolo della resistenza ai jihadisti Decine di morti, conquistati alcuni quartieri della periferia ALBERTO STABILE BEIRUT . I miliziani dello Stato Islamico hanno lanciato un attacco a sorpresa su Kobane, la cittadina curda al confine con la Turchia dalla quale erano stati cacciati nel gennaio scorso dopo una battaglia durata quattro mesi. Parallelamente, in quella che sembra una classica manovra diversiva per bloccare le forze curde nella loro avanzata su Raqqa, la cosiddetta “capitale” del Califfato, le formazioni jihadiste hanno scatenato l’offensiva anche su Hassakeh, il capoluogo dell’omonima provincia a Nordest di Kobane, in parte controllata dalle formazioni armate curde e in parte dall’esercito fedele ad Assad. Una terza coalizione di forze ribelli, il Fronte Sud, che si avvale degli aiuti americani, sta puntando su Deraa, la città al confine con la Giordania dove, più di quattro anni fa, la rivolta siriana ebbe inizio. Ma sia per il suo valore emblematico, che per la sua importanza strategica, è sulla nuova battaglia di Kobane, la cittadina diventata un luogo simbolo della resistenza curda contro la marea integralista dello Stato Islamico, che oggi si concentra la maggiore attenzione. Una battaglia cominciata con l’irruzione di cinque formazioni jihadiste che si sono fatte strada oltre le difese curde a colpi di autobombe. La prima è esplosa all’alba, nei paraggi del posto di frontiera con la Turchia di Mursitpinar, le altre nel corso della mattinata. I morti, secondo l’Osservatorio per i diritti umani, l’organizzazione non governativa di base a Londra, vicina all’opposizione siriana, sarebbero già 35, mentre 65 feriti hanno cercato soccorso nel villaggio di Suruq, in territorio turco. Gli assalitori hanno potuto contare sull’effetto sorpresa issando sulle auto sulle quali viaggiavano la bandiera della rivolta siriana e indossando divise dei miliziani del YPG, le unità di autodifesa curde, e del Libero Esercito Siriano. Evidentemente, i jihadisti erano riusciti ad infiltrare altri uomini nel dedalo di rovine in cui è stata ridotta Kobane. Sta di fatto che, dopo le autobombe, è cominciato uno scontro a fuoco che è andato avanti per tutto il pomeriggio, in alcune zone della città e nei villaggi del suo hinterland. Ma perché, di nuovo Kobane? Secondo gli osservatori impegnati ad analizzare tattiche e strategia dello Stato Islamico, più che una nuova offensiva gli strateghi del Califfato hanno voluto inscenare una controffensiva per fermare l’avanza delle milizie curde verso Raqqa. «Fanno sempre così – dicono questi analisti – quando i combattenti dello Stato Islamico sono in difficoltà in un determinato luogo, attaccano altrove». E non c’è dubbio che i jihadisti nelle ultime settimane siano apparsi in gravi difficoltà, dopo essere stati costretti dall’incalzante avanzata dei curdi del YPG a ritirarsi da Tel Abyad e da Ayn Issa, lasciando, in pratica, Raqqa, distante soltanto una cinquantina di chilometri, esposta ad un probabile attacco. 16 I curdi, inoltre, avevano esteso il controllo su 400 chilometri di confine con la Turchia, con grande allarme non solo dei ribelli islamisti, che hanno sempre potuto contare sulla compiacente retrovia turca, ma dello stesso governo di Ankara che vede i curdi del YPG, un’emanazione del PKK di Abdallah Ochalan, come una vera e propria minaccia alla sovranità turca. Da qui le polemiche che, anche in occasione della controffensiva dello Stato Islamico su Kobane, sono immediatamente esplose. Con i curdi che accusano che i miliziani islamisti sono arrivati dalla Turchia e il governo di Ankara che nega e smentisce. E con il leader del Partito Democratico del Popolo, filo curdo, entrato per la prima volta in parlamento alle recenti elezioni, che attacca Erdogan affermando che «il governo turco ha sostenuto per anni lo Stato Islamico. Il massacro di Kobane è frutto di questo sostegno». Del 26/06/2015, pag. 1-16 Le partigiane del Rojava Giuliana Sgrena Chi riuscirà a sconfiggere i terroristi dell’Isis? Solo chi ha un progetto di società alternativo a quello fondamentalista del califfato e dei suoi sostenitori, a oriente e a occidente. L’alternativa si basa sul Contratto sociale del Rojava, un progetto rivoluzionario portato avanti dai kurdi che finora hanno inferto le più cocenti sconfitte, anche se purtroppo non definitive, ai seguaci di al Baghdadi. Un progetto per la costruzione di una società laica, democratica ed egualitaria, dove possano vivere liberamente e pacificamente diverse etnie, confessioni, culture e identità. Sul piano economico propone uno sviluppo ecologicamente compatibile contro lo sfruttamento umano e della natura, incompatibile con il liberismo. Il riconoscimento dell’uguaglianza tra uomo e donna rappresenta forse, nell’immaginario dell’Isis, il nemico peggiore. Non a caso l’Isis ha proclamato le donne «il nemico numero uno». Sono state infatti le combattenti kurde dell’Unità di difesa delle donne a far crollare le certezze di coloro che combattono in nome di dio convinti che il martirio durante il jihad rappresenti il viatico per il paradiso dove li attendono le vergini. E invece si sono trovati sulla loro strada le «streghe» del Rojava che hanno inferto un duro colpo alla loro ideologia. Le donne come gli uomini del Rojava combattono per un ideale, per costruire una società più giusta, democratica e laica; per questo fanno paura, non solo all’Isis, ma a tutte le teocrazie della regione, innanzitutto alla Turchia che proprio ieri ha favorito il rientro a Kobane dei fascisti – perché chi sgozza, stupra, terrorizza la popolazione e distrugge la cultura e l’arte non può essere definito diversamente – dell’Isis. La Turchia è la principale responsabile degli aiuti forniti ai jihadisti che combattono in Siria e nello stesso tempo blocca il passaggio degli aiuti umanitari per la popolazione di Kobane, rimasta senza casa, senz’acqua, senza elettricità. Erdogan è spaventato anche per il successo ottenuto nelle ultime elezioni dal Partito democratico del popolo (Hdp) che condivide il progetto politico del Rojava, ispirato peraltro dal leader kurdo Ocalan, rinchiuso nel carcere di Imrali. I kurdi rinunciando all’indipendenza (un sogno che si è verificato irrealizzabile), pur chiedendo un’autonomia all’interno della Turchia o della Siria di cui gode già il Kurdistan iracheno, hanno fatto del modello sociale da costruire il loro obiettivo politico. Non hanno aspettato di aver sconfitto il nemico per applicarlo, né in Siria e nemmeno in Turchia, dove hanno anche deposto le armi. Erdogan, che si era detto pronto al dialogo per la soluzione della questione kurda, è rimasto spiazzato. Nel frattempo la lotta per il parco di Gezi ha permesso ai kurdi di costruire nuove alleanze e il risultato si è visto il 7 giugno (elezioni). Il nuovo sultano ha reagito istericamente e, rispondendo all’appello 17 dell’Isis che vuole rafforzare i combattimenti durante il Ramadan, ha favorito ancora una volta il passaggio di jihadisti. A Kobane si torna a combattere in queste ore, ma i partigiani della rivoluzione non cederanno, anche se le loro armi sono poche e obsolete il loro progetto rivoluzionario – che ha eliminato anche la pena di morte — è più forte del fanatismo oscurantista di chi non seppellisce i corpi dei combattenti se sono caduti per mano di una donna, perché non potranno accedere al paradiso. Del 26/06/2015, pag. 17 La Corte suprema salva Obama “La riforma sanitaria è legittima” Paolo Mastrolilli L’eredità politica del presidente Obama è salva, almeno quella della riforma sanitaria. Infatti la sentenza con cui ieri la Corte Suprema ha confermato la legalità del principale risultato ottenuto dal capo della Casa Bianca sul fronte interno, garantisce in sostanza che sopravviverà alla sua amministrazione. Sul tavolo dei giudici era arrivata una causa presentata da quattro abitanti della Virginia, legata a un aspetto specifico della riforma: quello dei sussidi offerti alle persone che comprano le nuove polizze. A livello nazionale, finora 10,2 milioni di cittadini hanno aderito all’Obamacare, ma questo numero include 8,7 milioni di utenti poveri che ricevono in media 272 dollari al mese dal governo per aiutarli a pagare le assicurazioni. Senza, molti di loro non potrebbero permettersele. Offensiva repubblicana La legge dice che tali soldi pubblici possono essere assegnati solo attraverso dei mercati «creati dallo Stato», e i repubblicani contrari alla riforma avevano approfittato di queste parole per cercare di farla deragliare, sostenendo che così discriminava alcuni cittadini. Infatti 34 Stati non avevano creato questi mercati per l’acquisto delle polizze, proprio per boicottare la riforma. Ma se i sussidi non erano disponibili per i loro abitanti, «Obamacare» violava il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e quindi doveva essere annullata. Il governo federale aveva risposto intervenendo direttamente, per dare le agevolazioni al posto degli Stati che le rifiutavano, ma questa iniziativa era stata contestata appunto dalla causa finita davanti alla Corte Suprema. In altre parole, i conservatori contrari per principio alla riforma avevano scelto questo cavillo per bloccarla. Il giudice scelto da Bush Ieri sei giudici su nove, compreso il presidente della Corte Roberts che era stato nominato da George Bush, hanno dato ragione a Obama. È vero infatti, come ha notato lo stesso Roberts scrivendo l’opinione della maggioranza, che il linguaggio della legge si presta ad equivoci, ma l’intenzione reale del governo era «migliorare il mercato delle assicurazioni, non distruggerlo». Quindi il testo va interpretato come una generale autorizzazione allo Stato di intervenire in aiuto dei cittadini interessati a sottoscrivere le nuove polizze. Il giudice Scalia, scrivendo l’opinione della minoranza, ha denunciato che «ormai questa è la Scotuscare, la riforma sanitaria della Corte Suprema, perché stravolge le sue parole pur di difenderla». La Casa Bianca festeggia Obama ha celebrato rispondendo che «nonostante tutti i ricorsi, questa legge aiuta milioni di cittadini ed è destinata a restare». I repubblicani hanno criticato la sentenza, ma dietro le quinte hanno tirato un sospiro di sollievo, perché non avevano un’alternativa pronta da 18 proporre ed erano divisi su come procedere. La riforma quindi sopravviverà al presidente che l’ha scritta, e se i suoi oppositori vorranno cancellarla, dovranno vincere le elezioni presidenziali e congressuali dell’anno prossimo. INTERNI Del 26/06/2015, pag. 2 Scuola ok, Renzi incassa la fiducia tra urla, insulti e finti funerali In Senato 159 sì e 112 no.Protestano le opposizioni,M5S contro Napolitano Romani: “Governo senza maggioranza” La piazza con Fassina,fischi a Mineo CARMELO LOPAPA ROMA . La riforma della scuola passa l’esame più difficile, a Palazzo Madama i sì sono 159, i contrari 112, tra lumini mortuari, fischietti, fasce nere, striscioni in aula. La “buona scuola” diventerà legge a Montecitorio dove approderà già il 7 luglio. Bisogna correre, dicono dal governo, per sbloccare le 103 mila assunzioni in tempo per settembre. “Ce l’abbiamo fatta” scrive via sms al premier Renzi la ministra dell’Istruzione Giannini. Ma si va sotto quota 160, la metà più uno dei senatori se si considerano quelli a vita. Tanto che il forzista Paolo Romani e il leghista Roberto Calderoli vantano una mezza vittoria, nella disfatta: «Il governo non ha più i numeri al Senato ». Fuori dall’aula i professori e gli studentidalle 17 attraversano Roma, partendo dalla Bocca della verità, saranno bloccati dalla polizia in stato antisommossa a piazza Sant’Andrea della Valle, poco distante da Palazzo Madama. I capannelli si animeranno parecchio in serata, quando i parlamentari grillini e quelli di Sel si uniranno ai manifestanti in piazza, per urlare anche da lì “vergogna” ai senatori di maggioranza che alla spicciolata escono e passano a tiro. I flash mob del pomeriggio lasciano il posto agli slogan urlati: “No pd, no pd, traditori, traditori”. Si becca la contestazione (“Vattene buffone”) Corradino Mineo, che pure ha negato la fiducia al governo con gli altri della sinistra pd: Roberto Ruta, Walter Tocci, Felice Casson. Pretendevano il no, piuttosto che la defezione dal voto. Tutt’altra accoglienza per l’ormai ex pd Stefano Fassina, applausi e abbracci dagli insegnanti: «È inaccettabile che vi sia stata sbattuta la porta in faccia», li consola lui. Dentro, l’aula è in subbuglio, lo sarà dal mattino fino al voto finale. Il governo ce l’ha fatta sì, il ministro Stefania Giannini («Non sono commissariata») e il sottosegretario Davide Faraone si abbracciano. Ma con voti e assenze che pesano. Con i sì, ad esempio, degli ex Fi Sandro Bondi e Manuela Repetti, con l’assenza fin troppo evidente di Denis Verdini, ormai in rotta col suo partito. Se è per questo non si fanno vedere nel giorno decisivo, ma per marcare la distanza, nemmeno il senatore a vita Carlo Rubbia, e Elena Cattaneo e Mario Monti, uomini di scienza e di università. Tra le file della maggioranza spicca anche l’assenza di Carlo Giovanardi, ma l’Ncd di cui fa parte è compatto e determinante. Dagli ultrà grillini e Sel non sarà risparmiato nessuno dei votanti a favore. Nemmeno, per la prima volta, l’ex presidente Giorgio Napolitano. Ha appena pronunciato il suo “sì” alla prima chiama e finisce sopraffatto da cori di “buu”, “bravo, bravo”, “vergogna” e fischi dai 19 banchi dei Cinque stelle. Lui si allontana lentamente sostenendosi sul bastone, senza voltarsi. Sono da poco passate le 18, è il momento più basso di una giornata che è andata degradando come su piano inclinato verso il caos finale. Una corrida, protagonisti anche prof e studenti dalle tribune in alto, che si scatenerà contro tutti gli ex grillini che oseranno pronunciare il “sì” alla chiama, ma anche contro chi, come Miguel Gotor sta alla sinistra del pd, ma non al punto da negare la fiducia. «Voto sì per disciplina, ma gli elettori non ci perdoneranno», è il suo presagio. A mezzogiorno i parlamentari di Sel compaiono con tshirt bianche con la scritta “Libertà di insegnamento” e “Diritto allo studio”, il clou sarà l’uso imperterrito dei fischietti in aula, stile Vuvuzelas ai mondiali del Sudafrica. La maglietta la indossa anche Maria Mussini del Misto e il presidente Grasso le chiede di toglierla. «Che faccio presidente, mi spoglio? Volete uno striptease?» La capogruppo Sel De Petris nel frattempo ha adagiato una di quelle magliette sul banco del ministro Giannini. «Fuori i bulli dalla scuola», campeggia sui cartelli mostrati dai leghisti con tanto di fotomontaggio del premier Renzi nei panni del Fonzie di “Happy days”. Nulla rispetto allo striscione che a un certo punto srotolano sempre i leghisti: «Difendiamo i nostri bambini dalla scuola di Satana», c’è scritto. Il loro Gian Marco Centinaio si distinguerà per aver paragonato il ddl alla “vaselina”. I grillini portano in aula i lumini mortuari, dopo averli ostentati in sala stampa a beneficio delle telecamere per il “funerale” della scuola. «Quei lumini che avete là non portano bene», li ammonisce con l’ultimo briciolo di ironia l’ormai esausto presidente Grasso. Perderà le staffe solo quando i banchi M5S si trasformeranno in curva sud pronta a colpire chiunque voti a favore o quasi: «Questi sono gesti di intolleranza. Il voto deve essere libero, non voglio commenti né prima, né dopo». Ma sarà inutile. Bondi e Repetti, con Casini e tutti gli ex grillini, i più tartassati. Beppe Grillo via Twitter sentenzia: «Hanno ucciso la scuola pubblica». I centomila da assumere tirano un sospiro di sollievo. Del 26/06/2015, pag. 14 De Magistris è in carica sospensione annullata oggi decreto su De Luca Il tribunale dà ragione al sindaco, Severino congelata E il precedente ora gioca a favore del governatore DARIO DEL PORTO NAPOLI. Luigi de Magistris non tornerà «sindaco di strada». La sospensione del primo cittadino di Napoli, ha stabilito il giudice civile, resterà congelata fino alla decisione della Consulta sull’eccezione di legittimità costituzionale della legge Severino. Ma quando l’Alta Corte si pronuncerà, la condanna per abuso d’ufficio riportata dall’ex pm nel caso Why Not sarà già stata cancellata in appello da un’assoluzione o dalla prescrizione. Caso chiuso, dunque. Per il neo governatore Campania Vincenzo De Luca, invece, la partita con la legge Severino comincia oggi, con il probabile varo del decreto interpretativo supportato dal parere dell’avvocatura dello Stato, e andrà avanti fino all’insediamento nella carica di governatore, l’inevitabile sospensione e lo scontato ricorso in tribunale. Davanti al giudice, il precedente di de Magistris potrebbe giocare a favore del presidente della Regione. L’ordinanza di ieri costituisce infatti il primo provvedimento da quando le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno assegnato al giudice ordinario, e non più al Tar, la valutazione dei ricorsi contro la legge Severino. I magistrati (presidente Umberto Antico, giudice estensore Ornella Minucci, a latere Roberta Di Clemente) ricordano il carattere temporaneo del mandato di sindaco e sottolineano: «Qualora la Corte Costituzionale 20 dovesse ritenere fondata la questione di legittimità » sollevata dagli avvocati Stefano Montone, Giuseppe Russo e Lelio Della Pietra, legali di de Magistris, sul nodo dell’applicazione retroattiva della Severino, il diritto del sindaco «resterebbe definitivamente ed irrimediabilmente vanificato» da una sospensione. E questo arrecherebbe «un pregiudizio grave ed irreparabile» all’amministratore che non potrebbe più recuperare «il tempo del mancato esercizio della funzione». Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, commenta: «Secondo me l’ordinanza è l’ennesima prova che la legge Severino non funziona. Non dico che non funzioni nel suo insieme perché stiamo contrastando più efficacemente la corruzione, ma per quanto riguarda i regimi di sospensione non funziona». Resta da capire quali saranno gli effetti nel caso De Luca, condannato in primo grado per abuso d’ufficio nel processo sulla nomina del project manager del termovalorizzatore di Salerno e per questo in procinto di essere sospeso. Oggi il governo potrebbe approvare il decreto legge interpretativo della legge Severino per consentire, prima della sospensione, l’insediamento della giunta e la nomina di un vice. In questo modo si garantirebbe, si legge nel parere dell’avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri, «l’esercizio delle funzioni sostitutive per l’ipotesi di sospensione del presidente e la continuità dell’indiritto politico emerso dalle consultazioni elettorali». Lunedì si riunisce il consiglio regionale, De Luca insedierà l’esecutivo, poi sarà sospeso. Il governatore, argomenta il giurista Gianluigi Pellegrino ( che nel giudizio su de Magistris assiste il Movimento difesa del cittadino), «non potrà giovarsi della decisione del tribunale di Napoli. L’eventuale ricorso di De Luca — scrive Pellegrino sul suo blog pubblicato dall’Huffington — avrebbe storia a sé e dovrebbe misurarsi con decine di motivatissimi precedenti di merito sia del Consiglio di Stato che dei giudici ordinari che hanno respinto il ricorso di altrettanti amministratori sospesi». Del 26/06/2015, pag. 17 Dossier Gabrielli, Marino in bilico Orfini: “Dopo quello decideremo”.Vicina la scorta per il sindaco LA GIORNATA GIOVANNA VITALE ROMA . «La linea non cambia: il se non è in discussione, quel che resta da capire è solo il come Marino lascerà». Se cioè qualcuno riuscirà infine a convincerlo a fare le valigie o si dovrà imboccare la strada, più traumatica, delle dimissioni di massa in aula Giulio Cesare. Ché pure il quando è già stabilito: la relazione del prefetto Gabrielli sull’eventuale presenza di infiltrazioni mafiose in Campidoglio. «Uno spartiacque», per il Nazareno. Lo ribadisce il presidente nazionale e commissario romano Matteo Orfini: «Dopo quella, si farà insieme un ragionamento per capire come andare avanti. Io però da qui ad allora eviterei di complicare il clima, che non serve a nessuno». Un avvertimento chiaro a Marino, che dal suo fortino assediato lancia messaggi, minaccia rivelazioni su chi lo avrebbe costretto a promuovere in giunta gli uomini del Pd risultati poi coinvolti in Mafia Capitale: «Ora pensi a lavorare e ad amministrare bene, senza alimentare polemiche e ulteriore confusione», taglia corto Orfini. Pronto a stoppare la manovra di avvicinamento al premier tentata dagli sherpa del sindaco per ricucire: «Tra lui e Renzi non è previsto alcun incontro, si farà quando, insieme, dovremo valutare il da farsi dopo il parere di Gabrielli». Il crinale oltre il quale «niente sarà più come prima», garantiscono i più vicini al capo del governo. Consapevoli che se un errore è stato fatto finora è «aver sottovalutato il carattere di Marino». Indifferente a ogni scossone, alle sberle assestate dal premier, alle 21 scomuniche che a cadenza quasi quotidiana piovono dai piani alti del Pd. Lasciato solo anche nel giorno del suo primo successo dopo settimane di tensione: il via libera alla mozione sulla candidatura di Roma ai Giochi 2024, approvata in consiglio comunale con i soli voti contrari dei grillini e dell’esponente di “Noi con Salvini”. Salutata con entusiasmo dai presidenti del Coni Malagò («Oggi lo sport ha prevalso su alcune logiche della politica») e del Comitato promotore Montezemolo («Saranno le Olimpiadi della bellezza, della cultura, della tecnologia»). Ma accolta dal gelo del governo: nessun ministro o sottosegretario che si sia congratulato, abbia espresso soddisfazione, «e dire che Renzi ci aveva messo la faccia». Una vittoria, quella di Marino, ottenuta solo a prezzo di una clamorosa ritrattazione: «Non mi sentirete più pronunciare quelle parole», è stato infine costretto a dichiarare in aula, a proposito dell’invettiva («La destra deve tornare nelle fogne») lanciata domenica scorsa alla Festa dell’Unità. La condizione posta dalla minoranza — da Ncd a Fi — per votare la mozione sui Giochi. Minacciando, se non si fosse scusato, di diffondere un dossier su tutti gli uomini nominati dal sindaco — politici e dirigenti — che intrallazzavano con il clan di Carminati. «Oggi inizia una sfida straordinaria, per la città e il Paese, che vogliamo vincere tutti insieme», esulta Marino. L’unica ombra è quella allungata dalla busta con i proiettili, indirizzata a lui e alla famiglia, intercettata allo scalo di Fiumicino. Un riferimento, alla moglie e alla figlia, che lo turba moltissimo. «Le minacce sono attendibili », fa sapere il prefetto, assegnandogli una scorta. Che lui però vorrebbe rifiutare: «Ci penso». Ma Orfini lo esorta: «Accettala, il clima è inquietante, il Pd è tutto con te». Del 26/06/2015, pag. 5 Roma 2024, già oro per Odevaine: amici scelti per l’ambiente Dal Coni 35mila euro in consulenze a Italia Green di Ferrante, già numero 2 nella Fondazione dell’ex funzionario di Veltroni Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, senatori del Pd fino al 2013, sono stati scelti dal Coni come consulenti per gli aspetti ambientali delle Olimpiadi del 2024. La società (di lobbying ambientale) Italia Green della quale sono soci e amministratori alla pari ha ottenuto, senza gara un contratto da 35 mila euro più Iva da parte di una società pubblica (Coni Servizi è al 100 per cento del Ministero Economia e Finanze) “perché si tratta di un valore ‘sotto soglia’”, spiega l’amministratore del Coni Servizi Alberto Miglietta. Il Coni ha pensato che l’ex presidente e l’ex direttore di Legambiente fossero le persone giuste per far digerire i cinque cerchi ai verdi. Il Campidoglio ieri ha approvato una mozione bipartisan per le Olimpiadi del 2024. La società scelta per seguire l’aspetto ambientale di Roma 2024, Italia Green, però non aveva un buon biglietto da visita, nel senso proprio del termine, per via della sede: nello studio di Stefano Bravo, arrestato il 4 giugno scorso per i suoi affari con Luca Odevaine. Bravo aveva ricevuto anche una procura per gli adempimenti amministrativi di Italia Green da Ferrante che spiega: “Era il nostro commercialista. La sede è stata spostata”. Nell’informativa del Ros dei Carabinieri del 16 febbraio del 2015 però ci sono un paio di conversazioni poco edificanti di Odevaine con Francesco Ferrante, vicepresidente della Fondazione IntegrAzione dentro i cui uffici era piazzata la cimice del Ros. Il 16 giugno 22 2014, il presidente di IntegrAzione Odevaine spiegava al vicepresidente Ferrante la gara per il Cara di Mineo che cinque mesi dopo sarà vinta dal raggruppamento capeggiato dalla Cascina grazie a una turbativa secondo i pm. Non sarà rassicurante per il Coni scoprire come Odevaine spiegava a Ferrante, (che non è indagato) la gara ‘finta’ di Mineo: “Si sono inventati una figura senza senso per fare due procedimenti separati uno per il reperimento dell’immobile che (…) cioè quale pensi che possa essere un altro immobile se l’ambito è quello del consorzio Calatino? Sarà di quei Comuni, non è che ne esiste un altro di immobile. Me fai fa una procedura per prendere in affitto l’immobile e poi la procedura di gara per affidare i servizi quando il proprietario dell’immobile sta in Ati con chi fa i servizi… cioè è chiaro che è finta no?!”. Solo Pizzarotti, alleato con La Cascina, possiede un immobile come quello del Cara di Mineo, spiega Odevaine ecco perché la gara da 100 milioni era finta. Ferrante replica: “Ora è tutto chiaro. Al momento sembravano solo chiacchiere che non riguardavano né me né la Fondazione che non c’entra nulla con Italia Green Srl”. Nell’informativa del Ros dopo questa intercettazione iniziano 120 pagine di omissis. Mentre è riportata la conversazione del 12 maggio 2014 nella quale Odevaine gli spiega il suo piano per la gara di San Giuliano di Puglia: “ho trovato già una persona che la fa per me… Patrizia Cologgi (funzionario della presidenza del consiglio, Ndr) lei la farà, è un soldato”. San Giuliano avrebbe reso alla Cascina più di Mineo: “A San Giuliano con c’è affitto (l’immobile era in questo caso il villaggio donato dagli italiani ai terremotati, Ndr) per cui vuol dire che tu c’hai 10 euro di margine sicuro … insomma anche se gli chiedo due euro (riferito agli accordi con la cooperativa, basati su un ‘tot’ al giorno per ogni ospite, Ndr) eh comunque diventano 30 mila euro al mese con cui ce mandiamo avanti qua la … ed è per tre anni qua il contratto!”. La sensazione è che Odevaine volesse spiegare a Ferrante come avrebbe fatto a far guadagnare la Cascina per poi chiedere alla coop ciellina 30 mila euro al mese per mandare avanti la Fondazione. “L’amicizia mi ha fatto velo: pensavo che parlasse di compensi per lavori svolti, non certo di mazzette”, spiega Ferrante. Ferrante e Della Seta nel giugno 2013 hanno creato il movimento Green Italia. Nel ‘comitato dei cento’ c’era anche Odevaine, proveniente da Legambiente anche lui. Italia Green Srl nasce a marzo 2013. Il nome è simile a quello del movimento ma non hanno nulla a che fare. La società svolge “attività di consulenza e assistenza nel settore ambientale”. I suoi clienti sono privati, come Parsitalia o Castalia. Ma anche pubblici. Nell’oggetto sociale ci sono anche le “azioni di lobbying per costruire coalizioni bipartisan a favore dei clienti e delle loro iniziative”. Del 26/06/2015, pag. 13 Il pasticcio delle firme false nel Pd paralizza il Piemonte di Chiamparino Il 9 luglio l’esame del Tar. Ma con un verdetto negativo o un lungo rinvio il governatore si dimetterà DAL NOSTRO INVIATO TORINO L’antefatto è la meravigliosa armonia che regna nel Partito democratico piemontese. Era la notte del 18 aprile 2014. A momenti si menavano, tra fassiniani, nel senso di sostenitori dell’attuale sindaco del capoluogo, sinistra interna, renziani reduci della Margherita e Ateniesi, la corrente locale degli ortodossi seguaci della prima ora del presidente del Consiglio. Mancavano poche ore alla presentazione delle candidature per le elezioni 23 regionali. Togli un nome, mettine un altro, la lista cambiava volto e nomi ogni minuto, a seconda di chi prevaleva nel braccio di ferro. Alla fine si trovò la quadra, la si trova sempre. Piccolo dettaglio, a forza di scannarsi non c’era più tempo per trovare invece le firme di sostegno ai prescelti, obbligatorie per legge. C’era bisogno di qualcuno che vidimasse quelle raccolte ai banchetti, ma ormai s’era fatta una certa ora, e forse a qualcuno venne in mente di falsificare quelle dei titolari. Sergio Chiamparino ha rapporti molti complicati, gentile eufemismo, con i vertici del Pd locale. Non da ieri è furibondo per come venne gestita quella specie di faida, della quale rischia ora di pagarne le conseguenze. Tu chiamala se vuoi, nemesi. Ma ancora una volta la Regione Piemonte è congelata nell’attesa del consueto giorno del giudizio che andrà in scena al Tar di Torino il prossimo 9 luglio. Il ricorso è firmato da una esponente della Lega Nord. Vendetta, tremenda vendetta. Nel 2010 la vicenda delle firme false diventò una spada di Damocle che tra sentenze, rinvii al Consiglio di Stato, ritorni al Tar, rese la vita impossibile all’allora governatore Roberto Cota e fu causa della sua caduta anticipata. Il successore ribadisce di non voler rimanere appeso a questa specie di stato vegetativo. Se la faccenda non verrà decisa in modo positivo o peggio sarà rimandata alle calende greche, la lettera di dimissioni è già pronta nel cassetto. Per un uomo politico che ha sempre fatto della praticità la sua cifra e voleva far ripartire la Regione, non c’è sorte peggiore di questa attesa simile all’inazione che potrebbe protrarsi per anni. All’inizio di giugno la conferenza dei capigruppo ha deciso di non convocare i lavori di giunta fino a dopo la sentenza del Tar. L’aria che tira è questa, avanti con l’ordinaria amministrazione, mentre Movimento 5 Stelle e centrodestra picchiano come fabbri su un pugile con le mani legate, chiedendo dimissioni, che forse avranno, e voto in autunno. «È quasi un anno che non posso più andare al bar. La gente mi vede e mi indica come quello delle firme false». Se quella notte avesse firmato davvero tutti quei moduli del listino regionale, il braccio gli farebbe male ancora oggi. In cinque minuti di conversazione Pasquale Valente, ex consigliere provinciale del Pd, pensionato, arrivato 45 anni fa nel quartiere di Madonna di Campagna dalla sua Canosa di Puglia con il camion guidato da papà e i mobili sul cassone, ripete altrettante volte «io sono una brava persona». I magistrati gli hanno creduto, anche perché il suo nome a certificare le liste è ovunque, ma con una ventina di versioni diverse della firma. Quella roba, ha detto, non è mia, suscitando malumori all’interno del Pd, che forse sperava nel capro espiatorio perfetto. «Spero che si scopra chi mi ha fatto questo. Per il resto, aspetto il 9 luglio, come tutti». Antonio Ferrentino invece autentica firme a Sant’Antonino, comune del quale è sindaco, e Torino, ma nello stesso giorno. «Faccio avanti indietro almeno tre volte. La Guardia di Finanza ha accertato che la grafia è la mia. Certo, dopo il precedente di Cota ci doveva essere maggiore attenzione e scrupolo». La Procura indaga, il Tar deciderà sulle carte della Procura. I conteggi dei presunti falsi riguardano gran parte dei moduli a sostegno delle liste del Pd e di quella personale del candidato, e soprattutto 1.240 firme su 2.180 del listino che assegna di diritto sette consiglieri al vincitore delle Regionali, autenticate negli ultimi tre giorni disponibili. La tesi dell’ininfluenza sull’esito del voto rischia di non stare in piedi. Lo slogan dei democratici per le elezioni regionali era «In Piemonte come in Italia il Pd dà il meglio». Magari la prossima volta è meglio ricordarsi anche di acquistare una copia del manuale Cencelli. Del 26/06/2015, pag. 8 Riforma della Rai e Todini al vertice 24 La tregua del premier con Berlusconi Il piano per cambiare la Gasparri con FI. E cercare un aiuto sul nuovo Senato ROMA Non sarà un patto del Nazareno con tutti crismi, non ci saranno più incontri, strette di mano, fogli protocollati e firmati, e ognuno (Matteo Renzi e Silvio Berlusconi) veleggerà verso il suo destino senza concedere troppo all’altro. Ma una qualche forma di collaborazione, o, quanto meno, di tregua più che disarmata, tra l’ex Cavaliere e il presidente del Consiglio c’è, con buona pace delle smentite che il leader di Forza Italia ha fatto, a dire il vero, senza troppo vigore, o di quelle virulente del capogruppo dei deputati azzurri Renato Brunetta. O, almeno l’hanno capita così i collaboratori del premier, quando hanno sentito Renzi ripetere per l’ennesima volta, con aria pacata e altrettanto ferma, che «la riforma della Rai si farà». Del resto, a sponsorizzare dall’altra parte della barricata un atteggiamento meno ostile nei confronti di Palazzo Chigi sono stati, non a caso, Fedele Confalonieri e Gianni Letta. E basta pronunciare questi due nomi per essere portati a pensare che in questa intesa una parte importante l’abbia la tv. E infatti così è. Raccontano al Nazareno che la sicumera con cui Renzi rassicura i suoi sul fatto che le prossime nomine dei vertici della Rai non verranno fatte con la legge Gasparri derivi proprio da là. Cioè dall’accordo che si sta costruendo (faticosamente) con Berlusconi per far passare in Parlamento la nuova normativa sulla tv di Stato. Come in ogni intesa politica, ognuno deve avere il suo. In questo caso il leader di FI avrebbe il presidente. Anzi, la presidente. Ossia Luisa Todini, che attualmente ricopre un altro incarico importante. È alla presidenza delle Poste italiane. Sì, è una delle nomine femminili che il premier Renzi volle fare per dimostrare che l’Italia non può essere declinata tutta al maschile. Ma tutti sanno che Todini ha lasciato il cuore alla Rai. E che con Berlusconi ha mantenuto ottimi rapporti (entrò in Forza Italia nel 1994, proprio alle origini dell’avventura del movimento azzurro). Per questa ragione nei conversari privati tra gli sherpa che cercano di trovare l’accordo per sbloccare la «questione Rai» è stato fatto il suo nome. E sia da parte del premier che da parte dell’ex Cavaliere non c’è stata nessuna obiezione. In questo contesto, ovviamente, Luigi Gubitosi lascerebbe l’attuale incarico per spostarsi altrove. Alle Ferrovie, dicono i più. Alle Poste, suggerisce qualcun altro. Comunque non spetterebbe a lui la poltronissima di Viale Mazzini. Quella dell’amministratore delegato al quale Renzi vorrebbe affidare tutti i poteri effettivi, quelli che finora nessun direttore generale ha mai avuto nell’azienda della tv pubblica. Il nome più gettonato per quel posto, al momento, è quello di Vincenzo Novari, genovese, classe ‘59, attuale amministratore delegato di 3 Italia, amico di Franco Bernabè e Renato Soru, ha parlato dal palco della Leopolda ed è in buoni rapporti con uno dei più cari amici di Renzi, Marco Carrai. Certo, viste le turbolenze parlamentari che sono all’ordine del giorno, è ancora presto per dire se questo patto reggerà. Ma il presidente del Consiglio continua a ripetere ai parlamentari a lui più vicini che «la riforma della Rai si farà». Segno evidente che avrà avuto un qualche «affidavit», altrimenti non sarebbe così tranquillo su un argomento di tale delicatezza. E non spiegherebbe ai fedelissimi: «Non ci possiamo permettere di rinnovare i vertici della televisione di Stato con una legge come la Gasparri». Quello che è più difficile capire è se questa intesa sulla Rai che si sta faticosamente costruendo (all’insaputa di molti, sia nel centrodestra che nel Pd) possa essere foriera di altre novità. Certamente non della modifica della legge elettorale, di cui pure si parla tanto in questi ultimi giorni. Su questo punto il presidente del Consiglio è netto: «Non cambio l’Italicum». Lo dice con grande sicurezza. 25 E allora è sulla riforma costituzionale che potrebbe giungere «un aiutino dal centrodestra» (lo definiscono cosi alcuni autorevoli esponenti del Partito democratico). Senza però rivelare di che tipo di sostegno si possa trattare. Cioè se di un «via libera ufficiale» (cosa assai difficile, visto che Berlusconi è partito all’inseguimento di Matteo Salvini) o, piuttosto, di un aiuto di un gruppo di forzisti che vengono incontro al premier non seguendo la linea di FI; disobbedendo, ma con l’autorizzazione de l «capo» in tasca. Del 26/06/2015, pag. 31 L’INVERNO DEI DIRITTI E LE “CONTROCOSTITUZIONI” STEFANO RODOTÀ L’INVERNO dei diritti è tra noi, e non è cominciato ieri. Vengono smantellate le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, ultime quelle riguardanti i controlli a distanza, alle quali era affidata la dignità dei lavoratoti. Alte mura si ergono ai confini dell’Unione europea e tra gli stessi Stati, per allontanare i disperati migranti in forme che negano la loro umanità. Si spende la parola solidarietà e mai le politiche sono state così poco solidali. Ai diritti sociali si oppone l’inesorabile logica economica. Si respingono le proposte sul reddito minimo in nome di una sua presunta incostituzionalità. E si minacciano barricate contro la civile legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso. Su questo dovrebbero meditare quanti continuano a parlare di un’enfasi eccessiva posta sui diritti, giungendo fino a dire che «di diritti si muore». A questa retorica è fin troppo facile opporre le durezze di una realtà che mostra come si muoia davvero, proprio per la mancanza di diritti. L’esistenza “libera e dignitosa”, di cui parla l’articolo 36 della Costituzione, si trasforma in vita disperata, in esistenza precaria, in sfruttamento che sconfina nella schiavitù. Le inchieste romane hanno mostrato l’indecente uso dei migranti attraverso accordi che assicuravano agli sfruttatori un euro per ciascuno di loro. Nelle campagne campane e calabresi lo sfruttamento di chi lavora nell’agricoltura ha assunto forme di schiavitù gestita anche da organizzazioni criminali, in quelle siciliane donne rumene vengono obbligate a prestazioni sessuali per mantenere il lavoro. E dovremmo distogliere lo sguardo dai diritti? Questo accade quando le società vengono “liberate” dalle costituzioni. Fragili barriere di carta, illusori riferimenti quando la politica impone le sue durezze? Forse stiamo per certificare la fine del costituzionalismo nato nel secondo dopoguerra, quando lo “Stato costituzionale di diritto” venne fondato sul riconoscimento dei diritti fondamentali e sul controllo di costituzionalità. Oggi stanno nascendo “controcostituzioni”, dominate dal primato della finanza, alla quale tutto deve essere subordinato. Qui libertà e diritti non trovano posto, e così è la stessa democrazia a rischiare la scomparsa. Qui è anche la radice della crisi dell’Unione europea. L’Europa, terra di diritti, sta negando se stessa. Nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali è scritto che l’Unione “pone la persona al centro della sua azione”. Nella realtà proprio la persona con dignità e diritti viene dimenticata e su tutto prevalgono gli impersonali meccanismi del calcolo economico e le pretese degli Stati membri di agire come meglio credono. L’Ungheria vuole costruire un muro al confine con la Serbia, e intanto ha già privato i suoi cittadini di garanzie fondamentali senza che l’Unione intervenisse per impedire ad Orbán di proseguire nel suo cammino autoritario. Ben diverso era stato l’atteggiamento quando in Austria si era manifestato il pericolo Haider, tanto che poi, con il Trattato di Maastricht, si era dotata 26 l’Unione di più incisivi poteri di intervento. Non sono stati esercitati, e questo non è solo un segno di debolezza, ma diventa un incentivo verso quella “rinazionalizzazione” strisciante che insidia il progetto europeo. Dall’orizzonte dell’Unione scompare anche un principio innovativo contenuto nella Carta dei diritti fondamentali e nel Trattato di Lisbona — la solidarietà. Dell’Europa fraterna si perdono le tracce, come accade quando si rifiuta l’assunzione di responsabilità comuni per l’accoglienza dei migranti. Lo stesso accade in Italia con l’esplodere degli egoismi municipali. Tutti ferocemente tesi a chiudersi in identità che escludono l’altro, e alimentano quello scomparire della coesione sociale e politica che alimenta il populismo. È vero che non si può invocare la solidarietà come fosse una bacchetta magica e non l’esito di politiche rigorose e coerenti. Ma queste politiche possono nascere solo se si parte dalla premessa del carattere fondativo di quel principio. La trama solidale è stata rotta, come mostra un bel libro del presidente della Fondazione Migrantes, monsignor Perego, e non è un caso che l’ultimo scritto di Enzo Bianchi si apra discutendo la parabola del buon Samaritano. Riferimento impegnativo perché, come ci ricorda Luigi Zoja, in quella parabola Cristo parla di «amare lo straniero». L’abbandono dei diritti, letti impropriamente da qualcuno come strumenti di frammentazione individualistica, nasce della regressione culturale e civile nella quale siamo immersi. Un’Europa cieca cerca sempre più la salvezza in direzioni sbagliate. Mentre gli Stati Uniti riducono i poteri della National Security Agency sui controlli di massa, le leggi di Francia e Spagna (in misura più ridotta quella italiana) imboccano il cammino opposto con il pretesto della lotta al terrorismo e trasformano le nostre società in nazioni di sospetti. L’accentramento di poteri di controllo negli organismi di sicurezza si congiunge così con l’accentramento nelle mani dell’imprenditore di poteri di controllo elettronico sui lavoratori. Prendere sul serio l’aggressione ai diritti è indispensabile per mettere a punto strategie di risposta, oggi affidate quasi esclusivamente alle corti costituzionali. Alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, in un caso riguardante Google, ha affermato che il rispetto dei diritti fondamentali deve prevalere sull’interesse al profitto; alla Corte costituzionale tedesca, che ha imposto al parlamento i criteri economici necessari per garantire l’esistenza dignitosa (estendendoli anche a chi ha avuto asilo); alla Corte belga, che ha bocciato una legge sulla raccolta e conservazione dei dati personali; a sentenze della Corte italiana sul rispetto dei diritti sociali in materia di pensioni e contratti nel pubblico impiego. Ho scritto in altre occasioni che non è un segno di buona salute di un sistema il concentrarsi della garanzia solo negli organi giurisdizionali. Ma gli equilibri non si ricostituiscono eliminando le garanzie essenziali, gridando tutte le volte all’invasione delle prerogative parlamentari. È stato invasivo l’intervento dei giudici costituzionali quando hanno quasi del tutto cancellato la più ideologica tra le leggi della Repubblica, quella sulla procreazione assistita, approvata da una maggioranza assai determinata, ma che violava clamorosamente in primo luogo il diritto alla salute delle donne? E non è stata invasiva la sentenza sulle pensioni, perché tutte le leggi sono sottoposte al controllo di costituzionalità e il rispetto del pareggio di bilancio non può consentire la violazione di diritti sociali. Né la Corte deve fermarsi se la violazione ha prodotto effetti finanziari rilevanti. Può “modulare” le sue decisioni, ma questo non restituisce discrezionalità piena a governo e Parlamento, né la misura del giudizio può diventare il puro calcolo economico. Altrimenti si arriverebbe alla paradossale conclusione che più consistente è la violazione, minore è la possibilità di sanzionarla. Siamo vittime di quello che Alain Supiot ha chiamato “le gouvernement par le nombre” , il governo affidato ai numeri, che rende impotente la politica e impraticabile la via dei diritti. Se non ci liberiamo da questa ipoteca, né i diritti, né la politica democratica possono salvarsi. 27 LEGALITA’DEMOCRATICA Del 26/06/2015, pag. 7 L’ex capo dei Servizi: “Per le stragi chiesi di indagare sugli 007” di Sandra Rizza Il segreto che doveva salvargli la vita stava in un libro di storia: Italy from Napoleon to Mussolini. Per anni ha conservato in quel volume della sua biblioteca a New York il foglietto dove aveva annotato, uno per uno, l’elenco degli Ossi (Operatori speciali servizi italiani, ndr), i 15 agenti speciali della VII divisione del Sismi addestrati “a maneggiare armi ed esplosivi” con obiettivi di “guerriglia urbana”: “Avevo detto a mia moglie: se mi succede qualcosa, vai a vedere questi dove si trovano”. Più o meno lo stesso suggerimento che l’ex ambasciatore Francesco Paolo Fulci, conclusa la sua esperienza al vertice del Cesis, offrì al comandante dei carabinieri Luigi Federici quando, dopo le bombe del ’93, lasciò New York e si catapultò a Milano per mostrare al generale quell’elenco di nomi, chiedendogli di verificare “la presenza dei 15 agenti” nei luoghi degli attentati. Il motivo di tanto zelo? “Sgomberare il sospetto di un coinvolgimento dei nostri servizi nello stragismo”. Ma è proprio vero che l’unico obiettivo della denuncia era quello di “lavare l’onta” di un’eventuale partecipazione dell’intelligence alla stagione delle bombe? Oppure l’ex ambasciatore sapeva molto di più sul coinvolgimento del Sismi nella strategia della tensione anni Novanta? E perché aveva tanta paura degli Ossi? È quello che ieri i pm di Palermo Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia avrebbero voluto scoprire, citando l’anziano ambasciatore nel processo sulla Trattativa, nella speranza che raccontasse qualcosa di più sulle attività clandestine degli 007 della VII divisione già riferite nel suo verbale del 4 aprile 2014. Fulci non ha deluso le aspettative: ha confermato punto per punto le perplessità su quella che ha definito “un’anomalia”: l’esistenza all’interno del servizi di “un nucleo addestrato” di agenti autorizzati ad azioni di guerra. Poi ha rilanciato i suoi dubbi sulla possibilità che i superuomini del Sismi possano aver avuto un ruolo attivo, forse quello dei telefonisti, nelle operazioni della famigerata Falange Armata, la sigla che ha firmato la stagione delle bombe ’92-’93. Fulci ha ribadito, infatti, che l’analisi del suo collaboratore del Cesis Davide De Luca, scopritore di una coincidenza “quasi perfetta” tra i luoghi di provenienza delle telefonate della Falange Armata e quelli delle sedi del Sismi, era “di una gravità estrema” e di avergli ordinato ulteriori indagini. Ma l’ambasciatore non ha voluto o saputo dire di più: e come preoccupato della sua stessa rappresentazione di quelli che ha definito i “terribili due anni passati al Cesis”, ha voluto sottolineare che il suo “apprezzamento” per i servizi italiani non è mai venuto meno. Poi l’avvocato Basilio Milio, difensore del generale Mori, gli ha chiesto se avesse fatto parte dell’associazione messinese Corda Fratres, e Fulci ha ammesso: “Sì, ma avevo 17 o 18 anni”. Si tratta di un circolo ormai chiuso, niente a che vedere con la Corda Fratres di Barcellona dove sono passati il boss Giuseppe Gullotti e l’avvocato mafioso Rosario Pio Cattafi, che è solo una filiazione. Tocca ora alla Procura di Palermo indagare a tutto campo per verificare il racconto dell’ambasciatore. Nel mirino degli approfondimenti investigativi, fulcro dell’inchiesta bis 28 sulla trattativa Stato-mafia, c’è in primo luogo la caccia alla famigerata cartina delle sedi periferiche del Sismi, che per Fulci è tuttora un documento coperto da “segreto di Stato”. Nei mesi scorsi, i pm del pool Stato-mafia hanno già eseguito numerosi accessi presso gli archivi dei servizi per acquisire la documentazione indicata dall’ex diplomatico, compreso l’elenco dei 15 agenti della VII divisione del Sismi che l’ex direttore del Cesis ha detto di aver consegnato anche al capo della polizia Vincenzo Parisi, dietro esplicito invito del presidente della Repubblica Scalfaro, sollecitando gli apparati a verificare la presenza di quegli 007 nei luoghi degli attentati del ’93. I tanto temuti Ossi furono poi indagati? “No – ha risposto Fulci – chiesi com’era finita al successore di Luigi Ramponi, capo del Sismi, e lui mi disse che gli attentati erano stati commessi dai mafiosi”. Qualcuno, Federici, Ramponi, disse mai di aver fatto un accertamento sulla localizzazione di quei 15 agenti sullo scenario delle stragi siglate Falange Armata? “No, nel modo più assoluto”. Dulcis in fundo, Fulci ha commentato in aula lo scoop sulle sue rivelazioni pubblicate ieri dal Fatto Quotidiano. “Sono stupito – ha detto – di aver appreso che quello che avevo detto nel mio interrogatorio è stato pubblicato stamane da un giornale di Roma”. Evidentemente confuso da tanto parlare di 007, l’avvocato Milio gli ha chiesto a bruciapelo: “Lei sa se i servizi hanno avuto rapporti con il Fatto Quotidiano?”. L’ambasciatore è rimasto in silenzio. E il presidente della Corte d’Assise Alfredo Montalto ha tagliato corto: “La domanda non è ammessa”. 29 RAZZISMO E IMMIGRAZIONE Del 26/06/2015, pag. 5 La carta del governo: nuove norme sull’asilo per accelerare i rimpatri DAL NOSTRO INVIATO BRUXELLES «Dobbiamo dare l’esempio a casa nostra». C’era una volta Renzi che chiedeva a gran voce all’Europa di fare qualcosa per l’Italia, che minacciava un piano B, che giudicava del tutto insufficienti i risultati raggiunti in sede comunitaria. Da un paio di giorni il premier ha cambiato registro: ha parlato dei rimpatri che il nostro Paese non esegue, almeno nei tempi e nei numeri che Bruxelles vorrebbe, ha accettato la creazione di almeno tre hotspot sul nostro territorio, grandi centri di smistamento degli immigrati clandestini, chiesti dalla Commissione, ha detto ieri mattina ai governatori, a Palazzo Chigi, che il governo sta prendendo in considerazione «modifiche normative» al Testo unico sulla materia. Può essere anche un modo per incassare la parziale sconfitta sulle quote, far buon viso a cattivo gioco, visti i risultati del vertice di ieri, che in sostanza ha discusso e varato un piano provvisorio e lontano dagli obiettivi originari italiani. E può anche considerarsi uno scambio con le istituzioni di Bruxelles: Juncker si è battuto per darci comunque una risposta europea, quel «primo passo» che un premier realista ora dice di considerare accettabile, l’Italia deve comunque rispondere dando maggiori garanzie rispetto al passato, e non come oggi, «producendo» di fatto più clandestini, che circolano sul territorio dell’Unione, degli altri Paesi. Ai governatori regionali riuniti a Palazzo Chigi ieri mattina Renzi ha chiesto unità, ha detto che «non è possibile che gli altri facciano sistema a Bruxelles e noi invece costantemente ci dividiamo in casa nostra, una cosa inaccettabile e autolesionista», ha fatto intravedere una maggiore attenzione, che è poi quella che ci è stata chiesta dai Paesi che hanno fatto muro sulle quote obbligatorie, sui fatti di «casa nostra»: modifiche normative sul processo di rilascio dello status di rifugiato, troppo lungo attualmente, modifiche anche nell’organizzazione giudiziaria, nel procedimento che oggi in sostanza «aiuta» chi vuole giocare con le nostre leggi a restare sul nostro territorio per troppo tempo, modifiche infine forse anche sull’onere della prova: sia chi chiede asilo a dimostrare di averne diritto in tempi certi, non sia lo Stato a doversi fare carico delle verifiche. Allo stesso modo, sui rimpatri, come ci è stato contestato a Bruxelles, dobbiamo cambiare registro; e in modo soft, senza aprire polemiche con il Viminale, Renzi lo ha detto. Anche questo tema fa parte di quel «lavoro che dobbiamo fare a casa nostra» di cui parlava ieri pomeriggio entrando nel palazzo del Consiglio europeo. Un lavoro che sarebbe certamente più semplice, ha detto per esempio ieri a Zaia, se almeno chi ha responsabilità istituzionali la smettesse di rilasciare interviste ai quotidiani internazionali parlando male del proprio Paese. L’Europa per il momento ci dà una prima risposta sui rifugiati siriani ed eritrei fissando una quota, 40 mila persone, che dovrà essere discussa nei dettagli nelle prossime riunioni. In cambio chiede centri reali di smistamento dei clandestini, come a gran voce ha chiesto anche Cameron, farà arrivare circa 200 funzionari europei che collaboreranno con la nostre forze di polizia. In fondo è al momento l’unico compromesso possibile e Renzi l’ha compreso. «Non faremo mai campagna elettorale su questo tema, abbiamo un approccio realista e quello di oggi è comunque un primo passo», era la chiosa di ieri sera, nello staff del premier. 30 Del 26/06/2015, pag. 6 Battaglia al vertice Ue sui migranti I paesi dell’Est bloccano l’accordo A Bruxelles scontro sulle quote L’ira di Renzi: “O solidarietà o qui si perde tempo”.Lite tra il premier e i governatori di centrodestra DAL NOSTRO INVIATO ALBERTO D’ARGENIO BRUXELLES. In mattinata il premier Matteo Renzi incontra a Palazzo Chigi regioni e comuni per fare il punto sull’emergenza sbarchi. Quindi vola a Bruxelles, dove nella notte il piano Ue sui migranti si incaglia di fronte al no dei paesi dell’Est che fanno blocco al Consiglio europeo e che entrano in rotta di collisione con Merkel, Hollande e Renzi. Lo scontro si protrae ed è violentissimo. Si registra anche una lite tra Juncker, numero uno della Commissione Ue, e il polacco Tusk, presidente del Consiglio europeo. In mattinata all’arrivo a Palazzo Chigi sono i governatori leghisti a dare i titoli ad effetto. Per Zaia «i prefetti devono ribellarsi al governo». Anche Maroni non vuole più ospitare i migranti e a fine incontro dirà: «Non è servito a nulla». In realtà la discussione è stata accesa e di sostanza. Renzi ha rimproverato ai leghisti di dare una cattiva immagine dell’Italia all’estero: «Non è possibile che gli altri paesi facciano sistema e arrivino a Bruxelles compatti, dovete ignorare i sondaggi e smettere di cavalcare le paure. Serve una risposta condivisa e congiunta per negoziare in Europa». L’Italia si deve attrezzare: in cambio della ripartizione di 40mila migranti tra tutti i paesi dell’Unione, Roma e Atene devono garantire ai partner l’identificazione dei migranti negli hotspot con personale Ue, la detenzione e il rimpatrio per quelli che non hanno diritto allo status di rifugiato. Uno sforzo necessario anche per arrivare con le carte in regola a dicembre, quando la Commissione di Jean Claude Juncker proporrà la vera rivoluzione con la revisione dei regolamenti di Dublino per rendere permanente la riallocazione dei migranti ora solo emergenziale. A Chigi Renzi spiega a sindaci e governatori che snellirà il sistema con «modifiche normati- ve», ad esempio creando giudici specializzati negli appelli dei migranti che si vedono rifiutare l’asilo dalle apposite commissioni. L’obiettivo è portare al di sotto dell’anno tutta la procedura per non intasare gli hotspot. Quindi ha insistito sui rimpatri, che partiranno con charter italiani ai quali si dovranno sommare mezzi e risorse europee. Nel pomeriggio il premier vola a Bruxelles per il summit europeo. La discussione sull’immigrazione a causa del dibattito sulla Grecia slitta a cena. Ma è scontro. Il pacchetto approvato a maggio dalla Commissione Ue guidata da Juncker prevedeva la spartizione obbligatoria tra i Ventotto di 40mila migranti sbarcati in Italia e Grecia. Per venire incontro ai governi che lo osteggiano nei giorni scorso il piano è stato annacquato dal punto di vista lessicale. Ad esempio cancellando il termine “quote” e l’obbligatorietà, ma prevedendo l’impegno di far approvare il meccanismo ai ministri dell’Interno a luglio e che questo sarebbe stato valido per tutti. Nelle previsioni della vigilia queste modifiche non avrebbero cambiato la sostanza ma avrebbero permesso di superare le obiezioni dei governi contrari. Però a cena i leader dell’Est Europa, e in modo più blando Cameron e Rajoy, puntano i piedi, chiedendo ulteriori modifiche e scontrandosi violentemente con Merkel, Renzi e Hollande. A sorpresa il polacco Tusk, che da presidente dovrebbe essere neutrale, si schiera con il blocco dell’Est facendo infuriare Juncker e aprendo un grave scontro istituzionale al termine del quale l’ex premier lussemburghese apostrofa il collega: «La tua posizione è oltre le tue competenze, io vado avanti da solo». Durissimo anche Renzi, che si rivolge ai leader dell’Est così: «Se non siete d’accordo con 40mila migranti non siete 31 degni di chiamarvi Europa. Se questa è la vostra idea di Europa tenetevela pure, o c’è solidarietà o non fateci perdere tempo. Se volete la volontarietà faremo da soli». Il punto è che il blocco orientale non si accontenta di un depotenziamento lessicale, che faceva venir meno il precedente giuridico, ma vuole che non ci sia alcun obbligo per i governi ad aderire al piano, nemmeno implicito. Lo scontro si è protratto nella notte. Del 26/06/2015, pag. 2 L’Ungheria insiste sulla linea dura “Bruxelles decida, o faremo da soli” Budapest non cancella il decreto con cui respinge i rifugiati Tonia Mastrobuoni Il decreto ungherese che sospende il regolamento di Dublino sarebbe ancora in vigore. Nonostante le rassicurazioni del ministro degli Esteri Peter Szijjarto, che aveva garantito ai partner europei mercoledì di «non aver mai preso la decisione di sospendere le regole europee», sembra che il governo Orban sia riuscito ancora una volta a mantenere una posizione ambigua. Il provvedimento pare non sia ancora ritirato e consentirebbe al governo magiaro di respingere i rifugiati «per motivi tecnici». Lo stesso Szijjarto ha sottolineato anche, dopo lo scandalo suscitato dall’annuncio della scorsa settimana, di voler costruire un muro alto quattro metri lungo il confine serbo, che Budapest «costruirà muri anche lungo altre frontiere, se non ci saranno altri modi di fermare i migranti». Una lettera spedita mercoledì da Orban ai vertici delle istituzioni europee conferma l’intenzione dell’Ungheria di ritagliarsi spazi di manovra autonomi, se l’Europa non dovesse fornire risposte soddisfacenti sulla questione dei migranti. In un documento di discussione inviato al Consiglio di cui La Stampa ha ottenuto una copia, il governo scrive che «se l’Ue non sarà in grado di adottare velocemente regole comuni per gli asili e politiche sull’immigrazione adeguate alle esigenze reali dei Paesi, la possibilità di interventi autonomi degli Stati membri non dovrebbe essere limitata». Il capo dell’ufficio del premier, Janos Lazar, ha confermato che Budapest avrebbe chiesto aiuto a Bruxelles per «superare il problema dell’immigrazione illegale». Nella lettera a Donald Tusk, Orban incalza le istituzioni europee sui «passaggi illegali delle frontiere e sul numero dei richiedenti asilo» che in Ungheria avrebbero «raggiunto la quota senza precedenti di 61mila, rappresentando così una pressione insopportabile sull’Ungheria». Nonostante le «circostanze eccezionali» Budapest continuerebbe, prosegue la lettera, «ad adempiere ai suoi obblighi europei e nessuna legge è stata modificata o sospesa riguardo al regolamento di Dublino». Tuttavia, lamenta Orban, la situazione si sta aggravando perché alcuni Paesi «hanno intenzione di trasferire in Ungheria i richiedenti asilo che sarebbero stati registrati in Ungheria, ma che avrebbero già lasciato l’Ungheria». In particolare, il premier punta il dito contro la Grecia: «Va chiarito che nel caso di quasi tutti i migranti che arrivano in Ungheria e sono registrati qui, il Paese d’ingresso è la Grecia». Perciò Budapest «è determinata» a «proteggere adeguatamente» i suoi confini. 32 Del 26/06/2015, pag. 6 I clandestini al Sud e i rifugiati al Nord il Viminale taglia in due la rete dell’accoglienza IL RETROSCENA VLADIMIRO POLCHI ROMA . Clandestini al Sud, rifugiati al Nord. La rete dell’accoglienza italiana è pronta alla rivoluzione. Addio vecchi centri, arrivano hotspot, hub chiusi e hub aperti. Cambia tutto, o quasi: le regioni di approdo dei migranti continueranno a sostenere il peso maggiore. Al Sud spetterà infatti accogliere migranti economici, irregolari e richiedenti asilo. Mentre, al Nord arriveranno solo i profughi. E così, se l’Europa frena sull’agenda immigrazione, al governo italiano non resta che premere sull’acceleratore delle espulsioni. «I richiedenti asilo si accolgono, i migranti economici vengano rimpatriati». Eccola infatti la ricetta targata Matteo Renzi per uscire dall’emergenza profughi. Peccato però che in Italia, se c’è una macchina che non funziona, è proprio quella delle espulsioni. Il nuovo piano del governo prova allora a cambiare le regole del gioco. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 18 maggio un decreto legislativo di recepimento delle direttive Ue, che prevede hotspot per la prima accoglienza e hub regionali per identificazione e smistamento. Come funzioneranno? «Spariscono tutti i centri di primo soccorso e accoglienza. Chi arriva sulle nostre coste verrà subito accolto in uno dei 5 o 6 hotspot che apriranno nelle regioni con punti di sbarco — spiegano dal Viminale — e dunque in Sicilia, Calabria e Puglia, forse anche in Campania». I luoghi per ora identificati sono Lampedusa (che è già considerata un hotspot) Augusta, Pozzallo, Porto Empedocle, Taranto. «Qui i migranti potranno rimanere non più di 48 ore. Verranno identificati, se sarà possibile, e riceveranno la prima assistenza». La seconda tappa sono gli hub, grandi centri di smistamento, distinti in “chiusi” e “aperti”. I primi saranno 6 e verranno allestiti sempre nelle regioni di approdo, dunque al Sud: «Alle spalle degli hotspot, come sarà a Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle ». Qui si proverà a distinguere tra migranti economici irregolari e chi invece ha diritto all’asilo o qualche altra forma di protezione internazionale. «Chi non ha manifestamente diritto all’accoglienza e chi rifiuta di farsi identificare — precisano i tecnici del ministero dell’Interno — verrà trasferito nei Cie. Chi invece legittimamente fa richiesta di asilo verrà trasferito nel circuito d’accoglienza Sprar o in un hub aperto». Eccola dunque la terza tappa: lo Sprar, ossia il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati affidato all’Anci (associazione dei comuni italiani) e gli hub aperti. Solo quest’ultimi saranno previsti in ogni regione, adattando per lo più grandi caserme dismesse e ospiteranno solo coloro che attendono lo status di rifugiato. Gli irregolari finiranno invece nei Centri di identificazione ed espulsione, le uniche strutture ereditate dal vecchio modello che sopravviveranno e che oggi sono ridotte a cinque: Torino, Roma, Bari, Trapani, Caltanissetta. Spingere sull’acceleratore delle espulsioni non sarà però facile. Il meccanismo è costoso e non marcia come dovrebbe. Un esempio: l’anno scorso su 15mila migranti espulsi con decreto dalle questure, la polizia italiana è riuscita a riportarne a casa appena 5mila. E sono proprio i Cie a non funzionare. Stando alla Commissione diritti umani del Senato, il numero dei migranti rimpatriati attraverso i Cie nel 2013 è stato pari allo 0,9% degli immigrati in condizioni di irregolarità presenti sul territorio (stimati allora in 294mila). Il flop dei Cie trova conferma anche nei dati del ministero dell’Interno relativi al primo semestre del 2014: 1.036 migranti rimpatriati, pari al 48,8% dei 2.124 stranieri trattenuti nei centri. «Il proble- ma — spiegano al Viminale — sono gli accordi di 33 riammissione coi Paesi d’origine dei flussi migratori». Senza questi, non si rimpatria nessuno e oggi ci sono solo con Tunisia, Egitto e Nigeria. In attesa di tagliandare la macchina delle espulsioni, il Viminale sta già avviando la rivoluzione della rete. Con un limite: hotspot e hub chiusi saranno solo al Sud, vicino a dove sbarcano i migranti e dunque resterà sempre a carico di queste regioni il compito più gravoso di gestione della clandestinità. Al Nord, negli hub aperti, arriverà solo chi ha diritto all’accoglienza. «Per questo — ammettono dal Viminale — dovranno essere previste delle misure compensative per le regioni meridionali». Del 26/06/2015, pag. 8 Saskia Sassen. La sociologa americana non ha dubbi: “In passato ci sono state fasi di grandi migrazioni ma mai così. Per troppo tempo la Sinistra ha sottovalutato il problema” “Questo è un esodo senza precedenti usare le espulsioni non risolve nulla” GIULIO AZZOLINI Oggi le coste italiane sono diventate il teatro di un evento profondamente diverso rispetto al passato. E basta volgere lo sguardo oltre il bacino del Mediterraneo per capirlo. Siamo di fronte a un grande esodo, che riguarda quasi tutto il pianeta». Saskia Sassen, economista e sociologa della Columbia University, tra i massimi esperti in tema di globalizzazione, non ha dubbi: «La storia ha già conosciuto fasi di grandi migrazioni, ma mai su questa scala, nello stesso periodo e con una tale rapidità». Professoressa Sassen, come si spiega la fatica dell’Unione Europea per elaborare un piano condiviso? «Negli ultimi decenni i Paesi europei — ma lo stesso vale per gli Stati Uniti — hanno seguito una sola strategia: accogliere i migranti, più o meno legali, finché hanno avuto bisogno di lavoratori a basso costo. Perché servivano a risolvere un problema interno all’economia occidentale. Ma non si sono preoccupati né dei governi dei Paesi da cui i migranti oggi scappano, né di programmare una politica migratoria sostenibile ed efficace». Verso quale soluzione si dovrebbe quindi lavorare oggi? «È difficile dirlo, perché la situazione sembra ormai sfuggita di mano, al punto che l’Alto commissariato per i rifugiati non sa nemmeno come chiamare le regioni d’origine dei 60 milioni di persone in fuga. Da “terre caotiche”, dice l’ultimo rapporto dell’Onu, visto che in molti casi — Libia inclusa — è impossibile stabilire quale sia il governo legittimo. Io di una cosa sono certa: non bisogna rinunciare a cercare interlocutori credibili in Africa. Senza di loro una politica migratoria resta impraticabile». L’Europa, invece, si chiude. La Francia respinge i profughi a Ventimiglia, l’Ungheria innalza un muro sul confine con la Serbia. E si fatica a trovare un accordo comune per fronteggiare l’emergenza. «Repressioni e misure di controllo sono soluzioni temporanee: forse possono tamponare provvisoriamente il flusso dei migranti, ma non incidono sulle ragioni delle migrazioni». Il progetto di un’Europa unita e solidale rischia di naufragare? «Spero che l’Unione Europea continui a rafforzarsi, ma penso che possa farcela solo a patto di diventare più democratica e meno neo-liberista. Perché l’accoglienza è più difficile 34 quando la ricchezza si concentra nelle mani di pochi e anche la classe media viene piano piano espulsa da case e da zone decorose». Da anni ormai l’estrema destra europea usa la leva della xenofobia. Crede che l’Italia e la Francia si consegneranno presto a Matteo Salvini e a Marine Le Pen? «L’Europa sarebbe la regione meglio posizionata per opporre alla logica dell’esclusione la cultura dell’inclusione, ma è anche vero che molti elementi lasciano presagire ben altro. Basta pensare alle recenti elezioni in Danimarca (il Partito del popolo danese ha ottenuto il 21,1% dei voti, diventando il secondo partito in Parlamento, ndr ). In un paese che pure è per molti versi illuminato e ragionevole... ». E la sinistra? Ritiene che debba rimproverarsi di non aver capito l’importanza del problema migratorio per le fasce più deboli della popolazione? «Stabilire di chi siano le colpe non porta da nessuna parte e non aiuta a trovare soluzioni. Ma penso che la sinistra paghi una certa noncuranza, l’incapacità di mettere a fuoco il problema e riconoscere le caratteristiche più sottili delle migrazioni. C’è stato un atteggiamento di semplicistico laissez faire . E nessuno ha saputo mettere minimamente in luce i nessi tra le guerre fuori dall’Occidente e tutte le tipologie di espulsione perpetrate nell’Occidente stesso». Il suo ultimo libro, invece, si intitola per l’appunto Espulsioni (a settembre per il Mulino). Oggi le farà un certo effetto osservare come ciò che ogni Paese europeo chiede è esattamente “espellere” gli immigrati irregolari… «Sì, proprio così. Ma il paradosso è che la maggioranza dei migranti che stanno approdando in Europa vive già in una condizione di espulsione. Direi anzi che gli sbarchi di queste settimane sono probabilmente il primo segnale di un futuro nel quale sempre più persone saranno costrette a muoversi, proprio perché espulse dall’economia globale. E quando il proprio territorio è devastato dalla guerra, ma anche da desertificazioni, inondazioni, espropriazioni terriere, non si aspira ad altro che alla mera sopravvivenza. Non si fugge in cerca di una vita migliore, ma soltanto per conservare la propria vita». 35 INFORMAZIONE Del 26/06/2015, pag. 6 “Diffamazione, adesso fare i cronisti sarà più difficile” È una legge con luci e ombre. Si voleva eliminare il carcere per i giornalisti, ma poteva essere fatto con un tratto di penna. E invece si è aggiunto molto altro”. A parlare è Caterina Malavenda, avvocato specializzato nelle cause che riguardano la stampa, il giorno dopo l’approvazione in seconda lettura alla Camera della legge sulla diffamazione. Avvocato, i giornalisti devono gioire o no? L’abolizione del carcere è sicuramente un fatto positivo. Anche se in realtà era una norma che non veniva applicata, se non in casi eccezionali. Comunque, meglio che sia sparita. E poi la legge è stata fatta apposta per questo, quindi va bene. Peccato vi siano tante ombre accanto alle luci. Partiamo dalle (poche) luci. Per esempio, la rettifica tempestiva. Il giornalista che si accorge di aver dato una notizia errata può chiedere al direttore di pubblicare una rettifica di sua spontanea volontà. Il direttore è obbligato a pubblicarla. La pubblicazione della rettifica è causa di non punibilità. Altri cambiamenti positivi? L’ampliamento del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti, che ora possono tutelare le loro fonti come i professionisti. Poi c’è il famoso emendamento salva-Conchita… Nato sull’onda del caso De Gregorio, avrebbe lo scopo di aiutare decine di giornalisti che si vedono costretti a risarcire danni a terzi al posto di editori falliti o che non vogliono pagare. La novità è che il cronista, dopo aver pagato di tasca propria, può rivalersi sull’editore come creditore privilegiato. La trovo una norma di difficile applicazione, ma è un passo avanti. Passiamo alle ombre. Tante, a partire dalla rettifica, che può diventare sconfinata, perché non è previsto un limite di lunghezza. Inoltre, deve essere pubblicata senza replica. Insomma, se tutti si mettessero a chiedere rettifiche, i giornali non conterrebbero più notizie. Si è potenziato in maniera eccessiva uno strumento legittimo. Poi c’è la questione dei due direttori. Ovvero? Il direttore di un giornale on line è stato parificato a quello della carta stampata. Ma, per esempio, sull’omesso controllo il primo è svantaggiato perché un giornale on line è sempre aperto e per un direttore è impossibile controllare tutto ciò che viene pubblicato. Lei ha criticato anche le modifiche sui blogger… Sì, perché d’ora in avanti un blogger querelato dovrà difendersi nel tribunale del luogo in cui abita la persona offesa, col rischio di dover girare qua e là per difendersi, tutto a spese proprie e senza rimborso. Parliamo delle multe, molto criticate per via dei tetti (da 5 mila a 10 mila euro) molto alti. Sembra quasi la compensazione per la scomparsa del carcere… Può essere che si sia allungato da una parte e mollato dall’altra. Stando così le cose, un giudice non potrà comminare una multa inferiore ai 5 mila euro. Solo se il giornalista è incensurato, con le attenuanti generiche, la multa è ridotta di un terzo, mentre chi è 36 recidivo viene sospeso dalla professione da 1 a 6 mesi. Il testo, invece, è soddisfacente sul potenziamento del risarcimento che i giornalisti possono ottenere nelle liti temerarie, che potrà arginare le richieste in sede civile, spesso totalmente fuori mercato. Insomma, la legge peggiorerà la vita ai giornalisti? Ripeto, ci sono luci e ombre. Il testo è migliorato, ma restano tanti punti oscuri: si poteva fare di più e meglio. È stato eliminato il carcere, ma d’ora in poi fare i giornalisti potrebbe risultare più complicato e rischioso. Del 26/06/2015, pag. 6 Esuberi, pagina nera per l’editoria I giornalisti dell’Ansa di nuovo in sciopero fino a lunedì contro il taglio di 65 redattori I giornali non vendono, pagano i giornalisti. Tempi duri per l’editoria. L’Ansa sciopera, ricevendo la solidarietà del web e delle istituzioni, ma senza smuovere l’azienda. E per questo continuerà a farlo. Il Corriere della Sera vota (a malincuore) un accordo che comporterà decine di esuberi. Wired chiude la rivista cartacea per puntare sul web, vittima dello stesso progresso tecnologico che racconta e promuove. E il minimo comune denominatore della crisi sono i dipendenti, sempre colpiti dai tagli. Martedì e mercoledì i giornalisti dell’Ansa sono stati in agitazione per 36 ore. Ieri hanno proclamato un nuovo “sciopero immediato” fino alle sette di lunedì prossimo. La principale agenzia di stampa del Paese si ferma per oltre quattro giorni in una settimana (con disagi importanti anche per le redazioni degli altri quotidiani e televisioni) per protestare contro il piano di ristrutturazione per far fronte alle perdite degli ultimi anni (5 milioni di euro solo nel 2015). Ma la soluzione è una massiccia riduzione di personale che il Comitato di redazione (cdr) ha definito “irricevibile”: 65 esuberi a partire dal primo luglio, facendo ricorso a cassa integrazione o contratti di solidarietà, che rischiano di “pregiudicare il ruolo dell’agenzia”. Non è servito il primo sciopero. Non è servita neppure la mobilitazione massiccia a sostegno dei giornalisti, dal presidente del Senato, Pietro Grasso, a quello della Camera, Laura Boldrini, passando per Martin Schulz del Parlamento europeo. Su Twitter è nato l’hashtag #resistAnsa. Ma l’azienda non ha fatto marcia indietro. E allora l’assemblea ha proclamato un’altra agitazione, che potrebbe ulteriormente prolungarsi, per un pacchetto di 20 giorni complessivi. Non va meglio in casa Rcs, dove le firme del Corriere della Sera hanno dovuto “ingoiare” l’accordo raggiunto tra azienda e cdr lo scorso 18 giugno. Votato a larga maggioranza (214 sì su 288 presenti), ma comunque con insoddisfazione: perché le trattative sono riuscite a ridurre di 20 unità gli esuberi, ma le uscite nei prossimi due anni saranno comunque 47. Esclusi i contratti di solidarietà, fra ottobre e dicembre scatterà anche la cassa integrazione a rotazione. Anche qui la colpa è dei debiti, intorno ai 480 milioni di euro all’aggiornamento dell’ultimo cda. E poco importa che per il 2015 Rcs Mediagroup preveda ricavi in lieve crescita. Scomparirà (o quasi) invece dalle edicole Wired Italia, che ha deciso di ridurre drasticamente le pubblicazioni cartacee, passando da dieci a due numeri l’anno (appaltati a un service esterno), per puntare tutto sull’online. E ovviamente ha deciso di tagliare anche i giornalisti: dei sei redattori del cartaceo, due verranno trasferiti sul sito, per altri quattro il futuro è un’incognita. 37 L’azienda minaccia licenziamenti individuali, o il ricorso alla cassa integrazione. Eppure, a differenza di Ansa e Rcs, i conti della Condé Nast – l’editore che comprende testate come Vanity Fair e Gq – sono positivi: Wired ha chiuso il 2014 sfiorando il pareggio. E dal bilancio del gruppo emerge un margine di 9 milioni di euro. Non basta per sfuggire ai tagli. “La verità – fanno sapere dall’interno – è che hanno approfittato dell’addio del direttore per dare il via a un piano di ristrutturazione che è una mattanza”. Non sarebbe la prima o l’ultima volta. Gli esuberi di Wired fanno parte di un più ampio piano che prevede uscite all’interno del gruppo per circa 50 unità. Presto potrebbe toccare a Vanity Fair, Gq e Ad (Architectural Digest). Del 26/06/2015, pag. 12 Tv. Dalla prossima settimana l’esame dei Lavori pubblici al Senato Rai, il riassetto incassa l’ok della commissione Bilancio ROMA Il disegno di legge sulla governance Rai può riprendere il suo iter al Senato. La commissione Bilancio di Palazzo Madama, infatti, ha approvato ieri mattina il proprio parere sul provvedimento, positivo con alcune osservazioni. Adesso, la commissione Lavori Pubblici e Comunicazione può cominciare a votare i 380 emendamenti presentati al testo base, quello approvato dall’esecutivo. Lo farà dalla prossima settimana: ieri tutti erano in Aula per il voto di fiducia sulla scuola. Il vertice della Rai è già scaduto, con l’approvazione del bilancio 2014 da parte dell’assemblea dei soci. Resterà in carica, senza alcuna “diminutio” dei poteri, sino alla nomina del nuovo vertice. A proposito di cda, sarebbe utile sapere con quanti voti a favore, degli otto consiglieri, sono stati approvati, il 18 giugno, i palinsesti presentati questa settimana agli inserzionisti: non si tratta di una questione aziendale interna, ma dei contenuti attraverso i quali il servizio pubblico informerà e intratterrà gli italiani nella prossima stagione televisiva. Quanto al vertice, bisognerà anche prolungare il contratto del direttore generale Luigi Gubitosi, in scadenza. Ora tocca alla politica, che ha già ridotto di 80 milioni l’introito da canone del 2015 (e degli anni successivi), dopo i 150 milioni del 2014. Va approvata una nuova legge per non rinnovare il cda con la Gasparri, come Matteo Renzi ha già minacciato di poter fare in caso di mancata approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento. Difficile, ma non impossibile, farcela prima della pausa estiva di agosto. Possibile, invece, approvarlo al Senato, per convertirlo definitivamente alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari. Il disegno di legge, in ogni caso, non è impantanato, nonostante le perplessità delle opposizioni e di diversi giuristi. Per l’insediamento del nuovo vertice, va tenuto conto che, una volta approvata la legge, occorrerà convocare sia la Camera sia il Senato per la nomina dei quattro consiglieri di loro competenza. Andrà, inoltre, nominato, se il ddl del Governo non verrà modificato, il rappresentante dei lavoratori della Rai. Non a caso, alcuni emendamenti da votare la prossima settimana prevedono un apposito regolamento e un mese di tempo per procedere alla nomina del loro rappresentante da parte degli oltre undicimila dipendenti della Rai. Bisognerà aspettare l’autunno, forse, per avere il nuovo vertice mentre sin dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale scatterà l’anno di tempo entro il quale 38 esercitare la delega per riformare il canone di abbonamento e il Testo unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici. Il Governo si è detto disponibile ad alcune modifiche al testo del disegno di legge, a patto di non stravolgerlo. Vi sono alcuni problemi aperti, come quello delle nomina editoriali di reti, newsroom e Tg che, con il testo attuale del governo, sarebbero di competenza dell’amministratore delegato - nominato dal cda su proposta dell’assemblea dei soci (Tesoro) - “sentito” lo stesso consiglio di amministrazione. Le nomine editoriali potrebbero “tornare” al cda, come avviene attualmente, su proposta del direttore generale. 39 CULTURA Del 26/06/2015, pag. 14 Una massa di scrittori in fuga dalla Storia Asor, nome gentile (il suo retrogrado / è il più bel fiore)”. In una poesia tarda Eugenio Montale se la prendeva col “funesto mistagogo” che “è nato a un parto col tempo / e lo detesta”, lo stesso che oggi riporta in libreria Scrittori e popolo (Einaudi), saggio di cinquant’anni fa. Il soggetto è Alberto Asor Rosa, storico della letteratura e voce della sinistra italiana da mezzo secolo e più. Quella del “barone rosso” – come da soprannome – non è un’operazione nostalgia, né (solo) un’autocelebrazione. In cauda venenum, infatti, come d’abitudine: al testo che nel 1965 uscì per Samonà e Savelli è aggiunto un breve saggio dal titolo Scrittori e massa. Un compianto sul tempo che fu? Non del tutto, piuttosto un ritratto corrosivo del presente. Il popolo, ci dice in sostanza Asor, non c’è più e insieme a lui – comunità attorno a cui s’erano più o meno organizzate le democrazie occidentali – se n’è andata pure la politica, che sopravvive solo nella forma degradata e impotente che è sotto gli occhi di tutti. Il presente è il tempo della massa, cioè – con spreco di citazioni da Le Bon a Freud – una “realtà umano-sociale in cui i caratteri individuali e distintivi sono meno rilevanti, e più rilevanti invece quelli della comunanza e della sovrapposizione”: la massa “ha stabilito col sistema democratico un compromesso, che consiste nell’accettare di viverci dentro, svuotandolo”. Proprio quando la libertà individuale – il “si può” di Giorgio Gaber – sembra l’unica regola, si scopre che la gabbia del sistema è chiusa e inscalfibile, persino alla conoscenza dei rapporti di potere: si può tutto, tranne cambiare, cioè fare politica, costruire società. E gli scrittori? “È del tutto ovvio che a una società di massa corrisponda una cultura di massa” e, dunque, una letteratura. Gli effetti sono molteplici e, pur descritti da Asor Rosa come conseguenza meccanica del contesto, non sono un complimento per lo scrittore contemporaneo (l’analisi riguarda, all’ingrosso, quelli nati dopo il 1960): nella massa – che poi è anche massa di scrittori – non esiste più “società letteraria”, né d’altronde “tradizione letteraria”. Al posto di una comunità capace di elaborare pensiero e poetica (e persino “identità nazionale”), c’è l’invenzione di un nuovo genere letterario: la pagina dei ringraziamenti. Una folla di nomi – “quando mai Moravia, Vittorini o Calvino hanno creduto di dover ringraziare qualcuno?” – che “con l’accumulo delle testimonianze di fiducia, affetto, stima, solidarietà” maschera la solitudine dello scrittore. A colpi di 40-50 titoli l’anno poi – “ma il calcolo è per difetto” – muore anche la critica letteraria, incapace di orientarsi e di orientare “nella polverizzazione delle tendenze e delle identità”. Per conquistare la massa (e la classifica, e il profitto) l’intera letteratura diventa narrativa, storytelling: “Tutti raccontano fondamentalmente storie: non storie di Storia, ma storie di storie”. Sul campo di battaglia, tristemente abbandonato, giacciono “questione sociale” e “questione politica”. Ormai indicibili. “Di amore invece ce n’è moltissimo”: “È una conferma – insieme con l’assenza di tragedia e satira – del carattere sostanzialmente normalizzante del racconto contemporaneo”. Pure il disagio, insomma, finisce per essere solo il canto nostalgico della normalità: la narrativa è ormai – oggettivamente? – conservatrice. Al netto delle poche eccezioni, “le storie di storie possono essere centomila, ma non essercene neanche una che intacchi poco più dell’ingannevole superficie del magma”. Fin qui Asor Rosa, la cui flebile, contraddittoria, via d’uscita è il vecchio, caro “conflitto” (ma il nuovo Moloch non era inconoscibile?). Se non esiste soluzione, però, c’è almeno la 40 possibilità – partendo da qui – di indagare lo stato dell’arte. Iniziamo oggi con le interviste a due scrittori, Emanuele Trevi e Giuseppe Montesano, altri interventi seguiranno. Sono gli amori della crisi: se la letteratura sta male, non è che i giornali si sentano proprio bene. 41 ECONOMIA E LAVORO Del 26/06/2015, pag. 21 La ripresa taglia fuori il Sud La fotografia di Bankitalia sulle regioni: tirano export e turismo Paolo Baroni La ripresa alla fine è arrivata e in questi primi mesi dell’anno interessa quasi tutte le aree del Paese. In circa metà delle regioni italiane i segnali sono significativi: la situazione si presenta decisamente più favorevole nelle regioni del Centro Nord, a cominciare da alcune regioni del Nord-Est, soprattutto per effetto delle esportazioni e della ripresa del fatturato industriale. Il Sud invece (soprattutto Calabria, Sicilia e Campania) fatica ad uscire dalla recessione. Mentre almeno sette regioni (tra cui Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo e Puglia) la ripresa è più faticosa. E’ fatto di luci ed ombre il check-up dell’economia italiana che si ricava leggendo i 20 rapporti regionali che la Banca d’Italia ha appena finito di pubblicare. Il dato generale è che nel 2014 la prolungata flessione del Pil si è finalmente arrestata al Centro Nord e si è attenuata nel Mezzogiorno. Con le esportazioni che sono rimaste la voce più dinamica della nostra economia: nel Mezzogiorno solo mezzi di trasporto e alimentare hanno però fornito un contributo positivo, mentre al Centro Nord tirano soprattutto macchinari, chimica, farmaceutica, mezzi di trasporto e beni tradizionali (compreso tessile, abbigliamento e mobili). Segnali positivi dal turismo, con ricadute su porti ed aeroporti. Ma situazione certamente ancora molto problematica, tant’è che proprio ieri il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha parlato di «ristagno». Epperò dopo tre anni di calo nel 2014 il tasso di natalità delle imprese ha segnato una ripresa e sono emersi i primi segnali di risveglio del mercato immobiliare. Anche l’occupazione è tornata a crescere in misura più pronunciata nel Nord-Est e soprattutto al Centro, mentre al Sud la flessione si è attenuta. Il lavoro dei giovanile rimane il nostro grande male: con l’aumento della disoccupazione, infatti, sono aumentate in misura significativa le migrazioni dei giovani, in particolare quelli più istruiti, dal Sud verso il Centro Nord e di entrambe queste aree verso l’estero . Un fenomeno che non risparmia nemmeno il Nord. 42
Scarica