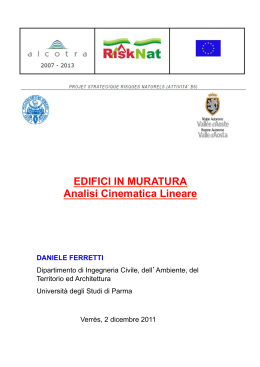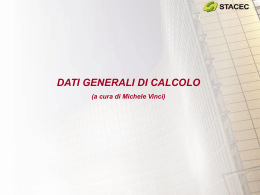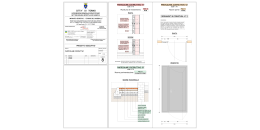Xella Italia S.r.l. Via Vespucci, 39 24050 Grassobbio (BG) Per informazioni: Numero Verde: 800 88 00 77 Fax Verde: 800 33 66 22 [email protected] Tel.: 035 452 22 72 Fax: 035 423 33 51 www.ytong.it [email protected] Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group. A4mmp/Gi&Gi/02/13/0000/1 NOTA: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni contenute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica delle costruzioni Ytong al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall’obbligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla data dell’acquisto o dell’utilizzo del materiali, nonché dall’obbligo del controllo statico, che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell’ambiente delle sostanze chimiche. Edizione 2013.1 YTONG Ytong - Sistemi in calcestruzzo aerato autoclavato EDIFICI IN MURATURA PORTANTE NOTE EDITORE Xella Italia S.r.l. Via Amerigo Vespucci, 39 | 24050 Grassobbio (BG) Tel: +39 035 4522272 | Fax: +39 035 4233351 www.ytong.it | [email protected] IMPRESSUM Autore: Ing. Giacomo Cadelli HDeM Ingegneria S.r.l. Viale D’Annunzio, 8 | 33080 Roveredo in Piano (PN) Tel: +39 0434 94140 | Fax: +39 0434 949904 www.hdem.it | [email protected] Copyright Xella Italia S.r.l. e HDeM Ingegneria S.r.l. Alcune immagini sono tratte dalla pubblicazione “Ingegneria delle strutture” di Elio Giangreco edito da UTET. 2 71 PREFAZIONE Oggetto del presente documento n Insensibilità al fuoco In particolare il buon rapporto è l’esposizione dei criteri gene- n Isolamento acustico resistenza meccanica/leggerez- rali e di calcolo per il corretto n Lavorabilità za rendono la muratura portante dimensionamento e la verifica n Leggerezza YTONG particolarmente interes- degli edifici con struttura in n Ottimo rapporto resistenza sante per l’impiego in zona meccanica/densità sismica poiché a parità di resi- muratura portante, realizzata con blocchi in calcestruzzo aera- stenza meccanica è possibile to autoclavato YTONG. Dal punto di vista normativo, il ridurre notevolmente le masse L’utilizzo di questa tipologia di dimensionamento e la verifica relative alla struttura muraria muratura portante, diffusissimo delle strutture in muratura por- rispetto ad una tradizionale all’estero, è sempre più apprezza- tante sono trattati nel DM muratura in laterizio. to anche nel nostro paese, grazie 14/01/2008 Norme Nel prosieguo saranno affrontati alle molteplici qualità del calce- Tecniche per le Costruzioni”, con gli argomenti relativi alla mura- struzzo aerato autoclavato quali: particolare riferimento alla con- tura, le normative di riferimento cezione strutturale che deve e i criteri di dettaglio per la pro- “Nuove n Isolamento termico essere la base per una corretta gettazione degli edifici sia in n Traspirabilità progettazione degli edifici in con- zona sismica che in zona non n Eco compatibilità e biocompa- dizione sia statica che dinamica, sismica. tibilità ovvero sotto l’effetto del sisma. 3 INDICE 1. IL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO (AAC) ............................................................................6 1.1 Materie prime e procedimento di produzione YTONG..........................................................................6 1.2 Tipologia e classificazione della malta e dell’elemento murario YTONG ...........................................6 1.3 Norme per le strutture in muratura .....................................................................................................9 2. GENERALITÀ SULLA MURATURA ............................................................................................................11 2.1 Legislazione e utilizzabilità della muratura in AAC YTONG...............................................................11 2.2 Tipologie di muratura ..........................................................................................................................12 2.2.1 Muratura ordinaria o non armata ..............................................................................................12 2.2.2 Muratura armata ........................................................................................................................12 2.2.3 Muratura confinata o intelaiata .................................................................................................12 3. PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA MURATURA YTONG .........................................................................13 3.1 Determinazione analitica delle proprietà meccaniche della muratura (EC6 ) .................................13 3.1.1 Resistenza caratteristica a compressione della muratura fk ...................................................13 3.1.2 Resistenza caratteristica iniziale a taglio della muratura fvk0 ...................................................14 3.1.3 Resistenza caratteristica a flessione per azioni fuori dal piano fxk1 e fxk2 .................................14 3.1.4 Moduli di elasticità E e G............................................................................................................15 4. COSTRUZIONI IN MURATURA...................................................................................................................16 4.1 Concezione delle strutture in muratura portante e requisiti minimi in zona non sismica ..............16 4.1.1 Regole per la muratura ordinaria..............................................................................................16 4.1.2 “Edifici semplici” in zona non sismica ......................................................................................18 4.1.3 Regole per la muratura armata.................................................................................................19 4.2 Criteri di progetto delle strutture in muratura portante in zona sismica .........................................20 4.2.1 Particolari disposizioni per le strutture in zona 4 con obbligo di progettazione sismica .......21 4.2.2 Regolarità strutturale.................................................................................................................22 4.2.3 Diaframmi rigidi nel piano, distanze tra gli edifici e altezze massime....................................23 4.2.4 Fattori di struttura ......................................................................................................................24 4.2.5 Requisiti minimi..........................................................................................................................25 4.2.6 Regole di dettaglio......................................................................................................................25 4.2.7 Concezione delle strutture in muratura armata e regole di dettaglio.....................................26 4.2.8 Edifici “semplici” in zona sismica..............................................................................................27 5. CRITERI DI CALCOLO E VERIFICA PER LA MURATURA .........................................................................30 5.1 Principali maccanismi di collasso delle pareti...................................................................................31 5.2 Resistenze di progetto per la muratura portante ..............................................................................33 5.3 Analisi e verifica della muratura portante..........................................................................................34 5.3.1 Analisi per azioni verticali ( condizione non sismica) ...............................................................34 5.3.2 Analisi per azioni orizzontali (condizione sismica) - muratura ordinaria ................................39 4 5.3.3 Pressoflessione nel piano ..........................................................................................................40 5.3.4 Analisi per azioni orizzontali (condizione sismica) - strutture miste.......................................44 5.3.5 Criteri di modellazione e limitazioni specifiche sui metodi di analisi .....................................44 APPENDICE 1: CALCOLO DI EDIFICI SEMPLICI IN MURATURA PORTANTE YTONG............................46 1 SCOPO .....................................................................................................................................................46 ESEMPIO DI RELAZIONE DI CALCOLO .....................................................................................................47 5.4 Caratteristiche del sito ........................................................................................................................47 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COME SEMPLICE.....................48 5.5 Criteri generali di progettazione .........................................................................................................50 5.5.1 Prestazioni di progetto, vita utile e procedure di qualità ..........................................................50 5.5.2 Valutazione di sicurezza delle strutture ....................................................................................50 5.5.3 Valutazione di sicurezza e basi di calcolo dell’azione sismica .................................................50 5.5.4 Caratterizzazione sismica del sottosuolo..................................................................................52 5.6 Azioni sulle strutture ...........................................................................................................................53 5.7 Criteri di calcolo: modalità di analisi soluzione e verifica .................................................................55 5.8 Caratteristiche dei materiali ...............................................................................................................55 5.9 Verifiche in condizione statica .............................................................................................................58 5.10 Verifiche in condizione sismica .........................................................................................................59 6. INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE MURATURA PORTANTE MEDIANTE L’USO DI SOFTWARE DI CALCOLO........................................................................................63 APPENDICE 2: NORME DI RIFERIMENTO ...............................................................................................69 INDICE 5 1. IL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO (AAC) 1.1 MATERIE PRIME E PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE YTONG per di mediante malta tipo YTONG. Tale muratura di calcestruzzo aerato tipo di malta ha come costituen- autoclavato” e viene fornito con ti principali cemento e sabbia Il calcestruzzo cellulare autocla- marcatura CE prevista dalla silicea ed è classificata secondo vato è prodotto con materie direttiva 89/106/CEE “prodotti la UNI-EN998-2: “Specifiche per prime quali la sabbia silicea, da costruzione”, recepita in malte per opere murarie – Malte cemento, calce. L’impasto viene Italia dal DPR21/04/1993, n. 246, da muratura”, secondo il siste- completato con acqua e reagen- così come modificato dal DPR ma di attestazione 2+, come ti in grado di provocare produzio- 10/12/1997, n.499. malta per uso strutturale in ne di idrogeno che, durante la Gli elementi costruttivi sono clas- murature a giunto sottile. prima fase di presa producono sificati secondo il sistema di atte- La gamma di blocchi e pezzi una microalveatura della massa. stazione di conformità 2+ in cate- speciali permette la realizzazio- Dopo la lievitazione all’interno goria I , ossia soggetti ad un con- ne di muratura portante e di delle casseforme la massa, che trollo di tipo statistico delle carat- tamponamento. assume consistenza plastica al teristiche meccaniche da parte di La gamma blocchi per muratura termine della prima fase di un organismo riconosciuto (DM portante è caratterizzata da maturazione, viene sezionata per 14/01/2008 maggiore densità e quindi mag- formare gli elementi desiderati. richiama la Direttiva 89/106/CEE, giori prestazioni meccaniche. In seguito la maturazione viene All.III.2(ii) – possibilità1). La gamma blocchi per muratura muratura. Elementi cap.11.10.1 che terminata in autoclave con sta- zata da bassa densità, quindi viene effettuata in stabilimento 1.2 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DELLA MALTA E DELL’ELEMENTO MURARIO YTONG conformemente con quanto pre- La muratura è costituita da un chi non portanti anche i blocchi visto dalla norma UNI-EN771- assemblaggio organizzato di per tramezzi e divisori e le tavel- 4:2005 - “Specifica per elementi blocchi in calcestruzzo cellulare le sottili. bilizzazione chimica e dimensionale degli elementi così formati. La produzione degli elementi 6 da tamponamento è caratterizottime proprietà di isolamento termico. Fanno parte della gamma bloc- Muratura portante YTONG: sciuto dalla norma tedesca sollevamento e la maschiatu- DIN 4109. ra dei blocchi unite al sistema Il ridotto peso non significa di lastre per solai e tetti, di blocchi per divisori interni e affatto che sia fragile. Le garantiscono tempi di posa murature esterne, e di lastre ottime caratteristiche mec- estremamente ridotti, sem- autoportanti per la realizzazione caniche consentono l’utiliz- plificazione della logistica di di solai e tetti. zazione sia per la realizza- cantiere ed un incremento Costituito da materie prime zione di edifici in muratura della sicurezza in fase di rea- naturali, essenzialmente da portante, sia come tampona- lizzazione. L’intero sistema sabbia, e mento o partizione in edifici assicura un notevole rispar- cemento, il blocco YTONG è con struttura portante in mio economico ed una quali- simile ad una “pietra natura- cemento armato o acciaio. tà costruttiva insuperabile. le” ed è quindi un materiale La favorevole coesistenza di minerale, biocompatibile ed capacità statica, isolamento materie prime minerali, il ecologico.Le caratteristiche termico, potere fonoisolante calcestruzzo cellulare è inin- ed il sistema di produzione, e semplicità di posa, garanti- fiammabile ed incombustibi- garantiscono la protezione sce all’immobile di conserva- le. Con YTONG è possibile delle preziose risorse del- re a lungo il proprio valore, realizzare pareti e solai l’ambiente, in tutte le fasi del estendendo il vantaggio eco- tagliafuoco per la realizza- suo ciclo di vita. I numerosi nomico dal costruttore all’u- zione progetti realizzati col siste- tilizzatore finale. antincendio. Il materiale è La caratteristica intrinseca classificato per reazione al modo rilevante allo sviluppo del materiale di contenere fuoco in Euroclasse A1, ed in sostenibile dell’edilizia. diffuse micro bolle d’aria, classe EI 180 dallo spessore La struttura cellulare del rende il calcestruzzo cellula- di 10 cm. calcestruzzo autoclavato re estremamente traspirante, YTONG, garantisce che i assicurando in tutte le stagio- la possibilità di realizzare rumori vengano attenuati ni un perfetto equilibrio tra edifici antisismici in muratu- dalle numerose micro bolle temperatura ed umidità del- ra portante ordinaria, in con- d’aria presenti nel materiale. l’aria interna agli alloggi. formità al D.M. 2008. La caratteristica di omoge- L’ulteriore controllo dell’iner- neità ed isotropia dei blocchi zia termica, con un elevato e delle lastre, assicura buoni valore di sfasamento ed un valori di isolamento acustico, ridotto fattore di attenuazio- con valori sperimentali di ne, garantisce un ambiente potere fonoisolante superiori più sano e sicuro in modo di 2-4 dB rispetto a quanto costante, giorno e notte, esta- calcolato con la legge di te e inverno. massa, così come ricono- La leggerezza, le maniglie di caratteristiche principali YTONG offre un’ampia gamma n acqua, calce ma YTONG contribuiscono in n n n n n Costituito esclusivamente da di compartimenti Il sistema YTONG garantisce CAPITOLO 1 7 Muratura portante con blocco sismico Il sistema è costituito da 6 ele- n armati; menti: n Blocchi portanti o di tampo- n Architravi armate; n Blocchi forati per realizzazione di irrigidimenti verticali; 8 Tavelle e blocchi sottili per tramezze e divisori; namento; n Blocchi ad U per cordoli n Lastre autoportanti per solai e tetti. YTONG è in grado di fornire un sistema costruttivo completo per realizzare l’intero involucro in AAC. 1.3 NORME PER LE STRUTTURE IN MURATURA zioni di muratura in generale, con Al 7.2.1 la normativa afferma particolare riferimento al mate- che deve essere adottata un’uni- riale, caratteristiche tipologiche, ca tipologia di fondazione per La normativa italiana di riferi- caratteristiche meccaniche e, una data struttura in elevazione, mento, attualmente in vigore: cosa molto importante, stabilisce a meno che questa non consista D.M. 14/01/2008: “Nuove norme la filosofia alla base della conce- di unità indipendenti. tecniche per le costruzioni”; zione strutturale. Vi si trovano Al 7.8.1.2 si trovano anche le Circolare Min. II e TT. 2/02/2009, inoltre, le diverse analisi struttu- prescrizioni circa la resistenza n. 617: “Istruzioni per l’applica- rali ammesse, le verifiche da ese- caratteristica a rottura in dire- zione delle «Nuove Norme tec- guire e la muratura armata. zione orizzontale e verticale, che niche per le costruzioni» di cui Al punto 4.5.6.4, si trovano le i blocchi portanti devono avere al D.M.14/01/08”. condizioni alle quali è possibile in zona sismica, e quella relativa È importante sottolineare che il eseguire le verifiche con il alla malta di allettamento. succitato decreto Ministeriale, metodo delle tensioni ammissi- Al punto 7.8.1.4 si trovano “i cri- già al capitolo 1, chiarisce che: bili ( edificio semplice). teri di progetto e requisiti geo- “Circa le indicazioni applicative Vi si trova anche, al punto 4.5.10, metrici”, alcuni dei quali fonda- per l’ottenimento delle prescrit- le indicazioni circa le norme da mentali ai fini della fattibilità di te prestazioni, per quanto non rispettare per la progettazione un edificio in muratura portante espressamente specificato nel in relazione al fuoco. in zona sismica, come ad esem- presente documento, ci si può Il capitolo 7 tratta della proget- pio la prescrizione sul muro in riferire a normative di compro- tazione per azioni sismiche in falso, tetti spingenti, solai con vata validità e ad altri documen- genere, e nel particolare al 7.8 funzionamento a diaframma e la ti tecnici elencati nel Cap. 12. tratta delle costruzioni in mura- tabella dei requisiti geometrici Il capitolo 4.5, tratta delle costru- tura. delle pareti resistenti al sisma Lastre solaio YTONG CAPITOLO 1 9 10 (importante l’indicazione circa lo ni di muro che presentino conti- scrizione sul metro di muratura spessore minimo e la snellezza nuità verticale dal piano oggetto portante all’incrocio d’angolo delle pareti). di verifica fino alle fondazioni. dei muri portanti perimetrali. Al punto 7.8.1.9 si trovano indi- Al capitolo 7.8.3 si trovano le Al capitolo 7.8.5.2 “costruzioni di cazioni circa l’edificio semplice e indicazioni circa le “ Costruzioni muratura armata”, si afferma vanno ad integrare quanto pre- in muratura armata”, quali cri- che per la muratura armata si sente al 4.5.6.4. teri di progetto e verifiche di può derogare dalla prescrizione Al capitolo 7.8.2 “Costruzioni in sicurezza. circa il sul metro di muratura muratura ordinaria”, vengono Al capitolo 7.8.4 la norma tratta portante all’incrocio d’angolo descritte le verifiche di sicurez- delle “ Strutture miste con pare- dei muri portanti perimetrali. za da effettuare per la muratura ti in muratura ordinaria o arma- ordinaria. ta”. Vi si trovano indicazioni rela- Al 7.8.2.1, si afferma ad esempio tive ad un tipo di strutture multo che le costruzioni in muratura diffuse, quali quelle ad esempio ordinaria debbono avere le che prevedono elementi portanti aperture praticate nei muri ver- in muratura e porzioni ad esem- ticalmente allineate e in assen- pio in calcestruzzo armato, quali za di valutazioni più accurate, si pilastri e/o setti. prendono in considerazione nel Al capitolo 7.8.5 vengono espo- modello strutturale e nelle veri- ste le “Regole di dettaglio”. Di fiche, esclusivamente le porzio- notevole importanza è la pre- 2. GENERALITÀ SULLA MURATURA 2.1 LEGISLAZIONE E UTILIZZABILITÀ DELLA MURATURA IN AAC YTONG esplicitamente dità della tabella semplificata riguardanti la muratura in giun- per la determinazione della L’impiego nella muratura por- to sottile, con spessore fino a 3 resistenza meccanica possono tante di elementi murari in cal- mm. Le tabelle per ricavare la essere utilizzate previa caratte- cestruzzo cellulare, non con- rizzazione meccanica mediante templato esplicitamente nel resistenza caratteristica (fk) della muratura a partire dalla DM20/11/1987 e, di conseguen- resistenza del blocco (fb) e dalla dalla norma vigente. za, neanche nel DM16/01/1996, tipologia della malta riportate al La muratura YTONG quindi, è stato esplicitamente introdotto cap.11.10.3.2, infatti, sono valide nonostante l’ampio spazio dedi- già dal DM14/09/2005 mediante solo per murature con giunto di cato alla muratura in calce- l’assunzione delle specifiche sui malta tra i 5 e i 15 mm. Quindi si struzzo cellulare dalla norma blocchi da muratura della UNI- possono adottare i riferimenti europea, è stata oggetto di EN 771 che al punto 4 riporta le specifici sulle murature in giun- diverse campagne sperimentali specifiche per gli elementi in to sottile, come previsto al che consentono al produttore di calcestruzzo cellulare. cap.12 del succitato DM.2008, dichiarare la resistenza della Lo stesso dicasi per la malta ricorrendo 6, muratura (fk e fvk0) ottenuta con- impiegata introdotta norma coerente nei principi e formemente a quanto previsto mediante l’assunzione delle spe- ammessa ad integrazione dalle dalle Norme Tecniche. cifiche di cui alla UNI-EN 998. NTC. Ciò che nella norma di riferi- In alternativa, come già previsto mento, il DM14/01/2008 non è dal DM87, murature che non è sono le soddisfino la condizione di vali- specifiche che invece, contemplato, all’Eurocodice le prove sperimentali previste CAPITOLO 2 11 2.2 TIPOLOGIE DI MURATURA Il D.M.14.01.2008 definisce costruzioni in muratura quelle costruzioni con struttura portante verticale realizzata con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni sia verticali che orizzontali, collegati tra di loro da strutture d’impalcato, orizzontali ai piani ed Fig.3.2 Muratura armata e muratura confinata eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. zione di armature verticali ed nelli murari tramite cordoli ver- La distinzione comunemente orizzontali della ticali e orizzontali in calcestruz- utilizzata per classificare le muratura. L’armatura verticale zo armato che collaborano con varie tecnologie di costruzione viene collocata all’interno di la muratura essendo costruiti in in muratura portante prevede: appositi fori presenti nei blocchi aderenza. Questa tipologia di all’interno muratura, non è espressamente contemplata dalla normativa italiana, ma è tuttavia trattata nell’Eurocodice 6 al capitolo 6.9. Le ultime due tipologie elencate hanno lo scopo di supplire al comportamento fragile e soggetto all’instabilità della muratura ordinaria mediante l’introduzone di acciaio che possa conferire ai pannelli murari duttilità e maggiore resistenza a Fig.3.1 Muratura semplice trazione. 2.2.1 Muratura ordinaria o non armata da muratura, concentrata o dif- Con gli elementi costruttivi da fusa, e l’armatura orizzontale, muratura YTONG è possibile La muratura di tipo tradizionale comunemente realizzare ottenuta mediante assemblag- barre semplici o tralicci, all’in- tutte le tipologie di muratura gio ordinato di elementi murari terno dei corsi di malta. portante elencate, grazie alla costituita da solidarizzati con malta. 12 edifici utilizzando vasta gamma di blocchi e pezzi speciali che consentono di rea- 2.2.2 Muratura armata 2.2.3 Muratura confinata o intelaiata Tale tipologia prevede l’introdu- Prevede il confinamento di pan- all’interno della muratura. lizzare pilastrini e cordoli in c.a. 3. PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA MURATURA YTONG Nel caso di elementi in calce- densità e conseguentemente 3.1.1 Resistenza caratteristica a compressione della muratura fk diverse classi di resistenza. La resistenza caratteristica a le si applica la (espressione 3.3): Il blocco Sismico è stato apposi- compressione della muratura tamente studiato per la realizza- viene ricavata dalla formulazio- zione di edifici in zona sismica. ne proposta dall’EC6 (3.6.1.2): I blocchi YTONG vengono prodotti in diversi formati, diverse struzzo aerato autoclavato posati con malta in giunto sotti- fk = 0.8 f b0.85 (3.2) essendo il valore di K fornito 3.1 DETERMINAZIONE ANALITICA DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA MURATURA (EC6) a b fk = Kf f b m (3.1) dalla tabella 3.3. in cui: K: fattore di forma costante La determinzione delle proprie- fb: resistenza media normalizzata a tà meccaniche caratteristiche compressione del blocco in della muratura, quando non N/mm2 esplicitamente dichiarate dal produttore, può essere svolto fm: resistenza a compressione della malta attraverso il procedimento previsto dall’Eurocodice 6. Table 3.3 - Values of K for use with general purpose, thin layer and lightweight mortars General purpose mortar Masonry Unit Lightweight mortar of density Thin layer mortar (bed joint 0,5 mm and 3 mm) 600 ρd 800 kg/m3 800 ρd 1 300 kg/m3 Group 1 0,55 0,75 0,30 0,40 Group 2 0,45 0,70 0,25 0,30 Group 3 0,35 0,50 0,20 0,25 Group 4 0,35 0,35 0,20 0,25 Group 1 0,55 0,80 ‡ ‡ Group 2 0,45 0,65 ‡ ‡ Group 1 0,55 0,80 0,45 0,45 Group 2 0,45 0,65 0,45 0,45 Group 3 0,40 0,50 ‡ ‡ Group 4 0,35 ‡ ‡ ‡ Autoclavated Group 1 Areated Concrete 0,55 0,80 0,45 0,45 Manufactured Stone Group 1 0,45 0,75 ‡ ‡ Dimensional Natural Stone Group 1 0,45 ‡ ‡ ‡ Clay Calcium Silicate Aggregate Concrete Combination of mortar/unit not normally used, so no value given. ‡ La resistenza media a compressione del blocco e la resistenza caratteristica sono dichiarati nella marcatura CE. CAPITOLO 3 13 3.1.2 Resistenza caratteristica iniziale a taglio della muratura fvk0 Table 3.4 - Values of the initial shear strength of masonry, fvko fvko (N/mm2) Masonry Units La resistenza iniziale a taglio si ricava dalla tabella 3.4 General purpose mortar of the Strength Class given M10 - M20 0,30 M2,5 - M9 0,25 M1 - M2 0,20 M10 - M20 0,20 M2,5 - M9 0,15 M1 - M2 0,10 Aggregate Concrete M10 - M20 0,20 Autoclavated Areated Concrete M2,5 - M9 0,15 Manufactured Stone and Dimensional Natural Stone M1 - M2 Clay Calcium Silicate Thin layer mortar (bed joint 0,5 mm and 3 mm) Lightweight mortar 0,30 0,15 0,40 0,15 0,30 0,15 0,10 3.1.3 Resistenza caratteristica a flessione per azioni fuori dal piano fxk1 e fxk2 Nel caso di flessione fuori dal piano si verifica la possibilità che i piani di flessione siano paralleli o ortogonali ai giunti orizzontali di malta: La resistenza caratteristica a flessione parallela al giunto orizzontale, può essere valutata da: fxk1 = 0,035 fb sia con giunti verticali incollati che non incollati. Fig.4.1 Flessione fuori dal piano 14 La resistenza caratteristica a flessione perpendicolare oppure dalla seguente tabella: al Values of fxk1 for plane of failure parallel to bed joints giunto orizzontale, può essere fvk1 (N/mm2) Masonry Units valutata da: fxk2 = 0,035 fb General purpose mortar fm 5 N/mm2 fm 5 N/mm2 Thin layer mortar Lightweight mortar nel caso di giunti verticali incol- Clay 0,10 0,10 0,15 0,10 lati; Calcium Silicate 0,05 0,10 0,20 not used Aggregate Concrete 0,05 0,10 0,20 not used Autoclavated Areated Concrete 0,05 0,10 0,15 0,10 Manufactured Stone 0,05 0,10 not used not used Dimensional Natural Stone 0,05 0,10 0,15 not used fxk2 = 0,025 fb nel caso di giunti verticali non incollati; Values of fxk2 for plane of failure perpendicular to bed joints fvk2 (N/mm2) Masonry Units General purpose mortar fm 5 N/mm2 fm 5 N/mm2 Thin layer mortar Lightweight mortar Clay 0,20 0,40 0,15 0,10 Calcium Silicate 0,20 0,40 0,30 not used Aggregate Concrete 0,20 0,40 0,30 not used Autoclavated ρ400 kg/m3 Areated Concrete ρ400 kg/m3 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,40 0,30 0,15 Manufactured Stone 0,20 0,40 not used not used Dimensional Natural Stone 0,20 0,40 0,15 not used 3.1.4 Moduli di elasticità EeG I moduli di elasticità possono essere determinati mediante le seguenti formule (rif. Cap. 11.10.3.4 NTC 08 ed EC6 cap. 3.7.2): E = KE fk (3.3) G = 0,4 E (3.4) In cui in generale KE può essere assunto pari a 1000. CAPITOLO 3 15 4. COSTRUZIONI IN MURATURA Nel presente capitolo si affron- L’edificio in muratura portante tano i criteri generali della pro- deve essere concepito quindi, gettazione delle strutture in come una struttura tridimensio- muratura portante secondo le nale in modo che il comporta- NTC cap 4.5.4, cioè edifici rica- mento denti in zona 4 e non soggetti fenomeni di cedimento locale alla progettazione sismica. degli scatolare elementi impedisca strutturali, soprattutto in presenza di azioni 4.1 CONCEZIONE D E L L E STRUTTURE IN MURATURA PORTANTE E REQUISITI MINIMI IN ZONA NON SISMICA 4.1.1 Regole per la muratura ordinaria orizzontali. Per questo i sistemi La muratura ha, in generale, Ai fini di un adeguato comporta- una buona resistenza a com- mento statico e dinamico dell’e- pressione, ma una scarsa resi- dificio, tutte le pareti devono stenza a trazione. Inoltre per assolvere sia la funzione portan- quanto riguarda le azioni oriz- te, sotto carichi verticali, sia la zontali, le pareti in muratura funzione di controventamento, se hanno una buona resistenza per sollecitate da forze orizzontali. resistenti di pareti di muratura, gli orizzontamenti e le fondazioni devono essere collegati tra di Fig. 5.1 loro in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali. le azioni agenti nel loro piano, mentre la resistenza alle azioni fuori dal piano è decisamente Fig. 5.2 minore. Fig. 5.3 16 Con riferimento a DM 14/01/2008 cap. 4.5.4, i pannelli murari sono considerati resistenti alle azioni orizzontali quando hanno una lunghezza non inferiore a 0,3 volte l’altezza d’interpiano. Fig. 5.4 Schematizzazione strutturale delle pareti Con riferimento a DM 14/01/2008 no essere opportunamente livello dei solai, aventi lo scopo cap. 4.5.4, per garantire il com- collegati tra loro. Tutte le pare- di collegare tra loro i muri portamento scatolare della strut- ti devono essere collegate al paralleli della scatola mura- tura è necessario che: livello dei solai mediante cor- ria. Nel caso di solai con gli orizzontamenti, solai piani doli di piano in calcestruzzo cappa collaborante armata e falde inclinate, siano in armato e, tra di loro, mediante con rete elettrosaldata, essi grado di ripartire le azioni ammorsamenti lungo le inter- sono da considerarsi dei piani orizzontali fra i muri di contro- sezioni verticali; rigidi e quindi la funzione di devono inoltre essere previsti collegamento è garantita in opportuni incatenamenti a entrambe le direzioni. n ventamento; n muri ed orizzontamenti devo- n Fig. 5.5 CAPITOLO 4 17 4.1.2 “Edifici semplici” in zona non sismica Si riporta di seguito la schematizzazione delle operazioni da seguire per la progettazione di edifici classificabili come semplici ai sensi del DM 14/01/2008. 4.1.2.1 Schema della procedura di verifica per l’ “edificio semplice” in muratura portante, in zona non soggetta a progettazione sismica. RISPETTO DI TUTTI I PUNTI DEL CAP. 4.5.6.4 L’edificio è classificabile come semplice L’edificio non è classificabile come semplice Ammessa verifica semplificata alle tensioni ammissibili VERIFICA STRUTTURALE ESTESA Se risulta verificata: σ = N/(0,65 A) fk /γM NO Bisogna incrementare la muratura La verifica si intende soddisfatta NON OCCORRE FARE ALTRO 18 Il succitato Decreto, al cap. zioni che un edificio deve neces- regionali non prevedano l’obbli- 4.5.6.4, prevede la possibilità di sariamente rispettare per poter go di progettazione sismica). effettuare una verifica semplifi- essere classificato come sempli- Per le zone soggette a progetta- cata, nel caso in cui l’edificio sia ce, in zona non soggetta a pro- zione sismica, si vedranno nel classificabile come semplice. gettazione sismica (per esempio seguito le prescrizioni aggiunti- Si riportano di seguito le limita- le zone 4 per le quali le norme ve a quelle sopra riportate. Pareti strutturali Continue da fondazione in sommità Altezza di interpiano 3,5 m Numero di piani entro e fuori terra 3 Rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto in pianta a/b 3 Snellezza della muratura λ 12 Carico accidentale qk 3,00 kN/m2 4.1.3 Regole per la muratura armata ti murarie incorporanti apposite acciaio inossidabile o in acciaio armature metalliche verticali ed con rivestimento speciale. Per le La muratura armata, trattata orizzontali, annegate nella malta armature orizzontali è concesso dalla normativa al cap. 4.5.7, è o conglomerato cementizio. l’impiego di tralicci elettrosaldati. costituita da blocchi e pezzi spe- Le barre d’armatura possono Le barre d’armatura devono ciali per la realizzazione di pare- essere in acciaio al carbonio, soddisfare i seguenti requisiti: Tipologia Diametro Armatura orizzontale nei letti di malta Interasse tra le barre orizzontali Armatura verticale L’armatura verticale Acciaio al carbonio o inossidabile Tralicci per le armature orizzontali Ø5 0,04% Area lorda trasversale della parete 0,5 %, con eventuale maggiorazione del 0,3% per aumentare la resistenza fuori dal piano 60 cm 0,05% Area lorda trasversale della parete 1 % d’area L’armatura verticale deve essere L’ancoraggio delle armature a minima pari a 2 cm deve essere collocata in apposite cavità di taglio deve essere effettuato collocata: dimensioni tali che vi risulti mediante ganci e piegature attor- alle estremità delle pareti inscrivibile un cilindro di 6 cm di no ad una barra longitudinale. portanti, diametro. La lunghezza di sovrapposizione alle intersezioni tra pareti L’ancoraggio delle armature delle armature deve essere di portanti, deve essere realizzato mediante: almeno 60 diametri, in mancan- in corrispondenza di ogni n barre rettilinee di lunghezza za di dati sperimentali specifici. apertura, calcolata come per le strut- La malta di riempimento deve e comunque ad interasse ture in calcestruzzo; avvolgere completamente l’ar- n ganci, piegature o forcelle; matura e deve avere una resi- n dispositivi meccanici di com- stenza minima di 10 MPa. Nel provata efficacia. caso di conglomerato cementi- 2 n n n n non superiore a 4 m. 1 2 3 zio esso deve risultare almeno di classe C12/15. Fig. 5.7 Muratura armata 1. Cilindro per armatura verticale d=6cm 2. Armatura verticale min Ø5 0.05%=At=1%; min 2cmq 3. Armatura orizzontale min Ø5 0.04%=At=0.5%; i=60cm CAPITOLO 4 19 4.2 CRITERI DI PROGETTO DELLE STRUTTURE IN MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA Le costruzioni che si trovano in di elementi pressoché orizzonta- zona sismica devono essere li con luce superiore a 20 m, ele- dotate di sistemi strutturali che menti a mensola di luce supe- garantiscano rigidezza e resi- rione a 4 m, strutture di tipo Si tratta di regole e prescrizioni stenza nei confronti delle due spingente, pilastri in falso, edifi- aggiuntive e non sostitutive componenti ortogonali orizzon- ci con piani sospesi, costruzioni rispetto a quelle per le zone senza tali delle azioni sismiche. La con isolamento purché il sito nel obbligo di progettazione sismica, componente verticale deve esse- quale la costruzione sorge non come previsto al cap. 7.8.1. re considerata solo in presenza ricada in zona 3 o 4. Fig.5.8 20 Si deve tenere, infine, conto resistenti a sviluppo verticale. vazione, a meno che questa non degli effetti torsionali che si Il sistema di fondazione deve consista di unità indipendenti. accompagnano all’azione sismi- essere dotato di elevata rigidez- Nella stessa struttura deve ca. A tal fine gli orizzontamenti, za estensionale nel piano oriz- essere evitato l’uso contestuale devono essere dotati di rigidezza zontale e di adeguata rigidezza di fondazioni su pali o miste con e resistenza tali da metterli in flessionale. Deve essere adotta- fondazioni superficiali. grado di trasmettere le forze ta un’unica tipologia di fondazio- scambiate tra i diversi sistemi ne per una data struttura in ele- Fig. 5.9 Schemadi ! propagazione del danno ? '= Fig. 5.10 Possibili meccanismi di collasso 4.2.1 Particolari disposizioni per le strutture in zona 4 con obbligo di progettazione sismica Approccio 1 - In ottemperanza a senza solo occasionale di perso- quanto indicato nelle NTC al ne) o II (Struttura in cui è previ- cap. 2.7 è possibile progettare sto un normale livello di affolla- con il metodo delle tensioni mento). È necessario, tuttavia, Per le costruzioni da edificarsi in ammissibili con riferimento al considerare nel calcolo un’azio- siti ricadenti in zona 4 (zone a bas- DM.20.11.87 qualora la struttura ne sismica corrispondente alla sa sismicità), il D.M. 14.01.2008, sia di tipo 1 (opera a carattere zona S5 del DM16.01.96 equiva- prevede due approcci diversi provvisionale) o 2 (Opera di tipo lente a Sd = 0.03g. (Circolare Min. II e TT. 2/02/2009, ordinario) ricadente in classe I n. 617, cap. 7): (Struttura in cui è prevista pre- CAPITOLO 4 21 Approccio 2 - applicabile a tutte limite ultimo. La verifica agli tuali rientri o sporgenze supe- le classi di opera e classi d’uso, stati limite d’esercizio non è ra il 25% della dimensione prevede che possano essere richiesta. totale della costruzione nella progettate e verificate applican- corrispondente direzione; do i metodi di calcolo agli stati Per gli edifici semplici si applica limite seguendo le sole regole la relativa verifica forfetaria che nitamente rigidi nel loro valide per le strutture non sog- non prevede verifiche di detta- piano rispetto agli elementi gette all’azione sismica, purché glio, verticali e sufficientemente siano rispettate alcune condizo- rispetto dei requisiti geometrici. ma semplicemente n il gli orizzontamenti sono infi- resistenti. ni relative al comportamento Una costruzione è regolare in i diaframmi orizzontali devo- 4.2.2 Regolarità strutturale no essere infinitamente rigidi Le costruzioni devono avere, requisiti: nel loro piano; quanto più possibile, struttura n gli elementi strutturali devo- iperstatica caratterizzata da cali si estendono per tutta no rispettare le limitazioni regolarità in pianta e in altezza. l’altezza della costruzione; geometriche relative alla Se necessario ciò può essere classe di duttilità “B”; conseguito la no costanti o variano gra- le debbono struttura, mediante giunti, in dualmente dalla base alla essere valutate considerando unità tra loro dinamicamente sommità della costruzione la combinazione di azioni defi- indipendenti. (le variazioni di massa da un nita al paragrafo 3.2.4 ed Al cap. 7.2.2 della normativa orizzontamento all’altro non applicando, in due direzioni dichiara che, na costruzione è superano il 25%, la rigidezza ortogonali, il sistema di forze regolare in pianta se soddisfa i non si riduce da un orizzon- orizzontali seguenti requisiti: tamento a quello sovrastante sismico: n n n sollecitazioni definito dalle espressioni (7.3.6) e (7.3.7), in n cui si assumerà Sd(T1) = 0.07g compatta e approssimativa- più del 10%); ai fini della rigi- (dove T1 è il modo di vibrare mente simmetrica rispetto a dezza si possono considera- principale nella direzione in due direzioni ortogonali, in re regolari in altezza struttu- esame); relazione alla distribuzione re dotate di pareti e nuclei in Le relative verifiche di sicu- di masse e rigidezze; muratura di sezione costante i rapporti tra i lati del rettango- sull’altezza ai quali sia affi- lo circoscritto è inferiore a 4; dato almeno il 50% dell’azio- nessuna dimensione di even- ne sismica alla base; n tuate, in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato n in massa e rigidezza rimango- più del 30% e non aumenta n configurazione n tutti i sistemi resistenti verti- pianta rezza devono essere effet- 22 suddividendo altezza se soddisfa i seguenti n eventuali 20% della dimensione corri- dari può determinare il passag- orizzontale spondente all’orizzontamen- gio da strutture “irregolare” a avvengono in modo graduale to immediatamente sotto- struttura “regolare”, né il con- da un orizzontamento al suc- stante. Fa eccezione l’ultimo tributo alla rigidezza totale sotto cessivo, i orizzontamento di costruzio- azioni orizzontali degli elementi seguenti limiti: ad ogni oriz- ni di almeno quattro piani secondari può superare il 15% zontamento il rientro non per il quale non sono previste della analoga rigidezza degli supera il 30% della dimen- limitazioni di restringimento. elementi principali. della sione restringimenti sezione rispettando corrispondente al In nessun caso la scelta degli primo orizzontamento, né il elementi da considerare secon- Fig. 5.11 Regolarità in elevazione 4.2.3 Diaframmi rigidi nel piano, distanze tra gli edifici e altezze massime La distanza tra costruzioni conti- di volume abitabile. Per le altre gue deve essere tale da evitare zone l’altezza massima degli fenomeni di martellamento, in edifici deve essere opportuna- Con riferimento al cap. 7.2.6, gli ogni caso la distanza tra due mente limitata, in funzione delle orizzontamenti si possono consi- punti che si fronteggiano non può loro capacità deformative e dis- derare infinitamente rigidi nel essere inferiore ad 1/100 della sipative e della classificazione loro piano, se essi sono realizzati quota dei punti considerati misu- sismica del territorio. in cemento armato, o in latero- rata dal piano di fondazione, mol- Ai fini delle verifiche di sicurez- cemento con soletta in c.a. di tiplicata per agS/0,5g 1. za, è in ogni caso obbligatorio almeno 40 mm di spessore, o in Per le costruzioni in muratura l’utilizzo del “metodo semipro- struttura mista con soletta in c.a. non armata che non accedono babilistico agli stati limite”. Il di almeno 50 mm di spessore alle riserve anelastiche, rica- coefficiente parziale di sicurezza collegata da connettori a taglio denti in zona 1, è fissata una da adottare per il progetto opportunamente dimensionati altezza massima pari a due sismico di strutture in muratura agli elementi strutturali in acciaio piani dal piano di campagna, è pari a 2. o in legno e purché le aperture ovvero dal ciglio della strada. Il presenti non ne riducano signifi- solaio di copertura del secondo cativamente la rigidezza. piano non può essere calpestio CAPITOLO 4 23 4.2.4 Fattori di struttura assumere e con cui individuare Al cap. 4.2, la normativa dichia- lo spettro di progetto da utilizza- ra i valori massimi q0 del fattore re nelle analisi lineari, sono di struttura che si possono indicati nella tabella seguente: Tipologia Strutturale q0 Costruzioni in muratura ordinaria 2,0 au / a1 Costruzioni in muratura armata 2,5 au / a1 Costruzioni in muratura armata progettati secondo GR 3,0 au / a1 Tabella 7.8.I - Valori di q0 per le diverse tipologie strutturali Si assume sempre q = q0 KR, costanti le altre azioni, la Nel caso di strutture da edificar- dove con KR si indica un fattore costruzione raggiunge la si in zona 4 per le quali si è scel- riduttivo che dipende dalla rego- massima forza resistente. to l’approccio 2 è possibile tene- larità in altezza della costruzio- Il valore di α1 / αu può essere cal- re in considerazione il compor- ne, esso assume valore 1 se la colato per mezzo di un’analisi tamento dissipativo adottanto struttura è regolare, altrimenti statica non lineare e non può in un fattore di struttura massimo assume il valore 0,8. ogni caso essere assunto supe- pari a q =2,15. I coefficienti α1, αu sono definiti riore a 2,5. come segue: Qualora non si proceda ad una n α1 è il moltiplicatore della analisi non lineare, possono forza sismica orizzontale per essere adottati i seguenti valori il quale, mantenendo costan- di α1 / αu: ti le altre azioni, il primo pan- n nello murario raggiunge la naria ad un piano sua resistenza ultima (a α1 / αu = 1,4 taglio o a pressoflessione); n n costruzioni in muratura ordi- αu è il 90% del moltiplicatore naria a due o più piani della forza sismica orizzon- α1 / αu = 1,8 tale per il quale, mantenendo 24 costruzioni in muratura ordi- 4.2.5 Requisiti minimi spingenti. Eventuali spinte oriz- essere superiore a 5 m. Come già enunciato le piante zontali, valutate tenendo in La geometria delle pareti resi- delle costruzioni in muratura conto l’azione sismica, devono stenti al sisma, deve rispettare i ordinaria debbono essere quan- essere assorbite per mezzo di requisiti della tabella seguente, to più possibile compatte e sim- idonei elementi strutturali. in cui t indica lo spessore della metriche rispetto ai due assi I solai devono assolvere funzio- parete al netto dell’intonaco, h0 ortogonali. Le pareti strutturali, ne di ripartizione delle azioni l’altezza di libera inflessione al lordo delle aperture, debbono orizzontali tra le pareti struttu- della parete, h’ l’altezza massi- avere continuità in elevazione rali, pertanto devono essere ben ma delle aperture adiacenti alla fino alla fondazione, evitando collegati ai muri e garantire un parete ed l la lunghezza della pareti in falso. Le strutture adeguato funzionamento a dia- parete. costituenti orizzontamenti e framma. La distanza massima coperture non devono essere tra due solai successivi non deve tmin (λ=ho/t)max (l/h3)min Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata 300 mm 10 0,5 Muratura ordinaria, realizzata con elementi artificiali 240 mm 12 0,4 Muratura armata, realizzata con elementi artificiali 240 mm 15 Qualsiasi Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata, in siti ricadenti in zona 3 e 4 240 mm 12 0,3 Muratura realizzata con elementi artificiali semipieni, in siti ricadenti in zona 4 200 mm 20 0,3 Muratura realizzata con elementi pieni, in siti ricadenti in zona 4 150 mm 20 0,3 Tipologie Costruttive Tabella 7.8.II - Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma. Le strutture di fondazione devo- cantinato o seminterrato in siti di continuità delle fondazio- no essere realizzate in cemento pareti di cemento armato esso ni, e non è computato nel nume- armato, continue, senza inter- può essere considerato quale ro dei piani complessivi in mura- ruzioni in corrispondenza di struttura di fondazione dei tura CAP 7.8.1.8. aperture nelle pareti soprastan- sovrastanti piani in muratura ti. Qualora sia presente un piano portante, nel rispetto dei requi- 4.2.6 Regole di dettaglio za del solaio e larghezza cate costituenti i solai deb- Per le costruzioni in muratura almeno pari a quella del bono essere prolungate nel ordinaria in zona sismica si devo- muro; è consentito un arre- cordolo per almeno la metà no rispettare le regole di detta- tramento massimo di 6 cm della glio indicate al cap. 7.8.5 della dal filo esterno; comunque per non meno di norma, nel seguito elencate: n n n l’armatura corrente non deve 2 ad ogni piano deve essere essere inferiore a 8 cm , le realizzato un cordolo conti- staffe debbono avere diame- nuo all’intersezione tra solai tro minimo non inferiore a 6 e pareti; mm ed interasse non supe- i cordoli debbono larghezza e 12 cm ed adeguatamente ancorate ad esso. riore a 25 cm; avere altezza minima pari all’altez- sua n travi metalliche o prefabbriCAPITOLO 4 25 n in corrispondenza di incroci n al di sopra di ogni apertura d’angolo tra due pareti peri- deve essere realizzato un metrali sono prescritte, su architrave resistente a fles- entrambe le pareti, zone di sione efficacemente ancora- parete muraria di lunghezza to alla muratura. non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale; 1 Solaio - YTONG 2 Cappa collaborante in c.a. 3 Cordolo in c.a. 4 Ferri longitudinali 8 cmq 5 Staffe minimo Ø6/ 25 6 Muratura - YTONG Fig.5.16 Cordolo di intersezione tra solaio e parete 4.2.7 Concezione delle strutture in muratura armata e regole di dettaglio Oltre alle regole di dettaglio già devono essere ben collegati enunciate per il caso statico, alle pareti adiacenti, garan- sempre al cap. 7.8.5 della tendo la continuità dell’ar- Come nel caso della muratura norma si trova che: matura orizzontale e, ove ordinaria anche per la muratura n armata le pareti murarie devono aperture possono essere in essere efficacemente connesse muratura armata; da diaframmi rigidi ed inoltre metrali è possibile derogare esclusivamente ad aderenza entrambe le pareti zone di re alle azioni orizzontali con un migliorata ed ancorate in parete muraria di lunghezza comportamento globale, consi- modo adeguato; non inferiore a 1 m. pareti nel proprio piano. devono agli incroci delle pareti peri- l’insieme strutturale deve reagi- n barre n dal requisito di avere su n le possibile, di quella verticale; essere derando solo la resistenza delle 26 gli architravi soprastanti le parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse 4.2.8 Edifici “semplici” in zona sismica sistemi di pareti di lunghezza Anche tra le costruzioni che si aperture, ciascuno non infe- trovano in zona sismica si pos- riore al 50% della dimensio- sono individuare degli “edifici ne della costruzione nella semplici” per i quali sono previ- medesima direzione. Nel ste delle prescrizioni aggiuntive conteggio della lunghezza rispetto a quelle degli edifici complessiva possono essere semplici in zona non sismica. inclusi solamente i setti Per le costruzioni semplici rica- murari denti in zona 2, 3, 4 non è obbli- requisiti geometrici della gatorio effettuare alcuna analisi Tab. 7.8.II della normativa. La e verifica di sicurezza, oltre a distanza tra questi due siste- ni siano presenti pareti resi- quella semplificata (vedasi for- mi di pareti in direzione orto- stenti alle azioni orizzontali mula nel seguito riportata). gonale al loro sviluppo longi- con interasse non superiore Gli edifici semplici in zona tudinale in pianta sia non a 7 m; sismica, oltre alle indicazioni inferiore al 75% della dimen- per gli edifici semplici in zona sione della costruzione nella non sismica, devono soddisfare i medesima direzione (ortogo- requisiti di regolarità in pianta nale alle pareti); ed in elevazione, i requisiti mini- complessiva, al netto delle n che rispettano verticali sia portato da pareti indicate e le prescrizioni elenca- che facciano parte del siste- te di seguito: ma resistente alle azioni in ciascuna delle due direzioni siano previsti almeno due n in ciascuna delle due direzio- almeno il 75% dei carichi mi, le regole di dettaglio sopra n Fig.5.17 i orizzontali; Fig.5.18 CAPITOLO 4 27 n per ciascun piano il rappor- non sia inferiore ai valori costruzione e della sismicità to tra area della sezione indicati del sito, per ciascuna delle resistente delle pareti e seguente, in funzione del superficie lorda del piano numero nella di tabella piani direzioni ortogonali; della Accelerazione di picco del terreno ag·S Tipo di struttura Muratura ordinaria Muratura armata Numero piani 0,07 g 0,1 g 0,15 g 0,20 g 0,25 g 0,30 g 0,35 g 0,40 g 0,45 g 0,4725 g 1 3,5% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,5% 2 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% 3 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 1 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 2 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 3 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 4 4,0% 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,5% 6,5% Tabella 7.8.II - Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma. n n il numero di piani non può somma dei carichi perma- zioni può essere effettuato in essere superiore a 3, per le nenti e variabili (valutati modo costruzioni in muratura ordi- ponendo γG= γQ=1), A è l’area conto delle tensioni normali naria; totale dei muri portanti allo medie e delle sollecitazioni per ogni piano deve risultare: f N σ= 0.25 γk (4.1) M A in cui N è il carico verticale stesso piano e fk è la resi- sismiche globali determinate stenza caratteristica a com- con l’analisi statica lineare. totale alla base di ciascun cale della muratura. piano, corrispondente alla 28 pressione in direzione vertiIl dimensionamento delle fonda- semplificato tenendo 4.2.8.1 Schema della procedura per la valutazione dell’edificio semplice in zona sismica RISPETTO DI TUTTI I PUNTI DEL CAP. 4.5.6.4 (ed. semplice in zona non sismica) CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COME REGOLARE IN PIANTA ED IN ALTEZZA, CAP. 7.2.2 NO RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL CAP. 7.8.1.9 SÌ NO L’edificio è semplice L’edificio non è semplice Rispetto dei criteri di progetto e requisiti geometrici del cap. 7.8.1.4 NO Rispetto delle regole di dettaglio in zona sismica cap. 7.8.5 NO Se risulta verificata per ogni piano: σ = N/A 0.25 fk /γM NO VERIFICA STRUTTURALE ESTESA Bisogna incrementare la muratura La verifica si intende soddisfatta NON OCCORRE FARE ALTRO In appendice si riporta il calcolo completo di un edificio semplice in zona sismica. CAPITOLO 4 29 5. CRITERI DI CALCOLO E VERIFICA PER LA MURATURA Nel calcolo e verifica degli edifi- un ordine di grandezza inferiore lemento meno resistente, influi- ci in muratura portante si assu- alla parete in modo da poter sce negativamente sulla resi- me implicitamente un compor- considerare una compensazione stenza finale dell’intero pannello tamento omogeneo. Ossia a delle disomogeneità locali. murario. La presenza della partire dalla disomogeneità, l’a- Sotto quest’ottica l’utilizzo della malta in giunto sottile invece, nisotropia e l’asimmetrica dei muratura portante YTONG offre minimizza questo effetto aumen- costituenti ci si riconduce ad un una maggiore garanzia di omo- tando la regolarità e l’omogenei- materiale continuo omogeneo di geneità, grazie a: tà della tessitura della parete. Si caratteristiche equivalenti al n non omogeneo di riferimento. Non solo, anche nella valutazio- n ne delle azioni si conduce un ragionamento basato su sollecitazioni macroscopiche valutate n Produzione controllata in sta- rileva inoltre, che in base a bilimento dei blocchi; prove effettuate, la forza di ade- Tolleranze dimensionali molto sione raggiunta dalla malta è basse; tale che il collasso nei pannelli Giunti di malta sottili (fino a murari non avviene quasi mai 3 mm). per rottura lungo i giunti di malta, bensì per frattura dei non localmente ma sull’intero elemento strutturale. Si ha infatti, che la presenza Ciò è possibile in virtù del fatto della malta, che all’interno della che gli elementi murari sono di tessitura muraria in genere è l’e- Fig. 6.1 30 blocchi stessi. 5.1 PRINCIPALI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE PARETI I principali meccanismi da con- Se sono rispettate tutte le rego- n siderare nel calcolo e nella verifica sono: le circa la concezione strutturale dell’edificio e le regole di det- fuori dal piano; n taglio, l’edificio in muratura portante è concepito perché siano n rottura per taglio nel piano della muratura; n ribaltamenti rigidi di pareti fuori dal piano o meccanismi di col- rottura per presso flessione nel piano della muratura; evitati tutti i meccanismi di rottura più fragili e imprevisti, quali rottura per presso flessione rottura per scorrimento alla base nel piano della muratura; n rottura per sollecitazioni lasso locali. Si possono quindi derivanti da effetti del secon- considerare i seguenti meccani- do ordine (carichi eccentrici). smi per la verifica dei maschi murari. Fig. 6.2 Rottura per flessione ?5) 3 6.3 Rottura taglioe rottura per alla base ?5-Fig. 3 per ! scorrimento CAPITOLO 5 31 Fig. 6.4 Rottura per flessione fuori dal piano (parallela ai giunti orizzontali e perpendicolare) Fig. 6.5 Rottura per fenomeni del secondo ordine (eccentricità del carico) 32 5.2 RESISTENZE DI PROGETTO PER LA MURATURA PORTANTE A questo scopo si definiscono: n La verifica va condotta confrontando le sollecitazioni di proget- criterio di Coulomb, la resisten- resistenza a compressione di za al taglio come ottenuta da un calcolo della muratura contributo fisso resistenza a fd = fk/γM taglio iniziale (fvk0) e un’aliquota (5.1) resistenza a taglio di calcolo dello sforzo normale mediato to con le sollecitazioni resistenti della muratura sull’intera sezione (σn). del materiale. fvd = fvk/γM Il coefficiente di sicurezza è n (5.2) In cui è stato definito fvk=fvk0+0,4σn definito dalla seguente: avendo considerato, secondo il Classe di esecuzione 1 Classe di esecuzione 2 Verifiche sismiche Elementi da muratura categoria I Malta a prestazione garantita 2 2,5 2 Elementi da muratura categoria I Malta a composizione prescritta 2,2 2,7 2 Elementi da muratura categoria II Ogni tipo di malta 2,5 3 2 pressoflessione fuori Materiale La classe di esecuzione 2 preve- volume’ con opportuni accorgi- de l’impiego di personale quali- menti e controllo delle operazio- ficato (se dipendente dell’impre- ni di miscelazione o uso di malta sa con la supervisione di un premiscelata con certificazione capocantiere, se non dipendente del produttore. n dal piano; n pressoflessione nel piano del muro; n taglio per azioni nel piano del muro; dell’impresa con la supervisione della direzione lavori). Le verifiche agli stati limite ulti- n carichi concentrati; La classe di esecuzione 1 preve- mi da effettuare secondo la nor- n flessione e taglio di travi di de, oltre ai soprascritti controlli, mativa, ed elencati al cap. il controllo e la supervisione in 4.5.6.2, sono: loco della qualità delle malte e n accoppiamento. pressoflessione per carichi del calcestruzzo e il dosaggio laterali (stabilità fuori dal dei componenti della malta ‘a piano); CAPITOLO 5 33 5.3 ANALISI E VERIFICA DELLA MURATURA PORTANTE il problema di interesse è la sversali consente di assumere verifica dei pannelli murari por- la struttura come a nodi fissi. tanti sottoposti ad eccentricità La struttura così definita, nella Come si è detto gli edifici in di essenzialmente realtà, sarebbe schematizzabile muratura sono struttura com- eccentricità fuori dal piano della con vincoli mutui tra gli elemen- plesse in cui tutti gli elementi, a muratura e nel piano, quindi ti di tipo incastro cedevole, tutta- vario titolo, cooperano alla resi- pressoflessione. via, per semplicità, si adottano carico, stenza strutturale. Il criterio di degli schemi limite di articola- modellazione più rigoroso è 5.3.1.1 Verifica e pressoflessione zione a cerniera o ad incastro quello di considerare un siste- Si opera su uno schema sempli- perfetto. ma scatolare applicando la non ficato e idealizzato della mura- L’applicabilità dello schema a linearità geometrica e del mate- tura, considerando una striscia telaio con connessioni ad inca- riale. di larghezza prefissata della stro perfetto necessita di solai Ai fini delle analisi e della verifi- muratura. Tale concio di mura- sufficientemente rigidi fuori dal che, è necessario impiegare il tura viene analizzato trascuran- piano e livello di carico trasmes- metodo semiprobabilistico agli do l’interazione con le sezioni so dal solaio alla muratura suf- stati limite con eccezione fatta adiacenti il ficienemente elevato da poter per gli edifici che rispettano i sistema come un telaio piano, in evitare la parzializzazione della requisiti per cui è ammesso cui la parete è un piedritto e i sezione con il mantenimento di esplicitamente del solai sono delle travi. Il contro- una rigidezza adeguata. metodo alle tensioni ammissibili. ventamento offerto dai muri tra- l’impiego schematizzando 5.3.1 Analisi per azioni verticali (condizione non sismica) La risposta strutturale è calcolata usando: n analisi semplificate; n analisi lineari; n analisi non lineari. Nell’analisi per carichi verticali Fig. 6.6 Schema a telaio (EC6) 34 La normativa, anche se non EC6), propone la schematizza- escludono la possibilità di utiliz- zione a completa articolazione: zo di schemi alternativi (si veda Fig. 6.7 Schema a completa articolazione Le verifiche a pressoflessione si viene ridotta per tenere in consi- gettazione per le azioni sismi- riconducono a verifiche di tipo derazione della non uniformità che), per muratura in elementi semplificato, in pratica situazio- della sollecitazione. resistenti artificiali pieni. ni di compressione semplice. Si introduce un coefficiente ridut- Per il controllo dei fenomeni del Questa semplificazione, tiene tivo della resistenza di calcolo: secondo ordine la snellezza comunque conto della parte nel piano della parete: della muratura convenzionale è φl(ml) flessionale della sollecitazione mediante l’introduzione delle (5.3) fuori dal piano della parete: φ(λ;m) eccentricità dei carichi. (5.4) definita da: λ = h0/t 20 (5.5) In cui h0 è la lunghezza libera di La verifica viene condotta con- funzione della snellezza e del inflessione del muro in funzione trollando che la sezione della coefficienti del suo grado di vincolo e t è lo parete non si parizializzi e che la ml=6el/l e m=6e/t. Da cui la sol- spessore. distribuzione non uniforme della lecitazione resistente di calcolo è: La determinazione della lun- compressione, indotta dalla sol- fd,rid = φl φ fd, quindi la verifica ghezza libera di inflessione h0 lecitazione flessionale conse- risulta: dev’essere effettuata valutando di eccentricità guente all’eccentricità del cari- Nsd/frid,d 1 co, non dia luogo a picchi di ten- φ è il coefficiente di riduzione sione superiori alla resistenza di della resistenza del materiale, h0 = hρ (5.6) calcolo a compressione. riportato in Tab. 4.5.III in funzio- dove ρ è il fattore laterale di vin- Trattandosi di uno schema sem- ne della snellezza convenziona- colo dato da almeno due muri plificato, ci si riconduce ad una le λ e del coefficiente di eccen- trasversali di spessore non infe- tensione agente costante di tricità m. riore a 200 mm e di lunghezza compressione, ma la si confron- Lo spessore dei muri portanti non inferiore a 0,3h posti ad ta con una resistenza a com- non deve essere inferiore a 150 interasse a, che si desume dalla pressione del materiale che mm (zone non soggette a pro- seguente tabella: h/a ρ h/a 0,5 1 0,5 h/a 1 3/2 - h/a 1 h/a 1 1+(h/a)2 il grado di vincolo della parete, nel modo seguente: Fig. 5.6 Schematizzazione dei muri di irrigidimento CAPITOLO 5 35 Se la parete di irrigidimento pre- riferimenti a detto metodo di veri- Si riportano di seguito i metodi senta aperture, si considera effi- fica e pressoflessione sono, per per la determinazione delle cace solo se lo stipite dell’apertu- la verifica nel piano della parete eccentricità, necessari alla deter- ra dista dalla superficie del muro la Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 minazione delle resistenze a irrigidito almeno 1/5 h, in cui h è cap. C 4.5, per la verifica fuori del compressione ridotte per la l’altezza del muro irrigidito. piano della parete il D.M. 14 gen- muratura. Dal punto di vista normativo, i naio 2008, cap. 4.5.6.2. 5.3.1.2 Eccentricità fuori del piano a) Eccentricità dei carichi verticali es1+es2, essendo: es1 l’eccentricità dei carichi trasmessi dai muri ai piani superiori es1 = N1d1 N1 + ∑N2 (5.7) es2 l’eccentricità della reazione di appoggio dei solai soprastanti la sezione da verificare es2 = ∑N2d2 N1 + ∑N2 (5.8) Fig. 6.11 Distribuzione dei carichi per la valutazione dell’eccentricità b) Eccentricità dovuta a tolleranze di esecuzione: ea = h 200 (5.9) c) Eccentricità dovuta ad azioni orizzontali agenti in direzione norMv male al piano della muratura: ev = (5.10) N Si considera, come già detto, uno schema a completa articolazione della parete e le NTC consentono di valutare il momento Mv , dovuto ai carichi orizzontali, considerando la parete incernierata anche lateralmente, quindi con un comportamento a piastra, purché in corrispondenza di muri trasversali che non abbiano interasse superiore ai 6 m. Per la valutazione delle sollecitazioni derivanti da uno schema a piastra incernierata agli estremi si suggerisce di riferirsi a quanto previsto dall’annesso E all’eurocodice 6 – parte 1-1. Le eccentricità calcolate vanno combinate nel seguente modo: sezione di estremità e1 = |es|+ea 0,33t (5.11) sezione di mezzeria e2 = |ev|+e1/2 0,33t (5.12) t è lo spessore del muro. Fig. 6.12 Valutazione dell’eccentricità di appoggio dei solai (a) solaio deformabile (b) solaio molto rigido 36 5.3.1.3 Eccentricità nel piano Questo caso si presenta nel momento in cui il carico non è trasmesso uniformemente alla muratura ma la risultante presenta una eccentricità nella direzione in cui si sviluppa la parete. Risulta, quindi: el = N1d1 + N2d2 N1 + N2 Fig. 6.9 Fig. 6.10 5.3.1.4 Verifica in presenza di carichi concentrati La metodologia di verifica esposta è completamente descritta nell’Eurocodice 6, cap. 6.1.3. Si tratta di una verifica locale, la cui positività è descritta dalla seguente disuguaglianza: NEdc NRdc CAPITOLO 5 37 Il primo termine rappresenta il carico verticale concentrato agente, il secondo il valore resistente della muratura. La resistenza della muratura può essere valutata mediante la seguente formula: NRdc=β Ab fd β = 1+0.3 dove, A a1 1.5-1.1 b hc Aef non inferiore a 1, e non più grande di: a1 o 1.5, prendendo tra i due il più piccolo. 2hc Il significato dei simboli è il seguente: 1.25+ β è un fattore di incremento per carichi concentrati; a1 è la distanza tra l’estremità del muro e il più vicino spigolo dell’area caricata, vedere figura sopra; hc è l’altezza del muro al livello del carico; Ab è l’area caricata; Aef è l’area di appoggio, valutata come: lefm * t; lefm è la lunghezza effettiva di appoggio valutata alla metà altezza del muro, vedere figura sopra; t è lo spessore del muro Ab/Aef non deve essere assunto maggiore di 0.45. Valori del fattore di incremento β cui possano sovrapporsi le ghezza addizionale è richiesta sono mostrati nell’appendice H superfici di appoggio di vari solo da un lato. dell’EC6, parte 1. carichi concentrati. Dove il carico concentrato è L’eccentricità del carico dalla I carichi concentrati devono gra- applicato per mezzo di un ele- linea di metà spessore del muro vare su blocchi appartenenti al mento ripartitore di carico, di non dovrà essere maggiore di /4 gruppo 1 (i blocchi YTONG adeguata rigidezza, larghezza dello spessore del muro. Vedasi appartengono al gruppo 1, rif. pari allo spessore del muro, figura 2. Tab. 3.1 Eurocodice 6), o altro altezza maggiore di 200 mm, In ogni caso, nella metà inferio- materiale solido di lunghezza lunghezza maggiore di 3 volte la re del muro al di sotto delle zone uguale alla lunghezza dell’ap- lunghezza dell’appoggio, il valo- di appoggio dei carichi, dovran- poggio, maggiorato da entrambi re di progetto della tensione di no risultare positive le verifiche i lati di una lunghezza addizio- compressione al di sotto del usuali relative alla muratura, nale ottenuta diffondendo il carico concentrato, non deve includendo tutti i carichi agenti carico con inclinazione di 60°. superare 1.5 fd. al di sopra della sezione di veri- Nel caso di carico concentrato fica, in particolare nelle zona in all’estremità del muro, la lun- 1 38 5.3.2 Analisi per azioni orizzontali (condizione sismica) - muratura ordinaria Il parametro di controllo intro- Nello specifico degli edifici in dotto è: muratura i criteri per l’impiego Come previsto dalla normativa In cui: n analisi lineare statica al cap. 7.8.1.5 i criteri per l’ana- P: carico verticale della struttu- n analisi lisi delle strutture sotto l’azione ra al di sopra dell’orizzontamen- sismica ammessi sono: to in esame; n analisi statica non lineare d r: n analisi dinamica non lineare n n analisi lineari con riferi- θ= Pdr Vh (5.13) spostamento orizzontale mento alla situazione in medio di interpiano; deformata V: delle varie metodologie di analisi sono: lineare dinamica (modale) forza orizzontale totale in Nel caso di carichi orizzontali e, corrispondenza dell’orizzonta- specificamente, di sollecitazione si al passo tenendo in consi- mento in esame; sismica, assumono particolare derazione le non linearità h: altezza di interpiano. significato, oltre a quelle da analisi non lineari anali- geometriche attuare nel caso statico, le veri- Il metodo principe per la valuta- Si presentano i seguenti casi: se fiche a pressoflessione dei pan- zione degli edifici in muratura è θ 0,1 non è necessario consi- nelli nel proprio piano e a taglio l’analisi non lineare, ormai dif- derare gli effetti delle non linea- alla base. fusa in quanto implementata in rità geometriche; se 0,1 θ molti calcolo. 0,2 l’azione sismica va incre- Nel caso di muratura ordinaria Tuttavia, rimangono molto uti- mentata di 1/(1-θ); se θ 0,3 non è necessario applicare i lizzati anche quelli di carattere vanno considerati metodi di principi di gerarchia delle resi- lineare, che hanno un campo di analisi non lineari. stenze. software di applicabilità limitato. Infatti è necessario, per poter impiegare i metodi lineari, che sia trascurabile l’influenza delle non linearità geometriche sulle sollecitazioni della struttura. CAPITOLO 5 39 5.3.3 Pressoflessione nel piano della sezione. È obbligatorio uti- La verifica a pressoflessione nel stati limite, ciò conduce alle piano della muratura si esegue seguenti espressioni per valuta- considerando il materiale non re le sollecitazioni resistenti reagente a trazione, assumendo degli elementi. lizzare il criterio di calcolo agli la possibilità di parzializzazione Fig. 6.13 Il momento resistente, quindi, Essendo: tiene conto di condizioni di equi- l: lunghezza della parete; librio globale del pannello e t: spessore della parete; viene formulato come segue: σ0: pressione media sulla pare- l2tσ0 Mu = 2 40 σ0 10,85 fd te considerando anche la (5.14) parte tesa, pari a N/A. 5.3.3.1 Pressoflessione fuori Quando l’azione assiale non sia dal piano nota (nel caso di modellazione La verifica è del tutto analoga del piano rigido attraverso rigid alla verifica a pressoflessione link, ache impedisce i mutui nel piano, l’unica cosa che cam- spostamenti di piano dei nodi bia è che come lunghezza deve complanari), ma siano presenti essere assunto lo spessore e, elementi con caratteristiche di viceversa come spessore la lun- resistenza a trazione come cate- ghezza della parete. ne o cordoli, si assumono valori Fig. 6.14 di resistenza di seguito riportati. 5.3.3.2 Taglio La resistenza al taglio è valutata Il massimo momento resistente, per seguente ammettendo la presenza di ele- (5.15) menti in grado di equilibrare a mezzo della espressione: Vt = l’tfvd trazione la componente di comIn cui: l’: lunghezza compressa della parete; pressione: Mu = Hp Hp h 10,85 fhdht 2 fvd: resistenza al taglio alla Coulomb calcolata assu- Essendo: mendo una pressione media Hp: il valore minimo tra la resi- sulla porzione di parete com- stenza a trazione dell’ele- pressa (σn = N/(l’t)). mento teso e 0,4fhdht Il valore di fvk è comunque limi- fhd: resistenza a compressione di tato a 1,4fbk o 1,5 Mpa, in cui fbk calcolo della muratura in indica la resistenza a compres- direzione orizzontale sione del blocco in direzione della forza. La resistenza al taglio viene assunta come il minimo tra i 5.3.3.3 Travi in muratura seguenti valori: La verifica di travi di accoppia- Vt =htfvd0 (5.17) mento in presenza di azione Vp=2Mu/l (5.18) assiale nota viene fatta analoga- In cui l è la lunghezza della mente a quella per gli elementi trave. verticali. CAPITOLO 5 41 5.3.3.4 Analisi per azioni oriz- 5.3.3.5 Pressoflessione nel zontali (condizione sismica) - piano muratura armata Per la verifica a pressoflessione Nel caso della muratura arma- si può assumere un diagramma ta, come detto, se si analizza la delle compressioni rettangolare struttura considerandone la con profondità 0,8x e sollecitazio- duttilità, vanno applicati i criteri ne limite pari a 0,85fd. Si possono della gerarchia delle resistenza, considerare come deformazioni nel rispetto dei principi elencati limite: al cap. 7.8.1.7. Ciò si riduce nel muratura: εm = 3,5‰ assicurarsi che i pannelli mura- acciaio: εs = 10‰ ri entrino in crisi per flessione In caso di analisi statica non prima che per taglio, general- lineare si adottano come valori mente sovradimensionando i di calcolo le resistenze medie pannelli a taglio in modo che dei materiali, e lo spostamento siano in grado di resistere ad ultimo può essere assunto pari una sollecitazione tagliante cor- allo 1,2% dell’altezza del pan- rispondente alle azioni flessio- nello. −0,2% 1 −0,35% ε 2 3 4 5 ε 1.00% ε ε 0 Fig. 6.15 nali risultanti dalla resistenza a collasso per flessione amplificata di un coefficiente γRd = 1,5. Il campo di rottura della sezione avere un campo di rottura rap- tiera sia determinata solo dalla è molto utile per una verifica presentato in maniera adimen- variazione dell’area di armatura: grafica del corretto dimensiona- sionalizzata cosicché la varia- mento. A volte è molto utile zione della posizione della fronN bdfcd μ= M bd2 fcd In questo modo si può determi- il coefficiente di sovraresistenza tazione di taglio per la verifica si nare, dovendo applicare i criteri della sezione Ω = μRd/μSd tale che può effettuare con: della gerarchia delle resistenze, la determinazione della solleci- Vsd = γRd 42 v= MRd,p + MRd,t Ω M + ΩtMSd,t = γRd p Sd,p h h (5.19) Essendo le quantità espresse Nei primi due casi, se si impiega 5.3.3.7 Taglio con pedice p e t rispettivamente il taglio di calcolo definito come La resistenza al taglio è calcola- riferite al piede e alla testa della 1.5*(Mrd,1+Mrd,2)/h si ottiene una ta come somma dei contributi parete e h l’altezza netta della sovrastima della sollecitazione della muratura e dell’armatura. parete stessa. per la verifica anche consistente Vt =Vt,m+Vt,s 0,3fd dt Nel calcolo della muratura arma- rispetto al taglio di calcolo in con ta è possibile utilizzare fattori di condizione elastica. Vt,m =dtfvd struttura maggiori applicando la Pertanto si adotterà, come taglio gerarchia delle resistenze. di calcolo per la verifica, il valore In cui d è la posizione del bari- È da sottolineare che tutt’oggi si minore tra quelli del taglio calco- centro dell’armatura tesa dal discute sui criteri per ricavare le lato tenendo in considerazione la lembo compresso ed fvd è calco- sollecitazioni di calcolo per la duttilità del sistema e quello di lato considerando una pressio- verifica nel caso in cui si voglia calcolo per il sisma in condizione ne mediata sull’area A = dt. applicare la gerarchia delle resi- elastica: Vt,s = (0,6dAs,w fyd)/s stenze. In presenza dell’azione sismica Vsd = min q*Vd;1,5* si possono verificare, per i setti (Mrd,1 + Mrd,2) h (5.20) (6.21) (6.22) (6.23) Essendo: As,w: area di armature a taglio sismoresistenti, tre situazioni disposta parallelamente definite dai valori del coefficien- alla forza di taglio ad un te di sovraresistenza a flessione 5.3.3.6 Pressoflessione fuori passo s misurato ortogo- Ω = Mrd/Msd: del piano nalmente a) La parete non plasticizza, La verifica è del tutto analoga taglio; rimane in campo elastico: Ω alla verifica a pressoflessione q nel piano. alla forza di fyd: tensione di snervamento dell’acciaio. b) La parete plasticizza parzial- In caso di analisi statica non mente (solo uno degli estre- lineare si adottano come valori di mi supera la fase elastica): Ω calcolo le resistenze medie dei - q materiali e lo spostamento ulti- c) La parete plasticizza interamente agli estremi: Ω q mo può essere assunto pari allo 0,6% dell’altezza del pannello. CAPITOLO 5 43 5.3.4 Analisi per azioni orizzontali (condizione sismica) - strutture miste strutture di altra tecnologia (ad è da preferirsi l’utilizzo della esempio pareti in c.a.), debbono rigidezza fessurata che può essere seguite le regole di pro- essere impiegata operando Si tratta, nella pratica delle gettazione riportate nei relativi una riduzione del 50% delle costruzioni soprattutto di civile capitoli della presente norma. rigidezze non fessurate. abitazione, di tipologie diffuse. In casi in cui si ritenesse neces- Spesso si abbina muratura por- sario considerare la collabora- 5.3.5.2 Elementi strutturali tante e strutture portanti in cal- zione delle pareti in muratura e Se è rispettata l’ipotesi di infinita cestruzzo armato, quali pilastri dei sistemi di diversa tecnologia rigidezza dei solai la struttura e travi. L’utilità risiede nel fatto nella resistenza al sisma, que- può essere modellata conside- che si sostituisce la muratura st’ultima deve essere verificata rando solo i maschi murari con- con pilastri e travi per la resi- utilizzando i metodi di analisi tinui da fondazione in copertura stenza ai carichi verticali, aven- non lineare. collegati al livello dei solai per do una pianta meno condiziona- Da sottolineare che, la norma tenere in conto il vincolo mutuo ta dalla presenza di muratura. permette di considerare la col- traslazionale offerto dai solai. In Chiaramente il sistema resi- laborazione dei due diversi alternativa possono essere con- stente diventa di tipo misto. sistemi resistenti, ma solamen- siderati nella resistenza gli ele- La normativa (DM 14 gennaio te con analisi di tipo non lineare. menti di accoppiamento (fasce di 2008) prevede espressamente al piano, cordoli) purché efficacemente ammorsati nella muratu- l’ambito delle costruzioni in 5.3.5 Criteri di modellazione e limitazioni specifiche sui metodi di analisi muratura è consentito utilizzare Gli accorgimenti da adottare, se efficacemente sorrette da un strutture di diversa tecnologia nella modellazione funzionale architrave resistente a flessione. per sopportare i carichi verticali, all’analisi da svolgere, per le purché la resistenza all’azione struttura in muratura sono forni- 5.3.5.3 Schematizzazione sismica sia integralmente affi- ti nel capitolo 7.8.1.5 della NTC. In presenza di tali elementi di cap 7.8.4 questa tipologia di strutture, affermando che nel- data agli elementi di identica 44 n ra. Le travi in muratura ordinaria possono essere considerate solo accoppiamento la schematizza- tecnologia. Nel caso in cui si 5.3.5.1 Rigidezza degli elementi zione della struttura può essere affidi integralmente la resisten- Le rigidezze degli elementi sono quella a telaio equivalente in cui za alle pareti in muratura, per da tenere in conto con le le parti di accoppiamento tra esse debbono risultare rispetta- seguenti modalità: elementi verticali e orizzontali te le prescrizioni di cui ai punti n va considerata l’influenza possono essere considerate precedenti. Nel caso si affidi della rigidezza flessionale e infinitamente rigide. integralmente la resistenza alle tagliante; 5.3.5.4 Redistribuzione 5.3.5.6 Limitazione per i diversi È ammessa la redistribuzione metodi di analisi delle forze di taglio tra i pannelli n purché: n n Tale tipo di analisi è applica- i solai siano infinitamente bile anche agli edifici irrego- rigidi; lari in altezza purché si le forze di taglio di piano ponga λ =1. risultanti rimangano invaria- n te (in modulo e posizione); n Analisi statica equivalente il valore assoluto della varia- Analisi dinamica modale Non ci sono limitazioni n Analisi statica non lineare zione della forza redistribuita L’analisi statica non lineare è in ciascun pannello deve applicabile agli edifici in rispettare: muratura anche nei casi in ΔVmax max (0,25 | V | ;0,1 | cui la massa partecipante Vpiano |) del primo modo di vibrare sia in cui Vpiano è la forza totale di inferiore al 75% della massa piano in direzione parallela al totale ma comunque supe- pannello. riore al 60%. n Fig. 6.8 Schematizzazione strutturale Analisi dinamica non lineare 5.3.5.5 Verifiche fuori dal piano Non ci sono limitazioni pur- Le verifiche fuori dal piano pos- ché i metodi di analisi non sono essere effettuate separa- lineare siano di comprovata tamente assumendo qa = 3. efficacia. CAPITOLO 5 45 APPENDICE 1: CALCOLO DI EDIFICI SEMPLICI IN MURATURA PORTANTE YTONG SCOPO Lo scopo della relazione seguente, è quello di mostrare il metodo di verifica e di redazione della relazione di calcolo, nel caso si debba realizzare un edificio in muratura portante che possa definirsi semplice ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008. Allo scopo di rendere più agevole il controllo delle prescrizioni per poter classificare un edificio come semplice, si propone qui sotto uno schema per orientarsi al fine di detta classificazione. 46 ESEMPIO DI RELAZIONE DI CALCOLO Descrizione generale dell’edi- sottotetto) con copertura lignea ficio e tipologia strutturale a due falde spioventi. L’edificio unifamiliare ha pianta Fanno parte dello stesso edificio 5.4 CARATTERISTICHE DEL SITO rettangolare e due piani fuori alcune terra con scala interna e costi- come pensiline o tettoie di vario L’edificio costruendo sarà situa- tuisce un unico organismo genere realizzate comunque in to in Comune di Paganica (AQ). strutturale. Le strutture di fon- struttura leggera e considerate Quota della località s.l.m. dazione sono di tipo continuo a disgiunte dall’edficio in esame. 575 m trave rovescia. Le strutture in La tipologia strutturale è quella Classificazione sismica zona 2 elevazione presentano due solai in muratura portante ordinaria. n n strutture secondarie (solaio del primo piano e solaio Pianta piano terra Pianta piano primo Prospetti CAPITOLO 5 47 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA CLASSIFI C MURATURA ORDINARIA E ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, PRESCRIZIONI E CRITERI PER LA VE ULTERIORI PR SÌ L’edificio è in ZONA SISMICA? ? NO L’EDIFICIO IN ZON A NO - È SEMP LICE Non servono ulte riori A.1 Struttura tridimensionale a funzionamento scatolare N/(0.65A) fk/γm B.7 SÌ A.2 Pannelli murari resistenti a forse orizzontali solo se la lunghezza è superiore a 0.3 volte l'altezza di interpiano (per quanto possibile le pareti devono sempre assolvere sia la funzione portante che quella di controventamento) SÌ SÌ A.3 Muri e solai opportunamento collegati tra loro (cordoli di piano e ammorsamenti tra pareti) SÌ A.4 Spessore minimo della muratura 20 cm SÌ RISPETTO DEI CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE PER EDIFICI IN ZONA NON SISMICA B. Verifiche alle tensioni ammissibili - rif. NTC08 cap. 4.5.6.4 A. Organizzazione strutturale - rif. NTC08 cap. 4.5.4 SÌ NO SÌ Carico variabile dei solai 3.00 kN/m2 B.6 NO SÌ Snellezza massima della muratura λ 12 B.5 NO L’EDIFI CIO - NON È SE MPL AI SENSI DE LLE SÌ d) pianta compatta: b/h 1/3 NO SÌ c) numero di piani fuoriterra 3 È NECESSARIO ESE IL CALCOLO ESP NO SÌ b) altezza massima di interpiano 3.50 m NO SÌ a) Pareti strutturali continue dalla fondazione in sommità NO L’EDIFICIO IN ZON A NO - È SEMP LICE Non servono ulte riori NOTE DI APPROFONDIMENTO SU ULTERIORI CR IT NOTA 1. e 2. - REGOLARITÀ DEGLI EDIFICI (NTC08 - cap. 7.2.2) NOTA 1. a) Configurazione in pianta compatta e pseudo simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali in relazione alla distribuzione delle masse e delle rigidezze b) Nessuna dimensione di sporgenze e rientri supera il 25% della dimensione nella corrispondente direzione c) Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano (ipotesi di funzionamento dei solai a diaframma) 48 SÌ RISPETTO REGOLARITÀ IN PIANTA 2.A Tutti i sistemi resistenti verticali si estendono dalla fondazione in sommità 2.B Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente dalla base alla sommità (tra un orizzontamento e l’altro le masse non variano più del 25% le rigidezze non diminuiscono più del 30% e non aumentano più del 10%) Eventuali restringimenti della sezione orizzontale avvengono in modo graduale da un orizzontamento al successivo: ad ogni orizzontamento il rientro 2.C non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento né il 20% della dimensione dell’orizzontamento sottostante SÌ FI CAZIONE DELL’EDIFICIO COME SEMPLICE A EDIFICIO SEMPLICE LA VERIFICA SEMPLIFICATA DI EDIFICI IN ZONA NON SISMICA E SISMICA ORI PRESCRIZIONI E CRITERI PER LA VERIFICA SEMPLIFICATA DI EDIFICI IN ZONA SISMICA ZON A NON SISMICA EMP LICE ulte riori verifiche! L’edificio è regolare in pianta NOTA 1. NO L’edificio è regolare in alzato NOTA 2. D.1 SÌ D.2 SÌ NO IFI CIO SE MPLICE DE LLE NTC08 Nelle 2 direzioni ci sono sistemi di pareti di lunghezza complessiva pari al 50% della dim. della costruzione nella medesima direzione, con una distanza minima misurata ortogonalmente al loro sviluppo longitud. pari al 75% della dim. della costruzione nella medesima direzione D.3 SÌ NO ARIO ESEGUIRE LO ESPLICITO D.4 Almeno il 75% dei carichi verticali è portato da pareti che fanno parte del sistema resistente alle forze orizzontali SÌ NO D.5 In entrambe le direzioni sono presenti pareti resistenti a forze orizzontali con distanza non superiore a 7 m NO D.6 Sono rispettati, per ciascun piano, i rapporti tra area della sezione di muratura resistente alle forze orizzontali e superficie lorda dell’edificio in pianta di cui alla tab.7.8.III in funzione del numero di piani e dell’accelerazione di picco del terreno agS NO D.7 N/(0.25A) fk/γm SÌ SÌ C.1 Assenza di pareti in falso SÌ C.2 Orizzontamenti non spingenti o dotati di opportuni dispositivi atti all’assorbimento delle spinte orizzontali SÌ C.3 Spessore minimo della muratura 24 cm SÌ SÌ C.4 Rapporto min. tra lunghezza parete e altezza delle aperture adiacenti (l/h’)min = 0.4 SÌ C.5 Rispetto delle regole di dettaglio NOTA 3. SÌ RISPETTO DEI CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, DEI REQUISITI GEOMETRICI E DELLE REGOLE DI DETTAGLIO PER EDIFICI IN ZONA SISMICA SÌ ZON A NON SISMICA EMP LICE ulte riori verifiche! SÌ C. Criteri di progetto e requisiti geometrici - rif. NTC08 cap. 7.8.1.4 NO D. Edificio semplice in zona sismica (zone 2-3-4) - rif. NTC08 cap. 7.8.1.9 SÌ EDIFICIO VERIFICATO secondo 4.5.6.4 e 7.8.1.9 R ITERI GENERALI PER EDIFICI IN ZONA SISMICA 2) SÌ NOTA 3. - REGOLE DI DETTAGLIO (NTC08 - cap. 7.8.5.1) NOTA 2. 3.A RISPETTO REGOLARITÀ IN ALZATO Cordoli di altezza minima pari a quella del solaio e larghezza pari almeno a quella del muro meno, al massimo, 6 cm dal filo esterno b) Armatura corrente dei cordoli non inferiore a 8 cm2 con staffe di diametro minimo di 6 mm ed interasse non superiore ai 25 cm NOTA 3. SÌ RISPETTO DELLE REGOLE DI DETTAGLIO c) In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono presenti zone di parete piena di lunghezza non inferiore a 1 m compreso lo spessore del muro trasversale d) Presenza, al di sopra di ogni apertura, di un architrave resistente a flessione CAPITOLO 5 49 5.5 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 5.5.1 Prestazioni di progetto, vita utile e procedure di qualità re per quanto riguarda materialavorazione, metodi costruttivi. 5.5.3 Valutazione di sicurezza e basi di calcolo dell’azione sismica Saranno seguiti tutti gli indero- L’analisi dell’azione sismica si gabili previsti basa sulla classificazione del Le prestazioni della struttura e nelle “Norme Tecniche per le tipo di costruzione che ricade le condizioni per la sua sicurez- Costruzioni”. nella Classe 2: Opere ordinarie, li, componenti, suggerimenti za sono state individuate comu- ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o committente. A tal fine è stata 5.5.2 Valutazione di sicurezza delle strutture posta attenzione al tipo della Il criterio adottato per il calcolo quali è prevista una vita nomina- struttura, al suo uso e alle pos- delle sollecitazioni e le verifiche le Vk 50 anni, mentre la tipolo- sibili conseguenze di azioni è quello semiprobabilistico agli gia è di classe d’uso II a cui cor- anche accidentali; particolare stati limite basato sull’impiego risponde un coefficiente d’uso rilievo è stato dato alla sicurezza parziale dei coefficienti di sicu- CU = 1,0. Pertanto l’azione sismi- delle persone. rezza (metodo di primo livello). ca è valutata in relazione al Altrettanta cura è stata posta Secondo tale impostazione la periodo di riferimento definito per garantire la durabilità della sicurezza strutturale è verificata come: VR =VN*CU = 50 anni. struttura, con la consapevolezza tramite il confronto tra il frattile Per lo sviluppo del presente che tutte le prestazioni attese inferiore delle resistenze e le esempio di calcolo si è scelto di potranno essere adeguatamen- sollectitazioni corrispondenti al adottare, ad efficace termine di te realizzate solo mediante frattile delle azioni che minimiz- paragone, come zona di riferi- opportune procedure da seguire za la sicurezza, dopo aver mento un centro abitato forte- non solo in fase di progettazio- opportunamente ridotto le resi- mente investito dal sisma che ne, ma anche di costruzione, stenze e amplificato le azioni ha colpito l’aquilano. manutenzione e gestione dell’o- portandole ai valori ‘di calcolo’ A questo proposito si simula una pera. Per quanto riguarda la tramite l’applicazione dei corri- progettazione nel centro abitato durabilità si sono presi tutti gli spondenti coefficienti parziali: di nemente dal progettista e dal verifica della sicurezza: Rd Ed che e dinamiche dei materiali e 50 Paganica frazione Comune de L’Aquila. accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisi- di importanza normale per le delle strutture, in considerazio- Nel dettaglio i dimensionamen- ne dell’ambiente in cui l’opera to e le verifiche anche in consi- dovrà vivere e dei cicli di carico a derazione del fatto che l’edificio cui sarà sottoposta. La qualità ricade in una zona sismica clas- dei materiali e le dimensioni sificata come zona 2, previo con- degli elementi sono coerenti con trollo di tutti i requisiti previsti tali obiettivi. dalle norme vigenti, saranno In fase di costruzione saranno svolti con i criteri previsti per gli attuate severe procedure di con- ‘edifici semplici’ dalle suddette trollo sulla qualità, in particola- norme. del Comune: L’Aquila Località: Paganica Latitudine di riferimento: 42,359710 Longitudine di riferimento: 13,470361 Zona sismica (Macrozonizzazione): 2 CAPITOLO 5 51 Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento Valori dei parametri aq, Fo, Tc per i periodi di ritorno TR di riferimento TR [anni] ag [g] Fo [-] Tc [s] 30 0,079 2,394 0,273 50 0,104 2,330 0,282 72 0,123 2,316 0,290 101 0,142 2,301 0,297 140 0,164 2,300 0,310 201 0,191 2,316 0,318 475 0,261 2,365 0,347 975 0,334 2,401 0,364 2475 0,4652 2,458 0,384 Gli stati limite che si definiscono con la rispettiva probabilità di superamento per la valutazione dell’azione sismica sono: Probabilità di superamento nella vita utile del fabbricato PVR STATO LIMITE TR = -VR ln(1-PVR) SLO - Stato limite di Operatività 81% SLD - Stato limite di Danno 63% 50 anni SLV - Stato limite di Salvaguardia della Vita 10% 475 anni SLC - Stato limite di Collasso 5% 975 anni 30 anni verifica di sicurezza dell’edificio 5.5.4 Caratterizzazione sismica del sottosuolo assunti sono quelli relativi agli Per la caratterizzazione del sot- edifici semplici, pertanto il livel- tosuolo, dalla relazione geologi- lo di sicurezza atteso per la ca e geologico-tecnica, viene struttura anche dal punto di attribuita categoria B. Come anticipato, i criteri per la vista sismico si ritiene implicitamente soddisfatto all’esito positivo della verifica. 52 Periodo di ritorno del sisma 5.6 AZIONI SULLE STRUTTURE 5.6.1 Pesi strutturali (PPk) Calcestruzzo armato 2,50 kN/m3 Pannello solaio YTONG sp. 20 cm con cappa in c.a. sp. 5 cm 2,70 kN/m2 Soletta rampante scala sp. 12 cm 3,00 kN/m2 Muratura sp. 36,5 cm 2,46 kN/m2 Muratura sp. 30 cm 2.02 kN/m2 Copertura in orditura lignea 0,70 kN/m2 Permanente residenza 2,5 kN/m2 Permanente sottotetto 1,0 kN/m2 Permanente copertura 0,8 kN/m2 Permanente scale 0,8 kN/m2 Accidentale categoria A: residenza 2,00 kN/m2 Accidentale categoria H: sottotetto accessibile per manutenzione 0,50 kN/m2 Accidentale categoria C2: balconi ballatoi e scale comuni 4,00 kN/m2 5.6.2 Azioni permanenti (Gk) 5.6.3 Azioni accidentali (Qk) 5.6.4 Azione del vento (Qvk) Zona 3 Altezza sul livello del mare as = 575 m Velocità di riferimento del vento vb 28.5 m/s Densità dell’aria ρ 1,25 kg/m3 Classe di rugosità B Categoria di esposizione IV Coefficiente kr 0,22 Altezza di riferimento z0 0,3 m Altezza minima zmin 8m Pressione cinetica di riferimento qb = ρ vb /2 507 N/m2 Coefficiente di topografia ct 1,00 2 2 Coefficiente di esposizione ce = kr ctln(zmin/z0)*[7+ln(zmin/z0)] 1,63 Coefficiente dinamico cd 1,00 CAPITOLO 5 53 Coefficiente di forma vento in pressione cpp 0,80 Coefficiente forma vento in depressione cpd -0,40 Carico vento in pressione vp 0,66 kN/m2 Carico vento in depressione vd -0,34 kN/m2 5.6.5 Azione della neve (Qsk) Zona I II Altezza sul livello del mare as = 575 m Topografia Normale 2 Carico neve al suolo caratteristico qsk = 0.51[1+(as/481) ] 1,24 kN/m2 Inclinazione della falda rispetto all’orizzontale α 19° 30° Tipo di copertura piana o a falda singola Coefficienti di forma copertura μ1 = μ2 0.80 Coefficiente di esposizione ce 1,0 Coefficiente termico ct 1,0 Carico neve copertura a falde qs = qskμctce = 1,00 5.6.6 Azione sismica (SD) te accelerazione del terreno pari Sia assume come azione sismi- a 0.261 g. Considerando inoltre, ca quella relativa al sisma SLV che il terreno è classificato in che per le costruzioni con vita categoria B, si avrà che l’accele- utile ha tempo di rotorno di 475 razione di picco del terreno da anni e quindi una corrisponden- considerare è SD = SSag = 0.3g. Valori dei parametri aq, Fo, Tc per i periodi di ritorno TR di riferimento TR [anni] ag [g] Fo [-] Tc [s] 30 0,079 2,394 0,273 50 0,104 2,330 0,282 72 0,123 2,316 0,290 101 0,142 2,301 0,297 140 0,164 2,300 0,310 201 0,191 2,316 0,318 475 0,261 2,365 0,347 975 0,334 2,401 0,364 2475 0,4652 2,458 0,384 In cui: SS = 1,00 1.4 – 0.4*F0*ag/g 1.2 = 1.15 54 kN/m2 5.7 CRITERI DI CALCOLO: MODALITÀ DI ANALISI SOLUZIONE E VERIFICA decomposizione. Potranno muratura portante è consentito, 5.8 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 5.8.1 Materiali e materie prime da impiegare e criteri di esecuzione qualora siano presenti tutti i A Calcestruzzo in c.a. in gene- la lavorabilità necessaria. requisiti definiti per la classifica- re eseguito secondo la UNI zione dell’edificio come sempli- ENV 13670-1:2001, ottenuto 425 conforme alla UNI EN ce, svolgere la verifica in manie- per impasto di: 197-1 nella dose necessaria aggregati di idonea granulo- ad ottenere la resistenza La verifica, quindi, consterà nella metria nelle proporzioni di caratteristica prescritta, dimostrazione del soddisfaci- mc 0.8 di ghiaia e mc 0.4 di mento dei requisiti geometrici e sabbia di provenienza fluviale di cloruri e solfati, nella di regolarità strutturale di cui: ben lavati e privi di materiali quantità necessaria per ren- In condizione statica, cap. organici e dere l’impasto omogeneo, 4.5.6.4 minerali nocivi potenzial- lavorabile ma non fluido e In condizione sismica, capp. mente reattivi agli alcali con- disaggregato conforme alla 7.2.2 – 7.8.1.4 – 7.8.1.9 formemente alle UNI EN UNI EN 1008, Per la tipologia strutturale in ra semplificata. n n n limo-argillosi essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento mantenendo n n cemento tipo Portland 325 o acqua dolce, limpida e priva additivi superfluidificanti con- In particolare, la verifica di resi- 12620 e UNI EN 8520-2 prov- stenza si svolgerà in maniera visti di marcatura CE. La semplificata tramite la valuta- sabbia deve essere viva, con zione del carico medio sulla grani assortiti in grossezza muratura: da 0 a 3 mm, non provenien- B Acciaio par c.a. in barre ad condizione statica: N f σ= 0,65 k essendo γM = 4.2 γ M A te da rocce in decomposizio- aderenza migliorata B450C o ne, scricchiolante alla mano, in fogli di rete elettrosaldata, pulita, priva di materie orga- non ossidato né corroso e condizione sismica: N f σ= 0,25 k essendo γM = 4.2 γM A niche, melmose, terrose e di privo di sostanze che possa- salsedine. La ghiaia deve no ridurre l’aderenza con il contenere elementi assortiti, conglomerato conforme a In cui N e A sono, rispettivamen- di dimensioni fino a 16 mm, UNI EN 10020, UNI EN 10021, te, il carico totale alla base della resistenti e non gelivi, non UNI EN 10027 con marcatura muratura del piano in cui viene friabili, scevri di sostanze CE e sistema di attestazione svolta la verifica valutato asse- estranee, terra e salsedine. di conformità 2+; gnando ai relativi carichi i coeffi- Le ghiaie sporche vanno C Legno massiccio per orditu- cienti amplificativi unitari (γG = 1; accuratamente lavate. Anche ra secondaria copertura con- γQ = 1) e l’area resistente totale il pietrisco proveniente da forme a UNI EN 14080 e UNI della muratura al piano consi- rocce compatte, non gessose EN 386:2003 tipo C16 con derato. né gelive, dovrà essere privo marcatura CE; n formi alla UNI EN 934, n ceneri volanti conformi alla UNI EN 450; di impurità od elementi in CAPITOLO 5 55 D Blocchi per muratura per E Malta per muratura per uso uso strutturale in calcestruz- strutturale del tipo Preocol zo aerato autoclavato tipo o Ytocol conforme alla UNI YTONG Sismico con resisten- EN 998-2 e provvista di siste- za caratteristica fk superiore ma di attestazione di confor- 2 a 5 N/mm conformi alla UNI mità CE tipo 2+. EN 771 e provvisti di sistema di attestazione di conformità CE tipo 2+; 5.8.2 Condizioni ambientali (UNI EN 206:2006 e 11104:2004) Ambienti con umidità relativa bassa Ambiente poco aggressivo Umidità relativa strutture di fondazione RH = 80% Umidità relativa strutture in elevazione RH = 50% Condizioni ambientali ordinarie Classe di esposizione per strutture di fondazione XC2 Classe di esposizione per strutture in elevazione XC1 Armatura lenta (poco sensibile alla corrosione) 5.8.3 Classificazione, dosaggio e valori di calcolo del calcestruzzo (UNI 206:2006 e UNI 11104:2004) CLS per fondazioni ed elevazioni Classe C25/30 Cemento TIPO II 32,5 N/R Dosaggio di cemento 300 kg/mc d’impasto Rapporto A/C 0,65 Contenuto massimo di cloruri Cl 0,20% Dimensione nominale max degli aggregati 16 mm Consistenza cls per fondazioni S3 - semifluida Consistenza cls per elevazioni S4 - fluida Copriferro 3 cm 5.8.4 Valori assunti per il calcestruzzo per il calcolo 56 Resistenza cubica caratteristica a compressione Rck 300 daN/cm2 Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck 250 daN/cm2 Resistenza caratteristica a trazione fctk,0.05 18 daN/cm2 Resistenza caratteristica a trazione per flessione fcfk 22 daN/cm2 Modulo di elasticità secante Ecm 314470 daN/cm2 Resistenza a compressione di calcolo fcd 141 daN/cm2 Resistenza a taglio di calcolo τrd 2.9 daN/cm2 Deformazione massima a rottura per flessione εc 0.35% Deformazione massima a rottura per compressione εc 0.20% Deformazione massima a rottura per trazione εt 0.015% Resistenza a trazione limite εtEcm fcf 46 daN/cm2 5.8.5 Parametri meccanici della muratura (UNI EN 771-4, UNI-EN 998-2, UNI EN 771 e UNI EN 1996-1-1:2006) A Caratteristiche del blocco dichiarate dal produttore Tipologia Sismico Sistema di attestazione di conformità 2+ Categoria I Densità nominale ρ = 5,75 kN/m3 Densità di calcolo ρd = 6,75 kN/m3 Modulo di Elasticità E =2125 N/mm2 Resistenza caratteristica a compressione fb =5,02 N/mm2 B Caratteristiche della malta dichiarate dal produttore Tipologia Precol Sistema di attestazione di conformità 2+ Categoria Malta a prestazione garantita Classe M10 C Caratteristiche della muratura Tipologia muratura calcestruzzo aerato autoclavato Tipologia dei giunti di malta spessore compreso tra 3 e 5 mm Resistenza caratteristica a compressione della muratura (dichiarata) fk = 2,81 N/mm2 Resistenza caratteristica iniziale a taglio della muratura fvk0 = 0,30 N/mm2 Resistenza caratteristica a flessione fuori dal piano parallelamente ai giunti di malta fxk1 = 0,15 N/mm2 Resistenza caratteristica a flessione fuori dal piano ortogonalmente ai giunti di malta fxk1 = 0,30 N/mm2 Modulo di elasticità assiale E = 1000fk = 2810 N/mm2 Modulo di elasticità tangenziale G = 0,4E = 1124 N/mm2 Modulo di Poisson ν = E-2G/2G = 0,25 5.8.6 Caratteristiche dell’acciaio da c.a. (UNI EN 10080:2005) BARRE DI ACCIAIO CONTROLLATE IN STABILIMENTO Tipo B450C Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 N/mm2 Tensione caratteristica di rottura ftk 540 N/mm2 Allungamento Agtk 7% 1,25 Rapporto fy/fyk 1,15 e 1,35 (ft/fy)k 50 diametri Sovrapposizioni barre 5.8.7 Valori assunti per l’acciaio per il calcolo Tensione caratteristica di snervamento (rottura conv.) fyk 450 N/mm2 Tensione caratteristica di rottura convenzionale ftk 450 N/mm2 Resistenza di calcolo fyd 390 N/mm2 CAPITOLO 5 57 Modulo di elasticità Es 210000 Deformazione massima a snervamento εyd 0.2% Deformazione massima a rottura εys 1.0% N/mm2 RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI Tipo B450C Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 N/mm2 Tensione caratteristica di rottura ftk 540 N/mm2 Allungamento Agtk 7% Rapporto fy/fyk 1,25 1,15 e 1,35 (ft/fy)k Sovrapposizioni 2 maglie 5.9 VERIFICHE IN CONDIZIONE STATICA Classificazione dell’edificio come edificio semplice in muratura ordinaria (NTC08 – cap.4.5.6.4) A Pareti strutturali continue dalla fondazione alla sommità B Altezza massima d’interpiano 2.65 m 3,50 m C Numero di piani fuori terra 23 D Pianta compatta b/h = 8.49/11.42 = 0,74 1/3 E Snellezza massima della muratura 265/30 = 8.8 12 F Carico variabile dei solai civile abitazione e neve e copertura non praticabile 3,00 kN A favore di sicurezza, si considerano efficaci in termini di area di muratura resistente solo la pareti continue dalla fondazione in copertura: Sovrapposizione delle piante della muratura del piano terra (rosso) e del piano primo (blu) e schema resistente dei setti continui da fondazione in sommità 58 Caratteristiche Geometriche Superficie in pianta residenza 91 m2 Superficie in pianta sottotetto 97 m2 Superficie in pianta copertura 134 m2 Superficie scale 6.2 m2 Lunghezza murature sp. 36 cm 38.4 m Lunghezza muratura sp. 30 cm 12.75 m Analisi dei Carichi Carico solaio residenza (PPk+Gk+Qk) 7.2 kN/m2 Carico solaio sottotetto (PPk+Gk+Qk) 4.2 kN/m2 Carico copertura (PPk+Gk+Qk) 2.5 kN/m2 Carico scale (PPk+Gk+Qk) 7.8 kN/m2 Murature sp. 36 cm 6.64 kN/m Muratura sp. 30 cm 5.45 kN/m Area totale di muratura alla base (A) 17.84 m2 N/0.65A Carico totale alla base piano terra (N1) Carico totale alla base piano primo (N2) 2137 kN 0.18 fk/γ m = 0.67 N/mm2 1109 kN 0.10 5.10 VERIFICHE IN CONDIZIONE SISMICA Criteri di progetto e requisiti geometrici per la muratura in zona sismica (NTC08 - cap.7.8.1.4) A Pareti strutturali continue dalla fondazione alla sommità B Altezza massima d’interpiano 2,70 m 5.00 m C Spessore minimo della muratura 30 cm 24 cm D Snellezza massima della muratura 8.80 12 Classificazione dell’edificio come regolare in pianta ed in altezza (NTC08 - cap.7.2.2) A Configurazione in pianta compatta e simmetrica B Rapporto lati rettangolo circoscritto alla pianta 1.35 4 C Limitazioni su rientri e sporgenze non ci sono rientri superiori al 25% della dimensione in pianta CAPITOLO 5 59 D Orizzontamenti considerabili infinitamente rigidi ipotesi soddisfatta poiché il solaio è realizzato con pannelli prefabbricati YTONG con cappa collaborante dello spessore di 5 cm E Sistemi resistenti verticali continui in altezza condizione soddisfatta Fasce murarie continue da fondazione in sommità F Massa e rigidezza costante o G Graduale restringimento del- variabile gradualmente la sezione orizzontale non c’è una sostanziale non ci sono restringimenti variazione di massa e rigi- della pianta in alzato dezza in alzato Classificazione dell’edificio come regolare in pianta ed in altezza (NTC08 – cap.7.8.1.9): prescrizioni aggiuntive per la zona sismica Definizione dei maschi murari Direzione x: A Presenza di due sistemi di sistemi di pareti: 3 pareti resistenti di lunghez- L= 17.3 m lx/2 = 4.25 m za complessiva 60 non inferiore al 50% della Direzione y: dimensione in pianta del sistemi di pareti: 3 fabbricato: L= 25.7 m ly/2 = 5.71 m B Distanza tra i due sistemi di C Almeno il 75% dei carichi è E Distanza massima tra i siste- pareti in direzione ortogona- portato da pareti resistenti al mi di pareti resistenti: 5.5 m le alle pareti stesse non infe- sisma: 7,00 m (per muratura ordi- riore al 75% della dimensio- Tutte le pareti sono da consi- naria) ne in pianta nella medesima derarsi resistenti alle forze direzione: orizzontali in quanto la lun- Condizione soddisfatta in ghezza minima delle pareti in quanto i sistemi di pareti più pianta è 1.1 m e l’apertura distante hanno distanza equi- adiacente misura 2.40 m per- valente alla dimensione in tanto pianta in direzione ortogona- l/h’ = 1.1/2.4 = 0.46 0.4 F Percentuale di area di muratura resistente le allo sviluppo delle pareti. L (m) Pareti sp. 36 dir. x 13.22 Pareti sp. 30 dir. x 3.67 Rapporto geometrico area resistente Pareti sp. 36 dir. y 15.52 Pareti sp. 30 dir. y 9.08 Rapporto geometrico area resistente Ax = 5.86 m2 Ax/Ap = 6.04% Ay = 8.31 m2 Ay/Ap = 8.57% Considerando che l’accelerazio- tabella seguente riportata nella ma di muratura resistente in fun- ne di picco del terreno clacolata normativa di riferimento, che la zione dell’accelerazione di picco in 1.3.5 è 0.30g si ha, secondo la condizione di percentuale mini- attesa del terreno è soddisfatta. Accelerazione di picco del terreno ag·S Tipo di struttura Muratura ordinaria Muratura armata (1) Numero piani 0,07 g 0,1 g 0,15 g 0,20 g 0,25 g 0,30 g 0,35 g 0,40 g 0,45 g 0,4725 g 1 3,5% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,5% 2 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% 3 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 1 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 2 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 3 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 4 4,0% 4,5% 4,5% 5,0% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,5% 6,5% ST si applica solo nel caso di strutture di Classe d’uso III e IV (v. § 2.4.2). Tabella 7.8.III - Area pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale per costruzioni semplici. CAPITOLO 5 61 G Valutazione del carico medio sulla muratura Caratteristiche Geometriche Superficie in pianta residenza 91 m2 Superficie in pianta sottotetto 97 m2 Superficie in pianta copertura 134 m2 Superficie scale 6.2 m2 Lunghezza murature sp. 36 cm 38.4 m Lunghezza muratura sp. 30 cm 12.75 m Analisi dei Carichi Carico solaio residenza (PPk+Gk+Qk) 7.2 kN/m2 Carico solaio sottotetto (PPk+Gk+Qk) 4.5 kN/m2 Carico copertura (PPk+Gk+Qk) 2.6 kN/m2 Carico scale (PPk+Gk+Qk) 7.8 kN/m2 Murature sp. 36 cm 6.64 kN/m Muratura sp. 30 cm 5.45 kN/m Area totale di muratura alla base (A) 17.84 m2 N/0.25A Carico totale alla base piano terra (N1) Carico totale alla base piano primo (N2) kN 0.48 fk/γ m = 0.67 N/mm2 1109 kN 0.10 Sono inoltre verificate le pre- di 1 m delle pareti d’angolo in scrizioni delle regole di dettaglio corrispondenza degli incroci. riguardanti la lunghezza minima 62 2137 6. INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE MURATURA PORTANTE MEDIANTE L’USO DI SOFTWARE DI CALCOLO 14 gennaio 2008, in quanto 2 Identificazione dei vari compo- caratterizzata da una configura- nenti strutturali, primari (pare- 6.1. MODELLAZIONE FEM CON ELEMENTI BIDIMENSIONALI (SHELL/PLATE) O MONODIMENSIONALI (BEAM): QUALE SCEGLIERE? zione ti, pilastri, archi) secondari La modellazione ad elementi (orizzontamenti, coperture) finiti di una struttura in muratu- 3 Schematizzazione della strut- ra può essere condotta utiliz- Vediamo invece come ci si deve L’analisi strutturale dell’edificio comportare se l’edificio da pro- in muratura è caratterizzata dai gettare non può essere verifica- seguenti punti: to attraverso i metodi semplifi- 1 Definizione dell’oggetto di stu- cati di calcolo proposti dal DM geometrico-costruttiva non riconducibile alla definizione di “edificio semplice”. dio: edificio nuovo o esistente tura portante Una volta eseguito il controllo relativo ai parametri geometrici 4 Definizione delle azioni di progetto zando differenti tipologie di elementi finti a cui corrispondono diversi livelli di raffinatezza del e di rigidezza dell’edificio, nel 5 Analisi strutturale, per la modello e diversi gradi di com- caso alcuni dei requisiti richiesti determinazione delle solleci- plessità computazionale. Le due dalle NTC non vengano soddi- tazioni macrocategorie di elementi fini- sfatti, o non è possibile interve- 6 Verifiche di sicurezza ti utilizzabili sono: nire su di essi per riportarli in 7 In caso di verifica insufficien- n una condizione di edificio sem- te, si procede: per i nuovi edi- tipo shell o plate che costitui- plice, è possibile procedere con fici, con la riprogettazione scono una modellazione più una metodologia più complessa, parziale o totale; per gli edi- raffinata e geometricamente basata sulle diverse teorie del fici esistenti, con lo studio attinente all’edificio reale ma comportamento degli edifici in dell’intervento di ristruttura- in cui spesso alla complessi- muratura soggetti ad azioni di zione e consolidamento. tà operativa e computaziona- gli elementi bidimensionali le non corrisponde un benefi- tipo sismico, che può essere però facilmente risolta attraver- Nel caso questa procedura cio in termini di informazioni so dei software di calcolo. venga applicata ad un software restituite; di calcolo il compito del proget- n elementi monodimensionali Essi, grazie ad un’implementa- tista è quello di controllare che tipo beam con i quali si può zione grafica della struttura e tutti i dati inseriti nel software impiegare una modellazione quindi ad una semplice model- siano corretti ed ovviamente a “telaio equivalente”, che lazione della geometria e dei eseguire delle verifiche manuali schematizza maggiormente materiali, permettono, attraver- per valutare la veridicità e l’affi- la struttura consentendo l’e- so degli algoritmi prestabiliti, la dabilità dei risultati ottenuti con secuzioni di analisi più sem- risoluzione veloce di edifici l’elaboratore. plici e snelle che, tuttavia, anche molto complessi. spesso sono in grado di cogliere efficacemente il CAPITOLO 6 63 comportamento strutturale. materiale e della non resistenza Pertanto un modello ad elemen- Questo secondo caso, soprat- a trazione, caratteristiche di ti bidimensionali è più sensibile tutto per la progettazione di analisi molto più agevolmente agli errori di modellazione e può edifici nuovi, rappresenta implementate nel modello sem- risentire di una eccessiva gros- sicuramente la metodologia plificato a telaio. solanità della mesh o, addirittu- consigliabile, in quanto per- Se il fabbricato è sufficiente- ra, di elementi finiti con propor- mette di raggiungere un’alta mente regolare la maggiore zioni troppo difformi (elementi affidabilità dei risultati sep- complessità triangolari, rettangolari a forma pur non spingendosi in anali- non trova corrispondenza in una si di modelli con un elevato maggiore precisione dei risulta- numero di nodi, e quindi di ti. A riprova di ciò si osserva che, Per tutta questa serie di motivi, gradi di libertà, come quelli se la geometria dei maschi il modello a telaio equivalente è ad elementi finiti bidimensio- murari e i dettagli costruttivi visto nali, o addirittura abbandona- impiegati e la tipologia e la dis- dalle più recenti indicazioni nor- re le analisi di tipo lineare tribuzione dei carichi (piano rigi- mative, e può costituire una (modale o statica equivalente) do, incatenamento ai piani, cari- base importante per la defini- per affidarsi ad analisi di tipo chi concentrati importanti ecc..) zione di un metodo comprensi- non lineare (push-over). non sono tali da indurre rilevan- bile a pieno in ogni suo aspetto, ti sollecitazioni fuori dal piano inclusi i vari passi eseguiti Un edificio in muratura può delle murature o rilevanti picchi durante l’analisi non lineare. essere rappresentato da un locali di tensione normale o, insieme di elementi finiti mono- ancora, rilevanti azioni torcenti dimensionali verticali e orizzon- sul singolo maschio, le pareti tali. Viene così a costituirsi un saranno sollecitati da azioni reticolo ad elementi finiti, in normali, flettenti e taglianti che 6.2. PROCEDURA DI CALCOLO ATTRAVERSO SOFTWARE 6.2.1. Dati di input modo del tutto analogo alla si possono considerare uniformi Il primo passo nella modellazio- schematizzazione dei telai in sulla sezione. Ecco dunque che ne di una struttura attraverso acciaio o in cemento armato con il metodo di schematizzazione a software di calcolo è quello di l’accorgimento telaio equivalente restituisce lo definire gli elementi resistenti delle stato di sollecitazione di ciascun dell’edificio, ossia gli elementi dimensioni geometriche di tali elemento strutturale (maschi caratterizzati da geometrie e elementi alcune murari e fasce piene) tramite i rigidezze tali da resistente alle semplici regole ampiamente parametri della sollecitazione azioni verticali ed orizzontali sia disponibili in letteratura. N,M,T noti dalla scienza delle in condizioni statiche che in con- Vi sono numerosi vantaggi nel- costruzioni, facilmente interpre- dizioni sismiche, e soprattutto l’adozione del metodo con ele- tabili e gestibili nelle verifiche individuare i parametri che menti monodimensionali, cosid- della sezione. caratterizzano i materiali. detto a “telaio equivalente”: è Si tenga in considerazione, inol- pur vero che la muratura è for- tre, che la funzione di forma uti- Solitamente, nella maggior parte mata da strutture a sviluppo lizzata dai software per la deter- dei software disponibili in com- superficiale, ma la modellazio- minazione degli spostamenti e, mercio, l’inserimento della geo- ne bidimensionale è molto quindi delle sollecitazioni, su metria dell’edificio è possibile impegnativa dal punto computa- ciascun elemento finito, nel tramite l’importazione di disegni zionale e richiede algoritmi ad caso degli elementi tipo beam è CAD, che permettono la succes- elementi finiti in grado di tener esatta, nel caso degli elementi siva modellazione (manuale o conto della non linearità del bidimensionali è approssimata. automatica) dei setti murari, ed nella 64 di utilizzare, determinazione strutturali, computazionale molto allungata ecc.). favorevolmente anche ottenere una struttura tridimen- nelle analisi lineari di edifici in modellate come diaframmi sionale, facilmente modificabile. muratura è preferibile utiliz- rigidi, dovrebbero prevedere zare rigidezze fessurate (§ una cappa collaborante in La procedura per l’inserimento 7.8.1.5.2) da assumere pari al c.a., o se non è fattibile, dei dei dati di input consiste nelle 50% delle rigidezze elastiche controventi di falda attraverso seguenti operazioni: (questo non vale per analisi bande metalliche, oppure in 1 Rilevare le reali strutture non lineari). alternativa un doppio assito portanti: schematizzare effi- 3 Interpretare correttamente cacemente gli elementi strut- gli schemi statici che colgono turali discernendo tra quelli meglio il comportamento del- 6.2.2. Analisi dei carichi che si possono considerare l’edificio nel complesso e delle Il secondo passo è quello di defi- resistenti e quelli che devono sue parti: in base alle caratte- nire tutte le azione agenti sulla essere trascurati. ristiche di collegamento tra le struttura, al quale corrisponde- Ci possono essere infatti ele- strutture è possibile applicare ranno delle sollecitazioni sugli menti murari con dimensioni diversi gradi di vincolo ai nodi. elementi resistenti modellati. tali da non poter essere consi- Con riferimento al § 7.8.4 del È necessario valutare attenta- derati come portanti (ad D.M. 2008, l’azione sismica è mente i carichi associati alle esempio tramezzature affidata completamente alle strutture portanti (pareti, solai, interne o maschi con lun- pareti in muratura, quindi ele- coperture) e non portanti (tra- ghezza inferiore a 0.3 volte menti in c.a. (oppure muratu- mezzature, elementi secondari), l’altezza del pannello). In que- re meno significative che non alla destinazione d’uso dell’edifi- sta fase bisogna individuare, rispettano i requisiti geome- cio (da cui si ricavano i valori dei nelle murature ‘forate’, le trici per poter essere conside- carichi accidentali) e alle carat- pareti verticali effettivamente rate efficaci) possono essere teristiche del sito di costruzione resistenti (i maschi murari) e modellati come bielle in modo (da cui si ricavano le azioni del quelle che non offrono nessun da svolgere una funzione por- vento della neve e del sisma). contributo in termini di resi- tante solo nei confronti delle In questa fase è possibile fare stenza. Le pareti resistenti da azioni gravitazionali, ma non riferimento ai §§ 2 e 3 del DM e considerare saranno quindi offrire alcuna resistenza alle ai corrispettivi paragrafi della quelle continue dalla fonda- forze orizzontali. Poiché ai §§ Circolare 617/2009 per determi- zione alla sommità mentre 7.8.1.4 e 7.8.1.5.2 si richiede nare i carichi statici (accidentali, eventuali murature in falso che i solai siano abbastanza vento e neve) mentre per i cari- vengono conteggiate sola- rigidi da garantire un adegua- chi dinamici (azione sismica) è mente ai fini del calcolo della to funzionamento a diafram- possibile ricavare i valori di acce- massa. ma, in questa fase è quindi lerazione e i parametri per la necessario la definizione degli spettri di pro- murario tramite idonei para- maniera più semplice per getto attraverso il software gra- metri meccanici: in questo garantire la rigidezza dei solai tuito messo a disposizione sul caso i parametri da inserire orizzontali e valutare se siano sito del C.S.L.P. che può essere a nel modello possono essere in grado di ripartire le azioni volte integrato direttamente nel recuperati direttamente dalle orizzontali sui setti murari programma utilizzato. schede tecniche dei produtto- proporzionalmente alla loro ri dei materiali utilizzati o rigidezza. Ad esempio per le In questo modo è possibile defi- dalle normative correlate. coperture in legno, che di per nire dei “casi di carico elementa- Per quanto riguarda le rigi- sé non hanno infinita rigidez- ri” che vengono implementati in dezze dei maschi murari, za nel piano, per essere “combinazioni di carico” attra- le 2 Caratterizzare il materiale individuare incrociato. CAPITOLO 6 65 verso specifici coefficienti di numero dei modi propri di de anche dopo l’insorgere del combinazione delle azioni ripor- vibrare di un sistema elastico primo collasso strutturale. tati nel § 2.5.3 del D.M., in fun- è uguale al numero dei gradi zione della verifica considerata di libertà del sistema stesso Tenere in considerazione la non (verifiche allo SLU e allo SLE). ed ad ogni modo è associabi- linearità del comportamento le un periodo di vibrazione ed strutturale significa, più in gene- 6.2.3. Metodo di analisi una massa partecipante. Lo rale, indagare come vari la rigi- Il terzo passo consiste nel defi- studio della dinamica della dezza della struttura e delle sue nire il metodo utilizzato per l’e- struttura elastica attraverso i parti al progredire del livello di secuzione delle analisi. suoi modi, prende il nome di danno, a cominciare dai fenome- Le analisi lineari costituiscono analisi modale. ni di prima fessurazione fino ad la prima classe di metodi utiliz- Le forze da applicare statica- arrivare alla progressiva perdita zati in ingegneria sismica e si mente alla struttura per delle caratteristiche meccaniche articolano in due tipi: analisi risolvere poi il sistema di del materiale per finire con il statica equivalente, ed analisi equilibrio, vengono calcolate comportamento post-picco. dinamica modale. considerando tutti i modi Ciò si ottiene con l’imposizione L’analisi statica equivalente significativi della struttura alla struttura di un percorso di prevede l’utilizzo di forze che stessa, cioè il primo modo e spostamento crescente. approssimano il primo modo tutti quelli successivi neces- All’aumentare dello spostamen- di vibrare, secondo una dis- sari per movimentare una to imposto la struttura reagirà tribuzione ‘triangolare’ che percentuale elevata (85%) inizialmente in maniera rigida e, associa ad ogni piano una delle masse. Definite le forze successivamente, con l’insorge- forza proporzionale alla loro ‘statiche’, da questo punto in re della fessurazione negli ele- massa inerziale. Le forze poi il procedimento di verifica menti strutturali, la rigidezza orizzontali vengono applicate è del tutto analoga alla diminuirà e con essa la forza all’edificio, ed il problema ‘sismica statica equivalente’. necessaria per progredire nel n matematico viene risolto, n fino alle sollecitazioni e alle Se però ci si confronta con situa- cedimento iterativo di analisi conseguenti verifiche. zioni particolari, ad esempio con consente quindi, di costruire un L’analisi dinamica modale strutture caratterizzate da geo- diagramma forza-spostamento con spettro di risposta, pre- metrie e modi di vibrare com- che prescinde dal livello di forza vede, prima della definizione plessi, o più semplicemente con sismica richiesta: costruita la delle forze orizzontali rap- edifici esistenti, può accadere curva, detta appunto curva di presentative che i metodi di analisi lineare, capacità, si potrà operare un di possono risultare eccessiva- confronto con l’azione sismica di un’analisi dei modi di vibrare mente cautelativi in alcuni casi. progetto in termini di sposta- della struttura. Se, dunque, c’è la necessità di mento. Le strutture che avranno Le oscillazioni libere di un eseguire una analisi più spinta si una capacità di spostamento sistema elastico lineare a più attinge a metodi di analisi non compatibile con la domanda di gradi di libertà si possono lineari (push-over) che sono in spostamento del sisma saranno considerare come la sovrap- grado di cogliere il comporta- quindi da considerarsi verificate. posizione di mento della struttura al progre- semplici’, ciascuna sismica, 66 percorso di spostamento. Il pro- dell’azione l’esecuzione ‘oscillazioni delle dire del livello di danno delle sue Bisogna sottolineare che le anali- quali corrisponde ad una ben parti e, quindi, tenere in conside- si non lineari nascono soprattut- determinata deformata razione tutte le riserve di resi- to per il calcolo di strutture esi- (forma modale o modo). Il stenza che una struttura possie- stenti, che non sono state edifica- te conformemente ai criteri delle spettri di risposta, prima in a condizione che l’equilibrio glo- moderne norme antisimiche, alle direzione X e poi in direzione bale di piano sia rispettato. quali non è possibile a priori attri- Y, considerando inoltre i Se anche in questo caso non si buire un fattore di struttura, e per momenti torcenti aggiuntivi; ottengono verifiche soddisfatte, cui è quindi necessario uno stu- 2 combinare i risultati ottenuti potrebbe essere utile in prima dio approfondito per simulare il per le due direzioni (con la battuta valutare la presenza di comportamento non lineare delle formula del 30%), ottenendo qualche anomalia o incongruen- murature, mentre per edifici di così i risultati sismici com- za dal punto di vista geometrico nuova costruzione resta uno stru- plessivi; o di rigidezza, e in quel caso mento aggiuntivo di conferma 3 combinare i risultati sismici procedere con una ridefinizione dei risultati ottenuti tramite le con i risultati statici, otte- del modello, altrimenti analiz- analisi lineari. nendo un inviluppo delle sol- zare la struttura con analisi più lecitazioni; raffinate che tengano conto 6.2.4. Verifiche di sicurezza 4 ottenute così per ogni parete degli effettivi modi propri di La prima verifica da eseguire, è muraria le sollecitazioni di vibrare simulando quindi un la verifica alle sollecitazioni calcolo comportamento più reale e derivanti da un’analisi statica taglio, momento), si sottopo- non sismica. ne la parete alle verifiche di Questa verifica, oltre a verificare resistenza allo SLU: la struttura dal punto di vista n PressoFlessione nel piano altro tipo di analisi sismica linea- statico, consente di valutare la n Taglio scorrimento/fessu- re: l’analisi dinamica modale. razione diagonale L’analisi PressoFlessione fuori dal modale consiste nel: piano 1 eseguire l’analisi modale distribuzione dei carichi gravanti sulla struttura e se la struttura si comporta in modo unifor- n (sforzo normale, meno approssimato. Si provi ora ad eseguire quindi un sismica dinamica me e simmetrico oppure risul- 5 si sottopone la struttura al della struttura: sono così tano concentrazioni di sforzi mal controllo degli spostamenti noti i periodi propri di vibra- distribuiti. (SLD). zione e le corrispondenti Verranno eseguite le seguenti verifiche di resistenza: deformate modali; Al termine dell’analisi, si pro- 2 risolvere la struttura sotto le n PressoFlessione nel piano pongono solitamente dei report azioni sismiche determinate n Taglio scorrimento/fessura- relativi alle verifiche eseguite, dall’analisi modale attraver- zione diagonale che sintetizzano i risultati ripor- so gli spettri di risposta PressoFlessione fuori dal tando i coefficienti di sicurezza, prima in direzione X e poi in piano pari al rapporto fra sollecitazio- direzione Y, considerando ne resistente e sollecitazione di inoltre i momenti torcenti calcolo. aggiuntivi; n Per iniziare lo studio del comportamento sismico della strut- 3 combinare i risultati ottenuti tura, si inizia dall’analisi lineare Se la prima analisi svolta, non per le due direzioni (con la condotta con il valore di ‘q’ pro- porta a risultati soddisfacenti, è formula del 30%) ottenendo posto dalla Normativa al § possibile solitamente eseguire così i risultati sismici com- 7.8.1.3. una ridistribuzione del taglio plessivi; sui setti murari, secondo le 4 combinare i risultati sismici L’analisi sismica statica lineare regole riportate al § 7.8.1.5.2, in con i risultati statici, otte- consiste nel: cui le sollecitazioni taglianti nei nendo un inviluppo delle sol- 1 risolvere la struttura sotto le diversi pannelli di uno stesso lecitazioni; azioni sismiche attraverso gli piano possono essere ridefinite, 5 ottenute così per ogni parete CAPITOLO 6 67 muraria le sollecitazioni di modo significativo i risultati otte- stente: prima di spingersi all’ul- calcolo normale, nuti dalla statica lineare in quan- tima categoria di analisi non taglio, momento), si sottopo- to restano condizionate dall’ap- lineari, si consiglia un percorso ne la parete alle verifiche di proccio puramente elastico, ma di controllo della modellazione e resistenza: combinando gli effetti legati ai di un’eventuale ridefinizione dei PressoFlessione modi di vibrare anche oltre il dati di input geometrici, affinché Complanare primo, produce risultati più si possa garantire un comporta- Taglio scorrimento/fessu- accurati per strutture poco rego- mento il più possibile riconduci- razione diagonale lari, per le quali il comportamen- bile alle definizioni di regolarità, PressoFlessione to dinamico non è ben descritto e quindi facilitare l’esito positivo Ortogonale dal primo modo di vibrare. delle verifiche. n n n (sforzo 6 si sottopone la struttura al controllo degli spostamenti Se l’esito delle analisi lineari (SLD). dovesse risultare negativo, questo potrebbe rappresentare un 68 Rispetto all’analisi sismica stati- primo campanello di allarme, e ca lineare, le verifiche condotte e potrebbe significare la presen- in analisi dinamica modale za qualche errore in fase di con- potrebbero non cambiare in cepimento della struttura resi- 6. APPENDICE 2: NORME DI RIFERIMENTO n UNI EN 678:1994: n n UNI EN 1991-1-1:2004: “EUROCODICE 1 – Azioni clavato (AAC) – Determina- opere murarie – Malte da sulle strutture. Parte 1-1 – zione della massa volumica a muratura”; Azioni in generale. Pesi per UNI EN 1015:2007: unità di volume, pesi propri e UNI EN 679:1994: “Metodi di prova per malte sovraccarichi per gli edifici”; “Calcestruzzo aerato auto- per opere murarie”; n n UNI EN 1992-1-1:2005: UNI EN 1052:2007: “EUROCODICE 2 - Progetta- zione della resistenza a com- “Metodi di prova per mura- zione delle strutture in calce- pressione”; tura”; struzzo. Parte 1-1 - Regole ge- UNI EN 1351:1998: nerali e regole per gli edifici”; UNI EN 680:1994: n n “Calcestruzzo aerato auto- “Calcestruzzo aerato auto- clavato (AAC) – Determina- clavato(AAC) – Determina- “EUROCODICE 6 - Progetta- zione del ritiro da essicca- zione della resistenza a fles- zione delle strutturedi mura- mento”; sione”; tura. Parte 1-1 Regole gene- UNI EN 1352:1998: rali e regole per strutture di “Specifica per elementi per “Calcestruzzo aerato auto- muratura armata e non muratura – Elementi di mu- clavato (AAC) o calcestruzzo armata”. ratura di calcestruzzo aerato alleggerito autoclavato”; aperta (LAC) – Determina- UNI EN 772:2004: zione del modulo di elasticità “Metodi di prova per gli ele- statico a compressione”; UNI EN 771-4:2005: menti di muratura”; n n “Specifiche per malte per clavato (AAC) – Determina- n UNI EN 998-2:2004: “Calcestruzzo aerato auto- secco”; n n n n con n UNI EN 1996-1-1:2006: struttura UNI EN 1353:1999: UNI EN 934-3: 2004: “Calcestruzzo aerato autocla- “Additivi per calcestruzzo, vato (AAC) – Determinazio- malta e malta per iniezione. ne del contenuto di umidità”; Additivi per malte per opere murarie. Parte 3: definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”; CAPITOLO 6 69 NOTE 70 NOTE EDITORE Xella Italia S.r.l. Via Amerigo Vespucci, 39 | 24050 Grassobbio (BG) Tel: +39 035 4522272 | Fax: +39 035 4233351 www.ytong.it | [email protected] IMPRESSUM Autore: Ing. Giacomo Cadelli HDeM Ingegneria S.r.l. Viale D’Annunzio, 8 | 33080 Roveredo in Piano (PN) Tel: +39 0434 94140 | Fax: +39 0434 949904 www.hdem.it | [email protected] Copyright Xella Italia S.r.l. e HDeM Ingegneria S.r.l. Alcune immagini sono tratte dalla pubblicazione “Ingegneria delle strutture” di Elio Giangreco edito da UTET. 2 71 Xella Italia S.r.l. Via Vespucci, 39 24050 Grassobbio (BG) Per informazioni: Numero Verde: 800 88 00 77 Fax Verde: 800 33 66 22 [email protected] Tel.: 035 452 22 72 Fax: 035 423 33 51 www.ytong.it [email protected] Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group. A4mmp/Gi&Gi/02/13/0000/1 NOTA: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni contenute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica delle costruzioni Ytong al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall’obbligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla data dell’acquisto o dell’utilizzo del materiali, nonché dall’obbligo del controllo statico, che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell’ambiente delle sostanze chimiche. Edizione 2013.1 YTONG Ytong - Sistemi in calcestruzzo aerato autoclavato EDIFICI IN MURATURA PORTANTE
Scarica