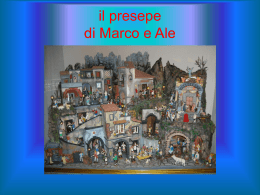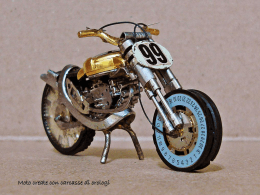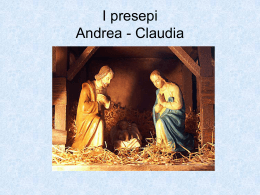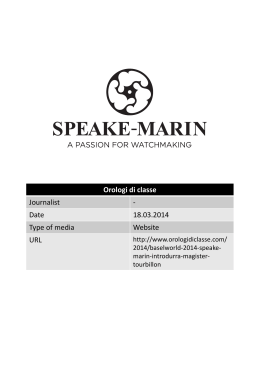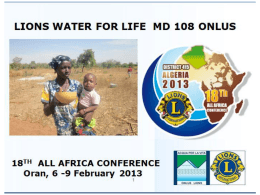Genova Insolita Genova Insolita è un’iniziativa organizzata dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale per il progetto Arte, Natura e Scienza del Comune di Genova e coinvolge le biblioteche e i musei presso cui le ragazze hanno prestato servizio durante l’anno 2014/2015. L’idea è nata con l’obiettivo di suggerire ai cittadini nove itinerari alla scoperta di mete inesplorate del territorio genovese, per valorizzare e promuovere il valore artistico, naturalistico e scientifico celato intorno ad ogni sede di progetto, punto di partenza di ciascun percorso. Armatevi quindi di scarpe comode e preparatevi a partire! Il percorso delle volontarie dei Servizi educativi e didattici del Settore musei Ciao! Siamo Francesca e Valentina. Dal momento che il nostro percorso di Servizio Civile si è svolto a stretto contatto con i bambini nell’ambito della didattica museale, abbiamo voluto proporre in linea con gli obiettivi del progetto due attività rivolte espressamente a questi e, invece, una sola traccia d’itinerario tematico. Pertanto, nelle pagine seguenti troverete: Natura: Tanti “cieli in una stanza” Scienza: “Tutto il tempo in una…mostra” Arte: Non solo a Natale: una traccia di itinerario tematico sul presepe genovese Buona visita! Percorso I – Natura Tanti “cieli in una stanza” Non vi è dubbio che il cielo faccia parte del nostro immaginario. Gli artisti ne hanno da sempre subito il fascino, si sono emozionati e hanno trasposto le loro sensazioni in colori tenui e saturi, sfumature e forme variegate. Ma c’è di più: i pittori di fatto, spesso, “fotografavano” i fenomeni atmosferici e ne registravano caratteristiche, dettagli, manifestazioni con estrema precisione. Difficile dire se dietro la rappresentazione di un fenomeno atmosferico vi fosse la piena consapevolezza del suo manifestarsi dal punto di vista scientifico. Ma cos’è il cielo? Il cielo è l'atmosfera della Terra vista dalla superficie. Ma perché ci appare blu? La luce solare è formata dalla sovrapposizione di onde elettromagnetiche di lunghezza diversa, che i nostri occhi percepiscono come violetto, blu, verde, giallo/arancione, rosso. La luce blu, avendo una lunghezza d’onda più breve, viene rifratta dalle piccole particelle degli strati più alti dell’atmosfera, e si diffonde in tutte le direzioni. In alta montagna il colore azzurro del cielo appare quindi più scuro a causa della minore densità dell’atmosfera; sulla Luna e su tutti i corpi celesti, dove l’atmosfera manca del tutto, il “cielo” è perennemente nero e le stelle visibili anche di giorno. E al tramonto? Quella calda sfumatura arancione che tanto ispirò poeti e artisti, deve la sua natura alla luce del sole, che, per raggiungere i nostri occhi, deve attraversare uno spessore maggiore di atmosfera rispetto a quando il sole è allo zenit (mezzogiorno): la luce blu viene diffusa meno in aria e contemporaneamente la luce rossa/arancione, di lunghezza d’onda maggiore si aggiunge alla diffusione espansa. Le nuvole invece appaiono bianche perché le particelle che le compongono hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle dell'aria; perciò rifrangendo tutti i diversi colori della luce nello stesso modo, ciò che risulta alla nostra visione è il bianco, inteso come somma delle componenti cromatiche. 2 Ma cosa sono le nuvole? Forse non tutti sanno che le nuvole, masse di minute particelle d'acqua condensata e/o cristalli di ghiaccio, sospese per galleggiamento nell'atmosfera e solitamente non a contatto con il suolo, assumono diverse forme e consistenze. L'aspetto generale di una nube è determinato dalla natura, grandezza, numero e distribuzione nello spazio delle suddette particelle, ma anche dall'intensità e dal colore della luce ricevuta, dalla sorgente di luce e, aspetto non secondario, dalla posizione relativa dell'osservatore. Ma come si formano le nuvole? Il riscaldamento solare stimola l'evaporazione dell'acqua presente sulla terra nei mari, nei laghi, nei fiumi e in ogni altro specchio d’acqua, generando la condensazione del vapore attorno ai nuclei di condensazione e di conseguenza la nuvola. Il fenomeno, per quanto complesso, si può sintetizzare così: L'irraggiamento solare aumenta la temperatura della superficie terrestre. Per conduzione termica il suolo caldo scalda anche l'aria a contatto con esso. L'aria calda, più leggera di quella fredda, tende a salire verso l’alto generando una corrente ascensionale e portando con sé l'umidità contenuta. Nel suo movimento ascendente, l'aria si raffredda e raggiunge il punto di saturazione del vapore. Questo grazie ai nuclei di condensazione si trasforma in minuscole goccioline di acqua che galleggiano nell'aria, e che formano, per l'appunto, le nubi. I nuclei di condensazione sono microparticelle di varia natura fortemente igroscopiche, cioè aventi affinità con l'acqua, che entrano in gioco nei processi di formazione, ovvero di condensazione, delle nubi in atmosfera. Se la temperatura è particolarmente bassa, queste si trasformano in microscopici cristalli di ghiaccio. Tipi di nubi Nubi a sviluppo orizzontale Cirri (1) Cirrostrati (3) Nubi medie Altostrati (5) Cirrocumuli (2) Altocumuli lenticolari Altocumuli (4) Nubi basse Stratocumuli (6) Strati (7) e nembostrati (8) Cumuli di bel tempo Cumuli (9) Nubi alte Nubi a sviluppo verticale Cumulonembo (10) 3 Per conoscere e distinguere le diverse tipologie di nuvola, nel XIX secolo è stato elaborato un sistema di classificazione, basato fondamentalmente sull’altitudine che queste masse di particelle raggiungono rispetto alla superficie terrestre, sulla loro consistenza e sulla forma. Occhio ai cieli dipinti I grandi maestri del passato hanno raffigurato le nuvole non in modo casuale, ma riprendendo esattamente le diverse tipologie definite dalla scienza! Il nostro breve percorso fra le opere delle Raccolte Frugone, attraversa paesaggi dipinti con uno sguardo particolare e attento ai cieli. Li guarderemo con lo stupore che sempre l’arte genera, ma anche con l’occhio analitico dello scienziato. La scoperta sarà un gioco divertente! Procediamo con una selezione di opere che allena il nostro sguardo e sarà facile successivamente proseguire affinando la capacità di contaminare arte e scienza. Ne Il mattino di Antonio Fontanesi, il cielo è protagonista. In una luminosa mattina di primavera, una pastorella siede tranquilla su una roccia, assorta nei suoi pensieri. Più della metà della tela risulta occupata, 4 se non dominata, da un limpido cielo azzurro, animato all’orizzonte da morbide nubi bianche. Il loro nome scientifico è Cirri: si tratta di nubi sottili e allungate, che appaiono come delicati filamenti o strette bande, la cui colorazione varia dal bianco al biancastro. Sono formate da cristalli di ghiaccio e risultano quindi trasparenti a causa della grande dispersione dei cristalli stessi; la luce del Sole attraversa i cirri quasi senza alcuna attenuazione e tale particolarità viene fedelmente resa da Fontanesi. Al limitare superiore della tela appare, affusolato dal vento, qualche Altocumulo. Queste nubi medie, composte di fiocchi globulari compatti estesi a tutto il cielo visibile, appaiono ben delineate e marcate rispetto ad un cielo sereno. Frequentemente l'altocumulo si presenta come una serie parallela di strisce compatte o formate da fiocchi allineati in ranghi dalla conformazione ondosa. In altri casi gli altocumuli si alternano ad altostrati, oppure a fenomeni nuvolosi di altitudine più elevata, quali cirrostrati. Al centro del dipinto, troneggia un Cumulo, una nube a piccolo o medio sviluppo verticale, che ha l’aspetto di una torretta o un cavolfiore, con una base e una sommità piatta o leggermente convessa, posta alla stessa altitudine dei cumuli presenti nelle sue vicinanze. La pennellata densa, veloce e materica, che Eugenio Gignous adotta per raffigurare Strada a Gignese mostra in maniera precisa e puntuale i cosiddetti Cirri di bel tempo, nubi che compaiono in situazioni di atmosfera stabile e si distinguono per la ristretta estensione, la struttura irregolare e il moto più lento. Al contrario, la comparsa di cirri in gran numero e disposti a bande in un cielo blu, annuncia generalmente l'arrivo di un fronte caldo entro 15 ore, accompagnato da precipitazioni spesso persistenti, oppure la fine di 5 un'attività temporalesca (in questo caso sono detti anche "falsi cirri"). Durante il crepuscolo spesso assumono una colorazione rosata o rossastra a causa della rifrazione che subisce la luce solare quando attraversa spessi strati di atmosfera. In Vegetazione ligure a Riomaggiore di Telemaco Signorini il mare azzurrissimo degrada verso il cielo all’orizzonte. Quest’ultimo è reso come un velo continuo, traslucido, che copre parzialmente il cielo con nubi chiamate Cirrostrati. Il loro spessore è molto limitato e il colore è normalmente biancastro e lattiginoso; talvolta è possibile intravedere una trama fibrosa. Nel caso in cui lo spessore sia ridotto ad un velo e la copertura si estenda a tutto il cielo visibile il cirrostrato risulta difficile da discernere, attenuando solamente il colore azzurro del cielo di giorno o rendendo lattiginoso il cielo di notte. Il cirrostrato si colora di tinte cangianti che variano dal giallo al rosso, durante e immediatamente prima dell'alba come del tramonto. In Marina a Venezia di Guglielmo Ciardi lo spazio è diviso orizzontalmente in due zone che creano due immagini pressoché speculari; così come il mare anche il cielo appare uniforme e costituito da un colore predominante, il grigio-argento, creando suggestivi effetti atmosferici. Quest’unità cromatica rende perfettamente lo sviluppo orizzontale dello Strato, una nube bassa e uniforme di colore variabile dal grigio chiaro fin quasi al bianco. A differenza dei nembostrati, lo strato può dare origine a piogge o nevicate ma molto deboli, ha un spessore minore, che spesso lascia trasparire la luce del Sole e della Luna, e una maggiore uniformità. 6 Osserviamo ora attentamente il paesaggio Torri a San Gimignano di Ferruccio Scattola. Accanto alle tre tipologie fondamentali di nubi (cirri, cumuli e strati) ben riconoscibili per forma e dimensione, è identificabile una variante ibrida, l’Altocumulo lenticolare. Caratterizzate da forma a lente, queste nubi sono spesso associate a onde orografiche (mountain waves), fenomeni che possono risultare molto pericolosi per il volo. Esse si generano quando una corrente d'aria incontra un rilievo o un sollevamento termico che devia verso l'alto il flusso. Questa deviazione è di solito invisibile ad occhio nudo, ma nelle giuste condizioni atmosferiche può venire evidenziata proprio dalla formazione di nubi lenticolari. Quali nubi annunciano il cattivo tempo? Quelle più vicine al livello del suolo, comunemente chiamate Strati e Cumuli; se le prime si sviluppano orizzontalmente coprendo vaste porzioni di cielo e creando quell’effetto di “cielo coperto”, ma piuttosto lattiginosa; le seconde sono più localizzate, ma proprio per il loro sviluppo verticale risultano molto più spesse e scure, e quindi portatrici di pioggia. In Monte Civetta di Francesco Sartorelli, troviamo Cumuli temporaleschi, che, come è tipico dell’ambiente montano, possono indicare un repentino cambiamento del tempo. 7 Nel Lago del Mucrone nel biellese, di Lorenzo Delleani splendida è la resa del riverbero luminoso che attraverso lo specchio d’acqua riflette la nuvola scura in alto a sinistra. Si tratta di un chiaro esempio di Cumulonembo, una nube a forte sviluppo verticale che si genera in condizioni di instabilità atmosferica. Vista a distanza si presenta come una torre che dalla base piatta e non molto alta dal suolo (mediamente intorno ai 2000 m alle nostre latitudini) si erge per alcuni chilometri, sino ad arrivare al limite della troposfera ovvero, alle nostre latitudini, meno ai poli e di più all'equatore. Raggiunto tale limite si espande orizzontalmente e non più verticalmente, dando luogo ad una sommità a forma di incudine. Nei cumulonembi possono essere presenti i fulmini. L’ampio spessore impedendo il filtrare della luce provoca il peculiare colore cupo; sulla tela di Delleani il grigio plumbeo annuncia dunque un temporale imminente. Troviamo questi tipi di nubi in altri dipinti della collezione, quali Paesaggio marino di Leonardo Bistolfi (cumulonembo – stratocumuli); Alberi in fiore di Eugenio Gignous (stratocumuli); Campo di San Maurizio, la brughiera, di Giacomo Grosso (cumulonembo – stratocumuli o altostrati) e La betulla, di Bartolomeo Bezzi (altostrato). In Bricole di Pietro Fragiacomo i due elementi protagonisti sembrano congiungersi all’orizzonte, distinti solo dalla diversa consistenza della pennellata: piatta e distesa per lo specchio d’acqua quasi immobile, più corposa per il cielo. In esso i nembi emergono dallo sfondo soltanto per la densità della materia di cui sono composti. Il Nembostrato è, infatti, una nube a grande sviluppo orizzontale, di colore grigiastro - nero, la classica nube da maltempo non temporalesco così come appare anche in Poesia invernale di Bartolomeo Bezzi. Di solito i 8 nembostrati portano precipitazioni di intensità moderata o abbondante, seppur non ai livelli di quelle prodotte dai cumulonembi, a cui si associano anche manifestazioni temporalesche. Il fenomeno atmosferico è ritratto con cura eccezionale nella Via ferrata di Tammar Luxoro. Sembra strano vedere nella stessa tela la compresenza di due differenti condizioni del cielo: una porzione cupa all’estrema sinistra, un’altra luminosa dalla parte opposta. Si tratta in realtà di una riproduzione fedele: il cumulonembo infatti, è una nube temporalesca imponente, a sviluppo verticale e perciò localizzata, la cui struttura non impedisce di intravedere un orizzonte sereno a pochi chilometri di distanza, come raffigurato sulla tela. Sotto il cumulonembo impazzano le raffiche discendenti, masse d’aria fredda e pesante che si muovono verso il suolo. Sono evidenti soffermandosi sulla direzione dello sbuffo di fumo che, uscendo dalla locomotiva, invece di disperdersi viene spinto a terra. Proprio lo scontro tra queste correnti e quelle calde ascendenti, possono generare la grandine. Che cos’è la grandine? Quando le correnti ascensionali in un Cumulonembo sono abbastanza forti si forma la grandine; in questo caso accade che un primo nucleo di ghiaccio viene trasportato in su e in giù nella nube, dove si fonde con altri piccoli aggregati di ghiaccio e gocce d'acqua per poi ricongelarsi nuovamente e diventare sempre più grande. Quando le correnti non riescono più a sollevare e trattenere i pezzi di ghiaccio, perché divenuti troppo pesanti, questi cadono a terra; gli aggregati di particelle ghiacciate che non riescono a fondersi prima di arrivare al suolo causano spesso notevoli danni sia nelle campagne (coltivazioni, frutteti, ecc.) che nei centri urbani (alle abitazioni così come ai mezzi di trasporto). È più probabile che la grandine cada d'estate, nonostante sia formata da ghiaccio, essendo una conseguenza dell'afa. Durante e dopo una grandinata la temperatura si abbassa rapidamente (anche di dieci gradi in mezz'ora) perché il ghiaccio solido per trasformarsi in acqua sottrae calore all'ambiente, con la possibilità a volte di generare trombe d'aria. La base del cumulonembo è scura, a volte quasi nera, con sfumature che possono andare dal verde al giallo soprattutto quando causa la formazione di grandine. 9 BIBLIOGRAFIA Un Museo in mostra. Due secoli di storia artistica nelle collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Genova, catalogo della mostra a cura di M. F. Giubilei, (Genova, Palazzo Ducale 20 febbraio-16 maggio 1999), Umberto Allemandi & co., Torino, 1999. S. Junaković, L. Mercalli, B. Tognolini, Cieli. Segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte, M. F. Giubilei e S. Maione (a cura di), Artebambini, Bologna, 2009. Maria Flora Giubilei (a cura di). Prefazione di Fernando Mazzocca Raccolte Frugone. Catalogo generale delle opere. Musei e collezioni della città di Genova, Silvana Editoriale, Milano, 2004. A. A. V. V., Galleria d’Arte Moderna di Genova con opere della Collezione Wolfson. Guida, M. F. Giubilei (a cura di), Maschietto Editore, Firenze, 2004. A. A. V. V., Galleria d’Arte Moderna di Genova. Repertorio generale delle opere, M. F. Giubilei (a cura di), Maschietto Editore, Firenze, 2004, vol. I-II. A. Perniola, Filosofisica, Ottimilibri, Santeramo in Colle (BA), 2014. 10 Percorso II – Scienza Tutto il tempo … in una “mostra” L’uomo del passato che viveva immerso nella natura, assoggettato completamente alle sue leggi, si abituò da sempre a un’attenta osservazione dei fenomeni naturali. Così la necessità di prevedere, se non di controllare, i ritmi giornalieri e annui della natura con cui doveva ogni giorno confrontarsi, lo ha spinto, nel corso della storia, a servirsi dei movimenti del Sole e dei corpi celesti per misurare il tempo. Ha seguito i ritmi naturali fissandoli nel ciclo delle stagioni e nel suo avvicendarsi temporale cui ha legato e condizionato l’organizzazione delle sue attività: agricoltura, allevamento, viaggi, vita quotidiana. Il primo orologio è stato probabilmente originato dall’osservazione della propria ombra e dalla sperimentazione di quanto accade conficcando un semplice bastone in uno spiazzo di terra. L’ombra del bastone, molto lunga nel momento in cui il sole sorge all’orizzonte, si accorcia a poco a poco; raggiunta una lunghezza minima a metà del giorno (a mezzogiorno), l’ombra riprende ad allungarsi, fino al momento del tramonto del Sole. Potrebbe nascere da questa osservazione la prima meridiana. L'uomo può aver cominciato a misurare il tempo «per scopi pratici». Un popolo che, da cacciatore-raccoglitore, diventa sedentario, legato, quindi, alla terra e ai suoi prodotti, ha bisogno di avere un riferimento temporale: non tutti i frutti e gli ortaggi sono seminabili e coltivabili in tutte le stagioni (oggi le moderne serre stravolgono completamente questo principio). Si sarà reso necessario di conseguenza avere una nozione di «tempo», partendo dal dato oggettivo ed evidente che le stagioni si avvicendano ciclicamente - primavera, estate, autunno, inverno e poi via, il giro riprende, sempre nello stesso modo. Conoscere il ciclo delle stagioni e la sua durata, permette di fare previsioni, di conoscere il momento buono per la semina e, di conseguenza, di calcolare quello in cui essa renderà frutto. 11 Un’evoluzione del semplice bastone conficcato a terra, fu dunque la meridiana. Esistono molti tipi di meridiane, verticali o a parete, orizzontali da giardino, equinoziali, portatili, ecc. Noi per comodità diremo semplicemente che la meridiana è un orologio solare, ovvero uno strumento che fornisce l'ora del giorno in base alla posizione dell'ombra proiettata su un piano esposto al sole, detto quadrante, da un'asta, chiamata già nel mondo greco gnomone o stilo. L'asta che produce l'ombra, di solito costituita da una freccia metallica, è disposta parallelamente all'asse terrestre e orientata verso il polo celeste; il quadrante invece, costituito da una superficie piana su cui sono tracciate semirette corrispondenti alle ore del giorno, deve tenere conto della latitudine del luogo. Per ricavare l'ora del fuso dall'indicazione di una meridiana, bisogna ricorrere a tabelle che tengono conto della variabilità della velocità apparente del Sole rispetto alla Terra. Si dice che i primi a realizzare meridiane precise e perfettamente funzionanti siano stati i Cinesi, più di 5000 anni fa (III millennio a.C.). Ben presto si comprese che per misurare con maggior precisione l’accorciarsi e il successivo allungarsi dell’ombra, era opportuno disporre di un bastone molto lungo. Gli obelischi dei caldei e degli egizi terminavano per questo motivo in una punta ed erano molto alti. Per i caldei gli obelischi erano veri e propri gnomoni, mentre per gli egizi erano simboli solari, che venivano innalzati davanti ai templi e solo talvolta funzionavano come stilo per la lettura delle ore. L’uomo quindi misura il tempo per motivi pratici, ovvero per l’agricoltura. Con un bastone, uno stilo o un obelisco, la lettura esatta dell’ora risultava, tuttavia, sempre difficile e approssimativa. Forse anche per questo ai tempi dei Greci e dei Romani la giornata veniva suddivisa in quattro parti principali. In particolare, per quanto riguarda il lavoro il giorno andava dall’alba a metà mattina (hora tertia), da metà mattina a mezzogiorno (hora sexta), da mezzogiorno a metà pomeriggio (hora nona), da metà pomeriggio al tramonto. Anche la notte veniva divisa in quattro parti, sulla base dei quattro 12 turni di guardia a cui le sentinelle della città erano chiamate a presiedere, dandosi il cambio ogni 3 ore. Possiamo dire che questo modo di suddividere il giorno era funzionale, ma sicuramente non aveva alcuna base scientifica: infatti dal momento che durante l’estate il Sole resta sopra l’orizzonte per un periodo molto più lungo rispetto all’inverno e si rendeva necessario cambiare la durata del tempo dedicato al lavoro, o ai turni di guardia, da una stagione all’altra. L’uomo quindi misura il tempo per motivi pratici, ovvero per il lavoro (in bottega, nei cantieri, ecc.) e per i turni di guardia. Per i marinai, agricoltori e pastori greci e romani, l’osservazione di giorno dell’altezza del Sole, di notte di alcune stelle o della Luna rendeva possibile un’indicazione sia pur approssimativa dell’ora. All’uomo comune dell’antichità, insomma, poco importava di conoscere con esattezza l’ora, il minuto e il secondo: non esistevano orari precisi come per noi oggi quali l’ora di partenza e arrivo dei treni, di inizio e fine dei turni di lavoro, dei film al cinema, della scuola etc. Gli astronomi però sentirono l’esigenza di trovare un metodo più preciso, che permettesse di determinare le ore del giorno anche quando il cielo era coperto di nubi, o durante la notte, quando l’assenza del Sole impediva di utilizzare le meridiane. C’era però anche un’altra esigenza, ovvero quella di determinare con esattezza la durata degli intervalli temporali. A questo scopo furono presto messi a punto veri e propri semplici strumenti. Il più antico è uno strumento ad acqua: la clessidra: da un contenitore colmo, con un forellino verso il fondo, l’acqua sgocciolava molto lentamente in un recipiente sottostante. Quest’ultimo si riempiva a poco a poco ed era dotato di una graduazione che consentiva di leggere quanta acqua era sgocciolata, cioè quanto tempo era passato. In alternativa, nel recipiente che riceveva l’acqua si metteva un galleggiante; questo si sollevava a poco a poco, abbassando un contrappeso esterno, che serviva come indicatore del tempo trascorso. 13 Ma la clessidra ad acqua aveva un grave inconveniente: se la temperatura scendeva sotto lo zero, l’acqua si trasformava in ghiaccio e l’orologio si bloccava. Nei paesi del Mediterraneo questo avviene raramente, ma andando verso Nord nel continente europeo le temperature invernali scendevano spesso sotto lo zero. Bisognava quindi trovare un sistema diverso, in grado di funzionare anche in tali condizioni. Così la clessidra ad acqua si trasformò in clessidra a sabbia (o clepsamìa). Due coni con il vertice in comune attraversato da un piccolo forellino permettono il defluire di granelli sottili di sabbia dal recipiente superiore verso quello inferiore; la lettura del tempo si compie su uno dei recipienti. La cosa importantissima è capovolgere al momento giusto la clessidra, quando tutta la sabbia è scesa nel recipiente inferiore, senza anticipare, ne ritardare l’operazione. Sia la clessidra che la clepsamìa erano funzionali ad un uso scientifico, in quanto segnavano intervalli costanti di tempo. Se appositamente modificate, lo sgocciolio dell’acqua veniva regolato attraverso un rubinetto, la clessidre a sabbia invece venivano modificate con strati di cera depositati sulla superficie interna, potevano servire anche nella vita di tutti i giorni. Meridiane e clessidre permettevano di misurare il tempo, ma avevano dei limiti, che furono superati dagli orologi meccanici. Col vantaggio che, dotati di una «sveglia», non dovevano essere sorvegliati continuamente; inoltre funzionavano sia di giorno che di notte. Non si sa come e quando sia nato l’orologio meccanico. Certamente, prima del Trecento nei monasteri esistevano i cosiddetti svegliatori o svegliarini, costituiti da una ridotta serie di ingranaggi che venivano trascinati da un peso, sostenuto da una corda che si avvolgeva su un tamburo cilindrico. Via via che il peso scendeva, gli ingranaggi ruotavano; a intervalli prestabiliti, nel corso delle ventiquattro ore di un giorno, un dispositivo semplicissimo,costituito da una serie di pioli fissati su rotismi oppure direttamente sulla fune, andava a scuotere una campanella, svegliando così i monaci. Per la ricarica era necessario riavvolgere la corda che 14 sorreggeva il peso sul tamburo cilindrico. Per l’uso specifico dei monasteri, dove le ore delle preghiere sono stabilite da una «regola» molto precisa, gli svegliarini risultavano molto efficaci. Nel Quattrocento, nonostante la maggior parte della popolazione fosse ancora dedita all’agricoltura e quindi non avesse un particolare interesse alla scansione precisa delle ore, lo svegliarino uscì dai monasteri, e i primi orologi meccanici iniziarono a comparire sulle torri comunali e sui campanili di alcune città. Si trattava, in realtà, di meccanismi che riproducevano con pochi miglioramenti quelli degli svegliarini. I primi orologi da torre non avevano un quadrante, ma si limitavano a battere le ore su una campana. Le campane successivamente diventarono due, permettendo così di scandire anche le mezze ore, attraverso suoni diversi e una messaggio di tipo sonoro. Solo più avanti furono introdotti i quadranti per una lettura anche visiva. Dalle torri e dai campanili l’orologio scese nelle case. I primi a possederlo furono i sovrani, i nobili, le famiglie più ricche. Naturalmente bisognava costruire orologi con ingranaggi più piccoli e sostituire i pesi con un’altra sorgente di energia che mettesse in moto rotismi di dimensioni ridotte. A questo scopo intorno al 1400 venne introdotta la molla, che però aveva il difetto di scaricarsi con grande regolarità. Anche la precisione non era ancora totale, l’importante era comunque possedere un orologio, che all’epoca rappresentava un vero e proprio status symbol. Gli orologi finirono così col diventare oggetti ornamentali da fare ammirare agli ospiti e pertanto, più interessanti se arricchiti da meccanismi stravaganti piuttosto che precisi. Per es. tra XVII e XVIII secolo, grande fascino esercitarono gli orologi notturni, quelle pendole cioè per la lettura notturna, dotate di cifre orario leggibili in trasparenza mediante una fonte di luce racchiusa entro la loro cassa. L’uomo quindi misura il tempo con orologi che costituiscono uno status symbol, da esibire per il loro valore estetico, come accade oggi con gli orologi da polso. Si racconta che nel 1583 Galileo Galilei, mentre assisteva ad una funzione religiosa nel Duomo di Pisa, annoiandosi, avesse iniziato ad osservare l’oscillare del lampadario. Realizzando che il movimento era sempre uguale a sé stesso, teorizzò il cosiddetto 15 isocronismo del pendolo: la durata dell’oscillazione di un pendolo resta costante e dipende soltanto dalla lunghezza del pendolo stesso. Ciò diede una svolta decisiva alla storia degli orologi, poiché l’isocronia venne sfruttata come unità di misura per calcolare il regolare trascorrere del tempo con sempre maggiore precisione. Anni dopo Galileo (1657), l’olandese Christiaan Huygens, che lavorava all’osservatorio di Parigi, inventò lo scappamento ad ancora, che andava a sostituire quello a verga. Lo scappamento è un meccanismo inserito fra la sorgente di energia e l’elemento di controllo della regolarità di andamento dell’orologio, l’isocronoia del pendolo. In sua assenza gli ingranaggi ruoterebbero velocemente fino a scaricare il motore. Negli orologi a pendolo, se nel caso dello scappamento a verga, la ruota di scappamento veniva ingranata da una semplice asticella uncinata - la verga appunto, nella nuova versione di Huygens, l’ancora ingrana la ruota di scappamento trascinata da un peso, e le consente di avanzare un dente alla volta ad ogni oscillazione del pendolo, ribloccandola subito dopo. In questo modo si ottimizzava l’impiego di energia, a vantaggio di una maggiore precisione della misurazione. Proprio il doppio movimento dello scappamento ad ancora produce il caratteristico tic tac dell’orologio. Ma Huygens non si fermò qua: gli orologi a pendolo, infatti, funzionavano esclusivamente in posizione fissa; voleva costruire orologi portatili in grado di funzionare in qualsiasi condizione. Propose dunque l’uso di una molla a spirale al posto dei pesi e l’impiego di un bilanciere a spirale che andava così a sostituire il pendolo, permettendo la miniaturizzazione di tutti gli ingranaggi. Nel 1800 in Europa e negli USA si delineò uno sconvolgimento delle caratteristiche della vita umana: le macchine iniziarono a prendere il sopravvento sull’energia muscolare degli animali e degli uomini, cominciò a svilupparsi l’industria e i ritmi di lavoro divennero più serrati. Se al contadino l’orologio poteva interessare relativamente perché il suo lavoro restava legato al ciclo del Sole, per chi lavorava nell’industria la scansione della giornata divenne essenziale. Nasce così l’industria dell’orologio. 16 L’uomo quindi misura il tempo per motivi pratici, ovvero per il lavoro in fabbrica quando «il tempo è denaro». Per rispondere all’esigenza di conoscere l’ora in tempo reale, la ricerca si orientò sempre più verso la creazione di orologi portatili e da tasca, dotati di una catenella e di quadrante protetto da un coperchio. La cassa poteva essere realizzata in metalli preziosi e artigianalmente lavorata. Anche il quadrante era spesso decorato e personalizzato, smaltato e variamente rifinito. Negli anni ’90 del novecento vi fu una vera e propria svolta con la diffusione degli orologi al quarzo. Il quarzo è un minerale dotato di proprietà piezoelettrica: comprimendo o esercitando una trazione su una sbarretta di quarzo, sulle facce opposte di questo cristallo si manifestano fenomeni elettrici che scompaiono non appena cessa la sollecitazione. Si verifica però anche il fenomeno inverso: applicando cariche elettriche opposte alle due facce de cristallo, il quarzo si contare e si dilata. Se l’esperimento viene compiuto utilizzando una corrente alternata, il quarzo oscilla con la stessa frequenza della corrente. Come il pendolo oscilla con una frequenza che dipende dalla sua lunghezza, altrettanto succede dunque a una sbarretta di quarzo. Per controllare la regolarità di andamento dell’orologio, come si usa un pendolo si può impiegare un cristallo di quarzo. L’orologio a quarzo che noi portiamo al polso, contiene una sbarretta che oscilla 32.768 volte al secondo. Gli orologi al quarzo possono essere analogici o digitali. Quelli analogici sono normali orologi con quadrante tradizionale e lancette, due o più indicatori uno più corto per indicare le ore, l’altro più lungo per indicare i minuti. Talvolta è presente l’indicatore che segna i secondi. 17 Gli orologi digitali invece, nati tra 1960-1970, sono privi di lancette, in quanto indicano il tempo mediante cifre (digits, in inglese): l’ora e i minuti appaiono scritti in forma numerica in un apposito riquadro. Ultima tappa del nostro viaggio è il cellulare. Negli ultimi tempi, infatti, questo piccolo oggetto è andato a racchiudere in sé molte funzioni, ultima delle quali quella per cui nasce, telefonare. Con il cellulare oggi, possiamo scattare fotografie, scrivere e mail, guardare film, navigare su internet, sentire la musica, ecc., ecco perché non sorprende che esso funga anche da orologio portatile. Certamente questo strumento ha sostituito, almeno nelle giovani generazioni l’orologio da polso assumendone anche il valore di status symbol. BIBLIOGRAFIA A. A. V. V., Il tempo e gli orologi, Rizzoli, Milano, 1992. A. A. V. V., Oggi andiamo al museo. Museo Luxoro, Sagep, Genova, 1991. G. Biavati, Gli orologi del Museo Luxoro, in “Bollettino dei Musei Civici Genovesi”, III, 7-8-9, Sagep, Genova, 1981. C. Galassi (a cura di), Museo Giannettino Luxoro, Nuova Alfa Editoriale, Genova, 1993. A. A. V. V., Gli Orologi antichi, Fratelli Melita editori, Milano, 1991. 18 Percorso III – Arte Non solo a Natale: una traccia di itinerario tematico sul presepe genovese Villa Luxoro e il museo La Villa, progettata dall’ing. Pietro Luxoro come casa di vacanza per sé e i suoi fratelli Giuseppe e Matteo in un terreno in splendida posizione nella zona di Capolungo, fu donata al Comune di Genova nel 1946 da Matteo, ultimo erede della famiglia per la morte precoce del nipote Giannettino durante la Grande Guerra. L’imponente edificio, ultimato nel 1903, richiama chiaramente motivi dell’architettura tardo barocca, per allinearsi allo stile delle ville più antiche che la precedono lungo la costa (Villa Gropallo, Villa Serra, Villa Grimaldi). La struttura si compone di due piani estesi da un sottotetto superiore e da un seminterrato presenta sulle facciate specchiature ed architetture a trompe l’oeil. Completa la facciata a mare una loggia angolare rivestita di “laggioni” - mattonelle policrome peculiari della tradizione ligure – con mensoloni sottotetto ornati da elaborati motivi fitomorfi. L’integrazione all’ambiente circostante per mezzo del revival architettonico, coinvolge anche gli ambienti interni realizzati dai decoratori Angelo Accorsi, Vittorio Gamba e Filippo Tami, su progetto di Pietro Luxoro, e contamina ispirazioni quattrocentesche e seicentesche alle contemporanee influenze neorococò. La passione per il collezionismo dei fratelli Luxoro, li portò ad arricchire la villa di arredi, opere d’arte e oggetti di arti decorative, acquistati nel corso degli anni sul mercato antiquario, trasformandola in una vera e propria “casa-museo” borghese di stampo ottocentesco. Fra i tre fratelli Matteo sviluppò un a vera e propria passione per le figure da presepe storiche e, tra il 1912 e il 1927, acquistò gruppi di figure, abiti ricamati e accessori e complementi di ogni tipo. Proprio lui, nel testamento del 1945, legò la proprietà al Comune di Genova con il vincolo di aprirla al pubblico, affinché le raccolte in essa contenute fossero accessibili alla cittadinanza, ponendo fra le condizioni che il nascituro museo fosse intitolato a Giannettino, il nipote morto in guerra. L’allestimento museale della Villa fu curato dall’allora Direttore dell’Ufficio di Belle Arti Orlando Grosso, che tentò di mediare la sistemazione tra un’organizzazione scientificamente rigorosa e il rispetto di quell’estetica 19 tipica della casa genovese di inizio XX secolo, così cara al donatore. Il compito non fu affatto facile, soprattutto quando scelte selettive improntate alla valutazione della qualità artistica di fatto impoverivano il carattere della dimora; la soluzione fu quindi di destinare a deposito e alloggio del custode gli ambienti del sottotetto, destinando all’esposizione i due piani nobili. Per facilitarne la comprensione, là si collocarono le opere più significative, raggruppate secondo i nuclei delle diverse raccolte e attorniate da preziosi arredi, rispettando in tal modo il gusto sovrabbondante di fin de siècle Il presepe a figure mobili di tradizione genovese Nel giorno di Natale del 1610, nella cappella della Croce della chiesa di Monte Oliveto a Multedo, fu esposto per la prima volta un presepe, andato poi disperso, di figure a manichino in legno scolpito e policromato vestiti con abiti in tessuto, con scene rappresentanti il ciclo natalizio dall’adorazione dei pastori e dei Magi alla presentazione di Gesù al tempio. A questa data dunque è attestata la produzione delle figure a manichino, più diffusa a Genova, rispetto a quella di figure interamente scolpite e policromate e l’uso di allestire all’interno del presepe scene, che scandivano la successione cronologica degli eventi legati alla nascita di Cristo. Una tradizione non documentata continua ad attribuire la maggior parte dei presepi settecenteschi pervenutici al grande maestro Anton Maria Maragliano (Genova 1664- 1739), notissimo per la produzione di gruppi di grande dimensione e per “maestose macchine” processionali. Dalle testimonianze giunteci sembra inoltre che la produzione su vasta scala di presepi lignei abbia preso campo a Genova soprattutto a partire dal quinto decennio del Settecento, ad opera degli epigoni del Maragliano, teoria che peraltro pare pienamente confermata dai pezzi pervenutici, in gran parte databili a partire dalla metà del secolo e certamente memori, in modo più o meno stringente, degli esempi della scultura lignea del maestro. Il nucleo storico di figurine del presepe è costituito da oltre 350 pezzi, di cui oggi è visibile una parte con un allestimento che, negli anni, ha integrato pezzi provenienti da altre 20 collezioni e sviluppato un taglio fortemente didattico, attribuendo alle diverse vetrine un carattere tematico. Presepe a sagome dipinte Alternativa al presepe scultoreo, la produzione di figure dipinte su carta e cartone e successivamente scontornate, finalizzata all’allestimento di presepi, si sviluppa parallelamente nella Germania cattolica e in ambito lombardo, a partire dal XVIII secolo. In Liguria questo tipo di produzione fu utilizzata piuttosto nell’ambito delle macchine effimere per gli apparti ecclesiastici e nelle coeve realizzazioni scenografiche teatrali. Tra gli artisti attivi in questo campo, degno di nota è Francesco Londonio (Milano 17231783), autore di scene di genere e scenografo al Teatro della Scala. A questa tradizione si rifà in parte l’esemplare conservato al Museo Luxoro nel quale la struttura delle figure dipinte su carta applicata a cartone e sorrette sul retro da filamenti metallici richiama il linguaggio stilistico di Landonio. Giunto nelle collezioni Luxoro in forma incompleta – mancano due fra i protagonisti della Natività -, il complesso è costituito da 19 figure dipinte ad olio, e, nell’allestimento proposto in museo, presenta scenograficamente l’adorazione dei Magi: i tre magi, contraddistinti dal turbante coronato, sono accompagnati da paggi, da soldati con cavalli e cammelli, da figure di popolani e pastori e da pecore. Non mancano due piccole quinte raffiguranti panneggi e doni. Sormonta il corteo un gloria di angeli in volo recanti il tradizionale cartiglio. All’interno della serie si individuano tre diverse mani: alla prima è riconducibile la figura di San Giuseppe caratterizzata da un chiaroscuro più intenso e da una pennellata più corposa; alla seconda spetta la figura del giovane Zampognaro, realizzata invece con campiture più sfumate e delicate, e una marcata attenzione ai dettagli ispirata ai modi di Londonio. Le restanti figure si attribuiscono ad un terzo artista dai modi più accademici e fedeli all’immagine del presepe tradizionale. Il complesso è stato valorizzato attraverso l’esposizione permanente al pubblico solo nel Dicembre del 1991, grazie anche alla realizzazione della moderna struttura scenografica appositamente progettata per uno spazio di risulta, adiacente la grande sala espositiva in cui sono collocate le collezioni presepiali, difficilmente sfruttabile altrimenti. 21 Tipologie e Tecniche del Presepe Barocco Pienamente allineato al clima seicentesco, il presepe barocco abbandona la scarna essenzialità dei presepi quattro/cinquecenteschi e si caratterizza per un’esasperata attenzione al dato realistico, tanto nella resa dei personaggi - manichini lignei, con occhi di vetro e abiti in tessuto, talvolta con parrucche di stoppa -, quanto nelle soluzioni coreografiche e scenografiche sempre più articolate e ricche di personaggi. Dalla figura interamente intagliata in legno, o modellata in terracotta o stucco e policromata, si passa al manichino ligneo snodato, più rispondente ad esigenze espressive e di allestimento. Le figure a manichino poi consentivano una maggiore rapidità di esecuzione e, conseguentemente, costi più contenuti; erano infatti scolpite con cura e policromate solo le parti visibili, non coperte dagli abiti, mentre il manichino si caratterizzava per una esecuzione rozza attento soprattutto alle proporzioni e alla funzionalità delle articolazioni, inoltre rispondevano meglio alle nuove esigenze spettacolari del presepe barocco, rendendo possibile, attraverso la semplice sostituzione degli abiti o degli accessori, una continua intercambiabilità dei personaggi e la conseguente trasformazione delle soluzioni coreografiche. Oggetto di devozione nonché artistico svago per nobili e ricchi borghesi, divenne strumento suggestivo capace di coinvolgere emotivamente i fedeli, anche i più umili ed analfabeti, rendendoli partecipi degli eventi rappresentati. Il presepe a figure mobili si diffuse quasi contemporaneamente in Europa in tutti i paesi di tradizione cattolica. Molto spesso si trattava di una successione di scene che comprendeva tutto il ciclo legato all’infanzia di Gesù Bambino (Natività, Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, Circoncisione, Strage degli Innocenti, Fuga in Egitto), e che veniva allestito nel periodo compreso tra l’Immacolata (8 Dicembre) e la Candelora (2 Febbraio). Struttura a manichino Le dimensioni variavano di massima tra i 25 e i 65 cm. Testa e busto venivano intagliati in un unico blocco di legno (in genere tiglio) e policromati fino al collo. Il busto del manichino maschile era caratterizzato da un’anatomia molto semplificata, quello femminile presentava una forma particolare fortemente ristretta dalle spalle alla vita, dove terminava con una punta allungata, e si espandeva posteriormente nei fianchi, secondo i dettami della moda del tempo, che modellava il corpo femminile con busti irrigiditi da stecche lignee. Due fori cilindrici all’altezza delle spalle e altri due nel piano di sezione del tronco consentivano l’inserimento degli arti, dotati di snodi a disco alle spalle, ai gomiti, al bacino e alle ginocchia. L’esecuzione più convenzionale e talvolta quasi grossolana, soprattutto nelle gambe e nelle calzature, lascia supporre che questo completamento fosse affidato ai garzoni di bottega. Le figure erano generalmente dotate di una base lignea intagliata a 22 simulare un piccolo scoglio colorato in verde e bruno che veniva ricoperta e camuffata dal muschio che, nella finzione scenica, alternandosi con la sabbia sostituiva il fondo erboso del paesaggio naturale d’insieme costituito prevalentemente da carta roccia, sughero, arbusti. Alla testina ancora grezza venivano applicati, in cavità opportunamente predisposte, piccoli occhi vitrei, rifiniti con palpebre in stucco, successivamente il “personaggio” realizzato dall’intagliatore veniva completato dall’intervento del coloritore, al quale era affidata la stesura delle lacche, che dovevano specificarne ulteriormente il “carattere”: un incarnato pallido, quasi eburneo, per i personaggi sacri (Gesù, la Vergine, San Giuseppe, gli Angeli) a sottolinearne la nobiltà; un rosa più acceso con sfumature sulle gote o sul mento per i personaggi generici; un incarnato più scuro, per i pastori rustici. Tonalità più scure, fino al nero dei mori erano riservate invece al variegato e multietnico corteo dei Magi. Ricorrenti sono le tipologie dei personaggi che si ripetevano da un presepe all’altro, secondo un copione ben preciso: la contadinella sorridente, il mendicante lacero con la stampella, lo zampognaro con le gote gonfie, i soldati, i mori. Un’attenzione a parte meritano gli animali alla cui realizzazione si dedicavano probabilmente artefici specializzati. Sono figure interamente scolpite e policromate, rese espressive dagli occhi in pasta vitrea, intagliate con grande cura nei dettagli anatomici e in diverse posizioni: al passo e rampanti i cavalli, talvolta accosciate le pecore, carichi gli asini, sempre invece poco oggettivamente rappresentati i cammelli probabilmente a causa di una conoscenza solo per via indiretta mediata dalla letteratura e dall’iconografia ad essa collegata. Nel presepe l’abbigliamento delle figurine è un elemento molto importante. Il costume, insieme ai tratti somatici del volto, definisce la tipologia del soggetto; esso costituisce un codice i cui dati permettono allo spettatore l’identificazione dei vari personaggi nel contesto della scenografia presepiale. 23 Gli abbigliamenti originali sono pervenuti oggi solo in parte per l’usura che subirono col passare del tempo quell’usura a cui sono sottoposti tutti i tessili, con relativi danni dovuti alla luce, alla polvere, ai parassiti. Fonti tradizionali non documentate, vogliono i costumi cuciti dalle stesse dame della nobiltà, a sottolineare il carattere di rito domestico dell’allestimento del presepe. In realtà sembrerebbe più logico supporre l’intervento di artigiani operanti per le Confraternite delle Casacce data l’affinità dei manufatti prodotti, nonché il lavoro delle monache di quegli Ordini che, all’inizio dell’Ottocento, ereditarono gran parte dei presepi nobiliari. I personaggi più importanti di solito presentano costumi ricchissimi: fra tutti, quello della Vergine - coronata in argento per essere stata designata regina di Genova - in raso bianco o rosso con vistosi ricami in fili d’oro e argento corredato da un mantello in seta azzurra. Color porpora e di foggia talare, anch’esso corredato di mantello, l’abito di San Giuseppe, cui, secondo la tradizione tramandata dai vangeli apocrifi si attribuisce il bastone fiorito in giglio realizzato in seta o in argento. Maestosi sono poi gli abiti dei magi dei quali spiccano i preziosi mantelli in velluto e in seta rifiniti con galloni dorati ed ermellino e ricamati in filo d’oro e d’argento. Coerenti con essi sono quelli dei paggi del corteo e il loro ricco corredo. Alla moda infine, gli abiti delle figure non popolari: marsine, panciotti, camicie in lino e braghe in seta per gli uomini, abiti scollati e riccamente ricamati e adorni di pizzo per le donne. Vanno infine ricordati come parte dei costumi, i gioielli: le piccole collane di corallo ed i pendenti di filigrana tipicamente liguri. Molto legati alla tradizione genovese anche i materiali adoperati per gli abiti dei popolani: contadini, pastori, venditori ambulanti, “besagnine” –termine dialettale per indicare le ortolane che scendevano dai campi lungo il Bisagno per vendere i loro prodotti ai mercati-, zampognari, mendicanti, questi ultimi due tipi in genere scalzi. Troviamo il panno, il fustagno, le tele di canapa, cotone e lino rigate o quadrettate, le “mezzelane”, le saie, ossia i diagonali di cotone blu antenate dei blue jeans; l’abbigliamento delle figurine presepiali funge dunque da importante documentazione dell’uso di numerosi tessuti caratteristici della più nota tradizione della Repubblica genovese. A completamento di costumi così dettagliati non mancano accessori ad hoc: turibolo, navicella per incenso, spade e corone in ferro o argento per il corteo dei magi, i cui cavalli rampanti presentano anche ricche gualdrappe e bardature in cuoio e velluto ricamato a filo d’oro; lance, alabarde e scudi per paggi ed armigeri; bastoni per i 24 pastori; vari strumenti musicali per zampognari e musici; ceste in vimini con variopinti prodotti per contadine; bisacce, ciotole e stampelle per i mendicanti. BIBLIOGRAFIA A.A.V.V., Oggi andiamo al museo. Museo Luxoro, SAGEP EDITORI, Genova, 1991. A. Bettanini, D.Moreno, Il presepe genovese, SAGEP EDITORI, Genova, 1970. G.Biavati, G.Sommariva, L’antico presepe genovese, Compagnia di Librai, Genova, 1993. M. Cataldi Gallo (a cura di), Il presepe della Madonnetta. Storia e restauro, LumiereArt, Sagl (Lugano), 2005. M. Fochessati, G.Franzone (a cura di), Dalla città al Museo. Percorsi nella Genova dell’Ottocento e del Novecento tra storia, arte e architettura, SAGEP EDITORI, Genova, 2014. C. Galassi (a cura di), Museo Giannettino Luxoro, Nuova Alfa Editoriale, Genova, 1993. I profili del Presepe. Le sagome dipinte del Museo Luxoro, catalogo di mostra a cura di C.Galassi, (Genova Nervi, Museo Giannettino Luxoro, 21 dicembre 1991-29 febbraio 1992), Editoria Brigati Glauco, Genova, 1991. G. Sommariva, Presepi di ieri e di oggi, in «La Casana» XLII n.3-4, 2000, pp.60-65. Testi a cura di Valentina Pestarino e Francesca Moretti, volontarie del Servizio Civile Nazionale, progetto “Arte Natura e Scienza”, anno 2014/2015. 25
Scarica