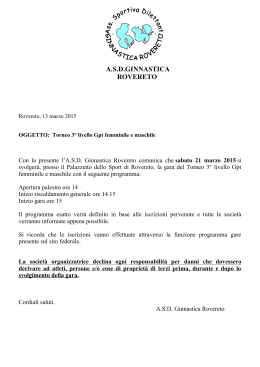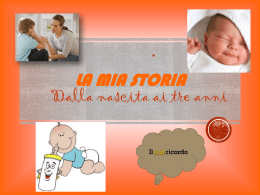RENATO STEDILE EL RAMINEL DEL LATE, LE FASCINELE DE LEGNA, I FONGHI, LA ZERLA... Quando le “teragnole” scendevano a Rovereto Maggio 2009 Comune di Rovereto 1^ Circoscrizione “Rovereto Centro” e 7^ Circoscrizione “Noriglio” 1 Comune di Terragnolo In copertina: “Teragnóla che scende dal vicolo del Portello in piazza del Grano 1910 circa Biblioteca Civica Rovereto (Ms 65.3 23K) 2 PRESENTAZIONE “Ma noi povera gente non abbiamo mai avuto nessuno che abbia sporcato un foglio per raccontare la nostra storia.” Con questa frase posta nell’ultima pagina del racconto “La stagione dei Bortolini” Gino Gerola ci consegna la sua opera nata dall’intento esplicito di non far sparire anche dalla memoria la gente di allora, le sue fatiche, la sua tenacia e umanità. Un intento rievocativo che non era mosso dalla nostalgia del passato ma “dalla sacralità che da esso riverbera, oggi che la solitudine ci ha fasciato tutti”. In qualche modo anche il presente lavoro trova la sua ragione d’essere nella avvertita importanza di farci custodi di una storia che ha visto protagonista una umanità umile, spesso ricondotta sul fondo, se non dietro le quinte, del palcoscenico della vita sociale dove altri ceti occupano o pretendono di occupare il proscenio. Una storia di donne che ci riporta a un ordine, un codice di valori, quali il senso del dovere, l’amore per la famiglia, la solidarietà, il farsi da sé, che vanno osservati e salvaguardati. Una storia scritta tra i viottoli e le strade che collegano la città con la valle e nelle case sul greppo dove si è consumata la parabola del vivere. Lungo il percorso da Terragnolo a Rovereto non vi è luogo ove non si sia dipanata la quotidiana fatica, non c’è sasso che non abbia una stilla di sudore, non c’è salita dove alla preghiera (si pensi ai capitelli) non si sia accompagnata la feroce volontà di costruire un avvenire migliore per i famigliari, per poter metterli nella condizione di aprirsi al mondo con nuovi strumenti, nuova forza, nuova speranza. Potremo così renderci conto che “nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che i piccoli hanno di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita” sta la loro grandezza. E finalmente capire che anche e forse soprattutto grazie alle loro febbri, alle loro passioni, al loro eroico lavorare si è aperto un tempo nuovo per la valle di Terragnolo e non solo. Infine un vivo grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo documento. Il Sindaco di Rovereto Gugliemo Valduga Il Sindaco di Terragnolo Danilo Gerola 3 La piazzetta delle “scotinere” in via Rialto a Rovereto 4 RENATO STEDILE “BETLAR” EL RAMINEL DEL LATE, LE FASCINELE DE LEGNA, I FONGHI, LA ZERLA... QUANDO LE “TERAGNOLE” SCENDEVANO A ROVERETO STORICHE FATICHE DI DONNE INCREDIBILI “La gente (di Terragnolo) è laboriosissima: gli uomini si occupano di lavori agricoli, dei tagli dei boschi, altri si portano sui lavori in Germania: le donne invece, oltre ai lavori di campi si occupano del piccolo commercio del latte, della legna da fuoco, dei frutti, dei funghi ecc. Si può calcolare che quotidianamente nei giorni feriali, fra le 70 e 100 donne di questo comune, si portano a Rovereto, curve sotto carichi pesanti, ove arrivano prima dell’alba, né è raro il caso magari nell’inverno quando la neve rende le vie impraticabili, vedere le “terragnole” aggirarsi coi loro lumicini ad olio, per città alle 4 o le 5 di mattina. Prima di mezzogiorno tutte se ne ritornano a casa cariche di provviste, né il dopopranzo se ne vedrebbe una a pagarla un milione.” Sono immagini vive e commoventi riportate nel Bollettino “Rododendro” del 1909, in un articolo che descriveva, valorizzando l’ambiente naturale, un’escursione fatta partendo da Rovereto fino a Terragnolo. Ancora nell’Ottocento erano soprattutto le donne terragnolesi protagoniste del “commercio minuto di legna”, tanto che il Giongo, in uno studio pubblicato sul Giornale Agrario di Rovereto del 1877, metteva in luce l’importante contributo all’economia della valle di Terragnolo fornito dalla popolazione femminile. “In vero le donne del paese, frodando di continuo agli occhi il sonno ed alle membra il conveniente riposo, senza distinzione di età, dalla tenera ragazza alla madre di famiglia, sia pure di età avanzata, alla prim’alba si vedono battere la strada di Rovereto col proprio carico. Veramente questo sistema di vita e di occupazione – proseguiva il Giongo – lo vorrei dire eccedente le forze limitate del sesso femminile; e ti cava un senso di compassione l’incontrarsi in verdi giovinette, o in vecchierelle ricurve sotto il grave peso ora intirizzite dal freddo, quando grondanti di sudore.” Una situazione, quella delle donne terragnolesi, che aveva particolarmente colpito l’autore dello studio, il quale così sottolineava: “ da un calcolo che volli fare risulta che il sesso femminile colla sua proverbiale laboriosità provvede la famiglia della polenta necessaria per quasi una metà dell’anno; la polenta (...), 5 che è il cibo quotidiano, deve tutta importarsi. Sembra cosa incredibile ma pur è vera, la donna di Terragnolo concorre al sostentamento della famiglia più di quello non vi concorrano le braccia nerborute dei nostri contadini” 1 . Anche il dottor Guido de Probizer, direttore medico del pellagrosario di Rovereto, in una sua pubblicazione del 1896, sottolineava le fatiche delle donne terragnolesi che portavano i loro prodotti nei mercati cittadini: “Non meno di 40-50 donne giornalmente inverno ed estate partono dalle varie frazioni alle 3 antimeridiane, portano alla città latte, legumi, frutti secondo le stagioni (...) e ritornano per mezzogiorno e prima, cariche dei loro fardelli di farina di polenta e 2 di altre provviste”. L’osservazione del dott. de Probizer è interessante perché indirettamente metteva in luce una tendenza emersa sul finire dell’Ottocento: la famiglia contadina, cercava di resistere alla crisi di fine secolo riducendo i consumi alimentari e affidando il proprio sostentamento alla sola polenta, acquistando la meno costosa farina gialla coi pochi guadagni ricavati dalla vendita di quei prodotti che prima erano destinati alla sua tavola, quali ortaggi, frutta, latte, formaggi, modificando di fatto la precedente dieta alimentare, povera ma comunque di una certa varietà, a favore della polenta come cibo esclusivo. Di qui, il diffondersi della pellagra - insufficienza di vitamina PP e carenza di altri fattori - che aveva colpito in maniera particolare la Vallarsa e la poverissima valle di Terragnolo.3 Il piccolo commercio delle “teragnóle” che scendevano a Rovereto durò fino alla metà del secolo scorso, scemando tra gli anni Cinquanta e Sessanta, perpetuando nel corso degli anni antiche usanze e rituali quotidiani descritti anche da Fiorio, nel 1935, nella sua articolata analisi riguardante lo spopolamento montano: “ ... parecchie contadine di Terragnolo e Trambileno che scendono a Rovereto per lo smercio giornaliero del latte, della legna, dei funghi, ecc., portano seco le scarpette basse “alla moderna” da sostituire alle pantofole di tela con cui percorrono le mulattiere sassose fin presso la città”. 4 Una “calata” a Rovereto che va letta, nel periodo fra le due guerre mondiali, “tenendo presente l’intreccio inestricabile che legava la città al contado e alle valli confluenti, l’industria alla 5 campagna”. 1 Giornale Agrario di Rovereto, a.VIII, n° 8, 1877, pp. 124-125. G. de Probizer, Considerazioni sulla pellagra avuto riguardo speciale alla sua diffusione nel distretto politico di Rovereto, Rovereto 1896, p. 35 3 G. Olmi, La pellagra nel Trentino fra Otto e Novecento, p. 376, in AA.VV. , Salute e classi lavoratrici in Italia dall’unità al fascismo, Milano 1982. Si vedano poi le ulteriori considerazioni del de Probizer: “Un’altra circostanza che favorisce lo sviluppo della pellagra fra noi, è la quasi totale mancanza dell’alimento latteo fra i contadini. A ciò concorrono due fattori principali. Il primo è, pei paesi limitrofi a Rovereto, il facile smercio dello stesso in città; il secondo, pei paesi lontani alla città, la costituzione dei caselli sociali. In questi il latte viene trasformato in massima parte in burro ed in formaggio magro. Il primo viene venduto, si può dire totalmente, il secondo serve in parte al companatico per il contadino. Il latte dunque viene per tempo sottratto ai bambini ed ai fanciulli, a scopo di poter comperare più polenta, e questo è un danno” (ibidem, p. 33) 4 L. Fiorio, Lo spopolamento nella Valle dell’Adige. Studi e monografie dell’Istituto Nazionale dell’Economia Agraria, III, 1935, p.16, 5 D. Leoni, La “Grande Rovereto”. Storia di un fallimento, in AA.VV., Rovereto 1919-1939. Studi, Rovereto 2000, p. 94 2 6 Tempi duri, gli anni Venti e Trenta: nel 1924 il 60% degli operai impiegati nelle fabbriche roveretane proveniva dal contado. Di quegli operai-contadini, circa 1200 erano donne, che si portavano giornalmente alla Manifattura Tabacchi, al Piave (Pirelli), alla Serica e al Nastrificio. A queste si aggiungevano le ragazze di montagna che scendevano “con i loro carichi di metalli di guerra raccolti dai padri e fratelli recuperanti, le contadine a vendere il latte, le uova, la legna, la cenere, i funghi, i fiori, qualche frutto, pollo o coniglio.(...) In questo andare e venire di gente la città e i paesi si compenetravano, legandosi indissolubilmente: la città garantiva lavoro, merci pregiate, luoghi di scambio; i paesi manodopera, prodotti alimentari e artigianali, che spesso passavano di mano attraverso la pratica antica del baratto” .6 7 Di queste donne di Terragnolo, abituate a “portare” , mi sembra doveroso sottolineare attraverso questo mio piccolo contributo, la forza di volontà, lo spirito di sacrificio, il senso di responsabilità e protagonismo verso la propria comunità. Caratteristiche umane, queste, che caratterizzavano anche molte donne norigliesi soprattutto della zona di Senter e Cisterna, pure loro coinvolte nel piccolo commercio quotidiano con la città, soprattutto del latte. Un modesto contributo, frutto del mio amore per Terragnolo (il mio nonno paterno nacque nella frazione Stedileri), del mio amore per la storia, ma soprattutto di piacevoli conversazioni con le ultime protagoniste ancora viventi. Si può senz’altro affermare, in via generale, che le lattivendole di Terragnolo abitavano nelle frazioni alte della valle, da dove quotidianamente partivano per la città: particolarmente da Potrìch, Scottini, Dieneri e Pornal, ma anche da Perini - 6 ibidem, p. 72. In ogni caso per moltissimi l’orizzonte più prossimo era quello della miseria o comunque di una vita di stenti. Per avere un’idea delle condizioni di estrema povertà in cui viveva la maggior parte della popolazione negli anni Venti, basti questo episodio raccontato da Leonella S. (classe 1922) che in quell’epoca viveva ai Rovri di Terragnolo: “Non andavo ancora a scuola. Eravamo pieni di debiti, nemmeno la vendita di un paio di caprette ci dava respiro economico, lavoro non ce n’era. Allora mio padre – sarà stato il 1928 – partì a piedi da Terragnolo per raggiungere Bolzano in cerca di lavoro. Mi ricordo che dopo una decina di giorni sentimmo bussare alla porta di casa. Mia madre chiese: “Chielo?”. Apparve sull’uscio mio padre, magro e stremato. Dapprima si sedette sul baule e poi si avvicinò al tavolo dove si appoggiò allargando le braccia, sfinito. Mia madre gli disse: stai a casa insieme a tutti noi, almeno moriamo tutti insieme.” (conversazione del 3/1/2009) Lo spettro della povertà traspare anche dal soprannome “Betlar”, probabilmente di origine tardo ottocentesca, con cui venivano denominate alcune famiglie della frazione Stedileri: è verosimile infatti che “Betlar” non sia altro che una storpiatura del termine “Bettler”, che nella lingua tedesca significa “mendicante”. 7 Si veda quanto scriveva nel suo diario, a tal proposito, don Giovanni Tschoen, parroco di Terragnolo: “Portare, ecco la legge dei Terragnoli, gli uomini portano la legna dai boschi, portano il fieno dai prati, e venendo qui dentro anche stamane (31.08.1919) incontrai donne che, secondo l’antico costume portavano fragole e funghi (le famose sponziole) a Rovereto. (...) Narra una leggenda che i Terragnoli vengono sepolti in piedi, con un sasso sulla testa. Essi sono avezzi a portare, che qualche cosa vogliono portare anche dopo morti”. 7 “Teragnóle” sulla strada del ritorno, poco sopra le Laste rosse, 1901 (in M. Scudiero, Saluti dall’Altipiano di Folgaria…e dalla Valle di Terragnolo, 2001) 8 dove passava la “strada vècia dei teragnoi” 8, ovvero la strada realizzata all’inizio del Settecento da Eugenio di Savoia - e più sotto, verso il torrente Leno, da Fontanelle e San Nicolò. Certo, anche dalle altre frazioni, da Zencheri, Incapo, Zoreri, Baisi, Valduga, si scendeva a piedi verso Rovereto per realizzare altri commerci, ad esempio per vendere uova, patate, funghi, fiori o ricotte (“poine”). Le lattivendole partivano il mattino presto con le loro “zerle” cariche di latte e di legna da Scottini e frazioni contigue, avviandosi per il sentiero – ancora oggi percorribile - che porta giù a Valgrande, per poi proseguire lungo lo stradone polveroso passando sotto il Maso Brenti, quindi al Beccaché, 9 arrivando in fila indiana, con i lumini ad olio ancora accesi, a Valteri di Noriglio; alla curva, dopo “l’osteria della Silvia”, imboccavano la “strada vecia”, passando davanti al “capitèl de Limom” e al “capitel de Sant’Antoni”, poi giù verso le Laste Rosse e Fontanom (l’acquedotto civico); quindi penetravano in città attraverso le due Valbuse per giungere infine alla “piazzetta delle scotinère” in via Rialto dove – se non lo avevano già fatto al Dosso del castello – si cambiavano le scarpe. In tarda mattinata, dopo aver servito i clienti occasionali di passaggio e quelli abituali delle “poste” fisse, ripartivano sempre a piedi per Terragnolo, quasi mai senza aver fatto prima una sosta all’osteria Stedile in Valbusa piccola, oppure alla trattoria Dorighelli in via Orefici, per sfamarsi con un buon piatto di trippe. Arrivate a Scottini, il lavoro continuava in cucina, magari a preparar la polenta da portare ai famigliari su in Finonchio, durante la stagione della fienagione, oppure nei terrazzamenti di campagna a zappare e coltivar la terra. I RICORDI DI V ITTORIA FAIT PROSSER Una bella descrizione di queste donne, forti e tenaci, che facevano la spola tra Terragnolo e Rovereto, ce la fornisce Vittoria Fait Prosser. Nel suo libro autobiografico essa descrive ricordi molto precisi risalenti al 1937, anno in cui con la famiglia prese in gestione il dopolavoro di Noriglio: “Le nostre avventore (clienti) donne, erano la maggior parte da Terragnolo. Io mi ricordo spesso, povere donne: venivano fuori dai loro paeseti, prestissimo la mattina. Per arrivare a Rovereto verso le 7 e mezza, avevano dovuto alzarsi alle 4 e poi fuori con un carico di legna, o di latte, oppure con un secchio di latte (da una parte) e, per fare il contrapeso, un fascio di legna, dall’altra. Qualcuna, se era aperta la nostra porta, Informazioni storiche su questa vecchia strada sono riportate da Italo Prosser, Un’escursione: notizie sulle strade antiche della valle di Terragnolo per Noriglio e Rovereto, in G. Gerola, Le pietre del passato, Rovereto 1996 9 La signora Natalina C. (classe 1923) riferisce che nella zona di Beccaché, presso una grande pianta di noce, le ragazze di Cisterna si incontravano con le donne provenienti da Terragnolo. “Scendevo il mattino presto con le sgalmere da Cisterna - avrò avuto quattordici anni - insieme ad altre ragazze, per andare a lavorare alla Pirelli. Mi ricordo che al Beccaché c’era una grande noghera e lì le teragnole si cambiavano le scarpe avvolte di stracci. Ci univamo a loro per proseguire verso Rovereto, cantando e chiacchierando. L’era ’na vita che voi no podè capir!” (conversazione del 17.01.2009) 8 9 infilava nel nostro forno del focolare delle patate, o qualche fetta di polenta: sapevano che io, il fuoco lo acendevo presto e, per quando ritornavano di ritorno, facevano colazione con un quarto di vino. Poi, fra due, tre persone, brustolavano una renga e, con un goccio di olio o di aceto e un mezzo di quello buono, riaquistavano le forze perdute. Qualche altra veniva fuori con un carreto di legna: “E’ niente – dicevano – a venire in fuori da Teragnolo perché la strada è in discesa; ma è, ritornando a casa, specialmente da Rovereto alla Costa di Noriglio, che si suda fuori la camicia!” Io le volevo bene a queste donne che di fatica ne facevano molta e, molte volte, se qualcuno non aveva niente, le regalavo il mio piatto di minestra che io dovevo mangiare (...). Erano tempi di miseria: pane senza tessera non se ne poteva avere”. 10 STORIE POPOLARI. I L MIRACOLO “ DE S ANTINTONI” Le “teragnóle” erano anche protagoniste di storie popolari, assai divertenti, come quella narrata dal quotidiano Gazzettino del 14 febbraio 1938 in cronaca di Rovereto, che dedicava alle lattivendole un gustoso articolo intitolato “El capitel de Santintoni”. Sembra interessante riproporlo in maniera quasi integrale. “Spieghiamo subito al lettore – precisava l’anonimo giornalista – il significato un po’ oscuro della parola “Santintoni”, che in questa forma conserva tuttavia l’originale freschezza del dialetto roveretano, sfiorato forse da una punta di sapore campagnolo. Diciamo senz’altro trattarsi del sacello di S. Antonio, sito sul crocevia del popoloso rione Valbusa grande – viale dei Colli. Non intendiamo pertanto narrare la storia dell’antico tabernacolo dedicato al grande Santo. (...) Vogliamo piuttosto ricordare con l’aiuto di un racconto popolare, un singolare fatto toccato parecchi decenni fa, ad una lattivendola di Terragnolo, e che a suo tempo venne addirittura interpretato come un miracolo. E’ ormai noto in città come quel punto della famosa Valbusa Grande sia stato per molti anni, e sia in parte tuttora, il luogo di convegno di molte lattivendole che da Terragnolo, Salteria, Zaffoni, Noriglio etc., scendono nelle prime ore del mattino con la saporita bevanda e con quant’altro esse pensano di smerciare in città. Una mattina – racconta la cronaca – una campagnola di Terragnolo, sentendosi indisposta per intraprendere a piedi l’abituale, faticoso viaggio in città, affidò l’incarico al suo ragazzo, il quale venne inoltre incaricato di portare due grossi pani di burro, ricorrendo proprio in quel giorno la data del mercato settimanale cittadino. Il figliolo, un pezzo di ragazzo grande e ben piantato, docile e pieno di premure, aveva avuto però la disgrazia di nascere, per dirla con un vocabolo di moda, un po’ picchiatello, tanto che in paese la sua minchioneria gli aveva fruttato il nomignolo di “Toni Zucon”. V. Fait Prosser, Cerano le ciliege matture ma non le abbiamo assagiate. Ricordi 1907-1945, Rovereto 1990, pp.221-222 10 10 Si pensi un poco quali e quante saranno state, di conseguenza, le raccomandazioni della mamma per impedire che Toni ne combinasse qualcuna delle sue. Siccome però la famiglia non navigava nell’abbondanza e lasciarsi sfuggire una simile occasione voleva dire attendere un’altra lunghissima settimana prima di realizzare qualche cosuccia, la buona donna dovette rassegnarsi a lasciarlo partire. Fra le tante raccomandazioni, Toni aveva avuto anche quella di non vendere il burro a persone troppo loquaci, o ad offerenti troppo precipitosi. Non si sapeva mai: i gabbamondo son sempre lì pronti per farla al galantuomo; specie poi ad uno che si avventurava per la prima volta sul mercato cittadino. Una devozione al “Capitel de Santintoni” – gli aveva detto la mamma – varrebbe certo ad aiutarti, a darti qualche buona ispirazione. Il ragazzo partì armato di fieri propositi contro i possibili lestofanti e, giunto all’imbocco della Valbusa, si fermò presso il sacello del Santo invocando la sua protezione. Al mercato però, piantato lì con un cipiglio quasi feroce non gli riuscì, naturalmente, di vendere un solo grammo di burro, parendogli le persone che gli sfilavano davanti tutte in combutta contro di lui e la sua merce. Verso sera si fermò di nuovo, sfiduciato, davanti al tabernacolo – a quei tempi non aveva l’odierna grata di riparo – e deponendo la merce, che egli aveva tenuto in braccio per quasi tutta una giornata, ai piedi della statua del Santo, aprì a questi tutto il suo cuore desolato. Siccome egli non aveva mantenuta la promessa fattagli il mattino, pensava il giovane, era suo dovere di acquistar egli stesso la merce invenduta. La sua statua, che rimase naturalmente muta, ispirò fiducia al contadino che, interpretando quel silenzio come un assenso, abbandonò il prezioso pacchetto rivolgendosi alla statua con queste parole: “i clienti come te non si trovano facilmente, delle persone tue pari ci si può fidar! Pagherai domattina a mia madre”. Manco a dirlo la povera donna, dopo il racconto del figlio per poco non svenne: accorsa subito sul posto vi arrivò, s’intende a tarda ora quando la città era già immersa nel sonno. L’involto non c’era naturalmente più. In preda al più vivo dolore per la perdita di quella merce, dal cui ricavato si riprometteva un buon aiuto per la famiglia, la povera donna si avvicinò ancora di più alla statua del Santo quasi per cercare di intenerirlo. Con sua grande sorpresa ella vide allora sporgere da dietro la statua un minuscolo involto, a prima volta insignificante. Apertolo, la buona donna vi trovò tanto denaro da mantenere un’intera famiglia per un anno. La contadina, rincasando con il munifico dono venne fieramente redarguita dal figliolo per la scarsa stima che ella aveva dimostrato nei riguardi del santo. In quella stessa notte, però, - narra la cronaca di quei tempi - venne denunciato un furto in una ricca casa colonica, poco discosta dal rione. La storia suppone che i ladri, vedendosi inseguiti e forse in procinto di essere raggiunti, abbiano frettolosamente nascosto il bottino dietro la statua di S. Antonio con la intenzione di appropriarsene in seguito. Ma della cosa non si è risaputo più nulla, ed il fatto, per quel tempo, venne considerato miracoloso.” 11 UN PERSONAGGIO INCREDIBILE “Poteva dire di avere fatto quattro volte il giro del mondo”. Con questo titolo Talieno Manfrini, sul Gazzettino del 9 giugno 1957, apriva un articolo per ricordare la scomparsa di Giuditta Scottini, avvenuta tre giorni prima, all’età di 87 anni. Giuditta Scottini, meglio conosciuta col nome di “Bianca dai Scottini”, è stata probabilmente la lattivendola più famosa di Terragnolo. La Scottini, percorrendo ogni giorno, d’inverno e d’estate, la strada dall’ultima frazione di Terragnolo a Rovereto “per portare il latte e dalla nostra città a casa sua con oggetti che le venivano commissionati (in totale 15 chilometri all’alba ed altri 15 al tramonto) poteva dire di avere compiuto un cammino complessivo pari a quattro volte il giro del mondo (...) pestando la neve e cocendosi al sole”. Era conosciuta da tutti a Rovereto, nella zona di Terragnolo e sull’altipiano di Folgaria. Durante la seconda guerra mondiale – proseguiva il giornalista – quando non aveva latte da vendere, “la Scottini portava a valle delle fascine di legna minuta per accendere il fuoco, poiché bisognava pur racimolare qualche soldo per il mangiare. Nel periodo estivo la si vedeva sovente lasciare Rovereto con grossi fardelli sulle spalle: un materasso, un tavolinetto, una pesante valigia, un lettino per neonato ecc., tutta roba destinata “ai siori”, come ella diceva, sfollati a Serrada. Le corriere in quel triste periodo – proseguiva Talieno Manfrini - erano limitatissime e facevano servizio quando le circostanze lo permettevano. Giuditta Scottini, in mezzo con le nipoti, 1951 circa La Scottini colmava la lacuna e non vi era persona o villeggiante che non avesse bisogno di lei. Un poeta, che a Serrada aveva trovato rifugio, l’aveva definita “un raro esempio di forza italica e di ferrea volontà fattiva”. Con la Scottini – 12 concludeva il giornalista – è un’epoca, un modo di guadagnarsi la vita, una fermezza di carattere che scompaiono per entrare nel mondo della leggenda. E lassù a Scottini se la ricordano ancora. Come la nipote Rita S. (classe 1931): “la mia nonna Giuditta portava sempre con sé una grande busta di pelle dove metteva le cose più varie, a lei ordinate dalla gente di Serrada ed acquistate a Rovereto: francobolli, lettere, tabacco etc. La vedevo rientrare a Scottini quasi sempre a metà pomeriggio”. Anche Maria P. (classe 1925), originaria dalla frazione Potrìch, ha un vivo ricordo: “Negli anni Quaranta, durante la primavera, vivevamo con la famiglia in una casetta di campagna in prossimità di Valgrande, con le nostre mucche. Mi ricordo - erano gli anni Quaranta - che Giuditta arrivava a Valgrande, gonna lunga e grembiulone, con “la zerla” carica e mi chiamava: “vei che te me aiuti en tochet”. Le prendevo allora una borsa o altre cose pesanti. Dopo aver percorso un tratto di sentiero del Pubil e arrivati alla croce – una grande croce di legno ora sostituita da un capitello costruito con sassi a vista – mi diceva: “ades te poi nar, me rangio”; e mi dava un pezzo di pane o un cioccolatino in segno di riconoscenza. L’era ’na donna de oro e de fer!”. Giuditta “Bianca” Scottini, 1950 circa 13 LE PROTAGONISTE Maria P. (classe 1925). Sono nata a Potrìch di Terragnolo e lì ho vissuto fino al 1950, quando mi sono sposata trasferendomi a Senter di Noriglio. All’epoca eravamo in tanti lassù al Potrìch. Per dare un’idea del numero di abitanti nelle frazioni alte di Terragnolo negli anni Trenta, basti pensare che alla scuola di Scottini, costituita semplicemente da un unico grande stanzone, eravamo una settantina di scolari in pluriclasse. Noi ragazze ci alzavamo alle quattro di mattina per mungere le bestie; la mia famiglia, come la maggior parte delle famiglie, aveva una sola mucca. Mettevamo il latte nel “raminel” e lo appendevamo nella parte anteriore del bilancere (zerla); dietro, a far da contrappeso, si metteva una fascina di legna. Si partiva che era ancora buio pesto, in gruppetti di tre o quattro ragazze e per far luce mettevo davanti al bilancere un lumino ad olio acceso. Percorrevamo il sentiero che porta alla grande croce di legno verso il Pubil, dove ci incontravamo con le ragazze di Scottini (“scotinère”) e quindi si proseguiva verso Valgrande. Poi a Noriglio, in prossimità di Valteri, si prendeva la “strada vecia” e quindi, giunti al “capitèl de Limom”, riposavamo qualche minuto, sedute sulle fascine di legna. Poi riprendevamo il cammino sorpassando il capitello di S. Antonio - lì qualche centesimo l’ho lasciato anch’io nell’apposita cassettina delle offerte - per arrivare alle Laste rosse. Quindi si sbucava in Valbusa piccola e in fondo alla strettoia, si girava a sinistra, nella “piazzetta delle scotinère”, dove c’è una fontanella, in cima a via Rialto. Eravamo vestite “de tute le sort”, con un grembiule, una maglia e sempre un fazzoletto in testa, soprattutto nelle giornate ventose. Nella piazzetta cercavamo di vendere dapprima la legna e quindi il latte. Ciascuna di noi aveva comunque le proprie “poste”, ovvero dei posti dedicati dove i clienti fedeli acquistavano il nostro latte ricco di panna. Le mie poste erano principalmente in via della Terra, in San Marco e in via Mazzini. Nelle giornate particolarmente fredde entravo nel negozio di frutta e verdura della signora Bandera, ubicato di fronte alla “piazzetta delle scotinère” (da alcuni decenni tale negozio non è più visibile perché sventrato e trasformato in spazio pedonale sotto la porta di San Marco, nda). In cambio del bastone di legno che usavo come appoggio durante la ripida discesa sotto Scottini, la Bandera mi dava tre o quattro castagne secche “da rosegar”. Se non si riusciva a vendere tutto il latte, eravamo allora costrette a “svenderlo” a poco prezzo. Mi ricordo che una volta, salite le scale di una casa in centro storico, suonai il campanello e piangendo chiesi ad una signora: “siora, volela late?” e lei per tutta risposta replicò: “cosa devo fare del latte? lavarmi le ginocchia?”. E non successe solo una volta. Tempi duri! Andavamo poi al molino Bertolini in via Campagnole; qui in cambio del nostro granturco e orzo ci davano un po’ di farina gialla o bianca. Al ritorno, spesso ci fermavamo all’osteria Stedile in Valbusa piccola, a mangiare delle ottime trippe oppure, quando era proprio freddo, a bere un brulè. Più raramente passavamo dall’osteria Gina Gambera in Valbusa grande, di fronte al Canevari, a 14 bere qualcosa. Mi ricordo poi che a Noriglio mi fermavo qualche volta alla Cooperativa per acquistare un quarto di olio e un cornetto di pane oppure, più avanti, al negozio di alimentari della “castellana” (qualche anno fa l’edificio è stato trasformato in garnì, nda). Molte volte ci fermavamo anche al dopolavoro di Noriglio, gestito dalla signora Vittoria Fait Prosser, che ci abbrustoliva una fetta di polenta o un pezzo di pane su un grande forno caldissimo. Vittoria ci voleva un bene dell’anima! A Noriglio eravamo molto conosciute e d’inverno, quando nevicava, i ragazzini che dovevano scendere a Rovereto per frequentare la scuola post elementare ci aspettavano ai Valteri, all’imbocco della “strada vecia”; noi arrivavamo cantando a squarciagola e loro quindi ci seguivano calpestando le nostre orme: praticamente ci “utilizzavano” come apripista! Mi ricordo che una volta, arrivata alle Laste Rosse, in prossimità dell’acquedotto civico, scivolai sul ghiaccio, rovesciando tutto il latte. Dovetti ricomprare il latte per poi rivenderlo alle mie “poste”! Che dire poi delle scarpe? “Taievem fora ’na vecia cuerta e la spontezevem” con dello spago, in maniera tale da formare una suola di una certa consistenza e poi usavamo per la parte superiore delle tele. Certo che quando pioveva si inzuppavano di acqua! Durante il periodo della guerra invece, come suola si usavano pezzi di copertoni di automobile che mio padre recuperava in un’officina di corso Bettini. Mio padre li ritagliava sagomandoli e li “chiodava” per unire la parte superiore della calzatura con la suola ma i chiodi non di rado fuoriuscivano e mi facevano sanguinare i piedi. Non ho mai avuto un paio di calze ma solo calzini che, pure quando ero giovane, realizzavo filando la lana di un paio di pecore che avevamo lassù ai Potrìch. Frequentemente scendevo a Rovereto, sempre a piedi e insieme a mia sorella Enrica, con un carretto carico di legna da vendere in piazza della Pesa; avevamo una clientela fissa in piazza Rosmini che ci comprava la legna: si trattava di tre signore anziane che abitavano all’ultimo piano dell’edificio dove un tempo c’era la vecchia Cassa Malati. Oltre al latte, si commerciavano anche i funghi. Molte volte, mi ricordo bene, andavamo sul Monte Maggio a cercar funghi che poi vendevamo – ma non sempre ci riuscivamo – nella zona di Volano, Calliano e Aldeno. Ovviamente ci recavamo in quei paesi sempre a piedi, partendo da Potrìch e tornavamo a casa che era sera inoltrata. Anche quando mi sono trasferita a Senter di Noriglio, per un periodo ho continuato a scendere a piedi in città per vender latte e legna, addirittura anche durante gli ultimi giorni della mia prima gravidanza. Era il 1951; la mattina ero stata a Rovereto a vendere i soliti prodotti e al ritorno, giunta al maso Brenti, avvertii le prime contrazioni. La signora che abitava in quel maso mi disse: “Toi, varda de nar su drita (al Senter, nda), che è arivà l’ora”. Infatti la sera diedi alla 15 luce mia figlia, con l’aiuto della levatrice di Noriglio signora Amalia Giori.11 “Mah ... quei de ancoi no i te ascolta e no i capis; noi sem nati con la povertà!” (conversazioni del 07.12. 2008 e 18.01.2009) Gruppo di ragazze alla fontana di Scottini, 1926 circa. Prima da dx: Ida Scottini Ines G. (classe 1931). Sono nata ai Dieneri e la mia famiglia era numerosa. Anch’io, come la maggior parte delle donne delle frazioni alte, ho percorso tantissime volte il tragitto fino a Rovereto per vendere il latte e la legna. Anche la mia famiglia, come molte altre, aveva una mucca. Partivo da Dieneri verso le cinque di mattina con le mie coetanee e con altre donne, tutti i giorni, tranne la domenica. In prossimità di Castèdile si ritrovavano i gruppetti delle “scotinère” e più sotto, verso la croce, le ragazze dei Potrìch. Verso le sette di mattina eravamo già a Rovereto nella “piazzetta delle scotinère”, in via Rialto, e questo accadeva in tutte le stagioni, anche d’inverno. Calzavamo le scarpe di pezza che venivano realizzate da noi ragazze con parti di vecchie coperte; d’inverno alcune di noi, per maggior sicurezza, mettevano anche dei ramponi (“scarpeloti”) sotto le scarpe. A questo proposito si veda anche Gino Gerola il quale, nella sua opera “La stagione dei Bortolini”, racconta di una lattivendola che, colta da improvvise doglie, partorì lungo il sentiero che da Valgrande porta a Scottini. (pp. 132-139) 11 16 Mi ricordo che, quando la temperatura scendeva sotto zero, il latte nel recipiente formava una pellicola di ghiaccio ed allora entravamo nella piccola rivendita di vini della signora Rita Raffaelli di Volano che c’era nel portichetto di fronte alla “piazzetta delle scotinère”. Qui ci scaldavamo un po’ e mettevamo il “raminel” del latte accanto alla stufa, in maniera tale da sciogliere la pellicola di ghiaccio. Giravamo per il centro storico dove ciascuna di noi aveva la propria “posta” e poi tornavamo a casa, sempre a piedi, talvolta dopo aver comperato un po’ di farina o di pasta. Sulla strada del ritorno, mi ricordo che arrivati al maso Brenti la signora Oliva, che abitava proprio in quella casa, aveva pronto un boccaletto di “vin picol” per quelle più assetate. In piena estate, tra luglio e agosto, si collaborava anche allo sfalcio dei prati del Finonchio. Infatti appena tornate da Rovereto, poco prima di mezzogiorno, si preparava la polenta e da Scottini la portavamo sul Finonchio, si pranzava insieme con mio padre e il resto della famiglia e dopo aver mangiato si proseguiva a rastrellare l’erba tagliata. Il fieno lo raccoglievamo in lenzuola di iuta, che poi richiudevamo incrociando e annodando gli angoli e portando il tutto alla Padrecim, dove c’era il punto di ritrovo delle slitte utilizzate per il trasporto in paese: era uno scenario bellissimo! Per noi non era fatica ma semplicemente la nostra vita. Verso il 1960 però ci proibirono di portare il latte a Rovereto: c’era la SAV e la centrale del latte e i tempi stavano cambiando... Spesso - durante il periodo della guerra, ma anche dopo - andavo anche a Rovereto con un carretto carico di legna che preparavamo la sera precedente. Portavamo le “stèle” di legna - già legate insieme con cerchi di ferro - giù alla Valgrande con le nostre slitte e ognuno le caricava sul proprio carretto; quindi risalivamo il sentiero con la slitta vuota verso Scottini. Il mattino successivo portavamo il carico a Rovereto fermandoci alla piazzetta del Trivio, dove aspettavamo i compratori. Mi ricordo che durante la guerra – avrò avuto tredici o quattordici anni – si presentò nella piazzetta una signora che mi chiese quanto costasse tutta la mia legna e le risposi che costava trecento lire. Mi disse quindi che avrebbe acquistato anche altri carretti di legna nei giorni successivi. Ciò mi rese felicissima perché avrei avuto un guadagno assicurato. Presi il carretto e lo tirai faticosamente – senza essere aiutata – verso piazza S. Marco e via della Terra. Entrai in un edificio proprio in fondo a via della Terra, oltrepassando un portone; iniziai a portare la legna fin su all’ultimo piano dove abitava questa signora e feci più volte le scale senza alcun aiuto - finché riuscii a consegnare tutta la legna. In quel mentre suonò l’allarme antiaereo e la signora voleva frettolosamente congedarmi dandomi solo cento lire. Allora mi misi a piangere perché m sentivo presa in giro. La signora, infastidita, mi liquidò dandomi le trecento lire che avevo pattuito e dicendomi in malo modo: “no sta pu portarme legna!”. Uscita dal portone, incontrai la mia mamma che aveva appena finito di vendere il latte presso alcune famiglie sue clienti abituali; di corsa andammo a ripararci nel rifugio antiareo di piazza 17 Podestà, sotto il castello. La mia gioia lasciò spazio a una profonda delusione e tristezza. Un altro episodio mi è rimasto tristemente impresso nella mente. Una mattina stavo risalendo a piedi da Rovereto verso casa con il carretto della legna vuoto. Nei pressi della Costa di Noriglio raggiunsi un carro trainato da un cavallo che stava salendo verso Terragnolo; allora provai ad attaccarmi dietro afferrando un traversino con una mano per farmi trainare. Il conducente, un signore di Serrada, accortosi della mia intenzione si girò verso di me dicendomi con un tono burbero: “popa, destachete da lì che el caval el fa fadiga!”. Ci rimasi veramente male, considerai quell’atteggiamento un atto di cattiveria umana. (conversazione del 18.10.2008) La lattivendola Gina Scottini, 1946 circa 18 Tullia S. (classe 1925). Innanzitutto ricordo che partivamo tutti i giorni da Scottini la mattina che era ancora buio pesto, con la testa coperta da un fazzoletto – praticamente come tutte le donne di Terragnolo - le scarpe di pezza e il lumino ad olio per far luce lungo i sentieri. Percorrevo con le amiche il solito giro, fin giù alla Valgrande, prendendo la strada provinciale all’epoca non asfaltata, attraversando la galleria di Terragnolo e giù fino a Noriglio attraversando la zona detta “marognon”; passavo davanti alla Silvia (negozio di generi misti/osteria ai Valteri), cinquanta metri dopo imboccavo la “strada vecia” e arrivata al capitello di S. Antonio, mi riposavo un attimo insieme alle mie amiche per poi proseguire verso le Laste rosse. Giunta in Valbusa piccola, depositavo la mia legna nella “piazzetta delle scotinère” e mi cambiavo le scarpe; appoggiavo le mie borse sopra il muretto basso che fa da schienale alla fontanella. Dopo aver venduto la legna, andavo alle mie “poste” abituali per vendere il latte. Quindi si tornava a casa, talvolta dopo aver comperato mezzo litro di olio. Mi ricordo che una volta a Rovereto – intorno al 1950 – presi una multa dal vigile sanitario perché il mio misurino del latte non era a norma. A mio parere però c’era un controllo fin troppo severo. Spesso poi andavo a raccogliere funghi, per poi venderli perfino ad Aldeno, dove mi recavo sempre a piedi. A Rovereto in piazza Erbe c’era una guardia severa, soprannominata “il Rosso”, che controllava la commestibilità e la bontà dei funghi: se trovava un fungo leggermente guasto, prendeva il cesto “de quela pora donna” e lo svuotava nella roggia vicina (di via Tartarotti, nda). Tempi di grandi fatiche, ma mi ricordo che c’era una grande amicizia e solidarietà tra noi “scotinère”, si camminava cantando, anche a braccetto, c’era molta allegria ed eravamo sempre contente. (conversazione del 25.10.2008) Rita S. (classe 1931). Sono nata a Scottini. Anch’io scendevo a piedi a Rovereto per vendere il latte, seguendo le orme di mia nonna Giuditta, famosa lattivendola che ha camminato così tanto da aver percorso tanti chilometri quanto quattro volte il giro del mondo. Ho praticato questo commercio fin verso il 1955, quando mi sono sposata. Avrei tanti episodi da raccontare, come quando una mattina del 1946, in pieno inverno, poco sotto Scottini, sono scivolata sul ghiaccio rovesciando una decina di litri di latte. Sono comunque scesa a Rovereto ove comperai alcuni litri di latte per poi rivenderlo ai soliti clienti, temendo i rimproveri dei miei genitori. Quella stessa mattina portai ad aggiustare il “raminel” da un artigiano (un “bander”) che aveva un negozio in prossimità della Posta. Ritornai a casa sfinita e la mia mamma non si accorse del malanno che avevo combinato: riuscì a scoprirlo solo l’anno successivo. Il posto di ritrovo delle “scotinère” era la piazzetta con fontanella in cima a via Rialto, mentre nel portico di fronte si concentravano le donne dei Dieneri e quelle provenienti dai Perini; le lattivendole che scendevano da Senter di Noriglio facevano quasi sempre base in prossimità del negozio dei fratelli Canevari (negozio di generi misti: tabacchi, mercerie, verdura, nda). Andavamo di casa in casa a vendere il latte: i portoni d’accesso all’epoca erano sempre aperti e si poteva 19 entrare tranquillamente nei cortili. Mi ricordo tra l’altro che uno dei miei clienti fedeli era il signor Bettini, proprietario della fabbrica (conceria) in via delle Fosse. Mi ricordo inoltre un altro episodio accaduto durante la guerra. Al ritorno da Rovereto, giunti in prossimità della galleria lungo lo stradone per Terragnolo, ci accorgemmo che era presidiata da un folto gruppo di soldati tedeschi: allora per aggirare l’ostacolo ripiegammo su alla Cisterna e di lì riuscimmo a girare verso Potrìch e quindi a Scottini. Durante la guerra talvolta ci pagavano il latte dandoci in cambio della pasta. Comunque non si scendeva a Rovereto solo per vendere il latte. Infatti si andava anche negli altri paesi della Vallagarina a vendere i funghi, partendo a notte fonda, anche all’una di notte, con i lanternini accesi!! (conversazione del 16.10.2008) Rosa S. (classe 1917). Fino al 1937 ho vissuto a Scottini dove la mia famiglia aveva un paio di mucche. Io scendevo poche volte a Rovereto con le mie amiche per la vendita del latte, più spesso trovavo qualche scusa per evitare queste lunghe camminate. Mi ricordo comunque che si scendeva a valle, con le scarpe di pezza che riuscivamo a farci da sole “spontezando” (cucendo ripetutamente, nda) la suola per indurirla. Un paio di ragazze di Scottini erano bravissime a realizzare questo tipo di calzature. Lungo tutta la discesa cantavamo sempre ed eravamo sempre allegre. Davanti al capitello di S. Antonio, sotto Noriglio, qualcuna si raccomandava al Santo. Si raccontava all’epoca che una donna di Terragnolo, di età piuttosto avanzata, aveva promesso a S. Antonio che se avesse venduto presto tutto il latte, al ritorno avrebbe rifornito di olio il lumino che si trovava all’interno del capitello; però non mantenne la promessa e poco dopo aver oltrepassato il capitello, le cadde in terra la bottiglia dell’olio che si ruppe in mille pezzi. In prossimità di Rovereto ci cambiavamo le calzature con scarpe più “degne” e ci mettevamo un po’ in ordine. Nella nostra “piazzetta delle scotinère” veniva spesso don Guido Gaifas che comprava la legna dalle mie compaesane (in particolare si rivolgeva a tre “scotinère” piuttosto anziane). Don Gaifas era di casa a Scottini, dove saliva frequentemente il sabato per celebrare la santa messa. Mi ricordo poi che molte “teragnóle”, conclusa la vendita del latte, andavano all’osteria del “Peloso” in piazza Malfatti a mangiare le trippe; a me quel nome non ispirava affatto perché mi suggeriva un’idea di sporcizia ed allora facevo una capatina all’osteria Stedile oppure al Dorighel. Anche le scarpe ogni tanto avevano bisogno di manutenzione, ed allora, quando ce n’era proprio bisogno, ci rivolgevamo al calzolaio che aveva il laboratorio in fondo a Valteri; al ritorno da Rovereto passavamo da lui a ritirarle. La strada da percorrere era molto lunga e al ritorno la fatica si faceva sentire; mi ricordo che arrivate finalmente alla Valgrande ci fermavamo a dissetarci alla sorgente, per poi proseguire fin su a Scottini. (conversazione del 02.11.2008) Angelina L.D. (classe 1921). Sono nata alle Fucine Sant’Antonio, vicino a San Nicolò ove ho vissuto fino agli anni Cinquanta. Ho fatto la lattivendola portando il 20 latte da San Nicolò a Rovereto nel periodo dal 1935 al 1936 circa. Eravamo circa una ventina di ragazze dedicate a questo lavoro; mi ricordo ancora bene: otto erano dalle Fontanelle, una decina da S. Nicolò, una abitava al Mas del Fo’ e si chiamava Delinda Potrìch e aveva poco più di trent’anni; due vivevano ai Rocchi e poi c’ero io da Fucine S. Antonio. Comunque anche mia madre portava il latte a Rovereto e precisamente alle suore delle Dame Inglesi. Tornando a noi ragazze, prima partivano quelle da S. Nicolò che arrivate alle Fucine, mi chiamavano gridando; mi aggregavo subito al gruppo, poi arrivavano anche le due ragazze dei Rocchi. La Delinda Potrìch, la più grande di noi, ci raccomandava sempre di non “slambrotar” il latte, cioè di non farlo muovere troppo nel contenitore per non rischiare di guastarlo. Per far questo dovevamo tenere un’andatura costante ed un passo sincronizzato (un tipo di camminata simile a quella degli sherpa sulle montagne del Nepal, nda). Nelle mattinate d’inverno ognuna di noi metteva sul gancio della “zerla”, nella parte anteriore, un lanternino ad olio. Mi ricordo uno scenario bellissimo di questi lumini che brillavano nel buio. Nella parte anteriore avevamo il “raminel del late col bochim strupà” (per evitare che il latte fuoriuscisse dal recipiente, nda) e un misurino da mezzo litro; nella parte posteriore talvolta avevamo appesa una fascina di legna. Quelle volte che non avevamo la legna, per far da contrappeso dietro usavamo un sasso che poi, arrivate verso le sette di mattina in prossimità di piazza Podestà, gettavamo ai bordi della strada, su un mucchio di ghiaia. Lo stradino di quella zona imprecava sempre contro di noi perché gli “sporcavamo” la ghiaia e la sabbia. In prossimità dell’edificio sede della Finanza le guardie municipali facevano frequentemente controlli sanitari: verificavano soprattutto se il misurino fosse 12 pulito. Io comunque non ho mai preso multe! Io vendevo il latte soprattutto nella zona di S. Maria, è per questo che raramente incontravo le colleghe “scotinère” che frequentavano altre zone della città (le due Valbuse, via della Terra etc.). Mi ricordo che vendevo il latte a ottanta centesimi il litro; alcuni clienti pagavano di volta in volta, altri invece ogni quindici 12 Nell’archivio storico presso la Biblioteca Tartarotti sono conservati i fascicoli contenenti le contravvenzioni al regolamento comunale d’igiene. Non sono rare le contravvenzioni comminate negli anni trenta alle lattivendole e alle venditrici di funghi. Si veda ad esempio il verbale del comando vigili urbani datato 8 marzo 1934: “Si denuncia Giuseppina S. da Fontanelle di Terragnolo perché alle ore 6.30 circa di ieri venne sorpresa in piazza Podestà mentre portava a vendere in giro per la città, litri 9 circa di latte molto sudicio. Detto latte venne immediatamente sequestrato ed in seguito ad ordine ricevuto dal signor ufficiale sanitario dr. Condini, distrutto”. (Ascr-Bcr, 12/1, 1934). Il controllo igienico del latte era sempre stato una delle preoccupazioni delle autorità sanitarie comunali. Si veda a tal proposito la pubblicazione dell’ufficiale sanitario Augusto Bresadola edita in epoca precedente alla prima guerra mondiale: A. Bresadola, Le sofisticazioni del latte introdotto in città. Ricerche chimiche preventive, Rovereto 1902. Interessanti sono poi le considerazioni di Diego Leoni il quale osserva: “(...) lo scambio di questo prodotto - il latte - divenne emblematico di quell’ambiguità che legava i due popoli, quello di città e quello del contado: elemento insostituibile dell’alimentazione dei bambini, veniva tolto agli uni per cibare gli altri, ai quali però poteva arrivare adulterato e fonte di malattie” (A. Leoni, La “Grande Rovereto” Storia di un fallimento, cit., p. 72) 21 giorni e questi mi lasciavano la chiave d’ingresso sotto lo zerbino. Alla fine del giro andavamo in un magazzino di frutta e verdura in piazza Malfatti, dove, per dieci centesimi, si poteva comperare la frutta che non era più commerciabile. Eravamo vestite con gonne “de moletom, fin sotto i polpacci, scarpe coi ciodi e broche”; a S. Colombano mi toglievo dalle scarpe le strisce di tela che mia madre mi faceva avvolgere intorno alle calzature, raccomandandomi: “entant che se bagna le fasce, no se bagna le scarpe!!”. Le fasce le nascondevo nelle fessure dei muri e al ritorno le ho sempre ritrovate nel posto dove le avevo lasciate. (conversazione del 13.11.2008 ) Gemma P. (classe 1938). Mia madre si chiamava Ida Scottini, nata nel 1910. Mi raccontava spesso delle sue “discese” a Rovereto per vendere il latte. Ecco un episodio che mi è rimasto impresso nella mente. Un giorno lungo la strada provinciale - stiamo parlando degli anni Trenta - mia madre aveva appena oltrepassato il Maso Brenti, quando incrociò una delle rare automobili che risalivano da Rovereto. L’automobile purtroppo la urtò scaraventandola a terra. Mia madre, invece di preoccuparsi delle abrasioni riportate, continuava a esclamare: oh Dio, il mio latte, il mio latte! Il commerciante che era alla guida - me lo ha riferito più di una volta lui stesso - si assicurò delle condizioni di salute di mia madre - per fortuna nulla di grave - le risarcì il latte e proseguì quindi la risalita verso Terragnolo e Serrada. Mia madre ritornò a casa, continuando a lamentarsi per la perdita del latte prezioso. La mattina, verso le quattro, mia madre si alzava a mungere la vacca e poi partiva per Rovereto dove arrivava verso le sette con il suo latte; per contrappeso portava sempre nella parte posteriore della “zerla” un rotolo di legna tagliata in “stèle” oppure una cesta colma di ciliegie, conforme la stagione, ma anche sacchetti di cenere per far la “liscia”. Percorreva sempre la strada provinciale, con le altre “scotinère”, fino a Noriglio e poi giù alle Laste rosse. Qui durante l’inverno, dopo abbondanti nevicate, i ragazzi che abitavano in quella zona erano soliti battere una pista, facendola ghiacciare, per slittare più veloci giù per via Acquedotto: la strada era molto pendente e pertanto molto pericolosa, quindi le “scotinère ” erano spesso costrette a tornare indietro in prossimità della Val Corbella e da lì scendere per un tratto di viale dei Colli; quindi giunte in prossimità di casa Salvetti, girare a sinistra scendendo lungo una scorciatoia che porta in via Balteri e quindi giù per la Valbusa piccola fino ad arrivare alla “piazzetta delle scotinère”. Alcune volte, terminata la vendita del latte e della legna, mia madre affidava la “zerla” alle sue amiche e si fermava in città a prestare servizio presso qualche famiglia, soprattutto per fare la “liscia”: quei giorni, terminato un bucato dietro l’altro, tornava a casa arrivando verso le otto di sera, passando dalla frazione Perini, ove abitava il suo fidanzato (mio futuro padre) che l’aspettava ma non voleva essere accompagnata: si accontentava che mio padre la seguisse comunque con lo sguardo mentre risaliva il ripido sentiero verso Scottini. 22 Una volta - circa negli anni Trenta, prima che si sposasse - si era fatta ricamare delle lenzuola da una cucitrice roveretana; un mattino andò a ritirarle, depositandole poi vicino alla fontana di via Rialto pensando di tornare a riprenderle più tardi, non appena concluso il giro delle “poste”. Al ritorno purtroppo trovò una spiacevole sorpresa: le lenzuola erano scomparse! Mia madre si sposò nel 1935 per andare a vivere ai Perini: così il mattino poteva svegliarsi più tardi! Tutti i giorni comunque la stessa storia: avanti e indietro a piedi con il latte e altri prodotti, e così per anni e anni. Negli anni Quaranta, nel periodo dei bachi da seta, mia madre, dopo aver finito con le solite “poste” del latte, andava a lavorare presso un contadino che aveva la campagna nella zona attualmente occupata a via Magazol per aiutarlo nelle operazioni di allevamento dei bachi: naturalmente quelle giornate rientrava a Scottini che era notte fonda. Talvolta insieme al latte, nel periodo primaverile, portava a Rovereto anche una discreta quantità di lumache che solitamente vendeva al negozio Farinati in via Rialto. Le lumache venivano raccolte, ad autunno inoltrato, nelle campagne intorno ai Perini e quindi poste in un grande cestone di vimini, chiamato “caselera”, che aveva una forma particolare, molto largo alla base e stretto nella parte superiore per impedirne l’uscita. Nella “caselera” le lumache venivano nutrite per tutto l’inverno in attesa di essere poi commerciate in città. Anch’io, seguendo le orme di mia madre, ho camminato avanti e indietro da Terragnolo a Rovereto, ma non per vendere il latte: dai primi anni ’50 fino al 1956 circa scendevo infatti a piedi in città dai Perini con il mio carico di legna e mele, insieme ad una decina di donne della mia frazione. Questo finché trovai da lavorare in una fabbrica in città. (conversazione del 18.02.2009) LE “OVAROLE” DI TERRAGNOLO E LE VENDITRICI DI FUNGHI Nella prima metà del secolo scorso - in particolare negli anni Trenta e Quaranta, le donne di Terragnolo, soprattutto quelle che abitavano nelle ultime frazioni di Zoreri e Incapo, superavano il passo della Borcola per calare, attraverso la vecchia mulattiera del “Sojo”, con la “zerla” e le ceste, in Val di Posina a commerciare e a cercare soprattutto le uova, per poi rivenderle con un leggero rincaro di prezzo a Rovereto, dove questo prodotto era facilmente smerciabile.13 Erano conosciute come le “ovarole” e ognuna a Rovereto aveva la sue “poste”, cioè i suoi punti vendita. Ecco le loro storie. Ida B. (classe 1923). Sono nata ad Incapo, l’ultima frazione di Terragnolo. Era soprattutto mio padre, talvolta con mia madre, che partiva il mattino prestissimo Si veda quanto descritto nella guida di L. Carollo, Guida escursionistica della Val Posina, Thiene, 2008, con riferimento all’itinerario n. 27: Da Cavallara (contrada Xausa) al Passo della Borcola per il “Sentiero dèe teragnole”, pp. 194-195. 13 23 per andare fin su alla Borcola e poi dirigersi verso Posina. Passava di frazione in frazione, come altre donne terragnolesi, arrivando talvolta fino alle Valli del Pasubio e qualche volta passava anche dal “casel” di Posina per acquistare il burro da rivendere a Rovereto. Mio padre acquistava le uova pagando in centesimi e le riponeva con cautela in due ceste sulla “zerla”, una davanti e l’altra dietro; e così di 14 casa in casa. Poi ritornava a Incapo e le altre “teragnóle” alle rispettive frazioni, percorrendo ripidi sentieri. In pieno inverno più di una volta, ritornando alla Borcola da Posina, le nevicate era così abbondanti che le ceste di uova toccavano il manto di neve e a causa del gelo qualcuna “scoppiava”. A casa le uova venivano messe in apposite ceste, dopo averle un po’ ripulite e le donne le portavano a Rovereto il mattino successivo. Queste donne si ritrovavano nella piazzetta di via Rialto, per poi recarsi presso varie famiglie. Tantissime volte ho accompagnato mia madre ed anche la mia nonna in questo commercio e i miei ricordi risalgono al periodo antecedente la seconda guerra mondiale. I miei genitori mi davano sempre l’incarico di portare un lanternino, per illuminare la strada poiché partivamo da Incapo che era buio pesto, alle quattro di mattina. Arrivati al Puechem verso le cinque, depositavo il lanternino su una finestra di una casa abitata da una famiglia che conoscevamo (mi sembra ancora di vederlo questo lanternino!). Alla Valgrande era facile incontrare le “scotinère” che si dirigevano in città per la vendita del latte. In città le nostre donne giravano di casa in casa - le chiamavamo “le case dei siori” - vendendo alle varie famiglie una decina di uova alla volta, mentre io rimanevo in prossimità del portichetto, di fronte alla “piazzetta delle scotinère” per controllare le grandi ceste usate per il trasporto. Mi ricordo che arrivavano in questa piazzetta le donne di Scottini con il latte, le “sarmente” per accendere il fuoco e anche sacchetti di cenere utilizzata all’epoca per fare il bucato: c’era anche una tal Marcella da Scottini che portava le uova, anche lei andava a Posina a prenderle e il giorno dopo le commerciava a Rovereto. Mi ricordo poi che mia nonna Fiore Gerola vendeva le uova anche ad alcuni negozianti roveretani e oltre a qualche soldo riceveva in sovrappiù anche un po’ di pasta e di riso. Io facevo sempr e compagnia alla nonna. In tempo di Pasqua scendeva a Rovereto anche un mio zio - figlio di mia nonna Fiore - con un cavallo ed un carretto a quattro ruote (chiamato “la bara”) carico di cassette piene di uova; le “ovarole” seguivano a piedi e arrivate in città avevano un bel da fare a smerciare tutto quel quantitativo! Ma ecco come nacque questo commercio delle uova tra Posina, Terragnolo e Rovereto. Quando ero piccola mia nonna Fiore mi raccontava che era solita 14 Secondo quanto ricordato dalla signora Ida B., le donne di Posina potevano gestirsi direttamente il guadagno che derivava dalla vendita delle uova alle “teragnole”, anziché consegnarlo ai mariti. Nel periodo pasquale - riferisce sempre la signora Ida - il parroco di Posina passava di casa in casa per la benedizione e riceveva un uovo per ogni componente la famiglia, ritrovandosi così con centinaia di uova; il padre di Ida, conoscendo questa usanza - era una sorta di decima - andava appositamente in canonica a Posina per acquistare a buon prezzo una gran quantità di uova che poi venivano appunto rivendute a Rovereto. 24 comprare una grande quantità di uova che le servivano per nutrire e rinforzare il fisico dei suoi figli spesso malaticci, per “tirarli su meglio”. Un giorno mia nonna avanzò parecchie uova ed allora provò a rivenderle a Rovereto dove furono molto apprezzate. E così, considerato il successo della prima esperienza, divenne una delle prime “ovarole” di Terragnolo, proseguendo per un lungo periodo questo piccolo commercio. Per ultimo, un breve ricordo sul nostro abbigliamento, soprattutto quello delle “scotinère”. Indossavamo “i scalfaroti” - calzettoni grossi - che sotto avevano una suola grossa fatta di lana e stracci di grosso spessore; la parte superiore era di lana e quindi rischiavano di inumidirsi presto. In particolare le “scotinère”, giunte a Rovereto, si cambiavano le calzature mettendo pantofole di pezza acquistate dalle ambulanti provenienti dal bellunese (queste vendevano anche utensileria da cucina), oppure con pantofole di panno portate da qualche emigrante che rientrava periodicamente dalla Francia. In genere le “teragnóle” indossavano vestiti scuri ed era usanza coprirsi la testa con un fazzoletto; in particolare le donne provenienti da Scottini usavano fazzoletti con colori vivaci e portavano anche il corpetto. (conversazione del 14.02. 2009) Onorina T. (classe 1913) . Sono nata a Zoreri di Terragnolo nel 1913. Eravamo una famiglia numerosa di tredici persone. Nel 1915 sono sfollata in Austria con i familiari (anche se ero piccola ho ancora dei ricordi vivi di quel periodo). Al rientro in paese, dopo la fine della guerra, c’era molta distruzione e miseria. Mi ricordo che nel primo dopoguerra le donne del paese andavano a recuperare le vecchie scarpe dei soldati, che avevano le suole con le “broche a zata”, per riutilizzarle e riadattarle a ciabatte, altrimenti dovevano camminare scalze perché non avevano nulla. Fin dall’età di tredici anni sono andata fuori paese in servizio, dapprima con le mucche a Pedersano e poi a fare le stagioni a Folgaria, S. Candido e anche a Lugano. Sono rientrata a Zoreri nel 1939 quando mi sposai. Da allora iniziai un’esperienza - durata qualche anno - di piccolo commercio di uova, patate e frutta di stagione - ma mai con la legna - giù nel roveretano. Mi ricordo che negli anni quaranta - avevo i figli piccoli e mi aiutava mia suocera - io e la mia amica Giuditta Fox, soprattutto nel periodo pasquale, partivamo alle quattro di mattina, per dirigerci alla Borcola, scendere verso la contrada di Bettale e quindi Posina, risalire al passo Xomo e giù a Ciccheleri e spesso a Valli del Pasubio. Passavamo di casa in casa a comprare le uova; in quella zona tante famiglie allevavano molte galline. Erano sempre le donne che ci preparavano le uova, ormai ci conoscevano. Ciascuna di noi riempiva un paio di ceste che poi mettevamo sulla “zerla”; quindi tornavamo a Terragnolo verso sera. Il giorno dopo - questo succedeva una volta alla settimana - partivamo per Rovereto anche alle due di notte, con le pantofole, la “zerla” e un lanternino. Lungo il percorso incontravamo le colleghe “scotinère” e quelle dei Pergheri. Mi ricordo che arrivate al capitello di S. Antonio sotto Noriglio, lungo la “strada vecia”, le donne di Scottini si fermavano per chiedere aiuto al Santo: supplicavano 25 di aiutarle a vendere il latte e in cambio accendevano un lumino. Dopo le Laste rosse, arrivate al Dosso del castello, le “scotinère” si cambiavano le giacchette tutte sudate e le scarpe, si pettinavano e proseguivano verso la Valbusa. Io e la mia amica Giuditta arrivavamo in piazza Erbe che era ancora buio e ci recavamo al magazzino del “Bibo” - questo era il soprannome del proprietario - che aveva un mantello scuro: ci sembrava quasi il diavolo! Il “Bibo” contava le uova una alla volta mettendole su un lungo tavolone e quindi ci pagava. Con venti centesimi si poteva comprare, lì nei paraggi, un “incarto di carobola e fichi secchi”. Analoga operazione succedeva quando portavamo dal grossista le nostre patate bianche, le noci, magari anche qualche mela. Mi ricordo anche che una volta in piazza Erbe - una zona sempre presidiata da molti militari - trovai per terra una tessera del pane e con questa potei acquistarne per due o tre mesi: una bella fortuna!! Terminate le operazioni di vendita, qualche volta andavo alla casa Fox (in prossimità della stazione autocorriere, nda) a bere una gassosa o un bicchierino di vermouth e mangiare “una ciopeta de pan”. Quando io e la mia amica eravamo proprio affamate, andavamo all’osteria Stedile, dove - mi ricordo bene - c’erano le panche belle calde e mangiavamo un piatto di trippe. Ovviamente non si entrava con le “zerle” e le ceste ma le depositavamo nel portico di fronte alla “piazzetta delle scotinère”. Qualche volta però ci rubavano i tovaglioli bianchi che usavamo per coprire le patate e che lasciavamo nelle ceste! Mi ricordo poi alcuni episodi che mi sono sempre rimasti impressi. Una volta, sulla strada del ritorno, arrivate a Ciccheleri, ci imbattemmo in un plotone di tedeschi e quindi impaurite ripiegammo su per i boschi con le nostre ceste di uova; arrivate al Xomo ci apparve un paesaggio terrificante: quello che nei giorni precedenti era un agglomerato di baracche era stato distrutto e bruciato. Un’altra volta i militari tedeschi ci fermarono in un paese delle Valli di Pasubio e volevano arrestarci perché ci accusarono di favorire i partigiani, fornendo aiuti alimentari. Ho ricordi anche belli: mio padre aveva degli alveari e io portavo il nostro miele ad una famiglia roveretana che abitava in fondo a corso Bettini; mi volevano così bene che mi offrivano sempre il caffelatte! Infine ricordo che alcune donne della mia zona - me ne ricordo in particolare tre della frazione Zoreri - andavano fino a Posina non tanto per le uova ma per vendere le nostre ciliegie perché in quella zona era difficile coltivarle. (conversazione del 21.02.2009) Sofia B. (classe 1922). Io negli anni Venti e Trenta abitavo nella frazione Incapo, dove sono nata. La mia famiglia aveva una mucca ed un maiale ma non andavamo a Rovereto a vendere il latte. Posso dire però che da piccola andavo alla Borcola a raccogliere legna per predisporre delle fascine. Anche se non sono scesa frequentemente a Rovereto come le altre lattivendole, ho comunque fatto un’esperienza di alcuni mesi come venditrice di uova in città. Era la primavera del 1943 ed ero appena rientrata da Milano dove prestavo servizio presso una famiglia. Mi ricordo che andavo a piedi a Posina con 26 una mia amica (Ida B.) in cerca di uova. Ci alzavamo il mattino presto e, in poco più di due ore di cammino, eravamo in prossimità delle prime case di Posina. Qui giravamo per le famiglie e acquistavamo 3-4 uova da una parte, poi 5-6 da un’altra famiglia e così via, fino a riempire una grande cesta. Quindi tornavamo a Incapo verso la sera. Il mattino successivo, verso le tre e mezzo, io e la mia amica Ida partivamo a piedi con il cesto pieno di uova. Giunte in prossimità dell’acquedotto civico (“fontanom”), incontravamo sempre un paio di fruttivendoli roveretani che ci aspettavano per condurci nei loro negozi. Mi ricordo che uno di questi era il signor Malena, che aveva un negozio di frutta e verdura in via Garibaldi. A loro vendevamo le uova guadagnando qualche soldo, perché le uova non erano soggette a tessera ma la loro vendita era libera. (conversazione del 13.12.2008 ) Pierina P. (classe 1930). Eravamo in otto fratelli ai Zencheri, dove sono nata. Verso settembre iniziava la raccolta dei funghi e la loro vendita in città. La mattina presto mia madre ci svegliava - anche alle due di notte - dicendoci: “dai putele, alzeve sù che ne per fonghi”. Partivo in compagnia di due sorelle e un paio di fratelli, senza lanternino ma con il chiarore della luna, verso le Coe e quindi ci dirigevamo ai Fiorentini e sul Coston. Si aggregavano anche altri ragazzi delle frazioni Valle, Pergheri e Zencheri (una quindicina in tutto) che poi si sparpagliavano in quelle zone a cercare funghi. Arrivati ai Costoni verso le cinque - all’incirca avrò avuto dodici anni - accendevamo un fuoco per abbrustolire alcune fette di polenta e poi, spuntata l’alba, ci sparpagliavamo in cerca di “brise e fonghi del sangue”. A metà pomeriggio il gruppo si riuniva per ritornare a casa e dare una ripulita ai funghi. La mattina successiva partivamo per Rovereto verso le tre e mezza con la nostra “zerla” e un lanternino. Passavamo dalla Costa e da lì prendevamo una scorciatoia che portava fin giù ai Pedrazzi e lì, al capitello sul ciglio della strada, riposavamo una decina di minuti, proseguendo poi lungo la provinciale; all’epoca automobili non ne passavano e pertanto non c’erano i pericoli di oggi! Giunte alla Valgrande, riposavamo un’altra volta davanti all’osteria del “Gobbo”. Sopra Noriglio prendevamo le scorciatoie e poi giù dalla “strada vecia” verso il “capitel de S. Antoni” davanti al quale veniva spontaneo recitare un’ave Maria. Al “Dos del Castel” riposavamo un’altra volta, sistemavamo i funghi nelle ceste e ci cambiavamo le scarpe perché percorrevamo il tragitto con vecchie ciabatte di pezza. Quindi proseguivamo verso verso la chiesa di S. Marco - verso le sette di mattina - per poi tagliare giù dalle scalette che portano in piazza delle Erbe. Qui aspettavamo l’Olivo, ovvero il vigile soprannominato “il rosso” - sto parlando degli anni 1944-1946 circa - depositando i funghi su un tavolo per il controllo 15 sanitario. 15 Il rischio di ricevere contravvenzioni per la vendita di funghi guasti (anche leggermente rovinati), era sempre in agguato. Erano multe salate che potevano mettere in crisi una famiglia. Basti frugare ancora nel fascicolo delle contravvenzioni dell’anno 1934 conservato in Biblioteca Tartarotti per comprendere 27 Tutto questo succedeva in prossimità della farmacia Perini, quasi tutti i giorni della settimana, durante la stagione dei funghi; avevamo una bilancia per pesare la quantità desiderata dalle nostre acquirenti, di solito 3-4 etti per volta (una volta una signora mi comprò addirittura più di un chilo di funghi e fu un colpo di fortuna!!). Verso le dieci tornava alla carica “il rosso” per un secondo controllo. Mi ricordo poi che a tarda mattinata spesso abbassavamo i prezzi per non rischiare di rimanere con funghi invenduti. Quindi verso mezzogiorno, conclusa la vendita, ci compravamo un pezzo di pane e ritornavamo a piedi verso Terragnolo. Molte “teragnóle” comunque andavano a vender funghi in altri paesi, ad esempio ad Aldeno, dove i controlli non erano così pignoli come a Rovereto. Io e i miei fratelli abbiamo praticato poi altre attività di piccolo commercio. In aprile infatti andavamo per “lumazi” - avrò avuto quattordici anni -, giù in fondo alla valle in prossimità del Leno, con un gruppo di 7-8 ragazzi e stavamo in quella zona tutto il giorno; crescevano belli grossi “i lumazi” e quando pioveva uscivano a decine dai sassi dei muretti. Li mettevamo nelle ceste e ogni tanto eravamo costretti a spingerli dentro per impedire che scappassero. Mi ricordo che il mattino, quando arrivavo con mia sorella al “Dos del Castel”, dove c’era una grande fontana rettangolare, davamo una bella lavata alle lumache e poi ci dirigevamo verso S. Giorgio, attraversando il centro storico e sgocciolando acqua dappertutto: le nostre lumache andavano a ruba ed era un prodotto assai ricercato e apprezzato dalla gente di quel sobborgo. A Rovereto vendevamo pure mazzetti di fiori, di varie specie e conforme alla stagione . Per esempio in aprile e maggio andavamo a raccogliere i mughetti sul versante sinistro del torrente Leno, meno battuto dal sole, di fronte a Pedrazzi e Fontanelle. In agosto invece nella zona delle Coe si raccoglievano le negritelle e le genziane mentre sul monte Maggio prendevamo i rododendri (i cosiddetti “martei”). I mazzetti di lavanda invece erano quasi l’esclusiva delle donne che abitavano alla frazione Rovri. A casa preparavamo dei bei mazzetti, ben curati e abilmente legati con fili presi da sacchi di iuta e il giorno dopo scendevamo a piedi in città per venderli, non senza aver fatto un breve sosta al “capitel de S. Antoni”, sotto Noriglio, per le drammatiche conseguenze di una multa. A tal proposito si riporta come esempio il verbale della contravvenzione - multa di venti lire - comminata a Rosa G. di Terragnolo in data 4 ottobre 1934: “Si denuncia la suddetta Rosa G. perché alle 9.30 di oggi venne sorpresa in piazza Erbe, mentre teneva esposto al pubblico per la vendita Kg. 1,5 di funghi porcini, sottratti dalla prescritta visita sanitaria e guasti. Detta merce venne immediatamente sequestrata ed in seguito (...) distrutta mediante getto in una fogna”. A seguito della contestazione presentata dalla signora, i carabinieri di Terragnolo fecero degli accertamenti relazionando che la signora Rosa G. era una povera contadina che versava in “miserrime condizioni”, abitava ai Baisi in una piccola casa e possedeva tre “appezzamenti di terreno ed una capra; si dedicava al commercio ambulante di legna “traendone appena il necessario per provvedere al sostentamento”. Il rapporto dei carabinieri precisava che la poveretta non era in grado di pagare l’ammenda. Il Comune di Rovereto, preso atto delle informazioni ottenute, a titolo di conciliazione condonò la contravvenzione avvertendo però che in caso di recidiva sarebbe scattata la denuncia alla Regia Pretura. (Archivio Storico Biblioteca Civica Rovereto, Ascr-Bcr, 12/1, 1934) 28 depositare un mazzetto e pregare affinché il Santo ci aiutasse a guadagnare qualche centesimo. La piazza delle Erbe era il punto di ritrovo per il commercio dei fiori ma non sempre si riusciva a vendere tutti i mazzetti. Allora noi giovani ragazzine andavamo di casa in casa, suonando i campanelli, talvolta anche in maniera insistente (“come i zingheni ades”), cercando di svenderli a poco prezzo: “siora chiedevo - me tolela en mazet de fiori, ghe digo n’Ave Maria alla Madonna”. Devo dire che non ho mai trovato persone che reagissero in malo modo! (conversazione del 16.02.2009) ANCHE I ROVERETANI RICORDANO Ancora un discreto numero di roveretani - anche qualche sessantenne - si ricorda delle donne di Terragnolo che giravano per la città vendendo i loro prodotti. La tradizione del latte scemò verso 1960, allorché un’ordinanza del sindaco vietò lo smercio ambulante del latte ma ciò non impedì che almeno alcune continuassero ancora per qualche anno a frequentare Rovereto, scendendo a piedi dalla loro valle con le loro ceste, per vendere patate o frutta di stagione. Angelina G. (classe 1909). Per molti anni ho abitato nella casa a fianco dell’acquedotto civico di Rovereto, nei pressi delle Laste Rosse, e le “teragnóle” me le ricordo benissimo. Passavano prestissimo davanti all’acquedotto, intorno alle sei di mattina e con il loro vociare tante volte mi svegliavano. Tante altre volte invece ero già in piedi - questo durante il periodo estivo - perché mi preparavo per andare a vender ciliegie insieme a mia madre, passando prima da un grossista di ortofrutta che aveva il suo magazzino in piazza S. Marco. Mi ricordo queste giovani “teragnóle” - erano circa gli anni Venti - che passavano davanti all’acquedotto con il fazzoletto in testa e le loro “zerle”, il lumino ad olio nella parte anteriore, con il “crazidel” pieno di latte e “’na fascinela de legna”. Passavano sempre a gruppetti di quattro o cinque ragazze e talvolta con loro c’era anche qualche uomo che portava ceste di funghi. Giunte all’acquedotto piccolo (al Dosso del Castello, nda), erano solite cambiarsi le ciabatte di pezza - che avevano una suola piuttosto dura - e nascondere quindi le fasciature protettive, nelle fessure dei muri lungo la strada. Alcune scendevano giù per via delle Fosse, altre proseguivano verso via Balteri e la Valbusa piccola per poi concentrarsi nella “piazzetta delle scotinère” in via Rialto, dove c’è una fontanella. Qualcuna riusciva anche a trovare qualche seggiolina per sedersi in attesa dei clienti che compravano la legna. Tutte avevano comunque le loro “poste” fisse per lo smercio del latte. Le “teragnóle” passavano anche nel rione di S. Maria per fare una capatina al molino e pastificio Piccolroazzi. Questo posso dirlo perché nei primi anni Trenta ci ho lavorato per circa tre anni. Le “teragnóle” si rivolgevano a me, che ero brava a far di conto, e mi davano i loro “curzetti” (sacchetti) pieni di orzo e granturco. Io li 29 pesavo e in cambio consegnavo loro farina gialla per un quantitativo pari all’80% di quanto avevo preso in carico. Posso dire che non mi hanno mai imbrogliata! (conversazione del 04.12.2008 ) Tullia B. (classe 1917). Io sono nata a Pozzacchio di Vallarsa nel 1917 e anch’io mi ricordo delle “teragnóle”. Noi “vallarseri” facevamo loro concorrenza soprattutto nella vendita della legna. Mi ricordo che spesso con mio padre – avrò avuto tredici anni – scendevo a Rovereto con un carretto di legna che vendevamo in piazza Pesa. Appena dentro il centro storico incontravamo le donne di Terragnolo, riconoscibili perché avevano quasi sempre un fazzoletto in testa. Mi sono sposata nel 1937 e poco dopo, con la mia famiglia, andai ad abitare nella casa Vescovi, adiacente alla “piazzetta delle scotinère”. La gente era affezionata a queste donne – se ben ricordo la loro età arrivava al massimo ai quaranta cinquant’anni - che arrivavano in via Rialto il mattino presto, in qualsiasi stagione, riempiendo la piazzetta di brusio e chiacchiericcio. Erano sempre almeno una quindicina. C’era sempre molta gente che comprava il loro latte, ma anche le patate e la legna. Anch’io lo acquistavo e me lo ricordo molto buono e genuino, ricco di panna. Spesso il mattino presto preparavo una moka grande di caffè e lo offrivo a queste simpatiche donne. (conversazione del 29.11.2008) Ada B. (classe 1927). Ho vissuto fin da bambina e per gran parte della mia vita nel rione di Valbusa Grande e le “teragnóle” non me le sono mai dimenticate. Mi ricordo soprattutto di un paio di “lattivendole” con le loro “zerle”, le gonne a puntini e i fazzoletti variopinti in testa: l’Amabile (rimasta vedova molto giovane) e sua sorella Carmela (penso fossero Potrìch di cognome) che aveva quattro figli i quali ci portavano la legna che trasportavano con un grande slitta. Sono ricordi che risalgono agli anni Trenta! Quando il “raminel” era quasi vuoto , qualche volta il poco latte rimasto lo vendevano a mia madre a prezzo ribassato; poi commerciavano le “rodelote de stèle de legna”. Nella stagione dei funghi mia madre ne comprava spesso da loro, come anche “le ciorciolete” per accendere il fuoco. In quegli anni i portoni di Valbusa grande erano sempre aperti e le “teragnóle” ne approfittavano per entrare e cambiarsi le scarpe. Entravano anche dal mio portone e mia madre spesso offriva loro il caffè d’orzo scambiando due chiacchiere e raccontandosi i loro problemi. (conversazione del 19.11.2008 ) Mario P. (classe 1920). Sono originario di Vallarsa e venni ad abitare stabilmente in Valbusa piccola nel 1952, appena sposato. Mi ricordo che le “teragnóle” passavano sotto casa mia poco dopo le sei e mezzo. Il portone d’ingresso era sempre aperto - all’epoca i portoni delle Valbuse non venivano quasi mai chiusi e alcune “teragnóle” entravano a cambiarsi le scarpe. Mi ricordo che trasportavano con le “zerle” le fascine di legna fina - che noi solitamente compravamo per “stizar el foc” -, le ricotte, il burro e il latte. Per un breve periodo, nel cortile di casa mia avevamo una capretta allevata dentro una specie di piccola stalla e talvolta mi 30 accorgevo che lì vicino, non di rado, qualche “teragnola” faceva anche la pipì, ma erano cose tollerabili, non le abbiamo mai rimproverate. Di solito passavano sotto casa mia in gruppetti di quattro o cinque donne e si fermavano alla fontanella di via Rialto; avevano le vesti piuttosto lunghe e portavano un fazzoletto che avvolgeva la testa; talvolta erano accompagnate da qualche ragazzino che le aiutava. Ho scritto anche alcuni versi dialettali riguardanti le donne e gli uomini di Terragnolo, avendo conosciuto alcuni anziani originari di quella valle durante la mia attività di ortolano svolta, nei primi anni Novanta, con gli amici di Pensione Viva, basandomi su quello che mi hanno raccontato e su quello che ho visto di persona. Ecco una parte della poesia: “Chi frà noi ghè teroni a baloni, trentini polentoni, valarseri sgolmeroni, en po’ de Roveretani, che cose e tase, l’ par i pù boni. Ghè Teragnoi che somena patate, salata e fasoi, ma con tanta esperienza per l’orto, e furbizia che lori i ghen sa. Perché mazoti de fiori a Verona a Bolzan e a Milan i ha portà. Chi a Rovereto i ha comercià late, buro, poina, fonghi, fiori, fascinele del legna, viscole e figoti. Tuti insieme, papà mama e i so puteloti.” (conversazione del 15.11.2008) Antonio C. (classe 1945). Mi ricordo che le “teragnóle” prima di raggiungere via Rialto, si levavano le pezze con cui avvolgevano le scarpe durante la discesa dai sentieri, per non usurarle troppo, e le infilavano nelle borse. Avevano il “raminel del latte” da una parte della “zerla” e dall’altra una “ruota di legna” oppure un cesto di funghi. Portavano sempre un fazzoletto in testa e i tipici lunghi costumi scuri con i fiorellini. Quando accompagnavo mio padre ad aprire il laboratorio artigianale che ho tuttora in Valbusa piccola, le vedevo arrivare in due o tre alla volta. I loro mariti magari si recavano alla piazza della Pesa a lavorare come manovali: erano soprannominati “i baroni del sol” perché stavano in attesa che passasse qualche motocarro di legna da scaricare. Finito il loro lavoro, gli uomini con le loro mogli si fermavano a mangiare crauti e trippe presso l’osteria Stedile, un tempo ubicata in prossimità del mio laboratorio. Le donne passavano anche dal negozio della signora Canevari, in Valbusa grande, per acquistare filo da cucire o altre piccole cose. Mi ricordo che sembravano tutte anziane, sembravano più vecchie della loro vera età. Poi, quando la SAV si espanse consolidando ulteriormente la propria attività, le “teragnóle” cessarono di transitare in Valbusa e il commercio ambulante del latte terminò. (conversazione del 18.11.08) Santino L. (classe 1938). Abitavo in fondo a via Valbusa grande. Mi ricordo, subito dopo la guerra, che “le teragnóle”, con le vesti piuttosto lunghe e il fazzoletto sulla testa, arrivavano il mattino, la “zerla” in spalla, un rullo di legna davanti e dietro un recipiente che conteneva il latte di mucca (più raramente commerciavano anche latte di capra). I miei genitori, verso le sette e mezzo mi mandavano nella piazzetta di via Rialto, con una bottiglia da un litro o anche da due litri, ad acquistare il latte e lì incontravo molti altri acquirenti. Mi ricordo che era un latte squisito! La 31 piazzetta era sempre animata da una decina di lattivendole e qualcuna di loro vendeva anche le ricotte. Qualche “teragnóla” si piazzava anche davanti al negozio del Canevari, in fondo alla Valbusa grande. “Porete, le ha fat na vita dura quele lì, i doveria darghe na medaglia d’oro!” (conversazione del 28.02.2009) Ida F. (classe 1927). Ho abitato dal 1946 in una casa alle Laste rosse e lì ho vissuto per parecchi anni con la mia famiglia. Mi ricordo che quando nevicava, le “teragnóle” mettevano “dei calzotti strazi” attorno alle scarpe, per non rischiare di scivolare e poi si fermavano all’acquedotto piccolo (Dos del castel) levandoli e riponendoli nelle borse, prima di entrare nel centro storico della città. Comunque era inevitabile che qualche volta, davanti alla casa della famiglia Giori, scivolassero ribaltando il recipiente del latte: infatti quei pochi ragazzi che abitavano alle Laste rosse si divertivano a formare una vera e propria pista per slittare fino in fondo a Valbusa grande! Queste donne portavano in città il latte e un po’ di legna - in autunno mele e funghi - per “poder guadagnarse en bocon”. Me le ricordo vestite con un pullover o uno scialle e il fazzoletto in testa; passavano verso le sette, una dozzina di donne in fila indiana, dall’apparente età di quarant’anni. Mi ricordo che mia suocera, che abitava nell’appartamento sottostante al mio, chiudeva gli scuri delle finestre, sprovviste di tende, per evitare che le “teragnóle” guardassero curiose dentro casa, essendo stata costruita sotto il livello stradale. Andavano a vendere i loro prodotti in piazza Erbe, dove c’era il “Rosso”, un vigile sicuramente poco amato dalle “teragnóle”. Lo posso affermare perché io queste donne le incontravo spesso in città e sentivo che si lamentavano del “Rosso”. Mi ricordo che qualcuna di loro vendeva anche le “poine”, prese in qualche malga sopra Terragnolo, avvolte dentro foglie di fico: ne ho comprate anch’io ed erano molto buone! (conversazione del 03.03. 2009) E’ ACCADUTO Sembra incredibile, eppure sono esperienze e storie veramente accadute quelle narrate in questo breve lavoro. Esperienze di vita che hanno come punto di riferimento quel senso del dovere verso la famiglia e la comunità, della “sopportazione senza disperarsi”, per dirla con Gino Gerola. Un senso del dovere non solo individuale ma anche collettivo. Una capacità di resistere agli aspetti più duri dell’esistenza e farsi comunque parte attiva per assicurare una vita migliore ai figli e alla comunità. Facciamone memoria. 32 “Scarpelot”: veniva legato alle scarpe per non scivolare sul ghiaccio Lanternino ad olio “Raminel” del latte 33 La “strada vecia” verso Noriglio – Terragnolo (Disegno di Mario Trentini) 34
Scarica