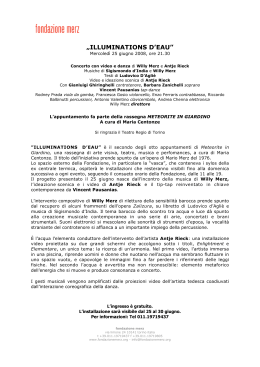Giuditta Divisato Il nostro percorso: • Il mito e l’archetipo • La matematica in Bruno • Doppio confronto: Atteone e Narciso Bruno e Caravaggio • “Se la forma scompare, la sua radice è eterna”: Mario Merz. • “La più grande opera d’arte mai realizzata”: L’attacco al WTC Il mito… ha una struttura estremamente complessa, è un sincretismo: non solo conserva il suo nucleo originario (l’archetipo), ma trascina con sé i suoi legami con il “rito”, le interpretazioni letterarie, il senso comune, le rielaborazioni… il mito è una realtà in divenire, si altera e si rifunzionalizza. E’ per questo che Bruno usa immagini mitologiche: sceglie una conoscenza dinamica, libera, eroica, che si approfondisce per passione grazie ai tanti piani della scrittura. IL MITO nasce come spiegazione irrazionale di fenomeni razionali (fase prescientifica) CREDENZA: Capacità di spiegare. Il mito ha una sua oggettività. RITUALE Mito come opera collettiva Comunicazione di massa Il mito non è esattamente un percorso simbolico pur contenendo simboli, ma ci fornisce una chiave per la leggibilità del mondo. Il mito è un’immagine. Le immagini “recano in sé qualcosa di ammirevole, di terribile, di gaio, di triste, da amico, da nemico”. Vai a: Il mito di Atteone Il mito di Narciso (G. Bruno) Alla base del mito c’è l’ Archetipo: un energia, una forza primordiale. L’archetipo è fermo, inchiodato, monocorde. Kandinskij : archetipi nitidi Si passa da un’arte interpretativa ad una “introversa. “Rigorosa astrazione, rigoroso realismo, rigoroso sentimento” (Kandinskij) Ma l’astrazione non può che partire dalla MATEMATICA Nello Spaccio, tra le nove Muse figlie di Mnemosine, “l’Aritmetica è primogenita” e “più volte che non concepe individui e specie di numeri, ed oltre per più millenarii de millenarii che mai possa con le sue addizioni apportar l’intelletto”. “La Geometria – invece- più che mai forme e figure formar si vagliano, e che atomi possa mai incorrere per le fantastiche risoluzioni di continui”. “Tutti i sapienti riconoscono inoltre che la matesi è particolarmente utile quando si lavora sull’anima, perché ciò che appare è immagine di ciò che è, dal momento che gli enti cha abitano il mondo intelligibile nel mondo sensibile si mostrano come in uno specchio. Qui sono in movimento, in varietà, mentre lì stanno perpetuamente immobili. La matesi insegna a fare astrazione della materia, dal movimento al tempo, ci rende capaci di intendere e contemplare le specie intelligibili… …Così Pitagora, Platone e tutti i maestri che hanno provato a fornirci insegnamenti profondi e difficili, hanno fatto uso solo di mezzi matematici. Il nemico stesso dei matematici, il logico Aristotele, più d’una volta avverte la necessità di ricorrere all’odiata matematica nello sforzo di spiegare i segreti più profondi della natura. Dalle immagini dei corpi e dalle ombre, che sono oscuri sensibili, tramite i matemata, s’apre l’accesso alle idee, che per lui sono chiari intelligibili...” La matematica è, nel Sigillus, il Terzo Reggitore. Consente il passaggio dall’ombra all’idea. Pitagora: “le cose si colgono su uno sfondo umbratile” Bruno: “Umbra profonda sumus” La capacità di astrazione è una Venatura mistica: Stimolo alla decifrazione, sforzo del pensiero Ma il Nolano può lasciarsi guidare dall’immaginazione verso l’infinito fondando una “metamatematica”, una “semigeometria”. Bruno non fornisce dogmi ma suggerimenti. Dunque, i quasi- spazi e i quasi-numeri sono vie, percorsi, binari. E’ un criterio analogico ma ugualmente rigoroso MATHESIS SINGULARIS= non dell’universale, ars combinatoria Con i “quasi” non si fa la scienza ma si può fare l’Arte. Atteone e Narciso Entrambi vedono la Verità nuda Fuori di sé Dentro di sé Entrambi eccedono la misura, pretendono di abbracciare la Verità così come l’hanno vista e muoiono. Bruno e IL FILOSOFO si perde nelle cose Caravaggio L’ARTISTA si perde in se stesso Mit o di Att eo ne E’ nel mito di Atteone che Bruno riassumere e concretizzare la sua concezione dell’omoiosis theo. Il filosofo rilegge in chiave filosofica, con interpretazioni, allegoriche il mito antico , cambiandone anche la gerarchia assiologica : la vicenda di Atteone, primitivamente fortemente negativa, viene reinterpretato, personalizzata, “positivizzata”. Alle selve i mastini e i veltri slaccia il giovan Atteon, quand’il destino gli drizz il dubio et incauto camino, di boscarecce fiere appo la traccia. Ecco tra l’acqui il più bel busto e faccia che veder poss’ il mortal e divino, in ostro et alabastro et oro fino vedde: e ‘l gran cacciator dovenne caccia. Il cervio ch’ a’ più folti luoghi drizzav’ i passi più leggeri, ratto voraro i suoi gran cani e molti. I’allargo i miei pensieri ad alta preda, et essi a me rivolti morte mi dan con morsi crudi e fieri. Dopo il sonetto, Bruno prova a raccontare il mito: racconta di questo cacciatore , Atteone , che inoltrandosi in una selva fitta e difficile da percorrere arriva ad un laghetto e vede la dea Diana nuda che fa il bagno. La pudica dea, irata, lo punisce trasformandolo in cervo e a questo punto i suoi cani, non riconoscendolo, lo inseguono e lo sbranano. Evidentemente il significato originario del mito era fortemente negativo : ben emerge il tema della ubris, dell' uomo che compie qualcosa che lo colloca su un piano che non é il suo, su un piano eccessivo, e lo uno sfondamento dei limiti viene punito. Invece Bruno lo legge diversamente perchè nulla é più positivo che sfondare i limiti , espandersi liberamente all' infinito. Così il Nolano legge ogni elemento del mito reinterpretandolo : Atteone é l' uomo ( più precisamente il filosofo ) ; i cani sono di due tipi , alcuni più agili ma meno forti , altri più forti ma meno agili , e rappresentano rispettivamente due aspetti delle facoltà umane, la volontà e l' intelletto ; la metafora dell’ attività venatoria é tipica per descrivere la ricerca filosofica (già Platone l’aveva usata), quasi si andasse alla caccia del sapere. Atteone ( il filosofo ) insegue la preda (la natura ): é il filosofo che ricerca l' essenza della natura; ma la selva non é facile da attraversare e non tutti possono farcela ; ad un certo punto il filosofo incontra la dea Diana che incarna la natura e che si rispecchia nello stagno : la dea che si rispecchia simboleggia la divinità che si rispecchia nella natura. Bruno riprende un' espressione già usata da San Paolo secondo la quale la divinità può essere letta "per speculum ", come attraverso lo specchio della natura. Il filosofo avendo inseguito la natura la vede nella sua nudità , nella sua essenza e lui stesso ne é trasformato (il cervo incarna anch' esso la natura) . I cani si rivolgono contro di lui , cioè i suoi pensieri prima rivolti ad una natura concepita come esterna finiscono per rivolgersi contro lui stesso finché non viene da essi catturato, l' uomo arriva cioè a capire che lui, la natura e la divinità sono la stessa cosa . Il filosofo che ricerca la natura trova la divinità e alla fine scopre che questa natura - divinità non é altro che lui stesso. “Rarissimi, dico, sono gli Atteoni alli quali sia dato dal destino di posser contemplare la Diana ignuda, e dovenir a tale che dalla bella disposizione della natura invaghiti in tanto e scorsi da que’ doi lumi del gemino splendor di divina bontà e bellezza, vegnano trasformati in cervio, per quanto non siano più cacciator ma caccia”. Il mito rappresenta tutta la filosofia bruniana , l' identità Dio natura - uomo che c'é sempre stata e sempre ci sarà , ma spetta alla filosofia portare l' uomo a rendersene conto. La narrazione assume dunque una denotazione fortemente positiva , perchè rappresenta l' uomo che arriva al traguardo del processo conoscitivo ma si tratta di attraversare luoghi " visitati e perlustrati da pochissimi, e però dove non son impresse l'orme de molti uomini " ; solo gli uomini superiori alla massa potranno farcela. L’incantesimo di Diana si fa incantamento, la sua magia rivelazione. L’avventura di Atteone concorre a definire l’itinerario del furioso. Non basta l’ “operazion de l’intelletto”, ma è richiesta anche quella “più vigorosa et efficace” della “voluntade”, poiché “a l’intelletto umano è più amabile che comprensibile la boutade e bellezza divina”. Nonostante la “lanterna” dell’amore, il suo cammino resta incerto, come “breve et instabile” è il furore. Atteone (o chi per lui) non può cogliere la “buntade” e o lo splendore divini se non “nel specchio de le similitudini”, e tale mediazione è tanto più necessaria in quanto è solo convertendolo in sé che il finito può cercare di mettersi sulla via dell’infinito. In forza di questa conversione il furioso diviene da predatore a preda. Questo impeto alla ricerca è chiamato da Bruno “eroico furore”. Traduce e reinterpreta la concezione dell' amore platonico. Il termine "furore" va inteso come "pazzia" (Platone stesso aveva insistito sul fatto che l' eros fosse una follia , anche se positiva). Ma l’ “eroico” va letto in un duplice significato: anche qui Bruno riprende un gioco di parole e una falsa etimologia di cui si era già servito Platone notando l' analogia tra eros ed eroe . Nel mondo greco classico, poi, eroe era anche la semi-divinità e Platone nel Simposio insisteva sul fatto che Eros fosse un semidio ; eroico vuol quindi dire sia eroico, nel senso di valoroso, ma anche nel senso di erotico per Bruno. Ma cosa sono gli Eroici furori ? E’ insita nell’animo umano un’inquietudine di fondo, un’energia primordiale che spinge ognuno alla ricerca di se stesso, alla comprensione della labirintica realtà che ci circonda. E’ un’inquietudine che non si placa e non tarda a divenire una naturale tensione verso l’Assoluto, volontà di trascendere il reale, il “folle volo” di chi vuole a tutti i costi superare il limite consentito e osa realizzare il proprio “aufhebung”. Gli “eroici furori” sono la tendenza mistica propria dell' uomo all' omoiosis theo ( assimilazione a Dio ) . Bruno riprende dalla tradizione platonica l' idea dell' avvicinarsi sempre di più a Dio fino ad " indiarsi " , come dice Dante , ma è convinto che sia contemporaneamente un fatto di ragione e di intelligenza da un lato ma anche di volontà e di amore dall' altro . Quello che é nuovo e rivoluzionario in Bruno é la concezione di quel Dio a cui l' uomo é invitato ad assimilarsi: lo slancio di amore e di intelligenza, ma anche di libertà, del Nolano, è totalmente diverso da quello dei cristiani. L' unico Dio che veramente c'é per l' uomo , e ancora di più per il filosofo , é il mondo, il Deus insitus omnibus. In Bruno non c'é Dio che si identifica con la forma e accanto la materia ; Diana e Atteone - Tiziano in Bruno non c'é opposizione materia - forma e quindi la sua attenzione é totalmente rivolta alla natura, che si identifica con Dio . Bruno é radicalmente panteista perchè tutto il mondo é Dio , non solo nei suoi aspetti formali , ma anche in quelli materiali . A questo punto, in un discorso di radicale immanentizzazione, l’omoiosis theo di Bruno sembrerebbe un’incongruenza, un paradosso: Se Dio fosse il mondo intero ( deus sive natura) e quindi già noi fossimo Dio, come facciamo ad identificarci con un Dio che siamo già noi? Cosa significa identificarsi in Dio se già lo siamo? Significa un qualcosa di piuttosto simile a ciò che intendevano gli stoici, significa "diventare ciò che si é", riconoscersi, rendersi conto di essere Dio perchè finché non ce ne rendiamo conto é come se non lo fossimo. Bruno era attratto dal mondo egizio soprattutto perchè le divinità egizie erano terioantropomorfiche ed il Nolano vedeva ciò come una rappresentazione simbolica dell' identità Dio - natura , ma anche natura - uomo e quindi Dio - uomo : questi tre aspetti sono quindi ai suoi occhi la stessa cosa e l'omoiosis theo realizza proprio questa identità . Il mito di Narciso è, fra i miti Il mito di Narciso Narciso e la ninfa Eco: pittura parietale (I sec a.C – I sec.) da Pompei classici, uno di quelli dei quali è possibile notare la ricorsività pressoché ininterrotta nella storia della cultura occidentale. La prima versione completa del mito è quella che troviamo nel terzo libro delle "Metamorfosi" di Ovidio. Qui, Narciso è figlio del dio del Cefiso e della ninfa Liriope. Quando nacque i genitori interrogarono l’indovino Tiresia, il quale rispose loro che il bambino “sarebbe vissuto fino a tarda età, se non avesse conosciuto se stesso”. Diventato adulto, lo splendido Narciso fu oggetto della passione di un gran numero di fanciulle e di ninfe, tra cui Eco. Eco era una ninfa che riusciva ad incantare con la parola. Zeus se ne avvaleva per distrarre Giunone e poterla così tradire con le altre ninfe. Ma la dea, scoperto l'inganno, punì Eco togliendole la possibilità di parlare autonomamente: ella poteva solo riferire le parole pronunciate da altri. Eco, innamorata e respinta da Narciso, disperata, si ritirò in solitudine dove dimagrì fino a ridursi a “puro suono” e trasformare le sue ossa in sasso, in prossimità di uno specchio d'acqua. Trovandosi alla sorgente, Narciso scorse la propria immagine riflessa e se ne innamorò perdutamente. Fu talmente desideroso di stringere e toccare il volto amato che annegò nelle acque. Sulla riva della sorgente, nel posto preciso in cui il giovane perse la vita, nacque un fiore che prese il suo nome. Il “Narciso” di Caravaggio Caravaggio non ritrae in modo diretto ed evidente il soggetto del quadro, ma il suo "Narciso" costituisce un esempio significativo di come l'arte possa rappresentare il rapporto tra la bellezza ideale e la complessità della realtà. In questa tela l'artista lombardo risolve il tema mitologico accentuandone la drammaticità, anziché risolverla in una composizione dall'equilibrio classico. Nulla è mostrato dell'ambiente che circonda il soggetto: Narciso emerge dall'ombra e ciò sottolinea drammaticamente lo stupore improvviso, la meraviglia ed il coinvolgimento che il giovane prova nel vedere un'immagine così bella, l’espressione anelante che si coglie dal suo profilo. La naturalezza della posa del giovane, inginocchiato che si protende verso l’acqua, segue l’andamento verticale della tela. Altro elemento di grande rilevanza è l'innovazione iconografica del soggetto: la doppia figura di Narciso dinamizza l'intera opera. Nella parte bassa del quadro, infatti, non vediamo l'immagine riflessa di Narciso, che si sarebbe vista dal basso, ma una "figura", realizzata con il puro e morbido variare tonale delle cromìe, pressoché identica a quella rappresentata nella parte superiore del dipinto . L'eccezionale invenzione della doppia figura a carta da gioco di cui è fulcro ideale il ginocchio in piena luce, fa emergere come la rappresentazione sia costruita magistralmente secondo una struttura circolare e speculare. Caravaggio predilige le atmosfere magiche, sorprese, introspettive, sonda le infinite possibilità del rapporto luceombra e ne risulta un fascio di luce quasi surreale che investe le spalle e la schiena di Narciso evidenziando le eleganti decorazioni della sua veste. Bruno e Caravaggio: parlare della luce attraverso l’ombra In un contesto, che viene definito di matrice “idealista”, è nato ed ha proliferato il rapporto tra Caravaggio e Giordano Bruno. Fu il grande storico dell’arte Giulio Carlo Argan, nel 1951, a parlare, riguardo alla lettura dell’opera caraveggesca, di una “religiosità eterodossa, bruniana”… Il discorso, in seguito ampliato ed approfondito, è stato ripreso negli ultimi anni dallo studioso Bruniano Nuccio Ordine. Gli Eroici Furori sono ricchi di rimandi all’arte pittorica e implicano un inseguire la forma, perseguire la bellezza, perché la passione per la verità è passione per l’arte, per il bello. Lo stesso Giò Bernardo, nel Candelaio, è un pittore. E infatti “metaforicamente, per Bruno, il pittore ed il filosofo fanno lo stesso mestiere che parte dall'ombra. Il contorno delineato dall'artista non basta a raggiungere la verità, più che l'osservazione dell'ombra nella caverna di Platone. Bisogna superare la soglia, osare non accontentarsi della riproduzione del modello, azzardarsi al di là dei limiti ammessi. Donare lo slancio supplementare indispensabile non promette la conoscenza, che non raggiungeremo mai. Ma come Socrate-Sileno, di cui condivide il gusto del dialogo come del comico, Bruno scopre la superficie, ricusa le apparenze, contesta gli errori che il linguaggio contiene.” (Nuccio Ordine) Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio - Autoritratto Tanto per Bruno quanto per Caravaggio è nel chiaro-scuro, nel gioco di luci ed ombre che è possibile comprendere il rilievo e la misura delle cose. Il pittore fa letteralmente uscir fuori il suo personaggio dall'ombra; l'ombra è la natura, la variabilità, mentre l'idea non è altro che ciò che resta. Ma, al di fuori delle congetture e delle supposizioni, della probabilità che Michelangelo Merisi frequentasse ambienti in cui la filosofia bruniana era ben conosciuta e delle stupefacenti quanto ironiche analogie caratteriali tra i due personaggi, li ritroviamo spesso sulla stessa lunghezza d’onda. Entrambi seguono un percorso estremamente complesso, un pensiero ricorsivo che non è chiarezza, che non scorge un ordine e una coerenza totale ma trova un’armonia. E come tralasciare la loro portata rivoluzionaria? Caravaggio e Bruno segnano uno stacco sostanziale, uno stravolgimento della tradizione, entrambi si affidano al furor, entrambi colgono la realtà in maniera intuitiva, è una sorta di ispirazione a disvelare la verità e dettare una nuova prassi. Caravaggio difende la pittura come poesia, allo stesso modo di Giorgione e Tiziano. La poesia non è un’invenzione fantastica, ma l’espressione della vita interiore, della più profonda realtà umana. Non è né contro né al di sopra, ma dentro il reale, ne costituisce il significato più autentico. Caravaggio riporta nella pittura la realtà viva, dimostra come, così inquadrata e messa a fuoco, la realtà si faccia più vicina e i suoi contrasti risultino più netti. Altrettanto può dirsi della storia: non allontana la realtà, l’avvicina; non rasserena, drammatizza. I fatti non sono dati come accaduti e giudicati, ma colti nella loro flagranza del loro accadere qui, ora. E’ un istante, un frammento: ma è un istante reale, un frammento vivo dell’esistenza. L’ideale non spinge a superare ma ad entrare più profondamente nella realtà. MARIO MERZ “Se la forma scompare la sua radice è eterna” Mario Merz, Bottiglia e bicchiere trapassati,1966-67. Bottiglia, bicchieri, neon, bambù, rotella, cm.130x70x35 coll. privata, Torino. Courtesy Archivio Merz, Torino "Parto dall'emozione che mi dà un oggetto artigianale, fatto per esempio di vimini intrecciati, la cui struttura archetipa annulla la materia. Dopo, procurandomi l'oggetto, cerco di appropriarmi manualmente della sua struttura disponendolo in varie posizioni finché non lo sento vivere all'unisono con la mia struttura fisica. A questo punto interseco tale forma con l'immagine di un'energia diversa. Come, per esempio, un tubo al neon". Mario Merz, Autocarro, 1957. Olio su tela, cm 70x100. Collezione privata "Solitario, nomade e visionario", come lo ha definito il critico Harald Szeemann, Mario Merz nasce a Milano nel 1925, ma si trasferisce presto a Torino dove intraprende gli studi in medicina senza concluderli. Nel 1953, autodidatta, Merz si affaccia al panorama dell'arte con una pittura nuova e imprevedibile, di segno astrattoespressionista che prende spunto dall'immagine naturale, disgregandone le forme, in un approdo informale con cadenze espressioniste. Partito da una pittura di riferimento espressionista, di una violenza materica e quasi pànica, carica di rimandi simbolici e visionari, vi tornerà in età matura, con la serie dei "preistorici", grandi immagini di animali dal sapore ancestrale. Ma negli anni Sessanta sceglie l'installazione e la sperimentazione con materiali eterogenei e contrastanti che formulano un discorso aperto e complesso sul continuo intrecciarsi di mondo naturale e realtà artificiale: ferro, cera, neon, terra, intesi ad un realismo oggettuale di carattere neo- dada. I tubi di neon luminoso sono tracce di energia che Merz inserisce negli oggetti più comuni: bicchieri, bottiglie, ombrelli, come "Che fare?" del 1968, una pentola ripiena di cera e attraversata da una scritta luminescente. E’ così che Merz, insieme a un gruppo di artisti di cui fanno parte Pistoletto, Zorio e Penone, dà vita a quel movimento che il critico Germano Celant nel 1967 consacrò come "Arte Povera", e che resta ancora oggi il l'avanguardia artistica italiana più nota e conosciuta all'estero. Vento preistorico dalle montagne gelate (1983) – pastelli su carta Mentre negli States esplodeva la pop art, Merz e gli altri sceglievano materie semplici, naturali, il legno, il vetro, il ferro, la corda, per la loro manipolazione artistica, trasformando quei materiali inerti in installazioni e sculture attraversate da energia vitale. Scriveva allora Celant: “Merz parte da una realtà interiore per approdare ad una realtà mondana. Stimolato emotivamente da un gruppo di oggetti familiari, banali, consueti… cerca di appropriarsene, collezionandoli. I suoi agglomerati oggettuali diventano così gruppo di sensi che evidenziano, mediante l’accostamento e il montaggio di immagini discordi, l’istante di partecipazione emotivo-gnoseologica avvenuta in Merz…” Merz, l’artista-alchimista, svolge un ruolo emblematico tra i “poveristi” attraverso la sua profonda ricerca sulle leggi del mondo naturale che lo porta a ribellarsi contro l’ordine “costruito” che l’uomo ha cercato di imporre. Di seguito, nell’ambito dell’arte povera, Merz passava alla realizzazione di ambienti nei quali la componente concettuale si univa ad una dimensione esistenziale intensa e violenta Mario Merz, Igloo con albero, 1968-1969 Tubolare in ferro, vetri, stucco, ramo. Igloo cm. 100xØ200. ramo h. cm. 320, Collezione Margherita Stein - Fondazione CRT progetto Arte Moderna e Contemporanea. Deposito permanente Castello di Rivoli - GAM Tutta la sua arte è un lavoro sull'energia. Nel 1968, l’anno della profonda critica sociale e politica, l’artista propone il primo esemplare della lunga serie di igloo realizzati con i materiali più diversi (creta, tela, pietra, vetro, cemento): una forma archetipica nata dallo sviluppo in tre dimensioni di una spirale. In questa forma, Merz riconosce l’energia strutturale della natura e crea uno "spazio esterno" che "è misura di uno spazio interno". Fibonacci igloo (1972) Gli igloo di Merz collegano l'antico al futuro, la dimensione umana dell'abitare e il rapporto vivo e dirompente con ciò che ci circonda. Con l'igloo l'artista recupera "una forma minimale come la bolla di sapone, cioè una membrana sempre tesa al massimo della sua plasticità...una fusione di tanti linguaggi e tanti) pensieri, di osservazioni geometriche, aritmetiche e geografiche: l'uomo ha acquistato diverse facce, un contadino, un marinaio: anche l'igloo assume diverse facce ogni volta che cambia posizione, anche geograficamente". (M.Merz) Il motivo ricorrente dell’igloo sembra voler chiudere, in un nucleo di forza, l’energia naturale; secondo la massima del generale vietnamita Giap, che Merz cita (“se il nemico si concentra, perde spazio, se si allarga perde forza”), e così commenta la scelta di questa sua immagine: “l’idea è rotonda… se seguite la massima, tornerete all’inizio e vedrete come essa si scuote e come si calma. Non c’è chiarimento, non logica, non progresso. Essa è una forza dinamica compressa”. E in nome di questa “forza” in questa sua continua ricerca di energia, Merz recupera, nei suoi lavori recenti (nei quali prosegue anche l’assemblaggio di materiali eterogenei) la pittura, una pittura grondante, di matrice espressionista e barocca, carica di drammatica, intensa, biologica sensualità. Dal 1970 questo interesse viene spesso sottolineato con l’inclusione di alcuni numeri che appartengono alla serie di Fibonacci: il matematico pisano aveva infatti individuato nel ritmo elaborato, in cui ogni cifra è la somma dei due precedenti, i processi di crescita del mondo organico. "Nella serie di Fibonacci non ci sono limiti spaziali, perché lo spazio diventa infinito" Tale serie che in geometria si svolge attraverso in spirali, rimanda ad un'idea di espansione e ritorno ciclico dello spazio-tempo e si presenta come une legge strutturale della natura. Il volo dei numeri, Mario Merz. Mole Antonelliana, Torino. Merz usa e interpreta la progressione numerica di Fibonacci come emblema dell'energia insita nella materia, collocando le cifre realizzate al neon sia sulle proprie opere sia negli ambienti espositivi, come nel 1971 lungo la spirale del Guggenheim Museum di New York, nel 1984 sulla Mole Antonelliana di Torino e nel 1990 sulla Manica Lunga del Castello di Rivoli. “Un numero” scrive Merz “può essere una cosa e nient’altro; scritto col neon, esso significa quel singolo numero e nient’altro, scritto in quel modo e in nessun altro. Il neon non è un oggetto, ma il fatto che l’elettricità fluisca attraverso di esso, lo rende meno oggetto”. “Io cerco l’Energia che scorre liberata dalle catene del ritmo, come la musica dell’India”. All’interno dell’ordine fittizio che l’uomo ha cercato di dare al mondo, si è acuita la sua separazione dall’istinto e dalle sensazioni elementari. Merz cerca, con le sue opere, per le quali ricorre a materiali diversi ed eterogenei, unificati dalla luce, il recupero di questa energia elementare che regola la natura. Mario Merz, Tavolo a spirale per festino di giornali datati il giorno del festino, 1976. Metallo, vetro, pietra, fascine, frutta. Altezza cm. 140, diametro cm. 630. Coll. Kunstmuseum Wolfsburg. Courtesy Archivio Merz, Torino Dal 1976 lavora alla figura simbolica della spirale che successivamente viene associata a quella, altrettanto ricorrente, del tavolo, sulle cui superfici vengono disposti frutti che, lasciati al loro decorso naturale, introducono nell'opera la dimensione del tempo reale. o l'utilizzo di materiali che vanno a formare strutture complesse a spirale realizzate con tubolari in ferro, cristallo, pietre, neon, fascine, ortaggi, frutta, giornali. Alla fine degli anni Settanta Merz recupera la figurazione dipinta, delineando grandi immagini di animali caratterizzati da una forte tradizione mitologica, "preistorici" come li definiva l'artista, quali Coccodrillo del Niger (1972-1989), in cui il coccodrillo, creatura archetipica che diventa una metafora della forza distruttiva, del Divoratore: insaziabile, freddo e sanguinario, che divora inesorabilmente tempo e spazio. In queste opere compaiono animali primordiali come iguana, zebre, tigri o chiocciole (replica dell'interesse per la forma a spirale e l'avvolgersi del tempo su se stesso) che divengono il soggetto di tele e installazioni che tendono a coinvolgere in modo sempre più vasto e potente lo spazio espositivo. Nel 1981 la Città di Kassel gli conferisce il premio Arnolde Bode mentre, due anni dopo, riceve a Vienna il premio intitolato a Oscar Kokoschka. Nella “poetica” di Merz la giustificazione della raccolta e degli accostamenti “azzardati” consiste nel fatto che “animali, vegetali e minerali sono insorti nel mondo dell’arte. L’artista si sente attratto dalle loro possibilità fisiche, chimiche, biologiche, e riinizia a sentire lo svolgersi delle cose del mondo, non solo come essere animato, ma produttore di fatti magici e meraviglianti. Mario Merz, Il vagabondo del torrente,1983. Acrilico su tela, neon, cm. 140x1050. coll. Moderna Museet, Stockholm. Courtesy Archivio Merz, Torino L’artista - alchimista organizza le cose viventi e vegetali in fatti magici, lavora alla scoperta del nocciolo delle cose, per ritrovarle ed esaltarle. Il suo lavoro non mira però a servirsi dei più semplici materiali ed elementi naturali per una descrizione e rappresentazione della natura; quello che lo Mario Merz, Senza titolo, 1963. Olio su tela,Collezione privata interessa è invece la scoperta, la presentazione, l’insurrezione del valore magico e meravigliante degli elementi naturali… Tutto il suo lavoro tende, di conseguenza, solamente alla dilatazione della sfera del sensibile; non si offre come affermazione, indicazioni di valore, modello di comportamento, ma come prova di esistenza contingente e precaria…” Mario Merz, Igloo, (Tenda di Gheddafi), 1968-1981 Tubolare in ferro, acrilico su tela di juta, cm. 240xØ500. Collezione permanente Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea Il ricorso a materiali “poveri”, naturali, antiartistici, la volontà di evidenziare l’energia, di analizzare i processi naturali rivela l’intenzione di fare un uso aformale dei materiali, affidando loro qualità che interessano soltanto l’artista, secondo una sua ermetica concettualità. Merz, spostando la visione della realtà, ci ha insegnato come il processo conti più dell’opera, ricorrendo all’impoverimento dell’alfabeto segnico per trasformare il messaggio artistico in momento di coinvolgimento emotivo dell’osservatore. La ricerca sensoriale dell’artista sfocia in combinazioni di elementi industriali e naturali che testimoniano di un’arte legata alla dimensione temporale proprio perché determinata dalla deperibilità dei materiali. Mario Merz, Il fiume appare, 1986. Quotidiani, vetro, neon, ferro (tondino di ferro), cavo elettrico, trasformatore cm. 268x1430x220 Fondazione Torino Musei - GAM Torino L’artista torinese parte “da un pittoricismo addirittura magmatico, sotto la cui scorza, però è già in azione un motivo strutturale biomorfo, la spirale, o comunque un elemento curvilineo che consente l’irradiazione di una specie di linfa organica”. (Lara- Vinca Masini) Linfa che poi si concretizzerà nell’intreccio di tubi al neon che avvolge e illumina di energia vitale gli oggetti e le installazioni realizzati da Merz degli anni ’60 in avanti. La spirale appare Se la spirale rappresenta il grande motivo semantico, e fascinosamente misterico allo stesso tempo, presente fin dalle prime prove della maturità artistica, la luce fredda e gelatinosa del neon rappresenta la concretizzazione dell’idea di energia, di esistenza vitale. Una sorta di metafisica realizzata con mezzi, materiali ed effetti semplici, che innalza la banalità del quotidiano a livello di arte. Merz ha coniugato sensorialità e concettualità nella sua concezione vitalistica dell’arte. E qui la forza spiazzante del suo concettualismo tocca i suoi vertici. “La più grande opera d’arte mai realizzata... Cinquemila persone che in un solo istante vengono cacciate a forza nella resurrezione. Io non potrei mai arrivare a niente di simile. Davanti a questo, noi compositori non siamo nulla.” -Karlheinz Stockhausen- Le immagini sono parte integrante della nostra esistenza e della nostra conoscenza, mettendo per un attimo da parte la mostruosità del gesto e le sue orribili conseguenze, non sarebbe forse possibile considerare i due impatti dell’11 settembre 2001 come la più enorme installazione di performing art della storia? Chi di noi non le riconoscerebbe? Quale segno grafico più indelebile nella memoria collettiva delle due torri in fiamme? Quale gesto artistico più estremo è immaginabile? L’inconsapevolezza dell’autore ha ancora un significato nell’epoca in cui l’arte e l’artista sono due mondi affatto separati, a volte in aperta contraddizione l’una con l’altro? In una mostra, organizzata da Vittorio Sgarbi, il video dell’attentato alle Twin Towers è diventato la sigla iniziale del XXI secolo. Ne è stata scelta una per secolo, la distruzione è il sigillo dei nostri anni. Che sia un’opera d’arte o meno, conta poco, l’intenzionalità dell’autore è relativa, quelle immagini ci appartengano e ci rappresentano, non sono un mero documento. L’arte contemporanea esibisce spesso, impietosamente, la crudeltà, ma non potrebbe fare diversamente: è la nostra storia masticata e digerita, restituita sotto nuova forma. Accusato di essere cinico ed irriguardoso, Stockhausen ha fatto scandalo con le sue dichiarazioni ma cos’è che infastidisce? Il compiacimento nella rappresentazione della violenza? Tanto scalpore, forse, perché la violenza talvolta diventa insostenibile? Nella caustica dichiarazione del maestro ritrova il fil rouge che ha caratterizzato tutta la storia del ventesimo secolo la “filofollia”: il capolavoro in negativo, per sottrazione. L’estetica della scomparsa… Una katastrofè che ci riporta a noi stessi, nudi nella nostra fragilità archetipale, in un momento di cesura decisiva: “dopo” non sarà mai più lo stesso ma al contempo è il preludio della palingenesi. La catastrofe, sia essa naturale o provocata dall’uomo, diventa categoria estetica dell’arte, le categorie spazio e tempo si riducono. “Creare l’incidente e non più tanto l’evento… rompere la concatenazione di causalità che caratterizza così bene la normalità quotidiana – questo tipo di espressionismo è oggi universalmente ricercato, tanto dai ‘terroristi’ quanto dagli ‘artisti’ e da tutti gli attivisti contemporanei dell’epoca della globalizzazione planetaria”. (Paul Virilio) Di fronte a qualcosa che lascia tutti col fiato sospeso di fronte al mondo agonizzante, la paura, l’incomunicabilità, il disorientamento…il sublime, quel sentimento, come ha affermato lo stesso Karlheinz Stockhausen, che è proprio della dismisura. Dismisura di volumi, dismisura di emozioni e di visioni, distorsioni, dismisura dei battiti. Si resiste alla repulsione e si resta lì, succubi, affascinati, impotenti. Il sublime è un sentimento che mescola insieme sgomento e piacere ed ha la propria origine nel grandioso, nell’incommensurabile di fronte a cui l’uomo prova un senso di finitezza, di fragilità. Il sublime si pone al confine fra etica ed estetica. Lì, il confine fra bello e brutto, piaciuto o meno si dissolve. Inizia dell’altro.
Scaricare