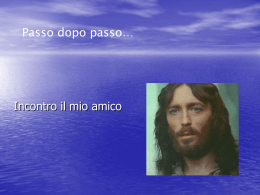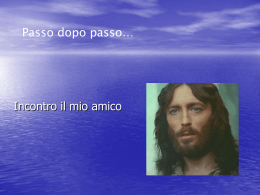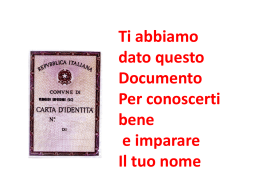ATTILIO GANGEMI L’operatore pastorale alla luce degli Atti degli Apostoli UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO SIRACUSA – 2010 1 Negli Atti degli Apostoli non troviamo alcuna definizione teorica dell’operatore pastorale, tuttavia a partire dagli elementi che caratterizzano la figura e il ministero apostolico possiamo delineare la sua fisionomia. 1. “riceverete lo Spirito santo che verrà su di voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme, Giudea e Samaria e fino all’estremità della terra (At 1, 8)”. La vocazione fondamentale dell’operatore pastorale: la testimonianza da rendere a Gesù senza limiti di spazio e di tempo. 2. “noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo che è risorto da morte (At 10, 41)”. Il fondamento esistenziale dell’operatore pastorale: l’Eucaristia, come luogo dell’esperienza del Signore e sorgente della missione. 3. “si presentò vivente per quaranta giorni parlando del Regno di Dio (At 1, 3)”. L’abituale atteggiamento dell’operatore pastorale: l’ascolto assiduo della Parola di Dio, come progressivo coinvolgimento nel mistero del Regno. 4. “comandò loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere la promessa del Padre, che avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi sarete battezzati di Spirito Santo (At 1, 4-5)”. Le dimensioni spirituali dell’operatore pastorale: l’attesa del momento di Dio, la coscienza di essere coinvolti in una storia di salvezza, la riscoperta del dono dello Spirito nel battesimo e nella cresima. 5. “come è salito in cielo così tornerà (At 1, 11)”. La fisionomia spirituale dell’operatore pastorale: il precursore in relazione alla futura venuta del Signore, come Giovanni in relazione alla prima. 6. “tutti erano intenti, unanimi, alla preghiera, con delle donne, con Maria la madre di Gesù e i suoi (di Gesù) fratelli (At 1, 14)”. La dimensione comunitaria dell’operatore pastorale: la preghiera come elemento di coesione, il senso ecclesiale, la riscoperta della figura di Maria modello e immagine della chiesa. 7. “giudicate se è più giusto ascoltare voi che ascoltale Dio: noi non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito (4, 20)”. Il coraggio dell’operatore pastorale: in forza di una irreprimibile esperienza, parlare anche dove la Parola di Dio non è accolta. 8. “se ne andavano gioiosi dal cospetto del Sinedrio poiché furono ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù (At 5, 41)”. La solidarietà dell’operatore pastorale con la passione di Gesù: accettare le ostilità che provengono dal ministero. 9. “La parola di Dio cresceva e si moltiplicava il numero dei discepoli (At 6, 7)”. La grandezza e l’umiltà dell’operatore pastorale: collaboratore subordinato della Parola di Dio. 2 I “Riceverete lo Spirito Santo che verrà su di voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme, Giudea e Samaria e fino all’estremità della terra (At 1, 8)” La vocazione fondamentale dell’operatore pastorale: la testimonianza da rendere a Gesù senza limiti di spazio e di tempo. Le parole di Gesù in At 1, 8 sono insieme una dichiarazione, un annunzio, un conferimento di missione. Ai discepoli Gesù dichiara cosa li attende nel futuro, annunzia il dono dello Spirito Santo, conferisce loro una specifica missione: essere testimoni di lui. Il primo aspetto che immediatamente emerge nelle parole di Gesù è la stretta relazione tra il dono dello Spirito Santo che i discepoli riceveranno e la missione di testimoni a cui essi sono chiamati. Si può notare la stretta consequenzialità tra i due verbi “riceverete” e “sarete”. Ciò significa che sarà proprio la presenza dello Spirito che li costituirà, quasi li consacrerà, testimoni e li abiliterà appunto a rendere testimonianza. D'altra parte la stretta connessione dei due verbi rivela che è impossibile essere testimoni di Gesù senza la presenza dello Spirito. Tutto il libro degli Atti degli Apostoli infatti mostrerà che i veri protagonisti del racconto non sono gli Apostoli. Essi non appaiono certo dei super-eroi o degli avventurieri, bensì dei testimoni. Il vero soggetto è la Parola di Dio che essi, animati, corroborati, rafforzati dallo Spirito Santo, debbono annunziare dovunque: nelle città, nelle piazze, nei tribunali, coscienti che tale annunzio è un loro inalienabile diritto (parrēsìa) che nessuno può mai coartare. Nella relazione Spirito-discepoli Giovanni si rivela ancora più radicale. Leggiamo infatti in Gv 15, 26-27: “egli (lo Spirito) mi renderà testimonianza [...] e anche voi mi renderete testimonianza”. Il primo e vero testimone di Gesù è lo Spirito; gli apostoli da esso animati appaiono così coinvolti nella sua testimonianza e in certo modo la riecheggiano. Le parole di Gesù sopra citate sono pronunziate da lui nel contesto di un dialogo con i discepoli. Essi gli chiedono con insistenza se “in questo tempo”, cioè nel tempo dopo la resurrezione, egli avrebbe ricostituito il regno di Israele. Emerge ancora nei discepoli una certa nostalgia nazionale, terrena che l’esperienza del risorto può avere in loro risvegliato. Gesù risponde che non è dato a loro conoscere i tempi e i momenti che il Padre invece ha riservato in suo potere, ma che riceveranno la potenza dello Spirito Santo e che saranno suoi testimoni. La risposta di Gesù rivela diversi aspetti. Da una parte anzitutto egli dichiara che il Regno di Israele certamente si compirà; dall’altra però egli mostra che esso sarà un’opera non solo sua ma insieme anche del Padre e dei discepoli. Sarà opera del Padre perché i tempi della sua realizzazione sono avvolti nel suo mistero; è opera dei discepoli perché essi dovranno rendergli testimonianza. I discepoli perciò sono chiamati ad essere non passivi spettatori della venuta di quel Regno, ma attivi collaboratori nella sua crescita. Essi collaboreranno appunto mediante la testimonianza che debbono rendere a Gesù. In altre parole, il Regno di Israele si compirà alla venuta del Signore Gesù, i cui tempi il Padre non ha rivelato. Nel frattempo però i discepoli dovranno collaborare alla sua crescita rendendo appunto testimonianza a Gesù. Ciò significa che il tempo dalla Resurrezione e Ascensione di Gesù fino al suo ritorno, cioè tutto il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza. Ma qual è l’oggetto della testimonianza? Esso è caratterizzato non da un pronome 3 possessivo (“miei”), ma da un pronome personale (“di me”). L’oggetto della testimonianza è la stessa persona nella globalità del suo mistero: la sua origine divina, la sua presenza nel mondo, la sua passione e la sua resurrezione. Soprattutto la sua resurrezione! Mattia infatti è eletto perché diventi, insieme agli altri, “testimone della sua resurrezione”. Tutto il libro degli Atti suggerisce che gli Apostoli testimonieranno la Resurrezione di Gesù portando il mistero della sua passione. Cfr. Pietro e Giovanni che si allontanavano gioiosi dal Sinedrio, perché “furono ritenuti degni di patire oltraggi per il nome di Gesù (At 5, 42)”. Ma chi è il testimone? I termini testimone, testimonianza, testimoniare sono categorie giuridiche, riprese ed applicate ai discepoli di Gesù nel NT. In un tribunale il testimone è colui che prende posizione a favore o contro l’imputato, affermando o smentendo la verità della sua persona o della sua opera. Se Gesù costituisce i suoi discepoli come testimoni, vuol dire che la storia è come un grande tribunale dove si svolge un processo. L’imputato davanti al mondo è sempre lui: Gesù. Egli sarà sempre sotto inchiesta fino al suo ritorno, fino a quando cioè non lo vedrà ogni uomo (Ap 1, 7). Molti in tale processo prenderanno posizione contro di lui; tocca ai discepoli però, corroborati dallo Spirito Santo, dichiarare e deporre a suo favore. Anche quando i discepoli sono condotti nei tribunali per essere processati, in realtà essi sono soltanto dei testimoni: il vero processato rimane sempre Gesù. Ma la prerogativa fondamentale del testimone è quella di avere fatto esperienza diretta di una persona o dei fatti che la riguardano: non ha infatti alcun valore giuridico chi dichiara soltanto per sentito dire. I testimoni di Gesù, per essere tali, debbono perciò avere fatto diretta esperienza di lui: conoscerlo non di seconda mano. Ciò è quanto dichiara Pietro davanti al centurione Cornelio: “...i testimoni: noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione” (At 10, 41). Dicevamo che la storia è come un grande processo a Gesù e la sua verità è filtrata dall’opera dei discepoli testimoni. Nel libro degli Atti i testimoni sono i discepoli rafforzati dallo Spirito. Il vangelo di Giovanni, che si colloca pure in analoga prospettiva, allarga la cerchia dei testimoni di Gesù. Questi sono: il Padre, lo Spirito, le sue opere, le Scritture, i discepoli, con particolare riferimento al discepolo che Gesù amava, Giovanni il battista che venne appunto per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui (Gv 1, 7). Sia Luca che Giovanni concordano perciò nel ruolo di testimoni che debbono assumere i discepoli di Gesù. Ma come si fa esperienza del Risorto? Dove lo si può incontrare? Il discorso a riguardo è molto lungo e complesso. Riconducendo schematicamente in sintesi le varie prospettive neotestamentarie, possiamo individuare cinque ambiti, concomitanti e non separabili l’uno dall’altro, dove è possibile fare esperienza del risorto. Questi cinque ambiti, dove il Risorto si rende particolarmente presente, sono: l’unità ecclesiale (Gv 17, 21-23), la Parola proclamata (Ap 1, 10-11), l’Eucaristia (Lc 24), l’esercizio della carità, i poveri (Mt 25). L’aspetto fondamentale però è e rimane l’esperienza liturgica di Gesù, che però non può e non deve essere separata dalla vita. Sull’esperienza liturgica del Risorto insistono molto i racconti evangelici delle apparizioni. Possiamo citare in modo particolare i racconti di Lc 24 e di Gv 20. Anche nell’espressione su citata di At 10, 41 il mangiare e bere con Gesù sembra Ma come rendere testimonianza al Risorto? Pure la risposta a questa domanda è assai complessa. Una prima risposta può venire dalla lista dei carismi elencati da Paolo in 1Cor 12 e in Ef 4, 11 ss. In questo senso possiamo dire che le forme di testimonianza sono tante e si attuano nell’esercizio dei vari carismi donati dallo Spirito. 4 Ma c'è un denominatore che è comune a tutti, qualunque sia il carisma che si esercita: il coinvolgimento nel mistero di Gesù; vivere cioè il suo mistero di morte e di resurrezione. Tale coinvolgimento appare soprattutto in diversi testi paolini come un elemento costitutivo della vita cristiana (cfr. Col 3, 1 ss.; Rm 6, 3 ss.; Fil 2). Ma anche Luca in tutto il libro degli Atti insiste su questo aspetto. Pietro predica, annunzia la resurrezione e fonda tale annunzio sulla testimonianza sua e degli altri con lui. Pure Paolo, impegnato in lunghi viaggi, predica abbondantemente. Luca però non trascura di evidenziare le passiones degli Apostoli. Ciò che li rende autentici testimoni, prima della stessa predicazione, è il fatto che essi si sentono coinvolti nel mistero della passione di Gesù. In questa stessa prospettiva si può collocare pure la figura di Stefano (At 7), testimone anche lui, il cui discorso ai Giudei, prima di essere lapidato, richiama diversi elementi del processo evangelico di Gesù davanti al Sinedrio. Si direbbe che, secondo Luca, prima ancora della predicazione, ciò che incide nella storia è il mistero della passione vissuto dagli apostoli nella loro persona. Non pare casuale infatti che Luca narri nel c. 7 il martirio di Stefano e poi nel c. 9 la conversione di quel Paolo che aveva acconsentito, custodendo le vesti, a quel martirio. Si direbbe che la conversione di Paolo si radichi nel martirio di Stefano e che il mistero della passione vissuto da Stefano produca nella conversione di Paolo i suoi frutti di resurrezione. Quali sono i limiti della testimonianza? Luca assegna due limiti, uno geografico e uno cronologico. Il limite geografico è costituito dall’espressione: “in Gerusalemme, in Giudea e Samaria e fino agli estremi confini della terra (At 1, 9)”: la testimonianza perciò deve arrivare fino agli estremi confini della terra. Ciò è ben comprensibile: infatti non'è dato altro nome sotto il ciclo agli uomini nel quale essi possano essere salvati (At 4, 12). Ciò spiega perché Luca chiuda la sua narrazione quando Paolo giunge a Roma, senza dir nulla del suo martirio: a lui interessa non tracciare la biografia apostolica di Paolo ma mostrare che l’annunzio e la testimonianza di Gesù hanno veramente toccato con lui gli estremi confini della terra. Il limite cronologico è costituito dall’espressione: “Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo (At 1, 11)”. La testimonianza perciò durerà fino al ritorno del Signore. Del resto, benché in diversa prospettiva, il Signore aveva già detto ai discepoli che non avrebbero finito di percorrere le città di Israele fino a quando egli non sarebbe tornato (Mt 10, 23). Fino al ritorno del Signore i discepoli perciò avranno ancora delle città da percorrere, dove rendere testimonianza e dove sperimentare anche il rifiuto. Questi due limiti, geografico e cronologico, in pratica coincidono con l’assenza di qualsiasi limite. La testimonianza a Gesù dovrà essere resa in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Dovunque, in ogni epoca, in ogni situazione sociale e in ogni cultura rimane integro per i discepoli di Gesù il dovere di rendergli testimonianza, anche a costo di entrare in conflitto con il mondo e di subire le sue ostilità. Come Paolo, le cui catene in ogni tribunale finiscono per diventare testimonianza a Gesù (Fil 1, 12). 5 II “noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo che è risorto da morte (At 10, 41)” Il fondamento esistenziale dell’operatore pastorale: L’Eucaristia, come luogo dell’esperienza del Signore e sorgente della missione. Le parole “noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo che è risorto da morte” in At 10,41, sono dette da Pietro quasi a conclusione del suo breve ma intenso discorso pronunziato in casa del centurione Cornelio (At 10, 34-43). Questo discorso è importante, oltre che per i contenuti, anche perché contiene una sintesi schematica dell’attività di Gesù, dal battesimo di Giovanni alla sua morte e resurrezione. Questa sintesi poi, ampliata, costituirà lo schema che soggiace ai tre vangeli sinottici. Dopo avere evocato gli eventi in Giudea e Gerusalemme, di cui egli e gli altri apostoli sono testimoni (v 39), Pietro passa all’annunzio della resurrezione (v 40): Dio ha resuscitato Gesù ed ha voluto che si manifestasse non a tutto il popolo ma a testimoni da lui prescelti. Questi testimoni sono appunto Pietro e gli altri: “noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione” (v 41). Nel seguente v 42 Pietro passa a descrivere la missione che Dio ha comandato a loro di assolvere. Questa è duplice: annunziare a tutto il popolo e testimoniare che Gesù è il giudice da Dio costituito dei vivi e dei morti. Nella loro prerogativa di testimoni, Pietro e gli altri si trovano sulla stessa linea dei profeti, ai quali (v 43) fu pure affidata una missione di testimonianza. Con una differenza però: mentre i profeti hanno testimoniato realtà future, Pietro e gli altri debbono testimoniare eventi già accaduti. Le due testimonianze, quella dei profeti e quella degli apostoli, pur distanti nel tempo, si richiamano a vicenda. E infatti Pietro, o Luca per lui, assegna a ciascuna di esse oggetti diversi ma complementari: gli apostoli debbono testimoniare che Gesù è il giudice dei vivi e dei morti; i profeti testimoniano che chiunque crede riceve per mezzo del suo nome la remissione dei peccati. Possiamo così parlare di una sola testimonianza storica resa a Gesù, in due aspetti: antecedente e conseguente. Quella antecedente è resa dai profeti, quella conseguente invece è resa dagli Apostoli. Cristo così appare al centro della storia e tutto converge verso di lui. * * * Prescindendo dall’esperienza profetica e fermandoci su quella apostolica, nel testo di Atti su citato Pietro, diversamente che in altri discorsi, offre qui un fondamento esperienziale su cui poggiano e da cui scaturiscono sia la testimonianza sia la missione: il fatto che egli e gli altri hanno mangiato e bevuto con Gesù dopo la resurrezione. Questo fatto costituisce quasi un anello esperienziale di legame tra gli eventi misteriosi di Gesù e la seguente missione di testimoniare e di annunziare. Possiamo così evidenziare tre aspetti: 1. eventi di Gesù 2. esperienza di lui 3. missione di testimonianza e annunzio Emerge ancora una volta la necessità dell’esperienza di Gesù per assolvere la missione di testimoni e annunziatori. 6 * * * Nasce ovvia la domanda: che significa l’espressione: “abbiamo mangiato e bevuto con Gesù”? Si tratta semplicemente di un comune fatto materiale, e perciò limitato soltanto alle poche persone di allora, oppure rimanda ad un’esperienza più profonda e, perciò, possibile anche alla chiesa di sempre e ai discepoli di ogni epoca? Nel testo stesso Pietro non spiega di più. Una lettura più attenta della frase rivela però che mangiare e bere con Gesù non esprime la semplice condivisione di una azione materiale, ma indica una profonda compartecipazione che mira a stabilire un intenso rapporto con Gesù. In altre parole: si tratta di un mangiare e bere dove prevale non il fatto materiale ma l’esperienza di intimità con Gesù. Nemmeno il libro degli Atti nel suo complesso aiuta ad illuminare questo particolare del mangiare e bere con Gesù, che pur si rivela carico di significato. Non manca invero qualche altro indizio. In At 1, 4 il Risorto rivolge le sue istruzioni ai discepoli mentre prendevano cibo, e questa sembra essere pure la circostanza in cui egli si è manifestato quaranta giorni parlando del Regno di Dio (cfr vv 1-3). Ma anche questo testo rimane vago, e un riferimento sacramentale è certo possibile ma non necessario. Possiamo però osservare che questo particolare sta all’inizio del libro e può costituire il punto di partenza di tutto il cammino apostolico narrato nel libro degli Atti. Ma possiamo ancora una volta tornare a rileggere il testo di At 10, 41: tale ulteriore e più profonda rilettura ci aiuta a comprendere che il mangiare e bere, indicato come fondamento della testimonianza apostolica, è ovviamente anche l’ambito dove il Risorto si è manifestato. Il Risorto è apparso mentre si mangiava e si beveva. * * * La menzione delle apparizioni di Gesù, nel contesto di un banchetto, ci induce a riferirci pure alle narrazioni evangeliche dove si parla appunto delle apparizioni di Gesù. È noto che i vangeli non offrono alcuna narrazione della resurrezione stessa. Ciò è ben comprensibile e depone a favore della storicità evangelica. Nessuno vide Gesù risorgere e a nessuno perciò è lecito narrare quello che non ha visto. Viceversa il Risorto si è manifestato ai discepoli. Essi che poco prima lo avevano visto morto, ora lo sperimentano vivo. Esclusa qualsiasi spiegazione di allucinazione o mito (che fra l’altro esige un racconto), il fatto che Gesù si presentava vivo non può avere altra spiegazione se non quella già preannunziata dalle Scritture: Gesù è il Santo di Dio e perciò non poteva restare nel sepolcro (Sal 15); egli ha superato la morte appunto risorgendo (cfr. Os 6, 1 ss). Questa conclusione tirarono gli apostoli e questa pure annunziarono: Gesù è risorto da morte il terzo giorno secondo le Scritture. Se non è possibile narrare l’evento stesso della Resurrezione, in se stesso inafferrabile e avvolto dal mistero di Dio, è possibile, e anche doveroso, narrare lc apparizioni del Risorto. I discepoli lo videro vivo e questo potevano e dovevano narrare. Ciò spiega perché tutti i vangeli, che si ricollegano e traggono origine, in progressivo sviluppo, dalla primitiva professione di fede, dopo avere narrato la passione e la morte, continuano il loro annunzio narrando appunto le apparizioni del Risorto. Delle apparizioni di Gesù risorto, in diversa maniera e con diversi racconti, parlano tutti i vangeli; ciò indica l’importanza che ad esse gli evangelisti hanno attribuito. I racconti evangelici stessi delle apparizioni di Gesù poi, al di là della loro apparente semplicità, si rivelano assai complessi e nascondono non pochi problemi. Tuttavia la chiesa apostolica ce li ha tramandati; non è lecito perciò ai cristiani di sempre trascurarli o limitarne la lettura solo nel tempo liturgico pasquale. In essi, oltre che la narrazione delle apparizioni di Gesù agli apostoli, sono contenuti criteri che 7 permettono ai cristiani di sempre di fare anch'essi, sulla scia degli apostoli, esperienza del Risorto. Ad una lettura più attenta, i racconti evangelici delle apparizioni tradiscono una preoccupazione: qualcuno dei cristiani potrebbe pensare che i primi apostoli siano stati più fortunati perché hanno visto il Signore risorto, mentre essi non lo vedono. A questa convinzione dei cristiani può anche alludere 1Pt 1, 8 che scrive: “pur non vedendolo credete in lui”. A questi cristiani Pietro risponde elogiandone la fede. I racconti evangelici però permettono di concludere diversamente. L’indole liturgica di alcuni racconti rivela un messaggio. I primi apostoli certamente hanno visto il Signore; essi però non sono stati più fortunati degli altri, perché a tutti è possibile vedere il Signore: appunto nell’esperienza liturgica, battesimale e soprattutto eucaristica. Si intende però non con gli occhi di carne ma con gli occhi della fede. * * * È impossibile, e probabilmente nemmeno utile, presentare in maniera completa, in questa breve riflessione, tutti i racconti evangelici delle apparizioni di Gesù risorto. Ci limitiamo perciò soltanto ad accennare a qualche racconto soprattutto di quelli proposti dai vangeli di Luca e di Giovanni. Luca Alle apparizioni di Gesù Luca dedica il c. 24 del suo vangelo. Ci narra in quel capitolo di tre apparizioni: quella a Maria di Magdala (vv 1-12), quella a due discepoli nel loro cammino di ritorno da Gerusalemme verso Emmaus (vv 13-35), infine quella agli undici (vv 14-35). È nota, e anche ormai quasi universalmente accettata, l’indole liturgica del racconto dell’apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus. Il racconto infatti gravita su due parti fondamentali: la presenza di uno sconosciuto che, lungo la strada, spiega lc Scritture e il riconoscimento aperto di Gesù a casa nello spezzare il pane. Tutto il racconto comprende allora quattro elementi: la situazione esistenziale dei due discepoli che, dopo gli eventi di Gesù in Gerusalemme, tornano amareggiati e delusi, la spiegazione delle Scritture lungo la strada fatta da Gesù sconosciuto, il riconoscimento di Gesù nello spezzare il pane, il ritorno dei due discepoli a Gerusalemme e il loro coinvolgimento nella professione di fede apostolica che Gesù è veramente risorto ed è apparso a Simone. Quest'ultimo aspetto poi è particolarmente importante e non può essere trascurato. I due discepoli, tornando a Gerusalemme, non narrano prima di tutto la loro esperienza, ma trovano gli undici che esprimono la loro professione di fede. La prima realtà a cui è chiamato chi fa esperienza del Risorto non è quella di narrare la propria esperienza bensì quella di entrare in sintonia con la professione di fede apostolica: l’esperienza personale abilita cosi a riecheggiare quella prima professione di fede. Possiamo dire che l’esperienza del Risorto, sia quella della chiesa sia anche quella personale di ogni cristiano, mira a perpetuare nella storia l’esperienza apostolica e a ricondurre la chiesa di sempre all’unica professione di fede. Pure importante è la seguente narrazione lucana dell’apparizione di Gesù agli undici. Gesù si fa riconoscere rimandando alla concretezza del suo corpo e poi chiede da mangiare. Narra l’evangelista che gli portarono un pezzo di pesce arrosto. Subito dopo Gesù torna ancora a spiegare il suo mistero alla luce delle Scritture. I due racconti, insieme, sono riconducibili ad una sola idea comune che può essere evidenziata dal seguente schema: 8 1. Apparizione ai due discepoli: spiegazione delle Scritture riconoscimento di Gesù nel pane 2. Apparizione agli undici: il pasto con il pesce spiegazione delle Scritture Nel racconto dei due discepoli di Emmaus prima Gesù spiega le Scritture poi si lascia riconoscere nello spezzare il pane; nel racconto dell’apparizione agli undici, al contrario, prima c'è il pasto con il pesce e poi Gesù spiega le Scritture. Nello sfondo delle Scritture si menzionano i due elementi del pane e del pesce; questi due elementi sono precisamente quelli che troviamo nei racconti evangelici della moltiplicazione dei pani. Qualunque sia stata la concreta esperienza dei due discepoli di Emmaus prima e degli undici dopo, emerge nei due racconti insieme scopo e un interesse catechetico. Luca vuoi dire ad ogni cristiano che non sono stati solo quei personaggi ad avere fatto esperienza del Signore. Tutti possono fare esperienza di lui; tale esperienza poi si fa in due ambiti strettamente collegati: nelle Scritture, lette alla luce del Suo mistero e che rivelano il suo mistero, nel banchetto eucaristico, indicato con i simboli del pane e del pesce. Giovanni I racconti postpasquali giovannei, nella loro simbologia, appaiono ancora più complessi. Essi, riferiti nei cc 20-21, si riducono sostanzialmente a tre: l’apparizione a Maria Maddalena (20, 1-18), l’apparizione ai discepoli (20, 19-31), l’apparizione di Gesù presso il lago e la conseguente pesca miracolosa (21, 1-14). Prescindendo dall’apparizione alla Maddalena, che pare evocare piuttosto l’evento battesimale, i due racconti seguenti contengono elementi che richiamano l’Eucaristia. Sono importanti anzitutto le indicazioni cronologiche che caratterizzano le apparizioni ai discepoli (20, 19-23) prima e a Tommaso poi (20, 24-29). Ai discepoli Gesù appare la sera del primo giorno dopo il Sabato; ancora ai discepoli e, più direttamente a Tommaso, appare otto giorni dopo. Queste indicazioni rivelano una cronologia liturgica ed indicano il tempo in cui la chiesa si raduna per far memoria, e perciò esperienza, del Signore morto e risorto. La stessa prospettiva sacramentale liturgica sembra soggiacere anche nel seguente racconto dell’apparizione di Gesù presso il lago con la conseguente pesca miracolosa. Questo racconto pone non pochi problemi dal punto di vista storico, soprattutto in relazione all’analogo episodio della pesca narrato in Lc 5. Il suo significato spirituale però è facilmente comprensibile: il raduno ecclesiale (la pesca) parte dall’esperienza di Gesù risorto che si manifesta. Tale raduno culmina poi nel banchetto con il pane, narrato nel v 13, dove si dice che Gesù viene, prende il pane e lo dona ai discepoli. Possiamo osservare che in Gv 21, 5 Gesù non chiede ai discepoli se hanno, in maniera generica, da mangiare, ma chiede, in maniera specifica, se hanno del companatico. Emerge così la tacita prospettiva di Gesù - pane che chiede il suo companatico; questo è la comunità ecclesiale, simboleggiata dai pesci, che si raduna attorno a lui, alla quale egli ancora dona il pane. Conclusioni Tutte queste osservazioni ci permettono di concludere che l’ambito primo e fondamentale in cui la chiesa e i cristiani di sempre fanno, sulla scia dell’esperienza apostolica, la loro esperienza del Signore risorto è appunto l’Eucaristia. Parliamo però di ambito primo e fondamentale. Ce ne sono altri infatti dove si fa esperienza del Risorto. Tutti questi però non sono separabili da quella fondamentale eucaristica. Da essa questi scaturiscono e ad essa convergono. 9 Nell’Eucaristia, in cui si fa memoria della morte e Resurrezione di Gesù fino al suo ritorno, il Risorto si manifesta; non però in maniera statica ma in maniera profondamente dinamica. Nell’Eucaristia egli parla e agisce. Quello che lui dice e ciò che egli compie può essere percepito però soltanto mediante una contemplazione e un ascolto di fede, altrimenti anche l’Eucaristia rimane muta e non si fa alcuna esperienza del Risorto. Le Scritture, soprattutto quelle del NT, aiutano a “comprendere” l’Eucaristia. Esse aiutano a fare esperienza del Risorto e aiutano anche a comprendere quello che lui dice e quello che lui opera. Si può porre infatti il problema se il Gesù dei vangeli sia solo quello dei pochi anni della sua vita terrena o non piuttosto il Risorto perennemente vivente nella sua chiesa nell’Eucaristia. Certo un’indole liturgica sacramentale può essere attribuita al vangelo di Giovanni, all’Apocalisse, alla prima lettera di Giovanni, alla stessa lettera agli Ebrei e al vangelo di Marco. Questi sembrano presupporre come loro punto di partenza appunto l’esperienza del Signore nell’Eucaristia. Alla luce di questi scritti, e come da essi emergono, possiamo indicare qualcuna delle sue opere, le più importanti, che il Risorto compie nell’Eucaristia: egli raduna la chiesa, effonde lo Spirito che da forza nel cammino quotidiano, ripete il comando dell’amore vicendevole. * * * Soprattutto nell’Eucaristia il Signore continua ad affidare ai suoi la loro missione. Qui emerge una differenza tra la missione nell’AT e la missione nel NT. Nell’AT Dio inviava direttamente i profeti e tutti coloro a cui affidava una missione. Nel NT invece la missione passa e scaturisce come conseguenza logica dall’esperienza del Risorto. A riguardo sono molto significative le parole di Pietro davanti al Sinedrio che abbiamo altre volte citato: “noi non possiamo non parlare di quello che abbiamo visto e udito (At 4, 20)”; è lo stesso Pietro che poi in 10, 41 dirà: “noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione”. Sono importanti le parole “non possiamo”: la vera esperienza obbliga a parlare; ciò significa che, se non si parla, non si è fatta vera esperienza. Il modo come parlare e il tipo di linguaggio da usare sarà ovviamente diverso in ogni cristiano in relazione al proprio carisma (cfr 1Cor 12). A Pietro fa eco anche Giovanni nella sua prima lettera: “ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, ciò che contemplammo e le nostre mani palparono [...] annunziamo a voi (1Gv 1, 1-5)”. Anche in questo testo l’annunzio scaturisce ancora dall’esperienza. Salva opinione migliore, la prima lettera di Giovanni è costruita dall’autore sulla formula dell’istituzione del calice. Che la missione scaturisca dall’esperienza, emerge pure dai vangeli. Benché Gesù abbia mandato i suoi anche durante la vita pubblica, la vera missione in realtà è affidata da Gesù dopo la sua resurrezione ed è proposta al termine delle narrazioni evangeliche. Ciò significa che la missione sta al culmine e ad essa si perviene attraverso un cammino esperienziale di Gesù sviluppato in tutto il vangelo. Un testo però vogliamo più particolarmente indicare. Si tratta del testo ben noto di Gv 21, 15-17. Esso è riferito direttamente a Pietro ma è estensibile anche a chiunque nella chiesa si occupa in qualche modo del gregge di Cristo e perciò ad ogni cristiano a cui è affidata la cura del fratello. Conosciamo bene il testo. Tre volte Gesù chiede a Pietro se lo ama e, ottenuta risposta positiva, tre volte lo incarica di pascere il suo gregge. Un particolare però è importante notare, trascurato talora nelle letture esegetiche. L’evangelista introduce quel dialogo nello sfondo di una indicazione cronologica 10 circostanziale: “dopo che ebbero mangiato”. Questo particolare non è secondario, anzi è fondamentale; si tratta di avere mangiato il pane che Gesù ha donato (v 13). Nel pane Gesù compie la sua opera di amore; nel pane egli la offre; chi mangia il pane accetta l’opera di amore di Gesù; ma chi ne mangia è impegnato anche a rispondere amando a sua volta Gesù. L’amore verso Gesù si concretizza nella cura del suo gregge e Pietro in questo senso è incaricato. Il dialogo tra Gesù e Pietro si ripete per tutti, pastori e fedeli, a pieno titolo ogni volta che si mangia il pane dell’Eucaristia. Non tutti ovviamente sono impegnati nel tipo particolare di missione in cui è impegnato Pietro pastore, ma a tutti compete una particolare forma di missione che è l’amore vicendevole (Cfr. Rm 13, 8). 11 III “si presentò vivente per quaranta giorni parlando del Regno di Dio (At 1, 3)” abituale atteggiamento dell’operatore pastorale: assiduo ascolto della Parola di Dio, come progressivo coinvolgimento nel mistero di Cristo”. Una lettura attenta del libro degli Atti degli Apostoli mostra che gli Apostoli, prima di iniziare la loro missione, trascorsero un tempo di preparazione. Il capitolo primo degli Atti può essere definito appunto come il “Seminario” apostolico”. Ma già fin dalle prime battute della sua opera Luca mostra in che cosa consistette questa preparazione: per quaranta giorni il Signore Gesù, risorto da morte, si presentò ai discepoli parlando loro del Regno di Dio. Prima perciò di essere mandati nel mondo, gli Apostoli furono impegnati in una attività di ascolto. Subito dopo, nel v 4, Luca riferisce il comando di Gesù di non allontanarsi, da Gerusalemme, ma di attendere la promessa del Padre, lo Spirito Santo, la cui effusione sarà poi narrata nel c. 2. Si direbbe che Gesù freni ansia dei discepoli di partire. Del resto non avrebbero potuto assolvere alcuna missione se lo Spirito Santo non fosse prima disceso su di loro. È significativa la circostanza in cui Gesù rivolge questo comando: mentre erano a tavola. Di questa circostanza abbiamo già parlato, benché in diversa prospettiva, già nella precedente conversazione. Ma è utile rievocarla ancora perché ci sembra di scorgere qui uno schema che costituisce quasi il terreno dove affonda le sue radici l’attività apostolica e, perciò, ogni attività pastorale. Questo schema è costituito dai seguenti elementi: 1 .Ascolto della Parola: Gesù parla del Regno di Dio 2. Liturgia eucaristica: mentre mangiavano 3. Il dono dello Spirito Santo: attendere la promessa del Padre 3. La missione: partire da Gerusalemme Questo schema ci rimanda ad una celebrazione eucaristica in cui, partendo dall’ ascolto della Parola, e passando attraverso il “mangiare con Gesù”, si è raggiunti dalla potenza dello Spirito che spinge a perseverare nella missione di testimoni del Risorto. Sull’aspetto dell’ascolto della Parola il libro degli Atti, diversamente dal terzo vangelo, non insisterà più. Piuttosto la sua attenzione si orienta verso annunzio della Parola. Ma è ovvio che annunzio presupponga ascolto, altrimenti si rischia di non annunziare più la Parola di Dio. La complementarietà dell’ascolto e dell’annunzio è appunto sottolineata da Luca nelle due parti della sua opera: terzo vangelo ed Atti. Nel terzo vangelo tutta l’attenzione è rivolta verso l’ascolto, nel libro degli Atti invece attenzione è rivolta all’annunzio. Ascolto e annunzio appaiono così come due realtà, oltre che complementari, anche inscindibili, necessarie una all’altra. Il vero ascolto deve portare, in una maniera o nell’altra, all’annunzio; ma annunzio esige ascolto. L’ascoltatore che non annunzia finisce per comprimere in sé la Parola, rischiando così di mortificarla e di spegnerla. L’annunziatore poi che non ascolta rischia seriamente di proporre altri messaggi che non quelli da parte di Dio. La centralità della Parola di Dio nella predicazione apostolica emerge nel libro degli Atti ad ogni pie sospinto. A tal punto essa è centrale che ci viene idea che il vero protagonista della storia narrata da Luca non siano gli Apostoli bensì la stessa Parola di Dio; questa, diffusa con la potenza dello Spirito Santo, determina la crescita della chiesa. Nota infatti ripetutamente Luca che la Parola di Dio si diffondeva e la chiesa cresceva (At 6, 7; 12, 24; 19, 20). Diffusione della Parola e crescita della Chiesa appaiono così 12 direttamente proporzionali. Di ciò gli Apostoli sono profondamente coscienti. A riguardo basti citare la vicenda narrata nel c. 6, che portò poi all’istituzione dei diaconi. Si creò nella chiesa primitiva uno squilibrio: le vedove dei pagani erano trascurate (At 6, 1). Nemmeno di fronte a questo fatto, che rischiò di spaccare la comunità primitiva, gli Apostoli ritennero di dovere venir meno alla loro primaria vocazione. Istituirono allora i diaconi a cui affidare le mense, riservandosi essi il duplice compito del ministero della Parola e della preghiera. Proprio la centralità della Parola di Dio nel ministero apostolico mostra l’assoluta necessità del suo ascolto. Pure di ciò gli Apostoli sono profondamente coscienti. Di fronte al Sinedrio dichiarano di non potere non parlare di ciò che hanno visto e udito (At 4, 20). Il fatto di avere visto e udito li induce a parlare; ma essi parlano proprio perché hanno visto e udito. Il loro diritto fondamentale a parlare, cioè la parresia apostolica (At 4, 29), scaturisce proprio dalla loro esperienza di ascolto. Senza questa esperienza, facilmente essi si sarebbero lasciati intimorire dalle proibizioni e dalle minacce dei giudei. * * * Quanto poi al tema dell’ascolto della Parola, nel terzo vangelo, ci limitiamo ad accennare solo a quattro testi, che riteniamo i più significativi. 1. Il primo è Lc 2, 51 che propone l’esempio di Maria; di lei si dice che “conservava tutte quelle cose meditandole nel suo cuore”. Si tratta certo degli eventi che caratterizzarono i primi giorni della vita terrena di Gesù; ma si tratta soprattutto del loro profondo significato: infatti sia nelle parole di Simeone, sia anche in quelle della profetessa Anna sia anche nelle parole di Gesù ritrovato nel tempio Dio rivelava già il senso della persona e dell’opera di quel bambino, ma rivelava anche la posizione spirituale di Maria, che, nell’anima, avrebbe condiviso la passione di Gesù. È assai significativo il fatto che di lei i vangeli riferiscano pochissime parole. Ella, come giustamente è stato sottolineato anche dalla spiritualità contemporanea, è presentata come la “vergine in ascolto”. Proprio tale atteggiamento di ascolto e, ovviamente, di accoglienza, che si manifesta soprattutto negli eventi dell’annunciazione, è la causa della sua totale e assoluta disponibilità a quanto Dio le ha indicato. Proprio accoglienza e la disponibilità alla parola di Dio la guiderà fin sotto la croce (Gv 19, 25-27), dove certo condividerà la passione di Gesù, dove però, ben lungi dall’apparire una madre sconsolata, essa sarà rivelata come la madre gioiosa di una moltitudine di figli. 2. Il secondo testo che possiamo citare è quello ben noto di Lc 10,38-42, il banchetto offerto a Gesù in casa delle due sorelle Marta e Maria. Marta serviva e Maria era ai piedi di Gesù in ascolto della sua parola. Alle osservazioni di Marta Gesù risponde dichiarando che Maria ha scelto la parte migliore. Il racconto lucano ha un carattere fortemente catechetico. Esso non mira né a disprezzare l’attività di Marta né a sottovalutare qualsiasi altra attività; tantomeno il racconto può giustificare forme di allontanamento dalla vita o dal servizio ai fratelli. Il punto fondamentale di questo brano è una tacita domanda che esso sembra contenere: qual è il modo migliore per onorare Gesù. Il testo di Luca risponde che questo è riconoscerlo come Maestro e mettersi ai suoi piedi per ascoltare la sua parola. Gesù non chiede agli uomini se non che lo ascoltino e imparino da lui. Da questo ascolto poi scaturirà ogni forma di attività che è rivolta come servizio non a Gesù ma ai fratelli. 13 3. Un terzo testo ancora è Lc 8,19-21. A Gesù annunziano che sua madre e i suoi fratelli stanno fuori e lo vogliono vedere. Gesù risponde che sua madre e i suoi fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questo episodio è comune anche a Matteo e Marco (Mt 12,46-50; Me 3,31-35). C’è però una differenza alquanto significativa tra questi due ultimi evangelisti e Luca. Mentre Matteo e Marco propongono come criterio di parentela con Gesù l’adesione alla volontà di Dio, Luca invece propone come criterio l’ascolto della parola di Dio e la sua osservanza. Probabilmente la tradizione precedente ai tre evangelisti parlava di adesione alla volontà di Dio, Luca mutò specificando che si trattava invece di ascolto della parola. Il senso globale del testo però è chiaro: adesione alla volontà di Dio, secondo Matteo e Marco, e ascolto della Parola di Dio, secondo Luca, determinano un rapporto di parentela con Gesù, non certo sul piano fisico, bensì sul piano spirituale. Lc due prospettive però non sono distanti. Per potere aderire alla volontà di Dio bisogna infatti conoscere questa volontà; ma per poterla conoscere è necessario prima mettersi in ascolto della sua Parola. Lo scopo di questo testo in tutti e tre i vangeli è catechetico e si legge meglio alla luce della resurrezione di Gesù. Si pone infatti il problema sulla sua parentela: chi sono i veri parenti di Gesù? Forse questo problema doveva porsi anche concretamente nella chiesa primitiva. La risposta è che i veri parenti di Gesù non sono quelli legati a lui con un vincolo di sangue; egli ormai nella chiesa non è più soltanto il Gesù terreno, ma è divenuto il Signore risorto. Nella resurrezione egli ha sperimentato una nuova nascita. Mentre nell’incarnazione egli è nato senza concorso di Padre, nella resurrezione egli invece è nato senza concorso di madre, ma è stato generato direttamente da Dio. La nascita pasquale di Gesù sgorga direttamente dalla sua morte e sepoltura, ma in ultima analisi si radica nella sua adesione alla volontà di Dio. Ma anche per Gesù l’adesione alla volontà di Dio scaturisce dall’ascolto della Parola di Dio. A riguardo i testi sono molti soprattutto dal vangelo di Giovanni. Ne citiamo solo uno: Gv 8,26: “ciò che ho udito da Lui (il Padre) queste cose dico al mondo”. Chi ascolta la Parola di Dio e, di conseguenza, aderisce alla sua volontà, ottiene, nella sua nuova nascita da Dio, una parentela con Gesù. Del resto il testo che stiamo commentando, solo in apparenza sembra sminuire la Beata Vergine Maria; in realtà esso contiene una grande lode: Maria è madre di Gesù non solo perché lo ha generato fisicamente, ma anche, e forse soprattutto, perché anche Lei- è stata in ascolto della parola di Dio ed ha aderito alla sua volontà. 4. Il quarto testo è ancora Lc 15,1, introduzione al c. 15, dove Luca raccoglie le tre parabole cosiddette “della misericordia”: la pecora perduta e ritrovata, la moneta perduta e ritrovata, il figlio andato via da casa e ritornato (il figlio prodigo). Il testo è il seguente: “si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo”. Probabilmente i pubblicani e i peccatori avevano una domanda tacita: che cosa ne pensa egli di noi? C'è per noi ancora speranza di salvezza? Attraverso le tre parabole Gesù risponde che il Padre li cerca, attende che essi tornino e, quando li avrà trovati o saranno tornati, gioirà e farà grande festa. Non interessa in queste riflessioni sviluppare il contenuto delle parabole; interessa invece sottolineare che, nell’ascolto della Parola di Gesù, i peccatori possono comprendere che per loro c'è salvezza, che sono invitati a convertirsi e che in quell’ascolto essi possono trovare la forza necessaria per uscire dalla loro situazione di 14 peccato. 5. Ai quattro testi lucani precedenti possiamo aggiungerne anche un quinto, che prendiamo dal vangelo di Matteo: Mt 7,24-27. Gesù conclude il discorso detto “della montagna” con una similitudine. Egli paragona chi ascolta la sua parola a colui che costruisce la casa sulla roccia; quella casa rimane salda e resiste, diversamente da chi non ascolta e perciò costruisce sulla sabbia, a qualsiasi intemperie, fiumi, vento o pioggia. Gesù sta così proponendo ascolto della sua parola come il fondamento su cui può costruirsi, in maniera stabile e solida, ogni esistenza umana e cristiana. Il cristiano che poggia la sua vita sulla parola di Gesù non ha nulla da temere di fronte alle tante intemperie che la potenza satanica scatena. * * * Poniamo adesso un duplice problema: come si attua un autentico ascolto della Parola di Dio? Inoltre dove si incontra la Parola di Dio che bisogna ascoltare? Quanto alla prima domanda, come cioè si attua un autentico ascolto, non consideriamo qui le varie tecniche di ascolto che oggi da più parti vengono suggerite. Queste tecniche hanno certo del valido, ma rimangono anche soggettive: esse infatti rispecchiano situazioni ambientali, psicologiche e culturali proprie di singoli o di gruppi. In questa conversazione interessa invece la metodologia universale proposta da Gesù stesso nella parabola del seminatore (Cfr Mt 13,1-8; Me 4,1-9; Lc 8,4-8). Questa parabola, in cui il seme è esplicitamente identificato con la parola di Dio, è importante, perché essa e la parabola della zizzania sono le sole due nei vangeli che sono spiegate direttamente da Gesù. Nella parabola bisogna notare le quattro sorti del seme; esso cade: lungo la strada, in un terreno pietroso, in un terreno spinoso, nel buon terreno dove, in maniera proporzionata, porta il suo frutto, il trenta, il sessanta, il cento per uno. Il seme che cade lungo la strada non porta alcun frutto perché, non penetrando nel terreno, rimane esposto agli uccelli che lo beccano. Il seme che cade in un terreno pietroso fruttifica solo all’inizio, ma poi muore perché, incontrando le pietre, non può affondare le proprie radici nel terreno. Il seme che cade tra le spine porta frutto, ma poi il frutto è soffocato dalle spine e muore. Porta frutto solo il seme che cade nel buon terreno. La parabola, appunto per il suo linguaggio parabolico, è aperta a molte applicazioni. Seguendo le indicazioni di Gesù, il seme lungo la strada è tolto via dal diavolo; quello che cade in un terreno sassoso ha a che fare con entusiasmi epidermici che svaniscono al momento della difficoltà; quello che cade nel terreno spinoso ha a che fare con attaccamenti alle ricchezze o alle cose del mondo. La parabola anzitutto vuole stimolare il cristiano ad una verifica: egli deve vedere qual è la sua posizione di fronte alla parola di Dio, se è una strada, un terreno pietroso, un terreno spinoso o un buon terreno. Ma riteniamo che la parabola, mentre presenta quattro sorti distinte e parallele del seme, delinea anche un itinerario che deve condurre il cristiano a diventare buon terreno. Non deve anzitutto essere strada. L’immagine della strada può evocare diversi aspetti, in particolare due: quello di un terreno duro, essendo calpestato dai passanti, e quello di un terreno aperto a chiunque. In simile terreno il seme rimane scoperto e può essere facilmente portato via. Bisogna allora non essere strada, ma accogliere il seme nel cuore e custodirlo da ogni influsso esterno. Il seme poi, accolto nel cuore, deve fare i conti con tutte le paure e resistenze, spirituali e psicologiche che albergano nel cuore umano. Queste infatti, dopo un primo ed epidermico entusiasmo, possono condizionare lo sviluppo del seme, fino a farlo morire. A 15 riguardo i vangeli ci offrono un esempio molto eloquente in Pietro durante la passione: l dichiarazioni assolute e perentorie a volere seguire Gesù si tramutarono poi, alla prova dei fatti, in misero rinnegamento. Bisogna perciò superare ogni paura ed ogni resistenza. In ciò non è estranea l’opera dello Spirito. Il seme poi, anche se riesce ad attecchire e a fruttificare, deve ancora fare i conti con realtà esterne, le spine, identificate dalla spiegazione della parabola con le preoccupazioni del mondo e inganno delle ricchezze, che possono suggerisce un compromesso, ma che poi finiscono per soffocare il seme della parola. Non che il cristiano non debba occuparsi delle cose terrene, ma non deve metterle al primo posto fino a lasciarsi coinvolgere da esse. A riguardo i vangeli ci offrono un esempio molto istruttivo nel giovane ricco (cfr Me 10,17ss), il quale, messo di fronte al dilemma di scegliere tra le ricchezze terrene e il tesoro in cielo, scelse le prime. La sua conseguenza fu la tristezza: dice il vangelo infatti che andò via triste, a differenza dell’uomo della parabola che, scoperto il tesoro nascosto, per la gioia andò a vendere quanto aveva e comprò quel campo (Mt 13,44-46). La Scrittura è esperta conoscitrice dell’animo umano e sa bene come esso facilmente si lascia coinvolgere dalle cose terrene e ancor più facilmente si lascia allettare dalle ricchezze, a scapito del germe della parola che a poco a poco finisce per morire. Ma come disporre il cuore umano ad accogliere il seme della parola e a diventare man mano buon terreno, secondo il progresso pedagogico della parabola, sicché il seme possa portare frutto? Non sta a noi adesso proporre indicazioni spirituali. Ci limitiamo soltanto a notare come tutta la Scrittura celebra la potenza della Parola di Dio legata alla forza dello Spirito. Possiamo così parlare di un’interagenza tra il seme della Parola e il cuore umano. Più il seme della Parola è accolto e più opera a trasformare in buon terreno il cuore umano; più il cuore umano diventa buon terreno e più accoglie e fa fruttificare il seme della Parola. È vero però anche il contrario: più il cuore umano si irrigidisce e meno accoglie la Parola, meno accoglie la Parola e più si irrigidisce. * * * Veniamo adesso alla seconda delle due domande su indicate: dove si incontra la Parola di Dio che bisogna ascoltare? Indichiamo alcuni ambiti, limitandoci però soltanto ad indicarli. Il primo ambito è l’Eucaristia. Essa infatti, nella prospettiva di Giovanni, è la Parola di Dio che, incarnata, caduta a terra come il chicco di grano, è divenuta Pane. Nell’Eucaristia perciò Gesù parla con un linguaggio misterioso trasmesso dallo Spirito direttamente al cuore umano e decifrabile solo nella fede. Il secondo ambito sono le Scritture, che la chiesa del Concilio Vaticano II ha riproposto con rinnovata energia alla vita cristiana, superando, e anche rigettando, paure e diffidenze del passato. Per la comunità primitiva le Scritture erano solo AT, per la chiesa seguente le Scritture comprendono anche gli scritti apostolici, cioè il NT. La chiesa accoglie con “pari venerazione” entrambi i testamenti. Oggi è importante tornare alle Scritture; non bisogna dimenticare che qualsiasi accostamento, da quello più scientifico esegetico a quello più spirituale carismatico, purché fatto nella fede, è sempre lectio divina. Un terzo ambito è la tradizione viva della chiesa, quella che, in maniera vissuta, essa ha ricevuto dalla chiesa primitiva e che coincide con la sua stessa fede. Il magistero, di per sé non è parola di Dio, ma deve aiutare a discernere tra ciò che appartiene alla tradizione di sempre e ciò che risale a tradizioni contingenti di particolari momenti nella storia. Alla prima bisogna restare assolutamente fedeli, dalle seconde bisogna al 16 momento opportuno sapersi staccare senza inutili attaccamenti. Un quarto ambito è la comunità ecclesiale di oggi con i suoi pastori. Essa esprime al momento presente un senso di fede. Certo delle prospettive di fede possono essere approfondite e certe forme possono essere abbandonate. Ma è importante restare al passo con il cammino ecclesiale, senza ingiustificati ritardi, frutto di nostalgie, e senza acritiche e soggettive proiezioni in avanti, frutto talora di insofferenza. Un quinto ambito è lo stesso cuore umano del cristiano. In esso dimora lo Spirito Santo che fa risuonare il grido: “Abbà, o Padre (Gai 4,6)”. Il carisma profetico del cristiano deve aiutare a sapere discernere la vera voce dello Spirito e saperla distinguere dalle mille voci, talora anche di indole satanica, che spesso interferiscono nel cuore umano. Un sesto ambito infine può essere costituito dai fratelli con le loro difficoltà, le loro esigenze, le loro richieste, i loro suggerimenti. Inoltre può essere costituito anche dai fatti quotidiani o dagli avvenimenti più grandi della storia. Infatti il Dio che, per parlare, anticamente non disdegnò un’asina (Nm 22, 22 ss), per parlare può servirsi anche oggi di tutto e di tutti. Tutti questi ambiti però debbono risuonare concordemente; sarebbe fatale infatti limitarsi ad un solo ambito, isolandolo o, peggio, ponendolo in conflitto con gli altri. Il rischio allora sarebbe di spacciare per parola di Dio i propri punti di vista umani, con la conseguenza tragica che non solo la chiesa non cresce ma anche che il terreno dove essa è piantata si inaridisca e si desertifichi, come si ha l’impressione che stia accadendo oggi in alcuni luoghi, dove la voce della Parola di Dio sembra essere coperta e messa a tacere dalla voce del benessere. 17 IV “mentre era a tavola comandò a loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere la promessa del Padre “che avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi sarete battezzati di Spirito Santo non fra molti giorni (At 1,4-5)” Le dimensioni spirituali dell’operatore pastorale: l’attesa del momento di Dio, la coscienza di essere coinvolti in una storia di salvezza, la riscoperta del dono dello Spirito del battesimo e nella cresima. Dopo avere informato che aveva istruito i suoi per quaranta giorni, parlando loro del Regno di Dio, Luca continua narrando che Gesù comandò ai discepoli di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere il dono dello Spirito Santo. Ciò che Gesù dice è molto importante e Luca lo sottolinea anche dal punto di vista letterario, passando nel testo sopra citato dal discorso indiretto al discorso diretto. Abbiamo proposto nel titolo, dedotte da questo breve racconto, alcune dimensioni spirituali dell’operatore pastorale, ma una considerazione più attenta del testo rivela diversi altri elementi. Specificamente questi sono: 1. anzitutto una esortazione negativa: Gesù comanda ai discepoli di non allontanarsi da Gerusalemme 2. positivamente poi li esorta ad attendere 3. l’oggetto dell’attesa è lo Spirito Santo che Luca però presenta come la “promessa” del Padre. 4. Possiamo inoltre notare il carattere trinitario della promessa: essa è la promessa del Padre, ma è mediata da Gesù e riguarda lo Spirito Santo. 5. Ancora i discepoli sono chiamati a coinvolgersi in una storia di salvezza che parte dal battesimo di Giovanni e culmina nel fatto che essi sono battezzati di Spirito Santo, ovviamente passando attraverso i vari punti intermedi del mistero di Gesù: passione, morte, resurrezione, ascensione ed effusione dello Spirito Santo. 6. Infine il testo evidenzia che, prima di partire da Gerusalemme, i discepoli debbono essere “battezzati” di Spirito Santo 1. Non allontanarsi da Gerusalemme Questa esortazione negativa in certo senso sorprende. Perché Gesù esorta i discepoli a non allontanarsi da Gerusalemme prima che non siano raggiunti e consacrati dallo Spirito Santo? La risposta può essere ovvia e facile: c'è il rischio che essi si allontanino da Gerusalemme prima che si compia tale evento. Che i discepoli debbono partire da Gerusalemme, lo dirà Gesù stesso poco dopo, affidando loro la missione di essere suoi testimoni in Gerusalemme, in Giudea e Samaria e fino agli estremi confini della terra. Gerusalemme però è il punto di partenza della loro missione, ma essa stessa dalla loro missione non è esclusa. A riguardo di Gerusalemme il libro degli Atti degli Apostoli mostra una tendenza inversa rispetto a quella del terzo vangelo: quest'ultimo ha un dinamismo Gerusalemme centripeto, il cammino di Gesù infatti è orientato verso Gerusalemme dove egli dovrà manifestarsi, soprattutto negli eventi della passione e della resurrezione, come il Messia. Gli Atti degli Apostoli presentano invece un dinamismo Gerusalemme -centrifugo. Non si tratta più del cammino di Gesù ma di quello dei discepoli. Questo infatti parte da Gerusalemme ed è proiettato verso gli estremi confini della terra. Gerusalemme rimane però in ogni caso il primo obiettivo dell’attività apostolica. Notiamo infatti che una larga parte del ministero apostolico, almeno agli inizi, si svolse a Gerusalemme; poi il vangelo, in parte con Pietro ma soprattutto con Paolo, si aprì 18 al mondo greco pagano. A Luca non interessa descrivere nel suo libro le gesta eroiche degli Apostoli, ma mostrare come il vangelo raggiunge veramente gli estremi confini della terra. Quando Paolo ha messo piede a Roma, cioè negli estremi confini della terra, Luca ha raggiunto il suo scopo e, senza aggiungere altro, può chiudere la sua opera. Tuttavia nel comando negativo di Gesù di non allontanarsi da Gerusalemme, forse si può scorgere un altro aspetto che non raramente è presente negli apostoli di sempre: la fretta di iniziare il proprio ministero. Tale fretta può essere certamente stimolata dall’amore di Cristo (cfr. 2Cor 5,4), ma può tradire talora anche aspetti più umani quali, la voglia di apparire, il desiderio di affermarsi, l’esigenza di realizzarsi, la tendenza ad autoesibirsi. Le parole di Gesù di non allontanarsi da Gerusalemme possono esercitare così una azione frenante a simili tendenze umane. Del resto nemmeno gli inizi del ministero paolino furono caratterizzati da tale fretta. 2. Attendere il dono All’esortazione negativa di non allontanarsi segue in corrispondenza quella positiva di attendere. Non si tratta di un’attesa immotivata o incerta, ma precisamente dell’attesa del dono del Padre. Ciò significa che senza tale dono il ministero apostolico rischia di fondarsi sul nulla e di votarsi così all’insuccesso. In questo senso Gesù è stato abbastanza esplicito. Annunziando ai discepoli: “riceverete lo Spirito Santo e sarete miei testimoni”, ha detto, in altri termini, che essi, senza lo Spirito Santo, non avrebbero potuto assolvere questa loro fondamentale missione. Gli apostoli però hanno ben recepito questa istanza del Signore Gesù. Li troviamo infatti, dopo l’Ascensione, in attesa dello Spirito Santo, nella preghiera, con Maria la madre di Gesù e con altre persone che formano bene un contesto ecclesiale. Due motivi rendono necessaria l’attesa del dono di Dio. Il primo motivo è stato già accennato: la vera testimonianza e l’autentico annunzio superano ogni capacità umana e necessitano perciò del dono di Dio. Senza di esso difficilmente gli uomini possono sfuggire al groviglio delle trame umane. Il secondo motivo è ancora più importante e fonda il primo. Come emerge dal NT, meno dal libro degli Atti ma molto più dal vangelo di Giovanni, i primi testimoni di Gesù nel mondo sono il Padre stesso e lo Spirito. L’annunziatore e il testimone umani perciò sono proiettati in un’opera divina nella quale è possibile coinvolgersi solo grazie all’opera dello Spirito. Di ciò gli Apostoli sono profondamente coscienti. Basti pensare alla formula usata da Pietro in At 15,28: “sembrò allo Spirito Santo e a noi”: essi sono consapevoli che è lo Spirito a prendere le grandi decisioni nella chiesa e che il loro compito è quello di discernere la sua strada. Non lo Spirito senza di loro ma nemmeno loro senza lo Spirito. Si comprende allora l’esortazione del Signore Gesù ad attendere la Promessa del Padre. Possiamo perciò parlare della spiritualità dell’attesa come la spiritualità tipica dell’operatore pastorale. L’attesa non si riferisce soltanto alla grande consacrazione battesimale o presbiterale ma anche alla quotidiana attività dove più immediatamente si manifesta la presenza e l’opera dello Spirito. In questo senso attendere significa essere in atteggiamento di continuo ascolto e sforzarsi di discernere la voce dello Spirito, che indica quando bisogna camminare o fermarsi, parlare o tacere, come la nube del deserto che segnalava al popolo quando doveva riprendere il cammino e quando doveva fermarsi e piantare le tende. Esempi significativi a riguardo si trovano nel ministero di Paolo: alcuni suoi progetti gli furono impediti dallo Spirito (At 16,6.7), il quale invece apri la via nuova ed inattesa verso la Macedonia. 19 3. La Promessa del Padre E significativo il fatto che lo Spirito è indicato nel testo che stiamo considerando con il termine promessa. Precisiamo che non si tratta di una promessa, ma della Promessa, la promessa cioè per eccellenza. Ciò significa che nel dono dello Spirito che i discepoli debbono attendere, trova il suo culmine tutta la storia delineata già nell’AT. Lo stesso mistero di Gesù, che pur è il massimo evento di salvezza, sarebbe stato inutile per gli uomini se da esso non fosse scaturito il dono dello Spirito. La promessa del Padre affonda perciò le sue radici nell’AT. La nube del deserto al tempo dell’esodo, l’acqua scaturita dalla roccia (Es 17) ancora nel deserto, il fiume di acqua che sgorga dalla porta orientale del tempio nella visione di Ezechiele (Ez 47) erano delle immagini che preannunziavano tale dono. Alcuni testi particolari poi più esplicitamente preannunziano tale dono. Possiamo pensare a Gv 3, citato da Pietro nel discorso della Pentecoste (At 2): Dio aveva preannunziato una effusione dello Spirito mediante la quale avrebbe conferito a tutti il carisma profetico. Possiamo pensare ancora a Zc 12,10, secondo cui Dio avrebbe effuso su ogni uomo uno spirito di grazia e supplica che avrebbe indotto tutti a guardare a quel Dio che pur avevano trafitto. Possiamo pensare infine ad Ez 36,26 secondo cui l’effusione dello Spirito avrebbe creato negli uomini un cuore nuovo ed uno spirito nuovo, o anche a Ez 37,1-12 secondo cui lo Spirito avrebbe ridato vita a tutte le ossa aride. Adesso la promessa si compie e lo Spirito è mandato a rinnovare la faccia della terra (Sal 103,30). I discepoli appartengono anch'essi a quella terra che deve essere rinnovata, ma sono chiamati a collaborare a tale opera di rinnovamento. Esortati ad attendere tale dono, da una parte essi appaiono come i destinatari della salvezza stessa, dall’altra sono chiamati a collaborare nell’opera di salvezza degli uomini. Tale promessa oggi è diventata realtà; il cristiano, che ha ricevuto tale dono nel battesimo e nella cresima, rivivificato continuamente nell’Eucaristia, e che perciò vive già in forza dello Spirito nell’attesa che anche il corpo sia rinnovato (Rm 8,24), non può non sentire o riscoprire nella propria vita questa presenza dalla quale trae luce e forza. In particolare lo Spirito Santo opera effetti grandiosi nel cuore del cristiano. Effonde l’amore di Dio (Rm 5,5), induce a gridare “Abbà, Padre” (Gai 4,6), accende la fede ed alimenta la speranza, nella preghiera interviene in aiuto alla nostra debolezza con gemiti inesprimibili. Sarebbe molto lungo, alla luce del NT, delineare la funzione e l’opera dello Spirito sia nella vita della chiesa sia anche nella vita personale del cristiano. Ci limitiamo solo a sottolineare che l’operatore pastorale, chiamato a collaborare nel ministero con lo Spirito Santo, è chiamato pure a riscoprire la sua presenza nella propria vita e affidare alla sua luce anche le scelte concrete nel ministero. 4. Il carattere trinitario della promessa II carattere trinitario della promessa emerge dalle parole stesse di Gesù. Si tratta chiaramente della promessa del Padre; essa però è stata comunicata attraverso Gesù: egli stesso infatti dichiara: “che avete udito da me (la versione latina traduce: che avete udito attraverso la mia bocca)”. Gesù così si presenta semplicemente come colui che ha trasmesso l’annunzio della promessa. In realtà Gesù non è stato soltanto un semplice trasmettitore della promessa. L’espressione, citata, di At 1,4, si legge ancora solo all’inizio del libro degli Atti, e Luca si esprime in maniera ancora generica, per non anticipare quello che invece con molta chiarezza mostrerà dopo. Gesù, con il suo mistero, ha attuato la promessa di Dio ed è stato la causa che ha permesso l’effusione dello Spirito Santo. Non è infatti casuale il fatto che nel discorso 20 della pentecoste, dopo avere spiegato alla luce delle Scritture che si era verificato l’evento dell’effusione dello Spirito Santo, Pietro passa subito ad annunziare il mistero di Gesù che i giudei hanno ucciso ma che Dio ha resuscitato. E noto che i due autori neotestamentari che più direttamente descrivono l’effusione dello Spirito Santo sono Luca e Giovanni. E nota pure la loro differente prospettiva. Mentre Luca differisce tale effusione alla festa giudaica del 50° giorno che celebrava il dono della Legge (pentecoste), Giovanni la fa scaturire direttamente dalla morte e al momento della morte di Gesù (Gv 19,30.34). Non bisogna assolutamente materializzare i tempi che nei due autori hanno un valore più teologico che non cronologico o, se vogliamo, hanno un valore storico salvifico. Il punto fondamentale ed essenziale però in cui i due autori concordano è il fatto che tale dono scaturisce dal mistero di Gesù. Interessa, al momento, caratterizzare la cristologia lucana e Giovannea in relazione allo Spirito Santo. Ciò esigerebbe una trattazione molto più lunga. A noi interessava, in questa prospettiva trinitaria, indicare la causalità di Gesù nell’effusione dello Spirito Santo. Emerge così il carattere trinitario della realizzazione della promessa. La stessa promessa è lo Spirito Santo; essa è stata fatta dal Padre e riguarda il suo Spirito che egli dona agli uomini; la promessa però è stata realizzata attraverso il mistero e l’opera di Gesù, che non è una semplice causa subordinata e strumentale, bensì in tale opera egli è coeguale al Padre. In ogni caso, soprattutto nella teologia giovannea, lo Spirito santo è presentato come il dono talora del Padre, talora di Gesù: ma mai del Padre senza Gesù, né mai di Gesù senza il Padre. Tuttavia l’opera trinitaria non si esaurisce qui. Adesso però è necessario superare la prospettiva più limitata dei primi versi del libro degli Atti e riferirci alla prospettiva globale, più o meno esplicita, di tutto il NT. Soprattutto il vangelo di Giovanni stabilisce una relazione che parte dallo Spirito e risale a Gesù: lo Spirito infatti deve insegnare e ricordare ai discepoli tutto ciò che Gesù ha detto (Gv 14,26) e deve introdurli in tutta la verità (Gv 16,13). Simile relazione, benché in maniera più implicita, è stabilita pure da Paolo. In Rm 5,5 infatti egli scrive che l’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori, e poi, nel v 8, aggiunge che Dio concretizza il suo amore per noi nel fatto che, essendo noi peccatori, Cristo per noi è morto. Perciò l’amore di Dio che lo Spirito Santo effonde nel cuore umano non è un vago sentimento ma coincide con la stessa persona di Gesù che manifesta e in quanto manifesta con la sua morte l’amore di Dio. Ma Gesù non è l’ultima meta dell’uomo. Soprattutto nella prospettiva giovannea, egli orienta e conduce verso il Padre. Egli infatti si è autodefinito come “la via, la verità e la vita (14,6)”, precisando subito dopo che nessuno può giungere al Padre se non attraverso di lui. Effondendo lo Spirito Santo, Gesù coinvolge i discepoli in tutta la dimensione trinitaria. L’effusione dello Spirito Santo è così il culmine di una storia trinitaria discendente che parte dal Padre e passa attraverso Gesù; ma è anche il punto di partenza di una storia trinitaria ascendente che passa ancora attraverso Gesù e che culmina poi nel Padre. In questo duplice cammino trinitario l’operatore pastorale, come cristiano, è inserito lui ed è chiamato a collaborare a che anche gli altri possano inserirsi. 5. La storia della salvezza Una breve storia della salvezza, come abbiamo già notato, è delineata da Gesù stesso nelle parole: “Giovanni battezzò con acqua, voi sarete battezzati con Spirito Santo”. Luca riprende e adatta in bocca a Gesù un’espressione che la tradizione 21 evangelica riferì a Giovanni: “io vi battezzo in acqua [...], egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3,16)”. Il battesimo con acqua amministrato da Giovanni e il battesimo con Spirito Santo annunziato da Gesù costituiscono rispettivamente il punto di partenza e il punto di arrivo di una storia di salvezza incentrata attorno al mistero di Gesù. Questi due punti si riferiscono ad una storia ancora più ampia di quella narrata dalle narrazioni evangeliche. Queste infatti partono dalla predicazione e dal battesimo di Giovanni e culminano negli eventi di morte e sepoltura, fino alle sue apparizioni che, ovviamente, presuppongono la resurrezione. Ma la storia ancora continua: Gesù infatti, risorto da morte, dopo avere trascorso ancora quaranta giorni con i discepoli, salì al ciclo e sedette alla destra di Dio. Come Luca stesso afferma per bocca di Pietro, elevato alla destra di Dio e, avendo ricevuto la proméssa del Padre, egli effuse sugli uomini lo Spirito Santo (At 2,33-34). Si realizzano così le parole di Giovanni che uno più forte di lui, dopo di lui, avrebbe battezzato in Spirito Santo. Nel giorno della pentecoste i discepoli sono stati appunto battezzati da Gesù mediante lo Spirito Santo. Ma la storia di salvezza su indicata è limitata soltanto al mistero di Gesù. In realtà essa è molto più ampia. Affonda le sue radici nello stesso mistero eterno dell’amore di Dio che diventa benedizione (Ef 1,3-4), passa attraverso la storia umana fin dalla creazione, e culmina nella parusia di Gesù quando egli tornerà nello splendore della sua gloria a rinnovare ogni cosa, ad operare mediante lo Spirito la resurrezione dei corpi (Rm 8,11), ad istaurare cieli nuovi e terra nuova (Ap 21,1 ss). Possiamo così distinguere tre parti concrete nell’unica storia del Dio Salvatore che va dalla sua eternità alla sua eternità. La prima parte va dalla creazione all’incarnazione di Gesù e alla predicazione di Giovanni: questa prima parte può essere definita “storia di salvezza che prepara”. La seconda parte, quella che abbiamo sopra già indicato, va da Giovanni Battista alla pentecoste: questa seconda parte può essere definita come “storia di salvezza che attua” in Cristo ciò che nella parte precedente era stato annunziato e preparato. La terza parte va dalla pentecoste fino alla parusia; questa terza parte può essere definita come “storia della salvezza in cammino verso il suo ultimo compimento”. Della prima parte conosciamo bene le tappe. Esse sono delineate nell’AT e sono: creazione, peccato, vocazione di Abramo, regno davidico, esilio babilonese, attesa messianica. Conosciamo pure le varie tappe della seconda parte: esse coincidono con i vari aspetti del mistero di Gesù già sopra indicate e sono delineate nei vangeli e negli altri scritti del NT. Invece non conosciamo ancora, né possiamo conoscerle, le varie tappe della terza parte, quella proiettata verso il futuro nella quale noi adesso viviamo e che coincide con il tempo della chiesa. Potremo conoscerle solo alla fine, al ritorno del Signore, quando, alla sua luce, sarà possibile rileggere ogni cosa. Ma perché Gesù, annunziando ai discepoli che sarebbero stati battezzati in Spirito Santo evoca, mediante la menzione del battesimo di Giovanni, la seconda parte della storia della salvezza, quella incentrata sul suo mistero di Gesù? La risposta potrebbe essere semplice: essi fanno parte di una storia della salvezza che continua anche attraverso la loro opera, o che prevede nel suo divenire anche l’azione dei discepoli. Subito dopo infatti i discepoli continuano chiedendo a Gesù se questo è il momento in cui egli ricostituirà il Regno di Israele. Gesù non risponde sui tempi, dichiarando che essi sono stati riservati dal Padre al suo potere. Dichiara però che da questa restaurazione essi non sono esclusi ma collaboreranno mediante la testimonianza che renderanno a lui fino agli estremi confini della terra e fino al suo ritorno. A tale scopo essi riceveranno lo Spirito Santo. La discesa dello Spirito Santo perciò conclude la seconda parte della storia della 22 salvezza ed inaugura la terza. I discepoli, coinvolti già nella seconda mediante lo Spirito Santo con il quale saranno battezzati, diventano, sempre mediante lo Spirito Santo, collaboratori nella realizzazione della terza. L’operatore pastorale così non può sentirsi o restare isolato; ma è chiamato a sentirsi coinvolto, come un anello di una lunga catena, in una storia di salvezza che si radica nel mistero dell’eterno amore di Dio e culmina nella parusia di Gesù. Egli deve vedere nella storia dell’AT il terreno dove affondano le sue radici; egli deve sentirsi anche coinvolto nel mistero di Gesù che riscopre ogni giorno attraverso la lettura e la meditazione degli scritti del NT; e deve pure sentirsi in cammino, fratello tra i fratelli ai quali rivolge la sua opera, verso il mistero della parusia di Gesù. Dal momento che nessuno conosce il cammino della storia della salvezza che va dalla pentecoste fino alla parusia, se non lo Spirito, emerge ancora la necessità di affidarsi all’opera dello Spirito che in genere suggerisce solo a brevissime tappe e volta per volta il cammino che bisogna compiere. Il dono dello Spirito è così come una cerniera che unisce il mistero di Gesù, anzi lo stesso mistero trinitario, e gli uomini. Promesso dal Padre e mediato da Gesù, Egli deve portare agli uomini e coinvolgerli in quella salvezza che Gesù, morendo e risorgendo, ha operato. 6. Il battesimo nello Spirito Santo A riguardo di tale battesimo parlano sia i vangeli sinottici e gli Atti degli Apostoli, nel contesto in cui parlano dell’attività di Giovanni in relazione a quella futura del Messia, sia anche il vangelo di Giovanni nel lungo dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo (Gv 3). Emerge però una differenza tra i vari testi. Mentre i sinottici e gli Atti in certo modo contrappongono il battesimo in acqua a quello in Spirito, Giovanni invece accosta le due nozioni di acqua e spirito e parla di una nuova nascita da acqua e Spirito Santo (Gv 3,5). Al di là di queste differenze, più specificamente esegetiche, nei testi sopra citati il battesimo in Spirito facilmente richiama il nostro battesimo cristiano. In esso infatti l’uomo è raggiunto da Gesù, riceve lo Spirito Santo e fa esperienza di una nuova nascita. Al battesimo possiamo unire il sacramento della cresima dove ancora si riceve una effusione Spirito Santo, che porta a compimento il cammino di formazione cristiana e rende idonei ad assolvere la missione di testimoni del Risorto. E doveroso però osservare che la marcata distinzione attuale tra battesimo e cresima appare più il frutto della riflessione e della prassi posteriore: si fa una certa fatica infatti a scorgere nel NT tale marcata distinzione tra i due sacramenti. È inutile forzare i testi; forse è meglio concludere che la comunità primitiva non ebbe ancora chiara o non ritenne utile tale distinzione. Prescindendo perciò dal problema sulla relazione tra i due sacramenti, orientiamo la nostra attenzione sull’Eucaristia. In essa si fa memoria di tutto il mistero di Cristo e perciò anche dell’evento della pentecoste. Nell’Eucaristia il cristiano fa memoria della prima pentecoste e da essa, come da una fonte perennemente aperta riceve ancora il dono dello Spirito che vivifica e rende operante l’effusione verificatasi nei sacramenti del battesimo, della cresima o anche dell’Ordine Sacro. Dal momento che l’Eucaristia, oltre che del mistero della morte e resurrezione di Gesù, fa memoria anche del dono pentecostale dello Spirito, l’operatore pastorale non può non partire da essa. Tanto più che nella celebrazione liturgica lo Spirito Santo è invocato due volte, perché trasformi il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù e perché faccia di tutti i cristiani un solo corpo, quello di Gesù, e un solo spirito, animato dalla carità vicendevole. 23 V “… tornerà allo stesso modo come voi lo avete visto salire in ciclo”(At 1,11)” La fisionomia spirituale dell’operatore pastorale: il precursore in relazione alla venuta futura del Signore, come Giovanni in relazione alla prima. “[...] tornerà allo stesso modo come voi lo avete visto salire in cielo (At 1,11)”. Quest'annunzio rivolgono i due uomini bianco vestiti ai discepoli che guardavano attoniti il Signore mentre saliva al cielo. 1. Il ritorno del Signore Risorto e asceso al cielo, il Signore Gesù si è celato alla vista umana. Egli però, come sottolinea la liturgia dell’Ascensione, non si è separato dai suoi, ma si rende presente mediante lo Spirito Santo che consacra e costituisce, nei sacramenti, dei segni visibili della sua presenza. L’assenza del Signore però è solo temporanea. La fede primitiva, mentre professava la sua resurrezione, si proiettava nella speranza verso il suo ritorno. Il Signore stesso aveva detto che un giorno sarebbe tornato. Lo aveva detto in diversi modi, con diverse parabole e con diverse espressioni. Si era persino paragonato ad un ladro il tempo della cui venuta è imprevedibile e, nell’attesa del suo ritorno, aveva esortato i suoi a vegliare nell’operosità. Del suo ritorno, e della conseguente attesa nell’operosità, Gesù aveva parlato soprattutto nelle parabole dell’attesa. Possiamo citare quelle più significative del c. 25 del vangelo di Matteo: la parabola delle dieci vergini e la parabola dei talenti che i servi debbono trafficare. A queste due parabole possiamo aggiungere anche la parabola lucana (Lc 10) del Samaritano: all’albergatore, che nell’economia della parabola può essere identificato con la chiesa che ha cura di quelli che Gesù guarisce, il samaritano comanda di spendere, perché egli avrebbe rifuso al suo ritorno. Del ritorno del Signore, oltre i vangeli, parlano anche altri libri del NT. Ne parla, pur in diversa prospettiva, anche Giovanni. Ne parla l’Apocalisse, che lo presenta come il motivo della speranza per i cristiani perseguitati e uccisi; ne parla anche Paolo, almeno nelle sue prime lettere, le due ai Tessalonicesi e la prima ai Corinti. Negli Atti degli Apostoli del ritorno del Signore si parla solo nel testo che stiamo considerando. Ma esso è sufficiente a conferire una prospettiva particolare a tutto il libro. Se la testimonianza apostolica conosce come limiti di spazio gli estremi confini della terra, conosce come limite di tempo il ritorno del Signore: essa cioè non ha alcun limite di spazio o di tempo. Nella prospettiva neotestamentaria la resurrezione del Signore, seguita dalla sua ascensione e dall’effusione dello Spirito Santo, segna l’inizio del tempo della chiesa che dura fino al ritorno del Signore, fino cioè alla sua parusia. Questo tempo intermedio è caratterizzato, secondo le parabole delle 10 vergini e dei talenti, dall’operosità dei servi; è caratterizzato, secondo la parabola della zizzania, da una mescolanza tra bene e il male; è caratterizzato, secondo il libro dell’Apocalisse, dal mistero satanico che si serve dei poteri terreni per muovere guerra ai santi di Gesù. Nella prospettiva del libro degli Atti poi, questo tempo intermedio è caratterizzato dall’attività degli Apostoli, o della chiesa intera, che attraversa le vie del mondo, rendendo testimonianza e annunziando che Gesù è l’unico salvatore. 2. Il tempo del ritorno Questo problema dovette costituire una domanda angosciosa tra i primi cristiani: 24 quando il Signore tornerà? Forse, almeno in un primo momento, dovette esserlo anche per gli apostoli. Ma poi essi capirono che il vero problema non era il tempo cronologico, ma la nuova prospettiva che la resurrezione di Gesù aveva inaugurato. Gli ultimi tempi erano già iniziati e perciò non bisognava attendere altro se non il suo ritorno. In questa prospettiva il ritorno del Signore diventa una realtà vicina, così come la posizione della causa ravvicina l’effetto. In questo senso la fede primitiva potrà dire che il Signore tornerà presto, non però in senso cronologico, ma in senso qualitativo. Posta la causa che è la resurrezione, l’effetto, cioè il suo ritorno, automaticamente diventa ravvicinato, anche se tra la resurrezione e il suo ritorno possono intercorrere migliaia di secoli. Tutto ciò fu compreso dalla chiesa apostolica che, con molta enfasi, soprattutto nei discorsi escatologici, riprese ed enfatizzò lc parole del Signore (cfr Mt 24,36) sulla inconoscibilità di quell’ora: Gesù aveva detto che nessuno conosce l’ora del suo ritorno, nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. Nel mondo greco quest'aspetto però non dovette essere compreso. Si credette che il ritorno del Signore fosse anche cronologicamente imminente. Questa fu per esempio la convinzione dei tessalonicesi, i quali, credendo che il Signore dovesse tornare a momenti, conclusero che era inutile lavorare, incrociarono le braccia e si afflissero per quelli che morivano nel frattempo. Contro queste convinzioni lottò Paolo nelle due lettere ai Tessalonicesi. In questo contesto si situa il famoso detto di Paolo che chi non lavora non dovrebbe nemmeno mangiare. Ma l’equivoco dovette essere un fenomeno molto più ampio, a giudicare dall’insistenza evangelica sull’operosità dei servi (cfr Mt 24-25; Lc 12) (il servo che non trafficò il talento fu cacciato via) e a giudicare anche dalla sottolineatura della parabola delle 10 vergini che le vergini, dato che lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono (allusione alla morte umana!). Ma al cristiano non deve interessare quando cronologicamente il Signore torna. A lui deve interessare che egli può tornare da un momento all’altro e perciò deve stare sempre sveglio e operoso. Se dorme, può essere sorpreso da quella venuta come il padrone di casa dalla venuta di un ladro o come gli uomini, al tempo di Noè, che mangiavano e bevevano e furono sorpresi dal diluvio. Tuttavia il cristiano deve guardare a quel ritorno, perché esso illumina la sua esistenza; in esso troveranno compimento tutte le promesse di Dio, e in esso saranno soddisfatte tutte le sue attese. Possiamo dire che una componente della spiritualità evangelica, dopo quella della sequela di Gesù, è la spiritualità dell’attesa, caratterizzata da due dimensioni: la vigilanza e l’operosità. Il cristiano perciò è colui che in questo mondo veglia ed opera nell’attesa che il Signore torni. Paolo, in 1Ts 5,1-11, propone altre dimensioni: essere sobri e rivestirsi della corazza della fede e dell’agape, e dell’elmo della speranza della salvezza. In questo modo il cristiano è nella luce e non può essere sorpreso dal giorno del Signore che viene come un ladro nella notte. 3. Il precursore Dal momento che si attende una venuta del Signore, è necessaria ancora la figura del precursore. Il Messia la prima volta è venuto nell’umiltà della condizione umana e il suo compito fu quello di espiare, con il sacrificio di se stesso, il peccato. Ma egli dovrà tornare ancora nello splendore della sua gloria, e questa forse è la vera venuta messianica. In questo senso la fede cristiana coincide con l’attesa di Israele. La tradizione rabbinica si era chiesta perché anticamente Elia non era morto ma era stato rapito su un carro (cfr 2Re 2,1-18). I rabbini avevano risposto che Elia era stato 25 nascosto perché avrebbe dovuto in seguito ricomparire e preparare la venuta del Messia (cfr anche Mal 3,22). Oltre l’attesa del Messia, nacque così nel giudaismo anche l’attesa di Elia. A Giovanni infatti i farisei chiedono tra l’altro se lui non sia Elia (Gv 1,21). Gesù identificò esplicitamente Elia con Giovanni: “ e se volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire (Mt 11,14)”. A Zaccaria, padre di Giovanni, è annunziato poi dall’angelo che quel bambino precederà il Signore con la potenza di Elia per preparargli un popoli ben disposto (Lc 1,17). O È noto che l’antico schema evangelico iniziava la sua narrazione né dall’infanzia di Gesù né dalla sua vita nascosta, ma, come appare ancora dai vangeli di Marco e di Giovanni, dalla predicazione di Giovanni il Battista. Tutti i vangeli infatti, prescindendo dai vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca, presentano Giovanni che predica prima dell’ingresso di Gesù nella vita pubblica. Introducendo la figura di Giovanni, tutti i vangeli vogliono sottolineare che quel Gesù di cui si accingono a parlare è appunto il Messia. Nel ministero di Giovanni, quale è presentato almeno dai tre vangeli sinottici, possiamo cogliere tre aspetti fondamentali: l’esortazione a preparare la via del Signore mediante la conversione, la concreta amministrazione di un battesimo che mira solo a disporre i cuori ad ottenere la remissione dei peccati, l’annunzio della venuta di uno più forte che battezza in Spirito e fuoco. In questo modo Giovanni prepara la via al Signore: disponendogli i cuori mediante un serio cammino di conversione. I vangeli di Matteo e Marco narrano anche il martirio di Giovanni attuato da Erode ma progettato dalla perfidia di una donna. Con la sua passione e morte Giovanni preannunzia così un Messia caratterizzato dal mistero della passione, morte e resurrezione. Ma se leggiamo più attentamente i racconti evangelici della predicazione di Giovanni il Battista, costatiamo che, mentre introducono la prima venuta di Gesù, tacitamente alludono al ritorno escatologico del Signore. L’espressione infatti: “colui che viene dopo di me è più forte di me”, rapportata al linguaggio evangelico, richiama appunto la venuta escatologica di Gesù. La seguente menzione di un giudizio di divisione (Mt 3,12; Lc 3,9) conferma appunto tale prospettiva. La prospettiva escatologica poi è confermata ancora dal fatto che in alcuni aspetti la predicazione di Giovanni richiama la predicazione apostolica. Giovanni predica la conversione e pratica un battesimo; Pietro pure, in At 2,38, esorta a convertirsi e a lasciarsi battezzare nel nome di Gesù. Dal momento che i vangeli stessi sembrano conferire alla predicazione di Giovanni un aspetto escatologico, ci si può chiedere chi, in relazione alla venuta futura del Signore, sia il precursore. Dobbiamo dire che Giovanni, il figlio di Zaccaria ed Elisabetta, anche lui è uscito dalla scena storica; ma il suo ministero rimane ancora nella chiesa. 4. Il precursore nella chiesa In relazione alla seconda venuta di Gesù il precursore non può essere se non la Chiesa. Essa eredita la prerogativa di Giovanni: ad essa infatti è affidato il compito di predicare la conversione in vista della remissione dei peccati e ad essa è pure affidato il compito di andare in tutto il mondo, predicare il vangelo ad ogni creatura (Mt 28,19). La chiesa può essere identificata con quella voce che nel deserto grida: “preparate la via del Signore (Is 40,3)”. La chiesa però è composta di molti membri. Tutti perciò sono insieme oggetto e soggetto dell’annunzio: “preparate la via del Signore”. Tutti siamo oggetto in quanto tutti dobbiamo ricevere quell’annunzio e tutti siamo chiamati a preparare in noi la via del Signore. Tutti però siamo soggetto di quell’annunzio perché tutti, con il linguaggio proprio a ciascuno e con il compito specifico a ciascuno affidato, in superficie o nel 26 profondo del grande mistero della chiesa, abbiamo il compito di annunziare agli uomini la venuta del Signore e di indurli a preparargli la strada. La prerogativa del precursore, appunto perché appartiene alla chiesa nella sua globalità, costituisce il denominatore comune di tutti i cristiani, al di là di tutte le differenziazioni gerarchiche pur necessarie e volute da Gesù. In questo senso l’immagine più appropriata è quella della barca che attraversa il lago. La barca evangelica attraversa il lago del mondo e già il suo stesso passaggio è un annunzio e un invito a preparare la via del Signore. Purché la chiesa cammini e appaia protesa verso quel ritorno; altrimenti, se appare ferma e impelagata nelle faccende nel mondo, da esso finisce per non distinguersi più e gli uomini non sono più stimolati a preparare la via del Signore. Ogni operatore pastorale, a qualunque grado egli appartenga e qualunque sia il compito che svolge nella chiesa, può a ragione identificarsi con la figura e il ministero di Giovanni. Ma ogni operatore pastorale deve non dimenticare un aspetto fondamentale ed avere sempre presente. In parole povere questo aspetto può essere espresso nel seguente modo: non deve assolutamente costituire un diaframma tra gli uomini e il Signore. Questo aspetto, l’umiltà cioè propria del precursore, appare nei racconti evangelici, ma è evidenziato ancora di più dal vangelo di Giovanni. Giova qui riferire alcuni testi. In Gv 1,19 leggiamo la domanda dei sacerdoti e dei leviti inviati dai giudei: “tu chi sei?”. Narra l’evangelista: “confessò e non negò e confessò; non sono io il Cristo”. Il dialogo continua ancora fino al v 27; nel v 23 leggiamo l’autodefinizione di Giovanni: “voce di chi grida nel deserto...”. A riguardo è molto bello il commento di Agostino proposto dalla liturgia delle ore nella terza Domenica di Avvento. Scrive Agostino che, se Giovanni avesse risposto di sì, tutti gli avrebbero creduto perché già ritenevano che fosse lui il Cristo. Disse quello che non era e disse anche quello che era. Precisò le debite distanze; si riconobbe solo una lucerna e temette di essere spenta dal vento dell’orgoglio. In 3,26ss, ai suoi discepoli che volevano solleticare la sua gelosia in relazione a Gesù, Giovanni ricorda loro di avere detto già che non era lui il Cristo. Poi aggiunge le bellissime parole: “chi ha la sposa è sposo; l’amico dello Sposo, che sta ed ascolta, gioisce per la voce dello Sposo. Questa mia gioia è completa: egli deve crescere, io debbo diminuire”. Una accurata esegesi, non opportuna però in queste note, potrebbe mettere in luce tutta la profondità e le concrete implicanze pastorali e spirituali di queste parole di Giovanni. Infine in 5,35 Gesù esprime un altissimo elogio di Giovanni: “egli era una lucerna che arde e splende”. Pure qui una accurata esegesi, ancora non opportuna in queste note, potrebbe mettere in luce tutta la profondità di queste parole di Gesù. 5. La venuta anticipata nell’Eucaristia Abbiamo già avuto modo di osservare che l’Eucaristia, essendo completa memoria di Gesù e del suo mistero, fa memoria non solo della morte e resurrezione ma anche del suo futuro ritorno. E infatti essa è celebrata “nell’attesa della sua venuta (3a anafora)”. Nell’Eucaristia infatti Gesù si manifesta come il Messia. Non è casuale il fatto che Matteo e Marco includono la loro sezione evangelica ruotante attorno alle due moltiplicazioni dei pani tra il racconto del martirio di Giovanni e la professione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo che Gesù è il Cristo. In questo senso la dimensione di precursore dell’operatore pastorale riceve una prospettiva ravvicinata. Lui stesso deve preparare la strada al Signore che viene nel Pane e tutta la sua opera pastorale mira ad orientare verso il Pane dove avviene l’incontro con Gesù Messia, nell’attesa, appunto, della sua venuta nella gloria. Possiamo dire che ogni 27 opera pastorale traduce concretamente l’antica invocazione: “maranathà: vieni, Signore Gesù” (Ap 22,21). 28 VI “tutti erano intenti, unanimi, alla preghiera, con delle donne, con Maria la madre di Gesù e i suoi (di Gesù) fratelli (At 1,14)” La dimensione comunitaria dell’operatore pastorale; la preghiera come elemento di coesione; la riscoperta della presenza di Maria nella chiesa. 1. L’icona di At 1,14 Parliamo di icona perché la bellissima ed efficacissima descrizione di At 1,14 è da ritenersi più un’icona da contemplare che non una descrizione da commentare. Tuttavia è utile un commento che aiuti a cogliere il suo significato. Notiamo anzitutto la sua posizione nel libro degli Atti degli Apostoli. I vv 9-11 del c. 1 contengono la descrizione dell’ascensione di Gesù. Poi i vv 12-13 descrivono il ritorno dei discepoli dal monte degli ulivi (v 12) e il raduno nel cenacolo, specificamente dove avevano dimora gli undici con Pietro (v 13), infine la descrizione del v 14 che abbiamo definito come una icona. Poi, nei vv 15-26, in tutto il resto del c. 1 cioè, Pietro pone il problema della ricostituzione del numero dodici degli apostoli, rimasti in undici in seguito alla defezione di Giuda: l’elezione di Mattia riporta a quel numero il collegio apostolico. Tra l’evento dell’ascensione e l’evento della discesa dello Spirito Santo si verificano così degli avvenimenti che si riconducono al denominatore comune dell’unità. I vv 12-14 descrivono, in maniera più ampia, la costituzione stessa ecclesiale; i vv 15-26 invece descrivono, in prospettiva più ristretta, la reintegrazione del collegio apostolico. Prescindiamo dalla descrizione dei vv 15-26 e fermiamo la nostra attenzione sui vv. 12-14. Possiamo scorgere in questa descrizione tre elementi. Il primo elemento, nel v. 12, è il ritorno dei discepoli a Gerusalemme dal monte degli ulivi dove avevano assistito all’ascensione di Gesù. Precisa Luca che la distanza dal monte degli ulivi a Gerusalemme era breve, quanto il cammino che è permesso coprire in giorno di Sabato. Il secondo elemento, nel v. 13, è costituito da un duplice dinamismo: verso il cenacolo e verso gli apostoli. Il terzo elemento, nel v 14, descrive la situazione e l’attività di una comunità già radunata. Il v 12 stabilisce un legame tra l’ascensione e Gerusalemme. I discepoli tornano in città perché il Signore aveva comandato loro di non allontanarsi da essa, ma di attendervi la promessa dello Spirito Santo. Il v 13 presenta però delle difficoltà. Alla lettera il testo greco dovrebbe essere tradotto nel seguente modo: “quando entrarono (dove?), nella parte superiore (della casa) salirono dove erano dimoranti Pietro [...]”. Emergono delle domande destinate forse a restare senza risposta: dove entrarono? Qual è l’edificio nella cui parte superiore gli apostoli dimoravano? È lo stesso dove Gesù celebrò la cena? Gli Apostoli erano già lì oppure entrarono anche loro? La versione latina risolve in parte il problema parlando di “cenacolo”, ma tale precisazione non si legge nel testo greco; rimangono perciò tutte le domande che abbiamo sopra elencato. È opportuno perciò prescindere da tutti questi problemi e fermarci al senso globale della descrizione. Il testo suggerisce un dinamismo di unità attorno agli Apostoli che Luca elenca singolarmente. Si direbbe che, dopo la partenza del Signore Gesù, essi, primo tra i quali Pietro, sono diventati il centro attorno a cui la comunità deve radunarsi. Nel v 14 abbiamo una descrizione statica di unità ecclesiale. Leggiamo nel testo: “tutti costoro erano perseveranti”. Chi sono i “tutti costoro”? Probabilmente gli apostoli 29 elencati appena prima. Subito dopo però Luca ci offre un’altra lista, costituita da: donne, la Madre di Gesù, i suoi fratelli. La descrizione lucana pone anche nel v 14 non pochi problemi esegetici che adesso evitiamo di elencare, anche perché anch'essi appaiono di difficile soluzione. Ci limitiamo ad evidenziare soltanto il senso globale. Troviamo due blocchi messi insieme, da una parte gli apostoli, dall’altra le donne, la madre e i fratelli. Prescindendo da più specifiche identificazioni, possiamo dire che tutto il brano globalmente ci offre una descrizione di unità ecclesiale. Questa unità, come appare dal comando di Gesù in 1, 4 di attendere il dono dello Spirito, e come apparirà anche dalla seguente descrizione della pentecoste, è finalizzata appunto alla recezione del dono dello Spirito Santo. Questa sembra essere allora l’intenzione lucana: descrivere la formazione della comunità ecclesiale prima di descrivere l’evento della discesa dello Spirito Santo. Emerge però una domanda; cosa precede: la costituzione dell’unità ecclesiale o il dono dello Spirito Santo? È l’unità ecclesiale già formata che riceve il dono dello Spirito Santo oppure è lo Spirito Santo che forma l’unità ecclesiale? Alla luce di tutto il NT entrambi gli aspetti sono veri. Il vangelo di Giovanni, nella narrazione degli eventi al Calvario (19,17-37), dove descrive la formazione della Chiesa attorno al crocifisso, presuppone entrambi gli aspetti: da una parte è lo Spirito Santo che raduna la chiesa attorno a Gesù, dall’altra sulla chiesa radunata Gesù effonde lo Spirito. Ma Luca stesso presenta la comunità cristiana come il frutto della presenza e l’opera dello Spirito. Nel c. 2 infatti, descritto l’evento della pentecoste (vv 1-13), descritto pure l’annunzio di Pietro (vv 14-36) e le prime conversioni con il conseguente battesimo (vv 37-41), egli passa a descrivere nei vv 42-47 la prima comunità cristiana: questa non può essere se non l’opera dello Spirito. Nel brano che consideriamo di 1,14 Luca invece sembra preferire il primo aspetto: sulla comunità ecclesiale già radunata è effuso lo Spirito Santo. Forse egli preferisce qui questo primo aspetto per evidenziare maggiormente l’aspetto della missione: la prima comunità cristiana attende di essere fortificata dallo Spirito Santo per mettersi poi in cammino per il mondo ed annunziare a tutti gli uomini che solo Gesù è il Salvatore. Possiamo fare nostre entrambe le prospettive, valide cioè per la chiesa di oggi: lo Spirito Santo raduna la chiesa, ci raduna, attorno a Gesù, ma nello stesso tempo egli la guida e ci guida nella missione di annunziare e testimoniare il Signore Gesù. 2. L’unità ecclesiale L’icona di unità ecclesiale offertaci da Luca in At 1,14 suggerirebbe di allargare la riflessione a tutto il resto del NT, dove, pur con diversi linguaggi e con diverse immagini questo tema torna quasi in tutti i libri. Il carattere ristretto di questo intervento induce però a limitare e ad evidenziare solo qualche aspetto dedotto soprattutto dal vangelo di Giovanni e dalle lettere di Paolo. Nel vangelo di Giovanni il tema dell’unità ecclesiale è al centro della riflessione di questo evangelista. Di essa egli parla con le immagini della tunica, che i soldati non stracciarono (19,23-24), o della rete che, nonostante la moltitudine di pesci, non si ruppe (21,11). Il centro dell’unità ecclesiale è il crocifisso che Dio ha innalzato in contrapposizione all’antica torre di Babele (12,31). Anticamente gli uomini eressero una torre, come centro di unità, appunto per restare uniti, essa però diventò per loro fonte di ulteriore disgregazione; adesso Dio stesso innalza un nuovo centro di unità che realizza pienamente lo scopo. L’unità è realizzata attraverso la via dell’amore. Attraverso la manifestazione del suo amore, Gesù coinvolge gli uomini, mediante l’amore vicendevole, nel suo stesso 30 amore. E così radicati in lui e nel suo amore, uomini, Gesù e il Padre formano una cosa sola. Questa unità deve indurre il mondo a credere che il Padre ha mandato Gesù (17,21). Il mondo fa di tutto per rompere questa unità; per questo Gesù prega il Padre di difendere i discepoli dal maligno. A riguardo di Paolo è sufficiente poi citare il c. 12 della prima lettera ai Corinzi, dove, riprendendo un antico apologo, Paolo sottolinea l’unità del corpo. Ma come nel corpo ci sono diverse membra, così nel corpo della chiesa ci sono diversi doni e diversi carismi. I vari doni e i vari carismi sono però elementi di differenziazione, non di divisione: essi servono a differenziare i vari membri, non a dividerli. Questi doni infatti provengono dallo Spirito, che è principio e fonte di unità, e sono orientati primariamente al bene di tutto il corpo. Dallo stesso Spirito infatti essi sono condotti all’unità del corpo. Nel capitolo seguente, il e 13, Paolo però indica il dono superiore a tutti gli altri. Quello che, al di là delle varie differenziazioni, realmente riconduce tutto e tutti ad unità. Si tratta della carità, quella che parte da Dio, che raggiunge gli uomini, che poi gli uomini si trasmettono reciprocamente e che induce a vivere in un certo modo. 3. La preghiera L’attività fondamentale della comunità ecclesiale descritta da Luca in At 1,14 è chiaramente la preghiera. In tale attività, precisa Luca, erano tutti di un solo sentimento. È errato pensare che nella comunità primitiva siano mancate le tensioni e i contrasti. Luca magari accenna ad esse con estrema delicatezza, ma non furono assenti. Il contrasto più forte probabilmente si ebbe al momento in cui la comunità primitiva prese coscienza che Dio chiamava alla salvezza anche i pagani, ai quali perciò non bisognava imporre la legge mosaica. Pietro stesso fu contestato dalla comunità quando andò in casa del centurione pagano Cornelio (At 10), anche se poi la sua spiegazione e soprattutto il rimando alla decisione di Dio, riuscirono a placare gli animi. Tuttavia non si può negare che la preghiera sia stata al centro della chiesa primitiva. Pietro e Giovanni solevano salire al tempio all’ora della preghiera (At 3,1). Più avanti, in 2,41 ss dei primi cristiani Luca dirà che erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere. In preghiera si mette la comunità dopo l’esperienza delle prime persecuzioni (4,23ss). E ovvio perciò che sia questa l’attività fondamentale, e anche l’unica secondo il testo di At 1,14 che descrive la comunità in attesa dello Spirito Santo. Il testo però non dice in che cosa consisteva quella preghiera; esso si limita soltanto a dire che nella preghiera tutti gli animi erano concordi. Ciò indica che nella comunità ecclesiale proprio la preghiera è l’elemento unificante tra membri del tutto diversi. Né può essere diversamente. Pregare infatti è riferirsi a Dio in Cristo e, attraverso la preghiera, Dio stesso diventa elemento di unità, di coesione e di sintonia di animi, al di là delle tante differenze e anche divisioni che, per diversi motivi, possono verifìcarsi tra i membri della Chiesa. Dicevamo che Luca non specifica in che cosa concretamente consista questa preghiera. Evidentemente a lui interessa non il modo come si prega ma il fatto di pregare. Si esprime così una fondamentale dimensione della comunità ecclesiale. Si direbbe che essa è tale appunto quando si mette in preghiera. Anzi possiamo dire che proprio la preghiera è il suo atteggiamento abituale. La preghiera stabilisce una profonda ed intima relazione con Dio. Pregando, la comunità primitiva dichiara la sua origine da Dio, la sua dipendenza da lui e il suo profondo orientamento a lui. Pregando, la comunità primitiva imita Gesù che espresse appunto nella preghiera la sua profonda relazione al Padre. Ma pregare significa soprattutto ricercare e aderire soprattutto alla volontà, appunto come fece Gesù nel 31 momento tragico al Getsemani prima della passione. Nella preghiera della comunità primitiva, menzionata da Luca in At 1,14, possiamo scorgere ancora altri aspetti. Anzitutto la stima del dono che si attende: esso è grande e la sua attesa porta ad intensificare la propria relazione a Dio. Inoltre l’anelito verso di esso: si direbbe che, pregando, la comunità quasi affretti la sua manifestazione. Infine la disponibilità ad accogliere il dono: pregando, la comunità dispone appunto se stessa in maniera ottimale a riceverlo. 4. Con Maria la Madre di Gesù Ad essere lì presente non è soltanto Maria. Con lei ci sono anche delle donne e i fratelli di Gesù. Menzionata però al centro, si direbbe che Maria presieda questa comunità che si unisce attorno alla comunità apostolica. Gli apostoli sono così al centro di due relazioni. A Dio anzitutto, al quale, come abbiamo già indicato, si relazionano nella preghiera; alla comunità che ad essi si unisce e con essi condivide questa relazione a Dio. Accenniamo pure ad un duplice problema che emerge dal testo stesso, evitando però di offrire delle risposte definitive: perché Luca menziona le donne senza ulteriore specificazione sulla loro identità e sulla loro funzione? Chi sono inoltre i fratelli del Signore: sono parenti secondo una discendenza fisica, di cui talora parlano anche i vangeli, oppure sono coloro che hanno stabilito un’intima relazione con Gesù, fondata sull’ascolto della parola (Lc 8, 21) o sull’adesione alla volontà di Dio (M 12, 50; Me 3, 5)? Abbiamo detto però all’inizio che il testo di At 1, 14 è come un’icona e si presta perciò a diverse letture. Specificamente per quanto concerne le donne qui menzionate esse possono richiamare quelle donne che seguivano Gesù nel suo cammino e lo accompagnarono fino alla sepoltura. In questo modo si stabilisce un ulteriore legame tra Gesù e la comunità primitiva: quelle donne che accompagnarono Gesù nella sua vita terrena, adesso accompagnano la comunità apostolica. Per quanto riguarda poi i fratelli di Gesù, si può certo pensare a quelli che avevano con lui legami di sangue, ma si può anche meglio pensare a coloro che hanno stabilito con lui una parentela spirituale, fondata, come abbiamo sopra notato, sull’adesione alla volontà di Dio e sull’ascolto della sua parola. In ogni caso donne e fratelli di Gesù indicano le due componenti in cui si articola l’unità ecclesiale. Esse possono richiamare anzitutto le due componenti umane, femminile e maschile, che ora raggiungono nella chiesa quell'unità da Dio voluta fin dalla creazione; ma che il peccato aveva disturbato. Inoltre nella menzione delle donne e dei fratelli di Gesù possiamo scorgere le due dimensioni della chiesa. Le donne, come appare meglio nel vangelo di Giovanni, richiamano la dimensione sponsale, mentre i fratelli di Gesù richiamano meglio quella dei discepoli. Al di sopra di tutti però, come immagine unificante ed elemento di sintesi, emerge la Madre. Ella è madre di Gesù e perciò, attraverso di lei, si stabilisce un legame con Gesù. Quasi a dire che l’unica chiesa, simboleggiata e riassunta dalla Madre, è profondamente relazionata a Gesù. 5. Maria la madre di Gesù Fermando poi la nostra attenzione sulla specifica figura della Madre, osserviamo anzitutto che di Lei non si dice null’altro. Non è indicata alcuna sua funzione concreta e Luca non la menzionerà mai più in tutta la sua opera. Tuttavia l’assenza di altre funzioni orienta l’attenzione su quella che appare la sua funzione prima e fondamentale. Possiamo dire che la sua funzione è quella di essere una 32 “presenza relazionante e rivelante”. È una presenza, in quanto è lì, menzionata al centro, in posizione privilegiata. Essa è lì nella comunità ecclesiale, come presenza vigile e discreta. La sua funzione è quella di essere presente come madre, pronta a sostenere, a confortare, a dare fiducia. Il fatto che Luca non la menzioni più, suggerisce che questa icona è come una luce che illumina tutta l’attività apostolica, descritta nel libro degli Atti. Dalla sua posizione privilegiata e, in certo senso, immobile, essa accompagna con il suo sguardo materno gli apostoli nel loro vagare per il mondo portando il vangelo. È presenza relazionante perché è la Madre di Gesù, e perciò orienta continuamente a lui. Si direbbe che la sua funzione materna sia appunto quella di additare continuamente Gesù alla chiesa, specialmente quando questa, dovendo percorrere le vie del mondo, può rischiare di restare impelagata nelle vicende umane. Infine è presenza rivelante perché mediante la sua stessa persona deve manifestare alla chiesa la sua intima realtà e natura. Maria è la madre di Gesù, ma anche la chiesa è la madre dei figli di Dio. Si direbbe che in tutta la seguente attività apostolica si attua la funzione della chiesa di generare i figli di Dio. I vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca sottolineano il mistero di Maria, quello soprattutto della vergine che diventa Madre per opera dello Spirito Santo. Pure la chiesa è la vergine che per opera dello Spirito Santo diventa Madre. A riguardo si può scorgere una certa analogia tra l’annunciazione e la nostra descrizione (entrambe di Luca): su Maria scende lo Spirito Santo e diventa madre, sulla comunità ecclesiale scende lo Spirito Santo ed acquista pure una funzione materna generante. La teologia posteriore evidenzierà altri due aspetti di Maria, solo adombrati nelle Scritture ma non per questo meno veri: la concezione di Maria senza peccato e la sua assunzione in ciclo. Entrambi gli aspetti appartengono alla chiesa. Nata dal costato di Gesù (Gv 19,34), pure la chiesa è santa e immacolata (Ef 5,25-26), anche se ancora bisognosa di continua purificazione. Inoltre la sua destinazione è il cielo, presso il Padre dove Gesù, ascendendo, è andato a prepararle un posto (Gv 14,1 ss). 33 VII “giudicate se è più giusto ascoltare voi che ascoltare Dio. Noi non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito (At 4,20)” Il coraggio apostolico in forza di una irreprimibile esperienza: parlare anche dove la parola di Dio non è accolta. “giudicate se è più giusto ascoltare voi che ascoltare Dio. Noi non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito (At 4,20)”. Questa è la disarmante risposta di Pietro al Sinedrio che aveva comandato a lui e a Giovanni di non parlare più nel nome di Gesù. 1. Il contesto Questo comando del Sinedrio appare come un tentativo estremo di frenare gli Apostoli nella loro attività di annunzio; nemmeno il carcere infatti era servito ad intimorirli. L’annunzio della resurrezione di Gesù per i giudei era scomodo, tanto più che Pietro, almeno in parte, aveva fatto già ricadere su di loro la responsabilità della morte di Gesù. D’altra parte i sinedriti non potevano negare il miracolo, ben evidente, della guarigione dello storpio operata da Pietro. Dopo essersi perciò consultati, addivennero alla decisione di imporre il silenzio agli apostoli. Nemmeno tale imposizione però sortì il suo effetto. Gli Apostoli continuarono ancora a parlare, tornarono ancora in carcere da cui però furono miracolosamente liberati, ricevettero una nuova imposizione rafforzata stavolta dalla flagellazione (5,40), ma essi accettarono tutto ciò con gioia, lieti di essere stati ritenuti degni di patire oltraggi per il nome di Gesù (At 5,41). Il coraggio disarmato degli apostoli vince qualsiasi minaccia e coartazione del Sinedrio. La persecuzione però continuerà; di essa acceso sostenitore sarà un certo Saulo, che però anche lui sarà vinto e trasformato in ardente apostolo. Dietro il coraggio apostolico si nasconde la potenza del Signore risorto. 2. L 'imperativo categorico Ma consideriamo più attentamente le parole di Pietro nei loro singoli elementi. Anzitutto Pietro dichiara “non possiamo [...] non parlare”. La formulazione letteraria dell’espressione, con due negazioni, è molto più forte e più obbligante di una eventuale frase corrispondente positiva del tipo: “dobbiamo [...] parlare”. Si esprime così non un dovere o una necessità che scaturisce da circostanze esterne, ma una intrinseca impossibilità che scaturisce da una concreta situazione. In queste parole Pietro riecheggia il profeta Amos, il quale in 3,8 dichiara: “ il leone ruggisce, chi non lo teme? Dio il Signore parla, chi non profetizza?”. Pure il profeta Amos è colto da intrinseca impossibilità; si tratta dell’impossibilità di non profetare e il motivo è che il Signore ha parlato. Benché con diverse parole, si può citare anche l’esperienza analoga di Geremia, il quale, in un momento di profonda amarezza, decise di non profetare più: “avevo detto: non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome” (Ger 20,8). Ma il profeta non può mandare in atto questa sua decisione, perché se tace, “allora mi accadeva come se nel mio cuore bruciasse un fuoco, chiuso nelle mie ossa (Ger 20,9)”. Il profeta è obbligato a parlare per il fatto che la parola di Dio è in lui, e, se tace, questa gli brucia nel suo intimo. La stessa cosa accade a Pietro e a Giovanni. Essi hanno ricevuto dal Sinedrio l’ordine di non parlare più nel nome di Gesù (4,17): anche a volerlo eseguire, per loro accogliere tale ordine è impossibile. 34 Sorprendono i due apostoli nella loro coraggiosa dichiarazione. Sorprendono specialmente se confrontiamo questa dichiarazione con quello che di loro ci tramandano le narrazioni evangeliche soprattutto quelle del Getsemani. Giovanni e Pietro erano dei tre ai quali Gesù aveva rimproverato di non avere potuto vegliare nemmeno un’ora con lui, e pure Giovanni era fuggito al momento della cattura. Pietro poi, che davanti a Gesù aveva preteso di non scandalizzarsi, peccando così di presunzione, aveva poi miseramente rinnegato davanti a dei servi. Da quel momento ad ora però si sono verificati nel frattempo due eventi che rendono quei fatti ormai molto lontani e dimenticabili: l’esperienza del Signore risorto e l’effusione dello Spirito Santo. Durante la passione Gesù non era ancora “il Risorto” e Pietro non era stato ancora raggiunto da una Potenza proveniente dall’alto. 3. Ciò che abbiamo visto e udito Quello di cui Pietro e Giovanni non possono non parlare è “Ciò che abbiamo visto e udito”. Il testo non precisa che cos'è ciò che gli apostoli hanno visto e udito. In 10,41, in casa del centurione Cornelio, Pietro caratterizzerà l’esperienza come un “avere mangiato e bevuto con Gesù”. In 1Pt 5,1 Pietro si presenterà come testimone dei patimenti di Gesù. In 1Gv 1,1 ss l’autore introduce il suo scritto con una frase solennissima con cui sottolinea la sua concreta e tangibile esperienza della “Parola della vita”: “ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, ciò che contemplammo e le nostre mani palparono della Parola della vita”. L’autore probabilmente si riferisce, contro qualsiasi forma di docetismo, alla dimensione terrena e concreta assunta dalla Parola della vita e, pertanto, tangibile e palpabile. Nel nostro testo di At 4, 20 l’espressione è molto ampia e, nel suo contenuto, non ammette limiti. Essa pertanto può essere riferita al fatto concreto della guarigione dello storpio, operata da Pietro ma nel nome del Signore Gesù, ma può essere riferita anche a tutta l’esperienza di Gesù, dalla sua esistenza terrena alla sua realtà di Signore risorto. In entrambe le dimensioni Gesù è ben reale e concreto e la verità di Dio in nessun modo può essere coartata da un comando di uomini. Quel Gesù, nella cui potenza Pietro ha operato il miracolo, è vissuto concretamente, i giudei lo hanno ucciso ma Dio lo ha resuscitato (At 4,10). Questi fatti sono sotto gli occhi degli apostoli e anche sotto gli occhi di tutti; ogni proibizione perciò di parlare nel nome di Gesù si rivela assurda. Il problema però non è soltanto l’esperienza esterna, ma l’esperienza profonda interiore. Gli eventi di Gesù non sono stati costatati soltanto all’esterno ma sono penetrati nell’intimo degli Apostoli ed essi si sentono profondamente coinvolti nel mistero di Gesù. Il Risorto si è manifestato non solo all’esterno ma si è impresso nel profondo del cuore. Se è possibile così falsare e nascondere i fatti esterni, è impossibile reprimere ciò che vive nel profondo del cuore. Sia i giudei come gli apostoli hanno potuto costatare in maniera esterna il miracolo operato da Pietro con la potenza del Risorto. Qui però sta la differenza tra i giudei e gli apostoli: i primi hanno avuto soltanto un’esperienza esterna, gli apostoli invece portano impresso il Risorto nel loro cuore. I primi possono reprimere la verità, i secondi invece no. Per mostrare l’assurdità del comando Pietro non usa molti ragionamenti. Si appella allo stesso buon senso di quelli che vogliono proibire. Pietro pone i suoi giudici davanti ad un preciso dilemma: cosa è giusto, obbedire a Dio o a loro? Loro comandano di non parlare, Dio invece comanda di parlare. La risposta dovrebbe essere ovvia: dal momento che bisogna obbedire a Dio, non si può obbedire agli uomini. Bisogna allora necessariamente parlare nel nome del Signore Gesù. 35 4. Il coraggio apostolico II coraggio apostolico nell’annunzio di Gesù e della sua parola appare anche in altri avvenimenti. In questo senso si può anche citare la visita di Pietro in casa del centurione Cornelio. Stavolta Pietro non sfida più la persecuzione del Sinedrio, bensì l’ostilità della stessa comunità primitiva. Il fatto è diverso, ma il principio che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini è identico. Conosciamo l’episodio narrato nel e 10 del libro degli Atti. A Pietro, ligio alla legge giudaica, Dio fa capire, mediante la triplice visione del lenzuolo, che egli ha chiamato alla salvezza anche i popoli pagani e perciò egli non può ritenere impuri i pagani che Dio, con la sua scelta, ha santificato. Il senso della visione è chiarito a Pietro quando, da lì a poco, vengono a bussare alla sua porta gli inviati del centurione Cornelio che gli chiedono di andare con loro e di annunziare anche a loro il vangelo. La legge proibiva ad un giudeo di andare in casa di un pagano. Ma la visione ha vinto la ritrosia di Pietro e questi va in casa del centurione Cornelio. Benché con molta finezza, Luca non manca di sottolineare la reazione della comunità primitiva, costituita prevalentemente da giudeo cristiani, ai quali non era ancora chiara la linea di demarcazione tra la legge e il vangelo. Nel c. 11 leggiamo il resoconto di Pietro alla comunità. Messo alle strette, quasi nel tono di chi si vuole scusare, in 11,17 Pietro conclude indicando il vero motivo della sua azione: “Se Dio ha dato a loro (i pagani) la stessa grazia che a noi, chi ero io che potevo impedire a Dio?”. Emerge ancora, ma in diversa maniera, il dilemma posto davanti al Sinedrio. Mentre però davanti al Sinedrio esso era: obbedire a Dio o agli uomini, adesso, davanti alla comunità il dilemma è obbedire a Dio o alla legge. La risposta è ancora scontata: Dio infatti, mediante l’episodio di Cornelio, ha significato di volere concedere la stessa salvezza anche ai pagani. Come prova del coraggio apostolico, possiamo infine citare At 17,16-34. Si tratta del discorso di Paolo all’areopago di Atene. Paolo conosce molto bene il mondo greco, specificamente quello ateniese. Egli sa che gli ateniesi sono aperti a qualsiasi conoscenza e dottrina, ma sa bene anche che il contesto filosofico ateniese, neoplatonico, difficilmente avrebbe accettato il messaggio della Resurrezione. Per questo motivo egli lo introduce solo alla fine, quasi di soppiatto, dopo avere tentato di accattivarsi la simpatia degli ateniesi proponendo prima delle prospettive più consone alla loro mentalità (cfr 17,34). Conosciamo l’esito di quel discorso: alcuni deridevano Paolo, altri gli dissero: “ti sentiremo di ciò ancora”. Certo Paolo avrebbe fatto breccia tra gli ateniesi se avesse taciuto la Resurrezione. Ma ancora una volta la Resurrezione è un evento assolutamente certo e insopprimibile e deve essere annunziato anche lì dove si sa che esso non è accolto. Tuttavia non tutti rifiutarono. Alcuni aderirono al messaggio di Paolo e credettero. Luca cita anzi due nomi precisi: Dionigi, membro dell’areopago e una donna di nome Damaris. Il coraggio apostolico però è premiato. La predicazione di Paolo non è stata inutile: anche nella terra restia degli ateniesi neoplatonici il germe del vangelo ha trovato dove attecchire Al contrario nel vangelo di Giovanni si sottolinea talora la totale assenza di coraggio a professare Gesù. Questo è il caso dei genitori del cieco venuto alla luce, i quali dichiararono la loro totale ignoranza a riguardo degli avvenimenti del figlio perché temevano i giudei (cfr. 9, 22). Questi infatti avevano stabilito di estromettere dalla sinagoga chiunque avesse confessato Gesù come il Cristo. 36 In Gv 12, 42 l’evangelista ci informa che, invero, molti dei capi credettero in Gesù, ma non confessavano a motivo dei farisei, per non essere cacciati dalla sinagoga. Con molta amarezza l’evangelista conclude che amarono la gloria degli uomini piuttosto che la gloria di Dio. I testi giovannei evidenziano con molta drammaticità la situazione contraria a quella degli Apostoli negli Atti. Gli apostoli ritengono di dovere obbedire a Dio e non agli uomini; quei capi di cui parla Giovanni, preferirono obbedire agli uomini piuttosto che a Dio e non confessavano Gesù. 37 VIII “Quelli (gli apostoli) se ne andavano gioiosi dal Sinedrio, poiché furono ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù (At 5,41)”. La solidarietà dell’operatore pastorale con la passione di Gesù. Nella conversazione precedente abbiamo commentato il testo di At 4,20. Nella narrazione seguente Luca ci informa che i giudei, dopo avere ancora minacciato gli Apostoli, li rimandarono liberi, sia perché non trovavano un motivo per cui punirli, sia anche perché temevano il popolo. 1. Gli eventi seguenti Le ostilità contro gli apostoli però non finirono. Tornati Pietro e Giovanni nella comunità e avendo essi narrato quanto era accaduto, tutti si misero in preghiera, implorando da Dio la coraggiosa libertà (parrēsía) di annunziare la sua parola (4, 21-31). Dopo avere narrato momenti significativi della crescita della chiesa, in 5,17ss Luca parla ancora di una nuova ondata di ostilità da parte dei giudei contro gli Apostoli. Questi furono messi in carcere (v 18), ma nottetempo furono miracolosamente liberati da un angelo (v 19) e ripresero ad insegnare nel tempio (v 21 ). Furono di nuovo catturati, benché senza violenza. Dovettero comparire ancora davanti al Sinedrio. Interrogati perché, nonostante il divieto, avessero continuato a parlare nel nome di Gesù, Pietro ribadisce quanto più o meno aveva dichiarato in 4,20: “bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”; anzi ne approfitta per riproporre un breve ma densissimo annunzio di Gesù. Solo l’intervento di Gamaliele salva Pietro e Giovanni dalla morte. Il sinedrio accettò la proposta di Gamaliele; rimandò liberi gli apostoli, non senza però averli fatti prima flagellare e avere ribadito a loro il divieto di parlare nel nome di Gesù (5,40). Qui si inserisce la breve ma commovente e grandiosa narrazione lucana del v. 41 che abbiamo riferito nel titolo. Con questa breve narrazione Luca vuol dire in pratica che, davanti al Sinedrio, gli apostoli hanno saputo tenere alta la loro fronte e sono stati essi a vincere. Sono stati maltrattati ma non sono stati piegati. Nel v 42 infatti egli descrive una intensa attività apostolica: essi ogni giorno nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di evangelizzare a riguardo di Gesù. 2. Gioirono perché furono ritenuti degni Indubbiamente né il carcere, né la flagellazione, né il processo, né le minacce, né il pericolo di morte, cose tutte che gli Apostoli sperimentarono, possono essere in se stesse motivo di gioia. Lo sono invece perché tutte queste cose, prima degli apostoli, le ha sperimentate Gesù; quel Gesù appunto che essi predicano. Subendo quelle ostilità, gli apostoli si sentono così ravvicinati a lui. L’espressione “furono ritenuti degni” rivela l’altezza vertiginosa a cui sono giunti gli apostoli. Le tribolazioni infatti possono costituire il terreno fertile dove attecchisce il germe della tentazione a desistere. Forse gli apostoli avranno sentito questo suggerimento satanico, ma di ciò Luca non dice nulla. Se pur lo hanno sentito, lo hanno superato e sono andati incontro alle tribolazioni sapendo di essere in questo modo assimilati a Gesù. L’espressione “essere ritenuti degni” rivela che le tribolazioni, assimilando a Gesù, costituiscono quasi un titolo onorifico che è conferito ad una persona degna di esso. Subendo le tribolazioni, gli apostoli si sentono perciò onorati perché con esse sono posti 38 sullo stesso piano di Gesù. Tale onore è per loro motivo di gioia, come la gioia del servo che è elevato all’altezza del suo Signore. Siamo ormai sideralmente lontani dalla paura e dalla viltà del Getsemani. 3. Le tribolazioni Delle tribolazioni del cristiano parlano moltissimi testi del NT. Anche Gesù le aveva predette. Aveva preannunziato ai discepoli quello che poi in realtà sarebbe accaduto. Sarebbero stati condotti infatti nei tribunali, sarebbero stati flagellati, sarebbero stati consegnati ai pagani (Mt 10,17ss; Lc 21,12ss). In queste predizioni troviamo gli stessi elementi riferiti a Gesù nella narrazione della passione. Ciò significa che i discepoli, sperimentando quelle tribolazioni, sono assimilati a Gesù e la loro passione è quella di Gesù. Questo è anche uno dei motivi che indusse la chiesa primitiva a redigere la narrazione della passione di Gesù. Con essa si voleva certo mostrare che tutto quello che era avvenuto per Gesù era stato previsto dalle Scritture e tutto si era verificato in conformità ad esse. Ma si voleva anche mostrare con molto realismo che il Gesù nel quale si credeva era certo il Gesù della Resurrezione, ma era anche il Gesù della passione. Accettare Cristo perciò significava battere la sua stessa strada, ma nella certezza che quella era l’unica strada che conduceva alla gloria. 4. La gioia dell’apostolo II testo di At 5,41 non è il solo nel NT a parlare della gioia nelle tribolazioni. A riguardo i testi si potrebbero moltiplicare: ne citiamo solo qualcuno più significativo. Il testo classico è quello di 1Pt 4, 13, dove l’autore scrive: “per il fatto che partecipate alle passioni di Cristo, gioite, perché possiate gioire anche nella manifestazione della sua gloria”. Scritta in tempo di persecuzione, la prima lettera di Pietro esorta a considerare le tribolazioni alla luce di Cristo. In questo modo esse appaiono non più motivo di tristezza ma di gioia: costituiscono infatti una realtà che accomuna a Cristo e perciò danno anche il diritto di condividere la sua gloria. Troviamo la stessa prospettiva del nostro testo di At 5,41; il testo della prima lettera di Pietro aggiunge in più la prospettiva della gloria. Nel c. 11 della seconda lettera ai Corinzi (vv 23ss) Paolo offre una lunghissima lista delle tribolazioni da lui sostenute nel corso del suo ministero. Conclude poi l’apostolo in 12, 10 che egli si compiace nelle infermità, nelle necessità, nelle persecuzioni sostenute per Cristo, aggiungendo che quando egli è debole è allora che è forte. Nella lettera ai Romani (Rm 5, 3ss) l’apostolo torna ancora su quest'aspetto. Dopo avere dichiarato che “noi”, lui con gli altri cristiani, ci gloriamo nella speranza della gloria dei figli di Dio, propone la strada che permette di pervenire a questa speranza. La strada è indicata nei versi seguenti. Continua infatti Paolo nel v 3: “non solo, ma ci gloriamo anche nelle tribolazioni”. Il punto di partenza perciò sono le tribolazioni che costituiscono motivo di vanto, non certo in se stesse, ma perché sono il punto di partenza di un cammino che conduce alla speranza della gloria dei figli di Dio. Tale speranza è il vero motivo del vanto. Il cammino che parte dalla tribolazione e culmina nella speranza passa attraverso la costanza e la virtù provata. La tribolazione infatti, in base al modo come la si accetta, può determinare due atteggiamenti opposti, o la defezione o la costanza. Paolo non considera il caso della defezione, che non costituisce una tappa ma un drammatico termine di cammino; considera invece il caso di chi nella tribolazione resta saldo: questi matura la virtù della costanza. Chi poi rimane saldo e non viene meno ottiene una virtù provata, la quale poi, a sua volta, sfocia, nella speranza. 39 Paolo così ha delineato tutto il cammino che dalla tribolazione conduce alla speranza. Si direbbe che la speranza, il cui oggetto è la gloria dei figli di Dio, di cui realmente ci si deve gloriare, in ultima analisi si radica nella tribolazione. Questa allora può essere motivo di vanto perché il suo frutto è appunto la speranza. L’oggetto della speranza, come dicevamo, è la gloria dei figli di Dio. Ma emerge una domanda: che fondamento ha questa speranza? È una realtà certa oppure solo una illusione o un’utopia? Ma se è un’illusione o utopia, vale allora la pena subire tribolazioni? La certezza della speranza poggia su un solidissimo fondamento che Paolo indica subito dopo: “l’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo”. A garantire la certezza della speranza sono perciò impegnati lo stesso amore di Dio, quell’amore che si è manifestato nella croce di Cristo e che lo Spirito Santo ha effuso nei nostri cuori. Dato questo solidissimo fondamento della speranza, ne vale la pena allora sostenere la tribolazione e si comprende anche perché essa, tanto innaturale alla condizione umana, può anche diventare motivo di vanto. La via verso la speranza, di cui è garante lo stesso amore di Dio, parte appunto dalla tribolazione. 5. La prospettiva del libro degli Atti Tutto quello che abbiamo sopra indicato corrisponde alla prospettiva fondamentale del libro degli Atti. Leggendo tale libro infatti ci si può chiedere perché Luca abbia scritto questo libro che talora assume il carattere di un freddo diario di viaggio. Lo scopo di Luca non è quello di dare un resoconto completo dell’attività apostolica, che peraltro sarebbe incompleto, né tanto meno quello di presentare gli apostoli come dei super eroi che mietono successi ad ogni pie sospinto. La scopo di Luca è invece quello di mostrare come il vangelo, per mezzo degli apostoli, raggiunge veramente gli estremi confini della terra. A riguardo degli apostoli poi, soprattutto di Paolo, Luca si preoccupa di presentarli come gente che passa di città in città, condividendo la passione di Gesù, così come lui stesso aveva preannunziato. Per questo motivo Luca non omette di narrare anche le persecuzioni e gli insuccessi a cui gli apostoli vanno incontro A riguardo possiamo richiamare il testo di At 14, 8-20, dove Luca narra due episodi, entrambi spiacevoli, benché opposti, accaduti a Listri. In seguito alla guarigione di uno storpio, Paolo e Barnaba furono scambiati per dei: a stento riuscirono a far desistere la folla dall’offrire loro dei sacrifici. Subito dopo (vv 19-20) Luca narra come i due furono linciati dalla folla, stimolata da giudei venuti da Antiochia e da Iconio. È interessante il modo come Luca descrive questo fatto. Si dice che Paolo, dopo essere stato lapidato, fu trascinato fuori dalla città, essendo stato ritenuto morto. Poi, circondato dai discepoli, ed essendosi alzato, entrò in città. Troviamo quattro elementi che ci inducono a scorgere tra le righe una allusione al mistero di Gesù: lapidazione, morte, resurrezione, ingresso in città. Tutte queste osservazioni ci dicono che la vera efficacia del ministero apostolico non poggia sulla bravura o sull’ascendente che può esercitare l’apostolo, bensì sul suo coinvolgimento nel mistero di Gesù e sulla condivisione della sua passione. Non è casuale il fatto che Luca inserisca delle bellissime descrizioni della comunità ecclesiale tra due ondate di persecuzioni. Dopo avere descritto l’ostilità dei giudei contro gli Apostoli (4, 1-22) e dopo avere riferito la preghiera con cui la comunità chiede a Dio la libera fiducia di annunziare Gesù (4, 23-31), Luca introduce, in 4, 32-37 e in 5, 12-16, due descrizioni della vita della comunità primitiva, interrotte dall’episodio spiacevole di Anania e Zafira. Poi, subito dopo, da 5, 12, egli introduce una nuova ostilità contro gli apostoli da parte dei giudei. 40 Si direbbe che la condivisione da parte degli apostoli della passione di Gesù determina la crescita interna e lo sviluppo esterno della comunità cristiana. La condivisione della passione porta alla chiesa frutti di resurrezione. Possiamo anche evocare in questo senso la conversione di Paolo alla quale abbiamo già alluso nelle conversazioni precedenti. Saulo non doveva avere l’età giuridica per partecipare all’uccisione di Stefano, ma moralmente partecipava e si rendeva anche utile custodendo i mantelli di quelli che eseguivano il linciaggio. Si può notare che il martirio di Stefano è narrato nel e 7 degli Atti, mentre nel e 9 è narrata la vocazione di Saulo. La sua menzione nel e 7 suggerisce che la conversione di Saulo affondi le radici, come frutto di resurrezione, appunto nel martirio di Stefano e anche nel martirio di quelli che Saulo aveva perseguitato. Possiamo allora concludere che il successo dell’operatore pastorale non poggia sulla sua bravura, ma sul suo coinvolgimento nel mistero della passione di Gesù, facendo particolarmente propria la grande regola indicata da Gesù che chi vuoi venire dietro a lui deve prendere la sua croce. Né può essere diversamente, perché ogni successo pastorale è un frutto di resurrezione che deve necessariamente affondare le sue radici nel mistero della passione. A riguardo è molto significativo quanto Gesù ha proposto, paragonando se stesso alla vite e i discepoli ai tralci. Come il tralcio non può portare frutto se non rimane nella vite, così nemmeno i discepoli se non rimangono uniti a Gesù (Gv 15, 1-8). 41 IX “La Parola di Dio cresceva e si moltiplicava il numero dei discepoli (At 6, 7)” La grandezza e l’umiltà dell’operatore pastorale, collaboratore subordinato della Parola di Dio. 1. La Parola di Dio nell’attività apostolica Iniziamo questa conversazione con una semplice constatazione quantitativa: nel libro degli Atti la Parola di Dio è menzionata ben 45 volte. Ciò indica che quello della Parola di Dio è un tema centralissimo nell’opera lucana. Possiamo anzi pensare che il vero protagonista di questo libro non siano gli apostoli bensì la stessa Parola di Dio. Gli apostoli sono a servizio della Parola e debbono rispettare le esigenze della Parola. L’esempio più significativo è in At 6, 4 dove gli apostoli sono chiamati a risolvere un problema che risentiva di storiche inimicizie e rischiava di spaccare la comunità: gli ellenisti, cioè i cristiani provenienti dal mondo greco, si lamentavano perché nel servizio quotidiano delle mense le loro vedove erano trascurate. Avere cura delle vedove anche degli ellenisti è certo un atto di carità, ma gli apostoli riconoscono che quest'atto non è di loro specifica pertinenza. Essi sono certamente al servizio, ma prima di tutto della Parola e di ciò sono chiaramente coscienti: “non è bene che noi lasciamo la Parola di Dio per servire alle mense” (6, 2). Pur tuttavia il servizio di carità dev’essere reso. Per questo essi istituiscono i diaconi deputati, appunto, a questo ministero, e loro si riservano il loro specifico ministero: “noi invece saremo intenti alla preghiera e al servizio della Parola” (6, 4). Il servizio della Parola, ascoltata ed annunziata, nella valutazione apostolica precede qualsiasi altra attività, pur caritativa. Simile valutazione può e deve costituire criterio nella definizione della scaletta delle priorità in coloro che continuano la loro opera. Tuttavia essa è parziale e non può essere direttamente riferita a qualsiasi operatore pastorale. Ciò emerge anche dal racconto stesso degli Atti: pure i diaconi possono e debbono entrare nella categoria degli “operatori pastorali”, tuttavia il loro primo compito è dedicarsi al servizio delle mense. Una riflessione più attenta però suggerisce che, nella chiesa, al servizio della Parola non sono solo quelli direttamente impegnati nella concreta predicazione, ma tutti coloro che, guidati dalla Parola, sono impegnati in qualche particolare servizio ecclesiale. Alla base di tutto infatti ci sta la prospettiva della Parola di Dio che, prima che essere oggetto di annunzio, è soggetto di azione e si manifesta nei vari servizi che ognuno nella chiesa è chiamato a compiere. 2. La Parola di Dio e la crescita della Chiesa L’espressione di At 6, 7, riferita sopra nel titolo, stabilisce una stretta relazione tra la diffusione della Parola di Dio e la crescita del numero dei credenti. Più essa si diffonde e più si moltiplica il numero dei credenti. La diffusione si attua non solo mediante la predicazione ma anche mediante l’accoglienza di coloro che l’hanno udita. Ciò appare anche in qualche altro passaggio. Così in At 2, 41 Luca narra che quelli che accolsero la parola di Dio furono battezzati e si unirono quel giorno persone nel numero di tre mila. In 12, 24 nota Luca che “la parola di Dio cresceva e si diffondeva”. Qui l’autore non dice nulla sui frutti di conversione; essi però debbono essere presupposti. La diffusione della Parola di Dio allarga i confini della chiesa e qui si inserisce il primo viaggio apostolico di Paolo e Barnaba. Analoga osservazione propone Luca in At 19, 20, nel contesto della predicazione di Paolo ad Efeso: “così con la forza del Signore la parola cresceva e si fortificava”. 42 La prospettiva degli Atti è riscontrabile anche in alcune parabole evangeliche. Possiamo citare la parabola del granello di senapa (Mt 13, 31-33), che è il più piccolo dei semi, ma che diventa un grande albero dove possono trovare rifugio tutti gli uccelli del cielo. A questa parabola segue, in Matteo, la parabola del pizzico di lievito che deve fermentare tutta la massa della farina. Possiamo notare che la precedente parabola del seminatore identifica il seme con la stessa parola del Regno (Mt 13, 19). 3. Una nuova creazione Possiamo allora paragonare la crescita della chiesa in forza della Parola di Dio ad una nuova opera della creazione. Scrive il Sal 32, 6: “dalla parola del Signore furono fatti i cieli; dal soffio della sua bocca tutte le loro schiere”. Il Salmo interpreta bene il racconto genesiaco di Gen 1, dove ogni opera della creazione è introdotta dall’espressione: “e Dio disse”. La relazione tra la manifestazione della Parola e la sua causalità nell’opera della creazione è espressa ancora dal Sal 32. In Sal 32, 9 leggiamo infatti: “egli parla e tutto è fatto; comanda e tutto esiste”. Anticamente la Parola di Dio si impose sul caos primordiale e creò l’universo. Adesso si impone al complesso umano, paragonabile, per tanti aspetti, al caos primordiale, e crea la chiesa, determinandone anche la crescita. Dal momento che la chiesa è opera della Parola di Dio, ne consegue che essa sola ne conosce i limiti, l’ampiezza, il cammino che deve seguire nella crescita, i tempi della crescita stessa. Tutto ciò all’apostolo non è rivelato se non in parte. Egli perciò, chiamato a collaborare con la Parola nella crescita della chiesa, da una parte non può non seguire il progetto di essa, altrimenti rischia di non collaborare più e di non concorrere alla crescita della chiesa; dall’altra egli deve vivere in atteggiamento di perenne ascolto, scrutando, per dirla con linguaggio odierno, i “segni dei tempi”, per comprendere quale cammino la Parola di Dio al momento intende seguire, dove essa deve arrivare e quali sono i tempi di crescita della chiesa stessa. 3. Le conseguenze per l’operatore pastorale Emergono allora alcune conseguenze. La conseguenza fondamentale, da cui scaturiscono tutte le altre, consiste nel fatto che l’operatore pastorale deve essere cosciente che anche il suo servizio è una manifestazione della Parola di Dio che opera nella chiesa. Ciò deve indurlo ad accettare il suo servizio con gioia senza trascurarlo e senza bramare altro. Proprio la coscienza che la Parola di Dio si manifesta nella sua opera e che essa, come per gli Apostoli, è il vero soggetto nella sua attività, deve indurre l’operatore pastorale ed evitare carrierismi, rivendicazioni e giochi di potere, memore delle parole con cui Gesù mise i discepoli in alternativa al mondo: “i capi dei popoli dominano e i loro principi spadroneggiano; tra di voi però non può essere così...” (Lc 22, 25-26). Inoltre l’operatore pastorale, dal momento che non è lui che serve ma la Parola di Dio attraverso di lui, non può rifiutare a nessuno il suo servizio, né indugiare a renderlo. Ma soprattutto la collaborazione con la Parola di Dio esige nell’operatore pastorale un atteggiamento di profonda umiltà. Nella crescita della chiesa egli deve collaborare. È impegnato in tutte le sue facoltà fisiche, intellettuali e spirituali; ma la chiesa stessa rimane opera fondamentalmente non sua. In questa prospettiva può rientrare anche il senso della relatività. L’operatore pastorale deve essere cosciente che a lui è affidata solo una parte in una storia che certamente supera ma che certamente rimane misteriosa. Per questo motivo egli deve sapere lasciare un compito con la stessa prontezza con cui l’ha accettato, ripetendo con Giovanni: “adesso la mia gioia è completa: lui deve crescere ed io debbo diminuire (Gv 4, 30)”. 43
Scarica